Morte e pianto rituale nel mondo antico. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria 9788833918952
1,169 76 19MB
Italian Pages 387 [222] Year 2008
Polecaj historie
Citation preview
559
Universale Bollati Boringhieri
Ernesto de Martino
Morte e pianto rituale nel mondo antico Dal lamento funebre antico al pianto di Maria Introduzione di Clara Galiini
Bollati Boringhieri
E dizione nella collana «bib lioteca di cultura scientifica» 19 5 8 , col titolo Morte e pianto rituale nel mondo antico: d a l lamento pagano a l pianto di Maria
Indice
E dizione nella collana «U niversale scientifica B oringh ieri» 19 7 5 con m odificazione del titolo per espresso desiderio d ell’autore Edizione nella collana «Saggi» 2000 E dizione nella collana «U niversale B ollati B oringh ieri» aprile 2008 © 19 5 8 , 19 7 5 , 2000 e 2008 Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino, corso Vittorio Emanuele II, 86 I d iritti di m em orizzazione elettron ica, di riprod u zione e di adattam ento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i m icrofilm e le copie fotostatiche) sono riservati Stam pato in Italia dalla L itografia « Il M ettifoglio » di Venaria R eale (To) i s b n 9 78 -8 8 -339 -189 5-2 Progetto grafico della collana d i En zo M ari w w w .bollatiboringhieri. it
vii
Introduzione, di Clara Gailini 1. Un uomo vestito di grigio, v n 2. La prim a recezione, ix 3. Q uestioni di linguaggio, X IV 4. Riprese critiche, x v n 5 . L ’interrogazione antropologica, x x 6. L ’intuizione (Tricarico, aprile 19 5 2 ), x x n 7. L a «spedizione 9. Tre lucana» (ottobre 19 5 2 ), x x v 8. La scelta (Lucania 19 5 3 ), x x v ii brevi terreni (Lucania 19 5 4 ), x x ix io . L ’incontro con C onstantin Bràiloiu (Romania, ottobre 19 5 5), x x x 1 1 . L a ricerca finale (Lucania, 3 1 luglio - 27 agosto 19 5 6 ), x x x i 1 2 . L ’ interrogazione d ell’etnologia, x x x n i 1 3 . L ’in terrogazione sul rito, x x x v n 14 . Il lavoro d el lutto, X L 1 5 . Verso un’et nografia europea, X L m Riferim enti bibliografici, x l v i
Morte e pianto rituale 3
Prefazione
7
Introduzione
15
1. Crisi della presenza e crisi del cordoglio 1. Il concetto d i perdita della presenza, 1 5 2. L a presenza malata, 25 3 . La vita religiosa come tecnica p rotettiva m ediatrice d i valori, 36 4. La crisi del cordoglio, 42 5 . D i alcune teorie psicologiche del cordoglio, 48
55
2. Il lamento funebre lucano 1 . G iustificazion e m etodologica della presente indagine etnografica, 55 2. Osservazioni sul metodo di raccolta, 68 3 . Stato attuale del lamento fune bre lucano, 72 4. C risi del cordoglio e presenza rituale del pianto, 78 5. La conquista del discorso protetto, 83 6. Il discorso protetto mediatore della singolarizzazione del dolore, 94 7. Lam ento funebre e ritorno irrela tivo del m orto, 97 8. Riepilogo dei risultati raggiunti, 10 2
INDICE
VI
10 4
3. Il lamento funebre folklorico euromediterraneo 1. L a presenza rituale del pianto, 10 4 2. Ebetudine stuporosa, planctus irre lativo e ordine della lam entazione, 10 8 3. L a conquista del discorso pro tetto: la periodizzazione délplanctus in ritornelli emotivi stereotipi, 1 1 5 4. La conquista del discorso protetto: l’incidenza corale dei ritornelli em otivi, 12 2 5. L a conquista del discorso protetto: i moduli letterari, mimici e melodici, 12 5 6. L a singolarizzazione del dolore, 1 3 0 7. Una lamentazione al C airo, 1 3 3 8. D elirio di negazione e lamento, 13 8 9. Ritualizzazione dei conflitti susci tati dall’ evento luttuoso, 14 4
Introduzione* Clara Gallini
150 4. I funerali di Lazzaro Boia i . N ota introduttiva, 13 0 2. D al lamento delle donne alle fiabe dei fanciul li, 15 4 3. L a veglia notturna e i giuochi lascivi, 16 4 4. I l trasporto dell’ a bete, la morte alla finestra e la risurrezione di Lazzaro, 16 6 5. Annotazioni conclusive, 17 5
17 8
5. Il lamento funebre antico 1. Ritualizzazioni del planctus, discorso protetto e singolarizzazione del dolore, 178 2. Lamento, mito del morto e rituale funerario, 19 2 3. Furore, lascivia, fame e rituale funerario, 200 4. Una interpretazione di K . M euli, 207 5 . Lo scudo di A chille, 209
2 14
6. La messe del dolore i. 3. 3. 7.
26 0
È in atto una vitalissima ripresa di studi che stanno concorrendo alla ricomposizione storico-critica della complessa figura di Ernesto de Martino, di certo uno dei maggiori intellettuali del Novecento italiano. La presente Introduzione intende contribuire a questo lavoro.
M orte, lavoro e cultura, 2 1 4 2. Protoagricoltura e cerealicoltura, 2 16 O sservazioni m etodologiche, 2 2 1 4. Raccolto e passione dei cereali, 223 R accolto e passione del lino, 2 37 6. Raccolto e passione della v ite, 242 A nalisi ierogenetica, 246
7. Grandezza e decadenza del Pianto Antico 1 . Il Pianto D ivino come modello, 260 2. Lam ento funebre e vita culturale in G recia e a Rom a, 2 75 3. Israele e la crisi del pianto rituale antico, 282 4. L a polemica cristiana, 288 5. Il declino del pianto antico e la Mater D olo rosa, 298
408
Epilogo
321
Aggiunte i . I ritornelli asseverativi nel Napoletano, 3 2 1 2. U na varietà di planctus rituale, 32 2 3. Intorno alle «definizio ni» del lam ento, 32 4 4. Traspo sizioni del lamento funebre, 3 2 5 5 . U n lamento Yam ana, 328
331
A tlante figurato d e l pianto
377
Bibliografia
1. Un uomo vestito di grigio Ernesto de Martino, professore, oltre i cinquanta, insegnante di liceo e libero docente di storia delle religioni. Privo di capelli, con molti denti pieni di sorriso. Ha confessato di appostarsi nei piccoli paesi del Sud in attesa che morisse qualcuno per registrare direttamente i lamenti funebri di millenaria tradizione ... Dieci anni di lavoro senza mai abbandonare un corno di corallo scaramantico (de Martino è napoletano) giustamente riconosciuto dai giu dici del Viareggio che cominciano a pensare all’aldilà.
30 agosto 1958. È appena stato proclamato il vincitore della ventesima edizione del premio Viareggio. Citiamo dalle cronache (Ugo Moretti). Si prevede «una serata mondana», con la Tv e la Settimana Incom, rallegrata dall’orchestra del maestro Martolini, con Fiorella Boni e i Rio Rita... Nell’atrio del Royal, belle donne cotonatissime sfoggiano smaglianti sorrisi, Leonida Repaci un cami ciotto bianco bordato al collo, stile etnico, un po’ «alla caprese» * Ringrazio Vittoria de Palma e Alfredo Saisano per la collaborazione che mi ha permesso di accedere agli archivi de Martino (Roma) e Bollati Boringhieri (Torino), per ritrovarvi rispet tivamente la documentazione dell’etnografia demartiniana e della rassegna stampa del premio Viareggio conferito nel 1958 a Morte e pianto rituale nel mondo antico.
v ra
CLARA GALUNI
ma da mugico, segnale di impegno politico e di trasgressività di costumi contrastivi alla moda «dei freschi in terital e gabardi ne»... Che la scena, questa scena, dia spazio a un discorso aperto sulla morte seppure altrui, di quelli del profondo Sud, provoca scon certo, innesca gesti apotropaici, toccamenti segreti o palesi. Si avverte che un tabù è stato infranto e che l’indicibile sta trovando parola. È questa, in effetti, la novità sostanziale di un libro come Morte e pianto rituale nel mondo antico (d’ora in poi: Morte e pianto rituale) capace di mettere sul tavolo un oggetto la cui evocazione non è mai stata pacifica, e assai meno lo era in anni in cui tutto doveva convergere a rappresentare l’avvenuta ricostruzione dai danni della guerra e l’imminente e generalizzata felicità procurata dal mondo dei nuovi consumi. Ai cronisti non può passare inosservato che il trasgressore sia «un uomo vestito di grigio» (Franco Tintori, «Paese Sera» e « L ’Ora»), e lo stesso Alfonso Gatto per il «Giornale del Mattino» costruirà il racconto del professore, uscito in fretta e furia dall’alber go per comperarsi un vestito nuovo da cerimonia. «Il particolare è commovente. La cultura, da noi, ha sempre un vestito solo, stretto stretto, e magari rimediato», commenterà in termini deamicisiani affatto inadeguati a rappresentare uno stile, che è anche scelta di vita, indifferenza all’apparire. Con maggior aderenza al personaggio, Aldo Santini ne tratteggerà per «Il Tirreno» un ritratto, che, seppu re «colorito» secondo le esigenze del linguaggio cronachistico di quegli anni, ne restituisce l’interloquire diretto, commisurandolo rispetto ai due poli opposti e complementari della retorica e della pedanteria professorali, per interpretarlo come espressione di pro fonda umanità. Ma c’è dell’altro, che il personaggio sembra evo care, ed è una persino inquietante capacità di interpellazione, capa cità in cui sembrano far tutt’uno sia l’autore che il suo testo: I suoi occhi celestini, vetrini, sono abituati a scrutare al di là dei confini del nostro tempo, del conoscibile, si indovina, e il suo volto è ossuto, squa drato a linee dure, è il volto di un uomo forte, talmente in confidenza con il mondo dei trapassati, si indovina subito anche questo, da poter essere considerato un uomo capace di apprezzare la vita come pochi altri.
Appena evocato, lo spettro dello iettatore si trasforma in presenza sciamanica: «Un libro che davvero parla ai vivi, e per i vivi» con cluderà l’articolista.
INTRODUZIONE
IX
2. La prima recezione Una lettura critica di un testo così complesso come Morte e pianto rituale richiede una sua attenta contestualizzazione. Colpisce (non siamo i primi a notarlo) l’estremo divario tra l’immediata - e spesso non banale - pubblicizzazione del libro in connessione all’evento Viareggio e il persistente silenzio mantenuto per anni da antropologi e storici nei confronti dell’argomento centrale di un’opera rispetto alla quale ci si sarebbe cominciati a misurare solo dopo il vuoto di una buona generazione, ormai, per così dire, a cose fatte, e fatte da altri, come meglio vedremo più avanti. Anche in questo caso - quasi a segnale della abnormità di un autore tra sgressivo e «fuori schema» - un testo demartiniano sarebbe ap parso superato da tempi da lui non previsti. Proviamoci a seguire l’ipotesi opposta: quella cioè che l’autore fosse, al contrario, molto, troppo avanti sui tempi. O che comunque si proponesse come una potenzialità, il cui senso richiedeva e ancora richiede piena esplicitazione. In quegli anni, la vitalità del Viareggio si reggeva anche in virtù delle cronache che ne seguivano dappresso i lavori, trovando spa zio in interi paginoni di tutti i quotidiani. Sui giornali delle più varie tendenze politiche - e sappiamo quanto allora contassero gli schieramenti ideologici - compaiono apprezzamenti, sintesi ragio nate di Morte e pianto rituale, profili biografico-culturali e intervi ste all’autore, che non banalizza mai il proprio discorso. Espres sione di un consenso unanime, seguito all’iniziale sconcerto rispetto a un argomento decisamente tabuato, Guido Piovene avrebbe giu dicato Morte e pianto rituale «il miglior libro di questi affini». Ed è in prevalenza nel campo della pubblicistica che - tranne alcune eccezioni - si iscrivono le più meditate recensioni uscite a ridosso del premio. Del libro si coglie l’interrogativo che più urge, ed è quello pro posto dal brano dei Frammenti di etica di Croce citato proprio all’i nizio di Morte e pianto rituale: che cosa dobbiamo fare dei morti? La domanda fa da sfondò ad ogni pagina del testo, che conduce il lettore attraverso tutte le tappe di una precisa procedura simbo lica indirizzata appunto a «fare» i morti - anzi: il morto - e as
CLARA GALLINI
sieme ad essi i vivi, costruendoli entrambi come esseri distinti e per questo capaci di relazionarsi in modi positivi. E una que stione filosofica di ordine generale, e come tale comincia ad essere trattata. Ma poi subito l’etnografia restituirà i modi con cui deter minati soggetti - le contadine lucane - procedono concretamente in questo lavoro. L ’analisi, che con minuzia si dispiega nella prima parte del libro, segue in tutti i dettagli lo svolgersi di questo lavoro, che impegna assieme la psiche e il corpo, l’individuo e la collettività. Vistose e clamorose, le manifestazioni del cordoglio di cui si fanno tragico carico le lamentatrici dei villaggi lucani appaiono pur sempre come comportamenti antitetici a quei modelli di interio rizzazione e privatizzazione del dolore che si presume siano domi nanti nella nostra società. Sul pianto formale, si presentano come drammatizzazioni a soggetto, svolte però ubbidendo a canoni codi ficati. Sul piano psicologico, sembrano esternare gradi di soffe renza e labilità incommensurabili rispetto ad esperienze altrimenti vissute in più moderni contesti. Sul piano storico, sembrano riaffio rare come «Atlantidi sommerse», rinnovando una memoria lunga che rinvia a orizzonti di significato ormai preteriti. La forte centrali tà simbolica del lamento funebre delle culture antiche sarebbe stata possentemente erosa dal cristianesimo, con la sua nuova concezione della vita e della morte. Ma non in misura radicale, in ogni tempo e in ogni luogo, sì che patteggiamenti ed esiti compromissori ne punteggerebbero la storia. Solo l’età moderna avrebbe messo la parola fine su un «pianto antico» (questo era stato uno dei possibili titoli del libro) ormai ridotto al massimo della marginalizzazione. L ’autore sembrerebbe insomma sostenere l’immagine positiva di una modernità priva di ombre e fantasmi, nella sua raggiunta capacità di operare quel solenne esorcismo contro la morte, che sarebbe rappresentato dalla laicizzazione dei valori della vita. Eppure proprio l’interrogativo iniziale del testo - che cosa dob biamo fare dei morti? - resta, con tutta la sua forza di interpellazione. E questo fu il punto che - alla prima recezione del li bro - parve a tutti come cruciale. A ll’interrogativo si potevano cercare risposte di ordine vario, persin opposto. Non poche di esse si configuravano come ribadite certezze nelle sorti umane e progressive: riprese dal discorso demartiniano, ma semplificate e persin banalizzate, argomentazioni di
INTRODUZIONE
ΧΪ
verse mettevano in scena quali vittoriosi ghostbusters vuoi il «pro gresso civile» (Vittorio Lanternari) vuoi un’«industrializzazione» comunque apportatrice di sviluppo culturale. Rilanciata dal socio logo Corrado Barberis, e rimbalzata sulle più varie testate, quest’ultima tesi doveva apparire la più convincente, in questo scor cio di fine anni cinquanta segnato dai prodromi del boom industriale e della relativa retorica. «Rivoluzione industriale contro lamenti funebri» poteva gloriosamente titolare un articolo di Domenico Izzo sulla «Tribuna» in cui si affermava che: Le premesse dichiaratamente marxiste dell’etnografo, se interpretate a modo, possono anche non turbare una coscienza liberista. Giacché sempre contrap posti aU’immobilità sono l’impresa, l’iniziativa e il lavoro.
Eppure, sensibilità più attuali e inquiete suggerivano altre pos sibilità di risposta al testo demartiniano, altri modi di misurarlo rispetto a quegli interrogativi dell’oggi, da lui stesso evocati come presenze possibili, dietro una scena che non era loro consentito di occupare. Dopo aver valorizzato come «fatto senza precedenti in Italia» il ricorso a Freud e Melarne Klein e, più in generale, l’attenzione a «tutta una letteratura psicologica e psicanalitica sul lutto, sugli usi funerari e sul sentimento della morte», al termine della sua recensione, Emilio Servadio suggerisce una comparazione tra le tematiche espresse nei lamenti funebri dei contadini lucani e «i sogni di un analizzando europeo di buona cultura durante una crisi del cordoglio». Ma appena suggerita, la crisi del cordoglio di un soggetto di tal genere - europeo e di buona cultura - rimane sospesa in un vuoto di referenti, che andrebbe quanto meno pro blematizzato.1 Diversa la posizione di Guido Piovene, che nella sua entusia stica recensione pone altre questioni al testo, chiedendosi se sia l’unica strada percorribile quella suggerita nel brano di Croce citato ad esordio di Morte e pianto rituale. Oltre alla prospettiva di un superamento della morte nei valori, «un altro modo di sentire, anch’esso ben presente alla coscienza moderna, consiste proprio 1 Tranne la conclusione, il contenuto della recensione di Servadio risponde ai temi che de Martino gli ha indicato di trattare, in una lettera a lui indirizzata e che si conserva nel fondo Servadio (Roma).
XII
CLARA GALLINI
nell’opposto:... un rifiuto di idealizzarla, di superarla, di trascen derla». E cita, a questo proposito, i versi scritti da Dylan Thomas in occasione della morte del padre. Non-senso della morte. Liquidazione del morto dentro di noi, con un lavoro sbrigativo, ma dagli esiti forse sempre segretamente aperti e disturbanti. La recensione di Pietro Citati è un testo di eccezionale pregnanza, degno di riconsiderazione, proprio per la forte consonanza che dimostra nel leggere la pagina di de Martino come un precipitato di materiali tumultuosi, segnalatori di una per cezione tutta moderna di una crisi della cultura al cui interno si iscrive anche la riflessione sul significato dei riti della morte e sul vuoto lasciato dall’apparente crollo della loro centralità nella società borghese. Già 11 mondo magico - scrive Citati - è «uno studio in cui si indaga la situazione-limite fra l’uomo e il caos, fra la coscienza e l’indistinto, la vitalità pura». E, quasi intuendo percorsi che de Martino avrebbe esplorato di lì a non molto, lavorando attorno a La fin e del mondo, Citati istituisce un confronto diretto con le più varie tendenze dell’arte del ventesimo secolo, che «ha rappre sentato, fino alla ossessione, codesto dramma». Ma questo - pro segue - è soltanto uno dei due poli entro cui si bilancia la ten sione di uno studioso come de Martino, comunque fedele alla sua formazione culturale crociana e storicistica. Così, nel momento stesso che indugia nei territori della follia, del puro dolore, dell’assoluta sessualità, egli tiene difatti sempre presente, con l’altro occhio, il polo contrario... il processo per il quale l’irrazionale diventa razionale, il vitale morale, l’astorico storico.
Citati è tra i pochissimi, forse l’unico, a cogliere nel segno anche sulla questione per de Martino fondamentale in questo suo nuovo libro: la teoria del mito e del rito, e la sua verifica nell’analisi di una pratica concreta e individuata. Che questo aspetto essenziale della ricerca teorica demartiniana non sia entrato nella discussione scientifica di quegli anni è una grave lacuna che dà molto da riflettere. Quanto a Citati - con una certa (seppur parziale) correttez za - la sua lettera della teoria demartiniana del rito ne sottolinea la centralità del modello della ripetizione, «chiave astorica che fa sì
INTRODUZIONE
xm
che non abbia luogo il sentimento unico, irripetibile», ne indivi dua le ascendenze freudiane nell’« interesse per il mito e il ritorno che sono connaturali alla psicanalisi», e ne segnala l’autonomia e la coerenza del costrutto argomentativo. Per Citati, il confronto con l’oggi non sembra del tutto paci ficante: Oggi si hanno altre tecniche ... questo controllo stoico nasconde, alle volte, una tecnica inconscia che permette di evitare i contatti col dolore, gli fa il vuoto intorno, restringe a poco a poco, e senza parere, la superficie col pita, neutralizzando alla fine il sentimento doloroso entro una zona sempre più vasta di indifferenza e di atonia.
E a differenza di de Martino, sembra guardare al rito come una sorta di bene perduto: Il rito non può nascere dalla civiltà dell’ understatement e dei sentimenti pro curati ed ambigui, ma soltanto quando si accetta la disperazione, e la si spinge, la si mima, fino al parossismo.
Rivelatrice di acute, attuali sensibilità, la pagina di Citati sem bra consonare con l’espressione dei primi dubbi, che proprio in quegli anni cominciavano ad affiorare, circa l ’efficacia, in termini di sanità mentale, di quelle forme di controllo e interiorizzazione del lutto, che si vorrebbero proprie dell’età moderna e che si con nettono all’occultamento sociale del malato e del morto. Citati a suo modo intuisce che morire soli rescinde entrambi - morituro e viventi - da un’esperienza che abbisogna di significati e di af fetti. E sembra assegnare alla pratica simbolica il carattere di una costante e necessaria dimensione espressiva dell’umano. La posizione di de Martino è apparentemente diversa. Egli da un lato assegna a un insieme di problematiche congiunturali (miseria economica, oppressione sociale) le ragioni della tenace persistenza, nel Mezzogiorno d’Italia, di forme di crisi del cordoglio per que sto bisognose di un controllo rituale. Dall’altro sembra confidare nell’immagine positiva di un certo «ordine civile» raggiunto dalla società borghese assieme alla laicizzazione dei valori e all’interio rizzazione delle emozioni. Ma che il suo universo fosse assai meno pacificato, ce lo rivela nel momento stesso in cui proprio partendo dalla citazione di Croce va a consegnare al piano dell’etica il «dover essere» di un auspicato pianto laico, non più bisognoso della me
CLARA GALLINI
XIV
diazione simbolica. Che appunto qui ci fosse un nodo duro da risol vere era uno dei compiti teorici che l’autore di Morte e pianto rituale prima ancora di suggerire al lettore doveva andar ponendo a se stesso. Come si vede, di materia messa al fuoco ce ne fu molta. E l’am pia e non banale risonanza mediatica di cui Morte e pianto rituale godette in quei giorni aveva innescato un dibattito, o comunque l’inizio di una riflessione, che avrebbe potuto incidere anche sul piano della ricerca antropologica. Effimera, quella suggerita dal Viareggio del 1958 fu però un’occasione mancata: non si realizzò, di fatto, un reale confronto di metodo, capace di innescare ana lisi, approfondite e pertinenti, sulla natura e le forme delle prati che simboliche che si attivano nei confronti della morte di un essere umano, in una società data. Ne testimoniano le ulteriori recensioni pubblicate su riviste scientifiche, o di varia cultura, a ridosso dell’uscita del libro. Due pregevoli critiche filosofiche (Carlo Azzimonti e Carlo Tullio Altan) - circospetta la prima, estremamente puntuale la seconda - ana lizzano il concetto demartiniano di «crisi della presenza», che, come vedremo, si approfondisce e riformula in Morte e pianto rituale. Si aggiungono le precise note di un antichista (Vittorio Cittì) e quelle, più arruffate, di un noto sociologo cattolico (Francesco Cre spi), che dopo aver elogiato l’analisi del compianto di Maria con clude rivalutando il senso cristiano della morte e avanzando appelli alla Fede alla Verità e alla Vita. E questo è tutto, o quasi. Con le sole eccezioni di Tullio Tentori e di Vittorio Lanternari (in interven ti peraltro assai rapidi) tacciono proprio i rappresentanti dei campi più caratterizzanti la ricerca di Morte e pianto rituale·, gli studiosi di etnologia, di storia delle religioni e delle tradizioni popolari. Il che non può non lasciare - come eufemisticamente si direbbe perlomeno perplessi circa certi abiti accademici... d’altri tempi.
3. Questioni di linguaggio Morte e pianto rituale è un libro indubbiamente ponderoso, ben diverso dalle altre due monografie (Sud e magia, La Terra del R i morso) che, in breve successione temporale, arriveranno a compor
INTRODUZIONE
XV
re la cosiddetta triade «meridionalistica» di de Martino, propo nendosi come narrazioni compatte, agili e di più cattivante lettura. La stessa varietà e ampiezza dell’apparato documentario di cui si avvale ogni sezione del testo è segnalatrice del forte investimento dell’autore in un’opera, in cui si concentrano i risultati di una mole di lavoro lungo e sistematico. Ma è anche un libro eccentrico, sia nel linguaggio sia nella forma espositiva. Non assomiglia infatti a una monografia etnografica «classica», in cui tra altri argomenti trovi spazio la descrizione degli «usi funebri» di una data popolazione. Ma neppure è comparabile a una trattazione storica sistematica, da un inizio a una fine. La sua natura interpretativa pone piuttosto il lettore di fronte a una serie di nodi problematici, che sembrano essere trascelti perché essenziali, rappresentativi del discorso dell’autore. Forse, la pon derosità stessa del suo impianto è segnalatrice di investimenti e assieme di impacci nel governo dei vari piani entro cui si distende una stesura pur consapevole del proprio procedere: l’esposizione di una teoria del rito e quindi l’individuazione di una precisa pra tica simbolica da analizzare mediante l’etnografia e da contestua lizzare nello spazio e nel tempo. Sperimentale, difficilmente col locabile, lo stesso linguaggio traduce lo sforzo di restituire la varietà delle stratificazioni interpretative attivate nel corso dell’intero pro cedimento. Anche quest’ultima dimensione del testo fu a suo tempo perce pita e segnalata, ancorché all’interno di una discussione origina tasi per diverse finalità. Dopo un anno da tutti indicato come molto critico, non passò pacificamente il fatto che il primo premio Via reggio venisse attribuito a un testo di saggistica e non di lettera tura. Era solo la quarta volta - si rimarcava - dopo il premio assegnato all’opera postuma di Antonio Gramsci nel 1947, a quella di Arturo Carlo Jemolo nel 1949, e infine a Eugenio Garin (insieme a Vasco Pratolini) nel 1955... E la distinzione tra letteratura e sag gistica, con l’implicita gerarchizzazione dei due generi, si ribadiva all’interno di discorsi, la cui portata simbolica andava oltre quella del premio stesso. L ’imputazione di incompetenza della giuria ad esprimersi in merito a un’opera di etnologia si accompagnava di fatto ad espliciti appelli alla «tradizione» letteraria del Viareggio, appelli che trovavano un consenso capace di travalicare quegli stessi
XVI
CLARA GALLINI
schieramenti ideologici, peraltro così rigidi e definitori in tempi di guerra fredda. Provenienti da personaggi diversissimi quali Carlo Bo, Enrico Falqui, Leone Piccioni, Giancarlo Vigorelli, da un lato, Gian Carlo Ferretti, Carlo Salinari (uno dei più duri), dall’altro, queste posizioni critiche ci appaiono oggi forse anche segnali della percezione di nuovi fermenti e non pacificate contraddizioni. Da un lato, l’erosione del campo letterario da parte delle nuove forme di romanzo-inchiesta così caratteristiche di molte scritture «impe gnate» di quegli anni poneva non pochi problemi, a destra come a si nistra. Dall’altro - ed è l’aspetto che a noi maggiormente interes sa - la stessa «confusione di generi» così evidente nella scrittura demartiniana poteva anche essere spia delle difficoltà incontrate dall’etnologia e dalla demologia italiana ad aprirsi a nuove e più attuali problematiche, rinnovando dall’interno il proprio linguaggio. Difficile, oscuro, per gli uni (Cesare d’Onofrio), iniziatico e pos sentemente evocatore per gli altri (Domenico Sassoli), il linguag gio demartiniano era l’aspetto del libro che parve più problema tico, al di là della scomodità stessa del suo argomento. Persin ovvia, l’analogia con l’autore della Scienza nuova - opera cui ogni testo del nostro studioso tributa riconoscimenti quasi di rito - è pre sente nei due tra i più attenti recensori di Morte e pianto rituale (Piovene e Citati), che non solo per ragioni di mestiere dimostrano di cogliere le problematiche novità del linguaggio di de Martino: una scrittura, con tutta la sua urgenza che preme sui più o meno consolidati steccati tra saggistica e letteratura. Personalmente, ritengo che in questa così tipica e pressante intrusione dell’autore nel testo risiedano molte ragioni dell’efficacia - ora attrattiva ora repulsiva - di una scrittura che tende ad imporsi come fatto etico e di comunicazione, al di là della severità dell’impianto metodolo gico che la sottende. Segnale di una modernità inquieta, della scrittura di de Mar tino Citati coglie l’eclettismo come caratteristica più visibile: Certamente de Martino dispone di una dote, molto felice, di invenzione e di definizione metaforica. Meno consenso potrà suscitare la congestionata, variopinta e barbarica congerie dei materiali linguistici con i quali è costruito Morte e pianto rituale nel mondo antico. La psicanalisi, il marxismo, l’esi stenzialismo, Croce, la critica letteraria, non manca nulla: ogni linguaggio ha lasciato a de Martino i suoi termini tecnici. Di questo mostruoso sac cheggio, compiuto con una vitalità molto meridionale, restanto dappertutto
INTRODUZIONE
XVII
le tracce, i detriti, come gli ideogrammi cinesi che Ezra Pound inserisce nel suo inglese. Non è che de Martino non abbia cercato di amalgamarli, o non li abbia impiegati al punto giusto. Ma non vi è dubbio che egli, se non è quello che si dice un ricercatore e uno sperimentatore, non è nemmeno una pura mente teorica. La sua intelligenza è genialmente eclettica e combinatoria.
Insomma, ci chiediamo con lui, un de Martino brìcoleur, esplo ratore di «generi confusi», alla ricerca di un linguaggio capace di rendere il suo complicato percepirsi come moderno? Non è C lif ford Geertz a suggerirci queste domande, oggi perfino inflazio nate, ma Citati nel 1958: il quale conclude il suo bell’intervento andando oltre la contingenza del dibattito sollecitato dal Viareg gio, per chiedersi se l’attitudine eclettica e combinatoria non sia esclusiva caratteristica di de Martino, ma piuttosto forse «il più grande dei vizi moderni».
4. Riprese critiche Riformulato in termini molto diversi da quelli di de Martino - ma anche immeritamente prescindendone dalla conoscenza l’interrogativo sul «senso della morte» e sulle varie forme dell’at teggiarsi rispetto al proprio e all’altrui morire, si sarebbe affac ciato come uno dei temi dominanti nel discorso sociologico, filoso fico e storico di buona parte della cultura europea - soprattutto di matrice francese - degli anni settanta. E appunto in sintomatica contemporaneità col risveglio di inte ressi per queste tematiche che un libro atipico e precoce come Morte e pianto rituale comincia a essere fatto oggetto di un’analisi perti nente al suo oggetto. La precedente critica demartiniana - i cui limiti temporali potrebbero essere rappresentati dai due libri di Giuseppe Galasso, Croce, Gramsci e altri storici e L'altra Europa, rispettivamente del 1968 e del· 1982 - aveva nel complesso pri vilegiato due direzioni: da un lato, quella filosofica dei rapporti tra il pensiero di de Martino e quello di Croce, dall’altro quella culturale, accentuando particolarmente la tematica delle dinami che tra egemonia e subalternità culturale. Una prospettiva, que st'ultima, di certo consona all’ottica demartiniana, ma insufficiente a focalizzare l’oggetto sottoposto al suo sguardo. Sono queste alcune
xvm
C L A R A G A L L IN I
delle ragioni per cui in tutti questi anni un libro così complesso e stratificato come Morte e pianto rituale è entrato per così dire di striscio nell’interesse di una critica perlopiù disattenta a quelle dimensioni del testo, che oggi ci sembrano più considerevoli. E del 1987 la raccolta di contributi di vari autori, Le Retour des morts, curata da Daniel Fabre che - per quanto mi consti rappresenta la prima occasione per un bilancio critico di quanto l’etnografia europea ha prodotto in merito a un argomento che, come si è visto, è tornato a essere oggetto di riflessione in anni relativamente recenti. Nel suo interno si situa, tra altri, il saggio di Giordana Charuty, Morts et revenants d ’Italie, che fa il punto della ricerca italiana sull’argomento. Con pertinenza, Charuty rico nosce a de Martino il merito di aver proposto nel suo libro la prima analisi dell’espressione codificata delle emozioni e delle credenze sui defunti... molto prima che, sotto l’influenza delle ricerche francesi, gli storici italiani reintegrassero nel loro campo di ricerca la questione delle rela zioni tra i vivi e i morti - che è diversa da quella delle rappresentazioni della vita e della morte.
Passa quindi a recensire gli importanti contributi di Francesco Faeta e Marina Malabotti (1980) e principalmente di Luigi Lombardi Satriani e Mariano Meligrana (1982), i quali ultimi, sulla base di un’etnografia condotta in Calabria, diversamente da de Martino estendono l’osservazione all’insieme delle pratiche e delle rappre sentazioni concernenti i rapporti tra i vivi e i morti. Quanto alle letture di Morte e pianto rituale affacciatesi sul nostro panorama culturale in anni ancora fortemente marcati dall’egemonia dello strutturalismo, è la presa di distanza critica a prevalere. Ai puntuali rilievi mossi da Valerio Valeri (1979) all’interno della voce Lutto dell’Enciclopedia einaudiana, seguiranno le revisioni siste matiche di settori essenziali del testo, sviluppate da Pietro Cle mente (1983) e da Maria Serena Mirto (1990) rispettivamente per le parti etnografiche e antichistiche. Nel complesso, queste critiche tendono a scardinare l’intero impianto metodologico del libro, insistendo sull’esistenza di un rapporto dialettico tra codice culturale e ruoli sociali attivati nelle diverse situazioni di lutto al fine di esprimere, a titolo individuale o collettivo, un cordoglio che è sempre socialmente e culturalmente condizionato e che dunque non può mai manifestarsi nelle forme
INTRODUZIONE
XIX
di quella «crisi» nuda e cruda, di cui de Martino riterrebbe di tro vare le testimonianze etnografiche e storiche. Su questo nodo cen trale sarebbe impossibile non convenire, se decidessimo oggi di condurre una ricerca sulle pratiche simboliche che si attivano in situazioni di lutto e di cui il lamento funebre è una delle possibili espressioni. L ’etnografia del lutto, che di recente si è esercitata su diverse aree culturali, si sviluppa di fatto secondo metodi visibilmente distanti da quelli di de Martino. Osserveremo anche che queste ricerche non concernono soltanto terreni extraeuropei o dell’Eu ropa rurale: possono farci accostare a pratiche simboliche presenti in contesti urbani dell’Europa o degli Stati Uniti, quasi a indicarci l’esistenza di risposte forti e contrastive rispetto a quell’occulta mento della figura del morto, che da più parti è stato teorizzato come segno della nostra modernità. La realtà risulta dunque molto più complessa e sfaccettata, se dal livello dell’astrazione si passa a quello dell’osservazione diretta dei comportamenti umani: è que sto quanto l’etnografia ci insegna e che pertiene anche agli intenti della ricerca demartiniana. Lo stato attuale delle ricerche è però molto rivelatore della distanza temporale che ci separa da Morte e pianto rituale. E appunto il riferimento al tempo mi sembra ineludibile per qualsiasi approccio critico al metodo di qualsiasi studioso. Ritengo insomma che il testo demartiniano vada debitamente storicizzato, assumendo nei suoi confronti quella presa di distanza prospettica, che mi sembra l’at teggiamento più adeguato per instaurare un reale confronto tra noi - col nostro sapere attuale - e coloro che ci hanno preceduti e questo sapere hanno in varia misura contribuito a formare. Morte e pianto rituale va dunque risituato nel tempo e nello spa zio culturale e restituito, per questa strada, a quegli ambiti di per tinenza che l’autore ritenne caratterizzanti del suo progetto di ricerca. Concordo con Charuty quando individua nell’etnografia e nello studio del rito in quanto pratica simbolica due assi portanti di questo progetto, in tutti i suoi limiti ma anche in tutta quell’ori ginalità che solo una presa di distanza storica ci consente di comin ciare a recuperare.
CLARA GALLINI
XX
5. L ’interrogazione antropologica Corrisponde al vero l’osservazione attribuita a de Martino da vari cronisti del Viareggio che in Morte e pianto rituale siano con tenuti i risultati di dieci anni di ricerca: sono i dieci anni che sepa rano l’uscita di questo libro da quella del Mondo magico, nel 1948. Per quanto entrambi i testi ruotino attorno alla tematica centrale della «crisi della presenza», la nuova opera si differenzia dalla pre cedente per due punti fondamentali: da un lato, lo sviluppo del l’apparato concettuale concernente l’analisi della genesi e della natura del simbolismo mitico-rituale, dall’altro lato, il passaggio da un’etnologia «da tavolino» all’esercizio della ricerca sul campo. Nel suo complesso, il testo intende restituire il senso di una sin gola pratica simbolica, individuata secondo alcune coordinate che a de Martino sembrano essenziali. A ll’analisi etnografica il lettore arriva condotto da una parte iniziale, che è forse anche la più nota e studiata per quanto con cerne i rapporti con le filosofie di Hegel, Croce, Heidegger. Sono pagine di forte concentrazione teorica, costruite per arrivare alla problematica destinata a fare da ponte alla successiva etnografia: qui si svolge il tema della genesi e della struttura del simbolismo mitico-rituale, individuato nella specificità formale e contenuti stica di un costrutto ruotante attorno alla formazione di paradigmi «metastorici», cioè atemporali e sempre ripetibili, a loro volta con notati da forti ambiguità espressive, in quanto metafore assieme del «negativo» e della sua risoluzione. Questa elaborazione rinvia sostanzialmente a due saggi fondamentali, comparsi entrambi in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» (rispettivamente nei volumi del 1953-54 e del 1957), Fenomenologìa religiosa e storici smo assoluto e Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni, saggi di cui di recente Marcello Massenzio (1995) ha proposto una attenta rilettura, anche sulla base di altri scritti inediti e che si possono integrare con l’importante nota Mito e rito (sulla stessa rivista, sempre nel numero del 1957), in cui viene argomentata l’articolazione di queste due diverse modalità dell’espressione sim bolica. E per precisione storica ricorderemo infine che il saggio Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, su «Aut Aut» del 1956, già sembra compendiare l’intero impianto dell’imminente libro.
INTRODUZIONE
X XI
Più nuovo, negli intendimenti dell’autore, è piuttosto l’abbozzo di analisi di quanto si situerebbe a monte dell’espressione simbo lica stessa. E in Morte e pianto rituale che comincia a emergere una sorta di primo progetto di ridefinizione dell’antropologia filoso fica demartiniana. Anzitutto, l’ampia revisione della questione delle categorie di economico e di vitale, cui de Martino intese affidare la parte per lui più impegnativa della sua risposta a Croce. E assieme, i nuovi termini con cui si ridelinea quel concetto di «crisi della presenza» che nel Mondo magico era ancora prevalentemente inteso come datità negativa concernente in misura quasi esclusiva i primitivi, mentre ora viene ripensato nei termini di una poten zialità rischiosa sempre insita nell’essere uomo. Nuovo, in Morte e pianto rituale, è tutto il ridisegnarsi di un’antropologia che risulta sempre più marcata da una dialettica bipolare, tra rischio del nega tivo e quell’«ethos del trascendimento» (la locuzione compare per la prima volta in questo testo) cui de Martino affida il compito di essere fondatore di cultura. Insomma, per concludere su questa parte, Morte e pianto rituale intende rappresentare, per il suo autore, una sorta di altopiano da cui guardare al lavoro teorico pregresso, per misurare le distanze che lo separano dal testo di dieci anni prima. A partire dall’etnografia lucana, piano teorico e piano, per così dire, empirico dell’analisi si svilupperanno assieme, secondo una progressiva apertura a ventaglio dei temi. Interpretato come tec nica di destorificazione di uno specifico «negativo» - la crisi del cordoglio - e smontato in tutte le sue componenti formali, il lamento funebre lucano viene ricollocato in una rete di più vaste comparazioni, sincroniche e diacroniche, che consentono alla fine di ritrovare un’intera area culturale, rappresentata dai paesi gra vitanti attorno al Mediterraneo. Cruciale, il capitolo La messe ,del dolore, col suo accento sui rituali agrari della mietitura e sul tema mitico del dio che muore, ambi sce a ricostruire l’esempio di una più complessa procedura: quella della destorificazione religiosa (eterogenesi»). L ’intento finale è di ridisegnare un panorama culturale in cui le due dimensioni del l’economico (agricoltura cerealicola) e del religioso funzionino da sfondo comune e significante dei vari modi di piangere i morti umani che hanno trovato la loro espressione nei diversi contesti
CLARA GALLINI
χχπ
storico-geografici dei paesi del Mediterraneo. Non senza ragione questo capitolo è sembrato il più fragile sotto il profilo storico documentario. Ma è anche quello a più alto tenore filosofico. Invi tiamo il lettore a ripercorrerne il pur breve esordio, cori la sua pre gnante riflessione sui rapporti tra natura e cultura e con la dram matica visione di un essere umano che «si costituisce come procu ratore di morte nel seno stesso del morire naturale, imbrigliando in una regola culturale del passare quanto passa senza e contro l’uomo» (p. 214). Infine, Morte e pianto rituale si avvia verso le nuove prospet tive di una riflessione sugli scontri ideologici aperti dall’espandersi del cristianesimo, coi suoi diversi modelli culturali, peraltro rima sti per secoli al livello di una performatività astratta e non concre tizzata. Da qui, l’insorgere di quelle dialettiche di «compromesso» tra ordini di discorso apparentemente incompatibili, che si esempli ficano nella splendida e convincente interpretazione del personaggio medievale di Maria, rappresentata come lamentatrice. Irriducibile a ogni «compromesso», il lamento funebre delle donne lucane segnalerebbe anche l’estrema marginalizzazione della sua pratica.
6. L ’intuizione (Tricarico, aprile 1952) L ’etnografia del lamento funebre che darà sostanza al secondo capitolo di Morte e pianto rituale è frutto di un lavoro lento e pro gressivo, in cui sono venuti a definirsi assieme terreni e proble matiche. La nostra ricostruzione delle tappe di questa ricerca intende restituire al testo demartiniano una delle dimensioni più pertinenti alla materia di cui esso è plasmato. Per avvicinarci a questa esperienza, ci faranno da guida la sag gistica e la pubblicistica del nostro studioso, integrate dalle sue note, sia di campo sia di lettura ed elaborazione critica. Raccolte nell’archivio de Martino, dobbiamo a Vittoria de Palma il grande merito di averle radunate e conservate fin dai lontani inizi della loro prima stesura.2 2 I materiali delle ricerche sul lamento funebre sono conservati (con un primo ordinamento) nei contenitori 7 -13 dell’Archivio de Martino. Sinora sono stati trascritti (da Maria Rosa Vil lano) e studiati (nella tesi di laurea di Paolo Pace, Facoltà di Sociologia, Roma) i taccuini delle varie ricerche sul campo in Lucania.
INTRODUZIONE
xxm
L ’etnografia del lamento funebre ha una sorta di preistoria, data bile alla tarda primavera del 1952. Siamo a Tricarico, ed è il primo lavoro di campo che ha portato de Martino in Lucania. Il clima è quello fervido di una riscoperta e rivalutazione collettiva delle espressioni culturali di contadini e braccianti. Si registra, si foto grafa, con la collaborazione di Benedetto Benedetti e Arturo Zavattini. Di questo momento - che è stato di recente restituito da chi scrive e da Francesco Faeta nel libro fotografico I viaggi nel Sud di Ernesto de Martino - ci interessa qui ricordare un episodio nar rato da de Martino stesso in Amore e morte nei canti dei braccianti lucani, pubblicato su «Vie Nuove» nell’agosto 1952. Siamo nella camera del lavoro, dove si svolge buona parte delle registrazioni, che saranno poi «restituite» ai loro esecutori, median te il riascolto. È qui che incontriamo il personaggio di Rocco Dasco, nell’atto di recitare un lamento funebre, memorizzando un testo che, diciottenne, aveva sentito «da una madre della Rabata». La delicatezza che si richiede nel raccogliere simili testimonianze è il primo problema che emerge, perché si tratta di un prodotto culturale popolare che difficilmente può essere sot toposto a registrazione fonografica, perché fuor dell’occasione reale della morte porta male cantarlo, e d ’altra parte la vera morte e il vero lamento non tollerano la presenza di apparecchiature per la registrazione.
Per questo i ricercatori si sono dovuti «contentare del semplice testo letterario» che «bisogna immaginare cantato dalla madre in un lugu bre metro e con tutte le più disperate manifestazioni del dolore». Non è dunque solo in questione la possibilità di costruire un pur importante rapporto dialogico. Quel che comincia a delinearsi è la consistenza di un prodotto culturale contesto assieme di parola, gesto, musica: il lamento funebre insomma nella sua dimensione pratica e non limitabile ai suoi contenuti testuali. Ma non è più di un’intuizione. La narrazione punta piuttosto sugli aspetti emo zionali dell’incontro: Quando Rocco Dasco ebbe finito di dettare questo lamento, io non potetti sottrarmi all’impressione che la vita culturale di questa gente fosse domi nata da una nota di cupa disperazione, da una profonda angoscia viscerale.
Potenti motori di ricerca, le emozioni agiscono positivamente solo a patto che non se ne decostruisca per intero la genesi cultu
XXIV
CLARA GALLINI
rale. D ’ora in poi, de Martino avrebbe tenuto fermo il pregiudizio iniziale che vedrebbe nel lamento funebre non l’espressione di senti menti socialmente costruiti, ma la manifestazione di angosce più pro fonde di quanto l ’uomo moderno non sarebbe più portato a prova re. Non è detto però che tutti gli errori vengano solo per nuocere. Restiamo ancora per un po’ nella camera del lavoro di Trica rico. E questa volta lo sguardo a registrare nuove presenze che sembrano contrastare con quanto l’orecchio ha appena captato:
0
Ma poi i miei occhi caddero su una parete della stanza dove si svolgeva nostro lavoro, e vidi un santino nuovo, che nessun prete aveva ancora bene detto: la fotografia di Giuseppe Noviello, e sotto la scritta Terra e non guerra. Mi resi conto allora che la mia impressione era almeno incompleta, e che la morte quaggiù non era soltanto una mostruosità della natura davanti a cui prorompere nel metro di un lamento, ma anche un ricordo benefico, che aiuta chi resta a migliorare il mondo.
Il senso della morte, l’opposizione tra orizzonti religiosi e oriz zonti laici, i nessi positivi tra memoria ed ethos... Oggetto di una continua interrogazione, questi temi acquistano per noi significato solo in virtù di una visione retrospettiva, che ne ritrova l’affiorare per poi, nel tempo, tradursi in quelle più sistematiche (ma meno evidentemente politicizzate) riflessioni, che vedremo espresse nella parte iniziale di Morte e pianto rituale. Per il momento, è la dimen sione etica, foscoliana, a prevalere, e assieme ad essa l’ottimistica fiducia in un futuro migliore e socialista, capace anche di confe rire nuovi sensi al morire degli uomini. Pubblicato nel 1955 su «Nuovi Argomenti», Considerazioni sto riche sul lamento funebre lucano svilupperà queste tematiche, pas sando attraverso una narrazione che inizia con II pianto di France sca Armento per concludere con il paragrafo II movimento operaio e il costume laico davanti alla morte·, attraverso gli esempi delle let tere dei condannati a morte della resistenza e di Gramsci alla madre, vi si esprimono fiduciosi appelli alla costruzione di un c o s t u m e p o p o l a r e l a i c o , sorpreso per così dire nel suo effettivo funzionamento istituzionale: di un costume collettivo maturato perentro un ben definito movimento unitario, prodotto della civiltà moderna, il movi mento operaio.
Ma ben presto accantonata ogni ottimistica fiducia nelle magni fiche sorti e progressive di un socialismo realizzato, quest’ultimo
INTRODUZIONE
XXV
paragrafo verrà eliminato nella nuova edizione di II pianto di Fran cesca Armento ripubblicata nel 1962 in Furore Simbolo Valore. Chi poi abbia presente la lucida esposizione del suo pensiero su una questione che ormai lo toccava da vicino - mi riferisco all’inter vista rilasciata a Franca Leoni da de Martino morente (Rapporto su ll’aldilà) - vi ritroverà espresse ben più profonde inquietudini circa la radicalità di un nodo, quale quello del senso della morte, inappagabile forse neppure all’interno di una dimensione stretta mente valoriale. Più che un presupposto, il piano dell’etica appare comunque a de Martino come il risultato di un lavoro culturale. Di questo lavoro partecipa anche l’elaborazione del lutto, con i suoi riti. Ma a T ri carico questa prospettiva è appena adombrata.
7. La «spedizione lucana» (ottobre 1952) Un’intuizione non basta ancora per trasformarsi nell’oggetto di una ricerca. Non va da sé che proprio il lamento funebre - e non invece il «senso della morte» - debba essere isolato come mate ria di studio. Né va da sé che il lamento funebre vada studiato in quanto pratica e per giunta simbolica. Ipotesi e oggetto di una ricerca si costruiscono assieme. La «spedizione lucana» dell’ottobre 1952, si muoverà seguendo altri progetti. Le tappe di questa ricerca - la prima realmente sistematica, e condotta in équipe con la collaborazione di Vittoria de Palma per i contatti con le donne, dell’etnomusicologo Diego Carpitella e del fotografo Franco Pinna - sono già state da noi ricostruite in tutti i dettagli in due libri, che contengono tra l’al tro la trascrizione delle note di campo stilate sia da de Martino che da de Palma (de Martino 19953 e 1996). La «spedizione lucana» venne a configurarsi come una raccolta a vasto raggio (sia geografico che tematico) di materiali etnogra fici che allo studioso stesso sarebbero apparsi disomogenei, tanto da essere poi destinati a trattamenti molto diversi. La documen tazione sulla «magia» sarebbe rimasta accantonata per qualche anno, prima di essere utilizzata per la stesura dei primi sei capi toli di Sud e magia, libro che sarà pubblicato nel 1959. Altra cosa
XXVI
CLARA GALLINI
erano i lamenti funebri, in quanto documenti vivi, alla cui esecu zione (a differenza delle pratiche magiche) si era potuto assistere, sia pure in condizioni molto speciali. E che proprio queste condizio ni sollevassero nuove problematiche, di ordine epistemologico, ci viene raccontato in Note di viaggio, pubblicato sulla rivista «Nuovi Argomenti» nel maggio-giugno 19 53, testo bellissimo, di denuda mento di affetti e di costruzione di percorsi riflessivi. Nell’ultima parte del saggio, vediamo susseguirsi in parallelo le osservazioni etnografiche dei vari lamenti funebri e delle interrogazioni che cia scuna di esse via via ha sollecitato. Rileggerle ci aiuterà a comprendere la genesi di una problema tica strettamente connessa all’interpretazione della natura di un rito, per quanto esso ha di convenzionale. E contribuisce a risi tuare teoricamente il paragrafo del secondo capitolo di Morte e pianto rituale intitolato Osservazioni sul metodo di raccolta, in cui si riflette sulle condizioni di esercizio di un’etnografia del lamento funebre, pratica riproducibile «artificialmente» proprio in virtù della sua natura rituale.3 In Note di viaggio, la sequenza degli esempi inizia con un’osser vazione mancata: il compianto per lo zampognaro di Colobraro, che non viene registrato per il rispetto di un lutto di cui la stessa équipe di ricerca è stata l’involontaria causa. Segue la lamenta zione raccolta a Pisticci, che viene semplicemente recitata di fronte al ricercatore, ma che proprio per questo suo modo di esecuzione comincia a porre il problema dei rapporti tra convenzione e verità del rito. Viene poi Giovanna Ragona di Ferrandina, che nel com pianto del morto ingloba l’esortazione, rivolta ai bambini presenti, a fare attenzione ai pesi della bilancia con cui stanno giocando. «La lamentatrice registra nel lamento tutte le variazioni di scena», si commenta a fianco di un testo che compare trascritto per intero nei taccuini e sarà poi ampiamente analizzato in Morte e pianto rituale. Infine, il lamento funebre registrato e Rosa, che per pian gere con convinzione ha bisogno di rifugiarsi in un ripostiglio, e l’immagine della mano di Vittoria che si insinua nello spiraglio di una porta... È in questa condizione reale di ricerca, osservata in tutte le sue implicazioni, che «torna di nuovo l’alternativa erme 3 Da qui alla fine del paragrafo riprendo testualmente dalla mia Introduzione a de Mar tino 19958, pp. 62-64.
INTRODUZIONE
xxvn
neutica fondamentale» del rapporto tra finzione e realtà, conven zione e sincerità: «E questo il nodo che devo sciogliere». La problematica epistemologica che informa l’interpretazione del lamento funebre lucano di certo sviluppa le più antiche tema tiche del Mondo magico e con maggior pertinenza quelle analiz zate nel saggio sul Mito Achilpa delle origini (1952), dove già si ragiona in termini di destorificazione e di «come se» rituale. Ma l’interrogativo ermeneutico che ruota attorno allo specifico con cetto di «finzione» si propone e risolve qui per la prima volta nella scrittura demartiniana. E affiora, quasi come folgorazione, nel corso di un’osservazione sul campo, che è anche un’interazione di due forme diverse di saper fare: dell’etnologo e della lamentatrice. E proprio il pianto di Rosa - eseguito e osservato in quelle condi zioni - aprirà la strada al capire: « L ’alternativa ermeneutica arti ficio-sincerità è mal posta», il lamento funebre è un «pianto sen z’anima» che aiuta a riguadagnare il proprio singolo piangere. La finzione è dunque parte del processo di destorificazione. Cosi riformulato, il concetto di finzione punta più verso un’i dea di «teatro rituale» che non di menzogna sia pure convenzio nale. Ma per arrivare a cogliere la dinamica di questa finzione biso gnerà passare attraverso l’analisi della convenzione. È questo il percorso prioritario che comincia a delinearsi.
8. La scelta (Lucania 19 53) L ’oggetto è ormai definito, circoscritto. Comporta la decisione di una ricerca e la delimitazione di un oggetto. C ’è una svolta radi cale rispetto ai modi in cui, nell’ottobre 19 52, l’équipe aveva lavo rato alla raccolta a vasto raggio di materiali concernenti la «magia», per cercarvi le tracce di una più generale rete di coerenze simboli che. Il lamento funebre è altro - non peritene alla pratica magica cui si chiede un’immediata efficacia operativa - e s’impone per una sua carica espressiva, drammatica e diretta, la cui interroga zione sembra toccare le radici stesse dell’umano. Isolarlo per com prenderlo significa forse poter raggiungere quel momento elemen tare, aurorale, in cui si genera la costruzione simbolica... Il 1953 è l’anno cruciale che, proprio attorno a questa nuova
χχνπ ι
CLARA GALLINI
scelta prospettica, vedrà consolidarsi alleanze, consumarsi distac chi. Ma varrà anche la pena di ricordare l’efficacia di momenti di comunicazione intensa tra gli studiosi più prossimi a de Mar tino e che gravitano in questi anni attorno al Centro etnologico italiano da lui diretto. E questa la temperie che sollecita un altro ricercatore, Franco Cagnetta, a partire per un’altra zona «arcaica», Orgosolo, nel cuore della Sardegna. Pubblicato nel 1954 su «Nuovi Argomenti», Orgosolo antica presenta al suo interno anche un pic colo corpus di lamenti funebri, accompagnati da un testo di de Martino, a guisa di commentario storico sul personaggio della attitadora e sull’istituto della vendetta. In anni poveri, i costi di un soggiorno sul campo ne condizio nano forme e durata. I viaggi nel Sud di de Martino furono sem pre brevi, talora autofinanziati, talora sulla scia delle esigenze di altre istituzioni che ne fornivano i mezzi, consentendogli di rita gliarsi propri spazi all’interno di progetti di diverso genere. Con dizionamenti, dunque, che lascerebbero qualsiasi ricerca in balìa della più rischiosa precarietà, se non fosse arginata da due sup porti fondamentali. Da un lato, una conoscenza pregressa, fatta di frequentazioni e amicizie. Dall’altra, una ferrea pianificazione del lavoro da eseguire - cioè degli ambiti da esplorare - in cia scuna delle occasioni. Queste sono appunto le caratteristiche di una ricerca che potremmo rassomigliare a una partita di scacchi - il gioco mentale preferito da de Martino - di cui uno solo dei due partner abbia nelle mani la strategia completa. Gli anni della ricerca «militante» possono dirsi ormai conchiusi. Ogni dialogicità si gioca sotto l’egemonia di una forte tenuta meto dologica da parte del ricercatore. Ma nuovi piani si articolano, pur senza problematizzarsi fino in fondo. Quello del lamento funebre è un mondo in prevalenza femminile, da avvicinare con estrema discrezione e grazie alla mediazione di una donna. Il lavoro di ricerca lo farà affiorare, anche per rivalutarne la generalizzata fun zione sociale. Ma se l’intero percorso lascerà dietro di sé vuoti e interrogativi - oggi ne siamo più avvertiti di ieri - è anche per l’offuscamento della specificità di genere che caratterizza l’intera procedura del teatro rituale del pianto. Vista retrospettivamente, comunque, tutta la ricerca si caratte rizza per una impressionante gradualità delle sue procedure. Si inizia
INTRODUZIONE
XXIX
con una sorta di verifica, di messa a punto, del noto. Dal 5 al 15 settembre 1953 l’équipe - formata da de Martino, Carpitella, de Palma - ritorna a Grottole, Ferrandina, Pisticci, cioè nelle stesse località che la precedente «spedizione» aveva rivelato come poten ziali terreni per la nuova ricerca. Qui, si raccolgono esclusivamente testi di lamenti funebri. Una prima selezione e analisi anche musicologica dei materiali è subito presentata nel saggio Rapporto etnografico sul lamento fune bre lucano, pubblicato su «Società» nell’agosto 1954. Dei testi si evidenziano gli aspetti modulari, le stereotipie formali, anche con nesse alle relazioni di ruolo familiare intercorse tra lamentatrice e persona defunta. E dunque l’aspetto sociale e convenzionale del l’espressione del cordoglio à imporsi come evidenza: ma un’evi denza non appagante, una sorta di tappa obbligata per la prima presa di un oggetto, intrigante nella sua natura recondita.
9. Tre brevi terreni (Lucania 1954) Dei tre brevi terreni del 1954, il primo (15-23 aprile) nelle colo nie albanesi della Calabria e della Basilicata è anche quello che deve maggiormente rispondere agli interessi di una committenza. Ma dalla profonda differenza contenutistica dei taccuini redatti sul campo da de Palma e de Martino, risulta evidente lo spazio che lo studioso cercò di ritagliarsi ai fini della sua più personale ricerca, selezionando esclusivamente informazioni attinenti alle pra tiche e alle ideologie funerarie. Il terreno successivo (8-14 agosto) è diverso, decisamente più «demartiniano» in tutto il suo impianto. L ’équipe torna nella Luca nia «classica». Per buona parte già toccate dalla spedizione del l’ottobre 19 52, le località prescelte - Gorgoglione (Stigliano), Valsinni, Rotondella, Colobraro, Senise, Roccanova, Sant’Arcan gelo - sono anche quelle che erano apparse le più conservatrici. La ricerca si fa più sistematica e più sensibile alle connessioni tra «rito» e «mito». Del lamento funebre è tutta l’esecuzione a farsi oggetto di un’at tenzione mirata a ricostruire le sequenze entro cui si scandiscono i gesti, le parole, i canti. Emergono i primi segnali di uno sguardo
XXX
CLARA GALLIN1
rivolto a scrutare entro le dimensioni psicologiche delle manife stazioni del cordoglio. A loro volta, le pratiche del lutto, nella loro complessa scansione temporale, interessano come segni di un con testo al cui interno la lamentazione si colloca in tutta la sua auto nomia formale. Sul versante «mitico», si indaga sulle immagini dell’aldilà e si raccolgono le prime narrazioni di incontri inquie tanti coi defunti. I giorni della festa dei morti (30 ottobre - 2 novembre) risulte ranno i più appropriati per tornare in Lucania (Calvera, Senise, Roccanova, Valsinni) e continuare la raccolta di questo genere di narrazioni. M a il cimitero di Roccanova è anche l’osservatorio pri vilegiato dove assistere all’esecuzione di un compianto, assieme individuale e collettivo, che si rappresenta come il rinnovarsi di memorie sopite nel corso di un’annata. Un ciclo può dirsi chiuso. Considerazioni storiche sul lamento fune bre lucano, pubblicato su «Nuovi Argomenti» agli inizi del 1955, ne presenterà i risultati, assieme alle prime ipotesi relative ai nessi tra crisi del cordoglio, ritorno irrelato del morto e lamentazione intesa come «rito». Il saggio testimonia anche che la prospettiva interpretativa si è nel frattempo estesa a comprendere la storia della polemica cristiana nei confronti del pianto «pagano».
io . L ’incontro con Constantin Bràiloiu (Romania, ottobre 1955) Mediato dalla Associazione per i rapporti con la Romania, rin contro con Constantin Brailoiou e il conseguente soggiorno di un mese a Bucarest presso l’Istituto di Folklore mette il nostro stu dioso a contatto con un’etnografia preziosa, di quello stampo docu mentaristico di cui ancora si apprezzava il rigore dell’impianto: registrazioni sonore, fotografie, schede di osservazione. Perfetto, sotto questo profilo, il dossier dei funerali di Lazzaro Boia doveva apparire a de Martino - oltre che utile integrazione all’etnogra fia lucana - un esempio di metodo, realizzabile solo all’interno di contesti istituzionali molto diversi dai nostri.4 4 II contenitore 9 dell’Archivio de Martino contiene le note di studio del soggiorno rumeno, un fascicolo con traduzione italiana della osservazione dei funerali di Lazzaro Boia, con sequenza fotografica, e infine una ventina di positivi con immagini di funerali, lamenta-
INTRODUZIONE
X XX I
1 1 . La ricerca finale (Lucania, 3 r luglio - 2 7 agosto 1956) Finalmente lunga, strutturata e pianificata in tutti i suoi detta gli, la ricerca dell’estate del 1956 ha lasciato tracce molteplici. Pre ceduta, nel giugno, da una preinchiesta affidata a Luciana Tede sco,5 parte per la Lucania la stessa équipe della prima «spedizio ne», che si era avvalsa non solo dell’inseparabile musicologo, ma anche del fotografo, Franco Pinna. Strumentazioni e tecnici sono forniti dalla r a i e dall’Accademia di Santa Cecilia. Le località toc cate sono: Castelsaraceno, Montemurro, San Giorgio Lucano, Albano, Lagopesole, Avigliano, Ruoti, Santuario della Madonna di Pierno, San Fele, San Cataldo. Nel libro, da me curato assieme a Francesco Faeta, I viaggi nel Sud di Ernesto de Martino, si è già parlato di questa esperienza anche come storia dell’affinarsi dello sguardo di un ricercatore, per cui la dimensione visuale entra in modo sempre più decisivo nell’ela borarsi di una riflessione sul rito, in quanto teatro in cui si mette in scena un corpo comunicante. E sono state pubblicate alcune delle sequenze più rappresentative dell’esecuzione di lamenti fune bri riprodotti davanti alla duplice strumentazione della macchina fotografica e del registratore magnetofonico. Inoltre sono state scelte alcune immagini del funerale di Castelsaraceno, eccezionali perché rappresentarono l’unica occasione in cui potè essere docu mentata un’intera sequenza cerimoniale. zioni, banchetti funebri, talvolta datate degli inizi degli anni trenta. In Morte e pianto rituale, vedansi a p. 4 i riferimenti ai materiali riportati dal soggiorno rumeno e utilizzati nel testo e alle pp. 66-67 un preciso riconoscimento del metodo etnografico di Brailoiou. E molto pro babile che Diego Carpitella abbia mediato i rapporti tra lo studioso rumeno e gli studiosi ita liani, tramite la Associazione per i rapporti con la Romania. Nel 1952 Brailoiou è a Roma, dove parla su Una antologia folklorica mondiale: «La collezione universale dell’Unesco» nell’ am bito delle «Conferenze del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare predisposte dall’A cca demia Nazionale di Santa Cecilia d’intesa con l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’insigne Accademia Nazionale di San Luca» (Accademia Nazionale i9 6 0 , p. 268; questo volume porta in epigrafe una citazione da Brailoiou). Nel quadro delle stesse iniziative {ibid., p. 271) de Martino tiene una conferenza su II pianto lucano e i riti funebri italiani e stranieri. Quanto a Brailoiou, il primo volume del suo Folklore musicale verrà tradotto in italiano nel 1978, a cura e con pre messa di Carpitella, di cui vedasi già Folklore romeno, del 1955. 5 Si conserva nell’Archivio de Martino una copia dattiloscritta, non firmata (ma attribui bile a Luciana Tedesco: vedi Morte e pianto rituale, p. 68, nota 1) di una relazione sugli usi funebri di Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico, Valsinni, San Giorgio Lucano, Stigliano.
XXXII
CLARA GALLINI
Questa forte dimensione visuale impronterà, più tardi, la stessa costruzione dell’Atlante figurato del pianto accluso a Morte e pianto rituale. Anche di questo si tratta nel libro I viaggi nel Sud di Erne sto de Martino, in cui si discute, tra l’altro, delle eventuali influenze warburghiane su una ricerca mirata, nella sua parte storico-icono grafica, alla restituzione di quella realtà rituale - fatta di gesti e di posture - che insisterebbe dentro (e dietro) la stessa immagine figurata. La dimensione visuale si aggiunge dunque al percorso demartiniano in una misura non secondaria al suo modo di guar dare al rito come pratica espressiva e comunicante attraverso il corpo dei suoi attori. Vediamo ora piuttosto contenuti e direzioni della ricerca sul campo. La formulazione di un «questionario» - che è piuttosto una traccia di argomenti da approfondire - incanala verso obiet tivi predeterminati e ristretti. Estrapolato da ogni altro possibile dato contestuale, il lamento funebre viene isolato nella sua speci ficità e sottoposto all’osservazione delle sue componenti formali. Si punta dunque sul piangere in quanto «sapere» (ma si cercano anche tracce di un «saper ridere» che risulterà molto meno evi dente di quanto non fosse in Romania). Questo sapere va situato rispetto a un duplice versante. Da un lato, la codificazione sociale: ed ecco le domande sulla terminologia (travaglio, travagliane ecc.) specifica di questa e non di altre modalità del piangere, sul suo apprendimento, sui ruoli sessuali degli esecutori. Dall’altro, si insiste molto sugli aspetti dinamici di un’espressione codificata del cor doglio, leggibile a livello del corpo attraverso le varie posture e gestualità attivate nel corso del rito, e a livello della psiche delle attrici, nel vario oscillare tra depressione (attassamento) e violenza, fino al raggiungimento di un particolare stato psichico, contesto assieme di astrazione e di prese di realtà. La ricerca sul campo non avrebbe disatteso nessuna delle due prospettive. Ma Morte e pianto rituale privilegerà decisamente la seconda, rispondendo a una scelta interpretativa di cui oggi pos siamo mettere in discussione tutti i limiti, ma che è stata comun que capace di restituirci puntualmente - visibili e udibili in cia scuno dei suoi dettagli - le modalità costruttive del «discorso protetto» della lamentazione lucana.
INTRODUZIONE
ΧΧΧΠ Ι
i2 . L ’interrogazione d ell’etnologia Il progetto demartiniano testimonia di un lavoro mobile, in pro gress, punteggiato da continui aggiustamenti e sondaggi per indi viduare la più appropriata definizione del proprio oggetto. Lo stesso accostamento dell’etnografia del Mezzogiorno italiano all’etnolo gia dei «primitivi» - che marca un preciso momento della storia della ricerca sul lamento funebre - avrebbe seguito fasi di avvi cinamenti e allontanamenti, via via rivelatori di nuovi ambiti pro blematici. A ll’inizio doveva essersi persino profilata l’idea di una ricerca «da tavolino» - e non su materiali etnografici - lungo una dire zione all’incirca consona alla possibilità delineatasi nella camera del lavoro di Tricarico: studiare il variare delle concezioni della morte. Due pagine deU’archivio contengono due stesure abbastanza simili di un progetto di lavoro per una storia dell’immagine della morte, dall’antichità fino alle nuove prospettive offerte dalla visione laica della vita. Dalla scaletta degli argomenti risulta evidente che la ricerca si sarebbe dovuta basare esclusivamente su documenti letterari: dunque, un’idea in qualche modo comparabile a quella che aveva dato materia alVAutunno del Medioevo di Johan Huizinga, tradotto per Sansoni proprio in quegli anni, nel 19 53, e che poi sarebbe diventata centrale nel bel libro di Alberto Tenenti sul l’immagine della morte e della vita nel Rinascimento, pubblicato per Einaudi nel 1957, quando ormai de Martino ha già decisamente abbandonato il campo della storia delle idee. Un secondo progetto di ricerca rinvia a un panorama culturale diverso e assai meno vago: si contestualizza infatti nell’ambito dei nuovi interessi per l’etnologia oceaniana, che de Martino aveva cominciato a coltivare a Roma, all’inizio degli anni cinquanta, nella sua pratica universitaria di libero docente di etnologia e che già era sfociato nel saggio Un mito Achilpa delle origini, poi annesso alla seconda edizione di Mondo magico. Nella sua ispirazione di fondo, questo piano di lavoro si iscrive nel programma di costru zione di un’etnologia religiosa, a impianto laico e storicistico, voluto e sostenuto da Raffaele Pettazzoni e condiviso anche da de Mar tino, almeno per quella parte del metodo storico-religioso che si
XXXIV
CLARA GALLINI
proponeva di studiare «il legame tra regime economico e visioni del mondo».6 Di recente, in La mia alleanza con Ernesto de Martino (1997), Vittorio Lanternari ha tratteggiato una attenta ricostruzione del biennio 1953-54, da cui emerge il convergere di obiettivi accomu nanti, anche sotto il profilo della passione civile. Ma gli stessi esordi dell’etnologia lanternariana sono impensabili senza il duplice rife rimento a Pettazzoni e a de Martino: le sue prime ricerche di etno logia comparata - a partire almeno da Orgia sessuale e riti di recu pero nel culto dei morti pubblicato in « Studi e Materiali di Storia delle Religioni» (1953-54), fino alla Grande festa, del 1959, testo introdotto da una Presentazione di de Martino - svolgono tutte il tema delle celebrazioni dei defunti, per interpretarle in chiave di crisi e di riscatto culturale. Quanto al progetto demartiniano di cui dicevamo, si tratta di una pagina dattiloscritta, contenente un testo privo di titolo, ma riferentesi a un’ipotesi di ricerca sulla «paura del morto» nelle cul ture primitive, specie australiane, con «cenni» al folklore e al mondo classico. La pagina, come sempre, non è datata, ma al retro e ai margini vede apposti vari grafismi e annotazioni manoscritte elen canti i brani registrati nel cimitero di Roccanova, dunque il 2 novembre 1954. Ricorderemo che in questa occasione si raccol sero diverse testimonianze di quegli incontri coi morti tradizio nalmente rappresentati come rischiosi per i vivi. L ’appunto recita nella sua parte iniziale: Impostazione del problema. La paura del morto nelle società etnologiche. Carattere secondario dei valori più propriamente morali e religiosi dell’im mortalità, e importanza della valenza magica della contagiosità del cadavere, e del pericolo che il cadavere tomi come spettro a dannegiare i viventi. Onde complessi mitico-rituali a carattere prevalentemente magico, e dominati dal tema della separazione, della conciliazione, del recupero o della appropria zione della potenza del morto, come nella necrofagia. La paura del morto nella paletnologia: il terrore del morto nella posizione rannicchiata e nel legamento del cadavere nel paleolitico superiore. La paura del morto nell’antichità classica: cenni. Nel folklore: accenni. Australia: Inumazione, esposizione su piattaforma arborea, cremazione e 6 L ’omaggio a Pettazzoni è tributato in una lunga nota (p. 5, nota 1) nella prima versione di La messe del dolore pubblicata nel 19 57 in «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», nota poi omessa in Morte e pianto rituale.
INTRODUZIONE
XXXV
necrofagia; seppellimento secondario dopo l’inumazione e l’esposizione su piattaforma arborea. La condizione psichica dei partecipanti ai rituali fune rari, soprattutto in rapporto al cordoglio e al lamento funebre. Il tabu del nome del defunto. L ’orgia alimentare e sessuale.
Segue una bibliografia sommaria, che parte ovviamente da James Frazer e Lucien Lévy-Bruhl, per indirizzarsi però subito verso il campo della storia delle religioni e dell’etnografia dei «primitivi». Le note di lettura presenti nell’archivio ne danno conferma. Anzitutto, Gerardus van der Leeuw, per quelle parti della Feno menologia della religione, in cui si compendiano le tesi di LévyBruhl - relative alle rappresentazioni primitive dello statuto dei morti percepito come stato differente da quello dei vivi - e le tesi di Arnold van Gennep - che legge il rituale funerario nei ter mini di un «rito di passaggio». Qui le note demartiniane al testo ne riorientano radicalmente l’interpretazione, per evidenziare resi stenza di una sorta di dialettica rischiosa insita all’interno dei riti del cordoglio, che fungerebbero da strumento per «separare il morto», ma in modi mai definitivi, perché «il morto non è morto ma entrato in uno stato di disponibilità onde tornerà in qualche momento». Il confronto diretto con i testi di quell’etnografia classica, di cui nessuno in quegli anni avrebbe contestato il valore di fonte documentaria, è occasione delle suggestioni più forti. Tra le note, troviamo raccolte e talora commentate alcune (seppure non nume rosissime) descrizioni di rituali funerari e/o di lamentazioni fune bri, tratte da testi principalmente di etnografia australiana, ma anche dei Bergdama e dei Fuegini, popolazioni tutte considerate comparabili sotto il profilo della primitività del regime economico. Risalta la lunga e minuziosa attenzione dedicata a due descrizioni di cerimonie funebri: quelle degli Aranda australiani e dei Selk’nam della Terra del Fuoco, rispettivamente tratte da Baldwin Spencer e J .F . Gillen e da Martin Gusinde e che ritroveremo sintetizzate nella parte introduttiva di Morte e pianto rituale (pp. i o - i i ). I com menti puntano a interpretarne le diverse fasi in termini di «rito», che opererebbe per «dimenticare il morto», «separarsi» da lui. Il progetto si è dunque ridefinito nei fatti: non più la frazeriana «paura del morto» ma il cordoglio nella sua dimensione di pratica simbolica. Le lamentatrici di Ferrandina e di Roccanova devono
XXXVI
CLARA GALLINI
aver contribuito a dare il colpo decisivo per questa prima virata di bordo che riplasma radicalmente il progetto etnologico, pur con tinuando a restare nel proprio interno. Ma, a questo punto, finiscono le tracce di un qualsiasi possibile progetto etnologico. Il confronto col terreno, come realtà concreta da prendere in carico, pone di fronte a una alternativa radicale: o una ricerca «da tavolino» condotta su materiali raccolti da altri - impostazione seguita, oltre che da Pettazzoni e Lanternari, dallo stesso de Martino fino almeno al Mondo magico - o un’e sperienza etnografica diretta, basata sull’interlocuzione tra ricer catore e terreno. Non si tratta certo di una condanna in blocco dell’etnologia classica. E l’interpretazione in quanto pratica a porsi come questione fondamentale: in questo senso si esprimerà in una pagina dell’Introduzione & Morte e pianto rituale (p. n ) all’interno di un discorso in cui si esplicitano le varie ragioni che hanno con dotto il ricercatore ad abbandonare il territorio di un’etnologia «da tavolino» per ingaggiarsi direttamente nell’interrogazione del campo lucano. Queste ragioni contengono, in sintesi, i presuppo sti di quelle tematiche dell’incontro etnografico e dell’etnocentri smo critico su cui de Martino avrebbe affinato cogli anni la pro pria riflessione: la Lucania diventa dunque il luogo dove interrogare se stesso e gli altri, per ritrovare in entrambi le tracce di una sto ria comune. Dentro questo progetto si situa, a sua volta, la necessità di una interrogazione diretta del terreno, difficilmente delegabile. Nel paragrafo Giustificazione metodologica della presente indagine etno grafica introduttivo al capitolo II lamento funebre lucano in Morte e pianto rituale, l’autore rivendicherà questo suo approccio, pren dendo questa volta distanza da tutti quegli studi demologici che sino ad allora si erano accostati al lamento funebre per analizzarlo in quanto prodotto testuale a suo avviso avulso dai modi specifici della sua costruzione e del suo utilizzo. E assieme esprimerà un giudizio sulla propria etnografia, considerandola come una strada ineludibile per procurarsi «una documentazione diretta che fosse adatta a rispondere alle nostre proprie domande e alle nostre pro prie ipotesi di lavoro» (p. 67).7 7 Per queste ragioni non mi sembra si possa interpretare la scelta demartiniana in termini di ripudio, tout court, dell’etnologia (così per Severi 1999).
INTRODUZIONE
X X X V II
13 . L ’interrogazione sul rito L ’etnografia lucana pone dunque a ragion d’essere della sua pra tica l’interrogazione sul rito. La presa d’atto dell’esistenza di una convenzionalità espressiva - gesti e parole codificati, ma anche cedibili ad altri, che si possono sospendere e rinviare, ora secondo scelte individuali ora secondo obblighi sociali che ne dettano gerar chie e temporalità di intervento - tutto questo pone questioni che per de Martino sono risolvibili solo entrando nel merito della lo gica costruttiva del discorso rituale. Anche questo aspetto della sua analisi - di certo il più difficile e complesso - va situato con una debita contestualizzazione. Come primo passo distintivo noteremo la decisa presa di distanza da ogni forma di psicologismo spicciolo, marcato da più o meno involontari etnocentrismi. Sempre nel paragrafo sopra menzionato, si riportano varie testimonianze, specialmente tratte dai folkloristi del secolo passato, in cui si esprimono giudizi moralistici, di insin cerità, nei confronti della pratica della lamentazione e delle relative esecutrici. Questa documentazione può essere integrata da un picco lo blocco di note di letture etnografiche di cui solo una parte è sta ta trasfusa nel testo (pp. 107-08), ma che per la loro ricchezza con tenutistica ci consentirà più agevoli riflessioni. Si tratta di un insie me di traduzioni di brani in cui, con straordinaria vivacità, i vari osservatori descrivono le modalità di esecuzione delle lamentazioni funerarie di questa o quella «tribù primitiva» (australiana, pigmea) manifestando nello stesso tempo un grado di chiusura etnocentrica che li rende assolutamente sordi e presuntuosi di essere loro nel giu sto modo di affrontare la situazione funeraria con una buona dose di dovuta, e razionale, compunzione. La principale materia di scan dalo è fornita dalla dimensione apparentemente fittizia di un pian gere, in cui si può entrare e da cui uscire a piacimento, alternan dolo con varie manifestazioni di socialità informale.8 Come si diceva, sono tutte traduzioni prive di commento. Ma c’è un indizio che segnala come lo sguardo demartiniano punti oltre 8 I brani sono tratti da Brough Smith, Spencer, Spencer e Gillen, Taplin, Vedder: sono tutti autori non utilizzati nel testo di Morte e pianto rìtuale ma citati nella sua bibliografia, cui rinviamo.
xxxvm
C L A R A G A L L IN I
l’evidenza della mera convenzionalità dell’espressione codificata dei sentimenti: questi materiali sono acclusi al dossier in cui si rac coglie la documentazione del folklore europeo relativa alla «distraibilità della lamentatrice». Se di convenzione si tratta, non vanno affatto da sé né le forme della sua manifestazione né i modi della sua gestione. E questo il primo indizio su cui si sarebbe esercitata l’etnografia lucana nel suo complesso, così attentamente indiriz zata all’analisi delle condizioni al cui interno si rende possibile l’esercizio del «discorso protetto». A ll’incirca le stesse testimonianze etnografiche considerate da de Martino in termini di «finzione rituale» avevano però già avuto altre interpretazioni. I riferimenti sono noti ed evidenti per il let tore di oggi: e rinviano a quelle interrogazioni sui rapporti tra emo zione individuale e codice sociale che da tempo si erano svilup pate in seno alla cosiddetta Scuola sociologica francese. Nel quinto capitolo del terzo libro delle Formes élémentaires de la vie religieuse, che svolge il tema dei riti piaculari, Emile Durk heim tratta ampiamente dei riti funebri, specie australiani, per tro varvi, come elemento costante, «il fatto che il lutto non è l’espres sione spontanea di emozioni individuali». La codificazione sociale risulterebbe, alla fine, come una sorta di involucro formale sovrap posto a un livello emozionale operante a titolo individuale e sog gettivo e dal contenuto al limite dell’inaccessibilità per un osser vatore esterno. Questa interpretazione presenta di certo il vantaggio di preservarci dal rischio - che ha corso anche de Martino - di interpretare gli altrui comportamenti in base ai criteri valutativi dei nostri, per cui ad esempio le contadine lucane col loro gridare e strapparsi i capelli dimostrerebbero un grado di sofferenza de! lutto assai più intenso di quanto non proverebbe un settentrio nale borghese. Ma a mio avviso va anche sottolineato che la stessa lettura durkheimiana si fonda sul presupposto, comunque sche matico, dell’esistenza di una coppia oppositiva di termini: inte riorità individuale, da un lato, ed esteriorità sociale, dall’altro, oppo sizione che essa stessa ci risulta al contrario essere il prodotto di categorizzazioni pertinenti alla nostra più recente storia culturale. Posta in questi termini, l’alternativa poteva anche essere capo volta, con gli stessi risultati. Nel suo breve e peraltro prezioso saggio L'Expression obligatoire des sentimenti (rìtuels oraux funéraires austra-
INTRODUZIONE
XXXIX
liens) del r9 2 i Marcel Mauss avrebbe notato come l’enfasi sulla non spontaneità delle lamentazioni funebri fosse ormai diventata quasi un «cliché etnografico». La sua analisi punta sul riconosci mento del carattere sociale di un linguaggio la cui convenzionalità non osterebbe all’ intensità dei sentimenti. Doverosi, i richiami a Durkheim e a Hertz definiscono forme e limiti di questa breve estensione al versante psicologico di un’evidenza che proprio in questi due autori aveva trovato una prima e importante definizione. Ricorderemo che il saggio fondamentale (la sua prima edizione è del 1907) di Robert Hertz Contrìbution à une étude sur la représentation collective de la morì, partendo dall’analisi del «doppio fune rale» praticato dai Dayak del Borneo, apre a una complessa inter pretazione - anche in chiave comparata - della funzione simbo lica e sociale di queste e analoghe cerimonie, scandite su tempi che possono essere anche molto lunghi. Non senza ragione, il sag gio viene oggi considerato come basilare per comprendere forme e misure in cui le modalità espressive del lutto risulterebbero costruite all’interno di un duplice condizionamento: lo statuto sociale del defunto e la convenzionalità di un codice simbolico con diviso. Come grave lacuna - dalle evidenti ricadute anche sul piano metodologico - è stata segnalata, e da tempo, l’assenza di questi autori dal panorama dei riferimenti demartiniani. Questa assenza va anzitutto storicizzata e iscritta nella più generale vicenda della recezione, assai limitata e selettiva, della Scuola sociologica fran cese da parte dell’etnologia italiana dell’epoca di Pettazzoni, Lanternari e de Martino. Può anche essere letta come un rifiuto capar bio, il che non disdice all’immagine corrente del nostro personaggio. Va però anche ridimensionata, in un confronto differenziante che tenga conto della profonda diversità di orientamenti dei rispettivi interessi dell’uno e degli altri studiosi.5 9 II saggio di Hertz viene meritamente riconosciuto come fondamentale per gli ulteriori studi antropologici sul lutto, in quanto «lavoro» che esige tempi e modi specifici di elabora zione del distacco dal morto (a partire da Valeri 1979, p. 594)· La singolare assenza di Hertz dal testo demartiniano è segnalata tra altri da Fabietti 19 9 1, pp. 144-45, sembrerebbe sug gerire l’esistenza di una sorta di rimozione dell’autore. Ma l’ipotesi andrebbe provata. Sono diversi invece gli indizi che avvalorano l’ipotesi di una mancata recezione dell’autore da parte degli studiosi italiani di storia delle religioni e di etnologia. Adriano Prosperi, nella sua Intro duzione alla traduzione einaudiana delle opere di Hertz (Hertz 1994, p. xxxni) a proposito
XL
C L A R A G A L L IN I
Per de Martino, se mai esiste un rapporto tra emozioni e codice, questo rapporto va visto in termini dinamici, nel senso che il codice simbolico che si mette in campo nel corso della azione rituale non è un dato, ma un prodotto. La sua ricerca non tende di fatto a indi viduare l’esistenza di un diretto e immediato condizionamento sociale dell’espressione delle emozioni. E mossa piuttosto dall’in tento di poter rivelare quelle dinamiche costitutive del codice stesso, che si celerebbero dietro e dentro la sua espressione. Soprattutto, in gioco non sono né emozioni né codici, ma «presenze»: cioè sog getti che la pratica simbolica costruisce assieme come esseri indi viduati e comunicanti. Questa è l’individuazione del senso e della forma di un rito. 14. 7/ lavoro del lutto Nel primo capitolo di Morte e pianto rituale, trova spazio la rilet tura critica di alcuni testi fondamentali sulla psicologia e psicopa tologia del lutto, a partire dalla vecchia (e amatissima da de M ar tino) casistica di Pierre Janet e dal testo fondamentale di Sigmund Freud, Trauer undM elancholie (1915). Pensate quasi come un gan glio tra riflessione teorica ed empiria dell’etnografia lucana, sono pagine di straordinaria finezza, che mettono il lettore a confronto con dimensioni a suo tempo assai poco frequentate, specie dalla nostra cultura antropologica, ma che anche a una rilettura attuale risultano efficaci. Lo stretto rapporto di interlocuzione con la psico analisi e la psichiatria che caratterizza (in modi non ancora intera mente studiati) la ricerca teorica di de Martino, si esplicherà nel l’intero corso dell’analisi del lamento funebre lucano, in misure decisive. Senza questa prospettiva, la stessa caratteristica di ritualità del compianto rimarrebbe inesplicata.10 La dimensione psicodinamica introduce un approccio inedito di Le Peché et l ’expiation dans les sociétés prìmitives osserva che questo studio rimase scono sciuto a Pettazzoni, che non ne fa cenno nella sua pur imponente bibliografia di La confessione dei peccati, Bologna 1926. Hertz non è utilizzato neppure da Lanternari, nei suoi vari scritti di cui al paragrafo 12 della presente Introduzione. Le uniche letture critiche di Hertz che sinora risultino dall’Archivio de Martino sono quelle presumibilmente posteriori alla ricerca sul lamento funebre e pubblicate in La fine del mondo, br. 324, concernenti il saggio sulla preminenza della mano destra (con citazioni dairedizione del 1928). 10 L ’interesse di de Martino per l’opera di Janet è assai ben analizzato in Barbera 1990.
INTRODUZIONE
xu
rispetto ai modi in cui la cerimonialità funeraria era stata sino ad allora studiata. Con ragione Charuty (1987) sottolinea ehe Morte e pianto rituale «inaugura una storia sociale della morte, da colle garsi anche al variare della psicologia del cordoglio»: direzione di analisi, quest’ultima, che si segnala anche come recente acquisi zione della ricerca etnopsichiatrica (Nathan 1988; Beneduce e Collignon 1995). Ma è, più in generale, tutta la restituzione del rito, nelle sue diverse forme e scansioni, che diventa perspicua attra verso questa griglia. Nel continuo rinvio a sottili intersezioni tra psiche e soma, soggettivo e formalizzato, si gioca tutta l’esplora zione di un codice, nelle sue modalità costruttive e nel suo dispo nibile flettersi alle varianti individuali. Che i due livelli del teorico e dello storico-etnografico mediati dalla psichiatria si articolino tra loro in modo sempre convincente, è difficile oggi riconoscerlo. Qui sta sempre il momento più fra gile della costruzione demartiniana, a partire dall’equivoco evidente che gli fa leggere la crisi di una paziente di Janet o di Freud come crisi tout court, «irrelata» dal contesto culturale che pure l’ha con dizionata anche per l’interdetto sociale che ha a lungo penalizzato l’espressione delle emozioni, per relegarla negli spazi della medicalizzazione. Onde, per de Martino, l’illusione di poter arrivare a toccare empiricamente l’esistenza di momenti «critici» precodi ficati - come Γdttassamento o la scarica parossistica - che, al con trario, possono anche essere interpretati come espressioni codifi cate della sofferenza. Il passaggio attraverso la psichiatria - più precisamente: la psi coanalisi - gioca però un ruolo essenziale e convincente quando si attiva nel concreto dell’interpretazione etnografica. In Trauer und Melancholie, Freud legge il lutto nei termini di un «lavoro» che conduce a un «distacco». Per lui a distaccarsi sarebbe la libido precedentemente investita sulla persona ora defunta, per de M ar tino - che in Morte e pianto rituale lo critica proprio su questo punto - il distacco sarebbe invece opera dell’ethos del trascendi mento. E comunque sul «distacco», sulla «separazione» dei vivi dai morti che abbiamo visto incentrarsi tutta la sua interpretazione dell’efficacia dei riti del cordoglio. Questo «lavoro del lutto» - che nel testo freudiano si rappre senta come un generico dato universale analizzabile attraverso la
IN T R O D U Z IO N E
XUI
XLIII
CLARA GALLIN1
casistica di pazienti occidentali - si piega dunque per de Martino alla varietà delle condizioni culturali del proprio esercizio. Per que sto la sua conoscenza, per quanto si diparta dalle premesse poste dalle varie discipline della psiche, richiede il passaggio attraverso un’altra procedura, che è quella della ricerca etnografica. Gli aspetti formali della lamentazione funebre (come, del resto, dei vari riti del cordoglio di cui essa è parte) appaiono dunque come il risultato di questo «lavoro». Pertanto, la specificità di questo «lavoro», coi relativi esiti, non consiste nell’eventuale adattamen to a una qualche «convenzione sociale» - in un certo senso, già data - quanto piuttosto nella dinamica costruzione di una «pra tica simbolica» che vede ingaggiati assieme l’individuo e il gruppo. E neppure consiste in un semplice modellamento o rimodellamento di emozioni: è in gioco qualcosa di più complesso, che investe l’in tera persona nel suo costruirsi come soggetto e nel suo rapportarsi al mondo degli uomini e delle cose. Vera e propria mimesis, il teatro del pianto si attiva dunque secondo un suo specifico linguaggio: un codice stratificato, che con cerne nello stesso tempo il piano della psiche e quello del corpo, dell’individuale e del sociale, del codificato e dell’istintuale. Rei terata e variabile, in tutte le sue diverse scansioni formali e tem porali, la lamentazione si attiva grazie alla sinergia del gesto, della parola, del canto, che rendono esprimibile l’ineffabile della con dizione di «crisi della presenza». Singolare tecnica di induzione e mantenimento di un particolare stato psichico della sua attrice, a sua volta l’esercizio del lamento funebre si rende possibile in virtù dell’ingresso in una condizione di diversità, contesta assieme di sogno e di rappresentazione dialogante, di temporalità e di atem poralità esemplari. Questo è il piano rituale della «destorificazione» del lutto. E dunque sul piano sognante di questa destorificazione rituale che si ridiscutono tutti quei confini tra soma e psiche, tra gesto e parola, stato di sogno e stato di veglia, i cui tracciati al contrario possono apparire meno labili agli occhi di una concezione strettamente razionalistica della comunicazione sociale. Segnale assieme di attrazione e repulsione, questa sensibilità rispetto agli stati di trance aveva già trovato in varie tematiche del Mondo magico - sciamanesimo, medianità ecc. - un consistente terreno di analisi. Ma il
capitolo degli interessi metapsichici può anche dirsi ormai chiuso. Il passaggio attraverso l’etnografia lucana ha aperto l’accesso all’in terrogazione dell’universo delle dinamiche psicofisiche che si atti vano nel corso dell’esercizio di una determinata pratica simbolica, per costruirne la realtà e l’efficacia.11
15 . Verso un’etnografia europea L ’etnografia lucana ha mosso il nostro ricercatore su binari eccen trici, per i suoi tempi, almeno per due ragioni. Della prima si è detto: ed è lo studio di una pratica simbolica, scelta a oggetto di un’analisi ravvicinata. Qualcosa ci resta da dire circa la seconda ragione. Sappiamo quanto sia nuovo e ancora aperto a discussione il campo di un’et nografia che oggi si designerebbe come «europea» o «mediterra nea». Semplificando al massimo, diremo che si iscrive in questo territorio - assieme fisico e concettuale - lo studio delle reti di pratiche e rappresentazioni messe in atto da soggetti vicini a noi (in quanto ricercatori) e coi quali interagiamo negli spazi di una tradizione culturale che è anche stata fortemente (ma non esclusi vamente) modellata dal predominio di una religione monoteistica. Questa osservazione ravvicinata ci rende sempre più sensibili all’e videnza dell’enorme divario esistente tra grandi generalizzazioni quali «modernità» o «postmodernità» e la realtà di condotte che si snodano come continue ricerche di significazioni, in un inces sante lavoro di rimodellamento di trame disponibili o comunque possibili. Un approccio del genere potrebbe trovare molte consonanze con il tentativo demartiniano di avvicinare la stessa realtà culturale del Mezzogiorno dei suoi tempi. Perspicuo è l’esempio del lamento funebre lucano, la cui modalità espressiva, per quanto insista in una memoria lunga, non viene riduttivamente interpretata in ter mini di «relitto» del passato. Questa posizione - che sottende
11 Con piena pertinenza, in un suo recente intervento nella rivista «Gradhiva» (1999), Charuty ipotizza che Γ individuazione della specificità del linguaggio simbolico abbia rappre sentato per de Martino un passaggio teorico, che comportava l’abbandono della prospettiva metapsichica presente nel Mondo magico.
xu v
CLARA GALLINI
tutta l’interpretazione dell’etnografia lucana di Morte e pianto ri tuale - è sottolineata in modo molto esplicito in alcune note di ricerca, a margine di una lettura del Manuel de folklore frangais di van Gennep: Giustamente il van Gennep nega che occorre vedere nel lamento funebre francese una sopravvivenza dei riti funerari gallo-romani (così come il lamento funebre lucano non è una sopravvivenza del lamento funebre greco attra verso la mediazione delle colonie della Magna Grecia, o di quello romano attraverso la romanizzazione della Lucania ecc.).
Per quanto indicato come «pagano» per la sua apparente anti tesi rispetto al modello proposto dal cristianesimo, il lamento fune bre lucano si colloca dunque «relativamente» a un universo cultu rale rispetto al quale preme con la sua richiesta di legittimazione. D ’altra parte, senza questa e altre scomode presenze, cattolicesimo e persino modernità risulterebbero parole astratte e meri modelli di una performatività priva di qualsivoglia forma di attuazione. Lo stesso decisivo impianto della ricerca lucana, che focalizza una regione e il Mediterraneo come contesto, marca anche la presa di distanza forse più significativa rispetto a quel comparativismo allargato, su cui ancora trovava sostegno il metodo di Pettazzoni e di altri studiosi a lui coevi.12 Viene così a delinearsi un modo diverso, più sottile, di analisi comparata, dove non ha più luogo il confronto tra grandi concet tualizzazioni, come l’idea di Essere Supremo, la categoria di Festa ecc. Con grande pertinenza Charuty (1987) segnala, come una tra le più importanti caratteristiche del testo demartiniano, l’apertura nella direzione di una antropologia del simbolico «in cui l’identi ficazione di un sistema dato rende legittimo il comparativismo». E tutta una attenzione per il modellarsi di una precisa pratica sim 12 La scelta di un comparativismo ristretto avviene in parallelo all’opzione etnografica. Pubblicato nel volume x x v i (1955) di «Studi e Materiali di Storia delle Religioni», il saggio La ritualità del lamento funebre antico come tecnica di reintegrazione, testimonia di una ricerca ormai strutturata verso queste nuove direzioni. L ’impostazione del saggio è incentrata sulla documentazione antichistica, passata al duplice (ma poco conciliabile) vaglio dell’ interpreta zione formale e funzionale del rito della lamentazione e dell’ analisi della dinamica storica degli scontri col cristianesimo. La comparazione è limitata all’ area mediterranea. Ancora nel volume x x v i di «Studi e Materiali di Storia delle Religioni» viene pubblicata la recensione alla cospi cua documentazione storica e folklorica raccolta da Kurt Ranke sul periodo di lutto rituale presso i popoli cosiddetti «indoeuropei». Detto per inciso, è in questa nota che compare la prima citazione dai Frammenti di etica di Croce, poi collocata nell’esordio di Morte e pianto rituale.
INTRODUZIONE
XLV
bolica che viene, per così dire, notomizzata e inseguita in quelle concatenazioni di similarità e differenze la cui lettura finale do vrebbe approdare al disegno di una struttura spazio-temporale di comune riferimento. Attraverso questo nuovo esercizio della com parazione il lettore verrà condotto a guardare e ascoltare le lamen tazioni funerarie della Grecia antica con gli stessi occhi e le stesse orecchie che avrebbe potuto aprire dinanzi a una lamentatrice di Ferrandina. La spirale della storia si svolge però - evidentissima in Morte e pianto rituale - secondo un singolare va e vieni, che procede per balzi, prima all’indietro - dalla Lucania alla Grecia antica - per poi ridiscendere giù fino al Medioevo e qui arrestarsi, nel difficile sforzo di accordare storicismo ed esemplarità di alcuni momenti individuati come emblematici nelle varie problematiche via via affrontate dall’autore. Ma possiamo anche leggere il libro come lo svolgimento di un discorso situato tra i due poli di due teatri rituali del piangere, assieme simili e diversi tra loro: quello delle donne lucane, da un lato, e, dall’altro, quello di Maria nelle sacre rappresentazioni me dievali. Ed è proprio quest’ultima la figura più enigmatica di un testo, che culmina con la sua evocazione, per conchiudere senza con cludere, arrestandosi prima del passo definitivo, che avrebbe potuto condurre a ritrovare nel Cristo morto e in Maria piangente sul Gol gota le due immagini forti, culturalmente dominanti, capaci di dar senso ai diversi farsi e disfarsi delle espressioni di un lutto «pagano» all’interno del cattolicesimo europeo. Ma il passo definitivo si risolverà tra poco, nella nuova presa d’atto dell’esistenza di quel reticolo, mobile ed esteso, al cui interno si situano tutte le più diverse e persin contrastanti espressioni del nostro cattolicesimo, nel loro concreto attuarsi. Siamo ormai a Sud e magia.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Riferimenti bibliografici Per un aggiornamento (anche bibliografico) sui diversi approcci filosofico, storico religioso, antropologico, psichiatrico all’opera di de M artino si rinvia ai saggi di vari autori contenuti in E mesto de Mattino nella cultura europea, a cura di C lara G aliini e M arcello M assenzio, Liguori, N apoli 19 9 7 . Per una ricostruzione delle principali tappe dell’intera etnografia dem artiniana si rin v ia a Clara G ailini e Francesco Faeta, I viaggi nel Sud d i Ernesto de Martino. Fotografie d i Arturo Zavattini, Franco Pinna, Ando G ilardi, Bollati Boringhieri, Torino 1999. Preceduto da una bibliografia delle opere di Ern esto de M artino citate nel testo, il presente apparato bibliografico segue l’ordine dei paragrafi d ell’Introduzione.
19 5 8 8 i9 5 8 b 1958C 19 5 9 19 6 0 19 6 2 19 6 5 i9 9 5 a i9 9 5 b 19 9 6
OPERE DI ERNESTO DE MARTINO CITATE NEL TESTO
1948 I95I-52
1952 1953 1953-54
19543 i 954b 19553
I 955b 1955C
i 95Óa i95Ó b
19573 I957b
1957C I957d
I l mondo magico, E in audi, Torino. Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito A chilpa delle origini. Contri buto allo studio della mitologia degli Arando, « Studi e M ateriali di Storia delle R eligioni», x x m , pp. 52-66 (rist. I l mondo magico, 1 9 5 8 2, pp. 2 7 7 - 3 11 ) . (con la collaborazione d i Benedetto Benedetti e A rtu ro Zavattin i), A m ore e morte nei canti dei braccianti lucani, « V ie N u o ve», v i i , 3 1 , 3 agosto, p. 19 . N ote di viaggio, « N u o v i A rgom enti», 1, 2, maggio-giugno, pp. 47-69 (rist. in de M artino 19 9 6 , pp. 96-128). Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto, « Studi e M ateriali di Storia delle R eligioni», x x iv -x x v , pp. 1 - 1 5 (rist. in de M artino I9 9 5 b , pp. 47-74). Rapporto etnografico sul lamento funebre lucano, « So cietà» , x , 4, agosto, pp. 655-65. in Franco C agnetta, Orgosolo antica, « N u o v i A rgom enti», io , settembreottobre, pp. 7 1-7 7 . Considerazioni storiche sul lamento funebre lucano, « N u o v i A rgom enti», 12 , gennaio-febbraio, pp. 1-3 3 . L a ritualità d e l lamento funebre antico come tecnica di reintegrazione, « Studi e M ateriali di Storia delle R eligioni», x x v i, pp. 15 -5 9 . I l periodo d i lutto rituale presso i p o p o li indoeuropei, « Studi e M ateriali di Sto ria delle R eligioni», x x v i, pp. 12 6 -30 . Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, « A u t A u t» , 3 1 , pp. 17 -3 8 . 1 documenti etnografici europei sul lamento funebre rituale e il loro valore storico religioso, in A tti d e ll’v m Congresso intemazionale dì storia delle religioni, Rom a 17 -2 3 aprile 19 5 5 , Firenze, pp. 387-88 (riassunto). Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni, « Studi e M ateriali di Sto ria delle R eligioni», x x v m , 1 , pp. 9 1-10 7 . L a messe del dolore, « Stu d i e M ateriali di Storia delle R eligioni», x x v m , 2, pp. 1-5 3 . M ito e rito, «Stu d i e M aterialid i Storia delle R eligioni», x x v m , 2, pp. 14 1- 4 3 . Diffusione di un m odulo di lamentazione rituale, « Studi e M ateriali di Storia delle R eligioni», x x v m , 2, pp. 14 8 -5 0 .
XLV n
Perdita della presenza e crisi del cordoglio, « N u ovi A rgom enti», 30, gennaiofebbraio, pp. 49-92. Morte e pianto rituale. D a l lamento funebre antico a l pianto d i Maria, B orin ghieri, Torino. II giorno dei morti a G ora, «Settim o G io rn o » , dicembre, p. 68. Sud e magia, Feltrinelli, M ilano. II gioco della fa lce, « L ’Espresso M ese», 1, 3 , luglio, pp. m - 1 4 . Furore Sim bolo Valore, Il Saggiatore, M ilano. Rapporto sull'aldilà, a cura di Franca Leoni, « L ’Europeo», x i, 2 1 , 23 maggio, pp. 82-87. Note di campo. Spedizione in Lucania, 3 0 sett. - 3 1 ott. 19 3 2 , edizione critica a cura e con introduzione d i Clara G ailin i, A rgo, Lecce. Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, a cura e con introdu zione di M arcello M assenzio, A rgo, Lecce. L ’opera a cui lavoro. Apparato critico e documentario alla «Spedizione etnolo gica» in Lucania, a cura di C lara G aliin i, A rgo, Lecce.
NOTE BIBLIOGRAFICHE Al PARAGRAFI DELL’ INTRODUZIONE
§§ 1-3 a. Cronaca del premio Viareggio (1958) Taccuino d e l premio Viareggio (Ugo M oretti, testata da identificare). I l segreto di Repaci è diventato il segreto di Pulcinella. Un ponderoso saggio di de Martino ha vinto il premio Viareggio 19 3 8 , « Il T irren o», 30 agosto. Repaci ha consegnato ieri i premi Viareggio. Marotta ha vinto un m ilione per aver «sbagliato» titolo, « Il T irren o», 3 1 agosto (Aldo Santini, con foto). I m otivi principali d e l «Viareggio» illustrati nella relazione della giuria, « Il T irren o», i ° settembre. Mondanità e cultura a l premio Viareggio, « Giornale del M attino », 30 agosto (Sandro Ricci). Ernesto de Martino è andato a comprarsi un vestito da cerimonia, «G io rn ale del M attino», 3 1 agosto (Alfonso G atto). Ernesto de Martino indicato come il p iù degno d e l « Viareggio», « L a N azione Italiana», 30 agosto (G iovanni Grazzini). Tutto da piangere e tutto da ridere tra i cinque libri premiati a Viareggio, « L a Nazione Ita liana», 3 1 agosto (G iovanni Grazzini). Senza segreti il verdetto del «Viareggio», «N azione Sera», 3 1 agosto (Aldo Valleroni). Poesia e saggistica a ll’assalto d e l Viareggio, « L ’U n ità», 30 agosto (Silvio Micheli). II «m ondo antico» vince a Viareggio, « L ’U n ità», 3 1 agosto (Silvio M icheli). Assegnato il «premio Viareggio» a ll’etnologo Ernesto de Martino, «Paese», 3 0 agosto (W al ter Mauro). Un libro sulla morte ha vinto il premio Viareggio, «Paese Sera», 1 ” settem bre (Franco Tintori). L'etnologo de Martino batte narratori e poeti, « L ’O ra», i ° settembre (Franco Tintori, stesso articolo del precedente). Sìntom i di decadenza nell'edizione di quest’anno. L a ponderosa opera dì de Martino ha vinto i due m ilioni del premio Viareggio, « Sicilia del Popolo», 3 1 agosto (Leone Piccioni).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
X L v ra
Facciamo un bilancio del premio Viareggio, «Popolo N uovo», 3 1 agosto (Leone Piccioni, stesso articolo del precedente). Dottrina e fantasìa a l x x rx premio Viareggio, « Il G iorn o», 2 settem bre (con foto). R iti d e l dolore in Lucania, « G azzetta del P opolo», 3 settem bre. Contiene due testi: L a nota del critico (Lorenzo Gigli) e un lungo estratto dal libro premiato (con foto di de M artino). I fig li dei ferrovieri conquistano Viareggio, « L ’Esp resso», 7 settembre. II prof, de Martino, premio Viareggio 19 5 8 , ci illustra la sua opera. L 'u om o e il dolore nel volgere dei secoli, «Paese Sera», 8 settem bre (A dolfo Chiesa, con foto. Lunga intervi sta a de M artino sulla sua form azione e la sua ricerca). Viareggio premia un saggista, « Il T em po», 9 settem bre (Giancarlo Vigorelli). L e difficili scelte del Viareggio, « V ie N u ove», settem bre, p. 26 (Silvio M icheli). E stato il «premio» di una magra annata, «V ie N uove», settembre, pp. 26-27 (Carlo Salinari). G li scrittori sono scontenti delle giurie che li premiano, « L ’U nita», 1 5 novembre (Gian C arlo Ferretti). Troppe «inchieste», « II G iorn ale di Sicilia», 8 novem bre (Enrico Falqui). Aspetti della narrativa odierna, « L a Fiera Letterària», 16 novem bre (Enrico Falqui, stesso articolo del precedente). Santini, A ldo, 1 9 6 1 , Breve curiosa storia d e l premio Viareggio, Il Cavalluccio M arino, V ia reggio. b . Prime recensioni (1958-60) Barberis, C orrado, 19 5 9 , Morte e pianto rituale nel mondo antico, « Leggere», v , gennaiofebbraio, p. 14 . C . A . (Azzim onti, Carlo), 19 5 8 , I l fenom eno religioso, «Tem pi M oderni», dicembre,
593 94
PP· - C itati, Pietro, 19 5 8 , L a morte nel mondo antico, « Il P unto», 4 Ottobre, p. 15 . C ittì, V ittorio, 19 5 8 , recensione, « Il M ulino», ottobre, pp. 800-06. Crespi, Francesco, 19 5 8 , recensione, «Sociologia», 3, luglio-settembre, pp. 320 -22. D ’O nofrio, Cesare, 19 5 9 , I l pianto antico, « Il M ondo», 27 gennaio, pp. 9 -10 . E . Z . (Zolla, Elém ire), 19 5 8 , Morte e pianto rituale, «Tem po Presente», settembre-ottobre. Izzo, D om enico, 19 5 8 , Rivoluzione industriale contro lamenti funebri, « L a T ribuna. Set timanale p olitico», 12 ottobre, p. 22. Lanternari, V ittorio, 19 5 9 , Ideologie e riti funebri nelle collettività umane, « Il Calendario del Popolo», gennaio (stesso articolo con qualche variante in « Scien tia», x i, 19 5 9 , pp. 302-04). Piovene, G uido, 19 5 8 , L a paura della morte, « L a Stam pa», x v i, 249, ottobre. Sassoli, D om enico, 19 5 8 , L o scandalo della morte, « Il Popolo», 30 novembre. Servadio, Em ilio, 19 5 8 , L a crisi d e l cordoglio e il trionfo della vita, « Il T em po», io novembre. Tentori, Tullio, i9 6 0 , recensione, « I Problemi della Pedagogia», 4, pp. 1-4 (dell’estratto). Tullio Altan, Carlo, 19 5 9 , recensione, « Il Pensiero C ritico», 1, gennaio-marzo, pp. 79-88. Vernoni, G iocondo, 19 5 9 , recensione, «Selezione T ributaria», v ii , 2, pp. 9 1 1 - 1 2 .
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
X LIX
§4 a. La critica a Morte e pianto rituale Charuty, Giordana, 19 8 7 , Morts et revenants d ’Italie, «Etud es Rurales », 105-06, pp. 79-90. Clem ente, Pietro, 19 8 3 , Morte e pianto rituale. Riflessioni su un lavoro di E. de Martino, «Annali della Facoltà di Lettere e Filo so fia dell’ U niversità di Sien a», 4, pp. 279-88. D i D onato, Riccardo, 19 9 9 , 1 Greci selvaggi. Antropologia storica d i Ernesto de Martino, M anifestolibri, Rom a. G alasso, Giuseppe, 19 6 9 , Croce, Gramsci e altri storici, Il Saggiatore, M ilano. - 19 8 2 , L'altra Europa. Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d'Italia, M ondadori, M ilano. M irto, M aria Serena, 19 9 0 , La morte e i vìvi. I l cordoglio nel mondo antico secondo Erne sto de Martino, in Riccardo D i D onato (a cura di), L a contraddizione felice? Ernesto de Martino e gli altri, e t s , Pisa 19 9 0 , pp. 14 3 -6 2 . V aleri, Valerio, 19 7 9 , voce Lutto, in Enciclopedia Ein audi, vm , pp. 594-04. b. R ecenti approcci etno-antropologici ai riti della morte Bloch, M aurice, e P arry, J . , 19 8 2 , Death and Regeneration o fL ife , C am bridge U niversity Press, Cam bridge. Danforth, Loring M ., 19 8 2 , The Death Rituals o fR u ra l Greece, Princeton University Press, Princeton. D i Nola, Alfonso, 19 9 5 , La morte trionfata. Antropologia del lutto, Newton Compton, Roma. - 19 9 5 , L a nera Signora. Antropologia della morte, N ew ton Com pton, Roma. «Etud es Rurales», 19 8 7 , 105-06, L e Retour des morts, a cura e con introduzione di Daniel Fabre. Faeta, Francesco, e M alabotti, M arina, 19 8 0 , Imago mortis. Sim boli e rituali della morte nella cultura popolare italiana, catalogo di m ostra, D e Luca, Rom a. «H ésiode. Cahiers d’éthnologie m editérranéenne», 19 9 4 , 2, La m ori difficile, g a r a e H ésiode, Carcassonne, con introduzione di D aniel Fabre. Lom bardi Satriani, Luigi M ., e M eligrana, M arino, 19 8 2 , Ilponte di San Giacomo. L ’ideo logia della morte nella società contadina del Sud, Rizzoli, M ilano. M etcalf, Peter, e H untington, Richard, 19 7 9 ( 1 9 9 1 2, ed. riv. ampi.), Celebrations o f Death. The Anthropology ofMortuary Rituals, Cam bridge U niversity Press, Cam bridge. Ruby, Ja y , 19 9 5 , Secure thè Shadow. Death and Photography in America, The MIT Press, Cam bridge-London. « T e rra in » , 19 9 3 , 20, La M ori, con introduzione di Claudine Fabre Vassas.
§5 C herchi, Placido e M aria, 19 8 7 , Ernesto de Martino. Dalla crisi della presenza alla comu nità umana, Liguori, Napoli. M assenzio, M arcello, 19 9 5 , introduzione e cura di E . de M artino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, A rgo, Lecce. Sasso, Gennaro, 1999, L e apocalissi culturali. Ultime riflessioni di Ernesto de Martino, « Nuovi A rgom enti», 5 , gennaio-marzo, pp. 35-80.
L
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
§§ 6-7 G allini, C lara, 19 9 5 , introduzione e cura di E . de M artino, Note di campo. Spedizione in Lucania, 3 0 set!. - 3 1 ott. 19 5 2 , A rgo, Lecce. - 1996, cura di E . de M artino, L ’opera a cui lavoro. Apparato crìtico e documentario alla 'Spedizione etnologica’ in Lucania, A rg o, Lecce.
§
8
Cagnetta, Franco, 19 5 4 , Inchiesta su Orgosolo, « N u o v i A rgom enti», io , pp. 1-2 6 7 (rist. in Banditi a Orgosolo, G uaraldi, Firenze 19 7 3 , da cui cito; alle pp. 1 0 4 - n la relazione di de M artino). « L a musica popolare», 19 7 6 , colloquio con A lberto M . C irese su Ern esto de M artino, I, 4, pp. 3-2 2 , a cura di M ichele Straniero (registrato su nastro il 22 luglio 1967).
$ io Accadem ia N azionale Santa C ecilia - RAI R adiotelevisione Italiana, s.d. (ma i960), Studi e ricerche d e l Centro Nazionale Studi d i musica popolare da l 19 4 8 a l i9 6 0 . Carpitella, D iego, 1955, Folklore romeno, « Italia-Rom ania », a cura dell’Associazione per i rapporti con la Rom ania, 4, pp. 12 -14 . - 1978, premessa a Costantin Bràiloiu, Folklore musicale, voi. 1 , Bulzoni, Rom a.
S 12 H uizinga, Joh an , 19 5 3 , L ’autunno d e l M edioevo, trad. it., Sansoni, Firenze. Lanternari, V ittorio, 19 5 4 , Orgia sessuale e riti dì recupero nel culto dei morti, « Stu d i e M ateriali di Storia delle R eligioni», x x iv -x x v (19 53-54 ), PP· 163-8 8 . - 19 5 6 , Tabù di lavoro e angoscia di frustrazione n e ll’annua festa di Milamala dei Trobriandesi, in Atti d e ll'v a i Congresso intemazionale di storia delle religioni, Sansoni, Firenze, pp. 162-64. - 19 59 , L a grande festa. Storia del Capodanno nelle civiltà primitive, Il Saggiatore, Milano. - 19 9 7 , L a mia alleanza con Ernesto de Martino e altri saggi post-demartiniani, Liguori, Napoli. Leeuw, G erardus van der, 19 4 8 , L a Relìgion dans son esserne etses manifestatìons. Phénoménologie de la relìgion, Payot, Paris (trad. it. Fenomenologia della religione, Boringhieri, Torino i960). Severi, C arlo, 19 9 9 , Une pensée inachevée. L ’Utopie anthropologique de Ernesto de Mar tino, « G ra d h iv a» , 26, pp. 9 9 -10 7 . Tenenti, Alberto, 19 5 7 , I l senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento, Einaudi, Torino.
LI
RIFERIM ENTI BIBLIOGRAFICI
§ 13 Durkheim , Em ile, 1 9 1 2 , Les Formes élémentaires de la vie religeuse, Paris (trad. it. L e form e elementari della vita religiosa, Com unità, M ilano 19 6 3). Fab ietti, Ugo, 1 9 9 1 , Storia d e ll’antropologia, Zanichelli, Bologna. H ertz, Robert, 19 0 7 , Contribution à une étude sur la représentation collective de la mori, «A nnée Sociologique », x , pp. 48-37. R ist. in Mélanges de sociologie religeuse et folklore, con introduzione di Alice H ertz, Alcan, Paris 19 28 e in Sociologie religeuse et folklore, con prefazione di G . Balandier e introduzione di A . H ertz Balandier, Presses Universitaires de France, Paris 19 7 0 . Traduzioni italiane: Sulla rappresentazione collettiva della morte, con introduzione di Pietro A ngelini, Savelli, Rom a 1 9 7 ® e in La preminenza della destra, con introduzione di Adriano Prosperi, Einaudi, T orino 1994. M auss, M arcel, 1 9 2 1 , L ’Expression obligatoire des sentiments (rituels oraux funéraires australiens), «Journal de Psychologie», 18 (rist. in M . M auss, Qeuvres, Edition s de M inuit, Paris, voi. 3, 19 6 9 , pp. 269-79).
% 14 Barbera, Sandro, 19 9 0 , «Presenza» e «M ondo». M odelli filo sofici nell opera d i Ernesto de Martino, in Riccardo D i Donato (a cura di), L a contraddizione felice? Ernesto de Mar tino e gli altri, e t s , Pisa 19 9 0, pp. 10 3 -2 7 . C haruty, G iordana, 19 9 9 , L ’Ethnologue et le citoyen, « G ra d h iv a» , 26, pp. 83-98. Beneduce, Roberto, e Collignon, René, i > Ideologìe della morte, lutto e depressione
995
in A frica, Liguori, Napoli. Nathan, Tobie, e C ollectif, 19 8 8 , Rituels de deuil. Travati du deuil, L a Pensée Sauvage, Paris.
M orte e pianto rituale
A Vittoria
Prefazione
Il presente lavoro è una ricerca storico-religiosa sul lamento fune bre antico nel più vasto quadro del pianto rituale collegato al nume che scompare e che torna. In quanto ricerca storica, e non mera mente filologica o tipologica, essa trae alimento da una concezione storicistica della vita e del mondo, e al tempo stesso vuol essere un incremento ed un rinnovamento di questa stessa concezione, secondo un rapporto dialettico che è caratteristico di ogni storio grafia consapevole del proprio compito. Il lettore italiano avver tirà subito che lo storicismo di cui qui si tratta è largamente influen zato dal pensiero del Croce, anche se altre istanze del moderno umanesimo - come l’esistenzialismo e il marxismo - vi sono ac colte e giudicate nel loro motivo di verità. Dal punto di vista docu mentario il problema storico-religioso del lamento antico e affron tato utilizzando un materiale di varia provenienza e di diverso valore dimostrativo: oltre alla documentazione propriamente antica è stato dato un notevole rilievo al materiale folklorico e a quello psicologico, senza contare i dati cristiani, cosi importanti per la comprensione proprio perché la loro aspra polemica contro il pianto antico ci aiuta a sorprendere in vìvo una memorabile scelta culturale fra due diverse concezioni della morte, una scelta che in un certo senso è ancora inclusa nel nostro attuale comportamento dinanzi all’evento luttuoso. Una ricerca concepita in una così ampia prospettiva non poteva essere condotta a termine senza molteplici aiuti di istituti cultu rali e di persone, soprattutto per quel che concerne la raccolta del materiale folklorico. Siamo in particolare debitori al Centro Nazio-
4
PREFAZIONE
naie per gli Studi di Musica Popolare presso l’Accademia di Santa Cecilia e al suo direttore Giorgio Nataletti se ci fu possibile com piere dal 1950 al 1956 una serie di esplorazioni etnografiche sul lamento funebre lucano, avvalendoci dell’attrezzatura tecnica della R a i -t v e della guida di uno studioso del folklore musicale come Diego Carpitella. Se si tiene conto del fatto che le idee interpreta tive fondamentali sul carattere e sulla funzione del pianto antico maturarono in noi proprio nel corso di queste esplorazioni, potrà essere valutato nella sua giusta misura quale sia il debito di grati tudine verso chi le ha rese praticamente possibili. Analogamente senza la generosa ospitalità e la preziosa assistenza tecnica del l’Istituto di Folklore di Bucarest non avremmo mai avuto la oppor tunità di studiare il copioso materiale discografico raccolto nel l ’Istituto stesso, e di consultare le schede di osservazione che sono conservate nel suo archivio: un intero capitolo del presente volume - i funerali del pastore Lazzaro Boia di Ceriscior nell’Hunedoara (Transilvania) - è da considerarsi il frutto della cortesia con la quale il direttore dell’Istituto, Mihai Pop, volle mettere a nostra disposizione le schede relative, ancora inedite. Qualche cosa di più di un ringraziamento dobbiamo alla signora Vittoria de Palma che nel corso delle nostre esplorazioni lucane condivise con noi le non lievi fatiche della ricerca, avvicinando lamentatrici, racco gliendo testi, e soprattutto concorrendo a creare quell’atmosfera di confidenza e di affettuosa e sincera partecipazione ai dolori altrui che è indispensabile affinché la memoria delle informatrici ritor nasse sui propri lutti, e insorgesse di nuovo il lamento con tutte le vibrazioni drammatiche e le particolarità concrete della reale situazione luttuosa e della effettiva esecuzione rituale. Per la scelta e per l’ordinamento del materiale illustrativo raccolto nell’Atlante Figurato del Pianto ci siamo avvalsi in parte di alcuni collabora tori e collaboratrici, a cui va la nostra gratitudine. Un ringrazia mento particolare dobbiamo al prof. Muller del Seminario slavo dell’Università di Kiel, al prof. Milovan Gavazzi di Zagabria e alla dott. Tecla Dobrovits di Budapest per averci reso accessibili pubblicazioni e monografie introvabili nelle biblioteche italiane. Ci sia infine consentito di ringraziare qui pubblicamente - e non importa se questo ringraziamento non raggiungerà coloro a cui è destinato - tutte le contadine lucane che di buon grado ci
PREFAZIONE
5
fornirono le informazioni richieste, piegandosi alla ingrata fatica di rinnovare davanti ad altri, nella forma del rito, il cordoglio per i loro morti: strumenti, esse, di una scienza che non intendevano, e per la quale tuttavia pagavano senza saperlo un umile tributo di dolore. Per queste povere donne che vivono negli squallidi vil laggi disseminati fra il Bràdano e il Sinni, non sapremmo disgiun gere il nostro ringraziamento dal caloroso augurio che, se non esse, almeno le loro figlie o le loro nipoti perdano il nefasto privilegio di essere ancora in qualche cosa un documento per gli storici della vita religiosa del mondo antico, e si elevino a quella più alta disci plina del pianto che forma parte non del tutto irrilevante della emancipazione economica, sociale, politica e culturale del nostro Mezzogiorno. E .d .M . Roma, 30 settembre 1957
Introduzione
In Naturalismo e storicismo nell’etnologia1 fu da parte mia, non senza qualche tratto di giovanile baldanza e di scolastica ingenuità, formulato il programma di «continuare a pensare» - e quindi a svolgere - lo storicismo crociano sottoponendolo alla prova di mondi storici dalla cui diretta esperienza storiografica esso non era nato. Nel Mondo magico2 il proposito fu addotto in medias res compiendo il tentativo di interpretare storicisticamente la magia delle cosiddette civiltà primitive, e il risultato più apprezzabile della ricerca fu la scoperta della crisi della presenza come rischio di non esserci nel mondo. Il presente lavoro sul pianto rituale antico, pur procedendo sulla stessa linea di sviluppo tracciata nei due prece denti, immette la ricerca in una direzione nuova, e non soltanto perché abbandona il terreno delle civiltà primitive e toglie ad oggetto di analisi storico-religiosa un determinato istituto del mondo antico, ma anche a motivo di alcune importanti correzioni e modifiche che sono state apportate alle tesi teoriche del Mondo magico. In un certo senso il presente lavoro si dispiega come un assiduo commentario storico-religioso ad un pensiero sui trapassati occa sionalmente espresso dal Croce nei Frammenti di etica: un assiduo commentario che ovviamente è da intendersi nel senso più attivo possibile e che di molto oltrepassa il testo commentato. Ecco ora il passo dei Frammenti·. 1 Laterza, Bari 1 9 4 1. 2 [Einaudi, Torino 1948; nuova ed. Bollati Boringhieri, Torino 1997]-
8
INTRODUZIONE
Che cosa dobbiamo fare degli estinti, delle creature che ci furono care e che erano come parte di noi stessi? «Dimenticarli», risponde, se pure con vario eufemismo, la saggezza della vita. «Dimenticarli», conferma l’etica. «Via dalle tombe! », esclamava Goethe, e a coro con lui altri spiriti magni. E l’uomo dimentica. Si dice che ciò è opera del tempo; ma troppe cose buone, e troppo ardue opere, si sogliono attribuire al tempo, cioè ad un essere che non esiste. No: quella dimenticanza non è opera del tempo; è opera nostra, che vogliamo dimenticare e dimentichiamo... Nel suo primo stadio, il dolore è follia o quasi: si è in preda a impeti che, se perdurassero, si conformereb bero in azioni come quelle di Giovanna la Pazza. Si vuol revocare l’irrevo cabile, chiamare chi non può rispondere, sentire il tocco della mano che ci è sfuggita per sempre, vedere il lampo di quegli occhi che più non ci sorride ranno e dei quali la morte ha velato di tristezza tutti i sorrisi che già lam peggiarono. E noi abbiamo rimorso di vivere, ci sembra di rubare qualcosa che è di proprietà altrui, vorremmo morire con i nostri morti: codesti senti menti, chi non li ha, purtroppo, sofferti, o amaramente assaggiati? La diver sità o la varia eccellenza del lavoro differenzia gli uomini: l’amore e il dolore li accomuna; e tutti piangono ad un modo. Ma con l’esprimere il dolore, nelle varie forme di celebrazione e culto dei morti, si supera lo strazio, ren dendolo oggettivo. Così cercando che i morti non siano morti, cominciamo a farli effettivamente morire in noi. Né diversamente accade nell’altro modo col quale ci proponiamo di farli vivere ancora, che è di continuare l’opera a cui essi lavorarono, e che è rimasta interrotta...3
In effetti questo passo del Croce racchiude una esattissima e uma nissima verità: per grande che possa essere il dolore di una per dita, sùbito si impone a noi, nella piena stessa del dolore e con tanto maggiore urgenza quanto più siamo prossimi alla dispera zione, il compito di evitare la perdita più irreparabile e decisiva, quella di noi stessi nella situazione luttuosa. Il rischio di non poter oltrepassare tale situazione, di restare fissati e polarizzati in essa, senza orizzonti di scelta culturale e prigionieri di immaginazioni parassitane costituisce la seconda decisiva morte che l’evento lut tuoso può trascinarsi dietro; perciò nella morte della persona cara siamo perentoriamente chiamati a farci procuratori di morte di quella stessa morte, sia destinando ad una nuova riplasmazione formale la somma di affetti, di comportamenti, di gratitudini, di speranze e di certezze che l’estinto mobilitò in noi finché fu in vita, sia facendo nostra e continuando e accrescendo nell’opera nostra la tradizione di valori che l’estinto rappresenta. IndipenCroce, frammenti di etica (1922) pp. 22-24; cfr. pp, 2 1 e i n .
INTRODUZIONE
dentemente dalla situazione luttuosa come tale, è appunto questa la varia fatica che ci spetta in ogni momento critico dell’esistenza, che è sempre un attivo f a r p a s s a r e nel valore, e quindi un rinun ziare e un perdere, un distacco e una morte, e al tempo stesso una opzione per la vita: ma nella perdita di una persona cara noi speri mentiamo al più alto grado l’asprezza di questa fatica, sia perché ciò che si perde è una persona che era quasi noi stessi, sia perché la morte fisica della persona cara ci pone nel modo più crudo davanti al conflitto fra ciò che passa irrevocabilmente senza di noi (la morte come fatto della «natura») e ciò che dobbiamo far passare nel valore (la morte come condizione per l’esplicarsi della eterna forza rige nerante della «cultura»). La fatica di «far passare» la persona cara che è passata in senso naturale, cioè senza il nostro sforzo cultu rale, costituisce appunto quel vario dinamismo di affetti e di pen sieri che va sotto il nome di cordoglio o di lutto: ed è la «varia eccellenza» del lavoro produttivo e differenziato a tramutare lo «strazio» - per cui tutti gli uomini rischiano di piangere «ad un modo» - in quel s a p e r piangere che reintegra l’uomo nella sto ria umana. A questo punto comincia a prendere consistenza il pro blema storico-religioso della nostra ricerca. Nel passo dei suoi Fram menti di etica il Croce fa esplicito riferimento alle «varie forme di celebrazione e di culto dei morti» attraverso le quali «si supera lo strazio, rendendolo oggettivo», cioè si avvia l’aspra fatica di far morire i nostri morti in noi. Questo acuto - per quanto occa sionale - pensiero del Croce merita di essere svolto e approfon dito nella concretezza di una ricerca storico-religiosa. Nel formu lare tale pensiero il Croce aveva presente soprattutto la forma cristiana del culto dei morti, e in sostanza spingeva al suo compi mento il motivo di vero racchiuso nella ideologia funeraria nata sotto la spinta del Cristianesimo come religione. Fu infatti la reli gione cristiana che inaugurò il grande tema culturale di Cristo vin citore della morte, e chiamò i morti dormienti in attesa di risve glio e insegnò agli uomini a non temere il defunto come larva, potenziando al massimo Yethos della «cara memoria»: e per quanto questo ethos vivesse per entro il m i t o in un a ld i là metastorico, e non ancora si fosse sollevato al p e n s i e r o dellW di là dell’ope ra umana, da dispiegare senza sosta nella storia per vincere il non essere perennemente risorgente, innegabilmente da quel mito si
IO
INTRODUZIONE
svolse questo pensiero, per filiazione diretta e secondo itinerari culturali dimostrabili. D ’altra parte l’interpretazione del Croce non vale soltanto per la civiltà cristiana, e per il cristiano culto dei morti, ma può essere estesa a tutte le possibili civiltà religiose. Anzi la più sicura conferma della sostanziale verità della formulazione del Croce sembra provenire addirittura dalle cosiddette civiltà primi tive, dove i rituali funerari mostrano nel modo più crudo e diretto il momento dell’oblio dell’evento luttuoso, o l ’espressione simbo lica - nel rito come nel mito - della separazione del morto dai viventi e della difesa dei viventi dalle funeste insidie del morto. Presso i Fuegini per esempio il tema dell’oblio trova espressione in numerosi tratti del rituale funerario. «Niente deve ricordarci più il nostro morto», dicono gli indigeni:45e in conformità a que sto proposito immobilizzano il cadavere affinché non torni come spettro a tormentare i viventi, cercando in vario modo di dissi mulare e di rendere irriconoscibile il luogo della inumazione, si inibiscono di pronunziare il nome del defunto, bruciano la sua capanna e gli oggetti che gli appartennero in vita, e così via .3 Fra i riti funerari dei gruppi Aranda osservati da Strehlow ve n’è uno particolarmente istruttivo a questo proposito: viene tessuto un cor done con i capelli del morto, e il fratello minore nel corso del rituale funerario pone uno dei capi di questo cordone in bocca ad un uomo, premendo l’altro capo sul proprio addome, dove cioè avverte l’an goscia. Quindi l’uomo morde il cordone, a significare la cessazione dell’angoscia: la stessa procedura è successivamente ripetuta per tutti i membri della comunità in lutto, prima con gli uomini, poi con la vedova e infine con le altre donne.6 Nelle lamentazioni rituali eseguite dai Paiute si ritrovano espressioni di questo tipo: «Questo era l ’ultimo nostro parente. Era un uomo buono. Sia pos sibile per noi dimenticarlo... Addio, v a’ alla terra dei morti, e non tornare... Abbiamo fatto del nostro meglio per curarti: non tor nare a disturbarci...» In particolare in un rito di liquidazione del periodo di lutto viene versata dell’acqua sul capo di colui che è 4 M . Gusinde, Die Feuerland Indiàner, i: Die Selk'nam (Mòdling bei Wien 19 31) pp. 550 sg. 5 Ibid., pp. 547 sgg. (legamento del cadavere), 550 (dissimulazione del tumulo), 566 (tabu del nome), 552 sg. (bruciamento delle appartenenze). 6 C . Strehlow, Die Aranda und Loritja Stàmme in Zentral-Australien (Veroffentlichungen aus dem stadtlichen Museum, Frankfurt a. M.) voi. 4, 2, pp. 15 sgg.
INTRODUZIONE
II
in cordoglio, accompagnando l’atto con le seguenti parole: «Que sto è l’inizio di una nuova vita per te. Acqua, lava via i dolori e le pene di quest’uomo: tu devi dimenticare il tal dei tali, ed essere in tal modo felice ».7 Eppure questi dati etnologici (che potrebbero essere moltipli cati a piacere) non agevolano gran che nel compito di «continuare a pensare» il pensiero racchiuso nel passo del Croce. La nostra lon tananza ideale dalle civiltà primitive, la mancanza di una docu mentazione diretta relativa al loro passato, il carattere equivoco dello stesso termine «primitivo», e infine i limiti inerenti alle mono grafie etnografiche di cui dobbiamo avvalerci quando manchi l’op portunità di una ricerca personale in loco, costituiscono altrettanti ostacoli per chi volesse direttamente appoggiarsi al materiale etno logico al fine di approfondire la formulazione del Croce oltre la cerchia della civiltà cristiana e della sensibilità moderna per entro la quale essa è nata e maturata. D ’altra parte approfondimenti di questo genere male cominciano col più arcaico e con l’idealmente più remoto da noi, per giungere poi sino a noi in un vano conato di storia universale, ma - al contrario - debbono partire dal certo e dal vero della nostra attuale consapevolezza storiografica per allar garsi nella direzione di quel passato culturale più prossimo dal quale la civiltà alla quale apparteniamo è nata per filiazione diretta .8 L ’approfondimento che ci proponiamo di eseguire si orienta così in modo del tutto naturale verso il mondo antico, e cioè verso le 7 J . H . Steward, Etbnography o f thè Owens Valley Paiute, Univ. California Pubi. amer. Archaol. Ethnol., voi. 23, n. 3, 296 sgg. 8 Una delle difficoltà che si oppongono alla storicizzazione della ricerca etnologica è da ricercarsi nel fatto che i popoli illetterati attualmente viventi non rappresentano affatto fasi culturali per le quali l’umanità più progredita sarebbe un tempo passata, ma sviluppi di una storia che si è svolta a lungo indipendentemente dalla nostra, e che solo in lontanissimi punti di selezione e in antichissime scelte si diparte da un processo storico comune. Non vi è quindi fra noi e questi popoli un rapporto culturale di filiazione diretta, ma piuttosto di lontana cugi nanza con paternità incerta. Per una completa storicizzazione delle civiltà dei popoli illetterati noi dovremmo quindi poter riportare alla memoria proprio l’ antichissima scelta culturale nella quale ci dividemmo imboccando cammini diversi, e dovremmo successivamente risalire il pro cesso indipendente che ne è seguito, sino alla situazione attuale, etnograficamente osservabile: il che è certamente possibile (ed oggi che sta tramontando il rapporto coloniale con quei popoli è anche augurabile che avvenga), ma comporta ad ogni modo una fatica «molesta e grave» - per dirla con Vico - ed il superamento di ostacoli notevoli sia nella formulazione dell’esatto problema storiografico, sia nel reperimento dei documenti necessari per la ricostruzione. Cfr. la nostra monografia Religionsethnologie und Historizismus, Paideuma, Mitt. Kulturkunde, voi. 2, n. 4-5 (1942).
12
JN T R O D U Z IO N E
antiche civiltà che si affacciarono al Mediterraneo, o che comun que gravitarono verso questo piccolo mare così importante per la storia dell’uomo. La civiltà cristiana si riattacca immediatamente a queste civiltà, ed è anzi sorta come loro vibrante negazione pole mica: in tale polemica noi siamo ancora in un certo senso impe gnati, e ne portiamo il documento interno nelle nostre persuasioni e nei nostri comportamenti, nelle nostre avversioni e nelle nostre preferenze. Si tratta di un passaggio avvenuto una sola volta nella storia, e che vive nella nostra coscienza culturale come conflitto fra Cristianesimo e paganesimo, e in particolare - per l’argomen to che qui ci interessa - come urto fra ideologia cristiana e ideo logia pagana della morte. Per questa polemica creatrice e per questo passaggio avvenuto una sola volta nella storia, le civiltà del mondo antico - per varie che siano - possono essere considerate come un’unità storiografica vivente, come l’altro da noi da cui noi siamo nati. Nel quadro di queste considerazioni si spiega perché la nostra scelta è caduta sui rituali funebri del mondo antico, e sulle figura zioni mitiche che vi si ricollegano. Tuttavia al fine di una mag giore individuazione storiografica ci è sembrata necessaria una ulte riore delimitazione dell’argomento. Fra i vari momenti degli antichi rituali funebri spicca come loro nota costante il lamento funebre: dall’Egitto alla Mesopotamia, da Israele ad Atene e a Roma il lamento riveste una importanza culturale di primo piano. In cia scuna di queste civiltà esso fu sottoposto ad elaborazioni diverse, sollevandosi in Egitto al lamento di Iside e Nephthys per Osiride, in Israele alle lamentazioni di Geremia, alimentando in Grecia la riplasmazione dell’epos, del commo tragico e della lirica della morte, e da per tutto collegandosi con determinati valori politici e sociali (lamentazioni collettive per il re o per il signore o per l’eroe). Ma c’è di più: il lamento funebre rituale si collega saldamente, nel mondo antico, al mito del nume che muore e che risorge, cioè a uno dei temi più importanti delle antiche civiltà religiose del Mediterraneo: questo rapporto è così organico da impedire di conside rare l’antico lamento per i morti al di fuori del grandioso orizzonte mitico del nume morto e risorto, sia esso Osiride o Tamùz o Baal o Adone o Dioniso o Kore, e quindi al di fuori del pianto rituale e del giubilo che nel rito attualizzavano la vicenda mitica di que sti numi. Nel che troviamo una conferma che il pianto rituale rap
IN T R O D U Z IO N E
13
presenta nel mondo antico non soltanto un importante momento dei rituali funerari, ma proprio il tema centrale di quel particolare s a p e r p i a n g e r e davanti alla morte che fu proprio delle civiltà religiose mediterranee. La crisi decisiva di questo istituto cultu rale fu inaugurata col Cristianesimo: il quale su tutta l’area della sua diffusione si scontrò col lamento funebre e aspramente lo com battè, respingendolo non già nei suoi eccessi parossistici o per ragioni suntuarie - come era già avvenuto nel mondo antico -, ma proprio sul terreno religioso e in quanto costume pagano anti tetico alla ideologia cristiana della morte. Si ingaggiò così, anche per tale ambito circoscritto, una lotta fra Cristianesimo ed ere dità del mondo antico, una lotta storica, avvenuta una sola volta, ed esattamente individuabile in senso storiografico, col risultato che il lamento cessò, per entro la civiltà cristiana, di far parte orga nica del rapporto fra morti e sopravvissuti, e di partecipare a un va rio e importante processo di plasmazione, per scadere - anche se lentamente - ad episodi relativamente secondari di circolazione culturale, e infine a relitti folklorici più o meno inerti e disgre gati. D ’altra parte vi è una seconda più particolare ragione che ci orienta verso il lamento funebre rituale del mondo antico, ed è il fatto che questo istituto si presenta nel quadro delle antiche civiltà mediterranee come il più adatto a consentire l’esplorazione di tutto l’arco che va dallo «strazio» alla oggettivazione del dolore, dalla crisi davanti al cadavere sino al riscatto culturale. Con una singolare ampiezza dinamica che ritrova continua eco nella nostra anima di uomini moderni il lamento antico ci permette di sorpren dere il modo col quale, in un ambiente storico dal quale direttamente proveniamo e che ci siamo appena lasciati alle spalle, la dispersione e la follia che minacciano l’uomo colpito da lutto furono istituzionalmente moderate nel rito, ridischiuse alle figurazioni del mito, e drammaticamente redente nel vario operare umano, cioè nell’ethos delle memorie e degli affetti, nei significati sociali, poli tici e giuridici, nell’autonomia della poesia e dei gravi pensieri sulla vita e sulla morte. Se pertanto il nostro proposito fondamentale è di «continuare a pensare» un notevole pensiero del Croce oltre l’esperienza cristiana per entro la quale esso nacque e maturò, il lamento funebre antico si presenta come il fenomeno culturale ideale per eseguire tale proposito e per rendere umanisticamente
Μ
INTRODUZIONE
più pregnante l’orizzonte di consapevolezza culturale che in quel pensiero è racchiuso. Per avviare a soluzione il problema storico-religioso del lamento antico, il primo compito della ricerca è di analizzare il cordoglio come crisi, cioè come rischio di «piangere ad un modo», rinun ziando a quella «varia eccellenza del lavoro» che differenzia i modi storici e culturali del s a p e r piangere, e che consente di rialzarsi dalle tombe, ridischiudendosi - e sia pure con animo mutato - ai doveri della vita. Una volta che sia stata preliminarmente condotta l’analisi del rischio umano di «morire con ciò che muore» in luogo di «farlo morire in noi» trascendendolo nel valore, potrà più age volmente essere affrontato il compito di ricostruire quella parti colare sapienza del pianto che si esprime nel lamento funebre antico e che il Cristianesimo soppiantò con la sua propria sapienza, di tanto più alta.
i. C risi della presenza e crisi del cordoglio
i . Il concetto di perdita della presenza [La crisi del cordoglio è una malattia ed il cordoglio è il lavoro speso per tentare la guarigioneT\questa proposizione può, nella sua ovvia genericità, essere considerata quasi come una verità del senso comune. Ma ci preme di mostrare qualche cosa di molto più pre ciso, e cioè che la crisi del cordoglio è un caso particolare di quel rischio di perdere la presenza che ebbe già a costituire argomento del secondo capitolo del Mondo magico. Per illustrare e svolgere questa tesi occorre, in via preliminare, sgombrare il cammino da alcuni equivoci ed oscurità che toccano lo stesso concetto di pre senza e di «perdita» della presenza. Nella formulazione di dieci anni or sono quel concetto restò infatti impigliato in una grave contraddizione, almeno nella misura in cui pretese di farsi valere come concetto di un’ u n i t à p r e c a t e g o r i a l e della persona e addirittura di un’unità la cui conqui sta avrebbe formato problema storico di un’epoca definita, onde poi, assicurata tale conquista, si sarebbe maturata la condizione fondamentale per la nascita dalle distinte categorie operative o valori. La contraddizione non sfuggì al Croce, che nella sua memoria Intorno a l magismo come età storica avvertiva non essere lecito distaccare con un taglio netto l’unità dalle forme distinte in cui si realizza, poiché le forme «non sono aggiunte a quell’unità, ma sono l’unità stessa, onde a voler considerare questa per sé, reste rebbe nelle mani un’unità, peggio che inerte, vuota».1 Pur con Croce, Filosofia e storiografìa (1947) p. 202.
ιό
C A P IT O L O P R IM O
diverso accento ed in una diversa prospettiva anche il Paci ripe teva lo stesso avvertimento quando metteva in rilievo che «la bar barie sempre minacciosa, l’idra di Lerna vichiana, è proprio la per dita delle categorie che costituiscono l’uomo nella sua storicità».2 Effettivamente una critica del genere è, nella sostanza, ineccepi bile. Il Croce aveva ragione: il «taglio» è davvero impossibile nel senso che si possa immaginare un’unità che non sia in atto di distin guersi secondo determinate potenze culturali del fare, e che non sia - in quanto unità di una presenza sana - questa stessa ener gia di oggettivazione formale fondatrice di civiltà e di storia. Ancor meno - per conseguenza - è lecito immaginare una astratta unità della persona che formi problema storico a sé: non si comprende infatti di che e come sarebbe diventata unità, placandosi nel risul tato di una reale risoluzione culturale. Acutamente il Croce poneva in evidenza che il «riscatto», nel modo in cui veniva prospettato nel Mondo magico, finiva col riuscire irrisolvente e fittizio, e che i protagonisti del supposto dramma - cioè gli operatori magici e i loro clienti - si dibattevano «nella stessa vitalità inferma e cieca che, col dar di volta in sulle piume, scherma il suo dolore».3 Tuttavia se è vero che il «taglio» dell’unità della presenza dalle categorie del fare significa l’annientamento della stessa possibi lità di esserci in una storia umana, e se è sommamente contraddit toria la pretesa di voler distendere in una immaginaria storia cultu rale questo nulla della cultura e della storia, i l r i s c h i o di t a l e a n n i e n t a m e n t o e s i s t e , dispiegandosi in tutta la sua potenza nelle civiltà cosiddette primitive, e riducendosi via via ed assu mendo modi meno aspri e più mediati con l’innalzarsi della vita culturale: il che appunto ammetteva il Paci. Il rischio radicale della presenza ha certamente luogo, un rischio che non è la perdita imma ginaria di una immaginaria unità anteriore alle categorie, ma che ben è la perdita della stessa possibilità di mantenersi nel processo culturale, e di continuarlo e di accrescerlo con l’energia dello sce gliere e dell’operare: e poiché il rapporto che fonda la storicità della presenza è lo stesso rapporto che rende possibile la cultura, il rischio di non esserci nella storia umana si configura come un rischio di intenebrarsi nella ingens sylva della natura. 2 E . Paci, Il nulla e il problema dell’uomo (1950) p. 126. 3 Croce, op. cit., p. 203.
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
17
In una pagina famosa de La storia come pensiero e come azione il Croce considera Vethos non più come una distinta forma del cir colo spirituale, ma come la potenza suprema che promuove e regola la stessa distinzione del vario operare umano, opponendosi «al disgregamento della unità spirituale».4 In rapporto a questo suo importante tema di pensiero la filosofia del Croce è apparsa ad un suo commentatore una «teoria della potenza etica» dominata dal senso di una costante immanenza della morte e dalla drammatica tensione fra l’«energia del fare» e il rischio di un assoluto non-fare, cioè di quel nulla «che si manifesta nel travaglio sterile, nell’acci dia inconcludente, nel vuoto smarrimento».5 Il passo dei Fram menti di etica che in un certo senso è la guida ideale della presente ricerca appartiene alla stessa tematica, poiché «il far morire in noi i nostri morti» è appunto possibile mercé del dispiegarsi della ener gia etica con la quale si supera lo «strazio», e sollevandosi al mondo dei valori si domina l’insidia della dispersione e della follia. Ora questo ethos coincide con la presenza come volontà di esserci in una storia umana, come potenza di trascendimento e di oggettiva zione. E infatti norma costitutiva della presenza l’impossibilità di restar immediatamente immersa, senza lume di orizzonte formale, nella semplice polarità del piacere e del dolore e nel gioco delle reazioni e dei riflessi corrispondenti: se vi si immerge, dilegua come presenza. La mera vitalità che sta «cruda e verde» neU’animale e nella pianta d e v e nell’uomo esser trascesa nell’opera, e questa energia di trascendimento che oggettiva il vitale secondo forme di coerenza culturale è appunto la presenza. [Esserci nella storia signi fica dare orizzonte formale al patire, oggettivarlo in una forma particolare di coerenza culturale, sceglierlo in una distinta potenza dell’operare, trascenderlo in un valore particolare: ciò definisce insieme la presenza come ethos fondamentale dell’uomo e la per dita della presenza come rischio radicale a cui l’uomo —e soltanto l’uomo - è esposto. Il trascendimento operativo che fonda e definisce la presenza possiede un ordine ideale, nel quale la vitalità non sta mai come forma, ma come materia: come materia trascesa nella coerenza cui4 Croce, La stona come pensiero e come azione, pp. 42 sgg. 5 C. Antoni, Commento a Croce (1955) pp· 144 e 150.
C A P IT O L O P R IM O
turale. Rispetto all’uomo e alla sua storia la vitalità appare sempre come una immediatezza bisognosa di mediazione formale: e se nel l’ultimo Croce essa appare ora come la materia di tutte le forme ed ora una forma fra le altre, ciò deriva dalla perdurante confu sione fra il vitale che è sempre materia e la coerenza culturale eco nomica che è certamente una forma.6*il Infatti l’economico segna il distacco inaugurale che l ’umano compie dal meramente vitale, dischiudendo con ciò l’ordine della vita civile. Quando il patire con la sua polarità di piacere e di dolore, e con le sue reazioni con formi, viene inserito in un piano razionale, deliberatamente scelto e storicamente modificabile, di produzione di beni secondo regole dell’agire, la vitalità si risolve nell’economia, e la civiltà umana c o m i n c i a . E la coerenza economica che fa associare gli uomini ai fini dèlia produzione, ripartisce il lavoro, e instaura determi nati regimi produttivi dotati di un più o meno esteso raggio di azione efficace; è la coerenza economica che ordina l’immediàtezza del vivere e del patire in un sistema mutevole di «oggetti natu rali » che indicano le linee dei nostri desideri e delle nostre avver sioni, e che racchiudono l’immagine e la memoria di possibili com portamenti efficaci; è la coerenza economica che appresta gli stru menti artificiali - materiali o mentali - che estendono e intensi ficano il potere del corpo umano e dei suoi organi; è la coerenza economica che elabora il linguaggio in quanto strumento di comu nicazione interpersonale; è infine la coerenza economica che regola la potenza dei gruppi umani e li inserisce in quella sfera di rap porti che va sotto il nome di politica. Ma il trascendimento inaugurale operato dall’economico costi tuisce soltanto la porta stretta di accesso al regno della cultura: e 6 La confusione fra vitale ed economico (o tecnico-economico) è palese per esempio nel seguente passo dell’Antoni: «Esercitando la sua intelligenza e la sua diligenza nel perfezionare gli strumenti della sua tecnica, l’uomo si solleva dalla passività e dall’inerzia della sua esistenza naturale. Sul piano strettamente economico, per effetto del semplice bisogno, questo distacco non avverrebbe, che anche la pigrizia è vitalità ed economia, e lo è anche l’ abitudine e l’osse quio alla tradizione» (Antoni, Commento a Croce, p. 193): dove, per un verso, si intravede il distacco dalla vitalità che Pethos realizza mediante la coerenza tecnico-economica, e per un altro verso si confonde vitale ed economico, attribuendo a quest’ultimo una inerzia culturale che è propria della vitalità animale e non della coerenza culturale economica. Per la caratteri stica incertezza del Croce e dei suoi discepoli a proposito del vitale si veda R. Franchini, Espe rienza dello storicismo (1933) pp. 130 sgg., incertezza e contraddittorietà che ha la sua ragione nella mancata distinzione tra vitale ed economico.
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
19
chi pretendesse di chiudersi nel possesso dell’economico e di restrin gere la vita culturale a questo semplice cominciamento o condi zione inaugurale del viver civile, non riuscirebbe in realtà a man tenersi neppure nel suo regno, che ha valore autonomo solo per entro un movimento che sospinge a valicarne i confini. L ’ethos della presenza si innalza così dall’economico alla poesia e alla scienza e alla vita morale dispiegata e consapevole di sé: salvo poi a tor nare all’economico, che non cessa mai di riproporsi, poiché mai il distacco dal vitale può essere definitivo. E tuttavia vi torna con nuove forze, accumulate nel vario operare e pronto quindi ad un più vigoroso sforzo di economica coerenza, capace di realizzare con maggiore efficacia il padroneggiamento della vitalità naturale nella sua immediatezza. Questo è il circolo, o meglio la spirale, della vita culturale, che ha il suo centro nella presenza come potenza di oggettivazione formale e di liberazione dalla «vitalità inferma e cieca»: circolo o spirale che è progresso, perché è incremento dell 'ethos nel suo civile realizzarsi. Senza questo ethos della pre senza non vi è cultura: e non soltanto diventano inconcepibili poesia e scienza, ma anche lo stesso distacco dal vitale inaugurato dall’e conomico. Senza questo ethos la più elementare invenzione tec nica dell’uomo, per esempio la fabbricazione di un’amigdale nel paleolitico o l’agricoltura primitiva alla zappa nel neolitico, non avrebbero mai potuto vedere il loro giorno nella storia umana. E infatti questo ethos che ci sospinge a farci coraggiosamente procu ratori di morte nel seno stesso del biologico morire, e che in ciò che passa senza valore - cioè senza il nostro concorso e contro il nostro sforzo - accende quell’energia di trascendimento formale col venir meno della quale l’umano operare resterebbe senza voce e senza gesto, paralizzato dall’angoscia. E tuttavia proprio questo ethos che attraversa il mondo degli uomini generando la varietà delle civiltà e degli istituti, degli ingegni e dei geni, e sollevando ben in alto l’umano sull’immediatamente vitale - proprio questo ethos può esser raggiunto dalla catastrofe e patire un morire incommensurabilmente più grave di quel morire naturale che condividiamo con gli animali e con le piante: qui si configura un’insidia radicale, che solo l’uomo minaccia e che solo l’uomo sa misurare. Non si tratta di quel negativo relativo e di quel relativo vuoto che nascono quando chi è impegnato nell’eser
20
C A P IT O L O P R IM O
cizio di una forma «fa un’altra cosa», e mescola insieme due diverse coerenze: come per esempio quando si spaccia per scienza la pro paganda politica, o per poesia ciò che in realtà è economicità, o per politica ciò che è invece sogno poetico. Questo negativo appar tiene al rapporto delle forme fra di loro, all’urto dei positivi: ma vi è il rischio di un assoluto negativo che si riferisce al rapporto fra la vitalità, che è sempre materia, e la presenza come volontà di forma. Qui si denunzia una tensione eccentrica che travaglia lo stesso circolo della vita culturale e che minaccia di spezzarlo: qui viene rimessa in causa la stessa possibilità del distacco dell’esserci dalla naturalità del vivere. La crisi della presenza è da ricondurre al doppio volto dell’eco nomico, che mentre per un verso è un positivo fra i positivi ed è esposto alla indebita intrusione degli altri positivi nella sua sfera, ovvero può intrudersi indebitamente nella sfera degli altri posi tivi, per un altro verso costituisce idealmente il positivo inaugu rale, che distacca la cultura dalla natura e rende possibile, con questo suo distaccarsi, la dialettica delle forme di coerenza culturale. Ciò significa che nella misura in cui il distacco si compie in modo rela tivamente angusto, si configura l’esperienza di un divenire che passa senza e contro di noi, funesto dominio dell’irrazionale, cioè di un «cieco» correre verso la morte. In generale, per alta e umanizzata che possa essere una determinata civiltà resta sempre (e non potrebbe essere altrimenti) una sfera di possibilità esistenziali in cui si manifesta ciò che passa senza e contro di noi, cioè una sfera che non può essere fronteggiata da tecniche efficaci di controllo e di umanazione: ora quando si verifica, in determinati momenti critici, l’incontro o lo scontro con questa sfera si profila il rischio di una tensione eccentrica, di una rottura, almeno nella misura in cui non si tratta più di scegliere fra i valori, ma di non poter sce gliere proprio nessun valore, neppure quello che ci strappa dalla immediatezza del vitale e ci fa accedere nel regno della cultura. Questo rischio concerne in primo luogo i momenti del divenire che nel modo più scoperto fanno scorgere la corsa verso la morte che appartiene al vitale nella sua immediatezza: nell’estrema e non eludibile tensione di questi momenti, allorché è in causa Tesserci o il non esserci come presenza, può consumarsi la crisi di oggetti vazione, lo scacco del trascendimento: e d i n v e c e di f a r p a s -
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
21
s a r e c i ò c h e p a s s a (cioè di farlo passare nel valore) n o i r i s c h i a m o di p a s s a r e c o n c i ò c h e p a s s a , senza mar gine di autonomia formale. Il presupposto kantiano di una unità sintetica originaria dell’appercezione comportava che tale unità fosse al riparo da qualsiasi rischio, e una diversa possibilità costi tuiva per Kant soltanto un argomento polemico, come si desume dal seguente passo della Critica della ragion pura: Il pensiero: queste rappresentazioni date nell’intuizione appartengono tutte quante a me, ha lo stesso significato del pensiero: io le riunisco in una sola autocoscienza, o almeno posso riunirle in essa. E sebbene il primo pensiero non sia ancora la coscienza della sintesi delle rappresentazioni, esso tuttavia presuppone la possibilità di quest’ultima; ossia solo per il fatto che posso comprendere in una sola coscienza il molteplice delle rappresentazioni, io le chiamo tutte quante le mie rappresentazioni: in caso contrario, difatti, 10 avrei tante variopinte e differenti personalità, quante sono le rappresen tazioni, di cui ho coscienza.7
In questo passo il «me variopinto» (cioè la presenza che passa con ciò che passa e che si annienta in questo annientarsi della sua potenza di oggettivazione) è assunto non già come rischio reale, ma come conseguenza assurda che deriverebbe dal mancato rico noscimento dell’unità sintetica originaria dell’appercezione: invece la tesi che forma il nerbo del secondo capitolo del Mondo magico interpreta come reale rischio esistenziale ciò che nella critica kan tiana sta solo come argomento polemico. Il dispiegarsi delle forze naturali ciecamente distruttive, la morte fisica della persona cara, le malattie mortali, le fasi dello sviluppo sessuale, la fame insaziata senza prospettiva, racchiudono - in date circostanze - l’esperienza acuta del conflitto fra la perento rietà di un «dover fare qualche cosa» e il funesto patire del «non c’è nulla da fare», da intendersi non già come rassegnazione morale (nel qual caso sarebbe una forza) ma come crollo esistenziale. Anche determinate esperienze della vita associata, nella misura in cui ripro ducono il modello naturale della forza spietata che schiaccia, aprono 11 varco alla possibilità della crisi: si pensi al rapporto dello schiavo rispetto al padrone, o del prigioniero rispetto al nemico che dispone della sua vita, o anche a determinate esperienze-limite di sentirsi 7 del Colli].
Kant, Crìtica della ragion pura, pt. I, libro I, cap. 2, sez. 2, § 16 [pp. 15 8 sgg. trad. it.
C A P IT O L O P R IM O
22
travolto da forze economiche o politiche operanti senza e contro di noi con la stessa estraneità e inesorabilità delle forze cieche della natura. In punti nodali o momenti critici come questi si annida la possibilità della crisi radicale e può manifestarsi quella funesta miseria esistenziale per cui ciò che passa ci trascina nel nulla ancor prima che la morte fisica ci raggiunga: ed è quella miseria una cata strofe molto maggiore di questa morte. Il concetto di una crisi della presenza come «miseria» è stato, se non visto, almeno intravisto da alcuni rappresentanti della moderna psichiatria. «Tutta la storia della follia - scriveva Pierre Janet nel lontano 1889 - dipende dalla debolezza della sintesi attuale, che è debolezza morale essa stessa, m i s e r i a p s i c o l o gi c a . Il genio, al contrario, è una potenza di sintesi capace di for mare idee nuove, che nessuna scienza anteriore poteva prevedere: è l’ultimo grado della p o t e n z a m o r a l e » . 8 Qui si parla espli citamente di «potenza morale»: e certamente può ben essere con siderato come ethos fondamentale dell’uomo questa potenza dia lettica che tramuta la natura in cultura, e che la vitalità accoglie e feconda, ma p e r aprirla alle singole concrete opere economiche, politiche, giuridiche, morali, poetiche e scientifiche. Anche alcune nozioni della psicoanalisi - pur nella distorsione propria di que st’indirizzo psicologico - possono valere come indicazione alme no allusiva allo stesso nesso. Ciò che Freud definisce come libido (e che in pratica considera essenzialmente nella forma di vitalità sessuale) è in realtà la presenza, cioè l’energia sintetica oltrepas sante le situazioni secondo distinte potenze del fare. Quando Freud parla dii fissazione della libido ad uno stadio arretrato particolare, assegnando a questa fissazione la responsabilità di una possibile regressione psiconevrotica, egli conferma nel quadro della sua teoria che la malattia psichica è un contenuto critico non oltrepassato, cioè non scelto e oggettivato dalla presenza, e per questo ritor nante come estraneità psichica e come sintomo non dominabile. Senza dubbio il Freud considera di fatto «critiche» quasi soltanto determinate situazioni connesse con la vita sessuale, e quindi inter preta la fissazione nel senso di una mancata evoluzione della ses sualità: ma a parte questo limite, in verità molto grave, egli lascia P. Janet, L automatisme psycbologique (1889) p. 478.
CRISI DELLA PRESENZA E CRISI DEL CORDOGLIO
23
tuttavia intravedere l’importante concetto della presenza fisiologica come energia oltrepassante. Analogamente il concetto di complesso accenna ad un conflitto non deciso nel quale la presenza è rimasta polarizzata, entrando in contraddizione esistenziale con se stessa; la traslazione e la sublimazione accennano alla ripresa e alla risolu zione del conflitto in un determinato valore culturale; e così via. Ma il precedente più pertinente del concetto di crisi della pre senza non si ritrova nella moderna psicopatologia, ma nello Fiegei, che su questo punto ha in parte detto e in parte intravisto l’essen ziale. A ciò che noi chiamiamo «presenza» corrisponde in parte nello Hegel il «sentimento di sé», che viene così determinato: La totalità senziente, in quanto individualità, è essenzialmente questo: distin guere sé in se stessa e svegliarsi al giudizio di sé, secondo il quale essa ha sentimenti particolari e sta come soggetto in relazione con queste determina zioni. Il soggetto come tale pone queste in sé come suoi sentimenti. Esso è im merso in codesta particolarità delle sensazioni; ed insieme, mediante la idea lità del particolare, si congiunge con sé come un’unità soggettiva. In questo modo è sentimento di sé; ed è tale soltanto nel sentimento particolare.9
Ora il soggetto come sentimento di sé può essere suscettibile di malattia, cioè «può restar fermo in una particolarità del suo senti mento, la q u a l e e g l i n o n p u ò e l a b o r a r e e d o l t r e p a s s a r e ». Qui è posto con la più grande chiarezza il rischio della pre senza come incapacità ad oltrepassare un suo determinato conte nuto critico, cioè a deciderlo secondo forme distinte di coerenza culturale. Per Hegel il soggetto fisiologico è il se stesso come co scienza coerente o intellettiva, il soggetto patologico è il se stesso reso prigioniero di un contenuto particolare: Il sé stesso ripieno della coscienza intellettiva è il soggetto come in sé conse guente: coscienza che si mantiene e ordina secondo la sua posizione indivi duale e la connessione col mondo esterno, il quale è altresì un mondo ordi nato. Ma, r e s t a n d o i m p i g l i a t o i n u n a s u a d e t e r m i n a z i o n e p a r t i c o l a r e , esso non assegna a siffatto contenuto il suo posto intellet tivo e la sua subordinazione che gli spetta nell’individuale sistema del mondo che è un soggetto. Il soggetto si trova, in questo modo, in contraddizione tra la sua totalità, sistematizzata nella sua coscienza, e la determinatezza particolare che non ha scorrevolezza e non è ordinata e subordinata. Il che è la follia.10 5 Hegel, Enc., § 407. La traduzione italiana di questo e degli altri passi è quella del Croce. 10 lbid., § 408.
C A P IT O L O P R I M O
24
Ovviamente i limiti dell’hegeliano sentimento di sé sono i limiti e le deficienze della stessa dialettica hegeliana: la totalità del sog getto non è qui la distinzione delle forme culturali, ma ancora la coscienza intellettiva, intesa come semplice giudizio di sé e come riferimento a sé dei suoi sentimenti: laddove la presenza è intesa da noi come potenza sintetica secondo categorie del fare. Tutta via, a parte questo limite, lo Hegel intende con straordinaria acu tezza il carattere di ciò che abbiamo chiamato la crisi della pre senza. Quando Hegel afferma che lo spirito è libero e non è quindi suscettibile di malattia, mentre il sentimento di sé può cadere nella contraddizione della sua soggettività per sé libera e di una sua par ticolarità, «la quale non diventa colà ideale e resta fissa nel senti mento di sé», accenna al concetto che lo spirito, cioè la presenza impegnata nella distinzione delle forme culturali, è la presenza fisio logica, mentre la presenza che non oltrepassa i suoi contenuti cri tici nella i d e a l i t à d e l l a f o r m a , è necessariamente una pre senza malata, che si sta perdendo. Quando Hegel sostiene che il vecchio concetto metafisico dell’anima come sostanza è in realtà il concetto dello spirito come suscettibile di follia (poiché l’animasostanza, che è soltanto esistente, naturale, fissata nella sua finità esistenziale, è appunto il concetto di follia), egli esprime nel lin guaggio che il suo sistema gli consente che la presenza è l’energia sintetica generatrice della dialettica culturale, e che quando Tes serci si riduce al semplice esistere naturale imprigionandosi in uno «stato» psichico e cominciandolo a «ripetere» invece di oltrepas sarlo, allora non può più esserci e comincia a perdersi, a dileguare: (Lo spirito) dall’anteriore metafisica è stato considerato come anima, come cosa; e solo come cosa, cioè come alcunché d i n a t u r a l e e d i e s i s t e n t e , è suscettibile di follia, della finità che si fissa in lui [...] Lo spirito, determi nato come tale che è soltanto, in quanto un tale essere sta nella sua coscienza senza soluzione, è malato.11
Lo spirito come essere che è soltanto e che sta nella coscienza senza soluzione è la presenza fissata o impigliata in un suo contenuto critico, e quindi non più presente perché l’andar oltre i contenuti è la definizione stessa della presenza: e l’essere senza soluzione si riferisce al contenuto che resta non scelto e deciso secondo valori,
11 Ibid.
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G LIO
25
e che perciò si rescinde come contenuto determinabile e torna come sintomo indominabile, come estraneità tirannica in una esistenza a vario titolo non autentica. Ma c’è di più: la follia come natura lizzarsi dello spirito è proprio il rischio di non esserci come pre senza, cioè appunto di recedere sul piano della naturalità, dove la presenza non ha luogo. Qui noi tocchiamo la suprema alterna tiva dell’esistenza in quanto fatto culturale: o la presenza sana che si dischiude alle opere e ai giorni dell’umana cultura, o la presenza malata che perde se stessa e precipita nella follia.
2. La presenza malata Per analizzare il rischio della presenza posseggono un notevole valore euristico le esperienze e i comportamenti della presenza malata. Senza dubbio la presenza malata è - dal punto di vista della storia culturale dell’umanità - una a s t r a z i o n e , poiché la cultura è il frutto della lotta vittoriosa della sanità contro l’insidia della malattia, cioè contro la tentazione di abdicare alla stessa pos sibilità di essere una presenza inserita nella società e nella storia. Ma proprio questa a s t r a z i o n e è l a minaccia mortale per eccel lenza: onde Tanalisi della malattia trionfante presenta il vantag gio metodologico di collocarci davanti al rischio quando esso, diven tando egemonico, si sottrae a quella potenza dialettica per cui, nella presenza sana, sta soltanto come momento negato e variamente redento nell’opera attuata e nel valore conseguito. Presenza malata significa - in generale - presenza che una volta, in qualche deter minato momento critico dell’esistenza, ha rinunziato a f a r l o p a s s a r e , risolvendolo nel valore, ed è invece passata con esso. Ogni contenuto critico sta per la presenza in quanto trasceso nella ogget tivazione formale, e ogni presenza si mantiene rispetto a un con tenuto critico nella misura in cui dispiega il suo margine formale di trascendimento: ciò significa che una presenza caduta in crisi di oggettivazione o di trascendimento p a s s a essa stessa in luogo di f a r p a s s a r e , perdendo se stessa nel contenuto e il contenuto in se stessa, ed entrando pertanto in una contraddizione esisten ziale che manifesta vari modi di profonda inautenticità. Il modo estremo è l’assenza totale o la degradazione delY ethos della pre-
26
C A P IT O L O P R IM O
senza nella scarica meramente meccanica di energia psichica: ma vi è tutta una gamma di inautenticità esistenziali in cui si manife sta la crisi patita e non risolta. Dalla esperienza critica non decisa la presenza può riemergere vulnerata. L ’ombra del passato che non è stato fatto passare si distende sul progresso del fare, spia l’occa sione per riproporsi: ma a cagione dell’interruzione che vulnera la durata della presenza non torna nella dinamica unitaria della memoria attiva e risolvente, sì bene nella estraneità irrelativa del sintomo morboso. La presenza malata si manifesta allora come pre senza apparente, che sta nel presente in modo inautentico, poiché vi patisce il ritorno mascherato e irriconoscibile di un identico pas sato in cui è rimasta impigliata. Per questa disarticolazione della dialettica del tempo il maggior numero di comportamenti morbosi della presenza in crisi non appare per l’osservatore sano in rap porto diretto con momenti oggettivamente critici, ma con situa zioni del tutto irrilevanti: in realtà per la presenza malata il «pre sente» perde la sua autenticità esistenziale e la sua attualità storica, e tende a configurarsi a vario titolo come simbolo cifrato del pas sato non oltrepassato, operante dal di fuori, irriconoscibile e indo minabile. Se la malattia della presenza può prendere corpo in occa sioni che sembrerebbero banali, ciò dipende dal fatto che quelle occasioni insorgono nel malato come iterazione senza soluzione di un momento critico nel quale la presenza, una volta, si è smar rita. In altri termini la presenza che, in qualche dove della sua bio grafia, è passata con ciò che passa, resta in varia misura incapace di un autentico presente, esposta al rischio di patire il ritorno inso lubile della situazione rescissa e di dover sostituire al rapporto for male con il presente storicamente determinato il rapporto senza soluzione col passato perduto: la presenza che non ha deciso la sua storia quando doveva farlo, sta ora destorificata, cioè fuori del rapporto reale con la storia concreta del mondo culturale in cui è inserita e in cui è chiamata continuamente ad esserci. L ’analisi della perdita della presenza attraverso le manifesta zioni morbose della vita psichica può essere condotta da diversi punti di vista: il nostro non sarà ovviamente quello della classifi cazione dei vari quadri nosologici e neppure quello della determi nazione della dinamica individuale della malattia, cioè dei momenti
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
27
critici iniziali e reali che non furono oltrepassati e di quelli simbo lici e secondari in cui la malattia attualmente si manifesta. Giova invece ai nostri fini l’analisi fenomenologica di alcuni caratteri stici sintomi della perdita della presenza, prescindendo da ogni con siderazione dinamica individuale e da ogni riferimento al carat tere reale o simbolico dei momenti critici in cui ha luogo l’insor genza morbosa. Particolarmente istruttive sono, a questo riguardo, le esperienze di un sé spersonalizzato, sognante, vuoto, automa tizzato, inattuale e simili. Una malata di Janet diceva: «Io mi sono smarrita, è orribile avere lo stesso volto e lo stesso nome e non essere la stessa persona... Voi non avete ancora visto la vera Letizia; se sapessi dov’è ve la farei vedere, ma non la posso trovare».12 E un’altra malata: «Di tanto in tanto la mia persona se ne va, io perdo la mia persona. È una cosa bizzarra e ridicola, ma è come se un velario cadesse e tagliasse in due la mia personalità. Le altre per sone non se ne accorgono perché io posso parlare e rispondere cor rettamente. In apparenza per voi io sono la stessa, ma per me le cose non stanno così».13 E ancora un altro malato: «Ciò che mi manca sono io stesso, è terribile sfuggire a se stesso, vivere e non essere se stesso».14 A queste esperienze della perdita della presen za fanno riscontro quella della perdita del mondo, che è avvertito come strano, irrelativo, indifferente, meccanico, artificiale, teatrale, simulato, sognante, senza rilievo, inconsistente, e simili. Diceva un malato di P. Janet: «Io intendo, vedo, tocco, ma non sento come un tempo, gli oggetti non si identificano col mio essere; un velo spes so, una nuvola cambia il colore e l’aspetto dei corpi».15 E un altro malato: «Voi non siete che un fantasma, come ce ne sono tanti: e non potete pretendere che si abbia obbedienza ed affetto per qual cuno di cui non si avverte la realtà».16 Ancora un altro malato: «Le cose non sono più nel loro quadro e non indicano più la loro utilità».17 Infine ecco come una schizofrenica sottoposta a trat tamento psicoanalitico da A. Sechehaye descrive nel suo diario la 12 P. Janet, De l ’angoisse à l ’extase (Parigi 1928) voi. 2, p. 56. 13 Ibid., p. 55 14 Ibid., p. 56 15 Ibid., p. 47 16 Ibid., p. 49 17 Ibid., p. 62
28
C A P IT O L O P R IM O
perdita del mondo: Per me la follia era come un paese opposto alla realtà, un paese nel quale regnava una luce implacabile, che non lasciava posto per l’ombra, e che acce cava. Era una immensità senza confini, illimitata, piatta, piatta, - un paese minerale, lunare, freddo... In questa estensione tutto era immutabile, immo bile, fisso, cristallizzato. Gli oggetti sembravano figure di uno scenario. Le persone si muovevano bizzarramente, compiendo gesti e movimenti privi di valore. Erano fantasmi che circolavano in questa pianura infinita, oppressi dalla luce spietata dell’elettricità. Ed io ero perduta là dentro, isolata, fredda, nuda sotto la luce e senza scopo. Un muro di bronzo mi separava da tutto e da tutti...18
In tali esperienze ciò che viene registrato senza soluzione è il vuoto dei valori, l’impotenza del trascendimento e della oggetti vazione, la inattualità dell’esserci: in questa inattualità affiora l’in solubile problema dell’astratta possibilità di sé e del mondo, al di qua della scelta concreta che fonda e autentica il sé e il mondo. Pur nella varietà delle loro espressioni questi malati esprimono lo straniarsi di sé a sé, la perdita di sé come potenza oggettivante e del mondo come risultato della oggettivazione. D ’altra parte gli oggetti che «non stanno in sé», ma vanno oltre in modo irrela tivo, riflettono e denunziano il perdersi della presenza che non riesce ad andar oltre le situazioni, e a gettarle davanti a sé, per entro un determinato valore operativo. Col venir meno della stessa funzione oggettivante gli oggetti entrano in un rischioso travaglio di limiti, per cui appaiono accennare ad un oltre inautentico, vuoto, estraneo: in realtà questo oltre improprio è la potenza oltrepas sante della presenza che in luogo di fondare l’oggettività sta diven tando essa medesima un oggetto, si sta alienando con l’oggetto e nell’oggetto. Per questo straniarsi della potenza oggettivante, il mondo e i suoi oggetti sono sperimentati in atto di non essere più «nel loro quadro», cioè nella memoria di una determinata tradi zione di significati e nella prospettiva di una possibile operazione formale della presenza. Il mondo diventa irrelativo, senza eco di memorie e di affetti, simile a uno scenario. Gli oggetti perdono rilievo e consistenza (la luce accecante e la mancanza di ombra), si pongono fuori della realtà storica (il paese lunare, minerale, immo bile). Tale estraniazione e destorificazione del mondo si riflette 18 A. Sechehaye, Journal d ’une schìzophrène (Parigi 1950) pp. 20 sg.
C R IS I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
29
nell’esperienza di una estraneità radicale, che chiede perentoria mente rapporto e che non può assolutamente trovarlo: una estra neità irraggiungibile, perduta in lontananze astrali, separata da un muro di bronzo. La crisi di oggettivazione non si riflette soltanto nelle esperienze di spersonalizzazione e di incompletezza di sé, e di fissità, incon sistenza e artificialità del mondo, ma anche nell’esperienza di una forza o tensione cieca in se stessi e nel mondo. Gli oggetti che non stanno in limiti oggettivi (riflettendo in tal modo l’alienarsi della stessa energia oggettivante della presenza) sono avvertiti qui come forze in atto di scaricarsi, come oscure tensioni spianti la più pic cola occasione per frantumare le barriere che li trattengono, e per fondersi e confondersi in caotiche coinonie. G li oggetti che «non sono più nel loro quadro» non si presentano più in questo caso con la valenza dell’artificialità e della lontananza, e come vulne rati da una perdita di prospettiva e di rapporto, ma si configurano piuttosto in atto di agire come potenze cieche ed estranee, che si scaricano disarticolando il reale, e incombendo minacciosamente sulla presenza: alla lontananza astrale si oppone, in una vicenda irrisolvente, la prossimità irrelativa degli oggetti fra di loro e del mondo oggettivo rispetto alla presenza, onde crolla la stessa pos sibilità di mantenere gli oggetti distinti gli uni dagli altri, e di con trapporre sé al mondo. Si ha allora la terrificante esperienza del l’universo in tensione, sul punto di annientarsi in una immane catastrofe. Racconta la malata di Sechehaye: Chiamavo [la fonia] il paese deH’illuminazione a causa della luce vivissima, abbagliante e fredda, astrale, e dello stato di tensione estrema in cui si tro vavano tutte le cose, me compresa. Era come se una corrente elettrica d’una potenza straordinaria attraversasse tutte le cose, e aumentasse sempre più la sua tensione, finché tutto sarebbe saltato in aria in una esplosione terrifi cante... In questo silenzio infinito e in questa immobilità tesa, avevo l’im pressione che qualche cosa di spaventoso sarebbe accaduto e avrebbe rotto questo silenzio, che qualche cosa di atroce, di sconvolgente stava per verifi carsi. Restavo in attesa, trattenendo il respiro, smarrita nell’angoscia, e non accadeva nulla. L ’immobilità si faceva ancor più immobilità, il silenzio ancor più silenzio, gli oggetti e le persone con i loro gesti e il loro rumore ancor più artificiali, staccati gli uni dagli altri, senza vita, irreali. E la mia paura aumentava, sino a diventare inaudita, indicibile, atroce.19 19 Sechehaye, op. c i t p. 2 1.
3°
C A P IT O L O P R IM O
Il rischio dell’alienarsi della potenza oggettivante della presenza può essere avvertito o nel dominio del divenire oggettivo, o per singoli pensieri e affetti, ovvero in rapporto alla presenza in quanto tale. Il rischio di alienazione del dominio oggettivo comporta l’espe rienza di una disposizione maligna delle cose e degli eventi, di un «esser-agito-da» che si sostituisce «all’agire su» della oggettiva zione. Si apre così una vicenda di oscuri disegni e di subdole mac chinazioni, di rimproveri e di accuse, di insidie e di influenze: e le cose diventano cause, non già nel senso fisico del termine, ma proprio in quello giuridico di cause intentate ai danni del malato. L ’alienarsi di singoli pensieri o affetti dà luogo alla interpretazio ne che altri li manovrino, li influenzino, li rubino, o ne siano i pa droni: a un grado più profondo di alienazione si avvertono i pro pri pensieri in atto di staccarsi dal flusso interno del pensare, per ripetersi per loro conto, a guisa di eco psichica, sino a risuonare pubblicamente anche se non comunicati con la parola. L ’alienarsi della presenza e l’esperienza immediata della impotenza di qual siasi scelta formale si rispecchia infine subiettivamente come colpa altrettanto mostruosa quanto immotivata: si tratta infine della col pa di non potersi motivare, che è - per essenza - radicale e senza motivo. La depressione melanconica è pertanto da interpretare, considerata in questa prospettiva, come l’esperienza di abiezione estrema e di incomparabile miseria che accompagna il senso di sé nel recedere dell’energia di oggettivazione su tutto il possibile oriz zonte formale. Il rischio radicale della perdita della presenza è segnalato - al meno sin quando la presenza resiste - da una reazione totale che è l’angoscia. Se depuriamo questo concetto da tutte le interpreta zioni non pertinenti alimentate da determinate suggestioni meta fisiche, o dalla crittogamia con l’esperienza religiosa o dai vari idoleggiamenti alimentati da una inerzia morale in atto, e se al tempo stesso ci tratteniamo dal cadere nella empiria della corrente psicopatologia, troviamo come risultato che l’angoscia si determina nella presenza come reazione davanti al rischio di non poter oltrepas sare i suoi contenuti critici, e di sentirsi inattuale e inautentica nel presente. Ciò equivale a dire che l’angoscia è il rischio di per dere la possibilità stessa di dispiegare l’energia formale dell’esserci.
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
31
L ’angoscia segnala l’attentato alle radici stesse della presenza, denunzia l’alienazione di sé a sé, il precipitare della vita culturale nella vitalità senza orizzonte formale. L ’angoscia sottolinea il rischio di perdere la distinzione fra soggetto e oggetto, fra pensiero ed azione, tra forma e materia: e poiché nella sua crisi radicale la pre senza non riesce più a farsi presente al divenire storico, e sta per dendo la potestà di esserne il senso e la norma, l’angoscia può essere interpretata come angoscia della storia, o meglio come angoscia di non poter esserci in una storia umana. Pertanto quando si af ferma che l’angoscia non è mai di qualche cosa, ma di nulla, la proposizione è accettabile, ma soltanto nel senso che qui non è in gioco la perdita di questo o di quello, ma della stessa possibi lità del quale come energia formale determinatrice di ogni questo e di ogni quello·, e tale perdita non è il non-essere, ma il non-esserci, l’annientarsi della presenza, la catastrofe della vita culturale e della storia umana. E infine: l’angoscia è esperienza della colpa, perché la caduta dell’energia di oggettivazione è, come si è det to, la colpa per eccellenza, che chiude il malato in una disperata melancolia. Nelle stesse trattazioni della psicopatologia questo carattere del l’angoscia si fa luce talora vincendo le empirie e le superficialità dell’ordinaria esperienza clinica. Il malato non ha angoscia di qualche cosa, egli è l’angoscia, senza aver coscienza né di un oggetto, né di un soggetto... L ’oggetto è l’utilizzazione ordinata dell’eccitazione, e la coscienza dell’io è il completamento neces sario della coscienza dell’oggetto. Ma nella dilacerazione catastrofica del l’angoscia non vi è oggetto - e per questo l’angoscia è senza contenuto e neanche coscienza precisa dell’io... Ciò che il malato vive e la dilacera zione della struttura della personalità: non si può dire neppure che egli provi angoscia, egli è l’angoscia e fa tutt’uno con essa in questo rovesciamento indicibile nel quale soggetto e oggetto sono scomparsi... L ’angoscia è il pe ricolo supremo, cioè il profilarsi di quella situazione finale in cui 1 organi smo non può adattarsi all’ambiente, e si trova minacciato nella sua stessa esistenza.
Queste proposizioni di Kurt Goldstein,20 sebbene inadeguate, trovano la loro elucidazione e la loro verifica nella teoria dell’an20 K . Goldstein, Zum Probkm derAngst, Allg. àrtzl. Z. Psychother. psych. Hygiene, voi. 2, n. 7, 409 sgg. (1929). Per un panorama sulle concezioni dell’ angoscia nella moderna psichiatria (e nell’esistenzialismo) è da vedere il libro di J . Boutonier, L ’angoisse (Parigi 1949)·
32
C A P IT O L O P R IM O
goscia come reazione totale al rischio radicale della perdita della presenza. Che cosa infatti può significare la perdita della distin zione fra soggetto e oggetto, l’essere immediatamente l’angoscia, il rovesciamento indicibile che comporta il pericolo supremo di non potersi adattare all’ambiente, che cosa può essere il sentirsi in seine Existenz bedrobt se non appunto la catastrofe dell’esserci nel senso che abbiamo chiarito? L ’ angoscia indica che la presenza resiste alla sua disgregazione: ma le resistenze e le difese che hanno luogo in regime di crisi hanno il carattere comune di essere sostanzialmente improprie, in quanto non ripristinano la signoria del mondo dei valori e non valgono a reintegrare in modo attivo nella realtà storica di cui si fa parte. La dialettica del «non fare» e del «fare» si disarticola: per la carenza del riscatto formale il «non fare» si orienta verso la paradossale ricerca dell’assenza assolutamente vuota di contenuti e di impe gni formali, ed il «fare» si dissolve nell’egemonia adialettica del vitale, che pretende in vani conati di ricostruire fittiziamente la presenza. I modi dell’assenza sono conati di destorificazione irre lativa, cioè di evasione totale dalla storicità dell’esistere: tali sono la reazione stuporosa, il ritualismo ed il simbolismo protettivi. Osti lità persecutoria del mondo, abiezione della presenza in crisi e ter rore del fare possono spingere alla reazione, tipicamente contrad dittoria e irrisolvente, della ricerca dell’assenza totale. L ’aggravarsi della crisi restringe sempre più il margine della possibile inizia tiva, finché in un supremo conato di rinunzia a sé e al mondo la volontà entra in un blocco spasmodico, restando come sospesa al gioco di un’assoluta ambivalenza, in cui ogni «sì» richiama peren toriamente e polarmente il «no». Nei casi più avanzati questo insta bile equilibrio di stimoli si riduce a una polarità praticamente auto matica, accompagnata da flessibilità cerea, da ecolalia e da ecomimia: ma nei casi meno gravi la presenza ha ancora un margine suf ficiente per avvertire il profilarsi della crisi. Uno schizofrenico di Arieti si rendeva conto, con crescente ansietà, che insormontabili difficoltà si opponevano alla sua azione: ogni movimento che si apprestava a compiere gli si configurava come rischiosa possibilità di compiere un atto nocivo oinefficace, e pertanto questo malato, dominato dall’angoscia, preferiva non mangiare, non vestirsi, non
C R IS I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G LIO
33
lavarsi, per ridursi infine all’immobilità assoluta dello stupore cata tonico.21 Il carattere estremamente contraddittorio e irrisolvente di tale reazione è che l’assenza viene cercata come tale, senza quel l’apertura formale che pur si realizza nelle esperienze estatiche con nesse alla vita magico-religiosa della storia culturale umana: l’as senza dello stupore è infatti sulla linea di quella stessa perdita della presenza che costituisce il rischio della malattia, e la clamorosa contraddizione del «farsi assente per terrore dell’azione» può met ter capo soltanto al nuovo e più grave sintomo morboso del blocco spasmodico della volontà. Il secondo modo della destorificazione irrelativa della crisi è costituito dal ritualismo dell’agire. Mentre nella reazione stuporosa il conato si dirige verso l’assenza totale dalla realtà storica attuale, nelle stereotipie e nei manierismi dell’agire soltanto determinati settori più o meno ampi e prolungati dell’ agire vengono sottratti alla storicità, chiusi al dialogo con essa, e irrigiditi in una iterazione dell’identico che è la negazione del mobile divenire storico e della necessità di rispondere ad esso con iniziative formalmente determinate. Nei manierismi e nelle ste reotipie dell’agire la presenza in crisi si chiude in un miserabile regime di risparmio vuoto di valore: chiusa nelle rigide barriere protettive del ritualismo in quanto tale, essa «sta nell’esistenza senza starci», poiché qualunque cosa accada essa contrappone all’ac cadere lo stare immobile nelle proprie iterazioni. Il rapporto col momento rituale della magia e della religione è soltanto apparente, perché nella magia e nella religione la ritualità dell’agire media, attraverso l’orizzonte mitico, una piena reintegrazione culturale, mentre le stereotipie e i cerimonialismi della presenza malata, sostanzialmente chiusi nella loro vicenda privata, si esauriscono in un vuoto tecnicismo dell’assenza, e perciò non si sollevano dalla crisi di oggettivazione, ma la ribadiscono e la aggravano. Il terzo modo della destorificazione irrelativa della crisi consiste nella desto rificazione per simboli protettivi, a cui si affida il compito di ridi schiudere l’azione. I simboli protettivi o allusivi, ansiosamente cer cati o costruiti, rappresentano il conato di occultare a sé la storicità del reale, e quindi la responsabilità personale delle iniziative, in modo che il fare effettivo sia nient’ altro che iterazione del già deciso 21
S. Arieti, Interpretation o f Schizophrenìa (New York 1955) pp. n o sgg.
C A P IT O L O P R IM O
34
e fatto su un piano metastorico. Anche i simboli protettivi, in quanto dovrebbero proteggere l’azione anticipandone il corso in un mondo a sé, non vulnerato dalla decisione personale, rappresen tano, al pari del ritualismo dell’agire, un modo di «stare nella sto ria senza starci», e un disperato tentativo di dischiudersi - attra verso questa miserabile frode - all’ azione. Un altro malato di Arieti quando usciva di casa era indotto a dare interpretazioni di qualsiasi cosa scorgesse per via, al fine di trarne indicazioni rassi curanti sulla non rischiosità della direzione da seguire. Se vedeva una luce rossa all’incrocio stradale la interpretava come un avver timento occulto a non procedere più oltre nella direzione corri spondente, se invece gli cadeva sotto gli occhi una qualsiasi frec cia stradale credeva trattarsi di un avvertimento del buon Dio per indurlo ad imboccare la direzione non rischiosa. Questa ricerca di simboli protettivi del fare non gli riusciva tuttavia di nessun giovamento, e al colmo dell’angoscia tornava a casa, dove cercava rifugio nella reazione stuporosa. Internato nell’ospedale psichia trico il terrore dell’azione e l’ansiosa ricerca di simboli protettivi non lo abbandonarono: se un dottore gli poneva qualche domanda, egli si sentiva al tempo stesso spinto e bloccato a rispondere, e cercava i segni che gli indicassero quale risposta dare e quale no. Sottoposto alla cAoc-terapia subì un miglioramento, «anche per ché - come osserva l’Arieti - nell’ospedale tutto si svolgeva se condo ordini, il che lo alleggeriva delle sue responsabilità».22 An che la destorificazione per simboli allusivi sembra ricordare i miti della vita magico-religiosa: ma i veri miti della vita magico-religiosa ridischiudono, come si è detto, determinati valori sociali, politici, morali, poetici e conoscitivi, mentre i simboli allusivi a cui ricorre la presenza malata sono conati individuali del tutto vuoti di pro spettiva culturale, e perciò sterili anche sul piano tecnico sul quale si muovono. Analoghe considerazioni valgono per le difese improprie orien tate verso il «fare». Qui i conati di recuperare la presenza riescono solo ad una caricatura ed una contraffazione dell’esigenza del tra scendimento, in quanto ciò che dovrebbe stare sempre come mate ria, la vitalità, pretende di assolvere compiti formali. Così il «far 22 Arieti, op. cit., pp. 1 2 1 sg.
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
35
passare nel valore», che comporta una appropriazione interiore e un far morire ideale, cede il luogo, in questa forma della crisi, alla appropriazione materiale di oggetti privi di significato attuale, alla mania del raccogliere e del conservare, alla incorporazione nelle cavità naturali del corpo, alla fame insaziabile di cibo e alla inge stione di oggetti anche non commestibili, allo sfrenato erotismo, al furore distruttivo e omicida. I momenti dell’innalzamento alla forma, cioè l’appropriazione, la conservazione ed il superamento formali, sono qui contraffatti sull’improprio piano materiale della vitalità in atto, chiusa in se stessa e adialettica rispetto al destino formale dell’uomo: diabolus simia Dei. L ’egemonia del vitale che pretende di surrogare la risoluzione formale si manifesta nel modo più netto nella cosiddetta eccitazione maniaca. Qui la presenza in crisi si limita a prestare all’ accelerazione vitale l’inerte conte nuto di rappresentazioni e di sentimenti che simulano, ma non sono, valori reali. Lo psichiatra George Dumas riferisce di un tal Victor, capitano dell’esercito francese e appartenente a una famiglia tradi zionalmente legata al culto della gioire e della patrie, .il quale nei suoi eccessi maniaci si abbatteva al suolo, ventre a terra, gridando: «A me il granito! », alzandosi poi lentamente e guardando intorno a sé con aria di sfida. Interrogato successivamente dal Dumas du rante un periodo di remissione, gli rese questa spiegazione: «Sì, mi ricordo: era per me una manifestazione di spirito patriottico, un appello alla vecchia terra francese, riboccavo di amor patrio e desi deravo farne mostra». Un’altra volta il capitano Victor accolse il Dumas ruggendo come un leone è roteando furiosamente gli occhi. Ecco la sua spiegazione successiva: «Sì, è così, era in onore di mio padre, ufficiale prima di me nell’armata d’Africa. Ruggendo come un leone africano credevo di incarnare il patriottismo della nostra famiglia, quello di mio padre ed il mio: oggi però la dimostrazione mi sembra debole». In altra occasione il capitano Victor aveva detto al Dumas che cercava di sentirgli il polso: «Prendi la mia pelle, se vuoi!» Spiegazione successiva: «Era il sacrificio della mia vita che io offrivo al mio paese». È sin troppo evidente che, in un caso come questo, determinati valori culturali come la gioire e la patrie stanno nel contesto in modo del tutto apparente e strumentale: ciò che predomina è la pura accelerazione vitale che si scatena senza nessun rapporto con la reale situazione del momento, dandosi a pretesto i vuoti nomi di valori politici e morali.
j 6
C A P IT O L O P R IM O
3. La vita religiosa come tecnica protettiva mediatrice dì valori Per quanto la crisi della presenza non abbia in sé storia cultu rale (essa è infatti per definizione la destorificazione della presenza, il non esserci in una storia umana), il numero, la qualità e l’inten sità dei momenti critici a carattere pubblico è determinabile solo per entro concrete società storiche. In società in cui il distacco dalle condizioni naturali non va oltre la caccia e la pesca ed alcuni strumenti litici, o in cui il regime economico si è sollevato dall’a gricoltura primitiva alla zappa o alla pastorizia o alla agricoltura dell’aratro, la sfera dei momenti critici è di fatto intensissima ed amplissima appunto perché ciò che passa senza e contro l’uomo si manifesta in una misura che noi a malapena riusciamo ad imma ginare, abituati come siamo all’ordine cittadino della moderna civiltà industriale. Nelle società primitive e nel mondo antico l’arco della vita individuale nel quadro della vita collettiva è disseminato di rischi esistenziali che per noi hanno perso ogni significato: rin contro con animali pericolosi, l’ attraversamento di paesi scono sciuti e selvaggi, l’incerto esito della caccia da cui dipende per intero il destino alimentare della comunità, la perdurante scomparsa della selvaggina che insieme alle radici costituisce l’unica base di regime dietetico, le vicende meteorologiche sfavorevoli che aprono per il gruppo sociale una prospettiva di morte per affamamento, la sic cità che inaridisce i pascoli e uccide l’unica ricchezza del bestiame, le grandi e frequenti epidemie sterminatrici costituiscono altret tante esperienze critiche di cui la moderna civiltà industriale ha perduto quasi la memoria. Restano per noi in comune con le civiltà primitive e con il mondo antico l’esperienza critica della morte della persona cara e delle fasi della evoluzione sessuale (sulle quali è merito della psicoanalisi aver richiamato l’attenzione), o l’insor gere delle grandi catastrofi naturali o delle malattie mortali; senza contare i momenti critici che sono connaturati alla civiltà capitali stica come tale (le crisi economiche e le forme spietate di sfrutta mento), o all’ atrocità delle guerre moderne, o al crudo dispotismo degli stati dittatoriali capitalistici o socialistici che siano. Ma nel complesso il nostro incommensurabilmente più alto distacco dalle condizioni naturali e l’ampiezza delle realizzazioni civili in tutti
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
37
i domini, e gli abiti morali e le persuasioni razionali che ne abbiamo acquistato, ci fanno molto più preparati a superare i momenti cri tici dell’esistenza, patendo senza dubbio il rischio di non esserci ma non più nei modi così estremi che nelle civiltà primitive e nel mondo antico minacciano di continuo la vita dei singoli e quella della comunità. Infatti nelle.civiltà primitive e nel mondo antico il rischio della presenza assume una gravità, una frequenza e una diffusione tali da obbligare la civiltà a fronteggiarlo per salvare se stessa. Nelle civiltà primitive e nel mondo antico una parte con siderevole della coerenza tecnica dell’uomo non è impiegata nel dominio tecnico della natura (dove del resto trova di fatto appli cazioni ancora limitate), ma nella creazione di forme istituzionali atte a proteggere la presenza dal rischio di non esserci nel mondo. Ora l’esigenza di questa protezione tecnica costituisce l’o r i g i n e della vita religiosa come ordine mitico-rituale. Già vedemmo come il rischio della presenza sia essenzialmente costituito da una destorificazione irrelativa che si manifesta in vari modi di inautenticità esistenziale. Il carattere fondamentale della tecnica religiosa sta nel contrapporre a questa destorificazione irre lativa una destorificazione istituzionale del divenire, cioè una desto rificazione fermata in un ordine metastorico (mito) col quale si entra in rapporto mediante un ordine metastorico di comporta menti (rito). Con ciò è offerto un orizzonte per entro il quale si compie la ripresa delle possibili alienazioni individuali e la loro riplasmazione nei valori culturali. Il carattere dialettico del nesso che lega il rischio della perdita della presenza e la sfera del sacro è illustrato con particolare evidenza da un’opera che ha avuto una notevole efficacia nel dominio della filosofia e della storia delle religioni: il Sacro di Rudolf Otto.23 Si tratta, com’è noto, di un’o pera religiosamente impegnata, e tuttavia proprio per questo capace di fornirci indicazioni preziose sul nesso in questione. Naturalmente ad un patto: che la problematica cominci per noi proprio lì dove Rudolf Otto ritiene di aver raggiunto l’ultima Thule, cioè l’espe rienza viva del nume che è presente. La connotazione caratteri stica, profondamente irrazionale, di questa presenza del nume 23 R. Otto, Das Heilige. Ober das Inatìonale in der Idee des Gòttlichen und sein Verhàltniss zum Rationalen ( i a ed. 19 17 ; i 8 a ed. 1929).
38
C A P IT O L O P R IM O
sarebbe, secondo l’Otto, il «radicalmente altro» e quindi il blinde Entsetzen, il dàmoniscbe Scheu che in cospetto del nume si impa dronisce della presenza, soggiogandola. Ora questo «radicalmente altro» che sgomenta chi ne fa esperienza è appunto il rischio radi cale di non esserci, l’alienarsi della presenza. L ’alterità profana è sempre relativa, inserita nel circuito formale, qualificata: ma quando comincia a diventare eccentrica, a isolarsi, e la presenza non è più capace di mantenerla come altra, e di conservare il proprio mar gine rispetto ad essa, allora comincia ad apparire quel carattere «radicale» deU’alterità che è da interpretare come segnale della crisi della presenza. Anche il blinde Entsetzen è eloquente: entset zen ha il duplice significato di «spossessare» e di «inorridire» o «essere pieno di raccapriccio», il che significa che qui si sta per consumare la perdita dell’energia formale, e appunto da tale spossessamento radicale nasce l’orrore caratteristico che individua la crisi. Ma il carattere dialettico del rapporto crisi-ripresa dell’espe rienza del sacro è illustrato altresì dall’espressione dàmoniscbe Scheu·. infatti se l’accento batte su Scheu si ha qualche cosa di praticamente identico a un puro stato ansioso, al blinde Entsetzen patolo gico, mentre se l’accento batte su dàmoniscbe allora già la ripresa comincia a fare le sue prove, sia pure in modo elementare, e l’or rore non sarà più «cieco» se almeno riesce a scorgere un’imma gine demoniaca o numinosa, partecipe di una tradizione culturale mitico-rituale organicamente inserita nel mondo storico nel quale si vive, e aperta al v a 1 o r e. Considerazioni analoghe possono farsi a proposito dell’altro momento polare del numinoso, il fascìnans. La paradossia di questa polarità non costituisce affatto un nesso misterioso, da rivivere nella sua immediatezza, ma racchiude una trasparente dialettica: ciò che nella crisi repelle e soggioga, il tremendum dell’alienarsi e del perdersi della presenza, tuttavia attira e chiama al rapporto, alla ripresa, alla reintegrazione nell’umano, e questo attirare o chiamare in modo perentorio è il fascinans del radicalmente altro. Nella limitazione dell’esperienza religiosa ciò che chiama è il nume, ma per il pensiero giudicante ciò che chiama è l’alienazione della presenza che reclama reintegrazione in una storia umana. O anche: è il non deciso, l’ambivalente, che esige decisione nel valore. La differenza tra l’ambivalenza patologica e quella religiosa sta unicamente nel segno del movimento per entro
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
39
il quale essa si manifesta: l’ambivalenza patologica è sintomo di una disgregazione che va recedendo verso modi sempre più com promessi, onde sta in modo irrisolvente in un regresso che distacca sempre più la presenza dalla realtà storica e che sempre più si chiude al significato e al valore che in quella realtà possono essere ricono sciuti; l’ambivalenza religiosa invece è inserita in un movimento di ripresa e di reintegrazione, che dalla crisi si solleva al valore, e che perciò va mediatamente ristabilendo col mondo storico i rap porti in pericolo. O anche: nella malattia l’ambivalenza prospetta una destorificazione irrelativa in atto, un compito di decisione e di scelta al quale si abdica, un non esserci in nessuna possibile sto ria umana; nella vita religiosa l’ambivalenza è già il numinoso, immagine mitica aperta al valore, rapportabile all’umano mediante il rito, inserita nella tradizione culturale: in ultima istanza è un ambivalente che va decidendo il suo valere. In un modo o nell’al tro l’ambivalente religioso è incluso in un processo che ferma nella metastoria mitica l’alienazione irrelativa della crisi e che realizza la reintegrazione del divino nell’umano. Ma il sacro manifesta la sua coerenza tecnica anche in altro modo: in quanto nesso mitico-rituale esso maschera il divenire sto rico nella iterazione rituale di modelli mitici in cui su un piano metastorico il mutamento è ammesso e al tempo stesso reintegrato: ne nasce così un particolare regime di esistenza protetta, nel cui ambito per un verso si entra in rapporto con le alienazioni della crisi, mentre per un altro verso si inaugura una dinamica che sospinge alla riconquista delle forme di coerenza culturale a vari livelli - storicamente determinati - di autonomia e di consapevo lezza. Questa dialettica di ripresa e reintegrazione dei rischi di alie nazione è caratterizzata dalla coerenza tecnica della destorifica zione mitico-rituale che si fa mediatrice del ridischiudersi delle altre forme di coerenza culturale, dall’economia all’ordinamento sociale, giuridico e politico, al costume, all’arte e alla scienza. Il concetto di sacro come tecnica mitico-rituale che protegge la presenza dal rischio di non esserci nella storia e media il ridi schiudersi di determinati orizzonti umanistici consente di consi derare sotto una nuova luce la vexata quaestio del rapporto fra magia e religione. Senza dubbio ogni forma di vita religiosa, in quanto fondata sulla destorificazione mitico-rituale, comporta un momento
40
CAPITOLO PRIMO
tecnico insopprimibile, che ne costituisce la sfera più propriamente magica; d’altra parte la tecnica magica più rudimentale, quando sia dotata di vitalità storica e organicità culturale, non si esaurisce mai nel semplice tecnicismo, ma media e dischiude un determi nato orizzonte umanistico, più o meno angusto. In tal guisa l’op portunità di considerare come magica o come religiosa una parti colare forma storica del sacro dipende soltanto dal grado relativo di sviluppo e di complessità del processo di mediazione dei valori che in quella forma ha luogo: quando prevale il momento tecnico della destorificazione mitico-rituale e l’orizzonte umanistico che ne risulta è particolarmente angusto (ma non mai inesistente!) il termine magia può sembrare più appropriato, quando invece rito e mito sono profondamente permeati di valenze morali, specula tive, estetiche ecc. allora la designazione di religione è certamente più opportuna. In sostanza il concetto di magia ha origine nella polemica culturale, allorché si prende a negare che una certa reli gione enuclei valori, e se ne avverte soltanto il momento mera mente tecnico: nel discorso storiografico la qualifica di magia ritiene un significato legittimo solo in senso comparativo, cioè per indi care una forma di vita religiosa in cui lo sviluppo del momento tecnico è relativamente esteso e l’orizzonte umanistico dischiuso relativamente angusto: il che del resto è ampiamente confermato dall’uso linguistico corrente, malgrado gli elementi di confusione che vi hanno introdotto alcuni falsi teorizzamenti della scienza e della storia delle religioni. Piuttosto è da mettere in guardia gli storici delle religioni da un altro uso linguistico, che poi racchiude a vari livelli di coscienza e di coerenza una determinata teoria della vita religiosa: alludiamo all’uso di estendere il nome di religione (o di «religiosità») a qualsiasi impegno etico fortemente sentito anche se accompagnato da un orizzonte esclusivamente umanistico e mondano. Per ricordare l’esempio più illustre del genere si pensi al capitolo che apre la Storia d'Europa del Croce, e che si intitola «La religione della Libertà», dove si ritrova anche la seguente giu stificazione teorica dell’impiego della qualifica di «religione» a pro posito dell’ideale liberale consustanziale al moderno pensiero dia lettico e storico: «Ora chi raccolga e consideri (i tratti) dell’ideale liberale, non dubita di denominarlo, qual esso era, una “ religione” : denominarlo così, beninteso, quando si attenda all’essenziale ed
CRISI DELLA PRESENZA E CRISI DEL CORDOGLIO
41
intrinseco di ogni religione, che risiede sempre in una concezione della realtà e in un’etica conforme, e si prescinda dall’elemento mitologico, per il quale solo secondariamente le religioni si diffe renziano dalle filosofie» (pp. 23 sg.). Ora l’essenziale e l’intrin seco di ogni religione sta, come si è detto, proprio nella destorifi cazione mitico-rituale come tecnica mediatrice di determinati orizzonti umanistici, e pertanto mal si attaglia la qualifica di reli giosa ad una concezione essenzialmente laica della vita e del mondo. Nei nostri studi poi, un concetto di religione come quello formu lato dal Croce può introdurre soltanto una serie di equivoci, o quanto meno vale a restringere il compito dello storiografo sol tanto a quel settore circoscritto che è l’enuclearsi della «visione del mondo» dal mito, lasciando fuori della considerazione proprio la ierogenesi come tecnica, e decurtando e oscurando in tal modo il processo dialettico della vita religiosa così come è stato qui som mariamente delineato. Se tuttavia è da respingere la tendenza panlogistica che risolve la religione in una sorta di philosophia inferior, non è nemmeno da accogliere l’esigenza irrazionalistica di un’autonomia formale della vita religiosa. La religione, ove sia intesa correttamente come nesso mitico-rituale, non è un λ priori: il tentativo di Rudolf Otto di completare le tre critiche kantiane con una quarta attinente al «sacro» deve considerarsi fallito. A priori però è certamente la potenza tecnica dell’uomo, sia che si volga al dominio della natura con la produzione dei beni economici, con la fabbricazione di stru menti materiali e mentali del pratico agire, sia che invece si volga ad impedire alla presenza di naufragare in ciò che passa senza e contro l’uomo. Sulla linea di questo secondo impiego della potenza tecnica si trova la religione, che resta definita dal carattere parti colare del suo tecnicismo, cioè dalla ripresa e dalla reintegrazione umanistica dei rischi di alienazione mediante la destorificazione mitico-rituale. La risoluzione tecnica della vita religiosa non è cer tamente nuova, se già Platone in un passo famoso del Fedone non esitava a considerare il mito delle anime dopo morte come un incan tesimo che giova fare a se stessi. Tale risoluzione tecnica presenta il vantaggio di orientare lo storico verso ciò che di specificamente mitico è nel mito e di specificamente rituale è nel rito, senza cedere alla tentazione di considerare soltanto le valenze etiche o specula
CAPITOLO PRIMO
42
tive o estetiche della vita religiosa, e senza d’altra parte postulare nel sacro una irrazionalità destinata a sfuggire al pensiero storiogra fico come tale. Il sacro, in quanto tecnica, è c o e r e n z a u m a n a , che il pensiero storiografico può ripercorrere senza lasciare pro prio nessun residuo all’immediatezza (e all’arbitrio) di un mistico rivivere. Si tratta certamente di una coerenza diversa da quella dell’arte, o della filosofia o della moralità dispiegata e consape vole di sé: ciò che qui si nega è che non gli sia immanente nessuna forma di razionalità, e che racchiuda un nucleo «irrazionale» irri ducibile, tale da indurre il pensiero storico alla contraddittoria fatica di uscire da se stesso e dalla storia umana.24
4. La crisi del cordoglio La crisi del cordoglio si presenta, nel quadro delle precedenti considerazioni, come il rischio di non poter trascendere il momento critico della situazione luttuosa. La perdita della persona cara è, nel modo più sporgente, l’esperienza di ciò che passa senza e con tro di noi: ed in corrispondenza a questo patire noi siamo chia mati nel modo più perentorio all’aspra fatica di farci coraggiosa mente procuratori di morte, in noi e con noi, dei nostri morti, sollevandoci dallo strazio per cui «tutti piangono ad un modo» a quel s a p e r piangere che, mediante l’oggettivazione, asciuga il pianto e ridischiude alla vita e al valore. Tuttavia quest’aspra fatica può fallire: il cordoglio si manifesta allora come crisi irrisolvente, nella quale si patisce il rischio del progressivo restringersi di tutti i possibili orizzonti formali della presenza. La crisi del cordoglio, come si è detto, appartiene alla condi zione umana: tuttavia la civiltà moderna l’ha di molto ridotta di intensità e di pericolosità, fornendole il soccorso di tutta l’energia morale maturata nel vario operare civile, e - per i credenti - con tenendola e lenendola mercé la prospettiva delle consolanti per suasioni della religione cristiana. Nel mondo antico (per tacere 24 Sul concetto di sacro, vita religiosa, destorificazione mitico-rituale, e sui rapporti fra religione e magia, e fra religione e storiografia religiosa ci permettiamo rinviare alle nostre due monografie Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, Aut-Aut (1955) n. 3 1 , e irrazionalismo e storicismo nella storia delle religioni, Studi M at. Stor. Rei., voi. 28, n. 1, 89 sgg. (1957).
CRISI DELLA PRESENZA E CRISI DEL CORDOGLIO
43
naturalmente delle civiltà primitive) la crisi del cordoglio assume invece ordinariamente, sia nell’individuo che nella collettività, modi estremi che hanno riscontro nella nostra civiltà solo in casi indivi duali eccezionali e palesemente morbosi, e più diffusamente appena in quelle poche aree folkloriche che per certi aspetti riproducono ancora condizioni di esistenza in qualche modo simili a quelle del mondo antico. Così ove prescindiamo dalla risoluzione poetica di Omero, la crisi di Achille per la morte di Patroclo si manifesta in modi «eccessivi» che noi oggi non saremmo disposti a conce dere a un uomo «normale», e che possiamo al più tollerare con varia disposizione d’animo nelle contadine dell’Italia meridionale o della penisola balcanica. Tuttavia noi qui dobbiamo analizzare proprio i modi «eccessivi» della crisi del cordoglio, cioè il rischio che essa comporta quando tocca per così dire il fondo. Quando la caduta della potenza oltrepassante consuma sino in fondo il suo rischio, la contraddizione esistenziale in cui la presen za si irretisce assume il modo estremo dell’a s s e n z a t o t a l e e del l a d e g r a d a z i o n e d e l l ’ eidos del l a p re s e n z a nella s c a r i c a m e r a m e n t e m e c c a n i c a di e n e r g i a p s i c h i c a . In generale la situazione luttuosa è tale solo nell’atto o nel tenta tivo del trascendimento formale, e d’altra parte la presenza si distacca da questa situazione, e si costituisce come presenza, nella misura in cui va dispiegando lo sforzo del trascendimento. Ciò signi fica che nel crollo completo della potenza oltrepassante la situa zione luttuosa si rescinde e scompare per la presenza, la presenza dilegua nel contenuto critico che non riesce a gettare davanti a sé come «oggetto» qualificato e lo stesso ethos del trascendimento si va annientando nel meccanismo convulsivo. Di tale assenza totale in cospetto dell’evento luttuoso rendono frequente testimonianza, in via di esempio, le Chansons de geste, dove le dame e i cavalieri, ma talora lo stesso re Carlo, se pasment in presenza del cadavere o per notizia di morte, cioè «perdono la presenza» nella forma del l’assenza totale: la perdono Sebille alla morte del marito Baudoin (quant Sebille l ’antant, li sans li est muez, I la véue lui troble, si a les danz serrez, I contre tene se pasme, ne peut sor piez ester), Carlo alla morte del figlio Lohier (Come Charles l ’entent, si ne set que il die, I il est cheiis pasmés devant sa baronie, I si qu’il ne pot parler d ’un lieu et demi), i cavalieri di Aymeri alla morte del loro signore (ςα et
CAPITOLO PRIMO
44
la gisent li chevalier pasmé), centomila franchi alla morte di Rolando 0cent m ilie frane s ’en pasment contre tere) P L ’assenza totale rappresenta il limite estremo della crisi del cor doglio: ma al di qua di tale limite stanno tuttavia determinate inau tenticità esistenziali della presenza, caratterizzate dal recedere verso l’assenza, e dall’irrisolvente patire e dibattersi per questo recedere. Sulla linea di tale recessione, ma al di qua del suo termine estremo, si trova uno stato psichico che in concreto può manifestarsi con varie sfumature individuali, ma che tipologicamente resta definito da una ebetudine stuporosa senza parola e senza gesto, e senza anamnesi della situazione luttuosa: uno stato simile, designato dal comune linguaggio con la espressione «impietrito (o folgorato o rag gelato) dal dolore», si riflette - com’è noto - nel mito di Niobe. Si tratta però di una calma inautentica, funesta e minacciosa, e di una instabile smemoratezza, che da un momento all’altro può rom persi in un planctus irrelativo, cioè in un comportamento orientato ad arrecare offese anche mortali alla propria integrità fisica. Questa polarità di ebetudine e di planctus denunzia una crisi profonda nella quale in luogo della decisione formale si instaura la paradossia estre mamente contraddittoria di un «non fare per farsi vuoti di conte nuto», ovvero di un furore che annienta materialmente quella pre senza che sarebbe invece chiamata ad oltrepassare formalmente la situazione. In particolare nel planctus il furore autodistruttivo si accompagna al sentimento patologico di una miseria o anche di una colpa smisurata che può ricevere nella coscienza varie moti vazioni fittizie, ma che in realtà nasce dall’esperienza critica di non potersi dare nessuna motivazione reale secondo valore, e di chiudersi nella situazione invece di oltrepassarla. Appena un po’ al di qua di questa irrisolvente polarità di ebetudine e di planctus sta la sgomenta coscienza di essere immerso in tale polarità e di non poterla padroneggiare. Al senso angoscioso del duplice rischio di cadere ηεΙΓάμηχανία o nel caotico κοπετός si ispirano le parole di Admeto al ritorno dai funerali di Alcesti: «Ahimè, ahi hai, I Dove andare? Dove stare? I Che dire? Che tacere? I Come morire?...»2526 25 Cfr. O. Zimmermann, Die Totenklage in den altfranzóùschen Chansons de geste (Berlino
1899) pp. 9 sgg. 26 Eur., A le., vv. 861-864.
CRISI DELLA PRESENZA E CRISI DEL CORDOGLIO
45
Del pari nelle Troiane Ecuba che giace a terra annientata, prima di inaugurare la lamentazione pronunzia analoghe parole di smar rimento: «Che debbo tacere? I Che cosa non tacere? I Su che la mentarmi...»27 Nella carenza dell’energia formale della presenza i tentativi di ripresa si risolvono in vani conati, in trascendimenti impropri, in cui la vitalità prevarica la funzione formale che non le può mai spettare: così il «far morire i morti in noi», che è un faticoso pro cesso interiore e ideale, si può manifestare nella modalità più impro pria, cioè nell’aggressività contro il cadavere, o nel bisogno di ven dicare il morto con una nuova uccisione operata su altri, o con l’insorgenza di un indiscriminato furore distruttivo; l’interioriz zazione del morto mercé dell’appropriarsi della sua opera per con tinuarla ed accrescerla si può degradare nell’incorporazione mate riale della necrofagia o della fame insaziabile; il compito di instau rare con colui che non è più un nuovo rapporto affettivo alimen tato da una benefica memoria può cedere il luogo all’erotismo della necrofilia; e infine l’esigenza di una ripresa formale in genere può dar luogo soltanto a modi meramente vitali di recupero, con l’esal tazione di impulsi aggressivi, o alimentari o erotici. In tutti questi casi lo scacco del trascendimento è palese: si cerca la scelta oltre passante secondo valore e si trova invece la contraffazione del com pito formale sul piano improprio della vitalità, si tenta di svolgere Vethos del trascendimento ed invece si mette in moto il furore, la fame e la libidine. Un’altra serie di sintomi di crisi si riferisce più particolarmente al centro della situazione luttuosa, cioè al cadavere. In effetti lo scandalo di tale situazione, la sua pietra d’inciampo e il suo segno di contraddizione, è costituito dal cadavere, dalla spoglia corpo rea che, dopo il trapasso, sta davanti ai sopravvissuti. Nella misura in cui abdica la potenza oltrepassante della presenza il cadavere comincia ad «andar oltre» in modo irrelativo: e il suo «oltre» irre lativo riflette il rischio della stessa potenza oltrepassante che invece di «andar oltre» alle rappresentazioni relative a questo suo conte27 Eur., Troiane, vv. n o sg. Nella ripresa istituzionale del lamento funebre questo momento di smarrimento è diventato spesso un modulo: per esempio, ite nato? It’ispero? (che dico, che spero?) nel lamento funebre sardo o come voggbie fa? come aggbia fa ? (cosa fare?) del lamento funebre lucano.
46
C A P IT O L O P R IM O
nuto, oggettivandole nel valore, comincia essa stessa a diventare il vuoto oltre, e quindi la crisi, dell’oggetto. È possibile dedurre, assumendo questo criterio ermeneutico, le varie esperienze mor bose che nascono dal rapporto non autentico col cadavere in quan to centro emozionale della situazione luttuosa. Il cadavere appare una «estraneità radicale»: infatti esso tende a sottrarsi alla potenza formale, e il suo «oltre» - che solo per entro il rapporto formale si determina - sta diventando «vuoto». Il cadavere appare una «forza»: infatti, per mancanza di determinazione, i suoi limiti sono entrati in travaglio, e vanno forzando il rapporto senza trovarlo. Il cadavere è una forza «ostile»: infatti esso, come oggetto in crisi, rispecchia l’alienarsi della stessa energia oggettivante, il che è l’ostile ed il funesto per eccellenza. Il cadavere «contagia»: infatti, nel suo andar oltre irrelativo e senza soluzione, comunica caoticamente il proprio vuoto ad altri ambiti del reale, e al tempo stesso i più disparati ambiti del reale, con progressione minacciosa, spiano l’oc casione più accidentale per farsi simbolici rispetto al cadavere, e per ripeterlo in una eco multipla senza fine. Il cadavere «torna come spettro»: infatti esso sta nella crisi dei sopravvissuti come contenuto in cui la presenza è rimasta impigliata e prigioniera, onde torna a riproporsi in modo inautentico nell’estraneità e nella indominabilità della rappresentazione ossessiva o dell’allucinazione. Il cadavere è «ambivalente», si dibatte per i sopravvissuti nella infe conda polarità di repulsione e attrazione: infatti il suo scandalo respinge in quanto centro di crisi e di dispersione, ma al tempo stesso comanda perentoriamente il rapporto, in una vicenda irri solvente. E infine la stessa attrazione, nella carenza della decisione formale, finisce col convertirsi nell’esperienza del cadavere che mali gnamente «attira a sé i vivi»: infatti il cadavere, come oggetto in crisi, non soltanto non mantiene le distanze rispetto agli altri og getti, ma non rispetta neanche la distanza rispetto alla presenza, e incombe su di essa catturandola e trascinandola via con sé, come Glauca morta il padre Cleonte, allorché esso volle sollevarsi dalla cara spoglia: ... Quando ebbe finito di piangere e di singhiozzare, volle risollevare il suo vecchio capo. Ma come l’edera ai rami d ’alloro, restò preso nel peplo leg gero: cercava di rimettersi in piedi, ed essa, in senso inverso, lo tratteneva. Tirava con violenza? Le sue vecchie carni si strappavano dalle ossa. Infine
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
47
vi rinunciò e rese l’anima, impotente ad aver ragione della sciagura. Giac quero morti la figlia e il vecchio padre, lato a lato - catastrofe fatta per ali mentare il pianto.28
Infine la crisi della presenza in occasione del cordoglio può assu mere i modi di un delirio di negazione dell’evento luttuoso: senza compiere il necessario lavoro di interiorizzazione del morto e di tra scendimento dell’evento luttuoso la presenza malata cerca di instau rare un comportamento c o m e s e il morto fosse ancora in vita, concentrando magari su un qualsiasi surrogato l’organizzazione del proprio delirio. In una certa misura ciò può accadere anche nel normale lavoro del cordoglio, come provano gli infiniti espedienti cui talora si ricorre per cancellare o attenuare l’asprezza dell’inac cettabile «mai più» e per guadagnare il tempo necessario a com piere il distacco e la risoluzione degli affetti che il morto aveva mobilitato in noi quando era in vita. Ma se il lavoro del cordoglio riesce, questi espedienti stanno nella dinamica del periodo di lutto appunto come strumenti di distacco e di risoluzione, e quindi come tecniche di riadattamento alla realtà storica, che alla fine sarà accet tata e riconosciuta come dolce e benefico ricordo velato di mesti zia. Al contrario nei patologici deliri di negazione ciò che dovrebbe funzionare come strumento tecnico di riadattamento diventa cen tro di organizzazione di tutta la vita psichica, inerzia e pigrizia in cui ci si adagia, argomento di progressivo distacco dalla realtà; e ancorché può sembrare che talora si tratti degli stessi espedienti adoperati nel lavoro efficace, la considerazione della dinamica in cui sono inseriti ci rende avvertiti che il segno nei due casi è oppo sto, e che i valori della vita umana nel primo caso si stanno dram maticamente ridischiudendo, e nel secondo si stanno dileguando. In ultima istanza in questi deliri di negazione si avverte che la pre senza non risolve la situazione luttuosa, ma semplicemente l’ha perduta, e non vi spende intorno nessun lavoro produttivo. Ciò appare particolarmente evidente in quelle ancor più gravi crisi in cui tutta la situazione luttuosa è colpita da un patologico oblio, e la presenza riemerge dalla rescissione in modo apparente onde nasce una inautenticità esistenziale nella quale la presenza si dibatte divisa fra la perdita dell’attualità del reale e il ritorno irrelativo 28 Eur., Medea, w . 1205-20.
48
C A P IT O L O P R I M O
del passato rescisso, il quale torna nel modo più inautentico, cioè senza appartenere alla stessa presenza, e quindi senza poter essere ripreso nella dinamica del «far passare». Ad illustrazione di que sto stato morboso basterà ricordare una malata di Janet che dimen ticò tutti i particolari relativi alla malattia, alla morte e alla inu mazione della madre, e che dal momento della amnesia smarrì l’attualità del reale e la possibilità di inserirsi in esso con azioni adatte: al tempo stesso l’evento luttuoso rescisso tornava, con le memorie relative, nel corso di crisi periodiche in cui la malata mimava le scene obliate come se ancora si trovasse a viverle, cioè come se appartenessero al presente e non al passato: poi, conclusa la crisi che aveva bruscamente interrotto la vita psichica, le scene e la situazione luttuosa erano di nuovo dimenticate.29
5. Di alcune teorie psicologiche del cordoglio Nel complesso la moderna psicologia non ha dedicato alla crisi del cordoglio tutta l’attenzione che sarebbe stata desiderabile, in parte perché nel mondo moderno la crisi del cordoglio non pre senta aspetti così pericolosi come nel mondo antico (per tacere delle civiltà primitive), ed in parte perché è sembrato che l’evento lut tuoso come tale non giustifichi una considerazione psicologicamente unitaria, potendo occasionare a seconda delle disposizioni indivi duali le più diverse nevrosi o psicosi. Tuttavia la moderna psico logia ha talora toccato il problema del cordoglio e delle reazioni anormali alla morte della persona cara. Pierre Janet interpreta la crisi del cordoglio come il prodotto della necessità di sopprimere un certo numero di condotte ormai non più impiegabili verso la persona morta, e di instaurare nuovi comportamenti che tengano conto del fatto della morte: ora questa soppressione e questa instau razione comporterebbero un lavoro, che può non riuscire, in quanto o si continua ad agire come se il morto fosse ancora in vita o si perde troppo presto la memoria dell’evento luttuoso, per improv visa amnesia.30 Questa interpretazione della crisi del cordoglio PP·
29 La descrizione del caso si trova in P. Janet, L ’état meritai des bystérìques (3* ed. 1923) sg. 30 P. Janet, De l'angoìsse à l ’extase, voi. 2, pp. 350, 367; cfr. p. 28 1.
55
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
49
non offre nessun criterio sicuro per distinguere il lavoro che rie sce da quello che fallisce: è infatti vero che durante il periodo di lutto, e anche oltre, hanno luogo comportamenti che ritardano o cercano di variamente attenuare il pieno riconoscimento della morte, come stanno a testimoniare non foss’altro i riti funerari di tutte le epoche, e i miti dell’al di là e del mondo dei morti, ma tale «ritardo» non costituisce in sé malattia se attraverso di esso si facilita il compito di «far morire i nostri morti in noi». D ’altra parte l’amnesia improvvisa dell’evento luttuoso non è patologica perché l’oblio si produce «troppo presto», e l’arresto concerne un numero «eccessivo» di atti, ma perché la situazione è rescissa dal l’orizzonte della presenza senza che sia stato compiuto il lavoro di interiorizzazione e di risoluzione che è proprio del cordoglio. In ogni caso il giudizio non è quantitativo, ma qualitativo, cioè concerne l’effettivo «passare nel valore» che si compie attraverso il cordoglio come lavoro: e qualsiasi ritardo non sarà mai ecces sivo né qualsiasi anticipo prematuro (cioè non si tratterà né di ritardo né di anticipo, ma semplicemente del tempo giusto) se l’uno o l’ altro ridischiuderanno gradualmente il vario operare culturale compromesso dalla crisi. D ’altra parte proprio il Janet, a propo sito della malata già precedentemente ricordata, e nel tentativo di spiegarne il comportamento patologico che abbiamo sommaria mente descritto, mette in rilievo come il tratto morboso più saliente fosse l’arresto della personalità alla situazione luttuosa, e la suc cessiva incapacità di «accrescersi per aggiunzione e assimilazione di elementi nuovi»:31 il che significa che la crisi del cordoglio è tale nella misura in cui spezza la «durata» della vita spirituale, asser vendola alla tirannia di uno stato psichico isolato che sta senza fluidità e che è fonte di inautenticità esistenziale. Relativamente più impegnata e complessa di quella del Janet è la teoria psico analitica del cordoglio, che fu inaugurata dal Freud nel suo scritto Lutto e melanconia (1915). Il Freud volle scorgere una differenza fra il cordoglio e la melancolia per il fatto che «mentre nel cordo glio è il mondo ad essere povero e vuoto, nella melancolia lo è l’io stesso».32 Una seconda differenza starebbe nel fatto che mentre 31 Janet, L ’état mentale des bystérìques, p. 82. 32 Freud, Ges. Scbr.t voi. 5, p. 538.
C A P IT O L O P R IM O
50
il cordoglio si riferisce «alla perdita cosciente di un oggetto amato» la melancolia è in rapporto con una perdita «che si sottrae in qualche modo alla coscienza».53 Ciò posto, il lavoro compiuto dal lutto consisterebbe nel distacco dell’energia libidica dall’oggetto perdu to, e nel reimpiego di tale energia per nuovi investimenti: ora il distacco e il reimpiego possono non riuscire, e la libido può restar legata al vecchio oggetto, che più non esiste, determinando una separazione dalla realtà e una psicosi allucinatoria del desiderio.34 Nella melancolia invece la perdita dell’oggetto amato (che non è necessariamente una morte fisica, ma in generale una impossibi lità di fatto di continuare il rapporto con l’oggetto amato) costringe la libido ad abbandonare l’oggetto, e a ritirarsi nell’io: qui però, in mancanza di impiego, la libido toglie a suo oggetto l’io stesso, con la conseguenza che la perdita dell’oggetto si tramuta nella per dita nell’io, e che l’abbassamento e l’avvilimento dell’io sta in luogo dell’abbassamento e dell’avvilimento dell’oggetto perduto, dell’i dolo infranto: come dice Freud « l’ombra dell’oggetto si distende nel soggetto».35 La melancolia, al pari del cordoglio, svolge un la voro per liberare la libido dal legame con l ’oggetto amato, renden dola disponibile per nuovi impieghi: ma mentre nel cordoglio tale lavoro si svolge prevalentemente nella sfera della coscienza e man tiene la distinzione fra io e oggetto perduto, nella melancolia il processo di distribuzione e di svalutazione si svolge nell’inconscio, finché le cariche libidiche, al termine del processo, ridiventano libere dando luogo all’accesso di mania.36 Questa prima interpre tazione del Freud subì successivamente alcune modificazioni, nel senso che le differenze fra cordoglio e melancolia furono in parte attenuate e in parte diversamente atteggiate. Fu osservato che anche nel cordoglio, al pari che nella melancolia, aveva luogo l’identifi cazione con l’oggetto amato e perduto, come quando i sopravvissuti riproducono - nel gesto, nell’inflessione della voce, nell’uso di determinate frasi e simili - particolarità anche minime del com portamento che già appartennero al defunto: tali identificazioni sono da interpretarsi come forme di consolazione della perdita ” lbid. 34 lbid., p. 537. 35 lbid., p. 542. 36 lbid., pp. 552 sg.
C R I S I D E L L A P R E S E N Z A E C R I S I D E L C O R D O G L IO
51
patita, o anche come utilizzazione narcisistica della libido ogget tuale rimasta libera da impiego.37 Tuttavia nella melancolia la per sona appare integralmente padroneggiata dall’identificazione del l’io con l’oggetto amato e perduto, senza che alla coscienza emerga che cosa propriamente fu perduto nel mondo oggettivo, mentre nel cordoglio - a meno di una sua degenerazione melancolica non è mai del tutto smarrito il rapporto cosciente con l’oggetto, e l’identificazione immediata col morto ritiene una importanza rela tivamente limitata.38 Un ulteriore sviluppo della teoria psico analitica del cordoglio fu determinato dalla considerazione dei rituali funerari delle cosiddette civiltà primitive, e anche di quelli del mondo antico (per tacere dei relitti folklorici che in generale restarono fuori dell’interesse dei psicoanalisti): qui la differenza fra cordoglio e melancolia sembra ancor più attenuarsi, perché quei rituali mostrano in larga misura le autoaccuse, le autoflagellazioni e le autopunizioni che caratterizzano il comportamento melancolico. D ’altra parte le «vendette», le effusioni di aggressività verso l’esterno, le orgie sessuali e alimentari che chiudono il periodo di lutto richiamano la fase maniacale che segue a quella melancolica nella forma clinica della cosiddetta psicosi maniaco-depressiva. Le affinità fra cordoglio primitivo (o antico) e il quadro clinico della melancolia spinsero Géza Róheim a tentare una nuova interpreta zione del cordoglio e delle forme di depressione melancolica o di aggressività maniacale che possono accompagnarlo. Se le autoac cuse e le autopunizioni del melancolico sono originariamente dirette a un’altra persona che ora è stata identificata con l’io, le autoac cuse e le autopunizioni che hanno luogo durante la crisi del cordo glio, e che si manifestano con particolare evidenza nei rituali del mondo primitivo e di quello antico, dovevano essere con tutta pro babilità ricondotte allo stesso processo di identificazione (o di «introiezione»), A questo punto venne in soccorso del Róheim la famosa teoria freudiana dell’Urvater ucciso e divorato dai figli gelosi, misfatto che avrebbe inaugurato la storia dell’umanità. Avendo mangiato il padre, il conflitto esterno fu «interiorizzato» 37 S. Freud, Ges. Schr., voi. 6, p. 374. Cfr. K . Abraham, Obiektsverlust und Introfektion in den normalen Trauer und in abnormen psychischen Zustànden, in Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido (1924) pp. 22 sgg.; e C. Musatti, Trattato di psicoanalisi (1950) voi. 2, p. 2 7 1. 38 Abraham, op. cit., p. 27.
5*
CAPITOLO PRIMO
nei parricidi: «qualcosa in loro era divenuto padre», dando luogo a un conflitto endopsichico fra «io ideale» e «io attuale», e quindi a una fase di depressione melancolica, con relative autoaccuse e autoflagellazioni. Il conflitto fu sciolto mercé la sua proiezione all’e sterno, cioè dando sfogo alle tendenze parricide che continuavano ad operare, ma volgendole a un oggetto surrogato, cioè al nemico, che era mangiato e divorato in una spedizione guerresca. La fase maniacale chiudeva così la fase melancolica, proprio come nella psicosi maniaco-depressiva: e i rituali funerari primitivi sembra vano ad ogni morte ripetere questa vicenda, sia pure in forma abbre viata, poiché il periodo di lutto si chiudeva in essi molto spesso con una spedizione di «vendetta», o con un’orgia sessuale o ali mentare. Allo stesso modo la zoofobia e il totemismo sarebbero stati un altro modo di proiettare all’esterno, in questo caso sull’a nimale, il conflitto interno .39 Più recentemente Melarne Klein ha ripreso il problema del cor doglio al di fuori delle istanze prevalentemente etnologiche che avevano indotto il Róheim a formulare la sua interpretazione. Per la Klein ogni lutto rinnova in generale il bisogno di restaurare den tro di sé la persona amata e perduta, così come avevano già detto il Freud e l’Abraham: ma al tempo stesso ogni lutto mette in peri colo gli oggetti amati per primi - in ultima analisi i «buoni geni tori» - e pertanto obbliga a restaurare in sé anche il mondo in terno, che sta perdendo il suo equilibrio e sta andando in rovina. Il cordoglio è un lavoro che provvede a questa duplice restaura zione: ma vi provvede riattivando e ripetendo - sebbene in di verse circostanze e con diverse manifestazioni - gli stessi processi maniaco-depressivi che sono propri dell’epoca infantile. Il lavoro del cordoglio non riesce quando la persona non ha potuto stabilire nella sua infanzia i suoi interni «buoni oggetti», e affronta perciò l’evento luttuoso già in condizioni di insicurezza e di squilibrio .40 Le teorie psicoanalitiche del cordoglio hanno in comune il limite fondamentale di restare essenzialmente al di fuori della grande tra dizione culturale che riconduce il lavoro del cordoglio al «far morire 39 G . Róheim, Nach dem Tode des Urvaiers, voi. 9, 8 3 -12 1 (1923). 40 M. Klein, Conlributions to Psycbo-analysis 19 2 1-19 4 5 (Londra 1948) pp. 3 11- 3 8 (Mourning and its relation to maniac-depressive States).
CRISI DELLA PRESENZA E CRISI DEL CORDOGLIO
53
i nostri morti in noi», cioè al far passare i morti nel valore, tra scendendo con ciò la situazione luttuosa. La vicenda della libido oggettuale che nel cordoglio sarebbe impegnata a distaccarsi dal l’oggetto perduto e ad impiegarsi in un nuovo oggetto parrebbe adombrare in qualche modo ciò che abbiamo chiamato «trascen dimento della situazione luttuosa»: ma in realtà la libido (o vita lità) non va oltre la polarità del piacere e del dolore e delle corri spondenti reazioni, e Γoggettivazione secondo forme di coerenza culturale non è opera della vitalità, ma dell’eidos del trascendi mento. Anzi il chiudersi della vitalità in se stessa, la sua reces sione adialettica, costituisce il rischio del cordoglio e la minaccia di una crisi nella quale possono apparire, degradati sul piano mera mente vitale e in una vicenda impropria e irrisolvente, i compiti ai quali Vethos del trascendimento sta venendo meno: una crisi in cui il far morire ideale e interiore può scadere nell’impulso mate rialmente distruttivo, l’interiorizzazione del morto smarrirsi nel mangiare il morto, la necessità della ripresa e della liberazione degra darsi nello scoppio irrefrenabile di riso, nell’erotismo e nella fame, e infine il complesso degli scacchi del trascendimento essere avver tito come estrema abiezione e come colpa radicale. Questa critica di principio alle teorie psicoanalitiche del cordoglio ci dispensa, almeno in questa sede, dall’esaminarne le singole parti e dal discu tere il romanzo etnologico di Géza Róheim: a noi basti aver spinto la polemica quanto occorre per ribadire quella tradizione cultu rale che assegna al cordoglio il compito di trascendere nel valore la situazione luttuosa, e che interpreta la crisi come impotenza a compiere questo trascendimento. Il cordoglio come malattia non è suscettibile di nessuna storia culturale: se infatti la malattia psichica è il rischio di non potersi inserire in nessuna possibile storia umana, la crisi del cordoglio considerata nella sua astrazione è non-storia per definizione. Tut tavia la cultura nel suo complesso appresta le forze che sono a dispo sizione dell’uomo per oltrepassare il momento critico dell’evento luttuoso e per ricacciare sempre più lontano e sempre più facilmen te le tentazioni della crisi: in questo senso, e cioè come momento negativo del riscatto culturale, il cordoglio come malattia entra nella storia. Nelle antiche civiltà religiose mediterranee, prima che il
54
CAPITOLO PRIMO
Cristianesimo inaugurasse il suo nuovo ethos della vita e della morte, una delle più importanti forze culturali per combattere la crisi del cordoglio fu l’istituto del lamento funebre rituale: noi dobbiamo ora analizzare come su questo punto si determinasse nel mondo antico l’innalzarsi della cultura sull’eterna insidia della natura resa cieca del suo lume umano.
Il lamento funebre lucano
i . Giustificazione metodologica della presente indagine etnografica Può sembrare strano che una ricerca storico-religiosa sull’an tico lamento funebre rituale si apra con una sezione folklorica di notevoli proporzioni, e che l’analisi della documentazione antica sia condotta a sviluppo, a integrazione e a verifica dei risultati rag giunti in questa sezione. Ancor più strano può sembrare il fatto che alla documentazione folklorica si sia data tanta importanza da non aver esitato ad eseguire una serie di esplorazioni etnografiche dirette in un’area folklorica particolare come la Lucania. Un pro cedimento così eccezionale, e a prima vista cosi discutibile, e cer tamente bisognoso di una giustificazione metodologica. Come è stato detto, noi consideriamo il lamento funebre innanzi tutto come una determinata t e c n i c a d e l p i a n g e r e , cioè come un modello di comportamento che la cultura fonda e la tradizione conserva al fine di ridischiudere i valori che la crisi del cordoglio rischia di compromettere.Un quanto particolare tecnica del pian gere che riplasma culturalmente lo strazio naturale e astorico (lo strazio per cui tutti «piangono ad un modo»), il lamento funebre è a z i o n e r i t u a l e c i r c o s c r i t t a da u n o r i z z o n t e mi t i c o . Sempre in quanto tecnica del piangere il lamento funebre antico concorre, nel quadro della vita religiosa, a mediare deter minati risultati culturali; ciò significa che attraverso i modelli mitico-rituali del pianto sono mediatamente ridischiusi gli oriz zonti formali compromessi dalla crisi, e cioè Yethos delle memorie e degli affetti, la risoluzione poetica del patire, il pensiero della
C A P IT O L O SE C O N D O
vita e della morte, e in genere tutto il vario operare sociale di un mondo di vivi che si rialza dalle tombe e che, attingendo forze dalle benefiche memorie di ciò che non è più, prosegue coraggio samente il suo cammino. Ora le istanze documentarie di cui può giovarsi lo storico del lamento antico per ricostruire questa vicenda di liberazione sono senza dubbio molteplici. Innanzi tutto sta la documentazione antica, e cioè il copioso materiale offerto dalle letterature religiose dell’Oriente vicino, le elaborazioni poetiche che in Grecia il lamento ricevette nell ’epos, nella tragedia e nella lirica della morte, i riferimenti di scrittori, eruditi e letterati greci e romani, gli accenni indiretti della legislazione funeraria in Israele, in Grecia e a Roma, e infine l’arte funeraria così ricca, soprattutto in Egitto e in Gre cia, di scene di lamentazione. Tuttavia ai fini della ricostruzione del lamento come tecnica la documentazione antica presenta dei limiti definiti, che le integrazioni comparative non possono supe rare senza lasciare troppo margine all’immaginazione. Così i lamenti che ci ha conservato l’epos o la tragedia o la lirica della morte sono già ormai letteratura e poesia, non rito in azione, e non è agevole raggiungere il lamento come rito partendo dalla sua elaborazione letteraria e poetica. Sommari sono i riferimenti di scrittori che occa sionalmente, e da vari punti di vista, ci hanno lasciato qualche noti zia sull’argomento, e ancor più sommari i dati della legislazione religiosa e civile, che ovviamente non si propone di descrivere la lamentazione, ma soltanto di regolarne e limitarne gli eccessi. L ’arte figurativa rispecchia senza dubbio il rito in azione, ma fissata nel suo momento mimico, e anche qui secondo le ragioni dell’arte e non dell’etnografia. Al contrario i relitti folklorici del lamento antico ci permettono ancor oggi di sorprendere l’istituto nel suo reale funzionamento culturale: e ciò che la documentazione antica ci lascia soltanto intra vedere o immaginare, cioè il lamento come rito in azione, la docu mentazione folklorica ce lo pone sotto gli occhi in tutta la sua evi denza drammatica, offrendoci in tal modo non sostituibili oppor tunità di analisi. Tuttavia l’importanza euristica del materiale folklorico ai fini della ricostruzione del lamento funebre antico è da ammettere soltanto entro limiti determinati, oltre i quali la docu mentazione antica torna ad assumere tutto il suo valore decisivo.
IL L A M E N T O F U N E B R E L U C A N O
57
Solo uno storico del tutto sprovveduto potrebbe infatti conside rare l’attuale lamento dei Copti come documento diretto dell’an tico lamento egiziano di cinquemila anni or sono, o le corrispon denti costumanze della Palestina e della Grecia moderne come testimonianze dell’antica qinà funeraria ebraica e del goos dell’e poca omerica. La comunanza territoriale non deve farci dimenti care il complicatissimo intreccio di eventi storici, le nuove ondate culturali e il corrispondente gioco di influenze che consumarono la loro vicenda nel plurimillenario lasso di tempo che saremmo mal destramente tentati di considerare come praticamente vuoto. In realtà lo stesso concetto di «relitto folklorico» del mondo antico ha un sapore naturalistico, almeno nella misura in cui si accompa gna all’immaginazione che qualche cosa di quel mondo sarebbe rimasta del tutto intatta sino ad oggi, sottraendosi come per mira colo al peso dell’accadere e anche alla possibilità di rigerminare per nuove linfe vitali in una direzione nuova. Ciò che differenzia notevolmente il lamento antico dai suoi relitti folklorici e limita per questa parte l’efficacia della comparazione concerne soprat tutto l’universo mitico della morte e delTal di là. Tale universo è stato o annientato o sconvolto o sincretisticamente alterato da quasi due millenni di Cristianesimo (e per l’Asia e l’Africa mediterranee da circa tredici secoli di Islamismo), sì che oggi quel che ne avanza è per lo più frammento e rottame. D altra parte per quanto con l’avvento del Cristianesimo (e successivamente dell’I slamismo) il lamento funebre antico si avviò a perdere il suo carat tere culturale organico, cioè la sua sostanziale omogeneità con deter minati temi della civiltà religiosa dominante, i fenomeni di circo lazione culturale continuarono a toccarlo in varia misura, secondo i luoghi e i tempi, e malgrado l’opposizione di principio della Chiesa (o dei fondatori della religione islamica). Non fu più certo la grande circolazione culturale che portò la lamentazione egiziana a ripla smarsi miticamente nel ciclo osiriano, rifluendo poi nel rituale fune rario carica dei nuovi significati assunti nel mito, o che in Israele dette luogo alle trasposizioni e alle riplasmazioni della qinà profe tica; e neanche fu l’impetuosa spinta in alto, verso il dominio del l’arte e della poesia, che in Grecia —oltre i vincoli del rito e del mito - aprì al lamento le vie dell’epos, della tragedia e della Urica della morte. Ma in sfere molto circoscritte e relativamente più
5«
CAPITOLO SECONDO
modeste il processo di circolazione continuò anche dopo l’avvento del Cristianesimo (e dell’Islamismo), come mostrano per esempio i lamenti antico-provenzali e quelli della Chansons de geste e in genere i vari planctus medievali di origine letteraria composti per personaggi importanti e destinati ad essere pubblicamente eseguiti in manifestazioni collettive di cordoglio: né infine vanno dimen ticate - sempre in epoca cristiana - le trasposizioni religiose nel Planctus Marìae e nelle passioni popolari. Tuttavia anche se il lamento funebre folklorico ha perso il nesso organico con i grandi temi delle civiltà religiose del mondo antico, e anche se i suoi orizzonti mitici sono particolarmente angusti e frammentari, esso può fornire ancora, almeno nelle aree di migliore conservazione, utili indicazioni per ricostruire la vicenda rituale che, nel mondo antico, strappava dalla crisi senza orizzonte e reinse riva nel mondo della cultura. Se pertanto noi vogliamo intendere proprio questo momento tecnico del lamento come c o n t r o l l o r i t u a l e d e l p a t i r e, dobbiamo rivolgerci ai dati folklorici attuali al fine di integrare su questo punto la documentazione antica. Resta ora da giustificare metodologicamente la necessità docu mentaria della ricerca etnografica da noi personalmente condotta sul lamento funebre lucano. Tale necessità è stata imposta dal fatto che, in generale, la documentazione folklorica esistente non è stata raccolta per rispondere alle nostre domande. In particolare la mag gior parte di essa è orientata a considerare il lamento funebre non tanto come r i t o che assolve una determinata funzione risolutrice rispetto ai rischi della crisi del cordoglio, quanto piuttosto come d o c u m e n t o d i p o e s i a p o p o l a r e . Ora è da osservare che nell’arco che il lamento funebre percorre dalla dispersione della crisi alla reintegrazione culturale può certamente accadere che sia raggiunto un orizzonte poetico: ma, in primo luogo, tale orizzonte può essere raggiunto al di fuori del rito in azione e indipendente mente da esso (come accade per le lamentazioni di origine e di ela borazione letteraria), ed in secondo luogo l’orizzonte poetico non è l’unico orizzonte formale che il lamento può raggiungere, poi ché per esempio la plasmazione può mantenersi nella sfera etica delle memorie e degli affetti, o far valere determinati interessi di prestigio sociale, e così via. La considerazione letteraria ed este tica del lamento funebre, per quanto legittima, presenta pertanto
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
59
da un punto di vista storico-religioso la duplice insufficienza di considerare come predominante ed esclusiva una risoluzione che è eccezionale fra le diverse possibili risoluzioni della crisi del cor doglio, e soprattutto di trascurare la determinazione del momento r i t u a l e nella sua qualità e nella sua funzione. Ora da un punto di vista storico-religioso proprio questo momento rituale sta in primo piano e attende definizione. La recitazione del lamento è legata a determinati periodi di tempo e a determinate date, si svolge con una mimica e con una melopea tradizionali, costituisce un obbligo religioso il cui mancato assolvimento ha conseguenze nefa ste, si indirizza a una certa figura mitica del morto e dell’al di là: il che manifesta in modo palese un significato rituale. La conside razione letteraria ed estetica del lamento è invece portata a consi derare come secondario questo significato, e a raccogliere testi let terari poeticamente autonomi, per i quali è in sostanza indifferente se furono o meno eseguiti nel rito, e se ebbero mai un quando un dove e un come nella recitazione rituale effettiva. Si consideri per esempio il caso della cosiddetta nenia di Amatrice, che una certa tradizione - da Silvio Spaventa a Pier Silvestro Leopardi - vuole sia un lamento funebre realmente eseguito in occasione di morte: Γ mi ricordo, abbascio a lu vallone quanno ci commenzammo a vulé bene: tu mi dicisti: - Dimmi: sine o none? i’ te vutaie le spalle e me nni jene. Or sappi, mio dulcissime patrone, che sine da tanno ti voleo bene. Vienci dumane, vienci a cunsulare, ca la risposta ti la voglio dare!1
Dal punto di vista del ricercatore di poesia popolare l’ottava di Amatrice è un testo poeticamente autonomo, come ben videro il Manzoni e il Croce; ma per lo storico del lamento funebre rituale nel mondo antico si tratta semplicemente di un documento inuti lizzabile perché tace sulle questioni relative all’effettiva esecuzione nel rito, e così come ci è pervenuto solleva persino il dubbio che non si tratti di un lamento funebre effettivamente recitato in qual che evento di morte. Del resto per il ricercatore di testi di poesia il difetto di queste notizie non è di grande momento, dato che 1 Croce, Conversazioni critiche, serie 2, pp. 246 sg.
6o
CAPITOLO SECONDO
gli sta davanti un testo che individua liricamente l’eterno tema di una realtà che non è più, e che tuttavia si vorrebbe che fosse. L ’ottava di Amatrice canta infatti l’amore di una donna, di una giovane popolana abruzzese, e il testo poetico ci dice soltanto che qualche cosa di irreparabile è accaduto, ma che potrebbe essere anche non una morte fisica, ma un suo equivalente lirico, una par tenza, una lontananza, o semplicemente la scoperta tardiva di un amore che ormai l’altro non potrà più accogliere, onde il penti mento e lo struggimento per aver perduto per sempre, allora, il momento unico, irrepetibile, della propria felicità di donna. Que sto si legge nell’ottava di Amatrice, che piacque al Manzoni e al Croce: e questo basta al cultore di poesia che non vi cercherà altro o di più, per la semplice ragione che il documento non ci dà altro o di più: e per il cultore di poesia non è poco. Ma per lo storico del l’antico lamento rituale resta l’esigenza di rintracciare altri docu menti che possano aiutarlo a risolvere il suo proprio problema, che è appunto il lamento come r i t o . 2 Il caso dell’ottava di Amatrice è un caso limite di un certo orien tamento dominante nella documentazione folklorica relativa al lamento: orientamento determinatosi per ragioni storiche alle quali è opportuno accennare. Dopo la monografia del Baruffaldi e le annotazioni erudite del Muratori, l’attenzione della moderna scien za del folklore fu attratta verso il lamento funebre nel pieno del l’interesse romantico per la poesia popolare, e pertanto serba le tracce e anche i limiti degli idoleggiamenti e dei fanatismi che si accompagnarono a questo momento della sensibilità romantica. 2 Prendendo spunto dai saggi critici di poesia religiosa di Paolo Lingueglia, il Croce, Con versazioni critiche, serie 2, pp. 250 sgg., propose il criterio metodologico di intendere la poesia religiosa nel suo ambiente storico - in questo caso il rito in azione suggeriva pertanto di tener conto delle condizioni ambientali ed emotive in cui essa poesia viene alle labbra, e di passare quindi dal mero testo letterario alla preghiera effettivamente recitata, al dramma rap presentato, al coro cantato. Il Croce adduceva a riprova di ciò alcune sue personali esperienze, come quando «tra le aguzze punte del Monserrato, al far dell’alba, [provò] la dolcissima impres sione di un canto da una processione che si avviava alla grotta della Vergine», per quanto il testo letterario di questo canto fosse soltanto «una povera parafrasi spagnuola deÙ’Avemaria»; o come quando assistendo una volta a Napoli al miracolo di S. Gennaro vide «i volti contratti da angoscia» delle devote e udì « il loro canto ansare nell’ attesa del miracolo», cioè le filastroc che delle «parenti» che, ridotte al semplice testo letterario, lo avevano altre volte indotto allo scherzo e al motteggio. Tuttavia, nel caso del lamento funebre rituale considerato da un punto di vista storico-religioso, non si tratta di rituffare i testi letterari nella loro effettiva recita zione per aprirsi meglio al loro eventuale significato poetico, ma si tratta di intendere nella sua specifica qualità e funzione proprio il momento rituale in quanto tale.
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
61
Toccò alle voceratrici còrse la sorte di entrare per prime nell’or bita di questo caratteristico zelo romantico per la poesia popolare, e le motivazioni della seduzione che esse esercitarono sulla sensi bilità dell’epoca si ritrovano già nella Colomba di Prospero Mérimée. In questo racconto Colomba vi appare come il cattivo genio che con sapienza implacabile e diabolica tesse la rete che indurrà il fratello, dapprima riluttante, ad eseguire la vendetta secondo il barbarico codice del paese. Colomba realizza a suo modo il tipo romantico di donna fatale e ricorda da vicino un’altra eroina del Mérimée, la gitana e fattucchiera Carmen, e anche la Velleda dello Chateaubriand o la Matelda di Lewis. Tuttavia il suo diabolico fascino non si esercita sul piano erotico, ma piuttosto come attizzatrice di vendetta e come voceratrice. Colomba è una donna di vent’anni, «grande, bianca, gli occhi azzurro carico, la bocca rosa, i denti come lo smalto», «fanatica delle sue idee di onore barbaro»: ma soprattutto essa è una poetessa ispirata, che effonde la sua vena in 1>òcerì improvvisati nel corso di veglie funebri.3 Qualche cosa di questa idoleggiata figura di donna fatale traspare nella lamentatrice Maria Felice Calacuccia di Niòlo, così come la tratteggia il Tommaseo: «Maria Felice, del villaggio di Calacuccia, aveva gli occhi chiari e cilestri, il viso delicato, lunga e folta la capigliatura, che con bello studio educata avvolgevasi, secondo il costume, a trecce intorno al capo: ed accoppiavasi ad una quasi virile vigoria del corpo non poca alacrità di mente ».4 Quando le fu assassinato il fratello essa intonò un vócero che divenne famoso: «... Bogliu veste li calzoni, I bogliu comprà la terzetta, I e mustrà la to carniscia: I tantu nimu nun s’aspetta I a tagliarsi la so barba I dopu fatta la vendettta...»5 E lei stessa, messi da parte l’arcolaio e la spola e gli altri lavori donneschi, diventò vendicatrice del fratello assas sinato, con cupa e selvaggia ostinazione, a lungo vagando armata per i monti, in cerca degli assassini.6 Questa inclinazione roman tica a considerare la voceratrice come una virago selvaggia e temi bile, e al tempo stesso come una ispirata capace di sollevarsi a grandi altezze poetiche, orientò nel complesso la ricerca successiva. Il Gre3 4 5 6
P. Mérimée, Colomba (1840) spec. capp. io e 16. N. Tommaseo, Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci (Venezia 18 4 1) voi. 2, p. 62. Ibid. Ibid., p. 64.
62
CAPITOLO SECONDO
gorovius, ricordando le più famose voceratrici còrse, come Mariola delle Piazzole e Clorinda Franceschi di Casinca, non esitava a para gonarle a veggenti e a Vellede, e a portare molto in alto la poeti cità delle loro lamentazioni: «Ecco il morto sulla tok, e le lamentatrici accoccolate al suolo: si leva una giovinetta, e, infiammato il sembiante dall’ispirazione, improvvisa, al pari di Miriam e di Saffo, versi di impareggiabile grazia, riboccanti di immagini ardite, inesauribilmente versando la sua anima nel ritmo, in ditirambi nei quali trovano espressione i temi più profondi e più alti del dolo re».7 E più oltre: «Si troverà in questi canti il linguaggio poetico di Omero e insieme dei Salmi e del Cantico dei cantici. Privi di artificio quali sono, portano solo l’impronta di improvvisazioni che liberamente si effondono: e per questa loro natura vive in essi il momento geniale del cuore ebbro».8 A questi «coralli còrsi rossi di sangue» (l’immagine è ancora del Gregorovius) facevano riscon tro gli attitidos dell’isola vicina, la Sardegna: e anche qui nei cri teri di raccolta e di analisi finì col prevalere la stessa disposizione d’animo e lo stesso orientamento culturale. Già nel 1839 il La Mar mora aveva dato una breve e disadorna descrizione della lamenta zione sarda9 così come egli ebbe occasione di vederla: ma appun to per questo suo carattere di freddo rapporto la descrizione del La Marmora non ebbe praticamente nessuna influenza orientatrice nel campo degli studi, e restò quasi dimenticata, mentre a quella successiva del Bresciani toccò larga risonanza, e non soltanto per il turgore dello stile, ma proprio perché in essa tornava a operare l’idoleggiamento della lamentazione come alta poesia di popolo, e come testimonianza viva della «natura poetica» delle prime genti: idoleggiamento che nel Bresciani si manifestava ad onta della sua avversione al romanticismo e della sua esplicita segnalazione delle «abbominande dottrine» racchiuse nella lamentazione e combat tute dalla Chiesa. Da questa petulanza romantica è molto facile cadere nel ridicolo, e non di rado vi cadono i più antichi etnografi e folkloristi della lamentazione funeraria. Nella prefazione alla rac colta dellO rtoli si legge per esempio che mentre in Grecia, in Ita 7 F. Gregorovius, Corsica ( i a ed. 1854 ; 2 a ed. 1869) pp. 37 sg. 2 a ed. 8 Ibid., p. 47. 9 A. de La Marmora, Voyage in Sardaigne, ou àescription statistique, physiqtie et politique de cette ile (1839) pp. 276 sg.
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
63
lia, in Spagna, in Irlanda, in India, nelle contrade dell’antico e del nuovo continente «non si canta quasi più sui morti»,10 solo in Corsica la tradizione si sarebbe invece conservata, custodita dalle «figlie di Kyrnos» (cioè, più semplicemente, dalle donne còrse), che nei loro vócerì si innalzerebbero a semplicità di accenti poe tici che «giammai» nessun poeta seppe raggiungere.11 A questa esaltazione del lamento come altissima poesia non tardò a seguire la delusione, come accade quando non si sa quello che si cerca o si cerca quel che non c’è: e poiché la realtà dell’esecuzione rituale del lamento non sembrava accordarsi con l’esaltazione che se n’era fatta, si attribuì il disaccordo alla decadenza del lamento, che da altissima poesia quale era stata in passato precipitava ora in forme fredde e convenzionali. Così Giuseppe Ferraro osservava che «attualmente o si fanno sentire pochi lamenti in poesia, o dei soliti (ohi! su coro meu - oh! su bellu meu), o si cantano le lodi del defunto molto freddamente, come per uso, rendendo più desiderati e impor tanti gli antichi attitidos».12 II Nurra, riprendendo questo giudi zio, osservava come i più recenti attitidos avessero perduto certi caratteri degli antichi e si fossero ridotti «a poche idee, spesso comuni e convenzionali, interrotte da frequenti esclamazioni di dolore»;13 e un letterato locale, A. Pasella,14 non esitava a dichia rare che il lamento funebre sardo è «falso, non sincero», anzi «la poesia popolare più falsa ch’io mi conosca, falsa nei paragoni incalzantisi e urtantisi in ogni verso, falsa nelle immagini tutte», a mala pena concedendo che vi si ritrovano talora alcune immagini felici: «ma son lampi fugaci - osservava - che non salvano questi com ponimenti dalla giusta indifferenza in cui son tenuti». Analoga mente il Salomone-Marino contrapponeva all’esaltazione roman tica delle lamentatrici-Vellede la ricorrente valutazione negativa secondo cui esse sono soltanto volgari «vendilacrime», la cui fun zione sarebbe alimentata dalla «vanità umana» che vuol «dar pol vere negli occhi della moltitudine», facendo mostra che persone 10 F. Ortoli, Les vocerì de Vile de Corse (Parigi 1887) pp. v i sg. 11 «Jamais poète ne trouvera d ’accents si simples et si déchirants: c’est que la femme corse parie d’après son coeur et chante selon son àme»: ibid., p. ix. 12 G . Ferraro, Canti popolari in dialetto logudorese {Torino 18 9 1) p. 205. 13 P. Nurra, La poesia popolare in Sardegna (Sassari 1893) p. 16. 14 A . Pasella, Vita Sarda (1891) n. 6, cit. da E. Scano, Saggio critico-storico sulla poesia dia lettale sarda (19 01) pp. 3 1 sg.
64
CAPITOLO SECONDO
estranee al defunto ne tessono il panegirico.15 Ora è da osservare che così estrema oscillazione del giudizio nasceva da un groviglio di equivoci che non staremo qui a districare, tenendoci paghi di aver segnalato l’equivoco, a nostro avviso fondamentale, e cioè la mancata distinzione tra il lamento come tecnica del piangere ed il lamento come eventuale risoluzione lirica del patire. Non diversamente stanno le cose se ci volgiamo alla maggior parte del materiale documentario proveniente da altre aree folkloriche europee. Così per esempio il Barsov nei suoi due volumi di lamenti della Russia settentrionale sfruttò in modo particolare il patrimonio letterario di una lamentatrice di Kasaranda (Olonec), Irina Fedosova, che fu sostanzialmente considerata come poetessa popolare di straordinario talento.16 Analogamente la raccolta dei μυρολόγκχ neogreci eseguita dal Passow consiste in un semplice elenco di testi letterari di lamenti, senza alcun riferimento alla loro esecuzione nel rito .171 8 A ll’estremità occidentale del continente europeo, nella penisola iberica, considerazioni dello stesso genere valgono per le endechas.'8 La mancata distinzione fra lamento come tecnica del piangere e lamento come risoluzione lirica del patire ha promosso una docu mentazione folklorica che, se può essere sufficiente per il cultore di poesia popolare e per lo storico della letteratura, presenta limiti molto gravi per lo storico del lamento funebre come rito. Appunto perché in tale documentazione prevale l’interesse letterario del rac coglitore, si è in generale proceduto alla raccolta di testi di lamen tazione nei quali gli accidenti di esecuzione o sono stati delibera tamente eliminati, o sono accennati come elementi secondari (per tacere della possibilità che il testo in questione sia soltanto una composizione letteraria, magari lavorata nello stile delle lamenta zioni rituali, ma senza essere mai stata effettivamente impiegata 15 S. Salomone-Marino, Le reputataci in Sicilia nell’età di mezzo e moderna (Palermo 1886) p. 8. Anche Giuseppe Ferraro. 16 Sul Barsov e sulle altre raccolte di lamenti russi è da vedere il lavoro complessivo di H. Mahler, Der russiscbe Totenklage (Lipsia 19 35). 17 A. Passow, Popularia Carmina Greciae recentioris (Lipsia 1860) pp. 257-88. 18 Sulla considerazione prevalentemente letteraria delle endechas si veda Carolina Michaélis de Vasconcellos, Cancioniero da Ajuda (Halle a. S. 1904) voi. 2, pp. 854-58; J . Amador de los Rios, Historia critica de la literatura espanola, voi. 4, pp. 425 sg.; R . Menéndez Pidal, Sobre primitiva Urica espanola, Cultura Neolatina, voi. 3, 203-13 (1943).
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
65
nel rito). Così, mentre il lamento rituale è sempre cantato - o al meno recitato con un ritmo o una cadenza che lo distinguono dalla parlata comune - noi possediamo intere raccolte di lamenti fune bri senza accenni alle melodie, e con qualche riferimento molto superficiale e sommario ad esse; mentre il lamento è accompagnato da una mimica definita, tradizionalmente fissata, la documenta zione esistente non ci dice quasi nulla di preciso su questo punto; mentre il lamento in azione ha per caratteristica dominante il dram matico sollevarsi del discorso dal parossismo iniziale della crisi, la documentazione esistente ha poche notizie su questa dinamica, e ancor meno sul carattere della crisi del cordoglio; mentre il lamento come discorso è lavorato su moduli verbali tradizionali, nella documentazione esistente non riusciamo a renderci conto con esattezza come operi in un dato ambiente il rapporto fra elementi fissi ed elementi variabili, e quale sia la funzione e il significato di questo rapporto; mentre il lamento rituale è contesto di ritornel li emotivi periodici, talora con incidenza corale, accade spesso che, nelle trascrizioni effettuate col metodo di farsi dettare il lamento dalle lamentatrici, ritornelli emotivi e incidenze corali risultano soppressi, suscitando così fallaci valutazioni nello studioso che rileg gerà il testo trascritto. La sostanziale indifferenza dei raccoglitori verso il lamento come rito si manifesta infine nel modo più sco perto quando i lamenti vengono raccolti per procura, cioè dando l’incarico della raccolta a maestri elementari, preti, farmacisti, me dici condotti ecc., magari sulla base di questionari inviati per posta: il che espone ovviamente al pericolo di ottenere prodotti dei quali non si sa quanta parte sia stata omessa o ritoccata o distorta, e che meglio si direbbero nuove elaborazioni folkloriche nate dal com mercio fra raccoglitori e informatori. Se l’orientamento che abbiamo definito romantico limitava l’uti lizzazione ai nostri fini di buona parte della documentazione esi stente, e ne rendeva incerta l’interpretazione rispetto al problema del lamento come rito, maggiori opportunità e agevolezze offriva quel distaccato naturalismo descrittivo della ricerca etnografica che sempre più, sotto la spinta del positivismo, ha conquistato terreno anche nella scienza del folklore. Qui il lamento appariva per quanto possibile reintegrato nella sua vicenda rituale, nella sua effettiva esecuzione sorpresa in vivo dall’etnografo. Proprio in forza di questa
66
CAPITOLO SECONDO
esigenza naturalistica di esattezza si osservò che il testo letterario della lamentazione non sta a sé, ma è innanzi tutto organicamente connesso con la sua recitazione rituale, e quindi con la sua melo dia. Questo orientamento della ricerca è legato soprattutto al nome di Costantino Bràiloiu. Per rendersi conto del notevole progresso nella tecnica di raccolta dei lamenti funebri realizzato dallo stu dioso romeno basterà analizzare i criteri metodologici con cui è stata condotta la sua eccellente monografia sui bocete della regione di Oa§.19 Qui il materiale appare in primo luogo ordinato secondo i suoi «gradi di realtà», in modo che il lettore è informato se il bocet che ha sotto gli occhi è stato realmente cantato al capezzale di un defunto, o davanti alla tomba («alla croce»), o è stato rico struito a memoria dalla lamentatrice su richiesta dell’etnografo, o è soltanto un modello letterario più o meno frammentario che è stato d e t t a t o sotto lo stimolo di un questionario ad hoc. Poiché secondo il criterio di realtà un bocet per un morto immaginario (cioè per la possibile morte di un parente di un certo grado) non è lo stesso bocet che poi viene cantato di fatto quando si è colpiti da un lutto reale, il Bràiloiu ha accuratamente segnato, per ciascun documento, se si tratta di lamenti veri («per padre», «per fratello» ecc.) o di lamenti possibili («come per padre», «come per fratel lo» ecc.). Dei lamenti cantati è riportata costantemente la melo dia (talora registrata fonograficamente), cioè la linea melodica su cui si canta un verso e le variazioni relative. Nella trascrizione dei testi letterari sono state conservate tutte le trasformazioni dovute al canto, e cioè ripetizioni, sillabe di anacrusi, sillabe di ripetizione. Infine sono riportati i dati relativi al carattere rituale del lamento, così come affiorano dalle testimonianze delle informatrici e dal l’osservazione diretta del rito in azione. Tuttavia anche un materiale documentario così coscienziosa mente raccolto presentava ai nostri fini alcuni limiti di impiego, poiché si trattava pur sempre di un materiale che non era stato raccolto per rispondere alle nostre domande. In sostanza il Brài loiu è interessato al lamento in quanto fatto poetico e musicale, 19 C. Bràiloiu, Bocete din Oa$, Grai si suflet, voi. 7 (1938). Si veda anche dello stesso autore Despre Bocetuldela Dragu$, Arhiva pentru stiinta si reforma sociala (1932) pp. 280 sgg. Particolarmente ricco è il materiale musicale sui bocete conservato dalla discoteca dell’Istituto di Folklore di Bucarest e corredato da minuziose schede di osservazione.
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
67
e i dati propriamente rituali sono tenuti in considerazione «per una migliore comprensione» dell’arte del bocet. Dal punto di vista storico-religioso il rito sta invece in primo piano, e la risoluzione poetica si configura come un possibile risultato secondario. D ’al tra parte l’ideale naturalistico di un ragguaglio etnografico assolu tamente oggettivo è in realtà irrealizzabile quando per «oggetti vità» si intenda un ordine di cose «in sé», indipendente da un particolare problema storiografico che aiuta a vedere, a scegliere, a collegare e a comprendere. Siamo stati pertanto costretti ad attac care il male alle radici, facendoci noi stessi etnografi della lamen tazione funeraria in un’area circoscritta, e procurandoci in tal modo una documentazione diretta che fosse adatta a rispondere alle nostre proprie domande e alle nostre proprie ipotesi di lavoro. In altre parole ci è sembrato che almeno in un punto fosse da superare il vizioso dualismo fra l’etnografo che raccoglie dati senza nessun problema storiografico preciso e lo storiografo che utilizza poi questi dati nella prospettiva di un determinato problema. Una volta ri stabilita, almeno in quell’unico punto, la più salda unità fra testi monianza e pensiero, ne sarebbe risultata maggiore sicurezza nel l’utilizzazione, sul piano comparativo e interpretativo, degli altri documenti - non direttamente raccolti - relativi al folklore euro mediterraneo. Con ciò resta metodologicamente giustificata l’in dagine diretta del lamento funebre lucano, da noi sistematicamente condotta in più riprese dal 1950 al 1956. Nell’economia del pre sente lavoro questa indagine è da intendersi come semplice mo mento euristico nel movimento di un pensiero storiografico impe gnato a ricostruire il lamento funebre e il pianto rituale nel qua dro delle civiltà religiose del mondo antico. Come tale un’inda gine del genere, sebbene applichi le tecniche dell’inchiesta, non è una monografia etnografica nel senso corrente del termine, e non è neppure in senso stretto un’analisi psicologica, per quanto fac cia larga parte ad analisi di determinati stati e comportamenti della psiche. Anche se in via provvisoria sono adottati metodi di lavoro dell’etnografia e della psicologia, ciò che conta è in ultima istanza, il conseguimento di un determinato risultato utile per la compren sione storiografica del lamento funebre antico.
7°
CAPITOLO SECONDO
mento furono direttamente raccolte sul posto utilizzando soprat tutto le persone ancora impegnate nell’esecuzione del rito, e sol tanto in casi eccezionali informatori e informatrici locali ormai estranei al rito stesso. Le osservazioni furono condotte durante ripetuti e lunghi soggiorni nei villaggi lucani, su un’area che prati camente copre tutta la regione lucana: furono infatti visitati i vil laggi di Castelsaraceno, Càlvera, Senise, San Giorgio Lucano, Valsinni, Colobraro, Montalbano Jonico, Craco, Stigliano, Pisticci, Bernalda, Ferrandina, Grottole, Tricarico, Albano Lucano, Pietrapertosa, Avigliano, Ruoti e San Cataldo. Una ricerca esaustiva comune per comune, con tutti i dati positivi e negativi e con tutte le caratteristiche differenziali era non necessaria in considerazione dell’obiettivo della ricerca, che non aveva intenti di compiutezza cartografica. I comuni visitati furono scelti con tre criteri princi pali, e cioè o per il loro tradizionalismo (Pisticci, Avigliano), o per la loro arretratezza e il loro isolamento (Castelsaraceno, San Catal do), o per la loro disseminazione geografica. Nella raccolta del mate riale si tenne sempre conto che il documento non era costituito dal testo letterario della lamentazione ma dal lamento in azione, cioè nel suo ordine verbale, mimico e melodico, sorpreso nella dina mica del cerimoniale funerario dal decesso alla inumazione, e nella iterazione successiva in date canoniche determinate. A questo fine si rendeva necessaria l’osservazione della crisi del cordoglio e dell’enuclearsi dell’ordine della lamentazione nel corso di reali occa sioni luttuose: il che fu fatto quando l’opportunità si presentava, e nella misura in cui l’osservazione era possibile. In gran numero furono invece osservati i lamenti artificiali, cioè ricostruiti a richie sta dell’etnografo al di fuori dell’occasione reale. L ’importanza documentaria data a questi lamenti artificiali potrebbe indurre nel lettore qualche riserva: ma poiché, come vedremo, il lamento rituale è sempre, per sua propria natura, in qualche misura «artificiale», la riserva non ha quel peso che sembrerebbe avere. Per diminuire e in dati casi praticamente annullare la distanza fra il lamento vero e il lamento a richiesta dell’etnografo, si ricorse tuttavia a due espe dienti tecnici di raccolta: e cioè l’invito alla lamentatrice di ripe tere un lamento già da essa realmente reso in occasione di qualche suo lutto, e la ricostruzione dello scenario della lamentazione vera (un finto morto sul letto, sul tavolo o al suolo; la penombra del
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
7
l’ambiente ecc.). Per lo studio dei moduli verbali e delle stereoti pie espressive, e per determinare in che misura in un dato villag gio il discorso della lamentazione è tradizionalmente vincolato, e in che misura è lasciato un margine al riadattamento e all’innova zione, si dovette necessariamente ricorrere al criterio quantitativo; raccogliendo nello stesso villaggio un numero relativamente ele vato di lamentazioni, classificate per destinazione (moglie al marito, figlia alla madre o al padre, sorella al fratello o alla sorella ecc.) e secondo le circostanze (morte naturale o violenta, morte del gio vane nel fiore degli anni o della ragazza non sposata ecc.): con que sto espediente si ottenne che cosa «si dice» tradizionalmente in un dato villaggio quando si rende il lamento nelle più diverse cir costanze luttuose. Un espediente meno faticoso, ma anche meno preciso nei risultati, fu di chiedere direttamente a una lamenta trice che cosa «si dice» nel suo villaggio quando per esempio la madre perde il figlio o la moglie il marito: in questo caso soltanto si preferì il metodo di farsi «dettare» (e non cantare e mimare) il testo, poiché nella dettatura affiorano quasi esclusivamente i moduli e le stereotipie espressive che sono a disposizione nella memoria culturale dell’informatrice.21 Molto più facile fu 1 accer tamento delle stereotipie mimiche e dei moduli melodici, poiché la mimica rituale si riduce ad alcuni pochi gesti tradizionali e la melopea è per ogni villaggio variamente caratterizzata, per quanto un orecchio non esercitato stenta talora a ravvisare le differenze che invece sono prontamente percepite dalle lamentatrici che ne formano spesso oggetto della polemica spicciola di campanile. An che qui si sarebbe potuto comporre carte di diffusione dei moduli verbali, mimici e melodici del lamento funebre nell’area folklorica lucana: ma a noi bastava l’accertamento generale che ogni vil laggio ha il suo modo tradizionale di lamentare il morto, e che i moduli verbali sono più esposti alla variazione individuale, men21 I testi di lamentazione artificiale che in seguito saranno riportati sono preceduti da sigle che indicano il loro grado di realtà ed il modo della raccolta. La sigla R C indica un testo lette rario dì lamentazione che una volta fu eseguito in una reale situazione luttuosa e che la lamen tatrice ha ripetuto cantando su richiesta dell’etnografo. La sigla PD indica invece un lamento possibile, il cui testo letterario è stato dettato dalla informatrice alla domanda «che cosa si dice quando una moglie perde il marito, o una sorella perde il fratello, o una figlia perde la madre ecc. ». In un solo caso appare la sigla aR C (p. 82), poiché, pur trattandosi di un lamento che una volta fu realmente eseguito, le informatrici che lo ricostruirono non furono a suo tempo le reali protagoniste della lamentazione stessa, ma soltanto spettatrici.
CAPITOLO SECONDO
72
tre quelli mimici e soprattutto quelli melodici presentano una stabi lità relativamente molto maggiore su tutta l’area folklorica esplorata. Per tutta una serie di questioni importanti fu adoperato il metodo dell’intervista sulla base di questionari, e del controllo reciproco delle risposte anche in uno stesso villaggio e in una stessa comunità. Infine la raccolta del materiale fu largamente accompagnata da regi strazioni fonografiche e da sequenze fotografiche, le une e le altre indispensabili per non perdere mai il rapporto concreto con il lamen to rituale come unità dinamica di parola, di melopea e di gesto.22
3. Stato attuale del lamento funebre lucano A differenza di altre regioni folkloriche nelle quali il lamento funebre possiede un vocabolo popolare che lo designa (attittu o attittidu per la Sardegna, vócero per la Corsica ecc.), manca un ter mine analogo diffuso in tutta la regione folklorica lucana. Tutta via in due circoscritte aree particolarmente conservatrici rispetto alle antiche tradizioni, il lamento funebre è designato con un voca bolo specifico. A Pisticci e a Montalbano Jonico il lamento si chiama infatti naccarata, mentre nel vasto comune di Avigliano e in quello finitimo di Ruoti esso è indicato con travagliane o travaglio, dal ritor nello emotivo che lo punteggia: ad Avigliano la espressione face li travaglioni vale appunto «eseguire il lamento». Non ci risulta che in altri villaggi o aree folkloriche della Lucania vi siano ter mini popolari del genere. Il lamento funebre lucano si presenta oggi all’indagine etnografica con diverso grado di diffusione in rap porto alle classi sociali, all’arretratezza e all’isolamento della comu nità, al sesso e all’età delle persone. In generale esso appare dif fuso soprattutto fra la popolazione contadina della campagna; e per quanto in dati casi esso impegni ancora ceti non popolari, sus siste tuttavia la persuasione, nel mondo contadino, che vi siano due modi di patire la morte, quello dei poveri, che adottano il la mento rituale, e quello dei ricchi che lo hanno in ispregio. Una con tadina di Valsinni ci ha reso in proposito la seguente testimonianza: 22 Le registrazioni fonografiche dei lamenti artificiali sono conservate nella discoteca del Centro per gli Studi di Musica Popolare presso l’Accademia di Santa Cecilia in Roma; le foto grafie fanno parte dell’Atlante figurato del Pianto.
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
73
- Volete dirci, Adelina, che cosa avviene nel cimitero di Valsinni il giorno dei morti? - Noi contadini e le persone per bene andiamo al cimitero e piangiamo alle nostre tombe. - Anche le persone per bene piangono vicino alle loro tombe? - Le persone per bene vengono al cimitero, ma non piangono. (Adelina assume l ’atteggiamento della persona rattristata·) Stanno cosi. Nel cuore loro piangono, ma le bocche, le bocche non piangono. - Dunque, le persone ricche non piangono? - Le persone ricche piangono, sì, ma non come noi pacchiani. Noi che siamo villani, contadini, piangiamo di più. I ricchi qualche volta piangono pure, ma dicono due o tre parole, poi hanno il conforto dalle altre persone per bene e si rassegnano.23
Questa prevalente limitazione del lamento al solo mondo conta dino (o di recente provenienza contadina), in un passato relativa mente prossimo doveva essere però molto meno netta, come prova il fatto che nei più vecchi si serba ancora memoria di una costu manza secondo la quale i contadini, e in particolare le loro donne, erano tenuti, per una sorta di corvée, a lamentare la morte del padrone o di qualche membro della famiglia padronale. La diffu sione del lamento varia anche in rapporto all’arretratezza e all’i solamento della comunità: praticamente scomparso - o comunque non più utilmente osservabile - nei due capoluoghi di provincia e nei grossi centri di Melfi, Rionero, Laurenzana, Corleto, Moli terno, Lagonegro e Lauria, esso persiste soprattutto nei villaggi disseminati sulle alture che si affacciano sulle vallate del Bràdano, del Basento, del Cavone, dell’Agri, del Sinni e del Sarmento, nei comuni di Avigliano, di Bella, di Ruoti e di San Fele, e in alcuni villaggi particolarmente isolati, come Pietrapertosa e Castelsaraceno. Eccezionalmente si impiega ancor oggi il lamento funebre in occasione di un equivalente critico della morte, come la par tenza per il servizio militare o per la guerra o per l’America: e anche qui vi sono segni che in un passato relativamente recente l’uso doveva essere molto più diffuso. Senza riscontro l’impiego del lamento in morte di animali, come pure scomparso è il lamento rituale della sposa prima di lasciare la casa dei genitori (tracce di quest’ultimo costume sono reperibili nelle colonie albanesi calabro23 Da una registrazione su nastro che è conservata nella discoteca del Centro Nazionale per gli Studi di Musica Popolare presso rAccademia di Santa Cecilia in Roma.
74
CAPITOLO SECONDO
lucane). L ’impiego del lamento come tecnica del piangere resasi indipendente dai vincoli del rituale funerario e trasposta in occa sione di dolore fisico acuto che accompagna malattie gravi e a lungo decorso fu da noi osservato a Senise, quando percorrendo le vie del paese in compagnia del medico condotto udimmo da una casa levarsi la caratteristica melopea di una lamentazione. Ma il medico ci informò che non si trattava di un lamento reso ad un morto, sì bene di una povera donna malata di cancro che soleva a quel modo lamentare se stessa ogni volta che era assalita dai dolori del suo male. In tutta l’area esplorata il lamento funebre femminile costitui sce la regola, e quello maschile l’eccezione: tuttavia in qualche vil laggio la sopravvivenza del lamento maschile è meglio rappresen tata, come in San Giórgio Lucano, dove gli uomini di «cuore molle» (secondo l’espressione di un informatore contadino) lo praticano ancora. Documento di tale sopravvivenza è un lamento di fratello a fratello da noi raccolto e registrato appunto in San Giorgio, e conservato nella discoteca del «Centro per lo studio della musica popolare» presso l’Accademia di Santa Cecilia. In rapporto al fatto che il lamento funebre appare oggi in Lucania un istituto culturale in via di rapido dissolvimento, la sua diffu sione è maggiore fra le donne anziane o di età media. La coscienza di tale dissoluzione è diffusa negli stessi ceti popolari, come prova la seguente dichiarazione di una vecchia contadina di Craco: «Ai miei tempi le donne tenevano le trecce raccolte e quando c’era un morto se le scioglievano, ma ora tutte tengono i capelli già sciolti, come se stessero sempre a piangere, e invece non piangono più». In generale il lamento è reso oggi in Lucania dalle parenti del defunto senza concorso di lamentatrici prezzolate o professionali. Tuttavia il ricordo di «prefiche» chiamate a prestar la loro opera nei funerali è ancora vivo, e si riferisce a un passato relativamente recente. Le lamentatrici di Senise, un tempo famose, erano chia mate nei paesi vicini a fornire le loro prestazioni molto apprez zate e altrettanto è da dirsi per quelle di Pisticci e di qualche altro villaggio. Attualmente la lamentazione professionale è sentita come una vergogna, e un villaggio accusa l’altro di praticare questo co stume, senza che poi l’accusa risulti fondata alla prova dei fatti. Così a Pisticci vi diranno che a Bernalda le donne si fanno pagare
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
75
per piangere, e a San Giorgio che la costumanza è ancora viva a Montalbano: in realtà vere lamentatrici a prezzo non s’incontrano né a Bernalda, né a Montalbano, né altrove, e queste reciproche accuse provano soltanto che il costume è esistito più o meno da per tutto in un passato recente, e che ora ne resta solo il ricordo nelle solite denigrazioni fra villaggio e villaggio. Le lamentatrici professionali non vanno confuse con le amiche e le comari che accor rono ai lutti e si associano al lamento, assumendone talora la guida. Si tratta di donne che colgono l’occasione di un lutto per rinno vare il lamento per qualche proprio morto: mostrano in ciò uno zelo particolare le madri che hanno perduto un figlio in giovine età e per morte violenta (per esempio in guerra), e soprattutto le vedove. Alcune di queste donne duramente provate dalla morte e da altre sciagure diventano ciò che potremmo chiamare delle vere e proprie «lamentatrici per vocazione», che volentieri accorrono a tutti i funerali quasi che il lamentare fosse per loro un bisogno e come se i lutti altrui fossero una buona occasione per riprendere a tessere il filo di un lamento soltanto interrotto. Queste lamenta trici di vocazione non sono oggi a prezzo, anche se può darsi che in passato si reclutassero fra esse le migliori lamentatrici profes sionali: esse sono semplicemente donne che «sanno piangere bene» per sciagure patite e per abilità tecnica personale. Il lamento funebre lucano presenta appena qualche influenza cristiano-cattolica nella forma sincretistica che è propria del cat tolicesimo popolare. In generale non vi appaiono né Gesù, né la Madonna, né i Santi, né la rassegnazione al dolore, né la speranza in un mondo ultraterreno nel quale siano riparati il male e il dolore della vita umana. La ribellione e la protesta di fronte alla morte vi hanno un posto preminente, e non recedono davanti a nessuna autorità, neanche a quella di Cristo, che in un modulo ricorrente è accusato apertamente di tradimento: «Oh, ce tradimente ha fatte Gesù Cristo! » A differenza di altri prodotti del folklore, dove attra verso i sincretismi e i compromessi del cattolicesimo popolare o attraverso i dati più elementari àeWetbos cristiano si palesano le modificazioni e le riplasmazioni di duemila anni di storia cristiana, il lamento funebre lucano serba con relativa fedeltà alcuni tratti importanti del rituale antico, anche se il logorio del tempo ne ha dissolto altri, e anche se, com’è ovvio, la vita moderna che preme
76
CAPITOLO SECONDO
da tutte le parti stia per travolgere con la sua onda vorace anche quest’ultimo isolotto di un’Atlantide inabissata. L ’orizzonte mitico per entro il quale si muove il lamento rituale lucano è ancora sostan zialmente pagano, e lo stesso «al di là» si configura come un mondo che continua in forma larvale ed evanescente il mondo nel quale viviamo. I morti continuano le abitudini che ebbero da vivi, come risulta implicitamente da questo lamento di Pisticci: (RD) Gioacchine mie, beni di la sora. Ce morte subitanea, beni di la sora. O ce mane pregiate ca tenivi, beni di la sora. Quanta fatia hai fatto a ssi mane, beni di la sora. E mo’ t’agghia dice ce t’agghie mise int’a la cascia, beni di la sora: dò cammise iune nova e iune arrepezzata, beni di la sora; la tuagghia pi annetta la faccia a cure munne, beni di la sora; e dò pare de calzunitte iune nove e iune c’a pezza ’nculo, beni di la sora. E pò t’agghie mise la pipa pe fuma, beni di la sora, ca tu iere tant’appassiunate pi lu fumé, beni di la sora. E mò pe cì t’agghia manna lu siere a cure munne, beni di la sora? (Gioacchino mio, bene della tua donna, che morte improvvisa, bene della tua donna. Oh le mani pregiate che avevi. Quanta fatica hai fatto con que ste mani, bene della tua donna. E ora ti debbo dire che cosa ti ho messo nella cassa, bene della tua donna: due camicie, una nuova e una rattoppata, bene della tua donna; la tovaglia per pulirti la faccia all’altro mondo, bene della tua donna; e due paia di mutande una nuova e una con la toppa nel sedere; e poi ti ho messo la pipa, bene della tua donna, ché eri tanto appas sionato del fumo, bene della tua donna. E ora per chi debbo mandarti il sigaro all’altro mondo, bene della tua donna?)
% Il caro Gioacchino continuerà dunque a condurre una vita non molto dissimile da quella di un contadino lucano: continuerà a pere grinare con la sua camicia e le sue mutande rattoppate, e per i giorni festivi avrà pronta la muta nuova, e fumerà la pipa e il sigaro, e suderà per caldo o per fatica, e si asciugherà il sudore con la «tova glia»: vien quasi voglia di pensare che lo scenario nel quale egli da ora in poi si muoverà non sarà troppo dissimile dai calanchi della sua Pisticci. Questo accentuato carattere pagano del lamento in confronto di altri prodotti del folklore rientra in un fenomeno generale che trascende la situazione lucana, e che appartiene alla storia della Chiesa nel suo complesso, come avremo occasione di esaminare altrove più da vicino: la Chiesa cattolica ha infatti sem pre rinunziato a venire a compromesso col lamento funebre come tale, e a modificarlo e a riplasmarlo per entro il suo proprio rituale
IL LAMENTO FUNEBRE LUCANO
77
funerario, dandogli un senso cristiano. La Chiesa ha battuto costan temente la via della polemica aspra e dei divieti canonici, rasse gnandosi a tollerare di fatto il costume solo lì dove non è riuscita a sopprimerlo: non mai essa ha intermesso la sua intransigenza su questo punto per lei vitale, appunto perché coinvolgeva l’ideolo gia della morte. Per tornare alla situazione lucana, ancor oggi è possibile assistere a singolari episodi di questa coesistenza contrad dittoria e forzata. Un vecchio parroco di Pisticci ci raccontò che una volta, in occasione di un funerale, le lamentatrici intonarono il lamento nella chiesa madre di Pisticci, nel bel mezzo del servi zio funebre. Il vecchio parroco, che cantava accompagnandosi all’or gano, si rivolse risentito alle donne, apostrofandole: «Insomma, o cantate voi o canto io! » Le donne tacquero per qualche tempo, ma poi ripresero il canto, e fu il buon parroco che dovette infine rassegnarsi a tacere, e a lasciare che ancora una volta insorgesse, nello stesso tempio di Cristo, questo arcaico modo di oltrepassare la morte. Anzi, un poco per celia e un poco perché vinto dalla sedu zione della barbarica melopea, il buon parroco si indusse ad accom pagnarla sull’organo per qualche istante. Episodi simili hanno luogo in molti cimiteri fra il Bràdano e il Sinni in occasione del 2 novem bre. A Roccanova, lamento funebre pagano e rituale funerario cat tolico si mescolano in questa occasione in un singolare contrasto: presso le croci dei più poveri, e tutt’intorno nelle cappelle dei meno poveri, si levano i lamenti, ora convulsi, quasi prossimi ad una vera e propria crisi parossistica, ora invece più umani, risolti in lunghe melopee velate di pianto; di tanto in tanto dal gemere e singhioz zare cerca di librarsi un abbozzo di canto, che qualche volta si man tiene a lungo, iterando senza fine il breve modulo melodico tradi zionale. Intanto, solenne e distaccato, il sacerdote passa tra le tombe, mormorando le sue preghiere e benedicendo: passa fra le la mentatrici inginocchiate presso le croci, entra nelle cappelle dove, accoccolate nell’ombra, altre piangenti rinnovano il cordoglio ri tuale. Ultimo miserabile avanzo della pagana offerta di cibo ai mor ti, alcune donne vanno versando, da una bottiglietta di gazzosa, un po’ di vino rosso su una grossa fetta di pane scuro, che depon gono poi presso la croce, nel fascio di fiori campestri. Il sacerdote passa, assolvendo il suo ufficio: e par che i suoi occhi non vedano
7»
C A P IT O L O S E C O N D O
e le sue orecchie non odano. Qui le due epoche culturali si incon trano senza reagire, immemori dei loro passati contrasti e della loro volontà di storia.
4. Crisi del cordoglio e presenza rituale del pianto Il lamento funebre lucano si enuclea per entro la crisi del cor doglio, gradualmente dominandola e risolvendola in un ordine cul turalmente significativo che è appunto il r i t o della lamentazione. Fra le donne delle campagne lucane i rischi psichici della crisi rag giungono tale ampiezza e gravità da conferire ad ogni evento lut tuoso una sinistra potenza di disgregazione e di follia. Il carattere spettacolare che il cordoglio assumeva nel mondo omerico - si ricordi Achille che si rotola nella polvere alla notizia della morte di Patroclo - o nell’antico Israele - si pensi a David che alla noti zia della morte di Saul «abbrancate le vesti se le stracciò» - si mantiene ancor oggi nelle campagne della Lucania, solo che qui non si tratta di eroi o di re protagonisti di una grande storia, ma di povere donne contadine che la civiltà cristiana e il mondo moderno hanno ancora lasciato fra coloro che, di fronte alla morte, si comportano - per ripetere le parole di Paolo - come «gli altri, che non hanno speranza». Nella sua forma più radicale la crisi del cordoglio presenta la caratteristica polarità dell’a s s e n z a e della scarica convulsiva: la presenza perde se stessa degradandosi a pura e semplice energia meccanica che defluisce senza significato. La frequenza di una rea zione di questo tipo è incredibilmente alta fra le contadine lucane, e presenta varie sfumature a seconda del grado di assenza e dei caratteri della scarica meccanica. In una forma meno radicale l’as senza si attenua in uno stato di ebetudine stuporosa, o in luogo della scarica meramente meccanica si ha la terrificante esplosione parossistica, tendenzialmente autoaggressiva. Lo stato di ebetu dine stuporosa ha fra le contadine lucane una incidenza così forte da essere indicato con un vocabolo di uso corrente nei villaggi lucani: attassamento. La persona attassata è irrigidita in una immo bilità fisica che riflette un vero e proprio blocco psichico più o meno accentuato. Le varie sfumature dell 'attassamento sono in qual
IL L A M E N T O F U N E B R E LU CA N O
79
che modo adombrate nelle rozze descrizioni che ce ne hanno dato diverse informatrici contadine. «La persona attassata — ci ha detto una informatrice di Montemurro - non riconosce le per sone: non ricorda neppure che c’è il morto. Se le si chiede qualche cosa non risponde, oppure dà risposte senza senso. E come se sognasse. Quando esce dalVattassamento, si guarda intorno per capire che cosa è successo, poi getta un grido e riprende la lamen tazione». Una informatrice di Albano Lucano: « L ’attassamento può durare un quarto d’ora. La persona attassata non risponde alle domande, o non risponde a senso, quando si riprende e si rende conto, getta un grido e riprende il lamento». Un’altra informa trice della campagna di Albano: «U attassamento viene specialmente quando si ha la notizia di una morte improvvisa. Può durare anche mezza giornata». Una informatrice di Avigliano: « L 'attassamento viene per il troppo piangere e disperarsi. Spesso prende quando si ritorna a casa dopo l’accompagnamento al cimitero». E, infine, una informatrice di Castelsaraceno: «Appena si esce άαΆ!attassa mento si dà un grido perché si riconosce che cosa è accaduto». Polarmente contrapposta allo stato di ebetudine stuporosa è l’esplosione parossistica!Se nell’ebetudine stuporosa la donna col pita da lutto sta come inèrte, senza anamnesi della situazione, nel l’esplosione parossistica essa si getta a terra, dà col capo nel muro, salta, si graffia a sangue le gote, è accesa da furore tendenzialmente diretto verso la propria persona, si strappa i capelli, si lacera le vesti, si abbandona ad un gridato che è piuttosto un ululato. A questo comportamento disordinato e pericoloso, possiamo dare la denominazione di planctus irrelativo. Ovviamente né l’assenza totale e la scarica convulsiva, né l’ebetudine stuporosa e il planctus irrelativo costituiscono il lamento funebre rituale: tuttavia per comprendere la struttura istituzionale del lamento come tecnica del piangere occorre tener presente innanzi tutto questi aspetti particolari della crisi del cordoglio. Il lamento funebre lucano è infatti da interpretarsi come ripresa e reintegrazione culturale dell’ebetudine stuporosa e del planctus irre lativo in quanto rischi a cui è esposto chi è colpito da lutto. Se nell'ebetudine stuporosa una sinistra inerzia avvolge e sof foca la vita psichica minacciando di annientarla nell’assenza totale, e se nel planctus irrelativo il cordoglio si disumanizza in compor-
8o
CAPITOLO SECONDO
tamenti che da un momento all’ altro possono ridursi ad una sca rica meramente meccanica di energia psichica, la lamentazione fune raria affronta l’ebetudine stuporosa e la sblocca, accoglie il planc tus e lo sottopone alla regola di gesti ritmici tradizionalmente fissati, con l’esclusione o l’attenuazione simbolica di quei comportamenti che sono più rischiosi per l’integrità fisica della persona. Operata questa prima selezione ordinatrice sul numero e sulla qualità dei gesti, il lamento rituale lucano riplasma il gridato e l’ululato in ritor nelli emotivi da iterare periodicamente, in modo che fra ritornello e ritornello sia dato orizzonte al discorso individuale. D ’altra parte il discorso individuale della lamentazione non è libero, ma vinco lato, ed è vincolato perché bisognoso di essere protetto dal rischio di tornare ad essere sommerso dal planctus irrelativo. La prima pro tezione sta innanzi tutto, come si è detto, nella regola della perio dicità dei ritornelli emotivi: ma vi sono vincoli protettivi interni al discorso stesso, e cioè l’obbligo di impiegare moduli verbali defi niti, cantati secondo una melodia tradizionale, e accompagnando la recitazione con una mimica ritmica definita. In sostanza dal planc tus irrelativo il lamento passa al planctus ritualizzato, e mediante questa ritualizzazione rende possibile l’enuclearsi di un discorso protetto. Per l’esatta comprensione di questa dinamica così carat teristica occorre premettere alcune considerazioni sullo stato psi chico in cui entra la lamentatrice in azione. L ’etnografo che osserva la lamentazione in atto non può sot trarsi all’impressione, soprattutto in dati momenti, che si tratti di un pianto senz’anima, inattuale, destorificato, come se non fosse la lamentatrice a piangere, ma un’altra, o quasi un’altra, anonima e sognante che piangesse in lei per un generico e anonimo «si muore», secondo gli schemi di un impersonale «si piange così». In realtà l’indefinita monotona iterazione dei modelli culturali di comportamento, sempre sullo stesso ritmo, attenua la presenza di veglia e induce e mantiene nella lamentatrice un leggero stato oniroide, una presenza rituale del pianto, sul cui piano si attenua l’asprezza dell’insopportabile situazione storica reale (questo lutto, che ha colpito me), e al tempo stesso si stabilisce un rapporto con le tentazioni irrelative della crisi, e soprattutto con gli impulsi del planctus caotico. D ’altra parte la presenza di veglia non scompare del tutto, ma si restringe alla semplice funzione di guida e di regìa,
IL LAM ENTO FU N EBR E LUCANO
81
e ad un generico rapporto con la situazione luttuosa nel suo com plesso. Viene così istituito, in luogo della normale presenza unita ria di veglia, un particolare regime di relativa dualità psichica che solo di grado differisce dalla più profonda dualità delle presenze simultanee che si realizza per esempio nella prassi sciamanistica e nella seduta spiritistica, allorché lo sciamano o il medium entrano in rapporto con uno «spirito». Mentre nella dualità delle presenze simultanee dello sciamano o del medium l’interruzione tra presenza normale e presenza seconda è così profonda da essere avvertita come manifestarsi di uno spirito che parla ed opera attraverso lo sciamano o il medium, nella relativa dualità esistenziale della lamen tatrice in azione l’interruzione è molto meno profonda, perché la presenza rituale del pianto non è interamente altra rispetto alla presenza di veglia. Ma che vi sia una interruzione relativa e una relativa dualità è dimostrabile da alcune particolarità. Infatti, in primo luogo, il pianto è concentrato e mantenuto unicamente sul piano della presenza del pianto: eseguita la lamentazione nei modi prescritti, chi l’ha eseguita resta libero da sollecitazioni, e può vol gersi all’opposto stato d’animo della spensieratezza e dell’allegria, o quanto meno può dedicarsi alle normali occupazioni come se nulla fosse successo. Trapassi bruschi di questo genere sono stati da noi frequentemente osservati nelle lamentatrici lucane. In secondo luogo durante l’esecuzione del lamento la lamentatrice può distrarsi e volgere momentaneamente l’attenzione ad eventi futili, che la piena del dolore non dovrebbe consentire di percepire se davvero una stessa presenza rigorosamente unitaria fosse impegnata nella lamentazione. Queste possibili distrazioni - come i bruschi tra passi di umore a cui si è accennato prima - possono indurre erro neamente l’osservatore a giudicare l’intero lamento come una fin zione ipocrita: in realtà la distraibilità della lamentatrice in azione è nient’altro che un effetto della relativa interruzione che sussiste fra la presenza di veglia, impegnata nella sua funzione di controllo e di guida, e la presenza oniroide nella quale il pianto è concen trato e mantenuto. La distraibilità delle lamentatrici in azione non sfugge all’osservazione popolare, e in ogni paese si serba memoria di determinati episodi del genere nel corso di determinate lamen tazioni. Così per esempio a Ferrandina ci è stato riferito che una volta mentre la tal dei tali eseguiva la lamentazione per il padre
82
CAPITOLO SECONDO
morto, i bambini inconsapevoli della gravità del momento si misero a giocare con i pesi della bilancia. Allora la lamentatrice inserì nel pianto rituale rammonimento: «Attenti ai pesi, altrimenti perdiamo i pesi con la bilancia, babbo mio». Ecco il testo letterario della lamentazione, dal quale sarà possibile formarsi un’idea più con creta di questo contrasto: (aRC) Attàne mie, attàne mie, ah ce sciurante è joce, aitane mie. Quanne n’amma scurdà sta data? Quanne jeve buone, amabele de tutte! Quanne fatìa si fatte, attàne mie! Sì muorte cu’ la fatìa e li mane! Ce nome m’è cadute de la vocca, attàne mie! Quanne jere buone, ca te la facive pure co’ le gal line! Mò s’ abbìa la campane, attàne mie. Se cette lu bande pe’ lu paese, attàne mie. E ci è muorte joce, è muorte Vitangelo Ragone. O ce male cri stiane! Quanne visite arricevime joce, attàne mie, quanne n’amme renne. Le vulemme renne tutte de cuntentezza, attàne mie. Mò vene commare Rita, te porta nu mazze de fiure. Vi’ quanne cammine c’ave fatte, ca mo non se ne acchiano, attàne mie! Attinti a li pisi ca po p erim m o li pisi co ’ la valanza, attàne mie. Quanne stive malate, attàne mie, me chiamaste vicino o’ lette, attàne mie, e me dicisti ca vulivi o’ melone zuccarino. Co na mano te dibbe o’ melone e Tolde la mettibbe sopa ’a ventre. E dopo mangiate o’ melone, me dicisti: «Sabedda, mi sì ricreate». Attàne mie! Mò vene compare Giu seppe, co’ le mani pulite. A quale fiera avita sci? A chedda de Gravina? Sfatte bone, attàne mie. Mò véneno le privite, mò vénene le monache, è arrivata la banda. Statte bone, attàne mie! Véneme ’nsuonne, e véneme a dice se si cuntente de cudde ca ti simmo fatte, attàne mie! (Babbo mio, o che giornata è oggi, babbo mio. Quando dobbiamo scordarci questa data? Quanto eri buono, amabile in tutto! Quanta fatica hai fatto, sei morto con la fatica alle mani! Che nome mi è caduto dalla bocca, babbo mio! Quanto eri buono, te la facevi anche con le galline! Ecco che comincia a suonare la campana, babbo mio. Si getta il bando per il paese, babbo mio. E chi è morto oggi, è morto Vitangelo Ragone. Oh, il malo cristiano che eri! Quante visite riceviamo oggi, quante ne dobbiamo rendere. Le vogliamo rendere tutte di contentezza, babbo mio. Ecco commare Rita, con un mazzo di fiori. Guarda quanto cammino ha fatto, ché non se ne trovano di fiori in questa stagione, babbo mio! Attenti ai pesi, ché poi perdiamo ì pesi con la bilancia, babbo mio. Quando eri malato, babbo mio, mi chiamasti vicino al tuo letto, e mi dicesti che volevi il melone zuccherino. Con una mano ti detti il melone e l’altra la misi sul tuo ventre. E dopo mangiato il melone, mi dicesti: «Isabella, mi hai consolato». Babbo mio! Ecco compare Giuseppe, con le mani pulite. A quale fiera dovete andare, a quella di Gravina? Addio, babbo mio. Ecco i preti, ecco le monache, è arrivata la banda. Addio, babbo mio. Ritorna in sogno, e vienimi a dire se sei contento di quello che ti abbiamo fatto, babbo mio).
IL LAM ENTO FUNEBR E LUCANO
83
Ma la dualità fra presenza del pianto e presenza di veglia, e in particolare la funzione di guida esercitata dalla presenza di veglia, si manifestano nel fatto che la lamentazione è sottoposta alla disci plina del rito, e può essere iniziata, interrotta e ripresa a volontà, secondo i momenti del rituale funerario e le date canoniche. «A l l’alba del terzo giorno ci si alza e ci si mette a piangere», ci diceva una lamentatrice di Stigliano alludendo all’obbligo di ripetere il lamento tre giorni dopo il decesso. Analogamente 1 esecuzione del lamento davanti al cadavere o durante i funerali o al momento della inumazione comporta interruzioni e riprese canoniche: infatti il lamento vero e proprio è trattenuto sin quando sono state con dotte a termine le operazioni di vestizione del cadavere, oppure deve essere sospeso al tramonto e ripreso all’alba, e così via. L ’evocabilità istituzionale della presenza rituale del pianto rende possi bile la distribuzione nel tempo del trattamento risolutivo della crisi del cordoglio e spiega il significato tecnico dell’obbligo di ripetere la lamentazione in date canoniche stabilite. In virtù della strut tura del lamento il lavoro del cordoglio viene eseguito in turni suc cessivi, utilizzando la condizione destorificata e protetta della pre senza rituale e fruendo di lunghi intervalli di riposo durante i quali l’attenzione può essere rivolta alle normali occupazioni. Tale strut tura del lamento spiega anche come l’etnografo possa invitare la lamentatrice a lamentarsi fuor dell’occasione reale del rito, e possa ottenere - col favore di determinate circostanze - una lamenta zione quasi simile a quella vera. In generale il risultato è molto migliore quando si invita la lamentatrice a rinnovare il cordoglio per un lutto più o meno recente da essa patito, e quando si rico struisce esteriormente lo scenario della lamentazione.
5. La conquista del discorso protetto L ’istituzione di una presenza rituale del pianto in relativa dua lità rispetto alla presenza normale che esercita funzioni di guida e di regìa possiede un significato tecnico fondamentale nella lamen tazione funebre. Nella crisi del cordoglio la presenza storica si smar risce in comportamenti alienati: l’istituzione della presenza rituale del pianto rende possibile la catabasi verso questi comportamenti
84
CAPITOLO SECONDO
in rischio di alienazione, e al tempo stesso Γ anabasi e la ripresa, cioè la loro reintegrazione culturale e il loro ridischiudersi verso il mondo dei valori.iÈ sul piano della presenza rituale del pianto che infatti viene compiuta la conversione del planctus irrelativo nel planctus ritualizzato, ed è su questo stesso piano che viene con quistato il discorso protetto della lamentazione. Noi possiamo ora considerare più da vicino la dinamica di questo discorso dramma ticamente raggiunto e mantenuto. Da un punto di vista strettamente letterario il discorso protetto della lamentazione lucana consta di brevi versetti senza metro né rima, terminanti quasi sempre con un ritornello emotivo (più pre cisamente vocativo: beni di la sora, attàne mie, frate mie, mamma mea, schianata me ecc.). Questi versetti cantati su una linea melodica tradizionalizzata villaggio per villaggio, sono lavorati con moduli espressivi fissi tradizionalizzati. Una parte di questi moduli ha un carattere tendenzialmente epico, di glorificazione delle res gestae, anche se si tratta di un operare che non va oltre la cerchia ristretta della vita familiare: i moduli cioè rispondono alla prepotente esi genza risolutrice di riappropriarsi di ciò che del morto effettiva mente è permanente e non patisce morte, cioè l’opera (nel nostro caso le opere del buon padre o del buon marito o della buona madre o della buona sorella o del buon figlio). I moduli offrono schemi emotivi di «buone opere» compiute, che sono attribuite al defunto anche se la realtà è stata diversa. Così per esempio in molti vil laggi lucani ricorre nei lamenti resi da moglie al marito il modulo: «Eri così buono: mi andavi levando le pietre da mezzo la via», al ludendo a un atto di gentilezza del marito che durante gli sposta menti faceva salire la donna sull’asinelio e andava togliendo le pietre sul percorso, per evitare i sobbalzi: questo modulo è convenzio nale, e si applica con scarsissima aderenza alla realtà effettiva delle cose. Senza dubbio in questi modelli convenzionali di opere buone agisce anche una valenza di prestigio sociale: ma il bisogno di riem pire il vuoto della morte con la risoluzione epica della vita costi tuisce l’aspetto fondamentale. In generale i moduli espressivi tra dizionali tendono ad esaurire, per quanto possibile, i casi tipici in cui - nell’ambiente economico, sociale e morale dato - la per sona può trovarsi quando sia colpita da lutto. Vi sono moduli gene rici, validi per ogni caso di morte e adatti ad esprimere le reazioni
IL LAM ENTO FU N EBR E LUCANO
»5
psicologiche più frequenti, e ve ne sono di quelli che si riferiscono a situazioni più particolarizzate, come la morte del marito, del padre o della madre, del fratello o della sorella, del figlio ancor giovine, o della figlia non sposata, e così via. Questi moduli hanno una dif fusione varia, e taluni di essi si ritrovano in più villaggi, anche se separati da una distanza di centinaia di chilometri, tanto che - se ne valesse la pena - si potrebbe costruire una carta di dif fusione di ciascun modulo: tuttavia in uno stesso villaggio e per una stessa comunità i moduli che formano patrimonio della memoria culturale di una lamentatrice sono così numerosi da poter imba stire con essi un lamento lunghissimo nelle circostanze luttuose più diverse. In via di esempio, a Montemurro una figlia lamenterà il padre morto utilizzando i seguenti moduli: (PD) Tatta mie come voglie fa, tatta mie. Addò n’è benuta sta morte tua, tatta mie. Cume n’aie abbandunate, tatta mie. O amore de le figlie, tatta mie. Te sò passate tutti li dulure, tatta mie. Che morte all’improvvisa, tatta mie. Hai lassate li figlie tue, tatta mie. Nun hai date nisciune scuonze, tatta mie. E comme amma fa senza di te, tatta mie...
L ’ordine di tali moduli potrà mutare nei singoli casi, ma se si chiede di ripetere un lamento di figlia a padre ogni lamentatrice farà ricorso agli stessi moduli, che essa considera ciò che «si dice» o «si deve dire» in una circostanza luttuosa del genere. Tra i moduli gene rici, adatti a tutte le circostanze, vi è per esempio la sequenza: «M ’agghia vutà e m’agghia girà e non t’agghia vedé chiù» (Pisticci, Grottole...). Durante l’esposizione del cadavere parenti e vicini vengono a rendere visita al defunto: la lamentatrice deve registrare nel suo lamento il mutamento di scena, segnalando il nome di chi entra, rammemorando i rapporti che lo legavano al morto e accen nando magari a qualche episodio saliente della passata dimesti chezza: e anche ciò avviene in modi stereotipi, che lasciano pochis simo margine alla variazione. A Ferrandina e a Grottole l’ingresso del visitatore viene registrato col modulo di prammatica: «Mo vene...» seguito dal nome della persona (per esempio «compare Nicola») e da qualche particolare correlativo (per esempio «co’ nu
IL LAM ENTO FU N EBR E LUCANO 86
87
CAPITOLO SECONDO
mazze de sciure»). La lamentatrice suole registrare con sequenze stereotipe anche altri momenti critici del cerimoniale funerario, come l’ingresso dei becchini o del prete, il suono delle campane, il trasporto della bara fuori casa ecc. Un modulo conclusivo riscon trato a Ferrandina, Pisticci e Grottole consiste nella richiesta al defunto se è contento di quanto «gli è stato fatto», cioè della mani festazione di cordoglio dei parenti e della pompa del funerale. Nel caso della vedova che lamenta la morte del marito è stereotipo il ricordo dei momenti critici passati insieme, di episodi salienti della vita in comune, e di qualche atto di gentilezza reso dal marito alla moglie, come quello di far salire la moglie sull’asinelio durante gli spostamenti, e di togliere le pietre dalla via per evitare i sobbalzi: il che si dice - come abbiamo già osservato - anche se la cosa non è vera. Quando la lamentatrice piange la morte di un uomo adulto, marito o padre o fratello, ricorre molto spesso il tema delle mani del morto e della fatica alle quali esse erano adusate: «Quanta fatta hai fatt’a sse mane» (quanta fatica hai fatto con queste mani), «Sì muorte co’ la fatìa a le mane» (sei morto con la fatica alle mani): ma per la morte della figlia ancora nubile è di prammatica l’anti chissima contrapposizione fra le nozze terrene - non ancora con sumate - e le nozze con la morte. Nel lamento reso a persone giovani o mature, ma comunque non propriamente vecchie o decre pite, ricorre con frequenza una invocazione amaramente sarcastica: «Oh! il vecchio che eri», intendendo dire il contrario, cioè che era giovane abbastanza per continuare a vivere. Sempre con la stessa figura retorica si dice: «Oh! ce male cristiane» (che malo cristiano), che significa anche qui il contrario, cioè «che uomo dabbene che eri». Molto diffuso (e largamente impiegato dalle madri che lamen tano i loro figli morti) è il tema della morte come sonno: la lamen tatrice immagina che il morto sia soltanto immerso in un sonno «troppo lungo» ed esorta e scongiura il dormiente a svegliarsi, ad alzarsi, a camminare. Un’altra serie di moduli è in rapporto alla condizione in cui viene a trovarsi la lamentatrice dopo la morte del sostegno della famiglia, marito o figlio che sia. Il regime tradi zionale di esistenza assegna alla contadina lucana una gravosa con dizione di soggezione, che le fa sperimentare quotidianamente come il suo operare sia fronteggiato, contraddetto, ridotto, smentito e schiacciato da forze incontrollabili. Per quanto non le sia rispar
miata la fatica, anche quella più aspra, essa vive in uno stato di continua dipendenza economica, sia da ragazza nel nucleo fami liare dei genitori, sia da sposa quando il marito sarà per lei «o’ trave de la casa», il trave maestro della casa. Essa affronta sotto il segno della buona o della mala «sorte» i momenti più delicati del suo destino di donna e di madre, la pubertà, le nozze, la gravi danza, il parto, il puerperio, l’allattamento. E proprio in rapporto a questa condizione di dipendenza, l’evento luttuoso che la colpi sce, soprattutto se si tratta del marito, risolleva di colpo, nella sua imponente carica emozionale, tutto l’arco di una vicenda esisten ziale deficitaria. Di qui alcuni moduli ricorrenti nella lamentazione: la vecchia madre perde il suo «bastone» e la sua «speranza», la vedova vede schiantato «il trave maestro della casa» e si sente abbandonata «in mezzo a-una strada» con «un fascio di figli in boccio». Il destino degli orfani senza la protezione paterna si con figura alla vedova come una vicenda di patimenti e di umiliazioni a cui essi da ora in poi saranno esposti: «chi darà loro uno schiaffo e chi un manrovescio» dice un modulo di Grottole. Il pensiero che ora toccherà alla Vedova lavorare per sfamare gli orfani ancora piccoli si esprime a Pisticci con il modulo: «m’agghie affritecà la stuane» (mi debbo rimboccare il grembiale, alludendo all’ abitu dine di rimboccarsi il grembiale sul davanti a mo’ di grossa tasca allorché la donna va al lavoro dei campi). La vita «pane senza pane», cioè trascorsa col suo uomo nel rosario dei giorni che portarono il pane e di quelli che non lo portarono, sta ora davanti alla vedova, in atto di prolungarsi in un nuovo rosario di giorni ancora più amari, dominati dall’incertezza. Alcuni frammenti di un lamento di moglie a marito, raccolto a Grottole, possono offrire un buon esempio di questa tessitura di stereotipie verbali: (RD) O frate mie, o frate mie buone e belle, quante te pense, a ogna a ogna. Frate mie, penze comme me lasse mienze na via cò tre file. Ci l’adda fa tranne a chisse, frate mie? Quanne me n’haie fatte passà pe’ l’amore de Tolde, frate mie! Mò sò rimaste cuntente: se pigghiassero na cianca e se la mangiassero. Frate mie, vuie esse pensate quanta fatìa haie fatte chi sti mane: Si muorte cu la fatìa a li mane. Dò t’agghia veni a cchià? (Entra nella stanza compare Giovanni e altri compari e comari che vengono a render visita di condoglianza:)
88
C A P IT O L O S E C O N D O
Mo vene cumpà Giuannine: nun t’adda veni chiù a chiama a li tre pe sci a la macchia. Mò vénene tutte, cummare e cumpare, senza ’nvetate, frate mie. Lu cumplimente come l’agghia dà, ca non ce n’è? Speriamo a Gesù Cristo cussu duvere ca te vénene a ffa cummare e cum pare li vogghie renne di buone. E ci è muorte, frate mie? È muorte Nicola. {Entra i l prete: la lamentatrice si strappa i capelli e li getta nella bara ·.)
Frate mie, non t’agghia che te dice e che te dà, tine li capidde mie pe’ ricurde. {Prima della chiusura della bara i fig li baciano i l morto·)
Frate mie, l’ultime vase ca te donne li fili toie: và prià a Die pi lore, non te scurdà mai de li fili toie e de la sora toia. Famm’aprl n’olda porta pe’ falle iranne. Chidde file anna sci sotto a li dispetti de Tolde: ci n’ave da nu scaffe e ci nu muffettone. {Entra zio M enico che accompagnò i l defunto a ll’ospedale di Matera quando v i fu trasportato per essere sottoposto a ll’operazione letale)
Frate mie, mò vene zi Meniche: quanne te purtò o’ spedale come te vedisti frate mie, sule sule senza la sora toia? Ci t’ha viste e ci t’ha date na stizza d ’acqua almeno quanne stave sotto a chidde curtedde, sopa a chedda baredda, e t ’adoperavano? {La bara è presa a spalle dai becchini. L a lamentatrice prorom pe in un gridato altissim o)
Frate mie, frate mie, pindiddi li pide a la porta e nun te ne sci, frate mie. (O marito mio, o marito mio buono e bello, quanto ti penso, a unghia a unghia. Marito mio, guarda come mi lasci in mezzo a una via con tre figli. Chi li deve far grandi questi figli, marito mio? Quante me ne hai fatte pas sare per amore degli altri, marito mio! Adesso son rimasti contenti: si pren dessero una coscia e se la mangiassero. Marito mio, vuoi essere ricordato per quanta fatica hai fatto con queste mani: sei morto con la fatica alle mani. Dove dovrò venirti a cercare? Ecco che viene compare Giovanni: non ti verrà più a chiamare alle tre del mattino per andare in campagna. Ecco che ven gono tutti, comari e compari, senz’essere invitati, marito mio. Come offrire qualche cosa agli invitati, ché non c’è nulla? Speriamo in Gesù Cristo che questo dovere che ti vengono a rendere comari e compari io lo possa ren dere in bene. E chi è morto, marito mio? E morto Nicola. Marito mio, non ho che dirti e che farti: prenditi i capelli miei per ricordo. Marito mio, Tul-
IL L A M E N T O F U N E B R E LU CA N O
89
timo bacio che ti dànno i figli tuoi: prega Dio per loro, non ti dimenticare mai dei tuoi-figli e della tua donna. Fammi aprire un’altra porta [fammi tro vare un’altra strada] per farli grandi. Questi figli debbono andar sotto i dispetti degli altri, chi darà loro uno schiaffo e chi un manrovescio. Ecco che viene zio Menico: quando ti portò all’ospedale come ti vedesti, marito mio, solo solo senza la tua donna? Chi s’è preso cura di te e chi t’ha dato una goccia d’acqua quando stavi sotto a quel coltello, sopra a quella barella, e t’operavano? Marito mio, marito mio, punta i piedi contro la porta e non te ne andare, marito mio).
Il testo letterario è qui interamente lavorato con moduli che sono tradizionali nel lamento di una vedova: infatti moduli ricor renti sono, per esempio, «O marito mio, o marito mio buono e bello, come ti penso a unghia ad unghia»; «Marito mio, come mi lasci in mezzo alla via con tre figli»; «Fammi aprire un’altra porta per farli grandi»; «Questi figli debbono patire i dispetti degli altri, e chi deve dar loro uno schiaffo e chi un manrovescio»; «Sei morto con la fatica alle mani» ecc. Analogamente è tradizionale sottoli neare l’ingresso di un visitatore con il modulo «Ora entra il tal dei tali», o rivolgere la domanda retorica «Chi è morto?» seguita dal nome del defunto. Per i morti lontani da casa, senza l’assistenza dei loro cari (per esempio all’ospedale o in guerra) è modulo fisso chiedersi chi avrà dato loro una goccia d’acqua per lenire la sete, mentre la scongiurante richiesta di «puntare i piedi alla porta» per non andarsene è ricorrente al momento in cui la bara è portata via. Ma la lamentazione è tradizionale non soltanto perché i suoi versetti sono lavorati secondo modelli stereotipi attinti alla memoria culturale della lamentatrice, ma anche perché vi è una mimica d’obbligo nell’esecuzione, una gesticolazione «prescritta». Quando si deve eseguire il lamento bisogna sciogliersi le chiome: le chiome sciolte fanno parte del «modello» della lamentatrice in azione, e il modello va rispettato con fedeltà rituale. Durante l’esecuzione il lamento è accompagnato a un determinato movimento ritmico del busto a destra e a sinistra, come per una ninna-nanna, o avanti e indietro, con appropriati gesti delle mani, secondo il modello di un discorso particolarmente vibrante e impegnato. Questi moduli mimici sono i più diffusi nell’area che è stata esplorata: ma in deter minati villaggi, o in rapporto a determinate forme di lamentazione, altri moduli sono stati tradizionalizzati, e valgono come modello da rispettare. A Pisticci la lamentazione durante la normale espo-
CAPITOLO SECONDO
90
sizione del cadavere è eseguita secondo un periodo mimico defi nito: la lamentatrice agita dapprima il fazzoletto sul cadavere e quindi lo porta al naso, iterando indefinitamente il gesto, versetto per versetto, in una sorta di andamento automatico che lo rende prevedibile al pari dell’orbita di un pianeta. Sempre a Pisticci, quando il cadavere è eccezionalmente deposto per terra sulla strada - come nei casi di morte violenta - il gesto risulta un poco più complicato: la lamentatrice agita il fazzoletto sul cadavere,24 si piega sulle ginocchia sempre agitando il fazzoletto25 e infine si rialza portando il fazzoletto al naso:26 il periodo mimico è scan dito sul ritmo della linea melodica che a Pisticci è tradizionale per lamentare il morto, e d’altra parte periodo mimico e linea melo dica formano organica unità con ciascun versetto della lamenta zione. In un lamento raccolto nel villaggio di Càlvera una madre lamentò il figlio morto secondo il tema del sonno troppo lungo in cui il morto è immerso, e da cui era invitato a svegliarsi: un tema che, come si è detto, è tradizionale nei lamenti resi da madre a figlio. La mimica relativa si legava organicamente al contenuto della lamentazione: la madre andava battendo a tempo le palme e danzava intorno al letto, interrompendosi di tanto in tanto per somministrare, ora sui piedi ora sulle guance del cadavere, dei rapidi buffetti come per risvegliare il figlio dal suo sonno maligno. Il terzo vincolo tradizionale della lamentazione è dato dal tema melodico, cioè dalla linea melodica con cui ciascun versetto è can tilenato, e dalla strofa melodica nel suo complesso. Si consideri, in via di esempio, il seguente lamento di Ferrandina, reso da sorella a fratello, che vale ad illustrare il nesso organico tra moduli lette rari e moduli melodici: 1. O Ciccille mie, o belle 2. O frate, o frate 3. O Ciccille mie, o frate, o frate 4. Come vogghie fà, o belle 5. O frate mie, o frate mie 6. ’O vogghie bé! 24 Atlante figurato del pianto, n. 3a. 25 Ibid., n. 3b. 26 Ibid., n. 3C.
O Francesco mio, o bello O fratello, o fratello O Francesco mio, o fratello, o fratello Come farò, o bello O fratello mio, o fratello mio Gli voglio bene!
IL LAM ENTO FU N EBR E LUCANO
7. O frate, o frate, o frate, o frate. 8. Come ’o vuogghie bé, o frate, o frate 9. Mo te n’aie sci, o frate 10. Come agghia fa, o frate. 11. O frate mie, frate mie 12. O Ciccille mie, o frate, o frate 13. Come vuogghie fa senza di te, o frate 14. Je me n’agghia sci, o frate 15. Agghia muri pur’ ie, o frate 16. O frate mie, o frate mie 17. O come vogghie fa, o frate mie 18. Vogghie muri pur’ ie, o frate mie 19. O frate mie, o frate mie 20. O frate mie belle belle, o frate mie 21. O frate mie, o frate mie 22. Frate mi!
9i
O fratello, o fratello, o fratello, o fratello. Come lo voglio bene, o fratello, o fratello Ora te ne devi andare, o fratello Come debbo fare, o fratello. O fratello mio, o fratello mio O Francesco mio, o fratello, o fratello Come farò senza di te, o fratello Io me ne debbo andare, o fratello Debbo morire anch’io, o fratello O fratello mio, o fratello mio O come farò, o fratello mio Voglio morire anch’io, o fratello mio O fratello mio, o fratello mio O fratello mio bello bello, o fratello mio O fratello mio, o fratello mio Fratello mio!
Il testo letterario di questo frammento di lamentazione consta di versetti ciascuno dei quali itera uno stesso ritornello emotivo (fratello mio, fratello) e si appoggia interamente a moduli letterari che «si dicono» nei lamenti. Ogni versetto è cantato su una linea melodica che in Ferrandina è tradizionale per lamentare il morto: essa è formata da una scala pentatonica discendente d al/ίΖ al si: ne nasce, per ogni versetto, un senso di caduta o addirittura di scarica, accentuata dal fatto che spesso appare un portamento del fa , cioè una breve salita iniziale, come un librarsi prima di preci pitare. Un secondo carattere che domina la melodia del lamento è il vuoto sonoro determinato in ogni versetto dalla costante man canza del re. Tale vuoto, non ha luogo a caso rispetto alla strut tura letteraria del testo, poiché cade sempre prima del ritornello emotivo invocante il fratello: je me n'agghia sci I o frate; vogghie murì pur’ ie I o frate; com'agghia fa I o belle. La dinamica di questo lamento presenta tre forme distinte: iterativa modulare, rubata e accele rata. La prima è normale e domina tutta la lamentazione; il rubato appare in genere in rapporto con il ritornello emotivo e in alcuni
94
C A P IT O L O S E C O N D O
versetti costituiti interamente da ritornelli emotivi, come i ver setti 7 e 19. L ’accelerazione si manifesta con particolare evidenza nei versetti 6 (’o vuoggbie bé) e 22 {frate mi) nei quali l’iterazione modulata è interrotta da due esplosioni angosciate della voce, così rapide e violente da troncare la parola finale {bé invece del con sueto bene, e m i invece di mìo). L ’esecuzione del lamento funebre lucano, così come oggi si pre senta all’osservazione dell’etnografo, è spesso individuale: una regola di incidenze corali dei ritornelli emotivi non è stata riscon trata, ma molto probabilmente per logorio attuale di antiche strut ture rituali, come risulterà dall’analisi del lamento folklorico euro mediterraneo. Abbiamo invece raccolto a Pisticci una lamentazione in cui le voci di due lamentatrici si inseguono a canone l ’un l’altra, di guisa che se la prima voce canta per esempio il modulo «Beni di la sora, ce tradimente a la casa mea», la seconda inaugura il suo mo dulo quando la prima è a «ce tradimente»: ne deriva una impressio ne di sinuoso rincorrersi di voci, complicata dal fatto che mentre la prima voce accelera, la seconda allarga, diminuendo e rubando.27
6. Il discorso protetto mediatore della singolarizzazione del dolore Fin qui il lamento funebre lucano è stato analizzato come itera zione di moduli letterari, mimici e melodici tradizionalmente fis sati. Senza dubbio allorché si raccolgono sporadicamente e asiste maticamente alcuni testi letterari di lamenti in questo o quel villaggio di un’area relativamente estesa può nascere la falsa impres sione che i moduli siano pochi e che la lamentatrice sia una «libera improvvisatrice» di lamentazioni. Ma se si adotta il criterio quan titativo, raccogliendo pazientemente in uno stesso villaggio un buon numero di documenti, ci si rende subito conto che la lamentatrice è legata ad un gran numero di vincoli rituali, e che il ricordare ha una parte molto più importante del variare e del rinnovare. Del che non dobbiamo stupirci, dato che questa iterazione di modelli rientra nella funzione protettiva del discorso individuale: si recita come in una scena in cui i personaggi sono sorretti quasi da un 27 Queste osservazioni musicali sono state redatte in collaborazione con Diego Carpitella.
IL L A M E N T O F U N E B R E LU C A N O
95
«libretto» già convenuto di comportamenti e di parole, perché se si dovesse accettare pienamente la storicità della situazione e l’ini ziativa personale si sarebbe esposti alla catastrofe. Tuttavia la pro tezione verrebbe meno al suo significato tecnico se non mediasse in qualche misura anche minima il ritorno alla situazione storica, e se non ridischiudesse l’anamnesi dell’evento luttuoso particolare, e quindi la possibilità di un riadattamento o di una variazione o di una innovazione dei moduli, o anche soltanto di una loro rein terpretazione personale. La lamentazione segna il passaggio dalla crisi al discorso protetto, ma la protezione del discorso media il discorso stesso in quanto individuale, e quindi non più imperso nale e anonimo. La lamentatrice trova riparo internandosi nella selva dei moduli tradizionali del «si piange così», ma per entro questo momento protettivo riguadagna se stessa e il suo proprio singolarizzato dolore, in una dinamica che è caratteristica del lamento e che all’osservatore disattento appare ora come fredda convenzione e ipocrisia, e ora come «libera» creazione. Il recu pero di sé e del proprio rapporto col mondo si compie nella lamen tatrice a vari livelli di autonomia, dalla semplice reinterpretazione recitante di moduli noti, sino alla variazione, al riadattamento e alla innovazione: ogni lamentatrice percorre in questa direzione il cammino che può o che sa. Ma ciò che consente di camminare è il lamento in quanto strumento tecnico di ripresa e di reintegra zione. Il lamento di Ferrandina che abbiamo più sopra esaminato ripete su una melodia tradizionale un’arida sequenza di moduli ver bali comunissimi e di ritornelli stereotipi; tuttavia anche un lamento così povero lasciò intravedere, nell’esecuzione cui assistemmo, il tormento di una persona in crisi che si cerca e che tenta di rico struirsi. In altri casi il riadattamento e l’innovazione avviene intro ducendo cautamente il particolare singolo nel quadro di giri di frase convenzionali. Si consideri questo lamento di Grottole, dove la vedova ricorda un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Picciano: (RC) Frate mie, quanne scimme a Picciano, quante divertimenti ne simme pigliati. Te ricurde quanne ne scimme muorte de fame e mò c’avemme sta nu picche cuntente e in grazia di Die è venuta a’ morte e n’ha separate. Va mò tu, frate mie, a cudde munne, e và prià Die come agghia asci l’an nata cò sta morra de file. Famme aprì n’olde porte pe’ fa grande le file noste...
96
C A P IT O L O S E C O N D O
(Fratello mio, quando andammo a Picciano, quanti divertimenti ci siamo presi. Ti ricordi quando ci siamo morti di fame, e ora che dovevamo stare un po’ contenti e in grazia di Dio è venuta la morte e ci ha separati. Va’ ora tu, fratello mio, all’altro mondo, e va’ a pregare Dio come debbo pas sare l’annata con tutti questi piccoli. F a’ che mi si apra un’altra porta per far grandi i figli nostri...)
L ’espressione «quanne scimme a...» è di prammatica quando si ricordano viaggi memorabili compiuti insieme, e cosi pure è un modulo ricorrente la frase: «V a’ mò tu, frate mie, a cudde munne ecc.» «Fammi aprì n’olde porte ecc.» è un altro modulo che abbiamo incontrato in gran numero di lamenti resi da vedova a marito. E tuttavia il pellegrinaggio al santuario della Madonna di Picciano è un ricordo personale, che affiora protetto dalla selva dei moduli e delle stereotipie. In un lamento di Ferrandina l’epi sodio ricordato è una minutissima vicenda accaduta una volta: (RC) Frate mie, quanne scimme o’ pantane, o belle o belle, quann’arrivamme int’a l’appiette, se ne venne a chiove, o belle. E non tenimme ombrelle, o belle. E ne mettimme o ’ sacche pe’ cappuccie, o belle. lune n’groppe e l’olde ’nsella, o belle... (Fratello mio, quando andammo al pantano, o bello o bello, e quand’arri vammo alla salita, venne a piovere, o bello. E non avevamo ombrello, o bello. E ci mettemmo il sacco per cappuccio, o bello. Uno in groppa aU’asinello e l’altro in sella, o bello...)
L ’episodio è chiaro: una volta marito e moglie furono sorpresi dalla pioggia in campagna e riparati sotto un sacco impiegato a mo’ di cappuccio ritornarono in paese sull’asinelio, uno in groppa e l’altro in sella. Ma anche quando, come in questi due lamenti, la situazione storica si fa luce attraverso la selva delle stereotipie espressive, restano tuttavia la melopea e la mimica ad uniformarsi ai modelli tradizionali, il che immerge anche il lamento che lette rariamente sembra abbastanza autonomo in un’atmosfera di reci tazione sognante, drammaticamente trattenuta nell’anonimia e nella convenzione. Naturalmente quest’atmosfera così caratteristica va interamente perduta quando ci si limita a considerare il solo testo letterario, che nel suo isolamento e nella sua astrazione non è più la lamentazione funebre come rito.
IL LA M EN T O FU N E B R E LUCANO
97
7. Lamento funebre e ritomo irrelativo del morto Abbiamo sinora considerato il lamento lucano soprattutto come tecnica protettiva dall’ebetudine stuporosa e dal planctus irrela tivo della crisi: ora noi dobbiamo accennare al fatto che il lamento assolve una funzione risolutrice anche rispetto a un altro aspetto della crisi del cordoglio, cioè il ritorno irrelativo del morto come rappresentazione ossessiva o come immagine allucinatoria. Il folk lore lucano è ancor oggi ricco, soprattutto fra le contadine, di con tinui richiami a questo terrificante ritorno del morto come spet tro. «Son cose che succedono a noi contadine», ci disse una volta con rassegnazione una informatrice di Roccanova. Particolarmente favorevoli all’insorgere di tali esperienze allucinatorie sono i mo menti di stanchezza fisica, di prostrazione per scarsezza di cibo, di grave disagio morale. Carminella Pugliese, contadina di Rocca nova, di anni 68, detta in paese «la sonnambula», ci ha reso la seguente narrazione: Una sera del 1915 Carminella non riusciva a prender sonno. Il marito era in guerra e l’aveva lasciata nella miseria con due figli piccoli. Quella sera non aveva mangiato, e forse per questo non riusciva a dormire. Si alzò dal letto, e tanto per distrarsi, andò ad attingere acqua alla fontana. Era notte alta. Passando vicino al cimitero vide una figura vestita in bianco che le veniva incontro, e che riconobbe per la madre morta. Carminella non ne provò paura, le sembrava quasi di sognare. La figura in bianco l’accompagnò alla fontana, in silenzio. Al ritorno, ripassando davanti al cimitero, ecco una nuova figura in bianco: era Vincenzo Cervino, un contadino morto da poco. Vincenzo le raccomandò di portare sue notizie alla moglie, che era ancora viva e abitava in paese. In compagnia delle due figure Carminella continuò il cammino verso casa, ma a un crocevia gli spettri si dileguarono. Tornata in casa, al momento di rimettersi a letto, Carminella si andò «revegghiando revegghiando», cioè le parve di uscire come da uno stato di sogno. Si guardò intorno: la brocca colma d’acqua stava lì a provare che era andata realmente alla fontana. Allora si rese conto di aver parlato con i morti, e dalla gran paura per tre giorni ebbe freddo e febbre.
Le lunghe marce per raggiungere il luogo di lavoro, o per rien trare nel villaggio, hanno una parte importante nell’occasionare esperienze del genere: Anna Padula di anni 40, contadina di Roccanova, nel settembre del 1953 si recò in campagna con altre sei compagne, per la raccolta dei fichi. Dove
98
C A P IT O L O SE C O N D O
vano essere all’alba sul campo, e perciò si erano messe in cammino versò mezzanotte. Arrivata la comitiva in un punto della strada dove qualche tempo prima un giovane contadino era morto per disgrazia, sembrò loro di scor gere nelle tenebre la figura del morto, che dopo qualche istante sparì dissol vendosi in una colonna di fuoco. Il panico si impadronì della comitiva: chi gridava, chi piangeva, chi si dette a una fuga disperata.
Maria Totaro, di anni 70, contadina di Roccanova, racconta che una volta da giovinetta, mentre era in cammino all’alba vide un serpe sulla strada. Lo uccise e lo appese ad un albero. La sera, dopo una giornata di lavoro nei campi, sulla via del ritorno ripassò per lo stesso posto: il serpe era sem pre appeso all’albero. Come per un presentimento, decise di seppellire il serpe e si avvicinò all’albero per farlo. Ma proprio mentre stendeva le mani, il serpe drizzò il capo e disse: «N on sei contenta di avermi uccisa, vuoi farmi ancora del male mettendomi sotto terra? » Da queste parole Maria capì che il serpe era l ’anima di un morto, e ne ebbe grande paura, tanto che, tornata a casa, dovette mettersi a letto con la febbre. Angela Conte, di anni 50, contadina di Roccanova, riferisce che qualche tempo fa un contadino tornava a sera dopo il lavoro dei campi, quando improvvisamente fu assalito da uno stormo di uccelli neri che presero a bec carlo e a tormentarlo. Il contadino difendendosi gridava: «M a che volete da me? Volete l’anima? E prendetevela, allora! » Infine gli uccelli neri spari rono e il contadino tornò a casa. Si era incontrato con le anime dei morti.
Anche l’attinger acqua alla fontana, soprattutto di notte, com porta rischi di incontro con i morti. A Colobraro circola un rac conto che riflette lo stesso tema: Una volta un forese scommise col suo padrone di andare di notte ad attin ger acqua ad una fontana lontana dal paese: se avesse vinto la scommessa il padrone gli avrebbe dato una moneta di tre grana. Il forese si mise in cam mino, ma giunto nei pressi della fontana di Tromacchio, vide quattro per sone che portavano a spalla una bara. E bbe paura, e tornò indietro, ma poi, per amore delle tre grana, decise di avvicinare la fontana dalla strada di Spandìo. Ma, anche qui, il cammino era sbarrato dai quattro. C ’era una terza strada per andare alla fontana di Tromacchio, la strada di Pietrapertusata, e il forese tentò da quella parte: ma, anche qui, lo stesso brutto incontro. Allora gli venne incontro un sacerdote morto da qualche tempo, che lo prese per mano e amichevolmente gli disse: «Queste scommesse non le devi fare. Ma non aver paura, ti accompagno io a casa». Il forese tornò a casa, sempre accompagnato dal sacerdote morto, bussò la porta, e appena la moglie venne ad aprire le disse: «Guarda chi c’è qui con me: don Francesco». M a don Francesco era scomparso. Il forese si ammalò di paura, e morì, e il padrone tenne per sé le tre grana.
99
IL L A M EN T O F U N E B R E LUCANO
Il carattere di queste narrazioni è di essere delle reali avventure psicologiche: tranne che nel caso del forese, si tratta di esperienze personali realmente vissute, e al tempo stesso di storie vere per chi le racconta, con l’indicazione precisa di nomi, di date e di circostan ze, e con la conferma di altri «testimoni» che narrano l’episodio con varianti minime. D ’altra parte tali narrazioni presentano anche il carattere di una certa tradizionalizzazione culturale, nella quale l’allucinazione viene interpretata ideologicamente, disciplinata e controllata nei modi del suo prodursi, che ubbidiscono appunto alle forme della tradizionalizzazione stessa. Così per esempio i morti appaiono come serpi, uccelli neri, insetti e simili, o come spettri. Una forma interessante di tradizionalizzazione culturale del «ritor no dei morti» è data dalla cosiddetta «messa dei morti», a cui molte contadine (e anche qualche contadino) hanno creduto di assistere almeno una volta nella loro vita. Eccone alcuni documenti: Adelina Truncellito, di anni 50, contadina di Valsinni, riferisce che la messa dei morti viene celebrata da un sacerdote che volge le spalle all’altare. Un certo Fiore vi ha assistito una mattina, quando doveva recarsi alla fiera di Rotondella. Vide la chiesa aperta e illuminata, zeppa di persone. Ma non erano persone, erano anime dei morti. Una di queste anime gli si avvicinò, gli toccò un braccio e gli disse: «Che fai qui? Non è messa per te». Fiore scappò via spaventato e per tre giorni ebbe freddo e febbre. Vittoria Laguardia, di anni 80, contadina di Rotondella, si recava in campa gna una notte, una diecina di anni fa. Dopo alcune ore di cammino, passò davanti a un convento e vide la chiesa aperta e illuminata. Vi entrò, ma comprese subito di trovarsi alla «messa dei morti» e scappò via. Per lo spa vento ebbe per tre giorni freddo e febbre. Una contadina di Colobraro, R. S., di anni 60, afferma che la messa dei morti è stata vista da Giuseppe Fiorenzo, una volta che tornava dalla campagna a notte inoltrata. Anche Rosa Modarelli, una contadina di 45 anni, ha visto la messa dei morti. Fu di notte, mentre andava ad attinger acqua alla fon tana. La porta della chiesa era aperta e Rosa vi entrò e assistette alla messa. Ma una delle anime presenti, che le era comare di San Giovanni, avvertì del pericolo che correva: «Vattene, questo non è posto per te, se non te ne vai ci rimarrai». Rosa scappò via, e la comare le chiuse la porta alle spalle, ma un lembo della gonna s’impigliò fra i battenti e si lacerò. Rosa tornò a casa e per tre giorni ebbe freddo e febbre.
1
Angela Conte di Roccanova riferisce che la sua amica Annunziata, di anni 35, ha assistito alla messa dei morti. Una notte fu svegliata dal suono delle
100
C A P IT O L O SE C O N D O
campane, corse in chiesa e si ritrovò ad assistere alla messa. Una comare di San Giovanni le toccò il braccio e le disse: «T e ne devi andare subito, non è messa per te, altrimenti resti qui». Scappò via, ma un lembo della gonna le restò impigliato nei battenti. Dallo spavento per tre giorni ebbe freddo e febbre.
Le esperienze allucinatorie del ritorno dei morti appaiono qui sottratte alla loro assoluta irrelatività e dominate in una tradizione culturale relativamente uniforme: esse si ripetono con tratti sen sibilmente analoghi e tendono a diventare v i s i o n i t i p i c h e intessute di elementi «pagani» e di influenze cattolico-popolari. In modo analogo le conseguenze della visione terrificante (tre giorni a letto con freddo e febbre) manifestano la stessa tendenza alla sistemazione stereotipa. Ma il controllo culturale del ritorno dei morti si manifesta anche in un rapporto preciso, che assegna a deter minate persone privilegiate l’attitudine socialmente riconosciuta (almeno fra le donne) di poter dialogare con i morti a vantaggio della comunità: Zia Maddalena, una contadina di Castronuovo, morta poco tempo fa, sapeva fare «le coronelle», cioè aveva l’attitudine di mettere i vivi in rapporto con i defunti. Una volta la madre morta di un tal Vincenzo Fortunato apparve in sogno a zia Maddalena e la pregò di avvertire il figlio che se fosse passato col mulo per una certa tempa avrebbe corso il rischio di cadere nel burrone. Vincenzo non si mostrò però molto propenso a prendere sul serio l’avverti mento, e chiese a Maddalena una prova che essa realmente era a contatto con la madre. Allora Maddalena gli disse: «Vieni con me per nove notti al Calvario: alla nona notte tua madre ti carezzerà». Vincenzo fece come la donna gli aveva detto, e si recò per nove notti al Calvario con lei. Alla nona notte, proprio a mezzanotte, apparve la processione dei morti, e a un certo punto si sentì carezzare da una mano gelida. Restò per tre giorni con freddo e febbre, e al terzo giorno, attraversando la tempa col mulo, una capra gli saltò improvvisamente davanti, e prese a girare intorno al mulo, che inciampò nella corda e poco mancò non cadesse nel burrone. Da quel giorno Vincenzo credette nelle «coronelle». Maria Di Serio, magata di Càlvera, aveva promesso a Maria Viviani di farle rivedere il marito morto. Una mattina per tempo le due donne si avviarono verso la campagna. Giunte che furono davanti a una grotta, le due donne si fermarono in attesa. D ’un tratto dal terreno antistante alla grotta si sol levò un mulinello di polvere, segno della presenza dell’anima del defunto. L ’esperimento non riuscì però completamente perché Maria Viviani si mise a gridare, e questo disturbò l’apparizione completa dello spettro.
IL L A M E N T O F U N E B R E LU C A N O
10 1
In queste forme di «difesa culturale» il ritorno del morto appare ormai ricompreso e controllato da una tecnica magica, con opera tore specializzato: attraverso questa tecnica è riaperta la possibi lità del morto come alleato e protettore del vivo, ed è ristabilito - sia pure in modo rozzo e rudimentale - l’aspetto più propria mente morale del rapporto fra morti e sopravvissuti. Altre forme più immediate del rischio del morto che torna come spettro a dan neggiare i vivi si manifestano nei tratti più arcaici del rituale fune rario tradizionale. Nel quadro delle tecniche per tramutare il ritorno irrelativo dei morti in un ritorno culturalmente controllato e signi ficativo sono da interpretare le pratiche per «separare» il morto dalla comunità dei viventi, o per allontanarne il contagio funesto: come per esempio aprire finestre e porte subito dopo il decesso, 0 gettare per la strada l’acqua «morta» - cioè contagiata dal morto - che si trova nei recipienti casalinghi nel momento in cui è avvenuto il trapasso. Il morto ritorna per tre notti successive al decesso, e occorrerà preparargli sulla tavola una fetta di pane e un bicchiere di acqua: solo così la sua anima inquieta si placherà. 1 morti tornano la notte del 2 novembre, e i parenti prepareranno il cibo sul davanzale della finestra, affinché, al loro passaggio pro cessionale a mezzanotte, possano cibarsi. Senza dubbio il momento della «separazione» media quello più propriamente morale dell’al leanza e della protezione: e lo stesso cibo offerto ai defunti, oltre a un mezzo per farli andar via senza rancore, presenta anche una valenza moralmente pregnante di comunione e di rinnovo della «cara memoria». Ma proprio questa «cara memoria» non può for marsi se non sia culturalmente fronteggiato con determinate tec niche istituzionali il rischio psicologico del «ritorno irrelativo» - cioè della «cattiva memoria» - come ossessione o allucinazione incontrollata. Anche il lamento funebre può essere considerato nel quadro delle tecniche indirizzate a combattere il ritorno irrelativo del morto. Un modulo col quale di solito ha termine la lamentazione lucana è il seguente: «Non ho più nulla da dirti, non ho più nulla da farti, statti bene, e vienimi in sogno a dirmi se sei contento di tutto quello che ti abbiamo fatto». In effetti il carattere di esibizione scenica che il lamento assume si spiega innanzi tutto con la funzione pro tettiva assolta dal recitare iterando modelli, ma in questa strut
C A P IT O L O SE C O N D O
102
tura drammatica si innesta, oltre che una valenza di prestigio sociale (il far mostra ai vivi) anche l’esigenza di far vedere al morto ciò che gli è dovuto, affinché il morto vedendo si plachi, e placandosi non vessi i vivi con irrelativi ritorni, ma si tramuti in alleato e in consigliere, in memoria benefica e in forza morale. Il lamento provvede anche a manifestare al morto questo «essere in regola» con lui, onde riceverne in cambio un ritorno regolato e favore vole. Ma il lamento è un regolatore dei rapporti col defunto anche in un senso più generale, poiché attraverso la sua iterazione nelle date rituali (dopo i tre, i nove, trenta giorni dal decesso, o dopo un anno, o nel giorno di tutti i morti, o in occasione di lutti altrui) «fa tornare» il morto in modo regolato e culturalmente significa tivo. La potenza ossessiva o allucinatoria del defunto è un rischio psicologico proprio perché la sua rappresentazione o immagine si comportano nella crisi in modo parassitario, insorgendo al di fuori di ogni controllo istituzionale, rifiutando ogni inserimento nella tradizione, sottraendosi ad ogni integrazione di valori, disgregando ogni possibile energia di ripresa. L ’iterazione rituale del lamento distribuisce nel tempo il lavoro del cordoglio, lo include in una determinata regìa culturale, e provvede a condurre innanzi quel processo di interiorizzazione del morto che costituisce, come già dicemmo, il vero superamento della crisi e la seconda morte cul turale che riscatta lo scandalo della morte naturale.
8. Riepilogo dei risultati raggiunti L ’indagine etnografica sul lamento funebre lucano ha messo in evidenza il carattere tecnico del suo ordine rituale. La crisi del cordoglio rischia di travolgere la presenza, di farla passare con ciò che passa in luogo di impegnarla a farsi centro della conversione nel valore, interiorizzando il morto e risolvendolo in benefica memoria stimolatrice dell’opera. Il lamento funebre provvede, per la parte che gli spetta, a facilitare nelle condizioni date la ripresa delle tentazioni della crisi e la loro reintegrazione culturale. Lo strumento istituzionale fondamentale che il lamento funebre offre è la presenza rituale del pianto, in dualità relativa con la presenza normale, che opera come guida. Sul piano della presenza rituale
IL LA M EN TO F U N E B R E LUCANO
103
del pianto l’ebetudine stuporosa è sbloccata, il planctus irrelativo è ripreso e riplasmato in ritornelli emotivi periodici che dànno oriz zonte protettivo al discorso, al quale a sua volta vengono fornite le protezioni interne dei moduli verbali, mimici e melodici. Le pro tezioni del discorso mèdiano tuttavia la cauta anamnesi della par ticolare situazione luttuosa, e quindi la singolarizzazione del dolore, il ridischiudersi dell’epos delle memorie e degli affetti, valenze di prestigio sociale, e in determinati casi anche una elementare riso luzione poetica. Appunto perché il lamento funebre è indirizzato a procurare al morto una «seconda morte culturale», il contenuto del discorso protetto è spesso tendenzialmente «epico», epitome glorificante delle resgestae. D ’altra parte il lamento funebre instaura col morto un rapporto di alleanza, e mediante la sua iterazione in date rituali distende nel tempo il lavoro del cordoglio, eseguen dolo per così dire in dosi successive ridotte e lasciando relativa mente sgombri gli intervalli dalle tentazioni della crisi: con ciò il lamento funebre porta il suo contributo, nel quadro del rituale fune rario, al controllo di un altro rischio del cordoglio, il ritorno irre lativo dei morti come rappresentazione ossessiva o come imma gine allucinatoria. Questi risultati della nostra indagine sul lamento funebre lucano vanno verificati, integrati e approfonditi su un piano etnografico più vasto, utilizzando il copioso materiale folklorico euromediter raneo accumulato dagli studiosi in quasi un secolo di ricerche. Ora che con una indagine etnografica diretta ci siamo procurati un cri terio ermeneutico, questo materiale documentario raccolto da altri potrà essere vantaggiosamente utilizzato ai fini della dimostrazione.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
3 ·
Il lamento funebre folklorico euromediterraneo
i . La presenza rituale del pianto Il primo dato lucano da verificare sul pianto etnografico euro mediterraneo è quello relativo alla presenza rituale del pianto come stato psichico istituito nel corso della lamentazione funeraria. In mancanza di analisi precise su questo punto dobbiamo contentarci di alcune indicazioni sommarie che affiorano dalla documentazione esistente, e che messe in rapporto con i risultati della analisi diretta condotta sul lamento funebre lucano acquistano valore di dimo strazione. Le voceratrici còrse, secondo la testimonianza del Marcaggi, eseguono il discorso della lamentazione «con un dondolio cadenzato del corpo»1 e il Lorenzi de Bradi - che fu uno degli ultimi a poter utilmente osservare il vòcero in azione - conferma questa oscillazione ritmica del busto,2 che del resto è un gesto antico, poiché anche Ecuba lo esegue nelle Troiane al momento di inaugurare la lamentazione: Che debbo tacere? Che cosa non tacere? Su che piangere? Ah! Quale pesan tezza opprime le mie povere membra, nella positura in cui giaccio qui, la schiena distesa su questo duro giaciglio! O mia testa, o mie tempie e miei fianchi, quale brama mi prende di far oscillare la mia schiena e la mia spina dorsale verso l’una e l’altra parte del mio corpo, per accompagnare il mio lamento e le mie lacrime senza fine!3
1 J .B . Marcaggi, Les chants de la mori et de la vendetta (1898) p. 22. 2 Lorenzi de Bradi, cit. da Van Gennep, Manuel du folklore frangais, tomo I, pp. 658 sg. 3 Eur., Troiane, w . 110 - 19 .
(1946)
10 5
La oscillazione ritmica del busto ben si addice alla melopea del lamento, e allo stato di concentrazione sognante che caratterizza la presenza rituale del pianto: è il moto che accompagna il ritmo della ninna-nanna, ed ha al pari di esso una funzione ipnogena. In una sequenza cinematografica girata con intenti documentari nel villaggio sardo di Fonni (Barbagia) l’oscillazione laterale del busto e lo stato di concentrazione sognante durante la esecuzione dell’attittidu appaiono nel modo più chiaro e sono controllabili nella successione dei fotogrammi.4 In altre sequenze del lamento di Fonni le lamentatrici accoccolate presso la bara eseguono il discorso con una oscillazione in avanti del busto, verso il cadavere, abbas sando ogni volta ambo le mani nella stessa direzione, come per un discorso particolarmente impegnato e vibrante: questa mimica forma un complesso isocrono di gruppo, un gestire per così dire «corale», per cui ciascuna lamentairice arriva nello stesso tempo delle altre allo stesso punto dell’orbita mimica tradizionalmente prescritta e indefinitamente percorsa e ripercorsa, il che conferisce alla scena un’apparenza di automatismo collettivo, o almeno di un patire freddamente calcolato e previsto nelle sue manifestazioni espressive.5 La stessa apparenza mostravano le vicende mimiche di Pisticci e di Càlvera, ricordate nel precedente capitolo.6 Come vedemmo, la presenza rituale del pianto in relativa dua lità con la presenza egemonica - che si restringe ad assolvere una funzione di guida e a mantenere un generico rapporto con l’am biente - comporta un certo grado di alienazione istituzionale e quindi controllata: la lamentatrice è «quasi un’altra che piange». Ora su una delle conseguenze di questa condizione psichica, la distraibilità della lamentatrice e la sua capacità di volgere momen taneamente l’attenzione a cose e ad eventi che per la loro futilità non dovrebbero essere percepiti, noi ritroviamo qua e là alcuni riscontri etnografici tanto più significativi proprio in quanto non si tratta di monografie psicologicamente orientate. W. S. Blackmann riferisce che tra ìfellahin dell’Egitto superiore la scena della lamentazione presso la tomba è particolarmente drammatica: le lamentatrici stanno inginocchiate, i volti profondamente alterati 4 Atlante figurato del pianto, n. 6g. 5 Ibid., n. 6c, d, e. 6 Per la vicenda mimica di Pisticci cfr. pp. 89 sg. e Atl. fig. pianto n. 3a, b, c.
ιο6
C A P IT O L O T E R Z O
dal dolore, le guance solcate da lacrime copiose. L ’oscillazione rit mica del busto, che accompagna la lamentazione, è complicata dal l’oscillazione ritmica del fazzoletto, tenuto da un capo e dall’al tro, con qualche analogia con la «mimica del fazzoletto» delle lamentatrici di Pisticci. Tuttavia «molte fra le lamentatrici appa rentemente immerse nell’angoscia erano professionali, e spesso men tre passavo fra di loro esse interrompevano i loro singhiozzi dispe rati per levare gli occhi su di me e sorridere amichevolmente, salvo a riprendere il loro cordoglio appena le lasciavo».7 Il Blackmann sembra qui insinuare che il pianto delle lamentatrici «professio nali» era una finzione ipocrita: anzi - se interpretiamo bene il passo - sembra dedurre la loro professionalità dalla facilità con cui si distraevano dalla esecuzione del lamento. Ma noi abbiamo buone ragioni per ritenere che, in generale, non si tratta dell’ordi naria «ipocrisia» che porta a fingere stati d ’animo che in realtà non si provano (e che cade pertanto sotto la valutazione morale) ma di una particolare forma di ipocrisia tecnica che nasce dalla destorificazione di un dolore troppo acuto e troppo psichicamente rischioso per essere accolto e vissuto nella sua storica realtà. Anche le lamentatrici di Beirut - secondo una notizia che ci fornisce il Littmann - sospendevano improvvisamente la lamentazione alla vista di conoscenti che rendevano la visita di condoglianze, e li salutavano ridendo, per riprendere poi a lamentarsi.8 Le lamen tatrici marocchine, che il Westermarck ebbe occasione di vedere in azione, interrompevano di tanto in tanto la lamentazione per chiacchierare e ridere insieme, e quindi tornavano con pieno impe gno all’esecuzione del rito.9 Ma il migliore documento folklorico sulla «ipocrisia tecnica» che il lamento comporta per la sua stessa struttura è costituito dalle minuziose schede di osservazione rac colte da un gruppo di folkloristi romeni in occasione della morte e dei funerali di un pastore di Ceriscior (Hunedoara, Romania).10 In tali schede sono riferiti i seguenti caratteristici episodi: una delle donne presenti, notando che gli etnografi dell ’équipe hanno sospeso 7 W. S. Blackmann, The Fellahin o f thè Upper Egypt (Londra 1927) p. 1 19 . 8 E . Littmann, Abessinìsche Klagenlieder (Tubinga 1949) p. n . 9 E . Westermarck, Ritual and Beliefs in Marocco (Londra 1926) voi. 2, p. 5 18 . 10 Si veda, per questa parte, il capitolo successivo al quale rinviamo il lettore che voglia formarsi una idea complessiva dell’atmosfera in cui si inquadrano le lamentazioni e gli episodi che qui ne riportiamo.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D I T E R R A N E O
107
il lavoro di trascrizione esorta le compagne: «Su, lamentatevi, così i signori possono scrivere»;11 la figlia rende al padre morto le consuete lamentazioni, ma al tempo stesso, punta da vanità, sbir cia l’etnografo per controllare se trascrive il suo canto;12 la nonna del morto si lamenta sbrigando le faccende di casa, oppure sospende improvvisamente il canto funebre per valutare la stoffa del vestito dell’etnografo presente;13 infine quando al tramonto è sospesa la serie di questi pianti controllati ha inizio un radicale cambiamento di umore, che si effonde nelle licenziosità e nell’allegria dei giuo chi funebri della veglia davanti al cadavere.14 Il lamentarsi appar tiene cioè ad una presenza rituale del pianto che può essere a volontà evocata, mantenuta e sospesa, ovvero sostituita con una opposta presenza rituale della lascivia e della disinvolta allegria: ma ciò diventa comprensibile solo se si ammette una relativa dualità fra la presenza rituale e la presenza di guida, una dualità tecnica che non fa avvertire il contrasto e che rende possibile il «salto» da uno stato psichico all’altro. Purtroppo la documentazione folklorica esistente non ci forni sce, a motivo del suo orientamento, altre indicazioni relative alla distraibilità delle lamentatrici in azione. D ’altra parte poiché tale distraibilità concerne un particolare strutturale che trascende di molto il lamento funebre antico in quanto tale, possiamo trovare qualche utile riferimento anche in ambienti culturali che non rien trano nei limiti del folklore euromediterraneo. Gioverà a questo proposito riferire un solo dato, ricordando tuttavia come anche la documentazione etnologica, al pari di quella folklorica, ha dato poco rilievo alla condizione psichica della lamentatrice in azione. Nella sua monografia sui Dama della Montagna (Bergdama) H. Vedder non esita a considerare «mistero» il fenomeno della di straibilità delle lamentatrici in azione: «Durante il canto funebre —egli dice —le lacrime scorrono in abbondanza e tutti i presenti hanno l’obbligo di piangere nel corso della lamentazione. Chi ha avuto occasione di osservare i Dama in circostanze del genere non può non rimanere meravigliato della potenza di cordoglio di cui 11 12 13 14
C fr. Cfr. Cfr. C fr.
p. 15 5 . p. 15 8 . p. 15 9 . pp. 16 4 sgg.
ιο8
C A P IT O L O T E R Z O
essi sono capaci». Ma subito dopo aggiunge: «Se ci si stanca di piangere e di lamentarsi, l’antifonaria sospende la lamentazione. Come a comando, cessano al tempo stesso le lacrime, e accade non raramente che immediatamente dopo, per avvenimenti e incidenti privi di importanza, si chiacchiera e si ride durante la breve pausa, di guisa che l’osservatore si trova davanti a un duplice mistero, quello della profondità del sentire e quello della superficialità».15 Ora questo mistero può, a nostro avviso, essere diradato se inter pretiamo il comportamento come manifestazione di una relativa dualità istituzionale di presenze, instaurata e alimentata dalla lamen tazione, col risultato di concentrare il pianto sulla presenza rituale mantenendo sgombra e autonoma la presenza egemonica, e quindi capace di interrompere o di riprendere la prestazione, e soprat tutto di distrarsi per eventi futili o per incidenti privi di impor tanza, proprio come se la presenza che piange e quella che si distrae non fossero pieno iure una stessa presenza.
2. Ebetudine stuporosa, «planctus» irrelativo e ordine della lamentazione Il secondo dato lucano che deve essere sottoposto a verifica e ad integrazione su un piano etnografico più ampio è la vicenda che ha luogo sul piano della presenza rituale del pianto, cioè la catabasi verso le tentazioni della crisi, lo sblocco dell’ebetudine stuporosa, la ripresa e la ritualizzazione del planctus, l’enuclearsi del discorso protetto, l’interiorizzazione della situazione luttuosa e l’anabasi verso il mondo dei valori. Un’importante precisazione 15 H . Vedder, Die Bergdama (1923) pp. 129 sg. Osservazioni analoghe per gli indigeni del distretto di Port Lincoln (Australia meridionale): «Il defunto era un vecchio che era stato malato a lungo... Appena ebbe esalato Γultimo respiro, le donne e i bambini lasciarono la loro capanna, e le donne sedendo a cinquanta iarde di distanza eseguirono una lamentazione cospargendosi di caolino tutto il corpo... Il lamento fu proseguito per ore: ma in realtà il cordoglio era scarso, perché, se si rivolgeva loro la parola le lamentatrici cessavano di piangere e rispondevano pro prio con il consueto tono di voce e con la normale espressione del volto». R. $rought Smith, The Abongìnal o f Victoria (1878) p. 118 . L ’osservazione è importante, non tanto per il riferimento etnografico che contiene, quanto per il giudizio morale che l’etnografo dà del comportamento: il che mostra il solito equivoco fra ipocrisia moralmente riprovevole e ipocrisia tecnica, con nessa alla struttura della lamentazione. Almeno il Vedder aveva avuto il buon senso di non incorrere nell’equivoco, e di avvertire nello strano comportamento un «mistero» da chiarire.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
109
documentaria ci viene innanzi tutto dall’attittidu sardo, dove stu pore senza anamnesi e planctus vengono ripresi e riplasmati come due momenti rituali successivi, a cui segue, dopo un intervallo di profondo silenzio, il discorso protetto della lamentazione. Ripor tiamo questa interessante sequenza di momenti rituali nella famosa descrizione del Bresciani: In sul primo entrare al defunto tengono il capo chino, le mani composte, il viso ristretto, e procedono in silenzio quasi di conserva, come se per avven tura non si fossero accorte che bara e morto ivi fosse. Indi alzati come a caso gli occhi e visto il defunto a giacere, danno repente in un acutissimo strido, battono palma a palma ed escono in lai dolorosi e strani. Imperoc ché, levato un crudelissimo compianto, altre si strappano i capelli, squarcian coi denti le bianche pezzuole ch’ha in mano ciascuna, si graffiano e sterminano le guance, si provocano a urli, a omei, a singhiozzi gemebondi e soffocati. Altre si abbandonano sulla bara, altre si gittano ginocchioni, altre si stramazzan per terra, si rotolan sul pavimento, si spargon di pol vere; altre, quasi per sommo dolor disperate, serran le pugna, strabuzzan gli occhi, stridono i denti, e con faccia oltracotata sembran minacciare il cielo stesso. Poscia di tanto inordinato corrotto, le dolenti donne cosi scon fitte, livide e arruffate qua e là per la stanza sedute in terra e sulle calcagna si riducono ad un tratto in un profondo silenzio. Tacite, sospirose, chiuse nei raccolti mantelli, con le mani congiunte e con le dita conserte mettono il viso in seno e contemplano con gli occhi fissi nel cataletto. In quello stante, una in fra loro, quasi tocca ed accesa da un improvviso spirito prepotente, balza in piè, si riscuote tutta nella persona, s’anima, si ravviva, le s’impor pora il viso, le scintilla lo sguardo, e, voltasi ratta al defunto, un presenta l o cantico intuona.16
La ripresa consiste dunque nel fatto che, in luogo dell’ebetu dine e della scarica irrelative, il rito come istituto stabilisce e tra16 A. Bresciani, Det costumi dell’isola di Sardegna comparati con gli altri antichissimi popoli orientali (Napoli 1850) p. 222. La relazione del Bresciani dipende, almeno in parte, da quella del primo etnografo del lamento funebre sardo, il La Marmora: «Quando qualcuno muore, si colloca il suo corpo nel mezzo d’una stanza, col viso coperto e rivolto verso la porta. Allora le parenti e le amiche del defunto, spesso anche donne retribuite, vestite a lutto e tenendo in mano un fazzoletto bianco, entrano in questa camera e osservano un silenzio profondissimo: hanno addirittura l’aria di ignorare il decesso della persona che vengono a piangere. D ’un tratto, esse levano un grido di sorpresa e di dolore, che è seguito da pianti e da gemiti; esse si abban donano a manifestazioni violentissime di disperazione, e le une si strappano i capelli, le altre si rotolano a terra, altre infine sembrano con i loro gesti minacciare il cielo. Ma ben presto una calma momentanea tien dietro a queste brucianti manifestazioni di afflizione: una di que ste donne si leva come ispirata, il suo viso si imporpora, ed essa improvvisa in versi un lungo elogio del defunto: essa declama in cadenza, e finisce ciascuna strofa con questi gridi: Ahi! Ahi! Ahi!, che sono ripetuti da tutte le compagne». A . de La Marmora, Voyage in Sardaigne, ou description statistique, physique et politique de cette Ile (Parigi 2839) pp. 276 sg.
C A P IT O L O T E R Z O
no
dizionalizza la norma culturale di un’ebetudine e di una scarica controllate nella durata e nell’intensità, cioè «permesse» soltanto secondo un ordine rituale collettivamente osservato nei tempi e modi prescritti. La ritualizzazione dell’ebetudine è chiaramente attestata, nell’area europea e mediterranea, soltanto dal Bresciani: e non è possibile decidere in che misura ciò sia dovuto ai limiti della documentazione esistente, che non è psicologicamente orien tata. Si consideri per esempio il seguente documento, che si rife risce a un rìpitu di cui fu testimone oculare il Salomone-Marino a Palermo nel 1830: Il cadavere di un uomo sui trent’anni stava accomodato in una sedia a brac cioli, vestito di tutto punto, con le mani conserte al petto e il rosario fra le dita; ai suoi piedi, due candele accese: dalla spalliera della sedia pendenti due cazzuole, due martelline e un archipenzolo, arnesi dell’arte muratoria cui apparteneva: a destra e a sinistra di lui due donne accoccolate sur un panchetto, con le chiome disciolte, le b r a c c i a p e n d e n t i , i m m o b i li, g l i o c c h i f i s s i a t e r r a . A d u n t r a t t o , c o m e s p i n t e da un a f o r z a , e n t r a m b e l e v a n o in a l t o le m a n i e si p e r c u o t o n o i l v i s o c o n u n m i s e r e v o l e g r i d o : indi, palma a palma giungendo, intuonano alternativamente una mesta cantilena ritmica, facendo una pausa ad ogni verso o proposizione, che finivano con un urlo o un ah! prolungato.17
Qui non è possibile stabilire se l’ebetudine che precede il planctus appartenga a un ordine rituale tradizionale, o sia soltanto un sin tomo della crisi irrelativa che si sblocca ritualmente nell’ordine della lamentazione. Analogamente nel primo carme di Gudhrun dell 'Edda l’inazione melancolica è interpretata dal poeta non già come parte integrante del rito, ma come crisi che il planctus ritua lizzato risolve, avviandola verso il discorso individuale della lamen tazione. Presso il cadavere del re ucciso sta Gudhrun immobile, a ciglio asciutto, irrigidita in una sorta di ebetudine dolorosa: Una volta Gudhrun moriva di dolore, quando afflitta sedeva vicino a Sigurdh; ella non si lamentava, né si batteva, né piangeva, come fanno le altre donne. 17 S. Salomone-Marino, L e reputatici nell’età di mezzo e moderna (Palermo 1886) p. 39. Il silenzio, l’immobilità e lo sguardo fisso a terra della lamentatrice siciliana descritta dal SalomoneMarino trovano riscontro in Lam., 6 ,10 : «Siedono per terra e tacciono gli anziani della figlia di Sion, hanno cosparso di cenere il capo, sono vestiti di cilizi, le vergini di Gerusalemme hanno abbassato a terra il loro capo ».
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D I T E R R A N E O
III
Andarono i saggi principi da lei e cercavano di consolarla. Gudhrun non poteva piangere, era cosi triste che voleva morire.
Invano le nobili spose dei principi cercano di indurla al lamento narrando ciascuna le proprie sventure: Gudhrun si rifiuta ostina tamente di entrare nella vicenda rituale liberatrice, e resta prigio niera nella sua inazione melancolica. Allora Gullrond ordina di sco prire il cadavere del re, e pone davanti alle ginocchia della sposa il tradizionale cuscino per la lamentazione: Ella tirò via il lino che copriva Sigurdh e pose il cuscino davanti ai ginocchi della sposa: «G uarda l’amato: bacialo sulle sue labbra, abbraccialo come quando era ancora in vita! »
Gudhrun si riscuote, spezza il penoso incantesimo della sua pola rizzazione, e rinasce all’impegno di oltrepassare la situazione: ma questa r i p r e s a si compie attraverso la mediazione del r i t o, inau gurando cioè una serie di gesti e di comportamenti tradizionali, eseguendo ciò che si fa quando si deve lamentare il morto: Lo guardò Gudhrun ad un tratto e vide i capelli dell’eroe raggrumati di sangue, gli occhi splendenti del re già spenti, il petto del re trafitto da un colpo di spada. Allora Gudhrun cadde riversa sul cuscino, la chioma si sciolse, illividì la guancia, ed una goccia di pioggia le corse giù per i ginocchi. Pianse ilo r a Gudhrun, figlia di Giuki, cosicché copiose sgorgarono le lacrime, e gridarono le oche della corte, i nobili volatili che ella possedeva.
Il planctus di Gudhrun non è una crisi irrelativa, poiché già comincia a operare il controllo drammatico del rito: e per entro le guarentigie protettrici del planctus ritualizzato Gudhrun rina scerà infine all 'ethos delle memorie e degli affetti, e tenterà di allar gare nel canto il suo dolore che ritorna umano: Era il mio Sigurdh rispetto ai figli di Giuki come il fiore di porro che nasce nei prati, o come un brillante incastonato nell’oro, pietra preziosa in fronte a un re!
C A P IT O L O T E R Z O
1 12
Gli eroi del re mi stimavano più grande di tutte le Dise di Herian; ora io sono più fragile di una foglia di salice per la morte del re!18
Allo stato attuale della documentazione folklorica noi non siamo in condizione di poter decidere in che misura la stessa ebetudine stuporosa entra a far parte del rito della lamentazione: in che misura cioè questo momento della crisi del cordoglio è ripreso istituzio nalmente e diventa un «mostrare» di essere come folgorati dal dolore, a cui seguiranno - nell’ordine rituale - il «mostrare» di riconoscere improvvisamente la situazione, e l’ulteriore vicenda della lamentazione. Nel caso àt\Y attassamento lucano non sembra - per quel che ci fu possibile osservare - che si possa parlare di una inclusione in una determinata orbita rituale, ma piuttosto di una vera e propria manifestazione della crisi, che il rito della lamen tazione avvia a soluzione. La documentazione folklorica euromediterranea conferma invece concordemente la distinzione, già messa in rilievo a proposito del lamento funebre lucano, fra planctus irrelativo, planctus ritualiz zato e discorso protetto. Per le colonie greche di Sicilia la distin zione risulta chiara da una testimonianza diretta del SalomoneMarino, che ebbe la ventura di assistere ad una scena di.lamentazione per la morte di un mulattiere di Piana dei Greci: Non appena egli ebbe mandato l’ultimo spiro (che fu dopo Fave), ed ecco che sua moglie, che baciatolo in bocca, esce di casa e ad una fassi ad invitare le vicine, acciocché tutte l’aiutassero a piangere lo sposo. Nel frattempo, venuto il cataletto, ella stessa rivestì degli abiti nuovi il già ripulito cadavere; stese una candida coltre sul cataletto, e su questa ella prima si adagiò, e poi, levatasi, adattow i convenevolmente il marito. Quindi, copertasi di lungo manto, disciolse le chiome; e in piedi dapprima e poi seduta presso la bara, piegò il capo sull’esanime corpo e si mise a gridare, a percuotersi, a strapparsi i capelli. Scorso alcun tempo di questo primo impeto, cominciò un pianto più misurato, più monotono, più umano, e diè principio a una cantilena la mentevole, interrotta e accompagnata sovente da un ohimè! desolatissimo.19
Qui si tratta di un parossismo non già irrelativo, ma ricompreso e controllato in una sequenza rituale. Infatti dopo il decesso la donna non si abbandona al planctus caotico (come parrebbe com18 Gudhrunarkvidha, I, trad. ital. C .A . Mastrelli in L ’Edda (Firenze 19 5 1). 19 S. Salomone-Marino, op. cit., pp. 43 sg.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
II 3
prensibile), ma prepara accuratamente le condizioni del planctus rituale. Essa va a chiamare le vicine per riceverne aiuto nel corso della lamentazione, dispone il morto nella bara dopo esservisi ada giata per esprimere simbolicamente la sua volontà di seguire il marito nella morte, si copre di un lungo manto e si scioglie i capelli per realizzare la figura tradizionale della lamentatrice, comportan dosi dunque proprio come un’ attrice che si appresta a recitare la sua parte. Solo quando le condizioni del rito sono pronte la donna si lascia andare al planctus, ma - anche qui - nei tempi e nei modi prescritti dal rito, cioè secondo una tal quale regia nel numero e nella intensità e nella durata dei gesti di disperazione: e infine, col progredire della tecnica di ripresa, la donna si dischiude a un pianto «più misurato, più monotono, più umano», cioè al discorso protetto della lamentazione. Anche il vòcero còrso conferma un rapporto analogo. Secondo la testimonianza diretta del Gregorovius, le voceratrici eseguivano intorno alla tota (cioè al tavolo dove si espone il cadavere) un furi bondo caracollo, al quale seguiva la lamentazione: « Sciolte le chiome sul petto al pari di menadi, gli occhi di fuoco, i neri man telli svolazzanti, esse vanno danzando e ululando, battono palma contro palma, si percuotono il petto, si strappano i capelli, piangono, singhiozzano, si gettano sulla tola, si cospargono di polvere». Ma dopo il caracollo segue, come nel lamento sardo, un «silenzio rituale» e quindi ha inizio la lamenta zione: «Poi cessa l’ululato, e le donne se ne stanno tranquille, simili a sibille, sul pavimento della camera mortuaria, sospirano profondamente, si acque tano... repentinamente dal cerchio delle lamentatrici ne salta su una, e simile a una veggente ispirata dà inizio al canto funebre».20
Da questa testimonianza si trae conferma che il parossismo irre lativo del cordoglio come crisi non è il parossismo istituzionale del caracollo come rito. Il parossismo irrelativo può insorgere in qualunque momento, non è prevedibile nel suo decorso e nei suoi modi, ed è ovviamente sprovvisto di qualsiasi valore sociale e cul turale (costituisce infatti soltanto un sintomo clinico di uno stato psichico morboso), il parossismo istituzionale del caracollo è col lettivamente iniziato ad un certo momento della esposizione del cadavere, dovrà essere seguito da una calma collettiva che segna il passaggio al discorso protetto della lamentazione, e infine per 20 F. Gregorovius, Corsica (2a ed. 1869) pp. 35 sg.
114
CAPITOLO TERZO
entro questi vincoli tecnici manifesta già una regola tradizionale nell’abbigliamento e un ordine almeno tendenziale nella stessa mimica, che itera modelli culturali e che perciò non è un semplice parossismo irrelativo: la scarica irrelativa di impulsi si curva nella danza intorno alla fola, ed è trattenuta in pochi gesti che, per quanto eccessivi, non sono mai tali da compromettere irrimediabilmente l’integrità fisica della persona. D ’altra parte la calma collettiva che segue il caracollo può ora svolgersi come pausa rituale di riposo, senza rischio di ricadere nell’inazione melancolica e in una nuova scarica irrelativa di impulsi: il planctus come rito ha ormai sbloc cato la presenza, e al tempo stesso ha compiuto una prima elemen tare catarsi dal caos del patire. Senza dubbio l’apparato tecnico della ritualizzazione del planctus può non funzionare, e la ripresa per alcune persone o per qualche tempo non aver luogo: ciò appar tiene agli «incidenti» della lamentazione, o - se l’immagine non parrà sconveniente - alla categoria degli «infortuni sul lavoro». Il rapporto etnografico del von Hahn sul lamento funebre alba nese mette in rilievo questo aspetto drammatico del planctus come rito che può non «riuscire»: Giunto il supremo istante, le donne vicine si precipitano gridando e batten dosi il petto verso la casa del morto, al fine di ingrossare il terribile mesto coro. Le sorelle, le cognate, le figlie adulte e la sposa del defunto, se questi non ha superato l’età media, si tagliano i capelli, rovesciano i loro mantelli di lana - in modo che il vello stia dalla parte esterna - , si strappano quel che avanza dei capelli tagliati, cadono a terra, dànno col capo nella parete, invocano il nome del defunto, e gridano così forte e senza interruzione da perdere la voce spesso per lungo tempo. L ’esaltazione delle nature più deboli provoca spesso deliqui e svenimenti, in quelle più robuste stati di momenta nea follia, onde sono continuamente tenute d ’occhio dai presenti, o addirit tura anche trattenute... [Dopo l’esposizione] «le donne si seggono intorno al cadavere, e s o l t a n t o o r a h a i n i z i o i l l a m e n t o f u n e b r e v e r o e p r o p r i o . . . c h e è p e r t a n t o da d i s t i n g u e r e n e t t a m e n t e d a l l a p r i m a s c e n a d i d i s p e r a z i o n e » . 21
Il von Hahn distingue nettamente il lamento funebre vero e proprio dalla «prima scena di disperazione» che segue il decesso, dove si verificano casi di «deliqui» e «svenimenti» (forse anche, se l’osservazione fosse stata condotta più a fondo, condizioni psi 21 J . G . von Hahn, Albanesische Studien (Jena 1854) voi. 1 , pp. 150 sg. Cfr. p. 198, n. 39: «Wohl zu unterscheiden ist von diesem Jammer der geordnete Klagesang».
IL LAMENTO FUNEBRE FOLKLORICO EUROMEDITERRANEO
” 5
chiche di ebetudine stuporosa), parossismi pericolosi per l’integrità fisica della persona.22 Tuttavia il rovesciare i mantelli dalla parte interna, e in generale la stessa limitazione tradizionale dei gesti di cordoglio indicano almeno una tendenziale regia del planctus irrelativo.
3. La conquista del discorso protetto: la periodizzazione del «planctus» in ritornelli emotivi stereotipi Come fu dimostrato nel corso dell’indagine sul lamento fune bre lucano, la protezione dalle insorgenze del planctus irrelativo non si limita a rendere possibile Ti n i z i o di un discorso, ma con tinua a discorso iniziato, poiché resta aperta la possibilità di nuove recessioni parossistiche che interrompano e sconvolgano il discor rere, rendendolo praticamente ineseguibile. Ciò avviene, nel la mento funebre lucano, innanzi tutto mediante la riplasmazione del planctus in ritornelli emotivi stereotipi, da ripetere con una certa regola di frequenza, in modo da poter dare al discorso, fra ritor nello e ritornello, un orizzonte definito e previsto di durata e di stabilità. Il materiale folklorico euromediterraneo non soltanto con ferma largamente questo accertamento, ma vi aggiunge alcune im portanti determinazioni tecniche che nel lamento funebre lucano, oggi alquanto logoro, sono molto probabilmente cadute e non più utilmente osservabili. La forma più elementare di riplasmazione del planctus irrela tivo in ritornelli emotivi periodici è data dalle sillabe emotive ste reotipe con le quali ha inizio talora il singolo verso della lamenta zione cantata. Queste sillabe emotive costituiscono per così dire germi di recessione parossistica, ma contenuta e dominata in una semplice sillaba emotivamente carica che viene assegnata alTini22 La legislazione di epoca cristiana contro il lamento pagano mostra talora preoccupazioni anche per l’integrità fisica delle persone. Così nelle Siete Partidas attribuite ad Alfonso X il Saggio (1265) si sottolineano - probabilmente con qualche esagerazione polemica - i rischi mortali cui potevano talora dar luogo le lamentazioni: « ... così vi erano alcuni che non volevano né mangiare né bere sino a morirne, e altri che si uccidevano con le loro stesse mani, e altri che a tal punto si immergevano nel cordoglio da perdere il senno: e i più moderati si strappavano i capelli o se li tagliavano, e sfiguravano le loro guance graffiandosele, oppure si gettavano a terra in modo da riceverne danno o addirittura morte» (Las Siete Partidas, p. i , tit. 4, 96).
120
CAPITOLO TERZO
Sorre ’e s’anima mia! E tocchende che ichola, Sorre ’e s’anima mia! Su padronu ch’e ’ fora...33
Un lamento di Ossi: Ohi su coro meu! Ah cantu so piedosa, Ohi su coro meu! Relthada so penosa Ohi su coro meu! Da Deu oifanada, Ohi su coro meu! Penosa so rethalda Ohi su coro meu! Male mosthe m’a’ tentu Ohi su coro meu! Sa pena mia e tuimentu...34
Un altro lamento di Ossi: Fizu de s’anima mia! Mancadu m’e’ su sole. Fizu de s’anima mia! Culthu non e’ dolore. Fizu de s’anima mia! Mi privo d’ogni gulthu, Fizu de s’anima mia! Non è dolore culthu. Fizu de s’anima mia! Isciareu chena brou, Fizu de s’anima mia! Culthu ’e dolore nou, Fizu de s’anima mia! Lassadu m’as mechina, Fizu de s’anima mia. In terra de mina. Fizu de s’anima mia! Isciaréu meu derettu, Fizu de s’anima mia! Fias (su) meu solu affettu...35 G . Ferrato, Canti popolari in dialetto logudorese (189 1) p. 206. È un lamento di moglie a marito, e il ritornello vocativo si suppone rivolto alla sorella della vedova, presente alla lamen tazione: Sorella dell’anima. 34 Ibid., p. 208, m: Lamento in morte del marito, cantato - a quanto dice una nota espli cativa del testo - da una attitadora professionale per conto della vedova. 35 lb id .t p. 2 15 , ix (Lamento di madre a bambino morto di pochi mesi). Cfr. per lamenti
121
IL LAMENTO FUNEBRE FOLKLORICO EUROMEDITERRANEO
In questi attittidos il planctus si disciplina in una invocazione stereotipa, da iterare con una frequenza che consente al discorso variabile l’orizzonte di un settenario. In apparenza è un orizzonte troppo limitato, poiché la regola di frequenza del ritornello emo tivo rende difficili i raccordi espressivi del discorso variabile, costringendo il discorso a continui rapidi «a capo» per ogni inter ruzione emotiva. Ma per quanto angusto sia l’orizzonte del discorso, si tratta pur sempre di un orizzonte: la regolarità periodica dell’«a capo» e la stereotipia del ritornello emotivo proteggono il discorso dalle insorgenze imprevedibili del parossismo irrelativo. Una mag giore continuità espressiva del discorso variabile è data dagli attit tidos in cui i ritornelli emotivi ubbidiscono a una periodicità più ampia, cioè quando separano distici di settenari rimati a coppie. In un attittidu raccolto a Nuoro, il marito lamenta così la moglie che lo ha lasciato senza figli: Ohi! columba mea! A chie m’as lassadu? Ohi su core meu! Chirchende so a tie, tue as lassadu a mie. Ohi su core meu! Tue a mie as lassadu, fizu non as chircadu! Ohi! columba mea!...36
A parte l’oscillazione fra l’uno e l’altro ritornello, è evidente il più largo orizzonte del discorso. In un lamento di Usini, reso da una donna già vedova al figlio morto, l’orizzonte strofico si allarga a una quartina: Tenia unu pizzinnu De sos primos de’ idda, Mi-nd’a’ segadu sinnu Sa mosthe ilthinchidda. Ohi su coro meu! So chiscende s’intimu della stessa struttura, pp. 2 18 , XII (raccolto nel villaggio di Tiesi; di moglie a marito); 2 19 , x m (anche di Tiesi; di sorella a sorelle e fratelli); 252, x l iii (Nule; di sorella a sorella); 257, XLViil (Oniferi; di comare a comare).
36 Ibid., p. 246, χχχνπι. Cfr. p. 275, u an bis (di Orane; moglie a marito): «Ohi su maridu meu I Mastra de lacchedda(s) I Como non mi faedda(s). I Ohi su maridu meu! M astra de taggieri(s), I Sos ocros non nd’abberi(s). I Ohi su maridu m eu...».
1
CAPITOLO TERZO
122
De mi lu assimizare, M ’è mosthu lu pizzinnu, A chie cherzo giamare? Ohi su coro meu! Povera domo mia Coniente ses’andada, Su chi mai creìa, Penosa e tribulada. Ohi su coro meu! I-ss’aìvure ’e fruttu mia Pius non potto aumbrare, Su chi mai creìa A chie cherzo giamare. Ohi su coro meu...57
4. La conquista del discorso protetto: l ’incidenza corale dei ritornelli emotivi Nel lamento funebre lucano non vi è traccia di una incidenza corale dei ritornelli emotivi. Ma a giudicare dalla frequenza con la quale tale incidenza è attestata dal materiale folklorico eurome diterraneo è da ritenere che soltanto il logorio del tempo abbia lasciato cadere nella Lucania di oggi questa importante determi nazione tecnica della lamentazione. L ’incidenza corale dei ritor nelli emotivi è da mettersi in rapporto con il carattere sociale del lutto e con la partecipazione collettiva al cordoglio. Ciò rende indi spensabile che i momenti del planctus ritualizzato e del discorso protetto siano disciplinati nella loro esecuzione non soltanto rispetto all’individuo, ma anche rispetto alla collettività. Una delle forme più elementari e più largamente diffuse che nel lamento funebre folklorico disciplina il cordoglio collettivo, stabilendo le «parti» che ciascuno deve sostenere nel rito, è la successione ordinata dei discorsi individuali e la partecipazione collettiva ai ritornelli emo tivi. Volta a volta una sola lamentatrice assume la «guida» del pianto, cioè inaugura il discorso protetto, con l’intesa tradizional mente stabilita e socialmente accreditata che soltanto al momento dei ritornelli emotivi può aver luogo l’incidenza corale della col-37 37 Ibid., p. 207, π.
IL LAMENTO FUNEBRE FOLKLORICO EUROMEDITERRANEO
12 3
lettività. Così, per esempio, nel vòcero còrso la voceratrice esegue il lamento «recitativamente, strofa per strofa, e ognuna termina con un Deh! Deh! Deh! che il coro delle lamentatrici ripete».58 Nell’attittidu sardo Yattittadora «termina ogni strofa in un guaio doloroso, gridando Ahi! Ahi! Ahi! e tutto il coro delle donne, rinnovellando il pianto, ripetono a guisa d’eco Ahi! Ahi! A h i!»59 Nei lamenti neogreci della Terra d’Otranto le lamentatrici irrom pono nella camera mortuaria e invitano a piangere «la padrona del pianto», cioè la donna che al morto è più vicina parente: alla «padrona del pianto» seguono in ordine di amicizia e di parentela tutti i presenti, e le incidenze corali del planctus per tutta la comu nità sono regolate dal coro delle lamentatrici.40 Nella sua opera panoramica sul lamento funebre russo la Mahler attesta che nella Russia del Nord la lamentazione ha luogo come un vero e proprio dramma rituale, poiché «una guida del coro intona il lamento, men tre il coro riprende e canta un ritornello cerimoniale a molte voci».41 L ’Africa e l’Asia mediterranee ci offrono molti esempi di questa struttura: ci limiteremo a un esempio tratto dal folklore egiziano. Fra gli arabi di Egitto la lamentazione procede con succes sivi interventi separati da silenzi intercalari, e tutta la cerimonia è inaugurata dalla «guida» specializzata, che ad ogni strofa è inter rotta dal ritornello stereotipo dei presenti: «Ja dahwiti! » a lungo protratto.42 In generale uno strumento di lavoro vale tanto di più quanto maggiore è il numero di operazioni tecniche che è possi bile compiere con esso per trasformare il dannoso nell’utile: la strut tura responsoriale del lamento realizza uno strumento che è atto a compiere al tempo stesso più operazioni utili per controllare i rischi del planctus irrelativo e per condurre a buon fine il lavoro 38 Gregorovius, op. cit., p. 37. 59 Bresciani, op. cit., p. 222, 40 Morosi, op. cit., p. 93. Un riscontro nella Roma medievale è offerto da una occasio* naie testimonianza del cronista Boncompagni: « La computatrice or siede composta, od ora sta prona in ginocchio co’ capelli scarmigliati, e presso il cadavere comincia a fare in variabil tuono la filastrocca degli elogi, e sempre verso la chiusa con piagnucolosa voce caccia fuori un Oh! o un Ih! E allora tutti gli astanti le fanno coro di flebili strida» (Ducange, s. v. Cantatrices). 41 E . Mahler, Die russische Totenkhge (Lipsia 1935) p. 8 1. Per altre forme responsoriali nel lamento funebre europeo cfr. O. Bòkle, Psycbologie der Volksdichtung (2a ed. 19 13 ) pp. SSS42 P. Kahle, Die Totenklage im heutigen Aegypten, Forsch. Rei. Lit. alten und neuen Testam., voi. 19 , 347 (1923). Per accenni alle forme folkloriche del lamento responsoriale nel Vicino Oriente, vedi I. Iahnow, Dos hebràische Leichenlied im Rahme» der Vólkerdichtung, Beih. Z. neuetest. W iss., voi. 36 (1935).
97
124
C A P IT O L O T E R Z O
di risoluzione della crisi del cordoglio. Innanzi tutto il fatto che la struttura responsoriale obbliga ciascuno a versare il planctus nei modi, nei tempi e nei ritmi che son propri del responsorio costi tuisce già di per sé una nuova forma di disciplina del planctus, e una protezione ulteriore per i singoli discorsi individuali, che ri schierebbero di andar sommersi nel caos della crisi collettiva. Ma questa è appena una delle operazioni tecniche che la struttura responsoriale rende possibile. Dal punto di vista di chi esegue il di scorso protetto la collaborazione corale nel momento del ritornello emotivo periodico rappresenta un vero e proprio «aiuto», in quanto facilita il controllo di tali ritornelli. Infatti anche nella sua forma ritualizzata le incidenze del pianto racchiudono pur sempre un rischio di recessione parossistica: e chi ha assistito di fatto a una lamentazione funeraria responsoriale avverte che proprio a que sto punto si verifica una tensione che minaccia - per così dire di far. uscire dalla sua orbita il pianeta del lamento rituale. Ora il condividere con altri il planctus, o addirittura il cederlo ad altri, at tua una forma di collaborazione nel momento più critico della lamentazione, proprio come se la coralità del planctus ripartisse e attenuasse in più individui la carica emotiva trattenuta nel ritornel lo emotivo o permettesse una vera e propria cessione integrale del planctus alla collettività. M a è possibile anche un’altra operazione tecnica: non soltanto il planctus ritualizzato può essere ripartito e ceduto collettivamente ad ogni incidenza periodica del ritornello emotivo, ma anche lo stesso discorso protetto, e quindi la guida della lamentazione, può essere ceduto ad una non parente, a una donna cioè non toccata immediatamente dal cordoglio, e che sia «specialista» nella fattispecie: in questo caso coloro che sono stati colpiti dal lutto riserbano per sé o una parte subordinata o addi rittura la sola parte del coro, nei tempi e nei modi che sono con sentiti dallo strumento tecnico della lamentazione responsoriale, adoperato dalla regista esperta. D ’altra parte la successione ordi nata dei discorsi protetti e dei ritornelli emotivi corali esercita un potere di sblocco sui rischi di inazione melancolica, e al tempo stesso appresta gli argini per entro i quali si verserà e si ordinerà la carica emotiva nel momento rischioso del suo sprigionarsi. Le tecniche di ripresa che abbiamo sinora analizzate sono con dizionate, rispetto al loro modus operandi, dalla presenza stereo
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D I T E R R A N E O
125
tipa del pianto e dal caratteristico rapporto che la lega con la pre senza egemonica. Appunto perché la presenza stereotipa del pianto si muove su un piano di attenuata storicità e di provvisoria sper sonalizzazione dei rapporti, e appunto perché il patire è riplasmato in una «parte» da recitare come se si trattasse del patire di un altro anonimo e sognante, è possibile in varia misura cedere la «parte» a un altro, come avviene nella ripartizione dei ritornelli emotivi, 0 nella cessione dello stesso discorso individuale della lamentazione. Proprio per il carattere i m p e r s o n a l e della presenza stereotipa del pianto viene reso possibile un nesso i n t e r p e r s o n a l e re citato a comando, con scambi e sostituzioni e collaborazioni pia nificate e tradizionalizzate che sarebbero del tutto inconcepibili in un regime strettamente individuale di cordoglio. In questo qua dro tecnico si comprende anche come sia possibile quel partico lare sviluppo tecnico del lamento per cui esso diventa un oggetto commerciabile, che può vendersi e comprarsi, come accade talora (ma non sempre) nel caso della lamentatrice specializzata, che offre 1 suoi servizi nei funerali.
5. La conquista del discorso protetto: i moduli letterari, mimici e melodici Nel lamento funebre lucano la protezione interna del discorso ha luogo anche mediante l’impiego di moduli letterari, mimici e melodici. «Lamentarsi» significa in Lucania innanzi tutto ricor darsi dei moduli letterari adatti scegliendoli fra quelli che stanno a disposizione della memoria culturale di ciascuna lamentatrice, e che tendono per così dire ad esaurire i tipi fondamentali delle possibili situazioni luttuose. Ma alla memoria culturale di ciascuna lamentatrice appartengono non soltanto questi moduli, ma anche - in organica connessione unitaria - la mimica che li deve accom pagnare e la melodia con cui vanno cantati. Analizziamo ora que sto rapporto sul più vasto piano del folklore euromediterraneo. Nel folklore attuale del Vicino Oriente i lamenti tradizionali sono articolati secondo il duplice criterio della persona cui sono destinati e delle circostanze della morte: nelle, raccolte e nelle descri zioni etnografiche si ritrovano lamenti destinati a uomo, a donna,
C A P IT O L O T E R Z O
I2 Ó
a giovinetto, a giovinetta, a sposa, a bambino, a persona morta senza figli o con molta prole, oppure perita per morte violenta o lontana dalla patria.43 Il folklore europeo conferma l’importanza di questa memoria culturale dei moduli letterari, sia per le lamentatrici professionali che per le parenti che assumono la guida delle lamentazioni. Così il von Hahn attesta che i lamenti albanesi sono fissati per tradizione (sind durch den Brauck festgestellt), e consi stono in una serie di distici da impiegare secondo la destinazione del lamento e le circostanze della morte: il von Hahn riporta distici che si cantano per bambini sino ai dieci anni: o boccio di rosa! Eri un fiore, e sei stato strappato via;
per uomini nel vigore degli anni: o tu serpente variegato, non facilmente ti si avvicini la sventura;
per giovani donne: o tu veloce come spola, dove recherai la tua vita?
per uomini anziani: o capo della comunità, primo fra i primi;
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
nel cimitero, quando si giunge alla tomba ecc.) e persino lamenti speciali quando il decesso avviene in primavera, il che offre un facile motivo di contrasto tra il risvegliarsi della natura e la morte della persona cara.45 Sempre in Romania nel villaggio di Dragu§ (distretto di Fagaras) spesso una lamentatrice conduce il canto ini ziando da sola i versi scelti da lei, e il coro continuerà con i versi successivi, il che presuppone moduli sconosciuti da tutti.46 In Let tonia la guida della lamentazione disponeva di un numero incre dibilmente alto di quartine tradizionali47 e una imponente rac colta di topoi della lamentazione russa si trova nella vasta silloge della Mahler.48 Infine moduli letterari stereotipi presentano in gran copia il vòcero còrso,49 1 ’attittidu sardo,50 il ripitu siciliano.51 In generale i moduli letterari delle lamentazioni funebri, come fu messo in rilievo nel corso dell’indagine sul lamento funebre lucano, hanno un’area di diffusione variabile: ve ne sono che si limitano ad un singolo villaggio, mentre altri coprono un’area molto più vasta, sia a motivo della connessione esistenziale largamente diffusa cui si riferiscono, sia in dipendenza di fenomeni di trasmis sione etnografica. Ci limiteremo a ricordare, a titolo di curiosità, un ben accertato cammino compiuto da un modulo del genere. Tutti ricordano, forse, la canzoncina infantile Marameo perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l’insalata avevi nell’orto Marameo perché sei morto.
per donne anziane: portavi le chiavi alla cintura, come il Palikari le armi.44
In Romania i bocete dei villaggi delPOa§ sono intessuti di moduli tradizionali che ognuno conosce e che impiega all’occasione: vi sono così lamenti per lattante, per madre vecchia, per giovane o per ragazza ancora vergine, e così via; oppure vi sono lamenti desti nati a certe occasioni, come per coloro che sono morti lontano o per un equivalente pratico della morte, cioè la partenza per il ser vizio militare; e infine vi sono lamenti destinati a determinati momenti del rito funerario (quando arriva il prete, quando si entra 43 P. Heinisch, Die Totenklage im Alteri Testament, Biblische Zeitfragen, voi. 1 3 , n. 9-10, 8 (1932). 44 J .C . von Hahn, Albanesische Studien, voi. 1 , p. 1 4 1.
127
Recentemente il Toschi ha richiamato l’attenzione su di essa nel quadro dei pianti rituali per la morte di Carnevale nell’Italia Cen trale.52 Quasi contemporaneamente al Toschi il padre Donatan-
45 C.
Bràiloiu, Bocete din Oa$, p. 4 dell’estratto. 46 C. Bràiloiu, Despre Bocetul dela Dragu?, Arhiva pentru stiinta si reforma sodala, voi. io , p. 3 dell’estratto (1932). 47 E . Winter, Lettiscbe Totenklagen, Globus, voi. 82, 368 sg. (1902). 48 E . Mahler, op. cit. 49 Gregorovius, op. cit., pp. 38 sg., accenna esplicitamente al carattere stereotipo dei vòceri. 50 Bresciani, op. cit., pp. 223 sg., dove si tenta anche di costruire una tipologia dei moduli ricorrenti. 51 G . Pitré, Usi e costumi, credenze e superstizioni del popolo siciliano (ed. naz.) voi. 2, pp. 2 14 sg.; Salomone-Marino, op. cit., p. 8. 52 P. Toschi, L e origini del teatro italiano (Torino 1955) p. 3 19 .
C A P IT O L O T E R Z O
128
gelo Lupinetti ha riportato alcune varianti della lamentazione tra dizionale resa nell’Aquilano dalla vedova al marito defunto: Mara me, mara me, pecché sci mortu? Tanta ’nzalata tu ci avii nell’ortu, lu pane e lu vine non te mancava, de tuttu ci avivi, de tuttu nu pocu, tanti de cerri pe’ fatti lu focu, tanti de frutti ci avii ne l’ortu. Mara me, mara me pecché sci mortu?5*53
Questo è il tema; naturalmente variano la qualità e la quantità delle buone ragioni per cui il morto non avrebbe dovuto morire. Nel testo riportato dal Lupinetti l’enumerazione dei possessi terreni che avrebbero dovuto trattenere il dipartito prosegue toccando il grano nel granaio, la coppia di buoi, le capre e le pecore, e final mente la moglie, che conclude la rassegna patrimoniale. Ora questo modulo letterario di lamentazione, la cui diffusione in Italia è limita ta, per quel che se ne sa, alla parte centrale della penisola, è sicura mente attestata in una vasta area che approssimativamente si stende dal Baltico al Mar Nero, comprendendo Balto-Slavi, Bielorussi e Ucraini, con penetrazione in aree marginali fortemente influen zate dal mondo slavo, come la Romania e le regioni del Caucaso. Giovanni Menezio, sacerdote polacco di Liko, in una lettera a Gio vanni Sabina del 1 5 5 1 e che porta il titolo D e s a c rific ìis e t y d o la trìa v e te ru m B o m s s o r u m , L iv o n u m a lia r u m q u e g e n tiu m ,54 riporta infatti un tipo di lamentazione, diffuso fra i Balto-Slavi o le popo lazioni finitime, che ripete fedelmente la lamentazione abruzzese: Durante i funerali è osservato dai contadini il seguente rito: i cadaveri sono vestiti e calzati e quindi collocati in posizione eretta su uno scanno: poi i più prossimi fra i parenti del morto vi si seggono accanto gozzovigliando e rappresentando agoni funebri. Dopo aver eseguito bevute di birra ha luogo una lamentazione funebre, che in lingua rutena dice così: «Ahimè, perché sei morto? Ti mancava forse pane e vino? Perché dunque sei morto?» Coloro che si lamentano a questo modo vanno enumerando ordinatamente tutti i beni di colui del quale deplorano la morte, vale a dire la moglie, i figli, le pecore, i cavalli, le oche, le galline. E ogni volta che enumerano ciascuno di questi beni ripetono il ritornello: perché sei morto?55 5i D. Lupinetti, Lares (1955) n. 3-4, 5 1. 54 In «Scriptores rerum livonicarum», voi. 2, pp. 389 sgg. 55 (Heu mihi, quare mortuus es? Num tibi deerat esca aut potus? Quare ergo mortuus es? Hoc modo lamentantes enumerant ordine omnia externa illius bona, cuius mortem deplorant,
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
129
Allo stesso secolo appartiene la testimonianza del letterato polacco Sebastiano Fabiano Klonowitz (1554-1604), che nel suo poema di imitazione bucolico-virgiliana dal titolo R o x o la n ia fra le costumanze della Galizia e dell’Ucraina fa riferimento anche al lamento funebre di queste popolazioni parafrasando il solito tema, che fra esse doveva essere molto frequente se viene qui assunto come tipico.56 La Mahler nel suo lavoro sul lamento funebre rus so osserva che moduli analoghi sono riscontrabili nell’attuale folk lore ucraino.57 In occasione del mio soggiorno durante l’autunno 1955 nel villaggio transilvano di Clopotiva (Hunedoara) per lo stu dio del b o c e t con la collaborazione dei folkloristi dell’istituto di folklore di Bucarest, l’informatrice Maria Draghiu di 74 anni ci riferì un modulo di lamentazione sensibilmente analogo: Lica tu di ce-ai murit? On n-ai avut ce mìnca? O n’ai avut ce imbraca? C-ai avut cioareci noi, ci coltuni cite doi! Lica tu di ce-ai murit?
[Lica tu perché sei morto? Non avevi da mangiare? Non avevi da vestire? Avevi brache nuove, e di cioce paia due! Lica tu perché sei morto?]
In una popolazione caucasica in parte frazionata e in parte som mersa dalla colonizzazione russa, i Circassi, ritorna come una eco lo stesso tema: Perché sei morto? Aiarirà! Non era il tuo viso ancora fresco e roseo? Aiarirà! Non avevi abbastanza cibo e cure? Aiarirà! Non ti volevano tutti bene, giovani e vecchi? Aiarirà! Perché sei morto? Aiarirà!58
La palese parentela con il modulo abruzzese non deve stupire se si pensa alle colonie slave del Molise, una volta più estese e oggi ridotte ai tre villaggi bilingui di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise (già San Felice Slavo). Senza voler qui decidere se tali popolazioni provengono, come è stato recentemente sostenuto, dall’Istria, ovvero - come sembra più probabile secon do la vecchia ipotesi del Resetar - dalla fascia dalmata compresa nempe uxorem, Iiberos, oves, equos, anseres, gallinas. Atque, singula rispondentes, ocinunt hanc neniam: Cur ergo mortuus es, qui haec Mabebas?) 56 II testo può leggersi in Mahler, op. cit., pp. 35 sg. 57 Ibid., cap. 5, pp. 307 sgg.; cap. 6, pp. 347 sgg.; cap. 7, pp. 352-408. 58 Bodenstedt, Tausend und ein Tag im Orìent, cit. dalla Mahler, op. cit., p. 3 17 .
1 30
C A P IT O L O T E R Z O
fra la Cetina e la Narenta, certo è che il flusso migratorio ebbe luogo non prima del secolo decimoquinto sotto la spinta della inva sione turca nella penisola balcanica. Com’è noto queste popola zioni slave insediatesi nel Molise mantennero a lungo, oltre la lin gua, il patrimonio dei loro canti popolari, e le tradizioni del loro folklore religioso, come per esempio la raffigurazione simbolica, in occasione del primo maggio, di un personaggio simbolico maschera to in un cono d’erba, in molto probabile connessione col «verde Giorgio» dell’altra sponda dell’Adriatico.59 Si deve pertanto con siderare come praticamente dimostrato che «Amara me perché sei morto...» che appare in Italia Centrale è di provenienza slava, ed è penetrato con le migrazioni avvenute non prima della seconda metà del secolo decimoquinto. Infatti il modulo in quistione appare dif fuso tra le popolazioni slave (o sottoposte a forti influenze slave); fi gura soltanto nell’Italia Centrale, dove d’altra parte consta storica mente una immigrazione di popolazioni slave; la sua presenza si ac compagna, nella stessa area di immigrazione, con quella di altri ele menti delle tradizioni popolari slave, come determinati canti popola ri e - con ogni probabilità - alcuni caratteri del Verde Giorgio. Per altri moduli di lamentazione si potrebbe tracciare, con l’aiuto di favorevoli congiunture documentarie, un analogo itinerario di diffusione nel tempo, o quanto meno la loro attuale diffusione geo grafica: ma qui basterà questo semplice esempio.
6. La singolarìzzazione del dolore Anche per il lamento euromediterraneo noi possiamo ripetere quanto fu detto per quello lucano, e cioè che il sistema di prote zioni destorificanti media la singolarìzzazione del dolore, il ritorno alla concretezza della situazione luttuosa, il riadattamento o l’in novazione dei moduli a vari livelli di coerenza formale e di auto nomia personale. Parlando in generale delle lamentatrici siciliane il Salomone-Marino annota come «i loro canti... son sempre gli stessi e si tramandano inalterati di generazione in generazione: 59 Sui canti popolari slavi del Molise è da vedere E . Cirese, I canti popolari del Molise, 2 voli. (Rieti 1953-57). Sul personaggio mascherato in un cono d ’erba cfr. M . A . Cirese, La pagliara del primo maggio nei paesi slavo-molisani, Slovenski Etnograf, voi. 8, 270 sgg. (1955).
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
13 1
mutano il nome dell’estinto e qualche circostanza accessoria, sono come un abito che si attagli al dosso di ciascuno».60 Vi è dunque la mutazione: e non sempre così irrilevante come par credere il Salomone-Marino. Attraverso la selva dei moduli e delle stereotipie si fa luce e drammaticamente si configura il ritorno alla situazione particolare, e attraverso la mediazione delle protezioni rituali il «si muore» e il «si piange» si ridischiudono a «questa morte» e a «questo mio pianto». Nelle forme ritualmente più vincolate, e stori camente più arcaiche, il margine di variazione è minimo. Vi sono ambienti folklorici in cui la frequenza dei ritornelli emotivi stereo tipi e il gran numero di moduli protettivi del discorso consente solo mutamenti irrilevanti: in tali ambienti i rischi connessi al cordo glio sono particolarmente acuti e pertanto più vivo è il bisogno di affidarsi a stampi rituali di comportamento. E molto difficile, allo stato attuale della ricerca folklorica e per la disgregazione che ormai quasi da per tutto colpisce il lamento funebre, accertare la reale diffusione di questo tipo di lamentazione fortemente vinco lata. Senza dubbio quando si raccolgono senza le opportune garanzie ed in modo del tutto sporadico e asistematico lamenti funebri di un’area folklorica abbastanza vasta, lasciandosi magari guidare da un criterio «estetico» di scelta, si può avere la falsa impressione che la parte riservata all’improvvisare sia nel corso della lamenta zione molto ampia: ma se la raccolta si effettua in un unico villag gio e se in questa circoscritta comunità si esplora con tutte le garan zie possibili l’effettivo svolgersi della lamentazione, accade spesso di veder moltiplicarsi a dismisura i moduli e i temi letterari del testo, e di veder ripetere indefinitamente sempre le stesse vicende mimiche, il che obbliga a considerare in proporzioni molto mode ste la possibilità del riadattamento, della variazione e della improv visazione. Un caso di testo vincolante che consente soltanto varia zioni minime è offerto dal seguente modulo siculo-calabro: Dunni vinni sta nevula? Vinni di l’autu mari; trasiu di la finestra, mi ruppi lu spicchiali! Lu spicchiali è mé maritu, beddu, bonu e politu.61 60 Salomone-Marino, op. cit., p. 8. 61 Pitré, op. cit., voi. 2, p. 2 15 . L ’antica area di diffusione di questo modulo doveva essere
I32
C A P IT O L O T E R Z O
Questo modello può essere utilizzato tal quale in tutti i lamenti resi da moglie a marito: e l’elemento personale potrà manifestarsi soltanto nell’interpretazione. Ma anche nel caso di morte del padre la figlia potrà adottarlo, purché al quarto verso sostituisca patri a maritu, ed accordi eventualmente la rima o l’assonanza del quinto verso. Allo stesso modo la madre che lamenta il figlio sostituirà figghiu a maritu, e così via. In altri ambienti folklorici la lamenta zione si è liberata dalla frequenza dei ritornelli emotivi, dalle perio diche collaborazioni corali, dalla selva dei moduli e dei temi obbli gati, mantenendo solo i vincoli del metro, della melopea, dello stile, della preferenza per certi giri del discorso e per certe immagini, e infine della mimica. In questi ambienti il lamento presenta una disposizione molto maggiore ad accogliere e ad elaborare nel testo letterario la varietà infinita delle situazioni storiche particolari che rendono ogni morte un evento a sé, irriducibile al comune deno minatore dei moduli verbali fissi, dei testi stabiliti e delle situazionitipo. D ’altra parte in uno stesso ambiente folklorico può accadere di incontrare lamentazioni a testo fisso che costituiscono veri e propri canti rituali, e lamentazioni a discorso più o meno improv visato, ciascuna destinata a momenti diversi del rituale funerario: è il caso, come vedremo, dei «funerali di Lazzaro Boia» dove il canto dell’alba o della morte alla finestra si distingue nettamente, sotto tutti i rispetti dai bocete relativamente personali delle varie lamentai rici.62 Infine in uno stesso ambiente folklorico e per uno stesso tipo tradizionale di lamentazione vengono raggiunti nel corso del rituale funerario vari livelli di autonomia e di variazione: una stessa lamentatrice passa dal planctus irrelativo alla sua rigorosa ritualizzazione protettiva, con assoluta stereotipia di parola e gesto e dizione, con periodizzazione regolarissima di ritornelli emotivi, accompagnati da incidenze corali altrettanto regolari, e infine, in altro momento, può conseguire una molto più larga possibilità di variazione personale, di riadattamento alle circostanze e di singolarizzazione del dolore non soltanto sul piano oratorio ed etico, molto estesa se il Casetti-Imbriani, voi. i , p. 19 6, Io dà come proveniente da Camporeale e se il Salomone-Marino, op. cit., p. 3 1 , ne ricorda la diffusione nella prossima Calabria. D ’altra parte un vòcero còrso riportato dal Tommaseo, op. cit., voi. 2, p. 19 7 , ne riecheggia in qualche modo il motivo: « D ov’è binuto su focu? dov’è falatu stu male I E falatu da lu cielu: O è sortitu de lu mare?» 63 Cfr. p. 165.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
133
ma anche su quello di un elementare - e tuttavia in sé compiu to - lirismo: allora baleni di poesia son strappati al caos del pa tire, e si innalzano sull’ordine meramente tecnico del rito e sulla risoluzione soltanto oratoria degli affetti. Una vedova còrsa lamenta il destino suo e degli orfani: Quannu venirà Testati, di la biada la stagioni, ci n’andremo a li spichi per Cardapu e per Uscioni. Così fàcinu li donni, che perdìnu lu patroni. Comu vinirà settembre. Piglieremo la Tavagna, ci camperemo a fascioli, rudaremo le castagna. Sempre saremo a li tozzi, per paesi e per campagna.63
Una madre còrsa di Pietra della Verde grida alla figlia morta: Oh mansa come lu pane, oh dolce come lu mele! Nun la vidite stamane, com’è turnata crudele? Amandula inzuccherata, occhie amare come fele.64
E una contadina molisana di Mascioni davanti alla tomba del congiunto invoca: A Pié, che fa che non revé? Arepassa jò le prata, e repija la cavalla, revéttene a Mascioni!65
Qui, come in altri esempi che si potrebbero addurre, il testo letterario ha spezzato ormai i vincoli col rito della lamentazione ed è diventato autonomo: ha riassorbito musica e gesto, e possiede in sé tutto quello che occorre per l’espressione poetica. Talora è da pensare che il risultato lirico non è stato guadagnato neppure 63 Tommaseo, op. cit., voi. 2, p. 234. 64 Marcaggi, op. cit., p. 90. 65 A. M. Cirese, Alcuni canti popolari abruzzesi raccolti in provincia di Rieti, Riv. abruz zese, voi. 5, n. 2, 42 {1952).
134
C A P IT O L O T E R Z O
nel corso del rito, ma da qualche poeta o poetessa popolari in momenti indipendenti dal funerale in atto, come sarà stato pro babilmente il caso della endecha che fu cantata per la morte del sivigliano Guillen Peraza, avvenuta nel 1443: Llorad las damas - si Dios os vaia. Guillen Peraza - quedó en la palma la fior marchida - de la su cara. Non eres palma, - eres retama, eres cipres - de triste rama, eres desdicha, - desdicha mala. Tus campos rompan - tristes volcanes, non vean placeres - sino pesares, cuebran tus flores - los arenales. Guillen Peraza - Guillen Peraza, do està tu escudo? - do està tu lanza? Todo lo accaba - la mala andanza.66
[Piangete o dame se Dio v’aiuta. Guillen Peraza lasciò nella palma il fiore appassito del suo volto. Non sei palma, ma sei ginestra, sei cipresso di funesti rami, sei sventura, nera sventura. Devastino i tuoi campi funesti vulcani, e gioie non veggano, ma solo lutti, sommerga la sabbia i tuoi fiori. Guillen Peraza, Guillen Peraza, dov’è il tuo scudo, dov’è la tua lancia? Tutto distrugge la mala sorte].
Noi possiamo ora misurare tutta l’insufficienza - dal nostro punto di vista - della documentazione raccolta con gli antichi metodi: gran numero di testi di cui disponiamo sono spesso dei r i s u l t a t i frammentari a cui la lamentazione si solleva, mentre il lamento è una d i n a m i c a ed una a g o n i s t i c a - e i n parti colare una t e c n i c a - per compiere la catabasi verso le tenta zioni del planctus irrelativo e l’anabasi verso le potenze formali del discorrere.67
66 M. Menendez y Pydal, Antologia depoetas liricos castellanos, voi. io (1923) pp. 229 sg. La Endecha per Guillen Peraza, proveniente dalle Canarie, fu raccolta dalla tradizione orale nel 16 32 dal francescano Abreu Gaiindo, e si trova trascritta nella sua Historia de las siete islas de la gran Canaria (ed. Santa Cruz de Tenerife, 1848) pp. 63 sg. Un altro fenomeno folklorico ben noto è il riassorbimento di temi caratteristici del lamento in composizione di altra natura: questo sembra essere il caso del tema morte-nozze nella famosa ballata popolare romena Mioritza: vedi C. Bràiloiu, Sur une ballade roumaìne (Ginevra 1946). 67 La circolazione folklorica dei canti popolari, con la sua ben nota dialettica di conser vatorismo ed innovazione, è da interpretare a nostro avviso come una laicizzazione di quel ripetere variando e riadattando che nel lamento funebre rituale e in altri prodotti appartenenti alla sfera magico-religiosa scopre la sua originaria funzione tecnico-protettiva di mediazione.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D I T E R R A N E O
135
7. Una lamentazione al Cairo La varietà delle forme di lamento nella concretezza di uno stesso rituale funerario si riflettono in un notevole documento etnogra fico, in un certo senso unico nel suo genere. Si tratta di una descri zione della scena di lamentazione dettata in arabo a Paul Kahle verso il 1908 da una lamentatrice del Cairo, Saijida Sabra.68 Qui è innanzi tutto resa in modo esemplare quell’atmosfera di crisi incombente, di recitazione sognante e di drammatica ripresa che è propria di ogni forma di lamentazione in generale. La norma della tradizione presso gli Arabi di Egitto stabilisce che il lamento deve essere ripetuto nei tre giorni successivi al decesso, e poi, durante i primi quaranta giorni, ogni giovedì: è questa, per così dire-, la posologia locale del rito. La narrazione di Saijida Sabra ci mostra il canovaccio del dramma, ciò che «si fa» quando ci si lamenta in uno di tali giorni prescritti. Fra i personaggi vi è anzitutto la persona colpita da lutto, che nel documento si suppone sia una donna che ha perduto il marito; e poi vi sono le condolenti, lamentatrici non a prezzo, e cioè parenti o amiche che son accorse per aiutare il pianto e al tempo stesso per approfittare dell’opportu nità tecnica che è data loro per svolgere un altro turno del lavoro di cordoglio per i loro lutti più o meno recenti; vi è infine la spe cialista del pianto, la lamentatrice professionale (mu’addida), che sopraggiungerà più tardi insieme alle sue assistenti, e che assumerà la guida complessiva del rito, e venderà lamenti a chi li vorrà com prare. La prima scena riflette i preparativi: è il risveglio, all’alba, nel giorno della lamentazione, e ci si affretta a preparare le stuoie dove le piangenti dovranno assidersi, mentre esplodono le mani festazioni di planctus più o meno ritualizzato: Colei che è in cor doglio si leva al mattino e dice: O mattino colorato di indaco! Distendi le stuoie, o sorella! Il tuo giorno è nero.
Si distendono le stuoie secondo il numero delle condolenti e la portatrice del cordoglio alza il grido della lamentazione: «Ja dahw iti!...» E le condolenti entrano col grido del lamento, salutano Kahle, op. cit., pp. 349 sgg.
136
C A P IT O L O T E R Z O
la portatrice del cordoglio e le dicono: «Come stai?» Essa risponde e dice: «Come può stare chi è annientata». E ognuna, cui è morto un uomo, nel sopraggiungere e nell’assidersi dice: «Come il padre della tal di tali» e getta il grido. Poi si siede e dice: «Il tuo giorno è nero, la tua rovina è molto grande, amore mio». E piange. Lo stesso dice ognuna: «Quésto è come questo o come quello», ed essa pensa a colui che le è morto. Questo periodo preparatorio della vicenda rituale non va oltre alcune forme di ritualizzazione del pìanctus e brevi frasi stereo tipe scambiate fra le condolenti e la portatrice del cordoglio: solo quando sarà giunta la moderatrice del rito, cioè la specialista del pianto, col suo corteo di assistenti, avrà inizio la lamentazione tra dizionale. Per una evidente contaminazione islamica, la lamentatrice professionale inaugura la lamentazione con una richiesta di perdono a Dio: poi scoppia il coro delle condolenti, con la fun zione tecnica di indurre la portatrice del cordoglio a dischiudersi alla vicenda rituale della lamentazione. Le condolenti stimolano al pianto colei che è «annientata», e infine lo sblocco ha luogo, e la portatrice del cordoglio dà inizio al lamento con una serie di moduli stereotipi: O giorno nero, o mia rovina, o chiusura della mia porta, o mio leone, o mio cammello, o padre degli orfani, a chi li hai lasciati, o mio tradimento, o mia sventura, o mia miseria dopo la tua partenza.
Le condolenti piangono: Si, sorella, dillo, a chi li hai lasciati (gli orfani).
La portatrice si dispera: Non avevo nessun desiderio, ero ricca, e ne avevo di troppo...
L ’atmosfera di recitazione sognante e di cordoglio calcolato e previsto è denunziata dal fatto che, a un dato momento, la lamen tazione è sospesa e si stabilisce una detente convenzionale, durante la quale la portatrice del cordoglio fa girare sigarette e caffè: tutto accade come se la presenza egemonica avesse consentito per un certo tempo di consumare una certa dose del pianto sul piano con venzionale della presenza rituale, e ora, a comando, avesse sospeso la prestazione. Intanto una delle condolenti è riandata con la memo ria ad un’altra sciagura, quando una sua amica o parente morì per
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
137
ché le si appiccò il fuoco alle vesti, e avvolta nella vampa prese a correre disperatamente nella stanza, e trovò la porta sbarrata, e nessuno le potè dare aiuto. Ed ecco che la condolente vuol rinno vare il cordoglio per la morta, e compra dalla mu’addida il lamento: Quindi una delle condolenti dà alla mu’aidida un regalo in denaro e le dice: «Parla, sorella, di quella che nessuno trovò che la spegnesse». La mu’addida accetta e dice: «L a parete la respinge e trova la porta, nessuna amica entra che la spenga». La condolente: «S ì, sorella, ahi per quella che non riuscii a raggiungere [per salvarla] ». E tutte alzano il grido della lamentazione. E la mu’addida riprende: «N ell’ora del destino il fuoco raggiunse il lembo della mia veste e la sua vampa crebbe ai miei occhi». E tutte fanno risuonare il grido della lamentazione, e la condolente si percuote il viso, le altre condo lenti la trattengono, ed essa si siede tranquilla.
Le memorie di antiche sciagure si moltiplicano nelle condolenti, e la lamentazione prende l’andamento di una «festa dei morti» nel la quale, con l’aiuto esperto della specialista del pianto, le crisi non ancora scontate sono affrontate e risolte nel discorso della lamenta zione. Un’altra condolente si leva, paga ciò che è dovuto per il ser vizio richiesto, e invita la lamentatrice a tesserle un lamento per un ragazzo che morì affogato, senza che nessuno potesse salvarlo: E una seconda condolente le dà un dono in denaro e le dice: «Parla, sorella, di colui che non trovò nessuno che lo tirasse su». La mu’addida accetta e dice: «Nell’ora in cui cadde in acqua non c’era nessuna zia materna o paterna. La gente della strada fece gruppo intorno a lui [intorno al suo cadavere] tratto dall’acqua». La mu ’addida risponde a tutte le richieste, evoca tutte le memo rie, impersona i vivi e i morti, e per ogni caso ricorda il lamento giusto o riadatta o improvvisa: per il giovinetto o la giovinetta che morirono prima di andare a nozze, per una donna senza figli o per una che ne ha molti, per chi è morto in paese straniero, o per una famiglia colpita contemporaneamente da più lutti, e così via. Essa figura qui come la vera regista della ripresa, e del progresso verso la ripresa, laddove la portatrice del cordoglio non aveva saputo andar oltre la recitazione di stereotipie verbali, e le condolenti rischia vano di restar piegate sotto il peso delle loro funeste memorie. Nella narrazione della lamentatrice del Cairo vi sono senza dub bio tutti i limiti che son propri di questo tipo di documenti: la lamentatrice che narra come ci si lamenta non è ovviamente l’et nografo che stende il suo rapporto sul rito della lamentazione, e
138
C A P IT O L O T E R Z O
che ordina la sequenza degli accadimenti rituali sottolineandone gli aspetti più importanti (o che gli appaiono tali): così, per esem pio, nella narrazione di Saijida Sabra è poco chiaramente espresso il carattere tendenzialmente periodico delle incidenze corali rispetto alla lamentazione-guida della specialista del pianto. Ma tale perio dicità è confermata da un rapporto etnografico relativo allo stesso ambiente e che il Kahle riporta: si tratta della descrizione lascia taci da Nyna Seiima, una europea che ebbe occasione di occuparsi del folklore dell’Egitto moderno.69 Nyna Seiima riferisce infatti nel suo rapporto che la mu ’addida rompe il silenzio con un grido altissimo, e dà inizio alla melopea, che ad ogni strofa è interrotta dal ritornello emotivo delle presenti: «Ja dahwiti! », con la i finale a lungo protratta e sottolineata da singhiozzi stereotipi convulsi. Inoltre nei silenzi intercalari fra lamentazione e lamentazione una recitatrice salmodia brani del Corano, cullandosi lentamente come per il canto di una ninna-nanna, mentre le piangenti stanno immo bili e a occhi socchiusi, quasi stessero per addormentarsi: poi, ces sata la salmodia, la lamentazione riprende con rinnovato vigore. Con l’integrazione del rapporto di Nyna Seiima la lamentazione funeraria fra gli Arabi di Egitto ci appare confermare largamente le strutture che abbiamo analiticamente esposte: e cioè la ritualizzazione del planctus, la ripartizione corale dei ritornelli emotivi, i moduli verbali del discorso protetto, la cessione del discorso a una specialista del pianto, l’utilizzazione della lamentazione per rinnovare lutti più o meno recenti, la notevole importanza tecnica della «guida» specializzata nell’effettuare la ripresa dalla crisi, la compra-vendita del lamento, e infine l’istituzione di una presenza stereotipa del pianto.
8. Delirio di negazione e lamento Già vedemmo come uno dei rischi della crisi del cordoglio sia un delirio parassitario in cui si nega l’evento luttuoso e ci si com porta come se il morto fosse soltanto un dormiente che si risve glierà, o un assente che da un momento all’altro può tornare, e6 5 65 II rapporto di Nyna Seiima si può leggere in Kahle, op. cit., pp. 346 sgg.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
139
che conviene attendere o addirittura cercare, e che infine si può credere anche di aver ritrovato. Il carattere delirante di questo comportamento sta nel fatto che qui la finzione diventa un centro di organizzazione di tutta la vita psichica e un argomento di pro gressivo distacco dalla realtà. Nella nostra indagine sul lamento funebre lucano non abbiamo rintracciato nessuna tecnica speci fica indirizzata a trattare questo rischioso delirio, e a cambiarlo per così dire di segno, riplasmandolo in una momentanea finzione istituzionale che attenua l’asprezza della nuova situazione, e dà il tempo necessario per compiere il lavoro di riadattamento alla realtà. Il lamento funebre folklorico euromediterraneo presenta invece qua e là alcune strutture tecniche che sono visibilmente indi rizzate in questo senso. Tali strutture consistono nell’offrire, me diante la protezione tecnica del rito, un modo per entrare in rap porto con la tentazione del rischio, cioè del comportamento irre lativo: una volta stabilito questo rapporto, viene avviato un oppo sto processo di reintegrazione del delirio nel circuito psichico, in modo da renderlo gradualmente accessibile alla lezione della realtà, e da dischiuderlo alla plasmazione delle forme di coerenza cultu rale. Nella sua forma più semplice la tecnica di reintegrazione trova espressione in quella forma di lamento in cui la lamentatrice recita successivamente in forma di monologo i due momenti del delirio e dell’anamnesi disingannatrice. Una lamentazione raccolta dal Barsov illustra molto bene questa tecnica: Rumoreggiate voi tempeste di primavera giù dai monti, dilavate la gialla sabbia, sollevate il coperchio della bara, squarciate i lini funebri, permettetemi soltanto una volta a me piegata dal dolore di contemplare colei che mi ha generato, la mia mamma! Ah! Le tempeste di primavera non rumoreggiano, esse non dilavano la gialla sabbia, non mi fanno vedere la mia cara mamma. Sollevatevi voi, venti impetuosi, da tutti e quattro i cieli, irrompete nella chiesa, sconvolgete l’umida terra, fate suonare la campana grande, risvegliate mia madre!
140
C A P IT O L O T E R Z O
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
I venti impetuosi non si sollevano, non battono sul campanone, non risvegliano mia madre.
Io ti aspetterò, mamma, io ti aspetterò sino alle nove: e se vedrò che non vieni, allora annerirò come fuliggine. E se vedrò che tu non vieni, alle dieci hai da vedere: alle dieci sarò diventata terra, terra terra da seminarvi!
Scendete dal cielo, voi schiere di arcangeli, riponete l ’anima nel petto esanime, date impeto alle bianche mani, e agli agili piedi il passo. Dal cielo non scendono gli arcangeli a schiera, non infondono l’anima nel morto petto ecc.70
Madre·. Non aspettarmi mai, figlia mia,
mai mai in nessun tempo, né per anni, né per secoli, né per il male né per il bene.72
La stessa struttura presenta un lamento raccolto da Azadovskij: Sollevatevi, nubi minacciose, spezzi la mamma il coperchio della bara! Svègliati cara mamma, strappati di dosso il bianco lino, distendi le bianche mani, apri i tuoi occhi luminosi, dischiudi la bocca dolce come zucchero, dimmi ancora una parola, ravviva ancora di gioia il mio cuore!
0
Tu non potrai strapparti lino dei morti, non distenderai le tue bianche mani, non parlerai dolci parole, non farai gioire il mio cuore ecc.71
In una forma tecnica più complessa la risposta delusoria viene data dal morto stesso, che è introdotto come personaggio in una lamentazione dialogica. In un lamento neogreco di Martano (peni sola salentina) la figlia annunzia alla madre di volersi struggere nel l’attesa del ritorno, e la madre risponde esortando la figlia a non aspettarla mai più: Figlia :
Io ti aspetterò, io ti aspetterò, mamma mia un momentino al giorno: affinché io ti dica il mio lamento, e come l’ho passata. Io ti aspetterò, mamma mia, ti aspetterò sino alle otto; e se vedrò che non vieni, allora comincerò a piangere.
70 Mahler, op. cit., pp. 478 sg. 71 Ibid., p. 476.
14 1
Un lamento della Russia settentrionale riprende la scena del tra passo, e in un dialogo fittizio fra la madre morente e i suoi bam bini avvia il rapporto verso la soluzione giusta: Bambini·. Dicci dunque, o mamma, come faremo senza di te? Madre: Bambinelli miei, non me lo chiedete, se avete pietà di me non mi
Bam bini: Madre: Bam bini: M adre: Bam bini: M adre: Bam bini: Madre:
tormentate. Vado male, molto male. Dire una parola mi costa un rublo. Mamma, nostra nutrice, come faremo a non parlare più con te? Bambinelli miei, pregate Dio per me, per questo mio patire. Così lo sopporterò meglio. Patisci, mamma, il signor Iddio ama le sofferenze. Bambinelli, voi miei colombini, ve lo torno a dire, ho tanto male. Mamma, tu che ci vuoi tanto bene... Vi prego ancora, non mi tormentate... Mamma, mamma cara! Basta col parlarmi, accendi il cero...
(nella finzione scenica si suppone che in questo momento avvenga i l trapasso:) M adre:
Vivete, bambinelli miei, secondo la vostra volontà. Basta con l’ascoltare le mie parole...73
Ad un ulteriore grado di complessità tecnica si sollevano le lamentazioni russe in cui viene mimata la ricerca rituale del morto. Nella Russia settentrionale dopo la sepoltura tale ricerca veniva eseguita da per tutto, in casa, nel cortile, nell’atrio, nella stalla, ma anche per i prati e per i boschi: era un vero dramma rituale, agi72 Morosi, op. cit., p. 12 . Il modulo si presta, con poche variazioni, a situazioni diverse. Cosi per esempio a Soleto è attestata la seguente variante {ibid., p. 55): «Io ti aspetterò, mio figliuolo, I io ti aspetterò sino alle tre: I e quando vedrò che non vieni ecc. ». Cfr. ibid., p. 59. 73 Mahler, op. cit., pp. 1 1 3 sg.
142
C A P IT O L O T E R Z O
to e cantato secondo forme tradizionali.74 Nel governatorato di Vladimir la scena della ricerca trova il suo appassionato commen tario nella seguente lamentazione: Per le distese dei campi, per le oscure foreste io vado, lamentandomi, chiamando ad alta voce colui che è la mia Legge. Mi seggo ai piedi di un alberello e attendo il mio Ivanuska, se almeno non venga come un animaletto, se almeno non voli a me come un passerotto, o come grigia tubante colombella. Ma la mia Legge non ritorna indietro, non ritorna indietro!
Ad un tratto sembra alla vedova che una betulla si chini sino a terra come in segno di saluto, e che questo albero animato sia il suo Ivanuska: Solo una bianca betulla si china sino a terra. Io scorgo la piccola madre, la bianca betulla, chinarsi sempre più sino a terra, come si piegava il mio uomo davanti alla brava gente. Ecco che mi par di capire: rifletto e sradico la piccola betulla: non è forse l’anima del mio Ivanuska? Si piega giù del tutto, e sempre sino a terra, proprio come Ivanuska vi salutava una volta. Nella mia camera, ho pensato, la voglio piantare, voglio a lungo guardarla pensando al mio piccolo Ivan, chiaro falchetto, amor mio.
La vedova porta con sé il ramo di betulla e lo colloca davanti alle icone, poi di nuovo si reca fuori casa a spiare l’orizzonte se mai veda tornare il caro Ivan, stacca un fiore dai prati, e infine fa ritorno così lamentandosi quando è giunta in cospetto degli ospiti: Ho colto questo fiore e ve l’ho portato. Guardatelo voi, brava gente: non rassomiglia alla mia Legge? Aiutatemi a intendere questa certezza che sento: non è questa Panima del mio Ivanuska? Serbare voglio questo rosso fiore, sul gran balcone della stanza alta, e così tenerlo, io sventurata come fosse la mia cara Legge, mio Ivanuska.75
0
74 Ibid., p. 1 2 1 , 75 Ibid., pp. 12 4 sgg.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D I T E R R A N E O
143
Le lamentazioni di questo tipo si concludono sempre con un modulo obbligato in cui è espressa l’inutilità della ricerca e l’irre vocabilità della scomparsa.76 Il significato tecnico di questo tipo di lamentazione è evidente. L ’azione rituale della ricerca cade in un momento particolarmente critico della situazione luttuosa, cioè dopo la sepoltura, quando anche la spoglia mortale è scomparsa alla vista, e si deve tornare nella casa vuota. Qui il lavoro psichico del cordoglio tocca uno dei suoi vertici più alti, e aumenta quindi il rischio di un delirio parassitario di attesa o di ricerca. Il rito affronta questo rischio nella protezione tecnica che gli è propria, e stabilisce la ripresa secondo un modello di comportamento in cui si dà parzialmente sfogo alla tentazione del delirio (ricerca e ritrovamento) e al tempo stesso si provvede a mantenere l’auto nomia necessaria per l’anamnesi dell’irrevocabile. La vedova cerca il marito «per le distese dei campi, per le oscure foreste», e grida e chiama il suo bene, e crede di averlo trovato nel ramo di betulla o nel fiore dei prati. Ma il discorso del lamento le «insegna» che il morto non può tornare (la m ìa L e g g e n o n to m a in d ietro , n o n to m a in d ie tr o !), e che il ramo di betulla o il fiore dei prati sono appena un «come se» mitico, su cui concentrare la carica affettiva rima sta senza oggetto. Ricerca rituale e discorso della lamentazione costituiscono in tal modo il sentiero tradizionale, il cammino pro tetto, lungo il quale si compie la catabasi verso il rischio e l’anabasi verso una soluzione di compromesso che restituisce orizzonte alla presenza: ciò che ne risulta non è più il delirio parassitario, ma un s i m b o l o m i t i c o padroneggiato, culturalmente aperto al progresso verso V eth o s delle memorie ed eventualmente anche verso la catarsi poetica: un simbolo dinamico, che resterà operoso nella sua funzione protettiva sin quando sarà praticamente esau rito il lavoro psichico della smobilitazione e della riconversione degli affetti, e il morto sarà morto una seconda volta, risolto senza residuo nel diritto dei vivi. 76 Ibid., p. 12 8 : «Die Klagenden schliessen ihr Suchen immer mit dem demutigen Ausruf: “ Nicht finden kann ich ihn, schmerzgebeugten Hàuptchen!” Auch die suchende Mutter bricht in den enttauschten Ruf aus: “ Wohin ich armes Schmerzenshàuptchen geh, ich finde mein Kindchen, mein geborenes nirgend” ». Anche in altri ambienti folklorici, dove la ricerca attuale non è più praticata, se ne serba traccia nel discorso individuale, della lamentazione. Così, per esempio, in un lamento neogreco raccolto a Zollino {penisola salentina) la madre - o la lamentatrice che la impersona - così si rivolge al figlio morto: «Io ti aspetterò, figlio mio, I io ti
144
C A P IT O L O T E R Z O
9. Ritualizzazione dei conflitti suscitati dall’evento luttuoso Il materiale folklorico euromediterraneo, offre esempi di un altro particolare impiego tecnico del lamento funebre, cioè la risoluzione rituale, nei modi che del lamento son propri, dei conflitti che un evento luttuoso può suscitare fra i sopravvissuti. In questa ulterio re applicazione tecnica la struttura del lamento che sinora abbiamo esaminato si mantiene soltanto per quel che concerne la melopea del lamentarsi e la sua eventuale struttura metrica: per il resto subi sce notevoli mutamenti, dando largo posto alla rappresentazione drammatica e alla improvvisazione. Si tratta insomma di un liti gio fra persone su argomenti scottanti che la morte rende attuali, ma di un litigio «recitato», in cui i contendenti sostengono una «parte», e vanno esprimendo le loro ragioni utilizzando lo stile del la lamentazione, in una sorta di contrappunto destorificatore che si sovrappone alla realtà della vita vissuta. Un notevole esempio di questo genere ci è offerto da alcuni frammenti di lamento funebre abruzzese recentemente raccolto da A. M. Cirese.77 Le circostan ze a cui il lamento si riferisce, sono le seguenti: una giovane con tadina abruzzese, recatasi dalla frazione di Mascioni al comune di Campotosto, apprende per caso in municipio che il marito Daniele è morto in guerra. La povera donna riprende la via del ri torno e giunta presso casa annunzia alla suocera la morte di Daniele, inaugurando il lamento: E tra Masciuni e Campetostu ce stanno li fossati, tra li pianti e li sospiri l’àj tutti rabboccati. ... E mamma mamma mamma, apreme le porte, prepararne la panca, che te porte la nova che Danielle manca... aspetterò sino alle tre: i e quando vedrò che non vieni, I metterò sossopra il cortile e Torto» (Morosi, op. cit,, p. 55), cioè inizierà la disperata ricerca del figlio. Ancor più chiaro questo motivo traspare in un altro lamento neogreco, raccolto a Soleto: «Io ti aspetterò, io ti aspet terò, babbo mio, I io ti aspetterò sino alTuna: I e quando vedrò che non vieni, I uscirò (a cer carti) nel vicinato» {ibid., p. 59). 77 Cirese, Alcuni canti popolan abruzzesi raccolti in provincia di Rieti, pp. 4 1 sg.
I L L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
145
A questo annunzio della sventura, eseguito dalla vedova secondo la forma tradizionale del lamento, cioè cantilenando quartine di settenari con versi dispari e versi pari rimati, segue - sempre nel la stessa forma strofica e metrica - un contrasto fra suocera, ve dova e cognata: Suocera·.
O figlia figlia figlia, vattene a rejì, Uà nn’i frateUi teo revattene a morì.
Vedova:
Que ce revaje a fà Uà ’n quelli frateUi, che solleu me dau queUi che sò tutti minoreUi?
Suocera·.
E figlia figlia figlia se te vò sta co me, pe l’amor’e lu figliu me te voglio tené.
Vedova:
E no me volate bene prima che c’era lu patrone, me volete bene mone che commanna zarrone?
Cognata: E zlttete cugnata
non di’ le parole strafottente, se no la faccio rie, cugnata, tutta sta gente.
In questo lamento i conflitti suscitati dalla morte di Daniele sono dai familiari affrontati, espressi e sciolti su un piano di recitazione sognante, che segna il passaggio dall’antico al nuovo ordine dei rapporti fra i componenti della famiglia. La suocera riattualizza antiche gelosie contro la nuora e manifesta il proposito di riman darla nella casa donde è venuta, la vedova sa di non poterlo fare perché i fratelli sono ancora minorenni e non la potrebbero sostene re, ma al tempo stesso sa che dopo la morte del «patrone» comanda «zarrone», cioè la cognata. Questa prospettiva è altrettanto temuta dalla vedova quanto ambita dalla cognata, che col suo intervento sottolinea bruscamente la nuova situazione, dando subito prova nel tono delle parole che effettivamente da ora in poi la suprema
14 6
C A P IT O L O T E R Z O
zia spetterà a lei. Attraverso il lamento questo nodo di conflitti è subito affrontato e liquidato sul piano destorificato della recita zione, anticipando su questo piano la soluzione che dovrà poi valere nella realtà: nei vincoli di una strofa cantilenata la suocera ingiunge alla nuora di tornarsene tra i fratelli, ora che il figlio è morto; nei vincoli di un’altra strofa la nuora risponderà che non può farlo perché i fratelli sono minorenni; e così via. Un altro esempio dello stesso tipo ci è offerto dalla documenta zione relativa ai v ò c e r i còrsi.78 Una Francesca Alibertini di Penta di Casinca è rapita da un Giovanni Felice di Pruno d’Ampugnani, e contro la volontà dei genitori di lei si sposa col rapitore. Dopo il rapimento e il matrimonio Francesca non s’incontra più con i suoi familiari, e vive col marito nel villaggio di Pruno. Una volta i familiari di Francesca avevano cercato di combinare un incontro nel convento di Sant’Antonio di Casablanca d’Ampugnani, pro fittando della pia occasione di una missione di frati francescani che aveva luogo appunto in quella località: ma il tentativo non ebbe effetto. Ora accadde che Francesca venne a morte: e solo allora la sorella Maddalena si recò a Pruno, rompendo l’impegno di non metter mai piede in quella casa. In una circostanza come questa noi ci aspetteremmo o la riconciliazione fra le due famiglie, o la repressione dei loro antichi risentimenti, o un violento litigio in cui ciascuno dice il fatto suo, vuotando per così dire il sacco. Invece nulla di tutto questo avviene davanti al cadavere di Francesca, ma una recitazione nella forma strofica e metrica del v ò c e r o . Madda lena e la cognata affrontano subito i temi del conflitto in un discorso vincolato che si snoda in quartine e senari di versi ottosillabici con rime variamente alternate, cantati sulla nenia tradizionale del v ò c e ro . Maddalena ricorda l’episodio che doveva particolarmente bru ciare a lei e alla sua famiglia, l’invito fatto e non accolto di un in contro in zona neutra: Non ti ne ricordi o Cecca, quandu in tempu di missione ti mandaimu a chiama a u conventu a Sant’Antone, pe bede la to famiglia e sfugatte lu to core? 78 Marcaggi, Les chants de la mort et de la vendetta de la Corse (1898) pp. 146-61.
H . L A M E N T O F U N E B R E F O L K L O R IC O E U R O M E D IT E R R A N E O
147
Vidi una to paisana, e mi missi a dumandà: avristi vistu a Cecca s’ella colla per ava? Allor ella mi rispose: un vurrà lu so maritu ch’ella colli a Sant’Antone, perché un’ha bellu vestitu.
Sempre nella struttura del v ò c e r o Maddalena esprime il suo disap punto che Francesca non possiede un d ra p p o d i c o lo r e , segno di di stinzione e di agiatezza, e il disappunto suona rimprovero al marito che non volle o non potè provvedere a tanto. Poi Maddalena rim provera Giovanni Felice di non averla mandata a chiamare per la morte della sorella. Allora la cognata della defunta risponde con ima quartina di versi ottosillabici, sempre secondo la nenia tradizionale: Or scusate: lu maritu v’averia mandaiu a dì: ma, signora, ellu crìdia ch’un vuleste culla qui.
E Maddalena, risentita: Era forse qualchi turca benuta li barberia, che pe’ a mio surella Cecca co cullata un ci seria?
Quindi Maddalena, rivolgendosi alla morta, deplora che la fami glia del marito l’abbia ingannata, lasciandola andare vestita del rozzo panno còrso: La famiglia di Trinchettu t’ha trattatu cun ingannu e perfinu m’hannu dettu che tu purtava lu pannu.
La cognata canta la sua smentita con la seguente quartina: Eo lo sò, la mio signora, Vi lagnate d’u maritu; ma, indeh!, pannu indossu a Cecca nun ci n’è andatu mai ditu.
I 4S
C A P IT O L O T E R Z O
Ma Maddalena prosegue nelle sue recriminazioni e nelle sue insi nuazioni malevole: E ancu m’è statu dettu da un tò paisana chi purtavi lu capagnu e ch’andavi alla funtana... O r dov’è lu to damascu, e dov’è lu tò vellutu? Chi n’ha fattu u to maritu? L ’ha impignatu, o l’ha vindutu? Mancu in quest’occasione addossu ti s’è veduto.
Ancora una volta la cognata smentisce: Lu damascu un n’è vendutu; e nun è mancu impignatu; perché pe’ le so figliole ne la cascia esté alìocatu.
Ma l’implacabile Maddalena vuol ora vedere la cassa e contare i capi di vestiario: e di fatto la apre e la rovista, lamentando durante l’operazione la scarsezza della biancheria: Insignatemi la cascia, quella de la viancheria: a me pare ch’in sta casa ci ne sta la carestia. Dove sò li to scuffiotti, dove sò li cappellini? Questu è l’onore che faci alla casa Alibertini?
Maddalena disprezza il paese di Pruno, sarcasticamente osservando che in giro non vi si vedono che capanne di pastori, e maledice chi ha portato la sorella in un ambiente così miserabile, dove la morte infine l’ha raggiunta. La cognata risponde fingendo di chiedere alla vicina se si chiama Maddalena la sorella di Francesca; finta igno ranza che dovrà stimolare ulteriormente la iattanza di Maddalena: Ora ditemi signora, ch’eo non achia a trasgredì, un si chiama Maddalé la surella ch’este qui?
IL LAMENTO FUNEBRE FOLKLORICO EUROMEDITERRANEO
149
E Maddalena: Nun avete fattu errore, nun pudete trasgredì: eo sò di li nomi antichi e mi chiamami così.
Alla iattanza di Maddalena la cognata risponde a tono: se sei di casata così antica e rinomata, modera il linguaggio: Ora anch’eo l’achiu saputa, e ne sò bene informata che vò site dill’antichi, site molto accasalata; ma parlate un pocu megliu, giacché site bennata.
Finalmente, liquidato il conflitto sul piano della recitazione, Mad dalena indirizza il v ò c e r o alla sorella morta: ... Or via, rizzatevi in piedi; alzate l’occhi, a mio velia: nun bullete falli mottu a’ vostr’unica sorella? Con qualunque v ’incuntraste nun parlavate che d ’ella...
Questo impiego della lamentazione per trattare i conflitti susci tati dall’evento luttuoso sfrutta la presenza rituale del pianto per dar sfogo sul suo piano al vario sentire acutizzato dalla circostanza e per impedire che esso prenda le forme eccessive di una lite vio lenta e pericolosa. Sul piano destorificato di un dialogo cantato nel ritmo della lamentazione ciascuno riversa l’animo suo, come in sogno e tuttavia essendo svegli: e le cose dette su quel piano non valgono proprio come le offese vere, ma un po’ di meno, pro prio come se ci fosse una soluzione di continuità fra la presenza rituale e quella «normale», e come se le persone che hanno agito nel rito non fossero p ie n o ju r e le stesse che si ritroveranno poi dopo l’esecuzione. Ma intanto con questo dire «su un altro piano» il conflitto è trattato in forma protetta, il sentire defluisce e si sca rica senza tutte le conseguenze di un litigio «vero», e i «perso naggi» che hanno recitato le «parti» si vengono adattando in qual che modo all’equilibrio che dovranno poi, a recitazione conclusa, mantenere come «persone».
I F U N E R A L I D I L A Z Z A R O B O IA
4·
I funerali di Lazzaro Boia
i. Nota introduttiva Il lamento funebre folklorico euromediterraneo costituisce ap pena un momento del rituale funerario, e soltanto per astrazione può essere considerato come fenomeno a sé. Lì dove le forme anti che di questo rituale sono meglio conservate, il lamento si inserisce in un ordine in cui troviamo anche giuochi funebri e banchetti, ed un gran numero di comportamenti superstiziosi. Un’analisi del lamento rituale non può pertanto prescindere dal considerare alme no una volta e in un caso ben caratterizzato l’arco operativo com preso dal decesso all’inumazione. A ciò soccorre un documento di notevole valore dimostrativo, ricavato dall’area folklorica romena. Il lamento funebre romeno (bocet) è fra i più ricchi e meglio studiati del folklore europeo. In generale il bocet è reso dai parenti al defunto e talora da lamentatrici a prezzo: consta di versi otto nari o settenari, alternantisi qualche volta con quinari e senari, a rima baciata o ad assonanza. Questi versi presentano con varia dosatura l’accennato rapporto fra moduli letterari e improvvisa zione. Ogni verso del bocet è cantato su una linea melodica definita, e queste linee melodiche sono in numero limitato, spesso diverse fra di loro solo per cadenza o per semplice variazione. Nei fune rali di Lazzaro Boia predomina un tipo di lamentazione individuale abbastanza libero, con larga parte all’improvvisazione. In generale dal bocet vanno distinti i canti rituali, con testo fisso, legati rigorosa mente a singoli momenti del rito funerario, con notevoli riferimenti mitici (come nel canto dell’abete o in quello dell’alba), con esecuzio
I5 I
ne corale e con una struttura melodica che si distingue da quello del bocet per ambitus, scala, cadenza e ritmo. A parte il vecchio lavoro del Marian,1 la bibliografia sull’argomento si è notevolmente ar ricchita negli ultimi trenta anni soprattutto per le pregevoli mono grafie di Costantino Bràiloiu.2 Inoltre il prezioso materiale custo dito nell’archivio dell’Istituto di Folklore di Bucarest consente di avvalersi di centinaia di registrazioni musicali di lamentazioni e di canti rituali in tutta l’area romena (Oltenia, Valacchia, Moldavia, Transilvania), e di minuziose schede di osservazione relative ad alcu ni funerali sorpresi in vivo e seguiti - talora da squadre di etno grafi - dalla esposizione del cadavere sino al banchetto funebre dopo l’inumazione. Il presente capitolo è stato lavorato direttamen te sulle schede di osservazione relative al funerale del pastore Lazza ro Boia, svoltosi nel villaggio di Ceriscior (Hunedoara, Transilvania) durante i giorni 29, 30 e 3 1 dicembre 1950. Tali schede, il cui ori ginale è conservato ai numeri 9158, 9217-18 dell’ archivio dell’Isti tuto di Folklore di Bucarest, furono raccolte da una squadra di etno grafi composta da M. Rabinovici, O. Bìrlea, A. Vicol per i testi let terari delle lamentazioni e per il rituale funerario nel suo complesso, da E. Comiscel e R. Weiss per la parte musicale, e da Mircea Eremia per la fotografia. Nel 1955 fu a noi possibile visitare, in com pagnia dell’etnografo Bìrlea, il villaggio di Clopotiva nell’Hunedoara, e quivi assistere ad alcune lamentazioni funebri a richiesta, ed eseguire interviste con lamentatrici del luogo. Naturalmente siamo debitori ai compilatori delle schede di osservazioni qui utilizzate, alla cortesia di O. Bìrlea che ci accompagnò a Clopotiva e alla gene rosità del direttore dell’Istituto di Folklore Mihai Pop - che con sentì l’utilizzazione da parte nostra delle schede ancora inedite se abbiamo potuto elaborare il presente capitolo del nostro libro. Lazzaro Boia, pastore di Ceriscior, morì a cinquant’anni nel l’ospedale di Ghelar, ad una diecina di chilometri da Ceriscior. Il suo cadavere fu trasportato da Ghelar a Ceriscior per la celebra zione dei funerali, ed in paese e nella sua casa si svolsero i riti e le 1 S. FI. Marian, Inmormintarea la romàni (Bucarest 1892) pp. 1 1 3 sgg. 2 II Bràiloiu, interessato particolarmente all’aspetto musicale del bocet, ha esplorato siste maticamente il villaggio di Dragu§ nel distretto di Fagaras: Deipre Bocetul dela Draguj, Arhiva pentru stiinta si reforma sociala, voi. io , 280-359 (1932); e la regione di Oa§ nel distretto di Satu Mare: Bocete din Oaf, Grai si sufflet, voi. 7, 90 dell’estratto ^938).
ι6 ο
C A P IT O L O Q U A R T O
nessuno ti amò perché eri un poveretto. E tu, caro, cosa hai fatto? Li hai lasciati soli, anche tu, mio buono, Lazzaro mio. Buono e paziente, buono e risparmiatore. Lèvati, figlio, e parlami, ché il tuo tempo è breve, e te ne andrai fra poco da me, e non mi hai ancora risposto (singhiozzi). Ché tua figlia è da maritare, e tuo figlio da sposare: dimmi, figlio, che debbo fare? ... Figlio, io non ho pensato che saresti partito prima di me, e mi avresti lasciata vecchia e triste, e priva di forze, figlio. Vuoi che io prenda su di me anche i tuoi affanni? (singhiozzi) Non ne sono capace, questa forza io non l’ho mai avuta, e perciò ho patito tanto mio buono, mio Lazzaro. Lèvati, figlio, alza la testa, e guarda la tua Marica. Ahimè, quanto soffre, e come si è scarnita, ché da quando te ne sei andato non trova riposo (singhiozzi)', (rivolgendosi alla figlia, moglie d e l morto·)
Dio mio, o Maria, come sei stata risparmiata, ed ora d ’un tratto, duramente, duramente colpita! Tu che ignoravi il dolore, tu che, da viziata, credevi di soffrire solo qualche volta, conosci ora realmente il dolore, ora che tuo marito se ne è andato...
Si ode la voce di un’altra donna: «Lèvati, Lazzaro!» Infine si lamenta la moglie, che svolge il modulo - ben noto nelle lamen tazioni russe - della bara come nuova dimora del morto: Vorrei bestemmiarti, o morte, ma temo che Iddio mi colpisca più forte ancora.
I F U N E R A L I D I L A Z Z A R O B O IA
161
Caro mio, Lazzaro mio, ahimè che misera casa, ti sei fatto, caro: non ha porte né finestre, come potrai starvi? Caro, prendimi con te, sono tua moglie... Ahimè, Signore, perché me li hai dati, i figli, se poi non me lo lasciasti? Ché ora non hanno nessuno, o Dio! (rivolgendosi a l cadavere)
Tu sai com’è duro ciò. Questo pane amaro, anche tu in vita l’hai provato...
Le lamentazioni si intrecciano e si avvicendano sino al tramonto. Poi vanno cessando, perché «dopo il tramonto non è lecito lamen tarsi». La stessa vedova ricorda alla figlia questo divieto rituale, e la figlia ora tace, ubbidiente. Si conversa. Il discorso cade sulle bestemmie, e lo zio del defunto osserva: «Se Dio esiste io non lo so, ma non dico mai bestemmie». Si accende una discussione in cui si riflettono i temi più rozzi della propaganda comunista nelle campagne. Lo zio dice a un certo momento: «Compare, Cristo è stato il più grande comunista, ma i preti in Chiesa non ne par lano». La vecchia Poanta, zia del morto, che poc’anzi si era lamen tata seduta sulla cassapanca accanto alla bara, interviene nella discussione osservando: «Gli scienziati dicono che Cristo sia stato un bugiardo». Ormai si è fatta sera e nella stanza dove il cadavere è esposto è rimasta poca gente. Un gruppo di ragazzi e di ragazze sui quindici anni, fra cui il figlio del morto, parla in un angolo a bassa voce. Un ragazzo per prova di bravura cerca di scrivere con la mano sinistra fra l’interesse degli altri. Poi una ragazza di quindici anni, Maria Poroc, comincia a raccontare la fiaba dal titolo Con la povertà: C ’erano una volta due uomini, uno aveva due bambini, l’altro sette. Quello che ne aveva due era ricco, quello che ne aveva sette era povero. Il povero andò dal mago, che gli disse di chiudere la povertà in una botte. Il povero lo fece, ma impoverì ancora di più. Allora liberò di nuovo la povertà. Il ricco andò in mulino in mezzo alla foresta: vi trovò tanti soldi e fece elemosina ai bambini del povero. I sette figli del povero dissero al padre: «Andiamo al mulino, vi sono tanti soldi! » Il povero andò di notte al mulino, ma vi
IÓ2
C A P IT O L O Q U A R T O
trovò undici diavoli. Il povero si nascose sotto la ruota del mulino e attese l’alba. I galli cantarono e i diavoli fuggirono. Allora, fruga e rifruga durante tutto il giorno, finalmente il povero riesce a trovare i soldi. Ma intanto era calata la notte, i diavoli tornarono e si presero tutto il denaro. Il povero rimase povero, con la povertà che gli correva sempre dietro. Il povero tornò dal mago, che gli disse di sotterrare la povertà. Cosi fece, ma la povertà venne fuori anche dalla fossa. Il povero se ne andò per il mondo, e la povertà sempre dietro. Trovò un mulino e il mugnaio lo prese per servo. Finalmente il mugnaio impiccò la povertà per la lingua, e cosi la povertà mori. Poi il mugnaio chiese al povero di buttarsi nel fuoco per far cuocere il pane. E il povero se ne andò e si impiccò ad un albero anche lui.
I ragazzi seguono con interesse la fiaba. Maria Poroc ne inizia un’altra dal titolo La figlia della vecchia e del vecchio, ma una donna che è intervenuta a sentire osserva: «La fiaba è più bella, ne hai raccontato solo la metà». Si accende una disputa. Maria Poroc dice: «Che bella fiaba ci ha raccontato Giorgio! Io ho un libro pieno di fiabe!» E intanto dà inizio alla fiaba di Pietro Piparus: Una donna aveva tre figli - due maschi e una femmina -. Una volta i due figli andarono ad arare, ma non c’era chi portasse loro il cibo. «Mamma, mandaci la sorella con il mangiare: perché non sbagli strada, facciamo un solco sino al campo». Ma il diavolo ne fece un altro, che portava a casa sua. La sorella seguì questo solco, che la portò in una grotta dove c’era il dia volo, che la fece sua. I ragazzi videro il solco, lo seguirono, e il maggiore entrò nella grotta. Il demonio agitava una grossa mazza. Poi ordinò di pre parare due forni di pane e due barili di vino, fece portare tutto in tavola, e disse al ragazzo che chi dei due fosse riuscito a mangiare tutto il pane e a bere tutto il vino avrebbe ammazzato l’altro. Il ragazzo non ci riuscì, e allora il diavolo lo ammazzò e lo buttò via. Il fratello minore entrò anche lui nella grotta. Di nuovo il diavolo prepara due forni di pane e due barili di vino. Il ragazzo non riesce a mangiare che una fetta di pane. Il demonio 10 ammazza e butta via anche lui. La madre dei ragazzi vuol morire: si alza, prende un seme che non stava fermo né sulla tavola né sulla stufa, lo inghiotte, e ne rimane gravida. Nacque un bambino. Cresceva, cresceva: quando aveva un giorno sembrava che avesse un mese. «Mamma, voglio poppare sotto le fondamenta della casa! » La mamma, con l’aiuto di un parente, solleva in aria la casa, e depone poi nelle fondamenta le sue mammelle, lasciandovele a lungo. Il ragazzo con il latte della madre si fabbrica una galletta, e poi parte per la grotta. Dà la galletta alla sorella, ed essa riconosce che è suo fratello. La sorella prega il fratello di tornarsene a casa, ma egli rifiuta. Il diavolo offre un’altra volta i due forni di pane e i due barili di vino. Ma 11ragazzo mangia e beve tutto, sotterra il diavolo sino alla cintura, poi sino al collo. Allora il diavolo dice dove sono i suoi fratelli. Il ragazzo li prende, li sfrega con acqua...
163
I F U N E R A L I D I L A Z Z A R O B O IA
(Q ui Maria Poroc imita chi si risveglia dopo un lungo sonno )
... «Ahi, da quanto tempo ho dormito! » Tornano tutti a casa, e vissero così bene che, se non sono morti, vivono ancora.
La comitiva è vivamente interessata alla fiaba. «Senti, ce n’è ancora?» domanda a Maria un ragazzo. «No, è tutto, lo giuro!» «La fiaba delle mele d ’oro è bella!» «Ma quella che Giorgio mi ha raccontata è ancora più bella: ha messo due ore per raccontar mela», dice Maria. Intanto la figlia del morto, Marica Boia, che con tanto impegno aveva partecipato alle precedenti lamentazioni, si è messa anche lei a raccontare una fiaba, La matrigna·. C ’era una volta un uomo che aveva due figli. Quest’uomo prese un’altra moglie, che era una donna cattiva, molto cattiva. La matrigna cacciò di casa i bambini, che andarono vagando per la foresta. Nella foresta trovarono una lepre, una volpe, un lupo, un orso. Ammazzarono questi animali, ne man giarono la carne, ma l’orso non lo ammazzarono, se lo presero con loro. Tro varono pane bianco, pane bianco a non finire. Poi videro nella foresta un fuoco grande: era il diavolo. Il diavolo si prese la sorella del bambino e la fece sua: poi le insegnò come doveva fare per sbarazzarsi del fratello, pro vocandolo ad accettare le scommesse del diavolo. Una volta la diavoletta disse al fratello: «C hi porta un legno più grosso, tu o diavolo?» Il diavolo si caricò sulle spalle un albero, ma il ragazzo prese un ramo e fece finta di recingerne il bosco per portarselo via. Un’altra volta la diavoletta disse al fratello: «Vediamo chi scorreggia più forte, tu o il diavolo?» Il diavolo tiro un peto così forte che andò in pezzi tutto l’intonaco della casa, e dovette mettersi ad aggiustarla, se no bastava un altro peto per farla crollare...
0
La fiaba di Marica Boia, ricca di omissioni, di allusioni e di inci denti che la rendono difficilmente ricostruibile sulla base delle schede di osservazione, prosegue a lungo, fra gli stupiti commenti dei ragazzi. Poi riprende Maria Poroc con La storia di Pacala, Lo zìngaro paraninfo del re, Lo zingaro alla comunione, Il corno del bue. È ormai sera e da circa due ore la comitiva si è divertita dietro le favolose fantasie narrate da Maria Poroc e da Marica Boia. La eco delle ultime fiabe si disperde nel brusio dei nuovi venuti che riempiono il cortile e la casa. Si avvicina la veglia funebre. Nella camera dove è esposto il cadavere quattro cassapanche sono state disposte lungo i muri, e ora vi seggono una cinquantina di per sone, uomini donne e bambini. L ’ambiente è illuminato da lam pade di minatori che pendono dal soffitto. La conversazione è ani mata, ma del morto si parla pochissimo. Si va diffondendo un’aria
16 4
C A P IT O L O Q U A R T O
di festa gaia e spregiudicata, che forma singolare contrasto con il cadavere esposto presso la finestra, avvolto in un velo e rischia rato dalla luce del candeliere a forma di croce.
3. La veglia notturna e i giuochi lascivi La veglia funebre ha inizio con il giuoco della «pulce». Nel mezzo della stanza dove è esposto il cadavere siede a cavallo di uno sga bello un uomo con una cinghia in mano, e accanto a lui, in piedi, sta un ragazzo anche lui fornito di cinghia. L ’uomo che sta seduto colpisce con la cinghia il ragazzo e indica il nome di una donna che dovrà baciare uno o più giovanotti. Il ragazzo a sua volta, colpisce la donna designata, per indurla a sbrigarsi. Se la ragazza fa la ritrosa, il ragazzo la colpisce ripetutamente, mentre l’uomo seduto a cavallo dello sgabello si va intanto spostando a salti per la stanza, minac ciando con la cinghia il peggio. Durante il bacio, per impedire che il contatto sia troppo rapido e superficiale, interviene spesso una donna a stringere forte insieme le teste della coppia. Il direttore di giuoco spinge al bacio ragazze, donne sposate e anche fanciulline, che baciano ragazzi sui dodici anni. Ma vediamo il giuoco in azione. Una giovane sposa, che ha il marito sotto le armi, si rifiuta di stare al gioco. Interviene un’altra donna: «Se non ne hai voglia, non ci andare alle veglie dei morti! » Una ragazza: «Il tal dei tali non lo bacio, siamo parenti». Poi; colpita da qualche cinghiata, cambia subito opinione: «Chi? Avanti, chi debbo baciare?» Un’altra ragaz za, appena designata, non ha bisogno di sollecitazioni e corre di buon grado a baciare chi deve. Una bambina di dieci anni: «Ci vado, non mi colpire, lo bacio». La scena si movimenta e si dif fonde una gaia eccitazione nella schermaglia delle proposte, delle ritrosie, delle minacce e delle acquiescenze. L ’uomo dello sgabello salta per la stanza, dà cinghiate al ragazzo che gli sta accanto, piega la schiena sotto i pugni delle vittime. «Tu, lascia che ti baci! » dice una donna ad un giovanotto appena arrivato. Una ragazza, che teme di dover baciare ancora un giovinetto quattordicenne, gli grida: «V a’ al diavolo, che non ti possa baciare più!» I frizzi, i commenti, si incrociano: «Ehi, bacia solo sulla guan cia!» «D i’ , non baciarmi l’orecchio!» «E questo bel giovanotto chi lo bacia?» «Bacia me che non ti sono parente». Alcuni giova
I F U N E R A L I D I L A Z Z A R O B O IA
16 5
notti reclamano perché non sono stati ancora baciati malgrado la designazione della «pulce». L ’eccitazione collettiva investe anche l’etnografo presente, Ovidio Birlea, che una donna infine si decide a baciare, dopo essersi fatta il segno della croce. La vedova sta in silenzio al capezzale del morto, e la figlia Marica si è coricata sul letto e riposa. Entrano due uomini con un fanale e mormo rano: «Dio gli dia riposo». Un altro giuoco è quello della «capra». Un giovane avvolto in un tappeto e camminando gobbo regge un bastone che all’estremità finisce in una testa di capra. Nascosto dal tappeto lanoso il giovane manovra il bastone in modo da simu lare una capra che colpisce gli astanti con la testa. Un venditore mena innanzi a sé la capra, decantandone al pubblico le buone qua lità: il venditore invita le donne a mungerle le poppe, e su questo punto si intreccia una serie di allusioni lascive che forma il centro del giuoco. Chiede il venditore: «Nessuno la compra, la mia capra?» E una donna: «Ce l’ha la poppa?» Il venditore: «Ce l’ha, cerca gliela di dietro». La donna: «Mi fanno male a morirne queste cose, non le guardo neanche!» La capra fa l’atto di alzarsi su due piedi, per mostrare la sua «poppa», che evidentemente allude ad altro. Le donne ridono, mentre la capra continua a fare il giro della stanza. A l giuoco della capra segue quello del pesce. Entra un pesciven dolo, che ha qualche cosa in bocca per cui invece di «p» pronun zia «f ». Legato all’altezza delle ginocchia il pescivendolo porta un filo di ferro, da cui pende un pezzo di legno allungato, a guisa di pendolo oscillante, con un trasparente simbolismo sessuale. «Vendi al pezzo?» domandano le donne. E il pescivendolo: «No, solo a peso». E la donna: «Non puzza?» Il pescivendolo: «Non puzza» (in lingua romena «No pute»; ma il pescivendolo, a causa del suo volontario difetto di pronunzia, dice «No iute», che equivale all’i taliano «Non fotte»). «Io ne voglio tre chili», dice una donna. Il pescivendolo prende alcune foglie di vite in salamoia che sono in un piatto, e le stropiccia sotto il naso dell’acquirente. «Fai la prova della bilancia», chiede la donna. Il pescivendolo agguanta allora il pendolo e dà tre colpi sulla tavoletta che, fissata sullo stomaco, è raggiunta con colpi secchi dal pendolo allusivo. Le donne si affol lano, si chiede, si contratta, fra commenti salaci. Finito il giuoco del pescivendolo, segue quello dei «Vecchi». Si tratta di un vec chio e di una vecchia, cenciosi e deformi, che fanno le mostre di litigare, di bastonarsi, e che infine eseguono un simulacro di accop-
C A P IT O L O Q U A R T O
174
Padre mio e buono mio, padre mio e buono mio, ma perché non fosti cattivo? ... Padre mio e buono mio, di’ alla mamma, che mi scavi una fossa, qui accanto a te. Perché i figli senza padre non son buoni per nessuno...
Ultima sosta presso il cimitero, quindi le donne con l’abete si portano alla testa del corteo, e muovono verso la fossa, cantando: l’abete è deposto per terra. Molte donne corrono verso le tombe dei loro morti e rinnovano il lamento. La bara è calata nella fossa fra canti e lamentazioni e preghiere, poi si versa del vino, e infine, colmata di terra la fossa, viene innalzato l’abete, che però non affon derà nel terreno, ma sarà soltanto legato alla croce dalla parte che guarda il sorgere del sole. Le parenti più strette - la figlia, la ve dova, la cognata, la zia - sono tornate a casa lamentandosi, e sono rimasti sul posto soltanto gli uomini più o meno prossimi parenti del morto, alcuni dei quali fanno da becchini. Durante il riempi mento della fossa i becchini non risparmiano motti e scherzi in relazione alla loro operazione. Nella casa del morto si va ricompo nendo lentamente un’atmosfera festiva, che prelude al banchetto funebre. Ancora un gesto solenne: un uomo sospende una candela a forma di croce al trave maestro della casa, poiché è morto appunto il «sostegno» della casa. Ma già le donne hanno provveduto a spaz zare e a rassettare la camera mortuaria, hanno acceso la stufa, e disposto due tavole lunghe e basse, con panche da ambo le parti, per il banchetto. E ormai sera. Dopo la messa, i bambini sciamano in cucina, dove è preparata una tavola per loro, la «pomana» dei bambini. Mangiano cavolo con carne, poi battono con il cucchiaio sul tavolo gridando: «pane, pane!», «grano, grano!». Viene servito per loro del grano cotto al miele. Nella stanza mortuaria il prete, tre donne e ventitré uomini partecipano al banchetto funebre. Due donne distribuiscono ciambelle con una candela accesa al centro: chi riceve dice la formula «Dio lo riceva», al che la distributrice risponde: «Lo riceva Iddio». Contemporaneamente un uomo offre a ognuno un bicchiere di acquavite, con la stessa formula nel rice vere e nel dare. A tavola si servono, nell’ordine, carne di maiale
I F U N E R A L I D I L A Z Z A R O B O IA
T7 5
con cavoli cappucci, brodo di vitello e grano cotto al miele. La con versazione è ora animata, si ride e si scherza. Risuonano per poco, in tonati dai cantori, i versi relativi al miracolo del Lazzaro giovanneo: Bel nome è Bethania Dio ha fatto un miracolo lo portarono alla tomba, lo calarono nel sepolcro...
Dopo circa un’ora e mezzo il banchetto ha termine con una pre ghiera del prete: subito dopo prende posto la seconda serie di ospiti, ventitré donne e tre bambini, con lo stesso ordine cerimoniale, ma questa volta è la figlia Marica che si dà da fare per distribuire le ciambelle. La terza e ultima giornata dei funerali di Lazzaro Boia com prende nuove lamentazioni al cimitero: la figlia maggiore, la vedova e la cognata di Lazzaro si avvicendano nel lamentarsi, la testa appog giata sulla croce che fa corpo con l’abete sradicato. A l ritorno dal cimitero, verso sera, moglie e cognata si lamentano insieme con le stesse parole e sulla stessa melodia. Marica si stacca dal gruppo, e insieme a due giovinette del villaggio si reca a fare gli inviti per la seconda «pomana», che ripeterà esattamente i modi della prima. Marica gira di casa in casa disinvolta e gaia, come dimentica delle lamentazioni di poco prima sulla tomba del padre.
5. Annotazioni conclusive I funerali di Lazzaro Boia ci permettono di sorprendere il lamento funebre in azione in un ambiente folklorico determinato e nel quadro di un concetto rituale funerario seguito nei tre giorni del suo svolgimento. Dal documento emerge innanzi tutto la ritualità della lamentazione, cioè il suo carattere di pianto istituzionale net tamente distinto dalla crisi del cordoglio e dalle manifestazioni pro fane del dolore. Il lamento appare infatti legato a determinate epo che rituali, come l’esposizione del cadavere, il trasporto e l’inu mazione, e può essere rinnovato in occasione di lutti, come testi moniano le vicine che si recano presso la bara di Lazzaro per ren dere il lamento ai loro morti più o meno recenti, o che per farlo
i
76
C A P IT O L O Q U A R T O
approfittano del momento dell’inumazione. Inoltre il lamento deve essere sospeso quando lo esigono determinate ragioni rituali e ideo logiche tradizionalmente stabilite, come per esempio al tramonto 0 durante le soste rituali del corteo funebre. Nel corso delle lamen tazioni riappare l’atmosfera di «recitazione sognante» e di «parte eseguita» che può tuttavia essere iniziata e interrotta quando occorre. Una donna esorta le lamentatrici: «Su lamentatevi, così 1 signori possono scrivere! »; Marica Boia controlla se il suo lamento è annotato dall’etnografo presente; la nonna di Lazzaro si lamenta sbrigando le faccende di casa; Maria Poanta interrompe la sua pre stazione per osservare il vestito di lana di Ovidio Birlea. Durante la veglia funebre dal primo al secondo giorno non soltanto il lamento è interrotto, ma si diffonde un’atmosfera opposta al cordoglio: si raccontano fiabe, si rappresentano pantomime licenziose, si giuoca e ci si diverte intenzionalmente. Al mattino del secondo giorno torna l’epoca del pianto, che durerà sino all’inumazione. Tuttavia mentre i parenti del morto, in funzione di becchini, gettano palate di terra sulla bara, si avverte di nuovo una non casuale propen sione allo scherzo e al motteggio, e nella successiva «pomana» pre vale una gaia atmosfera conviviale. Al terzo giorno la figlia mag giore, la vedova e la cognata del morto si lamentano al cimitero; a sera tornano a casa lamentandosi, ma poi la figlia si stacca dal gruppo e si reca in allegria ad invitare gli ospiti per la seconda «pomana». In contrasto con ciò affiora nei lamenti, almeno a tratti, un caldo ethos delle memorie e degli affetti, e talora la semplice risoluzione oratoria cede il luogo a un elementare lirismo. Una vicenda del genere è destinata a restare un «mistero» senza la postu lazione di una presenza rituale del pianto in relativa dualità con la presenza egemonica. I funerali di Lazzaro Boia ci presentano un tipo di lamentazione con testi letterari relativamente liberi e con esecuzioni di tipo pre valentemente individuale. D ’altra parte le schede di osservazione, per il modo col quale sono state compilate, non ci consentono di stabilire né i caratteri della crisi del cordoglio e l’innestarsi su di essa dell’ordine della lamentazione, né i moduli letterari e mimici circolanti nella comunità di Ceriscior (si intravede tuttavia il carat tere di modulo del tema della bara dimora angusta per il morto, o dell’imprecazione «vorrei bestemmiarti o morte», e simili). La
I F U N E R A L I D I L A Z Z A R O B O IA
177
larga parte assegnata all’improvvisazione letteraria si collega alla possibilità di riassorbire nella forma del bocet i temi più diversi e occasionali della conversazione: così per esempio Maria Poanta chiede cantando all’etnografo di scriverle una letterina per Tal di là e la madre del suocero di Lazzaro risponde cantando con un banale «no, voglio andarci» alla vicina premurosa che le consiglia di non affaticarsi a seguire il corteo funebre.3 Ma i funerali di Lazzaro Boia pongono nel modo più vivo il pro blema della funzione tecnica di altri momenti del rituale funera rio, come le rappresentazioni drammatiche della veglia funebre,4 il taglio dell’abete e il banchetto. Infine nel contrasto fra il canto della morte alla finestra e la parafrasi popolare della resurrezione di Lazzaro si fronteggiano nel modo più aperto due opposte con cezioni della morte, quella pagana e quella cristiana. Per conside rare però il lamento funebre in questa prospettiva più ampia noi dobbiamo abbandonare il terreno della documentazione folklorica, e internarci innanzi tutto nel mondo culturale a cui il lamento orga nicamente appartenne, cioè il mondo antico.
3 Si confronti questa struttura del lamento di Ceriscior con quella esaminata a pp. 144 sgg. 4 In generale sui particolari della veglia funebre e sui giuochi e le pantomime spesso a carat tere licenzioso che vi hanno luogo la documentazione folklorica euromediterranea è molto lacunosa e superficiale. Per il folklore romeno non conosciamo nulla di meglio a questo proposito di una descrizione di veglia funebre a Nerej (Vrancea, Moldavia del sud-est), dove appaiono maschere - evidentemente larvae di antenati morti - che eseguono fra di loro e con le persone non mascherate giuochi e rappresentazioni sceniche varie: si tratta delle stesse maschere che gli abitanti di Nerej impiegano nelle feste dell’anno nuovo; C. Bràiloiu e Η . H. Stahl, Nerej: un vìllage d ’une région archa'ique (Bucarest 1939) pp. 293 sg. Nella veglia a Nerej noi abbiamo un esempio interessante della trasformazione della esposizione del cadavere in una festa dei morti, in cui cioè i morti tornano per essere variamente respinti e liquidati: il che avviene, per ragioni che vedremo meglio in seguito, anche nelle feste stagionali.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
5·
Il lamento funebre antico
i. Ritualizzazioni del «planctus», discorso protetto e singolarìzzazione del dolore I due momenti della crisi e dell’ordine instaurato mediante la lamentazione rituale risultano in modo chiaro nel mondo greco. Quando Antiloco comunica ad Achille la notizia della morte di Patroclo il Pelide cade in preda ad una terrificante crisi di dispe razione: Così Antiloco disse: e una nube nera di cordoglio avvolse Achille. A due mani egli prende la cenere dal focolare, e se ne imbratta il gentile sembiante. Sulla sua tunica di nettare si spande ora una cenere nera. Ed eccolo lui stesso, il lungo corpo disteso nella polvere: con le sue stesse mani si imbratta, e si strappa i capelli. I prigionieri, bottino di Achille e di Patroclo, afflitti nel cuore, levano alte grida e accorrono intorno ad Achille il valoroso. Tutti con le loro mani si percuotono il petto, nessuno che non senta le sue ginoc chia venir meno. Antiloco, da parte sua, geme e si dispera: trattiene le mani di Achille... nel timore che non si tagli la gola con la spada.1
Questo evidentemente non è il lamento ma il planctus, che tra scina sino alle soglie della follia. Il discorso della lamentazione verrà poi, quando sul planctus degli Achei si leverà lo stesso Achille, fat tosi coraggiosamente, per sé e per gli altri, g u i d a d e l p i a n t o (εξαρχος γόοιο): Fra questi (cioè fra gli Achei gementi) il Pelide si fece guida del pianto, ponendo sul petto dell’amico la mano esperta nell’uccidere uomini.2
Quando il cadavere di Ettore viene trascinato intorno alle mura di Ilio, la madre si strappa le chiome, prorompe in un lungo gemito, cui la città fa eco «quasi fosse tutta intera consumata dal fuoco». Ma poi il planctus è dominato da Priamo, che si fa guida del pianto fra i cittadini; e dopo Priamo insorge a farsi guida del pianto la sciagurata Ecuba; «Alle troiane Ecuba a sua volta si fa guida di un lungo lamento». E dopo Ecuba, Andromaca: alla vista del cada vere di Ettore essa getta via dalla fronte le sue bende scintillanti, il diadema, la cuffia, e infine il velo donatole da Afrodite. Ma poi anch’essa padroneggia la crisi (ές φρένα ύυμός άγέρϋη), e dà inizio al discorso della lamentazione.3 Quando il cadavere di Ettore vie ne ricondotto alla reggia, ed è apprestata a prothesis, il planctus si ripete: poi Andromaca, Ecuba, Elena si levano successivamente fra le donne, e assumono la guida del pianto. L ’entrata di ciascuna lamentatrice è annunziata con l’espressione stereotipa: «Fra que ste (cioè fra le donne) Andromaca (o, rispettivamente, Ecuba o Elena) si fa guida del pianto».4 E come per Achille che rende il lamento a Patroclo, così per Andromaca il passaggio dal planctus al discorso della lamentazione è sottolineaLo da un gesto rituale: «Poi è Andromaca dalle candide braccia che si fa guida del pianto, tenendo fra le mani la testa di Ettore uccisore di uomini».5 D ’al tra parte l’ordine della lamentazione si lega, nel più antico lamento funebre greco, all’incidenza periodica del planctus collettivo nel corso del discorso individuale. Da Omero risulta senza possibilità di equivoco che Γ εξαρχος innalzava il discorso della lamentazione come solista, e che gli στεναγμοί corali rispondevano alla singola «guida». NéX’lliade (24, 720 sgg.) la moglie, la madre e la cognata di Ettore assumono successivamente la guida del pianto, e ogni volta al termine di ciascuna lamentazione individuale insorge la eco corale dei presenti. Altri passi àell’lliade confermano questo particolare ritmo responsoriale che articola il lamento rituale in discorso individuale e in στεναγμοί periodici collettivi.6 Talora la 3 II 22, 405 Sgg. 4 II. 24, 723 sgg. (Andromaca); 747 sgg. (Ecuba); 7 6 1 sgg. (Elena). 5 IbicL, 723 sg. 6 II 19, 301 (lamento di Briseide a Patroclo): "Ως εφατο χλαίουο’ , έπί δέ στενάχοντο γυναίκες; II. 19 , 8 (lamento di Achille a Patroclo): "Ως εφατο κλαίων, έπί δέ στενάχοωτο γέροντες; II 22, 5 1 5 (lamento di Andromaca a Ettore): "Ως εφατο χλαίουο’ , έπί δέ στενάχοντο γυναίκες (cfr. I l 24, 746); Il- 2 , 7 ^ 1 (lamento di Ecuba ad Ettore): "Ως έφατο κλαίουσα, γόον δ’ άλίαστον ορινε; ibid., 776 (lamento di Elena ad Ettore): "Ως έφατο χλαίουο’, έπί δ’ ϊστενε δήμος άπειρων. C fr. II. 18, 314 sgg.
33
4
1 11. 18, 23 sgg. 2 Ibid.y 3 1 6 sgg.
179
ι8ο
C A P IT O L O Q U IN T O
partecipazione corale sembra limitata ad una parte soltanto della collettività, in rapporto al sesso e al grado sociale dell’e?apxo?: così a Briseide e ad Andromaca rispondono solo le donne, e ad Achille solo gli anziani. Tuttavia nell’effettivo lamento funebre rituale reso dai familiari la periodicità degli στεναγμοί rituali sarà stata molto più frequente, e l’orizzonte del discorso individuale molto più limi tato di quel che appaia nella elaborazione epica.7 E anzi da rite nere che nel rito reso dai parenti uno stesso intervento individuale sarà stato più volte interrotto dall’incidenza corale e che solo in un secondo tempo, nel quadro dello sviluppo della società cavalleresca, vi furono cantori funebri e aedi - o lamentatrici professionali a cui i parenti cedevano la guida del coro, il che giovò a dare mag giore orizzonte al discorso. La struttura del lamento dovette però anche in questo caso restare sempre la stessa, poiché ai canti indi viduali e successivi degli aedi seguiva di volta in volta il p la n c tu s collettivo.8 Per meglio illuminare il rapporto fra guida e coro nel più arcaico lamento funebre greco possono giovare alcune elaborazioni della tra gedia, per esempio il lamento di Serse nei P ersia n i, anche se qui non si tratta di un lamento per morte, ma per una catastrofe militare: 7 Ecco come Martin Nilsson ricostruisce la struttura del lamento funebre greco nella sua più antica forma rituale: «In origine i parenti, uomini e donne, hanno assolto l’obbligo del lamento, nel quale si distinguevano specialmente le donne... Dopo che il (o la) εξαρχος aveva recitato, i presenti davano inizio al pianto battendosi il petto e la testa ». M. Nilsson, Der Ursprung der Tragòdie, in Opuscola selecta (Lund 19 5 1) pp. 56 sg. Cfr. Reiner, Die ntuelle Totenklage der Gnechen (Stoccarda 1938) pp. 56 sgg. In ogni caso le lamentatrici professionali costitui scono una specificazione ulteriore che non ha mai rimosso il lamento funebre dei parenti: cfr. ibid., p. 58. 8 II. 24, 720 sgg.: παρά δ’εΐσαν άοιδούς θρήνων έξάρχους, οι τε στονόεσσαν άοιδήν οί μέν αρ’ έΟρήνεον, επί δε στενάχοντο γυναίκες, che è appunto da interpretare nel senso di canti individuali e successivi degli aedi, interrotti dagli στεναγμοί collettivi. Il passo ha dato origine a molte discus sioni poiché, fra l’altro, all’annunzio delle lamentazioni cantate dagli aedi non seguono, come ci aspetteremmo, queste stesse lamentazioni, ma quelle delle parenti. E dubbio se si debba pensare, col Nilsson, ad un disordine del testo, oppure se sia giusta l’interpretazione del Weber secondo la quale ad una άοιδή dei cantori professionali periodicamente interrotta dalle donne seguivano le lamentazioni individuali delle parenti, a lor volta fattesi guida del pianto: cfr. L. Weber, Solon und die Scbópfung der attìscben Grabrede (1935) p. 19 . M a, a parte ciò, non sembra dubbio che gli aedi cantavano come solisti l’uno dopo l’altro: in Omero i termini αρχειν, έξάρχειν, Εξαρχος, sono sempre usati ad indicare cantori o musici solisti, o tutt’ al più, cantori in funzione di musici solisti. C fr. la dimostrazione in C. Del Grande, ΤΡΑΓΩ ΙΔΙΑ. Essenza e genesi della tragedia (Napoli 1952) pp. 3 sgg., in polemica col Bradac che aveva invece sostenuto essere gli εξαρχοι non già i solisti, che cantano distinti dal coro, ma i coreuti stessi: Bradac, Philol. Wochenschr., voi. 50, coll. 284 sg. (1930).
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro: Serse: Coro:
181
Piangi, piangi la catastrofe, e prendi la via del palazzo. Ahiahi, ahiahi, sventura, sventura. Urla per farmi eco. Favore miserabile reso da miserabili a miserabili. Gemi, mescolando i tuoi canti ai miei. Ahiahiahi... Ahiahiahi. Pesante è certo la sciagura. Ma ecco che ancora più grande diventa il mio dolore. Percuotiti, percuotiti il petto e lamentati per guadagnarti il mio favore. Sono inondato di lacrime; lamentevolmente. Grida per farmi eco. Ho di che ricordarmene. Signore. F a’ scoppiare i tuoi singhiozzi. Ahi, ahi, ahi. Ahi, ahi, ahi. E percosse lugubri, gementi, accompagneranno il mio pianto. Percuotiti anche il petto, e lancia l’urlo della Misia. Sventura, sventura. Strappati anche i bianchi peli della barba. Serrando i denti, serrando i denti, con alti lamenti. Getta ancora un grido acuto. Anche in questo ti obbedirò. E strappati con le mani il peplo che copre il tuo petto. Sventura, sventura. Stràppati anche i capelli, lamentandoti sull’armata. A denti stretti, a denti stretti, con alti lamenti. Ricolma di lacrime i tuoi occhi. Ne sono inondato. Grida per rispondere ai miei gridi. Ahi ahi ahi.9
La distinzione netta fra crisi del cordoglio e l’ordine della lamen tazione, e al tempo stesso la strutturazione di tale ordine rituale nel responsorio di discorso individuale e di p la n c tu s collettivo, non co stituiscono fatti specifici del mondo greco, ma appartengono al mon do antico in generale. Noi non sappiamo come venisse eseguita in Roma l’originaria n e n ia delle f u n e r a e ,10 ma circa le prefiche una glossa di Festo ci informa che esse erano «mulieres ad lamentandum mortuum conductae, quae dant ceteris modum plangendi»:11 e 9 Esch., Pers., 1038-77. 10 Serv., ad Aen. 9, 486: «funeras dìcebant eas ad quas funus pertinebant, ut matrem et sororem». 11 Festo, s. v .; cfr. Varr. 1 ,1.7 .7 0 : «quae praeficeretur ancillis, quemadmodum lamentarentur, praefica est dieta».
182
CAPITOLO QUINTO
che questo «dare modum plangendi» consistesse in un responso rio di discorso individuale e di planctus collettivo si ricava da un passo di Servio, dal quale apprendiamo che la folla disposta a cer chio intorno al rogo «rispondeva» al lamento della prefica, la quale appunto per questo poteva essere definita come «princeps planctuum», con espressione esattamente corrispondente all’omerico εξαρχος γόοιο.12 Nell’Antico Testamento traspare la stessa vicen da: Saul alla notizia della morte di David «abbrancate le vesti se le stracciò», e così pure le persone presenti, in una esplosione paros sistica della crisi: solo in un secondo momento ha luogo il vero e proprio lamento reso da Saul a David, con la partecipazione col lettiva del popolo.13 In generale nell’Antico Testamento si ritrovano accenni a determinati ritornelli emotivi (Ahi! Ahi!; Oh! Oh!; Ahi fra tello!; Ahi signore!) che avranno certamente avuto incidenza cora le.14 La connessione fra lamento individuale e planctus collettivo periodizzato era così popolare da dar luogo ai tempi dell’evangeli sta Matteo ad un giuoco dei ragazzi nelle piazze: «A che cosa dirò che sia simile questa generazione? E simile a quei ragazzi che stanno a sedere in piazza e che gridano ai loro coetanei e dicono: abbiamo cantato e non avete ballato, abbiamo intonato il lamento e non avete risposto col planctus (εΟρηνήσαμεν καί ούκ έκόψασΟε) ».15 Dal che si desume che una lamentazione individuale senza la risposta collet tiva del planctus periodico appariva all’evangelista una assurdità così evidente da potersene giovare comparativamente per illumi nare e rendere intuitiva l’altra assurdità della resistenza dei giu dei alla predicazione del Battista. Come già abbiamo avuto occasione di osservare, la documenta zione relativa al lamento funebre antico è generale e indiretta, occa12 Serv., ad A e n .i, 216: «Varrò tamen dicit pyras ideo cupresso circumdari propter gravem ustrinam. odorem, ne eo offendatur populi circumstantis corona, quae tamdiu stabat, respondens fletibus praeficae, id est principi planctuum, quamdiu consumpto cadavere et coUectis cineribus, diceretur novissimum verbum ilicet [ = ire licet]». 13 2 Sam. 1, 17 sgg., cfr. 3 ,3 1 sgg. (lamento di David per Abner). Conferma lo Iahnow: «Presso gli Israeliti, come presso altri popoli, il lamentarsi gridando si distingue nettamente dal vero e proprio canto funebre». H. Iahnow, Das ebraisebe Leichenlied im Kahmen der Vòlkerdìcbtung, Beih. Z . neotestam., W iss., voi. 36, 40 sg. (1923); cfr. p. 49. Sul lamento come ordine instaurato nella crisi vedi anche P. Heinisch, Die Totenklage im Alteri Testamenti Biblische Zeitfragen, voi. 13 , n. 9, 8 sgg. (19 31). 14 Per il lamento come responsorio presso gli Ebrei e nel Medio Oriente cfr. Iahnow, op. cit., pp. 80 sgg. 15 Matteo 1 1 , 17 .
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
183
stonale e frammentaria, di guisa che solo mercé la comparazione e con l’ausilio degli attuali relitti folklorici euromediterranei è per noi possibile ricostruire l’effettivo rito funerario della lamentazione, destinata a persone storiche morte. Il lamento funebre egiziano ci offre tuttavia una opportunità documentaria che non ha riscon tro nel mondo antico, poiché qui i brani di lamentazione attribuiti alle singole figure ritratte nelle raffigurazioni sepolcrali ci consen tono di approssimarci alla effettiva vicenda rituale. Approfittando di tale opportunità Erich Liiddekens ha recentemente dedicato al contenuto religioso, alla lingua e alla forma del lamento funebre egiziano una monografia16 che fornisce ulteriori prove a favore del lamento antico come ordine tecnico instaurato nella rischiosa caoticità Ad planctus. In base all’analisi di alcuni testi di lamenta zione il Liiddekens afferma esplicitamente che «gli esecutori pro rompono inizialmente in grida di disperazione per riplasmare poi il loro lamento in parole e frasi significative».17 e paragona que sta vicenda a quanto afferma il Wachsmuth a proposito del lamento funebre neogreco: «Le donne con le chiome disciolte si accostano al morto, e percuotendosi il petto con violenza si abbandonano in un primo momento a disordinati gridi di dolore, cui poco dopo fanno seguito i lamenti funebri cerimoniali eseguiti secondo regole definite, cioè i μυρολόγια».18 Anche nel lamento funebre egiziano il passaggio dal disordine iniziale del planctus all’ordine della lamen tazione sembra ispirarsi al fondamentale espediente tecnico della risoluzione del planctus in ritornelli stereotipi, spesso a carattere imperatorio (Non mi lasciare!; A occidente!; Torna a casa!) La forma più semplice è la iterazione indefinita di uno stesso conte nuto emotivo, il che appena si distingue dal semplice gemere in cui si itera uno stesso gemito, col risultato tecnico di attenuare la presenza di veglia mediante la monotonia della iterazione. Questa forma tuttavia non ha significato culturale apprezzabile, poiché non provvede a lasciare orizzonte alla enucleazione di un vero e proprio discorso. Il Luddekens cita a questo proposito una forma 16 E . Luddekens, Vntersuchungen iìber relìgiósen Gehalt, Sprache und Form der àgyptiscken Totenklagen, Mitt. dtsch. Inst. àgypt. Altertumskunde Kairo, voi. 1 1 , 1-18 8 (1943). 17 Ibid., p. 17 9 . 18 Ibid. Il passo del Wachsmuth è tratto dal suo lavoro Die alte Grìechenland im neuen, p. 109.
C A P IT O L O Q U IN T O
:8 4
di lamentazione che consta di quattro membri successivi, in cui solo nel terzo è possibile un certo orizzonte di riadattamento e di variazione in rapporto alla concreta situazione luttuosa. Esempi: Modulo A: Non mi lasciare N on mi lasciare Tu grande Non mi lasciare .19 Modulo B:
Salute a te Salute a te O babbo mio Salute a te .20
Modulo C: A occidente A occidente Tu lodato A occidente .21
In questi tre moduli il terzo membro soltanto può rompere la destorificazione rituale e introdurre la ripresa della situazione. Così, per esempio, in occasione della morte di un personaggio a nome Renni il modulo C diventò: A occidente A occidente Tu Principe, principe regionale e capo dei profeti Renni A occidente !22
Un ulteriore orizzonte di riadattamento e di variazione fu otte nuto mercé aggiunte al terzo membro, come nel seguente schema di lamentazione di sorella a fratello: Ahimè! Ahimè! Lamentate voi Lamentate voi Il grande Lamentate voi L ’uomo buono, di buon carattere, che odia la bugia .23
19 Luddekens, op. cit., p. 12 2 , n. 55. 20 Ibid., p. 85, n. 32. 21 Ibid., p. 14 0 , n. 67. Con il ritornello «A occidente!» l’esecutore del lamento indicava al morto la meta finale del suo viaggio. 22 Ibid., p. 36. C fr. pp. 1 7 7 e 1 8 1 sg. 23 Ibid., p. 12 7 , n. 59 b.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
185
Le interiezioni «Ahimè! Ahimè!...» accennano schematicamente al planctm o alla mera iterazione del gemere; ciò che viene dopo è lo schema del lamento. Un più ampio orizzonte del discorso sem bra aver luogo nel seguente tipo: Ahimè! Ahimè! Son rimasta senza assistenza, io la derubata, e tuttavia non fu trovata la mia colpa. Ahimè! Ahimè! In breve la mia casa fu distrutta; come una giovane bestia dell’armento io sono, smarrita a sera e senza scampo ...24
L ’incidenza corale dei ritornelli emotivi nel lamento funebre egiziano è in generale da ammettersi,25 per quanto su questo pun to non possano essere forniti dati particolari. Già nel Regno Antico troviamo esempi di canto alterno fra gruppi di lamentatori o di lamentatrici,26 il che è ovviamente una complicazione del più sem plice rapporto fra una «guida del pianto» e un coro che accompa gna i ritornelli emotivi. Un orizzonte di discorso molto più libero e ampio presentano infine le famose lamentazioni di Iside e di Nephthys contenute nel papiro 3008 di Berlino. Avremo occasione di ritornare su que ste lamentazioni: cui basterà notare che esse appaiono destinate ad una donna Tentruty o Teret, soprannominata Nyny, figlia di Persis. I brani della lamentazione alternativamente recitati da due lamentatrici che sostengono la parte di Iside e di Nephthys, ite rano il ritornello emotivo «torna alla tua dimora!», ma ormai è il momento discorsivo che predomina, ritessendo liberamente il tema del ritornello: Torna alla tua dimora, torna alla tua dimora! O tu di Eliopoli, torna alla tua dimora, poiché non hai più nemici. O bel suonatore di sistro, torna alla tua dimora, sì da potermi vedere. O bel giovinetto, torna alla tua dimora, poi ché è tanto tempo che ti vedo. Il mio cuore è in affanno per te, i miei occhi ti cercano.. 27
24 Ibid., p. 16 5 . 25 Cfr. H. Bonnet in «ReaJiexicon der «gyptischen Religionsgeschichte» (1952) s. v. «Klageweiber», pp. 376 sgg. 26 Luddekens, op. cit., p. 179; cfr. pp. 16 sg. 27 R . O. Faulkner, The Lamentations o f Isis and Nephthys, in « Melanges Maspero », voi. 1 (1934) pp, 337 sgg.
ι8 6
C A P IT O L O Q U IN T O
Come già sappiamo dai relitti folklorici, la ritualizzazione del planctus al fine di dar orizzonte al discorso della lamentazione non si compie soltanto nel senso della risoluzione del disordinato gri dare o del semplice gemere nell’incidenza periodica di ritornelli emotivi stereotipi, ma anche nel senso di una risoluzione della cao tica scarica parossistica in un numero limitato di stereotipie mimiche in cui gli atti più pericolosi sono evitati, o riplasmati in un come se allusivo, che attenua nella destorificazione del simbolo il gesto gravemente dannoso o addirittura suicida. Le stereotipie mimiche in cui si modera il planctus nell’antico lamento funebre rituale pos sono essere esaurite in un elenco relativamente breve: incidersi le carni, graffiarsi a sangue le gote o gli avambracci, percuotersi (il viso, la testa, la fronte, il petto, i fianchi, le gambe); decalvarsi, strapparsi la barba, voltolarsi nella polvere o nella cenere o cospar gersene il capo, stracciarsi i vestiti, scalzarsi, farsi crescere la barba o i capelli.28 Questi modelli di comportamento rituale non costi tuiscono soltanto l’equivalente attenuato e simbolico dell’impulso airannientamento totale, ma fissano anche la misura da osservare nella loro esecuzione, in modo che non ne provengano danni troppo gravi. Così per esempio, l’incisione delle carni - dove è praticata - e in genere qualunque forma di offesa o di mutilazione recata al corpo, non sono lasciate all’arbitrio individuale, ma tendono a non oltrepassare certi modi e limiti tradizionali di esecuzione, in modo che il pericolo non sia eccessivo: soprattutto son gesti che formano r i t o , cioè ordine di «recitazione», regola di iterazione di un destorificato «si fa così». In un passo di Geremia, che indi rettamente accenna ad alcuni modelli di comportamento della qìnà, si legge che «ogni testa sarà decalvata, ogni barba rasa, su tutte le mani vi saranno incisioni, e su tutti i corpi il cilizio».29 Ma il danno doveva essere relativamente modesto, anche se i partecipan 28 Per la mimica del lamento funebre greco vedi E . Reiner, op. cit., pp. 43 sg., e W. Zschietzschmann, Die Darstellung der Protbesis in der griechischen Kunst, Ath. M itt., voi. 53, 17 sgg. (1928). Per la mimica del lamento funebre ebraico si veda soprattutto lo Iahnow, op. cit., pp. g sgg. Per la mimica del lamento funebre egiziano, cfr. E . Werbrouck, Les pleureuses dans l ’Egypte ancienne (1938). Sulla mimica del lamento funebre indoeuropeo in generale è da vedere K. Ranke, Indogermanische Totenverehrungen, voi. 1 , F .F .C ., voi. 49, n. 140 (19 51), pp. 99 sgg. 29 Ger. 48, 37. La pratica delle incisioni nel lamento ebraico è attestata in Deut. 14 , 1 e Lev. 19, 28. C fr. Lev. 2 1, 5, e Ger. 16 , 6.
187
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
ti al cordoglio presentavano, dopo il rito, tracce di incisioni. Senza dubbio la misura rituale atta a risolvere l’impulso suicida in equi valenti attenuati e simbolici è da intendersi come misura dram matica, da instaurare di volta in volta nella vicenda concreta delle singole lamentazioni: il che significa che sussisteva il rischio che l’ordine rituale poteva anche non essere instaurato, e la crisi non essere ripresa e riplasmata nella «misura giusta» del compromesso da recitare nel «come se» della destorificazione istituzionale. Del resto la mimica del planctus ritualizzato appare nel lamento antico orientata verso una progressiva attenuazione simbolica rispetto all’ effettivo atto suicida della crisi in atto: dall’incidersi le carni secondo una certa misura si passa a forme di annientamento allu sivo meno impegnative, come il percuotersi, lo strapparsi i capelli o la barba, l’imbrattarsi di polvere c o m e s e si fosse inumati, il cospargersi il capo di cenere c o m e s e si fosse cremati; il lasciarsi cadere per terra c o m e s e si fosse folgorati da morte, e altri atti di avvilimento e di abiezione che raffigurano in forme relativa mente più blande e attenuate il co m e se della volontà di morire. D ’altra parte gli equivalenti rituali dell’impulso suicida tendono a cedere il luogo a forme stereotipe ulteriormente ridotte: così il decalvarsi si restringe al semplice raccorciamento dei capelli, o al ti glio di una sola ciocca, e accanto allo stracciarsi le vesti si fa valere, come sostitutivo attenuato, l’indossare il sacco quale modello ad hoc del vestito miserabile e stracciato.30 Infine la ritualizzazione del planctus si orienta con una certa preferenza verso moduli mimici 30 Nel lamento funebre greco il kopetòs e la stemotipìa sono largamente attestati, e, in par* ticolare, la lamentatrice in atto di portare le due mani {o una sola) alla testa diventò lo schema figurativo più diffuso: cfr. Reiner, op. cit., p. 20 e in Atl. fig. del pianto, n. 49 (scena di prothesis in un’anfora attica di stile geometrico); cfr. Benndorf, Attische Vasenmalerei, tav. xxrv, fig. 1,3: lamentatrice inginocchiata davanti a una stele; M . Collignon, De l orìgine du type des pleureuses dans l'artgrecque, Rev. Études grecques, voi. 16 , figg. 1-9 (I ° ) (statuette di terracotta raffi guranti lamentatricì), Atl. fig. del pianto, nn. 44'4&- Ovviamente il gesto e raffigurato non nella sua dinamica, ma come uno statico tener le mani al capo o alla fronte: ma, come osserva il Reiner, op. cit., p. 43, il gesto non consiste in un porre calmo della mano, ma in un percuo tere iterato. Nel lamento funebre egiziano il percuotersi ritmicamente la testa e frequentemente rappresentato (Werbrouck, op. cit., pp. 14 5 sg., figg. 10 1- 10 5 , Atl. fig. del pianto, nn. 18 e 28-30. Un gesto frequente è anche il graffiarsi le braccia (Werbrouck, op. cit., p. 39, fig. 22, Atl. fig. del pianto, n. 30), il percuotersi le gambe (Werbrouck, op. cit., p. 62, fig. 40; Atl. fig. del pianto, n. 32); il cospargersi la testa di polvere (Werbrouck, op. cit., p. 14 8 , fig. 139). Nel lamento funebre ebraico sembra che abbia particolare rilievo il percuotersi il petto e le anche (Iahnow, op. cit., pp. 12 sgg.).
93
1 88
C A P IT O L O Q U IN T O
iterabili secondo un ritmo: di qui la grande diffusione rituale del percuotersi il viso o la testa o il petto o le gambe, appunto perché tali gesti possono essere agevolmente iterati secondo un ritmo, e partecipare in tal modo organicamente alle regole rituali della lamen tazione.31 La ritualizzazione del planctus introduce dunque nella crisi ini ziale il suo proprio ordine moderatore sul piano mimico o del com portamento, e ciò al fine tecnico di dare orizzonte al discorso. Ma anche nel corso dello stesso discorso della lamentazione la mimica risulta tradizionalmente fissata: così Achille lamenta Patroclo «po nendo sul petto dell’amico la mano esperta nell’uccidere uomini» ed Andromaca lamenta Ettore tenendo fra le mani la testa del morto. Il gesto di Andromaca trova la sua espressione figurativa in un lutroforo attico,32 e il suo corrispondente folklorico nella se quenza di Castelsaraceno.33 Nelle Troiane Ecuba entra nel discor so della lamentazione accompagnandosi con un movimento di oscil lazione laterale del busto,34 il che è da mettersi a raffronto sul piano folklorico con l’oscillazione ritmica del busto durante il lamento còrso, sardo e lucano.35 Il passo delle Troiane è di note vole importanza documentaria perché dimostra in modo diretto come il discorso dell’antica lamentazione funeraria segnasse l’in gresso di uno stato psichico di concentrazione sognante, provo cato e al tempo stesso mantenuto dall’oscillazione ritmica del busto unita alla monotonia della dizione o della melopea. Tale stato psi chico era d ’altra parte preparato o da tutte le tecniche destorificatrici che abbiamo sinora esaminate, e costituiva una fondamen tale protezione del discorso chiamato a risalire la china della crisi e ad effettuare la ripresa. Periodizzazione del planctus risolto in ritornelli emotivi, riplasmazione del parossismo in ritmi mimici definiti e istituzione di 51 Iahnow, op. cit., pp. 2, 16 , 18 , accenna occasionalmente alla limitazione rituale del numero e dell’intensità dei gesti autoaggressivi nel lamento funebre ebraico. 32 Mon. Piot I, tav. 5-7; A tl. fig. del pianto, n. 5 1. 33 Cfr. Atl. fig. del pianto, n. ia, b. 34 Eur., Troiane, vv. 1 10 - 19 , cfr. il testo a p. 104 sg.
35 Cfr. Atl. fig. del pianto, n. 6 g e luoghi relativi dei capitoli dedicati al lamento funebre lucano ed euromediterraneo.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
189
una presenza destorificata del pianto operante in uno stato di con centrazione sognante non sono gli unici mezzi tecnici che il lamento antico offre per restituire orizzonte al discorso compromesso dalla crisi: come già vedemmo a proposito dei relitti folklorici vi è anche una protezione interna al discorso stesso, che si muove appoggian dosi ai puntelli di moduli letterari definiti, a vari livelli di autono mia per quel che concerne la possibilità di riadattamento al con creto evento luttuoso, di variazione e di improvvisazione. Pur troppo la documentazione antica non ci consente di esplorare diret tamente tali gradi di autonomia, e di formarci un’idea precisa di come a Roma, in Grecia, in Egitto, in Mesopotamia e in Israele i moduli letterari entrassero nella dinamica delle singole lamenta zioni rituali, e vi subissero determinate modificazioni. Questo rap porto, già difficilmente ricostruibile negli attuali relitti folklorici, sfugge in gran parte alla documentazione antica, così avara in gene rale di testi letterari di lamentazioni funebri rituali. Tuttavia gli studiosi concordano nell’ammettere in generale nel lamento antico il nesso modulo tradizionale-variazione, per quanto non ne inten dano di solito il significato tecnico-rituale. Secondo il Reiner la forma più antica del lamento funebre greco era caratterizzata da un logos ritmico fondato su ripetizioni, simmetrie e parallelismi e su periodiche incidenze dei ritornelli emotivi {aiai, ototoi, oimoi): d’altra parte la forma superiore del threnos con accompagnamento musicale doveva essere determinata, sia per il contenuto che per la forma, da «un nucleo tralatizio» (durch eine tralatizisches Kem). Il Reiner però immagina a torto che tali schemi fossero meno nume rosi e vincolanti nella forma più antica del lamento, cioè eseguita solo dai parenti e con l’aiuto corale dei presenti.36 In Israele è esplicitamente attestata37 l’esistenza di vere e proprie raccolte di lamenti, in una delle quali fu incluso il lamento di Geremia per Josia. D ’ altra parte da un passo di Geremia38 si ricava che vi era una trasmissione orale, anzi una sorta di insegnamento, da donna a donna.39 Dall’esame del materiale egiziano il Lùddekens crede 36 Reiner, op. cit., p. 62. 37 2 Cron., 35, 25. 38 Gerem. 9, 20. 39 Heinisch, op. cit., p. 8. L ’autore ritiene che, in generale, il lamento antico fosse arti-
190
C A P IT O L O Q U IN T O
di poter concludere che il lamento dell’antico Egitto «conosce testi fissi che non rivelano tratti individuali di nessuna specie, e che sono eseguiti in occasione di ogni inumazione durante il corteo funebre mutando semplicemente volta a volta il nome e le cariche del defunto allorché questi viene nominato».40 Così nel modulo più sopra ricordato «A occidente! I a occidente! lo N., I a occi dente! » offre la possibilità di accennare alle peculiari caratteristi che del morto, e di riguadagnare il piano del concreto evento lut tuoso. Inoltre appaiono in Egitto non pochi lamenti i quali rispetto al contenuto «sono adattati all’individualità del morto ovvero al rapporto personale dell’esecutore (o degli esecutori) col morto stesso, e quindi recitati una sola volta». Questo secondo gruppo di lamenti rende probabile l’ipotesi che «la lamentazione egiziana, al pari di quella di altri popoli, è di regola (fatta eccezione del rituale regio) una nuova creazione improvvisata ogni volta nel corso del cordoglio rituale, senza dubbio avvalendosi di antiche locuzioni, tipi e formule a diffusione popolare».41 Qui però osserveremo che anche per questo tipo di lamenti a più alto livello di autonomia non si può parlare propriamente di una «nuova creazione» nel senso strettamente letterario e profano del termine, poiché il discorso si muove sempre nel vincolo di locuzioni, tipi e formule a carat tere rituale. Un terzo tipo di lamenti a testo fisso è costituito dalle cosiddette lamentazioni di Iside e di Nephthys, dove l’assimila zione del defunto a Osiride consente di trattare ogni morte sto rica c o m e se fosse quella mitica del nume, e di trasferire al defun to il pianto rituale recitato nelle celebrazioni del quarto mese del l’inondazione: ma su questo tipo di lamenti torneremo più innanzi. Ma la protezione interna del discorso della lamentazione non aveva luogo soltanto mediante gli schemi letterari tradizionali, ma colato tipologicamente secondo le varie circostanze possibili della sua destinazione concreta (lamento per sposa, donna, giovinetto, giovinetta, infante, sposa, persona morta senza figli 0 con molta prole, oppure perita di morte violenta o lontana dalla patria), e opina che la lamentatrice antica doveva possedere un ricco patrimonio di moduli, a cui attingere al momento oppor tuno o per l’occasione giusta: a questa conclusione inducono i lamenti folklorici dell’ attuale Vicino Oriente. Lo Iahnow, op. cit., p. 1 x, pensa a una articolazione del lamento funebre secondo 1 gradi di parentela: ma è evidente che questi tentativi di ulteriore determinazione sono desti nati a restare meramente congetturali. 40 Liiddekens, op. cit., pp. 1 8 1 sg. Cfr. p. 17 8 . 41 Ibid.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
191
anche mediante il modo col quale il lamento doveva esser detto o cantato. Noi sappiamo ben poco di questi modi dell’antico lamen tarsi rituale; possiamo soltanto dire con sicurezza che si trattava sempre di modi diversi dal comune «dire» o «parlare». Secondo Reiner il goos dell’epoca omerica non era propriamente poesia, poi ché non ubbidiva a un metro, ma poteva essere assimilabile a un tipo di «prosa ritmica», con tono strascicato e dizione alta, cioè un prodotto intermedio fra la comune prosa parlata e il melos can tato.42 Solo successivamente, e senza dubbio senza che il logos rit mico del goos andasse mai intermesso nelle classi più umili, si svi lupparono le forme di threnos con accompagnamento musicale.43 Nel mondo mesopotamico si indicava con sa.su la salmodia del bandi tore cittadino, la caratteristica cadenza di chi si lamenta in tribuna le, il parlare in lingue straniere e infine il modo particolare con cui dovevano essere pronunziate le lamentazioni rituali.44 Considera zioni analoghe valgono per il lamento egiziano, che doveva essere det to «in modo diverso dal comune dire o parlare», e che in determi nati casi - per i testi più lunghi - era certamente cantato.45 Vi è infine un altro aspetto del lamento antico che coincide con quanto fu già accertato in sede folklorica, e cioè la iterazione rituale del lamento in occasione di lutti altrui ovvero in date canoniche definite. Solone infatti proibì το κοκύειν άλλον έν τάφοις ετέρων,46 cioè «di lamentare un altro durante la inumazione di altri», che è concordemente interpretato come divieto del costume di appro fittare di una inumazione per rinnovare il lamento per familiari defunti di un passato più o meno recente.47 Solone proibì anche έπ’άλλότρια μνήματα βαδίζειν χορίς έκκομιδής,48 cioè il portarsi - per 42 Reiner, op. cit., p. 30. 43 Ibid., p. 6 1. 44 O. Oppenheim, Bull. amer. Schools orient. Res., voi. 10 3 , n sgg. (1946). 45 Liiddekens, op. cit., p. 18 2 . Per ipotesi sulle melodie tradizionali dell’antico lamento funebre ebraico, vedi Iahnow, op. cit., pp. 80 sg. 46 Plut., Sol. 2 1. 47 Per l’interpretazione di questo passo cfr. Nilsson, Opuscoli selecta, p. 97, e Reiner, op. cit., p. 100, n. 2. Il costume doveva essere molto antico e non concerneva soltanto il momento della inumazione: Briseide alla vista del cadavere di Patroclo si abbandona al lamento e le altre donne le fanno eco colplanctus rituale, piangendo in apparenza Patroclo «ma in realtà ciascuna le sue proprie sventure» {II. 19 , 302). 48 Plut., Sol. 2 1.
192
C A P IT O L O Q U IN T O
eseguire il lamento - sulle tombe altrui indipendentemente dal trasporto funebre, e oltre i giorni commemorativi. Altre disposi zioni legislative regolano la durata del cordoglio e il rinnovarsi della lamentazione.49
2. Lamento, mito del morto e rituale funerario Il lamento funebre antico è soltanto un momento dei corrispon denti rituali funerari, ed è isolabile da essi solo in via di astrazione provvisoria. D ’altra parte tali rituali si muovono per entro oriz zonti mitici definiti, costituiscono cioè comportamenti resi ad un certo mito del morto. Pertanto se vogliamo approfondire il signi ficato religioso del lamento antico dobbiamo ora volgerci a conside rarlo in questa più ampia prospettiva. Innanzi tutto i rituali funerari del mondo antico appaiono dominati da quell’importante momento del mito del morto che è la ideologia del cadavere vivente.50 Si tratta di una fase intermedia di passaggio fra la condizione dei vivi e quella dei morti, fra l’ al di qua e Tal di là, comunque poi le sin gole civiltà religiose del mondo antico si configurino sia questa fase intermedia sia la condizione terminale delle anime del regno dei morti. La fase intermedia del cadavere vivente, durante la quale il morto si avvia a morire definitivamente e a raggiungere il suo regno, è sostenuta e determinata dal comportamento rituale del periodo di lutto, di guisa che se i riti non sono eseguiti, e il morto 49 Plut., tic . 27; Dittenberger, S .I.G ., voi. 3 (2a ed.), n. 438 (Legge dei Labyadi). 50 L ’espressione lebende Leiche o lebender Leichnam fu usata per la prima volta in Neckel, Walball: Studien iiber germanischen Jenseitsglauben (Dortmund 19 13 ), e successivamente dallo Schreuer, Das Rechi der Toten, A. vergleich. Rechtwiss., voli. 33 (1916) e 24 (1917). Per lo stesso concetto è da vedere Naumann, Primitive Gemeìmchaftkultur (Jena 19 2 1). Talora all’espressione lebende Leiche (o lebender Leichnam) si è preferita l’altra lebender Tote (Geiger, in «Handwórt. dtsch. Abergl. », voi. 8, 1024 sg.). In generale all’espressione viene dato un significato psicologico di reazione universalmente diffusa di fronte alla morte, tanto che il Ranke la definisce come « un postulato elementare a prìorì della mente, reperibile nell’umanità di tutti i tempi»: K . Ranke, Indogermanìsche Totenvereherung, F .F .C ., voi. 59, n. 140 (19 5 1) p. 2 1. In questo significato psicologico l’espressione è utilizzabile certamente per rituali funerari che non appartengono al mondo antico, e segnatamente per i rituali funerari delle cosiddette civiltà primitive. Nella nostra analisi ierogenetica l’espressione ha invece il valore di un momento del l’ esperienza culturale della morte che impegnò le civiltà religiose del mondo antico: un momento che va considerato nella dinamica e nella differenziazione del concreto processo storico, e non nella sua indifferenza tipologica.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
193
resta senza sepoltura e senza lamento, il regno dei morti non è raggiunto, e il cadavere permane inquieto in una sorta di rischiosa instabilità, tornando ostilmente fra i vivi. Il significato tecnico di questo ordine mitico-rituale è evidente: il centro della crisi del cor doglio è - come vedemmo - il morto come estraneità radicale, cioè come sintomo di un evento non oltrepassato, dinanzi a cui la presenza rischia di restare senza margine per esserci. Le raffigura zioni relative al cadavere vivente fermano in rappresentazioni tra dizionali culturalmente accreditate l’irrelativo travaglio di limiti in cui la morta spoglia sta nel quadro della crisi: in virtù di tale fermata il rischio di alienazione si tramuta in una alterità mitica qualificata che dà orizzonte alle possibili crisi individuali. In se condo luogo le rappresentazioni relative al morto vivente destorificano l’avvenuto passaggio storico dalla vita alla morte, ritardan dolo nella paradossia tecnica di una fase dinamica in cui il morto è per un verso ancora suscettibile di rapporti con i vivi, e per un altro verso è ritualmente avviabile alla sua condizione definitiva di morto nel regno dei morti. In virtù di questo trapasso ritardato e del suo legame col rito sono rese possibili le operazioni necessa rie per risolvere la crisi, e precisamente le operazioni di separa zione e di rapporto che debbono portare al nuovo equilibrio: di separazione rispetto al morto in quanto rischio di estraneità radi cale, e di rapporto in quanto il morto deve pur essere oltrepas sato, cioè interiorizzato e risolto in quella idealità dei valori che ne forma la cara e benefica memoria. La condizione di un morto ancora partecipe del mondo dei vivi, e tuttavia avviabile al mondo dei morti mediante la dinamica di operazioni rituali assegnate ad un periodo di lutto definito e circoscritto,51 consente di svolgere l’ambivalenza irrisolvente della crisi, cioè quell’attrazione e repul sione maligne che procedono dal cadavere e che stanno come sin tomo morboso di un compito culturale non assolto: il periodo di lutto è chiamato appunto a riprendere questa ambivalenza e a ripla smarla in quei graduali atti di distacco e di comunione, di allonta namento e di avvicinamento, di partecipazione del morto alla con51 Un periodo di lutto di trenta (o quaranta) giorni è certamente indoeuropeo: cfr. Ranke, op. cit., passim. Ma anche i Semiti lo conoscono: Num. 20, 29 (Aronne, pianto per trenta giorni); Deut. 2 t, 1 1 (lasciar piangere per trenta giorni la donna bottino di guerra); FI. Ios. de bello jud. 3, 9, 5 (lutto per la morte di Giuseppe durato ininterrottamente per trenta giorni).
194
C A P IT O L O Q U IN T O
dizione dei vivi e di partecipazione dei vivi alla condizione del morto che formano per così dire il supporto tecnico della reinte grazione, lo strumento di fondazione del nuovo equilibrio, l’arma di riconquista del diritto dei vivi. Allo spirare del periodo di lutto (per esempio al trigesimo) il morto è definitivamente morto, nel senso che esso ha una vita regolata nell’al di là, quali che siano le singole specificazioni che il mito delle anime dopo la morte riceve nelle singole civiltà religiose del mondo antico. Viene così raggiunto il momento mitico del regno dei morti, in cui il defunto acquista una condizione di esistenza più stabile e ritualmente controllata, e soprattutto un valore che regge la vita individuale e sociale, e la alimenta. Si compie così, mediata dagli orizzonti tecnici miticorituali, quella «seconda morte» culturale che l’uomo procura alla «prima morte» naturale, ridischiudendo il «diritto dei vivi». L ’ap parente paradossia del morto vivente risponde dunque ad una rigo rosa forma di coerenza tecnica, da valutare nei termini del pro blema da risolvere (la crisi della presenza in occasione dell’evento luttuoso), dei mezzi impiegati per risolverlo (il regno dei morti come condizione di esistenza da far conquistare al defunto mediante il rito, avviando al suo destino la fase intermedia del morto vivente) e dei risultati ottenuti (trascendimento del morto e della situazione luttuosa correlativa, liberazione mediata delle forme profane di coerenza culturale compromesse dalla crisi). A questa fondamen tale struttura tecnica partecipano tutti gli antichi rituali funerari, anche se l’ampiezza della crisi iniziale, le particolarità delle tecni che impiegate, il contenuto specifico del mito dell’al di là e il grado di autonomia e di consapevolezza della risoluzione del morto nel valore possono variare secondo le diverse civiltà religiose o le epoche o le classi sociali.3225 52 Nella sua analisi particolareggiata sul periodo di lutto nei popoli indoeuropei K . Ranke ha messo in evidenza (cfr. op. cit., passim, ma soprattutto pp. 3 5 3 sgg.) come solo dopo lo spi rare del periodo di lutto cessa la condizione di cadavere vivente ed è conquistata per il morto una condizione più stabile che lo trasforma in antenato della famiglia o della Sippe, al quale si rende un culto permeato di valori etici e politici. D ’altra parte la fine del periodo di lutto segna la fine del diritto del morto, e il ridischiudersi dei diritti dei vivi: per esempio la vedova potrà risposarsi, le interdizioni alimentari sono sospese, la proprietà potrà essere divisa o donata ecc. Analogamente il Frankfort, Ancient Egyptian Religion (1948) pp. 96 sgg., ha sottolineato il fatto che il rituale funerario egiziano trasforma il morto in Akh, cioè in una esistenza stabile, integrata nei grandi ordini cosmici naturali contrassegnati dalla permanenza e dal ritorno, quali le stesse circumpolari, il circuito del sole e della luna, la periodica crescita delle acque del Nilo,
IL L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
195
È in questo quadro complessivo, cioè nell’ordine rituale del periodo di lutto e nei due momenti mitici del morto vivente e del conclusivo stato del defunto nel regno dei morti, che va conside rato il lamento funebre rituale: tutte le sue particolarita tecniche ricevono senso ed efficacia solo in questo piu vasto sistema tecnico mitico-rituale. La tecnica della lamentazione rituale tende - come abbiamo visto - a dare orizzonte al discorso e a proteggerlo dalle insorgenze della crisi irrelativa: ma la conquista del discorso e pos sibile solo per entro un quadro mitico in cui il morto è come se fosse ancora vivo, trattenuto e ritardato nel suo trapasso in virtù dell’apparente paradossia che lo rappresenta al tempo stesso morto e partecipe del mondo dei vivi, avviato ritualmente alla lontananza del suo regno e al tempo stesso ritualmente richiamato ad intes sere con i vivi la rete dei rapporti interiori secondo valore. «A occidente! I a occidente! I ο N., I a occidente!», dice un modulo del lamento funebre egiziano, accentuando il momento dell’allonta namento rituale nel mondo dei morti; ma un altro modulo egiziano, accentuando l’esigenza del rapporto col morto come compito da attuare, scongiura: «Non mi lasciare I non mi lasciare, I o babbo I non mi lasciare». Da questo fondamentale dinamismo finalistico e dal tecnicismo che lo rende possibile scaturisce il carattere m a g i c o della lamentazione, cioè la sua efficacia ex opere operato in quanto parola e in quanto gesto rituali. Lamentarsi è innanzi tutto, come si è visto, un incantarsi nella presenza rituale del pianto, ed è al tempo stesso un incantesimo per il morto, una recitazione di moduli verbali e mimici che aiuta il cadavere vivente a raggiungere la sua stabile condizione nel mondo dei morti e che mediatamente ridi schiude il processo di interiorizzazione del defunto. Lamentarsi è un mobilitarsi dei vivi per operare sul morto in modo da facili targli il raggiungimento della sua dimora definitiva (= momento della separazione) ed in modo da tramutarlo in alleato dei vivi (= momento del rapporto e della interiorizzazione). Un testo delle Piramidi dice: «Per te sono in moto le anime, per te si percuotono il petto e battono palma a palma le mani, per te si strappano i capelli e si battono le gambe». Al che fa eco un passo del Libro dei Morti. la vicenda delle stagioni e della vegetazione: grandiosa figurazione destorificatrice che tuttavia media tecnicamente e rende possibile la reintegrazione dei morti nel valore, e il ridischiudersi, per i vivi, della storia dei vivi.
196
C A P IT O L O Q U IN T O
«Le lamentatoci con chiome ondeggianti sono davanti a te, per te si battono le braccia, per te alzano le grida della lamentazione, per te si lamentano: ed il tuo Ba esulta, il tuo cadavere è glorifi cato».53 Da questa forza magica della lamentazione si dovette poi sviluppare il vero e proprio incantesimo funerario cui molto pro babilmente si riferiscono le fonti ecclesiastiche quando parlano di cantica diabolica o turpia, o Ylndiculus superstitionum quando ricorda il sacrìlegium super defunctos id est dadsisas: cioè incantesimi che mediante 1’evocazione del defunto pretendevano di ricavare infor mazioni sull’al di là, o addirittura di attivare a profitto dei viventi le anime dei morti - nel qual ultimo caso si sarà trattato di vera e propria necromanzia.54 L ’interpretazione della lamentazione come dinamica della sepa razione e del rapporto ci consente di considerare sotto una nuova luce quella ritualizzazione del planctus che abbiamo indicato quale uno degli aspetti caratteristici della lamentazione antica. Dalle insi die della crisi la lamentazione rituale strappa non soltanto il discorso come parola, ma anche come gesto: il planctus ritualizzato riprende le tentazioni della crisi limitandole nel numero e nell’intensità e attenuandole nei simboli della recitazione rituale. D ’altra parte muovendosi nell’orizzonte mitico del morto-vivente la mimica rituale compie la catabasi verso le tentazioni della crisi e al tempo stesso Γ anabasi verso la coscienza culturale, sciogliendo dramma ticamente la rischiosa ambivalenza della crisi in gesti di separa zione e di difesa, ovvero in gesti di rapporto e di interiorizzazione: ma con ciò viene appunto eseguito il lavoro del cordoglio.55 Si consideri il gesto di cospargersi la testa di polvere (o di cenere), così caratteristico nelle civiltà del Vicino Oriente. Già vedemmo come la motivazione più immediata di quest’atto rituale è quella 53 G. Thausing, Der Auferstehungsgedanke in dgyptischen relìgiòsen Texten (Lipsia 1943) pp. 2 9 0 3 1 . Per la magia delle lacrime si veda, in generale, M. Canney, The Magic o f Tears, ] . Manchester egypt. orient. Soc., voi. 12 , 47-54 (1926); e A. Van Selms, Weenen ah aavengsrite, Nieuw Theologisch Tìjdschrift, voi. 24, 119 -2 7 (1935). 54 K. Ranke, op. cit., pp. 288 sgg. 55 In generale Γanalisi che segue sulle valenze mimiche della lamentazione rituale nel mondo antico è condotta basandosi sulle analisi parziali del Ranke, op. cit., pp. 99 sgg., per il lamento funebre indoeuropeo; del Reiner, op. cit., pp. 42 sgg., per il lamento funebre greco, dello Iahnow, op. cit., pp. 16 sgg., per il lamento funebre ebraico; nonché sui lavori più parti colarmente archeologici dello Zschietzschmann (raffigurazioni della prothesis in Grecia) e della Werbrouck {mimica delle lamentatrici egiziane).
197
IL L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
di una simbolica autoinumazione come risoluzione della tentazione suicida: in tal guisa non si offre soltanto parziale soddisfazione a un impulso insano attuandolo su di un piano simbolico-rituale, ma viene dischiusa la possibilità di un’esperienza di partecipazione dei sopravvissuti al destino dei morti, e quindi la possibilità di un’e sperienza di comunione che agevola il lavoro di interiorizzazione del morto da parte dei vivi. D ’altra parte il cospargersi la testa di polvere può presentare anche la valenza di occultarsi e di ren dersi irriconoscibile di fronte alla sgomentante estraneità del cada vere e ai rischi del morto che torna in modo irrelativo fra i vivi: e qui predomina il momento della separazione e della difesa. Infine il cospargersi la testa di polvere può anche valere come espressione della impurità (o dello sporcarsi in quanto simbolo di impurità) in cui il caso luttuoso ha gettato la casa e i sopravvissuti: nel che si configura l’aspetto «contagio» che si collega al cadavere, e la possibilità di determinati orizzonti mitico-rituali di purificazione. Analoghe considerazioni valgono per il cospargersi la testa di cenere in quanto surrogato simbolico del gettarsi nel rogo. Consideriamo ora un’altra espressione tipica della ritualizzazione del planctus nel mondo antico, lo strapparsi e tagliarsi i capelli e il gettarli sul cadavere: come fanno i Mirmidoni sul cadavere di Patroclo, e successivamente lo stesso Achille,56 o come fa Oreste sulla tomba del padre assassinato.57Anche qui siamo in presenza di un gesto che, in quanto ordinato nella misura del rito, attenua le automutilazioni gravi del planctus irrelativo, e le incanala in uno schema di mimica rituale individualmente e socialmente accetta bili. La ripresa non si limita però a questa misura, ma media deter minate motivazioni di separazione e di rapporto, come il già ricor dato sfigurarsi per rendersi irriconoscibile al morto, o come la necessità di placarlo mediante qualche cosa che viene pagata di persona, con una non equivoca testimonianza, o infine come il solenne suggello di una comunione interiore e di una alleanza instau rate per sempre.58 56 tl. 23, 13 5 sgg. 57 Esch., Coeph., inizio; cfr. Soph., E l.f 52 e 488 sgg.; Eur., E l , 90 sgg. e 520; Or., 96. Per la documentazione greco-romana sull’ argomento è da vedere Eitrem, Opfemtus und Voropfer der Griechen und Ròmer (Cristiania 19 15 ) pp. sgg. 58 Eitrem, op. cit., p. 350, pensa anche a una valenza catartica per liberarsi dal tabu del morto.
344
198
C A P IT O L O Q U IN T O
Un’analisi particolare meritano le mimiche connesse al percuo tersi ritmico, cioè al kopetòs rituale. Il materiale archeologico ci consente qui di raffigurarci la dinamica che conduce dal cadavere come «contenuto critico» della situazione luttuosa al morto come memoria morale e come valore. In generale il percuotersi la testa con ambo le mani (insieme al percuotersi il petto o altra parte del corpo) costituisce la risoluzione simbolico-rituale delle tentazioni indiscriminatamente autolesionistiche del planctus irrelativo. Il gesto ampiamente documentato nel materiale archeologico greco ed egiziano poteva essere eseguito sia individualmente che in un ritmo sincronico collettivo, sul tipo della oscillazione «corale» dei busti delle lamentatrici di Fonni.” Come gesto rituale, che deve essere reso al morto e che pertanto è ripreso dalla coscienza nel quadro di determinati significati tradizionali culturalmente accre ditati, il kopetòs (come del resto la stemotypia e le altre forme del percuotersi ritmico) può avere la valenza di una forma simbolica di autosoppressione e quindi di partecipazione del vivo alla con dizione del morto, o anche la valenza di far vedere al morto l’am piezza del cordoglio, in modo che vedendo si plachi, e placandosi desista dal vessare i vivi. Oppure il «far vedere» manifesta una esibizione resa ai vivi, per ragioni di prestigio sociale o addirit tura politico, come è certamente il caso del lutto nelle aristocrazie feudali e nelle monarchie divine, allorché masse di popolo - e in particolare di schiavi - vi sono impegnate. D ’altra parte il gesto tipico del kopetòs eseguito con ambo le mani si viene articolando in uno schema mimico diverso, che accenna a nuove valenze e moti vazioni. In tale schema un solo braccio è portato al capo per ese guire il kopetòs, mentre l’altro si distende in avanti, con la palma della mano rovesciata. Una valenza di separazione e di allontana mento compete sicuramente a questo ordine mimico del rito nella raffigurazione sepolcrale di Civitella San Paolo,59 60 dove accanto ad un gladiatore in atteggiamento agonistico appare una lamentatrice che porta la mano al capo violentemente voltato come per evitare una vista orrenda, mentre davanti a sé distende con energia l’al tra mano a palma aperta, in atto di difesa e di allontanamento. 59 Per il percuotersi la testa si veda Atl. fig. del pianto, nn. 18 , 3 1 , 42, 44-49. Per la sin cronia dei movimenti nelle lamentatrici di Fonni, ibid., n. 6f. 60 Ibid., n. 56.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
199
Gladiatore e lamentatrice sono dunque impegnati, ciascuno a suo modo, a combattere un agone contro la morte, il gladiatore con le armi, la lamentatrice col vibrante gesto apotropaico. La valenza agonistica di questo modello mimico dell’estensione del braccio a palma rovesciata sembra confermata dal fatto che nel registro inferiore di un lutroforo attico raffigurante una prothesis con lamen tazione il gesto è eseguito da cavalieri armati di lance,61 il che è da mettersi in rapporto con le parole di Adrasto nelle Supplici euri pidee: «Ma leviamo dunque la mano per farci incontro ai mor ti...»,62 dove il «farsi incontro» (άπανΦεΤν) va inteso con una sfu matura agonistica. Il gesto dell’estensione del braccio appare con nesso nelle rappresentazioni vascolari greche al corteo funebre, tan to da poter essere qualificato come «gesto processionale», correla tivo all’ekphorà:6} interpretazione che trova conferma nelle paro le pronunziate da Oreste sulla tomba di Agamennone nelle Coe fore·. «Non sono stato presente, o babbo, alla tua morte, I né ho disteso la mano al momento del trasporto funebre».64 Il rapporto è confermato anche da un passo dell’Alcesti («Essa ha lasciato la casa, né io l’ho seguita, né ho steso la mano, io che piango la mia padrona»).65 Qui evidentemente la valenza apotropaica che il gesto ha nel bassorilievo di Civitella San Paolo ha ceduto il luogo ad una valenza di rapporto e di saluto, a meno che non si voglia pensare anche ad una terza valenza, e cioè al vibrante indicare - nel cor so del trasporto funebre - la direzione che il morto dovrà seguire per raggiungere la sua mèta (si pensi al modulo egiziano: A occi dente! I a occidente! I ο N., I a occidente!). Comunque sia, la valenza di rapporto e di saluto appare chiaramente nel materiale archeolo gico, polarmente contrapponendosi a quella di difesa e di allonta namento: così al rilievo sepolcrale di Civitella, dove il gesto appare chiaramente in funzione agonistica e apotropaica, si contrappon gono idealmente le raffigurazioni egiziane in cui il braccio si allunga con trepido sgomento, accompagnato dal religioso curvarsi della silhouette della lamentatrice in piedi o inginocchiata.66 Analoga 61 Ibid., n. 50. 62 Eur., Su ppl, 722. 63 Cfr. Zschietzschmann, op. cit.t p. 27. 64 Eur., Coeph., 8. 65 Eur., A le., 768. 66 Atl. fig. del pianto, nn. 19-26.
200
C A P IT O L O Q U IN T O
valenza di rapporto e di saluto è da attribuirsi all’estensione del brac cio dei due personaggi che nell’affresco della parete di fondo del la Tomba degli Auguri a Tarquinia stanno ai lati di una porta chiu sa raffigurante l’entrata alla dimora del morto o l’accesso all’Ade.67
3. Furore, lascivia, fam e e rituale funerario Non rientra nell’economia del presente lavoro un’analisi parti colareggiata dei nessi mitico-rituali che dànno orizzonte alla crisi del cordoglio nelle civiltà religiose del mondo antico: sarà tutta via opportuno sottolineare il fatto che non soltanto il lamento fune bre ma l’intero periodo di lutto assolve nel mondo antico al com pito tecnico di riplasmare culturalmente i rischi connessi alla perdita della presenza davanti all’evento luttuoso. Tali rischi sono l’assen za e la scarica convulsiva, l’ebetudine stuporosa, il furore distrut tivo, il planctus, l’anoressia, la bulimia, l’erotismo, il ritorno irre lativo del morto come rappresentazione ossessiva o come imma gine allucinatoria, l’amnesia della situazione luttuosa e le varie inautenticità esistenziali che l’accompagnano, il delirio di nega zione dell’evento: ora si potrebbe dimostrare che gli antichi rituali funerari dispiegantisi nel periodo di lutto costituiscono dei sistemi tecnici per fronteggiare questi rischi di crisi e per aiutare la pre senza a oltrepassare nel valore l’evento luttuoso in quanto tale. Il lamento funebre è appena un momento di tali sistemi tecnici: il suo compito è soprattutto quello di riprendere il planctus e di restituire orizzonte al discorso. Ma in quei viventi organismi tec nici che sono gli antichi rituali funerari si ritrovano apparecchia ture destinate a trattare e a risolvere altri rischi di crisi. Ci limite remo qui ad indicare sommariamente in che modo ciò avvenga per i rischi del furore, dell’erotismo e della fame. Questi rischi sono da interpretarsi, come vedemmo, quali sintomi del crollo della potenza formale della presenza, che si avvia a restare senza mar gine di esistenza rispetto all’evento luttuoso: più precisamente il compito del trascendimento precipita dal piano legittimo del dispie gamento della potenza formale a quello illegittimo ed improprio 67 Ibid., n. 54.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
201
della mera adialettica vitalità, onde in luogo del trascendimento si h an n o vani e irrisolventi conati di cieco recupero ovvero diaboliche
contraffazioni di ciò che dovrebbe essere superamento, appropria zione e interiorizzazione ideali.68 Ora i rituali funerari del mondo antico riprendono queste morbose tentazioni della crisi e la sotto pongono ad un trattamento di reintegrazione culturale, combat tendo l’usurpazione irrisolvente della mera adialettica vitalità e restituendo alla potenza formale della presenza la sovranità che le spetta. Il furore trova orizzonte nell’ordine rituale della vendetta, del sacrificio di vittime umane o animali, dell’agonismo; l’eroti smo nell’ordine rituale dei giuochi lascivi e delle esibizioni oscene; la cieca bulimia nell’ordine rituale del banchetto funebre. D ’altra parte attraverso il rito ed il correlativo orizzonte mitico viene rigua dagnato, a vari livelli di autonomia e di consapevolezza, il mondo dei valori e lo stesso morto come «valore». Esaminiamo nell’es senziale queste tre diverse risoluzioni culturali. L ’esempio più illustre di risoluzione culturale del furore per una morte è naturalmente il χόλος di Achille per la morte di Patroclo. Questo χόλος non trova orizzonte soltanto nell’istituto della ven detta mediatore di una impresa eroica, ma anche nella sacra eca tombe sul rogo di Patroclo, compiuta da Achille «pervaso da furore» per la morte dell’amico (σέθεν κταμενόιο χολώνεις).65 Tale ritualizzazione del furore distruttivo - funzionalmente analoga alla ritualizzazione del planctus irrelativo della crisi - aiuterà Patroclo a varcare le soglie dell’Ade,70 e al tempo stesso attraverso il pre stigio di funerali eroici convertirà la rischiosa inquietudine del cada vere vivente nell 'ethos di una onorata memoria.71 Infine lo stesso χόλος, dispiegandosi nella violenza degli agoni funerari (si pensi soprattutto al combattimento cruento) trova orizzonte nelle prove di destrezza e nella riaffermazione di virtù eroiche, ovvero nello spettacolo che rallegra, placa e onora il morto legandolo moralmen te al mondo dei vivi. Erwin Rohde, che per il primo dette il giu sto valore documentario alla descrizione omerica dei funerali di 68 Cfr. cap. 1. 69 11. 23, 2 3; cfr. I l 18 , 337. 70 Appena prima dei funerali Patroclo appare in sogno ad Achille raccomandandogli di ese guire i riti della sepoltura, altrimenti non potrà varcare le soglie dell·Ade {II. 23, 7 1). 71 II. 23, 20 (cfr. 180).
202
C A P IT O L O Q U IN T O
Patroclo,72 fu anche il primo a riconoscere questo rapporto tra il furore di Achille durante la vendetta e il furore col quale uomini e animali sono immolati dall’eroe sul rogo: tralasciò però di rico noscere che anche gli agoni davanti al sepolcro rappresentano un’ul tima più mediata risoluzione culturale di quel χόλος originario che insidia l’eroe in crisi per l’evento luttuoso. Del resto che vi sia un nesso fra i sacrifici umani funerari e gli αγώνες έπιτάφιοι è con fermato da quanto dice Servio a proposito degli agoni gladiatori romani: «Sane mos erat in sepulcra virorum fortium captivos necari: quod postquam crudele visum est, placuit gladiatores ante sepulcra dimicare».73 E qui da osservare che sussiste un nesso fra il sacrifi cio funerario cruento e la lamentatrice che si graffia a sangue le guance, poiché in entrambi i casi il furore si risolve in uno spargi mento di sangue che dovrà placare il morto e legarlo moralmente al vivo: «mulieres in exequiis et luctu ideo solitas ora lacerare ut san guine ostenso inferis satisfaciant, quare institutum est ut apud se pulcra victimae caedantur».74 Proprio sulla base di questi nessi possiamo riconoscere il motivo di vero dell’interpretazione che Ger trude Thausing ha dato della lamentazione funebre egiziana come di un rito agonistico con valenza di autosacrificio: la lamentatrice compirebbe cioè una concentrazione agonistica di forze, assumendo su di sé le malignità che minacciano il morto, al fine di debellarle e di agevolare al morto l’accesso all’ al di là.75 Il già ricordato bas sorilievo di Civitella San Paolo, dove una lamentatrice appare asso ciata ad un gladiatore, è forse da intendere in questo quadro. Come la vendetta, il sacrificio cruento e l’agone dànno orizzonte al furore, così esibizioni oscene e giuochi lascivi dànno orizzonte al l’erotismo irrelativo. In generale su questo punto la documenta zione antica è relativamente povera: in compenso gli indici folklorici sono numerosi ed eloquenti. Già vedemmo a proposito dei funerali di Lazzaro Boia il succedersi di giuochi e di buffonerie a carattere lascivo.76 Residui del genere in epoca cristiana impe 72 Rohde, Psyche, p. 19. 73 Serv., Verg. Aen. io , 5 19 . 74 Varrò, ap. Serv. Aen. 3, 67. Per gli agoni rituali funerari è da vedere «Realencycl. PaulyWiss. », voi. 1, p. 841 (Reisch); L. Malten, Leichenspiele und Totenkult, Ròm. Mitt., voli. 38-39, 300 sgg. (1923-24). 75 G . Thausing, op. cìt., pp. 29 sg. 76 Cfr. sopra, pp. 15 7 sgg.
203
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
gnarono costantemente l’opera incivilitrice della Chiesa. Per citare solo qualche esempio, nel sinodo di Londra del 1342, canone deci mo, si parla di fornicazioni commesse durante le veglie funebri,77 nel sinodo di Praga del 1366, canone secondo, si fa cenno ad atti di deboscia che avrebbero avuto luogo nella stessa occasione78 e in un codice penitenziale boemo è detto che nel prònao della chiesa gli uomini erano soliti eseguire durante i funerali scherzi equivoci al fine di indurre al riso i colpiti da lutto.79 Gli attuali non irri levanti relitti folklorici e i dati ricavabili dai canoni sinodali ci con sentono dunque di concludere già di per sé che nei funerali del mondo antico l’erotismo doveva costituire una normale manife stazione. Nell’inno pseudomerico a Demetra la dea, in cordoglio per la perdita di Kore, si siede in casa di Celeo, senza occuparsi di alcuno né con parole né con atti, senza sorridere, rifiutando cibo e bevanda, struggendosi per la brama della figlia perduta. Ma ecco che Iambe, l’ancella «diligente e pratica», si abbandona ad una esi bizione oscena, inducendo la dea al riso.80 Questo episodio, come già ebbe ad osservare lo Usener, rappresenta il riflesso mitico di un rito che doveva aver luogo nell’antico cerimoniale attico, e che non doveva essere molto dissimile dalla parte sostenuta dalla «buffona sarda».81 Sono noti gli elementi osceni del culto dei morti sia a Roma82 che in Etruria.83 Le lamentatrici egiziane appaiono con i seni intenzionalmente scoperti, proprio come se si trattasse di un gesto rituale:84 d’al tra parte nelle feste romane dedicate a Flora, dea della vegetazione e al tempo stesso dei morti, apparivano ad un dato momento delle 77 Mansi, Conc. ampi coll., voi. 25, pp. 116 7 sgg. 78 Ibìd., voi. 26, p. 1549. 79 Lippert, Christentum, Volkslaube und Volksgebrauch (1882) p. 4 19 . 80 Inno pseudom., vv. 19 2 -2 11. Nell’Edda di Snorri (Thule 20, 119 ) vi e un episodio con simile: Skadi desisterà dal cordoglio per il padre assassinato se qualcuno lo indurrà a rìdere, il che fa Loki con scherzi e smorfie oscene. 81 Usener, Rhein. Mus. Philol., voi. 59, 265 sg. (1904) { = Kl. Schriften, voi. 4, pp. 469 sg.). Per la buffona sarda, cfr. F . de Rosa, Tradizioni popolari di Gallura (Tempio Maddalena 1898). 82 F. Altheim, A History of Roman Religìon (1938) p. 159; Terra Mater (1931) pp. 99, 140 sg. 83 Cfr. Atl. fig. del pianto, n. 55. 84 Werbrouck, op. cit., p. 129. Lamentatrici cananee in atto di esibire i seni in Gressmann, Altor. Texte u. Bilder, voi. 1, p. 2 1 1 , cfr. Atl. fig., n. 42. Per l’erotismo rituale funerario nel mondo indoeuropeo è da vedere Ranke, op. cit., pp. 276 sgg. Per una visione panoramica orien tale, però soprattutto in senso etnologico, cfr. Lanternari, Orgia sessuale e riti di recupero nel culto dei morti, S .M .S .R ., voi. 24-25 ( i * )·
953 54
204
C A P IT O L O Q U IN T O
meretrici che «armis certabant gladiatoriis atque pugnabant».85 Il significato tecnico dell’erotismo è vario: nell’episodio di Iambe sem bra evidente che debba trattarsi di un semplice espediente della ancella «diligente e pratica» onde sbloccare l’inazione melancolica della dea. Analogamente le buffonerie dei funerali di Lazzaro Boia utilizzano l’irrelativo erotismo della crisi in forme di tratteni mento e di distrazione, che valgono come piacevole e ordinato recu pero dei vivi. Ma gli orizzonti culturali in cui viene ripreso il crudo impulso sessuale possono partecipare a più mediate motivazioni, come allorché la manifestazione lasciva viene sperimentata quale forza largita al morto o quale spettacolo che deve placarlo e ralle grarlo, o quale gesto apotropaico che fuga le malignità addensate sui vivi dalla sinistra presenza del «cadavere vivente». Ma il gesto in apparenza lascivo può risolversi in altro, e mediare un ethos ele vato, come nel caso di una madre che esibisce i seni al figlio morto, i seni che qui assurgono a simbolo del latte dato e perduto e al tem po stesso a scongiurante invito al ritorno: a tanto accenna Ecuba che solleva il seno davanti a Ettore votato a sicura morte: «Ettore, figlio mio di questo abbi riguardo, e anche di me pietà».86 Per quel che concerne il banchetto funebre antico dobbiamo qui tener conto di alcuni indici che in parte provengono dal mate riale etnologico e in parte da quello folklorico. Nelle civiltà di rac coglitori e di cacciatori, e particolarmente in quelle che si sono sollevate all’agricoltura alla zappa, il banchetto funebre appare spesso nella forma del «mangiare il morto». Lo scacco del trascen dimento sospinge a sostituire l’ingestione orale all’interiorizzazione ideale: la necrofagia rituale funeraria riprende questo sintomo di crisi ridischiudendolo alla vera riappropriazione, che è secondo valore. Nel copioso materiale raccolto dal Vohlard nella sua opera sul cannibalismo questo significato tecnico della necrofagia rituale traspare talora in modo assai netto: valga per tutti il caso dei Dieri 85 Schol. Giov. 6, 250. Cfr. F. Altheim, Terra Mater, p. 1 3 1 . Vi sono residui di esibizioni oscene delle lamentatrici anche in epoca cristiana come attesta Ambrogio (P, L., voi. 16 , 1318 ): «Illud vero frequens in mulieribus ut clamores publicos serant, quasi metuant ne earum ignoretur aerumna: ut illuviem vestis affectent, quasi in ea sit sensus dolendi: ut impexum sordide immadident, caput; ut postremo, quod plerisque in locis vulgo fieri solet, discisso amictu, dilo ricata veste, secreti pudoris nuda prostituant, quia pudoris sua praemia perdiderunt. Sic procaces oculi provocantur, ut concupiscant, ut amare incipiant membra nudata». 86 II. 22, 83.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
205
australiani, presso i quali un prossimo parente del morto distri buisce ai presenti determinate parti del cadavere affinché man giandone l e n i s c a n o i l l o r o c o r d o g l i o . 87 Qui l’impulso necrofagico della crisi trova orizzonte in un certo ordine miticorituale per mezzo del quale si riapre ad esperienze di comunione e di riappropriazione ideali: lo stomaco come sepolcro media quell’uccidere i morti in noi che è il compito del lavoro del cordoglio. Il Vohlard ha messo in evidenza come nelle civiltà primitive che praticano il cannibalismo rituale le cerimonie funerarie ne costi tuiscano l’originario ed essenziale pretesto, tanto che nei territori in cui la colonizzazione europea ha quasi estirpato il costume esso continua tuttavia ostinatamente a persistere solo nel rituale fune rario, p r o p r i o c o m e s e q u i si t r o v a s s e l a r a d i c e d e l c a n n i b a l i s m o r i t u a l e n e l l e s u e v a r i e f o r m e . 88 Il Vohlard ha anche mostrato come il banchetto funebre con alimenti non umani si trova al termine di una serie di spostamenti e di atte nuazioni che ha per punto di partenza la necrofagia rituale fune raria.89 Così nel sistema tecnico del banchetto cannibalico dei nemici uccisi al termine di una spedizione di vendetta contro sup posti responsabili «magici» di una certa morte naturale avvenuta nella tribù, l’impulso necrofagico e al tempo stesso il furore distrut tivo sono spostati ai danni del nemico tribale, il quale ora subisce in luogo del morto l’atto di appropriazione: in tal modo si ha però una forma di esocannibalismo che media determinati rapporti intertribali e una forma embrionale di vita politica. D ’altra parte l’im pulso necrofagico può essere trasposto ai danni di vittime umane da immolare e divorare durante i funerali: i Waiangara per esem pio in occasione di una morte uccidono i malati e i bambini, vol gendo in tal modo il loro impulso a profitto dell’interesse econo mico di liberarsi di energie non produttive per il gruppo. Analo gamente le vittime umane possono essere scelte fra gli schiavi op pure, con una trasposizione più radicale, fra gli animali, raggiun gendo così la forma del banchetto funebre in cui sono rappresen tati soltanto cibi non umani. Tuttavia queste trasposizioni e atte87 E . Vohlard, i l cannibalismo, trad. ital. (Torino 1948) p. 220. C fr. a p. 2 16 sollievo che provano i Tangara a mangiare i loro morti. 88 Ibid., p. 489. 89 Ibid.
1 analogo
C A P IT O L O Q U IN T O
2θ6
nuazioni del banchetto funebre, quali che siano i valori che me diano, sono sempre da interpretare - in quanto rito del banchet tare durante i funerali - come risoluzione tecnica di un rischio di crisi che si manifesta nella cieca bulimia e nell’impulso di «man giare il morto». Se ci volgiamo ora al materiale folklorico europeo troviamo una sorprendente conferma di questa interpretazione in determinate espressioni linguistiche popolari che stabiliscono una equivalenza fra banchetto funebre e «bere» o «mangiare» i morti. Per fornire solo qualche esempio, il banchetto funebre era indi cato con den Toten vertrinken presso i tedeschi dei Sudeti, con den Vestorbenen vertrinken presso i Bavaresi e con Toten eindaycheln nell’Alto Palatinato (daichdeln dal gotico dautbs = banchetto). In particolare gli abitanti di Zurigo erano chiamati Totenfresser o Totentrinker a cagione dei loro imponenti banchetti funebri. A queste espressioni fa riscontro l’italiano «mangiare i morti», con lo stesso significato. Vi sono inoltre frasi e modi di dire in cui il seppellire il morto è indicato con espressioni come jemanden vertrinken (Baviera), onde chiedere per esempio Wenn hamm’n vertrunken? equivale a chiedere quando il tale è stato seppellito.90 Sulla base di alcune indicazioni lessicali il Ranke ritiene che questi modi di dire significano in generale «mangiare e bere a spese del morto», in conformità dell’ideologia che il morto stesso, ancora proprieta rio dei suoi beni per tutto il periodo del lutto, deve sopportare le spese del banchetto.91 Ma questa interpretazione rappresenta solo una particolare valenza che, in ambiente indoeuropeo, viene mediata dal rito del banchetto funebre: in realtà il «bere» o «man giare» i morti come designazione del banchetto funebre costitui sce una sorta di lapsus che documenta il rischio di cui il banchetto funebre, con tutti i suoi significati ammessi e coscienti, rappre senta la reintegrazione culturale. Nelle civiltà religiose del mondo antico non vi è traccia di necrofagia rituale, e il banchetto fune bre vi appare soltanto nella forma trasposta del pasto di cibi car nei o vegetali. L ’ordine cerealicolo dell’agricoltura con aratro ebbe ragione di tutte le forme di cannibalismo, e quindi anche della necrofagia rituale. Di questo grande evento della storia culturale la tradizione ha serbato memoria, come appare nella famosa nar razione del mito di Osiride resa da Diodoro Siculo: 90 Ibid., p. 2 2 1. 91 Ranke, op. cit., p. 192 e n. 2.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
207
Osiride soppresse innanzitutto il costume di mangiare carne umana dopo che Iside scoprì grano e orzo (queste piante crescevano cioè allo stato sel vaggio fra le altre piante, senza che gli uomini le conoscessero); e poiché Osiride trovò modo di trattare questi frutti, tutti di buon grado si abitua rono ad un altro tipo di alimentazione, trovando gradevole il nuovo cibo e ritenendo meglio abbandonare quel costume disumano .92
Ovviamente alla tradizione antica manca il senso storico per riconoscere alle forme rituali di antropofagia, e in particolare alla necrofagia funeraria, un qualsiasi valore culturale. Tuttavia il nuovo ethos che consentì il passaggio all’economia cerealicola, e rese ina doperabili le tecniche antropofagiche, non segnò in senso assoluto l’ingresso άΐΆ ’ethos umano nel mondo, poiché anche le civiltà che praticarono il cannibalismo lottarono a loro modo per un orizzonte umano, per quanto molto più angusto di quello che le civiltà reli giose del mondo antico seppero dischiudere. D ’altra parte il nuovo ethos che bandì il cannibalismo rituale fu pur sempre tecnicamente impegnato a combattere le tentazioni della crisi, e il banchetto fune bre, ancorché trasposto a cibi non umani, continuò ad assolvere il suo compito fondamentale di abbassare a strumento del valore gli irrisolventi conati della adialettica vitalità, e di ridischiudere alla riappropriazione ideale lo scacco della ingestione alimentare. Appunto per questo il banchetto funebre conserva nei rituali fune rari del mondo antico un posto molto importante, soprattutto come epilogo del periodo di lutto, quando cioè valeva come testimonianza di un’ultima definitiva interiorizzazione ideale del morto e come ristabilimento del diritto dei vivi.93
4. Una interpretazione di K. Meulì Secondo un’interpretazione di Karl Meuli gli antichi rituali fune rari avrebbero a fondamento determinate reazioni spontanee e na turali all’evento luttuoso, che soltanto in un secondo momento - cioè diventando costume e rito - trovano la loro giustificazione in motivazioni finalistiche diverse.94 Così per esempio il furore 92 Diod. Sic. i , 14 . 93 Ranke, op. cit., passim. 94 K . Meuli, Gnecbische Opferbràucbe; in «Phyllobolia fiir Peter von der Miihll» (Basilea 1946) pp. 185 sgg. Cfr. Entstebung und Sititi der Trauersitten, Schweiz. Arch. Vòlkskunde, voi. 43, 9 1 sgg. (1946).
C A P IT O L O Q U IN T O
2θ8
distruttivo è una di queste reazioni: esso costituirebbe, secondo il Meuli, uno sfogo «senza senso e senza misura» per il torto patito dal sopravvissuto, onde nasce un impulso di vendetta indifferen ziatamente rivolta verso l’esterno (o anche un impulso autodistrut tivo), un voler annientare quanto sembri che usurpi il diritto alla vita e all’esistenza, come grida re Lear davanti al cadavere di Cor delia: «No, no, non più vita! Perché un cane, un cavallo, un topo, debbono avere la vita, e tu neanche un soffio di essa?» Il Meuli sostiene che questo sarebbe il «significato originario» dei sacrifici funerari accompagnati dal violento annientamento di ciò che viene sacrificato: nel sacrificio in quanto rito e costume affiorano però delle motivazioni secondarie e derivate, più o meno superstiziose, nelle quali la reazione originariamente spontanea e naturale del furore si darebbe un orizzonte finalistico. Queste motivazioni pos sono essere diverse: per esempio si distruggono le appartenenze del defunto perché sono contagiate dalla morte o perché sia riaf fermato il diritto di proprietà del cadavere vivente o perché deb bono morire col morto per passare nell’al di là e servire come beni di uso e di consumo, o per testimoniare con un’offerta totale o perché vaste distruzioni e dissipazioni conferiscono prestigio sociale ai funerali. Ma quali che siano queste motivazioni, il furore distrut tivo come reazione primordiale all’evento luttuoso costituisce, secondo il Meuli, il φυσικόν che sta a base del νόμος, o addirittura l’elemento plasmatore (Formgeber) del costume irrigiditosi in con venzione e in obbligo rituali. Pertanto se vogliamo comprendere i vari comportamenti degli antichi rituali funerari dobbiamo innanzi tutto «metterci sulle tracce della vivente esperienza di cui una volta fu espressione, e che può sempre rifarsi attuale, per quanto senti mento ed esperienza solo raramente saranno abbastanza intensi da riempire la forma tradizionalizzata con un empito di vita così possente da far apparire tale forma come naturale adeguata espres sione di un sentimento».95 Quest’interpretazione del Meuli è in verità in parte superficiale e in parte oscura e contraddittoria. Il furore del cordoglio (come l’erotismo o la fame) è soltanto un sin tomo morboso: per il crollo degli orizzonti formali della presenza e per lo scacco del trascendimento l’ideale superamento dell’evento 95 Ranke, op. cit., p. 202 e n. 2.
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
209
luttuoso si tramuta in soppressione materiale, in annientamento dell’ordine esistenziale. Ciò significa che l’efficacia plasmatrice in senso culturale non può mai spettare al sintomo morboso, al rischio di non esserci, ma proprio a quella sfera di risoluzioni finalistiche che il Meuli non mostra di intendere nel suo proprio carattere. Non il furore è «datore di forma», ma la vendetta o il sacrificio o l’agonismo in quanto istituti; non l’erotismo, ma lo spettacolo lascivo, la buffoneria tradizionale, il racconto malizioso; non la fame, ma il banchetto funebre; e, infine, non il planctus irrelativo ma il lamento funebre. L ’ordine mitico-rituale dei funerali ha il f i n e t e c n i c o di riprendere i rischi della crisi e di mediare gli altri f i n i c u l t u r a l i che la crisi rischia di compromettere. Senza dubbio può accadere che la tecnica funeraria perda la sua funzione di ripresa e di mediazione dei valori, e degeneri in stereotipie mor bose. Qui però lo storico non ha più nulla da dire: poiché il suo compito fondamentale resta sempre quello di illustrare la lotta drammatica con la quale sull’ateleologico patire si innalza il regno dei fini della umana civiltà. Di questo innalzarsi rende testimonianza una famosa succes sione di episodi relativa al cordoglio di Achille per la morte di Patroclo.
5. Lo scudo di A chille Tra i pezzi dell’armatura che Efesto appresta per Achille ve ne è uno, lo scudo, su cui si è particolarmente esercitata l’arte del fabbro divino. Si tratta di una grandiosa raffigurazione dell’or dine naturale e culturale circoscritto da Oceano. La prima scena, al centro dello scudo, raffigura l’ordine della natura, la terra il mare il cielo, e nel cielo il sole che mai si stanca di compiere il suo giro, e la luna piena, e le Pleiadi, le Iadi, e la potenza di Orione e l’Orsa che mai non tramonta: cioè il cosmo come stabile permanenza o come eterno ritorno. Le scene successive, dal centro alla periferia dello scudo, sono destinate all’ordine culturale in quanto misurato intervento umano: innanzi tutto l’ordine cittadino del matrimo nio e della giustizia, la guerra e le sue astuzie, e poi l’ordine agri colo dei campi coltivati nei momenti decisivi dell’aratura, della
210
C A P IT O L O Q U IN T O
mietitura e della vendemmia, la domesticazione degli animali e la caccia alle fiere che minacciano gli armenti, e infine un luogo di ristoro e di riposo in un accogliente scenario pastorale ed il ritmo di una danza eseguita da giovinetti e da giovinette nel quadro di una festa.96 Tutte queste scene inondate di luce e governate dalla misura della vita e dell’opera appaiono infine circoscritte dalla cor rente Oceano, che accompagnando il giro estremo dello scudo segna simbolicamente il confine del regno delle tenebre e delle ombre, il misterioso accesso al regno dei morti. Il significato di questa descrizione nell’economia complessiva dell’Iliade ed il criterio di scelta nell’ordine e nella qualità delle scene descritte hanno costituito, com’è noto, un problema tradi zionale dell’esegesi omerica. Infatti sin dai tempi di Zenodoto non si riusciva a vedere il rapporto organico dell’episodio con la narra zione epica: sembrò, per esempio, che la sequenza avesse un valore puramente decorativo, senza rapporto né con l’uso dello scudo come arma, né con colui che lo doveva portare: da questo punto di vista apparivano più giustificabili la descrizione esiodea dello scudo di Eracle, riboccante di immagini terrorizzanti atte a sgomentare l’av versario, o la descrizione dello scudo di Achille in Euripide, Elet tra, 457, anch’esso figurato in modo da terrorizzare Ettore. D ’ al tra parte fu osservato che nella sequenza di scene relative all’ordine civile mancavano la navigazione e il commercio e in generale le manifestazioni del culto reso agli dèi. Un’altra quistione tradizio nale era se Omero nella sua descrizione avesse avuto davanti a sé uno scudo reale, oppure se avesse lavorato di fantasia. L ’imposta zione giusta fu però data dallo Helbig che insistette sulla coerenza estetica della descrizione, e quindi sul valore relativamente secon dario e subordinato di tutte le altre quistioni tradizionali.97 Nel quadro di questa impostazione dello Helbig, e approfondendo un giudizio già espresso dal Lessing nel suo Laocoonte (le scene raffi gurate sullo scudo come Inbegrìff von alles was in der Welt vorgeht), lo Schadewalt ha messo in rilievo come Omero rappresenti l’or 96 IL 18 , 468 sgg. 97 W . Helbig, Das homerische Epos aus den Denkmalem erlautert (Lipsia, 2 a ed. 1877) pp. 395 sgg. Cfr. G . Lippold, Griecbiscben Scbilde, in «Muncher archeologische Studien dem Andenken Adolf Furtwànglers gewidmet» (Monaco 1909). La tesi del modello reale a cui si sarebbe informata la descrizione omerica si ritrova ancora in W. Reichel, Homeriscbe Waffen (Vienna, 2 a ed. 19 0 1) p. 146.
211
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
dine della natura secondo la fondamentale intuizione unitaria di ciò che nella natura già è inserito nell’ordine della civiltà: sole e luna sono i grandi notificatori del tempo, le stelle valgono come guida per il pellegrino e per il marinaio, Odisseo viaggia verso l’oc cidente mantenendo alla sua destra l’Orsa maggiore quale infalli bile segno del Nord, e infine fra l’apparizione e la scomparsa delle Pleiadi, delle Iadi e di Orione il contadino esiodeo ripartisce i lavori agricoli. Appunto per questa pregnante risonanza umana e civile le immagini in cui Omero ferma l’ordine della natura vanno molto al di là di una semplice arbitraria scelta di fenomeni naturali, ed assurgono al valore di scelta poetica. Analogamente lo Schadewalt interpreta le immagini omeriche relative all’ordine civile come gui date dalla fondamentale intuizione di un trionfo della misura della vita umana che si solleva sulle condizioni meramente naturali, e giustifica questa serena fantasia come «un momento di riposo nel ritmo incalzante degli avvenimenti», e più precisamente come uno scenario che solleva il nostro sguardo fuor dei limiti di una situa zione opprimente (il cordoglio di Achille), dirigendolo verso l’am piezza di un mondo «wo nur die Tat einen Weg bahnen kann».98 Tuttavia proprio qui si avverte il limite dell’interpretazione dello Schadewalt, poiché resta ancora non sufficientemente chiarito il rapporto della descrizione dello scudo con l’episodio immediata mente successivo di Teti che reca ad Achille le armi apprestate da Efesto, e di Achille che dopo aver contemplato i daidala si ridi schiude al suo destino eroico.99 Teti trova il figlio riverso a terra, abbracciato al cadavere di Patroclo, in un nuovo accesso senza oriz zonte. Ora è appunto la contemplazione dei daidala di Efesto che media il passaggio decisivo di Achille dalla crisi irrisolvente all’or dine dell’impresa eroica vendicatrice. Alla vista del dono splen dente ritorna nel petto dell’eroe l’onda del cholos, che poi si stem pera nella gioia della contemplazione, maturando infine nella decisione che riapre il ritmo del destino umano: Νΰν δ’ήτοι μέν έγω ύωρήξομαι. Per quanto il poeta non lo dica esplicitamente, ciò che risolve in questo momento decisivo la crisi di Achille non è soltanto l’ov98 W . Schadewalt, Von Homers Welt und Werk (Stoccarda 1944) pp. 99 II. 19 , 1 sgg.
35 2 sgg.
212
C A P IT O L O Q U IN T O
vio richiamo al destino eroico evocato da così pertinente dono divino, ma anche la contemplazione delle scene rappresentate sullo scudo, e cioè la figurazione dell’ordine della vita e della civiltà oltre il mondo delle ombre che Oceano separa. La figurazione mitica che Achille contempla evoca dunque in adatte immagini di ripresa il compito del superamento della crisi, la meta della riconquista dei valori, il mondo della cultura intercalato fra l’ordine naturale e la corrente Oceano. Qui viene esibito alla vista uno scenario che scioglie Achille dallo sterile abbraccio col cadavere di Patroclo, proprio come nell’episodio di Iambe narrato nell’inno pseudomerico a Demetra un’altra esibizione risolleva la dea dolente dalla sua inazione melancolica: solo che mentre il gesto di Iambe si ispira ad un simbolismo sessuale molto elementare, sullo scudo illustrato dal fabbro divino il compito della ripresa si articola in chiare figure, che mediano visibilmente alti valori. Non si tratta quindi soltanto di una «pausa di riposo» che dovrà operare sulla fantasia del lettore, indirizzando il suo sguardo verso l’ampiezza ordinata di un mondo in cui l’azione umana può ancora ridischiudersi dopo che gli eventi angosciosi hanno toccato il loro vertice: la qualità e l’ordine delle scene raffigurate sullo scudo tro vano la loro coerenza di luminosità e di vita nella funzione che dovranno assolvere su Achille irretito nella crisi del cordoglio. Noi comprendiamo ora meglio, nella più vasta unità estetica dei due episodi, perché nella sequenza delle scene domina la misura di una vita civilmente ordinata e di una natura che si piega a quest’or dine: noi comprendiamo ora meglio perché la morte vi appaia o ricacciata al di là dell’orizzonte di Oceano o ricompresa e risolta nell’ergon umano. In questo quadro acquista nuovo significato la scena dell’ergow della vendemmia, in cui l’esperienza della morte appare risolta nella vigna luminosa in cui risuona il «caro lino» fra schiere di giovinetti e di giovinette che corrono recando panieri colmi del dolce frutto, la mente occupata da teneri pensieri: il «caro lino» che qui, in questa scena in cui la morte appare culturalmente controllata nel raccolto del prezioso bene vegetale, stempera la sua drammaticità di antico lamento funebre agrario nella dolce mesti zia di una tenue voce giovanile, cui fa eco il clamoroso ritornello di coloro che pigiano a tempo l’uva nel tino. Contemplando que st’ordine essenzialmente laico dell’opera civile Achille rompe la
I L L A M E N T O F U N E B R E A N T IC O
213
irrisolvenza della crisi e si avvia alla reintegrazione: tuttavia affinché il piano di reintegrazione dischiusosi ai suoi occhi sia poi effetti vamente attuato, Achille dovrà percorrere per intero le vie degli obblighi rituali, dalla vendetta al sacrificio, dagli agoni al banchetto, compiendo in tal modo quanto è tecnicamente necessario per l ’ef fettiva risoluzione della crisi, cioè l’allontanamento nell’Ade di Patroclo morto e al tempo stesso la riappropriazione dell’amico nell’ethos di una benefica memoria interiore e nella riconquista del diritto dei vivi. In quest’ordine rituale dominato dall’orizzonte mitico del cadavere vivente da avviare verso il mondo dei morti e da risolvere in valore per i vivi trova posto anche la ritualizzazione del planctus e la lamentazione funebre.
LA M E S S E D EL D O LO RE
6.
La messe del dolore
i . Morte, lavoro e cultura Se volessimo definire l’umana civiltà nel giro di una espressione pregnante potremmo dire che essa è la potenza formale di far pas sare nel valóre ciò che in natura corre verso la morte: è infatti per questa potenza formale che l’uomo si costituisce come procura tore di morte nel seno stesso del morire naturale, imbrigliando in una regola culturale del passare quanto passa senza e contro l’uomo. Il lamento funebre destinato alla morte di individui storici, come del resto i rituali funerari nel loro complesso, mettono in opera determinate tecniche per oltrepassare l’evento luttuoso e per pro curare al defunto quella seconda morte culturale che vendica lo scandalo della morte naturale: tuttavia se l’uomo non avesse avuto dalla morte che l’esperienza della finitezza fisica della vita umana, non avrebbe mai potuto darsi il coraggio civile di oltrepassare l’evento luttuoso, e sarebbe rimasto abbracciato a ciò che non è più, come Achille al cadavere di Patroclo prima di contemplare i daidala di Efesto: infatti sarebbe mancato al sopravvissuto pro prio ciò che quei daidala rivelarono ad Achille, e cioè la misura di un possibile fare umano culturalmente efficace. Un vecchio canto Dinca lamenta che mentre il sole sorge, passa e tuttavia ritorna, e così pure la luna, soltanto l’uomo nasce, passa e non ritorna più. Questo contrasto, a meno che non trovi la sua catarsi nel canto, è come tale destinato a restare senza soluzione, fra un eterno ritorno che non ci appartiene affatto ed un passare senza ritorno che ci appartiene anche troppo. Il centro culturalmente risolutivo del con
215
trasto sta invece in quelle sfere operative in cui si rivela la possi bilità di far passare e tornare la natura secondo la regola umana del lavoro: qui nascono e maturano le energie inaugurali che ren dono la morte culturalmente accessibile, e qui si costituisce il valido nucleo patrimoniale da cui attingere quando si manifesta lo scan dalo del morire naturale. Nelle civiltà religiose del mondo antico il centro culturale della esperienza della morte non sta nell’esperienza del sopravvissuto davanti alla spoglia della persona cara, ma è in organico rapporto con quella vicenda di scomparse e ritorni in cui l’uomo aveva appreso effettivamente a farsi procuratore di morte secondo una regola umana, inaugurando efficacemente il distacco dalle condi zioni naturali: cioè la vicenda della scomparsa e del ritorno delle piante coltivate. Arare, seminare, veder fiorire, raccogliere e veder scomparire; questa vicenda dipendeva certo in larga misura da potenze che sfuggivano al controllo umano, e tuttavia era integrata in un ordine di lavori agricoli per i quali dipendeva a n c h e dall’uomo. Ora proprio l’urto fra questo parziale controllo umano e le immense potenze resistenti o avverse ebbe importanza decisiva nella plasmazione dell’esperienza della morte delle civiltà antiche. In particolare soprattutto nel momento del raccolto l’uomo antico in quanto agricoltore apprese il suo destino di procuratore di morte secondo valore: e qui di nuovo riecheggiava nei campi il pianto rituale della passione vegetale, per esempio il kalon linon della ven demmia, secondo lo scenario raffigurato sullo scudo di Achille. «Ahi Lino, origine della morte (άρχή θανάτου), ahi ahi, al modo asia tico»:1 la morte violenta di Lino durante il raccolto introduce la morte nel mondo, la rivela culturalmente agli occhi degli uomini. Con ciò si dischiude davanti a noi un ordine mitico-rituale che ridimensiona il pianto rituale in un quadro che sempre più si avvi cina ad una individuazione storiografica precisa. In fondo le tec niche del lamento che abbiamo sinora analizzate sembrano, almeno in parte, accennare a modi non specificamente antichi, poiché si ritrovano anche fra i primitivi: infatti anche ai rituali funerari pri mitivi appartengono la ritualizzazione del planctus e la ricerca di orizzonte per il discorso. Con l’esperienza di una passione vegetale 1 Eur., Or., 139 5 .
2 l6
C A P IT O L O S E S T O
e col pianto rituale per questa passione noi ci interniamo invece decisamente in un mondo religioso che sempre più si colora di valenze individuate, che ebbero luogo «una sola volta» nella sto ria, e che danno alla frase «esperienza antica della morte» un signi ficato non tipologico, ma storiografico. Pertanto se vogliamo iden tificare ciò che di caratteristico e di fondamentale appare in tale esperienza, e se a questo scopo ci proponiamo di considerare i momenti critici in cui l’uomo antico patì nel modo più intenso il rischio del planctus irrelativo e fu al tempo stesso impegnato con maggiore energia a riguadagnare la misura della umana civiltà, noi non possiamo limitare la nostra analisi alla sfera del lamento fune bre destinato alla morte di individui storici nel quadro di determi nati rituali funerari, ma dobbiamo innanzi tutto volgere l’atten zione al pianto rituale nel suo nesso con la passione vegetale in occasione di quell’epitome esistenziale dell’anno agricolo che fu nel mondo antico il momento critico del raccolto.
2. Protoagricoltura e cerealicoltura L ’esplorazione del nesso fra il momento critico del raccolto, l’ideologia della passione vegetale e il pianto rituale deve necessa riamente cominciare con un’indagine sul primo momento del nesso: il raccolto come operazione agricola nel regime esistenziale delle civiltà mediterranee o che comunque gravitarono culturalmente verso questo mare. Innanzi tutto si pone il problema della sostan ziale diversità fra il raccolto nelle civiltà protoagricole alla zappa e nelle civiltà cerealicole o all’aratro. L ’agricoltura primitiva alla zap pa ha un abitato tropicale (tropico-africana o negra, asiatico sud orientale, oceaniano o melanesiano-polinesiano, amerindiano), ricco di vegetazione e di acqua, con clima caldo e stagioni alternanti piovosa e asciutta. Nell’agricoltura alla zappa la coltivazione com prende esclusivamente alcuni frutti e tuberi, come la manioca, l’igname, la palma da sago, la palma da cocco, la batata, le molte varietà di taro, la banana, i vari tipi di fave, il cetriolo, il melone, la zucca bislunga. La coltivazione si effettua mediante la tecnica fondamentale del trapianto o moltiplicazione vegetativa, cioè pian tando nel terreno un pezzo della pianta (radice, tubero, gambo),
LA M E S S E D E L D O LO RE
217
e quindi ignorando completamente la tecnica seminativa. La zappa come sviluppo del bastone da scavo dei popoli collettori costituisce 10 strumento fondamentale di questo tipo primitivo di agricoltura. Ignorata è la rotazione di culture, il che comporta come conseguen za la ridotta stabilità sul terreno: dopo alcuni anni di sfruttamento del suolo, il campo viene abbandonato per cercarne uno nuovo, che viene preparato mediante incendio, o dissodamento della macchia, le ceneri costituendo anche l’unico mezzo di concimazione cono sciuto. La domesticazione degli animali è limitata al piccolo be stiame, come la capra, il maiale, il cane, il gallo, per i quali però non viene esercitato né il pascolo regolare, né lo stallaggio, ancor meno il vero e proprio allevamento, con impiego nei lavori agri coli: gli animali domestici, che forniscono soprattutto carni per l’alimentazione, vengono lasciati abbandonati a loro stessi in pros simità del domicilio umano, ed è questa l’unica forma di pascolo in uso. Dal punto di vista della divisione del lavoro, l’uomo provve de alla caccia e alla pesca, al commercio, alla politica e alla guerra, al pesante lavoro di dissodamento della macchia e di sgombero del suolo: ma i lavori agricoli nel loro complesso ricadono soprattut to sulla donna. In considerazione del fatto che nell’area dell’Asia sudorientale si trova la patria di origine allo stato selvaggio delle piante più importanti che furono poi coltivate dal regime agricolo alla zappa, si è avanzata l’ipotesi che in tale area sia da ricercarsi 11 centro di origine e di diffusione di questa forma più primitiva di coltivazione delle piante. L ’agricoltura all’aratro, produttrice per eccellenza di cereali, è invece arativa e seminativa, pratica la rotazione delle culture, si insedia stabilmente sul suolo, dà grande sviluppo all’allevamento dei bovini e degli equini, conosce la mungitura del latte, e soprat tutto utilizza gli animali nel corso dei lavori agricoli. Il suo abi tato tende a spostarsi verso le zone temperate, dalle pianure del Gange sino al Mediterraneo, trovando in particolare nelle pianure alluvionali dell’Indo, della Mesopotamia e del Nilo le condizioni più propizie al suo sviluppo.2 Tale spostamento ambientale, accompa gnato da così importanti trasformazioni economiche ed ergologi2 Si veda, per questa parte, E . W erth, Grabstock Hacke und Pflug, Versucb einer Entstehungsgeschichte des Landbaues (Ludwigsburg 1954).
2l 8
C A P IT O L O S E S T O
che, comportò una nuova esperienza del ritmo stagionale, e un molto più acuto rapporto con la polarità morte-vita, sonno inver nale-risveglio vegetale.3 In misura molto maggiore l’uomo poteva ora controllare la natura, influendo con le regole della sua tecnica più avanzata su una sfera più ampia del «passare» e del «tornare» naturali: e con l’ampliarsi di questa sfera egli «esisteva» di più, cioè si poneva fuori della natura con una più garantita possibilità di presenza. Tuttavia malgrado questa innegabilmente più alta ener gia civile che seppero dispiegare i popoli del mondo antico inventori dell’agricoltura cerealicola e della viticoltura, il momento del rac colto nel ciclo dei lavori agricoli continuava a configurarsi - come già nella precedente agricoltura alla zappa - nel suo carattere di momento critico per eccellenza, rivelatore dell’urto fra la potenza del fare umano e la sterminata sfera di ciò che poteva passare o tornare senza e contro l’uomo. Come nelle civiltà protoagricole anche nelle civiltà cerealicole il raccolto chiudeva un’epoca e inau gurava un nuovo corso esistenziale, ma intanto lasciava davanti a sé un vuoto o una scomparsa, un periodo nel quale il ritorno del bene vegetale dipendeva ancora largamente da potenze umana mente non controllabili, come le avversità meteorologiche, i guasti arrecati da animali nocivi alle piante coltivate, le incursioni depre datrici di stranieri, e simili. La precarietà della vita alimentare nelle civiltà cerealicole del mondo antico è indirettamente documentata dalle catastrofiche descrizioni del vuoto vegetale che accompagna la scomparsa del nume della vegetazione. Nel lamento per la scom parsa di Tamuz si piange sugli orti senza ortaggi, sui campi senza spighe, sui canneti senza canne, sulle foreste senza tamarischi, sui frutteti senza miele né vino.4 La scomparsa di Telipinu si confi gura in un sinistro scenario di desolazione, in cui la natura è bru ciata dal funesto ardore del sole estivo e le pendici dei colli sono nude, spogli gli alberi, inariditi i pascoli, secche le fonti, affamati e languenti uomini e dèi.5 Dopo il ratto di Persefone i semi sono colpiti da sterilità: «molte volte il pallido orzo cadde senza effetto nel solco».6 Anche le immagini e le trasposizioni metaforiche nel 3 F. K em , Die Welt worein die Grìechen traten, Anthropos, voi. 24, 17 4 (1929). 4 W. Baudissin, Adonis und Esmun ( 1 9 11 ) p. 105. 5 Se ne veda la traduzione in T. Gaster, Tbespis (New York 1950) p. 3 6 1. 6 Inno a Demeter, w . 305-09.
219
L A M E S S E D EL D O LO RE
l’Antico Testamento ci offrono quadri terrificanti della vita vege tale che si sospende, e delle sciagure che si abbattono sulle campa gne. Lamenta Geremia: I grandi mandarono i loro subalterni ad attinger acqua, e non ne trovarono, riportarono le loro brocche vuote, e smarriti e afflitti si coprirono il capo... La cerva ha figliato nel campo e ha abbandonato il cerbiatto, perché non vi era erba. Gli asini selvatici si sono arrestati sulla sommità dei monti, e hanno sorbito il vento: i loro occhi si sono spenti, perché non vi era erba.7
E Gioele: L ’avanzo della cavalletta l’ha divorato la locusta, e l’avanzo della locusta l’ha divorato il bruco, e l’avanzo del bruco l’ha divorato il grillo. Destatevi, 0 ubriachi, e lamentatevi: date in urla, o beoni, per il vino che vi è tolto di bocca. Poiché assalito è il paese da una turba forte e innumerevole, con 1 denti di leone e le ganasce di leonessa. H a ridotto la mia vigna in desola zione, e la mia ficaia ha reso brulla... Devastato è il campo, afflitto il suolo, perché distrutto è il grano, seccato il mosto, esausto l’olio. Smarriti stanno i contadini, si lamentano i vignaiuoli sul grano e sull’orzo, poiché annien tato è il raccolto. La vigna è seccata, il fico languisce, il melograno, la palma, il pomo e tutti gli alberi della campagna sono secchi perché inaridita è la gioia degli uomini.8
A i temi della precarietà esistenziale che nascevano dall’urto della comunità con le forze della natura si intrecciavano poi quelli che d.pendevano più strettamente dall’oppressione sociale esercitata sui contadini. In un modello egiziano di lettera l’autore dà al suo allievo un quadro della vita contadina in cui i due temi appaiono fusi insieme: Gli insetti lo hanno defraudato della metà del raccolto, l’ippopotamo ha divo rato l’altra metà. Il campo è pieno di topi, le cavallette si sono abbattute a sciami, il bestiame ha divorato tutto, i passeri si sono abbandonati al sac cheggio. Oh, sciagura per contadino! Il resto, che è sull’aia, i ladri se lo sono preso. La muta di bestie è morta di fatica a forza di arare e di treb biare. Sbarca lo scriba sulla riva e vuole portar via il raccolto. I funzionari portano bastoni e i negri ferule di palme. Dicono: «Consegnaci il grano!» Se non ce n’è, lo bastonano... Egli è legato e gettato nel canale. Si lega la sua donna in suo cospetto, e i suoi bambini son messi in ceppi. I suoi vicini lo abbandonano e fuggono via per mettere in salvo il loro grano.9
0
7 Gerem. 14, 1-6. 8 Gioele 1, 4-12 . 9 A. Erman e H . Ranke, Àgypten und agyptisches Leben irn Altertum (Tubinga 1923) p. 532.
220
C A P IT O L O S E S T O
Il momento critico del raccolto è da considerarsi nella concre tezza di questo regime esistenziale se vogliamo intendere quel suo carattere «critico» che oggi - nel quadro della moderna civiltà industriale - è quasi interamente scomparso, per sopravvivere se mai in forme molto attenuate nelle campagne delle cosiddette «aree arretrate», dove si manifestano talora alcuni rapporti simili a quelli che furono dominanti nell’antica agricoltura cerealicola. Ma ciò che rispetto agli altri episodi dell’anno agricolo conferisce al rac colto il suo carattere di episodio critico per eccellenza è una parti colarità sulla quale non si è di solito soffermata abbastanza l ’at tenzione. Nell’episodio del raccolto è proprio l’uomo che, con un atto decisivo e irreversibile, e al tempo stesso economicamente necessario, si fa lui stesso procuratore di morte della pianta colti vata, avviandola alla consumazione e inaugurando così il nuovo ciclo esistenziale da percorrere. Nel caso della mietitura dei cereali è proprio l’uomo che nel modo più sensibile e pregnante - il ge sto inesorabile della falce messoria - cancella dall’esistenza l’ali mento fondamentale e si pone davanti ad un protratto vuoto vege tale e all’incertezza di un problematico ritorno del bene soppresso. Il raccolto pone in essere e manifesta, molto più dell’aratura o della semina e degli altri lavori agricoli, la regola culturale di un morire governato dall’uomo: ma proprio per questo rivela altresì la ster minata potenza di ciò che, nel morire culturale, resta non umano, intrinsecamente estraneo e cieco. La siccità che brucia i raccolti e le erbe dei pascoli, le piogge fuor di misura e di tempo, il rapido sciogliersi delle nevi sui monti e il rovinoso ingrossarsi dei fiumi (come nel caso dell’ambiente siro-palestinese), il ritardo o l’anti cipo delle piene periodiche (come nel caso dell’ambiente egiziano), le incursioni depredatrici di stranieri, i danni arrecati da bestie nocive all’agricoltura: questa è la sfera di funeste possibilità non umane che fronteggia l’operazione agricola del raccolto in quanto vertice e compimento di una regola umana della morte. L ’impor tanza ierogenetica del raccolto per entro le civiltà cerealicole del mondo antico sta dunque nel fatto che esso rappresenta, nelle cir costanze date, una sporgenza per eccellenza della storicità della condizione umana, un momento in cui si manifesta con partico lare evidenza l’urto fra la cultura come procuratrice di morte nel
L A M E S S E D E L D O LO RE
221
seno stesso del cieco divenire naturale e il dispiegarsi di quella potenza disumana di morte che è la natura senza lume di vita cul turale.
3. Osservazioni metodologiche Il nesso fra raccolto, passione vegetale e pianto rituale sarà qui esaminato assumendo come prevalente punto di riferimento la mie titura dei cereali, la vendemmia ed il raccolto del lino. Questa scelta e quest’ordine non sono arbitrari, ma dettati per così dire dalle cose stesse, poiché nel mondo antico mietitura e vendemmia, e anche il raccolto del lino, costituiscono momenti altamente pre gnanti di significato economico per la vita individuale e collettiva, e al tempo stesso occasioni di importanza decisiva per la genesi della ideologia dei πάθη των καρπών come esperienza religiosa. Del resto la coscienza culturale del mondo antico riconobbe esplicita mente nei cereali e nella vite i simboli dell’ordine alimentare di schiuso dall’agricoltura, e quasi il principio e la condizione del viver civile del suo complesso. Non a caso mietitura e vendemmia appaio no tra le figurazioni dell’ordine naturale e civile rappresentate sullo scudo di Achille, al che fanno eco i versi delle Georgiche: Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus Chaoniam pingui glandem mutavit arista, poculaque intentis Acheloia mutavit uvis .10
Senza dubbio anche altri lavori dell’anno agricolo (aratura, semina, potatura della vite) o determinate operazioni necessarie per tra sformare la pianta in alimento o in bene altrimenti economico (maci nare il grano, impastare la farina, cuocere il pane, cardare, filare e tessere il lino) contribuirono alla formazione della ideologia delle passioni vegetali e al correlativo rituale della lamentazione: ma noi vi accenneremo solo occasionalmente appunto perché al raccolto spetta sotto questo punto di vista una importanza preponderante e decisiva. Sul piano più strettamente metodologico è da osser10 Verg., Georg., 1, 7.
222
C A P IT O L O S E S T O
vare innanzi tutto che una denominazione tipologica come quella di «feste stagionali» è del tutto inadeguata per la soluzione dei problemi ierogenetici relativi al rapporto fra raccolto, passioni vege tali e pianto rituale: tale denominazione infatti pone insieme indi scriminatamente tutte le occasioni stagionali, da quelle legate ai singoli lavori agricoli sino ad una cerimonia così complessa e ricca di valenze religiose diversissime come può essere ad esempio Yakztu babilonese. L ’intento che può esser raggiunto utilizzando questa denominazione tipologica è la determinazione, anch’essa tipolo gica, dei seasonal pattern nel mito come nel rito (o addirittura nella letteratura religiosa), cioè nei modelli o schemi comuni alle feste stagionali nel loro complesso: resta però esclusa dalla considera zione proprio l’istanza ierogenetica, cioè la ricostruzione del pro cesso che da singoli determinati momenti critici dell’esistenza indi viduale e collettiva conduce ai complessi mitico-rituali delle passioni vegetali e del pianto rituale, e si lascia nell’ombra e nell’indeter minato proprio ciò che da questo punto di vista interessa di più, cioè la qualità dell’operazione agricola e della pianta coltivata, il carattere della crisi esistenziale che minaccia quella data opera zione, la funzione che rispetto al rischio di crisi assolvono le sin gole forme ideologiche della passione vegetale. I seasonal pattern non giovano a spiegare perché sul tronco di una determinata ricor rente situazione esistenziale ad interesse collettivo (il raccolto delle piante economicamente utili nelle civiltà cerealicole del mondo antico) si venga innestando una ideologia che non soltanto la situa zione non sembra richiedere, ma che addirittura rispetto ad essa (cioè rispetto al raccogliere in quanto operazione agricola) tende a configurarsi come un’inutile complicazione e come una supersti ziosa fantasticheria.11 Occorre però subito dire che ancor meno giova allo scopo il ricorso a un oscurissimo Denken im B ilde der Pflanze da rivivere e da contemplare. Ciò significa che il metodo seguito nella pre sente monografia si distingue nettamente dal metodo che sta alla base del lavoro dello Jensen sulla visione religiosa delle civiltà pro toagricole. Lo Jensen ha messo in evidenza come il tema mitico11 A nostro avviso proprio qui sta uno dei limiti metodologici dell’opera di Gaster, Tkespis.
LA M E S S E D EL D O LO RE
223
rituale di tali civiltà sia la morte violenta di un nume, evento pri mordiale che avrebbe inaugurato nel mondo la morte e la genera zione, e dal quale avrebbero avuto origine le piante alimentari per metamorfosi del nume ucciso. Lo Jensen però ci presenta la visione religiosa delle civiltà protoagricole come un complesso statico, nato tutto in una volta e dotato di intrinseca coerenza e necessità nelle sue parti, e non già come un processo genetico umanamente moti vato e dispiegantesi comprensibilmente da situazioni esistenziali determinate. Appena in un punto del suo libro lo Jensen accenna alla prospettiva ierogenetica, cioè all’effettivo generarsi del tema delle passioni vegetali da determinate situazioni a carattere ricor rente e di interesse pubblico della vita protoagricola: Molto più difficile - egli dice - è la quistione perché la prima morte abbia dovuto essere la conseguenza di un assassinio... Senza voler rispondere esau rientemente alla domanda, mi sembra tuttavia opportuno accennare ad un dato, che si ritrova nel mondo reale... Che l’uccidere stia così in primo piano in tale visione del mondo è un fatto che ricondurrei senz’ altro all’interesse per il mondo vegetale... La pianta veniva continuamente uccisa nella rac colta dei frutti, ed in modo straordinariamente rapido la morte veniva supe rata dalla nuova vita. Qui potè manifestarsi per l’uomo la conoscenza com binatoria (die kombinatorische Erkenntnis) che collegava questo destino con l ’animale, con la pianta, e anche con la luna .12
Senza dubbio è già una preziosa ammissione l’aver indicato, sia pure in modo sommario e ipotetico, il collegamento fra il mito pri mordiale dell’uccisione del nume e «un dato del mondo reale», cioè fra raccolto della pianta e passione vegetale nel quadro di un’a gricoltura alla zappa: ciò che però resta da determinare mediante l’analisi ierogenetica sono le chiare motivazioni umane che nelle civiltà protoagricole condussero dall’episodio del raccolto alla ideo logia della passione vegetale nella forma che di tali civiltà fu pro pria. Il raccogliere come operazione agricola, la passione della pianta e la violenza recata ad un nume, il mito del nume ucciso nella vicenda primordiale, l’uccisione del nume come origine delle piante alimentari, i nessi che collegarono la passione vegetale con la gene razione, con l’animale e con la luna costituiscono altrettanti mo menti di un processo ierogenetico che occorre percorrere pazien12 A . E . Jensen, Die religiose Weltbild einer friihen Kultur (Stoccarda 1948) pp. 169 sg.
224
C A P IT O L O S E S T O
temente passo per passo: una risposta ipotetica e sommaria, o addi rittura l’appello alla conoscenza combinatoria (cioè alla gratuita immaginazione) avvolgono nelle tenebre proprio l’elemento che è decisivo per la comprensione. Un’ultima osservazione. Nella presente ricerca l’analisi ierogenetica del nesso fra raccolto - passioni vegetali e pianto rituale è limitata - come si è detto - ad alcune forme elementari di que sto nesso, cioè a quelle che stanno in immediato rapporto gene tico con l’operazione agricola del raccogliere e che inaugurano in tal modo un determinato importante filone di sviluppo dell’antica religiosità agraria. In particolare l’analisi risulta limitata, nella pre sente ricerca, all’orizzónte mitico della pianta coltivata, all’espe rienza del raccogliere come colpevole violenza recata ad un nume, al lamento funebre dopo il raccolto, alla istituzione del covone rituale e degli operatori simbolici, al sacrificio di vendetta, all’an ticipazione mitico-rituale del nuovo raccolto, al sacrificio di rin novamento e di rigenerazione. Il tentativo di rispondere in modo non superficiale al problema dei rapporti genetici che nel mondo antico legano le passioni vege tali e il pianto rituale all’episodio del raccolto deve innanzi tutto fare i conti con la possibilità di disporre di documenti sufficienti per la ricostruzione ierogenetica. Si tratterà quindi in primo luogo di allineare e ordinare i dati documentari superstiti, non certo con la pretesa di completezza, ma almeno quanto basti per saggiare su di essi il metodo ricostruttivo annunziato. Ora è da osservare che proprio per il suo carattere germinale il nesso fra passione e raccolto appare nella documentazione antica attestato in modo molto frammentario, occasionale e indiretto. In particolare tale nesso spesso si presenta a noi quando già il suo germe religiosamente produttivo ha dato luogo a processi ierogenetici in fase avan zata di sviluppo, sia per il confluire e l’intrecciarsi di altri nessi germinali estranei alla stessa religiosità agricola in senso stretto, sia per l’enuclearsi di complessi significati culturali. Così, per esem pio, la documentazione antica sul rapporto tra la passione di Dio niso e l ’operazione agricola della vendemmia e della preparazione del vino (spiccare il grappolo dal tralcio, pigiarlo nel tino, cuocere il vino per renderlo migliore e più soave) ci è giunta solo per entro
LA M E S S E D E L D O LO RE
225
la teogonia, l’antropologia e la soteriologia dell’orfismo, e quindi ad un livello ierogenetico che sta molto più in alto dell’esperienza dei πάθη των καρπών rivissuta nel corso dei lavori agricoli. Ciò signi fica che, in generale, ai fini della nostra ricerca i grandi complessi mitico-rituali di Osiride, Adone, Attis, Tamuz, Dioniso, Demetra serbano un valore documentario relativamente secondario, poiché essi sono giunti a noi a livelli così avanzati di sviluppo, e in un in treccio di valenze religiose così ricco di motivi e di temi, da consen tire solo con estrema difficoltà l’individuazione dei loro nessi ieroge netici con l’operazione agricola del raccolto: figure minori - come Lityerses, Maneros, Bormos, Linos - acquistano invece un valore documentario preminente, perché appaiono incluse in linee di svi luppo più brevi e più semplici, che si mantengono più prossime alla occasione esistenziale e che comunque la lasciano più pronta mente trasparire. Anche qui, senza dubbio, la documentazione pre senta il limite di fornirci solo tarde elaborazioni letterarie di leg gende e sparsi ragguagli mitografici: il che rende indispensabile il ricorso ai relitti folklorici euromediterranei. Fu questo il metodo che, come è noto, seguì il Frazer a proposito della leggenda di Lityerses: e noi ora dobbiamo ripercorrere questo corso espositivo del materiale, integrandolo con altri dati, e inquadrandolo nella nostra propria prospettiva di ricerca.
4. Raccolto e passione dei cereali Il lamento funebre durante la mietitura come documento della ideologia religiosa di una passione vegetale connessa con l’opera zione agricola in questione è largamente diffuso nel folklore euro mediterraneo. Riferisce il Dalman che quando in Palestina la mie titura volge al termine e si avvicina il momento in cui l’ultimo fascio di spighe cadrà sotto l’ultimo colpo di falce, cominciano a levarsi dalla squadra di mietitori brevi frasi, foggiate secondo moduli tra dizionali, che accennano alla morte del «vecchio del raccolto». Si dice: «Il vecchio è malato», «il vecchio è in agonia», e infine col cadere dell’ultimo fascio di spighe sotto l’ultimo colpo di falce: «Il vecchio è morto, Dio lo aiuti». L ’ultimo fascio viene poi inu
22Ó
C A P IT O L O S E S T O
mato sul campo, si recita il credo - come si fa per una persona morta - e si rende il lamento funebre. Le donne si abbandonano al consueto parossismo, si strappano le vesti e intonano la nenia, contesta anch’essa di moduli tradizionali, e riecheggiante i temi dei lamenti per persone storiche: «Tu, padre del contadino, dove te ne vai?» «M e sventurata, amara me, o mio fascio di spighe», e simili.13 Questo dato palestinese può valere come esempio tipico del legame fra mietitura e passione vegetale: il mietere è sperimen tato come violenza mortale recata ad un nume, ma al tempo stesso - con un comportamento che si sarebbe tentati di definire ipo crita - se ne piange cerimonialmente la morte come se non fosse stato il contadino stesso a procurarla mercé il gesto inesorabile com piuto con la falce messoria. Il tema del lamento funebre durante il raccolto tornerà frequentemente nel corso della nostra esplora zione documentaria: qui però dobbiamo fermare la nostra atten zione non tanto sul lamento come tale, quanto piuttosto sul fatto che esso sta in rapporto con un covone simbolico, anche qui come se non tutto il campo di messi ma soltanto tale covone concen trasse in sé passione e morte. In generale le costumanze folkloriche euromediterranee relative al covone rituale (quasi sempre l’ultimo, qualche volta il primo) sono caratterizzate - nell’ideologia e nel comportamento - da spiccate ambivalenze che formano altrettan ti problemi di ierogenesi. Per un verso l’ultimo covone mietuto sembra configurarsi con un nume che patisce violenza e che muore, 13 G . Dalman, Arbeit und Sitte in Palastina (1928) voi. 1, 2, pp. 574 sg. Sul pianto rituale connesso con l’ultimo colpo di falce e col cadere dell’ultimo fascio di spighe, conosciuto dalla Baviera, lungo il Reno, sino in Inghilterra e alla Svezia (Gotland e Varmland), cfr. W . Liungman, Traditìomtvanderungen Euphrat-Rbein, voi. 1 (Helsinki 1937) p. 2 6 1, con bibliografia rela tiva. Tracce di un lamento durante il raccolto sono del resto attestate nel folklore euromediter raneo più o meno ovunque, e a questo proposito potrei per conto mio aggiungere un altro dato. Nel corso delle ricerche sul lamento funebre lucano ebbi più volte occasione di chiedere attra verso quali vie il s a p e r p i a n g e r e fosse appreso e circolasse nella comunità. In generale mi fu risposto che il lamento è ascoltato sin da bambini durante i rituali funerari o nel giorno dei morti, viene ripetuto nei funerali fittizi dei giuochi infantili, e in tal modo, si fissa nella memoria culturale senza altro tirocinio. M i fu tuttavia segnalata anche un’ altra occasione di circolazione del lamento: l’ e p o c a d e l r a c c o l t o . Secondo alcune informatrici di Pisticci durante il raccolto delle ulive accade talora di ripetere per celia lamentazioni precedentemente udite in paese, e a San Giorgio Lucano un informatore contadino mi riferì che durante la mie titura qualche mietitore intona - sempre per celia - una nenia funebre, o addirittura piange per morto un altro mietitore che lavora nel campo. E questo certamente un dato molto tenue e generico, che mostra ormai il fenomeno culturale in piena disgregazione: ma nel quadro della documentazione fin’oggi raccolta dagli studiosi serba il suo valore.
L A M E S S E D E L D O LO RE
227
per un altro verso esso accenna a una forza vegetale che si con serva, o torna, o che deve essere rianimata, malgrado ed oltre l’ope razione agricola che ne interrompe bruscamente la vita con l’ine sorabilità del mietere e del legare. L ’ultimo covone è così la gerbe de la passion (Franca Contea), ma altrove appare invece come la Stockgarbe, la Grundgarbe (distretto di Coblenza; distretto di Trier), ovvero la Glùcksgarbe (distretto di Oppeln), che è quanto dire il «tronco», la «matrice» e la «prospettiva favorevole» del nuovo raccolto. Analogamente le denominazioni dell’ultimo covone accen nano ora al languire o addirittura all’estinguersi di una energia numinosa decrepita a cui sta per essere procurata la morte («il vec chio», «la vecchia», «la morta»), ora alla permanenza di una po tenza riproduttrice inesauribile («la madre»), ora alla epifania di una forza giovanile immacolata («la vergine»), pronta a nozze fe conde («la sposa»). In rapporto all’emergere dell’una o dell’altra valenza il comportamento verso l’ultimo covone è ambiguo: esso viene inumato, bruciato, compianto ritualmente, sottratto al con sumo, serbato nella fattoria sino al prossimo raccolto, rianimato mediante aspersione, gettato in acqua. Caratteristico è il legamento di una persona nell’ultimo covone mietuto: questa persona è scelta con criteri tradizionalizzati in ciascun ambiente, e cioè si tratterà o del contadino (o della contadina) che ha falciato - o legato l’ultimo covone, o di uno straniero che si trova a passare vicino al campo, o del padrone, o del fattore. Il trattamento a cui viene sottoposta la persona legata nel covone partecipa della già notata ambivalenza: ora infatti essa deve subire forme più o meno atte nuate di violenza (minacce di morte, scherni, motteggi), ed ora invece sarà trattata con molti riguardi. Infine nell’ultimo covone appare l’animale del raccolto (lupo, cane, gallo, capro, toro, vacca, bue, cavallo, porco, uccello ecc.), il quale per un verso sembra talora identificarsi col nume del grano, e per l’altro verso con chi è legato nel covone rituale. In rapporto con l’ideologia dell’animale del rac colto (che si accompagna in dati casi all’immolazione sul campo di reali vittime animali) la mietitura assume talora l’andamento di una ambigua battuta di caccia dell’animale stesso, che è imma ginato nascosto nelle messi e come fuggente davanti ai mietitori che avanzano, finché è catturato, o ucciso e snidato nel suo estremo
228
C A P IT O L O S E S T O
rifugio dell’ultimo covone. Questi dati sono ben noti:14 converrà tuttavia soffermarsi, ai fini dell’analisi ierogenetica che sarà con dotta più innanzi, sulle espressioni impiegate dalla gente di cam pagna per indicare il rapporto fra l’animale e il campo di messi. Questo rapporto si manifesta elettivamente in determinati momenti, e cioè quando il vento piega le messi e le fa ondeggiare, o quando durante il raccolto il mietitore si mostra ammalato o affa ticato o neghittoso o si ferisce con la falce, ovvero quando è mie tuto l’ultimo covone. Quando le messi ondeggiano sotto il soffio del vento è «il lupo (o il cane o la volpe o il cavallo o il toro) che attraversa il grano» o che «corre nel campo», oppure sono «i capri che si inseguono». Quando il mietitore si ammala, o è affaticato o neghittoso, oppure si ferisce con la falce, si dice che «il cavallo bianco gli passa vicino», «ha la cagna bianca», «la cagna bianca 10 ha morso», «il capro del raccolto lo ha urtato», «la vacca lo ha ferito »: in generale i mietitori evitano di essere urtati, durante 11 raccolto, dal demoniaco animale dei cereali, poiché ciò avrebbe conseguenze nefaste. Quando si avvicina il momento della mieti tura dell’ultimo covone si ammonisce: «Guardati dal lupo», oppure si dice: «Stiamo per uccidere il cane», «vogliamo cacciare il lupo (fuori del campo) »; e quando infine è mietuto l’ultimo covone chi 10 miete grida «toro, toro!», oppure si dice che il mietitore «ha» l’animale dei cereali. Questo «avere» si tramuta però in un «diven tare», poiché chi «ha» l’animale dei cereali lo diventa, e la meta morfosi avviene a tal punto che l’ultimo mietitore assume il com portamento dell’animale dei cereali: se l’animale è un lupo, il mietitore morderà e ululerà come un lupo, se è un gallo imiterà 11 canto del gallo, se è gallina farà il verso della chioccia e gli si darà grano da beccare.15 Come si è detto, il Frazer mise in rapporto questi dati del folk lore euromediterraneo con un gruppo di leggende che, per la loro affinità, formano un tipo omogeneo e ben caratterizzato, le leg 14 Data la loro notorietà non se ne citano qui partitamente i luoghi relativi nelle opere del Frazer e del Liungman. Si veda, in generale, Frazer, Spiriti o f thè Corri and o f thè Wild, voi. 5 del Golden Bough ai luoghi indicati nell’indice analitico sotto i vocaboli «corn spirits », «harvest», « reapers» e «sheaf (last sheaf)», e Liungman, op. cìt., voi. i , ai luoghi indicati nell’indice sotto i vocaboli «Einbinden», «Erntetiere», «G arbe (rituelle Garbe)», «Totenklage»: in particolare per le espressioni locali «G erbe de la passion», «Stockgarbe», «Grundgarbe», «Gliicksgarbe», cfr. Mannhardt, Wald~ und Feldkulte (1904) voi. 1, pp. 2 13 sg. 15 Frazer, op. cit., 1, pp. 270 sgg.
LA M E S S E D E L D O LO RE
229
gende di tipo Lityerses. Secondo quanto si ricava dal dramma sati resco di Sositeo di Mileto Δάφνις ή Λιτυέρσης,16 Lityerses - figlio illegittimo di Mida, re di Celene in Frigia, sarebbe stato un valente mietitore che soleva costringere a mietere a gara con lui gli stra nieri che si trovavano occasionalmente a passare presso il campo. Lo straniero, che risultava sempre soccombente, era legato in un covone e decapitato. Sopravvenne una volta Eracle, che vinse la gara, decapitò Lityerses, e ne gettò la testa recisa nel fiume Mean dro. Dalla narrazione di Sositeo dipendono largamente gli accenni posteriori, che tuttavia vi aggiungono qualche dato interessante: così apprendiamo che Lityerses infieriva a quel modo sugli stra nieri «per ottenere un ricco raccolto»,17 e col nome di lityerses si indicava anche un «canto di mietitori»,18 eseguito col flauto,19 o «un canto di contadini» simile al maneros degli egiziani e al borimos dei maryandini.20 Che questo canto fosse un lamento funebre è attestato da Polluce che parla di un threnos cantato per le aie al tem po della mietitura, a consolazione di re M ida:21 la corrispondente designazione di ferale canneti si ritrova in Servio, il quale però atteg gia la narrazione in modo abbastanza diverso, ricollegando Lityerses - che non sarebbe figlio di Mida, ma re egli stesso - con la leg genda di Dafni e di Pimplea: Dafni cerca Pimplea rapita dai pre doni, e la ritrova alla corte di Lityerses, dove però corre il rischio, come straniero, di sottostare alla dura legge della gara letale; ma Eracle ha pietà di Dafni, si reca sul posto e decapita con la falce messoria il re assopito dal ferale carmen della mietitura.22 Infine secondo una tradizione accolta da Polluce, tutta la vicenda sembra ridursi a gare fra mietitori, nelle quali Lityerses riusciva sempre vittorioso, e flagellava i soccombenti: finché una volta fu sconfitto da un mietitore più valoroso, che alcuni pensano fosse Eracle, e a sua volta patì la morte. Nella redazione di Polluce si fa anche cenno a Lityerses come inventore dell’agricoltura presso i Frigi, al pari di Maneros presso gli Egiziani: sembra invece pas16 T .G .F .2, 821 sgg. Cfr. Athen. io , 4 i5 b . 17 Questo particolare si trova anche in schol. Theocr. io , 42. 18 Athen. 14 , 6 i9 a; cfr. Hesych., s. v. λιτυέρσας; Suida, s. v. λιτυέρσης. 19 Suida, l. c. 20 Poli. 4, -
54
21 ì h ì à .
22 Serv., in Verg. Bue. 8, 68.
C A P IT O L O S E S T O
23 0
sare in secondo piano il tema della gara con uno straniero che si trovasse a passare presso il campo, e della identificazione di que sto straniero con Eracle.23 Il combinarsi di tali elementi nella tradizione leggendaria lette rariamente elaborata non concerne soltanto Lityerses, ma anche altre figure mitiche affini, di cui Lityerses può essere assunto come tipo. Così si raccontava di un Bormos (Borimos) presso i maryandini di Bitinia, figlio di re24 ovvero guardiano dei mietitori,25 il quale si recò a prender acqua per i mietitori assetati e non fece più ritorno, «rapito dalle ninfe»,26 onde poi fu cercato e compian to dagli abitanti di quella regione, e bormos fu chiamato il lamento funebre simile al maneros degli Egiziani27 e al lityerses dei Frigi.28 Gli elementi della discendenza regia, della morte violenta, della connessione con la mietitura e della identità fra nome dell’eroe e nome del lamento funebre si ritrovano nell’egiziano Maneros, che Erodoto dice essere figlio del primo re d ’Egitto, e assimila bile al fenicio Lino: la sua morte immatura era lamentata con un threnos chiamato con lo stesso nome, che sarebbe stato il primo e unico canto degli Egiziani.29 Plutarco ci ha conservato anche la tradizione della identificazione di Maneros con quel Diktys, figlio adottivo di Iside, il quale - secondo una tradizione - sarebbe peri to affogando nel Nilo mentre si accingeva a strappare dal suolo una cipolla:30 dunque ancora una volta una morte violenta in acqua 23 Poli., I. c. Per la figura, probabilmente analoga, di Hylas cfr. P. Kretschmer, Lityerses und Hylas, G ioita, voi. 14, 33 sgg. (1925). 24 Athen. 14 , 6i9Ì-62oa.
23 Poli.,
I. c.
26 Hesych., s. v. βώρμον.
27 Athen.,
LA M E S S E D EL D O LO RE
231
in connessione con l’operazione del raccolto, per quanto non si tratti qui di cereali, ma di cipolle, e quindi di una passione vege tale che rinvia ad un ordine alimentare di tipo inferiore, in rap porto al quale i numi dell’ordine cerealicolo manifestano superio rità o esecrazione, oppure un rapporto di adozione.31 Dalle leggende di tipo Lityerses, e col sussidio dei dati folklorici euromediterranei, si ricava dunque almeno la probabilità che in un’area che si estende dall’Egitto (Maneros) sino all’Asia Minore (Lityerses, Bormos) sussisteva una forma ben caratterizzata del nesso fra mietitura dei cereali e passione vegetale: venivano ese guite gare fra i mietitori al fine di sottrarsi alla mietitura dell’ul timo covone, ed il soccombente - dopo essere stato legato nell’ul timo covone - veniva sottoposto ad un trattamento violento (de capitazione con la falce, flagellazione, lancio in acqua). La vittima poteva però essere scelta in uno straniero che si trovava a passare fuori del campo, oppure nel guardiano del raccolto, e simili. L ’ul timo covone, o la vittima che lo rappresentava, era compianto ceri monialmente, e il nome della vittima coincideva con quello del canto funebre della mietitura. Spesso colui che subiva la passione vege tale era di discendenza regia, o re egli stesso. Vediamo ora quali altri riscontri importanti si possono reperire nella documentazione antica in rapporto alla ideologia del covone rituale. L ’analisi ulteriore delle testimonianze può essere iniziata con un passo di Plutarco in cui viene riportata l’affermazione di Cleante secondo cui Persefone è un πνεύμα che erra per le messi ed è messo a morte. Sempre nello stesso passo Plutarco ricorda il verso di un poeta che raffigura i mietitori in atto di smembrare D e m e t r a.32 Secondo una testimonianza di Semos più manipoli
I. c.; Poli., I. c.
28 Hesych., s. v. Μαριανδυνός θρήνος. 29 Herod. 2, 79. C fr. Paus. 9, 29.7. Anche Suida considera Maneros come il nome di un canto, dello stesso tipo di quelli indicati coi nomi άνιακκάς e Μεριμανώς (corru2Ìone di Μανερώς?) (Suida, s. v. άνιακκάς). 30 Plut., de Is., 8 e 17 . Un’altra tradizione riferita da Plutarco {de Is., 17) si allontana sensi bilmente da questa cerchia di connessioni, per quanto resti sempre nella sfera della religiosità agraria: secondo tale tradizione maneros sarebbe stato « il simulacro di un morto in una cassa », simulacro che veniva mostrato e portato in giro durante i banchetti come invito a dar fondo alle provviste in vista del fatto che tutti sarebbero diventati come quel simulacro. Al tempo stesso maneros avrebbe avuto il significato di «buon prò ti faccia» o «salute!» (cap. 17). Lasciando da parte questa interpretazione che nella tradizione antica appare del tutto isolata, il trasporto del simulacro di un morto ben si accorda con la religiosità osiriana e ricorda fra l’altro ciò che avve niva durante le feste di Adone, quando le donne «solevano trasportare simulacri come di morti, e imitavano i funerali, percuotendosi il petto e cantando lamenti funebri» (Plut., Ale. 18).
31 Su Maneros cfr. Hopfner, Plutarch uberlsis und Osiris (1940) pp. 72 sgg.; e Lichtheim, J . near east. Stud., voi. 4, 180 (1945). Per Diktys cfr. Hopfner, l c. 32 Plut., de Is., 66: «Περσεφόνεν δέ φηοί πον Κλεάνθης το διά τών καρπών φεφερόμενον καί φονευόμενον πνεύμα. Ποιητής δε τις έπι τών θερίζόντων: Τήμος 8τ’ αιζηοί Δημήτερα κωλοτομεΰσιν». Μ . Nilsson, Symbolique astrale et mystique dans certains cultes publiques grecs, Hommages à J. Bidez et F. Cumont, collez. Latomus, voi. 2 (1949) p. 225, tende a interpretare il verso ripor tato da Plutarco come una semplice metafora, in tutto simile all’uso omerico di chiamare Hefesto il fuoco e Afrodite l’amore: qui perciò Demetra starebbe - secondo il Nilsson - per «grano». Quanto poco questa interpretazione sia pertinente il lettore può giudicarlo da sé. L ’esperienza religiosa delle passioni vegetali ha lasciato traccia di sé in un gran numero di metafore letterarie in parte ancora vive nel nostro uso linguistico (per esempio nella espressione «mie tuto dalla falce della morte» e nella figurazione tradizionale della morte armata di «falce») il che non toglie che, in determinati casi, tali metafore possano essere utilizzate come docu mento dell’esperienza religiosa da cui originariamente ebbero alimento.
232
C A P IT O L O S E S T O
di orzo legati insieme venivano chiamati δυλοι ο ίούλοι, ma Ίουλώ era anche un appellativo di Demetra, e δυλοι ο Εούλοι ο Δημήτρουλοι era il nome dei lamenti rituali relativi.33 Qui noi ritroviamo chiaramente espressa nel giuoco semantico di uno stesso vocabolo, la connessione fra orizzonte mitico delle messi, mietitura come pas sione vegetale, ritualità di un covone particolare e lamentazione funebre. Questa connessione doveva essere così familiare ai Greci da alimentare immagini e metafore dominate dal tema di una mie titura che è doloroso affanno e punizione di una colpa. Così alle parole di Clitennestra n ell’Agamennone: «Fin troppa ne abbiamo mietuta di messe del dolore» (άλλα καί ταδ’έξαμήσαι πολλά δύστηνον θέρος),34 fanno eco quelle di Dario nei Persiani: « Ε ’ΰβρις, giunta alla fioritura, ha dato come frutto la spiga della colpa e della puni zione, donde ne venne messe di infiniti pianti» (υβρις γάρ έξανθουσ’ έκάρπωσε στάχυν ατης, οθεν πάγκλαυτον έξαμά θέρος).35 Ora il tema di un δύστηνον ο πάγκλαυτον θέρος, cioè di una messe del dolore e delle lacrime, acquista la sua piena pregnanza metaforica in virtù dei lontani echi di religiosità agraria che esso risvegliava nel cuore dell’uomo greco: in particolare il riferimento di Dario ad una υβρις che mette capo ad una spiga della colpa e della punizione, e quindi al pianto senza fine, raggiunge il suo pathos poetico in virtù della reale esperienza religiosa nel corso della mietitura dei cereali, quando veniva vissuta sul campo di messi la υβρις del mietere, sino al momento culminante in cui cadeva sotto la falce messoria l’ul timo covone (ίούλος), ed insorgevano dal campo e si diffondevano nell’ardore della luminosa estate mediterranea i pianti cerimoniali a lungo protratti (ίούλοι). Il primo covone come covone rituale è esplicitamente attestato per gli Egiziani da Diodoro Siculo: i mietitori deposte al suolo le spighe «per prime tagliate» si abbandonano al compianto presso il covone, battendosi il petto ed invocando Iside.36 In una raffi gurazione sepolcrale della tomba di Ti (quinta dinastia) i mietitori 33 Semos, ap. Athen. 14 , 6 i8 d (F .H .G . 4, 495): « T à δράγματα τών κριθών αυτά καθ’αύτά προσηγόρευον άμάλας συναθροισθένθα hi καί έκ πολλών μίαν γενόμενα δέσμην ουλος καί ίούλους καί τήν Δήμητρα ότε μέν χλόην, ότέ δέ Ίουλώ». 34 Esch., Pers., 822. 35 Esch., Agamen., 16 5 5 . 36 Diod. Sic. 1 , 14 , 2: «έτι γάρ καί νυν κατά τον θερισμόν τους πρώτους άμηθέωτας στάχυς θένθας τούς άνθρώπους κόπτεσθαι πλησίον του δράγματος καί τήν νΙσιν άνακαλεσθαι».
L A M E S S E D EL D O LO RE
233
dànno inizio alla mietitura di un campo di messi, mentre un suo natore di flauto leva dal suo strumento il lamento rituale, e un cantore accompagna la musica col canto:37 il che ricorda il tracio σιτάλκας (da σίτος = frumento e dal tracio άλκας —flauto),38 che dovette essere appunto un canto della passione del grano durante la mietitura. D ’altra parte numerose indicazioni parlano a favore della ritualità di un particolare covone nella sfera della religiosità agraria egiziana. Spetta ad Alessandro Moret il merito di aver richiamato l’attenzione su un episodio rustico della festa della mie titura conservato in alcune màstabe del Regno Antico, dove fra le offerte dei campi recate al defunto figurano alcuni particolari simulacri che, in dati casi, evocano la forma del covone di lino. Questi simulacri, trascinati su appositi traini, portano il nome di mert stat che Moret interpreta come «l’amata che è trascinata», ponendo l’oggetto in rapporto con il tipo com-maiden del folklore europeo. Il Moret non esita a porre in rapporto il simulacro in que stione con la personificazione dello spirito del grano che si nasconde nel primo o nell’ultimo covone del campo mietuto.39 Inoltre la va37 Moret, La mise à mori du Dieu en Egypte (Parigi 1927) p. 2 1 e fig. 2. V i sono indica zioni a favore di un lamento rituale anche durante la semina autunnale nell’ antico Egitto. Una formula ritrovata su una stele di epoca saitica, ma di redazione antica, prega i passanti di non dimenticare la memoria di Osiride morto, ricordando loro la semina rituale: «Non avete visto il pastore del bestiame, quando cammina? Egli ha trovato una canna sul suo cammino: egli lamenta, nella sua gola, colui per il quale gli uomini scavano la terra (kbebes tà), colui che gli dèi daranno alla luce quando gli uomini hanno cessato di lavorare (di arare?)» Plut., de Is., 70 (cfr. Moret, op. cit,, pp. 26 sg., n. 5) mostra di stupirsi che gli Egiziani - al pari dei G re ci - agissero nel momento della semina «come coloro che inumano i loro morti», e Finnico Materno (de en. prof, rei 2, 7) chiede rivolto agli Egiziani perché essi piangano i semi che cre scono. Cfr. Moret, op. cit., pp. 32 sgg., dove è riportato anche un supposto lamento funebre della semina, che corrisponderebbe al lamento per le prime spighe tagliate cui accenna Dio doro Siculo e che sarebbe raffigurato nella tomba dì Ti. 38 Senoph., Anab. 6, 1.6. Cfr. R. Eisler, Orphìsch-dionysìsche Mysterìengedanken in derchristlicben Antike, p. 240, n. 2. Nel passo di Senofonte si tratta di una serie di manifestazioni agonistiche eseguite in occasione dell’incontro fra i Greci e gli ambasciatori dei Paflagoni: que sti ultimi eseguono armati una gara il cui vincitore cantava il sitalca. A favore dell’originario significato agrario di tali esibizioni testimonia, oltre l’etimologia di σιτάλκας, anche il fatto che, subito dopo i Paflagoni, gli Ananiesi e i Magneti eseguono una rappresentazione mimica detta καρπαία, visibilmente in rapporto con l’aratura e con la semina, per quanto il suo senso sia tutt’altro che chiaro. Il ben noto carattere agonistico delle cosiddette feste agrarie e stagionali sembra investire qualsiasi operazione eseguita sul prodotto cerealicolo. Athen. 12 , 5 i8 b atte sta che gli Etruschi «impastano il pane, fanno al pugilato ed eseguono la flagellazione al suono del flauto»: dove rimpastare il pane, in quanto momento della passione del grano, racchiude un elemento agonistico o di violenza da accompagnare col lamento del flauto. Eisler, op. cit., I. c., ricorda un gruppo beota di terracotta proveniente da Tebe, in stile arcaico, ora al Louvre, che riproduce una scena di impastatrici di pane accompagnate dal flauto. 39 Moret, op. cit., p. 29.
234
C A P IT O L O S E S T O
LA M E S S E D EL D O LO RE
235
lenza «covone rituale» palesa innegabilmente la sua presenza nella ierogenesi di quel complesso simbolo che è la colonna Ded. Walter Liungman, che ha particolarmente insistito su tale valen za, ha sottolineato in proposito alcune interessanti connessioni. Due colonne di ceramica della terza dinastia venute alla luce durante gli scavi di Sakkàra mostrano di essere formate da canne di papiro messe in fascio e legate: le canne verso la sommità della colonnacovone si allargano in spighe, e precisamente in modo da dare l’im magine di una quadruplice serie di capitelli sovrapposti, il che ricorda figurativamente la colonna Ded. In aggiunta a ciò, alcune tarde raffigurazioni della colonna Ded palesano nel loro interno una figura umana dissimulata, o addirittura una testa che sporge dalla quadruplice serie di «capitelli» (la figura umana rappresenta ordi nariamente Osiride): ora questo simulacro rinvia alla pratica del legamento di un uomo nel covone rituale.40 Il Liungman ritiene pertanto di poter individuare un primo grado di sviluppo della reli giosità agraria egiziana, risalente ai tempi in cui l’Egitto era ancora un terreno in gran parte paludoso ed il papiro forniva il materiale più importante per il vestiario e per la costruzione e al tempo stesso costituiva, insieme al fiore di loto, una base alimentare: in questo periodo - precerealicolo e preosiriano - durante il raccolto del papiro un uomo veniva legato in un covone, decapitato e gettato in acqua. Dalla pianta del papiro la pratica sarebbe poi passata ai cereali, inaugurando così la fase decisamente osiriana. A l termine del raccolto, cioè a metà maggio, si prendeva un uomo, lo si legava in un covone o in una colonna-covone, lo si batteva a morte e lo si decapitava, lo si aspergeva di acqua o lo si gettava in acqua, oppure lo si inumava. Alla sommità della «colonna» fu posto un ramo verde simboleggiante Osiride. Scene di cordoglio, lamenta zioni funerarie e agoni rituali accompagnavano la morte del nume. Sul piano simbolico l’uomo legato nel covone fu gradualmente iden tificato ad Osiride, chi gli recava violenza battendolo o decapi tandolo o affogandolo o inumandolo era assimilato a Set, simbolo della siccità, e ci si vendicava di lui sacrificando a sua volta un animale del seguito di Set, per esempio un capro, un’oca, un maiale,
un asino ecc.41 In che misura siano validi tutti i particolari di que sta interpretazione largamente ipotetica lasceremo qui indeciso: da essa tuttavia ci sembra che si possa almeno ricavare che la co lonna Ded, oltre ad essere simbolo della stabilità del potere regio, accenni ad una valenza più propriamente agraria, e cioè alla pra tica del covone rituale durante il raccolto dei cereali.42 Una lamentazione rituale al momento del raccolto è ricavabile anche dai dati mesopotamici, secondo le indicazioni di A. Leo Op penheim. I testi babilonesi e assiri del primo millennio accennano sporadicamente ad un’attività specifica ed importante dell’agricol tore con la frase sasu alala. Generalmente questa frase è stata inter pretata come dell’aratore che leva il grido di giubilo nel campo, o come da riferirsi ai canti di gioia che i contadini cantano al tempo del raccolto. Ma l’Oppenheim respinge tale interpretazione per ché sasu non significa mai «cantare», e ancor meno cantare per esprimere gioia: questo verbo, quando detto di persone, indica esclusivamente espressione di suoni diversi dal comune parlare, come il parlare in lingue straniere, la salmodia del banditore citta dino, la caratteristica cadenza di chi si lamenta in tribunale, ed infine il modo particolare con cui dovevano essere pronunziate le lamentazioni rituali (sigu). Inoltre alalu non significa grido di giu bilo, ma è da considerare un termine tecnico per indicare un par ticolare canto rituale accompagnato da flauto. D ’altra parte alalu appare in connessione con Alala, e la sua sposa (cioè la «dea pian gente Belili»), la sorella di Tamùz: Alala è dunque un nume ctonico appartenente alla cerchia di Tamùz, o addirittura è una diretta manifestazione di questo stesso dio. A conferma di tale interpre tazione in un frammento mitologico incluso in due scongiuri della serie Maqlu, Samuqan, divinità protettrice del bestiame, appare negli inferi in atto di suonare sul flauto la melodia alalu, ed il suo canto sembra stare in connessione col taglio dei rami di tamari sco. Da questi dati ΓOppenheim ritiene di poter concludere che alalu indichi «il lamento funebre cantato per il nume morto sotto la falce del mietitore», e che la connessione fra raccolto e lamento era in Mesopotamia così stretta, e costituiva un elemento così
40 Liungman, op. cit., voi. i , pp. 1 12 sgg. e £igg. 16, 24, 25 e 26. L ’affinità di forma tra i co voni di lino rappresentati in una scena del raccolto di questo vegetale, la stai in quanto covone rituale, e la colonna Ded, è stata sottolineata dal Moret, op. cit., pp. 24 sgg. e figg. 6, 9 e io.
41 Liungman, op. cit., pp. 128-35. 42 Questa valenza domina per esempio l’ erezione cerimoniale della colonna in occasione del trentesimo anno di regno di Amenhotep III. Cfr. Liungman, op. cit., p. 1 1 7.
236
C A P IT O L O S E S T O
importante di questa operazione agricola, che testi storici e docu menti politici potevano impiegare la frase sasu alala per riferirsi con espressione letteraria al raccolto dei cereali. Questo lamento funebre del raccolto ha il suo orizzonte mitico nella passione vege tale di Alala: qui si palesa una connessione fra ritornello emotivo del pianto rituale e nome della divinità scomparsa e invocata che ha riscontri numerosi in tutta la religiosità agraria mediterranea.43 Con questo riferimento mesopotamico possiamo considerare suf ficiente ai nostri fini la documentazione del nesso fra raccolto e passione dei cereali nel mondo antico. Come già abbiamo detto non rientra nella prospettiva del nostro lavoro la ricerca dello stesso nesso nelle grandi figure mitiche ricche di valenze cerealicole, come Tamuz, Osiride e Demetra. La ricerca sarebbe tuttavia interes sante anche se resa particolarmente difficile dalla complessità degli sviluppi religiosi in cui quelle figure appaiono incluse, e per la povertà dei dati documentari utili all’individuazione del contri buto genetico che, in ciascuna di esse, spetta al momento critico della mietitura. Tamuz, per esempio, nume che «da adulto vive immerso nel grano»44 e che scompare con le spighe per discen dere agli inferi, palesa un molto probabile rapporto con l’opera zione agricola della mietitura: il Moret non esita addirittura ad affermare che le lamentazioni che gli erano destinate «ci conser vano l’esempio più antico che si conosca del lamento funebre della messe, chiamato Maneros in Egitto e Linos in Fenicia, a Cipro ed in Grecia».45 Allo stesso rapporto accenna Attis nella sua valenza di «giovane spiga mietuta»,46 per tacere della famosa rivelazione dei misteri eleusini.47 Quanto alla complessa figura di Adone una serie di dati accennano alle sue feste estive, e quindi alla maturazio 43 A . L. Oppenheim, Bull. amer. Schools orient. Res., voi. 10 3 , 1 1 - 1 4 (1946). Nel poema di B a’al si trova inserito un episodio che è stato considerato come «il più antico esempio di rituale agrario dell’ultimo covone» da R . Dessaud, Les religioni des Hittites et dei Hurrites, dei Phéniciens et des Syriens (1949) p. 37 3 ; e cioè l’uccisione del nume della siccità M òt da parte di ’Anat: torneremo più oltre su questo punto (cfr. pp. 255 sg.). Per un altro probabile accenno al covone rituale nei testi cananei (Poema di Aqhat) vedi Gaster, op. cit., pp. 297 sg. 44 C. Frank, Kultlieder aus dem Ischtar-Tamùz-Kreis (1939) p. 67. 45 A . M oret, Rituels agraires de Vancien Orient à la lumière des nouveaux textes de Ras Shamra, Ann. Inst. Philol. Hist., voi. 3, 328 (1935). 46 Hyppol., Refut. omnium haeres. 5, 8. 47 Sul rapporto uomo-grano cfr. R .B . Onians, The Origin o f Europea» Throught (19 51) pp. 1 1 3 sg. C fr. Athen. 14 , 6i9b.
LA M E S S E D EL D O LO RE
237
ne dei frutti,48 mentre non mancano riferimenti espliciti, per quan to tardi, che fanno del nume «simbolo del raccolto dei frutti giunti a maturità»49 e che interpretano la sua morte violenta sbranato da un cinghiale come simbolo della violenza patita durante il raccolto.50
5. Raccolto e passione del lino Il canto Lino, secondo quel che ne dice Erodoto, era un canto di mietitori: si cantava, oltre che in Grecia, in Fenicia, a Cipro e altrove, ricevendo nome diverso presso altri popoli, e - in par ticolare - il nome di maneros presso gli Egiziani.51 La connessione con Maneros - confermata da Pausania52 - accenna a quella sfera mitico-rituale che abbiamo indicata con la denominazione tipolo gica di «Lityerses»: e del resto il linos e il lìtyerses come canti rustici sono una volta ricordati insieme.53 Erodoto è il solo ad accennare ad un canto di mietitori, e quindi al raccolto dei cereali, mentre nella famosa descrizione omerica il canto appare inquadrato in uno scenario di vendemmia: nella vigna luminosa, onusta di bei grap poli neri e puntellata di scale, giovinetti e giovinette, la mente occu pata da teneri pensieri, recano al tino panieri intrecciati colmi del dolce frutto, nel mezzo sta un cantore giovinetto che intona il καλόν λίνον al suono del liuto, e i vendemmiatori che pigiano l’uva lo accompagnano battendo i piedi a cadenza e levando a modo di ritor nello il grido ιού, ιού!54 Infine una terza tradizione considera Vailinos come canto di tessitori,55 e pone in rapporto il nome «lino» non già la persona mitica di Lino, ma col lino come pianta.56 In 48 Prax., fr. 2B; Tucid. 6, 30; Theocr., ìdìU. 15 . C fr. G . Glotz, Les fètes d ’Adonis sous Ptolomée II, Rev. Etudes grecques (19 2 1) pp. 169 sg. 49 Eus., Praep. Evang. 3, 1 1 - 1 2 (Mras, p. 13 7 , 9-13). Cfr. 3, 17 -18 (Mras, p. 138 , 13-14). 50 Amm. M arc., Hist., 22, 9 .15 . Cfr. 19, 1. 51 Erod. 2, 79. 52 Paus. 9, 29.7. 53 Poli. 1, 38: «λίνος καί λιτυέρσης σκαπανέων φδαί καί γεωργών». 54 IL, 18, 569 sgg. Diod. Sic. 3, 67.4 ricorda un canto di Lino in «scrittura pelasgica» concernente la passione di Dioniso, e d ’altra parte Schol. Clem. A lex., Protrept. (p. 297 Stàhlin), ad Protr. 2, 34 (Syllburg, pp. 10-25; Pott, p. 30) parla di «un rustico canto relativo allo smembramento di Dioniso, cantato durante la vendemmia». 55 Epicharm., ap. Athen. 14 , io .6 i8 d : «ή δε των ίστουργών ωδή αΐλινος». 56 Eusthat., ad II. 2, 1 1 6 3 : «ή μέντοι Ιξ Ηπιχάρμου κρήσις έθέλουσα τον αΐλινον ωδήν ιστουργούντων είναι, ού τον Αίνον το κύριον [cioè come nome proprio] κείσδαι, άλλα το λίνον».
2j8
C A P IT O L O S E S T O
Omero non vi è traccia di un mito di Lino, per quanto si tratti di un lamento per la passione della vite: per la prima volta in un frammento di Esiodo Lino si configura come personaggio mitico, il cui nome è chiamato all’inizio e alla fine dei threnoi cantati nei banchetti e nei cori.57 Il duplice significato di semplice ritornello emotivo e di eroe mitizzato si mantiene lungo tutto il corso della tradizione antica: così in Pindaro e nei tragici al' λίνον torna fre quentemente come grido di lamento o come forma particolare di threnos - senza poter sempre decidere se si debba intendere nel l’uno o nell’altro senso,58 mentre un’altra serie di dati accenna a Lino come eroe mitico discendente da Apollo,59 o da Hermes,60 o da una delle muse,61 maestro di Eracle,62 del quale si narrava la morte violenta, variamente avvenuta secondo le diverse tradizioni: per opera di Eracle,63 oppure colpito dalle frecce di Apollo,64 oppure sbranato dai cani da pastore, onde nella festa άρνίς ο άρνηίδαι celebrata in Argo si uccidevano tutti i cani che si incontrassero per via.65 Sul rapporto di Lino con l’Oriente la tradizione antica è del pari incerta: Erodoto accenna alla Fenicia e a Cipro,66 men tre per Pausania «il lutto per la morte di Lino giunse anche alle genti barbare»:67 però lo stesso Pausania quando ricorda che Saffo «compose canti nei quali erano insieme cantati Adone e Lino »,68 fa di nuovo pensare implicitamente ad una connessione con la Fenicia. Alla Frigia invece sembra rinviare un passo dell’Oreste euripideo.69 57 Frg. 19 2 Rzach. 58 Cfr. per l’elenco e l’analisi dei luoghi relativi, O. Eissfeldt, Linos und Alijan, in «Mélanges syriens offerts à René Dussaud», voi. 1 (1939) pp. 164 sgg. 59 Apollod. 1 , 3.2. 60 Suida, 568. 61 Esiodo, /. c.\ Anth. Pai. 7, 6 16 ; Apollod., I. c.\ Suida, l. c. 62 Theocr. 24, 103; Athen. 164ID-C; Apollod. 2, 4.9; Diod. 3, 67. Per una raffigurazione in un vaso di Pistoxenos del quinto secolo a. C. vedi Roscher, M. L. 2, colonna 2059 sg. 63 Apollod. 1, 3.2 e 2, 4.9; Diod. 3, 66. 64 Suida, l. c.\ Schol. ad II. 18, 570 (Bekk, p. 5 1 3 , 26; Cramer, Anecd., voi. 3, 1890); Propert. 3, 4 (2, 13.4 ). C fr. Gruppe, Grìech. Myth. (1906) p. 968, n. 6. 65 Lino sbranato dai cani da pastore: Conon, 19 ; schol. ad II. 18 , 569; Callim., frg. 31 5; O vid., Ibis, 478. Sulla festa ’Αρνίς celebrata in Argo, Athen. 3 , 99; Conon, /. c.\ Clearco di Soloi, ap. Aelìan. bist. anitn. 12 , 34, 66 Herod., I. c. 67 Paus. 9, 29.7. 68 Paus. 9, 29.8. 69 Eur., Or., 139 3.
L A M E S S E D E L D O LO RE
239
Una tradizione così ricca di elementi contrastanti par fatta appo sta per esercitare l’acume interpretativo degli studiosi: ed infatti da circa cento anni l’enigmatica figura di Lino forma oggetto di dibattito. La tesi della derivazione orientale fu inaugurata dal Movers, che volle vedere in Lino una figura mitologica comune a Fenici, Egiziani e Greci, diffusasi dalla Fenicia insieme alle feste Adonie. Anche al Movers risale la interpretazione di al'λίνον come fraintendimento greco del fenicio ai lanu (= ahi noi!), ritornello emotivo di compianto nelle feste stagionali.70 La connessione fra αί λίνον e ai lanu è stata prevalentemente seguita sino ai nostri giorni, finché la scoperta dei testi di Ras Shamra ha offerto la pos sibilità di una nuova ipotesi, e cioè il rapporto fra Pai λίνον come lamento, Lino e Aliyan (Aliyan B a’al).71 Un’interpretazione for mulata dallo Eisler che collega il mito di Lino con la passione vege tale della pianta di lino è rimasta quasi senza seguito, ed invece proprio su di essa conviene soffermare qui la nostra attenzione. Senza dubbio i due tardi e isolati riferimenti antichi ad una pas sione del lino che starebbe alla base del mito di Linos sembrano a prima vista essere soltanto una maldestra esplicazione aitiologica. Tuttavia occorre in generale andar molto cauti nel respin gere come equivoci aitiologici i dati di una tradizione, anche se tardi e isolati nel complesso della tradizione stessa. Nel presente caso poi vi sono molteplici ragioni per osservare questa cautela. Plutarco intanto attesta per l’Egitto una passione della pianta di lino,72 e d’altra parte l’affinità figurativa tra la meri stat («l’ama ta» o «la cara che è trascinata») e i covoni di lino fu già messa in evidenza dal M oret:75 vien fatto di pensare ad una forma egi ziana del «caro» o «bello» lino, e quindi ad una vera e propria famiglia mediterranea di «passioni vegetali del lino». Se ora pas siamo alla documentazione folklorica restiamo sorpresi della larga diffusione della «passione del lino» presso i popoli germanici, bai70 Movers, Die Phòniziers (1841) voi. 1, pp. 244-61. Cfr. Brugsch, Die Adoniklage und das Linoslied (1852) pp. 16 sgg.; Baudissin, Adonis und Esmun (1 91 1 ) p. 360; art. Linos in «Roschers Mythologisches Lexicon» (1896-97) col. 2053-63, e in «Pauly-Wissowa Realenc. » voi. 13 (1926) pp. 71 5- 1 7. 71 R. Dussaud, La mythologìe phénicienne d'après les tablettes de Ras Shamra, Rev. Hist. Rei., voi. 104, 387 (19 31); e Eissfeldt, op. cìt., pp. 1 6 1 sgg. 72 Plut., de Is., 2 1. 73 Moret, op. cit.y p. 25; cfr. p. 26, figg. 5 e 6.
2^0
C A P IT O L O S E S T O
tici e slavi.74 Una fiaba di Andersen narra appunto la passione del lino: come il suo seme gettato nelle tenebre della terra dovrà farsi strada verso la luce del sole, come i suoi fiori stanno esposti al calore bruciante e alla pioggia, finché un giorno sopravviene gente perversa che afferra la povera pianta per i ciuffi, la strappa con le radici dal terreno, la annega nell’acqua in un martirio senza fine, la arrostisce al fuoco, la batte, la carda, la fila, la tesse, la taglia con le forbici, la punge e la ripunge con l’ago, e finalmente la cuce per farne una camicia. Nel folklore palestinese ritroviamo «il tor mento mediante il supplizio del filo nell’ago» in un lamento per il grappolo d’uva spiccato dal tralcio: il che si spiegherebbe, secondo 10 Eisler, con la trasposizione di un frammento della passione del lino in una passione della vite, e ciò sulla base della somiglianza del movimento della mano nel piluccare l’uva e nel cucire la tela, e per il comune tormento che l’uno e l’altro atto recano rispetti vamente alla vite e al lino.75 In questo quadro della passione del lino (a cui occorre aggiungere la passione di altri vegetali econo micamente utili, e soprattutto del grano e della vite), i due accenni che la tarda antichità ci ha lasciato circa un nesso fra il giovinetto Lino morto di morte violenta e il raccolto e la lavorazione della pianta di lino non possono essere considerati come un semplice arbitrio di immaginazione combinatoria. Piuttosto tale nesso va assunto come originario in rapporto al mondo storico mediterra neo che imparò a coltivare e a lavorare il lino, e gli altri dati discor danti della tradizione sono da interpretare come ulteriori sviluppi ierogenetici del nucleo germinale. E ciò che fece appunto lo Eisler, 11 quale ritenne che come il tracio σιτάλκας lamentava la passione del grano e la τρυγωδία quella della vite, così la λινωδία era origi nariamente la passione del lino:76 cioè una esperienza di religio sità agraria connessa con il raccolto (e la successiva lavorazione) della pianta. La passione del lino cantata all’epoca del raccolto fu trasposta al raccolto di altre piante, in particolare alla vendemmia (Omero) e alla mietitura (Erodoto) secondo motivazioni di cui la più sopra ricordata trasposizione palestinese potrebbe darci un’i dea. Che la passione del lino sia diventata il modello di altre pas 74 Bucher, Arbeit und Ritkmus (1896) pp. 81 sgg. 75 Eisler, op. cit., p. 275. 76 Ibìd., pp. 244 sgg. Per la τρυγωδία cfr. Aristoph., Acham., 496 sg., e Vespae, 650.
L A M E S S E D EL D O LO RE
241
sioni vegetali par adombrato nel fatto che Fozio indica λινός nel significato complessivo di οίνθος, o di narciso (ma Narciso è anche esso un nume compianto!)77 Infine secondo lo scoliaste dell O re ste euripideo «i barbari son soliti porre Γαΐλινος all’inizio di ogni lamento funebre»,78 ed anzi sembra che quella di Lino sia stata la passione più famosa inserita in ogni lamentazione,79 finché il canto in questione finì con lo staccarsi non solo dall’occasione del raccolto, ma anche da ogni occasione luttuosa, e per diventare infine la generica esclamazione di dolore dei cori delle tragedie. Analo ghi processi di distacco dalla situazione esistenziale di origine, con trasposizioni e generalizzazioni, costituiscono del resto un feno meno ben conosciuto e verificato nel folklore religioso e nella dina mica della circolazione dei canti popolari: solo che processi del genere non vanno intesi soltanto come svolgentisi nel tempo, secondo un ritmo orizzontale di apparizione e di scomparsa, ma anche nel senso verticale di ascesa e discesa secondo le classi sociali, e secondo il carattere delle singole civiltà religiose, di guisa che la connessione originaria fra il raccolto del lino e la passione vege tale di questa pianta si mantiene ininterrottamente da epoche lon tane sino all’attuale dispersione o disgregazione folklorica, men tre il mito di Lino ha una vita culturale molto più circoscritta, e segue nel mondo antico sue proprie linee di diffusione e di sviluppo. La connessione particolare fra Lino ed il momento critico del raccolto si ricava senza sforzo dalla tradizione, e innanzi tutto dalla descrizione omerica e dal passo di Erodoto, dove però siamo già di fronte ad una trasposizione del raccolto del lino alla vendem mia e alla mietitura. Altre particolarità del mito accennano all’e poca del raccolto, come il motivo agonistico e la morte violenta dell’eroe sotto i raggi cocenti del sole estivo, in piena canicola (le frecce di Apollo, lo sbranamento per opera dei cani). Torneremo più oltre su questo punto. Ciò che ora resta da esaminare più da vicino è la connessione fra il lino come pianta, αϊ λίνον come ritor77 Phot., Lex., 19 3 ; cfr. Eisler, op. cit., p. 246, n. 4. Del resto con analoga trasposizione il lamento οΰλον ουλον tet, ΐουλον tei valeva non solo per la passione dei cereali ma anche per quella del lino, poiché Athen. 14 , 6 i9 a ritiene che secondo alcuni si sarebbe trattato di un canto di tessitori. 78 Schol. Eur. O r., 19 35: «είώθασιν οί βάρβαροι τον αιΧινον έν άρχή ΰρήνου λέγειν». Cfr. Eisler, op. cit., p. 246, n. 3. 79 Conon, 19 ; cfr. Eisler, /. c.
242
C A P IT O L O S E S T O
nello emotivo di un th ren o s e Λίνος come mito. Questa polivalenza semantica è sostanzialmente affine a quella fra ίούλος come covone di grano, ίούλος come ritornello emotivo del lamento rituale che accompagnava la mietitura e Ίουλώ come dea e come appellativo di Demeter. Il rapporto semantico fra ritornello emotivo e nume offre del resto numerosi riscontri nel mondo antico: così a h yla gm o s corrisponde Hylas, il grido rituale ia c c h o s dà origine a Iaccos, il sumero a la la si ritrova in Alala come nume, e - ove si voglia ac cettare la vecchia ipotesi del Brugsch - l’egiziano m aa n p e r .k (tor na a casa!) si sarebbe tramutato in Maneros. Analoghi rapporti si è creduto di ravvisare in Abobas e Gingras soprannomi di Adone, e ancora in Ialemos e in Hymenaios, Papaios ed Euios, e così via.80
6.
R a c c o lt o e p a s s io n e d e lla v it e
Già vedemmo come il canto rituale originariamente impiegato per la passione del lino fosse trasposto nella vendemmia alla pas sione della vite. M a oltre la famosa descrizione omerica una th ren o d ia della vendemmia trova in Grecia altri accenni. Durante la festa attica delle O s c h o p h o r ia , che aveva luogo appunto all’epoca della vendemmia, risuonava il ritornello έλελεΰ «in segno di coster nazione e di affanno», secondo che dice Plutarco.81 Del resto un Dioniso-grappolo (βότρυς) è menzionato in un’iscrizione misterica di Alistrati (Tracia occidentale), dove appare rozzamente inciso un grappolo, e un affresco pompeiano raffigura Dioniso in forma di gigantesco grappolo, da cui escono testa braccia e piedi del nume:82 se si tien conto che il folklore della Bassa Austria conosce un grap polo rituale del genere, artificialmente preparato e chiamato W ein b e rg b o c k o W ein b erg g o a s (capro della vigna),83 non sembrerà senza fondamento la tesi, già avanzata dal Frazer e sviluppata poi dallo Eisler, della corrispondenza fra covone rituale della mietitura e 80 Per i dati bibliografici relativi cfr. Gaster, Thespis, pp. 12 -15 . Per Abobas, Gingras, Ialemos, Papaios, Euios cfr. G . Hoffmann, Aramàische Inschrìften aus Nerab bei Aleppo: neue und alte Gòtter, Zeitschrift fiir Assyriol. u. verw. Gebiete, voi. 1 1 , 228 sg. (1896). 81 Plut., Tbes., 22. 82 Eisler, op. cit., p. 227 e tav. xvn , fig. 104. 83 Ibid., I. c. e tav. xvm , fig. 105.
L A M E S S E D E L D O LO RE
24 3
grappolo rituale della vendemmia.84 D ’altra parte la tradizione orfica interpreta la passione di Dioniso sbranato dai titani, e la cottura delle sue membra, come lo spiccare gli acini dal grappolo, la cottura del vino, il tralcio calpestato nella pigiatura, il grappolo piangente e dolorante e quasi sanguinante,85 e uno scoliaste del Protreptico di Clemente parla di un «rustico canto relativo allo smembramento di Dioniso, cantato durante la vendemmia»:86 ora anche se si vuole ridurre il valore di questi dati - come fa il Jeanmaire87 - a una tarda esplicazione allegorica, resta il fatto che la stessa possibilità di una allegoria del genere affonda le sue radici nell’esperienza agraria della passione della vite al momento della vendemmia e degli altri lavori agricoli che concernono la produ zione del vino. Secondo il Jeanmaire è «perfettamente ammissi bile» - per quanto «senza testimonianza certa» - che le opera zioni della potatura e della pigiatura siano state avvertite «come una mutilazione o un supplizio inflitti allo spirito della vegetazio ne»:88 ora ci sembra che nel mondo antico le testimonianze a favore di una tale esperienza siano così numerose - sebbene indi rette - da fornire la pratica certezza del rapporto, e non soltanto la sua ipotetica ammissibilità. Lasciando da parte l’oscura leggenda del lidio Syleo - nella quale alcuni elementi della leggenda di Lityerses sembrano trasferiti alle operazioni agricole eseguite nel la vigna,89 possiamo ricordare un lamento funebre cananeo di vi gnaiuoli, e precisamente di potatori, in cui la vigna potata è com pianta come nume dolorante per la violenza subita: «Qual signore e padrone sta egli sul trono, con lo scettro della desolazione in una mano, e lo scettro della vedovanza dall’altra...»:90 ma sono del pari eloquenti gli occasionali riferimenti a una passione della vite e a un cordoglio rituale durante la vendemmia indirettamente ricavabili dall’Antico Testamento. Al ritornello έλελεΰ durante le Oschophoria fa riscontro la costumanza degli abitanti di Sichem, 84 Per il parallelo tra covone rituale e grappolo rituale cfr. ibid., p. 229. 85 Diod. Sic. 3, 62.8 (Kern, Orph. fragm., 30 1); Kern, Orpb. fragm., 21 4; Corn., p. 185 (Lang, p. 62, io). Cfr. Eisler, op. cit., pp. 2 3 1 sg. 86 Vedi p. 236, nota 47. 87 H . Jeanmaire, Dionysos (Parigi 19 5 1) pp. 377 sg. 88 Ibid. 89 Apollod., Bibl. 2, 6.3: Syleo faceva seppellire gli stranieri che si avvicinavano alla sua vigna, finché Eracle uccise Syleo e sradicò la vigna. 90 Gaster, op. cit., p. 241 .
244
C A P IT O L O S E S T O
dei quali è detto che all’ arrivo di Gaal «uscirono verso la campa gna e vendemmiarono, calpestarono le uve e fecero hillulim ».91 Il profeta Michea così fa confessare ad Israele i suoi peccati: « ’aleloj-li, guai a me, come si canta nel raccolto estivo, come si canta nella vendemmia autunnale».92 E il profeta Isaia: «O donne ricche, levatevi in piedi ed ascoltate la mia voce; o figlie così confidenti, porgete orecchio alle mie parole... Voi sarete in cordoglio: termi nata è la vendemmia e passato per sempre è il raccolto. Spoglia tevi, raccogliete ai fianchi le vesti, percuotetevi i seni a causa della bella campagna e della vigna fertile».93 Nel salmo 80 si lamenta - col significato allegorico del popolo di Israele come vigna del Signore - il destino della vite danneggiata da tutti i passanti, abbandonata allo scempio di tutti gli animali del campo, tagliata e bruciata: ora il salmo 80, come i salmi 18 e 84, porta la indica zione a l hagatboth (nella Settanta: υπέρ των λενών; in San Gero lamo: in torcularìbus), il che li rende riconoscibili come antichi canti di pigiatura (probabilmente paragonabili agli epileni greci), trasposti nel significato simbolico della religiosità jahwistica e messianica e tuttavia ancora così collegati al mondo religioso popolare-agrario che il salmo 80, scritto nel piombo, veniva inumato nelle vigne per proteggerle dai topi.94 Come riscontro folklorico nella Pale stina moderna può valere il ritornello emotivo imlàlà, che si leva a gara da tutti gli orti al tempo della vendemmia, dà il nome all’in tero lamento della passione della vite.95 Ma non soltanto la mietitura e la trebbiatura dei cereali, o il raccolto e la lavorazione del lino, o la vendemmia e la pigiatura dell’uva appaiono nel mondo antico connessi con l’esperienza della passione di un nume: in realtà tutte le piante economicamente utili, nel momento in cui l’uomo se ne appropriava e le sottoponeva alle trasformazioni necessarie per renderle atte al consumo, entravano nella sfera religiosa, dei πάτη τών καρπών, o più esattamente si con figuravano come numi in passione, sollecitando un comportamento rituale di riparazione che ha nel lamento funebre un suo impor 91 Giudici 9, 27. 92 Michea η, i. 93 Isaia 32 , 9-12. 94 Eisler, op, cit., p. 270. 95 Ibid., pp. 273 sg.
L A M E S S E D E L D O LO RE
245
tante momento espressivo. In altre parole l ’esperienza fondamen tale della messe del dolore, connessa col raccolto dei cereali e del lino, investiva tutto il mondo vegetale in quanto mondo «colti vato» dall’uomo, ed economicamente utilizzato. Di ciò noi abbiamo soltanto indicazioni molto indirette, ciascuna delle quali isolatamente presa potrebbe apparire contestabile: però considerate insieme ed inserite nel quadro che finora abbiamo tracciato, esse acquistano un loro valore dimostrativo. Così lo Eisler ravvisa nelΠτυν ελελίζειν di Aristoph. Av. 2 10 lamentazioni rituali durante il taglio annuale dei vimini adoperati per la fabbricazione di panie ri,96 ed interpreta la passione di Adrasto come documento di un successivo mutamento dell’economia agricola della città di Sicione; dapprima Adrasto avrebbe indicato l’orizzonte mitico della pas sione dei papaveri, poi di quello dei meloni e dei cetrioli, e infine, con l’introduzione della cultura della vite, la passione dell’eroe avrebbe ceduto il luogo a quella di Dioniso (questa sostituzione di passioni starebbe quindi alla base della tanto discussa notizia erodotea del trasferimento dei cori di Sicione da Adrasto a Dioniso).97 Analogamente l’abbattimento del pino, accompagnato da lamen tazioni, nel culto di Attis, e altre forme di δενδροκοπία rituale rin viano alla stessa sfera.98 Altre indicazioni relative agli alberi da frutto sono date dal mondo cretese-miceneo, anche se noi cono sciamo molto approssimativamente la sua religiosità agraria, e soprattutto le incidenze mitico-rituali in rapporto alle singole ope razioni agricole: sembra tuttavia che non possa negarsi la parte importante che in questa civiltà religiosa dovette avere la connes sione fra raccolto degli alberi da frutto, passione vegetale per la morte del nume e giubilo rituale per la sua resurrezione. In un anello d’oro del periodo tardo-minoico è raffigurata una scena in cui un personaggio a destra è in atto di scuotere un albero sovraccarico di frutti, e di afferrarne uno per eseguire il raccolto, mentre una 96 Ibid., p. 276, n. 5. 97 Ibid., p. 243, n. 5. 98 Ibid., p. 248, n. 4. Per la δενδροκοπία cfr.: Bull. corr. hell., voi. 17 , n. io (1893). Per i dati folklorici sul lamento dell’albero segato, Grimm, Deutsche Mytbologie, p. 652. Un’inda* gine a parte meriterebbe la trasposizione di questo tema nei rituali funerari (uomo morto = albero tagliato) e nelle connesse lamentazioni e rappresentazioni drammatiche, di cui così notevoli tracce sono conservate nel folklore slavo: cfr. E . Mahler, Die russische Totenklage (Lipsia 1935)
p. 122.
246
C A P IT O L O S E S T O
figura di donna a sinistra, col busto inclinato su un tavolo-altare e con la testa poggiata nel cavo dell’avambraccio, esegue la lamen tazione rituale. Al di sotto della lamentatrice l’anello mostra sim bolicamente l’acqua vivificante (in rapporto con le lacrime del pianto?) che scende a zig-zag verso la semenza pronta a rinascere: e infine al centro una donna con gonna a volani esegue una danza nel caratteristico atteggiamento delle mani alla vita. Ora il perso naggio che esegue l’atto del raccolto si piega nelle ginocchia in una trasparente espressione mimica di religioso sgomento e storna vio lentemente la testa, come per i sacrifici nei quali è interdetto guar dare l’azione sacra che viene compiuta." Il carattere rituale della scena è fuori dubbio: e se l’interpretazione che ne è stata data è giusta, in essa scorgiamo come nella sintesi di un simbolo gli ele menti fondamentali della passione vegetale: cioè il raccolto come soppressione violenta di un nume, il pianto rituale e l’anticipazione drammatica e giubilante del ritorno del bene vegetale che scompare.
7. Analisi ierogenetica Circa trent’anni or sono Robert Eisler, analizzando alcuni nessi mitico-rituali relativi alle passioni vegetali nel mondo antico, ritenne che essi potessero essere interpretati come trasposizione della colpa del raccolto su operatori simbolici, e come vendetta riparatrice eser citata su tali operatori. Lo Eisler mise in rilievo l’importanza docu mentaria che a questo proposito aveva una formula rituale con servataci da Epifanio, il quale riferisce che i Manichei quando si cibavano di pane, rivolgevano al pane stesso la seguente dichiara zione di discolpa: «Non io ti ho mietuto, non io ti ho macinato, non io ti ho impastato, non io ti ho messo al forno, ma un altro; senza colpa io ho mangiato».9 100 Tuttavia lo Eisler non ricavò da 9 99 Evans, The Palace o/Minos, voi. 1 , p. 1 61 , fig. 1 x6; Id., Tree and Pillar Cult, p. 177, fig. 5 3; Nilsson, TheMinoan-Mycenaean Religion and its Survivals in Greek Religion (1950) pp. 237 sg. (cfr. p. 243, dove è detto che l’anello di Micene mostra i due aspetti polari del culto della natura, e cioè «joyous excitement and mournful lamentation»); Ch. Picard, Les religione préhelléniques (1948) pp. 14 7 sg. Naturalmente la scena dell’anello aureo di Micene è stata anche diversamente interpretata, ma la interpretazione più aderente ci sembra quella che abbiamo indicata nel testo, nella quale concordano il Nilsson e il Picard. 100 Epiphan., Haer. 62, 28. (Holl, voi. 3, p. 62): «ούτε σε έγώ έθερισα/οΰτε ελεσα οΰτε έθλιφα
L A M E S S E D EL D O LO RE
247
questo prezioso riferimento documentario tutto il profitto possi bile: il criterio interpretativo che lo studioso tedesco ne trasse restò infatti senza approfondita giustificazione ierogenetica, e fu da lui utilizzato nei singoli casi concreti in modo non sempre aderente ai dati. Epifanio inserisce la formula nel quadro dell’ideologia mani chea della trasmigrazione delle anime in piante (o animali) a cui veniva recata violenza, onde poi chi si macchiava di tale colpa doveva, talionis causa, subire la stessa sorte. Esemplificava Epifa nio che «coloro i quali raccoglievano fave e ortaggi, o mietevano fieno ed orzo, erano costretti a subire la trasposizione nelle fave, nel fieno, nelle spighe o negli ortaggi, al fine di essere anch’essi mietuti o recisi».101 Ad ulteriore chiarimento Epifanio aggiunge che, nel quadro di questa ideologia, «colui che avesse mietuto, doveva lui stesso esser mietuto, e del pari chi avesse gettato nel forno la farina impastata per cuocere il pane doveva subire la stessa sorte, e chi impastava il pane doveva essere impastato, e chi lo cuoceva esser cotto»:102 appunto per questo le corrispondenti operazioni erano interdette ai manichei,103 e l’indispensabile ci barsi di pane poteva esser riparato solo con la recitazione della formula di discolpa: «Non io ti ho mietuto ecc.». Questa ideologia manichea, che nel suo complesso sincretismo racchiude innegabilmente una eco della religiosità agraria popo lare, ha una notevole importanza ermeneutica ai fini della ierogenesi delle passioni vegetali nel mondo antico. Innanzi tutto i dati che ci offre Epifanio ci consentono di formarci un’idea della c r i s i che c o s t i t u i s c e il r i s c h i o de l m o m e n t o c r i t i c o del r a c c o l t o . Come dicemmo, nel regime esistenziale che fu pròσε/οΰτε ές κλίβανον έβαλον/άλλά άλλος έποείησε ταΰτα καί ήνεγκέ μοι: έγώ άναίτιος έφαγον». Cfr. Eisler, op. cit., pp. 234 sg. Tuttavia lo Eisler si limita a riportare soltanto la formula rituale di discolpa, senza utilizzare gli altri dati del passo di Epifanio. 101 «Διό άνάγκη αυτούς μεταγγισύηναι εις χόρτον η είς φασηλία η εις κριθήν ή εις στάχυν ή είς λάχανα, ΐνα καί αυτοί θερισθωσι καί κομώσι». 102 «ει τις θερίζει, θερκτθήσεται, ούτως έάν είς μηχανήν σίτον βάλλη (come quando si butta nel forno la farina impastata per cuocere il pane) βληθήσεται καί αύτός, ή φυσάσας φυσαθήσεται, ή όπτήσας άρτον ύπτηθήσαται ». 105 « διά τούτο άπείρεσαι αύτοις έργον ποιήσαι». Cfr. Theod., Haer. fab. comp. 1, 26: « Ου δή χάριν οί καλούμενοι τέλειοι παρ’ αύτοις, οΰτε άρτον κλώσιν, ούτε λάχανον τεμνουσιν, αλλα και τοΐς ταΰτα δρώσιν, ώς μιαιφόνοις προφανώς έπαίρονται· έσθίουοι δέ δμως τα τεμνόμενα καί τα κλώμενα ». Lo stesso tema in Agost., c. Faust. 5, 6: «Neque enim Christus vobis praecepit ut herbam non evelletis ne homicidium perpetretis»; 6, 4: «Dicitis enim dolorem sentire fructum cum de arbore carpitur, sentire cum conciditur, cum teritur, cum coquitur, cum manducatur».
248
C A P IT O L O S E S T O
prio del mondo antico l’operazione agricola del raccolto è una situa zione che fa emergere la storicità della situazione umana sino al limite della crisi: l’uomo apprende se stesso come procuratore di morte della pianta utile, e al tempo stesso si pone di fronte al pro lungato vuoto vegetale che segue il raccolto e all’esperienza di una scomparsa che solo in minima misura l’uomo può convertire in una adeguata riapparizione.104 Il «far passare» e il «far tornare» se condo una regola umana si vengono progressivamente restringendo, e si dilata invece la prospettiva di ciò che «passa da sé, senza e contro l’uomo». Ma questo restringersi e questo dilatarsi signifi cano che comincia a venir meno la stessa presenza, la stessa possi bilità di esistere come presenza operante: in luogo di «far passare» la situazione secondo la coerenza tecnica del raccogliere la pianta utile, la stessa presenza comincia a passare immediatamente nel la situazione e a perdersi in essa. Sulla linea di questo perdersi - che è un non poter mantenere la distanza rispetto all’oggetto, un restar senza margine di distacco - si ritrova l’atto del racco gliere avvertito come rischio di trapassare nella pianta raccolta, l’immediato patire con la pianta in un’assoluta identità di destino, l’angoscia paralizzante che trattiene dal fare. Ora i nessi miticorituali che accompagnano l’operazione del raccolto nella religio sità agraria del mondo antico costituiscono altrettanti modelli tec nici che fermano il rischio di alienazione, dànno inizio alla ripresa, e ridischiudono l’operazione agricola compromessa dalla crisi. Noi dobbiamo ora, sulla base della documentazione precedentemente raccolta, rigenerare le fasi di questa costruzione tecnica, e com prendere il modo del suo funzionamento. Nel caso dei cereali, il «pneuma che erra per le messi» costitui sce il primo fondamentale orizzonte rappresentativo in cui l’alie nazione irrelativa viene fermata, configurata e segnalata, e quindi 104 Anche per la semina si configura un'analoga prospettiva di incertezza, come si desume dal seguente passo di Plut. de Is.y 70: « ... G li egiziani chiamano il mese della semina athyr, gli ateniesi pyanepsion, i beoti il mese di Demetra. Era l’epoca in cui essi vedevano i frutti disseccarsi e cadere dagli alberi, mentre ne seminavano altri con pena e difficoltà, grattando con le mani la terra e ammucchiandola di nuovo n e l l a m a l c e r t a s p e r a n z a c h e c i ò c h e d e p o s i t a v a n o n e l l a t e r r a g i u n g e s s e a m a t u r i t à . Facevano, sotto molti rispetti, come quelli che sotterrano e piangono i loro morti». A l che fa riscontro Γimmagine di coloro che «seminano con lacrime» o di colui che «cammina piangendo quando porta la semenza» (Salmo 12 6 , 5), un’immagine che riceve il suo comprensibile senso metafo rico dal riferimento a un pianto rituale durante l’operazione agricola della semina.
LA M E S S E D E L D O LO RE
249
resa suscettibile di rapporto e di ripresa. Ne risulta un modello di compromesso che per un verso accoglie il rischio di alienazione - in quanto il pneuma che erra per le messi non appartiene all’or dine umano, ma si muove già sul piano mitico - , e per un altro verso offre un modello stabile, culturalmente accreditato, di arre sto dell’alienazione. Fermata sul piano mitico del «nume dei cereali», l’alienazione muta per così dire di segno, e si dischiude alla possibilità della ripresa, cioè dell’inclusione in una sfera di rap porti culturali definiti col mondo umano. Nel modo più traspa rente il nesso fra il rischio dell’alienazione e la ripresa del modello mitico appare in una tradizione norvegese, secondo la quale «lo spirito del grano» è lo stesso mietitore mitizzato (skurekait) che tutto l’anno vive immerso nel grano e che è poi catturato nell’ul timo covone.105 D ’altra parte quel trapassare nel frutto raccolto cui si riferiva Epifanio - e che si è tentati di interpretare come una gratuita immaginazione - riceve ora il suo esatto significato originario di rischio reale, che richiede riscatto. Tuttavia l’orizzonte mitico del pneuma che erra per le messi non racchiude in sé nulla che possa far pensare ad una risoluzione della crisi. Una sacralità uniformemente diffusa per tutto il campo da mietere segnalerebbe il rischio dandogli forma e figura tradi zionali, ma non gioverebbe a dischiudere l’operazione agricola del raccolto in quanto operazione economica profana, in quanto forma del lavoro umano. La passione irrelativa del mietitore si è ora data l’orizzonte culturale della passione di un nume: ma se non si trat tasse che di questo, il mietere resterebbe interdetto. Si rende quindi necessario un ulteriore sviluppo tecnico: la numinosità del campo da mietere viene condensata in un unico covone - il covone ri tuale - il primo o l’ultimo della serie, e soltanto il mietitore che inizia o chiude la mietitura assume su di sé il rischio dell’opera zione nel suo complesso. In tal modo, attraverso il «come se» tec nico di questa sacra simulatio, il mietere come operazione agricola viene liberato dopo la mietitura del primo covone rituale, o prima di quella dell’ultimo. Possiamo anche dire: la ίίβρις, cioè la vio lenta alterazione umana dell’ordine vegetale compiuta attraverso la mietitura, viene destorificata in un covone simbolico mietuto 105 V. Rantasalo, Der Ackerbau im Volksglaube der Eìnnen und der Esten mìt entspreckenden Gebrauchen der Germanen Verglicben, F. F. C ., n. 5 (Sortalava-Helsinki 1919-25) p. 5 1 .
250
C A P IT O L O S E S T O
da un simbolico mietitore, che potrebbe chiamarsi «il mietitore del misfatto». Il pianto rituale che accompagna la mietitura del primo o dell’ultimo covone ha il significato tecnico di occultare il misfatto: si piange la morte violenta del nume del grano «come se» non fosse stato l’agricoltore a procurarla, ma un altro. Soffermiamoci sulla tecnica che assegna all 'ultimo covone e l ’ul timo mietitore un significato mitico-rituale. Qui l’ultimo mietitore - o legatore - assorge a operatore simbolico che concentra su di sé il rischio che altrimenti avrebbe gravato su tutti gli operatori reali, paralizzando l’operazione agricola nel suo carattere di tec nica profana. Questo operatore simbolico consuma, come si è detto, il rischio di tutti: non solo ha, ma è l’ultimo covone, cioè il nume dei cereali che ne forma l’orizzonte mitico: egli confonde il suo proprio destino con quello del nume, «trapassa nel covone», è ormai «immerso nel grano», secondo un rapporto di identificazione che è reso anche esteriormente sensibile mercé del legamento nel covone stesso. Quel volto umano fermato nel suo alienarsi che è «il pneuma errante per le messi» traspare ora in modo materiale dietro il velario di spighe del fantoccio animato, oppure sporge dal manto vege tale. In virtù di questa apparecchiatura tecnica destorificatrice ha luogo una mietitura «protetta»: anzi, nel caso dell’elemento ago nistico che si introduce per la determinazione dell’ultimo mieti tore, l’apparecchiatura tecnica in quistione consente una più rapida esecuzione del lavoro, poiché ha come conseguenza un generale affrettarsi dei mietitori al fine di non soggiacere al destino riser bato a chi falcia l’ultimo covone. L ’operatore simbolico che concentra su di sé - sul piano meta storico mitico rituale che è il risultato della destorificazione - il rischio e la colpa della violenza recata al nume dei cereali apre la possibilità di un ulteriore sviluppo tecnico per la protezione del l’operazione agricola della mietitura: su di lui, infatti, è possibile esercitare la vendetta riparatrice. La formula «non io sono stato, ma un altro» ha il vantaggio tecnico di permettere l’operazione colpevole punendo però quest'altro: nel caso specifico il vantag gio è di mietere come se non fossero tutti i mietitori a farlo, e con sente di vendicare il misfatto come se uno solo lo avesse perpe trato. La scelta degli operatori simbolici fra gli operatori reali dell’operazione agricola non costituisce però l’unica possibilità tec
LA M E S S E D EL D O LO RE
251
nica di risoluzione: le leggende di tipo Lityerses e il materiale folklorico euromediterraneo mostrano infatti come la concentrazione e lo spostamento possono orientarsi anche in altro modo. Innanzi tutto la scelta può dirigersi verso esseri viventi che a vario titolo sono implicati nella violenza arrecata al nume, e che perciò sono particolarmente adatti a figurare come strumenti di spostamento e di concentrazione simbolica della colpa, in applicazione della for mula «non io sono stato, ma un altro». Come risulta dalle leggende di tipo Lityerses e dal materiale folklorico euromediterraneo, l’ope ratore può essere per esempio uno straniero che si trova a passare in prossimità del campo, e ciò perché il passante e lo straniero si associano naturalmente nella esperienza dell’agricoltore con colui che arreca danno al campo, come traspare dall’immagine del sal mista: «Perché hai abbattuta la cinta (della vigna), sì che la mano mette ognuno che si trovi a passare per la strada?»106 Ma l’ope ratore simbolico può essere anche un animale collegato con la passione vegetale, sia perché arrecatore di guasti alla pianta durante il pascolo non controllato, sia perché nel corso della sua utilizza zione durante i lavori agricoli tale animale può partecipare alla vio lenza recata dall’uomo come provocatore e regolatore del processo vegetale, presentando in entrambi i casi una predisposizione elet ti /a ad essere assunto come strumento simbolico di spostamento della colpa e come vittima della vendetta riparatrice. Come esem pio tipico del primo caso può essere addotta la tradizionale inimi cizia della vite verso il capro, inimicizia che trova il suo riflesso letterario in un epigramma di Euenus: κήν με φάγης επί ρίζαν, δμως ετι καρποφορήσω δσσον επισπεΤσαι σοί, τράγε, ύυομένω.107 Anche il maiale può arrecare danni ai cereali durante il suo pascolo non con trollato: in più la tecnica del calpestio animale utilizzata nella semina o nella trebbiatura, associa il maiale alla passione del nume dei cereali. Kore che sparisce nel suolo con una mandra di maiali con dotta dal pastore Zeus Eubouleus rappresenta infatti sul piano mitico la inumazione dei semi mediante l’irrompere della mandra sul terreno di fresco seminato, il che era un uccidere e un seppel lire di cui i maiali portavano colpa, non l’uomo: in accordo con questo mito i maiali venivano, talìonìs causa, uccisi e gettati in una 106 Salmo 80, 13. 107 Anth. Pai. 9, 75. Su questo punto può vedersi Eisler, op. cìt., p. 232, n. 4.
25 2
C A P IT O L O S E S T O
fossa durante le T h e s m o p h o ria . Analogamente, Osiride, Adone e Attis uccisi dal maiale appartengono ierogeneticamente alla stessa sfera di connessioni.108 In tal guisa la formula v ic tim a e n u m in ib u s p e r c o n tra rie ta te m im m o la b a n t u r appare come uno sviluppo tecni co del tutto trasparente della formula destorificatrice riferita da Epifanio.109 ™ va^enza «vendetta» del sacrificio animale, d ie qui viene messa in evidenza senza pregiudizio delle altre valenze che appartengono alla complessa ierogenesi del sacrificio nelle civiltà del mondo antico, si veda Liungman, op. cit., pp. 268 sg. Per la semina mediante calpe stio di mandrie di maiali come tecnica agricola egiziana vedi Erman e Ranke, op. cit., p. 5 17 . Lo Eisler, op, cit., pp. 249 sg., pone in rilievo come nelle Buphottia l’istituzione di responsabili animali delle passioni vegetali si combina con lo spostamento su oggetti materiali della respon sabilità umana della passione animale. Il rituale delle Buphonia è noto: viene deposto dell’orzo consacrato sull’altare di Zeus, e sono quindi avviati verso l’altare alcuni tori sazi, e che quindi non dovrebbero avere nessuno stimolo davanti al cereale. Il toro che divora l’orzo è ucciso dal sacerdote, che successivamente fugge appena compiuto l’atto, come farebbe un assassino. L'arconte basileo apre quindi un giudizio cerimoniale per il misfatto dell’uccisione del toro, giudizio che coinvolge tutti i partecipanti al sacrificio. G li idrofori spostano la colpa sul fabbro che ha affilato l’accetta, e infine l’accetta utilizzata nel sacrificio è riconosciuta colpevole e gettata in mare: solo ora i partecipanti possono cibarsi delle carni del toro, e a conclusione è simulata la resurrezione della bestia immolata, ricucendo la sua pelle dopo averla imbottita di fieno, e aggiogando il simulacro all’aratro. La concezione di colpe e delitti di animali condu ceva in Grecia alla celebrazione di regolari processi giudiziari contro di essi (Arisi., Coksì. Ath., 57, Plat., leg. 9, 873ε). Archi]., fr. 84, dice di Zeus: «σο! δε θεριών νβρις τε καί δίκη μέλει». Sulla quistione della ΰβρις e dei misfatti degli animali e sui processi criminali istituiti contro di essi e da vedere Eisler, op. cit., pp. 249, n. 5 e 296 sg., dove si ricorda anche la polemica cristiana (Gregorio Nisseno) che ha reso definitivo il concetto dell’ irresponsabilità morale e della non perseguibilità giuridica del mondo animale. 109 Com ’è noto l’identificazione dell’ultimo covone con l’animale dei cereali è ricondotta dal Frazer, Spirits o f thè Corti and thè Wild, voi. 1 , pp. 304 sg. all’associazione reale fra il campo delle messi e gli animali che un tempo, quando i campi erano senza difese, liberamente vi erra vano. L ’identificazione è ricondotta anche, dallo studioso inglese, al fatto che determinati ani maletti progressivamente scacciati dal loro nascondiglio vegetale via via che i mietitori avanza vano, saltavano fuori e fuggivano via dall’estremo nascondiglio dell’ultimo covone allorché anche questo veniva mietuto. Lasciamo al lettore giudicare la credibilità di questo rapporto e la sua pertinenza ai dati della documentazione. Ma, a parte ciò, è qui da mettere in rilievo che una spiegazione del genere in realtà non spiega nulla, poiché riposa in ultima analisi sul presuppo sto che per 1 uomo primitivo « thè simple appearance of an animai or bird among thè corns is probabily enough to suggest a mysterious link between thè creature and thè corn »: ora que sto «misterious link» ha tutta 1 aria di restare un mistero non solo per « l’uomo primitivo» ma anche per noi, un mistero sul quale sembra indiscreto volerne sapere qualche cosa di più, tranne che si tratta della solita stolidezza originaria dell’ uomo primitivo, o tutt’ al più di una stolidezza che ha certe sue banali leggi associative che presiedettero all’incredibile catena di equivoci e di qui prò quo. Abbiamo voluto ricordare questo punto non tanto per dar prova di una critica sin troppo facile verso un autore che ha reso così segnalati servigi alla scienza, quanto piuttosto per misurare la distanza che separa l’esigenza ierogenetica da quella che con duce soltanto alla catalogazione del materiale: il Frazer dedica infatti circa trenta pagine all’e sposizione dei dati relativi all animale dei cereali, ma una sola - e quasi di contraggenio —al problema ierogenetico, col bel risultato che si è visto: come se, dal punto di vista di una scienza che vuol «capire», non si trattasse proprio del problema fondamentale.
L A M E S S E D EL D O LO RE
253
L ’istituzione di responsabili animali delle passioni vegetali intro duce nella mietitura dei cereali una complicazione operativa che ha tuttavia la sua propria coerenza tecnica ed assolve una funzione protettiva definita. Come risulta dai dati folklorici euromediter ranei precedentemente ricordati, l’operazione della mietitura assume l’andamento di una partita di caccia, cioè viene eseguita per entro un mascheramento tecnico, una sacra s im u la tio , in cui tutto accade come se non si trattasse di mietere, ma di dare la cac cia all’animale connesso con la passione dei cereali: da questo mascheramento risulta un’efficacia protettiva sull’operazione stessa, che intanto, attraverso la mediazione di questa p ia fr a u s , risulta liberata dai rischi di crisi irrelativa che la minaccerebbero se fosse integralmente riconosciuta nella sua realtà storica. D ’altra parte questa s im u la tio si combina con l’altra del «covone della colpa» mietuto dal «mietitore del misfatto»: appunto per questo l’ultimo mietitore che miete l’ultimo covone non soltanto «ha» l’animale dei cereali, ma «lo diventa», in una identificazione di colpe e di destini che può giungere sino al punto di imitare, come abbiamo visto, il comportamento dell’animale mitico. Qui i rapporti prece dentemente studiati si riproducono esattamente anche nella tec nica dei responsabili simbolici animali, ma con la differenza che l ’inserzione dell’animale fra mietitore e nume ucciso offre l’op portunità di spostare sull’animale stesso le forme più radicali della vendetta riparatrice, cioè l’uccisione. L ’istituzione di responsabili animali della passione vegetale si intravede anche in livelli molto avanzati e complessi dello sviluppo ierogenetico delle antiche civiltà religiose, come per esempio nel dramma egiziano dell’incoronazione contenuto nel papiro dram matico del Ramesseo. Senza dubbio il cosiddetto dramma egiziano dell’incoronazione appare dominato da valenze politiche specifi che, come la stabilità e la continuità del potere statale nel momento critico della successione: il dramma infatti ripete ritualmente il mito di una successione esemplare o metastorica, in cui Osiride muore di morte violenta ad opera di Set, Oro e Set contendono fra di loro per la successione, ed infine Oro divora il nuovo re: più esat tamente il rito è la passione metastorica del re Osiride che muore e risorge in Oro, il quale non appare tanto come il nuovo re quanto piuttosto come lo stesso vecchio re che nel suo legittimo succes
254
C A P IT O L O S E S T O
sore ha vinto la morte. Tuttavia la passione di Osiride come re divino è ricalcata sui momenti della passione di Osiride come nume dei cereali, e presenta quindi una valenza agraria che rinvia ai cor rispondenti momenti della passione vegetale nel corso dei lavori agricoli del raccolto e della trebbiatura. Riportiamo qui la scena della trebbiatura dell’orzo, avvalendoci della traduzione e del com mento del Sethe e di alcune risoluzioni esplicative delle didascalie secondo l’interpretazione del Gaster: (Capri e asini irrompono nell’aia per trebbiare l’orzo mediante calpestio). O ro (rivolto al seguito di Set): N o » battete mio padre!
(Osiride viene battuto. I l n u m e è s m e m b r a t o . Oro batte a sua volta coloro che battono Osiride, scacciando a colpi di frusta gli animali che calpestano l’orzo sull’aia). O ro (rivolgendosi ad Osiride, cioè all’orzo che lo rappresenta): Ecco, guarda: io batto coloro che ti hanno battuto!
(L’orzo trebbiato viene caricato sul dorso di asini per essere avviato al magazzino: sul piano mitico ciò significa Osiride che è portato via dal seguito di Set). O ro (a Osiride): I l veleno di Set non sarà mai più sparso su d i te !110
La scena, com’è evidente, rappresenta una duplicità di valenze: in un’unica azione drammatica e per entro uno stesso simbolo mitico viene rappresentata la passione del re divino e quella vege tale del nume dei cereali. Ora se consideriamo la scena nella sua valenza più propriamente agraria, si presenta innanzi tutto il paral lelo fra il mietere come s m e m b r a r e D e m e t r a e i l trebbiare come s m e m b r a r e O s i r i d e : in entrambi i casi l’operazione agricola riceve orizzonte mitico nella rappresentazione di una vio lenza recata al nume. In particolare nella scena della trebbiatura dell’orzo del papiro drammatico del Ramesseo il trebbiare viene mascherato (o «destorificato») attraverso un «come se» tecnico religioso: la trebbiatura dell’orzo è la passione di Osiride, tutta via coloro che recano violenza al nume non sono gli uomini, ma gli animali (sul piano mitico: il seguito di Set) utilizzati nella tec nica della trebbiatura mediante calpestio animale: questi opera tori simbolici, su cui è stata spostata la colpa, vengono a lor volta puniti dal vendicatore Oro, che esibisce a Osiride la propria azione riparatrice: «Ecco, guarda: io batto coloro che ti hanno battuto». 110 K . Sethe, Drammatìsche Texte zu altógyptischen Mysterìenspielen (Lipsia 1928) pp. 134 sgg.; Gaster, op, cit., pp. 388 sg.; cfr. pp. 52 sg.
LA M E S S E D E L D O LO RE
255
Lino ucciso dalle frecce di Apollo o sbranato dai cani accenna ad un’altra forma dell’istituzione di responsabili simbolici della passione vegetale al fine di occultare la storicità dell’operazione agricola eseguita: si tratta dello spostamento della colpa sull’oriz zonte mitico della siccità e della torrida estate, che è appunto l’epo ca in cui si esegue la mietitura. Secondo lo Eisler la festa άρνέις - durante la quale si uccidevano i cani per vendicare Lino - sa rebbe da mettere in rapporto con la espressione φόνους άρνεΐσθαι = denegare misfatti (Eur., Jon., 1026) e avrebbe quindi il significato di un rituale di degenerazione del misfatto umano del raccolto, riversandone tutta la colpa sull’ardore del sole durante i giorni della canicola, e uccidendo i cani per vendetta di riparazione.111 Un analogo rapporto è forse rintracciabile nel poema cananeo di Ba’al. Lo sfondo esistenziale di questo poema è l’anno agricolo siropalestinese, caratterizzato da due stagioni fondamentali, quella pio vosa dalla fine di settembre al principio di maggio e quella secca dal principio di maggio alla fine di settembre. Il pericolo per l’agri coltura e per le messi è dunque rappresentato dalle piogge ecces sive e fuori tempo o dalla siccità prolungata, come anche dal rapido sciogliersi primaverile delle nevi montane seguite dal rovinoso in grossarsi dei fiumi.112 Il poema di B a’al rispecchia sul piano mi tico l’ordine drammatico delle relative forze cosmiche: Ba’al è l’oriz zonte mitico della giusta pioggia nella stagione che le spetta, e si presenta pertanto come un nume con nette valenze meteoriche; Yam è il nume delle acque terrestri e sotterranee e del mare aperto; Mòt è il nume della temibile estate, della siccità inaridente, degli inferi e della morte: l’irrigazione come potenza umana di control lare la sfera delle acque terrestri ha il suo orizzonte mitico in Asthar, che però non ha sovranità su nessun periodo dell’anno, e di cui il poema narra come E 1 abbia respinto ogni pretesa, ribadendone lo stato di minorità.113 Nel quadro di questo dramma dell’ordine cosmico trova posto «il più antico esempio di rituale agrario del l’ultimo covone»,114 la uccisione di Mòt da parte di ’Anat: «Essa afferra il divino Mòt, con la falce lo miete, con un vaglio lo vaglia, nel fuoco lo brucia, in una macina lo macina, sui campi lo disperde 111 112 113 114
Eisler, op. cit., p. 255 n. 3. Dalman, op. cit., voi. 1 , 2, p. 307. Gaster, op. cit., pp. 115 -2 9 . C fr. p. 236, nota 43.
2j6
C A P IT O L O S E S T O
affinché gli uccelli possano divorarne i resti... » L ’interpretazione di questo episodio ha dato origine ad una controversia tra gli stu diosi poiché per un verso Mòt appare nel corso del poema come l’orizzonte mitico della siccità distruttrice e mortifera, e per un altro verso nell’episodio in quistione esso subisce i momenti della passione del grano, quasi che si trattasse dello stesso nume dei cereali.115 La controversia però potrebbe essere risolta se l’ucci sione di Mòt nel poema di Ba’al fosse interpretata come un sacri ficio di vendetta eseguito su un operatore simbolico (il nume della siccità) della mietitura o della trebbiatura, allo stesso modo come nella scena della trebbiatura del grano nel papiro drammatico del Ramesseo la colpa è spostata sugli animali che recano violenza ad Osiride, eseguendo su essi la vendetta riparatrice. L ’istituzione di responsabili animali delle passioni vegetali come tecnica di destorificazione del raccolto al fine di liberare l’operazione agricola dal rischio di una irrelativa crisi paralizzatrice trova interessanti appli cazioni nella vendemmia. La tradizione ci ha conservato notizia di una festa attica della vendemmia chiamata Askolia (la festa del l’otre), durante la quale si saltellava a gara con un piede solo su un otre rigonfio di aria, deridendo chi cadeva.116 La danza appare anche in altre feste (Choe e Aiora), e diventò più tardi una danza intorno all’otre. La tradizione accenna concordemente, come aition della costumanza alla punizione di un misfatto animale: il capro ave va brucato la vite e perciò fu ucciso, e successivamente sulla sua pelle rigonfia d’aria tramutata in otre, veniva eseguita la danza.117 La vicenda è messa anche in connessione con la leggenda del vi gnaiuolo Icario, eponimo del demos di Icaria e diffusore della col tivazione della vite avuta in dono da Dioniso, così come Trittolemo diffuse la coltivazione dei cereali insegnatagli da Demetra: avendo il capro brucato la vite e danneggiato la vigna Icario per ira lo uccise, inducendo i suoi compagni a danzare intorno alla pelle rigonfia a modo di otre.118 Ora Eisler mise in rilievo come questa danza che la tradizione ci ha tramandato come una rappresenta zione a carattere meramente agonistico, si collegava in origine a 115 Per lo stato della quistione cfr. Gaster, op. cit., p. 124. 116 Schol. Aristoph. Plut., 1 12 9 ; Suida, s. v. 117 Verg., Georg. 2, 38 1 sgg.: Porph., de abst. 2, io. 118 Erathost., ap. Hyg. astr. 2, 4. Su Ikarios vedi in particolare M. Nilsson, Die Anthesteneri und die Aiora, Eranos Jahrbuch, voi. 15 (19 15), rist. in Opuscola Selecta (Lund 19 5 1) p. 16 1.
L A M E S S E D EL D O LO RE
257
un reale processo di lavorazione del vino. Dal semplice calpestio nel tino si otteneva il mustum lixivum, ma un vino più ricco di feccia e di acido tannico era prodotto nell’età ellenistica col tor chio a vite, e precedentemente mediante l’ammostatoio a rullo: una forma ancora più antica di ammostatoio constava di un sacco di materia permeabile che veniva riempito di mosto e sottoposto a torsione mediante rami a forchetta. A sua volta l’ammostatoio a sacco permeabile sarebbe stato preceduto da una pelle di capro, di cui si premeva il contenuto, mediante calpestio. In tal modo l’operazione tecnica dell’ammostare sarebbe stata ideologicamente inclusa in una tipica forma di destorificazione: la colpa della vio lenza arrecata al nume della vite per effetto del calpestio della pigia tura veniva «occultata» o «mascherata» in una vicenda esemplare in cui il vignaiuolo Icario si vendicava del misfatto del capro che aveva brucato la vite; ma intanto, attraverso questo «come se» protet tivo, l’operazione dell’ammostare era eseguita.119 Eisler avanza inoltre l’ipotesi che anche il capro sacrificato sarebbe stato a sua volta lamentato, e che il tanto discusso nome di τραγωδία «sarà de rivato dal fatto che durante la festa del raccolto i cori lamentavano a gara la passione del capro sacrificato, dato poi al vincitore come premio di questo agone poetico-musicale-orchestico».120 Sempre in questo quadro lo Eisler interpreta i vendemmiatori mascherati come rappresentazioni drammatiche della stessa esigenza di spo stare su responsabili animali la ίίβρις del raccolto: sacra simulatìo in virtù della quale la umana vendemmia era eseguita «come se» fosse un brucare di capri o di altri animali dannosi alla vite.121 119 Eisler, op. cit., pp. 264 sgg. e 276. 120 Ibid., p. 276. 121 Ibid., p. 252. Lo Eisler tenta di interpretare come rituali di denegazione le leggende di Erigone (p. 276) e di Orfeo ucciso con arnesi agricoli (pp. 242 sg.; cfr. p. 343: « L ’uccisione o anche il maltrattamento della vittima umana con tali arnesi è da considerare come un puro e semplice rito di compensazione esercitato sul preteso colpevole... rito di compensazione mediante il quale il contadino vuole stornare da sé l’ira della segale, del lino e simili»). Lo Eisler accenna inoltre ad un’altra forma di denegazione e di spostamento della colpa della vio lenza recata al nume della vegetazione mediante le operazioni agricole: «nei diversi tentativi di denegare e rimuovere gli περί τροφής άδικήματα, e di discolparsi da essi, appare particolar mente ovvia la scusa che il misfatto del maltrattamento e dello sbranamento del nume sia stato commesso in stato di ebbrezza o di licantropia, e che perciò coloro che avevano effettuato il raccolto in condizioni reali o pretese di ebrietà non potevano essere dichiarati responsabili» (pp. 334 sgg., a proposito della leggenda di Licurgo). Queste e altre suggestioni dello Eisler meriterebbero un’analisi particolareggiata, e un’ulteriore verifica: che però noi qui ci troviamo di fronte a un criterio ermeneutico fecondo di risultati, non par dubbio.
25 8
C A P IT O L O S E S T O
Nell’esposizione dei dati folklorici euromediterranei è stato pre cedentemente messo in rilievo come l’ultimo covone fosse carat terizzato da una spiccata ambivalenza: per un verso esso vale come simbolo di agonia e di morte, per un altro verso esso manifesta il significato di una forza permanente che anticipa e garantisce il nuovo raccolto, o di una forza da rianimare e da rigenerare, e che di fatto viene ritualmente rianimata e rigenerata (per esempio mediante l’aspersione con acqua e simili). Qui noi siamo di fronte ad una nuova tecnica di destorificazione, di natura diversa da quella che si ispira alla formula di Epifanio, e alla scelta degli operatori simbolici su cui esercitare la vendetta riparatrice. Orizzonte mitico delle specie vegetali economicamente utili, ideologia del covone rituale nel quale si concentra la morte violenta del nume, sposta mento della colpa e riparazione, non esercitano una diretta effica cia destorificatrice su uno degli aspetti critici fondamentali del l’operazione agricola del raccolto, sul grande vuoto vegetale che il raccogliere lascia dietro di sé e che si protrarrà - esposto a tutti gli incidenti e le incertezze della storia agricola - sino alla nuova germinazione e al nuovo raccolto. La destorificazione protettrice del raccolto non si esaurisce pertanto nelle varie forme del «non sono stato io», poiché chiunque sia stato l’operatore del misfatto e quale che sia la vendetta riparatrice, resta comunque il fatto della protratta scomparsa del bene vegetale, cioè una prospettiva sto rica ed esistenziale il cui pieno riconoscimento rischia ancora una volta di sommergere nell’amplissima sfera delle sue possibilità avverse all’uomo il modestissimo orizzonte operativo che cade sotto il controllo umano. Alle tecniche di occultamento delle responsa bilità umane (operare «come se» non fosse l’uomo ad operare) si innestano pertanto quelle indirizzate a cancellare o a variamente attenuare il vuoto vegetale che si manifesta con l’appropriazione e l’avvio alla consumazione del bene economico vegetale. Si tratta cioè di operare «come se» il risultato dell’opera fosse apparente, e il non essere che si manifesta fosse, sul piano metastorico, «già» reintegrato nell’essere. Su questo piano metastorico di comodo il nuovo ciclo esistenziale che dovrà essere percorso è «già» stato percorso in modo esemplare: in questa prospettiva il covone rituale muta di segno, diventa il simbolo di una permanenza o di un ritorno: il sacrificio di vendetta si tramuta in sacrificio di rinno
LA M E S S E D EL D O LO RE
259
vamento122 ed il pianto in giubilo: quel giubilo che suggerì al sal mista l’immagine di coloro che seminano nelle lacrime e raccol gono nella gioia. In luogo del raccogliere come iniziativa umana integralmente riconosciuta come tale sta ora il grande tema pro tettivo del raccogliere come iterazione di una vicenda di numi in cui tutto è già accaduto secondo un modello che reintegra tutte le violenze, cancella tutte le morti, risolve tutti gli incidenti, e che sul piano metastorico realizza una volta per sempre quella risolu zione umana del reale che occulta Γ ancor breve respiro della reale potenza pianificatrice e ordinatrice del lavoro umano. Intanto, per entro questo regime di protezione destorificatrice le spighe cadono sotto la falce per l’umana fatica degli uomini, e si ridischiude di fatto quella coerenza tecnica dell’operazione agricola decisiva che altrimenti sarebbe esposta, nelle condizioni storiche date, al nau fragio.
122 Quando il Liungman, op. cìt., p. 189, osserva che «in Fenicia e in Egitto non si è avuta esatta coscienza se si trattava di un sacrificio per rinnovare la forza del nume della vegeta zione, o di un sacrificio di vendetta per vendicare Tassassimo del nume stesso», sembra attri buire ad una sorta di confusione fra disparate e gratuite immaginazioni ciò che in realtà, nella presente ricostruzione ierogenetica, si manifesta come sviluppo di una stessa coerenza tecnica con diverse valenze protettive.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
7· G randezza e decadenza del Pianto Antico
i. Il Pianto Divino come modello Nella prefazione alla sua opera Dei costumi di Sardegna compa rati con gli antichissimi popoli orientali Antonio Bresciani si indu gia nella descrizione di una singolarissima danza di pastori cui egli stesso ebbe occasione di assistere. Riportiamo per esteso il passo data la sua notevole importanza documentaria. Visitando io la tenuta di Geremas, luogo solitario ed ermo in sul mare, ivi convennero da ogni banda pastori e vaccai di que’ monti colà intorno, e agricoltori di Pirris e di Quartu. A ’ quali avendo io fatto festa d ’una cena, e godutoli veder bere e mangiare secondo lor modi paesani, come la giocon dità del vino dié loro baldanza e caldezza di spiriti, si fur rizzati a sedere, e presisi per mano alla mescolata giovani e vecchi, misero una lor danza a suono della lionedda. Il cerchio era grande: e il sonatore delle tibie impose una cadenza, che li fé dare in certi passetti brevi e presti, i quali faceanli roteare quasi a rimbalzo. Tremavan tutti nella persona... ed il tremolio or era lieve a guisa di ribrezzo, e tal volta gagliardo da un certo come fre mere. I volti erano seri e scuri, gli occhi a terra, e il capo quando levato, e quando chino e col mento in seno. Segni di tristezza chiusa in fondo al cuore. E intanto la lionedda suonava un gemito rauco e lamentoso, e talora si fievole che pareva spento; sinché a mano a mano iva sollevandosi in uno strepito intronato e fondo, come di vento nella foresta. Allora fu il girare più avvivato, ché passò ben presto a concitazione; ed ecco un giovinetto scagliarsi improvviso nel mezzo del cerchio, ed ivi contendersi, divincolarsi, balenare e cadere tutto lungo in terra: e i danzatori battere il suolo rinfor zati, e tragittar le braccia, e percuotersi con le proprie mani e colle mani de compagni la fronte; attorno al caduto s’inginocchiano, s’accerchiano, s ingroppano, fan viluppo; indi si sbaragliano, s’attraversano, si confondono con simulata baruffa a legge, e colla maggior grazia che mai, dando mostra
2ÓI
d’un cruccio disperatissimo. In questo mezzo la lionedda spicca un suono allegro, e spiritoso, e il morto giovinetto guizza in pié, batte le mani, leva e trincia una caprioletta leggera, mentre tutta la brigata, dato giù quel furore, ricompone il passo, assesta il cerchio, e rapidissima galoppa, e scambietta, e si diguazza in un tripudio fiorito. Poi rimettono la carola a tondo, e divel tisi dalla corona a due a tre, danzano in atto carezzevole dinanzi al risorto donzello, il quale ballonzola e porge le mani a questo, e a quello. E così i primi, dato un salto indietro, si ricongiungono con gli accerchiati, ed altri muovono a misura in mezzo a rinchinare e riverire il giovine ravvivato. Per ultimo si ristringono a que’ passi di contegno, e tutti tremolosi rigirano con saltelli minuti, picchiando spesso il terreno nell’ atto del contrappasso, e vol gendo il capo lietamente, in qua e in là insino che l’un mezzo cerchio s’ avvi cina all’altro in due ali distese, e fatta una cotal riverenza e dato un rim balzo, sciolgon la danza .1
Senza dubbio per i pastori e per i contadini della tenuta di Geremeas che eseguirono questa pantomima davanti al Bresciani si sarà con ogni probabilità trattato di un semplice divertimento in onore dell’ospite: tuttavia il significato originario della vicenda mimica accenna molto lontano. Intanto noi ritroviamo una danza molto simile nel folklore funerario. Un tempo in Westfalia durante i fune rali una persona si collocava al centro della stanza mortuaria, e mentre i presenti danzavano si lasciava cadere a terra simulando la rigidità della morte. A questo punto seguiva il lamento funebre e il bacio rituale al finto morto: se chi ne sosteneva le parti era un uomo, le donne si recavano a turno a baciarlo, se era donna l’atto spettava agli uomini. Esaurita la cerimonia dei baci veniva eseguito un ballo tondo finché il finto morto al centro del cerchio si rialzava, mescolandosi alle danze.2 Inoltre è da osservare che una danza «saltellante» è caratteristica del cordoglio rituale e della lamentazione. Nel suo commentario al poema di Aqhat il Gaster ha recentemente osservato che in accadico ru-qu-ud-du è termine per indicare il lamentatore professionale: ora nell’ebraico biblico r-q-d significa «saltare» e questo è anche il significato dell’accadiano raqàdu e dell’arabo r-q-s e r-q-z. In arabico ed in siriaco le voci corrispondenti raqsath e marqódetd denotano un modo speciale di saltellare o di danza saltellante eseguita nel corso dei funerali.3 Se 1 Bresciani, Dei costumi di Sardegna comparati con gli antichissimi popoli orientali, pp. xxi-xxm. 2 Ranke, op. cit., pp. 294 sg. 5 Gaster, op. cit., pp. 306 sg.
2Ó 2
C A P IT O L O S E T T I M O
è giusta l’interpretazione che lo stesso autore dà di i Samuele, 15 .3 2 , Agag si sarebbe avvicinato al profeta con l’abituale anda tura saltellante delle persone che eseguono il cordoglio, e intonando un modulo di lamentazione («amara certo è la morte»).4 Infine era con ogni probabilità una danza saltellante quella indicata col termine mrqdm durante i funerali di Aqhat nel poema cananeo che si riferisce alla scomparsa e al ritorno stagionale del nume.5 D ’al tra parte la pantomima descritta dal Bresciani accenna visibilmente alla morte e alla risurrezione di un giovinetto, al compianto e al giubilo: e già il Bresciani pensava al compianto e al tripudio delle feste Adonie.6 Tutto ciò pone il problema del nesso che lega nel mondo antico i rituali funerari per la morte di persone storiche e i rituali agrari correlativi alla scomparsa e alla reintegrazione di un nume. Per intendere questo nesso nel suo significato tecnico occorre rifarsi ai risultati del precedente capitolo. Se trascendere ciò che passa senza e contro l’uomo significa farlo passare mediante l’uomo, cioè nel valore dell’opera umana, e se ciò che definisce la vita culturale è il suo farsi procuratrice di morte al naturale morire, ben si comprende come le civiltà agricole del mondo antico plasmarono la loro esperienza religiosa della morte innanzi tutto e fondamentalmente nell’ambito dei lavori dell’anno agricolo, e in particolare nell’ ambito del momento critico del raccogliere come mietere e come vendemmiare: qui infatti insorgeva con partico lare acutezza il conflitto fra la potenza reale della morte naturale e la potenza reale della regola umana della morte. A protezione tecnica del ciclo dei lavori agricoli, e del loro epilogo nel raccolto, fu istituita una duplice destorificazione: in primo luogo la stori cità del raccogliere fu occultata in una passione vegetale di cui altri sul piano mitico portavano la colpa, non gli uomini; ed in secondo luogo la storicità del vuoto vegetale fu attenuata o addirittura resa apparente mediante una reintegrazione già avvenuta in ilio tem pore, e mediante la iterazione rituale della mitica vicenda delle ori gini. Così Osiride ucciso da Set era reintegrato da Oro; Adone sbranato da un cinghiale risorge; la regalità di B a’al usurpata da Mòt ritorna a Ba’al dopo la vendetta che ’Anat esercita su Mòt; 4 Ibid., p. 307. 5 Ibid., pp. 306 sg. 6 Bresciani, op. cit., p. xxin.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
263
Kore rapita da Hades è restituita alla madre Demetra. Questo nesso mitico-rituale di destorificazione dello scomparire dalla vegetazione e dei vari incidenti storici a cui è esposto l’anno agricolo diventò nel mondo antico il grande centro di riplasmazione di altre sfere del morire, e innanzi tutto di quella in cui il vuoto della scomparsa denunziava nel modo più perentorio la irrevocabilità del passare, cioè la sfera del morire delle persone storiche. Questa modalità del la morte era esposta più di tutte le altre al «non c e nulla da fare» della crisi, ed era pertanto più di tutte bisognosa di protezione: ciò avvenne nel mondo antico, come abbiamo visto, mediante tecniche mitico-rituali quali il passaggio del morto dalla condizione di «cada vere vivente» a quella di morto nel regno dei morti, o la ritualizzazione del planctus nel lamento funebre, o del furore nell’agoni smo, o dell’erotismo nelle esibizioni oscene e nei giuochi lascivi, o della sitofobia nei digiuni e nelle astinenze rituali, o della buli mia nei banchetti funebri. Ma avvenne anche mediante una riso luzione più radicale e cioè con la integrazione della morte indivi duale col suo scomparire senza ritorno nel sistema di destorificazio ne mitico-rituale che era stato costruito per attenuare o cancellare la storica realtà dello scomparire vegetale. Si stabilì così un orga nico rapporto fra rituali funerari e rituali agrari: non soltanto sia negli uni che negli altri ritroviamo lamentazioni e digiuni, purifica zioni e sacrifici, agoni ed erotismo, orgiasmo e allegria e banchetti, ma il cerimoniale funebre si colmava di simboli vegetali e il cerimo niale agrario racchiudeva bene spesso una valenza di festa dei morti. In Egitto all’epoca della diciottesima dinastia si deponeva nelle tombe uno strato di terra disposto sopra un fondo di tela a contor no ritagliato in figura di Osiride, onde poi, germinati i semi e cre sciuta la messe, il morto (che era al tempo stesso un Osiride) veniva integrato nel ciclo vegetale del nume. In Mesopotamia Dumuzi risale dagli inferi col suo corteo di lamentatoti, di lamentatrici e di flautisti: ma dagli inferi nel giorno del suo ritorno sulla terra tor nano anche i morti a respirare l’incenso, e l’annuo compianto per il nume della vegetazione fu anche una festa dei morti. In Grecia le Anthesteria e in Roma la praefatio delle cerimonie primaverili con le Parentalia e le Lemuria accennano allo stesso rapporto.7 7 Sulla connessione tra feste agrarie e ritorno dei morti (che con ogni probabilità risale alle civiltà coltivatrici più primitive) cfr. Gaster, op. cit., pp. 28 sg.
C A P IT O L O S E T T I M O
264
Ma la destorificazione del vuoto vegetale mediante il sistema mitico-rituale del nume che scompare e ritorna fu il centro di riplasmazione culturale anche di un’altra sfera del morire, che acqui stò particolare importanza con lo sviluppo delle grandi monarchie: l’invecchiamento e la morte del re. In rapporto stretto con la sta bilità e la continuità del potere politico, cioè con il mantenersi di un’autorità esposta agli incidenti della storia e alle insidie del tempo, e soprattutto alla crisi connessa con la morte del re e con le riva lità per la successione, si fanno valere qui altri momenti critici del regime di esistenza delle antiche monarchie: appare pertanto del tutto naturale che anche quel manifestarsi del tempo e della morte che trova la sua più acuta espressione nello scandalo del trono vuoto fosse nel mondo antico sottoposto ad una protezione destorificatrice mediante la integrazione nel sistema mitico-rituale del nume vegetale che scompare e che torna. Come sia potuto avvenire tale spostamento di valenze e in che modo si sia prodotto il correla tivo sviluppo ierogenetico è problema che esula dai limiti della nostra ricerca: sarà tuttavia opportuno accennare ad una connes sione alla quale non è stato dato sinora il dovuto rilievo. Si tratta della presenza del re sui campi al momento del raccolto, a riaffer mazione della sua signoria sugli alimenti e con ovvie funzioni di sorveglianza. Nella scena della mietitura nel τέμενος βασιλήιον che è raffigurata sullo scudo di Achille noi vediamo il re che assiste ai lavori, muto, in piedi, con lo scettro in mano, il cuore riboc cante di gioia:8 e il Moret ha messo in evidenza come scene ana loghe si ritrovano nelle tavolette egiziane, come per esempio nella scena di lavori agricoli raffigurati nell’ipogeo di Nakhti, dove il padrone della tomba è presente assiso sotto un chiosco, rallegran dosi in cuor suo della vista.9 D ’altra parte la discendenza regia di Lityerses, Maneros e Bormos, sembrano accennare ad una con nessione fra passione vegetale e passione regale: connessione che trova una ultima eco nei relitti folklorici euromediterranei in cui il padrone, o il fattore o la fattoressa assumono su di loro la pas sione del grano in occasione del rituale dell’ultimo covone della mietitura o della trebbiatura. D ’altra parte in diversi momenti della 8 II. 18 , 556 sg. 9 A. Moret, Rois et dieux d ’Egypte ( 19 11) pp. 259 sg.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
265
dinastia il re in persona (Ramsés II, Ramses III) appare in atto di eseguire la falciatura del manipolo di spighe durante la festa della mietitura compresa nella panegiria del dio Min.10 E forse possibile intravedere qui un processo ierogenetico secondo il quale la tecnica destorificatrice degli operatori simbolici del raccolto, sotto la spinta di interessi politici, mise capo alla simbolica mietitura da parte del re, e poiché il mietere comportava sul piano mitico la passione e la reintegrazione di un nume, si comprende come potettero svilupparsi valenze spiccatamente politiche in seno al tema agrario del nume che muore e risorge, e come la passione vegetale del nume finì col diventare vicenda mitico-rituale di rinnovamento del re divino e metastorico modello di una regolata successione alla sua morte. Questo processo è particolarmente evidente nella figura di Osiride, nella quale i temi della regalità divina sono così accentuati da indurre alcuni studiosi della religione egiziana (Kees, Vandier) a formulare la cosiddetta k in g s h ip -th e o r y , cioè la teoria di Osiride come un re che fu poi associato col processo della vege tazione, in polemica con la cosiddetta v e g e ta tio n -th e o ry del Frazer e del Moret, cioè la teoria di Osiride come spirito della vegeta zione successivamente connesso con la regalità.11 In questo fondamentale quadro di destorificazione della morte noi dobbiamo ora considerare il pianto rituale nel mondo antico nelle sue forme di lamento funebre per la morte di persone storiche, di pianto rituale per la scomparsa del nume della vegetazione e di narrazione mitica che pone in ilio te m p o re un pianto esemplare per una esemplare morte divina. Un testo famoso, conosciuto sotto il nome di L a m e n ta z io n i d i Isid e e d i N ep h th y s ci consente di raggiun gere il più alto e complesso livello ierogenetico del pianto antico. Si tratta di un testo religioso in scrittura ieratica, del periodo tolemai co, facente parte del libro dei morti di una donna a nome Tentruty, figlia di Tekhao, soprannominata Persis. Nel preambolo si legge: Recitazione delle lamentazioni eseguite dalle due sorelle nel tempio di Osi ride, primo degli occidentali, signore di Abido, nel 25 ° giorno del quarto mese dell’inondazione, quando lo stesso si fa in ogni luogo che appartiene ad Osiride, in ogni sua festa: glorificando la sua anima, confermando il suo corpo, rallegrando il suo ka, dando respiro al naso di colui la cui gola è op10 J. Vandier, La religion égyptienne (1949) pp. 18 3 sgg., 202 sg. 11 Si veda in proposito A .H . Gardiner, J. egypt. Archeol., voi. 2, 12 2 (1925) e R. Weill, Bull. Inst. fran9- Archeol. orient., voi. 47, 14 3 (1948).
z66
C A P IT O L O S E T T I M O
pressa, facendo felice il cuore di Iside e di Nephthys, collocando Oro sul suo trono che appartiene a suo padre e dando vita, stabilità e benessere all’Osiride Tentruty, figlia di Tekhao, soprannominata Persis. E profittevole per coloro che le eseguono, come anche (per) gli dèi.
Seguono i brani della lamentazione, alternativamente recitati da due sacerdotesse che sostengono la parte rituale di Iside e di Nephthys: I s i d e . Torna a casa tua, torna a casa tua, o tu di Eliopoli, torna a casa tua, poiché non hai nemici. O bel suonatore di sistro, torna a casa tua, affinché possa vederti. O bel giovinetto, torna a casa tua: è tanto tempo che io non ti ho visto. Il mio cuore è in affanni)per te, i miei occhi ti cercano. Io sono alla tua ricerca, per contemplarti... E bello vederti, è bello vederti, o tu di Eliopoli, è bello vederti. Vieni da colei che tu ami, vieni da colei che tu ami! O tu giustificato Onnofri, vieni da tua sorella, vieni da tua moglie, vieni da tua moglie. O tu che hai il cuore dolorante, vieni dalla signora della tua casa, ché io sono tua sorella della stessa madre .e tu non devi star lon tano da me. Dèi e uomini, i loro volti sono verso di te, lamentandosi all’uni sono. Fin tanto che posso vederti, ti chiamo piangendo, anche nelle altezze del cielo, ma tu non senti la mia voce, sebbene io sia tua sorella che tu ama sti sulla terra e sebbene tu non amasti altri che me, o fratello, o fratello.
O bel sovrano, torna a casa tua e rallegrati poiché i tuoi nemici non ci sono. Le due sorelle sono accanto a te in piedi presso la bara e ti ammirano o beato. Dicci qualche cosa, o sovrano nostro signore, sì da poter cacciare tutta la sventura che è nei cuori. La tua corte, cioè uomini e dèi, ti rimirano: volgi il viso ad essi, o sovrano nostro signore, poiché il nostro viso vive alla vista del tuo... Io sono Nephthys tua sorella che tu ami: colui che si ribellò a te è andato in rovina e morirà, ma io sono con te a prote zione del tuo corpo per sempre. N eph th ys.
I s i d e . Oh tu di Eliopoli! Tu ti levi per noi nel cielo ogni giorno e noi non cessiamo dal vedere i tuoi raggi. Thot è la tua protezione, è lui che fa levare la tua anima dentro la barca in questo tuo nome di «luna»... Tu sorgi per noi come Re ogni giorno, tu sfolgori per noi come Atum: uomini e dèi vivono alla tua vista. Tu sorgi per noi, illumini le due terre, l’orizzonte ribocca del tuo manifestarsi; dèi e uomini, i loro visi sono rivolti verso di te, e nessuna maligna azione contro di te può aver luogo quando sorgi. Tu attraversi il firmamento, poiché i tuoi nemici non ci sono, ed io sono la tua protezione quotidiana. Tu vieni a noi come un bambino (?) nella luna e nel sole, e noi non cessiamo dal vederti. La tua sacra immagine, Orione nel cielo, sorge e tramonta ogni giorno;... la tua augusta immagine che procede da te nutre dèi e uomini, rettili e quadrupedi, ed essi vivono con tal mezzo. Tu vieni dalla tua caverna per noi alla stagione giusta versando acqua alla tua anima e offrendo oblazioni al tuo ka al fine di nutrire dèi e uomini egualmente...12 12 R .O . Faulkner, The Lamentatiom o f Isis and Nephthys, «Mélanges Maspéro» voi. i,
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
267
Il preambolo che accompagna questo lamento illumina la sin golare polivalenza religiosa del testo in questione. Si tratta infatti, in primo luogo, di una lamentazione per una persona storica defi nita, cioè per una tale Tentruty, figlia di Tekhao, soprannominata Persis. Ma questa Tentruty è una Osiride, ed il testo del lamento che le è destinato è lo stesso di quello che le due dee recitano ritual mente nel tempio il 2 5 0 giorno del quarto mese dell’inondazione, cioè verso la fine del mese di Choiak, quando aveva luogo la semina sulle terre emerse per il ritirarsi delle acque del Nilo. Dal pream bolo apprendiamo anche che le lamentazioni di Iside e di Neph thys non giovano soltanto a dare stabilità e benessere all’Osiride Tentruty, figlia di Tekhao, e a ravvivare il mitico Osiride durante le cerimonie del quarto mese dell’inondazione, ma anche «a collo care Oro sul suo trono che appartiene a suo padre», cioè ad assi curare stabilità e continuità alla monarchia divina, al di là del destino di invecchiamento e di morte che colpisce i re al pari di tutte le persone storiche. D ’altra parte la lamentazione si apre con il tema, successivamente più volte rinnovato, del ritorno: «Torna a casa!», e si chiude con una reintegrazione nei cicli cosmici di quanto ha patito o può patire la morte: Osiride torna come sole, come luna, come Orione, come datore di vita che nutre uomini e dèi, rettili e quadrupedi, come ritmo periodico delle acque del Nilo che «alla stagione giusta» torna dal suo ritiro, spandendo l’ac qua della sua anima e prodigando il pane del suo essere. Si ha qui un gigantesco simbolo di destorificazione mitica che risolve nel l’eterno ritorno in ilio tempore lo storico non tornare di ciò che passa, il vuoto di essere che travaglia ogni permanenza e che alla fine appare proprio come un orrendo vuoto che si rischia di non poter oltrepassare. In questo simbolo polivalente che cancella la morte del re e la scomparsa della vegetazione nel mito di una suc cessione esemplare già avvenuta e di una già avvenuta esemplare riapparizione della vegetazione, anche il vuoto lasciato dalla morte di Tentruty, figlia di Tekhao, soprannominata Persis, è colmato per sempre: e la stessa lamentazione che vale per Osiride nume vegetale e re divino vale anche per lei, e Iside e Nephthys ripe337 sgg. (1934). C fr. J . de Horrack, Les lamentatiom d ’Isis et de Nephthys (Parigi 1906); e in J. de Horrack, CEuvres (Parigi 1907) pp. 33 sgg. Si veda anche C. I. Bleeker, Isis and Nephthys as wailing, Numen (1958).
268
C A P IT O L O S E T T I M O
teranno nel rito funerario a lei destinato ciò che già fu fatto allora, nelT/7/ο tempore del mito, per Osiride. La iterazione rituale della lamentazione nel quadro della mitica destorificazione protegge tec nicamente il lavoro del cordoglio per la morte di Tentruty, cosi come lo protegge per la scomparsa annuale della vegetazione o per la morte del re: le tentazioni della crisi sono riprese, controllate, riconvertite in atti di separazione e di rapporto, di allontanamento e di comunione, e riplasmate infine come ethos delle memorie e degli affetti, come valore della fedeltà e della tradizione, dell’or dine e della permanenza. All’ombra protettiva del metastorico oriz zonte che cancella la morte in uno scenario che coinvolge il corso degli astri e il periodico flusso delle acque del Nilo sono riguada gnate le espressioni più semplici dell’eterno drammatico ethos del cordoglio quando i sopravviventi si fanno coraggio ad oltrepassare la morte: «torna a casa... è tanto tempo che non ti vedo... I miei occhi ti cercano... Ma tu non senti la mia voce, sebbene io sia tua sorella che tu amavi sulla terra e sebbene non amavi altri che me, o fratello, o fratello...» E anche il mito dell’integrazione nell’e terno ritorno dei cicli naturali media e fa da trama ad un allonta namento che al tempo stesso è una riappropriazione ideale, un con tinuare a vedere il caro volto in una memoria interna che toglie a pretesto e a sostegno il ritorno della luna, o del sole o di Orione o delle acque del Nilo. Viene così compiuta la necessaria rinunzia all’impossibile materiale ritorno in carne e ossa e si risolve il «mai più » che forma il grande scandalo della morte e il tremendo pun giglione del lutto. Ci appare ora in tutta la sua tragica grandezza quel carattere del rituale funerario egiziano per cui in ciascun con creto evento luttuoso «ogni sposa diventava un’Iside, ogni figlio un Oro, ogni cognata una Nephthys, ogni amico un Anubis o un Thot».13 Si può anzi dire di più: la destorificazione della morte di Tentruty nel mitico destino di Osiride, e del cordoglio dei soprav vissuti nella rituale iterazione di un esemplare cordoglio di pri mordi dissolve i rapporti reali della concreta situazione luttuosa, e li traspone in un «come se» che non rispetta né sesso, né età, né effettivi legami di parentela. La Tentruty che realmente visse, e che potè avere in vita marito e figli, diventa nella morte un Osi 13 R. Pettazzoni, I misteri (1924) p. 157.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
269
ride pianto da Iside e da Nephthys; vi è infatti una sola morte, quella che il mito raffigura essere avvenuta e cancellata sul piano della metastoria, e tutte le concrete morti storiche e tutte le con crete famiglie colpite da lutto sono ricondotte nel mito e nel rito a quell’unica morte, a quell’unico cordoglio e a quell’unica reinte grazione dei primordi: solo per entro la implacabile coerenza tec nica di questa trama di destorificazione protettiva gli Egiziani sep pero cercare e infine guadagnare il rapporto morale con i loro morti. Senza dubbio in nessun’altra antica civiltà religiosa come in quella egiziana il pianto rituale fu esplicitamente unificato in un unico simbolo utilizzabile per tutte le sfere esistenziali in cui si manifesta il morire: e in nessun’altra civiltà come in quella egi ziana il vuoto della famiglia in lutto, il vuoto della vegetazione e il vuoto del trono furono colmati da uno stesso pianto al quale faceva da orizzonte uno stesso mito di morte di cordoglio e di rein tegrazione. Tuttavia questo rapporto, anche se non esplicito, aleggia su tutte le civiltà religiose del mondo antico. Il mesopotamico Tamuz era, al pari di Osiride, un nume che pativa la morte: e le annue lamentazioni per il nume dovevano con ogni probabilità essere impiegate durante il servizio funebre.14 La struttura dei lamenti destinati a Tamuz ricorda talora così da vicino il lamento per la morte di persone storiche che almeno in dati casi si è indotti a pensare ad una pura e semplice trasposizione di lamentazioni ori ginariamente limitate al rito funerario. Si consideri per esempio questo lamento in forma di dialogo tra il coro e la madre che ha perduto il figlio: O madre, o orbata, sei stata defraudata dei figli? Il figlio, il generato da Anu (ancor ragazzo), me lo hanno portato via. Ahi, sei stata defraudata dei figli? Colui che è il Signore, Ununuzida (ancor ragazzo), me lo ha portato via. Coro: Ahi, sei stata defraudata dei figli? Madre: L ’eroe, il mio Damu, ancor ragazzo me lo hanno portato via.15 Coro·. Madre: Coro·. Madre·.
Forme responsoriali di questo tipo in cui il discorso è diviso fra la persona colpita da lutto (o chi ne sostiene le parti) e il coro sono 14 Ibid., p. 207. 15 W itzel, Tamuzliturgien, pp. 77 sgg.
270
C A P IT O L O S E T T I M O
ben conosciute nel lamento funebre folklorico: il coro aiuta a pian gere secondo moduli stereotipi stimolanti il dispiegamento del cor doglio, e la persona in cordoglio risponde anch’essa per entro la protezione di schemi tradizionali. Nel caso specifico questa lamen tazione per Tamuz sembra la semplice trasposizione di un lamento reso da madre a figlio, con l’aiuto collettivo dei presenti. D ’altra parte quando un testo liturgico di questo tipo veniva recitato nel corso delle cerimonie destinate al nume, tutte le madri cui la morte strappò i figli avranno rammemorato in cuor loro i figli perduti, e così pure - di eco in eco - le spose i loro mariti, le sorelle i loro fratelli e così via: analogamente, come vedemmo nella sezione folklorica, ogni singolo lamento funebre destinato a persone storiche poteva essere occasione del rinnovo del lamento anche per altre persone precedentemente morte.16 Noi ora comprendiamo meglio perché ogni rito agrario destinato alla scomparsa e al ritorno del nume della vegetazione racchiudeva in sé una tendenza elettiva a diventare anche una vera e propria festa dei morti. Le cerimo nie destinate alla morte e al ritorno del nume della vegetazione erano altrettante occasioni per trattare anche i trapassi senza ritorno delle persone storiche: i morti vi tornavano anch’essi, ma per entro la protezione di una vicenda metastorica che li integrava in un desti no divino che in ilio tempore aveva reintegrato il morire del nume. Il rapporto di struttura e di funzione che lega insieme il lamento funebre destinato a persone storiche e il pianto rituale destinato alla scomparsa del nume della vegetazione presenta anche un altro aspetto interessante. Nella sezione folklorica avemmo occasione di accennare a quel tipo di lamentazione funeraria in cui ha luogo un dialogo fittizio fra la persona colpita da lutto (o chi la rappre senta) e qualcuno dei presenti (forse, in dati casi, il coro) che sostiene la parte del morto (oppure un dialogo fittizio in cui una stessa lamentatrice sostiene entrambe le parti). Vedemmo anche come il fondamentale significato tecnico delle lamentazioni di que sto tipo fosse quello di indurre a poco a poco nei sopravvissuti in cordoglio la persuasione della irrevocabilità dell’evento luttuoso, 16 Si veda a questo proposito la lamentazione al Cairo (pp. 13 5 sgg.) e i funerali di Laz zaro Boia (pp. 150 sgg.): al che fa riscontro, nel mondo antico, il passo Iliade in cui le ancelle lamentano in apparenza Patroclo, ma in realtà i loro propri lutti (p. 19 1 nota 44; cfr. i dati ricavabili dalla legislazione funeraria, pp. 19 1 e 275 sg.).
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
271
in quanto il morto stesso annunzia la sua nuova condizione e la impossibilità di tornare in vita «come prima». Così in un lamento delle colonie neogreche della penisola salentina la figlia sopravvis suta grida alla madre morta che ne aspetterà pazientemente il ritorno di ora in ora, e quando ogni speranza sarà dileguata anche lei la seguirà nella tomba: ma la madre morta risponde «Non aspet tarmi mai, figlia mia I mai in nessun tempo, I né per anni né per secoli, I né per il male né per il bene». Analogamente in un lamento funebre della Russia settentrionale - nel quale è rappresentato il momento del trapasso - la madre morente implora i figli di non tormentarla con le loro assurde richieste che urtano contro il fato inesorabile della morte incombente (cfr. pp. 140 sg.). Ora in Mesopotamia un testo liturgico relativo alla passione del dio Lillu17 riproduce nella sostanza la stessa struttura tecnica. La scena della rappresentazione rituale raffigura la sorella di Lillu, la dea Egi-me, in atto di lamentarsi sul nume morto, che giace già nella tomba. Egi-me supplica il fratello, in nome della madre Gasan-hursaga e di altri parenti divini, di «alzarsi dal luogo dove giace», cioè di resu scitare. Ma Lillu risponde annunziando il carattere definitivo del suo nuovo stato e la impossibilità del tornare in vita «come prima»: Per mio fratello levo il lamento, sempre di nuovo Levo il lamento, un canto di dolore per Lillu, Levo il lamento, una lamentazione per Lillu. Ripeto «sino a quando?», «sino a quando?», ripeto sempre «sino a quando?» O Lillu, tua madre ripete «sino a quando?» Tua madre Gasan-hursaga ripete «sino a quando?» Egi-me, signora dell’E-maha, ripete «sino a quando?» Atu-tur, che sovraintende il culto, ripete «sino a quando?» O fratello, tua madre ripete «sino a quando?» Il grande tempio di Kes ripete «sino a quando?» L ’E-mah di Adabb ripete «sino a quando?» Le mura di Adab ripetono «sino a quando?» Tua madre grida: o figlio mio, a chi ti posso affidare? Essa grida: o mio caro, a chi ti posso affidare? 17 Sul dio Lillu è da vedere F. Thureau-Dangin, La passion du dieu L illu , Rev. Assyriol., voi. 19, 17 5 sgg. (1922); e S. Langdon, The Epic o f Creation (1923) pp. 2 15 sg. Il dio Lillu è un trasparente nume della vegetazione, figlio di Gasan-hursaga (= signora della montagna), tipica dea madre. Il nome del dio è stato messo dal Thureau-Dangin in relazione con Lillu, che significa debole di mente e di corpo, «svigorito», «estenuato»: appellativi che ben si atta gliano a un nume della vegetazione che scompare. Nel mito di Lillu una parte notevole ha la sorella Egi-me, così come Gestin-anna nel mito di Tamuz.
C A P IT O L O S E T T I M O
27 2
La sorella parla al fratello così: O fratello mio, dal luogo dove riposi, alzati: tua madre si volge a te Tua madre Gasan-hursaga, tua madre si volge verso di te Il signore, il principe, il sacerdote supremo di Adab si volge verso di te Assurkic, il principe di Kes, si volge verso di te Atu-tur, in lacrime, si volge verso di te O Lillu tua madre nelle lacrime non la lasciare Tua madre Gasan-hursaga nei lamenti non la lasciare Egi-me in pena per te non la lasciare Non farla gridare, dal luogo dove riposi alzati! O Lillu, non farla gridare, dal luogo dove riposi alzati! Il fratello risponde alla sorella: Liberami, sorella mia, liberami O Egi-me, liberami, o sorella mia, liberami O sorella non mi rimproverare: un uomo che abbia la vista io non sono più. O Egi-me, non mi rimproverare: un uomo che abbia la vista io non sono più. O madre mia Gasan-hursaga, non mi rimproverare: un uomo che abbia la vista non sono più. Il luogo dove riposo è la polvere della terra: fra cattivi io riposo Il mio sonno è angoscia: fra nemici io sto. Sorella, non posso levarmi dal mio giaciglio.18 (a) E-mah: Tempio in Kes, città della Babilonia meridionale. (b) Adab, città della Babilonia meridionale, oggi Bismaja: sia a Kes che ad Adab vi erano templi di Lillu. (c) Assurki: divinità simile a Tamùz.
Lo schema è chiaro: alla domanda «sino a quando?» (cioè sino a quando resterai immobile nella tomba) e alla scongiurante richiesta «alzati! » il morto risponde di essere ormai morto e di non potersi levare dalla tomba mai più, proprio allo stesso modo che nel lamento neogreco più sopra ricordato. Nel testo liturgico mesopotamico il morto prosegue raccomandando l’esecuzione degli obblighi rituali funerari e invitando a slegare il silah: Che mia madre, che è rivolta verso di me, sleghi il silah Che Gasan-hursaga, che è rivolta verso di me, sleghi il silah Appresta un seggio: fa’ sedere il silah! Poni un panno, per coprire il silah!
18 Thureau-Dangin, /. c,\ H. Gressmann, AltoHentalische Texte zum alten Testament (2a ed. 1927) pp. 270 sg.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
273
Il Thureau-Dangin ritiene che il silah sia un «duplicato del morto, che una volta slegato potrà tornare fra i suoi»: ed effettivamente tutto lascia credere che il silah sia un sostituto reso sensibile me diante qualche oggetto ad hoc, che dovrà colmare o attenuare il vuoto della perdita, concentrando su di sé il lavoro del cordoglio. Ma un altro nesso è possibile intravedere nel mondo antico fra ri tuali funerari e rituali agrari, confermando l’organico rapporto fra pianto destinato alla morte di persone storiche e pianto per la scom parsa di un nume della vegétazione. Già vedemmo a proposito della lamentazione di Olonec la connessione fra lamentazione e ricerca rituale del morto, sino al suo ritrovamento in un ramo di betulla (cfr. pp. 14 1 sg.). Vedemmo anche come questo tema della ricerca del morto avesse una non trascurabile diffusione nel folklore euro mediterraneo, e come se ne trovasse traccia nel contesto di lamen tazioni anche quando la effettiva ricerca non veniva più dramma ticamente eseguita, come nel caso di alcuni lamenti neogreci della penisola salentina. Noi non abbiamo una conoscenza tanto compiu ta degli antichi rituali funerari da poter citare anche un solo esempio di ricerca rituale del morto: ma già l’attuale disseminazione folklorica del costume sembra spiegabile solo come relitto di un costume antico. D ’altra parte abbondano nelle antiche forme di vita reli giosa agraria i dati relativi sia alla ricerca rituale del nume scom parso (ucciso, rapito) sia alla corrispondente vicenda mitica. Così Dioniso era cercato dalle donne nelle Agrionia di Orcomeno,19 Kore da Demetra in Eieusi20 e in Samotracia,21 Icario da Erigone,22 Adone da Afrodite,23 Osiride da Iside,24 B a’al da ’Anat,23 19 Plut., Quaest. symp. 8, poem.; cfr. Quaest. gr., 38. 20 Lactant., Divin. instit. epit., 23: «Cereris... mysterìum est in quo, facibus accensis, Pro serpina requiritur; et ea inventa rìtus omnìs gratulatione et taedarum iactatione finitur». 21 Schol. Eur. Pbon. 7. 22 Atben. 14 , 6 i8 e; Etym. Magnum, ed. Hesych, s. v. 23 Si veda il lamento per Adone di Bion, 19 sgg.: « E Afrodite scioglie le trecce e va vagando per i boschi, frenetica, violenta, a piedi nudi. Le spine la lacerano, mentre procede, e raccolgono il suo sangue divino, ma essa passa per le radure, gridando e chiamando il suo giovane, il suo assiro signore». 24 Cfr. l’inno di Amon-Mose in Roeder, Urkunden zur Religion der alten Aegypt, p. 24: «Iside che lo cercò e a cui non vennero meno le forze per questo, colei che percorse questo territorio senza soste, e che non si fermò prima di averlo trovato». C fr. per altri dati, Roeder, op. c it , pp. 4 1 sgg., e Hopfner, p. 45. 25 «Anche Γ ’Anat vaga e gira I in ogni montagna, proprio nel centro della terra, I su ogni collina, I nei luoghi più riposti della campagna... per veste essa cinge un perizoma, 1 essa vaga
274
C A P IT O L O S E T T I M O
Tamùz da Istar26 per tacere di altri esempi minori come la ricerca di Ila e di Priolas-Bormos.27 Ora per quel che concerne la genesi di questo tema della ricerca rituale (o mitica) del nume della vege tazione scomparso è da osservare che una ricerca affannosa di una persona cara di cui si attende il ritorno e che invece non torna a casa e scompare appartiene alla cerchia delle reazioni profane naturali, indipendentemente da qualsiasi rito. In un vòcero còrso, per esempio, si riflette appunto una ricerca del genere, che la figlia disperata compie al lume della torcia (deda) per ritrovare il padre ucciso in un conflitto: «Io partu dalle calanche I circa quattr’ore di notte, I mi ne falgu cu la deda I a circà per tutte Torte, I per trovallu lu mio vabu; I ma Taxianu datu morte».28 Qui, salvo la nar razione resa nel ritmo del vòcero, la ricerca al lume della torcia non ha ovviamente nulla a che fare col rito: occorre tuttavia osser vare che tali ricerche affannose dopo disgrazie o assassini avve nuti nelle campagne o nelle selve (la frequenza di una tale con giuntura doveva essere altissima nel mondo antico) trapassò dalla vita reale nel rito e nel mito. Nel già ricordato lamento di Olonec la lamentatrice ha assistito alla morte naturale della persona cara, e tuttavia effettua una ricerca fittizia nei campi e nel bosco, sino al fittizio ritrovamento del defunto in un ramo di betulla, che sarà staccato dal tronco e portato a casa: qui siamo di fronte ad un rito, a cui fa da orizzonte il mito del morto integrato nel mondo vege tale. Noi intravediamo così ancora una volta la coerenza tecnica che dovette presiedere al rapporto fra rituali funerari e rituali agrari: la integrazione del morto nel mondo vegetale, al fine di attenuare sia le scomparse senza ritorno delle persone care, sia anche la pro spettiva della propria inevitabile scomparsa. Noi comprendiamo in lutto sulla terra, I alla maniera di un... essa si ferisce, I graffia il suo avambraccio, I solca il suo petto come fosse un giardino, I incide le sue spalle come fossero una valle, I fa udire la sua voce e grida: I B a’al è morto!» (Poema di B a’al, Gaster, Thespis, p. 194, cfr. pp. 199 sg.). 26 Witzel, Tamuzliturgien, passim. 27 Per Ha vedi Strab. 12 , 4, 3 e Apoll. Rhod. I, 135 0 sg.; per Priolas-Bormos cfr. Nymphis, fr. 9, F H G , III, p. 14; Domit. Callistrat., fr. I, F H G , IV , p. 35 3 ; ap. Schol. Aesch. Pers. 9 31; Apoll. Rh. 2, 780, e scol. rei. Quanto sia tenace questo tema pagano della ricerca dello scom parso è confermato dal relitto folklorico di un canto natalizio romeno dove Maria cerca Gesù al modo pagano: « E d essa venne, lamentandosi e gridando, I torcendosi le mani e lacerando il suo bianco volto, 1 piangendo nei suoi neri occhi e sospirando dal suo cuore, I procedendo per la strada, cercando il Figlio»; citato da T. Gaster, Folk-Lore, voi. 34, 73 (1923). 28 Marcaggi, op. cit., p. 150.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
275
ora meglio che cosa dovesse significare per l’iniziato dei misteri eleusini la silenziosa contemplazione di una spiga di grano mie tuta, e comprendiamo meglio anche che cosa volesse dire il poeta dell’inno a Demetra quando chiama beati coloro che hanno visto i sacri riti, e considera invece gli altri destinati a svanire nelle tene bre dell’Hade.29
2. Lamento funebre e vita culturale in Grecia e a Roma Per quanto in Grecia il lamento funebre non fu mai intermesso (Luciano accenna ancora, come vedremo, al suo tipico carattere responsoriale, con guida del pianto e periodiche incidenze corali di ritornelli emotivi), noi possiamo riscontrare tuttavia nel corso della storia greca per un verso i primi segni di una svalutazione polemica, e per un altro verso la risoluzione del lamento in forme letterarie e drammatiche sempre meno dipendenti dal rito come tale. Col tramonto dell’età eroica, nella quale la lamentazione ebbe particolare favore anche per ragioni di prestigio sociale, e con l’av vento delle democrazie cittadine, si fece valere contro questo tem29 Sempre neH’ambito dei problemi ierogenetici sollevati dal pianto antico sia funerario che agrario meriterebbe un’analisi particolareggiata la trasformazione dei ritornelli emotivi della lamentazione in numi a cui la lamentazione è resa. Così gli ioùloi del culto di Demetra si tra mutano nella dea delle messi Iouló, da alala il sumerico nume agrario Alala, dagli bylagmoì stagionali la mitica figura di Ila, e così via (per una rassegna di questi numi si veda C. Hoffmann, Aramàische Inschrìften aus Nerab bei Aleppo. Neue und alte Gòtter, Z. Assyriol. u. verw. Geb., voi. 1 1 , pp. 22 sg. (1896), ed i dati bibliografici contenuti in Gaster, Thespis, pp. 12 sg.). È nota la spiegazione che solitamente viene data di questo fenomeno così largamente rappre sentato nel mondo antico: si tratterebbe di incomprensione per l’esatto significato dei ritor nelli, i quali sarebbero stati scambiati per il nome dei numi invocati. Ora a parte il fatto che sono generalmente sospette le spiegazioni che attribuiscono ad equivoci e ad errori di interpre tazione fenomeni religiosi a larghissima diffusione e che si riproducono costantemente nei più diversi ambienti culturali (si ricordi, al limite, la teoria del mito come «malattia del linguag gio»), è da osservare che in questo caso la teoria dell’equivoco potrebbe avere una parvenza di vero per ritornelli emotivi di lingue straniere sconosciute: cioè ha qualche parvenza di vero che, per esempio, il ritornello emotivo egiziano maa n per. k (torna a casa!) sia stato scambiato dai Greci per Maneros come nome di un nume. Ma i Greci dovevano pur sapere che ίου era grido di dolore, di collera o di giubilo, e che ουλοι ο ίούλοι erano i lamenti rituali (Semos ap. Athaen. xiv, 618 d, F H G , IV , 495) e Δημήτρουλίη i lamenti connessi alla mietitura dell’ultimo manipolo di orzo (cfr. p. 231): come possa in questo caso, e in altri analoghi, essersi prodotto l’equivoco che ha condotto alla trasformazione del ritornello emotivo in un nume resta un mistero di difficile soluzione. A nostro parere tutta la questione va ripresa su altre basi, e noi stessi speriamo di poterlo fare in avvenire.
C A P IT O L O S E T T I M O
276
pestoso momento del rituale funebre una opposizione sempre più accentuata: l’esaltazione epica dell’individuo e la magnificenza dei funerali che si collegavano al th ren o s apparvero non più accetta bili alla nuova società.30 Questa diversa disposizione degli animi si esprime in una serie di disposizioni legislative che non sono dirette tanto contro il g o o s dei familiari durante la p ro tb esis, quanto piuttosto contro il carattere pubblico, collettivo, clamoroso e fastoso della lamentazione dell’epoca eroica. Solone vietò i th ren o ì elaborati per singole circostanze luttuose (τό θρηνεΐν πεποιήενμα), il costume di rinnovare i lamenti per lutti passati prendendo ad occasione ogni inumazione31 e la esposizione del cadavere fuori casa.32 Un analo go divieto di eseguire il p la n c tu s rituale fuori casa si ritrova in una disposizione legislativa di D elfi33 e in una di Keos.34 Analoghe misure restrittive sono attribuite a Licurgo per Sparta35 e a Caronda per Catane.36 La legge di Solone prescriveva inoltre che sol tanto le donne oltre i sessanta anni potessero partecipare al corteo funebre, a meno che non fossero strette parenti,37 e la legge di Iuli a Keos obbligava le donne di lasciare il sepolcro prima degli uomini:38 disposizioni che con tutta probabilità tendevano a ridur re o a moderare sia il concorso di lamentatrici che rinnovavano il cordoglio rituale per i loro lutti più o meno recenti, sia la partecipa zione femminile in generale, come quella che occasionava le più cla morose manifestazioni di cordoglio. D ’altra parte queste disposizioni legislative - simili a quelle contenute nella legge delle X II tavole non dovettero avere soltanto motivazioni politiche e suntuarie, ma più specificamente morali e di costume, se proprio Plutarco ci informa che Solone proibì il k o p e tò s perché rozzo e barbarico, e per la sua a k o b s i a ,39 cioè per la sua mancanza di misura (nello stesso spirito Luciano parlerà di a m etria delle lamentatrici).40 Non 30 Reiner, op. cit., p. 65. 31 Plut., Sol. 2 1; cfr. 12 . 32 Demost., 4 3, 62. 33 Diftenberger, SIG , I I 2, n. 438. 34 Dittenberger, SIG , I I I 2, n. 1 2 18 ; IG , X II, 5, 593. 35 Plut., lnstìtut. Lac. 18 . 36 Stob., Fior. 44, 40 (II, p. 15 3 Hense). 37 Charikles, III, 27. 38 Dittenberger, SIG , l. c. 39 Plut., Sol. 2 1. 40 Lue., Dial. Mori., X , 12 .
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
277
vi è dunque dubbio che col progresso della vita civile determinati moduli mimici del p la n c tu s più o meno ritualizzato dovettero appa rire inattuali e inaccettabili, almeno nelle più elevate sfere della gerarchia sociale e della cultura. La più elevata e complessa moti vazione di questa esigenza di civile misura si ritrova in alcuni passi della R e p u b b lic a e delle L e g g i di Platone. Nel quadro della educa zione dei reggitori della p o lis ideale Platone respinge innanzi tutto le figurazioni che rendono temibile la morte, e quindi i corrispon denti passi di Omero: respinge i nomi terribili e paurosi che si rife riscono all'al di là, quali Cocyto, Stige, le ombre dei sepolti (ενεpoi), gli spettri (άλίβαντες). Figurazioni di questo genere rendereb bero molli e snervati i reggitori, e pertanto vanno bandite dalla loro educazione. Per la stessa ragione il costume della lamenta zione dovrà essere loro estraneo: il saggio non teme la propria morte e non deplora quella dell’amico, ma come colui che ha meno biso gno degli altri, si dispererà meno degli altri se la morte gli toglie un figlio, o un fratello, o le ricchezze, o qualsiasi bene. Achille in atto di lamentare Patroclo, e ancor più Teti che deplora il destino di Achille, o Zeus afflitto per la morte di Ettore o per quella del figlio Sarpedone, non costituiscono esempi pedagogicamente rac comandabili: «Se in realtà, mio caro Adimanto, i nostri giovani prenderanno sul serio simili discorsi, invece di riderne come di debolezze indegne di dèi, sarebbe difficile, per loro che non sono che uomini, di crederli indegni di se stessi, e di rimproverarsi i propositi e gli atti simili a cui potrebbero pur essere indotti: ma alla minima contrarietà si abbandonerebbero senza vergogna e senza coraggio a pianti e a t h r e n o i ».41 Il lamento funebre è addirittura messo da Platone sullo stesso piano del femmineo incollerirsi e vana gloriarsi e smaniare per amore o infermità o doglie del parto: e la stessa condanna colpisce insieme al lamento quelli che proba bilmente saranno stati i tipi melodici propri dei th r e n o i (θρηνώδεις άρμονίαι), cioè il lidio misto, il lidio acuto e alcuni altri simili, dan nosi non solo per gli uomini ma anche per le donne.42 Tuttavia occorre tener presente che questa severità nei confronti del lamento concerne solo la città ideale e in particolare l’educazione dei reg gitori supremi: nelle L e g g i Platone prescrive soltanto che la p rò 41 Plat., Rep., 386a-388d. 42 Ibid., 395d-e.
C A P IT O L O S E T T I M O
278
thesis non avvenga fuori casa43 e che al corteo funebre partecipino solo donne che abbiano superato l’età della fecondità, a meno che non siano strette parenti, e ciò con ogni probabilità al fine di limi tare il concorso di lamentatrici occasionali che rinnovano il cor doglio per i loro lutti passati. Saranno altresì interdette le lamen tazioni (θρηνεΐν) e il gridare (φωνήν εξαγγέλλει) in pubblico, e il rivolgersi al morto durante il trasporto.44 Nelle istruzioni relative ai funerali dei censori Platone sostituisce ai threnoi e ai pianti tra dizionali un responsorio di semicori formato da quindici giovanetti e da quindici giovanette schierati da ciascun lato della bara: que sto responsorio canterà inni composti in onore dei sacerdoti.45 Questo atteggiamento polemico nei confronti della threnetica riposa sulla persuasione che dopo la morte non si può portare al defunto nessun soccorso da parte dei vivi, e che le spoglie mortali dell’ani ma immortale non giustificano il lusso dei funerali: basterà un mo derato dispendio, come per un altare agli inferi deserto di vita.46 Non a caso gli unici spunti polemici contro la threnetica nel suo complesso e contro lo stesso goos dei familiari si trovano in un’opera filosofica come la Repubblica, che concerne la città ideale: nella città reale però né il goos né il threnos furono mai intermessi e soltanto se ne cercò di moderare, ingentilire e interiorizzare le forme in parte per ragioni politiche e in parte per esigenza civile di misura. Manca in ogni caso una polemica religiosa plasmatrice del costume: l’accenno delle Leggi al nessun soccorso che i vivi pos sono portare ai morti con l’imponenza dei funerali e del planctus rituale, e l’affermazione che più che giovare ai morti occorre aiu tare i vivi nell’esercizio della virtù, racchiudono un pensiero che è già nettamente orientato in senso filosofico e che comunque non 43 Leggi 959a-e. 44 Ibid. 9596-9603. 45 Ibid. b. 46 Ibid. ( . Per una raccolta di spunti polemici contro il lamento funebre fra gli scrit tori greci si veda J . Leipoldt, Der Tod bei Griechen und Juden (Lipsia 19 4 2) PP- I " - (Totenklage und Bestattung): il Leipoldt omette però stranamente nella sua rassegna la polemica plato nica. Da ricordare è anche il filosofo accademico Krantor di Soloi, che nel suo scritto consolatorio περί πέντους (indirizzato ad Ippocle in occasione della morte del figlio), sostiene in polemica con la άπάΟεια degli stoici la μετριοπάθεια come giusta reazione all’ evento luttuoso (cfr. Arnim, Pauly-Wissowa Realenc., voi. r i (1922) cc. 1585 sgg.). Occorre comunque osservare che que sti scritti consolatori pagani ispirati a riflessioni filosofiche sulla morte esercitarono una rela tiva efficacia solo per entro molto ristrette cerehie di intellettuali, e non mai operarono come vere e proprie forze plasmatrici del costume.
947 959 3
22 47
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
2
79
ebbe nessuna efficacia radicale sul lamento funebre come rito e costume collettivi. Nel secondo secolo d. C. Luciano può darci del rituale funerario un quadro nel quale appaiono in pieno vigore il planctus rituale, l’accompagnamento άεΙΓαύλός, la presenza di una guida dei threnoi (θρήνων σοφιστής), il goos reso dai parenti (lamento di padre a figlio).47 La civiltà greca si mantenne dunque fedele, nel suo complesso, al lamento funebre rituale, e lo stesso Solone ebbe una volta a esprimere il desiderio di essere compianto nel modo tradizionale:48 però, al tempo stesso, essa lavorò più di ogni altra civiltà del mondo antico a liberare il lamento funebre dal suo originario carattere rituale e a risolverlo in forme letterarie pro fane. Nella sua unità originariamente rituale di responsorio fra guida e coro, il lamento funebre greco accenna ad un importante svi luppo culturale: la tragedia. Aristotele nella Poetica definisce il commo come lamento eseguito sia dal coro che dalla scena,49 e d’altra parte nella forma più antica della parodo l’attore è al tempo stesso il corifeo, in ciò fedelmente rispecchiando la struttura del lamento rituale.50 Come giustamente osserva il Nestle, la Presa di Mileto e le Fenicie di Frinico, i commi di chiusura dei Persiani e dei Sette contro Tebe, la parodo delle Coefore, i commi e le mono die nello stile delle Troiane di Euripide sono impensabili senza il modello del lamento funebre, e senza postulare una imitazione della sua struttura rituale.51 Senza dubbio l’elemento più propriamente mimetico fu dovuto all’influenza del thiasos dionisiaco, ma il rap47 Lue., de luctu, cap. 1 1 , 12 , 19 ; cfr. c. 13 (lamento di padre a figlio). 1,8 Fr. 22, D, 5. 49 Arist., Poet. 1 4 5 2 ^ 24. 50 W . Nestle, Die Struktur des Eingangs in der attiseben Tragódie (Stoccarda 1930) pp. 18 sg. 51 Nestle, ibid. Per il rapporto fra lamento funebre e tragedia è da vedere M .P . Nilsson, Tragodie und Totenklage, Arch. Religionswiss. (1906) pp. 286 sgg.; e Der Ursprung der Trago die, N euejahrb. klass. Altertum, voi. 27, 609-42 ( 19 11) rist. in Opuscola Selecta (Lund 19 5 1) pp. 61 sgg. Circa poi gli έξάρχοντες τόν διθύραμβον del famoso luogo della Poetica, W. M. Cal der ha cercato di dimostrare, sulla base di una iscrizione frigia, che il ditirambo era in origine il lamento funebre anatolico, recitato davanti al monumento sepolcrale fornito di una porta a due battenti, o da due porte vicine, talora simbolicamente rappresentate; cfr. The Ditbyramb. An Anatolian Dirge, Classical R ev„ voi. 36, 1 1 - 1 4 (1922). Ora al mutamento della natura del ditirambo dall’Asia anatolica alla Grecia sembra accennare il frammento di ditirambo di Pindaro destinato ad essere eseguito a Tebe: «Un tempo si trascinava, come lunga gomena, il canto dei ditirambi, I e questo maledetto 5 usciva I dalla bocca della gente. I Ma ecco che ora si aprono porte I nuove per le sacre danze... » Vien fatto di chiedersi se il carattere di litania e l’accenno alle porte non si riferiscano all’epoca in cui il ditirambo era un canto funebre epitimbio nella originaria patria anatolica.
28ο
C A P IT O L O S E T T I M O
porto fra «guida del pianto» e «incidenza corale dei ritornelli emo tivi» costituisce se non proprio la cellula germinale almeno un ele mento importante nello sviluppo strutturale della tragedia greca. Battendo un’altra direzione di sviluppo il lamento funebre com posto per determinate esecuzioni rituali mette capo al threnos lirico, completamente sciolto dal rito come tale. E dubbio se i th re n o i di Pindaro furono realmente eseguiti nel rito funerario: in ogni caso tale esecuzione, se mai ebbe luogo, è un fatto secondario. Non si tratta più ormai di impiegare mezzi tecnici definiti per ridare orizzonte al discorso compromesso dalla crisi, e di orientare tale tecnica nel senso del mito e del rito, ma l’accento ormai batte sulla personale rappresentazione della morte espressa dal poeta. I ritor nelli periodici dei parenti e i moduli letterari da iterare perdono gradualmente di senso in questo affrancamento dagli schemi pro tettivi del rito. Come giustamente osserva il Reiner, solo attra verso l’emancipazione dai vincoli rituali sia rispetto alla forma che al contenuto il lamento potè diventare espressione lirica del senti mento di un poeta.52 Ma in una terza direzione si orienta la riso luzione del lamento funebre greco: cioè verso l’orazione funebre. La cessione della guida del coro a cantori e lamentatrici professio nali favorisce in generale il progresso di autonomia del discorso individuale, poiché gli specialisti del pianto possono realizzare un maggiore distacco dalla immediatezza della situazione luttuosa come tale e quindi anche una maggiore protezione dai rischi della crisi del cordoglio. D ’altra parte sia il g o o s dei familiari che il th ren o s degli aedi erano tecnicamente predisposti alla celebrazione delle res gestae del defunto: il bisogno di ridischiudersi al valore perma nente dell’opera nel momento stesso in cui si manifesta lo scan dalo di ciò che passa senza e contro l’uomo determina largamente il contenuto del discorso della lamentazione funebre. In Grecia questo processo conduce alla formazione dell’επιτύμβιος αίνος cioè all’esaltazione degli erga del defunto fatta alla tomba, e quindi - col favore di determinate circostanze sociali e politiche - al λόγος επιτάφιος, cioè all’orazione funebre in prosa quale omaggio col lettivo reso dalla p o lis ai soldati morti in guerra.53 Anche qui noi 52 Reiner, op. city p. 82. Su Simonide e su Pindaro come creatori del threnos indipendente dal rito si veda ibid., pp. 83 sg. 53 L. Weber, Solon und die Schòpfung der attìschen Grabrede (1935), passim. Il Weber con-
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
281
riscontriamo una emancipazione delle circostanze più strettamente rituali, quali la incidenza periodica dei ritornelli emotivi e i moduli letterari mimici e melodici del th ren o s individuale, e intravediamo uno sviluppo per cui la celebrazione delle res gestae prende la forma del discorso funebre in prosa, letterariamente autonomo e perso nale. Quando invece accanto ai temi elogiativi prenderanno parti colare rilievo quelli consolatori, si costituirà quel genere dell’ora toria funeraria che nella classificazione di Menandro di Laodicea va sotto il nome di παραμυθητικός λόγος.54 Anche la n en ia romana presenta a questo riguardo interessanti sviluppi culturali. Mentre i ritornelli emotivi che dovevano punteggiare l’antica n en ia fini rono con l’enuclearsi nel momento rituale autonomo della c o n c ia m a tto eseguita subito dopo il bacio che raccoglieva l’ultimo respiro del morente,35 dal vero e proprio discorso individuale della n e n ia si staccò la la u d a tio , sia quella detta dalla prefica prima della nenia, sia la pubblica orazione in prosa recitata dai parenti o da qualche amico nel foro, alla presenza del popolo e delle im a g in es degli ante nati.56 A questa risoluzione della n e n ia nella la u d a tio (salvo, s’in tende, il persistere delle nenie dei parenti durante la c o llo c a t io e l’intervento di prefiche che non pare sia mai stato intermesso) si accompagna un palese disprezzo nei ceti colti, almeno da Plauto in poi, per le nenie e le lamentatrici in generale.57 Particolare in teresse presenta la evoluzione semantica del vocabolo n en ia che è stato impiegato nei seguenti diversi significati: a) lamento fune bre; h) incantesimo magico; c) ninna-nanna; d ) frivolezza, cosa vana; e) giuoco infantile. Tale vicenda semantica si spiega molto bene se si assume come significato fondamentale della parola quello di «lamento funebre»: infatti il lamento è effettivamente, sia per il gettura addirittura che la cellula germinale deU’alvt^ sia da ricercarsi nel χαιρε, cioè nell’estremo saluto reso al sepolcro. Per la tesi che Solone, il riformatore del rituale funerario attico, fu anche il creatore dell’orazione funebre in prosa, cfr. Weber, op. cit.y p. 67. Senza dubbio lo sforzo di interiorizzazione e di approfondimento del culto funerario che traspare dalla riforma di Solone ben si accorda con lo sviluppo della orazione funebre libera da vincoli strettamente rituali ed ormai risolta in senso meramente letterario e morale. 54 Per la classificazione di Menandro cfr. A. C. Rush, Death and Burial in Christian Antiquity (Washington 19 4 1) pp. 258 sgg. 35 B . Riposati, M. Terenti Varronis de vita populi romani (Milano 1939) pp. 220 sgg. 36 C fr. H. de la Ville de Mirmont, Nenia, Revue Phil., voi. 26, 263 sgg., 335 sgg. (1902), ristampato in Etudes sur Γanciennepoésie latine (Parigi 1903) pp. 359 sgg.; Weber, op. cit., p. 85. 57 Luoghi relativi in J . J . Heller, Trans, amer. philol. Ass., voi. 84, 2 15 - 18 (1943).
C A P IT O L O S E T T I M O
282
suo modo di esecuzione sia per il fine che si propone, un incante simo, e al tempo stesso ha una parentela strutturale con la ninna nanna appunto perché deve suscitare, come vedemmo, lo stato oniroide controllato della presenza rituale del pianto. Infine il signi ficato di «cosa vana» o di frivolezza è da assegnarsi alla polemica colta contro la rozza nenia popolare, e quello di «giuoco» può richia marsi sia alla connessione fra lamento funebre e momenti più pro priamente ludici del rituale funerario (si pensi ai buffoni e ai mimi dei funerali romani, ovvero alle rozze oscenità rituali sul tipo di quelle dei funerali di Lazzaro Boia): ma si può pensare anche allo scadimento lusorio del lamento funebre, imitato dai bambini nei loro giuochi, come è attestato da innumerevoli esempi folklorici, e in particolare dal singolare esempio, già a suo tempo esaminato, di «Marameo perché sei morto?»58 Nella polemica della patristica occidentale, e soprattutto in san Gerolamo, la parola nenia ritiene soltanto il significato negativo di chiacchiera vana, delirio, favola eretica.59 Infine va ricordato come il παραμυθητικός λόγος si svol se nella consolatio cristiana. G ià gli apocrifi Atti di Pietro e A tti di Andrea mostrano come la mentalità cristiana fosse orientata verso l’orazione funebre quale parte integrante del funerale: ma soltanto col quarto secolo, con la vittoria della Chiesa e la conquista della sua libertà, ha inizio la classica età delle orazioni funebri cristiane, con i massimi elaboratori di tale genere che furono Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa in Oriente e Ambrogio in Occidente.60
3. Israele e la crisi del pianto rituale antico In un senso completamente diverso operò sul lamento funebre la storia religiosa di Israele. Senza dubbio noi non ritroviamo nel 58 Lo Heller, op. cit, sostiene la tesi che il significato originario di nenia fu quella di giuoco, e che il significato di funebre carmen appartiene alla tradizione dotta: ma è tesi poco persuasiva. Anche N .I. Herescu, Revue Études latines, voi. 25, 74 sgg. (1947), riconferma in sostanza, in polemica con lo Heller, il significato fondamentale di nenia come carmen funebre e cantus lugubrìs. 59 C fr. per esempio Gerolam., In Mattb. Praef. (Wordsworth-White) I, 14 : omnes apocryphorum nenias mortuis magis bereticis qrnrn ecclesiasticis v'tvìs canendas-, praef. Vulg. Pent., HeyseTischendorf, xxxm : quod multi ignorantes apocryphorum deliramenta sectantur, et Iberas naenias libns authenticis praeferunt. 60 C fr. H. Delahaye, Les passions des martyrs et les gemei littéraires (Bruxelles 19 2 1) pp. 18 1-2 35 ; L· Méridier, Vìnfluence de la seconde sopbistique sur Voeuvre de Grégoire de Nysse (Parigi 1906) pp. 2 2 5 -5 1; Rush, op. cit., p. 265.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
283
l’Antico Testamento nessuna polemica esplicita contro le lamenta zioni funerarie come tali; al contrario gli accenni al rito sono copiosi. In modo diretto possiamo ricavare l’informazione che David la mentò Saul e Gionata61 e Saul rese un canto funebre ad Abner,62 il che attesta il lamento dei parenti. D ’altra parte lamentatrici spécia liste del pianto venivano mandate a chiamare in occasione di eventi luttuosi,63 e i lamenti venivano trasmessi sia oralmente di madre in figlio o da donna a vicina,64 sia mediante apposite raccolte.65 Il lamento nella sua esecuzione reale comportava la iterazione perio dica di un ritornello emotivo (m is p e d ) col quale gli assistenti scan divano le strofe della q ih d , e questi ritornelli erano tradizionalizzati in un limitato numero di forme espressive, come A h , fr a t e llo m io ! A h , s o rella !, H o , h o !, ovvero A h S ig n o re ! quando si trattava di un re.66 Anche un profeta come Geremia compose una lamentazione funeraria per la morte di re Giosia.67 La q ìn à funeraria possedeva un metro caratteristico, il cosiddetto q ìn à m etro , che constava di due emistichi il secondo dei quali era più corto del primo per una o due sillabe toniche: ne risultava un ritmo accentuato particolarmente adatto per esprimere la disperazione del cordoglio.68 Molto proba bilmente anche in Israele vi erano melodie tradizionali per la q in a funeraria: a giudicare dalle sopravvivenze folkloriche della Palestina attuale doveva trattarsi di melodie molto monotone e a lungo pro tratte, che a lungo si mantengono su uno stesso tono per muoversi soltanto di un mezzo o di un intero tono sopra o sotto.69 Anche in Israele, come in Grecia e in Roma, vi furono prescrizioni legisla tive che senza colpire il lamento come tale intendevano moderare le forme più aspre del plan ctu s rituale, e in particolare le offese gravi recate al proprio corpo. Si legge nel D e u te r o n o m io : Siate figli del Signore Dio vostro: non vi farete incisioni, né vi raderete i peli tra gli occhi, per un morto: poiché tu sei un popolo sacro al Signore Dio tuo, e te ha scelto ad essere il suo popolo speciale fra tutti i popoli che si trovano sulla faccia della terra.70 61 2 Sam. 1, 19-27. 62 2 Sam. 3, 33-34. 63 Ger. 9, 17 . C fr. Amos. 5, 16. 64 Ger. 9, 20. 65 2 Chr. 35, 25. 66 1 Re 13 , 30; Ger. 22, 18 e 34, 5; Am. 5 , 16. 67 2 Chr. 35, 25. 68 Heinisch, op. cit., p. 1 5 ; cfr. Iahnow, op. cit., p. 92. 69 Iahnow, op. cit., pp. 80 sg. 70 Deut. 14, 1 . C fr. Lev. 19, 28 e 20, 5 dove la prescrizione concerne solo i Leviti.
284
C A P IT O L O S E T T IM O
Tuttavia la disposizione moderatrice non si fonda, come in Gre cia o a Roma, su ragioni politiche o di costume, ma fa esplicito appello a ragioni religiose: Israele è popolo speciale del Signore anche nei corpi, e l’attentato al proprio corpo è manomissione alla pro prietà di Dio. Qui noi ci imbattiamo in un orientamento compietamente nuovo che sarà di grande momento sul destino della lamen tazione funeraria. L ’esperienza religiosa della morte che fu propria delle civiltà «pagane» del mondo antico fu riplasmata come abbiamo visto, nella sfera delle passioni vegetali, cioè nella grande destorificazione dell’eterno ritorno. Nella religione osiriana questa destorificazione comportava un unico trapasso e un’unica reintegrazione avvenute una volta tanto nel mito e indefinitamente iterabili nel rito: comportava altresì un unico pianto e un unico giubilo meta storici, mediante la cui iterazione rituale venivano destorificate le tre fondamentali sfere in cui nel mondo antico sporgeva il morire: cioè il vuoto dell’uomo morto, il vuoto della vegetazione, il vuoto del trono. La religione di Israele rompe con questa tradizione in virtù della berìth, cioè del patto o alleanza fra l’unico Iddio ed il suo popolo speciale. La destorificazione dell’eterno ritorno viene decisamente respinta e per la prima volta nella coscienza culturale dell’umanità viene gettato quel germe che fruttificherà come rico noscimento della irreversibilità della storia: l’alleanza con Abramo introduce nel mondo un mutamento qualitativo che non potrà mai essere cancellato, e che è destinato a crescere e a dilatarsi secondo un piano divino inserito nella dimensione del tempo. La ciclicità dell’essere è spezzata: ha inizio invece la spirale di una storia sacra che narra mirabilia dei. Anche se talora il profetismo riprende i vecchi schemi dei riti stagionali con le loro tremende descrizioni delle scia gure che si abbattono sulla vita dei campi e con i loro lamenti, peni tenze, agoni e giubili per il rifiorire della vegetazione e della vita, in realtà non si tratta di una iterazione della esemplare vicenda dei primordi, ma di una esplorazione di segni per contemplare la trama della irripetibile storia santa. Questo rapporto traspare per esem pio nella profezia di Gioele, che si apre con uno scenario di desola zione vegetale per l’invasione delle cavallette: Ciò che la cavalletta ha lasciato la locusta lo ha divorato. Ciò che la locusta ha lasciato il bruco l’ha divorato.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
285
Ciò che il bruco ha lasciato il grillo lo ha divorato. Svegliatevi, o ubriaconi, e piangete: voi tutti, bevitori di vino, lamentatevi, poiché il mosto vi è stato strappato di bocca! Ché un popolo ha invaso il mio paese, un popolo potente e innumerevole. I suoi denti sono denti di leone, e le sue mascelle sono di leonessa. Ha saccheggiato la mia vigna ha distrutta la mia ficaia... Alza grida come vergine cinta di sacco per lo sposo della tua giovinezza Sono nel lutto i sacerdoti servitori dell’altare. I campi sono devastati; il suolo è in lutto. Ché il grano è distrutto, il mosto andato a male; l’olio, sciupato. I contadini sono confusi; i vignaiuoli alzano grida di cordoglio per il frumento e per l’orzo, ché la messe dei campi è perduta.
All’appello al digiuno e al pentimento segue l’annunzio dell’ av vento del «giorno di Jahve», con la finale raffigurazione di una defi nitiva reintegrazione: In quel giorno, le montagne stilleranno vino nuovo e le colline gronderanno latte. Tutti i ruscelli di Giuda avranno acqua; Una fontana zampillerà dalla casa di Jahve e bagnerà la valle di Chittim...
Il testo nel suo complesso racchiude numerosi richiami agli schemi stagionali (seasonal pattern): la vergine che piange vestita di sacco per l’amante (B a'al) della sua giovinezza ricorda la vergine ’Anat che lamenta la scomparsa di Ba’al o Isthar che lamenta Tamuz, anch’esso «l’amante della sua giovinezza»; lo scenario iniziale di desolazione e quello finale di ripresa lussureggiante della vita trova
286
C A P IT O L O S E T T I M O
riscontri nei testi di Ras Shamra; e così pure le lamentazioni, i di giuni, le penitenze, il combattimento ecc. richiamano altrettanti momenti caratteristici dei rituali agrari collegati con la passione vege tale di un nume:71 ma queste particolarità sono ora abbassate a segno e simbolo di un corso unico della storia santa instaurato dal l’evento della b erìth . Questo radicale mutamento di prospettiva spezzava però anche quel rapporto che nelle civiltà religiose pagane aveva legato insieme il lamento funebre per persone storiche, il pianto rituale per pas sioni vegetali e il pianto mitico delle origini reso da nume a nume nella esemplare vicenda di trapasso e di reintegrazione. Con lo scon volgersi di questa tessitura ierogenetica il lamento funebre desti nato alle persone storiche venne a perdere la molteplicità di oriz zonti mitico-rituali in cui era stato ricompreso e riplasmato nelle civiltà religiose pagane. Al geloso esclusivismo di Jahve era sostan zialmente estranea una religione dei morti come forze autonome da placare e da propiziare, da allontanare e al tempo stesso da inte riorizzare: era quindi estraneo anche il lamento funebre, che si inse riva organicamente in tale dialettica. Se di fatto il lamento funebre rituale si mantiene lungo tutto il corso della storia religiosa di Israele, ciò comincia già ad apparire come fatto folklorico, come sopravvi venza tenace, impartecipe della dominante linea di sviluppo del monoteismo ebraico.72 Al contrario appartiene in pieno a questa linea la trasformazione della q ìn à funeraria nella q ìn à profetica, cioè la trasposizione del lamento, sia in forma individuale che collet tiva, sul piano politico-religioso e morale-religioso. Così la raccolta di q ìn ó t che nella traduzione dei L X X va sotto il nome di th re n o ì contiene quattro lamenti collettivi che hanno per argomento la caduta di Gerusalemme nel 586 e la conseguente rovina della città. In una ancor più mediata riplasmazione profe tica l’antica q ìn à funeraria diventa il lamento funebre anticipato (m àchàl) rivolto per lo più a grandezze politiche nemiche di Israele, come il re di Babilonia,73 la città di Tiro,74 e il suo re,75 il Farao 71 Per i seasonalpattern affioranti nell’Antico Testamento, si veda Gaster, op. cit.y pp. 42 sgg. (profezia di Gioele) e pp. 73 sgg. (Salmi). 72 Cfr. A. Weiser, Einleitung in das alte Testament (Stoccarda 1939) pp. 24 sg. 73 Is. 14, 4 sgg. 74 Ez. 27, 2 sgg. 75 Ez. 28, 1 1 sgg.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
287
ne,76 i re di Giuda.77 In generale la q ìn à profetica mantiene alcuni caratteri della q ìn à funeraria tradizionale, in primo luogo il metro. Inoltre al pari della q ìn à funeraria la q ìn à profetica non vale sol tanto per la particolare circostanza storica a cui è legata, ma può essere periodicamente ripetuta in cerimonie commemorative: i th re n o ì che la traduzione dei L X X attribuisce a Geremia si riferiscono alla distruzione di Gerusalemme del 586, ma furono con ogni pro babilità rinnovati ogni anno al 7 e al io del quinto mese, almeno sino ai tempi del profeta Zaccaria.78 D ’altra parte le q in ó t profe tiche erano lavorate in modo da introdurre una certa indetermina tezza e genericità intenzionali nell’occasione concreta che ne costi tuisce la data di nascita, e ciò rendeva possibile la loro utilizzazione e il loro riadattamento a circostanze analoghe, proprio^ come nel caso del lamento funebre tradizionale. Una stessa q in a profetica poteva valere per ogni nuova invasione di cavallette, per ogni nuova siccità o carestia, per ogni nuova epidemia, per ogni nuova scia gura politica: così ancora oggi il libro delle lamentazioni è letto nelle sinagoghe nel servizio serale col quale ha inizio la giornata di lutto del 9 del quinto mese, data convenzionale della distruzione sia del primo tempio (586 a.C.) che del secondo (70 d.C.). Ma a parte questi rapporti, e gli altri che concernono le affinità di stile e l’impiego di analoghe locuzioni, la q ìn à profetica si distingue nettamente da quella funeraria —come si è detto —proprio per la sua profonda integrazione nel dramma della storia santa di Israele, e per il suo netto distacco dal pianto rituale pagano connesso con le passioni vegetali. Non si tratta più di una destorificazione che tende a risol vere il morire dell’uomo e della vegetazione nella iterazione di un identico modello metastorico di trapasso, di pianto e di reintegra zione, ma di un’altra tecnica destorificatrice che chiude la storia nel lasso di tempo compreso tra la vocazione di Abramo e il giorno di Jahve, fra un inizio assoluto e la speranza di un’assoluta conclu sione futura, nel quadro di un patto stretto fra l’unico Iddio e il suo popolo speciale: ma intanto, per entro i limiti di questa chiu sura protettiva, comincia ad apparire l’esperienza di un divenire contesto di eventi unici, rivelatori di un piano che si attua nel tempo. Mentre il pianto rituale pagano riassorbiva di continuo la prolife76 Ez. 32, 2 sgg. 77 Ez. 19, 2 sgg. 78 Cfr. Zach. 7, 3 sgg. e 8, 19.
288
C A P IT O L O S E T T I M O
razione dell’accadere nelTzY/o tempore mitico del «già accaduto» e del «già reintegrato», la qtnà profetica lasciava trasparire la sua data storica e il memorabile evento politico o morale che vi si era pro dotto: la vergine ’Anat che intemporalmente aveva pianto la scom parsa di B a’al si è tramutata ora nella vergine di Israele, cioè in un vivente popolo della terra immerso nel tempo e nel suo dolore. Per quanto la storia religiosa di Israele spezzi per un verso il legame del lamento funebre pagano con il pianto rituale connesso con le passioni vegetali, e per un altro verso riplasmi la qtnà fune raria nella qtnà profetica, la crisi decisiva del lamento funebre come rito pagano ha luogo soltanto con l’avvento del Cristianesimo. Quando la «storia santa» di Israele trovò il suo coronamento con l’incarnazione, un nuovo grande evento irreversibile si impiantò nel cuore della storia umana: e il divino di questa storia non fu più patto di alleanza di Dio con un popolo speciale, e drammatica attesa del giorno di Jahve, ma assunzione della morte e riscatto compiuti dal Dio-Uomo, dal Cristo, per tutti i popoli della terra. Alla destorificazione pagana orientata verso la iterazione rituale delle «ori gini» metastoriche, e alla destorificazione giudaica orientata verso l’attesa del «termine» della storia, si contrappone ora la destorifi cazione di un evento «centrale» che ha deciso il corso storico: un evento per cui la salvezza è data, e già comincia il Regno che ha reso la morte apparente, sino alla seconda definitiva parousia.
4. La polemica cristiana In questo quadro va collocata la polemica cristiana contro il la mento funebre pagano. La crisi decisiva, e la nuova scelta culturale, si annunzia nel famoso episodio della figlia del capo della sinagoga: Mentr’egli diceva queste cose, ecco che uno dei capi della sinagoga, accosta tosi, si inginocchiò dinanzi a lui e gli disse: «L a mia figliuola è appena morta: ma vieni, imponi la tua mano su di lei, ed essa vivrà! » E Gesù alzatosi, prese a seguirlo in compagnia dei suoi discepoli... E quando fu giunto a casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine in clamore (καί ίδών τούς αύλητάς, καί τον δχλον θορυβούμειον), disse loro: «R iti ratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò, e prese la fanciulla per mano, ed essa si alzò. E se ne divulgò la fama per tutto il paese.79
19 Mt.
9, 18-26 e passi paralleli di Marco e di Luca.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
289
Anche il lamento dei familiari durante il corteo funebre è respinto da Gesù in un episodio in cui è scelto per modello proprio il caso più disperato, la morte del figlio unico di una madre vedova: Ed avvenne che egli era in viaggio per una città chiamata Naim. E andavano con lui i suoi discepoli e una gran folla. E quando fu vicino alla porta della cit tà, ecco che veniva portato a sepoltura un figlio unico la cui madre era vedova, e gran folla della città seguiva la donna. Vedendola Gesù ne senti compassione e le disse: «Non lamentarti» (μή κσλαΐε). E si avvicinò alla bara e la toccò. E quelli che la portavano, si fermarono. Ed egli disse: «Giovinetto, ti dico, alzati». E il morto si alzò e cominciò a parlare. Ed egli lo rese alla madre...80
La stessa vicenda è ripetuta da Pietro al letto di morte della pia Tabitha: Viveva in Joppe una discepola, di nome Tabitha, che interpretato vuol dire Dorcas [gazzella]. Essa riboccava di buone opere e delle molte elemosine che fa ceva. Accadde che, in quei giorni, si ammalasse e morisse. E lavata che l’ebbe ro, la posero nella stanza superiore della casa. Ed essendo Lydda vicino a Joppe, i discepoli avendo saputo che Pietro vi si trovava, mandarono due nom ini da lui che lo pregassero: «Non ti sembri troppo grave venire da noi». E Pietro si alzò e andò con essi. Quando fu giunto lo condussero alla stanza su periore. E lo circondarono tutte le vedove che lamentavano la morta, mostran dogli le tuniche e le vesti che ad esse Dorcas preparava. Ma Pietro, cacciati fuori tutti, piegate le ginocchia pregò e rivoltosi al corpo, disse: «Tabitha, alzati». E lei aprì gli occhi e veduto che ebbe Pietro, si mise a sedere. E datole la mano, la fece alzare. E chiamati i santi e le vedove, la presentò loro viva. Si sparse la fama del fatto per tutta Joppe: molti credettero nel Signore.81
A ll’episodio esemplare di Gesù che vince la morte nella figlia del capo della sinagoga fa riscontro l’episodio esemplare di Pietro che vince la morte di Tabitha cristiana: e in entrambi gli episodi il miracolo si compie dopo aver cacciato le lamentatrici, che non potevano trovar luogo nella nuova epoca religiosa inaugurata da Gesù. Isaia aveva profetato il tempo in cui il Signore avrebbe creato nuovi cieli e una nuova terra, quando non si sarebbe più udito in Gerusalemme voce di pianto né grida di dolore:82 la tradizione cri stiana mantiene questa visione escatologica di un tempo terminale in cui «Dio detergerà tutte le lacrime dei loro occhi, e morte più non sarà, né grida, né dolore»,83 ma l’accento batte sull’ attualità 80 Le. 7, 12 -15 . 81 Atti 9, 36-42. 82 Isaia, 65, 17*19. 83 Apoc. 2 1, 4.
290
C A P IT O L O S E T T I M O
della redenzione, per cui già la morte non è più, è diventata appa rente, in virtù della passione e della risurrezione dell’Uomo-Dio. Durante l’ascesa al Calvario le donne intonano i tradizionali lamenti, ma Cristo solennemente li respinge: Molta folla lo seguiva, anche di donne, le quali si percuotevano il petto (έκόπτοντο) ed eseguivano lamentazioni per lui (έύρήνουν αυτόν). Ma Gesù si rivolse loro e disse: Figlie di Gerusalemme, non fate lamenti su di me (μή κλαίετε έπ’ έμέ), ma su voi stesse e sopra i vostri figli...84
Con queste parole il cordoglio si sposta dalla morte fisica del l’uomo a quella morte morale che è il peccato: al centro della storia sta ora la morte esemplare dell’Uomo-Dio, una morte che vince la morte e che per questa vittoria è «primizia dei dormienti», onde poi anche i dormienti risorgeranno con corpi incorrotti al suono dell’ultima tromba, come dirà Paolo.85 Da ora in poi, nella nuova coscienza religiosa e culturale, il morire naturale non dovrà più appa rire nella sua scandalosa forza autonoma, ma sarà ricondotto a quella vera forza annientatrice che è il peccato come «pungiglione della morte». Con ciò però appare decisa la sorte dell’antica lamenta zione funeraria, e chiusa per sempre la sua epoca storica. Al cri stiano non si addice il lamento davanti alla morte, ma se mai un sommesso versar lacrime, secondo il modello di Gesù al sepolcro di Lazzaro: καί έδάκρουσεν ó Ίησοΰς.86 Agli occhi di Paolo l’antica lamentazione appare come ignoranza che denega l’opera di Gesù e che quindi è incompatibile con la nuova condizione del cristiano: Ora, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati, come gli altri che non hanno speranze. Poiché se crediamo che Gesù morì e resuscitò, così pure quelli che si sono addor mentati, Iddio, per mezzo di Gesù, li ricondurrà presso di sé.87
La polemica aspra ed intransigente contro il lamento funebre e più generalmente contro la mancanza di misura nel cordoglio88 è rinnovata e sviluppata dalla letteratura cristiana dei primi secoli.89 84 Luca, 23, 27-29. 85 1 Cor. 15 , 1-14 . 86 Giov. n , 35. 87 1 Tess. 4, 12 -13 . 88 Nel loro fervore polemico gli scrittori cristiani non distinguono fra mero parossismo, planc ton (o kopetòs) più o meno ritualizzato e nenia (o threnos)'. anzi, come vedremo, sembrano talora coinvolgere nella condanna anche il semplice fletus (il versar lacrime), almeno oltre misura. 89 Per i dati di questa polemica cfr. Quasten, Musik und Gesang in den Kulten der heidni-
291
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
Spunti e motivi si trovano già in Tertulliano, Origene e Cipriano.90 In un passo famoso del suo De mortalitate Cipriano ricorda come i morti non debbono essere compianti, avendoli il Signore chia mati a sé e liberati dal mondo: con la loro partenza essi in realtà ci precedono, e pertanto non li dobbiamo considerare come per duti, ma solo mandati innanzi nel desiderabile viaggio. Coloro che compiangono i morti prevaricano la loro fede e la loro speranza di cristiani, contraddicendo con gli atti ciò che affermano di cre dere a parole, e offrendo in tal modo ai pagani uno spettacolo di incoerenza che giustifica le loro critiche.91 Ma il campione della lotta contro il lamento funebre è senza dubbio Giovanni Criso stomo. Ricollegandosi all’ ammonimento di Paolo nella prima let tera ai Tessalonicesi, il Crisostomo svolge una efficace argomen tazione contro il lamento funebre: Non io proibisco di piangere i morti, ma l’apostolo che ha detto: «N on voglio, o fratelli, che siate in ignoranza circa i dormienti, affinché non siate contri stati come coloro che non hanno speranza». La chiarezza del Vangelo non può essere offuscata dal fatto che piangevano i morti coloro che vissero prima della Legge o durante la sua epoca. Costoro con ragione piangevano poiché Cristo non era ancora venuto dai cieli, quel Cristo che con la sua risurre zione asciugò le lacrime dei loro occhi. Costoro con ragione piangevano, poi ché la risurrezione non era stata ancora predicata.92
Anche l’episodio della figlia di Jairo e quello della resurrezione di Lazzaro sono inseriti nel quadro dell’argomentazione polemica: Tu però dirai: nell’evangelo fu pianta la figlia del capo della sinagoga, e le so relle di Lazzaro piansero Lazzaro. Ma la mente di costoro era sino a quel mo mento ancora sotto l’imperio della vecchia Legge, non avendo ancora visto Cristo risorgere dai morti. Anche il Signore versò visibilmente lacrime davanti al sepolcro di Lazzaro, ma non lo fece per offrire un modello al piangere i morti, ma per mostrare attraverso le lacrime di aver assunto un corpo reale.93
295 347
schen Antike und christliche Friihzeit (Miinster i. W ., 1930) PP· ' > e A. C. Rush, Death and Furiai in Christian Antiquity (Washington 1941) pp. 176-84. Sempre come raccolta di dati può essere ancora utilmente consultata la vecchia monografia di G . Zappert, Uber den Ausdruck des geistigen Scbmerz itn Mittelalter, Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, voi. 5, 73-146 (1854). Per la formazione del rituale funerario cristiano si veda, in generale, L. Ruland, Die Geschichte der christlichen Leichenfeier (Ratisbona 1901 ) e per le soprav vivenze pagane e i compromessi in questo settore cfr. J. Lippert, Christentum, Volksglaube und Volksbrauch (Berlino 1882) pp. 383 sgg., 399 sgg. 90 Per i luoghi relativi si veda Rush, op. a i ., p. 178. 91 Cipr., De mori. 20. 92 Cris., De cons. moriis, PG , 56, 296. 93 Ibid.
292
C A P IT O L O S E T T I M O
Ricorda quindi due comportamenti esemplari davanti alla morte nell’Antico Testamento (la madre dei Maccabei e David), traendo da ciò argomento per consolidare le motivazioni del comportamento cristiano: Che se David, ancora sottoposto alla Legge, e quindi se non alla licenza almeno alla necessità della lamentazione funebre, seppe sciogliere il suo animo dalla irrazionalità del lutto, noi che già siamo sotto la Grazia e sotto la certa speranza della risurrezione (il che ci interdice ogni tristezza) come osiamo piangere i morti secondo il costume dei pagani, come leviamo insani ululati, o in altro modo baccheggiando ci denudiamo il petto e ci laceriamo le vesti, e andiamo cantando vani canti sul corpo e sulla tomba dei defunti?94
Può dunque piangere e lamentarsi davanti alla morte il Giudeo che non crede in Cristo, così come è da compiangere il catecu meno cristiano che per sua incredulità o per negligenza dei parenti muoia senza battesimo: ma quando un cristiano abbandona que sto mondo la sua sorte dev’essere per i vivi argomento di deside rio, non di compianto, e d’altra parte questo desiderio sia mode rato dalla certezza che in futuro ci ricongiungeremo a lui. L ’unico salutare cordoglio del cristiano è quello per la vera morte del pec cato.95 Svolgendo omileticamente l’episodio della figlia di Jairo il Crisostomo precisa il significato esemplare della cacciata delle lamentatrici operata da Gesù prima di compiere il miracolo, chiu dendo con ciò un’epoca della morte e inaugurandone una nuova in cui la morte diventava sonno: Se però già allora il Signore cacciò via costoro (cioè gli esecutori del lamento), tanto più ora. Allora non si sapeva che la morte era un sonno: ma ora questo è chiaro come il sole... Nessuno in futuro dovrà dunque effettuare il lamento funebre e disperarsi e screditare l’opera di salvezza di Cristo. Egli ha ormai vinto la morte. Che cosa dunque tu lamenti in modo cosi clamoroso? La morte è ormai diventata sonno. Che cosa gemi e piangi? La cosa fa già ridere quando la fanno i pagani. Se però anche un credente in Cristo non se ne vergogna, come scusarlo? Quale indulgenza meritano coloro che sono così sciocchi, e proprio ora che da così gran tempo sono state addotte prove tanto chiare della resurrezione? Tu però, proprio come se volessi darti premura di aumentare ancora il tuo peccato, continui a prendere donne pagane come lamentatrici per rendere più intenso il cordoglio e attizzare l’ardore del dolore, e non ascolti S. Paolo che dice: «Che cosa ha da fare Cristo con Belial? E che cosa ha in comune la fede con l’incredulità?»96 94 Ibid. . 95 ibid., 303. 96 In Matth. Hom., PG , 5 7 , 374.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
293
Con estrema chiarezza Giovanni Crisostomo tratteggia l’opposi zione fra le due epoche della morte, quella antica dominata dal planctus e dalle lamentazioni e quella cristiana in cui la morte, dive nuta ormai apparente e pausa di sonno prima dell’eterno risveglio, doveva essere accompagnata col giubilante innalzarsi dei salmi e degli inni: ... Prima durante i funerali avevano luogo planctus (κοπετός) e lamento (θρήνος), ora risuonano invece salmi e inni. Per quaranta giorni i Giudei lamentarono Giacobbe ed eseguirono il planctus, e per altrettanti giorni Mosè. Infatti allora la morte era morte. Ora però non è più così, ma inni e preci e salmi, che manifestano il carattere gioioso dell’evento: infatti i salmi sono simbolo di animo sereno... Per questo noi salmeggiamo per i morti...97
La polemica del Crisostomo contro il threnos e il kopetòs è con dotta innanzi con tanto rigore da coinvolgere addirittura lo stesso versar lacrime, almeno nella misura in cui esso manifesta una dispe razione contraria alla fede. Qui noi tocchiamo il vertice del dramma cristiano per quel che concerne il comportamento davanti alla morte: per un verso il rigore logico che procede dalla nuova fede comanda una dolce invidia per il fratello morto, per un altro verso la natura umana estorce lacrime anche ai cristiani allorché il fra tello abbandona il mondo. Ed ecco che a sciogliere questo dramma appare ora il modello di Gesù, il quale sommessamente e breve mente versò lacrime sul sepolcro di Lazzaro. Nella sua omelia al passo di Paolo, I Tess., 4. 1 2-1 3, il Crisostomo abbandona la giu stificazione di quel versar lacrime come testimonianza di reale cor poreità o come compianto per la incredulità dei Giudei, e contra riamente alla tesi sostenuta in De consolatione mortìs parla proprio di quel versar lacrime come di un modello del cordoglio cristiano: «In qual modo - chiederai - da uomo qual sono non dovrò patire cordo glio?» Non dico questo: non il cordoglio vieto, ma il suo eccesso. Infatti essere in cordoglio appartiene alla natura, ma l’esserlo oltre misura appar tiene alla mania, al delirio, all’animo muliebre... Gesù piangendo Lazzaro pose una regola ed un termine al piangere. Mi vergogno, credetemi, e arros sisco, quando vedo per le piazze torme di donne che senza decoro si strap pano capelli, si lacerano le braccia e le ginocchia, e questo fanno sotto gli occhi dei pagani.98
97 De S. Bemice et Prosd., P G , 50, 634. 98 Hom. de dormientibus, P G , 48, 10 19 .
294
C A P IT O L O S E T T I M O
La stessa contrapposizione fra lamento pagano e misura di Gesù al sepolcro di Lazzaro si può leggere in un’altra omelia del Cri sostomo: (Le donne) nelle lamentazioni e nei pianti si abbandonano ad esibizioni, denu dano le braccia, si strappano i capelli, si graffiano le gote, alcune per dolore altre per ostentazione, altre per impudicizia... Che cosa fai, o donna? Ti denudi turpemente, nel mezzo della piazza, tu che sei membro di Cristo, e questo in pubblico davanti agli uomini? Strappi le chiome, stracci le vesti, dai in ululati, vai ballando a imitazione delle menadi e non ritieni di recar offesa a Dio?... «M a come - dirai - da uomo qual sono non mi è concesso piangere?» Non vieto questo, ma il percuotersi, la sregolatezza nel piangere. «G esù versò lacrime per Lazzaro»: e anche tu fallo; lacrima, ma sommessa mente, con riservatezza e con pudore, con timore di D io."
Di questa radicale riplasmazione del comportamento davanti alla morte fanno fede taluni funerali cristiani nei quali i partecipanti si sforzano di testimoniare a favore del nuovo eth o s cristiano. Nella sua orazione in morte del fratello Cesario, Gregorio di Nazianzo ci offre il modello di comportamento della madre cristiana: ... La sua venerabile e preziosa polvere, condotta al riposo fra canti incessan ti, trasportata in festiva processione al luogo dei martiri, adornata dalle sante mani dei suoi genitori, onorata dalla madre, che in luogo del cordoglio appa riva vestita a festa in pia adorazione, con saggia rassegnazione frenando le lacrime e contenendo con il canto dei salmi l’impulso a intonare i th renoi.™
Ma soprattutto i funerali di Monica, la madre di Agostino, pos sono valere come drammatico modello di costume cristiano, qui impegnato a contendersi persino lo sfogo naturale delle lacrime: Io le chiusi gli occhi. Una immensa tristezza rifluì nel mio cuore, pronta a tramutarsi in lacrime: ma al tempo stesso i miei occhi, per l’imperioso comando della mia volontà, ne riassorbivano la sorgente sino ad essiccarle; e in questa contesa grandemente pativo. Nel momento in cui Monica spirò, Adeodato, fanciullo, ruppe in lacrime, ma da noi tutti fu costretto a tacere. E fu la sua voce giovanile - voce del cuore - che fece tacere anche in me quel tanto di puerile che mi induceva alle lacrime. Infatti non giudicammo conveniente celebrare quella cerimonia con lacrimosi lamenti e con gemiti, poiché così si suole compiangere il destino sventurato di chi muore ed il suo totale annientamento: ma Monica non era né infelice né per nulla morta, come ce ne rendevano testimonianza la purezza della sua vita e la schietta fede, di cui per ragioni sicure la sapevamo dotata.991001 99 In Johann. Hom., P G , 62, 3 16 e 347. 100 Greg. Naz., Oratio VII in laudem Caesarìs fratria, P G , 35, 773. 101 Agost., Confess. 9, 12 , 29.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
293
Ci par quasi di sorprendere in v iv o un momento di drammatica sospensione fra le due età della morte, quella pagana e quella cri stiana, e la scelta storica che infine trionfa, allorché represso lo scoppio di pianto di Adeodato, e quasi per dar corpo al nuovo sen tire cristiano, Evodio afferrò il salterio, intonando il salmo del con fidente abbandono alla misericordia e alla giustizia divina: C o h ib ito ergo a fle t o ilio p u ero , p salteriu m a rrip u it E v o d iu s e t cantare c o ep it p s a lm u m , c u i resp o n d e b a m u s o m n is d o m u s : m is e ric o rd ia m e t iu d i-
Eppure dopo la sepoltura, e dopo l’inutile ricorso superstizioso al bagno che avrebbe dovuto, secondo la credenza tradizionale, lenire l ’angoscia, al risveglio da un sonno riparatore e avvertendo la solitudine del nuovo giorno, anche Ago stino sentì la dolcezza del pianto: del che, come già Ambrogio per la morte del fratello,103 si confessa a Dio come di debolezza che appartiene alla natura umana: c iu m c a n ta b o tib i, D o m in e .102
Ed ora, Signore, io vi confesso tutto ciò in quest’opera: lo leggerà chi vorrà, e lo interpreterà come vorrà. E se qualcuno giudica che ho peccato pian gendo mia madre per breve tempo, questa madre morta temporaneamente ai miei occhi e che per tanti anni aveva pianto affinché io vivessi ai vo stri -, se qualcuno giudica così, si guardi tuttavia dallo scherno, e se è vera mente caritatevole pianga lui per i miei peccati davanti a Voi che siete il Padre di tutti i fratelli del vostro Cristo.104
Se il passaggio dall’antica alla nuova epoca della morte si confi gurava quale dramma negli stessi massimi fondatori del costume cristiano, e se anche essi pagavano il loro tributo alla natura umana cedendo se non alla prevaricazione del pagano lamento almeno alla violenza delle lacrime, ben si comprende come più intense doves sero essere le tentazioni del passato nella media delle persone meno compenetrate dalla forza della fede. G ià negli A t t i d e g li a p o s to li si legge che Stefano fu compianto con un grande k o p e tò s (καί έποίησαν κοπετόν μεγαν επ’ αύτω):105 ed in generale nei primi secoli dell’era cristiana le ricadute nel prisco costume dovettero costi tuire non l’eccezione ma la regola. Quando mori Macrina, la sorella di Gregorio Nisseno, si salmeggiò tutta la notte come per la vigi102 Ibid., 9, 12 , 2 1. 103 «Lacrimavi, ergo, fateor, etìam ego, sed lacrytnavit et Domittus... »: De excessu fratris, I, 9, io . C S E L , p. 2 14 Faller. 104 Agost., Confess. 9, 12 , 33. 105 A tti 8, 1-2.
296
C A P IT O L O S E T T I M O
lia di un màrtire: eppure al momento in cui si mise in movimento il corteo funebre si levarono dalla folla convenuta le antiche lamen tazioni, che si mescolarono al canto dei salmi, onde a fatica potè essere ristabilito l’ordine cristiano dei funerali.106 Gregorio di Nazianzo narra che durante i funerali di Basilio vescovo di Cesa rea di Cappadocia la nuova saggezza cristiana fu come travolta dal parossismo ed i salmi restarono sommersi dai threnoi (ψαλμοδίαι ύρήνοις ύπερνικώμενοι): dalla folla che seguiva la salma altissimo si levò il tumulto, e vi furono persino dei morti, la cui sorte fu però considerata fortunata poiché erano morti in una occasione come questa.107 Nella quarta omelia alla Epistola agli Ebrei il Cri sostomo, dopo aver ancora una volta delineato il quadro indeco roso del cordoglio rituale pagano, prega e addirittura scongiura di far bene attenzione a quel che si cantava nel corso dei funerali: M a fa ’ attenzione a quel che canti in quel periodo: «Ritorna, anima mia, al tuo riposo, poiché il Signore ti ha molto beneficato». E ancora: «N on temerò il male, poiché tu sei presso di me». E inoltre: «Sei il mio riparo nella sventura che mi ha serrato nelle sue braccia». F a ’ bene attenzione a ciò che questi salmi vogliono dire. Ma tu non vi presti attenzione, sei ebbro di cordoglio. Almeno fa ’ attenzione nei funerali altrui, in modo da poter trovare la medicina per i funerali che riguardano persone della tua famiglia. «Ritorna, anima mia, al tuo riposo, poiché Dio ti ha molto beneficato»: come puoi dir questo e al tempo stesso piangere? Si tratta forse di rappresenta zioni sceniche e di finzioni da istrioni? Infatti se credi in quel che dici, vano è il tuo cordoglio; se invece ciò che dici è soltanto rappresentazione scenica e simulazione, e credi che siano favole, perché allora salmeggi? Perché tol leri quelli che vanno salmeggiando e non piuttosto li cacci via? «M a questo - dirai - è da invasati». Quello però che tu fai lo è molto di più .108
Evidentemente il Crisostomo era vivamente preoccupato dal fatto che i funerali cristiani presentavano di regola una miscela di salmi e di threnoi, e che non di rado i threnoi sommergevano i salmi. Se ora ci volgiamo all’Occidente e diamo uno sguardo alle monarchie feudali dell’Europa medievale, constatiamo come sino al secolo decimoquarto la pagana lamentazione non soltanto restò in vita nella pratica privata di tutti i ceti sociali, ma mantenne un carattere pubblico in occasione della morte di personaggi illu 106 Greg. N iss., De vita Macnnae, P G , 46, 992. 107 Greg. N az., Oratio VII in laudetn Basilii Magni, P G , 36, 601. 108 Cris., In ep, ad Haebr., P G , 63, 43.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
297
stri, e soprattutto in occasione della morte di re o di membri della famiglia reale. G ià avemmo occasione di osservare l’ampiezza delle manifesta zioni di cordoglio nelle Chansons de geste: qui vorremmo ricordare le scene di lamentazione che accompagnarono la morte del figlio di re Carlo, ucciso da Huon: pleurent les dames, escuter et sergeant tordent lor puins, lo cavex von tirant trestot regretent Karlot le combatant grani duel deminnent li grani e li petit .103
Nella Chronica Adelfonsi imperatoris, scritta intorno al 1 1 50, è riportato un lamento funebre che le donne di Toledo avrebbero reso al capitano Munio Alfonso, morto il i ° agosto 1 1 43: Per molti giorni la moglie di Munio Alfonso, con i suoi amici e le altre vedove vennero al sepolcro di Munio Alfonso, ed eseguivano il pianto, e dicevano così: «O Munio Alfonso, noi ci lamentiamo su di te: come moglie che ama il suo unico marito, così la città di Toledo ti amava. Il tuo scudo non mai piegò in guerra, e la tua lancia non mai tornò indietro, e la tua spada non mai operò a vuoto. Non annunziate la morte di Munio Alfonso a Cordova e a Siviglia, non l’annunziate nel palazzo di re Texufino, affinché non gioi scano le figlie dei Moabiti ed esultino le figlie degli Agareni e si rattristino quelle dei Toletani ».110
Anche se questo lamento - visibilmente ricalcato nella sua seconda parte sul lamento di David per Gionata, 2 Re, 1,20-22, non sarà stato probabilmente quello effettivamente eseguito dalle donne di Toledo per il condottiero morto, tuttavia il passo della Cronaca prova almeno che in quella occasione si tenne un com pianto pubblico collettivo, e che in circostanze del genere la costu manza era in vigore. Quando nel 1252 morì Ferdinando III il Santo, ebbero luogo grandi manifestazioni pubbliche di cordoglio, e il ero109 Huon, 12 2 4 sgg., cfr. Zimmermann, Die Totenklage in den altfranzòsischen Cbanson de geste (1889) p. 17 . Per le sopravvivenze germaniche i dati e la bibliografia relativa in O. Ranke, Indogermanische Totenverehrung (19 5 1) pp. 96 sg., p. 287 note 1 e 2. In generale il lamento funebre pubblico per personaggi illustri scompare nell’ Europa occidentale verso il secolo deci moquarto: non così nell’ Europa orientale, dove si protrae molto più a lungo, in rapporto anche alla maggiore tolleranza della Chiesa orientale. Così per esempio in Russia il lamento funebre domina la vita privata e quella pubblica sino al 1 7 1 5 quando prendendo occasione della morte della zarina Maria Matvejevna Pietro il Grande vietò i pubblici compianti di corte (cfr. Mahler, Die russische Totenklage, pp. 19 sgg.). 110 Chron. Adel. imp. 86: citata in Ramon Menendez Pidal, Sobre primitiva lirica espanola, Cult, neol., voi. 3, 203 (1943).
298
C A P IT O L O S E T T I M O
nista della Primera Crònica General riferisce che mai come in quella occasione si videro « tanta duenna de alta guisa et tanta donzella andar descabennadas et rascadas, rompiendo les fazes et tomandolas en sangre et en la carne viva »; né mai come in quella occasione si videro « tanto infante, tanto rico omne, tanto infangon, tanto cavaliere, tanto otnne de prestar andar baladrando, dando bozes, mesando sus cabellos, et rompiendo las fruentas et faziendo en sy fuertes cruezas».ni
5. Il declino del pianto antico e la «Mater Dolorosa» Non rientra nella economia del presente lavoro l’analisi parti colareggiata delle sopravvivenze medievali dell’antico lamento fune bre rituale. Da un punto di vista storico-religioso tali sopravvi venze, medievali o moderne che siano, hanno un valore storico o per ricostruire il lamento antico ovvero per lumeggiare le resi stenze contro cui la Chiesa fu chiamata a combattere nel corso della sua opera plasmatrice del costume. Gioverà pertanto un accenno a quest’opera positiva, e ai modi con i quali essa si svolse. Stabilita in linea di principio la netta opposizione fra lamento fune bre pagano e concezione cristiana della morte, il conflitto si spo stò molto per tempo sul piano della denunzia degli abusi e della formulazione delle pene spirituali contro i trasgressori. Già il Cri sostomo nel passo più sopra ricordato della sua omelia sull’ Epi stola agli Ebrei passa dalla raccomandazione alla ammonizione per coloro che si abbandonano a kopetòi e threnoi, e intanto formula una precisa pena spirituale per coloro che incorrono nella colpa più grave di chiamare nei funerali lamentatrici prezzolate: Per ora mi limito all’ammonizione, ma col protrarsi dell’abuso perseguirò tale comportamento con maggiore severità, poiché ho gran timore che con tinuando le cose ad andare così un gran danno sia per sopravvenire alla Chiesa. E successivamente prenderò misure anche per il kopetòs : per ora mi limito a denunziarlo, vivamente scongiurando ricchi e poveri, donne e uomini... Se però dovesse aver luogo un amaro evento di morte e qualcuno dovesse assoldare lamentatrici, ebbene credi alle mie parole perché parlo come sento, costui per lungo tempo lo escluderò dalla comunità dei fedeli come idolatra .1 112 111 Primera Crònica General, cap. 1 1 3 4 (p. 773 ed. di Madrid, 1906). 112 Cris., In Ep. ad Hebr., P G , 63, 43 sg.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
299
Ed ecco le prime misure disciplinari a carattere ufficiale, fis sate nei canoni dei concili e dei sinodi. Tra i canoni dei Padri della Chiesa greca che costituiscono le fonti del diritto canonico del patriarcato di Alessandria si può leggere la seguente formulazione disciplinare: È stato portato davanti alla nostra assemblea il caso di singoli uomini i quali allorché sono colpiti da un evento luttuoso pensano come ipocriti intorno all’universale reggimento dell’onnipotente Iddio e come se, al pari dei pagani e di altri, non riconoscessero la resurrezione dei morti, e come uomini sciocchi e senza raziocinio... manifestano pubblicamente quanto sia grande il loro cordoglio, specialmente le donne, che si strappano i capelli, si stracciano le vesti, si graffiano le guance, fanno musica con timpani, tamburi e flauti, abbattono palme e altri vegetali, stanno a lungo in cordoglio, e fanno altre simili cose che contrastano con la fede. Ora ordina il sinodo che coloro i quali sono colpiti da lutto debbono trattenersi nelle chiese, monasteri o case silenziosi, calmi e seri, come si addice a coloro che credono nella verità, cioè nella resurrezione, e ne sono persuasi, e si debbono consolare con ciò con cui i sacerdoti e gli altri veri credenti li consolano. Chi si comporta altri menti l’intero sinodo lo scomunica e gli interdice l ’ingresso in Chiesa .113
Per l’Occidente è da ricordare il canone 220 del terzo sinodo di Toledo (589), dove si prescrive di accompagnare il defunto al solo canto dei salmi, e si proibisce rigorosamente «il carme fune bre che il volgo suole cantare ai defunti», ammonendo che i vescovi debbono «per quanto possibile» indurre i credenti e «almeno» gli ecclesiastici ad abbandonare la pagana costumanza.114 La legisla zione civile non tarderà ad ispirarsi a quella ecclesiastica, aggiun113 W . Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrìen (Lipsia 1900) p. 1 9 1 . Circa l’abbattimento di palme e di altri vegetali cui fa cenno il passo, è molto probabile che si tratti di dendrokopia funeraria analoga al taglio dell’abete nel documento folklorico dei funerali di Lazzaro Boia (cfr. pp. 166 sgg.), 0 addirittura ad una ricerca rituale del morto con ritrova mento in una betulla dalla quale si spicca un ramo, come nella lamentazione di Olonec (cfr. pp. 1 4 1 sg.). Anche il canone 40 del concilio nestoriano del 576 fa menzione di lamentatrici che «si radono i capelli, strappano le vesti, si lamentano e gemono, suonano tamburini e altri strumenti musicali, t a g l i a n o a l b e r i » . Il canone si limita a prescrivere di starsene in silenzio e calma nelle chiese e nei monasteri, esibendo un contegno conforme a chi nutre la speranza della risurrezione, e cercando consolazione soltanto in ciò che sarà loro detto dai dottori, dai sacerdoti e dai veri fedeli; J. B. Chabot, Synodicon orientale ou recueilde synodes nestoriens (Parigi 1902) p. 376, cfr. p. 489. Lo Chabot respinge come privo di senso il «taglio di alberi» e inter preta il luogo relativo del testo come «suonar le nacchere» (ma la dendrokopia rituale funera ria è un fatto ben noto nel mondo antico e nei suoi relitti folklorici). Il tentativo di istituire feminae canonicae et ascetriae che dovevano cantare inni durante i funerali (cfr. Corpus Juris Civilis, Novellae, L IX , 4, 320 Schoell-Kroll) fu abbandonato per le ricadute cui dava luogo: cfr. Quasten, op. cit., p. 302. 114 Mansi 9, 999. Cfr. Corpus Jur. Can. Decr. l i p. Caus. 13 , Quaest. 2, cc. 25-28.
300
C A P IT O L O S E T T I M O
gendovi talora la crudezza delle pene pecuniarie e corporali. Un modello del genere sono le Sette Partidas, in cui l’antitesi fra lamento funebre e concezione cristiana della morte è ragionata con gli argo menti tradizionali, e sono comminate pene spirituali contro coloro che si abbandonano a «duelos desaguisados per los muertos».115 Ma la Chiesa non operò soltanto con la polemica dei Padri e con i canoni dei sinodi, o influenzando la legislazione civile delle monarchie feudali del Medioevo, e successivamente delle costitu zioni comunali: vi fu anche una sua azione pedagogica più inte riore e religiosamente impegnata mercé la efficacia storica della figura della Mater Dolorosa nella scena della Passione. In perfetta coerenza con la solenne affermazione della vittoria di Cristo sulla morte e con la polemica sulla lamentazione pagana, il Nuovo Testa mento non conosce un pianto di Maria. In Giovanni, 19.25-27, Maria appare alla croce come muta spettatrice, e l’evangelista non pone sulla sua bocca nessuna espressione di dolore: Maria madre di Gesù, Maria di Cleopha e Maria Maddalena vi sono rappresen tate in atto di s t a r e davanti alla croce, chiuse in un patire inte riore e raccolto, che guadagna in singolare efficacia etica proprio per il fatto che noi appena intravvediamo nello scenario della Pas sione il disegnarsi di queste tre ombre silenziose e immobili. Tutta una tradizione si ricollega a questo interiore patire, cui Ambrogio contendeva anche lo sfogo delle lacrime {stantem illam lego, flentem non lego),116 e che nella sequenza dello Stabat Mater si ravviva e umanizza in un contemplare velato di lacrime: «Stabat Mater Dolorosa I iuxta crucem hcrymosa I dum pendebat filius: I cuius animam gementem, I contrìstatam et dolentem I pertransivit ghdius». Sulla linea di questa tradizione non troverebbe posto, a stretto rigore, la rappresentazione drammatica del dolore di Maria secondo 115 Las Sette Partidas, p. i, tit. IV, 96-100. Come esempio di pene pecuniarie e corporali inflitte alle Iamentatrici può valere il cap. 10 1 delle Constitutiones Federici regis Siciliae, dove si legge: « Quoniam reputationes cantus et soni qui propter defunctos celebrante, animos astantium convertunt in luctum, et movent eos quodammodo ad injuriam creatoris, probibemus reputantes funeribus adesse vel aliae mulieres, quae earum utuntur ministerio, nec in domibus seu ecclesiis vel sepulturis, vel alio quocumque loco, nec pulsentur circa funebria guidemae vel guitemae, vel timpana, vel alia solita instrumenta, quae ars magis ad gaudium quam ad tristitiam adinvenit, poena unciarum auri quattuor mulctandis iis, qui eas admiserint circa hoc, et ipsis reputatricibus simìliter: quae reputatrices si poenam solvere propter paupertatem non possint, ne poenalis prohibitio eludatur, fustibus caedantur per civitatem ettenam, ubi probibita tentaverunt» (citato in Du Cange, s. v. Reputatio). 116 Ambr., De obìtu Valent., 39, C S E L 73, p, 348 Faller.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
301
una mimica definita e un discorso contesto di moduli, ma soltanto il lirismo religiosamente impegnato del credente che alla Mater Dolo rosa chiede la mediazione per aprirsi alla passione di Cristo e per morire con Cristo al peccato; «fac me tecum phngere, fac ut portem Christi mortem», come si legge nella sequenza dello Stabat. Ma que sto altissimo modello del dolore cristiano non poteva operare real mente nella storia e svolgervi la sua effettiva p e d a g o g i a dell’u mano cordoglio se non avesse saputo raggiungere sul piano terreno la crisi che nel cordoglio sta come rischio, e se non avesse affron tato, assorbito e trasfigurato le tecniche pagane di controllo e di reintegrazione. Solo raggiungendo questo piano il modello mariano del dolore poteva trascinare i dolenti verso la nuova meta religiosa e culturale, e non importa se esso doveva affrontare tutti i rischi del compromesso, del sincretismo e del ritorno al passato. Il som messo e breve versar lacrime di Gesù al sepolcro di Lazzaro, esi bito dal Crisostomo come modello di moderazione per una morte che il miracolo avrebbe di lì a poco esemplarmente vinto, costi tuiva un ideale del comportamento per ogni cristiano: ma affin ché questo ideale potesse realmente plasmare il costume nelle con dizioni storiche date, occorreva una figura mediatrice interamente umana, come tale suscettibile di concedere di più alla terrestrità del dolore e che al tempo stesso togliesse gli umani cordogli dal loro rischioso isolamento, e tutti li concentrasse e li risolvesse nel simbolo di un unico cordoglio per un morire che cancellava la morte dal mondo. Qui sta il germe della profonda necessità storica degli sviluppi drammatici delphnctus Marìae. Negli apocrifi Acta P ih ti (che risalgono alla prima metà del quinto secolo) il pianto di Maria già tende a riassorbire e a trasfigurare nel pianto cristiano le forme esterne dell’antico lamento funebre rituale, con i suoi momenti dell’assenza, del phnctus risolto in una mimica tradizionale e del discorso della lamentazione. Alla vista del figlio coronato di spine e con le mani legate, Maria perde coscienza (όλιγοψύχεσε) e giace esanime a terra per lungo tempo, quindi tornata in sé entra nella vicenda della lamentazione, percuotendosi il petto e graffiandosi le guance con le unghie (καί ταοτα λέγουσα κατέξαινε μετά τών ονύχων τό πρόσωπον αύτής καί ετυπτε το στήτος) e innalzando un lamento che in più punti ricorda, per il suo contenuto, una comune lamen
302
C A P IT O L O S E T T IM O
tazione pagana resa da madre a figlio.117 Nella tragedia cristiana Christós pdschòn, attribuita a Gregorio di Nazianzo ma in realtà molto più tarda, Maria alterna lamenti di pagana ribellione con la coscienza di piangere non già il Cristo, ma il peccato di coloro che lo conducono alla croce. Altrove essa proclama di star salda nella fede della risurrezione, e annunzia che i suoi lamenti avranno termine quando vedrà risorto colui che ora è in preda alla morte. Davanti al sepolcro del figlio, pur continuando il lamento Maria esorta le donne di Galilea a non lamentare la morte di Cristo, poi ché nella prospettiva della risurrezione è ormai compiuta l’epoca degli antichi lamenti funebri:
in latino e poi in volgare, e la sua germinalità rispetto alle Passioni deriva soprattutto dal fatto che la rappresentazione drammatica del suo cordoglio oggettivava in un cordoglio esemplare, illuminato di pazienza e di speranza, gli infiniti cordogli terreni di un mondo vulnerato dalla morte, esposto al rischio della crisi e ancora incline a ricadere nei modi della lamentazione pagana. In questo quadro noi ora comprendiamo meglio come nelle Passioni drammatiche medievali sembra talora accogliersi la stessa mimica della disperazio ne pagana, come nel planctus della Cattedrale di Cividale del Friuli: M a g d alen a :
117 Si vedano gli Acta Pilati nella edizione del Vannutelli, Roma 1938. Le lamentazioni sono più brevi in Acta Pilati A e B , più lunghe in C. Per alcune lamentazioni tralasciate dal Vannutelli, cfr. la edizione del Tischendorf, p. 306. 118 Per il Christós pàschón è da vedere l’edizione critica di J . G . Brahms 1896 e la traduz. it. di Ottavio Prosciutti in Teatro religioso del Medioevo fuori d'Italia a cura di Gianfranco Con tini (1949) pp. 25-66. Frammenti tradotti del Christós pàschón anche in Cantarella, Poeti bizantini, voi. 2, pp, 19 1- 2 0 1. Per la discussione delle quistioni relative e per la bibliografia sull’argo mento cfr. C. Del Grande, Τραγφ&ία (1952) pp. 225 sgg., 322 sg. 119 Sul rapporto fra planctus e passione drammatica cfr. E . K . Chambers, The medieval
(hic vertat se ad homines cum brachijs extensis)
O fratres! (hic ad mulieres) Et sorores! (hic percutiat sibi pectus) Ubi consolatio mea? (hic manus ellevet) Ubi tota salus? (hic, inclinato capite, sternat se ad pedes Christi).
Come piangerò, come esprimerò il mio dolore per la tua morte? O voi che lasciaste la terra di Galilea, o mie compagne cui, ignare dei misteri, attrasse Gesù che ora giace nella tomba, non intonate i soliti lamenti, ma piangetelo con un sommesso pianto: con lieti canti lo celebrerete quando tornerà, re della vita, affinché si avveri la mia sicura speranza .118
Com’è noto il Christós pàschón è in parte un centone di versi di Eschilo, di Licofrone e di Euripide, ed ha un valore letterario scarsissimo: ma dal punto di vista storico-religioso è un documento notevole poiché ci mostra una Maria che pur assumendo i modi della lamentazione pagana appare in un certo senso come l ’ultima lamentatrice in atto di patire la morte di colui che vince la morte, e al tempo stesso di annunziare nella prospettiva della risurrezione la fine «dei soliti lamenti». Qui noi possiamo misurare tutta la distanza storica che separa il pianto di Maria da quello di Iside e di Nephthys per Osiride: mentre il pianto di Iside e di Nephthys diventò il modello della lamentazione per la morte di persone storiche, il pianto di Maria poteva assorgere soltanto a nucleo ger minale e successivamente a momento di una rappresentazione dram matica della Passione di colui che aveva liberato il mondo dalla morte.119 La popolarità del planctus Marìae medievale, dapprima
303
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
M aria M aior : (hic percutiat manus)
O dolor! Proh dolor! Ergo quare, (hic ostendat Christum apertis manibus) fili chare pendes ita cum sis vita (hic pectus percutiat suum) manes ante secula?
120
Il rapporto è ancora più evidente nei compianti in volgare. In un testo cassinese della Passione che risale alla metà del secolo deci mosecondo (e che quindi è il più antico fra quelli conosciuti), la vicenda drammatica in latino si chiude con un frammento di planc tus in volgare, corredato di note musicali, che sarà stato cantato in coro dai fedeli, specialmente dalle donne del popolo, e che rie cheggia un tema del lamento funebre di madre a figlio, il ricordo dei nove mesi di gestazione: Stage, voi. 2 (1903) pp. 39 sg.; e K. Young, The drama o f thè medieval Church, voi. 1 (Oxford ) P· · 120 Young, op. cit., II, pp. 506 sg.
1933
493
304
C A P IT O L O S E T T I M O
... te portai nillu meu ventre ... quando te bejo... (lo) co presente ... nillu teu regnu agirne ammette (a rumente?)1211 2*
Analogo rapporto può intravedersi nella più ampia ed elaborata drammatizzazione della passione inclusa nei Carmina Burana, dove alla remissione dei peccati fatta da Gesù segue - con poca coe renza, come nota lo Young - un lamento di Maria che si inizia con le disperate parole: «awe, awe, daz ìch ie wart gebom ».122 A proposito della famosa lauda di Jacopone «Donna del Paradiso» il Toschi ha osservato come determinate espressioni del corrotto («Figlio, amoroso giglio», «Figlio, occhi giocondi», «Figlio di mamma scura», «Figlio de la sparita, figlio attossicato», «Figlio, a chi m’appiglio? Figlio pur m’hai lassato», «Figlio, perché t’ascondi - dal petto o’ se’ lattato») non hanno riscontro «nelle trenodie ecclesiastiche, ma nello stile aedico e nel costume del répito o cor rotto popolare», cioè «ricalcano la fraseologia dei pianti funebri che le donne del popolo cantavano, ai tempi di Jacopone, a Todi ed in tutta l’Umbria».125 Tuttavia quali che siano i compromessi ed i sincretismi a cui dette luogo il culto di Maria nella sua espansione, resta il fatto che dal punto di vista storico-religioso la figura di Maria non appare ricalcata su quella della lamentatrice o della prefica del mondo antico, ancorché ne potè assumere occasionalmente alcuni tratti. 121 D. M. Inguanez, Un dramma della passione del secolo x n (Badia di Montecassino 1936) P- 38. 122 Young, op. cìt., voi. 2, pp. 158 sgg. 125 P. Toschi, L e orìgini del teatro italiano (1955) p. 685. Per il planctus Marìae è da vedere (oltre il Chambers, PErmini e lo Young già citati) E . Wechssler, Die romanische Marienklage (Halle 1893); A. Schònbach, Ueber dieMarienklagen (Graz 1874) pp. io sgg.; H. Thien, Ueber die engliscben Marienklagen (Kiel 1906) pp. 3 sgg. Si veda anche A . Lingfors, Contrìbution à la bibliographie des plaintes de la Vierge, Revue Langues romanes, voi. 1-3, 38-60 (19 10 ), e il lavoro mariologico di A . M. Lepicier, Mater dolorosa. Notes d ’histoire, de liturgie et d ’iconographie sur le culte de Notre Dame des Douleurs (1948). A parte i planctus Marìae, sarebbero da considerare nel quadro della trasposizione cristiana dell’ antico lamento funebre rituale i planc tus medievali destinati a pubblici personaggi, e talora composti da chierici. Almeno alcuni di essi erano destinati ad essere cantati in pubbliche manifestazioni di lutto, come si desume dalle melodie che li accompagnano e da alcuni luoghi dei testi: per esempio in un planctus per l’arci vescovo Fulco di Reims composto dal canonico Sigloardo (sec. x) segue all’intercessione per i defunti l’invito: «Amen, fiat ita, Dicat omnis ecclesia»; e un planctus per il duca normanno Guglielmo morto nel 943 si apre con la seguente didascalia di esecuzione: «Cuncti flètè prò Wilhelmo Innocente interfecto»·, cfr. H. Springer, Das altprovenzalische Klagelied mit Berucksichtigung der vcrwandten Literaturen (Berlino 1895) pp. 16 sg.
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
305
Anzi proprio per assolvere la sua funzione pedagogica di Mater Dolo rosa e di modello del nuovo ethos cristiano di fronte alla morte, la figura di Maria si adattò persino ad accogliere gli aspetti più arcaici del cordoglio antico, come il cadere inanimata ed il per cuotersi il petto e il graffiarsi le guance ed il lamentarsi, secondo che narrano gli Acta Pilati·, ma la sua figura di madre in lutto resta sostanzialmente legata ad un’altra immagine pedagogicamente ege monica, al suo stare raccolto, immobile e muto del Vangelo gio vanneo, o al contemplare velato di lacrime della sequenza dello Stabat. Ed il centro della cristiana religione non è nel cordoglio di Maria come tale, ma in quel «portare Christi mortem» che la Mater Dolorosa aiuta a vivere come esperienza (fac ut portem Chri sti mortem). Questo mutamento di prospettiva può essere esem plato con la vita di santa Emiliana de’ Cerchi, che rimasta vedova in giovanissima età si chiuse nella torre del palazzo avito, ricu sando ormai di lamentare la morte per lutti terreni, e decisa a desti nare le sue lacrime soltanto per i suoi peccati e per la passione di Cristo, a lungo resistendo alle tentazioni del diavolo, che le adduceva davanti agli occhi cadaveri di persone a lei care, come per risvegliarla al mondano patire: finché la santa vinse la lotta, e si votò interamente alla lamentazione per Cristo morto, onde «nocturno silentio, dormiente famula et illis de domo, fortibus clamoribus et duris lamentationibus deplorabat dilecti sui Jesu passionem, crinibus resolutis».124 La disarticolazione del pianto rituale antico e la plasmazione di un nuovo ethos della morte operate dal Cristianesimo appaiono ora in tutta la loro ampiezza. Per quel che concerne il lamento fune bre, il Cristianesimo e la Chiesa svolgono in sostanza fedelmente l’ammonimento di Gesù alle donne che lo seguono verso il Calva rio («non fate lamenti su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli»). L ’accento qui si sposta decisamente verso l’esperienza della morte come peccato, ed in conformità di ciò la mimica del planctus e i comportamenti del lutto sono dal Cristianesimo mantenuti soprat tutto sul piano della prassi penitenziale, dove il battersi il petto, lo sciogliersi e il radersi i capelli, il cospargersi il capo di cenere, l’assumere un aspetto sordido e l’indossare un abito ad hoc, il digiu124 Acta SS., 4 maggio 3890-3900, 393C.
306
G R A N D E Z Z A E D E C A D E N Z A D E L P IA N T O A N T IC O
307
CAPITOLO SETTIMO
nare e il lamentarsi accennano a quale debba essere per il cristiano la vera morte e il vero cordoglio. In questa disarticolazione del pianto antico anche al pianto stagionale toccò ovviamente una crisi decisiva. In polemica col culto di Attis e col pianto rituale che accompagna le operazioni agricole, Firmico Materno contrappone ai figmenta dei πάτη τών καρπών la simplicitas dell’ordine naturale della fatica umana, ed innalza il pieno riconoscimento di questa simplicitas a momento di una nuova esperienza religiosa del mondo:
era sollevata: e ancora al principio del nostro secolo una conta dina neogreca poteva dire nella Pasqua: «Sono in ansia perche se domani Cristo non risorge, noi quest’anno non avremo grano».128 Pertanto l’antico pianto stagionale percorre nel corso dei secoli tutti i gradi della sua disgregazione folkloristica, sino a ridursi al povero avanzo del pianto per l’ultimo covone mietuto o alla buf foneria quasi irriconoscibile del pianto grottesco per la morte di Carnevale.129
Novit agricola quando terram aratro demoveat, novit quando sulcis frumenta committit, novit quando maturatas solis ardoribus colligit segetes, novit quando tostas terat fruges: haec est physica ratio, haec sunt vera sacrificia, quae ab sanae mentis hominibus annuo labore complentur: hanc simplicitatem divinitas quaerit, ut homines, in colligendis fructibus ordinatis tempo ribus, legibus serviant. Cur huic ordini miserae mortis figmenta quaesita sunt? Cur celatis lacrimis quod celari non debuit ?125
Allo stesso modo Gregorio Nisseno libera gli animali dai loro «mi sfatti» e li proclama incolpevoli.126 Anche qui la passione del Cri sto potè conservare determinati legami con la passione vegetale, come mostra il pane eucaristico, e soprattutto spingere in deter minati casi molto innanzi questo rapporto, come nel Paternoster medio alto-tedesco di Johannes von Krolewitz (xm sec.), dove si legge che Cristo fu «seminato» dal creatore, «germogliò», «venne a maturazione», «fu mietuto», «legato in un covone», «trasporta to nell’aia», «trebbiato», «vagliato», «macinato», «chiuso in un forno», e infine dopo tre giorni «tratto fuori» e «mangiato» come pane.127 D ’altra parte il tema delle passioni vegetali, non ancora cristianamente riplasmato e ancora avvolto nei suoi originari fìgmenta, persisteva tenacemente nelle campagne, anche se ridotto ad angusti limiti di produttività religiosa e ormai tagliato fuori dal l’imponente processo di circolazione culturale che aveva caratte rizzato la sua complessa vicenda storica nel mondo antico. La stessa augusta passione di Cristo tornava a ricadere, durante i lavori agri coli, nella sfera di quella «gerbe de la passion» su cui di tanto si 125 Firm. M at., D e err. prof, r e i, 2, 8. 126 Cfr. Eisler, op. cit., pp. 296 sg. e 249 nota 5. 127 Ibtd., p. 239, dove sono riportati alcuni passi relativi a passioni di martiri cristiani espresse nei termini delle passioni vegetali. Per la passione di Cristo rappresentata come grap polo spiccato dal tralcio e spremuto dal torchio' cfr. ibtd., pp. 2 1 1 sg., tavole x v (fig. 10 1) e xv i {fig. 102).
128 J .C . Lawson, Modem Greek Folklore and Ancìent Greek Religion (19 10) p. 5 7 3. 129 Si veda, per i funerali di Carnevale e i relativi pianti grotteschi, P. Toschi, L e origini del teatro italiano (1955) pp. 308 sgg.
E P IL O G O
Epilogo
Noi siamo partiti dai frammenti di un’Atlantide sommersa e abbiamo cercato di ricostruire la configurazione del continente prima del cataclisma che lo sprofondò nell’Oceano, e il carattere del cataclisma che cagionò lo sconvolgimento. Fuor di metafora, siamo partiti dai relitti folklorici del lamento funebre, siamo risa liti al lamento funebre antico e al suo nesso col pianto stagionale, per ridiscendere poi nel corso del tempo sino al momento in cui, disarticolato che fu quel nesso nella storia religiosa di Israele, il lamento funebre entrò col Cristianesimo in una crisi decisiva. Siamo così tornati al punto di partenza, cioè alla disgregazione folklorica di quanto oggi, nel mondo moderno, non ha tenuto il passo con la storia. Il circolo del discorso storiografico è stato in tal modo chiuso: dal presente al presente, mediante il passato e per illumi nare il presente. Non resta ora che misurare il cammino percorso e determinare meglio l’incremento di consapevolezza umanistica che il discorso storiografico ha realizzato. Lo stimolo ideale della ricerca nel suo complesso è stato quel «via dalle tombe» che appartiene a tutte le epoche storiche e a tutte le umane civiltà, ma che in alcune pagine del Croce raggiunge una delle sue più alte espressioni di moderna consapevolezza. Per l’uomo moderno, che è passato per l’esperienza cristiana e che si è aperto all’umanesimo storicistico, conquistando la persuasione della origine e della destinazione umane dei valori culturali, rin contro con la morte altrui si configura come documento del per manente conflitto fra natura e cultura. Per l’uomo moderno la morte degli individui storici manifesta nel modo più crudo il conflitto
309
tra il morire naturale come espressione tipica di ciò che passa senza e contro di noi e quel dovere di procurare la morte secondo valori che costituisce Vethos fondamentale della cultura. In rapporto alla radicalità di questo conflitto si configura anche il rischio radicale del cordoglio, cioè il crollo dell’ethos culturale che sostiene la pre senza nel mondo e quindi il profilarsi della possibilità di passare col morire naturale invece di farlo passare, con noi e per noi, nel valore. Ciò però significa il perdersi della presenza, il suo dileguarsi e il suo trovarsi prigioniera di una esistenza a vario titolo inauten tica. I sintomi di questa malattia sono diversi, per quanto organi camente connessi fra di loro: l’assenza totale e la conversione della potenza etica della presenza nella scarica meramente meccanica di energia psichica, la ebetudine stuporosa senza anamnesi della situazione luttuosa e le varie forme di planctus irrelativo, lo scacco del trascendimento stesso (furore distruttivo, fame insaziabile, ero tismo), il senso di colpa mostruosa e di miseria estrema quanto immotivata, il ritorno irrelativo del morto come visione allucina toria o come rappresentazione ossessiva, l’amnesia della situazione luttuosa ed il suo periodico irrelativo riapparire in crisi che mimano i contenuti esistenziali rescissi e perduti, i vari deliri di negazione dell’accaduto che non mediano nessun riadattamento alla nuova situazione e che segnano una frattura progressiva con la realtà sto rica e culturale di cui si fa parte. Il rischio della presenza nella crisi del cordoglio fu così definito come rischio di non poter oltre passare la situazione luttuosa, di restare senza margine di oggetti vazione rispetto ad essa, e di scomparire come presenza nella misura del restringersi di tale margine. La vita culturale di tutti i tempi e di tutti i luoghi ha messo a disposizione degli individui vari sistemi t e c n i c i per facilitare il lavoro del cordoglio, cioè per riprendere le tentazioni della crisi e per ridischiuderle al mondo dei valori. Se la buona riuscita del lavoro del cordoglio consiste nel procurare la seconda morte cul turale a ciò che appare come scandalo del morire naturale, i sistemi tecnici sono orientati a rendere possibile questa seconda morte nel valore, che la crisi rischia di compromettere. Ora la crisi comporta, in tutte le sue manifestazioni morbose, un rischio di destorificazione irrelativa, cioè un cader fuori di ogni possibile storia umana culturalmente illuminata e aperta ai valori della cultura: l’assenza
3io
E P IL O G O
radicale e la conversione delVethos della presenza nella scarica con vulsiva costituisce il sintomo estremo di questa destorificazione irrelativa; ma anche gli altri sintomi comportano una estraneazione incompatibile con qualsiasi vita culturale. I sistemi tecnici di ripresa sono orientati verso la destorificazione istituzionale, che in quanto destorificazione raggiunge la crisi sul suo proprio livello, e in quanto istituzionale se la assume coraggiosamente ridischiudendola media tamente al mondo dei valori. In generale i rituali funerari e i loro orizzonti mitici formano appunto sistemi di destorificazione isti tuzionale della morte, da considerare nella loro qualità di coerenze tecniche risolutrici della crisi del cordoglio e mediatrici di altre forme di coerenza culturale. In questo quadro va analizzato l’antico lamento funebre in quanto partecipe di sistemi di destorificazione istituzionale (rituali e mitici) della morte. Innanzi tutto il lamento funebre antico è un momento tecnico dei corrispondenti rituali funerari rivolto a riprendere le tentazioni della ebetudine stuporosa e del planctus irrelativo e a ridare orizzonte al discorso della lamentazione. Mercé la istituzione di una presenza del pianto, anonima e sognante, impersonale e destorificata, la ebetudine stuporosa è ripresa e sbloc cata, e il planctus irrelativo riplasmato in ritornelli emotivi perio dici, in modo da lasciar orizzonte al discorso fra ritornello e ritor nello. La vicenda comporta, nella sua forma rituale tecnicamente fondamentale, una guida del lamento e una incidenza corale del ritornello: il significato tecnico di tale incidenza sta nel fatto che in tal guisa il ritornello è condiviso con la collettività o ceduto ad essa. Ma anche il discorso della lamentazione può essere ceduto ad altri: di qui la possibilità di istituire specialisti del pianto, lamentatrici professionali ed aedi, e di trattare il lamento funebre come prodotto commerciabile. D ’altra parte il discorso della lamenta zione oltre alla protezione tecnica della ritualizzazione del planc tus ne possiede un’altra interna al discorso stesso: la varietà infi nita delle concrete situazioni luttuose viene cioè destorificata in modelli mimici, melodici e letterari che sono fissati nella memoria culturale della comunità e ripetuti come obbligo rituale in ogni sin golo evento di morte. Attraverso questo fascio di destorificazioni tecniche è infine mediata la riconquista della situazione concreta, la interiorizzazione del morto nell’epos delle memorie e degli
EPILOGO
311
affetti, la variazione individuale e, in dati casi, la risoluzione lirica del sentire. In un’altra direzione il lamento funebre compie la sua funzione tecnica, e cioè mediante l’obbligo della sua iterazione rituale in date canoniche definite, cioè mediante la sua distribu zione nel tempo del lutto. Poiché la presenza rituale del pianto può essere promossa e sospesa a volontà, viene soddisfatta la oppor tunità tecnica di eseguire il lavoro del cordoglio a dosi successive, e di trattare a più riprese - fissate in date tradizionali - le ten tazioni della crisi: in tal modo gli intervalli fra data e data della iterazione rituale risultano relativamente sgombri da insorgenze irrelative e caotiche, ed impiegabili per le normali occupazioni pro fane. La possibilità di questa operazione tecnica dipende dalla strut tura della presenza rituale del pianto, che è quasi un altro che piange, un altro - come si è detto - anonimo e impersonale, e tuttavia controllato: anche nel corso della lamentazione si avverte la relativa dualità fra presenza egemonica e presenza rituale del pianto, poiché le lamentatrici sono facilmente distraibili, cioè pos sono per esempio interrompere la lamentazione e interessarsi a eve nienze più o meno futili senza rapporto con la situazione luttuosa. Per quel che concerne poi il contenuto, il discorso della lamenta zione insiste sul tema delle opere del defunto e cioè sulla riappro priazione nella memoria di ciò che effettivamente non patisce morte e che può essere continuato e accresciuto dall’opera dei sopravvis suti: nel caso del dialogo fittizio fra morto e sopravvissuti si fa valere il motivo tecnico del riadattamento dei vivi al fatto che il morto non può tornare in vita «come prima». Questi aspetti tecnici della lamentazione funeraria resterebbero privi di energia unitaria senza un comune orizzonte rappresenta tivo del comportamento rituale. Tale orizzonte rappresentativo, che costituisce il mito del morto e che si riferisce non soltanto alla lamentazione ma a tutto il rituale funerario nel suo complesso, ferma nel dominio metastorico dell’al di là l’irrelativo alienarsi della crisi, e si configura in modo che il «non-esser più» incluso nell’e vento luttuoso è in parte ritardato in una condizione intermedia e labile (il cadavere vivente) ed in parte negato in una diversa forma di esistenza fuori del mondo (il morto nel regno dei morti). L ’isti tuzione dell’orizzonte metastorico dell’al di là, e l’articolazione figurativa dell’al di là nei due momenti del cadavere vivente e del
312
E P IL O G O
morto nel regno dei morti, hanno il significato tecnico di strumenti mentali per una determinata dinamica operativa, e precisamente debbono essere interpretati come indici del compito che il rituale funerario assolve: infatti i rituali funerari antichi fermano e con figurano l’alienazione irrelativa della crisi, e riconducono il morto così configurato dalla condizione rischiosa di cadavere vivente a quella più stabile e garantita di morto nel regno dei morti, allon tanando «al di là» ciò che «di qua» incombe come troppo pros simo, e al tempo stesso guadagnando il tempo giusto per inserire il morto, che nella crisi del cordoglio sta come scandalo, nella sfera dei rapporti secondo valore. La reintegrazione del morto nel mondo dei valori e il superamento della crisi sono quindi tecnicamente mediati dall’arresto dell’alienazione irrelativa, dalla configurazione dell’al di là, dal ritardo del trapasso e dalla sua negazione, e dai corrispondenti comportamenti rituali: sono cioè protetti da parti colari modi di destorificazione mitico-rituale. La lamentazione fune bre partecipa di quest’ordine, e compie - per la parte che le spet ta - il suo proprio lavoro: se il lamento non è reso, il morto non entra nel regno dei morti e resta nella rischiosa condizione di cada vere vivente, che tormenta i vivi ritornando in modo irrelativo; d’altra parte nel corso della lamentazione le valenze di allontana mento si legano dialetticamente a quelle di riappropriazione, di interiorizzazione e di rapporto sul piano dei valori morali, sociali, politici, poetici e conoscitivi. A conferma di questa interpretazione del lamento funebre antico si può mostrare che anche gli altri momenti del rituale funerario sono impegnati nello stesso lavoro di ripresa e di riapertura al valore. Se il lamento è tecnicamente orientato verso la ripresa della ebetudine stuporosa e del planctus irrelativo e verso la riconquista di un orizzonte per il discorso compromesso dalla crisi, l’agoni smo rituale riprende il furore distruttivo, così come le oscenità rituali risolvono l’erotismo, i digiuni e le interdizioni alimentari controllano la sitofobia, e il banchetto funebre riscatta la bulimia: ma, in ogni caso, la ripresa rituale delle tentazioni della crisi si compie sempre nel senso della dinamica della separazione e del rapporto, e nello sfondo tecnico di uh «cadavere vivente» che deve tramutarsi in morto nel regno dei morti e in valore morale per i vivi. Il lamento funebre partecipa quindi a quel più vasto sistema
E P IL O G O
313
tecnico di destorificazione che caratterizza gli antichi rituali fune rari, in quanto strumenti per procurare a morti la seconda morte culturale, cioè la loro risoluzione nel valore. Ma il lamento funebre per la morte degli individui storici appare nel mondo antico inserito in un più vasto ordine di connessioni, e cioè in una fondamentale visione religiosa che include anche altre sfere del passare. Sussiste infatti nel mondo antico un organico rapporto fra lamento funebre destinato alle persone storiche e lamentazioni stagionali. In realtà l’individuale morire, ove sia arbi trariamente considerato nel suo isolamento, comporta la inevita bile presa di coscienza di una irreversibilità che nel modo più radi cale l’uomo non può far tornare «come prima». Per quanto questo passare possa essere destorificato con determinate tecniche pro tettive mitico-rituali, esso comunque sporge nel modo più crudo, denunziando il conflitto fra cultura e natura. Il ritornello emotivo dei lamenti funebri egiziani poteva scongiurare «torna a casa, torna a casa! », ma per quanto restasse fra i vivi il corpo incorruttibile della mummia il fatto era che il morto non tornava vivo «come prima». La destorificazione religiosa aveva soltanto il compito di proteggere questa presa di coscienza, di allontanare il morto nel regno dei morti e al tempo stesso di mediare l’unico possibile ritorno benefico, quello che aveva luogo nella memoria morale dei soprav vissuti. Ora le immense energie culturali per compiere ciò l’uomo antico poteva attingerle da una diversa sfera del morire, in cui egli col proprio lavoro faceva r e a l m e n t e passare e tornare il dive nire naturale secondo una regola umana e compiva così il distacco inaugurale della cultura dalla natura: questa sfera fu per l’uomo antico quella del ritmo stagionale della vegetazione sperimentato nel corso dei lavori agricoli. Qui l’uomo antico, in quanto agricol tore, si inseriva come procuratore di morte nel divenire naturale gettando le basi del viver civile: avviava il seme nel solco e lo faceva morire, e col gesto inesorabile della falce messoria avviava a morte il campo di messi, secondo una regola che era a n c h e umana. Senza dubbio in questa sfera del passare, come in qualsiasi altra, insor geva il conflitto fra natura e cultura, fra ciò che è in potere del l’uomo e ciò che dall’uomo non dipende: e col conflitto si profi lava il rischio della crisi. Anche questa sfera del passare era pertanto bisognosa di protezione destorificatrice: ma ciò che andava desto-
314
E P IL O G O
rificato non era solo, come nei rituali funerari, il morire, quanto piuttosto il far morire procurato dall’uomo mediante Tarare e il seminare, il mietere e il vendemmiare. Soprattutto nel momento del raccolto, epilogo dell’anno agricolo, il conflitto raggiungeva il vertice: col cader delle messi o con lo spiccare i frutti dall’al bero si profilava un grande vuoto vegetale, una pausa di vita, e d’altra parte quello svuotarsi era un raccogliere, un procurar la morte, un uccidere da parte dell’uomo. La destorificazione pro tettiva si orientò pertanto in questa sfera del morire nella duplice direzione dell’occultare la realtà storica dell’operazione compiuta, e del mascherare il vuoto vegetale mediante una vicenda mitica in cui esso appariva già reintegrato una volta per sempre in ilio tempore. Di qui due temi di destorificazione protettrice, il primo riassumibile nella formula «non sono stato io, ma un altro», e il secondo caratterizzato dalla trasposizione mitica di tutta la vicenda, cioè dalla passione vegetale di un nume, il quale pativa morte vio lenta seguita da reintegrazione. Nel quadro di queste mistifica zioni tecniche trovò posto nel mondo antico una nuova riplasmazione del lamento funebre, e cioè il pianto rituale al momento del raccolto e più generalmente con incidenza agricola e stagionale, ed il pianto mitico dei primordi reso da qualche nume al nume che ha patito violenza, secondo un modello che ripete in seno alla famiglia divina quanto avviene in ogni famiglia umana per la morte di un suo membro. D ’altra parte vi era ora la possibilità di ripla smare lo stesso lamento funebre per la morte di individui storici secondo la prospettiva mitico-rituale offerta dal pianto stagionale. La più notevole unificazione destorificatrice delle sfere fondamen tali del morire si ha nella religione osiriana, dove lo stesso pianto mitico dei primordi vale per tutte e tre le fondamentali sfere in cui si manifesta il vuoto del morire: il vuoto dell’individuo in seno alla famiglia, il vuoto della vegetazione nella distesa dei campi, e il vuoto del trono nello Stato. Per questa unificazione e per que sto rapporto fu possibile una integrazione del morto con il destino vegetale e astronomico, e la ulteriore destorificazione del suo «esser passato per sempre» nel ritornare della vegetazione, o del sole, o della luna, o di Orione, o del periodico flusso delle acque del Nilo. In Egitto, in Mesopotamia, presso Ittiti e Urriti e Fenici e Siri, nella civiltà minoica, in Grecia e a Roma il lamento funebre rituale
E P IL O G O
315
non cessò mai di fare parte integrante del rituale funerario: se con l’affermarsi di forme democratiche di vita cittadina in Grecia e a Roma vi furono interventi legislativi su questo punto, si trattò sempre di prescrizioni indirizzate a limitare alcune forme del planctus ritenute eccessive, e a moderare il fasto degli antichi funerali aristocratici ed eroici: ma il lamento funebre come tale non fu mai combattuto per ragioni religiose. In Grecia la polemica di Platone restò espressione di un pensiero senza efficacia plasmatrice del costume oltre una ristrettissima cerchia di intellettuali, e d’altra parte lo stesso Platone nelle Leggi di molto attenuò su questo punto la severa intransigenza della Repubblica. Tuttavia in Grecia, paral lelamente al non mai intermesso lamento funebre rituale, assistiamo ad un graduale liberarsi del lamento dal rito: il goos epico, il threnos lirico, il commos tragico, l’orazione funebre in prosa costitui scono altrettante risoluzioni del lamento sul piano della lettera tura e del dramma. In Roma tale processo risolutivo si compie in una sfera molto più circoscritta: dall’antica nenia infatti, prescin dendo dalla conclamatio che ha un carattere spiccatamente rituale, non si svolse sul piano letterario che la laudatio. La prima profonda disarticolazione del sistema di destorifica zione religiosa in cui è inserito il lamento funebre antico ha luogo però soltanto con la storia religiosa di Israele, dove il costituirsi di un rigido monoteismo respinge nettamente il tema pagano delle passioni vegetali: il lamento funebre si farà ancora valere nel corso di tutta la religione di Israele, ma il suo rapporto col pianto sta gionale sarà decisamente spezzato. Il sistema pagano di destorifi cazione religiosa di cui facevano parte il lamento funebre e il pianto stagionale occultava la proliferazione storica del morire riassorben dola di volta in volta nella iterazione rituale di una vicenda mitica dei primordi, una vicenda metastorica di trapasso e di reintegra zione: in questo sistema la storia umana non trovava nessun rico noscimento, e solo in modo molto mediato determinati valori eco nomici, morali, politici, giuridici, estetici e conoscitivi erano di fatto ridischiusi mediante questa mistificazione tecnica. Il sistema di destorificazione che si afferma nell’Antico Testamento poggia invece sui temi della berìth e del giorno di Jahve come termine della storia santa del popolo speciale: Tirreversibile comincia qui ad essere riconosciuto, per quanto nella duplice paradossia di una
3 i6
E P IL O G O
storia compresa fra un assoluto inizio e un assoluto termine, e di una storia assegnata come santa ad un solo popolo speciale dell’u nico Iddio. D ’altra parte proprio perché la gelosa proprietà di Jahve investe anche i corpi di coloro che fanno parte del popolo eletto, noi troviamo nel Levitico e nel Deuteronomio la prima polemica religiosamente motivata contro le offese recate al proprio corpo durante il planctus rituale: tali offese manomettono la proprietà di Dio e sono quindi interdette. La qinà funeraria appare pertanto nell’Antico Testamento per un verso relegata in un palese isola mento, in atto di recedere verso la disgregazione folklorica, e per un altro verso subisce una profonda riplasmazione nella qmà pro fetica, in cui il morire è investito in pieno dal dramma della storia santa, diventando il morire della vergine di Israele infedele al suo promesso sposo. La crisi decisiva del lamento funebre antico ha luogo però sol tanto con il Cristianesimo. Nel centro della storia si impianta ora l’evento della incarnazione, e la passione dell’Uomo-Dio, che assu me su di sé la morte umana e la vince per sempre, rendendola appa rente sino al giorno della seconda parousia, quando i morti risor geranno con corpi incorruttibili al suono dell’ultima tromba. In questo sistema di destorificazione della morte non soltanto il planc tus in alcuni suoi eccessi, ma tutto il lamento funebre antico diven tava misconoscimento dell’opera redentrice di Cristo: per ripren dere l’affermazione di Giovanni Crisostomo, il tempo in cui la morte era morte si era definitivamente chiuso, e con esso anche il tempo del planctus e del lamento. Il rigorismo dell’età apostolica e dei Padri della Chiesa verso il lamento funebre non fu mai smentito nella storia della Chiesa com’è provato in particolare dall’assidua polemica del Crisostomo e dalla ininterrotta serie di canoni conciliari e sinodali. Tuttavia la tenace sopravvivenza del costume costrinse talora la Chiesa a qualche compromesso di fatto, e soprattutto ad un’opera non sol tanto repressiva ma anche riplasmatrice e trasfiguratrice delle anti che lamentazioni funerarie e in genere del pianto rituale. Il grande strumento pedagogico del nuovo ethos cristiano di fronte alla morte fu la figura della Mater Dolorosa, così integralmente umana nel suo dolore per il figlio morto, e tuttavia così interiore e raccolta nel suo silenzioso «stare» velato di lacrime davanti alla croce. Tale
E P IL O G O
317
interiore raccoglimento del cordoglio di Maria rappresentava un modello anche perché toglieva dal loro isolamento i singoli lutti per lo storico morire e tutti li concentrava in un lutto esemplare per un morto che, con la sua risurrezione, era diventato «primizia dei dormienti». Tuttavia questo modello della Mater Dolorosa potè assolvere la sua alta funzione pedagogica nella misura in cui sep pe accogliere, trasfigurandoli, modi e forme del lamento funebre antico: di qui la grande fortuna dei planctus Mariae drammatici del Medioevo. Inoltre, proseguendo e sviluppando un processo già ini ziatosi nella storia religiosa di Israele, la mimica rituale del planc tus in occasione di un evento luttuoso fu riplasmata e interioriz zata come mimica penitenziale per la «vera» morte del peccato. Infine quanto ancora nelle campagne sopravanzava dei pianti sta gionali fu avviato lentamente a graduale disgregazione, o ricacciato nel breve orizzonte dei lamenti per il raccolto e dei relitti delle passioni vegetali, o ridotto alla irriconoscibile buffoneria dei pianti grotteschi per la morte di Carnevale. Senza dubbio il Cristianesimo inaugurò una nuova epoca del costume di fronte alla morte, del che rende fra l’altro testimonianza il mutamento semantico intervenuto nella parola planctus, che in latino indica il percuotersi (piangere pectora), mentre in italiano la parola pianto ha soltanto quello del versare lacrime, del sem plice fiere. Analogamente il kopetòs e la stemotypia dei Greci sono vocaboli senza corrispondenti in tutte le lingue del mondo moderno cristianizzato. Ora tutto ciò è in dipendenza del fatto che la plasmazione cristiana del costume ha tolto carattere pubblico e cul turale al planctus, relegandolo a irrelativo parossismo individuale, privo di qualsiasi regolarità e unità, e di qualsiasi significato che non sia palesemente morboso. Qui noi tocchiamo uno dei risul tati della scelta decisiva operata da Gesù nella casa di Jairo, e rin novata poi in altre case, sino al pregnante episodio di Evodio che contenendo la tentazione del pianto antico afferrò il salterio e intonò il salmo del confidente abbandono alla misericordia e alla giustizia di Dio. Va tuttavia sottolineato il fatto che la lotta con dotta dalla Chiesa per smantellare questa cittadella del paganesimo fu particolarmente aspra e che lenti e contrastati furono i successi conseguiti. Sino al secolo decimoquarto il pagano «saper piangere» i morti era in Occidente di norma nelle stesse corti, il che significa
3 i8
E P IL O G O
che tutti i ceti sociali partecipavano largamente al costume, almeno nella sua forma di lamento reso dai familiari del defunto. E ancor oggi, mentre l’ antico pianto stagionale è ridotto a pallidi riflessi folklorici, il lamento funebre è ancora esercitato nelle campagne di non irrilevanti aree del continente europeo: e ancorché sia ridotto quasi da per tutto alle sole plebi rustiche e abbia perduto ovvia mente l’ampiezza e la complessità degli orizzonti mitici pagani, e l’organicità rispetto al restante mondo culturale, qualche cosa della sua antica tragica serietà ancora in esso perdura. Si ripro duce così ancor oggi, per l’etnografo che si rechi nelle aree di soprav vivenza, lo spettacolo di due mondi, il cristiano e il pagano, che coesistono senza mescolarsi, ultimo avanzo di una grande batta glia che fu combattuta ma non interamente vinta. Così nel dì dei morti i cimiteri lucani risuonano delle antiche lamentazioni e di cristiane preghiere, e nelle chiese dei villaggi disseminati fra il Bràdano ed il Sinni il lamento talora prorompe veemente, disturbando il servizio funebre. Analogamente durante i funerali del pastore di Ceriscior vedemmo alternarsi al canto della risurrezione di Laz zaro, soffuso di cristiana serenità, il coro della «Morte alla fine stra», tutto fremiti di sorda ribellione e di cupo furore contro l’ine sorabile destino. Ma c ’è qualche cosa di più: la tenace resistenza dell’antica lamentazione pagana costrinse la stessa Maria ad abban donare il suo raccolto e muto «stare», e ad assumere modi e forme che riecheggiavano l’antico lamento: soltanto così, come si è detto, il planctus Mariae potè raggiungere la disperazione umana per innal zarla alla speranza della croce (le terrecotte di Niccolò dell’Arca e di Guido Mazzoni sono in proposito molto eloquenti). Questa tenacia di sopravvivenza e questo limite alla espansione del costume cristiano pongono senza dubbio un problema. Quasi si direbbe - e nella sostanza l’osservazione è giusta - che il Cristianesimo ebbe sì la potenza di riplasmare su questo punto il costume negli strati superiori della società civile, strappando via via le corti, i nobi li, i signori, la ricca borghesia cittadina al pagano «saper piangere» i morti, ma non potè dispiegare eguale energia plasmatrice nelle campagne, dove il progresso decisivo ebbe luogo su questo punto non tanto per la mai intermessa azione incivilitrice della Chiesa quanto piuttosto per opera della rivoluzione borghese e con lo svi luppo dell’epoca industriale, e con il corrispondente progresso civile
E P IL O G O
319
delle campagne. Se infatti ci provassimo a costruire una carta dia cronica del progressivo scomparire del lamento fra le plebi rusti che europee noi vedremmo come primi a perderlo furono i paesi e le regioni che più presto entrarono nell’orbita della rivoluzione industriale e dello sviluppo di una intraprendente borghesia citta dina, e ultimi invece quei paesi e regioni che perpetuarono più a lungo nella loro struttura sociale rapporti precapitalistici e semi feudali. Così una lamentatrice lucana di Valsinni riassunse con inconsapevole esattezza un aspetto non del tutto irrilevante di quel complesso di problemi sociali, politici e culturali che va sotto il nome di questione meridionale quando ci disse che nel suo paese vi erano due modi di patire la morte, quello dei signori che pian gono soltanto in cuor loro, e quello dei «cafoni» che si abbando nano al lamento rituale. La verità è che l’ampiezza della crisi davanti al cordoglio è il riflesso di una fondamentale precarietà esistenziale per cui la pre senza dispone di una povera memoria retrospettiva e di una angu sta coscienza prospettica di comportamenti culturalmente efficaci. 1 1 ethos della presenza non è una grazia che scende dall’alto (anche se così può apparire ai singoli individui nei momenti in cui si innalza improvvisa la loro iniziativa risolutrice), ma sta salda nella misura in cui si viene realizzando nel viver civile, e in un mondo in cui l’uomo è uomo per l’uomo. Quando questa realizzazione è angu sta anche la realtà della presenza è labile, e quando si accumula soltanto la memoria dei propri scacchi e si ha esperienza soltanto della irrazionalità delle forze naturali e della schiacciante oppressività delle forze sociali, ogni momento critico in cui si manifesta un passare ostile all’uomo può, nella carenza di forze culturali da mobilitare, scatenare la crisi. Le plebi rustiche, e particolarmente le donne, delle comunità agricole in cui vigono ancora rapporti pre capitalistici e semifeudali sono appunto in queste condizioni: ecco perché la crisi del cordoglio assume in loro forme così estreme, bisognose di essere adeguatamente fronteggiate, ed ecco perché vi si mantengono le tecniche della lamentazione; un’opera di inci vilimento che si mantenga esclusivamente sul piano della predica zione religiosa o «morale» è pertanto destinata ad avere qui una efficacia limitata. Questo rilievo conclusivo non sembri sproporzionato alla nar
320
E P IL O G O
razione storica che è stata sin qui condotta: senza l’occhio al patire dei propri contemporanei non si scrive storia del passato anche remotissimo. Israele attendeva il giorno di Jahve in cui «le mon tagne stilleranno vino nuovo e le colline gronderanno latte, e tutti i ruscelli di Giuda avranno acqua, e una fontana zampillerà dalla casa di Jahve e bagnerà la valle di Chittim»; il giorno in cui il signore avrebbe creato nuovi cieli e una nuova terra e non più in Gerusa lemme sarebbe echeggiata voce di pianto e grida di dolore. La tra dizione cristiana, pur serbando la visione di un tempo terminale in cui Dio avrebbe asciugato tutte le lacrime, e annullato anche la sola apparenza della morte, insiste sull’attualità della redenzione e sulla vittoria conseguita da Cristo sulla morte. La nostra moderna consapevolezza storicistica sa che il morire e il dolore sono consu stanziali alla storia e alla cultura, e che non mai potrà essere sop presso il conflitto fra la morte e l’inesauribile dovere di oltrepas sarla nel valore. Ma questa scienza resterà vana e gonfia, ed incapace anch’essa di far coraggio davanti alla morte sin quando non abbia apprestato una società in cui l’uomo - qualsiasi uomo - si senta a tal punto suo cittadino pieno iure da poter accettare il morire che la vulnera accompagnandolo soltanto con un sommesso pianto.
Aggiunte
i . I ritornelli asseverativi nel Napoletano La struttura fondamentale del lamento funebre antico come responsorio di guida e coro e l’originario carattere di semplice ritor nello emotivo della periodica incidenza corale risulta, come vedem mo, tecnicamente fondata dalla necessità di oltrepassare la situa zione luttuosa e di restituire orizzonte al discorso individuale com promesso dalla crisi. Già la sola analisi della documentazione antica non lascia dubbi in proposito: l’esame dei relitti folklorici euro mediterranei ne offre ulteriore conferma. Qui vorremmo sottoli neare che la incidenza corale periodica con la quale si determina la prestazione collettiva può in concreto assumere una grande varietà di sfumature a diffusione regionale. Un esempio di tale va rietà può essere dato dai ritornelli asseverativi, che - a quel che sembra - godevano un tempo nel Napoletano un diffuso favore. Fra gli usi funerari che alla fine del secolo scorso erano ancora in vita a Napoli e, in generale, in tutto il Sud, Th. Trede1 ricorda fra l’altro il lamento funebre di Giuliano, che a quel tempo con servava i caratteri della esecuzione responsoriale e della narrazione, da parte del solista, delle res gestae del defunto. «Ogni parente - riferisce il Trede - si avvicina isolatamente al morto, ne bacia la gelida mano e racconta cantando ai presenti, con voce velata di pianto, le buone azioni e le virtù del defunto, al che il coro dei presenti risponde con accenti di dolore». È evidente lo schema 1 Th. Trede, Das Heindentum iti der romhchett Kircbe, voi. 4 (1891) pp. 413-20.
322
A G G IU N T E
responsoriale antico, anzi addirittura vi è una esatta rispondenza strutturale con i lamenti successivi delle parenti resi al cadavere di Ettore2 (cfr. p. 179). Proprio nella stessa epoca in cui il Trede pubblicò il suo farraginoso lavoro sul paganesimo nella Chiesa romana, Gaetano Amalfi raccoglieva documenti di lamentazione a Tegiano, Pagani, Positano e persino nella stessa Napoli, nel popo lare quartiere di Santa Lucia. Dai dati dell’Amalfi appare il carat tere «asseverativo» del ritornello corale, cioè la vibrante conferma e quasi la ratifica sociale della veridicità di quanto va cantando il solista, come nel presente lamento di Positano: Moglie·. Coro·. Moglie·. Coro:
Era proprio ’nu paccu d’omme. Je r ’overo! Je r ’overo! M e portava le fave chiatte. Je r ’overo! Je r ’overo!...
Sul carattere tradizionale che nel Napoletano aveva questo ritor nello asseverativo corale ci offre conferma un riscontro anteriore di quasi due secoli, e concernente la stessa area folklorica. Il barone Carlo Celano così descrive infatti il lamento funebre nelle case dei suoi vassalli che appartenevano all’ordine dei gentiluomini, o dei «cappelli»: «(le lamentatrici prezzolate) vengono, battono a lungo le palme l’una contro l’altra, finché la più eloquente dice le azioni del defunto... Il soprano dice la canzonetta, le altre, finita la caden za, fanno quel suono basso. Così appunto una dice molto: quando si ferma le altre ripigliano e dicono vier’è, vier’è, che vuol dire è vero, è vero».3 Una nostra allieva di Sant’Elia a Pianisi ci comu nicava che ancor oggi ritornelli asseverativi del genere sono impie gati neH’ormai molto logoro lamento del suo paese.
2. Una varietà di «planctus» rituale Dall’opera dell’Amalfi più sopra ricordata si ricava che nel Napo letano era praticato un tempo un «riepito vattuto», cioè una lamen tazione accompagnata dal battersi rituale, nei modi che a suo tempo abbiamo analizzato. Ora il Celano, discorrendo del lamento fune 2 tl. 24, 723 sgg. 3 C. Celano, Degli avanzi delle poste (16 8 1) pp. 17 9 sg.
A G G IU N T E
323
bre fra i suoi vassalli, ci dà notizia di una varietà di planctus rituale in cui il percuotersi è sostituito dal farsi battere e martirizzare da altri, subendo passivamente la loro violenza. Questa varietà di planctus, secondo quel che ne dice il Celano, era propria non dei coppellanti, ma delle coppole, cioè dei rustici: I miei vassalli formano due ordini, cioè d e’ rustici e de’ gentiluomini, e si distinguono i primi dalle coppole, i secondi dal cappello... Quando muore uno delle coppole, e vi resta la moglie... si fa giacere in terra vicino al cada vere del marito con la chioma scinta. Fatto questo, vengono tutte le donne congiunte per sangue al defunto, che, per lo più, in questi castelli sono molte, ed ognuna nell’entrare, battendo le palme, con un tuono spaventoso comin cia a dire: «O h riègola tie !», che in buona lingua suona: «oh! misera te!» E dicendo così s’accosta alla vedova: accostata le strappa una branca di capelli, e la butta sul cadavere, che sta vicino. O h quel che scriverò appresso sarà creduta iperbole ma pure è vero. L ’ultime manigoldesse, che vengono, tro vando il capo senza capelli, come tante diavolesse con le unghie indurite e affilate a’ manichi delle zappe, dànno di mano in faccia e ne tirano giù pezzi di pelle: e questo si chiama onore al morto: ed allora si dice piu ono rato, quando porta più branche di capelli e spruzzi di sangue a spese della povera moglie. M ’inorridii vedendo una povera giovane, che pareva un mostro: ammirandomi insieme della costanza di quella misera, che alle sgraf fignate di quelle arpie non si muoveva, benché si poteva credere che avesse perduto i sentimenti. Finito questo, s’adunano d’intorno al cadavere, e tutte u lite insieme dicono le lodi del morto con certe nenie da spaventare per Γ orridezza il diavolo stesso... Finita questa funzione, con lagrime, e con urli da dannate, prendono la donna martirizzata, la spogliano fuor che della cami cia affumicata, e la pongono nel letto, dove finché sta bene le si porta dalle donne stesse il cibo apparecchiato.
Questa varietà di planctus si inserisce molto bene nel quadro della lamentazione come tecnica per oltrepassare la crisi del cordoglio. Già vedemmo come appartiene alla struttura del lamento il cedere ad altri i ritornelli emotivi o addirittura lo stesso discorso della lamentazione, chiamando la specialista del pianto, cioè una lamentatrice di vocazione, non retribuita, ovvero una vera e propria lamentatrice prezzolata. Dicemmo anche che tali cessioni, che giun gono alla trasformazione del pianto in una «merce» che si compra e si vende, diventano comprensibili come comportamento umano e manifestano la loro reale efficacia tecnica solo ove si tenga conto dei rischi connessi alla crisi del cordoglio (ebetudine stuporosa e planctus irrelativo, fame insaziabile, furore e libidine, deliri di nega
A G G IU N T E
324
zione, ritorno del morto come rappresentazione ossessiva o come immagine allucinatoria), e ove si consideri la lamentazione nel suo complesso - e in generale i rituali funerari - come un sistema di tecniche per raggiungere sul loro piano le realtà psichiche in rischio di alienazione, e per reintegrarle drammaticamente nel mondo dei valori culturali. Se è del tutto incomprensibile che si possa cedere ad altri in tutto o in parte ciò che è di più nostro e di più intimo, cioè piangere i propri morti, diventa invece comprensibile che si possa effettuare tale cessione quando si corre il rischio di alienarsi completamente nel piangere, e quando si impiega uno strumento di ripresa e di reintegrazione che comporta la destorificazione tec nica di una presenza rituale del pianto, quasi altra e tuttavia con trollata, quasi anonima e impersonale e tuttavia orientata verso la riconquista del livello personale. Nel caso descritto dal Celano la vedova si percuote affidando ad altri il compito di effettuare i gesti necessari: si fa cioè graffiare e lacerare le carni dalle compa gne. E un espediente tecnico che sta di mezzo fra il planctus ese guito in prima persona, e la cessione totale ad altri del planctus stes so, come fa Serse nei Persiani (cfr. p. 181).
325
A G G IU N T E
o il banchetto; 4) semplici gridi di lamento e di disperazione.5 Il Ranke osserva che «tale classificazione è condotta secondo punti di vista letterari, che non hanno nessuna validità rispetto alla tra dizione popolare», nella quale gli elementi che la classificazione dello Ehrismann separa «sono fusi in una forma unitaria».6 L os servazione è giusta, ma mostra anche il suo limite interno di valu tazione. Non si tratta infatti soltanto di respingere l’astratta qua dripartizione dello Ehrismann, ma anche di non cadere in una non meno astratta e indifferenziata unità, col pretesto di adeguarsi alla immediatezza della costumanza in atto. In realta il lamento rituale presenta una dinamica caratteristica che innestandosi nella crisi del cordoglio ridischiude al mondo dei valori la presenza in rischio: una dinamica che riceve senso soltanto in un mondo storico defi nito, quale fu appunto il mondo delle antiche civiltà religiose del Vicino Oriente e del Mediterraneo. Con ciò si intendono criti cate alla radice anche altre classificazioni del lamento rituale, come per esempio quella di Bugiel.7
4. Trasposizioni del lamento funebre 3. Intorno alle «definizioni» del lamento In generale le definizioni correnti del lamento funebre peccano di superficialità, in quanto per un verso lasciano senza analisi la crisi del cordoglio e per un altro verso trascurano di lumeggiare la motivazione tecnica dei diversi aspetti strutturali della lamen tazione. Così, per esempio, A .C . Rush ha creduto di definire il lamento antico come unione di planctus e nenia - o di κοπετός e ■ θρήνος,4 definizione che confonde il planctus irrelativo della crisi con il planctus ritualizzato, e che lascia completamente nell’ombra la dinamica della conquista della nenia come discorso protetto. Un conato definitorio ancor più infelice è quello dello Ehrismann, che distingue addirittura quattro forme di lamento, e cioè 1) il canto di elogio; 2) il lamento dei sopravvissuti improvvisato, e tuttavia in forma tradizionale; 3) i canti di intrattenimento durante la veglia 4 A .C . Rush, Death and Burial in Christian Antiquity (Washington 19 4 1) p. 163.
In una lettura tenuta due anni or sono alla Società etnografica ungherese di Budapest, B. Rajeczky ebbe occasione di illustrare alcuni lamenti funebri che confermano il vario impiego tecnico della struttura della lamentazione per occasioni indipendenti dall’evento luttuoso in senso stretto, cioè dalla morte fisica di persone care. Nella esemplazione del Rajeczky vi erano infatti lamenti per con giunti in partenza per la guerra, o semplicemente per il servizio militare o per l’emigrazione in paese straniero, lamenti nuziali quando le spose lasciano la casa paterna, lamenti per animali morti, ovvero lamenti di bambine per le loro bambole.8 Tranne quest’ul timo tipo, che appartiene ovviamente alla imitazione lusoria del lamento da parte di fanciulli, tutti gli altri si riferiscono a momenti
39
5 Ehrismann, Gesch. d. dt. Lit., voi. i , pp. s8* 6 K . Ranke, Indogermanìsche Totenverherung (1950) p. 93 nota 1. 7 Bugiel, Les chants funéraires de la Pologne, Bull. Mém. Anthropol., Paris, 12 2 sg. (1925). 8 Cfr. B. Rajeczky, Typen ungariscber Klagenlieder, Deutsches Jahrbuch fiir Volkskunde, voi. 3, 31-46 (1957)·
326
A G G IU N T E
critici di un certo regime esistenziale contrassegnati dall’alterazione brusca, e tuttavia inevitabile, di una certa situazione affettiva; alte razione che esige un passaggio e un riadattamento rapido alla nuova situazione, con la interruzione violenta di certi comportamenti con sueti e la instaurazione immediata di certi altri, e che perciò può considerarsi un equivalente pratico di quell’alterazione affettiva radicale che è provocata dalla morte fisica della persona cara. Di «compianti di reclutamento» è particolarmente ricco il folklore russo, probabilmente in rapporto al fatto che il servizio militare obbligatorio instaurato da Pietro il Grande durava venticinque anni, ed equivaleva per i contadini russi praticamente ad una morte.9 L ’ampiezza e l’importanza raggiunte in Russia da questo tipo par ticolare di trasposizione del lamento funebre è attestata fra l’altro dalla raccolta di E. Barsov,10 dove il secondo volume di circa tre cento pagine è interamente dedicato ai compianti di reclutamento, sulla base prevalente di un materiale fornito dalla lamentatrice Irina Fedosova, una contadina di Kusaranda.11 Per quel che concerne le lamentazioni nuziali è ancora il folklore russo che ce ne forni sce la documentazione più ricca. Anche qui noi troviamo lamenti della sposa in cordoglio e lamenti ceduti a lamentatrici prezzolate, con drammatizzazioni rituali molto interessanti dal punto di vista tecnico. In una di esse, secondo quel che ne dice il Sokolov, il pro tagonista della finzione scenica rituale sono la promessa sposa, le sue compagne e i familiari, ed il dialogo cantato si svolge rappre sentando la separazione della promessa sposa dalle persone e dalle cose della sua situazione di vergine. In particolare una intera scena mima l’addio della sposa al suo nastro di vergine, simbolo di libertà: la sposa passeggia nell’isbà, pavoneggiandosi davanti ai familiari, adorna del suo nastro virginale, poi essa chiede ai genitori di to glierle il nastro: Se non lo toglierai tu, o babbo che mi hai dato da mangiare, saranno i cattivi stranieri che lo toglieranno.
Ma né il padre né la madre possono decidersi a strapparle il nastro, 9 I. Sokolov, L e folklore russe, trad. frane. (Parigi 1945) pp. 12 5 sgg. 10 E . Barsov, Lamentazioni della Russia settentrionale (Mosca 1872-82). 11 Sull’opera del Barsov, rimasta per noi inaccessibile, informazioni in Mahler, Die russische Totenklage (1935) pp. 330 sg.
327
A G G IU N T E
che finalmente le sarà tolto dal fratello minore. La promessa sposa, percorre ora l’isbà senza il suo nastro, e supplicando i presenti di renderglielo, ma il coro risponde che potrà farlo solo a certe con dizioni, soddisfatte le quali la promessa sposa rientra in possesso del suo nastro. Finalmente la promessa sposa riconosce cantando di non aver più diritto di portarlo: Guarda, mamma mia cara, guarda babbo mio, che mi hai dato da mangiare, guardate la vostra bella figliola... sebbene io porti il nastro, non resta al suo posto, non si mantiene come si manteneva prima, come un tempo, sulla mia piccola testa capricciosa.
Il senso tecnico di questa rappresentazione drammatica è chiaro: sul piano rituale, e giovandosi della condizione protetta che gli è propria, viene eseguito in forma anticipata e simbolica, destorificata e come sognante, il processo che avrà poi luogo nella vita reale, cioè la perdita della verginità, che caratterizza in modo pre gnante la nuova situazione di sposa. Sul piano rituale il passaggio, occultato nel simbolo, è effettuato gradualmente, come se si trat tasse di un vero e proprio adattamento protetto alla nuova situa zione che si prospetta: il che ricorda le lamentazioni funebri fra morto e sopravvissuti, le quali sono lavorate tecnicamente allo stesso modo, in quanto preparano sul piano rituale il riadattamento all evento luttuoso, e al suo inesorabile «mai più». Tale significato tec nico affiora da un detto col quale le lamentatrici consigliano di lasciare che la promessa sposa si lamenti: «se non si lamenta ora - suona in sostanza il detto - piangerà poi alla casa del marito», il che comporta il riconoscimento che il lamento della sposa pre para e facilita, sul piano destorificato del rito, il passaggio effet tivo della realtà storica.12 Mentre i compianti di reclutamento accennano ad una traspo sizione relativamente recente e circoscritta dell’antico lamento fune bre, i lamenti nuziali risalgono con ogni probabilità al mondo antico. Invece i lamenti per la morte di animali —sopravvissuti qua e là nel folklore euromediterraneo - rinviano alle civiltà di cacciatori, 12 Sokolov, op. cit., pp. n o sg.
328
A G G IU N T E
dove ebbero la loro origine, inserendosi organicamente nella corri spondente vita religiosa. Com’è noto il Frazer ha fornito numerosi esempi di pianti rituali del genere. Così, per esempio, quando gli Ostiachi uccidono un orso a caccia fanno seguire alla uccisione un lamento rituale di questo tipo: «Chi ti ha ucciso? Sono stati i Russi. Chi ti ha tagliato la testa? Un’accetta russa. Chi ti ha scuoiato? Un coltello fatto da un russo».13 Come nella già ricordata formula di Epifanio si ha qui uno spostamento della colpa: solo che men tre nelle civiltà agricole tale spostamento concerneva le passioni vegetali connesse al raccolto, nelle civiltà di cacciatori lo spostamen to concerne la passione animale connessa con la caccia. In questo quadro di destorificazione del momento critico della uccisione del l’animale in una civiltà di cacciatori va collocato il lamento funebre come pianto rituale che occulta l’iniziativa storica, e intanto me diante tale occultamento la permette e la dischiude. Con la nascita dell’agricoltura e con la domesticazione degli animali, il pianto rituale per la morte di animali si tramuta o in pianto rituale per la uccisione di animali nocivi all’agricoltura, o in lamenti dopo sacri fici di vendetta compiuti con animali sui quali viene spostata la responsabilità umana della passione vegetale, o infine in veri e pro pri lamenti funebri per animali domestici, economicamente utili, e variamente collegati con l’uomo da rapporti affettivi. L ’età elle nistica conobbe una risoluzione letteraria del lamento per gli ani mali domestici, per quanto di solito questo trapasso non sia stato av vertito dai moderni studiosi degli epicedi ellenistici per animali.14 Sarebbe desiderabile che tali nessi storici concernenti il pianto ri tuale nelle civiltà di cacciatori e di quelle di allevatori e di agricol tori fossero sottoposti ad una approfondita analisi storico-religiosa.
5. Un lamento Yamana Già spiegammo a suo tempo le ragioni per cui un’analisi del lamento funebre nelle cosiddette civiltà primitive non rientra nella prospettiva del presente lavoro (cfr. pp. n sg.); tuttavia i dati etno 13 Per i dati etnografici cfr. Frazer, Il ramo d'oro, trad. it. (Torino 1950) voi. 2, pp. 166 sgg. 14 Cfr. Herrlinger, Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung (Stoccarda 1930).
A G G IU N T E
329
logici possono talora meglio lumeggiare alcuni aspetti meramente tecnici del lamento antico, ancorché grandissima è la distanza per quel che concerne i valori dischiusi. Valga un esempio. Abbiamo visto come il lamento funebre originariamente destinato a persone storiche subisse nel mondo antico varie trasposizioni e fra queste il lamento per qualsiasi catastrofe che colpisce la collettività (si pensi alla qìnà profetica, o al lamento di Serse per la flotta per duta, nel coro finale dei Persiani). Di una trasposizione analoga rende testimonianza una lamentazione funebre Yamana che fu rac colta dal Koppers e dal Gusinde in circostanze interessanti. Si tratta di una lamentazione a richiesta degli etnografi e quindi fuori della circostanza reale, ma appunto per questo particolarmente istrut tiva per le reazioni degli indigeni alla situazione innaturale. La prima reazione fu di stupore: «Come si può essere tanto tristi, se nessuno è morto?» Tuttavia essi finirono con l’accedere alla richie sta, e si prepararono alla lamentazione «con una meditazione di molte ore». Il lamento fu cantato da due donne, con esecuzione palesemente responsoriale, poiché «una donna cantava, mentre 1 al tra la interrompeva di continuo parlando in preda al piu vivo dolore ed esprimendo ciò che aveva nel cuore». La lamentazione delle due donne non fu però un vero e proprio lamento funebre, poiché ciò era impedito dalla mancanza del morto, ma una trasposizione del pianto rituale funerario alla catastrofe che aveva colpito la popo lazione Yamana, in via di estinzione per effetto della colonizza zione bianca. In mancanza della registrazione fonografica della melodia, che Gusinde e Koppers riuscirono ad ottenere in questa circostanza, diamo il testo letterario del canto delle due donne, così come i due etnografi lo hanno trascritto:15 O , come siamo disgraziate, che questi due [Gusinde e Koppers] ci obbli gano a cantare il lamento funebre. Essi vengono da un popolo numeroso e noi siamo in pochi. I pochi che ci sono rimasti sono come degli uccellini sfuggiti per caso al cacciatore. E Watauinéwa [l’essere supremo] ci portò via i buoni e solo i brutti e i meschini rimasero sino alla fine del popolo Yamana. Noi cattivi, noi malati rimanemmo fino ad oggi. Ed egli lasciò vivere noi che siamo deboli e siamo in pochi. A me ha rapito i figli, tutta la mia famiglia. E i figli che mi rimangono dovranno seguire ben presto la stessa strada che hanno presa gli altri perché sono deboli e malaticci. Mia cugina 15 C fr. W . Koppers, La religione dell’uomo primitivo, trad. E . Rosati (Milano 1947) pp. 12 9 -3 1.
33°
A G G IU N T E
ha perso anche lei molti parenti, ma possiede ancora un fratello che ha una numerosa famiglia. Ma io sono sola e non ho più che una lontana parente. Questa parentela però viene da un altro uomo, lontano di qui. Ahimè, ahimè, Padre mio, tu mi fai molto soffrire, tu mi hai duramente punita. Quanta gente c ’era una volta all’ovest [il luogo natio della donna]. Ora siamo rima sti in due o tre al massimo. E a me hai lasciato solo una parente di laggiù, ma alla fine rapirà anche lei. Questi due [Gusinde e Koppers] vengono per farci cantare il lamento funebre. Sebbene questo canto non lo ripetiamo da tanto tempo, questi due lo desiderano. Altre volte Watauinéwa ci ha obbli gate a cantare mandandoci qualche sventura. Adesso questi due lo deside rano. I bianchi finora credevano che questo fosse una specie di giuoco. Ma per noi è un canto serio. Se fossi un uomo soffrirei sotto il pesante lavoro che gli uomini devono fare nel bosco e in mare e in altri luoghi. Ma essendo una donna sono occupata nella capanna. Se tutti i miei parenti dovessero morire, avrei anch’io il coraggio di soffrire come un uomo. E allora lavore rei e soffrirei come loro nel bosco e in mare e in altri luoghi. Allora lavore rei fin che anch’io dovrei morire. Dei miei parenti sono rimaste solo poche donne e gli uomini Lui li ha portati via. Io non sono come le vecchie donne del nostro popolo. Queste parlavano e cantavano molto bene, molto meglio di noi oggi. E abbiamo perduto tutte queste belle parole, noi che adesso siamo costretti a parlare inglese e spagnolo. Così noi dimentichiamo le nostre belle vecchie parole yamana. La nostra lingua non ha più la vecchia sicu rezza. O come siamo infelici per questo! E guarda, quanto dobbiamo sof frire in questo mondo! Come siamo in pochi! M a nell’altro mondo, là dove ci sono gli Europei, sono in molti. Se là uno muore, poco importa, perché ne rimangono tanti. Ma da noi è diverso. Quando muore uno di noi è come se morissero mille di quegli Europei che sono tanto numerosi. Come sono angustiati il mio vecchio padre cieco e la mia vecchia madre! Il giorno in cui moriranno correrò nel bosco, mi sperderò e non mangerò e non berrò più e morirò di dolore. Se fossi un uomo andrei fuori a uccidere tutti gli animali e non porterei a casa niente. Ucciderei tutti. Farei come quello lassù che distrugge e uccide tutti come se volesse mangiare. Allora proverebbe anche lui se questo fa piacere. E allora lui avrebbe davvero ragione di punirmi.
Atlante figurato del pianto
Il presente atlante figurato si avvale di tre tipi fondamentali di materiale documentario, il folklorico, l’antico e il cristiano. Il materiale folklorico consta di un lamento funebre sorpreso in vivo (la sequenza di Castelsaraceno: n. i) e di una serie di lamenti arti ficiali, cioè eseguiti al di fuori della reale occasione luttuosa, e a richiesta dell’etnografo (nn. 2-6), e infine di alcune fotografie rela tive al rituale funerario romeno (nn. 7 -11). Il materiale fotografico lucano proviene dalle nostre esplorazioni etnografiche eseguite dal 1950 al 1956,1 il materiale fotografico sardo è ricavato dal negati vo di un documentario girato nel 1955 a Fonni (Sardegna) da Vito Pandolfi e Paola Mazzetti, il materiale fotografico romeno ci è stato cortesemente fornito dall’Istituto di Folklore di Bucarest. In gene rale i documenti lucani e sardi giovano ad illustrare alcune quistioni relative al lamento antico, ed in particolare la sua mimica e lo stato psichico della lamentatrice durante il discorso protetto della lamentazione stessa. Vorremmo qui sottolineare la novità del tenta tivo, poiché - come già fu dimostrato (pp. 58 sgg.) - nella scienza folklorica e nella storia della letteratura e della poesia popolare si è data fin’oggi assai scarsa importanza alla mimica rituale del lamen to e allo stato psichico della lamentatrice in azione, due elementi che invece hanno importanza notevole per una prospettiva storico religiosa. Il materiale antico (nn. 12-57) consta di un gruppo di fi gurazioni egiziane (nn. 12-32), fenicie (n. 42), greche (nn. 44-53), e romane (nn. 56-57) relative alla lamentazione per persone storiLe fotografie sono state eseguite da Franco Pinna.
332
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
che, e di altri dati figurativi direttamente o indirettamente colle gati al pianto rituale e al mondo mitico che ne costituisce l ’oriz zonte (nn. 33-4 1, 43, 54-55). Al contrario di ciò che è avvenuto per i relitti folklorici, la mimica della lamentazione nelle figura zioni corrispondenti del mondo antico è stata oggetto di indagine da parte degli studiosi: ricorderemo in particolare le monografie della Werbrouck per il lamento egiziano, e del Collignon e dello Zschietzschmann per quello greco. Tuttavia queste monografie, pur preziose e meritorie, presentano dal punto di vista storico religioso alcuni limiti che occorre sottolineare se si vuole apprez zare in giusta misura la relativa novità che anche per questa parte spetta al presente atlante figurato. In primo luogo le monografie della Werbrouck, del Collignon e dello Zschietzschmann sono ri spettivamente limitate al settore della sola civiltà egiziana o della sola civiltà greca, ed in secondo luogo il fine che si propongono non è tanto la ricostruzione della mimica rituale del lamento funebre antico nel quadro della sua corrispondente problematica storico religiosa, quanto piuttosto la valutazione del materiale archeolo gico in funzione della cosiddetta «evoluzione artistica» delle rap presentazioni figurative della lamentatrice in azione. Così la Wer brouck analizza la evoluzione artistica della rappresentazione della lamentatrice a partire dal Regno Antico, e lo Zschietzschmann esplora i mutaménti dello stile figurativo nella rappresentazione della prothesis dall’epoca geometrica in poi, e il Collignon si pro pone di ricostruire l’origine del tipo figurativo della lamentatrice in Grecia. Ora dal nostro punto di vista essenzialmente storico religioso non interessano le quistioni di stile e di storia dell’arte, e ancor meno la valutazione della efficacia rappresentativa delle singole figure, ma unicamente la mimica rituale che dal materiale figurativo del mondo antico è possibile ricostruire: noi cioè utiliz zeremo il materiale archeologico unicamente come documento del costume, e precisamente della lamentazione come rito. La terza sezione del presente atlante figurato comprende docu menti figurativi di epoca cristiana (nn. 53-67). Anche qui il mate riale è giudicato non già nel suo aspetto propriamente estetico, ma come documento del contrastato e drammatico affermarsi della visione cristiana della morte.
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
333
La serie folklorica si apre con alcuni momenti successivi di un lamento funebre reale che ebbe luogo a Castelsaraceno la mattina del 3 agosto 1956 (n. 1). La sequenza mostra le due figlie della morta che, a capo della bara, cantano il lamento: il n. ia è da con frontarsi con il corrispondente archeologico del n. 3 1 , dove è del pari raffigurato un discorso individuale al morto. Nella serie folklorica dei lamenti artificiali la fotografia n. 2 rappresenta un mo mento di esaltazione parossistica di una lamentatrice di Pisticci: 10 scenario di ulivi che qui fa da cornice si spiega col fatto che la lamentatrice si rifiutò di eseguire in paese quanto le veniva richie sto, motivando il suo rifiuto con le proteste che il vicinato non avrebbe mancato di sollevare: fu quindi necessario portarla in cam pagna per «farla piangere» con l’aiuto di una sua amica fidata. La sequenza n. 3 fu ottenuta in occasione di un documentario cine matografico girato da Michele Gandin fra i calanchi dei dintorni di Pisticci nel marzo del 1954. Per le esigenze del documentario cinematografico la ricostruzione dell’evento luttuoso dovette spin gersi ai minimi particolari. Si suppose un incidente nel quale un contadino avrebbe trovato la morte, precipitando col carretto e con Tasino in un burrone: la moglie e la cognata accorrevano sul luogo della sciagura ed effettuavano la lamentazione. Per quanto in tale occasione non fossero rispettate tutte le condizioni per otte nere un buon saggio di lamento artificiale, fu tuttavia possibile avere conferma del carattere stereotipo e rituale della mimica della lamentazione, come mostra la sequenza in quistione: per circa mez z’ora la lamentatrice nella parte di moglie iterò senza sosta sul ritmo della melopea una stessa successione di atti, agitando dapprima 11 fazzoletto sul morto ricoperto di un lino, poi abbassandosi sulle gambe e allargando le braccia, e infine rialzandosi portando il faz zoletto al naso. La mimica stereotipa col fazzoletto è caratteristica del lamento funebre di Pisticci, anche se - com’è ovvio - risulta alquanto diversa quando il morto, come accade nella maggioranza dei casi, non è disteso al suolo ma giace sul letto o nella bara. E anche da osservare che la esecutrice che sosteneva la parte di moglie in questa lamentazione era effettivamente vedova da qualche tempo, e tendeva a riprodurre nel lamento artificiale quello che essa aveva effettivamente recitato davanti al cadavere del marito.
334
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
La sequenza n. 4, ottenuta a Ruoti nell’agosto del '56, è di par ticolare interesse per illustrare in un caso concreto le fasi della pro gressiva impersonazione nella parte della lamentatrice quando il lamento è a richiesta. L ’immagine n. 4a mostra la giovane conta dina assorta davanti al suo compito ed in atto di chiamare a rac colta le memorie di una trascorsa situazione luttuosa della sua vita: le immagini n. 4b-d rivelano l’entrata in azione dell’organismo tra dizionale della lamentazione come complesso di moduli verbali, melodici e mimici; l’immagine η. 4ε segna ormai l’impersonazione completa nella parte, e il pieno sprofondarsi nell’onda indefinita mente rinnovantesi della melopea. La intensità della partecipazione che può ottenersi anche in un lamento a richiesta è documentata dall’immagine n. 5, che raffigura una lamentatrice di Montemurro che effettua la lamentazione davanti al microfono della r a i , nel l’agosto del 1956. Nella sequenza n. 6a-d le lamentatrici entrano in gruppo nella casa dove è stata ricostruita la scena luttuosa (n. 6a), e dànno ini zio alla lamentazione. Qualche lamentatrice mostra palesemente nella espressione del viso uno stato caratteristico di concentrazione sognante (n. 6b). Nel corso del lamento si notano determinate ste reotipie mimiche, come la oscillazione ritmica del busto in avanti verso la bara (n. 6c-e), eseguita sincronicamente da tutte le lamen tatrici, che insieme si abbassano sulla bara e insieme si rialzano (n. 6f). Un’altra stereotipia è il movimento oscillatorio laterale del busto sul ritmo della melopea, come per una ninna-nanna (n. 6g) e anche qui vi è tendenza al sincronismo di gruppo. Tale sincroni smo di gruppo della mimica della lamentazione ha numerosi paralleli archeologici sia nello stile geometrico greco (n. 49) sia in alcune raffigurazioni egiziane (nn. 28-32). Il movimento oscillatorio late rale del busto ricorda, come fu già osservato, le parole di Ecuba nelle Troiane (vv. 115 -19 ): O mia testa, o mie tempie, o miei fianchi, quale brama mi prende di far oscillare la mia schiena e la mia spina dorsale, verso l’una e l’altra parte del mio corpo, per accompagnare il mio lamento e le mie lacrime senza fine.
In generale per la mimica nel lamento folklorico rinviamo ai cor rispondenti commentari del testo (cap. 2, §§ 4 e 5, cap. 3, § 5).
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
335
Dall’analisi del materiale figurativo del mondo antico si ricava che il più elementare modello mimico della lamentazione è quello delle braccia sollevate ad angolo e piegate ad angolo (n. 16). E un gesto che d’altra parte non è specificamente funerario, poiché accanto a valenze di cordoglio e di disperazione può averne altre di giubilo e di richiesta implorante: tuttavia quando appare in scene di lamentazione esso assume il carattere di paradigma mimico fune rario e costituisce uno dei non molti atteggiamenti rituali da assu mersi nel corso dell’evento luttuoso. Il secondo diffusissimo modello della lamentazione nel mondo antico è quello che, con termine greco, potremmo chiamare del kopetòs: le braccia sollevate in alto del modello precedente si abbattono ora sulla testa o sono spinte verso il viso, con tendenza a iterare indefinitamente l’atto e a dargli un ritmo di esecuzione collettiva. Le lamentatrici raffigurate ai nn. 17 , 18, 42, 44-48 ci mostrano il modello mimico in quistione eseguito individualmente, mentre la sua esecuzione collettiva è rap presentata ai nn. 28-3 r, 49. La tendenziale uniformità dell atteg giamento in queste scene collettive non può essere interpretato unicamente come risultato di una stilizzazione, ma piuttosto la stessa stilizzazione figurativa ha il suo fondamento realistico di un ritmo rituale della mimica di gruppo, sul tipo di quella che abbiamo osservato a proposito della oscillazione collettiva e sin crona del busto delle lamentatrici di Fonni (n. 6f). Un modello largamente diffuso è anche quello di un solo braccio esteso in avanti, a palma rovesciata, mentre l’altro braccio è portato al capo, ovvero riposa (nn. 19-26, 50-52, 54, 56). È un modello che presenta due opposte valenze in atto di decidersi, la separazione e il rapporto, con varie sfumature nei singoli casi: così nel n. 56 prevale la valenza apotropaica mentre nei nn. 19-26, 52, 53 predomina la valenza del rapporto. Rinviamo comunque su questo punto, come del resto sulla mimica del lamento antico in generale e sul suo significato tecnico rispetto alla crisi, al capitolo 5, §§ 1 e 2: qui vogliamo aggiungere soltanto alcuni chiarimenti e integrazioni. La stemotypia (piangere pectora) —cioè il battersi il petto a palme aperte o a pugni chiusi - è figurativamente rappresentata dal n. 57 e let terariamente attestata da Sofocle, Aiace, 632 (χερόπληκτοι δ εν στέρνοισι πεσοΰνται δοϋποι) come anche da Apuleio, Metani., 8 («Nam mater pueri, mortem deplorane acerbam filli, fleta et lacrimosa
336
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
fuscaque vesta contecta ambabus manibus trahens cinerosa canitiem, eiulans et exinde proclamane, tunsisque a diverberatis vehementer ubera»). Nettamente distinto dal piangere pectora è la esi bizione dei seni delle due lamentatrici del sarcofago di Achiram (n. 42), con valenze di recupero dinanzi alla morte o di richiamo e di rapporto (cfr. cap. 5, pp. 202 sg.). Un’altra stereotipia mimica del planctus ritualizzato è il percuotersi le gambe: in questo senso va interpretato l’atteggiamento delle quattro figure centrali di lamentatrici della tomba di Amenemanet (n. 32), che leggermente piegate nel busto e nelle ginocchia eseguono appunto il gesto. La Werbrouck opina che le quattro figure stiano «dans une attitude qui serait presque de l’imploration»,2 ma si tratta di un equivoco: non c’è dubbio infatti che si tratti di un modello di planctus rituale. Durante le nostre esplorazioni etnografiche sul lamento funebre lucano e delle colonie albanesi calabro-lucane, abbiamo più volte osservato, in lamenti reali o artificiali, il modello mimico in que stione: la sua esecuzione, nella attuale situazione folklorica calabrolucana ha però luogo soltanto nella crisi oppure accompagna rit micamente il discorso protetto della lamentazione da parte della lamentatrice seduta accanto alla bara durante l’esposizione, e in tal caso i colpi dati sulle gambe scandiscono il ritmo della melopea. Nel già menzionato bassorilievo illustrato dal Garrucci (n. 57) ap paiono sulla destra tre figure di donne sedute - forse libertae in atto di abbracciare il ginocchio sinistro: questo modello mimico del cordoglio ha alcuni interessanti riscontri letterari. Si legge in Pausania io , 3 1 , 2: «Con ambo le mani Ettore abbraccia il ginoc chio sinistro, mostrando così il modello (σχήμα) di chi è in cordo glio». E in un passo di San Nilo: «M i sedetti e abbracciando con le mani le ginocchia e piegando su di esse il volto colmavo il grembo di lacrime» (PG 684). Anche Agostino accenna allo stesso gesto: « Si vulsi capillum, si percussi frontem, si consertis digitis complexatus sum genua» (Confess. 8, 26). Il canonico Andrea de Jorio3 segnala il modello mimico delle «mani a pettine sottoposte al ginoc chio piegato» ovvero della «gamba piegata e stretta con le due mani l’una sovrapposta all’altra» come espressione di dolore, e ricorda 2 Werbrouck, Les pleureuses ecc., p. 62. J A. de Jorio, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano (Napoli 1832) pp. 138 sg.
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
337
come «le nostre moderne prefiche così sogliono per lo più atteg giarsi allorché sedute al suolo ed accanto al morto ne compiangono le glorie vere o supposte». Il de Jorio osserva anche che le mani incrocicchiate o a pettine, ma a palme rovescie, e portate a braccia tese verso il basso del ventre, fanno espressione di dolore (p. 203): abbiamo osservato frequentemente questa particolarità mimica durante le lamentazioni funebri ancora in uso nel Mezzogiorno d’Italia, ma il de Jorio trascura di dire che il gesto in questo caso va immaginato nel gridato del parossismo o nel canto della melo pea, e accompagnato da un leggero moto oscillatorio delle braccia e del busto. Le braccia possono essere anche protese in avanti, sem pre a dita intrecciate e a palme rovescie, e sempre con la detta leggera oscillazione. Il significato è ovvio: si tratta di un gesto che vuol esprimere allontanamento da sé della sciagura. Le raffigurazioni di epoca cristiana si riferiscono in parte a scene di lamentazione raffigurate su tombe (nn. 58-60) ed in parte al pianto delle donne per la morte di Cristo (nn. 61-66), raggiungendo infine il loro epilogo ideale nei funerali di Santa Fina del Ghirlan daio (n. 66), che possono a buon diritto essere presi come modello dei funerali cristiani. Nei cortei funebri della tomba di Sancho Saiz de Carillo, nelle scene di lamentazione della tomba di Egas Moniz e di quella di Don Gonzalo de Hinopa il ritmo delle forme anti che del pianto rituale sembra dispiegarsi in tutta la sua veemenza, come se ancora non avesse esercitato nessuna influenza sul costume l’episodio esemplare evangelico in cui Gesù scaccia gli esecutori del lamento dalla casa della figlia di Jairo. Nella tomba di Don Gonzalo lamentazione funeraria e rito cattolico appaiono raffigu rati in due momenti successivi e distinti, la prima durante la espo sizione del cadavere, ed il secondo intorno al sarcofago. La descri zione delle lamentazioni per la morte di Ferdinando III il Santo nella Primeva Crònica General e altri dati (cfr. pp. 297 sg.) confer mano pienamente il valore documentario di queste raffigurazioni sepolcrali. I modi della lamentazione antica si riflettono chiara mente nel pianto sul Cristo di Fra Guglielmo (n. 61), e nelle terre cotte di Niccolò dall’Arca (n. 63) e di Guido Mazzoni (n. 64). Nella deposizione di Giotto nella Cappella degli Scrovegni (n. 6 1 a, b) le forme più acute della crisi, come lo strapparsi i capelli e l’ulu lato, sono attribuite alla disperata ridda degli angeli, il che ricorda
338
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
stranamente la ridda di figurine immerse nel planctus che sorvo lano il cadavere nel lecito attico del n. 53. La compostezza cri stiana illuminata di pietà e di speranza domina invece le composi zioni del Beato Angelico (n. 65) e del Perugino (n. 67). Infine i funerali di Santa Fina del Ghirlandaio (n. 66) presentano nel qua dro della solenne liturgia della chiesa volti gravi di uomini, com poste comari e incantati giovinetti, e una dolce melanconia che non va oltre il «sommesso pianto». Oltre alla documentazione strettamente attinente al lamento funebre, al suo pieno fiorire e alla sua decadenza per opera del Cristianesimo, il presente atlante figurato allinea - come è det to - una serie di dati documentari antichi e folklorici che per quanto abbiano un legame indiretto col lamento destinato a per sone storiche, posseggono tuttavia notevole importanza per illustra re e appoggiare determinate tesi sostenute nel corso del libro. In primo piano stanno i dati relativi al pianto rituale agrario e al mito del nume che muore e risorge (nn. 33-4 1, 43: cfr. capp. 6 e 7). Per gli agoni rituali, oltre al già ricordato lutroforo attico del n. 50 e al gladiatore del n. 56, rinviamo alle eloquenti figurazioni delle tombe di Tarquinia (tomba delle bighe, tomba della scimmia, tomba degli auguri).4 La risoluzione dell’erotismo nei giuochi lascivi cerimoniali trova il suo riflesso figurativo nei due gruppi erotici della tomba dei tori di Tarquinia, da paragonare con i corrispon denti folklorici dei giuochi lascivi nel corso dei funerali di Lazzaro Boia (cfr. pp. 164 sgg.). Per il banchetto funebre folklorico è da vedere il n. io: particolare interesse presenta il banchetto nel descobara (n. 1 1), che rende sensibile il passaggio risolutivo dal «man giare il morto» della crisi al «banchetto di separazione e di comu nione» aperto a determinate valenze etiche (cfr. pp. 203 sgg.). Infine il trasporto processionale dell’abete (n. 8) illustra una fase determinata dei funerali di Lazzaro Boia descritti nel capitolo 4 (pp. 166 s g g . ) . Possiamo ora valutare complessivamente il contributo conosci tivo che è risultato dalla comparazione del materiale fotografico folklorico, del materiale figurativo antico e di quello di epoca cri stiana. Il materiale fotografico folklorico ha messo in evidenza alcuni dati che la documentazione antica, sia figurativa che lette 4 Cfr. M. Pallottino, La peinture étrusque (Skira, Ginevra 1952).
A T L A N T E F IG U R A T O D E L P IA N T O
339
raria, non poteva fornirci, e cioè lo stato di concentrazione sognante della presenza rituale del pianto, e la oscillazione ritmica del busto come mimica elettiva durante il discorso protetto della lamenta zione. (Su quest’ultimo punto vi è tuttavia un riscontro letterario antico molto significativo nella oscillazione ritmica di Ecuba se condo il passo delle Troiane). In un caso particolare il materiale folklorico ha consentito di interpretare in modo giusto la reale dina mica del planctus rituale delle quattro lamentatrici della tomba di Amenemanet. Infine la lamentazione folklorica in azione ha reso possibile identificare come realisticamente fondati i sincronismi mimici di gruppo che nel materiale figurativo antico si è soliti attri buire unicamente a motivi stilistici. D ’altra parte l’esame del mate riale figurativo antico ha notevolmente allargato l’angusta prospet tiva mimica ricavabile dal documento folklorico attuale: l’indossare modelli di vestiti dimessi o stracciati, la esibizione dei seni, le mani a pettine sotto le ginocchia piegate, la estensione rituale del brac cio con valenza di separazione e di rapporto e infine il kopetòs e la stemotipia in quanto ritmi collettivi appaiono senza riscontro apprezzabile nel documento folklorico attuale. Senza dubbio la com parazione fra materiale fotografico folklorico e materiale figura tivo antico non ha il potere di esaurire il panorama mimico della lamentazione, poiché resta sempre aperta la possibilità di modelli mimici che non potettero trovare espressione nell’ arte figurativa antica e che andarono perduti nel processo di disgregazione folklorica senza lasciar traccia neanche nelle fonti letterarie. Tuttavia dalla comparazione delle due diverse istanze documentarie, la folklorica e l’antica, è possibile formarci un quadro abbastanza com pleto della mimica rituale del lamento funebre antico. Ciò che ad ogni modo tale comparazione non permette di determinare è la distribuzione dei modelli mimici secondo aree ed epoche definite: qui sta senza dubbio un limite oggettivo della documentazione non solo figurativa ma anche letteraria, e la ricerca deve contentarsi di una visione di insieme su un’area notevolmente ampia e per un lasso di tempo che abbraccia millenni. Una linea di sviluppo nella mimica è però ravvisabile, soprattutto se teniamo presente il mate riale cristiano, col quale la lamentazione entra in una crisi deci siva, e l’evento luttuoso tende a riflettersi nei volti e nei corpi umani secondo espressioni mimiche conformi al nuovo animo, che più non consente la pagana lamentazione.
378
B IB L IO G R A F IA
B IB L IO G R A F IA
379
Bràiloiu C ., « A le mortului» din Gorf (Bucarest 19 36). [Lam ento romeno].
D e Geram b M .J ., Pèlerinageà Jérusalem eta u M o n iS in a ì(Parigi 1836) voi. 1 , pp. 2 2 7 sg.
- Boòete din Oa§, G rai §i suflet, voi. 7, 1 sgg. (19 38 ). [Lam ento romeno].
[Funerali e lamentazione a Gerusalemme]. D e Gubernatis A ., Storia comparata degli usi funebri in Italia e presso gli altri popoli indoeu
- Despre bocetul dela Dragu$, A rh iva pentru §tiinta si reform a sod ala, voi. io , 280 sgg. (19 32 ). [Lam ento romeno], - Sur une ballade roumaine (Mioritza) (G inevra 1946). [La M ioritza e il lamento fune bre romeno]. Bresciani A ., Dei costumi dell'isola di Sardegna comparati con gli altri popoli antichissimi
orientali (Napoli 1850) pp. 314 -4 4 . [Lamento funebre sardo]. Bronzini G ., Tradizioni popolari in Lucania (M atera 19 5 3) pp. 229-48. [Lamento lucano e costumanze funerarie]. Brough Sm ith R ., The Aboriginal o f Victoria (1878) p. 1 1 8 . [Cordoglio e lamento funebre]. Brugsch H ., Die Adonisklage und das Linoslied (Berlino 18 5 2 ). Bugiel, Les chants funéraires de la Bologne, Bull. M ém. Soc. Anthropol. Paris (1925) 122-47: (1926} 5 7 -7 3 ; (1929) 7-36. Calder W . M ., The Dithyramb A n Anatolian Dirge , Classica! R e v ., voi. 36, 1 1 - 1 4 (19 22). [Il ditiram bo come originario lam ento funebre anatolico].
Calvia G., Canti funebri di Ploaghein Sardegna, Arch. Trad. pop., voi. 14 , 5 1 0 - 1 4 (1895). Canney M., The Magie ofTears , J . Manchester egypt. orient. Soc., voi. 1 2 , 47-54 (1926). Casas Gaspar E ., Costumbres espanolas de nacimiento, noviazeo, casamiento y muerte (Madrid
1947 )· Cham bers E . K . , The M edieval Stage (O xford T903) pp. 39 sgg. [Planctus M ariae]. Cicm il Ο ., O tuzbalicama, Prilozi proucavanju narodne poezije, voi. 1, 125-30 (1934). [Lamento funebre presso gli slavi meridionali]. C irese A . M ., Alcuni canti popolari abruzzesi raccolti in provincia di Rieti , R iv . abruzzese, voi. 5, n. 2, 4 1 sg. (19 5 2 ). [Lamento funebre abruzzese]. - Manzoni, Croce e una nenia di Amatrice, L a Lapa, voi. 2, n. 3 (1954).
- Nenie e prefiche nel mondo antico, Lares, voi. 1 7 , 20-44 ( 19 5 1) . - Il pianto funebre nei sinodi diocesani (Rieti 19 5 3 ). Collignon M ., De l'origine du type des pleureuses dans Vartgrecque, R ev . Etudes grecques,
ropei (3a ed ., M ilano 1890). D elahaye H ., Les passions des martyrs et lesgenres lìttéraires (Bruxelles 1 9 2 1) pp. 1 8 1 - 2 3 5 . [Origini della orazione funebre cristiana].
De Launay G . , Rites et usages funéraires: les pleureuses et les lamentations, Rev. Trad. pop., voi. 6, 628 -30 (18 9 1). D e L a Ville D e M irm ont H ., Nenia, R ev. Philol., voi. 26, 2 6 3 -7 1, 335 -4 8 (1902); anche in Etudes sur Vancienne poésie latine (Parigi 19 0 3) pp. 359 sgg. D el Grande C ., Τ Ρ Α Γ Ω ΙΔ ΙΑ . Essenza e genesi della tragedia (Napoli 19 5 2 ), pp. 3 sgg. [εξάρχοντες τον διθύραμβον ed εξαρχος γόοιο], 225 sgg. [Panorama delle teorie sulle ori gini della tragedia]. D e M artino E ., Fenomenologia religiosa e storicismo assoluto, Studi M at. Storia R ei., voi. 24-25 (1953-54). [M etodologia storicistica]. - I l mondo magico (Torino, i a ed. 19 4 8 , 2 a ed. 19 5 8 ) pp. 9 1 sgg. [Sulla crisi della presenza].* - Rapporto etnografico su l lamento funebre lucano, Società, voi. io , 656-65 (1954). - Religionsethnologie und Historizismus, Paideuma, M itt. K ulturkunde, voi. 2, n. 4/5 (1942). [M etodologia storicistica]. - Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni, Studi M at. Storia R ei., v o i. 28, 89 sgg. (19 57 ) [M etodologia storicistica]. - Crisi della presenza e reintegrazione religiosa, A ut-A ut (1956 ) n. 3 1 . D e N ino A ., Usi e costumi abruzzesi (Firenze 1879-97) voi. 2, p. 200. [Lamento funebre per la m orte di Carnevale]. Dólger F .J., Lachen w ider Tod, in «Pisciculi Franz Dòlger dargeboten» (Munchen i. W . 19 30 ) pp. 80-85. [Riso rituale funerario, riso sardonico, risus paschalis]. Drioton E ., Croyances et coutumes funéraires de Vancienne Egypte, Rev. Caire (1943) pp. 3 1 sg. [Lamentazioni].
Contini G ., Teatro religioso del Medioevo fuori dTtalia (1948) pp. 25 sgg. [Christós pàschòn].
D um as G ., L e sumaturel et les dieux d'après les maladies mentales (Parigi 1946). Dussaud R., Les religions des Hittites et des Hurrites, des Phéniciens et des Syriens (Parigi 1949) p. 3 7 5 . [Probabile rituale dell’ultimo covone nel poema di Baal].
Cram er M ., Die Totenklagen bei den Kopten, Stzber. A kad. W iss. W ien, Phil.-hist. K l.,
Eisler R ., Orphisch-Dionysische Mysteriengedanken in der Christlichen A ntike, Vortrage Bibl.
voi. 16 , 299-322 (1903).
voi. 2 19 , 78 sgg. (19 4 1). Croce B ., Conversazioni critiche, voi. 2 (Bari 1900) pp. 246 sg. [Sulla cosiddetta «nenia di A m atrice...»]. - Filosofia e storiografia (Bari 1947) pp. 202 sgg. [A proposito del mondo magico e della crisi della presenza]. - La storia come pensiero e come azione (Bari 19 38 ) pp. 42 sgg. [La presenza come ethos]. - I trapassati, in Frammenti di etica (Bari 19 2 2 ) pp. 22 sgg. [C risi del cordoglio]. Dalman G ., Arbeit und Sitte in Paldstina, I, 2 (19 28) pp. 574 sgg. [Lamenti per l’inumazione dell’ultim o fascio di spiga mietuto]. - Palestinische Diwan (Lipsia 19 0 1) pp. 3 1 6 sgg., 32 4 sgg. [Lam enti agrari]. D ankert W ., Das europàische Volkslied (Berlino 19 38 ) pp. 229 sgg. [Accenni alla melodia dei lamenti].
W arburg (19 2 2 -2 3) n. 2. Eissfeld t O ., Linos undA tijan, «M élanges syriens offerts à R e n é D ussaud», voi. 1 (1939) pp. 16 4 sgg. Elhorst H .K ., Dieìsraelitischen Trauerriten, Beihl. Z . alttest. W iss., voi. 2 7 ,1 1 5 - 2 8 (19 14 ). [pp. 12 0 sg. lamento funebre ebraico]. Erm ann A ., D ie Religìon der Aegypter (Berlino 19 34 ) p. 7 3 . [Lamento d i Iside e di Nephthys come modello del lamento funebre destinato alla m orte di persone storiche]. Erm an A . e R an ke H ., Aegypten und aegyptisches Leben im Altertums (Tubinga 19 2 3) pp. 5 1 3 - 3 2 . [Condizioni del contadino egiziano]. Erm ini C L o Stabat M ater e il Pianto della Vergine nella lirica del medioevo (C ittà di Castello 19 16 ). [Planctus Mariae]. * [Nuova ediz. Bollati Boringhieri, Torino 1997].
B IB L IO G R A F IA
380
Fara G ., L'anim a della Sardegna: la musica tradizionale (Udine 1940) p. 17 7 . [Accenni alla melodia del lamento funebre sardo]. Faulkner R .O ., T h eLam entationsoflsisandN epbthys, «M élanges M aspero» voi. 1 (1934)
337
PP· sgg. Favara A ., Corpus di musiche popolari siciliane (Palermo 19 56) voi. 2, nn. 566-75. [M elo die di lamenti siciliani]. Ferrato G ., Canti popolari in dialetto logudorese (Torino 28 9 1). [Lam enti del Logudoro]. Finam ore G ., Tradizioni popolari abruzzesi (Torino-Palermo 1894). Franck C ., K ultlieder aus Ischtar-Tamùz Kreis (Lipsia 1939). Fran kfort H ., A ncient Egyptian Relìgion (Chicago r948). - Kingship and thè G o d (Chicago 1948). Frazer J ., The GoldenBough, p arte5 “ : Spiritsofthe C om an do/th è Wild, voi. i , pp. 13 1-3 0 5 . [M adre o fanciulla del grano, animale dei cereali, Lityerse e figure analoghe].* Freistedt E ., AUchristliche Totengedàchtnistage und ihreBeziehungen zum Jenseitsglaube und Totenkultus der A ntike (Miinster 1928). [Cristianesimo e sopravvivenze pagane nel culto funerario]. Freud S ., Trauer undM elancholte, in Gesamm elteSchriften, voi. 5 (1924) pp. 5 3 5 -5 3 . [Psi copatologia d el cordoglio].** G aster T h ., Thespìs: Ritual, M yth and Bram a in thè Ancient Near East (New Y o rk 1950). G eiger P ., Totenklage, «Flandwòrterbuch dtsch. A berglaube», voi. 8 (1936) cc. 10 7 2 sgg. G iese W ., D ie baskische Totenklage, Iberica, voi. 4, 52 sgg. (19 2 5 ); trad. spagn. Las elegias bascas, Euskaleriaren A id e, voi. 17 , 4 52-59 (1927). G oldstein K ., Zum Problem der Angst, A llg. artz. Z . Psychother. psych. H yg ., voi. 2,
B IB L IO G R A F IA
382
H egel W . F . G ., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, trad. B . C roce, § 407. [C risi della presenza]. H einisch P ., D ie Totenklage im A lten Testament, Biblische Zeitfragen, voi. 23, n. 9-20, 84 sgg. (2932). - D ie Trauergebràuchen bei den Israelìten, ibid., voi. 2 3, n. 7-8, 99 sgg. (19 32 ). H elbig W ., D ai homerische Epos aus Denkmalem erlautert (Lipsia, 2 a ed. 2887) pp. 395 sgg. [Lo scudo di Achille]. H eller J . L . , Nenia «παίγνιον», Trans. Proc. amer. philol. A ss., voi. 74, 225-68 (2943). Herescu N . J ., Un écho des nénies dans la littérature, R ev . Études lat., voi. 25, 74-76 (2947). H errlinger G ., Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung (Stoccarda 2930). Floffm ann C ., Aramatsche Inschriften aus Nérab bei Aleppo, Zeitschrift fiir Assyriol. u. verw.
Geb., voi. 22, 228 sg. (2896). [Ritornelli emotivi che diventano numi], H op fn er T h ., Plutarch iiberlsis und Osiris (Praga 2940-42) voi. 2, pp. 72 sgg. [Maneros], H orrack J . de, Les lamentations d ’Isis et de Nephthys (Parigi 2906); rist. in CEuvres (Parigi 2907) pp. 33 sgg.
Hvidberg FI., Vom Weinen un dLachen in A T , Z . alttest. Wiss., voi. 5 7 , 250 sgg. (1939). Iaenov H ., Das hebraische Leichenlied im Rahmen der Vólkerdichtung, Beihefte Z . alttest. Wiss., voi. 36 , t-2 72 (1923). Inguafiez D.M., Un dramma della Passione del secolo x n (Badia di Montecassino 2936). [Planctus Mariae], Ioannidu, Untersuchungen zur Form der neugriechischer Klagelieder, diss. M onaco 19 38 . Iroaie P ., Vita e poesia popolare romena (Bucarest 2943) pp. 189-96. [Lamenti romeni],
409 sgg. (2929). G oldzieher J . , Muhammedanische Studien (Halle a. S. 2889) voi. 2, pp. 252 sgg. [Pole
Ja n e t P ., D e l ’angoisse à l'extase (Parigi 2928) voi. 2, pp. 350 , 36 7 . C fr. p. 282 [psicologia
m ica dell’Islam ism o contro il lam ento funebre]. G regorovius F ., Corsica ( 2 “ ed. 2869) pp. 34-48, 52-88. [Vòcero còrso]. Gressm ann H ., Altorientalìsche Texte und B ilder zum A lten Testament (Lipsia 2926). G rob er, Z ar Volkskunde aus Konzilienschliissen und Kapitularen (Strasburgo 2894). G uastella S. A ., Canti popolari d e l circondario di M odica (M odica 2876). [Reputatrici a
- Vautom atism e psychologique
M odica a p. l x x x ix ], G uerin V ., Voyage dans Vile de Rhodes (Parigi 2856) p. 69. [Lam ento presso gli Eb rei di Rodi], Gusinde M ., D ie Feuerland Indiàner, I: D ie Selk'nam (Mòdling bei W ien 2932) pp. 5 5 0 sg., 547 sgg., 566, 547 sg., 55 2 sg., 566. [Rituale funerario e ideologia relativa presso i Selk-
d el cordoglio], 4 7, 49, 52 [crisi della presenza],
(Parigi 2889) p. 478. [Miseria psicologica ed ethos della
presenza]. - L 'éta t mental des histériques
(Parigi, 3 a ed. 2923) pp. 5 5 sgg. [Psicopatologia del cor
doglio]. Jeanm aire H ., Dionysos (Parigi 2952) pp. 3 3 7 sg. [Passione di D ioniso e passione vege tale della vite].* Jen sen A . E ., Das religiose W eltbild einer friihen K ultur (Stoccarda 2948). Jeremias A ., Molle und Paradies bei den Babyhnem (Lipsia 2903) pp. 5 sgg. [Morte, sepoltura e riti funebri],
nam della T erra del Fuoco], H aavio M ., D ie finnisch-karelischen Klagelieder, J . Soc. finno-ougrienne, voi. 4 7, n. 3, 2 sgg. (2934). H a h n J.G . von, AlbanesìscheStudien (2854) voi. 2 ,p . 252. [Lamento rituale]. Ibid., voi. 2,
Ju n k er H ., D ie Stundewachen in den Osirismysterien nach den Inschriften von Dentiera, Ed/u
pp. 13 4 sgg. [Testi relativi]. H aller M ., D ie Klagelieder, in O . Eissfeld t, « D ie f iin f M egilloth, H andb. zur A lt. T est. » (Tubinga 2940) pp. 92 sgg.
K an t I., L a critica della ragion pura, trad. G . C olli (Torino 19 5 5 ) libro I I , cap. 1, sez. 11, § 25. [Crisi della presenza].
* [Trad. ital. dell’ediz. ridotta dall’autore, 2922: Il ramo d ’oro, Bollati Boringhieri, Torino 2990], ** [Vedilo in Opere di Sigmund Freud (ediz. Boringhieri) voi. 8, pp. 202-18: Lutto e melan conia (2925)].
K lauser T h ., D ie Kathedra im Totenkult der heidnìschen und christlichen A ntike (Miinster 2928).
und Philae, D enkschrift. A kad. W ien, phil.-hist. K l., voi. 5 4 (2920). K ahle P ., D ie Totenklagen im heutigen àgypten, Forsch. R ei. Lit. A lte Neue T est., voi. 19 , 346-99 (2923). [Lamento funebre nell’ Egitto moderno].
K ern F ., D ie Welt worein die Griechen traten, Anthropos voi. 4 5, 274 (2929). [Esperienza d el ritmo stagionale nelle civiltà cerealicole mediterranee].
* [Trad. ital.: Dioniso. Religione e cultura in Grecia (Einaudi, Torino 2972)].
B IB L IO G R A F IA
382
K lein M ., M oum ing and Its Relatìons to Manie-depressive States, in « C ontributions to Psy choanalysis 1 9 2 1 - 1 9 4 5 » (Londra 1948) pp. 3 1 1 - 3 8 . [Psicologia del cordoglio].*
B IB L IO G R A F IA
383
Lum ini A ., Studi calabresi: le sacre rappresentazioni, i l Natale, le reputatrici (1890). M aas P ., Threnos, «Pauly-W issow a Realenc.» voi. 6 (19 37) cc. 596 sgg.
Kódaly Z ., A magyar népzene (Budapest, i a ed. 19 3 7 , 2 a ed. 19 5 2 ). [Capitolo dedicato
M ahler E ., D ie russische Totenklage: ihre rituelle und dichterische Deutung (Lipsia 19 36 ).
alla lam entazione ungherese dal punto di vista musicale]. Koppers W ., La religione dell'uom o prim itivo, trad. E . Rosati (M ilano 1947) PP- I
M alten L ., Leichenspiele und Totenkult, Ròm . M itt., voi. 38-39, 300 sgg. (1923-24). [Sacri fici e agoni durante i funerali].
29 -3 t·
[Lamento Yam ana]. Ktetschm er P ., Lityerses und Hylas, G io ita , voi. 1 4 , 33 sgg. (19 25).
M annhardt W ., Mithologischen Forschungen (Strasburgo 1884) pp. 1 sgg. [Ideologia del l’ animale del raccolto].
K roll W ., Nenia, «Pauly-W issow a R ealenc.» voi. 1 6 (19 35) cc. 2390-93. Labat R ., Lecaractère religieux de la royauté assyro-babylonienne (Parigi 19 3 5 ) pp. 1 2 2 sg.
- Wald- und Feldkulte (Berlino, 2 a ed. 1904-05) voi. 1 , pp. 2 1 3 sgg. [ideologia del covone rituale], 2 10 [ideologia dell’ animale del raccolto],
[lamentazioni pubbliche per il re e per i membri della fam iglia reale], 1 2 1 [identifica
M ansikka, Z ur altostslawischen Totenklage, M ém. Soc. finno-ougrienne, voi. 58 , 1 3 8 sgg. (1928).
zione del re con Tamùz]. Lafaye G ., Laudario funebris, D arem berg-Saglio, v o i. 3, c. 996. Lalevic L . S ., Odnos i veze bugarstica i tuzbalica, Prilozi proucavanju narodne poezije, voi. 3, 50-73 (1936) con riassunto in tedesco. [Lamento funebre presso gli Slavi meridionali]. Lam arm ora A ., Voyage en Sardaigne (Parigi 1839-46) voi. 3 , pp. 276 sgg. [Lamentazione sarda]. Lane E .W ., A n Account o f thè Manners and Customs o f thè M odem Egyptians (Londra 1896) pp. 5 1 9 sgg., 5 3 2 . [Lamento funebre nell’ Egitto moderno], Langdon F ., The E pic o f Crearion (O xford 19 2 3) pp. 2 15 sg. [Passione di Lillu]. Lanternari V ., Orgia sessuale e riti di recupero nel culto dei morti, Studi M at. Storia R ei., voi. 24-25 (1953-54). Laslo K . K ., A kolozsvari hostatiak temetkezése (Kolosvar 1944) pp. 286 sgg. [Lamento presso gli ungheresi della Transilvania], Lawson J . C . , M odem G rek Folklore and Ancient G reek Religion (Cam bridge 1 9 10 ) pp. 546 sgg. [lamento funebre neogreco], 5 7 3 [passione di C risto e passione del grano]. Leicher, D ie Totenklage in der deutscher E p ik von den àltesten Zeiten bis zur Nibelungenklage (19 27). Leipoldt J . , Der Tod bei Griechen und Juden (Lipsia 19 4 2) PP· 12 2 -4 7 · [Lam ento funebre
M arcaggi J . B ., Chants de la m ori e de la vendetta (Parigi 1898). [Vòcero còrso]. - Lamenti, voceri, chansons populaires d e la Corse (Ajaccio 1926). M arian S. FI., Inmormintarea la romàni (Bucarest 18 2 2 ) pp. 10 3 sgg. [canto dell’abete], 1 1 3 sgg. [bocete], M aspero G ., Etude sur quelques peintures et sur quelques textes relatifs aux funérailles, Études egypt., voi. 1 , 8 1 sgg. (1879). M eissner B ., Babylonien und Assyrien (H eidelberg 19 2 5 ) voi. 2, p. 244. [Lamento fune bre mesopotamico], M enendez Pidal R ., Sobre la primitiva lirica espanola, C ultura neolatina, voi. 3 , 2 0 3 -13 (19 43). [Endecha]. M éridier L ., L 'influ ence de la seconde sophistique sur l ’oeuvre de Grégoire de Nysse (Parigi 1906) pp. 2 2 5 - 5 1. [O rigini d ell’orazione funebre cristiana]. M érim ée P ., Colom ba (Parigi 18 4 1 ) capp. 3 e 12 . [Trasfigurazione rom antica della voceratrice còrsa], M euli K ., Entstehung und Sinn der Trauersitten, Schweiz. Arch. Volkskunde, voi. 43, 9 1 sgg. (1946).
e sepoltura]. Lépicier A .M ., Mater Dolorosa, notes d ’histoire, de liturgìe et d ’iconographie sur le culte
- Griechische Opferbràuche, in «Phillobolia fu r P . v . d. M iih ll» (Basilea 19 4 5 ) pp. 18 5 sgg.
de Norie Dame des douleurs (Spa 1948). Lichtheim M ., The Song o fth e Harpers, J . near east. Stud., voi. 4, 17 8 sgg. (19 4 5) [p. 18 0
M ichaelis D e Vasconcellos C ., Cancìoniero da A ju d a (Halle a. S . 1904) pp. 854-58. [Endecha].
su Maneros]. Lippert J . , Christentum, Volksglaube und Volksbrauch (Berlino 1882) pp. 261 sgg., 4 1 3 sgg.
M ichel F ., L e pays basque (Parigi 18 5 7 ) pp. 272 sgg. [Lamento basco].
[Cristianesim o e sopravvivenze pagane], 38 3 sgg. [rituale funerario].
M onceaux P ., Epithaphia, Darem berg-Saglio, voi. 2, c. 728. M oret A ., L a mise à m ori du dieu en Egypte (Parigi 19 2 7 ).
Littm ann E ., Abessinische Klagelieder (Tubinga 1949). - Neuarabische Vólkspoesie, A bh. Ges. W iss. Gòttingen, phil.-hist. K l., N S , voi. 5 , n. 3
- Rituels agraires de l ’ancien Orient à la lumière des nouveaux textes de Ras Shamra, Ann.
(1902). Liungm an W ., Traditionswanderungen Euphrat-Rhein, F .F . C ., n. 1 1 9
- R oìs et dieux d ’Egypte (Parigi 1 9 1 1 ) .
, 1 (H elsinki 19 37 )
p. 2 6 1 [pianto rituale connesso al raccolto], 1 1 2 sgg. [covone rituale e colonna Ded]. Lom bardi Satriani R ., Credenze popolari calabresi (Napoli 19 5 1) . Liiddekens E ., Untersuchungen iiber religiósen Gehalt, Sprache und Form der àgyptiscken Totenklagen, M itt. dtsch. In st. aegypt. Altertum skunde K airo , voi. i r (19 4 2). * [Trad. ital.: Il lutto e la sua connessione con gli stati maniaco-depressivi, in Scritti 19 2 1-19 5 8 (Boringhieri, Torino 1977) pp. z - l-
3 7 53
Inst. Philol. H ist. orien t., voi. 3, 3 1 1 - 4 2 (19 35). M orosi G ., Studi sui dialetti della Terra d ’Orianto (Lecce 1870) pp. 8 sgg., 27 sg., 37 sg.,
54
sg., 59 sg., 65 sg. [testi di lam enti neogreci], 93 [descrizione della lamentazione rituale]. M usil A ., Arabia Periaea, voi. 3 : Ethnologischer Reisebericht (Vienna 1908) pp. 429 sg. [Lamentazione funeraria araba], M ylonas G . E ., Hom eric andMycenaean B urial Custom, Am er. J . Archeol., voi. 5 2 , 5 6 sgg. (1948). [C fr. p. 57 e nota: la lamentazione nell’ordine dei riti funerari].
B IB L IO G R A F IA
3*4
N estle W ., D ie Strukturdes Eingangs in derattischen Tragodie (Stoccarda 1930) pp. 18 sg. [Lamento funebre e commo tragico]. N ilsson M .P ., D ie Anthesterien und die A iora, E rano s Jahrbuch, voi. 1 5 ( 19 15 ) ; rist. in Opuscula selecta (Lund r 9 5 i) pp. 1 6 1 sgg. - Geschicbte der griechischen R eligion (Monaco 19 5 5 ) voi. 1 , p. 7 1 4 [lamento funebre], voi. 2, p. 18 7 [lamento funebre nel culto degli eroi]. - The Mynoan-mycenean Religion and Its Survival in Greek Religion (2a ed. 1950) pp. 18 2 [supposte statuette di lam entatrici nella civiltà minoica], 2 37 sg., 243 [lamentazioni stagionali]. - Tragodie und Totenklage, A rch . Religionswiss. (1906) 286 sgg. - D er Ursprung der Tragedie, N eue Jahrb . klass. Altertum ., voi. 27, 609-42 ( 1 9 1 1 ) ; rist. in Opuscula selecta (Lund 1 9 5 1 ) pp. 6 1 sgg. [Lamento funebre e tragedia]. N urra P ., La poesia popolare in Sardegna (Sassari 19 03). \Attittidos\. Onciolescu T ., Bocete, Folklore, voi. i o (19 35 ). O nians R .B ., T he Origin o fE uropean Thought (Cam bridge 1 9 5 1 ) pp. 1 1 3 sgg. [Rapporto uom o-grano]. Oppenheim L ., Mesopotamian Harvest Song, Bull. amer. Schools orient. Res. voi. 10 3 , 1 1 - 1 4 (1946). [Ritornello emotivo alala nei pianti stagionali del raccolto e Alala come nume]. O rtoli F ., Les voceri de l'ile Corse (Parigi 188 7). Osterm ann V ., L a vita in Erìuli (Udine, i a ed. 18 9 4 , 2 a ed. 1940) pp. 387 sg. [Lam enta zioni friulane]. Paci E ., I l nulla ed il problema d e ll’uomo (Torino 1950) p. 12 6 . [C risi della presenza]. Passow A ., Popularia Carmina Graeciae recentioris (Lipsia 1860) pp. 257-88. [Lamenti neogreci]. Petrovic V . Z ., Priloziproucavanju tuzbalica u sevemoj Srbiji, G lasnik etnografskog muzeja u Beogradu, voi. 1 1 , 1 18 - 2 6 (19 36 ), con riassunto in tedesco. [Lamenti della Serbia
B IB L IO G R A F IA
385
Rantasalo A .V ., D er Ackerbau im Volksglauben derFinnen un dderEsten, mit entsprechenden Gebràuchen der Germanen verglichen (Sortalava-Helsinki 19 25) voi. 5, p. 5 1 . [M itiz zazione del m ietitore nell’ultim o m ietitore mietuto]. Reiner E ., D ie rituelle Totenklage der Griechen, Tiibing. B eitr. Altertum sw iss., n. 30 (Stoccarda-Berlino 1938). Riedel W ., Die Kirchenrechtquellen des Patriarchats Alexandrien (Lipsia 1900) p. 1 9 1 . [Canoni contro il lamento funebre]. Riposati B ., M. Terenti Varronis de vita populi romani (M ilano 19 39 ) pp. 2 18 -30 . [Nenia, laudatio, conclam ano]. Roeder, Urkunden zur Religion der alten Aegypt (Jena 1924). Rohde E ., Psyche (Tubinga, i o a ed. 19 2 4 ) voi. 1 , pp. 24, 2 2 1 sg., 2 23 n. 2. [Lamento funebre greco]. Roheim G ., Nach dem Tode des Urvater, Im ago, voi. 9, 8 3 - 1 2 1 (19 2 3 ). [Interpretazione psicoanalitica del cannibalismo rituale funerario]. Rubieri E ., Storia della poesia popolare italiana (Firenze 18 7 7 ) pp. 1 3 0 sgg. [Lamento folklorico italiano], Ruland L ., D ie Geschicbte der kirchlichen Leichenfeier (Ratisbona 19 0 1). Rush A .C ., Death and F uriai in Christian Antiquity (W ashington 19 4 1). Salom one-M arino S ., L e reputatrici in Sicilia nell'età di mezzo e moderna (Palermo 1886). Santoro B ., L a nenia popolare e letteraria (Acireale 1902). Saulic N ., Srpske narodne tuzbaliche (Belgrado 1929). [Lamento funebre presso gli Slavi meridionali]. Schadewalt W ., Von Homers W elt und Werk (Stoccarda 1944) pp. 35 2 sgg. [Lo scudo di Achille]. Schanz M . e H osius C ., Geschicbte der romischen Literatur (4“ ed. 19 2 7 ) voi. 1 , pp. 22-24. [Nenia]. Schm idt B ., Totengebràuche und Grdberkultus im heutigen Griechenland, Arch. Religion
settentrionale]. Petrucciani M ., Valore poetico dei lamenti funebri italiani, Lares (19 53 ) pp. 50 sgg.
sw iss., voi. 24, 2 8 1 sgg. (1926). [Lamento neogreco]. Schneeweis E ., Grundriss des Volksbrauchs der Serbokroaten (Celje 19 3 5 ). [Capitolo spe
Pettazzoni R ., I misteri (Bologna 19 24 ). Picard C h., Les religions préhelléniques (Parigi 1948) p. 194. [Supposte statuette di lamen
ciale sui lam enti funebri]. Schònbach A ., Ueber die Marienklagen (G raz 1874) pp. i o sgg. [Planctus Mariae],
tatrici nella civiltà minoica]. Pinna O ., R iti funebri in Sardegna (Sassari 1 9 2 1) .
Schopen, Das Christentum der Katakomben, A rch. Religionswiss., voi. 37 , 329 sgg. (19 4 1).
P itré G ., Curiosità, voi. 8 dell’ ed. naz., p. 56. - Usi, costumi, credenze e pregiudizi, voi. 1 4 d ell’ed. naz., cap. 4. [Piagnisteo e nenie]. Poggi E ., Usi natalizi, nuziali e funebri della Sardegna (M ortara-Vigevano 189 7). Preuss Th. K ., D ie Totenklagen im alten A m erika, G lobus, voi. 70, 342 sgg. (1896). Pritchard J . P . , Ancient Near Eastem Texts (Princeton 19 5 5 ). Puech Ch., L e manichéisme (Parigi 1949) pp. 90 sg., 19 2 n. 390. [Raccolto, passioni vegetali e colpa]. Q uasten J ., Musile und Gesang in den Kulten d. heidn. A ntike und christl. Friihzeit (Munster 19 30) pp. 295-347. [Cristianesim o e lam ento funebre], Rajeczky B ., D omonkos P dlP éter, in The Folklore o fth e Csdngós, voi. 1 . [Lamentazioni], Ranke K ., Indogermanische Totenverherung, 1 : D er dreissigste und vierzigste Tage im Totenkult der Indogermanen, F .F . C . , n. 14 0 (Helsinki 19 5 1) pp. 92 sgg., 18 7 , 247, 248, 262, 28 7 sgg., 294, 304. [Lam entazioni funebri dei popoli indoeuropei].
[Cristianesim o e sopravvivenze pagane], Schrader O ., Reallexicon derIndogermanischen Altertumskunde, voi. 1 , pp. 124-27. [Lamento funebre indoeuropeo]. Sechehaye M . A ., Journal d ’une schizophrène (Parigi 19 5 0 ).* Sethe K ., Dramatische Texte zu altàgyptischen Mysterienspielen (Lipsia 1928) pp. 13 4 sgg. [Passione di O siride come re divino e passione dei cereali]. Sittl G ., D ie Gebarden der Griechen und R óm er (Lipsia 1890). Sokolov I ., L e fo lk lo re russe, trad. frane. (Parigi 1945) pp. 1 1 6 sgg. [lamenti funebri], n o sg. [lamenti nuziali], 12 4 sgg. [compianti di reclutamento]. Spano E ., Saggio critico-storico della poesia dialettale sarda (Cagliari 19 0 1) . [Lam enti fune bri sardi].
* [Trad. ital.: Diario di una schizofrenica (Editrice Universitaria, Firenze 1963)].
386
B IB L IO G R A F IA
Spencer B ., Native Tribes o fth e Northern Australia (Londra 19 14 ) pp. 228 sg. [Cordoglio e lam entazione nelle isole M elville e Bathurst]. Spencer B . e G illen J . F . , The Arunta (Londra 19 26) voi. 2, p. 14 2 . [Cordoglio e lam enta zione presso gli Aranda]. Springer H ., Das altprovenzalìsche Klagelied m it Beriicksichtigung der verwandten Literaturen (Berlino 18 9 5). Stew ard J . H . , Ethnography o f thè Owen Valley Paiate, U niv. C alifornia Pubi. amer. A rchaeol. A eth n ol., voi. 3 3 , n. 3 , 296 sgg. (19 33). Strehlow, D ie Aranda und Loritja Stdmme in Zentral-Australien, V ero ff. Volkermus. Fran k furt, voi. 4, n. 2, 1 5 sgg. [Rituale funerario], Stum pfl R ., Kultspiek der Germanen a b Ursprung des mittelalterlichen Drama (Berlino 1936) p. 249. [Cristianesim o e sopravvivenze pagane]. Szabolcsi B ., Osztydk hósdalek-magyar siraték m elódiai, Ethnographia, Budapest (19 33). [M elodie di lam entazioni ungheresi e ugro-finne], - Osztjak és vegul dallamok. Uj adatok a magyar népi siratodallam problémajahoz, ìbid. (r - [N uovi dati sulle m elodie del lamento funebre ungherese]. Taplin G ., The Narranjeri, in Native Tribes o f South Australia (Adelaide 2879) p. 20. [C or doglio e lam entazione presso i Narranjeri].
9371
Thalheim F ., Epitaphios, « Pauly-W issowa R ealenc.», voi. 6, 2 18 . Thausing G ., D er Auferstehungsgedanke im àgyptischen religiosen Texten (Lipsia 19 4 3). Thten H ., U eber die englischen Marienklagen (K iel 1906) pp. 3 sgg. [Planctus Mariae]. Thureau-D angin F ., L a passion du dieu L ìllu , R ev. A ssyriol., voi. 29, 17 5 sgg. (19 2 2 ). Toschi P ., Appunti sul pianto funebre in Italia, Lares, voi. 18 , 10 0 sgg. (19 52). - I l pianto funebre nella poesia popolare italiana, Poesia, voi. 7, 11- 4 0 (1947). - L e origini d e l teatro italiano (Torino 19 56) pp. 308 sgg. [la m orte di C arn evale e lam enti relativi], 683 [pianto di M aria, pianto della M adonna di Jacopone, e lam enti funebri um bri].* Trede T h ., Das Heidentum in der romischen Kirche ( 18 9 1) voi. 4, pp. 4 13 -2 0 . [Lam ento funebre nel Napoletano]. U ntersteiner M ., L e origini della tragedia e d e l tragico (Torino 19 5 5 ) p. 226. [O rigini anatoliche del ditiram bo, e ditiram bo come originario lamento funebre]. Usener H ., Klagen und Lachen, Rhein. M us., voi. 59, 623 sg. (2904); rist. in Kleine Schriften, voi. 4, pp. 469 sg. Vandier I ., L a religion égyptienne (Parigi 1949). V an G ennep A ., M anuel de fo lk lo re franpais, t. 1 , 2 (Parigi 1946) pp. 679-85. [Lam ento funebre in Francia e vòceri còrsi], V an Selms A ., Weenen als aavengsrite, Nieuw Theol. Tijdsschr., voi. 24, 12 9 -2 7 (19 35 ). [Valore magico del piangere]. Vargyas L ., A dalék a siratodallam eredetéhez, Uj Zenej Szemle (2954) n. 7-8, 46 sgg. [Sulla origine delle melodie delle lamentaziorti ungheresi], V edder H ., D ie Bergdama (Amburgo 2923) pp. 220 sg. [Lamento funebre presso i D am a della montagna], Vohlard E ., I l cannibalismo, trad. ital. (Torino 2948) p. 220. C fr. p. 226: cannibalism o e rituale funerario. * [Nuova ediz. Bollati Boringhieri, Torino 2999].
B IB L IO G R A F IA
387
Vollm er F ., Laudationum funebrium romanorum bistorta critica, Jah rb . klass. Phil., voi. 18 , suppl. (1893). - Laudario funebris, « Pauly-W issowa Realenc.», voi. 23 (1924) cc. 992 sg. Vukanovic T ., Tuzbalice u Kosanici, Labu i Pristini, Prilozi proucavanju narodne poezije, voi. 2, 9 3-10 9 (19 35 ). [Lamentazioni delle regioni di K ., L . e P.]. W agner L ., Das Undliche Leben Sardiniens im Spiegel der Sprache, W òrter und Sache, H ei delberg (19 2 1) n. 4, 16 4 sgg. [Lamento funebre sardo]. - D ie sardische Volksdichtung, «Festschr. 12 allg. deutsch. Neuphilologentage» (Erlangen 1906) pp. 278 sgg.; trad. ital. in A rch. sardo (1906) 36 5-422. C fr. pp. 4 0 2 -15 [attittidos], W eber L ., Solon und die Schópfung der attischen Grabrede (Frankfurt a. M . 19 35) pp. 44 sg., 62 sg., 85. [Orazione funebre in Rom a e in G recia, e Solone come riformatore del rituale funerario e come creatore della orazione funebre attica]. W echssler E ., D ie romanesche Marienklagen (H alle 189 3) pp. 12 sgg. [Planctus Mariae], W einreich O ., D ie Christianisierung einer Tibullsstelle, H erm es, voi. 62, 1 1 8 , n. 2 (19 27). [Elegia e popolarità di pianto e allegria nel rituale funerario]. W eiser A ., Einleitung in das alte Testament (Stoccarda 1926) pp. 24 [lamenti funebri, lamenti del raccolto], 2 5 2 sg. [lamentazioni di Gerem ia]. W ellhausen J ., Reste arabischen Heidentums (Berlino, 2 a ed. 18 9 7 ) pp. 177-8 6 . [Funerali]. W ensink A .J ., Ueber das Weinen in den monotheistischen Religionen Vorderasiens, «Festschr. E d . Sachau» (Berlino 1 9 15 ) pp. 12 0 sgg. W erbrouck M ., Les pleureuses dans TEgypte ancien (Bruxelles 1938). W e r t h E ., Grabstock, Hacke und Pflug: Versuch einer Entstehungsgeschichte des Landbaues (Ludwigsburg 19 5 4 ). [Origine e diffusione delle civiltà agricole]. W esterm arck E ., R itu al and B e lie f in Marocco, voi. 2 (Londra 1926) p. 42 3. [Lamento in Marocco]. W ilke G ., Totenkultus, «R eallexicon der V orgeschichte», voi. 1 3 , pp. 363 sgg. W ilkinson, The Manners and Customs o f thè Ancient Egyptìans (Londra 18 7 8 ) pp. 4 2 7 sgg. [Lamento funebre nel moderno Egitto], W in ter A .C ., Lettische Totenklagen, G lobus, voi. 8 2, 367 sgg. (1902). W itzel M ., Tammuzliturgien (Roma 19 35 ). Y oun g K ., The Drama o f thè M edieval Church (O xford 19 33) voi. 1 , pp. 492 sgg., 506 sg., 5 1 8 sgg. [Planctus Mariae], Zappert G ., U eber den Austruck des geistigen Schmerz in Mittelaltem, Denkschr. kaiserl. A kad. W iss., phil.-hist. K L , W ien, voi. 5 , 7 3 - 1 3 6 (1854). Zimmermann O ., D ie Totenklagen in den Altfranzòsischen Chansons degeste (Berlino 1899). Zschietzschm ann W ., Die Darstellung derprothesis in dergriechischen Kunst, Athen. M itt., voi. 5 3 , 17 -4 7 (1928).
Universale Bollati Boringhieri
Abraham, Teoria e applicazioni della psicoanalisi [171] Aleksandrov e altri, Le matematiche [104/105] Asimov, La fotosintesi [58] Barnett, Istinto e intelligenza [87] Bartók, Scritti sulla musica popolare [153] Baruffi (a cura di), Il desiderio di maternità [185/186] Bates, La storia naturale [46] Boas, Arte primitiva [222/223] Boas, Introduzione alle lingue indiane d’America [180] Bohr, I quanti e la vita [5] Boltzmann, Modelli matematici, fisica e filosofia [270] Bolzano, Del metodo matematico [277] Bolzano, I paradossi dell’infinito [275] Bondi, Sciama e altri, Cosmologie a confronto [145] Bonnor, Universo in espansione [3] Bonvallet, Veglia e sonno [26] Boole, L ’analisi matematica della logica [262] Borek, Il codice della vita [17] Born, La sintesi einsteiniana [43/44/45] Brewer, L ’organizzazione del sistema nervoso [38] Bridgman, La logica della fisica moderna [6] Bunge, La causalità [47/48] Carnot, Riflessioni sulla potenza motrice del fuoco [258] Cavanna (a cura di), Aspetti scientifici della parapsicologia [91] Chomsky, La grammatica trasformazionale [130] Clegg, Homo sapiens [59] Cocchiara, Il mondo alla rovescia [218/219] Cocchiara, Il paese di Cuccagna [196/197] Cocchiara, Storia del folklore in Europa [69/70/71] Courant e Robbins, Che cos’è la matematica? N. ed. [65/66/67] Claridge, Psicofarmaci: problemi e prospettive [165/166] Cremerius (a cura di), Educazione e psicoanalisi [12 0 /12 1] Crossley e altri, Che cos’è la logica matematica? [140] D ’Antonio (a cura di), La crisi postkeynesiana [127/128] Darwin, L ’origine delle specie [148/149/150] de Martino, Il mondo magico [98/99] de Martino, Morte e pianto rituale [123/124] Derry e Williams, Storia della tecnologia [167/168 e 169/170] Deutsch, Psicologia della donna voi. 1: L ’adolescenza [252/253/254] voi. 2: La donna adulta e madre [255/256/257] Dobb, Economia politica e capitalismo [108/109] Dodwell (a cura di), Prospettive della psicologia [143/144] Durell, La relatività con le quattro operazioni [15] Durkheim e altri, Le origini dei poteri magici [159] Eddington, Spazio, tempo e gravitazione [60] Einstein, Autobiografia scientifica [193/194] Einstein, Pensieri degli anni difficili [4]
Einstein, Relatività: esposizione divulgativa [24/25] Einstein e Infeld, L ’evoluzione della fisica [1/2] Eliade, Tecniche dello Yoga [240/241] Eliade, Trattato di storia delle religioni [141/142] Ellenberger, La scoperta dell’inconscio: storia della psichiatria dinamica [201/202/203 e 204/205/206] Fabietti, Alle origini dell’ antropologia [212/213] Ferenczi, La mia amicizia con Miksa Schàchter: scritti preanalitici 1899-1908 [259] Feynman, La legge fisica [13] Fogg, La vita e la crescita delle piante [34] Foss (a cura di), Nuovi orientamenti di psicologia infantile [154] Foss (a cura di), I nuovi orizzonti della psicologia [30/31] Frazer, Il ramo d ’oro [7/8 e 9/10] Freud (Anna), Conferenze per insegnanti e genitori [244] Freud (Anna), Il trattamento psicoanalitico dei bambini [88] Freud (Anna) e Bergmann, Bambini malati [106] Freud (Sigmund), Compendio di tutti gli scritti [245/246/247] Freud (Sigmund), L ’interpretazione dei sogni
[96/97]
Freud (Sigmund), Introduzione alla psicoanalisi
[39/40]
Freud (Sigmund), Freud (Sigmund), Freud (Sigmund), Freud (Sigmund), quotidiana [2] Freud (Sigmund), Freud (Sigmund), Freud (Sigmund), Freud (Sigmund),
[173/174]
Isteria e Angoscia [100/101] Il motto di spirito [210/211] Psicoanalisi infantile [29] Psicopatologia della vita La teoria psicoanalitica [181/182] Totem e tabù [36] La vita sessuale [51] Ossessione Paranoia Perversione
Friedrichs, I concetti matematici elementari della fisica [27] Frings, La comunicazione animale [57] Frisch, von, Il linguaggio delle api [136] Galbraith, Il grande crollo [80] Galbraith, La società opulenta [81/82] Galois, Scritti matematici [273] Garma, Psicoanalisi dei sogni [64] Granit, Le finalità del cervello [190] Gratton, Relatività Cosmologia Astrofisica [33] Greenberg, Introduzione alla linguistica [189] Guerraggio e Nastasi (a cura di), Gentile e i matematici italiani: lettere 1907-1943 [264] Heisenberg, Mutamenti nelle basi della scienza [172] Heisenberg e altri, Discussione sulla fisica moderna [195] Hilbert e altri, Geometria intuitiva [72/73] Horowitz (a cura di), Marx, Keynes e i neomarxisti [61/62]
Jacobi, La psicologia di C. G . Jung [89] Jung (C. G.), Il contrasto tra Freud e Jung [126] Jung (C. G.), La dimensione psichica: raccolta di scritti a cura di Luigi Aurigemma [83/84] Jung (C. G.), Introduzione alla psicologia analitica [272] Jung (C. G.), L ’Io e l’inconscio [21] Jung (C. G.), Un mito moderno: le cose che si vedono in cielo [276] Jung (C. G.), Il problema della malattia mentale [ 117 / 118 ] Jung (C .G .), Psicologia dell’inconscio [28] Jung (C. G.), Psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti [116 ] Jung (C. G.), La saggezza orientale [236/237] Jung {C. G.), Tipi psicologici [131/132 ] Jung (C. G.) e Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia [199/200] Jung (Emma), Animus e Anima [260] Katz, La psicologia della forma [179] Kenny, Wittgenstein [242/243] Kerényi, Miti e misteri [183/184] Kitaigorodskij, Ordine e disordine nel mondo degli atomi [32] Lambert e Brittan, Introduzione alla filosofia della scienza [228] Lashley e altri, La fisica della mente, a cura di Vittorio Somenzi [ 114 / 115 ] Lattanzi, La rivoluzione molecolare [103] Leeuw, van der, Fenomenologia della religione [133/134 /135] Lenneberg, Fondamenti biologici del linguaggio [232/233/234] Lerner (a cura di), Qualità e quantità e altre categorie della scienza [68] Lobacevskij, Nuovi princìpi della geometria [107] Lorenz, Evoluzione e modificazione del comportamento [71] Lovari, Etologia di campagna [214/215] Macfarlane, Psicologia della nascita [216] Mach, La meccanica nel suo sviluppo storico critico [161/162] Mainardi, La scelta sessuale [119 ] Makinson, Temi fondamentali della logica moderna [178] Malinowski, Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi [42] Mayr, Biologia ed evoluzione [235] Meschkowski, Mutamenti nel pensiero matematico [90] Millar, La psicologia del gioco infantile [19 1/19 2] Money-Kyrie, Il significato del sacrificio [266] Morgenstern, Teoria dei giochi [35] Morpurgo, Capire l’evoluzione [122] Musatti, Freud, con antologia freudiana [36] Nagel e Newman, La prova di Godei [102] Napoleoni, Smith Ricardo Marx [54] Oliverio Ferraris, Psicologia della paura [217] Oparin, L ’origine della vita [152] Patzig, Linguaggio e logica [92] Pavlov, I riflessi condizionati [112 / 113 ] Philippson, Origini e forme del mito greco [238/239]
Piaget, La rappresentazione del mondo nel fanciullo [93/94] Planck, La conoscenza del mondo fisico [261] Poincaré, Geometria e caso: scritti di matematica e fisica [269] Propp, Le radici storiche dei racconti di fate [75/76] Regge, Cronache deH’universo [221] Reik, Il rito religioso [163/164] Reynolds, I tre mondi dell’economia [187/188] Riemann, Sulle ipotesi che stanno alla base della geometria [265] Roll, Storia del pensiero economico [18/19/20] Rosenthal, Genetica delle malattie mentali [160] Schròdinger, L ’immagine del mondo [249/250/251] Schumpeter, Storia dell’ analisi economica [77/78/79] Segai, Melarne Klein [225] Sexl, Nane bianche buchi neri [226/227] Sexl e Schmidt, Spaziotempo [208/209] Simonetta, Ecologia [ i n ] Stabler, Il pensiero matematico [49/50] Steiner, Tabù [207] Sweezy e altri, La teoria dello sviluppo capitalistico, a cura di Claudio Napoleoni [229/230/231] Takeuchi e altri, La deriva dei continenti [55] Thenius, Testimonianze fossili [129] Thompson (D’Arcy), Crescita e forma [41] Thomson, Storia della psicologia [85/86] Tolansky, Introduzione alla fisica atomica [11/12 ] Toschi, Le origini del teatro italiano [137/138/139] Turing (a cura di G . Lolli), Intelligenza meccanica [268] Van Gennep, I riti di passaggio [220] Vygotskij, Il processo cognitivo [248] Waismann, Introduzione al pensiero matematico [63] Wald, Teoria del big bang e buchi neri [198] Wallon, L ’evoluzione psicologica del bambino [176] Wegener, La formazione dei continenti e degli oceani [146/147] Weyl, Il mondo aperto [224] Whitehead, La scienza e il mondo moderno [177] Wiener, Introduzione alla cibernetica [14] Wiener, L ’invenzione: come nascono e si sviluppano le idee [267] Wittgenstein, Lezioni sui fondamenti della matematica [274] Yang, La scoperta delle particelle elementari [37] Young-Bruehl (a cura di), Freud sul femminile [263] Young, La fabbrica della certezza scientifica [16] York, Il pianeta Terra [175]
Nuova serie Agosti e Bianco, Un’amicizia partigiana: lettere Ι943-Ϊ945 [533] Améry, Intellettuale a Auschwitz [551] Anders, L ’uomo è antiquato, 1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale [525] Anders, L ’uomo è antiquato, n. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale [526]
Augé, Genio del paganesimo [562] Bataille, La congiura sacra [556] Bauman, La decadenza degli intellettuali: da legislatori a interpreti [527] Beck e Beck-Gernstheim, Il normale caos dell’amore . [5 6 3l
Binswanger, Melanconia e mania: studi fenomenologici [516] Catoni, La comunicazione non verbale nella Grecia antica [560] Clifford, Strade: viaggio e traduzione alla fine del secolo xx [564] Coppo, Guaritori di follia: storie dell’altopiano dogon [535] Culianu, Eros e magia nel Rinascimento [505] Darwin, L ’origine delle specie: selezione naturale e lotta per l’esistenza [509] de Martino, Il mondo magico: prolegomeni a una storia del magismo [536] de Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico: dal lamento funebre antico al pianto di Maria [559] De Masi, La perversione sadomasochistica: l’oggetto e le teorie [549] Diamond, Il terzo scimpanzé: ascesa e caduta del primate Homo sapiens [500] Dupront, Crociate e pellegrinaggi [501] Eliade, Il sacro e il profano [515] Eliade, Tecniche dello Yoga [528] Eliade, Trattato di storia delle religioni [552] Ellenberger, Introduzione a Jung [508] Eulero, Lettere a una principessa tedesca [540] Farri Monaco e Peila Castellani, Il figlio del desiderio: quale genitore per F adozione? [548] Ferenczi, Elogio della psicoanalisi [504] Fermat, Osservazioni su Diofanto [514] Franz, von, Il femminile nella fiaba [537] Freud, Casi clinici [561] Gibelli, L ’officina della guerra [547] Guerraggio Nastasi, Roma 1908: il Congresso internazionale dei matematici [555] Guicciardini, Dialogo del reggimento di Firenze [524] Gurevic, Le categorie della cultura medievale [521]
Heisenberg, Fisica e oltre: incontri con i protagonisti 1920-1965 [554] Hodges, Alan Turing: una biografia [502] Jung, L ’albero filosofico [541] Jung, Psicologia e alchimia [517] Klinkhammer, L ’occupazione tedesca in Italia 1943-1945 [534] Krautheimer, Architettura sacra paleocristiana e medievale e altri saggi su Rinascimento e Barocco [558] La disputa Leibniz-Newton sull’analisi [512] Mazzarino, Fra Oriente e Occidente [529] Miller, Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero Sé: riscrittura e continuazione [538] Miller, La persecuzione del bambino: le radici della violenza [539] Oliverio Ferraris, Psicologia della paura [522] Panofsky, Idea: contributo alla storia dell’estetica [503] Pauli, Fisica e conoscenza [530] Pavone, Una guerra civile: saggio storico sulla moralità nella Resistenza [5 11] Resnik, Il teatro del sogno [550] Riegl, Grammatica storica delle arti figurative [545] Sabbatucci, Il misticismo greco [506] Sachs, Le sorgenti della musica [523] Salomé, Il mio ringraziamento a Freud e Tre lettere a un fanciullo [518] Saxl, La fede negli astri: dall’antichità al Rinascimento [546] Scarduelli (a cura di), Antropologia del rito: inter pretazioni e spiegazioni [542] Schlick, Forma e contenuto [557] Schur, Freud in vita e in morte: biografia scritta dal suo medico [520] Sini, Eracle al bivio: semiotica e filosofia [532] Spinoza, Etica [519] Stern, La costellazione materna: il trattamento psicoterapeutico della coppia madre-bambino [543] Upanisad antiche e medie [544] Van Gennep, I riti di passaggio [510] Young-Bruehl, Hannah Arendt: una biografia [507] Zanker, Augusto e il potere delle immagini [513] Zeki, La visione dall’interno: arte e cervello [531]





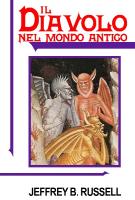
![Aspetti di letteratura gnomica nel mondo antico [2]
8822254007](https://dokumen.pub/img/200x200/aspetti-di-letteratura-gnomica-nel-mondo-antico-2-8822254007.jpg)

![Aspetti di letteratura gnomica nel mondo antico [1]
8822252152](https://dokumen.pub/img/200x200/aspetti-di-letteratura-gnomica-nel-mondo-antico-1-8822252152.jpg)

