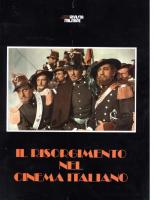Non solo dive. Pioniere del cinema italiano 8895862139, 9788895862132
Non solo dive ma registe, sceneggiatrici, montatrici, produttrici, giornaliste e spettatrici. Il cinema italiano degli a
398 69 3MB
Italian Pages 332 [336] Year 2008
Polecaj historie
Citation preview
Il cinema ritrovato
Non solo dive Pioniere del cinema italiano
NON SOLO DIVE Pioniere del cinema italiano a cura di Monica Dall’Asta
Questo libro viene pubblicato con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema, dell’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna e dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum
Il progetto Non solo dive. Pioniere del cinema italiano è promosso da Associazione Orlando Dipartimento di Musica e Spettacolo – Università di Bologna Cineteca di Bologna Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne della città di Bologna in collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale UniBoCultura AIRSC - Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema Circola nel cinema Alice Guy Women’s Film History International con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna
Redazione: Alessandro Cavazza, Paola Cristalli, Valeria Dalle Donne Grafica e Impaginazione: Caterina Martinelli Copertina: D-Sign © 2008 Cineteca di Bologna
Via Riva di Reno 72 – 40122 Bologna www.cinetecadibologna.it
Atti del convegno internazionale Non solo dive. Pioniere del cinema italiano Bologna 14-16 dicembre 2007 A cura di Monica Dall’Asta, con la collaborazione di Silvio Alovisio, Teresa Antolin, Claudia Gianetto, Giuliana Muscio, Kim Tomadjoglou, Micaela Veronesi Comitato scientifico: Gian Piero Brunetta (Università di Padova), Giuliana Bruno (Harvard University, USA), Giulia Carluccio (Università di Torino), Elena Dagrada (Università Statale di Milano), Ester de Miro d’Ayeta (Università di Genova), Jane Gaines (Columbia University e Duke University, USA), Jean Gili (Université Paris I), Christine Gledhill (Sunderland University, GB), Giovanna Grignaffini (Cinecittà Holding), Mariann Lewinsky (Association Memoriav, Zurich), Elena Mosconi (Università Cattolica, Milano), Giuliana Muscio (Università di Padova), Kim Tomadjoglou (American Film Institute, USA) Coordinamento: Azzurra Celli, Angelita Fiore, Giovanna Gozzi, Federico Pagello
Indice
Prefazione di Simona Lembi, Assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna
7
Introduzione. L’altra metà del cinema muto italiano di Monica Dall’Asta
9
PARTE PRIMA. Storia delle donne e storia del cinema Jane M. Gaines Esse sono noi? Il nostro lavoro sulle donne al lavoro nell’industria cinematografica muta
19
Christine Gledhill Pensare le donne nella storia del cinema: l’esperienza britannica
31
Elda Guerra Oltre i confini. Il movimento delle donne tra Otto e Novecento e l’affermazione di una nuova soggettività
39
PARTE SECONDA. Non solo dive Cristina Jandelli “La più intelligente di tutte”: Diana Karenne
51
Monica Dall’Asta Il singolare multiplo. Francesca Bertini, attrice e regista
61
Elena Dagrada La tentazione del silenzio. Eleonora Duse e Cenere
81
Roberta Gandolfi Il teatro italiano e le sue ‘donne nuove’, fra tradizione e riforma, emancipazionismo e modernismo
93
Valeria Palumbo Vipera: vita e mito di Anna Fougez
103
Elena Mosconi Dive e antidive. Elettra Raggio e Astrea
113
PARTE TERZA. Elvira Notari Vittorio Martinelli Due o tre cose che so di Elvira Notari
133
Giuliana Bruno Elvira Notari e la Dora Film d’America. Cinema e migrazione culturale
137
PARTE QUARTA. Film salvati e da salvare Marianna De Sanctis e Céline Pozzi Il restauro di ‘A santanotte
149
Micaela Veronesi Una donna vuol ‘rifare il mondo’. Umanità di Elvira Giallanella
159
Irela Nuñez, con la collaborazione di Franca Farina Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale
173
PARTE QUINTA. Torino, città delle donne Alberto Friedemann Imprenditoria femminile nel cinema torinese
195
Ester de Miro d’Ayeta Cucire nastri di celluloide. L’oscuro iter di montatrice di Esterina Zuccarone, ‘operaia’ a Torino
229
Donata Pesenti Campagnoni Maria Adriana Prolo
235
PARTE SESTA. Non solo spettatrici Gina Annunziata Matilde Serao e il cinematografo
249
Luca Mazzei Al cinematografo da sole. Il cinema descritto dalle donne fra 1898 e 1916
257
Silvio Alovisio La spettatrice muta. Il pubblico cinematografico femminile nell’Italia del primo Novecento
269
PARTE SETTIMA. Oltre le formule di genere Claudia Gianetto Gigetta Morano, una forza irresistibile
291
Stella Dagna All’ombra del gigante. Le comprimarie della serie Maciste
297
Maria Elena D’Amelio Belle e dannate. Donne di potere nel cinema storico-mitologico italiano
305
Appendice. Le protagoniste a cura di Monica Dall’Asta
317
Notizie sugli autori
331
Prefazione Qualche tempo fa, per una ricerca che s’intitolava Che genere di scuola, è stato chiesto a bambini e bambine di quinta elementare di esplicitare nomi di personaggi famosi nella Storia. Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone Bonaparte: questa la risposta, peraltro facilmente intuibile, dei giovani allievi. Solo a una successiva e più mirata domanda su quali fossero i nomi di donne celebri, i più hanno ammesso di ricordare Cleopatra. L’aspetto più stupefacente della ricerca, tuttavia, non è tanto questo, quanto piuttosto il fatto che alla domanda specifica “perché ricordate solo così poche donne?”, gli scolari abbiano risposto: “perché donne famose nella Storia non ce ne sono state!”. Potremmo cambiare l’ambito e parlare di pittura, del mondo del lavoro, di politica e, probabilmente non solo tra i più piccoli, riscontreremmo la medesima dinamica. Ci sono voluti la pazienza, la tenacia, il coraggio degli women’s studies per indagare su un passato raccontato solo da uomini e rompere stereotipi consolidati anche nella trasmissione del sapere. Pochi esempi possono essere già significativi: in ambito scientifico si parla addirittura di un Premio Nobel ‘negato’ alle donne. Quello di Lise Meitner che nel 1917 identificò, insieme al chimico Otto Hahn, l’elemento di numero atomico 91, chiamato protoattinio. E ancora, nel 1923 scoprì quello che successivamente il fisico francese Pierre Auger avrebbe chiamato l’effetto Auger. Tuttavia, nel 1944 solo ad Hahn venne attribuito il Premio Nobel per la chimica quale riconoscimento per le ricerche compiute sulla fissione nucleare, dimenticando il lavoro fondamentale svolto da Lise nello studio delle reazioni nucleari. Così pure, nel mondo dell’arte, gli women’s studies sono stati necessari per sfatare l’idea di una partecipazione delle donne solo episodica ed ‘eccezionale’, e per riconoscere talenti come quello di Properzia de’ Rossi, che nel terzo decennio del Cinquecento lavora in uno dei cantieri più prestigiosi d’Europa, la basilica di San Petronio a Bologna, seconda città dello Stato Pontificio. È la prima donna scultrice documentata in Europa, presa ad esempio da Vasari (1568) per affermare l’‘ardire’ spregiudicato delle donne del suo tempo, spintesi talmente oltre da non vergognarsi “quasi per tôrci il vanto della superiorità, di mettersi con le tenere e bianchissime mani nelle cose mecaniche, e fra la ruvidezza de’ marmi e l’asprezza del ferro; per conseguir il desiderio loro, e riportarsene fama”. La sua presenza, singolare e unica nella tradizione artistica fino a secoli dopo, si presta proprio a fornire la prova di uno spazio di affermazione per
lungo tempo precluso e reso inaccessibile alle artiste. La politica non fa eccezione: anche in questo caso ci sono voluti, infatti, gli women’s studies per riconoscere l’esistenza e l’importanza rivestita da intere società matriarcali, oppure per rintracciare la testimonianza di donne che, fin dal Trecento, come è accaduto per la nostra Christine de Pizan, si sono occupate di politica e, cioè, di quell’ambito legato a una dimensione pubblica del potere, in cui le donne sembrano ancora oggi non avere piena cittadinanza. Per giungere poi al progetto che ora ci vede coinvolte, Non solo dive mette a fuoco un nuovo sistema da esplorare, quello del cinema. A esso è dedicato questo volume che raccoglie gli Atti del Convegno tenutosi nel dicembre 2007 sotto la cura scientifica di Monica Dall’Asta. Due giornate ricchissime di contributi che documentano in modo inequivocabile come nella storia del cinema le donne non siano state solo dive (piccole o grandi interpreti), ma anche registe, sceneggiatrici, produttrici, distributrici, e si siano cimentate “nella difficile impresa di conquistare uno spazio di agibilità professionale all’interno di un’industria in via di formazione”. Numerose sono dunque le ragioni che motivano l’interesse dell’Assessorato Cultura e Pari Opportunità della Provincia di Bologna nei confronti della pubblicazione di questo testo: arricchire gli studi aprendo nuove prospettive d’indagine, meno frequentate e meno note, rappresentate dal punto di vista delle donne; promuovere l’affermarsi di una nuova consapevolezza storica, infrangendo certezze legate a stereotipi consolidati; riscoprire figure femminili che si sono sperimentate in ruoli professionali innovativi e trasmetterne la memoria per ricostruire la loro, la nostra presenza nel mondo del grande schermo e per delineare una storia del cinema in cui sia riconosciuta piena cittadinanza alle donne. Questi obiettivi non sono stati mancati dall’attività di studi e ricerche emersi nel corso del convegno e sottesi alla sua preparazione: senza alcuna ritualità e con profondo riconoscimento, desidero ringraziare Monica Dall’Asta per l’opera di cura e coordinamento del volume, insieme all’Associazione Orlando, che ha seguito l’intero progetto Non solo dive, e alla Cineteca di Bologna, che ha partecipato con l’Assessorato alla realizzazione del libro e alla restituzione alla comunità degli atti del convegno. Simona Lembi Assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità della Provincia di Bologna 7
Diana Karenne in Miss Dorothy, 1920 (CSC - Cineteca Nazionale)
Introduzione / Monica Dall’Asta
Introduzione / Monica Dall’Asta
L’altra metà del cinema muto italiano
Chi sa chi erano Elvira Giallanella, Frieda Klug, Esterina Zuccarone, o anche, tra le più note, Diana Karenne, Elettra Raggio, Bianca Virginia Camagni, Giulia Rizzotto? Ben pochi addirittura conoscono il nome di Elvira Notari, intraprendente regista napoletana che tra il 1911 e la fine degli anni Venti sceneggiò, produsse e diresse qualcosa come sessanta lungometraggi e un centinaio di corti. E ancora: chi ha mai sospettato che il primo scritto italiano sul cinema, forse il primo mai pubblicato al mondo, sia dovuto a una donna? Correva l’anno 1898 e l’autrice, Anna Vertua Gentile, era una popolare scrittrice di romanzi per signorine. In tutto il mondo, un imponente lavoro di ricerca, condotto dalla fitta rete di studiose e studiosi riuniti sotto la sigla Women’s Film History International, ha negli ultimi anni riportato alla luce numerose tracce della partecipazione delle donne all’industria cinematografica dei primi tempi, mostrando come i pochi nomi femminili accreditati nella storiografia ufficiale siano tutt’altro che casi isolati, ma al contrario solo la punta di un sorprendente, vastissimo iceberg. Tutto concorre a far ritenere che, nel primo periodo della sua esistenza, il cinema abbia costituito per le donne un terreno privilegiato di affermazione professionale, offrendo loro la possibilità di accedere a
nuovi strumenti espressivi e a nuove responsabilità direttive1. In questo contesto, l’appellativo di ‘pioniere’ assume di fatto un significato che eccede la sfera specifica del cinema e si allarga a investire la sfera sociale nel suo complesso. Nel dicembre 2007 una retrospettiva e un convegno promossi dall’Associazione Orlando e dal Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università di Bologna hanno voluto cominciare a far luce su questo fenomeno anche nel contesto italiano. Il tentativo era quello di sfidare l’immagine tradizionale che ha affidato alla figura per tanti aspetti regressiva della Diva il compito di rappresentare per intero il femminile nel cinema muto italiano, confinando ai margini non solo le cineaste che si impegnarono per affermare una propria autonomia di sguardo, ma anche le professioniste attive in ruoli tecnici e manageriali e le tante interpreti – attrici-produttrici, attrici comiche e perfino ‘forzute’ – che riuscirono a sottrarsi al ruolo di mero oggetto di contemplazione, contribuendo a rigenerare il nostro cinema con il dinamismo di figure femminili straordinariamente moderne, ben lontane dall’iconografia stantia della donna-ninnolo o della femme fatale. I risultati di quel primo momento di riflessione confluiscono oggi in questo volume, che vede la luce 9
grazie al contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Provincia di Bologna e dell’Università di Bologna, e con la fondamentale collaborazione della Cineteca di Bologna. L’idea di affidare a un convegno il compito di esplorare i percorsi dell’iniziativa femminile nel cinema muto italiano era nato, essenzialmente, da una scommessa: verificare se e fino a che punto la situazione italiana fosse equiparabile a quella già evidenziata in altri paesi. A conti fatti, al momento di dare alle stampe questo volume, si può dire che la scommessa sia stata ampiamente vinta. Il lavoro di scavo tenacemente condotto dalle autrici e dagli autori dei saggi che qui raccogliamo offre una nuova prospettiva non solo sulle figure più note e già, almeno in parte, studiate – Notari, Duse, Bertini, Karenne, Raggio –, ma anche sugli aspetti meno noti, per quanto forse storicamente più significativi, del fenomeno, come la moltiplicazione di imprese cinematografiche dirette da donne nella Torino di primo Novecento; la presenza rilevante, nel contesto del primo discorso sul cinema (letterario, teorico, critico), di figure femminili oggi praticamente dimenticate (Anna Vertua Gentile, Emilia Formiggini, Angelina Buracci e, per quanto riguarda i suoi articoli di argomento cinematografico, la stessa Matilde Serao); l’ingresso di personale femminile in comparti produttivi che ancora oggi siamo abituati a pensare come tipicamente maschili (Esterina Zuccarone e la sua lunga carriera di montatrice). Di sicuro anche in Italia, come nel resto del mondo, il cinema non fu solo un affare di uomini, ma una sfera professionale ed esperienziale nella quale le donne investirono grandi dosi di energia, intelligenza, passione e desiderio. Il clima misogino nel quale si trovarono a operare – desolantemente testimoniato dall’analisi delle modalità di rappresentazione del femminile sulle riviste cinematografiche degli anni Dieci e Venti – non contribuì certo a creare le condizioni ideali perché i loro talenti potessero esprimersi ed essere pubblicamente riconosciuti e può facilmente spiegare perché così tante di loro – quasi tutte in verità – furono così rapidamente, integralmente cancellate dalla storia del cinema. Gli interventi raccolti in questo volume sono ben lungi dall’esaurire la ricchezza e la diversità delle 10
loro esperienze di cineaste, di interpreti anticonvenzionali, di critiche attente e di spettatrici. Si tratta di una prima ricognizione in un territorio che resta ancora largamente inesplorato e lascia intravedere tante nuove occasioni di ricerca, ma che permette già di registrare una serie cospicua di scoperte. La più inaspettata – semplicemente elettrizzante – riguarda il recupero di un film e di una figura di cineasta dei quali si era letteralmente persa la memoria. Il ritrovamento di Umanità, diretto e prodotto da Elvira Giallanella nel 1919, rinvenuto in una copia nitrato presso l’archivio della Cineteca Nazionale e restaurato per iniziativa dell’Associazione Orlando, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresenta senza ombra di dubbio un evento di incommensurabile grandezza per la storia del cinema italiano. Non solo ha permesso di riportare alla luce frammenti di una biografia professionale esemplare, come fu quella, ancora per tanti aspetti misteriosa, di Elvira Giallanella, ma ha restituito alla visione un’opera semplicemente unica, che non somiglia in nulla alla produzione corrente del periodo, né italiana, né straniera: un film pacifista, interpretato da bambini, parzialmente girato sul Carso all’indomani del conflitto mondiale, realizzato con intenti educativi e animato dalla speranza di instillare l’orrore della guerra nelle giovani generazioni. Che una tale impresa sia legata a un nome di donna non sorprende, ma purtroppo non meravigliano neppure il totale insuccesso cui il film andò incontro, in anni che preludevano all’affermazione del fascismo, e la sua conseguente rimozione dal discorso storiografico. Per uno di quei paradossi che abbondano nella storia delle donne, il caso di Umanità appare emblematico proprio nella misura in cui è eccezionale, emblematico della singolarità dei percorsi che caratterizzano l’attività e la presenza delle donne nel cinema, esperienze spesso frammentarie e sfortunate ma proprio per questo tanto più eroiche e coraggiose, che testimoniano degli ostacoli opposti all’iniziativa femminile da un contesto sociale, culturale e politico da sempre fondamentalmente sfavorevole. Ma è anche qui a dimostrare come la ricerca sul cinema delle donne possa riservare formidabili sorprese, non fosse che in ragione della
Introduzione / Monica Dall’Asta
potente rimozione che ha costantemente operato per cancellare le tracce dell’iniziativa femminile. I saggi di questo volume mostrano come spesso sia sufficiente interrogare gli archivi con sguardo scevro da preconcetti per trovare un’enorme quantità di fonti documentali in grado di fornire tutta una nuova comprensione dell’esperienza storica delle donne, ovvero: della storia tout court. Lo si vede ancora nel caso del secondo restauro realizzato nell’ambito di questo progetto, ‘A santanotte (1921) di Elvira Notari. Ancora una volta, è bastato cominciare a cercare, senza dare per scontato che i materiali noti (in questo caso la copia safety depositata alla Cineteca Nazionale) fossero gli unici esistenti, per scoprire che una copia nitrato del film giaceva presso gli archivi della George Eastman House di Rochester. E ancora una volta, il valore del ritrovamento si è rivelato duplice: non solo ha permesso di realizzare un restauro che restituisce il film in una versione più completa e filologicamente accurata, ma ha fornito una prova concreta della circolazione dei lavori di Elvira Notari negli Stati Uniti, all’interno delle comunità italo-americane, a dimostrazione di come lo studio del cinema delle donne solleciti e addirittura reclami un approccio risolutamente transnazionale. Perciò, anche se è esplicitamente dedicato a esplorare le vie del femminile nel contesto nazionale del cinema muto italiano, il volume si apre con una serie di interventi che mettono a fuoco da punti di vista differenti il tema dell’internazionalismo come aspetto metodologicamente rilevante per gli studi di storia (del cinema) delle donne. Con il suo saggio, al solito eccezionalmente stimolante e provocatorio, Jane Gaines – promotrice del progetto Women Film Pioneers, che ha inaugurato in tutto il mondo una nuova stagione di ricerca femminista sul cinema2 – prova niente meno che a porre le premesse di una nuova filosofia della storia del cinema, nella quale i concetti di ‘donne’, ‘modernità’ e ‘internazionalismo’ risultano inestricabilmente implicati tra loro, intrecciandosi e riflettendosi tra loro da un secolo all’altro. In altri termini, per riprendere un’idea centrale della teoria della storia di Walter Benjamin citata da Gaines, se è vero che ogni testo porta in sé un “indice storico di leggibilità” che lo consegna al futuro3, al momento nel quale sarà divenuto piena-
mente comprensibile e attuale, allora non v’è dubbio che questa dimensione internazionalista, di cui l’opera delle pioniere del cinema costantemente ci parla, trovi solo oggi le condizioni per essere afferrata, riconosciuta e valorizzata: nello sguardo di chi, come noi contemporanei, si trova esposto da ogni lato all’irresistibile movimento della globalizzazione. Osservando questa nuova fase della ricerca dalla Gran Bretagna, dove coordina un gruppo di lavoro che può rappresentare un modello di riferimento per future iniziative di carattere locale – come quella che si è cominciata a sviluppare in Italia a partire dal convegno Non solo dive – anche Christine Gledhill sottolinea con forza la necessità di pensare l’internazionalismo come una condizione irrinunciabile dell’indagine femminista sulla storia del cinema, in termini sia di metodo sia di contenuto. L’insistenza sul lavoro di rete e sul carattere partecipativo che la ricerca dovrà assumere, oltre a far propria quella che è ormai una pratica consolidata nell’esperienza politica delle donne, è resa inevitabile dalla stessa natura transnazionale del medium cinematografico, dalla tendenza al nomadismo che caratterizza sia le opere, sia il personale attivo in questo settore industriale. Essendo la ricerca in una fase ancora iniziale, è normale che Gledhill sia portata a concentrarsi soprattutto sugli scambi e le relazioni che interessano Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti; ma non si deve credere che l’Italia sia poi così lontana. Lo dimostra, per esempio, il caso di Fabienne Fabrèges, attrice, regista e produttrice di cui si sa pochissimo, ma quel tanto che basta per delineare una carriera professionale divisa tra Parigi, Torino e Londra: dopo l’esordio alla Gaumont, come interprete fissa nei film di Léonce Perret e Suzanne Grandais, abbandona la Francia per impiantare a Torino una propria compagnia di produzione, con la quale realizza quattro film, tra cui L’altalena della vita (1919), da lei diretto, prima di partire alla volta di Londra per recitare al fianco di Stewart Rome in The Penniless Millionnaire (1921). Davvero le carriere di queste donne sono legate a doppio filo ai processi e alle trasformazioni della modernità, le quali, come Elda Guerra ricorda nel suo intervento, sono a loro volta fondamentalmente intrecciate all’apparizione della soggettività femmi11
nile sulla scena politica e sociale. Le biografie delle cineaste italiane, come quelle di tante altre donne che in questo primo scorcio di secolo cominciano ad affacciarsi nella sfera delle professioni, conquistando un titolo di studio e lottando per rivendicare la possibilità di esercitare mestieri fino a questo momento ritenuti di esclusivo appannaggio degli uomini, non possono essere comprese se non sullo sfondo di una mobilitazione collettiva, che per la prima volta vede le donne irrompere in massa sulla scena pubblica, per reclamare pari dignità e pari diritti. In questo senso davvero, come indica Jane Gaines, donne e modernità sono un binomio storicamente inscindibile, il quale può dunque a buon diritto essere studiato, come fa Roberta Gandolfi nel suo intervento, dal punto di vista del contributo femminile allo sviluppo di poetiche moderniste, nel caso specifico a livello delle culture teatrali. Lo studio di Gandolfi illumina aspetti ancora troppo poco indagati del rapporto tra teatro e cinema in Italia nei primi decenni del Novecento e apre tutta una serie di questioni circa la troppo limitata capacità degli schermi nazionali di accogliere e valorizzare le esperienze innovatrici di cui furono protagoniste le attrici-autrici e le drammaturghe del teatro modernista italiano (da Eleonora Duse a Irma Gramatica, ad Amalia Rosselli). Il nodo problematico delle tensioni moderniste presenti in nuce, e solo parzialmente espresse, nel lavoro di alcune delle prime cineaste italiane riguarda in modo diverso l’esperienza di figure come la stessa Duse, Diana Karenne ed Elettra Raggio. La celebre quanto sfortunata esperienza di Eleonora Duse in Cenere, qui ripercorsa e analizzata da Elena Dagrada, può ben essere letta come uno degli esiti più alti della poetica scenica della grande attrice, un momento di ricerca appassionata e convinta, che se pure non ottiene i risultati che poteva esser lecito sperare, resta però un tentativo stupefacente di metter capo a un cinema antispettacolare e addirittura “crudele”4, capace di legare interprete e spettatori in un rapporto che esclude ogni tentazione di narcisismo e compiacimento reciproco. Anche la personalità inquieta di Diana Karenne, altro esempio di cineasta nomade, in continuo movimento tra Germania, Italia e Francia, lascia trasparire un biso12
gno di ricerca, di fuoriuscita dagli schemi consueti di rappresentazione del femminile e di sperimentazione di nuove modalità di espressione che, come mostra Cristina Jandelli nel suo saggio, conosce pochi eguali nel panorama contemporaneo, anche a livello internazionale. Quanto a Elettra Raggio, il ritratto delineato da Elena Mosconi è assai preciso nell’individuare nel simbolismo e nelle suggestioni dell’arte liberty un’opzione poetica tutta risonante delle promesse e delle speranze di un puro modernismo. Ma al di là dell’originalità d’espressione di cui alcune di loro furono capaci, l’esperienza delle ‘pioniere’ è interessante soprattutto per quanto rivela del coraggio, della determinazione, della capacità di iniziativa di un’intera generazione di donne. In questo senso, anche le figure meno sensibili all’attrazione del modernismo, le più ancorate alle forme culturali della tradizione, si affermano di fatto come formidabili agenti di modernità. Il caso più eclatante è senza dubbio quello di Elvira Notari. Imprenditrice di grande talento, Elvira Notari non è solo la sublime cantrice dell’anima popolare di Napoli: è anche e soprattutto una straordinaria mediatrice culturale. Come osserva Giuliana Bruno – autrice di un libro che, oltre a far conoscere in tutto il mondo il nome di questa cineasta, ha segnato anche un punto di svolta nello sviluppo di una nuova storiografia femminista del cinema a livello internazionale5 – la circolazione di tante opere di Notari presso le comunità italiane degli Stati Uniti e dell’America Latina svolse una funzione importante nel dotare quel pubblico migrante di un sentimento forte di appartenenza culturale. Pur non essendosi mai mossa da Napoli, anche Notari è insomma (come tante altre cineaste di primo Novecento, a partire dalla ‘pioniera’ Alice Guy) profondamente implicata nei grandi processi migratori, di deterritorializzazione e riterritorializzazione culturale, che caratterizzano la sua epoca. Il successo dei suoi film negli Stati Uniti partecipa di quel grande movimento che in pratica fa di Little Italy la seconda patria della canzone napoletana e della sceneggiata teatrale, un processo che, si badi bene, non si colloca a posteriori, ma avviene simultaneamente allo sviluppo di questi generi e di queste forme culturali, in una Napoli che è insieme luogo
Introduzione / Monica Dall’Asta
originario e immaginario deterritorializzato. La capacità di Notari di interpretare e valorizzare questa dimensione transnazionale trova ulteriori conferme nel contributo del compianto Vittorio Martinelli, che qui presentiamo in forma di semplice trascrizione di quello che fu, purtroppo, il suo ultimo intervento pubblico. Martinelli – che tra gli altri suoi innumerevoli meriti ha anche quello di aver firmato il primo articolo mai pubblicato sulle pioniere del cinema italiano6 – convoca le memorie dello stesso figlio della regista, noto col nome d’arte di Gennariello, intervistato qualche anno prima della scomparsa, per ricordare l’abilità imprenditoriale con cui Notari riusciva a ottenere i fondi per i propri film dalle comunità immigrate in America, impegnandosi ad ambientarli nei luoghi di provenienza dei vari gruppi finanziatori. Nel cinema di Notari, in altri termini, ci troviamo di fronte a un misto contraddittorio di aspetti retrivi e progressisti, dove contenuti che non sempre, per citare Gledhill, appaiono “consoni al desiderio femminista” si sposano però a una professionalità e a un dinamismo che fanno di questa cineasta un modello quanto mai ammirevole di intraprendenza femminile. Lo stesso vale per un’altra grande figura del cinema muto italiano, la ‘diva’ per eccellenza – ma certo non solo diva – Francesca Bertini. Al di là dell’immagine che incarna sullo schermo – la quintessenza di una femminilità fondamentalmente autodistruttiva, se non addirittura misogina, giacché ispirata alle sfortune letterarie della femme fatale –, Bertini è una personalità fra le più autorevoli del cinema italiano di quegli anni, una donna potente capace di imporre le sue scelte ai produttori, nonché di gestire in prima persona tutte le fasi della lavorazione dei suoi film, dalla scelta dei soggetti alla regia, al montaggio, fino alla pubblicità. Indubbiamente il suo fenomenale successo finì per assumere valore d’esempio per tante altre giovani che in quella fase tentarono, con maggiore o minore fortuna, di farsi strada nel mondo del cinema e dello spettacolo, contribuendo quindi a fare della figura della Diva una sorta di modello obbligato per le donne che nutrivano un desiderio di affermazione e di creatività e libertà professionale. Ma ben poche furono quelle che riuscirono a ripercorrere le sue orme. Tra queste si può
senz’altro ricordare Anna Fougez, stella della rivista italica che fu l’ideale erotico di una generazione di giovani maschi annebbiati dalla roboante retorica di fascismo e futurismo, ma che, come osserva Valeria Palumbo nel suo intervento, fu soprattutto un’abile imprenditrice di se stessa, capace di sfruttare quei turbamenti e quella retorica a proprio esclusivo vantaggio, per imporre un’immagine eccentrica di ‘vipera’ che fece epoca e che si riassumeva nell’impagabile slogan: “Il mondo parla e io passo”. Da lei elaborato nei minimi dettagli, il suo iperbolico personaggio giunse anche sugli schermi in una serie di film ancora tutti da studiare, tra cui è da ricordare soprattutto Fiore selvaggio, realizzato su suo soggetto nel 1919 e conservato in una copia nitrato presso la Cineteca Nazionale. Ma è lungo l’elenco delle aspiranti dive che tentarono invano la via del successo realizzando in proprio dei film: da Diana D’Amore e Fabienne Fabrèges – registe – a produttrici come Berta Nelson, Elsa Tornielli, Vera Sylva, costrette ad abbandonare dopo aver girato spesso un solo film. Le loro storie rappresentano in qualche modo la faccia oscura del divismo, il paradosso di un fenomeno che, mentre spinge tante donne ad assumere l’iniziativa per inseguire un sogno, dall’altro limita e condiziona il loro immaginario e le loro possibilità espressive, esponendole al rischio di un probabile fallimento. Alcune delle loro storie sono tratteggiate nell’attento studio che Alberto Friedemann ha dedicato alle vicende dell’imprenditorialità femminile nel cinema muto torinese. Il saggio è una vera miniera di notizie, che porta alla luce figure fin qui perfettamente sconosciute, facendo emergere accanto a nomi comunque collocabili entro la sfera del divismo – come per esempio Bianca Maria Guidetti Conti, Maria Roasio, Maria Campi, Lydianne – anche personalità di imprenditrici a tutto tondo come Semele Bertolina, Lidia Doasio e soprattutto Frieda Klug, giovane ungherese che all’età di vent’anni era già titolare di un’agenzia di noleggio a Torino e che grazie al suo dinamismo e alla sua padronanza delle lingue ebbe un ruolo certamente non di secondo piano nel promuovere l’ingresso e la circolazione del cinema italiano negli Stati Uniti. Lo studio di Friedemann, che da solo produce una formidabile moltiplicazione dei 13
nomi femminili coinvolti nell’industria cinematografica italiana del periodo muto, lascia sperare che tanti altri nomi possano emergere, grazie ad analoghe ricerche, anche nelle altre città che furono all’epoca centri di produzione maggiori, in particolare Roma, Milano e Napoli. Ma certo Torino rappresenta un caso speciale e per molti aspetti unico. Il suo tessuto industriale, la sua vicinanza economica e culturale all’Europa, la rendono particolarmente ricettiva al desiderio di emancipazione delle donne. Così non può sorprendere che proprio a Torino si dipani la straordinaria vicenda professionale di Esterina Zuccarone, piccola immigrata pugliese che, come ricorda Ester de Miro d’Ayeta, passò in modo del tutto naturale da un lavoro di sarta a uno di montaggio, divenendo nel corso degli anni una delle più apprezzate professioniste di questo comparto. E ancora dunque non può sorprendere che una parte così importante della storia della conservazione cinematografica in questo paese, del riconoscimento del film come bene culturale, passi per il lavoro testardamente portato avanti a Torino da Maria Adriana Prolo in vista della costituzione del Museo Nazionale del Cinema. La passione totalizzante che Prolo investì in questa missione, riccamente descritta nel suo testo da Donata Pesenti Compagnoni, è un’altra dimostrazione del ruolo determinante che il desiderio femminile ha sempre avuto in un territorio troppo a lungo considerato come esclusivamente maschile. Del resto, da un secolo all’altro (“esse siamo noi”), la presenza delle donne nei luoghi della tecnica, nei laboratori in cui il film prende forma come oggetto materiale, è sempre stata tanto invisibile quanto insostituibile e preziosa. Ieri erano i laboratori di coloritura, di sviluppo e stampa, di montaggio, dove file interminabili di operaie attendevano al loro lavoro di precisione che portava nelle sale le immagini di cui si nutrivano i sogni di tutti; oggi sono le professioniste cui è affidata la salvaguardia e il salvataggio, spesso in extremis, di un patrimonio culturale e immaginario senza eguali. Di fatto, la possibilità di recuperare, preservare e restaurare il cinema delle donne di ieri dipende in gran parte dal lavoro delle donne di oggi all’interno delle cineteche e dei laboratori. Lo dimostra l’articolo di Marianna De 14
Sanctis e Céline Pozzi sul restauro di ‘A santanotte di Elvira Notari, operazione di enorme complessità che ha richiesto non solo pazienza e competenza, ma anche un’incalcolabile passione per la ricerca filologica e la sperimentazione tecnica. Non meno preziosa in questo senso è la testimonianza di Irela Nuñez, che con Franca Farina ha dato un contributo decisivo all’operazione di salvataggio che ha permesso, oltre che di restaurare ‘A santanotte, anche di strappare a un destino quasi certo di distruzione Umanità di Elvira Giallanella. Ma a Nuñez si deve anche una specifica ricerca, di cui dà conto nel suo articolo, condotta sui fondi della Cineteca Nazionale per rinvenire pellicole ascrivibili alla storia del cinema delle donne e verificarne lo stato di conservazione. I risultati di questo importante censimento sono incoraggianti e al tempo stesso inquietanti: se da un lato si scoprono copie di cui fino a questo momento si ignorava l’esistenza (come nel caso dei film di Anna Fougez e Berta Nelson e del misterioso, quanto sorprendente, Nobiltà di razza e nobiltà di cuore), dall’altro si scopre anche che lo stato di decadimento di questi materiali è ormai avanzato, spesso al limite della colliquazione, facendo temere, in assenza dei necessari interventi, la loro definitiva sparizione. La perdita sarebbe incalcolabile e ci auguriamo che la ricerca che qui presentiamo possa sollecitare l’avvio di quel processo di recupero e conservazione che appare tanto più necessario nel caso di un cinema come quello delle donne, che più di ogni altro si trova esposto alle conseguenze dell’indifferenza e del disinteresse. Ciò che si rischia di perdere per sempre potrebbe essere qualcosa di valore inestimabile, come Umanità: un film letteralmente incomparabile, realizzato da una cineasta il cui nome è ignorato da tutte le storie del cinema e sulla quale l’articolo di Micaela Veronesi prova per la prima volta a far luce, fornendo tutta una serie di informazioni da lei raccolte nel corso di una dettagliata ricerca, faticosamente condotta sulle pagine dei periodici cinematografici dell’epoca. Le ultime due sezioni del volume sono dedicate a esplorare il rapporto tra modernità, cinema e donne secondo altre due prospettive, anche queste largamente suscettibili di ulteriori sviluppi. Da una parte
Introduzione / Monica Dall’Asta
si tratta di verificare i percorsi del femminile nella scrittura, indagando il contributo di letterate e donne intellettuali alla riflessione sul cinema, come in modi diversi fanno Gina Annunziata e Luca Mazzei: la prima, occupandosi di ricostruire il travagliato quanto appassionato rapporto di Matilde Serao con lo schermo; il secondo, portando alla luce una serie di testi a sfondo pedagogico-educativo, che ancora una volta fanno emergere nomi non mai incrociati nelle storie del cinema muto, come Emilia Formiggini, Angelina Buracci o anche Anna Vertua Gentile, scrittrice di ‘romanzi per signorine’ e insieme autrice del primo testo sul cinema mai pubblicato in Italia, risalente addirittura al 1898. L’apparizione del femminile nel discorso sul cinema è anche oggetto dello studio di Silvio Alovisio, che però la osserva per così dire in assenza, analizzando le forme stereotipe e misogine nelle quali il pubblico femminile veniva rappresentato sulle riviste di settore, da parte di critici e giornalisti uomini. Infine l’ultima sezione mette a fuoco la comparsa di figure femminili non convenzionali a livello delle interpreti e dei personaggi. Il ritratto di Gigetta Morano proposto da Claudia Gianetto delinea il percorso professionale di un’attrice che giocò un ruolo fondamentale nello svecchiamento dei modi di rappresentazione del femminile, dando vita a personaggi brillanti che risentivano delle novità dell’emancipazione femminile: donne avvocato, donne domatrici, mogli più intelligenti dei loro mariti… Elena D’Amelio si concentra sulla rappresentazione dei personaggi femminili nei film di genere storico-mitologico, individuando nella figura della sovrana, plasmata sul modello di Cleopatra o Messalina, un luogo narrativo carico di suggestioni altamente eloquenti per le spettatrici dell’epoca. E non sorprende che le fantasie femminili di potere trovino spazio perfino nella serie intitolata a Maciste, ideale virile per eccellenza del cinema italiano: nella lettura di Stella Dagna, i muscoli ipertrofici di questo buon gigante valgono come un sintomo di impotenza di fronte alla vitalità irrefrenabile delle tante interpreti che di volta in volta lo affiancano nei suoi vari film. In ogni caso, questo volume è ben lungi dall’esaurire la varietà e la complessità della partecipazione femminile alla produzione e alla ricezione del ci-
nema italiano nel periodo muto. Basti citare i tanti nomi che ancora attendono di essere fatti oggetto dell’attenzione che indubbiamente meritano: registe (nonché in molti casi produttrici) come Giulia Rizzotto, Daisy Sylvan, Gemma Bellincioni (la celebre soprano che volle darsi al cinema), Bianca Camagni, Diana D’Amore, Fabienne Fabrèges; sceneggiatrici come Renée de Liot, Nelly Carrère, Vera D’Angara; fino ad attrici come Astrea e Lea Giunchi, vere e proprie ‘ragazze terribili’ del cinema muto italiano. Se qualcosa dimostra questa ricerca, è che il terreno da dissodare per pervenire a una riscrittura della storia del cinema italiano che tenga conto del desiderio femminile è ancora immenso, o in effetti, virtualmente infinito. Ringraziamenti sentiti vanno a tutte/i coloro che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione che è all’origine del presente volume: da Giovanna Grignaffini, Elda Guerra, Annamaria Tagliavini, Fernanda Minuz, Simona Lembi, Gian Luca Farinelli, che ne hanno promosso la realizzazione, a Giuseppina La Face, Franco La Polla, Carla Faralli, Giuliana Muscio, Mariann Lewinsky, che l’hanno sostenuta con entusiasmo e partecipazione concreta. Un pensiero particolare va poi a tutte/i coloro che hanno reso possibile il restauro delle due pellicole presentate in anteprima nel corso della retrospettiva,’A santanotte e Umanità: Sergio Toffetti, Patrick Loughney, Kim Tomadjoglou, Irela Nuñez, Franca Farina, Mario Musumeci, Davide Pozzi. La ricerca iconografica ha potuto avvalersi della preziosa competenza di Teresa Antolin, del supporto operativo di Anna Fiaccarini e Donatella Trono, ma soprattutto dell’amicizia e della generosità di Vittorio Martinelli, senza le cui insostituibili ricerche questo lavoro, di sicuro, non avrebbe neppure potuto essere intrapreso.
15
Note Tra i primi ad affermare che “prima del 1920 le donne impiegate nell’industria cinematografica americana erano molte di più di quante ve ne siano state in qualsiasi altro periodo della storia del cinema” fu Anthony Slide, nel suo pionieristico lavoro Early Women Directors, A. S. Barnes, New York 1977, p. 9. Più di recente la stessa tesi è stata sostenuta con forza da Karen Ward Mahar nel suo documentatissimo studio Women Filmmakers in Early Hollywood, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007. I primi risultati del lavoro in corso negli altri paesi permettono di estendere l’affermazione su un piano globale.
1
Destinata a confluire in un grande repertorio biografico in due volumi sotto il titolo Women Film Pioneers Sourcebook (Jane Gaines e Rada Vatsal, a cura di, Women Film Pioneers Sourcebook, vol. I: United States and Latin America, e Jane Gaines e Monica Dall’Asta, Women Film Pioneers Sourcebook, vol. II: Europe, Asia, Canada, Australia and Middle East, University of Illinois Press, Chicago, in corso di pubblicazione), la ricerca ha dato impulso al Convegno internazionale di studi Women and the Silent Screen, giunto alla V edizione (Utrecht 1999, Santa Cruz 2001, Montreal 2004, Guadalajara 2006, Stockholm 2008) e a una serie di pubblicazioni collegate: Jennifer M. Bean e Diane Negra (a cura di), A Feminist Reader in Early Cinema, Duke University Press, Durham e London 2002; Rosanna Maule, Catherine Russell (a cura di), Cinephilia and Women’s Cinema in the 1920s, numero monografico di “Framework”, n. 1, 2005; Rosanna Maule (a cura di), Femmes et cinéma muet, numero monografico di “Cinémas”, n. 1, 2005. Di recente il progetto si è esteso oltre i confini del muto, dando vita all’associazione Women’s Film History International.
2
3 Si veda il frammento N 3,1 del Passagenwerk (tr. it. Parigi capitale del XIX secolo, a cura di Giorgio Agamben, Einaudi, Torino 1986, p. 599): “L’indice storico delle immagini dice, infatti, non solo che esse appartengono a un’epoca determinata, ma soprattutto che esse giungono a leggibilità solo in un’epoca determinata. E precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora (Jetz) è l’ora (Jetz) di una determinata conoscibilità”.
Mi permetto di suggerire che questo film per tanti aspetti duro e refrattario potrebbe assumere un valore del tutto nuovo se affrontato nella prospettiva della categoria critica del “cinema della crudeltà”, elaborata da André Bazin (Il cinema della crudeltà, Il Formichiere, Milano 1979) sul modello del concetto di “teatro della crudeltà” introdotto da Artaud.
4
Giuliana Bruno, Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari, La Tartaruga, Milano 1995 (ed. or. Streetwalking on a Ruined Map: Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari, Princeton University Press, Princeton 1993). 5
Le metteuses-en-scène, “Cinemasessanta”, n. 141, 1981, pp. 21-25.
6
PARTE PRIMA
STORIA DELLE DONNE E STORIA DEL CINEMA
Alice Guy
1 / Jane M. Gaines
Esse sono noi? Il nostro lavoro sulle donne al lavoro nell’industria cinematografica muta
Se inizio con la domanda: “Esse sono noi?” è perché voglio arrivare direttamente al punto. Ovvero, vorrei capire se il nostro lavoro storico ci parli di noi più di quanto ci parli di loro. Quando insegniamo, quando parliamo o scriviamo di Alice Guy, Germaine Dulac, Dorothy Arzner, Elvira Notari, Asta Nielsen o Lois Weber, stiamo forse rappresentando noi stesse in misura eguale o persino maggiore di quanto rappresentiamo queste figure storiche? Ovviamente ciò dipende dal valore che esse rivestono per noi oggi, nel presente di cui fanno parte e per il quale rivendichiamo la loro importanza. L’urgenza del riconoscimento e della rivendicazione non è mai stata, forse, più chiaramente formulata che nelle tesi Sul concetto di storia di Walter Benjamin, laddove si legge che “È un’immagine non rievocabile del passato quella che rischia di scomparire con ogni presente che non si sia riconosciuto in essa”1. Tornerò più avanti su ciò che è urgente per noi, sul perché l’immagine di queste donne altro non sia se non l’immagine di noi stesse, e la nostra la loro. Per ora, diciamo che il quadro di riferimento di queste pagine, l’orizzonte all’interno del quale ci interroghiamo sulle relazioni che intratteniamo con figure ed eventi storici, è la filosofia della storia del cinema. La storia del cinema rappresenta un caso speciale e del tutto ecceziona-
le per la filosofia della storia, poiché studia il dispositivo che ripete la sua metafora. È in realtà la sola storiografia che deriva la sua forma dal dispositivo che studia: la macchina cinematografica, ovvero storiografica2.
Proprio come noi? Voglio subito affrontare la questione dell’origine stessa della domanda: “esse sono noi?” Giacché è da qui che ho cominciato a chiedermi: chi troveremo, al termine delle nostre infinite ricerche filmografiche e d’archivio? La domanda si è infine definitivamente cristallizzata per me in un recente, provocatorio volume dal titolo Literature after Feminism, nel quale Rita Felski riesamina un pionieristico studio – apparso nel 1979 – di Sandra Gilbert e Susan Gubar sulle scrittrici inglesi del diciannovesimo secolo, The Madwoman in the Attic3. Felski ritiene che nella loro operazione di recupero di romanzi come Jane Eyre di Charlotte Brontë o The Yellow Wallpaper di Charlotte Perkins Gilman, Gilbert e Gubart siano state mosse dal desiderio di trovarvi figure non già vittoriane, bensì modellate sull’immagine di ciò che esse stesse erano allora, in quel particolare mo19
mento degli anni Settanta. Secondo Felski, se The Madwoman in the Attic rappresenta senza dubbio un’analisi radicalmente innovativa della creatività femminile nella letteratura dell’Ottocento, esso può dirci anche di più sulle ‘istanze politiche’ degli anni Settanta. Inoltre, nel presentare queste scrittrici vittoriane come “fervide ribelli, piuttosto che come custodi della moralità; come vittime tarpate dal sistema patriarcale, piuttosto che come probe, severe madri di famiglia, [Gilbert e Gubar] si costruivano delle antesignane perfettamente rispondenti al proprio desiderio”. “Al proprio desiderio”: questa somiglianza un po’ sospetta tra le scrittrici vittoriane analizzate da Gilbert e Guber e le femministe degli anni Settanta, che Felski descrive come “donne in lotta contro una società repressiva, alla ricerca della loro vera identità” non può dirsi esattamente sorprendente. Ciò che ne derivò, come Felski ricorda e come alcune di noi possono certo confermare, fu una gran quantità di tesine universitarie sulla follia femminile, secondo il paradigma di Jane Eyre e del suo doppio selvaggio, Bertha Mason, finita rinchiusa in soffitta4. Ora, la nostra ricerca storica su Alice, Germaine, Dorothy, Elvira, Asta e Lois ci pone di fronte a un’interessante contraddizione. Per motivare il loro recupero, dobbiamo dimostrare che esse abbiano un significato per la nostra epoca. Tuttavia è evidente che gli interessi e le aspettative del loro tempo non corrispondono esattamente ai nostri. Di fatto, essi ci appaiono non di rado strani e incomprensibili. Per cominciare, Alice e le altre non sposarono la causa del femminismo. Come se non bastasse, ebbero spesso attitudini discriminanti, e verso se stesse e verso le altre. Una sceneggiatrice-regista della Universal, Ida May Park, affermò una volta di ritenere che le donne non fossero costituzionalmente idonee a dirigere film: “il lavoro di regista mi sembrava una cosa così completamente inadatta a una donna”, dichiarò in un’intervista a “Photoplay”, “che alla prima occasione che mi fu offerta preferii rifiutare la proposta della compagnia”5. Un’intera generazione di studiose femministe ha pensato che queste donne e il loro lavoro non avessero nulla da dirci perché non erano femministe. Ben poche delle sceneggiatrici e registe attive nel cinema americano muto aderirono al femminismo. Personalmente ne 20
ho individuate solo due e addirittura non è escluso che una delle due abbia ritrattato: si tratta di Sonya Levien, un’immigrata ebrea di origini russe; l’altra è Olga Petrova, falsa contessa polacca, in realtà una gallese il cui vero nome era Muriel Harding (vedi illustrazioni alle pagine 33 e 36)6. La questione che ci interessa, comunque, ha meno a che fare con la nascita del femminismo che con il tema più generale della ‘modernità’. Ma per pensare in termini di ‘modernità’, è necessario che assumiamo le cineaste dell’epoca muta come altrettanti esempi di New Women, non importa quanto poco nuovi o premoderni possano essere stati i loro comportamenti e i loro stili di vita. Dobbiamo studiarle come agenti di novità tecnologica, recuperare la loro fisicità straordinaria e senza precedenti, l’eccezionalità di un’immaginazione che è ben rappresentata, per esempio, dalle imprese seriali di eroine quali Pearl White e Helen Holmes7. Il paradigma del ‘corpo straordinario’ è presente anche nelle acrobazie di alcune comiche di Mabel Normand recentemente riscoperte, come Mabel at the Wheel (Keystone Company, 1914). Nuove ricerche hanno dimostrato che Mabel stessa diresse questo film, nel quale orchestra tra loro tre diverse tecnologie: il proprio corpo, l’automobile, e la macchina da presa. Ma a chi appartiene esattamente questa competenza tecnologica, questa agilità? Chi la possiede? Di sicuro a noi (a voi e a me) piacerebbe essere così fisicamente capaci, intellettualmente intraprendenti e tecnologicamente attrezzate. Qualcuno avrà forse notato che questa concezione del corpo femminile implica uno spostamento di paradigma dal terreno del voyeurismo a quello delle attrazioni, spostamento che ha effettivamente cancellato il precedente paradigma dello sguardo orientato dal genere8. Dunque, nel prendere partito a favore di questa dimensione fisica, noi stiamo unanimemente, sonoramente rifiutando il paradigma della oggettivazione e della esclusione femminile che era al centro dei nostri interessi negli anni Settanta9. Rifiutiamo il corpo sessualizzato per istituire una figura che è una ‘noi al quadrato’: una superdonna resa possibile dalla tecnologia, una controfigura metaforica di noi stesse. Ma torniamo alla contraddizione di cui sopra, che conduce a un paradosso: è solo nella misura in cui
1 / Esse sono noi? / Jane M. Gaines
queste figure sono figure della nostra epoca, che noi possiamo rivendicarle come storiche, cioè di fatto, come appartenenti a un’altra epoca, diversa dalla nostra. In breve, possiamo dirle storiche solo se non sono storiche. Ma si potrebbe dire anche: queste donne, così come ce le rappresentiamo, non ci sembrerebbero ‘storiche’ se non potessimo ‘riconoscerle’, per usare le parole di Benjamin, nel nostro presente, nelle problematiche che oggi ci investono10. Le pensiamo audaci, per il loro mettersi in gioco in un’industria nuova e piena di rischi, le immaginiamo mentre lavorano duro per superare gigantesche difficoltà economiche, tradite dai loro finanziatori (maschi) come dai loro mariti, impegnate a stringere reti di relazioni con altre donne, sedotte dai produttori, lacerate tra maternità e carriera. Ritroviamo in loro e dentro di loro, insomma, le preoccupazioni della nostra epoca, rileggiamo il nostro tempo alla luce del loro (o viceversa?). Questo ‘ritrovamento costruttivo’ le produce in quanto figure storiche e nel produrle come tali le produce come coincidenti con noi. Per illustrare il funzionamento di questo processo di cooptazione storica, posso fornire un esempio tratto da un mio lavoro. In un saggio intitolato Womens’s Dreams of Technological Dominance, sostenevo che la decisione di Helen Gardner di lasciare la Vitagraph, nel 1911, per dar vita a una propria compagnia, la Helen Gardner Film Company, era indicativa della sua competitività nei confronti degli uomini: voleva essere la prima a produrre dei lungometraggi. Tuttavia, bisogna riconoscere che è altrettanto possibile che Gardner abbia, o non abbia avuto tale obiettivo; del resto i cineasti che aspiravano a fare il salto dal corto al lungometraggio erano allora assai numerosi. Retrospettivamente, mi sembra che immaginare una Helen Gardner in competizione con gli uomini sia un’interpretazione funzionale a un’epoca nella quale le donne sono in competizione con gli uomini e nella quale la loro affermazione in un mondo professionale basato sulle determinazioni di genere è una questione cruciale. E non c’è dubbio sul fatto che io abbia scelto questo esempio proprio per produrre Helen Gardner come una nostra contemporanea, una figura significativa per noi, dunque simile a noi. Non diversamente, in Without Lying Down,
Helen Gardner
Cari Beauchamp descrive la sceneggiatrice Frances Marion come una donna capace di giocare secondo le regole dell’industria, ma al tempo stesso anche di valorizzare generosamente la propria rete di relazioni11. Per esempio, fu grazie a lei che l’attrice Marie Dressler poté ottenere una seconda possibilità e la parte principale in Min and Bill, testo che Frances Marion aveva acquistato dalla sceneggiatrice Lorna Moon, ormai ridotta in povertà e vicina alla fine, per poi riscriverlo e trasformarlo in una piattaforma di lancio divistico. Di fatto, Beauchamp ha romanzato in modo assai efficace la vita di Frances Marion, attribuendole qualità e motivazioni che ci invitano a riconoscerci in lei. La Marion di Beauchamp è la brava giocatrice che, in un mondo di uomini, segretamente aiuta le donne. Nessuna di noi raggiungerà mai la splendente perfezione della Frances Marion raccontata in Without Lying Down. In questo modo noi ‘scopriamo costruttivamente’ che le donne che furono attive nell’industria muta non sono altro se 21
non versioni idealizzate dei nostri attuali successi professionali. Troviamo in loro ciò che vorremmo essere e non troviamo ciò che non vogliamo essere. Frances Marion è il soggetto di studi femministi; Lorna Moon, viceversa, non lo è, ma è il soggetto di una biografia scritta dal figlio illegittimo avuto dallo sceneggiatore-produttore William DeMille, che fu cresciuto dallo zio Cecil B. DeMille12. Ma per chiarire meglio il problema, cioè il paradosso di figure che sono storiche solo in quanto non lo sono, può essere utile provare a declinare la metodologia sviluppata nell’ambito dell’analisi dei generi cinematografici a vantaggio del nostro lavoro storico. Il punto centrale riguarda ciò che Steve Neale ha definito con l’espressione di ‘verosimiglianza culturale’, ovvero quella peculiare commistione del probabile, del familiare e dell’accettabile13 che, come abbiamo appreso dagli studi di teoria narrativa e dei generi, viene entusiasticamente salutata come ‘la realtà’, o anche come ‘le cose come andarono davvero’. Le nostre narrazioni delle vite di queste cineaste mettono in evidenza quel che probabilmente esse sono state, nel loro tempo, ma tale probabilità può esistere solo entro i confini di ciò che è per noi immaginabile, o meglio ancora, di ciò che è per noi spendibile e funzionale oggi. In queste ‘ricostruzioni’, la nostra posizione somiglia un po’ a quella di sceneggiatrici che si interroghino circa il modo in cui il pubblico riceverà la loro storia di genere realista classico. Vi è tuttavia una differenza decisiva, poiché se è vero che il nostro lavoro di scrittura e di ricerca avviene in solitudine, è anche vero che poi ci confrontiamo e discutiamo, all’interno di seminari e convegni, e questo ci offre maggiori probabilità di produrre una narrazione collettiva. In pratica ci accordiamo circa i contenuti di un enorme spazio immaginario condiviso. Consentitemi di dargli un nome. Già in passato l’ho chiamato “l’universo del cinema-storia” (cinema historyland). È una sorta di spazio sotterraneo, anomalo, non situabile. Altri prima di me hanno fatto riferimento all’anomalia temporale che caratterizza lo spazio della storia. Gilles Deleuze, per esempio, ha scritto che “essa esiste nel momento stesso in cui non esiste”14. Citando Heidegger, Hayden White ha utilmente contrapposto l’esistenza degli eventi nello strano spazio della ‘storicità’ alla loro presunta esi22
stenza nel ‘tempo’, che può non condividere affatto lo stesso spazio della ‘storicità’ e, in certi casi, può costituire anzi un elemento assai problematico15. Forse, perché possiamo avere l’impressione che esse appartengano a questo spazio distante, eppure presente, della storia del cinema, che siano là mentre non lo sono, c’è anche bisogno che le donne che ritroviamo ci appaiano diverse da noi. Per esempio, come Lorna Moon, sono costrette a nascondere le loro gravidanze. O come nelle trame da lei sceneggiate per i suoi melodrammi realisti, a dare i propri figli illegittimi in adozione. E tuttavia, la nostra tensione a fare di loro figure ‘probabili’ è una tensione che ci parla soprattutto di noi: qualsiasi cosa esse siano state, dobbiamo pensarle non solo come nostre antecedenti, ma anche come nostre antitesi. Non devono essere noi solo per permetterci di scrivere la storia dei progressi femministi. Noi facciamo ricerca su di loro, di conseguenza, non siamo loro. Come potremmo esserlo? Quasi un secolo ci separa. Perché possano divenire una ‘realtà storica’, ovvero perché possano risultare concepibili per il nostro tempo, senza smettere di essere credibili come figure del loro, sembrerebbe insomma necessario che esse siano insieme e in egual misura abbastanza simili e abbastanza diverse da noi. Il paradosso è che abbiamo bisogno di pensarle come rappresentative sia della loro che della nostra epoca. La nostra contraddizione è quella di dover trovare a un tempo ‘noi e loro’, e nelle giuste proporzioni. Tutto ciò pone alla ricerca la considerevole sfida di fare, come ho già indicato, delle ‘scoperte costruttive’. Non mi sottrarrò certo al compito di affrontare il nodo più interessante e controverso di tutti, corollario alla questione della scoperta costruttiva. Come mai, negli anni che vanno grosso modo dal 1975 al 1999, abbiamo creduto che nel primo cinema donne come queste semplicemente non esistessero? Voglio ribadire qui l’importanza del libro di Giuliana Bruno su Elvira Notari16. Benché la Society for Cinema and Media Studies degli Stati Uniti gli avesse assegnato l’ambito premio riservato al miglior libro dell’anno già nel 1994, ci sono voluti ancora quasi dieci anni perché il paradigma della teoria femminista del cinema, con la lentezza di un iceberg, cominciasse a muoversi in un’altra direzione, permettendoci di
1 / Esse sono noi? / Jane M. Gaines
trarre vero profitto dalla storiografia teorica di Giuliana Bruno. Torniamo indietro di qualche decennio. Le prime storie generali del cinema tedesco, italiano, inglese, francese, americano, russo, messicano e cinese non citano affatto queste donne. Ma quando è stato che noi, appartenenti a un’altra generazione, abbiamo realmente cominciato a riconoscere l’evidenza e a opporci a quelle storie?17 Di sicuro non ci piace pensare di poter esser state, in qualunque momento, complici di una tale eclissi, ma forse è proprio così. Guardiamo agli anni Settanta. Nel momento ‘negativo’ della teoria femminista del cinema, avevamo bisogno di credere che il mondo del lavoro (di cui l’industria del cinema rappresentava il microcosmo) avesse sempre posto alle donne barriere impossibili da superare. Perché? Perché questa era, allora, la nostra esperienza. Negli anni Settanta non c’erano per le donne né posizioni di rilievo nelle università, né ruoli manageriali nell’industria cinematografica, in nessun paese del mondo. Non vi era alcuna cinematografia nazionale che proponesse immagini familiari dietro la macchina da presa. Vale la pena di ricordare che la strategia del controcinema femminista degli anni Settanta ci chiedeva di essere, se non proprio delle ‘agitatrici’, per lo meno delle ribelli scettiche e dunque di andare alla ricerca, nel passato, di altre ribelli altrettanto scettiche di noi. E poiché tra le cineaste del muto non si trovavano né ribelli, né tanto meno femministe, per noi queste donne erano effettivamente inesistenti. Vero, negli Stati Uniti c’era stata un’indipendente come Maya Deren, in Francia Germaine Dulac, in Germania Asta Nielsen (mentre Esfir Šub restava una figura lontana, nascosta dietro a ciò che era allora la cortina di ferro): ma si trattava di semplici eccezioni alla regola generale secondo cui la storia del cinema non conteneva alcun esempio di ribellione femminile. Considerando la cosa a posteriori, si può dire che una donna che non rispondesse al paradigma femminista ricadeva automaticamente in uno stato di inesistenza. Ancor peggio, si può dire che l’inesistenza delle donne nella storia del cinema sia stata ri-sancita dalle femministe sulla base di un giudizio di inesistenza già stabilito dalla prima generazione di storici del cinema. Devo precisare che questa generalizzazione affon-
da le sue radici nella mia esperienza accademica in ambito angloamericano; è ovvio che altrove le cose possono essere andate in maniera diversa. Nel mondo anglofono, in tutto il periodo di maggior rigoglio della teoria femminista, persino “Screen”, in quegli anni la principale rivista d’orientamento femminista del settore (la cui importante sezione storica dal titolo “Screen Reader” fu curata dal 1972 al 1999 da Annette Kuhn e Jackie Stacey), non ospitò neppure un articolo sulle cineaste del periodo muto18. Se non erano esplicitamente e consapevolmente rivoluzionarie, le donne cineaste non esistevano. Un caso diverso è certamente la Germania, dove “Frauen und Film”, la prima e più longeva rivista dedicata all’intersezione tra femminismo e cinema, ha pubblicato sin dall’inizio numerosi saggi sull’attività femminile nell’industria cinematografica dei primi decenni19.
La coincidenza storica: noi siamo loro ed esse sono noi Esse sono noi, noi siamo loro. Siamo storicamente coincidenti. È qui che la filosofia della storia del cinema ci viene in soccorso, aiutandoci a pensare la storiografia e quindi le relazioni storiche che abbiamo intrattenuto e intratteniamo con i materiali d’archivio. Così come il cinema ha stretto relazioni di tipo documentario con il mondo storico reale, allo stesso modo noi stabiliamo relazioni storiche con quel mondo attraverso i materiali d’archivio. Lo stesso dilemma che ci poniamo interrogandoci sulla coincidenza tra il ‘loro’ e il ‘nostro’ presente è stato già più volte affrontato dalla teoria del cinema. Nei decenni passati, si è sostenuto alternativamente che l’immagine cinematografica sia caratterizzata da un senso insistente di ‘presenza’ o, con altrettanta enfasi, che essa significhi ‘passato’. Edgar Morin ha risolto il problema una volta per tutte suggerendo che il cinema fa sempre uso di (almeno) due tempi alla volta, fondendo insieme presente e passato in un “passato-presente”20. Perciò, affermare che ‘noi siamo loro ed esse sono noi’ significa che noi, in un certo senso, ‘diveniamo’ loro. E se potessimo scegliere di essere una qualsiasi tra loro, chi vorremmo essere? Naturalmente vorremmo tutte 23
Germaine Dulac (seconda fila, terza da destra) a un ricevimento ufficiale
essere Germaine Dulac: Dulac, seduta allo stesso tavolo con tanti importanti uomini francesi, nel suo smoking tagliato proprio come quello di un uomo. Altra facile scelta paradigmatica sarebbe Dorothy Arzner, che visse la sua doppia vita di lesbica e regista nella Hollywood dell’età dell’oro21. La nostra preferenza per Germaine e Dorothy è teoricamente spiegabile, sostiene Rita Felski, in base alle ricche discrepanze paradigmatiche che donne come queste mettono in gioco22. Per usare le parole di Judith Butler, sono sempre “in lotta” con il genere, “lo rappresentano e lo interpretano”23. Il loro rovesciamento e la loro mascherata sono state le nostre. Qui negli Stati Uniti, molte ancora ricordano l’effetto delizioso che ci fece la definizione “signore delle 24
discrepanze”, quando la leggemmo per la prima volta nell’antologia Pleasure and Danger, apparsa nel 198424. Ecco il paradigma della nostra epoca, quello per cui saremo ricordate: la trasgressività testuale, al tempo stesso complice e spiazzante, e il proficuo paradigma che si è imposto nel momento in cui la teoria queer ha dato una scossa elettrica alla teoria femminista. Spero d’aver così chiarito il punto circa all’altro modo in cui ‘esse sono noi’, al perché le convochiamo, per confermare i paradigmi di cui il nostro presente ha bisogno, producendo un ‘esse’ che coincide con ‘noi’. In altri termini: noi ritroviamo ‘costruttivamente’ ciò che queste donne sono/sono state, cogliendole in due tempi diversi in una volta sola.
1 / Esse sono noi? / Jane M. Gaines
Devo a Rita Felski, all’ironia di cui è punteggiato il passo in cui parla di Charlotte Brontë come di una “fervida ribelle”, l’ispirazione alla base della domanda: “Esse sono noi?”. Ma è stato un altro progetto femminista che mi ha portata a superare produttivamente, in un duplice senso, la contraddizione (infatti, come pensare che possano essere a un tempo se stesse e noi?) Nel libro Telling Feminist Histories, la teorica femminista inglese Clare Hemmings propone una storia dei progressi del femminismo lungo gli ultimi tre decenni25. Ricordandoci che “scriviamo e riscriviamo continuamente la narrazione del passato al fine di assicurare legittimità a un particolare presente”, Hemmings afferma che “ogni storia ha luogo nel presente”. Il nostro punto di partenza può essere il desiderio di porre riparo alle ingiustizie del presente e questo intento può portarci a favorire certe narrazioni rispetto ad altre. Hemmings insiste sulla necessità di una “politica del presente nella costruzione del passato”. Tale politica ha un prerequisito: la nostra collocazione genealogica in quanto storiche/ci che propongono una certa narrazione26. Dunque non vi è che un’alternativa: farsi schierare inintenzionalmente dalle scelte che compiamo comunque, o situarci tra il loro e il nostro ‘adesso’ in maniera consapevole. Hemmings si chiede come si possa cambiare il quadro di riferimento, passando per esempio dalla domanda: “Che cosa è veramente accaduto?”, alle seguenti: “Perché voglio raccontare questa storia? E nel raccontarla, che tipo di soggetto divengo?”27. Personalmente ho il sospetto che le nostre narrazioni circa le origini globali del cinema possano essere un modo per pensare le aspirazioni globali che oggi nutrono tanto il femminismo e gli women’s studies, quanto la storiografia cinematografica. La coincidenza storica non è una coincidenza. Dopo tutto, l’interesse che ci fa convergere in questa ricerca consiste in certe tarde manifestazioni delle forze del capitale mondiale, che formarono il contesto entro il quale i ‘pionieri’ e le ‘pioniere’ diedero vita alle cinematografie nazionali. In un momento come l’attuale, nel quale tante cinematografie europee esistono solo grazie agli aiuti statali, ci poniamo consapevolmente la domanda: quante cinematografie nazionali vennero avviate negli anni Dieci allo scopo di contrastare Hollywood? E
quante avrebbero potuto, in altre condizioni, imporsi sulla scena mondiale? Perché il cinema messicano degli anni Dieci rende omaggio alle dive del cinema italiano? L’interesse sul quale convergiamo riguarda insomma le origini di una distribuzione globale quanto mai irregolare. Mi riferisco qui a quelli che Caren Kaplan e Inderpal Grewal hanno chiamato “i circuiti differenziati e irregolari della cultura e del capitale”, ovvero a una situazione mondiale che ha non solo dis/organizzato la distribuzione delle conoscenze ma, come sappiamo, ha anche provveduto a disseminare irregolarmente i modelli narrativi del cinema muto sul territorio mondiale28. Lo stesso titolo di questo volume, Non solo dive, suona come una ricerca esplicita di altri paradigmi. Che cosa, giunti in fondo a queste pagine, saremo
Dorothy Arzner 25
in grado di aggiungere alla figura della diva, prodotto italiano d’esportazione per eccellenza, capace di eclissare ogni altro paradigma? Il paradigma della diva – cui il recente libro di Angela Dalle Vacche, Diva: Defiance and Passion in Early Cinema, ha fornito il più coerente fondamento teorico29 – è quello d’una sofferenza gloriosamente impareggiata, rappresentata su scala globale. Esiste peraltro tutta una varietà di altri tropi della differenza, in gran parte ancora da studiare, che ispirano il lavoro teorico sul melodramma, nel quale tante di noi sono impegnate: iniquità e ingiustizie, separazioni e ritrovamenti, finzioni e disvelamenti. C’è la consumazione finale e c’è la rinascita. Ma accanto ai circuiti della differenza, si trovano anche quelli della somiglianza. Per esempio, vediamo apparire lo stesso modo di produzione familiare, semiartigianale e semindustriale attraverso i più distanti confini nazionali, dalla Casa di produzione creata in Italia da Elvira Notari, a quelle fondate nelle Filippine da Isabel Acuna e da suo marito, in Australia dalle sorelle McDonough, in Germania dalle tre sorelle norvegesi Aud, Gerde e Ada EgedeNissen.
Chi siamo / chi eravamo: l’eredità del passato nel presente Infine, voglio porre la domanda più difficile di tutte: chi siamo/chi eravamo? L’eredità che convochiamo nel presente fa eco al duplice tempo dell’immagine cinematografica, al suo essere passata-presente. Il modo in cui scegliamo di raccontare la storia delle donne nell’industria cinematografica egiziana, o russa, o francese, o indiana, o italiana, sarà comunque più eloquente sul nostro attuale momento storico di quanto non potrà essere sul ‘loro’. Se, seguendo Clare Hemmings, accettiamo che “ogni storia ha luogo nel presente”, quali nuovi paradigmi potranno essere attivati dalla transnazionalizzazione del nostro lavoro storico? Quali, se ciò che riusciamo a rappresentare è giusto l’impossibilità di questo ‘trans’? Per esempio, basta solo sollevare la questione delle copie preservate negli archivi fiaf per vedere come il prefisso ‘trans’ immediatamente si politicizzi e di26
vida nettamente il mondo30. Si è visto bene a Londra nel novembre 2006, in occasione della manifestazione Women and Silent Britain, dove gran parte dell’attenzione dei partecipanti ha gravitato intorno al problema dell’inaccessibilità di una copia, di un film particolarmente controverso di Eve Balfour, The Woman Who Did (1915), individuata presso il GosKino di Mosca. In epoca post-sovietica abbiamo dovuto renderci conto che il tentativo di ‘organizzare’ il mondo a partire dal lavoro delle donne non viene riconosciuto come una priorità, cosicché il solo fatto di promuovere eventi regionali o nazionali come questo finisce per toccare nervi politici scoperti. Ma passiamo dall’area ex-sovietica a quella asiatica, in un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati su Pechino e sui suoi giochi olimpici. Negli Stati Uniti, si è creato un certo interesse intorno al nome di Helen Wong, che oggi sappiamo essere stata una figura importante nell’industria cinematografica di Shanghai, un’attrice-produttrice attiva fino al 1928, che poi si dedicò all’industria cosmetica. Ci sono quindi le immigrate americane di prima generazione: un caso dei più notevoli è quello della sinoamericana Marion E. Wong, che nel 1916 diede vita alla Mandarin Film Company e il cui film The Curse of the Quon Dong è stato rinvenuto nel 2006 presso i suoi eredi. Riemerso all’improvviso tra migliaia di altri possibili titoli, il film è stato di recente iscritto negli elenchi del National Film Registry degli Stati Uniti. Un caso non troppo diverso è la ‘scoperta’ di Alice Guy Blaché come immigrata francese, che lotta per affermarsi nell’America del 1907: l’analisi condotta da Alison MacMahan su The Making of an American Citizen (1912) ha provveduto a rafforzare questa immagine di immigrata, decisamente in contraddizione con l’altra percezione che abbiamo di Guy Blaché come imprenditrice, presidente di una compagnia, la Solax, da lei creata nel 191031. La grande retrospettiva dell’opera di questa cineasta, attualmente in preparazione presso il Whitney Museum di New York, potrà mettere questa coppia di termini, ‘immigrata’ e ‘imprenditrice’, in un rapporto di fertile tensione. Ma è anche lecita qualche preoccupazione, un certo timore che un evento di tale portata finisca per produrre nel discorso collettivo l’ennesima figura di ‘donna eccezionale’, che eclis-
1 / Esse sono noi? / Jane M. Gaines
Lois Weber
sa tutte le altre, ponendole involontariamente in una posizione di ‘normalità’ insignificante. Di qui l’urgenza di stabilire correttamente la relazione reciproca esistente tra queste donne e il loro lavoro. E qui vorrei tornare all’inizio, a quel 1986 in cui cominciò a circolare nel mondo accademico anglo-americano un nuovo paradigma, che sfidava con forza la rappresentazione della scrittrice bianca e vittoriana e femminista di cui sopra. L’illustrazione di questo nuovo paradigma si trova nell’analisi del personaggio di Bertha Mason sviluppata da Gayatri Spivak. Sette anni dopo la pubblicazione di The Madwoman in the Attic, Spivak esplora i rapporti di potere latenti nel paradigma dell’eroina bianca e ne conclude che Bertha Mason, la moglie creola di Mr. Rochester, la donna proveniente dalle Indie Occidentali, deve per forza morire nella soffitta di casa Rochester affinché la seconda moglie, Jane Eyre, possa divenire la candida “eroina femminista individualista” della narrativa inglese32. La lezione offerta
da questa revisione paradigmatica, da questo vero e proprio paradigma rovesciato, definisce ancora con molta precisione un certo tipo di anglo-femminismo, segnato dall’esigenza di stabilire le proprie origini bianche. Sempre nello spirito della critica femminista antiimperialista di Gayatri Spivak, voglio aggiungere un’ulteriore osservazione. Infatti, se riconosciamo che il nostro rapporto con le cineaste del periodo muto si definisce in termini di coincidenza storica, dobbiamo anche essere in grado di riconoscere la coincidenza che esiste tra loro. Per esempio, mentre negli Stati Uniti ci prepariamo a celebrare l’immigrata bianca Alice Guy Blaché, dobbiamo riuscire a percepirla come coincidente con la sinoamericana Marion E. Wong, o con l’americana di origini messicane Beatriz Michelina, le cui opere sopravvivono alla Library of Congress. O per citare un altro caso anche più significativo, dobbiamo essere pronte ad attraversare più volte il confine tra il Messico e gli Stati Uniti, per costruire la coincidenza storica esistente tra Mimì Derba e la prolifica regista-produttrice americana Lois Weber, fino a far collimare titolo per titolo le loro opere ritrovate. Mentre sono stati fatti notevoli progressi nel restauro dei film diretti e prodotti da Lois Weber, è ancora aperta la caccia a una parte del film di Mimì Derba En defensa propia / In Her Own Defense, realizzato nel 1917 in Messico. In effetti si dice che questo elusivo segmento sia tuttora esistente, nel paese dove si consumò la breve stagione della Atzeca Films, la compagnia fondata dalla stessa Derba insieme al documentarista Enrique Rosas33. Nella storia dell’Azteca sono coinvolti tanto l’Italia quanto gli Stati Uniti. Come osserva Miguel Ángel, la principale fonte d’ispirazione di Derba furono proprio i film italiani, allora assai popolari a Città del Messico: i suoi modelli erano Pina Menichelli e Lyda Borelli e il suo primo film, En defensa propia, richiama chiaramente lo stile visivo del cinema italiano. Se l’Azteca emulava i film italiani, osava però sfidare apertamente il cinema americano. Il suo fine dichiarato era quello di produrre film che fossero volti a contrastare l’immagine del Messico abitualmente proposta dai film nordamericani, sostituendola con immagini di normale vita borghese34. Fondata a Città del Messico da Derba e Rosas subito 27
dopo un viaggio a New York, l’Azteca doveva, per usare le loro parole, “diffondere la vera immagine di un Messico civilizzato”. Del resto, alla luce del nostro paradigma, il fallimento storico di tale impresa non è meno significativo del divampare di speranze politiche che la generò. L’Azteca produsse quattro lungometraggi, più due film di formato breve, il tutto nel 1917, lo stesso anno in cui aprì e chiuse i battenti. Era il periodo in cui il cinema americano stava cominciando a imporsi sui mercati internazionali; il periodo in cui Lois Weber, sotto contratto alla Universal, stava conquistando quella reputazione che in breve l’avrebbe messa in grado di creare un suo proprio marchio, la Lois Weber Productions. Uno dei suoi film del 1916, Shoes, fu fatto arrivare dalla Universal fin nel lontanissimo Giappone, nel quadro d’un piano di distribuzione mondiale. Per comprendere bene sia l’aggressività dell’industria americana sia le aspirazioni di quella messicana, non dobbiamo dimenticare che tra il 1914 e il 1918 il primato nell’industria cinematografica globale non si era ancora chiaramente stabilito. Prima della Grande Guerra, la competizione per il predominio mondiale vedeva come principali contendenti l’Italia, la Francia e gli Stati Uniti. In questo turbolento periodo, Rosas e Mimì Derba poterono immaginare che l’industria messicana, in seguito alla rivoluzione, sarebbe riuscita, nelle loro parole, “a mettersi al passo con quella americana, francese e italiana, conquistando una posizione egemone nel mercato nazionale”. La guerra mondiale, scaraventando l’America in prima linea, offrì per un attimo un insperato vantaggio al cinema messicano. Non è un caso infatti che l’Azteca sia sorta nel 1917, cioè in un momento di temporanea mancanza di prodotti americani sul mercato interno, dovuta, come Kristin Thomson ha mostrato, alla drastica riduzione delle esportazioni verso il Messico che seguì all’entrata in guerra degli Stati Uniti35. Subito dopo il conflitto, l’affermazione del dominio statunitense su tutti i paesi dell’America latina permise alle compagnie indipendenti nazionali di conoscere un’effimera fortuna, contribuendo a quella che Karen Mahar ha chiamato la seconda ondata delle women’s companies hollywoodiane: marchi che fecero la loro comparsa a partire dal 1916, ma che erano già spariti 28
Mimì Derba
nel 1923, vittime dei processi di concentrazione industriale36. Dunque le compagnie gestite da donne seppero cavalcare l’onda del boom economico nazionale; ma se in un primo tempo risultarono favorite dalle grandi maree globali, finirono però ben presto per esserne travolte, vedendosi subito private delle opportunità che per un breve momento si erano aperte. Tutto ciò può mostrare come i temi della coincidenza e dell’interconnessione meritino di essere esplorati nella prospettiva più ampia e globale possibile, l’unica che potrebbe permetterci di confermare il sospetto che, se è vero che ‘esse sono noi’, allora è anche vero che siamo state transnazionali fin dall’inizio, ma senza sapere come fare a saperlo, senza sapere in quale luogo esattamente ci troviamo negli schemi del capitale transnazionale. Saper conoscere il luogo dove noi tutti ci troviamo è il compito di una nuova generazione di studiose femministe. Traduzione dall’inglese di Paola Cristalli
1 / Esse sono noi? / Jane M. Gaines
Note 1 Walter Benjamin, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997, p. 27. 2 L’idea del cinema come storiograph – una delle tante primitive definizioni per designare la macchina cinematografica – è tratta da André Gaudreault, The Cinematograph: A Historical Machine in David E. Klemm, William Schweiker (a cura di), Meanings in Texts and Actions: Questioning Paul Ricoeur, University of Virginia Press, Charlottesville-London 1993), p. 95. 3 Rita Felski, Literature after Feminism, University of Chicago Press, Chicago 2003. 4
Rita Felski, op. cit., p. 66.
Frances Denton, “Lights! Ready! Quiet! Camera! Shoot!” Photoplay (February 1918). Sulla rilevante presenza di donne – tra cui Ida May Park – impiegate in qualità di sceneggiatrici, registe, produttrici presso gli studi della Universal Pictures durante il periodo muto, si veda Mark G. Cooper, Universal Women: A Case of Institutional Change, University of Illinois Press, Chicago in corso di pubblicazione. La frase “la prima occasione che mi fu offerta” si riferisce probabilmente alla pratica di affidare un gruppo di attori a un regista, cosa che, nelle grandi compagnie come la Universal, significava in realtà avere la responsabilità di un’unità di produzione, all’interno della più ampia entità dello studio. Per maggiori dettagli sulle donne attive nell’industria internazionale del cinema durante il periodo muto si vedano anche Jane Gaines e Rada Vatsal (a cura di), Women Film Pioneers Sourcebook, vol. I: United States and Latin America, e Jane Gaines e Monica Dall’Asta, Women Film Pioneers Sourcebook, vol. II: Europe, Asia, Canada, Australia and Middle East, University of Illinois Press, Chicago, in corso di pubblicazione.
5
6 Petrova-Prophetess, “Photoplay”, December 1917; Larry Ceplair, A Great Lady: A Life of the Screenwriter Sonya Levien, Scarecrow Press, Lanham 1996. 7 Cfr. Jennifer Bean, Technologies of Stardom and the Extraordinary Body, Duke University Press, Durham 2002, dove l’autrice sviluppa il paradigma del “corpo straordinario”.
Si veda a questo proposito l’introduzione di Linda Williams al suo Viewing Positions, Rutgers University Press, New Brunswick, New York 1997 e gli articoli antologizzati in Wanda Strauven (a cura di), The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam University Press, Amsterdam 2006, nei quali si esamina in dettaglio la storia del paradigma del “cinema delle attrazioni”.
8
Per una recente ed esaustiva ricognizione degli studi femministi sul cinema, cfr. Alison Butler, Feminist Perspectives in Film Studies, in James Donald e Michael Renov (a cura di), The Sage Handbook of Film Studies, SAGE Publications Ltd, Los Angeles-London 2008, pp. 391-407.
9
10
Walter Benjamin, op. cit., p. 23.
Cari Beauchamp, Without Lying Down: Frances Marion and the Powerful Women of Early Hollywood, Scribner, New York 1997. 11
Richard DeMille, My Secret Mother: Lorna Moon, Farrar, Straus and Giroux, New York 1998. 12
13 Steve Neale, Questions of Genre, in Robert Stam e Toby Miller (a cura di), Film and Theory. An Anthology, Blackwell, Oxford 2000, pp. 168-69.
Gilles Deleuze, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano 1997.
14
15 Hayden White, Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1987, p. 52. 16 Giuliana Bruno, Streetwalking on a Ruined Map. Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari, Princeton University Press, Princeton 1993 (tr. it. Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari, La Tartaruga, Milano 1995) 17 Per una ricognizione della relazione tra teoria e storiografia femminista del cinema, si veda il mio Film History and the Two Presents of Feminist Film Theory, “Cinema Journal”, n. 1, 2004. 18 Cfr. soprattutto Annette Kuhn e Jackie Stacey, Screen Histories: An Introduction, in Id. (a cura di), Screen Histories: A Screen Reader, Clarendon Press, Oxford 1998, pp. 1-10. 19 Per una seria riflessione sulle figure di Asta Nielsen e Henny Porten cfr. Heide Schlüpmann, Unheimlichkeit des Blicks: Das Drama des frühen deutschen Kinos, Verlag Roter Stern, Frankfurt 1990 (traduzione inglese prevista per il 2009). Cfr. anche Heide Schlüpmann, Asta Nielsen and Female Narration: The Early Films, in Thomas Elsaesser (a cura di), A Second Life: Early German Cinema’s First Decades, University of Amsterdam Press, Amsterdam 1996, pp. 118-131. 20 Edgar Morin, Il cinema o l’uomo immaginario, Feltrinelli, Milano 1982. 21 Per il più importante studio storico-critico su Dorothy Arzner, si veda Judith Mayne, Directed by Dorothy Arzner, Indiana University Press, Bloomington 1994. 22
Cfr. Rita Felski, op. cit., p. 76.
Judith Butler, Imitation and Gender Insubordination in Diana Fuss (a cura di), Inside / Out: Lesbian Theories, Gay Theories, Routledge, New York 1991. 23
24 Carol S. Vance (a cura di), Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, Routledge and Kegan Paul, New York 1984. 25 Clare Hemmings, Telling Feminist Stories, in “Feminist Theory” n. 2, 2005, pp. 115-139.
29
26
Clare Hemmings, op. cit., pp. 118-119.
27
Clare Hemmings, op. cit., p. 119.
Caren Kaplan e Inderpal Grewal, Transnational Practices and Interdisciplinary Feminist Scholarship: Refiguring Women’s and Gender Studies, in Robyn Wiegman (a cura di), Women’s Studies on It’s Own: A Next Wave Reader in Institutional Change, Duke University Press, Durham 2002, p. 73.
28
29 Angela Dalle Vacche, Diva: Defiance and Passion in Early Italian Cinema, University of Texas Press, Austin 2008.
Sulla scomparsa di una parte consistente della produzione muta e sul lavoro in corso per catalogare e restaurare ciò che ne resta, rimando al mio Sad Songs of Nitrate, “Camera Obscura”, vol. 22, n. 3-66, 2007, pp. 171-178. 30
31 Alison McMahan, Alice Guy Blaché: Lost Visionary of the Cinema, Continuum, New York 2002 (cfr. soprattutto cap. 4). 32 Gayatri Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1999, p. 270. 33 Ángel Miguel, Mimí Derba, Archivo Fílmico Agrasánchez / Filmoteca de la UNAM, Ciudad de México 2000. 34 In questo senso il Messico si trovava in una situazione sensibilmente diversa rispetto agli altri paesi dell’America latina, tanto che nel 1922 il governo proibì la diffusione di film americani che rappresentassero i messicani in modo offensivo. Nelle parole di Ana M. López, “il Messico fu il primo paese a opporsi agli Stati Uniti sul piano ideologico” (Facing up to Hollywood in Christine Gledhill e Linda Williams, a cura di, Reinventing Film Studies, Arnold, London 2000).
Kristin Thompson, Exporting Entertainment: America in the World Film Market, 1907 – 1934, British Film Institute Publishing, London 1982, p. 81. 35
36 Karen Ward Mahar, Women Filmmakers in early Hollywood, Johns Hopkins, Baltimore 2006 (cfr. soprattutto cap. 6).
30
2 / Christine Gledhill
Pensare le donne nella storia del cinema: l’esperienza britannica
Questo contributo intende delineare il programma di una serie di iniziative e seminari di studio volti ad approfondire questioni che si sono affacciate alla nostra attenzione, nel momento in cui alcune di noi hanno provato a costruire un gruppo di lavoro sulla storia del cinema delle donne in Gran Bretagna e in Irlanda1. Mi auguro che le specifiche problematiche sollevate dalla situazione britannica e irlandese possano avere un valore più generale ed essere di qualche utilità ai fini dello sviluppo di una storia del cinema delle donne su scala internazionale. La nostra iniziativa ha tratto ispirazione dalle svariate, stimolanti attività promosse nel corso degli ultimi dieci anni dal Women Film Pioneers Project – oggi Women’s Film History International – nonché dai cinque convegni internazionali fin qui tenutisi in vari paesi sotto il titolo di Women and the Silent Screen2. Tuttavia, fino a tempi recenti, pochissimo del materiale messo in luce in queste occasioni proveniva dalla Gran Bretagna, e ciò a dispetto del fatto che, intanto, anche da noi era nata una ‘mini-Pordenone’: il British Silent Film Festival di Nottingham Broadway, che da undici anni a questa parte, grazie al lavoro di tante e tanti accademici, archivisti, collezionisti e appassionati, non ha mai cessato di rivelare sempre nuove e affascinanti scoperte. Confesso
che ancora nel 2004, benché avessi appena pubblicato un libro sul cinema britannico degli anni Venti, al momento di pensare a un intervento da presentare al convegno Women and the Silent Screen di quell’anno, mi trovai in difficoltà nel tentare di rinvenire nella produzione cinematografica britannica figure di donne non riconducibili ai settori della critica o del pubblico. Per quanto ne sapevo, l’episodio più rilevante dell’epoca in questione (gli anni Venti) era stato un lungo dibattito sul carattere represso dei personaggi femminili e sulla mancanza di sex appeal delle attrici britanniche3. Nel complesso sembrava che il cinema britannico, a parte alcune notevoli eccezioni, fosse un ambiente assai poco ospitale per le donne. D’altro canto, c’erano molte donne che avevano scritto di cinema: giornaliste che si erano battute affinché il cinema venisse riconosciuto come il medium per eccellenza del mondo moderno – in particolare Iris Barry e Caroline LeJeune – e letterate interessate al potenziale modernista del cinema – tra le quali, oltre a Virginia Woolf, vanno ricordate le scrittrici Dorothy Richardson e H.D. (Hilda Doolittle), che contribuirono a fondare “Close Up”, una delle prime riviste in lingua inglese dedicate al cinema come arte. Dell’unica donna regista degli anni Venti – Dinah Shurey – esistono pochissime testimonianze 31
documentate, fatta eccezione per la fine del decennio, quando Nerina Shute, enfante-terrible allora poco più che ventenne e collaboratrice della neonata rivista cinematografica “Film Weekly”, pubblicò un articolo dai toni scurrili intitolato “Can Women Direct Films?”, che usava Dinah Shurey come capro espiatorio per concludere con un sonoro “no”: “È pateticamente evidente che le donne non possono fare cinema. In Inghilterra una sola ha avuto l’ardire di tentare. Dina [sic] Shurey, (che andrà certo in paradiso in ragione del suo coraggio) ha realizzato una serie notevole di film terrificanti”4. Questo attacco finì per provocare parecchia agitazione nella stampa di settore, perché Dinah sporse una querela per calunnia nei confronti di Nerina, e vinse5. Su Dinah ritornerò in seguito.
Il British Women’s Film History Project L’inizio del lavoro di redazione del secondo volume del Women Film Pioneers Sourcebook6 ha offerto lo stimolo per promuovere una giornata di studio intitolata Women and Silent Britain, organizzata nel novembre 2006 da alcuni sostenitori del British Silent Film Festival con il generoso contributo del National Film Theatre e del British Film Institute. L’intento era quello di far conoscere il progetto della rete internazionale Women Film Pioneers a un pubblico più vasto, presentare alcuni esempi significativi sia del lavoro cinematografico delle pioniere britanniche (per esempio, Alma Reville, meglio nota come la signora Hitchcock, che lavorò come montatrice, sceneggiatrice e assistente alla regia prima e dopo aver incontrato il futuro marito), sia delle ricerche in corso su di loro, nonché affrontare alcuni dei problemi posti dalla ricerca della presenza delle donne nella storia del cinema. Gli interventi hanno sollevato una serie di questioni, a partire da quelle relative all’identificazione del ruolo svolto dalle donne nella lavorazione dei singoli film, alla necessità di basarsi su fonti spesso solo tangenziali ed effimere, alla difficoltà di fare storia orale con persone la cui memoria soffre spesso del peso dell’età. Alla fine l’entusiasmo e il desiderio di continuare erano tangibili, alimentati non solo dalla prospettiva di poter rivelare 32
nuovi aspetti della vita delle donne del passato, ma anche dalla naturale sorpresa e dal piacere di scoprire materiali risalenti ai primi decenni della storia del cinema, i quali sembravano dare accesso a una nuova sfera dell’esperienza professionale delle donne, della loro creatività ed espressione personale. Quella giornata ha moltiplicato in maniera esponenziale la conoscenza dell’attività cinematografica delle donne in Gran Bretagna, presentando figure sulle quali fino a quel momento si sapeva ben poco. Tuttavia, benché da allora (due anni a questa parte) la lista dei nomi candidati a rientrare nel Sourcebook non abbia fatto altro che crescere, il numero delle ricercatrici e dei ricercatori che si stanno occupando di indagarne l’attività è ancora insufficiente. Il problema non è solo che c’è sempre troppo lavoro da fare, e che il compito di studiare la storia delle donne è scoraggiante e pieno di insidie; il fatto è che siamo una comunità dispersa, che deve ancora trovare una modalità di comunicazione e di condivisione delle idee, delle conoscenze e dei problemi, un punto di riferimento e un obiettivo comune. Al termine di quel primo incontro si decise perciò di lavorare per creare un sito web, una banca dati e una lista di distribuzione elettronica per tentare di superare il problema della dispersione delle ricerche e di tutto lo sforzo supplementare che essa comporta. Sulla scia dell’entusiasmo di quella giornata, due giovani ricercatrici, Nathalie Morris e Clare Watson, hanno dato vita a un sito web, che rappresenta il primo esempio di uno spazio pubblico condiviso nel quale sia possibile far confluire tutti i nomi e le notizie raccolte in merito alla storia delle donne britanniche nel cinema muto, aggiornare le informazioni man mano che emergono, dar conto dei progetti di ricerca in corso, dei convegni in programma ecc.7 Peraltro, l’esigenza di disporre di strumenti come i siti web o le banche dati elettroniche solleva problemi che non sono solo di ordine tecnico e metodologico, ma toccano anche una serie di questioni concettuali preliminari, come indica il titolo di questo contributo: Pensare la storia delle donne nella storia del cinema. Il tentativo di rispondere a queste domande ha condotto un certo numero di studiose e studiosi, archiviste e bibliotecarie a formare un gruppo di lavoro – il British and Irish Women’s Film
2 / Pensare le donne nella storia del cinema / Christine Gledhill
Olga Petrova
History Network – allo scopo di affrontare i problemi inerenti al progetto, nonché di sviluppare, attraverso una serie di seminari, il quadro di riferimento entro cui attivare le strategie e gli strumenti di supporto per il suo sviluppo a lungo termine. Mentre l’ambito della ricerca andava progressivamente definendosi, il progetto si è rapidamente esteso, allargandosi oltre il periodo del muto, fino ad abbracciare la storia delle donne britanniche e irlandesi nel cinema e nell’audiovisivo anche lungo i decenni successivi. Infatti non solo è del tutto logico che le carriere delle donne che hanno contribuito alla transizione dal muto al sonoro possano essere studiate nella loro continuità, ma vi è anche un bisogno urgente di localizzare e preservare i materiali con cui verrà scritta la storia recente del cinema delle donne, specialmente quella dei collettivi indipendenti (ora in gran
parte estinti) attivi negli anni Settanta e Ottanta. Inoltre, la composizione della rete – di cui fanno parte docenti universitarie, archiviste e professioniste dei media – è intenzionalmente variegata, in modo tale che le istanze concettuali, di ricerca e di accesso alle risorse possano integrarsi le une con le altre. Tra i/le partecipanti vi sono non solo storiche del cinema ed esperte di teoria femminista, ma anche rappresentanti del National Film and Television Archive, del British Universities Film and Video Council, della Women’s Library, dell’Imperial War Museum, della sezione londinese dell’associazione Women in Film and Television, del British Silent Film Festival, del Women’s History Network, del Film and Video Databasing Project e così via. La rete è altresì interdisciplinare e coinvolge specialisti sia di storia moderna sia di storia delle donne, storia della letteratura e storia dell’editoria, produzione transmediale, televisione, storia del design e della videoarte. Ma lo sforzo più importante è quello di valorizzare la circolazione sia delle persone sia dei materiali attraverso la collaborazione con il progetto internazionale Women Film Pioneers, nonché di promuovere relazioni fertili con altre iniziative analoghe, come quelle italiana e scandinava. L’eterogeneità e la diversità degli orientamenti che caratterizzano questo gruppo di ricerca sono in sé indicative delle questioni concettuali che attendono qualsiasi tentativo di costruire una storia delle donne nel cinema britannico e irlandese. In ciò che segue cercherò quindi di delineare gli interrogativi finora emersi nel corso della progettazione di questo programma di seminari.
Primo seminario. Che cos’è la storia del cinema delle donne? Questo primo seminario chiama in causa il problema della storiografia femminista, concentrandosi sulle intersezioni tra storia delle donne, storia del cinema e teoria femminista del cinema. Il fatto stesso che vi sia un bisogno così urgente di studiare la storia delle donne cineaste suggerisce come la storia del cinema sia stata tradizionalmente indifferente alle questioni di genere. In ciò, di fatto, la storia 33
del cinema non fa che replicare le disuguaglianze di genere esistenti nella società di cui è testimone. Ma è ugualmente degno di nota il fatto che, fino a tempi recenti, nemmeno la teoria femminista del cinema si sia granché interessata alla storia del cinema delle donne. Il nostro evento londinese ha davvero rappresentato una sorta di ripartenza per la ricerca storica femminista, generando reazioni analoghe a quelle che avevano circondato i primi eventi dedicati al cinema delle donne. Perché infatti, mentre la prima teoria femminista del cinema aveva lavorato con passione alla riscoperta dell’opera delle donne registe, questo impulso è andato via via scemando nel corso degli anni Settanta e Ottanta, quando la teoria femminista ha cominciato a interessarsi di rappresentazione, ideologia e costruzione del soggetto, divenendo un punto di riferimento centrale per la riflessione su ognuna di queste questioni. Se la teoria femminista (soprattutto nei suoi aspetti più rivolti alle problematiche dello sguardo) è stata ampiamente accolta negli studi sul cinema, solo recentemente si è costruita un proprio percorso in quella che si può definire ‘la nuova storia del cinema’. Al tempo stesso, non solo le teorie della rappresentazione, della sessualità e del soggetto non hanno saputo fornire gli strumenti per aiutarci a parlare delle donne quali agenti sociali, ma lo strutturalismo, la cine-psicoanalisi e il post-strutturalismo hanno messo radicalmente in discussione il concetto stesso di autorialità. Forse è nel campo degli studi sulla ricezione che la ricerca femminista contribuisce in modo più significativo a una storiografia potenzialmente sensibile alle questioni di genere. Dunque il primo interrogativo è: che cosa significa aggiungere ‘le donne’ alla ‘storia del cinema’? Che tipo di rivendicazione facciamo quando ri-vendichiamo determinati film e determinate pratiche come ‘lavori di donne’? Di fatto, come fu subito indicato nel corso del primo incontro al National Film Theatre, i motivi del mancato riconoscimento del ruolo delle donne nella produzione cinematografica muta sono comuni anche a molti cineasti uomini. In primo luogo, nel periodo precedente la Prima guerra mondiale, i soli nomi che comparivano nella stampa di settore erano quelli delle case di produzione; gli specifici ruoli ricoperti nella realizzazione dei film non era34
no indicati. In secondo luogo, è stato solo in tempi relativamente recenti che la critica ha cominciato a rivolgere qualche attenzione a figure diverse da quelle del regista o dell’attore; mansioni come quelle di sceneggiatore, di montatore o di sound designer erano largamente ignorate, salvo nel caso in cui il loro ruolo fosse in qualche modo collegato a quello della regia. Perciò, perché la storia del cinema delle donne non abbia solo il senso di riempire dei vuoti all’interno di ricostruzioni largamente dominate da figure maschili, occorre confrontarsi con una questione più ampia e chiedersi che cosa significhi restituire visibilità a questi ruoli. In altri termini, occorre chiedersi in che modo una conoscenza più approfondita del lavoro delle donne nei campi della regia, della sceneggiatura, dell’ideazione, della promozione cinematografica possa cambiare la nostra cognizione della produzione filmica in generale e di conseguenza di come sia possibile costruire la storia del cinema. Una seconda questione riguarda più specificamente il ‘femminismo’ implicato in un approccio femminista alla storia del cinema delle donne. Durante il primo incontro al National Film Theatre, è emerso chiaramente che le carriere delle pioniere del cinema spesso non forniscono un materiale consono al desiderio femminista. Per esempio, la già citata Dinah Shurey, unica donna regista del cinema britannico degli anni Venti, pur avendo operato in un decennio fortemente pacifista, si era specializzata nella realizzazione di melodrammi patriottici a sfondo navale o militare, ciò che in qualche caso fu anche motivo di sorpresa per i recensori, come quando, a proposito del suo dramma navale Second to None, si parlò di una “spudorata esaltazione di fervore guerresco”. Nel suo commento, lo stesso critico scriveva: “Il primo film britannico realizzato con la supervisione di una donna è stato presentato la settimana scorsa a Londra. È strano: si tratta probabilmente della pellicola più militarista che io abbia mai visto”8. Rachael Low, che per la sua monumentale storia del cinema britannico ha intervistato molti pionieri del cinema9, mi ha detto, non senza una certa sorpresa per la mia domanda, che negli anni Dieci e Venti le donne non si consideravano affatto alla stregua di iniziatrici, né peraltro coltivavano ambizioni professionali in
2 / Pensare le donne nella storia del cinema / Christine Gledhill
alcun settore dell’industria, figuriamoci nel cinema. Del resto è vero che, in Gran Bretagna come altrove, la cinematografia fu all’inizio un ‘affare di famiglia’, nel quale le donne ricoprivano tutta una serie di funzioni di supporto, e ancora negli anni Venti sono frequenti i casi di coppie eterosessuali nelle quali il ruolo femminile era o pervasivo ma invisibile, o deliberatamente cancellato. Così Nerina Shute trova sostegno, per la sua tesi secondo cui la regia cinematografica non sarebbe cosa da donne, in un’intervista con la moglie di un noto attore-regista comico inglese, Walter Forde, la quale concordava che, se anche una donna poteva aiutare a trovare le idee, un’eventuale permanenza in un teatro di posa, con giornate lavorative di quindici ore, era fuori questione10. Risulta però che la signora Forde, con lo pseudonimo di Adeline Culley, lavorò nei film del marito non solo come montatrice, ma anche come aiuto regista. Come dobbiamo interpretare allora la sua risposta: un tradimento del proprio sesso? Lealtà fuori luogo verso il marito? O forse come un segno di relazioni sociali ancora non riconoscibili nel contesto sessualmente marcato della realizzazione cinematografica? Quale che sia la risposta, la nostra capacità di identificare la partecipazione delle donne alla produzione cinematografica dipenderà in larga misura da come sapremo andare al di là dei ruoli ufficialmente accreditati, per esplorare le relazioni e le pratiche interpersonali attraverso i quali i soggetti implicati nella realizzazione condividono e discutono, sviluppano e trasformano le loro idee, sia nella dimensione formale del teatro di posa o dell’ufficio, sia in quella informale dello spazio domestico o privato. A questo scopo sarà necessario individuare nuovi percorsi di ricerca biografica, nuove fonti su cui lavorare e nuovi interrogativi. Abbiamo dunque bisogno, al di là delle fonti cinematografiche tradizionali, di nuovi documenti e nuovi indizi. Per esempio, durante l’appuntamento londinese già più volte citato, è stato osservato come il fatto di entrare in contatto con gli eredi delle cineaste che sono oggetto della nostra attenzione – i quali possono a volte conservare materiali importanti come lettere e diari, quaderni di appunti e fotografie – possa essere di grande aiuto per ricostruire il loro operato. Ma abbiamo bisogno anche di
altri approcci, che tengano conto sia della memoria immagazzinata in quei materiali, sia dei processi della storia orale, e siano sensibili alle sfumature, consapevoli non solo della frammentarietà e della lacunosità della memoria, ma anche del fatto che il tradizionale disinteresse storico e critico conduce spesso le donne a sottovalutare l’importanza dei loro ricordi. E se riconosciamo che tanto i ricordi che i materiali personali sono di fatto plasmati da relazione sociali, culturali, e dunque di genere, di cui non viene conservata traccia nei documenti pubblici, dobbiamo anche tener conto di quelle forme più intime di relazione attraverso le quali le donne partecipano attivamente ai processi di realizzazione di film ufficialmente attribuiti a soggetti maschili. Potremmo addirittura arrivare a scoprire che, mentre le categorie di genere sono state determinanti nella definizione delle priorità della storia del cinema, una volta recuperata, l’attività delle donne smette di essere rilevante unicamente in termini di genere. Come già suggerito in precedenza, ciò può tradursi in primo luogo in una diversa concezione delle pratiche lavorative e delle dinamiche interpersonali che intervengono nel processo della realizzazione filmica.
Secondo seminario. Storia del cinema delle donne britanniche e irlandesi o storia del cinema delle donne in Gran Bretagna e Irlanda? Accanto al problema di chiedersi che cosa accade quando all’espressione ‘storia del cinema’ si aggiunge la declinazione ‘delle donne’, un ulteriore, spinoso problema sorge con gli aggettivi ‘britannico’ e ‘irlandese’. Poiché aggiungere ‘britannico’ o ‘irlandese’ a ‘storia del cinema delle donne’ è una limitazione decisiva, si viene a creare una barriera tra le cineaste attive in questi paesi e quelle operanti in altri paesi, come pure tra le studiose e gli studiosi britannici e irlandesi e coloro che lavorano su altri contesti nazionali. Per certi versi, la storia britannica del cinema delle donne condivide alcuni dei problemi che sono in genere associati alla ‘britannicità’ del cinema britannico – per esempio il fatto che sia stato incapace di raggiungere i valori produttivi di 35
Hollywood nell’ambito dei generi più popolari, o di produrre le eccellenze stilistiche del cinema d’autore europeo nelle sue diverse espressioni, che in certi casi fu all’origine di aspettative (e quindi di finanziamenti), in grado di favorire l’attività cinematografica delle donne. Allo stesso modo, il termine ‘britannico’, così come l’elisione che subisce nella sua frequente sostituzione con ‘inglese’, ignora o comunque approssima le distinzioni che caratterizzano la condizione delle donne nelle diverse regioni – la Scozia, il Galles, l’Irlanda del Nord e la separata, ma non certo scollegata in termini storici, Irlanda. Ma assai più decisivo è il fatto che le storie del cinema delle donne britanniche e irlandesi condividono gli stessi problemi di identità nazionale che caratterizzano qualsiasi cinematografia e che derivano dalla vocazione profondamente internazionale del cinema, inteso sia come medium, sia come istituzione. Di conseguenza, il concetto di ‘nazionalità’ come fondamento originario sta oggi subendo una critica simile a quella già subita da quello di autorialità. Il problema in questo caso non è più quello della demarcazione di genere tra lavoratori e lavoratrici del cinema, ma quello di una serie predeterminata di frontiere nazionali che occultano la realtà delle migrazioni e dei movimenti di personale e capitali attraverso i vari confini e che ignorano sia la vocazione internazionale del primo cinema e la rapidità con la quale si diffuse in tutto il globo, sia l’attuale, sempre crescente ricorso alle coproduzioni internazionali. Si pensi, per quanto riguarda il cinema muto, allo straordinario viavai da una sponda all’altra dell’Atlantico dell’americana Florence Turner, che, tra vari tentativi di risollevare la propria carriera in patria, tentò almeno due volte di ‘sfondare’ professionalmente, e come attrice e come produttrice, nel Regno Unito. In tempi più recenti, si può pensare ai film crossover di Sally Potter Orlando (1992) e Yes (2005), che offrono un esempio di collaborazioni complesse e intricate tra maestranze, fonti di finanziamento e produttori di diverse nazioni. Ciò indica, come minimo, che le fonti documentali sono sparpagliate tra differenti territori nazionali, e ciò non solo a causa del nomadismo dei cineasti, ma anche per via della circolazione internazionale dei film e dei modi va36
riegati in cui da sempre vengono commercializzati i prodotti legati ai film. Come le curatrici del Women Film Pioneers Sourcebook hanno scoperto al momento di assegnare le voci da coprire in ognuno dei due volumi, le carriere di queste cineaste internazionali possono essere portate alla luce solo per mezzo di una ricerca condotta in modo collaborativo da ricercatori di vari paesi e di una condivisione delle conoscenze attraverso le frontiere nazionali. Tuttavia, il riconoscimento degli intrecci e delle relazioni transnazionali che interessarono le cineaste attive in Gran Bretagna e Irlanda – per quanto forse percentualmente meno rilevanti di quelle riscontrabili nel caso del loro colleghi uomini – non deve far dimenticare gli specifici contesti sociali, culturali ed economici nei quali esse si trovarono a operare, e nei quali la differenza di genere ebbe certamente a giocare un ruolo assai peculiare. Di conseguenza, per cogliere questo doppio aspetto dell’esperienza professionale delle cineaste di cui ci occupiamo e al
Sonya Levien
2 / Pensare le donne nella storia del cinema / Christine Gledhill
tempo stesso per favorire la collaborazione internazionale tra i ricercatori, di recente abbiamo deciso di modificare la nostra prospettiva e quindi il titolo del progetto da ‘British Women’s Film History’ a ‘Women’s Film History International’: UK/Ireland’, nel tentativo di sottolineare tanto la partecipazione di questo progetto ‘nazionale’ a una più vasta iniziativa internazionale, quanto la possibilità di includere nella ricerca anche le donne straniere che giunsero dall’estero per lavorare in Gran Bretagna e in Irlanda, come pure le donne britanniche e irlandesi che furono attive professionalmente al di fuori dei propri paesi. Pensiamo che estendere la nostra concezione della storia del cinema delle donne dalla storia nazionale alla storia mondiale significhi concepire la possibilità di una storia comparata che consenta di mettere in luce le diverse modalità in cui la differenza di genere agisce nei vari contesti culturali nazionali o regionali.
Terzo seminario. La storia del cinema delle donne riguarda soltanto i film? L’ultimo degli elementi rilevanti per la costruzione di una storia del cinema delle donne in Gran Bretagna e Irlanda è il ‘film’ stesso, considerato in tutti i suoi aspetti transdisciplinari e transmediali. Sia in Gran Bretagna che in Irlanda, l’industria cinematografica è sempre stata in qualche modo collegata alla produzione letteraria, ovvero all’industria editoriale e al teatro. L’atteggiamento relativamente meno ostile nei confronti delle donne che prevaleva in questi ambiti ha in parte facilitato l’inserimento di alcune di loro nel contesto della produzione cinematografica e, in seguito, audiovisiva. Di conseguenza, l’identificazione dei percorsi delle donne nel mondo del cinema passa anche attraverso altri campi più o meno limitrofi: la ricerca degli storici del cinema deve entrare in contatto con la storia letteraria e con la storia delle pratiche editoriali, affrontando i problemi che sorgono nel momento in cui le premesse teoriche e le fonti specifiche di queste discipline vengono a interagire con quelle della storia delle donne e della teoria femminista del cinema. Inoltre, i nessi, generalmente trascurati, tra le industrie dell’editoria, del cinema, della radio e della
televisione (e, più di recente, dei nuovi media), nonché il nuovo fenomeno della convergenza mediale, rendono oggi sempre più problematica la pretesa di occuparsi di storia del cinema tout court. Benché il nostro scopo non sia e non possa essere quello di esaurire un oggetto così complesso come quello rappresentato dalla storia delle donne in tutte le diverse espressioni della produzione culturale e mediale, siamo però consapevoli della necessità di tener conto dell’esistenza di questo genere di relazioni transculturali e transmediali, come pure delle nuove possibilità di iniziativa e partecipazione femminile che potrebbero emergere grazie ai processi di digitalizzazione e di convergenza mediale.
Quarto seminario. In conclusione, quali scenari per il futuro? Un ultimo gruppo di problemi riguarda quello che è senza dubbio il compito più arduo: il tentativo di convertire tutti questi discorsi teorici in strategie pragmatiche volte a produrre le risorse digitali e di rete che possano supportare il lavoro di ricerca e contribuire allo sviluppo futuro della storia del cinema delle donne. Un’importante questione preliminare riguarda le modalità attraverso le quali fare interagire le banche dati e le fonti già esistenti e come tentare di rendere produttive ai fini della costruzione della storia del cinema delle donne fonti che appaiono insensibili alla differenza di genere, tracciando nuovi percorsi anche attraverso questi materiali. Allo stesso modo, pur senza voler produrre un’inutile duplicazione di cataloghi e banche dati, occorre però tener conto che un numero crescente di progetti nel campo della storia del cinema delle donne sta producendo tutto un nuovo bagaglio di conoscenze che necessita sia di un luogo proprio, sia più in generale di forme di connessione con il più vasto insieme rappresentato dagli archivi e dalle collezioni di tutto il mondo. In ogni modo, le definizioni di archivio e di catalogo rimandano a oggetti discreti, in grado di fornire una documentazione limitata. La digitalizzazione sia dei prodotti mediali sia dei documenti tradizionali permette tuttavia di prevedere una modificazione 37
sostanziale della natura stessa degli archivi, che già ora si confrontano con una pletora di accezioni in costante trasformazione, sollevando interrogativi su come la storia del cinema verrà pensata in futuro e come cambieranno non solo i suoi metodi ma anche i suoi oggetti. Per esempio, in questo momento la British Library ha in corso una sperimentazione sulle nuove modalità di archiviazione dei blog e della posta elettronica, ovvero di tutte quelle nuove forme di comunicazione che stanno prendendo il posto delle lettere e degli appunti e che diventeranno un materiale imprescindibile per i futuri ricercatori. È chiaro dunque che se vogliamo creare una rete capace di collegare i vari progetti di storia del cinema delle donne che sorgono in tutto mondo, situati localmente ma proiettati su scala transnazionale, abbiamo bisogno di una tecnologia digitale in grado di dar conto di tutte le diverse modalità attraverso le quali le donne hanno partecipato e partecipano alla produzione cinematografica (molte delle quali esulano dai ruoli industriali tradizionali) e di tenere il passo dei nuovi sviluppi tecnologici e metodologici che possono favorire l’interazione tra i vari progetti nazionali. In questo contributo ho tentato di elencare alcune delle questioni che abbiamo dovuto affrontare per ripensare la storia del cinema delle donne a partire dalla Gran Bretagna e per dar vita a un progetto che, se da un lato, dal punto di vista teorico, si colloca nell’ambito della storiografia femminista, dall’altro è culturalmente localizzato nelle specifiche storie sociali e nei contesti industriali della Gran Bretagna e dell’Irlanda, ma che non di meno aspira a dar conto sia dei processi transculturali della produzione cinematografica, sia dei nessi sempre più complessi che legano politica sessuale, differenza di genere e femminismo nel ventunesimo secolo. Traduzione dall’inglese di Marco Grosoli
38
Note Pur avendo convocato il ‘Women’s Film History Project: UK/ Ireland’, tengo a precisare che il presente saggio illustra unicamente la mia accezione personale dei propositi del gruppo e non è necessariamente indicativo delle opinioni degli altri membri dell’associazione.
1
Utrecht 1999, Santa Cruz 2002, Montreal 2004, Guadalajara 2006, Stockholm 2008. Gli atti di questi convegni sono stati in parte pubblicati nei seguenti volumi: Jennifer M. Bean e Diane Negra (a cura di), A Feminist Reader in Early Cinema, Duke University Press, Durham-London 2002; Rosanna Maule e Catherine Russell (a cura di), Cinephilia and Women’s Cinema in the 1920s, numero monografico di “Framework”, n. 1, 2005; Rosanna Maule (a cura di), Femmes et cinéma muet, numero monografico di “Cinémas”, n. 1, 2005.
2
Cfr. il mio Reframing British Cinema 1918-1928: Between Restraint and Passion, BFI, London 2003.
3
4
“Film Weekly”, 10 giugno 1929, p. 12.
Si veda in proposito il mio studio Reframing Women in British Cinema: the Case of Violet Hopson and Dinah Shurey, in “Journal of British Film and Television”, n. 1, 2007, pp. 1-17. 5
6 Jane Gaines e Rada Vatsal (a cura di), Women Film Pioneers Sourcebook, vol. I: United States and Latin America, e Jane Gaines e Monica Dall’Asta, Women Film Pioneers Sourcebook, vol. II: Europe, Asia, Canada, Australia and Middle East, University of Illinois Press, Chicago, in corso di pubblicazione. 7
http://womenandsilentbritishcinema.wordpress.com
“The Yorkshire Post”, 30 novembre 1926 (fondo Sidney Carroll, BFI Special Collections).
8
Rachael Low, History of British Film, 7 voll., Routledge, London 1997.
9
10
“Film Weekly”, 10 giugno 1929, p. 12.
3 / Elda Guerra
Oltre i confini Il movimento delle donne tra Otto e Novecento e l’affermazione di una nuova soggettività
Nelle pagine che seguono, tenterò di delineare il profilo del paesaggio storico in cui si mossero le prime cineaste italiane, le particolari ‘pioniere’ cui è dedicato questo volume, proponendone una lettura attraverso l’esperienza dell’appartenenza di genere. Il paesaggio al quale mi riferisco è quello della ‘modernità’, o meglio, dei processi di modernizzazione nelle forme che assunsero limitatamente alla parte occidentale del mondo – Europa e Stati Uniti d’America – tra Otto e Novecento: un paesaggio segnato dalla seconda fase dell’industrializzazione, dalle innovazioni tecnologiche, da una grande rivoluzione nelle comunicazioni, dall’intensificarsi dei processi di urbanizzazione e dalla nascita delle metropoli moderne, da intensi movimenti sociali e politici e dal delinearsi, certamente in modo ancora parziale, della società dei consumi e di quel fenomeno socialmente nuovo che verrà definito tempo libero. È il contesto dell’incipiente affermazione della società di massa, periodo di espansione e di fiducia nel progresso, che celebrava i suoi trionfi nelle grandi esposizioni universali: un contesto il cui rovescio era costituito dal dominio coloniale, dalle guerre che punteggiavano le diverse parti del globo, dalle tensioni indotte da una ‘questione sociale’ che andava assumendo contorni sempre più netti. Ma anche
un’altra forma di conflitto segnava fortemente quel paesaggio in mutamento, provocando diffusi allarmi sociali: era il conflitto fra i generi. Per disegnarne i contorni inizierò con la descrizione di due scene. La prima si svolge a Londra alla vigilia del nuovo secolo, nel luglio del 1899. Nelle sale della Westminster Town Hall, al centro della città, si trovano riunite alcune centinaia di signore, nobili e borghesi, appartenenti a quei ceti medi già destinati a divenire una delle articolazioni sociali portanti della società novecentesca. Sono in tante e diverse, provenienti da molti paesi d’Europa, dalle Americhe, dai domini coloniali britannici, dalla Cina, dalla Palestina e da altre parti del mondo, giunte a Londra per partecipare al quinto congresso dell’associazione internazionale di donne denominata International Council of Women, che riunisce gruppi e associazioni nati per sostenere gli interessi femminili e divenuti sempre più numerosi nel corso degli ultimi decenni dell’Ottocento1. Il congresso si articolò in diverse sessioni, ma qui prenderò in considerazione solo quelle dedicate alla presenza delle donne nella politica e nelle professioni. I lavori su “Women and Politics” furono aperti dalla relazione della rappresentante statunitense, Susan B. Anthony, un’autentica ‘pioniera’, come allora si 39
educare ed istruire i maschi [...]. Cinquant’anni fa nessuna occupazione era aperta per le donne tranne che cucinare, cucire, insegnare e lavorare in fabbrica. Pochissime donne erano sufficientemente istruite per insegnare, ma quelle che erano in grado di farlo ricevevano da quattro a otto dollari al mese con vitto e alloggio, quando gli uomini per lo stesso servizio ricevevano trenta dollari al mese. Una donna doveva sposarsi anche senza amore per sopravvivere, o sottoporsi ad una vita di dura dipendenza, vivendo, dopo la morte dei genitori, nella casa di un fratello o di una sorella sposati. […] Una donna che tentasse la sfida della lettere era quasi messa al bando. [...] In quel tempo una donna non poteva coltivare, nemmeno dentro di sé, un sogno come quello di entrare nelle professioni legate alla legge, alla medicina, alla teologia. [...] Ora, al compimento di mezzo secolo, troviamo che, con poche eccezioni, tutte le richieste che erano state formulate sono state riconosciute. La grande eccezione è costituita dai diritti politici e contro questo unico punto sono ora dirette tutte le artiglierie dello scorno, del dileggio, della denuncia che precedentemente avevano indirizzato il loro fuoco contro tutta la linea3.
Susan B. Anthony (in piedi) con Elizabeth Cady Stanton, in una foto del primi del Novecento (Library of Congress)
definivano le iniziatrici del movimento per i diritti delle donne. In quella sede, l’anziana suffragista, quasi ottantenne, aprì il suo discorso richiamando il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione di Seneca Falls del 18482: Cinquant’anni fa, negli Stati Uniti, la donna era priva di un’individualità riconosciuta in ogni aspetto della vita. Nulla era previsto per la sua istruzione nelle scuole pubbliche e private, al di là dei livelli elementari. Una donna istruita era una rarità ed era guardata con meraviglia. In quei giorni, nella famiglia, le donne erano tenute rigorosamente nell’ambito domestico, a cardare, filare e tessere, a fare il burro e il formaggio, a lavorare a maglia e cucire, lavorando giorno e notte, progettando e facendo economia per 40
Era un discorso forse eccessivamente ottimista, se pure limitato dalla sottolineatura della grande ombra rappresentata dalla mancanza di diritti politici, questione che, insieme ad altri divieti e preclusioni, sarebbe stata al centro dell’impegno dei movimenti delle donne per tutto il primo decennio del Novecento. Tuttavia le parole di Anthony, certamente legate al clima di un grande congresso internazionale e allo spirito con cui si inaugurava il nuovo secolo, coglievano un movimento sociale di cambiamento culturale e simbolico di grande potenza. Erano infatti in atto forzature ed erosioni dei confini esistenti tra le costruzioni sociali del maschile e del femminile, così come si erano andati definendo nel discorso dominante lungo l’Ottocento: era un processo dagli aspetti molteplici, tra i quali il più evidente era costituito dalla crescita della presenza di donne delle classi medie nell’istruzione e di conseguenza dall’apertura di nuove opportunità professionali, con cui molte si misuravano.
3 / Oltre i confini / Elda Guerra
Trasferendo lo sguardo in un’altra sala del congresso, nella sessione dedicata alle donne nelle professioni, ci troviamo infatti in un luogo assai affollato. La curatrice degli atti ci informa che il numero delle comunicazioni era andato assai oltre quello previsto, che la sessione aveva dovuto sdoppiarsi, ma che malgrado questo sforzo organizzativo importanti temi non avevano trovato spazio: i gruppi di lavoro riguardavano, come ci si poteva aspettare, l’ampio settore dell’educazione e dell’insegnamento e le attività di carattere sociale, ma accanto a questi, altri gruppi riguardavano la presenza delle donne negli ambiti della medicina, della legge, delle discipline scientifiche, del giornalismo, della letteratura, delle nuove mansioni impiegatizie4. Questo primo giro d’orizzonte su quella sessione del congresso, rimanda alla seconda scena che traggo dal bel libro di Valeria Babini e Luisa Lama, Una ‘donna nuova’. Il femminismo scientifico di Maria Montessori. New York 3 dicembre 1913. Il piroscafo Cincinnati attracca alla banchina della trentatreesima di South Brooklyn e scarica una folla di immigrati [...]. Molti di loro vengono dall’Italia: sono uomini donne e bambini che hanno lasciato dietro a sé un difficile presente […]. Pochi metri più in là, all’improvviso, compare ai piedi della scaletta per i passeggeri di riguardo una lunga striscia rossa sulla quale si vede avanzare una figura di donna imponente e risoluta [...]. Le sue braccia sono libere da qualsiasi bagaglio; solo le mani stringono alcune piccole scatole che contengono il suo tesoro: sono spezzoni di film, ultimo ritrovato della scienza mediatica, nei quali sono impresse immagini di fanciulli speciali, quelli educati nella sua Casa dei bambini del quartiere S. Lorenzo di Roma5.
La casa di cui si parla era la scuola-asilo del popolare quartiere romano, in cui i nuovi metodi pedagogici si intrecciavano a un progetto di emancipazione sociale dei bambini e delle famiglie dei luoghi urbani più disagiati e l’immagine descritta ci rimanda quella di una ‘donna nuova’, che porta con sé i risultati del suo impegno professionale e di studio. Il riferimento non è casuale, dal momento che la stessa Maria Montessori fu presente al congresso
londinese del 1899, dove, all’interno della sessione sull’educazione, affrontò tra l’altro il problema delle scuole rurali e della disparità salariale tra maestri e maestre6. Il nuovo secolo si apre, dunque, sull’onda di movimenti convergenti che avevano la loro origine nel desiderio di tante di uscire dai confini stretti delle loro vite, come si legge in una delle prime storie del movimento politico delle donne, pubblicata nel 19287. La modernità che si andava affacciando aveva posto il problema del riconoscimento dell’individualità e la tensione tra le soggettività singole e i modelli dominanti delle costruzioni sociali di genere era divenuta, nello scenario della modernizzazione, dirompente. Per usare le parole di Anna Rossi-Doria, uno degli elementi caratterizzanti la storia politica delle donne in età contemporanea è infatti rappresentato “dagli ostacoli frapposti all’affermazione di una individualità delle donne e, da parte loro, dei difficili sforzi per costruirla”8. Non posso qui esaminare le diverse articolazioni che assunse in quel torno di secolo questa tensione tra genere e individualità, tra la spinta a vedere riconosciute pienamente le proprie capacità di espressione e quella di accentuare e mantenere una differenza che non significasse inferiorità, in un gender system segnato dall’asimmetria e dal maschile come valore dominante. Ciò che mi interessa sottolineare è l’intreccio di un duplice processo: da una parte l’azione politica consapevole di un movimento delle donne sempre più forte e risonante, che costruisce nuove e diverse rappresentazioni e pone al centro il superamento di ostacoli legislativi, culturali e simbolici; dall’altra l’apertura assai complessa e differenziata dei percorsi di istruzione e la nascita di nuovi campi professionali legati alle trasformazioni degli stati e delle economie. Ma come si configuravano questi percorsi? Costituivano davvero una sorta di marcia trionfante e inarrestabile, come la stampa del tempo, con malcelato timore, talvolta li rappresenta, o erano piuttosto complicati, interstiziali, differenti a seconda degli ambiti e delle professioni? Prendo alcuni esempi dal caso italiano dove, come in altri paesi, ingresso nelle professioni e presenza di un movimento delle donne costituivano due 41
aspetti fortemente correlati. In un saggio recente, Simonetta Soldani rileva le contraddizioni presenti nell’architettura del Codice civile varato nel 1865 nella cornice del nuovo stato nazionale, un Codice dove affermazioni di principio sulla pari dignità di tutti “i regnicoli”, si accompagnavano a significative eccezioni relative alle donne, in particolare alla “donna maritata”: dalla obbligata acquisizione della cittadinanza del marito, alla norma che istituiva l’obbligo della “autorizzazione maritale”. Erano eccezioni che proiettavano il loro cono d’ombra sull’intero genere femminile che inoltre, con la legge elettorale amministrativa, sempre del 1865, rimaneva escluso dall’esercizio dei diritti politici ed assimilato ad analfabeti, interdetti, falliti, detenuti. Quello che vediamo riemergere anche al di là delle colonne d’Ercole segnate dalla condizione di moglie e di madre, è l’inserimento delle donne in un corteggio di figure dimidiate, inaffidabili, per diverse ragioni sotto tutela […]. Sacrificata a preoccupazioni patrimoniali e genealogiche di antica data, l’immagine di donna disegnata dalla legislazione risultava oltre che biologicamente e consuetudinariamente estranea alla sfera dei diritti politici, ammissibile solo con molte cautele all’effettività dei diritti civili, e di fatto inabile a ricoprire qualsiasi ruolo pubblico che richiedesse autonomia di analisi, di giudizio, di scelta9.
In questo quadro legislativo l’accesso a professioni che presupponevano la piena capacità giuridica diveniva davvero un percorso in salita e di fatto impossibile. Tuttavia non mancano le incrinature. La prima riguarda la legge per l’istruzione obbligatoria, che inaugurò un nuovo campo professionale: quello delle maestre, la scuola dell’alfabeto. La connotazione di genere in questo caso non subiva colpi mortali, era un lavoro appropriato, che però, intrecciandosi con le spinte della soggettività femminile, produsse mutamenti significativi. Precocemente, inoltre, in Italia le facoltà universitarie vennero aperte alle donne (1876), anche se questo provvedimento rimase sul piano formale, fino a quando, dopo circa un decennio, non venne consentito l’ingresso anche nei percorsi d’istruzione superiore, compresi i licei classici. Non si trattò di una scelta consapevole volta a favorire l’emancipazione femminile, anzi il nesso in42
scindibile tra istruzione e uscita da una condizione di minorità sociale e politica rimase opaco. L’apertura fu dovuta piuttosto alle caratteristiche specifiche del sistema d’istruzione, ma anche in questo caso si produsse un’incrinatura degli ostacoli culturali e simbolici che si frapponevano alla possibilità di crescita professionale delle donne, in un paese peraltro povero, segnato da profondi squilibri sociali e territoriali e dalla presenza ancora assai fragile delle classi medie. In particolare, l’apertura delle facoltà universitarie, i cui effetti rimasero assai limitati sul piano quantitativo, favorì le strategie messe in atto da alcune ‘pioniere’ per sfuggire a un’emarginazione resa apparentemente insuperabile dalle leggi non scritte della consuetudine10. L’Italia divenne così una delle destinazioni di quel particolare ‘nomadismo’ femminile esercitato da chi aveva una forte motivazione e condizioni sociali tali da consentire la ricerca di luoghi dove fosse possibile ottenere una laurea. Da questo punto di vista, emblematica è la vicenda di Anna Kuliscioff. Appartenente a quel consistente gruppo di giovani donne russe che in Francia, in Svizzera e anche in Italia, cercarono diverse opportunità, divenuta nomade per passione politica e intellettuale, Anna Kuliscioff si laureò in Medicina a Napoli, poi esercitò la professione a Milano in un ambulatorio per i poveri, seguendo un percorso simile a quello della sua coetanea Aletta Jacobs, fondatrice del movimento delle donne in Olanda. Altre seguirono percorsi più interstiziali: come la stessa Montessori, con la sua laurea in Medicina e il conseguimento della libera docenza in Antropologia, o Giuseppina Cattani laureata in Medicina nell’ateneo bolognese, prima donna ad avere conseguito la libera docenza in Patologia generale e docente, per un periodo della sua vita, nello stesso ateneo. Ma se l’accesso a Medicina appare, per diverse ragioni, meno ‘resistente’, è da notare come a livello europeo sia proprio un’italiana – Emma Strada – la prima donna a ottenere la laurea in Ingegneria, un ambito particolarmente difficile, oggettivamente e anche soggettivamente, rispetto alla presenza femminile11. E ancora molto italiano, per le sue contraddizioni, è il caso di Lidia Poët. Grazie all’apertura delle facoltà universitarie, questa giovane piemon-
3 / Oltre i confini / Elda Guerra
Anna Kuliscioff
tese giunse brillantemente al conseguimento della laurea in Legge all’Università di Torino, ma le fu poi interdetto l’esercizio dell’avvocatura, in nome della soglia, così a lungo invalicabile per un corpo sessuato femminile, costituita dalla legge in tutti suoi aspetti, dall’elaborazione nei parlamenti, all’applicazione nei tribunali12. Accanto a quello dell’istruzione, un altro campo che fu oggetto di importanti provvedimenti legislativi per l’ammissione delle donne – non solo in Italia – fu quello delle nuove comunicazioni: caso classico di una nuova tecnologia in cui le donne trovano spazio, ma con una serie ben precisa di limiti. Telegrafiste e poi telefoniste, divennero figure tipiche del tempo, frequentemente fotografate dalla stampa e rappresentate nella letteratura: esemplare a questo proposito è il testo di Matilde Serao Telegrafi dello Stato13. L’ampiezza delle rap-
presentazioni non nasconde, tuttavia, il rovescio di questo nuovo destino lavorativo, legato a un regolamento assai rigido che prevedeva come requisiti di ammissibilità il nubilato o la vedovanza, sanciva paghe inferiori e confinava le donne alle mansioni più basse, là dove erano richieste doti di relazione e di pazienza. A uno sguardo di più lungo periodo, telegrafiste e telefoniste appaiono come le antenate di una figura che sempre più rilievo avrebbe avuto nel Novecento: quella dell’impiegata, anche qui con tutti i limiti e le contraddizioni di uno status non completamente conseguito14. Il moltiplicarsi di queste figure, a cui dobbiamo aggiungere le commesse, legate alla nuova estensione dei consumi e all’apertura dei grandi magazzini, le molteplici professioni legate all’assistenza, ai nascenti sistemi di welfare e ai nuovi compiti degli stati nazionali, ci mostra dunque un processo che definirei di erosione dei confini, piuttosto che di rottura netta del gender system: un’erosione che comporta una lenta crescita della presenza femminile nei nuovi campi professionali legati alla modernizzazione. Infatti, un percorso di istruzione poteva adesso essere seguito, un salario – per quanto inferiore – veniva guadagnato e un passo verso l’indipendenza economica era, a conti fatti, compiuto. Virginia Woolf, salutando con gioia l’anniversario del Sex Disqualification Removal Act del 1919, che apriva alle donne inglesi tutte le professioni liberali, ne esprime in modo straordinario il significato per le ‘sorelle’ degli uomini colti: Le pareti domestiche finalmente si aprivano; in ogni borsellino brillava, o avrebbe potuto brillare, una bella moneta da sei penny alla cui luce ogni pensiero, ogni oggetto, ogni azione apparivano diversi. Vent’anni non sono molti e una moneta da sei penny non rappresenta una cifra cospicua; è troppo presto per trovare nelle biografie l’immagine della vita e dei pensieri di questa donna ora in possesso di una moneta da sei penny tutta sua. Possiamo però cercare di vederla con la fantasia, mentre esce dall’ombra delle pareti domestiche e, ritta sul ponte che unisce il vecchio con il nuovo mondo, si chiede rigirando tra le mani la sacra moneta: “Cosa ne farò? Cosa ci vedrò?” alla sua luce possiamo immaginare che tutto le apparisse diverso: gli uomini, le donne, le automobili, le chiese15. 43
Ma accanto a quelle indicate, altre ancora – nello scenario di inizio secolo – sono le occasioni di esercitare professioni nuove e meno strutturate nelle quali l’incertezza dei confini consente, almeno in una prima fase, una rilevante presenza femminile: tra queste la letteratura e il giornalismo. Cresce un pubblico femminile alfabetizzato e si moltiplicano le testate rivolte alle donne. In Italia sono circa una ventina i periodici femminili, assai diversi tra loro, che forniscono occasioni di lavoro a giornaliste, vignettiste, disegnatrici, fotografe. Il mondo nascente della comunicazione e della cultura di massa vede un’articolata presenza di figure, mestieri, professioni. In questi giornali il cinema conquista precocemente un suo spazio: per citare un solo esempio, molti numeri di “La Donna”, supplemento femminile illustrato della “Stampa” e della “Tribuna”, dedicano al cinema una serie di rubriche, con l’intento di esplorare non solo il mondo delle dive, ma tutto quanto opera nell’insieme della scena cinematografica16. Infine le donne diventano destinatarie di messaggi pubblicitari: nasce, insomma, la figura della consumatrice. Scorrendo le pubblicità dell’epoca, accanto ai messaggi legati a una più tranquillizzante figura di consumatrice all’interno dell’ambito domestico e del governo della casa, troviamo associazioni meno prevedibili che rimandano ad altri superamenti di confine, ad altre pioniere, come le viaggiatrici: la bicicletta, la macchina fotografica, l’automobile. Al 1910, ad esempio, risale un manifesto pubblicitario della Kodak nel quale campeggia, sullo sfondo di un paesaggio marino profilato da bianche scogliere, l’immagine di una giovane donna, con un vestito a righe bianche e blu e una macchina fotografica in mano, accompagnata dalla scritta “take a Kodak with you”. È la Kodak Girl, rappresentazione iconica destinata a conoscere una larga diffusione in molteplici forme (dalla cartolina, all’inserto pubblicitario)17. È degli anni post-bellici, invece, il messaggio pubblicitario della Ford T che invita le donne a godere della libertà legata alla guida di un’auto. In questo caso una figura di giovane donna in pantaloni sorride in mezzo a una natura lussureggiante da cui emerge il nero dell’automo44
La Kodak Girl in un’immagine pubblicitaria del 1910
bile, con la scritta: “To own a Ford is to be free to venture into new and untried places. It is to answer every challenge of Nature [...], safely, surely, and without fatigue”18. Tra Otto e Novecento, questo variegato mondo femminile che cresce nel contesto dei processi di modernizzazione e, almeno in parte, cerca la modernità di una piena espressione individuale, viene riassunto nella figura della ‘donna nuova’, al tempo stesso oggetto e soggetto di discorso. La ‘donna nuova’ è una codificazione di genere cui vengono attribuiti molteplici significati, ma in essa è possibile rintracciare anche un processo di autodefinizione da parte di donne che avvertivano in se stesse, nella loro biografia, il desiderio di un riconoscimento diverso da quello attribuito ai ruo-
3 / Oltre i confini / Elda Guerra
li femminili tradizionali19. Così Paola Baronchelli Grosson, giornalista e scrittrice, definisce questa difficile transizione:
della cultura di massa, mentre al maschile verrebbe mantenuta la prerogativa del fare e del produrre cultura alta.
Noi donne di questo secolo abbiamo sofferto di più perché ci è toccato fare le equilibriste, perché nel mentre ci si concedevano i doveri della cittadina, della contribuente, della professionista, della lavoratrice, non ci si concedevano i diritti relativi, tenendoci così librate tra due forze contrapposte20.
In questo trascinamento prende forma e si rafforza la contrapposizione tra arte alta, modernista (maschile) e arte bassa artigianale, oppure legata ai generi – ritratti, interni, ecc. – (femminile), in parte responsabile dell’oblio caduto sulle artiste novecentesche e sul loro lavoro. Insomma, nel passaggio dal XIX al XX secolo, il discorso politico, sociale, psicologico ed estetico ha attribuito un genere alla cultura di massa associandola insistentemente al femminile, mentre la vera, autentica alta cultura – tradizionale o moderna che fosse – restava indiscussa prerogativa maschile23.
O si vedano ancora le parole di Sibilla Aleramo, per molti aspetti incarnazione di questa donna nuova: Gli uomini ebbero in questo secolo a trasformare solo le idee, mentre le donne dovettero modificare l’indirizzo totale della propria esistenza, facendo d’un sol tratto quel cammino che i primi avevano percorso lentamente e faticosamente sin dagli inizi della civiltà21.
Forti erano dunque la contraddizione e l’asincronia tra le cornici legislative, giuridiche, di costume che ancora permanevano e i processi di trasformazione sociale e mutamento individuale. Trasformazioni così profonde, inoltre, non avvenivano in termini progressivi e lineari. I percorsi erano complicati e contemporaneamente scienziati, pensatori, con strumenti resi più acuti dagli stessi progressi della scienza, elaboravano antichi e nuovi discorsi sui confini tra i sessi, su differenze concepite come inferiorità, cercando legittimazione nella biologia e nelle teorie sulle razze che le nuove scienze positive andavano costruendo. Alla crisi delle costruzioni sociali e culturali intorno al genere femminile, si accompagnava poi la crisi di valori maschili che si sentivano minacciati e ai quali gli anni a venire avrebbero dato risposte inquietanti, con l’affermazione dei miti virili e delle culture fasciste22. Acutamente, Antonia Trasforini sottolinea un’altra contraddizione, più interna ai processi artistici e culturali. Tale contraddizione si manifesterebbe in una sorta di separazione, nella modernità, tra le donne e le nuove forme del discorso sull’arte. Dentro al moderno si opererebbe, infatti, un trascinamento delle opposizioni binarie per il quale al femminile sarebbe riservata l’azione del consumare propria
La guerra mondiale irruppe su questo mondo in cambiamento. A essa le pioniere che avevano costruito i movimenti politici delle donne diedero risposte diverse: posizioni di prudenza si alternarono all’accettazione del richiamo patriottico, ad adesioni convinte, soprattutto di singole, a posizioni nettamente pacifiste e a tentativi di scongiurare una guerra considerata fin dal luglio del 1914 “un disastro che non avrebbe avuto paragoni”24. Il significato per le donne e per la storia delle relazioni di genere della Prima guerra mondiale appare difficile da definire: le prime interpretazioni che sottolineavano la funzione emancipatrice della guerra hanno di recente ceduto il passo a visioni più complesse dell’esperienza femminile25. Certamente l’immediato dopoguerra fu caratterizzato da un’estensione dei diritti civili, sociali e politici delle donne: il voto si affermò in molti paesi e vennero varate leggi tendenti all’equiparazione, in termini di capacità giuridica, tra donne e uomini, a eliminare barriere e discriminazioni. Dai governi questi risultati furono spesso attribuiti a una sorta di ricompensa per il contributo femminile al sostegno del ‘fronte interno’, ma in realtà essi s’inscrivono nella storia di più lungo periodo dei movimenti emancipazionisti, che la guerra aveva bruscamente interrotto. Sul piano del lavoro questo periodo fu, invece, segnato dalla reazione nei confronti dell’occupazione femminile e le donne, che in parte avevano sostituito gli uomini mentre erano al fronte, furono chiamate bruscamente a cedere i loro posti agli uomini. Non 45
fu, però, un puro e semplice ritorno indietro: alcuni mutamenti erano intervenuti. La contrazione del lavoro domestico e il relativo aumento dell’occupazione industriale femminile nella grande industria moderna, anche se con una netta segregazione nelle mansioni meno qualificate, proseguirono, mentre l’espansione del terziario continuò ad aprire nuove possibilità di autonomia economica alle donne delle classi medie. Molti furono anche i mutamenti nel costume: le gonne si accorciarono, così come i capelli, ci si liberò del busto e degli ingombranti cappelli dell’anteguerra: il corpo femminile divenne più libero di muoversi. Anche la morale sessuale sembra divenire più libera, alla donna nuova dell’anteguerra si sostituì la flapper degli anni Venti, in cui una forma di emancipazione sul piano del costume sembra prescindere da qualsiasi connotazione politica, dalla presenza dei movimenti delle donne che cominciano a essere guardati con una certa sufficienza: essere femminista divenne infatti out of date26. Queste tendenze vengono però rapidamente a scontrarsi con un esito più duraturo: la reintroduzione sul piano delle rappresentazioni sociali diffuse e del discorso pubblico di una netta dicotomia tra maschile e femminile. La guerra aveva infatti “ridato vita ai vecchi miti virili: gli uomini sono fatti per conquistare, le donne per mettere al mondo figli e per allevarli, e questa complementarità tra i sessi appar[iva] necessaria per ritrovare pace e sicurezza in un mondo avvertito come in preda al caos”27. Le grandi campagne suffragiste erano alle spalle e minore, specie nei confronti delle generazioni femminili più giovani, divenne la forza di attrazione di un movimento politico autonomo delle donne. Molti studi sottolineano il backlash, che appare caratterizzare gli anni Venti e Trenta: forte fu, sotto diversi aspetti, la reazione del sistema patriarcale alle incrinature, e anche alle rotture, introdotte dal movimento delle donne. Karen Offen afferma che il femminismo si trovò a essere besieged, sotto assedio, sottoposto a una molteplicità di forze contrastanti: gli effetti della guerra con l’eccedenza di popolazione femminile, l’intensificarsi delle politiche nataliste, i processi di nazionalizzazione delle donne e il loro coinvolgimento in funzione subalterna nei partiti e nei sistemi totalitari che stavano profilandosi in Eu46
ropa, la crisi economica e la conseguente rimessa in discussione del lavoro extradomestico femminile e, last but not least, l’attacco in termini culturali che, in modi diversi, riproponeva una netta distinzione tra corpi e ruoli maschili e femminili e vedeva nel femminismo una delle espressioni della crisi della civiltà europea28. Femminismo, dunque, sotto assedio da una parte, ma persistenza dell’azione e dell’elaborazione di una cultura politica autonoma dall’altra: questa sembra essere la doppia faccia che caratterizza i due decenni successivi alla guerra. Ma nel contesto di questa cultura più debole, il rapporto donne e modernità emerso all’inizio del secolo diventa più oscuro e difficile nelle nuove forme della modernità degli anni Trenta. In altre parole, la sintesi tra un forte movimento di emancipazione politica e quell’apertura di nuove opportunità nell’istruzione e nel lavoro che aveva segnato l’affermazione delle pioniere, sembra appartenere definitivamente al passato. Nei tempi difficili dell’Europa degli anni Trenta ci si rivolge a quelle pioniere con uno sguardo nel quale il desiderio di proseguirne il cammino si unisce alla consapevolezza degli anni terribili che precedono la Seconda guerra mondiale. L’ottimismo di inizio secolo è molto lontano e assai diverse sono le parole che risuonano sulla scena dei congressi mondiali delle donne, da Istanbul nel 1936 a Copenhagen nel 1939. Vorrei concludere proprio con la rievocazione di quest’ultima scena, ricordando contemporaneamente il film recentemente ritrovato di Elvira Giallanella Umanità, del 1919, testimonianza di un impegno contro la guerra dopo la tragica vicenda della Prima guerra mondiale. Nel luglio 1939, nella capitale danese, ancora una volta donne di provenienza diversa si ritrovarono insieme come delegate di un’associazione internazionale, la International Women Alliance. Qui, dopo molte discussioni sulla necessità di prendere posizione nello scontro tra democrazia e fascismi trionfanti, scrissero una Dichiarazione in cui la storia delle fondatrici del movimento, le pioniere appunto, divenne l’ancoraggio per le scelte del presente: In questi terribili tempi in cui sono messi in discussione principi fondamentali concernenti le relazioni tra gli individui e lo Stato e tra gli Stati stessi, è es-
3 / Oltre i confini / Elda Guerra
senziale che le donne siano pienamente consapevoli delle responsabilità che le loro convinzioni femministe comportano. Le nostre grandi pioniere hanno combattuto per la libertà di coscienza e il pieno sviluppo della personalità, il diritto di scegliere la propria carriera, la partecipazione alla vita nazionale e politica e per contribuire alla definizione del destino della propria nazione. La loro lotta è stata essenzialmente parte della grande battaglia contro ogni oppressione di fede, di razza, di classe e di sesso. […] Ora noi conduciamo le nostre vite in tempi difficili, in cui la vita basata sui principi è a rischio. Di conseguenza, le donne […] fedeli ai loro principi fondamentali, devono difendere un sistema che condurrà verso una più grande giustizia e libertà, ad un’autentica pace, ad una generale prosperità e ad una maggiore felicità per tutti29.
Note L’International Women Council, fondato negli Stati Uniti nel 1888, è la prima associazione internazionale femminile. A esso potevano aderire associazioni di carattere nazionale di qualunque tendenza politica e religiosa e la sua finalità principale era quella di fornire uno strumento di comunicazione e un’opportunità d’incontro per le donne di tutte le parti del mondo. Per un approfondimento delle tematiche qui accennate mi permetto di rinviare a Elda Guerra, Storia e cultura politica delle donne, Archetipolibri, Bologna 2008. Sulla storia dei movimenti politici delle donne, fondamentale è lo studio di Anna Rossi-Doria, Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Viella, Roma 2007. 1
2 Steso sul modello della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, il documento presentato nella Convention di Seneca Falls da un gruppo di donne impegnate nell’affermazione dei loro diritti può essere considerato la prima espressione di un movimento organizzato negli Stati Uniti d’America. Per la sua presentazione e traduzione, cfr. Raffaella Baritono (a cura di), Il sentimento delle libertà. La Dichiarazione di Seneca Falls e il dibattito sui diritti delle donne negli Stati Uniti di metà Ottocento, La Rosa Editrice, Torino 2001. 3 International Council of Women, The Second Quinquennial Meeting Held in London July, vol. III, T. Fischer Unwin Paternoster Square, London 1899, p. 4. 4 Cfr. The Second Quinquennial Meeting Held in London July, cit., voll. IV e V. 5 Valeria Paola Babini e Luisa Lama, Una “donna nuova”. Il femminismo scientifico di Maria Montessori, Franco Angeli, Milano 2000, p. 16.
Maria Montessori partecipò al congresso come delegata del governo. Per una ricostruzione della sua presenza e anche delle posizioni e delle tensioni presenti nel movimento delle donne italiane cfr. Valeria Paola Babini e Luisa Lama, op. cit., p. 95 e segg.
6
Cfr. Ray Strachey, The Cause. A Short History of Women’s Movement in Great Britain, G. Bell, London 1928.
7
8
Anna Rossi-Doria, op. cit., p. XVI.
Simonetta Soldani, Un cammino in salita. Donne, diritti e professioni in Italia alle soglie del Novecento, in Giovanna Vicarelli (a cura di), Donne e professioni nell’Italia del Novecento, il Mulino, Bologna 2007, p. 56.
9
10 Per questa considerazione cfr. Maria Malatesta, Donne e professioni in Europa: le origini, in Giovanna Vicarelli (a cura di), op. cit., p. 35 e segg. 11 Emma Strada si laureò in ingegneria civile nel 1908 al Regio Politecnico di Torino. Cfr. Mirella Giannini e Ivano Scotti, Donne ingegnere: le pioniere del primo novecento, in Giovanna Vicarelli (a cura di), op. cit., p. 78 e segg.
47
12 Si pensi che solo nel 1963 venne consentito alle donne italiane il pieno accesso alla magistratura. Quello dell’amministrazione della giustizia rappresentò uno degli ambiti più resistenti in quanto le donne erano considerate irresponsabili e prive delle qualità necessarie a tale compito. 13 Matilde Serao, Il romanzo della fanciulla, Treves, Milano 1886; nuova edizione riveduta con il titolo Telegrafi dello Stato: romanzo per le signore, Ferrino, Roma 1895; riedito come Telegrafi dello Stato: sezione femminile, Rassegna Postelegrafonica, Roma 1957.
Sulle impiegate, fondamentale rimane lo studio di Barbara Curli, Italiane al lavoro: 1914-1920, Marsilio, Venezia 1998. 14
15
Virginia Woolf, Le tre ghinee, Feltrinelli, Milano 1992, p. 36.
Il supplemento, nato come quindicinale illustrato, della “Stampa” di Torino e della “Tribuna” di Roma, continua in questa forma fino al 1922. Cfr. la scheda descrittiva curata da Elda Guerra, Elena Musiani, Fiorenza Tarozzi nel sito www.bibliotecadigitaledelledonne.it, in cui è possibile accedere alla raccolta della rivista conservata presso la Biblioteca Italiana delle Donne. 16
17 Cfr. Colin Harding, The Kodak Girl, “Photografica World”, n. 78, 1996. 18
Per questa immagine, cfr. il sito: www.thehenryford.org
Cfr. tra i molti titoli disponibili: Juliet Gardiner (a cura di), The New Woman: Women’s Voices 1880-1918, Collins and Brown, 1993 e Angelique Richardson, Chris Willis (a cura di), The New Woman in Fiction and Fact: Fin-de-Siècle Feminisms, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2000. 19
20 Paola Baronchelli Grosson, figura intellettuale dei primi del Novecento, si firmava con il nome di Donna Paola. Per questa citazione e per una riflessione complessiva sul significato della ‘donna nuova’, cfr. Annarita Buttafuoco, Vite esemplari. Donne Nuove di primo Novecento, in Annarita Buttafuoco, Marina Zancan (a cura di), Svelamento. Sibilla Aleramo: una biografia intellettuale, Feltrinelli, Milano 1988, p. 144.
48
21
Ibidem.
Cfr. Sandro Bellassai, La mascolinità contemporanea, Carocci, Roma 2004. 22
23 Maria Antonietta Trasforini, Nel segno delle artiste. Donne, professioni d’arte e modernità, il Mulino, Bologna 2007. 24 International Manifesto of Women, “Jus Suffragii. Monthly Organ of the International Woman Suffrage Alliance”, n. 13, 1914, p. 1. 25 Questa considerazione e le seguenti sono in gran parte riprese da: Elda Guerra, Storia e cultura politica delle donne, cit., p. 23 e segg. 26 Cfr. Gisela Bock, Le donne nella storia europea: dal Medioevo ai nostri giorni, Laterza, Roma 2001, p. 303 e segg. 27 Françoise Thébaud, La Grande Guerra, età della donna o trionfo della differenza sessuale, in Id. (a cura di), Storia delle donne in Occidente. Il Novecento, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 81. 28 Cfr. Karen Offen, European Feminisms, 1700-1950: a Political History, Stanford University Press, Stanford 2000, p. 252 e segg. 29 International Woman Alliance, Report of the Thirteenth Congress, Copenhagen 1939, p. 8.
PARTE SECONDA
NON SOLO DIVE
4 / Cristina Jandelli
“La più intelligente di tutte”: Diana Karenne
Sono convinta che, nel periodo di maggior fulgore del diva film, le attrici del cinema italiano vollero tutte considerarsi artiste. Questo è infatti, insieme alla loro bellezza e sensualità, il tratto che le accomuna tutte, dalla prima all’ultima. Donne artiste moderne. Donne nuove, con la tradizione della morale cattolica a frenarne gli impulsi espressivi. Leucadia Konstanti[n/a], alias Anna Karènne, infine Diana Karren-KarènneKareni ovvero Karenne, fin dal nome costruisce un’immagine femminile: Anna come la passionale, romantica Karenina, poi trasmutata per l’aggiunta di una sillaba in Diana, nome della dea latina del culto lunare, austera e fredda. Uno pseudonimo, praticamente un ossimoro, che denota una trasformazione in atto: l’amante diventa vendicatrice. L’attrice, per una presunta più che provata formazione internazionale della quale non abbiamo alcuna testimonianza probante, presenta, rispetto alle altre, ancora più marcati i tratti dell’artisticità. Di se stessa dichiara di provenire dall’Opera di San Pietroburgo. E può essere vero. Ma cosa faceva all’Opera? In teoria di tutto. In Italia è attrice, sceneggiatrice, regista, produttrice e diva; ma a San Pietroburgo avrebbe potuto perfino fare la scenografa o la costumista. Personaggio in bilico fra lo stile italiano e quello, nascente, tedesco, volle legare la propria immagine a un’invenzione di Autoritratto di Diana Karenne (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
donna snob, aristocratica nell’ingegno e nella sensibilità, venata di una qualche tragicità espressionista. Se vogliamo un consuntivo plausibile della sua avventura italiana, possiamo trovarlo efficacemente rappresentato, in forma traslata, in un film americano, interpretato da un’allucinata Alla Nazimova che recita al fianco del nascente astro Rodolfo Valentino. I magnifici décor modernisti, nel film Camille di Ray C. Smallwood (1921), distraggono dalla palpitante vicenda di una signora dalle camelie newyorkese: analogamente sospesa possiamo immaginare Diana Karenne, l’artista del cinematografo venuta dall’est come un’autentica tigre reale verghiana, in bilico fra i primi ruggiti della femminilità ottocentesca e una lancinante sensibilità moderna. Nel periodo di massimo successo, cioè fra il 1916 e il 1920, Leucadia Konstantin appariva una bella donna matura, magra, con enormi occhi tristi un po’ sporgenti, naso piccolo, bocca grande con labbra fini appena piegate all’ingiù. Aveva un volto decisamente fotogenico e sottilmente inquietante. Il bistro spennellato a profusione rendeva gli occhi chiari ancora più evidenti e marcati: due grandi macchie oblique in un volto bianchissimo1. Un celebre autoritratto caricaturale, dal tratto grafico forte e incisivo la mostra a mezzo busto, con 51
Autoritratto di Diana Karenne
la mano grande e affusolata appoggiata sul fianco sinistro e un viso luminoso ritratto frontalmente, ma dallo sguardo fortemente angolato. I grandi occhi melanconici conferiscono al volto un’espressione altera, contraddetta però dal lieve sorriso disegnato sulle labbra che la trasforma in un’effigie sorniona. I grandi archi delle sopracciglia e le palpebre abbassate sembrano anticipare la celebre icona sognante della Garbo (pag. 50). Questo autoritratto ambiguo, delicatamente autoironico, non è l’unica testimonianza grafica delle inclinazioni artistiche della Karenne. Oggi, grazie al convegno Non solo dive, mi sono trovata per la prima volta di fronte a un altro disegno acquerellato, un autoritratto che il catalogo della manifestazione 52
pubblica sulla quarta di copertina. Secondo Teresa Antolin, cui si deve il reperimento dell’immagine, il soggetto va messo in relazione con le fotografie scattate dal fotografo Nunes Vais e pubblicate sulle riviste “Varietas”, “La Donna” e infine su “In penombra” nel luglio 1918. I particolari del vestito e del candelabro ebraico appaiono identici. L’acquerello mostra la stessa Karenne al pianoforte, sullo sfondo una parete ocra decorata con piccoli quadri allineati: ed è giusto un quadretto, forse una caricatura quella che nell’immagine, con una morbida chioma biondo-dorata raccolta alla sommità del capo, ella sta dipingendo con la mano sinistra sinuosamente sollevata, mentre con la destra contemporaneamente scrive e suona il pianoforte. I fo-
4 / “La più intelligente di tutte” / Cristina Jandelli
gli, numerosi, le scivolano a terra, dalla spalla spunta una chitarra a tracolla. Libri, piante e fiori, una stola e un candelabro ebraico completano il quadro, se non fosse che nella parte superiore dell’acquerello, a destra, un operatore sta riprendendo con la macchina da presa l’esibizione virtuosistica dell’attrice. Non è quindi uno studio né un salotto l’ambiente che la circonda, ma un set. Ma sembra quasi il suo ufficio: probabilmente per la Karenne, imprenditrice oltre che artista, con una Casa di produzione impiantata a Milano, set e ufficio e magari pure salotto sono la stessa cosa. Vi si fa arte ‘moderna’, in ogni caso, si fa il cinema. Questa donna disegnata e colorata dalla Karenne rappresenta l’immagine che intende comunicare di sé, “artista di cinematografo” poliedrica, bella e altera (il mento è ovviamente all’insù), eccentrica quanto autenticamente dotata. Un ultimo esame ai soggetti dei quadretti sullo sfon-
Diana Karenne (Archivio “In penombra”)
do rivela che si tratta di volti: uno di essi, il più visibile grazie allo sfondo nero, mostra una maschera bianca con occhi di alieno [pag. 52]. Analogamente a quanto mostra il disegno, una foto pubblicata da “In penombra” nel 1918 ritrae la diva seduta, con il volto pensoso appoggiato alla mano davanti a una dozzina di disegni schizzati di suo pugno, come se dovesse sceglierne uno fra i tanti. Infatti si tratta delle locandine da lei disegnate per pubblicizzare il film Pierrot, da lei diretto e interpretato e prodotto dalla David Karenne Film nel 1917. I primi disegni della Konstantin per la pubblicità sono dunque del 1917, quando fonda, insieme al fratello David, la Casa di produzione David-Karenne Film, che pochi mesi dopo diventa Karenne Film2, secondo l’ipotesi di ricostruzione proposta da Teresa Antolin. La locandina di Sleima, prodotto e distribuito dalla stessa Casa nel 1919, mostra però una diversa immagine femminile, decisamente più convenzionale: resta cioè da definire (lo si potrà fare solo consultando e comparando manifesti e locandine presso archivi, cataloghi d’aste e collezionisti) se la sua attività grafica fu episodica e circoscritta, o viceversa professionale e durevole. Su “In penombra” i disegni vengono pubblicati come corredo a un lungo articolo. Emergono, da uno sfondo scuro, i contorni di una maschera bianca tracciata con stile secco e marcato: sono tanti ovali ognuno simile all’altro, dalle fattezze stilizzate. Le espressioni mutevoli del volto, proposte in serie, acquistano risalto: osservati uno dopo l’altro, i Disegni fantastici della Karenne sembrano fotogrammi isolati di una lunga sequenza girata in primissimo piano. Non possiamo dimenticare che il personaggio di Pierrot rappresenta per lei una sfida divistica: la Bertini aveva trionfalmente portato al cinema la pantomima di Mario Costa Histoire d’un Pierrot già nel 1915. Dobbiamo supporre una preparazione accurata al delicato e significativo ruolo en travesti. I disegni, per l’artista Karenne, rappresentano probabilmente uno dei modi per prepararsi alla parte, ma ricordano anche la scelta dello storyboard da parte dei registi-illustratori (poi registi-pubblicitari tout court) del secondo Novecento, e penso anzitutto a Fellini. Le analogie non si fermano qui. Nell’universo visivo di Diana Karenne è presente un gusto 53
fa in modo vago e umbratile. Il testo di Fausto Maria Martini appare particolarmente reticente, riporta qualche frase pronunciata dalla diva ma il ritratto sembra non prendere forma. Così alla fine confessa che, mentre la diva lo respingeva, tutte quelle caricature lo hanno avvinto: La caricatura che ha un valore d’arte e d’umanità non è che un’ombra di dolore la quale s’affaccia a un volto. Guardate, ripensando a questo aforisma di un grande caricaturista, i disegni di Diana Karenne. E guardate soprattutto quello che s’intitola Il dolore. C’è una mano rapace che ferisce un volto e ne fa spicciare qualche goccia di sangue. L’ho davanti ai miei occhi: non riesco a distrarre lo sguardo da quella tristissima visione3.
Douleur, dai Disegni fantastici di Diana Karenne, “In penombra”, n. 2, 1918
caricaturale molto marcato: i suoi sono volti irrigiditi in espressioni sovraccariche, che vanno dal dolore all’angoscia, dal desiderio al sadismo. L’arte ‘moderna’ per eccellenza significa per lei fare cinema, creare immagini in serie, annunci, prefigurazioni e stilizzazioni delle future immagini in movimento. Nel primo dei due disegni intitolati Douleur (in alto) sgorga un rivolo di sangue all’angolo della bocca, nel secondo Douleur (in basso a destra) una goccia stilla dal mento artigliato da una mano adunca. La bocca stessa, nel volto, sembra una ferita: è troppo scura, nerissima come sullo schermo apparivano le labbra di Asta Nielsen, l’attrice danese amata dalla diva polacca. Gli occhi appaiono sempre cerchiati, ma in alcuni casi addirittura li occulta una macchia scura così decisa da nascondere la metà superiore del volto: sembrano occhiaie ipertrofiche. Alcuni di questi ovali sono riprodotti nelle pagine che Fausto Maria Martini le dedica sulla rivista in un lungo articolo scritto aderendo al modello, scelto da “In penombra”, dei ritratti d’autore dedicati alle dive del cinema. Durante la conversazione Diana Karenne si mostra refrattaria a mettersi in mostra, parla poco, pronuncia in francese parole di fuoco sull’arte e la povertà intellettuale del cinema ma lo 54
Negli anni Venti, in Italia, fiorisce una precettistica cinematografica destinata agli aspiranti attori cinematografici, con la pubblicazione di manuali di recitazione che insegnano agli allievi artisti come porsi di fronte alla macchina da presa. Lo scopo è insegnare loro ad acquisire la padronanza della cosiddetta ‘linea artistica’ del volto che significa: espressività destinata al primo e al primissimo piano. È qui infatti che si misurano le capacità dell’interprete protagonista, perché i primi piani certificano lo statuto di protagonista del film. Secondo i manuali, ogni passione ha una sua grimace, un atteggiamento particolare ottenuto combinando i diversi atteggiamenti di fronte, occhi, bocca.
Douleur, dai Disegni fantastici di Diana Karenne, “In penombra”, n. 2, 1918
4 / “La più intelligente di tutte” / Cristina Jandelli
Si suggerisce pertanto all’aspirante attore di allenarsi con una particolare ginnastica dei muscoli facciali, per ottenere scioltezza nel passaggio da un’emozione all’altra, in un improbabile trascolorare di sentimenti opposti uno nell’altro. Ad esempio il manuale di Paolo Azzurri, prototipo di diversi altri a venire, suggerisce una rapida messa in serie delle espressioni del volto come esercizio da compiere quotidianamente allo specchio. Passare rapidamente dal riso al pianto è un’ottima ginnastica per ottenere la massima mobilità della mimica facciale, requisito necessario a sostenere le inquadrature in primo piano4. I disegni della Karenne sembrano un’illustrazione deformata delle varie espressioni del volto esposte dalla manualistica cinematografica. Ma qui la gradazione cromatica pare concentrata sulle sole note cupe: angoscia (in basso a sinistra), desiderio, dolore (in due varianti, si è detto), sadismo (in basso a destra). Le gradazioni del dolore ricordano le pose assunte nei primi piani dalle dive del muto italiano, ma qui i tratti grafici sembrano piuttosto addensarsi alla maniera delle incisioni dei maestri dell’espressionismo tedesco, con particolare riferimento allo stile di Kirchner. L’opera grafica della Karenne è stata accostata a quella di artiste dell’area futurista come Tamara De
Lempicka, ma le maschere disegnate di cui amava tappezzare le pareti del suo appartamento portano invece chiaramente impresso il segno dell’espressionismo. Un altro accostamento pertinente è quello con la successiva lezione teatrale, in Italia, di Tatiana Pavlova, i cui personaggi, scrive Silvio D’Amico, appaiono stilizzazioni antinaturalistiche: Certe creature di questa raffinata civetta dell’arte, ci appaiono come quei disegni antirealistici per eccellenza, dove ogni figura è ben nettamente stilizzata da una linea che ne rileva, con amabile sfacciataggine, il contorno5.
Ancora, in questo senso, le maschere della Karenne potranno essere accostate al teatro della crudeltà di Artaud. Ogni autentica effigie ha un’ombra che costituisce il suo ‘doppio’; e l’arte cessa d’aver importanza a partire dall’istante in cui lo scultore, nel modellare, pensa di aver liberato una sorta d’ombra la cui esistenza strazierà il suo riposo6.
La presenza di una maschera che riproduce l’espressione del sadismo permette questo accostamento: occhi enormi che fissano, bocca atteggiata a
Disegni fantastici di Diana Karenne, “In penombra”, n. 2, 1918 55
un sorriso asimmetrico per effetto di un solo angolo delle labbra sollevato: è la stessa smorfia che assume la Borelli al momento di ostentare il massimo disprezzo, la stessa che increspa un angolo della bocca alla Menichelli quando finge d’ignorare l’uomo che le cade ai piedi. Il sadismo, nel diva film italiano degli anni Dieci, rappresenta l’espressione orgogliosa della femminilità indomita che intende misurarsi con l’uomo e assoggettarlo, farlo soffrire come la donna soffre, trascinarlo sul suo stesso terreno di battaglia per batterlo. Diana Karenne era considerata nel mondo dello ‘snob’ come una donna fatale, complicata, perversa. Perciò quando incominciò a recitare per lo schermo non trovò che autori preoccupati di trovare per lei drammi spaventosamente contorti e parti di una terribilità psicologica eccezionale. Ma Diana Karenne, la quale non è che una donna dotata di una eccezionale personalità, di una fine cultura e di molta intelligenza, dopo aver reagito contro questa tendenza, aspira a realizzare un’arte essenzialmente umana, profonda ma semplice7.
Fausto Maria Martini la descrive come una solitaria, un’esule volontaria dell’ambiente del cinema: incontrarsi con lei è tanto raro quanto piacevole perché è una donna spiritualissima. Il poeta si chiede se non sia un’innovatrice, non una diva ma un’intellettuale concentrata sulla propria concezione dell’arte. Ma Diana Karenne sa bene che “per far colpo occorre presentarsi nelle vesti ornate di una dominatrice che possiede quello che vuole”: il compromesso fra la ricerca artistica e le richieste dell’industria cinematografica è inevitabile. Così la Karenne gli appare una donna d’ingegno che parla poco di sé stessa e molto dell’arte, che si fa piccola e umile come una collegiale, come una lavoratrice, e vuole una lavoratrice ella apparire; il suo lavoro è la ricerca di se stessa e delle sue attitudini nella vigilia paziente dell’espressione artistica8.
Diana Karenne, la più intelligente delle dive, come la definisce Tito Alacci nel 19199, la prima attrice produttrice, regista, soggettista e sceneggiatrice del cinema italiano degli anni Dieci appare dunque una personalità a doppio strato. Da una parte aderisce al 56
cliché della donna fatale caricandone i tratti più esosi, esaltandone la perversione e lasciando esplodere nei film la violenza (i suoi personaggi la subiscono, e per reazione uccidono e si tolgono la vita), dall’altra rifiuta la mondanità e vuole accreditarsi come donna lavoratrice, indipendente, emancipata, coinvolta a tutto tondo nell’impresa produttiva, nonché artista inquieta alla ricerca dell’elevazione spirituale. Confessa infatti al poeta: Sì, è possibile che noi creiamo una bellezza profonda del gesto ritmata sulla bellezza del paesaggio […]; è possibile che noi disegniamo un’estetica del silenzio, sotto la quale traspare il profondo e spiritualissimo tormento del ricercarsi e del rivelarsi: ma per far questo occorre molto lavoro […], una saggia umiltà. Finora di tutto questo s’è fatto assai poco10.
In questi anni Karenne lavora a un preciso personaggio. Progetta di dirigere, dopo Pierrot, un film su Maria Nicolaievna Tarnowska, protagonista nel 1907 di un fatto di cronaca nera, cioè dell’omicidio di Pavel Kamarowsky a Venezia per mano di un altro russo, Nicola Naumof, un burattino nelle mani della bellissima contessa trentenne. A Vienna, nel 1910, veniva celebrato il ‘processo dei russi’ che culminò con l’incarcerazione della Tarnowska e di Naumof. Così la contessa russa si trasformò in un personaggio leggendario e maledetto, protagonista del romanzo Circe di Annie Vivanti: la scrittrice ne cedette i diritti cinematografici alla Karenne Film11. Prodotto, diretto e interpretato dall’attrice polacca nel 1917, Circe, con Alberto Capozzi nel ruolo di Naumof, non ha lasciato alcuna traccia di sé, tranne che nella memoria dei contemporanei. Un testimone indiretto è Lyda Borelli, cui la Cines propose di interpretare a sua volta il personaggio: secondo una tipica strategia divistica l’attrice rifiutò perché lo aveva già fatto la Karenne12. Si tratta della prima e unica Tarnowska del cinema italiano, dal momento che la sceneggiatura scritta da Visconti nello stesso anno di Ossessione, non fu mai realizzato. La Karenne cerca e trova soggetti cinematografici capaci di esprimere una nuova femminilità e si fa notare soprattutto per le sue interpretazioni anticonvenzionali. In Sofia di Kravonia (Ernesto Maria Pasquali, 1916) sfoggia l’uniforme militare e si met-
4 / “La più intelligente di tutte” / Cristina Jandelli
Diana Karenne (seduta) in Miss Dorothy, 1920 (CSC - Cineteca Nazionale)
te alla testa di un manipolo di patrioti, nel Pierrot appare in un ruolo en travesti, in Justice de femme! (Diana Karenne, 1917) espone la sua tesi sulla maternità illegittima, in La fiamma e la cenere (Giulio Antamoro, 1919) è una libertina che si traveste da mendicante per farsi accogliere nella casa dell’organista di cui si è incapricciata, in Ave Maria (Diana Karenne, 1920) mostra come i pregiudizi di classe rendano infelici le donne e predica unioni interclassiste, in Miss Dorothy (Giulio Antamoro, 1920) assume le sembianze di un’istitutrice anglosassone per vigilare sulla felicità della figlia, abbandonata a causa di un amore clandestino. L’anno prima, in Maria di
Magdala (Redenzione), diretto da Carmine Gallone, la Karenne si converte per amore di Cristo, ma la sua prostituta biblica appare una donna che ha subito violenza e che fa del mercimonio del proprio corpo uno strumento per esercitare il potere sul genere maschile che l’ha oltraggiata. I suoi personaggi sono donne mascolinizzate che vogliono forgiare il proprio destino a dispetto della morale borghese. Miss Dorothy e Maria di Magdala sono sopravvissuti13 e consentono di osservare la sua recitazione. La sobrietà, la secchezza del gesto, la ricchezza della stilizzazione cui giunge nel primo piano appaiono tutt’altro che convenzionali. 57
In Miss Dorothy la sua figura esile e nervosa è finemente cesellata dall’espressività del volto. Inquadrato in primo piano – i capelli raccolti e gli occhi grandissimi – o in piani americani dove la maschera dolente dell’attrice è esaltata dal contrasto con i castigati abiti scuri che indossa, il suo viso appare particolarmente misurato nell’esprimere sentimenti estremi, come nel finale in cui si sacrifica per il bene della figlia togliendosi la vita con una pugnalata. Di Miss Dorothy resta sul pavimento la macchia scura degli abiti che la ricoprono interamente, come una marionetta gettata a terra. Il personaggio non esita a indicare nel sacrificio di sé una possibile soluzione per consentire alla figlia una vita su cui non ricadano le proprie colpe. Nell’incipit del film di Gallone c’è un primissimo piano straordinariamente aderente alla tensione delle avanguardie verso la riduzione del volto a maschera irrigidita, priva d’espressione, caratterizzata da segni caricaturali, come gli occhi divenuti due profonde orbite scure nel volto cereo. Maria Maddalena è reduce dalla violenza carnale che la scena precedente ha mostrato con torbida efficacia: è stata svestita e, coperta di un solo velo, legata a un palo, poi guardata con sguardi lubrici dagli uomini assiepati intorno a lei e infine presa con la forza dal capo, come in un rito ancestrale. Ora ha raggiunto la città ed è accoccolata a terra coperta da un mantello: un uomo le si avvicina per aiutarla ad alzarsi e lei lo guarda, dal basso, con occhi imploranti, poi si copre il volto sopraffatta dal terrore, infine resta con lo sguardo pietrificato, perso in un’ipnotica lontananza. Due triangoli scuri solcano per metà il volto, proprio come si è visto nei suoi disegni fantastici. Nella sequenza successiva è già diventata la prostituta mitica coperta di ricchezze che mani operose provvedono a pettinare sotto una tenda lussuosamente arredata. Maria Maddalena è una peccatrice e insieme una donna che combatte contro il sopruso maschile. Essere donne intellettuali nell’Italia degli anni Dieci significa affermare, attraverso l’arte, le ragioni dell’emancipazione femminile, cioè mostrare un’immagine di donna guerriera, di virago indomita – il mito di Diana – che combatte la propria battaglia non al fronte, ma sul fronte della morale borghese di cui mette in evidenza lo stato di crisi. Le donne lavoratrici – di qui l’immagine che la Karenne intende 58
accreditare di sé – sono le giovani che la guerra ha messo per la prima volta in condizione di forgiare il loro destino, liberandosi dal giogo dell’asservimento domestico anche se solo per pochi anni, cioè prima che la restaurazione fascista intervenga a garantire il ritorno all’ordine (e gli schermi si riempiano di cinema americano). La seconda metà degli anni Dieci è un periodo decisivo per l’affermazione della donna nuova. Diana Karenne, la diva cinematografica polacca che ama circondarsi di mobili futuristi disegnati da Ginna e tappezza la casa di maschere funeree, diventerà anch’essa un esempio per le giovani generazioni. Scrive Alacevich: Se qualche arcigno aristarco storce il naso di fronte alle eccentricità dell’interprete che sa irridere ad una morale benpensante, di contro c’è tutta una generazione coetanea che l’adora, che vede in lei più che un’immagine allegorica, un emblema, un vero e proprio modello14.
Le giovani donne lavoratrici dei secondi anni Dieci sono anzitutto spettatrici. Si identificano con le dive che sono moltissime: esageratamente lodate ed esageratamente pagate […]. Conseguenza logica quindi è questa: che il cinematografo è nato per le donne. Ma è anche più logica quest’altra conseguenza: che le donne vanno continuamente al cinematografo come ad un’oasi. Le donne quindi hanno trovato nel cinematografo tutto il loro utile e tutto il loro diletto15.
Fra i loro modelli di stile – classe, eleganza, mimica e gestualità – c’è Diana Karenne, l’unica diva-autrice del cinema italiano. Anche quando la via dell’autarchia realizzativa si rivelerà impraticabile la Karenne continuerà a forgiare la sua immagine in totale autonomia, portando sullo schermo personaggi di donna emancipata che si scontra contro la morale borghese a rischio della vita, propria e altrui. Purtroppo della diva venuta dall’est, morta sotto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, restano pochissimi film e nessuno di quelli da lei diretti. Solo il ritrovamento di pellicole oggi perdute e accurate ricerche d’archivio potranno portare a nuove scoperte.
4 / “La più intelligente di tutte” / Cristina Jandelli
Note Secondo le sue dichiarazioni nasce a Danzica nel 1888 sotto il segno del Toro (cioè dal 21 aprile al 20 maggio). Giovinetta si trova presso dei parenti in Ucraina, poi è all’Opera di San Pietroburgo e nel 1914 emigra in Italia ed esordisce come attrice alla Roma Film di Torino col nome di Diana Karren. Cfr. Roberto Chiti, Dizionario dei registi del cinema muto italiano, Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo, Roma 1997.
1
“Diana Karenne non fa più parte della David-Karenne; anzi la David-Karenne non esiste più”. Pubblicità nella rivista “La Vita cinematografica”, 7-15 maggio 1917.
2
3 Fausto Maria Martini, L’esule delusa, “In penombra”, n. 2, luglio 1918, pp. 54-56. 4 Cfr. Cristina Jandelli, La tecnica della recitazione cinematografica. Il caso Paolo Azzurri, “Bianco & Nero”, n. 2, 2004, pp. 47-66.
Silvio D’Amico, Il tramonto del grande attore, La Casa Usher, Firenze 1985, p. 94. 5
Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 1968, p. 131.
6
7 Sintesi a piè di pagina dell’articolo L’esule delusa, cit., p. 61. 8
L’esule delusa, cit., p. 62.
“Una sola cosa non è dubbia in lei: l’intelligenza. Sì, la Karenne è forse la più intelligente di tutte le nostre attrici. Ma anche – come ho detto – la più stravagante”. Tito Alacci, Le nostre attrici cinematografiche, Bemporad, Firenze 1919, p. 121.
9
10
ra di Pierrot, che oggi va ad eternare sullo schermo bianco. Dopo Pierrot, la David-Karenne Film annuncia un lavoro sensazionale, nientemeno che il romanzo della Tarnowska, tratto dal Circe di Annie Vivanti! Chi delle nostre lettrici non ricorda il famoso processo alle Assise di Venezia di questa donna così fatale e cosi anormale, chi non ha rivìssuto – attraverso le pagine, della Vivanti – tutta la sua vita singolare e drammatica? La Vivanti, che aveva ricevuto offerte insistenti e cospicue da altre Case, ha ceduto solo dinanzi all’arte, di Diana Karenne. Ciò che è sicuro affidamento di una interpretazione veramente straordinaria. Circe della David-Karenne Film costituirà sicuramente l’avvenimento artistico più interessante dell’annata, nella industria cinematografica italiana, e formerà – per il pubblico femminile – la più attraente novità!” (“La Donna”, Torino, 15 marzo 1917. Per gentile segnalazione di Teresa Antolin). 12 Cfr. Teresa Antolin, La Contessa Maria Tarnowska e il Conte Luchino Visconti, in Il processo di Maria Tarnowska. Una sceneggiatura inedita, Il Castoro, Milano 2006. 13 In particolare il Filmmuseum di Amsterdam possiede di Resurrezione un frammento nitrato positivo (210 metri) con didascalie olandesi che è stato duplicato per conservazione nel 1992. Il documentario Rai di Paola Faloja Le pioniere della macchina da presa, realizzato l’anno successivo, ne consente la visione insieme ad altri significativi brani dei film interpretati da Diana Karenne. 14
Tito Alacci, op. cit., p. 34.
Ottorino Modugno, Le donne mute, Cecconi, Firenze 1920, pp. 96-97. 15
Tito Alacci, op. cit., pp. 62-63.
“Il primo film che la David-Karenne editerà in questi giorni avrà per titolo Pierrot. La signora Karenne, che interpreterà la parte di Pierrot, ha promesso di dare una delle più salienti sue manifestazioni di arte, che il mondo cinematografico e il pubblico attendono con grande ansia. Ogni lavoro di Diana Karenne è infatti un avvenimento artistico della massima importanza, tanto la squisita, intelligentissima attrice ha ormai conquistato il pubblico intero, con la originalità della sua arte. È quindi legittima l’attesa! Poche attrici posseggono una personalità artistica così completa e complessa come Diana Karenne. Essa, infatti, non è soltanto la interprete squisita, ma è altresì la creatrice e la fattrice più poderosa di ogni suo lavoro. Dotata di una grande versatilità nel campo artistico, squisita musicista, abile pittrice, essa tutto chiede a se stessa, al suo talento al suo cervello, al suo gusto raffinato; poco le donano gli altri. Il disegno che pubblichiamo, dimostra come, da pochi tratti, con un impiego rudimentale di mezzi, si possa far scaturire una espressione piena di pensiero e di significato! Esso ci dimostra altresì come la Karenne abbia compreso e vissuto, nella sua anima di artista, questa singolare masche11
59
5 / Monica Dall’Asta
Il singolare multiplo Francesca Bertini, attrice e regista
Bertini e la storia e del cinema Simbolo quanto mai persistente di femminilità e insieme esempio straordinario di donna autorevole e intraprendente, Francesca Bertini costituisce per la storiografia femminista una vera sfida. Come tutti sanno, la Bertini è l’attrice che in modo più durevole e con maggiore successo ha identificato se stessa con la figura della Diva, la creatura sublime e inimitabile che più di ogni altra costituisce l’emblema del cinema muto italiano. Dal punto di vista della critica femminista, questo statuto di figura incomparabile rivela subito una natura contraddittoria. Infatti, se da un lato la sua ineccepibile interpretazione del personaggio della Diva è quanto ha permesso alla Bertini di conquistare una posizione di primo piano nella storia del cinema tradizionale, facilitando lo stesso suo accreditamento come regista o co-regista di Assunta Spina (1915)1, dall’altro l’attitudine egocentrica che l’ha sempre contraddistinta ha finito per oscurare l’esistenza nel cinema muto italiano di tante altre donne influenti e produttive2. Inoltre, la peculiare ambiguità della figura della Diva si rivela con evidenza nel paradosso di una donna che appare bensì potente e carismatica, ma la cui ‘aura’ dipende interamente dalla propria Francesca Bertini in Assunta Spina, 1915
identificazione con i più triti stereotipi della letteratura maschile, in cui non vi è posto per alcuna significativa relazione tra donne3. Di conseguenza, la storica femminista viene a trovarsi in una situazione abbastanza insolita, dovendo fare i conti non già con una figura oscura/oscurata, ma al contrario con un’immagine che, per una volta, sembra essere anche troppo nitida e luminosa. L’analisi della carriera e della personalità cinematografica di Francesca Bertini può quindi trasformarsi in un test ideale per la storiografia femminista, una sfida a sviluppare un quadro interpretativo che permetta di innescare un processo di valorizzazione femminista anche in rapporto a figure che, come la sua, potrebbero apparire in una tale ottica ambigue o disturbanti. Le pagine che seguono tenteranno di svolgere questo compito proponendo un concetto di recitazione come iniziativa (o agency) volto a ripensare il ruolo dell’interpretazione in relazione alla regia, attraverso l’ipotesi di un tipo di recitazione capace di collocare il regista in una posizione vicaria o comunque subordinata rispetto all’attrice4. Infine, lo studio della Francesca Bertini regista ci porterà a riconsiderare la relazione, tanto problematica quanto imprescindibile per qualsiasi tentativo storiografico di orientamento femminista, tra le ‘poche visibili’ e 61
le ‘molte invisibili’ e in questo senso a riaffermare l’importanza di un metodo basato sul principio della contestualizzazione culturale. La Bertini è certamente una figura singolare nella mappa delle cineaste europee del periodo muto. Delle decine di donne che in questo periodo furono impegnate nell’industria cinematografica dell’intero continente, in ruoli professionali di vario genere – come registe, sceneggiatrici, produttrici, distributrici ecc. –, la Bertini è con ogni probabilità colei che raggiunse il più ampio successo internazionale. L’enorme visibilità del suo cinema è di per sé un tratto che differenzia in maniera significativa la sua esperienza da quella di tante altre cineaste coeve, le quali dovettero spesso faticare per realizzare i loro film e farli circolare5. Anche le più fortunate, quelle il cui lavoro era ben accolto in patria, solo raramente riuscirono a guadagnare qualche notorietà all’estero. Le rare eccezioni che affiorano alla mente sembrano confermare il punto anziché contraddirlo. Si pensi per esempio ad Alice Guy, che in oltre vent’anni di fortunata carriera rimase sempre sconosciuta al grande pubblico, per il semplice motivo che la sua attività si svolse quasi interamente in un periodo durante il quale il nome del regista, anche se uomo, non veniva accreditato nei titoli di testa. Oppure al caso di Elvira Notari, autrice di molti film di grande successo, la cui circolazione era però limitata a un contesto molto specifico, quello del pubblico dell’Italia meridionale e delle comunità degli immigrati italiani negli Stati Uniti. Anche più marginale, per quanto prestigiosa, può essere stata la circolazione dei film di Germaine Dulac all’interno del circuito internazionale dei cineclub. Né le prolifiche registe del cinema tedesco (da Holla Moya a Fern Andra, a Rosa Porten), né figure carismatiche e internazionalmente apprezzate come Musidora e Diana Karenne conobbero mai quel genere di successo universale che circondava la Bertini nel suo periodo d’oro, e che l’avrebbe accompagnata ancora a lungo in seguito. Si potrebbe obiettare che la straordinaria visibilità della Bertini non implica in alcun modo un apprezzamento del suo lavoro come regista, né da parte del pubblico né della critica, ma prova unicamente l’immenso potere di fascinazione esercitato dalla 62
Diva in quanto attrice. E in tal senso, allora, la posizione della stessa Bertini potrebbe non essere poi così diversa da quella di altre cineaste del periodo, giacché in effetti un’analisi attendibile del suo lavoro come regista dovrebbe concentrarsi esclusivamente sui film da lei diretti, sceneggiati e prodotti, i quali in ultima analisi potrebbero rivelarsi non poi così fortunati in termini di successo critico e popolare, né così differenti da un punto di vista stilistico e culturale, da quelli in cui fu impegnata unicamente come interprete. Ma com’è noto questo genere di distinzioni o divisioni di ruolo sono impossibili nel caso delle Dive. Tutti i resoconti del lavoro della Bertini in quanto Diva, da quelli dei suoi contemporanei a quelli dei suoi biografi e di storici moderni come Gian Piero Brunetta e Vittorio Martinelli (per non parlare dei suoi propri contributi autobiografici)6 hanno sempre evidenziato fino a che punto la sua capacità di controllo del set e il suo potere decisionale su diversi aspetti della produzione andasse ben al di là di quanto era consentito ad altre attrici del periodo, ivi incluse le altre Dive. Sulla volubilità e sui capricci della Bertini è stato scritto fin troppo perché valga la pena di insistervi ancora. In questi testi di natura prevalentemente aneddotica, ciò che la continua insistenza sugli aspetti caratteriali della sua persona finisce per oscurare è il lato economico del suo potere. Di sicuro, non solo la Bertini era perfettamente consapevole del valore del suo tempo, ma sapeva anche (come chiunque altro nella troupe) che il suo lavoro era una garanzia di lauti guadagni per un gran numero di persone. Di conseguenza le era permesso avere pretese che sarebbero state impensabili nel caso di altre attrici. Naturalmente la Bertini non era l’unica Diva del cinema italiano e lo stesso genere di volitiva eccentricità è stato ripetutamente attribuito anche a molte altre sue colleghe. Ma il valore della Bertini in termini di capitale naturale era semplicemente ineguagliabile. Poiché i suoi film ottenevano un successo molto maggiore in tutto il mondo di quelli di qualsiasi altra Diva, poteva a ragione ritenere di essere il più importante capitale naturale del cinema italiano, e comportarsi di conseguenza, scambiando il suo tempo prezioso con la soddisfazione dei suoi ‘capricci’.
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
Francesca Bertini con Camillo De Riso in La perla del cinema, 1916 (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
La Superfemmina In effetti tutto spinge a pensare che la Bertini fosse la donna più potente dell’intera industria cinematografica italiana, più potente anche della maggior parte degli uomini impiegati nel settore, e sebbene la natura esatta del suo apporto creativo alle varie fasi della produzione resti difficile da determinare, nondimeno è evidente che il suo raggio d’azione andava ben oltre la sfera della recitazione e si estendeva fino a includere funzioni quali la scelta dei personaggi e delle trame, le strategie di ripresa e di illuminazione, il montaggio e naturalmente la pubblicità. Ma prima di analizzare quello che senza alcun dubbio può essere definito lo stile di regia della Bertini, è necessario esporre con maggiore pre-
cisione le condizioni della sua iscrizione nella storia del cinema, in quanto esse sono al contempo largamente responsabili del paradosso che la sua figura rappresenta per la storiografia femminista. Nessuno dei film della Bertini accredita il suo nome in ruoli diversi da quello di attrice o, dal 1918, produttrice. Nel biennio 1915-16, quando aveva già creato alcuni dei suoi personaggi più famosi, da Nelly la gigolette a Ninì Verbena e Assunta Spina, una versione mascolinizzata del suo nome fu inclusa nei crediti di tre film, Nella fornace, La perla del cinema e My Little Baby, il cui soggetto veniva attribuito a un non troppo misterioso Frank Bert. Ma l’operazione non ebbe i risultati sperati e il nome non fu mai più usato in seguito. I critici non ebbero difficoltà a riconoscere la Bertini sotto il suo pseudonimo ma63
schile, ma ciò non li trattenne dal valutare le trame in modo assai severo7. Purtroppo nessuno di questi film è sopravvissuto e di conseguenza è impossibile giudicare fino a che punto queste critiche fossero fondate. Certo è che la Bertini abbandonò ben presto le sue ambizioni di soggettista. Per cominciare a dividere il lavoro della Bertini nei diversi ruoli da lei assunti nel corso della sua carriera occorrerebbe poter rinvenire qualche significativa differenza tra la trama di questi film e il resto della sua produzione. Ora, benché sia possibile giudicare solo da fonti secondarie, nessuno di questi soggetti sembra in alcun modo allontanarsi da uno schema già ben collaudato, basato sull’accentramento di tutto il film, a livello sia visivo che narrativo, intorno al corpo e alla personalità della Diva. Già nel 1915, i recensori notavano ripetutamente che la Diva “è – come sempre – troppo in scena”8, apparendo in quasi tutte le inquadrature, e criticavano le trame dei suoi film per il modo artificiale in cui venivano fatte ruotare intorno al suo personaggio, “unicamente per offrire a Francesca Bertini il campo a una nuova interpretazione” e per darle la possibilità di “porre in piena luce le grazie della sua flessuosa affascinante persona”9. Nella sua recensione a Nelly la gigolette, una delle tante pellicole in cui la Diva appariva al fianco di Alberto Collo ed Emilio Ghione, Pier da Castello osservava per esempio che il film poteva essere compreso solo “attraverso il carattere dell’attrice – ch’è attrice e personaggio insieme”, affermazione quasi letteralmente ripetuta da Louis Delluc nel 191710. Considerando l’attitudine dominatrice di tale personalità, è difficile poter supporre che i ruoli scritti di suo pugno e a se stessa destinati potessero divergere in maniera significativa dalle sue interpretazioni precedenti. Essi sembrano essere al contrario del tipo più convenzionale e forse perfino ancor più sfacciatamente celebrativi del mito della Diva. La perla del cinema, in particolare, potrebbe addirittura essere letto come una dichiarazione di poetica, dal momento che la trama si sviluppa come un dramma metafilmico, la cui protagonista è un doppio esatto dell’interprete: una Diva all’apice del suo successo. Il soggetto presenta numerosi aspetti che sono ricorrenti nel cinema della Bertini, come la struttura melodrammatica dell’intreccio, fitto di colpi 64
di scena e improvvisi capovolgimenti nei comportamenti dei personaggi, e il finale tragico, che inevitabilmente comporta la morte della Diva. Questa strategia di chiusura narrativa era già stata ampiamente sperimentata da Asta Nielsen fin dai suoi primi melodrammi, ma quel che qui colpisce è il modo in cui viene utilizzata per negare e delegittimare la fantasia che, con ogni evidenza, l’intreccio del film si sforza di alimentare nelle spettatrici: quella della semplice, ma bellissima contadina che per puro caso si vede all’improvviso proiettata nell’Olimpo del cinema11. Tutto ha inizio quando una Casa cinematografica invia una troupe a girare qualche scena in esterni nel villaggio dove vive la ragazza. Subito l’attor giovane della compagnia si innamora di lei e al termine delle riprese la porta via con sé, verso un luminoso futuro di fama e ricchezza. Ci si potrebbe aspettare che questa premessa serva a preparare il terreno a una celebrazione dello stile di vita della Diva, e in un certo senso questo è appunto quel che accade, giacché, come nota un recensore, “la creatrice del ‘soggetto’ ha voluto in modo soverchio indulgere alla lusinga di ‘far del teatro’: ha contemplato nella film che ideava troppo sé stessa e la sua parte e l’occasione di manifestarsi ‘attrice’”12. Ma il gioco di specchi nel quale il suo personaggio è preso in questo film è di fatto molto più complesso, in quanto l’ex-contadina-divenuta-Diva è condannata dal destino a trasformarsi in femme fatale, ovvero in una donna che non può sottrarsi alla colpa di suscitare negli uomini le più violente passioni e la cui unica speranza di redenzione consiste nel suicidio, come forma suprema di autosacrificio. Come se ciò non bastasse, il suicidio ha luogo di fronte alla macchina da presa, quale scena finale di un film nel quale la Diva pentita ha voluto rappresentare il dramma della sua vita. Per quanto ambigua, contraddittoria e paradossale possa apparire, la trama metafilmica di La perla del cinema era in un certo senso l’unico modo per una Diva di autorappresentare il proprio ruolo, dal momento che un’interpretazione completa del suo personaggio non poteva certo escludere la scena del suicidio. L’autorappresentazione della Diva culmina nell’autodistruzione, ma questo esito nichilista è di fatto speculare, direttamente proporzionale, all’am-
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
bizione totalizzante che la Bertini rivela nell’immaginare una simile trama. Se la reazione perplessa della critica è senza dubbio facilmente comprensibile, il soggetto di La perla del cinema può tuttavia essere apprezzato almeno per la chiarezza con cui espone il paradosso nichilista della femme fatale, un modello narrativo ottocentesco che sembra assorbire interamente l’ispirazione melodrammatica della Bertini13. Anche in seguito alla creazione, nel 1918, di una Casa di produzione a lei intitolata, i suoi personaggi continuarono a essere ispirati a quella tradizione letteraria, illustrando una lunga galleria di vittime dell’amore e di più o meno innocenti peccatrici che pagano con la vita il fatto d’esser belle e affascinanti. L’unica novità significativa a livello di strategie produttive fu rappresentata dal definitivo abbandono delle sceneggiature originali, ma la scelta dei soggetti continuò a esser fatta all’interno del tradizionale repertorio del melodramma francese della seconda metà dell’Ottocento, specialmente tra i testi di Alexandre Dumas figlio, Georges Ohnet, Octave Feuillet e Victorien Sardou. Ciò si spiega forse con il tentativo di rispondere al disappunto regolarmente espresso dai critici a proposito della confusione e dell’illogicità narrativa delle sceneggiature dei film della Diva. In effetti in qualche caso lo sforzo fu notato e apprezzato14, ma nel complesso l’enciclopedia di riferimento continuò a essere la stessa di sempre, un repertorio che comprendeva figure come Marguerite Gauthier, Tosca, Fedora, Odette, e tutte le situazioni e i temi classici che gli sceneggiatori avevano rielaborato e ricombinato per lei nei cinque o sei anni precedenti. Quasi senza eccezioni, i film della Bertini erano basati su un’unica struttura ricorrente: il triangolo amoroso nelle sue multiformi e mutevoli variazioni. La Diva poteva impersonare la moglie fedele tradita dal marito o un personaggio sul tipo della Bovary, la principessa rovinata dall’amante o la donna di mondo che rovinava un principe, o più spesso una combinazione di tutti questi tipi, come per esempio in Sangue bleu (Nino Oxilia, 1914), dove interpreta una principessa che diviene una donna di mondo dopo che il marito l’ha tradita. Spesso la frammentazione dell’immagine della Diva in una pluralità di ruoli ha luogo all’interno dello stesso film, condan-
nando i suoi personaggi a una contraddittorietà e una dissociazione che possono solo preparare una fine tragica15. Ma paradossalmente, era proprio questo processo incessante di frammentazione e transizione di ruolo in ruolo ciò che permetteva alla Bertini di acquisire la sua superiore identità di Diva, l’aura di un’immagine perfettamente singolare, giacché letteralmente ella era l’unica alla quale fosse dato di imitare il comportamento trasgressivo dei suoi personaggi (come per esempio il loro debole per i bei vestiti e i gioielli alla moda) senza incorrere in punizioni e rimanendo anzi la più ammirata e la più rispettabile di tutte le attrici. Ciò può forse spiegare perché nel suo soggetto metafilmico la Bertini avesse previsto di uccidere il suo doppio di fronte all’obiettivo, avendo appreso dalla sua esperienza precedente fino a che punto la creazione della sua immagine eroica, la realizzazione dei suoi desideri e delle sue ambizioni (come per esempio il suo proprio debole per i gioielli e i bei vestiti) dipendesse essenzialmente dalla distruzione di tutte le sue eroine. Non si può pensare a un modo più chiaro di dimostrare la sua unicità, la sua inimitabile capacità di imitare tante donne perdute e ambiziose senza essere condannata al loro stesso destino autodistruttivo. In effetti, l’autosacrificio della Diva su cui si conclude il soggetto di La perla del cinema può ben essere interpretato come un avvertimento rivolto alle spettatrici di non seguire il suo esempio, un’illustrazione moralistica dei pericoli in cui potrebbero incorrere se fossero così orgogliose da credere di poter essere simili a lei. Questa forma di nichilismo eroico era ben radicata nella cultura italiana del periodo, trovando il suo principale rappresentante in Gabriele D’Annunzio, un autore non a caso particolamente amato dalla Bertini. Per esempio, un passo della sua prima autobiografia descrive estaticamente le lunghe notti insonni spese nel tentativo di comprendere “la prosa tutta speciale del grande D’Annunzio. Mi accadeva talvolta di perdermi in labirinti paurosi, dai quali la mia anima usciva turbata e sconvolta; quella prosa magica, sonante, mi affascinava”16. Di fatto, l’ideale dannunziano di una Superfemmina capace di eguagliare gli insaziabili appetiti estetici dei protagonisti dei suoi romanzi trova nella Bertini una personificazione quasi letterale17. 65
Francesca Bertini in La contessa Sara, 1919 (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
Un modello irraggiungibile In quanto Superfemmina la Bertini era inimitabile per definizione, ma paradossalmente la perfetta unicità della sua immagine era al tempo stesso ciò che le consentiva di suscitare il più ampio processo di imitazione18. La sua immagine circolava largamente non solo sugli schermi, ma anche nei libretti preziosamente decorati che venivano stampati per pubblicizzare i suoi film, sulle pagine delle riviste femminili e in innumerevoli cartoline19. La sua eleganza era grandemente ammirata e lo spettacolo della moda offerto nei suoi film era un richiamo irresistibile per il pubblico femminile. Anche se certamente ben poche spettatrici potevano permettersi il costo (per non dire la varietà) dei suoi modelli esclusivi, la sem66
plice possibilità di ammirarli – così da poter copiare qualche dettaglio di stile (come per esempio il famoso cappello con un taglio nel mezzo che sfoggia in La contessa Sara, Roberto Roberti 1919) – era per tutte motivo di gran soddisfazione. In effetti la Bertini aveva stabilito un rapporto professionale con la Maison Paquin, una casa di mode parigina, fin dal 1914 e una delle regole stilistiche più riconoscibili nei suoi film è che ogni scena abbia il suo vestito: cosicché, nel cinema bertiniano, ogni cambiamento di scena implica in genere un cambiamento d’abito. In tal modo diventava possibile usare il film per presentare un’intera collezione, come si può vedere per esempio in Sangue bleu, uno dei film che si avvalsero della collaborazione della Maison Paquin. Di conseguenza, la conturbante femme fatale, am-
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
mirata e desiderata dagli uomini, era enormemente ammirata anche dalle donne: come i critici non mancano di far notare, scrivendo per esempio che la Bertini “ha innamorato di sé… le donne, e specialmente le fanciulle” 20, seducendole con il “lusso sbalorditivo” e “l’enorme quantità di toilettes”21 messi in mostra nei suoi film. Quindi la Bertini era un modello che le spettatrici desideravano imitare, ma che al tempo stesso in termini realistici rimaneva per loro totalmente inaccessibile. Ciò faceva sì che l’aura della Diva venisse preservata, alimentata da tutti i desideri inappagati delle sue ammiratrici, ovvero da quella che, seguendo Angela Dalle Vacche, potremmo definire la sindrome culturale del ‘vorrei-ma-non-posso’22. L’uso della moda nel genere divistico ha ricevuto una speciale attenzione nella storiografia del cinema muto italiano almeno fin dall’epoca in cui Emilio Ghione, interprete e regista di tanti dei primi successi della Bertini23, pubblicò le sue memorie nel 192824. In questo testo, com’è noto, Ghione attribuisce la rovina dal cinema italiano al costo sempre più elevato dei salari pretesi dalle Dive, e in primo luogo da Francesca Bertini (ironicamente definita, a un certo punto, “Sua Santità”). Da allora, la storiografia moderna ha mostrato tutti i limiti di un’interpretazione tanto semplicistica, situando i costi dello stile di vita delle Dive all’interno di una serie di altri fattori, primo fra tutti la frammentazione di una struttura industriale seriamente carente in termini organizzativi e di programmazione25. Ma vi è senza dubbio una parte di verità nelle affermazioni di Ghione, se è vero che uno dei principali responsabili della profonda crisi che colpì il cinema italiano dopo il 1918 fu Giuseppe Barattolo, ovvero l’uomo che tramite la Caesar Film aveva prodotto i maggiori successi della Bertini e il cui tentativo (portato avanti con Giuseppe Mecheri) di creare un cartello di produttori allo scopo di rafforzare il cinema nazionale doveva sfociare in un vero disastro. È interessante osservare che la Bertini Film, la Casa appositamente dedicata a produrre i film della Diva, fu costituita da Barattolo quasi contemporaneamente all’Unione Cinematografica Italiana, di cui entrò a far parte fin dall’inizio. Mentre non è possibile dimostrare che la Bertini abbia realmente operato nella nuova società in qualità di
produttrice26, la crescente concentrazione sul suo nome indica chiaramente fino a che punto il suo stile rappresentasse per Barattolo un modello di riferimento per il cinema italiano nel suo complesso. In ogni caso Ghione aveva più d’un motivo per non essere tenero con la Bertini. Nel 1914, il suo ambizioso tentativo di portare sullo schermo il celebre dramma di Roberto Bracco Don Pietro Caruso era naufragato a causa di uno dei famosi capricci della Diva, quando le riprese erano già terminate e il film era ormai pronto per la distribuzione. Il testo originale era concepito in accordo con i principi della scuola verista napoletana e anche il film era stato realizzato secondo uno stile realistico di messa in scena. Nella ricostruzione di Ghione, la Bertini riuscì a convincere Barattolo a non mettere in distribuzione la pellicola dopo essersi vista, delusa dall’immagine scialba che aveva in un film nel quale non appariva mai in abiti eleganti e lussuosi27. Le affermazioni di Ghione trovano un riscontro almeno parziale nelle fonti secondarie: infatti, alla martellante campagna pubblicitaria che annunciava il film in uscita sulle principali riviste di settore, non fece seguito alcuna recensione28. Sembrerebbe dunque che nel 1914 il potere della Bertini fosse già abbastanza grande da permetterle di decidere della distribuzione dei suoi film. Ma il suo uso di un tale potere è problematico da un punto di vista femminista, dal momento che la sua carriera non reca traccia di tentativi di sfruttare la sua influenza per offrire alle spettatrici modelli positivi di iniziativa femminile. In un’epoca nella quale la moda era ancora essenzialmente un affare d’alta sartoria, gli abiti splendidamente raffinati che indossava nei suoi film erano destinati a rimanere un puro oggetto di desiderio per il pubblico femminile, dunque un motivo di perenne frustrazione. In effetti, le incredibili toilettes che continuò a sfoggiare lungo gli anni della guerra possono sembrare almeno un poco anacronistiche se si pensa alla reale condizione che le donne italiane stavano sperimentando in quel periodo. Ma per un ulteriore paradosso, la prima a rivolgere a se stessa questa critica fu proprio la Bertini, in un film a sfondo patriottico: Mariute (Edoardo Bencivenga, 1918). Si tratta ancora una volta di un film autoriflessivo, nel quale la Diva svela 67
al pubblico i retroscena del suo lavoro, mettendo in scena una sua giornata tipo. Piuttosto sorprendentemente, la Bertini si rappresenta come una donna pigra e viziata, che arriva sul set sempre in ritardo, costringendo tutta la troupe a interminabili, costosissime attese. Questa rappresentazione semidocumentaria lascia il posto a una finzione patriottica quando un attore appena rientrato dal fronte le fa una lunga descrizione delle atrocità della guerra. Turbata da ciò che ha appreso, la notte seguente la Diva ha un incubo. Nel sogno ha le sembianze di una contadina friulana, che vive con i due figli e il suocero in una semplice casa, mentre il marito è al fronte. La tragedia esplode quando Mariute viene violentata da tre soldati austriaci: sconvolto, il vecchio suocero imbraccia il fucile e fa strage dei colpevoli. Il sogno sortisce un forte effetto sulla Diva, che la mattina dopo “si alza un po’ più presto del solito” e “procura di arrivare al lavoro con appena mezz’ora di ritardo” (dalle didascalie). In accordo con questo messaggio moralistico, in tutta la seconda parte del film la Bertini indossa sempre lo stesso abito di foggia popolare, in qualche modo nella vena verista di Assunta Spina. Tuttavia, la scelta di un’immagine più sobria e l’attitudine naturalista di Mariute furono abbandonate non appena il film successivo fu messo in produzione. Del resto, la subalternità della Bertini alla concezione patriarcale della femminilità non può essere giudicata unicamente dalla sua dipendenza nei confronti della moda. Molto più importante in questo senso è la scelta dei personaggi e dei soggetti, i quali, come si è detto, rimangono ancorati ai modelli più convenzionali della letteratura maschile dell’Ottocento, perpetuando il solito vecchio scenario nel quale le donne sono di regola condannate a finire vittime dell’amore. Ciò non significa che la Bertini fosse incatenata a un unico ruolo, perché anzi la facilità con cui sapeva passare da un ruolo all’altro, dando vita ai personaggi più diversi, era un aspetto caratteristico della sua personalità cinematografica e negli oltre cento film che interpretò nel corso della sua carriera fu senza dubbio in grado di sperimentare un’ampia varietà di posizioni narrative. Ma questa varietà si situa in ogni caso all’interno di un unico intreccio ricorrente: il triangolo sentimentale, 68
nel quale l’eroina finisce fatalmente per rimanere intrappolata. Da questo punto di vista, anche il caso di Histoire d’un Pierrot (Baldassarre Negroni, 1914), singolare prova en travesti della Bertini e dimostrazione tra le più esemplari della sua eccentricità, non sembra costituire un’eccezione. Tratto da una celebre pantomima francese, il film narra le vicende amorose dell’incostante Pierrot, un giovane uomo fantasioso e sognante che prima seduce e poi tradisce la dolce Louisette (Leda Gys), abbandonandola con un figlio per fuggire con la sua nuova fiamma29. Il tono fiabesco della messa in scena fa sì che la storia si concluda (evento raro nel cinema bertiniano) con un lieto fine, quando Pierrot, dopo un’assenza di sei anni e la fine della sua avventura, torna a casa pentito, dove la fedele Louisette ancora lo aspetta. Benché la Bertini sia senza dubbio sorprendente nella sua mascherata maschile, non vi è nulla in questa trama che possa contraddire o ribaltare il consueto schema moralista dei suoi film. Di fatto, il personaggio di Pierrot potrebbe essere letto come una versione mascolinizzata delle tante frivole e incostanti, inconsapevoli e sognanti eroine che avrebbe interpretato nella sua carriera successiva, ancora una volta un doppio che in effetti è anche il responsabile della vittimizzazione del personaggio femminile. Si può dire che in Histoire d’un Pierrot la Bertini abbia messo in scena la fonte patriarcale della sua ispirazione in maniera quasi allegorica, rappresentandosi come il giovane maschio romantico che agisce distruttivamente nei confronti del proprio ideale femminile, sotto l’impulso della passione.
Eroismo femminile e l’autrice come strategia di potere Tutto ciò fa della Bertini un caso piuttosto sconcertante per la storiografia femminista: quello di una donna estremamente potente, che tuttavia non provò mai a sfruttare la sua posizione per offrire alle donne modelli in grado di accrescere il loro potere sociale, che tentò in tutti i modi di costruirsi un’aura di inimitabilità nel momento stesso in cui alimentava un fenomeno generalizzato di imitazione. Ciò è pro-
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
blematico nella misura in cui l’individuazione e la valorizzazione di figure esemplari di ‘grandi madri’, capaci di funzionare come modelli positivi di riferimento, è sempre stato un aspetto importante nella metodologia della storia delle donne; almeno fin da quando Christine de Pizan, la celebre scrittrice del Tre-Quattrocento, immaginò la sua Città delle dame (1405), una costruzione allegorica nella quale riunì i profili di numerose donne illustri del passato30. Da allora, l’apertura di una prospettiva femminista nei diversi campi del sapere storico, per esempio l’arte o la letteratura, ha sempre preso le mosse da un analogo tentativo di delineare una genealogia di ‘grandi madri’ capaci di fungere da esempi positivi di iniziativa femminile. In questo senso anche l’importante progetto lanciato da Jane Gaines sotto il titolo di Women Film Pioneers non fa eccezione, se è vero che il suo scopo è quello di fornire un repertorio di casi biografici che rappresentino altrettanti casi di eroismo femminile, le storie di donne che furono in grado di intraprendere una carriera professionale in un’epoca in cui il potere e i pregiudizi patriarcali erano ancora molto forti31. Indubbiamente le vite di queste donne appaiono esemplari sotto una molteplicità di aspetti e il loro studio potrà rivelare importanti dettagli circa i modi nei quali la condizione femminile veniva declinandosi in vari contesti geografici e culturali nei primi decenni del Novecento. Ma che fare quando questo progetto di genealogia femminista si imbatte in figure che appaiono refrattarie a questo genere di lettura, donne che possono essere state indifferenti e perfino ostili alla causa femminista? Mentre non vi è ragione di ritenere la Bertini realmente ostile, in quanto non risulta che abbia mai preso posizione in merito, casi eclatanti di autrici antifemministe non sono rari nel periodo in questione, in Italia e non solo. Basti pensare per esempio a Matilde Serao, la prestigiosa scrittrice e direttrice del quotidiano napoletano “Il Giorno”, oppure a Neera, altra celebre autrice dello stesso periodo, e alle loro esplicite dichiarazioni di avversione al femminismo32. Come già le storiche della letteratura, anche le storiche del cinema devono imparare in che modo affrontare simili casi, perché la stessa storia dell’eroismo femminile non sarebbe concepibile se non sullo sfondo di un contesto largamente
sfavorevole all’iniziativa autonoma delle donne, di una cultura patriarcale egemone che ha sempre potuto contare sull’adesione non solo degli uomini, ma anche di un gran numero di donne. Eppure, anche nel caso di figure problematiche come queste, il compito della storiografia femminista rimane lo stesso di sempre, cioè a dire quello di rinvenire aspetti del loro eroismo che possano essere valorizzati in termini femministi, anche al di là della loro stessa intenzione ‘autoriale’. Nel caso della Bertini ciò conduce a un ulteriore paradosso, in quanto non sembra che la rivalutazione della sua figura possa avvenire senza ricorrere alla controversa nozione di ‘autore’. Il punto è delicato, in particolare alla luce di tutti i pericoli e limitazioni che l’approccio autoriale inevitabilmente comporta dal punto di vista della storia delle donne, come Jane Gaines ha ben mostrato nella sua critica del “soggetto analizzabile” in quanto mito teorico33. Tuttavia, come la discussione precedente dovrebbe già aver chiarito, il tipo di autrice che è qui in questione ha ben poco a che vedere con quella sorta di individualità inconscia e spirituale che costituisce l’oggetto della sua critica, soggetto trascendente che si rivelerebbe attraverso i segni del testo per fungere da garante della coerenza del senso. Nei termini della stessa Gaines, si potrebbe dire che l’autrice come qui la intendiamo non sia nemmeno esattamente un qualcuno, ma piuttosto un qualcosa di molto più storico, culturale e materiale, che certamente implica l’iniziativa concreta di un soggetto individuale, ma include anche tutta una serie di ‘oggetti’ storici e culturali, che non solo non dipendono dalle capacità di controllo e dall’intenzione di quel soggetto, ma anzi in buona parte lo costituiscono: per esempio i libri che leggeva, gli abiti che indossava, o più in generale le condizioni specifiche dell’istituzione patriarcale quali esse si davano in un determinato momento storico. Questa dialettica di iniziativa individuale e condizionamento culturale è un elemento decisivo nella metodologia della storia delle donne, che appare meno compromesso con la mistica del ‘soggetto analizzabile’ di quanto non ricordi invece il concetto originale di autore cinematografico come regista in lotta contro il sistema produttivo. In altri termini, una nozione restrittiva, essenzialmente 69
operativa di autore può ancora essere utile allo scopo di analizzare, anziché i soggetti, le forme di potere nelle quali i soggetti erano catturati e definiti e le strategie da loro organizzate per liberarsi: giacché si può porre come presupposto che, in quanto donne, fossero già da sempre in qualche modo impegnate a liberarsene. Ciò naturalmente non significa che la nozione di autore debba tornare a essere la misura esclusiva per apprezzare e valorizzare il contributo delle donne alla storia del cinema, perché senza dubbio questo obiettivo può essere perseguito e raggiunto in molti altri modi. Ma la nozione può ancora essere operativa almeno nel caso di donne che riuscirono a costruire se stesse in quanto autrici, come strumento per individuare e analizzare – al di là di qualsiasi ontologia del soggetto e del genio individuale – le strategie di potere messe in campo in una tale costruzione.
Bertini regista: una pioniera del neorealismo? Si arriva così ad Assunta Spina, ovvero al film che, tra oltre cento altri titoli, la Diva volle accreditarsi sotto ogni aspetto, dalla sceneggiatura alla scelta delle location, dalla regia al montaggio. Come nel caso di Alice Guy, anche qui la fonte principale per affermare la responsabilità della Bertini in questo e altri film sono le dichiarazioni contenute nelle sue autobiografie e nelle numerose interviste da lei rilasciate in tarda età, la più eccezionale delle quali fu trasformata in un film da Gianfranco Mingozzi nel 198234. Ciò che colpisce in buona parte di questi documenti è la determinazione della Bertini nel rivendicare uno statuto autoriale. Nell’intervista rilasciata a Costantini, per esempio, ella non esita ad affermare che “la storia del cinema bisogna rifarla dal principio alla fine” in quanto, quale vera autrice di Assunta Spina, deve esserle riconosciuto il merito di avere ‘inventato’ il Neorealismo35. Diversamente da Alice Guy, tuttavia, la Bertini sembra aver maturato la preoccupazione di essere riconosciuta come regista solo in una fase avanzata della sua vita, giacché nel periodo della sua carriera attiva non vi sono tracce di tentativi in questa direzione. Al contrario, sostiene la Diva, “non volevamo mettere il mio nome 70
[nei titoli, come regista]”36 e benché non ne spieghi il motivo è evidente che la decisione non era stata presa contro la sua volontà. Ciò può sembrare strano alla luce della natura egotistica, autocentrata della Diva, ma in fin dei conti è perfettamente coerente con l’intento di concentrare tutta l’attenzione sullo spettacolo offerto dalla sua persona. Ad ogni buon conto, la Bertini non sembra in alcun modo aver sofferto di questa situazione, se è vero che il suo desiderio di essere considerata una regista cominciò a manifestarsi solo quando l’idea del regista come autore si era ormai largamente affermata. Senza dubbio all’epoca della sua intervista con Mingozzi, la Bertini era perfettamente consapevole sia del nuovo statuto autoriale acquisito dai registi moderni – vale la pena di ricordare che la sua ultima prova cinematografica fu un piccolo, ma indimenticabile ruolo in Novecento di Bernardo Bertolucci (1976) – sia delle ricostruzioni storiografiche relative al cinema muto italiano, nelle quali Assunta Spina veniva ripetutamente indicato, accanto a Sperduti nel buio (Nino Martoglio, 1913), come un importante antecedente del neorealismo37. La rivendicazione della Bertini merita quindi di essere valutata nel modo più attento, dal momento che il suo obiettivo dichiarato è di promuovere una riscrittura della storia del cinema italiano nella quale una donna sia chiamata a occupare una posizione di vera e propria iniziatrice. A questo punto della sua vita, la Bertini sapeva bene che il suo riconoscimento in quanto pioniera del cinema dipendeva esclusivamente dal suo riconoscimento in quanto regista, di conseguenza nelle sue interviste era sempre attenta a sottolineare il proprio contributo alla mise-en-scène, presentando i suoi registi, anche i più dotati, come meri esecutori delle sue volontà. Nell’intervista con Mingozzi, per esempio, afferma che i registi “purtroppo non erano all’altezza di vedere certe cose, ecco. Sì, stavano dietro la macchina da presa ma… Io andavo sul set e dicevo: ‘Signorì, che facciamo? Ecco ci mettiamo qua, ci mettiamo là perché questa scena la vedo così, cominciamo!’”38 Allo stesso tempo è importante ricordare che negli anni della sua carriera attiva il lavoro di regista non era né così prestigioso, né così decisivo per poter accedere al rango di autore.
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
Francesca Bertini con Annibale Ninchi in La piccola fonte, 1917 (Cineteca di Bologna)
Anche se i crediti di Assunta Spina attribuiscono la regia a Gustavo Serena, il protagonista maschile del film, vi possono essere pochi dubbi circa il fatto che il pubblico contemporaneo riconoscesse nella Bertini la principale artefice dell’opera. Addirittura non sarebbe eccessivo affermare che il riconoscimento di uno statuto autoriale fosse parte integrante della sua immagine, così come sembra di poter evincere da un libretto pubblicitario del 1916, che la descrive come la principale autorità dello studio: “Il Direttore, gli attori, gli operatori, i macchinisti, i servi pendono se non dalle sue labbra, dal suo ‘gioco’: essi assistono a un’altra battaglia vinta!”39. O ancora si può citare un articolo del 1927 nel quale Roberto Bracco la definisce ironicamente con il termine di “cinematografaia” e presenta il suo “capriccio”
come l’unico “fattore del risultato della sua attività […] un capriccio che signoreggiava, comandava e ineluttabilmente operava”40. Il documento è particolarmente interessante in quanto sembra confermare le dichiarazioni della stessa Bertini circa la propria responsabilità registica nella realizzazione di La piccola fonte (1917, ancora una volta perduto), primo titolo di una lunga serie di film firmati da Roberto Roberti, suo regista di fiducia e nelle sue parole un uomo “buono, gentile, paziente”41. Bracco ricorda come, in quanto autore del dramma teatrale da cui il film era tratto, egli avesse inutilmente cercato di convincere Barattolo di non affidare il personaggio di Teresa alla Bertini, che ai suoi occhi era “troppo bella, troppo invadente, troppo protagonista” per il ruolo di una “piccola umile creatura dall’aspetto 71
insignificante”, resa folle dalle dimostrazioni di indifferenza del marito. Dopo lo sfortunato esito di Don Pietro Caruso, Bracco aveva più d’un motivo per non fidarsi della Bertini, ma dovette capitolare di fronte alla determinazione con cui la Diva insistette per ottenere la parte. La descrizione della sua visita allo studio Caesar è troppo divertente per non essere riferita. Bracco ricorda come, appena giunto sul set e vedendo la Bertini agitarsi follemente nei panni della sfortunata Teresa, egli sentì un colpo secco al mio cuore d’autore ed esclamai ‘Poveretto me!’ […] Non m’era mai parsa così sorprendentemente bella! Non m’era mai parsa così idonea a comandare, a spadroneggiare, a dominare pazzescamente! Don Peppino [Barattolo], che aveva dovuto tradirmi, andava sgattaiolando pei viali della villa. Francesca Bertini non badò a me, intenta a fare la pazza come la sua fantasia le suggeriva. L’operatore – il fotografo –, con assorta devozione, regolava i giri della macchina fotografica. Il metteur en scène, in un cantuccio, taceva, estasiato. E, ugualmente tacendo, io restai lì a guardare annichilito.
Bracco prosegue riferendo che non provò neppure a protestare, pur non riconoscendo nulla del suo lavoro in ciò che vedeva, in quanto gli sarebbe stato comunque impossibile interferire con l’autorità della Diva. L’articolo è soprattutto importante per il modo in cui descrive le relazioni di lavoro della Bertini in termini di relazioni di potere. Bracco si spinge fino a indicare la base di questo potere nel modo di produzione adottato alla Caesar, un sistema totalmente non metodico dominato dall’improvvisazione e dall’estemporaneità delle decisioni. Come si è visto ripetutamente nello studio delle prime donne cineaste, anche la Bertini sembra aver conquistato il suo potere grazie alle condizioni esistenti nell’industria cinematografica prima della sua istituzionalizzazione negli anni Venti: “Ella aveva bisogno di fare a modo suo in un ambiente che senza restrizioni glielo consentisse”42. In ogni caso, quell’atmosfera “caratterizzata dalla genialità inconsapevole, dall’assenza d’idee e di criteri precisi, dalla mutevolezza, dall’elasticità, dall’impreveduto, dall’imprevedibile, dall’avvento del capriccio, dall’indisciplina” che Bracco descrive 72
a proposito di La piccola fonte appare perfettamente congrua con la ricostruzione offerta dalla stessa Bertini del proprio metodo di lavoro, tanto in questo film come in Assunta Spina. Il punto è rilevante soprattutto in relazione ad Assunta Spina, in quanto è direttamente collegato alla richiesta di essere riconosciuta quale pioniera del neorealismo. Nel suo commento durante la proiezione del film in moviola, che costituisce uno dei momenti più emozionanti del documentario di Mingozzi, la Bertini parla di una scena girata in una delle strade più popolari di Napoli, non contenuta nel dramma di Di Giacomo e realizzata per sua iniziativa su due piedi, in modo del tutto estemporaneo. Sostiene inoltre di essere l’unica responsabile della “idea di girare per le strade di Napoli […], andare al Tribunale, prendere la gente della strada... Dicono ‘neorealismo, neorealismo’, ora tutti hanno inventato il neorealismo. Ma il vero film neorealista è Assunta Spina, del 1914” 43. E conclude: “Posso dire, senza immodestia, che il film lo diressi io, anzi che ne curai la sceneggiatura, l’adattamento, la scenografia e la regia. Io sono stata la prima donna regista della storia del cinema”44.
Dirigere se stessa, ovvero: lo sguardo nello specchio Questa abilità nell’improvvisazione è un elemento decisivo nella comprensione del potere della Diva, cioè a dire della sua capacità di controllare lo stile visivo dei suoi film. Di fatto, uno dei punti sui quali maggiormente insiste nelle sue interviste è la perfetta singolarità delle sue prove recitative, nel senso che ogni scena veniva ripresa, a suo dire, in un unico ciak. Dice per esempio: “Noi non provavamo mai, nessuna prova: io non ho mai provato una scena. Era difficile lavorare una scena con me, non provavo mai, allora, capisci, quello che veniva veniva”45. E ancora: “Giravamo sempre una sola volta. Ciò che davo la prima volta, d’impulso, sotto un moto del cervello, non potevo ripeterlo”46. Anche se è impossibile attribuire a queste parole un valore letterale, la visione del film girati alla Caesar rivela una strategia realizzativa che appare perfettamente compatibile con l’obiettivo di ridurre al mi-
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
Foto tratta dall’autobiografia di Francesca Bertini apparsa a puntate su “Film” nel 1938 (n. 29, 13 agosto). La didascalia indica, nell’ultima attrice a destra, una Bertini “tredicenne che interpretava, su un palcoscenico napoletano, Assunta Spina”
nimo il numero di riprese effettuate per ogni film. Di sicuro, nel cinema della Bertini, l’unità minima del linguaggio non è l’inquadratura, ma la scena. Si tratta indubbiamente di uno stile di regia il cui modello immediato è il teatro e nel quale l’aspetto più rilevante è la continuità della prestazione dell’attore. La Bertini chiarisce il punto con estrema precisione quando afferma che i primi piani ‘raffreddano’, ricordando come il cinema italiano non fosse aduso ai sofisticati effetti fotografici adottati dai registi americani per enfatizzare la bellezza delle attrici47. Uno stile di regia basato su singole riprese di lunghe inquadrature aveva ovvie implicazioni economiche per i produttori, la cui principale preoccupazione, sostiene ancora la Bertini, era quella di economizzare al massimo sul consumo di pellicola (afferma, per esempio, che le riprese di Assuna Spina non richiesero più di 2200 metri di pellicola)48. Ciò può contribuire a spiegare l’importanza acquisita in questo cinema da un certo tipo di attrice, capace non solo di recitare un’intera scena senza interruzioni,
ma anche di interpretarla subito bene al primo ciak. Il modello di riferimento era, con ogni evidenza, il teatro e certamente la Bertini non era la sola Diva ad aver fatto il proprio apprendistato sulla scena, l’esempio più illustre essendo quello di Lyda Borelli. La Bertini cominciò a recitare in teatro quando era ancora adolescente e la sua prima apparizione come comparsa, nel ruolo di una piccola stiratrice, sembra essere avvenuta proprio in un allestimento di Assunta Spina, a Napoli nel 1904. Ma ciò che appare straordinario nel suo caso è come sia riuscita ad adattare le sue qualità teatrali allo schermo al fine di garantirsi il più ampio margine di controllo sulla scena. Non solo la centralità narrativa dei suoi personaggi le assegnava automaticamente una posizione dominante all’interno dell’inquadratura, ma la sua capacità di far subito bene al primo ciak la poneva in condizione di esercitare la più grande influenza a livello della stessa regia. Ci si potrebbe spingere fino a suggerire che la sua strategia della ripresa unica servisse esattamente a permetterle di 73
sfuggire al controllo del regista e perfino a collocarlo in una posizione vicaria in rapporto a lei. Ancora una volta le sue parole sono eloquenti in proposito, come per esempio laddove afferma che era sempre lei a stabilire la posizione della macchina da presa, mentre il regista “aspettava che io decidessi. Io dicevo: ‘Mettete la macchina lì, perché io mi muoverò così’. E lui buono, zitto, eseguiva”49. Possiamo certamente trovare in queste parole qualche importante spunto di apprezzamento femminista, soprattutto in considerazione della dimensione puramente cinematografica nella quale la Diva sembra aver costituito il suo potere. Non può sfuggire infatti fino a che punto, nella sua recitazione, il modello teatrale sia abilmente piegato alle esigenze della resa cinematografica della sua immagine. La prevalenza di piani americani e campi medi consente alla Bertini di esprimere anche visivamente il proprio predominio sulla messa in scena, di manifestare con la massima evidenza il proprio ruolo di centro di gravità intorno al quale ruota l’intero universo del film. Del resto, sebbene i primi piani siano assai rari nel suo cinema, le intense espressioni del suo volto sono perfettamente leggibili anche nei piani d’insieme e sono continuamente sottolineate dai movimenti delle mani e dall’uso dei costumi (come per esempio nel caso dello scialle indossato da Assunta Spina, che diviene un mezzo per sottolineare sentimenti tanto diversi come l’orgoglio e la paura, la sensualità e la sofferenza)50. Benché i suoi movimenti siano sempre molto misurati, in realtà sullo schermo la Bertini non smette mai di muoversi, modellando il suo viso e i suoi gesti in un incessante processo di variazione emotiva. Indubbiamente la mutevolezza del suo viso estremamente reattivo è un elemento essenziale del suo stile di recitazione, in grado di produrre tutto un sottotesto pieno di significati che le trame non dicono, come per esempio la baldanza e l’orgoglio dei suoi personaggi, il loro istinto di provocazione, di ribellione e trasgressione. Questi aspetti si accompagnano ad altri più tradizionali, come la seduzione, la passione erotica, il dolore e perfino la sottomissione, componendo un misto contraddittorio di tipi e posizioni soggettive che incessantemente sfumano l’uno nell’altro. Dunque la Bertini è un multiplo già a livello della 74
sua recitazione, ma il processo della sua moltiplicazione e frammentazione ha il suo punto d’innesco a un livello ancor più primario, nello sdoppiamento immaginario tramite il quale, durante le riprese, ella proiettava il proprio sguardo al di fuori della sua immagine visibile, nel punto di vista vacante che di volta in volta decideva di assegnare al regista. In assenza della possibilità di trovarsi fisicamente fuori dal suo corpo, il solo modo che aveva per rivolgere su di sé il proprio sguardo era quello di guardarsi allo specchio, ciò che in effetti la si vede fare di continuo nei suoi film.
L’autrice autorizzata Ma non erano tutti quegli specchi (e film) semplicemente una trappola, un apparato di cattura per tutti gli sparsi, frammentari riflessi di se stessa? Quel che è certo è che nel cinema della Bertini l’incessante moltiplicazione della sua immagine non è in contraddizione con la produzione di un effetto di singolarità, cioè a dire con la continua conferma della sua inimitabile identità di Diva. Il circuito chiuso delle sue immagini visibili continuava a ruotare intorno a un punto cieco, il punto ideale al quale ogni singola immagine doveva infine essere riferita51. Ma tutto questo basta per fare di lei un’autrice? Se con questo termine si vuole intendere qualcuna che sia in grado di controllare il processo di realizzazione del film e di determinare, anche a dispetto delle costrizioni produttive, l’immagine risultante, allora senza dubbio la Bertini merita d’esser considerata tale. Tuttavia, in una diversa prospettiva, non è difficile vedere fino a che punto ella fosse contemporaneamente autorizzata e prodotta, quale risultato singolare di una molteplicità di fattori culturali. In fin dei conti, si può dire, non era nulla più che un’autrice, solo una dei tanti rinomati e celebrati autori che ancora in quei giorni continuavano a costruire la loro fama e le loro fortune sulla distruzione dei personaggi femminili, reiterando il vecchio, decadente stereotipo melodrammatico della donna fatale che finisce strangolata nelle spire della sua sensualità e della sua bellezza. Significativamente, una delle scene di cui andava più orgogliosa, affermando di
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
Francesca Bertini in Andreina, 1917 (Cineteca di Bologna)
averla creata contro il parere del regista (e senza dubbio di Bracco), era il sensazionale suicidio da lei introdotto nel finale di La piccola fonte, laddove la folle Teresa, in camicia da notte, i lunghi capelli sciolti sulle spalle, si gettava nel mare dall’alto di un muro52. Perciò il problema che si pone con la Bertini non è quello di stabilire fino a che punto ella fosse in grado di realizzare le sue fantasie, dal momento che tutte le fonti concordano nell’attribuirle un potere decisionale semplicemente immenso53. Il problema è piuttosto fin dove potessero spingersi le sue fantasie e se mai la sua immaginazione fosse in condizione di oltrepassare i limiti stabiliti dalla cultura patriarcale. Ma in effetti la Bertini sembra essersi sentita sempre a proprio agio all’interno di quei limiti e se indubbiamente fu molto abile nel volgere a proprio vantaggio gli stereotipi misogini di cui l’epoca pullulava, non si può dire che abbia mai minimamente cercato di metterli in questione, né nei soggetti scritti di suo pugno, né nel tentativo lungamente perseguito di
Assunta Spina. Giacché anche in quel caso, l’oggetto del suo desiderio era un personaggio tratto dalla lunga galleria di donne “timorate di Dio, ingenue, appassionate” create da Di Giacomo, che un lettore competente come Domenico Rea ha potuto criticare per la loro distanza da un tipo femminile ben più rappresentativo della realtà di Napoli, “la femmina violenta, acida e triste, che non tira dalla gola un solo rigo di canzone per un anno intero”54. Perciò non è possibile concordare con la Bertini quando afferma di avere inventato il neorealismo. Perché ciò fosse vero anche solo in parte, il suo cinema dovrebbe mostrare almeno qualche crepa nell’armatura melodrammatica che invece lo sostiene tutto intero e che del resto fornisce lo schema fondamentale alla stessa tradizione verista alla quale è ispirato. Di sicuro, scendere nelle strade non è sufficiente per realizzare un film neorealista, altrimenti sarebbero molti altri i registi che, a buon diritto, potrebbero rivendicare il titolo di neorealisti ante litteram. Per essere tale, la Bertini avrebbe dovuto mostrare almeno l’intenzione di un rapporto minimamente più impegnato con la realtà, mentre rimase sempre una figura distaccata, un’icona distante, irraggiungibile. Questo giudizio può suonare eccessivamente severo, giacché le condizioni generali in cui versava in quegli anni la cultura italiana, stretta tra moralismo bigotto e velleità superomistiche di stampo dannunziano, indubbiamente non incoraggiavano le donne a sviluppare e coltivare un immaginario autonomo e, a parte rare eccezioni, cinema e letteratura rimanevano territori fondamentalmente maschili. Eppure, anche in un contesto così sfavorevole, affiorano a tratti voci femminili che ci parlano di un altro genere di ricerca, voci che sono spesso assai sottili, quasi inudibili, quasi sommerse dal rumore di quella cultura misogina che al contrario garantiva alla Bertini la più trionfale visibilità e autorità. Voci critiche come quella di Donna Paola, giornalista e scrittrice che in un importante saggio del 1917 esprimeva il suo impaziente desiderio di una nuova letteratura, nella quale le donne non fossero più rappresentate unicamente come “le belle e le fatali peccatrici”, creature “di lusso, di frivolezza e di vizio”, dinanzi alle quali il pubblico maschile aveva da sempre bruciato “l’incenso della sua vile, cieca, folle adorazio75
ne”. Una nuova letteratura era necessaria per fornire alle donne modelli alternativi, per liberarle da una pletora di “sogni senza fondamento” e dal bisogno di “attizzare sino alla frenesia la propria femminilità, nel tentativo vano ed esasperante di dare al sogno una parvenza di vita”55. Ma le poche cineaste che tentarono di interpretare queste speranze non si trovarono certo a percorrere un facile sentiero. Il caso più eclatante è senza dubbio il coraggioso adattamento di Cenere, di Grazia Deledda, da parte di Eleonora Duse, un film aspro, rarefatto, in cui la Diva si riservò il ruolo di una vecchia madre rugosa e disperata. Ma il pubblico rimase deluso da questo tentativo che non concedeva nulla all’estetismo dannunziano e che non restituiva in alcun modo l’immagine attesa della grande attrice. Di conseguenza il film non ebbe successo e la Duse dovette rinunciare al suo progetto di realizzare un secondo film. Ancora si possono ricordare i nomi di Bianca Virginia Camagni, Elettra Raggio, Giulia Rizzotto, oltre a quello – appena riscoperto dopo quasi un secolo di oblio – di Elvira Giallanella: tutte cineaste che tentarono, ognuna a modo proprio, di esplorare qualche percorso originale al di fuori del genere divistico dominante, finendo anch’esse per essere rapidamente costrette a rinunciare ad altri progetti dopo aver girato solo pochi film. Per quanto ingenui e incerti possano essere stati, questi tentativi possono aver rappresentato un tipo di fantasia femminile che non rispondeva ai parametri stabiliti della cultura contemporanea e che forse proprio per questo era destinato ad affondare nel disinteresse e nell’oblio. Probabilmente molte altre fantasie rimasero solo allo stato di desiderio. Si pensi per esempio al lavoro di Lina Ferraris, i cui testi per il cinema (almeno cinque tra soggetti e sceneggiature, quattro dei quali conservati presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino) non giunsero mai (a parte un unico caso) a essere trasposti sullo schermo56. Nessuna di queste donne potrebbe mai essere considerata un’autrice, ma il loro lavoro può essere anche più importante di tutti i film largamente acclamati della Bertini, per comprendere fino a che punto le donne italiane furono – o piuttosto non furono – in grado di esprimere e realizzare il loro desiderio di fare cinema. La loro esistenza è anche decisiva per 76
aiutarci a determinare correttamente la posizione di Francesca Bertini nella storia delle donne: quella di un’autrice straordinariamente intelligente, autorevole e ambiziosa, che tuttavia non riuscì a creare le premesse di un nuovo cinema.
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta
Note
1 Già nel 1956, nella sua Storia del cinema muto (Giannini, Napoli, p. 160), Roberto Paolella riconosceva che “l’autentica creatrice del film è Francesca Bertini. Tutti coloro che nel suo nome sono disposti a facilmente ironizzare su la maniera delle nostre dive, la loro gesticolazione sommaria, il troppo e l’agitato della loro esuberanza, dovrebbero vedere almeno due volte Assunta Spina”. Anche se nei repertori il film continua tuttora a essere attribuito al solo Gustavo Serena (in accordo con quella che la stessa Bertini dichiara essere stata una sua precisa volontà, vedi infra, pag. 70), l’estensione in questo film del ruolo della Diva alla regia viene oggi in genere accettata dagli storici, soprattutto dopo la pubblicazione da parte di Vittorio Martinelli di uno stralcio di intervista con lo stesso Serena, in Il cinema muto italiano: i film della Grande Guerra. 1915, vol. 1, eri, Roma 1992, p. 56. Serena, che nel film interpreta il violento fidanzato di Assunta, Michele Boccadifuoco, ricorda che la Bertini era “così esaltata dal fatto di interpretare la parte di Assunta Spina, che era diventata un vulcano di idee, di iniziative, di suggerimenti. In perfetto dialetto napoletano, organizzava, comandava, spostava le comparse, il punto di vista, l’angolazione della macchina da presa; e se non era convinta di una scena, pretendeva di rifarla secondo le sue vedute. Era in un vero e proprio stato di grazia”. Assunta Spina era stata il cavallo di battaglia di Adelina Magnetti in teatro e nel portarla sullo schermo la Bertini intendeva probabilmente misurarsi con la reputazione e il talento della grande attrice napoletana (la quale, secondo Martinelli, era stata coinvolta, sempre nel 1914, da Giovanni Grasso, in un altro progetto di riduzione cinematografica della Morgana Film, che non vide mai la luce). 2 Va a Vittorio Martinelli il merito di aver per primo dedicato qualche attenzione alle donne registe del cinema muto italiano, nell’articolo Le metteuses-en-scène, “Cinemasessanta”, n. 141, 1981, pp. 21-25. Per una panoramica delle cineaste (registe, sceneggiatrici, produttrici, ecc.) attive in Italia nel periodo muto si veda l’appendice al presente volume. 3 Nelle sue numerose interviste la Bertini rivela sempre un’attitudine piuttosto aspra e competitiva nei confronti delle altre dive. In particolare, dimostra una spiccata antipatia per Lyda Borelli, l’unica attrice che si impose prima di lei nel panorama delle dive, raggiungendo il successo già nel 1913 in La memoria dell’altro, di Mario Caserini. Ma come la Bertini non manca di far notare, la Borelli era già un’affermata interprete teatrale al momento del suo ingresso nel cinema, che si limitò a girare qualche film, mentre il successo della Bertini fu un fenomeno esclusivamente cinematografico, conquistato quando era ancora giovanissima, apparendo in un gran numero di film. Le uniche eccezioni all’attitudine generalmente dispregiativa nei confronti delle sue colleghe sono i giudizi su Lina Cavalieri (“la sola donna alla quale non mi dispiace di essere paragonata”) e Leda Gys, che recitò con lei in Histoire d’un Pierrot. Si veda l’intervista contenuta in Costanzo Costantini, La diva imperiale. Ritratto di Francesca Bertini,
Bompiani, Milano 1982, pp. 57-61. 4 Come osserva Judith Mayne in The Woman at the Keyhole (Indiana University Press, Bloomington 1990, p. 93), “non sempre il ruolo dell’attrice è conforme alla comune convinzione femminista che il potere di controllo visivo sia per forza di pertinenza maschile, ovvero del regista: si pensi per esempio al caso di Bette Davis”. In questo senso, un concetto allargato di recitazione cinematografica sembra essere una inevitabile conseguenza dell’approccio femminista alla storia del cinema. 5 Le recensioni dei film diretti da donne erano non di rado decisamente negative. Sia Diana d’Amore (Sulle rovine di un sogno, Cines, 1920) che Fabienne Fabrèges (L’altalena della vita, De Giglio, 1919) furono esplicitamente invitate ad abbandonare le loro ambizioni registiche. Altre attrici che si cimentarono dietro la macchina da presa poterono farlo solo creando loro proprie Case di produzione, come Gemma Bellincioni e Giulia Cassini, i cui film furono spesso oggetto di critiche impietose. Se il lavoro di Elettra Raggio e di Diana Karenne fu accolto con maggiore simpatia, Eleonora Duse andò invece incontro, con Cenere, a un clamoroso fallimento, che la costrinse a rinunciare al progetto di un nuovo film. Altri film che ebbero un travagliato destino distributivo furono Fantasia (o Fantasia bianca, di Sepo e Bianca Virginia Camagni, 19211923) e Umanità di Elvira Giallanella, realizzato nel 1919 ma forse mai uscito sugli schermi. E si potrebbe continuare. 6 Per una valutazione della fortuna critica di Francesca Bertini si vedano, tra l’altro: Francesco Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935; Maria Adriana Prolo, Storia del cinema muto italiano, Poligono, Milano 1951; Giulio Cesare Castello, Il divismo, ERI, Torino 1957; Pietro Bianchi, La Bertini e le dive del cinema muto, Utet, Torino 1969; Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli, Francesca Bertini 1892-1985, csc, Roma 1987; Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano, vol. 1, Editori Riuniti, Roma 19932. Due importanti contributi recenti sulle Dive del muto italiano che dedicano ampio spazio alla Bertini sono i libri di Cristina Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’Epos, Palermo 2006, e Angela Dalle Vacche, Diva. Defiance and Passion in Early Italian Cinema, University of Texas Press, Austin 2007. La prima autobiografia della Diva fu pubblicata a puntate sotto il titolo Arte e vita di Francesca Bertini, sulla rivista “Film”, nn. 28-42, agosto-novembre 1938. Nuove memorie videro la luce vent’anni dopo nel volume Il resto non conta, Giardini, Pisa 1969. In tarda età la Bertini rilasciò numerose interviste, tra le quali la più straordinaria è senza dubbio quella filmata da Gianfranco Mingozzi nel 1981, in parte durante una visione privata di Assunta Spina presso la Cineteca Nazionale, in seguito inclusa nel documentario televisivo in quattro puntate L’ultima diva (1982). Prodotto dalla rai, il lavoro di Mingozzi ebbe anche un’edizione cinematografica, oggi disponibile in versione home video (Kino Video, 2003). L’intervista è parzialmente trascritta in Gianfranco Mingozzi (a cura di), Fran77
cesca Bertini, Le Mani, Recco 2003, pp. 49-78. Altre due interessanti interviste con la Bertini si trovano in Costanzo Costantini, op. cit., e in Enzo Biagi, Amori, Rizzoli, Milano 1988. 7 Le trame dei film furono tutte aspramente criticate. Secondo Vincenzo Guerriero (“La Vita cinematografica”, 22-30 luglio 1917), il soggetto di My Little Baby “è uno spunto che vanta una barba matusalemmica; è un vecchio leit-motif da pochade di marca francese”. La recensione indica esplicitamente la causa dell’insuccesso del film nei “non pochi difetti” del testo. Un giudizio analogo viene dato da Angelo Menini su “La Cinematografia italiana ed estera” (30 aprile 1916) a proposito di La perla del cinema: secondo il recensore, “Francesca Bertini attrice è di gran lunga superiore a Francesca Bertini autrice: inutile certamente voler esaminare questo debole soggetto e rivelarne le numerose pecche”. Entrambi i film furono firmati da Giuseppe De Liguoro, mentre Nella fornace (anch’esso giudicato da “La Vita cinematografica”, 30 marzo 1915, “farraginoso, complicato e… allungato per stiracchiamento […] inutile trattenersi sull’intreccio”), fu diretto da Nino Oxilia. 8 L’osservazione compare almeno due volte nelle recensioni di due film del 1915, Il capestro degli Asburgo e Nella fornace (diretti rispettivamente da Gustavo Serena e Nino Oxilia), entrambe pubblicate in “La Vita cinematografica”, 30 marzo e 22-30 luglio 1915. 9 Allan Kardec, Nelly la gigolette, “La Cinematografia italiana ed estera”, 15 febbraio 1915. 10 Pier Da Castello, Nelly la gigolette, “La Vita cinematografica”, 15 febbraio 1915; Louis Delluc, Notes pour moi, “Le Film”, 26 novembre 1917. 11 Il crescente richiamo esercitato sulle giovani donne dal mondo del cinema quale ambiente professionale ideale è ben documentato in un articolo pubblicato in due puntate, nel 1916, su “La Donna”, una rivista femminile che per qualche tempo dedicò considerevole spazio al fenomeno delle Dive. “A Parigi come a Pietrogrado, da noi come nell’America Latina, le giovani bellezze desiderose di vivere d’arte e d’amore hanno un culto per le stelle del cinematografo e ognuna ha le sue predilette: c’è chi adora la Borelli (in genere piace più agli uomini questa nostra bellezza proteiforme e piuttosto svestita), c’è chi ama la Bertini, altre sono per le straniere come la Makovska o la Karenn [sic], le due diverse personalità russe originali che il cinematografo ha rivelato quest’anno. C’è chi giudica la Menichelli unica e grande, c’è chi giura per Hesperia o Leda Gys! Tutte però finiscono per dare della loro ammirazione dei segni tangibili e qualche volta forse anche inconsci e inavvertiti – imitando le pose dolenti, l’andatura – direbbe il marchese Colombi buon’anima – un po’ sconnessa, le smorfie insistenti ma graziose. Il sesso gentile oggi ‘bertineggia’ come tempo fa aveva ‘borelleggiato’ o domani Menichellerà, e la facilità con la quale in breve tempo le regine della scena muta acquistarono notorietà e ricchezza è il tema preferito ai suoi discorsi. […] Si cerca di accreditare la leggenda che le nostre ragazze – ripetendosi in petto il quo non ascendam – di Simon Mago – si 78
suggestionano all’esempio delle rapide fortune delle artiste recentemente diventate celebri e si affollano alle porte delle scuole cinematografiche e delle manifatture di pellicole per darsi alla carriera neo-mimica. E questo, per fortuna, non è vero. […] Ebbene, mai come ora, le case cinematografiche hanno avuto a deplorare la penuria, come quantità e come qualità, di artiste cinematografiche. […] Manca ancora la scuola diretta da competenti, da istruttori seri, che abbia sinceramente lo scopo di produrre delle artiste. […] Tuttavia l’arte cinematografica ha bisogno di reclute ed un numero stragrande di fanciulle desidera dedicarsi alla cinematografia. Per quanto tempo ancora questi amori sono destinati a rimanere platonici?” Fabrizio Romano, Il fascino dello schermo, “La Donna”, nn. 227-278, 5-20 luglio 1916; cit. in Chiara Caranti, La Diva e le donne, in Gianfranco Mingozzi, op. cit., pp. 116-119. 12 A. R., La perla del cinema, “Apollon”, n. 4, aprile 1916. 13 Per una recente analisi della fortuna del motivo della ‘donna sconfitta’ nel teatro d’opera italiano dell’Ottocento e della sua persistenza nel cinema bertiniano si veda Michèle Lagny, Avec ou sans voix: la femme défaite, “Cinémas”, n. 1, 2005, pp. 117-137 (numero monografico Femmes et cinéma muet, a cura di Rosanna Maule). Sulla pervasività della figura della femme fatale nel cinema italiano degli anni Dieci, si veda Lisetta Renzi, Grandezza e morte della femme fatale, in Renzo Renzi (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo (1905-1930), Bologna 1991, pp. 121-130. 14 La grande attenzione che la Bertini riservava alle critiche che le venivano rivolte è ben documentata, dato che in più occasioni i recensori riconoscono i suoi sforzi per correggere i propri difetti e la propria tendenza a uno stile stereotipato di recitazione. Il corpus dei suoi film tuttora visibile evidenzia nettamente la sua grande capacità di trasformazione, come Gian Piero Brunetta ha messo in rilievo con particolare riferimento all’ultimo periodo della sua attività (si veda la sua intervista nel documentario di Gianfranco Mingozzi, L’ultima diva, cit.). 15 Per un’analisi della variabilità dei ruoli ricoperti dalla Bertini, si veda Angela Dalle Vacche, Francesca Bertini: la donna è mobile, “Cinegrafie”, n. 12, 1999, pp. 185-196. 16 La citazione è tratta dalla seconda puntata di Arte e vita di Francesca Bertini, “Film”, n. 29, 13 agosto 1938. Nel suo interessante saggio Autobiografia come ritratto d’artista (in Anja Franceschetti e Leonardo Quaresima, a cura di, Prima dell’autore, Forum, Udine 1997, p. 166), Antonio Costa propone un collegamento tra l’esibizione “di un’accesa sensibilità artistica e di attitudini intellettuali” che appare in questo e altri testi della Bertini e la sua “costante affermazione di un preciso ruolo nella realizzazione filmica che va ben oltre a quello tradizionale dell’attore”. 17 Il personaggio dannuziano della Superfemmina è analizzato da Mario Praz in La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Sansoni, Firenze 19882, p. 239. 18 Cfr. nota 11.
5 / Il singolare multiplo / Monica Dall’Asta 19 Si vedano le splendide illustrazioni che punteggiano il volume pubblicato dalla Cineteca di Bologna in occasione di una retrospettiva dei film della Diva, Francesca Bertini (a cura di Gianfranco Mingozzi), cit. Il libro è corredato da una filmografia completa a cura di Vittorio Martinelli. 20 “La Bertini ha conseguito un grande successo nel campo cinematografico; ha fatto una grande conquista che altre, non inferiori a lei, per bellezza e per arte, non hanno saputo ottenere: ha innamorato di sé… le donne, e specialmente le fanciulle. Il suo apparire sullo schermo è salutato dalle signorine con un sorriso di compiacimento. Tutta la sua azione è seguita con il più attento interesse. Pel pubblico gentile è lei che soffre, è lei che piange, è lei che gode; e questo pubblico, ch’è tutto sentimento, piange e gode, non col personaggio, ma coll’artista, colla Bertini. Le fanciulle – specialmente – tratto tratto si lasciano sfuggire a fior di labbra le più gentili e delicate espressioni. L’arte, quindi, di questa meravigliosa attrice, ha il consenso più autorevole nel fascino che ella ha saputo destare nel gentil sesso”. Pier Da Castello, recensione di La signora dalle camelie (Gustavo Serena, 1915), “La Vita cinematografica”, 20 ottobre 1915. 21 P. C., recensione di La signora dalle camelie, “La Cinefono”, 5 novembre 1915. Il critico scrive tra l’altro che “in questa film, indubbiamente, non si ebbe altro di mira che di fare sfoggio di lusso e di ricchezza, quindi posso ben permettermi di dire che si è voluto fare una Signora dalle camelie unicamente per dar modo alla Bertini di abusare di queste facoltà. E non nego che vi si sia riusciti, perché al pubblico le cose belle e sfarzose piacciono, tantopiù se in maggioranza è costituito da signore”. 22 Il movimento femminile. Sulla recitazione della Diva nel cinema muto, ”Bianco e nero”, n. 551, 2005, p. 150. 23 Ghione interpretò il ruolo di ‘terzo incomodo’ in numerosi film girati dalla Bertini in coppia con Alberto Collo alla Celio, tra il 1912 e il 1913. Sempre alla Celio la diresse in L’idolo infranto (1913). Passato come lei alla Caesar di Giuseppe Barattolo fu di nuovo suo regista nello sfortunato Don Pietro Caruso e in Nelly la gigolette, primo film nel quale faceva la sua apparizione il personaggio di Za-la-Mort. A proposito di quest’ultimo film, vale la pena di sottolineare che in diverse occasioni (tra cui l’intervista rilasciata a Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 55) la Bertini dichiarò di aver collaborato alla stesura della sceneggiatura, scrivendola insieme a Ghione “in una nottata”, nonché di avere inventato il nome di Zala-Mort. 24 Emilio Ghione, Memorie e confessioni (15 anni d’Arte Muta), Edizioni Cinemalia, Milano 1928, pp. 70-71. 25 Si veda in particolare Gian Piero Brunetta, op. cit., pp. 231259. 26 L’unica firma che appare nella corrispondenza riguardante la Bertini Film, conservata presso l’Archivio Documenti del Museo del Cinema di Torino, è quella di Giuseppe Barattolo. 27 Ecco come Ghione (op. cit., pp. 64-65 e pp. 70-71) ricorda la trattativa con Giuseppe Barattolo, a proposito dei film da girare come regista con Francesca Bertini, al momento dell’ingresso di quest’ultima alla Caesar: “Ero seduto alla scri-
vania, di fronte a quell’uomo, che se avesse voluto, sarebbe diventato l’autocrate assoluto della cinematografia mondiale. Amabile, sempre sorridente, mi disse: “Sa con chi sto facendo una combinazione?” Risposi: “Con Sua Santità” Scoppiò in una sincera risata. […] “Guardate però che ella impone il suo soggetto, e che il secondo che deve essere Assunta Spina, avendo ella scelto quale primo attore, Gustavo Serena, ella desidera…” Già prevedendo, con fine ironia, ribattei: “Desidera?” Frettolosamente, come per liberarsi, concluse: “Che sia lo stesso Serena a dirigerla”. Si stabilì un penoso silenzio; egli capiva di ferirmi; io riflettevo alla risposta da opporre, dissi: “Egregio avvocato, non mi permetto di sindacare i ‘beguins’ delle vedette, però, vista la mia qualità di Direttore della Caesar mi permetto a mia volta di dettare delle condizioni, esse sono: 1. Ghione sceneggierà (sic) il soggetto primo [Nelly la gigolette], lo dirigerà e lo interpreterà al fianco della Bertini; 2. Considerato che, fino ad ora, per mancanza dell’attrice non ha potuto girare il Don Pietro Caruso da lei avvocato acquistato da Roberto Bracco per la mia interpretazione, reputo ottima la combinazione che ci permette di fare interpretare il ruolo di Margherita alla Bertini, sotto la mia direzione. Finiti questi due lavori, cederò al camerata Serena il bastone del comando, per la messa in scena dell’Assunta Spina.” […] Con alacre volontà misi in scena il Don Pietro Caruso di Roberto Bracco. Il protagonista è un vecchio, sordido, farabutto, capace di non importa quale azione, ma è tutto illuminato da una adamantina religione per la sua Margherita, ed in fondo se di se stesso fa ogni mercato, non è che per rendere lieta, gaia, serena, la vita di lei. Ora la Bertini mi interpretava la figlia ed era quindi una semplice popolana: la mancanza di sfoggio di eleganze, di toilettes, fece sì che il ruolo me lo combinasse con la mosca al naso. Come Dio volle finii di girare anche Don Pietro Caruso […]. Se qualche mio ammiratore mi chiedesse: “Don Pietro Caruso? Non si è mai visto, non è stato proiettato mai”, gli risponderei: “Infatti non vide mai la luce per la semplice imposizione della diva, che non volle assolutamente venisse offerta al pubblico, essendo lei poveramente vestita in quel ruolo”. E furono queste mentalità, e fu questo sconfinato, superbo, orgoglio, che a poco a poco, calò a picco la nostra rinomanza, che distrusse, in perfetta idiota maniera, il valore di pochi. Il Divismo, ignorante, meschino, tardo, incominciò fin d’allora a minare un edificio, che non doveva crollare mai: la cortigiana, servile galanteria dei dirigenti, paurosi di vedersi scappare la Diva, plasmò un sistema di ricatti morali, che ci debellò”. 28 Cfr. Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano: I film degli anni d’oro, 1914, vol. 1, ERI, Roma 1993, p. 167. 29 È interessante notare come la figura di Pierrot abbia ispirato altri due tentativi di regia al femminile in Italia: Pierrot di Diana Karenne (1917) e Fantasia (o Fantasia bianca, 1919-21), co-diretto e interpretato da Bianca Virginia Camagni insieme a Sepo (Severo Pozzati). La complicata storia di quest’ultimo film è stata puntualmente ricostruita da Claudia Giordani in The Copy Vanishes, ovvero il film senza il film. Note su Fan79
tasia bianca, a Lost Film, “Fotogenia”, n. 4-5 (1997-98), pp. 335-341. 30 Christine de Pizan, La città delle dame (a cura di Patrizia Caraffi), Luni, Milano 1997. 31 Di Jane Gaines si veda tra l’altro l’articolo Film History and the Two Presents of Feminist Film Theory, “Cinema Journal”, n. 1, (2004), pp. 113-119. La nozione di ‘eroismo femminile’ è ripresa dal libro di Kay Armatage, The Girl from God’s Country: Nell Shipman and the Silent Cinema, University of Toronto Press, Toronto 2003. 32 Si vedano in proposito Wanda De Nunzio Schilardi, L’antifemminismo di Matilde Serao, in AA.VV., La parabola della donna nella letteratura italiana dell’Ottocento, Adriatica Editrice, Bari 1983, pp. 277-305, e Neera, Le idee di una donna, Editrice Nazionale, Milano 1904. 33 Jane M. Gaines, Of Cabbages and Authors, in Jennifer M. Bean e Diane Negra (a cura di) A Feminist Reader in Early Cinema, Duke University Press, Durham 2002, pp. 88-118. 34 Cfr. nota 6. 35 Costanzo Costantini, op. cit., p. 95. 36 Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 64. 37 Si veda per esempio Carlo Lizzani, Il cinema italiano 18951979, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 22-23. 38 Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 53. 39 Amleto Ragossa, Francesca Bertini così com’è, L’arte muta, fascicolo pubblicitario, Roma 1916. 40 Roberto Bracco, La cinematografia, Francesca Bertini, Giovanni Grasso ed io, “Comoedia”, n. 6, 15 giugno 1929. 41 “Roberto Roberti aveva le sue idee, era un grande regista, ma nel momento in cui doveva dirmi le cose non osava. Poi alla fine si decideva, mi spiegava come avrebbe voluto una certa scena, io naturalmente lo contraddicevo e lui mi diceva: ‘Faccia quello che vuole’ ”. Gianfranco Mingozzi, op. cit., pp. 53-54. 42 Di una vera e propria ‘maschilizzazione’ della sfera cinematografica, avvenuta a Hollywood a cavallo tra anni Dieci e Venti, dunque in corrispondenza con l’inizio del processo di istituzionalizzazione, parla per esempio Karen Ward Mahar nel suo puntuale studio Women Filmmakers in Early Hollywood, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007. 43 Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 65. 44 Costanzo Costantini, op. cit., p. 97. Nei suoi diversi testi autobiografici e nelle sue interviste Francesce Bertini si attribuisce la regia di almeno tre film: Assunta Spina, La piccola fonte e Tosca. In uno degli articoli pubblicati sulla rivista “Film” (n. 35, settembre 1938), afferma inoltre di avere avuto un ruolo anche nella messa in scena di Histoire d’un Pierrot, l’ultimo film da lei interpretato con il regista Baldassarre Negroni. Altrove (Gianfranco Mingozzi, op. cit., pp. 63 e pp. 55-57), riferisce di aver curato il montaggio di tutti i suoi primi film, compresi Assunta Spina e Il processo Clemenceau (Alfredo De Antoni, 1917). 45 Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 70. 80
46
Costanzo Costantini, op. cit., p. 100.
47
Gianfranco Mingozzi, op. cit, p. 70.
48
Gianfranco Mingozzi, op. cit, p. 63.
49
Enzo Biagi, op. cit, p. 111.
Sulla funzione drammatica e interpretativa dello scialle indossato da Francesca Bertini in Assunta Spina, si veda Gerardo Guccini, Note intorno all’interpretazione di Assunta Spina, in Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 84. 50
Gran parte delle riflessioni precedenti circa la relazione tra molteplicità e singolarità nel fenomeno del divismo sono ovviamente ispirate alla nozione di “aura” elaborata in vari saggi da Walter Benjamin. Significativamente, nelle sue dichiarazioni la Bertini insiste molto nel rappresentarsi come una personalità isolata, irraggiungibile, lontana dalla sfera pubblica e assai gelosa della sua vita privata, non meno misteriosa di quelle preziose reliquie la cui aura, afferma Benjamin, è inversamente proporzionale al loro grado di visibilità. (L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966). Nell’epoca della riproducibilità, il tradizionale incanto della singolarità trova una nuova forma dialettica nella capacità della Diva di preservare un nucleo di invisibilità nel cuore stesso del processo della sua moltiplicazione visiva. Gli stessi film, che ritraggono la Diva nelle situazioni più intime, sembrano fornire al pubblico un accesso immediato proprio a quegli aspetti che l’originale si sforzava di sottrarre nel modo più assoluto alla curiosità del pubblico, come per esempio la sua vita sentimentale. 51
52
Gianfranco Mingozzi, op. cit., p. 54.
Il riferimento è alla “teorizzazione del desiderio di fare film, della volontà di produrre fantasie, produrle al plurale e produrle per altri”, che Jane Gaines ha posto al centro della sua decostruzione del concetto di autore in chiave femminista in Of Cabbages and Authors, op. cit., p. 101. 53
Domenico Rea, Le due Napoli, in Gesù, fate luce!, Einaudi, Torino 1990, p. 199.
54
55 Paola Baronchelli Grosson (Donna Paola), La donna della nuova Italia, Quintieri, Milano 1917, p. 195.
Il catalogo dei fondi cartacei del Museo Nazionale del Cinema relativi al cinema muto torinese (Tracce, Il Castoro, Milano 2007, pp. 358-359), elenca sotto il nome di Lina Cazzulino Ferraris i titoli di due soggetti (Dramma e Un dramma nel deserto) e di due sceneggiature (La strada dei gatti, altro titolo Camillo è troppo amato, e Il volo sulla fiamma o La donna dello spazzino, 1915). Nata nel 1881 e morta l’8 settembre 1943 a San Maurizio Canavese, Maddalena Ferraris era moglie di Domenico Cazzulino, esercente e noleggiatore torinese della prim’ora, ma soprattutto azionista di riferimento e socio accomandatario della Film Artistica Gloria. L’unico suo soggetto che fu trasformato in un film, Diritto di uccidere, fu appunto prodotto dalla Gloria nel 1912. Ringrazio Alberto Friedemann per avermi fornito queste notizie. 56
6 / Elena Dagrada
La tentazione del silenzio Eleonora Duse e Cenere
M’aiuti Lei – Lei lo può – Mi veda qual sono – Ho anch’io la mia parte di... “Rosalia” cioè di destino, come dono e peso di vita. (Eleonora Duse a Febo Mari, 11 luglio 1916)
1. Quando Eleonora Duse si accinge a realizzare Cenere, fin dalla tarda primavera del 1916, ha già compiuto cinquantasette anni e non calca più le scene da circa sette1. Problemi di salute sono la ragione ufficiale per cui la grande attrice, all’apice del successo, aveva abbandonato il teatro nel febbraio 1909 (ma vi farà ritorno, nel maggio del 1921, con La donna del mare dell’amatissimo Ibsen)2. Biografi e studiosi, tuttavia, in qualche caso hanno intravisto altre motivazioni all’origine di questa lunga sosta in parte forzata, in parte però anche voluta. Motivazioni meno materiali: la ricerca di sé, il bisogno di silenzio3.Un bisogno divenuto quasi fisico, maturato nel tempo con la necessità di prendere le distanze dalla parola, in cui aveva fortemente creduto, ma che le aveva impresso dentro un segno profondo, attraverso l’esperienza del teatro dannunziano4. In questa prospettiva, il suo ritorno alla recitazione in un film muto – al di là delle ineludibili ragioni contingenti – diviene allora
una tappa importante della ricerca verso l’espressività del silenzio che l’attrice persegue da anni5. La prima offerta dal mondo silenzioso della celluloide le giunge niente meno che da Griffith, a riprova sia della grande fama dell’attrice italiana negli Stati Uniti, sia della predilezione griffithiana per le figure esili e i delicati visi di donna dai lineamenti regolari e sottili, come quelli che Eleonora Duse ha in comune con le sorelle Gish, o con Mary Pickford6. È l’11 settembre 1915 quando informa per iscritto la figlia Enrichetta di aver ricevuto un telegramma dall’America del Nord che la invita a lavorare “à je ne sais quoi, en cinéma [non so a che cosa, nel cinema]”7, per poi precisare due settimane dopo, nel caratteristico miscuglio di francese e italiano che contraddistingue le missive inviate alla figlia: [...] on m’a cablé d’Amérique d’aller pour 3 mois a Los Angeles, California, avec ce Griffith fameux du cinema, a quoi faire?? aujourd’hui avec Adolfo (De Bosis) je compose moi, et lui traduit en anglais un cable pour New York. Moi, le choix du travail? le quel? Et si ça s’arrange partir? Que de voyage j aurai fais en ma vie pour attendre “le voyage” le bon! La délivrance!! [Mi hanno telegrafato dall’America per andare 3 mesi a Los Angeles, California, con quel fa81
moso Griffith del cinema. A far che? Oggi, con l’aiuto di Adolfo (De Bosis) metto insieme, e lui traduce in inglese, un telegramma per New York. Ho la scelta del lavoro? Quale? E se si combina, partire? Quanti viaggi avrò fatto nella mia vita in attesa del “Viaggio” – quello buono! La liberazione!] 8
L’attrice appare incuriosita e lusingata, anche dal compenso altissimo (300.000 lire, sembra come solo anticipo) 9; chiede alla figlia che si informibene su Griffith e spedisce in America alcuni soggetti scritti personalmente, precisando che intende escludere qualunque testo tratto dal solito repertorio teatrale10. Già in questo frangente emerge con chiarezza il suo interesse sincero per l’arte muta, concepita come diversa dal teatro, come linguaggio eminentemente lirico e figurativo, la cui forza espressiva è nel gesto silenzioso e nella composizione pittorica11. Al punto che progetta un film sulla Cappella Sistina – concentrandosi sulle figure femminili dipinte nelle lunette da Michelangelo, giocando con le luci, i drappeggi, i gesti – e immagina di poterne rimandare la realizzazione a quando la Grande Guerra sarà finita, magari a Londra, vicino alla figlia, dove Griffith potrebbe raggiungerla. Nell’immediato, infatti, i pericoli del viaggio rallentano la trattativa, che finisce in nulla. Non è improbabile che sia proprio l’offerta di Griffith a suscitare l’interesse dei produttori italiani verso un’attrice assai celebre, certo, ma non più nel fiore degli anni12. Sicuramente, si tratta di un’offerta che rimette in moto in lei il desiderio prepotente di lavorare ancora; un desiderio che si sovrappone alla constatazione che sia divenuto sempre più necessario per ragioni economiche13; e finalmente resa possibile proprio grazie al cinema, che riesce a conciliare il suo bisogno di proseguire un personale percorso di ricerca con le potenzialità di un mezzo nuovo e meno faticoso, che non richiede lo sforzo fisico di una recita da ripetere ogni sera. Il 23 febbraio 1916 scrive all’amica Emma Garzes di aver “rotto i pensieri”, di aver pensato al cinema dove ha “trovato delle cose” che la interessano “immensamente!!!” e di essere in trattative con una Casa italiana, sebbene l’America resti ancora sullo sfondo dei suoi progetti14. Qualche tempo dopo, stando nuovamente a quanto scrive l’attrice, le Case italiane sono divenute tre: verosimilmente la Cines, la Tiber e l’Ambrosio15. Con la Cines 82
tratta concretamente, visita gli stabilimenti e familiarizza con le maestranze per imparare gli aspetti tecnici del mestiere; resta però delusa dalla pretesa di inserire fasti sontuosi, mondanità, donne in décolleté16. Perciò a metà maggio sospende i rapporti con la Cines e poco dopo opta per Arturo Ambrosio, ovvero per la Casa di produzione che sembra darle maggiori garanzie sul piano artistico. Firma il contratto con il produttore piemontese nel giugno 1916. Ma già da qualche mese, quella che l’attrice chiama più volte “la mia film” è stata da lei pensata a partire dal romanzo di Grazia Deledda, Cenere17. 2. La fama di Cenere è legata al fatto che si tratta dell’unico film interpretato da Eleonora Duse. Per questo suo unico film, tuttavia, l’attrice fa assai più che recitare. Sono numerose le sue dichiarazioni da cui si evince chiaramente la ferma intenzione di esercitare un controllo artistico totale sulla pellicola; dichiarazioni che contengono vere riflessioni di poetica e che hanno spinto assai presto alcuni studiosi a parlare di attrice-autrice: da Umberto Barbaro, che fin dal 1958 ha definito la Duse un’“attrice creatrice”, fino ai recenti studi di Cristina Jandelli che vede nella Divina un’attrice dal profilo autoriale18. Scrivendo alla figlia, definisce Arturo Ambrosio “un brav’uomo e intelligente e che farà tutto quel che voglio io! Voilà ce s’appelle selon moi être intelligent! [Ecco, questo significa secondo me essere intelligente!]”19. Le descrive in dettaglio le condizioni del contratto, davvero senza precedenti per l’epoca e per una donna in Italia: il 50% degli incassi, 40.000 franchi di compenso più 20.000 per le spese. Quindi aggiunge: J’ai “droit” (ah! j’aime cette parole) sur les machines et sur l’operatore, c’est cela l’homme le plus difficile! Mais dans le contract, j’ai voulu droit de choisir, dunque: giudizio. Je vais choisir! [Io ho “diritto” (ah! mi piace questa parola) sulle macchine e sull’operatore, che è la persona più difficile. Ma nel contratto ho voluto diritto di scelta, dunque: giudizio. Vado a scegliere!] 20
Ottiene, insomma, quella libertà apparentemente totale che a ben vedere le sarà fatale, tanto quanto
6 / La tentazione del silenzio / Elena Dagrada
più tardi sarà fatale a un altro grande attore-autore che come lei passerà dal teatro al cinema per restarvi più a lungo di lei: Orson Welles21. Come per Orson Welles, del resto, anche per Eleonora Duse non si tratta solo di assicurarsi un controllo artistico puramente astratto. L’attrice, infatti, dimostra subito un sorprendente e specifico interesse per gli aspetti tecnici del mezzo cinematografico. Nei mesi che precedono la lavorazione va al cinema quasi ogni pomeriggio, privilegiando le sale di terz’ordine, in periferia, dove spera di non essere riconosciuta. Coglie nei primi film americani proiettati in Italia “una più fresca sensibilità e una tecnica più raffinata”22. E poco prima delle riprese, in vacanza a Viareggio, ottiene da Arturo Ambrosio che le metta a disposizione un tecnico un’ora al giorno, affinché possa familiarizzare con la macchina da presa23. Anche il suo rapporto con Febo Mari, regista e interprete maschile della pellicola, è improntato a queste stesse istanze. Non solo perché è lei che lo sceglie,
dopo averlo visto recitare nel film Il fuoco (1916), nominalmente diretto da Piero Fosco – pseudonimo di Giovanni Pastrone – che ne “vigilò l’esecuzione”; e poco importa se tale scelta fu compiuta credendo che Piero Fosco fosse invece lo pseudonimo di Mari24. Anche le lettere che rivolge al giovane collega pullulano di istruzioni (“la tecnica è tutto un mistero”); indicazioni (“Mi metta nell’ombra [...] au premier plan mi fa terrore [...] mi tenga di scorcio, a passaggio, nulla sia immobile per questo ritorno di madre al figlio”); richieste (“Au premier plan, verso la folla, verso la belva, rimanga Lei, Lei ne ha la forza”)25. Nonché di suggestioni evocative, suscitate in lei dal ricordo delle pellicole studiate nei pomeriggi trascorsi al cinema, di cui vorrebbe riprodurre i risultati: Ho visto in Cavalleria rusticana (quella di Mascagni) (era presente Ambrosio) ho visto certe penombre, certi scorci che farebbero al caso mio – Ho visto nella Ragnatela del Griffith – ho visto gente, o venendo
Eleonora Duse in Cenere, 1916 (Museo Nazionale del Cinema, Torino) 83
di lontano, supplice o disperata, o in rivolta – insomma, ho visto creature, a lampi, ma simili alla forza attuale che mi anima, pari alla visione che inseguo26.
È chiaro, insomma, che si rivolge a Mari con l’intento di dirigerlo nel dirigerla, perché insegue davvero una visione e pensa così di poterla ottenere, di poter contare sul suo ascolto di regista-attore attento alle esigenze della sperimentazione. Ma soprattutto, è parte attiva nella scelta del romanzo di Grazia Deledda, voluto ancor prima di accordarsi con Ambrosio, verosimilmente per intercessione dell’amica Olga Ossani, alias Febea, forse su indicazione della stessa Deledda27. L’attrice, infatti, lo aveva già letto molti anni prima, durante una tournée, quando la figlia era ancora una giovinetta. Lo scrive a Enrichetta il 14 maggio 1916, per spiegarle il motivo di una scelta che non dipende da una scoperta casuale, occasionata dal ritorno al lavoro28. Così come risulta parte attiva nella collaborazione con Grazia Deledda, documentata sia da una lettera che la scrittrice indirizza all’attrice e che viene posta in esergo al film29, sia da altre lettere da cui si evince la presenza della scrittrice sul set: verosimilmente in concomitanza con la necessità di riscrivere un’intera scena – quella dell’ascesa di Anania al Gennargentu –, poi inviata per iscritto dalla Deledda a Febo Mari; nonché forse durante le riprese di una scena con Anania bambino, rifatta in seguito dall’attrice con il solo operatore Omegna perché giudicata “senza cuore”30. Suo, infine, è il primo trattamento o schema di sceneggiatura, che interviene con decisione sul libro e contiene già un’idea forte di regia31. Si tratta di uno schema rispetto al quale le copie del film giunte fino a noi presentano scarti importanti32. Al di là delle differenze fra le singole copie a disposizione, cioè, ognuna di esse si impone come ugualmente differente rispetto all’impianto drammaturgico inizialmente concepito dall’attrice. Anche per questo, oggi, il film è assai difficile da giudicare nel suo complesso. Come ha scritto Gianni Olla: “Cenere-romanzo è la storia di un figlio abbandonato, Cenere-film è la tragedia di una madre”33. Ma pur ribaltando la prospettiva del libro, nel suo schema la Duse ne fa un 84
Eleonora Duse (Archivio “In penombra”)
‘dramma a due voci’, composto perciò da due parti distinte – la prima, comprensiva di un prologo, incentrata sulla figura di Anania; la seconda incentrata su quella di Rosalia – in cui anche il personaggio del figlio s’impone all’attenzione. L’elemento unificatore è individuato in una reminiscenza di matrice letteraria, ovvero la frase “Dov’è? Dov’è?”, ricorrente nel libro e qui mutuata in una didascalia prevista sia nella prima parte, sia nella seconda. E mentre la seconda parte,più simile al film che conosciamo oggi, è incentrata sulla figura di Rosalia e permette all’attrice di concentrare la sperimentazione sul terreno della recitazione, la prima risulta di interesse
6 / La tentazione del silenzio / Elena Dagrada
forse maggiore sul piano della composizione scenica e drammaturgica; è infatti più sperimentale nella concezione luministica, più moderna nell’impianto narrativo. Qui la Duse aveva previsto di condensare – dopo un’immagine di Anania intento a leggere le lettere di Margherita – tutte le scene chiave della vita del figlio che precedono la ricerca della madre, in un susseguirsi di lampi e suggestioni visive, fino alla simbolica scalata al monte (il vento, l’infanzia a Nuoro, il Gennargentu...). Suggestioni, a ben vedere, non riconducibili a semplici flash-back (che pure sarebbero stati molto audaci per quel tempo, in Italia) e che l’attrice chiama “ganci”, perché supposti afferrare i ricordi alle pagine del romanzo. Sappiamo che le riprese del film ebbero inizio sulla base di questo primo schema e che furono girate inquadrature oggi assenti nelle copie giunte fino a noi: in una lettera a Febo Mari, l’attrice cita un “episodio della mano”, riferendolo al prologo, mentre in un’altra descrive tre scene da rifare (quindi già girate) di cui due sembrano collocabili nella prima parte (ma sono assenti nel fim), con queste parole: II La spinta al bambino (prima parte) si vede dalla cintola in su, non è bello – III La mano, sulla diligenza, con bambino in braccio, fatta nel giardino vostro Stabilimento – (La mano, rivela il viso)34.
Inoltre, come risulta da documenti e testimonianze d’epoca35, seguendo uno schema analogo a quello di Il fuoco la progressione narrativa avrebbe dovuto essere scandita dai tre seguenti titoli: L’ombra, La larva, La carne. Ma la lavorazione del film si rivelò difficile e faticosa. Eleonora Duse aveva paura, temeva che il risultato si discostasse dalle sue aspettative. Giunse a chiedere che il violoncellista Livio Boni suonasse durante le riprese per suggerire l’atmosfera che voleva rendere nel film36. E in corso d’opera, Arturo Ambrosio cominciò a temere per le sorti commerciali della pellicola37. Di certo, a film concluso, intervenne con rimaneggiamenti e un montaggio diverso dal previsto, più lineare e di facile lettura per il pubblico del tempo. Provò persino a cedere i diritti di distribuzione38, a riprova di quanta poca fiducia gli fosse rimasta nell’impresa. E l’uscita del film ne risultò ritardata
fino al mese di marzo 1917, nonostante il nulla osta fosse già stato concesso il 1 novembre 191639. Addirittura Mario Corsi40 racconta di aver visto il film un paio d’anni più tardi a New York, in un cinema di quart’ordine sulla Quattordicesima strada, in una copia “logora” intitolata La madre o il figlio della colpa. Forse un rimaneggiamento in chiave melodrammatica e sentimentale, che verosimilmente non ebbe miglior fortuna. Cenere, infatti, sotto il profilo commerciale fu un clamoroso insuccesso. Nonostante un lancio attento a sottolineare la grandiosità artistica dell’evento – ma forse non abbastanza a suscitare l’interesse del pubblico di massa – spettatori e critica per lo più non lo amarono. Significativo in proposito è il numero speciale de “L’Arte muta”, pubblicato per l’occasione e “offerto alla Divina come un mazzo di rose”, molto accurato nella sostanza (contiene scritti di Matilde Serao, Enrico Panzacchi, Roberto Bracco, Edoardo Boutet, Saverio Procida e numerosi omaggi lusinghieri)41, ma indubbiamene sobrio nella forma, privo di fotografie. In attesa di saperne di più, tanto sull’avventura – o disavventura! – della pellicola, quanto sui complicati tragitti della distribuzione italiana e internazionale, anziché lavorare sulle varianti di quelle che non sappiamo ancora se chiamare copie o versioni, allo stato attuale appare più produttivo riflettere sulle costanti, da cui è possibile risalire agli esiti della poetica più volte espressa dalla stessa Duse. Una poetica rintracciabile quanto meno nella sua recitazione. E in materia di recitazione, le immagini a disposizione ci restituiscono un saggio seducente anzitutto per la sua grande modernità. Una comprensione profonda del cinema muto, sottolineata molto presto dagli storici del cinema42. Una gestualità originale, personalissima e assai contenuta (ma “con momenti di calcolatissima espansione”43). E la volontà di sperimentazione di un’artista che non guarda al cinema come a un mezzo per replicare i propri successi teatrali, ma al contrario vi si avvicina come a un luogo dove proseguire un itinerario di ricerca maturato nell’esercizio della pratica teatrale44, provando a concepire qualcosa di diverso, seppure in continuità con un percorso personale, grazie allo stimolo ricevuto all’incontro con un’arte nuova. An85
che a costo di rinunciare alle proprie sicurezze, a rischio di avventurarsi su un terreno che la spinge a vedere il cinema più vicino alla pittura che non al teatro: e se con Griffith vagheggiava la Cappella Sistina michelangiolesca, qui la figurazione è eseguita a partire dagli affreschi di Giotto45. Non solo nei momenti maggiormente ispirati al modello pittorico, come nel gioco sul panneggio di mantelli francescani che rasenta spesso la citazione letterale. Ma anche nel lavoro sull’ombra e sulla luce: nella composizione scenica che, durante la prima parte, caratterizza le apparizioni della madre e del figlio – quando l’ombra della donna emerge dai vetri di una finestra del mulino; quando il figlio compare dinnanzi al padre come un’ombra proiettata sul pavimento; quando la madre cerca il bambino nella notte e il figlio si affaccia alla finestra, mentre l’ombra delle braccia materne protese in un abbraccio si proietta inutilmente sul muro. Sembra di assistere alla versione schermica delle celebri apparizioni ‘nascoste’ della Divina, che sul palcoscenico accentuavano – anziché attenuarla – la sua presenza carismatica e forse prefiguravano, per l’appunto, il suo anelito alla messa in scena del silenzio46. E nell’esibizione del silenzio la recitazione muta della Duse dà il meglio di sé. Perché in Cenere, come dichiara con orgoglio alla figlia, l’attrice non parla mai per tutto il film (“jamais dans toute la film je ne parle” [io non parlo mai per tutto il film])47. Non solo, infatti, non recita con la voce: non recita neppure con il movimento delle labbra. Una scelta radicale, il cui esempio più significativo è senza dubbio nella scena dell’incontro tra madre e figlio, in cui Rosalia apre la bocca solo per sorridere ad Anania ritrovato o per opporgli il suo diniego quando lui le annuncia di volerla tenere con sé. Un incontro importante, certo il momento più intenso di tutta la pellicola, in cui l’attrice affida il senso a qualche carezza appena accennata, alla rapida mutevolezza del suo volto espressivo, che in pochi istanti passa dal dolore al sorriso, poi nuovamente al dolore. Un incontro ripreso in una serie di inquadrature lunghe, per non spezzare la continuità della recitazione e la relazione del corpo con lo spazio circostante (in tutto il film, del resto, non c’è neppure un primo piano), mentre sono presenti alcuni movimenti di macchina a seguire. 86
Forse è nell’opposizione tra l’esibizione dell’ombra, nella prima parte, e quella dei corpi in azione, nella seconda, che ritroviamo almeno un poco di quel che resta di Cenere come l’avrebbe voluto l’attrice. 3. L’incontro velatamente incestuoso tra la madre e il figlio, nella seconda parte del film, è molto diverso da come si svolge nel romanzo, dove al contrario è violento, aggressivo, dolorosissimo – solo dolorosissimo. E non si tratta dell’unica modifica apportata dalla Duse alle pagine del libro. Elenchiamo brevemente le più significative. Vengono interamente eliminati l’inizio e quasi tutti i primi cinque capitoli (dei nove di cui il romanzo è composto). Scompare ogni traccia della giovinezza di Olì (diminutivo di Rosalia, un nome che in Cenere film non compare mai), descritta come una fanciulla ingenua, pronta ad aprirsi alla vita e all’amore ma sedotta dal giovane Anania, un sognatore fanfarone e bugiardo, che le nasconde di essere sposato, la mette incinta e l’abbandona, sottraendosi alle proprie responsabilità. Scompare quasi del tutto la vedova di Fonni che ospita Olì dopo che viene cacciata di casa (salvo comparire nella seconda metà del film, perché funzionale al ritrovamento di Rosalia da parte del figlio cresciuto). Scompare il compagno di giochi Zuanne, molta parte dell’adolescenza del piccolo Anania a Nuoro, la scuola e il teatro, la giovinezza e gli studi dapprima a Cagliari, poi a Roma, dove il ragazzo crede di riconoscere la madre nell’affittacamere Maria Obinu. Soprattutto, due sono le alterazioni significative imposte alla natura stessa dei personaggi e alle dinamiche dei loro rapporti interpersonali. La prima è la trasformazione di Olì in Rosalia, ovvero il mutamento radicale del personaggio della madre, che da femmina istintiva e selvatica, abbruttita in pochi anni dalla miseria, dalla disperazione e dalla malattia, nel film diviene una donna lucida, consapevole, forte, che agisce fin da subito per il bene del figlio e soprattutto lo ama, da sempre e per sempre; perciò si reca consapevole all’incontro con lui, uscendone comunque vittoriosa48. Diversamente dal romanzo, infatti, nel film la madre è una figura eroica che per il figlio si sacrifica due volte: dapprima rinunciando a lui e portandolo dal padre, affinché possa crescere
6 / La tentazione del silenzio / Elena Dagrada
lontano dalla miseria, dall’ignoranza e dall’infamante condizione di creatura illegittima; poi togliendosi la vita (ma non sgozzandosi, come Olì, che schizza il suo sangue intorno a sé e agonizza per ore, circondata da una piccola folla di curiosi come una bestia nell’arena; Rosalia muore fuori campo, in pochi istanti, quando la vedova la trova è già compostamente distesa come una salma sacra), per liberarlo definitivamente dalla sua presenza ingombrante e dannosa. La seconda è la trasformazione di Margherita, che nel romanzo è la figlia del ricco ‘padrino’ di Anania, datore di lavoro di suo padre, mentre nel film diviene una semplice compagna di scuola. Viene così eliminato il tema del riscatto sociale, a tutto vantaggio dei sentimenti privati, gli unici che qui contino. Non a caso, l’incontro tra l’attrice e lo studioso di origine sarda Paolo Orano, che inizialmente dovrebbe partecipare alla riduzione e la inonda di consigli e informazioni sulla storia della Sardegna, è caratterizzato dal netto rifiuto dell’attrice di seguirlo sulla via della realizzazione di un film incentrato sul folclore sardo, ovvero su aspetti estranei alla pura vicenda sentimentale. A ben vedere, in realtà, il romanzo della Deledda autorizzerebbe, eccome, una tale realizzazione; ma la Duse gli oppone un rifiuto stupito e indispettito. Sintetizzato in queste parole: Ma, suvvia, arricchire, che sia anche arricchire d’una ammirevole visione come quella che mi esponevate ieri sera, la quale inserita nel testo gli rimarrebbe sempre estranea. [...] Il libro di Grazia Deledda è solo una storia di dolore e d’amore [corsivo mio]. Ma la vostra abbondanza di leggende, di Storia sarda, il libro non ne contiene. Comunque va avanti, s’innalza per altre vie49.
E se le cose non stanno esattamente così, ovvero se è la Duse che spoglia le pagine deleddiane e le riduce a una pura dinamica di sentimenti, in fondo è anche perché ne è stata autorizzata dalla stessa Deledda, che le si era rivolta con la lettera posta in esergo al film, di cui scrivendo a Orano, a ben vedere, l’attrice ripete le parole: A Eleonora Duse. “Cenere” è la storia di una povera donna di Sardegna che, abbandonata dal primo uomo che amò, cacciata
di casa, raccolta dalla pietà di un’altra donna, dopo anni di miseria riconduce il figlio della sua colpa fino alla porta del padre di lui, perché solo il padre può dargli un avvenire di bene: e lei sparisce nell’ombra. Affido a Lei, cara amica, questa storia di amore e di dolore [corsivo mio] perché Lei sola può illuminarla con la luce della sua anima e viverla con la sua grande arte sincera. Grazia Deledda50.
Perché, allora, questo romanzo? Perché una scelta a quanto sembra contrastata da molti, che ne temevano l’insuccesso e provarono a sconsigliarla, come riferisce nella sua testimonianza Mario Corsi, il quale ricorda pure che fu la Duse a intestardirsi su questo soggetto perché “si era innamorata della parte, diceva di sentire il personaggio”51? Un personaggio che a ben vedere l’attrice cambia, fino al punto di snaturarlo, di trasformarlo in altro? Certo, questa vicenda ambientata in una terra nel cui antico regno era nata – la città di Vigevano, dove venne alla luce, nel 1858 faceva parte del Regno di Sardegna – esercita sull’attrice una presa viscerale che ancora una volta ci conduce al silenzio. Al suo silenzio più segreto e doloroso. Quello maturato nella consuetudine con l’assenza della figlia Enrichetta, cresciuta a distanza, lontano dai teatri e dalle tournée della madre. Ma anche quello che è all’origine della ‘Rosalia’ che è in lei, in gioventù sedotta e abbandonata da Martino Cafiero, da cui ha avuto un figlio vissuto solo pochi giorni52. Così che anche Eleonora, come Rosalia, è stata ragazza madre53, ha perso un figlio e ne ha sempre inseguito l’assenza. Nel lavoro e negli affetti. Nella scelta dei copioni e nei molti legami incentrati sull’impronta di una maternità vicaria. Non a caso, scrive Cesare Molinari54, quelli a ridosso di Cenere sono anche gli anni in cui l’ossessione dell’attrice per il tema del figlio perduto affiora maggiormente. Nella vita privata, in cui coltiva numerosi affetti di questo tipo. Ma anche in quella professionale, tanto che dopo Cenere, tra il 1921 e il 1924, porterà a teatro tre drammi incentrati sul motivo della maternità perduta – La porta chiusa, Spettri (o Fantasmi) e Così sia – che poi è anche il motivo centrale nell’opera scritta da Pirandello per lei, La
87
vita che ti diedi. E che naturalmente è anche il tema di Denise, scritto da Dumas figlio per la Duse, che lo recitò poco dopo la morte di Cafiero. In Cenere, fra i cambiamenti apportati dalla Duse al romanzo della Deledda non figurano solo eliminazioni ma anche un’aggiunta: la celebre scena in cui Rosalia, accovacciata in terra contro un muro di pietre, rinuncia a rammendare una calza che, ispezionata con attenzione, rivela buchi troppo grandi. È una scena accompagnata da una didascalia: “Rotta una maglia, i fili non si riannodano più”. E sul significato simbolico di questa frase molto si è scritto, anche per associarlo al conflitto bellico in atto a quel tempo e all’immenso dolore di tutte le madri costrette a perdere i propri figli in battaglia. Un dolore inconsolabile, così attuale durante i luttuosi anni della Grande Guerra. Ma un dolore perenne, per chi un figlio l’ha perduto anche senza guerra. E alla luce di un autobiografismo così scoperto, Cenere acquista un ulteriore valore di modernità, rivendicando il giusto rilievo nella produzione di un’attrice che alla modernità ha dato tanto.
Note
1 Nata a Vigevano il 3 ottobre 1858, Eleonora Duse avrebbe compiuto cinquantotto anni solo a lavorazione di Cenere conclusa (fatta eccezione, sembra, per i ritocchi da lei richiesti). Le riprese del film, infatti, si svolgono essenzialmente in luglio e agosto.
Cfr. William Weaver, Duse. A Biography, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1984 (tr. it. Eleonora Duse, Bompiani, Milano 1985), che a p. 297 riporta il testo di una smentita fatta pubblicare dalla stessa Duse sul “Corriere della Sera”, a proposito di voci su un suo presunto definitivo abbandono delle scene, in cui l’attrice motiva la sua assenza con problemi di salute. La malattia (un enfisema), del resto, la rende sempre più cagionevole e nel 1924 sarà la causa della sua morte, durante una tournée negli USA, a Pittsburgh. Si veda anche Clemente Fusero, Eleonora Duse, Dall’Oglio, Milano 1971.
2
3 Cfr. in particolare Olga Signorelli, L’epistolario di Cenere, “Bianco e Nero”, a. XIX, n. 12, 1958, secondo cui: “Arrivata alla vetta della sua carriera d’artista, ella ebbe la percezione acuta che tutti i trionfi esteriori erano nulla se la prodigiosa ricchezza spirituale non riusciva a definirsi in solidità di vita interiore. Fu allora, nel 1909, che all’apice della gloria ella lasciò le scene. Di lì ebbe inizio il suo silenzio decennale durante il quale, come tutti i veri poeti, disperatamente cercò se stessa”. Cfr. Olga Signorelli, Vita di Eleonora Duse, Cappelli, Bologna 1962, che a p. 62 ricorda:“ ‘L’istinto non basta: bisogna studiare, coltivare lo spirito, elevarsi’, le aveva consigliato Boito. E da allora si mise a studiare lingue straniere, a leggere, due, tre ore al giorno. E a mano a mano che il suo spirito si elevava, non ebbe più pace. Sentiva la vanità di quella fatica che la costringeva a dire tante parole vuote e inutili, prima di arrivare a una parola e a un gesto di vita”.
Cfr. in particolare Gigi Livio, L’attore cinematografico, Zona, Torino 2007. Per l’importanza del complesso rapporto umano e artistico di Eleonora Duse con D’Annunzio si veda anche Cesare Molinari, L’attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra i due secoli, Bulzoni, Roma 1985.
4
Fra gli altri, sono incentrati interamente su questo aspetto i testi di Riccardo Bacchelli, Commemorazione di Eleonora Duse nel primo centenario della nascita, “Bianco e Nero”, n. 12, 1958; e Umberto Barbaro, La Duse e il film come arte, “Filmcritica”, n. 81, 1958 (ora in Umberto Barbaro, Servitù e grandezza del cinema, a cura di Lorenzo Quaglietti, Editori Riuniti, Roma 1962). 5
Non mancano le testimonianze che datano l’interesse della Duse per il cinema ancora più indietro nel tempo (cfr. Roberto Paolella, Eleonora Duse in Cenere, “Bianco e Nero”, nn. 7-8, 1952). Lo stesso William Weaver (Duse. A Biography, cit.) racconta due episodi (senza indicare la fonte), fra cui quello in base al quale già nel 1914 l’amica Gemma Ferrug-
6
88
6 / La tentazione del silenzio / Elena Dagrada
gia avrebbe avanzato l’ipotesi di scrivere per lei un soggetto per il cinema basato sulla vita di Santa Caterina da Siena, ma l’attrice avrebbe stroncato sul nascere l’idea; secondo Deslandes (cfr. Jean-Louis Courtault-Deslandes, Eleonora Duse attrice cinematografica. Un’opera incompiuta, “Museo Nazionale del cinema. Notiziario”, nn. 34-35-36, 1977-1979), però, il libro di Emma Ferruggia (La nostra vera Duse, Sonzogno, Milano 1924) contiene particolari che spingono a datare quell’episodio più tardi, forse nel 1918, in ogni caso dopo Cenere. A proposito dell’offerta di Griffith, invece, un’ipotesi suggestiva è che il grande regista americano possa aver pensato a lei per il ruolo della madre intenta a ‘cullare’ il proprio figlio nel film Intolerance; le date coincidono: The Birth of a Nation è uscito negli USA l’8 febbraio 1915 e successivamente Griffith lavora appunto a Intolerance, che uscirà nel settembre del 1916 (lo ipotizza anche Gerardo Guerrieri, Eleonora Duse. Nove saggi, a cura di Lina Vito, Bulzoni, Roma 1993, pur senza evocare il possibile ruolo della madre intenta a cullare, interpretato poi da Lillian Gish). Vero è che i tempi di lavoro prospettati, sia durante il primo contatto (tre settimane a Los Angeles), sia nei successivi, sembrano indicati per interpretazioni diversamente impegnative, ma anche che Griffith riteneva quel ruolo di grandissima importanza. 7 Ove possibile, riportiamo qui la trascrizione nell’originale francese delle lettere scritte da Eleonora Duse alla figlia Enrichetta, durante gli anni della Grande Guerra, pubblicate in ordine sparso da Jean-Louis Courtault-Deslandes (op. cit.), Gerardo Guerrieri (op. cit.) e Maria Ida Biggi sulla “Turin D@ ms Review”, che ha recentemente messo in rete un’anticipazione della loro edizione critica progettata in occasione dei centocinquant’anni dalla nascita dell’attrice (Ma pupa, “Turin D@ms Review”, ottobre 2008). Sempre ove possibile, si fa seguire una delle diverse traduzioni italiane proposte in varie sedi, specificando la fonte, o una mia traduzione. Com’è noto, infatti, si tratta di lettere scritte in una singolare mistura di italiano e fancese (non privo di errori, che non sono stati corretti, né contrassegnati dal segno sic), ricopiate fedelmente dalla stessa Enrichetta, stando a quanto sostenuto da lei medesima (che tuttavia ha distrutto gli originali) in un insieme di volumi noti come Quaderni di Enrichetta, donati alla Fondazione Giorgio Cini dalla nipote di Eleonora (figlia di Enrichetta, maritata Bullogh e residente a Cambridge, in Inghilterra), divenuta Sister Mary of Saint-Mark. Questa prima frase è a p. 18 del saggio di Deslandes e la traduzione italiana compare anche in Weaver (Duse. A Biography, cit., p. 312).
L’originale francese è in Maria Ida Biggi, op. cit., traduzione nostra. 8
Una precisazione economica che, stando a Deslandes (Eleonora Duse attrice cinematografica. Un’opera incompiuta, cit.), si trova in una lettera della Duse alla figlia datata 20 dicembre 1915.
9
Cfr. William Weaver, op. cit., p. 213, dove si riporta un brano dell’attrice decisa “a escludere ogni soggetto tratto dal solito repertorio teatrale”.
10
11 Cfr., fra gli altri, Gerardo Guerrieri op. cit., e William Weaver, op. cit., dove si riporta che la figlia Enrichetta abbia segnalato alla madre il libro di Vachel Lindsay (The Art of the Moving Picture, Macmillian, New York 1915 [1922]; tr. it. L’arte del film, Marsilio, Venezia 2008) e la Duse, estasiata, le abbia chiesto di metterla in corrispondenza con l’autore. 12
Cfr. Jean-Louis Courtault-Deslandes, op. cit.
Pietro Crivellaro, Ultime notizie su Cenere. Con cinquantadue documenti inediti dall’archivio di Febo Mari, “Notiziario dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema”, n. 64, 2000, p. 15, sostiene che la “principale ragione che spinse l’attrice, autoesiliatasi dalle scene dai primi del 1909, a cedere alla tentazione dell’‘arte muta’ sulle orme di famosi colleghi del teatro come Ermete Zacconi, Lyda Borelli, Irma Gramatica, Dina Galli, Tina di Lorenzo, o la stessa rivale Sarah Bernhardt, fu tutt’altro che artistica. Con l’entrata in guerra dell’Italia contro Austria e Germania il fatidico 24 maggio 1915, la Duse non potè più disporre della rendita dei suoi risparmi amministrati dal banchiere berlinese Robert von Mendelssohn e si trovò costretta a riprendere il lavoro. Al ritorno della pace, con il crollo della Germania, quei marchi bloccati nella banca tedesca divennero ahimè carta straccia. L’irrisolta questione del bisogno economico non sarà affatto estranea al famoso rientro sulle scene dell’attrice anziana e malata, al Teatro Balbo di Torino nel 1921”. Il che è senz’altro vero, ma è altrettanto vero che Eleonora Duse avrebbe potuto porre fine ai suoi problemi economici andando a vivere in Inghilterra con la figlia, che non chiedeva altro (e osteggiava il ritorno della madre al lavoro sopra ogni cosa). Senza nulla togliere all’interesse dell’attrice per le prospettive di guadagno (“Buon compenso accresce coraggio”, scrive in un telegramma a Febo Mari il 20 giugno 1916, citato da Pietro Crivellaro a p. 26), più numerose ancora sono le tracce di un suo interesse autentico per l’arte del cinematografo e di un intimo bisogno di tornare finalmente al lavoro.
13
14 “Ora ho trattative e buone, anche qui a Roma; ma la proposta di America, mi piace assai più perché il viaggio mi raccoglie. Ma, in questo momento, tutto il mondo è zona di guerra e, forse, concilierò una cosa con l’altra [...]. L’offerta, qui, sarebbe, una film (grandiosa) ma una, e 100.000 franchi. Il che è qualche cosa. Però, ti dico anche, che ho un progetto di tre anni di lavoro, e questo di adesso sarebbe solo l’entrata in zona di cinema. [...] Acqua in bocca, ti raccomando perché les affaires sont les affaires” (Olga Signorelli, op. cit., p. 20).
Il 2 giugno 1916 Eleonora Duse scrive alla figlia: “Sono in trattative assai strette, e quasi concluse e tutte buone, con tre case di film” (Gerardo Guerrieri, op. cit., p. 215); quindi nuovamente a Emma Garzes, il 5 giugno 1916: “Devo dirti, che delle tre offerte ieri ho concluso con quella che più risponde allo spirito della cosa” (Olga Signorelli, op. cit., p. 22). È possibile che queste affermazioni dell’attrice siano all’origine della convinzione secondo cui le case in questione fossero appunto tre e – forse a partire da un’affermazione di JeanLouis Courtault-Deslandes, op. cit., p. 21, secondo cui erano 15
89
“senz’altro Cines, Itala Film e Ambrosio” – che tale convinzione si sia tramandata di studioso in studioso. Ma o le Case non furono solo tre, oppure uno dei tre nomi è da correggere. Non quello della Cines, né quello dell’Ambrosio, bensì quello dell’Itala, con cui la Duse in effetti non fu mai in trattative (al di là della loro effettiva attendibilità, infatti, non si possono considerare trattative gli scambi della Duse con Pastrone descritti con piglio narrativo da Montesanti a partire unicamente da testimonianze orali, oggi ritenute per di più sopravvalutate, cfr. infra, nota 24). Ci fu, invece, una trattativa documentata con la romana Tiber, cfr. infra nota 27. 16 Cfr. la testimonianza di Camille Mallarmé riportata fra gli altri da Jean-Louis Courtault-Deslandes, op. cit., da cui si evince che la trattativa con la Cines non andò in porto per la pretesa della Casa romana di inserire nel film ambientazioni mondane, mentre la Duse aveva in mente solo sobrietà contadina.
Lo dimostrano numerose lettere in cui l’attrice fa riferimento a Cenere già dal marzo 1916. Cfr. in particolare William Weaver, op. cit., che alle pp. 316-317 riporta una lettera dell’attrice alla figlia in cui le scrive che nel suo film illustrerà un libro di cui non può ancora farle il nome, ma la cui trama è chiaramente quella di Cenere. In una lettera successiva (datata 11 aprile 1916) annuncia che glielo spedirà e il 2 maggio le spiega che dovrebbe andare in Sardegna, ma poiché al momento viaggiare è fuori questione, tutto resta sospeso. Finalmente il 14 maggio le annuncia il titolo (cfr. Gerardo Guerrieri, op. cit.).
17
Cfr. Umberto Barbaro, op. cit., p. 129; e Cristina Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’Epos, Palermo 2006.
18
19
Cfr. Gerardo Guerrieri, op. cit., p. 215.
Cfr. Gerardo Guerrieri, op. cit., p. 216. È in questa lettera che chiede alla figlia di esser messa in corrispondenza con Lindsay. 20
Sui limiti e le insidie della supposta libertà totale accordata a Welles dalla RKO, cfr. Elena Dagrada, Da Heart of Darkness a F for Fake, in Luca Giuliani, Giorgio Placereani (a cura di), My Name is Orson Welles. Media, forme, linguaggi, Il Castoro, Milano 2007. Welles, del resto, era un giovane incosciente (se non proprio innocente); mentre Eleonora Duse, a proposito del cinema, avrebbe dichiarato: “Mi dispiace che non sono più giovane: mi sarei messa con tutte le mie forze sulla nuova via, e sono certa che qualche cosa avrei trovato” (cit. in Eugenio Ferdinando Palmieri, La Duse protagonista di Cenere, “Bianco e Nero”, n. 12, 1958, p. 51).
21
22 “In quell’epoca [...] ella frequentava molto i cinematografi e spesso voleva che io l’accompagnassi – come lei diceva – ‘per imparare insieme l’a.b.c. di quest’arte nuova’ ”, cfr. Riccardo Artuffo, Testimonianza di un collaboratore, “Bianco e Nero”, n. 12, 1958, p. 50. Molti studiosi, inoltre, citano una testimonianza di Colette che avrebbe visto l’attrice fra il pubblico in una sala cinematografica romana. 23
Cfr. Cristina Jandelli, op. cit., che riporta anche il passo di
90
una lettera della Duse alla figlia, scritta il 9 settembre 1916 (ripresa dal volume di Antonio Cara, Cenere di Grazia Deledda nelle figurazioni di Eleonora Duse, ISRE, Nuoro 1986, p. 123), in cui spiega che il film è finito e manca “solo un raccordo, cioè non una scena centrale ma un passaggio tra le due”, dimostrando interesse per la terminologia tecnica. Nella stessa lettera annuncia di aver cominciato il secondo film, La donna del mare, che non farà mai. La tesi di una supposta congiura di Pastrone e Mari ai danni della Duse è stata tramandata da Fausto Montesanti (a cura di), Pastrone e la Duse: un film mai realizzato, “Bianco e Nero”, n. 12, 1958. Si tratta di una tesi oggi ridimensionata: cfr. Nino Genovese, Febo Mari, Papageno, Palermo 1998; e Massimo Moretti, Febo Mari vigilò l’esecuzione, “Fotogenia”, nn. 4-5, 1996-1997.
24
25
Cfr. Pietro Crivellaro, op. cit., p. 30.
26
Ibidem.
Cfr. Ferdinando Cordova, Grazia Deledda e Febea. Cronistoria di un soggetto cinematografico, in Gianni Olla, Scenari sardi. Grazia Deledda tra cinema e televisione, Cagliari, Aipsa, 2000, secondo il quale è possibile che la scelta del romanzo sia stata suggerita a Eleonora Duse dall’intima amica Olga Ossani (maritata Lodi), giornalista e scrittrice che si firmava con lo pseudonimo Febea. La Ossani, a sua volta, era vicina alla Deledda, che già in passato si era rivolta a lei per far recensire il suo lavoro e ne era divenuta intima amica dopo il trasferimento a Roma. Olga Ossani era di casa negli ambienti letterari e dello spettacolo, aveva tradotto e adattato opere di autori stranieri e “avviato, su incarico delle interessate, incontri con il marchese Luigi Villani della Polla e il comm. Augusto Laganà, rappresentanti della romana Tiber, i quali si erano dimostrati ben disposti a finanziare l’impresa, confidando che la presenza della Duse sarebbe stata occasione di pubblicità e incassi” (p. 118). Le trattative avanzarono al punto da discutere il compenso economico per la scrittrice ma fallirono, secondo Cordova, perché la Duse preferì concludere con Ambrosio. Fra le carte di Olga Ossani, Cordova ha rinvenuto anche lo Scenario sardo per il cinema di Grazia Deledda (pubblicato all’interno del suo saggio), scritto dalla Deledda per la Duse e risalente al maggio del 1916, nonché altre corrispondenze che sembrano confermare questa ipotesi. Si noti che in una lettera alla figlia la Duse fa esplicitamente riferimento a un compenso di 5.000 lire ricevuto da Olga Ossani per Cenere (“...on donne 5 mille à Olga Ossani pour (trop long à te raconter) ses bonnes paroles données pour une autre société” [vengono dati 5 mila a Olga Ossani per (troppo lungo da raccontare) le buone parole che ha speso per un’altra società]), in Gerardo Guerrieri, op. cit., p. 216 (traduzione nostra). E in Pietro Crivellaro, op. cit., viene riportato un telegramma in cui la Duse chiede a Mari di confermarle che non ha firmato con la Tiber e solo dopo la conferma gli riscrive che potranno allora fare insieme cosa d’arte. 27
28 “Je te dis: Le livre est basé sur la nécessité (n’importe la quelle) d’une séparation entre mère et fils” [Ti dico: Il libro è
6 / La tentazione del silenzio / Elena Dagrada
basato sulla necessità (non importa quale) di una separazione tra madre e figlio] (traduzione nostra), in Gerardo Guerrieri, Eleonora Duse. Nove saggi, op. cit., p. 213. 29 Si noti che questa lettera non è presente in tutte le copie giunte fino a noi.
Cfr. Pietro Crivellaro, op. cit., p. 33. Cfr. in Olga Signorelli, op. cit., altre missive da cui risulta che per qualche tempo i contatti continuarono e la Deledda non fu soddisfatta del film. 30
Gli appunti originali di Eleonora Duse si trovano presso l’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, che ospita il Museo Deleddiano. Sono stati trascritti da Antonio Cara, op. cit. Una minuta è conservata anche presso la Fondazione Giorgio Cini. Si veda anche il volume di Paola Bertolone, I copioni di Eleonora Duse, Giardini editori e stampatori in Pisa, Pisa-Roma 2000, per la forte impronta registica lasciata dall’attrice sui testi che recitava e sui quali era solita intervenire autorialmente.
31
Copie del film sono conservate presso il Museo del cinema di Torino, la Cineteca del Friuli, la George Eastman House, la Cineteca Sarda e la Cineteca Italiana di Milano, che ne ha di recente curato un restauro pubblicandolo in DVD nel 2008.
32
33
Gianni Olla, op. cit.
34
Cfr. Pietro Crivellaro, op. cit.
Cfr. Giuseppe Paolo Pacchierotti, Pellicole torinesi. Indiscrezioni con discrezione, “Film”, n. 25, 1915, che a p. 6 racconta quanto Febo Mari gli ha confidato sul set negli stabilimenti Ambrosio, prima di essere interrotto dal cavalier Arturo che chiede di rispettare il riserbo voluto dall’attrice. In quell’occasione Mari avrebbe detto a Pacchierotti che “il cavaliere Ambrosio, che cura l’esecuzione, ha trovato scorci e quadri assolutamente michelangioleschi”; un’affermazione da cui si deduce il ruolo attivo dello stesso Ambrosio nel “vigilare l’esecuzione del film”. Cfr. anche Saverio Procida, La maschera. Ad Eleonora Duse, “L’Arte muta”, n. 3, 1916, p. 37: “I soliti indiscreti hanno già dispensato ai profani qualche notizia dalla prima film che la Duse ha condotto a termine. Si sa, fra le quinte degli edotti reporters, che il romanzo di Grazia Deledda, Cenere, ha una prima parte, L’ombra, in cui l’immensa protagonista agirà come uno spirito e non come un corpo. Si sa inoltre che nella seconda parte, La larva, lo spirito fluttuerà in parvenze fantomatiche di mani, che segneranno uno scorcio impressionante sullo schermo – e che infine, nella terza, La carne, la donna apparirà intera nel gioco della luce e nel fremito del dramma”. Non c’è traccia di questi titoli nelle copie del film attualmente accessibili agli studiosi. 35
36
Cfr. Olga Signorelli, op. cit.
Ambrosio procrastinò anche il saldo del compenso all’attrice, che se ne lamentò più volte con la figlia. 37
38 Cfr. Pietro Crivellaro, op. cit., che riporta anche un documento da cui risulta che lo stesso Mari si interessò a subentrare nell’impresa. Cfr. pure Cenere e fumo, “Contropelo”, n. 2, 1916, p. 2, dove si fa dell’ironia sul ritardo nella distri-
buzione e si sostiene che al di là di chi sbaglia a pretendere tagli e migliorie, giudicando il film non pronto o insoddisfacente, ha sbagliato “la casa che, scritturandola, ha accettato l’inverosimile clausola di sottoporre il proprio lavoro al nulla osta dell’interprete”. Comunicazione personale di Pier Luigi Raffaelli da fonti SIAE.
39
40 Cfr. Mario Corsi, Il cinema della Duse, “Cinema”, n. 97, 1940, p. 20.
Cfr. “L’Arte muta”, n. 3, 1916, in cui si afferma che l’ingresso della Duse nel cinema e la realizzazione di Cenere segnano “una battaglia vinta: quella del cinema come arte”. Mentre di lì a poco si potrà vedere una vignetta pubblicata su un giornale satirico (Cause ed effetti... “Contropelo”, n. 16, 1917, p. 3) in cui gli spettatori escono dalla sala in cui si proietta Cenere con la barba.
41
Fra i contributi qui già ricordati cfr. almeno Umberto Barbaro, op. cit., e Jean-Louis Courtault-Deslandes, op. cit.
42
Cfr. Gigi Livio, op. cit., p. 163, che a proposito di Cenere parla anche di “poetica dell’Ombra”, al cinema più efficace e suggestiva che in teatro. Cfr. anche Donatella Orecchia, La prima Duse. Nascita di un’attrice moderna, Artemide, Roma 2007, che ricostruisce la progressione nei giudizi espressi dalla critica sulla recitazione dell’attrice, dapprima definita “strana”, poi “nervosa” e “moderna”, fino a riconoscerne definitivamente la grandezza e l’originalità. 43
Cfr. in proposito le riflessioni di Gerardo Guccini, Il grande attore e la recitazione muta, in Renzo Renzi (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo (19051930), Cappelli, Bologna 1991.
44
Per un raffronto tra il film e gli affreschi di Giotto si vedano Antonio Cara, op. cit.; Gian Piero Brunetta, Ut pictura ita cinema, in Leonardo Quaresima e Laura Vichi (a cura di), La decima musa. Il cinema e le arti visive, Forum, Udine 2001; Cristina Jandelli, op. cit.
45
46 Si veda l’indimenticabile descrizione di Charlie Chaplin in My Autobiography, Simon & Schuster, New York 1964 (tr. it. La mia autobiografia, Mondadori, Milano 1964), nonché lo scritto di Rouben Mamoulian, Bernhardt e Duse, due interpretazioni, “Bianco e Nero”, n. 12, 1958. 47
Gerardo Guerrieri, op. cit., p. 219.
Nel romanzo, la vedova di Fonni convoca Olì con uno stratagemma, sapendo che mai si recherebbe a un incontro con il figlio, di cui ha paura perché teme che la denunci ai carabinieri. Nel film, al contrario, Rosalia accetta lucidamente di incontrare il figlio e, nonostante una didascalia dialogica attribuita alla vedova reciti: “Tua madre ha paura di te”, è evidente che Rosalia non teme Anania. Addirittura, a un certo punto lo comanda (nel brano in cui si atteggia a “Noli me tangere”).
48
Cit. in Jean-Louis Courtault-Deslandes, op. cit., p. 20. In realtà, che il libro di Grazia Deledda sia intriso anche di quel
49
91
folclore caro a Orano (futuro marito di Camille Mallarmé) lo si evince con chiarezza anche dallo Scenario sardo per il cinema che la scrittrice invia alla Duse e che concepisce nello stesso periodo in cui sono in corso le trattative per l’adattamento di Cenere (cfr. supra la nota 27). 50 Non è inverosimile supporre che la stessa Deledda abbia scelto queste parole consigliata da Olga Ossani, che conosceva bene Eleonora Duse e sapeva quanto ne sarebbe stata colpita. 51
Mario Corsi, op. cit., p. 20.
Cfr. Mario Cacciaglia, Eleonora Duse, ovvero vivere ardendo, Rusconi, Milano 1998, per il comportamento di Cafiero che non volle assumersi in alcun modo le proprie responsabilità (tanto che la giovanissima Duse fu assistita in tutto dall’amica Matilde Serao); e per il mistero che circonda sia la nascita, sia la morte del bambino di Cafiero, che non si sa dove sia sepolto. 52
Cfr. Riccardo Artuffo, Testimonianza di un collaboratore, “Bianco e Nero”, n. 12, 1958, p. 50, che ricorda un pomeriggio al cinema con la Duse, in cui “nel film a cui assistevamo c’era una scena – è l’unica cosa che ricordo con precisione – in cui la protagonista, una piccola attrice oscura e povera, doveva difendersi contro la galanteria brutale di un dongiovanni da strapazzo. Quale non fu la mia meraviglia quando, finita la parte e rifattasi la luce, io, volgendomi verso la signora, le vidi il volto tutto irrorato di lacrime. Forse la triste scena le aveva ricordato qualche doloroso episodio della sua giovinezza? O forse l’interpretazione veramente artistica l’aveva profondamente presa e turbata?”. 53
54 Cfr. Cesare Molinari, op. cit., in particolare il capitolo Nel ruolo di madre. Fra le persone con cui in questi anni l’attrice assume il ruolo di madre vicaria, Molinari ricorda il giovane avvocato fiorentino Giovanni Rosadi; Alberta Aliprandi, figlia dell’attrice Giovanna; Cordula (Lina) Poletti; e soprattutto il giovane militare Luciano Nicastro, con cui la Duse imbastisce anche un fitto scambio epistolare (cfr. Luciano Nicastro, Confessioni di E. Duse, 3 voll., Gentile, Milano 1945). In quest’ottica, tuttavia, si può ritenere che anche la lunga e tormentata relazione con D’Annunzio – più giovane della Duse di sette anni e da lei chiamato “figlio” in numerose lettere – acquisti legittimamente una dimensione analoga.
92
7 / Roberta Gandolfi
Il teatro italiano e le sue ‘donne nuove’ Fra tradizione e riforma, emancipazionismo e modernismo
Come si configura il protagonismo femminile nel teatro italiano all’inizio del Novecento? Dove indirizzare lo sguardo per individuare figure e soggetti che, in maniera analoga alle pioniere del cinema, agirono da innovatrici rispetto alla cultura scenica dell’epoca? Intendo rispondere a tali quesiti con un sintetico, ma problematico affresco d’insieme: non tanto e non solo un promemoria di nomi e figure, quanto l’indicazione delle prospettive feconde e delle buone domande, e al contempo una ricognizione critica dello stato degli studi sull’argomento, compresa l’indicazione delle zone d’ombra, frutto della rimozione storiografica che ha colpito le artiste del periodo modernista, nel cinema come nel teatro e nelle altre arti1. In partenza, credo sia indispensabile indicare un orizzonte importante, un fenomeno che fu italiano ed europeo: l’assodato legame fra emancipazionismo e teatro. Le attrici furono idealmente le sorelle delle ‘donne nuove’: The New Woman and Her Sisters, titola significativamente un’antologia dedicata a femminismo e teatro fra il 1850 e il 19142. Per quanto riguarda l’Italia, già Ciotti Cavalletto segnalava che negli ultimi decenni dell’Ottocento, a fianco delle interpreti che proponevano, in scena
e nella vita, convenzionali e conformisti modelli di femminilità, si delineò una catena di attrici ‘nuove’, che rifiutavano la connivenza col pubblico borghese, e lungi dal blandirlo, pensavano a educarlo e provocarlo; professavano sentimenti anti-monarchici e repubblicani e rispecchiavano nelle scelte di repertorio il loro impegno ideologico, privilegiando il dramma verista e il teatro ibseniano3. Nel 1991, con Il tempo delle attrici, Laura Mariani ha aperto nuove prospettive in questo senso; attingendo alla storia delle donne e agli studi sull’emancipazionismo, ha ricostruito come le attrici nuove – da Giacinta Pezzana a Eleonora Duse – nel tempo che va dal Risorgimento alla Prima guerra mondiale, si siano nutrite di legami e intrecci concreti con il movimento emancipazionista, cercando consapevolmente di dar vita a teatro all’inquietudine e alla diversità dell’anima femminile, contribuendo a creare modelli identitari e un immaginario che vibrava e risuonava nella cultura delle spettatrici4. Queste attrici, insomma, nutrirono quel “desiderio di tante di uscire dai confini ristretti delle loro vite”, di cui parla Elda Guerra in altro saggio del volume; con loro le scene teatrali assunsero una peculiare centralità nell’immaginario del primo femminismo. È significativo che negli anni Dieci, proprio quan93
do nel teatro italiano comincia lentamente a manifestarsi un declino dell’egemonia attorica (è l’inizio di una stagione che è stata battezzata “il tramonto del grande attore”)5, il cinema muto, in un giro ristrettissimo d’anni – quelli della Grande Guerra, che vedono in crisi il mercato teatrale – si faccia testimone dell’arte scenica di queste grandi attrici di prosa, aprendosi al loro contributo non solo recitativo e interpretativo ma anche ideativo, sul lato registico e/o delle sceneggiature: del 1914 è la trasposizione scenica del cavallo di battaglia di Giacinta Pezzana, Teresa Raquin, capolavoro per attrice del teatro verista di Zola; del 1915 è Cenere di Eleonora Duse, da un romanzo di Grazia Deledda, cui Elena Dagrada dedica uno studio specifico in questo stesso
Irma Gramatica (Archivio “In penombra”) 94
volume, ricordando il ruolo autoriale della Duse per quanto riguarda la scelta del soggetto, la sceneggiatura e le scelte visive; agli schermi si avvicinano come interpreti anche le sorelle Gramatica: Emma in Quando il canto si spegne (Emilio Graziani-Walter, 1916); Irma in Sacrificio sublime (Riccardo Tolentino, 1915) e Un avviso in quarta pagina (Alberto Giovannini, 1916), ma nel 1917 le riviste di cinema attribuiscono a Irma anche il soggetto di un misterioso film dal titolo Usque dum vivam et ultra, messo in produzione dalla Zero Film ma a quanto pare mai distribuito (entrambe però saranno maggiormente implicate nel cinema negli anni Quaranta, dopo decenni di esclusiva dedizione alle scene teatrali). Ancora, la più giovane Maria Melato, che sulle scene teatrali degli anni Venti è continuatrice e reinventrice di un legame di grande intensità col pubblico femminile, fra il 1914 e il 1920 interpreta sette film, fra i quali un Anna Karenine (Tespi Film, regia di Ugo Falena, 1917) di cui resta da indagare una sua collaborazione alla regia6. Al cinema come a teatro, queste artiste dunque sono più che interpreti: lavorano da attrici-autrici. All’indagine sul teatro di prosa borghese va affiancata quella sul teatro popolare: nel periodo a cavallo fra i due secoli, a Napoli e a Roma, emerge infatti un fenomeno di protagonismo tutto femminile, una nuova tipologia di attrici soliste, le canzonettiste, poi soubrettes, che si affermano sulle scene del café chantant e in seguito del varietà. Il fenomeno interseca e interessa anche il cinema in maniera rilevante, sia per il diffondersi dell’avanspettacolo nello spazio ibrido del cinema-varietà, che per le concrete peripezie biografiche che portano moltissime soubrettes sugli schermi; infine, soprattutto, per le peculiari interpretazioni del divismo femminile che emergono dal loro mondo, costruite su un immaginario che intreccia alla seduzione scenica una storia di vita creata ad hoc, di carattere finzionale, che viene data in pasto ai mass-media, diffondendo modellizzazioni che, come sostiene Teresa Megale, sono all’origine sia del divismo cinematografico del primo Novecento che del successivo star system7. È indubbio che da quest’area di teatro popolare, nei primi del Novecento, emergano rappresentazioni del femminile che sono agli antipodi della figura della ‘donna
7 / Il teatro italiano e le sue ‘donne nuove’ / Roberta Gandolfi
nuova’; centrate sulla fisicità e sulla seduzione, e indirizzate a un pubblico monosessuato, tutto maschile; sono immagini che preparano la strada alla novecentesca versione della donna-oggetto, fino al grottesco scadimento odierno in ‘velina’. Tuttavia è bene accogliere il suggerimento di Megale, quando ci invita a rivisitare l’azione delle soubrettes tenendo conto di segnali anche contraddittori di libertà espressiva, come l’esercizio del capocomicato che fu tentato da molte di loro (come dalle loro sorelle maggiori del teatro di prosa), e quando ci indica come interrogare con ottica gender le loro numerose autobiografie e le strategie narrative e sceniche delle loro modalità di autorappresentazione8. In questa occasione vorrei segnalare la possibilità di indagare ulteriormente l’azione innovatrice delle artiste del palcoscenico, nei primi tre decenni del Novecento, provando a inforcare anche altri occhiali. Suggerirei un’indagine che, senza tralasciare le acquisizioni storiografiche relative alla storia d’attore/d’attrice, parta, prima che dai soggetti (le singole figure e le loro biografie), dagli ambiti e dagli ambienti del teatro del tempo, sia concreti e operativi che discorsivi, che articolano anche in Italia il discorso modernista, declinando la cultura nuova del teatro come arte, indipendente dalle logiche del profitto e dalla routine del sistema mercantile dello spettacolo. Mi riferisco al fenomeno europeo dei teatri d’arte e dei piccoli teatri, alle istanze culturali e alle pratiche artistiche a esso correlate: l’allestimento del dramma di idee, la nuova editoria teatrale, l’istanza registica. Si tratta di interrogare questi ambienti esplorandovi la consistenza, il segno e la qualità dei contributi delle donne. L’orizzonte di fondo è quel “paesaggio della modernizzazione”, e quel rapporto fra donne e modernità, cui fa riferimento Elda Guerra nel suo saggio.
I teatri indipendenti e d’arte A cavallo fra i due secoli in Europa si diffonde a macchia d’olio un fenomeno nuovo: la fondazione di teatri d’arte e piccoli teatri, che contribuiscono a riconfigurare lo spazio del teatro, spostando il campo delle pratiche teatrali dai terreni dell’intrattenimento
verso quelli di un’arte pura, libera dai vincoli e dagli intenti delle scene commerciali. Al loro interno il teatro viene progettato e fruito in quanto esperienza seria, esperienza d’arte opposta alle logiche del consumo spettacolare; sono luoghi di progettazione e animazione culturale, spesso legati a orizzonti progressisti, e nutriti di slanci utopici verso la ricerca drammaturgica, la sperimentazione artistica e il legame ai rispettivi territori e pubblici di riferimento9. Nel mio lavoro di storica del teatro, più tracce e più storie mi hanno portato a individuare in questo arcipelago nuovo – relativamente aperto perché non rigidamente strutturato, e fortemente motivato al dialogo con varie istanze culturali e sociali, fra le quali l’emancipazionismo e la cultura delle donne – un ambito che va scandagliato con attenzione per indagarvi il contributo e il protagonismo innovatore delle teatranti di inizio secolo. Gli esempi maggiori e un po’ più studiati riguardano realtà europee di primo piano – eppure a lungo rimosse dalla storiografia – come la compagnia femminista e socialista delle Pioneer Players (19111925), attiva a Londra per tutti gli anni Dieci e diretta dalla prima regista del teatro europeo, Edith Craig; i Provincetown Players dell’americana Susan Glaspell – oggi largamente riscoperta come complessa drammaturga del New Drama e della ‘donna nuova’ – e di suo marito George Cook, attivi nello stesso periodo negli Stati Uniti; o ancora il francese Laboratoire Art et Action (1912-1952), altra straordinaria realtà indipendente che unisce, come la compagnia inglese di Edith Craig, logica di ricerca artistica e logica di teatro sociale, fondato dall’attrice Louise Lara insieme al marito, l’architetto Edouard Autant, e alla nipote Akakia Viala, che dirige le pubblicazioni del gruppo10. In Italia l’arcipelago dei teatri indipendenti e d’arte ha minor peso e consistenza che negli altri paesi europei – complice l’enorme peso della tradizione attorica – e non sussistono esperienze di questo rilievo dirette da donne, ma una indagine accurata potrebbe riservarci qualche sorpresa. Prendiamo il caso di quello che la storiografia segnala come primo teatro d’arte italiano11, ovvero Il Teatro d’Arte di Torino fondato da Domenico Lanza, critico drammatico liberale e più tardi fiero antifasci95
Maria Melato (Archivio “In penombra”)
sta. Sostenuto da vari circoli intellettuali torinesi, il teatro fu attivo per una sola ma importante stagione, il 1898, contribuendo attivamente al quinto Congresso drammatico italiano che si svolse quell’anno in città, proprio mentre Torino (precoce città di cinema, dove esordirono in Italia i Lumière) ospitava l’Esposizione nazionale; intanto a Mosca Stanislavskij e Nemirovic-Dancenko fondavano il loro celeberrimo Teatro d’Arte… Il teatro torinese si proponeva obiettivi analoghi a quelli dei suoi omonimi europei: ricerca artistica anziché logica del profitto, aggiornamento del repertorio (con forte interesse verso il dramma d’idee), apertura a nuovi pubblici, politica popolare dei prezzi, compagnia stabile, tendenza 96
verso la recitazione d’ensemble e la direzione unitaria (regia). Nella breve esistenza di questa esperienza torinese, il momento clou fu la rivelazione di Anima di Amelia Rosselli, un dramma progressista ed emancipazionista che replicò per oltre cento serate, fu ripreso anche da altre compagnie, e costituì un caso teatrale di primo piano. Si tratta di un dramma davvero ben scritto, riuscito e incisivo, sia nelle forme drammatiche, che nei contenuti moralmente densi e tesi; il titolo stesso, Anima, è significativo, rimanda al dibattito sull’anima femminile che è al centro del discorso emancipazionista e risponde polemicamente a un dramma di Giacosa, I diritti dell’anima, che Rosselli non aveva amato, rigettandone il ritratto ipocrita e borghese della protagonista. Il suo Anima vede al centro una ben diversa figura femminile, una giovane pittrice, una ‘donna nuova’. Nel primo atto, Olga lavora con serietà e concentrazione nel suo studio ingombro di quadri, fra cui numerosi nudi, ritraendo dal vero un’altra donna, una modella che posa per lei; a questo spazio, un’enclave femminile al di fuori della quale rimane intatto l’ordine patriarcale delle relazioni fra i sessi, Rosselli contrappone nel secondo atto un ambiente tutto maschile, la sala da pranzo dove un giovane uomo riceve i suoi amici, intrecciando con maestria e sottigliezza un dialogo dal quale emerge l’ipocrisia e il sessismo dello sguardo maschile sulle donne, principale oggetto delle loro sarcastiche conversazioni. La prospettiva, ancora da sviluppare, con cui guardare a questo e ai successivi lavori teatrali di Amelia Rosselli (che è stata oggetto di riscoperta e di attenzione editoriale nell’ultimo decennio in quanto intellettuale antifascista12, ma lasciando in ombra il suo teatro, sul quale mancano indagini sistematiche) ci è indicata dalle colleghe straniere che operano nel campo di gender and theatre: Anima va fatto rientrare nel movimento internazionale del Modern Drama e in particolare nel Modern Drama by Women, cui Katherine Kelly ha dedicato nel 1997 un’importante antologia13. Kelly e le sue collaboratrici partono dalla attestata centralità della questione femminile nel modern drama europeo (o new drama, o dramma d’idee come venne chiamato da noi) di Ibsen, Strindberg, Shaw, Cechov, Brieux, dove “la
7 / Il teatro italiano e le sue ‘donne nuove’ / Roberta Gandolfi
questione della modernità viene a coincidere con la rappresentazione della donna in crisi” rispetto ai convenzionali ruoli di genere14, e discutono e decostruiscono la solo apparente mancanza di contributi di donne drammaturghe a questa tendenza. In realtà per un breve periodo (quello dell’affermazione professionale delle artiste, 1890-1920) il teatro accolse la drammaturgia femminile, soprattutto sulle scene sperimentali e d’arte, ma poi questa stagione si chiuse; la rimozione storiografica ha varie cause, fra le quali, scrive Kelly, l’affermarsi di un canone cosmopolita e universalista (sparisce ciò che non viene tradotto e che non circola oltre i confini nazionali), il diniego del realismo come forma stilistica degna del modern drama (mentre le autrici di drammi d’idee ricorrono spesso a canoni realistici) e l’uso delle donne di scrivere sotto pseudonimo per pregiudizi di genere. L’antologia curata da Kelly sceglie appunto Rosselli, quale esempio italiano del modern drama delle donne, traducendo e pubblicando Anima in inglese, e indica accanto a questa pièce anche quelle di altre drammaturghe, quali Annie Vivanti, Teresa Gray Ubertis, Clarice Tartufari, il cui lavoro è in parte ancora da indagare. Il debutto di Anima a Torino esemplifica insomma anche nel contesto italiano il legame significativo fra teatri d’arte, modern drama, questione femminile e azione innovatrice delle teatranti. Non è affatto un caso, a mio parere, che all’interno dell’esperienza torinese convergano le culture sceniche emancipazioniste delle scrittrici, con Rosselli, e della tradizione attorica, con Giacinta Pezzana, la cui presenza dà rinomanza e credito alla compagnia. Comune alle due artiste, pur diverse per generazione e per sfera d’attività, oltre ai legami con il movimento delle donne, è la profonda idealità politica, di stampo mazziniano e post-risorgimentale, affine anche a quella del fondatore del Teatro d’Arte, Lanza. A proposito di Giacinta Pezzana (la cui biografia è stata indagata in ampiezza e profondità e con prospettiva di genere da Laura Mariani, sia nel libro già citato che nel suo ultimo poderoso volume, L’attrice del cuore, che ne raccoglie le lettere)15 segnalo che la troviamo sempre in prima fila nei principali tentativi di teatri d’arte e popolari italiani: dopo l’esperienza torinese, nel 1905 si impegna nella Stabile romana
di Edoardo Boutet – altro tentativo di breve durata; in seguito, mentre frequenta il circolo di intellettuali che si raccoglie intorno alla casa di Sibilla Aleramo e Giovanni Cena, si dedica anima e corpo al suo progetto di compagnia romanesca, una compagnia dialettale che fonda a Frascati in nome di un teatro popolare ed educativo, portandola avanti per due anni (1907-1909) nonostante incomprensioni, insuccessi e grandi fatiche. Per comprendere il senso culturale di questo suo impegno tenace e anche struggente, giova ricordare che accanto all’arcipelago dei teatri d’arte e a volte intrecciato con esso, vibra in quegli anni attraverso l’Europa una forte istanza progressista a favore di teatri popolari e politici, dove si intersecano feconde dinamiche di interazione fra professionisti e dilettanti della scena: anche qui è ancora da dissodare il contributo delle donne; anche qui ci aspettano certamente interessanti scoperte. Ad esempio Niccolò Baldari mi ha segnalato le pièces in lingua italiana di donne che scrissero per le scene anarchiche e socialiste, testi di denuncia e di problematica sociale che ebbero vasta circolazione e rappresentazione nei circoli anarchici mondiali, dall’Europa fino agli ambienti italo-americani degli Stati Uniti d’America, in questi stessi primissimi anni del Novecento16.
L’editoria teatrale Connessa al fenomeno dei teatri d’arte e dei piccoli teatri è la diffusione di una nuova editoria teatrale: bollettini, riviste e pubblicazioni che diventano un formidabile mezzo di divulgazione ed elaborazione del verbo modernista di una nuova arte scenica17. La possibilità di esplorare proficuamente tale campo di produzione culturale secondo un’ottica gender è stata segnalata, tra gli altri, dalla studiosa americana Charlotte Canning, nella sua indagine dedicata alla rivista “Theatre Arts”, voce americana del Nuovo Teatro negli anni Venti18. Nonostante la debolezza strutturale dell’arcipelago italiano dei teatri d’arte, dal punto di vista delle sue creazioni editoriali l’Italia si trova in prima fila, perché qui dal 1908 al 1928 viene concepita, stampata, e divulgata internazionalmente la rivista che più di ogni altra è portaban97
diera del ‘teatro del futuro’: si tratta di “The Mask”, prestigiosa e duratura impresa concepita da Gordon Craig, fratello di Edith; è una rivista-manifesto, la scena concreta e metaforica di un discorso teatrale fra i più influenti del secolo19. Solo di recente, i contributi critici di Ilaria Sborgi20 stanno portando intelligentemente alla luce che a fianco, e non dietro a Gordon Craig, e per molti versi co-autrice dell’impresa, è una donna di nascita inglese, trasferitasi a vent’anni a Firenze, Dorothy Nevile Lees. Ella stessa una donna nuova, sola, indipendente, quando incontra Craig ha ventisette anni e vive del proprio lavoro, dirigendo insieme a un’amica un’agenzia editoriale fiorentina che lavora per il locale mercato anglofono; intanto scrive e pubblica le sue prime prove letterarie nella tradizione della scrittura di viaggio. Nevile Lees si innamora dell’uomo e della sua fortissima idealità artistica, del progetto modernista di un teatro del futuro cui “The Mask” vuol dar corpo e sostanza, e rinunciando a una bene avviata carriera letteraria, si dedica con abnegazione alla rivista, andando ben al di là del ruolo segretariale che all’inizio pattuisce con Gordon Craig. Non solo si occupa di tutti gli aspetti materiali della rivista (stampa, tipografia, abbonamenti, vendite), ma per molti versi e in modo via via più consistente contribuisce da co-autrice. Mentre Craig compone i profetici editoriali di “The Mask”, scrive e informa dell’attualità del teatro d’arte in Europa – Stanislavskij a Mosca, Wyspiansky in Polonia, Hevesi a Budapest –, e ospita contributi d’avanguardia – da Yeats ai futuristi –, Nevile Lees su sua indicazione si fa storica e archivista, ed esplora gli archivi fiorentini alla ricerca di studi e immagini sulla storia delle gloriose forme teatrali italiane pre-borghesi: la commedia dell’arte, vero mito del teatro modernista europeo, la storia delle marionette, le sacre rappresentazioni, la trattatistica rinascimentale sull’architettura teatrale e persino la tradizione dei Maggi Toscani… Poi seleziona e traduce in inglese per la rivista tutto questo materiale, provvedendo anche introduzioni, note e rimandi. Si fa così anima centrale di questa impresa editoriale, che ha il senso di costruire un ponte e un legame fra il progetto modernista del teatro del futuro e la secolare tradizione teatrale21. Le ricerche di Sborgi invitano insomma a ripensare 98
l’autorialità di “The Mask”, a concepirla in termini più estesi, a diffidare del concetto di ‘paternità’, a prendere in considerazione l’asimmetrica dialettica del maschile e del femminile anche per quanto riguarda le più importanti progettazioni culturali del nuovo teatro.
Regia: il contributo delle attrici-artiste22 Connesso al diffuso arcipelago dei piccoli teatri e dei teatri d’arte è tutto un nuovo universo di problemi, di punti di riferimento e di orientamento, fra i quali spicca la questione della regia, ovvero della nuova istanza professionale e culturale che, nel racconto della storiografia, è venuta a coincidere con la rivoluzione del Novecento teatrale. Con dinamiche e tempi specifici alle diverse aree linguistico-culturali, la regia teatrale si afferma come fatto d’arte, come animazione e progettazione culturale e come istanza autoriale nel lavoro creativo della messinscena; così al teatro di tradizione attorica, che ha al suo apice il lavoro interpretativo sul personaggio e il sistema dei ruoli, subentra culturalmente un teatro centrato sulla scrittura scenica e il lavoro d’ensemble, governato dall’occhio esterno del regista. Riferendoci alla prima fase della regia novecentesca, vale la pena di interrogare la consuetudine storiografica, avvezza a declinare un universo tutto maschile di Padri Fondatori23. L’affermarsi della regia in Italia è vicenda storiograficamente complessa: se per lungo tempo è prevalsa la vulgata che ha letto il tardivo affermarsi della regia teatrale come necessaria modernizzazione del logorato teatro della tradizione attorica, altre ipotesi storiografiche hanno invece rimescolato le carte sottolineando sia il legame di continuità fra tradizione attorica e regia, sia il parallelo fiorire di un teatro degli attori-artisti, nutrito da un bisogno di purificazione, e dal rifiuto dei limiti e dei meccanismi della routine teatrale, simile a quello che animava l’istanza registica; è stato argomentato che la via degli attori-artisti costituisce, in Italia, un’altra strada maestra al teatro del Novecento24. Di più: se si segue quest’ultima narrazione declinandola al femminile, e prestando attenzione alle traiettorie esemplari di
7 / Il teatro italiano e le sue ‘donne nuove’ / Roberta Gandolfi
alcune attrici-artiste, credo si debba ricordare che, nei primi tre decenni del Novecento, le loro pratiche diedero un contributo decisivo all’iniziale diffondersi di una cultura registica (mentre in Italia il consolidarsi del mestiere registico è successivo e data solo al secondo dopoguerra). Eleonora Duse è sempre citata a proposito della liaison fra grande attore e regista: oltre alla nota tensione etica, all’insofferenza per la routine teatrale e alle sue collaborazioni con grandi registi europei – Gordon Craig e Lugné-Poe –, va senz’altro ricordato l’importante capitolo delle messinscene dannunziane, nei primissimi anni del Novecento, che ella volle, progettò e realizzò come allestimenti d’arte, aprendo il dibattito sul teatro d’arte e la regia in Italia25. Ma Duse non fu un unicum in questo senso: alla linea delle attrici-artiste che si fecero portatrici di cultura registica vanno aggiunti altri nomi, e in primis quello di Tatiana Pavlova, che da attrice e capocomica, e attraversando non episodicamente il cinema, approdò decisamente alla regia. Alla sua traiettoria artistica dedico l’ultima parte di questo intervento, ricontestualizzando criticamente dati e informazioni tratti principalmente dall’unica biografia a lei dedicata, uscita dopo decenni di disinteresse storiografico26. Nel 1917 Pavlova arriva in Italia dalla Russia, introducendo sulle nostre scene la cultura scenica già pienamente registica del suo paese. Mentre si guadagna da vivere lavorando come attrice nell’industria del cinema muto, studia lingua e dizione, preparando con attenzione il suo debutto sulle nostre scene; non vuole solo affermare la propria arte di interprete a fianco delle attrici italiane che ammirava, ma intende agire da capocomica-regista per esprimere con i suoi spettacoli una cultura scenica moderna, affine a quella prodotta dalla Grande Riforma del teatro russo di inizio Novecento. Pavlova debutta nel 1923 con una sua qualificata compagnia (Renato Cialente, Ernesto Sabbatini, Annibale Betrone, Evi Maltagliati e, il primo anno, anche il giovane Vittorio De Sica), che si attiene al principio della recitazione di complesso anziché a quello dell’esibizione mattatoriale; per tutti gli anni Venti propone un repertorio fortemente europeo, privilegiando la drammaturgia russa (Cechov, Gor’kij, Gogol, Tolstoj) ma affian-
Tatiana Pavlova in una caricatura di Umberto Onorato (1933, coll. Burcardo)
candovi il dramma d’idee europeo, da Strindberg a Shaw, e la drammaturgia italiana contemporanea di vena avanguardista, come i grotteschi Rosso di San Secondo e Bontempelli. I suoi ricchi spettacoli diventano un caso, sono notati e molto discussi dalla critica per la cifra stilistica essenzialmente visiva: al teatro di parola e d’attore predominante sulle nostre scene sostituiscono un teatro di forte impatto visivo, al lavoro di interpretazione del personaggio affiancano incisive operazioni di scrittura scenica con l’apporto di sperimentali drammaturgie delle luci. Questa declinazione tutta modernista e deci99
samente europea di un teatro ‘teatrale’, che investe sui linguaggi coloristici e compositivi della scena (gusto che Pavlova teorizza esplicitamente, da artista intellettuale, in varie interviste e interventi sui giornali) si nutre dei contributi di scenografi e scenografe di fama internazionale che Pavlova chiama a collaborare, fra i quali Mario Pompei e Aleksandra Ekster; il segno decisamente registico e interpretativo degli allestimenti, curato da Pavlova in prima persona nella maggior parte dei casi, si avvale anche di prestigiose collaborazioni, come le due regie firmate per la sua compagnia nei primi anni Trenta da Nemirovic-Dancenko, co-fondatore del Teatro d’Arte di Mosca insieme a Stanislavskij. Il contributo di Pavlova alla cultura scenica in Italia negli anni Venti, in direzione dell’avvento della regia, va accostato a mio parere, per la matrice visiva e sperimentale, a quello compiuto su scala più ridotta e avanguardista presso il Teatrino degli Indipendenti di Bragaglia, scena nota per le ricerche visive, che è forse l’esperienza italiana di più lunga durata dentro la variegata realtà dei teatri d’arte; d’altro lato va letto in continuità con il ruolo trainante che proprio le grandi attrici, con la loro cultura cosmopolita, svolgono rispetto all’internazionalizzazione e alla modernizzazione della cultura scenica in Italia. Nel periodo successivo al decennio da noi considerato, la traiettoria artistica di Pavlova si sviluppa in direzione pienamente registica: nel 1936 diventa regista-pedagoga, quale prima insegnante di regia presso la neo-costituita Accademia d’arte drammatica fondata da Silvio d’Amico, poi dagli anni Trenta ai Cinquanta si qualifica come regista tout-court (abbandonando il lavoro d’attrice), firmando molte importanti regie liriche. Mi sembra interessante chiarire in questo contesto la sua implicazione nell’industria cinematografica. Già in Russia, negli anni Dieci, Pavlova è interprete cinematografica oltre che teatrale, come protagonista di almeno dodici film prodotti fra il 1914 al 1917; quando arriva in Italia, proprio il cinema muto, per tre anni, diventa il suo principale campo professionale, che le permette di lavorare senza l’ostacolo della lingua. Nel 1920 recita in due film dell’Ambrosio, la stessa Casa che aveva prodotto Cenere. Al cinema torna poi nel 1934 per altre due interpreta100
zioni, in Creature della notte di Amleto Palermi e La signora di tutti di Max Ophuls. In occasione dell’uscita di Creature della notte, accetta di scrivere un articolo per la rivista “Scenario” e lo intitola Cinema=Teatro27: è un intervento da intellettuale della scena, che in modo provocatorio si allontana dal discorso canonico – cinema e teatro come arti molto diverse – per tracciare invece vari parallelismi fra i due campi, o piuttosto fra il cinema e la nuova arte scenica di tradizione russa, e per sottolineare che le due arti appartengono alla stessa famiglia. Dal punto di vista recitativo, il richiamo ai metodi pedagogici della grande scuola russa (stanislavskijana), buoni a suo parere per il teatro come per il cinema, costituisce un’intuizione importante, prefigurando la straordinaria fortuna che avranno in America i metodi dell’Actor’s Studio, mutuati da Stanislavskij, per gli attori cinematografici28. Lo studio di Danilo Ruocco su Tatiana Pavlova, filologicamente importante nella ricostruzione del suo operato artistico, è però carente per quanto riguarda il taglio di genere. A quanto mi risulta, Pavlova non è femminista, né attiva nel movimento delle donne (d’altronde molto indebolito negli anni fra le due guerre, rispetto al periodo emancipazionista), eppure le reti di relazioni intrecciate con altre artiste sono importanti e significative, sia con le sue connazionali (le scenografie di Aleksandra Ekster) che con le italiane. Ad esempio la sua compagnia, nel 1924, è l’unica ad accettare la sfida di portare in scena Endimione di Sibilla Aleramo, primo dramma della scrittrice e poetessa femminista, di ispirazione estetizzante-decadente, che nonostante sia intitolato a un uomo, vede protagoniste una donna-deapittrice e il suo gruppo ideale di amiche, altrettante trasfigurazioni mitiche della figura della ‘donna nuova’. Come racconta Laura Mariani nel già citato Il tempo delle attrici29 (pp. 171-174), Endimione aveva debuttato all’estero, su una prestigiosa scena europea dei teatri d’arte – L’Oeuvre del regista Lugné-Poe – ma in Italia le altre compagnie di giro lo rifiutavano; direi che l’allestimento italiano di Pavlova segnala convergenze operative e di repertorio fra le compagnie attoriche di giro – quale era la sua – e le scene d’arte, oltre che l’esistenza di una cultura teatrale delle donne. Lo spettacolo fu in realtà
7 / Il teatro italiano e le sue ‘donne nuove’ / Roberta Gandolfi
un insuccesso, attribuito in parte al testo, in parte alla messinscena, ma significativamente lo difesero scrittori e intellettuali quali Annie Vivanti, Giacomo Debenedetti e Piero Gobetti, che parlò della necessità di accostarsi alle opere femminili senza pedanteria e diffidenza. In generale andrebbe dunque meglio inquadrato l’operare di Pavlova nell’ambito della cultura delle donne italiana e europea degli anni Venti e Trenta, e con taglio di genere andrebbe poi rivisitato tutto il dibattito intorno al suo teatro, perché le ostilità e le critiche numerose che le si mossero furono certamente imbastite con mentalità maschilista e nazionalista. In conclusione, vorrei esplicitare un dato che emerge nettamente da questa ricognizione orientata, e cioè il fatto che le ‘donne nuove’ del teatro italiano tutte declinarono, sia a livello biografico che di discorso culturale, una cultura cosmopolita e internazionale: o perché erano straniere esse stesse, come è il caso di Pavlova e Nevile Lees, o perché erano nomadi e poliglotte, come nel caso di Rosselli, che prima di scrivere Anima aveva vissuto quattro anni a Vienna, frequentando le scene di quel ricco ambiente teatrale – e un discorso simile riguarda altre sue colleghe che scrissero per il teatro, come Annie Vivanti, che visse fra l’Italia e l’America. Duse e le grandi attrici, poi, erano al tempo stesso soggetto e ricettacolo di cosmopolitismo per via delle tournée internazionali su cui si reggeva la loro strategia imprenditoriale. Furono tutte, in certo senso, geniali mediatrici culturali, capaci di transitare culturalmente e creativamente fra mondi diversi: anche questo dato mi pare accomunarle alle pioniere italiane del cinema muto.
Note
1 Cfr. a questo proposito Maria Antonietta Trasforini, Arte a parte. Donne artiste fra margine e centro, Angeli, Milano 2000.
Vivien Gardner e Susan Rutherford, The New Woman and Her Sisters. Feminism and Theatre 1850-1914, Harvester, London/New York 1992.
2
3 Giovanna Ciotti Cavalletto, Attrici e società nell’Ottocento italiano, Mursia, Milano 1978, p. 91. 4 Laura Mariani, Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia fra Ottocento e Novecento, Mongolfiera, Bologna 1991.
Tramonto del grande attore (1929) è il titolo di un noto volume di Silvio d’Amico che leggeva criticamente i percorsi dei nostri grandi interpreti di tradizione, insistendo per un rinnovamento culturale che passasse per l’istanza della regia.
5
Ringrazio Monica Dall’Asta per le segnalazioni relative alle prove cinematografiche di alcune di queste attrici. Per tutte, rimando alle rispettive voci biografiche sui classici volumi dell’Enciclopedia dello Spettacolo diretta da Silvio d’Amico (Le Maschere, Roma 1954-1962).
6
7 Teresa Megale, Declinazioni per attrici soliste: le soubrettes, in Nicola Pasqualicchio (a cura di), L’attore solista nel teatro italiano, Bulzoni, Roma 2006. 8
Ibidem.
Cfr. Roberta Gandolfi, L’arcipelago europeo (e americano) dei piccoli teatri e la cultura nuova della regia come arte, in Roberto Alonge (a cura di), La regia teatrale. Specchio delle brame della modernità, Pagina, Bari 2007, pp. 215-236 e Georges Banu, Les Cités du Théâtre d’art, de Stanislavski à Strehler, Editions Théâtrales, Paris 2000, pp. 16-23. 9
Si vedano in proposito: Roberta Gandolfi, La prima regista. Edith Craig, fra rivoluzione della scena e cultura delle donne, Bulzoni, Roma 2003; Linda Ben-Zvi, Susan Glaspell, Her life and Times, Oxford University Press, Oxford 2005; Michel Corvin, Le Théâtre de recherche entre les deux guerres. Le laboratoire Art et Action, La Cité – L’Age d’homme, Paris 1975.
10
11 Andrea Camilleri, I teatri stabili in Italia, 1898-1918, Cappelli, Bologna 1959, pp. 18-22.
Amelia Rosselli, in Marina Calloni (a cura di), Memorie, Il Mulino, Bologna 2001. 12
13 Katherine E. Kelly, Modern Drama by Women, 1880s1930s, an International Antology, Routledge, London 1997. 14 Ibidem, p. 3 (trad. mia). Si pensi al personaggio di Nora in Casa di bambola di Ibsen come riferimento emblematico. 15 Laura Mariani, L’attrice del cuore. Storia di Giacinta Pezzana attraverso le lettere, Le Lettere, Firenze 2005. 16 Alcuni nomi e titoli, per i quali ringrazio Niccolò Baldari: Nena Becchetti, I minatori e La figlia dell’anarchico; Inkio
101
(pseudonimo di Nella Giacomelli), Meteore rosse; Bice Larossa, Vittime; Vera Starkoff, Via d’uscita. Cfr. Niccolò Baldari, Pietro Gori e la drammaturgia anarchica in Italia, tesi di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università degli Studi di Bologna, a.a. 2003/2004, testo inedito. 17 Cfr. André Veinstein, Du Théâtre Libre au Théâtre Louis Jouvet. Les théâtres d’art à travers leurs périodiques, Librairie Théâtrale, Paris 1955, e Marco Consolini, Le riviste del Novecento fra processi di creazione e processi di ricezione, “Culture Teatrali”, n. 7/8, 2002-2003, pp. 275-281. 18 Charlotte Canning, Directing History: Women, Performance and Scholarship, “Theatre Research International”, n. 1, 2005. Dal 1922 caporedattore di “Theatre Arts” fu una donna, Edith Juliet Rich, affiancata da un’altra intellettuale, Rosamond Gilder: con marcata consapevolezza di genere, le due giornaliste interpretano il compito di informazione e divulgazione circa la nuova arte scenica e le pratiche registiche, volgendo particolare attenzione alle esperienze di carattere sociale-educativo, quelle che più marcatamente sono segnate dalla cultura delle donne e dal protagonismo femminile. Rosamond Gilder nel 1931 sarà poi, non a caso, la prima storica del protagonismo femminile a teatro, con il suo volume Enter the Actress!
22 Un grazie a Laura Mariani che ha ispirato una parziale revisione della narrazione proposta in questo paragrafo. 23 Per un approfondimento di questo approccio critico rimando ad altri miei scritti: Gli studi sulla regia teatrale, “Annali di Lettere”, Università degli Studi di Ferrara, n. 1, 2006 (online: http://eprints.unife.it/annali/lettere), e l’intermezzo La regia estesa. Una pratica refrattaria al pantheon della mise en scène, in La prima regista, cit., pp. 179-204.
La vulgata canonica riceve la sua formulazione culturale nel volume di Silvio d’Amico, Tramonto del grande attore, La Casa Usher, Firenze 1985 ( 1a ed. 1929); per le contronarrazioni, cfr. invece Mirella Schino, Controattore e attore-norma. Una proposta di continuità, “Teatro e Storia”, n. 17, 1995, e Claudio Meldolesi, Questo strano teatro creato dagli attori artisti nel tempo della regia, che ha rigenerato l’avanguardia storica insieme al popolare, “Teatro e Storia”, n. 18, 1996. 24
25 Si vedano Andrea Camilleri, I teatri stabili in Italia, 18981918, cit., cap. 3: Gli spettacoli dannunziani e la Duse, pp. 29-39, e Valentina Valentini, Il poema visibile. Le prime messe in scena delle tragedie di Gabriele D’Annunzio, Bulzoni, Roma 1993.
Danilo Ruocco, Tatiana Pavlova diva intelligente, Bulzoni, Roma 2000. 26
19
27 Tatiana Pavlova, Cinema=Teatro, “Scenario”, n. 11, 1933, pp. 561-563.
Ilaria B. Sborgi, Behind the Mask: Dorothy Nevile Lees’ Florentine Contribution to Edward Gordon Craig’s “New Theatre”, in Bruno P. F. Wanrooij (a cura di), Otherness. AngloAmerican Women in 19th and 20th C. Florence, Cadmo, Fiesole 2001; e Alessandra Contini, Anna Scattigno (a cura di), Dorothy Nevile Lees, in Carte di donne. Per un censimento regionale della scrittura delle donne dal xvi al xx secolo, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2005; su Dorothy Nevile Lees cfr. anche Beth Carrol-Horrocks, A Working Relationship: The Dorothy Nevile Lees Papers Relating to Edward Gordon Craig and The Mask, at the Harvard Theatre Collection, “Theatre Survey”, n. 1, 2005, p. 103-113.
28 Tatiana Pavlova sostiene un’argomentazione contraria a quella che sarà poi formulata da Benjamin nel suo noto saggio L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica. Mentre Benjamin sosterrà che l’organicità dell’interpretazione del personaggio al cinema è frantumata dalla modalità delle riprese, che sono girate per frammenti, senza seguire la diegesi narrativa, Pavlova dice che l’arte dell’immedesimazione, secondo la scuola di Stanislavskij è frutto di lungo studio, ma serve a far sì che l’attore possa poi rispondere immediatamente a qualsiasi stimolo, senza il bisogno di una storia che si snodi organicamente. Pavlova avanza anche altri parallelismi fra arte teatrale e arte cinematografica; non è vero, scrive, che l’attore cinematografico reciti ‘senza pubblico’ il suo pubblico sono il regista e i tecnici; ricorda poi che il cinema dà modo agli attori di potersi vedere e rivedere.
Olga Taxidou, The Mask. A Periodical Performance by Edward Gordon Craig, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 1998. 20
21 Purtroppo è lavoro arduo stabilire l’esatto contributo autoriale di Nevile Lees a “The Mask”: primo, perché lei e Craig ricorsero continuamente agli pseudonimi per motivi sia estetici (l’autore mascherato, è stato sostenuto, è parte del gioco del teatro modernista con le identità) sia di politica editoriale (la rivista di fatto fu tutta scritta e composta dai due, tranne pochi interventi esterni, e il ricorso ad altri nomi fittizi serviva a simulare il senso di una impresa collettiva). Secondo, molto spesso gli interventi e gli articoli furono ‘a quattro mani’: scritti da Craig e rivisti da Lees, o viceversa. Insomma: mentre Craig per firmare articoli e contributi ricorreva, accanto agli pseudonimi, anche al suo vero nome, la stessa cosa non valse per Dorothy: così il gioco degli pseudonimi contribuì alla sua cancellazione dall’impresa…
102
29
Laura Mariani, op. cit., pp. 171-174.
8 / Valeria Palumbo
Vipera: vita e mito di Anna Fougez
Il mondo parla e io passo “Chi me piglia pe’ francese, chi me piglia pe’ spagnola, ma so’ nata a Ponte ’e Mola”: Anna Fougez, nata l’8 luglio 1894, si chiamava Maria Annina Laganà Pappacena ed era di Taranto. Ma per avere successo nel mondo della rivista italiana del primo Novecento, nel quale entrò prestissimo, dovette necessariamente assumere un nome d’arte straniero. Gliene imposero uno su imitazione della celebre chanteuse di Avignone Eugénie Fougère, che all’epoca aveva successo in Italia. E lei ben presto prese a entrare in scena al tempo di una marcetta: “Anna Fougez, signori, vi si presenta già per danzar... per cantar...”, una vera sigla. Attrici, prostitute e sciantose, in fondo poi non è che all’epoca si facesse tanta differenza, il nome d’arte andava bene per tutte: “’Nfaccia a ’o cartiello so’ Mademoiselle Lilì, ma sempe Nannina so’”, come cantavano in ’A sciantosa. Della sua infanzia ha raccontato lei stessa in una autobiografia, Il mondo parla e io passo, che iniziò a scrivere nel 1930 e pubblicò con la Casa editrice Pinciana di Roma nel 1931. Si tratta di un racconto piuttosto reticente. Sono riuscita a trovarne una copia, che una certa Maria Laura ha firmato nel
1932, praticante intonsa (ma le pagine erano state tagliate, e quindi è stata letta) presso la Biblioteca di Area delle Arti dell’Università Roma Tre. Appartiene al Fondo Castello. So che ne esiste un’altra copia all’Università del Salento e un paio sono riuscita a rintracciarle sul mercato antiquario. Non credo che ne girino molti altri esemplari e, a dire il vero, ci sono ottime ragioni (per esempio la sfilza di insulsi aforismi alla fine) per evitarne la lettura. Il che spiega, forse, anche perché gli annunciati volumi successivi, sia autobiografici, sia di narrativa, poesia e massime morali, non abbiano mai visto la luce. Tanto per essere più chiara, ecco alcuni illuminanti esempi di ‘filosofia alla Fougez’, di curiosa misoginia: Una donna che torna a maritarsi giace con un vivo e con un morto. A vent’anni la donna è un madrigale; a quaranta un romanzo; a sessanta un memoriale. Fra la donna e l’impiccato non passa alcuna differenza; tutti e due mostrano la lingua, quando sono forzati al silenzio.
Conservatorismo, retorica, conformismo: la Fougez riuscì a riempire pagine perfettamente in linea con 103
da raccontare... perché ha molto viaggiato, molto sognato, molto combattuto e molto osservato”. In particolare è attentissima al look: Io ho sempre curato una moda originale, particolare, personale più che ho potuto... sempre tentai di accoppiare alle qualità canore, alla grazia, alla mimica, alla padronanza della scena, una originalità di abbigliamento che mi distinguesse fra tutte. E vi riuscii quasi subito, malgrado i mezzi modestissimi di cui disponevo nei primi anni... Quando finalmente potei emanciparmi da ogni strettezza, e consacrare tutte le mie risorse finanziarie a crearmi una moda tutta particolare, i miei vestiti, le mie pellicce e i miei mantelli hanno sempre ed ovunque formato un numero a parte di attrazione vittoriosa, in un plauso vibrato, senza rammarico di contrasti e divergenze.
Copertina dell’autobiografia Il mondo parla ed io passo di Anna Fougez
la morale fascista e al tempo stesso continuò a mostrare spregiudicatezza, modernità e indipendenza. Un mix nient’affatto raro per le donne dell’epoca. In ogni caso è significativa la scelta di scrivere un’autobiografia anziché affidarsi, per esempio, come avrebbe poi fatto Coco Chanel con Louise de Vilmorin, a una penna esperta. Perché, nella costruzione attenta del suo mito, la Fougez non ha trascurato alcun dettaglio. Abiti, profumi, gioielli, gesti, la cura dell’immagine sulla scena come in privato, il rapporto con il pubblico, Anna si riserva tutto. E con questo elabora una strategia molto moderna per rafforzare la sua fama di diva. In qualche modo il suo approccio ricorda quello di Mae West. Senza ovviamente toccare le sue vette di genialità e humour. Scrive dunque la Fougez per giustificare la sua autobiografia: “Una ‘diva’, convenitene, ne ha 104
Disegnava lei stessa i suoi vestiti e riceveva tantissime lettere di ammiratrici che, sul tema, le chiedevano lumi e consigli. In un’Italia segnata da profonde differenze sociali e da un’altrettanto grande miseria, anche nel mondo dello spettacolo, la Fougez intuì che il lusso era la chiave del successo: “Ho tentato il rinnovamento del teatro di Arte Varia italiano”, scrive in Il mondo parla e io passo. “In tale rinnovamento l’eleganza della mia moda ha avuto una parte, se non predominante, certo importantissima”. La sciantosa cedeva così il passo alla diva, alla signora della scena. Scriveva “Il Piccolo” di Trieste il 14 maggio 1929: “Quando ella compare sul palcoscenico è sempre per presentare acconciature fantasiose, toilettes fastosissime, costumi bizzarri, vestiti lussuosi e pellicce ricchissime”. Le donne restavano incantate. In questo gioco (la diva appunto seduce anche le donne) la Fougez assegnava un’incredibile importanza al profumo: diede il suo nome a una fragranza, conscia che, fino a quel momento, le scie odorose e personalizzate erano appannaggio esclusivo delle dame di alta classe (in Francia lo erano da tempo anche delle demi-mondaines che dettavano la moda, come Cora Pearl e Liane de Pougy). In più, con una brillante e maliziosa intuizione, si applicò persino al disegno della biancheria intima e di conturbanti reggiseni. Sempre pericolosamente in bilico tra provocazione e fascino fatale (il modello della femme fatale in Italia andava ancora messo a punto)
8 / Vipera / Valeria Palumbo
esibiva lunghi bocchini. Fumare in pubblico era già di per sé provocatorio per una donna. Farlo col bocchino era un esplicito richiamo erotico. Ma farlo con lo stile della Fougez metteva al riparo (non sempre, in realtà) dalle battutacce del pubblico maschile. Con grande intelligenza Anna sarebbe riuscita, nei suoi spettacoli, a coinvolgere gli spettatori nell’azione scenica (per simulare battaglie con la neve, per esempio, come nel quadro dell’inverno di Trionfo italico), sottraendoli al solito e frusto gioco dei commentacci sull’avvenenza delle ballerine. E attraendo un numero crescente di spettatrici donne.
Il teatro Il debutto ufficiale della Fougez nel mondo dello spettacolo era stato a otto anni a Ventimiglia, con un successo immediato, grazie alla canzone ’A tazza ’e cafè. Rimasta orfana, due anni prima, di Angelo Pappacena e Teresa Catalano, era stata adottata da Giuseppe Laganà e Giovannina Catalano, sua zia. I nuovi ‘genitori’, sostiene lei, assecondarono le sua innata predisposizione per il canto e lo spettacolo. Più probabilmente, per ragioni economiche, intravvidero la possibilità di guadagnare grazie alla nipotina prodigio e lasciarono così cadere tutte le remore morali che, a Taranto, avrebbero trattenuto anche una famiglia di mezzi modesti dal far salire una bambina così piccola sul palcoscenico. Lei lo racconta così: Con una intelligenza ed un senso pratico di cui non li loderò mai abbastanza, i miei zii, dunque, decisero di secondare la mia vocazione, e ad otto anni mi ‘lanciarono’ coraggiosamente su di un palcoscenico di Varietà.
Anna lascia intravedere solo a tratti le improvvise paure che la colsero nell’affrontare una vita del tutto nuova, in un’età destinata ai giochi con le bambole. Scrivendo dei suoi primi anni di lavoro ammette: Cominciavo a capire che ero uno strumento passivo in mani altrui, ed a misura che la mia personalità si formava, non sentivo una grande soddisfazione di
essere al mondo. Anch’io alle volte, provavo l’indicibile spleen del crepuscolo... se fossi stata ricca, o almeno avessi potuto bastare a me stessa, avrei abbandonato il teatro....
E stiamo parlando di un’adolescente. La verità è che comprese subito che sul palco non la si voleva bambina, ma donna. Dopo i quattordici anni, ed io non potevo più nascondere il mio appariscente sviluppo, col suo barbaglio sinistro cominciava il gioco diabolico della lotta dei sensi. I giovanotti già prendevano di mira la ‘sciantosa’ Fougez.
Anna ne era turbata, ma decise di cavalcare l’onda. Appare evidente che la decisione sia del tutto sua e del tutto consapevole. A sedici anni si cucì sulle calze decine di strass, comprò per due lire due ventri di lepri, se li drappeggiò al collo come se fossero state volpi e cantò Bambola al Teatro Mastroieni di Messina. L’obiettivo era superare la fama di Elvira Donnarumma. Ci riuscì presto: la corpulenta cantante napoletana non aveva armi contro il potenziale seduttivo della snella e furbissima ragazzina pugliese. I tempi erano cambiati. La ragazzina andò in fretta. Riuscì subito a sbarcare al Gambrinus di Milano, poi alla sala Umberto I di Napoli, quindi al Trianon di Roma. I soldati impegnati sui fronti della Prima guerra mondiale impazzivano per lei: disinvolta ed elegante non aveva nulla, fin dall’inizio, delle sciantose che l’avevano preceduta e assomigliava moltissimo alle eteree dive del cinema muto come Francesca Bertini. Infine, nel 1921, approdò all’Alhambra di Parigi, da dove tornò con un carico di idee ma soprattuttto di piume, paillettes e boys che avrebbero costituito da quel momento l’armamentario fondamentale per ogni diva della rivista. Nel 1922, cantava all’Apollo di Roma: i nuovi gerarchi erano già tutti lì ad ascoltarla. Tra il 1919 e il 1925, divenne una diva strapagata: 500 lire a sera (ancora dieci anni dopo, nel 1939, in Italia si sarebbe cantato Se potessi avere mille lire al mese), il che dimostra prima di tutto il suo forte potere di contrattazione, cosa niente affatto scontata per una donna dell’epoca. Arrivò anche 105
Anna Fougez (Archivio “In penombra”)
a prendere 2.000 lire a sera. I conti si fecero più difficili da quando divenne manager della sua stessa compagnia, ma i gioielli sfarzosi che esibiva in scena (li usava proprio come segno del successo) dimostravano che era ricca. Nel 1928 fondò la sua compagnia di rivista. Ne faceva parte anche il marito, il ballerino francese di tango René Thano. Non soltanto, però, Anna ne era la star indiscussa, ma ne curava l’amministrazione, fin nei minimi dettagli, organizzava le tournée, ideava gli spettacoli, disegnava i vestiti, scriveva le parole delle canzoni, a volte le musiche stesse, creava coreografie e sketch. Sui cartelloni, poiché ancora non era stata importata la parola soubrette, si faceva definire “stella eccen106
trica”. Termine delizioso. Così per esempio apparve nello spettacolo in cui era in coppia con uno dei comici più celebri dell’epoca, il napoletano Pasquale Villani (interprete di canzoni come Ciccio Formaggio e Dove sta Zazà). Nel 1928 era già la diva più acclamata di grandi teatri come l’Eliseo di Roma, dove portò al successo Trionfo italico, forse il suo best-seller, e Si vede tutto. Ancora quattro anni dopo, nello stesso teatro, faceva il tutto esaurito con un’altra rivista. E lo stesso accadeva alla Sala Umberto di via della Mercede, insieme con Ettore Petrolini, del quale fra l’altro si conserva una delicata lettera d’amore alla Fougez scritta nel 1913. Trionfo italico è, con il suo quadro Trionfo del grano, il simbolo stesso dell’abilità, della versatilità e della furbizia della Fougez: strizzava l’occhio alla retorica nazionalista fascista, conquistandosi così anche un pubblico più alto (andarono ad applaudirla anche le principesse di casa Savoia). Ma giocava come non mai sullo sfarzo delle scene e dei costumi, sugli effetti da cabaret d’Oltralpe, sulla bravura dei singoli interpreti. Le recensioni dei giornali di tutta Italia, galvanizzati appunto anche dalla ‘ortodossia’ fascista della Fougez, furono entusiastiche. Il “Brillante” di Roma parlò di “uno spirito di sana propaganda profondamente italiana”. Subito dopo seguì l’altrettanto spettacolare successo di Donne, ventagli e fiori. Nella stagione 1935-36, la Fougez presentò Sogno di una notte di primavera di Ricciuti e Spadetta al Quattro Fontane di Roma. Lo spettacolo segnò il debutto di un comico napoletano di talento, Nino Taranto, che già l’anno successivo avrebbe fondato una sua compagnia. In questo Anna Fougez si rivelò sempre abile e forse generosa: nella sua compagnia sono passati alcuni dei migliori talenti comici del nostro teatro e cinema, come Alberto Sordi. Aldo Fabrizi fu spesso suo partner e insieme fondarono una compagnia nel 1936. La stagione 1936-37 fu caratterizzata in particolare dallo spettacolo Svegliati Giacomino, con il comico abbruzzese Virgilio Riento, a cui la Fougez e Thano fingevano, in scena, di dare inutili lezioni di danza. L’anno successivo la compagnia presentò Bentornata Primavera, con Rosalia e Dante Maggio, e so-
8 / Vipera / Valeria Palumbo
prattutto un bravo Carlo Dapporto, che con i due si lanciava a ballare il Bolero di Ravel. Sempre attenta alle novità francesi, la Fougez aveva inaugurato con Trionfo italico la discesa da una scalinata lunga e scenografica, che anticipava le celebri entrate in scena di Wanda Osiris. Fu lei a portare in Italia anche le fontane d’argento e luminose, altro ‘arredo’ tipico del varietà. Di Mistinguett, la sua più grande ispiratrice, scriveva: “È la più grande e completa artista che io abbia conosciuta in questo genere”.
Le canzoni Debuttò con le canzoni napoletane. Ma divenne celebre con un testo, Vipera, che segna un passaggio fondamentale anche per la storia del costume e quindi tout court per la storia delle donne nel nostro Paese. Erano stati i futuristi e in particolare Filippo Tommaso Marinetti (che pure adorava il varietà), nel punto n. 9 del Manifesto del futurismo del 1909, a esaltare il “disprezzo della donna”. Eppure proprio Marinetti, riferendosi a donne di tutt’altra tempra rispetto alle mogli e alle madri esemplari sognate dal fascismo, aveva esaltato il modello della nuova femme fatale, che “si beveva gli uomini come se fossero tuorli d’uova”. L’aveva fatto, per esempio, con Valentine de Saint-Point, autrice del Manifesto della donna femminista, del 1912, e del Manifesto della lussuria, del 1913. Lo stesso Marinetti, grande ammiratore della Fougez, l’aveva definita “stella futurista”. Anna, che nella sua biografia rivendica i suoi legami con il futurismo, avrebbe potuto certo sposare molti dei principi propugnati dalla ben più moderna (ed eccentrica) de Saint-Point, che esaltava lo stupro come forza che crea la vita e disprezzava tutte le manifestazioni di amori romantici (“il sinistro ciarpame romantico”), allora tanto in voga nelle canzonette e anni dopo esaltati nelle commedie del genere telefoni bianchi. Le tesi della Saint-Point, l’esaltazione del libero amore e il rifiuto totale delle rivendicazioni femministe, pur nella loro contraddittorietà, risultavano provocatorie e trasgressive almeno quanto quelle di Marinetti. C’è ancora da indagare su questa ‘misoginia d’avanguardia’, ma
è certo che, involontariamente, inveendo contro le convenzioni cattolico-patriarcali, aprì brecce mai più richiuse nel costume borghese. Con Vipera, del 1919, la Fougez diventa il simbolo stesso della nuova donna che non è evidentemente portatrice di istanze emancipazioniste (non in modo esplicito, anche se in realtà, rivendica il proprio diritto all’autonomia affettiva ed economica, anzi dà per scontato di poter gestire un’attività imprenditoriale, sia pure legata allo spettacolo). Ma rappresenta una rivoluzione nel modo di concepire i rapporti tra uomo e donna, sul valore da attribuire alla sensualità femminile, sul diritto a esibire in modo anche molto esplicito questa sensualità. La Vipera è una donna che usa gli uomini e non ne viene usata e che non si vergogna affatto di essere perfida (la ‘perfidia’, versione femminile, ben più temibile dunque, della cattiveria maschile, diviene di moda in letteratura e al cinema proprio in quel periodo). Ella portava un braccialetto strano: una vipera d’oro attorcigliata, che viscida parea sotto la mano, viscida e viva quando l’ho toccata… quand’ella abbandonavasi fremente sul mio seno, parea schizzasse tutto il suo veleno Vipera… Vipera… sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei, sembravi un simbolo, l’atroce simbolo, della sua malvagità.
Nel 1923 la Fougez impose la canzone Salotto Bleu, che presentò all’Eldorado di Napoli. Due anni dopo portava al successo Il fox-trot delle piume, scritto per lei da Ennio Neri, che, in parte come Vipera, disegnava il suo personaggio. Numerose le altre canzoni di successo: dalla pensosa Maschere (“maschere, la farsa della vita recitiamo, noi non siamo che maschere”) ad Abat-jour, fino ad Addio mia bella signora, Chi siete?, Passa la ronda, che l’hanno affrancata dal cliché della sciantosa e della cantante di melodie napoletane. Grande cantante? Molto di più. Anna Fougez fu anche autrice, di musiche e testi. Ma soprattutto fu la prima a sottolineare come in scena non si dovesse 107
soltanto cantare bene: “Più che il cantante, occorre il dicitore. Mimica facciale, comica, pronunzia, voce, plastica, bel corpo, abbigliamento, truccatura, tutto concorre ad unico risultato di una buona, perfetta interpretazione”. In più Anna si rese conto che era il contesto a contare. E così si impegnava a danzare, recitare, muoversi con sempre maggiore disinvoltura sulla scena ed ad arricchire abiti e scenari. L’ansia dello ‘spettacolo perfetto’ la portò appunto a concepire quella ‘creazione globale’ che è stata la Grande Rivista italiana. Si basava su una serie di quadri non del tutto scollegati fra di loro, ma non necessariamente tenuti insieme da una storia o dagli stessi personaggi, e che si rivelavano di grande impatto visivo. Paradossalmente, le canzoni per cui oggi la si ricorda, e che molti interpreti hanno ripreso negli scorsi decenni, non sono quelle di cui andava forse più fiera. Lei amava, per esempio, quella del grano: A te sia gloria Santa vittoria Dei nostri campi dal solco fecondo; Provvido grano Sogno italiano Or sei ricchezza che c’invidia il mondo.
Il cinema Il debutto cinematografico di Anna è nel 1916, in un film quasi scabroso per l’epoca, come lo saranno, almeno negli intenti, i successivi: Le avventure di Colette. La regia è di Roberto Savarese, il copione di Pierre Veber e Henri de Borsse. Tra gli altri interpreti Irmai Bruni, Renato Fabiani, Gina Frine, Angelo Gallina e Léon Pollos. Nel 1919, Anna Fougez recitò in tre film, tutti diretti da Gustavo Serena (che è anche sempre nel cast): La vita e la leggenda, interpretato anche da Tina e Rinaldo Rinaldi; L’ultima recita di Anna Parnell, in cui la Fougez è accanto a Pier Camillo Tovagliari; L’immagine dell’altra, in cui recitano di nuovo anche Tovagliari e Tina e Rinaldo Rinaldi. Ma ai fini della nostra ricerca, il film che ci interessa è Fiore selvaggio, del 1921, ancora diretto da Gusta108
vo Serena, perché in questo caso, oltre a recitare, Anna collaborò con Serena alla sceneggiatura. Del film esiste un’unica copia, non visionabile, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Del cast, oltre a Fougez e Serena, faceva parte Clarette Sabatelli. Dello stesso anno è Senza colpa, sempre di Gustavo Serena, con Ignazio Bracci e Isa Novegradi. Nel 1922 Anna gira Il fallo dell’istitutrice, diretto ancora una volta da Gustavo Serena e classificato come dramma. Tra gli interpreti, oltre alla Fougez e al solito Serena, Olga Benetti e Isa De Novegradi. A questo punto la carriera cinematografica della Fougez si interrompe bruscamente e probabilmente in modo non felice se, nella sua autobiografia, che seppure incompleta è dettagliatissima sui primi anni, all’esperienza cinematografica non si fa alcun cenno, nemmeno di sfuggita. Né c’è da credere che la Fougez omettesse tutti gli eventi infelici o negativi della sua carriera: nel parlare del modo in cui gli uomini la importunavano riesce a essere non solo esplicita ma anche sorprendentemente spiritosa (cosa che non era sempre, quando scriveva). Quanto alle persone che hanno vissuto con lei la stagione cinematografica, Serena, attore di teatro convertito alla regia (con tutti i limiti del caso, almeno nei primi anni) è di sicuro il più singolare. Prima di tutto per la sua longevità artistica: dirisse film per almeno tre decenni, dagli anni Dieci ai Trenta. Il debutto certo avvenne nel 1912 con almeno due film, I carbonari e Disillusione. L’ultima firma come regia è del 1932, The Toiler. In mezzo una lunga serie di film dedicati alle donne, da La signora dalle camelie e Assunta Spina, uno dei maggiori successi italiani del cinema muto, a Ivonne, la bella danzatrice e Diana, l’affascinatrice, tutti del 1915. Sino a Fedora (1916), Fernanda (1917), Nellina (1920), Diana Sorel (1921), Zaganella e il cavaliere (1932), oltre a quelli che abbiamo già citato con la Fougez. Attore fin dal 1909, in Bianca Cappello, Serena, dopo una pausa di dieci anni, dal 1939 al 1949, e un’esperienza statunitense, ricomparve in due film del 1949, Fiamma che non si spegne e Santo disonore, per poi ritagliarsi qualche particina anche in Casa Ricordi, nel 1954, I soliti ignoti e Don Camillo monsignore ma non troppo, del 1961. Nato il 5 ottobre
Anna Fougez (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
8 / Vipera / Valeria Palumbo
109
1881 a Napoli, morì il 16 aprile 1970 a Roma. Fiore selvaggio, il copione firmato con Anna Fougez, fu tra le sue rarissime esperienze come sceneggiatore: le altre due sono per Assunta Spina e Zappatore, del 1930. L’esperienza di Assunta Spina è interessante perché la protagonista, Francesca Bertini, non si limitò a recitare, ma collaborò da co-regista. Come avrebbe raccontato lo stesso Serena: “E chi poteva fermarla? [...] organizzava, comandava, spostava le comparse, il punto di vista, l’angolazione della macchina da presa; e se non era convinta di una certa scena, pretendeva di rifarla secondo le sue vedute”. La Bertini, che sarebbe stata la protagonista anche di La signora dalle camelie, aveva anche provocato, in Fedora, la sostituzione del regista Giuseppe De Liguoro con lo stesso Serena.
La vita privata Nel 1922 la Fougez si esibì all’Apollo di Roma. Nel pubblico in delirio c’erano anche i capi del neonato governo fascista e in particolare il triumviro Michele Bianchi, ministro dei Lavori pubblici. Fu amore a prima vista e grande amore per otto anni. Bianchi, uomo in apparenza tutto di un pezzo, era un fanatico di fascismo e lavoro. Eppure si innamorò ricambiato e non si trattò solo di una delle tipiche liaisons tra un gerarca e una stellina del varietà. Fu una passione clandestina, che si spense con la morte di lui per tubercolosi: Anna seguì il funerale in disparte, i giornali non osarono fare commenti. Per tutta la vita conservò sul pianoforte una foto di lui, con una dedica sentimental-dannunziana: “Alla Vipera che per me non ebbe veleno”. Vi è stato chi ha voluto far risalire il declino della Fougez addirittura al 1931, quando non riuscì a organizzare una tournée in alcune città europee. Ma è un’esagerazione. Certo la morte di Bianchi fu un brutto colpo. Ma la Fougez non si lasciava abbattere facilmente. Nel 1933 era nel cast di Piedigrotta Santa Lucia (un festival canoro che si tenne dalla fine dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento e di cui la Fougez fu una delle star). Con lei si esibivano, per esempio, Eduardo De Filippo e Tina Castigliana, la quale, con 110
Gigi Pisano, nel 1934, entrò nella compagnia della stessa Fougez e di Amedeo Girad. Il 12 agosto la compagnia debuttò coraggiosamente al Lido dorato di Portici con il capolavoro di Salvatore Di Giacomo, Assunta Spina. La tournée durò oltre tre mesi. È vero però che subito dopo la Fougez organizzò una prima serata di addio alle scene: ancora una volta con lei c’erano Tina Castigliana e Gigi Pisano, oltre a René Thano. Anna presentò una passerella ideata e curata da lei stessa, La moda italiana. Poi ci ripensò e non si ritirò. In qualche modo fu la guerra a decretare il suo tramonto definitivo, anche se gli anni Trenta avevano già visto, con il successo dei giornali femminili tipo “Novella”, l’affermarsi di un modello di diva cinematografica molto diverso da quello imposto da Anna vent’anni prima.
La fine Nel 1940 la Fougez si ritirò nella sua villa di Santa Marinella, dove morì, l’11 settembre 1966, a 72 anni. Aveva passato gli ultimi anni immersa nei suoi ricordi da diva, insieme con le sue amiche di sempre Amelia e Annamaria De Fazi. Ma la villetta sulla piazza della stazione di Santa Marinella, come racconta nella sua autobiografia, era da tanti anni il suo rifugio: vi tornava dopo le tournée, si occupava dei conti e dei fiori. E riceveva gli amici che, già negli anni Venti, la raggiungevano avventurosamente in automobile. Erano per esempio gli autori delle sue canzoni: Libero Bovio, Ernesto Tagliaferri, Gaetano Lama, Ernesto Murolo. Anche suo marito René, Thanatopoulos, come lo chiamavano, sarebbe morto a Santa Marinella. Nel film Gran varietà (Domenico Paolella, 1954) il suo personaggio venne rievocato da Lea Padovani, mentre Alberto Sordi rifaceva Fregoli.
La fama Come la stessa Fougez ricorda, non fu soltanto il pubblico popolare a osannarla. Certo, da Marinetti a D’Annunzio, le ‘donne nuove’ come la Fougez,
8 / Vipera / Valeria Palumbo
che solo apparentemente sembravano uscite da un romanzo decadente, ma nella realtà erano molto meno languide e fatali e molto più attente al loro successo e ai guadagni, ponevano diversi problemi: come inquadrarle? Come ‘normalizzarle’? Guido Da Verona definì Anna “la maga Fougez”. Questa sorta di incantamento che, sulla scorta di dive (e cortigiane) internazionali come la Belle Otero e Lola Montez, le nostre prime ‘stelle eccentriche’ riuscivano a creare, costituiva una realtà esaltante e al tempo stesso difficile da gestire anche per loro stesse: “È una gran bella cosa essere una persona conosciuta, far parlar di sé, essere guardata per la via e magari additata, udire, non appena si entra in un luogo qualsiasi, lo smozzicarsi di frasi a mezza voce...”, scrive la Fougez. E aggiunge con ironia: “Ah sì, è una gran bella cosa essere una persona conosciuta, sentirvi a disagio dovunque entriate, sentirvi chiamare familiarmente a voce alta, per far vedere all’amico o all’amica che si è vostri conoscenti”. La Fougez fa un quadretto spassoso dei rompiscatole che con i pretesti più vari (non escluso il tentativo di spillarle denaro) le piombavano in camerino. I paparazzi ancora non esistevano, ma si era già alle prove generali della grande macchina dei mass-media.
111
112
9 / Elena Mosconi
Dive e antidive. Elettra Raggio e Astrea
Le stelle minori Alla base di questo intervento vi sono un incontro e una preoccupazione. L’incontro è avvenuto – in due tempi diversi della mia ricerca presso la Fondazione Cineteca Italiana di Milano1 – con due donne affascinanti, dalle personalità così differenti ed eccentriche da suscitare in me il desiderio di ripercorrerne tutte le scarse tracce lasciate. Non solo per comporne un profilo professionale, ma pure per capire le intenzioni, le motivazioni con cui si accostarono al cinema in una certa fase della loro vita; in una parola per portarne alla luce l’immagine di sé, tanto quella privata quanto quella riflessa dallo schermo. L’incontro si è poi fatto più vivo – se così si può dire – con Elettra Raggio, a contatto con i materiali da lei consegnati, nel 1953, alla Cineteca Italiana di Milano: alcune carte vergate di suo pugno, diverse fotografie, libretti e programmi di sala, qualche manifesto illustrato, una copia del film La morte che assolve interpretato con Ermete Novelli, e alcuni rotolini di pellicola in nitrato che contengono fotogrammi sparsi delle sue scarse opere. L’esiguità dei materiali, se da un lato fa scaturire l’entusiasmo della scoperta e della testimonianza, è al tempo stesso fonte di alcune cautele metodologiElettra Raggio in Primavera, 1916 (Fondazione Cineteca Italiana)
che. Da una parte vi è la necessità di operare delle letture critiche di oggetti apparentemente secondari, come fotografie e articoli pubblicati a pagamento sui giornali, che forniscono tracce utili benché a volte fuorvianti2. Più a fondo, però, vi è l’urgenza di chiarire perché mettere a fuoco personalità certamente secondarie per la storia complessiva del cinema. Semplice curiosità, esotismo? A preservare dai rischi di una storiografia ‘vintage’ sovvengono i problemi che lo storico mette in campo, come hanno dimostrato autorevoli contributi della storiografia generale e del cinema3. L’orizzonte problematico in cui si inscrivono queste note è lo statuto divistico di Elettra Raggio e Astrea, stelle minori del firmamento delle celebrità nazionali la cui luce si è spenta prematuramente4. E ciò, si badi, a dispetto del loro nome d’arte, che direttamente rimanda agli astri. Elettra fa parte infatti della costellazione delle Pleiadi, cantata da D’Annunzio alla fine del 1903 nel II libro delle Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. Astrea è invece il nome di una costellazione – un tempo della Vergine, ora della Bilancia –, e di una vera e propria dea, figlia di Zeus e di Temi, l’ultima a lasciare la terra ormai corrotta dopo l’età del ferro e “madida di sangue”, come canta Ovidio nelle Metamorfosi; ma anche la 113
confonda con la vita, che ne rimane al di fuori. Ma per delinearne meglio le peculiarità, è opportuno ora affrontare singolarmente le due carriere.
Elettra Raggio alle soglie della modernità
Astrea (Archivio “In penombra”)
vergine di cui parla Virgilio nelle Bucoliche, origine di una progenie celeste deputata a salvare e rigenerare il mondo. Questi nomi – consapevolmente scelti dalle due donne – designano un’identità e un mandato attoriale precisi. Il primo, quello di Elettra, legato ai circuiti di amore e morte, di vendetta familiare ed espiazione del ciclo sofocleo; il secondo, Astrea, connesso con l’amore per la giustizia, la riparazione dei torti e il soccorso alle vittime. La creazione di un tale marcato profilo, battesimo della nuova vita schermica e porta d’accesso al turbine mediatico del divismo, è in questo modo un atto profondamente intriso di autorialità5; è la tessitura di un perimetro entro il quale l’attore gioca la sua esperienza cinematografica, senza che essa si 114
Ginevra Francesca Rusconi, in arte Elettra Raggio, nasce il 21 febbraio 1887 a Milano ove morirà il 21 dicembre 19736. La sua educazione risente dell’ambiente alto borghese di provenienza: impara musica, canto, recitazione e danza7; nel 1912, scritturata da Ermete Novelli, effettua una tournée teatrale che la conduce in America meridionale. La si scorge in una fotografia, scattata in uno studio di Montevideo, accanto ad altri attori che di lì a poco effettueranno il passaggio dal teatro al cinema, come Tullio Carminati. L’attrice è fortemente legata alla sorella minore Maria, che coinvolge spesso nei suoi progetti cinematografici, affidandole anche ruoli di prestigio: la dolcezza del volto, la regolarità dei tratti la spingono a farsi promotrice della sua breve carriera attoriale che però, a quanto sappiamo, si limiterà a poche esperienze, delle quali sopravvivono solo immagini e singoli fotogrammi8. Ma il suo nume tutelare è sicuramente Ermete Novelli, padre di Enrico (Yambo) e interprete di chiara fama del teatro ottocentesco italiano. In precedenza, all’inizio degli anni Dieci, Novelli aveva portato sullo schermo alcuni dei suoi successi teatrali come La morte civile, Il mercante di Venezia e Re Lear (diretti da Gerolamo Lo Savio per la Film d’Arte Italiana nel 1910); negli anni della guerra accetta di lavorare su soggetti inediti e di lasciarsi dirigere da una sua ex attrice. Nel 1917 recita infatti in Automartirio, scritto, interpretato e prodotto da Elettra Raggio (ma diretto da Ivo Illuminati); l’anno successivo in La morte che assolve (1918, regia di Carlo Alberto Lolli, su soggetto di Francesco Serravalli, prodotto dalla Raggio Film), tuttora visibile. La sopravvivenza della pellicola è dovuta quasi certamente proprio alla presenza di Novelli, ultimo documento della sua istrionica recitazione prima della morte che lo coglierà a breve9. La presenza di Novelli in questi due film testimonia la stima dell’attore per la più giovane collega – si
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
può anche maliziosamente pensare a una ‘stima’ remunerata dall’aristocratica dama – e tuttavia documenta pure una costante dell’imprenditoria cinematografica di Elettra Raggio: la tendenza a dividere la scena, e in generale il lavoro di produzione del film, con altri professionisti, formando team consolidati e affiatati. Elettra Raggio rinuncia a un cliché divistico di solitaria stella e adotta prassi operative di tipo collaborativo e moderno perché il fine dell’arte, cui continuamente tende, richiede la prestazione di
Elettra Raggio (Archivio “In penombra”)
professionisti, siano essi operatori e direttori della fotografia come Emilio Roncarolo, o pittori come il cartellonista Luciano Mauzan a cui affida, oltre alla cura di libretti di sala e affiches, la regia di due film10. Questi professionisti a loro volta sottolineano il fascino della donna, come si può notare dagli eleganti manifesti, da brochure e fotografie che giocano su particolari aspetti figurativi o sul motivo della luce, di cui Elettra Raggio si sente apostola. Nel suo nome si riverberano le suggestioni futuriste di Marinetti che canta l’avvenire di un’Italia “interamente vivificata, scossa e imbrigliata dalle nuove forze elettriche”11: il cinema è per eccellenza la macchina elettrica, in grado di ridurre la consistenza corporea e materiale dell’attore sullo schermo al puro riflesso di un raggio luminoso; ma per altri aspetti il cinema di Elettra Raggio è decisamente lontano dalle posizioni antiromantiche dei futuristi. Personalità affascinante, Elettra Raggio non è ritenuta bella, in senso classico. Almeno questo è il giudizio di Tito Alacci, critico della rivista “Film”, che scrive: “Tra le cento attrici dell’arte muta, Elettra Raggio rappresenta l’eccezione. A questa donna non si deve chiedere di farsi bella: sarebbe inutile”12. Il giornalista classifica oltre centocinquanta tra dive e divette sulla voga dei manuali fisiognomici introdotti nel passaggio tra i due secoli da Paolo Mantegazza13: dell’attrice milanese mette in luce il “bellissimo sguardo, emanante da un’anima dominatrice, ma giusta, ma generosa, ma incorruttibile […] E dietro quello sguardo quanta intelligenza, quale ricchezza di energie, quanta attività!”. Nonostante il naso affilato e lungo, la corporatura esile, il volto teso, Elettra Raggio merita di essere inserita nel pantheon delle dive in quanto “intellettualmente è la più bella”, e la sua immagine di donna energica dalla “fronte pensosa”, gli “occhi rivoluzionari”, le “labbra frementi di comandi e di rimproveri” suscita nel critico un senso di ammirazione. Questo ritratto, nella misura in cui si discosta dalle tradizionali icone divistiche, suggerisce l’idea di un approccio riflessivo al cinema, un’immagine che trova conferma nelle poche testimonianze giunteci. Per questo la rapida carriera dell’attrice/autrice può essere oggi letta come un tentativo di fecondare una giovane forma di espressione – dalle molte possibilità ancora 115
Primavera e la danza delle arti
Primavera (Fondazione Cineteca Italiana)
latenti – attraverso un contributo personale sorretto da finalità artistiche o pedagogiche, più che remunerative e autocelebrative. D’altra parte si tratta di una tendenza diffusa negli ambienti altoborghesi e mondani milanesi, per esempio quelli della Milano Film14, che perseguono un’idea nobilitatrice dell’immagine in movimento. Ciò fa di lei una figura eccentrica rispetto al panorama attoriale del tempo, capace di guardare ai modelli divistici dominanti e di metterli in discussione, ma inevitabilmente destinata allo scacco. L’esordio nel cinema di Elettra Raggio avviene nel 1915, all’interno della Milano Film. L’anno successivo escono cinque film che la vedono impegnata nel ruolo di attrice, autrice di soggetti, direttrice e quindi tra le prime donne responsabili di una Casa di produzione che porta il suo nome, una sigla che risulta un’emanazione della Milano Film ed è sostenuta dagli ambienti dell’aristocrazia e della finanza milanese. In La cattiva stella (scritto e diretto da Eugenio Perego, 1916), un dramma avventuroso e sensazionale, recita con Ugo Gracci e Lina Millefleurs, attrice di punta della casa milanese. Scrive, dirige e interpreta quindi il mediometraggio Le due seduzioni15, segnalandosi per la “bella, misurata, persuasiva interpretazione dell’affascinante ingenua e talora perversa protagonista”16, accanto a Giulio Donadio. 116
L’opera più significativa del 1916 è tuttavia Verso l’arcobaleno (1916, regia di Eugenio Perego), scritta dalla Raggio e da lei interpretata sempre accanto a Lina Millefleurs e Ugo Gracci. In questo film l’autrice sceglie una modalità antiretorica per affrontare il tema della guerra, dando prova di una sensibilità sotterraneamente pacifista, nonostante la scelta di ambientare la vicenda in un paese immaginario (forse il Belgio) allenti i riferimenti all’Italia: la guerra viene colta nelle sue tragiche conseguenze tanto sull’economia quanto sulle relazioni sociali e affettive tra le persone. In questo film comincia a manifestarsi anche l’attitudine simbolista di Elettra Raggio, che suddivide l’azione in quattro tempi e connota ciascuno con una situazione meteorologica: il sereno delle fiorenti relazioni economiche e dell’innamoramento tra due giovani di due diversi paesi; le nubi dell’incrinarsi delle relazioni politiche e tra i promessi sposi; il temporale della guerra che impone a ciascuno eroici sacrifici in nome della patria; infine l’arcobaleno della pace. Sugli stessi simboli ritornano le poche fonti superstiti: l’affiche disegnata da Achille Mauzan, e il libretto di sala che conclude, in una prosa poetica dal tono enfatico: “Andò l’eroina verso il sacrificio e la gloria, e […] placati gli odi, si riaffacciò al mondo, più gagliardo e puro, il Genio del lavoro carico di messi per gli eroi che sopravvissero e di alloro per i martiri che la Storia onora di eterna gloria”. Sempre nel 1916 prende vita l’attività produttiva dell’attrice con due film diretti da Achille Mauzan, autore anche dei manifesti illustrati: il mediometraggio leggero Galeotto fu il mare e Primavera, “cinepoema con personaggi allegorici”. Quest’ultimo film – abbastanza pubblicizzato sulle riviste, ma poco visto dagli spettatori – sancisce non solo l’incontro tra l’illustratore e l’attrice, ma anche il tentativo di trasporre sulla pellicola la leggerezza, l’inconsistenza della figura umana tipica delle arti grafico-pittoriche, penalizzata dalla materialità del corpo dell’attore17: la corrispondenza tra affiche e personaggi è infatti strettissima. La trama presenta un dramma pastorale chiuso in una cornice didascalica: poiché la contessina Mary Dalla Verbena è innamorata di uno
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
stolido ufficiale e rifiuta di essere ricondotta sulla via della ragione dai familiari, l’anziano e saggio nonno racconta la fiaba di Zefiro e Giovinezza. Il primo, “genietto del buon senso”, è amico di Giovinezza, figlia di Primavera. I due vivono una casta e profonda amicizia in un regno di beatitudine edenica finché un banale incidente (la distruzione di un nido di uccellini) non li allontana. Giovinezza sperimenta la sofferenza e il dolore, fa esperienza dell’amore. Colpita da Cupido, e con la mente offuscata dai sensi, entra “nel castello dell’amore” e assiste alle tragiche conseguenze della passione attraverso la visione dei danteschi Paolo e Francesca (“amor condusse noi ad una morte”). Della rovina di Giovinezza, conclude il nonno, si rinviene “solo il prezioso retaggio dell’esperienza, che insegna la saggezza”. L’esempio della ninfa conduce la giovane contessina a soprassedere ai propositi amorosi. L’apologo rivela tutta la naiveté di cui soffre il cinema di Elettra Raggio, con la morale familista (esplicitata dalla difesa del nido) e del ‘buon senso’ di cui si fa emblema il genietto Zefiro: in questo senso l’intento pedagogico e didattico dell’opera è fin troppo esplicito. E tuttavia – senza sottintendere rivalutazioni per un cinema che, nella sua consistenza materiale, neppure esiste18 – mi pare interessante la proposta di un linguaggio che sembra andare in altra direzione rispetto al cinema delle dive19. Il film è ricco di citazioni iconografiche, mitologiche e letterarie della cultura classica e contemporanea che vanno dal ri-
Primavera (Fondazione Cineteca Italiana)
mando esplicito alla Primavera botticelliana, all’iconografia del dio Pan per il personaggio di Zefiro, al quinto canto dell’Inferno dantesco. Ma anche nella messa in scena di un ambiente pastorale e edenico, di danze di ninfe, del mito di Cloris-Flora e Zefiro, Elettra Raggio riverbera echi del dibattito culturale del tempo, come il recupero del neoplatonismo di Porfirio (L’antro delle ninfe) e delle teorie dell’amore di Marsilio Ficino, anche in una possibile declinazione esoterica, fino agli studi di Aby Warburg20. Nell’impossibilità di stabilire influssi certi, vale la pena accennare almeno alla componente simbolista presente nell’opera dell’attrice milanese, come già sottolinea la critica coeva: “Primavera è un poema che ha tutti gli elementi del fantastico e dell’irreale: ed è insieme poema didascalico, il cui simbolo è velame a una filosofia tanto profonda quanto umana”21. Elettra Raggio crede nella capacità dell’arte di dar luogo a significati che travalicano le forme visibili, e soprattutto coglie il processo di continua smaterializzazione e rifigurazione che informa la creazione artistica. Già gli autori simbolisti di fine Ottocento, attraverso le nuove tecniche di stampa, avevano messo a fuoco il problema della scomposizione e stratificazione dei processi di rappresentazione. Da qui l’adozione di tecniche miste, per esempio tra pittura e stampa, tra fotografia e pittura, legate alle nuove esigenze della vita moderna, al cangiante prender corpo dei significati, e ai nuovi stili di visione, più rapidi e collettivi. Ancor più a fondo, la concezione simbolista trova nell’arte stessa un dispositivo di stilizzazione capace di rievocare l’idea dell’unitarietà del mondo attraverso il superamento della separatezza tra le diverse discipline artistiche22, e la sinestesia è lo strumento retorico deputato a ricostituire il senso di questa unità smarrita, come insegnano le Correspondances baudelairiane. Elettra Raggio vede nel cinema un linguaggio polisensoriale e sinestetico, in grado di dar vita non solo a un continuo interscambio tra sfere sensoriali – vista e udito, tatto e olfatto, qui sotto forma di aliti di vento o di fragranze di fiori –, ma anche all’avvicendamento tra linguaggi diversi, poesia e pittura, scultura e danza23. Gli aspetti del simbolismo che vengono filtrati dalle sue opere – in modo più o 117
118
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
meno consapevole – sono, così, numerosi: a livello tematico, come abbiamo visto, vi è la ripresa del mito antico, per quanto caricato delle inquietudini della modernità; oppure la valorizzazione di un paesaggio che, recisi i contatti con una realtà oggettiva, tende a farsi proiezione psichica, manifestazione di un mondo filtrato dal soggetto. Da questo punto di vista, la ricerca da parte di Elettra Raggio di location per i suoi film è davvero attenta: i versanti montani della Grigna di La cattiva stella24, i giardini di Primavera, con il tempietto delle ninfe – della villa di Gorla, concessa a pagamento dalla milanese Rosa Film come set di prestigio25 –, la cascata di Morte che assolve. Altre analogie tra il simbolismo e il cinema di Elettra Raggio riguardano le funzioni dell’arte, per esempio il decorativismo – un problema che diventerà ancora più esplicito con il passaggio all’Art Nouveau e al Liberty italiano –, che si traduce in una consapevole ricerca ornamentale e nell’uso della superficie stessa (anche dello schermo) come ‘decoro’ pittorico monumentale, al pari della pittura dei palazzi. Infine la presenza della componente floreale, destinata a esplodere nel gusto Liberty, e qui già presente nelle cascate di fiori che punteggiano il paradiso terrestre di Giovinezza e Zefiro: “candide e vermiglie rose olezzanti”, “fiori nuovi con nuovi profumi”, gelsomini. Rose, fiori e giardini – così come il cinema della Raggio che ne è ricco – intercettano bene l’assimilazione e l’indistinzione tra un’estetica dannunziana decadente, il delicato vitalismo dei simbolisti e l’esplosione ornamentale del Liberty26. E insieme nascondono, dietro l’agognato ritorno a uno stato di natura27 e alla fusione con l’armonia del cosmo, la freddezza di un mezzo di rappresentazione meccanico come il cinema e l’inarrestabile marcia della modernità novecentesca.
Morte e resurrezione del dramma I cinepoemi di Elettra Raggio non sembrano incontrare granché il gusto del pubblico. La loro circolazione risulta piuttosto ridotta nonostante essi siano destinati, per quel che si può dedurre dalla stampa e dalle brochure, a un pubblico internazionale. Nel 1917 Elettra Raggio recita in due film di Case
Elettra Raggio (Fondazione Cineteca Italiana)
produttrici torinesi: Il fango della Jupiter Film (diretto da Adelardo Fernandez Arias), nel quale riveste i panni di una donna che viene salvata da un malvivente, e Maciste medium della Itala Film, diretto da Vincenzo C. Dénizot, accanto a Italia Almirante Manzini e all’ormai celeberrimo Bartolomeo Pagano. Intanto continua la sua attività produttiva con due pellicole concepite per sé e per Ermete Novelli, negli anni del suo progressivo allontanamento dalle scene. Nel 1917 esce Automartirio, girato a Torino nei locali della Gloria Film e diretto da Ivo Illuminati, scritto e prodotto da Elettra Raggio e da lei interpretato insieme alla sorella. Il titolo, che presenta echi filosofici di un certo spessore (come Nietzsche e Kirkegaard), è in realtà piegato verso il dramma familiare, un tema centrale nella drammaturgia della Raggio, solitamente improntata alla rinuncia alla felicità personale in nome di un ideale superiore di tipo materno, genitoriale o filiale. In questo caso si tratta del sacrificio “di una donna che sottomette volontariamente se stessa al più duro martirio, ovvero quello di privarsi dell’affetto del figlio, per creargli un avvenire migliore ed agiato”28. Il coinvolgimento della Raggio è evidente a partire dall’uso dei nomi dei personaggi, Elettra ed Ermete. Nel film la protagonista, che ha avuto in gioventù un figlio da un medico morto prima di poterlo riconoscere, accetta di sposare un gentiluomo, il conte Ermete dell’Oro, per continuare a mantenere – benché in segreto – il figlio in collegio. La donna è però ricattata da un losco figuro di cui già aveva dovuto respingere le avances: aggredita, si difende sparandogli e uccidendolo, ma viene da questi accusata di illeciti amori di fronte al marito che, dal dolore, esce di senno. Anni dopo il conte la scopre in conversazione con un giovane: pensando che si tratti nuovamente di un amante, dà fuoco al padiglione ma subito dopo, alle grida di Elettra, accorre per salvare madre e figlio. La confessione finale ristabilisce la verità e la pace familiare. La trama non sembra particolarmente originale, ma la brochure, redatta nella solita prosa poetica dalla Raggio, si preoccupa di precisare il senso del film: “L’automartirio è il sacrificio volontario della propria esistenza morale, senza il miraggio della pace eterna, che il suicidio offre alle anime stanche”29. Il 119
Elettra Raggio (Fondazione Cineteca Italiana)
récit moral di Elettra Raggio guarda da un lato ai decadenti e languidi diva film, dall’altro alla situazione sociale del 1917, proponendo un’alternativa di segno positivo. Per questo condanna apertamente il suicidio – “può dirsi coraggio, l’automartirio? Non sempre! Spesso è malattia e degenerazione della volontà come il suicidio” –, contrapponendovi l’etica del sacrificio e la fiducia nella capacità rigenerante dell’amore. Non a caso la frase finale è tratta dal Canto dell’amore (contenuto nei Giambi ed Epodi) di Carducci: “Amate! Il mondo è bello e santo l’avvenir”. Nel 1918, con Morte che assolve, riprende la formula del film con Ermete Novelli: questa volta il soggetto è di Francesco Serravalli e la regia di Carlo Al120
berto Lolli. Elettra Raggio interpreta la doppia parte di madre e figlia: la prima, Maddalena30, già moglie di Renato Falco e madre di una bambina, è scacciata dal marito e costretta a fare la domestica. Le sue condizioni di salute si aggravano, ma il marito si rifiuta di aiutarla e la donna muore tra le braccia della piccola figlia Erica dopo aver assistito a un omicidio perpetrato da Falco nei confronti del vicino, in seguito a un banale litigio. Il Conte Giancarlo Della Croce, passato per caso dal luogo della sciagura, soccorre la bambina e l’affida a una ricca signora americana che la porta a vivere lontano. Falco viene assolto dall’accusa di omicidio per mancanza di prove: tuttavia, sentendo su di sé l’odio dei vicini,
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
e sofferente di allucinazioni, abbandona il paese e accetta l’invito del Conte Della Croce per lavorare presso di lui come guardaboschi. Erica (Elettra Raggio), divenuta grande, torna in Italia e diviene oggetto di attenzione da parte dello stesso Conte, che si spinge a pesanti avances e in seguito al diniego di lei, fidanzata al giovane Marco Dickson, le rivela le sue vere, umili origini. Alla fine il Conte, respinto, rapisce Erica: Falco accorre a difenderla e viene ferito a morte, mentre la ragazza lo assolve da tutte le sue colpe passate. Ancora una volta il dramma contiene un insegnamento, dal momento che termina con il ristabilirsi di un nucleo familiare e la vittoria di sentimenti positivi, benché a prezzo di vite umane. La trama asseconda la centralità dei protagonisti Ermete Novelli ed Elettra Raggio, costretti ad alcune costanti di ruolo dalla differenza anagrafica. I due attori evidenziano anche stili di recitazione differenti ma ugualmente interessanti, come sottolinea la critica, perché non convenzionali e abbastanza maturi. A Elettra Raggio, unanimemente riconosciuta come donna intelligente, viene riconosciuta una certa capacità di “immaginare le figure che poi farà vivere sulla scena”; da qui la facilità di variare registro interpretativo, passando dal genere tragico al sentimentale, dal drammatico al gaio. […] Nel poco tempo da che Elettra Raggio ha portato nel cinematografo un soffio di arte naturale, abbiamo avuto il piacere di ammirare parecchi lavori suoi. La ricordiamo in Verso l’arcobaleno, piena di tragicità e di bello ardore patriottico; in Le due seduzioni, dolce di ingenuità e di fede; in Primavera, stilizzata nella georgica raffigurazione classica; in Galeotto fu il mare, adorabile nella sua aria sbarazzina di giovane innamorata31.
L’artista sembra mettere progressivamente a fuoco una tavolozza di espressioni che sfociano, con Automartirio, nella creazione di un personaggio che vive di una sua vita interiore, sì da sembrare – tanta è l’efficacia espressiva dell’interprete – ad un’anima spoglia di corpo. Quel tormento incessante, quell’automartirio traspare in ogni atto e in ogni gesto dell’attrice. E in certi momenti di questa sofferenza, il suo fisico sembra proprio esulare, per lasciare libera l’anima di espandere il suo dolore32.
Della sua versatilità dà testimonianza anche Landi: Elettra Raggio ha la spigliatezza dell’americana, l’eleganza dell’inglese, lo charme della francese, la passionalità dell’italiana, il fuoco della spagnuola, la freddezza della scandinava, l’impenetrabilità della slava. […] È tigre ed angelo; è furba e ingenua; è ilare e mesta33.
Nonostante ciò permane nel suo gestire un che di immediato, non studiato, una “semplicità […] di gioco mimico”, il desiderio “di abbandonare tutte le ricerche artificiose, le leziosità, le stucchevoli preziosità della plastica e della posa”34; Manelli parla di una recitazione quasi ‘primitiva’ nel senso di profonda, di sana, di contrapposta alla nervosità isterica del nostro tempo, al contorsionismo spasmodico dei nostri nervi irritati da profumi acuti e strani, messi in vibrazione dalla vertigine della nostra vita35.
Questi tratti si possono notare anche dall’analisi dell’unico film superstite, per quanto mutilo di circa un terzo rispetto alla sua lunghezza originaria. Due opposti stili di recitazione connotano i personaggi cui dà vita: quello della dimessa e malata Maddalena, ripresa in sofferenti primi piani o nel lento incedere; oppure il passo leggero e veloce della giovane Erica, elegante nelle sue toilette, sportiva a cavallo, ma mai voluttuosamente diva, piuttosto scattante e quasi nervosa, come sottolineato anche da alcuni critici che parlano di “elettrico ed espressivo gestire”36, quando non di “una certa malaugurata rapidità, che le nuoce un poco”37. Questa accelerazione ‘giovanile’ marca la distanza rispetto al più anziano Ermete Novelli, già icona del teatro nazionale ora prestata al cinema38. Come accade negli stessi anni a Eleonora Duse o Ermete Zacconi, nei film si registra l’inarrestabile “tramonto del grande attore”39, dovuto all’esaurirsi di una stagione generazionale, ma anche teatrale e culturale, caratterizzata dall’estro dei mattatori40. I recensori delle pellicole si rivolgono con deferenza ai grandi della scena italiana, auspicando il loro coinvolgimento nel cinema e sottolineando il valore aggiunto che essi possono portare a un linguaggio in cerca di un proprio statuto artistico: “Chi più di 121
un attore drammatico conosce i segreti dell’arte rappresentativa? Chi più di lui ha la duttilità necessaria per piegarsi alle esigenze dell’arte nuovissima?”41. A loro volta, i grandi della scena si accostano alla fotografia animata con parsimonia e con una certa umiltà, dando prova di voler riconfigurare attentamente la loro esperienza attoriale in funzione del nuovo medium42. La critica nota il lavoro di sottrazione di Novelli, che in Automartirio per dare “efficace rilievo alla sua parte” fa ricorso a una “sobrietà di gesto, ma con non minore potenza”43; un giudizio che può essere confermato oggi dalla visione di La morte che assolve. Anche quando la macchina da presa concede largo spazio ai soliloqui dell’attore, alle sue camminate, alla relazione con altri personaggi, l’espressione di Novelli appare trattenuta, istrionica ma non eccessiva, il gesto non amplificato o caricaturale e riconducibile nei limiti di un incisivo naturalismo. Nel compianto per la morte dell’attore, Giulia Cassini Rizzotto esprime in questi termini il lavoro di Novelli nel cinema: negli ultimi anni suoi, Egli portò anche nel campo cinematografico la luce dell’arte sua. E fu anche qui, grande; non brusco, volutamente, sforzandosi in tragiche espressioni, non disordinate e pagliaccesche smorfie bernesche, ma forti, incisive, e, soprattutto vere maschere dolorose, e piane, dolci, serene espressioni di letizia. E anche qui Egli diede la sua nota di bontà e di amore e il suo entusiasmo sempre giovanile, in certi momenti fanciullesco addirittura, tanta era la vivacità che brillava negli occhi suoi quando parlava di quest’arte muta che molti dei suoi stessi attori misconoscono prima di comprenderla, e che molti mediocri attori drammatici ostentano disprezzare, forse perché si vergognano di avervi trovato la cuccagna!44.
Dunque anche la recitazione conferma il lavoro della Raggio sui film: una ricerca spesso controcorrente, che pur conoscendo il panorama coevo mira a un ideale artistico personale e più elevato, per quanto non ancora definito. In questo percorso alterna spunti interessanti e motivi ingenui, dimostrando tuttavia quali possibilità di sperimentazione il cinema degli anni Dieci possa accogliere. Successivamente registra il mutare del gusto: nel 122
1919 scrive e produce Miracolo d’amore (regia di Ivo Illuminati, conosciuto anche come Matrigna), interpretato dalla sorella Maria, storia di una giovane la quale abbandona il tetto familiare quando il padre vedovo si risposa con una donna che la detesta, e fa una vita di stenti fino al momento in cui l’uomo non la ritrova dopo aver rinunciato alla ‘matrigna’, e La valanga (diretto da Francesco Bertolini e interpretato da Maria ed Elettra Raggio), torbida vicenda di una Sibilla che si lascia andare alla passione in un momento di debolezza e da allora, carica del disprezzo paterno, precipita in un vortice di perdizione. L’anno seguente dirige (con Emilio Roncarolo, già fotografo di alcune opere precedenti) e interpreta San-Zurka-San, vicenda dai contorni orientaleggianti e ricchi di mistero, incentrata sulla figura di una ballerina, sacerdotessa di una setta giapponese, che non può amare nessun uomo, pena il causarne la morte. Assistita da un medico di cui è innamorata, è vittima delle ritorsioni dei membri della setta, i quali vengono però sconfitti dalla polizia. Infine nel 1926, dopo aver posto fine all’attività produttiva, recita in Tempesta nel nido, un ultimo film a sfondo familiare, accanto alla piccola Marichette, figlia del regista Nino Valentini della Milano Films, ambientato nel mondo musicale milanese. Con tutta probabilità Elettra Raggio nutre una grande propensione anche per la musica: dopo aver abbandonato il cinema crea la Casa Aedo per la quale, a partire dalla metà degli anni Trenta, pubblica numerosi testi di musica appartenenti a generi differenti: dalle canzoni per bambini a quelle popolari, fino a liriche e opere più impegnate45. Si sposa con Alberto Graffi nel 1947, e muore a Milano il 23 dicembre 1973. Per il rifiuto di proporsi come ideale di bellezza o di vita inimitabile, per una recitazione che si mantiene dentro i canoni di una misura di stampo teatrale, oltre che per la sua consapevole dimensione autoriale, infine per il dialogo intessuto programmaticamente con le altre forme artistiche, in vista di una loro nuova compattazione nel cinema, Elettra Raggio mi pare possa rappresentare, nel panorama italiano, una figura carismatica, consapevole portatrice a un tempo di tratti divistici e antidivistici. Si-
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
curamente non una figura centrale nello sviluppo di questo linguaggio ma, persino nell’opinione dei suoi più accaniti avversari del tempo, una “signorina per bene” che “alleva ancora delle idealità per un’arte cinematografica”46.
La dismisura di Astrea Con Elettra Raggio Astrea condivide la sorte di precoce oblio e il luogo di conservazione dei pochi materiali filmici superstiti, la Fondazione Cineteca Italiana di Milano. Eppure anche questa mastodontica donna, che passa come una meteora attraverso la produzione cinematografica italiana in un periodo di ricerca di nuove formule produttive, lascia un piccolo ma indelebile segno, frutto, se
non altro, di una misura scenica fuori dal comune. Protetta dal nome d’arte, che avvolge in un alone di mistero la sua identità alto borghese (Contessa B., forse Barbieri, di probabile origine veneta), entra nel cinema in occasione di La riscossa delle maschere, un soggetto di Valentino Soldani messo in lavorazione dalla Carlucci Film nel 1917, all’indomani della sconfitta di Caporetto. Il film è un’allegoria delle vicende belliche raccontata attraverso due fasi storiche diverse (il 1866 e l’epoca della Prima guerra mondiale) e interpretata dalle maschere regionali della tradizione italiana. La distribuzione tardiva, a guerra finita, vanifica in parte l’obiettivo della riscossa patriottica, ma segnala l’interpretazione di Astrea e la sua possanza attoriale. L’esordiente interprete, al pari di giovani colleghe e dive affermate, offre il suo contributo alla causa nazio-
Astrea in Justitia, 1919 (Fondazione Cineteca Italiana) 123
Astrea in Justitia (Fondazione Cineteca Italiana)
nale e, nello stesso tempo, mette in luce alcune componenti del suo personaggio che ritorneranno nella successiva, breve carriera. Come in tutti i settori della sfera lavorativa e sociale, anche nella produzione cinematografica l’evento bellico assegna un nuovo protagonismo alle donne, chiamandole a colmare le assenze degli uomini impegnati al fronte. Ciò spiega quella eccezionale fioritura di progetti, iniziative imprenditoriali, esordi attoriali al femminile della seconda metà degli anni Dieci, che non troverà riscontri in periodi successivi. Non solo: sul versante delle forme di rappresentazione, l’impatto della guerra produce una ricodificazione in chiave patriottica dei modelli di femminilità all’epoca diffusi e socialmente riconosciuti. Lyda Borelli, per esempio, volge in chiave allegorica la sua apprezzata statura attoriale interpretando ora l’Italia turrita “che indica agli italiani la via della riscossa e della vittoria”47 (Per la vittoria e per la pace!, Cines 1918), ora la martire Santa Barbara, sacrificatasi a prezzo della stessa vita per impedire l’assalto dei nemici nella propria città48. Francesca Bertini preferisce rinsaldare la sua figura divistica attraverso forme di comunione con il vasto pubblico degli italiani, anziché essere glorificata in un’aura di lontananza. Così si fa exemplum della dedizione alla causa: è promotrice di iniziative caritative nei confronti dei soldati ammalati e nel film Mariute (Edoardo Bencivenga, 1918) si cala nei panni di una contadina 124
friulana, madre di tre figli, che durante l’assenza del marito per la guerra al fronte viene violata da tre soldati austriaci ed è poi vendicata dal proprio padre. Tale abbassamento è peraltro provvisorio: nel film, fortemente autoreferenziale, la dimensione divistica è predominante, e la sequenza della contadina è prudentemente messa en abîme attraverso l’artificio del sogno. Ma – come sottolinea la stampa del tempo – per tutte le donne e le madri italiane Francesca Bertini diviene “un simbolo”49. La stessa Elettra Raggio, come si è visto, in Verso l’arcobaleno (Eugenio Perego, 1916) rivive il conflitto attraverso il sacrificio amoroso, sublimando la perdita del fidanzato che si trova sul fronte opposto con la generosa dedizione ai soldati feriti. Madri e sorelle, fidanzate, persino figlie o maestre, crocerossine, simboli e personificazioni della patria affollano gli schermi regalando alle italiane modelli di comportamento e occasioni di confronto per elaborare i traumi della guerra. In tale contesto la posizione di Astrea mi pare – da quel che consentono di inferire le rare cronache al riguardo – segnalarsi per originalità: l’attrice incarna il ruolo della donna forte che non esita a ricorrere alle maniere pesanti per sconfiggere i nemici. La sua audacia, informa Martinelli, la fa cadere nelle maglie della censura che impone di “eliminare le uccisioni per annegamento di una spia, sopprimere le scene in cui la protagonista getta ai porci, a mano a mano che li cattura, i soldati austriaci”50. Certo, la donna avventurosa non è una novità per il cinema, e i modelli più prossimi di Astrea sembrano essere figure come Protéa – al secolo Josette Andriot, che condivide con lei un’assonanza onomastica – o Pearl White: “corpi frenetici che impongono una nuova immagine della femminilità, non più basata sulla tranquillità, la mansuetudine e la posatezza, ma sulla scioltezza muscolare, l’agilità felina, il movimento elastico e scattante”51. Tanto più che queste stesse eroine danno prova di saper trasformare prestanza e agilità in un’arma al servizio della guerra, aggiungendo alle loro doti “l’ultima qualità fisica rimasta fino allora appannaggio del maschio: la forza”52. Anche in Italia attrici come Berta Nelson, Piera Bouvier, Cristina Ruspoli, Henriette Bonard, Ethel Joyce, Gisa-Liana Doria, Letizia Quaranta e Linda Albertini si cimentano negli stessi anni in film che si
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
collocano a mezzo tra l’avventuroso delle serial queens e il coevo genere dei forzuti, di cui sono spesso compagne53. Tuttavia Astrea sembra compiere un passo ulteriore: non solo è protagonista – e non gregaria – fin dal suo esordio cinematografico; non solo basa la sua performance sulla forza più che sull’atletismo, grazie alla robusta corporatura; ma, a dispetto delle nobili origini, fa ricorso a questa forza quasi brutale in nome e come metafora della patria stessa. Astrea non si limita ad essere un’adiuvante nel processo di liberazione dallo straniero: lo pone in essere, grazie alla sua tempra, risvegliando le maschere regionali dal loro torpore, e lo fa in quanto donna, in quanto patria, e con il probabile avvallo delle nobili origini. Rispetto alle condizioni storiche e politiche dell’Italia del 1917, Astrea compendia in sé le contraddizioni di una fase di transizione nella quale vecchi modelli e nuove istanze sociali si combattono tra loro, ma la componente eversiva del suo personaggio si stempera nella retorica patriottica e della rivincita nazionalista. Come ha suggerito Monica Dall’Asta, Astrea è la “superfemmina” vaticinata dai futuristi, una donna che combatte ad armi pari con gli uomini – la critica la definisce “emula di Maciste” –, rifiuta il sentimentalismo e non indulge a relazioni amorose54. E tuttavia, rispetto alle emancipate eroine straniere che mettono in scacco l’iconografia tradizionale della donna e della madre, dando prova di un virile comportamento, Astrea fa riemergere anche taluni aspetti della cultura matriarcale italiana. All’inizio del successivo film Justitia (Ferdinand Guillaume, 1919)55, il suo principale successo cinematografico, prende casa presso il Castello di San Germano, accolta dall’omaggio degli abitanti del borgo e, smessa la divisa da cavallerizza, si comporta da perfetta gentildonna offrendo un sontuoso banchetto. Successivamente si fa carico delle necessità di due fratelli, Michele e Jole, vessati dal perfido Barone Max: accoglie nel palazzo il giovane macilento, sfrattato e costretto a vivere in una baracca, e in un’altra sequenza solleva tra le braccia – in un eccesso di zelo – la giovane insidiata dal cattivo. Infine adempie fino in fondo al proprio mandato ricomponendo l’unità familiare: ritrova l’anziano padre e benedice il matrimonio di Jole.
Nuova matriarca, più che donna moderna, la forte Astrea non persegue un processo di liberazione personale e sociale, ma il raddrizzamento di torti, la riparazione delle ingiustizie: “Her large size turned the modern Italian woman into a powerful and reassuring keeper of public order”56. L’erculea giustiziera che porta con sé l’immagine di una nobiltà in declino (in Justitia è addirittura una principessa), in cerca di una tardiva forma di legittimazione sociale, diventa così una “donna-Chisciotte”, come l’apostrofa il “Bioscope”57. In questo senso Astrea allenta i legami sia con la modernità tumultuosa delle eroine urbane francesi e americane, sia con quella più decadente e inquietante delle dive, apportatrici di nuovi interrogativi in ordine alla dimensione pubblica e a quella sessuale58. E tuttavia conserva, sopraffina arma difensiva, la capacità di non prendersi troppo sul serio. Il film presenta infatti numerosi elementi comico-parodistici, a partire dalla presenza del celeberrimo Polidor, qui impiegato, nelle vesti di Birillo, come servo e spalla della protagonista, fino all’uso di didascalie caricaturali che punteggiano alcuni momenti salienti della vicenda, del cartellonista Tarquinio Sini59. Sembra esservi in questo lavoro, in certe scene, la volontà di parodiare, quasi, le portentose gesta che si riflettono sullo schermo. Mentre in certi film d’avventure le inverosimiglianze più inverosimili vengono ammannite come indiscutibili realtà […] in questa Justitia le scene più epiche e fantasiose […] sono condotte con appariscente umorismo60.
È su questa ambiguità che Astrea costruisce, in fondo, il suo personaggio. La sua figura che in abiti virili sconfigge un manipolo di ‘uomini forti’ mi pare speculare, e non contraddittoria, rispetto a quella che, abbigliata in sontuose toilette, sfodera una più tradizionale immagine divistica, sia dentro il film che sulle pagine pubblicitarie delle riviste. Nell’uno e nell’altro caso Astrea non cela la sua ‘dismisura’, piuttosto la rappresenta: la esibisce scherzosamente a uso di un pubblico popolare e con una più consapevole ironia nei confronti di quello che – più colto e abituato ai film internazionali – è in grado di cogliere il provincialismo dei forzuti e la vacuità delle dive italiane. La matriarca veneta torna poi pre125
Astrea e Polidor in Justitia (Fondazione Cineteca Italiana)
cocemente nell’ombra, avendo forse intravisto per tempo – dall’alto della sua superiore statura – la fine di una stagione storica e culturale. Dopo L’ultima fiaba, sempre con Polidor, il suo atto di congedo è I creatori dell’impossibile61. Nel titolo del film, che sigilla una carriera cinematografica brevissima, si spegne il trionfalismo dell’auspicata (e mai avvenuta) riscossa delle maschere: all’alba degli anni Venti la creazione dell’impossibile suona come metafora della fragilità di un cinema e forse di un’epoca storica fatti di modesti e grandi eroismi femminili. Dive e insieme antidive, Elettra Raggio e Astrea – 126
come certamente anche altre figure minori del cinema delle origini – mi paiono godere di uno statuto particolare, a un tempo interno ed esterno al mondo della celluloide, che rappresenta nella società del tempo il passatempo mondano per eccellenza. Del cinema colgono ora le potenzialità intellettuali, ora quelle popolari e parodistiche, camminando ai lati degli itinerari divistici consolidati. Forse proprio per questo il loro sguardo va oltre lo schermo, e ne sancisce la modalità sopra le righe, persino autoironica, con cui si rapportano a esso. E, da questa distanza ammiccante, giungono fino a noi.
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi
Note Desidero a questo proposito ringraziare Cristina e Luisa Comencini, Matteo Pavesi, Roberto Della Torre e Luigi Boledi per la disponibilità e l’amicizia accordatami negli anni. Alcuni esiti di queste ricerche sono: Elena Mosconi, Verso il lungometraggio: Justitia, in Elena Mosconi (a cura di), L’oro di Polidor. Ferdinand Guillaume alla Cineteca Italiana, Il Castoro, Milano 2000, pp. 45-65 e Elena Mosconi, Elettra Raggio e la sua opera: antiretorica della Diva nel cinema della transizione, in Raffaele De Berti, Massimo Locatelli (a cura di), Figure della modernità nel cinema italiano (1900-1940), ets, Pisa 2008, pp. 47-72 ai quali rinvio per una contestualizzazione circa i casi affrontati. 1
Interessanti considerazioni sulle funzioni della fotografia pubblicitaria a supporto dell’attrice nel passaggio dal teatro al cinema sono svolte da David Mayer, The Actress as Photographic Icon, in Maggie B. Gale e John Stokes (a cura di), The Cambridge Companion to the Actress, Cambridge University Press, New York 2007, pp. 74-94.
2
Rinvio in particolare alla riflessione metodologica di Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006 e, in ambito cinematografico, ai sempre fondamentali contributi di Gian Piero Brunetta, come Storia e storiografia del cinema, in Gian Piero Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale. Teorie, strumenti, memorie, vol. V, Einaudi, Torino 2001, pp. 191-219; nell’ambito della storiografia delle origini si vedano André Gaudreault, Cinema delle origini o della cinematografia-attrazione, Il Castoro, Milano 2004, Noël Burch, La lucarne de l’infini: naissance du langage cinématographique, Nathan, Paris 1991 (tr. it. Il lucernario dell’infinito: nascita del linguaggio cinematografico, Pratiche, Parma 1994), Wanda Strauven (a cura di), The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam University Press, Amsterdam 2006; per la storiografia di matrice femminista, Jennifer M. Bean, Diane Negra (a cura di), A Feminist Reader in Early Cinema, Duke University Press, Durham e London 2002, Rosanna Maule (a cura di), Femmes et cinéma muet: nouvelles problématiques, nouvelles méthodologies, “CiNéMAS”, n. 1, 2005.
3
Alcuni recenti, importanti contributi hanno aggiornato lo spettro delle questioni inerenti il divismo femminile italiano degli anni Dieci: Angela Dalle Vacche, Diva. Defiance and Passion in Early Italian Cinema, University of Texas Press, Austin 2008, Cristina Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’Epos, Palermo 2006; Rinaldo Censi, Formule di pathos. Genealogia della diva nel cinema muto italiano, Cattedrale, Ancona 2008; Divine apparizioni, “Cinegrafie”, n. 12, 1999; Gian Luca Farinelli, Jean-Loup Passek (a cura di), Stars au féminin, Étidions du Centre Pompidou, Paris 2000 (trad. it. Star al femminile, Transeuropa, Bologna 2000).
4
5
Sullo statuto problematico dell’autorialità delle dive nel pri-
mo cinema, con riferimento a Francesca Bertini, rinvio al saggio di Monica Dall’Asta in questo stesso volume. Non tutte le fonti concordano su tali date: la più attendibile mi pare quella proposta da Roberto Chiti, Dizionario dei registi del cinema muto italiano, mics, Roma 1997, p. 230.
6
Queste notizie provengono da una biografia stesa dall’attrice nel 1953, in occasione del deposito presso la Cineteca Italiana dei propri materiali.
7
8 Maria Raggio viene coinvolta dalla sorella nei film Galeotto fu il mare, Primavera, Automartirio, Miracolo d’amore, La valanga. In una breve presentazione sulla stampa (a pagamento) in occasione del film Miracolo d’amore, viene paragonata a Mary Pickford per “la sua grazia speciale di spontaneità. […] In Maria Raggio tutto è umano, spontaneamente e profondamente umano: dal bel viso senza bistro e senza cerone alla ingenuità quasi infantile” (Maria Raggio, “La Cinematografia italiana ed estera”, nn. 15-16, 15-21 dicembre 1918, p. 36).
In occasione della morte di Ermete Novelli, avvenuta a Napoli il 30 gennaio 1919, la stampa cinematografica esprime gratitudine a Elettra Raggio per averne immortalato l’immagine e la tecnica attoriale nei suoi film.
9
10 Achille Luciano Mauzan dirige i film Galeotto fu il mare (1916) e Primavera (1916). Su questo artista e la sua attività per il cinema rimando a Roberto Della Torre, Classicismo e modernità nel manifesto artistico per il cinema di Achille Luciano Mauzan, in Raffaele De Berti, Massimo Locatelli (a cura di), Figure della modernità nel cinema italiano (19001940), cit., pp. 73-90.
Filippo Tommaso Marinetti, La guerra elettrica, in Guerra sola igiene del mondo, Edizioni Futuriste di “Poesia”, Milano 1915; ora in Luciano De Maria (a cura di), Teoria e invenzione futurista, Mondadori, Milano 2005 (1a ed. 1968), p. 319. 11
12 Tito Alacci, Le nostre attrici cinematografiche studiate sullo schermo, Bemporad, Firenze 1919, pp. 120-121. 13 Paolo Mantegazza, Fisiologia della donna, Treves, Milano 1893. Sull’evoluzione dei modelli di bellezza femminile nel primo Novecento si vedano Stephen Gundle, Bellissima. Feminine Beauty and the Idea of Italy, Yale University Press, New Haven e London 2007 (tr. it. Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Laterza, Roma-Bari 2007); Georges Vigarello, Histoire de la beauté. Le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos jours, Éditions du Seuil, Paris 2004 (tr. it. Storia della bellezza. Il corpo e l’arte di abbellirsi dal Rinascimento a oggi, Donzelli, Roma 2007). 14 Su questo aspetto e per una ricostruzione complessiva dell’attività della Milano Film si veda Raffaele De Berti, Milano Films: The Exemplary History of a Film Company of the 1910s, “Film History”, n. 3, 2000, pp. 276-287.
127
Le due seduzioni, v.c. n. 11238 del 6 marzo 1916, m. 557, produzione Milano Films, Milano.
15
16
Fandor, “Il Tirso al Cinematografo”, 11 novembre 1916.
Traggo l’idea da Eric De Kuyper, Alla ricerca delle tracce dell’Art Nouveau e del Simbolismo nel cinema dei primi decenni, in Gian Piero Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, vol. I, Miti, luoghi, divi, Einaudi, Torino 1999, pp. 190-191; sull’assenza di peso della rappresentazione della donna nell’arte di fine Ottocento-inizio Novecento si veda anche Bram Dijkstra, Idols of Perversity, Oxford University Press, Oxford 1986 (tr. it. Idoli di perversità, Garzanti, Milano 1988, pp. 136-139). Sui libretti di sala confezionati da Elettra Raggio e sulla loro finalità letteraria rinvio a Elena Mosconi, Elettra Raggio e la sua opera: antiretorica della Diva nel cinema della transizione, cit., pp. 57-59. 17
18 La descrizione del film è frutto delle didascalie e dei fotogrammi superstiti, probabilmente uno per ognuna delle scene principali.
L’aspetto rovinoso dell’amore-passione è un tema assai presente, in modo più sotterraneo e ambiguo o decadente, anche nel genere dei diva film. 19
La primavera e la danza delle ninfe trovano numerose corrispondenze nella pittura italiana (e internazionale) nel passaggio tra i due secoli: basti citare il manifesto di Leonardo Bistolfi per l’Esposizione Internazionale delle arti decorative di Torino del 1902, oppure i pannelli di Galileo Chini per la Biennale di Venezia del 1914 dedicati alla Primavera e alla rinascita della vita, o ancora Ninfa (1890) di Giuseppe Cellini, La primavera (1896) e Verba ad pictorem amatoris (Primavera) (1903) di Adolfo De Carolis, Il sogno del melograno (1912-13) di Felice Casorati. Sulla figura della ninfa, si vedano Giorgio Agamben, Ninfe, Bollati Boringhieri, Milano 2007; Georges Didi Huberman, Ninfa moderna. Essai sur le drape tombé, Gallimard, Paris 2002 (tr. it. Ninfa moderna. Saggio sul panneggio caduto, Il Saggiatore, Milano 2004); Bram Dijkstra, op. cit., pp. 131-183 e, riguardo all’ambito cinematografico, Rinaldo Censi, op. cit., pp. 132-140. 20
Francesco Manelli, Elettra Raggio e la sua nuova produzione, “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 14, 31 luglio 1916, p. 44. 21
22 Rodolphe Rapetti, Le Symbolisme, Flammarion, Paris 2007, p. 169. In merito alla diffusione nazionale si veda Anna Maria Damigella, Il Simbolismo italiano: cultura europea e identità nazionale, in Geneviève Lacambre, Il simbolismo da Moreau a Gaugin a Klimt, Ferrara Arte, Ferrara 2007, pp. 5162 e Id., La pittura simbolista in Italia (1885-1900), Einaudi, Torino 1981. 23 Il potere di trasfigurazione della danza è affrontato da Paul Valery, Filosofia della danza, in Barbara Elia (a cura di), Filosofia della danza, Il Melangolo, Genova 1992; in una prospettiva interdisciplinare si veda anche La danza delle avanguardie, Skira, Milano 2005. 24
Il Rondone, “La Vita cinematografica”, 22-30 novembre
128
1916. Un altro elogio sulla concezione paesaggistica di Elettra Raggio è espresso da Aurelio Spada: “Il paesaggio […] è trattato con intenzioni psicologiche, cioè corrisponde, o almeno vuol corrispondere allo stato d’animo dei personaggi, e alla situazione drammatica”; cfr. Aurelio Spada, Valanga, “Film”, 19 agosto 1920. 25 “Chi ha visto Primavera certamente avrà dovuto domandarsi dove mai si son potuti trovare quegli esterni così nuovi e così squisitamente meravigliosi. È un miracolo che solamente Elettra Raggio poteva realizzare. Con pazienza da certosino è andata in sacro pellegrinaggio per i più celebrati giardini delle più aristocratiche famiglie della Lombardia e della Liguria […] Giardini studiati con l’illuminata collaborazione del pittore Achille Mauzan, angolo per angolo, palmo per palmo, e resi nelle loro più recondite bellezze!” (P.T. Elio Landi, Elettra Raggio, “La Vita cinematografica”, nn. 19-20, 22-30 maggio 1917, p. 86).
Rimane da approfondire la relazione tra cinema divistico italiano e Liberty, a partire dalle suggestioni di Gian Piero Brunetta ed Eric De Kuyper: Gian Piero Brunetta, Cantami o Diva …, “Fotogenia”, nn. 4-5, 1998, pp. 27-43 e Id., Divine apparizioni, “Cinegrafie”, n. 12, 1999, pp. 168-176; Eric De Kuyper, op. cit., pp. 189-196. Per De Kuyper gli elementi liberty dei diva film sono ravvisabili soprattutto nella recitazione e nella scenografia (a dispetto delle trame, prevalentemente a sfondo melodrammatico). Esistono a mio parere diverse affinità anche sostanziali tra il Liberty, declinazione nazionale dell’Art Nouveau, e il cinema divistico italiano, entrambi frutti della sensibilità della Belle Époque: oltre all’aspetto decorativo e alla ripresa del mito e della tradizione, filtrata attraverso l’eredità preraffaellita e simbolista, l’idea di un’arte ‘applicata’, che viene esperita quotidianamente, a differenza dell’arte tradizionale di carattere elitario. Dal punto di vista produttivo, il Liberty – come il diva film – unisce spesso in modo cooperativo professionalità diverse, valorizza l’artigianato in luogo della produzione seriale e, pur essendo promosso da classi sociali medio-alte, propone l’accessibilità degli oggetti artistici a tutte le classi sociali. Anche i luoghi di produzione sono simili, in particolare Torino, Roma, Milano e Napoli. Da ultimo, l’aspetto a volte velleitaristico di entrambi i fenomeni, che scadono – in particolare negli epigoni – in formule consunte o eccessive. Sul Liberty si vedano: Fabio Benzi (a cura di), Il Liberty in Italia, Federico Motta, Milano 2001; Laura Vinca-Masini, Il Liberty-Art Nouveau, Giunti, Firenze 1976; Rossana Bossaglia, Il Liberty in Italia, Charta, Milano 1997. 26
27 Eva Vittadello, Il canto silenzioso, Divismo e opera lirica nel cinema muto italiano, in Michele Canosa (a cura di), A nuova luce. Cinema muto italiano I, Clueb, Bologna 2000, pp. 164165 e Lisetta Renzi, Le dive del muto. Modelli di femminilità e iconografia, in Michele Canosa, op. cit., pp. 171-173. 28 Così recita la brochure del film, redatta in italiano e francese. 29 Il testo della brochure, bilingue, è pubblicato anche in “Cinereporter”, n. 1, 5 agosto 1917.
9 / Dive e antidive / Elena Mosconi 30 Ancora una volta i nomi propri sono usati con funzione simbolica: l’amore dissoluto ma generoso di Maddalena è accostato al radicamento della figlia Erica alle origini familiari, mentre il rapace e avido Falco si contrappone al pietoso benché infido Conte Della Croce.
Veritas, Automartirio, “La Vita cinematografica”, nn. 9-10, 7-15 marzo 1918, p. 79. 31
32
Ibidem.
33
P.T. Elio Landi, Elettra Raggio, cit., p. 85.
34
Aurelio Spada, op. cit.
35
Francesco Manelli, op. cit., p. 44.
36
Ibidem.
A.M., Verso l’arcobaleno, “La Cinematografia italiana ed estera”, 30 aprile 1916. 37
I film interpretati da Novelli sono: Re Lear e La morte civile (Gerolamo Lo Savio, 1910), Il mercante di Venezia (1910), Ritratto dell’amata (Gerolamo Lo Savio, 1912 con Francesca Bertini) per la Film d’Arte Italiana; quindi, per l’Ambrosio nel 1914 La gerla di Papà Martin e Michele Perrin (diretti da Eleuterio Ridolfi), Il Leone di Venezia (di Luigi Maggi); infine Il più grande amore (Enrico Novelli, 1915 per la Giano Films), Fiorenza mia! (Enrico Novelli, 1915 per la Maskera Film), oltre alle opere prodotte da Elettra Raggio. Nell’autobiografia raccolta e pubblicata dal figlio Yambo dopo la morte (Ermete Novelli, Foglietti sparsi narranti la mia vita, Mondadori, Roma 1919) Novelli non fa menzione dell’attività cinematografica; al contrario il profilo di Giuseppe Pardieri (Ermete Novelli, Cappelli, Bologna 1965, p. 95), sottolinea l’irriducibilità delle interpretazioni cinematografiche a quelle teatrali.
38
Silvio D’Amico definisce Novelli come “l’ultimo e il grandissimo dei comici dell’arte”, cfr. Silvio D’Amico, Tramonto del grande attore, Mondadori, Milano 1929, p. 81. 39
40 Su questo aspetto rinvio a Cristina Jandelli, I ruoli nel teatro italiano tra Otto e Novecento, Le Lettere, Firenze 2002; Luciano Bottoni, Storia del teatro italiano 1900-1945, Il Mulino, Bologna 1999; Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Laterza, Roma-Bari 2001; Gigi Livio, La scena italiana. Materiali per una storia dello spettacolo dell’Otto e Novecento, Mursia, Milano 1989. 41 Rugantino, La direzione artistica, “La Cine-fono e La Rivista fono-cinematografica”, n. 287, 18 luglio 1914; ora in Tra una film e l’altra. Materiali sul cinema muto italiano 1907-1920, Marsilio, Venezia 1980, p. 227. 42 Il caso di Eleonora Duse è sotto questo profilo emblematico. Si veda la ricostruzione di Cristina Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., pp. 147-180. 43
Bertoldo, “La Vita cinematografica”, 25 dicembre 1918.
Giulia Cassini Rizzotto, Ermete Novelli. Il grande scomparso!, “Film”, 5 febbraio 1919. 44
45
Tra queste l’ode Ave Maria purissima di Pietro Dentella,
l’epitalamio Alba Nuziale, l’elegia Dinanzi al SS. Crocefisso e la ninna nanna Dormi e sogna di Mario Pieraccini (tutte risalenti al 1956). 46 Elettra Raggio, “Cronache d’Attualità”, V, febbraio-marzo 1921. 47 Vittorio Martinelli, Per la vittoria e per la pace!, in AA.VV., Lyda Borelli, mics, Roma 1993, p. 159. Il film, della durata di 18 minuti, era stato commissionato dal Ministero della Guerra. 48 La leggenda di Santa Barbara è utilizzato come prologo del film L’altro esercito (Cines, 1918), in cui vengono illustrati i processi di lavorazione delle armi da guerra. 49 Cose mai viste: uno spettacolo cinematografico frutta ventimila lire, “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 7, 1918, p. 30, ripreso e commentato in Cristina Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’Epos, Palermo 2006, pp. 71-75. Altrove, nello stesso brano, si sottolinea il valore emblematico della pellicola: “Mariute è un simbolo e significa: la patria invasa, l’oltraggio dello straniero accampato sul sacro suolo d’Italia, le nostre donne violate, la nostra terra profanata, i nostri bambini mutilati, la nostra proprietà depredata”. 50 Vittorio Martinelli, “Lasciate fare a noi, siamo forti”, in Alberto Farassino, Tatti Sanguineti (a cura di), Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983, p. 22.
Monica Dall’Asta, Donne avventurose del cinema torinese, in Paolo Bertetto, Gianni Rondolino (a cura di), Cabiria e il suo tempo, Museo Nazionale del Cinema – Il Castoro, TorinoMilano 1998, p. 354. Cfr. anche Id., La diffusione del film a episodi in Europa, in Gian Piero Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, vol. I: L’Europa. Miti, luoghi, divi, cit., pp. 285-298. 51
52 Monica Dall’Asta, Pearl White come una belva. Il filone bellico del serial e il trionfo del potere femminile, in Renzo Renzi (a cura di), Il cinematografo al campo. L’arma nuova nel primo conflitto mondiale, Transeuropa, Ancona 1993, p. 105. La quale aggiunge: “Indossata la divisa, la soldatessa Pearl diventa il modello delle forzute italiane degli anni Venti”.
Su questi argomenti sono imprescindibili i riferimenti a Alberto Farassino, Tatti Sanguineti (a cura di), Gli uomini forti, cit., e Monica Dall’Asta, Un Cinéma musclé, Éditions Yellow Now, Crisnée 1992. 53
54 “Astrea provoque la rencontre de l’iconographie populaire (issue du cirque) de la femme-forzuta et du thème, propre au XIXe siècle, du ‘surhomme de masse’, défenseur des faibles et des justes, ici dans sa version féminine”; Monica Dall’Asta, Un Cinéma musclé, cit., pp. 115-117. 55 La pellicola, originariamente lunga 2095 metri, sopravvive presso la Fondazione Cineteca Italiana di Milano in una copia fortemente mutila (983 metri). Il film, prodotto dalla Polidor Film, ha soggetto e sceneggiatura di Guido Serra, ed è interpretato da Polidor (nella parte di Birillo), Astrea (principessa Justitia), Maud Guillaume (Jole di S. Germano), Francesco Cianciamerla (il padre), Alberto Monti (Giorgio), Natale Guil-
129
laume (il Segretario del Barone), Nello Carotenuto (il Barone), Ivan Krasno (Michele). 56 Angela Dalle Vacche, Diva. Defiance and Passion in Early Italian Cinema, University of Texas Press, Austin 2008, p. 178. 57
“The Bioscope”, 1 aprile 1920.
Angela Dalle Vacche identifica in Lyda Borelli e in Astrea due opposte rappresentazioni del corpo femminile e del desiderio sessuale – introdotte dal cinema e dalla conquista dello spazio – che sottendono anche diverse posizioni sociali e concezioni estetiche. La prima, associata a Lyda Borelli, è tesa all’astrazione, alla smaterializzazione dell’arabesco, e a un oltrepassamento dei limiti del corpo femminile attraverso la suggestione di una possibile androginia. Al contrario, il corpo di Astrea esprime per la studiosa la dismisura di un eccesso grottesco, che la radica pesantemente a terra, e ne fa un esemplare clownesco di ginandria (Angela Dalle Vacche, Diva. Defiance and Passion in Early Italian Cinema, cit., pp. 114-120). 58
In merito a questo disegnatore e alla sua attività a supporto del cinema si veda Anna Pau, Tarquinio Sini, Ilisso, Nuoro 2004, pp. 20-27. 59
60 “La Rivista cinematografica”, n. 20, 25 ottobre 1920. Sulla parodia, con particolare riguardo al cinema italiano, rinvio a Roy Menarini, La strana copia. Studi sull’intertestualità e la parodia nel cinema, Campanotto, Pasian di Prato (Ud) 2004 e Id., La parodia nel cinema italiano, Hybris, Bologna 2001. 61 L’ultima fiaba (conosciuto anche con il titolo L’ultima avventura di Astrea e Polidor), prodotto dalla Polidor Film (1920), è diretto da Ferdinand Guillaume, e schiera la coppia di Astrea e Polidor (nei panni di Birillo), come il successivo I creatori dell’impossibile (1921).
130
PARTE TERZA
ELVIRA NOTARI
10 / Vittorio Martinelli
Due o tre cose che so di Elvira Notari
Di Elvira Notari ho sentito parlare per la prima volta alla fine degli anni Quaranta, doveva essere il ’47 o il ’48. Era l’epoca in cui c’erano i cineclub: a Napoli, dove abitavamo, c’erano almeno quattro cineclub che si facevano una lotta tremenda fra loro, cercando di proiettare film che non si riuscivano a trovare, perché le cineteche non funzionavano e quindi ci si ritrovava con la solita, famigerata, Corazzata Potëmkin, o con film presi dai distributori, magari film di o con Eric von Stroheim che però venivano proiettati con il suo nome cancellato… Cose di questo genere. Fra gli organizzatori di quei cineclub c’erano il famoso matematico napoletano che vi ricorderete dal film di Martone [Morte di un matematico napoletano, 1992, ndr], il professor Caccioppoli, e Roberto Paolella, autore di quella che è rimasta una delle migliori storie del cinema italiano, almeno fino all’epoca di Gian Piero Brunetta. Fu proprio Paolella a scovare un film napoletano, di proprietà di un carbonaio di San Giovanni a Teduccio. Il carbonaio aveva preso parte a un film di Elvira Notari, e quando il film aveva finito la sua circuitazione lui era andato al macero delle pellicole, aveva comprato una copia, s’era messo le pizze sotto il braccio, se l’era portate a San Giovanni a Teduccio e se le teneva sotto il letto. Non Elvira e Nicola Notari (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
avendo una moviola per poterlo visionare, lo srotolava per vedere le scene dove appariva. Paolella trovò questo individuo, dopo lunghe contrattazioni riuscì a convincerlo a mostrare il film e organizzò una serata a cui parteciparono Alberto Consiglio, che allora era il direttore di “Il Risorgimento” (“Il Mattino” aveva infatti cambiato titolo, era stato epurato e lo chiamavano “Il Risorgimento”), Paolo Ricci, che allora era un pittore molto noto, Curzio Malaparte e Caccioppoli, che venne a presentare il film. Il film è Carmela la santina di Montesanto (1916). Devo dire che non ne ricordo granché, perché era molto rovinato: il carbonaio, dopo aver guardato le scene che lo interessavano, riarrotolava da sé il film, che quindi era tutto ondulato. L’abbiamo proiettato così alla Società Meridionale di Elettricità, che aveva una specie di sala di proiezione in via Toledo a Napoli. Però ricordo una cosa curiosa: accanto ai due attori principali – lei era Tina Somma, che ha interpretato diversi film napoletani, lui non ricordo chi fosse – c’erano Tina Pica e Carletto Pisacane, conosciuto poi con il nome di Capannelle, che allora erano molto giovani ed erano la seconda coppia del film. Caccioppoli parlò a lungo del cinema napoletano, spalleggiato anche da Paolella, che fra l’altro aveva lavorato come aiuto regista e aveva fatto anche 133
qualche piccola parte: e infatti è stato il primo a scrivere del cinema napoletano muto, facendo nel suo libro interessanti paragoni con la pittura spagnola, dicendo che gli straccioni che appaiono nei film napoletani richiamano certe figure tipiche dei disegni spagnoli. E questo fu il mio primo ‘incontro’ con Elvira Notari. Dopo, non ho più sentito parlare di lei per lo meno per trent’anni, fino a che, a un certo punto, c’è stato un risveglio di studi sul cinema del muto italiano, e dunque anche sul cinema napoletano. Ebbi allora la fortuna di trovare l’indirizzo del figlio di Elvira Notari, Edoardo, che in arte era chiamato Gennariello. Abitava a Vermicino. Gli telefonai: “Commendatore, posso venire a trovarla?” “Ah, ma voi siete napulitano, allora venite! Già sapite tutti i film ch’aggio fatto?” “Sì sì, ho la lista.” “Allora venite, vediamo chi è più bravo, vediamo se ve li ricordate tutti”.
Arrivai là con la mia lista, preparata sulla base dei visti di censura, film per film; lui invece aveva buttato giù dei titoli così, molti li ricordava, molti non li ricordava, e li aveva messi in un ordine casuale (io li avevo in ordine cronologico). Arriviamo al 1921, quando lui, che era apparso in tutti i film della madre, aveva avuto dei problemi con lei e aveva detto “No, io mi metto in proprio, fondo la Gennariello Film, e i film usciranno con il nome Gennariello Film”. Ne fece due, effettivamente: Gennariello pulizziotto e Gennariello il figlio del galeotto. Quando citammo il primo, Gennariello pulizziotto, lui si fermò e io completai: “…e Gennariello il figlio del galeotto”. Spalancò gli occhi e disse: “Ma come caspita avete fatto? So’ quarant’anni che nun me ricordo ’sto titolo! Arriva lui… Maria! ’O dottore è napulitano, mi raccomando il ragù, chisto resta a pranzo”. Diciamo che così conquistai la sua fiducia. Poi io ricominciai a chiedergli della madre, e lui mi disse che era soprannominata ‘la Marescialla’, perché comandava lei. Tirò fuori dei barattolini di vernice e dei pennelletti sottili, con i quali tutta la famiglia colorava i film della Pathé, prima che Elvira si mettesse a fare il cinema da sé. Avevano fatto una specie di contratto con il distributore della Pathé, il 134
quale gli passava i film che loro dovevano pitturare a mano. Mi raccontò che a quell’epoca non era la madre, ma la nonna, che allora era ancora giovane, a comandare il gruppo di madri, figli, nipoti, cugini. Tutti quanti lavoravano su una specie di tavolo lungo; ognuno di loro aveva un pezzo di pellicola e lei, tipo direttore d’orchestra, diceva “L’occhio! La bocca! La mano!”, e tutti quanti dovevano dare il colpo di colore. Elvira Notari aveva due idoli: uno era Matilde Serao, l’altro Carolina Invernizio, le due scrittrici che all’epoca andavano per la maggiore. Carolina Invernizio non voleva che le sue opere venissero trasportate al cinema, si era sempre opposta. Ma morì nel 1916, e nel 1917 i parenti vendettero tutto: nella filmografia del cinema italiano ci sono sedici film tratti dalla Invernizio, tutti usciti nel 1917, tra cui due film i cui diritti furono comperati da Elvira Notari. Per quanto riguarda invece la Serao… Matilde Serao era una donna tremenda, faceva delle cose tremende, era un po’ una ricattatrice; con il soprannome di Gibus scriveva delle cose… insomma, era piuttosto odiata nell’ambiente napoletano. Gennariello mi raccontò che quando Elvira Notari andò da lei, la Serao le disse: “Sentite, voi che fate quello schifo di film, come vi permettete di venire da me? Fateme ’o piacere, iatevenne. Non vi fate cacciare da me, iatevenne per conto vostro”. La Notari avrebbe voluto tanto che la Serao le desse Sterminator Vesevo, racconto che la scrittrice vendette invece a una Casa di produzione minore. Anche Castigo e Addio amore li vendette a una casa che poi fallì, e non la pagò nemmeno: la Floreal di Velletri, una delle tante compagnie che sorgevano e morivano dopo un solo film. Steminator Vesevo lo cedette a una casa ancora più scalcinata di questa Floreal film. Un’attrice che aveva lavorato negli anni Venti da ragazzina, aveva fatto dei film con Maciste, Adelina Pretolani in arte Mimì, mi raccontava che era andata a vedere a Civitavecchia quando si girava Sterminator vesevo (1921). A Civitavecchia avevano fatto una specie di Vesuvio come si fa con la sabbia: si fa un buco sotto, si mette un giornale e si dà fuoco. Questo era lo Sterminator Vesevo di cui la Serao si vantava tanto. Elvira Notari era la Marescialla perché, anche una volta finito di girare il film, comandava su tutti: co-
10 / Due o tre cose che so di Elvira Notari / Vittorio Martinelli
mandava sul figlio, comandava sulla figlia, che pure aveva interpretato qualche parte, comandava sul marito, che era l’operatore – e il marito, a fine riprese, piegava le tre gambe del treppiede della macchina da presa, se lo metteva a tracolla come un moschetto 91 e la seguiva. Praticamente la Marescialla con la guardia del corpo dietro. La cosa interessante della Notari è il fatto che questi film, che non avevano successo al di là del Garigliano (perché qualcuno arrivò a Firenze o a Milano, ma nelle recensioni che ho letto le si diceva che avrebbe dovuto cambiare mestiere: “A Napoli fanno delle belle scarpe, perché non imparate a fare le scarpe, lasciate perdere il cinema che non è roba vostra”), invece avevano un successo inconcepibile, clamoroso, a Napoli, a Palermo, a Bari, a Catania, addirittura a Malta. Il corrispondente da Malta di “La Rivista cinematografica” scriveva: “C’è stata la folla per vedere ‘A legge o ‘A santanotte. Soltanto il pubblico si lamenta che le didascalie sono scritte in dialetto napoletano, che qui non viene capito. Se si potesse fare in modo di usare l’italiano, che lo capiamo bene…”. Questi film avevano un successo veramente spettacolare nei cinema di Napoli che erano il tempio del film napoletano, come il Cinema Vittoria nella Galleria Umberto e il Monte Maiella nella Galleria Principe di Napoli. C’erano tali code di gente per vederli che molte volte la questura, per smaltire la folla che intralciava il traffico, aveva dovuto autorizzare le proiezioni fin dalle dieci del mattino. Ma i film della Notari andavano anche in America, e ci andavano con il cantante appresso, un certo Mario Massa, un cantante grasso che si metteva sotto lo schermo e cantava le canzoni dei film, tutti più o meno ispirati, negli anni Venti, dalle canzoni che avevano vinto il festival di Piedigrotta. La Notari comprava i diritti di riproduzione cinematografica di tutte le canzoni che partecipavano a Piedigrotta, tutti quanti, perché non si sapeva quale avrebbe vinto; uno di questi vinceva e subito dopo veniva fatto il film, in dieci giorni, in modo da sfruttare l’onda del successo della canzone. E’ piccerella e ’A santa notte sono appunto due canzoni, del 1921 e del 1922, che hanno vinto Piedigrotta. In America avevano un successo delirante, gli emigranti accorrevano, c’è stato chi ha scritto che
questi film avevano il sapore della pizza e il profumo degli spaghetti. Andavano a vedere queste vicende dello scugnizzo, della vecchia maga avvolta nello scialle nero, del camorrista: piangevano, si emozionavano, e questo accadeva sia in America del Nord che in America del Sud. Un certo Crapanzano, rappresentante della Dora Film a New York, ebbe l’idea di rivolgersi direttamente ai gruppi di meridionali che si erano trasferiti lì – perché in genere, quando si trasferiva uno, poi venivano il fratello, la moglie, i parenti, i cugini, gli amici, e si ricostituiva in piccolo quello che era il paese da cui provenivano. Quindi lui andava e diceva: “Voi da dove siete?” “Da Grumo Nevano”. “Volete fare un film su Grumo Nevano? Facciamo la piazza principale, la chiesa, il municipio, casa vostra con i parenti seduti fuori dalla porta?” “Sì sì”. “Cinque dollari a testa”.
Di questi film ne fecero tanti. Un giorno Crapanzano si recò a Pittsburgh, dove vivevano molti emigranti di Ariano Irpino, che gli risposero: “No, non vogliamo il film su Ariano Irpino, non ce ne frega niente. Dovete fare un film sul nostro santo”. “E chi è il vostro santo?” “Ma come, non lo sapete? Il Santo Pellegrino”.
Insomma, si viene a scoprire che il Santo Pellegrino era un santo che si era battuto per il cristianesimo all’epoca dell’imperatore Commodo Aureliano, restauratore del paganesimo. Catturato dai pretoriani, era stato condannato alla consunzione: era stato legato nudo attorno a un palo e tre donne nude si dovevano strusciare su di lui fino a farlo morire di consunzione. Mi disse Gennariello: “Dotto’, con le dovute cautele, la parte del santo l’ho fatta io. Mia madre fece cucire alle sarte dei costumi color carne, aderentissimi. Sia io che le tre donne che si strusciavano su di me sembravamo nudi, ma non eravamo nudi”. Questo film, che si intitola Trionfo cristiano, arrivò in Italia, ha un visto di censura del 1930, è ancora muto, e girò, per quanto sono riuscito a trovare, du135
Gennariello in ‘A santanotte, 1922 (CSC - Cineteca Nazionale)
rante le Settimane sante. Gennariello mi mostrò dei ritagli di giornali americani in cui si diceva che il clero della Pennsylvania, compresi vescovi e cardinali, andarono a vedere questo film e lo giudicarono uno dei migliori film religiosi mai realizzati. Queste sono storie, sono microstorie: non è la Storia del cinema come la intendiamo normalmente, con la maiuscola, quella che trovate sui libri. Queste sono le piccole storie che nessuno sa e che danno un po’ di pimento... Avevo dimenticato di dire una cosa. L’attrice che nel 1922 interpretò E’ piccerella e ’A santanotte si chiama Rosé Angione ed era la maestra di matematica e fisica di Gennariello. Poiché Gennariello andava piuttosto male in queste materie, la madre gli aveva 136
preso un’insegnante di matematica che veniva da San Severo di Puglia e si chiamava Rosella Angione. Poi, vista la ragazza, Elvira Notari le disse: “Ma tu guarda, sei uguale a Pola Negri”, un’attrice che all’epoca andava di moda, “dovresti fare il cinema”. Tanto fece che alla fine la convinse e infatti, con il nome Rosé, la Angione interpretò cinque o sei film della Notari, tra il 1920 e il 1923. Poi ad un certo punto si annoiò, anche perché, col fascismo, il cinema napoletano cominciò ad andare male, e allora tornò a fare la professoressa di matematica e fisica a San Severo. E questa è una notizia che riguarda gli attori, dei quali in genere si sa sempre tutto, ma credo proprio che di questa Rosé Angione non si sapesse ancora niente.
11 / Giuliana Bruno
Elvira Notari e la Dora Film d’America Cinema e migrazione culturale
Elvira Notari (1875-1946), forza trainante della Dora Film, fu la prima e più prolifica regista cinematografica d’Italia, autrice di circa sessanta lungometraggi e di oltre un centinaio tra cortometraggi e documentari, prodotti tra il 1906 e il 19301. Notari ritrasse la sua città natale, Napoli, e la raccontò come un luogo organico, permeabile e transeunte. La sua Napoli era una “metropoli plebea”, per usare la famosa espressione coniata da Pier Paolo Pasolini. Ritmo urbano, musicalità, rumore e linguaggio gestuale definivano la cine-città che emerge dai suoi film, tra cui ricordiamo E’ piccerella (1922), ’A santanotte (1922) e Fantasia ’e surdate (1927). La corporeità musicale di Napoli si presta qui alle rappresentazioni filmiche della cultura popolare e alle sceneggiate della vita di strada. Tali visioni, prodotte molto localmente, funzionavano comunque ‘in transito’ e furono pioniere di un fenomeno di movimento sociale e culturale. Infatti, i prodotti della Dora Film circolarono non solo in Italia ma anche al di fuori dei suoi confini. Come rivelano vari documenti, furono coinvolti in un interessante processo di ‘migrazione culturale’: l’emigrazione dall’Italia meridionale all’inizio del secolo comprendeva anche i moving pictures, i film. Benché in genere i film di Elvira Notari non fossero
ufficialmente coperti da copyright per la distribuzione, una buona parte di quelli da lei realizzati negli anni Venti raggiunse gli Stati Uniti2. Come altri ‘emigranti’, i film di Elvira Notari viaggiarono per mare, spesso accompagnati dai cantanti che dovevano eseguire dal vivo la colonna sonora delle sceneggiate filmiche. La Dora Film trovò un avamposto a New York, città con una forte presenza di emigrati italiani, molti dei quali venivano dall’area napoletana3. La Dora Film di Napoli realizzò il ‘sogno americano’, diventando la Dora Film d’America e aprendo un ufficio sulla Settima Avenue. Sulla sua carta intestata era stampata una lista di film per la distribuzione. Gran parte dei titoli erano sia in italiano (o napoletano) sia in inglese e venivano spesso trasformati nella traduzione, al punto che “Madonna” divenne mad woman, pazza. La Dora Film d’America distribuiva anche altri film girati appositamente per il pubblico italo-americano, e agiva come produttore. La produzione di Elvira Notari ebbe diffusione soprattutto all’interno della comunità italo-americana di New York. Le informazioni raccolte rivelano comunque che circolò anche in città come Pittsburgh e Baltimora, così come in paesi sudamericani come il Brasile (specialmente a San Paolo) e l’Argentina, 137
138
11 / Elvira Notari e la Dora Film d’America / Giuliana Bruno
‘A santanotte (CSC - Cineteca Nazionale)
dov’era presente una forte comunità italiana. La Dora Film di New York funzionò come punto di ingresso della distribuzione nel nuovo continente. Durante gli anni Venti i film di Notari furono programmati pubblicamente e regolarmente a New York, soprattutto nei cinema di Little Italy e Brooklyn. I film erano ampiamente pubblicizzati sul quotidiano Il Progresso italo-americano. Gli annunci sono pomposi: ’O festino e ’a legge (1920) viene presentato come “il più grande successo dell’epoca”, “colossale cinematografia italiana”, “ritirata espressamente dalla Dora Film-Napoli. Questo film sarà esibito al pubblico solo dalla nostra Ditta”4. Gli annunci erano di solito in bell’evidenza sulla pagina. L’annuncio per Core ’e frate (1923) è più grande di quelli per le rappresentazioni dell’Aida e della Traviata alla Manhattan Opera House5.
Core ’e frate, pubblicizzato come seguito di ’O festino e ’a legge, ottenne il visto di censura in Italia il 31 dicembre 1923, e fu proiettato a Manhattan dall’1 al 7 settembre 1924, ancor prima di essere presentato in anteprima a Roma il 28 novembre 1924. Non fu un’eccezione. I film di Notari generalmente arrivavano negli Stati Uniti piuttosto rapidamente, entro un anno al massimo dalla data del visto italiano, poco dopo l’uscita a Napoli, ed erano spesso programmati a New York addirittura prima dell’uscita a Roma. Questo fatto è particolarmente significativo in termini di circolazione dei codici culturali tra Napoli e New York. Il fenomeno è basato sul fatto che New York ospitava molti emigrati napoletani. La velocità del passaggio dei film aggiungeva una dimensione di comunicazione simultanea al legame storico e immaginario tra le due città.
Elvira Notari nei primi anni Quaranta (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
139
C’era anche un aspetto legale della distribuzione Napoli-New York, che implicava l’aggiramento di Roma. Come capitale del paese, Roma rappresentava il potere centralizzato e il centro della burocrazia nazionale. Era il luogo dove in definitiva venivano prese le decisioni sulla distribuzione: i visti della censura si ottenevano a Roma. Durante gli anni Venti, Elvira Notari incontrò molte difficoltà nell’ottenere i visti per i suoi film, che non incontravano il favore del fascismo. Ad alcuni venne negato, e le fu spesso chiesto di rimontarli o di fare modifiche e tagli. Si trovò però un metodo ‘locale’ per aggirare il potere centralizzato. Mentre i film venivano inviati a Roma per ottenere il permesso di distribuzione (una pratica amministrativa tradizionalmente lenta), Notari otteneva un visto provvisorio per la distribuzione dall’ufficio napoletano6. Questa inusuale procedura non era del tutto inconsueta in un paese di città-stato. Il detto popolare “fatta la legge, trovato l’inganno” riassume l’invenzione di sistemi semilegali per evitare le burocrazie centrali. Questo documento temporaneo permetteva a Notari di far uscire i film a Napoli. A giudicare dalle date, sembra che gran parte dei film fossero poi imbarcati e spediti a New York. Quando finalmente la burocrazia centrale romana arrivava a rispondere in un modo o nell’altro, i film erano già ‘emigrati’ e già ampiamente diffusi. Se si otteneva il visto, il film veniva ripresentato a Napoli e spedito nelle altre città italiane. In caso contrario, il danno non era terribile,
Rosè Angione, Elisa Cava e Alberto Danza in ‘A santanotte (CSC - Cineteca Nazionale) 140
dato che il mercato italo-americano si era già preso cura della distribuzione. Gli introiti provenienti dal mercato degli emigrati facilitarono la riproduzione del cinema popolare nostrano. Il legame con le comunità emigrate garantì in definitiva la sopravvivenza economica di Notari per tutti i difficili anni Venti, così come l’aggiramento della censura nel primo decennio del regime fascista. Il cinema emigrante di Notari costituisce un caso particolare entro la “sfera pubblica proletaria” del cinema muto7. La circolazione dell’opera di Notari tra gli italiani d’America conferma l’impatto che il pubblico immigrato e operaio ebbe sullo sviluppo nel cinema muto. In una forma di ricezione che collegava sfera pubblica e privata, il cinema prese il posto di precedenti luoghi di svago popolare e interazione sociale, e divenne inoltre spazio di riconoscimento pubblico per gli emigranti8. Tra il pubblico degli emigrati le donne predominavano. Questo dato solleva la questione del ruolo della spettatrice, affrontata dagli studi anglo-americani nel contesto di una discussione che riguarda anche l’influsso operaio e delle classi meno abbienti sul cinema delle origini9. L’attrazione esercitata dal cinema sugli emigrati va letta in termini di modificazione culturale della sfera pubblica e privata. Il cinema, come forma di spettacolo collettivo, costituiva per queste persone un mezzo cruciale di ridefinizione sociale e un luogo per la rinegoziazione dell’identità. Per le donne emigrate, il cinema era un tipo di svago approvato dalla società e dalla famiglia. A questo proposito, Judith Mayne suggerisce un parallelo tra la lettrice del diciottesimo secolo e il pubblico degli emigrati dei primi film: Sia il romanzo che il film hanno dato l’illusione di partecipazione sociale a gruppi relegati, per una ragione o per l’altra, ai margini di attività significative. […] Seduta in un cinema, all’emigrata viene offerta una forma di spazio privato: immagini sullo schermo da consumare, fantasie che permettono un’intensa identificazione personale. […] Il romanzo diede alle lettrici l’illusione di partecipazione sociale, mentre il cinema diede alle emigrate un senso di realizzazione di fantasie personali. […] L’essere spettatrici e l’essere lettrici sono in maniera simile adattamenti alla mutevole relazione tra vita privata e pubblica10.
11 / Elvira Notari e la Dora Film d’America / Giuliana Bruno
Una rara immagine giovanile di Elvira Notari (Fondo Vittorio Martinelli - Cineteca di Bologna)
Discutendo del cinema delle origini in termini di “sfera pubblica proletaria”, Miriam Hansen avanza l’idea che il cinema abbia rappresentato una “sfera pubblica alternativa”, mettendo in risalto il ruolo della fantasia nella produzione di esperienza e ripercorrendone le traiettorie storiche: Il cinema offrì alle donne, come fece per gli emigrati e per la classe operaia di recente urbanizzazione, uno spazio a parte e uno spazio intermedio. Era il luogo della negoziazione immaginaria delle differenze tra famiglia, scuola e lavoro, tra standard tradizionali di […] comportamento e sogni moderni11.
Il successo dei film di Elvira Notari presso il pubblico degli emigrati fa parte della negoziazione culturale
tra i termini in trasformazione del privato e del pubblico. Le vite private di queste persone recavano il trauma della separazione dalla terra e dall’ambiente natali. In particolare, coloro che provenivano dall’Italia meridionale, dove la piazza rendeva possibile un’esistenza privata comunitaria, dove la separazione tra privato e pubblico derivante dall’industrializzazione non era del tutto in atto, sperimentarono in America l’esperienza traumatica della fondamentale separazione tra le due sfere. Il cinema poteva offrire loro un legame immaginario, costruito non solo nello spazio reale della sala, luogo di socialità, ma anche e specialmente nella geografia mentale della ricezione, spazio di transito tra testi e pubblico. Poiché affonda in un’‘etica delle passioni’, la sfera testuale del cinema di Elvira Notari è il campo pubblico delle passioni private. A livello di immaginazione, l’esperienza, le emozioni, i sentimenti, la sessualità – tutti elementi della sfera privata – vengono qui intensificati. I film di Notari offrono un esempio in cui “il legame creato dal cinema tra fantasia e immagini costituisce, per lo spettatore, forme di soggettività che sono esse stesse, inequivocabilmente, sociali”12. Diversamente dagli emigranti stessi, i film di Notari non viaggiarono con un biglietto di sola andata. Effettuarono un viaggio completo, culturale e produttivo, di andata e ritorno: da un lato, il successo americano aiutò la Dora Film a produrre film in Italia durante tempi difficili; dall’altro, con il loro effetto di document(ari)o turistico culturale, i suoi film permisero agli emigrati di ‘tornare a casa’. I film di Notari a New York agirono come veicolo per la trasformazione della memoria in architettura della visione: nell’era della riproducibilità tecnica, lo status della memoria cambia e assume un carattere spaziale. Il movimento del tempo si fa geografia. Ricordi sia personali sia collettivi perdono il sapore di madeleines proustiane e acquistano la visione/veduta di fotografie e film. I film di Notari, per gli emigrati, finirono per sostituire la memoria. Il canale di comunicazione filmico tra Napoli e New York portò a diversi sviluppi. A metà degli anni Venti, alcuni anni dopo che i lungometraggi della Dora Film avevano cominciato ad essere distribuiti, gruppi di emigrati italo-americani le commissionarono la 141
Rosè Angione e Alberto Danza in ‘A santanotte (CSC - Cineteca Nazionale)
realizzazione di brevi documentari. Questo sviluppo getta una luce nuova sulla questione del pubblico degli emigrati. Gli spettatori di Notari si trasformarono, letteralmente, da lettori in produttori di significato. I documentari commissionati dovevano ritrarre i luoghi d’origine degli emigrati: la piazza, le case, i parenti che avevano lasciato in patria. I rappresentanti della Dora Film d’America ebbero cura di raccogliere da parte della comunità italo-americana somme di denaro, che venivano inviate alla Dora Film di Napoli. I Notari viaggiarono allora tra i villaggi dell’Italia meridionale per realizzare documentari di circa cinque minuti, concepiti specificatamente per il pubblico produttore d’oltreoceano. Secondo lo storico Vittorio Martinelli, tra il 1925 e il 1930 la 142
Dora Film produsse con questo metodo settecento brevi film e un lungometraggio13. Trionfo cristiano (1930), il lungometraggio prodotto con la sponsorizzazione di emigrati provenienti da Altavilla Irpina, fu probabilmente l’ultimo film di Notari. Gli sponsor chiesero un resoconto cinematografico della vita del santo patrono locale14. Sfortunatamente, nonostante i molti sforzi per ritrovare i film italo-americani, né Trionfo cristiano né i documentari sono stati rintracciati15. Se venissero recuperati, potrebbero costituire un prezioso archivio storico di un transito, di un’Italia osservata, ricostruita, trasferita all’estero – conservata, sì, ma anche persa. Sutura cinematografica di distanze e differenze, i film emigranti sono documenti, agenti e fonti di storia.
11 / Elvira Notari e la Dora Film d’America / Giuliana Bruno
Insieme macrostoria collettiva e microstoria personale, sostennero e difesero le culture popolari meridionali espatriate. I film emigranti costituiscono non solo una rappresentazione di culture (ri)mosse, ma anche un’autorappresentazione. In mancanza dei testi, persi o distrutti, possiamo fare solo ipotesi sul modo di produzione e ricezione, consci dei limiti di tali speculazioni e della loro incapacità di tenere conto delle differenze. La prima questione riguarda la motivazione degli emigrati a sponsorizzare i film. La natura stessa dei lungometraggi di Notari – quella di una finzione che rendeva presente il ‘corpo’ del testo urbano, poiché documentava luoghi e fisionomie locali riconosciute e rimpiante dagli emigrati – molto probabilmente innescava da parte del pubblico la richiesta di film ‘fatti in casa’. Quest’uso documentario del cinema prefigura il ruolo che gli spettacoli cinematografici hanno giocato nello sviluppo delle tecnologie video e digitali. I documentari funzionavano come istantanee in movimento del ricordo, da possedere, preservare e rivedere ad infinitum. Prima del Super-8, del video e degli schermi digitali, legarono la sfera pubblica del cinema alla sfera privata. È interessante notare che, in maniera diversa dalla privatizzazione messa in atto oggi dall’apparato digitale, questi film non erano concepiti come eventi privati. Furono l’archivio personale e collettivo di una comunità. I film emigranti si basavano inoltre su un fondamentale paradosso, in quanto erano testimonianze di viaggio particolari: travelogues in absentia, tracce turistiche per un viaggio impossibile. Il cinema stesso divenne un viaggio, il veicolo di un’esperienza negata – viaggio, per così dire, di ritorno al futuro, o al passato. Non meri sostituti o semplici duplicati di un evento, i film emigranti svolsero una funzione storico-sociale per il fatto stesso di essere dei film privati. In questo caso il cinematografo colma le distanze spazio-temporali: trasporta e mette in circolo geografie culturali, permettendo agli emigranti di essere là dove non sono più, restando però qui, dove non sono ancora inseriti. Le immagini funzionarono come spazio di memoria collettiva – ‘architettura’ condivisa – mentre gli emigrati erano in procinto di acquisire una nuova identità. Documenti di una storia culturale e veicoli per la sua transcodificazione in
un’altra cultura, i film della Dora facilitarono il processo di migrazione dei codici culturali. Lungo tutta la carriera produttiva di Elvira Notari, i suoi film continuarono a emigrare e a ottenere successo presso il pubblico italo-americano. È interessante notare che, per quello che sono riuscita a stabilire, Notari non mise mai piede a New York. Come dichiarò suo figlio, “nonostante tutti gli inviti che le fecero, preferì restare a Napoli, inviando ai suoi ammiratori solo delle belle cartoline illustrate”16. L’America circolò avanti e indietro come topos, partendo e ritornando come una rappresentazione intertestuale. Una frammentaria sequenza di un film dipinto a mano mostra il ritorno del ‘sogno americano’ nell’universo iconografico di Notari. Nel frammento, una donna suona un enorme tamburo. In maniera surreale, il tamburo serve da specchio/schermo su cui vengono costantemente proiettate e sovrimposte immagini di altre donne. A un certo punto sul tamburo appare un’iscrizione a grossi caratteri: Jazz Jazz Hop Hop Whopee! (vedi infra, p. 180) Il viaggio di Elvira Notari in America fu un viaggio dell’immaginazione, una transcodificazione. E forse fu costruito su un’intrinseca comprensione della condizione emigrante perché, in una certa misura, emigrante era la stessa Notari, sia in senso letterale che figurato. Da una piccola città come Salerno era emigrata verso una grande città come Napoli, ciò che le aveva richiesto di percorrere la distanza tra due sistemi e codici culturali piuttosto diversi. Ma, cosa ancor più importante, era emigrata in un nuovo territorio. Nella città cominciò a operare in un terreno non suo, colmando il divario tra mondo privato e pubblico: Elvira Notari, madre e moglie, divenne regista-scrittrice-produttrice di una casa di produzione, una posizione socioculturale, ancora inserita nel privato, che aveva una funzione pubblica, non scontata per una donna. In quanto pioniera del cinema, era anche una sorta di emigrante, che si avventurava su un terreno che doveva essere conquistato ed esplorato, ai confini di una nuova frontiera del linguaggio. Come nel caso del ‘sogno americano’ di Notari, la relazione tra la donna e l’emigrante implica sia l’essere autrice che l’essere spettatrice, ma il legame dovrebbe essere posto sul livello più profondo 143
dell’inconscio politico. A questo proposito, il dibattito italiano sulla differenza di genere può offrire un contributo all’articolazione dell’associazione tra donna ed emigrante suggerita dagli studi americani. Nella sua analisi del linguaggio della rappresentazione della differenza, Paola Masi ha sottolineato l’importanza della metafora dell’emigrazione per la scrittura femminile17. L’emigrazione è un topos ricorrente della stessa autorappresentazione femminile: le donne parlano spesso di sé come emigranti. La relazione tra donna ed emigrazione è stata anche discussa in termini di perpetua condizione di esilio, una maniera fluida di esistere il cui punto di partenza è una fondamentale e originaria perdita, una separazione dalla madre(lingua)18. Segnata da una lacuna, la condizione della donna quale emigrante implica l’abitare una lingua e codici stranieri – e il terreno altrui. Invitando a ulteriori ricerche, Paola Melchiori scrive: C’è troppa letteratura sul viaggio, figura dell’uomo. Molto meno sull’emigrazione, l’esilio, figura prevalentemente scelta dalle donne. […] Nell’esperienza femminile le due si confondono. Gli uomini da sempre hanno rappresentato la loro iniziazione, la propria maturazione, il proprio accesso alla vita usando l’andare, lo smarrirsi, il perdersi, la fuga. […] Ma tutti i viaggi maschili presuppongono, reale o immaginato, sognato o progettato, il ritorno. […] Per le donne non c’è l’immagine del ritorno. Abbandoni e tuffi in un’assoluta alterità, fughe da cerchi interni, senza ritorni desiderati, le caratterizzano. Migrazioni, appunto. […] Se c’è una così grande continuità tra viaggio ed emigrazione è perché nell’andarsene di una donna e nel rapporto con la ‘materia’ che si incontra nel viaggio c’è sempre anche il segno della ricerca di una terra natale. Il futuro predomina, ma è un futuro passato, quello di un oggetto immaginario19.
Superando la costruzione dell’essere donna come luogo ‘negativo’, l’esempio di Elvira Notari suggerisce modi in cui la condizione di perdita femminileemigrante può essere intesa in termini dinamici. La perdita può essere affermata come una positiva mancanza di confini e limiti. La condizione di per-
144
dita non implica necessariamente un perdere, ma significa piuttosto perdita di un dato terreno, spazio, ‘casa’, imposta al soggetto, e tensione creata da un’estensione del limite. La deterritorializzazione può essere affermata come identità mobile e ibrida. In questo senso, l’emigrazione dovrebbe essere considerata non come una condizione storica monolitica, bensì come una geografia della molteplicità. Come condizione presente tra due sistemi culturali e due linguaggi, l’emigrazione appartiene al mondo del transito, dell’intersoggettività, della topografia spaziale20. Immaginare l’identità femminile come spazio di intersoggettività21 illustra ulteriormente la relazione tra le donne e l’ emigrazione, che si dispiega sul terreno della fantasia e dell’immaginario. Compreso in questi termini come atopia, il discorso sull’emigrazione entra in una più ampia zona culturale dove la soggettività è rivelata nella sua dimensione spaziale, errante e in movimenti interattivi aperti all’alterità.
11 / Elvira Notari e la Dora Film d’America / Giuliana Bruno
Note Questo saggio elabora materiali studiati a fondo in Giuliana Bruno, Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari, La Tartaruga edizioni, Milano 1995 (ed. it. a cura di Maria Nadotti; ed. or. Streetwalking on a Ruined Map: Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari, Princeton University Press, Princeton 1993).
1
Nella documentazione ufficiale della Library of Congress di Washington sono elencati i visti di soli tre film, tuttavia non solo i giornali italo-americani, ma anche lettere e materiale pubblicitario testimoniano che molti altri furono distribuiti negli Stati Uniti. Evidentemente non tutti i film in circolazione avevano ottenuto il regolamentare visto.
2
Si veda in proposito Thomas Kessner, The Golden Door: Italian and Jewish Immigrant Mobility in New York City, 18801915, New York, Oxford University Press 1977. Sul tema delle donne immigranti, cfr. Louise C. Odencrantz, Italian women in industry: a study of conditions in New York City, Russel Sage Foundation, New York 1919; Elizabeth Ewen, Immigrant Women in the Land of Dollars: Life and Culture on the Lower East Side 1890-1925, Monthly Review Press, New York 1985.
3
Da un annuncio pubblicitario pubblicato su “Il Progesso Italo-Americano”, 9 luglio 1921.
4
5 Vedi, ad esempio, “Il Progresso Italo-Americano” dell’1 settembre 1924.
Secondo Vittorio Martinelli, questa era una pratica comune anche ad altre case di produzione napoletane.
6
7 L’espressione è di Miriam Hansen, che prende come punto di partenza il lavoro di Oskar Negt e Alexander Kluge sulla sfera pubblica e l’esperienza. Cfr. Miriam Hansen, Early Cinema: Whose Public Sphere?, “New German Critique”, n. 29, 1983, pp. 147-184; Miriam Hansen, Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film, Harvard University Press, Bambridge 1991, in cui viene ulteriormente discussa l’idea di cinema come “sfera pubblica alternativa”.
Tra i resoconti storico-sociologici su immigrazione e cinema negli Stati Uniti, si veda in particolare Roy Rosenzweig, Eight Hours for What We Will: Workers and Leisure in an Industrial City, 1870-1920, Cambridge University Press, LondonNew York 1983, soprattutto pp. 190-215. Sulle spettatrici all’interno delle comunità di immigrati, Elizabeth Ewen, City Lights: Immigrant Women and the Rise of the Movies, “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, n. 3 (supplemento), 1980, pp. 45-65; Elizabeth Ewen, Immigrant Women, cit.; Kathy Peiss, Cheap Amusements: Working Women and Leisure in Turn-of-the Century New York, Temple University Press, Philadelphia 1986.
8
Tra i primi studi sul fenomeno del pubblico degli immigrati, si vedano Robert C. Allen, Vaudeville and Film, 1895-1945: A Study in Media Interaction, Arno Press, New York 1980; Id., Motion Picture Exhibition in Manhattan: Beyond the Nick-
9
elodeon, “Cinema Journal”, n. 2, primavera 1979, pp. 2-17; Russel Merritt, Nickelodeon Theatres, 1895-1914: Building an Audience for the Movies, in Tino Balio (a cura di), The American Film Industry, University of Wisconsin Press, Madison 1976; William Everson, American Silent Film, Oxford University Press, New York 1978. Per un’analisi di questi studi, compresi quelli degli storici sociali, si veda Robert Sklar, Oh! Althusser! Historiography and the Rise of Cinema Studies, “Radical History Review”, n. 41, 1988, pp. 10-35. 10 Judith Mayne, Private Novels, Public Films, University of Georgia Press, Athens-London 1988, pp. 80-81. 11 Miriam Hansen, Babel and Babylon, cit., pp. 90-118. 12 Teresa de Lauretis, Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema, Indiana University Press, Bloomington 1984, p. 50. 13 Vittorio Martinelli, Sotto il sole di Napoli, in Gian Piero Brunetta e Davide Turconi (a cura di), Cinema & Film, vol. 1, Curcio Editore, Roma 1987, p. 368; si veda anche l’intervista a Vittorio Martinelli pubblicata su “La Repubblica” del 29 gennaio 1981, p. 16. 14 Il film è perduto, ma resta lo schema narrativo. 15 Ricerche in archivi pubblici e privati, una ricerca sul campo in centri e comunità italo-americane, e appelli attraverso reti televisive e giornali italo-americani non hanno prodotto risultati concreti. Luigi Russo, proprietario di una libreria italo americana a New York, in Mulberry Street, ha generosamente condiviso i suoi ricordi dei film di Elvira Notari, fornendo un resoconto interessantissimo dal punto di vista della storia orale. 16 Intervista a Edoardo Notari, citata in Mario Franco, Stefano Masi, Il mare, la luna, i coltelli: per una storia del cinema muto napoletano, Tullio Pironti Editore, Napoli 1988, p. 160. Notari aggiunge che “proprio lei, che aveva un caratterino terribile, ebbe sempre paura del viaggio”. 17 Paola Masi, Autoscatti: lettura della figurazione di sé nel femminismo, “DWF”, n. 1, primavera 1986, pp. 11-21. 18 Cfr. Piera Detassis, La valle delle bambole, “La luna e l’altro”, supplemento di “DWF”, n. 16, 1981. 19 Paola Melchiori, Un involucro mistico per una passione domestica, “Lapis”, n. 6, 1989, pp. 50-52. 20 Studi filosofici convalidano questa argomentazione; si vedano per esempio, Mario Perniola, Transiti: come si va dallo stesso allo stesso, Cappelli, Bologna 1985; Franco Rella, Limina. Il pensiero e le cose, Feltrinelli, Milano 1987; Rosi Braidotti, Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, Donzelli, Roma 1995 (ed. or. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, Columbia University Press, New York 1994). 21 Jessica Benjamin, A Desire of One’s Own: Psycoanalytic Feminism and Intersubjective Space, in Teresa de Lauretis (a cura di), Feminist Studies/Critical Studies, Indiana University Press, Bloomington 1986; e Jessica Benjamin, Legami d’amore. I rapporti di potere nelle relazioni amorose, Rosenberg & Sellier, Torino 1991. 145
PARTE QUARTA
FILM SALVATI E DA SALVARE
12 / Marianna De Sanctis e Céline Pozzi
Il restauro di ‘A santanotte
Il restauro di ’A santanotte (promosso dall’Associazione Orlando e dalla Cineteca Nazionale, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) è stato effettuato nel 2007 presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata di Bologna. Quanto segue vuole essere il resoconto e l’analisi del lavoro svolto.
Testimoni Benché ‘A santanotte avesse riscontrato all’epoca un discreto successo di pubblico e di critica1, sia in Italia che nelle comunità italiane d’America, sono solo due i testimoni giunti fino ai giorni nostri, a partire dai quali è stato effettuato il restauro.
CIN NAZ: Cineteca Nazionale, Roma Il primo testimone è un controtipo safety conservato presso la Cineteca Nazionale di Roma, ottenuto nel 1979 da una copia positiva nitrato oggi non più disponibile. Nello stesso anno da questo controtipo furono stampate due copie positive in bianco nero, le quali hanno rappresentato finora, in epoca recente, l’unica versione conosciuta del film. Il controtipo
di Roma non presenta lacune evidenti e conserva alcune inquadrature mancanti nel secondo testimone sopravvissuto – una copia americana, come vedremo in seguito. Le didascalie sono in lingua italiana, con cartiglio Dora Film e, insieme ai cartelli iniziali di presentazione del film e dei personaggi e ai cartelli di inizio e fine parte, sono numerate progressivamente. Le cifre sono scritte a mano, in basso a sinistra all’interno del cartiglio. Nonostante la ricchezza di informazioni che questa copia conserva (per quanto riguarda le didascalie e il montaggio), il controtipo di Roma presenta allo stesso tempo alcuni difetti estetici derivanti non solo dalle condizioni del materiale nitrato di partenza (i classici segni del tempo: restringimento del supporto, perforazioni rotte, numerose righe e graffi, l’immagine stampata del nastro adesivo applicato sulla pellicola ecc.), ma anche dai difetti di duplicazione che vi si sono aggiunti: principalmente un fastidioso doppio interlinea, causato dalla stampa alternata a contatto di un materiale ristretto, difetto tipico dei duplicati negativi prodotti negli anni Sessanta e Settanta. Il doppio interlinea è particolarmente visibile nelle didascalie poiché risulta raddoppiata la parte bassa del cartiglio con la scritta Dora Film (figura 1). A questo si aggiunge una forte instabilità dell’imma149
1. Fotogramma da CIN NAZ.
gine, effetto della duplicazione di un materiale originale ristretto e danneggiato, e un intenso flickering, difetto che era già del materiale nitrato. Nessuna informazione sulle colorazioni è stata conservata. Al di là dei difetti elencati, la qualità fotografica è buona e l’importanza principale di questo testimone sta sicuramente nella sua completezza e nel fatto che è l’unico a conservare informazioni certe sulle didascalie italiane e sul montaggio.
GEH: George Eastman House, Rochester Il secondo testimone è un duplicato negativo su supporto nitrato conservato presso la George Eastman House di Rochester. Si tratta di una recente acquisizione, risalente a circa cinque anni fa, e fa parte del150
la Ruggeri Collection, un fondo che comprende numerosi film italiani che venivano distribuiti all’estero per le comunità di emigranti2. Il controtipo GEH è la matrice dell’edizione americana e pertanto conserva tutte le preziose indicazioni originali di colorazione, montaggio e posizione delle didascalie, delle quali sono trascritte le prime parole. Inoltre conserva anche le parti che poi la censura americana avrebbe eliminato, come riportato dal visto di censura del 6 luglio 1922. Nel visto si legge che le autorità americane sollecitarono l’eliminazione delle inquadrature più esplicitamente violente del film, tanto che la motivazione è “inhuman, incite to crime” (“inumano, incita al crimine”). Nel dettaglio: “Reel 1: both scenes of father dragging Nanninella by the hair” [“Rullo 1: entrambe le scene in cui il padre trascina Nanninella tirandole i capelli”] e “Reel 5: scene of Tore threatening revenge with dagger in his hand. Scene of Nanninella stabbed lying on the steps” [Rullo 5: la scena in cui Tore minaccia di vendicarsi con il pugnale in mano. La scena in cui Nanninella, pugnalata, giace sui gradini”]. La copia conservata a Rochester è divisa in quattro rulli (reels) all’interno dei quali sono stati montati i rulletti più piccoli di lavorazione originali (rolls), comprendenti inquadrature che dovevano essere stampate con la medesima luce e sottoposte al medesimo processo di colorazione3. Nel montaggio attuale dei quattro rulli, i rolls si susseguono senza una logica apparente che non sia quella di preservarli e conservarli in rulli di lunghezza più consona agli attuali standard di lavorazione. Ciascun roll è aperto e chiuso da un codino sul quale sono indicati il titolo del film in inglese, il numero di reel, il numero di roll, una sigla per la colorazione (talvolta compare anche il nome del colore per esteso) e il numero della prima scena4 punzonato sulla pellicola. I numeri delle scene successive compaiono in altri brevi codini che si trovano all’interno dello stesso roll5. Le didascalie sono indicate anch’esse su brevi codini sui quali si trovano trascritte solo le prime parole del testo, in italiano, talvolta con errori di spelling. La copia è in buono stato di conservazione sia fisico che chimico; i problemi principali riguardano invece la sua qualità fotografica. A testimonianza del successo del film ci sono le moltissime righe stampate,
12 / Il restauro di ‘A Santanotte / Marianna De Sanctis e Céline Pozzi
Collazione delle copie
2a. Fotogramma da CIN NAZ. 2b. Fotogramma da GEH.
mentre codici presenti sul bordo della pellicola ci dicono che il negativo è composto di parti datate 1920, 1921, 1922, 1923, e alcune anche 1926. Come tutti i duplicati d’epoca, realizzati su una pellicola priva di quelle caratteristiche idonee agli elementi intermedi cui oggi siamo abituati, ha un elevato contrasto e una bassa definizione, difetti che sono maggiormente visibili nelle scene in esterni. Inoltre l’immagine presenta un forte flickering. Una volta ricostruito il montaggio originale, è stato possibile constatare che anche questa copia è sostanzialmente completa e presenta in più alcune inquadrature o parti di inquadrature assenti nella copia cin naz. Tuttavia nella maggior parte dei casi le inquadrature di geh sono leggermente più brevi di quelle della copia di Roma, nell’ordine di non più di una decina di fotogrammi.
Dall’esame dei due testimoni è risultato chiaro che provengono da uno stesso negativo ed è quindi filologicamente accettabile un’operazione di collazione per integrare tra loro le due copie (figure 2a, 2b). La copia di cin naz presenta in generale inquadrature leggermente più lunghe, ma il negativo di geh conserva alcune inquadrature assenti nella copia italiana. cin naz è il testo più utilizzato nella collazione, poiché presenta una qualità fotografica superiore e una lunghezza media delle inquadrature sempre leggermente maggiore rispetto all’altro materiale. Le integrazioni dalla copia geh sono state effettuate nei casi in cui se ne presentava la necessità. Tra le inquadrature presenti esclusivamente nella copia geh troviamo alcune scene di forte impatto drammatico: la numero 15, ad esempio, è un’inquadratura in campo lungo in cui Giuseppone ubriaco picchia sua figlia Nanninella tirandola per i capelli; mentre la numero 311 ci mostra in piano ravvicinato Nanninella a terra che si trascina agonizzante a seguito della coltellata inflittale da Carluccio. La maggior parte delle inquadrature presenti esclusivamente nella copia geh si trovano nella parte finale del film, in cui l’intensità drammatica e la crudezza delle immagini è maggiormente accentuata. Il ritrovamento dell’ultima inquadratura, numero 337, modifica di fatto la percezione del finale della storia: mentre in cin naz la mancanza di questa inquadratura lasciava supporre che la storia si concludesse con l’uccisione di Carluccio da parte di Tore, l’inquadratura 337 rinvenuta nella copia geh lascia intuire che Tore, accorgendosi della pazzia di Carluccio, rinuncia alla sua vendetta. Un dettaglio della storia che la copia di Rochester mostra più chiaramente è il passaggio di denaro da Carluccio a Giuseppone: nell’inquadratura numero 118, in geh sensibilmente più lunga, si vede chiaramente Carluccio che passa delle banconote a Giuseppone inducendolo a recarsi alla cantina dello ‘sfregiato’ per incontrare Tore, incontro che si concluderà con la morte di Giuseppone e l’arresto dello stesso Tore. È questo l’unico momento del film in cui si vede un reale passaggio di denaro mentre altrove veniamo semplicemente 151
informati dalle didascalie che è sempre Carluccio a pagare da bere durante i suoi incontri con Giuseppone. Anche nella copia di Roma ci sono tuttavia delle inquadrature assenti in geh e che possiamo raggruppare in tre blocchi. La parte iniziale di presentazione dei personaggi è completa in cin naz mentre è estremamente lacunosa nell’altra copia dove mancano totalmente le inquadrature di presentazione di Nanninella e di Tore. Le altre presentazioni sono brevissime e in pessime condizioni. La sequenza della festa di matrimonio mette in scena l’esecuzione della popolare canzone napoletana Voce ‘e notte: il film si dilunga in primi piani del cantante e degli sposi come a voler lasciare spazio all’esecuzione, in tempo reale, della canzone durante la proiezione, secondo una modalità in voga anche oltreoceano6. In questa sequenza la copia cin naz conserva ben sei inquadrature assenti in geh, mentre le restanti inquadrature comuni alle due copie sono spesso decisamente più lunghe nella copia geh. Non abbiamo gli elementi per affermare se queste differenze siano frutto di una scelta di edizione7 o di una semplice lacuna causata da perdite fortuite. Di fatto le sei inquadrature mancanti potrebbero essere state omesse volontariamente o, data la loro contiguità, potrebbero appartenere allo stesso roll, il quale potrebbe essere andato perso. Anche la lunga scena finale del film è accompagnata da una canzone, la famosa ‘A Santanotte, che dà il titolo alla pellicola. È inoltre la parte più drammatica, intensa e cruda del film, realizzata mediante un montaggio serrato. Abbiamo già analizzato le parti assenti in cin naz e presenti solo in geh, ma contestualmente la copia di Roma conserva sei inquadrature mancanti in quella Rochester. Quattro di queste inquadrature mostrano Tore che canta (299, 307, 314) e Nanninella che lo ascolta (298); le altre due (324, 330) sono primi piani di Carluccio ormai impazzito dopo aver ucciso Nanninella. In generale possiamo dire che questa lunga sequenza finale, in cui entrambe le copie sono particolarmente lacunose, è la più complessa dal punto di vista del montaggio integrativo. 152
Didascalie Le didascalie sono state restaurate a partire dagli originali presenti nella copia di Roma che fortunatamente conserva la quasi totalità dei testi originali. Il cartello “Prima parte” è stato ricostruito digitalmente a partire dal frammento dell’unico fotogramma sopravvissuto (figure 3a e 3b). Il cartello “Parte seconda” è stato ricostruito integralmente poiché quello rinvenuto nella copia era evidentemente non coevo alla prima distribuzione (figura 4). Tre sono i cartelli perduti nella copia di Roma, di cui come già detto vi è traccia nella copia di Rochester: n. 37 (“Così tutte le sere mentre Napoli dorme nel”), n. 38 (“Quanto dolore mi costerà questa felicità”) e n. 95 (“Il giorno
3a. Cartello originale di fine parte come si trova sulla copia Cin Naz. 3b. Ricostruzione digitale dello stesso cartello.
12 / Il restauro di ‘A Santanotte / Marianna De Sanctis e Céline Pozzi
negativo geh due flash titles negativi, su pellicola Kodak, con testo bilingue in italiano e inglese, senza nessun cartiglio o scritta Dora Film, che corrispondono alle didascalie n. 22 e n. 86 della copia cin naz (figura 5). Naturalmente, avendo scelto di utilizzare le didascalie italiane complete, non abbiamo tenuto conto dei due flash titles in questo restauro. Sono però un’altra chiara indicazione della tipologia di pubblico italo-americano cui si rivolgeva la distribuzione Dora in America.
4. Cartello di Parte seconda presente nella copia CIN NAZ.
dopo Gennariello”). In geh la posizione delle didascalie è indicata da un pezzo di coda opaca su cui sono scritte a mano le prime parole di ogni didascalia. In questi casi si è dunque preferito adottare una soluzione neutra, utilizzando sempre lo stesso font, ma senza il cartiglio, e aggiungendo dei puntini fra parentesi quadre a indicare che il testo non è completo. È stato però inserito il numero progressivo che compare in basso a sinistra all’interno del cartiglio di ogni didascalia; essendo queste tre le uniche didascalie mancanti non vi erano dubbi sul numero da attribuire, visto che tutte le didascalie, compresi i cartelli di inizio e fine parte, e tutti i cartelli di cast and credits all’inizio del film, sono numerate. Due didascalie sono state probabilmente aggiunte dopo che la lista completa era stata numerata, dal momento che riportano un numero ripetuto con asterisco: la n. 95* (“Trova il mezzo di evadere, quest’arma può servirti a qualcosa... Nanninella sposa stasera Carluccio per strappargli la confessione della tua innocenza; salvala, ne morirà!”) e la n. 96* (“Tore non ha potuto evadere, povera Nanninella!”). In questo caso, singolarmente, due didascalie che avrebbero potuto essere censurate, dato che esplicitano il delitto d’evasione e di possibile omicidio o ferimento di una guardia carceraria, vengono invece reintrodotte. Ultimo appunto, ma non meno importante, per quanto riguarda le didascalie. Erano presenti nel
Il restauro dell’immagine Il restauro dell’immagine ha avuto principalmente due obiettivi: la correzione dei difetti insiti in ciascuna copia e l’omogeneizzazione delle due copie. Entrambi gli obiettivi sono stati perseguiti sia nella prima fase di duplicazione fotochimica, che nella seconda fase di restauro digitale. Per quanto possibile si è cercato di rimediare alla scarsa qualità dell’immagine propria di entrambe le copie e si è lavorato per attenuare le differenze fotografiche tra immagini provenienti da fonti qualitativamente diverse. Il restauro di ‘A santanotte rappresenta un valido esempio di integrazione fra procedimento fotochimico e digitale, poiché entrambi i sistemi hanno permesso di risolvere alcuni problemi legati alla natura dei materiali originali. Innanzitutto abbiamo riparato e duplicato il negativo nitrato di Rochester. Trattandosi di una pellicola nitrato, non era opportuno passarla direttamente allo scanner: poiché gli scanner, come tutti gli strumenti pensati per la lavorazione di film contemporanei, non sono mezzi idonei ad accogliere materiale d’archivio. Il rischio fisico per la pellicola è rappresentato dal funzionamento a pin register, che non ha margine di adattamento a materiali non standard; peraltro la necessità di mantenere la lettura ottica del ccd a una determinata distanza fissa non permette di correggere i difetti di posizione dell’interlinea. Inoltre intendevamo produrre un elemento di conservazione e da vari test effettuati sul negativo di Roma è risultato che lo scanner avrebbe continuato a riprodurre i difetti originali della copia. 153
5. Dascalia bilingue presente nella copia GEH.
Abbiamo quindi deciso di stampare un controtipo positivo con stampatrice ottica alternata e sotto-liquido, che ci ha permesso di risolvere il problema dell’ampia variazione di posizione dell’interlinea e di bilanciare la qualità fotografica del materiale in vista delle lavorazioni digitali che avrebbe subito. Inoltre le didascalie sono state stampate a parte, operando uno zoom out maggiore per permettere poi al software di restauro digitale di stabilizzarle, raddrizzarle e pulirle dal doppio interlinea che ha sdoppiato la parte finale del cartiglio, senza perdere informazioni all’interno dello stesso fotogramma. Abbiamo poi scansionato entrambi gli interpositivi in risoluzione 2K (2048x1556). Il film è stato montato e dopo un primo passaggio di color correction digitale, utile soprattutto per omogeneizzare i due diversi materiali, il film è stato stabilizzato e pulito. Il lavoro più complesso è stato quello sulle didascalie. Come già accennato, queste si presentavano con un doppio interlinea prevalentemente nella parte inferiore, che sdoppiava il cartiglio Dora-Film creando un fastidioso e continuo sfarfallio della scritta e della parte inferiore del cartiglio. Erano inoltre molto instabili ed essendo anche in alcuni casi storte obliquamente il cartiglio arrivava al limite estremo del fotogramma. Per poterle stabilizzare senza tagliare il fotogramma, dopo averle raddrizzate, c’era bisogno di ampio margine (che avevamo appositamente guadagnato con uno zoom out in fase di 154
stampa), perché il software modifica la posizione di ogni singolo fotogramma per allinearli e questo crea un bordo nero in movimento che si elimina con lo zoom o coprendo l’area del movimento visibile. Una volta stabilizzate le didascalie, si è potuto procedere a ripulire una singola scritta “Dora Film” per didascalia e a copiarla sugli altri fotogrammi, senza che risultasse muoversi diversamente dal resto del fotogramma. In questa maniera abbiamo evitato un tipico artefatto digitale come l’effetto ‘puzzle animato’, ma non siamo state costrette a ricostruire da zero digitalmente tutte le didascalie, potendo utilizzare tutte quelle preesistenti. Per quanto riguarda il digital cleaning in generale, si è cercato si eliminare le spuntinature, residui di colla, emulsione mancante (figure 6a e 6b), strappi residui di nastro adesivo, tracce di riparazioni e altri difetti evidenti della pellicola. Non siamo invece intervenute pesantemente sulle righe, essendo queste in numero tale da costituire una sorta di continuità di immagine del film. Toglierle tutte sarebbe stato impossibile, perché avrebbe creato una superficie completamente artefatta. Toglierne alcune è inutile, perché lo spettatore non vede il prima e il dopo e in digitale lo ‘strato’ di sporco che viene tolto porta in evidenza lo strato successivo che prima era dissimulato. È necessario quindi decidere che tipo di aspetto omogeneo mantenere anche negli interventi di pulizia. In questo caso avevamo a che fare con materiali molto usurati dal tempo, ma le tracce di quest’usura rimangono a testimonianza della storia della copia; la visione è stata tuttavia alleggerita delle tracce più pesanti estranee all’immagine e la cui eliminazione non ha compromesso l’integrità del film. Tramite il film recording è stato poi prodotto un nuovo controtipo su pellicola bianco e nero della versione restaurata, da cui ottenere copie colorate secondo il metodo Desmet. Paradossalmente, oggigiorno lavorare con il bianco e nero in film recording è più problematico che con il colore, poiché le macchine più avanzate non sono mai pensate per lavorare con materiali ‘arcaici’, ma sono invece perfettamente tarate per la produzione cinematografica contemporanea e per la tipologia di pellicola che meglio vi si adatta. Aver lavorato in b/n, quindi, non è affatto scontato. La maggior parte dei laboratori
12 / Il restauro di ‘A Santanotte / Marianna De Sanctis e Céline Pozzi
stampa su internegativo, ma si tratta di un materiale non adatto alla conservazione a lungo termine, data la maggiore instabilità dell’emulsione colore. Lo standard del film muto così come arriva a noi oggi è quanto di più lontano possa essere concepito dai tecnici contemporanei, perché il film del secolo scorso porta con sé una serie di difetti che la lavorazione digitale si sforza di eliminare. Quando questi difetti rappresentano però anche l’estetica di un film di un’altra epoca, di un’altra tecnologia, bisogna adeguare lo standard e inventarne uno nuovo ogni volta. Quando invece il supporto finale di destinazione è il video, all’Immagine Ritrovata si è proceduto tramite quello che è stato chiamato metodo ‘Desmet video’, ovvero all’immagine in bianco e nero del file restaurato si applicano dei filtri colore desunti, tramite conversione dei valori utilizzati in fotochimico per il Desmet color in valore RGB. Dopo questa applicazione di colore si rende infine necessaria una seconda fase di color correction per la bilanciatura dei neri.
Colore Non essendo sopravvissuta alcuna copia positiva, le uniche informazioni sul colore sono contenute nelle indicazioni scritte a mano sulle code dei rolls della copia geh, a partire dalle quali si è cercato di ricostruire il colore basandosi su esempi di film coevi e cataloghi di colorazione. 6a. Fotogramma danneggiato. Come già detto, nessuna copia positiva 6b. Lo stesso fotogramma ricostruito digitalmente. colorata di ‘A santanotte è giunta fino a noi. E non sono sopravvissute nemmeto di frammenti di film della Notari, assemblati dal no copie originali colorate di altri film della Notari. I figlio Eduardo Notari, che lo utilizzava come showmateriali presenti in Italia di film della regista sono: reel in retrospettive dedicate al cinema napoletano Dduje paravise (Elvira Notari, Dora Film, Napoli (figura 7). Il film è noto anche con il titolo Napoli, 1927), depositato presso la Cineteca di Bologna con sirena delle canzoni, perché formato da spezzoni il titolo Gennariello, copia positiva safety, stampata ispirati a famose canzoni napoletane. Anche questo all’inizio degli anni Ottanta a partire da un rullo nitra155
nitrato però è andato perduto8. Gli altri film reperibili della Notari si trovano tutti depositati presso la Cineteca Nazionale. Si tratta sempre di copie safety. Oltre al controtipo negativo di ’A santanotte, la Cineteca conserva L’Italia s’è desta (1927)9, un triacetato colore, come Gennariello, e Fantasia ‘e surdate (1927), un triacetato bianco e nero10. Le copie colore safety conservano naturalmente la ricchezza e la complessità delle splendide colorazioni pochoir per cui la Dora Film era famosa, ma non sono un riferimento affidabile per quanto riguarda imbibizioni ed eventuali viraggi. Fortunatamente il negativo di Rochester riporta delle indicazioni colore. Si tratta quindi di una ricostruzione ipotetica delle colorazioni che sarebbero state presenti nell’edizione americana. Per quanto riguarda la scelta dei valori di colore, ci siamo basate sulla nostra esperienza e sui documenti che consultiamo normalmente. In mancanza di un positivo di riferimento, abbiamo inizialmente identificato i colori attraverso il loro nome sui campionari colore raccolti nel testo Tutti i colori del mondo11, in primo luogo per avere un’idea della differenza di tonalità fra il colore pieno e la sua versione chiara, come nel caso del verde e del blu. Stabiliti i nostri riferimenti cartacei abbiamo poi cercato corrispondenze sia con i colori di film coevi, sia nel nostro database di colori relativi a film italiani dei primi anni Venti. Ad esempio abbiamo tenuto conto delle colorazioni rintracciate nei coevi e coloratissimi Umanità (Elvira Giallanella, Liana Film, Roma 1919)12 e Leonardo Da Vinci (Mario Corsi e Giulia Cassini Rizzotto, Historica Film, 1919)13. Abbiamo poi potuto consultare alcuni positivi nitrato di film napoletani, depositati presso la Cineteca Nazionale, che condividono con ‘A santanotte, oltre al luogo e al periodo di produzione, anche una parte del cast. Si tratta in particolare di tre film di Ubaldo Maria del Colle: I figli di nessuno (1921), Carnevale tragico (1924) e Piango per te (1925). Come risulta evidente dai fotogrammi che riproduciamo qui a lato, è riconoscibile uno stile comune di rappresentazione degli ambienti popolari e dei personaggi, come negli intensi primi piani dell’eroina, nella figura della madre sofferente per i destini avversi dei figli (figure 8, 9 e 10). 156
7. Fotogramma dalla copia safety di Gennariello.
Ma non si tratta di una continuità solo ‘narrativa’: anche dal punto di vista tecnico ci furono chiaramente diversi contatti fra realtà produttive più o meno sviluppate. Come per la colorazione dei film i Notari erano un punto di riferimento in tutta Napoli, così quando iniziarono a realizzare film in proprio si avvalsero dei laboratori della Vesuvio Film14 prima di spostarsi nel proprio laboratorio nel 1912. Sappiamo da numerose recensioni quanto fossero accese le colorazioni dei film napoletani. Lo storico Roberto Paolella scrive di “bizzarre imbibizioni all’inchiostro viola e rosso cocomero”. E non facciamo fatica ad immaginare questi rossi accesi nelle ultime inqua-
8. Fotogramma da Carnevale tragico: Elisa Cava, che in ’A santanotte interpreta Maria, madre di Tore.
12 / Il restauro di ‘A Santanotte / Marianna De Sanctis e Céline Pozzi
Tabella delle colorazioni utilizzate nel restauro di ‘A Santanotte
Colore Blu Blu chiaro Verde Verde chiaro Rosa Ambra chiaro
RGB 50 25 00 25 15 00 40 00 20 25 00 10 00 25 05 00 05 15
Riferimento I figli di nessuno Catalogo Pathé Maciste innamorato Piango per te Cataloghi Pathé Carnevale tragico
9. Fotogramma da I figli di nessuno.
drature di ‘A santanotte, da una recensione citata da Giuliana Bruno nel suo libro, si parla di “emozionante dramma in cui sboccia, rosso di sangue, il fiore della passione”15. È vero che le colorazioni segnalate sui codini americani sono colorazioni abbastanza ‘banali’, ma erano comunque pensate per una platea di italo-americani e non per un pubblico strettamente italiano abituato a tinte aggressive. Riportiamo in tabella un riassunto delle colorazioni utilizzate nel restauro di ‘A santanotte, con i rispettivi valori Desmet Color attribuiti, sempre suscettibili di piccole correzioni di scena in scena.
Regista Ubaldo Maria Del Colle
Produzione Lombardo Film
Anno 1921
Romano Borgnetto Ubaldo Maria del Colle
Itala Film Any film
1921 1925
Ubaldo Maria del Colle
Any film
1924
colore indicato perché, in mancanza di una controprova, dal punto di vista narrativo, il blu è credibile. Dalle scene precedenti, esterni colorati in blu, sappiamo che è sera. Nanninella ha deciso di sacrificarsi sposando Carluccio per scoprire la verità e si reca da Maria per comunicarglielo. L’anziana madre è seduta da sola in cucina, con aria affranta. Nanninella entra e le due donne si fanno coraggio. Perché accendere la luce in una situazione di tale tristezza? Il colore ambra torna nell’inquadratura successiva, solo quando i vicini, saputa la notizia del matrimonio di Nanninella, vanno a trovare Maria per il gusto sadico di vedere la sua reazione a una tale notizia. Maria fa nascondere Nanninella e poi li accoglie. Gli ospiti non si accolgono al buio, mostrandosi tristi, specialmente quando sono malelingue venute per sparlare. Ecco che quindi ricompare la luce e torna il colore ambra.
Un luogo critico della colorazione Nella copia di Rochester, le inquadrature 186 e 187 erano segnalate come colorate in blu, anche se si tratta di due interni. Abbiamo deciso di lasciare il
10. Fotogramma da Carnevale tragico. È riconoscibile Alberto Danza, che in ’A santanotte interpreta Tore. 157
Note 1 “‘A santanotte fu uno dei grossi successi dell’editrice napoletana Dora-film. Una corrispondenza da Palermo apparsa nel n. 4 di “La rivista cinematografica” (febbraio 1923) lo conferma: “si è avuta, a richiesta generale, una ripresa di ‘A Santa notte della Notari, girata dalla Dora-film di Napoli. Crediamo doveroso rilevare che questo film ha tenuto il cartello per più di un mese, il che vale quanto dire che ha in sé tutti i requisiti necessari a suggestionare e soggiogare gli spettatori”. Vittorio Martinelli, Bianco e Nero. Il cinema muto italiano 1922-1923, Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma 1996, p. 134.
Informazione gentilmente fornitaci da Kim Tomadjoglou dell’American Film Institute, che ha fornito una consulenza preziosa ai fini del restauro.
2
All’epoca i negativi venivano assemblati secondo esigenze di lavorazione, erano poi le copie positive a essere montate secondo l’ordine narrativo: “Nel periodo muto spesso il negativo non era montato a formare un roll completo, ma suddiviso in gruppi di scene che richiedevano la stessa colorazione, per imbibizione o viraggio. Il film veniva infine montato copia per copia”. Paul Read, Mark-Paul Meyer, Restoration of Motion Picture Film, Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, p. 37. Si legge inoltre in un manuale d’epoca: “Il negativo [...] viene ordinato dalla persona preposta al montaggio, e passato alla stampa. Per ordinare si tiene conto dei numeri con i quali l’operatore ha contrassegnato il negativo e di quelli secondo i quali si susseguono le scene e i titoli, notando le luci necessarie per la stampa, suggerite dall’operatore. In apposita tabella sono riunite le disposizioni d’ordinamento e misura del negativo e di stampa, viraggio e tintura del positivo”. Vittorio Mariani, Guida pratica della cinematografia, Hoepli, Milano 1916, p. 151. Da notare, inoltre, che i rolls non potevano superare una certa lunghezza, per motivi tecnici legati all’ampiezza dei telai impiegati nelle varie fasi di sviluppo e colorazione: “Tale Telaio si compone di due montanti [...] collegati da sbarre trasversali [...] e dalle sbarre di avvolgimento [...] sulle quali il film viene disposto e tenuto teso. Allo scopo di non far accavallare il film, dette sbarre sono divise da puntine di legno o metallo in spazi larghi su per giù quanto il film. Ogni telaio così costruito contiene da 40 a 45 metri di film”. V. Mariani, op. cit., p. 173. 3
Per scena intendiamo in questo caso un blocco di una o più inquadrature consecutive e dello stesso colore.
4
Su alcune delle code principali sono presenti ulteriori codici che però, nell’impossibilità di interpretarli correttamente sulla base dei pochi dati reperibili, non è stato possibile utilizzare nel restauro. In sei casi compare infatti la scritta “Marmorino” seguita da un codice a cinque cifre di tre tipi diversi. Nel dettaglio: scena 2, roll 22, colore green, esterno, primo dialogo fra Nanninella e Tore alla finestra, codice 18850. Scena 15,
5
158
reel 3, roll 5, colore light blue, interno, dialogo fra Gennariello e la madre di Tore. Scena 17, roll 1, colore blue, esterno, Gennariello ai cancelli del carcere, codice 29463. Scena 18, roll 3, colore blue, interno, Nanninella a casa della madre di Tore, codice 29463. Scena 19, presentazione Carluccio, codice 29464. Scena 20, roll 2, colore blue, presentazione di Giuseppone, codice 29463. “Come altri emigranti, i film emigranti di Elvira Notari viaggiarono per mare, spesso accompagnati dai cantanti che dovevano eseguire dal vivo la colonna sonora delle sceneggiate”. Giuliana Bruno, Rovine con vista, La Tartaruga edizioni, Milano 1995, p. 132.
6
“I film di Notari [...] venivano spesso presentati al pubblico simultaneamente in diverse versioni e ri-presentati in differenti edizioni, di solito per ragioni di censura.” Giuliana Bruno, op. cit., p. 166.
7
Informazioni ottenute durante una conversazione con Vittorio Martinelli. La copia safety apparteneva all’Airsc ed è stata poi depositata dallo stesso Martinelli presso l’Archivio della Cineteca di Bologna.
8
9 L’Italia s’è desta (Elvira Notari, 1927), identificazione in corso, positivo, colore, triacetato. 10 Fantasia ’e surdate (Elvira Notari, Dora Film, 1927), positivo, bianco e nero, safety. La Cineteca Nazionale conserva anche il controtipo negativo da cui questa copia proviene. 11 AA.VV., Tutti i colori del mondo, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 1998, pp. 172-179.
In particolare per le imbibizioni ambra e tre tonalità diverse di verde. 12
13
In particolare per le imbibizioni giallo/ambra e blu.
“Nel 1911, quando cominciarono a realizzare film narrativi, i Notari [...] presero ad usare lo studio e il laboratorio di Gennaro Righelli che era a capo della Vesuvio Films.” Giuliana Bruno, op. cit., p. 348. 14
15
Giuliana Bruno, op. cit., p. 51.
13 / Micaela Veronesi
Una donna vuol ‘rifare il mondo’ Umanità di Elvira Giallanella
Il professore: E cos’è che fanno, gli uomini? Marina: Gli uomini fanno la guerra. La guerra è nella natura umana. Il professore: Verità implacabile. E le donne cosa fanno? Marina: La stessa cosa degli uomini. Il professore: E anche lei fa la guerra? Marina: La facciamo tutti, professore1.
La riscoperta di un film come Umanità2 di Elvira Giallanella, oltre che un evento importante per gli studi sul cinema muto italiano, è sicuramente anche uno spunto per riflettere sulla soggettività femminile in generale e sulla sua specificità nella storia italiana del primo Novecento. In particolare questo film apre due questioni. La prima, più ampia, è direttamente connessa alla soggettività femminile, e riguarda il pacifismo come peculiarità delle donne, all’insegna di una presunta dicotomia fra donne pacifiste e uomini militaristi. Si tratta in realtà di equilibri piuttosto complessi, che vanno collocati anche alla luce della situazione culturale in cui si trovano le donne italiane in quel periodo storico. La seconda questione riguarda la stessa autrice di Umanità, della quale
Umanità, 1919 (CSC - Cineteca Nazionale)
sappiamo davvero poco, sia in termini di biografia che di carriera professionale, e quel poco, per la maggior parte, è dedotto dalla visione del suo film, che restituisce una personalità enigmatica, non lineare e superficialmente incoerente. 159
160
13 / Una donna vuol ‘rifare il mondo’ / Micaela Veronesi
Le donne e il pacifismo Esiste in effetti una tradizione pacifista femminile, che dobbiamo tuttavia legare al contesto sociale in cui si muovono le donne prima, durante e subito dopo la Prima guerra mondiale. “Alla fine del XIX secolo non vi fu associazione femminile che non esaltasse i valori eterni della pace, dell’armonia e della sicurezza, della vita contro la morte ecc.3”. Nel congresso internazionale dell’Aja del 1907, “le donne riconobbero nel pacifismo la loro ‘naturale’ politica, vista la loro condizione biologica di generatrici di vita”4. In questo periodo la donna è un’entità fragile sia come individuo sia come soggetto sociale, non ha diritti ma solo doveri, è considerata solo per le sue virtù materne, sul lavoro è pagata meno di un uomo a parità di mansioni e sovente è vessata da avances sessuali. È spesso relegata in luoghi e cliché che la pretendono bella, elegante, vezzosa, affabile… Cliché accettati dalle donne stesse soprattutto nell’ambiente borghese, nel quale prende forma la cultura di massa. L’ideale di donna maggiormente diffuso è più che altro legato a concezioni maschili: una donna che sa stare al suo posto, che è poi soprattutto la casa, nella quale l’uomo può trovare rifugio, consolazione, cura, senza essere disturbato nelle sue attività5. A questa donna/cliché si contrappone la “donna nuova” secondo il termine coniato da Sarah Grand nel 18946, una donna che non è né madre, né prostituta, che sa essere critica nei confronti del matrimonio, che ha bisogno di affermarsi nell’attività produttiva e intellettuale. Inoltre, a partire dalla metà dell’Ottocento si sono imposti e hanno fatto parlare di sé anche i movimenti femminili per il diritto di voto. Questi movimenti e i relativi dibattiti portano l’attenzione su numerose questioni fino a quel momento relegate alla sfera privata: prima ancora che sul diritto di voto, si dibatte sulla parità e l’eguaglianza e – specularmente – sulle diverse specificità attribuite al sesso femminile7. Sulle donne pesano luoghi comuni e stereotipi assai radicati, come le credenze legate alla loro minore intelligenza e quelle che emergono nella sfera degli studi antropologici, prima fra tutte quella relativa all’isteria femminile, a cui è direttamente colle-
gata la convinzione che vuole le donne più “rissose e facilmente suscettibili”8. In alcuni casi, come negli studi sulla folla di Gustave Le Bon9, si arriva persino ad affermare che le masse che caratterizzano la vita delle città moderne mostrano caratteristiche “specificatamente femminili” come: credulità, irrazionalità e instabilità emozionale10. Non appena iniziamo a interrogarci sulle donne del primo Novecento e sulla loro reale o presunta predisposizione al pacifismo, ci troviamo di fronte a infinite sfaccettature e opinioni differenti, quando non opposte e in contraddizione tra loro. Certo è che le donne nuove di questo inizio secolo, oltre a organizzarsi in movimenti per il suffragio, per i diritti politici e giuridici, si riuniscono in movimenti pacifisti. In Italia troviamo organizzazioni come la Società per il Lavoro delle Donne e l’Associazione per le Donne, entrambe costituite nel 1890, che cercano di secolarizzare l’istruzione per le donne, di agevolare la presa di coscienza dei loro diritti e di sensibilizzarle alle questioni pacifiste11. “Agli inizi del ventesimo secolo il pacifismo era una forma di partecipazione femminile, con base popolare, alla sfera pubblica. Inoltre il pacifismo era associato alle cosiddette qualità femminili, il desiderio di nutrire e di proteggere la vita”12. Bertha von Suttner pubblica in questi anni il romanzo Abbasso le armi!13, che a partire dal 1905 viene tradotto in una dozzina di lingue e che “contribuì a far aderire il popolo femminile alla causa del pacifismo”14. Forse proprio a causa del suo dilagare fra le donne, il pacifismo fu visto da molti uomini come un fatto eccessivamente idealistico e ineluttabile, non consono alla coscienza maschile che doveva farsi carico della difficile situazione internazionale. Alle soglie della guerra, tutta l’Europa è percorsa da fermenti femministi e da gruppi organizzati di donne che si muovono per ottenere il riconoscimento dei loro diritti, ma la crisi politica e il rapido propagarsi del conflitto bloccano tutto: come ha scritto Françoise Thébaud, “il 1914 avrebbe potuto essere l’anno delle donne, fu invece l’anno della guerra che riporta ogni sesso al suo posto”15. La guerra pare portare una sorta di parità tra i sessi. Gli uomini partono per il fronte e alle donne resta il compito di prendersi cura del lavoro, della casa, 161
dell’assistenza a bambini e soldati. Da un lato il conflitto ristabilisce l’ordine sociale tanto auspicato dai movimenti antifemministi, dall’altro però lascia spazio alle donne, permettendo loro di accedere a quei ruoli che fino a quel momento erano stati di esclusiva pertinenza maschile, soprattutto nel mondo del lavoro. La guerra è per le donne un’occasione di emancipazione; è incontestabile, scrive ancora Thébaud, che essa abbia costituito per le donne un’esperienza senza precedenti di libertà e responsabilità. […] La guerra per necessità infrange le barriere che dividevano rigidamente i lavori maschili da quelli femminili, precludendo alle donne molte professioni […]. Ovunque le mansioni affidate a donne (caffè, hotel, banche, commercio, uffici amministrativi) rendono le donne visibili nello spazio pubblico, facendo apprezzare le loro qualità di onestà e precisione. […] La maggior parte delle lavoratrici prendono coscienza delle proprie capacità e apprezzano la nuova indipendenza economica16.
In Italia l’esperienza delle donne durante il conflitto presenta aspetti addirittura rivoluzionari, perché intacca alla radice la tradizionale identità femminile. Nelle campagne francesi e italiane […] le donne arano, seminano, falciano, irrorano col rame i vigneti; scoprono la solidarietà tra vicine, si barcamenano con la pubblica amministrazione, giungono persino, in Piemonte, a nascondere giovani disertori17.
Ma la Grande Guerra è anche un’infinita sequenza di lutti, e anche se molte femministe sono interventiste – fino al punto di sospendere in alcuni casi le rivendicazioni, per dare tutto il loro sostegno alla chiamata alle armi (soprattutto in Inghilterra e in Francia) –, l’avanzare del conflitto ne palesa sempre più l’assurdità e la crudeltà. L’orrenda carneficina sul fronte si riflette sullo stato d’animo delle migliaia di donne che perdono figli, mariti, fidanzati, padri e, con loro, anche molte speranze e possibilità di sostentamento. In Italia molte donne, memori dell’esperienza disastrosa della guerra di Libia del 1911 e del lutto per la perdita di figli e mariti, si schierano contro e gridano “pane e pace” nelle strade. Nel 1915, 162
appare sull’“Avanti!” l’appello del Comitato Internazionale delle Donne Socialiste, che vuole sensibilizzare le donne proletarie contro la guerra e ne sottolinea l’inutile violenza e crudeltà; ma su altre testate, come “La Donna”, il fermento interventista frena la memoria della tradizione pacifista femminile, così che nella primavera del 1915 la rivista arriva persino a sconsigliare vivamente le lettrici di aderire al congresso per la pace convocato dalle donne olandesi18. Occorre quindi tener conto del fatto che, anche se il pacifismo non precludeva necessariamente il patriottismo, molte donne che si definirono e si sentirono veramente patriote ritennero di dover esprimere il proprio senso della patria preparandosi e accettando la guerra19. Sfaccettata e contraddittoria, la storia delle donne è soprattutto una storia di soggettività diverse, tanto limitata è stata per molti anni anche l’autocoscienza e la possibilità effettiva delle donne di essere intellettualmente autonome. Per questo è difficile generalizzare e trovare percorsi univoci. È semplicistico definire il femminile più propenso alla pace del maschile; possiamo parlare tuttavia di un distacco delle donne dal dogmatismo della politica e di una visione più ampia dei conflitti. Ecco dunque perché può essere oggi interessante indagare la storia di Elvira Giallanella, perché significa provare a districare un poco l’enigma della soggettività femminile e imparare a conoscere meglio le nostre antenate e noi stesse.
L’enigma di Elvira Umanità fu girato subito dopo la Prima guerra mondiale. Il film risente della guerra come esperienza tragica e catastrofica, ma è anche il tentativo di superare il trauma per guardare al futuro senza paura. Il film presenta però anche alcune contraddizioni. Prima fra tutte, l’anomalo incontro fra Giallanella, Golia e Bravetta. Il soggetto è tratto dal racconto Tranquillino dopo la guerra vuol creare il mondo… nuovo, un testo in rima per ragazzi scritto da Vittorio Emanuele Bravet-
13 / Una donna vuol ‘rifare il mondo’ / Micaela Veronesi
Fotogrammi da Umanità: nel terzo in basso, il ‘teatro della guerra’ immaginato da Elvira Giallanella (CSC - Cineteca Nazionale)
ta e illustrato da Golia, pubblicato nel 1915. In questi anni Bravetta lavora anche come soggettista per il cinema (fu tra l’altro a capo dell’ufficio soggetti dell’Ambrosio), ma è noto soprattutto come poeta e scrittore di romanzi storici e popolari. Non è nuovo a lavori per l’infanzia e in particolare ha già prodotto, nel 1914, un altro testo ambientato durante il conflitto, Pentolino e la grrrande guerra, anche questo illustrato da Golia. Bravetta è un personaggio discutibile, maschilista, interventista – aderirà al fascismo –, ma da queste sue opere in versi si evince quanto fosse importante per lui affermare che i bambini non dovessero essere coinvolti nelle atrocità della guerra. Golia è a sua volta un famoso illustratore umoristico, amico di Guido Gozzano. Nel 1914 fonda con Caimi (direttore di “La Donna”) il settimanale satirico “Numero” e collabora con le principali testate umoristiche dell’epoca. Fra tutti, la più sconosciuta è proprio Elvira Giallanella, regista, sceneggiatrice e produttrice del film. Le poche e frammentarie informazioni su di lei provengono esclusivamente da fonti pubblicistiche d’epoca, dalle quali è possibile ricostruire solo un piccolo tratto del suo percorso professionale. Queste notizie possono suggerire alcune ipotesi, che tuttavia restano per lo più supposizioni e contribuiscono soltanto ad accrescere il mistero. Alla fine del 1919 Elvira Giallanella fonda a Milano la Liana Films, con l’intento di “realizzare film per bambini in cui i bambini stessi fossero protagonisti”20. Altre notizie relative al periodo precedente la individuano come responsabile per le vendite presso la Vera Film di Roma21. Da articoli apparsi sulle riviste di settore nel periodo compreso tra il settembre 1919 e il marzo 1920 si apprende che, dopo aver venduto la sua quota della Vera Film ad Aldo Molinari, Elvira si trasferisce a Milano per mettersi in proprio, con il progetto di realizzare un film tratto da Tranquillino dopo la guerra vuol creare il mondo... nuovo, mantenendo lo stesso titolo del poema di Bravetta. Ma che cosa accada esattamente a Milano non è chiaro. Si può supporre che nel capoluogo lombardo Elvira abbia delle conoscenze: è infatti certo un suo legame professionale con un distributore milanese fin dai tempi della Vera Film. Alcuni film della Casa (nello specifico Maria di Magdala e Saffo) erano infatti sta163
Umanità (CSC - Cineteca Nazionale)
ti acquistati per la vendita dal Monopolio Principe, un concessionario di cui si trovano tracce sparse sulle principali riviste d’epoca tra il 1918 e il 1922, e il cui titolare, un certo Pasquale Principe, risulta proprietario anche della Mercurio Film, nonché di un’etichetta dal nome inequivocabile: f.u.s.e. ovvero ‘Films Umoristiche Satirico Educative’, marchio che compare anche nei titoli di Umanità, e dunque un nome su cui dovremo tornare tra poco. La rivista “Film” fornisce altre due notizie circa l’attività di Giallanella: nel numero 37 del 29 novembre 1919 si annuncia l’uscita di Tranquillino, ma si accenna anche a un secondo film, Tomba nuziale, a proposito del quale si citano spettacolari scenografie, descrivendo addirittura alcuni esempi. Si sottolinea inoltre l’interesse della produttrice per le questioni educative: Elvira Giallanella s’è interessata vivamente a tutti i problemi di psicologia infantile, e s’è convinta che è una necessità pedagogica offrire a questi uno spettacolo cinematografico che non può essere quello per adulti e che dei bambini aiuti a formare il carattere e lo spirito pur divertendoli con episodi che essi possano intendere e che prediligano22. 164
Ancora in “Film”, qualche mese più tardi, si legge che è imminente la pubblicazione del primo lavoro della nuova Casa editrice milanese, sorta “per iniziativa e volere di una donna assai nota negli ambienti cinematografici per serietà e fermezza nei propositi, la signorina Elvira Giallanella”23. Nell’articolo si afferma anche che Elvira ha dovuto interrompere il suo lavoro a causa di una malattia ma che, ormai completamente guarita, partirà per il Carso per le riprese di Tranquillino, con una piccola troupe fatta per lo più di bambini e coadiuvata dall’operatore Sestilio Morescanti. Tuttavia le cose non sembrano andare secondo i piani di Elvira. Su “La rivista cinematografica” dell’aprile 1920 si annuncia che la Monopolio Principe curerà sotto l’etichetta f.u.s.e. l’edizione di una serie di film “umoristici educativi” basati sulla figura di Tranquillino, definito come “un piccolo gamin che dopo la guerra vuol creare il mondo nuovo”. Anche “Film” del primo aprile 1920 dedica una pagina pubblicitaria all’uscita di Tranquillino, “primo film della serie f.u.s.e.”. Sia nel flano, sia nella breve notizia apparsa su “La rivista cinematografica” si danno i nomi degli interpreti: un bambino di quattro anni, Léon Bombouchée (Tranquillino), e una bimba
Tavola dal volume Tranquillino dopo la guerra vuol creare il mondo... nuovo, 1915
13 / Una donna vuol ‘rifare il mondo’ / Micaela Veronesi
di tre anni, Ivonne Leroux (Sirenetta); si sottolinea inoltre che accanto a loro ci saranno “leoni, elefanti, foche, scimmie, cani, gatti e pecore ammaestrate”. In entrambe le fonti, il nome del regista è quello improbabile di un certo Edmond Davidson, probabilmente uno pseudonimo, mentre l’operatore risulta sempre essere Sestilio Morescanti, unica costante rispetto alle notizie dei mesi precedenti. Si nomina inoltre l’autore del soggetto, ma con il nome errato di Carlo Bravetta. Elvira Giallanella è sparita, così come la Liana Films. Lo stesso nome di Bravetta è storpiato e nomi improbabili sono attribuiti al regista e al bambino che interpreta Tranquillino. Va sottolineato inoltre che in tutte le citazioni d’epoca del film, sia in fonti primarie come le pubblicità, sia in fonti secondarie come le notizie brevi, non compare mai il titolo Umanità, ma unicamente quello di Tranquillino dopo la guerra vuol fare (o creare) il mondo nuovo. L’ipotesi che pare più probabile è che Giallanella non sia riuscita a vendere il suo lavoro e che con l’aiuto di Principe abbia tentato di riposizionarlo in una veste diversa, che potremmo definire meno educativa e più umoristica, sfruttando il filone dei film interpretati da divi bambini e inventando nomi dalle assonanze internazionali che possano dare – almeno secondo la tendenza dell’epoca – una maggiore credibilità. Su “La Vita cinematografica” dell’aprile 1920 appare la pubblicità di una società di compravendita (la Industrial Film di Trieste) che reclamizza una lunga lista di pellicole, tra cui una intitolata Tranquillino e attribuita alla Vera-Film di Roma, cui è aggiunto il seguente slogan: “la celebre macchiettina italiana”. Poi, dopo l’aprile del 1920, non si trova più alcuna traccia né di Tranquillino né di Elvira Giallanella, il cui film pare cadere nell’oblio. La pellicola che fortunosamente è arrivata fino a noi (un positivo nitrato in 35mm, imbibito e virato, con didascalie in italiano non numerate) sembrerebbe non essere mai stata proiettata in pubblico, in quanto, come riporta Vittorio Martinelli nella sua scheda filmografica, non sembra avere ottenuto il visto di censura. Perché Giallanella, una professionista attiva nel mercato cinematografico da almeno tre anni, che lavora sulla piazza di Roma (una delle poche, insieme a Torino e Napoli, ancora abbastanza in salute
in quegli anni di crisi e decadenza dell’industria cinematografica italiana), decide di aprire una Casa di produzione proprio a Milano, la città meno promettente fra le grandi? Che cosa la lega a Principe e alle sue società meteore? Che tipo di contratti commerciali la portano a un certo punto a togliere il proprio nome dalla pubblicità del film? E perché il titolo Umanità non compare mai? In quegli anni sono innumerevoli le Case di produzione e noleggio che appaiono e spariscono, così come si succedono infiniti i fallimenti, i film pubblicizzati e mai usciti nei cinematografi, i personaggi che promettono successi mai arrivati… Umanità è uno di quei film mai visti. Ma tutti gli indizi lasciano supporre che Giallanella non mirasse tanto al successo commerciale decidendo di produrre il suo film proprio a Milano, ma inseguisse piuttosto il sogno di un progetto cui credeva fortemente. Forse a Milano aveva trovato un finanziatore e, forte della sua esperienza nel campo della promozione, voleva tentare di avventurarsi in una nuova attività, sperando in un successo che invece non arrivò. Così, forse, si trovò costretta a vendere i diritti di sfruttamento commerciale del film o, in ogni caso, è facile supporre che possa essere ritornata a Roma per tentare di posizionare ancora la sua pellicola nella capitale (ciò spiegherebbe anche perché la copia conservata presso la Cineteca Nazionale riporta il marchio “Liana Films – Roma”). Storia di sogni irrealizzati, di oblio e fallimenti: la storia di Elvira è anche e soprattutto una storia femminile e, per lei come per tante altre donne, sono la tenacia, la passione e la lungimiranza ad averla portata comunque lontano. Viene anche da chiedersi perché e come il suo film sia arrivato fino alla Cineteca Nazionale e perché sia potuto restare per cinquant’anni inosservato... Ma l’enigma di Elvira è ancora lontano dall’essere risolto.
L’adattamento: poema maschile, film femminile? Umanità è fedelmente ispirato al poemetto di Bravetta per quanto riguarda l’intreccio e alle illustrazioni di Golia dal punto di vista iconografico. Ma gli aspetti più interessanti del film sono le differenze, 165
minime ma sostanziali, che lo discostano dalla sua origine letteraria: soprattutto l’incipit e il finale ma anche alcuni passaggi intermedi, come ad esempio le sequenze in cui compare la figura dello gnomo, che in Bravetta ha una parte decisamente più limitata, o quelle in cui è presente la bambina, che Bravetta dipinge come una piccola Eva che ripete il peccato originale e che Giallanella rifiuta invece di far apparire in quella veste, tanto che nel film è il maschietto a compiere il peccato su cui si conclude la vicenda. Nel film, diversamente che nel racconto, Tranquillino vive da protagonista l’esperienza traumatica della guerra dentro a un sogno. Il sogno usato come espediente per rappresentare la guerra con gli occhi dei bambini è un motivo presente in almeno altri due film dell’epoca, Il sogno patriottico di Cinessino (Gennaro Righelli, 1915)24 e La guerra e il sogno di Momi (Segundo de Chomón, 1917)25. Ma in entrambi i casi si tratta di film prodotti durante il periodo bellico e quindi con intenti a metà strada fra la propaganda e lo sforzo catartico di affrontare il dramma in corso. Inoltre, se per Momi e Cinessino la guerra è un gioco, per Tranquillino è uno scenario allucinante, dove non ci sono che resti, carcasse, rovine di un mondo che non c’è più e che non si sa da che parte incominciare per ricostruire. Questo senso di impotenza è presente, in forma embrionale, anche nel poemetto di Bravetta, ma Giallanella lo sviluppa e soprattutto lo traduce in
Umanità (CSC - Cineteca Nazionale)
166
Tavola dal volume Tranquillino dopo la guerra vuol creare il mondo... nuovo
potenza visiva. Quelle che nelle tavole illustrate di Golia appaiono come allegorie un po’ distaccate dal reale, stilizzate con tratto satirico, nel film diventano rappresentazioni decisamente meno mediate, immagini fotografiche che non dissimulano, che riproducono la devastazione così come la si può vedere alla fine della guerra. Le location del film sono infatti rovine e resti reali di artiglieria bellica, che l’autrice aveva avuto il permesso di riprendere direttamente nel Carso26. Altre volte, come per esempio nella sequenza degli stivali, la messa in scena è visivamente più potente di quella del libro. Gli stivali dei soldati allineati come nelle file di un plotone, ma privati del loro contenuto, sono un’immagine surreale, inquietante, inventata dagli autori del libro ma ripresa e intensificata nel suo messaggio politico dalla regista, che mette in scena l’esito della guerra vista come carneficina di una massa anonima, allineata e spersonalizzata27. L’inizio del film presenta una sequenza del tutto nuova rispetto alla fonte letteraria. Le prime due inquadrature mostrano una serie di oggetti casa-
13 / Una donna vuol ‘rifare il mondo’ / Micaela Veronesi
Umanità (CSC - Cineteca Nazionale)
linghi (un vassoio, un servizio da tè, sigarette, un vasetto di marmellata), e sembrano quasi costruite pittoricamente, così da dare loro una connotazione particolare. I due bambini si muovono in un interno di carattere chiaramente borghese, in cui però gli adulti sono assenti, estromessi nel fuori campo. Questo primo elemento anticipa una costante stilistica di tutto l’incipit, ovvero la presenza di alcune tracce avanguardistiche, sia nella scelta narrativa del tema della trasgressione (i bambini che rubano la marmellata e le sigarette all’insaputa dei genitori che dormono; il ragazzino che fuma leggendo il giornale a letto), sia nello stile con cui Giallanella filma gli oggetti di questo prologo.
Tranquillino si addormenta leggendo il giornale – che riporta notizie dai titoli poco rassicuranti come “la rivoluzione divampa in tutto il mondo” o “la storia di ogni popolo è scritta col sangue, è fatta di sacrifici” – e fa un sogno che la regista rappresenta con un montaggio di immagini di repertorio. La sequenza si conclude con la ripresa di una massa di uomini radunati per un comizio, di cui Tranquillino diviene protagonista attivo, immaginando (tramite una sovrimpressione) di essere l’oratore che arringa la folla. A questo punto il prologo finisce e il racconto del film si ricongiunge con l’inizio del poema di Bravetta, ovvero con il momento terribile dello scoppio della guerra. 167
(CSC - Cineteca Nazionale)
Ma perché Giallanella associa le immagini di una folla di uomini in piazza alla potenza distruttiva della guerra? La regista sembra fare un’equazione banale tra masse popolari/dialettica socialista/rivoluzione/ violenza/conflitto mondiale. Forse il ragionamento non è poi così superficiale e va comunque collocato nel contesto storico del dopoguerra. Per comprenderlo appieno, bisognerebbe indagare la portata mediatica della rivoluzione bolscevica in Italia e capire quale fu il suo impatto sull’immaginario collettivo. Altro elemento introdotto da Giallanella e assente nel testo originale è l’importante funzione narrativa assegnata allo gnomo, un pupazzo nella stanza dei bambini, che prende vita all’interno del sogno. A livello visivo e di composizione dell’inquadratura c’è un interesse specifico della regista nel creare un mondo fittizio, il mondo del sogno, a partire da una commistione fra realtà e fantasia. Quello che passa dall’immaginario del dormiente al sogno è ciò che egli ha visto da sveglio e che ritorna in forma alterata28. Sembra quasi che per Giallanella il mondo di fantasia inventato da Bravetta e Golia non possa essere accettato se non come orizzonte onirico29. In termini proppiani, lo gnomo svolge la funzione di aiutante, avendo il compito di guidare i ragazzini attraverso la devastazione postbellica. Insieme vanno “al teatro… della guerra”: pare che la guerra come spettacolo sia per la regista uno scenario possibile solo nella dimensione onirica. Così trasforma ciò 168
che nel testo di Bravetta è un semplice modo di dire – “teatro della guerra” – in un vero e proprio teatro con tanto di palco, su cui campeggia un inquietante scheletro di soldato avvolto nella bandiera. L’immagine è originale e audace: la regista mette in scena una sorta di ‘scheletro ignoto’, un emblema dei tanti militi ignoti che si stavano cominciando a celebrare nei monumenti, e l’umorismo e la satira annunciati nei titoli di testa si trasformano in humour nero. Insieme all’immagine successiva degli stivali dei soldati rimasti allineati ma deprivati del loro contenuto umano, il macabro teatro inscenato da Giallanella restituisce nel modo più inquietante e potentemente allusivo il senso della tragedia bellica da poco conclusa. Lo gnomo continua la sua visita guidata facendo uscire i bambini dalle quinte, nel retro del teatro, e accompagnandoli attraverso uno scenario desolante di rovine, detriti, pezzi di artiglieria e brandelli di armi abbandonate. Di fronte a tutto quello scempio, assumendo un’espressione di grave serietà, Tranquillino decide di prendersi carico del compito di rifare il mondo. La parte centrale del film ricalca abbastanza fedelmente il testo di Bravetta30, dove pure tutti i tentativi di Tranquillino falliscono in un crescendo di tragica impotenza e, come in un’inarrestabile coazione a ripetere, sono interrotti o sopraffatti dalla violenza: non solo quella esterna, ma anche quella che è in lui e che lo porta ad agire a sua volta in modo distruttivo e crudele, come quando non esita a bombardare il gruppo di animali che ha osato criticare l’‘umanità’ per la sua ferocia. Si noti come il peso della responsabilità sia tutto attribuito al personaggio maschile, mentre la figura femminile (co-protagonista attiva nel furto della marmellata del prologo), pur mantenendo un’indole più pratica e propositiva, svolge per lo più una funzione consolatoria, e infine addirittura scompare dalla scena. L’unica possibilità di salvezza in mezzo a tanta distruzione pare essere Dio, che interviene in più occasioni e che nel finale si manifesta per portare Tranquillino in cielo, facendogli osservare il mondo dall’alto. Mentre il poema di Bravetta termina con l’ascesa in cielo di entrambi i bambini, cui fa seguito il risveglio
13 / Una donna vuol ‘rifare il mondo’ / Micaela Veronesi
di Tranquillino dal suo incubo, nel film c’è una sorta di epilogo, introdotto da una didascalia che annuncia: “realtà”. Così come il prologo ricostruiva in modo decisamente artificioso lo scenario prebellico con immagini di repertorio la cui derivazione storica non era dichiarata, anche l’epilogo è risolto con un montaggio che mostra inquadrature generiche di ciminiere, operai che entrano dai cancelli di una fabbrica, scene di lavoro nei campi, nelle miniere ecc. Questo finale, realizzato come un inno al lavoro che pacifica, sembra confezionato nello stile delle ‘apoteosi’ che concludevano le prime féeries cinematografiche, con un chiaro messaggio che inneggia alla pace che nasce dall’operosità e a Gesù come supremo rappresentante di questo valore.
Rifare il mondo
Tre fotogrammi da Umanità (CSC - Cineteca Nazionale)
Dopo la guerra, come Tranquillino, Elvira Giallanella vuole rifare il mondo e per riuscire nel suo intento utilizza i materiali che ha a disposizione: una fiaba per bambini, uno scenario di rovine di guerra e immagini documentarie di scene di massa. Il suo film mescola fantasie regressive e realismo sociale, una volontà moralizzatrice e i metodi antiquati del film a trucchi delle origini. Queste contraddizioni vanno collocate nel periodo storico in cui si muove la cineasta, nella condizione precaria sperimentata dalle donne nei primi decenni del Novecento e nel disorientamento che caratterizza i primi anni del dopoguerra, ovvero, in altre parole, in quel “mondo capovolto” citato da Françoise Thébaud31 che rende possibili molte novità, soprattutto per la vita delle donne, ma diffonde anche tanta insicurezza. Il ribaltamento delle norme, e la conseguente destabilizzazione, ritornano anche nella vicenda di Tranquillino, bimbo borghese abituato a dormire tra due guanciali (e cioè nella pace e nella sicurezza della casa e della famiglia), che si ritrova solo, con l’unica compagnia dell’amica/sorella Sirenetta, in un mondo totalmente distrutto che tenta invano di ricostruire, ma solo per cadere di continuo in quella stessa spirale di odio e violenza che ha fatto di lui un sopravvissuto. In questo mondo capovol169
to è possibile che i bambini fumino le sigarette, che tengano comizi in piazza e che pilotino aeroplani… esattamente come durante la guerra era stato possibile che le donne svolgessero ruoli tradizionalmente maschili nel lavoro e nelle attività sociali. Quello del mondo capovolto, inoltre, è un tema tipico del Futurismo e a questo proposito è interessante ricordare l’esistenza di un legame almeno indiretto e traslato tra la cineasta e il movimento di Marinetti: Aldo e Renato Molinari, suoi partner nella gestione della Vera Film, erano stati nel 1913 i realizzatori di Mondo baldoria, un film ispirato al manifesto Il controdolore di Palazzeschi, che tuttavia fu pubblicamente sconfessato da Marinetti. In Umanità si trovano peraltro innumerevoli elementi vicini alla morale cattolica tradizionale. Colpisce soprattutto la confusione che si crea nel finale, dove idee di pace e fratellanza si mescolano con ideali di stampo socialista (si veda la didascalia “lavoro per ognuno – pane per tutti – ozio per nessuno”), culminando tuttavia nell’esaltazione di Gesù come esempio di chi si è saputo “sacrificare per un ideale di umanità” e ha predicato di “non uccidere i propri fratelli”, come si legge nella didascalia su cui termina il film. In questa specie di ‘confusione’ possiamo ritrovare sia la tendenza specificamente femminile a una presa di posizione ideologica situata al di fuori degli schemi politici – come è stata definita da Dora Marsden32 – sia la mancanza di consuetudine delle donne di quell’epoca con il ‘fare politica’ – si veda il discorso di Virginia Woolf in Le tre ghinee33. A questo proposito, emblematico è anche il caso della scrittrice Vera Brittain, i cui scritti sulla guerra (lettere e diari) restituiscono la profonda divisione da lei vissuta tra un patriottismo idealista e l’orrore del conflitto scoperto nelle corsie degli ospedali, prima di arrivare a delineare, nella sua autobiografia, un vero e proprio manifesto contro la guerra, espressione di un pacifismo di matrice cristiana che inneggia alla natura non violenta delle donne34. Le donne sono sempre state soggetti reclusi, poste ai margini della vita politica e sociale, semplici spettatrici, ma proprio per questo spesso più capaci di giudicare in modo più imparziale. Come ha scritto Dora Marsden, esiste in alcune donne uno 170
spirito semi-anarchico, che le porta a non sentirsi mai interamente rappresentate da un partito o da un’ideologia, a prendere da ogni cosa solo quello che ritengono giusto, a essere curiose ma mai dogmatiche, a darsi totalmente a una causa ma anche a riorientarsi se un ideale le delude. Marsden sottolinea la natura individualista del carattere femminile, meno portato all’omologazione, portatore di bisogni e desideri personali35. In questa prospettiva possiamo forse comprendere meglio il senso del film di Elvira Giallanella e il suo impegno per la pace, con la sua strana alchimia tra idee di tipo socialista e altre di matrice cattolica. Così come Virginia Woolf, nel decennio successivo, a metà degli anni Trenta, si troverà in difficoltà nel decidere quale posizione assumere per prevenire la guerra e darà in Le tre ghinee una risposta volutamente evasiva – perché tesa a ribaltare il pacifismo femminile da semplice attitudine a scelta consapevole, libera, autonoma, fatta non per omologarsi agli uomini ma per dare vita e voce a desideri differenti36 –, allo stesso modo Elvira Giallanella, in attesa che “le tre ghinee” siano spese per rendere le donne culturalmente più autonome e libere, mette in gioco la sua individualità e, con tutti i suoi limiti, prova a rifare il mondo, affermando “il proprio desiderio di pace e di libertà per il mondo intero”37.
13 / Una donna vuol ‘rifare il mondo’ / Micaela Veronesi
Note
1
Amélie Nothomb, Libri da ardere, Robin, Roma 1999, p. 29.
Questo film giaceva inosservato negli archivi della Cineteca Nazionale a Roma dal maggio 1957 e probabilmente non era mai stato proiettato in pubblico prima della sua presentazione a Bologna nel dicembre 2007, nell’ambito della manifestazione Non solo dive. Pioniere del cinema italiano. La sua riscoperta, avvenuta in modo fortuito, nel corso di tutt’altra ricerca, è tuttavia strettamente connessa al progetto Women Film Pioneers, coordinato a livello internazionale da Jane Gaines e per l’Italia da Monica Dall’Asta. Sfogliando il volume della filmografia del cinema muto italiano di Vittorio Martinelli dedicato al 1919, non avrei mai prestato la dovuta attenzione al nome di Elvira Giallanella se non fossi stata coinvolta in questo progetto dall’entusiasmo di Monica Dall’Asta. E se non fosse stato per la sua professionalità e per la sua tenacia forse non avremmo cercato, visionato, iniziato a studiare e infine promosso il restauro del film, realizzato per iniziativa dell’Associazione Orlando e della Cineteca Nazionale, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Questa serie di coincidenze e di incontri casuali ci stupisce e allo stesso tempo ci fa sentire orgogliose perché è come se, in qualche modo, attraverso il nostro lavoro, Elvira rivivesse e portasse a compimento il suo progetto. Ma devo ringraziare anche tutte le altre persone che, in modo diverso, hanno contribuito a questo studio: Jane Gaines, Franca Farina, Irela Nuñez, Davide Pozzi, Luca Mazzei e, naturalmente, Silvio Alovisio. Un doveroso pensiero va poi al compianto Vittorio Martinelli, che per primo ha scoperto Umanità, includendolo nel suo fondamentale repertorio filmografico.
2
Rachele Farina, Paule Lejeune, Guerra alla guerra, in Rachele Farina (a cura di), Esistere come donna, Mazzotta, Milano 1983, p. 189.
3
4
Ibidem.
Si tratta naturalmente di cliché ricorrenti in tutta la letteratura ottocentesca, nel teatro e poi nei plot cinematografici, ma soprattutto di un modo di pensare diffuso e radicato fra le donne stesse. Si pensi a quanto scrive Gina Lombroso in L’anima della donna, Zanichelli, Bologna 1921, p. 42: “Più che emancipare la donna io insisterei per rendere più cavalleresco l’uomo, il che avrebbe il doppio vantaggio di ingentilire l’uomo e di soddisfare la donna”.
5
Sarah Grand, The Modern Man and Maid, Horace Marshall & Son, London 1898. “Coniato inizialmente in Gran Bretagna, nel 1894, dalla romanziera Sarah Grand, il termine ‘donna nuova’ venne utilizzato per descrivere personaggi dei suoi racconti e per riferirsi alle donne del tempo, che cercavano di condurre vite assai diverse da quelle delle loro madri, impegnandosi in attività con le quali proclamare la loro indipendenza, il loro senso di dignità e il loro diritto a un ruolo pubblico. La Grand continuava a rifiutare gli ideali femminili 6
della classe media, definendo ‘donna nuova’ una donna che non accettava né di essere trattata come una macchina nutrice né come una prostituta, che rigettava l’idea che “la sfera della donna è la casa” e che cercava un più ampio mondo del pensiero e dell’attività”. Cfr. Barbara Caine, Glenda Sluga, L’Europa e la donna 1780-1920, Wizarts, Ascoli Piceno 2003, p. 134. Sulle ineguaglianze fra donne e uomini si veda quell’eccezionale documento del 1899 che è Inchiesta sulla donna di Guglielmo Gambarotta (Fratelli Bocca, Torino 1899, pp. 24-35), con particolare riferimento alla parte introduttiva del testo.
7
Secondo alcuni positivisti come il romanziere Émile Zola (cfr. Germinal, 1885) e gli studiosi Max Nordau e Gustave Le Bon, le donne sarebbero dotate di un potenziale violento elevato: coinvolte nella rivoluzione francese, nei moti del 1848 o nella Comune di Parigi del 1870, sono state le più sanguinarie, violente e distruttive. Anche Cesare Lombroso, intervenendo a proposito del comportamento politico delle donne, aveva affermato che una volta coinvolte nella rivoluzione “le donne diventano terribilmente furiose”. Cfr. Barbara Caine e Glenda Sluga, op. cit., pp. 124-125.
8
Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Parigi, Félix Alcan, 1895 (tr. it. Psicologia delle folle, TEA, Milano 2006).
9
“Sia secondo Zola sia secondo Le Bon l’aspetto più terrificante del comportamento della folla era che essa si comportava come le donne colpite da isteria, in modo irrazionale e estremista”. Cfr. Barbara Caine e Glenda Sluga, op. cit., p. 125.
10
11
Cfr. Barbara Caine, Glenda Sluga, op. cit., p. 138.
12
Cfr. Barbara Caine, Glenda Sluga, op. cit., p. 151.
Per la più recente edizione in lingua italiana di questo testo, si veda Bertha von Suttner, Abbasso le armi! Storia di una vita, a cura di Giuseppe Orlandi, con prefazione di Laura Tirone, Centro Stampa Cavallermaggiore, Torino 1996. 13
14
Cfr. Barbara Caine e Glenda Sluga, op. cit., p. 152.
Françoise Thébaud, La Grande Guerra: età della donna o trionfo della differenza sessuale?, in Françoise Thébaud (a cura di), Storia della donne. Il Novecento, Laterza, Bari 1992, p. 29. 15
16
Françoise Thébaud, op. cit., p. 45.
17
Françoise Thébaud, op. cit., p. 52.
Sulla situazione femminile in Italia, si veda anche l’interessantissimo testo d’epoca di Paola Baronchelli Grosson, La donna della Nuova Italia: documenti del contributo femminile alla guerra (maggio 1915 - maggio 1917), Quintieri, Milano 1917. 18
19 Sulla posizione contraddittoria delle donne rispetto alla guerra può essere utile ricordare la distinzione, proposta da
171
Jean Bethke Elshtain, tra le “molte noncombattenti” e le “poche feroci” in Donne e guerra, Il Mulino, Bologna 1991. Si veda inoltre Anna Bravo (a cura di), Donne e uomini nelle guerre mondiali, Laterza, Bari 1991. 20 Una delle poche notizie fin qui emerse circa l’attività cinematografica di Giallanella si trova in: R. Mattozzi, La rassegna del film, nel quale la “Liana Film” è segnalata come Casa di produzione con sede a Milano, fondata nel 1919 e di proprietà di Elvira Giallanella, e di cui si annota come unica produzione effettuata un film intitolato Tranquillino dopo la guerra vuol fare il mondo nuovo (lo stesso Mattozzi dà poi notizia di un secondo film in preparazione intitolato Tomba nuziale). L’annuncio della fondazione della Liana appare per la prima volta nella rivista “Film”, n. 30, 30 settembre 1919, p. 21, in cui si legge che Giallanella si è sciolta dall’impegno con Aldo Molinari e con la Vera Film e ha fondato a Milano una propria società di produzione, la Liana Films, ma anche di un progetto per la costruzione di un teatro di posa; si apprende inoltre che la società si occupa già di acquisto, vendita e concessione di film. La notizia della nascita della nuova Casa è riportata anche da “La Vita cinematografica”, n. 7-8, 22-29 febbraio 1920, p. 119, e da “La Rivista cinematografica”, n. 6, marzo 1920, p. 62.
L’informazione si evince dalla pubblicità di un film della stessa Vera (Lotta di elementi, raffiche d’anime, regia di Aldo Molinari), apparsa su “Film”, n. 5, 10 febbraio 1917, p. 5. 21
Cfr. Informazioni Liana Film, “Film”, n. 37, 29 novembre 1919. 22
23
La “Liana Films”, “Film”, n. 8, 26 febbraio 1920.
Il bambino è preoccupato per il papà al fronte e non riesce a dormire. Gioca con i soldatini e si addormenta. Sogna una battaglia in cui suo padre viene ferito, ma alla fine risulta vittorioso. 24
25 Il bambino dorme e sogna uno scenario bellico in cui i suoi soldatini prendono vita e combattono crudamente; il risveglio porta sollievo al piccolo spaventato: ma fuori c’è davvero la guerra. 26 Si veda “Film”, 26 febbraio 1920, in cui si dà notizia dell’inizio delle riprese del film e si afferma che la regista “è partita con tutta la sua minuscola troupe per eseguire gli esterni, i quali, per gentile concessione delle autorità militari, e per le esigenze del lavoro, avranno come sfondo il Carso e i punti più importanti della oramai ex-zona di guerra”.
Questo tipo di metafore forti sono tipiche anche del cinema di Lucio d’Ambra, a quel tempo sicuramente il regista di riferimento per un cinema basato sulla figuratività del racconto illustrato. 27
28 Si ricordi in proposito quanto scrive Deleuze in L’immaginetempo, Ubulibri, Milano 1989, p. 69, a proposito della “teoria bergsoniana del sogno [la quale] dimostra che il dormiente non è per nulla refrattario alle sensazioni del mondo esterno e interiore”.
172
Si veda, oltre alla figura dello gnomo, il barattolo di marmellata da cui sbuca Sirenetta dopo lo scoppio della guerra, lo stesso dal quale la bimba stava mangiando di nascosto all’inizio del film, altro elemento della realtà che entra nel sogno con una funzione alterata, impossibile. 29
30 Una differenza è rappresentata dal volume di “Storia Universale” che Tranquillino consulta nel film per trovare spunti su come assolvere al difficile compito e che nel poema è invece una “Storia sacra”. 31
Françoise Thébaud, op. cit., p. 43.
“Un numero molto limitato di donne, prese singolarmente, sta ponendo l’accento sul fatto che quando si parla di loro la prima cosa di cui tenere conto è che esse sono individui e non possono essere assimilate in una classe, in un genere sessuale o in un ‘movimento’ ”. Dora Marsden, Opinioni e commenti I (originariamente apparso in “The New Freewoman”, 15 giugno 1913, ora in The Freewoman / La donna libera, Liguori, Napoli 2004). 32
33
Virginia Woolf, Le tre ghinee, Feltrinelli, Milano 2000.
Per una descrizione del caso di Vera Brittain si veda Françoise Thébaud, op. cit., p. 64. 34
35
Dora Marsden, op. cit., pp. 285-287.
36
Cfr. Virginia Woolf, op. cit., pp. 146-148 e pp. 187-188.
37
Virginia Woolf, op. cit., p. 147.
14 / Irela Nuñez, con la collaborazione di Franca Farina
Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale
All’interno del Centro Sperimentale di Cinematografia si è andata costituendo, fin dalla sua fondazione nel 1935, una collezione di film che dal 1949 è divenuta la Cineteca Nazionale, con il compito istituzionale di conservare, restaurare e diffondere il patrimonio cinematografico italiano. Di notevole valore, sia per quantità che per qualità, è la collezione di film muti, che copre tutto l’arco storico compreso tra le origini e i primissimi anni Trenta, nella quale sono conservate numerose copie d’epoca, spesso impreziosite da splendide colorazioni. Molti di questi materiali, talvolta ‘sconosciuti’ o dimenticati, testimoniano l’apporto femminile al progresso del cinema, un pezzo di universo delle immagini che resta in parte ancora da scoprire. La presente relazione si propone di individuare e segnalare alcuni preziosi film conservati nella nostra istituzione che furono scritti, diretti o prodotti da donne nel periodo muto, o che possono comunque risultare interessanti dal punto di vista della rappresentazione di genere in virtù della trama o della qualità dell’interpretazione, anche allo scopo di interessare la comunità cinearchivistica e promuovere progetti di preservazione e restauro. Nel corso di sessant’anni, la Cineteca Nazionale ha salvato tanti film unici al mondo, italiani e non, che oggi conserva su supporto di lunga durata: in questa
relazione, abbiamo dedicato particolare attenzione a quelli dei quali ancora conserviamo l’originale in nitrato, sui quali stiamo lavorando, o che non ci risulta siano ancora stati oggetti di un restauro, o per i quali è auspicabile un ulteriore intervento; analizzandone l’importanza, l’accoglienza che essi hanno ricevuto sulla stampa dell’epoca, la loro provenienza e il loro stato attuale di conservazione, dando la precedenza al cinema italiano. La ricerca si è basata, oltre che sulle informazioni contenute nei nostri database, su numerose altre fonti, tra cui in particolare i lavori filmografici di Riccardo Redi1, accanto certamente al fondamentale Archivio del cinema italiano di Aldo Bernardini e alla collana Il cinema muto italiano di Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli. Il criterio guida è stata la tipologia tecnica ed editoriale degli interventi fatti per preservare ciascun film, interventi che possiamo suddividere in quattro categorie: 1. Antologie storiche 2. Semplice trasferimento su supporto di sicurezza per produrre materiali d’archivio, oppure trasferimento e aggiunta dei credits per produrre copie di circolazione 173
3. Restauri (anche in collaborazione con altre istituzioni) 4. Studi preliminari: gruppo costituito dai film in attesa di preservazione e restauro, per i quali sono in corso le ricerche e le analisi preliminari. Accanto a questi quattro gruppi ne abbiamo individuato un quinto, rappresentato dai film di produzione estera con partecipazione femminile nella realizzazione.
Antologie storiche Diverse delle nostre pioniere compaiono già nelle prime compilazioni antologiche del cinema italiano prodotte subito dopo la fine del periodo muto, per rivisitarlo e rendergli omaggio, per studiarlo e rivalutarlo, per sottrarre qualche frammento alla decomposizione, per far conoscere i ‘tesori’ dei collezionisti (poi delle cineteche), per rispondere alle necessità formative delle nuove generazioni e, più tardi, anche per arricchire la nascente programmazione televisiva. Tanto di quello che oggi sappiamo del cinema muto italiano si deve al lavoro pionieristico dei primi collezionisti e alla loro opera di ricerca e salvataggio di copie o frammenti, riprodotti, moltiplicati e scambiati per fornire alla comunità cinefila e agli archivi quelli che erano destinati a divenire i ‘classici del muto’, ristampando negativi dimenticati e copie uniche, nonché all’occorrenza singoli rulli o brani recuperati dal macero. Della passione per queste selezioni d’immagini e per questi ricordi si è nutrito in gran parte il corpus degli studiosi e degli storici, i quali hanno a loro volta riorganizzato e sceneggiato questo complesso di materiali in forma di antologie. Sebbene arbitrarie e frammentarie, prive di cartelli, colori e musica, queste compilazioni rimangono ottime testimonianze, che possono rivelarsi ancora oggi preziose per il nostro lavoro, assumendo il valore di veri e propri ‘album’ del cinema. Delle nostre pioniere, in particolare, le antologie conservate presso la Cineteca Nazionale fanno prevedibilmente un ritratto storico, distinguendo le celebrità del teatro prestate alla nuova arte, come la Duse, le prime personalità venute alla ribalta con l’avvento del cinema, come Maria Gasparini, le dive come la 174
Bertini, la Borelli o Pina Menichelli, fino alle personalità emerse nel periodo maturo del muto come Elena Sangro, Diana Karenne, Astrea o Elena Makowska. Volti e immagini del cinema muto. le attrici del vecchio cinema italiano (regia di Luigi Rognoni, Cineteca Italiana?, Milano 1952?) Conosciuto anche come Volti e immagini del cinema muto 1908-1928. Album delle attrici del vecchio cinema italiano, il film ha partecipato alla 13a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1952). Il documentario si apre proprio con l’omaggio del regista e noto musicologo Luigi Rognoni – uno dei fondatori della Cineteca Italiana – alle dive Borelli, Hesperia, Menichelli, Makowska, Jacobini, Almirante-Manzini e Bertini. Saluto appassionato, questa antologia muta è segnata dall’intervento dell’autore che analizza, attraverso l’edizione dei brani, i volti, gli atteggiamenti e gli stili di recitazione, alternandoli sullo schermo a presentazioni e spiegazioni tratte dalle riviste d’epoca, fotografate e ‘sfogliate’ in truka. Tra le molte notizie e spunti che il film ci suggerisce, menzioniamo il frammento di Voglio a ‘tte con Francesca Bertini e Guido Grazioli (1920), che reca il cartello “ideato e diretto dalla Bertini stessa”2. La valigia dei sogni (regia di Luigi Comencini, Produzione Cinematografica Mambretti – Società Villa M., Milano 1953) Si tratta di un affettuoso omaggio a Mario Ferrari e alla sua opera di salvataggio e diffusione del cinema, che avrebbe condotto alla nascita della Cineteca Italiana. Pur essendo un film di finzione vero e proprio, presenta però un carattere per così dire ‘meta-antologico’, in quanto segue il protagonista mentre raccoglie la sua collezione e la esibisce al pubblico di un cineclub. Con un tocco di amarezza, il film mostra la scarsa accoglienza del vecchio cinema da parte dei giovani degli anni Cinquanta, che non apprezzano l’arte di attrici come Italia Almirante-Manzini, Francesca Bertini, Lyda Borelli, Wanda Capodaglio, Eleonora Duse, Pina Menichelli ed Elena Makowska: al termine del film quest’ultima
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
scende rediviva dall’Olimpo delle stelle di celluloide per salvare il protagonista dal carcere e aiutarlo a fondare il suo Museo del Cinema. Antologia del cinema italiano. I capitolo: il film muto 1896-1926 (regia di Antonio Petrucci, Cineteca Italiana - Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma 1956) Già autore nel 1935 di Cinema che passione, Antonio Petrucci realizza questa interessante raccolta del ‘testamento muto’ con selezioni di film conservati nelle cineteche di Roma e Milano. Il film riserva ampio spazio alle donne, privilegiando però il loro lavoro davanti alla cinepresa, assai meno quello registico o tecnico. La presenza femminile, immediatamente percettibile o ellittica, attraversa il film in modi diversi, fin dalla premessa d’autore: dalla stesura dei soggetti e delle sceneggiature, al ruolo cruciale da loro occupato sullo schermo, partendo dalle grandi celebrità della scena e dalle grandi icone, come Duse, Fougez, Bertini, Borelli, Gasperini, Karenne, ma dando spazio anche ad attrici meno note e ai cast segnati da una massiccia presenza femminile. La sceneggiatura esplora in successione epoche, registi, generi e stili, senza nascondere il proposito didattico, ma scegliendo i frammenti in modo assai accorto per tutta la durata dell’esposizione narrativa delle scene, sicché l’immagine conserva una bellezza virginale e antica, propria di quel mondo lontano che andiamo scoprendo. Vediamo brani completi di film come Cenere, La serpe, Fiore selvaggio, Assunta Spina, Madonna errante, La regina del carbone, Ma l’amor mio non muore. Nonostante qualche limitazione di post-produzione, l’omaggio è davvero monumentale (più di 160 minuti!). Poiché i diritti appartengono al Centro Sperimentale di Cinematografia e alla Cineteca Italiana, sarebbe auspicabile la sua ristampa e pubblicazione. La lunghezza attuale è di 3805 metri.
Semplice trasferimento ‘di emergenza’ su supporto di sicurezza per produrre materiali d’archivio e restauri ‘prima maniera’ Un secondo livello di salvataggio è ben introdotto e spiegato dalla lettura della documentazione storica
relativa agli anni Sessanta e Settanta conservata in Cineteca: se nei controlli di routine veniva individuato un film nitrato in decomposizione, l’istituzione provvedeva alla duplicazione di emergenza, producendo un controtipo e una stampa positiva, talvolta anche una copia lavanda; dopodiché, per ragioni di sicurezza e seguendo i protocolli in uso in quegli anni, a volte il nitrato infiammabile veniva distrutto. Questo tipo di intervento puntava a produrre principalmente materiali d’archivio, copiando i film così com’erano, senza interventi di ordine filologico. Realizzati in una logica di emergenza, questi duplicati ci sono pervenuti senza annotazioni tecniche o catalografiche sulle matrici e, inoltre, nelle attuali copie si sono perse diverse informazioni presenti sugli elementi originali, nitrati unici distrutti prima di avere affrontato e risolto il problema di come copiare materiali usurati e ristretti. Di conseguenza, la qualità di queste ‘copie di emergenza’ è spesso scarsa, perché vi si ritrovano fotografate sporcizia, righe, giunte deformate, con occasionali perdite di stabilità dell’immagine e di corretta posizione del quadro, spesso con un contrasto troppo alto, senza più informazioni sui colori, né segnalazioni sull’entità delle lacune narrative. E molte volte questi controtipi rappresentano tutto quanto ci rimane di alcuni film. Il nostro compito in questi casi è quello di studiare tutti questi interventi e ricercare il modo di correggere queste edizioni con le nuove informazioni che possiamo acquisire oggi. Restauri ‘prima maniera’ sono invece quelli fatti prima degli anni Ottanta, perciò in bianco e nero, talvolta col mascherino sonoro e, in genere, con un livello di qualità e di completezza filologica che oggi appare insufficiente. Tra l’altro senza un confronto fra i materiali originali conservati in Cineteca e quelli presenti in archivi esteri. Bisogna ricordare che all’epoca l’interesse per il cinema muto era molto minore di quello attuale, che non esisteva una filmografia sistematica3, che la comunicazione fra gli archivi e fra questi e i centri di ricerca e i singoli ricercatori era molto più lenta e che spesso, nonostante l’appartenenza alla fiaf (Fédération Internationale des Archives du Film), nelle cineteche prevaleva una consolidata tendenza alla riservatezza riguardo alle proprie collezioni. 175
Diversamente da allora, oggi è possibile trasferire il materiale senza troppi rischi su supporto video, un ottimo mezzo ausiliario di valutazione, identificazione e catalogazione, assai utile per facilitare lo studio e la circolazione (anche se a volte questa apparente facilità di duplicazione offerta dal video rischia di offrire il pretesto per rinviare un lavoro di preservazione completo). Elenchiamo di seguito alcuni casi che abbiamo identificato far capo a queste prassi: Lea salva la posizione (regia non reperita, Cines, Roma 1911) Interpretato da Lea Giunchi, Ferdinand Guillaume, Giuseppe Gambardella e Lorenzo Soderini, il film fa parte della serie comica dedicata al personaggio di Lea. Per evitare che il marito la sorprenda con l’amante Tontolini (Ferdinand Guillaume), che ha ricevuto nella propria casa, Lea finge che questi sia un ladro e lo minaccia con la pistola. Il marito lo fa arrestare. Nella scena successiva ritroviamo tutti i personaggi in commissariato. Lea decide velocemente di corteggiare il commissario, che fa uscire i due uomini dalla stanza per rimanere da solo con lei. Alla fine, il commissario libera Tontolini e se ne va con la signora. La Cineteca Nazionale conserva un duplicato negativo in bianco e nero senza titolo e senza didascalie, copiato nel 1982, che reca i difetti del controtipo. Il nitrato è tuttora esistente. Lunghezza originale: 152 metri; lunghezza attuale: 119 metri. La memoria dell’altro (regia di Alberto Degli Abbati, Film Artistica Gloria, Torino 1913) Basato su un soggetto di una non meglio identificata “baronessa De Rege”, questo film narra una storia di amour fou che avrebbe potuto servire da spunto a François Truffaut. Appassionato e femminile, il film intriga immediatamente per una felice combinazione di elementi: interpreti di buon livello che danno vita a personaggi interessanti fuori e tormentati dentro, in primo luogo la protagonista Lyda (Lyda Borelli), stella dell’aeronautica amata da tutti; ambienta176
zione inconsueta, che inizia nei cieli e finisce con la protagonista che crolla a terra in un anonimo ospizio di carità in una città straniera, mentre cerca di recuperare il ritratto del suo amore impossibile, ormai deceduto. Bellissime alcune inquadrature con macchina da presa in movimento; bravi Mario Bonnard, Vittorio Rossi Pianelli e Letizia Quaranta, nei panni di altrettanti personaggi posseduti dalla propria ossessione. Oggi può non sembrare molto femminista l’idea di una donna che perda tutto per amore ma, vista con gli occhi dell’epoca, l’affermazione del desiderio femminile da parte di un personaggio che pure non è la ‘cattiva’ della vicenda è quanto meno rivoluzionaria. Inoltre, il film mostra chiaramente la suggestione di una realtà meno banale dell’ordinario, alla quale il pubblico è introdotto sul filo di una trance ipnotica scatenata dalla passione, in una sorta di corto circuito emotivo che si gioca tutto sull’assenza, sull’inafferrabilità dell’oggetto amato: come sottolineano la cura e insieme l’evanescenza delle toilettes (e il loro progressivo disfarsi verso la fine), le atmosfere surreali (il teatro, Venezia, la taverna degli apaches), i messaggi, gli spostamenti continui, la malattia, la morte triste e solenne come una fuga verso il nulla, magnificamente interpretata da Lyda Borelli. Esisteva in Cineteca una copia positiva infiammabile d’epoca, da cui sono stati ricavati controtipo e copia nel 1977, purtroppo destinata al macero nel 1979. I materiali odierni recano i difetti dell’originale di partenza (eccessivo contrasto, righe e sporcizia). Lunghezza originale: 1650/2000 metri; lunghezza attuale: 1474 metri. Miss Dorothy (regia di Giulio Antamoro, Nova Film, Roma 1920) Miss Dorothy Chester diviene l’istitutrice e l’insegnante di pianoforte di Mara, figlia della duchessa di Sangro. La ragazza ha un fidanzato, Giorgio, che sente un’attrazione corrisposta per l’istitutrice. Giorgio scopre che Dorothy è in realtà Thea Nottingham, la vedova di suo fratello, che tutti pensavano morta e che è tornata per sapere di più sulla morte della sua bambina, di cui è stata informata dalla suocera. La bambina, Alma, in realtà è stata adottata da un
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
Miss Dorothy, 1920 (CSC - Cineteca Nazionale)
maggiordomo. Giorgio la ritrova e se ne innamora. Vorrebbe separarsi da Mara ma il suo atteggiamento spinge la duchessa a pensare che in realtà egli sia innamorato di Miss Dorothy, e a minacciarlo di denunciare l’istitutrice. Per salvare sua figlia e la sua reputazione, Dorothy preferisce suicidarsi. Nessuno dei film diretti, sceneggiati e prodotti da Diana Karenne è sopravvissuto e Miss Dorothy (insieme al Casanova di Alexandre Volkoff, anch’esso conservato alla Cineteca Nazionale) è una delle rare testimonianze delle sue doti recitative, che le permettono di tratteggiare con estrema sensibilità figure complesse come questa Thea Nottingham: donna apparentemente fredda, maestrina dai modi rigorosi, e insieme pianista e madre appassionata.
L’originale è stato mandato al macero nel 1979, dopo la stampa di un controtipo. Le copie attuali provengono tutte da questo elemento, duplicato purtroppo con qualche fuori quadro a causa del restringimento, difetto che ora è possibile correggere digitalmente. Lunghezza originale: 1487 metri; lunghezza attuale: 1232 metri. A mosca cieca (regia, soggetto e sceneggiatura di Giulia Cassini Rizzotto, San Marco-Film, Roma 1921) Divertente commedia romantica basata sulle vicende intrecciate di due coppie. Due amici di nobili natali, uno dei quali si è rovinato al gioco, rispondono 177
a un annuncio matrimoniale che un’ereditiera americana, consigliata dalla sua inseparabile amica, ha fatto pubblicare su un quotidiano. I due giovani incontrano le ragazze, senza sapere quale delle due sia la miliardaria. L’amore sceglierà ciecamente. Eccellente prova degli attori, molti dei quali appartenenti al mondo dell’aristocrazia romana; direzione artistica notevole, montaggio interessante. La copia – realizzata nel 1980, duplicando in bianco e nero il nitrato colorato originale – è mancante di circa 100 metri, soprattutto nei titoli di testa e coda e riproduce molti difetti del nitrato di partenza. In questo caso fortunatamente si è conservata la copia positiva nitrato, con imbibizioni e viraggi, dalla quale si può dunque ripartire per un restauro vero e proprio. Lunghezza originale: 1035 metri; lunghezza attuale materiali safety: 906 metri; lunghezza attuale del materiale nitrato: 960 metri. È Piccerella (regia e sceneggiatura di Elvira Notari, Dora Films, Napoli, 1922) Tore conosce Margaretella a Montevergine e, nonostante gli ammonimenti della famiglia, s’innamora della vanitosa ragazza. Per farle dei regali sperpera il denaro dei suoi, compreso quello destinato ai macchinari della fabbrica che gestisce insieme al fratello Gennariello: l’azienda va in rovina. Noncurante di ciò, Margaretella sceglie Carluccio – suo antico spasimante – per accompagnarla alla festa del Carmine. Tore, che la credeva malata, la incontra al ballo, vestita con l’elegante abito che le ha regalato e la umilia, strappandoglielo di dosso davanti a tutti. Carluccio lo sfida a duello, proprio sotto la finestra della giovane, e Tore rimane ferito. Il fratello Gennariello riesce a riportarlo a casa, dove la madre, malata e agonizzante, lo aspetta per morire in pace. Passa un anno. Durante la sfilata dei carri di Carnevale a Montevergine, Tore incontra Margaretella e la uccide. Ma nemmeno in prigione riesce a dimenticare. Girato a tempo di record per approfittare del successo dell’omonima canzone di Libero Bovio e Salvatore Gambardella lanciata al concorso di Piedigrotta 178
del 1922, il film narra una storia di ossessione e di morte, con lo stesso quartetto di interpreti di ‘A santanotte: Rosé Angione, Alberto Danza, Eduardo Notari ed Elisa Cava. Si tratta di un film molto interessante, perché fonde la storia passionale ripresa dalla canzone con il paesaggio, le figure e le tradizioni napoletane. Il positivo nitrato colorato fu inviato al macero nel 1979. Del film sopravvive in Cineteca un controtipo di discreta qualità. Non siamo certi se l’ultima immagine pervenuta corrisponda veramente al finale del film. Dal duplicato provengono tre positivi realizzati in epoche diverse, più un rullino di tagli. A qualche copia sono stati aggiunti cartelli con i credits del film. Lunghezza attuale: 1214 metri; lunghezza originale: 1272 metri. Ali spezzate (regia di Luigi Maggi, Nelson Film, Roma 1923) Prodotto e interpretato da Berta Nelson4 nel 1920, ottenne il visto di censura nel 1923 e secondo Vittorio Martinelli risulta aver circolato pochissimo. È un film interessante, narrato in una chiave che oggi diremmo minimalista, molto moderno: Berta Nelson è eccellente nell’interpretazione di Solange, la figlia di un farmacista di provincia che però non vuole conformarsi al triste destino che la madre ha in mente per lei. In un primo tempo si vorrebbe suicidare; poi trova lavoro in città come istitutrice, nella casa della Duchessa di Santa Marina, che ha due figli, entrambi sensibili alle grazie della nuova arrivata. Innamorata di uno dei due, Solange deve soffrire la persecuzione dell’altro, che le rende la vita impossibile. Senza più amicizie, giacché il suo principe azzurro preferisce ascoltare i pettegolezzi del fratello e i consigli della madre, la ragazza torna in provincia, alla sua famiglia e al promesso sposo designato. Si tratta di un film molto originale, con una messa in scena coinvolgente e intimista, sottolineata anche dalla scelta di colori poco comuni per i viraggi e le imbibizioni, delicati, intimi e un poco spenti. Il montaggio suggerisce una serie di metafore per mezzo di dissolvenze. Come in altri film caratterizzati da un marcato punto di vista femminile, la
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
scena del matrimonio è malinconica, rassegnata. La Cineteca Nazionale conserva due edizioni del film, una in bianco e nero su supporto safety, destinata alla circolazione, stampata da un duplicato negativo (anch’esso conservato in archivio), realizzato nel 1980. L’altra è una copia nitrato d’epoca, colorata, che presenta moltissimi fotogrammi cancellati col taglierino in prossimità delle giunte: non è certo se sia essa la fonte del duplicato. O forse è stata invece utilizzata come copia lavoro e i graffi sarebbero segni di riferimento per l’inserimento di nuove didascalie? Si impone la necessità di fare un progetto sistematico di studio inquadratura per inquadratura di questi materiali e su quanto possa essere sopravvissuto in altri archivi per procedere a una ricostruzione del film. Lunghezza originale: 1004 metri; lunghezza attuale: 804 metri. Fantasia ’e surdate (ovvero Patria e mamma, ovvero Er fattaccio, regia e sceneggiatura di Elvira Notari, Films Dora, Napoli 1927) Giggi Veti rimpiange l’amore perduto della fioraia di Piazza di Spagna, una ragazza dolce che però lo ha tradito. Un giorno, giocando a carte nella taverna di Porta Pia, conosce Rosa Grazioli, una donna ancor più problematica. Per questa passione, Giggi abbandona lavoro e scrupoli, arrivando a sottrarre denaro e gioielli alla madre malata. Scoperto, si suicida, lasciando una lettera a Rosa in cui l’accusa di averlo rovinato. Invece di confessare l’accaduto ai parenti di Giggi, Rosa scrive un biglietto anonimo alla polizia, incolpando Gennariello della morte del fratello. Per evitare il carcere, il ragazzo si offre come volontario nell’esercito, parte per il fronte e viene ferito in combattimento. Finalmente pentita, Rosa consegna alla madre dei due giovani i gioielli e la lettera di Giggi, rivelando così l’innocenza di Gennariello. Inizialmente realizzato nel 1925 come adattamento di un classico della poesia popolare romana (Er fattaccio, di Americo Giuliani), il film si vide ripetutamente negare il nullaosta richiesto dai produttori alla censura. Nel 1927 venne infine accettata la versione intitolata Fantasia ‘e surdate, che include
una sequenza basata sulla canzone omonima, nella quale i soldati provenienti da tutta Italia intonano motivi dialettali delle proprie regioni. Il film fa ampio uso di flashback come tipico mezzo di espressione del rimpianto e dell’assenza. È interessante come nei film della Notari la figura paterna sia in genere assente. Gennariello, figlio responsabile e onesto, fedelissimo alla mamma, fa in parte le veci del padre, ma è presentato come figlio adottivo. Il figlio più amato è invece tipicamente un debole, dominato dalla passione e dal gioco e che addossa alle fidanzate, di volta in volta, la responsabilità dei propri sbagli. La sola figura femminile libera da ogni macchia è sempre la mamma e spesso nel finale si consolida e si esalta il nucleo familiare originale, all’interno del quale l’unica donna è appunto la madre. L’ultimo quadro di Fantasia ‘e surdate mostra la mamma, Gennariello guarito dalle ferite e l’amante pentita, tutti raccolti intorno alla tomba di Giggi. Nel lontano 1968, da un nitrato probabilmente poi andato al macero, vennero realizzati un controtipo e copie safety in bianco e nero, utilizzando purtroppo un mascherino del formato Academy sonoro: di conseguenza, sia le immagini che le didascalie risultano tagliate sul lato sinistro, oltre a qualche difetto come qualche fuoriquadro, righe e fotogrammi mancanti. L’esame dei toni fotografici dimostra che l’originale era colorato con diversi metodi, inclusa la coloritura a mano. Lunghezza originale: 1067 metri; lunghezza attuale: 702 metri. L’Italia s’è desta (regia e sceneggiatura di Elvira Notari, Dora Films, Napoli 1927) Gennariello, ingelosito per le civetterie della sua ragazza, ferisce un uomo e litiga furiosamente con la giovane. Lo vediamo prima in manette accanto alla madre, poi mentre si accinge a partire per arruolarsi nell’esercito, portando con se la chitarra. Saluta una coppia di anziani e la fidanzata. Tra le altre immagini che appaiono in questo frammento, inquadrature della baia di Napoli, un violino, una fanciulla che suona la batteria. 179
L’Italia s’è desta di Elvira Notari (CSC - Cineteca Nazionale)
Questo pezzo a colori su supporto safety senza didascalie, precedentemente catalogato sotto il titolo di Fantasia ‘e surdate, è stato da noi recentemente identificato come un frammento di L’Italia s’è desta5: fu depositato negli anni Novanta dall’airsc (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del cinema) e la sua importanza consiste nel fatto che riproduce – sia pure con inevitabile approssimazione – imbibizioni, viraggi e colorazioni a pochoir, come si evince dalle tracce fotografiche dei segni di spillo usati per il montaggio. Si tratta dell’unica testimonianza esistente presso la Cineteca Nazionale della continuità dell’uso del colore da parte di Elvira Notari, in un’epoca in cui tale pratica non era più di moda: un segno ulteriore del carattere artigianale e personalissimo della sua attività cinematografica. Lunghezza originale: 1820 metri; lunghezza attuale: 175 metri.
Restauri Il restauro è un’attività tecnica e culturale al tempo stesso. Lo sviluppo delle conoscenze sulla storia del 180
cinema e delle risorse a disposizione della ricerca, la consapevolezza dell’impossibilità di affrontare questo lavoro enorme isolatamente, unita a una coscienza cinearchivistica internazionale e a una comunicazione più efficace, stanno consentendo uno scambio sempre più fruttuoso fra gli archivi e le altre istituzioni. Un problema che si sta cercando faticosamente di risolvere è quello delle relazioni con gli aventi diritto, snodo cruciale in quanto potenzialmente in grado di bloccare tutto il sistema. Il miglioramento delle tecnologie analogiche e digitali, grazie all’impegno di molti professionisti e l’offerta di diversi laboratori, consentono oggi di ambire a una ricostruzione sempre più fedele del film originale, attraverso idonei interventi, sempre più con l’obiettivo della diffusione del materiale prodotto nei circuiti dei festival, sui canali televisivi o su supporti home-video e perfino sul web. A partire dagli anni Novanta sono stati intrapresi diversi progetti di restauro in questo senso ‘maturo’ del termine, anche se con risultati molto diversi. Leonardo (regia di Mario Corsi e Giulia Cassini Rizzotto, Historica Film, Roma 1919) Si tratta di uno dei due film diretti e sceneggiati da Giulia Cassini Rizzotto conservati presso la Cineteca Nazionale. Si proponeva di offrire un ritratto del genio rinascimentale, confrontando la sua personalità e la sua attività artistica, scientifica e ingegneristica con i retaggi di una cultura e di una società ancora profondamente intrisi di Medioevo, tra Firenze, Milano e il castello di Amboise. L’operazione risulta interessante sotto diversi aspetti, non ultimo il fatto che secondo alcune fonti bibliografiche il film sarebbe stato realizzato utilizzando un sistema di ripresa stereoscopica brevettato da Lamberto Pineschi. Secondo Mario Musumeci, che ha seguito il restauro, gli archivi non conservano traccia dei brevetti di Pineschi il cui uso, nell’unica copia d’epoca sopravvissuta, potrebbe essere forse suggerito solo dal ricorrente uso di scenografie d’interni nelle quali oggetti e arredi appaiono disposti in modo da creare ‘linee di fuga’ diagonali all’interno dell’inquadratura, per accentuare l’illusione della tridimensionalità.
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
Il film, mancante di un rullo, con didascalie bilingui in finlandese e svedese, è arrivato alla Cineteca Nazionale come parte di uno scambio con il Suomen Elokuva-Arkisto di Helsinki. Nel 2000 è stato realizzato un primo controtipo nei laboratori di Cinecittà. Quando, nel 2003, è stato intrapreso il restauro, la copia si trovava già in grave stato di decomposizione. La duplicazione del film sotto liquido, effettuata dopo adeguato trattamento chimico sotto la direzione tecnica di João de Oliveira, presso il laboratorio Augustus Color di Roma, ha eliminato molti dei problemi dovuti allo stato fisico dell’originale. Le didascalie sono state tradotte in italiano e reinserite nelle scene. Quanto alle lacune (manca un rullo completo) si dovrebbero ancora creare ex-novo circa trenta cartelli, da inserire eventualmente insieme a immagini fisse da ricavare da fotografie di scena e altre fonti extra-filmiche. L’attuale restauro offre quindi un’opportunità di studio e confronto, ma resta ancora da perfezionare. Lunghezza originale: 1682 metri; lunghezza attuale: 1495 metri. Umanità (regia di Elvira Giallanella, Liana Film, Roma 1919) Un titolo importante nel nostro contesto, Umanità è l’unica regia di Elvira Giallanella, figura tanto interessante quanto, per il momento, perfettamente misteriosa. Le sole notizie che si hanno di lei riguardano la sua compartecipazione nella Vera Film – Casa di produzione cui si deve la realizzazione di uno dei primi film di ispirazione futurista, Mondo baldoria (Aldo Molinari, 1913), sconfessato da Marinetti – e la sua responsabilità nella creazione della Liana Film, attraverso cui produce e realizza Umanità, film senza paragoni nella produzione coeva, tentativo singolare di una donna di testimoniare e trasmettere attraverso il cinema il proprio impegno contro la guerra. Introdotto da una didascalia che lo presenta come un lavoro “umoristico-satirico-educativo”, Umanità ha per protagonisti due fratellini, Tranquillino e Sirenetta. Durante la notte i piccoli si alzano e mentre la bambina va a rubare nel vaso della marmellata, il maschietto si dedica alle sigarette di papà. Il fumo
provoca a Tranquillino un sogno angoscioso: il mondo è stato distrutto da una terribile guerra e a lui tocca il compito di ricostruirlo. Le scene successive mostrano Tranquillino che ripercorre gli errori accumulatisi nella storia dell’umanità: ma anche scavando in profondità e addentrandosi negli strati più remoti della storia non riesce a trovare altro che armi e segni di conflitto… Infine i fratellini si rifugiano nella preghiera e trovano conforto tra le braccia di un Dio barbuto. Tra gli aspetti più interessanti del film è da segnalare l’uso delle colorazioni. Ma soprattutto significativo è il fatto che sia stato voluto e realizzato da una donna, a conferma della sensibilità femminile verso i valori della pace e l’educazione dell’infanzia. Negli archivi della Cineteca è conservata una copia nitrato d’epoca, con viraggi e imbibizioni, composta di tre rulli in scatole da 300 metri. Al momento del ritrovamento, lo stato di conservazione risultava buono: la copia mostrava solo qualche lacerazione e alcune macchie; nessuna traccia – edge marks o cartelli – che potesse fornire informazioni circa l’epoca di produzione e la provenienza. Didascalie in italiano, con il logo liana film. Dalla documentazione cartacea conservata in Cineteca, la copia risulta acquistata nel luglio 1957. Questo importante e unico reperto d’epoca è stato duplicato analogicamente presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna. Lunghezza attuale: 800 metri. Maddalena Ferat (regia di Febo Mari, Bertini Film, Roma 1920) Basato sul romanzo Madeleine Férat di Émile Zola, il film narra la storia di Maddalena, una ragazza piuttosto passionale. Lasciato il collegio per andare a vivere con il tutore, si trova costretta a subire le sue attenzioni, fino a un tentato stupro, che la induce a fuggire senza meta. Disperata, accetta l’ospitalità di un giovane uomo, Giacomo, cedendo questa volta alle sue seduzioni. Tempo dopo la ritroviamo sposata a un altro uomo e madre di una bambina, ma ancora ossessionata dal ricordo dell’amante e di quella prima notte d’amore. Quando Giacomo riappare, Maddalena confessa la sua passione al marito, che però 181
non comprende. Maddalena torna con Giacomo, ma il tormento per la morte della sua bambina la porta a togliersi la vita. Vittorio Martinelli cita nella sua filmografia una scena censurata in cui Maddalena, in agonia, è sdraiata sul letto accanto all’amante6. Il film è stato restaurato nel 2002 partendo da un positivo nitrato con colorazioni di 1214 metri. Le didascalie mancanti sono state riprese dal visto di censura, conservato presso il Museo del Cinema di Torino. La terza parte, completamente mancante, è stata integrata con cartelli riassuntivi. Quanto alle colorazioni, sono state stampate due copie con il metodo Desmet al Laboratorio Studiocine (Roma) mentre una terza copia è stata stampata in bianco e nero allo Studiocine e poi successivamente colorata utilizzando il metodo tradizionale dell’imbibizione presso Augustus Color (Roma). Lunghezza originale 1859 metri; lunghezza attuale: 1140 metri. Il nodo (regia di Gaston Ravel, Bertini Film– Caesar Film, Roma 1921) Nel mezzo della notte, un’automobilista raccoglie una ragazza in difficoltà, Agnese Amiati, che si è persa nel bosco. Poiché la giovane sta molto male, l’uomo la conduce nella sua casa e chiama un medico per assisterla. Si tratta del pittore Lelio Salviati: subito fortemente attratto da Agnese, egli decide di tenerla presso di sé e fa di lei la sua musa. Nel frattempo, la marchesa Della Croce scopre l’ennesima avventura del marito e gli chiede la separazione. L’uomo rifiuta e a sua volta l’accusa di avere un amante: la marchesa dignitosamente si ritira a vivere nel padiglione del parco. In realtà, il pittore è innamorato della marchesa. Quest’ultima e Agnese si incontrano e diventano amiche e confidenti. Agnese ha appreso di essere gravemente malata, in fin di vita. Una sera in cui la marchesa ha appuntamento con Lelio, la ragazza si offre di andare al padiglione per accendere la luce e sviare i sospetti del marito sull’incontro degli amanti. Poi, vestita come la nobildonna, incendia l’edificio, immolandosi e facendo credere che sia la marchesa a rimanere vittima del rogo. Gli amanti le saranno grati per sempre, col182
locando il suo ritratto in una posizione d’onore nel loro rifugio. Tempo dopo, Lelio incontra per caso il marchese che, incuriosito dalla riservatezza del giovane, si introduce nel suo studio, dove ritrova la moglie. Sopraggiunge Lelio e il marchese gli spara, ma il colpo spezza il sostegno della pesante cornice del quadro di Agnese, che lo uccide cadendogli sulla testa e salvando per la seconda volta i due amanti. Colori caldi e intensi accompagnano la bella fotografia di Alberto Carta, che illustra questo soggetto originale che combina dramma e avventura, moderno e anche coraggioso nella sua difesa del diritto al divorzio. La Bertini disegna un personaggio molto passionale. Ha un’amante, ma innanzitutto è tradita vergognosamente dal marito. Vive in un primo tempo da sola, ma poi fugge con l’uomo che ama. Inoltre, non c’è rivalità fra i personaggi femminili. D’altra parte, appare oggi decisamente classista e poco verosimile sul piano della sceneggiatura il fatto che una povera ragazza uscita dal nulla scelga di immolarsi volontariamente per la felicità della coppia. Il materiale sopravvissuto è stato restaurato presso il laboratorio Cinecittà, riproducendo le colorazioni col metodo Desmet. Sarebbe comunque necessario colmare alcune lacune del film e completare i titoli di testa, così come ricostruire qualche didascalia e correggere difetti dell’immagine7. Lunghezza originale 1598 metri; lunghezza attuale: 1236 metri. ‘A santanotte (regia di Elvira Notari, Dora Films, Napoli 1922) Basato sull’omonima canzone di Eduardo Scala e Francesco Buongiovanni, il film narra la storia di una ragazza angariata da un padre alcolizzato e contesa tra due amici. Finirà per sposare uno dei due per salvare l’altro, ingiustamente incarcerato con l’accusa di avere ucciso il padre di lei. Il film è tragico e fatalista, con una fisicità decadente, una sensibilità particolare per i volti, appassionato e poetico, con un ottimo senso dei tempi. Caratteristico e incisivo è anche l’uso parziale del dialetto napoletano nelle didascalie dialogiche. Il film ottenne critiche negative sulle riviste italiane dell’epoca, ma fu ben accolto dalla comunità italiana residente negli Stati Uniti, anche se la cen-
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
sura d’oltreoceano ebbe a eccepire sulle scene che mostravano la ragazza maltrattata dal padre8. Per quanto riguarda l’operazione di restauro, bisogna ricordare che la copia nitrato a suo tempo pervenuta alla Cineteca Nazionale fu mandata al macero nel 1979, dopo averne ricavato un controtipo e due copie positive safety. Il controtipo presentava un brutto fuoriquadro, causato dall’aver copiato il film senza correggere il restringimento della matrice, difetto riportato anche nelle due copie positive. Non mancavano tracce di rimontaggio, salti, fotogrammi totalmente bianchi, perforazioni forzate, ripetizioni, salti di inquadrature e di didascalie, ecc. Nel 2007 il progetto Non solo dive ha permesso di intraprendere il restauro del film, grazie al ritrovamento di un controtipo nitrato presso la George Eastman House che presentava alcune inquadrature e didascalie assenti nella copia di Roma e indicazioni circa le colorazioni originali. I materiali sono stati ripresi e lavorati digitalmente ed è stato realizzato un nuovo controtipo, da cui sono state ricavate nuove copie positive, cercando di riprodurre le colorazioni originarie. Come sempre, il restauro rimane perfettibile, soprattutto per quanto riguarda il contrasto, l’equilibrio dei colori e il montaggio della parte finale. Lunghezza originale: 1285 metri; lunghezza attuale: 1389 metri.
Studi preliminari Il fondo dei film muti conservati alla Cineteca è assai esteso e la catalogazione ancora da perfezionare. Il primo compito è quello di identificare e analizzare il materiale: spesso le pellicole sono prive di cartelli e, come ben sappiamo, il periodo muto è ricco di versioni differenti dello stesso film, di riedizioni realizzate per sfuggire alla censura, di film diversi realizzati con lo stesso titolo, magari per sfruttare la pubblicità di un’altra produzione e così via. Per questo, nel caso di analisi, il nostro lavoro consiste nel verificare lo stato generale, la completezza, l’identità del film, del regista e dei collaboratori; è inoltre consigliabile analizzare lo stile del linguaggio cinematografico, il valore estetico e storico del materiale – ricorrendo per questo anche alla documen-
tazione extra-filmica – identificare i luoghi nei quali il film è stato ambientato e girato. Inoltre valutiamo ogni informazione che possa essere utile per salvarlo, anche al fine di individuare e sollecitare sponsor eventualmente interessati a un restauro, giacché i costi sono molto alti e i budget di un archivio sono sempre limitati e spesso impegnati in altri progetti. Al termine della ricognizione, il film viene segnalato sia all’Ufficio Studi, sia al Conservatore. A differenza del passato, quando le cineteche privilegiavano i ‘capolavori’, oggi cerchiamo di salvare tutti i film e anzi privilegiamo per quanto possibile i film ‘particolari’, quelli meno conosciuti o considerati ‘meno importanti’ nella storia del cinema. Questo perché troppo spesso in passato quest’ultima è stata scritta in base a quello che dicevano i libri, la stampa, il governo e la censura, e non invece tenendo conto di quello che dicono i film stessi. Per un’identificazione efficace e una comunicazione veloce, sarebbe utile estendere le banche dati a livello nazionale o mondiale, coinvolgendo non solo gli archivi o le cineteche, ma anche i collezionisti, gli studiosi e i ricercatori indipendenti. Tra i ‘lavori in corso’ abbiamo opere splendide in attesa. Amore senza stima [ex La bufera? / L’avvoltoio? / L’avvoltoio nero?] (regia di Baldassarre Negroni, Celio film, Roma 1913?) Il film narra la storia di Maria, giovane dattilografa e madre di un bimbo che è il frutto della passione per un uomo che l’ha sedotta e abbandonata. La vediamo angosciata, col figlio in braccio, mentre insegue il seduttore – un giocatore perseguitato dai creditori – e si ferma a parlare con la ricca fidanzata che egli intende sposare. Dopo aver rifiutato il denaro che la donna le offre per convincerla a farsi da parte, Maria prosegue il suo vagare disperato, finché decide di accettare le profferte di uno sconosciuto, all’unico scopo di comperarsi un’arma per compiere la propria vendetta. In questa storia trasgressiva, vero capolavoro di un primo naturalismo del cinema romano, la protagonista praticamente si prostituisce per farsi giustizia da sola: questa eroina con il bambino in braccio e la pistola in pugno riuscì a ottenere il nullaosta della 183
Nobiltà di razza e nobiltà di cuore, 1915 (CSC - Cineteca Nazionale)
neonata censura solo nel 1918, quando Francesca Bertini era ormai una diva e il pubblico rivedeva volentieri i vecchi successi del suo periodo alla Celio. La copia a noi pervenuta – che reca il titolo Amore senza stima ed è probabilmente il frutto di un’operazione di rimontaggio, effettuata sostituendo alcune didascalie e forse interpolando il materiale originale con scene di un altro film – corrisponde appunto a questa terza o quarta versione9, ma resta incerto il titolo con cui il film fu inizialmente distribuito nel 1913. La ricerca preparatoria al restauro ha infatti rivelato che la trama del film non corrisponde – come si pensava – a quella di La bufera (1913), ma ricorda per certi aspetti quella di un altro film di Baldassarre Negroni, L’avvoltoio (1912) oppure L’avvoltoio nero (come rilanciato nel 1913)10, soprattutto per la 184
caratterizzazione del personaggio di Emilio Ghione. Ma ancora non abbiamo trovato dati che permettano di confermare definitivamente questa ipotesi. Le difficoltà di identificazione dovute alle complesse vicende editoriali del film hanno causato il rinvio del restauro, il quale dovrà prevedere un doppio livello di lavorazione, integrando tecniche analogiche e digitali, perché la pellicola è in fase di decomposizione. Lunghezza attuale: 808 metri. Nobiltà di razza e nobiltà di cuore (regia non reperita, Adria Film, Milano 1915) Sceneggiato e interpretato (forse anche diretto?) da Maria Bermudes, o Maria Rosa Bermudez, questo interessante film che combina commedia e avven-
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
tura non risulta essere stato mai censito nei repertori filmografici del cinema muto italiano. Nella filmografia di Martinelli11, il nome dell’attrice compare soltanto nel 1914, nel cast di alcuni film d’avventura girati a Genova, Torino e Roma, diretti da Enrico Vidali o Luigi Mele. Teresa Antolin ci ha girato la segnalazione di un giornale di 1915 nel quale “la Signora Bermudez” è indicata come proprietaria di uno studio chiamato Fiat Film, sito in Via Angelo Secchi a Roma (già sede di una Elettra-Film), dove riunisce “una valorosa raccolta di attori”. La copia conservata presso la Cineteca Nazionale, unica al mondo, è stata scoperta solo recentemente, perché nella catalogazione era stata confusa con un’altra dal titolo molto simile (Nobiltà di casta e nobiltà di cuore, 1914). La pellicola misura 760 metri, di cui l’11% (ovvero 85 metri) risulta colliquato (cioè in stato di rilevante decomposizione del supporto, con conseguente, parziale o totale, dissoluzione dell’immagine). Per quanto riguarda l’epoca di realizzazione, i marchi di fabbrica impressi sulla pellicola12 permettono di datare il film tra la metà del 1914 e la fine del 1915. Il film stesso contiene materiale girato in due momenti storici significativi del 1915: il terremoto di Avezzano e la piena del Tevere, che si verificarono rispettivamente nel gennaio e nel febbraio di quell’anno. Entrambi questi eventi sono esplicitamente citati (anche a scopi filantropici: i produttori volevano aiutare le vittime del terremoto). La storia è ambientata a Roma, presentata come una città ricca di possibilità di incontri e di bellezze artistiche, tra cui la Fontana di Trevi, il Colosseo, Piazza di Spagna, San Paolo e Tivoli. Si tratta di una commedia drammatica sviluppata in modo originale, con una buona qualità tecnica, con intriganti chiaroscuri, colori brillanti e una narrazione e un montaggio efficaci. A livello di narrazione, il film presenta una veloce carrellata di personaggi appartenenti a diverse classi sociali, descrivendoli a partire dal modo in cui si rapportano alla protagonista Mary, una modesta stiratrice che poi diventa attrice di cinema. Non essendo la Bermudez una diva, è interessante che il film ruoti comunque intorno alla sua figura. Peraltro, a uscire vincente dal confronto con il nobiluomo francese che seduce Mary è un semplice emigrante, Pietro,
che, rientrato ricco dalla sua avventura in Canada, riesce a salvare la figlioletta di Mary, guadagnandosi la sua stima e il suo amore. Con molti giri nella trama e svariati personaggi, il film riesce a creare l’immagine di un mondo moderno movimentato, nel quale c’è spazio anche per la campagna, ma dove a prevalere è comunque il senso di modernità legato alle automobili, alla possibilità di far fortuna velocemente nell’industria, all’estero, oppure nel cinema. Particolarmente gustoso è poi il modo in cui vengono mostrati diversi personaggi e aspetti caratteristici della settima arte: l’attrice capricciosa, il produttore, gli sceneggiatori, i cameramen, le azioni impossibili, l’apparente facilità di arricchirsi, ecc. L’Archivio fotografico della Cineteca Nazionale conserva anche una quindicina di foto di sala relative a questo film. Sempre in Cineteca abbiamo inoltre reperito un visto di censura, che però contiene soltanto il titolo e non riporta le didascalie. Per quanto riguarda la salvaguarda del film, a scopo di preservazione, abbiamo separato le sezioni incollate da quelle in buono stato e le abbiamo collocate in scatole separate. Se si procederà velocemente, sarà possibile recuperare gran parte dell’immagine in pericolo. Lunghezza attuale: 760 metri. La piovra (regia di Eduardo Bencivenga, Bertini Film-Caesar, Roma 1919) Daria è trascurata dal marito, Maurizio di Grafenthal. L’amico Giorgio Morel è innamorato di lei e Daria ne fa il suo confidente. Per fare ingelosire il marito, appare elegantissima in un locale notturno, ma ne riceve solo rimproveri. Una sera a teatro le viene presentato Petrovich. Daria cerca di evitarlo, perché l’uomo l’attrae in modo sconvolgente, ma infine cede. Lascia il marito, che le toglie il bambino, e si trasferisce in Riviera. Qui la raggiunge Petrovich che, privo di risorse, arriva al furto. Daria si rifugia all’estero, dove incontra Morel, che la porta a vivere con lui. Ma Petrovich riappare all’improvviso armato e Daria, impaurita, dice addio a Morel. Promette a Petrovich di partire con lui, ma alla prima occasione si impossessa dell’arma e gli spara. La fotografia del film è particolare, molto stilizzata: in 185
Francesca Bertini in La piovra, 1919 (CSC - Cineteca Nazionale)
alcune scene presenta drammatici contrasti di luce e ombra, in altre è fredda, clinica. La copia di Roma ha spettacolari colorazioni ottenute per imbibizione e viraggio, spesso combinando i due procedimenti. Ciò è specialmente importante perché nel film i colori contribuiscono a creare un’atmosfera rarefatta, esprimono gli stati interiori della protagonista con inusuale intensità, il suo graduale isolamento emotivo. Diversamente da altre copie censite, riproduce la versione italiana, ciò ne fa una fonte obbligata per qualsiasi eventuale futura operazione di restauro. Lunghezza originale: 1687 metri; lunghezza attuale: 1390 metri. 186
Il fauno di marmo (regia di Mario Bonnard, Celio Film, Roma, 1920) Tratto dal romanzo di Nathaniel Hawthorne The Marble Faun, scritto nel corso del lungo soggiorno dell’autore a Roma e Firenze tra il 1859 e il 1860, il film ottenne buone recensioni dalla critica per l’originalità del soggetto, l’eleganza dell’ambientazione e le ottime interpretazioni di Elena Sangro ed Elsa D’Auro13. Infilando il fantastico nel reale, l’antichità romana avvolge in un affascinante e scuro pathos l’esplorazione del senso di colpa e l’espiazione. La Cineteca Nazionale conserva un controtipo e un positivo bianco e nero copiati dal positivo nitrato an-
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
dato al macero nel 1979, duplicazione che presenta qualche fuoriquadro e fotogrammi bianchi. Alla copia si sono aggiunti dei cartelli con il cast artistico e tecnico. Lunghezza originale: 1785 metri; lunghezza attuale: 1392 metri. La serpe (regia di Roberto Roberti, Bertini Film-Caesar Film, Roma 1920) Naia, detta ‘la serpe’ per la sua aggressività, vive in campagna ignara delle sue origini, fino a quando un banchiere rivela in fin di vita di essere suo padre all’altra figlia, Adonella, che la prende a vivere con lei. Addolorata per la scomparsa del padre e della
sorella, Naia accusa Mario, un impiegato, della loro morte. L’uomo si rifugia nella musica e conquista il successo come violinista con il nome di Max. I due si ritrovano, entrambi ricchi e famosi, alcuni anni dopo. Non riconoscendolo, Naia si innamora dell’uomo, ma quando scopre la sua identità, malgrado il sentimento che prova per lui, lo denuncia e lo fa condannare. La Cineteca Nazionale conserva, molto danneggiato e lacunoso, un frammento d’epoca con imbibizioni e viraggi, che fa bella mostra dello stile di recitazione della Bertini. Lunghezza originale: 1580 metri; lunghezza attuale: 1050 metri. La girandola di fuoco (regia di Eugenio Testa, Ambrosio, Torino 1920)
Liana Mirette in Maschietta, 1921 (CSC - Cineteca Nazionale) 187
Maschietta
I conquistatori
(regia di Arturo Ambrosio, Ambrosio Film, Torino 1921)
(regia di Luigi Maggi, Nelson Film, Roma 1921)
Sebbene non direttamente realizzati da donne, questi film dell’Ambrosio hanno come protagonista l’attrice Liana Mirette in ruoli di ragazza espansiva e moderna, ispirata alla flapper statunitense. In La girandola di fuoco, Liana Mirette è Minnie Linton, la stravagante figlia del re dei profumi. Fa innamorare di sé molti uomini, promettendo un bacio al corteggiatore che le riporterà uno dei fazzoletti che ha legato a tanti palloncini lasciati liberi nel vento. Intanto, sfidando il padre, la ragazza si dedica a diverse avventure, compresi piccoli lavori di cameriera e acrobata. Avendo accettato di aiutare il suo amico Max, un giornalista e poeta italiano – che però vive soprattutto scrivendo testi per la pubblicità –, scopre un traffico d’oppio proprio nella casa dei suoi ex-datori di lavoro. Infine i due giovani si fidanzano e Max viene assunto dal futuro suocero per pubblicizzare i suoi profumi. Il soggetto è di Roberto Omegna ed Ermanno Geymonat ed è un po’ razzista nel ritratto del personaggio orientale del film. La copia conservata in Cineteca Nazionale presenta belle immagini arricchite da viraggi e imbibizioni.
Tratto dal dramma Il conquistatore di Luigi Maggi, presentato all’inizio del 1919 al Teatro Argentina di Roma15, il film è uno dei titoli prodotti dalla casa di cui era titolare Berta Nelson, che questa volta non figura nel cast. Quattro ragazzi sono rimasti orfani16. Gli zii accolgono le sorelle Fanny e Gipsy nella loro dimora parigina. Rimangono Roberto, il fratello minore, e Claretta. Quest’ultima trova una casa grazie al matrimonio con l’ingegner Marco Silvestri, impegnato nella costruzione di una fonderia. Silvestri è un brav’uomo che cerca di tutelare la formazione della moglie, ma Claretta è circuita da un suo dipendente, l’ingegner Pandolfi, che cerca di attirarla verso una vita frivola. Lo stabilimento è colpito da un grave incidente, al quale fa seguito un processo. Intanto le sorelle di Claretta rientrano da Parigi, formandole intorno un cerchio che non è ben visto dal cognato. Claretta lascia il marito per seguire le sorelle, che la spingono verso l’infedeltà. Infine, pentita, la giovane torna al tetto coniugale, ma solo per scoprire che un’altra donna ha preso il suo posto. Annunciato in lavorazione sulla stampa di settore alla fine del 1920, il film non sembra aver ottenuto il visto di censura e in effetti, come anche nel caso di altri film interpretati e prodotti da Berta Nelson, non risulta che sia mai stato recensito: se abbia avuto una circolazione e di che tipo resta dunque un mistero da indagare17. La Cineteca Nazionale conserva soltanto il primo rullo, in mediocri condizioni fisiche, che inoltre sembra essere stato oggetto di un rimontaggio.
Lunghezza originale: 1279 metri; lunghezza attuale: 1080 metri. Le prime inquadrature di Maschietta, del quale la Cineteca Nazionale conserva il primo rullo, mostrano la spensierata ragazza in campagna, mentre gioca con dei maialini. Come ci viene subito spiegato, i genitori hanno mentito sul sesso della figlia, nata in America, per compiacere l’unico parente, uno zio miliardario di Torino, che ha promesso di lasciare i suoi averi al loro discendente solo nel caso fosse nato maschio. Una ventina d’anni dopo, lo zio vuol conoscere il ragazzo. Esplicitate le premesse, il regista si diverte mostrando i particolari della trasformazione (l’attrice è un poco androgina e in effetti qualche critico non risparmiò qualche ironia circa il suo aspetto14). Abiti su misura, taglio di capelli… Ma bastano gli abiti per fare il monaco? A giudicare dalle passioni che il ‘ragazzo’ risveglia nelle passeggere della nave che lo porta, lungo un suggestivo tragitto, a incontrare lo zio, sembrerebbe proprio di sì... 188
Lunghezza originale 1200 metri; lunghezza attuale 300 metri ca. Fiore selvaggio (regia di Gustavo Serena, Libertas-film, Roma 1921) Anna è una vivace pastorella che, attratta dalla musica del compositore Ugo, viene da lui scoperta e amata, diventando poi l’ispiratrice della sua opera. Anna va a vivere con Ugo, ma presto si innamora di un giovane aristocratico e fugge con lui. Tempo dopo, malata e delusa dall’uomo, che si rivela es-
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
Anna Fougez in Fiore selvaggio, 1921 (CSC - Cineteca Nazionale)
sere un contrabbandiere, si pente e, dopo una peregrinazione che la riconduce agli amici e ai luoghi di origine, torna dal musicista per morire tra le sue braccia, sotto una croce lungo la strada. Il film ha una stupenda e luminosa fotografia. Gli effetti visivi cercano anche di tradurre interessanti effetti musicali, per esempio mostrando disegni di note in sovrimpressione nella scena dell’innamoramento, e non manca un accenno a una sorta di ‘musical’ muto in una sequenza, evidentemente pensata per l’accompagnamento dal vivo o con fonografo, nella quale si vedono i personaggi cantare. Basato su un soggetto della stessa interprete protagonista, Anna Fougez, il lungometraggio ebbe – secondo quanto riportano le fonti d’epoca – una calorosa accoglienza18. Interessante e trasgressivo, propone la figura della pastora di capre come immagine di libertà e innocenza, che riesce a far innamorare di sé il solitario musicista rientrato nel piccolo e conservatore paese d’origine dopo aver conquistato la celebrità. Ancora, è rimarchevole che la protagonista rivendichi il proprio diritto a essere felice, a preferire un uomo più giovane e affascinante: non è prostituzione, solo voluttà, innocente quanto amorale. Vittorio Martinelli cita qualche didascalia censurata, come la seguente: “un languore, un turbamento indefinibili s’impadronirono di lei, mentre le braccia di Pottmann la guidavano nel giro di una danza molle e carezzevole”.
Ma il film ha la propria morale: così come la ragazza ‘cade’, così ha la capacità di discernere il bene dal male. Scopre che il presunto gentiluomo è in realtà un volgare delinquente – e il film non ci risparmia la dura frase del finto aristocratico, che, stanco di lei, la congeda dicendo: “se vuoi te ne puoi andare” – e realizza che deve tornare dove può ritrovare un po’ di pace. Ed è un ritorno all’innocenza, alle origini, al pascolo delle capre, al paesino del compositore, dove si ricongiunge a lui per morire fra le sue braccia. Il salvataggio del film è urgente. La copia della Cineteca Nazionale, unica al mondo, è senza titoli di testa e in pessimo stato fisico, oltretutto molto ristretta ed estremamente secca e fragile. Manca il trenta per cento della lunghezza originale e anche se ciò non compromette la comprensione della storia, si sono purtroppo perse alcune sfumature psicologiche riguardo alle scelte fatte dalla protagonista. A causa delle caratteristiche fisiche della pellicola, è necessario provvedere all’umidificazione controllata del materiale e al suo immediato trasferimento. Lunghezza originale 1692 metri; lunghezza attuale 1200 metri ca. Sogno d’amore (regia di Elena Sangro, Lenzi – Stella d’Oro Film, 1947) Immagini di Villa Adriana (regia di Elena Sangro, Stella d’Oro, 1948) Oltre ai film a soggetto interpretati nel periodo muto da Elena Sangro (Maria Antonietta Bartoli Avveduti19) – alcuni dei quali già restaurati, come Fabiola (Enrico Guazzoni, 1918), altri ancora in attesa, come Sansone (Torello Rolli, 1922) –, sono stati proposti per il restauro diversi documentari e cinegiornali artistici da lei realizzati negli anni Quaranta sotto pseudonimo: Amore e arte nel 500, Sogno d’amore, Arte moda e bellezza, Dintorni di Roma, Immagini di Villa Adriana, Grandi armonie, Madonne di Raffaello. Firmando soggetto, organizzazione e regia di Sogno d’amore come Maria Antonietta Bià, Elena Sangro recita anche una particina in questo discreto ma interessante cortometraggio, che evoca un roman189
tico episodio della vita di Franz Liszt durante il suo soggiorno a Villa d’Este, a Tivoli. Il film ripopola i magnifici paesaggi della leggendaria dimora con i personaggi della vicenda storica, animando le composizioni del maestro con i giochi d’acqua del parco: vengono così ‘illustrate’ la Rapsodia ungherese n. 2 e il brano che dà il titolo al film, Sogno d’amore. Lunghezza originale: 450 metri; lunghezza attuale: 270 metri. Una struttura per molti aspetti simile caratterizza Immagini di Villa Adriana, firmato come Anton Bià. La magnifica residenza dell’imperatore Adriano è oggetto di un’esplorazione sia spaziale che temporale: una giovane ‘compagnia di artisti del cinema’ vi arriva in gita e, mentre la voce off fa una serie di considerazioni storiche, le immagini trasportano lo spettatore nel passato, attraverso una serie di quadri che illustrano la vita quotidiana ai tempi di Adriano. Il film è praticamente completo, ma un po’ deformato, ristretto e leggermente usurato. Lunghezza originale: 344 metri; lunghezza attuale: 284 metri.
Pioniere all’estero La Cineteca Nazionale conserva diversi materiali – a volte lacunosi o incompleti, ma spesso interessanti perché in nitrato 35mm, portatori delle colorazioni originali o delle didascalie italiane – dei seguenti film di produzione straniera, che registrano le presenze di: Mistinguett: interpretazione di Fleur de Paris (André Hugon, 1915) Eva Unsell e Hope Loring: sceneggiatura di Shadows (Tom Forman, 1922) Edla Hansen: montaggio di Häxan (Benjamin Christensen, 1922) Marie-Antonine Epstein: sceneggiatura di L’Affiche (Jean Epstein, 1924). Elizaveta Svilova: montaggio di Kino-Glaz (Dziga Vertov, 1924) Aleksandra Chochlova: aiuto regia e interpretazione di Neobycainye priklyuceniya Mistera Vesta v strane 190
bol’ševikov (Le straordinarie avventure di Mr. West nel paese dei bolscevichi, Lev Kulešov 1924); interpretazione di Luc Smerti (Il raggio della morte, Lev Kulešov 1925); Po Zakonu (Dura Lex o Secondo la legge, Lev Kulešov 1926), Vaša Znakomaja (Una persona di vostra conoscenza, Lev Kulešov 1927) Vera Eri: aiuto regia di Ego Prizyv / 23 Janvarja (Il suo appello / 23 gennaio, Jakov Protazanov 1925) Renée de Liot: sceneggiatura, in collaborazione con il marito Mario Guaita ‘Ausonia’, di Nelle soffitte di Parigi (Dans le mansardes de Paris, Mario Guaita Ausonia 1925) Germaine Dulac: supervisione alla regia di Mon Paris (Albert Guyot, 1927) Frances Marion: sceneggiatura di The Scarlet Letter (Victor Sjöström, 1927) Hella Moja: sceneggiatura di Das Karussell des Todes (Paul Heinz,1928) Fanny Carlsen: sceneggiatura di Mary Lou (Friedrich Zelnik, 1928) Henny Porten: produzione e interpretazione di Mutterliebe (La maschera di ghiaccio, Georg Jacoby 1929) Luise Fleck: regia di Das Recht auf Liebe (1930) Katherine Hilliker: didascalie e montaggio, in collaborazione con il marito H. H. Caldwell; Marion Orth: co-sceneggiatura; Sophie Hachner: costumi di City Girl (Friedrich W. Murnau, 1930) Desideriamo ringraziare per la preziosa iniziativa Monica Dall’Asta e Sergio Toffetti. Un grazie personale va ai colleghi della Cineteca: Raffaele Marinaro, Maria Assunta Pimpinelli, Mario Valentini e Daniele Venturini. Un ringraziamento specialissimo a Mario Musumeci e Mario Lucioni per le conversazioni, i suggerimenti e le pazienti correzioni: questo testo è anche loro.
14 / Film salvati e da salvare alla Cineteca Nazionale / Irela Nuñez
Note Cfr. Le filmografie di Riccardo Redi, Cineteca Nazionale. Catalogo dei film muti (infiammabili) e Cineteca Nazionale. Catalogo dei film muti (safety), Centro Sperimentale di Cinematografia- Cineteca Nazionale, Roma - s.d. Copie dattiloscritte.
1
Si tratterebbe di Consuelita (1925), un film che ebbe diverse edizioni. Nella filmografia di Vittorio Martinelli il film è accreditato a Roberto Roberti. Cfr. Gianfranco Mingozzi (a cura di), Francesca Bertini, Le Mani – Cineteca di Bologna, Genova 2003, p. 172. 2
La collana Il cinema muto italiano di Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli inizia la sua pubblicazione a partire dall’anno 1991, Nuova eri, Roma. 3
Altri film interpretati da Berta Nelson e prodotti dalla Nelson Film restaurati in Cineteca Nazionale sono Sélika (regia di Ivo Illuminati, 1921) e La dama errante (regia di Alexander Uralsky, 1922)
4
13 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film del dopoguerra. 1920, cit., pp. 133-134. 14 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti. 1921, Roma, Nuova eri, Roma 1996, p. 199.
Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni Venti. 1921, cit., p. 83. 15
16 Riccardo Redi, Cineteca Nazionale. Catalogo dei film muti (infiammabili), cit., p. 31. 17 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni Venti. 1921, cit., p. 83 18 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni Venti. 1921, cit., pp. 141-142 19 Alan Goble, The Complete Index to World Film since 1895, http://www.citwf.com/person373466.htm
Il pezzo contiene in realtà scene prive di continuità, che potrebbero coincidere con la sinossi del film L’Italia s’è desta, così come attestato dalla presenza di tutti i personaggi del film nella foto di scena riprodotta dal libro di Vittorio Martinelli Il cinema muto italiano. I film degli anni Venti. 1924–1931, Nuova eri, Roma 1996, p. 182.
5
Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film del dopoguerra. 1920, Nuova eri, Roma 1995, p. 194.
6
Scuola Nazionale di Cinema, La memoria del cinema. Restauri, preservazioni e ristampe della Cineteca Nazionale 1998-2001, Fondazione Scuola Nazionale di Cinema, Roma 2001. p. 32.
7
È quanto risulta dalla lettura della “copyright description” e relative note di censura, gentilmente forniteci da Kim Tomadjoglou dell’American Film Institute (Los Angeles).
8
Addirittura distribuita nei primi anni Venti, come rilevato dai marchi del fabbricante presenti sul materiale.
9
Martinelli dà notizia dell’uscita di L’avvoltoio (El buitre) in Spagna; cfr. Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1912, Nuova eri, Roma 1996, p. 52 e, come testimoniato da una superba cartolina pubblicitaria della collezione di Teresa Antolin, il film sicuramente apparve anche in Italia. Qualche mese dopo, la ditta Stefano Pittaluga-Genova pubblicizza, insieme a La bufera, la programmazione di Avvoltoio nero [sic], film “in quattro parti”. Cfr. “La Vita cinematografica”, n. 7, 15 aprile 1913. pp. 72-73. 10
11 Aldo Bernardini, Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1914, Nuova eri, Roma 1993; vol. 1, p. 129, vol. 2, pp. 167, 286, 292. 12 Si tratta di un codice stampato dai fabbricanti della pellicola vergine. In questo caso “EASTMAN”.
191
PARTE QUINTA
TORINO, CITTà DELLE DONNE
15 / Alberto Friedemann
Imprenditoria femminile nel cinema torinese
Se si cerca di definire con precisione il concetto di ‘imprenditoria femminile’1 nell’Italia dei primi decenni del secolo scorso, si rischia di giocare sul filo del paradosso o di formulare un ossimoro: nel Bel paese, tradizioni, usi e pregiudizi tengono saldamente la donna su un gradino subordinato al maschio dominante e le leggi danno un contributo rilevante nell’impedire ogni mutamento2. La componente fondamentale di una situazione siffatta è certamente l’egoismo, peculiare a tutte le forme di sfruttamento: ciò che sembra soprattutto interessare alle élite maschili del potere è inibire ope legis ogni espressione di volontà personale e di attività autonoma, usando come strumento il Codice Civile del 1865 e stilando una serie di barriere insuperabili e di norme repressive; oltre alla mancanza dei diritti politici fondamentali – l’elettorato attivo e passivo – buoni esempi di questa determinazione nel campo del lavoro sono il divieto per le donne di accedere alla carriera in magistratura o la cura di impedire loro ogni possibilità di influenzare la formazione giovanile, negando per legge la possibilità di diventare presidi nelle scuole medie superiori o di insegnare determinate discipline3. Il lavoro femminile è visto negativamente, anche se è considerato un male necessario imposto dal
bisogno. Le occupazioni dipendenti sono condizionate dalla sperequazione salariale fra i sessi, che non invoglia la donna a uscire di casa se non per assoluta necessità: in nessun settore esiste parità di compensi per uguali mansioni e si arriva al 30% e fino al 50% di retribuzione in meno4. Non può stupire che gli imprenditori privilegino la manodopera femminile per un lavoro industriale non qualificato e alienante – all’inizio del secolo almeno la metà delle maestranze generiche nelle fabbriche è costituita da donne – né che nel settore agricolo la donna venga considerata forza-lavoro non retribuita della microeconomia contadina a conduzione familiare, e come tale sia attentamente valutata nel caso dei contratti di mezzadria5. I progressi in questi settori saranno quasi nulli fino alla caduta del fascismo6: ancora nel 1938 il regime propone di limitare per legge al 10% la percentuale di donne nelle aziende pubbliche e private medio grandi, escludendole del tutto da quelle con meno di dieci dipendenti7. Numerose ricerche negli ultimi anni hanno affrontato il tema del lavoro femminile dipendente, ma molto meno si conosce a proposito delle attività autonome, in particolare quelle che richiedevano investimenti finanziari e controllo dei capitali: è ancora il Codice Civile a porre un ostacolo difficilmente su195
trionale, si fanno sentire, debolmente e in ritardo, anche in Italia, accentuando la forbice fra “grande proprietà, impresa industriale e grande commercio da un lato, e piccoli operatori commerciali e dettaglianti dall’altro”9: le donne, ben presenti nel secondo settore, sono, di diritto e di fatto, quasi del tutto escluse dal primo. Strategie femminili nella gestione dei patrimoni familiari non sono da escludere, ma restano spesso sotterranee, informali: solo la donna sposata rimasta vedova che aveva ricevuto come eredità e godeva di beni parafernali, se poteva recuperare effettivamente il capitale dotale, se si trovava in condizione di ereditare qualcosa dal marito, allora, solo allora, essa poteva dirsi cittadina a tutti gli effetti civili e diventare davvero titolare di un patrimonio10.
Una raffigurazione della ‘donna tipo tre’: Marcello Dudovich, La Signorina della veletta, cartolina pubblicitaria della Biennale di Venezia del 1920. Stampa Alfieri & Lacroix, Milano
perabile imponendo con l’articolo 134 la cosiddetta ‘autorizzazione maritale’: “La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l’autorizzazione del marito”8. Ovviamente vi sono patrimoni controllati da donne e investimenti gestiti in prima persona, ma si tratta soprattutto di attività economiche a carattere familiare; le trasformazioni del sistema commerciale e produttivo del secolo diciannovesimo, conseguenza della rivoluzione industriale dell’Europa setten196
Fin qui il desolante quadro istituzionale: tuttavia, nei primi decenni del secolo ventesimo cominciano a sorgere alcune forme di imprenditoria femminile, per la cui conoscenza completa sarebbe necessario rispondere a questioni impossibili da trattare in questa sede: chi ne sono le protagoniste? si tratta di casi singoli, atipici, o rappresentano una tendenza più ampia? quale rapporto esiste con le correnti di pensiero dell’epoca11? Col nuovo secolo, anche in Italia, a imitazione di quanto si sta verificando in altri paesi, si assiste alla progressiva presenza della ‘donna nuova’12, che oltre ai diritti elettorali rivendica il proprio diritto all’autonomia nel lavoro. Chi è la ‘donna nuova’, cosa si intende con precisione con questa definizione? Una brillante analisi d’epoca, espressione di un punto di vista maschile affascinato e preoccupato13 a un tempo, si trova in un saggio di Umberto Notari, pubblicato per la prima volta nel 1924: l’indagine dell’autore, tenuta fra l’ironico e il paradossale, ma non per questo meno significativa, è interessante anche per lo stretto legame istituito fra la macchina e la donna nuova: La donna ‘tipo tre’ è colei che dai proventi del proprio onorevole lavoro trae i mezzi di sussistenza e si trova di fronte all’uomo – padre, fratello, marito o amante – in condizioni di assoluta indipendenza economica14 […] nel secolo XX non sono più un regime, un sistema, un popolo, una razza, una dottri-
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
na, una religione che possono costituire un’impronta prevalente […] L’unica grande ‘isotermica’ chiara e sicura, il solo punto di riferimento generale e collettivo è la ‘macchina’ ossia la civiltà meccanica […] la Macchina, dominatrice dell’Universo civile, ha messo al mondo la donna ‘tipo tre’ 15.
Per l’autore vi sono diversi modelli di donna ‘tipo tre’. I suoi plotoni, diremo così ‘premilitari’, sono costituiti di stenodattilografe, di contabili, di cassiere, di archiviste, di magazziniere, di telefoniste, di segretarie, di ragioniere, di insegnanti. Le dottoresse, le avvocatesse, le pediatre, le ginecologhe, le farmaciste, le chimiche, le giornaliste, sono ‘pattuglie di punta’ in formazione. All’estero, la ‘tipo tre’, capo azienda, proprietaria o dirigente di opifici, fondatrice e amministratrice di società anonime, è già sulla breccia con notevoli risultati. Taluna è giunta all’amministrazione di grandi città. Altre sono il deus ex machina di colossali formazioni industriali e finanziarie16. La superiorità [maschile] non è più che apparenza. Le forze intellettive della donna del ventesimo secolo si sono moltiplicate. La loro istruzione è pari a quella degli uomini del medesimo grado sociale. La loro intelligenza è più fine, più pronta, più intuitiva. Sul terreno degli affari la loro sensibilità è maggiore; maggiore è la loro attenzione, la loro prudenza, la loro discrezione, la loro tenacità17.
Per quanto riguarda il cinema, lo stato attuale degli studi non permette di tracciare un quadro completo della dimensione economica e sociale della situazione torinese, né sono stati affrontate in modo esauriente questioni fondamentali sia a proposito della politica degli investimenti che della forza lavoro: il reale impatto sociale del cinema nei primi decenni del Novecento18 è ancora in gran parte sconosciuto, al di là di affermazioni non documentate e di miti che spesso si rivelano ‘leggende metropolitane’. Questo studio si propone di affrontare l’imprenditoria femminile19 nell’industria cinematografica torinese; non pretende di dare risposte definitive, ma vuole essere un contributo alle conoscenze in proposito, raccogliendo i dati a disposizione negli archivi, ri-
cercando la presenza della donna in ruoli ritenuti tipicamente maschili e cercando di comprendere se il cinema, ‘macchina’ moderna per eccellenza, può essere stato terreno d’azione privilegiato della donna “tipo tre”; la mancanza di un quadro di riferimento complessivo impedisce di inserire compiutamente i risultati nel sistema economico cinematografico torinese.
Nota metodologica La ricerca analizza i tre rami in cui è comunemente divisa l’economia filmistica: produzione, noleggio/ distribuzione, esercizio, aggiungendone un quarto, in cui saranno prese in esame altre tipologie di aziende di solito trascurate (società tecniche, immobiliari, finanziarie…). Nomi, cariche e cifre sono stati ricavati dagli atti e dai documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Torino, l’Archivio Notarile Distrettuale di Torino e Milano, gli archivi del Comune di Torino e della Camera di Commercio e, in via subordinata, dagli estratti di documenti pubblicati sul Foglio di Annunzi Legali della Prefettura di Torino, che come tali rivestono valore ufficiale; sono invece attualmente in disordine e inutilizzabili per ricerche storiche gli archivi del Tribunale di Torino per gli anni considerati. Solo in mancanza di atti legali sono state prese in considerazione le poche informazioni economiche provenienti dai periodici di settore, scarsamente attendibili perché sempre retorici e superficiali, sovente ambigui e in contraddizione da un numero all’altro, incapaci di pubblicare smentite e correzioni. Sono state identificate tutte le società anonime (sa) e in accomandita semplice (sas), obbligate, dal Codice di Commercio, a depositare in tribunale e a rendere pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento, e da questi documenti sono stati ricavati i nomi dei soci fondatori e dei dirigenti – consiglieri di amministrazione e accomandatari; purtroppo, non sempre le società si preoccupavano di pubblicare gli spostamenti di pacchetti azionari e i mutamenti in consiglio. Non erano invece sottoposte a obblighi di pubblicazione degli atti le società in nome collettivo (snc) e le società di fatto, che quindi sfuggono all’inda197
gine d’archivio e per le quali ci si deve limitare alle notizie comparse sui giornali: se aziende impostate con una scelta strutturale e organizzativa siffatta costituiscono una percentuale trascurabile nei settori della produzione e nel noleggio, sono invece la maggioranza per quanto riguarda la gestione delle sale, dato il capitale, sovente minimo, necessario a rilevare i locali periferici di categoria inferiore e il logico desiderio di evitare spese burocratiche e notarili superflue. A titolo indicativo sono state riportate le quote iniziali sottoscritte dai soci fondatori, da mettere in rapporto al capitale sociale per comprendere appieno la portata della presenza femminile; vale la pena di ricordare che secondo l’articolo 131 del Codice di Commercio, per costituire legalmente una società anonima era necessario versare solo i tre decimi del capitale sottoscritto e a questa prassi si uniformavano quasi tutte le aziende, per cui l’entità reale del capitale effettivamente versato va in generale ridimensionata. Per i film (date, cast, critica), i repertori di riferimento sono stati: Aldo Bernardini (a cura di), Cinema italiano 1905-1969, 4 voll., Anica, Roma 19911993; Aldo Bernardini, Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1905-1931, 15 voll., Nuova eri / csc, Torino, Roma 1991-1996. Per valutare, sia pure in modo forzatamente approssimativo, l’importanza dell’impegno finanziario delle diverse aziende e dei soci, dato il continuo e irregolare andamento della lira nel periodo considerato, nella Tabella 1 vengono riportati i valori (ricalcolati in base a coefficienti che definiscono il potere d’acquisto) della lira negli anni, espressi in lire 2005.
Produzione È ben noto l’impetuoso sviluppo della produzione cinematografica a Torino nei due primi decenni del secolo scorso, tuttavia il grande numero di società fondate a Torino nel periodo del muto, oltre centoquaranta, non deve trarre in inganno: la maggioranza di queste aziende, fondate con capitali esigui, senza programmi chiari e con la speranza – specialmente fra il 1913 e il 1921 – di partecipare a quelle che sembrano insperate possibilità di realizzare ingenti guadagni senza possedere doti particolari, ha vita effimera; spesso queste società non riuscirono a portare alla distribuzione commerciale alcuna pellicola o si limitarono a realizzare uno, due film di pessima qualità, prima che l’azienda venisse chiusa con la perdita completa del capitale. La partecipazione femminile nelle anonime e nelle accomandite è minima: analizzando gli elenchi dei soci delle società con capitale maggiore – è il caso dell’Ambrosio e della Cenisio – in cui l’impegno finanziario è diviso fra un grande numero di sottoscrittori, è chiaramente avvertibile che la maggioranza degli impegni finanziari è dovuta a rapporti di parentela o comunque di affinità. Va sottolineata la presenza di numerose vedove, in percentuale sicuramente sopra la media demografica nel caso dell’Ambrosio, ma, come si è già accennato, la condizione vedovile è l’unica a permettere alla donna una completa autonomia nella gestione del proprio capitale, mobiliare e immobiliare. Si tratta comunque di cifre abbastanza contenute, versate da signore di cui non si sa nulla, per cui è oggi impossibile attribuire la sottoscrizione di quote a scelte
Tabella 1 – Valori della lira 1905-1946 1905 1911 1917 1923 1929 1935 1941
7.123,94 6.590,91 3.441,61 1.582,52 1.465,46 1.900,96 1.063,53
Fonte: istat 198
1906 1912 1918 1924 1930 1936 1942
6.994,00 6.531,47 2.468,15 1.528,70 1.513,44 1.767,46 920,15
1907 1913 1919 1925 1931 1937 1943
6.678,69 6.518,41 2.431,33 1.360,83 1.675,25 1.614,66 548,68
1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944
6.747,83 6.518,41 1.850,24 1.261,54 1.720,35 1.499,51 123,46
1909 1915 1921 1927 1933 1939 1945
6.941,86 6.091,87 1.563,91 1.379,84 1.828,44 1.436,08 62,68
1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946
6.754,82 4.868,11 1.573,35 1.488,90 1.927,95 1.230,58 53,11
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
di investimento piuttosto che a rapporti di amicizia e di parentela. I vincoli di parentela giocano sicuramente un ruolo essenziale in alcune società minori, come la Fiorini Film, in cui la maggioranza assoluta delle azioni appartiene a due fratelli, o la Perla Film e la Realcine, in cui è una coppia di coniugi a detenere la maggioranza del capitale sociale. Anche in questi casi non è possibile decidere se queste partecipazioni di famiglia con la divisione delle azioni fra due coniugi siano dovute a ragioni fiscali o ad altre motivazioni. La partecipazione femminile a funzioni direttive nelle anonime esaminate è nulla con due sole eccezioni in società di minima importanza, quelle di Luisa Zeme in Feroldi eletta nel consiglio d’amministrazione della Realcine nel 194120 e Carla Righini in Cavalli, cooptata nel consiglio dell’Ancora Film nel 194421: per quanto non si sappia nulla della signora Righini, si tratta presumibilmente di una professionista, dato che né lei né il marito figurano fra gli azionisti della società. Non vi è alcuna indicazione di presenza femminile nelle funzioni direttive nelle anonime esaminate, anche se un caso lascia qualche perplessità: la Delta Film Ettore Ridoni & C. viene fondata nel 1918 come accomandita con un capitale di 125.000 lire, cui partecipa per un quinto, alla pari con gli altri quattro soci, Roberto De Fernex, un industriale cotoniero appartenente a una nota famiglia di banchieri torinesi22. Meno di un anno dopo, De Fernex muore e la vedova, Semele Temofila Bertolina, non solo sostituisce il marito nella proprietà delle carature sottoscritte, ma rileva anche la quota di uno dei fondatori: diventa in tal modo l’azionista di maggioranza – controlla 50.000 lire su un capitale di 125.000 – ma non assume alcuna responsabilità direttiva23. Probabilmente la signora De Fernex considera la produzione cinematografica un investimento sicuro, perché la Delta Film, che ha sotto contratto Saetta, al secolo Domenico Gambino, uno dei tanti ‘uomini forti’ nati sulla scia del successo di Maciste, riesce a distribuire con buoni risultati un film nel 1918, quattro nel 1919, tre nel 1920: nello stesso 1920 tuttavia la società è messa in liquidazione24, probabilmente perché Gambino ha abbandonato la Delta costituendo una propria società, la Saetta Film.
Iniziative imprenditoriali sono prese da alcune attrici, non solo di cinema, che nella presuntuosa convinzione che il loro nome su una pellicola basti ad attirare il pubblico nelle sale, danno vita a case di produzione25. Di queste aziende si conosce ben poco: le poche notizie in merito provenienti da rari accenni comparsi nelle riviste di settore – sempre superficiali e secondo l’uso giornalistico del tempo improntate alla più smaccata adulazione, senza molti riguardi per la realtà – e da qualche inserzione pubblicitaria, non dicono nulla sulla struttura sociale (data la mancanza di atti legali registrati, si tratta di società di fatto o a titolo individuale), né sul capitale impiegato e sull’organizzazione interna; è tuttavia legittimo pensare che le attrici eponime abbiano
Fabienne Fabrèges, titolare della Fabrèges Film, creata nel 1918
199
rivestito un ruolo importante, sia nel versamento dei capitali iniziali sia nelle decisioni più importanti e nelle scelte strategiche. Di vita brevissima, queste società – solo un paio raggiungono i due anni di vita, stando alle date dei visti di censura delle pellicole distribuite con quel marchio26 – sono frutto di una concezione esasperata del nascente divismo e dell’eccessiva importanza attribuita al protagonista nel successo di un film27, cosicché molte attrici furono convinte di poter agire come la diva per eccellenza, Francesca Bertini, anche se non vanno sottovalutate la pericolosa euforia produttiva del primo dopoguerra e le tendenze puramente speculative, sempre presenti nel cinema italiano: i risultati sono comunque miseri e i pochi film che riescono ad arrivare alle sale, ottengono quasi sempre giudizi – di critica e di pubblico – severi. Un’attrice di buon nome, Mary Cléo Tarlarini, è fra le prime ad aprire a Torino nel 1918 una società di produzione28 – anche se forse nel suo caso possono avere giocato altri motivi29 – la Cléo Film: la società riesce a distribuire cinque film nel 191830 (Il Canto della fede, Contrasto d’anime, Gli invasori, Il lampionaro del Ponte Vecchio31, Le peripezie dell’emulo di Fortunello e compagni) e uno nel 1919 (Dalle catene alla morte), con risultati di critica mediamente discreti, ma insufficienti a proseguire l’attività.
Logo della Cléo Film, fondata nel 1918 da Mary Cléo Tarlarini 200
Amara è la breve avventura nella produzione di film col proprio nome da parte di un’attrice dal buon curriculum, Fabienne Fabrèges: francese di nascita, dopo una discreta carriera in patria e diversi film in cui era stata diretta da Léonce Perret, si trasferisce a Torino nel 1914 lavorando per società di secondo piano – Corona, Latina Ars, Gladiator – per decidere infine di dare vita a una propria società, la Fabrèges Film32 nel 1918: tuttavia, l’unico film in programma, Supremo fascino, nonostante una pubblicità martellante non riesce ad arrivare alla distribuzione commerciale nelle sale. Pure legata a un progetto di esaltazione divistica, ma più interessante per il nostro assunto perché legata a imprese condotte con reale spirito imprenditoriale, è la vicenda di un’altra Casa di produzione costituita nel 1920, le Edizioni Films d’Arte Contessa Bianca Guidetti Conti33, dalla pomposa ragione sociale in cui il nome dell’attrice, quasi sconosciuto, è sostenuto da un titolo nobiliare – presente con una coroncina comitale anche nel logo. Bianca Guidetti, comparsa nel panorama del cinema torinese nel 1918, è una bella donna molto alta, bionda, con gli occhi chiari, ma dal look piuttosto in ritardo, chiaramente ispirato a Lyda Borelli; il matrimonio le ha portato il titolo di contessa e la possibilità di unire al cognome di nascita quello del marito34, scrivendolo con un trattino in mezzo, a suggerire un doppio cognome nobiliare. Il suo passato di attrice teatrale è incerto35, ma, oltre al titolo, possiede un villino a due piani in via Romani 1036, può disporre di un capitale – di origine ed entità sconosciuta – ed è amica di un divo, Febo Mari che, dopo una bella carriera di attore e regista, ha deciso di mettersi in proprio costituendo la Mari Film e lavorando inizialmente nel vecchio stabilimento della Navone Film di via Romani 1737, quasi di fronte alla casa della contessa. È Mari a impiegare per primo38 nel 1918 l’amica – presentata come Donna Bianca Licia Guidetti39 – come attrice40 in due film (Giuda, L’orma) dall’esito catastrofico: i risultati negativi anche degli altri film prodotti dalla sua società inducono l’attore-regista-produttore a chiuderla e a cambiare strategia fondando con l’amica una nuova Casa di produzione, dal nome suggestivo, Circe, acronimo
Bianca Guidetti Conti
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
201
Bianca Guidetti Conti
di Compagnia Italiana Rodriguez Cine Edizioni41: un omaggio di un gentiluomo al fascino della donna o una prima affermazione di potere da parte dell’attrice? La sede legale della nuova editrice è in casa della Guidetti, mentre le riprese saranno eseguite in via Romani 17 o in via Morghen 17, dove Mari era riuscito ad aprire un proprio stabilimento42. I risultati della Circe (cinque pellicole distribuite nel 1919, tre nel 1920) non si scostano dai fallimentari risultati del tentativo precedente di Mari e probabilmente è a questo punto che Bianca, stanca di partecipare a iniziative produttive velleitarie e senza esito, decide di staccarsi dall’attore siciliano e di costituire una casa editrice gestendola direttamente, le Edizioni Films d’Arte-Contessa Bianca Guidetti Conti43; la Circe interrompe la produzione e, mantenendo la sede in via Romani 10, cerca di sopravvivere trasformandosi in società di sviluppo e stampa44. Quanto 202
alla Guidetti Conti Films, le pellicole effettivamente distribuite (sei nel 1921: L’ape, Cipria e sangue, Doloretta, Idillio, Tragedie d’anime, La verità della favola; due nel 1922: Il miraggio di mezzanotte, La via delle lacrime) vedono la contessa protagonista, e riscuotono un successo di critica senz’altro maggiore di quelle della Mari Film e della Circe; i giornalisti non si compromettono sulla qualità dei film, mentre viene invece giudicata favorevolmente la recitazione di Bianca: è “attrice di singolari attitudini”45, in grado, come capita alle vere dive, di salvare un film, giudicato “buono, primieramente per merito della Guidetti”46 e anche di sostenere exploit notevoli: “La Contessa Bianca Guidetti Conti, che sostiene due parti, ci ha sorpresi per la facilità con la quale disimpegna la sua non facile fatica”47. Nell’avventura di produttrice/attrice di Bianca Guidetti sorprende l’unanimità dell’atteggiamento critico favorevole alle sue doti di recitazione: d’altronde, il numero inconsueto di fotografie, anche in copertina, pubblicate dai giornali48 è segno evidente che l’appoggio editoriale va alla donna, più che ai suoi film: che le riviste privilegino, nelle recensioni e negli articoli, le società più generose nell’acquisto di pagine pubblicitarie, è una costante dell’editoria cinematografica, ma per la contessa si tratta di qualcosa di diverso – le inserzioni della Casa di produzione non sono particolarmente numerose – e sembra palese che siano intervenuti altri fattori. Per un cinico, ben noto principio, all’origine di ogni problema c’è sempre una donna 49, ma in questo caso si può provare a capovolgerlo cercando una presenza maschile dietro a Bianca: una breve ricerca porta facilmente a identificare l’uomo in Emilio De Bono, eroe di guerra, generale di corpo d’armata, fascista della prima ora – parteciperà alla Marcia su Roma come quadrumviro e verrà nominato immediatamente dopo il 28 ottobre capo della polizia e comandante della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Non può essere un segreto nel ristretto ambiente torinese che fra i due esiste un rapporto molto stretto: forse non è ancora una relazione sentimentale, ma lo diventerà presto50 e durerà fino alla morte di De Bono51. Conoscendo la personalità rigorosa del generale, si può escludere che vi siano state pressioni da parte sua per favorire la contessa,
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
ma gli interventi diretti non sempre sono necessari: nel piccolo ambiente cinematografico dell’epoca, a Torino tutt’altro che ostile al fascismo52, la conoscenza, sia pure come semplice pettegolezzo, del rapporto privilegiato fra Bianca e un personaggio importante come De Bono, e il desiderio cortigianesco di fare cosa gradita ai potenti, possono contare come e più di pressioni e interventi diretti. Dopo il 1922 le Edizioni Films d’Arte interrompono la produzione e Bianca chiude con l’attività cinematografica, nonostante il giudizio favorevole della critica53. Non sono noti i motivi della decisione: forse per l’attrice nella scelta di rinunciare a un’affermazione personale gioca un ruolo importante la volontà di non nuocere alla figura di De Bono rendendo nota su scala nazionale la scandalosa relazione di un uomo sposato, alto ufficiale vincolato al rispetto dei rigidi principi di onore della tradizione militare sabauda e figura rappresentativa di un fascismo in cerca di una legittimazione borghese, con una donna di spettacolo54, forse c’è la consapevolezza di incarnare un modello divistico irrimediabilmente superato55: qualunque sia stato il motivo del ritiro, Bianca Guidetti comincia una nuova carriera di imprenditrice con risultati alterni. La Casa di produzione non rende e viene chiusa, ma nel frattempo la signora, diventata proprietaria del terreno di via Morghen 1756 e dello stabilimento della Mari Film, dopo un tentativo fallito di far rendere gli impianti cinematografici locandoli a terzi57, elimina le poche attrezzature tecniche e per un paio d’anni nel terreno è sistemata un’impresa di fornitura all’ingrosso di legna e carbone58: la ‘contessa’ doveva vergognarsi un poco di questa nuova attività commerciale, dato che la nuova azienda e il terreno compaiono come di proprietà di Bianca Conti Guidetti, con l’inversione dei due cognomi e senza esibizione di titoli nobiliari. Liquidata anche questa impresa59, sul lotto di via Morghen/via Migliara, cambiata la destinazione d’uso, Bianca Guidetti costruisce una palazzina di tre piani, che resterà di sua proprietà anche dopo il trasferimento a Roma nel 193560. L’ultimo tentativo di un’attrice di nome di dare vita a una propria casa editrice è quello di Maria Roasio, una giovane interprete che si è affermata nel dopo-
guerra lavorando in numerose pellicole dell’Ambrosio. Forse delusa dalle tristi vicissitudini della Casa madre, Maria dà vita a una propria società, sperando di iniziare una serie Roasio, ma riesce a realizzare un solo film, La bambola vivente, distribuito nel 1924: le critiche mediocri e l’accusa di plagio nei confronti di una pellicola tedesca del 1919, Die Puppe, pongono fine alla sua avventura imprenditoriale. Vi sono altri casi di imprenditoria femminile nel settore produzione, ma lasciano perplessi, perché nati da attrici senza alcuna fama o addirittura da estranee al mondo del cinema, che tuttavia pretendono di dare il proprio nome a effimere società.
Maria Roasio 203
Vera Sylva, “La Vita cinematografica”, 1920
La Campi Film nasce nel 1917 per sfruttare il nome di una “stellissima del varietà”61, Maria Campi, ma il risultato della prima pellicola realizzata, Passa la gioventù, è disastroso, con giudizi sulla protagonista ai limiti dell’insulto personale, insieme a crudeli richiami a un passato ormai lontano: “Questa povera femmina grottesca […] Frequentavamo le scuole elementari quando furoreggiava nei maggiori variétés urbani una chanteuse volgare anzichenò di fisico e di stile […] Non taceremo la nostra indignazione di fronte a questa noiosissima, fastidiosissima donna…”62. Ovviamente per la società non vi è futuro; quanto alla Campi, lavora in qualche altro film di scarso successo ricevendo altre critiche dello stesso tenore63, poi scompare dalle cronache cinematografiche64. Quali motivi possono avere spinto una protagonista indiscussa del teatro leggero a un’iniziativa così mal 204
calcolata e rischiosa, anche finanziariamente? Probabilmente giocarono fattori diversi: la sopravvalutazione del proprio nome, la voglia di mettersi in gara con le nuove stelle dello schermo – le Borelli, le Bertini, le Menichelli – che stavano rubando a quelle del varietà fama e guadagni, forse anche la consapevolezza che gli anni del maggior splendore erano ormai alle spalle, per l’età, più che matura, dell’attrice65. Vi è tuttavia una profonda differenza di giudizio fra critici del varietà e del cinema, anche in prospettiva storica: ciò che per i primi è “volgare” e “noiosissimo”, per gli altri, pur trascurando naturalmente le valutazioni sulla voce, con ben più di un pizzico di compiacimento è considerato soavemente “provocatorio e inducente al peccato [perché] il suo fisico è giustamente di quelli che ha immaginato, o tratti dal vero, Domenico Morelli nelle sue parlanti Tentazioni di Sant’Antonio”66. Neppure i motivi della fondazione di un’altra azienda, la Tornielli Film, sono chiari: l’attrice eponima, Elsa Tornielli, è quasi una sconosciuta, nota forse soprattutto67 per essere “Alta, slanciata, di figura prestante [ma anche] audace, temeraria, sprezzante d’ogni pericolo...”68 caratteristiche che le avevano valso la partecipazione come comprimaria a Sansonette e i quattro Arlecchini, una delle pellicole avventurose con cui la Albertini Film cercò di dare vita all’equivalente femminile degli ‘uomini forti’ lanciando Sansonette, al secolo Linda Albertini69. Nelle riviste professionali alcuni brevi articoli di lode all’attrice e ai programmi della nuova casa, e diverse inserzioni pubblicitarie, specialmente sulla “Rivista cinematografica”70, informano che la Tornielli Film sta preparando alcune pellicole: quattro (La ballata del destino, La bocca suggellata nel 1920; Il fazzoletto insanguinato, La spiga, la nube e il re, nel 1921), con Elsa protagonista e un ex-operatore della Albertini Film, Michele ‘Lele’ Malerba, alla regia71, arrivano alle sale, del tutto ignorati dalla critica – e presumibilmente dal pubblico; altre due pellicole annunciate in lavorazione, L’uomo che non riconobbe se stesso72 e Nostra signora dei peccatori73, non riescono a essere distribuite. Dopo il 1921 la società scompare e non si hanno più notizie di Elsa Tornielli né di Malerba. Curioso è anche il percorso della Vera Sylva Film: la società nasce nel 1920 e prende il nome da Vera
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
Sylva, una signora sconosciuta di cui la pubblicità dice che è una “scrittrice, dotata di intelligenza non comune, aperta a ogni manifestazione d’arte e del bello”74 e che “non ha la bellezza della classica bambola, calma, statuaria, dalle linee pure, ma ha la bellezza dell’essere vibrante, fasciato di nervi, sensibilissimo”75. Le numerose inserzioni le valgono tre copertine e un lungo articolo di lode76, ma l’unico film77 di cui è certa la realizzazione (Da Lord a detective), con un cast artistico e tecnico di sconosciuti78, sarà distribuito nel 1922, non ottenendo neppure una recensione. Va citata ancora l’Aloisia Film: la società di questo nome inizia nell’autunno del 1923 e prosegue a lungo79 una massiccia campagna pubblicitaria, condotta quasi esclusivamente su “La Cinematografia italiana ed estera”, annunciando che è in preparazione un film, La denunzia, tratto dalla commedia omonima di Pier Nicola Gallesio: lo stesso personaggio, impiegato delle ferrovie dello stato e del tutto ignorato dalle storie del teatro, è autore della riduzione cinematografica della pièce e della messa in scena. Dopo una visione privata nel dicembre 1923, la pellicola arriva infine in una sala pubblica, il Nazionale di Torino, il 20 febbraio 1925, ottenendo una recensione entusiasta solo da parte di Gualtieri I. Fabbri, direttore della “Cinematografia italiana ed estera”: per diversi numeri la rivista ripubblica – con traduzioni in francese, inglese, tedesco e spagnolo, ma senza citarne l’autore, segno forse di un sopravvenuto pudore professionale da parte di Fabbri – le iperboliche lodi del critico per Aloisia, nella parte della madre, come attrice e come donna: “Efficacissima la Aloisia – veramente nel fiore della bellezza”80, anche se in base all’unica, piccola fotografia nota della signora, si direbbe che l’attrice sia una donna di una certa età, senza alcuna caratteristica notevole81. Secondo Roberto Chiti, la produzione della Denunzia fu finanziata da una sorella dell’autore, Aloisia Gallesio, che impose di dare il proprio nome alla società e di ottenere una parte di rilievo82. Né la società né Aloisia ebbero un futuro nel cinema. È forse da attribuire a Torino83 anche l’avventura di Lydianne e della sua Casa di produzione: l’attrice è
una perfetta sconosciuta quando nel 1916 la stessa pagina pubblicitaria, ripetuta solo due volte, informa che “Lydianne, francese di nascita, è un novello fulgido astro che appare nell’Olimpo cinematografico nazionale” e che nel film da poco terminato, Rosa mistica, ha “superato ogni aspettativa” e che altri sono in preparazione84; dopo queste poche righe, sul film, sulla protagonista e sulla casa editrice cala il silenzio. Rosa mistica, con altri tre titoli: Sirena, Per una lagrima, Un notturno di Chopin, diretti da Enrico Vidali, riesce finalmente ad arrivare a una stentata distribuzione nel 1919, ottenendo recensioni mediocri; con il marchio della casa verranno commercializzate altre due pellicole, Ferragus, nel 1920 e La donna che fu molto amata, nel 1922, sempre per la regia di Enrico Vidali. Sono ignoti i motivi dei ritardi di commercializzazione, forse dovuti alla scarsa qualità delle opere: probabilmente La donna che fu molto amata fu recuperato in virtù della dissennata politica di acquisizione di film e società dell’uci, che lo distribuì riscuotendo unanimi critiche negative. La società era ormai da tempo defunta; quanto a Lydianne, nonostante i dubbi sulle sue doti recitative85, riuscì a ottenere ancora per due-tre anni qualche parte secondaria nei film del trust. La Manzini Film non ha invece nulla a che fare con la nota attrice Italia Almirante Manzini86: l’iniziativa di una società con questo nome è dovuta ad Amerigo Manzini, marito di Italia, giornalista e commediografo87, con qualche esperienza come attore e regista, ma la casa realizza un solo film, L’inferriata della morte, con la partecipazione dell’attrice. Per motivi sconosciuti, la pellicola viene distribuita solo due anni dopo la produzione, nel 1920, ricevendo pessime critiche: reagendo alle notizie pubblicate dai giornali, che la vogliono coinvolta nella società, Italia Almirante invia una dura smentita alle riviste professionali: “Io mi prestai, circa due anni fa, a solo scopo di beneficenza […] la Manzini Film non mi riguarda e non ho mai lavorato per questa ditta”88. È diversa e del tutto particolare l’esperienza nella produzione di un’ex attrice, Adriana Costamagna, di breve durata, ma molto interessante per quanto rivela della personalità della protagonista. Giovanissima 205
– era nata nel 1889 – Adriana comincia a lavorare come comparsa all’Itala, guadagnando rapidamente una promozione a ruoli più impegnativi e ottenendo ottimi giudizi critici, anche dalla stampa internazionale, per le sue caratteristiche insolite: “Talent actress in every sense of the word... Her versatility is wonderful. She is a beatiful woman, with mobile features and has the God-given power of transforming them at will”89. Nel 1913 la sua carriera subisce un brusco arresto, quando durante la lavorazione di una pellicola della Savoia Film, l’attrice è assalita e sfigurata da un leopardo: anche se il giorno dopo i quotidiani annunciano che l’attrice, prontamente medicata in ospedale, guarirà in venticinque giorni, secondo una leggenda metropolitana ampiamente diffusa da allora Adriana non avrebbe più permesso a nessuno di vedere il suo volto, coprendolo con un velo scuro90. Con velo o senza, Adriana Costamagna dimostra un carattere forte e insolite capacità di reagire alla sfortuna, partecipando, il 31 dicembre 1914, alla fon-
dazione di una Casa di produzione, l’Enotria Film, snc che dovrebbe durare fino al 31 dicembre 1919. L’esiguo capitale di 6.000 lire è sottoscritto in parti uguali da tre soci, Adriana, Annibale Durelli, Michele Tricarico: la divisione degli utili secondo lo statuto sociale chiarisce che il ruolo principale, anche se non definito con precisione, spetta alla giovane donna, dato che 15/30 restano a disposizione, 7,5/30 andranno a Costamagna, 5,5/30 a Durelli, 2/30 a Tricarico91. Tuttavia, pochi mesi dopo la fondazione, per motivi sconosciuti, Adriana abbandona la società cedendo la propria quota a un altro attore, già suo partner in alcune pellicole, Dillo Lombardi92. Qualche anno dopo, nel 1923, i giornali danno nuovamente notizia di un’attività non recitativa di Costamagna, annunciando che partecipa come direttore artistico alla costituzione di una nuova società, la Almozara Film, di cui non viene fornito alcun dato93: la nuova impresa però non riesce a far giungere alle sale neppure il film annunciato come in lavorazione per la regia di Adriana, Prevaricazione.
Adriana Costamagna
Un caso particolare è quello di Lidia Dosio, la cui attività si svolge in un settore particolare del lavoro cinematografico, quello pubblicitario. Nell’autunno 1913 è fondata a Torino una società in accomandita semplice, la Lydel-Cav. I. Leonardi & C., con un oggetto sociale nuovo per l’Italia: “l’industria della pubblicità a mezzo del cinematografo comunque e ovunque esercitata”; in contrasto con le consuetudini, i tre soci sottoscrittori del capitale sociale di 15.000 lire, non partecipano direttamente alla gestione dell’azienda, ma nominano accomandatari la signora Lydia de Liguoro94, pubblicista, cui “spetterà in modo speciale la cura della ricerca e la trattativa degli affari, sia nei riguardi dei clienti, sia in quello dei cinematografi” e Ippolito Leonardi, che curerà l’amministrazione; in riconoscimento del suo lavoro a Lydia spetterà il 30% degli utili e a Leonardi il 20%, mentre i tre accomandanti si divideranno il 50% residuo95. Poco meno di un anno dopo, nell’aprile 1914, per facilitare lo sviluppo dell’azienda, l’accomandita viene trasformata in anonima, semplificando la ragione sociale in Lidel e portando il capitale a 55.000 lire: alla sottoscrizione partecipa questa volta anche Lydia, che si impegna per 5.000 lire96.
206
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
Tabella 2 – Produzione Casa di produzione
Anno di fondazione
Capitale sociale (lire) Partecipazione femminile (lire)
Almozara Film Ambrosio SA
1923 1907
700.000
Ancora Film Biblia Film
1944 1915
500.000 55.000
Campi Film Cenisio Film
1917 1914
300.000
Cléo Film 1918 Delta Film-Ettore Ridoni & C. 1918
125.000
Edizioni Films d’ArteContessa Bianca Guidetti Conti Enotria Film Eporedia Film Fabrèges Film Fiorini Film
1920
1914 1920 1918 1919
6.000 51.000
Gladiator
1919
1.500.000
Italo-Egiziana Film “Mario Ceccatelli” Leonardo da Vinci SA Lydel-Cav. I. Ippoliti & C. Lydianne Perla Film Realcine Roasio Films Torino Film Tornielli Film Vera Sylva Film
1917
35.000
1914 1914 1916 1921 1941 1923 1912 1920 1922
400.000 55.000
100.000
400.000 500.000 100.000
Costamagna Adriana Almonte Catterina, ved. Luciano Molin (2.000) Caffarel Adelina, ved. Caffarel (700) Clerico Estella (2.500) Gribaudi Ernestina, ved. Molin (2.000) Gribaudi Giuseppina (2.000) Gribaudi Marina (2.000) Piovano Delfina, ved. Lodi (5.000) Pollarolo Delmira (1.000) Prato Antonietta, ved. Damianino Molin (4.000) Taddei Enrica, ved. Ronco (1.000) Righini Carla in Cavalli (cda) Ghilia Anna, detta “Nancy” (5.000) Vinca Maria (1.500) Campi Maria Camusso Maria, ved. Di Scalzo (10.000) D’Alberti Emilia (5.000) D’Alberti Nerina (5.000) Frisetti Felicita in Lana (5.000) Parvis Giulia in Bernocco (1.000) Ravignani Rosa in Guarienti (4.000) Sobrero Alice in Guarienti (5.000) Sobrero Ida (3.000) Vigo Maria (5.000) Vischi Enrichetta, ved. Geymonat (5.000) Vigo Carola in Voena (5.000) Tarlarini Mary Cléo Bertolina Semele Temofila, ved. Roberto De Fernex (50.000) Guidetti Bianca in Conti
Costamagna Adriana (2.000) Fioravanti Gianna (1.000) Fabrèges Fabienne Magnoni Cecilia (5.000) Mestrallet Anna (25.000) Corsetti Margherita, ved. Manavello (50.000) Mazzucchelli Angelica, ved. Torretta (50.000) Pini Linda, ved. Ceccatelli (5.000) Ricotti Armanda in Grillandini (600) Dosio Lidia in De Liguoro (5.000) Lydianne Ghidini Giuseppina in Calandra (125.000) Zeme Luisa in Feroldi (166.700) Maria Roasio De Guidi Irma in Ubertalli (5.000) Elsa Tornielli Vera Sylva 207
La vita dell’anonima non è facile e i documenti disponibili non ne chiariscono del tutto i motivi, anche se è possibile intuirli: lo scoppio della guerra europea ha contratto il mercato pubblicitario, mentre sono saliti bruscamente i prezzi delle materie prime, tutte d’importazione, per cui l’assemblea del 7 aprile 1915 è costretta a ridurre alla metà il capitale sociale per compensare le perdite; con un’altra delibera Lydia de Liguoro viene emarginata dalla gestione della società, di cui nel corso della riunione aveva chiesto la liquidazione97. L’andamento continua a essere sfavorevole anche nell’esercizio successivo; nell’assemblea del 27 aprile 1916 si informano i soci che le perdite sono ancora aumentate né si intravede la possibilità di invertire la tendenza negativa: lo scioglimento appare inevitabile. La riunione è tumultuosa perché la de Liguoro, già in contrasto con tutti gli altri soci, arriva in ritardo e affermando di non essere stata avvertita, pretende di annullare l’assemblea; i presenti le rinfacciano di non avere alcun diritto dato che non ha ancora completato il versamento della quota sottoscritta; ma nonostante la sua offerta di saldare immediatamente il debito, la decisione di sciogliere la società non viene annullata98. Secondo quanto emerge dai documenti, il comportamento di Lydia Dosio non appare ineccepibile, in ogni caso non al livello del compito che le era stato affidato, sviluppare gli affari della azienda; la giovane donna però saprà dimostrare le proprie capacità nel dopoguerra, iniziando nel 1919 la pubblicazione a Milano di “Lidel”99, una rivista indirizzata al pubblico femminile della media borghesia con un programma nuovo, dalle accentuate caratteristiche culturali, per diversi aspetti in anticipo sui tempi: “Lidel” è in particolar modo una rivista illustrata. Oggi […] l’immagine, dalla fotografia al disegno, dal quadro al croquis, è il riflesso veloce, pronto, sicuro, comunicativo che mette l’individuo a diretto contatto con la vita esteriore nazionale e mondiale e che appaga il suo bisogno di sapere, di conoscere tutto e tutto afferrare con rapido sguardo100.
“Lidel” avrà un buon successo e durerà fino al 1935: forse un po’ partigiana, “La Vita cinematografica” la giudicherà “la più bella rivista d’Italia”101. 208
Noleggio Nel complesso mondo economico del cinema, il lavoro di indagine sui primi decenni di distribuzione e noleggio è quello più irto di ostacoli, per diversi fattori: oltre ai problemi generali già indicati102, non vi sono resti materiali, spesso le aziende sono difficilmente identificabili perché hanno come ragione sociale solo il nome – sconosciuto – dei proprietari e non riportano apposizioni chiarificatrici come ‘film’ o ‘cinema’: le citazioni sui giornali e le inserzioni pubblicitarie, anche se ambigue e spesso contraddittorie, restano la fonte principale di conoscenza iniziale. Tutti questi fattori giocano negativamente, ma una volta preso atto dell’esistenza delle imprese, per conoscerne le vicende si deve affrontare un’altra difficoltà: al di là dei proclami delle inserzioni pubblicitarie secondo cui gli affari vanno sempre benissimo e sono in continuo aumento, le società di distribuzione tendono a mantenere riservata la reale consistenza del proprio patrimonio di concessioni e l’ammontare dei bilanci annuali, sì che a volte giunge assolutamente inaspettato l’annuncio della chiusura o di un fallimento. D’altronde va detto che sono proprio i fascicoli dei procedimenti fallimentari a fornire i migliori strumenti di comprensione della storia di una società: redatti da specialisti di gestione e di bilanci aziendali, entrano nel vivo di un’impresa, ricostruendone il passato e portando alla luce il reale andamento economico e le scelte strategiche più importanti. Per quanto riguarda la situazione torinese, non si può trascurare che a partire dal 1919 noleggio ed esercizio soffrono della fortissima presenza nella zona nordovest (Piemonte e Liguria) della Società Anonima Stefano Pittaluga, che limita gravemente la possibilità di sviluppo di altre aziende del settore, sì da rendere disponibile ai possibili concorrenti solo la penetrazione nei circuiti di periferia e di provincia, o comunque nelle sale meno lucrose; la situazione cambierà dopo la liquidazione della sasp nel 1935, e il passaggio delle sue attività più redditizie – noleggio e parte dell’esercizio – all’enic, permettendo il fiorire di diverse agenzie di noleggio e di embrionali catene di sale103. A differenza di quanto si verifica per le società di produzione, dove la gestione femminile è rilevante solo
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
nel caso particolare delle piccole imprese fondate da dive o aspiranti tali, nel noleggio emerge in modo significativo – nel bene e nel male – l’attività imprenditoriale di alcune donne. Purtroppo, mentre delle attrici che affrontarono la produzione si ha una – relativa – ricchezza di informazioni a ragione della loro attività primaria, in questo settore, a meno di casi particolari, le protagoniste della distribuzione sono conosciute solo per le vicende della loro società. Nonostante la scarsità di notizie, le figure di alcune imprenditrici si impongono all’attenzione e fra queste il personaggio più interessante è sicuramente quello di Frieda Klug, la prima donna a imporsi nel mondo degli affari cinematografici di Torino agli albori del Ventesimo secolo e probabilmente la figura più notevole dell’intero panorama
Frieda Klug, “La Vita cinematografica”, febbraio 1910
imprenditoriale femminile: la conoscenza della sua vicenda, nei limiti permessi dai pochi documenti noti, permette di apprezzarne la personalità. La prima notizia su Frieda Klug comparsa sui giornali risale all’estate 1910, da cui si apprende che la giovane è appena ritornata dall’America: di cui, pur facendosi valere quello che vale, cioè moltissimo, non è rimasta troppo soddisfatta degli yankees cinematografici. Abbiamo conosciuto questa valida giovane negli uffici della ormai defunta Ditta, che, cinematograficamente, ha, da Torino, sconvolto mezzo mondo, noi compresi, causa l’inatteso suo fallimento. Brameremmo rivedere Miss Freda [sic!] per stringerle la delicata mano, virilmente [sic!] e onestamente operosa, e augurarle ogni prospero successo, qui, tra noi, suoi ammiratori104.
Poche righe significative, che informano come per la giovanissima ungherese – è nata a Budapest il 6 luglio 1888105 – si tratta di un ritorno a Torino, dove è in rapporti di lavoro con l’agenzia di noleggio di Adolfo Schultze – e che il suo viaggio d’affari negli Stati Uniti non ha dato i risultati sperati. Sono mesi fondamentali per il futuro e Frieda è donna dalle decisioni rapide, forse avventate: al ritorno dall’America e in seguito al fallimento di Schultze il 18 giugno 1910, dopo neppure un mese inizia un’attività di noleggio in proprio. Pur in mancanza di documenti, sembra innegabile che la decisione di aprire una propria agenzia dipenda dal fallimento dell’amico: Frieda scrive ai giornali che non vi è alcuna “relazione fra la cessata Ditta Schultze e la mia”106, mentre sulle riviste di settore si può leggere, con alate parole, che Miss Frieda Klug “la cui energia, attitudine, zelo, conoscenza intellettualità ed alte aderenze cinematografiche e amicizie sono arra sicura di continuo e vasto esito alla propria produzione”, che avrà l’esclusiva per tutto il mondo della produzione Helios Film di Velletri e rappresenterà in Italia il distributore anglo-americano J.F. Brockliss107. Klug, esperta delle tecniche di comunicazione americane, dà il via a una martellante campagna pubblicitaria che ne fa rapidamente conoscere il nome, e acquisisce la distribuzione della cattolica Unitas, ma non tutto deve andare per il meglio dato che un comunicato commerciale informa come “Frieda 209
Klug traduce lettere e titoli in inglese, tedesco, russo e ungherese”108, che sembra un modo per portare a casa qualche spicciolo in contanti. La possibilità di ricamare sulla singolarità della nuova protagonista del commercio – ma certamente pesano anche gli ingenti acquisti di pagine pubblicitarie – prende larghi spazi sui giornali, anche con la pubblicazione di una fotografia, caso pressoché unico per i commercianti: Un esile corpo irrequieto, pieno di scatti e di movenze feline; uno spirito alacre ed una mente fertile; due sopracciglia foltissime, sotto cui guizzano incessantemente, nella loro orbita i vividi bulbi visivi che non conoscono la calma della contemplazione e la fissità dell’estasi. Un viluppo di muscoli, protesi costantemente nell’alterna vicenda delle soste brevi e dei viaggi snervanti, tale è Frieda Klug, quale io l’ho sorpresa nel suo minuscolo ed un po’ disordinato ufficio, in Galleria Nazionale, mentre di poco tornata da una corsa rapida per l’Italia, ad un’altra si accingeva con la stupefacente disinvoltura di chi esce di casa per comperare un pacco di sigarette. E mentr’io, ammirato da tanta fervorosa attività, contemplavo la sua agile personcina sdoppiarsi e moltiplicarsi in tante piccolissime cure, dar passo alla corrispondenza abbondante e plurilingue, Ella con bel garbo mi porse una sua fotografia, dicendomi: “Prendete e ricordatevi qualche volta di me”109.
Peccato che queste parole, così ‘poetiche’ e improntate a un cattivo gusto di sapore dannunziano, vengano rovinate dalla conclusione, in cui il giornalista dimostra la sua incapacità di informare rettamente il pubblico scrivendo che “Frieda Klug è nata in Rumania [sic] e da tre anni tiene Agenzia e rappresentanze qui a Torino”. Sempre secondo le riviste, la ditta mette a segno buoni risultati grazie a “l’attività meravigliosa […] della infaticabile signorina Klug, la quale va sempre più acquistandosi le migliori simpatie dei nostri cinematografisti”110, assicurandosi l’esclusiva della francese Lux Film e soprattutto con la distribuzione di L’Inferno della Helios Film, anche se a proposito di questa pellicola, la Klug viene coinvolta con antipatiche accuse di concorrenza sleale nella polemica accesa dalla Milano Film (soprattutto per voce della
210
sua esclusivista, la Sigla di Gustavo Lombardo, con diversi articoli su “Lux”), la cui impegnativa edizione dell’opera di Dante (1.200 metri) è stata bruciata sul tempo dall’uscita della piccola versione (400 metri) della casa di Velletri111. Le lodi nei confronti di Frieda continuano senza sosta, anche quando mancano notizie effettive circa il suo lavoro: “[Frieda Klug] è uno dei più solidi e attivi valori della cinematografia mondiale. E dicono che le donne valgono meno degli uomini! Misogini autentici!”112, estendendo l’apprezzamento anche ai parenti, scrivendo che ha visitato Torino la signora Klug “madre dell’attiva e buona Signorina Frieda. La Signora Klug è una colta, intellettualissima dama gentile […]”113. In realtà, probabilmente, la signora viene in Italia in quel periodo per assistere la figlia durante una grave malattia, che causò, secondo quanto scriverà successivamente il curatore fallimentare, spese ingenti e un forte rallentamento del lavoro. Sulla malattia, la stampa, incurante della tempestività delle notizie, si limita a brevi accenni a posteriori, redatti secondo il consueto stile ridondante: “Miss Frieda Klug è stata piuttosto ammalata; ma ora ritorna alla vita operosa che la rende sì superiore alle altre donne”114, “La signorina Frieda Klug ristabilitasi ormai completamente ha ripresa con maggiore attività la trattazione degli affari”115. Quanto all’attività di lavoro, secondo varie inserzioni pubblicitarie, l’azienda rappresenta le francesi Excelsior e Lux, l’americana Nestor, le italiane Helios di Velletri e Psiche di Albano Laziale, oltre alla società tecnica tedesca Lato116; ha invece rinunciato alla Pharos la quale produce poco o nulla e perciò rende meno a chi può più utilmente impiegare il suo tempo e la sua attività. Non è vero quindi, ciò che stampa una rivista napoletana, che cioè la sig.na Klug perde terreno e qualche ottima casa, e questa notizia va accolta come una malignità fuori posto. La nostra amica, quando mai, guadagna fior di quattrini, cosa forse che può far velare a qualcuno la giusta visione delle cose117.
Uno dei pochi articoli realmente interessanti riporta la concezione che Frieda ha del commercio cinematografico, ripresa da un’intervista a un giornale
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
tedesco, di cui non si cita il titolo: secondo la professionista, il mercato tedesco è più sano perché è libero e, a differenza di quanto avviene in Italia, si cerca di piazzare ogni pellicola attraverso accordi con i singoli esercenti e non viene cercata l’esclusiva: ciò porta a un maggior attivismo dei noleggiatori e a un abbattimento dei costi, senza i sovrapprofitti dei monopoli118. La stampa italiana invece non cessa di infilare gemme inutili, francamente stucchevoli, nella collana di lodi, scrivendo che La florida Maison Klug può andare superba di questi elementi [il giornalista allude ai dipendenti da poco assunti], dovuti all’intelligenza squisita, alla perspicacia profonda di Miss Klug, che coll’energia, la dottrina, la praticità nei negozi e tante altre buone doti, fanno di quella gentile un essere veramente meraviglioso119.
o, senza alcun senso della misura, che la sua mente elettissima, il tatto fine negli affari, la signorilità della vera gentildonna, la praticità dei modi sono arra, anzi certezza d’indiscusso successo. E la Signorina Klug non ha solo l’Italia a suo campo; ma sappiamo che la sua attività si spinge ben oltre: all’Europa intera, sino alla remota Scandinavia, alla lontanissima Australia e alla non meno lungi America120.
Leggendo le riviste, tutto sembra andare per il meglio per la ditta e giunge quindi assolutamente inattesa per i lettori la notizia della sospensione dei pagamenti da parte di Frieda Klug, con la proposta di un concordato preventivo col pagamento al 30% dei debiti121, cui segue, dopo che qualche creditore ha rifiutato l’accordo extragiudiziale, l’annuncio del fallimento122. La relazione del curatore fallimentare, Lorenzo Martinetti123, è fondamentale per conoscere la vera storia professionale di Frieda Klug, ma è anche utile per verificare il valore delle informazioni fornite dalle riviste. Il curatore chiarisce come Klug lavorasse per Adolfo Schultze con uno stipendio di 250 lire mensili oltre alle percentuali e per incarico del suo datore di lavoro fosse andata negli Stati Uniti come procuratrice, trattenendovisi per circa un anno124, e fornisce una nuova interpretazione dell’inizio dell’attività:
le viene offerta la rappresentanza della Helios che, alla ricerca di un nuovo concessionario dopo il fallimento di Schultze, ricorre con una certa mancanza di logica a una sua collaboratrice. L’inizio dell’avventura imprenditoriale della Klug è però segnato da un grave peccato originale, la minima disponibilità di denaro contante: “Il 15 luglio 1910 incominciò il commercio o meglio la rappresentanza di pellicole cinematografiche con un capitale di lire diciasette”. La ditta non ebbe mai periodi di vera fioritura: sia le pellicole dell’Unitas che quelle della Helios – eccezion fatta per L’Inferno – non incontrarono mai un grande successo e l’acquisto di negativi in America la cui distribuzione fu bloccata dalla censura, determinò una perdita di circa 18.000 lire. Martinetti individua con chiarezza le cause del fallimento dell’impresa: la mancanza quasi assoluta di capitali e il conseguente ricorso a mutui dai forti interessi; la necessità di accettare il pagamento delle pellicole con cambiali a lunga scadenza che portava a scontarle con tassi che annullavano il guadagno; spese generali troppo alte per il bilancio aziendale (4.000 lire al mese!) e una lunga malattia che comportò altre forti spese. Il 26 maggio, Klug offre ai creditori il pagamento integrale dei debiti privilegiati e del 15% di quelli chirografari125; dopo il consenso della maggioranza dei creditori, il Tribunale omologa il fallimento chiudendo la procedura il 24 luglio 1913. Questa rapida sintesi dei documenti del procedimento fallimentare dà un’idea precisa dello scarso valore che si può attribuire alle informazioni delle riviste, viziate da un’insopportabile retorica e pesantemente condizionate dalle somme versate per la pubblicità, senza il minimo accenno di autocritica da parte di chi, un paio di mesi prima del crollo, esaltava le virtù e le capacità negli affari che portano ‘fior di quattrini’ della fallita. Per comprendere come la sconfitta di Frieda Klug sia stata vista dai giornali, si possono citare due commenti improntati a un antipatico moralismo: dopo il fallimento dell’esercente di una sala a Torino, “La Cinematografia italiana ed estera” non trova di meglio che avvicinare i due casi, scrivendo che “Decisamente le donne non donne non hanno fortuna in cinematografia”126; dopo la chiusura del 211
fallimento, lo stesso giornale acidamente scrive “15%: pochino proprio: e abbiamo rinunciato, e a questo solo è giunto il concordato con la Maison Frieda Klug”127. Dopo il fallimento, Frieda continua a lavorare nel mondo del cinema, dapprima, a quanto risulta dai documenti fallimentari, con la Pasquali, poi con l’Ambrosio: è per incarico della società torinese che si reca nuovamente negli Stati Uniti col marito Giulio Schultze128, sbarcando il 12 giugno 1915129; ritornata in Europa, attraversa nuovamente l’Atlantico in compagnia di Arturo Ambrosio come interprete e public relations woman130, sbarcando a New York il 6 dicembre dello stesso anno131. Informazioni particolareggiate sugli scopi del viaggio e sui compiti di Klug vengono da un articolo della rivista americana “Moving Picture World”, riportato da “La Cinematografia italiana ed estera”: Cav. Ambrosio on his way here. With Mrs Frieda Klug Schultz He Will Study American Conditions. According to a cable dispatch received at the office of the mpw, Cavaliere Ambrosio, the famous founder of the producing house of that name, will visit this country by the end of this month. He will be accompanied by Mrs. Frieda Klug Schultz, who is well known in film circles here and in Europe. Mrs Schultz has recently been on a business visit in this country of several valuable features to the Universal Film Company. Mr Ambrosio will bring with him several six-reel features in which Rita Jolivet, the well known French-America actress, has the leading part. Under the guidance of Mrs. Schultz, Mr Ambrosio intends to stay here long enough to become familiar with the conditions of the American market132.
La signora Schultze non ritorna a Torino con Ambrosio, probabilmente temendo qualche problema per la sua nazionalità di origine dopo l’entrata in guerra dell’Italia133: resterà negli Stati Uniti fino al 12 maggio 1920, quando riacquista la residenza a Torino, per trasferirsi poi a Tortona nel gennaio 1922134, forse per motivi di lavoro del marito. L’avventurosa ragazza ungherese tornerà a Torino per morirvi di leucemia il 9 febbraio 1926, dopo pochi giorni di degenza in ospedale135; la lapide che le dedicò il marito, benché abbandonata, è ancora 212
visibile nel cimitero di Torino: nessuna delle riviste che la osannarono per un paio d’anni ne segnala la scomparsa. Il fallimento del tentativo imprenditoriale di Frieda non deve portare a sottovalutare il valore dell’iniziativa di una ragazza giovanissima, sola in un paese straniero e certo non favorevole a progetti di matrice femminile. Credo che, rubando una definizione coniata per Lee Miller, un’altra donna che si fece strada nel mondo maschile della fotografia, anche di Frieda Klug si possa dire che “fu una donna, indipendente, libera, geniale, coraggiosa e ricca di talento”136, una delle prime donne ‘tipo tre’ in Italia. Sarebbe altrettanto interessante conoscere e comprendere le motivazioni di tre signore che, nel 1917, fondarono un’accomandita esclusivamente femminile, ma allo stato attuale degli studi ciò non è possibile. Della società, la (The) Italian Film Company-A. Colonnello Jahier & C. si ha un’unica notizia, l’atto di fondazione a Ronco Scrivia, sull’Appennino genovese: oggetto dell’accomandita, che fissa la sua sede a Torino, è “il commercio e lo sfruttamento delle pellicole cinematografiche in Italia ed all’estero”; il capitale di 45.000 lire è corrisposto in parti uguali da Virginia Colonnello in Colonnello, Alice Jahier in Colonnello, socia accomandataria con diritto al 50% degli utili, e da Carolina Piazza in Cilento137. Si tratta evidentemente di un affare di famiglia: Virginia Colonnello è sorella del marito di Alice e cugina o comunque parente – stando alle paternità indicate nell’atto anche per i mariti – del proprio consorte, ma ciò che rende interessante l’impresa nel panorama del tempo è il fatto di essere fondata e gestita esclusivamente da donne, anche se, rispettando la legge, nell’atto è ripetuto per ognuna delle tre signore che “[il marito] è presente per la debita autorizzazione”. È insolito anche che le tre signore, tutte indicate come di condizione agiata e residenti a Genova, abbiano deciso non solo di lavorare, ma di aprire un’attività a Torino nel periodo bellico, non certo ricco di possibilità per il commercio cinematografico. Purtroppo l’atto di fondazione è l’unica notizia dell’accomandita, che seppure nata, almeno apparentemente, con chiarezza di intenti, non svolge alcuna attività e scompare senza lasciare traccia.
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
Poco si sa di un’altra noleggiatrice, Ulde Torri, e della sua attività. Nel 1927, in alcuni numeri della “Rivista cinematografica”, inserzioni e trafiletti redazionali annunciano a più riprese la nascita della fiet: a quanto si capisce dai comunicati, poco chiari, la ditta Ulde Torri-Nolo Film, che dal 1921 rappresentava la Moretto di Brescia per il Piemonte e alcune province della Lombardia occidentale (Milano, Varese, Pavia, Sondrio; stranamente non è indicata Como), è stata incorporata da una nuova impresa, la fiet138. La nuova società ha sede a Torino in via Lagrange 29 – dove dal 1924 era la subagenzia della Moretto – e agenzie a Genova, via XX Settembre 12 e a Milano, via Sala 8; sfoggiando la consueta retorica adulatoria, gli scritti redazionali informano che “il naturale incremento e la perfetta organizzazione sono in gran parte dovuti alla operosità e alla intelligenza della signorina Torri”139. La fiet sarà fondata legalmente l’anno successivo come anonima per azioni, con oggetto la “compravendita e noleggio di films cinematografiche, macchinario cinematografico e accessori, gestione di cinematografi e rappresentanza di case produttrici e noleggiatrici di films” e un capitale di 500.000: un’iniziativa dall’accentuato carattere familiare dato che i sottoscrittori sono i fratelli Ulde, Roberto e Maria Torri, oltre a una minima partecipazione, solo 25.000 lire, di Pietro De Lange; consigliere delegato è Ulde Torri, che ha la maggioranza assoluta delle azioni. L’entità del capitale iniziale non deve ingannare, dato che è costituito completamente dal valore di stima del materiale d’ufficio, del magazzino e dei diritti di sfruttamento, senza il versamento di una lira in contanti140. Non si hanno altre notizie di Ulde Torri né della fiet, che figura solo per due anni nella Guida Paravia141: non vi sono spiegazioni per la repentina scomparsa della ditta, sicuramente da mettere in relazione con la mancanza iniziale di contante. Molto diverso è il caso di Maria Reposi: poche righe sulla “Rivista cinematografica” alla fine del 1928 informano che Maria Reposi in Rolla ha iniziato un’attività di noleggio pellicole, con sedi ad Alessandria e a Torino142. La figura di Maria viene lumeggiata con qualche particolare nel numero successivo: appar-
tiene a quella famiglia Reposi che con Felice, Adolfo, Alberto, era già stata presente nel commercio cinematografico torinese e ligure dell’inizio secolo e l’allusione nei giornali a una precedente “gestione di una delle più antiche ditte nel settore” da parte di Maria, si allude forse a un’attività nella Ligure Film di Genova, anche se la proprietà di questa azienda era passata da tempo dai Reposi all’Anonima Pittaluga: la vaghezza dell’informazione non permette tuttavia di escludere che abbia lavorato nelle sale cinematografiche di famiglia. Con questi precedenti familiari, è quasi una conclusione scontata che a un certo punto la signora Reposi “abbia costituito una propria agenzia, coadiuvata dal figlio Adolfo”143, ma, dopo un’ultima notizia su un trasloco degli uffici torinesi nel giugno 1930, non vi sono altre notizie sulla società di Maria Rolla Reposi; continua comunque a essere citata fra i “Rappresentanti e Noleggiatori” della “Rivista cinematografica” fino al 1932144. Ambigua e non proprio limpida, è un’altra figura femminile di imprenditrice, Virginia Casetta: le prime notizie su una sua società sono del 1927, quando un trafiletto, segnala che ha iniziato l’attività di noleggio, coadiuvata da Armando Manti, la ragioniera145 Virginia Casetta, già procuratrice della casa editrice Latina Ars146. Nel corso dell’anno la pubblicità dell’azienda è costante, con inserzioni che indicano l’indirizzo torinese e quello di una seconda sede a Genova; è interessante una manchette caratterizzata da una verve polemica insolita per il periodo e chiaramente indirizzata: “Non è vero che tutta la produzione italiana e quella eseguita all’estero da elementi italiani sia stata acquistata da una sola casa di noleggio, perché la ditta V. Casetta ha acquistato la produzione recentissima della Italica Film di Roma e i film di Marcella Albani realizzati in Germania”147. Dopo un ultimo trafiletto ai primi del 1928, in cui si legge che un’agenzia genovese ha acquistato molte pellicole dall’impresa V. Casetta148, non compaiono più sui giornali notizie della ditta. La scomparsa della ditta trova una spiegazione nell’entrata di Virginia in un’altra agenzia di noleggio, la face (Forniture Artistiche Cinematografiche Educative): fondata nell’estate 1928 come anonima, con oggetto “l’esercizio del commercio e dell’in213
Tabella 3 – Distribuzione/noleggio Casa di distribuzione
Anno di fondazione
Capitale sociale (lire)
Partecipazione femminile (lire)
Cervino Film Espero Film face (Forniture Artistiche Cinematografiche ed Estere) fides (Film Internazionali Diversi Esclusività e Sfruttamento) fiet (Film Italiane ed Estere Torino)
1945 1942 1929
45.000 20.000 500.000
1939
10.000
Bianco Orso Matilde (15.000) Perrone Giuseppina (10.000) Bandino Angiolina (15.000) Casetta Virginia (50.000) Grassino Maria Luisa (5.000)
1927
500.000
Florentia Film-Ettore Colombo & C.
1916
45.000
Frieda Klug Italian Film Company
1910 1917
45.000
Maria Rolla Reposi Musso Mutoson sce (Società Cinema Educativo) Torino Films Virginia Casetta
1929 1925 1932 1925 1926 1927
25.000 100.000 -
dustria cinematografica in Italia e all’estero” e un capitale di sole 50.000 lire149, portato pochi giorni dopo a 500.000150: l’aumento è totalmente sottoscritto da Virginia Casetta, ma il saldo avviene con la cessione alla face di diversi pacchetti di pellicole della ditta V. Casetta, di cui sono rilevati anche gli impegni e le scadenze verso altre società151; nonostante Virginia detenga quasi tutto il pacchetto azionario della face, non assume un ruolo direttivo che implichi responsabilità legale, ma si limita ad assumere il ruolo di direttore generale, “riconosciuto che la provata abilità tecnica dell’interessata potrà esser assai profittevole per la società”: un organigramma del genere è insolito, ma diventa comprensibile alla luce degli eventi successivi. Ha poco interesse seguire in questa sede le intricate vicende e la serie di errori – alcuni sicuramente voluti – che caratterizzano la vita della face, ma la conclusione inevitabile è che, esattamente un anno dopo la fondazione, il 214
Torri Maria (75.000) Torri Ulde (300.000) Carena Ludovica in Ettore Colombo, 9.000 Faccanone Ida, ved. Sard (8.000) Mangini Lucia Italia in Alessandro Colombo (3.000) Klug Frieda Colonnello Virginia in Colonnello (15.000) Jahier Alice in Colonnello (15.000) Piazza Carolina in Cilento (15.000) Reposi Maria in Rolla Bianco Maria in Doglioni Castellano Angela in Cattaneo (1.000) Borghini Maria in Rossi (10.000) Maina Libera Casetta Virginia
6 giugno 1929, un esperto esterno chiamato a dirimere la complicata situazione amministrativa della società dopo aver cercato di far chiarezza sulla situazione contabile, si arrende e chiede che questa sia ammessa al concordato preventivo per evitare il fallimento. Il concordato non viene concesso per il disordine amministrativo e la prima conclusione del curatore fallimentare è drastica: “L’anonima è stata creata per ottenere la sistemazione della Ditta V. Casetta”; le cause del fallimento sono chiare: “Esiguo capitale iniziale […] investimenti patrimoniali eccedenti il limite ragionevole delle forze […] organizzazione deficiente per lo sfruttamento delle films […] spese generali eccessive […] assenteismo del consiglio d’amministrazione […]”. Il fallimento viene poi chiuso con l’accettazione della proposta della face di pagare al 40% i debiti chirografari. La breve avventura della face non è un caso isolato, anche se appare insolito il succedersi delle
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
Tabella 4 – Le sale cinematografiche di Torino 1907 1925
10 51
1910 1930
21 58
1915 1935
63 48
1920 1940
41 51
Nota: Le cifre forniscono un’indicazione di massima, utile per individuare un trend. I dati sono tratti dalle Guide Paravia: altre fonti forniscono dati diversi, in alcuni casi più attendibili, ma è stata privilegiata la Guida per la completezza della serie e l’omogeneità nella raccolta dei dati. A queste sale vanno aggiunti, soprattutto negli anni trenta, i locali allestiti dai dopolavoro, dalle organizzazioni del pnf, dalle parrocchie e dai collegi cattolici.
vicende che hanno portato al fallimento: le stesse critiche a imprese mal impostate e peggio gestite ricorrono in tutti i procedimenti fallimentari e potrebbero senza dubbio essere estese a quasi tutte le società non fallite.
Esercizio Una ricerca sull’economia dell’esercizio cinematografico torinese si scontra con problemi complessi, impossibili da trattare a fondo in questa sede: si conosce il numero delle sale in città, la categoria, i periodi di apertura, i mutamenti di nome152, ma di poche è nota la proprietà, la struttura sociale, l’andamento economico. Le cause di questa situazione non sono difficili da individuare: delle cinquanta, sessanta sale presenti mediamente a Torino (tabella 4), la grande maggioranza è costituita da locali di terza o quarta visione, per la cui gestione, spesso, è sufficiente il lavoro di una famiglia: nelle sale di periferia, il personale può essere ridotto al minimo – un proiezionista, una cassiera, eventualmente una maschera – e il tempo richiesto per le due proiezioni serali e qualcuna nei pomeriggi festivi, non è molto: condurre una sala cinematografica può essere un secondo lavoro, da gestire con la massima semplicità amministrativa. Per quanto riguarda le sale di maggior prestigio del muto, concentrate in centro, scompaiono quasi tutte153 durante i lavori di rifacimento di via Roma nella prima metà degli anni Trenta: i lavori di demolizione e la successiva ricostruzione di numerose sale di prima visione annullano il contesto esistente e cambiano radicalmente il panorama architettonico ed economico dell’esercizio torinese.
Né si può dimenticare l’importanza del ‘fattore cui si è già accennato a proposito delle società di noleggio: la maggioranza dei locali di prima visione appartiene alla società di Stefano Pittaluga e condiziona gravemente con la forza del rapporto integrato produzione-distribuzione-esercizio la nascita e lo sviluppo di altre sale a Torino. Non per caso un’accentuata vivacità nella nascita di nuove aziende interessate a costituire catene di esercizi, e nella costruzione di nuove sale, caratterizzerà l’ambiente nella seconda metà degli anni Trenta, quando si tratterà di completare le infrastrutture della rinnovata via Roma e la sasp non sarà più che un ricordo. sasp’,
Sarebbe presuntuoso in un panorama così complesso e con pochi dati disponibili e non omogenei, ritenere di potere trarre conclusioni sulla presenza femminile nell’esercizio; saranno quindi indicati solo alcuni casi particolari, assai diversi per impegno economico e ruoli svolti, mentre in tabella 5 sono elencate le altre partecipazioni femminili a società riconducibili al tentativo di gestione di una sala, non sempre indicata nei documenti. La prima donna che compare già nel 1910 in atti delle società d’esercizio è la signora Enrichetta Langmann, una vedova benestante che partecipa con la sua proprietà immobiliare di via Roma alle iniziative di un dinamico esercente, Vittorio Ghersi, ma di cui non risulta alcun interessamento alla gestione dei locali. Breve e con una conclusione infelice è il caso della Fortino Società Anonima costituita nel 1927 per gestire il cinema Fortino, una curiosa costruzione sorta nel 1907 come birreria con caratteristiche stilistiche vagamente nordiche, cui fu 215
Tabella 5 – Esercizio Esercizio
Anno di fondazione Capitale sociale (lire) Partecipazione femminile (lire)
Anna Compareti Cine Stadium Torino Cine Massimo sas Cine Massimo sas-Pilla G. & C.
1918 1934 1942
20.000 50.000 440.000
Cinema Cibrario Cinema delle Famiglie Cinema Eridano (via Nizza) Cinema Eridano (corso Casale) Cinema Ireos
1931 1914 1913 1914 1920
-
Cinema Sacchi
1913
-
Dancitesa (D’Angennes Cine Teatro Società Anonima) ecit (Esercizio Cinema Italiano Torino)
1940
150.000
1945
60.000
Fortino Società Anonima Gestione Cinema Kursaal
1927 1927
40.000 60.000
Ing. Palomba & C.
1920
45.000
Laezza Beatrice sas
1944
50.000
Mezzano & Rolla
1942
50.000
Moderno Cinema Alpi 1914 (Noleggi Imprese Cinematografiche 1935 Società Anonima) Novarese Ida Rosalia & Novena Riccardo 1941
30.000 10.000
Compareti Anna (10.000) Pilla Giuseppina in Zaccone (25.000) Pilla Giuseppina in Zaccone (6.000), accomandataria Panella Giuseppina in Maddalena Cavaglione Emma in Treves Barberis Adele Goria Caterina Cairo Rosa in Parodi Parodi Ida in Maggiani Ampalla Carolina in Donadio Graglia Rosa in Carello Cordero Francesca in Occhetto e Giacinta Cordero amministratici (per un anno) Cardinali Fernanda (30.000) Gatta Ortensia in Fantino (30.000), accomandataria Cavadini Giulietta (30.000), a.d. Francia Maria in Lubiani (2.000) Franco Clotilde in Milanesio (1.000) Lora Maria in Crosetti (1.000) Broglio Federica in Palomba (15.000) Faggiani Ida Laezza Beatrice ved. Giacovelli (40.000), accomandataria Maria Caterina Lenci in Ghibellini (10.000) Mezzano Maria in Fornaca (5.000), accomandataria Gambetta Rosa (7.500) Sappa Celestina, ved. Giacheri (1.000), cda
15.000
Novarese Ida Rosalia (5.000)
Novarese dott. Umberto e sorelle
1941
12.000
Odeon-Ghersi V. & C. sicat (Società Italiana Cinematografi Avanspettacoli Teatrali) Società Cinema Italia Sorelle Novarese
1910 1936
100.000 15.000
Novarese Ida Rosalia in Finzi (4.000) Novarese Margherita in Graziano (4.000) Langmann Enrichetta, ved. Rollino (50.000) Cavetto Giuseppina, ved. Boffa (5.000)
1944 1942
50.000 8.000
Vittorio Ghersi & C.
1913
900.000
nicsa
successivamente aggiunta una sala cinematografica154; Giulietta Cavadini, appartenente a una famiglia di esercenti di sale di secondo piano155, partecipa alla costituzione del capitale sociale di 40.000 lire con una quota di maggioranza assoluta, 30.000 lire, mediante il conferimento della sala 216
Panero Dina in Brovida (5.000), cda Novarese Ida Rosalia in Finzi (4.000) Novarese Margherita in Graziano (4.000) Langmann Enrichetta, ved. Rollino (80.000)
cinematografica, già di sua proprietà ed è presumibilmente il consigliere delegato156. La gestione di Giulietta non deve essere stata soddisfacente, dato che già il 30 ottobre 1932, dopo una serie di bilanci negativi la società è posta in liquidazione157. Non sono per nulla chiari gli scopi delle sorelle Ida
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
e Margherita Novarese, che danno vita, da sole o col fratello Umberto a ben tre società diverse fra il dicembre 1941 e il gennaio 1942158, per gestire una sala, la Novocine, che tuttavia non compare nei repertori e nelle programmazioni dei quotidiani: impossibile comprendere il vero scopo di queste operazioni, condotte con un capitale minimo. Resta del pari sconosciuto lo scopo della costituzione nel 1944 della accomandita Laezza Beatrice ved. Giacovelli, con oggetto “l’esercizio di cinematografi e varietà” e un capitale di 50.000 lire, sottoscritto in parti uguali da Beatrice Laezza, accomandataria, e da Maria Caterina Lenci in Ghibellini159: della società non si ha alcuna notizia dopo la fondazione. Avrebbe potuto invece diventare interessante l’attività di Giuseppina Pilla, che viene nominata nell’ottobre 1942 accomandataria della Cine Massimo sas, proprietaria di una sala di seconda visione dal discreto andamento160: la signora dispone di una quota personale di capitale minima, 6.000 lire, ma anche di quella del marito, Raffaele Zaccone, di poco inferiore alle 300.000, su un capitale di 400.000 lire; purtroppo, già il 10 dicembre dello stesso anno, il Massimo viene distrutto da un bombardamento161. Nel dopoguerra la società, mantenendo gli stessi soci, diventa l’anonima Cinemassimo e per alcuni anni gestisce il locale ricostruito; dopo diversi passaggi di proprietà, che lo portano infine nel demanio comunale e una ristrutturazione in multisala, il Massimo passa in comodato d’uso al Museo Nazionale del Cinema. Fra le varie società d’esercizio, forse l’unico caso in cui si possa veramente parlare di imprenditoria femminile, sia per i successi ottenuti dall’azienda, sia soprattutto per la personalità della protagonista, è quello di Maria Mezzano: il suo nome figura per la prima volta in un documento legale come partecipante alla fondazione, nel gennaio 1942, dell’accomandita Mezzano & Rolla, che ha per oggetto “l’acquisto, la vendita, la gestione di cinematografi e sale di spettacolo” e un capitale di 50.000 lire sottoscritto per 5.000 lire a testa da Maria e da Adolfo Rolla: socio di maggioranza è il signor Ferdinando Sismondi con 40.000 lire, ma è a Mezzano e a Rolla che viene affidata la gestione dell’impresa162: chi è la signora Maria Mezzano in Fornaca, che viene
associata come accomandatario a un esercente di lunga esperienza come Adolfo Rolla? Maria è nata nel 1906 in un minuscolo paesino del Monferrato, Villamiroglio, da una famiglia contadina; a 14 anni, per sfuggire a una vita senza prospettive, va a piedi a Torino, trovando lavoro in un primo momento come cameriera, per entrare poi come apprendista presso un parrucchiere di fama, Mezzo. La giovane Mezzano cerca di aprire un negozio del genere in proprio, ma lavora anche come comparsa negli ultimi film in lavorazione nell’ex capitale del cinema finché, conquistata dal nuovo medium, verso la fine degli anni Venti riesce ad assumere la gestione di una sala di quarta visione, il Brescia. Vincolata da un contratto capestro che le impone di proiettare solo film muti, si rivolge per un parere a uno fra gli esercenti più noti, Adolfo Rolla: questi l’aiuta a risolvere il problema cui segue la decisione di lavorare insieme, anche perché nel frattempo fra i due è sbocciato l’amore, una storia complicata dal fatto che Maria Mezzano è sposata. Risolti in qualche modo i problemi personali, negli anni prima della guerra Maria e Adolfo praticano un’intelligente politica di acquisizione di sale, evitando di scontrarsi con le grandi catene d’esercizio che controllano il circuito torinese di prima visione, sasp, poi dopo il 1935 enic e Leoni: nel giro di pochi anni passano sotto il loro controllo diverse sale di periferia oggi tutte scomparse, Barolo, Adua, Mirafiori, Regina – la cui gestione viene affidata a parenti stretti per mantenere un rigido controllo – e un’unica sala centrale di seconda, il Torino, che i due soci riescono a far diventare luogo d’incontro privilegiato dei commercianti torinesi163: la costituzione della Mezzano & Rolla appare come un passo necessario non solo per ottimizzare la gestione del piccolo patrimonio di sale, ma probabilmente anche per l’esigenza di disporre di denaro contante, forse legato all’acquisizione del cinema Torino. La storia della Mezzano & Rolla continua con buoni risultati nel dopoguerra, gestita dalla sola Maria, dopo la scomparsa di Adolfo; la società passerà a controllare anche esercizi di maggior prestigio, acquisendo fra gli altri locali il Lux, la prima sala costruita nel 1934 nella rinnovata via Roma. 217
Altre società Nello studio dell’economia del cinema, c’è la tendenza, almeno in Italia, a studiare e analizzare solo i tre settori tradizionali legati alla produzione e al successivo sfruttamento commerciale delle pellicole, dimenticando la grande importanza di altri campi, forse meno affascinanti, ma la cui conoscenza è essenziale se si desidera giungere a una conoscenza completa dell’industria cinematografica: non è ancora stato studiato a fondo, per esempio, il ruolo fondamentale delle banche d’affari nella strategia delle società editrici italiane164, pur sapendo dagli esempi degli altri paesi produttori come già negli anni Venti la produzione e il mercato dipendano dalle scelte dei maggiori gruppi bancari nazionali. Questa negligenza è in parte dovuta a fattori oggettivi, come la mancanza di un background industriale significativo165, ma non si può comunque dimenticare l’importanza delle aziende di trattamento delle pellicole, delle finanziarie e delle immobiliari, e dell’indotto propriamente detto: costumi, mobilio, costruzioni, scuole di recitazione... Si tratta spesso di realtà locali che dipendono dall’andamento della produzione, ma talvolta il loro raggio d’azione si estende a tutto il paese, come nel caso della Immobiliare Cinematografica Italiana (ici), la cassaforte del gruppo sasp che detiene la proprietà di gran parte degli immobili comunemente attribuiti alla società principale (stabilimenti e teatri di posa, sale cinematografiche, edifici e appartamenti a uso residenziale o ufficio). Oggi, gran parte delle società torinesi – in questa sede sbrigativamente classificate come ‘altre’ – è conosciuta per nome, almeno negli atti costitutivi: ai ricercatori il compito di studiarne la vita e di ricostruire con le vicende di ognuna, il mosaico completo del sistema-cinema cittadino. Per quanto rivelano i pochi documenti fino a oggi conosciuti, colpisce la mancanza pressoché assoluta di una partecipazione femminile sia nel finanziamento che nelle funzioni direttive. Non è possibile formulare per ora un’interpretazione valida dei motivi di questa assenza: un’ipotesi, forse troppo semplicistica, potrebbe essere che sia mancata alle donne la possibilità di una preparazione adatta all’impiego in società dedite ad attività tecniche o economiche ad alto livello. 218
Il caso più clamoroso di mancanza di presenza femminile è quello della sasp e delle numerose società controllate, che sono il cinema italiano dal 1925 al 1935; manca a oggi un profilo complessivo del gruppo di cui la sasp costituisce la holding166, ma dai documenti noti delle singole aziende è possibile essere certi di questa assenza. L’assenza della componente femminile in un gruppo di grandi dimensioni in cui sono presenti società di ogni tipo, editrici, commerciali, tecniche, finanziarie, immobiliari, non può essere casuale: probabilmente è una scelta precisa di Stefano Pittaluga, che preferisce inserire ai vertici aziendali i fidati conoscenti e gli amici degli anni Dieci con cui aveva fondato la ditta nel 1919167. L’unica eccezione, se così si può definire, è costituita da Anita Pilotti, moglie di Stefano, che riceve una procura generale nel 1923168 e fa parte brevemente del consiglio d’amministrazione della sasp nel 1928169; secondo alcune indicazioni provenienti da fonti non documentate, Anita si occupa della gestione della Positiva, la redditizia società di sviluppo e stampa del gruppo, continuando a rivestire incarichi di responsabilità anche dopo lo smembramento del gruppo e la cessione dell’azienda chimica all’enic. Si ha solo un caso di forte partecipazione femminile in queste imprese, ed è quello della Cinestampa Torino, la cui storia d’impresa costituisce un caso interessante sia per la capacità dell’azienda di cambiare adeguandosi ai tempi, sia per una presenza ai vertici di donne che se pure non compaiono fra i quadri dirigenti, sicuramente hanno contato molto nelle scelte strategiche. La Cinestampa di A. Bursi & C., società in accomandita semplice, viene fondata nel 1919 avendo per oggetto il trattamento delle pellicole e un capitale di 250.000 lire; fra i soci compaiono Rina Gioia in Bursi e Elvira Demarchi, vedova Bonadè Bottino, con 25.000 lire di impegno a testa, ma nessuna delle due assume responsabilità direttive170. Accomandatario è Arturo Bursi, marito di Rina, ma la mente direttiva dell’azienda è l’avvocato Livio Pugliese, già protagonista dell’avventura dell’Aquila Film. La società lavora per alcuni anni con bilanci mediamente positivi, ma la situazione del cinema torinese non è
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
Tabella 6 – Altre società Società Cinestampa Cinestampa Torino
(Monterosa Anonima Cinematografica) Piemontese Cinematografi Società Anonima
mac
sasp
Anno di fondazione Capitale sociale (lire) Partecipazione femminile (lire) 1919 250.000 Gioia Rina Maria in Bursi (20.000) De Marchi Elvira, ved. Bonadè Bottino (25.000) 1922 900.000 De Marchi Elvira, ved. Bonadè Bottino (30.000) Fiorio Pinuccia in Canepa (50.000) Gays Mariannina (10.000) Ramella Gemma, ved. Canepa (445.000) Re Virginia in Fiorio (25.000) 1941 12.000 Cugiolu Maria, cda 1940
50.000
De Michelis Angela in Nebiolo, cda
1919
-
Pilotti Anita in Pittaluga, cda
tale da concedere speranze di grandi miglioramenti: il 14 aprile 1922 la Cinestampa viene messa in liquidazione171 e il giorno dopo si procede alla costituzione di una nuova accomandita con un capitale di 900.000 lire, La Cinestampa Torino, che di fatto nasce dalla fusione fra la Cinestampa sas e un’altra società di sviluppo e stampa, la sci (Stampa Cinematografica Italiana)172: questa era sorta nel 1919, con un capitale di 60.000 lire per iniziativa di tre soci, Vittorio Canepa, azionista di maggioranza e socio accomandatario, e i fratelli Uberti173. Entra nella nuova anonima come socio di maggioranza sottoscrivendo una quota di 445.000 lire la signora Gemma Ramella, vedova di Vittorio Canepa, diventata l’unica proprietaria della sci pochi giorni prima della fusione, dopo avere rilevato le carature dei fratelli Uberti174: pur senza assumere ufficialmente un ruolo direttivo, è chiaro che la sua voce conterà parecchio nelle future strategie dell’azienda; anche Elvira Demarchi Bonadé Bottino è presente nella nuova impresa, aumentando il proprio impegno fino a 30.000 lire. Lo scopo di un’operazione apparentemente insensata non è esplicitato nei documenti, ma la realtà del progetto viene presto alla luce: la fusione fra le due società e l’aumento di capitale non stanno a indicare che la Cinestampa Torino intende potenziare i laboratori di sviluppo e stampa, ma che ha cambiato la propria gamma di interessi, abbandonando un settore in agonia per lanciarsi nei più promettenti campi degli affari immobiliari e dell’esercizio. Le vi-
cende successive non sono conosciute nei particolari, ma nel giugno 1925 è ultimato il primo risultato della nuova impostazione della Cinestampa, il Cinepalazzo di corso Vittorio Emanuele, “la più significativa opera dell’Art Déco torinese”175, progettato dall’ingegnere Vittorio Bonadè Bottino, figlio della signora Demarchi, come si è visto azionista di rilievo delle due Cinestampa. Nel 1928 la Cinestampa Torino, dopo avere portato il capitale fino a otto milioni, indispensabili per muoversi nel mercato immobiliare, si trasforma ufficialmente in anonima immobiliare, pur mantenendo la stessa ragione sociale176; due anni dopo si chiude il periodo torinese della società col trasferimento della sede a Milano177.
Conclusione La mancanza di studi d’insieme di riferimento incide negativamente quando si vogliono analizzare settori particolari, tentando, come in questo caso, di definire con precisione la portata della presenza femminile nell’imprenditoria cinematografica e di valutarne l’importanza: manca la possibilità di operare confronti con altri campi di attività e ogni tentativo di generalizzazione corre il rischio di essere solo un’ipotesi azzardata. Nel corso delle ricerche d’archivio è stata reperita una quantità sorprendente di informazioni, insufficienti per ora ad avanzare ipotesi generali, dato il 219
campionamento limitato a una sola città, ma che rivelano una presenza femminile di cui sfugge l’esatta portata e che aprono la via a nuovi problemi. Come già detto, questo studio non vuole dare risposte definitive, ma solo fornire informazioni che potranno diventare parte di un mosaico globale e proporre alcune vie di ricerca. In rapida sintesi, è evidente che la componente femminile nel cinema torinese fino al 1945 è minoritaria, con notevoli, interessanti, difformità fra i vari settori. È presenza rilevante nel commercio – pur con differenze notevoli fra noleggio ed esercizio – sia nell’impostazione finanziaria sia nella gestione; non raggiunge mai livelli imprenditoriali di rilievo nella produzione, anche se non sono mancati i tentativi in società di minor importanza; è del tutto assente fra le società tecniche, finanziarie, immobiliari, ecc., per cause su cui non è possibile al momento formulare ipotesi; l’unica eccezione appartiene al caso particolare di gestione del patrimonio ereditato da una vedova178. Se si vuole allargare il campo di indagine sull’imprenditoria femminile nel cinema dalla ricerca locale a una dimensione nazionale e inserirla nella storia economica del paese, è necessario dare una risposta precisa ad altre questioni: in una città aperta alle nuove possibilità di sviluppo industriale come Torino, la novità rappresentata dal cinema ha costituito un motivo d’attrazione particolare per le donne179? La dimensione economica delle aziende incide nella presenza femminile? La presenza femminile nel ‘settore cinema’ è confrontabile a quella in altri settori industriali, commerciali e mediatici180, o costituisce una situazione atipica?
220
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
Note
In questo studio il termine ‘imprenditrice’ sarà usato in senso lato, comprendendo anche chi ha partecipato solo finanziariamente alla costituzione di un’azienda o a svolto un ruolo dirigenziale.
1
Naturalmente non si tratta di un fenomeno solo italiano: “Nel modello vittoriano che si affermava nell’Europa di fine secolo […] l’uomo agiva nella sfera pubblica ed esprimeva opinioni politiche, le donne erano il pilastro della casa ed esprimevano i sentimenti dell’intimità. Nel momento in cui si affidava alla famiglia il compito di riaffermare le distinzioni di rango e di status, le donne, in particolare quelle di classe media, venivano escluse dalla vita attiva all’esterno delle mura domestiche, relegate alla costruzione e alla cura del focolare”; Victoria De Grazia, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia 20073, p. 24. Ciò che caratterizza il nostro paese come altri dell’Europa periferica è la persistenza di questo modello per tutta la prima metà del ventesimo secolo, mentre altrove era ormai difficilmente sostenibile, soprattutto dopo la Grande Guerra. 2
Un decreto del 1926 vieta alle donne di insegnare nelle ultime classi delle scuole medie superiori le materie ritenute ‘formative’, storia e filosofia nei licei classici e scientifici, Italiano e storia negli istituti tecnici: in un certo senso fu un riconoscimento alle loro capacità dato che l’accesso femminile alle università risaliva solo al 1876.
3
Si tratta di una prassi talmente consolidata che il Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto (poi di Grazia e Giustizia) prevedeva (prevede?) paghe orarie diverse per i due sessi anche per i miseri ‘servizi domestici’ svolti dai detenuti condannati nelle case di pena.
4
Se la forza lavoro bracciantile è quasi esclusivamente maschile – con l’unica rilevante eccezione delle mondine – sulla donna ricade non solo il grave compito della gestione quotidiana della casa, della cura del bestiame e dell’orto, ma anche di coadiuvare i familiari specialmente nei periodi critici come il raccolto o la vendemmia. Secondo un’indagine dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (inea), negli anni Venti nei poderi toscani le mogli lavoravano ben più dei mariti, con una media di 3.315 ore annue contro 2.749; in Victoria De Grazia, op. cit., pp. 250-251. 5
Sulla legislazione italiana nei confronti del lavoro femminile, si veda Maria Vittoria Ballestrero, Dalla tutela alla parità, Il Mulino, Bologna 1979.
6
R.D.L. n. 1514 del 5 settembre 1938. Il decreto non fu applicato causa la guerra, ma era l’espressione di un pensiero preciso: “l’abolizione del lavoro femminile deve essere la risultante di due fattori convergenti: il divieto sancito dalla legge, la riprovazione sancita dall’opinione pubblica. La donna che lascia le pareti domestiche per recarsi al lavoro, la donna che in promiscuità con l’uomo, gira per le strade, sui trams,
7
sugli autobus, vive nelle officine e negli uffici, deve diventare oggetto di riprovazione, prima e più che di sanzione legale”; Ferdinando Loffredo, La politica della famiglia, Bompiani, Milano 1938, p. 356; cit. in Elisabetta Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa e nella cultura del Ventennio, Editori Riuniti, Roma 1982, p. 22. L’art. 134 sarà abrogato solo nel 1919; l’art. 135 concedeva generosamente che l’autorizzazione del marito non era necessaria “quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l’espiazione della pena”. Per i problemi connessi ai rapporti familiari e ai condizionamenti sanciti per legge, si veda Paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, Il Mulino, Bologna 20022.
8
Raffaele Romanelli, Donne e patrimoni, in Angela Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 353.
9
10
Raffaele Romanelli, op. cit., pp. 360-361.
Anche il Futurismo, nonostante la pretesa di essere l’avanguardia dei tempi nuovi e la partecipazione attiva di numerose donne all’elaborazione teorica, è sostanzialmente misogino o comunque legato a concezioni parziali del ruolo della donna; vedi Elisabetta Mondello, op. cit., cap. I. 11
12 Il modello culturale della ‘donna nuova’, piatta traduzione della new woman e della femme nouvelle di altri paesi, compare in Italia al volgere del secolo, ma si diffonde solo dopo la Grande Guerra. Il fascismo si approprierà del termine, identificandolo con la ‘nuova italiana’ cui il regime intende dare vita; vedi Michela De Giorgio, Le italiane dall’Unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 20 e segg. 13 La paura dell’emancipazione femminile è in quegli anni assai diffusa: nel 1920 Alfredo Panzini dedica un articolo a un quadro di Marcello Dudovich, La signorina dalla veletta, da cui prende spunto per una serie di osservazioni sulla ‘donna nuova’, che “vuole il potere. Se la ride della consacrazione del matrimonio, delle vecchie convenzioni morali e fisiologiche. Essa vuole il potere come il proletariato. La ‘signorina’ rappresenta un grande, un nuovo proletariato”: il breve saggio è improntato a un’aspra misoginia, ma è interessante vedere come le paure borghesi per la perdita del potere considerino equivalenti la marcia inarrestabile delle donne e di una classe operaia che, nel 1920, sembra vittoriosa in Russia, in Germania, in Ungheria; vedi Alfredo Panzini, La signorina dalla veletta, “Rassegna italiana, politica, letteraria e artistica”, n. 31, 30 novembre 1920, pp. 477-485. 14 Umberto Notari, La Donna “Tipo tre”, La Vita Felice, Milano 1998, p. 106 (ed. or. Notari, Milano 1924), p. 11, in corsivo nel testo. Per l’autore, scrittore e giornalista legato al Futurismo, la donna ‘tipo tre’ è il superamento della conce-
221
zione tradizionale, peraltro teorizzata nel 1912 da Valentine de Saint Pont nel Manifesto della donna futurista: “La donna deve essere madre o amante […] la madre che riceve il figlio fa, con del passato, dell’avvenire. L’amante dispensa il desiderio che trasporta verso il futuro”. Ovviamente la nomenclatura ‘tipo uno’ e ‘tipo due’ per i ‘modelli’ tradizionali di donna è di Notari. 15
Umberto. Notari, op. cit., p. 55.
16
Umberto. Notari, op. cit., pp. 58-59.
17
Umberto. Notari, op. cit., p. 102.
Il periodo preso in esame in questo studio giunge al 25 aprile 1945, nella convinzione che la tradizionale periodizzazione della storia del cinema – muto/sonoro – perda di significato nel caso di un’analisi sul lavoro femminile e che vi sia una sostanziale omogeneità di atteggiamento fra i primi due decenni del secolo e il ventennio fascista: se è vero che il fascismo prese numerosi provvedimenti di tutela a favore della maternità e dell’infanzia, si deve sottolineare che non solo furono irrigidite le discriminanti contro il lavoro della donna nel settore pubblico, ma che questo non fu favorito nemmeno nel privato, e che anzi “La ‘civiltà del lavoro’ di Mussolini sminuiva le abilità e le inclinazioni professionali delle donne non solo agli occhi dello Stato, degli imprenditori e degli uomini, ma delle donne stesse”; vedi Victoria De Grazia, op. cit., p. 232.
18
19 Conoscere l’imprenditoria femminile non è che un passo nella comprensione del lavoro femminile nel cinema: è noto che il lavoro dipendente e meno qualificato (colorazione, laboratori chimici, montaggio…) era svolto in grande maggioranza da donne, ma allo stato attuale degli studi non ne sono conosciute le dimensioni né le caratteristiche peculiari.
Archivio Notarile Distrettuale, Torino (andt) – 11 febbraio 1941. Notaio P.M. Emprin Gilardini. 20
21 Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino (cciaa). Archivio imprese estinte – Ancora Film. Assemblea 3 aprile 1944. Notaio E. Lapidari (Milano). 22
andt
– 9 giugno 1918. Notaio O. Costa.
23
andt
– 25 febbraio 1919. Notaio O. Costa.
24
andt
– 11 maggio 1920. Notaio O. Costa.
Il modello ispiratore è ovviamente quello di Francesca Bertini, che all’inizio del 1918, d’accordo con la casa che l’ha sotto contratto, la Caesar Film, dà vita a una società autonoma, ma collegata, la Bertini Film: le sue imitatrici peccano sicuramente di presunzione, ritenendo che il proprio nome abbia lo stesso potere sul pubblico di quello della diva per eccellenza, ma soprattutto non riescono a comprendere che la Bertini Film poteva contare sull’organizzazione, i capitali e l’esperienza di Giuseppe Barattolo, proprietario della Caesar. La prima protagonista italiana del mondo dello spettacolo a cercare di sfruttare il proprio nome è stata la diva del varietà Lina Cavalieri, “la donna più bella del mondo”, che aprì diversi saloni di bellezza col suo nome in Francia e negli Stati Uniti, firmando anche numerosi articoli e un libro in propo25
222
sito; vedi Stephen Gundle, Figure del desiderio. Storia della bellezza femminile italiana, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 129-130. In Italia è prassi datare una pellicola in base al visto di censura o alla prima proiezione pubblica, ma, per diversi motivi, un film può arrivare alla distribuzione commerciale mesi o, in casi particolari, anni dopo le riprese e la postproduzione: la mancanza di dati sicuri sul periodo di produzione pone gravi ostacoli nello studio delle società di produzione. 26
Il fenomeno di divi che s’improvvisano produttori non è solo femminile: a Torino, ne sono tentati Luciano Albertini, Mario Bonnard, Cannelloni, Febo Mari, Polidor, Saetta e altri ancora. L’attore e regista Carlo Campogalliani dà vita a una Casa di produzione col proprio nome, la Campogalliano & C. (il nome compare sempre nelle riviste e nella pubblicità con la ‘O’ finale), contando sull’apporto finanziario di un amico, l’avvocato Carlo Pollone, e sulla disponibilità, forse anche finanziaria, della sua compagna, Letizia Quaranta; sono sconosciuti i particolari economici e organizzativi della società, ma la scelta della ragione sociale e i molteplici ruoli ricoperti da Campogalliani in tutti i film realizzati: soggettista-sceneggiatore-regista-protagonista, dimostrano chiaramente che la gestione dell’azienda fu di sua pertinenza esclusiva. 27
28 “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 10, 10 settembre 1918; n. 12-13, 31 ottobre 1918. 29 Forse ha influito sulla decisione della Tarlarini di fondare una casa editrice la speranza di mutare il proprio ruolo nel cinema: nel 1919 i giudizi su di lei, nata nel 1878, sono impietosi, Tito Alacci (Le nostre attrici cinematografiche studiate sullo schermo, Bemporad, Firenze 1919, pp. 86-87) non esita a scrivere che “Appartiene alle attrici anziane […] L’età non ha deformato in lei alcuna linea, né ha spento il fulgore degli occhi; solamente la pelle appare alquanto devastata […] si vede a colpo d’occhio che doveva essere stata una gran bella donna”, ma già dal 1913 le sue parti erano limitate ai ruoli di “madre nobile, di antagonista (nel cinema muto, un’attrice di 35 anni non poteva aspirare a nulla di meglio)”; cfr. F.S. [Francesco Savio], Filmlexikon degli autori e delle opere. Vol. T-Z, Edizioni di Bianco e Nero, Roma 1967, pp. 65-66.
Secondo “La Cinematografia italiana ed estera” (n. 9, 15 agosto 1918), nell’estate 1918 Mary Cléo Tarlarini è “proprietaria assoluta e impegnata nell’amministrazione” della Edison Film, per cui stava preparando anche due film (Il canto della fede, Il lampionaro di Firenze), ma si tratta di un abbaglio dell’anonimo giornalista, dato che un mese dopo gli stessi film vengono citati come in lavorazione alla Cléo Film; secondo inserzioni pubblicitarie successive, l’Edison ha invece assunto la concessione per tutto il mondo della distribuzione della Cléo Film; “La Vita cinematografica”, n. 27-28, 22-30 luglio 1918, p. 80. 30
Nel Lampionaro del Ponte Vecchio recita anche la “piccola meravigliosa Bianca Maria Tarlarini”: è evidentemente parente di Mary Cléo, ma non viene specificato il grado del rapporto.
31
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann 32 “La Vita cinematografica”, n. 9-10, 7-15 marzo 1918; “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 6, 15-30 aprile 1918; n. 9, 15 agosto 1918.
“La Rivista cinematografica”, n. 20, 25 ottobre 1920; “La Vita cinematografica”, n. 35-36, 7-15 ottobre 1920. 33
34 “Bianca Guidetti Conti era contessa perché aveva sposato un tale che di questo titolo nobiliare era fregiato. Diciamo ‘un tale’ perché non ci è riuscito di sapere nulla sul suo conto: la figura del marito di Bianca è una specie di ectoplasma di cui si sa che esiste, ma del quale non si parla mai”: la citazione è tratta dal volume dedicato a Emilio De Bono da Franco Fucci, un lavoro che si avvale, in parte, dei diari del maresciallo conservati all’Archivio Centrale dello Stato (Emilio De Bono, il Maresciallo fucilato, Mursia, Milano 1989, p. 159). Nei riguardi dei rapporti De Bono - Guidetti Conti, l’autore azzarda giudizi temerari (“[Bianca Guidetti] col cinema, ebbe a che fare, anche se non come attrice” (Ibidem), non giustificati da una migliore conoscenza dei fatti.
Secondo un articolo ridicolmente adulatorio, “Educata alla scuola della Marini, Donna Bianca Guidetti Conti ha sostenuto trionfalmente primissime parti nelle nostre primarie compagnie, recando recentemente oltre l’oceano, nelle Americhe […] il nome e l’arte d’Italia” (vedi Donna Bianca Guidetti Conti, “La Vita cinematografica”, n. 35-36, 7-15 ottobre 1920); secondo l’unico nome citato dall’anonimo estensore del pezzo, dunque Bianca si formò sotto Virginia Marini, attrice di una certa fama, che dopo il ritiro dalle scene insegnò a lungo alla scuola di recitazione dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma: è la sola informazione disponibile sul passato dell’aspirante diva. 35
36 Bianca Guidetti risiede come locataria in un villino in via Romani 10 dal 1909 (vedi Guida commerciale e amministrativa di Torino, Paravia, Torino 1910); dal 1913, come Contessa Bianca Guidetti in Conti è anche proprietaria dell’edificio (Guida Paravia, 1914 e seguenti). Il villino fa parte di un complesso di quattro palazzine che occupa un intero isolato compreso fra le vie Romani, Superga (oggi Martiri della Libertà), Ludovica e Verrua, ed è una delle prime opere di Pietro Fenoglio, il maggior esponente dell’Art Nouveau torinese, in questo progetto ancora legato a valenze eclettiche (vedi Archivio Storico del Comune, Torino-Pratiche edilizie, 1897 / 11). L’alto livello dell’insieme, evidente nella varietà formale delle quattro palazzine, nella complessa articolazione dei volumi, negli ampi spazi destinati alle stanze e ai giardini e nella sobria eleganza della decorazione, rivela chiaramente come i villini siano destinati a residenze di livello medio alto; oggi il gusto fin-de-siècle del progetto originale non è più avvertibile, annullato da ampliamenti e sopraelevazioni inconsulte.
precedente, ma è Mari a dare fiducia all’attrice affidandole ruoli di primo piano. 39 Così recita la didascalia della prima fotografia di Bianca Guidetti comparsa sui giornali; vedi “La Vita cinematografica”, n. 21-22, 7-15 giugno 1919. 40 Mari dimostra coraggio impiegando l’amica in parti di rilievo: anche ammettendo che siano corrette le poche informazioni sul suo passato di attrice teatrale, la Guidetti non è giovanissima nel 1918: nata a Bologna il 29 maggio 1883 (asct-Schede anagrafiche), ha 35 anni, età inconsueta per un debutto. La mancanza di atti legali sulla costituzione della Mari Film e delle società successive non permette di avanzare ipotesi sicure sugli accordi economici fra Febo Mari e Bianca Guidetti.
Rodriguez è la forma del cognome usata da Febo Mari, anche se quella legale è Rodriquez; vedi Nino Genovese, Febo Mari, Edizioni Papageno, Palermo 1998, pp. 31-32. 41
42 La carenza di spazio disponibile e il livello medio-alto degli edifici (vedi nota 36) permettono di escludere che qualunque tipo di lavorazione cinematografica – riprese o trattamento pellicole – sia mai stata eseguita nei parterre di via Romani 10. Per lo stabilimento di via Morghen 17, vedi Alberto Friedemann, op. cit., pp. 150-155 e pp. 156-161.
Vedi “La Vita cinematografica”, n. 35-36, 1920; “La Rivista cinematografica”, n. 20, 25 ottobre 1920. 43
44 Vedi Alberto Friedemann, Celluloide e argento. Le società tecniche torinesi, Biblioteca Fert, Torino 2003, pp. 33-33. La Circe è citata fra le società di sviluppo e stampa nella Guida Paravia nelle edizioni dal 1921 al 1926, ma non si hanno notizie di attività. 45
“La Vita cinematografica”, n. 35-36, 7-15 ottobre 1920.
In La vendetta dei serpi, uno dei due film interpretati da Bianca per una società diversa dalla sua, la De Giglio; vedi Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1921, cit., p. 353. 46
47 In La via delle lacrime; vedi Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1922/23, cit., p. 172. 48 “La Rivista cinematografica”, n. 14, 25 luglio 1921; n. 2, 25 gennaio 1922; “La Vita cinematografica”, n. speciale, dicembre 1921; n. 1-2, 7-15 gennaio 1922; n. 17-18, 7-15 maggio 1922. 49 Alexandre Dumas père: “Il y a une femme dans toutes les affaires: aussitôt qu’on me fait un rapport, je dis: cherchez la femme”, Les Mohicans de Paris, 1854.
37 Per le vicende dello stabilimento Navone, vedi Alberto Friedemann, Le case di vetro. Stabilimenti cinematografici e teatri di posa a Torino, Associazione Fert, Torino 2002, pp. 156-161.
50 Nei diari del maresciallo manca il periodo gennaio 1920-agosto 1924, e la “contessa” (sempre scritto fra virgolette), viene citata per la prima volta il 3 settembre 1925, ma dal contesto – un telegramma di Bianca a De Bono, in cui gli annuncia una truffa di cui è stata vittima – è evidente che una conoscenza intima fra i due è ben precedente; vedi Franco Fucci, op. cit., p. 160.
38 Nello stesso 1918 Bianca Guidetti ha una parte minore in Olì, un film per ragazzi della Delta Film Ettore Ridoni, forse
51 De Bono votò a favore dell’ordine del giorno Grandi durante la seduta del Gran Consiglio del 24-25 luglio 1943, e dopo
223
l’armistizio e la costituzione della Repubblica Sociale, nonostante i velati suggerimenti dello stesso Mussolini perché si rifugiasse in Svizzera, rifiutò di fuggire; arrestato a dicembre, nel processo di Verona fu condannato a morte per alto tradimento e fucilato con Ciano e gli altri gerarchi non latitanti il 9 gennaio 1944. Il Fascio artistico torinese venne costituito il 14 agosto 1921; fra i partecipanti, Camillo Bruto Bonzi, Domenico Gambino ‘Saetta’, Emilio Ghione, Umberto Mozzato, A. Pasquali, V. Rossi Pianelli, F. Sala; vedi Il Fascio Artistico Cinematografico Torinese, “La Rivista cinematografica”, n. 16, 25 agosto 1921; n. 17, 10 settembre 1921; Il fascio artistico cinematografico torinese, “Conquista cinematografica”, n. 3-4, 24 ottobre 1921; Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema muto. 1895-1929, Editori Riuniti, Roma 20012, pp. 271-272.
52
53 Secondo la segnalazione di una rivista, Bianca Guidetti avrebbe ancora partecipato nel 1925, nella parte di Maddalena, all’infelice tentativo di realizzare La passione di Cristo, inscenato a Roma da Domenico Gaido e concluso con l’incendio del set e il fallimento dell’iniziativa; vedi “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 9-10, 15 settembre-15 ottobre 1925, p. V.
Oltre a essere un’attrice, lavoro ancora guardato con un certo sospetto dai benpensanti negli anni Venti, non è di secondaria importanza il fatto che Bianca sia sposata: per l’art. 559 del Codice penale l’adulterio femminile è un reato e solo una sentenza della Corte Costituzionale nel 1968 (!) dichiarerà illegittimo distinguere fra i sessi in tema di infedeltà coniugale. La rinuncia volontaria della contessa al cinema per non danneggiare l’amante è un’ipotesi non documentata, ma plausibile, conoscendo quali saranno i rapporti affettuosi di Bianca con Emilio De Bono e con la moglie Erminia negli anni successivi: ancora nell’autunno-inverno del 1943, la Guidetti, per quanto sia una fascista convinta, cerca in ogni modo di salvare la vita del compagno, chiedendo indulgenza per il maresciallo in udienze private presso il ministro della giustizia, Piero Pisenti, e lo stesso Mussolini; vedi Franco Fucci, op. cit., pp. 335-336. 54
Di fronte all’irrompere anche sulla scena cinematografica delle flappers, delle garçonnes, il modello italiano di diva degli anni Dieci non ha più mercato, neppure all’interno del paese.
55
“La contessa Bianca Guidetti Conti sta riorganizzando il proprio stabilimento di via Morghen”; vedi “La Vita cinematografica”, n. 39-40, 22-30 novembre 1921, p. 80; Guida Paravia, ed. 1922-23. 56
57 Sul terreno di via Morghen 17 nel 1923 hanno sede i Teatri Cinematografici (vedi Guida Paravia, ed. 1924-25), presumibilmente un tentativo di rendere il complesso disponibile alla produzione di terzi, ma è un’iniziativa destinata al fallimento, sia perché l’attività cinematografica si sta avviando allo zero, sia per il mediocre livello tecnico dello stabilimento (vedi Alberto Friedemann, Le case di vetro, cit., p. 153), pecca grave in una città dove non mancano certo i complessi cinematografici ben attrezzati e senza lavoro.
224
58
Vedi Guida Paravia, edd. 1925-26 e 1926-27.
Forse una conseguenza di questa iniziativa è la causa che oppone Bianca a persone che l’avevano truffata, conclusa con la vittoria della ‘contessa’ e con un risarcimento danni per 600.000 lire nell’ottobre 1931; vedi Franco Fucci, op. cit., p. 160. Conoscendone le attività intraprese dopo la fine della Casa di produzione, è scorretto il giudizio espresso da Franco Fucci, che, ignorandole, sulle capacità manageriali della Guidetti scrive: “i numerosi guai della contessa andarono avanti per un bel pezzo ed erano connessi alla sua attività imprenditoriale nel campo della cinematografia, un’attività che lei certamente condusse in modo dissennato, sprovveduta com’era in materia d’affari”; p. 160. 59
asct-Schede anagrafiche. La palazzina di via Morghen sarà distrutta da un bombardamento nel 1944. 60
61 Così Maria viene definita sulla copertina di una rivista (“La Vita cinematografica”, n. 17-18, 7-15 maggio 1917) e nei soffietti pubblicitari: le inserzioni tacciono pudicamente – o forse si ritiene superfluo ricordarlo – il maggior motivo di fama dell’attrice, l’invenzione della “famosissima ‘mossa’ ovvero il ‘coup de ventre’, che consisteva nel sincrono movimento delle anche, del ventre e del petto, avviato dal rullio del tamburo e concluso da un colpo di grancassa”; vedi Francesco Mottola, Il teatro di varietà, Nuove Edizioni Culturali, Milano 1995, p. 282. All’invenzione della ‘mossa’, si rifà molto liberamente un film del 1970, Ninì Tirabusciò. La donna che inventò la mossa, con Monica Vitti nella parte di Maria Sarti (il nome della protagonista nel film). 62 Za, in “Cronache dell’attualità cinematografica”, n. 5, 2 marzo 1919; citato in Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1917, cit. p. 218.
Una sola recensione salva, almeno in parte, la presenza di Maria sullo schermo: “sempre bella e sempre nel pieno fascino del suo celebre sorriso, ha compreso cosa sia il cinematografo”, Anonimo, La capanna dello zio Tom, “Film”, 9 febbraio 1919; citato in Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1918, cit. p. 37. 63
64 Un’ultima presenza di Maria Campi nel cinema sarà nel 1946 con la parte della Chiromante in Sciuscià. 65 Maria De Angelis, in arte Maria Campi, era nata a Roma nel 1877 e l’età era ormai avanzata “relativamente alle esigenze degli habitués del caffè-concerto, per i quali le canzonettiste trentenni erano già vecchie”; vedi Enciclopedia dello spettacolo, vol. bas-cap, Unedi, Roma 1954, p. 1565.
Luciano Ramo, Storia del varietà, Garzanti, Milano 1956, pp. 88-89. 66
67 Nella pubblicità si cita la partecipazione di Elsa a diversi film, nei cui cast tuttavia non resta traccia dell’attrice, dimostrazione evidente che si trattò di particine. 68 Fortunello, Elsa Tornielli, “La Rivista cinematografica”, n. 12, 25 giugno 1920, p. II. 69
Di Linda Albertini si sa ancora oggi molto poco, anche se
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
lavorò in numerosi film in Italia e in Germania, sia come spalla del marito, Luciano Albertini, sia come protagonista nelle vesti di Sansonette: dopo la rottura col marito, di Linda non si sentì più parlare; vedi Vittorio Martinelli, I Gastarbeiter fra le due guerre, “Bianco e Nero”, n. 3, 1978; Id., Lasciate fare a noi, siamo forti, in Alberto Farassino e Tatti Sanguineti (a cura di), Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983, p. 21. 70 Secondo quanto appare in una inserzione pubblicata una volta sola, la società è “proprietà di Malerba e Tirelli” (“La Rivista cinematografica”, n. 10, 25 maggio 1920): Casimiro Tirelli è anche il proprietario della Cellulosa Film, un’azienda di recupero pellicole, sita in corso Dante 44, lo stesso indirizzo degli uffici della Tornielli Film. 71 Vedi Roberto Chiti, Dizionario dei registi del cinema muto italiano, Mics, Roma 1997, p. 173. 72
“La Rivista cinematografica”, n. 11, 10 giugno 1920.
73
“La Rivista cinematografica”, n. 12, 25 giugno 1920.
74
“La Vita cinematografica”, n. 29-30, 22-30 agosto 1920.
Ego, Vera Sylva, “La Rivista cinematografica”, n. 15, 10 agosto 1920. 75
76 “La Rivista cinematografica”, n. 15, 10 agosto 1920; “La Vita cinematografica”, n. 29-30, 22-30 agosto 1920; Il girovago, Vera Sylva, “La Vita cinematografica”, n. 41-42, 22-30 novembre 1920. 77 Secondo un articolo pubblicato da “La Vita cinematografica”, la Vera Sylva Film realizzò anche un altro film, Gloriana, sempre diretto da Cagliero-Terni, che non risulta però distribuito; vedi Il girovago, Vera Sylva, “La Vita cinematografica”, n. 41-42, 22-30 novembre 1920.
Solo l’operatore Natale Chiusano, già dell’Itala, è noto; il regista, Gigi Cagliero-Terni è forse il marito della protagonista; vedi Roberto Chiti, op. cit., p. 45. 78
79 “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 10, novembre 1923; n. 12-13, 31 dicembre 1923-31 gennaio 1924; n. 14-15, 29 febbraio-31 marzo 1924; n. 1-2, 31 gennaio-15 febbraio 1925; n. 1-2; 12 aprile 1925; n. 5-6, 31 maggio-30 giugno 1925. 80 “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 1-2, 31 gennaio-15 febbraio 1925. 81 Alcune inserzioni pubblicitarie permettono di conoscere i volti degli interpreti, tutti sconosciuti, tranne Umberto Mozzato; vedi “La Rivista cinematografica”, n. 2, 25 gennaio 1924; “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 5-6, 31 maggio-30 giugno 1925. Le due inserzioni sono impostate su piccoli tondi con le fotografie degli attori e differiscono per alcuni particolari: quella sulla “Rivista cinematografica”, per esaltare il ruolo della Gallesio nella società, fa partire dal tondo di Aloisia tanti segmenti che raggiungono le fotografie degli altri attori. 82
Vedi Roberto Chiti, op. cit., pp. 128-129.
La Lydianne Film viene considerata come una casa torinese sia da Vittorio Martinelli (Il cinema muto italiano. 1919, 83
1920, 1921, 1922-23) che da Aldo Bernardini (Archivio del cinema italiano. Volume I - Il cinema muto, Anica, Roma 1991), anche se in un trafiletto sulla “Cinematografia italiana ed estera” (n. 4-5, 28 febbraio-15 marzo 1919) si scrive che la Lydianne Film ha sede a Milano in via Leopardi 10. “La Vita cinematografica”, n. 7-8, 22-28 febbraio 1916; n. 9, 7-15 marzo 1916. 84
85 “La protagonista Lydianne potrà anche incarnare la figura di Sirena, per la linea scultorea delle forme, ma come attrice lascia molo a desiderare”; Ref, “La Vita cinematografica”, 22 marzo 1921; cit. in Vittorio Martinelli, Il cinema muto. 1919, cit., p. 194. “La bella Lydianne […] è veramente una bella … statua, perciò non si muove nemmeno nelle scene più terribili”; Giu, “La Rivista cinematografica”, cit. in Vittorio Martinelli, Il cinema muto. 1922-1923, cit., p. 44. 86 “La Rivista cinematografica”, n. 5, 10 marzo 1920; “La Vita cinematografica”, n. 5-6, 10-25 marzo 1920; il lungo intervallo fra le riprese e la distribuzione non ha alcuna spiegazione. 87 L’anno precedente Manzini aveva costituito, con l’appoggio di “La Rivista cinematografica”, lo Studio Letterario e Cinematografico, che aveva l’ambizione di diventare un polo di riferimento per gli sceneggiatori cinematografici e per le case editrici. 88
“La Vita cinematografica”, n. 9-10, 7-15 marzo 1920.
Harry W. De Long, Satanella, “Moving Picture World”, 28 marzo 1914; in Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1913-II, cit., p. 225. 89
I giornali dedicarono ampio spazio all’episodio: vedi “La Stampa”, 18 ottobre 1913; “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 159, 20 ottobre 1913; “La Vita cinematografica”, n. 31, 31 ottobre 1913. Ignota l’origine della leggenda del velo, forse da attribuire alla fantasiosa narrazione fattane da Emilio Ghione quindici anni dopo l’episodio: “Adriana Costamagna, orribilmente sfigurata dall’artiglio della belva, visse i suoi giorni e le sue notti col suo bel viso di una volta coperto da un velo, né mai più si specchiò, avendo di sé orrore pietoso” (Emilio Ghione, Memorie e confessioni, “Cinemalia”, n. 10, 5 maggio 1928, p. 21 f.t.). Ciò che scrive Za-la-Mort non è giustificato, oltre che dalle notizie molto meno drammatiche comparse sui quotidiani torinesi, anche da quanto si pubblica successivamente nelle riviste professionali: due anni dopo, “La Vita cinematografica” dedica una copertina fotografica ad Adriana, “La grande attrice italiana, interprete delle films d’arte che verranno edite dalla Enotria Film” (n. 11, 22 marzo 1915), e i critici esprimono sul suo conto giudizi positivi anche sul piano estetico: “bella di nivea purezza” (in Il genio della guerra; vedi Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1914-I, cit., p. 233) e “La brava sig.a Adriana Costamagna dalla bella figura decorativa” (in Segreto di stato; vedi Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1916-II, cit., p. 185). 90
91
andt
– 31 dicembre 1914. Notaio V. Provera.
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 11, 15 giugno 1915. 92
225
93 “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 3, 15 marzo 1923. 94 Il cognome di nascita figura negli atti ufficiali con l’indicazione delle generalità del padre, mentre in tutti gli altri documenti la signora compare solo col cognome del marito, Vincenzo de Liguoro, anch’egli pubblicista: con un certo snobismo di cui non si può non sorridere, al cognome dello sposo si fa spesso seguire “dei conti di Presicce”, dato che il titolo nobiliare spetta solo al cugino, il noto regista Giuseppe de Liguoro. Il nome di battesimo compare scritto sia con la “y” che con la “i”. 95
andt
– 13 ottobre 1913. Notaio A. Germano.
andt – 15 aprile 1914. Notaio A. Germano. Alla costituzione del capitale dell’anonima partecipa anche Vittorio Valletta, giovane commercialista con un’ottima reputazione di specialista in analisi dei bilanci.
96
Archivio Storico, Torino. Atti di società (ast.as) – 1915 / v. 2, f. 360.
97
98
ast.as
– 1916 / v. 3, f. 12; 1916 / v. 3, f. 145.
Il titolo della rivista esalta il nome della proprietaria e riprende la ragione sociale della sfortunata impresa di pubblicità del 1914, ma è anche l’acronimo del programma editoriale: Letture, Illustrazioni, Disegni, Eleganza, Lavoro. 99
Frieda Klug, Lettera, “La Vita cinematografica”, n. 5, 5-20 marzo 1911. L’accanita difesa da parte di Lombardo su “Lux”, la rivista di cui è proprietario, di L’Inferno della Milano Film non gli porta fortuna, dato che in estate la Casa milanese rompe il contratto e gli ritira la concessione: la rivista deve interrompere le pubblicazioni e la Sigla viene posta in liquidazione; vedi Aldo Bernardini, Cinema muto italiano. Arte, divismo e mercato. 1910-1914, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 23.
111
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 104, 15-20 aprile 1911.
112
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 105, 1-5 maggio 1911.
113
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 110, 15-20 luglio 1911.
114
115
“La Vita cinematografica”, n. 15, 10 settembre 1911.
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 17, 10 ottobre 1911.
116
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 16, 20-25 settembre 1911.
117
118 Da un’intervista con Miss Frieda Klug sul mercato tedesco, “La Vita cinematografica”, n. 8, 30 aprile 1912.
100
“Lidel”, n. 1, maggio 1919.
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 126, 1-15 marzo 1912.
101
“La Vita cinematografica”, n. 15, 10 agosto 1924.
120
Un aspetto negativo di qualunque ricerca storica sulle società di noleggio e distribuzione è la mancanza di documenti legali: era opinione diffusa che i fondi necessari per costituire una società di distribuzione potessero essere limitati, portando quindi a privilegiare le forme organizzative più semplici e non sottoposte a obblighi legali di registrazione. L’intero sistema commerciale si basava su una gestione assurda, basata su assegni postdatati e sullo sconto delle cambiali.
102
Il fiorire di nuove aziende di distribuzione ed esercizio non trova riscontro in un corrispondente aumento dell’imprenditoria femminile.
103
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 87, 1 agosto 1910, p. 875.
104
105
Comune di Torino. Ufficio di stato civile (ct.usc).
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 92, 15 ottobre 1910.
106
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 92, 15 ottobre 1910. In realtà avrà solo la rappresentanza per l’Italia della tedesca Pharos Film e per il Piemonte della Helios Film di Velletri.
107
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 95, 1 dicembre 1910.
108
C. Casella, Frieda Klug, “La Vita cinematografica”, n. 2, 20 dicembre 1910. 109
110
“La Vita cinematografica”, n. 3, 15 febbraio 1911.
226
119
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 135, 20 agosto 1912. Curioso l’atteggiamento giornalistico verso il sesso di Frieda: alcuni mesi prima si poteva leggere che era dotata di “un virile carattere commerciale che molti uomini invidiano perché non lo posseggono”; “La Cinematografia Italiana ed estera”, n. 114, 15-20 settembre 1911.
121
“La Vita cinematografica”, n. 2, 30 gennaio 1913.
“La Vita cinematografica”, n. 3, 15 febbraio 1913, p. 57; “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 146, 20 febbraio 1913, p. 278.
122
ast.pf – 1913 / 598. Dai documenti del fallimento sono tratte le citazioni e i dati seguenti, se non altrimenti indicate.
123
Al di là delle doti personali della ragazza, un ruolo fondamentale per un lavoro così impegnativo deve averlo giocato la conoscenza delle lingue, così poco diffusa in Italia; forse Frieda ha conoscenze nel mondo del cinema anche per motivi familiari, dato che una sorella, Adele, gestisce un’agenzia di noleggio a Vienna. Il curatore non si preoccupa di spiegare, la questione esula dai suoi compiti, come Klug e Schultze siano entrati in contatto e cosa abbia portato la ragazza a trasferirsi da Budapest – o forse da Vienna: nome e cognome sono tedeschi – a Torino: anche Schultze vantava nella pubblicità di avere rapporti con case di Vienna e Budapest e in particolare di rappresentare la SA Projectograph, Budapest; vedi “Lux”, n. 2, gennaio 1909 e numeri successivi.
124
Fra i creditori chirografari compaiono anche Guido Schultze, fratello di Adolfo, e la sorella di Frieda, Adele: cu-
125
15 / Imprenditoria femminile nel cinema torinese / Alberto Friedemann
riosamente il loro indirizzo per le comunicazioni del curatore è quello di Frieda, corso Siccardi 82.
nell’edizione 1927-28 della Guida Paravia, da ‘M’ nel 192829.
126
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 148, 31 marzo 1913.
142
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 154, 15-31 luglio 1913.
143
127
Frieda aveva sposato Giulio Schultze, fratello di Adolfo e di Guido e già dipendente nella sua ditta, il 25 gennaio 1914; vedi ct.usc – Estratto di atto di matrimonio.
128
Cfr. www.ellisislandrecords.org: nel sito sono schedati oltre 24 milioni di sbarchi a New York dal 1892 al 1924.
129
“Vado a New York e mi sarà compagna una valorosa collaboratrice e interprete: la signora Frieda Klug-Schultze che conosce a meraviglia l’ambiente americano e vi conta molte aderenze e amicizie!”; Veritas, Scambiando quattro chiacchiere col cav. Arturo Ambrosio prima della sua partenza per l’America, “La Vita cinematografica”, n. 42-43, 22-30 novembre 1915.
130
131
Cfr. www.ellisislandrecords.org
“La Cinematografia italiana ed estera”, n. 1, 15 gennaio 1916.
132
Frieda rinuncia alla residenza a Torino il 14 luglio 1915 ed è registrata nei documenti comunali come emigrante negli Stati Uniti (ct.usc – Anagrafe storica): la seconda traversata atlantica, quella con Ambrosio, è quindi per lei un viaggio da cui ha già deciso che non farà ritorno. Di una comunicazione del 1916 della società Ambrosio ai giornali sarebbe difficile capire il senso sapendo che Frieda non è a Torino, se non si accetta l’ipotesi di un esilio volontario per motivi ‘politici’: “Per troncare errati commenti, su richiesta dalla signora Frieda Schultz, dichiariamo con piacere che la predetta Signora fa sempre parte del personale amministrativo della nostra Casa, dalla quale è temporaneamente assente per motivi di salute. S.A. Ambrosio”; vedi “La Vita cinematografica”, n. 9-10, 7-15 marzo 1916. 133
134
ct.usc
– Anagrafe storica.
Ringrazio per l’informazione la dottoressa Rossana Becarelli, direttore sanitario dell’Ospedale San Giovanni - Antica sede, di Torino.
135
Mark Haworth-Booth, The Art of Lee Miller, Yale University Press, New Haven 2007. 136
137
ast.as
– 1917 / vedi 5, f. 115.
“Rivista Cinematografica”, n. 7, 15 aprile 1927; n. 14, 30 luglio 1927; n. 18, 30 settembre 1927.
138
139
“Rivista Cinematografica”, n. 7, 15 aprile 1927.
andt – 18 aprile 1928. Notaio A. Cecchetani. L’atto di fondazione dell’anonima è irregolare, perché non compare il deposito dei tre decimi del capitale iniziale previsto dall’art. 131 del Codice di Commercio.
140
L’agenzia compare sotto il nome Torri, accompagnata dall’iniziale ‘V’ (probabilmente un errore di stampa per U)
141
“Rivista Cinematografica”, n. 23-24, 15-30 dicembre 1928. “Rivista Cinematografica”, n. 1, 15 gennaio 1929.
“Rivista Cinematografica”, n. 12, 30 giugno 1930. Con ogni probabilità, è Adolfo Rolla a rilevare contatti e (forse) esclusive della società materna, limitando la propria attività all’esercizio (vedi anche Mezzano & Rolla, nel paragrafo Esercizio).
144
Virginia Casetta doveva amare molto il suo titolo di studio, perché in tutte le inserzioni il nome è preceduto da ‘Rag.’.
145
“Rivista Cinematografica”, n. 7, 15 aprile 1927. Virginia probabilmente succede al padre.
146
147
“Rivista Cinematografica”, n. 17, 15 settembre 1927.
148
“Rivista Cinematografica”, n. 3, 15 febbraio 1928.
149
andt
– 5 giugno 1928. Notaio A. Ventre.
andt
– 30 giugno 1928. Notaio A. Ventre.
150
– 1929 / 13. Le citazioni e i dati successivi sono tratti dai documenti del Procedimento fallimentare.
151
ast.pf
Un censimento completo delle sale torinesi con un profilo delle loro vicende edilizie è in Maria Grazia Imarisio, Diego Surace, Marica Marcellino, Una città al cinema. Cent’anni di Sale Cinematografiche a Torino. 1895-1995, Neos, Rivoli 1996.
152
In via Roma scompaiono i cinema Borsa, Ghersi, Meridiana, Minerva, Odeon, Royal, Splendor, Vittoria, Volta. Fra le sale storiche di prima visione, non furono demolite perché a qualche distanza da via Roma, l’Ambrosio, il Cinepalazzo (poi Corso) di corso Vittorio Emanuele - via Carlo Alberto e il declassato Kursaal Trianon di via Viotti.
153
Maria Grazia Imarisio, Diego Surace, Marica Marcellino, op. cit., pp. 215-216.
154
Il fratello Arturo gestiva già nel 1913 il cinema Impero (oggi Empire) di piazza Vittorio 5; Maria Grazia Imarisio, Diego Surace, Marica Marcellino, op. cit., p. 191
155
156 andt – 18 giugno 1927. Notaio G. Alessio. Una quota di 5.000 lire fu sottoscritta da Arturo Ambrosio.
Giulietta Cavadini dopo l’avventura del Fortino tornerà in famiglia, partecipando alla gestione dei cinema Impero e Imperial (oggi Arlecchino)
157
andt – 10 dicembre 1941. Notaio P.E. Masenti; 31 dicembre 1941. Notaio P.E. Masenti. La terza società fu costituita cambiando il nome da ‘Novarese dott. Umberto & Sorelle’ a ‘Sorelle Novarese’.
158
159
andt
– 24 febbraio 1944. Notaio C. Cassinis.
160
andt
– 10 ottobre 1942. Notaio E. Fantini.
Maria Grazia Imarisio, Diego Surace, Marica Marcellino, op. cit., pp. 229-230.
161
227
162
andt
– 15 gennaio 1942. Notaio A. Ragusa.
Per i dati biografici di Maria Mezzano, vedi Paolo Poncino, Breve storia dei cinema torinesi, Bolaffi Editore, Torino s.d., pp. 43-44.
163
Dopo il pionieristico lavoro di Riccardo Redi sulla Cines (La Cines. Storia di una casa di produzione italiana, cnc, Roma 1991) è stato fatto poco in merito. Mi permetto di segnalare un mio studio di recente pubblicazione, Cines e Cines Seta artificiale. Appunti per una storia d’impresa, “Le culture della tecnica”, n. 18, 2007, in cui la consultazione degli archivi del Banco di Roma, della Banca d’Italia e della Banca Commerciale Italiana ha permesso di comprendere l’importanza determinante del BdR nella gestione della Cines e il sostanziale fallimento – al di là delle chiacchiere e delle lodi senza reale conoscenza dei bilanci da parte dei giornalisti – della strategia commerciale della società romana. 164
In Italia la fabbricazione industriale di pellicole comincia solo nel dopoguerra con la fondazione della Ferrania, motivata soprattutto dall’esigenza di convertire gli impianti dedicati alla produzione di esplosivi, mentre l’hardware meccanico, nonostante la presenza di diverse aziende a Milano – Cinemeccanica, Pio Pion, Prevost – e della Microtecnica a Torino, non diventerà mai un settore commercialmente trainante.
165
Sono naturalmente numerosi gli articoli su aspetti parziali della vita della sasp, ma neppure l’unica monografia dedicata all’azienda, Tatti Sanguineti (a cura di), L’anonimo Pittaluga. Tracce, carte, miti, “Cinegrafie”, 1998, numero speciale, ne dà un quadro esauriente: il curatore si limita a prendere in considerazione i documenti del mnc di Torino, in genere riguardanti distribuzione-lancio-edizione di singole pellicole. 166
167 L’organigramma della sasp cambia radicalmente nel 1926, quando la comit finanzia l’acquisizione dell’uci e, diventata l’azionista di riferimento della anonima e delle controllate, impone personaggi di propria fiducia. 168
andt
– 15 novembre 1923. Notaio R. Frassati.
169
andt
– 23 aprile 1928. Notaio R. Frassati.
170
andt
– 23 febbraio 1919. Notaio L.C. De Benedetti.
“Foglio di Annunzi Legali”, Prefettura di Torino, m. 112, 28 aprile 1922, a. 4593. Alcuni giorni prima erano usciti dalla società i Bursi, evidentemente in disaccordo con la nuova strategia di azione; vedi “Foglio di Annunzi Legali”, n. 107, 11 aprile 1922, a. 4228.
171
172
andt
– 15 aprile 1922. Notaio A. Germano.
173
andt
– 19 maggio 1919. Notaio M. Valente.
“Foglio di Annunzi Legali”, n. 116, 5 maggio 1922, a. 4712. I fratelli Uberti acquisteranno comunque alcune quote della Cinestampa Torino.
174
Cfr. Maria Grazia Imarisio, Diego Surace, Marica Marcellino, op. cit., pp. 217-218. Il Cinepalazzo, cambiato il nome in Corso nel 1935, fu distrutto da un incendio il 10 marzo 1980, dopo la proiezione di una pellicola, Amityville Horror, il cui sottotitolo italiano, L’incendio della casa maledetta, sembrò
175
228
un lugubre presagio. Le strutture edilizie parzialmente recuperate (è andato però perduto quasi completamente l’apparato decorativo progettato da Giorgio Ceragioli) ospitano oggi una banca d’affari. 176
andt
– 11 ottobre 1928. Notaio A. Rossi.
“Foglio di Annunzi Legali”, n. 94, 23 maggio 1930, a. 6884.
177
178
Vedi nota 9.
È generalmente trascurata l’importanza della preparazione culturale a ogni livello: nel 1901, a Torino è analfabeta il 21,4% della popolazione femminile contro una percentuale del 54% a livello nazionale; nello stesso anno le laureate all’università subalpina rappresentano il 26,85% del totale; vedi Michela De Giorgio, Le italiane dall’Unità a oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali, cit., cap. 7.
179
Per un corretto inquadramento del cinema come fenomeno culturale, vedi David Forgacs, L’industrializzazione della cultura italiana, Il Mulino, Bologna 20002, e David Forgacs, Stephen Gundle, Cultura di massa e società italiana. 19361954, Il Mulino, Bologna 2007.
180
16 / Ester de Miro d’Ayeta
Cucire nastri di celluloide L’oscuro iter di montatrice di Esterina Zuccarone, ‘operaia’ a Torino
sempre stata una capitale del gusto e dell’eleganza, La vita e l’opera di Esterina Zuccarone si inscrivono è per le donne quello di sarta e di modista, lavoro tra le innumerevoli storie dell’emigrazione meridionale verso il nord, quell’Altitalia che, nel linguaggio equivalente a quello che facevano a Parigi le codialettale di coloro che partivano, assumeva spesso siddette midinettes, ovvero le sartine che, nel loro la storpiatura, non priva di senso, di ‘Altritalia’. Agli ruolo oscuro e modesto, hanno fatto grande la moda inizi del Novecento, infatti, rispetto al sud prevafrancese nel mondo. È un lavoro che richiede abilità lentemente agricolo e arretrato, quella del nord era nell’uso delle mani, occhio, precisione, senso della davvero un’Italia ‘altra’, il luogo dove fioriva l’indumisura e del dettaglio, capacità di confezionare un stria e, con essa, una possibilità di lavoro, guadagno prodotto ben rifinito, e, in più, un vero senso della e sopravvivenza sino ad allora moda, ossia del presente, di ciò insperata nei paesi e nelle sonche va e di ciò che invece è sornolente campagne meridionali. passato. A Torino, inoltre, la bamNata in Puglia, a Foggia, nel bina cresce in un contesto che 1905, in una famiglia numerosa diffonde e promuove tutte le novità composta dai genitori, sette figlie della tecnica: automobili, ferrovie, e un unico maschio, Esterina si telefoni, grammofoni, autobus, trasferisce con i suoi a Torino a macchine fotografiche, macchine sette anni, nel 1912, e assiste da cucire, che accelerano il lavoall’emancipazione delle sorelle ro e gli spostamenti. È l’inizio di più grandi, che, invece di restaun’epoca che mette in primo piare a casa in attesa di marito, nel no le conquiste della tecnica e al nuovo contesto trovano del tutto centro di ogni aspirazione la vita naturale andare a lavorare1. Il di città. E, come ci ricorda Metromestiere più comune e richiepolis di Fritz Lang, la città è fatta sto, in una Torino che ha intensi di persone che godono i benefici rapporti con la Francia e che è Esterina Zuccarone negli anni Cinquanta della vita moderna e di altre – la 229
Esterina Zuccarone, ritratto giovanile
maggioranza – che lavorano perché essa esista. Una sorella di Esterina, operaia in fabbrica, esce a tarda sera e la bambina accompagna in tram la madre che va a prenderla all’uscita, perché non debba affrontare da sola, nel buio delle strade, il ritorno verso casa. Ma quello di sua sorella è un lavoro tutto particolare: infatti la nascente industria cinematografica utilizza l’abilità manuale delle ragazze che sanno cucire per il lavoro di sviluppo e stampa e per il montaggio delle pellicole. In pratica, al di là dei connotati concreti di un mestiere a metà strada tra artigianato e industria, scintilla il miraggio del cinema, questa nuova forma di spettacolo popolare, non ancora considerata arte, che mette in gioco nuovi modelli di vita e nuove aspirazioni per le donne, esaltati dalle luci del teatro di posa, dagli abiti glamour, 230
dalle scenografie che, soprattutto in Italia, tendono al grandioso. Le operaie dello stabilimento, a differenza delle dattilografe o di altre lavoratrici, possono quindi vedere il risultato del loro lavoro proiettato sul grande schermo, in una cornice ben più allettante di altre. In questo periodo, del resto, le sale cinematografiche sono il luogo di ritrovo di cameriere, sartine, militari e impiegati, che trovano questi ambienti certamente più accessibili dei teatri. Esterina si propone quindi di seguire le orme della sorella, la quale invece abbandona quasi subito il lavoro per sposarsi. Ma il padre, da tipico meridionale che porta le sue idee tradizionali anche nel nuovo contesto, intuisce il potenziale di novità e di autonomia sprigionato dal cinema e si oppone. La ragazzina inizia quindi a lavorare a dodici anni in sartoria. Qualche anno dopo, però, quando l’Itala Film di Giovanni Pastrone è in pieno sviluppo, riesce a trovare un posto a La Positiva, lo stabilimento di sviluppo e stampa dell’Itala, dove può finalmente mettere al servizio della pellicola, e delle macchine usate per trattarla, tutta la sua abilità manuale e la sua intelligenza pratica, duttile, portata all’uso della tecnica. In questo periodo lo sviluppo della pellicola viene ancora realizzato a mano, il che significa passare dalle dodici alle quattordici ore al giorno in camera oscura, dove, con il solo aiuto della luce rossa, bisogna accoppiare negativo e positivo e inserirli nei dentini delle macchine, che lasciano poi cadere in una vasca sottostante i rotoli di pellicola sviluppata. Un lavoro, quindi, di precisione, da operaio specializzato, che richiede una grande attenzione, ma Esterina è la più brava nel farlo, tanto che a soli diciassette anni riesce a diventare caporeparto. In seguito viene assegnata a un’altra macchina, la passafilm, attraverso la quale si occupa del controllo della pellicola sviluppata, fino a quando, dopo aver ottenuto diversi premi di produzione per la sua abilità e rapidità, viene spostata alla moviola e incaricata del montaggio dei film. È questo un compito di molto maggiore responsabilità, perché si tratta di unire gli spezzoni di pellicola e le varie scene per mezzo di graffette, secondo gli ordini del regista, e poi di raschiare una sottile striscia di pellicola lucida in testa e in coda ai due spezzoni, in modo che la colla faccia presa e le sequenze, messe in conti-
16 / Cucire nastri di celluloide /Ester de Miro d’Ayeta
nuità, possano scorrere in successione. Esterina ha la possibilità di usare la prima moviola, disegnata e messa a punto dall’ingegnere De Rossi, proprio per l’Itala Film. I volti delle dive dell’epoca, come Italia Almirante Manzini, Pina Menichelli, Maria Jacobini, passano sotto le sue dita con acconciature di piume e di perle, con cappelli che le rendono fatali. E uomini affascinanti offrono regali o si disperano per loro. Ma a Esterina tutto questo non interessa molto. Col suo senso pratico, vive il cinema nei suoi processi fisici e palpabili, seguendo passo passo la sua evoluzione tecnica: nelle sue mani quelle immagini sono come strisce di tessuto2, nastri di pellicola lucente che devono rispondere a un ordine preciso, che vanno trattati con le imbibizioni e le coloriture adatte per farli risaltare e poi rifiniti e curati sino a ottenere la resa di un lavoro tecnicamente perfetto. In una visita al Museo del Cinema di Torino, fatta negli anni Novanta assieme a Milli Toja, realizzatrice dell’interessantissimo film che ce l’ha fatta scoprire, appena due anni prima della sua scomparsa, Esterina ormai anziana si aggira tra i proiettori e le apparecchiature che sono andate evolvendosi nel corso degli anni, dimostrando di conoscerle tutte alla perfezione: le loro caratteristiche e il loro funzionamento, quelle che sono venute prima e quelle che le hanno seguite, con una sorprendente precisione. E si intuisce in lei una vocazione ancora viva di ‘donna faber’, di colei cioè che vuole e sa costruire con le sue mani un prodotto concreto che funzioni in modo perfetto, anche se il mondo da esso generato è poi un universo di luce e di illusione, impalpabile, effimero, che invecchia presto e va incontro all’oblio. Intorno agli anni Venti c’è anche per lei una storia d’amore, ma il fidanzato vorrebbe convincerla a lasciare il lavoro dopo il matrimonio. Esterina fa la sua scelta e rompe il fidanzamento, troppo convinta e presa dalla sua vocazione, ma anche dall’ambiente di lavoro, dove è circondata da colleghi che la stimano e riconoscono le sue capacità. In questo periodo acquista anche una sua coscienza politica, e partecipa allo sciopero che porta le montatrici a manifestare in Piazza Vittorio Veneto a Torino, nel corso di una delle prime crisi del cinema italiano. Subito dopo la guerra, infatti, nel 1919, viene fondata l’uci
(Unione Cinematografica Italiana), praticamente un ‘cartello’ che raccoglie la maggioranza delle case di produzione italiane in crisi e riceve i finanziamenti di grosse banche. Dal gruppo, però, resta fuori la società torinese Itala Film, di cui fa parte il laboratorio La Positiva, dove è appunto occupata Esterina. In altri termini, la principale Casa di produzione torinese si rifiuta di farsi inghiottire da Roma: ciò che tuttavia, fatalmente, non tarderà ad avvenire in seguito. Stefano Pittaluga, che acquisisce l’Itala dopo il ritiro di Pastrone nel 1925, malgrado la passione non perde di vista i bilanci e invita l’ingegner Agnelli, padre di Gianni e proprietario della fiat, a visitare gli stabilimenti nella speranza di convincerlo a investire nel cinema, ma l’ingegnere declina l’invito: “Lei faccia i film, che io continuo a fabbricare automobili”, è la frase con cui si congeda. È singolare come, riferendo l’episodio nel film di Milli Toja, Esterina sembri ancora, dopo molti anni, delusa di come andarono le cose. Per lei il cinema era nato e doveva restare a Torino e, pur nel suo piccolo, considera riprovevole la decisione di Agnelli, come una grande occasione mancata sia per lui che per tutta la città. Singolare – e molto ‘pugliese’, vorrei dire – è anche il modo sempre diretto, ma non arrogante, di dire ciò che pensa, che si tratti di Agnelli, di Pittaluga o del fidanzato abbandonato. Destino vorrà che parecchi anni dopo Esterina entri direttamente in contatto con la grande industria torinese. Tutt’altro che romantica, finisce con lo sposare un uomo che lavora nello stesso settore e che ugualmente, con la mentalità di quegli anni, ancora una volta le chiede di restare a casa. Ma Esterina non gli dà ascolto e continua per la sua strada, con una volontà ferrea che non si lascia smontare. Solo molto più tardi, nel 1941, gravemente malato di cuore, il marito le riconoscerà il merito di aver continuato nel suo lavoro. Solo poco prima di morire, infatti, egli comprenderà quanto sia importante che anche senza di lui la moglie possa almeno vivere senza affanni economici. La maggior parte dell’attività di Esterina si svolge in ogni caso nell’ambito della fert (Fiori Enrico Roma Torino), società nata nel 1919 e passata nel 1925 sotto il controllo di Pittaluga. Oltre a comprendere tre grandi studi per le riprese, la fert possiede le 231
Esterina Zuccarone
attrezzature più moderne nel campo del montaggio, nonché, dopo il 1930, della sonorizzazione e del doppiaggio. La carriera di Esterina si svolge quindi tra La Positiva e la fert, in quanto, come accadeva agli attori delle case di produzione americane, viene ‘ceduta’ da una società all’altra a seconda delle necessità di lavoro. Alla fert conosce Harry, progettista e fabbricante delle famose cineprese che ancora portano il suo nome e in seguito, con l’avvento del sonoro, si specializza nella sincronizzazione del suono. La moviola diventa più grande e tecnicamente più complessa, a sei piatti, ma la pellicola è ancora infiammabile. Così avviene che un giorno Esterina sia costretta a buttarsi di sotto da una finestra della fert a causa di un incendio. Scoppia la guerra e cominciano i bombardamenti. Molte persone non vogliono andare nei rifugi e cercano protezione nelle cantine dei palazzi. Esterina, che continua a lavorare, porta da mangiare a tutti facendo ogni giorno il tragitto da una cantina all’altra del suo quartiere. In questo periodo dà anche lezioni di montaggio a un giovane e gentile avvocato 232
appassionato di cinema che si chiama Franco Cristaldi, il quale produce il suo primo film proprio a Torino, nel 1954: La pattuglia sperduta, con la regia di Piero Nelli. Il film, oggi dimenticato, ha un certo successo e dà il via alla carriera di uno dei più sensibili produttori italiani che, tra l’altro, stupì tutti quando decise di rimontare personalmente il film di Giuseppe Tornatore Nuovo Cinema Paradiso, che vinse l’Oscar dopo questa operazione. Merito remoto di Esterina? Fatto sta che un telegramma inviatole da Cristaldi, nel quale egli, dovendosi assentare, le raccomandava di seguire personalmente la lavorazione di un suo film, fu da lei gelosamente conservato fino alla morte. Alla fine della guerra, il nuovo proprietario della fert, Catalucci, smantella gli studi e trasferisce a Roma la sua attività. Esterina costituisce allora con gli altri operai una cooperativa e continua a tenere in piedi l’azienda. Un giorno Catalucci torna nella vecchia sede della fert per salutare i suoi ex dipendenti, ma Esterina non gli perdona di aver abbandonato la sua attività torinese e con la sua schiettezza e il suo
16 / Cucire nastri di celluloide /Ester de Miro d’Ayeta
campanilismo lo mette alla porta. La cooperativa in effetti sopravvive a stento e nel 1951 è costretta a chiudere. Esterina, rimasta senza lavoro, va a fare l’operaia alla fiat. Sono i primi anni Cinquanta, il paese tenta la ripresa dopo gli stenti e la miseria provocati dalla guerra. Si punta allo sviluppo industriale e la fiat decide di creare un Dipartimento Cinema che avrà il compito di produrre documentari e pubblicità per promuovere l’azienda. La fama di Esterina è arrivata anche alla fiat ed è dunque a lei che viene assegnato l’incarico di progettare e realizzare il nuovo settore. Per gli sketch pubblicitari vengono scritturati grandi nomi, tra cui il vecchio Blasetti, che firma e incassa la parcella, ma lascia fare tutto il lavoro a Esterina, di cui ‘si fida ciecamente’. Esterina quindi dirige, monta, sceglie gli attori per i commenti, va anche all’estero per seguire il doppiaggio in altre lingue, si trasferisce da Mirafiori a Viale Marconi, ma la sua qualifica alla fiat rimane quella di ‘operaia metalmeccanica’. Cionondimeno è soddisfatta, qualifica e carriera non la interessano: ciò che le importa è imparare a conoscere le nuove macchine, i nuovi accorgimenti tecnici, perché il cinema per lei è una bella macchina che deve funzionare e ogni ruolo è importante per il suo funzionamento. Se guarda indietro alla sua vita passata, non ha rimpianti, perché, come dice nell’intervista con Milli Toja, è certa di aver ricominciato ogni volta “prendendo più di ciò che si è lasciata alle spalle”. La sua fama, nell’ambiente tecnico del cinema, continua a crescere e arriva oltreoceano, tanto che quando Walt Disney si reca a Torino per visitare la fiat, la vuol conoscere, le fa i complimenti per il suo lavoro e al ritorno le invia un regalo da Disneyland. Una volta in pensione, non smette di darsi da fare: si prende cura di persone anziane che a volte sono più giovani di lei e organizza in casa letture dei Vangeli e rinfreschi per stare con i suoi amici. Le sue mani non si fermano mai, cerca sempre di essere utile, la sua memoria non cede. Presa dalla sua passione per il lavoro manuale in un ambito particolare come il cinema, è probabile che Esterina non si sia mai chiesta se la sua maestria fosse arte, ma senza il suo lavoro oscuro nella sala di montaggio, l’arte del cinema comunque non avrebbe potuto vedere la luce.
Note
Queste e altre informazioni biografiche sono fornite dalla stessa Esterina Zuccarone in un’interessantissima intervista realizzata da Milli Toja, contenuta nel suo documentario La storia di Esterina (1995).
1
Sui rapporti tra cinema e industria tessile è da segnalare un’originale ricerca inedita di Alberto Farassino del 2002 che esamina dagli anni Dieci ai Trenta i complicati intrecci tra la Cines di Fassini e la Snia-Viscosa, la Rumianca e la Lux di Gualino, in quanto i materiali sintetici per i tessuti utilizzavano la stessa fibra usata per la pellicola cinematografica.
2
233
17 / Donata Pesenti Campagnoni
Maria Adriana Prolo
Premessa Parlare di Maria Adriana Prolo significa occuparsi del caso del tutto particolare di una donna che, in un’epoca in cui pochi ‘pionieri’ (e pochissime ‘pioniere’) guardavano al cinema come a un’arte da tramandare ai posteri, scopre improvvisamente questa problematica e se ne innamora a tal punto da farla diventare la passione totalizzante della sua vita e il suo unico obiettivo: dare vita e forma compiuta al Museo del Cinema di Torino, la sua ‘creatura’ amatissima, l’oggetto (dichiarato) di tutti i suoi istinti materni. Scrivere sul mio piccolo Museo che presto compirà tredici anni è per me come scrivere su un bambino di cui mi fossi occupata e che fosse cresciuto a costo di sacrifici e sofferenze, ma dandomi anche tanta gioia. La sola differenza tra un bambino e lui: non ha bisogno di cromosomi stranieri!
afferma nel 1954, in occasione della mostra parigina dedicata al museo torinese dall’amico Henri Langlois, che con lei condivide ansie e aspettative, sovente frustrate, e che nutre un analogo sentimento verso l’istituzione che ha creato, la Cinémathèque Française, il suo “bambino da tenere in braccio”1.
A differenza di Langlois, tuttavia, Maria Adriana Prolo non conosce in vita (e neppure dopo la morte) quella celebrità e quella legittimazione pubblica che segna, nel bene e nel male, il fondatore dell’istituzione parigina, uomo di carisma e di successo che arriva dall’esperienza dei cineclub e della cultura cinefila diffusa nel milieu culturale parigino e propagatasi attraverso l’Europa nel corso degli anni Trenta, figura di riferimento che – operando nella capitale francese – potrà entrare in stretto contatto con tutti i grandi protagonisti della settima arte. Diversamente da lui, Maria Adriana Prolo è una persona caratterizzata da una normalità quasi sconcertante, del tutto estranea alla ‘comunità’ dei cinéphiles, e pressoché sconosciuta. È una donna che viene da un piccolo paese del Piemonte e che si impone – o, meglio, che impone il suo progetto – grazie alla sola forza del carattere di cui è dotata, vincendo il sottile e radicato snobismo del contesto in cui opera: il mondo ristretto delle cineteche italiane, interamente declinato al maschile2. E, tuttavia, quella fra Henri Langlois e Maria Adriana Prolo non è semplicemente, come si sarebbe tentati di dire, un’ovvia diversità ‘di genere’. Se si guarda alle rare protagoniste presenti sulla scena delle prime cineteche, la fondatrice del museo torinese si 235
Maria Adriana Prolo
distingue infatti per i tratti peculiari che la rendono inconfondibilmente diversa da ogni altra figura. Basti pensare all’inglese Iris Barry, che cresce a sua volta nell’esperienza dei cineclub, diventando la raffinata cinefila cui sarà affidato il compito di costituire la collezione di film del nuovo dipartimento di cinema del Museum of Modern Art di New York (aperto nel 1935), una donna più vicina – per formazione, cultura e mentalità – a Langlois che non a Prolo, forse ancor più dinamica di lui nell’entrare in contatto con le star e l’industria cinematografica, dapprima hollywoodiane (con il risultato di assicurare al MoMA le donazioni e i depositi della Warner Brothers, Twentieth Century Fox, Samuel Goldwyn, Walt Disney, David W. Griffith, Harold Lloyd, Mary Pickford, David Selzinick, etc.) e poi europee3. Affinità anche minori vi sono con le esperienze delle tre 236
‘fedelissime’ di Langlois: Lotte Eisner, Marie Epstein e Mary Meerson, da cui la separano sia il rapporto di totale devozione che queste donne stabilirono con il creatore della Cinémathèque (Maria Adriana Prolo era invece una protagonista per eccellenza, del tutto refrattaria a posizioni di subalternità o dipendenza), sia un percorso personale che nel loro caso è ancora una volta legato – pur se in modi diversi – al cinema; un percorso che, a un certo punto della loro vita, le portò a incrociare il fondatore della Cinémathèque Française e, di lì in avanti, a camminare devotamente al suo fianco4. Quanto poi a Olwen Vaughan, segretaria generale della National Film Library di Londra, fondata in seno al British Film Institute nel 1935, le notizie sono scarse se non addirittura inesistenti. Del resto, ben poco si sa, in generale, delle tante donne che fecero
17 / Maria Adriana Prolo / Donata Pesenti Campagnoni
la storia delle cineteche e di tutto quel movimento che permise di trasformare in realtà l’aspirazione a salvaguardare l’arte cinematografica (tema su cui, peraltro, varrebbe la pena fare una seria indagine). Per questo la figura di Maria Adriana Prolo è tanto più meritevole di attenzione. Questo contributo tenterà di tratteggiare la sua vicenda biografica soffermandosi in particolare su quelli che, nell’opinione di chi scrive, sono i momenti e le caratteristiche salienti della sua vita e della sua personalità.
Vita e storia di Maria Adriana Prolo Nata il 20 maggio 1908 a Romagnano Sesia – un piccolo paese situato tra Milano e Torino – Maria Adriana Prolo è l’ultima di tre sorelle, figlie di una famiglia benestante molto nota nella zona. Cresce all’insegna di una vita agiata, educata secondo schemi inconsueti per l’epoca: studia le lingue, pratica sport e svolge un’intensa attività culturale. A spingerla in questa direzione è la madre, donna di raffinata formazione intellettuale che segna profondamente la personalità delle figlie. L’impronta materna porterà, infatti, una sorella a frequentare l’Accademia di Belle Arti e a diventare pittrice, un’altra a studiare il pianoforte e Maria Adriana a suonare il violino e scrivere poesie. Il padre, una figura autoritaria, si preoccupa invece di consolidare le aspirazioni professionali delle tre ragazze. Trova terreno fertile soprattutto nella figlia minore, Maria Adriana, che rivela fin da piccola un carattere caparbio e tenace, capace di affermarsi in qualsiasi situazione. Accanto a un temperamento forte e volitivo va delineandosi tuttavia una personalità creativa e fantasiosa. Maria Adriana Prolo manifesta da subito anche un notevole estro inventivo: “Utilizzando delle scatole, esponevo un sassolino verde, dei fiori secchi, dei pezzi di bambole. Forse la mia passione per il museo è nata in quel momento”5. Giovane matura, il padre vede in lei la naturale erede cui affidare la gestione dei beni di famiglia, anche se Maria Adriana non seguirà le orme paterne e si avvierà su un percorso autonomo. L’esigenza di creare e di spaziare nel proprio mondo la porta a coltivare un ideale di assoluta indipendenza, a una
vita da vivere con la forza delle proprie convinzioni e il bisogno di raggiungere le proprie mete a qualsiasi costo, senza inutili compromessi. Tale è negli anni della giovinezza e tale sarà negli anni che la vedranno portare avanti la causa del Museo, ostinatamente, con il solo obiettivo di difendere la propria autonomia, incurante dei rischi nei quali potrebbe incorrere. Si pensi per esempio al rifiuto – a quanto sembra espresso senza mezzi termini e con modalità poco consone alle regole del ‘bel mondo’ torinese – da lei opposto all’ipotesi di trasferire il Museo, allora situato in Palazzo Chiablese, in una piccola parte del Museo dell’Automobile. In una lettera del 16 dicembre 1978 indirizzata a Mario Villa, presidente della Cineteca Italiana di Milano, la stessa Maria Adriana descrive così la situazione: L’anno scorso cominciò l’assurda tragi-commedia dell’iniziativa del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, ambedue facce da sedere, con una corte interessata alla cosa, tra cui il Presidente del Museo, creduto persona perbene, di portare il Museo in due magazzini del Museo dell’Automobile, per dargli vita senza sala di proiezione e in mezzo a nebbia, puttane e travestiti. Non so come sono riuscita a lottare contro i capoccioni tra cui il Gianni Agnelli e a riuscire a mandare all’aria il progetto. Soltanto dopo mi è venuto il grande spavento di aver lottato (aiutata dai colleghi giornalisti e da tante persone di buon senso) e di essere riuscita a stare qui6.
Prima di interessarsi al cinema e di lavorare al progetto del suo Museo, Maria Adriana Prolo si occupa di storia e letteratura, studiando in particolare tutto ciò che riguarda la sua terra, a conferma del legame profondo che la unisce al Piemonte e specialmente a Torino, città sempre amata, anche se spesso in modo conflittuale. Di fatto, è proprio questo legame così intimo con la sua terra che la spinge verso il cinema ed è perciò che guarderà sempre al suo primo amore – il cinema muto torinese – con un occhio di riguardo e di rimpianto. Giovanissima, si laurea in materie letterarie e incomincia immediatamente a lavorare con il generale Brancaccio presso la Biblioteca Reale di Torino, impegnandosi nella pubblicazione di un ricco volume sulla storia della dinastia sabauda con più di quat237
trocento illustrazioni da lei selezionate7. Durante il tirocinio nella più prestigiosa e antica biblioteca di Torino, frequenta anche un corso di Biblioteconomia e, a quanto sembra, uno di Archivistica e Paleografia 8. Arriva così a completare una formazione che, nei suoi successivi studi, la porterà a cercare sempre nuove fonti documentarie, spesso attinte da ambiti molto diversi tra loro (e all’epoca non sempre legittimati dalle discipline storiche, come nel caso dei documenti fotografici), prese in esame attraverso una metodologia di analisi trasversale e comparativa che le consente di evidenziare correlazioni e discordanze tra i diversi materiali consultati. È ai suoi studi che deve del resto l’attitudine che la contraddistingue nella compilazione di indici e repertori (frutto anche del lavoro di collazione tra i vari documenti) tesi a contestualizzare l’analisi storica. Questa stessa formazione sarà anche alla base delle scelte che farà come futura collezionista e creatrice di musei. Si spiega così, almeno in parte, la presenza nel patrimonio del Museo del cinema di raccolte di fonti documentarie di indubbio pregio e consistenza: un archivio cartaceo unico nel suo genere, una biblioteca e una fototeca non meno importanti, e collezioni ricchissime di manifesti, stampe e altri reperti che potremmo genericamente etichettare come ‘iconografici’. Dopo la collaborazione svolta presso la Biblioteca Reale, Maria Adriana Prolo decide di occuparsi di temi legati alla storia del Risorgimento e pubblica numerosi contributi su testate specialistiche, approfondendo a Londra le sue ricerche. Parallelamente, porta avanti una serie di studi letterari, privilegiando alcune figure di donne (forse per l’importanza del ruolo avuto dalla madre e per la presenza di un ambiente familiare molto connotato al femminile). Cura così la raccolta di poesie edite ed inedite di Agata Sofia Sassernò, che la giovane ricercatrice si propone di celebrare per la “traccia che lasciò nella letteratura femminile piemontese ed italiana” e per la “vita di rinunce di crudeli sacrifici di intera dedizione all’ideale della poesia”9. E correda la raccolta con l’ampio e interessante Saggio sulla cultura femminile subalpina dalle origini al 1860, che illustra la biografia della Sassernò, ricostruendo anche con grande precisione l’ambito culturale en238
17 / Maria Adriana Prolo / Donata Pesenti Campagnoni
Maria Adriana Prolo accanto a un pezzo della sua collezione di precinema (Museo Nazionale del Cinema) 239
tro cui altre poetesse “onorarono le terre subalpine con il loro ingegno e la loro grazia”10. Tra le righe sembra emergere anche un ideale di donna “forte intelligente studiosa”11 (per riprendere gli aggettivi con cui parla della poetessa e pedagoga Giulia Molino Colombini) che rispecchia a sua volta la ormai compiuta personalità di Maria Adriana Prolo. Il suo interesse per la poesia si sta peraltro delineando in tutta la sua portata: sono gli anni in cui scrive poesie (non smetterà mai completamente di farlo) con l’ambizione dichiarata di pubblicarle. È però una ricerca di materiali sulla letteratura piemontese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, svolta nel 1938 con Francesco Pastonchi, a indirizzarla verso la ‘settima arte’: Fu allora che incontrai il poeta Carlo Chiaves e Guido Volante, che avevano scritto entrambi delle sceneggiature e Ernesto Maria Pasquali che aveva lasciato il giornalismo per la regia. Non riuscendo a trovare materiale su di loro, sfogliai, volume dopo volume, le riviste di cinema muto che avevo trovato alla Biblioteca Nazionale12.
Nello stesso anno, intuendo la centralità del ruolo svolto da Torino nell’ambito della prima produzione cinematografica, pubblica sulla rivista “Bianco e Nero” l’articolo Torino cinematografica prima e durante la guerra (Appunti): ovvero, una sorta di mappa storica delle case di produzione torinesi e dei periodici di cinema dell’epoca, “appunti presi qua e là, data l’inesistenza di una storia della cinematografia italiana in cui cercare notizie sul passato cinematografico di Torino”13. Solo da questo momento in avanti si trovano segni inequivocabili del suo interesse verso l’universo cinematografico dal punto di vista storico e culturale. Due anni dopo l’articolo, Maria Adriana Prolo avvia uno studio sulla storia della cinematografia italiana in accordo con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con l’allora direttore Luigi Chiarini, che aiuta la giovane storica a entrare in contatto con alcuni studiosi e rappresentanti del mondo del cinema: allora conobbi e divenni amica di Giovanni Pastrone e di Arrigo Frusta, incontrai Charles Lépine, che dal suo piccolo letto in cui era inchiodato, mi raccontava 240
come una fiaba, i primi anni del cinema francese. Dopo ci furono registi, attori, attrici, sceneggiatori, cartellonisti, tutti con lo stesso rimpianto: l’età d’oro del cinema torinese era anche stata quella della loro vita. Quasi tutti avevano documenti, foto, apparecchi ed è per questo che quel famoso 8 giugno 1941 scrissi sulla mia agenda ‘pensato il Museo del Cinema’14.
Inizia così il lavoro per raccogliere i materiali da esporre e conservare in un “Museo del Cinema Italiano” e, parallelamente, per raccogliere le testimonianze orali dei protagonisti della stagione del muto con cui entra in contatto. Nello stesso tempo svolge un’intensa ricerca di dati e materiali bibliografici presso le più importanti biblioteche pubbliche e private, allo scopo di preparare un’antologia del cinema muto con “scritti di Ricciotto Canudo, D’Ambra, Papini, etc. etc.”15 e una storia del cinema muto italiano, che sarà poi pubblicata dalla casa editrice Poligono (mentre il primo progetto non andrà in porto). Della Storia del cinema muto italiano uscirà peraltro solo il primo dei due volumi previsti dalla casa editrice, con anni di ritardo rispetto agli accordi presi e con non pochi patemi d’animo per l’autrice, desiderosa di vedere il risultato delle sue incessanti ricerche e soprattutto convinta che l’uscita del libro avrebbe agevolato la parallela avventura del suo Museo: fa che esca presto il mio libro! Con quello il problema Museo sarebbe risolto, ed io riuscirei a raccogliere in Italia tutto quanto c’è ancora da raccogliere! Lo so, è un pallino, il mio, ma sono così stupidamente certa che il cinema e la sua storia meritino i miei molteplici sacrifici!16
Il primo volume esce dunque nell’autunno del 1951 e si distingue per la ricchezza dell’apparato iconografico (centosedici foto che illustrano la produzione del periodo, selezionate tra le moltissime raccolte dall’autrice) e per l’“Elenco delle pellicole mute realizzate in Italia dal 1904 al 1915” (ordinato per anno e per Casa di produzione) redatto grazie a quelle “migliaia di schedine” faticosamente compilate negli anni con i dati ottenuti dallo “spoglio dei periodici cinematografici, dalle memorie pubblicate e dalle testimonianze orali e scritte dei cinematografari del
17 / Maria Adriana Prolo / Donata Pesenti Campagnoni
muto ancora viventi nel 1941”17. È un “corpus filmorum italicorum” senza pretese di completezza18, “disperante come un elenco di preziosi incunaboli o rari disegni distrutti o smarriti” che prova quanto “la produzione italiana per un lungo periodo fu qualitativamente importante”19. L’opera segna una soglia fondamentale per quanto riguarda gli studi sulla cinematografia italiana del periodo muto, fino ad allora scarsi e poco attendibili, ma è accolta con evidente disinteresse da buona parte della critica cinematografica italiana del periodo. L’importanza del lavoro svolto da Maria Adriana Prolo sarà riconosciuta solo a distanza di molti anni, quando il cinema muto nostrano si affermerà finalmente come un tema centrale di ricerca e di studi. E anche se la sua specifica formazione l’aveva spinta a privilegiare le fonti extra-filmiche, che oggigiorno appaiono insufficienti per una ricerca come quella da lei intrapresa, è giudizio oramai corrente che il suo libro emerga rispetto alla produzione dell’epoca “per la ricchezza delle informazioni, la visione di insieme, i criteri rigorosi di ricerca e l’esame delle fonti” e continui a rappresentare “una base indispensabile per tutta una serie di studi sul cinema muto italiano, sia per la mole dei documenti che per la cura con cui è stato redatto”20. Nella sua assoluta passione per la Torino cinematografica, Maria Adriana Prolo si dimostra dunque un’antesignana, lucidamente consapevole dell’importanza del suo oggetto di studio (pur trattandosi di una scelta istintiva, diretta conseguenza dell’amore per la sua terra). E, forse proprio per questa sua capacità di lungimiranza fuori del comune, è un’antesignana anche in altri ambiti di ricerca, anche quando il risultato dei suoi studi non è finalizzato a pubblicazioni, bensì alla raccolta di testimonianze da esibire nelle sale del suo museo (o nelle numerose mostre temporanee che organizza in prima persona o alle quali partecipa). Della settima arte intuisce la fisionomia complessa, che nel film ha il punto di arrivo; per questa ragione adotta quella stessa metodologia di analisi trasversale e comparativa già testimoniata dai lavori svolti in gioventù ed è spinta verso un’attitudine collezionistica a tutto campo, che la porta a raccogliere materiali di ogni tipo, in grado di docu-
mentare il cinema nei suoi diversi aspetti – materiali relativi alla pre e alla post-produzione, alla produzione, alla distribuzione, e via dicendo. Analogamente, della storia del cinema interroga i labili confini cronologici, che vanno ben oltre la data di una prima fatidica proiezione e si dilatano in un terreno plurisecolare dove si avvicendano le esperienze della visione più eterogenee, dove la scienza e la tecnica si intrecciano a un susseguirsi di pratiche spettacolari, lasciando una stratificazione di tracce che forma l’humus sul quale si sviluppa il cinema. All’archeologia del cinema, l’altra passione che affianca quella per il cinema muto, Maria Adriana Prolo dedica una parte centrale della sua attività di archeologa-collezionista e, pur senza scrivere molto sull’argomento, trova, salva e tramanda reperti in apparenza privi di significato, che tuttavia, se interrogati e radiografati, si rivelano fonti ineguagliabili di documentazione e conoscenza, come scopriranno in seguito gli storici che accosteranno l’universo complesso di ciò che precede e sta alla base della settima arte. E così come la sua Storia del cinema muto italiano resta una pietra miliare nell’ambito della storiografia di settore, allo stesso modo la raccolta documentale da lei assemblata è di tale importanza, da diventare un punto di riferimento centrale per tutti i ricercatori e gli studiosi che si occupano di indagare l’universo della visione prima della nascita del cinema. Una parte significativa della sua attività di studiosa e collezionista è inoltre dedicata alla fotografia, che riveste un’importanza centrale sia come fonte per la storia del cinema, sia come trait-d’union tra l’archeologia del cinema e la settima arte. Come sempre, Maria Adriana Prolo indaga in particolare gli aspetti legati a Torino che “oltre ad essere stata il primo centro cinematografico, fu anche il primo centro italiano della fotografia artistica”21. Anche in questo caso non finalizza le sue ricerche settoriali a una pubblicazione specifica (pur sottolineando spesso la necessità di realizzare una “Storia della fotografia in Italia”) ma porta avanti un’opera incessante di divulgazione attraverso la raccolta di apparecchi, testimonianze e riviste d’epoca (di cui pubblica regolarmente alcuni documenti inediti o rari sul “Notiziario” del Museo22). Raccoglie specialmente 241
fotografie sul cinema – in particolare quello muto torinese – e sulla storia della fotografia di ambito prevalentemente locale cui dedica un approfondito lavoro di ricerca (il primo nel settore) finalizzato, ancora una volta, alla ricostruzione di una mappa della produzione in Piemonte23. Realizza infine una serie di mostre su temi spesso nuovi o poco trattati, che contribuiranno allo sviluppo della storiografia di settore: come nel caso della mostra sulla Stereoscopia, allestita nel 1966, che segna in Italia l’avvio di un rinnovato interesse per il tema della terza dimensione. La sua tenacia e l’implacabile determinazione con cui persegue i propri obiettivi la portano a creare due musei: il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Museo Storico-Etnografico di Romagnano Sesia. Che cosa la spinge verso l’idea di museo? Il bisogno incessante di conoscere e ricostruire la memoria della propria terra? Il piacere di farlo mettendo in scena il risultato dei suoi percorsi intellettuali e del nuovo sguardo verso il passato? Oppure una semplice bramosia collezionistica, alimentata da un carattere passionale? Probabilmente tutte e tre le istanze, anche se è quella conoscitiva che pare riaccendere desideri sopiti dell’infanzia e funzionare da motore propulsivo rispetto alle altre due. Non a caso, l’idea di dar vita a un museo dedicato al cinema nasce dall’interesse che suscita in lei il passato mondo della Torino cinematografica, con il quale è entrata in contatto scrivendo nel 1938 l’articolo per la rivista “Bianco e Nero”: le due iniziative finiscono ben presto per sovrapporsi e intrecciarsi, tanto che i primi fondi raccolti nel 1941 sono in molti casi destinati a entrambi gli scopi. Da questo momento in poi (fino a quando la guerra e l’immediata fase postbellica interromperanno bruscamente l’avventura) viene allo scoperto anche la sua natura di collezionista che la porta verso una “ricerca appassionata e puntigliosa [...] sempre legata all’ansia, alla preoccupazione di un parto difficile, alla nascita del Museo – del suo Museo – nella sua fredda Torino”24. Una Torino che, peraltro risponde subito positivamente alla travagliata ‘maternità’, destinando al progetto di costituzione del museo, per certi aspetti velleitario e senza prospettive certe, un finanziamento e alcuni locali della 242
Mole Antonelliana, destinati a conservare i materiali che Maria Adriana Prolo raccoglie con la rapidità del fulmine25. A fronte di un contesto locale favorevole, si presenta però un contesto nazionale disinteressato alla realizzazione del progetto (tanto più per la sua collocazione nel capoluogo piemontese). È la stessa Maria Adriana Prolo a mettere polemicamente il dito nella piaga in una lunga nota della sua Storia del cinema muto italiano: Ancor oggi, anno domini 1950, non hanno avuto in Italia una degna sistemazione né le cineteche né le raccolte di cimeli storici della cinematografia; eppure è da più di quarant’anni che si pubblicano progetti di musei nazionali, di archivi cinematografici et similia. […] Mentre in Italia preziosi materiali andavano in tanti anni distrutti e dispersi, a New York sorgeva il ricchissimo Museum of Modern Art Film Library e a Parigi la Cinémathèque française raccoglieva i cimeli delle cinematografia francese istituendo recentemente il ‘Musée du Cinéma’. L’iniziativa torinese di un ‘Museo del Cinema’ sorta nel giugno 1941 ed appoggiata dal Municipio di Torino con l’assegnazione di locali nella Mole Antonelliana, servì a salvare macchine e documenti che la guerra avrebbe dispersi, come infatti avvenne per il ‘Museo del Cinema Ricciotto Canudo’ istituito a Roma nel 1942, in seguito alla donazione di preziosi cimeli storici cinematografici da parte di Dante Vannucchi. Si spera ch’essi si possano ritrovare e così istituire finalmente un ‘Museo cinematografico nazionale’ che raccolga e conservi quel materiale prezioso – ve n’è ancora molto in Italia – che si riferisce alla storia gloriosa della nostra cinematografia26.
Nella nota però, la promotrice di questo ambizioso progetto non precisa che, nelle sue aspirazioni, siffatta istituzione dovrà aver sede a Torino: un obiettivo perseguito caparbiamente, che nel 1951 porta Maria Adriana Prolo a proporre al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma di intitolare le sue collezioni alla cineteca dell’Ente, nella speranza di ottenere un riconoscimento istituzionale e di favorire la ricerca di una sede nel capoluogo piemontese. Come risposta, l’Ente romano opporrà negli anni soluzioni mirate a portare il museo torinese nella capitale. Ma inutilmente. A vincere è il coraggio e il
17 / Maria Adriana Prolo / Donata Pesenti Campagnoni
radicato senso di autonomia di Maria Adriana Prolo che, alla fine, impone la sua ferma determinazione ad aprire il Museo a Torino. Nel 1955 riesce infatti a ottenere una sede – Palazzo Chiablese – dove, a chiusura di una gestazione lunga e travagliata, tre anni dopo allestirà e aprirà al pubblico il Museo del Cinema 27: “Sono 14 anni che lavoro sempre a questo scopo, sacrificando tante cose che a una donna farebbero molto piacere, e spero che il periodo più brutto sia ora finito”28. Il presupposto su cui si basa il percorso compiuto da Maria Adriana Prolo per dar vita al Museo sembra sintetizzato in una frase che apre un quadernetto di appunti e studi relativi all’allestimento: “La serietà e il prestigio di un museo dipendono dal rigore della scelta delle opere esposte”29. Altri numerosi foglietti di note e schizzi abbozzati di getto, come pensieri estemporanei fissati sulla carta, fanno da contrappeso a questa osservazione che rievoca la formazione e la metodologia di ricerca acquisita in gioventù, testimoniando in parallelo il modo di operare di Maria Adriana Prolo. Accanto al rigore e alla sistematicità di chi si è formata nelle biblioteche e negli archivi, adotta una modalità più istintiva, in apparenza poco metodica e più simile a un processo creativo elaborato tra l’agire sul campo e lo scrivere per frasi spezzate, quali: “il lato spettacolare deve essere potenziato”, “una cosa messa bene è più espressiva di trenta messe male”, “accanto a una macchina fotografica mettere una foto fatta con quella macchina, gusto fotografico del momento, utilizzando il procedimento di allora”. In realtà la fisionomia del Museo del Cinema allestito da Maria Adriana a Palazzo Chiablese non mostra segni di frattura e appare anzi lineare. Il percorso del visitatore si sviluppa in sedici spazi espositivi, tra cui una galleria per le mostre temporanee e la sala da proiezione, e rispecchia nelle sue articolazioni principali le caratteristiche della collezione formata nel corso degli anni: ampio spazio è pertanto dedicato all’archeologia del cinema, alla fotografia, alla storia del cinema muto italiano, in particolare torinese, e alla storia della tecnica cinematografica. E tuttavia, quelle note scarabocchiate sui foglietti riecheggiano di sala in sala: la spettacolarità dei materiali scelti
e dei criteri espositivi adottati per raccontare – e far sperimentare in prima persona agli spettatori – le esperienze della visione prima della nascita del cinema, un evidente interesse verso gli aspetti tecnologici, seppur illustrati nel loro rapporto con le immagini prodotte e, ovunque, l’orgoglio della collezionista per i materiali raccolti, per la loro magnificenza e sorprendente varietà, ma anche per la loro sbalorditiva quantità. L’interesse per la fotografia, abbinato al piacere del creare musei, la fa anche sognare un “Museo ideale della fotografia” dove riunire tutte le informazioni sulle raccolte di materiale fotografico, da un lato, e sui musei che le conservano, dall’altro. È il 1968 e nel settore foto-cinematografico la moda di un museo virtuale è ancora di là da venire ma, con il dinamismo mentale che la caratterizza, Maria Adriana Prolo vagheggia già questa ipotesi, perché “così si potrebbe avere un’idea degli oggetti che esistono ancora oggi!”30. Il sogno del “Museo ideale della fotografia” non sarà realizzato, mentre andrà a buon fine un altro progetto di museo, ancora una volta frutto dell’amore di Maria Adriana Prolo per la sua terra. Nel caso del cinema non volevo lasciar perdere un pezzo di storia del cinema di Torino. Così come ho fatto a Romagnano quando nel 1973, con alcuni collaboratori, ho avuto l’idea del Museo Storico Etnografico: non volevo che andasse dispersa… anzi volevo che si conservassero le testimonianze degli usi e costumi, della storia, della cultura della mia Romagnano31.
Il Museo Storico-Etnografico di Romagnano Sesia, l’altra istituzione creata da Maria Adriana con l’amica Fernanda Renolfi, viene fondato nel 1973 (e aperto due anni dopo), con la finalità di raccogliere e conservare le testimonianze più diverse della vita locale, dall’Ottocento fino alla Grande Guerra. La fisionomia che Maria Adriana Prolo dà alla sua ultima creatura richiama la fisionomia del Museo e della collezione cui ha dedicato gli anni passati. D’intesa con amici e collaboratori, raccoglie qualsiasi testimonianza “della civiltà e della cultura rurale, e successivamente industriale, in tutte le sue espressioni 243
e forme: artistiche, artigianali, industriali, agricole, commerciali, folkloristiche, ecc.”32. Vale a dire, tutto ciò che possa diventare, nella sua ottica, evidenza storica, doveroso riconoscimento del passato. E questa eterogeneità di materiali si riflette nelle scelte museografiche che, come nel caso di Torino, mirano all’estrema varietà delle testimonianze esposte e palesano il piacere della collezionista nel mostrare la sua raccolta, la preziosità e rarità dei materiali, oltre che la consueta eccezionale “accumulazione” di pezzi esibiti. Anche a Romagnano, le raccolte sono organizzate per settori, tra cui trova spazio privilegiato il tema della donna e del lavoro femminile (eco degli interessi e degli studi giovanili rivolti ‘al femminile’). Alle raccolte di oggetti e attrezzi della cultura contadina si affianca una pregevole raccolta fotografica, a conferma di un’attenzione alla fotografia mai venuta meno, e una di testimonianze orali registrate tra la gente del luogo, frutto di una ricerca che non pare tanto l’emulazione di una prassi diffusa in quel periodo, quanto piuttosto il perdurare di un’attenzione ai vissuti, alla gente: è questo stesso interesse che l’aveva portata, molti anni prima, a cercare i vecchi protagonisti del cinema muto, dai quali aveva ricevuto informazioni e documenti sulla storia di quel glorioso passato e ai quali aveva espresso la sua riconoscenza per il contributo che avevano dato alla costituzione dell’apic – Associazione Pionieri Italiani del Cinema33. Maria Adriana Prolo muore a Romagnano Sesia, il suo amato paese natale, il 20 febbraio 1991, dopo aver ‘sistemato’ le sue creature. Per quanto riguarda il Museo Nazionale del Cinema di Torino, una serie di importanti modifiche statutarie apportate nel 1983 e nel 1986 avevano di fatto dato ai tre enti pubblici locali il controllo della sua governance, con l’ovvia conseguenza di garantire in tal modo anche la copertura di una buona parte dei costi per la sua gestione e le sue attività34. I destini del Museo Storico-Etnografico di Romagnano Sesia erano invece affidati al gruppo degli appassionati soci co-fondatori, che ne avevano preso in mano la conduzione con l’intento di allestirlo in una nuova, più adeguata sede.
244
Per un assurdo gioco del destino o, forse, per il semplice fatto di non doversi più occupare di queste sue creature e di non dover più combattere per la loro sopravvivenza, nel giro di poco tempo Maria Adriana Prolo si ritira dalle scene e, vittima di una salute sempre più malferma, trascorre l’ultimo periodo della sua vita in un pensionato, lontano da quel ‘glorioso museo del cinema’ cui aveva dato vita e forma con tanta fatica.
17 / Maria Adriana Prolo / Donata Pesenti Campagnoni
Note
“Abbiamo i nostri bambini che sono i più tirannici del mondo perché non hanno mai vent’anni e bisogna sempre tenerli in braccio”, scrive Henri Langlois in una lettera a Maria Adriana Prolo del 23 luglio 1965 (coll. A50/1). La metafora del ‘bambino’ ricorre spesso nella corrispondenza tra la Prolo e Langlois, legati, come noto, da una forte amicizia.
1
2 Vedi Donata Pesenti Campagnoni, Di una “piccola provinciale” e del suo museo per il “glorioso cinema muto” torinese, in Carla Ceresa, Donata Pesenti Campagnoni (a cura di), Tracce. Documenti del cinema muto torinese nelle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, Il Castoro, Milano 2007, pp. 114-125.
Su Iris Barry si veda Peter Decherney, Hollywood and the Culture Elite. How the Movies Became American, Columbia University Press, New York 2005, pp. 97-121; Haidee Wasson, Museum Movies. The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema, University of California Presse, Barkeley, Los Angeles-London 2005. 3
4 Su Henri Langlois, Lotte Eisner, Marie Epstein, Mary Meerson, si veda Laurent Mannoni, Histoire de la Cinémathèque française, Gallimard, Paris 2006.
Citazione inedita tratta da un’intervista a Maria Adriana Prolo registrata in occasione della mostra Il mondo nuovo. Le meraviglie della visione dal ’700 alla nascita del cinema, allestita a Bassano del Grappa nel 1988.
5
Coll. A562/1. Sempre a proposito della stessa vicenda, scrive in un’altra lettera dell’11 aprile 1979 a Paola e Primo Zeglio, coll. A562/1: “Lo sciagurato progetto di farci traslocare al Museo dell’automobile (iniziativa del “Giovanni di Mirafiori” – detto in dialetto è assai meglio – [N. d. R.: Giovanni Agnelli]) che trovò la stupidissima alleanza del sindaco dell’assessore alla cultura e del presidente del Museo di allora, allo scopo di rivitalizzare quel Museo, poco frequentato. Ma la sottoscritta riuscì a resistere ed a resistere a Palazzo Chiablese”.
6
Nicola Brancaccio, Maria Adriana Prolo, Dal nido savoiardo al trono d’Italia. Vita, ritratti e politica dei Savoia dall’anno 1000 al 1870, Zucchi editore, Milano 1930.
7
8 Il dato è stato riportato in Liborio Termine, Maria Adriana Prolo, “Premio Circolo della Stampa di Torino 1984-1985”, Palazzo Ceriana-Mayneri, Torino 1985, pp. 31-35. Tuttavia, non sono stati trovati documenti in proposito.
Maria Adriana Prolo, Poesie edite ed inedite della poetessa nizzarda Agata Sofia Sassernò, Treves, Milano 1937, p. I
9
10
Ibidem.
11
Maria Adriana Prolo, op. cit., p. LXXIX.
12 Maria Adriana Prolo, Naissance d’un Musée (Le Musée du Cinéma de Turin), “Cahiers du cinéma”, n. 33, marzo 1954, p. 19.
13 Maria Adriana Prolo, Torino cinematografica prima e durante la guerra (Appunti), “Bianco e Nero”, n. 10, ottobre 1938, p. 60. Nello stesso numero di “Bianco e Nero” Maria Adriana Prolo pubblica anche uno studio su Guido Gozzano e la cinematografia che si rifà ai suoi studi letterari. L’anno successivo pubblica un ricordo di Carlo Chiaves e di Ernesto Maria Pasquali in “Torino. Rassegna Mensile Municipale”, n. 6, giugno 1939. 14
Maria Adriana Prolo, Naissance d’un Musée, cit., p. 19
Lettera di Maria Adriana Prolo al dott. Leone del 3 maggio 1943, coll. A21/1 15
16 Lettera di Maria Adriana Prolo a Ugo Casiraghi del 7 maggio 1950, coll. A571/4.
Maria Adriana Prolo, Storia del cinema muto italiano, vol. I, Poligono, Milano 1951, p. 89. 17
18 “Nell’Elenco non si trovano i 1478 film vantati dalla ‘Ambrosio’, i 1525 attribuiti alla ‘Cines’ dal 1909 al 1919, i 103 di Emilio Ghione, i 790 dell’ ‘Itala Film’, perché per quanto mi fu possibile, controllai se veramente i film annunciati dalle case vennero poi realizzati. A tutti coloro che sono in grado di correggere e di aggiungere dati e notizie, rivolgo un cordiale invito affinché tanto la Storia, quanto l’Elenco possano in seguito raggiungere la massima precisione”. Ibidem.
Maria Adriana Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., p. 6.
19
20 Cesare Biarese, Bibliographie critique sur le cinéma muet italien, in Le cinéma muet italien, “Les Cahiers de la Cinémathèque”, nn. 26-27, 1979, p. 192. 21 Maria Adriana Prolo, La George Eastman House, “Cinema”, n. 36, 15 aprile 1950, p. 212. 22 Si vedano in proposito: Anton Giulio Bragaglia, L’Arte nella fotografia, “Museo Nazionale del Cinema. Notiziario”, n. 3-4, gennaio 1967, pp. 9-12; Pietro Masoero, Decalogo del dilettante fotografo, “Museo Nazionale del Cinema. Notiziario”, n. 13, gennaio-aprile 1970, pp. 5-8; G. Ottavio Baratti, Della necessità di una società fotografica in Italia, “Museo Nazionale del Cinema. Notiziario”, n. 19, gennaio-aprile 1972, p. 5; A. Montagna, Le associazioni, “Museo Nazionale del Cinema. Notiziario”, n. 19, gennaio-aprile 1972, pp. 8-10; A. Montagna, Ai cultori dell’arte fotografica in Italia, “Museo Nazionale del Cinema. Notiziario”, n. 19, gennaio-aprile 1972, pp. 1112; Venanzio Giuseppe Sella, Plico del fotografo…, “Museo Nazionale del Cinema. Notiziario”, n. 37, dicembre -gennaio 1980, pp. 11-32. 23 Si vedano in particolare: “Museo Nazionale del Cinema Notiziario”, n. 31-32-33, gennaio-dicembre 1976, pp. 11-26; Maria Adriana Prolo, Alcune notizie sulla dagherrotipia a Torino in AA.VV., Fotografi del Piemonte1852-1899. Duecento stampe originali di paesaggio e vedute urbane, catalogo della
245
mostra, Città di Torino-Assessorato alla Cultura, Torino 1977, pp. 13-16. 24 Tratto dalla testimonianza di Guido Aristarco trasmessa al Museo del Cinema per la realizzazione di un numero del “Notiziario” poi non pubblicato, coll. A157/8. 25 Per chi voglia ulteriori informazioni su quanto accennato qui e nelle pagine successive, si rimanda al mio contributo Alla luce delle fonti d’archivio: il volto storico del Museo Nazionale del Cinema di Torino in Carla Ceresa, Donata Pesenti Campagnoni, Nero su Bianco. I fondi archivistici del Museo Nazionale del Cinema, Lindau, Torino 1997, pp. 31-51.
Maria Adriana Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., nota 3, p. 90. Il Museo del Cinema Ricciotto Canudo era stato costituito grazie al particolare interessamento di Vittorio Mussolini.
26
L’altro grande obiettivo – quello di un riconoscimento nazionale – sarà raggiunto nel 1965. Cfr. Donata Pesenti Campagnoni, Alla luce delle fonti d’archivio: il volto storico del Museo Nazionale del Cinema di Torino, cit., pp. 33-35. 27
28 Lettera di Maria Adriana Prolo a Beaumont Newhall, allora conservatore della George Eastman House, del luglio 1955, coll. A30. 29
Si veda fascicolo coll. A15.
Lettera di Maria Adriana Prolo a Jean Fage, presidente e fondatore del Musée de la Photographie di Bièvres, dell’8 febbraio 1968, coll. A122. 30
31 Maria Adriana Prolo racconta in Carlo Brugo, Romagnano Sesia. Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia, “Bollettino Storico per la Provincia di Novara. Rivista della Società Storica Novarese”, n. 1, giugno 1983, p. 107. 32
Maria Adriana Prolo racconta, cit., p. 167.
L’associazione viene fondata a Roma nel 1956 con scopi culturali, organizzativi e assistenziali. Maria Adriana Prolo costituisce la sezione di Torino e si occupa dei pionieri torinesi all’epoca dimenticati. Scrive a D. Catani Romano nel 1965: “Sono assai contenta che, finalmente, dopo aver inviato i curriculum vitae al Sig. Manfrino che avrebbe dovuto già da anni occuparsi dei pionieri torinesi esclusi, per ragioni che non sappiamo, da assistenze che altri già godono, le nostre faccende vadano in porto. Dico ‘nostre’ perché il Museo del cinema è un po’ la casa di quei pionieri che con la loro attività hanno dato lustro al cinema torinese. Voglia per favore dar corso alle loro domande, perché il loro anno di nascita come Ella vedrà, merita un pronto riconoscimento, di cui hanno estrema necessità”, coll. A563/6. 33
Vedi F. Napoli, Dalla collezione Prolo al Museo del cinema di Torino attraverso gli atti giuridici, Dissertazione finale in Organizzazione ed Economia dello Spettacolo cinematografico e televisivo, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione. 34
246
PARTE SESTA
NON SOLO SPETTATRICI
18 / Gina Annunziata
Matilde Serao e il cinematografo
Toute vibrante d’action, de pensées, Mathilde Serao évoque la vie grouillante de Naples, dans le soleil de feu e d’or. Tracer d’elle un portrait n’est pas chose facile. Les aspects sont nombreux, variés comme son talent. [...] Redactrice en chef d’un grand quotidien, femme de coeur qui s’interesse à ses enfants, romancière émérite, elle a tour à tour la faconde âme du journaliste, la douceur attendrée de la mêre, la profondeur de l’ecrivain qui pense1.
Così appare Matilde Serao agli occhi di Germaine Dulac, in un ritratto di cui l’Archivio Documenti del Museo Nazionale del Cinema di Torino conserva svariate versioni manoscritte (almeno otto). La regista e giornalista francese scrive e riscrive quasi maniacalmente l’incipit del suo articolo, cercando la forma e il vocabolario più adatti a delineare la figura complessa di questa scrittrice definita “exuberante, pétulante, pleine d’ésprit”. E riflette: Il faudrait pour donner un croquis exacte de Mathilde Serao en réunir [de ses aspects variés] une série disparate, et les dérouler avec la rapidité de vues cinématographiques. Ce n’est pas dans une seule image que l’on peut fixer les different aspects de sa physionomie mobile.
Matilde Serao nasce il 7 marzo 1856 a Patrasso, in Grecia, dove il padre si è rifugiato nel 1848 per sfuggire alle repressioni borboniche. Il padre, Francesco, è un giornalista; la madre, Paolina Bonelly, una greca di sangue nobile. La Serao inizia giovanissima la carriera di giornalista, dapprima come redattrice del “Corriere del mattino” di Napoli e poi a Roma, come redattrice fissa del “Capitan Fracassa” e collaboratrice di altri noti periodici: la “Nuova Antologia”, il “Fanfulla della Domenica”, la “Domenica letteraria”. Nel 1881 pubblica il suo primo romanzo, Cuore infermo. La notorietà come scrittrice le giunge due anni dopo con Fantasia. Nel 1885 sposa Eduardo Scarfoglio e, tornata con lui a Napoli, si occupa per alcuni anni di una rubrica mondana sul “Corriere di Napoli”, da lei fondato e diretto insieme al marito. Nel 1892, sempre col marito, dà vita al “Mattino”. Nel 1904, dopo la separazione da Scarfoglio, da cui ha avuto quattro figli, fonda un giornale tutto suo, il “Giorno”, che dirige fino alla morte, avvenuta nel 1927. Dalle pagine del suo giornale interviene sul cinematografo già nel marzo 1906, in anticipo sul pur precoce articolo di Giovanni Papini2, con un breve scritto dal titolo Cinematografeide!. Nel suo testo la Serao descrive efficacemente l’epidemia del ci249
nematografo che si diffonde a macchia d’olio nella Napoli di inizio secolo, come un morbo che si propaga lentamente, comparendo dapprima in un caso isolato per poi colpire indiscriminatamente tutti, al punto che nessuno può più sottrarsi. Il cinematografo regna, e impera, e s’impone, e domina, e spadroneggia, e invade ogni cosa, la mondanità, la beneficenza, l’arte, il teatro. E la macchina terribile, non contenta di aspettarvi in agguato nella sala semibuia, viene fuori alla luce del sole e vi colpisce in pieno movimento e coglie a tradimento, quando meno l’aspettate. Siete in villa, aspettando qualcuno? Ed ecco il cinematografo che vi piglia in pieno colloquio e immortala nei suoi films il vostro innocente flirt. Dove salvarsi? Come salvarsi? Nessun rimedio, lettrice, lettore! Rassegnarsi, e aspettare l’ora della liberazione! Ed essa verrà quando i cinematografi saranno tanti che finiranno col divorarsi a vicenda, e noi andremo a fare, io lo giuro, una danza di gioia, innanzi all’ultimo obiettivo che esalerà l’ultima proiezione!3
La descrizione della città affetta dal morbo del cinematografo è suggestiva, ma ancor più interessante è la concezione del cinema come dispositivo, come meccanismo di ricezione e insieme di produzione, che l’autrice delinea descrivendo il percorso di un occhio meccanico che esce dalla sala cinematografica per lanciarsi a inseguire gli spettatori4. Nonostante questa descrizione apocalittica, pochi anni dopo Matilde Serao dedicherà parecchio tempo e spazio al cinema, seguendo tutte le prime napoletane dei film più importanti, regolarmente recensiti sul suo giornale. È noto l’entusiasmo della scrittrice per un film come L’Inferno, che ha proprio a Napoli la sua prima proiezione pubblica, al Teatro Mercadante, nel 1911. Così come è nota la sua battaglia (persa) contro la presentazione di Cabiria al Regio Teatro San Carlo, in aperta polemica con “Il Mattino” diretto da Scarfoglio e redatto dai suoi figli, conclusasi con un’appassionata recensione nella quale riesce a non indicare mai il nome di D’Annunzio (da lei detestato), che invece ricorre a ogni rigo nelle colonne dell’articolo scritto da suo figlio Antonio5. Come tanti altri letterati del periodo, anche la Serao si impegna in prima persona a dare il proprio contributo alla nuova arte, scrivendo per la Caesar Film il 250
soggetto di un film dal titolo La mia vita per la tua!, diretto e interpretato da Emilio Ghione nel 1914 (e oggi perduto). La scrittrice lo definisce “tentativo di romanzo cinematografico” e in effetti, stando alle critiche dell’epoca, si può dire che tale rimase. Nondimeno, il lancio pubblicitario sulle riviste crea un clima di grande attesa nel pubblico, puntando soprattutto sul nome della Serao. Per esempio, “La Vita cinematografica” pubblica un’intervista a Maria Carmi (protagonista nel ruolo di Elena de Soubise), nella quale l’attrice si dice molto presa dal soggetto del film, come poche volte le è capitato, e non manca di elogiare la Serao, definendola capace di scrivere un “soggetto davvero cinematografico”. L’intricata vicenda pare suggestionare gli interpreti, prima ancora che gli spettatori, e l’autore dell’articolo, riferendo la sua visita sul set durante le riprese del film, scrive di aver avuto il sentore che negli studi della Caesar Film si stesse preparando il più grande avvenimento dell’arte cinematografica italiana6. In occasione della prima visione romana, la stessa rivista pubblica una recensione che occupa tre pagine intere, con una dettagliata descrizione della trama. Ma il commento non è affatto positivo, la vicenda è ritenuta troppo complicata per essere seguita e compresa dal pubblico. I nomi della Serao, della Carmi, di Ghione e di Tullio Carminati sono considerati una garanzia di successo finanziario, ma non bastano per raggiungere quello artistico7. La stroncatura del film non impedisce però che si attinga all’opera letteraria della scrittrice per una serie di adattamenti8. Nelle sue memorie, l’avvocato Francesco Soro riferisce di un altro sfortunato tentativo di collaborazione dell’autrice con il mondo del cinema. La questione riguarda la commissione da parte della David Karenne Film di due soggetti originali, per il corrispettivo di sedicimila lire. Ma al momento della consegna del primo testo, intitolato Il doppio volto, il compenso non arriva e la Serao si vede costretta a minacciare un’azione legale. Purtroppo nemmeno l’intervento di Soro presso Diana Karenne sortisce i risultati sperati e alla fine la scrittrice si rassegna9. Il doppio volto sarà poi realizzato da Giulio Antamoro nel 1918, con l’attrice americana Helen Arnold nel ruolo principale, ma risulta prodotto dalla Polifilms di Napoli.
18 / Matilde Serao e il cinematografo / Gina Annunziata
Nonostante la vicinanza tematica e geografica a Elvira Notari, la Serao rifiutò sempre di concedere alla regista napoletana i diritti di adattamento cinematografico dei suoi romanzi. Secondo quanto riportato da Vittorio Martinelli, il rifiuto opposto dalla scrittrice alle richieste di trasposizione di alcuni suoi testi, soprattutto quelli nei quali la descrizione degli ambienti popolari e borghesi di Napoli è più intensa, fu sempre motivo di grande rammarico per la Notari. Ma la scrittrice disdegnava a tal punto il cinema della regista da preferire piuttosto di cedere i diritti di Addio Amore! e Castigo alla Floreal, una Casa di produzione laziale di bassissimo profilo. Sterminator Vesevo, anch’esso tra i desiderata della Notari, fu invece prodotto dalla Palatino-uci, con il paradosso del Vesuvio ricostruito sulle spiagge di Civitavecchia10. Come si spiega questo atteggiamento così rigido nei confronti della Notari? Antonia Arslan, studiosa di letteratura popolare e femminile, suggerisce una chiave di lettura che può servire a comprendere un atteggiamento che pare comune anche ad altre letterate del tempo. Proprio le donne di successo – e di ‘rispetto’ – le punte di diamante dell’affermazione femminile in letteratura, si dimostrano […] incerte nel trarre in sede teorica le conseguenze di ordine emancipazionista e sociale che sembrerebbero logica conseguenza dei casi descritti nella loro narrativa. È un fenomeno che si può riscontrare […] in Matilde Serao […] e in molte altre […] come se la scrittura creativa e l’osservazione della realtà, il concepire e accompagnare i loro personaggi di ‘vinte’, le avesse indotte a una riflessione sostanzialmente negativa e autoeliminativa su sé stesse e sul mondo […] Matilde Serao nega addirittura che esista una questione femminile o ironizza con toni riduttivi e sprezzanti sulle donne che lavorano11.
In ogni caso, nonostante i malriusciti tentativi di adattamento dei suoi romanzi e le difficoltà incontrate nel suo percorso di soggettista, sembra che la Serao abbia coltivato il suo interesse per il cinematografo fino all’ultimo, come dimostra questo testo tardo nel quale riferisce di numerosi altri soggetti mai giunti a realizzazione:
Matilde Serao, in una foto di M. Nunes Vais (Archivio “In penombra”)
Conosco – scrive nel 1926 – un antico proprietario di una grande sala cinematografica, che è restato coi cassetti pieni di manoscritti pagati e mai eseguiti. Ve ne è uno mio, da darsi in quattro serate, uso Fantomas: s’intitolava: Il talismano. Mi fu pagato diecimila lire. Mai vide le scene. E fu l’ultimo. Da allora giacciono in un mio cassetto speciale, ben sette film, dico sette, rimaste ahimé, inedite! Nessuno me le ha mai chieste: nessuno me le chiederà. Per brevità non enuncio i sette titoli di queste mie opere. E, forse, fra queste composizioni sconosciute alle genti vi è il capolavoro della cinematografia. Tutto accade. E questo capolavoro resterà ignoto. Così, per questa mia rabbia silenziosa, ma sempre viva, in fondo al mio spirito, io avevo finito di frequentare da anni, le sale tenebrose12.
Dalla rivista “Al cinemà” ricaviamo la notizia della partecipazione di Matilde Serao alla realizzazione 251
Matilde Serao con Francesca Bertini sul litorale di Viareggio, in una cartolina d’epoca (Cineteca di Bologna)
del film di Roberto Roberti Napoli che canta, del 1926. La pellicola – riferisce l’articolista – risulta essere un vero e proprio ‘film della canzone’ in quanto le canzonette napoletane sono ciò che animano, non già una trama, ma una presentazione fotografica di usi e costumi napoletani, di tipi e macchiette partenopee caratteristiche. La vita di Napoli, insomma. […] Napoli canta ci trasporta per qualche istante in un’atmosfera di sogni e di poesia. L’averlo ideato e realizzato torna quindi di lode a Roberto Roberti e a Matilde Serao, che hanno saputo magnificamente integrare le visioni e le melodie che l’accompagnano, procurando un’illusione che se non supera, uguaglia la realtà stessa13.
Le didascalie di Napoli che canta sono quasi tutte letteralmente tratte dalle novelle e dai bozzetti giovanili che la scrittrice pubblicò nel 1879 nella raccolta Dal vero14. Il volume conobbe ben sette edizioni, l’ultima delle quali pubblicata nel 1916. Gran parte 252
del testo confluito nei cartelli del film proviene da uno scritto dedicato a quella particolare espressione che è la canzone popolare, quasi sempre legata all’amore. Amore diverso dal nostro amore grossolano e che può giungere a certe delicate espansioni, sognate solo dalla fantasia del poeta; amore che dona egualmente un garofano ed un colpo di rasoio: amore che non s’inchina, non porta guanti e suona per ore intiere la chitarra sotto la finestra dell’amata15.
Il passo appena citato risuona brevemente in una didascalia del film: Nella canzone si parla quasi sempre d’amore… amore che non s’inchina, non porta guanti e suona per ore intere sotto la finestra dell’amata.
Al cartello seguono le immagini di una serenata suonata alla finestra di una giovane donna che, sdraiata, si rallegra ad ascoltare. È questo uno fra i numerosi esempi che rinveniamo in Napoli che
18 / Matilde Serao e il cinematografo / Gina Annunziata
canta dell’avvenuta trasposizione scritta e visiva dei primissimi lavori della Serao. Resta da accertare se la scrittrice, come lascia intendere l’articolo sulla rivista “Al cinemà”, abbia direttamente collaborato alla realizzazione del film oppure abbia semplicemente ceduto i diritti della raccolta. L’approdo della Serao al cinema sembra passare attraverso le maggiori possibilità economiche che il nuovo medium offre rispetto alla letteratura. “Carmina non dant panem”, ricorda più volte, e il cinema sembra arrivare per lei, donna divorziata e madre di quattro figli, giusto nel momento di maggior bisogno, spingendola a superare la diffidenza per la nuova arte. La prima impressione – scrive nel 1916 – che prova uno scrittore cui si chieda di scrivere per il cinematografo, è un senso di ripugnanza. E si comprende: il poeta, il romanzatore, il commediografo, il giornalista non possono non ritenere la rinuncia alla parola come una diminuzione capitale…16 Eppure – prosegue – non si può rimanere indifferenti a nessuna forma artistica, tanto meno a una “nuovissima forma d’arte” che possiede qualità entusiasmanti per chiunque sia impegnato a rappresentare le azioni umane, come la capacità di rappresentare la folla, i movimenti collettivi, le grandi scene di ambienti naturali. Io penso che le produzioni cinematografiche possano raggiungere notevole dignità d’arte ed alto interesse solamente quando vi siano interposte scene di grande movimento e di spettacoli naturali che soddisfino l’occhio dello spettatore.
L’esperienza dello spettatore è tra i temi che la interessano più da vicino, tanto da ispirarle uno dei suoi articoli più intensi e personali, uscito su “L’Arte muta” e suggestivamente intitolato Parla una spettatrice. Per mesi e mesi […] sono andata a vedere, coi miei occhi mortali, per i miei dodici soldi, per i miei otto soldi, che cosa mi piacesse, che cosa mi allettasse, che cosa mi commuovesse, in uno spettacolo cinematografico. Mi sono seduta, in un angolo, allo scu-
ro, in silenzio e in immobilità come tutti gli altri miei vicini; e la mia figura anonima, la mia persona ignota, sono diventate consimili a tanti altri esseri anonimi… E, sapete voi quello che è accaduto? Che io ho ricevuto, esattamente, le medesime impressioni del mio vicino di destra che era forse un commesso di negozio; le medesime impressioni della mia vicina di sinistra, che, io mi immagino, una piccola provinciale, che aveva inurbato17.
Così ella stessa è divenuta – scrive – la perfetta spettatrice; ridendo e piangendo come tutti gli altri nel buio della sala, ha compreso che “il pubblico del cinematografo è fatto di migliaia di anime semplici, o che diventano tali, per uno dei miracoli più bizzarri, penetrando lì dentro, anzi è tutta un’unica anima semplice”. È evidente che la concezione che la Serao ha del cinema è quella di un’arte popolare, capace di arrivare a tutti indistintamente. Ne fa fede anche l’articolo Consigli di famiglia, apparso sul primo numero della rivista romana “Cin”, una pubblicazione di stampo satirico-umoristico. La scrittrice interviene direttamente nel dibattito sulla necessità di un cinema educativo e moralizzatore, prendendosela con quei ‘consigli di famiglia’ che, dopo aver stigmatizzato il teatro delle compagnie stabili, ora scatenano la loro mentalità benpensante contro il cinema, con giudizi retrivi che la giornalista sintetizza così: – Il cinematografo è una trivialità esosa… – I cinematografari sono cretini o birbanti… – Il cinematografo è immorale… – Il cinematografo deve essere un’altra cosa… – Il cinematografo lo dobbiamo fare noi … – Bisogna scacciare i mercanti dal tempio del cinematografo… – La censura che fa? – Il popolo si corrompe, al cinematografo… – Tassate i cinematografi, sino all’osso…
– Chiudete i cinematografi...18 La Serao descrive efficacemente le violente campagne giornalistiche che indiscriminatamente prendono di mira produttori, autori, soggettisti, dive. Non si corre forse il rischio – avverte – che “questa mirabile forma della vita moderna”, una volta costretta 253
a educare, moralizzare, essere Arte con la lettera maiuscola, finisca per smarrire la propria natura e perdere la propria capacità di attrarre e conquistare popolazioni intere, diventando qualcosa di noioso e incomprensibile? Il suo auspicio è perciò che di fronte a questa offensiva il mondo del cinema trovi la forza di resistere, ma certo non senza “discernere la ragione dal torto” e sempre migliorando ed esaltando la propria opera. Infine, sembra opportuno concludere ricordando uno scritto dedicato a Rodolfo Valentino, ma che per la Serao è ancora una volta il pretesto per parlare di donne, di spettatrici. Valentino muore per un banale attacco di peritonite all’età di trentuno anni il 23 agosto 1926. Due settimane dopo la Serao pubblica sul suo giornale un lungo articolo a lui dedicato, ma il cui vero soggetto è in realtà l’universo femminile. La giornalista immagina il lutto delle donne, di tutte le donne, dall’adolescente alla “signora capricciosa”, dalla “sposa scontenta di provincia” alla “sartina romantica” (e sembra di veder sfilare in questa galleria i tanti personaggi femminili dei suoi romanzi), un cordoglio di fronte al quale a nulla valgono gli oltraggi degli uomini. L’attore dallo sguardo magnetico che incantava senza possibilità di scampo il pubblico femminile non è altro – scrive l’autrice – se non un fantasma, qualcuno che pur esistendo in carne e ossa, ha esercitato il proprio fascino solo attraverso un’ombra sullo schermo, penetrando nei cuori delle spettatrici. È appunto questa sua natura di essere intoccabile, irraggiungibile, ad averne fatto il centro del desiderio di milioni di donne, un’immagine indispensabile per sopportare la vita di tutti i giorni. Qual donna – si chiede Matilde Serao – è senza fantasma, grandioso, esiguo, piccino, qual donna può sopportare la vita reale, se non porti in sé, questa invitta simpatia, questa fedele devozione, questo legame tanto più forte, in quanto è fondato sullo spirito, quasi sempre, e non sui sensi, quasi mai? Quale donna non porta, con sé oltre il suo destino, oltre ogni suo tempo, questo suo fantasma, che è talvolta, purtroppo, un sublime tranello della fantasia, un sublime inganno del cuore? Una donna va alla sua morte, col suo 254
fantasma […] E hanno ragione forse gli uomini di essere gelosi del fantasma? Eh sì, forse, hanno ragione…19 Ritroviamo qui in parte il pensiero della Serao sulla condizione femminile, la sua attitudine conformista nei confronti del processo di emancipazione. Un’attitudine contraddittoria che è ben rappresentata nella sua posizione di donna separata eppure contraria al divorzio, in accordo con la sua tesi secondo la quale siccome “nessuno muterà tutto non vale la pena di mutare niente”, ovvero non togliere alla donna l’unico compenso, l’unico diritto che le resta: quello di soffrire per sé e per gli altri20. Ma il discorso sul rapporto della Serao con il femminismo è troppo complesso per essere affrontato in questa sede. Alla sua morte, avvenuta nel marzo 1927, la sua opera letteraria cadrà nell’oblio per quasi vent’anni. Sarà Pietro Pancrazi nel 1944 a curare la prima edizione delle sue opere. Ma bisogna registrare che spetta al cinema il merito di aver riportato per primo l’attenzione sulla sua letteratura. Nel 1941 Alberto Consiglio, in un suo intervento su Cinema e letteratura popolare apparso su “Film quotidiano”, rivolge un invito ai produttori a guardare ai romanzi della scrittrice napoletana, alle possibilità cinematografiche offerte dalla sua opera. Nello stesso tempo la Fauno Film commissiona a Sergio Amidei una riduzione dei romanzi Addio Amore! e Castigo, che sarà girata da Gianni Franciolini nel 1942, con Clara Calamai nei ruolo principale. Nello stesso anno esce il primo film di Luigi Chiarini, Via delle cinque lune, tratto da O Giovannino o la morte e basato su una sceneggiatura dello stesso Chiarini, di Umberto Barbaro e Francesco Pasinetti, che ne traspone l’ambientazione da Napoli a Roma. Intorno alla Serao gravitano nello stesso periodo altre storie di film mancati: un progetto di riduzione di La virtù di Checchina, su cui lavora nel 1943 Alberto Lattuada, e un soggetto di Luigi Zampa dal titolo Notizie sensazionali, sulla travagliata vicenda sentimentale e professionale della coppia Serao-Scarfoglio. Non resta che augurarsi di imbattersi in nuovi documenti, articoli e soggetti inediti, che permettano di delineare in modo più preciso la complessa relazione con il cinema di questa straordinaria autrice.
18 / Matilde Serao e il cinematografo / Gina Annunziata
Note
1
Manoscritto autografo di Germaine Dulac su Matilde Serao, Fondo Germaine Dulac del Museo Nazionale del Cinema, u.a. A327/21. Ringrazio Carla Ceresa per la disponibilità dimostratami durante la consultazione del citato manoscritto.
inglese e italiano è stata ritrovata negli Stati Uniti, in California, nel 2000, restaurata dalla George Eastman House e presentata alla XXII edizione delle Giornate del cinema muto nell’ottobre 2003.
Giovanni Papini, La filosofia del cinematografo, “La Stampa”, 18 maggio 1907.
14 Matilde Serao, Dal vero, Perussia & Quadrio, Milano 1879, ora in Id., Dal vero, a cura di Patricia Bianchi, Dante & Descartes, Napoli 1999.
2
3 Matilde Serao, Cinematografeide!, “Il Giorno”, 30 marzo 1906.
Cfr. Giuliana Bruno, Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari, La Tartaruga, Milano 1995, pp. 91-92 (ed. or. Streetwalking on a Ruined Map: Cultural Theory & The City Films of Elvira Notari, Princeton University Press, Princeton 1993).
4
Matilde Serao, Chi si commuoverà? Chi ammirerà?, “Il Giorno”, 29-30 aprile 1914, p. 2, anche in “La Cine-fono e la Rivista Fono-cinematografica”, n. 280, 9 maggio 1914; ora anche in Sergio Toffetti (a cura di), Il restauro di Cabiria, Lindau-Museo Nazionale del Cinema, Torino 1995, p. 72. Cfr. Edoardo Scarfoglio, Il poema delle fiamme, cit. in “Il Tirso” (edizione speciale), n. 17, 24 aprile 1914.
5
Cfr. Maria Carmi parla del “soggetto” che Matilde Serao ha scritto ed ella ha interpretato per la MONOPOL FILM di Roma, “La Vita cinematografica”, n. 34-35, 15-22 settembre 1914, pp. 41-42.
6
15 Matilde Serao, La canzone popolare, in Id., Dal vero, cit., p. 167. 16 Matilde Serao e il cinematografo, “Apollon”, n. 1, 1 febbraio 1916, p. 32.
Matilde Serao, Parla una spettatrice, “L’Arte muta”, n. 1, 15 giugno 1916, p. 31. 17
18 Matilde Serao, consiglio di Famiglia, “Cin”, n. 1, 12 maggio 1918, p. 2. 19 Matilde Serao, Fantasma, “Il Giorno”, 8 settembre 1926. Ringrazio Silvio Alovisio per avermi segnalato l’articolo in questione. 20 Cfr. Matilde Serao, E i figli?, “Il Mattino”, 19 novembre 1901.
Cfr. La mia vita per la tua! di Matilde Serao, “La Vita cinematografica”, n. 44-45, 30 novembre – 7 dicembre 1914, pp. 81-83.
7
Di seguito i titoli tratti da opere della Serao di cui si ha notizia: O Giovannino o la morte (Gino Rossetti, 1914), Addio amore! (Alberto Carlo Lolli, 1916), Castigo (Ubaldo Maria Del Colle, 1917), La mano tagliata (Alberto Degli Abbati, 1919), Dopo il perdono (Ugo De Simone, 1919), Temi il leone (Ubaldo Maria Del Colle, 1919). 8
Cfr. Francesco Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935, p. 163.
9
10 Cfr. Vittorio Martinelli, Sotto il sole di Napoli, in Gian Piero Brunetta e Davide Turconi (a cura di), Cinema e Film: la meravigliosa storia dell’arte cinematografica, vol. 2, Armando Curcio Editore, Roma 1988, p. 366. 11 Antonia Arslan, Ideologia e autorappresentazione, in Marina Zancan e Annarita Buttafuoco (a cura di), Svelamento. Sibilla Aleramo. Una biografia intellettuale, Feltrinelli, Milano 1988, pp. 168-171 (citato in Giuliana Bruno, op. cit., pp. 250-251). 12 Matilde Serao e il cinematografo, “Lo schermo”, n. 17, 11 dicembre 1926, p. 13. 13 Il film della canzone: Napoli canta, “Al cinemà”, n. 23, 6 giugno 1926, p. 7. Una copia del film con didascalie in
255
19 / Luca Mazzei
Al cinematografo da sole Il cinema descritto dalle donne fra 1898 e 1916
Fedeli tremate: le streghe (al cinematografo) son tornate! Rosellina: Quando viene la festa la si santifica meglio che si può, ma poi non si vede l’ora di andare al cinema… Don Franco: E ci andate sempre? Rosellina: La domenica e le altre feste comandate, come dice il Catechismo. Don Franco: Mi pare che il Catechismo, o meglio il primo precetto della Chiesa, parli di andare a messa, non di andare al cinema. Rosellina: Ho detto così per dire… Però mi ricordo che un giorno voi al Catechismo ci spiegaste che la festa è stata messa da Dio anche perché sia un giorno di onesto sollievo. Don Franco: E ho anche detto di… completare la santificazione della festa con l’onesto sollievo del cinema?
Rosellina: Questo non lo avete detto, ma… Dopo tutto non è un divertimento come gli altri? Credete voi che ci si vada per fare del male?1 A volte la vita postuma di un testo letterario può andare ben oltre le intenzioni del suo autore. Al cinema. Sorprese e pericoli del cinematografo, dialogo immaginario fra la ‘quasi onesta’ (o innocentemente
peccaminosa che dir si voglia) dodicenne Rosellina e il sacerdote maieuta Don Franco, fantasioso scambio di battute dato alle stampe una prima volta dalla casa editrice cattolica milanese Vita e Pensiero alla fine del 19412, ci parla così, nell’oggi del 2008, più del notevole (e poi dimenticato) ruolo svolto dalle sale di proiezione nel campo della emancipazione femminile italiana che della pericolosità sociale dell’oggetto film durante i tormentati anni di guerra. Leggendo il dialogo qui sopra riportato questa sembrerà forse un’affermazione azzardata. Basta però andare avanti di poche pagine per scoprire come uno dei punti più scabrosi del finto dialogo platonico fosse proprio non tanto l’alta concentrazione di una fauna femminile e adolescenziale all’interno delle sale di proiezione del Regno (ricordiamoci che, in uno Stato che si voleva far forte, le fanciulle erano considerate la parte più esposta ai pericoli di un Sesso ritenuto già di per sé ‘debole’), ma piuttosto il ruolo della sorellanza nel promuovere la ritualità tutta pagana, quando non addirittura esplicitamente anticattolica (in questo senso Canudo nel 1908, nel suo veder sostituita la funzione religiosa domenicale alla visita al cinema, aveva visto lontano)3, della partecipazione di massa all’evento collettivo ‘proiezione cinematografica’. 257
Infatti a portare Rosellina sulla cattiva strada della sala di proiezione non sarebbe stata (e qui sta l’innovatività del libretto di Don Franco...) la sua infantile voglia di divertimento, ma la scaltrezza di Lisetta, la cugina più grande, una matura adolescente ormai perduta, ahimè usa da tempo recarsi nelle sale cinematografiche in compagnia di ulteriori disinibite coetanee, e ora decisasi ad allargare la cerchia delle compagne di sala (la voglia di corrompere non è mai troppa!) anche alla piccola parente. Ma per quale ragione – viene da chiedersi – tanto interesse della femminil gioventù italiana nei confronti delle sale cinematografiche? La risposta, per Don Franco, sembra essere più nella penombra della sala che nel cono di luce della proiezione. Motivo di tanta passione cinematografica nella ‘cugina-guida’ e in chissà quante altre adolescenti, più delle attrattive insite nella licenziosità dei film (cioè anche quella, ovviamente, che è poi lo stesso magnetismo che colpisce inconsciamente la naturale curiosità di Rosellina) sarebbe infatti la possibilità d’incontrare nel cinematografo nuovi e futuri amanti. Oltre che, nel caso specifico di Lisetta e Rosellina (Maligno ci cova...), il poter perpetuare nel tempo, con l’iniziazione della cuginetta, il malvagio habitus della corruzione femminile sotto il cono di luce della proiezione. Perché – è sottinteso – se una donna non fa peccato, due, o (peggio!) tre insieme, lo fanno di sicuro. Specie se in un luogo buio. E poi peccare insieme, evidentemente, come il mal comune del mezzo gaudio, fa meno paura.
Un testo inutile? Destinato ad un’utenza ben precisa (i fedeli ‘devoti’ e timorati di Dio di una certa sfera conservatrice e retriva del mondo cattolico italiano imperiale e postconciliare), il fascicoletto è assai tardo e quindi poco è utile, inteso ‘in senso stretto’, per disquisire sul cinema delle origini, nonché sul contesto in cui operarono le pioniere della spettatorialità. Il lettore mi scusi quindi una certa pretestuosità dell’occasione documentale. Il fatto è che l’istituzione ecclesiastica (e qui spero che il lettore voglia riconsegnarmi il cre258
dito perso due righe più avanti), nella sua intrinseca lentezza nell’esprimere le proprie analisi sociologiche e nella parallela smisurata cautela nel reagire agli attacchi del moderno, è comunque da secoli un’attenta osservatrice delle dinamiche di quest’ultimo. Le sue osservazioni, seppur spesso espresse – come dire? – ‘fuori tempo’, sono spesso ficcanti. Perché non prendere dunque le osservazioni di Don Franco come un ottimo viatico per un viaggio a ritroso nella storia della sala italiana?
Cinefile sul lettino dello psicanalista Proviamo così, sulla scorta dei suggerimenti offerti dal libretto ecclesiastico, a fare un passo indietro. Più precisamente fino al 1912. Ci accoglie adesso una pubblicazione scientifica. Più esattamente il fascicolo n. 1 della catanese “Rivista di Neuropatologia Psichiatria ed Elettroterapia”, uscito in gennaio per i tipi della cittadina Tipografia Giannotti. In apertura, sotto il titolo Turbe nervose consecutive alle rappresentazioni cinematografiche. Noticina clinica vi compare un articolo del neuropatologo prof. L. Lojacono, allievo ed aiutante presso l’Università di Palermo del più famoso Giuseppe d’Abundo. Qui, a compendio delle tesi del maestro, illustrate con ampiezza nel precedente numero della stessa rivista, Lojacono annota: Ricordo infatti il caso di una ragazza nevrastenica, abbastanza intelligente, la quale, consultandomi, mi confessava che sin dalla prima audizione cinematografica, aveva provato una sofferenza non lieve sia pel buio, sia pel movimento vibratorio, che la disturbava tanto alla vista, quanto all’udito. Essa cercò di vincersi e di imitare le compagne, che mostravano divertirsi e ritornò più volte al cinematografo, ma non poté mai vincere la sgradita impressione che ne riportava4.
Il cinema dunque, secondo il neuropatologo palermitano, è ormai un obbligo sociale. E frequentarlo per una donna, nella sua implicita ma anche smaliziata analisi, vuol dire adeguarsi a un costume femminile diffuso. Ripensiamo ora al testo di Don Franco e facciamo le dovute proporzioni. Cambia il contesto, cambiano i
19 / Al cinematografo da sole / Luca Mazzei
decenni, cambia la localizzazione geografica, ma la traccia di base rimane lo stessa. Nei discorsi degli uomini sulle tendenze cinematografiche dell’altro sesso, nuovamente il passaparola fra una donna e l’altra e l’habitus della libera associazione femminile sotto lo schermo tornano sempre a far mostra di sé. In trent’anni, le cose evidentemente erano cambiate assai poco.
A mezzanotte sotto il noce. Pardon... sotto lo schermo Si tratta ovviamente, per i testi che ho citato, di proiezioni delle proprie idee e delle proprie convinzioni sociali sul fondo scuro di un altro da sé non bene definito ed evidentemente ancora tutto da conoscere. Ma se invece di un’ipotesi maschile, questa debordante femminilità della sala cinematografica fosse un dato di fatto? Se la paura della nascita di un’associazione segreta all’ombra dello schermo, oltre che su fantasmi di discorsi passati di bocca in bocca e su paure politico-sociali sopravvissute ai secoli e ravvivate poi dalla Storia, si basasse anche su notazioni realistiche? Dubitosi nelle conclusioni, ma anche forti di quanto acquisito, potremmo adesso percorrere liberamente quei tre decenni dell’esperienza cinematografica e della documentazione a essa relativa in lungo e in largo, magari cercando fuori dal mondo di carta eventuali prove filmico-narrative, come l’incipit del Maciste di Giovanni Pastrone del 1915 – con la protagonista che per scappare a degli inseguitori, si siede da sola nella sala cinematografica senza suscitare scalpore alcuno negli altri spettatori –, oppure ulteriori saggi di rilievo, come quelli meravigliosi e meravigliosamente ricchi di spunti pubblicati da Emilio Scaglione su “L’Arte muta” nel 19165. Ma su ulteriori già disponibili emergenze di autori maschili relative al periodo del muto italiano e sul portato di queste, è inutile insistere. Non è il compito che mi sono dato (di nuovo vado fuori strada). E poi un’acuta analisi di molti fra questi testi la fa già, con ampiezza di considerazioni, Silvio Alovisio nel saggio in questo stesso volume pubblicato. Per questo campo d’indagine non mi resta dunque che rimandare
il lettore a considerazioni altrove e meglio espresse. E riprendere invece, con il bagaglio di quanto finora acquisito, una nuova strada.
Ripartendo dal 1907 Ripartirò dunque stavolta da un periodo decisamente più vicino ai confini temporali che mi sono autoimposto. Anzi proprio dal ‘centro’ esatto del lasso temporale cui desidero dedicarmi. Il documento cui voglio far riferimento, anche se nuovamente scritto da un uomo, è d’altronde un testo chiave per la ricerca storiografica italiana sul cinema. Si tratta di La filosofia del cinematografo, articolo che com’è noto il letterato d’avanguardia e filosofo battagliero Giovanni Papini scrisse per il quotidiano “La Stampa” nel maggio 1907, epoca in cui, un po’ come in tutto il mondo, l’establishment della cinematografia nazionale premeva perché l’andare al cinema venisse finalmente accreditato fra i riti ‘leciti’ della vita borghese. Di questo singolare articolo mi interessa in particolare una frase: I filosofi per quanto uomini ritirati e nemici del chiasso, farebbero molto male a lasciare codesti nuovi stabilimenti di passatempo alla semplice curiosità dei ragazzi, delle signore e degli uomini comuni6.
Ciò che vorrei qui mettere in luce, è proprio l’ammissione da parte del letterato-filosofo fiorentino che il cinema in Italia sia stato per anni, almeno fino a tutto il primo semestre del 1907, un affare di donne. Un’ammissione amara per Papini, scrittore che al mondo femminile non era certo vicino, né per tematiche, né per sensibilità. La femminilità della sala cinematografica per Papini costituiva infatti proprio il suo ‘peccato originale’, mentre la stabilità sociale (anche quella del rito cinematografico) e la sua futura culturalità erano invece per lui questione di maschi, meglio se adulti ed esperti di buone lettere.
Un matriarcato cinematografico? Un’attenta lettura di La filosofia del cinematografo mi sembra insomma, specialmente sulla scorta di 259
quanto lumeggiato da altri articoli e libretti comparsi nei decenni successivi, porre agli storici tre domande: è vero che le sale cinematografiche italiane fra il 1896 e il 1907 erano frequentate soprattutto da donne? E davvero le donne in Italia erano tenute così lontane dal mondo delle lettere e della cultura da non aver lasciato traccia della propria partecipazione a questo rito moderno e cittadino in testi scritti da loro stesse? E gli eventuali documenti oggi disponibili di che tipologia e di che spessore sono? Per offrire una risposta che possa dirsi congruente, si possono prevedere nel concreto, tre ipotesi di lavoro. Una di queste, forse la più proficua, potrebbe essere la ricerca di appunti, stralci e note contenuti nelle raccolte di epistolari e diaristiche di donne di diversa estrazione sociale7, su similitudine di quanto già fatto per il rapporto delle donne italiane con la Prima guerra mondiale. Un lavoro enorme, ma comunque doveroso. E sicuramente da tentare. Un secondo modus operandi potrebbe essere quello di compulsare con attenzione tutte le rubriche della posta delle riviste femminili o di cultura varia (ma anche cinematografiche, ovviamente), raccogliendo e collazionando fra loro tutti i discorsi relativi al cinema redatti da mano di donna. E qui alcuni risultati ci sono già8. Un terzo sistema potrebbe consistere nel far banalmente molta più attenzione all’eventuale presenza di firme femminili negli articoli e nei racconti a tema cinematografico comparsi sulla stampa corporativa, settore che, in sé per sé, è ben lungi dall’essere bibliograficamente esaurito; e continuare poi su quei periodici – mensili, quindicinali ma anche quotidiani e settimanali a questi legati – che si sanno avere lasciato spazio talvolta a riflessioni ad ampio raggio sulla modernità e in cui quindi possono essere anche apparsi articoli sul cinematografo di autrici donne. Infine, c’è un quarto sistema, in fondo il più semplice: cercare sui database delle biblioteche italiane, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in testa (che poi fra le Biblioteche Nazionali Centrali è quella addetta a stampare annualmente la Bibliografia Nazionale Italiana, e quindi è a tutt’oggi l’archivio librario più utile per questo genere d’in260
dagini), quanti volumi, libretti, fascicoli riguardanti il cinematografo siano stati pubblicati in Italia dal 1895 al 1930 da autrici donne. Poi passare ad una eventuale analisi comparativa dei testi identificati. È questo il sistema che ho personalmente sperimentato. Ecco dunque direttamente le risultanze. Stavolta presentate invertendo, o se vogliamo riproponendo in versione ‘classica’, l’ordine cronologico dei documenti identificati.
Una pioniera: Anna Gentile Vertua Dopo una prima interrogazione informatica, domanda resa particolarmente fortunata dall’immissione negli scorsi anni, all’interno del database online, di molte schede di opuscoli un tempo disperse per vari cataloghi cartacei (schedari che, com’è facile immaginare, sarebbe impossibile compulsare per ‘parola chiave’), il primo testo che ho individuato è stato Cinematografo. Commedia in 2 atti per fanciulle9, opera dovuta come mi diceva la scheda stessa, alla prolifica scrittrice lombarda Anna Gentile Vertua10. Il libro era esile, un testo teatrale destinato più alla lettura che altro ed inserito fin dalle origini nella divertente e affascinante collana delle Scene famigliari per fanciulle: tutte commedie ‘pedagogiche’ con protagoniste giovani ragazze in grado di maneggiare e usare a proprio favore una novità tecnologica del mondo moderno, dal telefono, alla fotografia, alla bambola fonografo, alla bicicletta, a molte altre11. A dispetto della scarsa voluminosità e dell’origine seriale del volumetto, la sua data di pubblicazione era però sicuramente sorprendente: 24 gennaio 1898. Basti dire che la prima opera di narrazione dedicata al cinema scritta da un uomo, in Italia comparve solo nel 190512... La prima scoperta è dunque che Anna Gentile Vertua non fu solo la prima narratrice italiana a occuparsi di cinema, ma anche il primo personaggio del mondo delle lettere italiano a occuparsi con un’opera autonoma del nuovo spettacolo. E già questo basterebbe a segnalarla come una pioniera assoluta. Cinematografo però ha anche altri pregi e altre spe-
19 / Al cinematografo da sole / Luca Mazzei
cificità, tutte a vantaggio del lavoro dell’autrice lombarda. Innanzitutto nella costruzione dell’intreccio. Per meglio valutarne le potenzialità, ecco un breve riassunto della vicenda.
Dietro la siepe: il mondo del cinematografo come racconto per sole donne Tre giovani donne di età comprese fra i quindici e i diciotto anni, le sorelle Linda, Bice e Lina, si trovano in una grave condizione di disagio economico. Il padre e la madre sono morti, e le donne, che prima abitavano in una bella casa in campagna, sono state costrette a spostarsi in città in un piccolo e malsano appartamento. Da benestanti che erano, sono adesso diventate operaie domestiche: e vivono costruendo a casa fiori finti per conto terzi. La paga è misera e Bice, la più piccola fra loro, è malata e bisognosa di cure che le altre due, con il loro misero stipendio, non riescono a garantire. Moderna e intraprendente, Linda ha deciso però di affiancare al magro stipendio di operaia anche il più remunerativo guadagno di insegnante privata di francese. Darà ripetizioni a una ragazza che abita al confine con la campagna. Una scelta azzeccata. Mentre sta impartendo la sua prima lezione, da una siepe del giardino di casa spunta infatti un uomo dall’accento francese. Questi ha con sé uno strano strumento, simile a una macchina fotografica. È, in altri termini, un operatore cinematografico, probabilmente un operatore Lumière. Lo scopo della sua ‘invasione’ è chiedere alla madre della sua piccola allieva, intenta a lavorare all’orto, se vuole concedergli di farsi riprendere per qualche istante. La donna non è colta abbastanza da poter insegnare il francese alla figlia, ma conosce bene i suoi diritti. Accetterà solo in cambio di dieci lire: “Faccia pure signore, se le accomoda, ma quanto mi paga la compiacenza?”13. Il fotografo sorride e accetta il ‘contratto’. Poi, effettuata la ripresa e pagato il disturbo, si rivolge a Linda: “Fanciulla […] mi concede il favore di cinematografarla?”. Linda, presa alla sprovvista, rimane interdetta. “Ci-ne-ma-to-gra-fa-rla – ripeterà poi alle sorelle – Una parola lunga che non finisce
più”. E qui interviene, strappandole quasi le parole di bocca, la madre dell’allieva: “Sì; ma per lo stesso compenso!”. “Ça va sans dire” risponde il signore. E dopo averla fotografata le porge il biglietto da dieci lire al di sopra della siepe. Quando torna a casa dalle due sorelle, Linda, felicissima, si scontra però subito con le loro preoccupazioni. Non si è vergognata a farsi “pagare per un semplice atto di compiacenza”? Rotta a tutte le esperienze, Linda risponde loro con le stesse parole della madre della sua allieva: “Quel signore va intorno a fare fotografie che poi farà vedere in qualche teatro facendosi pagare. E se lui si fa pagare perché non ci pagherà noi?”. E se il cinematografista, aggiunge allora Bice, fosse stato un dilettante? Di nuovo Linda risponde con le parole della madre dell’allieva, una semplice ortolana qui assurta al ruolo di sua stessa insegnante nei casi della vita moderna: “Se è un dilettante le foto le fa per suo piacere. E paghi allora il suo piacere. Che si ha da farsi rubare il muso e gli atti […] per niente?”. Convinte da quelle frasi di spicciola economia, anche le sorelle plaudono alla risposta: “E teniamoci il nostro biglietto da mille senza scrupolo!”, gridano all’unisono. Il racconto dunque non è ancora finito che già offre numerosi spunti di riflessione. Prima di tutto la totale assenza dal contesto di figure maschili di rilievo: l’unico uomo presente non ha nemmeno un nome, ma solo un mestiere, il ‘fotografo’. Poi la matriarcalità degli insegnamenti, che passano qui da donna a donna. Infine, la grande agilità nel superare le difficoltà offerte dalla vita moderna. Ma continuiamo con il racconto.
Il cinema e i lupacci cattivi Lina, dicevamo, ha risolto già una prima volta il grave problema del disagio economico che attanaglia lei e le sorelle. Le dieci lire sono però solo un palliativo. La povertà delle tre donne rimane infatti intatta, come la grave malattia di Bice e il suo bisogno di medicine. Che fare? Linda ha una nuova idea: farà la cantante in un caffè-chantant. Qui però, con sor261
presa del lettore, l’accoglienza del mondo femminile cui fa riferimento è differente. Interviene infatti sulla questione Margherita, un’anziana operaia che fa insieme da donna di servizio e da madre adottiva alle tre ragazze e che fino ad adesso è rimasta in disparte: “Una fanciulla come lei in un caffè-chantant? Un agnellino compagno in bocca di lupacci cattivi? No, no, no – dice Margherita – dia retta a me; ascolti la vecchia Margherita che la sa lunga, che conosce la vita, non si lasci passare per il capo idee compagne! […] Credano signorine, meglio, cento volte meglio, l’ospedale che il caffè-chantant!”. Per il lettore di oggi, specialmente se ha presente i racconti cinematografici di penna maschile redatti fra 1916 e 1920 in cui ‘attrice cinematografica’ è quasi sinonimo di ‘prostituta’ – la risposta è incomprensibile. Perché lavorare per il cinematografo sarebbe lecito, mentre lavorare per il caffè-chantant no? Perché – sembra di capire dal racconto della Vertua – nel primo caso per Linda sarebbero ancora rispettate tre condizioni: 1) è stato lasciato a lei il compito di guidare la trattativa sul compenso da ricevere per la vendita della prestazione del proprio corpo; 2) la ripresa è stata poco più che uno sguardo innocente sulla sua vita pubblica; 3) il lavoro non prevedeva né prevederà mai alcun contatto fisico o una variazione di abitudini. Invece, nel secondo caso, ovvero quello del caffèchantant, nessuna delle tre condizioni, neanche la prima, sembra possa essere rispettata. Ma c’è anche un quarto motivo. Dal nostro punto di vista è il più interessante, ma l’autrice lo lascia volutamente tra le righe.
Uno spettacolo per famiglie (di donne) Ciò che infatti non ho ancora spiegato al lettore è che, come anticipa già il colophon della commedia, in questa storia di donne, oltre a Linda, Lina e Bice esiste anche una quarta sorella. È Giulia. Impiegatasi come istitutrice presso una famiglia ricca, ella aveva infatti paura di dire ai suoi datori di lavoro di avere delle sorelle che vivevano in povertà. Sposatasi con il figlio dei padroni e divenuta benestante, 262
ha deciso poi di mantenere il segreto anche con lui. Un giorno però, Giulia si reca al cinematografo e... sorpresa! Al cinema vede Linda che fa lezione all’aperto. E vede – come ricorda lei stessa – la sua mano muoversi sulla carta, le sue labbra muoversi14. L’emozione è grande e la voglia di riunire la famiglia enorme15. Giulia si rivolge quindi al marito che acconsente con piacere al progetto di sistemare economicamente le sorelle con una piccola rendita e, dopo aver tanto cercato, ella riesce infine a trovarle. Arrivata appena in tempo per far sì che Bice non finisca all’ospedale, le porta dunque via con sé, insieme all’anziana Margherita, assurta ormai ufficialmente al ruolo di vecchia madre adottiva, nella vecchia casa paterna ricomprata per loro dal marito. Insieme, possono quindi urlare con Giulia: “Sia dunque benedetto il cinematografo!”16. Ecco allora forse spiegato perché la concessione della propria immagine all’obiettivo di una macchina da presa cinematografica, nel 1898 italiano, non sembrasse a Margherita/Vertua apparentabile, se non con delle forzature, al prestare il proprio corpo a una esibizione di caffè-chantant. Non perché nel primo caso si ceda solo la propria immagine e nel secondo il corpo, ma soprattutto perché, con il cinematografo, ci si rivolge principalmente a un pubblico essenzialmente femminile (qui rappresentato dalla sorella Giulia) o comunque, anche se misto, a forte componente familiar-femminile e solo in ultima analisi a un pubblico esclusivamente maschile (“i lupacci cattivi del caffè-chantant”). Il cinema insomma, sembra dirci la Vertua è, nel 1898, un aiuto alla sorellanza, ovvero è uno spazio femminile, in cui gli uomini sono solo intermediari di sguardi principalmente femminili.
Tra donne sole: una nota della pedagoga Formiggini Lasciamo adesso il piano della narrativa e con esso il XIX secolo e passiamo a una nuova figura autoriale. Mi riferisco qui a Emilia Santamaria Formiggini, ovvero la seconda delle spettatrici armate di penna che voglio sottoporre all’attenzione dei lettori17. Pedagoga di grandissime capacità, la Formiggini
19 / Al cinematografo da sole / Luca Mazzei
d’altronde fu figura assai importante per il mondo didattico italiano e, in via generale, non sarà certo il mio intervento a consegnarla alla Storia. Ai nostri fini però interessa non tanto la sua figura, quanto unicamente la sua prima opera, La psicologia del fanciullo normale e anormale con speciale riguardo alla educazione, un testo pubblicato solo nel 1910 ma che fu sicuramente scritto fra 1906 e 190818. E di questa, in particolare, un brano: Però non sono rari i casi in cui il bambino prova simpatia anche per le altre persone, anzi per ignoti, ciò avviene specialmente quando queste persone esprimono con molta vivacità ciò che sentono, o quando si tratta di dividere un sentimento ben noto al bambino. Una bimba di quattro anni, che condussi al cinematografo, alla vista di un soldato a cui, nella rappresentazione, si tagliava la testa, incominciò a piangere dirottamente, e ciò non per timore od orrore, ma pensando al dolore che doveva provare il decapitato19.
Il brano, finora sepolto nella gran massa delle riflessioni della pedagoga, mi sembra molto interessante. Anche qui infatti l’osservazione cinematografica è tutta al femminile. È donna la studiosa, ma lo è anche il piccolo individuo oggetto di osservazione. Di nuovo dunque si presenta una relazione di sorellanza, che però qui, al contrario di quanto emerso nella commedia della Vertua, implica anche nuove e più azzardate osservazioni. Sottolineando la facilità dei bimbi ad allacciare ed esternare relazioni empatiche, la Formiggini non sottolinea infatti solo la capacità della bimba ‘osservata’ di leggere la violenza nascosta dietro lo schermo, ma anche come quella condizione sociale, evidente a tutte le donne fin dalla più tenera età, trovi nella fruizione cinematografica una sua più limpida capacità di espressione. La Formiggini indica insomma chiaramente come ogni visione cinematografica non possa prescindere, nel mondo femminile, da un sostrato psichico modellato dalle relazioni sociali esistenti all’esterno della sala. Il suo è dunque un testo di ricezione di raro pregio20. Ma torniamo per un attimo alla questione delle date. Chi in quegli anni, fra gli accademici italiani, si occupava in termini scientifici di cinematografia?
Probabilmente nessuno. Le prime pubblicazioni scientifiche sulla psicologia dello spettatore cinematografico risalgono infatti in Italia, che fu probabilmente anche all’avanguardia in questo campo, solo al 191121.
Parlerò solo di quello che ho visto: il pedagogismo rigoroso di Angelina Buracci La stessa caratteristica, il parlare cioè con serietà scientifica, solo di fatti osservati in prima persona, è però patrimonio anche di un altro testo femminile della storia letterario-cinematografica italiana delle origini. Parlo qui del terzo e ultimo fra i testi femminili di rilievo da me identificati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: Cinematografo educativo di Angelina Buracci, un eccezionale volumetto dato alle stampe nel 191622. Ho scelto quest’opera a tal fine, non tanto perché sia l’unico libro scritto dopo il 1906-08 da una donna e dedicato al cinematografo. Altri quattro opuscoli di penna femminile, tutti dedicati alle potenzialità didattiche del cinema escono infatti fra 1908 e 191523. Ho tenuto invece conto nella scelta di tre ragioni, che vi espongo qui di seguito. La prima è che Angelina Buracci, al contrario di altre autrici che mostrano in genere di ripetere unicamente moduli già in circolazione nel mondo maschile, è una studiosa interessante e ha pure un ulteriore assai provocatorio testo all’attivo, Il pensiero educativo di Caterina Franceschi Ferrucci e la moderna cultura femminile24, pubblicato tre anni prima. Dal confronto con quest’ultimo possiamo ricostruire così il suo pensiero, ispirato in generale a un femminismo (la Buracci usa esplicitamente questa parola) ‘moderato’, o se vogliamo ‘all’italiana’, da contrapporsi cioè a un femminismo di matrice anglosassone, impostazione rispetto alla quale l’autrice sembra volersi decisamente svincolare. È una riflessione sociale la cui radicalità cioè si arresta alle soglie dell’età adulta, dato che le nuove figure femminili che la Buracci propone si dovrebbero spingere nella rivendicazione dei loro diritti solo fino all’età del matrimonio25. Comunque, essa risulta assai inno263
vativa rispetto all’asfittico contesto della cultura nazionale del periodo. Passando alla seconda delle ragioni che mi hanno portato a scegliere fra tutti proprio il libro di Angelina Buracci, è che esso si presenta come un lavoro di tutto rispetto, vario nei temi, ma anche composto di cinque capitoli e complessivamente disposto su sessanta pagine. Non è quindi il semplice testo di una breve conferenza dotta stampato ad uso dell’ascoltatore distratto, né – pare di poter affermare – uno dei tanti estratti, ovvero pubblicazioni a sé stanti di saggi (generalmente non brillantissimi) già comparsi in rivista di cui sono inflazionate le biblioteche italiane e con cui lo storico del cinema muto italiano si deve spesso confrontare. Il terzo motivo è di origine, se vogliamo ‘cinefila’. La frequentazione dei cinematografi da parte di Angelina Buracci appare infatti davvero di lunghissima data, e le sue visite alle sale di proiezione, per sua stessa ammissione sono “numerosissime”26, un dato davvero assai raro nel contesto degli intellettuali italiani, che era però principalmente composto, come sappiamo, da maschi adulti.
Dodici anni di storie di cinema e di donne Veniamo ora però alle specifiche caratteristiche del libro, elementi che trovo possano essere riassunti nei seguenti nove punti: 1) Il testo inizia con una lunga descrizione delle sale cinematografiche italiane visitate di persona dalla Buracci a partire – l’ammissione è di sua penna – dal 1904, fatto che la pone all’avanguardia fra gli storici e le storiche dell’esercizio cinematografico, settore di cui, di fatto, è la pioniera assoluta. 2) Riporta, negli snodi chiave, solo osservazioni scientifiche registrate in prima persona o da altri di provata serietà ed esperienza, quali appunto Emilia Santamaria Formiggini. 3) Cita sempre, o almeno descrive in modo tale da renderli perfettamente individuabili (e in Italia è cosa rara), i film cui si riferiscono le sue osservazioni. 4) Non costruisce mai una teoria pedagogica del 264
cinema partendo da assunti già in circolazione nel discorso culturale italiano. 5) Usa sempre un linguaggio piano, ma preciso, funzionale quindi a una descrizione di carattere scientifico. 6) Il fine del saggio, è soprattutto quello di proporre uno studio sul funzionamento dei modelli cognitivi infantili davanti allo schermo cinematografico e solo in seconda istanza quello di proporre una serie di operazioni adatte a piegare questo processo cognitivo verso soluzione nuove di interesse prettamente didattico. È quindi un caso unico nel panorama italiano, pochissimo attento, dal 1911 in poi, agli aspetti cognitivi della ricezione cinematografica, ma in generale interessatosi solo alla creazione di modelli pratici per l’utilizzazione del cinematografo ai fini didattici. 7) È il primo saggio in Italia a rendersi conto dell’esistenza di un cinema interpretato da bambini e diretto ai bambini. Per trovare uno studio analogo bisogna rivolgersi infatti al molto meno pregnante Spettacoli massimi e spettatori minimi di Carlo Scarfoglio comparso sul numero datato 15 agosto-1 settembre di “L’Arte muta” (il libro della Buracci è registrato presso la bncf di Firenze con timbro del 7 luglio ed è quindi stato sicuramente pubblicato entro il maggio dello stesso anno, se non prima), oppure aspettare il ben più tardo, per quanto interessantissimo, volume di Jolanda Cervellati Piccoli spostati27, basato è vero su un tesi discussa dalla stessa autrice nel 18 aprile 1918 presso l’Università di Bologna, ma comunque sempre frutto di un lavoro avviato in un periodo posteriore28. 8) È il primo saggio scientifico di sociologia del pubblico cinematografico, qui analizzato, tanto nella sua composizione quanto nelle dinamiche che questo attiva nei confronti del film proiettato. Ciò sempre nella convinzione che un eventuale progetto di dissuasione del reale o potenziale pubblico del cinematografo nei confronti di particolare tipologie di film sarebbe “impossibile, perché troppe cause vi si oppongono, in ispecial modo i gusti del pubblico”29. 9) È il primo, e forse unico, saggio che illustri, in maniera convincente, quale sia il rapporto fra mondo femminile, mondo infantile e cinematografia nell’Italia degli anni Dieci.
19 / Al cinematografo da sole / Luca Mazzei
Una storia matrilineare Essenziale, dal nostro punto di vista, è proprio quest’ultima attenzione ai legami matrilineari, conseguenza logica d’altronde del sottofondo femminista che animava e sostanziava la cultura pedagogica di Angelina Buracci, ma anche del lungo periodo d’osservazione precedente la stesura. Per capire meglio i motivi di tale, assai controcorrente, scelta metodologica bisogna però prima avere ben presente la struttura interna del volumetto. Fondamentale è l’obiettivo dichiarato dell’intera opera: osservare quali film generalmente vedono i bambini italiani e monitorare quale sia l’effetto di queste proiezioni sulla loro psiche. Per far ciò Angelina Buracci ritiene di aver bisogno prima di ricostruire l’ambiente della sala cinematografica (ed ecco il cap. I, dedicato a Le sale cinematografiche), poi di spiegare quali siano i film generalmente in programmazione all’interno di queste (oggetto del cap. II, I soggetti di spettacolo), indi osservare a quali film vengano esposti precisamente i piccoli (nel cap. III, Il cinematografo per la coltura dell’intelletto), e solo in ultimo affrontare un’operazione di carattere maggiormente speculativo, tratteggiando alcune ipotesi sulle modalità con cui essi accolgono l’esperienza del film e sui risultati di questa sulla loro psiche in formazione (nel cap IV, Il cinematografo per la coltura degli affetti). Infine, con una sorta di appendice, essa decide di affrontare il tema della eventuale ‘positività’ didattica dei film allora considerati per bambini, in particolar modo quelli a tema patriottico-risorgimentale e quelli a carattere bellico anti-austriaco, mostrando qui, nel negare a questi prodotti particolari valori aggiunti, anzi rovesciando le opinioni comuni a riguardo, tutta la sua indipendenza di giudizio rispetto ai canoni culturali allora in voga e agli obblighi sociali e politici che ad essi si affidavano (cap. V, Bimbi e fanciulli, artisti del cinematografo). Fedele al suo mandato, l’autrice nelle prime pagine del libro inizia a tratteggiare quello che possiamo definire il più ampio affresco fino ad allora conosciuto della sala cinematografica italiana, un lavoro che esegue con passione e maniacalità, avendo cura di descrivere con estrema attenzione gli interni
e l’arredamento, ma anche l’età, i ruoli sociali e il genere sessuale di lavoratori dipendenti e pubblico pagante. La registrazione delle presenze femminili inizia d’altronde, in un incrocio di sincronia e diacronia, fin dall’ingresso del pubblico in sala: Si entra: l’elegante signorina (gli uomini non hanno più tale incarico) distribuisce i biglietti. Passando poi alla descrizione della folla che si accalca sulle sedie, il quadro diventa ancora più preciso: È una folla eterogenea in cui si scorgono tutti gli elementi più varî della società, uniti in uno scopo unico, il divertimento: signore impellicciate, sfolgoranti di gemme; professionisti distinti, dall’espressione seria e intelligente; uomini austeri e imbronciati; profili civettuoli di ragazze, vestite con una pretesa d’eleganza; visetti incipriati di sartine; donne del popolo coi bambini assonnati in braccio; fanciulli accompagnati dalle mamme, eleganti e profumati; adolescenti allegri e chiassosi, impazienti, che uniscono le loro chiacchiere e le loro risate gioconde alla musica che accompagna la scena.
La varietà del pubblico femminile è qui preponderante, ma soprattutto una buona quota di questo è da subito associata a quello dei bambini e degli adolescenti. Quando però l’obiettivo della Buracci si stringe ulteriormente, dedicandosi ai motivi di tanta passione nei confronti del cinematografo, il mondo maschile tende ulteriormente a perdere di rilievo: Tra un affare e l’altro, tra due adunanze, due sedute, in un ritaglio di tempo lasciato dal lavoro, il commerciante, il professionista, l’operaio, la signora colta all’improvviso da un acquazzone e dal quale non sa come ripararsi, si rifugiano in un cinematografo ad aspettare che il tempo passi e la pioggia diminuisca. Si va al cinematografo, perché passandovi accanto, si vede un programma che interessa; non c‘è bisogno di cambiare la camicetta e di mettersi i guanti bianchi e (questa è la ragione più importante), il divertimento costa, relativamente poco. Perché dunque non si dovrebbe approfittarne? 265
Le notazioni sono inedite e suggestive ma soprattutto sono arricchite da un ampio corredo di osservazioni sui legami fra spettatrici donne e spettatori di tenera età, nodo gordiano che la Buracci presenta peraltro qui in termini inediti, completamente ribaltati rispetto a quanto ci aspetteremmo. Ma lasciamo di nuovo la parola alla pedagoga: Perché si conducono i bambini e i fanciulli al cinematografo?, indifferentemente, senza informarsi del soggetto dello spettacolo? Perché, in certi giorni, nelle sale, si vede un numero rilevante di testine irrequiete che formano la disperazione delle mamme e delle bambinaie, e che danno all’ambiente una nota di gaiezza e di riso? Perché la madre vuol divertirsi e trascina con sé i figliuoli, non sapendo a chi affidarli, perché i bambini stessi si divertono e perché (anche se la scena è un po’ scollacciata) i bambini non capiscono nulla. Ecco le ragioni per cui, spesso, si vedono irrompere nelle sale cinematografiche signore seguite da un codazzo di bimbi vivaci e chiassosi; ecco perché tanti folletti si precipitano, correndo fra le poltrone, urlando di gioia e chiamandosi ad alta voce, come se, dalla scelta del posto, dipendesse qualche grave fatto della loro vita.
Sono le madri e le bambinaie, insomma, secondo Angelina Buracci, le vere cinefile, e non i bambini che acquisiscono questo status, diciamo così, solo in seconda battuta. Il cinematografo inteso come luogo fisico e quindi come fenomeno sociale, per Angelina Buracci, sia quel che sia, è sicuramente donna.
Contro Papini Sulla scorta di quanto detto, non ci meraviglierà così di leggere, con nuovi occhi e rinnovata coscienza, questa frase, altrimenti criptica, o al massimo semplicemente banale, con cui la Buracci apriva il suo stesso libro: “La vecchia idea che ritiene il cinematografo un passatempo per i bambini e per le menti mediocri o inferiori alla mediocrità […] ormai è tramontata”.
266
È chiaro infatti che Angelina Buracci – pur glissando per decenza sul riferimento alla “non intellettualità” delle donne – citava qui esplicitamente la frase più importante dell’articolo del 1907 di Giovanni Papini; la stessa, insomma, da cui ho iniziato la seconda parte delle mie riflessioni Allo stesso tempo però è anche evidente che con queste righe, scritte a nove anni di distanza dall’uscita del testo del filosofo fiorentino e ad altrettanti dalle prime crepe di quel matriarcato cinematografico che mi sembra di intravedere dai documenti e di cui ben poche spettatrici ebbero probabilmente coscienza, Angelina Buracci volesse anche sottolineare quell’attenzione al moderno fenomeno del cinema, che solo il mondo femminile ebbe con anticipo e della quale il suo testo era la prova finale. Era d’altronde ormai il 1916, in Italia gli uomini erano quasi tutti al fronte e le donne facevano mostra di sé in molti mestieri a loro prima non riservati. La figura di una donna nuova si stagliava sul panorama d’Italia, ed anche nel mondo della riflessione cinematografica, una nuova era sembrava alle porte30. Come sappiamo bene, non durò molto...
19 / Al cinematografo da sole / Luca Mazzei
Note
1 Don Franco, Al cinema. Sorprese e pericoli del cinematografo, Vita e Pensiero, Milano 19422, pp. 6-7.
Presso la Biblioteca Nazionale di Firenze è conservata solo la seconda edizione. Nel colophon della stessa è però possibile leggere oltre alla data di stampa (24 aprile 1942) anche la data dell’imprimatur (20 ottobre 1941), e quella del reimprimatur (10 aprile 1942), Presente, ad inizio testo, anche una data – “Natale 1939” – che non si capisce bene se è da intendersi come reale termine di scrittura del testo originale o (come più probabile) quale ambientazione ideale del dialogo stesso.
2
Cfr. Ricciotto Canudo, Trionfo del cinematografo, “Il Nuovo Giornale”, 25 novembre 1908 (ora anche in “Cinema/Studio”, n. 14-16, aprile-dicembre 1994, pp. 21-28). 3
L. Lojacono, Turbe nervose consecutive alle rappresentazioni cinematografiche. Noticina clinica, “Rivista Italiana di Neuropatologia, Psichiatria ed Elettroterapia”, n. 1, gennaio 1912, pp. 14-15
4
5 Emilio Scaglione, Le signorine del cinema, “L’Arte muta”, n. 2, 15 luglio 1916 ed Emilio Scaglione, Il cinematografo in provincia, “L’Arte muta”, n. 6-7, dicembre 1916-gennaio 1917, p. 14. 6 Giovanni Papini, La filosofia del cinematografo, 18 maggio 1907, p. 1.
Tutti da studiare ad esempio sono i testi, peraltro in continuo accrescimento, conservati presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (2238, secondo il sito dell’Archivio, le scritture femminili depositate al 16 agosto 2006).
7
Cfr. Silvio Alovisio, Cineposta, in Emiliano Morreale (a cura di), Lo schermo di carta. Storia e storie dei cineromanzi, Museo Nazionale del Cinema - Il Castoro, Torino-Milano 2007, pp. 143-159.
8
Anna Gentile Vertua, Cinematografo. Commedia in 2 atti per fanciulle, Paravia, Torino 1898. 9
Nata a Dongo nel 1850, Anna Gentile Vertua (spesso firmatasi, per quanto riguarda il nome di battesimo, con il vezzeggiativa Annetta) esordì nella scrittura giovanissima. Il suo primo libro fu Letture giovanili per fanciulle, pubblicato nel 1868. Da allora fu tutto un susseguirsi di pubblicazioni, soprattutto racconti e romanzi per fanciulle e fanciulli, ma anche romanzi a tema romantico e numerosi manuali di buone maniere. La sua opera più famosa fu il prontuario di etica sociale Come devo comportarmi? Libro per tutti, Hoepli, Milano 1897, oggetto di ben dieci ristampe, di cui l’ultima nel 1921. Morì nel 1927 con circa duecento pubblicazioni all’attivo. I Libri della Vertua continuarono però a essere ristampati fino a vent’anni dopo la sua morte. Per ulteriori notizie bibliografiche, oltre agli schedari della bncf, vedi la voce Vertua Gentile Anna in Enzo Ronconi (a cura di), Dizionario generale degli 10
autori italiani contemporanei, Vallecchi, Firenze 1974; Maria Bandini Muti (diretta da), Enciclopedia biografica e bibliografica “Italiana”. Serie VI. Poetesse e scrittrici, ebbi Istituto Editoriale Italian, Milano 1942, voll. 2; Carlo Villani, Stelle femminili, Tip. Aldina, Napoli 1913, nonché Federica Cutrona, Il palcoscenico dei buoni sentimenti. Anna Vertua Gentile Scrittrice per l’infanzia, in Pino Boero (a cura di), Storie di donne: Contessa Lara, Anna Vertua Gentile, Ida Baccini, Jolanda. Scrittura per l’infanzia e letteratura popolare fra Otto e Novecento, Brigati, Genova 2002, pp. 35-44. 11 Le commedie ammontano a tredici, e sono tutte pubblicate fra il 1897 e il 1898 nella più ampia collana di libretti editi da Paravia sotto il titolo Teatro educativo. Alcune delle Scene famigliari per fanciulle (in alcuni record bibliografici erroneamente segnate come “familiari” senza la g) vennero poi ripubblicate, sempre da Paravia, nel 1910 e nel 1914. 12 Un re d’attore [Jarro?], In...cinematograf’...andoci, “Il Signor Pubblico”, Roma, n. 30, 1905, p. 2. Ovviamente, dato che la ricerca nel campo dei racconti cinematografici è ancora tutta da fare, il dato va preso con una certa cautela. Qualcosa di antecedente potrebbe anche esserci. Così come, se vogliamo, è vero per converso che In...cinematograf’...andoci è un racconto sui generis, più una prolusione ad una serie di articoli poi (sembrerebbe) mai scritti, che un vero racconto. In un certo senso la data del primo scritto ‘maschile’ sul cinema può quindi essere fin da oggi spostata ulteriormente in avanti, diciamo fra il generico Scene cinematografiche del prof. Augusto Pala (Tip. Festa, Torino 1906), che riguarda più situazioni comuni raccontate in modo cinematografico che altro, e il più sorprendente Al cinematografo: novella di Gualtiero Italo Fabbri (Tonini, Milano 1907), racconto di finzione interamente ambientato in una sala di proiezioni. 13
Anna Gentile Vertua, Cinematografo, cit., p. 12
“Sì, ti ho veduta, Linda. Eri seduta a un tavolino e davi lezione a una fanciulla. Vidi le tue labbra muoversi; vidi la tua mano far scorrere la penna sulla carta; ti vidi gli occhi come adesso!...”. Anna Gentile Vertua, Cinematografo, cit., p. 25. 14
15 “E subito nell’anima mi entrò il desiderio di vederti; di vedervi tutte e tre!...”. Anna Gentile Vertua, Cinematografo, cit., p. 25.
La frase viene ripetuta due volte, di cui la prima a chiusura della V scena, l’ultima a chiusura della scena successiva che è poi conclusiva dell’intera commedia. Va detto comunque che la chiusa finale con l’esclamativa benedizione è qui irregimentata in una struttura a chiave. Tutte le commedie ‘moderniste’ della Vertua si concludono infatti con la benedizione da parte di una o più delle donne presenti in scena della novità tecnologica o dell’oggetto socialmente inusuale cui la pièce (e il titolo della stessa) è dedicata. Vedi, fra tutte le divertentissime ed assai interessanti: Bambola fonografo 16
267
(Paravia, Torino 1898), Al telefono (id.) e Fotografia istantanea (id.) 17 Nata a Roma, Emila Santamaria Formiggini si era laureata in Lettere e Filosofia nell’Ateneo romano La Sapienza, presso il quale aveva poi ottenuto la libera docenza in Pedagogia. Impegnata nell’Istituzione Scolastica, fu però principalmente insegnante di filosofia, pedagogia ed economia politica nei RR. Istituti Magistrali (fra cui la Regia Scuola Normale Lambruschini di Genova), ispettrice delle Scuole Medie nelle province ‘redente’ (nel 1919), e membro della Commissione per la riforma dei Licei Femminili della Venezia Giulia e Tridentina. Fu inoltre un’attiva collaboratrice di “L’Italia che scrive” e di altre riviste italiane ed estere. D’altronde, legatasi dal 19 settembre 1906 al futuro editore Angelo Fortunato Formiggini (L’Italia che scrive era pubblicata per i suoi tipi), che aveva conosciuto presso il suo soggiorno romano mentre erano entrambe studenti, per tutto il periodo della Grande Guerra, a causa dell’impegno al fronte del marito, fu personalmente a guida dell’impresa di questi.
Emilia Formiggini Santamaria, La psicologia del fanciullo normale e anormale con speciale riguardo alla educazione, Formiggini, Modena 1910. La stesura del testo comunque doveva essere stata portata a termine in un periodo precedente dato che, come si dichiara nel colophon, esso vinse il concorso Ravizza dell’anno 1909, assegnato il 2 aprile 1909 per il biennio 1907-1908. 18
19
Emilia Formiggini Santamaria, op. cit., p. 248.
Curiosamente, uno dei pochissimi (ma anche assai interessanti) appunti sulla ricezione pubblicati in Italia nel primo periodo del muto è proprio una nota contenuta nella tesi di laurea di Angelo Fortunato Formiggini, il marito di Emilia Santamaria. Lo studio, dedicato alla Filosofia del ridere, venne discusso presso l’ateneo di Bologna, dove il futuro editore si era trasferito dopo il matrimonio, nel giugno 1907. Le notazioni dovevano però risalire a qualche mese prima, quasi certamente a un periodo compreso tra la fine di febbraio (si cita il film ‘dal vero’ sulla morte di Carducci, avvenuta il 16 febbraio) e la fine di maggio, cioè ai primi mesi di matrimonio con Emilia Santamaria, e dovevano quindi essere coeve alle note riportate dalla moglie nella sua ricerca. A differenza di quelle di Emilia però le note sul cinematografo di Formiggini (che ha comunque il pregio di citare con esattezza un ‘dal vero’) sono, dal punto di vista della ricezione, di carattere volutamente più generico, aspirando direttamente alla considerazione di carattere universale. Cfr. Angelo Fortunato Formiggini, Filosofia del ridere: note ed appunti, Clueb, Bologna 1989, pp. 88-89.
20
Mi riferisco qui a Mario Ponzo, Di alcune osservazioni psicologiche fatte durante rappresentazioni cinematografiche, “Atti della R. Accademia delle scienze di Torino pubblicati dagli accademici segretari delle due classi”, XLVI, disp. 15a, 1910-1911, pp. 943-948, ora in “Cinema Nuovo”, 296-297, agosto-ottobre 1995, pp. 53-56); Giuseppe D’Abundo, Sopra alcuni particolari effetti delle projezioni cinematografiche nei nevrotici, “Rivista italiana di neuropatologia, psichiatria ed 21
268
elettroterapia”, n. 10, ottobre 1911, p. 440, ora in “Bianco e Nero”, n. 550-551, 2004-2005, pp. 61-65; seguito da L. Lojacono, Turbe nervose consecutive alle rappresentazioni cinematografiche. Noticina clinica, cit.. Il testo di Mario Ponzo e di Giuseppe d’Abundo sono ora scaricabili dal sito del Permanent Seminar on History of Film Theories (www.museonazionaledelcinema.it/filmtheories) 22 Angelina Buracci, Cinematografo educativo, Tip. Sociale Carlo Sironi, Milano 1916. 23 Ai libretti del periodo muto dedicati alla didattica del cinema e scritti da autrici donne, Domenico Spinosa ha dedicato un documentato intervento nell’ambito del convegno “Women and Silent Screen V” tenutosi presso la Stockholm University dall’11 al 13 giugno 2008. L’intervento è attualmente in via di pubblicazione all’interno degli Atti. 24 Angelina Buracci, Il pensiero educativo di Caterina Franceschi Ferrucci e la moderna cultura femminile, Baragiola, Menaggio 1913. 25 “Gli uomini, in generale, vedono non troppo volentieri le donne professioniste che hanno ormai invaso il campo riservato, anni or sono, esclusivamente a loro. Da un lato non hanno torto, ma se facessero un po’ di esame di coscienza, troverebbero che la colpa di quest’invasione femminile è tutta loro, e che ci sarebbe un solo mezzo per porvi un termine ed avere il campo completamente libero. Bisognerebbe che tutti gli uomini si armassero di buona volontà e si mettessero nella condizione di condurre tutte le donne alla vera meta desiderata: al matrimonio. E questo, al mio sesso, felicemente augurando!”. Angelina Buracci, Il pensiero educativo di Caterina Franceschi Ferrucci e la moderna cultura femminile, cit., p. 80. 26
Angelina Buracci, Cinematografo educativo, cit., p. [7].
Jolanda Cervellati, Piccoli spostati, Petracco e Paroni, San Vito al Tagliamento 1922. 27
28 La tesi di laurea di Jolanda Cervellati è stata scoperta dalla studentessa bolognese Lara Cupi, che ringrazio per l’informazione, durante le ricerche svolte per la stessa tesi di laurea (dedicata a film muti italiani tratti dal libro Cuore). Per una analisi del libro della Cervellati, oltre alla tesi di Lara Cupi, attualmente in fase di elaborazione, vedi comunque anche Micaela Veronesi, L’introvabile del mese. Rarità dalla Biblioteca del museo: Jolanda Cervellati, Piccoli spostati, “La Rivista del cinema”, n. 56, febbraio 2008, p. 11. 29
Angelina Buracci, Cinematografo educativo, cit., p. [7].
Non credo d’altronde sia un caso che fra la primavera e l’estate del 1916 escano quasi contemporaneamente, il libro di Angelina Buracci; il reportage dalla sala cinematografica Parla una spettatrice di Matilde Serao (“L’Arte muta”, n. 1, 15 luglio-1 agosto 1916), testo di cui tratta con ampiezza in questo stesso volume Gina Annunziata; l’articolo, per rivista femminile, di Guido Gozzano Il nastro di celluloide e i serpi di Laocoonte (“La Donna”, n. 273, pp. 10-11); e i due già citati articoli di Emilio Scaglione per “L’Arte muta”. 30
20 / Silvio Alovisio
La spettatrice muta Il pubblico cinematografico femminile nell’Italia del primo Novecento
Ipotesi per una ricerca Negli studi, ancora piuttosto esigui, dedicati allo spettatore del cinema muto italiano1, il pubblico femminile non è stato ancora l’oggetto di una ricerca capace di investigarne le articolate identità sociali e culturali, i comportamenti e le modalità di consumo, gli orientamenti del gusto e i portati emotivi. Una delle principali ragioni di questa emarginazione risiede senz’altro nell’oggettiva difficoltà di individuare un corpus rappresentativo di fonti che riescano ad attestare più o meno direttamente l’esperienza delle spettatrici italiane in quella fase storica. Le prove di esistenza di un pubblico cinematografico femminile sono infatti affidate a tracce per lo più sporadiche e indirette, caratterizzate da livelli molto spesso elevati di mediazione discorsiva, disperse nella stampa di opinione, nelle riviste popolari di settore, nelle rubriche della posta, nella narrativa maschile e femminile di ambientazione cinematografica, nelle fonti legislative. Per progettare l’avvio di una ricerca il più possibile documentata sull’argomento è indispensabile provare a individuare organicamente le tipologie e le caratteristiche di queste tracce, puntando alla graduale composizione di un insieme significativo da
sottoporre al lavoro critico dell’interpretazione storica. L’obiettivo prioritario di questo intervento consiste proprio nel presentare alcune ipotesi di lavoro per il recupero delle fonti disperse, interrogandosi sulle tracce di documentazione ancora reperibili e sulla loro problematicità come testimonianze critiche di una storia quasi del tutto dimenticata. Prima di sviluppare queste ipotesi, tuttavia, è ancora necessaria una premessa: il soggetto spettatoriale convocato in questa sede non è una spettatrice ‘empirica’ storicamente attestata, una pluralità di corpi concreti e determinati, inseriti nella loro fattiva contingenza sociale, quanto una costruzione discorsiva che si attualizza in una serie differenziata di occorrenze rappresentative. Non si tratta però di una costruzione discorsiva inscritta all’interno del testo filmico quanto piuttosto di una rappresentazione che abita i discorsi sviluppati intorno al nuovo medium nel periodo del muto, implicati o generati dall’istituzione-cinema in via di formazione, e variamente approfonditi nella stampa di opinione, in quella di settore, nella narrativa di consumo, nella letteratura d’intervento e simili. Inoltre, ulteriore e ultima precisazione, le occorrenze rappresentative di cui proverò a rendere conto non sono autorappresentazioni di genere (come nel caso dei testi 269
analizzati da Luca Mazzei in questo volume) quanto etero-rappresentazioni prodotte dall’universo maschile. I due principali soggetti in gioco, in questo caso, sono dunque il pubblico femminile e i discorsi su di esso. Per capire meglio le modalità della loro interazione è necessario ricollocare temporaneamente questi due soggetti all’interno di una dinamica storica più ampia, legata all’evoluzione primo-novecentesca dei rapporti tra cinema, sfera pubblica borghese, poteri economici e istituzioni. La crescente socializzazione di massa del consumo cinematografico ha rappresentato al tempo stesso uno dei sintomi e una delle cause più evidenti di un fenomeno storicamente più vasto e complesso che investe la storia sociale dell’Occidente soprattutto dalla seconda metà dell’Ottocento: la lenta ma progressiva erosione della separazione gerarchica tra pubblico e privato, intesi come domini di prevalenza, rispettivamente, del maschile e del femminile2. Come si colloca l’avvento del cinema nel quadro di un processo di crisi della sfera pubblica borghese? L’egemonia di quest’ultima, sin dalle origini, come sottolinea Landes, era sempre stata prerogativa dell’“uomo pubblico”, e se esisteva una donna pubblica, questa era essenzialmente “la prostituta, la cittadina di basso rango, una pubblica moglie”3. Il cinema offre invece alla donna, così come ad altri soggetti esclusi o emarginati dalla sfera pubblica borghese, un luogo di esperienza che fuoriesce dal privato. Pur non essendo riducibile a una sola dimensione funzionale, il cinema del primo Novecento si sviluppa anche come evento-chiave di una logica capitalistica votata alla mercificazione e alla massificazione dell’estetico. Nel suo aprirsi, quasi immediatamente, al coinvolgimento sistematico e reiterato del pubblico popolare, il nuovo medium istituisce quindi una sfera pubblica alternativa (o comunque differenziata) rispetto al modello borghese, una sfera in cui le donne non solo emergono alla luce del ‘pubblico’ come soggetti del consumo, ma vi occupano anche un posto rilevante, perché ne rappresentano la quota prevalente. Gli apparati economici del cinema, pur interessandosi ai bisogni privati delle donne nella prospettiva 270
di un’appropriazione finalizzata al profitto, propongono a queste ultime – escluse da uno spazio pubblico dominante ma in crisi – un inedito orizzonte di esperienza pubblica potenzialmente contrapposto al perimetro chiuso e sorvegliato della loro sfera privata: esse possono accedere allo spazio buio e promiscuo delle sale fuori dagli orari canonici4 e autonomamente, senza il vincolo e la tutela di un accompagnamento maschile. Da questo punto di vista, dunque, le spettatrici del primo cinema si presentano come soggetti sociali pronti a emergere in uno spazio poco controllabile, protagoniste di un consumo di massa a sua volta indispensabile per alimentare e incrementare una sempre più significativa attività tecnologico-industriale.
I soggetti in gioco, tra mediazione e conflitto Il cinema inteso come attività economica più o meno redditizia in grado di coinvolgere ampie fasce di consumatori misura le sue condizioni di esistenza e le sue possibilità di produttività ‘ideologica’ confrontandosi con altri soggetti in gioco: la sfera pubblica borghese da un lato, con i suoi organi di stampa, e le istituzioni (il Governo e il Parlamento, il potere giudiziario, la Chiesa…) dall’altro. Tra questi soggetti si stabiliscono delle dinamiche di interazione non solo negoziali ma anche conflittuali. La sfera pubblica borghese, almeno nel suo orientamento liberal-conservatore, contesta la massificazione dell’estetico e cerca di riaffermare il suo primato culturale e morale, introducendo dei dispositivi di controllo e condizionamento, e contestando la logica puramente economica come danno per la cultura e la moralità (“sarebbe ben tristo il paese che non l’affare alla morale, ma la morale sottoponesse all’affare”, scrive ad esempio nel 1917 un tipico intellettuale ‘governativo’ come lo storico dell’arte Corrado Ricci5). L’attenzione tutt’altro che occasionale e distratta riservata al cinema dalle forze che orientano l’opinione pubblica borghese in Italia è un sintomo significativo dell’importanza sociale riconosciuta al nuovo medium. Il problema è che queste voci cercano di
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
Giovani spettatrici in un disegno di Wladyslaw T. Benda, They Were Permitted to Drink Deep of Oblivion, “The Outlook”, 14 giugno 1991
instradare il cinema come fatto sociale sui binari di un’ideologia borghese i cui fondamenti (tutela della famiglia, integrità della morale domestica, primato dell’estetico ecc.) stridono con le dinamiche economiche e socio-culturali in atto. Gli errori che ne conseguono sono almeno due. Il primo è quello di postulare una scissione tra pubblico colto e popolare: se uno è di estrazione borghese e maschile, l’altro possederebbe invece connotati della primitività, dell’incultura, e sarebbe a larga base femminile6. Il secondo errore, conseguente al primo, è quello di non comprendere che il mercato dei consumatori
non solo si sta allargando ma si sta anche integrando in una prospettiva interclassista. All’interno di un conflitto, tutto interno alla borghesia e palesemente dichiarato, tra le logiche della mercificazione del prodotto culturale e la necessità di salvaguardare i fondamenti della società borghese, l’élite liberal-conservatrice si colloca quindi precocemente in una posizione offensiva. Già nel 1907, ad esempio, quando in Italia non si sono ancora stabilizzati i primi apparati di produzione cinematografica, c’è chi denuncia una degenerazione del nuovo spettacolo, travolto e immiserito da una 271
“foia speculatrice” che compromette la “squisitezza estetica” e la “serietà morale”7. Preoccupazioni analoghe ricorrono per tutto il decennio successivo, soprattutto nelle argomentazioni, vagamente antiindustriali, di alcuni esponenti della destra liberale (si vedano, solo per fare un esempio, le posizioni di Bortolo Belotti8). La ‘popolarità’ del cinema, insomma, è per queste voci un fattore di criticità, in piena coerenza con quella larga parte degli ambienti politico-intellettuali borghesi che contestano il progetto giolittiano di assicurare una piena cittadinanza politica alle masse. I moralisti, gli aspiranti censori, i ‘cinematofobi’ rappresentano, in definitiva, l’espressione di una sfera pubblica dominante che tenta di perpetuare ciò che il capitalismo avanzato sta facendo crollare: la separazione tra interesse economico privato e discorso pubblico borghese (un discorso che pretende di esprimere l’interesse generale, ma in cui gli specifici status sociali e sessuali che abitano questa ‘generalità’ sono sospesi, come se tutti fossero uguali). L’allargamento del mercato e gli stereotipi della cultura del consumo, come si è anticipato, stanno invece offrendo un orizzonte nuovo e problematico di esperienza pubblica per soggetti che ne erano stati emarginati o esclusi. La formazione della nuova sfera è promossa e organizzata dall’‘alto’, bisogna riconoscerlo, ma implica comunque un vasto coinvolgimento dal ‘basso’. Inoltre l’‘alto’ che innesca il processo (le forze economiche che lavorano in una dimensione artigianal-industriale, e i capitali finanziari che le sostengono) non coincide perfettamente con l’‘alto’ che vuole assimilare e controllare il processo stesso (l’élite politica e la morale pubblica). C’è qualcosa di contraddittorio e di teso, tale da rendere l’impatto del cinema con la socialità particolarmente produttivo. Anche gli altri soggetti in gioco si muovono tatticamente all’interno di questa controversa e complessa rete di confronto interna alla borghesia con finalità piuttosto chiare. Gli apparati economici del cinema cercano una legittimazione culturale e chiedono che la loro attività economica sia riconosciuta dallo stato come una risorsa produttiva di interesse nazionale. L’autorità statale aspira più che altro a regolamentare il consumo cinematografico, ma non vuole porre 272
troppi ostacoli al coinvolgimento delle masse nell’industria culturale (non si dimentichi che la censura introdotta da Giolitti da un lato è richiesta anche da molte case di produzione, dall’altro lato sarà a lungo contestata dall’élite borghese conservatrice per la sua morbidezza). In questo intreccio di mediazioni e di interessi, la Chiesa intuisce precocemente le potenzialità sociali del nuovo medium e rivendica per questo un ruolo prioritario nella moralizzazione dello spettacolo cinematografico e dei suoi spettatori, un ruolo che lo stato, di fatto, le nega9. L’ipotesi che orienta questo primo tentativo di studio è che in tali dinamiche il pubblico femminile rappresenti una delle principali poste in gioco, una sorta di presenza costante, un ‘basso continuo’ sempre sotteso e implicato, anche se quasi mai questa presenza è riconosciuta ed esplicitata.
La stampa di settore: un agente di mediazione? Una prima fonte, già decisiva, per sperimentare la verifica di questa ipotesi è rappresentata da un ‘soggetto’ che, malgrado le apparenze, non coincide per intero con gli apparati economici del cinema, ma che fa parte integrante delle dinamiche negoziali e conflittuali appena descritte: la stampa di settore. Se è vero che la stampa professionale nasce come strumento di difesa corporativa degli interessi di una categoria, è anche vero che la sua genetica ‘militanza’ è spesso disciplinata da una chiara volontà di mediazione. Le riviste di settore diversificano nel corso della loro storia gli interlocutori della mediazione: in un primo momento, soprattutto nei primi anni Dieci, nella stagione dei grandi periodici di categoria (“La Vita cinematografica”, “La Cinematografia italiana ed estera”, “La Cine-fono”), esse devono mediare tra apparati economici e istituzioni, ma dalla seconda metà degli anni Dieci si aprono al confronto con la sfera pubblica borghese, cercando il coinvolgimento di intellettuali e letterati. Riviste cinematografiche ‘d’arte’ come “L’Arte muta”, “Apollon”, “In penombra”, vogliono supportare “i tentativi dell’industria di stabilizzare la nuova sfera pubblica che era sorta intorno al cinema”10. Successivamente, a partire
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
dai primi anni Venti, le riviste di settore si orientano gradualmente verso i consumatori, e in particolare verso le fasce popolari del pubblico. In tutti i casi la strategia prevalente è sempre quella del compromesso: le posizioni quindi sono spesso ambivalenti, e i modelli di pubblico che prendono vita sulle pagine delle riviste risultano particolarmente problematici. Si veda ad esempio quanto accade nell’estate del 1912: “Il Corriere della Sera” dedica un articolo al cinema in terza pagina, dal titolo Il cinematografo che ci meritiamo: il tono è polemico proprio nei confronti delle logiche del profitto (“La brutalità e la stupidità rientrano nella legge fatale della domanda e dell’offerta”) e plaude all’interpellanza presentata dall’onorevole Ettore Candiani (per altro un imprenditore tra i più noti dell’area milanese) contro l’immoralità delle proiezioni cinematografiche. “L’Illustrazione cinematografica”, la più importante rivista milanese di cinema di quel periodo, replica a questo articolo con argomentazioni che non cercano lo scontro ma la mediazione. La rivista parte dalla constatazione che in effetti il cinema può essere uno spettacolo dannoso e che l’“arte cinematografica non può purificarsi e perfezionarsi se non camminando accanto alla moralità”: di conseguenza si invoca l’introduzione della censura. Tra le argomentazioni di questa mediazione ce n’è almeno una che chiama in causa la donna: Qualcuno potrebbe affermare – scrive l’editorialista – che a quegli orribili garbugli di drammi possano servire di antidoto le massime della morale domestica. Errore! La morale domestica non è migliore di quella di certe cinematografie. Il sentimento di dovere della donna non è inculcato troppo bene nella zucca delle signore mogli. Se qualcuno osasse smentirci lo rimanderemmo semplicemente alla cronaca quotidiana. E se ciò non gli bastasse, gli citerei un’infinità di processi recenti e trapassati avvenuti per adulterio11.
Queste affermazioni rivelano un paradosso, forse solo apparente, tipico di queste riviste, evidente soprattutto dal momento in cui la stampa di settore non si rivolge più ai produttori ma ai consumatori. In quest’ultima fase il ruolo della donna cresce
sensibilmente. Le riviste di cinema popolari (“Al Cinemà”, “Cine-cinema”…) si rivolgono a un pubblico in larga misura composto da donne, come dimostrato non solo dall’egemonia delle lettere femminili nelle rubriche della posta ma anche dalla presenza, quasi ordinaria in molte riviste, di rubriche dedicate alla moda. Quest’ultimo fenomeno, già evidente nei primi anni Dieci su alcune riviste corporative (per esempio “Il Maggese Cinematografico”), si estende poi con le riviste d’arte (“In penombra” proponeva la rubrica Tutte le mode. Novità della moda femminile; “Apollon” invece pubblicava La moda, con corrispondente da Parigi), e poi praticamente si generalizza con le riviste popolari (si veda per esempio L’angolo delle signore, su “Al Cinemà”, La casa e la moda, su “La Bottega delle Ombre”, Eleganze femminili, su “Cine mondo” etc.)12. Il paradosso a cui si faceva cenno è che queste riviste, pur alimentate in buona parte dal pubblico femminile, erano fatte quasi per intero da uomini. Non mancavano firme femminili, ovviamente, ma erano una netta minoranza e non arrivavano mai a occupare posti direttivi nella redazione13. Le riviste cinematografiche erano quindi animate da discorsi (e presupposti ideologici) borghesi e maschili. Questi discorsi, tuttavia, proprio per la loro collocazione ideologica, possono aiutarci a comprendere meglio da un lato certe processualità storiche della ricezione femminile, dall’altro lato le modalità con cui i soggetti delle diverse scene pubbliche hanno tentato di regolare e disciplinare queste processualità.
La criticità dell’esperienza cinematografica Le strategie dell’élite borghese puntano alla costruzione di un dispositivo che riduca o controlli quelli che appaiono come elementi di criticità dell’esperienza cinematografica. Nella definizione di questi fattori critici, la donna svolge un ruolo decisivo. Il cinema preoccupa e al tempo stesso attira proprio perché si presenta come un’esperienza accessibile, e perché coinvolge ampiamente quelle che sono considerate le fasce deboli (dal punto di vista psicologico, morale e culturale) della società: i ragazzi e, appunto, le donne. 273
Il nesso donne-fanciulli è un motivo ricorrente nei discorsi prodotti dalla sfera pubblica borghese. Anton Giulio Bragaglia così si esprime su “Cronache d’attualità” nel 1916: La maggior parte della produzione odierna è assillata da tale ricerca di mezzi provocatori di sensazioni, le quali sono d’indole sottile e d’indole grossolana. Chi si preoccupa di nulla? Si pensa forse ai ragazzi, alle bambine, alle donne oneste, che costituiscono il nucleo principale degli spettatori nei cinematografi?14.
Lo stesso nesso viene ribadito dal già ricordato Bortolo Belotti nel 1918: “Le vittime del malcostume sono specialmente i deboli, cioè le donne e i fanciulli”15. Anche l’avvocato Piero Pesce Maineri, pochi anni dopo, riprende l’associazione: “Una fonte di deleterie impressioni suggestive dello schermo cinematografico è per il popolo e soprattutto per quella parte più emotiva di esso che è rappresentata dalle donne e dai minorenni”16. Dentro l’inscindibilità di questo nesso le donne sono viste esclusivamente come madri, principali responsabili dell’educazione dei figli, come sottolinea Belotti, che di fronte all’ipotesi di dividere la produzione in due categorie, una per ragazzi e l’altra per gli adulti, dichiara la sua contrarietà con questa argomentazione: Ma, tornando alla sostanza delle cose, creare una categoria di pellicole per adolescenti contro una categoria di pellicole per adulti, vuol dire liberar la briglia per queste seconde, ossia vuol dire instaurare per esse il sistema della piena libertà, e giungere all’istituzione del ‘cinematografo in busta chiusa’. Bel progresso! E il pubblico degli adulti non deve, anch’esso, essere difeso? Le statistiche dimostrano che il cinematografo è specialmente frequentato da donne; dunque la busta chiusa sarebbe destinata specialmente ad esse. E così, col pretesto di difendere i fanciulli si abbandonerebbe ogni riguardo per quella metà del genere umano che deve averne la cura e seguirne l’educazione. Il che è evidentemente e ironicamente contraddittorio!17.
Già da queste poche citazioni si può capire come la preoccupazione sociale nutrita dall’élite borghese si catalizzi intorno alla moralità, una questione che non 274
investe mai lo spettatore maschio borghese sano, ritenuto perfettamente in grado di discernere il bene dal male, la realtà dall’illusione, la presentazione dalla rappresentazione: gli spettatori a rischio, quelli potenzialmente o effettivamente immorali, sono piuttosto i proletari analfabeti, le donne, i minorenni, i neuropatici. A questi soggetti del consumo non si riconosce un’autonomia etica, né la possibilità che essi possano recepire consapevolmente e criticamente ciò che vedono al cinema: sono spettatori ingenui, puramente passivi, totalmente suggestionabili. La loro moralità può migliorare o peggiorare (su questo punto le voci sono discordi) ma resta comunque sempre instabile e plasmabile. Queste convinzioni vengono riprese anche da chi, all’interno della stampa di settore, cerca una mediazione tra sfera pubblica borghese, apparati di produzione e nuovo pubblico. Nel 1906 il giornalista cinematografico Gualtiero Fabbri pubblica un romanzo breve, Al cinematografo18, il cui obiettivo è quello di legittimare il cinema attraverso la legittimazione del suo pubblico. Secondo Fabbri solo la borghesia può sdoganare il cinema, istradando il consumo popolare sui binari del disciplinamento morale e pedagogico. Lo spettatore maschio borghese e colto, nella visione ideologica di Fabbri, è l’unico capace di svolgere una corretta interpretazione delle immagini: non stupisce quindi che nel romanzo egli sia il solo a capire la morale della rappresentazione e che di conseguenza sia pronto a divulgare quest’ultima alle spettatrici, soprattutto quando sono le donne stesse al centro della rappresentazione cinematografica19.
Modelli di spettatrici, spettatrici-modello La cultura della sfera pubblica borghese, egemonicamente maschile, tenta di controllare questa nuova dimensione popolare dell’esperienza cinematografica attraverso la produzione di schemi interpretativi che riducano la problematicità della situazione, o che almeno la riconducano a modelli etici e ideologici noti e rassicuranti. Le novità legate alla presenza della donna come frequentatrice assidua dei cinematografi non possono essere negate, ma esse sono spesso ricondotte a schemi già noti e stereo-
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
tipati. Le riviste di settore riprendono e rilanciano queste modellizzazioni. Compulsando a campione le riviste di settore alla ricerca di costruzioni discorsive sul pubblico femminile, si possono già esprimere alcune constatazioni: la prima è che il pubblico, in generale, al di là delle distinzioni sessuali, non è un oggetto posto con frequenza al centro dei discorsi, anche quando – dai primi anni Venti – le riviste diventano prodotti destinati al pubblico stesso. In secondo luogo, la modalità di rappresentazione del pubblico più frequente passa attraverso la forma del racconto. In terzo luogo, al centro di questi racconti sul pubblico vi è quasi sempre una spettatrice e non uno spettatore. Può essere utile, fatta questa premessa, cercare di riportare la molteplicità delle identità spettatoriali femminili evocate in questi discorsi ad alcuni modelli comuni che restituiscano la traccia di una trasformazione storica della ricezione femminile dalla fine del primo decennio del secolo al cuore degli anni Venti. La storiografia post-Brighton, ricostruendo la storia della ricezione cinematografica, ha stabilito più o meno esplicitamente una distinzione significativa: da un lato, nel cinema delle origini, lo spettatore sarebbe un corpo che agisce e percepisce all’interno di una sala, mantenendo una condivisione percettiva con lo spazio del film ma nella piena consapevolezza di occupare una concreta posizione fisica da ‘questa’ parte dello schermo; dall’altro lato, nel cinema istituzionale, il corpo invece svanisce, si smaterializza a profitto di uno sguardo che viene assorbito e posizionato all’interno del film, mentre lo spazio della sala si de-realizza. Nelle costruzioni discorsive relative al pubblico femminile fino agli anni Venti, questa distinzione appare assai meno netta: l’esperienza del cinema è spesso raccontata come un’esperienza di corpi all’interno di una sala, ma non mancano tracce discorsive che rinviano a una centralità dell’esperienza del film rispetto all’esperienza della sala.
Molestate e adultere L’esperienza cinematografica delle donne è comunque rappresentata prima di tutto come un’espe-
rienza di corpi che agiscono, interagiscono e si esibiscono all’interno di una sala. Nello spazio fisico dei cinematografi la stampa, di settore e non, rileva come vi siano almeno due fattori di criticità, il buio e la promiscuità, capaci di incoraggiare azioni pulsionali e moleste (non a caso “Civiltà cattolica”, nel 1914, prova vanamente a invocare la separazione fisica del pubblico maschile da quello femminile)20. Il nesso buio/sessualità alimenta sin dai primi anni del Novecento un’ampia ‘letteratura del pizzicotto’. “Svolgendosi ogni interpretazione al buio” scrive ad esempio Panteo nel 1908, “ogni spettatore è padrone di provare autenticamente le proprie emozioni e sinceramente manifestarle con rossori, contrazioni, pallori, lacrimucce, interiezioni e magari… pizzicotti anonimi alle vicine di sedia”21. La donna diventa così oggetto tangibile e palpabile del desiderio, oppure si predispone all’adulterio: non a caso quello della spettatrice adultera, insieme alla spettatrice molestata, rappresenta uno dei primi modelli di costruzione discorsiva maschile dell’esperienza cinematografica femminile. La spettatrice, prima di essere uno sguardo è dunque un corpo, vicino e toccabile, pronto all’atto sessuale illecito. Ci si può recare al cinema non per vedere un film ma per avere un incontro fisico con l’altro sesso. La premessa ideologica ricorrente in tutte le rappresentazioni della spettatrice adultera è che l’infedeltà è una predisposizione quasi genetica della donna. Ancora 1919, ad esempio, in un articolo di Pitigrilli pubblicato sulla rivista “In penombra”, si legge che “in ogni donna esiste un’adultera latente, un’adultera potenziale; per renderla attuale non manca che l’occasione, in ogni donna c’è un’adultera come in ogni uomo c’è un soldato” 22. Riccardo Artuffo, nel firmare un articolo in cui attacca ironicamente la censura fingendo di difenderla, adotta una strategia retorica che dice molto di più sulla concezione della donna e della spettatrice di quanto voglia rivelare23: per difendere la censura, Artuffo fa due esempi di soggetti potenzialmente criminali, il ladro adolescente e la donna adultera, e già l’accostamento è in sé significativo. Nel secondo caso, Artuffo sostiene di fatto che il cinema svolge una funzione di regolatore e normalizzatore dell’instabilità sociale: l’insistita rappresentazione 275
dell’adulterio al cinema è per la spettatrice geneticamente adultera un ‘derivativo’, una sorta di compensazione immaginaria. Si tratta, in altri termini, di “froler la colpa senza cascarci; di assaporare il frutto proibito senza farsi male ai denti; di godersi lo spettacolo dell’Inferno, rimanendo sulla soglia del Paradiso (mettiamo del purgatorio)”24. Chi è secondo Artuffo la spettatrice geneticamente e quindi potenzialmente adultera? È una donna perfettamente onesta, come tutte quante le altre, cioè… fino a prova contraria. Ora, tutto quel che c’è in lei di esuberanza sentimentale, e che non può avere il suo naturale sfogo nel pachidermico marito, aveva trovato fin’oggi un derivativo nelle storie passionali proiettate sullo schermo. Io avevo un bel dipingerle a vivaci colori le gioie sublimi dell’adulterio. Ella approvava entusiasticamente, ma si riferiva sempre agli adulteri pellicolari di Maria Jacobini o, putacaso, di Italia Almirante […] Che le resta, povera e diserta Penelope? Accontentarsi di films oneste e pure, in cui Taddeo e Veneranda, regolarmente uniti dinanzi a Dio e agli uomini, filano il perfetto amore dal primo all’ultimo quadro? Grazie tante! In fatto di amori coniugali ella ne ha abbastanza del suo pezzo da cento chili. E le avanza25.
Il cinema, quindi, secondo Artuffo è un produttore di surrogati di esperienza, anche di quelli legati all’illecito, e svolge una funzione catartica: il processo è assai semplice. Quella vaga, incerta, quasi paurosa curiosità dell’amore illegittimo che finora trovava soddisfazione nelle immoralissime films che la saggia Censura ha draconianamente soppresse, non può naturalmente rientrare di colpo o squagliarsi come neve al sole; bisogna quindi che cerchi di saziarsi per altre vie […]. Un adulterio in meno sullo schermo – qualche migliaio di paia di corna in più nella realtà26.
Quasi dieci anni dopo, nel 1927, vent’anni dopo le prime testimonianze della ‘letteratura dei pizzicotti’, in una sorta di poema in rima firmato da un critico che usa lo pseudonimo di Pasqualazio, si assiste ad una forma di rovesciamento del cliché: se fino ai primi anni Dieci la spettatrice era oggetto del desiderio, un corpo-preda da toccare furtivamente, ora 276
invece diventa soggetto del desiderio. Nel poemetto citato la donna sola cattura l’uomo con lo sguardo per la strada e lo invita allusivamente a seguirla. A un certo punto la donna si ferma: Signora, vi fermaste al Cinema Moderno. L’occhiata che vibraste non fu certo di scherno… Entrai. Signora, giuro, che vedevo all’oscuro molto meglio d’un gatto: e vi vidi nell’atto di deporre la vostra seducente persona, con un gesto d’offerta, sulla terza poltrona d’una fila deserta27.
La donna quindi entra da sola in un cinema, ma non si ferma qui. Vi entra con lo scopo preciso di incontrare di nascosto un uomo sconosciuto. Quest’ultimo tuttavia si mostra troppo indeciso, non ha il coraggio di spostarsi per occupare l’ultima sedia che lo divide dalla spettatrice. “Restammo lì un’ora, guardando ogni tanto quel posto accanto. Attesi. Ammirammo l’intera commedia: ma non superammo la sedia intermedia”. Il rispetto dell’etichetta, della ‘buona creanza’, porta l’uomo allo scacco: dopo un’ora il posto verrà infatti occupato da “un signore gentile e garbato […] che dopo un minuto, tastato il terreno, tastava ben altro, tranquillo e sereno”28. Il rovesciamento di prospettiva investe quindi anche l’uomo: nel cliché del ‘pizzicotto’ l’uomo infrangeva le regole dell’etichetta, qui invece le rispetta, ma sembra poi pentirsene. Se da un lato la donna sembra muoversi più a suo agio nello spazio pubblico, e individua nel cinema il luogo dove vivere consapevolmente un’esperienza di trasgressione, dall’altro lato il giudizio maschile che investe questa disinvoltura è decisamente negativo: la spettatrice viene infatti rappresentata come una donna facilmente disponibile ad andare con il primo che capita.
Corpi in eccesso e lacrime interclassiste In altre costruzioni discorsive, ancora più frequenti, l’entrata per certi aspetti non governabile di un corpo femminile all’interno di un’esperienza pubblica di consumo è messa in scena nelle forme variabili dell’eccesso. La tanto citata polemica sulle larghe falde dei cappelli delle signore che ostruiscono la vista dagli spet-
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
tatori, al di là dei suoi lati faceti, tradisce – nell’ampia eco che trova sulla stampa – il disagio di certi strati della società nei confronti dei nuovi diritti di accessibilità delle donne: è la loro corporalità, in primo luogo, ad apparire come problematica e turbatrice. Non a caso vi è persino chi, ed è una donna, propone
titolo in quest’ultima categoria. I discorsi, soprattutto narrativi, sul pubblico femminile indugiano spesso sull’associazione tra donna ed emozione incontrollata. La spettatrice è un’individualità elementare, fragile, istintuale, e quindi facile preda delle emozioni. Si legga ad esempio quanto scrive Jarro (alias Giulio Piccini) nel 1911:
di dividere le signore dai signori […]. Le signore così collocate magari si accapiglieranno tra di loro, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso! […] non ci faremo nemici quei bravi signori uomini, specialmente ora che stanno cercando tutti i mezzi per farci ottenere… anche il voto politico!29.
Un altro quadro si offriva agli spettatori. Sopraggiungevano alcuni ufficiali della polizia; sollevavano alquanto il cadavere dal baule. E tutti ne scorgevano la faccia. Allora, nell’oscurità della sala, si udì un grido acutissimo, un grido di dolore, di spavento, di strazio. […]. Il grido udito aveva lasciato nel pubblico un po’ di sorpresa e si era alzato da un angolo della sala ove erano raccolte varie donne. Tutti avevano riconosciuto una voce femminile. Ma le stesse donne le quali erano accanto a colei che aveva gridato sarebbero state perplesse nell’indicarla, perché tutte erano agitatissime, in preda a commozione: la verità de’ quadri cinematografici da esse veduti, la riproduzione efficace, le avevano sconvolte31.
Le donne, quindi, sono vittime di quello stesso gioco di apparenze, di maschere, di artifici in fondo imposto da liturgie essenzialmente maschili. Il gesto femminile di recarsi al cinema è dunque visto con frequenza anche come un atto di esibizione eccessiva: non tanto e non solo un puro esercizio del vedere, anzi, al contrario, un fastidioso ostacolo all’atto limpido – maschile? – della visione. Un’altra costruzione discorsiva che chiama in causa le forme dell’eccesso investe non tanto la dimensione fisica della spettatrice quanto il suo portato emotivo. La donna introduce nello spazio pubblico del cinema non solo il suo corpo, ma anche una modalità del vedere: in questi casi il cinematografo è quindi descritto e rappresentato prima di tutto come un’esperienza della percezione, potenzialmente pericolosa. Da più parti emerge la convinzione che l’occhio e la mente degli spettatori non siano preparati a gestire le nuove modalità del vedere. Percepire meglio, in altri termini non significa vedere nel modo giusto: l’immagine, proprio nel momento in cui – attraverso il cinema – si configura come l’oggettivazione del reale, sembra non riflettere più la verità delle cose, invece di rivelare molto spesso violenta la percezione. Più l’immagine diventa nitida e potente, illimitata e definitiva, oggettiva e materiale, e più l’occhio diventa sfocato e debole, limitato e provvisorio, soggettivo ed evanescente. La pericolosità del cinema, in ogni modo, non coinvolge la generalità degli spettatori: le immagini del cinematografo scatenano un’aggressione traumatica alle “menti ignoranti, o poco evolute, o nevropatiche”30, ma le donne rientrano a pieno
La stessa confusione tra rappresentazione e presenza era stata raccontata cinque anni prima da Fabbri: sopraggiunge il direttissimo... la donzella sta per essere travolta da quello... - Ah! Prorompe, a siffatta vista, con un altissimo grido, una bionda signora delicatissima, che, non sapendo controllare i suoi nervi, né la propria mente, ha creduto alla realtà della ragazza, nonché all’imminente sfracello di questa32.
Pur restando sempre valide le distinzioni di classe33, nei discorsi maschili sulle spettatrici si postula la sostanziale indistinzione interna del genere femminile, unificato da una sua supposta naturalità pre-sociale, attinente all’ordine del non culturale e dell’istintuale. Le donne sono un pubblico unito e compatto, perché vivono le stesse dinamiche di ‘ebetismo collettivo’, le stesse ingenuità emotive, la stessa vulnerabilità. E dov’è più – si chiede per esempio Emilio Scaglione nel 1916 – la superiorità della signora, che veste con nuova grazia estiva, se ha la stessa espressione un 277
po’ ebete della provinciale, arrivata il giorno prima, per comprare un inverosimile mazzo di ciliegie su un mastodontico cappello che in paese farà furore?34
Quasi dieci anni dopo, nel cuore degli anni Venti, ancora si scrive: Al cinematografo si piange spesso e più facilmente che a qualsiasi altro spettacolo. C’è una parte di pubblico che possiede un alto grado emotivo e si lascia commuovere con facilità estrema dalle vicende degli eroi dello schermo. [...] Ad un finale patetico, i bambini e le signore presenti nella sala, versano complessivamente qualche litro di lacrime [...]. Il pianto rappresenta il pericolo di un vero disastro oggi, per una signora elegante. Qualche giorno fa, al Salone Ghersi di Torino, si proiettava L’ultima danza [...]. Era interessante osservare, all’uscita della galleria, le tracce che la commozione aveva lasciato sul ‘maquillage’ delle eleganti spettatrici; rivi di ‘rimmel’ e di bistro solcavano lo strato diafano di cipria sui volti graziosi; e le piangenti si affrettavano senza eccezione, a riparare i danni, davanti agli specchi della sala, sfolgorante di luci35.
Lo stereotipo della lacrima femminile facile ha una radicata fortuna negli anni Dieci e Venti, e non sembra essere influenzato dai cambiamenti storici dello spettacolo cinematografico e delle sue modalità di ricezione. Lo ritroviamo per esempio ancora in piena forma nel 1927, quando sulla rivista “Al Cinemà” si descrive la nuova spettatrice “maschietta ultramoderna”: È di carattere sensibilissimo: se prima c’è il dramma la sentite gemere, piangere, strillare, urlare (in sordina, s’intende!) con maniera commoventissima. Se dopo viene la comica, la sentirete sbellicarsi [...] con licenza parlando, dalle risa. È un essere pericolosissimo. [...] Ma dove è ottima questa habituée, è nel drammatico, come ho già accennato: nelle agonie a lungo metraggio (tipo Lilian Gish) che la fanno gemere come una cagnolina cui abbiano pestata la coda, e nei colpi di pistola improvvisi (tipo Tom Mix) che le fanno cacciare un grido che interrompe nei loro dolci colloqui persino i colombi della sala36.
L’insistenza sulla forme eccessive della ricezione femminile traduce all’interno di un nuovo orizzonte 278
dell’esperienza uno stereotipo-chiave della cultura positivista: quello della donna isterica. D’altronde è molto significativo che sia la stessa psichiatria in formazione a iniziare a interessarsi alle spettatrici descrivendole nella forma del caso clinico. Lo psichiatra Giuseppe D’Abundo, autore nel 1911 di un importante intervento dedicato ai disturbi allucinatori indotti dalle proiezioni cinematografiche37, cita alcuni casi di donne affette da patologie isteriche, innescate il più delle volte o dalla menopausa, o dalla prima comparsa delle mestruazioni. In particolare D’Abundo cita il caso di una giovanissima paziente che dopo aver visto la rappresentazione cinematografica di un sogno in cui un impiegato delle ferrovie veniva assediato da numerose mani che emergevano dal buio aveva accusato allucinazioni non solo visive ma persino tattili, disturbi che andavano aumentando prima e dopo il ciclo mestruale. Altre due pazienti avevano sofferto disturbi analoghi dopo aver visto al cinema le immagini di numerosi serpenti che si attorcigliavano sul collo e sulle braccia di un fachiro. La sfera pubblica consegna l’eccesso del vedere al perimetro clinico della neuropatologia, e si pone il problema della prevenzione e della terapia di queste patologie. Occorre aggiungere, tuttavia, che nella sua volontà terapeutica, D’Abundo identifica, forse quasi senza volerlo, una dimensione specificamente femminile dello sguardo, sorprendentemente simile a quella – centrifuga e non testualmente predeterminata – descritta tre anni dopo dalla sociologa tedesca Emilie Altenloh38: secondo quest’ultima le spettatrici risponderebbero meglio ai processi associativi, agli aspetti sinestesici e cinetici del film, dimenticandone con facilità l’intreccio e ricordando più intensamente i dettagli e le immagini non narrative39.
La spettatrice e la diva: liturgie del consumo Dopo il 1912, l’affermazione del lungometraggio, l’egemonia del film narrativo, il perfezionamento di modelli di messa in scena sempre più funzionali all’assorbimento dello spettatore all’interno del film incoraggiano un processo di de-realizzazione dello
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
spazio della sala: cresce quindi la centralità dello spazio illusorio dello schermo rispetto allo spazio reale della sala e alla materialità empirica del corpo spettatoriale. Se il coinvolgimento sempre più strutturale della media e alta borghesia (legato anche al significativo ma non generalizzato aumento del biglietto nelle sale più prestigiose) è un dato indiscutibile, ciò non significa tuttavia che il pubblico popolare venga emarginato (le sale periferiche e dei borghi operai mantengono infatti la loro presenza sul territorio, anzi in alcuni casi la rafforzano): più che di una mutazione genetica dell’identità sociale degli spettatori sarebbe più corretto parlare di una sua estensione e di una sua contemporanea e crescente differenziazione interna. Queste dinamiche portano anche alla nascita di nuovi cinema eleganti, luminosi, di vasta capienza, lussuosamente arredati e decorati, appetibili per un pubblico non solo borghese ma anche ‘sceltissimo’, aristocratico. In alcuni casi il crogiolo sociale tipico dei cinematografi degli anni 1905-1910 lascia il posto a una divisione in settori piuttosto rigida, anche per prevenire incidenti di etichetta tra fasce sociali sempre più diverse. La riqualificazione delle sale dei centri cittadini implica anche una parziale normalizzazione dei comportamenti non consoni all’etichetta. Sulla scia dell’apertura del lussuoso Cinema Palace di Torino, un anonimo spettatore del 1912 coglie – sia pure scherzosamente – questa mutazione del comportamento sociale del pubblico e la progressiva smaterializzazione del corpo, rilevando come un tempo nessuno o pochi badavano alle cinematografie, tutti chiacchieravano, bevevano, ridevano, facevano all’amore con la suola delle scarpe, al più i ginocchi, ma null’altro […] E l’altra sera […] i pizzicotti brillavano per la loro assenza. I pizzicotti!… Ma non sapete che i pizzicotti sono il primo ingrediente di quello strano minestrone che è il cinematografo?40 Come si trasformano le modalità della ricezione femminile all’interno di queste mutazioni storiche dello spettacolo cinematografico? Per provare a dare una risposta si può partire da un nesso molto sentito nelle costruzioni discorsive sulla spettatrice nella
seconda metà degli anni Dieci: il nesso spettatrice/ consumo/divismo femminile. Quest’ultimo sembra essere infatti un fenomeno alimentato soprattutto dalle donne stesse. Il legame tra la spettatrice e la diva è più volte sottolineato nell’editoria di settore. Tito Alacci (Alacevich), per esempio, dedica un intero capitolo del suo volume Le nostre attrici cinematografiche studiate sullo schermo al rapporto che lega il pubblico femminile alle dive, partendo dalla constatazione, a suo avviso non più sorprendente, che “certe attrici devono la loro fama più al plauso delle donne che a quello degli uomini”41. Un riscontro più diretto di questo nesso, isolato ma significativo per la sua eccezionalità, è dato da un documento conservato negli archivi del Museo Nazionale del Cinema di Torino42: si tratta di due quaderni, datati 1915, dove una ragazza di Novara raccoglieva fogli pubblicitari e articoli ritagliati dalla stampa locale. Questi quaderni costituiscono una sorta di autobiografia per immagini di una giovane spettatrice degli anni Dieci: la maggioranza dei ritagli, infatti, è costituita da materiali di argomento cinematografico che la ragazza incollava sul quaderno come traccia di una sua visione in sala oppure di un suo desiderio di visione, per i film che non aveva potuto vedere. Un aspetto che colpisce, in quest’operazione di collage e nei brevi commenti che la ragazza scriveva a margine delle foto e degli articoli è la netta predilezione per le attrici, e in particolare per Diana Karenne e Maria Laetitia Celli (descritta, significativamente, come “una squisita espressione di femminilità”, ma anche “una donna eminentemente intellettuale”). Un altro dato interessante, proprio perché ‘contiguo’ a questa prevalenza iconografica delle dive, è l’attenzione che la ragazza riserva alle donne che stanno cercando di assumere un nuovo ruolo nella società durante la guerra: i quaderni ospitano fotografie di ragazzebagnino, crocerossine, volontarie, postine, poliziotte, ecc. L’universo maschile invece è emarginato, reso visibile non tanto nella sua versione cinematografica quanto piuttosto in quella pubblico-politica del potere: le sole immagini di uomini presenti nel quaderno sono ritratti monarchi, ufficiali, politici, alti ecclesiastici. Questo nesso tra la diva e il pubblico femminile è 279
una costruzione funzionale alla promozione del consumo. Il cinema del divismo femminile alimenta nelle donne un eccedente desiderio di consumare, costruisce identità sociali alternative per le spettatrici, incoraggia o inventa nuovi bisogni e nuovi desideri. La pubblicità stessa, sulle riviste cinematografiche e femminili, contribuisce a saldare il bene di consumo alla sua dimensione filmica43. Il cinema amplifica e potenzia, sul piano dell’intensità scopica e sul piano della base sociale della consumatrici, l’esperienza, tipica della borghesia femminile, del grande magazzino, e crea le premesse per un’autentica pedagogia del consumo di massa: Quante cose le ha insegnato [alla donna] il cinematografo – si legge per esempio, su Cinemagraf nel 1916 – innanzi tutto, l’eleganza, l’eleganza vera, ricca, sapiente; eleganza di vesti, di casa, d’arredi. Ella l’aveva indovinata da lontano, cercando di osservare dal loggione o dalla galleria le belle signore vestite o svestite nei palchi, osservando la messa in iscena di qualche commedia di Bernstein, sbirciando fra le porte socchiuse degli appartamenti dei quali non poteva varcar l’anticamera; adesso ella sa; al Cine ha imparato le belle stanze arredate, i salottini pompadour e i saloni da pranzo dai ricchi scuri mobili fiorentini in stile, gli angoli di veranda ornati di piante rampicanti e di porcellane danesi; sa valutare il prezzo d’una toilette, studia le pettinature più moderne, beve con gli occhi il bisogno della ricchezza e del buon gusto44.
Dopo la seconda metà degli anni Dieci, quindi, la costruzione discorsiva della spettatrice recepisce e rilancia modalità di ricezione che possono considerarsi come una sorta di trasformazione in chiave consumistica di quella modalità di fruizione selettiva, atemporale, sinestesica e cinetica, del dettaglio propria della spettatrice ‘eccessiva’. Accanto a queste modalità selettive, scollegate dalle logiche temporali del racconto, ve n’è però anche un’altra, più legata ai processi narrativi, all’azione dei personaggi, e quindi ai processi di identificazione. La spettatrice, pagando il biglietto, compra infatti anche un modello alternativo di esperienza. La necessità commerciale di alimentare modelli alternativi e irraggiungibili di esistenza amplifica un bisogno di evasione che la stampa di settore interpreta come 280
una sorta di bovarismo di massa. Sembra quasi che il cinema degli anni Dieci voglia proporre deliberatamente modelli aggressivi e per certi versi antagonisti di femminilità a uso e consumo dei processi di identificazione del pubblico femminile. La diva è un modello non tanto e non solo di eleganza e di ricchezza ma anche di supremazia sul genere maschile: Al cinematografo ci andava solamente la domenica sera quando si metteva il vestito nuovo e le calze di seta, perché era una ragazza onesta e fabbricava scatole di conserva […]. I biglietti da mille che nel suo cervello danzavano in ridda la danza dei… minuti, poiché, pensava, un minuto di posa ed ecco un bigliettone! Ah! Che cosa stupenda la cinematografia! Ma una grande, sconfinata melanconia la premeva nel ritorno verso casa, a braccetto del suo Nando, così rozzo e bestemmiatore, lei che si sentiva fremere nelle vene la passionalità bertiniana, la focosità lindiana-piniana e la perversione thedabariana… Ah! Poter un giorno diventare come quelle signore, così eleganti, belle, malvagie, che con un solo cenno fanno cadere ginocchioni gli uomini in frak, e dispongono di toilettes sfarzose e dell’automobile, quando c’è l’altro che paga… Capiva, Mariuccia che a fabbricare scatole di conserva ci si rovina le mani e la pelle si screpola. Perché lei, così bella e procace, la magnifica, come la chiamavano nel sobborgo, non poteva diventare almeno come le altre o giù di lì?45
La stessa domanda era stata posta sei anni prima, nel 1916, su un’altra rivista di settore: Che la spettatrice sia una piccola operaia dal dito punzecchiato dall’ago, o una travettina la cui clorosi guata dalla tastiera della macchina Remington, o una borghesuccia troppo modestamente maritata pei capricci del suo cervellino di farfalla avido di voli sfavillanti, il pensiero, sotto quelle grandi ciglia immobili, è uno solo: Perché lei e non io? 46
Questa proiezione della spettatrice in un universo immaginario non è quasi mai visto come un fenomeno positivo. Sono rare le osservazioni come quelle, per altro incredibilmente precoci, espresse da Giustino Ferri nel 1906: Una signorina accanto a me ha gli occhi pieni di lacrime e le labbra aperte al più dolce sorriso. Va
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
via, verosimiglianza! Che c’importa di te al cinematografo? Finché ci saranno a questo mondo anime tenere, signorine i cui occhi si empiano di lacrime a coteste trasposizioni grafiche del vecchio romanzo d’appendice, è inutile che tu brontoli, verosimiglianza! Purtroppo quella sensibile fanciulla ti ritroverà al canto della via e dovrà piegarsi alle leggi della vita che l’obbligano forse a passar dieci ore in un’amministrazione di commercio, al banco d’un negozio, nell’aridità delle cifre, nella monotonia di un ufficio di copiatura a macchina; ma lascia che per venti minuti, ogni tanto, ella si esalti e si creda in un mondo diverso nel quale i fiori aprono i loro calici per diffondere nell’aria piccole fate, nel quale le ingiustizie si riparano col solo incomodo del crepitio che scandisce lo svolgimento di una pellicola47.
Molto più frequentemente prevalgono invece le dichiarazioni di allarme: il desiderio di consumo non può essere prodotto in eccesso, così come la costruzione di identità sociali immaginarie. Le immagini di vite alternative devono essere disciplinate, perché l’impossibilità di vivere realmente una vita diversa provoca sofferenza e frustrazione, una dinamica particolarmente evidente proprio nelle spettatrici che seguono assiduamente il cinema delle dive, come sottolinea nel 1916 Anton Giulio Bragaglia: Poi che le signorinette avranno studiato per bene i gesti e le pose di Lyda Borelli si ravviveranno i capelli sulla fronte col noto gesto borelliano, guarderanno lontano lontano […] e la notte avranno visioni meravigliose e all’indomani, dopo aver vissuto una vita favolosa in cinematografici ambienti di lusso, considereranno amaramente il povero vestitino e il povero cappellino, i quali tutt’insieme, non varranno cinque dei cinquemila ‘asprits’ della acconciatura di Lyda Borelli; e, venuto il fidanzato, aspirante impiegato alle ferrovie, a 90 mensili – lo paragoneranno di certo al divino Visconte X, straordinariamente elegante, stupendamente ‘style’, magnificamente ricco e generoso… E ripenseranno alla etèra maliosissima per cui il visconte faceva delle inverosimili follie e spendeva delle colossali somme: e ricorderanno che, un tempo […] quella creatura felice era una modesta sartina solo perché dall’ago al milione non c’è che un passo, quello della compiacenza, anzi della seduzione… Le visioni di una vita fastosa, al-
legra, scialacquatrice: di una vita senza sofferenze, senza sacrifici, senza privazioni […] turba in ogni modo, dolorosamente: devia, impone delle nostalgie penose, dei desideri difficilmente raggiungibili col modesto lavoro, travia, corrompe48.
Un’identica preoccupazione è espressa dieci anni dopo, nel 1926: “La stessa visione del lusso, cui si dà tanta importanza dal pubblico femminile, è estremamente pericolosa, perché rappresenta un eccitamento a goderne e una tentazione a procurarselo in ogni modo”49.
Spettatrici sempre, in ogni dove… Dalla seconda metà degli anni Dieci, parallelamente all’emergere del fenomeno divistico, si assiste anche all’allargamento dell’esperienza spettatoriale al di fuori della sala. La spettatrice non è più soltanto colei che si reca al cinematografo per vedere un film, ma anche una donna che vuole conoscere in dettaglio il mondo del cinema e dei suoi divi. Hansen, studiando il caso americano e citando un precedente studio di Doane, sostiene che nel corso del “processo di allineamento della spettatorialità femminile a una gerarchia sessuale di visione”, l’industria del cinema propone al pubblico femminile un’offerta che si focalizza sull’“apparato discorsivo intorno al film più che sul film stesso”50, come ad esempio le riviste di cinema popolari per i fan. Un fenomeno del tutto analogo, malgrado la diversità di contesti, ha luogo anche in Italia, dove la stampa di settore svolge un ruolo ambivalente: da un lato, documentando e celebrando il fenomeno divistico, dà alle lettrici/spettatrici la sensazione che la distanza tra queste ultime e il mondo del cinema non sia poi così abissale; dall’altro lato, in realtà, gestisce questa distanza cercando di perimetrare la donna, i suoi bisogni, le sue aspettative, nei confini del suo ruolo di spettatrice e ammiratrice. Questa dinamica è molto chiara nelle rubriche della posta. I titolari delle rubriche di corrispondenza, tutti maschi, svolgono la funzione di regolatori dissuasivi nei confronti di questa forma di bovarismo novecentesco: la spettatrice deve stare rigorosamente al suo posto, il cinema visto da fuori è legittimo, mentre visto da 281
282
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
dentro è un mondo di approfittatori e libidinosi, capace di attentare alla stabilità della sfera pubblica borghese imperniata sull’ideologia della famiglia. Le risposte gestiscono questa funzione dissuasiva con toni di paternalistica sufficienza e superiorità, pronti a sfociare in dichiarazioni apertamente maschiliste. A una lettrice veneziana che si firma Scimmietta bianca, Luciano Doria per esempio risponde: “Se siate bianca non so, ma scimmia siete certamente. Solo le scimmie riescono ad essere più maligne delle donne”51. Doria è ancora più esplicito con una lettrice di Pitigliano: Io credo, con convinzione profonda, che un’anima di donna non possa mai nascere artisticamente perfetta. Le donne, perdonatemi la brutale sincerità, sono e resteranno sempre esseri inferiori: una specie di piccoli e graziosi insetti, parassiti di quelle enormi e superiori bestie che sono gli uomini52.
Dalle pagine di “Al Cinemà” gli fa eco un altro rubricista che si firma Cicerone: “Il maggior pregio di una donna è la bellezza, e una donna bella ha il dovere di studiare meno che può. Il troppo studio rovina la bellezza e rende pedanti”53. A volte le risposte assumono i toni di un confronto esplicitamente sessuale, goliardico e orgogliosamente maschilista. A tre lettrici che si firmano “bimbe fasciste”, sempre Cicerone risponde: “Spero che rinuncerete al proposito di una spedizione punitiva e che vi servirete del manganello per un uso vostro personale più intimo e più dilettevole… Tanto per allenarvi e badate che non sia troppo voluminoso…”54.
La buona spettatrice Se le costruzioni discorsive sul pubblico femminile fin qui analizzate mettono in evidenza una preoccupazione verso le criticità sociali potenzialmente implicate dall’esperienza filmica e rivelano il tentativo di interpretare queste criticità, può essere a questo punto produttivo interrogarsi sulla natura non solo delle denunce ma anche delle risposte prodotte da questi discorsi di mediazione. L’interrogativo da porsi potrebbe essere duplice, e complementare. Prima di tutto ci si può chiedere se esistono, nella stampa Lyda Borelli, una delle dive più amate dalle spettatrici degli anni Dieci
di settore, delle risposte costruttive, non solo critiche e allarmanti, in materia di modellizzazione del pubblico femminile: se esiste, in altri termini, un modello funzionante e legittimato, di ‘buona spettatrice’. In secondo luogo sarebbe interessante verificare invece l’esistenza di eventuali modelli difformi rispetto ai supposti canoni di comportamento della ‘buona spettatrice’, ma privi di quelle criticità che invece appartengono per intero ai modelli della spettatrice ‘eccessiva’. Per i portavoce più conservatori della sfera pubblica, uno dei modelli discorsivi di ‘buona spettatrice’ più convincenti è quello della madre di famiglia. Non si tratta solo di un modello ideale, perché a un certo punto diventa anche un ruolo normativo: dopo la riforma della censura, con il nuovo regolamento del 22 aprile 1920, le madri di famiglia entrano a far parte delle commissioni di revisione. La svolta riformatrice è importante: se fino a quel momento la censura era stata controllata da funzionari di polizia, ora si cerca di coinvolgere nella pratica censoria settori delle istituzioni (come la magistratura) e della società civile: è significativo, però, che alla donna si conceda l’esercizio di una funzione pubblica solo in ragione della sua appartenenza esclusiva alla sfera privata (il suo ruolo di madre in seno alla famiglia). La cooptazione della spettatrice all’interno dei dispositivi di controllo passa quindi attraverso la sua completa riduzione a fondamento del modello ideologico borghese, pienamente sostenuto anche dalla Chiesa55. Il concetto è ribadito con chiarezza da uno dei padri della riforma, il funzionario ministeriale Giuseppe Guadagnini: La donna-madre entrerebbe a rappresentare i fanciulli e i giovinetti pel compito sacro che è a lei da natura demandato di essere l’educatrice della prole nel seno della famiglia. I padri sono da mille cure distratti, le madri hanno una cura soltanto: i figli. Esse sono per eccellenza degli educatori principi, e riuniscono in sé, oltre la competenza generica comune a tutte le altre donne, quella specifica tecnica che occorre a giudicare nella censura. La donnamadre sarebbe nel suo ufficio l’interprete dell’anima femminile e dell’anima del fanciullo e integrerebbe con le sue delicatezze e sfumature, con le sue doti 283
di grazia e di sentimento la più robusta e più rude concezione maschile, che, per quanto comprensiva, non può tutto abbracciare e tutto sentire, specialmente di fronte a spettacoli che generalmente hanno una maggioranza di spettatori costituita da donne e da fanciulli56.
Al di là del modello, si potrebbe dire ‘militante’, della ‘madre di famiglia’, nelle costruzioni discorsive sulla spettatrice prende vita anche un’altra forma di modellizzazione del buon consumo femminile di massa. La matrice del modello è già nel più volte citato romanzo di Fabbri del 1906. Nella sala cinematografica di Fabbri non ci sono mai donne sole: la spettatrice perfetta è quella che entra in sala al fianco di un uomo, sia questi un marito oppure, ancora meglio, il padre, o il padrone (come nel caso della “servotta” evocata da Fabbri). La buona spettatrice del romanzo di Fabbri è Olga, la figlia del professore, che assiste alle proiezioni sotto la vigile guida del padre. Di lei si innamora il protagonista, Gastone Fedi, che “scorge in quel viso ovale di madonna, in quegli occhi purissimi celesti, dall’umido languore di commozione estrema, in quella bocca sospirosamente socchiusa, e dalle brevi e rosee labbra tremolanti, tutta una santa promessa di anima candida, immacolata, un’intera manifestazione di cuore eccezionale, purissimo, e tutto inteso a nobili palpiti”57. Siamo agli antipodi delle adultere e delle isteriche, ma lo stereotipo è forse ancora più evidente.
Prove di libertà A questi ultimi modelli propositivi ma votati al controllo e al disciplinamento del pubblico femminile, si possono contrapporre o affiancare altre costruzioni discorsive, in verità assai più marginali, che invece riconoscono alla spettatrice il diritto a una relativa autonomia. La solitudine dello spettatore, rafforzata nell’anonima coralità del pubblico, e il suo contrario (ovvero la promiscuità), il suo mascherarsi che è quasi un nascondersi, e il suo contrario (l’esibizione più o meno involontaria del corpo), l’indebolimento dei legami tradizionali: tutto ciò è interpretato in alcuni interventi non come un fattore critico o una 284
negativa esperienza di smarrimento e abbandono. La dialettica tra individuale e collettivo, snodo cruciale dell’esperienza novecentesca, può esprimersi al cinema anche come una feconda opportunità di emancipazione, soprattutto per le donne. Nel 1916, Emilio Scaglione, giornalista di talento ma anche convinto democratico, in un intervento di grande (e isolata) acutezza psicologica e sociologica rileva come grazie all’oscurità del cinematografo la donna possa liberarsi dalla tutela obbligata del padre o del consorte, restando finalmente sola con sé stessa: Il cinematografo, dimostrando alle donne che si può rimanere al buio, a pochi centimetri da uomini non consanguinei, senza per questo dover svenire di paura, contribuisce all’educazione morale in provincia, irrobustisce la coscienza dei propri doveri, tempra i caratteri […]. Il cinematografo può essere considerato come una conquista del femminismo.
Nello spazio indistinto della sala buia, precisa meglio Scaglione, la donna non nega la sua identità, non scompare nell’anonimato. Al contrario, diventa un soggetto finalmente attivo e consapevole: una spettatrice può scegliere, con la relativa indipendenza del corpo e dei sensi, se e come rendersi disponibile all’interazione con gli altri spettatori. Secondo l’autore questa possibilità di scelta restituirebbe alla donna l’autonomia della sue scelte morali, di solito frutto di imposizioni esterne: Mi pare che il cinematografo tolga le nostre donne dalla campana di cristallo nella cui aria viziata chi ne ha diritto le tiene abitualmente e le restituisca, sia pure per un’ora, en plein air. Esso dà loro improvvisamente la sensazione che possono anche essere riservate e fedeli per elezione o sia pure per capriccio, quando invece debbono di solito esserlo per forza. […] In ogni modo il cinematografo in provincia mette la donna a discrezione di sé stessa. Le dà facoltà di scelta, sviluppa il suo senso d’iniziativa. Questo io chiamo educazione morale58. Scaglione, peraltro, valuta in termini positivi la promiscuità sessuale del cinematografo: a suo avviso la vicinanza tra uomini e donne contribuirebbe, soprattuto nelle province, a creare occasioni di in-
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
contro e di conoscenza normalmente precluse, a incoraggiare momenti di vera e propria educazione sentimentale, senza che questi degenerino necessariamente in violazioni dell’etichetta: In provincia due persone di sesso differente che non siano padre e figlia, fratello o sorella, zia e nipote, cugini e almeno cognati, quante volte possono vedersi da vicino? La provincia non ha i vostri mezzi termini: o consanguineo, o marito, o fidanzato ufficiale, o niente. In altre condizioni, ammirarsi a bell’agio è quasi impossibile. Discorrere è assurdo. Una stretta di mano? Favole. Un bacio? Miti […]. Che bouleversement, immaginate! Due che non avrebbero mai potuto varcare i dieci metri che dal balcone alla via s’interpolavano tra i loro desideri, si sentono ora a pochi millimetri, tanto pochi che è persino possibile scambiarsi reciprocamente, e per un’oretta, il calore d’un ginocchio e di un gomito. E questo può ripetersi per sere e sere giacché il tenue costo dei biglietti non esulcera, come a teatro, la suscettibilità paterna. Inoltrando l’ora, le petit si fa più vicino, più insistente, più accorato; la petite trema, trasalisce, si confonde […] il suo primo orgasmo di donna a contatto con un uomo, gl’intimi suoi rossori di vergine, la paura che i suoi, seduti dall’altra parte, la sorprendano; questa folla di sentimenti differenti lei scambia per amore, per un amore infinito, straziante, che la mette fuor di sé verso l’uomo che le è al fianco59.
Le aperture di Scaglione lascerebbero allora intravedere la possibile liceità di un incontro amoroso, di una presa di contatto tra uomo e donna, nel buio delle sale cinematografiche, un’ipotesi di relazione che vada oltre le divertite condanne moralistiche della ricca letteratura dei ‘pizzicotti’. Resta tuttavia il problema – implicato tra le righe anche dallo stesso Scaglione – di una regolazione comportamentale di queste eventuali revisioni della tradizionale etichetta, il bisogno di un controllo sociale, la ricerca di nuove conformità in un rituale di comportamento assolutamente moderno. Un ulteriore e diverso rovesciamento degli stereotipi negativi o disciplinati relativi all’immagine pubblica della spettatrice lo si individua, sulla stampa di settore, in due racconti, piuttosto simili ma firmati da autori diversi (l’appena ricordato Scaglione e Camil-
lo Bruto Bonzi60) e a dieci anni di distanza (il primo è del 1916, il secondo risale invece al 1925). In questi due casi prende vita un modello di spettatrice fortemente attiva, capace di produrre, a sua volta, emozioni artificiali, proprio come il cinema, in una prospettiva che capovolge e smentisce lo stereotipo della spettatrice passiva e isterica. Dai due racconti traspare il segnale evidente che dalla seconda metà degli anni Dieci la spettatrice sta assumendo un ruolo via via più consapevole in un dispositivo della visione collettiva sempre più istituzionalizzato. Nel racconto di Bonzi, Chiarino Chiarini, un attore giovane ma già celebre, si reca in un cinema per vedere un suo film, e si siede vicino a una ragazza sola che scatena in lui un desiderio sessuale incontenibile: “egli immaginò quel giovane corpicino spasimante di piacere, stretto tra le sue braccia. Ebbe un fremito delizioso”. I due iniziano a parlarsi, lei gli dà confidenza, e gli rivela di essersi emozionata troppo all’ultimo film dell’attore e di essere persino svenuta. Poi inizia la proiezione, e la “bionda vaga spettatrice” erompe “in singhiozzi soffocati”. Chiarino, sempre più eccitato, intravede “i piccoli e rotondi seni sollevarsi in un grande sospiro d’angoscia”. A un certo punto il pianto della ragazza diventa contagioso, si allarga agli spettatori seduti nelle “poltrone vicine, davanti e di dietro, di fianco”. Di fronte alla più prevedibile e ingenua delle reazioni femminili, Chiarino si sente autorizzato a rassicurare la ragazza, prima con la stessa persuasione intellettuale attuata dal professore quasi vent’anni prima nel romanzo di Fabbri (“Per carità signorina, non pianga così! […] Si tratta di una finzione scenica!”), poi con una rassicurazione più fisica: Chiarino allungò il braccio sopra la spalliera della poltrona […]. Egli chiuse gli occhi, assaporando quel tepore di carne profumata e palpitante. Poi le prese una mano, le baciò le punta delle dita, ad una ad una. La dolente lasciò fare anche questa volta… Chiarino allora le baciò il polso e con l’altra mano premette uno dei seni rotondi e solidi.
Dopo la fine del film e le luci in sala, la ragazza si congeda, e solo dopo l’attore viene a sapere che la spettatrice in lacrime non era altro che una ragazza assunta dal proprietario del cinema per piangere, 285
“cioè per trascinare il pubblico, per guidarlo”, assicurando così il successo del film. La spettatrice pagata per piangere diventa quasi la metafora narrativa di un cinema istituzionale che programma e controlla a monte le strategie del coinvolgimento emotivo: la stagione dell’ingovernabile performance del corpo isterico all’interno della sala sembra ormai definitivamente tramontata. La stessa idea narrativa, come si è detto, era stata anticipata da Emilio Scaglione nel 1916: in questo caso, addirittura, la spettatrice pagata per piangere non rappresentava un caso isolato, ma era solo la pedina di un’organizzazione ben più vasta: l’Itala Film aveva infatti disseminato per l’Italia una trentina di ragazze trasformandole in réclame della sua produzione, dopo un periodo di formazione. Ciascuna si specializza per conto suo – scrive Scaglione – e segue i suoi metodi. C’è chi ha ingegno e c’è chi è bella. Tutto si mette a frutto. La sola cosa necessaria è avere intuito, calcolar bene, non perdere tempo; non innamorarsi, soprattutto. Questa è una specifica clausola del contratto con la casa. Non si deve amare che il cinematografo61.
Quest’ultima immagine è forse il modello più estremo e moderno tra tutti quelli prodotti dall’immaginazione maschile borghese: una donna che da creatura isterica diventa prima soggetto e poi medium di consumo, attrice della realtà capace di superare per bravura l’attore della finzione. Da donna oggetto del desiderio calato più o meno a forza in uno spazio di relazioni problematiche e turbative con l’altro sesso, la spettatrice diventa soggetto desiderante, votato però al solo desiderio del cinema, sguardo solitario e alieno a qualsiasi amore che non sia compreso nell’esperienza del film.
286
20 / La spettatrice muta / Silvio Alovisio
Note
1 Cfr. Francesco Casetti, Elena Mosconi (a cura di), Spettatori italiani: riti e ambienti del consumo cinematografico (1900-1950), Carocci, Roma 2006; Francesco Casetti, Silvio Alovisio, Lo spettatore disciplinato. Regole di etichetta, di morale e di igiene nella fruizione filmica dei primi tempi, in Michele Canosa, Giulia Carluccio (a cura di), Storia del cinema italiano, vol. 2, Marsilio, Venezia, in corso di stampa; Luca Mazzei, Amor de terra loidana: appunti su metamorfosi e visione cinematografica nei racconti degli spettatori italiani 1906-1914, in Alice Autelitano, Valentina Re (a cura di), Il racconto del film. La novellizzazione: dal catalogo al trailer, Forum, Udine 2006, pp. 427-438; Luca Giuliani, “Magnifico l’effetto corrida”. Stampa e pubblico alle origini del cinema in Italia, in Aldo Bernardini (a cura di), Storia del cinema italiano, vol. 1, Marsilio, Venezia, in corso di stampa.
Per un approfondimento problematico di queste dinamiche alla luce della storia socio-economica del cinema muto si rinvia naturalmente a Miriam Hansen, Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Film, Harvard University Press, Cambridge 1991 (tr. it. Babele & Babilonia. Il cinema muto americano e il suo spettatore, Kaplan, Torino 2006).
2
3 Joan B. Landes, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Cornell University Press, Ithaca 1982, p. 3 (cit. in Miriam Hansen, Babele & Babilonia, cit., p. 22).
Si legge per esempio nel 1908: “Ecco, quand’è già notte, un gruppo di sartine graziose e dall’aria birichina che invadono la sala d’aspetto col naso in aria, fra squilli di riso” (Il pubblico del cinematografo, “La Rivista fono-cinematografica”, n. 11, febbraio 1908, ora in AA.VV, Tra una film e l’altra. Materiali sul cinema muto italiano 1907-1920, Marsilio, Venezia 1980, p. 44).
4
Cit. in Piero Pesce-Maineri, I pericoli sociali del cinematografo, Lattes, Torino-Genova 1922, p. 22.
5
Già nel 1908 c’è chi critica “i discorsi di quegli idioti che si nascondono sotto il nome di intellettuali’ [che] giudicano questo [il cinema] il sollazzo delle cameriere educate” (T. Panteo, Il cinematografo, “La Scena illustrata”, n. 19, 1 ottobre 1908, ora in Aldo Bernardini, Cinema muto italiano, vol. 1, Laterza, Bari-Roma 1981, p. 235).
6
Paulette, La follia del cinematografo, “Scena Illustrata”, n. 4, 15 luglio 1907, (ora in Aldo Bernardini, Cinema muto italiano, vol. 2, cit., p. 232)
7
8 Bortolo Belotti, La questione del cinematografo, “Nuova Antologia”, p. 196, 1 agosto 1918 (poi in Bortolo Belotti, Politica del costume, Unitas, Milano 1924).
Cfr. Francesco Casetti, Silvio Alovisio, Il contributo della Chiesa alla moralizzazione degli spazi pubblici, in Ruggero Eugeni, Dario E. Viganò (a cura di), Attraverso lo schermo.
Cinema e cultura cattolica in Italia, vol. 1, Dalle origini agli anni Venti, Ente dello Spettacolo, Roma 2006, pp. 97-127. 10
Miriam Hansen, Babele & Babilonia, cit., p. 68.
Il cinematografo che ci meritiamo, “L’Illustrazione cinematografica”, n. 12, 5-10 luglio 1912, p. 669. 11
12 Le tecniche di coinvolgimento del pubblico femminile prevedevano anche modalità di interpellazione diretta. Nella primavera del 1923 “Al Cinemà” propone addirittura un concorso di bellezza per eleggere la reginetta della rivista, destinato “indistintamente a tutte le lettrici, abbonate o non, del nostro periodico”. Alle lettrici la redazione richiede l’invio della loro “effigie smagliante di giovinezza e di conturbante soavità”. (Cfr. Alla ricerca di una reginetta per Al Cinemà, n. 21, 27 maggio 1923, pp. 6-7). 13 Ancora nell’aprile 1920 su “La Vita cinematografica” la presenza di una firma femminile era così insolita da giustificare un occhiello sopra il titolo con la scritta pomposa “La parola alla donna”. 14 B. Galaragi [Anton Giulio Bragaglia], L’opera deleteria del cinematografo sulla morale delle folle e il mondo cinematografico intimo, “Cronache d’Attualità”, n. 2, 31 maggio 1916, p. 9. 15
Bortolo Belotti, Politica del costume, cit., p. 29.
Piero Pesce-Maineri, I pericoli sociali del cinematografo, cit., p. 40. 16
17
Piero Pesce-Maineri, op. cit., p. 126.
Gualtiero I. Fabbri, Al cinematografo, P. Tonini, Milano 1907 (poi Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1993). 18
Dopo la fine di un film in cui una donna muore tormentata dai sensi di colpa per non aver badato al figlio, che è morto cadendo dalla finestra, il professore sentenzia: “È doloroso, è straziante anzi, ma questo insegna a delle madri, che di madre hanno solo il nome, quale sia e debba essere il vero sentimento materno, colle sue forze incalcolabili di affetto, di entusiasmo, di frenesia” (Gualtiero I. Fabbri, op. cit., p. 57). 19
20 Cfr. Cinematografo e moralità pubblica, “Civiltà cattolica”, n. 1546, 21 novembre 1914, pp. 421-440. 21
Tullio Panteo, Il cinematografo, cit., p. 236.
Pitigrilli, La tecnica dell’infedeltà, “In penombra”, giugno 1919, p. 11. 22
23 Riccardo Artuffo, Io difendo la censura, “La Vita cinematografica”, numero speciale, dicembre 1918, p. 81. 24
Riccardo Artuffo, op. cit., p. 80.
25
Ibidem.
26
Riccardo Artuffo, op. cit.
9
287
27 Pasqualazio, La signora del cinematografo, “Cinema-star”, n. 1, 9 gennaio 1927, p. 2 28
Ibidem.
45 Adolfo Sarti, Cinque lire, “Al Cinemà”, n. 1, 25 giugno 1922, p. 10. 46
Haydée, op. cit., p. 3.
29
Irma F., I cappelli delle signore, “La Cine-fono e la Rivista fono-cinematografica”, n. 106, 23 aprile 1910 (ora anche in “Immagine”, n. 1, 1981, p. 27).
G. Ferri, Tra le quinte del cinematografo, “La Lettura”, n. 10, ottobre 1906 (poi in “Cinema/Studio”, n. 14-16, apriledicembre 1994, pp. 9-15).
30 Sopra alcuni particolari effetti delle projezioni cinematografiche nei nevrotici, “Rivista italiana di neuropatologia, psichiatria ed elettroterapia”, 10 ottobre 1911, p. 434 (ora anche in “Bianco e Nero”, n. 550, 2004).
48
31 Jarro, Un delitto in un baule, in Id., Le novelle del cinematografo, Bemporad, Roma 1911, p. 10. 32
Gualtiero I. Fabbri, op. cit., p. 47.
33 Nel descrivere la dimensione interclassista del nuovo pubblico cinematografico, Fabbri, per esempio, si affretta subito a precisare che anche se “ve n’erano per tutti i gusti e di tutte le tinte […] l’elemento signorile e quello borghese avevano il sopravvento”. Fabbri dipinge con tratti molto positivi “le madri di famiglia” (che, lo vedremo, saranno una presenza ricorrente nelle costruzioni discorsive sul pubblico femminile): esse sono descritte come “elegantissime signore […] buone malgrado la ricchezza”. Molto più ironica è invece la descrizione delle popolane, “ragazzine di modiste, petulantissime e dal chiacchericcio vivace” (cfr. Gualtiero I. Fabbri, op. cit., p. 43-44). 34 Emilio Scaglione, Le signorine del cinematografo, “L’Arte muta”, n. 2, 15 luglio 1916, p. 37.
Il pubblico del cinematografo, “Films Pittaluga”, n. 5-6, 15 maggio-15 giugno 1925, p. 102. 35
Grog., Gli ‘habitués’, ovvero Come ti illustro il pubblico, “Al Cinemà”, n. 43, 23 ottobre 1927, p. 5. 36
37
Cfr. nota 30.
Emilie Altenloh, Zur Sociologie des Kino: die Kino-Unternehmung und die sozialen Schichten ihrer Besucher, Diederichs, Iena 1914 (il testo è consultabile on line: http://gallica. bnf.fr/ark:/12148/bpt6k941691). 38
39
Cfr. Miriam Hansen, Babele & Babilonia, cit., p. 115.
40 Un pizzicottaro, “La Cinematografia italiana ed estera”, n. 125, 1912, p. 1927.
Tito Alacci (Alacevich), Le nostre attrici cinematografiche studiate sullo schermo, Bemporad, Firenze 1919. 41
42
Archivio del Museo Nazionale del Cinema, A327/29.
Solo un esempio tra i tanti possibili: “Offriamo alle nostre gentili lettrici alcuni modelli di pellicce appositamente creati dalla ditta nobili di Torino per la giovane e affascinante attrice Bianca Maria Hubner” (“Al Cinemà”, n. 18, 2 dicembre 1922, p. 10). 43
44 Haydée, La donna e il cinematografo, “Cinemagraf”, n. 4, 25 marzo 1916, p. 3.
288
47
B. Galaragi (Anton Giulio Bragaglia), op. cit., p. 9.
Lorenzo Dalmasso, Teatro e cinematografo (1926), in Tre questioni vitali per la pubblica moralità, Fratelli Bocca, Torino 1928, p. 28. 49
50
Miriam Hansen, Babele & Babilonia, cit., p. 114.
L. Doria, Bric à brac, “Romanzo-film”, n. 5, 26 febbraio 1921, p. 38. 51
52
Ibidem.
Che ne dice lei?. “Al Cinemà”, n. 48, 30 novembre 1924, p. 2. 53
Che ne dice lei?, “Al Cinemà”, n. 25, 20 giugno 1924, p. 15. 54
55 In una lettera della Segreteria di Stato della Santa Sede – datata 9 agosto 1922 – si plaude al fatto che è stato consentito alle donne e alle giovani cattoliche italiane di “insinuarsi nelle commissioni di revisione per la moralità dei teatri e delle films cinematografiche”; cfr. Enrico Baragli (a cura di), Cinema cattolico: documenti della Santa Sede sul cinema, Edizioni “La civiltà cattolica”, Roma 1958, p. 42.
Giuseppe Gudagnini, La censura degli spettacoli cinematografici, Tipografia del Ministero, Roma 1918, p. 46. 56
57
Gualtiero I. Fabbri, op. cit., p. 52.
Emilio Scaglione, Il cinematografo in provincia, “L’Arte muta”, n. 6-7, dicembre 1916-gennaio 1917, p. 14 (il testo è consultabile on line, anche in versione inglese, sul sito del Permanent Seminar of History of Film Theories, http://www.museocinema.it/filmtheories).
58
59
Emilio Scaglione, op. cit., p. 15.
Emilio Scaglione, Le signorine del cinema, cit., pp. 37-42: Camillo Bruto Bonzi, La signorina del cinematografo, “Al cinemà”, n. 38, 20 settembre 1925, pp. 3-4. 60
61
Emilio Scaglione, Le signorine del cinema, cit., p. 42.
PARTE SETTIMA
OLTRE LE FORMULE DI GENERE
21 / Claudia Gianetto
Gigetta Morano, una forza irresistibile
Una carriera all’Ambrosio Film di Torino L’attrice Gigetta Morano (Luigia Maria Morano, nata a Verona il 2 agosto 1887 e morta a Torino il 9 ottobre 1986)1 vive a Torino, nubile, sino quasi a raggiungere l’età di cento anni. La sua carriera cinematografica è interamente ed esclusivamente2 legata alla Società Anonima Ambrosio, la prima, e con l’Itala Film la più grande, Casa di produzione torinese3, per la quale interpreta più di centocinquanta film tra il 1909 e il 1920. Di questo corpus, in cui trovano posto titoli appartenenti a svariati generi narrativi del cinema italiano degli anni Dieci, è nota a oggi l’esistenza di trenta opere, conservate in archivi italiani e stranieri4. Con versatilità Gigetta Morano prende parte alle più importanti produzioni storiche e drammatiche della Casa, al fianco di divi dell’epoca come Mary Cléo Tarlarini, Alberto A. Capozzi, Mario Voller Buzzi ed Elena Makowska. Eccola infatti far capolino – nel ruolo di ancella, vivandiera o cortigiana – in Didone abbandonata (1910), La figlia di Jorio (1911), Giuda (1911), Il Granatiere Roland (1911), Sogno di un tramonto d’autunno (1911). Tra i film drammatici, la Morano ama molto ricordare i due film interpretati con l’attore teatrale Ermete Novelli, che considera suo maestro, Michele Perrin (1913)
e La gerla di Papà Martin (1914), entrambi diretti da Eleuterio Rodolfi. Sono numerosi i titoli della prestigiosa “Serie d’oro” dell’Ambrosio che la Morano interpreta come protagonista, vestendo i panni della regina Tamari o quelli della prima Lucia dello schermo; tra questi Il segreto del gobbo (1910), La regina di Ninive (1911), Salambò (1911), I promessi sposi (1913) e La trovata del brasiliano (1913)5. Al di là del sodalizio con Rodolfi, lavora con importanti registi come Luigi Maggi e Mario Caserini, ma anche con Carlo Campogalliani ed eccezionalmente con Febo Mari. È proprio Luigi Maggi a metterla in contatto con Arturo Ambrosio e l’ancora sconosciuto mondo del cinema; la Morano descrive in più occasioni l’inizio della sua carriera di attrice: Fu Luigi Maggi a farmi assumere. Prima lavoravo in teatro. A 17 anni avevo lasciato la mia famiglia per unirmi alla Compagnia del grande Ermete Novelli. Ebbene, un giorno Maggi mi incontrò in un momento di riposo della trournée e mi disse: - C’è una cosa nuova -. Mi accompagnò alla barriera di Nizza, dove Ambrosio aveva una casa rustica con molto terreno, sul quale aveva costruito il suo primo teatro di posa6. Fui assunta e cominciai a girare brevi comiche in 291
coppia con Robinet. La prima si intitolava Un signore che soffre il solletico7 e io facevo la parte di una donnina di strada che avvicina un uomo su una panchina del Valentino.8
Il temperamento e le abilità sportive permettono all’attrice di cimentarsi in film d’azione o noir come La nave dei leoni (1912), dove interpreta la domatrice Jeannette, o La figlia del ghigliottinato, terzo episodio di Il fiacre n. 13 (1917). Proprio per portare a termine le riprese di quest’ultimo film, in pieno gennaio la Morano non esita a gettarsi nella Dora, uno dei fiumi che attraversano Torino9. Per La leggenda della Croce (1910)10, che narra della tragica e popolare vicenda legata alla Torre della Bell’Alda, le riprese sono realizzate in esterni dal vero e l’attrice accetta di lanciarsi nel vuoto cadendo in una rete, impresa che le costa qualche giorno di forti dolori e difficoltà nei movimenti. Come in più occasioni ama sottolineare – e lo fa sempre usando il presente storico, che rispettosamente mantengo – è piuttosto abile in differenti discipline: sa andare in bicicletta, a cavallo, sa nuotare, impara la boxe e all’inizio degli anni Venti ottiene la patente per guidare l’automobile. Gigetta Morano non ricorre mai a controfigure, offrendosi invece lei stessa per sostituire altre attrici in scene spericolate o pericolose; unico aiuto per alcune di queste imprese, due manichini con sembianze femminili e maschili11. Gigetta si specializza nel genere comico e brillante lavorando non solo, come già accennato, con Marcel Fabre in alcuni film della serie Robinet12 e con altri comici della Casa come i fratelli Ercole ed Ernesto Vaser, ma soprattutto collaborando con l’attore e regista Eleuterio Rodolfi, figura eclettica e misteriosa. Del lavoro con Fabre, uno dei frutti migliori resta sicuramente il delizioso e malizioso Robinet innamorato di una chanteuse (1911), dove l’elegante Robinet, ostinato corteggiatore e intraprendente voyeur, si vede respinto dalla bella ma nient’affatto disponibile cantante. La sua collaborazione con l’attore francese – del quale ricorda la sicurezza e l’abilità nell’improvvisazione – s’interrompe bruscamente per l’entrata in scena di una seconda attrice, Nilde Baracchi, che vuole l’esclusiva a fianco del grande comico e l’ottiene, dando vita al personaggio 292
di Robinette. Ecco quanto accade sul set dell’ultimo film della Morano con Fabre, Robinet troppo amato da sua moglie (1912): A volte saltavano fuori anche scene impreviste come è successo in un’altra comica dove io dovevo interpretare il ruolo di una moglie mite e sottomessa che sorprende il marito con un’altra donna. Io dovevo reagire con dei timidi rimproveri ma l’attrice che svolgeva la parte dell’amante non mi poteva soffrire e ha approfittato della situazione per darmi uno schiaffo. Allora io non ci ho visto più e, lasciando da parte la sottomissione, le sono saltata addosso e abbiamo cominciato a darcele di santa ragione: lei mi tirava per le trecce e io le sferravo dei calci come una mitragliatrice. L’operatore riprese tutta la scena e la comica ebbe un grande successo per il suo realismo13.
Gigetta Morano ed Eleuterio Rodolfi danno vita insieme alla coppia Gigetta e Rodolfi, personaggi protagonisti di una nuova e autonoma serie di storie divertenti e piccanti; il loro sodalizio non si esaurisce nella rigida formula del cortometraggio e anzi segna il graduale passaggio dalla comica breve alla commedia di media e lunga durata. Dai primi anni Dieci Gigetta conquista e mantiene incontrastata – con interpretazioni che hanno un enorme successo di pubblico e di critica come Santarellina (1912), ispirato all’operetta di Hervé Mam’zelle Nitouche), La bisbetica domata (1913), Le nozze di Figaro (1913) e La meridiana del convento (1916) – il titolo di prima attrice comica e brillante del cinema italiano. Definita da alcuni “la Mary Pickford italiana”14, dà vita a molti famosi personaggi letterari e teatrali ma soprattutto – con uno stile personalissimo che si discosta dai canoni del grande divismo dell’epoca – costruisce una galleria di nuovi personaggi, non rifiutando l’interpretazione di personaggi maschili come in Preferisco l’inferno (1916), dove è sia Gigetta sia Asmodeo, figlio del diavolo inviato in missione sulla terra15. I suoi personaggi più riusciti sono forse quelli dei film ambientati in epoca moderna, nei quali Gigetta Morano, con grazia ma anche con un’energia che l’affranca da connotazioni sessuali riduttive, incarna figure femminili della piccola o media borghesia, capaci di libero e consapevole (talvolta anche sfac-
21 / Gigetta Morano / Claudia Gianetto
ciato) arbitrio e che spesso esercitano professioni di appannaggio prettamente maschile. La produzione meno nota può dunque riservare piacevoli sorprese: in Che paese allegro! (1913)16, Gigetta accetta da Rodolfi un invito per un convegno amoroso evidentemente al di fuori dei regolari schemi coniugali. Di fronte agli eventi che impediscono ai due di ritrovarsi soli in intimità, la donna non fa mistero di desiderio e delusione, mentre il labiale del personaggio che li costringe a dormire separati recita: “La morale!”... In Forza irresistibile (1913)17, Gigetta veste i panni di una seria avvocata coadiuvata da numerose assistenti, talmente presa dal lavoro da non avere alcuna intenzione di dare spazio a un appassionato corteggiatore come Rodolfi. Gli equilibri uomo-donna sono capovolti e in realtà non si ristabiliscono in un ordine costituito nemmeno nel lieto fine, quando l’avvocata, costretta ad assumere la difesa del corteggiatore, cede alle sue avances: l’insistenza di Rodolfi può aprire una breccia, ma non allontanare Gigetta dal suo ruolo e dalle appassionate arringhe.
Memorie di un’attrice giovane L’impressione, a distanza, è che ogni qualvolta il mondo del cinema si ricorda di lei, Gigetta Morano è pronta a entrare in scena. A dispetto di decenni di inattività. La Morano abbandona definitivamente il cinema nel 1920, quando il fallimento delle Case torinesi pare definitivo e lo stesso Arturo Ambrosio è ormai pronto a lasciare Torino per la capitale. Solo a distanza di molti anni l’attrice torna sul grande schermo, chiamata da Federico Fellini, che nel 1953 la vuole nel ruolo della madre di Alberto Sordi in I vitelloni. Interpreta poi piccole parti nel 1961 in La spada della vendetta e La corona di fuoco, entrambi diretti da Luigi De Marchi, nel 1963 in Otto e mezzo (dove, com’è noto, compare anche Ferdinand Guillaume, in arte Polidor) e nel 1964 nell’episodio Caccia al tesoro di I quattro tassisti di Giorgio Bianchi. Quanto a I vitelloni, ricorda con un po’ di sgomento questo ruolo finalmente di madre (lei che è stata sempre, sia in teatro sia al cinema, solo ed esclusivamente ‘attrice giovane’), ma madre di uno spo-
Gigetta Morano negli studi della Società Anonima Ambrosio di Torino (Museo Nazionale del Cinema)
stato che torna a casa ubriaco e di una figlia che scappa… Anche se c’è almeno un’attrice del sonoro che ammira e della quale sente che avrebbe potuto interpretare i ruoli, Monica Vitti18, Gigetta decide che il cinema non fa più per lei: Era troppo faticoso, così ho lasciato. Non era come essere all’Ambrosio Film. Cinecittà non è una Casa di produzione: lì, il lavoro bisogna andare a cercarselo. E quelli che non ti pagano? Le dico solo questo: non ho mica preso i soldi tanto facilmente quella volta. Mi dovevano ancora 50 mila lire; ma io, sa, non sono stupida. Sono andata all’ufficio produzione e ho detto all’impiegato: “Me ne vado solo quando mi avrà dato quello che mi spetta”. Ho avuto i miei soldi, ma lo sa che cosa hanno scritto sul registro degli 293
attori? “Bisogna pagarla subito”. Non mi sono offesa per niente. All’Ambrosio, invece, ero pagata tutti i mesi. In più ricevevo una percentuale sui film che uscivano con il mio nome. Così, succedeva a volte che Ambrosio mi dicesse: - Gigetta, questo mese ha guadagnato più di me - perché anche lui era uno stipendiato della Società Anonima19.
Recentemente, ho raccolto la testimonianza di Costantino e Alessandro Morano, che ricordano la prozia con un misto di commosso affetto e di ammirata curiosità. È stata in parte un mistero per la sua stessa famiglia, dalla quale dopo la sua fuga per “fare il teatro” rimane sempre lontana: appare nelle grandi occasioni, bella e trasgressiva a ogni età, per poi tornare alla sua vita sulla quale trapelano poche indiscrezioni. Gigetta Morano proviene da una famiglia tradizionale cattolica: il padre è un ufficiale veterinario della cavalleria dei Savoia, la sorella è suora e scompare tragicamente nel terremoto di Messina del 1908, mentre il fratello è imprenditore. Costantino ricorda un’ultima visita poco prima della morte: Gigetta Morano chiede ai suoi nipoti due giorni di tempo prima dell’incontro e poi li accoglie, radiosa e impeccabile, con una bottiglia di champagne nella sua residenza per artisti. E ancora in quell’occasione lamenta che le foto pubblicate sugli articoli dei quotidiani non le rendono affatto merito... Gli articoli che l’attrice ha puntigliosamente raccolto e poi donato all’amica Maria Adriana Prolo, fondatrice del Museo Nazionale del Cinema di Torino, sono oggi parte della ricca collezione di ritagli conservati dalla Biblioteca del Museo20. Vittorio Martinelli21, che ha incontrato l’attrice all’inizio degli anni Ottanta, aggiunge un dettaglio che connota in modo forte queste due pioniere: entrambe anziane s’incontrano nelle sale del Museo a Palazzo Chiablese e, messo su un disco, si ritrovano a ballare insieme il cancan. Un’immagine incancellabile. Poco prima della morte, la Morano accetta non solo di incontrare storici e studiosi, ma anche, in due diverse occasioni, di essere ripresa nel ricovero dove vive ritirata da anni, sulla collina torinese: testimonianze rare, quasi eccezionali, di una protagonista del cinema dell’inizio del secolo scorso, passata indenne attraverso due guerre mondiali e, a suo modo, oltre l’oblio del mondo dello spettacolo. Il primo videodocumento è l’intervista realizzata da 294
Gianni Rondolino nel 1980, della quale ho già citato alcuni passaggi, mentre le ultime immagini a noi giunte di Gigetta Morano sono quelle dell’intervista realizzata da Alberto Farassino nel 1985, in occasione della grande retrospettiva dedicata quello stesso anno dalle Giornate del Cinema Muto di Pordenone ai comici del muto italiano22. La vivacità e la lucidità di questa donna minuta, costretta a letto solo temporaneamente, a causa di un piccolo incidente, “unica sopravvissuta tra i silent clown di quella gloriosa stagione del nostro cinema”, riescono a cancellare ogni barriera temporale: è lei, è la Gigetta che (ri)conosciamo e che guarda in macchina sorridendo, perfettamente consapevole di essere ripresa in primo piano. La videointervista si apre con la lettura di brani tratti dal curioso volume di Tito Alacci, in cui l’autore propone il profilo delle attrici cinematografiche da lui direttamente “studiate sullo schermo” nelle sale degli anni Dieci. Nella scheda dedicata alla Morano si legge: Gigetta Morano è, per esempio, un’artista vera, non già perché ella riesca a svolgere con efficacia delle figurazioni artistiche sullo schermo, se non ché per quell’invidiabile privilegio di immunità, ch’ella possiede contro l’opera deleteria del tempo. La Morano è stata la prima interprete che io abbia conosciuta nell’arte muta. La vidi per la prima volta nella Vergine del Giglio, nel 191023, e da allora l’ho riveduta in un gran numero di produzioni, sempre collo stesso viso e colla stessa persona. Il tempo non ha alterato in lei una linea; tutt’al più ha sciupato ma in modo appena apprezzabile qualche forma. Ella è forse la più veterana delle attrici, eppure sembra ancora una delle più giovani. Questo miracolo è opera dell’arte. La Morano è, naturalmente, una bella donna; se la linea della sua fronte fosse un poco meno prominente, il suo volto sarebbe un modello di plastica. Ella ha inoltre uno degli sguardi più sereni e sorride ancora come una bambina. Le sue mani ed i suoi piedi sono di una fattura mirabile. Il corpo non ha difetti. Questa donna eccezionale ha fatto ridere milioni di spettatori 24.
Nei suoi racconti Gigetta Morano fornisce molte informazioni su coloro che hanno lavorato con lei alla casa Ambrosio, senza nascondere alcune sue
21 / Gigetta Morano / Claudia Gianetto
Foto pubblicitaria di Gigetta Morano (Museo Nazionale del Cinema)
preferenze, come quella che manifesta per uno dei due fratelli Vitrotti, Giovanni. Secondo le sue parole, le troupe spesso uscivano per girare in esterni e non di rado avevano anche l’opportunità di viaggiare all’estero per le produzioni più importanti. Ed ecco che racconta della malattia e del suicidio di Rodolfi, ma anche della tresca che si consuma nei camerini tra Capozzi e Mary Cléo Tarlarini, la quale peraltro non fa segreto della sua bisessualità e tenta, invano, di sedurla. Anche di Arrigo Frusta la Morano riesce a tratteggiare un’immagine nitida: un uomo a cui piacevano forse troppo le donne – le altre, non la sportiva e minuta Gigetta –, ma anche il vero genio della Casa di produzione torinese. La Morano narra come, superato il primo breve periodo caratterizzato dal predominio dell’improvvisazione, il suo lavoro sul
set dipendesse da un soggetto che non era mai lei a scrivere; dei film comici o brillanti, anche della cosiddetta “serie Gigetta”25, spesso è Arrigo Frusta l’autore. Secondo i dati disponibili e le fonti d’epoca, sono almeno diciotto i film interpretati dalla Morano e sceneggiati da Frusta proprio nel periodo più intenso della produzione muta torinese, iniziando da Il naufrago della vita (1909) per finire con Gigetta è gelosa (1914); quest’ultima sceneggiatura26 contiene anche un monologo eccezionalmente lungo e intenso scritto per l’attrice. Un articolo pubblicato su la Gazzetta del Popolo aggiunge ulteriori dettagli e notizie sui suoi rapporti, alcuni di grande sintonia e altri invece piuttosto contrastati, con alcune figure di primo piano come Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse. È solo in questa occasione che Gigetta Morano dichiara che, prima di morire, vorrebbe che qualcuno le permettesse di realizzare un sogno: fare Teresa Raquin, parte drammatica che sente profondamente sua27. L’attrice descrive più volte il suo lavoro a interlocutori diversi, sempre abile nell’eludere alcune domande, in particolare quelle sulla sua vita privata. Recitare le ha dato moltissimo, anche se è stata proprio la sua professione – considerata sconveniente negli ambienti più tradizionali – che le ha impedito di sposare l’unico uomo che abbia mai veramente amato e che, partito per combattere al fronte durante la Prima guerra mondiale, non ha mai fatto ritorno. La famiglia di lui, comunque, non gli avrebbe permesso di unirsi a un’attrice e quindi le era chiaro che, anche senza la tragica scomparsa dell’uomo, il suo sarebbe stato un amore impossibile28. A un giornalista che le chiede esplicitamente che cosa abbia fatto in tutti questi anni, da quando ha smesso di recitare, di fronte all’insistenza risponde, ma senza rinunciare ai suoi segreti. Dice che si è molto divertita e che ha sperperato il suo denaro; degli ambienti che frequenta anche fuori dal set s’intuiscono poche cose, da esili dettagli: le feste, le ville, il mare, il suo adorato cane San Bernardo seppellito nel giardino dell’amico Puccini… Ha rimpianti? Risponde: “Uno solo, non essere diventata madre. Non ho mai voluto sposarmi”29. 295
Note
1 Dati riportati dal certificato di morte, Atto 00729, Uff. 1, Parte 1, Serie -, anno 1986, Servizi Demografici, Città di Torino.
La Morano non stringe alcuna collaborazione con altri produttori e non si allontana mai dalla Ambrosio, nemmeno quando Eleuterio Rodolfi fonda una sua propria Casa, attiva a Torino tra il 1917 e il 1923.
2
La Casa Ambrosio è attiva dal 1906 al 1921, la chiusura ufficiale avviene nel 1923. Si veda per ulteriori notizie Claudia Gianetto, Società Anonima Ambrosio. Cinema muto nei documenti d’epoca. Un percorso tra i materiali d’archivio del Museo del Cinema, Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema, Roma 2002.
3
Il lavoro di identificazione sulle fonti, con ricerche come quelle condotte, grazie alla competenza e alla generosità di Gianna Chiapello, sulla produzione Ambrosio e nuovi interventi di restauro potranno nel tempo modificare positivamente questi dati.
4
Nelle filmografie il titolo è indicato come produzione del 1916, ma nei materiali pubblicitari d’epoca è tra i film realizzati nel 1913.
5
6
Probabilmente verso la fine del 1906.
La Morano confonde le date e anticipa il suo incontro con Marcel Fabre, avvenuto più tardi. Per contro, il titolo citato, attualmente considerato perduto, è tra i film prodotti dall’Ambrosio & C. nel 1907.
7
8 Alberto Barbera, Io, Gigetta regina del muto, “Gazzetta del Popolo”, 6 marzo 1981. 9
Ibidem.
Spesso la Morano, sia nelle interviste filmate sia negli articoli, ricorda dettagli dei suoi film senza citarne espressamente i titoli. Segnalo le attribuzioni che considero certe, senza escludere possibilità di ulteriori precisazioni. 10
11 Del salto dalla torre e di quelli che chiama i “pupazzoli”, la Morano parla a Gianni Rondolino nella terza puntata della trasmissione da lui curata I giorni di Cabiria. Il cinema a Torino dal 1898 al 1918, un programma della Sede Regionale della Rai, con la regia di Ermanno Anfossi e la voce di Renzo Palmer, messo in onda il 22 febbraio 1981. 12 La Morano ne interpreta una decina tra il 1910 e il 1912. Si veda il fascicolo monografico Paolo Cherchi Usai, Livio Jacob (a cura di), I comici del muto italiano, “Griffithiana”, n. 24/25, 1985. 13 Gianna Baltaro, Così lavorava una diva circa… settant’anni fa, “Stampa Sera”, 23 giugno 1976. Del film è sopravvissuta una copia, conservata dal Nederlands Filmmuseum di Amsterdam.
Ugo Buzzolan, Cabiria e Torino, un viaggio tv nella capitale del cinema muto, “La Stampa”, n. 45, 22 febbraio 1981. 14
296
15 Io, Gigetta regina del muto, cit.. Per questo film la Ambrosio fece preparare su misura per l’attrice, divertita dal ricordo di essere stata anche un seducente corteggiatore di mogli altrui, un ricco guardaroba di abiti maschili. Il film è considerato perduto.
Film preservato nel 1997 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dalla Cineteca del Friuli di Gemona. 16
17 Una copia del film è conservata dal collezionista Bruno Boschetto, che ringrazio per la sua disponibilità. 18
Così lavorava una diva circa… settant’anni fa, cit..
19
Io, Gigetta regina del muto, cit..
Ringrazio Silvio Alovisio e i colleghi della Biblioteca del Museo per avermi permesso di consultare questi materiali in corso di inventariazione. La donazione della Morano raccoglie articoli di differenti testate di quotidiani, pubblicati tra il 1965 e il 1981, alcuni dei quali citati in questo lavoro. 20
A Vittorio Martinelli – impossibile non avvertirne la mancanza – rivolgo ancora una volta un pensiero di stima e di gratitudine per l’insegnamento, i suggerimenti e per molto altro ancora. 21
22 Ringrazio Livio Jacob della Cineteca del Friuli di Gemona per avermene gentilmente concessa una copia. 23 Secondo le filmografie di riferimento, Gigetta Morano interpreta la modella in La vergine del giglio, realizzato nel 1912 su soggetto di Arrigo Frusta. Il film è considerato perduto. 24 Tito Alacci (Alacevich), Le nostre attrici cinematografiche, Bemporad, Firenze 1919, pp. 82-83. 25
Tra il 1910 al 1916 almeno quindici titoli.
Documento conservato dall’Archivio Documenti del Museo Nazionale del Cinema di Torino, Fondo Frusta, A344/13 (sceneggiatura della seconda parte). Il film è considerato perduto. 26
27 Beppe Ferrero, Gigetta Morano regina del muto sul set a Torino per D’Annunzio, “Gazzetta del Popolo”, 21 ottobre 1979. 28 Si tratta di uno dei momenti più intensi e commoventi dell’intervista concessa ad Alberto Farassino, op. cit. 29 Emanuele Montà, Affascinante anche se ha 90 anni la diva del “muto” Gigetta Morano, “La Stampa”, n. 171, 31 luglio 1977.
22 / Stella Dagna
All’ombra del gigante Le comprimarie della serie Maciste
Una serie di successo Questo studio propone alcuni spunti di analisi intorno alla rappresentazione delle figure femminili nella serie di film che hanno per eroe il forzuto Maciste. Ruoli, recitazione, funzione narrativa delle attrici che hanno lavorato con Bartolomeo Pagano, infatti, sono ad oggi poco indagati. La serie godette per molti anni di una popolarità enorme presso tutti gli strati sociali e rivelò una spiccata attitudine a catturare, interpretare e plasmare l’immaginario popolare. Se la capacità di imporre ‘archetipi sociali’ ha fatto della serie un terreno fertile, per esempio, per le analisi politiche del personaggio e delle narrazioni1, ancora non è stato affrontato compiutamente il tema del rapporto di genere tra Maciste e le donne che lo ostacolano o lo coadiuvano nelle sue avventure. Il mio intento è suggerire alcune ipotesi interpretative che possano proporsi come punti di partenza per una ricerca di questo tipo. Per chi studia la produzione muta italiana (e non solo), la possibilità di una ricerca è fortemente condizionata dalla disponibilità materiale dei film e della loro accessibilità alla visione su supporto di sicurezza. Il progetto di restauro ‘seriale’ dedicato ai film
di Maciste, curato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dalla Cineteca di Bologna a partire dal 2005, offre un’opportunità privilegiata a chiunque si proponga di studiare topoi, stile e funzioni della serie. A oggi, considerando i film restaurati in precedenza e titoli riproposti nell’ambito del progetto, è possibile visionare, Maciste (1915), Maciste alpino (1916), Maciste innamorato (1919), Maciste imperatore (1924), Maciste all’inferno (1926), Maciste nella gabbia dei leoni (1926), Maciste contro lo sceicco (1926). È inoltre in corso di restauro Maciste in vacanza (1921). L’analisi che propongo si basa sulla visione di questi film, integrata dallo studio dei documenti extrafilmici conservati dal Museo Nazionale del Cinema di Torino; si tratta di soggetti, sceneggiature, elenchi didascalie e fogli di montaggio e tintura utilizzati nel corso della produzione che, oltre a svelarci struttura e dettagli di film oggi perduti o mai realizzati, permettono di ripercorrere le fasi di sviluppo dell’intreccio e dei personaggi, anche per quanto riguarda titoli più conosciuti2. Il personaggio di Maciste nasce, schiavo e nero, nel film Cabiria (1914, Itala Film); gli dà nome Gabriele D’Annunzio e lo interpreta Bartolomeo Pagano, ex camallo nel porto di Genova. Il successo eccezio297
nale che il pubblico gli riserva convince l’Itala e in particolare Giovanni Pastrone a dedicargli una serie di film da protagonista, anticipando l’odierna tecnica dello spin off. Ancora una volta Pastrone rivela la sua doppia natura di grande regista e genio del marketing: la serie sarà un successo internazionale ultradecennale. In Italia usciranno più di quindici titoli, senza contare le produzioni tedesche e le innumerevoli imitazioni. Diventando un personaggio seriale Maciste cambia profondamente e diventa un bonario borghese italiano di pelle bianca. Gli sceneggiatori dell’epoca si posero il problema di come accompagnare l’eroe di Cabiria attraverso questi cambiamenti, dovuti anche alla necessità economica di abbandonare il dispendioso genere storico, senza alienargli le simpatie del pubblico. Vennero formulate ipotesi diverse; per esempio, un soggetto non realizzato del 1915 propone un Maciste “professore di cultura fisica”3. I vantaggi individuati dal soggettista nella scelta di questa professione sono due; da un lato la possibilità di consentire all’eroe in ogni momento gran sfoggio di muscoli, dall’altra quella di ambientare le storie in luoghi e contesti sociali diversi e variati: Maciste sarebbe stato libero di frequentare il suo ambiente popolare di provenienza ma anche l’alta società rappresentata dagli allievi della sua palestra. La soluzione adottata nei primi film, in realtà, è più semplice e più efficace: il protagonista lavora come attore all’Itala Film ed è buono e coraggioso nella realtà quanto sullo schermo.
Ogni donna è unica Maciste dunque, approdando ad una serie tutta sua, cambia pelle, epoca e mestiere. Una cosa non cambia mai: al suo fianco in ogni avventura c’è sempre almeno una ragazza nei guai. Ma quale ragazza? Che tipo di donna trova protezione all’ombra del gigante? In realtà, parlare di ragazza-tipo può essere fuorviante. Il rischio è quello di omologare le partner ‘buone’ di Maciste a un modello unico, che potremmo definire il ‘modello Cabiria’. Come è stato più volte sottolineato (con diversa delicatezza) da storici 298
e commentatori, l’eroina del film di Pastrone è più un McGuffin, un pretesto narrativo, che un vero personaggio. Lydia Quaranta, che la interpreta, pur essendo un’attrice deliziosa non riesce ad affrancarsi dal ruolo passivo che è chiamata a interpretare; nel corso del film trascorre la maggior parte del tempo in balia degli eventi, rapita, involata, imprigionata, trasportata, salvata; si limita a essere bella e pura, ogni azione di cui è protagonista risulta sempre indipendente dalla sua volontà. Ma il ‘modello Cabiria’ è ben lontano dall’esaurire le possibilità messe in campo dai film della serie. Le donne di Maciste non sono tutte uguali. Non si può negare che le figure femminili dei film macistiani, così come richiedono le regole della serialità, rispondano spesso a funzioni canoniche e si muovano in una serie di situazioni topiche, che si ripetono di episodio in episodio per gratificare le attese dello spettatore: vengono rapite, s’inteneriscono con animali e bambini, sono tratte in salvo all’ultimo minuto, diventano merce di scambio e di ricatto nei confronti di padri e fidanzati. I film del ciclo, che trovano uno dei punti di forza nelle situazioni metacinematografiche, mettono ripetutamente in abisso la scena madre alla base del successo della serie: tutte le volte che lo vediamo recitare sul set (Maciste, Maciste alpino, Maciste innamorato, Maciste in vacanza), il gigante è impegnato a salvare una ragazza indifesa, aggredita, imprigionata, maltrattata. A funzioni comuni, tuttavia, corrispondono psicologie e tecniche attoriali diverse che offrono delle vere e proprie ‘variazioni sul tema’. La prova più evidente di tale varietà ci è fornita dall’ampiezza delle differenze che distinguono tra loro le interpreti che si sono avvicendate al fianco del gigante buono. Per evidente effetto di contrasto si tende a privilegiare attrici giovani dalla figura sottile e dalla mobilità scattante e moderna; tuttavia Clementina Gay, Henriette Bonard, Cecyl Tryan, Pauline Polaire, Linda Moglia, Mimy Dovia, per non parlare di vere e proprie dive come Italia Almirante Manzini o Diomira Jacobini presentano curriculum, storie personali e temperamenti molto diversi. Basta sfogliare le riviste d’epoca per rendersi conto di come ogni attrice, nella costruzione della propria immagine pubblica, si affidi a iconografie tra
22 / All’ombra del gigante / Stella Dagna
loro assai differenti. Cecyl Tryan, trepida educanda in Maciste contro lo sceicco, ha il physique du rôle dell’eroina romantica classica, è gelosa della sua vita privata e s’ispira a un modello di serenità bucolica, quasi pastorale. Un emblematico articolo promozionale ce la presenta dedita a una vita semplice nella sua villa in campagna: Ella sorride, ma la mia attenzione è ancora turbata. Un tintinnio di piccola sonagliera viene da oltre uno dei bordi del viale, non molto discosto. Mi volto. Due piccole caprette immobili mi guardano stupite, evidentemente sorprese dal giungere inaspettato di un uomo. – Vostre? – la interrogo più con lo sguardo che con la parola. – Sì, sono le piccole amiche di mia figlia ed anche mie quando il lavoro mi concede la possibilità di restare quieta in mezzo al verde della mia casa silenziosa4.
Non sarebbe certo facile immaginare in un analogo contesto Henriette Bonard, compagna di Pagano in diversi episodi della serie, ex indossatrice cosmopolita dal fisico asciutto e dal look raffinato. La tecnica pubblicitaria scelta per presentare la giovane attrice ce la descrive a passeggio sotto i portici della centralissima piazza Castello di Torino, in un brulicare di folla e rumori: Dritta e slanciata come uno stelo floreale, fascio di nervi racchiuso in un irreprensibile tailleur di moda con in capo un minuscolo cappellino a forma di elmetto di sotto la cui ala spiovevano certi biondi riccioli capricciosi e ribelli, e spuntava un visetto impertinente, camminava con passo sicuro e spedito, con franca disinvoltura e con un po’ d’alterezza, indifferente a tutto quanto avveniva intorno a lei, insensibile ai mormorii d’ammirazione che commentavano il suo passaggio5.
La Bonard costruisce il suo fascino di donna moderna sulla spigliatezza blasé che, per esempio, le permette di dichiarare senza alcuna remora di fare cinema per i soldi: “Mi avevano detto che c’era molto da guadagnare e poco da lavorare; ed io mi ero perciò subito sentita invasa da tutti i più ardenti e sacri fuochi dell’arte! Avevo anch’io sentito risvegliarsi la passione e la vocazione dell’arte, confessa oggi
Bartolomeo Pagano scherza con Romano Luigi Borgnetto ed Henriette Bonard in una pausa sul set di Maciste in vacanza (Museo Nazionale del Cinema)
candidamente Henriette Bonard, con una franchezza sbalorditiva e non senza una punta di ironia”6. Anche le cartoline promozionali possono rivelare l’evidente differenza di modelli di riferimento. Pauline Polaire, per esempio, assume spesso pose ispirate all’iconografia religiosa delineando, malgrado la figura mediterranea e opulenta, un’immagine di vittima sacrificale che trova piena corrispondenza con il ruolo da lei interpretato in Maciste all’inferno. Niente di più lontano dall’immagine che propone la piacente Elena Sangro, apprezzata da D’Annunzio anche per lo sguardo altero che nelle foto è solita posare su partner maschili spesso seduti, inginocchiati o comunque posti in subordine rispetto alla femmina dominatrice7. 299
Queste personalità così diverse attivano una gamma di relazioni molto vasta con il coprotagonista. La chimica che si crea sullo schermo tra Maciste e le sue partner non è mai la stessa. Pagano, uomo semplice, sembra trovarsi maggiormente a suo agio con le interpreti più giovani, dalla recitazione spigliata e istintiva come Clementina Gay, compagna di Maciste nel primo episodio della serie, o Mimy Dovia, interprete di gran temperamento e di soli diciassette anni in Maciste nella gabbia dei leoni. Con loro Pagano si concede una relazione molto fisica e giocosa, più naturale rispetto per esempio a quella che instaura con Henriette Bonard in Maciste in vacanza. Sebbene l’attrice fosse specializzata nei film d’avventura, i suoi modi sofisticati e il suo portamento elegante non potevano non mettere in imbarazzo il partner. Romano Luigi Borgnetto, regista del film e consumato professionista, con l’aiuto di una sceneggiatura scoppiettante trasforma le difficoltà del suo primo attore in un escamotage narrativo: nel film Maciste si relaziona fisicamente con la bella miss Edith soprattutto subendone gli attacchi o allontanandone le avances. La sua goffaggine diventa una delle risorse comiche del film. Non sempre questo tipo di difficoltà riesce a essere tematizzato in modo brillante. Lola Romanos in Maciste imperatore contribuisce a rendere ancora più scipito un personaggio già debolissimo sulla carta, facendoci peraltro percepire sullo schermo l’assoluta e totale mancanza di feeling con Pagano: i due non solo non entrano mai in relazione fisica ma addirittura compaiono raramente nella medesima inquadratura. Maciste imperatore è, non a caso, il film meno femminile e più politico della serie, girato nel 1924 con chiari riferimenti al regime fascista e al modello mussoliniano di leader assoluto e populista. Le donne del cast, compresa la fascinosa Elena Sangro, sono ridotte a stereotipi mentre il ruolo della vittima in pericolo, solitamente riservato a una fanciulla, è stavolta ricoperto da un uomo, l’imbelle principe Otis interpretato da Raoul Mayllard. Non è escluso che le ragioni di questa marginalizzazione dei ruoli delle donne siano da ricercare nell’adeguamento a un modello di femminilità fascista che si esauriva nei ruoli antitetici di angelo/madre e di prostituta. 300
All’opposto, Maciste innamorato costruisce l’esempio più complesso di relazione con il personaggio femminile. Tutto il film è giocato sull’alternarsi di desiderio e di imbarazzo per il proprio fisico sovradimensionato che Maciste prova al cospetto di Linda Moglia: si intimidisce, la sfiora, la abbraccia quasi lei fosse di porcellana. Sicuramente i film scomparsi avrebbero contribuito ad arricchire di sfumature ulteriori il panorama variegato dei rapporti del forzuto con le donne. Per ora, per esempio, rimaniamo col rimpianto di non poter vedere di nuovo recitare insieme Italia Almirante Manzini e Bartolomeo Pagano dopo Cabiria; l’attrice, diva altera per eccellenza, nel kolossal cartaginese interpretava la principessa Sofonisba, che in poche scene degnava lo schiavo numida appena di qualche sguardo in tralice. È difficile immaginare tra loro un’affinità, eppure recitarono insieme in ben tre film della serie nello stesso anno 1918: Maciste atleta, Maciste medium, Maciste poliziotto.
L’erotismo negato Il corpo esagerato di Maciste domina la serie, costruita sia visivamente sia narrativamente intorno alla sua eccezionalità fisica. Tale eccezionalità trova un adeguato elemento di contrasto nella fragilità delle donne, che funge spesso da cassa di risonanza alle imprese straordinarie dell’eroe. A questo ruolo di alterità, destinata a esaltare l’altrui forza attraverso la propria debolezza, non sfugge nemmeno la mamma, spesso per gli uomini modello di riferimento più o meno inconsapevole nelle relazioni adulte con l’altro sesso. Scrive il soggettista in un inedito Maciste innamorato poi non realizzato: [Maciste] adora la vecchia mamma – una donnina piccola piccola che non si sa per quale bizzaria della natura abbia potuto generare un colosso. Ed ella ricambia di pari tenerezza il suo Macistino, che per lei è sempre un bimbo – enorme sì, ma bimbo. Come quando era piccino (piccino per modo di dire, perché egli non lo fu, veramente mai – e in qualche quadro retrospettivo, opportunamente imbibito e virato si vedrà il colossale infante che assorbe in pochi sorsi il contenuto di un biberon grosso quanto una
22 / All’ombra del gigante / Stella Dagna
damigiana, e che, in fasce, con grande terrore della mamma le cresce in braccio a vista d’occhio)8.
Spesso analisti e commentatori tentano di far rientrare la corporeità macistiana, e il fascino da essa esercitata, nei canoni di bellezza classica ispirati alla statuaria greca e romana. Se il discorso vale sicuramente per altri forzuti di stile diverso, in primis Carlo Aldini, ci sembra invece poco applicabile a Bartolomeo Pagano. Il tratto essenziale del suo fisico è la sovradimensione, l’eccezionalità da freak circense, richiamata da prove di forza quali la rottura delle catene o il sollevamento di grossi pesi coi denti, più vicine allo spettacolo da fiera che alle dimostrazioni ginniche. La nostra ipotesi è che sia proprio questo scarto quasi mostruoso rispetto alla norma che, contrariamente a quanto accade per altri forzuti, inibisce a Maciste ogni rapporto erotico. L’asessualità dell’eroe, infatti, venne evidentemente individuata dagli sceneggiatori come una caratteristica imprescindibile nella costruzione del personaggio di Maciste. Questa particolarità aveva la chiara funzione di depotenziare agli occhi del pubblico una corporeità che altrimenti avrebbe presentato aspetti minacciosi (in senso diverso) sia per gli uomini sia per le donne. C’è questa ineluttabile presa di consapevolezza alla base dello struggente finale di Maciste innamorato. Ma ci sono anche la convinzione e il desiderio che la sessualità femminile sia sempre mediata dallo sguardo (mai dal contatto) e dalla ricerca del proprio simile, armonico ed esangue. Maciste, innamorato di Linda Moglia, si è illuso di esserne ricambiato. A una festa elegante, vestito in frac e imbarazzatissimo, decide di dichiararsi; seguita la sua amata sul terrazzo, la scorge però amoreggiare con un altro. Le tenerezze della ragazza erano dunque solo dovute a riconoscenza e curiosità nei confronti di quello che viene definito nel corso del film “l’uomo fenomeno”. Il suo vero amore è un giovane smilzo ed elegante. Maciste ha uno stordimento. È il primo colpo al cuore… forse l’ultimo. Riguadagna in tutta fretta la sua camera, si guarda allo specchio si fa violenza e sorride amaramente.. si scuote... Riprende i suoi abiti… Ridiviene il buon colosso. Pronto a dare il suo brac-
cio forte... e prima di allontanarsi dalla casa dove una manina minuscola ha saputo imprigionare il suo cuore grande; lascia sul cranio lucido del maestro di casa un bacio destinato a colei che ha avuto il potere di strappare una lacrima ai suoi occhi sereni9.
Maciste innamorato segna un momento di cesura. Se nei primi film della serie l’asessualità del gigante è a-problematica, a partire dal 1919, questo tema rimosso viene tematizzato sempre più spesso e sublimato nelle maniere più diverse, come se un’urgenza ne impedisse il totale occultamento. Un esempio di bizzarra rappresentazione del problema ce la fornisce Maciste in vacanza, forse l’episodio più surreale della serie. Maciste, inadeguato alle donne normali, si fidanza con la Diattolina, un’automobile su misura. Una giovane americana cercherà di fargli cambiare idea. Il tema della difficoltà nel gestire la propria corporeità ipertrofica in relazione al gentil sesso è riproposta in chiave grottesca. Così è descritta in sceneggiatura una colazione con la ragazza alla presenza della zia: PP. Del gruppo. Maciste appare imbarazzatissimo e non sa come contenersi secondo gli usi della buona società. La fidanzata e la zia sorridono divertite da ogni goffaggine di Maciste. Questi prende la fragile anfora del latte per versarlo nella sua tazzina, ma senza volerlo le sue mani stringono troppo ed il ninnolo s’infrange facendo rimaner confuso, umiliato del malanno il povero Maciste. Ma la giovane ride più della confusione che del piccolo guaio, e Maciste si rincuora e sorride alla sua volta10.
Fin qui la corporeità fuori norma e gli inevitabili sottintesi sessuali sono ancora giocati su toni delicati e garbatamente ironici. Procedendo nella lettura della sceneggiatura, tuttavia, ci imbattiamo in una scena dai toni decisamente più espliciti ed inquietanti che non a caso è stata poi eliminata in fase di ripresa: 382. Visione della cameretta ove dorme la cameriera: questa seguita i suoi sogni, mentre Maciste, attraversando la penombra, viene vicino al suo letto. 383. PP dei due: Maciste è irresoluto. Non sa come destarla senza che essa gridi. Pensa. Poi si curva e la bacia. 301
384. PPP. Dei due mezzi busti: la cameriera non si desta. Il bacio anzi sembra far parte del suo sogno perché sorride seguitando a dormire. Maciste è imbarazzatissimo. Alla fine gira il commutatore della luce. La cameriera all’improvvisa luce apre gli occhi: si impaurisce vedendo Maciste vicino a sé. Maciste le accenna di star zitta. La vuol rassicurare. Le mormora: - Ssst... Correte un grave pericolo... Fidatevi di me… Sono Maciste... Quello che salva tutti... Il salvagente!... Ma la cameriera non si raccapezza. E Maciste le ripete invano il suo mestiere. Finalmente egli le domanda: - Non siete mai andata al cinematografo? La cameriera risponde negativamente. Maciste guarda il cielo. Doveva proprio trovar qui la rarità vergine! Ma egli non s’arrende: le dice:
carica sessuale proprio in virtù delle sue dimensioni e della sua eccentricità. Alla censura certi dettagli non sfuggono: l’apprezzamento “Con un simile torace figuriamoci, tutte le diavolesse se lo contenderanno!”, diviene “Con un simile coraggio, figuriamoci”12. Questi piccoli accorgimenti non bastano però a ridimensionare l’immagine dirompente di Maciste trasformato in diavolo, prigioniero all’inferno e coi piedi caprini ma, in un certo senso, libero per la prima volta di manifestare il proprio desiderio e le proprie pulsioni. La sensualità porta la dannazione, come recita una didascalia sulla falsariga del dramma di Paolo e Francesca: “…quella sera non aveva più letto avante”. Il bacio è sensuale, il contatto è pericoloso, irreversibile e immobilizza il gigante che, per una volta, non si libera da solo da lacci e catene. È la preghiera di un bambino, nato dall’amore di Graziella
- Venite… Vi conduco… Al cinematografo!... 385. Allont. di poco la macch.: Maciste avvolge nel lenzuolo la cameriera e la porta via di peso, tenendole una mano sulla bocca11.
Tra le righe affiora la natura ambigua di un eroe che pone la propria superiorità fisica nei confronti della fragilità femminile non più come baluardo difensivo, ma come elemento di sopraffazione. È questo un timore taciuto che percorre la vita intera del personaggio: per esorcizzare, sarà dunque necessario de-erotizzare. Maciste dovrà aspettare il 1926 per baciare finalmente una sua partner, la sensuale diavolessa Elena Sangro. L’eccezionalità dell’evento richiedeva un contesto e conseguenze particolari: siamo all’inferno e l’esito di questa leggerezza è nientemeno che la pena eterna e la condanna per Maciste a non poter tornare mai più sulla terra. Il film, Maciste all’inferno, è un vero manifesto freudiano. Mentre nella realtà del mondo terrestre si reitera per l’eroe il rifiuto affettivo e la preclusione a una vita erotica, visto che la vicina Graziella gli preferisce l’azzimato damerino Giorgio, all’inferno finalmente il corpo di Maciste si riappropria della 302
Elena Sangro domina Raoul Mayllard in Maciste imperatore, 1924 (Museo Nazionale del Cinema)
22 / All’ombra del gigante / Stella Dagna
e Giorgio, coppia che per quanto illegittima viene ricondotta nei cardini della normalità, a salvarlo dalla dannazione.
Note
A titolo di esempio e senza pretese di esaustività segnaliamo tra i lavori dedicati al cinema degli uomini forti nel periodo del muto: Alberto Farassino, Tatti Sanguineti (a cura di) Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983; Monica Dall’Asta, Un Cinéma musclé. Le surhomme dans le cinéma muet italienne, Editions Yellow Now, Crisnée 1992. Tra i saggi dedicati specificamente alla figura di Maciste: Fabio Pezzetti Tonion, Corpo della visione, corpo della narrazione: Maciste in Cabiria in Silvio Alovisio e Alberto Barbera (a cura di), Cabiria & Cabiria, Museo Nazionale del Cinema-Il Castoro, TorinoMilano 2006.
1
Baluardo di virtù Maciste all’inferno, tuttavia, rimane un’eccezione. Il grande torace di Pagano, più che richiamo erotico, è un baluardo in difesa della virtù. Col passare degli anni, certo anche a causa della terribile esperienza della guerra mondiale, il pericolo da cui Maciste salva le sue partner si connota sempre di più come afferente alla sfera sessuale. Mentre la protagonista di Maciste (1915), pur prigioniera in un covo di banditi, rischia la perdita della famiglia e forse della vita ma non viene minacciata di abuso, a partire da Maciste alpino (1916) – in cui due soldati austriaci si contendono la giovane protagonista in una partita di carte – lo stupro rimarrà la minaccia più frequentemente scongiurata dal gigante. Questa tendenza si consolida alla fine della guerra: uno dei film migliori della serie, Maciste contro lo sceicco (1926), è tutto giocato sul tema della minaccia e della frustrazione erotica provocata ai marinai dalla presenza sulla nave di una ragazza rapita e destinata all’harem di un sultano. In Maciste nella gabbia dei leoni (1926) la giovane creola Seida è importunata ripetutamente dall’atleta Sullivan che, esasperato dal rifiuto, arriva ad aggredirla e a tagliarle le unghie con violenza davanti a tutti, per punirla di essersi difesa graffiandolo. La scena è di violenza rara per un film comunque destinato alle famiglie. Sullivan è interpretato da Umberto Guarracino, in arte Cimaste, antagonista ma anche alter ego dell’eroe, come dimostra l’anagramma dei nomi d’arte. La lotta tra Sullivan e Maciste, intervenuto in difesa della giovane Seida, assume quasi la valenza simbolica di una lotta interiore tra opposte pulsioni di uno stesso uomo. Cimaste è il mister Hyde di Maciste? Anche Maciste, eroe tutto d’un pezzo, di fronte alla complessità dell’universo femminile, non sfugge alle ambiguità dell’uomo moderno.
Per approfondire la conoscenza della collezione di materiali extra-filmici conservati dal Museo Nazionale del Cinema di Torino è possibile consultare: Nero su bianco. I fondi archivistici del Museo Nazionale del cinema, Museo Nazionale del Cinema-Lindau, Torino 1997; Carla Ceresa e Donata Pesenti Campagnoni, Tracce, Museo Nazionale del Cinema-Il Castoro, Torino-Milano 2007. Da qui in poi si citeranno documenti conservati dal Museo, identificandoli con il numero di inventario della cartella in cui sono contenuti.
2
3
Maciste, soggetto non realizzato, A160/9.
Umberto Colombini, Cecyl Tryan, “Al Cinemà”, n. 4, 1926, p. 4. 4
5
Henriette Bonard, “Al Cinemà”, n. 37, 1925, p. 11.
6
Henriette Bonard, cit., p. 13.
Si vedano per esempio foto di scena e materiali pubblicitari di Maciste all’inferno, film che vede impegnate entrambe le attrici in ruoli antitetici.
7
Maciste innamorato, sceneggiatura manoscritta non realizzata, A179/1.
8
9
Maciste innamorato, soggetto, A179/1.
Maciste in vacanza, sceneggiatura dattiloscritta di Alessandro De Stefani, A184/7. 10
11
Ibidem.
Le versioni diverse della didascalia sono riportate in due elenchi stilati in momenti successivi della produzione, A241/5. 12
303
23 / Maria Elena D’Amelio
Belle e dannate Donne di potere nel cinema storico-mitologico italiano
La figura della tiranna detentrice di potere, della regina bella e dannata è una presenza diffusa nei film storico-mitologici del muto italiano. Film come La caduta di Troia di Luigi Romano Borgnetto e Giovanni Pastrone (1910), Quo Vadis? di Enrico Guazzoni (1913), oltre al celeberrimo Cabiria di Giovanni Pastrone (1914), furono i primi kolossal che fecero conoscere al mondo la cinematografia italiana. Nel periodo delle origini, il cinema italiano aveva spesso utilizzato materiale narrativo proveniente da un repertorio popolare, ma ben presto quella prima ingenua produzione si esaurì, sia per la mancanza di una consistente produzione di romanzi d’appendice (al contrario di quello che succedeva in Francia), sia per la progressiva maturazione culturale del pubblico dell’epoca. Era il tempo di Giolitti, della crescita economica di un’Italia nella quale le masse conoscevano un miglioramento del loro tenore di vita, cominciavano a partecipare alla vita pubblica e domandavano una maggiore offerta di attività culturali e ricreative1. Il cinema colse al volo questa possibilità, ma dovette rivestirsi di panni più dignitosi. La sua ‘elevazione’ poté avvenire solo tramite la produzione di film tecnicamente decorosi, ricchi di fasto spettacolare e basati su temi considerati colti: i registi quindi si ispirarono a eventi storici di
rilevanza nazionale, a opere letterarie e soprattutto alla grande tradizione dell’antichità classica. Gli elementi di suggestione erano numerosi, la commistione di storia e leggenda rendeva facile e legittimo il ricorso a invenzioni e trame fantastiche e gli spunti erano infiniti, dal momento che l’antichità e la mitologia classica erano un patrimonio largamente condiviso dalla popolazione italiana e permeavano l’immaginario collettivo, tramite una sedimentazione di archetipi, miti e favole accumulatisi nel corso dei secoli. L’ambientazione storica, inoltre, dava la possibilità di portare sullo schermo personaggi noti per la loro grandezza morale, ma anche estremi nella loro follia e nel loro peccato, come appunto la figura della meretrix regina. Spesso interpretata da note attrici dell’epoca – come Italia Almirante Manzini – molto più famose e molto più ‘dive’ rispetto alle attrici che impersonavano personaggi positivi, la meretrix regina divenne una figura frequente nei film di ambientazione storica o pseudo-storica. Due esempi tra i più noti sono la regina Sofonisba di Cabiria e la regina Proserpina di Maciste all’inferno, due tipiche incarnazioni della donne di potere nel cinema degli anni Dieci e Venti, corrispondenti a due figure classiche della meretrix regina: Cleopatra e Messalina, figure storiche ma leggendarie, immagini eterne 305
la prima volta sugli schermi nel 1910 da Asta Nielsen nei suoi film danesi e poi ripreso dall’americana Theda Bara. Si tratta in entrambi i casi di donne di eccezionale bellezza, ma mentre la femme fatale è causa involontaria di drammi, provocati dalla sua sola presenza, da un potere d’attrazione sessuale spesso involontario che il più delle volte la conduce alla morte, la vamp è la donna dannante, che gode della sua malvagità4. Nei film che intendiamo analizzare, la figura della regina Sofonisba è più vicina allo stereotipo della femme fatale, la quale subisce lo stesso male che procura, mentre Proserpina è più in linea con la rappresentazione della vamp nordica, la ‘mangiauomini’ che gode nel distruggere l’uomo. Ma la Diva del genere storico-mitologico presenta una caratteristica unica e originale rispetto al modello della femme fatale e della donna dannunziana, estrema e decadente: nel kolossal storico il personaggio femminile che funge da antagonista è sovente una donna che detiene non solo il potere sessuale, ma anche e soprattutto quello politico. Nel binomio seduzione-potere, le ‘donne negative’ rappresentate nei film storici sono sovrane a tutti gli effetti, donne che occupano ruoli di comando, che esercitano un effettivo potere d’azione. Sono personaggi femminili che subiscono una ‘maschilizzazione’ del ruolo5.
della donna pericolosa, potente e fatale2. Entrambe fungono da archetipi per la rappresentazione delle tiranne del film storico-mitologico italiano degli anni Dieci e Venti. La figura della sovrana cinematografica è ovviamente imparentata con quella della femme fatale, che arriva al cinema dalla letteratura ottocentesca, in particolare di fine Ottocento3. Sullo schermo, la donna fatale, pericolosa e portatrice di sventure (presente fin dalle culture più antiche, come testimoniano la Pandora greca e la Eva biblica) si afferma nel personaggio della Diva, che in Italia si nutre del clima culturale dannunziano che esalta gli ‘individui d’eccezione’. All’interno della categoria delle Dive, si può distinguere tra il tipo della femme fatale italiana e quello della vamp, quest’ultimo portato per 306
Anni Dieci: Sofonisba-Cleopatra Per l’Occidente, il topos della donna di potere, seduttrice, pericolosa, destabilizzante per l’autorità maschile ma terribilmente affascinante ha coinciso, nei secoli, con la figura di Cleopatra, quale ci è stata tramandata dalle fonti latine. Gli storici e letterati romani hanno descritto Cleopatra come una meretrix regina dissoluta e avida di potere, che vince il debole Antonio ma è vinta dal forte Ottaviano, simbolo delle qualità migliori di Roma. Nelle fonti greco-egizie, invece, Cleopatra è rappresentata come una vera e propria salvatrice della patria, madre amorosa del suo popolo e dea protettrice. La trasformazione del personaggio da positivo a negativo avviene a opera degli storiografi di Ottaviano, e ha ovviamente chiari significati politici in una Roma ormai divenuta impe-
23 / Belle e dannate / Maria Elena D’Amelio
riale6. La definitiva consacrazione del personaggio come eroina tragica dell’immaginario occidentale avviene però con la tragedia di Shakespeare, Antonio e Cleopatra. Shakespeare fa di Cleopatra l’emblema della donna seduttiva e dannata, l’archetipo della femme fatale che verrà portata al successo dal cinema. Nel 1913 la Cines e Guazzoni traggono dalla tragedia del Bardo il film Marcantonio e Cleopatra. Siamo “nell’epoca d’oro”7 del cinema muto italiano, la cui punta di diamante è appunto il genere storico-mitologico, che risponde all’esigenza di legittimare il nuovo mezzo attraverso la patina culturale e il supporto all’ideologia nazionalista, dai primi desideri di conquiste coloniali in età giolittiana fino all’entrata in guerra dell’Italia. In questo senso, il film Marcantonio e Cleopatra attribuisce alla figura della sovrana chiari significati politico-ideologici. Rispetto al testo di Shakespeare, Guazzoni insiste meno sui risvolti romantico-passionali della storia tra Antonio e Cleopatra a favore di una lettura in chiave anti-orientalista. Più che come la femme fatale sessualmente vorace del XIX secolo, all’inizio del film Cleopatra è presentata come una strega, una maliarda che prepara filtri ingannatori. La contrapposizione tra la barbarie della regina orientale e la virtù di Ottavia, la moglie romana ingiustamente tradita, permea tutto il film8. Nel 1914, Cabiria di Pastrone e D’Annunzio porta sulla scena la figura tragica della regina orientale Sofonisba, interpretata da Italia Almirante Manzini. La sovrana cartaginese, sposa prima di Sibace poi di Massinissa e morta suicida in seguito alla vittoria dei romani, presenta evidenti affinità con Cleopatra e a sua volta incrocia i suoi destini con quelli della Roma pre-imperiale. Si può pensare che, per la costruzione del personaggio di Sofonisba, Pastrone e D’Annunzio abbiano tenuto conto sia del film di Guazzoni, sia dell’iconografia tradizionale della regina egizia. Infatti, pur essendo cartaginese e richiamando come riferimento culturale immediato un’altra nota sovrana – la Didone virgiliana, infelice figura di regina sedotta e abbandonata – Sofonisba appare plasmata sul modello di Cleopatra, donna potente e seduttrice, regina che non ha bisogno di un re. Nella sequenza
in cui fa la sua prima apparizione, Sofonisba è nelle sue stanze, circondata da ancelle e da oggetti da toilette, tra cui fa capolino uno specchio, simbolo di narcisismo e seduzione femminile fin dai tempi delle fiabe9 e oggetto tipico della femme fatale del cinema muto, soprattutto italiano10. Mentre il padre la promette in sposa a Sibace, fiero oppositore della repubblica romana, gli spettatori osservano Sofonisba che si guarda allo specchio. In termini lacaniani, lo specchio simboleggia la soggettività dello sguardo: in questo caso la regina è insieme soggetto e oggetto della visione, in una sorta di autarchia dello sguardo che basta a se stesso. Nel gesto di specchiarsi, vanità, autoaffermazione e autosufficienza sentimentale sono strettamente connesse. La donna che si appropria della possibilità di guardarsi esclude l’uomo dal suo campo visivo e quindi dal controllo sulla sua persona. Non a caso, Sibace parte per la guerra e lascia Sofonisba padrona del regno e quindi regina legittima senza più bisogno di un re al fianco, come Cleopatra. Dopo la sconfitta di Sibace da parte di Massinissa, Sofonisba dovrebbe essere giustiziata come preda di guerra. Ma la regina evita la morte conquistando sessualmente il conquistatore, così come Cleopatra fece con il ‘nemico’ Antonio. Infine, un’ultima analogia si rivela nel momento della sua morte: anche Sofonisba, infatti, si suicida, come la regina egizia, con il veleno. Per tornare alla Cleopatra portata sullo schermo da Guazzoni, il suo personaggio si spoglia del fascino della femme fatale costruito dalla letteratura fin-desiècle per caricarsi di significati politici. Raffigurata come una maga barbara che strega Antonio e lo distoglie dal suo ruolo di comandante, rappresenta un Oriente femminilizzato che minaccia la virilità espressa dall’Occidente romano. I rapporti di forza nella seduzione tra Antonio e Cleopatra adombrano l’idea della conquista di un Oriente-femmina da parte di un Occidente-maschio, tema presente fin dai tempi della conquista egizia di Napoleone. L’antiorientalismo del film di Guazzoni riflette così la luce ideologica delle prime conquiste coloniali dell’Italia giolittiana. L’orientalismo del XIX secolo è quindi una dinamica di empire, oltre e più che di desire11. Anche in Cabiria l’ambientazione privilegia il contesto orientale: la barbara Cartagine di Sofonisba si 307
contrappone alla civile Roma di Fulvio Axilla, e molto è già stato detto e scritto sulla metafora con cui D’Annunzio sostituisce Cartagine alla Libia12. Nella figura di Sofonisba, però, il rapporto tra sesso e potere sembra non riguardare più l’opposizione Oriente/Occidente, bensì una negoziazione più familiare e insieme più complessa: quella che ha luogo tra ruolo maschile e ruolo femminile in Italia alle soglie della Grande Guerra. In altri termini, il film sembra invitare a un’interpretazione in chiave di genere. Al contrario della Cleopatra di Guazzoni, nel film di Pastrone Sofonisba è in genere ripresa sola, in posizioni di comando, spesso inquadrata con il braccio alzato in un gesto di imperio, nell’atto di dare ordini. Calata quindi in un ruolo tradizionalmente maschile, Sofonisba è la regina cui Maciste, emblema della virilità, affida la piccola Cabiria, riconoscendole un chiaro potere politico. Le pose di Italia Almirante Manzini – il mento spesso alzato, il viso fiero, un portamento giunonico dovuto anche al fisico prorompente dell’attrice (soprannominata “Grand’Italia”)13 – le conferiscono un’apparenza dominante, facendo sì che finisca per sovrastare nell’inquadratura entrambi i suoi sposi, sia il piccolo e vecchio Sibace, sia il giovane e forte Massinissa. Anche le sequenze in cui Sofonisba è insieme a Cabiria, la fanciulla protagonista, che rappresenta invece la sottomissione femminile, sottolineano il carattere dominante della sovrana: Cabiria viene spesso mostrata ai suoi piedi, in ginocchio, oppure in secondo piano. La femminilità e la sessualità assertive di Sofonisba contrastano con la verginità e il ruolo di vittima designata assegnato alla giovane. Dal punto di vista iconografico, le due donne sono costruite in maniera antitetica: Sofonisba è giunonica, ricoperta di gioielli che simboleggiano il potere (infatti se li toglierà prima di morire, dopo che il suo regno sarà stato conquistato), bruna e scura, mentre Cabiria è fragile, delicata, bionda e chiara. Il tipo di donna rappresentato da Sofonisba è portatore di quella che – riferendosi a Cleopatra – Maria Wyke chiama una “assertive female sexuality”14, simile a quella della femme fatale tradizionalmente rappresentata nel cinema italiano, ma con in più la consapevolezza del proprio potere di genere e del suo utilizzo politico, volto a garantirle autonomia e pari 308
autorità nei confronti degli uomini. Non a caso questa figura è calata nelle vesti di una sovrana orientale, appartenente a una cultura diversa rispetto a quella occidentale e latina simboleggiata dalla remissiva Cabiria. Nel cinema storico italiano, nato con intenti pedagogici e poi divenuto supporto dell’ideologia nazionalista, la figura della diva-regina acquista un preciso significato socio-politico: rappresentando una donna che usa il proprio potere di seduzione non tanto per conquistare un uomo, quanto per prenderne il posto e valicare così i limiti dell’ambito domestico, il cinema rappresenta l’antitesi dell’ideale tradizionale di femminilità borghese e nello stesso tempo mette in luce il desiderio di emancipazione delle donne coeve. La maschilizzazione della donna è infatti un processo che si evidenzia nella società e nella moda fin dalla metà del XIX secolo e che va di pari passo con le rivendicazioni delle suffragette e dei primi movimenti emancipazionisti femminili15. Se nella moda emancipazionismo può significare un taglio di capelli alla garçonne, o la scelta di un modello di tailleur all’inglese, nel cinema esso si rispecchia nei comportamenti della femme fatale: infatti, come afferma Mary Ann Doane, la iperfemminilizzazione delle pose, degli abiti e del trucco delle dive del muto altro non è se non una mascherata, cioè l’assunzione consapevole della femminilità come strumento di potere da parte della donna16. Il cinema ha la capacità di negoziare i processi sociali in atto nel suo tempo attraverso la rappresentazione dell’immaginario, dei miti che quella società produce. Come ha scritto Roland Barthes, attraverso la creazione di miti la società borghese ridefinisce le sue norme, storicamente determinate, come leggi di natura ovvie ed universali17. Per questo nel kolossal storico italiano, che ha come pubblico privilegiato la borghesia degli anni Dieci, le regine – e in generale le figure femminili detentrici di potere politico – sono sempre negative: per crudeltà, dissolutezza, perché stanno dalla parte sbagliata della Storia, o semplicemente perché la femminilità che rappresentano, seppure affascinate e desiderata, altera e disorienta i tradizionali rapporti di forza della società italiana dell’epoca. Il potere di seduzione della donna è da sempre viItalia Almirante Manzini nel ruolo di Sofonisba in Cabiria, 1914 (Museo Nazionale del Cinema)
23 / Belle e dannate / Maria Elena D’Amelio
309
sto come fonte di mistero e di pericolo per l’uomo e diviene ancor più temibile quando la donna non ne è più la vittima, ma l’agente consapevole. Proprio perché traslate nel tempo e nello spazio, le sovrane del film storico, possono interpretare quel ruolo maschile che è lo spettro, il desiderio e il timore della società borghese di primo Novecento. Una poesia umoristica del 1914 dedicata alla donna moderna recita : Ella parla di politica/ e discute i ministeri/ Nietzsche, Haeckel, Schopenauer/ più per lei non son misteri/ Giuoca in Borsa e in fondo esamina/ le vicende del listino/ alpinista di prim’ordine/ salì fin sopra il Cervino/ Ella guida l’automobil/ va a cavallo, in bicicletta/ al bigliardo ell’è invincibil / e tirar sa di fioretto/ cocktail beve e fuma avana/ ama i tiri, il cannottaggio/ le questioni femministe/ ed al Congo fece un viaggio/ nulla è in lei non modernissimo/ e sportivo e forte e ardito/ oh, se donna io fossi!/ prenderla/ penserei come.. marito!18
Nello stesso tempo il cinema, come strumento negoziatore, esorcizza questa paura, in un movimento che ripete sullo schermo ciò che avviene nella realtà. Per questo Sofonisba deve morire, abbandonando negli spasmi del veleno bracciali e gioielli, cioè i simboli del suo potere politico e sessuale, per tornare a essere una donna debole, quasi isterica, che come afferma Mary Ann Doane “è l’opposto della mascherata”19. Sofonisba, regina senza re e quindi donna autonoma e indipendente, deve morire proprio perché Cabiria, rappresentante di una femminilità tradizionale, possa vivere. Così, nelle didascalie finali, D’Annunzio fa dire alla moribonda Sofonisba queste parole, rivolte a Fulvio Axilla e riferite a Cabiria: “Te la dono: scendendo nel buio, faccio sul tuo volto la luce”. La deviazione dalla normalità borghese, rappresentata da una donna ‘eccezionale’, non può assurgere a modello universale. Il sacrificio della sovrana, donna dai tratti e dal ruolo maschile, quindi solitaria e sterile, è necessario affinché Cabiria possa salvarsi e in tal modo ristabilire il ruolo tradizionale della donna, remissiva, sottomessa e pronta a congiungersi con il campione della virilità romana, Fulvio Axilla. 310
Anni Venti: Proserpina-Messalina Altro film, altra regina, altro tempo: tra Sofonisba e Proserpina passano più di dieci anni, un decennio che sconvolse il mondo. La Grande Guerra sancisce la fine della Belle Époque e del periodo progressista e lascia dietro di sé l’orrore di un conflitto devastante, soprattutto per l’Italia. Nel 1922 la marcia su Roma apre il Ventennio fascista, che dal punto di vista delle conquiste femminili (e non solo) segna un periodo di profonda regressione. La femme fatale inizia un inesorabile declino, così come il kolossal storico-mitologico, che aveva fatto conoscere la cinematografia italiana a livello mondiale20. Anche la serie di Maciste, iniziata sulla scia del successo del personaggio in Cabiria, risente della stanchezza del periodo e dello sfruttamento intensivo che il cinema aveva fatto dell’erculeo personaggio. Uno degli ultimi film della serie ottiene tuttavia un buon successo di pubblico, il canto del cigno dell’eroe buono del muto: Maciste all’inferno. La storia vede il protagonista vivere bonariamente in un paesetto di montagna, continuando a raddrizzare i torti e le malvagità del mondo. Proprio questo suo ‘lavoro’ mette in crisi l’Inferno, ormai strapieno di peccatori e con i diavoli disoccupati per colpa di Maciste. Così Pluto, re degli Inferi, invia sulla Terra Barbariccia, suo infido luogotenente, per sconfiggere Maciste. Ma il gigante ha la meglio sul demone, che di conseguenza si vendica sulla dolce e ingenua vicina di Maciste, Graziella, facendola sedurre, ingravidare e abbandonare da Giorgio, un giovane scapestrato. Maciste sistema anche questo torto, costringendo Giorgio a sposare Graziella e a occuparsi del neonato, ma cade nel tranello di Barbariccia e finisce all’Inferno. Qui è insidiato dalle lusinghe amorose di Proserpina, sposa infedele di Pluto, che con l’inganno gli strappa un bacio e lo tramuta in demonio. Con l’aiuto di Luciferina, la compassionevole figlia di Pluto, e grazie alle preghiere del bimbo di Graziella nella notte di Natale, Maciste viene liberato dall’incantesimo di Proserpina e torna sulla Terra. A livello narrativo e simbolico, il film ha una chiara connotazione cristiana, essendo costruito sulla dicotomia peccato-purezza, incarnata dalle coppie
23 / Belle e dannate / Maria Elena D’Amelio
maschili e femminili Maciste-Barbariccia e Proserpina-Graziella. Quel che fece scandalo all’epoca fu proprio l’insistita raffigurazione dell’inferno come un baccanale, al modo di un bordello fin de siècle, come fu da più parti notato21. La visione delle ‘diavolesse’ discinte fu bocciata dalla censura nel 1925 e il film dovette attendere il 1926 per circolare nuovamente. Ma la pellicola era già stata vista da migliaia di spettatori alla Fiera di Milano del 1925 e ancora nel 1940 circolava nelle sale della penisola in una versione postsincronizzata22. Uno dei primi ricordi di Fellini al cinema, com’è noto, è appunto il ‘donnone nudo’ che appare in Maciste all’inferno. Regina di questo mondo alla rovescia, ribaltato, tanto nei costumi che nei comportamenti, è Proserpina, la moglie infedele di Pluto. Come Sofonisba, anche Proserpina è la sovrana di un mondo altro, in questo caso addirittura esplicitamente infernale, quindi un simbolo di alterità totale. La figura della regina adultera, o meglio sessualmente insaziabile, è modellata sul topos della meretrix regina più nota della storia romana, Messalina. Questo exemplum (come Cleopatra per Sofonosba) è utile per indagare la costruzione delle relazioni di genere e della sessualità femminile veicolata dal cinema nei primi anni del fascismo. Già nell’Italia di primo Novecento, Messalina è sinonimo di donna dissoluta e sessualmente degenerata, in linea con la tradizione tramandata da Giovenale e Plinio. Giovenale pone Messalina al culmine di un lungo elenco di femmine adultere e la presenta non solo come donna infedele, ma anche come prostituta e ninfomane. È di Giovenale l’epiteto meretrix Augusta, coniato sopra il meretrix regina di Properzio, riferito a Cleopatra. Plinio, nella sua Storia naturale, rincara la dose paragonando gli istinti sessuali di Messalina a quelli delle bestie. Negli storici più tardi, tuttavia, l’insaziabile appetito sessuale della sposa di Claudio viene ridimensionato, o comunque ricollocato in una drammatizzazione dei fatti che ne accentua la dimensione politica (Tacito usa la parola fabulosus), ai fini di una vera e propria damnatio memoriae23. Al cinema, Messalina compare per la prima volta nel 1910 nel film omonimo basato sulla novella di Pietro Cossa, poi nel 1918 in La moglie di Claudio, di Giovanni Pastrone, e ancora nel 1923 in un ko-
lossal interpretatato dalla contessa Rina de Liguoro (Messalina, di Enrico Guazzoni). Il film di Guazzoni è quello che più ci interessa per la sua prossimità temporale a Maciste all’inferno. Presentata un anno dopo la marcia su Roma, la pellicola appartiene alla fase stanca e decadente del film storico di ambientazione romana, quando ormai anche la figura della Diva fatale sta perdendo il suo fascino. Il giro di vite del fascismo sui costumi sessuali delle italiane, l’enfasi posta, in accordo con i dettami della chiesa Cattolica, sul ruolo della donna come madre, la decisa condanna della moda alla ‘maschietta’ e delle rivendicazioni emancipazioniste del decennio precedente contribuiscono a trasformare la figura della femme fatale da indipendente seduttrice, pericolosa ma anche affascinante, in prostituta e femmina degenere. In Maciste all’inferno, infatti, Proserpina è rappresentata come una mangia-uomini, sessualmente vorace e infedele, in accordo con l’immagine tramandata della meretrix Augusta Messalina. Nella prima sequenza ambientata negli Inferi, Proserpina viene ripresa mentre seduce Barbariccia all’insaputa del marito. Quando Pluto le intima di allontanarsi dall’amante, Proserpina non ubbidisce e anzi mette a tacere il marito con un gesto imperioso, rendendo evidente quale sia la vera gerarchia di ruoli all’interno della coppia e ribaltando così il tradizionale rapporto di genere tra moglie e marito. Nel film di Brignone, la figura di Proserpina ricorda quella di Lilith, dea vendicatrice e sessualmente sfrenata, il cui simbolo è un gufo. Nel cinema muto italiano, Lilith è spesso presa a modello per la costruzione del personaggio dell’adultera nei film di Pina Menichelli, sulla cui fisicità è improntata anche la Proserpina di Elena Sangro24. Quest’ultima aveva già dato vita a un altro personaggio di sovrana proveniente dall’antichità classica. Nel Quo Vadis? del 1924 aveva infatti impersonato Poppea, altra donna potente e di facili costumi, come Messalina. La sua bellezza altera e bruna trova però la sua migliore espressione nel ruolo della sensuale regina degli Inferi. La prima inquadratura la ritrae in figura intera, sola; la posa è imperiosa, i capelli corvini, le unghie lunghe come artigli e laccate di nero. Proserpina non è solo un’adultera, ma è anche sospetta di tradimento: nel corso del film, infatti, Bar311
312
23 / Belle e dannate / Maria Elena D’Amelio
bariccia, da lei sedotto, si rivolta contro Pluto, il quale sarà difeso nientemeno che dallo stesso Maciste. Proserpina appare sempre come una ‘dominatrice’, poiché la sua figura predomina non solo su quella del marito, ma anche su quella dei suoi amanti. Soprattutto con Maciste, la regina infernale assume il ruolo di femmina tentatrice, in quanto vuol tenere l’eroe imprigionato negli Inferi per suo capriccio, disobbedendo volontariamente agli ordini del marito: baciato con l’inganno dalla regina, Maciste è tramutato in diavolo. Quando Pluto, in segno di gratitudine per il suo aiuto contro la rivolta di Barbariccia, decide di liberare Maciste dal maleficio, Proserpina – folle di passione e gelosia – lo incatena a una rupe, dalla quale sarà liberato solo grazie alle preghiere del bimbo di Graziella. In questo film Maciste incarna le qualità maschili positive, soprattutto in relazione all’ideologia fascista: virilità, sprezzo del pericolo, forza fisica. Una delle didascalie introdotte nella sequenza della lotta tra i diavoli e Maciste recita infatti : “E come sempre le masse si inchinano al più forte”, punto di massimo contatto con l’ideologia fascista del ‘ritorno all’ordine’. Proserpina è dunque l’antagonista dell’uomo fascista, una donna sessualmente indipendente che cerca di spodestare il potere del marito e che, come se non bastasse, rifiuta addirittura la maternità. Infatti la figura di Proserpina contrasta non solo con il suo opposto terrestre, la dolce Graziella, madre e sposa devota, ma anche con il suo doppio infernale, la candida Luciferina, figlia di primo letto di Pluto, ingenua e chiara, di occhi, capelli e animo, complice e aiutante di Maciste nella sua resistenza contro le mire sessuali della matrigna. Proserpina ha un rapporto di vera e propria rivalità con Luciferina: la maltratta, la rifiuta e ne è nascostamente gelosa. Il loro rapporto non è più quello gerarchico, ma quasi materno, esistente tra Cabiria e Sofonisba, la quale sembra addirittura sacrificarsi per la giovane protetta. Il rapporto tra la regina degli Inferi e la sua figliastra evidenzia invece una netta mancanza di senso materno, il che – aggiunto alla voracità sessuale – la connota come una figura agli antipodi del modello femminile divulgato dal fascismo. La mancanza di senso materno, infatti, è tanto Italia Almirante Manzini nel ruolo di Sofonisba in Cabiria, 1914 (Museo Nazionale del Cinema)
più colpevole in quanto è sinonimo di una ribellione a quel ruolo tradizionale di madre che il fascismo si stava sforzando di imporre. Nel 1928, solo due anni dopo l’uscita del film, nel suo articolo Il fascismo e la donna, Margherita Armani scrive: Nel 1927 il fascismo ha fatto scoccare l’ora della ricomposizione delle virtù e dei valori che si erano venuti disordinando nel loro campo d’azione. Per la donna era successo precisamente questo, di essere uscita dal suo ruolo naturale e storico25.
Con la sua sessualità marcata, il suo desiderio di potere e la sua mancanza di senso materno, Proserpina è quindi è l’antitesi della donna ‘nuova’ dell’Italia fascista. Ancora una volta, l’espressione della negatività femminile è affidata a una figura di donna dominante e di potere. Come dire: la donna che reclama per sé il potere è naturalmente una Messalina, che rifiuta il ruolo materno in nome di una sessualità deviata e selvaggia. Dieci anni dopo Cabiria, il simbolo dell’indipendenza femminile non è più una donna forte e seducente, e infine positiva, come Sofonisba/Cleopatra, ma una figura perversa e dannata, sotto il segno di Messalina.
313
Note
1 Vittorio Spinazzola, Ercole alla conquista degli schermi, “Film 1963”, Feltrinelli, Milano 1963, p. 83.
Per un approfondimento dell’impatto di queste due figure sull’immaginario collettivo e soprattutto nel cinema si veda l’interessante saggio di Maria Wyke, The Roman Mistress: ancient and modern representations, Oxford University Press, Oxford 2002.
2
3 Si veda Anna Lisa Balboni, La donna fatale nel cinema muto italiano e nella cultura tra L’Ottocento e il Novecento. Iconografie e simbolismi. Vespignani, Castrocaro Terme 2006, p. 33. 4
Anna Lisa Balboni, op. cit, pp. 86-88.
Sulla maschilizzazione dei personaggi femminili si vedano Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, in Penley Constance (a cura di) Feminist and Film Theory, Routledge - British Film Istitute, London-New York 1988, pp. 57-68, e Mary A. Doane, Donne fatali. Cinema, femminismo, psicoanalisi, Pratiche edizioni, Parma 1995, pp. 21-45.
5
6
Maria Wyke, op. cit., p. 245.
Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1914, “Bianco&Nero”, eri, Roma 1993, p. 7. 7
8
Maria Wyke, op. cit., p. 262.
La Grimilde del lungometraggio d’animazione Biancaneve (David Hand, USA, 1937) prodotto da Walt Disney, con il suo “specchio specchio delle mie brame”, può essere considerata una delle prime vamp del cinema. 9
Si veda la tecnica di Lyda Borelli descritta da Cristina Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’Epos edizioni, Palermo 2006, p. 112. 10
11
Maria Wyke, op. cit., pp. 254-256.
314
12 Si vedano in particolare Luciano Curreri, Il mito culturale di Cartagine nel primo Novecento tra letteratura e cinema, in Silvio Alovisio e Antonio Barbera (a cura di), Cabiria & Cabiria, Il Castoro, Torino 2006, pp. 299-307. Per i legami tra cinema muto italiano e fasti nazionalisti si veda Gian Piero Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, Einaudi, Torino 2003, pp. 27-34 e Antonio Costa, Dante, D’Annunzio, Pirandello, in Renzo Renzi (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo, Cappelli, Bologna 1991, pp. 59-65.
Questo soprannome è riportato da Vittorio Martinelli, Le dive del silenzio, Le Mani, Genova 2001, p. 12. 13
14
Maria Wyke, op. cit., p. 283.
Giuliana Dal Pozzo ed Enzo Rava, Le donne nella Storia d’Italia, vol. 1, Teti, Torino, 1969, pp. 334-335. 15
16
Mary A. Doane, op. cit., pp. 21-43.
Roland Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Torino 1974, pp. 222223. 17
18
Giuliana Dal Pozzo ed Enzo Rava, op. cit., vol. I, p. 355.
19
Mary A. Doane, op. cit., p. 34.
20
Anna Lisa Balboni, op. cit, pp. 105-106.
Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano. 1924-1930, cit., pp. 143-144. 21
22
Ibidem.
23
Mary Wyke, op. cit., pp. 323-326.
Su Pina Menichelli si veda Cristina Jandelli, op. cit., pp. 181-206. 24
25
Giuliana Dal Pozzo ed Enzo Rava, op. cit., vol. II, p. 494.
APPENDICE
Le protagoniste
Non solo dive / Le protagoniste
Non solo dive ... ... ma anche registe, produttrici, sceneggiatrici, montatrici, comiche e atlete dall’impareggiabile verve: sebbene l’immagine tradizionale delle donne attive nel cinema muto italiano sia per lo più legata a quella eclatante delle poche, grandi dive del periodo, la presenza femminile sui set degli anni Dieci e Venti fu in realtà molto più ampia e variegata1. Come in altri paesi, infatti, anche in Italia durante il periodo muto il numero delle donne impegnate nella produzione cinematografica in ruoli tecnici, creativi e manageriali risulta decisamente più elevato che nei decenni successivi. Non solo dive, dunque, ma artiste e/o professioniste a tutto tondo, donne autorevoli e decise che, sfidando i pregiudizi del loro tempo, si cimentarono nella difficile impresa di conquistare uno spazio di agibilità professionale all’interno di un’industria in via di formazione. Indubbiamente, diversi fattori possono aver contribuito a sostenere il loro spirito d’iniziativa. In primo luogo, i primi decenni del Novecento sono caratterizzati anche in Italia da una significativa affermazione del movimento femminista che, con le sue lotte in difesa dell’autonomia femminile, nel 1919 riesce a ottenere l’emancipazione giuridica delle donne,
facendo abolire l’obbligo all’‘autorizzazione maritale’ nella gestione dei loro beni, nonché il divieto di assunzione nel pubblico impiego. Questi provvedimenti riflettono un crescente movimento di partecipazione delle donne nella sfera pubblica, con un consistente aumento del personale femminile impiegato in attività di tipo professionale. In questo contesto, l’industria cinematografica sembra offrire margini d’azione particolarmente ampi all’iniziativa femminile, verosimilmente in ragione del modo di produzione ancora scarsamente strutturato e gerarchizzato che la caratterizza in questa fase iniziale. Quando ancora i ruoli sono poco definiti e l’attoredivo può facilmente trasformarsi in regista o produttore, in una condizione produttiva ancora largamente di stampo artigianale e relativamente poco impegnativa dal punto di vista finanziario, l’ingegno e la capacità d’iniziativa delle donne possono trovare per qualche tempo un terreno singolarmente favorevole in cui esprimersi. Si tratta in effetti di una breve parentesi, che non a caso ha il suo punto culminante negli anni della Grande Guerra e in quelli immediatamente successivi, quando il richiamo al fronte di una gran massa di uomini apre per le donne nuovi spazi d’azione e di responsabilità, permettendo loro di occupare posizioni lavorative 317
tradizionalmente maschili. Poi, col fascismo, la normalizzazione non tarderà ad arrivare. Contemporaneamente all’affermazione di una retorica di regime che valorizza le donne unicamente come mogli e madri, eroiche ‘fattrici’ votate alla riproduzione dei figli della Patria, lo spazio faticosamente conquistato da queste cineaste della prim’ora si restringe sempre più, fino a scomparire. Ma prima che questo avvenga, prima che l’esperienza artistica e professionale di queste donne venga cancellata e rimossa dalla memoria collettiva, la loro ricca, ostinata presenza nel primo cinema italiano testimonia di un acuto desiderio, al tempo stesso di espressione individuale e di affermazione sociale, di una curiosità e di una passione così forti da bastare da sole a connotare un intero periodo storico. Di queste donne e del loro lavoro oggi si è persa la memoria, al punto che perfino i loro nomi suonano in molti casi del tutto misteriosi. Ricostruire le loro biografie e ridare visibilità alle loro opere è un compito affascinante, che ci può permettere di guardare alla storia del cinema italiano da un’altra prospettiva, più aderente alla realtà sociale e culturale e alle sue contraddizioni.
tratti dal vasto repertorio della ‘sceneggiata’ e del romanzo d’appendice e narrano storie di donne sedotte e abbandonate, giovanotti di belle speranze che si perdono in loschi affari e madri pronte a difendere l’onore della famiglia con ogni mezzo. Elvira dirige, sceneggia e cura il montaggio di tutti i suoi film, che ottengono un clamoroso successo in tutta l’Italia meridionale (mentre raramente vengono distribuiti al Nord), come pure nelle comunità italiane del Nuovo Continente. A Napoli poi, l’uscita di un suo film è un vero evento: nel 1919, per esempio, la prima di ’A legge attira un pubblico così numeroso da bloccare il traffico in via Toledo, sulla quale si affaccia il Cinema Vittoria. La Questura autorizza l’anticipo degli spettacoli alle dieci del mattino e il film resta in cartellone per trentasei giorni di fila. Con l’avvento del fascismo, che non vede di buon occhio una produzione popolare così fortemente radicata nella cultura locale (di regola i testi delle didascalie sono scritti in napoletano), la regista è costretta prima a ridurre e poi a interrompere l’attività. Della sua vastissima produzione sono rimasti appena tre film, peraltro in copie notevolmente lacunose: ’A santanotte (1922), E’ piccerella (1922) e Fantasia ‘e surdate (1927).
... ma anche registe...
Va a pieno titolo annoverata tra le registe anche ‘la Diva’ per antonomasia Francesca Bertini (al secolo Elena Vitiello, 1892-1985), che in tarda età rivendicò ripetutamente la maternità di numerosi suoi film3. Giunta al cinema giovanissima dopo una breve esperienza teatrale, raggiunge in pochi anni un successo strepitoso, divenendo una delle donne più ammirate del mondo. Dotata di un aspetto magnetico e di una personalità dominante, negli studi romani della Caesar – la Casa presso la quale interpreta i suoi più grandi successi – Francesca è in grado di controllare ogni fase della realizzazione dei suoi film, dalle scelte di regia al montaggio, alla pubblicità. Numerose testimonianze d’epoca la descrivono come il centro carismatico intorno a cui si articola tutto il lavoro della troupe, regista compreso. Ciò vale anche e soprattutto per Assunta Spina (1915), il film in cui investe forse più passione e più energie, che lo stesso regista accreditato, Gustavo Serena, qualche anno prima di morire dichiarò essere il pro-
Anche se non numerose in termini assoluti, le donne che in Italia affrontarono in modo deciso e autorevole la regia cinematografica tra anni Dieci e Venti del Novecento formano un gruppo non trascurabile, non meno nutrito che all’estero, per esempio in Francia, Germania e Regno Unito. Tra tutte spicca la figura di Elvira Notari (18751946), donna di grandi doti artistiche e imprenditoriali, capace di realizzare oltre sessanta lungometraggi e un centinaio di cortometraggi in meno di vent’anni, dal 1911 al 19292. La sua attività ha inizio nel 1909, anno in cui fonda a Napoli (insieme al marito Nicola, operatore di tutti i suoi film) un laboratorio di stampa, titolatura e coloritura di pellicole cinematografiche, la Dora Films, che nel giro di due anni si trasforma in Casa di produzione. I suoi film, tutti ambientati nei quartieri popolari di Napoli, sono 318
Le protagoniste
dotto dell’entusiasmo e dell’ingegno della sua partner. Nella testimonianza rilasciata a Vittorio Martinelli, Serena afferma che Francesca, per l’euforia di interpretare la parte di Assunta Spina, era “divenuta un vero e proprio vulcano d’idee, d’iniziative, di suggerimenti [...] in perfetto dialetto napoletano organizzava, comandava, spostava le comparse, il punto di vista, l’angolazione della macchina da ripresa [...] in un vero e proprio stato di grazia”4. Di assoluto rilievo, benché limitata a un unico titolo, è pure l’esperienza cinematografica di Eleonora Duse (1858-1924). Ormai sulla soglia dei sessant’anni, la grande diva del teatro italiano comincia a interessarsi al cinema quando, nel 1915, David W. Griffith le propone di recitare in un suo film. Nella sua corrispondenza di questo periodo, si trovano riflessioni che testimoniano di una viva attenzione per le possibilità espressive del nuovo mezzo e accenni a una personale visione dell’arte cinematografica5. Contattata dal produttore Ambrosio di Torino, Eleonora accetta di apparire in una pellicola diretta da Febo Mari, di cui si riserva di scegliere il soggetto e gli interpreti. Secondo alcune fonti, è l’amica Olga Ossani a suggerirle l’idea di trasporre un romanzo di Grazia Deledda, Cenere, ambientato nel cuore della Sardegna e incentrato su un intenso personaggio di donna anziana, una madre che rivede il figlio dopo anni di lontananza. L’attrice si getta nell’impresa senza risparmio di forze ed energie intellettuali. Scrive la sceneggiatura e propone una precisa impostazione figurativa, ispirata alla pittura di Giotto. Inoltre interviene decisamente nelle scelte di regia, pretendendo di non essere mai inquadrata in primo piano. Spesso imputata a un banale narcisismo, alla preoccupazione di non mostrare al pubblico i segni evidenti della sua vecchiaia, questa scelta trova una spiegazione più verosimile nella natura fondamentalmente teatrale della sua recitazione (di fatto l’attrice non fa niente per nascondere la sua età). Ma è vero che l’assenza di primi piani conferisce al film un andamento ieratico e solenne, che delude le aspettative del pubblico: al cinema, la grande Duse appare così piccola e insignificante da sembrare una donna qualunque. Uscito nel 1916, Cenere si risolve in un gigantesco insuccesso, tanto da spin-
gere la Duse a rinunciare definitivamente ad altri progetti cinematografici di cui si trova traccia nella sua corrispondenza di questo periodo. Altra figura di grande personalità è la polacco-ucraina Diana Karenne (vero nome Leukadia Konstantin 1888-1940), emigrata in Italia nel 1914 e subito scritturata come attrice alla Roma Film di Torino. Sempre a Torino, lavora all’Aquila, all’Ambrosio e alla Pasquali, facendosi notare per la sua fisionomia non convenzionale e per uno stile di recitazione inquieto, moderno, di sapore vagamente espressionista. Dirige il suo primo film, Lea, nel 1916 e l’anno dopo dà vita a una propria Casa di produzione, la Karenne Film. Tra il 1917 e il 1922, anno in cui interrompe la sua attività registica per dedicarsi, tra Francia, Germania e Italia, unicamente alla recitazione, si dirige in dodici film, dando vita a una galleria di figure femminili anticonvenzionali, sofferenti ma dotate di grande forza interiore, in cui traspare una sottile vena femminista e un’insolita capacità di introspezione psicologica, forse debitrice della drammaturgia di Ibsen. Purtroppo nessuno dei film da lei diretti è sopravvissuto e rare sono pure le testimonianze del suo lavoro di attrice. Secondo Vittorio Martinelli “quasi tutti i suoi film incontrarono intoppi”, perché la censura “non le dava tregua”: in particolare un film interpretato nel 1916, Quand l’amour refleurit, “perché vi si parlava liberamente di aborto”6. Nata a Palermo nel 1865, Giulia Rizzotto (in Cassini) esordisce in teatro nella compagnia del padre, il celebre attore Giuseppe Rizzotto. Nel corso della sua lunga carriera teatrale lavora presso compagnie prestigiose (Ermete Novelli, Talli-Gramatica-Calabrese, Ruggeri, Tumiati, Zacconi). Passa al cinema nel 1912, quando ha già quarantasette anni, interpretando parti di madre o di seconda donna presso numerose case di produzione (Latium, Roma, Etna, Cines, ecc.). Nel 1918 apre a Roma l’Ars Film, una delle prime scuole di recitazione cinematografica. Contemporaneamente dirige Scugnì (1918), basato sulle disavventure di un ragazzo di strada napoletano, realmente conosciuto dalla regista e interpretato da un’allieva del suo corso di recitazione, Franca di Leo. In seguito gira con Mario Corsi un film di am319
bientazione storica, Leonardo da Vinci (1919), che risulta aver circolato anche al di fuori dell’Italia, nei paesi scandinavi. L’ultima delle sue cinque regie, A mosca cieca (1921) è un tentativo di commedia brillante che si avvale dell’interpretazione di alcuni rappresentanti del patriziato romano, affiancati da giovani sconosciute, presumibilmente formate presso la sua scuola. Innocuo divertissement senza pretese, ma non privo di momenti gustosi, il film costituisce insieme a Leonardo uno dei rari esempi tuttora visibili della produzione femminile del cinema muto italiano. La carriera di Giulia Rizzotto si conclude in Argentina, dove si trasferisce con la compagnia di Maria Melato dopo la morte del marito (l’attore Alfonso Cassini, deceduto nel 1921) e dove prosegue la sua attività di insegnante di recitazione fino alla morte, avvenuta nel 1943. Piuttosto consistente è anche la produzione registica di Gemma Bellincioni (1864-1950) celebre soprano, moglie dell’altrettanto celebre tenore Roberto Stagno, che una volta abbandonate le tavole del palcoscenico si dedica per un certo periodo al cinema, dirigendo diversi film interpretati dalla figlia Bianca e prodotti in proprio attraverso la Biancagemma Films. Grande diva dell’opera, in particolare nella sua versione verista (nel ruolo di Santuzza ha portato al trionfo La cavalleria rusticana), Bellincioni sembra trovarsi perfettamente a suo agio anche dietro la macchina da presa, dirigendo una decina di lungometraggi tra il 1917 e il 1923. Sistematicamente interpretati dalla figlia Bianca, i suoi film si basano su soggetti piuttosto convenzionali, che spesso non incontrano il favore della critica. In assenza dei film, tutti perduti, è oggi impossibile stabilire fino a che punto questi giudizi negativi fossero fondati, o non piuttosto motivati dalla diffusa misoginia che caratterizza la cultura italiana del periodo. Tra i suoi film, vale la pena ricordare almeno Giovanna I d’Angiò, regina di Napoli (1920), da lei stessa interpretato nel ruolo della belluina sovrana strangolatrice che, dopo aver ucciso il marito, andò incontro a una fine altrettanto crudele. A Milano, che insieme a Torino, Roma e Napoli è uno dei quattro centri in cui si divide la produzione cinematografica italiana del periodo muto, è attiva 320
Elettra Raggio (al secolo Ginevra Francesca Rusconi, 1887-1973). Dopo un apprendistato teatrale come prima attrice nella compagnia di Ermete Novelli, viene scritturata alla Milano Film, dove interpreta Verso l’arcobaleno (1915), che le vale l’ammirazione della critica e del pubblico. Con il suo viso pallido e affilato, Elettra Raggio (così battezzata, secondo una notizia che non trova riscontro nelle fonti, da Guglielmo Marconi) introduce sugli schermi italiani una fisionomia che si distacca decisamente dalle convenzioni estetiche di primo Novecento, una bellezza moderna ben lontana da quella delle dive del periodo. Ma la sua modernità si esprime soprattutto nella creatività e nella capacità d’iniziativa che dimostra, prima scrivendo soggetti e sceneggiature per la Milano Film, e poi creando, nel 1916, una propria Casa di produzione, la Raggio Film. Qui supervisiona la realizzazione di diverse pellicole tratte da suoi soggetti, in cui appare al fianco di Ermete Novelli, o interpretati dalla sorella Maria: tra questi, Automartirio (Ivo Illuminati, 1917) narra la storia di una donna che, con immensa pena, sceglie di allontanare da sé il proprio figlio per assicurargli un avvenire migliore. Realizza anche due film come regista, Le due seduzioni (1916) e San-Zurka-San (1920), purtroppo oggi perduti. Tutto ciò che resta del lavoro di colei che fu definita “l’audace amazzone dell’arte cinematografica”7 è una copia di Morte che assolve, da lei prodotto e interpretato (al fianco di Ermete Novelli), nel 1917. Non può mancare in questa rassegna il nome di Bianca Virginia Camagni (1889), attrice raffinata e intellettuale, legata sentimentalmente allo scultore Severo Pozzati (Sepo) e protagonista insieme a lui di una delle sperimentazioni cinematografiche più interessanti – ancorché sfortunata – tra quelle realizzate nel periodo muto, che merita di essere ricordata con una certa ampiezza. All’origine del progetto vi è Alfredo Masi, regista con ambizioni di teorico, che sulle pagine della rivista “Apollon”, difende l’idea di un cinema concepito essenzialmente come arte figurativa, basata sulla luce, le forme e i colori e resa più espressiva dal connubio con la musica. Nel 1919 (con il sostegno dell’industriale milanese Achille Brioschi) Masi ha l’idea di girare un film ba-
Le protagoniste
sato su queste premesse, una ‘sinfonia visionata’ di cui cura la regia insieme all’amico Sepo. Per le musiche, che hanno un ruolo fondamentale nel progetto, viene coinvolto Vittorio Gui, mentre la parte principale, quella di un Pierrot malinconico e crudele, viene affidata a Bianca Camagni. Impossibilitato a seguire il montaggio per motivi familiari, Sepo ritrova il suo film completamente stravolto solo al momento della sua presentazione pubblica, rendendosi conto che in sua assenza Gui e Masi hanno ridotto il lavoro a un’astrusa successione di immagini, facendo della musica il vero fulcro dell’opera. La prima si risolve in un disastro e il film viene ritirato dalla circolazione. A questo punto entra in gioco Bianca Camagni che, coadiuvata da Tito A. Spagnol, rileva la pellicola e la sottopone a un nuovo montaggio, aggiungendo nuove scene e introducendo un nuovo personaggio, che affida ad Amleto Novelli. Modificato il titolo (da Fantasia bianca a Fantasia), ripresenta il film in censura e lo riedita nel 1921 tramite la Camagni Film, Casa di produzione appositamente costituita. L’operazione ha un discreto successo, sia di pubblico che di critica, dando modo a Camagni e Spagnol di realizzare un secondo lungometraggio, La sconosciuta (1921), che in una recensione è salutato come una “geniale intuizione”, condotta “con linee di grande passionalità”. Entrambi i film sono andati perduti, cosicché per farsi un’idea della complessa personalità di questa cineasta non resta che affidarsi alla testimonianza di un giornalista che la intervistò nel 1917: “la stanza dove Bianca Virginia Camagni mi ha ricevuto, mi ha destato l’impressione di uno studio da giornalista, o d’uno scrittoio da letterato. Negli armadi, negli scaffali stavan premuti dei gran volumi, di ogni sorta di autori: sul tavolo si notava quella confusione di libri e carte che mi par proprietà delle persone di molto ingegno [...]. E mi ha colpito la vista d’un teschio umano che biancheggiava nella sua nudità orrenda tra mezzo lo scompiglio dei libri aperti e delle pagine sfogliate”8... Un altro caso curioso, che si conclude a sua volta in un fallimento, è quello del film Bolscevismo??!! (1920), prodotto, diretto e interpretato da una giovane fiorentina (Elena Mazzantini, 1900), che si cela dietro lo pseudonimo di Daisy Sylvan. Il soggetto,
firmato da un certo Danilo Korsakoff e presentato come “un dramma sociale raccapricciante”9, è animato da un evidente spirito anticomunista: cosa del tutto inconsueta nella produzione del periodo, che in genere evita attentamente di schierarsi su posizioni politiche esplicite. In ogni modo non è il soggetto a causare la violenta polemica, riportata da molte riviste di settore, che determina la mancata distribuzione del film. Alla base sembrano esservi piuttosto motivi di carattere sindacale: il critico Giuseppe Lega arriva ad accusare la Daisy Film di comportamenti antisindacali nei confronti del personale della società, licenziato in tronco per motivi imprecisati. La Daisy Film risponde con grandi annunci su tutta la stampa specializzata, precisando che al contrario i motivi erano gravi e plausibili, e presenta una querela che a sua volta dà luogo a una controquerela… Del film non si hanno altre notizie ed è lecito dubitare che sia mai stato presentato al pubblico. Anche un secondo film, Sovrana!..., prodotto, diretto e interpretato da Daisy Sylvan nel 1923, non sembra aver avuto alcuna distribuzione. Scarse sono pure le notizie relative alle esperienze registiche di Diana D’Amore (vero nome Floriana D’Amore, 1896) e Fabienne Fabrèges (1889). Entrambe attrici – la prima presso varie Case di produzione torinesi; la seconda presso la francese Gaumont, al fianco di Suzanne Grandais in numerosi film di Léonce Perret –, tentano la strada della regia con entusiasmo, ma con scarsi riscontri di critica e di pubblico. Diana D’Amore gira Sulle rovine d’un sogno (1917), basato su una sua sceneggiatura, per il quale disegna anche un manifesto e alcune caricature utilizzate nelle didascalie. La seconda, giunta in Italia nel 1915, lavora come attrice in diversi film, prima di curare la produzione di due serial presso la De Giglio di Torino, S. M. il denaro e S. M. l’amore, entrambi del 1919. Nello stesso anno dirige, sceneggia e interpreta due film: L’altalena della vita e Il cuore di Musette. Ancor più misterioso è il caso di Elvira Giallanella, un nome che sarebbe caduto per sempre nell’oblio se l’unico film da lei diretto, Umanità (1919), non fosse fortunosamente sopravvissuto, recentemente 321
ritrovato presso gli archivi della Cineteca Nazionale. Di lei si sa solo che i suoi primi contatti con il cinema risalgono al 1913, quando firma insieme ad Aldo Molinari l’atto costitutivo della Vera Film di Roma. La Vera è la Casa che nel 1913 produce Mondo baldoria, film di ispirazione futurista (liberamente tratto dal manifesto Il controdolore di Aldo Palazzeschi) che subisce l’attacco della censura e dello stesso Marinetti, che lo sconfessa in un testo intitolato Gli sfruttatori del Futurismo10. Nel 1920, un articolo apparso su “La Rivista del cinematografo” ci informa che “la signorina Elvira Giallanella, che diede prova di intelligenza e d’attività e di gusto artistico e di sani criteri commerciali” alla Vera Film, ha fondato a Roma la Liana Film “con un vasto programma di lavoro, che comprende grandi films di intreccio o di ricostruzione storica e films per bambini, le quali saranno interpretate da bambini”11. Ma di questo “vasto programma”, l’unico titolo a vedere la luce sembra essere Umanità, una singolare allegoria di ispirazione pacifista i cui protagonisti sono appunto due bambini, Tranquillino e Serenetta. Tratto da un racconto per ragazzi di Vittorio Bravetta intitolato Tranquillino dopo la guerra vuol ricreare il mondo… nuovo – in versi e impreziosito da illustrazioni a colori –, il film è presentato come un lavoro “umoristico-satirico-educativo” e nella sua ambizione di coltivare nei fanciulli l’orrore della guerra spicca come un’opera di assoluta originalità nel panorama cinematografico del periodo.
… imprenditrici… Una parte importante della storia della partecipazione delle donne italiane all’industria del cinema riguarda il loro impegno imprenditoriale nel settore della produzione e del noleggio. A cavallo tra anni Dieci e Venti si contano numerosi casi di donne che si affacciano sulla scena cinematografica in qualità di produttrici o distributrici. Alle Case fondate dalle registe già ricordate (Notari, Karenne, Raggio, Cassini, Bellincioni, Sylvan, Camagni, Giallanella) si aggiungono quelle iniziate da attrici o semplici imprenditrici, che scelgono di investire in proprio in un settore industriale particolarmente dinamico e in 322
apparenza promettente. In molti casi si tratta di brevi esperienze che non resistono alla prova della concorrenza, ma che ci parlano, ancora una volta, di un desiderio di affermazione sociale e di un bisogno di emancipazione in anticipo sui tempi, di una capacità di iniziativa che contrasta con la concezione egemonica della donna come figura vincolata alla sfera domestica. Il fenomeno è notevole soprattutto a Torino, città dotata di un solido tessuto industriale e particolarmente sensibile agli stimoli della cultura europea, che costituisce in questi anni il secondo principale centro di produzione cinematografica della Penisola. Per interpretare correttamente questa fioritura di imprese cinematografiche dirette da donne è necessario tener conto del generale contesto produttivo entro cui si sviluppa. Come gli storici hanno ripetutamente sottolineato, verso la fine degli anni Dieci la produzione cinematografica italiana manifesta una tendenza sempre più evidente alla frammentazione e all’improvvisazione industriale, con un gran numero di imprese che nascono e muoiono nel giro di pochi anni o addirittura di mesi, create su due piedi e destinate al fallimento dopo aver editato, magari, un solo film. Questo gran fermento di iniziative determina un’inflazione dell’offerta che alla lunga destabilizza il sistema (peraltro indebolito dalla mancanza di una solida struttura distributiva) e conduce alla ben nota crisi che colpisce il nostro cinema all’inizio degli anni Venti. La proliferazione di imprese cinematografiche al femminile si inserisce dunque in un quadro generale fortemente eterogeneo e frammentato, che proprio nella sua mancanza di solide strutture economiche e di potere può aver incoraggiato i progetti industriali di molte donne. Non è interessante in questa sede sottolineare l’esito spesso poco fortunato di queste iniziative: in questo periodo, si tratta di un destino condiviso anche da un gran numero di imprese create da uomini. Del resto non è lecito dubitare che le varie iniziative imprenditoriali delle donne finiscano per scontrarsi con una serie di pregiudizi sociali e culturali, che rendono il loro percorso enormemente più difficoltoso di quello dei loro colleghi e competitori maschi. Quello che davvero conta è la capacità
Le protagoniste
di queste pioniere di affermare il proprio desiderio di intraprendere e di fare cinema, di non restare semplici spettatrici di progetti e iniziative esclusivamente maschili. Tra le attrici che tentano la via della produzione nel capoluogo piemontese merita di essere segnalata Mary Cléo Tarlarini (Maria Cleope Terlani), interprete fin dal 1908 di numerosi film di successo presso l’Ambrosio, la Pasquali, l’Itala e altre Case di produzione. Nel 1918 fonda con Eugenio Vecchioni la Cléo Film, che in breve tempo edita sei lungometraggi. Sempre a Torino, nel 1921, Bianca Maria Guidetti Conti dà vita a una Casa di produzione che nel giro di appena due anni realizza otto lungometraggi, tutti da lei interpretati, alcuni dei quali, come Tragedie d’anime, diretto da Febo Mari, ottengono recensioni lusinghiere. Tra le scarse notizie che si hanno di questa esperienza imprenditoriale spicca la testimonianza di Gian Paolo Rosmino, co-protagonista di Il miraggio di mezzanotte (Achille Consalvi, 1922) che, in un’intervista rilasciata a Vittorio Martinelli, ricorda l’“energico attivismo” dimostrato nel corso della sua breve attività dall’attrice-produttrice12. Colpisce anche che il film venga realizzato negli studi della Italo-Egiziana, piccola compagnia creata nel 1917, tra i cui soci figura il nome di un’altra popolare attrice del periodo, Linda Pini. Altre Case torinesi dirette da donne, i cui prodotti hanno una circolazione limitata al circuito regionale, sono la Tornielli Film e la Sylva V.: la prima, fondata da Elsa Tornielli, realizza quattro lungometraggi tra il 1920 e il 1921, tutti interpretati dalla proprietaria; la seconda ha all’attivo un unico film, Da Lord a detective (Gigi Taglieri Terni, 1922), scritto e interpretato da Vera Sylva. Altri casi interessanti sono quelli di Letizia Quaranta e Maria Roasio. La prima, vivace attrice (e forse sceneggiatrice) di film avventurosi al fianco di Carlo Campogalliani, fonda con lui la Campogalliani & Co., che tra il 1921 e il 1922 produce sei pellicole che ottengono un buon consenso di critica e di pubblico e fanno paragonare la sua dinamica interprete alla diva dei serial americani Pearl White. La seconda produce almeno uno dei film da lei interpretati, una bizzara fantasia fantascientifica, tramite la Roasio Film (La bambola vivente, Luigi Maggi, 1924),
ma già nel 1922 risulta come proprietaria della Star Film (marchio che tuttavia sembra essere rimasto solo sulla carta). E ancora, tra le donne che tentano la strada della produzione nel capoluogo piemontese, si possono ricordare i nomi di Semele Temofila Bertolina, editrice tramite la Delta di tanti film del piccolo, scapestrato forzuto Domenico Gambino (Saetta), Aloisia Gallesio, promotrice della singolare operazione che porta sugli schermi un film del fratello Pier Nicola (impiegato delle Ferrovie), La denunzia (1923), e delle attrici Adriana Costamagna e Lydianne13. Il ritrovamento di tanti nomi di donne nell’industria cinematografica torinese testimonia certo di un tessuto economico e sociale particolarmente dinamico e aperto alle innovazioni della modernità, ma è anche il risultato di un lavoro di scavo e di ricerca che per altre città non è ancora stato intrapreso. Anche fuori da Torino tuttavia non mancano casi significativi di donne impegnate nella produzione cinematografica. Basti pensare per esempio a Paula Grey (vero nome Clelia Paradisi): sorella di Umberto Paradisi e collaboratrice alla messa in scena di molti film del fratello, edita tre titoli tra il 1920 e il 1923, attraverso una Casa di produzione legata alla scuola di recitazione (l’Accademia d’Arte Muta) che dirige a Genova. O ancora a Berta Nelson, che dopo aver esordito come attrice protagonista nel rutilante dramma avventuroso Vittoria o morte (Segundo de Chomón, 1913), nel quale ricopre un ruolo eroico di donna d’azione, sembra avere difficoltà a sfondare e forse per questo, nel 1921, apre a Roma una propria Casa di produzione, che realizza quattro film, due dei quali, La dama errante (Aleksandre Uralsky, 1921) e Ali spezzate (Luigi Maggi, 1923), sono conservati presso la Cineteca Nazionale. Altre esperienze imprenditoriali si sviluppano nel settore della distribuzione e della pubblicità. La figura più affascinante è quella di Frieda Klug, una giovane ungherese che nel 1909, dopo essere stata un anno negli Stati Uniti, diviene titolare di un’agenzia di noleggio a Torino. Evidentemente stupito di fronte a tanto dinamismo, così la descrive nel 1910 un cronista della “Vita cinematografica”, con una 323
prosa tanto forbita quanto incoerente con la modernità di questa figura: “Un esile corpo irrequieto, pieno di scatti e di movenze feline; uno spirito alacre ed una mente fertile; due sopracciglia foltissime, sotto cui guizzano incessantemente, nella loro orbita, i vividi bulbi visivi che non conoscono la calma della contemplazione e la fissità dell’estasi. Un viluppo di muscoli, protesi costantemente nell’alterna vicenda delle soste brevi e dei viaggi snervanti, tale è Frieda Klug, quale io l’ho sorpresa nel suo minuscolo ed un po’ disordinato ufficio, in Galleria Nazionale, mentre di poco tornata da una corsa rapida per l’Italia, ad un’altra si accingeva con la stupefacente disinvoltura di chi esce di casa per comperare un pacco di sigarette. E mentr’io, ammirato da tanta fervorosa attività, contemplavo la sua agile personcina sdoppiarsi e moltiplicarsi in tante piccolissime cure, dar passo alla corrispondenza abbondante e plurilingue, Ella con bel garbo mi porse una sua fotografia, dicendomi: “Prendete e ricordatevi qualche volta di me”14… Ancora a Torino, nel 1912, ad opera di un gruppo composito in cui spicca la figura di Lydia De Liguoro, nasce la Lydel Film, società che si occupa di “pubblicità animata nei cinematografi”. In pratica, si tratta di una Casa specializzata nella realizzazione di film pubblicitari, che si inserisce agilmente nel fiorente commercio del cinema torinese degli anni Dieci. Il marchio Lydel, pseudonimo giornalistico di Lydia Dosio De Liguoro, viene in seguito adottato come titolo di una rivista di moda da lei fondata nel 1919: con abile mossa promozionale Lidel viene ora presentato come l’acronimo di Letture, Illustrazioni, Disegni, Eleganza, Lavori, ovvero delle cinque aree tematiche in cui è suddivisa la rivista. La carriera di questa brillante e popolare giornalista, che si definisce “l’indomabile fantaccina della moda italiana”, prosegue baldanzosamente lungo tutti gli anni Venti, favorita anche dalla scelta opportunistica di aderire al fascismo.
… soggettiste e sceneggiatrici… Il rapporto delle donne con il cinema passa anche attraverso la scrittura. Si tratta di un fenomeno che in Italia risulta meno rilevante che in altri paesi (si 324
pensi soprattutto agli Stati Uniti e alla Germania, dove le donne che si affermano nel settore della sceneggiatura sono decisamente più numerose), ma in cui non mancano alcuni casi notevoli. Di fatto, l’unica donna che sembra aver praticato con continuità l’attività di sceneggiatrice è Renée de Liot, moglie dell’attore-regista Maro Guaita, noto per le sue prestazioni atletiche in un consistente gruppo di film appartenenti al cosiddetto filone degli ‘uomini forti’. Di origine marsigliese, Renée de Liot scrive in pratica tutti i film interpretati dal marito nel ruolo di Ausonia (circa una quindicina), contribuendo ad alimentare la fortuna di questo particolare genere avventuroso, fiorito in Italia sulla scia del successo del personaggio di Maciste15. Un interessante esempio tuttora visibile del suo lavoro è L’atleta fantasma (1919), “bizzarria cineatletica” incentrata su una simpatica figura di ladro gentiluomo, che testimonia di una sicura padronanza degli strumenti della drammaturgia cinematografica. Nulla è sopravvissuto invece del lavoro di Nelly Carrère, moglie dello scrittore e sceneggiatore Jean Carrère, accreditata come soggettista di una manciata di film realizzati tra la fine degli anni Dieci e l’inizio degli anni Venti. Uno dei suoi lavori – Lolita, di Ugo Falena, 1918 – viene elogiato da un critico per l’assenza dei difetti che in genere caratterizzano i soggetti scritti appositamente per il cinema, ovvero per “lo svolgimento non artificioso, ricco di logica e verosimiglianza… l’assenza di colpi di scena più o meno fantastici, e poi [per] una semplicità di conduzione, un’esattezza psicologica … che va dritta alla fine, attraverso la strada assegnatale fin dal principio”16. Meno fortunato è il tentativo di affermarsi come sceneggiatrice di Lina Ferraris (1881-1943) moglie di Domenico Cazzulino, un esercente e noleggiatore torinese che ha una partecipazione di primo piano nella Film Artistica Gloria. Dei cinque soggetti da lei firmati, due dei quali conservati presso L’Archivio Documenti del Museo del Cinema di Torino, l’unico realizzato, prodotto dalla Gloria, porta il titolo Diritto di uccidere17. Limitate a un unico titolo sono anche le esperienze cinematografiche
Le protagoniste
di Ofelia Colautti e Suzanne De Canalis. La prima, figlia del poeta Attilio Colautti, nel 1917 si occupa di ridurre per lo schermo un poema del padre, L’Aquila, affidato alla regia di Mario Gargiulo (Flegrea Film). La seconda, la cui figura rimane avvolta nel mistero, firma il soggetto di una commedia decisamente audace per l’epoca, La signorina… madre di famiglia (Carmine Gallone, 1924), incentrata su una figura di donna anticonvenzionale (l’artista Thea Carrell), che sceglie di avere un figlio al di fuori del matrimonio. Un capitolo a parte riguarda la collaborazione al cinema di alcune popolari scrittrici dell’epoca. Il caso più eclatante è quello di Matilde Serao (1856-1927), la romanziera e giornalista napoletana che rappresenta una delle personalità femminili più presenti sulla scena pubblica italiana di primo Novecento. Divorziata (dal giornalista Edoardo Scarfoglio) e madre di cinque figli, Serao trova il tempo di dirigere un giornale e di intervenire regolarmente nel dibattito culturale, manifestando la più viva curiosità per le molte novità che si affacciano sulla scena all’inizio del secolo. Il suo interesse per il cinema risale al 1906, anno in cui pubblica quello che viene ricordato come il primo articolo sull’argomento scritto da un intellettuale in Italia, in anticipo su Papini, Pirandello ecc., dal titolo Cinematografeide18. In seguito continua a seguire con grande attenzione gli sviluppi dell’industria cinematografica, in particolare facendosi portavoce, sulle pagine del suo quotidiano “Il Giorno”, delle iniziative del distributore napoletano Gustavo Lombardo. Vale la pena di ricordare il suo impegno nella promozione del film Inferno (Francesco Bertolini, Adolfo Padovan, 1911), importante produzione della Milano Film tratta da Dante, di cui Lombardo acquisisce i diritti per lo sfruttamento nell’Italia meridionale. Amica di Francesca Bertini e di Eleonora Duse, pubblica inoltre alcuni articoli sulla rivista “L’Arte muta” fondata da Lombardo. Si cimenta anche nella stesura di soggetti originali, ma purtroppo con scarso successo: La mia vita per la tua!, realizzato da Emilio Ghione nel 1914 subisce pesanti stroncature, senza peraltro convincere l’autrice, che all’epoca ha già cinquantotto anni, a desistere dal suo interesse per il cinema.
Studi recenti hanno portato alla luce anche un soggetto originale per il cinema di Grazia Deledda (1871-1936). Ambientato in Sardegna e costellato dei temi e delle immagini cari alla scrittrice, questo testo ha forse origine nel disappunto che le sue lettere testimoniano in relazione all’adattamento di Cenere da parte di Eleonora Duse. Probabilmente delusa dalla scelta di girare il film in Piemonte, e infastidita dalla libertà con cui l’attrice-drammaturga rielabora il suo testo, la scrittrice esprime esplicitamente le sue riserve nei confronti di “chi lavora per fare apparire sullo schermo cinematografico una Sardegna fotografica e commerciale” e manifesta il desiderio, “per amore della mia isola, mio primo amore”, di non lasciarsi “sfuggire l’occasione di farla apparire qual essa è”. Nasce così un testo di straordinaria intensità, che si apre con una bellissima figura di “donna anziana” che “cavalca come un uomo”19 e che riassume al meglio tutto il sentimento di appartenenza culturale della scrittrice. Ma non sembra tuttavia che il soggetto sia mai stato proposto per una produzione, privandoci per sempre di quello che avrebbe potuto essere un incontro singolarmente fertile tra una delle più vive intelligenze di quegli anni e la nascente industria del cinema. Un altro caso interessante di letterata che si avvicina con entusiasmo al cinema è quello di Annie Vivanti (1866-1942). In un articolo pubblicato sul mensile “La Donna”, ricordando con ironia le circostanze che l’hanno condotta a scrivere un soggetto per un’attrice americana con velleità di diva, la scrittrice racconta come la sua vita sia “entrata nel turbine del cinematografia”, che esalta come “il trionfo del moto, della rapidità, dell’impeto, del vertiginoso, dell’inaspettato, dell’inverosimile, del parossismale!”20. Purtroppo ben poco si sa di questo aspetto della sua attività: l’unico titolo in cui risulta accreditata come soggettista è un film della Floreal del 1916, oggi invisibile: Astrid, di Carlo Alberto Lolli. Esito negativo ha invece la trattativa che la scrittrice porta avanti con la David-Karenne Film per la realizzazione di due pellicole su suo soggetto, una delle quali avrebbe dovuto essere un adattamento del suo romanzo Circe. Lo stesso titolo è poi coinvolto nella causa che Annie Vivanti intenta contro l’Unione Ci325
nematografica Italiana nel 1921, accusando la Casa di aver tratto dal suo libro, senza riconoscerle i diritti d’autore, uno dei cavalli di battaglia di Francesca Bertini, Piovra (Eduardo Bencivenga, 1919) Ma l’uci ha la meglio, in quanto, come riferisce l’avvocato Francesco Soro21, il Tribunale stabilisce che il film è ispirato non al libro, ma ai fatti reali in esso narrati, ovvero ai tragici fatti di sangue che avevano visto protagonista, all’inizio del secolo, la contessa Maria Tarnowska. L’invenzione di storie per il cinema sembra aver appassionato anche un nutrito gruppo di attrici. Tra le grandi interpreti teatrali che si cimentano nella stesura di testi per il cinema, ricordiamo Maria Melato (1885-1950) e Irma Gramatica (1870-1962), entrambe accreditate nel cast di alcuni film realizzati tra anni Dieci e Venti, oggi non più visibili: la prima fornisce la riduzione di Anna Karenine (Ugo Falena, 1917), da lei stessa interpretato (e forse in parte diretto); la seconda scrive il soggetto per un film in cui è coinvolta anche Bianca Camagni, dal titolo Usque dum vivam et ultra, messo in produzione, ma a quanto pare mai distribuito, dalla Zero Film nel 191722. Degni di nota sono anche i casi di Maria Jacobini (1890-1944), Anna Fougez (1860-1966) e Vera D’Angara. La prima, attrice estremamente originale nel panorama dell’epoca, caratterizzata da uno stile di recitazione fresco e naturale, lontanissimo dalle iperboli divistiche, è accreditata come soggettista di Cainà (Gennaro Righelli, 1922), un film di ambientazione sarda, che si segnala per la sensibilità protofemminista con cui affronta il tema dello stupro, facendo della vittima della violenza un’eroina di prima grandezza. Anna Fougez, celebre stella del caffè chantant, ancora oggi ben nota per la sua languida interpretazione della canzone Vipera, uno dei motivi più popolari degli anni Venti, fornisce il soggetto di Fiore selvaggio (Gustavo Serena, 1921), una delle sette pellicole che interpreta tra il 1916 e il 1922. Infine, Vera D’Angara firma soggetto e sceneggiatura di almeno tre dei film che interpreta al fianco del marito, l’eclettico artista Toddi (Pietro Silvio Rivetta). Attrice spigliata e vivace, dà vita a commedie brillan326
ti tra cui spicca Dva sagapà para (Toddi, 1923), che un critico dell’epoca saluta come un film di “pura essenza comica, fine, aggraziato, pieno di garbo, di scintillante brio, di trovate inesauribili”23.
… attrici comiche e atlete di prim’ordine… Infine vogliamo ricordare i nomi di alcune grandi attrici che riuscirono a sovvertire i classici stereotipi di genere grazie a un formidabile talento comico o atletico-acrobatico e che, forse proprio per questo, stentano ancora oggi a essere riconosciute nel loro giusto valore24. Del resto, il ruolo essenziale che l’improvvisazione assume nei generi d’azione del periodo muto può facilmente far presumere un importante intervento creativo delle attrici anche a livello della elaborazione dei soggetti e delle trame, in molti casi semplici canovacci che trovano la loro realizzazione drammaturgica solo grazie all’ingegno dell’interprete. Vera e propria ‘ragazza terribile’ del primo cinema italiano, Lea Giunchi esordisce alla Cines come partner di Tontolini, personaggio creato da Ferdinand Guillaume, fratello di suo marito Natale. Tra il 1911 e il 1914, sempre alla Cines, ricopre il ruolo di Lea in una serie che conta più di quaranta titoli, talvolta in coppia con i comici Kri-Kri (Raymond Frau), Checco (Giuseppe Gambardella) e Cocò (Lorenzo Soderini), o affiancata dal piccolo Cinessino (suo figlio Eraldo). Dal 1915 è con il marito alla Caesar dove gira ancora diversi film come Lea o come spalla di Polidor (nuovo personaggio lanciato dal cognato Ferdinand Guillaume). Nelle brevi comiche che la vedono protagonista (tra cui vale la pena di ricordare un Lea femminista del 1910), Lea agisce come una forza irresistibile capace di trasformare in gioco qualsiasi ostacolo che le si pari innanzi. Si veda per esempio Lea e il gomitolo: per obbedire ai genitori che le chiedono di occuparsi di cucito invece di perdere la testa sui libri che l’appassionano, la ragazza si mette alla ricerca di un gomitolo ribelle che non si vuol far trovare e nell’operazione mette la casa a soqquadro, rompe mobili e ceramiche, finché i genitori, disperati, le concedono di tornare sui suoi libri, che in
Le protagoniste
fin dei conti sembrano essere il male minore... O ancora in Lea si diverte: molestata da un grassone che importuna tutte le ragazze dell’ufficio in cui lavora, Lea prepara al prepotente una lezione. Finge di starci e gli dà un appuntamento in un ristorante dove ne succedono di tutti i colori e dove l’uomo, conciato per le feste, subisce anche la beffa di vedersi presentare un conto stratosferico per i danni causati dalla vulcanica fanciulla. Più eclettica, ma a sua volta particolarmente versata nella farsa e nella commedia, è la torinese Gigetta Morano (1887-1986). Scritturata dallo studio Ambrosio nel 1909, appare in diversi film drammatici prima di scoprire il proprio talento comico in Gigetta al reggimento (1910), primo titolo di una serie che ne conta almeno quindici. Impareggiabile spalla, compare al fianco di Marcel Fabre in alcuni film della serie Robinet e accanto a Eleuterio Rodolfi, in numerose pellicole di grande successo. Con il suo stile di recitazione ammiccante e ricco di sottintesi, è l’interprete ideale di tante commedie degli equivoci, da La meridiana del convento a Le nozze di figaro, divenendo una delle figure più popolari del cinema muto italiano. Ritorna sugli schermi alla fine degli anni Cinquanta, accogliendo l’invito di Federico Fellini, che le offre una parte prima in I vitelloni e poi in Otto e mezzo. Una memorabile testimonianza della sua attività cinematografica e della sua orgogliosa personalità è l’intervista filmata da lei rilasciata, ormai quasi centenaria, ad Alberto Farassino, nel 1985. Altre popolari attrici comiche del periodo muto sono Valentina Frascaroli e Nilde Baracchi. La prima, moglie di André Deed, in arte Cretinetti, è al suo fianco in una lunga serie di film realizzati in Italia e in Francia, e sua partner sul palcoscenico in tante farse di successo. Bimba agitata da irrefrenabili pulsioni in L’ultima monelleria di Cretinetti (André Deed, 1911) è una ladra dai mille volti e di inesauribili risorse in L’uomo meccanico (André Deed, 1922) dove sembra ispirarsi, per il suo personaggio, alle notturne eroine dei serial francesi. Quanto a Nilde Baracchi, partner di Marcel Fabre in molti film della serie Robinet, riesce a svincolarsi del suo ruolo di semplice
spalla in un piccolo gruppo di film intitolati al suo personaggio Robinette, spesso basati sull’effetto di disorientamento provocato da una figura femminile che si sottrae ai canoni della tradizione. In Robinette nichilista, per esempio, è una scrittrice che viene scambiata per un’anarchica incendiaria e inseguita dalla polizia, che la confonde con il personaggio da lei creato nella finzione letteraria… La si può ancora ricordare in un episodio del serial Le straordinarissime avventure di Saturnino Farandola (Marcel Fabre, 1914), dove dà vita all’affascinante figura di Mysora, bellissima palombara che il cattivo di turno rapisce e imprigiona in un’acquario sottomarino. Un discorso a parte va riservato alle donne d’azione, vero e proprio fenomeno caratteristico del muto italiano. In testa alla lista bisogna ricordare Astrea, poderosa atleta di cui nessuno ha potuto fin qui ricostruire, anche per grandi linee, la biografia. Forse proveniente dal mondo del circo (ma è questa una pura ipotesi suggerita dagli spettacolari numeri di stampo culturista di cui è protagonista, mentre alcune cronache in riviste di cinema la indicano come una “nobildonna veneziana”25), appare in non più di quattro pellicole, di cui almeno una, Justitia (Ferdinand Guillaume, 1919), la fa conoscere in tutta Europa come la ‘donna Maciste’. Fortunosamente giunto fino a noi in una versione molto lacunosa, il film la mostra nel doppio ruolo di principessa – truccatissima e in abito da sera, secondo il più consueto cliché divistico –, e di giustiziera dal grande cuore, che prende sotto la sua protezione una coppia di innamorati perseguitati dai soliti cattivi. All’inizio della vicenda, la vediamo impegnata nei suoi esercizi quotidiani, a sollevare pesi e bilancieri, per poi assistere a un incontro di boxe nel quale sconfigge, sulla pubblica piazza, un muscoloso avversario. I critici vanno in visibilio: se un recensore italiano la definisce “forte, agile, ardita e atleta di prim’ordine e signora elegantissima al tempo stesso”, la rivista inglese “The Bioscope” ne parla come di “un’erculea donna che sembra avere le astuzie di Houdini, una sorta di cavaliere femminile che vaga per il mondo alla ricerca di torti da raddrizzare, sgominando, con la forza dei suoi muscoli, un’accolita di furfanti matricolati”26. 327
Ma in questi anni, le donne che si lanciano a testa bassa nel cinema d’azione, confrontandosi con gli uomini sul terreno acrobatico e muscolare, sono tutta una schiera27. Si va da Piera Bouvier, una rossa alta un metro e ottanta, protagonista del serial L’elegante canaglia di Parigi (Gennaro Righelli, 1919) nel ruolo di un’imprendibile ladra in tuta nera, a Henriette Bonard, partner di Maciste e di altri forzuti in tante concitate avventure, che nel 1920 veste i panni di Nina la poliziotta (Giuseppe Guarino, 1920), personaggio ispirato a un romanzo di Carolina Invernizio, alla danese Emilie Sannon che, già ben nota nel suo Paese come stella del cinema acrobatico, gira in Italia un film di avventure aeree (La fanciulla dell’aria, Alfred Lind, 1923), in cui si esibisce in una serie di numeri da brivido, a Gisa-Liana Doria, altra acrobata specializzata in numeri aerei (Il pilota del Caproni n. 5, 1919), a Fede Sedino, esperta cavallerizza che per le sue arditezze cinematografiche diviene presto nota come la “Pearl White italiana”. Al modello di Pearl White, regina del serial americano, si richiama anche il personaggio interpretato da Ethel Joyce in Gli artigli d’acciaio (Giuseppe Guarino, 1920), otto mirabolanti episodi in cui l’attrice (affiancata da una giovanissima Paola Borboni) ha modo di dimostrare, come scrive un critico, una “valentìa ginnica” e una “destrezza di movimenti” fuori del comune. Linda Albertini, presentata nella pubblicità come la “moglie” di Luciano Albertini (Francesco Vespignano, in arte Sansonia), è al suo fianco in una lunga serie di film d’azione prima di divenire titolare di una propria serie nel ruolo di Sansonette, intrepida giustiziera che sorprende grandi e piccini con le sue doti di trapezista, acrobata, cavallerizza…
… e altre ancora Possiamo dunque ritenere completa questa rassegna delle donne di cinema che, pur nello sfavorevole contesto di un’Italia bigotta e patriarcale, riuscirono a essere qualcosa di più e di diverso che non semplici icone di grazia e di bellezza? Tutt’altro. Di sicuro sono ancora molti i nomi e le storie che attendono di essere sottratti all’oblio, perché l’esplorazione del nostro cinema muto da un punto di vista 328
di genere è appena all’inizio e lascia intendere di poter rivelare molte altre sorprese. Resta, per esempio, ancora tutta da indagare la presenza delle donne nei comparti tecnici della produzione, nei laboratori, nelle sale di montaggio, nel settore della scenografia e dei costumi. Di sicuro, la prevalenza di mano d’opera femminile nelle manifatture cinematografiche è testimoniata da un gran numero di fotografie, che mostrano lunghe file di operaie intente al lavoro negli stabilimenti di sviluppo e stampa. È così che ha inizio, in effetti, la lunga, straordinaria carriera cinematografica di Esterina Zuccarone (1905-1999), da lei stessa rievocata, due anni prima della morte, in un toccante film-intervista realizzato da Milli Toja (La storia di Esterina, 1997). Emigrata a Torino dalla Puglia insieme alla famiglia nel 1912, Esterina viene assunta come operaia alla Positiva, un laboratorio di sviluppo e stampa, a soli quattordici anni, dopo un breve apprendistato come sarta. Nelle sue testimonianze ricorda che “il lavoro era duro, dodici, quattordici ore di lavoro e la paga era bassa. Che ero brava lo capirono subito, a diciassette anni ero la capo-reparto di una bella squadra di dieci uomini e tutti mi davano retta!”. Forse grazie alla sua esperienza nel taglio e nel cucito riesce facilmente a impadronirsi dei segreti del montaggio, attività che continua a svolgere con competenza e passione fino alla fine della sua carriera. Trasferita dalla Positiva alla Itala nel 1926, vi lavora per tre anni prima di passare alla f.e.r.t., il principale stabilimento cinematografico torinese, dove si occupa tra l’altro di montaggio del suono. Negli anni Sessanta viene chiamata a costituire e dirigere il reparto cinematografico della Fiat, presso il quale supervisiona la realizzazione di numerosi documentari industriali, alcuni dei quali firmati da Alessandro Blasetti e Mario Soldati. Pur avendo lavorato sempre nell’ombra, nel buio delle sale di montaggio, Esterina si staglia come una figura esemplare nella storia del cinema al femminile. Può valer la pena, per mostrare come questa ricerca sia in realtà soltanto all’inizio, concludere con un
Le protagoniste
ritorno alle origini, a colei che più di ogni altra merita d’esser ricordata con l’appellativo di ‘pioniera’. Sul finire dell’Ottocento, proprio mentre in Francia Alice Guy fa le sue prime esperienze dietro la macchina da presa, in Italia Anna Vertua Gentile (1850-1926) dà alle stampe un libretto sul cinema che, se non il primo, è di sicuro uno dei primi testi mai pubblicati a livello mondiale28. Scrittrice prolifica, autrice di svariate decine di romanzi e commedie per signorine, Vertua pubblica il suo Cinematografo nel 1898, a soli tre anni dall’annuncio dell’invenzione dei Lumière. In questo interessantissimo racconto lungo, in sorprendente anticipo su altri testi dello stesso genere, l’autrice descrive affascinata l’effetto di stupore e meraviglia suscitato sulle giovani spettatrici dalle immagini in movimento. È troppo poco per dire che in Italia il discorso sul cinema nasce donna? Ma basta e avanza per affermare che, diversamente dall’immagine che una lunga consuetudine storiografica ha finito per imporre, fin dall’inizio è esistito un cinema delle donne, tutta una visione e un’immaginazione declinate al femminile. A cura di Monica Dall’Asta in collaborazione con Teresa Antolin, Angelita Fiore, Alberto Friedemann, Micaela Veronesi
Note
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, una puntuale ricostruzione è fornita da Karen Ward Mahar nel suo recente Women Filmmakers in Early Hollywood, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.
1
Su Elvira Notari, si vedano gli studi monografici di Enza Troianelli, Elvira Notari, pioniera del cinema napoletano (18751946), Euroma, Roma 1989, e di Giuliana Bruno, Rovine con vista. Alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari, La Tartaruga, Milano 1995; nonché l’intervista al figlio Gennariello in Mario Franco e Stefano Masi (a cura di) Il mare, la luna e i coltelli. Per una storia del cinema muto napoletano, Pironti, Napoli 1988.
2
Si veda soprattutto la lunga intervista registrata da Gianfranco Mingozzi nel suo documentario televisivo in quattro puntate L’ultima diva (1982). Prodotto dalla rai, il lavoro di Mingozzi ha avuto anche un’edizione cinematografica, oggi disponibile in versione home video (Kino Video, 2003). 3
Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano: i film della Grande Guerra. 1915, vol. 1, eri, Roma 1992, p. 56.
4
Per maggiori informazioni sul rapporto tra Eleonora Duse e il cinema si veda Antonio Cara, Cenere di Grazia Deledda nelle figurazioni di Eleonora Duse, Istituto Regionale Superiore Etnografico, Nuoro 1984.
5
Vittorio Martinelli, Le metteuses-en-scène, “Cinemasessanta”, n. 141, 1981, p. 22.
6
7
Ibidem.
Il brano è citato da Claudia Giordani nell’articolo The Copy Vanishes, ovvero il film senza il film. Note su Fantasia Bianca, “Fotogenia”, nn. 4-5, pp. 133-148.
8
Sulla vicenda cinematografica di Daisy Sylvan si veda Gaetano Strazzulla, Il (non) mistero di Daisy Sylvan, “Immagine”, n. 33, 1995-96, pp. 25-27.
9
Filippo Tommaso Marinetti, Gli sfruttatori del futurismo, “Lacerba”, n. 7, 1 aprile 1914. 10
11 Annuncio comparso su “La Rivista cinematografica”, n. 6, marzo 1920, p. 62. 12 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano: i film degli anni Venti. 1921-1922, “Bianco e Nero”, n. 1-3, 1981, p. 454. 13 Si veda, per maggiori informazioni sulla presenza femminile nell’imprenditoria cinematografica a Torino, il dettagliatissimo studio di Alberto Friedemann pubblicato in questo volume.
Carlo Casella, Frieda Klug, “La Vita cinematografica”, 20 dicembre 1910, p. 11. 14
15 Si vedano le notizie riportate da Roberto Chiti, alla voce Mario Guaita, nel suo Dizionario dei registi del cinema muto italiano, Gremese, Roma 1999.
329
16 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano, 1918, Nuova eri, Torino 1991, p. 119. 17 Cfr. il catalogo dei fondi cartacei del Museo Nazionale del Cinema relativi al cinema muto torinese, Tracce, Il Castoro, Milano 2007, pp. 358-359. 18
“Il Giorno”, 30 marzo 1906.
Si veda lo Scenario sardo per il cinema, in Gianni Olla (a cura di), Scenari sardi: Grazia Deledda tra cinema e televisione, Aipsa, Cagliari 2000. 19
La donna e la cinematografia. Secondo me, “La Donna”, n. 294, 1917, pp. 24-25. 20
21 Cfr. Francesco Soro, Splendori e miserie del cinema italiano, Consalvo, Milano 1935, p. 164. 22 Notizie fornite da Teresa Antolin e basate sullo spoglio delle riviste d’epoca. 23 Vittorio Martinelli, Il cinema muto italiano: i film degli anni Venti. 1923-1931, “Bianco e nero”, n. 4-6, 1981, p. 39. 24 Gli studi dedicati alle attrici comiche del muto italiano (e non solo) sono desolatamente scarsi. Bisogna dunque salutare con gratitudine l’uscita del volume di Claudia Preischl, Lachende Körper. Komikerinnes im Kino der 1910er Jahre, Synema, Wien 2008, che offre una vasta panoramica sulle numerose ‘dive’ del comico muto europeo, con un capitolo dedicato alle interpreti italiane (Lea e Gigetta).
Vittorio Martinelli, Mario Quargnolo, Maciste & Co. I giganti buoni del cinema muto italiano, Edizioni Cinepopolare, Gemona 1981, p. 21. 25
26 Si vedano le recensioni al film citate da Vittorio Martinelli nella sua filmografia del cinema atletico-acrobatico, in Alberto Farassino e Tatti Sanguineti (a cura di), Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983, p. 124.
Si veda, per notizie più dettagliate sull’attività di queste acrobatiche interpreti, il paragrafo “Amazzoni dell’aria e danzatrici della prateria”, contenuto nell’articolo di Vittorio Martinelli, Lasciate fare a noi, siamo forti, in Gli uomini forti, cit., pp. 21-23. 27
28 Cinematografo. Scene famigliari per fanciulle, Paravia, Torino 1898.
330
Notizie sugli autori Jane M. Gaines è professore di cinema presso la Columbia University, New York. È autrice di numerosi saggi sulla teoria del cinema documentario, la proprietà intellettuale, il rapporto tra cinema e femminismo e la teoria critica della razza. I suoi libri Contested Culture: The Image, the Voice, and the Law (1991) e Fire and Desire: Mixed Race Movies in the Silent Era (2001) sono stati vincitori di premi. Attualmente sta lavorando al completamento del secondo volume del Women Film Pioneers Sourcebook (con Monica Dall’Asta) e del suo nuovo libro Fictioning Histories. Christine Gledhill è attualmente Visiting Professor di Cinema Studies presso la University of Sunderland (UK). Ha pubblicato estensivamente sulla critica femminista del cinema, la teoria del melodramma e sulla storia del cinema britannico. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Reinventing Film Studies (curato con Linda Williams, 2000) e Reframing British Cinema 1918-1920: Between Restraint and Passion (2003). Ha in preparazione un’antologia sulla differenza di genere nel cinema di genere. Elda Guerra insegna didattica della storia presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di Bologna. Tra le socie fondatrici dell’Associazione Orlando, è responsabile dell’Archivio di storia delle donne del Centro di documentazione delle donne del Comune di Bologna. Specializzata in Storia contemporanea, ha curato varie ricerche nel campo della storia delle donne e ha recentemente pubblicato il volume Storia e cultura politica delle donne (2008). Cristina Jandelli è ricercatrice presso il Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Firenze, dove insegna Storia del cinema muto e Storia e analisi del film. Ha pubblicato tra l’altro: I ruoli nel teatro italiano fra Otto e Novecento (2002), La scena pensante. Cesare Zavattini fra teatro e cinema (2002), Le dive italiane del cinema muto (2006), Breve storia del divismo cinematografico (2007). Monica Dall’Asta insegna discipline cinematografiche presso l’Università di Bologna. È autrice di numerosi saggi sulla storia delle teorie del cinema, sulle origini del film seriale e sulla storia delle donne nella storia del cinema. Ha curato tra l’altro l’autobiografia di Alice Guy, Memorie di una pioniera del cinema (2008), e l’antologia Fantômas. La vita plurale di un antieroe (2004). Sta lavorando con Jane Gaines al completamento del secondo volume del Women Film Pioneers Sourcebook e ha in uscita la monografia La trama spezzata. Archeologia del film seriale. Elena Dagrada insegna discipline cinematografiche presso l’Università degli Studi di Milano. Si è occupata a lungo di cinema delle origini pubblicando, fra l’altro, La rappresentazione dello sguardo nel cinema delle origini in Europa. Nascita della soggettiva (1998); ha inoltre fatto parte del comitato direttivo di Domitor, associazione internazionale che promuove la ricerca sul cinema delle origini, per la quale ha stilato la seconda edizione dell’International Bibliography on Early Cinema (1995). Il suo ultimo libro è Le varianti trasparenti. I film con Ingrid Bergman di Roberto Rossellini (2005), vincitore del premio CUC 2006. Roberta Gandolfi è ricercatrice in Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Parma, dove insegna Storia del teatro con-
temporaneo. Ha pubblicato ricerche e studi sul teatro di primo novecento, fra i quali il volume La prima regista. Edith Craig, fra rivoluzione della scena e cultura delle donne. Valeria Palumbo è caporedattore centrale di “L’Europeo”. Iscritta alla Società italiana delle storiche, ha pubblicato numerosi saggi sulla storia delle donne, tra cui: Lo sguardo di Matidia, sulla suocera dell’imperatore romano Adriano e le matrone romane, Le donne di Alessandro Magno (2005), Donne di piacere (2005), La perfidia delle donne (2006), Svestite da uomo (2007) e Le figlie di Lilith, sulla trasformazione della femme fatale in diva. Il suo libro Prestami il volto (2003), indagine sulle compagne di artisti famosi, è stato vincitore, nel 2006, del premio ‘Il Paese delle donne’. Elena Mosconi insegna Storia e critica del cinema presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano. È autrice di L’impressione del film: contributi per una storia culturale del cinema italiano 1895-1945 (2006). Con Francesco Casetti ha curato Spettatori italiani: riti e ambienti del consumo cinematografico, 1900-1950 (2006) e con Mariagrazia Fanchi Spettatori: forme di consumo e pubblici del cinema in Italia, 1930-1960 (2002). Vittorio Martinelli (1926-2008), storico del cinema muto italiano, ha dato un contributo inestimabile alle conoscenze in questo settore con la pubblicazione della sua monumentale filmografia in ventuno volumi, Il cinema muto italiano 1905-1931, in parte realizzata in collaborazione con Aldo Bernardini. Oltre a monografie su registi (Genina, Gallone, Guazzoni, Roberti) e attrici e attori del muto italiano (Ghione, Menichelli, Jacobini, Leda Gys), è stato autore di studi filmografici sulla ricezione del cinema americano, francese, tedesco e inglese. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Giuliana Bruno è professore ordinario di Visual and Environmental Studies presso la Harvard University. È autrice, tra l’altro, di Atlante delle emozioni: in viaggio tra arte, architettura e cinema (2006), premiato dalla Kraszna-Krausz Foundation come “migliore libro del mondo sulle immagini in movimento”, e di Rovine con vista: alla ricerca del cinema perduto di Elvira Notari (1995), vincitore del Premio Filmcritica. Il suo ultimo libro, Pubbliche intimità: architettura e arti visive, è previsto in uscita in Italia nel 2009. Marianna De Sanctis e Céline Pozzi, laureate presso il DAMS di Bologna, lavorano da alcuni anni presso il laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata. Si sono occupate, tra l’altro, della realizzazione del restauro di ‘A santanotte. Micaela Veronesi, storica e critica del cinema, ha pubblicato la monografia Le soglie del film (2005) e numerosi saggi su riviste e in volumi collettanei. È collaboratrice di “Segnocinema” e di “La Rivista del cinema”. Insegna Lettere in una scuola media vicino a Torino. Irela Nuñez, nata a Lima (Perù) ha studiato Scienze della comunicazione con indirizzo Cinema all’Università di Lima. Fondatrice dell’Archivo Peruano de Imagen y Sonido, si è specializzata in 331
restauro cinematografico lavorando presso le cineteche di Lima e Madrid. Attualmente si occupa dei progetti di restauro della Cineteca Nazionale. Franca Farina è archivista presso il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale. Alberto Friedemann, docente di Storia delle arti visive e studioso di storia del cinema, si interessa alle forme dello sviluppo economico e al progresso tecnologico e industriale. Fra le sue pubblicazioni: Le case di vetro. Stabilimenti cinematografici e teatri di posa (2002), Celluloide e argento. Le società tecniche (2003), I brevetti del cinema muto torinese (2005) e, con Chiara Caranti, Dizionario dei brevetti di cinema e fotografia rilasciati in Italia. 1894-1945 (2006). Ester de Miro d’Ayeta insegna Storia del cinema presso l’Università di Genova. Nel corso della sua carriera si è dedicata prevalentemente al cinema sperimentale e al cinema delle donne. Oltre ad articoli e saggi su riviste italiane e straniere, ha pubblicato nel 1999 la monografia Margarethe von Trotta: l’identità divisa e ha in corso di pubblicazione un libro su Germaine Dulac. Donata Pesenti Campagnoni è conservatrice presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove sovrintende il Dipartimento Collezioni e Patrimonio. È autrice di numerosi studi sul precinema, tra cui il recente Quando il cinema non c’era. Storie di mirabili visioni, illusioni ottiche e fotografie animate (2007). Ha curato con Carla Ceresa i volumi Nero su Bianco. I fondi archivistici del Museo Nazionale del Cinema (1997) e Tracce. Il cinema muto torinese nelle collezioni del Museo Nazionale del Cinema (2007). Gina Annunziata è dottoranda in ‘Studi sulla rappresentazione visiva. Storia, teoria e produzione delle arti e delle immagini’ presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Siena, con una tesi su La Gerusalemme Liberata di Enrico Guazzoni. Si occupa di cinema muto, dei rapporti tra cinema e arti figurative e del cinema del Maghreb. Luca Mazzei insegna Storia e critica del cinema e Storiografia del cinema presso l’Università di Roma Tor Vergata. Co-autore con Federico Vitella del volume Geometrie dello sguardo. Contributi allo studio dei formati nel cinema italiano (2007), ha al suo attivo varie curatele e numerosi saggi, apparsi su riviste quali “Bianco e Nero”, “Cinema & Cie” e “Comunicazioni sociali”, o in volumi collettanei. Suo principale campo di ricerca sono le prospettive offerte dall’incrocio tra materiali filmici e fonti cartecee nello studio del cinema italiano. Dal 2003 è redattore della rivista “Bianco e Nero”. Silvio Alovisio è ricercatore di Storia del cinema presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. Tra le sue pubblicazioni, Roman Polanski. Chinatown (2002), Voci del silenzio. La sceneggiatura nel cinema muto italiano (2005) e numerosi saggi sul cinema muto e contemporaneo, editi su riviste italiane e internazionali. Collabora con “Segnocinema” e “La Rivista del cinema”. Claudia Gianetto è responsabile dei progetti di restauro cinematografico presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove è stata a lungo responsabile della Cineteca. Ha pubblicato vari articoli sulla storia del cinema muto torinese e la monografia Società Anonima Ambrosio. Cinema muto nei documenti d’epoca (2002).
332
Stella Dagna, dottoranda presso l’Università di Pisa, si occupa di estetica del cinema muto italiano e dei rapporti tra filologia delle copie e analisi filmica. Collabora dal 2005 con l’Archivio film del Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove si occupa in particolare dei progetti di restauro e di valorizzazione della collezione di cinema muto. Maria Elena D’Amelio ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di San Marino nel 2008. Attualmente è iscritta al programma di Dottorato della State University di New York, Stony Brook, dove svolge attività di collaborazione alla didattica come Teaching Assistent.
Non solo dive Pioniere del cinema italiano
Questo volume è stato stampato nel mese di dicembre dell’anno 2008 presso Tipografia Moderna Bologna


![Splendor : storia (inconsueta) del cinema italiano [6. ed.]
9788858108352, 8858108353](https://dokumen.pub/img/200x200/splendor-storia-inconsueta-del-cinema-italiano-6-ed-9788858108352-8858108353.jpg)