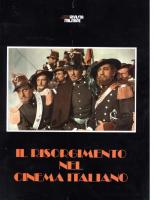Anni fuggenti. Il romanzo del cinema italiano 8845255468, 9788845255465
Il cinema muto e la Belle Epoque, il fascismo e il cinema dei "telefoni bianchi", i primi divi, i colossal di
366 53 2MB
Italian Pages 499 [309] Year 2003
Polecaj historie
Table of contents :
Copertina
Trama
Biografia
Frontespizio
Copyright
Dedica
PREFAZIONE
1
TULLIO PINELLI - Auguri di capodanno al Duca d'Aosta
2
LUIGI COMENCINI - Pinocchio si nasce
3
MARIO MONICELLI - La libertà al settanta per cento
4
DINO RISI - Ma quanta fatica la lira e la f....
5
GIULIO ANDREOTTI - Il neorealismo al settanta per cento
6
CARLO LIZZANI - Su e giù dal neorealismo
7
BENVENUTI & DE BERNARDI - Amici per la pellicola
8
ALBERTO SORDI - Sembra ch'è passato un giorno
9
RODOLFO SONEGO - A Venezia con le scarpe chiodate
10
DINO DE LAURENTIIS - Sogni colossal. La mia Rosebud
11
AGE - Generale, non vi suonerò più la liana
SCARPELLI - La palla al piede: far ridere
12
ENRICO LUCHERINI - I dolci inganni
13
LUCIANO EMMER - La notte che ho inventato la pubblicità
14
UGO PIRRO - Nascita
15
PIETRO INGRAO - I "tempi moderni" del cinema italiano
16
GILLO PONTECORVO - Da Saint Tropez ad Algeri
17
SUSO CECCHI D'AMICO - Il panchetto di Luchino
18
FRANCESCO ROSI - La vita come impegno
19
FRANCO ZEFFIRELLI - Shakespeare e il bushbaby di Liz
20
CARLO RUSTICHELLI - Andiam filibustier, ohi ohi ohi
21
TONINO DELLI COLLI - So' sparite le lucciole
22
MORANDO MORANDINI - Non sono che un critico
23
LUIGI MALERBA - Cronaca di uno scrittore
24
FRANCA VALERI - Storia di un'italiana
25
NINO MANFREDI - Mio nonno paraculo, maestro d'ironia
26
NATALIA ASPESI - Maschi e moralisti
27
VALENTINA CORTESE - Confesso che ho vissuto
28
ETTORE SCOLA - C'eravamo tanto amati
29
FRATELLI TAVIANI - Un'aggressiva fiducia nel domani
30
ERMANNO OLMI - Il mestiere di vivere
31
Enrico Ghezzi - Passato-morto e sparizione
EPILOGO
POSTFAZIONE
RINGRAZIAMENTI
Citation preview
Alberto Sordi, balilla, in udienza dal duce; Monicelli rifiuta Brigitte Bardot; Dino Risi accede alla corte del Liechtenstein con la tessera del tram; Valentina Cortese lascia Hollywood insidiata da Zanuck; Ermanno Olmi tra i martiri di Loreto; Zeffirelli a lezione di “mistica comunista”; Manfredi canta “Tre per tre Nava”; Comencini censurato da Andreotti; Andreotti esaltato da de Laurentis; De Laurentis, un gigante per Ugo Pirro. Dalla biografia alla storia, dalla vita al film, l’avventura della cultura e del cinema italiani raccontata dai protagonisti, registi, attori, produttore, sceneggiatori, direttori della fotografia, musicisti, press-agent chiamati all’appello come i sopravvissuti di una comunità irripetibile che ha radicalmente indirizzato, se non deciso, l’identità artistica della Repubblica. Il cinema muto e la Belle Èpoque, il fascismo e i “telefoni bianchi”, i primi divi, i colossal di Cinecittà, guerra e Resistenza, neorealismo e maggiorate, intellettuali e commedia all’italiana, Sessantotto e Mostre di Venezia, la televisione e il cinema, l’arte e il mercato. Eventi storici, personaggi, film, si richiamano da un testo all’altro in un divertente mosaico sullo sfondo del ’900. Una voce “fuori campo”, accordata all’età e alla sensibilità artistica dei protagonisti, suggerisce, per ogni testimonianza, lo sfondo emotivo della memoria e del vissuto. Un romanzo corale da consegnare alle generazioni presenti e future. Un libro “del tempo” che agisce “nel” tempo.
Silvio Danese è giornalista e critico cinematografico de “Il Giorno”, “La Nazione” e “Il Resto del Carlino”. È stato orchestrale, attore, insegnate, cameraman, consigliere d’amministrazione di teatro pubblico, consulente della Biennale. Tra i suoi saggi, Abel Ferrara, l’anarchico e il cattolico.
Silvio Danese
Anni fuggenti Il romanzo del cinema italiano
Proprietà letteraria riservata © 2003 RCS Libri S.p.A., Milano eISBN 978-88-58-76101-4 Prima edizione digitale 2013 In copertina: Alberto Sordi e Silvana Mangano, foto Licio d’Aloisio, Polifoto. Progetto grafico Polystudio. Copertina di Aurelia Raffo. www.bompiani.eu
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
Dedica A mia madre e mio padre
Vittorio Gassman e Maria Meneghini Callas ballano il cha-cha-cha al “Rancio Fellone”, Ischia 1956.
PREFAZIONE di Mario Nicolao
C’era una volta un’Italia contadina, appena inurbata (uscita da una guerra rovinosa dove questo inurbamento si era accelerato), che esponeva le sue maschere regionali e paesane, le sue parlate diverse e antiche, al mercato dei sogni di allora, il Cinema. Questo catalogo di diversità regionali, se non costituiva tutto lo spettacolo, ne determinava almeno l’intreccio. Ecco allora, trascinati sullo schermo dai teatri e teatrini dove la rivista incontrava l’avanspettacolo, una miriade di caratteristi: siciliani come Turi Pandolfini, abruzzesi come Virgilio Riento, pugliesi come Guglielmo Inglese, e naturalmente la scuola napoletana intera dai fratelli Maggio ai De Filippo, e quella romana, da Ettore Petrolini ad Alberto Sordi che ne fu l’epigono, riuniti in diverse combinazioni. E persino un genovese anomalo, Gilberto Govi. Tutte le regioni erano rappresentate. Lo schema era far incontrare questi virtuosi del vernacolo attorno all’attor giovane e all’attrice, in film di serie A o di serie Z, mescolando i dialetti e la mentalità che esprimevano, e questo schema molto tenace resisteva ancora nel 1958 quando Mario Monicelli girò I soliti ignoti: Vittorio Gassman, nel ruolo e nella parlata del pugile romano, Totò, mago napoletano delle casseforti, Tiberio Murgia, pregiudicato siciliano, Carlo Pisacane nel ruolo di Capannelle, ladruncolo bolognese e quindi goloso, Carla Gravina, cameriera veneta. Questo chiamare a raccolta le regioni, attraverso le maschere, corrispondeva probabilmente a una lunga ricerca dell’identità nazionale nelle sue differenze, molto sentite e rispettate, anche se bonariamente satireggiate. Si pensi quanto è durata l’espressione dialettale nel cinema nazionale e come, anche in seguito, la comicità sia sempre stata giocata sulla parlata regionale. Persino otto anni dopo I soliti ignoti, quando lo stesso Monicelli girò L’armata Brancaleone (1966), i tipi regionali sopravvivevano, modificati e adattati al Medio Evo fantastico di Age e Scarpelli: Gassman, il fiero guerriero di Norcia (patria di stimati norcini), Gian Maria Volonté, l’astuto Bizantino, e ancora Pisacane nel ruolo dell’“abbreo” Abacuc. Il catalogo, sempre il catalogo, padroneggiato con talento linguistico e psicologico straordinario da Agenore Incrocci e Furio Scarpelli, qualcosa di più di due bravi sceneggiatori: un misto fra il ricercatore del folklore, tipo Alan Lomax, che gira i paesi col magnetofono, e il ricreatore geniale del linguaggio. Due geni, che si affiancavano ad altri grandi sceneggiatori, nati sul campo, come Tullio Pinelli, lo stesso Federico Fellini, Ennio Flaiano, Rodolfo Sonego, Sergio Amidei, Piero De Bernardi, Leo Benvenuti, Suso Cecchi d’Amico e via dimenticando. Eppure, di pari passo a questa attenzione continua all’identità nazionale, come per timore di perderla o di non averne una, il cinema italiano si pensava e si voleva già internazionale, almeno da Roma città aperta (1945) e Germania anno zero (1948) a I vinti di Antonioni (1952) e cresceva, sprovincializzandosi rapidamente, in anticipo sulla letteratura di quegli stessi anni. Non erano solo il cosmopolitismo (anche sentimentale) di Roberto Rossellini o la raffinata cultura europea di Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni a dare la linea, era che quel cinema si dimostrava capace di pensare in grande in tutti i suoi autori, anche quelli
che venivano dai giornali umoristici o dalla caricatura, come Federico Fellini. Quando si pensa a quei tempi gloriosi, tempi in cui il cinema italiano era giunto a insidiare la supremazia artistica e persino commerciale di Hollywood (secondo la testimonianza di Dino De Laurentiis), bisogna ricordare che accanto ai grandi registi (i sempre citati Rossellini, De Sica, Visconti, Fellini e Antonioni, sul versante “serio”, Monicelli e Dino Risi su quello della intelligente “commedia all’italiana”) fioriva questa straordinaria e ricca scuola di scrittori da cinema (se si pensa che siamo passati dalle sceneggiature di Age e Scarpelli a quelle di Simona Izzo, sembra che in mezzo ci sia stata una qualche catastrofe nucleare) e accanto a loro fotografi e operatori di talento, scenografi e costumisti, tutto il meglio dell’alto artigianato e del “fai da te” italiano. E poi i produttori; dove sono finiti oggi quei produttori ruspanti che non capivano niente di arte però la promuovevano con coraggio e ostinazione, magari rubando di notte la pellicola ai registi che rifiutavano tagli, ma decisi a conquistare il mercato americano e, all’occorrenza, capaci di opporsi con mille astuzie al potere politico? Bisogna ricordare, dicevo, ma per ricordare bisogna attingere alla memoria di chi c’era, e tale meritoria intenzione ha guidato Silvio Danese in questo libro, dove parlano i protagonisti, i sopravvissuti di quella irripetibile stagione. Guardate il sommario: è come se l’autore del libro avesse fatto l’appello e chi c’era avesse risposto “presente”. A cucire i monologhi Danese ha poi introdotto un espediente cinematografico, la voce fuori campo, quella di una donna immaginaria che ha vissuto in quell’epoca ad alta densità artistica che ancor oggi, anzi soprattutto oggi, ci meraviglia. Questo cinema che sembrava dubitare della propria identità nazionale, si è dimostrato capace di una fortissima identità artistica. Nasceva lo stile cinematografico “all’italiana”, come si diceva e si dice in tutto il mondo sulla scorta del film di Pietro Germi sul divorzio. Farò un esempio recente: quando si è trattato di spiegare Bossi e la Lega diversi giornali europei hanno parlato di un caso “all’italiana”. Sì, perché l’italiano esiste, è il padano che è virtuale. Com’è stato possibile che questo cinema italiano del dopoguerra, pur restando a volte così “paesano”, così locale – come si diceva all’inizio – abbia poi conquistato il mondo intero? Com’è nato il neorealismo? Che cos’era? Come si spiega la forte penetrazione del cinema italiano sui mercati, mentre Hollywood arretrava? È vero – come sostiene De Laurentiis – che è stata una sciagurata legge, firmata da un socialista, a bloccare per sempre lo sviluppo del cinema italiano? Oppure c’è dell’altro? Gli intervistati forniscono molte risposte a queste domande ed è proprio in questa coralità che si trovano spiegazioni attendibili. Certo, il regime fascista aveva valorizzato il cinema di propaganda ed esistevano registi di talento come Alessandro Blasetti, Goffredo Alessandrini, Augusto Genina o Mario Camerini, certo, città come Torino avevano cultura e sapere cinematografico fin dagli inizi del secolo XX e Venezia aveva una mostra del cinema. Ma sembra poco per spiegare l’esplosione mondiale dell’arte italiana d’immagine, dopo la guerra, l’impatto di Roma città aperta e Paisà o di Ladri di biciclette e Sciuscià, anche pensando ad antecedenti stilistici come Ossessione. Per non parlare di quello che sarà il post-neorealismo, il cinema di Federico Fellini e di Michelangelo Antonioni, così “en avant” su quanto si faceva nel resto del mondo, a parte Ingmar Bergman (Vampata d’amore è del 1953). Come si spiega questa successiva fioritura? Certo, se si osserva l’opera inquieta di Roberto Rossellini, si vede che in quel suo cinema
c’è già tutto: il neorealismo e il suo superamento. Stromboli, terra di Dio (1948) e soprattutto Viaggio in Italia ( 1953) sono già vicini all’indagine esistenziale di Antonioni e si potrebbe dire che in qualche misura anche il cinema di Fellini viene da Rossellini, “cinica” levatrice (com’è stato osservato). Questa forza propulsiva incredibile viene dunque dal neorealismo e da tutti coloro che gli si raccoglievano intorno. Com’è stato possibile? Ma ecco che Mario Monicelli ci ricorda che “il neorealismo era uno sguardo morale” – qui la sua forza dirompente – e quasi tutti i testimoni di questo libro ci dicono che quel cinema “era nato dalla Resistenza”, era un cinema-contro. Fortemente osteggiato da Giulio Andreotti (intervistato giustamente fra i protagonisti di questo libro e di quel tempo) e sotto la mira continua delle commissioni di censura, che sono ricordate in diversi interventi, pure la sua marcia è stata inarrestabile. Lo stesso Andreotti, del resto, è indicato da De Laurentiis come titolare di una buona legge sul cinema negli anni ’50. Comunque, nonostante la censura che riguardava soprattutto le questioni sessuali (Cinecittà era troppo vicina al Vaticano di Pio XII, il papa severo e spaesato di quegli anni), il messaggio politico passava dappertutto, anche nelle commedie: il cinema italiano era davvero “di sinistra”, come qui viene più volte ricordato. E nello stesso tempo era un affare, un grande business, come diceva De Laurentiis che poi, quando si sentiranno gli effetti della legge Corona, partirà per l’America. Sarà casuale ma quando il produttore italiano decide di lasciare l’Italia per gli Usa, la spinta propulsiva del grande cinema del dopoguerra si era già attenuata e stava addirittura affievolendosi. Cominciava una lenta decadenza, segnata ancora dai grandi exploit dei maestri, ma inesorabile. Restavano i guerrieri solitari ma la tribù era stata decimata.
1 Mi chiedo perché un ventenne sia così solerte con una donna di ottant’anni. Mi ha telefonato il nipotino per scusarsi di non essere venuto. Questo rende più dolce la sera. Nel corso degli anni, la scelta di vivere sola e resistere in questa casa ha alimentato la mia energia. Ammetto che sono diventata più debole. Filippo lo capisce. Mi frequenta perché rappresento la continuità della famiglia, il passo solido della vita? Non mi convince. È così intelligente e originale quel ragazzo. Sospetto, ma non ne sono certa, che la ragione di tanto accresciuto affetto sia un’altra, un interesse preciso. L’ho visto scrutarmi, lo sento indagare nella mia vita, con furbizia e dolcezza. Avverto come riesce a sospendere il bisogno di affermarsi per penetrare nel regime dei discorsi e ricevere quanto più possibile. A volte mi sembra voglia impadronirsi di un sapere intero dell’esistenza per ogni anima che incontra. In una forma incompiuta e ancora inconsapevole, credo che gli interessi conoscere il mio resistere da vecchia, come se, nel mio esserci ancora, insieme con i cavi ottici negli oceani e le antenne satellitari nello spazio, si nascondesse un mistero difficile da penetrare, ma non insondabile. La sua curiosità dispone di una vera attitudine a ricevere. Parte da piccole cose, frammenti di vita, eventi storici, e riesce a ricostruire una mappa, attirandoti nel gusto della memoria. Un paio d’anni addietro mi riferì che, da un ristorante, aveva visto uscire Monicelli e Scarpelli, gli unici che aveva riconosciuto in un corteo di vecchietti intorno a una sventola da rotocalco. Era mercoledì. Dunque, mi capitò di dire, era il mercoledì di Otello, l’antica, ricorrente riunione al ristorante, nel cortile di via della Croce. E gli altri dovevano essere De Bernardi, Leo Benvenuti, forse Age, Delli Colli, Scola, Ugo Pirro, se ci andava ancora. Un rito che durava nei decenni, molto simile a certe riunioni di compagni di scuola dove sfottersi era ricordarsi e insieme dimenticarsi. Mi interrogò. Gli sembrava “forte” e “ingenuo” quel rito. Lo colpiva la durata. Le stesse persone, per decenni. Perché gli apparisse ingenuo aveva richiesto una spiegazione difficile, filosofica, che non ricordo, o non voglio ricordare: credo fosse legata al cibo e alla morte. Gli raccontai di Leo, che avevo conosciuto alla Lux quando non ero ancora sposata col nonno. Leo era sceneggiatore di Macario. Dal secondo piano, dove lavoravo, sentivo litigare Ponti e De Laurentiis; si insultavano da una stanza all’altra, si sbattevano la porta alle spalle e poi, uno alla volta, salivano da Gualino. Gli dissi dell’ufficio dove vedevo transitare Tullio Pinelli e Fellini per gli assegni degli anticipi, e dell’insegna luminosa di via Po, un Lux Film al neon sotto il quale accadeva di passeggiare la notte accompagnati dalla fenice del cinema. La passeggiata finiva sulle panchine di Villa Borghese. Filippo mi imbarazzò chiedendomi il significato per me, oggi, di quei ricordi. Ma che cosa credi sia la mia vita? Non c’è niente di speciale, di glorioso, o irripetibile. La giovinezza... Ma no. La commemorazione della vita si carica sempre di sentimento, e sempre commette l’errore di invocare l’eccezionalità, che diventa all’istante un abbaglio condiviso su cui si fondano l’orgoglio di una generazione e la prospettiva dei posteri. Io parlo così di me, di noi; mio padre parlava così delle trincee sul Carso, dei bambini salvati dalla penicillina, della macchina fotografica portatile; mio nonno della visita di Giolitti in caserma e dell’odore di concime. Il nostro cuore si illude, protetto dall’egocentrismo. E chi può dire veramente che il mio passato sia speciale rispetto a quello di mio padre o a quello che
avrai accumulato tu? Ogni memoria ha il tumore della vanità, non dimenticarlo. Ero riuscita a essere sgradevole. Volevo parlargli della libertà da ogni eredità e da ogni futuro, invece... Ma il ragazzo è un osso duro. Non era soddisfatto della risposta. Senza dubbio riteneva, sebbene non lo dicesse, che, per aver lavorato nel cinema, avessi partecipato a qualcosa di speciale, di cui gli sfuggiva la natura. Ma io allora scrivevo lettere, Filippo. Soltanto lettere commerciali. Finivo saltuariamente in sala montaggio come assistente, perché sapevano della passione di mio padre per la fotografia. Incominciavo, senza saperlo, una carriera di montatrice. Ma ancora spedivo ricevute, annunciavo compensi, richiedevo comparse e animali. A una ditta di Parigi avevo mandato il contratto per le belve di Teodora, imperatrice di Bisanzio: tre pantere addestrate, sei leoni capaci di corpo a corpo con l’uomo e sei cani lupo bianchi in grado di lavorare con un orso grigio. Certo, avrei voluto leggerle le sceneggiature sui tavoli di Gualino, De Laurentiis e Ponti. Ma non potevo neanche avvicinarmi alle buste. Al terzo piano non ero ammessa. Una volta, però, ho ribattuto alcune scene di Traviata ’53 e sono andata a casa di Pinelli a consegnarle. Violetta era diventata Margherita Rinaldi, vestita in tailleur, restaurata con un accento della borghesia milanese. Non sono mai riuscita a considerare Pinelli uno del cinema, forse per la sua eleganza impiegatizia, per quella gentilezza severa, molto piemontese, forse perché era scrittore di teatro. Non so più niente di lui, non so più niente di nessuno.
TULLIO PINELLI Auguri di capodanno al Duca d’Aosta Sono nato nel 1908, a Torino. Adesso, a 94 anni, tutto quello che mi è successo nel cinema non riesco più a guardarlo con occhio critico. Lo penso con simpatia, con affetto. Come un ricordo personale. Mi viene da dire “privato”. Un periodo lontano, a cui tengo molto. Ho lavorato per Duilio Coletti e per Federico Fellini. Per Pietro Germi e per Matarazzo. Anche quei registi che mi parevano di secondo piano oggi li considero con molta affezione. Riconosco certe qualità a confronto con la produzione italiana più recente. Ma aggiungo che, per età, so di appartenere a un mondo scomparso e che, ora ch’è scomparso, mi sta molto a cuore. Voglio dire sentimentalmente. Evidente che i grandi... Le cose che hanno fatto. Anche che abbiamo fatto, s’intende. Che cosa resta? Restano tutti i nomi che vengono in mente. Cioè, se vengono in mente allora restano, no?
Un’Itala da spingere. Da bambino ho visto Intolerance di Griffith, credo sia stato il mio primo film. Che cos’era il ’16 o il ’18? E poi bisognerebbe vedere quando è stato distribuito in Italia. Comunque è il primo film di cui ho ricordo. Nella vecchia via Roma c’era un cinematografo con le panche di legno. Scomodo, un po’ maleodorante, e il pianoforte era sempre scordato. I film di Tom Mix li ho visti lì. Ma allora, adesso che ci penso, era prima di Intolerance. Ecco, non so più ordinare... Sento però l’odore della sala cinematografica, quasi una puzza, perché a volte si stava stipati. Costava pochissimo. Io ero di famiglia benestante, ma a quel tempo i ragazzi non erano viziati. Ho ricevuto un’educazione alla parsimonia, in fondo. In confronto al teatro andare al cinema era un evento. A ridosso della prima guerra mondiale, ma anche dopo, Torino era una città già molto borghese, molto conservatrice e chiusa. Era difficile entrare in certi giri. Il principe ereditario aveva la sua piccola corte e i ragazzini di buona famiglia ambivano a prendervi parte. Per i compleanni e le feste si usava andare a omaggiare qualche aristocratico, il principe di Genova o il duca di Pistoia. C’erano proprio i giorni di ricevimento. Quando ero molto piccolo mio padre mi portò a fare gli auguri di capodanno al duca d’Aosta. Lo ricordo ancora in tight, appoggiato col gomito al camino. Fu gentile. Ma aveva fatto il suo tempo. A quel mondo vedevo già contrapporsi un ambiente nuovo. Un parente, marito di una zia di mia madre, era uno dei direttori della Itala, la fabbrica che ha preceduto la Fiat. C’era questa automobile meravigliosa, che però bisognava sempre spingere per farla partire, perché da sola non ce la faceva. Era faticoso e divertente. Lo zio ci portava in giro ogni tanto, ma per le cene ci mandava l’autista, come fosse una carrozza spedita da palazzo. Gli industriali andavano in automobile. I principi ancora in carrozza. In strada era pieno di vetture a cavalli, nelle piazze c’erano i fiacres guidati dal vetturino col cappello in testa. Io abitavo nel quartiere nuovo. La nostra casa era proprio di fronte a quella della famiglia Agnelli. Vedevo per strada Gianni Agnelli e la sorella, piccoli piccoli, accompagnati dalle bambinaie. Io ero già un ragazzo naturalmente, e loro rampolli di una famiglia di primi industriali. Quel quartiere era spesso fotografato dagli operatori della Fert, la produzione
cinematografica di Torino. Si trattava di scenette di interventi di pompieri o di fughe di ladri, che noi ragazzini spiavamo dalle finestre di casa nostra. C’erano questi figuri con i cappellacci da ladro che s’arrampicavano sui muri e l’operatore giù che riprendeva. Torino era una capitale del cinema. Ma questo già lo sapete. E si sentiva nell’umore della città. Io lo sentivo.
Un velo, un morto. La prima guerra mondiale, nella mia memoria di bambino, è scolpita come un’eco di notizie tremende che arrivavano dai fronti. Caporetto e il giuramento di resistenza erano qualcosa di incommensurabile; a otto, dieci anni, come avevo io, facevano impressione. Al ritorno dei reduci, Torino viveva un momento di forti pressioni dall’estrema sinistra. Gli ufficiali non potevano circolare in divisa senza essere insultati. C’erano scontri nelle strade. Mio padre era un magistrato, procuratore del Re. Una volta fu chiamato per uno scontro di piazza. Tornò a casa pallido, per il sangue che aveva visto. L’aggressività dell’estrema sinistra era altissima, e innestò il successo del fascismo anche a Torino, dove c’era una specie di resistenza borghese. Poi, dalla Russia arrivavano notizie spaventose: fucilazioni organizzate, espropri violenti, massacri, e questo ha influenzato il favore con cui una larga parte della borghesia in tutta Italia accolse il fascismo. A Torino poi c’era una grande fedeltà alla dinastia. L’idea della sovversione non era conciliabile con l’idea più o meno forte che avevano i cittadini dello Stato monarchico. La minaccia di una rivoluzione antimonarchica voleva dire una minaccia per lo Stato. Era una cosa seria. Non piaceva l’idea, devo dire. Quando si voleva dire che c’era casino, si usava l’espressione: “L’è una repubblica”. La mentalità era quella. Intorno ai primi anni ’20 in città c’era proprio un clima da guerra civile. Ricordo le passerelle delle guardie rosse. Botte da orbi nelle strade. E la presa della Camera del Lavoro, con i morti lì davanti. La borghesia non poteva accettare di essere attaccata su un tema importante come la guerra e la vittoria nazionale. Il numero di morti tra gli ufficiali di complemento, cioè tutta la borghesia, era stato altissimo. A dieci anni avevo già i miei morti. Il cappellano con cui avevo fatto la prima comunione. Calandra, il figlio dello scrittore. Un magistrato cugino di mio padre. Per andare a scuola passavo sotto i portici e incontravo le donne col velo nero fino ai piedi: erano le vedove di guerra. Portavano il lutto per mesi, per anni. Tu sapevi che a ciascuna corrispondeva un morto. Verso la fine della guerra erano diventate una specie di altro esercito. Un esercito nero che attraversava la città.
Litigando con Pavese. Mettendo da parte i centesimi, avevo costruito con mio fratello un teatrino di legno per le marionette. I testi li scrivevo io. La prima cosa che ho scritto era una leggenda indiana. Ne ho fatto dodici atti. Non avevo problemi di tempo. A vent’anni, in campagna, nella soffitta dove avevo messo su un teatrino con degli amici, erano venuti Leone Ginzburg e Cesare Pavese, che era stato mio compagno di scuola. Peggio che malinconico. Passava da momenti di euforia a momenti tenebrosi, così, in un istante, bruscamente. Andavamo al cinema insieme. Certe discussioni! La rivelazione di quegli anni fu La grande parata di King Vidor. Era speciale
perché c’era una sonorizzazione ad hoc. Venivano cantate canzoni scritte per il film. Nelle scene di battaglia, l’orchestra aveva una partitura per alludere ai rumori. Il tamburo faceva le cannonate, la raganella le mitragliatrici. Ma con Pavese la discussione finiva sempre in un braccio di ferro: io sostenevo che il teatro era meglio, lui che il futuro era il cinema. Ironia della sorte: è finita che io ho fatto il cinema. Le prime teatrali di Pirandello, di Campanile o di Sem Benelli, che ho avuto occasione di conoscere benissimo, erano per me momenti eccitanti. Benelli era un post-dannunziano molto simpatico, molto convinto di essere un grande poeta. Forse si sbagliava un pochino. Non si muoveva dal modello della Cena delle beffe.
Petrolini mangiabambini. Il primo testo compiuto l’ho scritto in torinese, per un concorso indetto dalla Famija Turinesa, con un premio di ben mille lire. Be’, ho vinto, e il testo fu rappresentato al teatro Rossini, distrutto poi dalle bombe della seconda guerra mondiale. L’attor giovane di quella occasione era un ragazzo strano, e molto bravo, uno che sembrava un po’ sollevato da terra: Erminio Macario. Ma il direttore di compagnia non gli dava fiducia. Mi chiese con gentilezza di guidarlo nella parte. Fu un successo. C’era un professore che indirizzò un po’ tutti noi al teatro e alla letteratura, Monti, un esempio di civismo, antifascista da subito. Gli stavamo vicini. C’erano anche Bobbio, Antonicelli e Argan. Questo gruppo, a cui si unì Primo Levi, ha fatto storia nella Torino tra le due guerre. Scrivevo in pura perdita. Il mondo del teatro era chiuso. Le compagnie si formavano a Milano o Roma, e poi arrivavano in città. Gandusio, Galli. E Petrolini, che mi dissero di andare subito a vedere. L’ho conosciuto quando ho trovato il coraggio di andare in camerino, una volta. Ero pallido, non so come ho trovato la forza di chiedergli se poteva leggere un mio testo. E lui: “Massù, ti senti male davanti a me? Non ti mangio mica.” L’impressione però era proprio quella. La mia carriera è passata per il Teatro sperimentale di Firenze. Mia moglie (la prima, che adesso non c’è più) era un’ammiratrice dei libri di Silvio D’Amico. Allora, senza dirmi niente, decise di prendere La pulce d’oro, un mio testo, e spedirlo proprio a D’Amico, che finì per rispondere apprezzando, e poi addirittura lo propose a Venturini, direttore del teatro di Firenze, che lo fece rappresentare quasi subito. Siamo alla fine degli anni ’20, direi. Stava arrivando il sonoro. Io avevo imparato a scrivere anche per la radio. Un mio testo entusiasmò Pavese, che ne parla anche nel suo diario.
I bej fieui van fè el suldà. Il primo cinema sonoro italiano era tutto scritto dai commediografi: Gherardi, Cantini, Bazzolotti; nomi di successo a quei tempi, adesso dimenticati. Per alcuni anni nessuno scrisse per il cinema sonoro, si derivava tutto dal teatro o dai romanzi. De Sica traeva i suoi primi film dalle commedie, per esempio Una dozzina di rose scarlatte. E così Soldati e Blasetti. Io sostengo addirittura che il neorealismo ha cancellato tutto questo mondo letterario e, dopo la rivoluzione dell’attore preso dalla strada, abbiamo finalmente incominciato a scrivere per il cinema. La sceneggiatura per il film è incominciata molto più tardi di quel che non si creda.
Comunque, tra il 1929 e il 1930, ho fatto un’esperienza che mi ha segnato: il servizio militare in cavalleria. Diciotto mesi. Amavo i cavalli, e tremavo all’idea di essere riformato. Si diceva: i bej fieui van fè el suldà e i macacu restu a cà. Ho portato cavalli fino a 80 anni. Ho conosciuto il fratello di Luchino Visconti nel mio reggimento. Avevo una paga che mi permetteva di non chiedere niente a casa. Tornato a Torino, sono ridiventato uno studente, ancora un laureando a carico dei genitori, dovendo chiedere 50 lire ogni tanto: ed è stata dura accettarlo. Dopo la “pulce” ho conosciuto Orazio Costa e Rissoni, che erano venuti in tournée a Torino e per loro ho scritto I padri etruschi. Mi interessavano i miti, in questo caso la scoperta della Maremma Toscana, le tombe e i briganti. Arrivando in quella regione da Torino s’aveva l’impressione di tornare indietro di trecento anni, c’era ancora un’atmosfera da epoca feudale. Il testo restò lì per qualche anno. Riuscì a metterlo in scena Nino Meloni nel ’41, a Roma, al Quirino, con una compagnia importante, perché c’erano i fratelli Pavese e Laura Carli; ebbe, devo dire, un successo strepitoso, anche di critica. Il mio ingresso nel cinema è avvenuto così. Perché la Lux film di Gualino cercava talenti letterari nuovi da inserire nel cinema. Mi affidò un testo da Puškin, La figlia del capitano. Quando Emilio Cecchi aveva tentato la stessa cosa alla Cines, quasi una decina di anni prima, io consideravo il cinema un’arte di secondo piano. Pensavo a O’Neill, che avevo scoperto da solo, al Pirandello dei Giganti della montagna. Soltanto il cinema francese, con i film di Carné e Renoir, lasciava intuire, forse, un futuro più importante. In Italia c’erano al massimo Blasetti e Camerini. Noi giovani del teatro ci sentivamo membri di un mondo più aristocratico. È a questo, credo, che devo la mia “duplicità”: lavorando per certi film, per certi registi, non so, per Coletti, mi sentivo un professionista, non un artista. Poi se mi chiamavano a scrivere per Fellini, sapevo che c’era in gioco qualcosa di diverso, forse di più creativo.
La camionetta con la cinepresa. A introdurmi professionalmente nel cinema è stata la seconda guerra mondiale. Avevo già quattro figli, e così, fatto il primo richiamo nel ’39, al secondo mi hanno lasciato a casa. Al di là delle idee politiche, odiavo la guerra. Non potevo ammettere l’idea di andare in qualche posto ad ammazzare qualcuno. Ha ragione Monicelli, quando dice che la guerra la volevamo perdere, noi. Io comandavo una compagnia di mitraglieri. I soldati capiscono subito come la pensi. Una volta siamo andati a fare un’ispezione sul confine francese, appena prima della dichiarazione di guerra. Eravamo schierati davanti alle guardie di frontiera e alcuni appuntati mi dicono: signor comandante, se scoppia la guerra dovremmo sparare ai tedeschi, non a questi francesi. Per dire che atmosfera c’era tra i soldati. Questa era la radice dell’8 settembre e poi della Resistenza. Quando sono tornato in Piemonte, dopo l’8, ho preso subito contatto con amici che sapevo antifascisti. Antonicelli era presidente del Comitato di Liberazione Nazionale e come tale condannato a morte, dunque nascostissimo. Io conoscevo un altro resistente, Alberto Tedeschi, il padre della modella Carla Bruni e dell’attrice Valeria Bruni Tedeschi. Era membro del partito liberale clandestino. Lui mi portò da Antonicelli, al comando del quale ho fatto la Resistenza fino alla fine, come rappresentante del partito ad Albignano. Mi sono occupato anche degli ordini di insurrezione generale e dell’arresto di
ufficiali e sottufficiali repubblichini. Poi ci fu la tremenda giornata della Liberazione. È stato... Sono io che ho dato l’incarico a Borghesio di girare con le camionette e la troupe cinematografica per documentare quei giorni. E Borghesio chiamò il giovane Leo Benvenuti, che voleva fare il cinema...
Letteratura e vita, scrivere il cinema. Non è vero, come ho letto in certe enciclopedie, che scrissi In cerca di felicità per Giacomo Gentilomo, a Torino. La prima cosa che ho fatto per il cinema è stata la riduzione da Puškin. Eravamo in tre concorrenti per la sceneggiatura, e ho vinto io. Mi chiamò Gatti, il braccio destro di Gualino. E la Lux mi fece un contratto per tre lavori all’anno con un compenso che ricordo bene perché era una cosa spettacolosa, ottantamila lire. L’affitto per me, mia moglie e i quattro bambini, in un ottimo appartamento, costava tremila e cinquecento lire l’anno. Ho fatto allora il Travet di Soldati, lavorando sulla commedia di Bersezio con Aldo De Benedetti. Nel cast c’era un giovane attore, un po’ pedante, di quelli che stan sempre lì a chiedere e fare: si chiamava Alberto Sordi. Dal Piemonte mi chiamò Duilio Coletti, che voleva fare un film da una mia pièce. Così vien fuori la sceneggiatura di L’adultera. In fondo come sceneggiatore per il cinema avevo poca esperienza. Non sapevo proprio se andava bene quello che avevo fatto. Ho seguito molto il lavoro sul set. È stata brava Clara Calamai, che per L’adultera ottenne l’unico Nastro d’Argento della sua carriera. Insieme a Coletti la guidavo, le spiegavo il personaggio, la istigavo. Coletti aveva una grande fantasia. Ed era un ottimo cineasta. Scrivevo professionalmente per il mio contratto e incominciavo a vedere i primi film neorealisti di De Sica e Rossellini. Per la Lux ho scritto Il passatore, ma quando mi chiamò Lattuada per Il bandito, il lavoro diventò tutta un’altra cosa. Con Lattuada si uscì subito da un certo professionismo per arrivare alla verità, puntando a una qualità dei personaggi legata alla storia da raccontare e alla Storia del nostro tempo. Credo di aver cercato un punto d’incontro tra la mia esperienza drammaturgica, diciamo la mia cultura letteraria, e l’esperienza di vita nella guerra, la Resistenza e la Liberazione, e in quello che vedevo nella ricostruzione del paese. È una cosa che ho cercato di fare sempre.
Premiata ditta Fellini&Pinelli. Produttori e registi pretendevano versioni diverse delle sceneggiature, che passavano di mano e si strutturavano, con tagli e aggiunte di un’équipe cangiante. Oggi è impensabile una cosa del genere. In America poi non parliamone. Questo è il motivo per cui più tardi si formarono coppie di sceneggiatori, che tentavano di garantire, con minori passaggi, prodotti dialettici: Monicelli e Steno, Scola e Maccari, Benvenuti e De Bernardi, e poi Fellini e Pinelli, se vogliamo. Federico l’ho incontrato per caso negli uffici della Lux di Gualino, un ragazzo alto, magro, con tanti capelli neri, guardato con un certo sospetto perché era diverso, era inquietante. Ci siamo conosciuti e affiatati subito in un bar di piazza Barberini. Stavamo leggendo dallo stesso giornale a un’edicola e ci siamo messi a parlare, così ci siamo seduti a bere. Lui parlava. Raccontava tante cose, storie, personaggi, panzane. E io, che dovevo fare? in
principio prendevo tutto per buono, poi ho dovuto imparare che molte cose le inventava; la sua fantasia era irrefrenabile, un vero seduttore. Abbiamo incominciato subito a lavorare insieme. Lui stava combinando qualcosa per Lattuada, che preparava Senza pietà, e ci siamo associati. Così è incominciata e siamo andati avanti per tanti anni. Lavoravamo moltissimo a quei tempi, i produttori erano tanti, c’era una frenesia di fare film che non ho mai più visto. Lì è nata davvero l’industria del cinema italiano, film per Righelli, Bonnard, Gentilomo. E Fellini. In fondo è vero che Fellini, come ha raccontato Flaiano, ci prosciugava. Era una spugna. Captava da tutti quello che gli interessava. Zapponi diceva bene: si comportava con qualcuno come se avesse passato tutta la vita aspettandolo, e poi prendeva quello che riteneva interessante. Io credo però di essermi difeso bene. D’altro canto è vero, in parte, quello che dice Suso: che noi, sceneggiatori molto tecnici, avevamo la funzione di dare struttura e concretezza a virtuosi come Fellini o Flaiano. Ero io che scrivevo in realtà tutti i soggetti e i trattamenti. La sceneggiatura di La strada per esempio l’ho proprio scritta tutta io dalla prima all’ultima battuta. Perché già scrivere è creare, avere il compito di scrivere e ordinare le cose che sono state dette vuol dire creare: noi non eravamo stenografi. A parte il fatto che le mie invenzioni si ritrovano in tutti i film di Fellini, fino a Ginger e Fred e La voce della luna... In quel periodo mi riservavo sempre una parte dell’anno per scrivere testi teatrali. Per esempio, per I vitelloni ho scritto il soggetto e il trattamento, e Federico naturalmente ha collaborato come sempre, ma subito dopo ho lasciato, e mi sono ritirato a scrivere Gorgonio, che tra l’altro vinse il Premio Riccione e fu rappresentato anche a Parigi. Federico continuava a tempestarmi di chiamate: vieni giù, vieni giù, stiamo scrivendo la sceneggiatura, ma sai com’è con Flaiano, non si riesce a concludere le cose, bravo e intelligente, per carità, ma è così difficile concretizzare... Allora sono intervenuto, con un’operazione di scrittura, sistemazione, dialoghi e tutto il resto. La strada l’abbiamo inventato insieme, Federico e io, ma come sempre a me è toccato scrivere il trattamento come un vero romanzo. Poi, deciso il piano, lui girava I vitelloni e io scrivevo la sceneggiatura della Strada, e gli mandavo le sequenze. L’episodio di Steiner, l’intellettuale, nella Dolce vita, l’ho portato io. Anche l’episodio del padre. Insieme a me Federico ha costruito tutta la scena corale delle donne in cascina in 8 e 1/2. Ma la cosa importante è che più andavamo avanti, più Federico acquistava la coscienza di se stesso e delle sue possibilità. Mentre in principio lavoravamo ex aequo, diciamo, tutti e tre, Federico, Flaiano e io, con il tempo Federico prendeva piede e noi diventavamo dei collaboratori. Insomma io direi che 8 e 1/2 è un film quasi completamente suo. Ma quel finale gliel’ho suggerito io. È noto che Federico ne aveva girato un altro, che mi fece vedere, e a me sono cascate le braccia. C’erano tutti i personaggi vestiti di bianco, seduti su un treno che viaggiava viaggiava... Io gli ho detto: senti Federico, se tu finisci così ammazzi tutto, è talmente deprimente. Era in calando. Ci voleva un finale in crescendo. Il ritorno della fantasia. Il giocoliere, l’illusionista, e tutto si rianima. La sfiducia che il protagonista ha in se stesso si risolve in questo gioco creativo, con tutti i personaggi che rappresentano la sua vita, non è vero?
Flaiano e l’ingrato Fellini. Ho smesso la collaborazione dopo Giulietta degli spiriti. Per molti anni. Ci fu una vera
frattura. Flaiano non ne poteva più di quel senso di subordinazione. E se ne andò prima di me. Si sentiva autore, e autore importante, quindi tollerava sempre meno di vedere usate cose sue, usate nel senso che lui non entrava a farne parte, non sentiva dire da Federico: grazie Flaiano, grazie Pinelli. E questo lui non lo sopportava. Io sì. Perché ho sempre saputo che Fellini era geniale. Avevo capito che era un privilegio lavorare con lui. E vero che La strada l’ho praticamente inventato io. Ma non sarebbe stato quel film in mano a un altro regista. Se Federico non fosse entrato nella storia, con quegli attori, con quelle immagini... Flaiano era una persona di grande simpatia e umanità, un ingegno vivace, versatile, un po’ balzano, molto sospettoso, da abruzzese, chiuso. In tanti anni di lavoro insieme sono riuscito a parlare soltanto una volta della penosa situazione di sua figlia. Una cosa che lo disperava e lo inteneriva. Mi disse che quando suonava il piano lei era attratta, c’era un forte contatto emotivo. E lui tentava di spiegare sempre agli altri che sua figlia aveva delle possibilità. Qualcuno mi riferì che per Flaiano gli altri giovani, a confronto di sua figlia, sembravano i ragazzini di Carosello. Per dire la profondità del sentimento. Quando io e Federico andavamo a trovarlo a Fregene, nella sua villa, era felice. Facevamo il bagno insieme e poi lui ci aspettava in giardino per bagnarci con la pompa dell’acqua. Ma anch’io per un altro verso non ne potevo più di Federico, a quel punto. E cioè vedevo, sentivo, che prendeva sempre di più la strada della decorazione, dell’immagine fine a se stessa, sempre meno legata a una necessità interna ai personaggi e alla storia. Avevo anche la sensazione di non essergli più utile. Pochi l’hanno detto, ma ci fu una autentica svolta per Fellini. I nostri film erano soggetti originali. Poi Fellini si rivolse ai libri. Casanova, che gli avevo comunque consigliato io, e Satyricon. Si era però riservato quel bellissimo Amarcord. E Casanova, intendiamoci, aveva immagini straordinarie, anche se io non ero d’accordo sul tipo di film, mentre Satyricon ha un’interpretazione della romanità che è stupenda.
Federico forever. Sono stato vent’anni lontano dal lavoro di Federico. Ho ripreso a lavorare con Germi, con cui avevo collaborato per In nome della legge e Il cammino della speranza, alla fine degli anni ’40. Quando uscì Divorzio all’italiana mi sentii sorpreso, incredulo. Che quel ragazzo scontroso, cupo, fosse riuscito anche a trovare una strada nuova, per la commedia. Divorzio all’italiana aprì un filone. Avevo di Germi un’idea diversa, come uomo e come autore. Era di una onestà tutta d’un pezzo. Il socialista deamicisiano. Sentimentale, fiducia nella gente, la città che si difende da sola: lui ha travasato queste cose nei suoi film, a incominciare da In nome della legge. E ha continuato così anche sotto la spinta del cinema americano western, che amava molto. Era tutto preso da John Ford. Dalle posture dei personaggi, gli sguardi, lo slancio e l’onestà. Anche nel modo di girare. Ed è stato sorprendente che abbia poi cambiato, verso la fine della carriera. Io però difendo il lavoro che abbiamo fatto per Alfredo Alfredo: per me è un bellissimo film. E Serafino, so che è discutibile, ma ha una tale energia, è talmente fuori dalle regole. Come professionista venivo chiamato a sistemare certe sceneggiature, già negli anni ’50. Volevano da me la costruzione della struttura e i dialoghi. Con Matarazzo credo di aver fatto soltanto Wanda la peccatrice. Con Cottafavi Traviata ’53, che non era male per niente, una
trascrizione nella borghesia milanese degli anni ’50. L’interprete era Barbara Laage, che a Parigi aveva fatto La puttana rispettosa di Sartre. Persona intelligente e fine, Cottafavi. Ma succedevano cose assurde. Mi sono trovato il nome tra gli sceneggiatori di Ritorna Za la Mort, per il quale non avevo scritto neanche una parola. Quando ho ripreso con Federico c’era un soggetto a tre episodi di Tonino Guerra, una cosa per la Masina. Mi chiamò perché aveva deciso di fare un film dal terzo episodio, che era un soggettino, un pezzetto di film. Venne da me e disse: vedi un po’ se trovi il modo per completarlo. Non solo trovai il modo. Era necessario farlo, perché mancava proprio tutta la parte emotiva, umana, il rapporto tra questi due ballerini che si erano conosciuti tanti anni prima, si erano amati, si erano separati. E su questo abbiamo ripreso a lavorare in perfetta intesa. Come se non fossero mai passati quei vent’anni. Ed è, naturalmente, Ginger e Fred. Non ho mai pensato agli attori scrivendo. Salvo per Giulietta Masina. Troppo particolare. Bisognava stare attenti, e scrivere pensando a lei. Soprattutto per la televisione. Federico non ha mai amato che Giulietta lo abbandonasse per la tv. Per lui era una sua creatura esclusiva. Sui set andavo soltanto per visite di cortesia. O quando mi chiamavano. Per esempio Federico mi fece portare subito sul set della Dolce vita quando scoprì, lì nel castello fuori Roma, che ci si poteva parlare da una stanza all’altra con una sorta di interfono nel muro. Avevamo scritto un dialogo d’amore tra Mastroianni e Anouk Aimée. Allora pensò che sarebbe stato più bello se Mastroianni parlava sotto e lei sopra. E me lo fece riscrivere. Ma mi sono sempre annoiato all’idea di stare sul set. Non ho mai voluto fare il regista. Al momento del primo film da direttore, che era Lo sceicco bianco, Fellini ebbe un attacco di paura. L’idea di fare il regista lo terrorizzò. A quel tempo eravamo proprio sempre insieme, ogni giorno. E mi disse: vieni con me, tu sei pratico di teatro e dirigi gli attori, io mi occupo delle immagini e di tutto il resto. Ho subito detto no. Non avevo proprio lo stomaco per fare il regista. Ci vuole una salute d’acciaio, intanto. Ma sapevo distinguere un grande regista. Lo erano Germi, Lattuada, Monicelli. Antonioni... Ho rivisto recentemente Deserto rosso e sono rimasto dello stesso parere della prima volta: una noia mortale. Ho una grandissima stima di Antonioni, ma ci sono anche cose incomprensibili nei suoi film. L’elemento assurdo di quegli anni era che se non affrontavi temi sociali non potevi girare un film neorealista. La cultura era dominata dalle sinistre, che perseguivano quel modello di film. Se non lo seguivi, rischiavi di passare per reazionario. Pensa un po’, io... Non c’era niente di più rivoluzionario di un film di Fellini, allora. Noi eravamo o traditori o mestieranti. Quando uscì La strada ci chiamarono “i sorridenti affossatori del neorealismo”. Figuriamoci se noi volevamo fare la guerra al neorealismo. Guardavo con sincera ammirazione film come Il sorpasso. La nuova generazione, Bellocchio, Pasolini, Bertolucci, la Cavani, faceva cose nuove e buone. Loro hanno svecchiato... Il primo lavoro per il cinema Pasolini l’ha scritto con me. Era sull’attentato di Sarajevo. C’era un film da progettare. Ma poi non se ne fece niente. La Cavani non sapevo neanche che esistesse. Mi chiamò Angelo Guglielmi e mi disse che c’era una giovane regista promettente che voleva fare un film su San Francesco. E abbiamo incominciato la collaborazione.
Cinemateatro, la tv.
Con la televisione ho iniziato molto presto, quando gli altri sceneggiatori disdegnavano ogni tipo di collaborazione. E sono sempre andato avanti. Ho almeno quindici lavori fatti per la tv, a partire da quel Carlo Magno che trasmettono ancora, ho visto. E sempre sceneggiati di molte puntate. Lavoravo quasi sempre partendo da un testo letterario, a parte la Eleonora che veniva da un mio lavoro sulla Scapigliatura di fine ’800. Gli altri erano sempre romanzi e racconti epici, Pirandello e la De Cespedes, Capuana. La tecnica era diversa, era molto vicina al teatro, quindi tornavo alle mie origini... una via di mezzo tra teatro e cinema, per me non era difficile. La cosa difficile per me fu il passaggio dal teatro al cinema. Fatto quello... Raccontare i personaggi attraverso il dialogo al cinema è una cosa, anche molto difficile, farlo per la televisione è un’altra, per una certa chiarezza “teatrale” che devi avere, ma non è teatro. È difficile da spiegare. Da qualche anno mi dedico alla narrativa. È stato faticoso passare al racconto. Mi sono dovuto impegnare a scegliere storie che non potevano assolutamente diventare soggetti cinematografici. Perché la parola fosse fondamentale e bastante. Nel vero racconto letterario l’azione diventa un trampolino per la scrittura valida in sé. Ho l’impressione che queste differenze non siano molto note agli sceneggiatori delle ultime generazioni. Ma non voglio dire che il cinema italiano non va bene per questo. Si dice che non sanno raccontare l’Italia di oggi. Ma chi lo sa che cos’è l’Italia di oggi? Io non riuscirei a dirlo. La contraddizione: forse il tema è questo. Di sera non esco quasi più per andare al cinema. Prendo però molte videocassette. Mi piace Agosti, un matto di genio. E Moretti m’interessa sempre. Non ho nessuna preclusione per quello che arriva dai giovani. Purtroppo non avviene il contrario.
La meraviglia. Da un po’ di tempo mi succede di guardare al mio passato come fosse un film. Cioè come se fosse successo a un’altra persona, che io conosco benissimo. Mi sono reso conto che sono arrivato in una zona della vita per cui i fatti che la compongono cessano di essere personali e appartengono a una storia. Sento la vicenda. Ho sempre avuto il pensiero della morte. Mi sono convinto di un’altra esistenza. Non so cos’è. E sono un po’ curioso. Spero che questa curiosità non sia soddisfatta subito. Ma a un certo momento... Anche Federico. Una volta mi disse che lo consolavano dicendogli: la morte è un sipario che cala. E lui: macché, la morte è un sipario che si leva e finalmente si vede che cosa c’è dietro. Un aspetto della vecchiaia che ormai mi è noto, e che invece non sospettavo così intenso, è l’impossibilità di fare conti a lunga scadenza. Per quanto si sia ottimisti, a 94 anni... Voglio dire, cinque, sei anni. Sono già un bel record. Ma sei anni poi passano subito. Lavoro ancora con quella Olivetti Studio, un cimelio storico ormai. Non so neanche che cos’è il computer, se non quando guardo il mio pronipote alla tastiera. Perché sono bisnonno. Non capisco niente, se non la meraviglia.
2 Sento il rocchetto a fine corsa. La pellicola esce dalla torretta. Il piatto è vuoto, la lampada mi acceca, la luce diventa un’onda enorme, il mare mi travolge. E mi sveglio. Il profumo del gelsomino mi placa. D’estate tengo la finestra socchiusa, per sentire subito che sono viva. Il sogno era un avvertimento? Un avvertimento qualche ora prima di un premio. Se uno ci crede, i sogni ti indeboliscono. Io mi accontento di incontrare qualche volta mio marito, e tiro dritto. Non voglio sapere. Le lapidi del sogno, però, sono certa di averle già viste, poggiate sul ciglio della spiaggia, rivolte al mare come un coro muto. In Francia, un minuscolo cimitero stagliato sulla costiera, lungo la provinciale tra Banyuls e Cérbère, oltre gli alberghi, verso la frontiera spagnola. Apparivano dopo la curva, in fondo alla passeggiata che infliggevo alle mie gambe ogni pomeriggio. Nel sogno, prima dell’onda, una donna con un libro in mano cantava. Non so dire chi era. Ma sì, certo, Eleonora Duse, ecco chi era. Non eravamo più in Francia. Lei stava in vestaglia, al balcone di una palazzina. Con un libro in mano, recitava. Il mare batteva, ma non riuscivo a sentirlo. Dalla Duse mio padre era più che affascinato. Ne aveva il culto. Raccoglieva ritagli, seguiva le recensioni di Simoni, i viaggi all’estero. Quand’ero ragazzina, sosteneva che le assomigliavo. Io sono cresciuta con l’idea della Duse, per il mio corpo asciutto, col ventre un po’ sporgente, come le ragazzine di oggi, e il volto che si innalzava dalla curva profonda del collo. Mi ha salvato, questa curva, perché adesso, ancora adesso, posso offrire un autentico profilo. Deve esserci da qualche parte una fotografia, un’istantanea della Duse in cui si vede bene il collo dritto e fine. Nel mio studio il sole estivo è smorzato. Casa mia è un attico senza terrazzi. Vedo un terzo del parco di Villa Torlonia e, se mi sporgo dalla finestra della camera da letto, il balcone dell’ultimo appartamento di Luigi Pirandello. Ecco, ho trovato la fonte del sogno. Clemente Fusero, Eleonora Duse, Dall’Oglio 1971, con la silhouette dell’attrice in copertina incastonata da una cornice di fregi alla maniera di Klimt. Nel 1897 la Duse era a Santa Margherita Ligure a provare Come vi piace di Shakespeare, che Arrigo Boito, innamorato, le aveva tradotto e spedito. “La grande viandante stanca viveva una di quelle pause della vita in cui l’anima non fa che ascoltare se stessa e affidarsi alla benefica monotonia delle giornate.” Bravo Fusero. Ha speso la vita a raccontare la vita di altri uomini. Ecco anche la fotografia della Duse che cercavo. Per leggere la didascalia devo cambiare gli occhiali. America, 1924: l’ultima foto. Il volto, di profilo, bilanciato dai capelli lunghi che cadono sulle spalle e dal naso pronunciato, è proteso, le labbra sottili semiaperte, come in una flebile invocazione. Si vede la vecchiaia. La vecchiaia si vede subito. Dopo pranzo prendo un caffè su questa poltroncina rivolta verso il parco. È l’ultima cosa della giornata che Miriam fa per me prima di andarsene, il caffè e il cuscino sotto i piedi. Le due del pomeriggio sono un momento magico. Mi piace muovere lo sguardo dal cappello del platano alla fratina in fondo al salone, ingombra di cornici come un’isola che non riesce più a contenere la sua foresta. Mi vergogno di questa malinconia, ma è un conforto e non so spiegare perché. La fratina è nella penombra, e io aspetto un amico luminoso che, ogni giorno,
d’estate, viene a infilzare l’oscurità. Guardo ancora il platano e il tavolo. Laggiù brillano, adesso, toccate dal sole, le sentinelle della mia vita. Per ogni essere umano di questa terra esiste un santuario generato dalla sparizione, dalla irreperibilità dei sorrisi che esplodono dalle cornici. Mio padre avrebbe voluto fare l’attore, ma non poteva ammetterlo. Lui, affascinato dalla Duse, ufficialmente disprezzava i teatranti. Suo padre era militare e sardo, combattente del Regio Esercito. Nelle lettere mio padre gli dava del lei: “Aff.mo papà, non il costume o la convenienza m’avvertono di scriverle al rinnovarsi dell’anno, ma sono la tenerezza e la gratitudine che mi portano a esprimerle i sentimenti di figlio affettuoso; sembra che il giorno della festa mi riconduca proprio a lei o, per dir meglio, mi faccia più vivamente sentire la nostra separazione.” Queste lettere le ho conservate perché oggi nessuno ci crederebbe. Quando la Duse riapparve sulle scene, dopo la storica assenza, papà andò due volte a teatro per lei, nel 1921, a Torino, poco prima che io nascessi. Non osò mai avvicinarla. Mio padre era fotografo, con il negozio, il laboratorio, due commessi, e una grande certezza della propria vita. Dall’età di sedici anni era fotografo e fotografo sarebbe morto: fotografo di ritratti e matrimoni. Il nonno lo biasimava. Una sfida non dichiarata opponeva la disciplina di un conservatore di fine Ottocento, insediato nella capitale sabauda, al richiamo della modernità di un ragazzo del secolo nuovo che imparava l’inglese. Papà voleva dimostrare che si poteva conciliare la disciplina con la nuova era, mantenendo dignità e guadagnando soldi. La sua sola rivoluzione fu il trasferimento a Roma per sposare mia madre. Durante la guerra lo vedevo correre avanti e indietro a cercare invano matrimoni che nessuno poteva permettersi. Per il resto rifiutava tutto. Un giorno un amico ci raccontò che in via della Vite certi giovanotti cercavano un fotografo. Erano appena entrati a Roma gli alleati. Quei ragazzi avevano aperto una specie di negozio di caricaturisti. Si trattava di scattare le foto ai militari, in gruppo o da soli, con le caricature in mano, svilupparle e raggiungerli al comando o nei locali notturni per rivenderle. La mamma non disse niente. Mio padre finse di non sentire. In un mese avevo stretto due volte l’elastico di una gonna di seta che adoravo. Così, per settimane, abbiamo continuato a mangiare patate e pane e formaggio. I ragazzi erano: Steno, Federico Fellini, Resentera e Tino Scotti; i soldi glieli aveva dati Forges Davanzati, il produttore. In pochi mesi aprirono un negozio più grande, in via Nazionale. Lo abbandonarono dopo un anno per riprendere a lavorare nello spettacolo. Mio padre non tornò mai sull’argomento. Dopo la guerra, il negozio e un’eredità ci fecero dimenticare tutto. Poi, sposata ed entrata a Cinecittà io, pure con qualche iniziale protesta, mio padre diventò un genitore appagato. Che cosa mi succede oggi? Continuo a pensare al premio. Eppure, devo soltanto ritirare una medaglietta. Sabato vado, prendo quello che devo prendere, saluto e torno a casa. Da Pescara potrei farmi riaccompagnare la sera stessa, se me la sento. Ma è che ho ancora qualche perplessità su questa cerimonia. La mia carriera non merita un premio; forse un premio merita me, non si dice così? Tutti rimangono colpiti perché, dopo una vita passata alla moviola, sono diventata sceneggiatrice e scrittrice. In fondo, a parte i racconti e qualche sceneggiatura, ho
scritto soltanto un romanzo in vent’anni; e naturalmente sono felice che abbia avuto il successo che ha avuto. Io soltanto so (e forse mia figlia, ma non ho mai capito se lei lo ha veramente capito) perché ho deciso di scrivere: perché era il mio sogno da quando facevo il liceo classico e perché ho perso mio marito che non avevo ancora sessant’anni. Agli altri, però, lascio credere che sia per la pletora di storie a cui ho assistito. Oggi tutti sono disposti a ritenere glorioso qualsiasi passato. Ma la sostanza del mio lavoro era tagliare e cucire Lori Randi che faceva Cenerentola per Cerchio, le inaugurazioni di De Gasperi o l’arrivo all’aeroporto di Liz Taylor. Andavo a Cinecittà come si va in ufficio. A volte mi chiamavano come un medico del pronto soccorso. Come successe per Giuseppe De Santis. C’era un problema per Uomini e lupi, con la Mangano, verso la fine degli anni ’50. La Titanus voleva tagliare mezz’ora: a quei tempi superare i 100 minuti di proiezione era rischioso. Lombardo, il capo della Titanus, aveva affidato la revisione a Zavattini e Tullio Pinelli, che voleva il taglio di una scena intera. Pirro e Petri difendevano De Santis. Ho capito dopo che uno come Pinelli non poteva accordarsi con un austero comunista come De Santis. Un giorno, durante la discussione, De Santis entrò in montaggio da Varriale, di cui si fidava ciecamente: lo trovò che tagliava su ordine di Lombardo. Chiamarono me: De Santis ha litigato con Varriale, vieni. Ero felice. Riso amaro e Roma ore 11 per me erano capolavori. Ma bastò il tempo di un pranzo perché mi rimettessero al mio posto; fu l’intervento più breve mai realizzato su un film d’autore: non toccai neanche la moviola. Però non ho mai avuto ragione di sentirmi frustrata. Avevo Francesco, mio marito, la bambina, i miei libri di storia e i miei taccuini. E qualche volta ho messo le mani anche sulle pellicole che contano. Lattuada, sebbene puntasse sui suoi tecnici di fiducia, aveva un debole per me. E Comencini. Ricordo le ricerche per Tutti a casa. Volevano materiali d’archivio, qualsiasi cosa riuscissi a trovare sui giorni intorno all’8 settembre; ma poi non furono mai impiegati. Comencini lo avevo già incontrato; ero stata in montaggio per Mariti in città e Mogli pericolose. Di lui ricordo una gentilezza naturale, mai distratta dall’interesse. La sua cultura sul cinema degli anni ’30 era profonda; a Milano aveva raccolto molte pellicole per i cineforum. Una zia di mia madre conosceva i Comencini quando Luigi nacque, a Salò. Sparirono dal paese improvvisamente e il nome di Comencini ricomparve trent’anni dopo come il regista di Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, il maresciallo e la bersagliera. E ora non so più neanche se è vivo. Ho visto tutti e in fondo conosciuto quasi nessuno.
LUIGI COMENCINI Pinocchio si nasce Ho capito che volevo diventare regista quando ho visto L’Atlantide di Pabst. Fu un’emozione fortissima. Avevo quindici anni. La sensualità di Brigitte Helm mi aiutò a dimenticare una ragazza che, invitata al cinema, non si presentò mai all’appuntamento. Il primo film visto invece era una comica, ricordo appena la pancia enorme di un uomo e degli angioletti che vi si arrampicavano. Mi ci aveva portato la cameriera.
Il calesse e la radio. Non andavo spesso al cinema. Tantomeno in Francia, dove ci eravamo trasferiti da Salò. Mio padre viaggiava cercando affari immobiliari, ma poi, diventato agricoltore senza volerlo, perse tutto a causa di un’inondazione. Abitavamo in campagna, nel sud-ovest, in una specie di castello isolato. Per raggiungere il cinematografo in città, ad Agen, ci voleva una pedalata di cinque chilometri. Mia madre usava un calesse trainato da Stella, una cavallina di cui distinguevo il suono degli zoccoli a distanza, dalla mia aula di liceo. Per me vedere un film diventava un evento. Ricordo però, durante una visita a Parigi per incontrare mio padre, da bambino, i manifesti colorati e ammiccanti dei film. Mi colpivano, mi attiravano, ma non c’era mai tempo per andare al cinema. La sera, a casa, si ascoltava la radio, quando funzionava. Era la metà degli anni ’20 e la radio era un apparecchio molto complicato. Mio padre tentò addirittura di metterne insieme una seguendo le istruzioni di un giornale. Alla fine, tra i rumori e le interferenze, l’unica cosa che siamo riusciti a sentire erano le nostre voci. Le cose cambiarono soltanto quando mio padre incominciò ad avere problemi di salute: trasferiti in un appartamento in città, per essere vicini all’ospedale, il cinema era quasi sotto casa. Un giorno, in programma c’era un film con musica e rumori, protagonista Douglas Fairbanks. Si sentivano le lame delle spade e gli zoccoli dei cavalli. Era il sistema Vitaphone. Il sonoro, con le voci, era alle porte.
Paura d’abbandono. Non ho avuto un vero rapporto con mio padre, che era sempre in giro per lavoro e che ho perduto quando avevo diciotto anni. Veniva da una famiglia modesta di Orzinuovi, in provincia di Brescia, aveva studiato come un matto per diventare ingegnere. Parlava poco. In generale si parlava pochissimo in casa. Anche con mio fratello. I figli erano una priorità di mia madre, ed è probabile che la mia predilezione per le storie in cui spicca la relazione tra padre e figlio venga da questa mancanza. Io avevo sempre paura che mia madre mi abbandonasse, una paura senza motivo, ma profonda.
Ingegnere, regista, anzi artigiano.
Comunque, ai miei genitori non piaceva la mia aspirazione per il cinema. Pensavano a un futuro come ingegnere, essendo io portato per la matematica, e così andò a finire che mi laureai in architettura all’università di Milano, dove incontrai Lattuada. Non seguivamo i corsi regolari, non ci sembravano fruttuosi. Con altri studenti abbiamo formato un gruppo che studiava Gropius e il Bauhaus, e i lavori più moderni degli americani. Cercavamo informazioni diverse da quelle del regime. Gropius aveva un’idea precisa, l’unione tra il bello e l’utile per cose che potessero servire a tanta gente, come poi ho cercato di fare io con i miei film, anche se non ho mai ben capito che cosa sia un “film d’autore”, e me lo sono chiesto davvero diverse volte. Come la definizione di “artigiano”. In fondo me la sono voluta io. Ma considero “artigiano” anche chi riesce a realizzare capolavori, come Chaplin, per esempio. Il fatto è che io considero tutto il cinema “arte applicata”, a discapito di quel che diceva la critica italiana troppo ideologica. Comunque, mi ero appassionato all’architettura al punto che non sapevo più se volevo fare il cinema, anche se La novelletta, il mio primo film (l’avventura agreste di una contadina e un giovane borghese che scopriva la campagna), finanziato da mia madre con i soldi ricavati dalla vendita del suo amato pianoforte, arrivò quinto al concorso dei littoriali, rappresentante del Cineguf di Milano. I primi classificati, però, erano film politici. L’amicizia con Lattuada, lo sanno quasi tutti ormai, si fondava anche sulla passione per i film da salvare. Io avevo incominciato a raccogliere pellicole con il libraio Mario Ferrari. Cercavamo di trovare i titoli di cui sentivamo parlare, e così abbiamo scoperto che le vecchie pellicole, vendute a peso per recuperare il bromuro d’argento, potevano essere ritirate e conservate. C’era una specie di mercato clandestino nel quale anche i capolavori costavano quasi niente. Ci siamo trovati tra le mani Il monello di Chaplin o L’angelo azzurro di Sternberg. La Cineteca di Milano, (oggi diventata una Fondazione), inaugurata dopo il ’45 grazie a mio fratello Gianni, che ne fece la sua professione, e a Ferrari, è nata così, con lo scambio di film tra noi e la cineteca di Langlois a Parigi, e con la guerra, che a un certo punto ci costrinse a nascondere le pellicole in un pollaio di Vaprio d’Adda, nella cascina dello zio di Lattuada.
Dalla guerra al set. La Cadillac di Carlo Ponti mi portò a Roma per girare il mio primo lungometraggio. Ponti l’avevo incontrato qualche volta a Milano, prima della guerra. Sognava anche lui di fare il cinema. Ogni tanto mi dava biglietti gratuiti che io, in caserma a Udine, giravo a un superiore, un maresciallo che aveva il compito di selezionare i militari in partenza per il fronte sovietico. Mi salvai la vita così. Come succede in Tutti a casa, dopo l’8 settembre sono scappato. In Svizzera ho aspettato la fine della guerra, scrivendo per i giornali socialisti. Quando sono tornato a Milano, volevo fare un pezzo su piazzale Loreto. Andai a vedere, di notte. I corpi buttati lì e i partigiani di guardia. Non scrissi niente. Comunque, Ponti era diventato avvocato e i film li faceva davvero. Io cercavo di guadagnare qualcosa scrivendo come critico cinematografico. Tramite la Lux, Ponti stava mettendo in piedi la produzione di un film sui bambini. Anche il capo economico della Lux, Gatti, conosceva il mio cortometraggio Bambini in città, girato nella Milano distrutta dalle bombe e premiato con un Nastro d’Argento. Mi lasciai trascinare, ma non ero convinto per
niente che rifare La città dei ragazzi fosse una buona idea. Fu in quelle settimane che partecipai a una delle “domeniche mattina” del Barberini. De Sica faceva vedere Ladri di biciclette. Mi impressionò profondamente. Finì che cambiammo la prospettiva del nostro film; era ambientato a Napoli e decidemmo che dovevano essere i bambini ad aiutare il prete. Emilio Cecchi era entusiasta del risultato, forse per i primi piani che lasciavano parlare le facce, furono in pochi a vedere Proibito rubare. Ero un po’ demoralizzato.
Quando Germi girò il mio film. Detestavo già allora i film che non hanno successo. Infilai anche l’errore di accettare un Totò, L’imperatore di Capri, che ancora oggi non riconosco. Avevo dei progetti che non riuscivo a concludere. Volevo fare un soggetto civile, La città si difende, ma tutti mi reputavano un regista di film comici. Fellini arrivò a sollevarmi dall’impasse con una telefonata per conto del produttore Rovere, nel ’50: Puccini non voleva più continuare Persiane chiuse, scritto da Fellini e Tullio Pinelli. Se lo sostituivo, Germi avrebbe fatto La città si difende. Non capivo che cosa ci avrei guadagnato. Non si poteva fare il contrario? Alla fine, confortato dal consenso di Puccini, accettai. Germi girò il mio film. Così andavano le cose, mentre il cinema italiano viveva un vero boom e tutti volevano fare film. Persiane chiuse ebbe successo, nonostante la storia del padre che va a cercare la figlia finita in un giro di prostituzione fosse piuttosto irreale. Ero ormai il regista delle prostitute, così arrivò anche La tratta delle bianche.
Le bugie del cinema. L’incontro con Ettore Margadonna aprì invece una svolta nella mia carriera. Cercavo un soggetto vitale, spiritoso e, tra un recente, modesto racconto di parrocchiani (Paolo aiuta Dio) e un vecchio, vivace racconto di paese, entrambi di Margadonna, trovai i personaggi giusti, a cui aggiunsi un maresciallo dei carabinieri. Il maresciallo e la bersagliera. Pane, amore e fantasia diventò un film dopo la morte del produttore, il vinaio Motta, quando De Sica, che non ne voleva sapere, accettò di ascoltare la storia incisa da me e Margadonna al registratore, un filo magnetico, perché il nastro non era ancora in uso. Bisogna capire quando un progetto, nato per diventare una cosa, ne diventa invece un’altra. Io ormai mi ci ero specializzato. Doveva essere una satira, il nostro film, invece si stava trasformando in un vaudeville, con la benedizione dell’Arma. De Sica e la Lollo, le star, avevano completato la demolizione. Avevo deciso di lasciare il film. Eravamo a Castel San Pietro. Mi bloccò il produttore Marcello Girosi, di notte, con le valigie in mano: mi ubriacò in trattoria e mi fece chiamare al telefono da De Sica. Che mi implorò. Implorato dal più grande regista d’Europa. Gli ricordai che interveniva nella regia in ogni momento. Perché non se lo faceva lui, il film? Disse: non fare lo stronzo. Però non interferì più nella mia regia. Il successo di Pane, amore e fantasia non attenuò la mia insoddisfazione. Avevo inventato il “neorealismo rosa” dicevano, ma era un’accusa per me, e un castigo, che a quel punto ritenevo giusto.
La telefonata di Andreotti in trattoria.
Forse il primo film che mi lasciò invece il senso di una piena soddisfazione è stato Tutti a casa. Mi rendevo conto che raccontare l’8 settembre era un’occasione unica, pensando anche al consenso che aveva appena ricevuto il mio amico Monicelli con l’onestà di La grande guerra. Mi bruciava ancora l’esito di La finestra sul luna-park, un film a cui tenevo molto. A Berlino, quando si parlò dell’Orso d’oro, fu boicottato dalla delegazione italiana che, con gesto significativo, abbandonò il festival prima della fine. Il tema era semplice: che cosa succede se un padre non ha il tempo di fare il padre? Era un film neorealista, d’ambiente operaio, quando nessuno voleva più il neorealismo. Andreotti intervenne prima dell’uscita: attraverso Monsignor Angelicchio, il presidente del Centro cinematografico cattolico, impose tagli che accettai fino a un certo punto, per salvare il film senza cedere troppo. Mi aveva telefonato in trattoria, Andreotti. Avevano fretta. Dunque, La finestra sul luna-park, che secondo la loro subdola visione poteva diventare un capolavoro, uscì in poche sale e sparì per sempre. Andreotti tentò d’influire anche su Tutti a casa. Ordinò di ritirare dal set i carri armati, sostenendo che era un film disonorevole per l’esercito italiano. Li feci sostituire con due figure di compensato, montate su una jeep. Ma se uno ci fa caso, si vede. Il film era nato involontariamente durante un viaggio in treno verso Milano. Io e Scarpelli ci raccontavamo della baraonda dell’8 settembre, che ci sembrava un evento unico: in nessun paese, eravamo convinti, era successo che un’intera nazione sapesse dalla radio che gli alleati erano diventati nemici e i nemici alleati. De Laurentiis si ostinava a voler fare il seguito di La grande guerra. Per fortuna quando vide il primo materiale girato, esultò e tirò fuori un po’ di soldi e di mezzi. E ne è venuto un film di successo che funziona ancora oggi. Pensavo che La ragazza di Bube avrebbe avuto strada facile, a quel punto. Ma non fu così. I maggiori produttori respinsero il soggetto: della Resistenza non si parla. Poi l’adesione di Claudia Cardinale consentì di produrre un film molto stimato, a cui ero personalmente affezionato, perché il rapporto tra Bube e Mara riprendeva l’amore tra me e mia moglie. Fu uno degli ultimi film in bianco e nero.
Rizzoli e Don Camillo. Il mio interesse per l’infanzia non è programmatico, né sono in grado di dare una spiegazione. Incompreso, Pinocchio, Voltati Eugenio, Cuore e anche la mia inchiesta televisiva I bambini e noi, forse la cosa più bella che ho fatto sull’argomento... Ci sarà una ragione se, quando mi proposero un film su Casanova, scelsi di raccontare proprio la prima parte della sua vita. L’infanzia forse è l’unico momento di grande libertà. La scuola, la famiglia, l’educazione, cercano di opporsi. Il dramma nasce qui. Incompreso lo voleva fortemente Rizzoli, che un giorno trovò il coraggio di rivelarmi la sua commozione, da ragazzino, per questo libro inglese di fine Ottocento, in cui si parlava di una madre morta, di un padre troppo rigido e di due bambini sconsolati. Non sapevo cosa fare. Con Rizzoli ero appena uscito dal pasticcio del quarto Don Camillo. Insieme con alcuni soci di una società fallita, la Morino Film, ero debitore di Rizzoli per una sessantina di milioni. Pretendeva che dirigessi quell’episodio, con Fernandel e Gino Cervi. Pensare che a Ischia prometteva di regalarmi un promontorio, per poi dirmi sconsolato, qualche mese dopo: “Caro Luigi, sapessi a quanti l’ho già regalato...” Insomma, quando decise di riscuotere, fui costretto ad accettare quella regia, di cui oggi un
po’ mi vergogno. Rizzoli era un vero furbo. Mi fece chiamare in aeroporto, mentre ero in partenza, per mettermi alle strette. O facevo il film o mandava le cambiali in protesto. Gli dissi sì. Dopo mezz’ora, tornato a casa, scoprii che quella stessa mattina avevano svaligiato il suo studio: tra le altre cose, erano sparite anche le mie cambiali. Ero libero, e Rizzoli aveva tentato di fregarmi. Ma avevo dato la parola e la mantenni.
Incompreso 97 volte. Così, la scoperta del bambino di Incompreso, e le varianti che decisi di apportare trasformarono il progetto in un film di grande successo. Sapevo che in fondo era un film sulla morte di un bambino. E forse la parte della morte è un po’ ruffiana. Ma i fan del film sono stati tantissimi. Un bambino di Ginevra mi raccontò di averlo visto novantasette volte. Per istinto, ho cercato la natura complessa dell’infanzia. Non mi convinceva, per esempio, che Pinocchio fosse trasformato in bambino soltanto nel finale. Mi sembrava un ricatto incombente, in cui si risolveva l’intero racconto. Così ebbi l’idea di adottare la trasformazione del bambino in Pinocchio come punizione ogni volta che non rispettava gli accordi con la fata. Ma la fortuna fu anche trovare Andrea Balestri, un vero Pinocchio, e Nino Manfredi, l’unico attore capace di parlare con un pezzo di legno. Dicono che Pinocchio è un pilastro della televisione pubblica e, onestamente, lo penso anch’io. È il film con cui credo di aver detto tante cose che mi stavano a cuore dell’infanzia. E pensare che avevo tergiversato davanti alla spinta di mio cognato, Massimo Patrizi, a cui devo amicizia e collaborazione lungo quarant’anni di lavoro. A cui devo tra l’altro la spinta per voltati Eugenio, che andò a Venezia nell’80 e fu accolto benissimo. Tergiverso spesso, è nel mio carattere quando non sono convinto. Con Incompreso come per Marcellino, e anche per Cuore, dove però prevalse la voglia di fare. Temevo che la malattia potesse fermarmi da un momento all’altro. È invece pienamente mia la responsabilità de L’ingorgo. Ed è vero che mi appassionai subito alla sceneggiatura de Lo scopone scientifico. Sono stato fortunato ad avere vicino persone care, come Massimo o le mie figlie, quando, dopo il grande successo di La storia, credevo di non avere più le forze di continuare, e invece girai ancora quattro film, tra cui Un ragazzo di Calabria, ancora una storia di adolescenza, e il film-opera dalla Bohème.
Adulti e bambini. Dicono che sono stato il regista dei bambini. Una volta, quando ormai avevo capito che stavo per chiudere definitivamente con i set cinematografici, volli andare a cercare il protagonista di Pinocchio. Era diventato un uomo, ma si riconosceva sempre la stessa dolcezza. Decisi di ritrovare tutti i bambini dei miei film, ormai adulti. E di riunirli. A loro insaputa, li feci filmare man mano che entravano nella stanza e si presentavano l’un l’altro. Io avrei voluto nascondermi, sparire, ma qualcuno invece mi scoprì, in un angolo.
3 Il sole si è preso il salone. La pigrizia mi distrae. Oggi non me la sento di andare nello studio. Era la stanza in cui stava sempre mio marito. Al posto dello schedario di ferro, dove ordinava gli appunti delle lezioni universitarie, c’è un quadrilatero impettito, poggiato su un collo sottile. Schermo al plasma. Quando lo guardo penso a una figura geometrica con il sangue che scorre in antri invisibili. Quelli del premio mi hanno chiesto se so usare le e-mail: ho detto di sì. Ma l’unica cosa che so fare col computer è accenderlo e aspettare. Poi guardo il foglietto con gli appunti di mio nipote: cercare l’immagine della busta, schiacciare due volte, schiacciare sul rettangolo, aspettare che tossisca. E, se tutto va bene, trovo i suoi messaggi – vuole sempre sapere cose che non so – e un saluto di mia figlia quando è all’estero. Sono gentili i miei ragazzi a farmi credere che faccio ancora parte di una famiglia, di una famiglia moderna e affettuosa. Vedo un marchietto con la cinepresa e la pellicola: non hanno molta fantasia. È confermato per sabato 23. Tra quattro giorni. Mi mandano la macchina, così tornerò la sera stessa. Il premio lo consegnerà Mario Monicelli, Sandra Milo è candidata come madrina della festa. Monicelli non deve sapere neppure chi sono. Avrà dato un’occhiata al romanzo, questo è possibile. A volte mi sembra che sia eterno. Da anni si muove innalzando il vessillo del cinema italiano. Siamo tutti sopravvissuti? Ormai abbiamo imparato a restaurare tutto, film, libri, mobili e automobili, ma finiamo in realtà per cancellare il tempo. Non riusciamo a vivere “con” il vecchio. Si restaurano anche le persone. Se avessi tirato la pelle qui, sotto l’orecchio, sarei restaurata? Quando mi tocco le mani, sento l’effetto di uno smottamento tellurico, vene sprezzanti che la terra non riesce più a contenere. Perché, allora, in un gesto fantasma, avverto ancora la grazia delle mie carezze? Qualche tempo fa ho visto un documentario di Gianni Celati sulle abitazioni abbandonate del Po. Ho percorso quella strada molti anni addietro. Viaggi per ore dal Piemonte al Delta e ti passano di fianco enormi cascine disabitate, ruderi solitari, chiesette sfondate. Se ascolti bene, però, senti ancora i bambini sull’aia, vedi i cappelli dei contadini, le biciclette e le galline. Monicelli l’ho visto per la prima volta a Cinecittà insieme a Franco Fraticelli, che montava per lui e Steno È arrivato il cavaliere, con Tino Scotti. Mio padre aveva conosciuto Scotti al suo negozio e si era fatto promettere un tentativo per me con la Minerva. Per due anni ho aspettato invano. Poi, ad aiutarmi, è stata Lidia, compagna al liceo e amica per sempre. Lavorava come dattilografa da un avvocato all’Eur, ma conosceva Adelaide Mary, direttrice dei dialoghi di Fanciulle di lusso. Era il 1952 e Adelaide era una donna già proiettata nel futuro: portava un foulard annodato alla nuca, pantaloni neri e calzini bianchi di cotone pesante, il bordo rivoltato sulle caviglie. Quella che ora si chiama solidarietà femminile era già cominciata quando Adelaide riuscì a impormi come assistente di montaggio a un direttore amministrativo, un tipo tarchiato che ballava tenendo la mano sul fermaglio del reggicalze. Odorava di naftalina e con i baffi mi pungeva la spalla. Sempre stringendomi la coscia, mi disse: “Domani ti presento a Monicelli e dopodomani a Fellini.”
MARIO MONICELLI La libertà al settanta per cento Non è che taglio corto sulla memoria, è che proprio non ne ho di memoria. Cancello tutto quello che succede. Non trattengo niente. Non ho vecchie sceneggiature, ho poche fotografie, quando cambio casa non mi porto niente. Perché, non so. E non soltanto quanto concerne il mio lavoro. In genere è così per tutto quello che riguarda la mia vita. Sarà una difesa, chi lo sa. Non coltivo ricordi, non mi soffermo mai a rivedere qualcosa, e dimentico tutto molto facilmente: i volti, le persone, le località. Questo in fondo non mi crea problemi. Forse me ne toglie. Anzi, adesso che ci penso non mi sono poi posto nemmeno la domanda se me ne crei o me ne tolga. Sono fatto così, mi va bene così. Mi dà problemi, ecco, in questo caso. Quando mi chiamano, mi chiedono storie, aneddoti, ricordi. Chissà quanti ne potrebbe raccontare qualcun altro al posto mio. Io non ho mai niente da dire, da citare. Se poi nei film entrano delle memorie, questo credo che sia inconscio.
Film a colpi di tamburo. Da bambino ho visto i film del muto, naturalmente. Ma proprio non so dire quale sia stato il mio primo film da spettatore. Mi piacevano molto le comiche. Aspettavo la conclusione del film ufficiale, in genere i melodrammi con Mary Pickford o giù di lì, per vedere la comica finale, con Chaplin, Buster Keaton, Fatty Arbuckle. Forse la prima immagine che mi è rimasta impressa e che posso ricordare è un film con la Pickford; bisogna tener presente che allora si facevano i film a episodi, quindi ogni settimana cambiava l’episodio e si doveva aspettare per vedere come andava a finire; mi colpiva questa sospensione, perché serviva a tenere il pubblico sulle spine e a costringerlo a tornare dopo qualche giorno. Non sono sicuro fosse un western. C’era una carrozza, anzi una diligenza che, percorrendo una prateria, finiva nelle sabbie mobili. Piano piano affondava, e i viaggiatori uscivano uno a uno. E salivano sul tetto della carrozza per cercare di salvarsi, ma anche il tetto entrava inesorabilmente nelle sabbie mobili, e a quel punto il film finiva lì. Così bisognava aspettare una settimana. Ma non ricordo come andò a finire. Forse è per questo che mi ha impressionato e che ancora oggi riesco a ricordarlo. Ricordo però che c’era Mary Pickford. Comunque, io ero più per le farse. Ero capace di rivedere tutto il film principale per assistere poi alla nuova comica. A teatro vedevo tutto invece, drammi, tragedie, commedie. Il teatro, quando ero ragazzo io, era molto popolare. Se ne faceva tanto, se ne vedeva tanto, era facile andarci, anche per un ragazzo. Ho sempre distinto il teatro dal cinema. Nei primi anni ’20 il cinema era già uno spettacolo di massa, anche in Italia. C’erano le file, come oggi. A Roma, ma anche a Viareggio dove sono nato, i cinematografi erano molti, però bisogna pensare che Roma faceva seicentomila abitanti, non quattro milioni come adesso. Le sale erano affollate. Spesso si stava in piedi, appoggiati alle pareti, seduti sulle scale. Una grandissima partecipazione. Secondo me, più di adesso. In fondo era l’unico passatempo a basso prezzo disponibile. Non è soltanto che non c’era la televisione. Non c’erano soldi per fare altro, almeno per la gran parte della gente. Il sabato si lavorava. La domenica non c’era la
seconda casa da raggiungere. I romani al massimo prendevano il trenino, invece che andare al cinema, e andavano ai castelli a mangiare il pollo fritto. Il mare cominciava appena a essere una meta, ma per pochissimi. E non c’erano soltanto i film americani. Dai film di Guazzoni ai Cretinetti il cinema italiano aveva un suo vastissimo pubblico. È vero che anche negli anni ’20... Anzi, cominciò negli anni ’20 la fortuna del cinema americano, che si era organizzato per conquistare i mercati, dominando sui francesi e gli inglesi: non essendoci il sonoro avevano tutti possibilità uguali di raggiungere il pubblico. Un anno e mezzo prima dell’uscita del Cantante di jazz, che aveva le parti sonorizzate delle canzoni di Al Jolson, mi ricordo che già nei cinematografi di prima visione (perché poi c’erano le seconde e terze visioni, dove andava un ragazzetto come me perché si pagava pochissimo) in platea c’erano parti sonorizzate artigianalmente. Sotto lo schermo c’erano macchinette che facevano il rumore delle mitragliatrici, le bombe si facevano con una grancassa, c’erano gruppetti di trombe per certe fasi militari e altri stratagemmi di suono. Mi ricordo La grande parata visto con queste animazioni sonore. Un film che m’impressionò nel ’28 o nel ’29 fu Il fantasma dell’Opera con Lon Chaney. Lì il pianoforte aveva un ruolo drammatico fondamentale, e quando lui si voltava e si vedeva quella maschera orrenda, un colpo spaventoso di grancassa risuonava in tutta la sala. Faceva una grande impressione. Questo per dire che il sonoro ha avuto anche qui da noi una fase preparatoria suggestiva. Non fu però un’invenzione sconvolgente: ci si aspettava che il cinema andasse in quella direzione. E i primi tempi si sentiva male, il film era pieno di stridori, il sincrono era imperfetto. Era molto affascinante la novità, però devo dire che io avevo intuito che andava a finire così, e poi continuavo a vedere sempre i muti di Chaplin, di Buster Keaton e gli altri comici, che erano importanti e belli proprio perché erano muti. Ricordo il successo clamoroso della Canzone dell’amore di Gennaro Righelli. Si sentiva parlare chiaramente in italiano, una grandissima novità. Le cose però avanzarono parallelamente, perché c’erano gli autori che avevano raggiunto una grande perfezione nella realizzazione dei film muti e quindi non ti facevano mancare emozioni e grande spettacolo, anche senza quella nuova tecnologia.
“Me ne frego”. Il sonoro portò poi il regime fascista a occuparsi del cinema, a usare il cinema per raccontare la storia come voleva, con quei film agiografici. Avevo sette anni quando arrivò la marcia su Roma. Riesco a ricordarmi di aver visto, affacciato alla finestra di un palazzo di via Nazionale (credo fosse la casa della famiglia d’Amico), una fiumana di gente con la camicia nera e i calzoni alla zuava che sfilava padrona delle strade, un po’ cantando, un po’ rumoreggiando, vagamente minacciosi. Mi impressionò che alcuni avessero il teschio della morte sul petto e altri la scritta “Me ne frego”. Ma poi il teschio era ridicolo, forse. La morte c’era dappertutto: sui pali della luce, alla stazione ferroviaria, era un simbolo più frequente. Invece “Me ne frego” era molto trasgressivo per un ragazzino. Procedevano scomposti. Non era affatto una marcia. Ho questo ricordo dall’alto, come una cosa un po’ lontana. Qualche giorno dopo li vidi ancora circolare per Roma, una volta che Mussolini era stato designato a formare il governo. E lì mi sembrarono un po’ più invadenti. Mio padre ebbe dei problemi seri.
Camicie azzurre a Bologna. Era un nazionalista, lui. Apparteneva a un gruppo politico che si chiamava le “camicie azzurre”, anche loro con dei simboli, dei coltelli disegnati sulla stoffa azzurra. Insieme a Federzoni e altri fiancheggiò il fascismo. Era direttore di un giornale che, al momento del delitto Matteotti, nel ’24, stigmatizzò la responsabilità di Mussolini, e fu buttato fuori. Il giornale era “Il resto del Carlino”, a Bologna. Ho dei ricordi in quella città. Stavamo in una villetta alla periferia. Che poi chissà che cosa doveva essere la periferia di Bologna nel 1925, sarà stato il centro di oggi. Avevamo un garage. Mi ricordo che mio padre era costantemente minacciato di essere bastonato. Così nel garage, per un po’ di tempo, la notte dormiva un drappello di venticinque, trenta soldati. C’era il gruppo di Arpinati, che credo fosse il federale: e questi qua volevano punire mio padre, fisicamente, voglio dire. Mio padre perse l’incarico in università, cessò di fare il giornalista, insomma non poteva più fare nulla, anche perché continuò a essere un oppositore del fascismo. Quindi io sono nato in un clima antifascista, in un modo anche un po’ ridicolo, visto con gli occhi di oggi, perché ricevevamo un sacco di gente, intellettuali e politici, da Missiroli a Meraviglia, che pronosticavano la fine del fascismo in sei mesi. E a me sembrava che non ci pigliassero molto, perché crescevo e il fascismo continuava. Io sempre più consapevole, se vogliamo, della dittatura, di questi “distruttori della libertà”, di sarcasmi e ironie. Seguivo questo andazzo, mi ritenevo antifascista, ero contro le camicie nere, non andavo a nessuna manifestazione. E seguivo quello che sentivo a casa.
Via Paal con Mondadori a Milano. In quegli anni, tra le due guerre, venne in voga la letteratura ungherese, Molnár, Körmendi. C’erano un tre o quattro romanzieri che andavano per la maggiore. E I ragazzi della via Paal mi aveva conquistato. Avevo diciassette, diciotto anni, quando decisi di farne un film, dopo il corto Il cuore rivelatore, tratto da Poe. Per un ragazzo che aveva voglia di esprimersi in maniera moderna, il cinema sembrava fatto apposta. Credo che anche oggi sia un po’ così, ma a quel tempo mancava la gente che faceva cinema. Era l’inizio, in fondo erano in pochissimi a occuparsene. Per I ragazzi eravamo io, Alberto Mondadori, che era mio cugino, e Lattuada, che faceva lo scenografo; poi Cesare Civita, un po’ più grande di noi, come operatore, perché aveva la cinepresa a sedici millimetri che serviva per il film. Tutto a Milano, l’abbiamo fatto. Io vivevo a Milano, a quel punto. E l’abbiamo realizzato con i ragazzi più giovani del liceo classico Carducci. Mondadori invece stava al Berchet, con Risi ed Emmer, un liceo da cui ero scappato. Troppo severo per me. Io ero un somaro. Non avevo voglia proprio di studiare. Il Carducci era dopo piazzale Loreto, quasi alla fine di Milano, allora. Era un liceo nuovo e i professori erano di manica larga perché avevano bisogno di attirare studenti. Faceva al caso mio. Dunque, a metà degli anni ’30 la Biennale cinema era alla prima o seconda edizione, e c’era anche una sezione per i film a passo ridotto. E mandammo questo filmetto. Filmetto mica tanto, perché durava più di un’ora. I ragazzi della via Paal vinse il primo premio di quella sezione, che consisteva nella partecipazione a un set di un film professionale, come trovarobe, terzo assistente costumista, o cose del genere, lavori umili insomma.
Il segreto della regia. A me e Mondadori toccò Ballerine girato dal vincitore della Mostra dell’anno prima, nel ’34; si chiamava Machatý e aveva vinto con Estasi, interpretato da Hedy Lamarr, una bellissima ragazza che dalla Cecoslovacchia andò a Hollywood. Anzi, anche Gustav Machatý fu chiamato a Hollywood, con questa giovanetta che andava in giro nuda per i boschi, nel primo film di successo, uno dei primi film erotici. Di passaggio in Italia, il Minculpop lo invitò a fermarsi e a lavorare un po’ qui. Il ministero della cultura popolare era un ministero che funzionava abbastanza e che aiutò molto il cinema, senza esercitare grandi pressioni di propaganda. Che poi, di film di propaganda fascista veri e proprio se ne sono fatti pochissimi: in Italia il pericolo maggiore era la “setta” del buon costume, più che la politica. Così, sul set di Ballerine, agli studi di Tirrenia, lavoravo con un gruppetto di cecoslovacchi, l’operatore, gli assistenti, eccetera; be’, erano tutti vessati dal regista, che era un po’ matto, un vero esaltato che ogni tanto veniva preso da crisi, e a un certo momento diceva: fermi!, voleva il buio totale e si metteva lì seduto con i piedi sull’alternatore, in silenzio, a pensare per otto, dieci minuti, al buio, trenta persone tutte ferme ad aspettare, dopodiché si rimetteva al lavoro. Non ho mai capito perché, e su che cosa doveva concentrarsi, non sapevo che aveva dei problemi psicologici, ma la cosa mi piaceva molto, mi piaceva lui con quegli eccessi, pensavo che un regista doveva fare così. Vedevo che era un demiurgo, un creatore. Ma non fu quella l’esperienza giovanile fondamentale. Io lavorai molto come assistente in quegli anni. In Italia il cinema funzionava bene. E c’era un sacco di lavoro. Mi capitò così di andare a lavorare con Augusto Genina in Libia per Squadrone bianco. Ero esaltato dall’idea. Un’avventura, per un ragazzo, a quel tempo. Si viaggiava in nave, poi gli autobus, le piste nel deserto e tutto il resto. Per i tempi era impressionante. Però, questo Genina, che era bravissimo, era esattamente il contrario di Machatý. Uno conciliante, si metteva d’accordo con tutti. Chiedeva al datore di luci come avrebbe girato con una certa luce solare di taglio, se l’attore aveva qualcosa da dire lui gliela faceva dire, discuteva, dava ragione. Io disprezzavo questo atteggiamento. Lo ritenevo un mestierante qualsiasi. Poi, arrivò l’inverno, e andai a vedere i film. Sia Ballerine c h e Squadrone bianco. Il primo era una stupidaggine clamorosa, una cretinata, malfatta, presuntuosa e basta. E invece Squadrone bianco era un bel film, un film importante. Quella fu la mia prima lezione. Capire, parlare, ascoltare. Genina sapeva quello che voleva fare. Tra l’altro poi girò Il cielo sulla palude, bellissimo. Imparai molto da Genina. Ma imparai di più da Machatý. Imparai quello che non si doveva fare.
Una speranza: perdere la guerra. La società fascista del cinema era abbastanza tollerante. C’era Vittorio Mussolini che proteggeva un po’ tutti. Certo, non si poteva parlar male del fascismo né dei fascisti. Si mandavano i copioni al ministero, per il controllo e l’approvazione. E in genere tutto filava liscio, se evitavi gli adulteri e i suicidi. Non parliamo del sesso. Insomma l’Italia doveva essere una nazione dove le cose infine si risolvevano, le famiglie erano a posto, l’assassino veniva sempre scoperto. Un’immagine pulita era importante. Il cinema in fondo era la parte buona del fascismo italiano. Poi c’erano i filmoni sull’Etiopia e la Libia, ma a parte Scipione l’Africano di Blasetti, non avevano successo. Vecchia guardia andò malissimo, dal punto di
vista industriale. La parte cattiva del fascismo era invece... il fascismo: la mancanza di libertà di stampa, di parola, le coercizioni, e poi la guerra. Io sono stato militare e partigiano. Tutte le mie speranze come militare erano di perdere la guerra. I miei commilitoni no. Non erano politicizzati, quindi non sapevano bene che cosa c’era in gioco. Io ebbi poi la fortuna di essere chiamato in cavalleria, che non serviva più a niente, perché c’erano ormai i carri armati.
Clandestino per Colorni. Lasciai nel ’43, credo a luglio. Me la squagliai subito. Ero a Napoli. Sottotenente. Aspettavamo di essere imbarcati per andare in Africa. Per fortuna i giorni passavano e non ci imbarcavano mai. Avevo in valigia ancora il vestito borghese. L’ho indossato per una libera uscita e sono sparito. Tornai a Roma, dalla famiglia. Ma forse era settembre. Perché mi ricordo questa strada ferrata piena di gente, un fiume umano di opposte direzioni, questi soldati mezzi vestiti che camminavano sulle rotaie e andavano a nord o a sud. Uno strano trasmigrare d’autunno. Roma era semivuota, con i problemi dell’oscuramento. Quando arrivai fui subito contattato da un curioso personaggio, uno che dovevo aver conosciuto qualche mese prima. Il suo nome era un programma: Comunardo Bracialardi. Il padre era un anarchico, naturalmente. E il figlio anche. Così entrai in un gruppo per il quale svolgevo dei servizi: portare volantini, tenere i contatti, fare la staffetta. Erano incominciati i rastrellamenti. Era molto pericoloso. Noi si faceva, ma bisognava evitare i locali pubblici, dove il rischio di essere intercettati era altissimo. Non andavo più al cinema, naturalmente. Il cinema a Roma non si faceva più. C’erano i film con Maria Denis, o quelli con la Ferida, che arrivavano da Salò. Il problema era che io ero noto, come aiuto regista. Se mi avessero trovato mi avrebbero mandato a Venezia o a Salò a lavorare, e io non volevo fare il cinema della Repubblica di Salò. Il lavoro da partigiano l’ho fatto per il gruppo di Colorni. Lui dava anche delle lezioni in un appartamento di Corso Trieste, lezioni di antifascismo e socialismo. E poi addestramento per l’attività clandestina. C’era un’attività clandestina accurata, dentro Roma. E del cinema non riuscivo più a occuparmi.
Cinema&libertà. La mia fortuna (ma non solo mia, di tutti noi cinematografari) è stata l’exploit di Roma città aperta. Perché dalla Liberazione in avanti eravamo sicuri, noi tutti, che con l’arrivo degli americani il cinema italiano fosse morto e sepolto. Non ci aspettavamo più nessuna possibilità di lavoro. Questa esplosione del film di Rossellini e la riscoperta del cinema come momento liberatorio cambiò le nostre aspettative. Proprio dai giorni appena seguenti la fine della guerra la gente voleva il cinema. Nelle settimane e nei mesi successivi le sale incominciavano a riempirsi, piene piene che non ci s’entrava neanche. E all’inizio erano i film americani a incassare tutto. In questo clima, il successo internazionale di Roma città aperta trascinò con sé Vivere in pace, di Zampa, e subito dopo ci fu il film di Fabrizi Viva la ricchezza; e fu una catena, proprio uno dietro l’altro, come un risorgimento, con quell’idea del cinema della gente che, non si sa perché, toccava il cuore, mostrando i mercati, le case distrutte, la borsa nera,
quello che poi si chiamò il neorealismo. Che poi forse l’unico vero regista neorealista è stato Rossellini. Ma insomma, il neorealismo non era quello che mettevi nelle immagini, o il realismo di strada, ma lo sguardo morale che veniva fuori. Io dico sempre che anche un film di fantascienza può diventare neorealista. Fu un successo immediato. E io fui subito chiamato per fare dei film come aiuto. Il primo, mi ricordo, fu il mio amico Giorgio Bianchi che era riuscito a trovare i soldi per girare con Nazzari e Maria Ninchi, che era stata in America ed era diventata molto importante. Poi avevo incominciato a scrivere sceneggiature, partendo dal fatto che prima mi ero arrangiato a scrivere per i giornali umoristici, quindi pensavo a delle storie, e andavo avanti sulle due cose, le sceneggiature e l’aiuto regista. Per Mattoli, Brignone, Alessandrini, Freda, che mi fece conoscere Steno, anche lui collaboratore di giornali, ma molto più richiesto di me. Sapevamo che i produttori cercavano le storie per Macario, per Scotti o per Totò. La nostra amicizia si sviluppò scrivendo questi soggetti. Come persi la guerra e L’eroe della strada per Macario. Ma anche film per Freda. Fu un successo per esempio Aquila nera, dove Rossano Brazzi faceva un eroe tratto da un racconto di Puškin. Collaborò anche Fellini alla sceneggiatura. Con Gentilomo facevo sia lo sceneggiatore che l’aiuto-regista. Questo per dire che di lavoro ce n’era tantissimo nel cinema italiano di quegli anni e che ci si poteva provare in tante cose. E poi, ci conoscevamo un po’ tutti. Scrivevo per Macario e Totò perché li seguivo a teatro e li conoscevo bene. Loro però se ne stavano un po’ isolati. Macario e Totò erano della stirpe dei capocomici; gentili, amichevoli, ma non c’era convivialità, frequentazione. Venivano dal teatro di varietà, avevano strutture organizzative proprie, erano abituati ad avere dei veri dipendenti. Totò cerca casa è il primo film in cui io e Steno abbiamo firmato la regia insieme. Cos’era, il ’48 o il ’49? Ecco, mentre cresceva la mia attività nel cinema comico il neorealismo incominciava a lasciare il posto (nei primissimi anni ’50) alla commedia, come se avesse esaurito la sua funzione dirompente, di denuncia, che passava invece, in un modo diverso, in un certo tipo di commedia che facevamo noi.
Le campagne dei forchettoni. C’erano state delle illusioni, che poi si erano spente. Tutto il cambiamento che ci aspettavamo... Anche se qui bisogna precisare che una cosa era la commedia cinematografica di film anche gentili, ben fatti, come Poveri ma belli o Pane, amore e fantasia per esempio, e una cosa era quella che in un secondo momento avremmo chiamato “commedia all’italiana”, che è sempre rimasta aggressiva, acida, ed è quella che facevamo noi. L’altra commedia non andava a sondare la verità del costume e delle idee nella nuova società. Noi invece, con Sordi, Tognazzi, eravamo più cattivi, graffianti, nei riguardi della società che si stava formando in Italia. Sordi fu un vero ispiratore per tutti noi. Lui, Gassman e pochi altri, portavano dei personaggi da cui poi partivamo per sviluppare i film. E anche se eravamo noi a suggerire certe storie, erano pensate per personaggi che Sordi, Tognazzi, Gassman e anche Manfredi volevano fare. Avevamo di fronte un’Italia che era ancora quella degli anni del fascismo, dal punto di vista sociale ancora molto arretrata, in mano alle parrocchie, soggiogata dall’ignoranza, mentre il potere politico si consolidava. C’era però la libertà di stampa, che sembra poco ma era una differenza enorme, perché si potevano leggere anche posizioni diverse da quelle dominanti, c’erano le battaglie tra Dc e Pci, le “campagne dei forchettoni”
come noi socialisti le chiamavamo, e i tabù, le corna, i delitti d’onore, le miserie, i rapporti tra campagna e città. C’erano un sacco di temi da toccare, che allora erano intoccabili, da trattare per riderci su e per fare critica sociale.
Madonne pellegrine, anatemi e censura. Io per esempio parlai del suicidio: Totò e Carolina, che subì molti tagli e che adesso è stato ricostruito e restaurato. Un film molto diverso da Totò cerca casa, perché là c’era un’Italia nelle macerie, il problema della casa era il più importante, e quindi mettere in scena una famigliola di disgraziati che per sopravvivere doveva cercare un tetto era molto attuale, molto vera e coinvolgente, e al tempo stesso piena di possibili spunti comici e drammatici: quello che cercavamo per il Totò di quel momento. Con Totò e Carolina invece l’Italia si era determinata politicamente, era diventata democristiana, a distanza di pochi anni. Ma per esempio anche Guardie e ladri, che sta in mezzo tra i due, mentre la situazione politica si evolveva in un certo modo, aveva incontrato guai perché metteva sullo stesso piano un ladro poveraccio e una guardia onesta, con il ladro che si fa portare in galera raccomandandogli tutta la famiglia, e quel momento di solidarietà e comprensione era una parte che sembrava addirittura sovversiva. E dovemmo cambiare, fare dei tagli; il film ebbe molte difficoltà a uscire, per delle stupidaggini. Come ho già detto altre volte, la verità è che l’Italia stava a destra, il cinema a sinistra. C’erano le madonne pellegrine, le condanne della chiesa, un moralismo imponente, Pio XII e l’eterno Andreotti. Tornava un clima di censura, ma diversamente dal fascismo, la censura alla fine poteva poco, perché i film uscivano e la loro forza si sentiva, la spinta era tale... c’era una libertà di fondo. Direi che al settanta per cento abbiamo potuto fare quello che volevamo.
L’impegno, nemico della risata. La sinistra non capiva. O non voleva capire. Dico il cinema che facevamo. Il film comico faceva ridere, e questo non andava bene con l’idea dell’impegno, con quell’idea dell’impegno che dominava in Italia. La cultura era in mano alla sinistra. Cioè era prerogativa del Pci. Le persone più importanti, più aggiornate, anche più intelligenti, stavano da quella parte. Per loro però l’impegno era sempre senza risate. C’era la paura della risata. Però, attenzione: la paura della risata c’è anche adesso. La metto in relazione alla paura della popolarità. Se un film non solo fa ridere, ma ha anche molto, troppo successo, può indurre a credere che sia populista, che trasmetta valori banali che vengono dal livello basso della vita, solleticato per suscitare reazioni volgari. Anche se poi noi veniamo da Ruzante. E quindi tutti i nostri film erano sempre tacciati di bozzettismo, di facilità. Ma noi in realtà ce ne siamo sempre fregati. Avevamo la risposta della gente. Sui giornali eravamo recensiti dai “vice”, perché i critici titolari li consideravano film di seconda categoria. In Francia però accadde che videro questi film che facevano ridere su aspetti drammatici della nostra società, e gridarono al miracolo: ma come fanno questi, dicevano i francesi, a far ridere su temi così tragici? Non lo faceva nessuno in quel momento. E vien fuori “la commedia all’italiana”. Dalla Francia venne questa riscoperta, dopo, naturalmente. Io dico sempre che la maturità degli individui, e quella di un
popolo, si vede nella capacità di filtrare la realtà nell’umorismo. Niente di speciale, ma come tutte le cose semplici è difficile accettarle. In questa via ci si può far comprendere da un pubblico molto vasto. Tra i miei film non si parla quasi mai di Le infedeli, che avevo firmato con Steno, ma che invece diressi completamente io, mentre Steno lavorava a Totò e le donne. Ebbene, quella non era una commedia, volevo far vedere anch’io che stava nascendo una borghesia senza scrupoli, corrotta, pronta a qualsiasi compromesso, in un’atmosfera non comica, e scelsi allora un fatto di cronaca, una donna di servizio incolpata di aver rubato, che poi si suicidò. E venne fuori questa serie di ritratti di donne della prima borghesia italiana del dopoguerra, mentre Antonioni girava La signora senza camelie.
Antonioni sì, Fellini nì. Il marchio Italia. Io ero molto affascinato da Antonioni. Eravamo amici. Ho avuto anche dei problemi con quei critici che sghignazzavano per i film di Antonioni. Avevano la stessa posizione di Dino Risi, quando diceva che l’incomunicabilità derivava dal fatto che Antonioni non sapeva scrivere i dialoghi. Invece a me piaceva moltissimo. E anche adesso. E d’altra parte, doveva essere così per me, perché quelli erano i film che io non avrei mai saputo fare. M’interessava Fellini, ma meno. Più Antonioni e Visconti, che Fellini. Lo sentivo lontano da me, era sempre un bel cinema, ma proveniva anche lui dalla commedia, aveva un po’ la mia stessa matrice, quindi... Il visivo di Antonioni e Visconti per me erano cose molto distanti. Volendolo, il visivo di Fellini si poteva farlo invece. Ma il punto non è questo. Fellini aveva un senso del grottesco che era irripetibile. A meno di fare il felliniano. Nell’insieme, eravamo i più forti. E il mondo intero l’aveva capito. Anche se finì male, perché non sapevamo vendere i nostro prodotti. Il problema del cinema italiano non sono stati gli autori o gli attori che a un certo punto mancavano, ma che i produttori non sono più stati in grado di promuovere il prodotto. Tra la fine degli anni ’50 e la metà degli anni’60, attraverso i festival, le nomination agli Oscar, i giornali internazionali, le facce dei nostri attori, e anche la commedia, il cinema italiano era diventato il più importante nel mondo. Non so se si riesce a immaginare, oggi. Ma lo era. Il fatto è che sono mancati quelli che un prodotto così sapessero venderlo. Ma quanti sanno che in quel periodo Hollywood non funzionava, era praticamente chiusa, e che noi non ne abbiamo approfittato?
I soliti noti. Il cinema non è niente di trascendentale. È un artigianato divertente. Da ragazzo avevo capito che il cinema era il mezzo del futuro, e da lì mi sono occupato solo di quello per tutta la vita. Uno dei momenti più spassosi, e anche creativi, è stato con I soliti ignoti. Perché, a parte la sceneggiatura di Age e Scarpelli che funzionava bene per ridere, avevo una serie di problemi seri: intanto, un attore drammatico da trasformare in comico, Gassman, che abbiamo reinventato completamente; poi, una ragazzina che non sapeva nemmeno che cosa fosse l’italiano né che cosa stavamo facendo, da trasformare in attrice, ed era la Cardinale, una miss che voleva fare il cinema e che fino all’ultimo non ho chiamato perché dovevamo farla arrivare da Tunisi per un provino; e poi due attori un po’ così, uno che faceva lo sguattero in
una trattoria di via Sistina, che era Murgia, un comico che non rideva, alla Buster Keaton, e l’altro che faceva il teatro di strada, che era Carlo Pisacane, cioè Capannelle; e poi c’era Mastroianni giovanissimo, che faceva sempre il latin-lover, ma qui era un poveraccio senz’arte né parte. Insomma, la combinazione di rovesciamenti era straordinaria. Ogni mattina sul set avevo un sacco di cose da risolvere, ma al tempo stesso stimolanti.
Gassman col sughero in bocca. E mi divertivo. Sono andato in giro per Roma a farmi raccontare come si facevano i furti nelle case, o quelli che si chiamavano “gli sgobbi”, un po’ nei commissariati, un po’ da certi ladruncoli, bravi ragazzi, che si vantavano anche di fatti che forse poi non avevano compiuto loro, ma intanto seguivo il frasario, le facce, le situazioni. Gassman ci sfidava. Diceva che non ce l’avremmo mai fatta. Con Piero Gherardi, che era scenografo e costumista, abbiamo studiato la faccia di Gassman, altera e da pensatore, e abbiamo incominciato a modificarla, col taglio di capelli abbassato da gorilla, e quella gobba sul naso che gli nascondemmo un po’ perché aveva qualcosa di amaro; poi le narici con i tamponi e l’apparecchio di sughero in bocca. Era fatta. La cosa incredibile è che Gassman si sciolse anche nello spirito, diventò più affabile e allegro. Mi piacevano queste scoperte. Ma devo contare anche i miei fallimenti. Quando facevo i provini per Proibito, fra le tante si presentò una ragazzetta francese, aria spavalda e capelli neri che le coprivano la faccia: con un’occhiata da esperto le dissi che non aveva futuro nel cinema, mancavano le doti fondamentali, e non le feci neanche il provino. Era Brigitte Bardot.
Andreotti blocca la guerra. I soliti ignoti lanciò all’estero la commedia all’italiana, e poi finalmente avvicinò un po’ i critici, ma per il pubblico era sempre un film come quelli che era abituato a vedere da anni, quelli di Risi, Sordi, Tognazzi. Noi sostenevamo l’industria, eravamo il supporto del cinema italiano. In Italia si facevano fino a 250 film all’anno. Anche le commedie più immonde andavano bene al botteghino. Oggi non c’è più l’impegno di raccontare, bene o male, la gente, un piccolo mondo, una piccola storia, perché proprio senti la necessità di farlo. C’erano dei veri e propri clan di amici e professionisti che lavoravano per questo. C’era il mio, con Benvenuti, Suso, De Bernardi, Age e Scarpelli. Poi c’era il clan di Risi, con i suoi, e c’era Corbucci, che faceva film a un livello più basso, e quelli che invece facevano western. Ciascuno aveva un pubblico che li seguiva. In questo modo c’era un’industria che sorreggeva produzioni più difficili e impegnate. La grande guerra fin dall’inizio non volevano farcelo fare. Non avevamo ancora aperto il set, che i giornali ci attaccavano. Per forza, perché era la prima volta che si parlava così della guerra ’15-18, con i disgraziati mandati a morire in quel modo. Per il nulla osta se non sbaglio De Laurentiis andò a parlare con Andreotti. Venne anche un ufficiale dell’esercito a controllare le riprese. E quando De Laurentiis vide le prime scene girate, arrivò sul set: “Ma che razza di film stiamo facendo?” mi disse. Gassman e Sordi li avevo messi in un finale tragico che anche il produttore non voleva accettare. Così, abbiamo bloccato il film per sei mesi. Fu un braccio di ferro tra me e lui. Ero sicuro di quello che stavo
facendo? Non so, intuivo appena che era giusto così, ma finché il film non ebbe quel successo non sapevo se avevo fatto una buona scelta. Io non avrei neanche messo quella marcetta con l’“arrivano i nostri” dopo la fucilazione. Con i produttori ho dovuto lottare altre volte. Non fu facile, per esempio, convincere Mario Cecchi Gori a fare l’Armata Brancaleone. A un certo punto gli ho detto: allora dividiamo i profitti degli incassi. Non ho mai guadagnato tanto. Ma al momento, giuro, non sapevo che cosa stavo facendo. E poi è venuto anche fuori che stavamo parlando dell’Italia contemporanea. Ma figuriamoci. Non era affatto nelle nostre intenzioni. Non ho mai creduto ai messaggi. Credo che non bisogna mai averla, quella preoccupazione. Basta divertirsi e seguire le storie che si vogliono raccontare.
Un ’68. L’Italia degli anni ’60, semmai, è stata raccontata da altri film. Ho apprezzato molto quei “nuovi” italiani, come Bellocchio o Pasolini. Bellocchio è uno straordinario narratore di nevrosi. E Pasolini mi ha colpito sempre. Anche lui perché faceva un cinema che io non avrei saputo fare. Bertolucci mi piaceva meno. Ho delle riserve anche oggi. Già allora sentivo una presenza molto forte del sé. Io, non so neanche che cosa vuol dire che nei film di Monicelli c’è un po’ di Monicelli. È una cosa di cui non mi va neanche di parlare. Non sopporto le sottolineature. Nella Grande guerra ho voluto la fucilazione di Gassman e Sordi in secondo piano, vista da lontano, da una finestra. Del ’68 c’è una cosa sola che mi ha veramente colpito: la cosiddetta liberazione della donna, la conquista dell’autonomia. Che queste ragazze potessero improvvisamente fare cose fino a quel tempo proibite: tornare a casa a notte fonda sole, andare a picchettare le strade e le fabbriche, fare l’amore quando volevano senza sensi di colpa, vivere insomma una vita libera. Non è stata un’avventura altrettanto esaltante per gli uomini, che sono invece rimasti molto disorientati. Quando poi ho fatto Speriamo che sia femmina ho cercato di ricavare anche il risvolto più amaro dell’autonomia femminista. Non era certo una soluzione escludere gli uomini. L’aspetto più negativo del ’68 invece è stato l’avventura politica, perché è sfociata nel terrorismo, che ci ha lasciati senza parole. Non si capiva da dove venisse, che cosa stava realmente succedendo. E non si capisce neanche oggi, intendiamoci. A noi cineasti è una cosa che ci ha disorientati. Ci ha proprio bloccati, credo. Io ho fatto però Un borghese piccolo piccolo. Credo ci fosse qualcosa del disastro del tempo. Il terrorismo ha fermato anche il percorso del cinema italiano, che non sapeva più rapportarsi con la realtà per raccontarla, perché poi la gente ha preteso giustamente di uscire dall’incubo e ha voluto soltanto evasione. Che il cinema americano ha prontamente fornito. Da noi il cinema delle storie si è bloccato.
Amici, famiglie e serpenti. Credo che Amici miei racconti quell’Italia dei primi anni ’80 che ci portiamo fin qui, ma c’era anche una certa cattiveria. Con quegli scherzi terribili, e il morto, la visita della moglie, eccetera. Mi dicono che più invecchio, più divento cattivo. Non so se è vero. Forse in questo caso la cattiveria è anche lucidità. Per esempio, Parenti serpenti viene dalla cronaca, rimette in circolo in un’apparente normalità l’aggressività della famiglia, che nella nostra società si è
espressa anche in fenomeni tragici, terribili, come l’uccisione dei genitori per comprarsi un’auto. Ma a che punto siamo arrivati? Vedo male questi anni ’90 alla fine, e quest’Italia del 2000. La famiglia, che in fondo è al centro dei miei film di questo decennio, è la cartina di tornasole di questa nostra società, ormai ricostruita definitivamente, consolidata. Adesso, quelli della mia generazione, quelli che sono arrivati fin qui, hanno davanti la cosa finita, quello che c’è, quello che è stato fatto. Partendo dalla famiglia, ho fatto un film sulla frenesia del gioco che, attraverso la televisione, scompiglia ogni valore. Ma com’è possibile che qualcuno ti telefona a casa e, se indovini che la risposta giusta è Leonardo da Vinci, ti metti in tasca dieci milioni? È assolutamente diseducativo. Non dico la parola immorale perché non sono un moralista. Ma come fa, un padre che invita un figlio a impegnarsi a lavorare, se poi il figlio gli dice: che cosa vuoi da me? guarda che se mi va bene al gratta e vinci ti mando al diavolo, non avrò più bisogno di te. Che valori trasmettiamo così? Ancora oggi credo che il cinema deve intervenire. Da qualche tempo nel cinema italiano, con Salvatores, Virzì, Tornatore, vedo qualcosa di buono. Ma quello che devono fare i giovani cineasti oggi è ricostruire un dialogo tra loro e con il pubblico, rimettere insieme i gruppi di lavoro, i clan. Raccontare storie, i casini degli amanti, i problemi sociali.
Che cos’è il cinema. Devono riprendersi in mano l’avventura della vita. Il successo del cinema italiano di un tempo viene dal successo delle amicizie di quelli che lo facevano. Ci sono casi in cui grandi personalità riescono a esprimersi in modi autonomi, altissimi. Ma è raro. Un Marco Ferreri nasce ogni tanto. E non credo che la televisione abbia rovinato il cinema. Io trovo che i film di Bergman, Pasolini o Ferreri sono splendidi anche in televisione. Il cinema avrà un futuro non soltanto nelle sale. Ci sono le videoteche, i dvd, il salotto di casa non è necessariamente la distruzione del cinema. Ci saranno sempre grandi autori, ma per il resto non è niente di trascendentale, il cinema. È arte applicata. E basta.
4 Il signore tarchiato che ballava con la mano sul reggicalze diventò il marito di Lidia. Un vero mascalzone. Sfruttava la sua carica per promettere favori alle aspiranti, ragazze modeste, figlie di ferrovieri, impiegati comunali, al massimo piccoli commercianti. Arrivavano a Cinecittà, tutte agghindate, con il prolungamento della linea urbana TerminiQuadraro, pigiate nel tram che profumava di lavanda e lucido da scarpe, le voci impacciate, incollate ai loro sogni. Ma agli occhi di Fellini quel percorso in tram era un viaggio onirico, esaltante. Con la sua visione poetica ha dettato legge al nostro immaginario, ha preso sotto la sua tutela il mito del cinema. E ormai tutti ne hanno la stessa immagine. Io, quando cercavo lavoro, ricevevo un invito quasi ogni sera, in trattoria o al cinema. Anche dagli amici di mio padre! Spesso capivo e rifiutavo. Se accettavo, mia madre mi aspettava alzata, e il giorno stabilito controllava le date del ciclo mensile. La guerra aveva fatto impazzire gli uomini. E le donne. L’ossessione della maternità involontaria non vinceva la gioia di incontrarsi e abbandonarsi fugacemente. Non ricordo di aver mai avvertito il desiderio attorno a me con quella cupidigia collettiva, come lo avvertivo in quegli anni; e senza dubbio mai più ho avvertito che quella cupidigia veniva dall’euforia della vita, come una corrente gassosa sui nostri corpi. Eravamo scampati alla morte. La cortina tetra che condizionava il tempo era esplosa. Io desideravo accettarli, quegli inviti. Al plagio delle ragazze si contrapponeva, nell’attività delle produzioni, un atteggiamento forzatamente moralistico: l’autocensura delle sceneggiature, che evitava problemi con l’Ufficio per la Cinematografia. L’Ufficio esercitava un controllo preventivo di cui personalmente non mi rendevo conto, perché, da un punto di vista strettamente giuridico, la censura dei copioni era decaduta subito dopo la guerra. Qualcosa, certo, si finiva per sapere, i casi più clamorosi, ma ci sembravano informazioni da addetti ai lavori. Sapevo dei tagli a Totò e Carolina: il film uscì nelle sale a fatica, un anno dopo la fine della produzione. Ma anche di quello sapevo poco, e ridevo vedendo la scena in cui gli operai sul camion, con striscioni e vessilli, cantavano una canzone del Piave, senza pensare immediatamente che Monicelli, com’era logico, quella scena l’aveva girata con gli operai che cantavano Bandiera rossa (inno che del resto ho sempre trovato sgradevole nel picco finale, quando equipara comunismo e libertà). Non capivo, ero piena di fiducia e così sazia d’innocente normalità. Mi sentivo felice, libera. Il sole di Roma penetrava anche a Cinecittà, nella mia stanzetta buia che odorava di nicotina e cellulosa. Maledetta felicità, si dice. Prima di incontrarla personalmente, la censura, quando incominciai a occuparmi delle rubriche dei cinegiornali, mi svegliò mio marito, per spiegarmi la sentenza del tribunale militare che condannava il direttore e un giornalista della rivista “Cinema nuovo”, Aristarco e Renzi, arrestati per la pubblicazione di un soggetto sul comportamento disonorevole dei soldati italiani in Grecia. Francesco insegnava storia al liceo e teneva seminari all’università. Era vigile, appassionato. Con lui ho scoperto che esiste una distanza minima necessaria perché i fatti diventino documenti, e che i documenti sono segni del mondo. Che ogni uomo, con la sua singola storia, davanti a tutti gli uomini, è un segno del mondo. Per noi ora il tempo è diventato troppo. Voglio dire: la distanza accumulata è diventata
troppa. Mi sembra che tutti quanti noi, come la ciurma di un vascello di predestinati, con la pelle vecchia e le ossa curve dei lungodegenti, abbiamo addirittura varcato la soglia dei segni e, forse, quella del mondo. Eppure no, ancora non basta; c’è qualcosa che resiste, insiste, come un ritmo, lento, sì, ma tenace. Ecco, leggo due foglietti strappati da un libro, conservati in una cornicetta di plastica, con una firma in rosso. Il primo dice: Sono vecchio sono pazzo sento battere le ore è il mio cuore di ragazzo E il secondo: Sempre più andiamo a un mondo di vecchi si vendono bastoni si rompono specchi La firma in inchiostro rosso è: Dino Risi.
DINO RISI Ma quanta fatica la lira e la f... La “struggente fiducia nel domani”, di cui parla Ugo Pirro nel suo libro: è vero, era facile illudersi. Quando si è giovani... Poi, noi partivamo da zero. Lo zero subito dopo la guerra. Era tutto possibile, più che in altri momenti. Eravamo vivi dopo un disastro. Poi tutto si è aggiustato, politicamente voglio dire. Un periodo così non l’ho più visto. Forse quando Di Pietro beccò Chiesa con i sette milioni in tasca, nel ’92. Ci vuole una guerra per tirare fuori il meglio degli uomini? Non so, non credo. C’era uno stato generale di coraggio, l’ottimismo era diffuso. Se nasce un talento come Fellini non c’è bisogno della guerra per riconoscerlo. Certo, le guerre fanno male, ma fanno anche bene. Danno una tremenda ripulita, e poi si va a ricostruire, purtroppo è così.
Itteroemolitico. Io mi sono salvato per un’epatite virale. Ero ad Avellino, dovevo partire per la Russia. Al tempo non si conosceva ancora questa malattia. Il colonnello medico aveva diagnosticato un danno “itteroemolitico”, qualcosa del genere, una roba che ti spediva al Creatore. E invece mi sono ritrovato a Milano. I miei compagni sono partiti in 200: ne sono tornati meno di una quarantina. Mi sono salvato così, ma ho vissuto tutti i bombardamenti di Milano. Avevo un amico che è impazzito in quei giorni. Andavamo sul tetto di casa mia a vedere i cieli della città attraversati dalle fortezze volanti. Arrivavano sempre verso l’una di notte. Mi ricordo ancora il primo bombardamento, credo fosse luglio, nel 1942. Avevo un appuntamento con una bella ragazza che avevo conosciuto all’Annonaria. La corteggiavo, forte del fatto che ero riuscito a ottenere una doppia tessera per il pane. Le avevo dato appuntamento alle cinque in corso Monforte, al caffè Ranaldi. Ricordo l’ora perché ho aspettato fino alle cinque e mezza e, quando ormai ero convinto che mi avesse tirato il bidone, ho sentito un botto tremendo, lontano: era la prima sventagliata su Milano. Sono corso a casa e ho trovato mia madre, con le mie sorelle e due bambini stretti sotto il muro maestro. Piangevano, urlavano. La Raf aveva attaccato di sorpresa. Le sirene non erano partite. La gente restò intrappolata. Fu un disastro. I bombardamenti sistematici avvenivano di notte. E noi giovani salivamo sempre sul tetto a vedere qualcosa di terribile e spettacolare. Una volta, mentre Milano era in fiamme, questo mio carissimo amico, un compagno di università che finì per rischiare la fucilazione, si alzò in piedi, esaltato e disperato, urlando “l’Apocalisse, l’Apocalisse”. Era il primo segno della follia. Una storia terribile. Voleva fuggire anche lui in Svizzera, ma fu respinto. Io invece mi rifugiai in Svizzera con Strehler, Giansiro Ferrata, Livio Garzanti. Poi c’erano i politici che, da Lugano, organizzavano la Resistenza. Ma la loro è un’altra storia. Io volevo fare lo psichiatra. C’erano 3500 ricoverati al manicomio di Voghera, dove ero andato a fare l’internato dopo la laurea in medicina per intraprendere la specialità. Era un lager spaventoso. A parte i pochi malati veri, c’era gente che veniva spedita lì perché “disturbava” in famiglia. Uno che aveva un tic, oppure un tipo soltanto un po’ originale, poteva finire lì dentro. Non si può immaginare che fabbrica di follia era. Non ne potevo più, e ho deciso di lasciar perdere
con la psichiatria. Ma non credo che sia stato l’interesse per i casi psichiatrici a introdurmi al cinema, ai caratteri del cinema. Sono stato cinefilo dall’età di otto anni. Andavo al cinema con un amichetto, Battino, figlio del console di Grecia. Lui aveva la tessera per entrare gratis. Io mi aggregavo. Andavamo al Silenzioso, di mattina. Facevano le proiezioni per gli studenti che bigiavano. Noi eravamo precoci. Andavo pazzo per i film di Tom Mix. Ma ricordo anche il primo film che mi lasciò una forte impressione: L’eroina della strada ferrata, dove una ragazza veniva legata alle rotaie per essere uccisa e liberata all’ultimo istante. C’era anche Douglas Fairbanks, se non mi sbaglio. Era il ’25, ’26, poco dopo la prima fase fascista.
I foruncoli di Rachele. Mio padre era medico della famiglia Mussolini, questo è noto, ma pochi sanno che Mussolini lo chiamava e gli diceva: vieni a vedere la Rachele che ha dei foruncoli sospetti. Ai tempi si era terrorizzati dalla sifilide. Quando mio padre era capitano medico, Mussolini era caporale. Questa amicizia salvò uno zio antifascista che era coinvolto nell’attentato di Sbardellotto a Mussolini. Tornava da Parigi con parti di una bomba a orologeria che aveva tentato di nascondere in una toilette del treno. Finì a giocare a carte con un carabiniere per sei mesi in una stanza di ospedale. Sbardellotto fu fucilato. Mussolini mi faceva anche ridere. Me lo ricordo come un pagliaccio con una voce profonda e sensuale. Un contrasto incredibile. Le donne erano tutte innamorate di lui. Avevo una cugina che ne era pazza. Le piaceva che fosse così maschio, un toro, diceva. Mussolini scopava tutti i giorni, tre volte. Gli si offrivano, le donne. Un’amica di mia madre era stata praticamente violentata da lui. Con soddisfazione, naturalmente. Ho avuto l’occasione di ascoltare il racconto: Mussolini, all’Hotel Regina, che la inseguiva col membro in mano urlando: figa d’oro, figa d’oro. E per lei è stato il più bel ricordo della sua vita.
Un libero pensatore. Odiavo la scuola, ma alle elementari di via Corridoni davano le comiche di Charlot. Mi divertivo un sacco, in terza, quarta elementare. Non credo che questa buona abitudine sia rimasta. Forse adesso, alle medie o alle superiori... Insomma non avevo bisogno di diventare grande per capire che mi piaceva il cinema. Io la resistenza l’ho fatta a scuola. Nel senso che mi ci dovevano trascinare. Per fortuna una volta alla settimana saltavo due ore. Non ero battezzato, quindi non andavo al catechismo. A sei anni mi ricordo che ho detto: io sono un libero pensatore. Me lo aveva suggerito mio padre, se mi facevano delle domande. La mia famiglia era di tradizione liberale. Un nonno garibaldino. Un altro parente mazziniano. Non avevo mai fatto niente nel cinema quando, nel negozio dei miei amici antiquari Schubert, nel 1940, ho incontrato Alberto Lattuada che mi ha proposto di fare, insieme con lui, l’assistente di Mario Soldati per Piccolo mondo antico. Lattuada era mio compagno di liceo, al Berchet. Lui era avanti di un paio d’anni. Luciano Emmer invece era mio compagno di banco. Eravamo tutti innamorati della stessa ragazza al liceo: Valentina Visconti. Un sogno di ragazza. C’era un gruppo di amici che aspettava Valentina fuori dalla scuola. Si pigliava il tram 35 e si andava fino a Taliedo dove lei abitava, vicino al palazzo del ghiaccio. Un vero corteo, oggi
non si può immaginare. Io stavo nelle ultime file. Andavano avanti gli sportivi, i giocatori di hockey, i più audaci. Mi ricordo un pomeriggio di neve in cui stavo lì a guardare le finestre illuminate per vedere se mi notava. Un cenno, anche soltanto uno sguardo... Poi però se la portava via Carlo Ponti, perché aveva la macchina. Lui era laureato. Lui era l’avucàt.
Dietro la curva. Sono stato anche critico cinematografico, a “Milano sera”, per un paio d’anni. Ma improvvisavo. Intanto avevo preparato dei documentari. C’era una legge che prevedeva un abbinamento tra lungometraggio e cortometraggio. Era fiorita un’industria del cortometraggio che poi è sparita. Ne ho fatti una trentina. Alcuni riusciti, credo. Quelli sui vecchi della Baggina, i barboni. Un grande materiale umano. Forse legati al mio interesse psichiatrico, ma non so... Secondo me, sarei stato un buon medico, un buon diagnostico. Dicono che vengano da questa vocazione i miei tipi, i personaggi di Gassman, del Sorpasso e dei Mostri, ma allora anche gli altri, quelli di Tognazzi e di Mastroianni, insomma quelli che ho fatto con gli attori “caldi” che avevo a disposizione. Bravissimi attori. C’era un’empatia tra di noi, una risposta diretta, vitale. Oggi non ci sono quegli attori, non vedo dei Tognazzi in giro. Forse è questione di generazione. Forse la televisione ha proprio annacquato l’idea di personaggio, ne ha ridotto la forza, e gli attori sono inconsapevolmente disorientati. C’erano poi gli sceneggiatori: Sonego, Benvenuti, Margadonna, Age e Scarpelli. E c’erano i gruppi che lavoravano insieme. I film di Fellini erano legati a un gruppo, si sa: Gherardi, Flaiano, Rota. Quando li ha persi non è più stato lo stesso. Il punto di rottura è stato il mostro che c’è qui di fianco, questa scatola che ha trasformato il pubblico, e le sue scelte, in audience. Negli anni ’70 è cambiato tutto. Si sono tutti un po’ dispersi. La televisione ci ha disorientati. E quella falsa rivoluzione che ha fatto male a tutti, anche a quelli del cinema. Fino al boom ci siamo divertiti. Ho fatto cinema perché mi divertivo. Ci si godeva la vita. Edonismo e moralismo, ha detto qualcuno. C’erano gli intellettuali, tutti di sinistra, che separavano il cinema popolare e il cinema d’arte. Noi non ci preoccupavamo più di tanto del consenso degli intellettuali perché il pubblico ci premiava. Certo, dava fastidio. Ma non è che ci facevamo una malattia. Forse oggi è un po’ diverso. Meno pubblico, più critici... Germi fu maltrattato dalla cultura di sinistra. Germi non era comunista. Era socialdemocratico. Si è permesso di votare per Saragat e l’hanno distrutto. È incredibile. Il boom è stato il raggiungimento di uno scopo. Incominciare a consumare. Che poi ci ha portato dove ci ha portato. La curva del Sorpasso... Dietro quella curva c’era l’Italia degli anni ’70, la logica del consumismo e tutto il resto. Nel periodo del boom sentivo già scricchiolare la società italiana, il pericolo del qualunquismo, la spavalderia di certi personaggi. Quello di Gassman era ispirato a un mio vecchio amico. In fondo alcuni miei personaggi li avevo frequentati davvero. Una volta, sarà stata la metà dei ’50, Gigi Martello, produttore di cortometraggi, mi aveva chiesto di accompagnarlo a Varese, da sua sorella, in macchina. Poi mi ha portato a Lugano. E lì mi chiede se avevo mai visto il Liechtenstein. Mai, risposi. E lui parte per il Liechtenstein, e va fino al castello del principe. E lì succede una cosa assurda: tira fuori la tessera del tram di Milano e si fa passare per giornalista, un pezzo grosso. Un’ora dopo ci siamo trovati a mangiare col principe. L’arte di simulare, di arrangiarsi, una grande esuberanza. La guerra aveva forgiato quel genere di carattere. Avevo un elettricista che
si era salvato a Mauthausen diventando amico del cane lupo del colonnello. Lui entrava nel canile, giocava, aspettava l’arrivo della zuppiera per il cane e la divideva a metà. Così riusciva a sopravvivere. Il mio cinema però è sempre stato lontano dalla politica. Film politici erano quelli di Rosi, Petri e altri. Non mi è mai piaciuto schierarmi. Anche per non perdere il piacere di fare il mio cinema. E non mi è mai piaciuta la posizione intellettualistica di certi “artisti”. Come Antonioni, per esempio.
Quelli che vanno al cinema perché capiscono più degli altri. Non mi andava giù quell’aria di superiorità, quella moda. È stata anche necessaria, mi rendo conto. Antonioni ha fiutato un vento nuovo, che era nelle arti, non solo nel cinema. Ma era poi un gusto intellettualistico, letterario, lontano da me. Quei film che bisognava capire o farsi piacere. Comunque, quando Antonioni ha fatto quei due o tre film che mi piacevano... come Blow up, io l’ho detto. Antonioni ha inventato l’incomunicabilità perché non sapeva scrivere dialoghi cinematografici, che è una delle cose più difficili del mondo. Lui faceva camminare la Vitti sulle strisce pedonali, la faceva appoggiare ai muri, e la critica andava in brodo di giuggiole, soprattutto i francesi dei “Cahiers du Cinéma”. Quelli che vanno al cinema perché capiscono più degli altri. Era così: io sono più intelligente perché capisco Antonioni. Noi invece eravamo i più stupidi. C’erano dei personaggi strani. Se penso che Aristarco era diventato il Benedetto Croce della critica. Un francese un giorno mi ha detto: “Vous avez Aristarcò,” voi avete un Aristarco. Hai capito? Era uno che non era riuscito... Insomma all’inizio voleva scrivere racconti, voleva diventare l’Oscar Wilde italiano. Sarebbe stato un ottimo direttore di “Novella 2000”. Poi ha cambiato strada ed è diventato il grande critico cinematografico italiano. Della nouvelle vague italiana mi piacevano Bertolucci, soprattutto Strategia del ragno e Il conformista, poi I pugni in tasca di Bellocchio, i Taviani. Di Pasolini ho amato La ricotta e basta. Me lo ricordo una volta, alla Fonoroma: sono stato in studio quattro ore e quando sono uscito alle sei di sera era ancora lì appoggiato al muretto con un ragazzino in motocicletta. Un gatto selvatico. Era il lato che mi piaceva, la sua bestialità, che veniva fuori anche nella poesia. O nei romanzi. Mi piacciono i personaggi un po’ fuori dalle regole, come Céline o Villon. Quando c’è qualcosa che viene dal ventre... Il cinema viene dalla pancia. Oggi mi vanno bene anche quelli che piacciono a Ghezzi, come si chiamano, Ciprì e Maresco. Kubrick era uno “di pancia”. Fellini aveva questa dote. Rossellini, che era intelligentissimo, aveva la capacità di cogliere il momento, era un occhio, un vero giornalista. Billy Wilder era uno così. Morandini ha scritto che io ero il Billy Wilder italiano. Figuriamoci. Forse perché anch’io ho fatto i generi come lui, il comico, il nero, la commedia, la farsa. Amo molto i film neri che ho fatto negli anni ’70, Anima persa e Profumo di donna. Negli anni ’70 il pubblico è cambiato. La televisione, il consumismo, le masse, i clan, le parrocchie. Io mi sono orientato verso l’indagine psicologica. Ho avuto sempre questo interesse, ma l’ho tenuto a bada: volevo divertirmi, facendo cinema. Poi sono invecchiato. Le ragazze hanno smesso di amarmi. Sono in fondo un malinconico, uno schivo. Da trent’anni vivo solo, in un residence. Mi sono spostato verso il mio baricentro.
Chi sorride si presta, chi ride si dà.
Chi sorride si presta, chi ride si dà. Non mi è piaciuta quella falsa rivoluzione: il ’68. Butterei tutto nel cesso, meno una cosa: il fermento giovanile. Ce ne vorrebbe una ogni dieci anni. Ma quando è entrata in campo la P38. E quel ragazzo intelligentissimo che sta in galera, come si chiama? Sofri. Lui non avrà ammazzato Calabresi, ma ha delle enormi responsabilità. Come per il delitto Matteotti. Non è stato Mussolini a farlo, ma lo ha fatto qualcuno per far piacere a Mussolini. Hanno sparato addosso a tutti, ai magistrati, ai giornalisti, ai poliziotti. Era un clima terribile. È stato un momento vergognoso per l’Italia. Certo, i primi tempi sono stati straordinari. Ma anche col contadino Di Pietro, è stato straordinario all’inizio. Il processo Enimont. Gli interrogatori, i fatti concreti. Poi tutto si è aggiustato, no? Ci sono dei passaggi nella storia d’Italia, precisi, visibili. Anche le lucciole di Pasolini. Pochi sanno che l’idea non è di Pasolini. Fu il suo direttore della fotografia, Tonino Delli Colli, che un giorno gli fece notare che erano sparite le lucciole. Pasolini capì che era una cosa vera e la collegò alle fasi della democrazia cristiana, in quel celebre pezzo sull’Italia delle lucciole, sul “Corriere”. È divertente. Amo molto queste cose. I comunisti non potevano ridere, invece. Era borghese, ridere. Al massimo sorridevano. Gide diceva: chi sorride si presta, chi ride si dà. Se tu ridi, sei nelle mani dell’altro... E poi, forse, non sorridevano neanche. Se pensiamo alla vicenda di Totò, è incredibile. Era considerato un personaggio marginale. Quanti anni e quanti cambiamenti politici ci sono voluti perché venisse fuori la grandezza di Totò. Ma lui era un genio già negli anni ’30. E le donne lo amavano.
Le gambe delle gazzelle. Ho amato molte donne, ma belle come quelle che ci sono adesso non ne ho mai viste. Negli anni ’30 non avevano le gambe così lunghe, non erano così flessuose. Oggi ci sono in giro dei pezzi di ragazza. Neanche Alida Valli da giovane era così bella. La Lollobrigida aveva le gambe corte, quasi una nana. La Loren è un mistero. Era unica, con quelle gambe così lunghe e quelle tette così grosse e piene. Rarissima combinazione. Forse ne aveva anche troppe. Per quello ha avuto successo in America. Gli americani sono tettofili. Oggi le donne belle sono meno esposte ai pericoli. La società dell’immagine difende la bellezza. Le sfilate di moda, queste cose assurde, finiscono per proteggere la bellezza. Il che permette delle scorciatoie. Le occasioni sono infinite, oggi, per una ragazza bella. Se vuole. Le opportunità sono enormi. Il fenomeno moda è una cosa esagerata. È incominciato negli anni ’80, con la televisione e tutto il resto. Volevo fare un film su questo fenomeno, ma non quello su Miss Italia, che poi è naufragato per problemi di pubblicità. Volevo fare un film così: la condanna alla bellezza. Una ragazza intelligentissima e bruttina che vede volare verso il successo una compagna bellissima... Il successo, che cosa significa? Denaro. E i soldi sono la libertà. Sei libera, coi soldi. Questo credono. Abbiamo perso la trebisonda, correndo dietro al successo. C’è un mio amico giornalista, un giovane, che... ma non so se si può raccontare. Insomma è capace di cenare tre volte in una sera per non saper dire di no alle donne che gli chiedono di essere accompagnate. E lui, che spera sempre di scoparsele, paga e poi le vede andar via con altri. Sarebbe un’altra bella storia. Insegue gazzelle, il mio amico. Come diceva il poeta Galastro: “Ma quanta fatica / la lira / e la fica.” Era un poeta disperato.
Il disturbo. L’ultimo film che ho fatto per il cinema è su un uomo che torna nella società. Esce dal manicomio e trova quello che trova. Tolgo il disturbo, con Gassman. È buono, secondo me, perché si vede la frattura delle generazioni. Gassman anche lì fa una parte che gli assomiglia. Non stava molto bene. Ho sempre lavorato bene con Gassman, soprattutto nel suo periodo alcolico, fino agli anni ’70. Poi è andato in depressione. Ci siamo anche scritti delle lettere, perché anch’io non stavo bene: io avevo una depressione da dilettante. Lui da professionista. Così diventò più simpatico. Non è facile invecchiare. Poi, adesso, tutto accade così in fretta. Il tempo si muove troppo veloce anche per i giovani. Questi ragazzi che fanno il cinema oggi non riescono a star dietro ai cambiamenti. Questo è uno dei motivi più forti della crisi del cinema italiano, insieme all’influenza della televisione. Vedo buone cose tra i film di Amelio, Tornatore, Muccino. Ma poi c’è il problema dei produttori. Manca ormai la figura del produttore-autore. Cristaldi, ma anche De Laurentiis e Ponti: loro fiutavano il film giusto e il regista giusto, avevano qualcosa in più. Mario Cecchi Gori faceva i film un po’ obtorto collo, ma poi arrivava anche lui a capire dov’era il talento. Poi è arrivata Rita Rusic, che aveva un notevole fiuto con i comici toscani, lei che viene dall’Est. Forse anche gli sceneggiatori non riescono a star dietro alla velocità dei cambiamenti, sono disorientati. Come i produttori. Mi chiedo, se oggi arrivasse da Rimini un giovanotto spilungone, un po’ così, con un cappello e un abito modesto da bighellone, c’è qualcuno che saprebbe riconoscere Federico Fellini?
5 Spengo il computer. È sera. Mi accorgo ora che il cuore della macchina copriva il silenzio della casa vuota. Con tutte le voci che sento, oggi rischio di finire seppellita dai fantasmi. A volte mi manca la moviola. In trent’anni di lavoro al montaggio ho accumulato macerie di pellicole. Montando insieme tutte le parti non utilizzate, si otterrebbe materiale per una storia parallela del cinema. Se qualcuno decidesse di cucire a caso tutte le scene tagliate, e poi proiettarle in una piazza... Come nella celebre scena di Nuovo cinema Paradiso, dove il pezzo dei baci sulla bocca, che commuove il pubblico fino al pianto, è composto da tutti gli spezzoni censurati dal prete. Era quindici anni fa? Eravamo insieme, io e Lidia. Quel pezzo fece piangere anche noi, ma per un accumulo di emozioni private. Lidia era l’unica collega ammessa tra le amicizie mie e di mio marito. Mi ha accompagnato nelle interminabili notti della fine di Francesco. Ora è l’unica nonna che lascia il marito per passare le serate con una vedova. Quella sera, tornate a casa, mentre preparavo qualcosa, lei inventò un gioco. “Facciamo il nostro film. Prova di memoria sui tagli per il visto di censura. Le ragazze in mutandine e reggiseno che ballano il can can,” urlava dal salone. “È un film di Vittorio Metz, Lo sai che i papaveri, con Walter Chiari e la Ferrero. Mi chiamarono per tagliare quindici metri quando il film era già pronto.” “Una segretaria che si spoglia mentre Franco Franchi stringe la fronte e Ciccio suda,” rilanciai, convinta di darle scacco. “In ogni film di Franco e Ciccio c’è una segretaria che si spoglia.” “Rinunci? I marziani hanno dodici mani, di Castellano e Pipolo. Me lo raccontò Gisa Radicchi Levi, te la ricordi? L’aveva montato lei.” “La figlia di Vallone che spia il padre mentre slaccia la camicetta a Dorian Gray, ma così ti ho già detto tutto.” “Il grido, di Antonioni. Non volevano farlo uscire, vero? Adesso senti questa. La Mostra del Cinema di Venezia. Passano le ragazze in bikini sulla spiaggia dell’Excelsior, in primo piano il fondoschiena che ondeggia, e la voce fuori campo annuncia: ‘La proiezione di interessanti retrospettive e di autentici pezzi di repertorio...’” “Ma questo è materiale mio. Una Incom o giù di lì.” “Un numero del cinegiornale.” “Ieri, oggi domani.” “Brava, ma per te è facile. Questa frase, da quale film è stata tagliata? ‘Siamo inquadrati peggio di prima, non ci resta che fare il passo romano.’ Allora?” “Sì, l’ho già sentita. Tagliata per il riferimento al fascismo che ritornava nel dopoguerra, no? Dev’essere alla fine degli anni ’40. Ancora non lavoravo. Mi arrendo.” “L’onorevole Angelina, il film di Zampa con la Magnani. La frase era stata censurata dal ministero prima del visto alla sceneggiatura.” “Adesso mi ricordo. C’era Zeffirelli ragazzino che faceva il figlio di un riccone.” “La richiesta del taglio era firmata dottor Calvino, ma l’ordine era di Andreotti. Era il Segretario di stato plenipotenziario con la delega per il cinema.” “Superdonna spaziale che strozza il suo uomo e lo disintegra.” “Impossibile.”
“I criminali della galassia, di Margheriti, con Lisa Gastoni. Lo so perché ero andata da Otello in moviola. Un paio di metri che, per la rabbia, la commissione ministeriale, composta tutta di maschi, avrebbe anche masticato.” “Una madre col velo nero che bacia il cadavere del figlio. Ci sono voluti diciassette metri di pellicola per quel bacio. Si sente crescere il dolore, in silenzio, fino allo strazio. Tagliato. Dimmi qual era il film.” “Salvatore Giuliano. E tu dimmi perché.”
GIULIO ANDREOTTI Il neorealismo al settanta per cento Ritengo che la stagione migliore del cinema italiano sia stata quella del neorealismo. Io mi attirai i fulmini a far notare che oltre ai ladri di biciclette e ai barboni vi erano “anche” altre realtà italiane validamente considerabili (citai Don Bosco e il grande tisiologo Forlanini). Tuttavia mi accredito il merito di aver promosso leggi di sostegno del cinema italiano, in un clima che non era molto favorevole. Eppure in tutto il mondo nostri film raccolsero successi straordinari. Ci fu una vera svolta rispetto agli anni del fascismo.
Legione di decenza. Il cinema dei miei anni giovanili non sfuggiva al clima del ventennio. È vero: Camicianera, Luciano Serra pilota ed altri titoli erano politicizzati. Ma la gran parte della produzione era piacevolmente aperta. Andavo al cinema pagando una lira, e il film me lo godevo: Topolino e il giornale Luce. Ero appassionato di soggetti musicali, italiani e non: tifavo, ad esempio, per Jan Kiepura e Martha Eggerth, una coppia di cantanti celebre negli anni ’30, in certi film di Carmine Gallone, credo. Ma il nostro ambiente, nel periodo in cui frequentavo per esempio la Biblioteca Vaticana, quando incontrai De Gasperi, e più tardi da sottosegretario, non era sensibile al cinema. E a non incoraggiarlo contribuivano i tentativi operati dalla sinistra con firme facili ai manifesti di propaganda e con i comizi demagogici. Occorre però rammentare l’attività del Centro cinematografico cattolico che, oltre a classificare i film sul modello americano della Legion of Decency, creò un buon contatto con la “gente di cinema” (penso a certe significative udienze di Pio XII). Vorrei poi ricordare, a chi parla di “bacchettoni”, che nella Costituzione della Repubblica (art. 21) si dice che contro gli spettacoli osceni possono essere adottate anche misure preventive. Il livello dell’osceno, di cui al Codice Penale, è ora molto cambiato. Ma la Costituzione è quella che è.
Controcorrente. Ho già fatto cenno al problema delle leggi sul cinema nell’immediato dopoguerra, quando da sottosegretario mi sono dovuto occupare dello Spettacolo. Ebbene, in un certo senso fui l’asino tra i suoni. L’ambiente parlamentare, alle prese con problemi drammatici di ricostruzione e miseria, era molto restio a destinare fondi al cinema. Per di più i proprietari delle sale erano soddisfatti dell’importazione di film americani e vedevano con preoccupazione che un certo numero di settimane fosse riservato per legge alla produzione italiana. Andar controcorrente era difficile; e per farlo erano indispensabili delle soddisfazioni alle legioni di ostili. Quest’aspetto industriale era molto chiaro al governo De Gasperi. Si trattava di scegliere se soggiacere al cinema estero o intraprendere una nostra strada. L’attesa era forte tra la gente di cinema. Qualcuno diffuse la falsa notizia che ci fosse un veto americano contro la rinascita della nostra cinematografia. Lavorai anche per creare armonia tra le categorie dei produttori, dei noleggiatori e degli esercenti. Grande merito lo ebbero
personaggi come Eithel Monaco, Franco Penotti, Italo Gemini.
De Gasperi e il peggiore film di Rossellini. Non è casuale che, con tutti gli esponenti del mondo cinematografico di allora, io abbia avuto rapporti cordiali; e con molti di autentica amicizia. Tra i registi, De Sica e Rossellini, tra gli attori la Magnani e Sordi. Un mio articolo su Umberto D e sulla responsabilità dei grandi autori di opere cinematografiche rispetto all’opinione pubblica fu apprezzato da De Sica. Da spettatore informato, credo che il peggiore film di Rossellini fu quello biografico su De Gasperi, dei primi anni ’70. Quando la politica entra nel cinema si cammina sui carboni accesi. Ma la colpa fu anche della segreteria democristiana. Rossellini mi aveva dato in lettura la sceneggiatura e dedicai un’intera giornata a stilare osservazioni e proporre tagli e aggiunte. Roberto mi ringraziò molto, ma neppure uno dei miei rilievi fu di fatto accolto. Le lotte interne di noi democristiani lo impedirono.
I comizi di Nannarella, Totò sul treno-letto. La personalità della Magnani era attraente e non gliene volli mai per alcuni suoi comizi un po’ demagogici. Nannarella era troppo simpatica per portarle rancore. Tra le sue cose che m’impressionarono citerei il monologo della Voce umana. La fotografia a braccetto con Anna sulla terrazza del Lido di Venezia, negli anni ’50, mi provocò l’unica scenata di gelosia (si fa per dire) di mia moglie in cinquantaquattro anni di matrimonio. Vera amicizia vi fu invece con Federico Fellini e con Alberto Sordi, per il quale accettai anche quella particina nel film Il tassinaro. Con Totò i rapporti furono frequenti, anche perché era divertentissimo. Lo avevo conosciuto a Milano, dopo teatro, nel suo camerino. Ho seguito alcuni suoi spettacoli e i film come ho potuto. Ho già raccontato un incontro sul treno-letto Nizza-Roma. Bussò alla porta per darmi la buonanotte insieme a Franca Faldini. Lui era stato in crociera. Cominciò con una battuta per me ministro delle finanze: “A tutti piace essere sopravvalutato. Io lo sono dal Fisco.” La sua comicità era compresa da tutti. E lo è anche oggi. Nel periodo del suo declino fisico fu esemplare. Sul set era in grado di tornare vivacissimo, ripiombando subito dopo nella quasi cecità. A parte Fellini, ricordo doverosamente Blasetti. Di lui conservo una massima: “Narrare le cose buone è difficile. Mi sentirei di girare un film sull’Inferno dantesco; forse sul Purgatorio; certamente no sul Paradiso.”
Ispiratore. Entro ora nel cinema come ispiratore di un film. L’idea di impostare un lungometraggio sul mio piccolo saggio sull’Operazione Appia Antica è stata di Lizzani. E a me ha fatto molto piacere. Che il cinema sia importante lo abbiamo visto qualche tempo fa a Firenze. In un contesto in cui c’erano il Presidente Clinton, Tony Blair e tanti capi di Governo, gli obiettivi si sono puntati su Benigni. Un ex presidente non è davvero geloso. Credo anche il presidente attuale.
6 Lidia veniva spesso al cinema con me e Francesco. Per un paio di decenni siamo stati un autentico trio, prima e dopo il mio matrimonio, prima e dopo quello di Lidia, che stimava, e forse amava segretamente, Francesco. Io al centro, loro ai lati. Avvolti nella nebulosa di una sigaretta, il tempo del film diventava l’isola di un rapporto a tre, inverecondo ma sublimato. Io credo a un equilibrio misterioso: altrimenti non potrei spiegarmi perché fosse tanto rassicurante per noi vedere insieme Il cammino della speranza e Rocco e i suoi fratelli, potendo ricostruire ogni volta, nella trama di tutte le immagini che per noi li congiungeva, il decennio che in realtà li separava. Una volta Francesco spiegò la nostra unione cinematografica con un’esperienza comune: da giovane, ciascuno di noi era stato al cinema con un topo. Quanto a me, non so più dire se fosse vero. Confondo la mia esperienza (forse al Moderno, in compagnia di mia sorella) con un fatto di cronaca: la signora al cinema Lux di Parma che assisteva rapita al Serpente a sonagli di Matarazzo, credo a metà degli anni ’30. Si era lasciata scivolare dalle spalle la pelliccia di castoro. Tranquilli e silenziosi, due topini se la mangiarono. E dovettero mangiarsi anche il film, perché di quella commedia non esiste più una sola copia. Nel ripensare alle discussioni e ai silenzi meditabondi del nostro trio cinematografico, mi torna alla memoria la gioia di mio marito quando incontrava un film italiano che gli piaceva davvero. Mi trasmetteva con la sua reazione una sorta di fiducia nella vita, perché in realtà gioiva della sua capacità di credere, attraverso le storie e i personaggi dei film, nella nostra società, nelle nostre radici. Aveva amato il neorealismo. Capì tardivamente Antonioni. Premettendo che non sapeva nulla di estetica, sosteneva che, con i film di Rossellini, De Santis e De Sica, il pubblico aveva una parte più attiva. Era cinema americano, come certi film di gangster o certi melodrammi del dopoguerra, ma senza la mano amichevole che accompagnava lo spettatore. Era proprio questo che il potere temeva. Il confronto “diretto” con la realtà fisica, storica, diceva, era la differenza epocale, irripetibile. Due volte ottenne incarichi di consulenza storica, una per il teatro, chiamato da Paolo Grassi nel gruppo che preparava il Galileo di Brecht diretto da Strehler, e una per il cinema, quando Lizzani stava preparando Il processo di Verona. Di Lizzani, Francesco, che aveva frequentato il liceo Visconti a Roma, mi aveva già parlato. Era un compagno di scuola serioso, alto e magrissimo, di un paio d’anni più giovane di lui. Un ragazzo bizzarro che amava la radiotecnica, ma era considerato un esperto di letteratura straniera. Una volta, ascoltandolo in televisione discutere, con tono professorale, di certe questioni di storiografia del cinema, Francesco sentenziò che quel signore sempre alto e magrissimo, acclamato come il cineasta della realtà, studiato come testimone del neorealismo dagli allievi dei primi corsi di storia del cinema, era un sognatore, un poeta mascherato da materialista.
CARLO LIZZANI Su e giù dal neorealismo Sognavo sugli atlanti. La mia passione era la geografia. Avevo dieci, dodici anni e il mondo, a chi si affacciava allora, appariva immobile. Sembrava che la storia fosse ferma, che gli eroi appartenessero a un passato chiuso. Girare sui mappamondi era ripercorrere la strada dei pirati, dei grandi navigatori, ripercorrere i sentieri degli esploratori di continenti. Salgari mi portava all’atlante, l’atlante ai libri di Salgari. E di Verne e Jack London. A casa mi divertivo anche a fare il disegno animato, ritagliando le figure dagli album.
Sogno e tecnica. Il mio primo film da spettatore fu un Topolino. Lo ricordo appena. Il primo film “vero”, invece, fu Il fantasma dell’Opera, che ho visto qualche anno dopo la data di edizione, se non sbaglio era del ’25. Mi colpivano certe vicende insolite, con viaggi o personaggi strani. Per conto mio imbastivo storie ritagliando, da vecchi numeri della “Domenica del Corriere” o dell’“Illustrazione Italiana”, figure curiose della pubblicità, donne con seni enormi, facce strane, situazioni grottesche. Immaginavo un percorso in genere spiritoso, abnorme. Mi immaginavo scrittore, o giornalista. Il cinema non mi attirava al punto di farlo. Mi ricordo che elencavo i film col titolo e il marchio. Alla fine dell’anno sapevo, che so, di aver visto 25 film Metro Goldwin Mayer e 21 Paramount, una decina Cines e altrettanti Rko. Facevo la classifica. Vinceva sempre la Metro. C’era già l’indole del collezionista cinefilo. Al massimo, immaginavo che un giorno avrei inventato un soggetto per un film. Da scrittore però. Semmai m’interessava molto la radio. Dico tecnicamente. Pigliavo piccoli apparecchi, li analizzavo, li ricostruivo. Ero abbonato a una rivista. Mi piacevano le valvole, e il ricevitore radio col cristallo di galena. Andare al cinema metteva insieme il sogno e la tecnica, cioè il senso dell’avventura moderna. Quando uscivo mi restava la frustrazione, perché quei sogni erano lontani. Qualcuno mi aveva portato là e riportato indietro.
Cineguf al Barberini. Al liceo, nel ’38, ’39, s’andava alle mattinate del Barberini, che erano a tre lire anziché dieci. Erano organizzate dai Cineguf, la sezione cinematografica dei gruppi universitari fascisti, dove noi eravamo tollerati anche se liceali. A qualche serata speciale intervenivano dei registi. Ho visto lì per la prima volta Blasetti. Quando ho incominciato giurisprudenza mi sono iscritto subito al gruppo universitario di cinema. Qui però entra in campo il discorso sull’ambiguità del fascismo, che è stato un fenomeno di governo molto diverso da una dittatura militare puramente reazionaria come quelle di Franco o dell’America Latina. Perché, intanto, si parlava molto della lotta alla borghesia e della “rivoluzione”. E questo piaceva ai giovani. Io insisto sempre su un fatto: il fascismo indirizzava comunque i giovani verso una forma di “socialità”, che poi è il filo rosso che arriva fino al movimento “sociale”, il fascismo di sinistra, eccetera. Eravamo sì obbligati a iscriverci ai Guf, ma eravamo anche attratti dalle
attività culturali. Il Cineguf disponeva di una cinepresa 16 millimetri per fare dei documentari. Chi amava la letteratura aveva accesso a libri particolari della biblioteca dell’Istituto di cultura fascista, dove si potevano leggere anche le opere di Labriola e Marx. Si sviluppò una specie di fronda tra il ’38 e il ’40. All’interno di queste attività parascolastiche molti giovani fascisti di sinistra si resero conto dell’ambiguità del regime e delle sue contraddizioni, e arrivarono poi al socialismo e al marxismo. Leggendo il settimanale del Gruppo avevo scoperto che esistevano e si potevano vedere anche film russi o francesi, al Centro di cinematografia, che allora era ancora in via Foligno. Scoprii cioè l’altro cinema, il film come creazione artistica. Vidi René Clair e Pudovkin, Carné, Renoir. Per un giovane erano incontri folgoranti. Quelle luci così pittoriche, i personaggi d’intensità letteraria e insieme quotidiana, una società angosciata da problemi morali complessi, le combinazioni di montaggio dei russi da cui assorbivi le idee. Chiesi se potevo scrivere qualcosa sulla rivista “Roma fascista”. Dopo un paio di saggi, diventò un appuntamento fisso di recensioni.
La fronda con De Santis, Puccini, Ingrao. Avevo diciannove anni e fui subito “contro”. Mi schieravo contro il cinema italiano accademico, di Carmine Gallone e Blasetti, che doveva addirittura diventare un mio maestro e che imparai ad apprezzare poi, quando vidi 1860, il film sul Risorgimento. Mi piaceva osteggiare quel tipo di intellettuale che sposava il cinema perché era trucco, sogno, qualcosa di più della realtà. Un certo istinto mi portava a pensare anzitempo che il cinema non doveva essere “di più” rispetto alle altre arti, gli bastava quello che era. Già tanto, se poteva entrare come arte a fianco delle altre arti. Non me ne rendevo conto, ma ero diventato un animatore culturale, un organizzatore di proiezioni, a cui incontrai Giuseppe De Santis, Massimo Mida, Puccini, Pietro Ingrao, che aveva frequentato per un anno il Centro sperimentale di cinematografia, Umberto Barbaro, Luigi Chiarini e altri. Cioè quei giovani, o gli intellettuali più maturi, che erano già in contatto col partito comunista o comunque in dialettica col regime. Cercavano nuove persone, scavando tra l’altro proprio nei gruppi giovanili fascisti; seguivano, direi, la dichiarazione della III Internazionale del ’36 dove si diceva: il fascismo ha ottenuto un tale consenso di massa che è inutile lavorare su cellule clandestine, meglio entrare nelle organizzazioni di massa e operare dentro la demagogia e l’ambiguità del populismo.
Protetti dal figlio del duce. Mi proposero di partecipare alla rivista “Cinema”, scrivendo e andando alle riunioni. Avevo successo come critico. Questo mi spostò dalla letteratura al cinema. Ero sorpreso, devo dire. Alcuni miei articoli venivano catapultati come editoriali. Avevo un’impostazione storicistica. Per me Francesco De Sanctis e la sua Storia della letteratura erano un fondamento. Si discuteva molto di tutto in redazione e dopo le proiezioni. I film di Lattuada, Castellani e Soldati li sentivo appartenere a un cinema nobile, colto, ma ancora lontano dal cinema di osservazione realista della società, che sentivo urgente. Mi sollecitarono a leggere Verga, in particolare I Malavoglia. Un libro importante, anche se poi finì osteggiato, era La storia della rivoluzione russa di Trockij. Il fascismo aveva permesso una traduzione italiana perché
conteneva critiche aspre allo stalinismo. In certi casi, c’era il problema, questo sì, di non farsi scoprire. Li nascondevo certi libri, quelli di Lenin e altri, prima in casa, poi pensai che il luogo più sicuro era l’ufficio del Gruppo fascista romano. Il libro di Labriola sul materialismo storico lo leggevamo all’Istituto di cultura fascista. Da organizzatore riuscivo a scovare pellicole che erano praticamente proibite, i film di Pabst, Murnau, King Vidor, perfino Chaplin. Ci accusarono, poi, come gruppo di “Cinema”, di essere stati schematici, di non avere capito che anche altri si muovevano in una certa direzione. Ma i movimenti innovatori sono anche schematici, faziosi. Se prendiamo la Nouvelle Vague, be’ loro ammazzarono registi come Clouzot e Cayatte, che avevano appena cinquant’anni, e si era in democrazia. Io segnalavo il talento di certi registi italiani giovani, ma sottolineavo che non ci si poteva fermare alla bella forma come unico tentativo di alternativa ai “telefoni bianchi”: il talento, sostenevo, doveva essere impiegato per osservare da vicino la società italiana. E scrissi anche questo: non basta non fare dell’arte per fare del buon mestiere. Indubbiamente, tra le tante cose, stavamo ragionando anche su un’idea di “cinema moderno”. Mario Mattoli era uno dei più bersagliati, con Gallone e Righelli. In Poggioli e Franciolini, e soprattutto in un certo Blasetti, serpeggiava un interesse per il realismo, però non faceva tendenza, come si dice oggi. I film di Mario Camerini suscitavano in noi una certa attenzione, perché cercavano di osservare la vita quotidiana, con dei bagliori di autenticità. Ancora ai tempi di “Roma fascista”, mi era successo di lodare Teresa Venerdì di De Sica e Zavattini per lo sguardo preciso sui piccoli personaggi. Erano talmente contenti, che ci incontrammo. In quell’occasione ricevetti la promessa di assistere alle riprese del loro film seguente, I bambini ci guardano, un momento fondamentale del passaggio al neorealismo, proprio perché implicava il coinvolgimento morale, nel quotidiano, della famiglia, così esaltata dalla retorica fascista. Ma anche il fascismo, in qualche modo, invocava un cinema non di pura evasione, certo non il fascismo più conservatore, che appoggiava il disimpegno dei “telefoni bianchi”. Era un altro equivoco della posizione fascista “sociale” in materia di cultura. D’altra parte, è noto che il direttore della nostra rivista era Vittorio Mussolini (proprio il figlio del duce), che aveva una visione ampia e non censoria, né s’era accorto che nella sua redazione teneva un gruppetto di antifascisti (Vittorio e Bruno Mussolini avevano studiato al Tasso a fianco di futuri antifascisti come Zangrandi, i fratelli Puccini e Vladimir Kamenevski, il nostro compianto Ugo Stille, costretto poi all’esilio). Noi però, per “realtà”, a un certo punto intendevamo anche la guerra, gli aspetti tragici e contraddittori che il fascismo non voleva assolutamente mostrare. Su “Cinema” comparvero testi fondamentali sulla crisi del cinema italiano, come “Cadaveri” del giovane Visconti, nel ’41, testi per orientarsi verso il realismo, come quelli di Peppino De Santis sul paesaggio italiano e su Verga, o di Antonioni sulla gente del Po. Le spinte erano molte, forse confuse. Poi Visconti riuscì a girare Ossessione, e tutto fu più chiaro. Era il ’42.
Il nostro neorealismo. Il neorealismo è stato una rivoluzione formale innestata su certi eventi specifici della storia d’Italia. Lo sostenni fin dalla prima edizione della mia Storia del cinema italiano nel 1953. A casa Puccini, che incominciai a frequentare dal 1941, non si parlava soltanto di Murnau e
Pudovkin, ma anche di Thomas Mann, Proust, delle prime cose di Moravia, si scopriva Guttuso, Mafai, la scuola romana, e i libri proibiti: Hemingway e Miller. I progetti di Giuseppe De Santis prima della fine della guerra erano in gran parte letterari. Il fascismo non aveva rotto con l’arte, come aveva fatto Hitler. Futurismo, surrealismo e metafisica avevano grande spazio da noi. Il neorealismo insomma aveva dietro una grande cultura: il ’900. Sarebbe diventato una rivoluzione formale, non solo di contenuti. Conoscevamo i movimenti artistici europei, le avanguardie, avevamo letto Kafka e Joyce nelle preziose edizioni di Frassinelli. Invocavamo una letteratura che fosse né troppo concreta né troppo astratta, che riuscisse a decifrare questa nazione molto fragile, arrivata all’unità molto tardi rispetto agli altri paesi europei, ancorata prevalentemente alla cultura rinascimentale e barocca. Sentivamo il bisogno di uscire da questa stasi. Moravia e Calvino, per esempio, erano in sintonia. Al nostro cinema, narrativamente, sentivamo che mancava quello che era riuscita a fare la grande letteratura francese dell’800, ma anche le letterature russa e inglese. Insomma, cercavamo nello stesso tempo di recuperare un passato molto dinamico e di raccordarci alle novità del nostro secolo, nel senso di un lavoro in profondità per verificare e raccontare storie e personaggi d’un paese che cercava se stesso, che cercava una sua identità. Sarebbero entrati pienamente in questa prospettiva anche i film storici di Visconti, realizzati molti anni dopo la guerra, come Senso o Il gattopardo, e naturalmente tutto quello che raccontava l’Italia contemporanea, come fecero Rossellini, De Sica e gli altri appena finì la guerra. Ossessione restava il punto di riferimento. Ma anche Un pilota ritorna di Rossellini, voluto dal fascismo per celebrare il coraggio individuale nelle azioni di guerra (alla sceneggiatura aveva partecipato Vittorio Mussolini, ma anche il giovane Michelangelo Antonioni), e tuttavia importante per i dettagli umani e le parti documentaristiche. Ma qui bisogna intendersi sull’idea di neorealismo. Noi tutti avevamo solide origini letterarie e culturali. Non si trattava di tendere alla documentazione diretta. Perfino Ossessione era un film “surreale”, nel senso di pregno di letteratura. La cornice era reale, ma nei personaggi non c’era l’Italia, piuttosto un innesto del cinema francese in una certa realtà italiana. Perfino i critici dicevano: macché realismo. Ed è vero. Ma proprio questo fa capire in che misura il neorealismo era ibridato da fattori culturali di vario genere. Visconti ha messo dentro tutto: personaggi della letteratura americana, certi film francesi, il melodramma. Però ne esce un film di straordinaria verità. Quattro passi tra le nuvole di Blasetti, con Gino Cervi, era l’altra strada, un po’ populista. Anche Rossellini era immerso in una dimensione di alta cultura. Casa sua era frequentata da pittori e musicisti. Ci trovavi l’anziano Mascagni o Zandonai. E così Zavattini.
Compagni ebrei spariti per sempre... Quello fu per il cinema, per l’Italia, per tutti noi, un periodo di straordinarie mutazioni, che hanno formato la realtà d’oggi. In un mio breve racconto ho ricostruito come in certe mutazioni grandi e decisive di un decennio della mia vita, dal ’34 al ’44, si riflettessero (ed era così in ogni uomo di quel momento) mutazioni grandi e decisive del nostro paese, anche se eravamo ancora dei ragazzi. Al liceo Visconti, c’era un insegnante che era il figlio adottivo di Musil, il professor Marcovaldi. Nel ’38, quando ancora Marcovaldi c’insegnava greco e latino,
i miei compagni ebrei sparirono dal liceo. Poco prima, nel ’36, era stato Marcovaldi a sentire il fiato di Hitler sul collo nella casa viennese della madre, che viveva con Musil, mentre io nella mia stanzetta segnavo con le bandierine, sulla cartina geografica, le conquiste militari di Badoglio in Etiopia. E poco dopo, nel ’44, la compagna timida che un po’ prima, interrogata dal severo Marcovaldi, rispondeva “non saprei”, avrebbe sparato ai tedeschi ai Castelli Romani. Una ragazza molto sofisticata, Carla Capponi, ma ebbe la tenacia per partecipare anche all’attacco di via Rasella. Ancora nel ’36, cioè poco prima (perché il raccontino giocava su questo correre avanti e indietro con l’opposizione “poco prima... poco dopo”) ero rimasto folgorato dagli occhi di una compagna che stava al primo banco (io ero al secondo). Si chiamava Giovanna Pontecorvo. Aveva una bellissima treccia bruna. Non la rividi più a partire dal 1938. Quello fu l’anno in cui un’altra mia compagna, Vittoria Ottolenghi, ripiegò nel cassetto un bell’abito bianco preparato per festeggiare l’imminente maturità classica. Le leggi razziali le impedirono di sostenere l’esame. E di indossare l’abito... Fu lei, ebrea, che poco dopo, nel ’43, mi aiutò a trovare una casa per riunire i giovani del movimento studentesco romano e organizzare la Resistenza dentro l’Università. Erano anni in cui ai giovani erano date possibilità di investimenti in ruoli imprevedibili, con occasioni d’esperienza irripetibili. Ai giovani non ebrei naturalmente. Perché i ragazzi ebrei invece sarebbero spariti con le loro famiglie. Alcuni per sempre. È per quei giovani che ho fatto L’oro di Roma, nel 1960, raccontando le false promesse di tedeschi e fascisti.
Magrolino, per fare il regista. Alla fine degli anni ’40 la passione politica e le precedenti esperienze (ero stato aiuto di Rossellini, De Santis e Lattuada, tre pilastri) mi indirizzarono al cinema, come vera professione. Ma avevo ancora qualche resistenza. Pensavo anche che un regista dovesse avere un’attrezzatura fisica potente, e io ero magrolino. Mi vedevo più a scrivere sceneggiature. Però avevo fatto dei documentari. Giuliano De Negri, un operatore culturale di Genova (poi ottimo produttore) voleva valorizzare il movimento della Resistenza ligure, ambientando la storia in una fabbrica tra il ’43 e il ’44. Mi convinse a dirigere il primo lungometraggio, Achtung! Banditi!, nel ’51. Mi colpì l’idea di mettere per la prima volta una fabbrica al centro di un film italiano, con la resistenza operaia sulle montagne appena sopra la città, in una regione poco vista al cinema. La cosa incredibile fu il successo d’incassi, qualcosa come venti miliardi di oggi per un piccolo film che arrivò fino in Cina, attraverso Praga, con una quasi sconosciuta Lollobrigida.
Follia di Rossellini. Com’è noto, il successo del neorealismo non piaceva al governo. Noi eravamo un po’ come un castello assediato. Ci difendevamo anche con manifestazioni di piazza, quella celebre del ’49, che ho fatto insieme con De Sica, la Magnani, Gino Cervi e Rossellini. E c’era da difendersi anche dagli attacchi sulla stampa. Ugo Casiraghi ci sosteneva da Milano. Kezich e Cosulich da Trieste. Ci fu il manifesto dei cento per la difesa del cinema italiano. Il clima era da caccia alle streghe. Il governo censurava quasi tutto. Sottosegretario con delega allo spettacolo era
Giulio Andreotti. Per forza di cose, il cinema italiano finì per gravitare intorno alla sinistra. Con noi c’era anche Pietro Germi, che non era comunista, per esempio. Per molti, il legame veniva dalla Resistenza. Era stato Antonello Trombadori, mio caro amico, a segnalare il mio nome a Rossellini che cercava un aiuto per girare a Berlino Germania anno 0. Trombadori era stato accanto a Giorgio Amendola, il leader che aveva ispirato a Rossellini la figura centrale di Roma città aperta. Le mie lettere a Trombadori da Parigi e poi Berlino raccontano tutta l’avventura di Germania, nella quale emerge il lato folle di Rossellini, capace di abbandonare il set per settimane, di utilizzare il suo fascino per far lavorare gratis i collaboratori (per esempio l’aiuto Basilio Franchina) e di chiudere il set anzitempo per tornare a Roma, dove la Magnani scalpitava reclamandolo (perché lei non voleva prendere aerei). Avevo scoperto interni straordinari a Berlino, ma ero dovuto tornare in Italia con la troupe e gli attori tedeschi. Anche gli esterni, con le rovine e la gente ancora in giro, erano impressionanti. In tre settimane, la genialità di Rossellini recuperò tutto il tempo perduto. Ma a Roma accadde qualcosa di incredibile.
La fame. Sistemati in città per girare gli interni, gli attori tedeschi avevano finalmente trovato cibo a volontà: pizze, pasta, vino, cappuccini. Rapidamente, girammo gli interni mancanti, ma il primo giorno di moviola, un disastro: si vedevano questi personaggi scarni, sofferenti, attraversare le strade e le macerie di Berlino, e poi, pasciuti, perfino un po’ grassi, quando entravano nelle case. Abbiamo aspettato due settimane che gli attori perdessero peso, poi abbiamo dovuto rigirare ogni scena. Lavorando con De Santis e Lattuada, avevo sentito l’importanza della parola scritta, della sceneggiatura. Rossellini non ne voleva sapere. Andava a braccio con la sceneggiatura. E si defilava spesso. Io non capivo. Ora lo dico, perché ormai è di dominio pubblico: rimasi a Berlino a girare parti essenziali del film. Quasi tutto il finale, per esempio. Ma lui ha fatto certo un capolavoro. E quel rischio di “arronzamento” del progetto, che temevo, e di cui scrivevo a Trombadori, poi fu annullato dalla capacità di sintesi di Rossellini.
Veto sulle esportazioni. Ma Totò parla cinese. Cronache di poveri amanti era un progetto finito dalle mani di Visconti alle mie, che esprime bene, credo, l’intreccio tra i miei gusti letterari e l’impegno sociale. Ma fui boicottato. Negli anni ’50 la situazione produttiva per me, per quelli che erano bollati da un certo maccartismo italiano, era precipitata. Visconti riuscì a cavarsela, perché lui faceva il grande teatro. Perfino De Santis, comunista, era corteggiato dagli americani, dopo il successo di Riso amaro con la Mangano. Riuscirono a far fallire la nostra cooperativa (ma qualche anno dopo, a Genova, con Giuliani fondammo la Ager Film, che per esempio avrebbe laureato i fratelli Taviani). A Cannes si fece di tutto per impedire alla giuria di dare il Gran Premio a Cronache di poveri amanti. Era l’ennesima pressione per evitare che certi film italiani riuscissero a raggiungere le sale all’estero. C’era un veto alle esportazioni, senza spiegazione. Dopo il premio a Cannes il mio film avrebbe certamente avuto ancora più fortuna all’estero. In questo contesto accettai la
regia di un film strano, con i giovanissimi Dario Fo e Franca Rame, Lo svitato, del ’55, una commedia di puro divertimento che a me allora parve una resa davanti all’ostracismo, perché mi sembrava di abdicare ai miei ideali d’impegno sociale e culturale. Invece Lo svitato resta un film pieno di umori del tempo, una satira della città, dei consumi, della corsa al successo, molto prima del boom. Non ero conquistato dalla commedia, ma apprezzavo certi film di Totò, che aveva alti e bassi. Alcuni erano straordinari. Da Totò cerca casa a Guardie e ladri. Quando Totò era anche diretto. Ho visto in Cina Guardie e ladri, doppiato in cinese, e funzionava. A quel tempo però credevamo ancora che il nemico principale fosse il cinema “d’evasione”. Noi consideravamo il cinema di Matarazzo e Freda, che poi è stato valorizzato, un cinema minore. Ero naturalmente attratto da certi lavori di Comencini, Monicelli, Risi, ma non c’era un gran dialogo tra noi. Era troppo presto. C’era ancora una battaglia di prima linea per cercare di sviscerare problemi e mostrare ambienti mai sfiorati della realtà italiana. Antonioni, interessato al mondo borghese, riusciva a raccontarlo straordinariamente. Era una grande novità.
Fellini e Visconti, fine del neorealismo. Il neorealismo fu messo in crisi dalle opere innovative di Fellini e Visconti. Eravamo stanchi, in fondo. Anche di noi stessi, perché l’occhio stava diventando naturalista, e Senso di Visconti (ancora Visconti) cambiò le carte in tavola, virando verso il racconto storico, mentre nasceva il cinema diverso di Rosi, Pasolini, Bellocchio, i Taviani, Ferreri, Bertolucci e Petri. Ancora quando la commedia all’italiana era in auge, stavano andando in crisi i grandi disegni ottimistici. Negli anni ’60 succede qualcosa di eminentemente italiano, secondo me. Lo dico anche nella mia Storia del cinema: sorge un cinema cosmopolita, che tuttavia è italiano, perché riflette un’ibridazione culturale interessante e fruttuosa, tipica dell’identità italiana fin dal Rinascimento. Cioè per me sono italiani anche Antonioni che va a Londra a girare Blow up e poi in America per Zabriskie Point, o Ferreri che va in Francia a fare La grande abbuffata. O Bertolucci in Cina. Sergio Leone in America. Gli anni ’60 e ’70 sono stati anni importanti per il cinema italiano. Leone mi disse qualcosa di poco modesto, ma di profondamente vero quando una volta gli chiesi come si vedeva quale interprete della realtà italiana: un Ariosto che recuperava la “chanson de geste”. Quindi il nostro Rinascimento, la nostra poesia. Ecco allora perché dico che anche Fellini, nelle opere dopo La dolce vita, intraprende una strada italiana verso un fantastico e un immaginario che ha anche requisiti specificamente nostri. Io ho seguito una mia strada verso il realismo, con Il processo di Verona nel ’60, o Banditi a Milano, sulla banda Cavallero, e poi con Mussolini ultimo atto, nel ’74, ma credo un po’ anche con altri miei film, compresi Mamma Ebe e Fontamara, negli anni ’80. È stato detto che nella mia filmografia è possibile ricostruire una storia completa del fascismo in otto titoli. Purtroppo quello che andò in pezzi negli anni ’70 e ’80 fu l’industria cinematografica. Questo è stato il vero problema degli ultimi due decenni. La crisi della produzione media che teneva in piedi l’industria.
Sdoganato da De Laurentiis.
La televisione scompaginò i modelli noti e non vi fu la scoperta di nuovi modelli. Questo però è accaduto in tutta Europa, un po’ anche in America, quando emersero di conseguenza gli indipendenti Scorsese, Coppola, De Niro e tutti gli altri. In Francia dopo la Nouvelle Vague erano scesi a 80 milioni di biglietti l’anno quando noi ancora ne vendevamo 300 milioni. Non credo cioè che sia soltanto l’Italia ad aver accusato il colpo dei nuovi modelli di consumo e di impiego del tempo libero (semmai nella televisione si sono inseriti meccanismi censori che una volta erano rivolti al cinema). Di conseguenza, i produttori si sono tirati indietro. Uno come De Laurentiis, per esempio, è difficile trovarlo oggi. Se torniamo ai miei anni “difficili”, chi mi sdoganò da una situazione di stallo fu proprio lui, De Laurentiis. A cui un giorno dissi con franchezza: senti, per questioni politiche io non riesco più a lavorare; però, in fondo, sono uno degli autori del tuo grande successo, Riso amaro, tu sei un uomo coraggioso e indipendente, perché non facciamo ancora qualcosa insieme? Intanto mi affidò subito una “seconda unità”, per guadagnare qualcosa. Poi mi fece fare Esterina e Il gobbo, a cui partecipò anche Pasolini, un film importante, con cui rientrai nei miei temi, perché riprendeva un momento della Resistenza romana e ne mostrava forse per la prima volta certe ombre: un partigiano, “er Gobbo del Quarticciolo” che diventava un bandito. Con De Laurentiis feci poi L’amante di Gramigna e Banditi a Milano, un successo che mi diede da vivere per dieci anni.
La crisi oggi. C’era sempre un principio di sintonia con la realtà a farci sopravvivere, un cordone ombelicale tra il film e la realtà, che alimentava anche uno come Fellini, e naturalmente Olmi, Scola, Monicelli e tutti i nostri straordinari sceneggiatori, da Suso ad Age e Scarpelli e Pirro: qualcosa che invece è venuto a mancare nell’ultima parte della storia del cinema italiano. La nostra generazione partiva da elementi minimi ma riusciva ad allargare lo sguardo a tutto campo sulla società, a ogni livello, metaforico, lirico, metafisico, di apologo. Una piccola realtà riusciva a coniugarsi quasi sempre con una realtà più vasta. Mi pare che nei cineasti italiani d’oggi lo sguardo si sia ristretto. Non parte più dal buco della serratura per vedere l’intera stanza. Ci sono alcuni talenti che si perdono per mancanza di dialettica coi produttori. E, alla ricerca affannosa della cosiddetta globalità, si finisce per essere assai meno “globali” di quanto lo eravamo noi.
L’atlante. Il mio eclettismo, che viene, credo, dagli interessi della mia giovinezza, mi ha sempre condotto a spostarmi verso esperienze molteplici. Film d’impegno e di generi diversi, tra cui commedie e addirittura western; libri di storia e di critica del cinema; viaggi nel mondo per documentari; e il lavoro di organizzatore cinematografico, culminato nella direzione della Mostra del cinema di Venezia. Quando scelsi di andare con Rossellini a Berlino, ero, per esempio, candidato a girare un documentario sulla Sicilia per il quale poi fu interpellato Visconti. Non sto dicendo naturalmente che avrei fatto io La terra trema. Ma andare a Berlino nel ’47, col cadavere di Hitler ancora caldo, mi affascinava di più che girare un documentario in Italia. Così, nella mia vita, ci sono tutti quei viaggi: in America, in Messico, in Cina, dove
vissi i momenti salienti della crisi internazionale del comunismo dopo le rivelazioni di Kruscev, in Africa, quando l’Angola conquistò la decolonizzazione; in Vietnam, dove – come inviato della Rai – ero addirittura diventato “maggiore” dell’esercito americano, con uno scontrino che dovevo consegnare in caso di cattura per essere trattato come un ufficiale... Avevo scoperto che, diversamente da quello che credevo quando scrutavo l’atlante, la storia non era affatto finita. E io ero proprio nell’occhio del ciclone.
Avanti e indietro. In risposta a una mia lettera di complimenti per Medea, Pasolini finiva così un discorso a proposito del sentimento della storia: “Ciò che ci attrae a tornare indietro è altrettanto umano e necessario di ciò che ci spinge ad andare avanti.”
7 Se questa notte riuscirò a dormire sarà un miracolo. Mi sento assediata, e non vedo eserciti. Forse sono invisibili perché mi attendono nel sonno. Seduta in poltrona, davanti alla televisione, vedo, nell’ordine: il giornalista Bruno Vespa che ha il colletto bianco come la benda di un piccolo africano ferito, immortalato nella gigantografia alle sue spalle, con gli occhi spalancati che sembrano fissare il titolo “Morire bambini. Il mondo ci guarda”; il quadrante di un telefonino che racchiude una fotografia di ragazzi che guardano il quadrante di un telefonino che racchiude una fotografia di ragazzi; una strada devastata dalle bombe con il primo piano di una donna che urla; il maestro Riccardo Muti che svirgola nell’aria; Maurizio Costanzo; una donna poco per bene che slaccia la cintura di un uomo; il mezzobusto di Macario militare che fa balzare un soldatino a molla sotto il naso di un nazista. Macario l’ho conosciuto nel giardino di una villa a Santa Margherita, l’unica estate che decisi di trascorrere da mia sorella. Ero stata in montaggio, come assistente, per due o tre film in cui vedevo andare avanti e indietro la sua faccia da uovo sorridente. Ho conosciuto Leo Benvenuti, quando scriveva i film di Macario, prima di fare coppia fissa con De Bernardi. Nel periodo in cui ci siamo incontrati stava scrivendo, proprio per Macario, Il monello della strada. Era un donnaiolo, un ragazzone alto e cinico col gusto goliardico per la vita. Per qualche giorno ho ascoltato le storie di guerra di Leo, corteggiata con molta eleganza. Sapeva che ero fidanzata. La sera lo vedevo uscire con le “girls”, le ragazze del varietà che tentavano col cinema. Camminavano sventolando la gonna per alzare l’indiscrezione al ginocchio. Ricordo Ady Marzano e Paola Certini. Le ho viste anche a teatro, in bikini o fasciate di raso fino alla caviglia, con quelle piume ridicole in testa. Speravano di fare il cinema con le gambe. Ora saranno madri, nonne. Saranno sole, forse anche loro sulle spine per la notte.
BENVENUTI & DE BERNARDI Amici per la pellicola Piero De Bernardi. Il primo film che ho visto, credo, è Le due orfanelle di Griffith, un melodrammone muto con Lillian Gish. Certi parenti avevano una sala cinematografica a Prato, dove sono nato. I miei genitori non mi mandavano al cinema, ero ancora troppo piccolo. E io, mi ricordo che, di nascosto, stavo in cabina di proiezione inginocchiato, per spiare il film dal finestrino. Era molto affollato quel finestrino. Leo Benvenuti. Io invece identifico il mio primo film con quello che m’ha dato la voglia di fare questo mestiere: Incantesimo, di George Cukor. Quindi ero già un ragazzo. S’era alla fine anni ’30. Quei personaggi, il fratello Ned ubriaco, la Hepburn così ribelle rispetto alla famiglia formale e dedita solo a far soldi, Cary Grant titubante, e poi quei dialoghi... l’era proprio il piacere di sentire belle battute perfette per la tonalità dei personaggi. Era un mondo speciale. In fondo la nostra vita era legata alla provincia, e per noi giovani era animata dai Guf e da poche altre cose.
Macario comico della terra. De B. Non c’era quasi niente, in verità. Quello che si faceva era, la domenica mattina, andare al cinema, a Prato prima, e a Firenze poi. B. Be’, parla per te, io facevo l’attore per la Gil e i Guf, ho partecipato alle filodrammatiche, poi ho scritto per il varietà, ho fatto un po’ di regia. Quando sono sfollato da Milano per la guerra e sono tornato a Firenze, dov’ero nato, mi sono buttato nelle attività dei Guf. Abbiamo fatto spettacoli grossi, come il Glauco di Morselli, le commedie di Goldoni. Il teatro ti permetteva di imparare un sacco di cose dello spettacolo. Per lo sport e gli spettacoli i regimi totalitari hanno sempre funzionato... De B. E poi a quel punto non c’erano più film americani. C’era Luciano Serra pilota, Sentinella di piombo, Vecchia guardia. Invece i primi film del dopoguerra che m’incantarono furono quelli di Fred Astaire e Ginger Rogers. B. Sì, anch’io, questo anch’io. De B. Ma credo un po’ tutti quelli della nostra generazione. B. Be’, noi due in comune avevamo il gusto per la commedia. C’era questo mondo fantastico, Broadway. E subito dopo, quando t’arrivano Sciuscià e Ladri di biciclette, be’ abbiamo scoperto il realismo. Io ero già a Roma, stavo incominciando a lavorare ai film di Macario. Anzi, con Carlo Borghesio, praticamente, abbiamo trasformato Macario da pupazzetto della luna a comico della terra. Come persi la guerra, in cui ho esordito da sceneggiatore, è il primo film comico neorealista, se così si può dire. Macario faceva un soldatino italiano. Del suo personaggio mantenne soltanto quella virgola dei capelli, ma c’era uno sfondo realistico. L’abbiamo girato per le strade di Roma in diciotto giorni. Alla sceneggiatura parteciparono prima Pinelli e più tardi Steno e Monicelli. Fu un successo enorme. Anche in Francia. Era il ’47. E poi se ne fece un secondo, L’eroe della strada, che provocò una protesta del ministero.
De B. Ma quando ci fu...
Andreotti avverte. Togliatti cade. B. Aspetta. Andreotti ci fece chiamare. Piero non c’era ancora. È una cosa indicativa dei tempi questa. Erano già incazzati per il film precedente, per quel soldato che praticamente disertava, cambiava divisa, cambiava esercito, e qui c’era ancora una storia di povertà, furti, e un partigiano che faceva la voce grossa. De B. Era la volta dell’attentato. B. Sì. Andreotti chiamò me, Rovere e Borghese come responsabili di quei film di Macario. Fu una lavata di testa. Era il 1948. Per una volta Andreotti aveva abbandonato quei modi cortesi, l’understatement che gli conosciamo da cinquant’anni. Incomincia a parlare direttamente. L’Italia non è così, c’è una smania di ricostruzione, non è vero che le volanti picchiano gli scioperanti, semmai ci vuole un po’ di pudore, poi questi film può accadere che vadano all’estero, disse. Era la questione dei panni sporchi che si lavano in casa propria. Vi avverto, precisò, che c’è in atto una censura preventiva su quello che farete; se crediamo, sapete che possiamo bloccare... ve lo dico perché poi non ve la prendiate, eccetera. E mentre dice: “perché quello che fate vedere non è vero” si spalanca la porta dell’ufficio e un funzionario grida: “Hanno sparato a Togliatti!” E tutti, compreso l’Andreotti, lanciano le braccia in alto con un urlo. Di meraviglia, ma anche quasi d’esaltazione, perché l’era incredibile, capito? E corrono fuori lasciandoci in questo ufficio enorme, come tre fessi. E venivano a dirci che non c’era un conflitto politico in corso?
Gli scorci di Borghesio. Comunque, tutti quei film di Macario andarono bene. La novità era l’inserimento del comico nel realismo, come successe poi per Totò. Qualche anno prima, all’inizio della guerra credo, avevo visto un film di Borghesio che mi aveva colpito proprio per l’attenzione realistica: Il vagabondo, nel quale Macario viene dalle borgate, salva una ragazzina, e poi ritorna nella sua miseria. E avevo notato che Borghesio girava per le strade, prendeva scorci di Roma, insomma vedevi degli sfondi. Poi, sempre all’inizio della guerra, mi avevano colpito i film del vero inventore del neorealismo, il comandante De Robertis: Alfa Tau!, Uomini sul fondo, storie della marina italiana senza retorica. E lì gli attori erano veri marinai. De Sica, Rossellini, Visconti poi impiegarono spesso interpreti non professionisti. De B. Sì quelli li ho visti anch’io, La nave bianca, e quell’altro... Ma vedevamo poi Il conte Max, e gli altri di Camerini, i “telefoni bianchi”; mi ricordo Addio Kira di Alessandrini, dove c’era Alida Valli giovanissima che s’innamorava dell’aristocratico russo Rossano Brazzi, un film in due parti, se non sbaglio. B. Ma non è che la società che raccontava Camerini corrispondesse all’Italia del tempo. De B. Qualcosa in Gli uomini che mascalzoni!, con un amoretto vero, ambientato nelle strade di Milano. Ma quando si metteva a fare Darò un milione o Il signor Max, be’ la realtà era proprio un’altra in Italia. Appena Camerini cercò di fare neorealismo nel dopoguerra, (lui e Blasetti, perché in qualche modo furono obbligati a farlo) per esempio Molti sogni per le
strade, con la Magnani e Girotti, ogni volta che varcava la soglia della commedia il risultato, be’... E comunque non è che poteva fare un granché politicamente, durante il fascismo. B. Il dissenso stava nelle adunate obbligatorie del sabato, erano un pretesto per sbeffeggiare il regime. Non c’era inno che non avesse la parodia interna, cantata tra di noi, per irridere, a volte proprio antifascista. De B. Dipendeva dalle famiglie. Io avevo una famiglia fascista. E non ho esperienze giovanili di questo genere. B. Io invece avevo una famiglia quasi anarchica.
Sei mesi di fame. De B. Noi eravamo ricchi. Ci siamo risvegliati dopo la guerra poveri. Mio padre morì. E io ho dovuto interrompere gli studi. Ho fatto molti mestieri. Sono stato segretario di una cooperativa, ho lavorato in una segheria, ho fatto il venditore di calcolatrici. Ma evitavo d’impiegarmi. Quando c’era l’occasione d’un posto fisso sfuggivo, perché il mio sogno era andare a Roma a scrivere per il cinema. Credo di essere stato l’unico, della nostra generazione, ad andare a Roma non per fare il regista, ma per fare lo sceneggiatore. Sei mesi di fame, poi ho scritto sette film in un anno, tre Salgari, due Carolina Invernizio e un paio d’altre cose. Mi feci prestare un copione per imparare a scrivere professionalmente. Ma erano altri tempi. Si facevano 250 film l’anno. Appena avevi un po’ di talento... Incontrai Migliacci, che non era nessuno. Mangiavamo dalle monache. E lui mi presentò uno sceneggiatore che invece andava per la maggiore, Giuseppe Mangione: ha lavorato anche per Germi. Mangione mi portò da un produttore, Venturini, e gli raccomandò: “Fai lavorare questo ragazzo.” Da Venturini incontrai lui. B. Be’, tra me e te ci corrono un 23 o 24 film, che io avevo già fatto come sceneggiatore. Ho incominciato il cinema a Torino. L’attività teatrale amatoriale tra Milano e Firenze finì con una scelta professionale: andai in compagnia con Gandusio, come segretario, ma in realtà ero assistente, non dico alla regia, perché non esisteva questa funzione, ma cercavo per Gandusio copioni introvabili, frugavo tra i testi di Zambuto, Antonelli, Zacconi, rincorrevo vecchi suggeritori di buca che avevano conservato delle copie. Eravamo partiti da Firenze verso il nord, quindi ci siamo trovati proprio nella Repubblica di Salò, quasi tagliati fuori. Lì abbiamo incontrato un produttore avventuriero, Luigi Giacosi, che poi è stato direttore di produzione per Rossellini, Fellini, Germi, e questo qui scritturò tutta la compagnia in blocco per fare due film a Torino. Diventai segretario d’edizione per Il processo delle zitelle di Borghesio, tra il ’43 e il ’44. Io non avevo mai visto in faccia Giacosi. Uno dei primi giorni, mentre assistevo alle prove di scena prima di girare, s’avvicina uno, vestito un po’ male, e mi chiede che cosa ne penso. Io dico sinceramente: mi sembra una boiata, perché l’è tutto finto, e si vede e si sente. Mi dice: “Vieni questa sera all’Hotel Sitea.” Era Giacosi. Al Sitea mi mette in mano il copione: “Ti ho preso una camera. Riscrivilo nei punti dove pensi che è finto.” Nella notte feci quello che potevo, pensando a Borghesio, era tutto quello che mi veniva in mente. Diventai immediatamente assistente alla regia, e incominciò una collaborazione molto lunga. E andai a Roma con lui.
Scusi, c’è una fucilazione da girare? De B. Be’, intanto c’era stata la Liberazione. Per tutti. B. Io ho filmato con Borghesio tutta la Liberazione a Torino, tra fucilazioni, impiccagioni e atti innominabili. Un materiale che poi ho sotterrato personalmente. Avevamo due camioncini, uno del partito socialista, con cinepresa e operatore, diretto dal torinese Fernando Cerchio, regista e amico, scortato da due partigiani armati che stavano seduti sul parafango anteriore; e uno del partito liberale, con cinepresa sul treppiede e operatore diretti da Borghesio, anche lì con due partigiani in vedetta. S’incominciò dalla prima alba della Liberazione. Abbiamo beccato l’impiccagione di Solaro, che era stato il federale di Torino. Terribile, perché si ruppe la fune, in corso Valdocco, mi pare, dove c’erano quegli alberi alti alti. E lui crollò a terra, rompendosi la gamba. Incominciò a urlare invocando la Convenzione di Ginevra, e una certa tradizione che quando si rompe la corda interviene la grazia. Lo ributtarono su. E non dico che cosa successe su quel cadavere, botte, calci. In quello stesso tratto di strada Solaro aveva appena fatto impiccare una decina di partigiani. La città era stremata da un anno di terrore. Era esplosa. Non si poteva fare niente per fermarla. Noi giravamo a documentare. Tutto. Sul Po galleggiavano centinaia di cadaveri. Una cosa irreale. Borghesio, che aveva in mente di riprendere tutte le situazioni ed era una persona moderata e gentile, si lanciò improvvisamente con un gruppo di partigiani all’attacco della caserma Cernaia, mescolandosi alla battaglia. E alla sentinella partigiana chiese se c’era una fucilazione da girare. “No, ma ve la facciamo subito, se aspettate un momento,” disse il partigiano. Borghesio ebbe il controllo per rispondere che, grazie, ci saremmo arrangiati con le riprese alle Nuove, e infatti s’andò a fare una carrellata sul corridoio, dove io ero stato cinque giorni preso dai tedeschi quando abitavo al Sitea a lavorare a quel film. Si passava con la cinepresa seguendo i partigiani che chiedevano, alla finestrella d’ogni prigione: tu che hai fatto? Ladro. Assassino. Rissa. Stupro. Guai a dire “politico”. Siamo tornati alla Cernaia, e la fucilazione c’era, questa volta. Fecero scendere uno con l’impermeabile chiaro, spavaldo, che fumava vistosamente, e un altro invece cupo. Avevamo due macchine, la Harriflex piccola la presi io, volevo fare le riprese dal sole, e chiesi di farli spostare. E poi... girammo. Fucilazione e colpi di grazia. Tutto. Davanti a quei corpi mi ricordai di un paio di ragazze che erano state trascinate dai fascisti dalla stazione a piazza Castello col cartello appeso al collo: spie. Erano nude, solo con lo slip, bruciacchiate dappertutto. E furono poi fucilate. La gente ormai era scoppiata. Aveva vissuto vessazioni d’ogni genere. Aveva perso il controllo.
Meglio parlare di cinema. De B. Io non ho vissuto esperienze di questo genere. Semmai un’avventura... Per non andare in Germania con la classe e alcune mamme per “esperienza nei campi di lavoro” (ero nell’organizzazione Tod) scelsi di fare lavoretti, in genere fasulli, per i tedeschi, pontificazioni mai finite, cose del genere. Quando a Milano Mussolini fu impiccato mi sono trovato a Schilpario, in montagna vicino a Bergamo, con una banda d’impiegati, lavoratori e il capocantiere, a venire giù verso il paese mentre con una mitragliatrice stavano facendo fuori una decina di Brigate Nere che avevano dichiarato di volersi arrendere. E noi ci siamo trovati in mezzo. Ma insomma, meglio parlare di cinema.
B. Be’ io restai a Torino, a lavorare agli stabilimenti Fert, di cui Borghesio era in parte proprietario, con Capitani. Ho fatto il doppiatore, il rumorista, il dialoghista. Viaggiavo tra Cinecittà e gli stabilimenti Fert. Venne Lattuada a fare Il bandito, con De Laurentiis, che si era messo in società con Rovere. Passò Rossellini. Ma non bisogna immaginare una vita mondana, a Torino. De B. Io invece a Roma stavo proprio nella dolce vita. I caffè di via Veneto erano il luogo d’incontro di tutti. Finita la guerra le generazioni del cinema ricominciarono a frequentarsi lì, e anche noi, dopo che c’eravamo conosciuti da Venturini. B. Veramente m’ero ricordato io di te quando dovevo fare la revisione delle Ragazze di San Frediano, ch’era il ’54. E mi son ricordato perché anche questo ragazzo che avevo conosciuto da Venturini era toscano. Era amico di un mio cugino. De B. E di lì son passati ormai quasi cinquant’anni. B. Nella coppia lui è quello che si occupa dei conti, dei contratti, delle cose più pratiche. C’è un gioco delle parti che ha funzionato subito. Ma quando scriviamo, lui è quello che sta zitto se non gli va qualcosa. Io allora passo all’attacco e cerco di tirargli fuori il rospo. Nelle coppie di sceneggiatori l’altro è il primissimo contatto col pubblico. Vede subito come va una battuta, se un personaggio vien fuori. Un pubblico molto consapevole ed esigente, naturalmente. De B. Da adesso però va avanti lui a raccontare, perché eravamo sempre insieme, e allora... Littorio Fez, i singhiozzi di Rustichelli e l’assegno di Fellini. B. Allora. Le ragazze di San Frediano l’abbiamo fatto per Valerio Zurlini, mio amico d’infanzia. Io dopo la guerra avevo lavorato con altri sceneggiatori, Age, Scarpelli, Metz, Marchesi. Vittorio Metz era unico. Prendeva la simpamina al mattino, col caffè, e filava dritto fino alle sei del pomeriggio, poi si fermava, come una macchina, crollava a metà di una frase e Marchesi doveva riaccompagnarlo a casa. Erano personaggi unici, francamente. Metz era ancora fascista. Si faceva chiamare Littorio Fez. E loro non sopportavano il neorealismo. Non ne volevano sapere di cose diverse dal comico, la satira, la farsa. Mi consideravano il poeta del gruppo. Mi appassionavano le biografie, le vite di grandi personaggi, grandi musicisti. Feci un Napoleone, Giuseppe Verdi, Schubert e Casa Ricordi insieme ad Age e Scarpelli. Lavorai anche alla biografia di Puccini diretta da Carmine Gallone. Le musiche originali le fece Rustichelli. Non dimenticherò mai la reazione di Rustichelli alla prima proiezione, quando Toscanini, eseguendo la Butterfly, getta la bacchetta e dice “Basta, fin qui arrivò Puccini, io mi fermo,” e vidi Rustichelli alzarsi di scatto e buttarsi contro il muro. Mi avvicino: stava piangendo! Ma dei singhiozzoni... Rustichelli era un vero compagno di lavoro. Era un musicista che frequentava gli sceneggiatori. Mi ricordo una sera in osteria, con Pietro Germi. Cercavamo di mettere le parole di una celebre canzone siciliana, per Il cammino della speranza. E venne fuori: “Vitti ’na crozza suuu-pra nu cannuuu-u-u-ni.” Lavoravamo per la Lux di Gualino. Vedevo Fellini sceneggiatore che entrava da Rovere e, trac, sentivo l’assegno, e pensavo: speriamo che non abbia portato via tutto. S’andava anche noi prima di Natale a prendere qualche anticipo. Ai produttori piaceva tenerti in mano. Schubert lo scrissi a Capri e Positano, mandato da Rovere per la Lux. Ai produttori italiani piaceva molto possederti e dirti: vai lì, non pensare a niente, scrivi. Lo facevano De Laurentiis, Ponti, Rizzoli, Gualino. Pensare che gli appartenevi era importante per un produttore. Noi eravamo i prediletti di Rizzoli per la
lettura dei soggetti. Incominciammo a lavorare per lui nel terzo Don Camillo. Un industriale molto intelligente, Rizzoli, per me una figura importante. La sua intelligenza riempiva le lacune della sua cultura. Credo di averlo conosciuto bene Rizzoli. Era intimorito dall’arte. Ma ne era anche attratto. Sono arrivato a credere che non gli andava giù il successo di Fellini, che pure gli faceva incassare dei soldi.
La dolce vita è ’na schifezza. Eravamo da lui quando arrivò Peppino Amato a ingiungergli di fare La dolce vita. Mi ricordo bene perché stavamo parlando, io Piero e Rizzoli, del culo della Granata, fenomenale (“il commendatore è in riunione” avevano detto le segretarie ad Amato). Si spalanca la porta e arriva Amato col copione. Lo brandisce sotto il naso di Rizzoli, che si ritrae. “Questo film fa schifo,” dice Amato. “M’ha fatto cagare, m’ha fatto vomitare, e se lo leggi anche tu vomiti anche tu. E allora tiè...” e tirò il malloppo contro il muro sopra la nostra testa. Poi s’avvicina a Rizzoli: “E proprio per questo tu lo devi fare, bisogna farlo, e noi lo faremo!” Rizzoli con Fellini fece anche 8 e 1/2. Be’, prima stavo dicendo delle Ragazze di San Frediano. Quando Zurlini legge le prime scene che gli avevo scritto, mi spiega che bisognava accelerare i tempi di produzione. E così penso a De Bernardi. Io stavo lavorando a quella sceneggiatura per la protesta di un’altra versione scritta dall’autore del romanzo, Pratolini, e la Suso. Da quando presi in mano io la cosa Pratolini mi tolse il saluto, e non so perché. Con De Bernardi si fece subito dopo un capolavorino, che è Amici per la pelle di Franco Rossi, su due adolescenti molto diversi di quegli anni.
Dal panettiere alla supercazzola. La nostra osservazione sociale era attentissima, a quel punto. Lo è anche oggi. Mi rendo conto adesso che siamo nati per questo. Infatti, ora che mi chiedo che cos’ho fatto fin qui, e parlo per me, credo di aver sviluppato la mia vocazione alla biografia della gente che ho incontrato, che abbiamo incontrato, per trasferirla al cinema in certi personaggi. Sono il biografo di quei personaggi. Se c’è un panettiere da fare, noi andiamo e saccheggiamo la vita di dieci panettieri. Facciamo un salto negli anni ’70: Amici miei. Be’, telefona Germi, che era amico di tante avventure e tanti film, dall’Uomo di paglia a Serafino, ma sempre molto brusco, introverso, e dice: vengo lì per un film. Arriva, si siede e tace. Dico, Pietro hai qualche idea... Dice: no. Faceva sempre così. Il suo metodo, che è il migliore di tutti, era arrivare col nulla. E, senza termini di tempo, esplorare, aspettare, parlare delle cose. Ma quella volta, dopo il primo silenzio, tira fuori un libro mai pubblicato intitolato Adani e Caprai, due soldati che nel ’17, durante la guerra, disertano, vengono ricercati, vivono alla macchia rubando, in Emilia si mettono dalla parte del socialismo rurale e alla fine muoiono come ladri di polli. Amici miei nasce da lì, dall’intensità dell’amicizia che usciva da quel racconto inedito. Perché parlando di questi due con Germi, abbiamo dovuto tirar fuori persone reali per somiglianza o contrasto, e io raccontavo aneddoti di amici miei che facevano ridere e interessavano, e pensavamo che se si rideva a tavola di questi personaggi si poteva ridere anche al cinema, con un modo adeguato
di racconto. Avevamo ragione. In Amici miei non c’è quasi nulla d’inventato, o meglio c’è la trasformazione della verità in una verità più marcata, più rappresentata. Così abbiamo spesso lavorato io e De Bernardi per la commedia. Molti personaggi sono poi un insieme di due persone, altri sono invece “puri”. Il conte Mascetti di Tognazzi non è altro che Raffaello Pacini, che faceva davvero la supercazzola ai cardinali: lui aveva ereditato un miliardo e mezzo di lire nel ’21, era proprietario di un intero paese, e se li era sputtanati tutti i soldi, e alla fine la moglie e la figlia si ritrovarono ad andare in giro nel loro paese in mezzo alla neve con le scarpe completamente aperte, e lui le sfotteva: oh, sono arrivate le sciatrici! Il personaggio di Moschin veniva da un architetto fiorentino con la barba, romantico, burbero. Le biografie sono avventure straordinarie. Frugare negli epistolari, scoprire verità umane... essere convinto, come sono io, che Verdi fu l’assassino della moglie e dei due figli, un vero mascalzone, e lo dico riferito anche all’ultimo film che abbiamo fatto con Castellani sulla vita di Verdi. Ma tutto il nostro cinema è così. L’uomo di paglia, quell’operaio che ha l’avventura con una donna poi suicida, e si ritira quando torna la moglie dalle vacanze, be’ anche lì per noi fu la ricostruzione di una vita, di persone che avevamo incontrato, anche se poi Germi era uno che rifuggiva totalmente dalla sua personale biografia. Credo che in questo senso i nostri film più riusciti sono proprio Amici per la pelle con Rossi, l’ambientazione di Guendalina di Lattuada, che avevamo scritto però per Zurlini, il nostro contributo a C’era una volta in America di Leone, credo anche Per grazia ricevuta con Manfredi e mi piace Compagni di scuola; ecco Io e mia sorella di Verdone è una bella commedia, e poi naturalmente Amici miei, perché la vena del sarcasmo ci assomiglia e ci riesce bene.
Sceneggiare i contratti degli attori... Noi in fondo non ci siamo gettati nella mischia della commedia all’italiana, o nel cosiddetto boom, anche perché per esempio io sono uno che non si rende conto bene delle cose quando succedono. Ho visto mia madre gettata dal treno da un tedesco, e ho dovuto accettarlo lì per lì. Sopportavo la fame, ma quasi non ce l’avevo più quando uscivo dall’albergo Croce di Malta di via Borgognona, sentendo dalle finestre i piatti tintinnare e le voci, e tiravo dritto. Frequentavamo De Sica e Zavattini nei primi anni ’60. Abbiamo partecipato alle battaglie di quel tempo per esempio con Matrimonio all’italiana. Quando con la soluzione di Fanfani si perse praticamente la battaglia del divorzio, pensammo che ormai non c’era più niente da fare. A un certo punto diventò una necessità criticare la sinistra da sinistra. Perché la reattività era scesa, e il fatto che pian piano anche la Dc avesse aperto il “regime” ci toglieva obbiettivi di critica, di satira. La commedia all’italiana deriva da due cose: dal neorealismo, e questo lo sanno tutti, e dagli attacchi della Democrazia Cristiana al cinema neorealista e poi a quello di satira sociale. Perfino la censura ha spronato il cinema italiano. Poi arrivò il ’68, e lì bastava essere giovani per fare cinema. Proponevi e lavoravi. Io invece, se devo guardare un mio limite, facendo un consuntivo, è di aver fatto poche proposte perché sommerso dalle offerte. La proposta la facevamo invece cambiando l’offerta. Spesso andava così, e un po’ va ancora così: qui c’è un titolo e ci sono degli attori, si deve fare un film così e così. E noi dovevamo inventare tutto. Da cui quel detto: sto sceneggiando i contratti degli attori. Il soggetto era Montesano o il comico del momento. Perfino con Verdone, negli anni ’80, per noi è andata
così. E questo è anche “merito” della televisione. Nessuno diceva, e dice, a Verdone che cosa fare. Ci mettiamo lì con lui e si parte da una storia, ma a volte, come dicevo prima a proposito di Germi, è bello anche partire da un gruppo di persone, di amici, che non ha niente. C’è una specie di feeling, tra le persone, che pensa a spingere le cose, le idee e poi la storia e i personaggi. Quello per esempio che succede in questi giorni col Chiambretti, per il film che stiamo scrivendo.
Una battuta da un milione e mezzo di dollari. Noi alla fine abbiamo sempre pensato a fare narrativa col cinema, a costruire una storia anche partendo dal nulla. Insomma finora s’è fatti 178 film. Luigi De Laurentiis, che dice che i film assomigliano ai suoi autori, sostiene che per noi è particolarmente così. Io sono nato cantando. E l’atteggiamento verso la vita è stato sempre divertito, un po’ sfottente, anche se poi non ci manca il tragico. Anche in C’era una volta in America ci sono questi elementi. Altra grande storia d’amicizia. Con Leone dovevamo fare anche il film su Leningrado. Scrissi io al Cremlino proponendo un grande film su Leningrado. Era una specie di lettera d’intenti. Allora c’era Brežnev. Leone poteva fare qualsiasi cosa. Era l’unico regista italiano, e uno dei pochi nel mondo, che avesse quella libertà. I russi volevano un colossal, ma mai avrebbero dato in mano un progetto del genere a un regista americano. Era impossibile prendere quella grande storia russa e darla in mano a Coppola, per esempio. E Leone era perfetto. C’era una volta in America aveva conquistato il mondo. Mi ricordo quando abbiamo presentato la sceneggiatura tradotta a De Niro. La sapete già questa storia? Perché costò molto cara, una mia battuta. Allora. Lo script nel film fu rispettato alla perfezione. Veniva dal libro di Harry Grey, Mano armata, ma era un pretesto. E De Niro non cambiava una battuta. A noi sembrava impossibile. Ma sei sicuro che va tutto bene, chiedevamo. E lui: è okay. Be’, quando arriva a Roma, vedo De Niro che assomiglia a un garzone di panetteria. Legge, discute, si accorda. Questo ragazzotto... C’era il problema delle due età dei protagonisti. Da giovani e da vecchi. E io, conoscendo il metodo di De Niro, che per esempio chiedeva tempi lunghi tra le riprese per ingrassare o dimagrire, ho la prontezza di dire: be’, questa volta non è che possiamo aspettare trent’anni finché invecchi. Lui mi guarda, e fa un sorrisino. È costata un milione e mezzo di dollari quella battuta: De Niro chiese alla produzione due mesi tra le riprese della prima parte del film e quella della seconda. Una catastrofe. Ma poi i risultati, quel misto di amarezza e sorriso che c’è nella sua faccia... È la stessa cosa che troviamo nella Ragazza con la valigia, ci assomiglia molto.
Meglio i difetti delle virtù. Io sto con quelli che pensano che una delle ragioni, se non della bellezza, del successo del film, è la sua simpatia. Di tutti gli elementi. Da qualche tempo ormai riesco a capire subito se un film è simpatico o no. Per esempio, I picari di Monicelli è venuto un film antipatico, perché non era sincero, e lo dicevo sempre a Mario mentre lo scrivevo. Era assurdo prendere Montesano per fare uno spagnolo. Amici miei era evidente che veniva un film simpatico, perché nasceva dai difetti, non dalle virtù. A chi gliene frega delle virtù? Noi abbiamo scritto e
fatto il film perché amavamo quei difetti. Le virtù passano, i difetti restano.
8 Questa mattina Miriam non parla. Finge di non vedermi. L’ho appena rimproverata. Per non allungare la strada di mezzo chilometro, rischia di lasciarmi senza pastiglie. O non mi porta il giornale. “Non tornare se non passi in farmacia,” le ho detto, e adesso mi tiene il broncio. Ogni tanto scatta questo braccio di ferro tra noi. Lei vuole sentirsi più forte. E naturalmente lo è: mi tiene in pugno. Non potrei vivere qui, da sola, senza il suo aiuto. Sono dodici anni che resiste. Quando chiamo mia figlia e le dico: “Basta, ho detto a Miriam di non tornare più! ”, sento il panico nella sua voce. La mia indipendenza è un vanto per mia figlia, che mi esalta con zii e nipoti, e con le sue amiche, tutte separate, pubblicamente fiere della loro condizione, intimamente disorientate dalla solitudine e dal sospetto di avere fallito. Così io, con la mia indipendenza, divento l’involontaria portabandiera di questa disfatta della famiglia. Mio povero Francesco. Dove hai trovato la forza di stringermi la mano come Ercole prima di lasciarti andare. So in realtà che l’orgoglio di mia figlia nasconde l’inconfessato terrore che io decida di trasferirmi da lei. In fondo, la casa dove abita è ancora intestata a me. Pazienza. Andrò da sola in farmacia e per il giornale. Miriana Ducovic, diventerai vecchia anche tu. Questa mattina non va, proprio non va. Non ho più voglia di andare a Pescara. Oggi telefono e dico che mi sono rotta una gamba. Questo venticello di giugno... Anche se ho un sibilo alle orecchie come una sirena, mi piace sentire la pressione del vento sul padiglione, e il suono cupo, che batte dolcemente e si modula proprio lì, dove il silenzio si rompe. Ma poi, basta uscire dal cortile, e in strada il suono diventa rumore. Uscendo dal tendone dell’edicola aggiro un cartone enorme poggiato a terra, e vedo la faccia di Sordi che mi arriva al petto. Sono tre mesi che continuano con le cassette dei suoi film. Lui non ha avuto i miei problemi per la vecchiaia, si era creato il suo “harem”: Pierina che gli cucinava; la sorella Aurelia che gli faceva da madre; e la fedelissima Nunziatina, compagna di oratorio di Aurelia. Probabilmente, avevano fatto voto insieme. La devozione di queste tre donne si presta alla satira, ma è anche una sorta di monumento per un mondo estinto. Con quella spavalda sicurezza, Sordi esibiva il vizio infantile del maschio italiano diviso tra moglie, amante e madre. E inconsapevolmente lo ratificava. Alla fine degli anni ’60 ho partecipato a quei collettivi di donne nei quali si parlava di rivolta contro i mariti. Povero Sordi, se avesse sentito che cosa dicevano di lui e dei suoi personaggi. Ha evitato il matrimonio per un calcolo preciso. Sposandosi, avrebbe dovuto limitarsi a un solo sostegno, una sola donna, che avrebbe potuto crollare in qualsiasi momento; e lui allora non avrebbe saputo che cosa fare. Così, di sostegni se ne era assicurati tre. Quanto ai figli, poi... Aveva bisogno lui di sentirsi sicuro e protetto in ogni momento, per concentrarsi sul lavoro e coltivare il proprio successo. Era un bambino. È morto che era ancora un bambino.
ALBERTO SORDI Sembra ch’è passato un giorno Questa storia del mio desiderio di successo... Non diciamo successo. Ero stato avvertito da mio padre, che non mi ha mai impedito niente devo dire (e neanche mia madre). È lui che, per primo, mi ha fatto capire l’antifona. Mio padre era professore d’orchestra, si era diplomato a 14 anni a Pesaro, ma aveva preso uno strumento d’accompagno: il basso tuba. A quell’età si pensa a essere un primo violino, no? Tutti corono ar protagonismo. Anche oggi; sì, sono aumentate le orchestre, ma insomma, non c’è molto in giro. Quello di mio padre però era uno strumento indispensabile, anche se io non lo capii subito. Quando mi portava al teatro dell’opera, e mi teneva lì sotto la buca dell’orchestra (ero un po’ la mascotte di tutti), pensavo: aho, ma non suona mai papà? Poi ogni tanto saltava su: poh, poh, poh, e via. Da ragazzetto io m’ero fatto l’idea di crescere, sposarmi e farmi una famiglia, non pensavo ai problemi del successo facendo il lavoro dell’attore. Mio padre invece ci pensava. Dice: vedi, ho avuto la fortuna di essere indispensabile, perché siamo praticamente in due in tutta Italia, uno a Milano e l’altro a Roma, e quando Toscanini dopo la guerra riformò l’orchestra della Scala a New York chiamò a me, perché l’altro basso tuba era impegnato a Milano con la filarmonica; vedi che a un certo momento si possono avere delle soddisfazioni, anche se non sei il primo violino, ma comunque c’hai la certezza di lavorare sempre. Allora, dice ancora: tu vuoi fare l’attore, bene; ma ricorda, ci sono altri, tanti altri, che vogliono diventare primi attori; se tu a una certa età non hai raggiunto un certo livello, e c’hai una famiglia, dei figli, be’ guarda fjo mio ch’è umiliante, molto umiliante non avere successo nel lavoro che vuoi prendere tu. Insomma mio padre mi avvertiva per me, ma mi diceva anche che il successo è invecchiare bene senza successo. Capito? E io non ho mai fatto delle mattane per la celebrità, ho sempre vissuto nella mia famiglia d’origine, non mi è mai piaciuto apparire e tutto il resto. Per me forse è mio padre che ha inventato l’umiltà, era un uomo di valore, ma molto umile, e aveva rispetto per tutti. E questo è il successo per me. Capito?
Una lira per il cinema. Poi, è chiaro che la mia passione per il cinema ha fatto il resto. Mia madre era molto appassionata del cinema. Si andava spesso. Quando vinsi il concorso dei “Bambini belli” il primo premio per me fu una tessera gratis per il cinema, valida per tutta la famiglia. Quindi tutte le sere stavamo là. Una volta cresciuto, la mia preoccupazione era trovare una lira ogni giorno per andare al cinema. E allora risparmiavo su tutto. Mi attaccavo al tram, sul predellino, per non pagare, rinunciavo a comprare qualsiasi cosa. L’importante era mettere insieme questa lira ogni giorno per il cinema. Il primo film che ricordo, quando ero proprio piccino, era con Ermete Novelli. Un film muto, naturalmente. Sentimentale, perché quello era il genere che piaceva a mia madre. E c’era poi l’avventura, che invece mi prendeva a me. Non era Pirata. Era un titolo simile. C’era lui sempre con la spada. Ecco, Il Corsaro. Negli anni ’30 muovevo i primi passi come attore del Teatro delle Marionette, che era composto dai balilla come me. A 13 anni, nel ’33, la domenica battevo la provincia e durante
la settimana mi dividevo tra lo studio e le prove. Non ero un balilla eroico. E più che la guerra mi interessava l’idea di diventare ricco. Il motto era “ridere patriotticamente.” Un professore di ginnastica, poliglotta, musicista, scrittore, stendeva i testi che portavamo in giro. Dove oggi c’è l’Accademia di Danza, all’Aventino, facevamo gli spettacoli. Veniva a vederli anche Mussolini. C’era un palcoscenico enorme, che è stato il mio primo palcoscenico. Rolando Ricci, presidente dell’Opera Nazionale Balilla, era il nostro protettore. Insomma incominciavo praticamente come “attore di giro”.
Udienza dal duce. Un giorno arriva un ex ufficiale dei bersaglieri, uno che era stato in Libia e aveva fatto la Grande guerra. Lui c’aveva un sogno, un progetto che sembrava pazzesco e poi è praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto sulle autostrade di oggi: pensava a tanti pullman da gran turismo con stazioni di posta, tipo Pavesini. C’aveva in mente come una grande statale RomaMilano con posti di sosta organizzati dalla stessa società dei pullman, dove potevano fermarsi anche le auto in viaggio. Allora, gli mancava soltanto il benestare di Mussolini. E questo tipo sapeva che io ero balilla e frequentavo l’ambiente. Noi eravamo un po’ privilegiati. Dice: se riesci a farmi parlare col duce, c’è un grande regalo per te, vedrai. Io ci speravo. Lo dico a Ricci, che riesce ad avere un’udienza. E andiamo, una mattina, a Palazzo Venezia, dove l’usciere Navarra ci fa entrare nella Sala del Mappamondo. Enorme, lucida. E io: madonna mia bella, fa che vada tutto bene e che mi prendo il regalo. Salutiamo romanamente, tutti in divisa. Il tizio si fa avanti, mostra fogli e mappe a Mussolini, spiega che è un piano laborioso che darà lavoro a centinaia di persone. Mussolini ascolta, guarda rapidamente i fogli. Dice: ma che cosa chiedete? E il tizio: che venite per la posa della prima pietra. Il duce dà ancora un’occhiata alle carte, fa la sua faccia, arrotola i plichi, li restituisce e dice severo: “Andate. Ci sarò per l’ultima.”
Imboscato al Continental. E così non ho avuto niente. A scuola, all’Istituto di avviamento commerciale Giulio Romano, mi rimandavano a settembre per tutte le materie, ma soltanto perché m’impegnavo in giro con la compagnia. Se fossi andato a scuola regolarmente tutto sarebbe filato liscio. Amavo l’italiano e la matematica. Agli esami di settembre mi facevano i complimenti. Studiavo ancora, quando mi sono presentato a Milano per fare l’Accademia dei Filodrammatici. Scrivevo fiabe per bambini, c’avrò avuto un 15 anni. La Fonit Decca lesse le fiabe e mi chiamò a Milano per conoscermi, perché avevano intenzione di incidere una serie di cose del genere. Bisognava stare un po’ di tempo a Milano, perché c’era anche una parte musicale e l’orchestra Semprini interrompeva le registrazioni per fare delle tournée. Dissi: bene, così frequento l’Accademia. Che poi è venuta fuori la storia, che ormai sanno tutti da quando mi hanno dato il diploma honoris causa quest’anno, che mi bocciarono all’esame di dizione. Sarà stato metà degli anni ’30. E alloggiavo al Continental. Cioè, siccome conoscevo un po’ di francese e mi avevano mandato dal portiere del Continental, io l’aiutavo fino al cambio di
notte, e poi me ne andavo all’Accademia, e lui mi teneva lì a dormire. Così partecipavo a tutte le feste importanti dell’hotel, mi cambiavo e m’infilavo tra gli ospiti. Mi ricordo la contessina Palazzi, un fiorellino. Dice: ma lei dove abita? E io: qui al Continental, signorina. Così, ballavo con questa bella gente, e tutto il resto...
Guèra e fèro. Feci le fiabe con la Fonit. Le matrici ormai nun se trovano più, da nessuna parte. E frequentai l’Accademia per un paio di mesi, che allora era l’unica prestigiosa in Italia. Non c’era la Silvio d’Amico né quella del Piccolo. Non sapevo ancora se volevo fare il cinema o il teatro. Ma ero certo che volevo fare l’attore. Si diceva che Milano era la città del teatro e che il pubblico era generoso. Dopo due settimane che ero all’Accademia l’insegnante di dizione, la signora Emilia Varini, mi chiama. Fa: ragazzo mio, tu non ti applichi, sei così indolente, non si riesce a cambiarti quell’inflessione dialettale. Ma quale dialetto, dico, questo è un accento romano de’ Roma. Noi diciamo guèra e fèro. Se dicessi guerra e ferro non mi sentirei più io. Insomma, io non potevo cambiare. Mi piaceva parlare come la gente, non come volevano sul palcoscenico. Così ho puntato sulla mia spontaneità. E loro poco dopo mi hanno espulso. Di neorealismo ancora non si parlava. La mia fortuna è stata che proprio qualche anno dopo ho potuto lavorare come volevo, senza parlare il “linguaggio degli attori”, quelli che poi per fare certi film si sarebbero trovati impacciati. Ho capito che bastava che mi guardassi intorno, prendevo un tipo qua e uno là, e si scriveva la sceneggiatura con Pinelli, Continenza, Maccari, Amidei e poi Sonego e tutti gli altri, ma anch’io naturalmente facevo la mia parte. E a un certo punto ho proprio capito che volevo formare un affresco della società italiana per le generazioni che sarebbero venute dopo.
La lotteria di Tripoli. Tornato a Roma m’iscrissi all’Accademia Lirica di via Gregoriana, volevo studiare da basso, ma quindici giorni dopo l’inizio delle lezioni, alla Metro Goldwyn Mayer bandirono il concorso di doppiatori per Stanlio e Ollio. E io me presentai, ma senza speranza, perché c’erano più di 200 concorrenti, molti attori già fatti. E invece mi presero a me. C’era una canzoncina da provare, io la cantai, e dissero: ecco la voce. Accidenti, dico, aho ce l’ho fatta. Porca miseria, non mi sembrava vero. È stato dal doppiaggio che poi ho allargato all’avanspettacolo con i primi successi, Muraglie, Fra’ diavolo e gli altri. Era il 1936. Un altro sistema di vita. Il consumismo non si sapeva neanche che cosa fosse. Le automobili erano pochissime. La gente si adattava alle proprie condizioni. E questo spirito di adattamento faceva tutti felici, perché una piccola cosa in più era già un evento. Quando la domenica c’era un po’ di carne per il sugo era una festa. Questa povertà de’ oggi non ha niente a che vedere con quella povertà de’ ieri. Tutti avevano una casa, non c’era l’accattonaggio, la gente non dormiva per terra nelle strade. Dice: eravamo in pochi. E vabbè, eravamo in pochi ma l’ordine era questo qui. Non c’erano certi odi di classe che ci sono oggi. Poi l’automobile ha appagato i sogni e i desideri dei poveracci. Negli anni ’30 c’era la lotteria di Tripoli. Si vinceva un milione, che era come dei miliardi di oggi. Vinse uno che si chiamava Giacomini.
La prima cosa che se fece fu l’automobile. Roma era senza automobili. Al massimo passava Mussolini che andava a Ostia con l’Alfa Romeo. Massi, qualche nobile c’aveva l’automobile. Chi vince oggi invece c’ha una disgrazia davvero. Non è preparato a tutti quei soldi, in mezzo a tutta ’sta disumanità, ’sta cosa de arrivismo... È pericoloso il successo per chi non ha una preparazione morale. Il mio fu un successo clamoroso. Negli anni ’50 ero solo a fare tutti quei film. A volte sei, sette in un anno. Ma questo è stato possibile perché il successo l’aspettavo, io. Ero preparato al successo. Capito? Se arriva così improvviso può fare disastri. La mia invece era una vocazione. Mi sono impegnato per quello. Per me non c’era altro. Io volevo diventare un attore. Dovevo diventare attore. Volevo anche dimostrare a mio padre che la mia lotteria la sapevo vincere.
Imboscato con la cetra. Per far contenta a mia madre presi il diploma da ragioniere. E mi iscrissi come allievo ufficiale, intanto ch’era ’ncominciata la guèra. E mio padre mi disse: alt, aspetta un momento; andare di leva adesso non è la stessa cosa, a parte la questione dell’incolumità, insomma la guerra non è una vita facile. Io non ero nato per fare l’eroe. Dice: tu devi continuare la tua strada, devi stare a Roma; conosci la musica, io parlo col maestro dell’81° Fanteria, Castrucci, che è una brava persona, così se ti prendono come allievo musicante alla banda, tu non te movi da qui, è come se fossi un allievo ufficiale perché porti la cetra al braccio. Infatti andai sotto le armi a Roma, e quando in caserma un tenente o un maggiore mi vedevano nuovo, mi chiamavano: ehi senti tu, ma poi vedevano la divisa con la cetra e dicevano: oh, scusa, non avevo visto che sei maestro. Questo, elargendo un po’ di biglietti al direttore Castrucci, mi permise di fare con Mattoli la Za Bum, nel ’42 e poi Chi lo dice, e così via. Era l’unica forma di teatro che funzionava a Roma in quegli anni terribili, il varietà. La gente arrivava alle due e mezza del pomeriggio e se ne andava alle cinque, perché c’era il coprifuoco. E i teatri, il Quirino, il Quattro Fontane, erano pieni zeppi. Tutti i giorni. La gente che voleva farsi quattro risate... capito? Con i tedeschi in casa e tutto il clima de’ violenza e tutte cose.
Ar coprifuoco coi salami. Quando ci fu via Rasella stavamo in scena io e Benti al Quattro Fontane e fu un botto tremendo, noi e il pubblico pensavamo si trattasse di un bombardamento; abbiamo chiuso le saracinesche, siamo rimasti ad aspettare e abbiamo visto poi tutta la gente che avevano preso che veniva giù da via del Tritone. Terribile. Dei bombardamenti, che poi effettivi saranno stati pochi, e noi in centro stavamo bene, ricordo i ritrovi al coprifuoco. Io, Agus, Benti, Mazzarella e gli altri abbiamo molto goduto per questi inviti che ricevevamo. C’erano delle vettovaglie straordinarie, pensando che questa guerra non sarebbe mai finita. Salami, prosciutti, ogni genere di formaggio, una quantità per la Guèra dei Cent’anni. Si andava a fare il coprifuoco in queste case ben arredate, con donne bellissime, e si facevano certe magnate... Capisco che poi c’era sofferenza, vere tragedie, ma non ho mai dimenticato queste serate. Ho dimenticato invece i luoghi. Ricordo un po’ i nomi, Alberti, Amati. Aprivano ’ste cantine, fjo mio, era una roba... che poi io ho messo in Polvere di stelle. Tutti a casa nasce da uno spunto mio, un
episodio che accadde proprio all’81° Reggimento Fanteria: il comunicato di Badoglio sull’armistizio fu ascoltato soltanto dal cuoco che c’aveva la radio accesa. I comandi non erano stati avvertiti. Così i tedeschi sono entrati subito nelle caserme. Era folle. Dicevamo: pronto comando, aho i tedeschi se so’ alleati cogli americani, ce sparano addosso tutti!
Arriva il neorealismo. Alla fine della guerra arriva il neorealismo, e per me era fatta. Sono sempre stato un po’ autore di me stesso. Sapevo che il pubblico poteva accettarmi com’ero, e che quella direzione era il massimo delle mie possibilità. Tutti quei personaggi che avevo incontrato e incontravo in giro, ne parlavo con De Sica, Zavattini, e c’era la stessa attenzione, la stessa idea. De Sica c’aveva già l’Oscar in mano quando mi ascoltava alla radio e mi apprezzava. Avevamo la stessa intesa sull’attore, che al cinema poteva essere una faccia, un corpo, cioè anche uno de’ strada. E io riuscivo a stare nel mezzo, no? Rossellini era il più grande affascinatore, uno che ti convinceva su tutto, nun se sapeva se era regista, letterato, affarista o cosa, gli servivano sempre soldi, te li portava via e poi scoprivi che li dava alla gente che non li aveva, quelli che gli stavano vicino dopo la guerra. Zavattini era uno che rasentava la follia, in certi momenti, se stavi a sentire un po’ bene quello che diceva; ma c’era una genialità che De Sica coglieva. E infatti il segreto della loro collaborazione era che De Sica capiva quello che de’ Zavattini se poteva realizza’. A quel punto arrivo io.
Il difetto fa ridere. 50 film in 6 anni. Quando ho capito che avevo la fiducia, e ormai potevo lanciarmi tra gli addetti ai lavori, allora feci un programma. Dal quale non mi volli mai distaccare: andare al passo con l’evoluzione del costume, prendere spunto da tutto quello che accadeva nella ricostruzione e successivamente in Italia, anche se a volte anticipavo cose che poi sarebbero accadute. Era un vero e proprio programma, da svolgere nei decenni. Negli anni ’50 partirono offerte per portarmi in America. De Laurentiis impazziva per questo. Io non capivo perché. Dico: Dino, ma che ce vado a ffa’ in America? Come, dice lui, vai a ffa’ er cinema americano, ma che se’ matto? Ma in America non potevo fare una critica di costume. Ma chi li conosce, ’sti americani? Che tte frega, dice; fa’ i fantastici e le commedie. Ma io non volevo far vedere alla gente che ero bravo, né volevo solo il successo. Pensavo al mio percorso. C’avevo un impegno. Volevo fare la storia d’Italia. Io volevo fare neorealismo non a sfondo drammatico ma a sfondo ironico. E non si accorsero subito del mio lavoro. Passarono cinque, sei anni, e io avevo già fatto 50 film. Quando poi hanno capito, se so’ buttati tutti a propormi i 250 film che si facevano in Italia in un anno. Da Mamma mia, che impressione, che era del ’51, ho fatto i difetti degli italiani per 50 anni. Il difetto fa ridere. Il santo, l’eroe, non fa ridere. Si possono fare film con uno sviluppo da eroe, come La grande guerra, con il personaggio che diventa un eroe, ma prima ’mbroglia, se dà da fa’, insomma è il solito personaggio; ed è un grande film quello perché si vede quanto è breve la distanza tra un vigliacco e un eroe.
Da Fellini a Sordi.
Da Fellini a Sordi. Io che cosa ho fatto? Ho detto, attraverso il cinema: aho, guardate che ’sti tipi qui vivono intorno a noi, li riconoscete? E la gente diceva sì. Mi sono sempre preoccupato non di far ridere, ma di far dire: ’sta scena è vera. Infatti non ho avuto pagine di critici, ma pagine di scrittori, come Marotta, per esempio. Ho sempre pensato che non è necessario cercare affannosamente la comicità, come purtroppo avviene oggi. Se prendiamo quella scena del Marito, quando arrivo a casa, dopo dieci ore di lavoro da geometra e trovo questa moglie raffinata che suona il violoncello, che me guarda co’ quella faccia... e le dico: “Ma che vvoi? Vuoi litigà?” Fa ridere, ma è anche vera: il pubblico ride perché si riconosce in un meccanismo sbagliato di coppia. I critici si occupavano dei film che la gente non capiva. I miei la gente li capiva. C’è una battuta di Flaiano su di me che dice: “L’italiano che corre sempre in soccorso del vincitore.” Buona, no? Flaiano era straordinario. Un battutista. Lo si ascoltava sempre quando ci s’incontrava a casa di qualcuno. Si facevano le cinque del mattino, con Patti, Talarico, Zavattini, poi De Sica, che arrivava tardi, e non c’erano donne, solo maschi che si trovavano per commentare le notizie politiche o di economia, con discussioni interminabili. Però Flaiano, forse, non sapeva comporre uno spettacolo. E infatti la sua vicinanza a Federico si deve a questo: Fellini sapeva incanalare, concretizzare le idee di Flaiano, come con Lo sceicco bianco o I vitelloni. Comunque Fellini non voleva diventare un grande regista. Voleva diventare unico. Voleva fare anche l’attore, ma non era fotogenico. Aveva invece questa fantasia da sogno, anche se nun sognava mai, eh. Che poi uno dice... e invece Fellini di notte non sognava neanche le pecorelle. Però aveva capito che in queste sue fantasticherie il mondo della cultura, quello che ti fa grande e universale, trovava dei simboli, vedeva significati in cose che lui neanche pensava. Ed erano realizzate così bene. Lui voleva diventare unico, così. Infatti ci siamo salutati decisamente, poi. Le nostre strade erano diverse. I suoi film poi mi sono piaciuti. Cioè, piaciuti... nel senso che aveva quella capacità... Intanto però non era un grande pittore, lui. Sognava anche quello: di esserlo veramente. Per esempio stava vicino a Geleng, che ritraeva tutti gli americani e faceva quei manifesti straordinari di cinema, con la Mangano, la Magnani, e lo invidiava in una maniera, perché lui non riusciva a fare quelle cose. Perciò, lo scarabocchietto, lo schizzo, ma nella sua mente c’era la grandezza, ed ecco la sua capacità di realizzare le cose al cinema con l’aiuto di Gherardi, con costumi, scenari, piume di struzzo e tutto il resto: era bravissimo. E infatti il suo tocco è unico al mondo. Io ero contento per lui, ma io dovevo fare il realismo.
Lo schiaffo der Magnozzi. La cultura italiana non capiva la commedia perché non sapevano essere spiritosi. C’è un personaggio importante della cultura che a volte scriveva di musica e che gli capitò di dire in un salotto: io di musica, niente, non ne capisco niente, e sghignazzava. Un personaggio grossissimo, che adesso nun posso di’. Ma che, se fa così? Insomma, siamo dovuti invecchiare per essere riconosciuti, noi comici. E questo è un rammarico. Però abbiamo avuto la possibilità di vivere un’epoca unica, dove è accaduto tutto, dove il mondo è cambiato in una maniera incredibile, con proposte scientifiche, tecnologiche, era un’epoca fatta anche da certi uomini che non hanno ancora, e forse non avranno mai, un cambio generazionale. E nei miei
film un fondo etico viene sempre fuori, più o meno. Anche il Magnozzi di Una vita difficile di Risi, che con uno schiaffo al padrone riscatta la sua onestà di fondo; e dopo che ha dovuto rinunciare alla sua integrità politica per paura di restare senza soldi e perdere la famiglia, sgancia un cazzotto all’industriale e lo sbatte in piscina. Però, attenzione, quello è il finale, un bel finale, di un film. Poi non sappiamo che cosa gli succede. Non so, nella vita... Che faccio poi? ’Ndo vado? Ci vuole una vincita all’Enalotto. Allora sì che glielo darei davvero lo schiaffo. Ma bisogna proprio essere sicuri che hai vinto. I debiti, i soldi da trovare, il tenore di vita da mantenere. Chi ha vissuto quegli anni sa che erano quelli i problemi. Nel Boom di De Sica, per amore di una donna che non volevo perdere, decido di farmi cavare un occhio, per riparare ai debiti e restare nel mio ambiente. Lì tutti spendono, spendono, e a un certo punto questo non ce la fa più. Dietro la sua vita lussuosa c’è una situazione fallimentare, capito? È un episodio che viene dalla realtà purtroppo. C’è dietro anche lo strozzinaggio, i debiti che si facevano per seguire certe mode. E oggi, qualcuno nun se vende pure un rene pe’ i soldi? Tutto nasceva però in quegli anni. Quella era la società nuova, capito?
Contestazione. Nel ’68 ho fatto un piccolo episodio, nel film di Zampa La contestazione generale, intorno a un problema importante della chiesa. C’era tutta ’sta contestazione, ’ste cose. Insomma, avevo capito che il più grave problema della chiesa era l’ignoranza dei preti. Alcuni preti esercitavano il sacerdozio in piccoli centri che si spopolavano perché i giovani andavano a lavorare nelle fabbriche, con i vecchi incattiviti che non conoscevano la vita delle grandi città, le esigenze e la formazione dell’uomo nei centri urbani: be’ io faccio un pretino, un santarello, che riceve lettere anonime dalle vecchiette che aiutava in cui veniva accusato di farsela con la cassiera di un bar, perché l’avevano vista andarsene con un prete. E invece era monsignore, capito? Il suo superiore. No, lui era proprio un santo, nel bar entrava soltanto per scaldarsi, e alla fine, quando che il vescovo vuole chiudergli la parrocchia, allora lui chiede di andare in città per poi sposarsi. In concomitanza con questa incoscienza degli studenti che facevano ’ste cose, queste manifestazioni, senza rendersi conto bene se valeva la pena o no distruggere certe cose, certe istituzioni, con poi quegli atti di terrorismo eccetera, ho fatto quel pretino per dire: guardate che la contestazione si fa anche rappresentando le virtù di un prete che non sono riconosciute perché non si ha tempo per la riflessione.
M’arrangio io. Io sono convinto di vivere nel paese più bello del mondo, comunque. L’ho capito visitando tutti gli altri paesi. Ho praticato anche popoli e genti che qui da noi imitano, senza sapere chi sono e perché li stanno a imità. Il popolo italiano è superiore a tutti gli altri: per fantasia, per intelligenza, per intuito, tutto. Per i modi, perché sa arrangiarsi, si sa riparare e controllare. E ha saputo non ascoltare gli altri che gli dicevano come doveva fare le cose. Qui la gente sa dire: sai che te dico? Possono di’ quello che te pare, io vedo come stanno le cose, di che cosa ho bisogno e me arrangio da solo. Capito? L’arte di arrangiarsi è proprio un’arte italiana. Proprio come il titolo del film di Zampa, dal racconto di Brancati, che feci nei primi anni ’50.
Dallì parte tutto, ecco. Il costume, la storia. E tutti quei gruppi del ’68, che facevano parte di una certa intellighenzia, erano strumentalizzati. Hanno sbagliato, ecco. Di buono però c’era il fatto di far presente che vivevamo in un paese democratico dove c’era la libertà di protestare. E che, se le cose non vanno e tu protesti, insomma nun te succede niente, nun te fucilano.
Rivoluzione sessuale, borghesi piccoli piccoli, trafficanti e detenuti. La cosa più incredibile che è successa in quegli anni è la liberazione sessuale, una cosa inverosimile, che il cinema ha colto. E lì c’è secondo me una bella combinazione con l’arte di arrangiarsi. Tutte ’ste professioni che sono nate: il sociologo, il sessuologo, lo psicologo. Io ho passato l’infanzia tenendomi dentro tutto quello che scoprivo. Non lo comunicavo mica a casa, perché a casa una volta si parlava un altro linguaggio. Non quello che succede oggi coi ragazzi che coi genitori parlano de’ sesso. Se ’sto ragazzo trova il paradiso terrestre, se lo tiene per lui. E tutte le cose che succedono sono una sua scoperta. Se continua a parlarne perde il bello, il mistero, che è la sua esperienza. E poi negli anni ’70 certi problemi sociali so’ venuti fuori davvero. C’erano i miei film come Lo scopone scientifico o Un borghese piccolo piccolo. E poi, anche con l’aiuto del povero Amidei, Detenuto in attesa di giudizio. Ero andato in Svezia, perché ero fidanzato co’ la figlia del Sovrintendente delle Belle Arti e si parlava dell’Italia, di certa gente imprigionata e poi innocente. Dice lei, una ragazzina che mi portava in giro: vuoi vedere le carceri? Non mi sembrava ’sta bellezza. Dice: ti faccio vedere una cosa. E mi porta davanti a un albergo: qui, mi spiega, vengono ospitati i detenuti in attesa di giudizio, con le loro mogli, le compagne e i figli. Alla fine della giornata di lavoro, sono qui a disposizione del giudice che deve istruire l’indagine e decidere se hanno veramente commesso un reato oppure, scusate, potete andare a casa. E allora io pensai subito a un italiano che viveva in Svezia, un geometra, che per un ponte caduto di cui non sa niente passa dall’albergo in Svezia alle carceri italiane. Poi con Amidei abbiamo puntato proprio sulla situazione delle carceri e sull’innocenza, con il turista accusato di un omicidio che non aveva commesso. E abbiamo dato il film a Nanni Loy, bravissimo, a cui avevo chiesto vent’anni prima di fare Il marito, il suo primo film, ambientato tutto a Roma ma girato interamente a Madrid perché il produttore era spagnolo e io il film lo dovevo fare per forza, perché avevo fatto Lo scapolo e quindi poi dovevo fare Il marito. Ho proprio voluto farlo io anche Finché c’è guerra c’è speranza, sul traffico di armi in quegli anni. Toccavo un argomento molto delicato e portarlo su un piano di commedia poteva essere pericoloso. Avevo letto un articolo su “Epoca”, l’intervista a un grande mercante d’armi, Samuel Kamens, che diceva che la colpa del traffico d’armi non era la sua, lui era soltanto un commerciante che pensava all’avvenire dei suoi figli. E la cosa m’impressionò. Andai a Montecarlo a incontrarlo e mi raccontò della sua fabbrica d’armi a Manchester. È un film in cui sono andato sul sicuro, quello, perché c’avevo lui che mi seguiva. E il film arrivava quando si parlava di quei carri armati che passavano da La Spezia e non si sapeva dove andavano. Dopo il boom le famiglie non si contenevano più. Le mogli, come quelle descritte nel film di De Sica, negli anni seguenti avevano spinto i mariti ad approfittare di certe situazioni per seguire l’onda del consumismo, i figli volevano le moto, le automobili, le spider, e poi tutti quanti c’hanno le ville e noi non le abbiamo: ed ecco questo personaggio che converte le pompe idrauliche in lanciafiamme.
Avrei sposato la Mangano. Ho fatto un lavoro che aveva bisogno di una libertà e di una indipendenza assoluti. Non avrei potuto realizzare 150 film se mi fossi sposato. Non avrei potuto realizzare quel programma che mi ero prefisso di realizzare. E questo è uno scotto molto alto. Però, con la mia esigenza di essere libero e indipendente, senza il controllo di nessuno che te dice: ’ndo vai, che fai?, è diventata un’abitudine che per me andava bene. Ogni volta che dicevo: be’, ho un’età che se non lo faccio adesso, se non mi sposo... mi dicevo però, ma è possibile che devo cambiare sistema di vita? Queste abitudini mi hanno portato lontano nella vita, e perché le devo cambiare? Come dico sempre, poi, le mogli costano. Con tutte le donne che avevo a disposizione per scegliere. Comunque è vera la storia che mi era preso il panico quando c’era da fissare la data delle nozze con Uta, un’austriaca bellissima che aveva fatto arrivare la famiglia per conoscermi, e io m’ero defilato. Forse sono due le donne che avrei sposato davvero. Una, la sanno tutti, è stata la Pagnani. La quale, donna con grandissima personalità, elegantissima, da signora ha detto: no, nun me becchi. Può durare quanto? Aveva quindici anni più di me che ne avevo poco più di venti quando abbiamo incominciato, ed è durata nove anni, finché una mia avventura con una blue bell offrì l’occasione ad Andreina per troncare tutto. Io mi ero innamorato proprio di una personalità così indipendente. L’altra, se avessi potuto, era la Mangano. Di lei, tutto mi piaceva. Proprio tutto. La capivo. Lei era un impasto unico, era nata da un siciliano e da un’inglese. Il padre era controllore della ferrovia e durante un viaggio aveva conosciuto una inglese, e si erano sposati. E lei era un’inglese siciliana. Una cosa incredibile. E aveva una gran voglia di vivere, di divertirsi. Frenata da Dino De Laurentiis. Perché Dino, non è che nun capiva, proprio non c’aveva tempo de’ capì. Stava colla testa da un’altra parte. E invece Silvana amava molto fare il cinema. Quando capitava un film insieme era una festa e lei era felice. De Laurentiis invece era un grande giocatore. Non aveva tempo però di approfondire le cose, non stava a sentire. Quando gli dicevi: te devo spiegà, lui diceva, vabbè ho capito, fàmolo e basta. Perché sapeva che aveva i più bravi. Puntava forte e qualche volta faceva bum, ed era l’en plein.
La contessa a cavallo. Mi viene in mente la storia di Sarazzani, di cui ero molto amico, un grande giornalista che c’aveva “l’Osservatore Romano”. Lui era conte, aveva sposato una contessa, ma ormai non avevano più rapporti, lei s’alzava alle sei del mattino e andava a cavallo. Insomma, un giorno stava scrivendo un articolo nel suo studio e nota queste due chiappone che facevano la pasta fatta in casa. Non l’aveva mai notata, quella persona di servizio. Quando la ragazza a un certo momento dice: è pronto, aspettiamo la contessa, poi servo. Dice lui: no, se è pronto puoi servire. Lei porta ’ste fettuccine che aveva appena fatto, e lui dice: mettete un po’ a sede’ lì. La ragazza, stupefatta, dice: ma non c’è la contessa. E lui: e vabbè, mettete a sede’ e famme compagnia. Così mentre magnano arriva la contessa. Dice: be’, che cosa succede qui? E lui: e che succede, niente, stiamo a magnà. E la contessa inviperita: e io dove mi metto allora? Dice lui: e tu te ne devi andà. Prendi ’r cavallo e te ne vai. E così il conte incomincia a girare con questa bonona de’ cameriera, la presenta nei teatri come la contessa e se la prende in casa.
Dopo tutta una vita di finzioni aveva scoperto una che, avendo le funzioni di moglie, compiva anche le altre funzioni, dalle fettuccine al sorriso. Per dire quelli che non si accorgono di avere vicino certe donne e non riescono a scoprirle perché sono talmente presi dal loro lavoro, neanche per crudeltà o per altro, ma perché più si va avanti e più si è presi, capito? Quando sono andato l’ultima volta a Los Angeles a trovare De Laurentiis mi viene ’ncontro cor pupazzetto ’n braccio, la Francesca, l’ultima figlia di adesso, che mi sembrava come cinquant’anni fa co’ la prima. Capito? Questo è Dino. Macché, se’ matto, dico, ricominci daccapo. Ammazza Di’, me sembra ch’è passato un giorno.
9 Ho attraversato la strada, il sole brucia sotto i capelli bianchi, raccolti sulla nuca in uno chignon. Qualcosa mi spinge a tornare con lo sguardo all’edicola. Dal marciapiede di fronte, sotto un glicine rigoglioso, contemplo il cartellone pubblicitario che promuove la videocassetta del film di Sordi Detenuto in attesa di giudizio. Dal finestrino posteriore dell’auto della polizia, stretto fra due agenti, Sordi si guarda alle spalle con indifesa angoscia. Qualcosa mi colpisce, sento un tuffo al cuore, una detonazione della vita. Come se una freccia vagante nell’atmosfera infinita, che avrebbe potuto risparmiarmi per sempre, avesse invece trovato la traiettoria che la porta dritta al mio cuore, inesorabilmente. Avevo cinquant’anni quando ho visto quel film, e ho pianto tanto, in silenzio, assurdamente, guardando per la prima volta la scena, lui che si volta indietro, verso la moglie, dal lunotto della macchina della polizia, e tutta la sua vita di innocente istantaneamente messa sotto inchiesta. Una scena grottesca, come succede ogni volta che Sordi deve immaginarsi tragico. Piangevo seduta accanto a mio marito, che non si accorse di niente. Piansi allo stesso modo, di uno stesso dolore primitivo, a ventitré anni. Se ne era andato così, su una Lancia nera, tra due ceffi dell’Ovra, con un mezzo sorriso fiducioso affidato a me, un dolce e impavido ragazzo ebreo che ho amato per sempre. Sono qui, ora, ipnotizzata da un’immagine su un marciapiede di Roma, nell’estate del 2003. Una vecchia magra e alta, retta da due bastoncini pallidi che spuntano dal grembiule fiorato, immobile a fissare nel vuoto tutto il pieno che non c’è.
RODOLFO SONEGO A Venezia con le scarpe chiodate Ho conosciuto Sordi la prima volta che sono andato a Roma, poco dopo la fine della guerra. Non potevo immaginare che avrei scritto quasi tutti i suoi film. Ero a casa di Amidei da mezz’ora. Stavo seduto sul divano con Giovanna Ralli. Amidei ci faceva delle foto per un provino. Qualcuno suonò alla porta. Come una palla che rotolava entrò questo ragazzo, che investì subito Amidei, anche con una certa violenza: e aveva telefonato qua, e poi là, e poi era stato lì, ma nessuno gli aveva risposto precisamente, e aveva parlato con Fabrizi che aveva promesso, e con quell’altro che aveva concesso, ma poi non si poteva fare... Amidei lo spingeva intanto verso la porta. “Insomma non mi rompere le palle,” gli urlava. Non lo sopportava. Fino a quel momento Roma era un’immagine da libro di scuola, per me. Qualche arco di trionfo, il Colosseo. Una cosa lontanissima. Conoscevo vagamente i nuovi nomi del cinema italiano. Rossellini, Visconti, Lattuada. Sordi era uno sconosciuto. Parto da questa borgata a diciotto chilometri da Belluno... 44 abitanti. Il censimento a Valzella l’abbiamo fatto noi, nel ’37. Ma io sono nato a Cavarzano. Mi ricordo il giorno in cui mia madre annunciò che saremmo andati a Venezia. Prima di partire mi fece indossare un paio di scarpe mai viste. Con i chiodi. Per andare al mare. Quel viaggio sembrava un’impresa, andare a Venezia era come immaginare oggi una trasferta in Australia. L’emozione di vedere l’acqua. Una città sul mare. Una specie di sogno. Quindi Roma, figuriamoci. Era un mondo irraggiungibile per me che vivevo in mezzo alle montagne, in un paesino di emigranti, tutti soli, vecchi, donne e bambini.
Il cinema in uno zainetto. Ho visto il cinematografo per la prima volta a sette anni. Era a Belluno. Anche in questo caso un viaggio. Era di pomeriggio, con mia zia. Un film muto, in bianco e nero naturalmente, di cui ricordo soltanto una cosa, il commento di mia madre a mia zia: lui è troppo piccolino, troppo bambino per capire. Ho l’impressione che fosse un film con Rodolfo Valentino. Mi sembra un sogno. Poi, nel corso degli anni, da studente, mi rendevo conto che il cinema non era... rispettabile, non era giudicato una cosa che apparteneva al mondo della cultura, tantomeno dell’arte. L’incontro più profondo col cinema è del tutto casuale, indiretto, lo capisco adesso. Succede una sera, in soffitta. Mio padre era emigrato in Australia. Ci restò per cinque anni. S’andava con mia madre ogni tanto nel sottotetto. Mentre lei si dava da fare, vidi uno zainetto. L’aveva dimenticato un professore che veniva lì a fare le vacanze, uno molto povero, perché in quel posto miserabile c’era poco, e per tutti era così. In questo zainetto non c’era niente, se non due libri. Uno con una copertina marrone, ed erano gli scritti di Newton. Il secondo era grigioverdolino, le scoperte sull’evoluzione della specie di Darwin. L’ottica e l’uomo. Non capivo naturalmente, ma ero attratto da una sorta di mistero. Portai i libri in camera da letto. Dormivo con mia madre in quegli anni. E le chiesi di leggermi qualcosa. Mi addormentai mentre lei recitava la fine della prima pagina. Non so com’è possibile, ma ricordo di aver afferrato l’idea della corporeità, cioè che le stelle che vedevo non erano puntini, ma enormi sfere pesanti. Nel
giro di due anni mia madre mi aveva letto i due libri pagina per pagina, questi due fondamenti della cultura moderna. Come si fa con un racconto. Associo questa bellissima esperienza a un’altra di ribellione. Un giorno scappai dal paese con un cugino di Padova, che portava i pantaloni alla zuava. Volevamo lasciarci alle spalle la vita grama. Mi rifugiai a casa dei miei zii e andai subito a vedere la specola, l’osservatorio astronomico di Padova. Una visione grandiosa. Così è partita la macchina della cultura, per me.
Dall’Upim alla Resistenza. A 14 anni ho raggiunto mio padre, che era tornato dall’Australia e faceva l’operaio a Torino. Trovai un lavoro alla Upim. Andavo a scuola alla sera: inglese, matematica, disegno, per agganciarmi al liceo artistico. Disegnando giorno e notte sono riuscito a iscrivermi all’Accademia di Belle Arti di Torino, dove insegnavano Casorati, Maggi. C’era Michele Guerrisi, allievo di Croce. Mi prese in considerazione, fu un’esperienza importante. A 17 anni l’Accademia ci portò a visitare gli stabilimenti cinematografici Fert. C’era una scena pronta, carta, gesso e mobili, era per un film con la Ferida, ma non fu possibile assistere alle riprese. Mi colpì però la costruzione dell’ambiente, come fosse un disegno a tre dimensioni. Poi ci fu la parentesi della guerra, perché io ho fatto il partigiano. A Valzella non s’erano mai visti i fascisti. C’era un soldato in divisa che passava ogni tanto. Il fascismo l’avevo conosciuto a Torino. Vivevo nella borgata operaia di San Paolo, in un edificio soprannominato ca’ dei ratt, cioè casa dei topi. Si era organizzata una forma di antifascismo che un ragazzo di quattordici anni non poteva capire bene. Il capo caseggiato faceva la spia al gerarca, così sentivo la gente parlare in codice, anche nei negozi. Diventai allievo ufficiale a Pinerolo, per la leva militare. Dopo l’8 settembre siamo scappati praticamente tutti in montagna, con le armi, e lì avviai una piccola formazione partigiana, una ventina di uomini. Uniti agli altri, da brigata diventammo una divisione. Controllavamo i passaggi in Germania attraverso il Brennero. Il nostro compito era affrontare piccole battaglie vicino ai ponti, che facevamo saltare. Una notte d’inverno caddero in trappola trecento uomini dei nostri. Vennero tutti trasferiti a Mauthausen. Non ne tornò neanche uno. Ma non avevamo notizia delle cose tremende che succedevano nei campi di concentramento. I comandanti cadevano svelto. Si faceva in fretta la carriera militare nell’esercito partigiano. Si parla di “uomini” partigiani. Ma è un equivoco. La gente pensa che lassù c’erano eroi come John Wayne, impavidi e maturi cinquantenni con la barba e lo sguardo buono, cosa che il cinema italiano poi ha lasciato credere. Invece eravamo tutti ragazzi, dai sedici ai diciannove, vent’anni. Ero comandante di brigata a ventitré anni, e venivo considerato un vecchio. Non è che c’era un ideale, un’ideologia, tra di noi. L’8 settembre significava scegliere: essere invasi dai tedeschi o stare con loro, e io non ebbi il dubbio, me ne andai subito. Ci siamo trovati abbastanza armati. Loro si piazzavano nei mulini, nelle cascine, nelle scuole. E noi li attaccavamo di sorpresa. Subito ai primi scontri siamo riusciti a disarmare tre o quattro di questi presìdi. Non erano ancora avvertiti di possibili attacchi. E noi ci rifornivamo di tutto. Quando tornai a Valzella, ripresi a disegnare e dipingere, volevo proprio fare il pittore. La guerra era appena finita quando conobbi Migliolella e Santomaso, che venivano lì in vacanza. Mi portarono a Venezia tre mesi e fu l’occasione per conoscere molti altri artisti italiani.
Raccontavo spesso episodi della guerra partigiana. Io non me ne accorgevo, ma loro erano molto interessati ai miei racconti.
“Presso Sergio Amidei”. Insomma, a un certo punto mi accorgo che al bar le mie storie le ascoltano, le chiedono. A Torino i miei amici, i compagni di scuola, mi cercavano perché raccontassi storie del mio paese. Ma l’ho capito dopo, che avevo una qualità. La mia vocazione alle storie la scoprirono altri. Così una sera a Venezia cenò con noi un certo Bianchin, un signore vestito sempre di chiaro, elegante. C’era anche Turcato, con Migliolella e altri. E questo dice: se lei potesse scrivermi quello che ha appena raccontato, vado a Roma tra un paio di giorni e lo faccio leggere a Castellani, magari a qualcun altro. Era una specie di organizzatore cinematografico. A quei tempi la produzione si doveva ancora rimettere in piedi. Non ero interessato al cinema, se non perché avevo visto dei film. Passano quindici giorni e ricevo un telegramma di Roberto Rossellini. Ne avevo sentito parlare, di Rossellini. Offriva trentamila lire di allora per andare subito a Roma, e c’era l’indirizzo: a piazza di Spagna, “presso Sergio Amidei”, scriveva. Stavano girando Paisà, e io mi sono trovato lì in mezzo, incontrai Tellini, che era il soggettista del momento, Amidei il grande saggio, e in quella casa andavano avanti e indietro dei giovani, conobbi Giovanna Ralli, che aveva quindici anni, bellissima, e Sordi, subito il primo giorno. Il mio racconto non era poi niente di speciale, uno scorcio di vita lassù in paese, un cenno alla guerra partigiana, qualche ritratto, i problemi di sopravvivenza. Restai con Rossellini e Amidei per una ventina di giorni, in quella casa. Amidei (ma anche Rossellini era d’accordo) sosteneva che dovevo scrivere dei romanzi, perché quel racconto non era un vero e proprio soggetto cinematografico, ma “un sintomo di romanzo”. Invece di scrivere cinque cartelle ne avevo scritte sessanta. Non feci caso, ma c’erano quei soldi e un po’ di lavoro. Senonché, accadde che un figlio di Rossellini durante un viaggio verso la Spagna morì d’appendicite. Rossellini scomparve.
Trovare da mangiare. Io mi trovai a piedi. Non c’era una lira. Avevo il problema di sopravvivere, mangiare e dormire. Riuscivo a rimediare qualcosa in certe osterie. La fine della guerra rendeva la gente più sensibile. Oggi, non credo... E ritrovai Turcato, che cercava di piazzare qualche suo dipinto. Prima mi aveva aiutato Guttuso, presentato da Amidei. Dormivo nei sottoscala degli studi di questi pittori. La cosa che mi ricordo davvero come ansia quotidiana era rimediare qualcosa da mangiare. Il cinema non mi sembrava ancora uno sbocco, ma si era sparsa la voce che io raccontavo storie sull’Italia. E mi sedevo ai tavoli, parlavo, e mangiavo qualcosa. Scarpelli, Flaiano, quelli che si erano più inseriti nel cinema, mi fermavano dicendomi: mi han detto che racconti storie buffe e drammatiche. E una volta mi chiamano a collaborare, con Lattuada e De Santis, con cui lavorava Gillo Pontecorvo che era un giovanotto vivace. Partecipavo alle riunioni, nelle case di De Santis o Lattuada, e poi subito dopo di Zavattini, perché era il centro di tutto, lui. Mi diceva: vieni anche tu, ma poi io non firmavo. Mi dicevano: butta giù questa cosa, e
allora andavo a casa e lo facevo. Per me però era un lavoro quasi estraneo. Io disegnavo bene, ma non mi sembrava che la scrittura... Mi davano qualche lira ogni tanto, ci campavo. Roma ore 11 e La spiaggia sono state le prime sceneggiature dove ho firmato, credo. Per Roma ore 11 c’erano Elio Petri che si occupava dell’inchiesta, Zavattini che poteva restare solo per venti giorni, ogni tanto Basilio Franchina e Lizzani, e io. Ci si riuniva in casa di De Santis, una bella casa. De Santis mi metteva in mezzo e diceva: adesso Sonego ci racconta qualcosa del suo paese, poi lavoriamo. Si divertivano, s’interessavano. Adesso so che quei racconti creavano un clima e un’attenzione, cose sconosciute alla città di Roma, un mondo di caratteri e potenziali personaggi. Soprattutto era una base di umanità e di vicende che aiutava e indirizzava il lavoro.
L’ultima spiaggia. La spiaggia lo sceneggiai io. Lattuada mi raccontò un fatterello di cronaca, di cui era venuto a conoscenza. Bellissima anche la casa di Lattuada, lui era un architetto, un precisino del nord. Era chiamato la vedetta lombarda, osservatore freddo del dettaglio. Lombardo della Titanus voleva fare un film come Catene, ma artisticamente più alto, mi disse. Comunque un film popolare. Non una serie C, ma una serie B: parlavano in questo modo. Nel fatto di cronaca c’era una prostituta che aveva portato la figlia al mare, per curarla. Certi villeggianti l’avevano riconosciuta e l’albergatore l’aveva cacciata. Mi sembravano noiose, le riunioni. Lavorare insieme, io e Lattuada, con la segretaria, e Malerba, che era addetto stampa di Lattuada, mi sembrava pedestre. Dovevo dire quello che mi piaceva e quello che no. Finì che Lattuada fece un giro per il mondo per seguire un film. I viaggi a quei tempi erano lunghi. Tornò che il mio copione era finito. Chiamò Martine Carol e Vallone. Il film esplose subito, con un enorme successo di cassetta. Cinquanta miliardi di oggi. La critica, che io non sapevo neanche che esisteva, fu favorevole. Presi per una volta certi giornali milanesi. Pietrino Bianchi scriveva che era una commedia corale che tutti potevano andare a vedere, ma innestata nella vita sociale e perfino nella politica italiana, un film buono per capire tante cose. Mi colpì questa considerazione. Perché mi rendevo conto meglio del risultato, di quello che avevamo e che avevo fatto. Da giovani si è proprio quasi incoscienti. Credo che il film fosse anche stato attaccato in parlamento. A Ischia, dove eravamo andati per La spiaggia, mi avevano presentato Rizzoli, circondato di personaggi strani. Mi ricordo di un finto inviato speciale, che doveva essere a Hong Kong e invece scriveva i pezzi da lì, ma non mi ricordo per quale giornale. Tutto il dopoguerra era un po’ un imbroglio. A Ischia c’erano dei piccolo borghesi, commercianti, che stavano lì sperando di conoscere Rizzoli. Il padrone dell’isola era un grande capitalista. Il sindaco un comunista. Dopo La spiaggia, dal miserabile che ero stato, diventai qualcuno a cui telefonavano De Laurentiis, Ponti, Lombardo, che mi offrivano contratti grossissimi. Per Ponti, con Pasolini, Bassani, e Soldati, lavorai al primo tentativo di lanciare la Loren, con La donna del fiume. Io, Pasolini e Bassani ce ne andammo dopo quindici giorni. Stavano facendo fregnacce. Pasolini e Bassani erano stati invitati proprio come scrittori, da Ponti. Pasolini mi chiamò anni dopo, perché nello studio di Cassuto, un produttore, mentre lo aspettava aveva trovato sulla scrivania un mio soggettino, “La ragazza in vetrina”, trenta paginette. E mi chiese se poteva farne una sceneggiatura, senza essere pagato,
sperando che qualcuno poi lo producesse. Lo diresse Luciano Emmer.
Alberto. Come ho detto, il primo giorno che sono arrivato a Roma ho incontrato Alberto Sordi. L’ho ritrovato, Alberto, quando Cristaldi mi chiamò per trarre qualcosa da una commedia di Diego Fabbri, Il seduttore, una commedia tragica di “uno scrittore cattolico molto simpatico”. E così era, Fabbri, una bravissima persona, intelligente, veramente delizioso. Mi trovai in un salotto con un gruppetto di sceneggiatori, c’era anche Franco Rossi designato per la regia. E c’era Sordi. Erano in una impasse totale. Cristaldi si era messo in testa di fare il film con Sordi, che aveva fin lì fatto soltanto grandi macchiette. Qui doveva fare il protagonista di una commedia rilevante, con certi simbolismi cattolici, con momenti che potevano ricordare Bernanos. Sono stato ad ascoltare e ho capito qual era il problema. Dissi: trasferiamo l’azione a Roma, perché Sordi è spiccatamente romano; poi non è un intellettuale, è un piccolo borghese, secondo me; e le tre donne, la moglie, l’amante, l’amica, bisogna inserirle nella tendenza di quest’uomo a seguire una debolezza diffusa tra i maschi italiani, in contrasto con il mondo protestante, rigoroso, di altre regioni. Il titolo Il seduttore era giusto in questo senso, perché fa un po’ ridere. Dissi che per me era il marito di una donna che aveva una piccola trattoria, che assicurava una certa sopravvivenza. E incominciai a raccontare come facevo di solito quello che mi veniva in mente. Sordi ascoltava con attenzione. A un certo punto disse che era tardi, doveva andarsene e mi chiese di accompagnarlo con una scusa. Scendevamo giù dai Parioli, verso via Flaminia: insomma, non gli andava quel gruppetto, si stava annoiando, sono cose molto di testa, letterarie, mi diceva: “Io non capisco, non capisco, io non leggo commedie, libri.” Non sapeva niente di certe cose. Per lui c’era il varietà, le ragazze, e l’idea di fare delle parti nei film. Mi chiese di vederci, di conoscerci, io cercavo di capire chi era veramente.
Il nostro paese. Come nascevano i nostri film. Il seduttore ebbe un enorme successo. Era il ’53 e Sordi fece per la prima volta un personaggio. Poi venne Un eroe dei nostri tempi, Il marito, Il vedovo. E Sordi diventò un attore. Il seduttore comunque fu un boom. Succede a volte al cinema. Sordi ammazzò tutti. Non rimase più nulla di Walter Chiari, di Macario, di Rascel. I comici del momento, perfino i loro registi, come Mattoli, tutto quel cinema diciamo brillante e artificiale che veniva dal varietà, si trovò spiazzato. Non restò più niente: in pochi giorni Sordi prese tutti i contratti. Infatti se si va a vedere quanti film faceva in quegli anni... Mi sembra ci siano momenti di dieci titoli per anno. Credo che abbiamo sorpreso il pubblico prima che avesse il tempo di riflettere. Con un’atmosfera riconoscibile socialmente, per la tipologia e anche la critica sociale, se vogliamo, ma implicita, non sbandierata. Se prendiamo l’inizio... I film cominciano sempre con un’azione. Per Il seduttore invece mi vedevo questa Roma di notte, una strada del centro deserta, e questo tizio col suo capufficio, uno un po’ timido e riservato, e che cosa fanno questi due italiani per strada? Dovrebbero andare a casa svelti, invece no, li sentivo camminare piano piano, e sentivo la voce di Sordi, la sua prima battuta, che diceva: “Ma lei l’ha mai conosciuta la spagnola?” Ed era già spiazzante come inizio. Il capufficio allora dice:
“Ho conosciuto qualche turista, ma francese.” E Sordi, da grande intenditore, uno che crede di aver vissuto, allude: “Eh, no, deve conoscere la spagnola.” Non far niente, vivere più di commenti che di fatti, di fantasia più che di realtà, di evasioni, di provincialismo culturale, in un’Italia di figli di bottegai che sognano l’estero che arrivava dalla guerra e dall’immagine dell’America... Già in quella prima scena si sentiva questa parte del paese che abbiamo poi raccontato a lungo. E Sordi, che allora col capufficio si mette a raccontare della spagnola incontrata nell’ascensore, scendendo in dettagli, da esperto. Be’, ma forse non è neanche vero, forse sentiamo che non gli è neanche successo.
Inutile discutere con Sordi. Ecco era questo che sentivo di poter raccontare con uno come Sordi. Diego Fabbri, drammaturgo abile, serio, o Alessio Siciliano, uno sempre un po’ cupo, ma bravo, non avevano capito una cosa fondamentale: era inutile parlare con Sordi, discutere del retroscena culturale di una sceneggiatura, storico o sociale, perché lui non ti capisce proprio, non ti segue. E io l’avevo compreso. Dissi: perdete tempo, vi arrabbiate e non concludete niente. Avevo anche provato a dirgli che c’era un risvolto sociale nella storia, che gli sceneggiatori pensavano di inserirlo meglio nella società... Che la società era importante. Ma lui mi guarda e dice senza ambiguità: ma che, c’hanno una società di loro proprietà? Cinematografica?
Il mio pretino. Il personaggio scritto per Sordi che mi sta più a cuore è il prete povero della Contestazione generale. Ma non perché vien fuori un risvolto inedito del ’68, come dicevano. È un ricordo della mia infanzia. Un paesino povero, dove si beve qualche bicchierino e non succede mai niente. Lo feci per Vasile, il produttore cattolico di Fabbri. Era un film a tre episodi, due li avevano già girati. Zampa stava cercando il terzo. Mi disse che c’era una cosa da fare con Sordi, se ci potevo pensare. Non volevo mischiarmi con il ’68 della cronaca. E poi i film direttamente sul ’68 non sono mai riusciti. Non esiste un film sul ’68. Allora spiego a Zampa il soggetto, gli piace, ma io preciso: prima dovresti andare a Civita di Bagnoregio a vedere il paese, così capisci meglio. Lui va con l’architetto mentre io scrivo ancora. E decide subito di chiamare Sordi e la troupe. Ma io dovevo ancora consegnare la sceneggiatura. E loro incominciano lo stesso, credo che Zampa spiegasse a Sordi semplicemente che cosa c’era da fare... Io ero a Orvieto. Finisco, prendo la macchina e parto per Belluno. Pioveva forte, un tempaccio, e allora vedo un pretino, tutto bagnato, nero e fradicio, e lo carico, poveretto. Non riesco a fare a meno di raccontargli la storia del film, di questo povero sacerdote che s’invaghisce di una cassiera, questo paesino sperduto, la scoperta dell’intrallazzo con l’altro, e lui che pensava di sposarsi... Dice scuotendo la testa: è la mia storia.
Dall’America al Giappone. A dire la verità il ’68 l’ho visto dall’estero. Ero sempre fuori. Avevo incominciato a viaggiare
per La ragazza in vetrina. In America avevo casa a New York e a Los Angeles. Quando andavo a Londra, stavo da De Laurentiis. Stavo fuori perché mi stimolava. Tornavo qualche mese in Italia, pigliavo dei soldi per le sceneggiature e ripartivo. Scrivevo film italiani da fuori, ecco. Da un grattacielo di New York scrivevo di una strada romana. Lo scopone scientifico o Il gatto, per esempio, sono nati in ambiente newyorkese, poi per ragioni produttive inseriti in un contesto locale. Mi facevo prendere dal piacere di andare in giro. Una volta sono partito per Giacarta in sandali e sono stato via settimane e settimane. Erano cose che faceva nessuno, prima. De Laurentiis mi mandava dove volevo. Un giorno gli dico che c’è qualcosa di interessante in Giappone, c’è da studiare la condizione femminile, e lui subito: “Vai! Liliana prepara il biglietto.” E mi davano soldi e collegamenti. Poi tanto portavo sempre qualcosa. Si utilizzava tutto. Oggi è impensabile. Be’, oggi poi non ci sono proprio più i produttori. Il cinema non è più un’entità indipendente, che produce quindi cultura propria a partire da scelte indipendenti. È pagato dallo Stato, dalle televisioni. Non può che essere un’altra cosa. Un ibrido. Lo si fa e lo si mette in cantina. Quindi non è che il ’68 mi è arrivato qui a Roma, in quel contesto che in Italia era quasi medievale. Perché in realtà il ’68 è stato una vera scossa in Italia, un attrito violento. Noi stavamo in un paese medievale, ripeto. Proprio nella comunicazione. Anche le strade, voglio dire. Io, per andare a casa mia... ci volevano due giorni. Ancora poco prima del ’68 si faceva il passo della Futa con l’auto, di notte c’erano i lupi, si diceva proprio: non fermarti, stai attento, capito? I colori erano ancora quelli dei dipinti del Quattrocento. Quando invece arrivavo in America era un altro mondo. I colori erano quelli della plastica e della cellulosa. Negli Stati Uniti, ma anche in Svezia, al nord, e anche in Inghilterra, l’impatto fu diverso. Semmai per l’America il ’68 significò un impatto sul puritanesimo. Mentre per noi fu una botta per tutto. Per i costumi, per la sessualità, per l’abbigliamento. Per tutto. Eravamo medievali e piccolo borghesi. Per me non fu una sorpresa. In California avevo visto una trasformazione generale prima del ’68, spinta dall’economia e dal mercato, una spinta che poi si è affacciata al movimento hippy e ai movimenti politici. Era come un flusso. Zabriskie Point, che cercava di raccontare quell’ambiente, era in realtà un film sull’America fatto da europei, un film simbolico. Ricordo che i ragazzi americani mi dicevano di non riconoscersi. Come Sistemo l’America e torno, col principio di “vado lì e gli faccio vedere io”, che è proprio l’ottica europea verso l’America, ma è un punto di vista che l’America non riesce a comprendere.
Il disagio della modernità. Il boom psicologico è stato la vera rivoluzione generale che ha investito la società. Che cosa vuol dire? Il disagio della trasformazione. Tutto quello che è successo dalla politica alla sessualità ha creato disagio. Pensiamo al boom della psicologia, anche quella clinica, la psicanalisi, gli psicofarmaci. Tutto è girato intorno alla ricerca di un adeguamento. La farmaceutica della mente nasce a metà anni ’50 ed esplode negli anni ’60. Parlo dell’America, per dire che vedevo prima quello che sarebbe successo qui. La vibrazione delle capitali, questo movimento delle metropoli con le auto, gli americani che uscivano dalle città, avevano già i fuoristrada, piantavano le tende, facevano i fuochi, creavano bisogni, e desideri di mercato. Anche negli altri paesi. Erano più ricchi. E poi la droga. La farmacia mentale, anche quella
sperimentale, e la droga vanno di pari passo. Parlano del disagio generale. Ma per noi tutto questo è venuto dopo. Prima abbiamo dovuto “sentire” il cambiamento. Alla fine degli anni ’70, la società ha incominciato ad andare in psicanalisi. Oggi vanno tutti dall’analista. Certo, per noi c’era già stato il boom economico nei primi ’60. Ma era un’altra cosa. L’aspetto sociale e quello psicologico andavano di pari passo. Non fu una divaricazione. Il boom, dico il film, adesso: ritagliai io l’articolo sul tizio che offriva un milione per un occhio e lo mandai a Lombardo. Ma non scrissi la sceneggiatura. Non mi piaceva l’idea, e non mi piace ancora. Però, dico, magari con Totò. Che sarebbe stato un effetto paradossale mica male, sapendo della sua quasi cecità. Sordi si sente che è un po’ tirato... Oddio, poi c’è De Sica come regista, quindi tutto diventa credibile.
Il sorpasso è mio. Il sorpasso praticamente l’avevo scritto dieci anni prima. Parlo di un racconto intitolato “Storia di un mulo e di un cannone” che mi comprarono tutti. Anche se non fecero mai il film. Una storia di esercito, con due soldati, con quei rapporti umoristici, da letteratura russa, dove c’è un superiore, un ufficiale, e un soldatino. Nelle campagne lombarde. C’era un problema, perché il cannone si era inceppato e loro erano rimasti indietro, e si tiravano questo cannone per città e osterie. Mi appassionava il rapporto tra due universi mentali completamente diversi, questi due così lontani e costretti a condividere... Poi, più avanti, quando De Laurentiis mi regalò una 1100 scoperta di seconda mano, vecchia, andai a Belluno in macchina, e durante il viaggio notai per la prima volta il traffico, questa gente avanti e indietro, col gomito fuori dal finestrino, e mi venne un’idea di viaggio legata al racconto che avevo scritto prima, un’avventura di confronto tra due personalità diversissime. Cercavo un titolo. Mi era venuto in mente “Il gomito e il finestrino”, ma no, non funzionava, e poi “Il gomito sul finestrino”, neanche. Allora pensando alle auto mi venne Il sorpasso, un problema che non esisteva prima, si comincia ad ansimare, a voler sorpassare. E non l’avevo scritto per Sordi. Come Una vita difficile, che avevo scritto per Mastroianni. Questo era per Franco Fabrizi, che avrei voluto sperimentare. Al posto di Gassman, dico. Per una figura malefica, che poi era il diavolo. Ma non lo volevano Fabrizi, non lo chiamavano, non ci credevano. E lui: adesso telefono a Federico, gli chiedo di fare qualcosa. Ma no, dico, lascia stare. Un giorno Dino Risi e De Laurentiis mi chiamano in ufficio. C’è anche Sordi. Leggo le paginette e arrivo al finale con l’incidente: quello buono muore e invece sopravvive il diavolo. Dicono: ma no, questo finale non va bene, non lo facciamo. Va be’. Vado in Svezia con Sordi per Il diavolo, guarda caso, regia di Polidoro; lo scrissi lì sul posto, praticamente mentre giravano, e arriva su un aiuto regista che dice: sai, stanno girando un film, ti hanno preso il titolo, si chiama Il sorpasso. Ma il titolo per me non rappresentava niente. Invece stavano proprio girando Il sorpasso. Quando sono tornato, sono andato da Scarpelli per capire che cosa era successo. Dice: ma no, volevano girare un film estivo, una commediola rapida rapida, sai l’ha messo in piedi Cecchi Gori. Al momento Mario Cecchi Gori era un segretario di produzione, era un po’ un tirapiedi di De Laurentiis, poi lo fece anche direttore di produzione, ma insomma... Il sorpasso gli diede credito in tutto il mondo, e alla fine poteva fare tutto quello che voleva. Comunque, mi piace come è venuto fuori il film. Di per sé, pezzo per pezzo, la
regia, la recitazione, è come gli altri film. Risi andava veloce, non è mai stato uno che curava... un pignolo. Ma è intelligente, spiritoso, non è ideologico. Va al sodo. Non annoia. I particolari non sono... Ma non vuol dire niente: è l’insieme che è buono. È rimasto in tutte le cineteche del mondo. Negli Stati Uniti tutti i registi hanno quel film in cineteca. Isolato da tutti gli altri, studiatissimo. Fellini è più grande, ma non diventa un modello. Hanno Paisà come modello di capolavoro di guerra. E Il sorpasso come commedia. Uscì col titolo Easy life al cinema Baronett di New York. Combinazione, uscì la stessa sera di Il diavolo, che era al Coroner, proprio di fronte al Baronett. Tutta New York andava lì. Si fermò il cinema americano. Da quel momento, m’invitarono sempre, pagavano alberghi, viaggi, mi chiedevano di raccontare come erano fatti i film, la luce, gli attori, tutto. Si trattava di fermarsi lì, vivere di molto denaro, lavorare per loro. Io ho capito subito che non potevo farlo. Non era per me.
La caduta. Ma poi c’è stata la caduta dell’impero romano. C’è una specie di romanzo della caduta del cinema italiano. Gli anni ’80. Uno dice: perché il Milan non gioca più bene? Come si fa a dire perché? Cambia tutto... Noi, io e Scarpelli, per esempio, ci vediamo ancora come prima, prendiamo un caffè insieme e chiacchieriamo anche di questo, abbiamo più volte cercato un motivo, delle ragioni. Lui dice che è “la caduta della tensione ideologico-politica”. Non so. Non credo che ci sia una questione ideologica alla base dei registi che hanno fatto grande il cinema italiano. Rossellini era un cinico. De Sica in quel senso era un ignorante. Risi si disinteressava alla politica. Oggi semmai, ma già da vent’anni, si cerca il politically correct. E questo può essere un problema, perché non si rischia, non ci si spinge... Il fatto è che il cinema oggi è dei giovani, e così si fanno quelli che si credono film “per i giovani”. Poi ci sono la Rai e il governo, che per il cinema sono praticamente un club per ricevere soldi. E allora? Allora cercate i produttori. Se siete capaci...
10 Da qualche anno, per evitare faticose salite, tornando a casa aggiro il quartiere e passo da via Torlonia. Le case del Nomentano una volta erano in mano a poche famiglie. È difficile capire oggi il senso di sicurezza e il prestigio che la borghesia derivava dalla proprietà dei muri nei primi decenni del secolo scorso. Qui vicino, credo abiti ancora il nipote di Augusto Genina, apprezzato direttore della fotografia. Tra Villa Massimo, Vescovio e via Morgagni i Genina possedevano un patrimonio immobiliare. Mio padre ci portava a vedere i film di Genina perché era una sorta di vicino di casa celebre. Una fortuna che papà si abbandonasse alle affinità elettive di condominio. Genina era un grande cineasta, pignolo e bravissimo. Un cattolico convinto. Un uomo dell’800 che aveva fatto il cinema muto. Cielo sulla palude, il film su Maria Goretti, è così emozionante perché lui, da ragazzino, poteva averla incontrata davvero Maria Goretti. Io lo conobbi appena. Ero andata qualche giorno in montaggio, come assistente, per Maddalena, storia di una prostituta che, interpretato il ruolo della Madonna, in una processione viene lapidata dai benpensanti del paese. La casa produttrice, la Titanus, spingeva il film con un manifesto tenebroso e sensuale per tenere testa alla concorrenza della Lux, che già contava sulla spregiudicatezza di De Laurentiis. Dal manifesto spiccavano gli occhi fiammeggianti di Marta Toren, una svedese hollywoodiana drogata d’alcol, depressa, terribilmente sola, che morì di leucemia qualche tempo dopo, lo stesso anno in cui morì Genina. Ai tempi di Maddalena non frequentavo più la Lux, ma l’ascesa di De Laurentiis si leggeva su tutti i giornali. Però fui invitata alla festa per il ventennale. Era il ’54, non posso sbagliarmi: l’anno in cui mi sposai, il 12 ottobre. L’anno in cui morì De Gasperi. La festa fu una cosa grandiosa, con invitati venuti dall’estero. Gualino riuscì addirittura a farsi ricevere da Pio XII. Ma fu anche, per la Lux, l’inizio della fine. Con Maddalena uscì Ulisse, che portava soprattutto la firma di De Laurentiis, con il marchio americano di Kirk Douglas. Credo che Gualino avesse soltanto messo una parte dei soldi. Dicevano fosse il film più costoso del dopoguerra, e Cinecittà che, dopo la Liberazione, aveva ospitato i campi profughi gestiti dagli americani, toccando con mano la precisa volontà colonizzatrice, viveva così una sorta di rivincita, la migliore, penso, poiché ribaltava la sottomissione economica e politica in alleanza industriale. Ci sentivamo importanti, ma eravamo come la gazzella che cammina di fianco al leone. Quel sontuoso matrimonio con il cinema americano durò poco meno di un decennio, e probabilmente è da assegnare quasi esclusivamente all’iniziativa di De Laurentiis, che componeva, faceva e disfaceva con un raro senso di grandezza e di opportunità. Su De Laurentiis non ho mai avuto un’idea precisa. Un mulo dotato di cervello, iniziativa e malizia. Non ho mai creduto però all’amore tra lui e Silvana Mangano. Pensavo piuttosto a una sorta di coniugazione verbale in cui lei era la radice, lontana, immutabile, e lui la variante dei singolari e dei plurali, dei tempi e delle persone. Non andarono ad abitare a Capri, come De Laurentiis avrebbe tanto desiderato. Coniugando il suo vivace desiderio di mare con il costante bisogno di isolamento della moglie, finirono nella fastosa villa di Cap Martin, con decine di stanze, il parco e le guardie. La Mangano non amava molto il cinema. Diventava
attrice ogni tanto, in funzione degli ordini di De Laurentiis. La ricordo alla festa dei Nastri d’Argento, nel luglio del ’55, dove lei vinse con la sua interpretazione nell’Oro di Napoli. Ritirando il premio, accennò imbarazzata ai suoi piccoli attacchi di panico, e subito fuggì via. Poteva essere un artificio, ma io rimasi impressionata da quella donna inquieta, che in una mano teneva il premio e con l’altra stringeva la stoffa dell’abito. Tra molte immagini confuse che ho di De Laurentiis, una è nitida e precisa. Forse a quella festa della Lux, o a un’altra: questo non saprei dirlo con certezza; era un ricevimento con il buffet, a cui tutti si ammassavano, mentre a pochi tavoli sedevano soltanto le signore. C’era anche la Mangano a uno di quei tavoli. Il décolleté, da spalla a spalla, era disegnato da un corpetto bianco trasparente, con preziosi ricami in rilievo e strass. Mangiava come un automa, fissando un punto imprecisato, tra il piatto e il bicchiere, spenta e bellissima. Alle sue spalle, De Laurentiis, in smoking e occhiali rettangolari da intellettuale, teneva il piatto in mano, la forchetta sospesa. Muoveva gli occhi a destra e a sinistra, in agguato, come una guardia del corpo.
DINO DE LAURENTIIS Sogni colossal. La mia Rosebud Siamo stati quelli dell’Italia povera che l’hanno fatta ricca. Quelli del cinema povero che l’hanno fatto ricco, almeno per un po’. Eravamo una generazione speciale perché non avevamo niente. È come con un affamato: gli metti un piatto di spaghetti davanti e se lo mangia in tre secondi. Questi uomini, che poi erano Rossellini, De Sica, Fellini, Sordi e compagnia bella, avevano la passione d’incominciare. Avevano qualcosa dentro che li spingeva a dimostrare che le loro idee erano valide. Avevano la voglia di creare un’industria che in Italia proprio non esisteva. Ma dico: non c’era niente. Macerie. Avevamo intorno macerie e gente che aveva fame. Da questa disperazione nacque la voglia di storie. Per parlare di quella gente, di noi, delle speranze, anche.
La giovinezza è uguale per tutti. Eravamo giovani. Perché oggi non troviamo più il tempo per pensarci, ma i giovani sono il futuro, il nuovo sangue di ogni cosa che deve nascere, di ogni industria. Oggi a ogni giovane bisognerebbe raccomandargli di scoprire la sua passione e temperarla con la pazienza e l’umiltà. E non mi vengano a dire che i tempi sono diversi. La giovinezza è uguale per tutti. Nel nostro mestiere, poi, chi non ha umiltà, non va avanti. Si possono insegnare delle cose... Io ho imparato quasi tutto da solo. Mio padre faceva il pastaio a Torre Annunziata e non capiva bene perché volevo andare a Roma per fare il cinema. Ma io ho rinunciato anche all’ aiuto dei miei genitori. Contavo su me stesso e sulla fiducia che potevo ottenere. Quando cercavo lavoro a Cinecittà, per partecipare a un provino per un film era indispensabile avere belle scarpe nere. Non c’avevo una lira. Ma volevo fare quel provino. Sono entrato in un negozio, ho scelto le scarpe, ho spiegato al padrone che mi servivano per un provino e che sarei tornato con i soldi. E lui si fidò, perché aveva capito che io ero convinto di quello che facevo. Tornai e pagai. Prendiamo un esempio: Picasso. Un grande maestro. Certamente Picasso, da giovane, avrà avuto a sua volta dei maestri che gli hanno insegnato la tecnica, del disegno, del dipinto, la storia, e tutto il resto. Però quei colori? Non glieli ha insegnati nessuno. È la sua ispirazione d’artista che ha tirato fuori dei rossi, delle combinazioni, delle scomposizioni, per cui è diventato Picasso. Si può insegnare l’abc, ma poi se non c’è quell’insieme di talento, passione e umiltà... Neanche l’urgenza di dire qualcosa, basta. Perché se non c’è dentro qualcosa che risolve quest’urgenza, non vien fuori niente. E si vede, poi. In tutte le cose. A maggior ragione per i film, dove la gente che si muove è tantissima, i soldi che si rischiano sono pure tantissimi. E per raggiungere il risultato bisogna avere le idee chiare.
Due più due fa venti, o trentasei. Il nostro mestiere è un mestiere dove non c’è niente di logico. Non è un’industria a prototipi. Io voglio fare un telefonino, ed ecco qua il pezzo, faccio la ricerca di mercato, vedo se va bene, vedo poi quelli che sono i costi, lo metto in vendita e ne faccio migliaia, milioni. Ogni
film invece è un prototipo, perché ogni film affronta problemi diversi. Oggi la produzione è cambiata e non è cambiata. Sembra più facile lavorare con le nuove tecnologie. Però ogni lavoro presenta sempre problemi nuovi. Ho fatto centinaia e centinaia di film, colossal come La Bibbia e fantascienza come King Kong, ma non mi era mai capitato, come nel mio ultimo film, di dover costruire un sommergibile quasi vero. Uno da scendere in navigazione, dico, perché ho fatto ricerche in tutto il mondo e non esisteva un sommergibile funzionante della seconda guerra mondiale. E l’abbiamo costruito. Un anno solo per costruire il sommergibile. Nel mio lavoro due più due non fa quattro. Fa venti, trentasei. Vai a capirlo, quanto fa di volta in volta.
Il cinema della povertà. Non avevo neanche vent’anni quando sono andato a Torino per inventare il mio primo film. Ho trovato i soldi da una specie di mobiliere e da un’ereditiera. Questo mobiliere era uno diffidente. Lo convinsi che c’erano dei soldi da guadagnare. Fondai una casa di produzione, la Realcine, e non sapevo neanche che film avrei fatto: non avevo ancora il soggetto! Questi mi davano i soldi per viaggiare in vagone letto e ingaggiare chi volevo e io non avevo il film. Nessuno credeva che sarei riuscito a trovare i quattrini senza uno straccio di sceneggiatura ed essendo praticamente un dilettante. Avevo partecipato a un anno di lezioni del Centro sperimentale, a Roma, e facevo un po’ l’attore, delle particine nei film di Camerini. E invece, mi sono inventato una cosa: tra molti film tedeschi o svedesi di scarso valore, io comprai i diritti per l’Italia di uno che mi sembrava buono, lo feci riscrivere adattandolo per noi e poi lo presentai ai produttori. E funzionò. Mi ero procurato Massimo Serato e Maria Denis, un’attrice molto in voga alla fine degli anni ’30. Questo per dire che stavo già incominciando a capire, a vent’anni, che non c’è un manuale con le regole per questo lavoro. Nell’immediato dopoguerra, in un’Italia sconfitta, uscita fuori dall’occupazione prima dei tedeschi e poi degli americani, noi pochi uomini di cinema senza mezzi tecnici alle spalle, tra le industrie distrutte, ci guardavamo intorno e trovavamo storie incredibili, come Sciuscià, Roma città aperta, Il bandito di Lattuada, che produssi io nel ’46, Paisà, e poi Riso amaro, che produssi ancora io, quando scoprii Silvana Mangano. Senza strutture, senza un’organizzazione finanziaria, senza un teatro di posa, il cinema italiano è riuscito a fare capolavori che sono andati in giro in tutto il mondo. C’erano gli uomini giusti con le idee giuste nel momento giusto. E soprattutto con l’energia necessaria. Per Il bandito avevamo tre lampade, ogni giorno non sapevamo come illuminare la faccia della Magnani, c’era il povero Tonti che impazziva con la luce, eppure che fotografia, e l’hanno celebrata tutti. Noi abbiamo accettato a un certo punto che i critici chiamassero questo periodo produttivo “neorealismo”. Ma la realtà è diversa. Era il “cinema della povertà”, cioè non avendo niente, non avendo uno studio, neanche un soldo per costruire i set o comprare i riflettori, che cosa potevamo fare? Andavamo per le strade e cercavamo set veri, e abbiamo inventato, senza volerlo, il neorealismo. Ma per necessità. Come popolo, siamo rinati con i nostri film. È stato questo il periodo in cui il cinema italiano è stato praticamente il primo ambasciatore di un’Italia sconfitta all’estero, perché ha riportato verso l’Italia tutte quelle simpatie che la guerra fascista aveva fatto perdere. Succedevano fenomeni strani. Che la gente, in tutto il mondo,
andava a vedere un film italiano, applaudiva, e poi quando usciva, appena c’era l’occasione, voleva comprare un prodotto italiano. Questo significa che il cinema italiano è stato in parte artefice del boom economico che è seguito alla ricostruzione. Ha dato una spinta. Quando Antonioni dice: “Ma la guerra ci ha lasciato di buono solo le speranze, magari fasulle: e infatti andarono deluse,” sono d’accordo solo sulla prima parte. La guerra ci lasciò le speranze, cioè la forza di fare, ma non andarono deluse: almeno per quanto riguarda il nostro settore, molti seppero prendere al volo l’occasione, e contribuirono al boom del cinema italiano.
Affari con gli americani. Allora che cosa è successo? Dietro la spinta di questi ottimi risultati ci fu la legge Andreotti sul cinema. Finalmente uscì una legge. Dove si dava la libertà al produttore di scegliere se combinare, fino al 50 per cento, il personale artistico e tecnico italiano con quello straniero, conservando la nazionalità, cioè restando di fatto “film italiano”. Questa legge ci ha dato la possibilità di diventare competitivi col cinema americano. E abbiamo tirato fuori dei film inimmaginabili prima. Io ho fatto Guerra e pace, Barabba, La Bibbia, e poi tutta l’avventura di Dinocittà. E Lombardo, per esempio, ha prodotto Il gattopardo e Sodoma e Gomorra, Ponti La ciociara, e così via. Io ho capito al momento giusto che il cinema da noi non poteva essere fatto se un film nasceva e moriva in Italia. Cioè ho capito soprattutto che un film per coprirsi delle spese e portare un po’ di utile doveva espandere il suo mercato. E con un gruppo di volontari ci siamo mossi già all’inizio degli anni ’50 a cercare le coproduzioni, prima in Europa, con spagnoli e francesi, più tardi con gli americani. Che incominciavano ad avere interesse per certi prodotti che contribuivano a realizzare. Allora, il sistema per me era questo: arrivavano gli americani che dicevano: noi vogliamo Guerra e pace; e io rispondevo: ah, vi interessa? okay, io vi do Guerra e pace se prendete Le notti di Cabiria di Fellini, perché i distributori italiani, per esempio, avevano rifiutato Le notti di Cabiria, che invece poi diventò famosissimo; oppure: io vi do Mambo se voi prendete anche La strada, un altro capolavoro che i distributori italiani avevano rifiutato. Quando ho costruito Dinocittà facevo Lo straniero di Visconti, ma anche I due nemici con Sordi e David Niven e Waterloo, che nell’edizione originale durava quattro ore ed era coprodotto con i russi e gli americani. Tanto per dire: facevo lavorare insieme Russia e Stati Uniti, i grandi nemici. E i nostri film andavano in giro all’estero. Ma qui non bisogna dimenticare che la cosa funzionava a un punto tale che gli americani iniziavano a preoccuparsi, anche perché cominciavano ad attraversare un periodo per loro non troppo buono al cinema. Io so che di noi dicevano: non è che questi fanno soltanto La strada, che in America proiettiamo con i sottotitoli in piccole sale, ma sanno fare anche grandi spettacoli, che la nostra stessa industria a volte non è in grado di fare.
Esiliato dalla legge Corona. Insomma, negli anni ’60 eravamo fortissimi. Ma proprio nel momento in cui si aprivano spazi più vasti di mercato, uscì fuori la “legge Corona”, a metà degli anni ’60, anche se poi incominciò a funzionare realmente verso il ’68, ’69. La legge Corona disse: no, un momento; non si fa più la combinazione dei cast e dei tecnici al 50 per cento. Il film nazionale deve
essere tutto italiano. Limitando l’uso di artisti stranieri il cinema italiano si rinchiuse nel provincialismo. E incominciò a stancare anche il pubblico. Allora, a quel punto decisi: be’ signori, io me ne vado; a queste condizioni il cinema italiano, in quel particolare modo che avevo impostato io, non si può più fare. E così ho venduto tutto e sono andato in America a fare Serpico, King Kong, I tre giorni del condor: ma io anche lì ero un film-maker, il mio padrone era il pubblico. E questo in Italia non si voleva capire. Per me la legge Corona affossò l’industria cinematografica. E infatti, basta andare a fare una ricerca all’Ufficio commercio con l’estero, per verificare che le entrate di valuta del cinema italiano erano arrivate a un livello massimo proprio appena prima della legge Corona. Poi sono precipitate. Una discesa progressiva fino a oggi, a parte qualche annata. Per esempio ultimamente c’è stato La vita è bella. Ma La vita è bella direi che è un caso a parte, più che un film del cinema italiano è un film del nuovo Charlie Chaplin. Perché sono convinto che Benigni è il Chaplin della nuova era. È un genio, e quando nasce un genio, non ha nazionalità.
Ho tagliato 20 minuti al grande Altman. Perché tutto si è frantumato? Negli anni ’70, non potendo fare film di respiro internazionale, il nostro cinema non riuscì più a realizzare film d’avventura, cioè a trovare storie buone di grande spettacolo. Fino ad oggi, praticamente non ci sono più stati film da esportare, a parte qualche raro caso, come Il postino, o Benigni. Resta l’immagine di un’Italia scialba, con storie poco interessanti per il grande schermo. Negli anni ’80, poi, imperavano le commediole, i film di cattive parole, nessuna spettacolarità, perché gli autori non attingevano alla letteratura d’amore o d’avventura, e oggi non ci sono più le star italiane per poter fare, che so, una Disfida di Barletta da esportare. Per me la vera star di qualsiasi film resta lo scrittore. Il ragionamento è questo: se prendiamo un ottimo script e lo mettiamo nelle mani di un grande regista, è certo che vien fuori un grande film; se lo stesso script lo mettiamo nelle mani di un regista mediocre, c’è sempre un film buono; ma se invece facciamo il contrario, cioè un ottimo regista con uno script mediocre, il film riesce male. Sono stato frainteso quando dicevo che il produttore è il responsabile del film. Ho sempre detto, dico e dirò, che il produttore è l’unico vero responsabile dell’insuccesso del film. Perché? Il produttore sceglie la storia. Poi sceglie gli sceneggiatori e il regista, e con lui fa il cast. Poi segue la lavorazione del film, vede i giornalieri, decide se vanno bene o no, chiede di girare altre scene, poi va in montaggio, c’ha il “final cut”, c’ha la supervisione dei manifesti, cioè è in charge di tutta l’operazione, fino alla campagna pubblicitaria. Io accompagnavo Jessica Lange in tutto il mondo a promuovere King Kong, per fare un esempio. Se il film è un fiasco vuol dire che questo tipo di produttore in qualche cosa deve aver sbagliato. Ho dovuto tagliare venti minuti al grande Bob Altman per il Buffalo Bill. E a Fellini rubai la pellicola di notte perché non voleva accettare un taglio nelle Notti di Cabiria. Anche i grandi autori possono sbagliare. Non dico, al contrario, che se il film ha successo è soltanto merito del produttore. No: è merito del regista, degli attori, di tutti. Detto questo, secondo me tutto dipende dallo stadio iniziale del film: se hai nelle mani una storia che potenzialmente può interessare il pubblico... poi il film deve avere un solo elemento fondamentale: l’emozione.
Rifiutai La dolce vita. Devi capire che tutto quello che di buono c’è nello script si ricongiunge sempre all’emozione. Io non è che non ho commesso errori, intendiamoci. Per La dolce vita di Fellini, nel quale avevo già messo i soldi per produrlo, ho seguito le indicazioni dei miei consiglieri artistici Chiarini, Perilli, tutti contro. Dino non lo devi fare per questo motivo e per quest’altro; Dino non lo devi fare perché non c’è nessuna giustificazione in un padre che uccide i figli. E io mi feci convincere. E sbagliai. Ma non perché non avevamo capito il film. Per un motivo più serio: perché sono andato contro la mia filosofia, cioè che nel cinema non c’è logica. Anche l’idea di un padre che ammazza i figli, se è nelle mani di un grande regista come Fellini, sarà realizzata, sarà diretta e girata in modo che provocherà una grande emozione. E il pubblico l’accetta e applaude. Come è accaduto. Mi hanno detto: De Laurentiis è come una macchina priva di marcia indietro. Fin qui, fino a questi annetti che mi porto sulle spalle, ho sempre cercato di guardare avanti, anche quando ho avuto dei momenti negativi, e ce ne sono stati. Ma io ho sempre cercato di tirarmi fuori guardando al futuro, per realizzare i miei sogni.
Colossal nel cassetto. Volevo passare dal sogno alla realtà, sempre. Io sognavo, per esempio, di portare la Bibbia al cinema. Una sera, a New York, prendo dal cassetto di una camera d’hotel una Bibbia e la leggo. È il libro che si trova in tutti gli alberghi del mondo. Il vero best-seller di tutti i tempi. E dico: cazzo, ma perché un sogno? Posso farlo veramente. E così tutti gli altri grandi film, che mi sono nati nella mente come sogni e che con la mia volontà ho cercato di realizzare. E con la mia umiltà. Perché se io mi fossi messo a dettar legge, era finita. A ottant’anni, con centinaia di film alle spalle, oggi imparo ancora qualcosa di nuovo dal cinema. Il mio ritorno in Italia, dice qualcuno, sembra quello del Conte di Montecristo. Ma che c’entra? Io ho pensato: ma vediamo se, mentre in Italia parlano tanto della crisi del cinema, io, che sono stato trent’anni in America, riesco a tornare per fare delle storie italiane, con personaggi italiani, che però possano avere subito una risonanza internazionale. Sono sempre venuto a fare le vacanze a Capri, a portare i bambini, a rivedere degli amici, ancora quando c’era Silvana (io devo molto a Silvana: nei momenti difficili mi ha sempre fatto trovare una casa tranquilla, senza problemi, dove potevo dimenticare gli assegni, i registi esigenti e i capricci delle attrici). E allora proverò a fare dei film italiani di coproduzione europea.
L’euro al cinema. Io sostengo che non sono più necessarie leggi per la protezione del cinema italiano, francese o spagnolo. Ma, se è vero che esiste l’euro, bisogna unire le forze e fare un cinema europeo di concorrenza. L’Europa ha un mercato potenziale di 350 milioni di spettatori contro i 250 degli Stati Uniti. Bisogna mettere insieme le forze, scegliere la lingua unificata, cioè l’inglese, e via. Certo, bisogna anche tornare a ragionare come noi, negli anni ’60, quando per esempio stavamo costruendo un vero star system. Esistevano degli attori bravi, e noi ci sforzavamo di farne delle star. Così ho creato la Silvana Mangano, la Lollobrigida, Sordi, la Rossi Drago,
Gassman. Come in America, ho creato la Bo Derek, Jessica Lange o Schwarzenegger. Ma intendiamoci, due più due non fa quattro, ripeto. O ce l’hai dentro di te, quest’esigenza di creare star... Il regista di U 571, il film che ho fatto a Cinecittà adesso, l’ho scoperto io, Jonathan Mostow, un giovane al secondo lungometraggio, e gli ho dato un film da 150 miliardi. Un professionista non sarà mai affamato di successo come un giovane alle sue prime esperienze. Ognuno di loro, da Sordi a Gassman, voleva il successo.
L’immagineshon. Nel nostro mestiere non si può diventare uno qualunque. Questo l’avevamo capito tutti, noi di quella generazione. E ci vuole fantasia, genialità, immagineshon, coraggio, perché se non c’hai soldi, ma l’idea è buona, quell’idea è sufficiente per trovare i soldi. C’era quel film di Orson Welles dove lo slittino, che si chiamava Rosebud mi pare, era il segreto del protagonista fin dall’infanzia. Se è un segreto, dovrebbe restare un segreto. Comunque credo che la mia Rosebud è stata la passione. Che per me resta sempre un bel mistero.
11 La segreteria del festival di Pescara ha fissato l’appuntamento con l’autista sabato pomeriggio alle tre, e io non ho neppure provato a inventare scuse. Potrebbe farmi bene: un omaggio e qualche saluto mi faranno bene. Da Londra mia figlia ha annunciato la decisione di accompagnarmi. Laura, il solo ingegnere donna che conosca, lavora nei telefoni. Forse ha deciso di accompagnarmi perché il premio è intitolato “Artigianato nella comunicazione”. Io non riesco ancora a capire che cosa significhi, ma so che premiano un libro, un produttore, due attori, i soliti personaggi televisivi, un industriale, uno psicanalista (come comunicatore?), perfino una società di telecomunicazioni; e questo potrebbe essere il legame con Laura. Sono un’artigiana? Non lavoro il legno, non faccio scarpe su misura. Nella motivazione del premio si legge: “Per aver saputo trasferire nella scrittura la sapienza compositiva e l’osservazione umana acquisite al tavolo di moviola, inanellando la vita di una comunità e illuminandola sub specie æternitatis.” Quando ho ricevuto la lettera non sapevo che cosa dire. Mi sembrava così pomposa quella frase. Quante persone sanno che il mio talento, se davvero esisteva, veniva comprato a ore per mettere mano a centinaia di film, spesso in assoluto anonimato? Una volta, a metà di un western, mentre il villaggio bruciava un pistolero doveva fermarsi sulla porta di casa e lasciare intendere che stava pensando alla moglie e al figlio morti. Gli occhi dell’attore risaltavano in primissimo piano, ma non bastava. Era una faccia etrusca con la barba di Garibaldi che non riusciva a esprimere tristezza. Nei due campi lunghi precedenti, che il regista mi aveva chiesto di tagliare, si vedeva bruciare una chiesa. Li recuperai, montai anche un dettaglio della chiesa e decisi di provare con dei tocchi di campana, come se il fuoco e il crollo l’avessero messa in movimento. Lasciai il suono della campana sul primo piano dell’attore. Quanti ricordi... Forse questo è artigianato? E poi c’è il libro che ho scritto: un romanzo sulla vita di un ricovero per artisti, uomini e donne non più illustri che ho osservato quando andavo a trovare mio padre in una casa di cura, fuori Roma. Mi ha dato una certa fama, quel libro, e ha compensato la solitudine. Non ho una carriera da scrittrice, dunque sono un’artigiana? Continuo a pensare che le giurie sono gruppi curiosi di persone; sono composte da intellettuali; in una giuria diventano intellettuali anche quelli che non lo sono, e per questo esagerano. L’espressione latina alla fine della motivazione, per esempio, mi sembra particolarmente enfatica. Ci è voluto Filippo, il nipotino filosofo, per farmela accettare. “È un’espressione dell’etica di Spinoza riferita all’uomo saggio, ma è usata come la intendeva Wittgenstein nel suo discorso sull’arte. Chi l’ha inserita deve essere molto colto. E poi non è riferibile soltanto a un’opera d’arte,” mi ha spiegato. “Riguarda anche le persone, forse i fatti della vita, quando li vedi in un certo modo. Quando riesci a mostrare qualcosa che esiste come disteso sullo sfondo del tempo che passa e che passerà. L’opera d’arte è qualsiasi oggetto visto sub specie æternitatis.” Rimane la parola “artigianato”. Forse gli sceneggiatori sono stati definiti “artigiani” del cinema perché hanno affrontato il lavoro di scrittura del film come un mestiere, da eseguire con scrupolo professionale, senza sentirsi necessariamente “artisti”, ma che artisti lo erano, o lo sono diventati. Age e Scarpelli, per esempio, hanno iniziato separatamente scrivendo canzoni, o inventando
battute su misura per i comici, come si costruisce un abito su misura in una sartoria, e hanno poi firmato film come Tutti a casa, La grande guerra, L’armata Brancaleone, La terrazza. Le parole finali della spiegazione di Filippo possono adattarsi più a loro che a me: “Quell’espressione latina non è così sballata, nonna. Forse, per voi del cinema di una volta, vuol dire che oggi sembrate pezzi d’arte, per tutto il tempo che è passato e per tutto quello che avete fatto.”
AGE Generale, non vi suonerò più la liana Mi ha tenuto a battesimo Cesco Baseggio. Dico proprio quand’ero in fasce. E mi han dato nome Agenore. Sono nato a Brescia, ma non ci sono più tornato, per tutta la vita. Adesso, che senso avrebbe? Potrei telefonare al sindaco e dirgli: senta, io sono Age, di Age&Scarpelli, vorrei visitare la città in cui sono nato, grazie. Ma non me la sento. Da figlio d’attori di teatro ho trascorso un’infanzia rara, se non eccezionale. Mio padre era anche amministratore delle compagnie. Mia nonna era attrice. Mia madre era attrice, e mia sorella, e alcuni zii. Dalla terza elementare ho viaggiato sempre. Frequentavo la scuola a pezzi, un po’ in tutta Italia. Ogni volta scoprivo e venivo scoperto da nuovi compagni di scuola. Avevo il privilegio di un dinamismo speciale per quegli anni, e parliamo del 1926, ’27. Spesso arrivavo in classe e dicevo: ah no, qui voi non ci siete ancora arrivati, a quest’Impero, e guardate che questa guerra alla fine sarà vinta. Questa posizione mi metteva davanti a reazioni disparate: di ammirazione e di diffidenza. Ma è successo anche che, per quasi due anni, non sono andato a scuola. Dal ginnasio ero più o meno stabilmente a Roma. Il fatto è che recitavo anch’io. Le parti di bambino toccavano a me. Il repertorio in gran parte era teatro veneziano, quindi molto Goldoni. Giravo con le compagnie più importanti d’Italia. Benini, Micheluzzi, Baseggio, Basile, Cavalieri. Li ho conosciuti tutti. Fin dalle elementari, quando c’era un testo da leggere l’insegnante chiamava: Incrocci, dai, leggilo tu.
Sul Carro con Donadio. La compagnia che posso ricordare meglio è quella del Carro di Tespi, nel ’33 e nel ’34. Molto celebre. Donadio faceva Garibaldi, io ero il suo trombettiere. Però non sapevo suonare, così uno degli attori strombazzava dalla quinta. E funzionava. Tutti credevano che suonassi la tromba. Una sera, a Civitavecchia, questa mia controfigura musicale perde tempo in camerino... Alzo la tromba e non esce niente. Volevo sprofondare. Ero stato smascherato. La mia parte si concludeva in barella, con le bende, davanti a Donadio-Garibaldi. Morendo, recitavo con enfasi, anche se con poca accuratezza: Generale non vi suonerò più la liana. Una volta, in sala c’era Guglielmo Marconi. Chiusa la replica, strinse la mano a tutti, anche a me. Attraversavo l’Italia fascista senza capire molto quello che succedeva, se non perché mio padre era antifascista e non lo diceva a nessuno.
Parola d’ordine: compagnia. Andare al cinematografo era un privilegio dei lavoranti nel teatro: quando ci fermavamo in qualche città per le repliche, s’entrava gratis al cinema. La parola d’ordine era: compagnia. Questo mi permetteva di vedere i film anche tre volte. Credo che mi abbia influenzato molto questa frequentazione. Il primo film che ricordo direi che era un film “di famiglia”, I due crocefissi: tra gli interpreti c’era mio zio Alberto Pasquali. In realtà il film era del 1918, quindi un anno prima che nascessi. Però mi toccò vederlo più tardi, molte molte volte... Se
invece devo dire il film che ricordo meglio, tra quelli che ho visto da ragazzo, allora c’è King Kong, l’originale, del ’33 se non sbaglio. Il cinema era una passione, ma mi piaceva molto anche l’illustrazione. Mi piaceva disegnare. Ce li ho ancora certi fogli, ecco: ippopotami, l’Africa, una scena di Giulietta e Romeo, un generale Custer, un Buffalo Bill. Queste cose, insieme alla lettura dei copioni e alla familiarità con le battute e i toni della recitazione, le metto tra le mie fonti d’arte, se vogliamo dir così. Credo di aver assimilato un’educazione passiva alla rappresentazione fin da bambino, un modo di fare esperienza che oggi pochi possono dire di aver conosciuto. L’esperienza casuale, quella che spinge verso qualcosa a partire da una matrice che non sai spiegare, contiene una ricchezza che difficilmente le scuole possono trasmettere, anche per gli sceneggiatori, dico.
Avevo paura del cinema. Ho fatto l’attore per anni, pur in piccole dosi, senza desiderarlo particolarmente. A metà anni ’30, quando lavoravo con una filodrammatica a Roma, un giornalista propose a me e a un paio di giovanissime attrici di compagnia di essere fotografati da Luxardo, famosissimo ritrattista e talent-scout. Le ragazze erano al settimo cielo. Quando andiamo in studio, lui sbriga le fanciulle. Poi, invece, s’accanisce su di me, d’angolo, di fronte, in primissimo piano, e mi dice di tornare che la mia faccia era importante. Non mi sono mai più fatto vivo. Avevo paura delle conseguenze nel caso fossi diventato attore cinematografico. Avevo paura del cinema, credo. Non riuscivo a immaginarmi in mezzo alla gente, a fare il divo. Però non mi dispiaceva scrivere. Anche canzoni.
400 lire al giorno col Quartetto Cetra. Questa cosa delle canzoni o non si sa o se la sono dimenticata un po’ tutti. Ho scritto le prime canzoni del Quartetto Cetra. L’arca di Noè, per esempio. Avevo una bella voce e per un certo periodo ho anche cantato con loro. Nel ’43 mi trovavo a Roma in licenza militare per dare degli esami. Mio padre Augusto mi aveva iscritto a chimica. Lui era matematico, ecco perché faceva anche l’amministratore delle compagnie. Be’, mi chiama Virgilio Savona e mi dice che c’era un invito per lavorare una settimana a Milano. Enrico De Angelis era sotto le armi, Tata c’era. Bisognava arrangiarsi, ma abbiamo messo in piedi uno spettacolino di cui ero autore e presentatore. Ci davano 400 lire al giorno, a testa, è come dire un milione oggi. Insomma, andiamo a Milano, facciamo le prime uscite, il pubblico è contento, un successo. Ma succede qualcosa. Una sera, il direttore d’orchestra, Pippo Barzizza, attacca un pezzo. Mi accorgo che si distrae, guarda qualcuno in quinta, cerca tra i tavoli. Poi si gira di scatto. Come un fulmine abbandona il podio, va in quinta, torna subito e ferma tutti: è caduto Mussolini, dice. Un casino. Urla e disorientamento. Era il 25 luglio. Ci abbiamo messo due giorni per tornare a Roma. Un disastro. La gente era tutta incazzata. Non si capiva niente. Che cosa avremmo fatto, che cosa sarebbe stato di noi.
La figlia del borsaro nero.
Io ho fatto il mio zaino da alpino e mi sono presentato al comando, ma avevo accumulato nove giorni di ritardo. Ero già diventato un disertore. Mi salvò il mio capitano, scrivendo che ero stato ammalato. Poi fui preso dai tedeschi. Fu un anno di prigionia in condizioni pietose, in un campo di concentramento in Francia. Ci chiesero due volte di entrare nella Repubblica di Salò, se volevamo salvarci. Ma noi pensavamo alla fuga. E infatti. I tedeschi ci facevano fare delle buche, non sapevamo neanche perché. Io, che conoscevo il francese, un giorno andai dal prete a chiedergli se poteva aiutarci. Lui fece soltanto un movimento con la testa, verso l’alto. Non disse una parola. Avevo capito subito: il campanile. Certe scalette a pioli portavano alla cella campanaria. Siamo rimasti lì tutta la notte, al buio, senza fiatare, aspettando che accadesse qualcosa. Al mattino i tedeschi spararono incazzati per tutto il paese. Partirono a cercarci. Erano furibondi. Ci gettammo sul magazzino, razziando quello che potevamo. I tedeschi tornarono proprio in quei minuti e uccisero quattro dei nostri. Io ero riuscito a scappare. Da lì sono finito con l’armata americana, quasi per un anno. Altra storia, quella. Ero comandante della compagnia di ex prigionieri dei tedeschi. Portavamo l’uniforme americana. E sono riuscito a fare un paio di giornaletti. Quando sono rientrato a Roma, nel ’45, la situazione era disastrosa, si viveva con niente, tutto alla borsa nera. Dovevo ingegnarmi a fare qualcosa, e così ho trovato da scrivere una serie per la radio intitolata La figlia del borsaro nero. Mia sorella Zoe era la protagonista, suo marito faceva il regista radiofonico.
Battute e doppiaggio. Tra la fine del ’46 e il ’47 ho incontrato Furio. Avevo incominciato a frequentare il “Marc’ Aurelio”, giornale satirico di cui ero appassionato lettore, avendo anch’io partecipato alla creazione di un paio di giornali in Francia e poi in Italia. Sono anche diventato giornalista professionista. Fu Vittorio Metz a spingermi a scrivere una cosa con Steno, per Totò, ed era I due orfanelli, ancora senza il contributo di Furio. Poi insieme abbiamo scritto Totò cerca casa. Scrivere per Totò era una cosa molto precisa: dovevi immaginare che fosse lui a suggerirti la battuta. Andavamo a teatro ad ascoltarlo, vedevamo i suoi film. Ma Totò era già stufo di stare in scena. Recitava un po’ il ruolo del “principe attore”. Totò era uno straordinario inventore, ma da qui a dire che le battute che faceva erano sempre farina del suo sacco, be’... Negli anni seguenti la fine della guerra lavoravamo in casa, in mezzo alla famiglia, che andava avanti e indietro. Minimo eravamo in due, io e Furio, ma spesso in quattro, in cinque. Non c’era lo spazio per dividersi, lavorare separati e concentrati e poi ricollegarsi. Soldi, pochissimi. Mio padre aveva fondato la compagnia Cdc per doppiare i film americani. Si tirava avanti così. Per fortuna con la fine della guerra arrivò l’ondata massiccia dei film americani. Cioè, per fortuna per la mia famiglia, ma non per il cinema italiano, che doveva rimettersi in piedi e difendersi. Nel gruppetto guidato da Metz e Marchesi c’erano Monicelli e, di rado, Fellini, un ragazzone burlone, un motteggiatore. Aveva un anno meno di me. Metz faceva il talent-scout, si guardava intorno per capire a chi dare spazio, quantomeno un ruolo di battutista o sceneggiatore adatto. Lui era diventato anche direttore del “Bilione”. Non c’era soltanto il “Marc’Aurelio”. E il gruppo beneficiò degli scambi tra giornale satirico e riunioni di sceneggiatura. Per me, che disegnavo e avevo recitato e avevo anche il gusto del grottesco, era come riversare molte esperienze in una cosa nuova e avventurosa.
Commedia umanistica. La nostra è diventata una ditta. Dico Age&Scarpelli, con la “e” commerciale. Di qui in avanti si potrebbe raccontare insieme. C’era una sintonia evidente, un modo di vedere le cose e di divertirsi che veniva riconosciuto dai committenti. L’unico errore che abbiamo fatto è stato aspettare molto tempo prima di scegliere un rappresentante legale. Con un agente avremmo guadagnato subito qualche soldino. Ma pazienza. Il problema, invece, fu rifiutare certi lavori, dopo I soliti ignoti e, soprattutto, La grande guerra. Avevamo deciso di non ritornare a certe farse. Era una questione di maturità artistica, se vogliamo. Se c’era un film buono da scrivere, con un regista all’altezza, non importava se i soldi arrivavano tutti e subito. Anche perché facevamo i conti, come uomini e cittadini, con la società che si era costruita dalle illusioni del dopoguerra. Avevamo la fortuna di venire a conoscenza delle vicende della gente “di rimbalzo”, come succede nel biliardo, quando la palla tocca le sponde e poi non riesce a centrare i birilli. Ma era anche il nostro segreto, perché avevamo la distanza giusta dalle cose da raccontare. E questo permetteva una certa ironia. Finita la scossa del neorealismo, era la commedia che riusciva a cogliere i cambiamenti. A far data da Domenica d’agosto di Emmer, se vogliamo. La commedia di “capacità realistica”, nella forma sempre combinata di sorriso e amarezza, proseguiva l’indagine sociale, segnalava le storture e le inadeguatezze, i vizi e le debolezze. Era sostanzialmente umanistica. La gran parte degli intellettuali italiani sottovalutarono la portata del nostro lavoro. Fu un errore, poi riconosciuto. Ma anche noi “commediografi” sapevamo che certe farse non potevano essere difese.
Le nostre intraprese. C’eravamo tanto amati è il film che tengo nel cuore per quello che il nostro lavoro, credo, è riuscito a mettere a fuoco di un’epoca e dei suoi cambiamenti. Ma anche La terrazza. Perché è un film rivolto a tutto il percorso della nostra società, implicitamente. I personaggi agiscono, discutono, si scontrano nel 1980, ma si sente la provenienza da una storia, da una società, da un’impresa: almeno questo volevamo. Bisognerebbe poi ragionare sul successo di una nostra scommessa, L’armata Brancaleone. Davvero era impossibile prevedere le reazioni. Fu visto e distrutto, in anteprima, dagli addetti dei David di Donatello, professionisti e critici. Ma fu accolto in sala da ogni genere di pubblico. E allora? Parlavamo sempre dell’Italia, forse. Di cose che ci riguardano da vicino. È probabile che quel film, in una forma mediata, grottesca, introducesse già un bisogno di bilancio generazionale, per tutto quello che ci avevano costretto a fare, cioè la guerra, e per tutto quello che avevamo intrapreso di nostra volontà, ovvero la ricostruzione e la fondazione di una nuova società. Ma Furio, che ha detto?
SCARPELLI La palla al piede: far ridere Io ricordo bene soltanto le sparatorie in bianco e nero, nel silenzio meravigliato del cinema. Il pianista non veniva sempre, forse perché costava. Così le sparatorie mute erano spezzate dal cartello con la scritta. Però erano emozionanti. Non chiedevamo più di tanto. Un bambino del 2000 si stancherebbe davanti a un film d’azione bloccato ogni tanto da tre, cinque righe di parole da leggere. Noi avevamo una certa fantasia, che andava bene per assecondare un mezzo ancora rudimentale. Oggi c’è una giustificata pigrizia davanti al film. La fatica che facevamo settant’anni fa non si potrebbe più affrontare. A casa, io e i miei fratelli interpretavamo La grande parata di King Vidor come i bambini d’oggi interpretano Schwarzenegger, se lo fanno ancora. Ricordo bene la cura che avevamo per i “caratteri”, non soltanto per i personaggi principali: quello che masticava tabacco, il forzuto, lo straniero. Però bisogna dire che il cinema italiano non forniva possibilità di gioco all’altezza dei film americani. Sì, c’erano certi film storici. E in seguito le commedie di Camerini. I “caratteri” dei suoi film erano sempre divertenti. Il destino mi ha portato a conoscere e lavorare con Camerini. Siamo diventati amici, gli volevo bene.
Camerini e l’ego. Camerini fu davvero alle fondamenta del rinnovato cinema italiano. Un personaggio particolare che non voleva essere particolare. Non lo sospettava nemmeno, di essere speciale. Aveva, non so come definire questa qualità... insomma, tutto quello che riusciva a fare di bello sembrava metterlo in piedi con distrazione, per una leggerezza del sentire, una mancanza di retorica e di manierismo che gli faceva fare le cose giuste al momento giusto. Il tema (o il problema) dell’ego, di che cosa sia, o di quanto si debba alla sua attività, credo non se lo sia mai posto. Non ha mai avuto percezione dell’esistenza dell’inconscio. Come Einstein, che diceva: “Non ho rapporti, né voglio averli con questa entità sconosciuta.” Mi colpì molto questa caratteristica di Camerini, forse mi influenzò. Il lavoro di sceneggiatori, di cineasti, ci ha insegnato a stare attenti a quello che accade agli altri. Se vuoi raccontare quello che succede ad altre persone, e lo vuoi raccontare a loro, non a te stesso, devi concentrarti sull’osservazione degli altri, e imparare in qualche misura a dimenticarti dell’ego. È una formulazione opposta all’attenzione per se stessi. Se guardiamo i bambini, è facile capirlo. Se stiamo attenti a che cosa attira la loro attenzione. I bambini capiscono la decima parte di quello che succede, perché sono inesperti, ma non gli sfugge niente. Ecco, all’epoca, quand’ero ragazzino io, posso dire di aver imparato a tirar fuori quello che catturavo, in forma d’imitazione, parodia, recita, aneddoto. Parlo per me, ma non so perché, ho quasi l’impressione di parlare per gli amici, forse per una generazione intera.
Ironia e sfottò. Con gli amici, quelli dell’infanzia, come quelli del periodo militare e poi della professione,
ciò che catturavamo della vita non lo si disperdeva. Sto parlando di un “modo” della nostra vita. Faccio un esempio. Se con certi vecchi compagni, ancora oggi (anzi, forse oggi più che mai), capita di parlare di un nostro caro “scomparso”, ci troviamo a riferire sempre qualcosa di parodistico, ricordiamo certe sue battute, certi atteggiamenti, che poi messi insieme danno un’idea della psicologia del personaggio. Ecco, mi è uscita la parola personaggio... La cosa curiosa è che tutti sono personaggi. Per via dell’ironia, capito? C’era (e io mi domando: nelle generazioni nuove c’è ancora? Se dovessi dire di no mi verrebbe quasi da piangere) un uso costante dell’ironia. Non soltanto nel nostro gruppo. Poteva degenerare in presa in giro, è vero. Pasolini condannava lo “sfottò” alla romana, che esulava dall’ironia, perché dentro trovavi cattiveria, una perfidia magari incosciente, non matematica, ma molto grave, una degenerazione. Jankélévitch ha scritto un buon libro sull’ironia. Lui dice una cosa, che non so spiegare con precisione, anzi ricordo di non aver compreso bene il ragionamento, ma so che è vera: il riferire è già un atto d’ironia. Da giovane sono stato vignettista e giornalista. I compagni più bravi, più attenti, più idonei a catturare ciò che avviene agli altri e a trasferirlo al cinema, scoprivo che erano stati giornalisti. Ho insegnato per anni, ad allievi non più giovanissimi, magari con professioni alle spalle. Avevano già due piedi nel lavoro di scrittore per il cinema quelli che erano stati anche giornalisti. E il discorso vale anche per la letteratura. Nel dopoguerra fu enorme la necessità di raccontare la gente. Ma qui bisogna spiegarsi bene. Altrimenti continuiamo a mitizzare il cinema e non gli facciamo un buon servizio. Perché il cinema è fatto di storie. E di Storia.
Scrittori e cinema, i valori. Il fascismo soffocò certe vocazioni, certe tensioni alla narrazione libera della società. Con la guerra, il tappo esplose. Torino, anche editorialmente (per l’Einaudi) ebbe un ruolo fondamentale nella costruzione di questa prima ossatura della narrativa italiana, che non fu senza influenza sul cinema: Pavese, Fenoglio, Pratolini, Calvino, Bassani, grandi romanzieri, come Cassola. Poi, questo processo si bloccò, anche a causa del Gruppo ’63, a cui va attribuita la responsabilità di aver censurato quegli scrittori che stavano stabilendo una prima “tradizione” di narrativa italiana. C’erano stati alcuni autori, nella prima parte del secolo, ma il romanzo italiano moderno era davvero appena nato con quella generazione di scrittori. Per certi versi, come accade talune volte nel rapporto tra vittima e carnefice, qualche scrittore fu connivente. Perché Pratolini decide di smettere di scrivere, per esempio? Secondo la testimonianza di Suso Cecchi, smette per l’avvilimento di attacchi così violenti. Calvino si trasferisce a Parigi e intraprende un altro percorso, da un piano più alto, naturalmente. Cassola fu massacrato. Non voglio dire che cambiò “grazie” alle critiche del Gruppo ’63. Pasolini si dedicò quasi soltanto al cinema, al teatro, alla poesia. Bassani, anche lui, smise poi di scrivere. Tutti nello stesso periodo. Possibile che siano state soltanto coincidenze? C’è forse da dire qualcos’altro sul Gruppo. L’intento di rinnovare, di arricchire un “modo” diventato forse “maniera” è sacrosanto. Ma lo si può svolgere soltanto costituendosi in centuria critica? Belinskij era una critico rigorosamente solitario che istigò e guidò una schiera di scrittori nuovi (tra i quali Gogol’ e Dostoevkij, tanto per dire). Qui abbiamo avuto una frotta di critici e analisti innovativi – di valore, certo – e poi... non un solo egregio narratore davvero nuovo. Per
tornare al cinema, proviamo a pensare se Rossellini, Zavattini, De Sica, Amidei e gli altri della grande congrega, invece di narrare, si fossero messi insieme solo per sparlare dei “telefoni bianchi” (il vituperato “modo” delle commedie dell’era fascista). Quando Cesare Pavese disse “il più grande romanziere italiano è Vittorio De Sica” intendeva sottintendere che il buon cinema italiano aveva tratto profitto dalla scuola letteraria neorealistica. Forse fu anche un indiretto omaggio a se stesso. Il neorealismo nacque prima sulla carta stampata. Con questo non si vuole intendere che i cineasti leggessero tanto, assiduamente, e ne traessero consapevole profitto. Ma, come dire? i valori non vivono in se stessi, in qualche modo volano, diventano un pulviscolo che ti arriva addosso, ti ci trovi dentro, anche se non sai che cos’è e da dove proviene.
Politicamente allegri. Dicevo del tappo esploso appena finita la guerra. Noi scrittori del cinema comico praticavamo, come dire... una sorta di legittima allegria politica. Anche in contrasto con certe cattedrali della sinistra, che non amavano che noi si scherzasse su alcune vicissitudini sociali; non amavano Totò più di tanto. Dico “noi” perché parlo di Age, naturalmente, e poi Scola, Steno, Monicelli e gli altri. Eravamo dei rozzi? La nostra biblioteca era vasta. Non ci mancavano le basi di una solida cultura. Eravamo di sinistra. Il cinema era di sinistra, su questo non c’era dubbio. La situazione dell’Italia era una situazione “per” la sinistra. La guerra aveva proletarizzato il paese. Qualsiasi tipo di sicurezza era scomparsa: lavoro, vitto, il minimo di benessere. Ebbene, tuttavia noi lavoravamo liberi, seguendo una nostra visione del grottesco della vita, compresa la satira, compresa la comicità surreale di Totò e Macario. Dopo il fascismo, pensavamo, era legittimo essere “politicamente” allegri.
Neorealismo e borghesia, il caso Antonioni. Il neorealismo, sia quello dei film di De Sica, Rossellini, Visconti e gli altri, sia quello letterario, era stato compreso soltanto per i suoi aspetti materiali. Si riteneva cioè che avesse la sua forza di propulsione e di consenso nell’esposizione di problemi concreti, fisici: il lavoro per mangiare, la casa per abitare, la formazione della famiglia come microsocietà solidale. Ma non era soltanto questo, il cinema neorealista. Questi erano gli aspetti che colpivano di più il pubblico, che certo non era tenuto a fare analisi. Gli autori e gli osservatori dei fenomeni culturali sì, dovevano capire. Se noi guardiamo, e riguardiamo, Ladri di biciclette (come pensiamo e ripensiamo I promessi sposi), scopriamo facilmente anche gli aspetti psicologici, e soprattutto quanta spiritualità c’è dentro questa storia proletaria. In pochi hanno raccolto quest’esempio di narrativa cinematografica, finché il neorealismo in Italia è morto. Oggi sappiamo che il secondo capitolo del neorealismo è stato scritto in America e in Inghilterra, non in Italia. Qui da noi abbiamo dovuto cavalcare l’asino scalpitante dell’ironia, per poter dire qualcosa e, nei casi migliori, tenere viva anche l’analisi psicologica e parlare di un certo malessere. Malessere che poi stava cambiando. Non si potrebbe forse ipotizzare che, in assenza, qui da noi, di un alto ceto sociale degno di analisi, Antonioni l’abbia immaginato? Quella privilegiata, straziata borghesia era, è, davvero presente in Italia? Può darsi che questo
non costituisca una riflessione di qualche valore, ma vorrei concluderla. L’incomunicabilità di cui pativano (e patiscono?) certe sfere alte della società è causata più da chiusure mentali che non da soverchiante sensibilità esistenziale e da contraddizioni interne. Pur di far apparire il nostro paese “normalmente superiore” si conferisce dignità e magari fascino anche a ciò che è greve e peggiore. Certo, è lodevole, magica impostura che fa anch’essa parte della grande arte di narrare.
Magica ironia. Non è detto infatti che la borghesia russa scandagliata da Čechov fosse anagraficamente rilevante, né, forse, tanto consapevolmente sofferente di sé. E però Čechov intingeva – come si dice – la penna del dramma nel calamaio dell’ironia. Guai a metterla da parte l’ironia, si finisce per lasciare nuda e cruda l’apologia, dalla quale il lettore e lo spettatore si tengono alla larga. In America, si dice, è in atto nella critica alta – c’è anche lì – un inaspettato prevalere delle doti di John Fante rispetto al valore di Ernest Hemingway. La forte presenza di ironia nel primo e l’assenza totale nel secondo non c’entrano nulla? C’è chi dice che la borghesia un po’ volgare degli anni ’70 e ’80, dalla quale fugge Alberto Sordi in Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? (il film di Scola che fu campione d’incassi di una stagione alla fine degli anni ’60) è anche oggi più credibile di quella nobilitata da un tragico, e immaginato, “mal di vivere” di un certo cinema seriosamente psicologistico dello stesso periodo. Non sarò io a negarlo. Se guardiamo le commedie neorealistiche inglesi troviamo un approfondimento psicologico reale. Cipputi non è soltanto un vecchio operaio: propone rinnovate esigenze interiori ogni volta. Grazie Altan! A pane e lavoro si può, e si deve, aggiungere che cosa c’è dietro. L’anima non è una caratteristica dei ceti alti.
Come lavoravamo. Noi, io e Age, ci inseriamo tra la fine anni ’40 e la fine anni ’50 in questo contesto, convinti (a torto, e spinti anche dai produttori) di dover escludere le problematiche psicologiche dalle nostre commedie. Salvo scoprire che facevamo rientrare dalla finestra ciò che avevamo messo fuori dalla porta. Ma per forza. Lavoravamo comunque sulla realtà italiana. È una strada che ci portò, come scrittori di cinema, a realizzare Totò cerca casa, La grande guerra, Tutti a casa, lavori in cui, poi, con più distacco, abbiamo riconosciuto di aver raggiunto un certo approfondimento. Come abbiamo lavorato? I soliti ignoti, Tutti a casa o L’armata Brancaleone sono legati in larga misura all’osservazione di uomini che avevamo conosciuto e allo sfruttamento di queste conoscenze. Tutti a casa nasce da esperienze che avevamo fatto un po’ tutti dopo l’8 settembre. Non ricordavamo soltanto i tratti fisici e talune battute del compagno che stava di fianco a noi in branda, ma anche il carattere a cui quei tratti e quelle battute ci riconducevano. Entrati nel carattere per quelle porte, potevamo anche raggiungere una psicologia particolare e narrarla. Ci accontentavamo di seguire questa strada semplice e diretta. Anche perché sostenuti da attori come Sordi, Gassman e gli altri valentissimi. Non cercavamo subito una “psicologia profonda”, ma una superficie vera. E veniva fuori un tizio che fisicamente era così, si comportava così, e dentro invece era cosà. Cercavamo questa
specie di triade. Se a me e Age non riusciva di mettere in piedi questi tre elementi, non pensavamo, né lo penso ancora adesso, di essere davanti a un personaggio. Anche una piccola figura, soltanto in funzione della struttura narrativa, senza almeno questi tre elementi, non è niente, viene fuori una stronzata. Neanche in un poliziesco violento americano, pieno d’azione e sparatorie, funzionerebbe. S’annacqua tutto se non certifichi, secondo una certa psicologia, anche un’apparizione minore. Che cos’è, allora, la galleria dei piccoli personaggi di I soliti ignoti? Questa cosa è risaputa. Eppure devo dire che in Italia ci sono sempre state resistenze a lavorare in quel modo. Probabilmente una difficoltà “etnica”. Quando si parla del sottotesto, anche citando i maestri della recitazione... Abbiamo visto cadere le braccia a tanti produttori, e anche a qualche collega sprovveduto. Si può trovare qualcosa di psicologico nei film farseschi? Credo che qualcosa nei nostri film sia passato. Nei film di Totò, certamente. La comicità viene dal basso, dal popolo, da rapporti diretti con la vita; il comico vive nel magma umano reale, per forza ha potenzialità rivelatrici dei comportamenti. Totò, è vero, era fantasioso, era sopra le righe, aveva una componente futuristica, ormai riconosciuta, ma portava barlumi di psicologia che rivelavano una particolare condizione dell’uomo. Attraverso Totò si vedeva la povertà, l’orgoglio di non accettare prevaricazioni, certe subitanee reazioni all’inferiorità sociale e culturale, i condizionamenti imposti dalle diverse realtà con cui si scontrava. Così quando si scriveva una storia per Totò queste cose si tenevano presenti, nelle battute, magari anche nella struttura narrativa. Si sentono invece manierismo e falsità, quando esplode la ricercatezza drammatica. Credo fosse ancora Jankélévitch a dimostrare che, laddove si sceglie di essere pregiudizialmente drammatici, si fa opera di falsità. Allora, mentre il cinema passava da “pane e lavoro” a una incerta, fantasiosa descrizione di un malessere psicologico, raccontando l’“avventura” dei sentimenti, mentre calava l’attenzione per il neorealismo puro, c’è chi si è salvato proprio con quest’attenzione all’uomo e alla nuova società nell’ironia e nella satira. Oggi il cinema comico ha dimenticato, o non sa praticare, questa via. E allora tutto sembra così vuoto, così appeso. Non voglio fare nomi, ma proviamo soltanto a pensare alle figure dei film comici che ogni anno arri vano sul mercato a Natale...
Negri per Metz&Marchesi. Io e Age ci siamo conosciuti frequentando giornali e riviste satiriche. Adesso fare i nomi è impossibile: ne uscivano in continuazione. Facevo una vignetta fissa sull’“Avanti” diretto da Sandro Pertini, ma intanto scrivevo su “Vie Nuove”. Age collaborava al celebre “Marc’Aurelio”, dove s’incontravano Fellini, Ruggero Maccari, Ettore Scola. Col “Marc’Aurelio”, che non era certo di sinistra, ero riuscito a ottenere di non realizzare mai vignette politiche, perché ero già legato all’“Avanti”. Facevo quelle di genere, sulle sigarette nazionali, o su altre cose di costume. Mio padre era giornalista, illustratore e scrittore affermato. Il padre e la madre di Age invece erano gente di teatro. Eravamo un po’ dell’ambiente, ma la paga era comunque ridicola. Così si lavorava scrivendo per certi sketch della radio, per i primi film comici del dopoguerra, quelli di Bragaglia, Mattoli, si scrivevano battute per Fernandel, i primi film di Totò, e intanto venivano fuori Tognazzi, Vianello, Walter Chiari, cose un po’ da pirati. I film di Mattoli e Bragaglia avevano però un’aria così spavalda, così libera, senza nessun problema di mandare messaggi o piacere alla critica...
Duravano lo spazio dell’uscita al cinema. C’era un Cadetti di Guascogna dove trovi tutti i comici del momento, da Billi e Riva a Tognazzi. Si scriveva su ordinazione. Eravamo i “negri” di Vittorio Metz e Marcello Marchesi. Occorrevano delle gag? Ci chiamavano. Per esempio, ci dicevano: c’è un’arena dei tori, c’è il torero, che è Totò, fra tre giorni consegnate tot numero di gag su uno come Totò e il toro. Ne abbiamo fatti una ventina di Totò. A volte eravamo ricercati esclusivamente come “battutisti”, un lavoro diffuso anche in America. Bob Hope aveva una redazione che gli scriveva gag e battute tenendo conto della sua recitazione senza smorfie, un po’ gelida.
Age&Scarpelli. Corrispondendo contrattualmente a ciò che chiedevano il produttore e la sala, cioè ridere, ridere e ridere, ci siamo poi sentiti autorizzati a metterci dentro qualcosa di più. Non ci mancavano la cultura e l’esperienza. E questo “qualcosa in più”, A) lo sapevamo tecnicamente e B) continuavamo a catturarlo nella vita quotidiana. L’Italia proletarizzata, e poi della piccola borghesia, era cosa viva, un vero spettacolo. Alcuni film di Totò sono stati realizzati proprio in questo secondo periodo di consapevolezza psicosociale, per usare un parolone. Totò cerca casa, per esempio (credo fosse del ’49, ’50) nasceva come una farsa assoluta, ma le tematiche erano socialmente, e politicamente, aggressive. Metz diceva: se aboliscono la fame, non sapremo più come far ridere. Un punto di vista che appartiene alla comicità partenopea, che non è assoluto, per fortuna. Ma poi come lavoravamo sulle sceneggiature? Per noi suggerire l’immagine è sempre stato fondamentale, proprio come succede in un romanzo, dove, certo, tutto è più sviluppato con la parola. Anche per uno come Totò, che sembrava creare tutto per conto suo.
Da Totò a Sordi. Noi eravamo completamente “totoizzati”. Come i giovani della nostra generazione, avevamo assimilato gesti, atteggiamenti e battute di Totò. Ed eravamo in grado ormai di crearne perfettamente aderenti ai bisogni di scena. Ci sono certe sue celebri frasi, ma non tutte erano di Totò. Battute che sono sembrate visceralmente di Totò, le abbiamo scritte noi. Ma il comico da solo, che fa i suoi lazzi e cerca la sublimazione delle sue considerazioni sociali in una macchietta, non sarebbe nulla se non fosse inserito in una situazione narrativa, psicologica, sociale, che in quel tempo era più realistica, ma poteva anche essere di fantasia, con Totò vestito da pellerossa, per dire. Allora l’immagine è assolutamente necessario suggerirla. E ogni attore la pretende in un modo diverso. Molto precisa, chiusa direi, per Totò. Più libera per Gassman, che non veniva né dalla borgata, né dal rione, veniva dall’alto, era colto, era un attore che adeguava se stesso alle situazioni. Per Sordi un’altra cosa ancora, perché era un comico-autore. Sordi aggiungeva la sua capacità d’osservazione, e voleva certi personaggi, certe situazioni. Voglio fare un esempio con un film che non abbiamo scritto noi: Un americano a Roma. Sordi era il motociclista che parlava in “americanese”, e ci sono da notare due cose, una fondamentale, l’altra straordinaria. Quella fondamentale era che lui prendeva in giro tutta la gioventù italiana americanizzata, osava qualcosa che oggi nessuno fa più (gli altri
comici di oggi non hanno più forza e coraggio per prendere in giro i giovani! prendere in giro i vecchi e i nemici non è ironia). La cosa straordinaria è che Sordi ha ironizzato su un modello americano, il motociclista bullo, un anno prima che in America il fenomeno spettacolare, drammatico, e fesso, scoppiasse veramente, con il film di Marlon Brando Il selvaggio. Come lo vogliamo chiamare? Istinto, magia, intuito di influssi culturali, che si moltiplicavano di giorno in giorno nel dopoguerra. Ma è comunque “fuori dall’ordinario” che la parodia preceda il suo oggetto. Sordi interpretava un barlume di intuizione inconsapevole della gente, qualcosa stava per accadere, e quando accadde lui aveva già fatto il film. Le signore restavano fuori dal nostro lavoro satirico. Le donne non si spernacchiavano, non avevano ancora conquistato ciò che era legittimo conquistassero, un potere, e quindi non era pensabile che Lollobrigida e altre potessero affrontare ruoli di quel genere. E certo le donne avevano un altro ruolo, semmai quello più positivo. Noi con i comici maschi facevamo satira sui maschi. Non era nello spirito del tempo che con le attrici si facesse critica sulle donne. E fare comunque non era il nostro mestiere.
L’interiorità dei Mostri. È stato Zavattini a intuire per primo che il boom cambiava le cose e che dovevamo riaccodarci. Zavattini l’orecchio per queste cose ce l’aveva, anche se lo costrinsero un po’ a tirarsi da parte, quanto alla realizzazione di taluni film. Ma era sempre un passo avanti. Per De Sica aveva scritto proprio il soggetto e la sceneggiatura di un film emblematico, Il boom, in cui Sordi deve vendersi l’occhio per pagare i debiti. Dopo La dolce vita, Rocco, La grande guerra, nei primi anni ’60 il cinema italiano aveva avuto una grande spinta anche sul piano internazionale. Ma a quel punto la commedia entrò in crisi, si creò una frattura con la produzione, che era rimasta legata o ai “fattacci” o alle “farse”. Tutto doveva essere evidente, niente poteva restare sottinteso, alluso, e questo rendeva difficile, molto difficile il nostro lavoro, perché di certe cose non si poteva più parlare direttamente, e quindi rischiavi di non parlarne affatto. E l’ambiguità era comunque incisiva. Gli autori hanno la loro responsabilità: pochissimi hanno fatto il passo verso la scoperta dell’interiorità, voglio dire per “far diventare realistico” ciò che è nascosto dentro, invisibile e inudibile, l’interiorità. Il silenzio non è accettato sullo schermo, si crede. E tuttora è raro nel cinema italiano. Che cosa succedeva? Stava emergendo l’ego, la società stava incominciando a vivere su forme forti di individualismo e di arrivismo sociale. Vengono in mente i Mostri? Il nostro gruppo non si è mai distaccato dall’appartenenza a una sorta di “liberalismo sociale”, che ci guidava dal dopoguerra... Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male? E anche quando abbiamo scritto film che potevano essere definiti farse, non abbiamo mai dimenticato questa appartenenza. Certo, la massa della produzione della commedia non era di alta qualità, perché la risata invece di attaccarsi a grandi obiettivi, come accadeva in classici della forza di Molière, si rivolgeva a obiettivi deboli, il gallismo, l’equivoco di persona. Ma I mostri, che nasceva come una farsa, conteneva una dose di satira sociale, credo forte, pur se sguaiata, fino alla cattiveria, fino alla condanna implicita. Nella misura della barzelletta, cioè in una forma possibile di sintesi, abbiamo cercato di comporre un mosaico sociale che rivelasse, per quanto minimamente possibile, anche l’interiorità di queste “nuove” figure. Avevamo un mandato a cui dovevamo
obbedire: far ridere. Così voleva il produttore. Altrimenti un film come quello non ce l’avrebbero mai fatto fare.
Ma farà ridere? Comunque stava succedendo qualcosa in quegli anni, che noi abbiamo incominciato a cogliere e a raccontare. Vogliamo chiamarla una “resa dei conti generazionale”? Un bilancio, non fosse altro che di gruppo, ma spero fosse anche di una società, di speranze, risultati e illusioni, in cui potesse riflettersi una vasta parte del pubblico del cinema. C’eravamo tanto amati, dei primi anni ’70, è proprio questo, e si va fino alla Terrazza, entrambi diretti da Ettore Scola. Ma allora qui occorre dire che avevamo incominciato anche prima, con frammenti di film: sempre un gruppo di amici a rappresentare una microsocietà che affronta un’avventura di speranza e deve poi elaborare il fallimento. Abbiamo sentito la necessità di guardare in faccia la nuova miseria, le speranze, le fregature. L’armata Brancaleone? Sì, anche. Era sempre un gruppo, un’avventura simbolica di un tempo, cioè di una stagione, della storia e della vita. C’era anche l’intenzione di dissacrare i miti della cavalleria per dimostrare che l’esistenza umana ha un valore maggiore nell’istintività. Eravamo partiti da letture alte, Rabelais, Boccaccio, avevamo esaminato i testi dell’Opera dei Pupi siciliani. Sempre però a patto di far ridere. Il vecchio Cecchi Gori ci chiamò una sera a casa sua, dopo aver letto la sceneggiatura dell’Armata, e pensavamo volesse farci a pezzi; disse, con aria tristissima, che si era fatto un sacco di risate. Far ridere: la nostra palla al piede, una palla che amavamo.
Esistenza e professione. Ecco, forse il discorso più diretto siamo riusciti a farlo con alcuni film di Scola. Se in Riusciranno i nostri eroi c’erano dietro, per noi, Cuore di tenebra e tante tante letture, è anche vero che quel film nasceva alla fine anni ’60 da un’analisi sociale e psicologica: il benessere che conduceva a una smania, forse provocata in parte da una depressione capovolta, la vita che scappa e il desiderio di andare a compiere fosse pure una bislacca avventura per evadere da un’esistenza centrata sul far quattrini. Ed è proprio con Scola che siamo riusciti a non ascoltare la domanda ossessiva: “Ma farà ridere?” Preoccupazione che poi abbiamo anche irriso nella Terrazza, con lo sceneggiatore ossessionato. Ecco, con Scola io e Age abbiamo ridotto in percentuale la dose di comicità, di un cinquanta per cento direi, e poi fino al trenta, e al venti, voglio dire cioè che cambiava la qualità della comicità, che diventava più pacata e vera.
Il buco degli anni ’80 e ’90. E qui torniamo al discorso che facevo prima sul romanzo. Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 era ormai chiaro che la crisi del romanzo aveva raggiunto un compimento. Allora la domanda era: ma chi scriverà la storia di quella generazione a Roma, composta da quel tizio, da quell’altro, e quell’altro ancora, che conosciamo così bene, che ci appartiene quasi? E chi scriverà
addirittura la storia di un arco temporale vasto e ormai compiuto di una certa società italiana del ’900, lunga tre generazioni? Ancora il respiro della narrazione. Così sono venuti fuori C’eravamo tanto amati e La famiglia. Ma pensiamo anche a tutto quello che non è stato raccontato degli anni ’80 e ’90. Se fra trecento anni arriva un marziano e vuole sapere cos’è successo in questi due decenni, troverà poco o niente nei testi narrativi. Può soltanto consultare le pagine dei giornali e forse i prossimi libri di storia. Il cinema no. C’è un buco. C’è un’evidente difficoltà della generazione di mezzo. Che, una volta rifiutata la narrativa sulle spinte che dicevamo, e il rapporto narrativo con la società, non riesce a trovare una via nuova. Credo che alla base ci sia l’esplosione dell’ego. Mi ripeto, ma è così. James Hillman ha detto che l’autoanalisi è una psicopatologia. Io penso che si è spento lo sguardo sugli altri. Qualcuno cerca di sfruttare questa situazione. Nanni Moretti ci prova. Lo dico per fare un esempio in positivo. Moretti è come Gianburrasca, che fa del suo ego un burattino per specchiare gli altri, usa se stesso per fare comunque narrazione sociale.
Psicopatologia del cinema italiano. Viceversa altri tirano fuori cose futili, osservazioni minori, personaggi deboli, insomma cose peggiori di quello che in realtà hanno dentro da raccontare, perché sono concentrati sul “modo in cui” anziché sul mondo oggettivo che mette lì, sul piatto, i fatti, gli uomini. Questa è una psicopatologia del cinema italiano. Mi colpì quello che un giorno disse Sergio Amidei, uno dei nostri grandi sceneggiatori e narratori: se da un film puoi tirar fuori un buon romanzo, quello è un buon film. Mi colpì perché contraddiceva quello che pensano abitualmente i produttori, che da un buon libro puoi tirar fuori un buon film. Non è così. Solo se il cinema è romanzo, se è narrazione, è qualcosa; altrimenti non è né cinema né nulla. Scrivere è un’altra faccenda, scrivere può essere tutto, non ha obblighi, né limiti.
12 Miriam mi ha portato come sempre il caffè del pomeriggio. Il salone è nell’ombra. Un velo di nubi rende uniforme la luce. Sto leggendo su un giornale femminile le parole di un amico che non incontro più. È per leggere le sue interviste che ogni settimana compro quel giornale. Domenico è il miglior giornalista di costume che io conosca, amico fraterno di mio marito fin dai tempi dell’università. L’ho sempre considerato uno scrittore sacrificato alla nascita di un genere giornalistico. A casa sua, sulle colline di Albano, in giardino c’era una pianta insolita, afflitta dal peso dei rami. E lui, ogni volta che voleva indicarci la natura inafferrabile di un fatto o di una persona, ci riproponeva la storia di quel susino, la misteriosa attività di un albero di prugne che dava albicocche. Per anni ho ascoltato i suoi racconti; li leggevo sui rotocalchi e mi dicevo con tristezza che faceva letteratura sulla carta per avvolgere gli spinaci. Lavorava come sollevato da terra, dimenticando il giorno precedente con la noia per quello seguente. Non cercava significati, non chiedeva spiegazioni; se lo esortavano a precisare, lasciava cadere il discorso. Flaiano, che lo stimava e che conosceva la sua riluttanza, gli attribuì una battuta: “Se lei si spiega con un esempio, non capisco più niente.” Mi hanno detto che, come sempre, spende più di quel che guadagna. Lo testimonia una storia recente che circola su di lui; vera o inventata, gli va a pennello. Pare avesse dato l’acconto per un abito di Caraceni, un gessato blu, che fece poi ritirare da sua moglie. Il saldo si aggirava sui tremila euro. Un anno dopo, Domenico, alto, incoronato da folti capelli bianchi, entra nel negozio indossando l’abito. Serio e arrendevole, chiede del direttore e, slacciando la giacca, ammette di non poter pagare, “né ora né mai”. Potevano mai chiedergli di restituire l’abito e di tornare a casa in calzini? La cosa straordinaria della sua scrittura è la delicatezza: nei suoi articoli un velo finissimo di polvere di vaniglia copre le sciocchezze e le volgarità della cronaca rosa. Ha quasi sempre assecondato il gioco dei press-agent, che producevano le notizie come piccoli film, simulando litigi, incidenti, fughe dal set e ritorni alla dolce vita, come piaceva ai lettori, o come i pressagent decidevano dovesse piacere ai lettori. Primo fra tutti Enrico Lucherini, il press-agent che ha praticamente inventato tutto.
ENRICO LUCHERINI I dolci inganni A un certo punto anche qui in Italia fu evidente che il cinema non finiva in sala. Quello che si portava dietro un film, oltre alle idee, era la scia delle persone che l’avevano fatto. Chi erano? Che cosa si poteva dire di speciale su di loro? I manifesti erano l’unica cosa a disposizione per avvertire il pubblico e per influenzarlo. Dopo la guerra, ancora a metà degli anni ’50 contavamo soltanto su qualche anteprima per i giornalisti, qualche incontro con gli attori, pochissimi articoli. E sui manifesti. Nessuno aveva mai pensato a inventare qualcosa. Come si fa a dire com’è nata la promozione cinematografica in Italia. Be’, con me è successo qualcosa, l’inizio di qualcosa. Quindi bisognerebbe vedere come mi sono inventato il lavoro io.
Dive e bombe. Da ragazzino, mi colpivano i manifesti dei film. Quella immagine della Mangano nella risaia con i pantaloncini, e le calze nere strappate sul titolo Riso amaro. E Lucia Bosè con la pelliccia ai piedi per Cronaca di un amore. Prima c’era qualche immagine forte, durante il fascismo. Per esempio Doris Duranti nel manifesto della contessa Castiglione, molto scollata, con una farfalla attaccata al petto che impressionava, e Clara Calamai con Girotti quando lui l’abbraccia alla fine di Ossessione. Queste immagini colpirono la mia fantasia fin da bambino. La strega di Biancaneve: è la cosa più forte che ricordo del mio incontro col cinema, a Roma, nel ’42 credo, quindi a otto, nove anni. Facevo la gara delle figurine con mio fratello. Per me le attrici del cinema degli anni ’30 e della fine del fascismo, ai primi ’40, erano già dei miti. Lui copriva il volto delle attrici e io, dalle pettinature, riuscivo infallibilmente a dirgli chi erano. Riconoscevo subito se era Maria Denis o Alida Valli, e magari non le avevo mai viste al cinema. Subivo un fascino enorme dai cartelloni pubblicitari dei film, un fascino quasi erotico. Eravamo in mezzo alla guerra, in mezzo alla morte. Roma era in mano ai tedeschi. Vivevamo in una villa a Castelgandolfo. Mi ricordo i bombardamenti tra Frascati e Roma. Mio padre era medico, lavorava all’ospedale, e con mia madre correvamo lì in bicicletta per vedere se mio padre l’aveva scampata, perché le bombe finivano anche sugli ospedali. Ho visto le stragi. A Frascati, la prima volta che ci fu un bombardamento, mio padre ci portò immediatamente sul luogo del massacro: esperienza di vita, diceva, dovete vedere, dovete sapere. E così vidi i morti e i feriti che urlavano, mentre tutti accorrevano. Preferivo le attrici, ma le cose misteriosamente s’associavano, la morte e le donne. Ancora adesso, quando al cinema si parla del nazismo, in La vita è bella, o Canone inverso, mi appassiono alle vicende. Già a quel tempo ero informatissimo sulle vicende torbide delle attrici del fascismo: sapevo che Doris Duranti era l’amante del ministro della cultura, Pavolini, e che faceva il cinema per quello. Sapevo della Petacci, perché mi colpiva che la sorella facesse il cinema, ed era evidente che lo faceva perché era parente dell’amante di Mussolini. Seguivo le attrici che venivano a lavorare in Italia perché erano state le amanti dei gerarchi nazisti o fascisti, tipo Lyda Barova, Cristina Soderbaum. Amai subito il “dietro le quinte”. Era già una vita nel cinema, la mia, da adolescente.
Passeggiando per via Veneto. Non mi piaceva l’idea di fare il medico, come voleva mio padre, che m’iscrisse all’università nel 1952. Mi appassionava l’evento-cinema con la grande attrice. Non capivo ancora il neorealismo. Mi eccitavo invece quando c’era Lucia Bosè all’anteprima di Cronaca di un amore di Antonioni, o con Peccato che sia una canaglia! di Blasetti con la Loren, e mi colpiva la Lollobrigida perfino nei filmetti con Rascel. Non m’interessava un’anteprima di Lizzani, o Roma ore 11, che era bello, ma io non lo capivo ancora. Mi piaceva la diva e quello che c’era intorno, che immaginavo che ci fosse intorno, perché non c’era niente di tutto quello che c’è oggi. S’incominciava a parlare di via Veneto. Il cinema non finiva dopo la proiezione. Questa era la novità. Ma non c’era ancora la costruzione degli eventi mondani come poi avrei fatto io. Si andava in via Veneto per parlare di cinema e di teatro. Qualche produttore incominciava a discutere dei film con sceneggiatori e attori. Un anno era di moda Donei, l’anno dopo Café de Paris, e io, che intanto mi ero iscritto all’Accademia d’Arte drammatica, ho incominciato a frequentare quella gente, Fellini, Visconti, Flaiano, Bolognini. Li ascoltavo incantato. Mi piacque subito studiare le mosse, i giri privati, i casini di tutti. Al secondo anno d’Accademia, Romolo Valli, Patroni Griffi, De Lullo e Rossella Falk mi presero in compagnia. Ero un cane. Anche dopo sessanta repliche ero terrorizzato soltanto a dover dire “Il pranzo è servito”. Mi facevano mille scherzi. Nella Bugiarda di Diego Fabbri dovevo aprire il secondo atto. In sala c’era Sofia Loren, che per me era già la Loren, prima che andasse in America. Era lì per vedere la commedia e decidere se farla al cinema. Che poi andò a finire che Ponti la fece fare alla Spaak. Io dovevo dire in scena: “Signora...” e Rossella Falk mi rispondeva da dietro le quinte come fosse nuda. De Lullo mi aveva dato azioni precise da fare, cose da toccare, sedie da spostare, perché altrimenti mi veniva il panico. Eravamo a Civitavecchia, e vedo tutta la compagnia schierata dietro le quinte che mi guardava. Avevano complottato qualcosa, ma cosa? Be’, avevano attaccato al suolo ogni cosa, le sedie, i bicchieri che dovevo alzare, il libro che non veniva via. Un disastro. Sono uscito e li ho mandati tutti al diavolo. Ma mi hanno voluto ugualmente per la tournée in Sudamerica. Ed è stato lì che ho capito che volevo fare il press-agent. Ognuno aveva un ruolo organizzativo. Rossella s’occupava della sartoria. Valli del ruolino per le prove. A me chiesero di occuparmi delle relazioni della compagnia. Il pranzo con l’ambasciatore, chi si doveva invitare, se c’era qualche giornalista, che cosa si poteva dire dello spettacolo. Un lavoro mai esistito. Fino a quel momento avevo soltanto immaginato che dietro la decalcomania di Rita Hayworth sulla bomba atomica doveva esserci qualcuno: come si poteva credere che era stata lei a entrare alla Nasa e a farsi fotografare così? In Italia nemmeno ci si pensava. C’era materiale, questo sì: le prime fotografie delle anteprime sui rotocalchi, la gente che si accalcava in via Veneto per vedere le attrici, i turisti e i professionisti americani... C’era la società che si stava riorganizzando e la gente che aveva potuto smettere di pensare soltanto alla fame e al lavoro. I concorsi di bellezza producevano bellone. Le mamme accompagnavano le figlie in via Veneto per mostrarle ai fotografi e speravano che qualche produttore le notasse.
Sempre d’accordo con gli attori.
Ho parlato del teatro, alle origini del mio lavoro, perché lì ho incominciato a provare le prime iniziative. Patroni Griffi mi scrisse un ruolo per D’amore si muore, che io rifiutai per dedicarmi soltanto alla promozione, alla Biennale Teatro, raccontando che cosa succedeva dietro le quinte. In teatro ho fatto cose incredibili. Alla prima di Metti una sera a cena (ma ormai ero già maturo) ho messo amanti ed ex uno dietro l’altro in modo che il flash mi beccava Anna Maria Ferrero e Sorel con Gassman, che si era lasciato con Anna Maria, e Gassman era seduto di fianco a un’altra ex, Annette Stroyberg, quella di Vadim. Una volta, a teatro si andava come in chiesa. Da quando c’ho messo il naso io, lo spettacolo incominciava mezz’ora prima, perché partiva un giro di flash e di combinazioni infernali, per i giornali, ma più avanti poi è stata la televisione a lavorare su tutto questo casino. Cercavo di fare lo spettacolo nello spettacolo. Alla prima di Dopo la caduta, che era la storia di Marilyn Monroe e Arthur Miller, invitai Ava Gardner, che sapevo di passaggio a Roma, e la misi in mezzo alla platea, e a metà del primo tempo, come speravo, la Gardner s’alzò per andarsene. I giornalisti non si potevano muovere. Alla fine del primo tempo tutti addosso a me per sapere, dissi: se n’è andata perché era talmente emozionata di rivedere la sua cara amica Marilyn in scena... La Gardner era scappata in taxi perché non capiva una parola d’italiano! Tornato in Italia dal Sudamerica, avevo incominciato a spifferare ai fotografi di certi incontri di cui venivo a conoscenza grazie alle mie amicizie. Li facevo correre in un bar sapendo che c’erano, che so, Anthony Franciosa, che stava con Ava Gardner. Un giorno Bolognini mi spiegò che per La notte brava voleva inventare qualcosa. C’erano belle attrici nel cast, come Rosanna Schiaffino, Anna Maria Ferrero, Elsa Martinelli, e altre. Dovevano fare le puttane. Lì, conobbi Pasolini, che aveva scritto il film. Inventai il bagno notturno in mare di tutte le ragazze, ancora vestite, all’ultimo ciak, a Fregene. Una sera ho fatto andare la Schiaffino in via Veneto con un abito che s’apriva fino al culo, e ai fotografi dicevo di seguirla, e non di precederla, e a un mio segnale Rosanna lasciava cadere il soprabito e zac, c’era la foto sul sedere. Sempre d’accordo con gli attori: questa è la verità. Non piacerà che ora si svelino queste cose, ma alla mia età ormai... Il fatto è che in questo modo scoprivo che era possibile promuovere il film prima che andasse in sala, addirittura prima che fosse finito.
Didascalie diaboliche. S’andava ai tavolini di via Veneto dopo il cinema o dopo teatro a discutere: la Masina era Macario vestito da donna o no? No, forse no. Gassman il bello altero era diventato un comico pezzente per via dei Soliti ignoti o no? E così via. E si fronteggiavano i clan. I più importanti erano quelli di Visconti e di Fellini. Con Visconti c’erano Rosi, Zeffirelli, tutta la Compagnia dei giovani di Valli e De Lullo, Patroni Griffi, dei sarti, come Lancetti, Gassman che aveva fatto con Visconti Oreste. E con Fellini c’erano Flaiano, che veniva poco e andava a letto presto, poi Mastroianni, De Feo, e la corte di ragazze e intellettuali del momento. Questo era nello stesso tempo scambio di intelligenze, di cultura, e materia per me, perché io ci lavoravo su quegli incontri. La cronaca rosa che usciva sui giornali era roba combinata da me, questa è la verità. E studiavo, perché c’era proprio da analizzare le situazioni e scoprire le soluzioni. Ho avuto alcune insegnanti, certo. La Loren, prima di tutte. E anche Virna Lisi. Per esempio, quando doveva fare delle foto con un gruppo di altre attrici per un nuovo film da lanciare, mi
sono accorto che lei si metteva sempre a sinistra delle varie Marisa Mell, Claudine Auger, Ursula Andress. Insomma, un bell’insieme di prime donne. Be’, io pensavo fosse per una questione di fotogenia, offrire il lato migliore del viso. Quando mi sono trovato davanti tutte le pagine dei giornali per controllare i servizi ho capito: il primo nome nella didascalia era sempre Virna Lisi. Magistrale.
Incassi, che dolce vita. Quando Tazio Secchiaroli fotografò al Rugantino la ballerina che si spogliava, la celebre immagine ripresa da Fellini con lo spogliarello di Nadia Gray per La dolce vita, ebbene quello fu l’inizio ufficiale. Ma ormai tutto era già avviato e i giornali incominciavano a sapere dove pescare. Da me. C’era un fotografo che di cognome faceva Paparazzo. Ma questo lo sanno tutti, ormai. Quello che Fellini prendeva da via Veneto per La dolce vita l’avevo provocato io giorno per giorno scoprendo il mio lavoro. Però non avrei mai pensato che Fellini si sarebbe giovato delle foto che avevo combinato io nel corso degli anni. E d’altra parte, c’erano proprio tutti, dalle star di Hollywood sul Tevere (Grant, Hepburn, Douglas) a re Faruk, gli armatori, gli industriali. È finita perché La dolce vita, successo mondiale, ha portato i turisti in via Veneto e noi siamo dovuti sloggiare. Comunque, non mi è mai piaciuto il pettegolezzo antipatico. Oggi siamo arrivati a dei livelli... Mi piaceva il gossip in funzione del film. Fatti che avrebbero aiutato l’attore o l’attrice protagonisti, e quindi la distribuzione. Prima c’era soltanto qualcuno che telefonava ai giornalisti per dire che c’era un’anteprima, c’erano i manifesti e i prossimamente, ma non sempre. Figuriamoci poi la televisione, che era appena nata e faceva i drammi a puntate e i giochi a premi con Mike. Per me gli incassi erano la prova del nove. Controllavo subito, per vedere se ero riuscito a far viaggiare il film. Quando poi mi sono occupato di televisione, guardavo l’auditel. La risposta della gente anche al mio lavoro.
Nascita di una Ciociara. Non fu difficile promuovere per Ponti la giovanissima Catherine Spaak de I dolci inganni, perché il regista Lattuada aveva una bella ninfetta da mandare avanti a ogni film, prima la Del Poggio, che aveva sposato, poi Antonella Lualdi, Jacqueline Sassard. Il lancio della Spaak fu clamoroso perché riuscii a ottenere delle copertine di settimanali. Dai manifesti, più o meno eclatanti, si stava passando alla forza delle copertine. E io incominciavo a capire qual era la portata dei giornali, la loro gerarchia, per avere i primi, i più importanti anche per ordine d’uscita, e poi, a ruota, tutti gli altri. Per esempio, quella volta avevo capito che “Gente” doveva essere il primo. A quel tempo non esistevano dati sulla diffusione dei giornali. Bisognava capire a occhio. Non sapevo però che Ponti mi stava mettendo alla prova per Sofia, che doveva rientrare in Italia dopo il successo americano, essendo giudicata qui una “sciupafamiglie”, perché stava con Carlo Ponti, che si era separato, e nel passato era stata anche una sexy star. Bisognava recuperare l’immagine per il nostro paese. E Sofia mi ha introdotto alla professionalità. Ponti dice: dobbiamo inventare “la ciociara”, una donna semplice, che ha sofferto, con una figlia violentata, senza trucco. E Sofia dice: dobbiamo
incominciare da “Life” per finire a “Grand Hôtel”, compresa la Rai. Lei sapeva benissimo qual era l’arco della promozione e la sua cronologia. Sofia era bravissima. Aveva imparato tutto in America e aveva trasportato tutto in funzione del suo personaggio. Al mattino voleva sempre le rassegne stampa. Dove il suo nome era stato citato e basta scriveva: ni. E passava. Sì, dove si parlava bene. No, dalle minime critiche alle stroncature. Non soltanto dei suoi film, ma di ogni cosa che riguardava la sua immagine. E passava tutto a Carlo Ponti, che prendeva provvedimenti cercando soluzioni per intervenire sui giornali, credo. Forse, in certi casi, avrebbe fatto prima leggendo le sceneggiature a dei critici, per avere qualche consiglio. Bisognerebbe chiederlo a lui. Io parlai con Sofia dei grandi esempi di dive americane e italiane e dei loro grandi personaggi, Gilda-Hayworth o la Mangano-Anna. Lei odiava la Mangano. Ma non era la strada giusta, il conflitto. Mi insegnò che bisognava partire da un’immagine forte, completa, da imporre per tutto il film fin dalla prima conferenza stampa. E per la Ciociara scelse quella del sasso scagliato: lei stracciata, un po’ sexy ma non troppo, la bambina lì per terra. Diventò il manifesto, il flano per il giornale, il simbolo del film, insomma quello che oggi chiamiamo logo. E io così ho lavorato fino a oggi. Lei aveva imparato molto dagli uffici stampa americani. A Hollywood aveva fatto qualcosa come dieci film in cinque, sei anni. Per indurre il pubblico italiano, soprattutto il pubblico femminile, ad accettarla di nuovo, avevamo deciso di lavorare sul desiderio di maternità di Sofia. Ogni volta che incontrava un bambino facevo fermare il fotografo e Sofia accarezzava il bambino. Siamo andati a fare anche un pellegrinaggio in Ciociaria, in mezzo alla povera gente. E lei piangeva, perché avrebbe proprio voluto avere un figlio, no?
Viale del tramonto. Inizialmente Sofia non si fidava troppo di me. Mi vedeva come un ragazzino pieno di idee, ma doveva calmarmi e farmi ragionare. Fu lei a imporre a De Sica di girare per prima la sequenza del sasso per avere immediatamente l’immagine. Per il Bell’Antonio si trattava invece di trovare un colpo d’occhio su Marcello, sul suo sguardo, che doveva darci subito l’idea del film. Con Mastroianni facevamo delle nottate in macchina in giro per Roma e mi facevo raccontare tutto, del film, della sua vita negli anni ’50, del teatro, tutto. Per me è come una droga ascoltare. La vita di certi personaggi m’intriga, i fatti di sangue, i delitti passionali, il terrorismo, le dark ladies, un mio film cult è Viale del tramonto, perché si parla proprio della vita del cinema.
Incendi e ciliegi dal Giappone. Ho chiamato Matteo Spinola perché il lavoro improvvisamente diventò tantissimo. E sono stato fortunato. Ha la mia stessa passione ed è completamente diverso da me, calmo, equilibrato, introverso: lui conta fino a dieci prima di parlare. Abbiamo incominciato subito bene, e questo è stato importante: La dolce vita, La notte brava, e via. Gli elementi della promozione sono stati: prima il sexy, poi le maggiorate, dal film di Blasetti con De Sica che esaltava le doti della Lollo; e noi, venuti dopo, abbiamo usato di volta in volta questi elementi per lanciare questa o quella attrice. I problemi più grossi del mio lavoro li ho avuti coi registi.
Vai a far accettare ai registi italiani una stroncatura della critica. Una volta Alberto Bevilacqua, a Venezia, per La donna delle meraviglie mi obbligò a chiamare i critici per tentare di modificare almeno i titoli dei quotidiani. Visconti invece incassava benissimo. Guardava i giornali con me, e poi: “Be’, dove si va a mangiare?” La censura non era nostra amica, però ci ha aiutati qualche volta. Quando bloccarono l’Arialda di Testori, a Roma, riuscii a portare in piazza un gruppo in cui c’erano Paolo Stoppa, Rina Morelli e Luchino Visconti, con i cartelli in mano: “Ridateci il teatro”. Una cosa che impressionò tutti. E Luchino, con me, si faceva un sacco di risate per queste manifestazioni di artisti. Con Visconti, inventavamo cose incredibili. E i giornalisti, ancora oggi non riesco a crederlo, riportavano tutto. Per Il giardino dei ciliegi dissi che i ciliegi arrivavano ogni cinque giorni dal Giappone. E tutti lo scrissero. Ma ci pensate? Una volta ho preso Jean Sorel e Lea Massari durante le riprese di un film, ho fatto rovesciare un vecchio camion (togliendo il motore, perché costava) e li ho fatti uscire dallo sportello mentre io stesso davo fuoco e il fotografo scattava. Incidente sul set, salvi Sorel e la Massari! Ma i direttori dei giornali perché ci credevano? Evidentemente anche loro volevano vendere. E Sandra Milo, in Vanina Vanini (che ribattezzai Canina Canini), d’accordo con me sfiorò una candela con la parrucca, che prese fuoco, e appena prima di gettarle la coperta addosso feci scattare la foto. Un’immagine drammaticissima, che “Oggi” comprò per una grande copertina. Ci credevano? Ma quando lavoravo con Pasolini non fu mai necessario fare queste cose. Con Pier Paolo bastava convocare degli amici scrittori e giornalisti, parlare, farlo parlare e far uscire buoni articoli sull’“Espresso”.
Loren versus Lollo. Il conflitto Loren-Lollo l’ho già trovato avviato. Erano davvero nemiche. Senza particolari spiegazioni. Una cosa come Bartali e Coppi. Due grandi caratteri, due diverse e straordinarie bellezze. In Italia c’è sempre il mito dei duelli. La Lollo era un ciclone. Se m’acchiappava prima lei diventavo l’uomo-Lollo. Ma non era intelligente come la Loren nella gestione del suo personaggio. L’ho ritrovata per La romana televisiva, quasi vent’anni fa, e lì non ho dovuto faticare per la promozione. C’hanno pensato da sole lei e la Dellera. Alla conferenza stampa non invitai la Lollo, perché m’aspettavo un casino che francamente non volevo. Be’, lei venne ugualmente (credo mi odi) e, tra un Moravia sordo e un Patroni Griffi allibito, disse: “Per colpa di quella lì mi sono dovuta doppiare.” E la Dellera, malefica e bravissima: “Veramente, noi tutti ci siamo dovuti doppiare per colpa della signora, perché quando c’era lei si sentiva il suggeritore...” Non è una scena della strega di Biancaneve?
I miei film. Il ’68 cambiò il rapporto con le star. Tutto fu smitizzato. L’ironia cambiò le cose. Oggi poi è diventata cattiveria. Dal ’68 in avanti attori e attrici incominciarono a sedersi su ogni divano, davanti a tutti i giornali, cosa di cui s’impadronì subito la televisione, altro elemento che cambiò tutto. E il lavoro è diventato più complicato, si tratta di evitare strafalcioni, errori d’immagine, cadute di stile, perché questo oggi è il problema maggiore. Con gli spot che
promuovono il divano su cui stai seduto, mentre sullo sfondo vedi il nome di una banca, son cose bestiali queste. Non è facile, perché prima Ricci e poi Blob esercitano un controllo spietato. È difficilissimo il lavoro. La tv manda praticamente in onda pezzi di film, gli attori parlano subito dopo, la tv va sul set, presenta, lancia, ripete. Sono i tempi ormai che dobbiamo controllare. Prima i giornali, poi le tv, in ordine a seconda della coproduzione di rete. Ma il lavoro di press-agent degli anni d’oro, con i piccoli eventi, le scaramucce finte, insomma l’immaginazione e la fantasia, quel lavoro è finito. Sono stato regista: erano i miei film, quelli.
13 Filippo mi ha incantato. Per spiegarmi quelle parole latine mi ha preso per mano, con affetto, senza alcuna condiscendenza. Sapevo di avere un nipote intelligente, profondo. Ora ho scoperto la sua astuzia dialettica, la vivace cultura in formazione. È una delle ultime cose belle che la vita mi concede. Non è soltanto questo, però. Ho avuto un piccolo choc ascoltando le sue parole: Filippo mi ha emozionato come mi emozionava mio marito, quando mi parlava accompagnandomi in qualche viaggio nel tempo, in un cortile medievale, a raccontarmi i segni di ogni stendardo o di fianco a un lanzichenecco che carica l’archibugio, e poi in un istante mi riportava indietro, a vedere il riscatto di quel tempo nello sguardo del presente: il militare che schiaccia un pulsante e vede un puntino verde deflagrare sullo schermo, ma ha appena fatto crollare tre palazzi e ucciso cento persone. Ho sentito la sua carezza, una carezza del pensiero che tocca le mani e la mente. E questa sera ho fatto tardi, rovistando nello studio. Ma ho trovato quello che cercavo. Le mie domande. Mio marito ascoltava tutte le mie domande. A volte mi trovavo a parlare per associazioni, parlavo e parlavo, pacifica nella mia ignoranza e inquieta nei miei bisogni. Lui non rispondeva. Lasciava una pausa, uno spazio. Poi, la sera seguente, trovavo una lettera appoggiata al cestino della frutta, in cucina, che cominciava sempre: “Mia dolce signora”. La scriveva all’università, nel tardo pomeriggio, segnando data e ora, nell’ufficio ricavato dall’abbaino dell’istituto di filosofia della storia, con una Parker smaltata verde scuro. Ritagliava questo tempo per me, per lasciarmi qualcosa che è permesso soltanto alla scrittura. Conservo una ventina di lettere scritte in cinque, sei anni. Ecco quella che cercavo:
“Ufficio, 4 maggio 1976, ore 17.27 Mia dolce signora, mi ha colpito che nelle tue questioni a partire dal senso etico che spinse Luciano Emmer ad abbandonare disgustato la sua professione, tu abbia legato il senso del mestiere, come è nato, modernamente, nella società medievale, al lavoro collettivo del cinema, un mezzo di comunicazione che comprime il tempo, lo imita, lo svolge in una narrazione parallela al tempo reale e lo mette sempre nella prospettiva del passato, inesorabilmente del già stato... Posso dire, come studioso che il cinema italiano del dopoguerra è una fonte necessaria per uno storico. E questo lo avvertiamo anche emotivamente, come spettatori e uomini e donne di questo paese per i film che abbiamo avuto e per quelli che abbiamo perduto, per esempio, le opere inesistenti di Emmer, che andava a riempire la storia dove gli altri lasciavano il vuoto! ... A tra poco Franz.”
LUCIANO EMMER La notte che ho inventato la pubblicità La storia del cinema alla mia maniera è la storia di uno che anziché fare l’idraulico ha fatto il cinema. Cioè un mestiere. La gente lo piglia per chi sa che cosa. Io non l’ho mai considerato di più. I film lasciano tracce forti? Come i rubinetti buoni, che fanno la tranquillità di una famiglia. La vita è una sola: è fatta di case, gente, mestieri, film e tutto il resto. Prostituzione, governi... Le cose che fanno gli uomini. C’è chi lo fa bene e chi lo fa male. Se l’idraulico ripara bene, è una cosa concreta. Se un rubinetto funziona per quattro o cinque anni, è stato riparato bene. Ma poi, chi decide se si fa bene o male un film? E già difficile valutare se un politico fa bene oppure no il suo mestiere, e le cose concrete già incominciano a sfuggire, ci sono le opinioni, i punti di vista. Come si fa.
Lapide per il cinema italiano. Ho un’idea per la copertina di questo libro. Una bella lapide, con una data e un’iscrizione che dice: il cinema italiano è morto qui, nel 1960 o pressappoco. Una lapide come quella di Ozu, nel film di Wenders. Quell’orrendo documentario su Tokyo in cui Wenders crede di impressionare il pubblico con quella sua voce da checca mancata, declamando in quel modo lento e scandito: “Se-sì-sè-la-tomb-de-Ozù-e-il-i-aecrì-Mmmù-che-signifi-riàn.” Ma va’ al diavolo, pirla: di’ che questa è la tomba di Ozu e che in giapponese c’è scritto “niente”. E poi perché doveva farlo in francese, che non è la sua lingua? A volte la supponenza produce strane scelte. Si crede che oggi sia più difficile fare il cinema che cinquant’anni fa, ma non è vero. È più facile oggi, perché il cinema è quasi sparito. Tutti possono farlo, tutti lo vedono, e nasce facilmente il desiderio. Ma il cinema, prima, stava al livello dell’opera lirica. E quindi non era cosa facile.
Assunta Spina sul lenzuolo. Il primo incontro col cinema per me è il lenzuolo del mio letto, l’ho raccontato una volta quando mi hanno invitato a una rassegna dei miei film, caso raro in Italia. Ho visto il mio primo film nei primi anni ’20, a Venezia, dove mio padre si era trasferito da Milano per lavoro. Nel tinello si riuniva sempre tutta la famiglia. Un giorno mio padre portò una macchina da proiezione e la poggiò sopra le scale. Poi sistemò le sedie di paglia in fila e appese proprio il mio lenzuolo. Il proiettore assomigliava all’androide di Guerre stellari. Avrò avuto cinque o sei anni. Quando incominciò, io fissavo l’occhio del proiettore anziché il lenzuolo. Ero meravigliato dalla luce che usciva e dal rumore a scatti rapidi. E quando mi hanno fatto voltare verso il lenzuolo ho visto una donna che saliva una scala e bussava disperata a una porta, mentre mio zio diceva che aveva sbagliato rullo: aveva montato l’ultimo. Poi ho ricostruito, anche se non posso esserne sicuro, che quella donna poteva essere Francesca Bertini nelle scene finali di Assunta Spina. Da bambino, a Venezia, andavo al cinema gratis perché mio padre, che era ingegnere del Comune, aveva una tessera d’ingresso e
io ci passavo i pomeriggi. Negli anni ’20 c’erano i sedili di legno e le soubrettes. O si andava al cinema o si andava all’operetta o si aspettava di vedere Fregoli. Io l’ho visto Fregoli. Una volta, un varietà creò scompiglio. Era la compagnia Poker d’Assi. Quattro belle ragazze, ciascuna un asso, di cuori, di picche, eccetera, ma avevano una gamba scoperta, e passarono subito al film, che era Il re dei re di Cecil De Mille, la storia di Cristo, dopo le ballerine. Non ho mai sopportato la musica di accompagnamento dei film muti, mi distraeva. Preferivo il rumore del proiettore, alle spalle. Per una mia zia l’arrivo del sonoro fu un disastro economico. Lei aveva imparato a suonare il pianoforte quando suo padre era ricco (era proprietario di una cartiera ai primi del secolo) e negli anni ’20 si manteneva accompagnando i film in un cinema di Tivoli. Improvvisamente perse il lavoro.
A scuola con Risi. A Milano, dove ero stato costretto a tornare sempre al seguito di mio padre, ero in classe con Dino Risi. Facevamo il liceo. Risi mandava avanti me, per le interrogazioni. Ho dato degli esami all’università, ma avevo già incominciato a fare il cinema, con il dissenso di mia madre che trovava poco serio quel mestiere. E aveva ragione. Per una donna longobarda com’era lei, non era una cosa concreta. La mia era una famiglia di ingegneri. Battere a macchina era un lavoro. Io non ho mai battuto a macchina in vita mia, anche se adesso sono capace. Ho sempre scritto a mano. Mi scarica di più. Ho incominciato a scrivere storie per conto mio, non sapendo disegnare. È una cosa che mi manca. E poi ho fatto documentari con un mio amico, quello stupido di Enrico Gras che ha avuto la pessima idea di andare a vivere in Argentina, perché sua sorella aveva paura che, dopo il campo di concentramento (Gras fu catturato dai tedeschi), a causa della Guerra Fredda fosse ancora pericoloso qui in Italia. Faceva lo schiavetto negro per un produttore. Tornò a fare un paio di documentari per la televisione che stava nascendo, film medici. Destino crudele, lui che informava sulle malattie di cuore, è morto d’infarto.
Contrabbando d’impermeabili. Gras voleva fare cinema per fare cartoni animati. Io invece avevo fatto dei film a colori per conto mio. Erano idee pubblicitarie, per certi impermeabili e un ombrello rovesciato con scarico della pioggia. Li coloravo fotogramma per fotogramma, con una batteria di sette, otto amiche, compresa mia sorella. Ero rimasto impressionato dai film delle origini che avevo visto alla Cinémathèque a Parigi, cose del 1905, 1906. Contemporaneamente al lavoro pubblicitario, facevo il contrabbandiere, perché portavo in Svizzera questi impermeabili, nel ’45. Dal 1938 al 1945 sono stato fermo, ho conosciuto il mio grande amico Henry Langlois, fondatore della Cinémathèque, ma non ho operato né in favore della patria né in favore del cinema. A parte l’episodio del film per Mussolini, di cui non voglio mai parlare. Preferisco non passare per un antesignano della lotta al fascismo. Non me ne frega niente. E quando ne parlano gli altri, devo sempre dare spiegazioni, proprio per questo.
La stanga, bordello per poveri.
La stanga, bordello per poveri. Quando ho fatto i primi film sull’arte, quello di Bosch, vincendo la ritrosia di Gras che voleva fare i cartoni animati, ho costituito una società, anche se non mi piaceva. Sono sempre stato contrario alle società. Tant’è vero che quella che ho adesso è composta soltanto da me. C’erano comunque mio cognato, Gras e Massimo Dallamano, direttore della fotografia: la Dolomiti Film. Loro avevano fatto un contratto per dei documentari con la Scuola di mistica fascista. E fecero un film sul covo di via Paolo Da Cannobio, che io non ho mai visto. Non m’interessava, non perché ero antifascista. Ero a-fascista. Conoscevo la zona perché andavo al bordello da quelle parti. Casini per poveri, non come quelli belli dove andava Lattuada. Ce n’era uno che si chiamava “La stanga”, dove andavo sempre. Al piano terreno c’era un lungo corridoio, gli uomini stavano tutti da una parte, le donne tutte di fronte, e in mezzo questa stanga di separazione che non si poteva superare. La cassiera chiamava: “Libera Milano 2, libera Parma.” Il nome della città corrispondeva al tipo di servizio che ti dovevi aspettare.
A Vallauris con Picasso. Insomma la società poi si è sciolta, mentre lavoravo al Bosch con Gras. Eravamo i primi a fare film narrativi sulle opere d’arte. Eravamo interessati a isolare e raccontare la vicenda contenuta nel quadro, dai particolari. Nel caso del Bosch la serialità dei volti, la fissità nordica; il Paradiso Terrestre diventava la storia viva della cacciata di Adamo ed Eva. Adesso fanno i Cd-rom per “viaggiare nel quadro”. C’è però un equivoco in questa storia dei miei film d’arte. In Francia è nato addirittura il Prix Luciano Emmer alla Biennale du film sur l’art del Centro Pompidou. Ma io cercavo un rapporto puramente cinematografico col dipinto, con la sua vicenda. Mi piaceva fare un racconto del quadro. Mi chiesero sempre questo genere di documentari, anche quando ormai facevo i lungometraggi di finzione. Antonello Trombadori mi convinse addirittura a fare il film con Picasso, nel ’54. Sono stato un mese a Vallauris. Picasso lavorava senza farsi impressionare dalla cinepresa. Andavamo a fare il bagno a Golfe Juan, dove Picasso veniva circondato da giornaliste che avevano dimenticato l’intervista... In quei giorni accadde un episodio storico che pochi conoscono. Una sera chiesi a Picasso se non era il caso di smettere di riprenderlo al lavoro soltanto per le fasi preparatorie. Quando avremmo filmato l’opera? E lui comprese subito. Nella cappella sconsacrata di Vallauris fece sistemare un pannello e mi fece piazzare la cinepresa. A torso nudo, in cima a una scala, disegnò con un grande carbone tre donne danzanti, una colomba e un mostro. Camminò svelto sul fondo della chiesa per vedere nell’insieme com’era venuto. Mancava qualcosa. Cercò del rosso e macchiò il tridente che il mostro puntava verso la colomba. Tornò giù e disse: “C’est fini!” La mattina dopo, un disastro: gli operai della cappella coprirono con la calce ogni traccia dell’opera pensando fosse uno schizzo, qualcosa di provvisorio. Picasso era disperato. Avevano cancellato l’opera del significato più profondo della colomba picassiana, lacerata tra la serenità della pace e l’orrore della guerra. Resta soltanto il documento nel mio film.
Da Dreyer a Picasso. Insomma, dicevo di questa storia del film sul paese di Mussolini. Dopo alcuni mesi di lavoro
nella società ero rimasto solo, nel ’40. Mio cognato e gli altri mi avevano ceduto le quote della Dolomiti Film. E arriva la richiesta di un documentario sulla terra di Mussolini, già concordato, dicevano. C’erano delle penali, se non si faceva, ed eravamo vicini all’inizio della guerra. Così sono partito per Forlì in treno, per fare il sopralluogo; poi ho preso un biroccio per salire a Predappio, con un povero vecchio cavallo che è stramazzato il giorno dopo. Ho visto questo paesino arroccato, con una fuga di colline e montagne, lunga, vasta, e lì, purtroppo, è scattato un interesse. C’era un temporale incombente. E io amo molto il paesaggio che fugge verso l’infinito. Amo molto il Tavoliere delle Puglie, per esempio. Qualche anno fa ho fatto Foggia non dire mai addio, che in Italia non ha visto nessuno, ma a Parigi ha avuto successo, e poi l’ho presentato a Foggia, davanti a 5000 persone in lacrime per la commozione. Non ha importanza, comunque. Se uno vuole avere soddisfazione al botteghino deve abolire il cinema. Deve fare come gli americani, cose che stanno a metà tra le videoclips e gli spot pubblicitari. E la gente corre in massa. Oggi potrebbero anche evitare di farli uscire i film e passare subito a ritirare i soldi versati in cassa. Oppure potrebbero puntare tutto subito sull’industria delle armi, non si capisce perché devono spendere tutte quelle energie per fare dei film. È che ci sono degli imbecilli che hanno ancora la vanità di voler fare il cinema. C’è un problema però: che i film condizionano psicologicamente la gente. Con le armi e la droga si fanno solo i soldi. Con i film invece si fa anche un’ottima propaganda per il mercato. Si orienta la mente. Si colonizza il cervello.
Imprecazioni a Villa Torlonia. Ecco, si vede che non ho voglia di raccontarla questa faccenda di Mussolini. Il paesaggio di Predappio mi colpì. Era ancora un periodo in cui mi lasciavo sedurre da immagini alla Dreyer. Così sono tornato con un operatore, che ho scoperto poi che era quasi cieco. A quel tempo si guardava nelle macchine da presa, quei parallelepipedi compatti, attraverso la pellicola. E non si vedeva niente. Poi questo era proprio cieco, e allora ho fatto tutto io. Ho chiamato uno da Bologna, un piedipiatti simpatico, si chiamava Nasi, e almeno sapeva caricare uno chassis, e ho girato questa specie di scena rupestre, questo squallore di colline con le contadine e il temporale che arrivava, che poi creavo io con la pompa. Per ripararsi dalla pioggia le contadine si mettevano le gonne in testa e scappavano verso i casolari, e ce n’era uno che era la casa dei genitori di Mussolini, su cui mi soffermavo. La panoramica continuava sui cipressi e si fermava sulla lapide dei genitori, e c’era l’unica frase del film, con la musica di Mussorgskij, che diceva: “Non eravamo più ignari del dolore e della morte.” Succede qualcosa che non doveva accadere. Questo Nasi, ho scoperto subito dopo, era, “per caso”, il proiezionista di Mussolini a Villa Torlonia. Mussolini guardava spesso il cinema. Si faceva proiettare film d’ogni genere. Insomma, Nasi portò anche il mio film montato e finito e lo proiettò. Mussolini era in pantofole e pantaloni da militare slacciati sulla pancia. Stava sempre seduto di traverso su una poltrona. Alla fine, dopo la frase sul dolore e la morte, si è alzato come una bestia, e si è messo a urlare come un pazzo: “Mascalzoni! Porta sfiga maledetti!” Mi han detto che imprecava in bolognese. E diede subito ordine di bruciare tutto, stampa e negativo. Uno dei titoli proposti per il film era: “La Sua terra”. Insomma, Mussolini non era scemo. C’era una vastità immensa a Predappio, la mietitura del grano, quelle colline che
andavano ritmiche con le nubi cupe. Si sentiva la morte. E Mussolini se n’era accorto. Sono stato indagato per alcuni mesi dall’Ovra. Per fortuna avevo già i contatti con i miei amici della rivista “Cinema”, quella di Vittorio Mussolini, e cioè Alicata, De Santis, Mida, Puccini: erano tutti comunisti, e lo sapevano tutti. Questa era la cosa assurda del fascismo. Certe zone intoccabili. Era una barzelletta. Non per i politici, però. Per loro c’è stato quello che c’è stato.
Ostriche e gelato con Langlois. Il mio vero grande amico è stato Langlois. L’ho frequentato molto quando mi ero rifugiato a Parigi, per un paio d’anni. È lui che ha fatto nascere la Cineteca italiana di Milano, lui raccoglieva le prime cose e spronava gli altri a farlo. Io ero la persona meno ufficiale della Cineteca, non avevo incarichi, è per questo che siamo diventati così amici. Andavamo a mangiare il gelato al Duomo, ma la sua passione era abbinare il gelato alle ostriche. L’avevamo imparato a Parigi durante la guerra. Era l’unico cibo che si trovava, arrivavano i camion e scaricavano, e noi mangiavamo dozzine di ostriche. Era roba da poveri fino a lì. Soltanto con la società del benessere sono diventate preziose.
Il cinema non è Schopenhauer. Amo la superficie. Per me è la profondità per esteso. E non ho mai sopportato la tragedia. C’è già tanta tragedia nella commedia umana. Non ha senso dire che la commedia all’italiana è nata dai telefoni bianchi, o da Camerini, o da chissà cosa. La prima commedia al cinema è stata L’innaffiatore annaffiato a fine ’800. Marx diceva che preferiva la commedia perché la tragedia correva sempre il rischio di degenerare in farsa. Io dissento, perché la farsa non è da meno della commedia. In Domenica d’agosto anche quando un episodio finisce con l’arresto del ragazzo per rapina davanti agli occhi della fidanzata, è così perché è la vita, e non c’è nessuna aria di tragedia incombente, non è una scena con Anna Magnani che corre e i tedeschi che sparano, quella è la tragedia, la stupidità dell’uomo. È la stupidità della tragedia. È già talmente disperata la condizione umana che non c’è bisogno di sottolineare niente. Non è che non mi piaceva Rossellini, La presa di potere di Luigi XIV è strepitoso, il più bello. Poi Rossellini non ha mai fatto dei film, ha fatto dei pezzi di film. Lui li abbandonava e li faceva finire da altri. Aveva delle intuizioni straordinarie, ma poi... Se uno vuole, la stessa Roma città aperta aveva una parte centrale che era un melodramma di quart’ordine, con quella storia di lesbiche. E Paisà, episodi bellissimi, il partigiano alla fine, il negro all’inizio, ma non tutto era buono. Perché Rossellini era così, era un uomo estroso, con una grandissima vena di pazzia. Francesco giullare di Dio aveva delle parti altissime, altre non erano neanche girate da lui, e si vede. Una volta, per tre giorni di seguito, ha girato il suo autista. Anch’io ho girato per Rossellini. Mi chiamava il produttore, mi chiedeva di fare delle riprese. Per esempio per La macchina ammazzacattivi. E in montaggio Rossellini non ci andava quasi mai. C’era una persona di totale fiducia, come Jolanda Benvenuti, uno dei grandi personaggi del cinema. E prima c’era Eraldo da Roma. Con uno come Rossellini... Jolanda era talmente vicina allo spirito di Roberto. Poi lui controllava. Io d’altra parte non guardavo mai in macchina, lasciavo fare all’operatore, pensavo agli attori. René Clair diceva che la cosa più importante è
preparare quello che va davanti alla macchina da presa. Il montaggio per certi versi a volte è già fatto, se c’è una storia da raccontare con degli attori buoni. Adesso c’è questa mania del salto, s’è fatto contagiare anche Bertolucci nell’ultimo film, che sembra un po’ Carolina Invernizio. Domenica d’agosto, con i suoi episodi, non era già un montaggio? Nell’arco di una giornata s’incrociavano le storie, io le ho girate in sequenza, ne interrompevo una, passavo all’altra e poi riprendevo. Al montaggio ho messo tutto insieme, ma era quasi pronto. Questo alternarsi fa parte della vicenda, al cinema. Il cinema non è Schopenhauer, che anche lui poi salta qua e là. E Nietzsche, che lavorava sulla composizione dei frammenti ma aveva un disegno vastissimo, anche nello Zarathustra compone una storia, un racconto. Credo che di tutte le arti, di tutte le espressioni, il romanzo sia quella più concreta, racconta la vita, più di qualsiasi altra cosa. Il cinema viene dal romanzo. In fondo il mio desiderio di fare film nasce dalle prime esperienze sui quadri, quando incominciavo a filmare i dettagli per seguire la vicenda, l’avventura del dipinto. Un film che si ricorda ha una storia forte, funziona anche 50 anni dopo. Quando non è così durano lo spazio di un mattino. Un parallelo tra Idioti di Lars von Trier e La vita sognata dagli angeli di Zonca: del primo, che cosa resterà? I movimenti di macchina? Non sono i movimenti di macchina che fanno un film. Mentre La vita sognata dagli angeli è un film che poteva essere girato anche 50 anni fa e che potrebbe essere girato tra 50 anni, se ci sarà ancora qualcuno che ha voglia di fare un film.
Il cinema è. Il cinema è: delle facce che raccontano delle storie. È un prolungamento della letteratura. I produttori non capiscono, ma questo non c’entra. Loro sono come i produttori di latte o di qualsiasi altra cosa. Devono fare i soldi. È anche stupido lanciare l’anatema nei loro confronti. Mi è venuto da ridere quando ho letto di De Laurentiis che, sul “Corriere”, adesso che è tornato in Italia, diceva che la tragedia del cinema italiano è incominciata quando sono intervenuti i registi al posto dei produttori. Perché in effetti, fino a 20 anni fa, in Italia era il produttore che era iscritto alla Società degli Autori. L’autore era il produttore, capito? Poi si è scoperto che non era giusto. Per il produttore il cinema è: acchiappare una storia, trovare uno che gliela gira con gli attori, trovare uno che la monta, e via. E poi non rischiano. Oggi non ci mettono i soldi perché li prendono dallo Stato. Prima non ce li mettevano, perché li cercavano in giro. Ponti e De Laurentiis li fregavano a Gualino, la Lux. Ghezzi, produttore di Castellani, se li faceva dare dal marchese Roi, pieno di proprietà. Il produttore era un po’ come il protettore per una prostituta. Quello che incassa, ingaggia, eccetera. Naturalmente la prostituta è il film. O, come si diceva ai tempi del muto, la filma. C’era qualche produttore vero, raramente. Rizzoli, per esempio. Ma lui aveva un sacco di soldi. E delegava sempre.
Mo’ piangi, mo’ ridi, mo’ penza a mmamma toja. Peppino Amato era il suo uomo per il cinema. Amato era un vanitoso. Voleva fare l’artista, perché aveva incominciato come attore. Viveva in albergo, nonostante tutte le case che aveva in giro. Riceveva lì tutti, in vestaglia, ma questa è una cosa ormai risaputa. Gli piacevano Rossellini, Fellini; intuiva, ma non capiva molto. La dolce vita l’ha fatto per Rizzoli. È stata
una vera fortuna per lui. Per Rizzoli ha fatto anche il mio Parigi è sempre Parigi. Ma accadeva spesso che a metà di un film gli prendeva il terrore e chiedeva di uscire dalla produzione. Un po’ anche per gelosia, perché era lui che avrebbe voluto dirigere i film, come poi faceva ogni tanto, con Yvonne la nuit, o quell’altro, Morte di un bandito. I suoi provini erano celebri. Chiamava le ragazze, le riceveva nella camera d’albergo, in pigiama, metteva un faro, faceva partire la cinepresa e diceva: “Mo’ piangi, mo’ ridi, mo’ penza a mmamma toja.” Non amo riferire i fatti degli altri. Ma questa dice in due parole Peppino Amato. Quando eravamo a Parigi per il mio film, una sera libera ha invitato tutte le attrici della produzione, Lucia Bosè e le altre, più Silvana Mangano e Alida Valli, che erano a Parigi anche loro, e ci ha portato a bere champagne allo Sherazade, dove c’era un’orchestra che suonava Violino Tzigano. Ha fatto un giro di ballo, poi mi ha chiamato in disparte e mi ha detto: “Luciano, me ne vado perché sono stufo. Paga tu,” mettendomi in mano una manciata di franchi. Ma quando ho pagato il conto, ho scoperto che i soldi bastavano per la mancia al cameriere. Ho dovuto fare la colletta tra la Mangano e la Bosè. E Peppino aveva anche offerto una bottiglia di champagne all’orchestra! Il benessere ha ucciso il cinema italiano. Per paradosso la lapide per il cinema mondiale si potrebbe datare 1933, l’avvento del colore, The Trail of the Lonesome Pine, Il sentiero del pino solitario, perché il colore ha ammazzato il cinema, come la fotografia, che quando è a colori non significa un cazzo.
Un altro finale. La vera storia del perché ho smesso di fare il cinema quarant’anni fa sta in una cassetta, in un pezzo di programma di Telepiù sulla censura, una cosa che ha ricostruito Tatti Sanguineti. Mi hanno costretto a tener fermo La ragazza in vetrina per sei mesi. Tra gli sceneggiatori c’era anche Pasolini. Nel mondo del cinema è come dire a tutti i produttori che Emmer non è affidabile. Alla fine il ministero mi ha proposto di girare un altro finale, cose incredibili. Era la storia di emigrati per lavoro in Olanda, ad Amsterdam. E nel mirino c’era la scena in cui Bernard Fresson, appena arrivato e appena scampato a un incidente in miniera, tanto che decide di tornarsene a casa, paga una prostituta delle vetrine. Ogni gesto erano dei soldi, ma si vede soltanto una spalla nuda. Figuriamoci se io mi metto a fare scene osé. Che cosa me ne fregava a me. Era semplicemente una scena di vita. Il direttore della cinematografia di stato aveva un altro problema. Propose al mio produttore di rigirare quella scena con la prostituta, facendola vedere anche nuda, se volevamo, simulando anche l’orgasmo, se volevamo, ma a una condizione: che alla fine lei leggesse su un giornale che un minatore era morto dopo essere rimasto sepolto tre giorni (al tempo morivano venti, trenta minatori al mese) e, appresa la notizia, si mettesse in ginocchio dicendo: io sono una miserabile prostituta, tu sei un eroe. La cosa che mi ha fatto andare in bestia, è che hanno deciso comunque di tagliarla la scena dell’incontro d’amore, ed era fondamentale, perché lui prima di andarsene voleva darle un bacio e lei risponde: No kiss. Cioè, questo non è amore. Quando alla fine lui sta per prendere il treno, dopo che i due hanno passato un intero weekend insieme, lei dice le stesse parole, No kiss, rifiuta ancora di baciarlo, ma stavolta ha il volto pieno di lacrime. Questa era la storia d’amore del film. Tagliando quella scena della vetrina, non si capiva più niente. Questa è stata la puttanata di quei mascalzoni ai miei danni.
Carosello e Pascal. Allora sono andato incontro alla realtà del boom economico, e alla televisione. Sono andato a Milano perché da lì partiva tutto. Ho incominciato seguendo la mia curiosità, le scuole di ballo e la candid camera, anche se non ero attratto dall’idea di sorprendere la gente che provocavo, mentre mi accorgevo al contrario che nessuno era turbato dal fatto che lo riprendessi. Forse un giorno non ci sarà più la necessità di produrre delle fiction: basterà il bisogno di protagonismo di ogni singolo telespettatore. Tutti sono disponibili a raccontarsi. Finché però resterà almeno uno spettatore a casa ad ascoltare. Mi viene in mente il giorno prima che incominciò la pubblicità in televisione, di cui io in qualche modo ero responsabile. I dirigenti non avevano pensato alla sigla. La inventai in una notte, con i primitivi marchingegni del cinema (non c’era l’elettronica per la realtà virtuale). Una pittrice lavorò per decorare dei sipari, io scoprii una musichetta in un documentario sulle lumache, feci aprire i sipari in una sequenza di sei, mentre avanzava la macchina da presa. Nacque Carosello. Sia chiaro, io ho soltanto inventato la sigla. Poi ho realizzato qualche migliaio di Caroselli. Così mi sono distratto dalla delusione del cinema. L’errore più grosso che si può fare è credere che oggi non è possibile che questo accada ancora. Ad altri livelli, per altre vie, non è spento il tentativo di ammazzare la libertà di espressione; il moralismo è ancora vigente. In un mio libretto cito una frase di Pascal, dal settimo capitolo dei Pensieri: “L’uomo corre spensieratamente verso il precipizio, dopo essersi accuratamente posto davanti agli occhi qualcosa che gli impedisca di vederlo.” Mi piace, perché l’estrema semplicità di questa frase mette al sicuro da ogni interpretazione moralistica.
Il caso e la necessità. Non do consigli a nessuno. A malapena riesco a darli a me stesso. Ma vedo che questo moralismo è diffuso anche nei giovani che fanno il cinema oggi. Il benessere corrompe. È il peggior corruttore. Quando hai la necessità di fare cinema per guadagnare, il bisogno aguzza l’ingegno. Se vuoi l’aragosta e tutto il resto, invece, rischi di prendere un’altra strada. Forse questo è successo al cinema italiano. Il talento si è spento. Si sente la non-necessità di fare il cinema. Quanti hanno l’urgenza di dire qualcosa? Nessuno, quasi nessuno. Non vedi quasi mai un film di cui dici: c’è dentro il bisogno di dire qualcosa, nel migliore o nel peggiore dei modi, questo è un altro discorso. Forse avrà un senso se a 80 anni sono tornato a fare film. Ma la necessità di dire qualcosa, quella è importante. Per questo all’inizio dicevo che il cinema oggi credono di poterlo fare tutti. Non sanno bene che cos’è, il cinema.
14 Riponendo la lettera di Francesco nel fascio delle altre e il fascio nella scatola, mi accorgo che una collana di libri di filosofia nasconde, in seconda fila, disposti in orizzontale, due volumi che avevo dimenticato. Il primo è Vestendo le dive, un libretto con una copertina ocra e la silhouette di una donna nuda avvolta da una spirale. All’interno c’è una dedica: “Natale ’56. A M., che poteva esserlo nel nome della Duse, V.” V. sta per Vittorio, mio cognato. Mi adulava, scherzando sulla presunta somiglianza con la Duse inventata da mio padre. Vittorio era un sarto per uomo che aveva incominciato come aiuto costumista a Cinecittà. Gli piacevo. Sì, ho conosciuto mio marito perché suo fratello mi faceva la corte. L’altro libro, con una sovracoperta nera tagliuzzata, un Garzanti degli anni ’70, è un libro importante, che non ho mai letto: Che cos’è il cinema? di André Bazin. Dentro c’è un vecchio biglietto da visita di Francesco con un appunto: Ugo Pirro, ore 18, Centro sperimentale di cinematografia: Rossellini è più importante di Carducci?
UGO PIRRO Nascita (incerta) di una nazione Il mio primo ricordo del cinema è la sala Iride in piazza Garibaldi a Napoli, nel 1925. La sala Iride era il più vecchio cinema della mia città. C’erano le sedie di ferro. I bambini si sistemavano tutti nelle prime due, tre file. Il pianista stava lì davanti. Un uomo con la bacchetta era addetto a sorvegliare e bastonare i ragazzini che facevano troppo chiasso. Urlavamo, piangevamo. E arrivavano le bacchettate. Non riesco a ricordare un titolo, però. Io abitavo in una stazione ferroviaria, perché sono figlio di un capostazione. Quando mio padre fu trasferito a Napoli-Mergellina, il mio cinema, dove mi portava la donna di servizio, diventò il Maximum, che esiste ancora, con altro nome. Ma anche lì, non ho titoli di film da ricordare. Ero troppo piccolino. Un giorno, quando già ci eravamo trasferiti in un appartamento a via Ferraro, sempre delle ferrovie, mio padre mi mandò a comprare un fiasco di vino. Per un disguido, non pagai questo litro di vino e in mano mi rimasero i soldi. Decisi di andare al cinema pagando per me e per mio cugino. Al cinema Bella Napoli. Vidi la proiezione tre volte di seguito, come rapito, e quando tornai a casa fui bacchettato sulle gambe. Ma ancora non ricordo il titolo del film. Sono certo però di aver trascorso la mia infanzia con le comiche e di aver amato Charlot. Una mattina entrando in prima ginnasio (e allora si sceglieva a undici anni la scuola superiore) mi venne di camminare come Charlot. Tentai un’imitazione. In fondo al corridoio c’era il professore di francese. Mi osservò con disprezzo e mi additò agli altri: “Guardate, questo è un delinquente in erba.” Così era visto il cinema alla fine degli anni ’20 a Napoli.
Anni ’30, equivoci sul cinema. Speravo di riuscire a fare il cronista, come professione. Anzi, da ragazzino mi ero messo in testa di fare l’Accademia militare. Non avevo la vocazione del cinema. Mi piacevano moltissimo i film musicali del cinema italiano, con Besozzi, Elsa Merlini, Il re burlone con Armando Falconi, Felicita Colombo con Dina Galli, i film di Musco. Conoscevo e ricordo ancora tutte le canzoni. La borghesia colta però non andava al cinema. Non era bene. Almeno, in provincia. Era una società chiusa, la nostra. Ma io parlo da un osservatorio molto limitato. Ero sempre il figlio di un capostazione. Però, da ragazzino, a un certo punto ho sentito parlare molto, anche in casa credo, di Gli uomini che mascalzoni! di Mario Camerini, col magrissimo De Sica; dal che dedussi che qualcosa stava succedendo, un pubblico un po’ più esteso si occupava del cinema. Quando si parla del fenomeno del divismo degli anni ’30, non ci si deve immaginare qualcosa di simile al dopoguerra, con le maggiorate e la dolce vita, né tantomeno a quel mondo frastornante a cui siamo abituati oggi. I cinematografi erano molti, è vero, ma il cinema restava sempre un divertimento minore. Anche nelle classi popolari c’era una certa prevenzione verso il cinema. Parlo sempre della provincia e del Meridione. Dirò una cosa, che può sembrare paradossale: secondo me la visione che certi scrittori della mia generazione hanno avuto del cinema, con quell’atteggiamento di sufficienza anche nel dopoguerra, e poi per la commedia all’italiana, nasce da questo rifiuto del cinema che c’era nelle loro famiglie
durante l’infanzia. Perché l’atteggiamento della maggior parte degli scrittori era qualcosa di incredibile. Il cinema per loro era un divertimento per i semplici, o per le signorine di buona famiglia, che ne approfittavano per pomiciare. Il successo delle commediole dei “telefoni bianchi” era generato da questo tipo di pubblico, a cui il regime aveva tolto le commedie sentimentali americane. L’alternativa erano pesanti film tedeschi, e basta. Questa chiusura ha spinto in campo i cineasti italiani, ha aperto la strada a Bonnard, Genina, Alessandrini, Blasetti, Camerini, e un gruppo di attori, come Nazzari, Giachetti, Isa Miranda, Maria Denis. Quel vuoto creò per la prima volta le professionalità del cinema italiano. La verità è che all’inizio del cinema sonoro, quando si usava la presa diretta e gli attori dovevano recitare come a teatro, non si capiva niente di quello che dicevano, e anche di quello che provavano. Non facevano capire le parole e non riuscivano a recitare davanti alla cinepresa. Non lo sapevano fare, il cinema. Poi, a furia di sbagliare, si è creata una categoria di professionisti.
In trattoria non potevo pagare. Quando mi sono trasferito a Roma, per tentare di guadagnare qualcosa e fare il giornalista, scrivendo articoli sui film che dovevano uscire (non era diverso da oggi: embrionali uffici stampa che ti facevano chiamare), durante la ricostruzione, vestito male, camicie sporche, senza soldi, una cosa penosa, mi viene da buttar giù un soggetto. Si chiamava “Ti scrivo questa lettera”. E non sapevo che cosa fare. Gettarlo, farlo vedere a qualcuno? C’era uno sceneggiatore che mangiava nella mia stessa trattoria, però lui pagava, io no. Era Ivo Perilli. Mi son fatto coraggio e gliel’ho raccontato. Mi dice: è formidabile. Era una persona seria, ma anche un amico. Non potevo prendere sul serio né lui né me. Ma Ivo mi invitò a consegnarlo a De Santis. Andai alla Lux, aspettai Giuseppe De Santis sulle scale, gli misi in mano il pezzo di carta e scappai. Mi vergognavo. Invece De Santis ne voleva fare qualcosa. Quando iniziò una trattativa per vendere “Ti scrivo questa lettera”, misi come condizione, non so con quale faccia tosta, che per la sceneggiatura fosse incluso anche Rodolfo Sonego, amico di trattoria e di alterna fortuna. Dopo questa faccenda con De Santis abbiamo incominciato a frequentare la sua casa. Tralasciata l’idea di fare il mio soggetto, De Santis pensò a un nuovo film sull’occupazione delle terre, che si chiamava Noi che raccogliamo il grano, e partì per la Calabria portando soltanto Sonego. A me mi lasciò a Roma. Così Sonego, ma questa è una mia ricostruzione, perché a Rodolfo non gliel’ho mai chiesto, si batté perché facessi la sceneggiatura di Achtung banditi!, per ricambiare quello che avevo fatto per lui. Fu il mio primo film da sceneggiatore, diretto da Lizzani.
Carla Del Poggio inseguita dai questurini. Il centro delle attività dei giovani autori del cinema italiano era il Circolo Romano del cinema, luogo storico, che alla fine degli anni ’40 era diventato il Circolo Italiano del cinema. Si facevano le proiezioni al Barberini di domenica. Il cineclub della domenica mattina era molto di moda. Un luogo d’incontro. Io ero ai margini, e a me serviva. Di lì sono nate le riunioni per la difesa del cinema italiano. Difesa da chi? Be’, il nemico era Andreotti. Ci sono stati due momenti. Quando io ancora non appartenevo al mondo degli autori del cinema, ci fu la celebre
manifestazione di piazza del Popolo. Il famoso comizio della Magnani, che a nome dei grandi cineasti e attori, disse a tutti: aiutateci. Il corteo partì per via del Corso e a largo Goldoni intervenne la polizia. Io stavo lì come giornalista. Mi ricordo Carla Del Poggio che scappava inseguita da alcuni questurini. C’erano Amidei, De Sica, che aveva fatto un intervento. Non mi ricordo di Fellini e Rossellini. Il secondo momento di lotta per la libertà del cinema invece partì dal Circolo Italiano in relazione al caso Renzi-Aristarco per il soggetto “L’armata sagapò”, una memoria di Renzi sulla sua esperienza in Grecia, pubblicata su “Cinema Nuovo”. A quel punto però ero un po’ più inserito. Avevo scritto il mio secondo soggetto, “L’armata dell’amore”, stesso argomento del testo di Renzi, che io conoscevo molto bene come ex militare, cioè le malefatte dei soldati italiani in Grecia e delle prostitute bambine reclutate per essere distribuite con le vettovaglie, cosa di cui era proibito parlare. Aristarco e Renzi finirono in carcere. L’esercito (e la chiesa) non si potevano toccare. Una vicenda grottesca. E Carlo Ponti affidò a me e a Sonego il compito di cavar fuori una sceneggiatura, combinando un racconto di Renzo Biasion e quello di Renzi. Ma era un’idea balzana. Ponti era uno che non leggeva mai i copioni. Smontava quello che gli portavi soltanto per una sua intuizione. C’è a proposito quella storia di Monicelli e Steno che, esasperati perché Ponti non leggeva i testi, una volta gli consegnarono una sceneggiatura inserendo una pagina d’insulti. Ponti li convocò dopo qualche settimana, distrusse il loro lavoro e non proferì parola su quella pagina. Fu la prova del nove. Comunque, non si fece mai quel film. Ci provò Rossellini molti anni dopo, chiamando la Magnani, quando già era tutto finito con Ingrid Bergman e Roberto si era portato dall’India la terza moglie Sonali. Be’, le liti tra Rossellini e la Magnani erano acqua passata, ma lei era ancora così bruciata dalla perdita di Roberto che se avessimo fatto quel film, forse...
L’abiura di Fellini. Scrissi una lettera di solidarietà per Renzi, che fu pubblicata su “Cinema Nuovo”, e praticamente si formò una specie di organismo politico, da cui poi è nata l’Associazione italiana degli autori cinematografici, l’Anac, che funziona ancora oggi. La situazione era dura. Non è facile capire, oggi. Per andare in America, se uno apparteneva al cinema italiano non otteneva il visto. Era sistematico. Perfino Fellini, che vinse un Oscar con La strada. Insomma, la questione è un po’ complicata da spiegare oggi. Tanto per restare al caso eclatante di Federico, quando gli rifiutarono il visto perché era membro dell’Anac, lui accettò di firmare, diciamo, una “dichiarazione di abiura”. L’aggravante di Federico era che aveva sottoscritto il Manifesto per il cinema italiano che negli Stati Uniti si diceva fosse stato stilato dal comunista Mario Alicata, mentre la stesura definitiva fu invece di Ennio Flaiano, come sanno tutti. Per farsi perdonare, Fellini versò centomila lire all’Anac, le iscrizioni arretrate e molte di quelle future. E poi, tra l’altro, non bastò, perché Fellini all’aeroporto di New York fu fermato lo stesso, il visto del consolato americano di Roma non fu giudicato sufficiente e la questione fu risolta dall’intervento di un italoamericano, un gangster che aveva amicizie a Washington.
Essere politico.
In realtà io ho costantemente badato a essere un politico in tutte le mie attività culturali. Quando arrivai a Roma ero già politicizzato. Ero stato funzionario del partito comunista ad Ancona, per sei mesi. Ma non avevo buoni rapporti col partito. Non per fatti politici. Quando ero nell’esercito, dopo l’armistizio, mi ammalai di malaria. E mi diedero cinquanta giorni di convalescenza da fare in Sardegna. Invece, clandestinamente, m’imbarcai per Napoli, e disertai. Quando a San Benedetto del Tronto incominciai a fare attività politica, subito dopo la guerra, diedi molto fastidio ai democristiani, al punto che fecero trasferire mio padre, a cui mancavano appena due anni per finire il servizio. Il partito comunista lì era composto soltanto da pescatori. Io ero praticamente l’unico che sapeva scrivere un buon articolo. Scoprirono che ero stato disertore proprio mentre stava arrivando l’amnistia. Ma mi fermarono ugualmente per una decina di giorni e fecero uno scandalo. Collaboravo all’“Unità”, così credevano chissà che avessi fatto, non avendo partecipato alla guerra di Liberazione in nessuna formazione. E il partito mi mise in disparte. Queste sono cose di cui non si parla mai. Prima di questo arresto momentaneo, mi era successa un’altra cosa incredibile. Dopo pranzo, a San Benedetto, noi comunisti, e anche i socialisti, tra cui alcuni attori, c’incontravamo in un bar vicino alla stazione. La compagnia filodrammatica in cui lavoravano questi compagni socialisti decise di mettere in scena Mimusa di Guglielmo Giannini, provocando una ribellione dei dirigenti del partito, perché Giannini era un avversario. Convinsero il protagonista, che si chiamava Ninsi, a ritirarsi, e la commedia non si fece. A me sembrava assurdo. Un giorno, sul “Borghese”, il quotidiano dell’Uomo Qualunque, Giannini scrive una lettera a De Gasperi in prima pagina, quattro colonne in cui mi accusava di togliergli i diritti d’autore, cosa di cui io non sapevo assolutamente un cavolo. Questo per dire il clima in cui s’intrecciavano spettacolo e politica, in quegli anni.
La spinta a ricostruire. Non sono d’accordo con chi sostiene che la guerra ha lasciato di buono soltanto le speranze, che poi sono state deluse. Che significa? Per noi giovani, anche per quelli che non si sono buttati nello spettacolo o nella cultura, il partito, per esempio, è stata una scuola morale. Una scuola morale di fratellanza. C’è poco da fare. Io sono stato in polemica, sono passato al “Manifesto”, ho fatto le mie denunce, ma possono dire quello che vogliono: la formazione mia, morale, un certo mio rigore, li debbo all’esperienza nel lavoro di partito. E affermo che c’era una vitalità nella gente che oggi ce la scordiamo. Il cinema lo dimostra. Tutti volevano andare avanti per costruire il mondo. Come, poi, è un altro discorso. C’erano due avvenimenti insieme: la fine del fascismo e la fine della guerra, che generavano una spinta sociale enorme. Noi oggi siamo in una fase nuova. Abbiamo visto la conclusione di quell’epoca e ne stiamo incominciando un’altra, in cui non ci sono più ideologie, è una fase di frammentazione che prelude a nuove forme di pensiero ancora in formazione. Questa transizione, secondo me, rende difficile afferrare il senso delle cose che capitano. Se ci fermiamo a riflettere come eravamo appena dieci anni fa, be’ tutto è già cambiato. Il cinema italiano di oggi non è capace di cogliere questi mutamenti con la velocità con cui avvengono. Non si può però fargli una colpa. Il cinema degli anni ’40, ’50, e anche ’60, beccava con precisione quasi tutto. Ma non è la stessa cosa. Noi abbiamo vissuto una situazione simile al Rinascimento. La spinta
all’edificazione, dell’uomo e della società, corrispondeva a quella delle arti, e dell’artigianato, cinema compreso. Si potrebbero definire i nostri anni: nascita di una nazione.
Visconti “tappezziere”, Rossellini annoiato. La mia generazione ha avuto la fortuna di trovarsi in quel momento storico a fare il mestiere del cinema. Ricordo tutti, amici e nemici, all’interno di questa situazione speciale di nuova realtà e di necessità. Molti di noi l’hanno fatto per lavorare, il cinema. Oggi l’accesso avviene per ragioni diverse. Per esempio, ci sono spettatori dei nostri film che pensando a quello che avevamo fatto, e criticandoci per quello che avevamo fatto, sono diventati professori universitari. Ma quante ce ne hanno dette... Noi invece il cinema lo facevamo per sopravvivere. Naturalmente, io mi diverto e mi divertivo a provocarli, i professori. Anche con i migliori. Una volta Guido Aristarco m’invitò a Genova a un convegno, su Visconti e la musica. Dissi a un certo punto: Visconti è un tappezziere. Non lo credevo, ma oggi potrei invece discuterne... Visconti era intransigente, quasi arrogante. Non pensava mai al costo di un film. Aveva delle manie che probabilmente a un artista servono, ma che poi, chi è fuori da certe convenzioni non capisce. Mi hanno raccontato che in Senso, per la scena delle monete, voleva i pezzi veri dell’epoca. Ma perché? Geniale era Rossellini. L’ho conosciuto molto bene. Frequentavo la sua casa. Grande artista, ma era annoiato dai tempi e dalle cose del cinema. I film non li finiva mai. Gli piaceva leggere e parlare. Nel suo salotto si restava a chiacchierare fino a tarda notte, mentre la Bergman di sopra s’annoiava, beveva champagne, che adorava, e ogni tanto chiamava col citofono giù, ma Rossellini se ne fregava; il matrimonio era già finito. Sono stato a Palermo un mese con Rossellini. Scrivevo per lui la sceneggiatura di Un uomo al giorno, un libro di Zigallo che poi in realtà era stato scritto da Comisso. Rossellini stava girando Viva l’Italia per il centenario dell’Unità d’Italia e mi disse: vieni, stai in albergo da me, poi la sera lavoriamo. Ma la sera eravamo lì nel giardino di villa Igea, al fresco, con Paolo Stoppa, Sonego, Renzo Ricci, Eva Magni, a parlare, intorno a Rossellini, vestito di lino bianco. Non ho mai fatto una riunione in un mese. Litigava invece con Amidei e Trombadori per tutto quello che cambiava della loro sceneggiatura. Aveva fatto lavorare tutti a quella sceneggiatura, democristiani, socialisti e comunisti, ma poi fece soltanto di testa sua. Perché Rossellini era gentile, puntuale e professionale quando doveva preparare i progetti e firmare i contratti per acquisire danaro, ma poi si riprendeva il potere di lasciarsi andare all’estro e all’improvvisazione. Il cinema lo lasciò per un’idea superiore di cultura, che credeva di poter raggiungere con la tv. Studiò i testi fondamentali della storia dell’uomo. Mi è capitato di vederlo nella camera da letto circondato da montagne di libri...
Amato in vestaglia, De Laurentiis un gigante. Anche Peppino Amato, per certi versi fu unico. Come regista è stato un cane. Donne proibite o Yvonne la nuit non erano buoni film. Come produttore era speciale. Sapeva fare Umberto D e Don Camillo, capito? Il finale di Quattro passi fra le nuvole lo girò lui, contro quello di Blasetti, che poi ammise: Peppino, c’hai ragione, il tuo è il finale giusto. Peppino un giorno entrò da Rizzoli superando la barriera delle segretarie e, facendo volare i fogli della
sceneggiatura della Dolce vita, rifiutata da De Laurentiis, urlò: lo vedi questo “scripte”? È una ssschifezza, donne, festini, suicidi; ma proprio per questo tu lo devi fare, questo film! Poi, adesso si dice: altri tempi. E non stiamo più a pensarci. Ma la vita di Amato è proprio un simbolo d’altri tempi. Viveva in via Veneto all’hotel Excelsior. Riceveva la moglie e le figlie nella hall, i produttori delle major americane e le attrici per i provini nella sua suite, in pigiama. Aveva ville con la servitù dove non andava mai. Gli piaceva sapere che stavano là, come quella di Cortina. Sul tavolino vicino al letto teneva sempre l’immagine della madre, che girava verso il muro quando si coricava con una starlet. Poi la sera s’agghindava e usciva a passeggio riverito da tutti. E il modo con cui faceva il cinema rifletteva in qualche misura quello che era. Altro modello, De Laurentiis. Io lo considero un gigante. Ci ho litigato tante volte, ma era ed è un vero appassionato del cinema. Ancora oggi, mi chiama due volte al giorno per la sceneggiatura che gli sto scrivendo, a che punto sei, come ti è venuto quel passaggio. Ma chi è che mi telefona ormai per questo? È uno che si preoccupa dei suoi film. Ha qualcosa di speciale: a lui proprio gli piace il cinematografo. Non è che a Rossellini o De Sica... Come mi è già capitato di dire, Amato e De Laurentiis in comune avevano il mito di possedere gli studi cinematografici. De Laurentiis con Dinocittà, e Amato in società con Rizzoli i bellissimi studi Safa-Palatino. In modo diverso, loro erano appassionati del cinema.
A pugni per De Sica. Ma, per fare un altro esempio, uno come De Sica era molto preso dalla sua vita, le famiglie, il gioco. Lo incontravo tutte le mattine in via Dell’Oca, quando usciva per la passeggiata. Non mi riusciva proprio di dargli del tu. Anche quando ho collaborato al Giardino dei Finzi Contini. Per lui a Venezia, durante le Giornate del cinema, in pieno ’68, ho preso a pugni un giovane. De Sica non era potuto venire alla presentazione di Una breve vacanza, il film con Florinda Bolkan sulla tubercolosi. Allora dissi due parole io, perché ero nell’organizzazione delle Giornate. E uno di questi giovani dice: “Ma che crepi.” Gli dissi: appena t’incontro ti rompo la faccia. Lo incontrai in un bar e lo sfidai: così vediamo se dici ancora una cosa del genere di una persona. Conobbi insieme Vittorio De Sica e Sordi nei primi anni ’50 aprendogli la porta di casa di Sergio Amidei, maestro e amico che sopportava le mie visite quotidiane, anche se so che poi gli facevano piacere. Erano tristi entrambi, delusi per l’esito del primo film di Sordi Mamma mia che impressione, che in realtà aveva diretto De Sica senza figurare e che riprendeva i pezzi radiofonici celebri di Sordi. Il quale a un certo punto tentò di sollevare l’atmosfera ballando il tip-tap, cercando di sorridere della delusione. E non stava fingendo. Lui era proprio così. De Sica recitava invece la parte del ferito dignitoso, ma non gliene poteva fregare di meno.
Il conto di Sordi dal Bolognese. La storia dell’avarizia di Sordi è vera. Sono testimone di un episodio al Bolognese, qui dietro, in piazza del Popolo. Eravamo io, Amidei credo, Sordi e un amico suo. Quando chiediamo il conto, siccome lo conoscevo, sapevo già che senza un attimo di discussione avrei pagato io per tutti, per evitare scene penose, anche perché eravamo circondati di gente. Ma in un tavolo
vicino alcuni clienti, molto eleganti ma intraprendenti, chiamano Sordi e gli fanno i complimenti per l’ultimo film, la sua bravura, eccetera. Arriva il cameriere con il conto e Sordi dice: no, fermi tutti, pago io. Salutiamo, usciamo in corteo, e appena fuori, Sordi ci ferma e dice: aho, fa tanto a testa, grazie. Ma era anche capace di amicizia, Sordi.
Mogli e produttori. C’era una grande amicizia tra Sordi e la Mangano. Personalità inquietante, la Mangano. Aveva una complessità. E dico inquietante in senso positivo. Incantava. Si sentiva che era una persona molto turbata nella vita. Lei soffriva la sua esistenza. Era un’esistenzialista non per cultura, ma per natura, per vocazione. Un carattere indipendente, ma era un po’ trascurata dal marito, molto preso dal lavoro. Li ho frequentati lei e De Laurentiis, soprattutto quando ho scritto Il processo di Verona, nei primi anni ’60. Fu di Dino l’idea di fare un film su Galeazzo Ciano ed Edda Mussolini. Quello è un film che conserva una memoria rara dei meccanismi del fascismo e dell’influsso della personalità di Mussolini. Ciano al Consiglio votò contro suo suocero, dopo il 25 luglio’43. E lì Mussolini, dopo la fuga a Salò, incominciò la vendetta. Io ero sottoposto da tempo a ostracismo nel cinema per l’intervento del direttore dello Spettacolo Nicola De Pirro, democristiano, che consigliava i produttori di tenermi alla larga per la mia sceneggiatura del Gobbo, che Lizzani fece per De Laurentiis. Così Dino De Laurentiis provò un certo disappunto quando gli rivelarono che la scaletta del Processo, che gli era piaciuta, era stata scritta da me. Poi, come solo lui sa fare, se ne fregò delle pressioni di De Pirro e mi affidò la sceneggiatura. Questo era Dino. Era diverso il rapporto tra Ponti e la Loren, che ho conosciuto ben prima che diventasse famosa. Perché la Loren si affidava molto a Ponti. Scrissi un film per lei, che doveva dirigere De Sica e poi non si fece, Il coraggio e la fame, la storia di una donna del popolo napoletana che si estendeva dall’anteguerra al dopoguerra, ma De Sica si era ammalato e la Loren non era ancora molto in voga. Sono invece sempre stato tenuto fuori dalla commedia all’italiana, perché ci inquadravano in categorie, e io ero giudicato un drammatico.
Perseguitato. Credo di poter dire invece, e oggi ormai si può dire, di essere stato perseguitato. S’intende, nella mia “categoria” di comunista. Il momento cruciale fu tra il ’59 e il ’60 quando scrissi il Gobbo di Lizzani, che ottenne il record di una trentina di tagli. E non volevano neanche farlo uscire. Era la storia di un partigiano disilluso che diventava un delinquente, con episodi della malavita romana nell’immediato dopoguerra riferiti al mitico “Gobbo del Quarticciolo”. Il film si concentrava per la prima volta, credo, su certe devianze del movimento partigiano. La censura però riguardava proprio il soggetto: parlare dei partigiani era una cosa sconveniente. Improvvisamente, noi eravamo una Repubblica che non aveva mai avuto né la Resistenza né gli uomini che l’avevano fatta. Uno dei tagli riguardava addirittura la musica di Piero Piccioni, figlio di un eminente democristiano. Per motivi squisitamente narrativi a un certo punto Piccioni aveva dovuto introdurre un cenno a Bandiera Rossa, che fu cassato. Con noi lavorò Pasolini, incominciava a girare il suo nome anche per la sua speciale precisione nel
linguaggio dialettale. Ebbi degli scontri violenti con Pasolini, che alla fine non riuscì a imporre i cambiamenti di sceneggiatura che voleva. Ma poi ho sempre apprezzato e rispettato il suo cinema. Comunque, accusai pubblicamente per le censure De Pirro, che per ritorsione ordinò ai produttori di tenermi alla larga. Ma così è stato anche per il film tratto dal mio romanzo Le soldatesse. E per Jovanka e le altre il Ministero ottenne di trasformare un soldato italiano che approfittava delle donne d’un villaggio in un tedesco. Insomma, non era facile.
Petri e il ’68 dei critici idealisti. Poi l’incontro con Elio Petri mi permise di sviluppare certi temi in un clima di richiesta di libertà e ripensamento della nostra storia in generale, nel ’68 e negli anni immediatamente seguenti. Credo che A ciascuno il suo, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso e La proprietà non è più un furto siano stati film importanti. La cosa che vorrei ricordare era la pressione che abbiamo subìto io e Petri dalla critica di sinistra. I nostri film cercavano di analizzare la condizione della sinistra all’interno del sistema capitalistico in Italia, in quelli che si dicevano i “meccanismi della produzione”. Subimmo i rimproveri della critica, che era un centro di potere, un potere autoritario anche, perché in certi casi la natura idealistica della critica italiana e la corporazione dei critici creavano un insieme di grande influenza sugli intellettuali. Influenza negativa, credo. E non era facile anche lì per un certo cinema d’impegno civile e politico, perché tra la critica e la distribuzione che non voleva aiutare certi film, certi autori, l’attacco al cinema si ripeté anche in quegli anni. C’erano problemi per Ferreri, Maselli e molti altri. La cosa curiosa è che tra la fine degli anni ’60 e i primi ’70 io e Petri siamo riusciti a farli quei film grazie a produttori di second’ordine. Quello di A ciascuno il suo si occupava di piastrelle. Significò una certa libertà. Sarebbe stato difficile ingaggiare uno come Volonté per il film tratto da Sciascia. Eh, insomma lavorare con Volonté, attore straordinario, non era facile. Aveva esplosioni di aggressività, che maturava piano piano, con ironie, sottintesi. Era lucido e intelligente. Capitò anche a me, sul set, quando giravamo La classe operaia. Petri e Volonté litigarono spesso. Per una discussione in fase di doppiaggio ci fu quasi uno scontro fisico. Ricordo Petri che lo rincorreva agitando la prima cosa che gli era capitata per le mani, un bastone credo, e poi fu lui a cadere e a rompersi qualcosa. Ma insomma queste son cose che succedono. Film così però non ne ho più visti. Raccontavamo il distacco dell’intellettuale dalla realtà e il nuovo rapporto tra la classe operaia e gli intellettuali, implicitamente o esplicitamente. Anche Indagine, che svolgeva il tema del potere in rapporto alla nuova società italiana, era in fondo un film rivolto anche agli intellettuali.
I “nuovi” giovani. Il terrorismo spiazzò tutti, ma il ’68 fu un evento molto positivo a mio parere, nonostante tutto. Idee nuove, una forte reattività sociale contro il conformismo, anche un’espansione della democrazia. Per il cinema questo fu importante. Ma dico, vogliamo dimenticare quello che successe per Ultimo tango a Parigi e Salò negli anni ’70? Dichiarare la distruzione di una pellicola è una cosa gravissima per una società. Perché gli attacchi al cinema, che ancora oggi
avvengono in Italia, più raramente, ma con censure assurde, sono attacchi alla democrazia. Non vedo nel cinema italiano di oggi quella che si direbbe un’eredità del cinema d’impegno civile. Ho apprezzato per esempio Il muro di gomma di Marco Risi o Palombella rossa, ma in generale i giovani lavorano su strutture narrative tradizionali. È strano, perché cercano conferme senza buttarsi a scoprire qualcosa di nuovo. Ho il sospetto che la ricerca maggiore sia verso il denaro. Sembra la sola sicurezza. C’era una battuta che ci scambiavamo con Petri per obbligarci a ragionare: “Indecisi a tutto”.
15 Prima di andare a letto spengo tutte le luci e socchiudo le persiane. Mia sorella stava spesso a una di queste finestre, sperando di sorprendere Mussolini a cavallo. Come molte ragazze, era sedotta dall’immagine del duce. Fu un affronto per lei quando raccontai che, invece, era successo a me. Non dal nostro appartamento, cosa che attenuò appena la sua invidia. Eravamo affacciate, io e due compagne di scuola, alla finestra del liceo classico di via Antonio Musa. Una delle due, Emma, urlò: il duce! E vidi brillare la sua testa pelata, ondeggiante al trotto. Vidi quell’uomo un’altra volta, qualche anno dopo. Tornavo a casa costeggiando il lunghissimo muro inferiore di Villa Torlonia. Davanti al cancello riconobbi il brigadiere che, il giorno della deportazione dal ghetto, aveva detto a me e a mio padre, dopo l’abituale saluto alla visiera: “Questo ora si chiama muro del pianto.” Mio padre, che aveva creduto nel fascismo, sollevò il cappello, forse per rispondere al saluto, forse per onorare quel sincero bisogno di dissenso. Mentre attraversavo il passo carraio la mano del militare mi fermò. Usciva un’auto dalla Villa, e seduto sul sedile posteriore c’era Mussolini. Leggeva qualcosa, aveva gli occhiali. Mussolini portava gli occhiali: anche il duce era deteriorabile. Collego ora quella scoperta di fragilità del duce alla voce radiofonica del comunicato dell’8 settembre, nel quale lo sconcerto, il disorientamento, forse la paura, avevano eliminato ogni accento declamatorio, rivelando un indizio di interiorità. Avrei voluto almeno vederla al cinema l’espressione diversa del suo viso che doveva certo accompagnare la nuova voce, perché soltanto una finzione potrebbe restituirci quell’umana verità. Un uomo politico sarebbe il migliore cineasta, in questo caso. Come avrebbe potuto trattare un tema simile, Pietro Ingrao, un politico che amava tanto il cinema da avere frequentato il Centro sperimentale di cinematografia?
PIETRO INGRAO I “tempi moderni” del cinema italiano Quando mi ci sono appassionato, al punto di iscrivermi al Centro sperimentale di cinematografia, il cinema era sotto il controllo del fascismo, in molti casi sotto ispirazione. Mussolini aveva intuito che il cinema poteva esercitare un vero potere sulle masse. Lo capirono anche la democrazia cristiana e i governi che si sono succeduti subito dopo la guerra. Il periodo più riuscito, e più importante credo, del rapporto tra cinema e società italiana fu il neorealismo. Questo cinema della realtà rompeva gli schemi della rappresentazione, raccontava la diseguaglianza, evocava una descrizione classista dell’Italia, conteneva un’importante critica sociale in pagine altissime, come a dire che erano film straordinari anche a livello formale. Dopo Ossessione, in certi film di Rossellini, De Sica o Visconti, si notava uno scavo, una profondità di analisi della vita e del destino, qualcosa che riguardava la condizione umana, un valore al di là delle battaglie politiche di quel tempo. Ma fu già alla fine degli anni ’30 che, nel gruppo di amici che frequentavo, sull’interesse giovanile per il cinema cominciò a innestarsi l’idea di una cinematografia italiana della società contemporanea. Che noi, a quel punto, incominciavamo a leggere come una società tragica, a suo modo malata, dominata dal fascismo. Il cinema poteva diventare, e lo diventò, uno strumento attraverso il quale parlare con quest’Italia. Quanto alla mia particolare esperienza di spettatore, tutto cominciò molto prima.
Gli ultimi giorni di Pompei. L’incontro col fantastico, l’incontro col racconto del mondo, della vita, vedere svolgersi storie di persone, dell’umanità, trovarsi dinanzi a quella tela, nella sala buia, in mezzo a queste storie, fu subito questo per me, il cinema. Tenendo conto che fino a quei primi incontri con qualche film, nei miei dieci anni a Santa Maria Capua Vetere non avevo per le mani tanti libri. Non ho però l’impressione, nella mia infanzia, di un momento preciso della rivelazione del cinema. Ma so dire gli strumenti con cui, tra la fine delle elementari e i primi anni del ginnasio, negli anni ’20, un ragazzino di paese come me entrò in relazione col fantastico, in una prima elaborazione di ciò che potevo vedere del mondo. E sono tre gli strumenti: i libri di scuola, per esempio l’Iliade nella traduzione di Romagnoli, di cui leggevo da solo tutti i riassunti, parteggiando per Ettore, non per Achille; poi il western, che però arriva non ancora attraverso il cinema, ma con le dispense, quelle di Buffalo Bill per esempio, che compravo con due soldini rubati ai genitori; e infine la sala cinematografica del paese, con due comici per me indimenticabili, Fatty Arbuckle e Charlot. E poi c’è il cinema italiano. Ho un ricordo abbastanza preciso di un film muto, Gli ultimi giorni di Pompei, a metà degli anni ’20 credo, perché è qualcosa di cui si parlava anche in casa. Mia madre non veniva mai al cinema. Ma vide quel film. Uno dei più importanti, credo, in quel genere di film italiani che proiettavano la fantasia sui tempi lontani, con la ricostruzione di fatti antichi, i Romani, la distruzione spettacolare della città di Pompei; mi colpì perché era uscita una pubblicazione a puntate del romanzo d’appendice da cui era tratto e di cui sentivo parlare anche nel mio paese.
C’andavamo la domenica, al cinema, combinando con la partita di calcio. Ricordo alle quattro e mezza del pomeriggio, dopo la partita, la fila davanti al cinema. Ma in quegli anni, parliamo del periodo tra la fine anni ’20 e i primi anni ’30, era il cinema americano a dominare l’attenzione.
Telefoni troppo bianchi. Mi sono avvicinato al cinema italiano con la rivista dei Guf di Venezia, il “Ventuno”, nella quale scrivevano i fratelli Pasinetti, Francesco, poi grande storico del cinema, e Piero. Mi arrivò per le mani quella rivista al liceo classico perché io mi occupavo di letteratura. Dalle loro recensioni, da come parlavano del cinema italiano e mondiale, mi accorgo delle potenzialità artistiche del cinema. Mi succede allora di incominciare a leggere il western americano non solo come avventura, ma anche a livello espressivo, e come rispecchiamento di alcuni miti della storia d’America. Vedo la Garbo in un’altra prospettiva. E John Barrymore, che non mi stava simpatico, ma che apprezzai per Ventesimo secolo (è il mio amico Gianni Puccini che mi guida a scoprire invece il senso dell’ironia di Barrymore). Verso la fine del liceo, aiutato dalla lettura di alcune riviste che incominciavano a contenere articoli sul cinema, tra cui “L’Italia letteraria”, diretta da Corrado Pavolini, divento consapevole di un’attrazione e osservo anche il cinema italiano in modo più critico. Ricordo come spettatore giovane il disinteresse nei confronti dei film dei “telefoni bianchi” e verso certi altri registi, che so, Brignone; e invece come mi colpì, per esempio, Gli uomini che mascalzoni! di Camerini, che era del ’32 o ’33, con il giovane De Sica. Incominciavo a sentire una lettura un po’ ironica della società italiana e uno sforzo espressivo. Era narrazione della vita comune, con i soliti rapporti amorosi e la vita quotidiana, ma si sentiva in Camerini, anche negli altri film, una certa malinconia, un punto in cui i sentimenti rivelavano un segno di sofferenza della società. Già erano personaggi che alludevano a una complessità psicologica. Come a dire che si poteva estrarre, volendo, un disagio sociale. Questo ci interessava e ci colpiva, che cioè il cinema potesse funzionare da rivelazione di qualcosa di non esplicito del nostro tempo. Eravamo nel pieno della propaganda di regime. Io stesso, si sa, ho creduto nel fascismo per un certo momento. Come dicevo, il cinema era controllato dal fascismo. Camerini e Blasetti erano due registi riconosciuti e accettati dal fascismo, ma si vedeva un occhio più attento e curioso.
Montale e i Littoriali del dissenso. Non è però che il cinema italiano abbia, nel mio caso, spinto a una visione critica del fascismo. Questo per me accadde più avanti, con l’esperienza della clandestinità. È vero invece che un dissenso si esprimeva all’interno delle organizzazioni fasciste. Io ricordo bene che i primi discorsi critici sul fascismo li ho fatti ai Littoriali di Firenze, nel 1934, quando sono andato a concorrere con una mia poesia. È difficile raccontarlo, questo, perché non ci si crede. Ma ormai è storia. Quegli incontri, proprio nei primi anni dei Littoriali, erano costruiti sull’apologia del fascismo, e tuttavia erano anche i luoghi dove si esprimeva
un’insoddisfazione, un modo di essere contro. C’erano personaggi di grande spicco della cultura italiana, per esempio io incontro Ungaretti. E sono anche andato alle Giubbe Rosse a cercare Montale, un poeta che rompeva con le tradizioni. Cioè, all’interno di quegli incontri, c’era anche modo di avvicinare artisti e intellettuali che rappresentavano un’Italia diversa. Montale me lo feci indicare dal cameriere e, con l’improntitudine della giovinezza, gli affidai la poesia che ero andato a leggere ai Littoriali. Ebbene, io già cercavo una cultura diversa, che al liceo avevo incominciato a conoscere leggendo, come ho detto, la rivista di Pavolini, poi “Circoli” di Adriano Grande, “Il frontespizio”, ma meno, e poi “Solaria”, assai importante, dove scoprii Quasimodo e Ungaretti, e Attilio Bertolucci che incominciava in quegli anni (mi ricordo bene che lui ai Littoriali portò una poesia che riguardava la fagiana). Le esperienze culturali che cercavo erano l’ermetismo e la letteratura e la pittura italiana della fine anni ’20, legate ai movimenti europei dell’arte. Come a dire che non tanto nei film italiani, ma nella letteratura italiana cercavamo un’uscita dal fascismo. Ai Littoriali di Firenze conobbi proprio Pietrino Bianchi, giovane critico che combinava l’attenzione alla letteratura e l’attenzione al cinema. Stava con un gruppo di letterati parmensi, tra cui mi pare ci fosse anche il giovane Bertolucci. Parlavamo di cinema, ma molto anche di letteratura. Bianchi è stato senza dubbio uno che, con Pasinetti, mi ha avviato all’analisi critica del cinema, finché non mi decisi a frequentare il Centro sperimentale di cinematografia. Non credo che lo sappiano in molti che ho fatto il Centro. Sempre ai Littoriali, per dire quanto furono importanti per la connessione di persone che poi diventarono antifasciste, incontrai Gianni Puccini, a cui mi legò profonda amicizia. Puccini era molto avanti nella conoscenza delle cose di cinema. Ed è con lui che scatta una passione vera al punto che decidiamo di avviarci a fare regia, di tentare con questo mezzo. Io mi iscrivo al Centro sperimentale, che era appena nato, provvisoriamente collocato in una scuola abbandonata di via Foligno, perché voglio imparare a fare il cinema. Già con un’idea sul cinema nuovo italiano. Con Alicata, Giuseppe De Santis e altri.
Il cinema nuovo della società italiana. L’idea che avevamo del nuovo cinema era naturalmente lo sviluppo filmico di una critica della società italiana. Due cose erano comuni a noi giovani: la critica al fascismo e la percezione che il cinema poteva essere strumento creativo per esercitare quella critica secondo un forte potenziale di comunicazione di massa. Io avevo anche una grande passione per il teatro. Partecipai ai Littoriali teatrali. Mi interessava l’esperienza molto singolare di Anton Giulio Bragaglia e del Teatro degli Indipendenti a Roma. Avevamo però coscienza delle differenze fondamentali tra il cinema e il teatro, anche a livello formale. Il cinema ci affascinava di più per la capacità di parlare a grandi masse. Questa prerogativa, nelle nostre discussioni, incontrava l’idea di un cinema nuovo della società italiana. In questi benedetti Littoriali, stavolta a Roma, ho incontrato una persona che ha pesato molto nella mia vita, Antonio Amendola, uno dei figli di Giovanni, fratello di Giorgio e di Pietro. Antonio vinse a quei Littoriali con un saggio letterario dedicato alla rivista “La voce”, cioè con un saggio che ripercorreva in forma critica un periodo fondamentale della storia della cultura italiana: la sua vittoria creò protesta e scandalo. Antonio introdusse nel mio interesse per il cinema il motivo politico. Per noi si sviluppò una lettura più drammatica della società italiana, da raccontare
attraverso il cinema. Al Centro sperimentale insegnava Umberto Barbaro, che tuttavia con noi non fece mai discorsi politici espliciti. Forse il suo modo di intendere la forma era già politica. Barbaro e Rudolf Arnheim, i cui testi poi sistemarono un po’ tutte le conoscenze frammentarie che avevamo sui grandi autori tedeschi, russi e americani, sono stati i punti di riferimento che mi hanno aiutato a pensare il cinema come un’arma critica per parlare della società. L’assurdo dell’esperienza al Centro era che non abbiamo mai potuto né vedere né usare una cinepresa. Ricordo però una prova di sceneggiatura che io e Puccini abbiamo affrontato come se fosse uno script all’americana, come un western, cioè con le indicazioni delle azioni, assalti, scontri, fughe, movimenti di macchina, tutto. E questo per dire: guardate che noi siamo capaci di fare una sceneggiatura completa e d’azione, ma stiamo cercando qualcosa di diverso.
Scrivere per Visconti. Ossessione. Luchino Visconti s’innesta con la sua esperienza su questo percorso. Ma qui siamo già nel ’39, forse ’40. Incontro Visconti grazie a Puccini. Una figura scura, curiosa. Che noi, a dire la verità, trattavamo con una certa sufficienza. Lui era tornato dalla Francia. Sapevamo che aveva lavorato con Renoir. Ci sembrava però l’aristocratico che voleva fare il cinema. Non giuravamo che sarebbe stato un grande regista. Per noi era più uno strumento con cui pensavamo di poter entrare nella produzione di film come registi. Nelle richieste che ci faceva, molto utili perché poi ci pagava dei buoni soldini, tra cose interessanti trovavamo anche inutile robaccia, come il trattamento di una Signora delle camelie, che eseguimmo con assoluta freddezza, mentre più vicino alle nostre corde fu il lavoro su una novella di Verga, Il pastore, che veniva incontro alla nostra vocazione sociale. Ci sbagliavamo. Non avevamo capito la complessità e la ricchezza di Visconti, né l’avevamo sondata e saggiata. Partecipai a una prima elaborazione del soggetto di Ossessione, poche cartelle, dovevamo trasformare il romanzo Il postino suona sempre due volte in ambiente italiano, questo fu il compito che ci diede Visconti. Ma già negli incontri seguenti io non c’ero più, ero entrato in clandestinità e quando poi, a marzo del ’42, uscì il film io ero sui monti della Sila. Sapevo da Puccini, De Santis e Alicata che figura importante era diventata lo spagnolo, interpretato da Elio Marcuzzo, attore del cinema sperimentale, un caro amico che avevo visto crescere al Centro e che finì tragicamente ucciso durante la guerra partigiana. Con lui, emblema del clandestino, s’apriva il ragionamento politico, e questo era stato voluto da Puccini e gli altri, compreso Visconti. Alcuni sostengono che Visconti nel film avesse rappresentato con lo spagnolo la figura dell’omosessuale. Nelle intenzioni della sceneggiatura è sicuro invece che Puccini, De Santis e Alicata, intendono dare, di fronte a quel mondo in sfacelo, l’immagine di uno straniero, di un clandestino, che vuole salvare Girotti, richiamandolo alla lotta. Ho visto Ossessione subito dopo la Liberazione, dopo i miei anni di Resistenza e dopo la partecipazione alla liberazione di Roma.
Andreotti faceva il suo mestiere. Gli ideali con cui siamo usciti dalla Resistenza richiamavano un cinema che rispecchiasse la
società e la lotta di classe. Io ero comunista, quindi leggevo i film del neorealismo nei suoi aspetti formali, certo, ma anche politici. Non è un caso che De Santis e Alicata partecipassero poi al secondo film di Visconti La terra trema, dai Malavoglia, un testo molto importante per la sinistra. Su “Cinema” i pezzi di Alicata e De Santis parlano a chiare lettere di un nuovo cinema, critico, politico. Una lettura della lotta di classe nel cinema era evidente per noi spettatori comunisti anche in certe pagine di Rossellini. L’ultimo episodio di Paisà è per me la pagina più alta del cinema italiano, dove la lotta contro Hitler si fonde alla lotta contro l’ingiustizia sociale. Ladri di biciclette ci colpì molto, questo lo ricordo bene. Per noi significò la lotta alla disoccupazione, la tragedia del lavoro che manca, la prova di risvolti iniqui nella società dell’immediato dopoguerra. Credo che molti di quei film trovavano poi un nesso con l’analisi della società che s’andava facendo mentre si ricostruiva il paese e si scriveva, io stesso, la costituzione italiana. E poi c’era una vera e propria connessione col partito di molti uomini del cinema italiano, se vogliamo badare anche a quest’aspetto. La “cospirazione romana”, per esempio: io, Alicata e altri avevamo un rapporto stretto con Sergio Amidei. Mi ricordo gli incontri nel suo appartamento a piazza di Spagna. Fu il punto d’unione tra il cinema italiano e la Resistenza, che poi si sviluppò in certe lotte contro la censura a Liberazione avvenuta, e anche più in qua. Il cinema entrò nel clima di lotta politica di quegli anni. Andreotti, delegato allo spettacolo, era sì un uomo di De Gasperi, ma si dislocò subito su posizioni di destra, all’interno della democrazia cristiana. La dc tendeva a nascondere gli aspetti negativi della realtà sociale che il cinema riusciva con tanta potenza a portare alla luce. Ma quella era la lotta politica. Ci si schierava. Quanto agli episodi di censura, be’ in fondo la democrazia cristiana faceva il suo mestiere. Si combatteva una guerra politica, anche per il potere, quindi...
Neorealismo e politica. Rossellini, De Sica, Visconti e Zavattini, che era una figura molto importante in questo contesto: ebbene, i loro film erano certamente scomodi. Se avesse potuto la Dc li avrebbe eliminati. Miracolo a Milano, un film fuori dai canoni del neorealismo, ebbe un impatto sociale molto forte, proprio perché metteva in gioco anche il fantastico e il surreale per parlare di critiche sociali e spinte ideali. E questo era Zavattini. Poi Roma ore 11 di De Santis, un altro episodio sull’ingiustizia nel mondo del lavoro, divise Zavattini dal gruppo, ci fu una separazione in particolare con De Santis, che in questo film si era avvicinato a un racconto quasi documentario. La terra trema restava ancora il punto di riferimento per un certo mondo politicizzato del cinema. Io non lo rividi più, ma devo dire la verità: a me non piacque. Mi sembrò un film non riuscito. Era fuori dalle corde di Visconti, e si sentiva; secondo me, il pubblico lo avvertì. Visconti è stato un grande uomo di cultura, d’innovazione culturale e di costruzione d’immaginario, ma non il più grande regista italiano. C’è stato un momento in cui pensavo che il suo film più riuscito fosse Bellissima, anche se poi rivedendolo... Certo, per me il cineasta più grande fu Rossellini. Anche se non tutto quello che ha fatto, né ogni parte dei suoi film... Ma l’episodio finale di Paisà, ripeto, resta a mio parere la cosa migliore mai prodotta dal cinema italiano, uno dei pezzi più alti di cinema a livello mondiale. Noi fummo molto vicini a Visconti, ma io, lo dico con grande esitazione perché la sua influenza è stata
enorme e importante, lo penso come un grande intellettuale, non come un grande regista. Se ne sapessi di più, forse concorderei con chi sostiene che Visconti è stato il più grande regista italiano d’opera lirica e di teatro.
Direttore all’“Unità”. Pesantezza della critica cinematografica. Quando Togliatti mi chiamò alla direzione dell’“Unità” ritenevo di non essere adeguato. Ero stato capocronista, lavoro che avevo svolto con passione, ma non ero allineato ai tempi rapidi del giornale. Ero lento. Con una certa civetteria scrissi anche un elogio della lentezza. Restai all’“Unità” fino al ’56, quindi ci furono molte occasioni di battaglie in difesa di un certo cinema italiano, per Miracolo a Milano, Umberto D, mentre nasceva una commedia cinematografica che a me non diceva niente, a parte un certo valore cinematico. Come critico cinematografico avevamo a disposizione un nome enorme, Giacomo Debenedetti, vale a dire uno dei massimi intellettuali del tempo. Ma il problema fu proprio questo: insieme per esempio a Bruno Barilli, altro straordinario critico musicale e intellettuale, questi personaggi usavano un linguaggio troppo distante dal livello medio del nostro pubblico, mentre noi ci sforzavamo di fare un giornale molto popolare. I nostri lettori erano operai, contadini. È un problema che si presentò ciclicamente nel rapporto tra critica e pubblico sui quotidiani italiani. Arrivò poi un’altra generazione di critici. Da noi Ugo Casiraghi: la severità rigida di Casiraghi corrispondeva parecchio alla pesantezza politica della nostra ideologia a quel tempo. La fine del neorealismo, a far data da Umberto D, nel ’51, aveva portato una serie di commedie superficiali che a noi proprio sembrarono uno scadimento, come Pane, amore e fantasia, Poveri ma belli, certe comicate di Totò, che invece fu un grande per altre cose.
La storia del cinema Italiano secondo me. Bisogna aspettare Fellini per trovare ancora un “nuovo” artistico. Anche se devo dire che, a un certo punto, ho creduto che un equilibrio potesse essere rappresentato da Renato Castellani, perché manteneva i temi del filone sociale e raggiungeva una certa lievità di racconto. La storia del disoccupato di Napoli, per esempio, in Due soldi di speranza con Vincenzo Musolino, mi sembrò l’inizio di qualcosa, che invece poi... Ci misi del tempo come spettatore per capire Sordi e i suoi film. C’era secondo me un difetto di misura. Mentre, per Totò, ero già stato avvertito vent’anni prima, quando era un fantasista, un attore di avanspettacolo. Lo ricordo come fosse adesso, al Centro, nel ’35. Fu Umberto Barbaro, in corridoio, davanti alla nostra ammirazione per Chaplin, a dirci: guardate che c’è un altro attore che fa i fuochi d’artificio, si chiama Totò. Certo, in Guardie e ladri o Totò cerca casa, non c’erano gli elementi di rigore formale per cui noi avevamo sostenuto che il film era arte, ci sembrava tutto sovrabbondante, ma c’era una presenza fisica, in quel rettangolo, che trascendeva queste imperfezioni: Totò. E infatti poi Pasolini ne capì le potenzialità estreme e fece Uccellacci e uccellini. Comunque, io avevo molto rispetto per i registi della commedia, e per Monicelli in particolare, ma a me sembra che non si cimentassero nemmeno con il problema espressivo, che non riuscissero, né lo volessero, a toccare un livello di linguaggio, una ricerca. Avverto brandelli di una società vera nel Sorpasso, in Tutti a casa; e I soliti ignoti parve anche a me
come spettatore un film curioso, ci facevano vedere certi aspetti della società... ma insomma le novità, le cose importanti del cinema italiano a quel punto, erano altre: Fellini e Antonioni. La dolce vita è un film che destò in me una grande impressione, perché affrontava temi drammatici della nuova società girandoci improvvisamente intorno come una canzonetta. Certamente segna la fine del neorealismo e l’inizio di un altro sguardo sulla nostra società, ampio, complesso. E Antonioni trovo che abbia alti e bassi, il più riuscito è quello su Londra, Blow up. Non ho amato i primi film, L’avventura, Il grido; mi piacevano, ma c’era qualcosa di imperfetto, di inconcluso. E non ho trovato che mi abbiano aiutato a capire come cambiava la borghesia. Invece Blow up ricordo che m’illuminò, alla fine degli anni ’60, portandomi a ragionare sull’ambiguità, sulla sua fluttuazione. Dov’è la verità? Che cosa è successo veramente, questo o quello? E non poterlo quasi mai risolvere compiutamente, l’affanno a individuare, a cercare qualcosa che poi ti sfugge ancora tra le mani. L’allusività di quel finale, la partita a tennis senza palline... questa segretezza del reale, questa difficoltà di acciuffare la verità. E quindi trovo importante anche Professione reporter, proprio in quei primi anni ’70. La ricerca dell’identità, lo scambio: ancora, l’incertezza della verità. Fellini è certo l’altro grande autore italiano, ma vorrei ricordare un’esperienza negativa, curiosa, da spettatore, di un suo film, Prova d’orchestra. Andai al Quirinale a vederlo, con Pertini. Non solo mi deluse, ma m’irritò. Mi sembrava mettere in discussione il senso di tutto il casino che c’era stato, la confusione sociale e politica di quel momento. Mi sembrava, come un richiamo all’ordine, un monito per ristabilire un passo indietro. Dopo il film, chiacchierando in un gruppo, espressi a Fellini questo mio pensiero. C’era Pietro Notarianni, mio cugino, molto in vista nel mondo del cinema italiano e suo collaboratore. Lo dissi anche a lui. Ma Fellini s’irrigidì. Se la prese proprio. Non l’ho rivisto recentemente, Prova d’orchestra, ma resto con questa precisa impressione. Ci sono film non risolti di Fellini, e cose importantissime. Non mi piacque La città delle donne. Sono convinto che Amarcord sia un capolavoro, lì davvero non toccherei neanche una virgola. Forse non così potente come certi pezzi di Roma. Ma ha un senso dell’evocazione melanconica della complessità della vita e della società. Un film così compiuto... be’, La voce della luna è un altro buon esito, una visione di questi ultimi nostri anni, anche delle contraddizioni... Questi grandi autori del cinema italiano hanno partecipato, ciascuno a modo proprio, al dibattito, allo scontro di classe, di quegli anni: con i loro film, sin dal dopoguerra, hanno cominciato a discorrere su quello che è poi il dispiegarsi della società del Novecento in Italia, quello che segue il capitalismo fordista, lo sviluppo in certo modo di Tempi moderni, il film di Chaplin che afferra con una lucidità sbalorditiva il significato della macchina, del lavoro in fabbrica, le connessioni con l’uomo e la società, la modernità, il Novecento insomma. Il neorealismo ragiona con una società che è gretta, poi con Fellini già questa società si è dispiegata. La fabbrica non entra nel nostro cinema, ma la società che si rappresenta è figlia delle trasformazioni della fabbrica, della macchina e del sapere. Non ho rivisto Trevico-Torino di Scola, uno dei pochissimi titoli che raccontano la fabbrica, all’inizio degli anni ’70, con La classe operaia va in paradiso di Petri, che ci piacque perché era il primo film italiano ad affrontare la questione dell’officina e a usare la parola “classe”. Anche Visconti, con Rocco e i suoi fratelli, di grande fascino espressivo, non tocca però la questione del lavoro in fabbrica e la sua influenza sull’uomo. Ho visto con interesse i film dei Taviani, che però non ho particolarmente amato, a parte
quello del rivoluzionario che fallisce, San Michele aveva un gallo, credo girato proprio negli anni della Classe operaia. Mi impressionò anche per una circostanza familiare: ho avuto un nonno garibaldino mazziniano che a metà dell’800 in Sicilia aveva messo insieme una rivoluzione fallita, proprio come fallisce in quel film. Ho visto i loro film con grande rispetto, ma non mi sono entrati nel cuore. E comunque negli anni ’60 e ’70 secondo me è ancora Fellini che ci parla dell’inquietudine sociale, è sempre il tema della Dolce vita che spinge Fellini a vedere questa società che produce, compra, allestisce, gode, scopa, e tutto questo sempre con una domanda, che arriva chiara, ripeto, con Amarcord. Lì, collocato nel tempo, c’è proprio un pezzo di società che sta alle fondamenta della storia d’Italia. E non è tanto una denuncia, che va verso la tragedia, come La dolce vita, ma un ritratto con un accento di malinconia e di indicibilità di altra forza critica, molto profonda. Quei passi del ragazzo che cerca di alzare la donna, il vecchio nella nebbia, e il pazzo che s’arrampica sull’albero: tre momenti di grande leggerezza e verità, fuori da certi eccessi caricaturali felliniani. Anche in Ginger e Fred o E la nave va, non completamente riusciti, Fellini tocca sempre elementi inquietanti dei rapporti sociali, delle relazioni, in questa società di capitalismo dispiegato.
Dov’è il cinema italiano? Il cinema italiano in generale non colse la crisi della società fordista come si sviluppò nel ’68. Come faceva la povera cultura italiana? Non lo dico con disprezzo, ma siamo un paese che arriva in ritardo alle grandi novità, con atteggiamenti confusi. Non riusciamo a tenerci all’altezza dei grandi eventi che accadono. Noi facciamo la Fiat. E questa è una cosa. Diamo da mangiare un po’ di più ai contadini. Bene anche questo. Ma ci portiamo sempre un po’ di fascismo appresso. Per fortuna impariamo dagli altri le grandi scoperte. È come succede anche adesso, nel post-fordismo, il nuovo capitalismo dell’informatica: cerchiamo di imparare da quelli che stanno un po’ più avanti di noi, un po’ più sopra di noi, l’America, per esempio. Non proviamo nemmeno a ragionare sulle contraddizioni di questa fase che chiamo ancora post-fordista. Perché? Non abbiamo la forza, le competenze culturali? Che ne so, è difficile capire. Certo, non mi sembra che il cinema italiano riesca a entrare in questi argomenti. Mi piacerebbe molto veder raccontare la storia degli incapaci, quelli che non riescono, i nonbravi. Ci provò soltanto Zavattini. Ogni volta che esco in questo mondo, che accendo la tv, che mi guardo intorno, finisce a “chi è più bravo”, chi sa fare, chi scopre, anche cose molto importanti, intendiamoci, cose che ci servono ogni giorno. Figurarsi se penso di tornare indietro... Però, nessuno che racconti un’altra vicenda: quelli che non ce la fanno, che sono deboli perché disorientati e non riescono a inserirsi, a trovare uno spazio. Possibile che questa società non riesca a vederli? Il neorealismo invece parlava di questi poveri, di cose, di persone e di talento umano. Con lucidità e precisione. C’è troppa arroganza, oggi... E non sto parlando dei pazzi, di cui invece si discute, si rappresenta. Mi riferisco a un’altra categoria: quelli che non sono nemmeno capaci di essere pazzi.
16 Non riesco a prendere sonno. Mi inquieta aver ritrovato la dedica di Vittorio. M’inquieta tutto in questa giornata, come in ogni giornata che accumula le ore in una sorta di attesa. A volte mi sorprendo a scandire le settimane nella prospettiva di piccoli eventi. Il ritorno di mia figlia da un viaggio. La visita di mio nipote. Quando partiranno per le vacanze. Quando torneranno, dalle vacanze. E poi sarà un Natale o un’altra partenza. Vittorio non mi chiama quasi mai. Una visita alle due feste comandate dell’anno, neanche il pranzo in famiglia. La morte di suo fratello è stata anche la morte di mio marito. Adesso, lui non è più nulla per me? Non so spiegare cosa voglio davvero dire. Vittorio era uno studente di medicina – anche il padre era medico, un medico condotto friulano trasferito a Roma – quando incominciò a fare la staffetta per la Resistenza, a Roma. Si trovò coinvolto quasi per caso in uno scambio di messaggi tra un vicino di casa, un impiegato delle poste, e alcuni studenti di medicina: una cellula della Resistenza. Scappò al nord due giorni dopo l’8 settembre: ai mercati generali, mentre i nazisti disponevano l’occupazione della città, arrestarono il suo capo, un ufficiale spia della Brigata Sassari. Vide sfilare i graduati di quella brigata con un fazzoletto sugli occhi. Finivano alla tortura, in qualche appartamento. Quanto avrebbe tenuto la sua copertura? Qualcuno lo trasferì a Cuneo e poi nella fabbrica clandestina di divise per i partigiani. La sua passione per la sartoria, ereditata dalla nonna, lo salvò. Entrò in contatto con le Brigate del Piemonte e dell’Oltrepò Pavese, dove incontrò sua moglie e, tra gli altri, Gillo Pontecorvo, che era allora capo partigiano. Dopo la guerra Vittorio abbandonò l’università e incominciò a cercare lavoro come aiuto costumista a Cinecittà. Lo incontrai così, una mattina di settembre sul tram che tornava a Roma. Mi aveva seguito. Si era seduto davanti a me, come se fosse casuale, ma io aveva capito. Si voltò per dirmi: “Con il suo cappotto spigato ci vorrebbero dei bottoni neri. Questi di madreperla sono molto belli, ma si vede che è un’aggiustatura.” Si accorse di avere esagerato. “Mi scusi. Se vuole, domani passi in sartoria. Ci sono bottoni neri a matrice doppia. Belli e pesanti, che danno sicurezza.” In seguito Vittorio mi raccontò che le persone che stimava le aveva incontrate quasi sempre sui mezzi di trasporto. Dopo la guerra, nei primi anni ’50, incontrò anche Pontecorvo, ma per timidezza non si era fatto riconoscere. Erano tutti e due in un autobus, dalle parti del Colosseo. Pontecorvo tornava a casa, con Solinas, lo sceneggiatore. Non sapeva ancora che avrebbe diretto La battaglia di Algeri. Aveva una giacca beige a quadretti a cui era appuntato un distintivo Cvl della Resistenza.
GILLO PONTECORVO Da Saint Tropez ad Algeri La pigrizia è una balla. Anzi. Quando giro mi becco spesso gli scioperi della troupe, perché pretendo di lavorare oltre gli orari dei contratti. È vero, semmai, che mi è successo di non riuscire a immaginare o identificarmi in progetti convincenti e che mi sono permesso tempi molto lunghi tra un film e l’altro. Agli osservatori superficiali, quelli che guardano la mia carriera e dicono: ha fatto soltanto sei film, be’ a loro basta questo per convincersi che si tratta solo di pigrizia. Una volta ho detto a un giornalista: “Ho speso la maggior parte del mio tempo pescando, il resto l’ho sprecato”, ma è chiaro che si tratta di un paradosso, di una provocazione. Per dire che la mia passione per il mare e la pesca subacquea è stata un elemento prevalente nella mia vita. Anche ora che ho smesso, o quasi smesso, succede che di notte sogno scene di immersione. È un paesaggio talmente inusuale e affascinante, di una varietà spesso più ricca del paesaggio terrestre. Sto parlando delle immersioni in apnea, perché quando hai le bombole puoi andare dove vuoi e fare quello che vuoi, mentre come scendo io, devi calarti in un paio di minuti o poco più, raggiungere l’angolo di una caverna, inseguire il baluginare argentato, poi vedi il pesce, ti viene un tuffo al cuore, spari, lo prendi forse non lo prendi, e intanto stai finendo l’aria nei polmoni, insomma c’è veramente mistero e lotta col tempo.
Pescare a Saint Tropez per sciare a Megève. Mi sono sposato prestissimo la prima volta, e molto tardi la seconda. Avevo vent’anni, lei era del sud della Francia. Litigavamo come due ragazzi. Io difendevo la supremazia della bellezza dei paesaggi italiani nel Meridione, lei combatteva per la Francia del sud. Henriette era la pronipote di Niepce, l’inventore della fotografia. Da Parigi, dove ero capitato a trovare mio fratello, mi trascinò a Saint Tropez, che allora era un villaggio di pescatori e in cui si erano rifugiati alcuni pittori e scrittori, tra cui Tristan Tzara, che era diventato cittadino onorario di Saint Tropez. Non una lira io, non una lira lei. Cercavo di dare lezioni di tennis, ma di nascosto, perché chi faceva i tornei, come me, non poteva. A pensarci oggi, era una situazione assurda. Poi un amico dice: perché non fai la pesca subacquea cercando di vendere quello che trovi? Ho incominciato così. Scendevo fino a trenta metri. Vendevamo il pesce ai ristoranti e ci veniva fuori da vivere. E perfino i soldi per andare a sciare nel weekend. Ogni tanto, col vagone letto (pagato con i soldi della pesca!), andavamo dalla parte opposta della Francia, a Megève. A Parigi, invece, ero finito per caso. In una pausa dei tornei internazionali di tennis, tra quelli in Costa Azzurra e quelli inglesi, ero andato da mio fratello Bruno. Trovai Parigi una città entusiasmante, e cercai subito di radicarmi. Ero un po’ incosciente, perché la Francia era già in guerra da alcuni mesi. Ma non avevo voglia di tornare a fare gli esami di chimica. Tra l’altro avrei preferito fare lettere, ma a casa mia, assurdamente, non erano ben visti gli studi umanistici per i maschi.
L’agente Gillo.
L’agente Gillo. Di cose politiche ero totalmente ignorante. Venivo dall’Italia fascista, dove nei bar vedevo scritto “qui non si parla di politica né di altre strategie”, non avevo la più vaga idea di cosa volessero dire democrazia o libertà. La mia era una famiglia di origini ebraiche, ma non religiosa. Fino a un certo punto i miei considerarono le leggi razziali come un passaggio sgradevole, ma non drammatico. Lì a Parigi ho trovato un mondo vivacissimo. Prima per curiosità, poi per interesse sincero, ho incominciato a partecipare alle manifestazioni, con Henriette, ho letto libri e ho conosciuto emigrati antifascisti, tra i quali Giorgio Amendola, Natoli, Negarville che, cercando di educare la mia ignoranza politica, mi consegnarono un libretto: Précis du Marxisme, cioè “Compendio del Marxismo”. Poi, per prendermi in giro, mi chiedevano se avevo finito di leggere “diventare marxisti in quindici giorni”. A loro restò impresso che ero fratello di Bruno, un giovane scienziato di cui avevano grande stima. Lui era in Francia da tempo, era politicizzato, e come persona lo consideravano un cristallo di quarzo. Per riflesso, avevano un po’ di fiducia anche in me. Così, un bel giorno (un giorno che avrebbe significato una svolta radicale nella mia vita futura) vennero a trovarmi a Saint Tropez per chiedermi di accettare una “missione” in Italia. Bisogna tener conto che a quel tempo la polizia segreta fascista, l’Ovra, funzionava come un orologio, rodata da quasi due anni di potere fascista. Così, in media, un clandestino che operava contro il fascismo riusciva a sfuggire all’arresto sì e no per due o tre mesi; ovviamente, stessa sorte poteva capitare a chi veniva inviato in missione in Italia. Questo spiega il loro viaggio a Saint Tropez: in mancanza di altri, per disperazione, dovevano accontentarsi di me, un ragazzo poco politicizzato e persino un po’ playboy. Negarville e Amendola mi chiesero: “Faresti un viaggio in Italia per noi?” Accettai. Nel doppio fondo di una valigetta sistemarono materiali clandestini. Io ero “regolare”. Avevo il passaporto, avevo ventidue anni, ero incensurato, avevo i genitori a Milano. Insomma ero piuttosto insospettabile. Consegnai tutto a Torino a un gruppo clandestino di operai della Fiat. E poi, altro materiale alla Breda di Milano. In questo primo viaggio andò tutto bene. Nei viaggi seguenti cominciai subito a contattare gente negli ambienti che conoscevo meglio, tentando di incanalare il maggior numero possibile di persone nel movimento che, in quel periodo, aveva come obiettivo compattare un fronte clandestino antifascista. Uno dei primi contatti fu Ugo La Malfa a Milano. La parola d’ordine era “Vengo da parte dell’uomo che mangia le mele per la strada” (si trattava di un suo amico d’infanzia). Prima di rispondere passarono molti secondi. Lui non era convinto. I suoi occhi, dietro le lenti spessissime, dicevano: “Ma guarda quei disgraziati chi mi hanno mandato!” Iniziò allora la clandestinità. Dopo qualche mese di lotta militare e politica, una notte la polizia trovò un nostro deposito con i ciclostili e delle bombe, e trovarono anche una tessera falsa con una mia foto. Il comando partigiano mi ordinò di non uscire di casa fino a quando non fosse decisa una nuova destinazione. Restai per molti giorni a casa delle sorelle Musci, due donne severe e fidatissime cui il comando aveva dato l’ordine tassativo di non lasciarmi uscire mai. Io però mi ero rotto le scatole, dopo un po’. Un giorno, quando le signore uscirono per la spesa, decisi di mettere fuori il naso per qualche minuto. Mi ero dato anche una giustificazione: vado soltanto a comprarmi una lobbia, che può contribuire a camuffare il mio aspetto, già mutato da grandi baffi neri che mi ero lasciato crescere, e da occhiali finti che mi aveva mandato il comando. Nel negozio non avevano la lobbia grigia che avevo chiesto. Ne comprai una nera. Me la ficcai in testa e mi riavviai verso casa. Dopo pochi passi incontro Giancarlo Pajetta. Mi
fulminò con un’occhiataccia. Avevo sgarrato. Quando gli fui accanto, guardando il mio “insieme” disse: “Poi mi spiegherai perché, piccolo genio, ti sei travestito proprio da ebreo!”
Una relazione che cambiò la mia vita. Dopo una decina di viaggi, Amendola mi chiese di restare in Italia più a lungo per trasmettere notizie su ambienti che conoscevo, sulla guerra e la crisi del fascismo. A Pisa frequentai i miei amici dell’università e gli operai tessili. Mio padre era un industriale del settore, anche se era stimato e considerato equanime come “padrone”. Tornato a Parigi, mi chiesero una relazione. Be’, mi scappò di mano, e scrissi settanta pagine. Cambiarono la mia vita quelle pagine. Un giorno Amendola decise che dovevo smettere di fare avanti e indietro e mi chiese di contattare persone, convincerle, trascinarle. Si trattava allora di creare un fronte nazionale per la resistenza più visibile. Era poco prima degli scioperi di Torino. Dissi: faccio tutti i viaggi che volete, ma non posso mettermi a fare il “rivoluzionario professionale” come si diceva allora. Amendola s’incazza: vergogna morale. Personalmente avrei preferito andare nelle formazioni partigiane di montagna perché nel lavoro “militare” in città i nervi si logoravano subito per la continua, spasmodica, attenzione a non creare eventuali pedinamenti della polizia. Il coraggiosissimo comandante di una brigata giovanile, che non voglio nominare, a un certo punto ebbe un esaurimento tremendo. Sono pedinato o non sono pedinato? Pretese una staffetta ogni volta che doveva muoversi e poi pregò di essere trasferito in montagna. Io mi spostavo tra Milano, Torino e le colline. A Torino comandavo la Brigata d’assalto Curiel. Per quattro mesi ebbi anche un doppio lavoro.
Panico a Milano. Prima che ritornassero i tedeschi, appena fuggiti i fascisti da Milano, ci furono giornate, ore, entusiasmanti. Mi capitò tra l’altro di partecipare a un memorabile comizio di Ingrao. Forse il primo di Pietro. Non sapevo certo che aveva fatto il Centro sperimentale di cinematografia, né che aveva scritto sceneggiature per Visconti. Per me il cinema non esisteva proprio. Elio Vittorini aveva affittato un camion. Eravamo a Porta Venezia. Dal tetto Pietro arringava la folla. A un certo punto voleva passarmi il megafono. Rifiutai, anche se poi mi dispiacque. Io ho sempre avuto orrore di parlare in pubblico. Uno psicologo più avanti mi ha spiegato che dipende da un trauma giovanile. Per via della famiglia, dice. Io ero il quinto di otto fratelli, sei anni di differenza tra me e il quarto, che era Bruno, il fisico. I primi erano tutti dei secchioni pazzeschi. Pensiamo soltanto a Guido, il più vecchio, che fu un grande genetista. Un altro era un grande matematico. E io ero la pecora nera. Pensavo alle ragazzine e a giocare a tennis. Rispetto a loro avevo un complesso di inferiorità più che giustificato. E questo complesso, fin da piccolo, si è così radicato che io non riuscivo a parlare se c’erano più di quattro persone. Finita la guerra, il partito voleva che continuassi a fare lavoro politico. Ma non era per me. Una volta, durante un’assemblea, Secchia mi chiama senza preavviso al microfono. Mentre vado al palco mi tremano le gambe e penso a cosa posso inventare. Quando prendo il microfono dico che la cosa più giusta in quel frangente era dare la parola a un partigiano locale, tutti applaudono e io mi defilo. All’Anac, l’Associazione degli autori, dove siamo tutti
amici fraterni e ci prendiamo sempre in giro, non sono mai riuscito a parlare in assemblea. Quando ho qualche polemica da fare, ancora adesso scrivo. Mi prendono in giro, sbandierando il foglio: “C’è la scritta di Gillo.” Le cose sono un po’ migliorate dopo la direzione della Mostra di Venezia. Ero costretto a parlare davanti a tutti ogni cinque minuti. E ora, se mi mettono alle strette e devo proprio farlo, riesco a cavarmela, ma solo nel senso che non ho più quell’impressione di panico. Così, dicevo, rifiutai l’invito di Ingrao sul tetto. Tra l’altro ricordo che erano arrivati i carabinieri e le donne si fecero avanti per trattenerli: ma come, i fascisti sono fuggiti e adesso arrivate voi? Infatti durò poco. Ritornarono i tedeschi.
Regista per caso. Ho incominciato il cinema molto tardi. Quel poco che sapevo di inquadratura lo sapevo dalla macchina fotografica. Poi ho visto Paisà di Rossellini, un po’ dopo l’uscita ufficiale. L’ho visto alla Salle Pléyel, a Parigi. So solo che appena uscito ero talmente entusiasta... (perché è il tipo di cinema che io adoro) che mi sono detto: devo cambiare mestiere. Facevo il giornalista in quel momento. Avevo incominciato in Francia, per caso. Quasi tutto nella mia vita è incominciato per caso. Mi ero iscritto a una scuola di giornalismo. Mi chiesero di fare un pezzo, non ricordo dove, su una festa di studenti parigini. Credo che il cinema mi interessasse per lo stesso motivo per cui mi interessava il giornalismo, un modo di avvicinarsi alla gente e alle cose. Allora, con qualche soldo che avevo messo via ho comprato una Paillard 16 millimetri e ho realizzato dei piccoli documentari. Mi interessava la realtà. Anche lì, fu per caso che Antonello Trombadori, che mi vedeva andare in giro con la cinepresa, mi chiese di vederli. E disse: allora sei proprio sciocco! Questi devi trasferirli su 35 millimetri e usufruire della sovvenzione di legge per la distribuzione dei documentari, che a quei tempi era obbligatoria. Così diventai professionista. Avevo sempre vivacchiato fin lì. Facendo un po’ il giornalista e altre cose. Avevo lavorato per l’agenzia “Havas”, quella che poi diventò “France Presse”. Poi sono stato anche corrispondente per “paese Sera”. Per i documentari c’era il Premio di qualità, che ti permetteva di vivere benino. Franco Solinas e Pirro, di cui ero amico, mi spinsero a cercare di fare l’aiuto regista, per acquisire esperienza di set. Dice Solinas: lo vorrai fare prima o poi un film, no? E io: l’aiuto di chi? Di Gesù Bambino? Insomma mi sembrava una cosa impossibile. E invece venne fuori il nome di Monicelli. Gli dissero: c’è questo morto di fame che vorrebbe lavorare con te. E feci l’aiuto, tra l’altro non come volontario, ma pagato. Il film era Totò e Carolina. Poi fui aiuto regista in Francia. Così avevo cambiato mestiere per l’ennesima volta nella mia vita.
Contro la Dc. Quando è venuto fuori che potevo girare un episodio per La rosa dei venti di Ioris Ivens ormai sapevo tenere in mano la cinepresa. Non avevo più paura o dubbi sui tempi di una panoramica o sulle possibilità della macchina da presa. Il documentario era più di una scuola. Ho rivisto recentemente Giovanna, non mi è sembrato peggio di Kapò o di Ogro, o di altri che ho fatto. Ho notato una meticolosità nell’inquadratura che derivava dal lavoro sul documentario. Il documentario era il modo diretto della gente di cinema per denunciare i problemi del paese.
La Dc era il bersaglio, si tentava di mettere sempre qualcosa di negativo. Non era certo quello che la sinistra poteva augurarsi, ma devo dire che l’avevamo demonizzata fin troppo. Il disprezzo che c’è oggi per Berlusconi è più motivato, credo. Col cinema io e molti miei amici, giovani documentaristi, volevamo sottolineare i problemi della maggioranza della popolazione. Non si discuteva neanche, era quello l’obiettivo. C’erano Zurlini, Maselli, Solinas, cineasti fortemente impegnati politicamente. Un gruppo diverso da quello di altri esordienti, come Bertolucci o Bellocchio. Avevamo un certo disprezzo nei confronti della commedia all’italiana. Forse non eravamo abbastanza maturi, però a me proprio non interessava. Volevamo un cinema diretto sulla realtà popolare e la lotta per la sopravvivenza. Ma, visto a distanza, c’era un evidente errore di valutazione, di proporzioni. Rossellini per me era un dio a quel tempo. Fellini, pur facendo un cinema che era lontanissimo da quello che volevo e poi ho fatto, mi piaceva per la carica creativa, straordinaria. Monicelli mi è sempre sembrato uno talmente padrone di questo mestiere... Avrebbe meritato più successo di quello che aveva. Uno dei freni era il suo understatement, quello spirito di autocritica e autoironia che a un certo punto diventa nocivo se uno deve illudersi, anche, di essere grande e lasciarsi andare allo slancio del momento. Questo depone a favore della sua simpatia. Forse, non ne sono sicuro, gli ha impedito di diventare uno dei grandi geni del cinema italiano. E poi c’era Franco.
Da Squarciò a Kapò. La prima volta che portai Franco Solinas a fare la pesca subacquea, vicino ad Anzio, lo buttai in acqua con occhiali e fucile e poi mi allontanai dietro a una preda. Quando esco lo vedo con un gronco enorme, quasi due metri. Ma come, dico, appena metti il fucile in mare tiri fuori un pesce così? E lui, per dare un’idea del suo carattere cristallino, dice: ma no, era praticamente tramortito, devono essere passati i pescatori con le bombe e ne hanno dimenticato uno. Franco era appassionato dei miei documentari. Mi fece leggere il suo primo e unico romanzo, Squarciò, e per un enorme colpo di fortuna (debuttare non era facile, neanche a quei tempi) incontrai Maleno Malenotti, pisano come me, che ebbe il coraggio di produrre il film e farmi debuttare. Non mi entusiasmava la storia, non era il tipo di film di cui mi sarei innamorato, ma dire no sarebbe stato una follia. Il libro di Solinas è molto meglio del film che io ne ho tratto. Stranamente il film incassò e ottenne anche dei premi. Per la regia a Karlovy Vary. Ma i film che mi interessavano (ora quello che dico sembrerà pomposo, ma lo dico lo stesso) erano quelli collegati all’interesse, direi all’affetto, per l’uomo in considerazione della durezza della condizione umana. Ho sempre cercato di raccontare il faticoso arrancare dell’uomo per uscire da questo stato di impedimento e di sofferenza. Nel realismo, innanzitutto. Da qui deriva anche la mia passione per la fotografia in bianco e nero o per l’impiego di attori non professionisti. Ho fatto Kapò con grande entusiasmo. Vero, poi, che io sono sempre un po’ scontento. Chi va al cinema non ci pensa, ma se hai in mente una scena con la luce grigia, in una certa giornata, per un certo risultato, e poi arriva il produttore e ti obbliga a girare con il sole, be’ in genere finisci per accontentarti, e questo per me non va bene. Se alla fine di un film metti insieme molte di queste delusioni... E poi, magari dopo tre anni, ti accorgi che queste cose forse non erano così importanti. Il discreto successo del
lungometraggio d’esordio mi ha permesso di chiedere attori e risorse su un piano internazionale.
I conti con Rivette. Vorrei rimettere al loro posto Jacques Rivette e il critico Daney che hanno duramente attaccato, a suo tempo, Kapò, definendo “estetismo immorale” l’idea che soggiaceva alla scena in cui c’è un carrello in avanti verso il corpo di una donna che si è appena suicidata gettandosi sui fili elettrificati del campo di concentramento. In realtà il carrello è stato creato perché nella sua posizione di arrivo la macchina da presa può inquadrare la donna suicida nell’angolo sinistro del fotogramma e nel restante spazio (il centro destra) un gruppo di deportate che facevamo passare pochi metri dietro il cadavere. Le deportate passando davano una breve occhiata verso la suicida e continuavano il loro cammino. La mia intenzione era di raccontare, attraverso la scarsa reazione delle deportate, l’assuefazione alla morte, tragicamente diffusa nei campi di sterminio. Invece di parlare di “estetismo immorale” si sarebbe dovuto criticare piuttosto l’illusione, forse perdonabile, in un regista al suo secondo film, di poter rendere leggibile un concetto come quello di “assuefazione alla morte” grazie a una scena così breve. D’altra parte, se l’attenzione e la sensibilità di Rivette fossero state meno scarse, una scena che viene, nel film, poco tempo dopo, gli avrebbe potuto facilmente aprire gli occhi: in primo piano si vede un deportato in mezzo a tanti altri costretti a spostare delle pietre; improvvisamente si sente vicino una scarica di mitra, segno che una delle SS di guardia aveva punito un prigioniero; il deportato, in primo piano, alza appena lo sguardo in direzione dello sparo, poi riprende a lavorare con tristezza, ma quasi con indifferenza, leggi “forza dell’assuefazione”.
Algeri in America. Nei cinque anni che passano tra Kapò e La battaglia di Algeri mi sono arrangiato con qualche aiuto regia, qualche sceneggiatura non firmata. Bisogna sfatare l’idea che ci fossero chissà quali difficoltà per fare un film politico. Io ho sempre fatto i film che volevo fare. Forse con l’eccezione di un paio di progetti... Diciamo uno, in particolare. Volevo fare un film sulla vita di Cristo, ma più che su Cristo sulla Palestina durante l’occupazione romana. Il produttore, Goffredo Lombardo, era in fondo molto spaventato. Era un film carissimo, pieno di masse in movimento. Poco prima che finissimo la sceneggiatura, uscì un pessimo film americano sulla vita di Cristo e Goffredo si ritirò. La sua paura non era assolutamente di tipo politico. Era un film serio, senza concessioni commerciali, ma molto costoso. Un rischio. Perché dalla sceneggiatura al film... Non bisogna sottovalutare, nel lavoro del nostro gruppo, l’importanza degli sceneggiatori, e di Solinas in particolare. Per La battaglia la scrittura del punto di vista della controparte, cioè dell’esercito francese, fu importantissima. Ci aiutò a orientare tutto il film. L’affinità tra le cose, le persone, le facce immaginate durante la scrittura e la realtà del film per me è decisiva. Per esempio la scelta degli attori. È più importante la forza di un volto, di una persona, anche se non è un attore professionista, anche se poi devi sputare sangue per ottenere quello che vuoi, piuttosto che la facilità di un buon interprete. Quante volte ho scelto
qualcuno dicendo al produttore “che Dio ce la mandi buona”. Ho incontrato uno dei protagonisti al banchetto di un mercato di Algeri. Non capiva neanche che cosa volevamo. Poi ha intuito che gli davamo dei soldi e ha accettato. Non gli ho fatto un provino, perché mi sarei scoraggiato. Come per tutti gli altri ho preso delle fotografie e ho visto che veniva proprio come pensavo che dovesse essere. Arriva il giorno giusto per girare, e lo mandiamo a prendere. Ma non lo trovano più. Era finito in carcere. Aveva rubato qualcosa al mercato della frutta. Di autorità in autorità sono finito dal ministro degli interni dell’Algeria di allora. Lo pregai di prestarmelo, se così si può dire, per venti giorni. Fu rilasciato per il tempo necessario e poi tornò in carcere, poca roba, un paio di mesi. Insomma non volevo rinunciare a quella faccia, e credo che la sua necessità si senta. Finito il film, i dubbi che avevo mi sono costati cari. Ero abbastanza soddisfatto, ma mi sembrava un film da cineclub. Non farà un lira, pensavo. Magari piacerà ai critici. Quando negli Stati Uniti un distributore importante mi offrì una cifra di base, pensando, come succede, che io poi avrei chiesto il doppio, feci i salti mortali e accettai al primo colpo. In dieci giorni, solo negli Stati Uniti incassò la cifra per cui era stato venduto in tutto il mercato angloamericano. Incredibile come fu accolto questo film. Ancora adesso nelle università americane durante il corso di cinema fanno un paio di lezioni sulla Battaglia di Algeri. Mi dovrei vergognare a dirlo, ma ho saputo che in queste lezioni di estetica lo mettono di fianco al Potëmkin di Ejzenstejn. Credo che il mio film li abbia colpiti per una sorta di “dittatura della verità”, come è stato detto anche alla Bbc. Io scartavo subito quegli effetti che uno avrebbe detto facilmente vincenti, al cinema, se scalfivano la mia idea di verità. Questo deve averli colpiti, era diverso. E l’insolito è sempre trendy. Sette anni dopo un avvocato che aveva coprodotto il film per l’Algeria, viaggiando spesso a New York, si divertì a calcolare quanto avevo perduto chiudendo subito quel contratto. Una cifra da svenimento. Ogni regista ha un paese dove viene sopravvalutato. Il povero De Santis aveva l’Unione Sovietica. A me son toccati gli Stati Uniti, un paese che non è tra quelli che amo di più.
Le paure di Marlon Brando. Il successo americano mi portò tra le braccia Marlon Brando. Durante un giro europeo, gli chiesero se avrebbe girato un film in Europa. E lui rispose sì, ma con grande cautela nella scelta del regista. Il primo che mi viene in mente, disse, è Gillo Pontecorvo di cui ho visto recentemente La battaglia di Algeri. Brando era il numero uno, ormai da quasi vent’anni. Io e Solinas non ci rendevamo neanche conto della portata delle nostre parole quando, letta quella dichiarazione, ci siamo detti: di faccia ci starebbe proprio bene Brando per Queimada. Non ci era mai passata neanche per l’anticamera delle mente l’idea di una grande star per un nostro film. Visto che è in Europa... Brando chiede di leggere la sceneggiatura. Non c’era una sceneggiatura. Soltanto un soggetto e un centinaio di pagine di battute. Il resto glielo raccontai a voce. Mi disse semplicemente: ok, di’ al tuo produttore di parlare col mio avvocato. Grimaldi spese un sacco di soldi, una cosa pazzesca. Ma lui, che aveva fatto i film di Leone, sapeva che stava facendo un affare straordinario. Conosco bene Dustin Hoffman, De Niro, i grandi insomma. Sono già un gradino più sopra delle star hollywoodiane più importanti. Gente di cultura e di idee. Brando però era molto di più. Uno che legge come un matto. Ha idee
politiche e le segue. Metà dei suoi averi sono andati per i diritti dei pellerossa. Ma lavorarci... c’è da spararsi. È come un cavallo di razza inquieto e ombroso. Lo disturba qualsiasi cosa. Se sta girando e incrocia gli occhi di un elettricista, lontano, su una scala, dice subito: scusa Gillo, stop. Ma per che cavolo stop, urlo. Stop lo dico io. Tu puoi bestemmiare quanto vuoi prima e dopo, ma non puoi fermarmi le riprese. Una volta, prima degli ultimi grandi litigi, mi disse una frase che mi colpì, non me l’aspettavo: “Non dimenticare mai che, nonostante i centoventi film che ho girato, quando parte il ciak mi sento come un passerotto catturato da un ragazzino.” Una volta, siccome si fermò perché non ricordava il testo, imprecai: ma uno che prende tutti quei miliardi le battute le deve sapere cantando, porco boia! E lui: io le so perfettamente. Gli dico di non prendermi per il culo. Lui mi tira da parte e sottovoce mi dice rapidissimo tutte le battute. Era la paura. Incredibile, no? Era l’effetto di una ipersensibilità d’artista, anche per tutte le questioni che si poneva. Poi invece abbiamo incominciato a litigare di brutto. Diceva che io gli toglievo spazio creativo. Sulla regia non apriva bocca. Un professionista come nessun francese o italiano si sognavano di essere. Correttamente, non osava dire una parola. Ma sulla sua recitazione era severissimo. Arrivava sul set avendo pensato ogni passaggio, ogni battuta. Se la mia impostazione collimava con la sua, bene. Altrimenti lo considerava “un furto dei suoi spazi creativi”. Diventava insopportabile. Così si rendeva necessario fare dieci ciak prima che accettasse di mettersi in un altro ordine di idee, con discussioni e molte, molte arrabbiature.
Terrorismo e cinema, gli anni ’70. Tra Queimada e Ogro sono passati dieci anni, ma io non riesco mai a crederci. Non me ne sono accorto. Né avevo bisogno di fare un altro film per forza. Aspettavo un progetto che mi attirasse. Lavoravo su alcune sceneggiature, accettavo collaborazioni. Queimada mi aveva fatto guadagnare un sacco di soldi. Gli stipendi degli americani sono da capogiro. Ci vivi quindici anni bene. Poi io vivo modestamente. Non c’era proprio il problema. Il fatto è che l’Italia era completamente cambiata. In quel decennio c’era stata piazza Fontana da una parte e il delitto Moro dall’altra. Poi la fine della guerra del Vietnam. Le stragi. Il terrorismo delle Brigate Rosse. Quando stavamo finendo la sceneggiatura di Ogro hanno rapito Moro. Marzo 1978. Be’, Cristaldi, che produceva il film, ex partigiano, e io ci siamo detti: ma fare adesso un film su un attentato politico, che deve essere epico, pena perdere la sua carica, non finirà per portare acqua al mulino del terrorismo? No, non si può fare. Pazienza, ci abbiamo perso un anno, ma moralmente non si può più fare. In realtà siamo andati avanti un paio di mesi con un gioco delle parti, prima io lo riprendevo in mano e lui mi tratteneva, e viceversa. Poi ho pensato di cambiare qualcosa. Facciamo incominciare il film da quando il processo democratico in Spagna è avviato e il protagonista, che ha commesso l’attentato contro il primo ministro, si trova isolato, dal momento che vuole continuare la lotta armata a differenza di tutti i suoi compagni dell’Eta, che lo isolano. Isolato perfino dalla moglie, che non lo segue più. In questo modo, però, è vero che abbiamo potuto fare il film, ma ne abbiamo anche indebolito la portata epica. Con tutte quelle domande: se mettiamo questa cosa, poi pensano che siamo dalla parte dei terroristi. E allora, via. Il clima italiano ha influenzato le scelte. Così il film è stato un po’ tarpato, e non ha avuto la spinta che deve avere un film epico. Era
meglio, pensandoci oggi, se non mi facevo venire in mente quello stratagemma. Così non avremmo fatto il film. Lo amo altrettanto poco che La strada azzurra. Eppure oggi incontro persone e amici che mi dicono: ma perché invece di lamentarti non te lo riguardi? Sono quindici anni che non lo rivedo. Prima o poi lo farò.
Volevo fare il direttore d’orchestra. La mia passione per la musica, che a un certo punto sarebbe stata la mia vera via, per cui oggi se potessi appoggiare un dito sul bottone e rifare tutto sarei direttore d’orchestra, ebbene quella passione fu arrestata dalla crisi dei cotonieri. L’azienda di mio padre era a terra. Quando si trattò di decidere l’iscrizione al conservatorio (nove anni di studi) mio padre non aveva più una lira. Ho preso una rivincita quando ho incominciato a realizzare i documentari. Non ero in grado di scrivere la musica, ma al pianoforte oppure fischiandola, trasmettevo le parti orchestrali, i motivi, le variazioni, a qualche studente del conservatorio. La soddisfazione più grande, però, è stata quando, diventato regista di lungometraggi, nei miei contratti facevo mettere la clausola che qualora avessi voluto decidere la musica ne avevo facoltà. Di farla e di firmarla. Con un musicista professionista, per legge. Con Rustichelli Kapò e con Morricone La battaglia di Algeri. Ma quando ho sentito i miei temi suonati da un’orchestra di cinquanta elementi, pagata dal produttore, grazie a Dio, è stata un’emozione straordinaria. Tra le nomination ai Nastri d’argento per la Battaglia quella a cui tengo di più è quella per la musica. È una gioia enorme. Un piccolo risarcimento. La cosa più curiosa è questa. Dunque, la premessa è che io sono un caga-dubbi. Prima di decidermi a fare un film scarto cinquanta progetti. Una volta ho avuto anche una causa con un produttore perché, dopo avergli proposto un film e scritto il trattamento, gli ho detto che non volevo più farlo, gli ho reso gli anticipi e ho perso per un po’ la sua amicizia. Però quello che volevo raccontare è diverso.
Un kirie per Queimada. Non c’è un film tra quelli che ho fatto per cui la decisione definitiva non provenga dall’idea certa del tema musicale. Durante la produzione di Queimada mi sono trovato nel solito impasse. Io questo film non lo faccio, non fa per me. Mi tormentavo. Come faccio a dirlo al produttore? Mi do malato. Invento qualcosa. Nel frattempo, siccome si procedeva verso l’inizio del film, continuavo a rielaborare la sceneggiatura. Un giorno ho riletto una delle scene madri. L’esercito, ma più che un esercito è un popolo con le capre, i carriaggi, le galline, i feriti e anche i soldati, marcia in una laguna verso la città. Penso: caspita, qui ci vorrebbe una musica di tipo popolar-religioso. Mi sono messo al piano e ho cercato. Non veniva fuori niente, però. Poi improvvisamente mi sono ricordato che anni prima avevo ascoltato una messa africana, intitolata La messa Luba in cui c’era un kirie straordinario, era un grido che partiva violento in alto: ki-ri-e-e-e ta-ra-ra-ra. Ho cercato il disco. Mi sono riletto la scena ascoltando la musica. Mi sembrava perfetto. Da quel momento sono diventato un treno. Mi sono preparato e tre mesi dopo abbiamo incominciato a girare. Inutile dire che quando si è trattato di girare quella scena ho mandato gli aiuti a comprare sei copie dei dischi e ho piazzato sei megafoni con la musica in altrettanti punti, tra le mille comparse. La protagonista
era la musica. Non solo per me. Lietta Tornabuoni, che era venuta a fare un servizio, mi pare, per “L’Europeo”, ha scritto che non le era mai capitato di assistere alla ripresa di una scena dove l’intera troupe era in trance. Avevo piazzato sei cineprese, come si fa per queste scene di massa. Ogni operatore e ogni aiuto mi chiedevano indicazioni sulla regia dei vari gruppi. E io rispondevo di non dire niente, di tracciare soltanto il percorso e di farglielo seguire. Al resto ci pensava il kirie. Mi chiedevano indicazioni sugli obiettivi. Normalmente avrei messo il 100 millimetri. Invece scelsi il 220. Per dire che tutto era estenuato e aumentato dall’atmosfera della musica anche sul set. E questi marciavano con una ieraticità popolar-religiosa che corrispondeva esattamente a quello che cercavo io. Finito il film, viene a trovarmi Ennio Morricone, non soltanto il mio abituale compositore, ma mio amico fraterno. Mi dice che ha scritto tutto quello che gli avevo chiesto e che per il finale aveva in mente... Non gli faccio neanche finire la frase. C’è il kirie, per il finale, come gli avevo già annunciato. Insiste perché io ascolti. Proprio perché era un caro amico lo assecondo. Ebbene, considero Ennio un genio nel suo lavoro. Capisco, e gli dico, che è una delle cose più belle che avesse scritto fino a quel momento. Ma c’è il kirie. Il suo era un bellissimo inno laico alla rivolta, alla libertà, eccetera, mentre la valenza del pezzo che avevo scelto io era religiosa. Ero convinto che su quel tipo di immagini faceva fare un balzo a tutto il film. Quindi lo ringrazio e gli dico che di quel pezzo non se ne fa niente. Ennio mi prega: senti, fai una cosa per me, vedi le immagini in moviola con la mia musica. Sempre per amicizia, accetto. E lì succede il miracolo. Credo che il rapporto tra sonoro e immagine sia una delle cose del cinema su cui posso dire molto. Queste scene, sotto il segno del kirie, comunicavano alla musica laica composta da Ennio la valenza popolar-religiosa che ricercavo. Ho sempre pensato che musica e scena dovevano agire in modo complementare. Insomma, ero soddisfatto. Chiamai subito Ennio: la tua testa dura come al solito ha vinto. La metto.
17 Le due. Devo usare il bastone per raggiungere la cucina. Il polpaccio destro si è gonfiato. Proverò con la tisana di Saturnia. Mia figlia ogni anno mi riempie di sacchetti di foglie secche. Di rosa selvatica, di tiglio, di verbena aromatica, di rosmarino. Che cosa fa una vecchia? Prende tisane. L’altro giorno, ho provato desiderio, e non sapevo come accettarlo: dalla fioriera del salone il ragazzo del vivaio, un siciliano con i riccioli neri e gli occhi azzurri, tirava con tutte le sue forze le radici del rododendro malato, gonfiando la schiena come Ercole. Per difendermi da momenti così difficili ho deciso di affiancare due fotografie mie sul comò della camera da letto. Un colpo secco: io a ventidue anni, io a ottanta. Per la seconda foto ho voluto un primo piano: sembra di toccare i solchi della pelle. Il fotografo è stato costretto ad attendere qualche minuto perché sparisse il riflesso delle lacrime. Non avevo previsto che la poltroncina girevole e i due fari ai lati avrebbero risuscitato mio padre, dritto e contegnoso dietro la macchina, mentre alza il mento per dire: pronti. Ogni tanto getto un’occhiata sulle due cornici d’argento e vetro smaltato: come un’esplosione, la freschezza profumata della prima immagine carica l’età della seconda di un’energia fuori da ogni spiegazione. Ricordo bene quando ho preso la decisione di fare quella foto per affiancarla alla prima. Sono state due fotografie di Maria Denis nel suo libro di memorie a suggerirmelo. La foto di copertina, e una fotografia all’interno: Maria Denis da ragazza, assorta in abito nero e doppio giro di perle, nella prima; vecchia, maldestramente disinvolta col suo cane, nel giardino, la seconda. In entrambe, la stessa espressione da bambolina e lo stesso ciuffo sfuggente sulla guancia sinistra, capelli corvini e capelli argentati, pelle lustra e pelle opaca. Nel libro, Maria Denis narra dell’arresto e della misteriosa liberazione di Luchino Visconti nella primavera del ’44. Una delle tante vicende inafferrabili della guerra. La Denis era stata accusata di collaborazionismo con il famigerato Pietro Koch (ma fu poi prosciolta in istruttoria nel ’46), un ragazzo di venticinque anni, agente torturatore della questura, tra i responsabili delle Fosse Ardeatine. Koch arrestò Luchino Visconti, sostenitore della Resistenza, ma gli salvò la vita liberandolo, per intercessione della Denis, la “fidanzatina d’Italia”, innamorata di Visconti, mentre Koch aveva una sfrenata passione per lei. Intrecci di amore, passione, coraggio, false accuse, eroismi, che sarebbe difficile accettare in un melodramma. Io rimasi colpita soprattutto dalle scelte dei tre protagonisti. La Denis, una ragazza semplice e famosa, che vive nel periodo del terrore, in piena battaglia tra fascisti e partigiani, e corre pericolosamente la via ambigua dell’adulazione all’aguzzino per salvare un amico. Koch, manipolatore di vite umane che sente il potere di salvare una vita, sperando forse di ricavarne sconti e perdoni se la situazione fosse diventata pericolosa per lui. E Visconti, che sceglie di dimenticare Maria Denis, invano in attesa di un gesto di riconoscenza al processo, e decide di filmare la fucilazione del suo feroce liberatore quando Koch, nel ’45, venne catturato, processato e fucilato. Sento ancora oggi, in ognuno dei tre, una tremenda angoscia, sul bordo acuminato degli eventi. Ma forse, il più difficile da comprendere rimane ai miei occhi Visconti. Che Visconti sia stato per molti un enigma, un uomo difficile da decifrare e da sentire autenticamente
vicino, non sono soltanto io a dirlo. Suso Cecchi d’Amico, sceneggiatrice dei suoi film, frequentava la sua casa e lo ospitava nella propria: non soltanto evita di darne una definizione, ma ricorda che, fino alla fine, si sono sempre dati del lei.
SUSO CECCHI D’AMICO Il panchetto di Luchino Su questo panchetto, che tengo sempre qui vicino alla mia poltrona nonostante il ricamo assai consumato, poggiavamo la macchina da scrivere. Abbiamo lavorato in questa casa e nelle case di Luchino, prima nella villa di via Salaria, negli anni più importanti, fino alla sua malattia. Però mai a Castelgandolfo, dove non abitava perché si sarebbe sentito isolato. Anche nella villa di Cernobbio abbiamo lavorato, una proprietà immensa, grande come Villa Borghese per capirci, divisa un po’ tra tutti i fratelli. L’hanno recuperato qualche tempo fa tra le cose imballate, superstite di molte ruberie, di ladruncoli o della servitù. Mi hanno chiamato a casa, come se fosse un tesoro: “Suso! Abbiamo ritrovato il panchetto.” Era mio “di diritto”, sostenevano. Credo di averle girate tutte le case di Luchino Visconti. C’era sempre gente, avanti e indietro. Luchino frequentava soprattutto gli attori, ma ogni tanto capitava qualche artista, qualche scrittore. Quella vita d’incontri e passaggi mi ricordava un po’ le domeniche in casa dei miei genitori, quand’ero ragazza.
Con Chesterton, Valéry, Pirandello. Casa Cecchi è stata un posto indimenticabile. Se mai si riuscirà a pubblicare i taccuini di mia madre... C’è passata tutta l’Europa, a casa Cecchi. Scrittori, registi, attori, pittori. Mia madre era una pittrice notevole, un suo maestro è stato Giovanni Fattori, per dire. A parte certe serate o appuntamenti particolari a colazione, erano celebri i pomeriggi domenicali. Babbo era molto ricercato negli anni ’30. Era importante riuscire ad andare nel salotto di Emilio Cecchi. Molti artisti chiedevano di essere invitati per conoscerlo e incontrare altri personaggi. E presto, visto che la cosa diventava frequente, mio padre stabilì un appuntamento fisso, il pomeriggio della domenica. Ma si andava poi avanti fino a tarda sera. Lui era stato l’unico che, per diverso tempo, aveva vissuto all’estero. Aveva portato la letteratura angloamericana in Italia, promuovendo autori e traduzioni. Certi elzeviri, che uscivano sul “Corriere della Sera”, venivano subito tradotti in Germania, in Francia e in Inghilterra. A casa ho visto passare Paul Valéry, Chesterton, Saroyan. Ho pranzato con Luigi Pirandello che diventò un nostro parente indiretto, come riuscì a provare Paolo Grassi, che si divertiva a ricostruire i rami aggrovigliati della nostra famiglia aiutato da mio suocero Silvio d’Amico. Ai pomeriggi della domenica c’erano Roberto e Lucia Longhi (in arte Anna Banti), Leo Longanesi, i giovani Nino Rota, Soldati e Moravia, che più in là incominciò a portare Elsa Morante, Ennio Flaiano, e venivano compositori come Casella, Malipiero. I musicisti si mettevano al pianoforte e passavano le ore, soprattutto Nino Rota che era un grande pianista, sempre pronto a eseguire qualsiasi musica gli si richiedesse. E il mio futuro marito... Lele d’Amico.
Il cinema non vale Dostoevskij. Quando poi mio padre ha fatto il cinema, si è portato un gruppetto di personaggi poco amato dai frequentatori abituali di casa Cecchi. Perché la verità è che non piaceva che lui, Emilio
Cecchi, un intellettuale insigne, si fosse invischiato col cinema. Venivano Camerini, Blasetti, Walter Ruttman, e certi produttori. Adesso non ci si pensa, ma quando Emilio Cecchi fu chiamato dal banchiere Toeplitz a dirigere la Cines, nei primi anni ’30, dopo l’anno trascorso a Berkeley e una visita curiosa a Hollywood, ebbene il cinema non era una cosa presa molto sul serio. Giustamente. Un’esperienza piacevole, certo, ma anche oggi, dico, vogliamo paragonarlo a un’opera letteraria? Il cinema è un bel gioco, credo; ma resta una cosa che non può essere fatta da un uomo solo, anche se poi sappiamo che, per esempio, uno come Bergman è senz’altro un grande artista. Il teatro è diverso, perché il vero autore è lo scrittore del testo; che si può leggere, ed è fine a se stesso, come succede con Shakespeare. Indubbiamente l’intervento di mio padre nella produzione ebbe una grande importanza per l’industria cinematografica italiana. Chiuse la strada al cinema dei cosiddetti “telefoni bianchi”, commedie ambientate, non si sa perché, in Ungheria, con delle storielle di contessine e arciduchi che non potevano certo essere apprezzate dagli intellettuali, roba addirittura peggiore della odierna fiction televisiva. Sempre di cinema si trattava, anche se i film fatti produrre da mio padre furono molto diversi (Gli uomini che mascalzoni!, 1860, T’amerò sempre, O la borsa o la vita). La diffidenza dei colleghi verso il cinema restava, e a mio padre un pochino era pesato quel giudizio. Lasciò per questo la direzione della Cines, anche perché non riusciva più a scrivere una riga, tale era la passione e l’impegno che metteva in quel lavoro, al quale chiamò a collaborare amici, pittori, scrittori. Promuoveva i giovani. Da Torino fece venire il giovanissimo Mario Soldati, che cambiava continuamente aspetto: barba lunga, barba corta, baffi, basette a rasatura. Chiamò Guglielmo Alberti. Invitò anche Carlo Levi, che però rifiutò. Babbo era capace di passare negli studi Cines tutta la giornata e poi, a tarda sera, a casa, era ancora lì al telefono, ore intere a ridiscutere le sceneggiature, i cast, il girato. Tutto, si occupava di tutto. E si divertiva molto. L’avventura di Acciaio fu imponente, un passaggio della storia del cinema, anche se non riscosse il successo che si aspettavano. Avere intorno tutto questo, andare ai teatri di posa, incontrare gli attori, vedere i costumi e la baraonda del set, per noi figlie di Cecchi era entusiasmante, soprattutto per me che da bambina volevo fare l’acrobata. Finii invece a lavorare al ministero delle corporazioni come interprete, per interessamento di Bottai, che era il ministro fascista della cultura, l’unico che cercava di frequentare un po’ gli intellettuali. Non è che babbo guadagnasse molto scrivendo; così mi sono messa subito a lavorare. Alla fine della prima guerra mondiale la nostra famiglia era proprio a terra. Nel 1918 babbo era andato un po’ a Londra. Ci siamo trasferiti stabilmente a Roma soltanto nel ’19. Comunque, non ho mai pensato che avrei scritto per il cinema. Non lo faceva nessuno alla fine degli anni ’20, ma mio padre mandò allora mia sorella e me, come si fa oggi, per qualche tempo in Inghilterra a studiare l’inglese. Non ero che una ragazzina. Mi piaceva la letteratura. Mi piaceva tradurre, dall’inglese e dal francese, anche se a volte era una faticaccia. A Visconti gli avevo tradotto testi per i suoi spettacoli: La via del tabacco, veglia la mia casa Angelo, Vita col padre, dopo l’impresa in collaborazione con babbo delle Allegre comari di Windsor e dell’Otello. Non so se si riesce oggi a immaginare che cosa significava per un giovane frequentare tutte quelle persone appassionate, intelligenti, colte, vivaci e piene di esperienze. Noi avevamo pochi amici tra i nostri coetanei, e molti tra quelli dei nostri genitori. Come è accaduto anche ai miei figli, che, per esempio, sono amici di Monicelli come se fosse un coetaneo; e da un certo punto hanno incominciato a incontrarsi per conto loro. Siamo stati fortunati. Voglio dire: personaggi così oggi non esistono più. Non dico questo per
rispetto dei morti, e perché tutto si abbellisce nel ricordo che ti riporta alla giovinezza. Credo obiettivamente che sia difficile trovare l’equivalente. Quello fu un momento speciale del secolo, per tutto: le arti figurative, la poesia, la letteratura, le avanguardie. Perché speciale? Non lo so. Forse perché gli uomini poi sono cambiati. Mah. Mi vien da dire però che l’impatto con l’America, dopo la seconda guerra mondiale, è stato drammatico. Il culto del denaro, la corsa al successo da raggiungere ed esibire... I giovani oggi non sanno che cosa è un ideale. Forse la fortuna vera è di chi non si rende conto di quanto son cambiate le cose. Dai taccuini di mia madre, che vanno dal 1911 agli anni ’70, si conosce un patrimonio sterminato di vitalità culturale e artistica perduto progressivamente. Quella era gente che passava le serate a discutere un articolo, un fatto, un quadro, un aggettivo. Mia madre annotava quasi ogni giorno: “Parlato d’arte”. Oggi chi può dire d’incontrarsi per questo piacere? Certo, loro lasciavano fuori il cinema. Quando arrivò il sonoro poi, un po’ tutti, e anch’io, eravamo certi che sarebbe stato un episodio, comunque un fenomeno di decadenza nel caso avesse preso piede. Perché montava tutta l’arte della mimica, che aveva raggiunto una maturità vera. E invece il sonoro portava a me il mio lavoro. Questo è curioso... Mi ricordo il primo film sonoro, Sonny Boy. E poi il colore... Secondo me il colore può essere considerato un progresso nel cinema soltanto dal 1954 con Senso. Credo che Visconti e Aldo fecero un miracolo con la fotografia. Era un genio dell’immagine, Luchino, anche se io resto convinta che le cose più alte di Visconti non appartengono al cinema. Parlo dell’opera. Oggi sarebbe inconcepibile assistere a opere messe in scena come quelle che ho visto io con Beniamino Gigli e la Muzio. La Traviata di Visconti con Maria Callas fu un capolavoro. O la Manon, a Spoleto, l’ultima opera di Visconti. Sono cose altissime. Ineguagliabili dal cinema. Insomma il cinema non è un fenomeno all’altezza di Dostoevskij o Tolstoj. È sleale non ammetterlo.
Blasetti, 42 scrittori per una scena. Comunque, è vero che quasi non mi sono accorta di entrarci nel cinema. A casa mi chiedevano sempre di leggere dei copioni e di dare anch’io dei giudizi. Poi un giorno arrivò Carlo Ponti, questo giovane avvocaticchio milanese, e con Renato Castellani mi chiede perché non scrivevo qualcosa per il cinema. Io avevo un raccontino di un’esperienza fatta quando siamo stati sfollati in campagna, che poi è diventato, nel 1946, Vivere in pace di Luigi Zampa. Nei film che abbiamo fatto subito dopo la guerra, quando ho esordito io, i titoli riportavano spesso uno stuolo di sceneggiatori, che non erano gli autori effettivi. Ci finivano anche nomi che dovevano figurare nel film per un qualche motivo, e non si sapeva dove metterli. Oppure riflettevano tutti i passaggi della sceneggiatura, perché allora era frequente che un soggetto passasse da una produzione a un’altra riscrivendo e cambiando gli sceneggiatori. C’era il caso a volte di persone consultate per alcune informazioni precise, di umoristi ai quali si chiedevano delle battute (Age e Scarpelli incominciarono così). Per Fabiola Blasetti aveva messo insieme tredici sceneggiatori. Ma per la sola scena d’amore tra Fabiola e il gladiatore che s’incontrano di notte su una spiaggia ne aveva consultati quarantadue (oltre agli sceneggiatori), facendoli pagare tutti. “Mi scrivi la scena sulla spiaggia? Mi scrivi una scena d’amore?” chiedeva a scrittori e giornalisti che, per rispetto verso Blasetti e invogliati dal “gettone” offerto, si mettevano al lavoro. A sua volta Blasetti aveva grande rispetto per i suoi
collaboratori e cercava di citarli appena si presentava l’occasione, anche se non aveva usato che un frammento del loro lavoro.
Il cuscino di sabbia per Fabiola. Io sono stata citatissima perché ho inventato il cuscino di sabbia su cui si stende Fabiola, che tanto era piaciuto a Blasetti. Mi aveva portato in giro in macchina per mezza giornata, spiegandomi che per risolvere il problema delle scene d’amore io (che ero una un po’ freddina sensualmente) dovevo vincermi e sapermi finalmente sfogare. Quando uscì il film mi presentava a tutti: “Lei è quella del cuscino di sabbia.” Non ho mai dimenticato l’effetto folgorante che mi fece Blasetti la prima volta che lo vidi. Ero una ragazzina e mio padre mi portò a un’anteprima di Sole. Era il 1928 o forse il ’29. Mi ricordo il vestitino di voile di cotone che indossavo e ricordo bene che avevo freddo, perché eravamo in una specie di capannone all’aperto. Era una proiezione privata. Ero lì perché a casa mio padre non aveva trovato nessuno a cui lasciarmi, e io rimasi abbagliata dalla figura imponente e autorevole. Era veramente affascinante. Poi, l’ho rivisto già ragazza, quando incominciò a frequentare la casa dei miei genitori al tempo della Cines e di Mario Camerini, un uomo divertentissimo con cui siamo diventati tanto amici. Mi ricordo del viaggio in Sicilia di mio padre, scontento del primo materiale girato per 1860. Non era il tono del film che voleva, e andò giù a chiedere a Blasetti di rifare un sacco di cose. C’erano discussioni infuocate tra il produttore e il regista, anche se Blasetti aveva la massima considerazione per mio padre. Quando tanti anni dopo mi è capitato di lavorarci, con Blasetti (per Peccato che sia una canaglia, con la Loren e Mastroianni, o La fortuna di essere donna), come pure con Camerini, non mi sono trovata molto bene. Insomma, sul lavoro non ho trovato con loro quel rapporto disinvolto necessario alla collaborazione, perché erano rimasti per me i mitici personaggi della mia adolescenza. Lo stesso sarà stato per loro, che mi consideravano sempre una ragazzina. Con Mario Soldati è stato diverso. C’era differenza di età, ma era come non ci fosse. Lui mi aveva fatto la corte. Uscivamo. Era stato richiamato severamente da mio padre. Soldati aveva una moglie americana... Ma fu un disastro, con lei. L’amicizia con Soldati è durata tutta la vita, con lui non ho mai lavorato. Ricordo l’eleganza di Gianni Franciolini, con cui poi ho fatto Il mondo le condanna e Buongiorno elefante. Era di famiglia agiata, vestiva in modo estremamente elegante. Non era un carattere molto vivace; la cosa che mi colpì fu quando andai a trovarlo a casa e mi aprì la porta la Flecchia, una compagna di scuola della squadra sportiva del Tasso. La Flecchia! Lei era una che si ossigenava i capelli in terza liceo, a quel tempo una delle primissime a farlo. Era diventata la moglie del sobrio Franciolini, che morì giovanissimo.
La banda degli sceneggiatori. Da Zavattini a Moravia. Il primo contatto con Fellini è stato da cosceneggiatrice per Il delitto di Giovanni Episcopo, diretto da Lattuada. Fellini, per la verità, non faceva niente durante la lavorazione del film. Cercai di spiegarlo, una volta, quando sentii un funzionario Rai che esultava perché aveva trovato una sceneggiatura col nome di Federico Fellini. Ma figuriamoci. Come ho già detto,
per far guadagnare un po’ gli amici c’era questa connivenza. A Fellini, poi, di lavorare alla sceneggiatura di un film non gliene fregava niente. Vittorio De Sica l’ho conosciuto che era un ragazzo, magrissimo, quando aveva fatto Gli uomini che mascalzoni! con Camerini. A quel tempo girò alla Cines anche una commediola, un tentativo di musical, dove cantava una canzone, “How do you do, mister Brown?”, che ebbe un certo successo. Ricordo che portai la Sarfatti (amante del duce) a vedere De Sica che usciva, elegantone, con la mano in tasca, e che cantava: “Aau ddu iu dduuu / mi-ste-r Brouuun”. Somigliava moltissimo, De Sica, a un fratello di mio marito, Marcello, anche per il modo di fare e per la verve. Quando Sergio Amidei lasciò Ladri di biciclette, dicendo: “È una stupidaggine”, Zavattini volle me che avevo già fatto coppia con lui. Risultano molti sceneggiatori anche in quel film. Ce ne sono sei o sette, se non sbaglio, ma i più fecero ben poco. C’è anche il nome di un commediografo che quando incominciammo quella sceneggiatura era morto. Questo dice tutto del pasticcio nei credit dei film. Zavattini era simpatico e vanitoso, un omone con mani bellissime, da aristocratico, un fisico da contadino e gli occhi da poeta. E anche un po’ bugiardo. Alla fine della nostra collaborazione ci fu quella storia di un film di Zampa mediocre, con Jean Gabin, che finì alla Mostra di Venezia contro il parere mio e di Brancati, che l’avevamo scritto, mentre Zavattini, impegnato per un’altra cosa, ci aveva ringraziato per la collaborazione e aveva firmato lo stesso, promettendo di rendere il favore. Fu lui, poi, a sostenere che il film doveva partecipare alla Mostra, contro ogni evidenza. Quando uscirono le stroncature, Zavattini dichiarò ai critici che lui, per carità, non c’entrava niente. Brancati era furibondo. Io ci ho riso sopra, ma ho smesso per sempre di lavorare con Zavattini. Peccato, perché eravamo così diversi che ci completavamo bene. Una buona coppia di sceneggiatori deve essere composta da personalità opposte. Insomma, per Ladri di biciclette ero entrata io al posto di Amidei. Appunto, eravamo una coppia perfetta, con Zavattini. Perché questi veri scrittori, come Zavattini, Flaiano o Tonino Guerra, sono preziosi nelle riunioni. Elargiscono idee. Ma poi, quando si arriva ai “blocchi” di sceneggiatura da dividere per la stesura, a loro non andava di mettersi a scrivere, giustamente anche. La penna la vogliono adoperare per altro. Ho lavorato lunghi anni con Flaiano, brillante e riservato nello stesso tempo (un carattere molto complesso e delicato), ma di sceneggiature ne ha scritte ben poche. Centinaia di sedute con lui, di fondamentale utilità, e poche pagine. Anche Moravia aveva gli stessi problemi, ma lui non era un buon sceneggiatore. La verità è che quel lavoro non gli interessava proprio. Metodico, Moravia dedicava l’intera mattina al suo lavoro di scrittore. Il suo tempo libero, nel pomeriggio, lo dedicò qualche volta alle riunioni di sceneggiatura nelle quali, più che creare, criticava. Accettai con grande timore di sceneggiare Gli indifferenti. Mai un lavoro fu tanto studiato, e non ho mai perdonato a Maselli di avere ceduto col produttore, rinunciando al colore, quando Cristaldi si impuntò sui costi. Perché d’accordo con Maselli avevo dato funzione narrativa al colore. Quando scrivi e pensi ai colori delle cose... non puoi all’ultimo momento trovarti il bianco e nero. In quella sceneggiatura era stato un po’ come per Senso. Allora si lavorava sul serio, mica come adesso. Con Senso Visconti mostrava ai collaboratori pacchi di riproduzioni dei dipinti dell’epoca di riferimento. Sapevamo che drammaturgicamente andavamo dai toni chiari al tutto nero della fine. Per questo per gli Indifferenti fu un vero dolore finire col bianco e nero, che ha maggior forza drammatica di per sé. Avevamo studiato un’ambientazione e un clima che dovevano
essere quasi senza colori. Ma quel “quasi” doveva farsi notare, e come! Faceva parte del lavoro di sceneggiatura.
Il furto della bicicletta. L’ho detto sempre, lo sceneggiatore deve scrivere con gli occhi. Con Guerra, Flaiano, Zavattini discutevamo, divagavamo, poi veniva il momento di raccogliere il seminato e mettersi a scrivere, con soggezione da parte mia e sempre sul lavoro scalettato nei minimi particolari. Quando incominciammo Ladri di biciclette Zavattini avrebbe lasciato il passo episodico del racconto di Bartolini, ma quando a me venne in mente l’idea del furto della bicicletta fu il primo a dare il suo consenso. Tra Fellini e Flaiano c’era sempre Pinelli che impugnava la penna. Questo non significa assolutamente che Pinelli fosse un amanuense. Aveva più esperienza di sceneggiatore di Flaiano e sapeva quel che deve essere scritto, a incominciare dalla descrizione degli ambienti, utile ai produttori. Il giro di Roma per Ladri di biciclette l’abbiamo fatto Zavattini, De Sica, io e Gerardo Guerrieri, che fu assistente alla regia. Uscivamo insieme e cercavamo insieme; andammo anche da quella donna che “riceveva” nella casa davanti a villa Torlonia. C’era la fila di gente che andava per parlare delle disgrazie, amori infelici, cancri e tutto il resto. E anche noi ci mettemmo in fila per sentire e capire. Con Antonioni è stato un po’ diverso. Antonioni era una persona molto divertente, spiritoso, al contrario di quello che può apparire dai suoi film. Se penso che con La signora senza camelie credevo di aver scritto una commedia! Le amiche ha una vivacità che è di Antonioni, perché non bisogna assolutamente pensare che Michelangelo fosse un mattone. Non gli interessa fare il comico. La versione inglese dei vinti è bellissima, quello è un film che abbiamo realizzato proprio come Ladri di biciclette, andando in giro a vedere i posti, a parlare con le persone. Non c’è nulla di inventato nell’episodio inglese; sono veri perfino i nomi della vittima e dell’assassino.
Spaventati dagli americani. Non ho mai avuto una frequentazione stabile con gli attori. Ho conosciuto abbastanza bene Sordi, Gassman. Ma i miei grandi amici sono stati soltanto tre: Mastroianni, la Magnani e Lancaster. Mastroianni veniva sempre al mare, a Castiglioncello, dove aveva casa come me. L’amicizia con la Magnani era in alternativa a quella con Rossellini che, quando si mise con la Bergman, non ho più potuto frequentare. Comunque il rapporto fra i due non è quello che si racconta nel film di Lizzani e Pirro Celluloide. Vero è che io conoscevo la storia dalla parte della Magnani, un punto di vista che manca nel film. Anni prima mi ero data da fare per Rossellini, ai tempi di Roma città aperta. Ci eravamo mossi un po’ tutti per cercargli la pellicola, ma ancora non lo conoscevo personalmente. Poi, dopo la morte della Magnani, quand’eravamo già piuttosto anziani, abbiamo ripreso i rapporti. Ce l’ho avuto per casa fino alla fine. Per molti anni sono stata vicesegretaria dell’Associazione degli autori e quando c’erano gli incontri con i ministri o le manifestazioni in difesa del cinema italiano, convocavamo i grandi nomi, come Rossellini o De Sica, che avevano già avuto successo. C’era tutto da fare, ed
eravamo spaventati, molto spaventati, per quello che stavano facendo gli americani, con tutti quei film che avevano invaso il mercato italiano. Gli americani erano uomini d’affari formidabili, ma anche implacabili. Vista da oggi, è una cosa spaventosa quello che hanno fatto gli americani contro il cinema europeo. Salvo gli inglesi, che si sono un po’ salvati per la lingua. L’Europa è stata colonizzata da una cultura cinematografica esterna, perdendo spazio, perdendo forza di creatività e di autonomia. Il pubblico italiano era un pubblico formidabile, avido di cinema e amante del suo cinema. E gli americani lo sapevano benissimo.
Luchino era... Luchino Visconti non partecipava alla vita collettiva del cinema. Lui stava fuori, frequentava semmai la gente di teatro. Veri grandi amici di Luchino erano Paolo Stoppa, Romolo Valli, Giorgio De Lullo e il giornalista politico Antonello Trombadori. Non frequentava i salotti, i ristoranti o i caffè. Soltanto per un periodo, quando già era malato, gli piaceva venire a casa mia per parlare di politica e di musica con Lele, e ascoltare Nino Rota al pianoforte. Comunque: “si andava” da Visconti, a casa e in teatro. Lui aveva questa grande, grande amicizia con gli attori. Gli piaceva inventarli e allevarli, istruirli, farne grandi interpreti, come fu con Alain Delon e Helmut Berger. Mentre, in genere, tra i registi e gli attori non c’era una grande frequentazione. Luchino era un artista di una disciplina fantastica, capace di infuriarsi davanti agli errori altrui. Io sono stata fortunata, credo, perché con me era molto gentile. Ci siamo dati sempre del lei, fino alla fine. Ci conoscevamo profondamente, e non mi era difficile lavorare per lui: per esempio, della sceneggiatura della Recherche ne abbiamo parlato qualche volta, e ho potuto scrivergliela tutta. La cosa importante era che io sapevo a quali scene non avrebbe rinunciato mai. Anche per Senso si parlava fino a un certo punto e poi si scriveva, ma non c’è mai stato un tempo “medio” di lavoro. Per Rocco abbiamo fatto un sacco di ricerca insieme, abbiamo viaggiato, fatto inchieste. Il lavoro era veramente più collettivo, prima. Poi siamo andati verso il primato della regia. Finché oggi, seguendo questa strada, si è deteriorato spesso il risultato, perché i nuovi registi vogliono fare tutto da soli, e va bene, finché la loro preparazione lo consente. Ma non mi sembra che il risultato sia sempre positivo. Oggi molti scrivono, in buona fede, di cose che non conoscono. Mi è capitato più volte di leggere soggetti di giovani che non sanno di che cosa parlano e non conoscono il fascino del lavoro della ricerca, lo studio degli ambienti, la storia e gli uomini. Per Senso abbiamo studiato sulle carte topografiche le strategie degli eserciti. Visconti era... non è facile sintetizzare. Era la perfezione applicata a ogni singola voce in un grande disegno d’insieme. Non c’è niente di affidato al caso. Era un tutto pieno di spunti presi dalla vita e dalla letteratura. Faccio il primo esempio che mi viene in mente: Nastasja Filoppovna dell’Idiota di Dostoevskij è stata d’ispirazione per Natalia di Rocco. Nelle lettere tra Visconti e me si fanno continuamente riferimenti. Difficile che lo spettatore del film riesca a individuare sempre che cosa ci abbiamo messo dentro. Sceglievamo tra conoscenti e amici i modelli per i nostri personaggi. Come capitò a Burt Lancaster, avevo tenuto anch’io presente Luchino Visconti per riscrivere il principe. Per esempio, quando Stoppa o la Cardinale si presentano al principe nel Gattopardo, deve risaltare di colpo la personalità diversa, contadina, di Angelica e la razza aristocratica di Salina in un’unica immagine. Monicelli, Comencini, Antonioni. Ciascuno
richiedeva un suo modo di procedere nel lavoro. Io sono un artigiano, e cerco di fornire buone soluzioni ai registi. Il comico richiede di essere inventato in compagnia, mentre il drammatico a volte richiede di essere soli, perché si ha più pudore a tirar fuori certe cose. Io non so essere spiritosa, ma fare il comico mi diverte proprio. Per Totò invece, quelle due volte che ho lavorato, ho capito che non c’era niente da fare. Era molto maschilista. Ho visto subito che non mi avrebbe dato mai fiducia. La sua fantasia era enorme. Ma non c’era paragone tra il privato e la scena. In privato era contenuto, riservato. Un signore d’altri tempi.
Le ambizioni sbagliate. Forse l’ho già detto, ma io sono felice di aver lavorato con tutti loro. Mi ha permesso di affrontare con serenità i momenti difficili della mia vita, le delusioni, anche le delusioni della storia, il tradimento della fiducia che avevamo avuto. Tra gli sceneggiatori, non c’è modo di spiegare come fosse divertente stare con Flaiano, lavorare, vivere con lui. E con Monicelli, Rosi, Comencini, Age, Scarpelli, Zavattini, Castellani, Zampa, Zurlini, Benvenuti e De Bernardi, De Sica, pieno di pasticci, mogli, amanti, gioco. So per certo di aver lavorato con talenti – uomini e donne – che non sono stati sostituiti. Né l’avremmo immaginato, a quel tempo, che erano unici. Credo che le “ambizioni sbagliate” abbiano bloccato il ricambio di quella generazione. Anche i migliori, voglio dire... Bertolucci, è un sottoprodotto di Visconti, no? La commedia italiana ha parlato della gente e dell’epoca in cui veniva prodotta, e oggi posso dire che la commedia italiana riflette veramente quel tempo, le persone, i rapporti, i costumi di una società. La nostra generazione, invece, è rimasta fuori dagli avvenimenti terribili della fine anni ’70. Non li abbiamo capiti, credo, e non li abbiamo saputi raccontare. Non solo noi anziani, neanche i giovani. Fu un vero momento di rottura. Noi siamo rimasti fuori, a quel punto. E non siamo più riusciti a rientrare in forze. Forse ha ragione Furio Scarpelli: non è vero che gli anni scappano, siamo noi che scappiamo agli anni.
18 Questa mattina Miriam mi ha fatto trovare il giornale sulla poltrona. Io leggo sempre tutto, dalla prima pagina alla grande pubblicità in ultima. Lo considero un privilegio dell’età. Avere il tempo. Ho il tempo perché il tempo sta finendo. A un certo punto della vita ti lasciano andare (salvo poi ricordarti per un premio). Non sei più necessaria. Gli artisti, no, gli artisti riescono a lavorare fino a ottant’anni e più. Ma gli artisti sono abituati dalla nascita a considerarsi non necessari e hanno innestato nei geni la volontà di esistere. Così avviene il peccato di presunzione: si credono necessari; fanno opere della senescenza. Che vuol dire incontinenza del cuore e della psiche. Tranne casi rari. Non li invidio. Però mi commuovo pensando alle giornate laboriose di un regista di ottantaquattro anni... La resistenza. Qualcuno ha scritto che la vecchiaia è l’unico modo scoperto per continuare a vivere. Un postino, però, un impiegato delle assicurazioni, un bidello: che speranze hanno? Un insegnante può ostinatamente contare sulle lezioni private, tra un ricovero ospedaliero e una vacanza comandata con i nipotini. Ho sentito parlare della depressione dei manager. Alcuni diventano amministratori di condominio. Io preferisco avere tutto il tempo. Tutto il tempo del poco tempo. Ma anche questo privilegio ha il suo rovescio. Leggere il giornale può diventare uno strazio alla mia età. Da una colonnina, che sembra impaginata per puro dovere di cronaca, leggo: “Il pubblico ministero Calia ha richiesto al Gip Fabio Lambertucci l’archiviazione per il procedimento relativo alla misteriosa morte del presidente dell’Eni Enrico Mattei, avvenuta in seguito al disastro aereo del 27 ottobre 1962 in provincia di Pavia. Per il Pm l’incidente fu un attentato e Mattei fu assassinato, ma ‘è impossibile risalire sia ai mandanti sia agli autori materiali’. Mattei, al centro dei conflitti di potere internazionale del mercato del petrolio del dopoguerra, non intendeva né cambiare la sua politica petrolifera, che favoriva l’espansione italiana, né dimettersi, come gli fu chiesto.” All’epoca, anch’io avevo creduto all’incidente, e soltanto il film di Francesco Rosi sul caso Mattei smontò, per me, la tesi dell’incidente e mi convinse dell’attentato. Ricordo un clima tetro attorno a quel film. L’eco permanente della strage di piazza Fontana, tre anni prima, gli rendeva un macabro servizio promozionale, per il bisogno di verità e di giustizia. Oggi è necessario avere gli anni che ho io per sentirsi avviliti e insieme sollevati. E perché anche sollevati non è difficile a dirsi. Quest’inverno ho ritagliato per mio nipote due notizie sullo stesso giornale. In una pagina, il comandante che trucidò i partigiani bianchi a Malga Porzus riconosce davanti ai figli degli assassinati la sua terribile responsabilità. È un vecchio di 93 anni, e sembra che l’eccidio lo abbia fatto da solo. Nell’altra pagina, la ricostruzione della strage dei braccianti a Portella della Ginestra, con i documenti che finalmente provano il coinvolgimento della Cia nell’azione attribuita ufficialmente soltanto alla banda di Salvatore Giuliano. Ogni vecchio potrebbe aprire un suo personale Vaso di Pandora. E quando ogni costola del tuo corpo ha conosciuto lo sgomento di questi lunghi elenchi di morti, ti senti sollevata se la memoria spinge ancora l’indignazione. Film come quelli di Rosi sono importanti. Costringono a interrogarsi. Noi, che ascoltiamo la voce dei morti, andremo nella tomba ignari. I vecchi non sapranno. Mi sentirei più utile se almeno potessi passare le ore che mi restano a baciare sulla fronte ogni vittima.
FRANCESCO ROSI La vita come impegno Nel 1945 le scelte civili s’imponevano. Voglio dire che erano dettate dalle circostanze. C’è il nostro cinema a dimostrarlo. Di tutte le espressioni d’arte, quella che riuscì maggiormente a registrare la realtà intorno a noi fu il cinema. La letteratura... sì, c’erano Pavese, Calvino, Levi, che elaborarono poi testi fondamentali. Ma appena la guerra cessò fu il cinema che recepì e raccontò il processo di ricostruzione. Un processo sia morale che fisico: fisico perché il paese era distrutto dalla guerra e il cinema lo fotografava, lasciandoci documenti importantissimi; morale perché dopo il fascismo, e con lo spirito della Resistenza, c’era un desiderio di individuare nel modo più chiaro (e fu anche il più incerto) la strada per partecipare alla rinascita.
Raccontare la realtà, ieri oggi domani. Il cinema neorealista, che già si muoveva quando la guerra non era ancora finita, aveva fatto una scelta vincente: far parlare i fatti. La maniera in cui Rossellini prima, e De Sica e Visconti poi (i tre maestri del neorealismo) si sono messi davanti alla realtà cercando di far parlare gli eventi quotidiani e di collegarli alla storia, era determinata dallo spirito dei tempi. Oggi la realtà è molto più complessa, direi complicata. È più intricata, ecco. Quando ho fatto Salvatore Giuliano certe collusioni tra la mafia, la polizia e la politica era possibile delinearle in modo semplice e chiaro, anche se nessuno ci credeva, al momento (il cinema mostrò venti, trent’anni prima ciò che abbiamo potuto provare poi). Oggi la connivenza delle attività pulite con quelle sporche è moltiplicata rispetto a quei tempi, ma soprattutto è diventata quasi inafferrabile. Negli anni ’70, nella mafia c’è stato il passaggio dall’attività preminente di contrabbando a quel nuovo tipo di attività, il narcotraffico, che ha rivoluzionato in modo totale l’accumulo di reddito e di crimine. Una quantità immensa di denaro sporco, che prima era inimmaginabile, doveva essere riciclata e reinvestita. E qui arrivano le attività “lecite”, e le banche. E la questione si fa intricatissima. Al cinema oggi diventa più arduo raccontare questa realtà rispetto a trent’anni fa. Io ho provato comunque. Forse sarà sempre più difficile.
La scoperta di De Sanctis. La mia concentrazione sulla realtà è sempre stata forte, anche se non è vero che io sia estraneo a esperienze artistiche più fantastiche, cioè che mi collocherei più dalla parte di Rossellini che da quella di Fellini. Il quale, non dimentichiamolo, era assistente proprio di Rossellini per Paisà. E l’aiutò anche a scriverlo. Gli interessi di Fellini in origine, nei suoi primi film, erano rivolti a un cinema, come si dice, “di realtà”, o di realismo. Poi, un suo istinto al fantastico, più sopra le righe, più evidentemente poetico, è venuto fuori mano a mano. D’altra parte, io, anzi, noi meridionali, e specialmente noi napoletani, abbiamo due anime. Teniamo a due aspetti della cultura: da una parte c’è l’anima razionale che ha prodotto filosofi eccelsi, dall’altra invece una creatività fantasiosa, svincolata dalla razionalità. La mescolanza di questi
due elementi è possibile sentirla nelle opere dei napoletani. E poi, nel mio caso, c’è la scoperta di Francesco De Sanctis, che in una raccomandazione ai giovani, scriveva che la vita è una missione, che bisogna viverla consapevolmente per il raggiungimento dell’arte, della scienza e della morale, insomma di quello che è bello, buono e giusto.
La mia anima leggera. A me questa cosa colpì fin da quando lessi la prima volta le opere di De Sanctis. Ma queste parole, il fatto che la vita è una missione, è una cosa che alla fine, insomma, mi ha inguaiato. Mi ha fregato perché ho anche un’altra natura, che è emersa solo a tratti, e io... Insomma io sono uno che ha fatto anche Carmen, per dire, o C’era una volta; mi piace la musica, mi piace il musical, ho una visione appassionata del pittoresco e, per esempio, di tutto il mondo latinoamericano. Se contiamo anche la fine di Camicie Rosse, che girai io, e la direzione tecnica del Kean per Vittorio Gassman, ho fatto 19 film, dei quali quattro, cinque, sono parte della mia altra natura. Tant’è vero che continuo a meditare di fare un musical, ma insomma, non so. La mia dimensione poetica è venuta fuori lavorando sulla realtà, ma come d’altra parte aveva fatto Federico all’inizio. Federico era veramente unico. Il suo modo d’interpretare la realtà e di restituirla allo spettatore (e siamo sempre a un’idea di “fatti”, di cose che sentivamo che erano accadute fuori o dentro gli uomini di quel tempo) era personale e collettivo insieme, perché lo spettatore poteva ritrovare i suoi interrogativi, le sue ispirazioni, che però invece di essere riferiti esclusivamente al rapporto dell’uomo-cittadino con la società, erano riferiti anche all’uomo con se stesso, con la dimensione psichica, con un luogo più segreto, più intimo, ma che poi finiva anche quello per essere un modo per raccontare la realtà. Perché in definitiva Lo sceicco bianco o I vitelloni erano ritratti della vita italiana. E I vitelloni è un film straordinario, uno scorcio della provincia italiana. Basta il ritratto di quel padre, è una figura così precisa... è meravigliosa (ecco non capisco perché ’sti Vitelloni non lo facciano vedere più spesso, è uno dei più belli di Federico).
Onore alla commedia all’italiana. Io penso che la caratteristica del cinema di quegli anni era di trovarsi sempre rivolto ai problemi del suo tempo, nei modi di una narrativa sia realistica, sia fantastica, sia di commedia, la quale riusciva a graffiare come, se non più, di un film drammatico (perché quanto la commedia all’italiana sia riuscita a metterci di fronte ai nostri difetti, non si è mai visto nel rapporto tra il cinema e la società). Ma pensiamo ai film di Germi e Dino Risi, a quelli di Zampa e di Monicelli, di Bolognini e Petri. Voglio dire che sono riusciti a raccontare gli italiani nei loro aspetti più criticabili, ma facendo sentire alla gente “dove” erano i difetti, “dove” erano i problemi. Per questo i politici s’incazzavano su certi argomenti. Quando uno fa un film come Divorzio all’italiana, come Sedotta e abbandonata, o come Il bell’Antonio, o Il sorpasso, Tutti a casa... Sono film di grandissima penetrazione. Oggi non abbiamo questa capacità. Non l’abbiamo perché... francamente è un discordo globale, non so se si può spiegare bene. Ci siamo troppo dentro. Ma posso provarci.
Tesi. Pubblico e realtà. Se noi partiamo dalla constatazione che il cinema è lo specchio della realtà e della società che lo produce, be’, la società è estremamente cambiata, il mondo nel quale viviamo è diverso. Fino a trent’anni fa, noi della mia generazione, anche quelli più anziani che sono scomparsi, ci si guardava intorno, si vedeva quello che avveniva, s’indagava, ognuno aveva la sua strada per esprimersi. E poi, si proponeva tutto a un pubblico molto più attento a riconoscersi, anche nella distrazione. Oggi il pubblico è molto meno desideroso di riconoscersi. Il cinema ha sviluppato una tendenza alla fuga dalla realtà, nel bisogno sempre crescente di svago e rapido consumo. E il pubblico è più “spettatore”, è più passivo. Per noi invece la cosa fondamentale era che ci rivolgevamo a persone più sensibili su certe cose, il paese era in generale più ricettivo. E dal punto di vista estetico, così come costruivamo i film, era quel tipo di spettatore ricettivo che andavamo a stuzzicare. Abbiamo sempre cercato il modo per non abbacinare il pubblico. Al contrario, lavoravamo per chiamarlo in causa. E non l’ho fatto solo io, o il cosiddetto cinema drammatico d’impegno civile. Perché quando Germi faceva Divorzio all’italiana, non era la stessa cosa? Allora, che cosa è successo?
Analisi. I miei film. Ebbe’, è successo che il complesso della società italiana è diverso. Questa differenza ha influito anche sugli sceneggiatori e cineasti, e sul tipo di ricezione del pubblico, sulla sua disponibilità a mettersi in discussione. Allo sviluppo che c’è stato non è corrisposto altrettanto progresso reale, di coscienza, di civiltà, di solidarietà... Il paese, da nazione con una metà sottosviluppata, il Meridione, finalmente è arrivato a una forma di sviluppo che ha coinvolto tante cose. Ma nel baricentro, siamo un po’ fermi allo stesso punto: la burocrazia bloccata, la mancanza di riforme dei grandi problemi, lo sviluppo della rete viaria, il sistema fiscale, la sanità, la scuola, cioè l’educazione di un popolo che si rinnova (in certe zone è rimasta carente, ma forse proprio nell’impostazione generale è ancora carente). E poi c’è la televisione, che in tutto questo è andata avanti per conto suo, perché infine la tecnologia ha uno sviluppo che divora il tempo. E dunque, la telematica da una parte, l’impiego del computer nella produzione e nel lavoro dall’altra, hanno portato a uno sviluppo accelerato che per certi versi dà l’impressione che il paese sia cambiato. In effetti io credo che l’Italia sia cambiata molto a livello delle cose promosse dal mercato, e sia cambiata molto anche nelle province del Sud, maggiormente sottoposte alla tragedia di una società criminale dominante. È cambiato anche lì il paese, anche se non come tutti quanti vorremmo. Quando facevo Salvatore Giuliano, non so se si riesce a immaginare, la parola mafia non veniva neanche pronunciata. I preti non avevano certo il coraggio che hanno oggi, sollecitati anche dalle invettive del Papa. Quando ho fatto Le mani sulla città la magistratura non aveva affatto la libertà e l’autonomia, e il merito, che ha la magistratura da alcuni anni a questa parte, d’indagare e di raggiungere certi reati, con tutte le possibili critiche che si possono fare a eccessi di protagonismo ed errori. Sono stati avviati processi sulla criminalità organizzata e sulla corruzione che erano impensabili trent’anni fa. Le mani sulla città, lo dico non per merito, ma per evidenza, ha anticipato di trentatré anni Mani Pulite. La magistratura a quel tempo non poteva avere quella forza, e soprattutto quella “volontà”, di azione. Io non avrei
mai pensato che saremmo arrivati a manifestazioni contro la mafia in certe città di provincia, nei paesi. Oggi la Sicilia ha preso consapevolezza dell’importanza delle manifestazioni pubbliche di avversione alla mafia, a costo di pericoli, di soprusi e minacce, e di morti.
Sintesi 1. Confusione e turbamento. Insomma, tornando allo spettatore del cinema, abbiamo visto che il paese è cambiato in tante cose e che però in tante altre è rimasto fermo; cose anche molto concrete che soltanto superficialmente sembrano non influire sulla coscienza della gente e sulla disponibilità a sentire certi rovesciamenti, a riconoscersi come un popolo che cambia, e nel caso dello spettatore di cinema, a sentirsi coinvolto in esperienze di consapevolezza anziché in momenti di spettacolarità e di disimpegno, e basta. Bisogna aggiungere che dopo il ’68 ci sono stati due fenomeni gravissimi: le stragi e il terrorismo. Momenti feroci. Una cosa che in Europa hanno avuto soltanto i tedeschi, e per un tempo assai più breve. Per noi si tratta di quindici anni, con stragi di cui non sappiamo niente, o di cui non si conoscono ancora le conclusioni. E poi i delitti politici che ci sono stati in Italia, dal caso Mattei al delitto Moro, Falcone e Borsellino, Dalla Chiesa e gli altri poliziotti e giudici. Questa carneficina... Per tornare, quindi, alla questione del cinema italiano d’oggi: ebbene, il cinema, e il suo pubblico, partecipano della stessa confusione e dello stesso turbamento che ha provato il cittadino, che ha sofferto la gente. Sono le stesse persone, gli stessi uomini tra gli altri uomini. Se parliamo di una tendenza generale, questo è il fatto. Se invece parliamo di casi individuali, be’ io per esempio nell’81 ho fatto Tre fratelli, nel quale ho affrontato anche il problema del terrorismo. Uno dei tre era un giudice impegnato in un processo di terrorismo, il suo comportamento dipendeva da questa responsabilità. Un altro era un operaio emigrato a Torino, uno che aveva fatto il ’68, ma si distingueva dal fratello: pur avendo partecipato alle lotte riteneva di non avere alcuna responsabilità col terrorismo.
Sintesi 2. I cineasti oggi. Ora, nei casi singoli il cinema italiano è entrato ancora ad analizzare i nuovi fenomeni d’instabilità, come facevamo noi: per esempio nel caso del terrorismo c’è La seconda volta di Calopresti. Noi però partecipavamo a una tendenza di tutto il cinema a parlare della società, una tendenza che ci accomunava e che ci permetteva di fare dei film che, e questo è fondamentale, erano incoraggiati e realizzati dai produttori, oggi ben lontani dal voler fare un cinema di questo genere. Il sistema produttivo è cambiato per almeno un fatto preciso: la progressiva affermazione della televisione come compartecipe o acquirente immediato del prodotto cinematografico. In certi casi questo fatto ha trasformato la figura del produttore, che è sempre stata “a rischio”, in un mediatore tra il piccolo schermo (cioè il capitale finanziario) e il grande schermo (l’attività produttiva vera e propria). È aumentata la dipendenza dal finanziatore. E il produttore è diventato meno determinante a definire il prodotto cinematografico. Non è che non si trovano più persone capaci come nel passato. I talenti non mancano. Ma da un lato, il cinema minimalista e una certa comicità, frutto di quegli anni terribili che abbiamo attraversato e che provocarono proprio un rifiuto di guardarsi, hanno per
ora preso il sopravvento. Dall’altro lato, sono venuti fuori casi di film che riescono per fortuna ad analizzare proprio questo nostro disorientamento, restando però isolati. E il cinema italiano nel suo complesso non raggiunge più la struttura industriale e la coesione collettiva di un tempo. Pochi sanno che cos’era il Circolo Romano del Cinema.
Noi eravamo una comunità. Ecco basterebbe rifondare certe cose... Nei primi anni del dopoguerra, la domenica mattina, al cinema Barberini, il Circolo organizzava delle mattinate nelle quali venivano mostrati i film che man mano erano girati da De Sica, Rossellini, Zampa: tutti, proprio tutti. La sala ogni volta era gremita fino all’inverosimile, con la gente nel vestibolo e fuori, per sentire anche i dibattiti. E lì c’erano: Rossellini che stava in piedi, appoggiato al muro, a vedere il film di Visconti; Visconti che stava lì a vedere l’ultimo film di De Sica; De Sica che vedeva Rossellini; Zavattini che discuteva con il giovane Lizzani. Era una cosa esaltante, va bene? Come tutti i giovani della mia età, e con me c’erano Petri, Fellini, Risi, mi sentivo dentro un’esperienza che assomigliava a una scuola, ma non lo era nel senso istituzionale, perché ciò che contava erano i film, ogni film era un mattone aggiunto a una costruzione collettiva. Questa comunicazione tra gli uomini di cinema era fondamentale. Ancora un momento intenso l’abbiamo vissuto con la generazione di cineasti appena successiva alla mia, Bellocchio, Bertolucci, Pasolini, lui che era la coscienza critica del paese... Comunque, la coesione di cui parlavo rafforzò il nostro cinema anche come immagine all’estero. Oggi questo, da molto tempo ormai, non esiste più. E infatti uno dei problemi è che il film italiano non esce dal confine nazionale, a parte pochissime eccezioni. Il periodo felice degli anni ’50-60 resta un caso a sé. D’altra parte neanche col cinema muto siamo mai riusciti a sfondare certi mercati, se non mi sbaglio. Anche lì, abbiamo avuto episodi importanti nei primi anni ’10, o con certe comiche. Io ho amato moltissimo il cinema muto.
’U ciucc Isechello. Fu Il monello di Chaplin il primo film della mia vita. A Napoli, naturalmente, dove ho vissuto fino al ’46, tranne l’anno in cui ho fatto il militare e poi il periodo di clandestinità a Firenze, durante la guerra. Mio padre era dirigente di una compagnia di navigazione, ma la sua vera vocazione e la sua vera, notevolissima, capacità, era quella del disegnatore. E lo faceva appena poteva. C’erano molti giornali negli anni ’30 a Napoli. Si stampava il “Giornale dei Tifosi”. Mio padre ha inventato insieme a due suoi colleghi il simbolo del Calcio-Napoli, il ciuco, “’u ciucc Isechello, trentattré chiaie e la coda fracita” (trentatré piaghe e la coda fradicia). Era un grande caricaturista, mio padre. Ci sono delle mie caricature strepitose. Per una caricatura del re e di Mussolini finì sotto processo. Era un appassionato di cinematografia, come si diceva. Nella guerra ’15-18 aveva portato una macchina fotografica e le sue straordinarie fotografie mi sono servite per documentare il mio film Uomini contro, dal libro di Lussu Un anno sull’altopiano, oltre ai racconti dei miei zii che avevano tutti fatto quella guerra. Appassionato di fotografia e di cinema, mio padre possedeva anche una piccola cinepresa Pathé da 8 millimetri, con perforazione centrale, e una macchina di proiezione. Li montava lui i suoi
piccoli film, e poi li sonorizzava collegandoli a una radio Telefunken. Era insomma un vero appassionato del cinema. Io credo che avrebbe voluto fare o il regista o il direttore della fotografia.
Quando assomigliavo a Jackie Coogan. Oggi posso dire che era un grande fotografo. In una fotografia da ragazzino, pubblicata ora su un libretto, io assomiglio a Jackie Coogan. Avevo tre anni. Allora, mio padre mi portava sempre al cinema. E io ero l’attore dei suoi film amatoriali nel corso degli anni, come ero uno dei soggetti preferiti delle fotografie. Il monello è un film del ’21, io sono nato nel ’22, ma bisogna calcolare che i film americani non uscivano subito in Italia, ci mettevano due, tre anni per arrivare in Europa. Io ho calcolato che dovevo avere poco meno di tre anni quando ho visto Il monello, gli anni di quella fotografia. La cosa incredibile è che, nonostante l’età, ho un ricordo preciso di quella volta al cinema. Un ricordo netto di certe immagini e un po’ della situazione. Il cinema muto era una cosa straordinaria. In alcune sale di Napoli c’era il pianoforte in buca, a volte con un violino. Era un’emozione immensamente diversa dalle sale d’oggi, con la gente che parteggiava, gridava, piangeva.
Hollywood addio. Un giorno, con quella mia fotografia da bambino, mio padre vinse un premio a un concorso: un viaggio a Hollywood, con la promessa di essere infilato come fotografo di scena in qualche produzione, per tentare di intraprendere un lavoro laggiù come direttore della fotografia. Mia madre si oppose. Forse abbiamo perso l’occasione, mio padre e io, perché mi sarei potuto aggregare, credo... Comunque, lì nasce questa mia passione del cinema: la frequenza assidua delle sale. È una cosa che mi è ancora rimasta, perché mi piace ancora andare al cinema, ma ci vado da solo, adesso; prima andavo con gli amici o con mia moglie. Adesso vado al primo spettacolo, e ne vedo anche due o tre, ora che c’è il sistema delle multisale, perché esco da una ed entro in un’altra. Mi piace che si spengono le luci e mi trovo in mezzo a gente che non conosco e che però partecipa a emozioni analoghe alle mie, stiamo lì insieme... Ecco, credo che la forza del cinema, ridotta all’essenza, è rappresentare su uno schermo, su un lenzuolo bianco, queste ombre che diventano corpi, anima, spirito, volontà, desideri, azioni, e quindi lo spettatore si trova a sognare davanti a questo schermo, o magari a rimproverarsi, perché vede qualcosa che lo mette improvvisamente di fronte a un problema di coscienza.
Il pubblico e Il caso Mattei. Perché allora, bisogna dire che il cinema non ha soltanto un potere evocativo o di attrazione spettacolare, ma ha un potere di analisi psichica, non so come dire. Specialmente quando la concentrazione è aumentata dalla visione collettiva. Il sorriso e il pianto di fronte a qualcosa che o ti imbarazza o ti pone un problema intimo, l’esigenza di riflettere, anche se poi il cinema ti dà pochissimo tempo per pensare; credo che il cinema in fondo ti impone, in quelle
due ore, le immagini del film e dell’autore, finisce che quasi la devi pensare come lui. Il film ha un suo potere, non dico di sopraffazione, ma di imposizione. Voglio dire: gli autori hanno fatto una scelta, il regista con le immagini la porta più avanti, fino alla creazione del fatto emotivo, che è quello che ti accomuna agli altri. E questa è l’imposizione: il fatto emotivo. Ecco perché dico che il mio sforzo, nella quasi totalità dei miei film, è stato cercare, al di là dell’emozione, di fare entrare lo spettatore anche in una dimensione razionale, proprio perché sono consapevole del rischio dell’affidarsi solamente all’emozione. Molte volte nella costruzione dei miei film, e questo lo hanno notato un po’ tutti in Salvatore Giuliano come nel Caso Mattei, Le mani sulla città o Cadaveri eccellenti, Lucky Luciano, Tre fratelli , molte volte, insomma, a un certo punto ci sono dei momenti che creo apposta perché il pubblico abbia la possibilità di pensare. Tutto il processo in Salvatore Giuliano è la lettura riflessiva che viene dopo le azioni precedenti. Nel Caso Mattei l’indagine che svolge il giornalista per cercare di mettere in luce le contraddizioni del risultato della commissione d’inchiesta ufficiale, che escludeva nella maniera più assoluta l’attentato, è fatta perché il pubblico possa diventare partecipe di quel tipo di ragionamento critico e rifletterci su. Non è un film a tesi. Non ho mai sostenuto la sicurezza assoluta che Mattei fosse morto per una bomba nell’aereo. Ho detto: è possibile che sia morto anche per un incidente, vista la bufera, la benzina che stava finendo, come dicevano. Ma ho detto anche: guardate che potrebbe trattarsi di un attentato. E poi la nuova commissione, e quel giudice di Pavia, dopo venticinque anni dal film e trentacinque dalla morte di Mattei, hanno scoperto che si trattò di un omicidio. Ma io non avevo fatto l’indovino. Ho lavorato intorno all’analisi di certe contraddizioni contenute nei documenti ufficiali. Se avessi voluto fare un film a tesi avrei dovuto dare una versione certa come quella che credeva di poter dare la commissione. Io invece ho detto al pubblico: scegli tu. Anche dentro le mie intuizioni, naturalmente. In Lucky Luciano, quest’uomo, in quanto boss di mafia, era rappresentato come possibile organizzatore, sottolineo possibile, della rete del narcotraffico in tutto il mondo, la rete che approfittando della rete esistente del contrabbando, l’ha tramutata in sistema di narcotraffico. Ma bisognava dimostrarlo, e la dimostrazione categorica non c’è, e quindi sono passato attraverso il racconto delle varie possibilità, delle varie certezze e, ancora, delle loro contraddizioni. Era un’inchiesta. Non un film d’azione gangsteristica. E questo mi è stato riconosciuto dai miei illustri colleghi americani Martin Scorsese e Coppola, pubblicamente. Norman Mailer fece una dichiarazione importantissima per me: che era per lui il film di mafia più interessante e rigoroso che avesse mai visto, perché accostava fatti ed elementi che facevano sì che un film non fosse soltanto frutto di fantasia ma di un ragionamento, per una verifica dei fatti, qualora si fosse voluto andare a verificarli.
Da Radio Napoli a Salvatore Di Giacomo. Quando sono tornato a Napoli, dopo la guerra, i miei amici mi avevano tenuto un posticino a Radio Napoli. Ero stato lontano un anno. Per il militare. Cercavamo di procrastinare la partenza con la scusa dell’università. Non avevamo certo voglia di fare quella guerra, ma poi... Avevo fatto l’allievo ufficiale in autocentro, che era a Firenze. Di lì siamo andati a Massa Marittima; il 25 luglio ci hanno scaraventato in Liguria a fare la guardia a certi
accampamenti; e l’8 settembre, con lo sbandamento totale, ero a difendere Cuneo e Mondovì con la IV Armata. C’erano già i comandanti in borghese, che quasi subito ci dissero: “fuggite, fuggite”, e noi ci siamo dispersi. In un gruppetto siamo finiti nelle braccia dei tedeschi, ma dopo appena quattro giorni io riuscii a scappare con alcuni commilitoni, e mi rifugiai a Firenze, dove ho fatto un anno di clandestinità collegato con Giustizia e Libertà. Una grande esperienza, perché ero in contatto con personaggi come Ludovico Ragghianti, capo del Comitato di liberazione nazionale di Firenze, e mi ero nascosto da una famiglia legata per parentela con Ernesto Rossi. Ho avuto un anno di clandestinità, direi, privilegiato. Radio Napoli era nelle mani del Psychological Welfare Branch, un’istituzione diretta da Misha Vladimir Kamenevski, cioè Ugo Stille, mio grandissimo amico. Lì, ho incontrato Ettore Giannini, celebre regista di teatro, che ci coordinava un po’ tutti, perché non c’erano solo giornalisti. Molti, come me, volevano fare spettacolo, il teatro o il cinema: Antonio Ghirelli, Maurizio Barendson, Peppino Patroni Griffi, La Capria che venne dopo, alla Rai, Achille Millo, Aldo Giuffré, che faceva lo speaker e l’attore alla radio. Perché facevamo tutto. E imparavamo un sacco di cose. Sono diventato poi aiuto di Giannini, per un paio d’anni a Roma. Ho fatto l’attore in teatro con lui, Il voto di Salvatore Di Giacomo, e altre cose.
Visconti. L’aggancio col cinema è stato Luchino Visconti. Il mondo del teatro romano nell’immediato dopoguerra era un fermento inarrestabile. E l’artefice di questo mondo in ebollizione era Luchino. Giannini, come Orazio Costa, era un regista di repertorio, bravissimo. Ma Luchino arrivò con una carica di provocazione intellettuale e culturale. A Roma, tutte le grandi novità di allora, Sartre, Williams, Cocteau, Miller, le aveva introdotte Luchino (a Milano c’era invece Strehler). Secondo la buona mentalità borghese cautelativa, mio padre voleva che mi laureassi, prima di provare col cinema. Io tentavo di seguire questa volontà, ma volevo iscrivermi al Centro sperimentale di cinematografia, e per l’ammissione avevo scelto I Malavoglia di Verga. Combinazione, Visconti voleva fare i tre episodi, partendo da quello del mare. Conoscevo poco Visconti, andavo a vedere i suoi spettacoli, e la sera mi univo agli amici a cena, e Visconti pagava sempre per tutti. Era una persona generosa, un uomo speciale, un artista. Basta vedere la sua faccia: Visconti era Bartolomeo Colleoni. La sua origine aristocratica con la mescolanza degli Erba delle farmacie, che avevano origini invece popolari... Un uomo anche severo. Questo ne faceva un professionista. La sua grande qualità era dare l’occasione ai giovani di accedere al lavoro. Quando abbiamo fatto La terra trema nessuno di noi, tranne l’operatore Gianni Di Venanzio, che poi diventò il mio direttore della fotografia, aveva mai fatto niente di serio al cinema. E Visconti, in fondo, aveva diretto soltanto Ossessione. Ma aveva il gusto di rischiare. Per me, per Zeffirelli, anche lui aiuto, e per gli altri, La terra trema è stato il Centro sperimentale, l’università, l’accademia d’arte, una scuola di vita: insomma, tutto. Io ho potuto seguire l’intero processo del film e capire il metodo di lavoro di Visconti, che da una traccia creava, di volta in volta, con l’aiuto di tutti i noi, i dialoghi, il perfezionamento delle scene: insomma un film che nasceva giorno per giorno. Ma questo è storia del cinema, la grande storia del cinema.
Nell’abisso con Dudu. Poi per me sono venute le sceneggiature con Amidei, un grande maestro, le esperienze come assistente di Antonioni, Emmer, Matarazzo, Monicelli e poi ancora Visconti, per Bellissima e Senso. La sfida fu il mio film d’esordio, ma io avevo un’altra cosa in ballo. Avevo scritto una sceneggiatura sulla Napoli del dopoguerra con Amidei, che poi non si è mai fatta, e pazienza. C’era una storia di vecchie navi e di porti, che speravo diventasse il mio primo film. Quando arrivo in una città di mare, ancora oggi, non posso fare a meno di visitare subito il porto. Con i miei, ancora neonato, vivevo in una casa affacciata sulla spiaggia. Gli anni della mia infanzia li ho passati a Posillipo, a girare per ogni insenatura, dove sorgevano ville antiche, del tempo dei Borboni, credo, e allora il mare... Da ragazzi ci tuffavamo in un’acqua oggi inimmaginabile. Posillipo era una delle sette meraviglie. Quel mare era emozionante sopra come sotto. Con Dudu La Capria facevo immersioni di pesca. C’era con noi anche un pilota tedesco campione di apnea. Usavamo certi rudimentali fucili subacquei e altri metodi tradizionali. Quando i pescatori mettevano le mummarelle per i polipi (quelle piccole anfore che si adagiano sul fondo), noi eravamo lesti e arrivavamo prima, portandoci via quel che finiva dentro. E i pescatori dietro, a inseguirci. E noi giù sott’acqua. Ma Dudu e il pilota andavano giù giù, che non si sapeva più dov’erano.
19 Chiudo il giornale sulla pubblicità di una società medica specializzata in dialisi. Sento un rumore nell’altra zona della casa: un lungo scrocchio, un suono che si interrompe e riprende, un suono amico. Non mi sembra possibile. Per alzarmi mi appoggio alla spalliera della poltrona: voglio raggiungere il salone. Barcollo fino alla porta. La luce di mezzogiorno si spegne tra me e la sala da pranzo. Dalla porta del corridoio sporgo appena la testa e guardo intimorita verso la sala. Un attacco largo di violini, qualche goccia d’arpa, poi qualcuno canta: “No, la commedia è inutile / ti leggo in fondo al cuore / quello che vuoi nascondermi / sta scritto in fronte a te / su, non mentire, dimmelo / ch’è spento il nostro amore / tanto che vale illudersi / tutto finisce ahimè.” Un accordo, una sospensione: “Addio, mia beeella signoraaa / lasciamoci così senza rancor / al destino che vien / rassegnarsi convien / sospirare piangere perché?” Per un istante non vedo più i divani di pelle, il tappeto rosso, la libreria in tek. Mia sorella, con l’abito arancione e i capelli sciolti, balla con un uomo invisibile, mia madre si è addormentata sulla poltrona. Con la mano sulla manopola, piegato sull’apparecchio, vedo mio padre. “Non funziona più,” mi dice Miriam inginocchiata davanti alla radio, la mano sulla manopola della sintonia. “Guardi. C’è la corrente, ma i canali non arrivano.” Mi sento mancare. “Ho provato a mettere la spina. Volevo sempre accenderla, perché non l’ho mai vista una radio così, ma avevo paura che lei si arrabbiava... In Jugoslavia c’erano soltanto le radio di plastica e quelle russe dai tempi di Tito. Le dispiace?” Si alza e viene verso di me pulendosi le mani su un panno: “Si sente bene, signora?” Intorno a quella radio ho passato alcune delle sere più serene e protette della mia vita. Mio padre imponeva i radiodrammi. Io restavo incantata dai concerti e dalle opere. La mia passione per Arturo Toscanini passa da questa radio Marelli, anche se riuscivamo raramente ad ascoltare i suoi concerti. Lui aveva già lasciato l’Italia da qualche anno, quindi poteva essere il ’36 o il ’37, e io avevo quindici anni. Volevo studiare musica, diventare compositrice, conquistare consenso e fama come Toscanini. Uno psicologo insinuò che questo rappresentasse l’esuberanza della mia parte maschile. Aveva probabilmente ragione. Studiai pianoforte per tre anni e il sogno di gloria si arenò. Ma non ho mai rivelato a nessuno, neanche a mio marito, che durante la guerra, in certi giorni di sconforto, mi chiudevo nella mia stanza e dirigevo davanti allo specchio, immaginando il podio alla Scala, rapita da un delirio di onnipotenza e con la sensazione subconscia di violare la mia natura femminile, o quella che credevo fosse la mia natura femminile. A volte penso che Toscanini fosse per me come la Duse per mio padre, un miraggio di elezione. Per questo, forse, non ho provato alcun desiderio di vedere il film che gli ha dedicato Zeffirelli: non volevo che un’altra immagine appannasse quella che io mi ero costruita. Alla Scala sono andata una sola volta in vita mia, e davano appunto la Turandot con la regia di Zeffirelli. Aveva acquistato i biglietti mia sorella per distrarmi dall’anniversario della morte di Francesco. Era l’inaugurazione della stagione, il 7 dicembre 1983. Indimenticabile. C’era anche Pertini, che io non riuscii a vedere, ma di cui ricordo l’elogio pubblico rivolto a Zeffirelli: “È un mago.”
FRANCO ZEFFIRELLI Shakespeare e il bushbaby di Liz Il primo film importante della mia vita è Il campione, di King Vidor. Avevo otto anni, durante la mia infanzia a Firenze. Lo rividi per caso, quarant’anni dopo, a Londra. Stavo montando il Gesù, quindi era il 1976. Mi ero cucinato degli spaghetti al sugo. Ero in cucina e avevo acceso il televisore. Esce il titolo The Champ. Be’ che bello, un film in bianco e nero. Ma non l’ho già visto? E boom, un tuffo al cuore. Ho mangiato degli straordinari spaghetti in salsa di lacrime che consiglio ai migliori chef.
Ciclamini freschi per tutta la vita. Senza saperlo, lo ricordavo a memoria, tutto. Prima avevo visto qualche film di Rodolfo Valentino. Mia madre mi portava spesso al cinema, ma ero così piccino. Le donne andavano pazze per Valentino. Ma non riesco a focalizzare bene dei titoli. Invece, tornando a quella sera a Londra, quando finisce The Champ, lì nella mia cucina, con le guance ancora bagnate, mi viene un’idea. Mi avevano chiesto di proporre qualcosa a Hollywood, qualsiasi cosa. Erano le dieci di sera, a Londra, quasi pomeriggio a Los Angeles. Ho telefonato subito. Tra un singhiozzo e l’altro, ho detto: se volete che venga davvero a girare un film, facciamo Il campione, andate in magazzino, tirate fuori la copia, guardatevela se per caso non la conoscete, e poi fatemi sapere. Dalla Metro Goldwin Mayer mi richiamano, incerti: se proprio vuole fare questa cosa... Il campione uscì nel 1979 e incassò 265 milioni di dollari. Se oggi sono qui, circondato ogni giorno da ciclamini freschi e tutte queste belle cose, lo devo ancora a quel film. In tutte le altre occasioni, invece, mi hanno fregato.
Mary Pickford all’Edison. Da bambino m’impressionò La mummia con Boris Karloff. Avevo anche proposto di rifarlo. Quando ho visto l’orribile remake di questi giorni... Ricordo bene l’emozione per L’angelo azzurro, a cui ho assistito praticamente di nascosto, perché non era un film per bambini. C’era una zia che non sapeva dove parcheggiarmi. Mi portò in sala e cercò di farmi addormentare prima del film. Io sono stato al gioco, ma ho visto tutto. Le gambe di Marlene col reggicalze, quelle labbra, i baci. Avevo scoperto l’erotismo. S’andava al cinema un giorno su due. La gente frequentava assiduamente le sale. Era incredibile il numero di sale disponibili a quei tempi in rapporto alla popolazione. Belle, con ampi foyer, spazi per fumare e parlare. Il Nazionale di Roma è rimasto così com’era. Si chiamava Excelsior, e chissà quante sale cercheranno di ricavarci lì dentro con questa mania dei multiplex. Come l’Odeon di Milano, che era un’unica meravigliosa sala liberty o il Galileo di Firenze, in stile fiorentino rinascimentale, e l’Imperiale, sempre a Firenze, art déco, con una vasta scalinata, molto alla moda in quegli anni. Il cinematografo aveva qualcosa di maestoso, epico. S’andava al cinema, ecco. L’ultimo anno trascorso con mia madre (avrò avuto sei, sette anni) abitavamo in piazza Vittorio Emanuele (oggi è piazza Repubblica, la piazza principale di Firenze, vicino al
Duomo). E lì sotto, all’angolo, c’era il cinema Edison; mi ricordo questa folla immensa davanti al cinema, la grande sala piena e urlante. Mary Pickford era venuta per l’anteprima di un suo film. Io non capivo, ma questa adunata oceanica era molto simile alle manifestazioni fasciste dopo il delitto Matteotti. Ho fatto in tempo a vedere certe manifestazioni, ma essendo così piccino, mi poteva colpire solo il motivo delle canzoni, “Giòvinezzaaa, giòvinezzaaa”, a tre, quattr’anni... Devo dire che preferivo le folle del cinematografo. Per La canzone dell’amore era venuta Dria Pola. Era la prima pellicola italiana sonora, una bella storia d’amore. Dria Pola alloggiava al Savoia. Tutta Firenze era lì. La gente stazionava in massa davanti alle finestre. E quando Dria Pola s’affacciò dal primo piano, tutti in coro: “Sooolo per te, Driiaaa, vaaa la canzone miiaaa.” Il mio primo teatro è stato all’opera. A nove anni. E cosa vidi come prima opera? La walkiria di Wagner. Questo balocco spropositato... Mia madre era morta. Mio zio era un vero appassionato. Manteneva in affitto un palchetto al Comunale, e anche lì mi portarono perché nessuno voleva restare a casa con me (non si parlava di babysitter, allora). Mi sistemarono su un panchetto indietro. Rimasi incantato. Con questi cento professori d’orchestra in frac. Le scene immense, il fumo, i balli, le voci straordinarie e sinuose. Non c’era una storia. Solo questa musica totale, che mi attirò in un sogno interminabile. Uno spettacolo mirabolante. Un impatto puro col “fenomeno opera”. Rimasi sveglio tutta la notte. Quando invece mi portarono a vedere Carmen accadde un’altra cosa. Mi addormentai appena l’orchestra attaccò. Ma mi svegliai bruscamente al momento dell’assassinio, sul palco tutti urlavano, mentre la musica cresceva, ta ta taaan..., e mi trovai davanti alla gente che partecipava: “Ah, è morta.” Qualcuno si alzò in piedi: “L’ha ammazzata davvero!” Questa impressione di verità portata non dai gesti, ma dalla musica, è incredibile, è la magia dell’opera. E anch’io ero impressionato. Il sipario calò improvvisamente. Molti si alzarono in piedi. Altri applaudivano. E quando comparve la cantante per ringraziare ricordo di aver sentito qualcuno commentare con liberazione: “Ma nun l’ha mica ammazzata, via.”
Ho ucciso un tedesco. Vinsi il premio come attor giovane dei Filodrammatici fiorentini dopo tante piccole esperienze, occasioni anche scolastiche. Recitavo benino, ed ero molto bellino. Fu un momento intenso della mia vita, che ho raccontato, credo bene, in Un tè con Mussolini. Ho glissato soltanto sulla parte politica, per ragioni di concentrazione narrativa e di spazio. Ma la storia fu terribile: vedere che dovevo perdere delle persone care per ragioni che non capivo, delle vere amiche, queste signore che mi avevano dato tanta gioia. Improvvisamente non potevo più vederle perché erano delle nemiche: era folle, folle. La storia bisognerebbe raccontarla attraverso l’effetto degli eventi sull’individuo. Per me, per esempio, il senso della guerra è stato questo: che non dovevo più frequentare persone a cui volevo bene e che mi volevano bene. Ero un ragazzino. Quindici, sedici anni. Per me fin lì Mussolini era un’entità acquisita. Esisteva da sempre. Le mie signore inglesi mi fecero invece capire che non era onnipotente. Era un uomo che finché governò bene poteva ricevere anche del rispetto, ma quando incominciò a fare scelte da pazzo, anche loro lo ripagarono con un giusto disprezzo. Fui costretto a continuare gli studi, in mezzo a tante difficoltà.
Poco dopo il settembre ’43, arrivò la chiamata alle armi. Dovevo scegliere: tra le ipotesi, scappai in montagna. Diventai un renitente alla leva, ma lo feci tanto per salvare la pelle, perché a quel punto sapevo che Mussolini era un mascalzone e non avevo intenzione di stare dalla sua parte. Scelsi la via delle montagne con un gruppetto di amici di scuola ben radicati democraticamente. Con noi erano saliti certi inglesi che mi avevano aperto gli occhi, in momenti non sospetti, sul fascismo e Mussolini. Devo dire che mi consigliò anche La Pira, che ebbi la ventura di conoscere bene: viveva al convento di San Marco, che frequentavo per l’Associazione Cattolica. Mi disse: “Che devi fare? Vai in montagna. È l’unica soluzione per salvarsi e combinare qualcosa di utile. Ma attenzione: ricordati sempre che comunisti, nazisti e fascisti sono la stessa cosa.” Il nostro era un gruppo di liberali cattolici, ma eravamo associati alla Brigata Garibaldi. Dopo un po’ le cose precipitarono. Gli altri erano in gran parte contadini. Ci guardavano male, a noi studenti. Facevamo azioni di guerriglia tutti insieme. Fu terribile la prima volta che uccisi un tedesco. Era lì, davanti, col fucile. Sparai subito, e lui morì. Restai sconvolto per molti giorni. Poi accadde qualcosa di pazzesco. A poco a poco ci accorgemmo che sparivano alcuni partigiani, quelli che non la pensavano strettamente come loro. Bisogna sapere che durante la clandestinità si svolgevano le lezioni di “mistica comunista”. Ci si riuniva due volte la settimana. I capi stalinisti introducevano le teorie di Marx e Lenin. La nostra indifferenza e freddezza non piaceva. In realtà molti di noi non condividevano una parola. Io e altri disertavamo questi incontri quasi sempre. La nostra fortuna era che ci avevano affidato la tutela di frange internazionali di prigionieri di guerra, soldati scappati dai campi di concentramento che ci raggiungevano al campo. I comunisti, in genere, non sapevano come comunicare con loro, così ce li passavano perché sapevamo le lingue. Si formò un gruppetto misto, e questa fusione per fortuna ci salvò dai comunisti, che avevano già in mente di eliminarci. Un giorno arrivò il momento. Era nell’aria. Ci avvertì un amico: scappate ragazzi. Insomma, facevamo insieme la Resistenza, e questi qui volevano farci fuori perché temevano che un giorno o l’altro li avremmo traditi, capito? Soltanto perché non obbedivamo a tutto. Siamo scappati subito per le montagne.
Il cielo sopra la Scala. Mi sono “liberato” quando abbiamo incontrato la Prima Divisione delle guardie scozzesi, che avevano bisogno di un interprete. Diventai la loro mascotte. La conoscenza dell’inglese mi salvò la pelle. Avevo incominciato a parlarlo a otto anni. A dodici lo sapevo già perfettamente. Gli inglesi mi avevano catturato insieme ad altri, da partigiano, e diventai praticamente uno di loro. Passai l’inverno del ’44 con la Prima Divisione. Nel ’45, sfondata la Linea Gotica, entrammo in Emilia e poi sempre più su. Ero a Bergamo quando al nostro comando generale arriva un ufficiale americano della Quinta Armata: “I must go immediately to Milan” dice. Era il giornalista del “Washington Post”, il tenente Keith. Voleva una jeep con un autista e un interprete. E allora mandarono me. Vestivo la loro divisa di soldato. Ero orgoglioso. Mi sentivo un po’ americano. Arrivai a Milano il 28 aprile. Per me era un’avventura eccitante. Cercai subito la Scala. Avevo ascoltato alla radio tutte le opere in scena in quel teatro. Avevo immaginato, sentito, sognato: Toti Dal Monte, Beniamino Gigli, Volpi. Mi ricordavo il
fervore delle prime: ah, questa sera c’è la Lucia di Lammermoor che inaugura la stagione, e stavo ad ascoltare tutto, per ore e ore. E adesso ero lì. L’edificio esterno era intatto, ma si capiva che c’era qualcosa di assurdo... Quando entrai fu incredibile: davanti a me c’era un dirupo, ai lati le macerie, sopra un meraviglioso cielo azzurro. Un cortile! La Scala era diventata un cortile di detriti. Io e il mio tenente ci siamo arrampicati per raggiungere i resti del palco reale. Sotto c’era gente che s’aggirava cercando souvenirs, poltroncine, tronconi di stucchi, trovarobato, dei pazzi forse. Un anno e dieci giorni dopo la Scala riaprì con un concerto di Toscanini, completamente ricostruita, più bella di prima. Mi chiedo ancora oggi come hanno fatto, dove hanno preso velluti rossi, cristallerie, sipario, legni, in una Milano, in una regione intera, completamente devastate, mentre la gente viveva ancora nelle tende. Sono segni fondamentali per una civiltà. Sto dalla parte della disperazione dei terremotati umbri, ma la ricostruzione di Giotto e della cattedrale è un simbolo intorno al quale si riaggrega la comunità. Bisogna ottenere entrambe le cose. Se non accade, bisogna attaccare i governi. A Milano avevano capito subito che il teatro avrebbe spinto la ricostruzione generale. Non qui, ora, ma cinquant’anni fa. Oggi, dopo cinque anni, non hanno ancora deciso qual è la società che deve rimuovere le macerie della Fenice.
Go and see. Vidi Mussolini appeso. Da lontano, perché non si riusciva quasi a entrare in piazzale Loreto. Mentre cerchiamo un varco, ci viene incontro un gruppetto di soldati americani: “Go there and see... Something out of the world.” Il mio tenente voleva fare un grande servizio, e lo fece davvero, un servizio serio, sulla liberazione di Milano, sulle prime ore del trapasso del fascismo. La notte siamo entrati furtivamente all’Università degli Studi, perché lui aveva saputo che alla sezione di Medicina Legale forse avevano portato la salma di Mussolini. Era lì. Lo vidi ancora. Una cosa spaventosa. Sfigurato, gonfio, guardato da due ragazzini partigiani indifferenti. Ma che cosa potevano capire? Ne ho viste di cose incredibili. Qualche anno fa mi è successa una cosa curiosa, quando ho consegnato la mia biografia all’editore inglese. A un certo punto hanno smesso di chiamarmi. Telefono: ma come, non vi interessa più? Tutto bene, abbiamo bisogno di tempo, rispondono. Non capivo. Poi ho scoperto che stavano verificando tutto, con ricerche negli archivi, e addirittura rintracciando le persone. Volevano essere certi che tutto quello che raccontavo era vero.
Come ho conquistato Visconti. Conobbi Luchino Visconti nell’aprile del 1946. Tornato a Firenze, cercavo di guadagnare qualcosa facendo l’aiuto scenografo alla Pergola, per il Maggio Musicale. Impastavo i colori sul pavimento di legno al terzo piano, per il Boris Godunov. Di lì, s’usciva sulle balconate del palcoscenico. Sotto, c’era una compagnia di prosa che provava. M’interessava molto, perché ero anche un giovane attore. Giù, c’erano Visconti, Laura Adani, Girotti, il giovane Gassman: provavano La via del tabacco. Gassman era bellissimo, molto vanitoso. Visconti era già una leggenda, celebre per Ossessione, e aveva già i suoi scandali. Aveva un giro molto importante, particolare, internazionale. Elegantissimo, ricco. Per un ragazzo come me era un mito. Come
dico ancora oggi, le donne erano “alluchinate”. A un certo punto lo sento urlare: “Ma con chi vi credete di lavorare, possibile che non siete capaci di trovarmi una vecchia, non chiedo mica la Calamai, voglio soltanto un’attrice anziana, e che cosa mi avete portato, cazzo? Delle morte. Ma mandatele al cimitero. Andate dove volete, cercate anche negli ospizi, muoveteviii.” Una furia. Ne avevo sentito parlare come di un re dell’Olimpo, garbato, elegante, e invece eccolo lì come un pescivendolo che insultava i collaboratori. Da bambino andavo spesso in via dei Malcontenti a trovare una vecchia domestica in un asilo di mendicità (si chiamava Monte Domini, ma io interpretavo male il nome, perché quando mi portavano vedevo sempre soltanto donne e chiedevo: ma dove l’è ’sto monte d’omini?). Insomma, vado a chiedere se per caso non c’era qualche ex attrice, che si tenesse ancora in piedi però, e piccina anche, che volesse guadagnare dei soldini. Mi dicono subito: “Ci sta precisa precisa, oh c’è la Virginia Garattoni, quella lì, che fa sempre la pagliaccia dappertutto.” Lei arriva con la sua vocina nervosa: “Ho fatto teatro, strada, circo. Sono bravissima. Lo vuol vedere come fò la zoppa? Vedere la gobba?” Me la portai via subito. Alla Pergola Visconti stava ancora lì a provare e quando arriva il momento della vecchia, si ferma e ricomincia la piazzata. A quel punto mando avanti la Virginia, che si presenta facendo la riverente, con la sua vocina, e mentre Visconti sta per urlare di portarla via, parte con i suoi numeri. E tutti, Visconti, gli attori, gli attrezzisti, restano di sasso. “Bravissima, finalmente,” urla Visconti. “Ma chi me l’ha portata?” Si fa avanti il solito opportunista, che aveva l’incarico. Ma subito il direttore di scena dice: “No maestro. È quel ragazzo.” Così Visconti mi chiama. Era sorpreso. Ho capito subito che dovevo farmi coraggio. E gli ho detto tutto, che avevo sentito le sue urla da sopra, che ero stato al convitto, e che volevo fare teatro. E lui: “Bravo, ti farò un’audizione.”
Visconti globale. Entrai nella sua compagnia nell’ottobre del ’46. È stato forse il momento più eccitante della mia vita. Ero pieno di energie e di voglia di fare. Visconti fu un maestro, una fonte d’ispirazione, un grande amore. Visconti era globale. Con lui o tutto o niente. Lui doveva possedere tutto e darti tutto. Voleva prima conquistarti totalmente, poi apriva i serbatoi, tutto quello che sapeva e aveva. Ma era un travaglio continuo. Più amava una persona, più diventava feroce. Io da fiorentino me ne fregavo un po’, ma Franco Rosi napoletano... “Capisci che m’ha dato di stronzo? Io me ne vado, non posso guardarlo più in faccia,” diceva sul set di La terra trema, quando facevamo gli aiuti. Era molto, molto difficile condividere la vita con Visconti. Il lavoro con lui per La terra trema fu un’esperienza incredibile.
“Vattene!” Per sette mesi Visconti ci studiò e ci fece sgobbare. La situazione produttiva era difficile. Fu risolta all’italiana. Quando finirono i soldi messi insieme con i contributi del Pci e della “Carlo Erba”, cioè i parenti di Visconti, e con lo sciopero delle maestranze (un regista comunista che lavorava per un film di sinistra bloccato dagli operai!), ebbene la cosa finì tra le mani di un democristiano siciliano, Salvo D’Angelo, che per miracolo trovò una trentina di milioni per finire il film. Fu lo stesso Togliatti a consigliare Visconti di accettare comunque i
soldi. Io seguivo soprattutto la recitazione, per la mia preparazione teatrale. Da fiorentino ho dovuto istruire tutti i non-attori siciliani che dovevano e sapevano parlare soltanto il dialetto. In un mese ho dovuto imparare il siciliano. Non volevo fallire. Tra il regista lombardo e gli attori siciliani, c’ero io. Altrimenti nessuno si capiva. Aci Trezza era fuori dal mondo. Un posto irreale. Bellissimo. Con Visconti, io e Rosi abbiamo condiviso ire, angosce, scoperte, gioie. Infine, ci laureò. E sui titoli di testa pretese, subito dopo il suo nome, i nostri. Una volta si diventava registi dopo essere stati aiuti. Ma non perché era una norma, una tradizione, e basta. Aveva un senso. Perché oltre al lavoro, alle cose da imparare, c’erano esperienze di vita con cui confrontarsi, i dubbi, la solitudine, l’autorevolezza del regista. Oggi nessuno lo capisce. Chi fa più l’aiuto per diventare regista? Tra i tanti, questo è uno dei problemi del cinema italiano. Prima di esordire col mio primo film, Camper, nel ’57, ci furono molte esperienze, sul palcoscenico e al cinema. Visconti mi affidò ruoli di grande responsabilità come scenografo. Ma non era facile. Mi fu particolarmente ostile quando mi proposero la mia prima regia teatrale, la Lulù di Bertolazzi. Lui aveva un miscuglio di gelosia e di amore, e durò parecchio, finché non spiccai il volo alla Scala, con l’Italiana in Algeri di Rossini, nel ’53. Era geloso Visconti. E a un certo momento, con tono sprezzante, mi disse: “Vattene!” Mi disse di volare via, di sparire, magari pensando che mi sarei spezzato le ali.
Da Coco Chanel. C’è da dire che ero molto prezioso per Visconti. Facevo le scene e pagavo i conti dal macellaio, leggevo i testi e rispondevo al telefono in tutte le lingue, andavo a Parigi a parlare con Dalí e a impegnare i gioielli della madre. Fu un viaggio straordinario, quello per parlare con Dalí. La mia prima volta a Parigi. Avevo tre lettere di presentazione di Visconti. Una per Coco Chanel. Un’altra per Jean Cocteau. La terza per Jean Marais. Ero solo un giovanotto e mi muovevo per il casting di una coproduzione italo-francese per Visconti, Cronache di poveri amanti. Un film che non si fece mai perché morì un parente strettissimo di Visconti e il progetto passò poi a Lizzani. Conobbi Parigi. Conobbi Brigitte Bardot. Aveva diciassette anni, stava già tra le braccia di Roger Vadim, una ragazzina da capogiro. Per me fu un viaggio iniziatico, un torneo della vita. Potevo entrare in un mondo che avevo soltanto immaginato... L’incontro con Dalí, le serate... Tornando al mio “volo”, bisogna dire che Visconti ebbe dei problemi a separarsi. Fu dura per tutti e due. Lui era troppo abituato ad avere qualcuno che, senza dire niente, sbrigava le incombenze quotidiane e lo sosteneva artisticamente. Qualcuno che io non sono mai riuscito a trovare, purtroppo. Visconti aveva sempre dei debiti in giro. Ma poi provvedeva a tutto. E s’incazzava se le cose non erano a posto. Uuh, mi ha fatto tanto soffrire! Me ne faceva di tutti i colori. Di tutti i colori, sì. Amandomi, poi, profondamente. Perché l’ho detto: più amava una persona, Visconti, e più era tremendo. Anche con i parenti. Trattava malissimo anche una sorella, che in realtà idolatrava. Se non c’era lei, era finito.
C’est génial, Zeffirellì. Il cinema è legato alla lirica. Il melodramma, i colpi di scena, i grandi personaggi del teatro, la
musica. Ecco perché io non sono solo un regista di cinema o soltanto un regista di teatro. Il canto... Il mio incontro con la Callas, che cantò per me a cominciare dal Turco in Italia del ’55, e poi in Traviata , Lucia, Tosca... risale alla fine del ’48, primi ’49, ed è sempre legato a Visconti. Salvator Dalí aveva firmato le scenografie e i costumi del Come vi piace di Shakespeare, e toccava a me mettere le cose in scena. Non dovevo fallire. Una prova mortale. O riesco o muoio. Bisognava capire come realizzare le cose che aveva in mente Dalí. C’era una foresta, con le foglie che dovevano cadere ogni tanto, gli alberi che dovevano diventare elefanti, con lunghissime zampe, una parte bruciava, insomma una cosa complicatissima. E bellissima. Tutto, poi, doveva avvenire in un costante turbine di vento. Dalí e Visconti volevano che migliaia di foglie, fatte da una modista di via dei Serpenti, ogni tanto si sollevassero. Quindi, ventilatori, e in conseguenza maglie di lana sotto i vestiti degli attori (ma se Visconti se ne accorgeva urlava come un pazzo). Visconti voleva addirittura che le sottane, le redingotes, tutti gli abiti, si sollevassero in un certo modo, in una certa direzione. Venne fuori quest’idea dei fili di nylon attaccati alle mani, cosicché quando arrivava il boato di vento gli attori tiravano, ed ecco il quadro che voleva Visconti. Una follia. E non erano ammessi errori. Dalí imperversava a cicli con le sue richieste. Pretendeva per esempio che il salotto buono della foresta di questo re spodestato fosse composto da un gregge parcheggiato lì. Un gregge vero. Voleva pecore vere sulle quali gli attori, Rina Morelli, Stoppa, Gassman, il grande Ruggeri, a un certo punto, si sarebbero dovuti sedere e recitare. Ma come si faceva ad avere lì sei o sette pecore che avrebbero belato per tutto il tempo e sarebbero poi scappate appena questi provavano ad appoggiarsi? Trovai un artigiano straordinario che mi fece pecore finte semoventi. E Dalí: “C’est génial, Zeffirellì.” Mi ero plurivaccinato.
Callas, in un’altra dimensione della vita. Dunque, l’incontro con la Callas. Vado per Visconti in sartoria, che stava in via Frattini, dalla Palmer, dove c’erano tutti i nostri costumi, e quando arrivo lì, non era pronto niente. Avevano dovuto lavorare per gli abiti di scena di questa soprano greca, astro nascente, che in teatro si era lamentata per i ritardi e aveva voluto per la scena di seduzione del Parsifal una valanga di chiffon colorato, subito, in modo di potersi muovere come voleva lei, una volta in rosso, una in verde. Ma chi è? La sera c’era la generale e andiamo a vedere, a sentire, chi è questa qua che ci aveva bloccato tutto. Mai, dico mai, ho più provato l’emozione di una voce così. Un altro pianeta sonoro. In un’altra dimensione della vita. Una voce che non somigliava a niente. Imperfetta e sublime. Capace di fare una Kundry d’una potenza tremenda. Alla fine dello spettacolo andai in camerino, in mezzo agli altri, e le dissi che mi aveva creato un bel guaio in sartoria, che le avevo mandato un sacco di accidenti, ma che quella sera mi aveva dato una delle più grandi emozioni della mia vita. Era la prima volta della Callas in scena a Roma, se togliamo le Terme di Caracalla. A Venezia, alla Fenice, aveva fatto una cosa straordinaria. Era lì per Walkiria, ma quando Margherita Carosio s’ammalò Tullio Serafin le chiese di cantare lei. In cinque giorni imparò la parte e alternò, una sera Walkiria e un’altra I puritani. Diventò subito una leggenda, la Callas.
Soprannaturale.
Soprannaturale. Aveva un seguito di ammiratori sin dalle prime uscite. Visconti poi l’ammirava moltissimo. Diventammo amici la seconda volta, quando l’incontrai a un tè da Serafin. I direttori d’orchestra ricevevano per tradizione un giorno o due alla settimana. Toscanini, per esempio, era metodico, riceveva il pomeriggio, a via Durini, prima di andare alla Scala (poi usciva e faceva a piedi il percorso fino alla Scala, entrava, lasciava cadere il mantello, che qualcuno raccoglieva, e puntuale saliva sul podio, preciso, alle nove). Serafin mi aveva invitato con Visconti alla sua casa ai Parioli. C’erano cantanti, direttori, qualche scrittore. “Eccolo qua, il nostro camp-follower,” mi dissero, che è quello che mette le tende per seguirti. La Callas parlava sicura, tranciava giudizi come la più esperta dei musicisti. E aveva ragione. “Avanti Maria, basta con le cazzate, attacca la Traviata!” urlò Serafin. Lei obbediente. Aveva una giacca di velluto rosso scuro, una gonna nera e un cappello verde alla Raffaello, di velluto scuro, occhiali spessissimi, era grassa, destinata a un’obesità perpetua come la Tetrazzini o la Pagliughi. Una boccona, un nasone. In questo appartamento di elegantoni. E ci portò via. Tutti quanti. Una presenza soprannaturale era entrata lì tra noi. Così andai subito a sentire l’opera, a Firenze. Ci conoscemmo meglio. Tutto quello che hanno fatto per lei direttori d’orchestra, amici e mariti ha soltanto alimentato quello che già era. Ci confidavamo sulle questioni d’amore. Per lei l’amore era tutto. Ma c’era sempre qualcosa di tenebroso, di eccessivo. Quando provava Medea l’ho sentita spesso parlare della Colchide, delle tradizioni antiche, come se ci fosse una forza misteriosa che le era familiare, e da cui noi tutti eravamo esclusi. Per me è stato un grande esempio di intensità umana e artistica. Non si riusciva quasi mai a parlare di lavoro con lei, a parlare di progetti. Voleva vedere qualcosa, e su quello poi si lavorava. Mi sono impegnato, dopo la storia con Onassis, a riportarla in scena, nella Tosca, nel ’64 che, dopo una Norma di passaggio a Parigi riprese per le ultime repliche a Londra, nel ’65. L’ultima sera fu per la regina, a Londra, nel ’65. Sentivo nella sua voce che poteva essere anche l’ultima volta in scena. Chiamai tutti gli amici che riuscii a raggiungere. Fu proprio l’ultima opera della Callas.
Il mio segreto chiuso in me. La regia d’opera per me è guidata dalla musica. Amare tanto la musica, questo è la mia ispirazione. E il cinema vien dietro. Questo è il mio segreto: le passioni, i sentimenti espressi in maniera semplice e diretta, astuta poi, perché io sopra il melodramma ho la cultura elisabettiana e il sangue fiorentino. L’ Otello per me è il film migliore che ho mai fatto. C’erano tutti gli elementi che più amavo. La letteratura italiana, per il libretto di Arrigo Boito. La musica di Verdi. Poi Shakespeare, per tutto quello che avevo fatto a teatro e in particolare per un Otello a Milano. Un cast eccezionale, Domingo, Diaz e la Ricciarelli, Maazel direttore. E il cinema, con quelle possibilità che dava una storia così: tutto quello che posso desiderare dalla vita. Per me la musica di un’opera è una cosa viscerale, un’eiaculazione, una penetrazione, l’idea della scena e della regia vengono dal tipo di intensità dell’esperienza dell’ascolto musicale. Poi la cultura ti porta a scelte espressive, a fare una scintilla con quello che sai. Infatti Traviata, il film, l’ho girato in una specie di estasi, di realtà che diventa fantasia, con la scenografia in plexiglass. Invece nell’Otello ho messo la violenza della musica, i movimenti del male, la forza virile e l’innocenza femminile, armi, l’orrore e la
gelosia. Vinsi con questo film il Premio della critica americana. Ho fatto il cinema a Hollywood perché in America avevano imparato a conoscermi come regista d’opera. A metà degli anni ’50 ero a Dallas con Maria Callas, un festival importante, che diffuse maggiormente l’opera negli Stati Uniti. Ho fatto cinque, sei allestimenti laggiù, pagati benissimo. I texani avevano i soldi. Una stagione d’opera prima che incominciassero le grandi stagioni europee, a fine ottobre. Per l’opera ti chiamano dappertutto. Sono stato in Israele, in Sudamerica, a Siviglia. L’opera e l’inglese mi hanno aperto le porte del mondo anglosassone. Al cinema invece un genio può stare fermo. Fellini andava da casa a Cinecittà. Io ero spesso all’estero. A quei tempi ero molto a New York. Ballavo il twist al Pepper. Un’altra vita. Per arrivare alla Bisbetica domata, con Liz Taylor e Burton, il giro è stato molto largo. E passa ancora dall’opera. Nel ’59 Serafin mi chiamò al Covent Garden, mi fece lasciare un progetto di Don Pasquale alla Scala per una Lucia di Lammermoor a Londra. Mi attirò dicendomi che c’era una grande novità. Una giovane bravissima. Era la Sutherland. Mi disse che nessuno al mondo era riuscito a far recitare quella voce straordinaria in quel corpo immobile. Brutta, più che brutta. Scoprii che l’unico vero motivo per cui Serafin mi aveva chiamato a Londra era perché io provassi a rendere credibile in scena quel corpo così sgraziato. Inventai uno spettacolo per lei, con la nebbia scozzese che confondeva un po’ le cose, luci laterali, ampie gonne, capelli coi boccolotti romantici. E la obbligai a camminare con le ginocchia un po’ piegate. Una gorgiera fece risaltare gli occhi, bellissimi. E questa poveretta, dopo la disperazione di molti registi, trovò un pazzo come me che le fece fare di tutto. Riuscii perfino a farle attraversare il palco con un drappo insanguinato, camminando bene. I suoi mi naturali fecero il resto. “Two stars are born: Sutherland and Zeffirelli”, sui giornali inglesi. Così mi richiamarono l’anno dopo, al Covent Garden. E qui inizia qualcosa che negli anni mi portò al secondo lungometraggio con la Taylor e Burton.
Liz, la bisbetica, e io, il suo eroe. L’Old Vic, in crisi, cercava qualcosa di nuovo. Il direttore mi disse che voleva un giovane, per fare uno Shakespeare un po’ italiano. Non ci credevo. Era un Romeo e Giulietta. Come prosa io avevo fatto soltanto la Lulù di Bertolazzi, anni prima. Tantomeno Shakespeare. Tantomeno in inglese e all’Old Vic. Chiesi consiglio a Luchino. Disse: “Non vorrai mica farlo davvero?” Voleva totalmente dissuadermi: “Sei pazzo, te ne pentirai per tutta la vita.” Così capii che dovevo farlo. Debuttava la bravissima Judy Dench in Giulietta. Fu un grande successo. E di lì feci altre cose, altri Shakespeare, un Otello a Stratford, e ancora all’Old Vic Molto rumore per nulla con Albert Finney e Maggie Smith. Ecco il miracolo. Venne a vederlo anche Richard Burton, che era rimasto sempre attaccato al teatro, detestava Hollywood, diceva di sentirsi una puttana, un verme, era sempre così veemente, eccessivo. Il giorno dopo mi telefona alla Scala (stavo lavorando lì) il mio agente. La premessa è che c’era in ballo un nuovo film per me, una Bisbetica domata, una cosa italiana, allegra, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Ma io avevo già capito che non dovevo tornare a lavorare come “italiano”. Volevo far tesoro della posizione internazionale eccelsa che avevo conquistato. Avevo visto giusto. L’agente mi spiegò che Burton era
entusiasta dello spettacolo di Londra e voleva conoscermi e lavorare con me. Nel ’66 abbiamo fatto la Bisbetica a Hollywood. Fu complicata la lavorazione, ma diventai amico di Liz. Loro non si lasciavano mai per lavoro. Liz aveva imposto questa regola. Io ero riuscito a farli stare insieme lavorando entrambi. Ma non era facile. Incontrai Liz Taylor per la prima volta a Dublino, mentre Burton finiva un film e io li seguivo per preparare la Bisbetica. Una notte sento urlare nella camera di fianco. Vedo correre camerieri con molte bottiglie di whisky. Compare anche un facchino pallido con una retina per farfalle. Ma cosa stava succedendo? Esce Burton urlando con un bicchiere in mano: “Scusami, mia moglie è pazza, dietro quel bushbaby.” Non capivo. Arriva lei urlando, in vestaglia, coi suoi celebri occhi verdi pieni di rabbia e senza presentarsi mi chiede aiuto disperata per il suo bushbaby. Chiedo cos’è. Lei incomincia a inveire contro di me. Burton si mette in mezzo: “Questo è il regista del nostro prossimo film. E avendo speso per sua fortuna gran parte del suo tempo e della sua intelligenza a studiare e dirigere i testi di Shakespeare può permettersi il lusso di non sapere che cos’è un bushbaby.” Lei sostiene che un vero artista deve conoscere anche animali dolci e carini come il bushbaby. Lui sostiene che è un animale selvaggio e puzzolente. E su questo riprendono a litigare. A quel punto capisco finalmente che si parla di una specie di scoiattolino. Liz mi porta nel bagno. E sul soffitto vedo il bushbaby. Terrorizzato. Ci chiudiamo dentro. Io e lui. Con un asciugamano stretto al braccio e l’accappatoio col cappuccio, per difendermi, provo ad avvicinare l’animaletto che, docilmente, forse stremato, si fa acchiappare e riportare dalla sua padrona. Diventai amico di Liz per sempre. Quando morì Montgomery Clift, che Liz adorava, eravamo sul set della Bisbetica. A un certo punto Liz guarda l’orologio, ferma la scena, e scappa piangendo. Burton la segue e dopo un po’ torna con un whisky in mano: “Questa è l’ora in cui stanno seppellendo Clift. Chissà se piangerà così quando toccherà a me.”
Ostracismo comunista. Sono tornato al cinema con le grandi esperienze del teatro lirico e classico. Questo è il modo giusto per vedere la mia attività di autore al cinema. Esperienze che mi hanno poi portato avanti, fino a dirigere Laurence Olivier per esempio. Cioè, dirigere... Era uno con cui era meglio andare d’accordo. Ne sapeva talmente tanto. Lui diceva molto chiaramente: “Franco, conosco il testo dieci volte meglio di te, ma ho bisogno di suggerimenti. Buttane giù un po’.” Lui ne sceglieva uno. E su quello lavorava. L’unica cosa che non potevo fare era lavorare in Italia. Ero inviso alla intellighenzia di sinistra. Non una riga sui giornali del mio successo con Romeo e Giulietta a Londra, alla fine degli anni ’50. Poi, col cinema, le cose cambiarono un po’. Ci fu anche la nomination all’Oscar per il Romeo e Giulietta della Paramount. Ma perfino alla Scala, a un certo punto, mi allontanarono. Dicevano che ero fascista. Il mio modello era invece l’America. Persi tutti i miei soldi per fare la compagnia con Giannini e la Guarnieri e tornare a fare teatro in Italia. Compagnia privata, nessuna sovvenzione pubblica, e così i 120 milioni d’allora guadagnati con la Bisbetica andarono in fumo. Riportai in teatro la Magnani, nella Lupa, con quei soldi. Ma prima, nel ’63, con Sarah Ferrati e Salerno avevo fatto Chi ha paura di Virginia Woolf?, acquistando i diritti della commedia di Albee a New York per una sciocchezza. Fu un grandissimo successo. Fu il 25 luglio del teatro italiano. Perché c’erano
Strehler, Visconti, e sbuca questo Zeffirelli. Tornavo in Italia ogni tanto per fare teatro, ma l’ostracismo verso di me c’era sempre, soprattutto da parte degli intellettuali comunisti. E anche oggi. L’ultimo spettacolo che ho fatto alla Scala è stato nel ’92. E pensare che in questo periodo ho nove produzioni che girano al Metropolitan di New York.
Quando puoi avere Mel Gibson... Io non sono un regista italiano. Non ho mai fatto un film in lingua italiana. Che m’interessava di fare Amleto per l’Italia, se potevo farlo in inglese con Mel Gibson, cioè con un attore che immediatamente avrebbe potuto eclissare tutte le interpretazioni femminee di Amleto? Questo è un vantaggio. Certo, quando ho potuto lavorare con gli italiani, mi ha fatto piacere. Per Storia di una capinera o Un tè con Mussolini , per esempio, ma non sono strettamente “film italiani”. E dove li trovo poi gli attori italiani adeguati? Mi accusano per i miei film, fatti per far incassare. Ma come? Io penso che un produttore che investe i suoi soldi ha tutti i sacrosanti diritti di recuperarli. Così va bene anche Il campione o Brookie Shields. Poi ho fatto il film sulla vita di Maria Callas. Ho trovato l’attrice giusta. Perché devo dire addio a tutto quello che ho conquistato? Sono diventato un regista a livello internazionale per venire a fare i filmetti in Italia?
20 Miriam mi ha aiutato a sedermi e mi ha portato un caffè. Mi sento un po’ ridicola per questa tempesta di emozioni. Non riesco a smettere di contemplare l’apparecchio. Questa vecchia Marelli che ha tanto incuriosito Miriam, è incastonata in un mobile di radica che feci restaurare. Lo devo a un amico sceneggiatore, un ragazzo omosessuale (lo chiamo ragazzo, ma oggi avrà sessant’anni). Era appassionato di mobili antichi. Commerciava con un antiquario, e parlava del suo commercio come di un hobby, perché non aveva il coraggio di ammettere che, scrivendo sceneggiature, non riusciva a vivere. È meglio che passo da questo monumento alla radio vera, un impianto ad alta fedeltà installato più di vent’anni addietro da mio cognato. La accendo. Ignoravo esistesse una versione per quartetto d’archi dell’Intermezzo di Cavalleria Rusticana. L’annunciatore presenta una trascrizione eseguita dal gruppo Michelangelo e Secondi. Senza l’orchestra il crescendo perde maestosità e acquista strazio. Penso che da qualche parte devo ancora avere un disco veramente speciale, la Cavalleria diretta dall’autore, per i cinquant’anni della prima esecuzione. Un regalo della Voce del Padrone: un’addetta stampa si era ricordata che io avevo partecipato al montaggio del Mascagni di Gentilomo, con Pierre Cressoy, Mario Del Monaco, e, credo, Carla Del Poggio. È una registrazione storica. Appena si appoggia la puntina sul disco, la voce enfatica di Mascagni annuncia “masse orchestrali che non hanno rivali al mondo”, affidando all’ascoltatore l’opera come un autografo, “il più vivo che si possa dare, e quello che meglio mi rappresenta nella doppia veste di autore e direttore della musica mia.” Questa voce stentorea dall’oltretomba, un po’ cardinalizia, scandita nella prosopopea delle “cose ardite” colloca l’ascolto in una dimensione temporale distaccata e immortale. Alla rappresentazione in teatro della Cavalleria ho assistito una sola volta. Era dopo la guerra, con la direzione di Carlo Rustichelli, che aveva appena iniziato la sua carriera di musicista cinematografico. Di persona, ho avuto un unico incontro con Rustichelli, a una festa della Lux. Ricordo una persona schiva, gentile, stimata: segno forte di differenza nella comunità invidiosa e sarcastica del cinema.
CARLO RUSTICHELLI Andiam filibustier, ohi ohi ohi Ho scritto quasi 500 colonne sonore per il cinema, dagli anni ’30 a oggi. Da ragazzo volevo dedicarmi alla carriera sportiva. Volevo fare il corridore in bicicletta. Ho vinto anche delle coppe. Ma era destino che il vero record lo stabilissi nel cinema. Credo di aver composto fino a 30 colonne in un anno, anche se fare in fretta non è sinonimo di risultati facili. Mi sono appassionato alla lirica quasi subito. Ho diretto tante opere a Carpi, a Pescara, al Comunale di Reggio Emilia. E così la lirica è entrata nelle mie colonne sonore. Forse ha influenzato anche la mia capacità di inserire le canzoni. Di inventarle proprio, come delle arie. Il cinema è un mezzo simile all’opera. Perché uno non ci pensa, ma è così: la musica al cinema allude a certe emozioni, a certi sentimenti dei personaggi. Sono sicuro che Mascagni, Puccini, Cilea sarebbero stati anche grandi autori di colonne sonore per il cinema. E questo molti registi con cui ho lavorato lo sapevano, per esempio Germi, e anche Pasolini, musicalmente il più colto e sensibile dei cineasti con cui ho lavorato.
Suonando al cinema di Luzzara. I primi commenti musicali li ho scritti in collaborazione col maestro Carabella, nel 1941: Il figlio del corsaro rosso e Gli ultimi filibustieri. Tra gli sceneggiatori, c’era Pietro Germi, giovanissimo. Un duro dal cuore tenero. Uno che non perdonava mai per restare fedele alla sua onestà. Avevo scritto un tema dei filibustieri che aveva funzionato: “Andiam filibustier, ohi, ohi, ohi, u-u-una pinta di rhu-u-um.” La canticchiavano tutti. Ma io ritenevo fosse un episodio nella mia carriera. E invece, Germi si ricordò di me nel 1948 quando aveva bisogno di un commento per il suo secondo lungometraggio, Gioventù perduta, quello della banda dei ragazzi rapinatori nel dopoguerra, quando Germi pensava ancora al cinema d’azione americano. Ero al Politeama di Terni a dirigere una Tosca. Alla fine del secondo atto trovo in camerino due tizi: uno era Luigi Rovere, il produttore, l’altro era Germi, che mi aveva riconosciuto. E di lì non ho più smesso di lavorare. Ho fatto centinaia di film, senza fermarmi mai. E ancora adesso, a quasi novant’anni, mi porto nel cuore il cruccio di non aver continuato una brillante carriera da direttore d’orchestra. Mio padre aveva un debole per la musica; anche i miei fratelli sono musicisti. Lui era capo usciere e custode del Municipio di Carpi, così vivevamo in un appartamentino nel palazzo. Io studiavo violoncello, sotto. Insomma, facevo credere a mio padre che studiavo. Mettevo un disco e leggevo la raccolta a fumetti di Petrosino. Immagini e musica... Mi ero diplomato in pianoforte, ma lo suonavo già nel cinema di Luzzara, il paese di Zavattini, quando ancora c’era il muto. Però a modo mio. Sullo schermo c’era Tom Mix che faceva a cazzotti e io montavo dei frammenti della Traviata. Era un cinemino in un piccolo paese di cascine, con tutti i ragazzini che urlavano, la gente che si spaventava o piangeva. E anche con i film di Greta Garbo ci mettevo sempre l’opera. Però non incontrai mai Zavattini quand’eravamo giovani. Ci siamo frequentati dopo, a Roma, quando avevamo amici in comune, Guttuso, Germi, Nanni Loy, e una volta per un paio di mesi gli ho prestato la mia villa a Castelfusano
per finire un libro.
Contro l’uniformità tematica. Ai tempi del diploma ascoltavo Petrassi e Pizzetti, la musica moderna italiana, sempre sul versante dell’opera lirica, ma per me era uno sforzo. Sapevo che ero giovane e “dovevo” ascoltare gli autori nuovi, ma mi era necessario concentrarmi molto, m’imponevo di seguire almeno per cinque minuti. Il rifiuto era quasi fisiologico per me. Credo di essermi rifugiato molto volentieri nel cinema perché quello che stava accadendo nella musica, in quegli anni... non faceva proprio per me. Al contrario, scoprivo che il cinema accettava quello che ero, la mia sensibilità, il mio gusto melodico. Che poi so benissimo che la musica si divide soltanto in due categorie: quella bella e quella brutta. Petrassi e gli altri erano bravi, ma per me la loro musica era poco aderente ai sentimenti umani. Ed è un discorso che faccio ancora oggi. Io ascrivo alla musica moderna, anche quella elettronica, la responsabilità dell’uniformità tematica. Non si può sentire l’amore e il dolore con certi blocchi ripetitivi, o quelle dissonanze che hanno soltanto un valore per l’ascolto e la ricerca; è come il colore per i pittori, insomma. Intendiamoci, Stravinskij, Schoenberg e Hindemith sono il massimo per me. Oltre non si va. Anche i vari Varèse, Boulez o Stockhausen non ci riescono, non rimangono. O meglio, resistono per una certa politica musicale. C’è un’imposizione. E allora.
Musica con i frullatori. Per certi versi la musica moderna non è musica nuova, ma colorazioni dell’orchestra, esasperazioni foniche, timbriche, di movimenti di masse. Per questo in alcuni casi può funzionare al cinema. Che infatti oggi saccheggia tutto. Con certi impasti d’orchestra e di elettronica si suscitano emozioni stridenti, si tocca l’orrore, la ferocia, l’inquietudine. Quando ho fatto la colonna per La morte viene dallo spazio, ed eravamo nel 1958, sono andato a incidere con l’orchestra e dei frullatori di frutta, l’estintore dei pompieri, fischietti, e sono stato il primo, credo, ad aver impiegato in Italia le Onde Martenot, che fanno quel sibilo con intervalli più piccoli del semitono. E poi per me la musica non deve mai sopravanzare l’aspetto narrativo e artistico del film, non deve prendere il sopravvento, far dimenticare i dialoghi. Non sopporto, ancora oggi, quelle lunghe tirate di sottofondo mentre gli attori recitano. E intendiamoci, tutto è musica. Anche il silenzio è musica.
Il classicismo per i neorealisti e l’invenzione di “Vitti ’na crozza”. Quando io dopo la guerra mi dedicai definitivamente alle colonne sonore Federico Fellini chiamava Germi “maestro”. Non avevo frequentato molto il cinema. Conoscevo poco il lavoro dei colleghi celebri degli anni ’30 e ’40, come Cicognini, Trovajoli, Carabella. Conoscevo soltanto qualche film del neorealismo. Capitò anche a me di scrivere musiche per film neorealisti, o post neorealisti, non so come si dice, per esempio Tiro al piccione di Montaldo o La lunga notte del ’43 di Vancini, e Kapò di Pontecorvo. Il classicismo musicale era richiesto
dai registi neorealisti. Per Aldo Vergano scrissi la colonna di I fuorilegge, alla fine degli anni ’40, ispirato a una vicenda legata a Salvatore Giuliano, con accenti molto foschi anche nell’orchestrazione. Per Il cammino della speranza di Germi ho mediato tra una tradizione folcloristica siciliana, che ci portò a scoprire e quasi inventare la celebre Vitti ’na crozza, e un motivo tragico e nello stesso tempo inneggiante a un’apertura, appunto a una speranza (non è stato Modugno il primo a farla Vitti ’na crozza; fu Germi a fare una registrazione rudimentale da un pastore che cantava qualcosa di simile; io poi la strumentai e sistemammo le parole). Certi toni drammatici, certe accentature dei violini erano fondamentali per quei registi. E per me non era difficile, con l’educazione operistica che avevo. Pontecorvo era uno che conosceva la musica e finiva per chiedermi cose molto precise, entrando nel merito anche dell’orchestrazione. Amava Kurt Weil e mi chiedeva di collegarlo a un certo classicismo. Mi hanno anche detto che in Kapò sono riuscito a reinventare Bach, con quel motivo al cembalo. Non so. Certo che dopo un po’ ho incominciato a credere di essere anche un compositore. Casa Ricordi mi contattò per chiedermi quale brano di Bach avevo usato. Ma era musica mia. Però a me piacevano molto anche gli americani. Non è un caso che poi ho lavorato per Billy Wilder, per Che cosa è successo tra tuo padre e mia madre. Ma la mia vena è sempre stata vicina alla lirica. I film sulla vita di Schubert e di Puccini... Così ho conosciuto meglio importanti artisti della lirica di quegli anni. Beniamino Gigli, un grande uomo. Ora mi chiedo perché il cinema italiano ha perso la tradizione dell’opera reinventata al cinema. Sì, vien fuori uno Zeffirelli ogni dieci anni. Mi sono convinto che il popolo italiano è erroneamente creduto un popolo musicale.
La musica è un corpo umano. Purtroppo a un certo punto i giovani sono stati plagiati dai discografici, che avevano capito, grazie agli americani, che si potevano raccogliere emolumenti formidabili. Il pop, il rock. Ma la musica è come un corpo umano. C’è il cuore, ci sono gli altri organi. Bisogna sentire che esiste tutto. E allora, spiegatemi perché i giovani devono dimenticare Gershwin, o le canzoni di Cole Porter, o il jazz di Gillespie? Perché conviene. Ecco. E il cinema oggi è il viatico commerciale di questa musica. Molto più di quei filmetti musicali che mi chiamavano a fare un tanto al pezzo negli anni ’50, come Canzoni, canzoni, canzoni, Perdonami con Claudio Villa o Destinazione San Remo di Paolella. C’era Infascelli, il produttore, che era capace di chiamarmi all’una di notte e dirmi che il giorno dopo avremmo registrato delle canzoni. Io protestavo, ma poi. Anche perché c’erano musicisti, veri musicisti di grande talento, che lavoravano quasi esclusivamente per il cinema, come Brandi, Pomeranz, e il direttore Ferrara, uno che suscitava il rispetto di Karajan. E così si scriveva svelti per Consolini, Gigli, Tajoli. Oggi il cinema ha grandi responsabilità educative anche per la musica. Basta mettere qualche atmosfera rock, e via. Ma vorrei discutere se sono le scelte migliori. Comunque, per me la canzone è un elemento della colonna sonora, perché tocca l’ambiente, il costume e i personaggi. E poi, se sei capace, si lega tutto con la colonna di commento. Ne ho scritte tante per il cinema, alcune mi hanno portato addirittura al successo discografico. Per esempio Serafino, con Celentano, o Si no me moro, che cantava mia figlia Alida Chelli per Un maledetto imbroglio di Germi, dal Pasticciaccio di Gadda. Ma sono affezionato anche al
Nanni per il film di Bolognini Gli innamorati o all’uso che ho fatto dello stornello in Un giorno da leoni di Loy.
Farsa e sentimento per Totò. Un musicista del cinema deve saper fare tutto. Deve essere capace di uno sguardo totale sulla musica e sul suono e deve saper prendere e utilizzare quello che gli serve. Io ho scritto per film di ogni genere. Per i film mitologici di moda nei primi anni ’60, dove si cercava l’impatto imperiale, grandioso, della musica, come I giganti della Tessaglia di Freda o l’Annibale di Bragaglia. Ho fatto dei Sandokan, un Maciste, e un Ercole , film di guerra, mi ricordo Il tesoro di Rommel, e avventurosi, come Atlantide, Mondo sommerso, molti Totò, compreso quello neorealista di Totò cerca casa di Steno e Monicelli. Con Totò bisognava cercare un equilibrio tra la farsa e il sentimento. Ma in genere la musica per i film comici è la più difficile. A meno di mettere i tromboni e i tamburi, allora son capaci tutti. E non faccio nomi. Ma io con Totò usavo musica colta, ricordo di aver lavorato la musica di Mussorgskij per quel personaggio che tornava dalla Russia e trovava la moglie risposata. In certi casi funzionava l’ironia. Per esempio nel film di Tessari Arrivano i Titani ho messo dentro dei brani militari, la marcia dei Marines, una specie di Marsigliese, perfino l’Aida . E nel primo spaghetti-western di Bud Spencer e Terence Hill, I quattro dell’Ave Maria , di Colizzi, mi sembra alla fine degli anni ’60, si richiamava un po’ tutta la musica del genere. Ho sempre preferito il film in costume. Ma non ho mai pensato che esista una musica per il cinema di serie A e una per quello di serie B. È sempre difficilissimo lavorare bene per il cinema. Se c’è un tema giusto, lo spettatore resta colpito.
Il grugnito di Germi. Spesso, al cinema, un motivo con delle parole può funzionare meglio di qualsiasi commento. Il cantato crea atmosfere. Guardate per esempio come lo usa uno come Woody Allen con tutte quelle canzoni d’epoca. E negli anni ’50 c’era tutta un’Italia popolare da suggerire, gente comune, quartieri, la società che si era rimessa insieme dopo la guerra, proprio la voglia di tornare a cantare e ascoltare. Il fatto è che con i registi-autori bisogna cavar fuori qualcosa di cui loro hanno bisogno, che intuiscono appena e che, soprattutto, non sanno come trovare. Con Germi sedevo al pianoforte pomeriggi interi. Lui stava lì ad ascoltare. Ho fatto tutti i suoi film, praticamente. Prima mi dava il soggetto e anche la sceneggiatura da leggere, ma non è che mi spiegasse niente sui personaggi. E comunque erano pochi quelli che ti davano la sceneggiatura prima e ti parlavano dei rapporti tra i personaggi; in genere si componeva sempre a film finito. Io cercavo dei motivi, un’ouverture, pensando ai temi, e Germi stava sul divano a fumare. Sonnecchiava. Si abbandonava. E ogni tanto mi diceva: “Com’è rilassante ascoltarti.” Ma io in realtà aspettavo un segnale. Se trovavo qualche tema che secondo me andava bene, provavo a ripeterlo. Quando vedevo un cenno d’attenzione, ripetevo ancora e ampliavo, e poi ripetevo, e ripetevo ancora. Finché non faceva il gesto che ormai avevo imparato a conoscere bene: tirava indietro la testa e faceva un verso, una specie di grugnito. Allora, c’era moneta. Da genovese, non era uno molto espansivo. Non una volta che mi abbia
fatto un complimento diretto. Io comunque capivo che c’eravamo. Con L’uomo di paglia è stata durissima, perché cercavamo una combinazione di temi della famiglia e della ragazza di cui s’innamora l’operaio, la pace e il mistero, la colpevolezza, i sensi. Ma è una delle colonne di cui sono più soddisfatto, per l’equilibrio della cromaticità, che si sposa con l’atmosfera inquieta del film. Germi tagliava spesso delle parti, senza dirmi niente, al massimo un avviso freddo prima di entrare in moviola. E nonostante certi tagli, secondo me con la musica esagerava. Ma il lavoro con Germi era sempre di alto livello. Mi piace Il ferroviere , per il motivetto dell’osteria, L’uva, che avevo ricavato da una canzone popolare, e poi Germi e Giannetti, se non sbaglio, avevano messo le parole, come era successo per Si no me moro: le parole erano loro. Per Le castagne sono buone avevo tirato fuori un motivo di Bellini. Divorzio all’italiana, Signore e signori e Sedotta e abbandonata sono temi, mi hanno detto, molto centrati per il film. Per me Sedotta e abbandonata è uno dei grandi film del cinema italiano, forse il migliore di Germi. A volte Germi girava delle sequenze facendo ascoltare la musica sul set. Quasi sempre la voleva in moviola. Credo di essere stato il primo a portare il pianoforte in sala di montaggio. Germi era un tagliatore straordinario. Un montatore magistrale.
Brancaleone fisssch bum! E via le cambiali. Anche Monicelli gradiva il pianoforte in moviola. Era molto esigente Monicelli. Con lui ho f at t o I compagni, i due Brancaleone, i due Amici miei. Mi fece uno dei più grandi complimenti: secondo lui la marcetta di Brancaleone, che all’inizio richiama il “trionfo di Radamès” dell’Aida e le cui parole furono scritte da Age e Scarpelli, era un tema di per sé valido, un tema che aveva spinto il successo del film, disse. È un semplice-composto quel tema, una graffiatura, come la chiamo io. Ne vado fiero soprattutto per l’invenzione del fischio e del bum! E per una citazione dal Tannhäuser di Wagner che ero riuscito a metterci dentro. Perché mi ero appassionato molto a Wagner, a quel tempo. Una sera, in sala, io e Monicelli abbiamo osservato le reazioni degli spettatori: ci colpì che l’operaio e l’intellettuale coglievano subito il rapporto del motivo con l’atmosfera del film. Poi abbiamo scoperto che c’era gente che al mattino andava a lavorare e cantava Brancaleone, e magari riusciva a dimenticare le cambiali, perché negli anni ’60 si faceva tutto a cambiali. In Amici miei c’è il Rigoletto: “Bella figlia dell’amo-oo-re”. Anche con Bolognini il sodalizio funzionò, e con Dino Risi, per il quale ho scritto le musiche di Un amore a Roma e In nome del popolo italiano. Con Florestano Vancini, per Le stagioni del nostro amore o, negli anni ’80, La neve nel bicchiere (bel film, ancora) ho usato liberamente la mia cultura melodica e lirica. Ecco, mentre Nino Rota incontrava Fellini e incominciava un momento importante della sua carriera, a me capitò d’incontrare e lavorare con un altro grande regista, Pier Paolo Pasolini.
Un Savonarola per Pasolini. Fu la produzione a chiamarmi per Accattone, ma io sapevo chi era Pasolini. Gli volevo affidare la scrittura di un libretto per una mia opera, ma non se ne fece mai niente. Avevo già scritto un’opera, con don Zeno, quello di Nomadelfia, la città dei ragazzi trovatelli. Stavo
partendo per il Venezuela, nel dopoguerra, e lui, avendomi ascoltato al pianoforte in un albergo, mi propose di dirigere la banda dei suoi ragazzi. Poi diventammo amici. Lui era stato avvocato, era uno che frequentava Fanfani e correva in motocicletta, un prete speciale. Abbiamo scritto insieme La vittima, mai finita, nonostante gli incoraggiamenti di Beniamino Gigli e del maestro Conca. Ci chiedevamo chi era la vittima, il protagonista o il pubblico costretto ad ascoltare... Comunque, con Pasolini fu un’esperienza importante. Era un conoscitore raffinatissimo di musica. L’altro era Luchino Visconti. Pasolini mi chiedeva raccordi precisi tra i brani che sceglieva, in genere da Bach. Dopo aver fatto insieme anche Mamma Roma e La ricotta, certo non è un caso che Pasolini abbia continuato scegliendo e mixando da solo le musiche. Un caso quasi unico nel cinema italiano. Lo ricordo come un uomo dolcissimo. Fu al caffè Canova che trovai il coraggio per proporgli di scrivere il libretto di un’opera che ancora adesso aspetto di realizzare. L’idea nacque da un libro che vidi in una vetrina, sul Savonarola. Si accese una lampadina: era una specie di Forza del destino. Pasolini non se la sentiva. E allora mi sono rivolto ad altri.
Tra Fellini e Rota... La musica da film italiana è tra le migliori del mondo, secondo me. Da Trovajoli a Nino Rota, musicisti completi, come Piccioni, che proviene più dal jazz americano, ed Ennio. Per me Morricone è bravissimo al cinema. Tutti musicisti che si erano perfettamente integrati con i registi e con i film. Una volta con Morricone ci siamo trovati ad Acqui Terme per una serata, con Rota, Lavagnino e altri. Io avevo dato Bubu di Montparnasse. Le musiche le dirigeva tutte Carlo Savina. Meno il pezzo di Morricone, che diresse lui, un brano composto non per il cinema. Alla fine, tutto contento, mi passa di fianco e mi chiede che mi sembra. Io trovai il coraggio e dissi: senti, a dire il vero a me mi fa schifo questa roba. Che cosa dovevo dire? Aveva fatto uno di quei brani moderni, in stile “nuova consonanza”, la corrente sperimentale. Ma Ennio è un grande al cinema. Adesso dico un’altra esagerazione: secondo me tra Fellini e Rota quello più innovativo era Rota. Battaglia di giganti, intendiamoci. Ma Fellini per me era diventato ripetitivo, con quelle deformazioni che ormai ti aspettavi. Invece Rota, con una personalità sempre riconoscibile, andava avanti. Basti pensare al lavoro che ha fatto per Il padrino di Coppola. Fosse stato per Fellini, gli avrebbe sempre chiesto di fare il motivo di Gelsomina.
Come fa, quel pezzo? Certe musiche vivono in modo meraviglioso al di fuori del film, ma nessuna musica deve spiccare sul film. Una volta, a Hollywood, quando avevo fatto la pellicola con Billy Wilder, sono entrato in un albergo e nell’atrio sento: “Avete gli o-o-cchi belli”, il pezzo di Divorzio all’italiana, e mi sono reso conto che reggeva da solo e che aveva avuto successo in America. Prendo ancora oggi emolumenti per i miei pezzi distribuiti in America. Dicono che io sono un melodico. Dicono che la mia vena musicale è “semplice”. Lo dicono per farmi i complimenti. Ma scrivere in modo semplice il più delle volte è molto difficile. Perché la vita ti mette addosso un sacco di cose, man mano che va avanti. E queste influiscono, creano una
complessità che influisce, che tu voglia o no. E poi, per esempio, c’è una “semplice complessità” già nel tema de L’uomo di paglia. Bisognerebbe risentirlo un momento. Posso provare, anche se ormai mi metto sempre più raramente al piano, perché questa retina maculata... Come fa? Incomincia con sol e fa diesis, se mi ricordo. Ecco.
21 Di quella Cavalleria diretta da Rustichelli, ricordo vivamente l’emozione delle luci. Ero in seconda fila, al centro, in compagnia di un’amica che conosceva bene la sorella del giovane direttore, corista all’Opera di Roma. Avevo forse venticinque anni. Non avevo mai immaginato si potesse illuminare con tale violenza uno spazio chiuso. Tutto il sole di Sicilia in una stanza, perché il palcoscenico sembrava una grande stanza. Erano state impiegate lampade speciali, con un dispendio enorme di energia. Se ne sentiva il calore. Sotto i piedi le assi di legno accoglievano il terremoto dell’orchestra, lo sguardo restava abbacinato dal guizzo dei coltelli. Lavorando al montaggio, ai miei tempi, dell’immagine si perdeva sempre la qualità luminosa. Era quasi impossibile afferrare nei dettagli la luce di un film dal piccolo visore del bancone. Per noi, gran parte del lavoro del direttore della fotografia andava perduta. Oggi è tutto diverso, come è tutto diverso per il colore. Ai miei tempi le pellicole erano rozze. Un giorno, collaboravo ancora con la Lux, arriva qualcuno dagli stabilimenti della Vasca Navale e racconta che Totò aveva rischiato di bruciare. Stavano girando il primo film italiano a colori (Totò a colori , credo), una produzione che aveva messo in piedi Ponti, senza la Lux, se non sbaglio. La pellicola richiedeva forti esplosioni di luci. Totò portava una parrucca e sotto la parrucca fu sistemata una borsa del ghiaccio. Non bastò. La testa del grande attore a un tratto cominciò a fumare. Il direttore della fotografia era Tonino Delli Colli, non ancora il mitico Delli Colli dei premi internazionali, un pollice d’uomo che parlava soltanto romanesco e si muoveva come fosse il padrone di Cinecittà. Dicevano che Tonì fosse un grande amatore. Qualcuno giurava su un incontro erotico con Brigitte Bardot, nella sua roulotte sul set.
TONINO DELLI COLLI So’ sparite le lucciole È stato un caso che ho fatto il cinema. Avevo la terza media. Un po’ perché non potevo andare avanti per questioni finanziarie, un po’ non c’era proprio voglia. Parliamo di Roma ai primi anni ’30. Sono del ’21, quindi. Non del ’23, come sta scritto. È stato un trucchetto. Me so’ levato un paio d’anni. Embè.
Operatore o fonico? Mio padre faceva il carrozziere delle prime automobili. E a un certo punto è fallito. Era socio con un altro che verniciava le vetture, in via La Spezia, a San Giovanni. Poveretto, lui non era un abile ladro come certi suoi soci. Quando perse tutto, fu assunto come magazziniere nel negozio di fianco, una delle prime rivendite di pellicole, con stabilimento di sviluppo e stampa. E allora succede che una contabile che lavorava in questo stabilimento viene presa come segretaria a Cinecittà, che aveva appena aperto. Mio padre le dice: guarda, questo ragazzo non gliene importa niente di studiare, i mezzi son quelli che sono, vedi un po’ se riesci a farlo entrare. E così, con la raccomandazione, perché funzionava solo in quel modo, sono entrato. Ma non sapevo neanche che cos’era il cinema. Ho fatto l’apprendista per molto tempo, roba che oggi non esiste più. Per quello è sparito l’artigianato. Quando escono dal Centro sperimentale sarebbero “direttori della fotografia”, ma che vor di’? Quelli furbi si mettono a bottega con uno di noi. Per fortuna io so’ cresciuto con un bravo direttore, Mario Albertelli. Ma è casuale che mi sono occupato di fotografia. Quand’è che mi so’ trovato a Cinecittà, mi hanno chiesto: fonico o operatore? E io ho detto: operatore. Ma non sapevo neanche che voleva di’. Nella vita è anche una questione di fortuna. Basta una parola, e cambia tutto, a volte. Se dicevo fonico...
Welles e le latrine al Quirinale. Già prima della guerra ero al lavoro. Come assistente di Albertelli. Il primo film è stato Finalmente sì. Ma era successo che Albertelli, soffrendo d’ulcera, spesso mi lasciava fare. Dava le indicazioni, e poi io preparavo e andavo avanti. Lui tornava e correggeva. Così s’impara. Non ero responsabile, ma nello stesso tempo potevo impostare l’immagine. Anzi, devo di’ che a un certo punto mi scocciava pure che lui arrivava e cambiava delle cose. Lavoravamo con Bragaglia, Bonnard. Appena finita la guerra i giovani assistenti come me, siccome che non c’era lavoro, tornavano alla macchina come operatori. E così mi sono ulteriormente perfezionato con grandi direttori della fotografia, come Brizzi e Arata. Ho fatto tanti film che me so’ proprio dimenticato. Recentemente mi hanno mandato una lista dall’Inghilterra dove ho scoperto cose che non ricordavo. Io, poi, ho scritto una lettera per ringraziarli, perché in fondo me l’hanno fatto sapere loro i film che avevo fatto. Ecco qua, nel ’45 O’ sole mio di Gentilomo, con Tito Gobbi, che io finii in parte come direttore, perché l’aveva in mano Brizzi. In pratica tutta la parte di Napoli l’ho fatta io. Nel ’46 Trepidazione, e
qui ripresi come fotografia, con Toni Fringuelli. Poi Felicità perduta con Filippo Carpi, Voragine nel ’48, poi L’isola di Montecristo, Città dolente, e qui ormai ero entrato fisso alla Scalera. Con Arata e Brizzi nel ’48 facemmo Cagliostro, con Orson Welles. Lui venne un mese dopo l’inizio. Io stavo in macchina, prima con Arata, che morì, poveretto, durante le riprese, e poi appunto con Brizzi. Welles era presuntuoso. Come tutti gli americani. So’ proprio dei... Poi, quando invece vedono che conosci il tuo mestiere, diventano agnellini. Ma io, siccome che ero a contratto, stavo sicuro e tranquillo, e dicevo quello che pensavo. Così alla fine di litigi e incazzature succede che ’sti americani mi volevano fa’ ’n contratto per sette anni. Loro fanno sempre sette anni. Come accadeva con gli attori. Sofia, Virna Lisi, la Mangano, Alida Valli, che poi tornò indietro quasi subito. Ma anche le altre poi si son liberate. Welles faceva l’americano. Con la fine della guerra pensavano di essere in mezzo agli africani. Si portavano i cuscini, le lenzuola e la carta igienica. Non so che cosa gli avevano raccontato quegli stronzi di soldati loro. Sembrava che sbarcavano in una colonia. Be’, c’era una contestazione fra me e il fonico americano. Secondo loro io non permettevo una buona ripresa del sonoro in diretta. Dicevano sempre: adesso quando arriva Orson... Embè? Ma chi è ’st’ Orson? A me dava fastidio mettere la cuffia, proprio non m’andava. Ma poi c’ho provato ad adattarmi. E il primo giorno di Welles, come uno spione il fonico gli dice che io non volevo mai metterla. Welles allora s’incazza, perché voleva le cose precise, e si mette a impreca’ in inglese. Io chiamo l’interprete, me faccio di’, e poi gli dico quelle due, tre parolacce in inglese che conoscevo. Un casino. Welles se ne va ’ncazzato. Siamo rimasti fermi un giorno. Insomma, loro arrivavano da padroni e volevano comanda’. Come oggi, d’altronde. Welles litigava con tutti, anche col regista, un russo, Gregory Ratoff, il quale per fare l’arrabbiato pigliava il bastone e il cappello e se ne andava, e Welles dirigeva lui naturalmente. Ma se dico quella del Quirinale... Giravamo dentro il palazzo, con le comparse, perché allora se poteva fa’. Be’, al mattino presto vediamo che gli americani fanno scaricare cinquanta, sessanta cubi con un buco. Ma che roba è? Dico: va’ un po’ a chiama’ er cowboy. Arriva il boss, e che vien fuori? Vien fuori che erano per i bisogni, sì proprio per la pipì e la cacca, perché temevano che le comparse sporcavano in giro. Ma te rendi conto? Abbiamo fermato tutta la produzione, subito. E li hanno portati via. Era una lotta per farsi rispetta’, perché con la guerra pensavano di esse’ ’n mezzo a le bestie, capito?
Pellicola dura, lampade al carbone. In quel periodo chiunque parlava inglese era qualcuno. Ma era mejo fa’ i vitelloni a via Veneto. Andavo da Donei, quando ancora via Veneto non era la Dolce Vita. Si ricominciava a uscire la sera, questo sì. E da Donei aspettavamo che scendeva Peppino Amato, che stava alla suite dell’Excelsior. C’erano Bonnard, Sordi, Rosi giovanissimo, proprio ’n ragazzino, Alessandrini, più vecchio di tutti, l’unico che c’aveva un po’ di soldi e offriva un pranzo. Pranzo per dire, ’na frittata, un po’ de vino, in una trattoria lì dietro, dove adesso ce sta ’n cinese. Era quasi ’na famija. Che non c’è più. Perché s’è avverato quello che diceva Pasolini del consumismo. Che ha distrutto le professionalità e il dialogo. Quando se cantava “se potessi avere mille lire al mese”, adesso sembra de fa’ il nostalgico, ma mille lire al mese quando ero ragazzo io erano come un milione e mezzo adesso, e sembrava tanto. Oggi ce paghi l’affitto.
Invece prima bastava e avanzava perché non c’era niente, non c’erano le auto, i taxi, la benzina, i ristoranti, le vacanze, la servitù, i giochi. In casa, io e mia sorella aiutavamo a lavare per terra. Mia madre c’aveva la cucina a carbone. I panni si stendevano fuori. E s’illuminava le stanze con le lampadine al carbone, la luce di una candela. Proprio non si spendeva niente. Appena finita la guerra negli studi erano rimaste delle grandi lampade che si sparavano sugli specchi per rifrangere e aumentare la luce. Si schermava con pezzi di legno, bandiere. I proiettori c’erano anche nel ’38, quando ho incominciato io, ma era raro. C’erano le lampade ad arco, sempre a carbone. La pellicola era dura, a bassa sensibilità. Si usava la Ferrania, che aveva appena 100 Asa. Quando poi ho lavorato con Pasolini, a lui gli piaceva la Ferrania, perché era contrastata. Ma, insomma, un conto era sceglierla negli anni ’60 per un motivo preciso e un altro fare tutto con quel tipo di pellicola perché c’era solo quella. Quando ho lavorato con Risi o Camerini la pellicola era più sensibile.
Risi svelto, Pasolini da 50 millimetri. Ho rivisto Primo amore, quello di Camerini, in televisione, e mi sono chiesto come ho fatto a fare quella fotografia, che sembra uscita appena ieri. Camerini era uno simpatico, sapeva quello che voleva. Dino Risi mi piaceva più degli altri, perché lui la sera voleva finire e andare a casa presto. Uno pratico, senza fisime. Come Monicelli. C’erano certi intellettuali che ’ncominciavi alle otto e te davano la prima inquadratura a mezzogiorno. Anche oggi, purtroppo. Ma Pasolini era un’altra cosa. Io ho lavorato quindici anni co’ Pasolini, da Accattone a Le giornate, con Il Vangelo , Il Decameron e il resto, ma non ho mai perso un minuto. Sapevo che era bravo, anche se di fotografia non aveva conoscenze tecniche, all’inizio. Quando abbiamo incominciato Accattone gli ho dovuto spiega’ quali erano gli obiettivi. Però, dopo tre settimane, dico tre settimane, aveva già capito tutto. Gli piacque subito il 50, in quanto che le figure si vedevano bene, anche se lo sfondo s’avvicinava e si schiacciava un po’. Ma a lui piaceva perché diceva che era tutto più concentrato. Alla fine, arrivava anche lui con i suoi quadrucci, al mattino, disegnati abbastanza male, ma giusti, e si lavorava svelto. Già si sistemava tutto la sera prima, sapendo se voleva una figura intera o altro. L’ha fatto per i primi due film. Poi s’andava via così.
Totò accecato a colori. Stavo in contratto con Ponti-De Laurentiis quando ho usato la prima pellicola a colori nel cinema italiano di mercato. Che era poi per Totò a colori , appunto. Nessuno voleva farlo. L’illuminazione diventava complicatissima. E m’hanno acchiappato a me, dicendo: tu stai a contratto, devi fare quello che diciamo noi. Allora parlai con la Ferrania. La pellicola era 6 Asa. Dico, ma siete matti? Insomma ci voleva una valanga di luce. E il povero Totò era sottoposto a questi bagni di lampade. Poveretto. Tra l’altro era già predisposto al suo problema agli occhi, per dire. Appena Steno diceva stop! Totò scappava via. Voleva uscire subito da quell’inferno, e beccava tutte le porte di scena, che non portavano da nessuna parte. Girava e girava, come le farfalle quando finiscono dentro la lampada. Guarda caso fu un successo il film, sia di pubblico che di critica. Che uomo. Non ho pianto per i miei genitori.
Ma ho pianto per Totò. Una volta che andò in Svizzera con l’autista, che era già quasi cieco, mi portò in regalo un Dupont d’oro.
Campo a Roma e controcampo in Africa. Ponti e De Laurentiis me facevano fa’ i film con Billi e Riva, Mattoli, Totò. Invece i film importanti, o d’arte, glieli facevano fa’ ad Aldo Tonti, perché lui era più... Stavo in Africa, credo per Il ladro di Bagdad, quando pensai di fare il primo film con Pasolini. Venne giù l’architetto della produzione, Flavio Mogherini. Mi disse che andava a lavorare con Bini, per il primo film di Pasolini. Io incominciavo a veder girare le prime cambiali, quindi la situazione mi preoccupava un po’. Mogherini mi parlava di questi giovani che incominciavano a fare il cinema con Bini. Dissi: vengo anch’io. Mogherini disse che io costavo troppo, allora lo pregai di dire a Bini di darmi quello che poteva. Ebbi un’intuizione, credo. Perché quel giorno cambiai completamente la mia carriera. Ma non fu difficile, anzi: Pasolini aveva l’intelligenza di chiedermi che cosa fare. Aveva in mente qualcosa, mi dava delle suggestioni. E io facevo. Poi col colore, invece, diventò più preciso, perché aveva come riferimento dei quadri, come il Mantegna per La ricotta, per esempio. Cercava di lavorare in combinazione con i costumi, scegliendo i colori. Col tempo aveva messo insieme proprio un bel gruppo, perché c’erano Ferretti, Donati. Sul set Pasolini aveva rispetto per tutti. Una persona di una dolcezza. Poi, vabbè, lui viveva avventure forti la notte. Insomma lui tutte le sere doveva uscire. Non c’era niente da fare. Perfino nello Yemen. Stavamo facendo un episodio del Decamerone che non è mai stato montato. Dico: ma dove vai? Guarda che qui c’ammazzano. Già c’eravamo inimicati una banda con le riprese di un ragazzino nudo. E non me sembrava il caso de andà ’n giro così. Ma lui... Come regista Pasolini era capace di fare il campo a Roma e il controcampo in Africa.
Pasolini e le star, la Magnani col velatino. Voleva delle cose precise, e della facce precise. In questo caso, un pezzo l’avevamo girato sull’Etna e l’altro nello Yemen. E io, che mettevo sempre l’occhio dove diceva lui, capivo che non poteva che lavorare così. Con gli attori veri però non funzionavano bene le cose. Nemmeno con la Magnani fu facile. Quando cercava i soldi per fare Il vangelo, Bini andò da Carizzoni, che gli disse: “Ti do anche un miliardo, ma devi mettere Burt Lancaster a fare Gesù.” Quando Bini riferì, Pasolini quasi svenne. Figurarsi se prendeva una star. Si arrangiò con 250 milioni. Così Cristo è quel ragazzino spagnolo. Me lo fece vedere in albergo, senza barba, con i capelli corti e gli occhi storti. Però se vedi l’immagine aveva ragione Pier Paolo. Era goyesco. La Magnani invece voleva sempre vedersi in proiezione, se non le andava bene rompeva le scatole. Per Accattone io ho dovuto girare due film. Uno era Accattone, l’altro quello della Magnani. Per lei bisognava mette’ er velatino. Dico, mi sta’ a rovina’ il film, te possino. E lei: ah no, io non ce la faccio. E verificava in proiezione. Si metteva le parrucche e si faceva tirare la pelle indossandole. E io a dirle che faceva ’na stronzata: tu sei bella come stai, con le tue occhiaie, la tua pelle così. Però il truccatore le dava corda. Nel finale, poi, c’è la scena madre che lei, per fortuna, decide di fare senza parrucca e senza trucco. E quando la
rivede, allora dice che è bellissima. Ma se lo dico dall’inizio... La Magnani era ’na testarda. Comunque Pasolini poi praticamente non mi diceva più niente, già dal Vangelo. Dopo Uccellacci, dovevo fare anche Edipo re, ma si vede che Bini voleva pagare anche meno del solito. Perché andò che stavo facendo cinque settimane con Louis Malle, per l’episodio di Tre passi nel delirio. Pasolini aveva chiesto di me. Io avevo visto la situazione, con questi qui che partivano per il Marocco praticamente senza ’na lira. Ma chi me lo fa fa’. L’accordo era che dopo Malle sarei passato all’Edipo. Ma Bini mi diceva ogni giorno di aspettare a partire. Aspetta aspetta, il film lo girò Ruzzolini, e Bini risparmiò un po’ di soldi. Non feci né Teorema, né Medea. Intanto avevo lavorato con Lattuada e Zurlini. Insomma avevo proprio cambiato giro. Per Le soldatesse fu complicato. Zurlini era uno che perdeva tempo. Un pezzo l’avevamo girato in Grecia d’estate, e poi abbiamo dovuto rifare tutto in Jugoslavia d’inverno. Con Pasolini è stato difficile soltanto alla fine, quando abbiamo fatto Salò. C’erano certe parti erotiche che i ragazzini non riuscivano a girare. Anche se era cioccolato, qualcuno si rifiutava di fare la scena della merda da mangiare. Proprio non ce la facevano. È stata dura. Pier Paolo non era più sereno. Quando siamo tornati a Roma non era tranquillo. Ma già prima di partire. Era cambiato il giro che frequentava. Una volta gli offriva una pizza, a ’sti ragazzi, e via. Adesso c’avevano la rivoltella. Lui pigliava i ragazzini alla stazione, come uno piglia le puttane, credendo che era uguale. Ma invece era tutto diverso. Visconti stava in villa, capirai. Lui invece andava in certi posti... Erano proprio i posti che erano assurdi. Una volta stavamo in un campo, de notte, credo a Cinecittà. Me guardo ’ntorno, e gli dico: aho, hai visto che so’ sparite le lucciole?
L’arte di Sergio, ovvero Bob Robertson. Se però torniamo un po’ indietro, ancora all’inizio degli anni’60 quando ho fatto la svolta della carriera, allora l’altro incontro fondamentale per me è stato con Sergio. Con lui ho fatto tre film importanti: Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West e C’era una volta in America. Sergio era un ragazzetto magrissimo che faceva l’aiuto con Bonnard. Venne in Spagna dove stavo facendo un film di Berlanga, con Nino Manfredi. Era il ’63, e lui cercava dei soldi dal nostro produttore, l’ex portiere del Real Madrid, che a sua volta si faceva finanziare da un industriale farmaceutico. Gli portò l’idea di un peplum sulle aquile de’ Roma, con i romani e tutto il resto. Però non c’era una lira. Allora, dico: quando torniamo ti telefono e vediamo se trovo qualcuno. E a Roma, lui una sera mi porta a vedere Yojimbo di Kurosawa e mi dice che è un’idea buona per un film da produrre con pochi soldi. Vero, perché si svolgeva tutto in un villaggio. E in Spagna c’erano ancora questi villaggetti già pronti. Così l’ho aiutato a cercare il produttore, ma non avevo certo in mente di farlo io il film, perché non se poteva lavora’ gratis. E comunque avevo in programma il film con Zurlini (e poi gli mandai Dallamano). Insomma, gira gira, troviamo Colombo, che era cugino di mia moglie. All’inizio non ne voleva sape’. Poi intervenne Papi e hanno messo insieme un contratto, in cui ci mettevo anch’io dei soldi, ma per un piccola percentuale, anche se invece ero riuscito a strappare per Sergio il trenta per cento. Stare a Sergio, lui avrebbe accettato cinque, sei milioni una tantum per fare il film. Be’, quando stavo già lavorando per Zurlini, un giorno
viene Giraldi, che aveva fatto l’aiuto di Sergio e che adesso era stato mandato a dare una mano a Zurlini, che proprio non se finiva più. E dice: a Roma sta succedendo un casino, stanno distruggendo il Supercinema, per entrare a vedere il film di Sergio, sai si sono messi tutti i nomi americani: Leone è Bob Robertson, Dallamano è Jack Dalmas, Morricone me pare che è Don Savio. Insomma, era uscito Per un pugno di dollari e c’era la celere davanti al cinema, un successo che la gente non se teneva. Io non ho mai visto una lira da Colombo e Papi. Una volta, dopo molti anni, mi hanno promesso una Mercedes. Mai vista. E neanche Sergio ha mai visto il trenta per cento. O meglio, gliel’hanno dato in un altro modo vent’anni dopo, anzi due anni prima che morisse, con la distribuzione tardiva nel Messico, perché era un film che laggiù non avevano mai voluto. Ma questo gli servì di lezione. Perché per fare Per qualche dollaro in più ha chiesto venticinque, trenta milioni d’allora per la regia e il cinquanta per cento del film. E gliel’hanno dato. Ed è diventato uno abile, coi soldi. Anche se poi non gli bastavano mai per i nuovi progetti, soprattutto negli ultimi anni. Ma lui era veramente una bestia di cinema.
Primi piani coi peli della barba. Per me è paragonabile a John Ford o John Huston. Non badava a spese poi, perché aveva capito che i soldi glieli davano. Lui era capace de ’mbriacare i produttori raccontando l’inizio dei film, quando ancora bisognava scrivere la sceneggiatura. Bino Cicogna gli aveva dato sessanta milioni soltanto per farsi promettere che C’era una volta il West l’avrebbe fatto con lui. Per le immagini Sergio chiedeva cose che erano veramente efficaci. Tutta luce per i campi lunghi, perché voleva far vedere i dettagli a tutto schermo. E poi i primi piani con i singoli peli della barba. In Spagna era impossibile per il caldo, lui voleva le ombre lunghe, che più lunghe non se poteva. E la luce scendeva tardi, si preparava dal mattino e poi se moriva ad aspetta’. Facevo tutto per accontentarlo, fino al possibile. E poi i dettagli, i duelli. Gli occhi. Lui voleva girarli ogni volta che c’era la scena. Io invece gli dicevo che si potevano fare cento metri de’ occhi, sguardo de qua, sguardo dellà, e poi li usavano quando voleva. Macché. E così s’andava sempre per le lunghe. Però poi i suoi film di tre ore e passa volano via. Adesso tre ore di film si sentono. Guarda Tornatore. Che è bravissimo, perché è capace di girare. Ma se gli togli quaranta minuti dall’ultimo film forse non se ne accorge neanche lui.
Effetti speciali: ma di chi è l’immagine? Mi sono divertito molto con Ferreri. Era un genio. Storie di ordinaria follia l’abbiamo girato in America, siamo andati in Georgia, se non mi sbaglio, al mare, ma me sembrava Fiumicino o Fregene. Dico: Marco, ma non potevamo restà llà? Girato in sei settimane, era rapidissimo lui. S’incazzava con tutti, e io l’attizzavo, perché me faceva divertì. Altroché i film sugli storyboard, con gli effetti speciali che risolvono tutto. Almeno, loro credono che risolvono tutto. Perché poi Spielberg, se vuole vincere l’Oscar, deve fare un film vero, mica coi pupazzetti. Deve fa’ E.T, non i dinosauri che saltano. Gli effetti speciali e il digitale non mi piacciono perché non sai più di chi è l’immagine. Di chi è la fotografia? Botti, fuochi artificiali, ma la luce non c’entra niente. E quello che fanno loro però va tutto bene. Mi
avevano chiamato per fare Asterix, con Benigni, ma ho detto di no. E anche lui, ha fatto bene a non farlo. Con Benigni devi far vedere bene la sua faccia, come con tutti i comici. Una fotografia chiara ho fatto, come per le commedie classiche, perché La vita è bella è una commedia anche quando diventa drammatico. Comunque nel cinema del futuro il direttore della fotografia sparirà, secondo me. Anche adesso, se si guarda bene, l’immagine è quella pubblicitaria portata avanti per tutto il film. E non devi inventare più niente. La storia poi non c’è. Anche Tornatore, che invece le storie le ha, usa molto gli effetti speciali, ma per certe cose capisco che si possono usare. Se devi moltiplicare le persone, se devi fare uno scorcio di New York in modo poetico, come fa Tornatore. Che ricorda un po’ Fellini.
Luci sulla canna da pesca. Ecco, invece con Fellini si diceva sempre di fare un film insieme e poi è successo nel peggiore dei modi. Perché dopo una settimana di riprese per Ginger e Fred, Guarnieri non funzionava, almeno per quello che voleva Federico. Prima, Giulietta aveva fatto uno spot con Guarnieri, che venne molto bene, ma con i velatini. E allora Federico pigliò lui. Però non aveva fatto i conti proprio con i suoi velatini. Che per lui era un po’ un vizio. Comunque io non ci volevo andare. Se dovevo fare un film con Fellini, volevo farlo dall’inizio. Federico mi convinse, ma mi son trovato in una situazione un po’ scabrosa. Dovevo illuminare tutta quella scena dello studio televisivo, partendo da cose già fatte, insomma non volevo sbagliare. Era molto preciso Federico, si parlava della fotografia volta per volta. Per La voce della luna abbiamo fatto tutto quel buio notturno, ch’è stato un bel lavoro d’invenzioni: per dire, ancora a proposito della scena con le lucciole, avevo fatto fare delle minuscole lampadine che, appese alle canne da pesca, ballavano davanti alla cinepresa. Fellini pensava a quelle vere. Ma anche lui: non s’era accorto ch’erano sparite per sempre.
22 Il direttore della fotografia era un addetto. Poi, improvvisamente, è diventato qualcuno. Noi montatori non siamo esistiti. Nella storia della democrazia cinematografica, da quando ho smesso io, più di vent’anni fa, esistono soltanto i montatori americani. Quando Vittorio Storaro è l’autore della luce, lo sanno tutti. Ma nessuno ricorda – e non parlo soltanto degli spettatori, ma anche dei critici – Franco Fraticelli, Adriana Novelli, Otello Colangeli, Alberto Gallitti, oppure Dolores Tamburini, Mario Serandrei, Franco Arcalli, Gisa Radicchi Levi, Gabriele Varriale, Ornella Micheli, Nino Baragli. Forse si conosce Ruggero Mastroianni, ma il suo cognome aveva le ali. Però capisco il perché: la nostra arte è invisibile. La luce si vede, è come la pelle di un corpo. Il montaggio è il cuore. Bisogna aprirlo un film, guardarci dentro, per vedere come batte. Un’operazione a cuore aperto: chi la sa fare? Prometto a me stessa di non lasciarmi andare a queste stupide recriminazioni, ma ogni tanto cedo. Possiedo una storia del cinema italiano, in cui non c’è il nome di un solo montatore. Eppure, quante volte ho fissato io le sequenze, la scelta dei campi, spostavo sospiri e urla, tagliavo strade medievali con la bicicletta sullo sfondo, aggiungevo o sottraevo un tempo a un viso modificando l’intensità della rabbia o della meraviglia. Chi lo sapeva? Il problema è dato dall’ignoranza e dal lassismo. Quando una monografia cita il cast, trovi sceneggiatori, fotografo, musicista, produttore, poi un taglio e si passa agli interpreti. I registi non se la sentono di presentarsi così: “Non avrei fatto questo film senza il mio montatore.” Essere autori è una professione, oggi ancora di più. Lo richiede il narcisismo, e lo pretende il marketing. E i critici, poi... I giornalisti non conoscono quasi mai la storia del film, e pochi critici sanno leggere il montaggio. I critici, del resto, per molto tempo, non sono riuscita a capirli: trovavo inafferrabile, quasi buffa l’esistenza di uno spettatore di professione. È stato mio marito ad avvicinarmi al concetto di critica cinematografica proponendomi di rileggere “Il personaggio uomo” di Giacomo Debenedetti, sostituendo la parola “film” alla parola “romanzo” e la parola “cinema” a quella “letteratura”. Fu una magia: compresi la responsabilità dell’interpretazione, la materia e la costanza del dialogo con la storia e il destino nel lavoro della critica. Con la responsabilità sociale del critico compresi l’importanza della tavola dei giudizi come un divertente esercizio di relazione con il mondo e con gli uomini.
MORANDO MORANDINI Non sono che un critico Credo di essere un critico anomalo. È vero che sono stato principalmente un critico di quotidiano. Cominciai a farlo su “L’Ordine”, un quotidiano cattolico di Como, nel 1946, sia pure come numero due, in supporto al titolare Bice Scolari, professoressa e latinista insigne, ma mi capitò di recensire, tra molti altri, Paisà di Rossellini e L’orgoglio degli Amberson di Orson Welles. A rileggermi oggi provo tenerezza, ma avevo ventidue anni e alle spalle il buco nero della guerra, ventidue mesi in cui vidi non più di due o tre film (tedeschi e in tedesco) e lessi non più di una dozzina di libri. Perciò ho il diritto di dire, citando Aden Arabia, che non permetto a nessuno di dire che i vent’anni sono la più bella età della vita.
Ritagli e dettagli. Mi dispiace, ma non ricordo il mio primo film e nemmeno quel che provai. Nato a Milano, dai cinque ai dieci anni ho abitato a Monte Olimpino, una frazione di Como sulla strada per Ponte Chiasso. Allora, non c’era niente. I miei pochi ricordi sono legati soprattutto alla vita di campagna, ai giochi, ai libri. Non ricordo nemmeno l’anno dei miei primi film. Introverso com’ero, anche a causa della balbuzie, ero un lettore vorace, tanto da diventare presto miope, anche perché, data la disciplina di mia madre, leggevo a letto, di nascosto, con una lampada tascabile sotto le lenzuola. Viaggiavo. Evadevo, forse. Mi divertivo nel senso più ampio della parola. Però ricordo bene il primo film che vidi a Milano, nella grande e sfarzosa sala dell’Odeon. Ero con mia madre e il film era È arrivata la felicità, con Gary Cooper, nel 1938, credo. Per me era già un film di Frank Capra, non soltanto di Gary Cooper. Ero, comunque, già appassionato di cinema, visto che a 12, 13 anni, tra il 1936 e il ’37, cominciai a ritagliare e incollare su un quadernone le recensioni di f.s. (come si siglava Filippo Sacchi) sul “Corriere della Sera” e a meravigliare le amiche di mia madre perché conoscevo a memoria i nomi delle attrici e degli attori. Quando avevo dieci anni ci trasferimmo a Como, e lì la frequenza al cinematografo (ma anche a teatro) aumentò. Di giorno ci andavo da solo, soprattutto al cinema Moderno, che faceva il doppio programma a un prezzo inferiore rispetto ai locali di prima visione; di sera, più raramente, con mia madre, quando c’era qualche film che l’attirava. Cinema italiano, poco. Ricordo Cavalleria rusticana (del ’39, a 15 anni) di Palermi perché fu il primo film che vidi con gli occhiali (una rinascita), e la fotografia in bianco e nero di Massimo Terzano mi colpì per il suo splendore (per ricordarmi il nome di Terzano ho dovuto consultare me stesso sul Morandini). Ricordo i primi film di Soldati, di cui mi piacque molto Tragica notte, e quelli di Castellani, Poggioli, qualche Camerini e Blasetti: Sissignora mi garbò assai per la finezza del suo populismo. E ricordo anche Uomini sul fondo, il film di Francesco De Robertis sul recupero dei marinai di un sommergibile incagliato, che mi diede una forte emozione. Probabilmente, influenzato dalle prime letture critiche, ero già orientato verso il neorealismo. Riuscii persino a vedere, anche se non ricordo dove, Ossessione, che m’impressionò per la sua dimensione francese, perché tra i quindici e i vent’anni furono proprio i film francesi e hollywoodiani a darmi le prime vere emozioni. I miei idoli di quel
periodo erano Jean Gabin e Gary Cooper.
Vice di Biagi. Nella mia vita, dicevo, c’è una cesura violenta, dall’autunno del ’43 all’autunno del ’45. Come se fossi passato di colpo da adolescente ad adulto. In quei due anni, fra l’altro, maturò la mia educazione democratica e antifascista. Nel dicembre del ’45, a 21 anni, cominciai a fare il giornalista all’“Ordine”. E mi mantenevo. Mia madre morì nel 1942, mio padre tornò dalla prigionia in India nel 1946. Il critico a tempo pieno incominciai però a farlo nel 1952 su “La Notte”, e nei primi nove mesi ero il Vice (firmavo così) di Enzo Biagi. In quel periodo firmai molti più film di lui. Tempo pieno, si fa per dire: facevo anche il caposervizio degli spettacoli e il critico del teatro di rivista (e talvolta, come Vice, quello teatrale). A proposito: su “L’Ordine” siglavo (m.m.) le recensioni e mettevo già le stellette di critica. È quasi un peccato originale.
I bambini non sognano di fare i critici. Come sento oggi quegli anni ’50 a “La Notte”, e che cosa provo? Potrei cominciare con i rimorsi. Lavoravo tanto – e con un furore tutt’altro che astratto – che inevitabilmente passavo troppo poco tempo con i miei figli – tutti e tre nati in quel decennio – e scaricavo tutte le fatiche e le incombenze della famiglia su Laura. È vero che, a cavallo tra i ’50 e i ’60, si andava tutti e cinque al Lido per la Mostra di Venezia, e che i bambini si divertivano assai sulla spiaggia, ma quasi sempre non ero con loro per ovvi motivi. Ricordo un anno in cui c’era una retrospettiva di Buster Keaton, e cercai di portarci Lia e Luisa. Non ci riuscii: tutte le proiezioni della Mostra erano vietate ai minori perché, almeno in teoria, erano tutti film senza visto di circolazione. Ma se si passa dagli inutili rimpianti a considerazioni meno private, posso dire che fin dagli inizi ero consapevole di alcuni principi: 1) nessun bambino ha mai sognato di fare da grande il critico di cinema o d’altro. Avevo 14 o 15 anni quando lessi il mio primo libro sul cinema: Come si scrive un film. Era un regalo di mia madre con questa dedica: “A Morando che non vuole diventare regista”. 2) Il nostro è un mestiere che si occupa del tempo libero degli altri. Strano, no? Pensiamo ai figli piccoli. Gli domandano: dov’è il papà? Rispondono: è uscito, è andato a lavorare, a vedere un film. C’è una tale confusione tra lavoro e divertimento (tempo libero) che, a lungo andare, può ingenerare squilibri, fraintendimenti, una sorta di schizofrenia. 3) Ho sempre cercato di non prendere troppo sul serio il mio lavoro, cioè di fare autocritica. Non a caso ho intitolato un mio libretto con una frase di lago: Non sono che un critico. Non a caso il saggio di apertura s’intitola “Il critico come eunuco e parassita”. E qui si potrebbe riaprire il vano capitolo dei rimpianti: essermi impegnato troppo nel mio lavoro giornalistico di critico quotidiano; non aver lasciato un margine più ampio all’approfondimento, alla riflessione, a cimenti più creativi. Narrativi, perché no?
La vita contro un muro.
Ho cominciato definendomi anomalo come critico. Mi spiego. Critico quotidiano, d’accordo, ma sono uno dei rari casi di quotidianista che ha scritto per settimanali, mensili, trimestrali, annuari. Per dieci anni (1965-75) ho fatto su “Il Giorno” il critico tv. Ho partecipato alla stesura di una Storia del cinema con Fofi e Volpi. Ho fatto il non attore in una parte vera e propria di Prima della rivoluzione (21 giorni su un set non sono pochi). Ho accanitamente rifiutato di raccogliere recensioni in volume e, come per contrappasso – o risarcimento – sono passato da critico quotidiano a critico annuale per il Dizionario dei film. Ho diretto a lungo un festival (1984-1994, poi nel 2002), sia pure il più povero e marginale, “Anteprima”, rassegna del cinema indipendente di Bellaria. Critico a tutto campo, insomma. Talvolta, però, sospetto di aver passato la vita contro un muro, voltando le spalle alla realtà.
Passaggi. Mi sono fatto l’idea che i momenti cruciali del cinema italiano dopo il 1945 sono tre. Il primo: il neorealismo del dopoguerra, ma con o senza “neo” un’accentuazione realistica è rilevabile in quegli anni anche in diversi altri paesi (Gran Bretagna, Giappone), Hollywood inclusa. Conseguenze della guerra, credo. Il secondo: gli anni ’60, quelli delle “nouvelles vagues”. In Italia non ci fu come movimento, ma la fioritura di nuovi talenti fu eccezionale. Inutile fare i nomi, no? Anche se ce ne accorgemmo in ritardo, fu il periodo in cui il cinema italiano divenne il secondo del mondo (occidentale, almeno): commedia, spaghetti o tortilla western, storico-mitologico, horror ecc. Si producevano 200-250 film all’anno, e se ne esportavano molti. Il terzo: il fenomeno dei “cantautori” a cavallo tra i ’70 e gli ’80, che coincise o seguì alla fine o alla trasformazione della cosiddetta commedia all’italiana. Chiamo così i nuovi autori/attori: Moretti, Nichetti, Nuti, Troisi, Verdone ecc. Sembra curioso, ma non lo è: fu in quel periodo - sebbene fosse iniziato negli anni ’70 – che avvenne e si diffuse il nefasto sopravvento del cinema d’autore in Italia, quello che nei titoli di testa (ormai è una moda) si esplica col cartello: “un film di...” anche per registi esordienti, appena usciti dal Centro, presuntuosi e arroganti, incapaci di scrivere una sceneggiatura, senza un bagaglio tecnico alle spalle, ma tutti dediti alla mdp (macchina da presa) e ignoranti dei mdp (modi di produzione). Appartengo a una generazione di critici che fece e vinse la battaglia per il regista; e mi ritrovo da vent’anni, ormai entrato nell’alta età, a fare, senza vincerla, una mia piccola e personale battaglia contro il cinema d’autore all’italiana, contro i tanti che si credettero e fin dall’inizio si credono Bertolucci o Bellocchio. È anche vero che poi mi contraddico perché da tre o quattro stagioni sostengo che ogni anno si fanno da noi una decina di film di registi esordienti o, comunque, giovani che per motivi diversi vale la pena di vedere. Nella maggior parte, però, sono “invisibili” e, tolti rari casi, non sono nemmeno premiati, com’è successo nel 2002 a Santa Maradona, Tornando a casa, L’uomo in più e Respiro.
Realismo rosso, neorealismo rosa. Pensando ai film popolari del dopoguerra, si potrebbe incominciare dagli anni ’50 con la serie di Don Camillo e Peppone e con quella di Pane, amore.... Come recensore, iniziai con Il ritorno di Don Camillo (1953). Sono andato a rileggermi e ho trovato un passaggio
interessante: “Il mondo piccolo di Guareschi non ha ancora trovato, nella critica italiana, il suo esegeta; ed è un’altra prova dell’accademismo in cui è insabbiata la nostra cultura, ma rimaniamo ancora dell’opinione che nel passaggio dalla pagina alla pellicola quelle che sono le doti positive di Guareschi narratore si sbiadiscano e che, invece, affiorino quelle negative.” Non mi sembra un’annotazione da critico di sinistra allineato. Nel recensire il terzo film, Don Camillo e l’onorevole Peppone (1955) ribadivo che il suo vero autore era Guareschi, rischiando di fare il signor di La Palisse. Oggi, però col senno di poi, si deve constatare che quella serie era ben legata all’attualità socio-politica del paese e che il successo popolare si spiegava anche con questo rispecchiamento. Si potrebbe fare un discorso analogo per Pane amore e fantasia, ecc. e su quello che fu chiamato il neorealismo rosa. A essere maligni, sarebbe da domandarsi se in quell’aggettivo cromatico non fosse sottinteso che il vero realismo era e doveva essere rosso. Ma in fondo che cosa erano i film del neorealismo rosa? Commedie. E qui parte il discorso sulla svalutazione preconcetta della commedia rispetto al dramma, svalutazione che fu superata – ma in ritardo e col senno di poi – soltanto nei riguardi della “commedia all’italiana” degli anni ’60, una grande stagione, sempre col senno di poi. Nemmeno io mi sottrassi a quella svalutazione nei primi anni ’60, anche se, chiamato a risponderne in tribunale, potrei affidarmi all’alibi inoppugnabile della mia esclusione dalla critica quotidiana dal 1963 in poi.
Alla larga dai registi. Durante il mio decennio di critico tv ebbi modo di frequentare Vittorio Cottafavi, un vero signore, nel senso che si dava un tempo alla parola (figura rara tra i registi, almeno in base alla mia esperienza personale, quella del signore). Si parlò molto insieme della differenza tra cinema e tv, anche a livello di scrittura: sintetica nel cinema, analitica in tv a causa dei differenti modi di percezione (grande, piccolo). Se ne avessi i mezzi e il potere, organizzerei una retrospettiva a lui dedicata, scegliendo il meglio dei due mezzi. Lo merita. Un altro regista con cui ebbi, sia pure in tempi scaglionati, un rapporto (anche epistolare) amicale fu Zurlini che era un toro aggressivo fuori, e un uomo assai vulnerabile e delicato dentro. Sosteneva, almeno in privato con me, che i due critici che apprezzava di più erano Kezich e il sottoscritto. Un giorno del 1972, lo incrocio a Roma in piazza del Popolo (quando il caffè Rosati era ancora un punto di incontro per scrittori e cineasti) e, senza nemmeno salutarmi, mi fa: “Quanto aspetti a mettere il mio film tra i consigliati?” Scrivevo di cinema sul settimanale “Tempo” dove, in fondo alla mia rubrica, c’era un boxino con “Li consigliamo” e “Li sconsigliamo”; nel 1971 sconsigliai Scipione detto anche l’Africano. Turi Vasile, il produttore, ci querelò e in primo grado fummo condannati (editore, direttore e io). Finii sulla prima pagina del “Corriere della Sera” con un articolo di Pansa. Sul “Giornale dello Spettacolo” mi chiamarono per mesi lo sconsigliori. Fummo assolti in appello. Secondo la prima sentenza, il mio torto era “di non aver motivato lo sconsiglio”. Infatti, non l’avevo recensito. Ovviamente ebbi rapporti più stretti e frequenti con i registi residenti a Milano: Olmi (credo di essere il primo critico in assoluto a vedere Il tempo si è fermato), Bozzetto, Nichetti, Soldini anche se, in fondo, si è parlato poco del cinema, quasi nulla. Tirate le somme, l’unico regista con cui ho un vero rapporto è Luigi Faccini, anche perché in questi ultimi anni passo molto tempo a Lerici, suo
paese natale, e, lui, non riuscendo a fare i film che ha in mente, lavora molto sul territorio con iniziative varie e si è messo a scrivere. Curiosamente ha, come temperamento, più di un punto di contatto con Zurlini. Generally speaking, comunque, ritengo che un critico non debba avere rapporti personali con gli autori. Meno ne ha, meglio è. È più libero, meno influenzabile. Il problema non è quello di scrivere quello che pensi del lavoro altrui; l’ho risolto ogni volta, quando avevo da dissentire (da “criticare”), esprimendo le riserve in modo gentile e sfumato. Il vero problema, quando conosci bene l’autore, è di scambiare le intenzioni per risultati. Nel mio libretto Non sono che un critico ho già affrontato questo tema. Il fatto di vivere a Milano (di essere un “critico di frontiera”, come talvolta dicono anche in pubblico e con un pizzico di polemica) e non a Roma ha i suoi vantaggi.
Critico politeista. Tra viscontiani e felliniani mi situavo fuori dalla mischia, ma non sopra. Non credo di aver mai fatto parte di schieramenti, né nel senso triviale (giornalistico), né in quello astratto (teorico) della parola. Un buon critico è un politeista. È la risposta che davo già da giovane quando mi si domandava: ma come fai a farti piacere Clouzot e Bresson insieme? (C’è stato un periodo, a cavallo tra i ’50 e i ’60, in cui mi definirono “il più francese dei critici italiani”. Etichetta immeritata, secondo me, e a doppiotaglio.) Mi “sono fatto piacere” Rossellini e Visconti, Antonioni e Fellini. E allora? Felliniani e viscontiani si diedero battaglia a Venezia nel 1954 quando un’inconsulta giuria interna spiazzò gli uni e gli altri col Leone d’Oro a Castellani per Giulietta e Romeo. Senso e La strada. sono film incomparabili, ma in ogni modo in quell’occasione preferii il primo, misi l’accento sull’importanza del primo. Quando, tempo dopo, Senso uscì a Milano, gli diedi cinque stellette alla fine di una lunga recensione che, riletta oggi, mi soddisfa ancora e che, tra l’altro, mi procurò una bella lettera di Visconti. Ma non sono mai stato un viscontiano di stretta osservanza. Durante il mio decennio televisivo sul “Giorno”, chiusi la recensione a Morte a Venezia, scritta per il settimanale “Tempo”, con una frase perfida: “Gli ultimi film di Visconti assomigliano agli ultimi spettacoli teatrali di Strehler.” Ludwig, invece... Bellissimo nei suoi eccessi, e così sincero. Curiosamente sono diventato felliniano da Casanova in poi. Agli storici, ai sociologi ecc. che tra 50 anni o un secolo studieranno la società italiana dell’ultimo ’900, il cinema di Fellini servirà meglio di tanti libri e inchieste. Con chi sto oggi? Martone e Soldini mi sembrano i più dotati della generazione nata tra gli anni ’50 e ’60. Nonostante gli ultimi insuccessi, continuo a credere che tra i cantautori della commedia, i “malinconici” postmoderni, Nichetti sia il più inventivo a livello registico, quello che rischia di più sia nell’affabulazione sia nella scrittura. Oggi mi interessa assai il fenomeno del cinema che si fa “lontano da Roma”, fenomeno che avevo visto nascere a poco a poco ed emergere dall’osservatorio di “Anteprima” di Bellaria, dal 1984 alla fine degli anni ’90. Parlo dei napoletani (oltre a Martone, Capuano, Sorrentino, Marra, De Lillo, Di Majo), dei siciliani (Emanuele Crialese, Scimeca, Ciprì e Maresco, Roberta Torre), dei pugliesi (Winspeare, Pozzessere, Alessandro Piva), dei piemontesi (Tonino De Bernardi, Daniele Segre, Pier Giorgio Gay, Guido Chiesa, Tavarelli), dei lombardi (Bigoni, Maderna), dell’“argentino” Marco Bechis.
Vita da giornalista. Dalla fine del ’52 al settembre 1961, dunque, faccio il critico quotidianista su “La Notte”. Poi passo a “Stasera”, quotidiano di sinistra, scandalizzando Aristarco e qualche suo allievo di “Cinema Nuovo” (ma come? Uno che apprezza Samuel Fuller viene assunto a sinistra!). “Stasera” dura meno di un anno, e mi trovo disoccupato, a fare il “freelance”, per due anni e mezzo. Con tre figli da mantenere. Con due liquidazioni a breve distanza, d’accordo, in parte investite per comprare un appartamento per mio padre, che si risposa. Nella primavera del ’65 entro al “Giorno”, ma dal 1966 al 1975 faccio la critica televisiva, pur continuando ad avere una rubrica di cinema su settimanali e a recensire sul mio quotidiano qualche film trascurato da Pietro Bianchi, come vice. Si usava ancora. Come caposervizio e titolare a “La Notte” fui il primo in Italia a far firmare con la sigla i miei vice: Giampiero Dell’Acqua, Guido Gerosa, Valentino De Carlo e altri più effimeri. Insomma, lavoravo in modo esagerato, e non avevo modo né tempo di cimentarmi con i temi teorici. Pur arricchendomi per certi versi, il decennio televisivo mi taglia fuori da Venezia, Pesaro (il che è più grave), e dagli altri festival. In compenso, frequento il Prix Italia di tv. Nel 1975 Bianchi si ammala e per un anno faccio contemporaneamente critica di cinema e di tv. Quando nel settembre 1976 Bianchi muore, Afeltra mi chiama e mi chiede di scegliere. Scelgo il cinema, e, avendo già capito e previsto l’importanza della tv, Afeltra scuote la testa, sottintendendo che non avevo capito nulla, io.
Generi e critica nel cinema italiano. Nascono le stellette. Ebbi naturalmente i miei rapporti negli anni ’60 con i generi e il cinema popolare. Nel 1964, ancora libero disoccupato alle prese con le collaborazioni, a Roma Bernardo B. mi chiede di andare a vedere con lui Per un pugno di dollari. Poche settimane dopo pubblico su un settimanale (“Le Ore”, se non sbaglio) un’intervista con Leone, corredata di una mini inchiesta sul western italiano, anzi europeo. Non posso giurarlo, ma fu forse il primo articolo un po’ serio sull’argomento apparso in Italia. Avevo già scoperto Cottafavi con Traviata ’53, e non mi fu difficile vedere i suoi primi film mitologici, soprattutto Ercole alla conquista di Atlantide (1961). Ma furono approcci quasi casuali, isolati, legati al nome di un regista, cioè, in fondo, a un cinema d’autore. Così fu per l’horror con Freda di cui vidi e apprezzai moderatamente I vampiri (1957) e L’orribile segreto del dottor Hitchcock (1962). Ma anche qui bisogna tener conto di una circostanza che i critici delle generazioni successive trascurano: negli anni ’60 si producevano in Italia 200-250 film all’anno: com’era possibile che un quotidianista potesse seguire tutto per trovare le perle tra la spazzatura mercantile? Senza dire che, in quell’epoca, degli incassi ci si infischiava e che, in questo campo, l’informazione era per quantità il decimo di quella attuale. Su “La Notte”, un anno dopo la nascita, alle stellette della critica (proposte da me a Nino Nutrizio) furono aggiunte le palline del successo di pubblico. Ecco perché. Esce Il ritorno di Don Camillo (1953). Lo recensisco e gli do 2 stellette (da 1 a 4, la quinta fu introdotta tempo dopo). Rizzoli telefona a Nutrizio per lamentarsene: soltanto 2 stellette al campione d’incassi dell’anno? Nutrizio mi convoca. Un qualsiasi altro direttore mi avrebbe chiesto di dargliene 3. Lui, invece: cosa facciamo? Gli rispondo: aggiungiamo un segno grafico per indicare il successo di pubblico. Detto, fatto. E il don Camillo ebbe due stellette e quattro palline.
Attore per Bertolucci. Nella primavera del 1963, col tramite di Gianni Amico che allora dirigeva il festival ligure dell’America Latina (frequentato anche da me, perché ero un libero disoccupato, ed ero andato due volte, nel ’61 e nel ’63, al Festival di Mar del Plata), incontro Bernardo Bertolucci e Adriana Asti. Improvvisa simpatia reciproca. Mi dà da leggere la sceneggiatura di Prima della rivoluzione. Era la prima volta che leggevo la sceneggiatura di un film da fare. Passano i mesi e in settembre Gianni mi telefona da Parma (alla fine della prima settimana di riprese del film) per dirmi se mi era possibile recarmi a Parma perché Bertolucci voleva parlarmi. D’accordo, vengo. A cena Bertolucci mi domanda se ho letto la sceneggiatura. L’avevo letta. Vuoi fare la parte di Cesare? D’accordo, OK. E lui si arrabbia o finge di arrabbiarsi: ma come? Ti propongo di fare l’attore e, senza nemmeno chiedere una pausa di riflessione, rispondi che sei d’accordo. Sto allo scherzo e gli espongo la mia teoria sugli attori presi dalla strada: se funzionano, il merito è del regista; altrimenti, sua è la colpa. Avevo già visto La comare secca. E l’avevo recensita con questo titolo: “Bertolucci è soltanto bravo?” (su “Le Ore”). Il film andò alla Semaine de la Critique di Cannes dove qualcuno mi soprannominò “il ragazzo della valigia” (per la sequenza lunga in cui accompagno in stazione Adriana Asti, portandole la valigia). Due o tre anni dopo qualcuno mi riferì che Bertolucci aveva offerto la parte, prima che a me, a Cesare Garboli che conosceva attraverso suo padre. All’ultimo momento si era ritirato. Anni dopo ancora ne parlai con Bertolucci che si trincerò dietro un diplomatico “non ricordo”. (Da Cannes riportai un portacenere con una dedica a pennarello di Bertolucci a “Little Caesar”. A proposito dell’ultimo libro di Bocca.)
Prima e dopo la rivoluzione. Il ’68? Ero troppo vecchio per farlo e avevo figli troppo piccoli perché lo facessero. Sono convinto, e l’ho scritto più di una volta, che gli anni ’60 siano il decennio più fecondo di novità stilistiche nella storia del cinema insieme con quello degli anni ’20. Dopo l’attentato alla Banca dell’Agricoltura nacque a Milano un Comitato dei Giornalisti Democratici che per due o tre anni pubblicò il BCD (Bollettino di Controinformazione Democratica) al quale collaboravano Guido Nozzoli, Dell’Acqua, Marco Nozza, Stajano e tanti altri. In pratica aveva come redazione via Tasso 14, il mio indirizzo, ma il mio contributo era minimo poiché non mi occupavo di politica né di cronaca.
Il film, opera collettiva. Sono debole in teoria, sono un critico empirico, quello che un tempo veniva classificato, con una punta di dispregio, “critico di gusto”. Non me ne vanto, lo constato e mi accetto come sono. Non credo di essere impermeabile né all’autocritica né alla revisione critica e cerco di essere aperto e disponibile al nuovo. In linea generale, e qui parlo soprattutto del cinema italiano, diffido della linea “orfica” e prediligo quella narrativa. In fondo, considero quello del regista un mestiere così come credo siano mestieri quelli del romanziere, del musicista (compositore o esecutore), del pittore, dell’architetto ecc. Mestieri artistici, ma mestieri,
anche quello del poeta che pure esigerebbe un discorso a parte. Handwerk, in tedesco. Che in rari casi il mestiere coincida con l’arte, lo decidono i posteri. Allo stesso modo ritengo che, come critico, privilegiando la macchina da presa a scapito dei modi di produzione, si rischiano di prendere molti abbagli. Non bisogna mai dimenticare che un film è il frutto di un’operazione collettiva. Altrimenti non si spiega come mai registi medi o mediocri azzecchino, una o due volte nella loro carriera, un film riuscito, felice, risolto.
23 In una giornata che sembrava declinare nel consueto dilemma della tisana adatta, la visita di mio nipote ha dato smalto alla sera. Ha portato con sé un libro, una conversazione con Walter Murch, il montatore di Apocalypse Now. Dice che sembra scritta per me. Si muove in casa, apre e chiude sportelli, si prepara una spremuta, va in studio a cercare qualcosa. Tace, e poi improvvisamente torna ad abitare il mio silenzio. Dalla poltroncina del salotto – il mio scafandro – i rumori nelle altre stanze mi consolano. La sua voce per me è un dono: “Murch è un grande, nonna! Ha vinto due premi Oscar come montatore e ha scritto dei racconti. Leggi la quarta di copertina. L’hanno scritta pensando a te.” Vado in camera da letto a prendere gli occhiali. Attraversando il corridoio sento il profumo delle arance pressate. Ormai ci vuole la luce della lampada per leggere: “Un percorso nel mondo della creatività cinematografica e letteraria, dove l’arte del montaggio e della scrittura si fondono per dare sostanza alle emozioni.” Sembra scritto per me? Forse. Senza dubbio, mi spinge a interrogarmi sul rapporto tra letteratura e cinema. Il mio personale passaggio dalla forbice alla penna è stato in qualche modo causato anche dalla guerra? Io sono cresciuta tra persone che continuavano a raccontare storie e queste storie continuavano a girare, trasmesse dal cinema e in minima parte dalla letteratura. Forse la facevano gli sceneggiatori, la letteratura italiana. Sto esagerando. Sono certa però che il cinema italiano ha raccontato le latterie e il prezzo del pane, il coraggio e la vigliaccheria degli impiegati, la Resistenza e la fuga, la diffusione della Vespa e l’arrivo del plexiglas e del mangiadischi, la speculazione edilizia e la diffusione della mafia. Sento di potermi affidare a quel cinema come persona e come progetto, come radice e come fallimento. Filippo esce sbattendo la porta, portandosi via la mia breve felicità. Provo il desiderio profondo di parlare con qualcuno, degli slanci del cinema e del contegno della letteratura, della fiducia nel domani e della fatica di crescere come popolo. Restandomi soltanto i libri, raggiungo lo studio. Luigi Malerba, tra gli scrittori che hanno lavorato per il cinema, è forse l’unico che, descrivendo la sua esperienza, è riuscito a raccontare l’avventura collettiva di una generazione di artisti e intellettuali italiani. Da Città e dintorni, leggo parole che alimentano il mio umore: “L’odore di zolfo continuava a molestare le narici ufficiali, con i film di Rosi, Petri, Lizzani, Pontecorvo...”.
LUIGI MALERBA Cronaca di uno scrittore Uno scrittore al cinema fa esperienza di frustrazione. Grande frustrazione. Credo di aver partecipato a una cinquantina di sceneggiature. Uno scrive una storia immaginando il paesaggio, la faccia del protagonista, gli ambienti. Quando il film è fatto non c’è niente che corrisponda. Lo scrittore è l’unica persona che non riconosce il film. Voglio dire che non riesce a identificarsi. Perché quando scrive pensa a un insieme, alle emozioni, agli intrecci, ai personaggi concreti. Poi, quando andavo alle proiezioni, non riconoscevo né i personaggi né i paesaggi, mentre gli altri non avevano questa sensazione di scompenso. Tra gli scrittori arruolati al cinema conoscevo bene solo Flaiano. Ugo Pirro anche, ma lui era già uno sceneggiatore professionista. Alberto Moravia, be’ come sceneggiatore... preferiva vendere bene i suoi romanzi. Tonino Guerra aveva già pubblicato un libro, quando diventò sceneggiatore. Mi sono sempre trovato bene con Tonino. Basta. Non vedo questo grande rapporto tra scrittori e cinema italiano. Alcuni registi avevano una notevole capacità di prelevare dalla letteratura italiana storie che diventavano ottimi film. Per tutti, Visconti. Ma questo è un altro discorso.
Un cavallo per Rascel. All’inizio c’era un po’ di confusione giovanile sul mio destino da scrittore. Cinema o letteratura? Già prima di laurearmi in giurisprudenza ero diventato direttore di “Sequenze”, la rivista di cinema. Non avevo ancora 21 anni e non potevo firmare legalmente come direttore responsabile. Mi divertivo molto, ma sentivo che non era la mia strada definitiva. Mi sono trasferito a Roma nel 1950. Per una serie di combinazioni, attraverso Luigi Bartolini, ho conosciuto Alberto Lattuada. La prima sceneggiatura era con Flaiano, per un film che non fu mai realizzato: Servizio sensazionale, una storia ambientata all’Eur. Poi ho lavorato alla sceneggiatura di Anna, il melodramma di Lattuada con Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Un certo numero di copie porta anche il mio nome. Ero giovane e poco pratico. Ero stato ammesso dalla porta di servizio. Ma non ho mai capito perché il mio nome non dovesse comparire, né me ne sono più occupato. Per me era un film commerciale e forse una parentesi, credevo. Mi sono accorto dopo, invece, che l’incontro con Flaiano per me è stato determinante. Fu Ennio a raccomandarmi a Bompiani quando decisi di pubblicare i miei primi racconti. Siamo rimasti amici, con Ennio, ma non c’era una frequentazione assidua. Lattuada mi richiamò per Il cappotto. E lì trovai Zavattini, una celebrità. Ho avuto un ruolo considerevole nella stesura, anzi direi importante, nonostante le sei, sette firme ufficiali nei titoli di testa. Sinisgalli veniva lì, fumava molte sigarette, ma esprimeva poche idee, forse nessuna. Un uomo intelligentissimo, intendiamoci, ma negato per il cinema. La cosa curiosa era la mia tendenza zavattiniana. Un’idea che impressionò De Laurentiis e Ponti è la scena del cavallo, quando Renato Rascel, infreddolito, si guarda intorno e allunga le mani per scaldarle al vapore delle narici dell’animale. E poi l’idea dell’eco durante il discorso, per confondere le parole. Zavattini era sconcertato. Dicevo cose più zavattiniane di lui. Siamo diventati amici,
poi. Sul momento non è stato facile. Zavattini, che pensava al protagonista, si lasciava andare a cose un po’ troppo “rasceliane”, i coriandoli, o certi giochini da rivista. Cose poi abbandonate, per fortuna, per dar vita a un film solido e ben inventato. Il lavoro per il cinema ha aiutato il mio lavoro per la letteratura, se pensiamo al montaggio. Quando si lavora a uno script ci si divide per blocchi o per personaggi. E poi tutto confluisce nell’assemblaggio. Siccome si parte sempre da un soggetto, lavori alla sceneggiatura conoscendo più o meno il finale. A me invece succede spesso di partire a scrivere un libro dal finale. Così il resto diventa un viaggio, un percorso, verso una meta che conosco o che credo di conoscere. Perché posso arrivare a un approdo diverso.
Super-corte-d’autore. Il cinema era un veicolo di denaro, per un giovane scrittore. Da quando il mio lavoro di romanziere diventa stabile ho il rammarico di aver rinunciato alla collaborazione di film importanti. In alcuni casi ti chiedevano un anno d’impegno. E io non potevo. Una volta mi chiamò Antonioni. Io accettai subito. Ma poi mi disse: andiamo un paio di mesi in Sardegna, pensiamo al soggetto, vediamo che cosa succede, e poi bisognava prevedere altri quattro, cinque mesi per la sceneggiatura. Non era possibile. Io, per un film, non mi sono mai impegnato più di due o tre mesi al massimo. Sono rapido a scrivere. E i soldi, con Antonioni, non erano tantissimi, più o meno quelli per i film comici con Tognazzi, Gassman o Manfredi. L’unica differenza era che per Tognazzi ci mettevi due mesi e per Antonioni un anno. E poi, quando veniva pubblicata da Einaudi la sceneggiatura di un film di Antonioni, vedevi il suo nome e, in piccolo, in fondo, Tonino Guerra, che magari aveva fatto più di Antonioni. Non mi andava di partecipare a quella piccola corte che ogni regista importante voleva avere intorno per distillare ogni tanto delle idee nel corso di settimane e settimane di frequentazione. Ho così rinunciato a film importanti e accettato le offerte di Festa Campanile o Franco Indovina, lavori professionali, che facevo seriamente e rapidamente. Nel ’63 ho pubblicato il mio primo libro, La scoperta dell’alfabeto, e avevo per fortuna le spalle coperte da un’altra attività. Nei primi anni ’60 si fece sentire la crisi del cinema. Io avevo fondato una società per realizzare film pubblicitari. Lavoravo con le grandi aziende commerciali. Le caramelle Dufour, per esempio. Con Buscaglione ho fatto uno short sulla pasticca del Re Sole. Qualche Supercortemaggiore, la benzina, per Carosello. Più che per la tv eravamo specializzati in pubblicità per il cinema.
Lista nera. A quel tempo Andreotti, sottosegretario allo spettacolo, pesava sul cinema. C’era una lista nera. Io ero dentro. So anche chi aveva l’incarico di suggerire i nomi, due spioni che non vorrei nominare, uno è morto e l’altro è vecchissimo. A un certo punto c’era una parola d’ordine: che il cinema diventi leggero, così evitiamo di mostrare i problemi veri, “i panni sporchi”. Il governo italiano è stato ostile agli autori. Film come quelli di Rosi, Lizzani e poi Petri e Pontecorvo avevano la vita difficile. Io ero amico di Zavattini. Ero segnato come comunista. In realtà votavo per Nenni. Una volta stavo lavorando a una sceneggiatura
importante, da La colonna infame di Manzoni. Mi chiama il produttore, Goffredo Lombardo: lasciamo perdere, dice, non è un film gradito. Sapevo che cosa intendeva, che ero io non gradito. Ho dovuto troncare la collaborazione. Se eri malvisto dalla Titanus non lavoravi più. È stato un periodo nero. Nella seconda metà degli anni ’60 ho ripreso con Pasqualino Festa Campanile, e abbiamo fatto Adulterio all’italiana, La ragazza e il generale e altri. E un Petrosino televisivo, in costume. Lì è successa una cosa curiosa. Nella sceneggiatura compariva un ministro dell’interno legato alla mafia. La cronaca italiana incominciava a fornire sospetti sui legami tra mafia e politica. Il funzionario Rai ci chiamò: questo no, non si può fare. Allora io e Fabio Carpi abbiamo minacciato di togliere il nome dal film, cosa non piacevole per la Rai. Non c’è stato verso. Incastrato, quasi certamente, dai politici, il funzionario non poteva farci niente. Allora abbiamo proposto uno pseudonimo. Luigi Bricconcelli, era il nome che proposi per me, Fabio Rintontelli quello per Fabio Carpi. Poi ci mettemmo d’accordo per Luigi Gualtieri e Fabio Guastalla. Una cosa che ha fatto ridere tutta la televisione.
Kolossal e ipoteche. Il cinema italiano di oggi è claustrofobico, si muove chiuso in una stanza. Ma fino a tutti gli anni ’70 era ricco, esuberante. I produttori incassavano con certi filmoni popolari, come La Bibbia e Cleopatra, e poi facevano i film di Fellini e Antonioni, che comunque, in altro modo, erano ricchi, pieni di spazio e di attori bravi; o le commedie di Monicelli e Comencini. Film quasi sempre intelligenti. Guardie e ladri era bellissimo. Oppure I soliti ignoti. E Risi, Festa Campanile. Con Tognazzi ho fatto un buon film poco fortunato, Sissignore. Ma il pregio, direi, era un livello medio generale. Nei colossi storici c’era anche una certa megalomania. Gli sceneggiatori che lavoravano nella villa di De Laurentiis sull’Appia antica sapevano che erano ipotecate anche le sedie. Dinocittà fu costruita con i contributi della Cassa per il Mezzogiorno, nell’ambito di una speculazione edilizia a sud di Roma. Alla fine degli anni ’50 a Cinecittà si ricostruiva tutto: il Circo Massimo, le Mura di Gerusalemme, l’Arco di Tito, l’Arca di Noè. Come un signore d’altri tempi, Lombardo, con la Titanus, pagava tutto quello che gli americani chiedevano. E in Italia i film coprodotti incassavano. Ponti e De Laurentiis hanno giocato la loro fortuna sui kolossal con gli americani. Ma quello che la gente non sa, o non vuole ricordare, è che fu un ragioniere, un semplice ragioniere, a dare un colpo mortale al cinema italiano. Mi riferisco al ragionier Ciucci, parente del Presidente della Repubblica, che ai tempi era Gronchi. Il sistema italiano che assicurava la distribuzione dei nostri film si reggeva in gran parte sul circuito statale Enic. Ciucci passò tutte le 300 sale del circuito a società private, italiane solo di nome. Di fatto, tutte americane. Erano i primi anni ’60 e l’invasione di film americani fu massiccia e definitiva. La situazione negativa del cinema italiano oggi deriva anche da quella scelta.
Io per il “Corriere”, Lattuada per il “Resto del Carlino”. Quanto a me, e ai pochissimi scrittori che lavoravano per il cinema, be’ eravamo guardati con molta diffidenza. Ponti, alla fine, è stato gentile, con me, perché mi ha fatto lavorare a molte
sceneggiature. Simpatia, affetto, ma, ripeto, anche diffidenza. E imbarazzo. L’imbarazzo con cui le persone non di cultura vedono dal basso la cultura. Lattuada o Antonioni no. Semmai in loro c’era un’altra cosa. Un po’ di gelosia. Qualcuno aveva, giustamente, certe aspirazioni. Per esempio ricordo che a Lattuada sarebbe piaciuto scrivere sul “Corriere della Sera”. Faceva dei pezzi ogni tanto per “Il Resto del Carlino”. Io scrivevo sul “Corriere”. Credo non gli andasse giù. Si trattava di un complesso di inferiorità degli intellettuali del cinema nei confronti degli intellettuali della letteratura. Flaiano conosceva bene questo problema. Lo invidiavano. E non lo riconoscevano come meritava. I film non sempre appartenevano al regista. Voglio dire che ci sono film in cui prevalgono evidentemente o la sceneggiatura o gli attori oppure la produzione. I kolossal di De Laurentiis erano del produttore. Le commedie sceneggiate da Ben Hecht erano film di Ben Hecht. Dico anche che certi film di Fellini erano più di Flaiano. Con Lattuada e Fabio Carpi credo di aver prodotto elementi forti dei film: Il cappotto di Lattuada e L’età della pace, Corpo d’amore, di Fabio. Mi divertivo con Pasquale Festa Campanile. Inventavo scene comiche e battute, e lui, cinico e attento, prendeva le cose più commerciali. Era molto più intelligente dei suoi film e dei suoi libri.
Una mina vagante: l’autore. Frequentando creativamente il cinema ho avuto l’impressione (ma posso sbagliarmi) che uno scrittore ha una marcia in più nella costruzione dei personaggi, anche se ci sono sceneggiatori, che proprio per questa capacità, sono dei veri scrittori. Di Flaiano ho già parlato. Moravia non voleva fare lo sceneggiatore. Però nei suoi romanzi c’era la materia per cavar fuori veri personaggi. Il cinema italiano non si è sufficientemente giovato, per esempio, dell’ondata di novità strutturale portata dagli scrittori del Gruppo ’63. La crisi del cinema era già incominciata. E stava anche nascendo il film d’autore: l’autore totale. Il regista che scrive il soggetto, la sceneggiatura e fa la regia naturalmente. L’apporto di uno sceneggiatore era raro. Quello di uno scrittore, non parliamone. Ci sono ancora oggi giovani che mi chiedono consigli nella lettura delle sceneggiature che vogliono dirigere, ma temono (lo vedo, lo sento) che io possa intervenire e quindi chiedere la firma, sminuendo, secondo loro, l’immagine di autori. In qualche caso mi hanno letteralmente rubato il soggetto. Stefano Reali ha avuto una nomination all’Oscar del miglior cortometraggio, preso di sana pianta da un mio racconto pubblicato su un quotidiano. Ho dovuto intervenire con un avvocato e Reali ha dovuto inserire il mio nome nei titoli di testa. Monicelli, invece, ha ammesso in tv che non avrebbe mai fatto L’armata Brancaleone se non avesse visto il film di Malerba e Marchi Donne e soldati. Questo denota una qualità e una sicurezza di livello diverso, mi sembra.
Regista di lanzichenecchi. La mia incursione nella regia cinematografica è nata dall’amicizia di Marco Ferreri. Negli anni ’50 Ferreri faceva il produttore. Perché non facciamo un film insieme e tu lo dirigi? mi disse. Si appoggiò a Luciana Momigliano, che finanziò il film e ottenne il nome nella sceneggiatura. Marchi aveva girato dei documentari per la Cittadella film. Era molto abile tecnicamente. La storia era mia. Nell’assedio interminabile di un gruppo di lanzichenecchi a
un castello emiliano gli assediati hanno fame e gli assedianti desiderano le donne. Lo scambio era già un modo per raccontare un Medio Evo di poveracci affamati in cui non ci sono più cavalieri erranti. In realtà, in Emilia c’è un paesino che si chiama Rimagna, che viene da Alemagna, dove un gruppo di lanzichenecchi si ambientò e s’insabbiò. Si sposarono con le donne del castello. La visione irridente è nella sceneggiatura. Era davvero un’Armata Brancaleone ben prima del film di Monicelli.
Il ruscelletto di Antonioni. Ferreri è stato un grande regista. La generazione degli anni ’60, da Ferreri a Bellocchio, da Pasolini a Bertolucci, in fondo è l’ultima che riuscì a rinnovare il cinema italiano realizzando film importanti, con sceneggiature originali e senza ricorrere agli scrittori. Erano avviati all’idea del regista-autore, contando però su un mondo complesso e strutturato come succede in un romanzo. Pasolini, poi, dirigeva i suoi romanzi, oppure trasponeva dei libri, come il Decamerone o i racconti di Chaucer. Bellocchio ha la levatura di un romanziere, a mio parere. Bertolucci di un romanziere più commerciale. Per intenderci, Rossellini era per me un grande autore, lui sì un grande romanziere del cinema, con un rapporto diretto con le cose che racconta, di “scrittura” viva, se si può dire. Fellini anche. Antonioni non lo amo molto. È uno che, dando importanza a cose un po’ sfuggenti, rischia sempre di diventare troppo intellettuale. Nell’Eclisse fa vedere un ruscelletto con un filo di paglia che scivola sull’acqua, e questo dovrebbe essere molto significativo. D’accordo, i critici hanno dato grande importanza a questo modo di fare cinema, ma il fatto è che Antonioni è un letterato, non un vero autore, secondo me. È probabile che a un certo livello il cinema di Antonioni sia affine a una certa letteratura dello sguardo, ma il problema è che il suo è un cinema “letterario”. Blow up sembra bello, ma è un po’ falso, troppo voluto, proprio nel senso di “letterario”. È come un romanziere più letterato che scrittore. Ci sono romanzieri che sono più intellettuali, con un rapporto mediato e concettuale con il mondo, rispetto a scrittori con un rapporto diretto con la storia che raccontano. Lavorano più sui libri che sulla vita. Ed è un modo anche questo di essere scrittori, intendiamoci. Ne ho parlato con Calvino qualche volta. Insomma, questa mediazione per alcuni è necessaria. Sono artisti che devono passare attraverso un filtro. Mi viene in mente un turista davanti alla meravigliosa scalinata del duomo di Orvieto. Non guardava la facciata vera del Duomo, che aveva alle spalle, ma la fotografia della facciata, a colori, di una guida. L’unico film di Antonioni che ho amato è Il grido. Un vero autore è Fellini. Se vogliamo, anche Visconti è un po’ un arredatore, pur di grandissima levatura.
Tv e carne in scatola. La televisione ha semplicemente ignorato gli scrittori. Calvino tentò molte volte di collaborare con la tv. Non lo volevano. E neanche artisti come Soldati o Fellini. Né gli scrittori, né i grandi registi del cinema, volevano. Quando la televisione ebbe il potere di scegliere, per le cosiddette fiction, si vendicò della presunta superiorità del mondo del cinema. Negli anni ’60 Soldati andava in giro con la Rover, Fellini cambiava sempre auto. I funzionari televisivi vivevano di stipendio. Direi che era una posizione di indipendenza orgogliosa e un
po’ complessata quella della tv verso il cinema. Ci fu un breve periodo in cui Paolo Valmarana, con le coproduzioni, riuscì a portare in televisione Olmi e i Taviani. Ma per il resto la televisione ha sempre lavorato con sceneggiatori seriali. Al mio libro Il fuoco greco, nato da una suggestione storica (avevo letto che l’imperatore di Bisanzio non poteva essere toccato nemmeno dai suoi cortigiani: ma cosa succede se cade da cavallo?), è associata una curiosa vicenda televisiva. Assonitis, un produttore greco, ricevette da Melina Mercouri, che allora era ministro della cultura, dei soldi per un film su Bisanzio. Assonitis mi chiese di scrivere la storia di sette imperatrici. Con la sceneggiatura, andò in America per cercare i finanziatori. Si trattava di fare un kolossal televisivo da vendere nel mondo. I finanzieri delle società televisive americane, letta in inglese la mia sceneggiatura, obbiettarono che non avevano mai sentito parlare di Bisanzio, ma che la vicenda era interessante e spettacolare. Per loro andava bene. Era necessario però l’ultimo passo. Ascoltare il parere degli inserzionisti. Su Le imperatrici di Bisanzio ci fu una riunione di produttori di carne in scatola e produttori di pop corn che dovevano finanziare l’impresa. Dissero: ma Bisanzio proprio non sappiamo che cosa sia, non si capisce a chi potrebbe interessare. Rifiutarono. Una volta sono stato alla Normale di Pisa a raccontare come il progetto per un film d’argomento storico, promosso da un illuminato ministro della cultura europeo, sia finito sul tavolo di inserzionisti pubblicitari di carne in scatola americani per la parola finale e decisiva. Ho fatto il pubblicitario per quattro anni, ma spesso non riesco a capire la pubblicità televisiva di oggi, anzi, vedo che altrettanto spesso non la capiscono nemmeno i miei amici. Nel corso del tempo il rapporto con l’immagine è cambiato molte volte. Quando ero ragazzo un giorno ho portato al cinema un mio contadino. Era la sua prima volta. A un certo punto arrivò il primo piano del protagonista e lui mi domandò impressionato: perché gli hanno tagliato la testa, che cosa ha fatto di male? Insomma, l’avventura continua.
24 Preferisco non dire il nome dell’amico che ha telefonato, angosciato dal grande problema di questi tempi: la casa. È un grande attore comico, ormai dimenticato e squattrinato. Per me un’amicizia solidale da decenni, maturata dopo un estenuante quanto vano corteggiamento. Mi ero appena sposata. Lo conoscevano un po’ tutti P., che veniva dal giro del teatro e, soprattutto, da una facoltosa famiglia di proprietari terrieri in decadenza. È stato un pioniere misconosciuto del cabaret italiano, nei primi anni ’50, quando nessuno sapeva che ci sarebbe stato un cabaret italiano. Fu Lidia a presentarmelo. Attratta dal mondo del cinema, era finita nelle braccia di questo attor giovane, svelto e brillante, un affascinante autore di promesse mai mantenute. Nell’euforia per il denaro seguita all’avvilimento della guerra, il mio amico visse da ricco per più di un decennio. Il cinema lo fagocitò per impiegarlo in ogni angolo delle commedie necessarie ai listini. Per altri dieci anni dilapidò la sua fortuna come risposta negligente e spavalda alla moria dei contratti. Da quasi un ventennio tira avanti con piccole eredità, trattenendo il fiato mentre perde inesorabilmente terreno tra i lussuosi bisogni di un anziano borghese, assediato da una terza moglie altezzosa che non è disposta a cedere. Al telefono mi ha detto: “Siamo costretti a lasciare l’attico di Roma. Non ce la facciamo più. Isidora aveva deciso di accettare la casa disabitata dei cugini, a Sanremo. A Sabaudia ci sarebbe anche un mini appartamento di mia sorella. Un altro parente offre una casa sfitta a Milano. Chiediamo la carità immobiliare. Ma che faccio io a Sabaudia o a Milano? Poi, oggi, una cosa incredibile. Un amico scenografo che vive a New York le ha detto: la città per vivere ora è Napoli, la gente è calda e sorridente, la frutta costa poco, gli affitti sono bassi. Ma che ne sa uno che vive a New York? Isidora si è quasi convinta. Io ho appeso nello studio una grande carta geografica d’Italia e, ogni giorno, a seconda delle proposte, tolgo e metto le bandierine. Comunque, fosse Napoli, negli ultimi due anni ci abbiamo già pensato noi a distruggere le fiancate della Mercedes.” Dopo la telefonata di P. non riesco più a leggere. Accendo la tv. Non credo che le generazioni successive alla nostra potranno mai comprendere che la televisione ha distrutto la piccola comicità inaspettata della vita. Quante persone, oggi, sanno ancora guardarsi intorno e ascoltare, liberi dall’assillo delle immagini? Era il cinema a educare il nostro sguardo. Sordi e Manfredi hanno osservato il mondo con i loro occhi. Tognazzi era un biologo della comicità. E non erano ancora “televisione”, nel senso degenerato del termine, gli sketch di Walter Chiari e Franca Valeri. Sembravano, semmai, teatro filmato con la materia delle commedie cinematografiche. Forse la Valeri è l’unico comico donna che ho mai visto nella mia vita. Forse dovrei smettere di pensare che il passato, perché irripetibile, ha sempre un vantaggio sul presente.
FRANCA VALERI Storia di un’italiana Da ragazzina il cinema era una vacanza, una distrazione. I miei genitori erano molto severi rispetto al cinema, quindi mi permettevano esclusivamente film per l’infanzia, dominati da Charlot. Nessuna rivista di personaggi. Molto rigore a casa mia, direi. Andavo invece alla Scala. La mia passione per la lirica si manifestò quasi subito, ma Il monello di Chaplin restò a lungo nella mia memoria. Poi arrivarono Stanlio e Ollio. Per loro ho avuto una vera passione. Il destino me li fece incontrare a Parigi nel 1950. Un attore della compagnia con cui ero in scena a Parigi, aveva una piccola parte nel film che Hardy e Laurel stavano girando: Atollo K. L’ultimo di Stanlio e Ollio. Dicono il peggiore. Ollio era accompagnato da una bellissima donna. L’altro sembrava sempre distratto, spiritoso. Erano dei miti della comicità, per noi, per tutti. Li seguiva un corteo. Avevano queste mogli bionde, agghindate, molto “comprate”, vero.
Papà non voleva. Ho manifestato molto presto le mie capacità, più che d’imitazione, d’umorismo. Trovavo dei bersagli. A sette, otto anni avevo individuato nella mia maestra elementi di satira, ma non sapevo che cosa stavo facendo quando la imitavo per il divertimento delle mie compagne. Per i miei genitori era la reazione di una bambina intelligente, vivace. Non hanno mai pensato all’embrione di una carriera nello spettacolo. E comunque, quando parve così, erano fermamente contrari. Ho incontrato l’ostilità di mio padre, che riteneva il mio desiderio un’illusione. Era un ingegnere. E poi non era un lavoro adatto a una signorina. Io abitavo a Milano, città del varietà. Non era molto amato dai miei genitori. Non c’erano neanche dei precedenti in famiglia, per cui uno potesse dire... ecco l’eredità. Facevo il liceo e, per quanto fossi una giovinetta, del fascismo avevo solo la speranza che finisse. Ero convinta che la guerra ci avrebbe portato fuori dall’incubo. Non ho mai pensato che avrebbero vinto tedeschi e fascisti. Quello che si aspettava era una grande liberazione, un impeto nuovo per la vita. E così è stato. Mio padre era un convinto antifascista. Alla fine degli anni ’30 gli sentivo dire con certezza che sarebbe scoppiata una guerra. Era ebreo. C’era lo spettro di questa cosa che avanzava. Fui costretta a lasciare la scuola, in seguito alle nuove leggi razziali emanate nel ’38. Adesso, i vari Savoia chiedono perdono in ginocchio, ma mi fanno veramente ridere. Ci precludevano la vita pubblica. Un momento tremendo, al quale io ho reagito con determinazione. Mio fratello e mio padre invece erano rimasti molto colpiti. Io ricordo di aver inalberato uno spirito combattivo. Ho fatto in tempo a uscire dal liceo concentrando due anni in uno, dribblando all’ultimo momento le nuove norme. Poi mi sono rassegnata ad aspettare. Mio padre e mio fratello sono sfollati in Svizzera. Io e la mamma siamo rimaste a Milano. Lei era molto spaventata. Io invece tenevo duro. Ho rischiato molto, devo dire. L’aggressività dei ragazzi era forte. Anche mangiare non era facile. È stata dura, ma era destino che me la cavassi. Il giorno della Liberazione ero a Milano con mia madre. Ci eravamo rifugiate con un nome falso in una casa bombardata, vicino a piazza Cordusio. Quando trovai il coraggio per uscire, la piazza era deserta. Ricordo di aver visto un amico, che riconobbi a stento perché
aveva la barba. Era molto più grande di me ed era entrato in un gruppo di partigiani. Mi disse di tornare immediatamente a casa. Arrivavano gli alleati. E i tedeschi, scappando, facevano disastri. Io volevo vedere l’arrivo degli americani, era una cosa troppo grande per perderla. Ho fatto a tempo a vedere una colonna di tedeschi che fuggiva. Il giorno dopo si camminava per le strade, liberi di vivere.
Da Strehler ai Gobbi. È noto che tentai di entrare all’Accademia di Roma e fui respinta. Volevo fare l’attrice ed ero timidissima. Tentai la scuola di un regista russo, per poco tempo, però. Mi ero anche iscritta alla facoltà di lettere. Ebbi l’improvvisa occasione di debuttare sostituendo la protagonista (che si era allontanata per fare del cinema) in uno spettacolo di Alessandro Fersen, una fantasia intorno a una leggenda ebraica, credo fosse il ’47 o il ’48. E ho conosciuto subito i miei futuri compagni, Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, che diventò mio marito. Lo stesso anno, a Milano conobbi Testori, che aveva scritto Caterina di Dio e mi affidò la parte in uno spettacolo quasi privato, perché fu allestito in una chiesa sconsacrata di Milano (dieci anni dopo avrei fatto un testo straordinario di Giovanni, la Maria Brasca). Non avendo un’idea precisa del mio carattere, tendevo ad accettare testi drammatici, come di consueto quando si vuol fare gli attori. Incontrai Strehler e Paolo Grassi. Strehler mi fece subito un piccolo esame, il monologo di Nina nel Gabbiano di Čechov. Mi disse che ero molto dotata. E mi prese per un Pirandello e per La parigina, di Becque. Ma progettando qualcosa con Bonucci e Caprioli, e Luciano Mondolfo, che si era aggregato, venne fuori l’idea di una compagnia di giovani. Vittorio sosteneva addirittura che non ero dotata, per via della mia timidezza. Io mi divertivo già a ripetere certi personaggi femminili che incontravo, le snob dei salotti milanesi. Bonucci e Caprioli ebbero l’occasione di mettere in piedi un programma per la radio, a Milano. Incominciai a rompere le scatole per andarci anch’io. Avevo in mente la signorina snob. Vittorio trovò uno stratagemma con la Rai. Disse che c’era una signorina della buona società, un’ereditiera un po’ matta, ma di talento, che faceva scenette nei salotti e che voleva fare l’attrice comica, ma che probabilmente non avrebbe mai accettato di esporsi alla radio. Mi chiamarono. Con Bonucci e mio marito nacque il Teatro dei Gobbi, al teatro di via Vittoria a Roma, con il primo dei “Carnet des notes”, dove finalmente ho tirato fuori, grazie anche a loro, la mia vena satirica. Eravamo tre ragazzi entusiasti, molto nuovi uno per l’altro, uno napoletano, l’altro romano, io milanese, poi c’era il cosiddetto “quarto gobbo”, Mondolfo, il regista, un uomo molto spiritoso che mi adorava, un mio grande sostenitore. Curiosamente il debutto fu all’estero, a Parigi. Io conoscevo bene il francese. Loro un po’ meno. Piaceva però la loro incertezza e l’accento. Si vedeva subito che l’ironia sulle cose del tempo era universale. Mi chiamavo già Franca Valeri. Il mio nome è Franca Norsa. Siccome avevo fatto una prima apparizione in una compagnia estiva a Milano, l’amministratore voleva sapere che nome doveva segnare, perché s’aveva paura delle reazioni di mio padre. Stavo con una mia amica che aveva in mano un libro di Paul Valéry. E così... Subito dopo ho fatto la signorina snob alla radio e il nome girava, ed è rimasto Valeri.
Donne, madri e bellone.
Donne, madri e bellone. Alla fine della guerra il mondo femminile non era così sicuro di sé, le donne non erano emancipate o, come dicono loro, “realizzate”. C’erano molti problemi, per quanto la prova della guerra avesse rafforzato la voglia di vivere liberamente e avviato una certa agilità della donna. Il voto fu un passo importante. Io però non ho mai incontrato difficoltà a essere donna. Probabilmente in altri campi, in certi tipi di lavoro, dev’essere stato più difficile. L’uomo ha bisogno di lavorare, quindi in qualche modo per un certo tempo si è difeso. La famiglia si basava molto sulla madre. Le rappresentazioni della mamma che abbiamo dal cinema italiano del dopoguerra sono ancora materno-centriche, a parte certi personaggi, appunto, che facevo io, rendendomi conto di pulsioni diverse. Il discorso è complesso. L’abbandono della famiglia da parte della madre a cui abbiamo assistito progressivamente, fino a oggi ha creato problemi molto grossi per la crescita sana dei figli. Si fa presto a dire. Ma l’educazione dei figli “moderni” ha subito un tracollo. Certe manifestazioni del “disuso” della famiglia di oggi sono dovute soprattutto allo squilibrio che si è creato nelle giovani persone che sono entrate nella società. Se penso al mio lavoro complessivo nel cinema, ma anche alla radio o nel teatro, come commediografa, in questo contesto in movimento dopo secoli credo di aver contribuito a svegliare nelle nostre compatriote anche il senso dell’umorismo, che era praticamente nullo. E oggi finalmente vedo molte attrici comiche e satiriche. Il cinema si giovava soprattutto di bellone. Le cercava. Le inventava. Come adesso fa la televisione. Perché le donne si prestano. Le prestazioni di carattere sessuale e decorativo c’erano già allora e sono cresciute in modo esponenziale, a partire dal cinema italiano degli anni ’50 e un po’ da tutti i mass-media. Questa presunta rivoluzione della donna... In un certo senso credo di essere stata l’unica fuori dal coro. Un’attrice comica senza diventare ridicola. Una giovane donna che riusciva a rivaleggiare col primo attore. Ho fatto tanti film con Sordi e con De Sica. Bisogna pensare che c’erano la Lollobrigida, la Loren, con cui ho lavorato, e poi tutte quelle di passaggio. Erano belle, prima di tutto. E poi, piano piano, si sono sforzate di darsi una dimensione di attrici.
Salotti e signorine. La radio e gli spettacoli del Teatro dei Gobbi mi avevano dato quasi subito una certa popolarità. Fui chiamata da Fellini per una parte in Luci del varietà, il suo primo film da regista, anche se condivideva lo scettro con Lattuada. Una sera, con Vittorio, ero andata a cena a casa di Lattuada. Vittorio sapeva che io inventavo questi personaggi. È venuto fuori, parlando, il personaggio della coreografa, che io improvvisai subito. C’erano Fellini, Giulietta. Fellini decise di aggiungerlo al film. Questi incontri tra amici erano frequenti. Per gruppi. Ci scambiavamo idee. Ecco, questa è una cosa che rimpiango e che mi manca. Cineasti e attori oggi non vivono più in gruppo, non sentono il bisogno di incontrarsi. Io sono diventata molto amica di Fellini e De Sica, la Morelli e Stoppa. Era facile incontrare Visconti a Roma e Strehler a Milano. E quindi capire che cosa bolliva in pentola. Ho conosciuto Ionesco, una sera. Poi l’ho frequentato a Parigi. E così Genet. Per strada incontravo Sartre, e ti potevi fermare per chiacchierare. La stessa via Veneto, che nel mito diventa un po’ artificiosa, imbalsamata, era un posto vivo. Il tipo di vip che incontriamo oggi a confronto è spazzatura. Forse perché eravamo giovani? Il fatto che Visconti scegliesse persone giovani per le serate nella sua villa principesca ci permise di diventare amici. Lavoravo a una commedia musicale
intitolata Lina e il cavaliere e vedevo spesso Luchino in quinta. Andava a cena fuori e poi passava a rivedere un pezzetto che gli piaceva tanto. De Sica era il mio idolo. Se c’è qualcuno da cui ho imparato qualcosa di fondamentale per la comicità è lui. I tempi della comicità. Che sono un po’ istintivi, intendiamoci. Ma era straordinario. Con De Sica passavo le feste di capodanno. Incontravo Rossellini a Parigi, quando stava con la Bergman. Un signore elegante con questa bella signora svedese, che teneva spesso in disparte. Con la Bergman credo che lui rinunciasse un po’ alla sua vivacità, alle sue stramberie. La Bergman era austera. Una coppia defilata. La parola diventa un eufemismo se pensiamo invece a De Laurentiis e Mangano. All’inizio lei era una ragazza semplice e diretta. Si è delineata dopo come signora appartata e sofisticata. Con lei ho fatto Crimen, ed è stato molto divertente. Come compagno di lavoro Sordi era meraviglioso. Ho fatto molti film con Alberto e non era affatto invadente, come dicono altri. Forse con me lavorava bene perché mi stimava. Ho fatto con lui un pezzo della sua storia di un italiano. Trovavo sceneggiature di valore che contemplavano un’idea della società italiana, a cui noi aggiungevamo ironia e vivacità.
Opera o cara. L’amicizia con Visconti veniva anche dalla mia passione per la lirica. Da ragazza conoscevo alcune opere quasi a memoria. Appena era possibile i miei genitori mi mandavano alla Scala. Ero stata educata da un amico di famiglia che era un cultore, grande, verdiano. Quindi tutte le opere di Verdi, i segreti degli allestimenti, le differenze tra i cantanti. Quando ho incontrato il mio secondo compagno, direttore d’orchestra, abbiamo creato un concorso e ho potuto mettere in scena tante opere. Per me è stato affascinante. È uno spettacolo completo. Avevo la fortuna di avere a disposizione dei giovani, liberi dai difetti dei soliti professionisti. Ho fatto grandi Traviate e Butterfly, una bellissima edizione di Macbeth. Devo dire che per me il più grande regista d’opera italiano è stato Strehler. Subito dopo, Visconti. Luchino ha fatto spettacoli stupendi con grandi cantanti, allestimenti accurati, realistici e raffinati, a volte di una pedanteria di altissimo livello, che ha ereditato Zeffirelli, il quale fa pure bellissimi spettacoli. Ma Strehler aveva la magia dell’invenzione. Le trovate che spuntano oggi nel tentativo di ammodernare l’opera... ebbene Strehler aveva intuito in modo geniale, e irripetibile nella misura, come reinventare l’opera. Macbeth e Simon Boccanegra furono grandissimi spettacoli. La musicalità è anche il segreto del successo dei suoi spettacoli di prosa. Oggi Ronconi fa cose egregie.
Le due Callas. Non parliamo poi dei cantanti. Certe voci sono irripetibili. Non parlo solo della Callas. Non ho visto il film di Zeffirelli sulla Callas. Non oso. Ho qualche difficoltà davanti a un personaggio che ho conosciuto così bene. La Callas era due persone. La cantante, per ora insuperata, proprio per un fatto vocale, che è stato anche studiato, e la donna, una ragazzona fragile, simpatica anche, che andava sempre incoraggiata. Se bisognava sempre parlarle di lei era per darle sostegno, fiducia. Io l’ho frequentata però prima della relazione con Onassis. Dopo l’ho vista soltanto un paio di volte e ho ricavato l’impressione di una donna malinconica. Mi disse:
sono stanca, non ce la faccio più. Cose che prima non avrebbe mai detto. La Callas era un mistero. Dalla donna che incontravi a tavola non si poteva pensare che uscisse quel mostro scenico che dominava ogni volta in teatro. La sua fragilità credo derivasse dall’enorme concentrazione che aveva sulla sua arte. Poi si svuotava, e allora non sapeva più... si era dimenticata di sé. Era come se non potesse reggere anche fuori dal palcoscenico quella energia.
Una, cento, mille Cecioni. Ho realizzato uno dei primi spettacoli della televisione, nel ’54. Diversamente dai miei compagni di lavoro, che si sono poi rivolti al cinema, essendo io un’attrice comica che inventava i suoi personaggi, ho continuato a “professare” anche in televisione, incamerata soprattutto dagli spettacoli di Falqui, il sabato sera. La signora Cecioni è nata alla fine degli anni ’50, quando la realtà stava cambiando e questa popolana captava i nuovi linguaggi, i tic delle donne. Ho scritto per la prima volta la Cecioni una sera, in campagna. Feci subito la prova con Vittorio. Rideva, rideva come un matto. Allora ho pensato: si vede che è buono. È infatti è un personaggio inesauribile. Si può andare avanti all’infinito. Il complimento più grande l’ho ricevuto da Aldo Fabrizi, la prima volta che sentì la Cecioni: sei più romana de me, mi disse. Potevo fare quello che volevo in televisione. Però ricordo una serie più difficile, e interessante, con Vittorio, Le divine, che rievocava personaggi femminili celebri dello spettacolo di varie epoche. Al momento non ha avuto grande successo. Poi furono riscoperte e ritrasmesse. La televisione può dare grandi possibilità. Sono affezionata anche ai miei atti unici. Forse valgo qualcosa anche come commediografa. Mi sono trovata a pensare che il grande affetto del pubblico femminile per i miei personaggi fosse in realtà una gratitudine, perché riconoscevano qualcosa della loro vita quotidiana. Credo che i miei personaggi raccontassero in breve delle storie. Il successo delle fiction di questi anni deriva proprio da questo: sono delle storie. Un po’ stupide, forse. Ma ci sono dei sentimenti. Io credo più ai sentimenti che alle conquiste sociali, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta emancipazione femminile.
Femminismo, che ’68. Con il mio lavoro credo di aver fatto molto per l’evoluzione della donna, non fosse altro perché sono stata la prima donna in Italia a ridere di se stessa. Però mi ha sempre dato noia la forma che ha preso il femminismo qui da noi, anche per l’esagerato antimaschilismo, che non si è manifestato come una difesa di se stesse, ma si è espresso soprattutto nel tentativo di mistificare l’uomo. Una cosa stupida, che ha creato molti guai nei rapporti all’interno della famiglia italiana, che ha equilibri suoi propri, e nei rapporti tra uomo e donna in generale. La ragione per cui non reggono più i matrimoni è la scarsa identificazione di ciascuno dei due membri. Io che ho vissuto tempi migliori oggi vedo una società non attraente, che ha perso alcuni punti fermi su cui basare l’educazione dei figli, su cui avere l’impressione di poter creare il futuro. Attenzione, non sto dicendo che la donna negli anni ’60 stava meglio. Non erano bei tempi. Ma adesso c’è una mancanza di idee per ritrovarsi. Non vedo, per esempio,
scrittori capaci di diventare un punto di riferimento. La scienza, diversamente da quel che sembra, è ferma, se vogliamo, perché sta diramando le sue branche in campi sgradevoli, investe in modo equivoco. Una delle ultime commedie che ho diretto riguarda proprio la medicina, che si dibatte tra ideale e reale. Il dialogo tra lo spettacolo, l’arte se vogliamo, e la società è stato più intenso indubbiamente tra il dopoguerra e il ’68. Nel ’68 c’è stata questa esplosione... Sappiamo ormai che cosa è stato il ’68, nel bene e nel male. Eppure, a pensarci ora, io non ho avuto grandi problemi. Ho continuato a lavorare bene. Forse per la mia grande onestà. Non ho virato verso astruse ricerche. Semmai, nella mia “carriera” che, devo dire, continua anche oggi, alla mia età, ho sempre cercato del nuovo. Mi sono mantenuta quella che ero. Quella che voglio essere.
25 La mia amica Lidia non ha mai saputo come voleva essere veramente. È morta due anni fa sognando di diventare proprietaria di un agriturismo sull’Amiata. A settant’anni! Amò sinceramente il mio amico attore. P. la faceva ridere, la faceva sognare. Correvano con l’auto fino a Ostia e facevano l’amore sulla spiaggia. La portava a teatro, da Visconti, oppure alle riviste. Fu il solo momento in cui ricordo Lidia serena. Ecco, l’unica cosa che credeva di sapere di sé, era che aveva bisogno di un marito. Nel dopoguerra, per noi ragazze avere un uomo accanto, un marito, sembrava tutto. Finì a lavare i calzini a quello squallido impiegato di Cinecittà, da cui divorziò a cinquant’anni. Si servì della nuova legge il primo giorno utile. Ho conosciuto il varietà grazie all’amicizia di Lidia e al suo amore per P. Uscivamo noi quattro, io, Francesco, Lidia e P., che alla fine dello spettacolo ci conduceva pomposamente nei camerini, dove aveva libero accesso, a salutare “gli artisti”. Le ballerine passavano in corridoio, da una stanza all’altra, una mano sul corsetto aperto sul seno, cercando con l’altra di chiudere la vestaglia, con un gesto ostentato per esibire dignità, ma sapevano bene di lasciare la scia di profumo dolce e nauseante che attirava i mariti deboli. Una notte P. ci fece attendere quasi un’ora davanti a una porta chiusa. Diceva che il ragazzino con le gambe storte e la voce gentile sarebbe diventato famoso. Ci raccontò che l’aveva conosciuto al secondo tentativo d’esame di ammissione alla Scuola d’arte drammatica. Il ragazzino fu preso, P. nuovamente respinto. Ormai avevano lasciato il teatro anche le ballerine. Spensero le luci in sala. Spensero la luce principale del corridoio. Venne il portiere. “Ma non ci sta più nessuno. Quello non è un camerino. Abbiamo cambiato. Adesso ce stanno i costumi, lì. Er giovanotto che aspettate se n’è andato subito. Non si strucca quello. E poi non c’ha mica ‘il camerino’. Che ve credete? Quello proprio nun c’ha ’na lira”. Era Nino Manfredi.
NINO MANFREDI Mio nonno paraculo, maestro d’ironia Il mio grande maestro era analfabeta. Un ciociaro cocciuto, mio nonno materno. È stato mio nonno a trasmettermi l’ironia che m’ha portato al successo. Non dico che l’Accademia è stata meno importante. Silvio D’Amico, Orazio Costa. Uomini straordinari da cui imparare tanto. Però, per me il più grande pensatore è stato mio nonno, perché vedeva la vita in modo diverso. Mi ha insegnato qualcosa di cui non mi rendevo conto, trasmettendomi la sua ironia. E quando me ne sono accorto, di avere questa caratteristica, non è stato facile capirlo, e poi non è stato facile farsi accettare. Un giorno stavamo provando dei brani di Shakespeare all’Accademia d’arte drammatica. Toccò a me. Salgo in pedana. Dovevo fare “essere o non essere, questo è il problema”. Attacco. E sento giù che ridono. Me guardo ’ntorno, me rimetto in posizione e riprendo, cercando di darmi un tono, con lo sguardo concentrato sulla mano tesa in avanti: Esse-re, lunga pausa, o-non-essere. E sento ancora che ridacchiano. Dico: “Ma che ve ridete, aho?” E Orazio Costa: “Vada avanti Manfredi.” Ricomincio. E ridono ancora. Basta, scendo e me ne vado, deluso e incazzato. Alla fine della giornata di lezione, Costa mi piglia da parte e con fare confidenziale dice: “Vedi, tu non ti devi arrabbiare. Tu hai una nota in più: il senso dell’ironia. Sarà il tuo modo di fare l’attore. Quindi, ricordati sempre: ‘castigat ridendo mores’. E non è una cosa che si compera al mercato.” Hai capito? penso. Ci ho l’ironia. E che devo fa’?
Il nonno che parlava con Dio. Eravamo poverissimi, noi. Mio nonno ci manteneva quando andavamo in campagna da lui. E quando stavamo a Roma, ce mandava ’a robba da magnà: farina bianca, farina gialla, le pagnottelle, quello che c’aveva. Questo pane durava fino a quindici giorni, perché ci mettevano dentro le patate. Lui era un paraculo incredibile. Non sapeva né leggere né scrivere, ed era stato trentadue anni in America. Era partito per restare un annetto e mettere insieme un po’ di soldi, e poi s’è fatto prende’ un po’ la mano... Faceva due lavori: uno di giorno, in miniera; di notte invece andava ad aggiustare gli scambi dei binari delle ferrovie e dei primi tram. Era la fine del secolo scorso, dell’800, voglio dire. Quindi mia madre era stata in America. Ce ne parlava sempre, e noi eravamo affascinati. Infatti, quando ci voleva dare qualcosa da mangiare, che era sempre la stessa roba ogni giorno, ci diceva: “Do you want some bread? Do you want some milk?” E per noi pane e latte diventavano speciali. Io sapevo solo questo d’inglese. La moglie di mio nonno era la figlia di un doganiere di Bologna. Per riuscire a sposarsi sono scappati insieme. In pieno Ottocento. Uno scandalo, allora. Quando son tornati dall’America, che noi ancora non c’eravamo, il nonno s’è costruito una casetta a due piani, ma non ha fatto il gabinetto. E noi, poi, quando andavamo non capivamo. Ce l’avevamo a Roma il water, ma in un bugigattolo che nun ce s’entrava nemmeno. Avevamo dovuto fa’ ’na modifica alla porta, perché non c’era lo spazio per chiuderla. Mi ricordo che montavo sopra il water, richiudevo la porta, e poi allora me riusciva appena appena de’ sistemarmi. E lui con tutta quella casa... Un giorno che c’avevo un po’ di coscienza, dico: “Ma
nonno, perché non l’hai fatto il gabinetto?” E lui: “E a che serve? Vieni un po’ fuori che ti faccio vedere.” Me pija per mano, me porta dietro la casetta e fa segno all’ettaro di terra che c’aveva: “Guarda quanto spazio.” E poi, allora, incominciò addirittura a dislocarci: “’Sta settimana fatela lì che s’è infiacchito il pero.” E noi lì a fare la cacca. “Ma domani fatela sotto er caco, che ce vole.” Perché lui era convinto che il concime animale e quello umano erano un insieme perfetto. E un giorno, stavamo lì a lavorare (perché ci portava a tagliare l’erba col falcetto) e si ferma, piazza la vanga tra le gambe, guarda su in cielo, e dice a piena voce: “Senti un po’ tu, mo’ m’hai ’a spiegà perché mi se’ fatto nasce’ a Castro de’ Volsci, ’i poi mi si mandato pe’ trentadue anni in America. Ma tu lo sai ando sta l’America? Fatte spiegà da tuo figlio che se ne va sempre a girenne.” Noi ci guardavamo allibiti. Lo faceva ogni tanto. E mia madre s’affacciava, urlando: “Ma che educazione dai a li tuoi nipoti? Parli con Dio, ma che te credi d’esse’?” E lui si mortificava.
L’estrema unzione a 15 anni. A quindici anni mi hanno dato l’estrema unzione. C’avevo la tubercolosi. Dovevo morire. Ma io non morivo. Stavo in sanatorio e mio nonno non poteva venire a trovarmi. C’è morto di dolore, poveretto. Mi ricordo che una volta a Roma mi portò in chiesa, c’avevo dieci anni, abitavo lì a San Giovanni. E mi fermai davanti al crocefisso: “Nonno, ma perché Gesù l’han messo in croce? Era cattivo?” Lui glie dà ’na guardata, e dice: “Si ce lo hanno messo, tanto bbono nun doveva esse’.” Perché Gesù dava fastidio, voleva dire il nonno. E io c’ho fatto su un film, poi, Secondo Ponzio Pilato. E per dire ancora la scorza, perché è sempre dallì che ho imparato. Lui si vantava di fare il vino buono, ma era al massimo un fragolino o giù di lì. Un giorno (c’avevo un dodici anni) io, mio fratello e un nostro cugino più grande, gli prendiamo un bicchiere d’aceto e glielo diamo, dicendo: “Nonno ce sarebbe un amico nostro ch’ha fatto ’sto vino e però vorrebbe sapere da te, che sei un competente, come te pare.” Era aceto puro. Lui lo beve tutto, resiste, e dice: “Non è male. Però bisogna beverselo subbito perché c’ha già uno spunto d’aceto.”
Per grazia ricevuta. Al sanatorio mi avevano messo nella camera ultimale. Avevo sentito dire dai medici che ero spacciato. Al Forlanini il professor Besta disse ai miei: bisogna isolarlo perché è pericoloso per gli altri. Mia madre mi aveva comprato piatti e bicchieri apposta per me, facendo un grande sacrificio. Li ho cercati dappertutto, e son sicuro di averli portati anche in questa bella casa, ma non li trovo, e neanche Erminia, ch’è ordinata, c’è riuscita. Be’, c’era il prete che non voleva confessarmi, perché io dicevo che ero ateo. Così Besta lo convince, assicurandogli che sarei campato al massimo due mesi. Ci sono rimasto tre anni. Ho studiato lì dentro, praticamente. Perché poi mi sono anche laureato in legge, quando sono uscito. Ma soprattutto, lì dentro ho scoperto il teatro. Mi piaceva osservare i pazienti, la gente che veniva in visita. Ho imparato a suonare il mandolino, c’avevo questa grande voglia di raccontare le favole. Abbiamo fatto un’orchestrina, ma ogni tanto me svejavo al mattino e c’era il paravento intorno a un letto: avevamo perso er trombettista. Io ero il più piccolo e mi facevano
annunciare gli spettacolini. E facevo ridere. Un giorno venne De Sica, con Melnati e Giuditta Rissone, la prima moglie di De Sica, a fare Due dozzine di rose scarlatte. Bellissimi, elegantoni. De Sica magro magro. E io me credevo che quelli erano malati. Quando poi sono uscito dal sanatorio, l’altro professore, Morelli, mi dice: “Sei un ragazzo forte. Potresti vivere altri quattro, cinque anni.” Mi son messo a piangere dalla gioia, li mortacci.
Nino salvato da un casino. Andavo a studiare all’Istituto di rieducazione fascista e pensavo sempre al teatro. C’avevo vent’anni, ma non li dimostravo, avevo questo faccino, ero così magrolino. Quando in città comandavano i tedeschi e i fascisti, c’erano le retate, cercavano i ragazzi per arruolarli o per scoprire le staffette della Resistenza. Una volta ero in strada, scappavo, i negozi erano tutti chiusi, i portoni anche. Ce li avevo addosso. In via Cimarra, quando si dice il destino, trovo l’unico portonicino socchiuso. Entro, volo sulle scale e apro una porta: sul letto c’è una ragazza in vestaglia che se sta a laccà le dita de’ piedi. Ho capito subito che ero finito in un casino. Io grido: “I tedeschi, i fascisti.” E lei, rapida, mi fa entrare in uno spazio tra l’armadio e la finestra, mi sembra, una specie di doppio fondo, dicendo: “Per carità, non respirare, non fare un colpo di tosse che ci arrestano tutti.” Capirai, io uscivo dal sanatorio. Entrano i tedeschi, spianano i fucili, chiedono, indagano, molto professionali, tecnici direi, e se ne vanno. Poi arrivano i fascisti e fanno un casino. Se prendono ’sta ragazza, urlano, spaccano. Quando se ne vanno, esco, finalmente mi siedo, pallido. Non mangiavo da due giorni. Lei era piemontese. Gli dissi che ero convalescente di tubercolosi e che non potevo fare il militare. Allora chiama la maîtresse e mi fa portare una colazione. E siamo diventati amici. Ci volevano diciotto anni e tre mesi per entrare nei casini. Non ho mai capito questi tre mesi.
Iolanda. Comunque io sapevo che non potevo fare niente con lei. Ero terrorizzato di contagiarla. Poi accadde una notte di bombardamento... Che dovevamo fa’? magari ce cadeva ’na bomba ’n testa. Lei era stata cacciata di casa dai genitori perché era rimasta incinta a quindici anni del suo primo amore e non aveva voluto abortire. Andavo a trovarla quando potevo. Mi dava mille lire per comprarle la cipria e altre cose. Ne spendevo seicento, settecento, e lei mi diceva di tenere il resto, di comprarmi del pane. È stato il mio più grande amore, perché me dava da magnà. Non c’avevamo niente noi, durante la guerra. E lei si raccomandava: “Non venire più qui, neh. Perché guarda che è qui che cercano i ragazzi per arruolarli.” Ma io c’andavo lo stesso. Nun me chiedeva mai niente. Solo una volta. Mi disse: “Ho un grande desiderio. Non ho mai visto Roma. Un giorno mi ci porti?” La presi a braccetto, feci Colosseo, Fori Imperiali, piazza Venezia. Tra le altre donne lei sembrava la più bella, la più pura. Mi disse che faceva quel lavoro per mantenere il suo bambino. Quando la guerra ormai era quasi finita, le chiesi di sposarmi, senza dormire nello stesso letto, ma volevo occuparmi di lei. Disse: “Ma sei scemo? Vediamo di non mettere insieme le nostre disgrazie, va’.” L’ho perduta, poi. L’ho cercata per dieci anni, Iolanda, disperatamente.
Arrestato da papà. L’Accademia sono riuscito a frequentarla per una sfida con mio padre. Era uno con le palle, mio padre. Voleva ordine e disciplina in casa. Era diventato capofamiglia a 14 anni, non so se me spiego. Non è che s’andasse d’accordo... Quando ancora non avevo l’età per andare nei casini, sono stato beccato in una retata. Be’, non vuoi che finisco proprio nella caserma di pubblica sicurezza dove mio padre era maresciallo? Noi stavamo lì vicino a Ponte Casilino. Lì c’era la scuola, lì la caserma. E lui me lasciò ’ncarcera’, aho. C’erano due delinquentelli, che inveivano: “Ma che fate, lasciate er ragazzino in cella? Li mortacci vostri.” Io non gli dissi che il maresciallo era mio padre. Lui a pranzo tornò a casa. A mia madre che mi cercava, disse dov’ero: “E lascia perdere, che stia lì, che impari a vivere.” Uscii alla sera, avvilito. Non era facile, con mio padre. Per lui un attore era uno perduto. Ho scelto giurisprudenza per andare, di nascosto, all’Accademia, perché era l’unica facoltà al tempo che non richiedeva la frequenza obbligatoria. Così al mattino uscivo puntuale come uno studente modello. Fu questo a insospettire mio padre. Cacciato di casa, sono stato per un po’ da una zia, ma poi son dovuto tornare perché anche la zia ’n c’aveva un soldo. E mio padre mi permise di restare e frequentare l’Accademia soltanto a patto di laurearmi. Ancora adesso non so come sono riuscito. Non sono neanche andato a ritirarla, poi, la laurea.
Tre per tre Nava. Ho esordito sul palcoscenico a Praga, al Festival della Gioventù, nel ’47, appena finita l’Accademia. Una città con grandi problemi peggio di noi. Mi ero innamorato di una ragazza, lì. Facevamo l’amore e non capivamo una parola. E anche lei, me la volevo portare via. I miei amici più importanti dell’Accademia erano Buazzelli, che dormiva da me tutta la settimana, il più bravo di tutti, poi Panelli, Sbragia, la Falk, insomma aho, eravamo la squadra dei mejo. Gassman era uscito l’anno prima e mi scelse per fare L’aquila a due teste di Cocteau, con Luciano Salce, e prese Squarzina per la regia. Mi ero innamorato anche di un’allieva del mio corso, Flora Carabella. Questa storia la sanno tutti. A me piacevano le sue buone maniere, era elegante, se vedeva già ’a signora che diventò. Poi arriva un altro, certo uno meno rustico di me, gentile. Se la prese e se la sposò. Era Marcello Mastroianni, naturalmente. Me portò via Flora, sì... Quanto c’ho sofferto. Poi, ho incominciato con la rivista. Ma perché non trovavo lavoro. Sono entrato in compagnia con le sorelle Nava. Facevamo Tre per tre Nava. Con Billi e Riva più tardi ho fatto Gli italiani son fatti così: mi pare fosse questo il titolo. Ma mi sembrava di non essere apposto. Io avevo fatto l’Accademia... Mi ero dato da fare un po’ anche col doppiaggio. Che mi ha dato da vivere per anni. E certe cosette radiofoniche. La radio mi ha dato da mangiare per tanto tempo. Così mi ricordo che un giorno mi sono sentito d’andare dal presidente dell’Accademia a chiedere scusa e a spiegare che accettavo quei lavori perché non c’era altro. E Silvio D’Amico: “Hai fatto bene. Quando venite a Roma con la compagnia, dimmelo, che ti vengo a vedere.” Poi mi prese sotto braccio, mi accompagnò fuori, lontano dagli altri allievi, e mi disse: “Manfredi, ricordati sempre, però, che tre per tre non fa Nava. Fa nove. E tu le carte in regola le hai.”
La porta di Visconti. Non è che le cose sono andate subito meglio. Il successo è arrivato che ero già grandicello, dopo un sacco di teatro, di varietà e di tentativi nel cinema. Fu la Magnani che per prima parlò di me in giro, credo. Io e Gianni Bonagura facevamo un pezzo con Billi e Riva che si chiamava La psicanalisi, un pezzo che non piaceva a nessuno, e che ci avevano affidato per vedere come funzionava. Durava cinque minuti. La Magnani c’andava pazza, e il pezzo passò lungo fino a venti minuti. Venne in camerino: “Fammi un po’ conoscere ’sto fijo de ’na bona donna, che me fa tanto ride’.” Voleva fare un film con me, diceva, dove lei avrebbe fatto mia madre, ma poi andò in America. Fellini mi disse che non andavo bene per lui perché avevo troppa personalità. Ora che abbiamo visto i film che ha fatto ho capito che non era per sbolognarmi. Proprio nun c’entravo niente. Ho avuto anche una grande occasione con Luchino Visconti. E che occasione... Ero allievo all’Accademia, un giovanotto di venticinque anni. Mi voleva fare un provino per Giulietta e Romeo e mi fece invitare a Ischia, dove mi accomodarono nella camera accanto alla sua. Quando uno dei suoi collaboratori mi raccomandò di non interferire con i desideri del Maestro, pensavo che mai avrei fatto l’errore di contraddire il Maestro, che appunto era un maestro. Poi capii. Si trattava di non contraddire altre cose. La mia camera aveva una porta in più, senza chiave. Chiesi dove portava. Nella camera del Maestro, mi rispose un cameriere. Be’, dico, mettiamoci questa sedia che nun se sa mai. E poi, da un fascio di vecchi bastoni da passeggio ne sfilo uno, lo poggio sul letto, e dico al cameriere: questo lo tengo qui, nel caso la notte, per i ladri... Non ebbi mai la parte. Non lavorai mai con Visconti.
Il soldato di Calvino. Però per me il teatro era più importante del cinema. Il teatro mi ha insegnato tanto. Sapevo quando ridevano. Studiavo i punti. Il rapporto col pubblico è esaltante. A Milano ho tentato col Piccolo, ma ero troppo ciociaro per Strehler. Invece Eduardo, ancora ai tempi dell’Accademia, mi scelse perché voleva un giovane senza accento napoletano. Che esperienza. Eduardo non era ancora così amato dalla critica. Durante le pause si metteva a leggere un libro e quando provavi, sembrava non ti ascoltasse, poi interveniva: “Ma che fa, Manfredi? Mi fa il verso?” Il teatro mi ha aiutato anche a scrivere, per esempio i film di cui ho fatto la regia, L’avventura di un soldato, episodio da L’amore difficile, dove la sfida era vedere se il pubblico rideva anche se non dicevo delle battute: il film è una storia d’amore muta, dal racconto di Italo Calvino. Calvino sosteneva che era impossibile farne un film. Poi mi scrisse: “Caro Manfredi, sono andato al cinema a vedere il nostro episodio, mi nascondevo nella poltrona, perché mi sentivo scoperto dentro. Le posso dire che è molto più bello il suo film del mio racconto.” Be’, soltanto un grande scrittore può farti un complimento così. Di lì m’acchiappò Dino De Laurentiis. Lo temevo, Dino. Sono andato negli studi a vedere L’audace colpo dei soliti ignoti, che per me fu un successo personale, col cuore in gola. Mi ero rifugiato in cabina, perché me prendeva er batticuore a stare in sala con loro. Col cinema, comunque, ho sempre dovuto difendermi dai registi. Perché me facevano fa’ cose che non sentivo adatte a me, io cercavo magari vie più spiritose per le battute, che me venivano così, e allora me ’nventavo che me l’aveva dette lui, il regista, il giorno prima, di farle così.
Io, Sordi e gli altri. Non si dice mai che c’era una lotta tra i grandi registi e gli attori. Quando siamo andati in Angola per fare Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, la storia di uno che s’era rotto le palle e se n’era andato, Scola voleva che Sordi, che era più importante di me, prendesse il ruolo dello stregone e io quello del borghese che va a cercare il cognato, che poi se scopre ch’è lo stregone. Gli dico: guarda che la parte dello stregone è tragica con risvolti comici, bisogna inventasse qualcosa, non è roba di Sordi, che invece farebbe bene la sua parte di borghese (perché Sordi ha sempre fatto lo stesso modello di personaggio, in fondo, e questo era il suo limite, lui era una maschera). Scola per fortuna alla fine s’è convinto. E io me ’nventavo ’n sacco de cose, per esempio in quella scena della danza della pioggia, mentre Sordi sta per scoprire che forse suo cognato è proprio lo stregone, cioè io, e mi chiamano : “Titinooo,” e io continuo: “A-ranga-te-tin-ghe-teponga-ti-tanga-cherompa-li-coiota-sti-qua.” E poi scappo. Scola mi ringrazia ancora adesso, anche se c’avevamo ’na paura: c’era il “sette passi”, il nostro incubo, un serpentello che se te pigliava non facevi più di sette passi. E quando ho fatto Cafè express Nanni Loy voleva fare soltanto un episodio. Ne abbiamo parlato molto, ed è venuto fuori invece quel film, un buon film no? Ma anche in teatro, quando mi volevano far fare Molière, cose che avevo studiato in Accademia, ma mi sembrava tutto già fatto e fuori dalle mie corde, e allora m’inventai quel Gente di facili costumi a due personaggi, che facevo con Pamela Villoresi all’inizio, ma son riuscito a svilupparla bene nell’edizione con Lia Tanzi, perché lì si capiva proprio che la prostituta vera non era lei, ma io, che mi vendevo ai giornali, e a tutti. Era quello che volevo venisse fuori dalla mia commedia...
Album. Ma non c’è un personaggio che in qualche modo non abbia reinventato a modo mio. Quello del Padre di famiglia di Nanni Loy, che se doveva adatta’ alle maniglie ad altezza de bambino per segui’ er metodo Montessori e io allora sbattevo dappertutto. E poi c’è... Famme ’n po’ vede’ sti ritagli, ecco questo è Anni Ruggenti, di Zampa, che me mettevo la retina ’n testa, e mi ero sentito tutti i discorsi di Mussolini. E questo è Vedo nudo di Risi, un regista che mi è sempre piaciuto tantissimo, perché me faceva fa’ quello che volevo. Ecco Straziami ma di baci saziami, che ho fatto con Ugo Tognazzi; eh Tognazzi, s’andava a magnà a casa sua, grande cuoco, e una volta, quando faceva Il petomane me disse: “Io t’invidio moltissimo, perché fai tutti questi film storici, le commedie, fai la regia, sei sempre lì a lavorare.” Qui sono con Delia Scala, noi abbiamo inventato il varietà che poi è diventato parte integrante della televisione (oggi per me la tv è quasi tutta pubblicità, a parte certe cose, per questo che ho puntato su Linda e il Brigadiere, perché è ancora una storia, con dei personaggi, e l’ho fatto contro il consiglio degli amici che temevano il confronto con una star bella e giovane). E questo è Per grazia ricevuta, dove ho voluto fare la regia per essere sicuro, perché per me era un film sulla ricerca di Dio, sempre a modo mio, e Rizzoli non voleva crederci; allora, lo sanno tutti, ho scommesso: dico, se il film è un successo me dai trenta milioni de regalo, se va male ne faccio un altro per te senza prendere un quattrino, e m’ha dovuto da’ ’sti trenta milioni. Ecco Erminia, embè la vita mia, adesso s’occupa dei nipoti, ma me dice sempre ch’io
so’ er nipotino più caro. Oddio, qui stiamo sul palco dell’Accademia, questo è Gassman, nel breve periodo giovanile in cui credeva di essere un attore comico, non so se me spiego... Buazzelli magrissimo, Salce già smorfiosetto, e io, che me facevo venti chilometri in bicicletta per andare da casa all’Accademia. Eh, ’mmadonna mia... e questo cos’è? Ndo’ l’avete presa? Li mortacci. Ma che, so’ io?
26 Ho sempre provato diffidenza e insieme tenerezza per quel frammento d’umanità che decide di vivere fuori di sé, forse perché mio padre, sognando di diventare attore, estingueva il desiderio nell’istante in cui si presentava. Appena usciti dalla guerra consideravo l’attore o un affamato senza speranza o un poeta ridicolo. Ho scoperto con l’esperienza che, in alcuni grandi interpreti, esiste un vigoroso equilibrio del narcisismo. Ma per gli altri? Mi colpiva che alcuni uomini e donne accettassero di assecondare l’ambizione della nomea, dell’apparire, diventando un modello agli occhi di milioni di altri uomini e donne, spiati, immaginati, vergognosamente invidiati lungo una strada lastricata di frustrazioni e nostalgie. In un album fotografico impaginato con mio marito, c’è una fotografia del mio amico P. con Franca Marzi. Lei indossa un abito da sera. Una vertiginosa scollatura esalta il prorompente balcone che le aveva dato la celebrità quando dominavano le ragazze da quinta misura. Ai tempi dell’istantanea, lei era già decaduta, decaduta l’immagine e decaduta l’attrice. Era diventata grottesca. Perduta la linea, s’imponeva per la stazza. Francesco sosteneva di conservare quella fotografia non per ricordo del nostro amico attore, ma per testimoniare perché avesse scelto me, una ragazza smilza che, negli anni ’50, andava orgogliosamente controcorrente. Sotto la fotografia di P. che fa il baciamano a Franca Marzi, Francesco, con perfidia, ebbe il coraggio di incollare il ritaglio di un’ingenua battuta dell’attrice a un rotocalco: “Non feci La dolce vita perché pesavo troppo per Mastroianni”. Si sapeva anche che Fellini, per Le notti di Cabiria, aveva chiesto alla Marzi di ingrassare fino a 120 chili, e lei, poveretta, era incinta. Detestai il cinismo con cui, anni dopo, qualcuno riportò che il cineasta americano Ulmer l’aveva soprannominata “meat ball”. La chiamavano “polpetta” gli stessi uomini che, dieci anni prima, avrebbero dato una mano per una notte con lei: tecnici, macchinisti, impiegati, addetti alla fotografia. La verità è che, nel periodo seguente alla montatura delle maggiorate, le donne incassarono il danno del declino e la beffa della satira. Tra le altre ragazze finite nel mirino dei giornali, c’era Yvonne Sanson, che ormai viveva senza un quattrino, cercando di lavorare come traduttrice. Questa nuova condizione non la salvò dall’ironia della stampa. In un servizio sulle attrici formose del dopoguerra “Il resto del Carlino” – eravamo negli anni ’70 – scrisse: “Fu dimenticata perché non seppe dimagrire in tempo.”
NATALIA ASPESI Maschi e moralisti Mia madre, che lavorava tutto il giorno e non sapeva dove lasciare me e mia sorella, ci cacciava in un cinema alle due del pomeriggio. Potevamo restare al Magenta quasi fino a sera. Ho visto film italiani che mi appaiono bellissimi anche oggi, Pia dei Tolomei, Pietro Micca, Violetta dei tuoi capelli, i film degli anni ’40, gli anni di guerra, quando il cinema americano da noi non esisteva. Sono film che, in fondo, non ho mai dimenticato. Però, devo dire che non mi appassionavo agli attori. Mia sorella, invece, raccoglieva dai rotocalchi le foto delle dive e le appiccicava sui quaderni a quadretti. A me i divi non interessavano. Mi colpivano invece le storie. Ricordo La corona di ferro di Blasetti. Però bisogna dire la verità su quegli anni. Eravamo molto snob: guardavamo i film italiani, ma sognavamo i film americani.
Loren, Lollo, Mangano alla meta. Il divo italiano per me non esisteva. L’ho scoperto dopo. Vent’anni fa ho scoperto Amedeo Nazzari, che secondo me è stato un grandissimo divo, bello, bravo, di alto livello. Da bambina mi sembrava ridicolo perché portava i baffi. Un uomo elegante, riservato. Il migliore dei divi dell’epoca antecedente al neorealismo. Tra le donne, l’unica che mi colpiva era Alida Valli, in Piccolo mondo antico o, dopo la guerra, nel Caso Paradine di Hitchcock. Però, ripeto, non ero sensibile al divismo, ma al film e ai registi, che inconsciamente mi piacevano più degli attori. Quando io non ci facevo caso l’Italia dei rotocalchi (pochi) aveva Maria Denis o Massimo Serato: ero io che non recepivo il fenomeno perché non m’importava. Ho incominciato a capire il divismo con Sofia Loren, e anche con la Lollo. Erano creature eccezionali. Prima di tutto per l’epoca. Noi eravamo smunte, poverelle, malvestite, uscite malamente dalla guerra, loro invece, ragazze del popolo come noi, ma floride e di successo. Le trovo, anche col senno di poi, più brave e “riuscite” delle colleghe americane. Se prendi un film degli anni ’50 americano, risalta quanto le attrici erano artefatte, mentre le nostre erano naturali e dotate artisticamente. Noi abbiamo sempre visto i film americani doppiati, non dimentichiamolo, cosa che rende difficile capire le qualità di un attore. Lollo e Loren usavano la loro voce, quindi per noi erano divi più completi. Per molti anni correva l’idea (maschile) che, se sei bella, sei stupida o che, se sei brutta (forse) sei intelligente. Queste donne, invece, dimostravano non solo di essere di formidabile bellezza (tutte e due assolutamente fuori dalla media della grazia femminile italiana), ma anche di essere donne intelligenti, che sapevano sostenere un’intervista mostrando una personalità. Ma qui bisogna citare anche Silvana Mangano. La Mangano però è stata una diva più costruita, suo malgrado. Mentre la Loren e la Lollo hanno voluto quel successo, hanno lottato per ottenerlo, la Mangano ha subito un divismo che poi ha sempre detestato. Penso che lei, come molte donne dell’epoca, ha scoperto che le interessava di più la famiglia del lavoro. Per cui, affrontare il cinema, la concorrenza, le relazioni pubbliche, non era quello a cui aspirava. Era protetta da un marito come De Laurentiis, potente produttore. È probabile che abbia lavorato per fargli piacere. Non mi sembra che abbia mai avuto il sacro fuoco. È stata diva malgrado se stessa. Nella coppia
Loren-Ponti, invece, il motore era lei. Carlo Ponti, uomo di grande intelligenza e abilità, per quel poco che conosco, si trovò accanto una donna che doveva riscattarsi da qualcosa e che quindi aveva bisogno di raggiungere la celebrità. Non ha dovuto imporla.
Maggiorate e minorate. Non credo che la diffusione del modello di bellezza femminile venisse dal cinema. Aspirare a essere formose era un’idea che veniva dalla realtà, dalle immagini delle “Signorine ‘Grandi firme’”, dal bisogno di abbondanza. Anche in Francia la moda, con Dior, con il “nero look”, faceva la vita sottile, il busto fiorente e i fianchi rotondi. Era l’uscita dalla guerra che imponeva questo tipo di donna. Loro l’hanno rappresentata. C’erano anche la Pampanini, Yvonne Sanson, Franca Marzi. Anzi, Loren e Lollo erano magre rispetto alle altre. Le ragazze di oggi si sognano un corpo come il loro. La famosa scena di Altri tempi di Blasetti, nella quale De Sica esalta la “maggiorazione fisica” della Lollo per strappare una assoluzione al processo, inventando quel modo di dire che fece epoca, recepiva i modelli della realtà, non credo fosse un’idea originale del cinema. Esistevano delle minorate? Be’ erano le false maggiorate, anche loro però con quei seni aguzzi poco erotici, perché sembravano dei siluri americani, quei seni a punta duri, imbustati, in modo di richiamare semmai la maternità.
La sottoveste della Calamai. La moda ha influito sulle mode. La società ha influito sul cinema, non il contrario. Forse l’unico periodo in cui la direzione era invertita, fu durante la guerra perché noi vedevamo i vestiti, e quindi il rapporto tra corpo femminile e “modo di essere”, soltanto al cinema. Avevamo perso il contatto con la realtà, anche se esistevano le signore ricche che andavano a vedere le sfilate sotto i bombardamenti. Ma la persona comune non aveva alcun contatto con l’abbigliamento, se non il problema di mettere insieme due cappotti per farne uno. Il massimo che posso ricordare del cinema è l’influenza, se ci fu, di Clara Calamai in sottoveste nera nel primo film di Visconti Ossessione. C’è da dire che queste attrici dall’aspetto fiorente nei film si trovavano spesso mortificate. Perché, o dovevano interpretare un ruolo di puttana (c’era un periodo in cui si fecero soltanto film sulle puttane), e allora morivano e buonanotte, la morale era salva. Oppure interpretavano ruoli di bonaccione, donne semplici che non la davano mai. Quando abbiamo visto per la prima volta Brigitte Bardot, per citare un caso eclatante anche se non è italiano, aveva un corpo meraviglioso e doveva essere, secondo il personaggio, una donna poco seria. Ma nella storia in realtà era una santa. C’era un moralismo nel cinema che non aveva niente a che fare con la realtà. Il cinema italiano, poi, ieri e oggi, è dominato dal moralismo.
Il papa e l’igiene femminile. Il cinema semmai poteva influire sull’igiene femminile: mostrava gambe depilate, acconciature e pause in bagno, anche se Irene Brin, parlando del cinema italiano, notò quanto
erano tristi le ascelle non depilate delle dive italiane. Le nostre dive erano rustiche, come le ragazze vere, come noi, che non ci depilavamo perché era peccato. Depilarsi era un segno molto erotico. Non posso dimenticare che, sotto i bombardamenti, mentre la gente moriva, papa Pio XII scrisse ammonendo le donne che si depilavano. In una frase si denunciava la donna che, alzando le braccia, mostrava la pelle nuda.
Fellini. Fellini, considerato come il vate della femminilità nel cinema italiano, era un uomo un po’ frustrato e moralista, che si era scelto come moglie una ragazza completamente diversa dal suo sogno erotico. Non era bruttina Giulietta, come si vorrebbe, era molto graziosa, ma da giovane aveva un fisico adolescenziale, poi come tutte è cambiata. Credo che le donne abbiano sempre considerato grottesca l’idea che Fellini aveva della femminilità nei suoi film. Il gioco però funzionava perché si esauriva nel film. Le donne hanno amato Fellini per questo, perché mostrava quanto la femminilità poteva essere terribile. A lui piaceva quella femminilità. A noi no.
Cinesogni femminili. Nel mio immaginario il divo maschile è sempre stato quello americano. È una considerazione personale, non so quanto generale. Se dovevo immaginare il divo, o anche un uomo bello, non mi veniva in mente Mastroianni, che era molto affascinante, bello e delizioso. Credo che molte di noi hanno legato il divismo all’America, ovvero alla lontananza, all’estraneità e alla irraggiungibilità. Io trovavo bellissimo Girotti, ma non me lo sognavo di notte...
Il tango impossibile. Divorzio, aborto, famiglia, omosessualità, rivoluzione sessuale: il cinema italiano ha raccontato quasi sempre questi cambiamenti dalla parte del maschio. Il cinema è ancora oggi uno strumento che rispecchia la mentalità maschile. Con questo non voglio criticarlo, perché ogni mezzo ha una sua specifica attinenza con i sessi. Per quanto... L’omosessualità è stata vissuta in Italia come una cosa comica, in America come una cosa tragica. Nei film di Pasolini, il ragazzo che lui vedeva come preda sessuale, sembrava ridicolo alle spettatrici, come Citti in Mamma Roma, o gli altri attori giovani nel Decameron o nei Racconti di Canterbury. Ma c’era sempre molto moralismo. Il ’68, inteso come rivoluzione sessuale, non solo non è entrato nel cinema italiano, ma non è arrivato neanche nella vita, a parte alcune studentesse di sociologia a Trento che volevano a tutti i costi perdere la verginità e non trovavano nessuno disposto. L’abbiamo tentato, immaginato, voluto, scritto, il sesso libero, ma non è successo niente in realtà. Se penso a Ultimo tango a Parigi, fin dalla prima volta che l’ho visto mi son sempre chiesta come poteva avvenire una sodomizzazione senza togliersi i pantaloni. È impossibile. Mentre era interessante che fosse un rapporto tra sconosciuti. Bertolucci ha colto qualcosa che era nell’aria, perché si riferiva alla libertà sessuale fuori dal
matrimonio. Ma non è stato il cinema che ha prodotto i cambiamenti. Il divorzio, l’aborto, queste uniche, vere rotture con la continuità le hanno volute le donne. Sul sesso, comunque, è accaduto tutto dopo, col consumismo, cioè anche il sesso è diventato bene di consumo. Ai tempi era invece giudicato un gesto rivoluzionario, ma non ha attecchito, perché la rivoluzione non piace agli italiani.
27 Un tuono mi sveglia liberandomi da un sogno faticoso. Ero in fuga tra le poltroncine porpora d’un teatro, sparse nel vuoto a vista d’occhio, una specie di bosco di spettatori assenti in fondo al quale, come nel sogno di qualche notte fa, Eleonora Duse, eretta e immobile come una statua, leggeva qualcosa. Ma al contrario della prima volta, potevo sentirla declamare queste parole: “L’età sesta... l’età sesta...” Sono ancora qui sul divano. Credevo fosse trascorso qualche istante, invece ho dormito quasi due ore. E se fossi morta? Uno scroscio picchietta i vetri semichiusi, l’acqua raggiunge il parquet. Che fatica alzarmi. Quanto vorrei lasciare al mio corpo il piacere di soccombere. Tirando le imposte, m’investe uno spruzzo di pioggia, così resto in piedi per qualche istante ad assaporare i rivoli che scendono dai capelli come un segno di vita. La mano si muove a cercare il foulard. Portavo il foulard quando, d’estate, andavo in campagna dal mio nonno materno. Passavo i pomeriggi ad aiutare a coltivare un orto immenso. Il foulard lo legavo stretto dietro la nuca, coprendo la testa fino alla fronte, come le paesane in lutto, per difendermi dal sole e sfidare gli acquazzoni improvvisi. Mi dava una sensazione di protezione, come se potesse nascondere certi pensieri inconfessabili mentre lavoravo con i parenti. Anni dopo osservai sui rotocalchi le fotografie di Valentina Cortese. Per me era già l’unica autentica diva italiana, con i suoi foulard alla contadina e le pose sui divani. Mi colpiva però il contrasto tra il segno di clausura del copricapo e la disinvoltura mondana della grande attrice. Il sorriso da infermiera charmant non mi convinceva, percepivo che quella copertura era, come per me, un bisogno, una protezione, una difesa dal mondo. Sognavo di andare a Milano per assistere al Giardino dei ciliegi di Strehler e incontrarla, ma la malattia di Francesco ormai impedì qualsiasi viaggio.
VALENTINA CORTESE Confesso che ho vissuto Per parlare di me devo parlare della mia terra, della mia gente. Sono grata a loro, perché mi hanno insegnato i primi passi nella vita; con i contadini ho capito che cosa vuol dire camminare nel dolore. Gente così vera, così meravigliosa, così povera. La loro amicizia fu un insegnamento di vita, per me. Nonostante tutto quello che mi sta intorno, le case, i viaggi, la mia vita, io sono rimasta una di loro. Meno male che le cose sono cambiate per me, dalla mia infanzia. Non nego la felicità per tutto quello che mi è successo. E quanto, quanto tempo è passato... Ho fatto il compleanno in gennaio. Ai miei amici, dico: Valentina ha compiuto otto anni! otto anni! Sono così lunghi. Oh mio Dio, I can’t believe it.
Il valore della recitazione. La mia balia... Quanto l’ho amata. E suo marito Giuseppe. Faceva il falegname. Sono stati i miei primi genitori. Mia madre, pianista, era sempre in giro per il mondo. Mamma Rina, così chiamavo la balia. Dopo un paio di giorni dalla nascita, sono stata portata ad Agnadello, vicino a Crema. E dopo qualche anno siamo passati a Rivolta d’Adda. Avevo due fratelli di latte, molto birichini. Ci nascondevamo sotto il tavolo, correvamo in giro, e papà Giuseppe, stanco, ogni tanto ci sculacciava. Care creature, tutte. La comprensione del mondo e degli uomini che credo di avere, la devo a loro. Se qualche cosa ho dato durante la mia carriera, nel teatro come nel cinema, il dolore che ho dovuto ascoltare nei personaggi che interpretavo, la semplicità e la gioia di piccole cose, ebbene l’ho fatto rivivendo quelle radici. Se ho dato della verità, lo devo a loro. Uno dice: ah l’attore, che bello, e bla bla bla... ma un attore, anche nel Cinquecento, nel Seicento, era una persona eccezionale a partire dalle sue esperienze di vita, perché gli attori vanno a frugare nel loro mondo interiore per dare il meglio al loro pubblico, nel tragico come nel comico. Il valore della recitazione nella mia vita... La recitazione mi ha dato l’opportunità di interpretare, attraverso i vari personaggi, diverse visioni del mondo. Mi ha concesso di moltiplicare la mia anima e di allargare la mia capacità di conoscenza, una lenta, graduale, inarrestabile maturazione.
Balla Valentina. Ho sempre avuto il pallino di recitare. La balia mi portava spesso a casa di una contessa, che mi metteva su un tavolo e mi diceva: balla Valentina, balla. E io sentivo il rumore dei piedini sul legno, e mi muovevo, inventavo dei passi, quel legno che scricchiolava era il futuro palcoscenico. Mi esaltavo, inventavo delle cose, recitavo, danzavo, mi sentivo libera, libera. Sentivo il bisogno di creare. Il marito della mia balia, come ho detto, faceva il falegname. La famiglia era molto, molto povera. Non ho mai avuto una vera bambola, Non voglio piangermi addosso, per carità. La bambola più bella che ho avuto la costruì per me la Rina, con gli stracci. Giuseppe sapeva che io adoravo le marionette e che non potevo averle. Ebbene, un giorno mi costruì un palcoscenico incredibile, quasi astratto, una base così, di legno, e un
fondale semplice, anch’esso di legno. E io ci passeggiavo dentro, creavo delle mie marionette, immaginavo personaggi e storie. Ci sognavo dentro.
La pipì e il cardinale. A Rivolta d’Adda le suore mi adoravano. La mia prima recita fu per loro. Dovevo fare il ruolo di un angelo vicino alla culla di Gesù. Non avevo più di cinque anni. Per l’occasione erano venuti il vescovo e un cardinale. È successo un pasticcio, non so se si può dire... Al momento della mia unica battuta non sono riuscita ad aprire bocca. Ero imbarazzatissima, e dall’emozione ho fatto una pipì lunga lunga che è arrivata fino al cardinale. Coi vescovi e i cardinali non ho mai avuto fortuna. Si vede che li temevo. Così, mi hanno preso di peso e portato su in cucina, e queste suore, creature divine, ma anche folli, per calmarmi mi hanno dato un bicchiere di vin brûlé. In pochi secondi sono diventata ciucca, e allora volevo scendere, volevo recitare. Non fu più possibile. Avevo peccato. L’anno dopo venne un altro vescovo. Puntarono su di me per la poesia. Si vede però che la dicevo così male... L’affidarono a un’altra bambina. Questa cosa mi ferì profondamente. Per consolarmi, mi regalarono tre castagne. Con queste castagne e tanto dolore mi avviai verso la casa della balia, vicino a un mulino, dopo un fossato. Mi fermo, apro la prima castagna, la mastico, ma la sputo subito, perché era cattiva. Apro la seconda e vedo che è tutta marcia. Apro la terza, marcia! C’era una roggia con l’acqua, vicino al mulino, dove una volta rischiai di morire affogata, ma non è per dire, ero proprio certa di morire. Mi gettai lì e piansi, piansi disperatamente... Decisi che sarei diventata attrice. Far vedere a questi signori che un giorno avrei saputo recitare! Papà Giuseppe, allora, costruì delle spade. La Rina pulì il fienile. E inventammo una recita, io e i miei fratellini di latte, con le battute e una storia che ora non ricordo. Fu la rivincita. Invitammo i vicini, che pagarono “cin’ ghej”. I soldi servirono per comprare zucchero e caffè per una povera creatura, la mamma di sette figli, con un marito malato che non poteva lavorare. Eravamo così felici quando le portammo queste cose...
In braccio a Ermete Zacconi. Tutti i ragazzini erano affascinati dal cinema. Solo l’idea dei divi, di quel mondo misterioso... Quando andai ad abitare a Milano, in via Washington, se facevo tutti i compiti mia nonna mi portava al cinema, in piazza Napoli, al Ducale, una piccola sala che oggi è risorta come multisala. Si potevano vedere gli spettacoli due, tre volte di seguito. La mia diva era la Garbo. Oh come mi piaceva! Decenni dopo scambiai un sorriso con la Garbo al Ritz di Parigi, durante una sfilata di Chanel. E poi la Dietrich. Non sapevo che l’avrei conosciuta a Hollywood. Una volta m’invitò a casa sua. Voleva fare gli spaghetti, a me e alla sua amica Jane Wyman. Che cosa? dissi. Vengo, ma gli spaghetti li cucino io. Non c’è nessuno che li sa cucinare da voi, ti faccio mangiare la pasta come si deve. Che cara! Ma la Garbo! In un baule, in una soffitta, avevo trovato un libriccino con un titolo: La signora delle camelie. Non vedevo l’ora di tornare a casa da scuola per mettermi davanti allo specchio, scoprire la spalla, e recitare come faceva lei. Avevo i boccoli allora... Poco prima che scoppiasse la guerra, a Stresa, dove i miei nonni avevano una casa, con alcune amiche decidemmo di mettere in piedi delle recite per
mandare gli incassi ai soldati che stavano in Africa. Andavamo in giro con la bicicletta a vendere i biglietti. Davanti a un grande albergo c’erano delle personalità dell’arte, della musica. C’erano il maestro Giordano, il grande regista teatrale Salvini, e c’era questo grande uomo, di cui mi innamorai subito, il maestro Victor De Sabata. Ero una ragazzina, non avevo ancora compiuto diciassette anni, tra di noi c’erano trent’anni di differenza. E allora era uno scandalo. Ma quest’uomo, con quegli occhi meravigliosi che rispecchiavano la sua anima... Era qualcosa di più di un uomo, per me. Un grande amore, grande, che durò tutta la vita. Loro si divertivano a venire alle nostre prove. De Sabata mi diceva: tu dovresti tenere la mano così, il busto così. Insomma mi insegnarono un po’ a recitare. E Salvini, che era proprio un regista, ci dava consigli sulla messa in scena. In quel breve periodo estivo, circa due mesi, abbiamo allestito quattro testi, tra cui Scampolo e La maestrina. Accadde una cosa strana per me. Nella “Maestrina” mi ero talmente immedesimata che svenni. Per fortuna riuscii ad arrivare alla fine dell’atto, poi mi lasciai cadere dietro le quinte. Ero così commossa da questa creatura che non poteva più vedere la sua bambina... Salvini e gli altri mi dissero che l’unica cosa che potevo fare per continuare questa passione era andare a Roma e iscrivermi alla Scuola d’Arte Drammatica. Per il rischio di una tubercolosi ossea, dopo una notte passata sotto l’acqua, al lago, fui costretta a stare a casa due mesi. E lasciai il liceo. Avevo il pensiero a Roma e all’Accademia. Appena guarita, chiesi di partire. Ero cresciuta con mia nonna, persona meravigliosa: fu lei a mandarmi, ospite dai miei zii. Incontrai Silvio d’Amico. Disse che era troppo tardi, i corsi erano già incominciati. Si trattava di perdere un anno. Lo pregai. E lui: recitami qualcosa. Con una faccia tosta che non so dove ho trovato, parto con un passo della Signora delle camelie, poi un pezzo di Scampolo e alcune cose di Shakespeare. E d’Amico: vedo che hai del talento, non ti farò perdere un anno, leggi queste cose e poi torna. Ero al settimo cielo. Ma la fortuna non era ancora finita. Prima di partire, credo fosse la fine del ’40, i miei zii mi portarono a fare un giro a Cinecittà. In uno dei teatri dove potevamo curiosare chi c’era? Salvini. Stava girando un film con attori di teatro. Gli raccontai, come si dice a Milano, la rava e la fava. Per essere carino e per darmi una chance, come mi rivelò poi, mi chiese di fare una cosetta lì per lì. Cercava una ragazzina per un ciak come figlia di Zacconi, il grande Ermete Zacconi. Il film s’intitolava Orizzonte dipinto. Mi mandarono a truccare. Intanto imparai le battute. Feci quella scena con un tale trasporto, una tale gioia. Salii sulle ginocchia di Zacconi, eseguendo tutto quello che mi chiedevano. Ma le battute, cercai di farle durare il più possibile! Mi piaceva tanto quel momento, l’avevo così sognato... A quei tempi, ogni tanto, dopo i ciak, succedeva che i macchinisti e gli addetti applaudivano. E così fu per me. Che bello. Salutai tutti, dissi: ci vediamo tra un anno, tornerò per l’Accademia. Dopo un mese e mezzo mi arrivano due contratti, uno della Scalera Film, l’altro della Ici, entrambe case di produzione molto importanti. E io li firmai tutti e due. Brava scema! Avevo diciassette anni, non sapevo che non si poteva. Mi chiamarono a Roma, perché uno escludeva l’altro, ma non potevano fare niente contro di me, ero minorenne. Dopo discussioni e liti tra di loro, la Scalera vinse. Promisi un film all’Ici, che poi fu il secondo, Primo amore, di Gallone, con quella dolcissima ragazza, Clelia Matania, e Osvaldo Valenti. Con la Scalera invece feci il mio primo film, Il bravo di Venezia, di Campogalliani, e c’era anche Rossano Brazzi.
A colazione con Goering.
La guerra arrivò e fu terribile. Si tentava di sopportarla, come si poteva. È vero che questo cinema era “d’evasione”, era un’evasione soprattutto per noi che lo facevamo. Eravamo privilegiati, in un certo senso, noi del cinema. Finché si stava sul set, finché vivevi dentro un personaggio, in un’altra vita, tutto sembrava lontano, eri obbligata a stare in un altro mondo. Poi uscivi... Durante le riprese di un film, alla Scalera, abbiamo avuto dei bombardamenti terrificanti, bombe a catena, si correva a rifugiarsi in una chiesa lì vicino, ma spesso io restavo nello studio. Mi chiamarono per un film con Blasetti, La cena delle beffe. Che figura straordinaria! Ce l’avevano con lui per i film vicini al fascismo, ma in realtà era con Mussolini che ce l’avevano, per la guerra in Africa e per i soldati allo sbando. Fu Genina a fare il film che Mussolini voleva per sostenere le azioni in Tripolitania, Squadrone bianco. A proposito di Genina, mi ricordo di sua moglie, in un’occasione speciale. Ero a Milano con Victor, che dirigeva Tristano e Isotta alla Scala, con l’orchestra e i cantanti di Berlino. Il führer, che amava molto la musica e conosceva Victor De Sabata (l’aveva sentito a Bayreuth), tramite Goering mandò una corona d’alloro. Mi sembrò bizzarro, ero così piccina. Victor abitava al Continental, in un appartamento meraviglioso, da cui si vedeva tutta la città. Goering portò in pompa magna questa corona a Victor, che fu costretto a invitarlo a colazione. Io, scema, appena diciottenne, partecipai tutta contenta. C’era anche Betty Genina, la moglie di Augusto, una bellissima americana. Non parlavo, non capivo una parola di tedesco, ma sedevo al tavolo con questo mostro. Uno che ci teneva a farsi considerare un signore, un amico degli artisti, uno che poi organizzò attentati contro il führer. Ho letto che, quando fu condannato all’impiccagione, decise di morire con una pillola avvelenata.
Divine creature e gerarchi fascisti. Ero troppo giovane per capire che cosa stava succedendo e per poterne dare una valutazione precisa. La società che ricordo, quando incominciai a lavorare a Cinecittà, era in rapida mutazione. La guerra e la speranza che finisse con un grande cambiamento occupavano i discorsi di tutta la gente del cinema. Grazie al cielo il mondo andava verso un idealismo diverso. Ma noi ragazze, come potevamo sapere? Una volta mi trovai molto a disagio col genero del duce, Galeazzo Ciano. Poveretto, fucilato proprio dai suoi parenti... Era venuto a fare visita agli stabilimenti. Allora si usava spesso la visita ufficiale tra le maestranze del cinema. Mi ricordo che, gentilmente, volle accompagnarmi a casa. Mi sentivo imbarazzata su questa macchina, con questo signore importante e molto gentile. La sua famiglia era di Livorno. Da bambina andavo al mare a Livorno e, un giorno, ci fu una grande colazione collettiva con la famiglia Ciano (mi ricordo di suo padre). Non so come, mi trovavo anch’io lì in mezzo. Insomma, quel giorno con l’auto fu molto galante con me, ma non successe niente, sia chiaro! Doris Duranti, che conoscevo bene e che era bel-lis-si-ma, un incanto, era invece l’amica di Pavolini, lo sapevano un po’ tutti. Con Blasetti abbiamo fatto insieme Nessuno torna indietro di Alba De Cespedes. Dio mio, quante star, c’erano proprio tutte: Mariella Lotti, Maria Denis, Maria Mercader, altra divina creatura, così bella, con una carnagione così bianca intorno a quegli occhi meravigliosi, su-bli-me, e la Dina Sassoli, adorabile, e Doris naturalmente. E poi chi c’era? I don’t remember. Ah, la Elisa Cegani, com’era deliziosa quella donna. E io, piccola, che le avevo ammirate al cinema da ragazzina. Devo dire una cosa, lo so
che salto un po’ da un argomento all’altro. Ero a Torino, ho abitato un po’ lì, in via Po. Adoro quella città, trovo che sia una delle più belle del mondo. Avevo quattordici, quindici anni, e un giorno vedo che stavano girando la scena di un film di Blasetti, credo Contessa di Parma, con Elisa Cegani, un film di evasione, come si diceva, o dei “telefoni bianchi”. Per la prima volta vidi questa cinepresa che si muoveva, Blasetti con gli stivaloni, proprio come si leggeva sui rotocalchi, e lì davanti Elisa, elegantissima, con uno chauffeur che l’accompagnava all’automobile. Sono stata conquistata dal cinema, quel giorno. Volevo fare il cinema. Ma poi mi dicevo: non sono abbastanza bella!
Star e attori della strada, l’arte della recitazione. Ho vissuto il passaggio dal cinema dei “telefoni bianchi” alla nascita del neorealismo, dal disimpegno all’impegno sociale, come una fondamentale transizione d’epoca. Esistevano anche altri generi popolari, che continuarono a raccogliere il consenso del pubblico, come I miserabili, che feci con Riccardo Freda, un grande regista non ancora capito. Adesso fanno questi recuperi, ma Freda è sempre dimenticato. C’erano Gino Cervi, che faceva Valjean, e, mamma mia com’era giovane, Marcello Mastroianni! Era un film prodotto dalla Lux. La scuderia di attori bravissimi era ampia. Cinecittà era così cambiata, ma non è mica vero che c’era soltanto il neorealismo. C’era Alida Valli, cos’era Alida in quegli anni..., ma è sempre, sempre stata meravigliosa, e la Carla Del Poggio, il grande Cervi, Massimo Girotti. Massimo... Conobbi Rossellini, un uomo molto, molto affascinante. Federico l’avevo incontrato invece durante la guerra, quando giravo un filmetto con Dino Falconi, Quarta pagina, a Torino, al Valentino. Fellini, uno spilungone, molto magro, era lì a riscrivere il copione, prima di fare l’aiuto di Rossellini. Vent’anni dopo avrei fatto con lui Giulietta degli spiriti. E De Sica, anche lui così cambiato dopo i film con Assia Noris degli anni ’30. Prima dei Miserabili, appena finita la guerra, avevo fatto, con Ponti, Un americano in vacanza, una commedia carina diretta da Luigi Zampa, e Roma città libera, di Pagliero. Ma bisogna ricordare quello che intanto ci dava De Sica, con quegli attori straordinari presi dalla strada! Avevo una grande ammirazione per le capacità tecniche di De Sica, come riusciva a lavorare con quegli attori. Se pensiamo a Umberto D, a quel vecchio, ai suoi sguardi. In fondo, però, dico che non è una cosa così difficile, perché basta una profonda attinenza col personaggio, una grande immedesimazione. E quindi, questo “ladro di biciclette” che non sapeva neanche che cos’era un palcoscenico, aveva però la sua esperienza di vita da portare lì, sul set, davanti alla cinepresa. È una cosa così semplice, ma non ci si pensa: le condizioni che un attore ricostruisce per immedesimarsi in un personaggio per loro erano le autentiche circostanze della vita di quel momento, di quelle strade e di quei piccoli grandi eventi quotidiani. C’è un motivo se io preparavo i copioni in treno, in mezzo alla gente. La vita è la materia di un attore, sempre. Ed è sempre un’avventura pericolosa, quella dell’attore, perché devi assumere destini che non sono tuoi. Essere te stessa e, contemporaneamente, un altro, una sorta di vivere doppio che può diventare demoniaco... sì, anche demoniaco. Forse per questo non si seppellivano gli attori in terra consacrata. Finivano con gli eretici, i suicidi, non perché fossero anormali o immorali, ma perché si credeva che avessero perduto la propria anima, la propria identità. Mettevano paura, gli attori.
Dal varietà a Hollywood. “Qui nel cuor c’è l’amor, il calor, il dolor”. Ho fatto anche il varietà, perché non c’erano soldi, non si facevano più film, durante la guerra. Lavoravo con Anna Magnani. Ci fu una grande amicizia tra me e Anna. Mettevamo su compagnia così, come si poteva. S’andava in Sicilia, perché l’Italia era divisa in due, e lì si poteva lavorare un po’. Insomma, tra queste avventure da poveri e i primi successi del dopoguerra arriva, inaspettato, un evento in Inghilterra. Mi offrirono di fare un film, Glass Mountain, “La montagna di cristallo”, un bel film per quell’epoca, con Tito Gobbi, il celebre baritono, due attori inglesi, e io, che facevo una ragazza italiana che s’innamora di un aviatore caduto sulle Dolomiti. Ebbe un enorme successo in Inghilterra, e per me fu un trionfo personale: le critiche furono totalmente favorevoli. Non dovrei dirlo, non sopporto di parlare di me come attrice, a volte quando mi rivedo scappo via, sono una perfezionista, ma ammetto che m’impressionò che il più grande critico londinese cominciasse il pezzo così: “First Garbo. Then Bergman. Now Cortese”. Sulle pareti dei palazzi, le insegne luminose per la pubblicità riportavano il mio nome. Il film uscì due volte in due anni. Questo per dire solo una cosa: per mia fortuna, avevo le carte in regola quando sono partita per New York e poi per Hollywood, dove ottenni una parte in un film di Jules Dassin, un cineasta straordinario. Il film era Thieves’ Highway, del ’49, con Richard Conte. Poi Zanuck, il potentissimo produttore, il massimo boss della Fox, mi fece interpretare Ho paura di lui, di Robert Wise, altro cineasta eccezionale, con l’attore che sarebbe diventato mio marito, Richard Basehart. Ma prima avevo fatto Malesia, con Spencer Tracy e Jimmy Stewart. A-do-ra-bi-li. Al mattino facevano a gara per mandarmi i fiori alla roulotte, dei mazzi enormi, bellissimi, uno dietro l’altro, e a un certo punto non riuscivo più a reggere il profumo, tanto era intenso. Fu Spencer che m’insegnò molte cose, ripassando le battute, parlandomi con grande semplicità e schiettezza. Stavamo così bene insieme, c’era un dialogo vero. Un carissimo compagno di lavoro. Mi sollecitava la verità e la semplicità. Ma qui ora devo raccontare una cosa. È la prima volta, ma la devo dire. Adesso queste cose le devo dire.
Zanuck, la carogna. La mia carriera a Hollywood era aperta. Avevo offerte incredibili. Lavoravo tra l’Italia e gli Stati Uniti. Accadde che Darryl Zanuck, il mio producer, a un certo punto si incapricciò. Aveva perso la testa per me. Io ho rifiutato. Io proprio non la volevo quella cosa! As-so-lu-tamen-te. Una sera ci fu una lite e io gli buttai un bicchiere di whisky in faccia, dicendogli: mi fai schifo, me ne vado da Hollywood, mi fate tutti schifo. La mia carriera era finita. Quel poco che avrei fatto lo volevo raggiungere con le mie forze, non perché ero l’amante di Zanuck. No, mi dispiace, no e no, anche se mi fosse piaciuto. Il giorno dopo mi chiamò: “Don’t you know I can make the greatest star in America and I can destroy you just like that?” Era proprio quello che volevo: “You destroy me just like that, okay, and I want to go back to Italy.” Cancellare la mia carriera americana però non gli bastava. La cosa tragica di quest’uomo, di questa carogna, è un’altra. Mi trattenne lì per due anni e mezzo, vincolata dal contratto, senza fare niente, proibendo alle altre major di prendermi per qualche film. Non potevo fare niente. Vuol dire uccidere un attore. Se tu, a Hollywood, tieni un attore emergente bloccato per tutto questo
tempo, lo distruggi. Infatti tornai in Italia che non ero più io, praticamente ho dovuto ricominciare da capo. E non era finita. Raddoppiò la vendetta. Per molto tempo bloccò anche mio marito Richard, povero Richard, dopo il trionfo che aveva avuto con Quattordicesima ora. Che schifo.
Visconti il leone. Michelangelo Antonioni mi chiamò per Le amiche, un ruolo bellissimo, e poi ci furono dei film con Mastroianni e Alberto Sordi, e Federico mi aiutava, Richard ebbe una parte nella Strada. Ma non era più come prima, era difficile avere una parte giusta, il mio nome non stava in testa, e tutte queste storie assurde, cretine, bleah! Poi ho recuperato. Cito per tutti Effetto notte di Truffaut. Ritornai al teatro, il mio primo amore. E poi conobbi Luchino. Ci siamo incontrati molto tardi purtroppo, io e Visconti. Lui mi ha adorata. In questa fotografia dice: grazie, grazie Valentina. Ci vediamo presto, mi diceva, ma era già malato. Voleva affidarmi una parte nell’ultimo film, L’innocente, però io avevo già firmato a teatro per Il giardino dei ciliegi, con Strehler. Ma qui siamo arrivati di corsa agli anni ’70! Non posso dimenticare quanto ci volevamo bene io e Luchino. E quante invidie, uuh che invidie. Io che non ne ho mai avute per nessuno. Ciascuno ha un mondo proprio da raccontare, perché essere gelosi? Era una pièce di Pinter, e lui mi seguiva in ogni particolare. Gli altri due attori non lo sopportavano. A un certo punto ho detto: mi avete voluto voi, se andiamo avanti così me ne torno a Milano. Era il primo lavoro che Luchino riprendeva dopo una prima fase della malattia. Sono stata sfortunata con quei colleghi: alla prima, all’Argentina, per gli applausi proposi di uscire insieme a ogni chiamata, siamo in tre gatti, dissi, meglio se stiamo insieme. Eh no, noi vogliamo prendere i nostri applausi, uno per uno. Via il primo, via il secondo, con tanti applausi. Ma quando toccò a me, venne giù il teatro. Non dovrei dire queste cose, pecco di vanità. Ma insomma, viva la verità! E quando il riflettore puntò sul palchetto di Visconti, questo leone ferito si arrampicò da solo, si appoggiò con le due mani al davanzale, rifiutò l’aiuto degli amici e si alzò in piedi con le sue forze a prendere l’ovazione.
Anni ’70... Quella sera ero arrivata alla fine facendomi coraggio, perché mi raggiunse una notizia tremenda. Una carissima amica mi aveva telefonato un quarto d’ora prima di andare in scena per darmi una notizia terribile. “Darling, how are you?” Le dico. “Desperate,” mi urla piangendo: hanno ammazzato mia figlia, le hanno tagliato la testa e l’hanno messa dentro un vaso di fiori. Non potevo crederci. “Yes, Valentina, they cut off the head of my daughter...” Questa ragazza ricchissima era finita in un giro di droga, si era innamorata di un ragazzo ultraperbene di Parigi, e avevano incominciato a farsi i taglietti, perché non bastava quello che prendevano... E il ragazzo gli aveva tagliato la testa. Il mondo dei giovani stava impazzendo. E io ero lì, davanti al pubblico, ai miei colleghi (vedevo nel buio la Magnani, Sordi), c’era tutta Europa in quel teatro, e io cercavo di prendere forza in qualche modo. Lo spettacolo doveva continuare. Ma che cosa stava succedendo ai ragazzi?
Sedute spiritiche con Fellini. Ero già stata qualche volta a vedere le prove degli spettacoli di Visconti, anni prima, perché conoscevo Paolo Stoppa, Rina Morelli, Mastroianni. Ecco, qui ci sono tutte le loro fotografie. Marcello era bellissimo. Lo incontravo all’aeroporto di Parigi, quand’era innamorato della sua bella, ed era davvero bella, la Deneuve, erano pazzi d’amore; lo vedevo carico delle torte salate che faceva sua mamma da portare a Catherine, era sempre pieno di cose da mangiare, vieni, vieni Valentina a mangiare da noi. Abitavano in un appartamento molto chic. Quando recitava qui al Nuovo, l’ultimo lavoro, mi ricordo che gli portavo le uova fresche dalla campagna, e gli dicevo: Marcello mangia le uova al mattino, che ti fanno bene, ti devi nutrire... Federico. Venivano sempre a trovarmi a casa a Roma, lui e Giulietta. A volte veniva anche Nino Rota, che aveva fatto le musiche di Glass Mountain. Caro Nino. Insieme facevamo le sedute spiritiche, con la Masino. Non la Masina! La Masino era una celebre medium, l’amica di Massimo Bontempelli, il drammaturgo. Accadevano cose incredibili in quella casa. Certe notti si sentivano correnti gelide attraversare i corridoi. Ecco Vittorio Gassman. Mi portava in bicicletta sulla canna, quando andavamo a girare, agli stabilimenti dietro via Flaminia, un film di Alessandrini, L’ebreo errante. E Gregory, povero! Sono stata la madrina del figlio di Gregory Peck. E Ingrid.
Oscar perdonato. C’è una storia con Ingrid Bergman. Non vorrei raccontarla, perché non voglio pronunciare una frase che m’imbarazza molto. Stavo provando Il giardino dei ciliegi con Strehler. Mi chiama Truffaut, che l’anno prima aveva vinto l’Oscar per il miglior film straniero con Effetto notte, e mi dice: Valentina, ora che il film è uscito anche in America, siccome il regolamento lo consente, ci hanno candidato di nuovo agli Oscar, e hanno nominato anche te, ma non possiamo vincere un’altra volta, però, è una gentilezza, e dovremmo andarci. Io sapevo che avrebbe vinto Ingrid, per Assassinio sull’Orient Express. Lo sapevo da una chiromante, Magda, dove andavamo un po’ tutti, io, Ingrid, Federico, Giulietta. Poco prima della premiazione, la chiamo per farle i complimenti e Ingrid mi dice: mi danno questo premio soltanto perché sono stati delle carogne con te. Arriva il momento della consegna. “And the winner is: Ingrid Bergman.” Lei sale con aria furente e, invece di ringraziare l’Academy, davanti alle televisioni di tutto il mondo, dice: “This prize belongs to Valentina Cortese.” Alzati Valentina! E mi fa alzare, se la prende con le regole dell’organizzazione e, alzando tra le mani la statuetta, dice una frase che mi tocca il cuore e provoca un applauso fragoroso: “Forgive me Valentina,” perdonami Valentina.
La mia casa a Marilyn. Li ho conosciuti tutti i grandi attori di Hollywood. Perché non era una vita molto exciting. I tempi sul set erano lunghissimi. A volte stavi giornate intere a fare niente, e così ci si trovava nelle case. Ho fatto anch’io molti ricevimenti. Quando De Sica venne a Los Angeles, e poi quando venne Vittorio Gassman, che si sposò in America ed era spesso a casa mia. Mi piaceva
cucinare a quei tempi. La mia casa era sempre piena di ospiti. Quella casa, poi, la prese Marilyn Monroe, una creatura straordinaria. Mi diceva: sai Valentina, “I don’t like to go out with silly people, silly young actors”. Per questo si sceglieva vecchi intellettuali, o uomini molto importanti: voleva sempre imparare qualcosa. Quando prese la mia casa era già una ragazza triste. Che peccato.
Ricomincio da Gilliam. Il cinema ai miei tempi era bello, era bellissimo. Perché eravamo un gruppo, c’erano i gruppi di amici e ci si voleva molto bene. Adesso non so, le cose sono completamente diverse. Nella seconda parte della carriera ho lavorato meno, ma con grandi artisti internazionali. Era diverso fare il cinema negli anni ’80. Intanto era tutto più ricco. Proprio i finanziamenti per il film. Perché noi eravamo poveri, prima, non dimentichiamolo, già dai tempi di Mussolini. Terry Gilliam venne a cercarmi a Venezia nell’88 per fare Le avventure del Barone di Münchausen. Come mi sono divertita. Dovevo fare due ore di trucco ogni giorno, mi mettevano su questa cosa. I soldi, in questo caso, ti permettevano, per esempio, di avere uno scenografo divino come Dante Ferretti, che ti faceva intorno quella fastosa giostra. Per me era come se fossi tornata ragazzina, cominciando da capo a fare il cinema. Sì, non posso dire di aver avuto una vita monotona.
L’amore in palcoscenico. L’incontro con Strehler cambiò ancora la mia vita. Ma qui torniamo agli anni ’70. Al cinema credo di aver fatto alcune cose buone, altre da prendermi a sculaccioni. Col teatro sono stata più seria. Non ne ho fatto molto, ma quello che ho fatto era importante. Cito la Lulu di Wedekind diretta da Patrice Chéreau. E Strehler. Avevo debuttato in teatro giovanissima con Amarsi male di Mauriac, con la regia di Costa. La critica la fece Paolo Grassi. Sono stata in compagnia con la Pagnani e Giannini. Insomma, non ero una sconosciuta a teatro... Quando conobbi Giorgio passavo una crisi matrimoniale molto forte. Venne a trovarmi Grassi, a Roma, un uomo magnifico (i due litigavano spesso, ma si amavano), per propormi Platonov di Čechov. Con Giorgio ho incominciato e finito con Čechov, con Il giardino dei ciliegi. Ci incontrammo per lo spettacolo, io e Strehler, e lì nacque l’amore. Un amore meraviglioso, non facile, intendiamoci. Fu bellissimo, era come continuare a fare l’amore lavorando. Abbiamo vissuto insieme per quindici anni. E non era così facile questo ragazzo di quarant’anni. E molto birichino... A un certo punto non ce la facevo più. Un giorno dissi: è bene che chiudiamo, anche se eravamo tutti e due innamorati. Che stupida che sono stata. Però ci siamo sempre voluti bene. Peccato che sia andata a finire male con Andreas, perché Giorgio ha sofferto tanto. Non se lo meritava. La vita passa, e io ho fatto un altro incontro, il mio secondo marito, un uomo stupendo, un uomo number one. Lui non voleva che io facessi teatro. Il teatro non era il suo forte, aveva cose più importanti da fare per il bene dell’umanità. Non voleva che mi impegnassi in quella vita. Una volta Zeffirelli, che per me è come un fratello, mi chiamò per fare Maria Stuarda. Sono nelle tue mani, mi disse, abbiamo soltanto ventidue giorni. Mi sembrava impossibile, è un lavoro che ha bisogno almeno di due mesi. E non era facile l’idea
di andare in scena priva dell’appoggio della persona che ami. Bisogna provare a sentire le ossa che tremano. Eravamo così impreparati, ma qualcuno lassù ci amava, perché alla fine venne giù il teatro tanti erano gli applausi. C’erano tutti quella sera, c’era anche Gregory Peck. E il mio caro husband, il mio adorato Carlo, che mi manca tanto, mi abbracciò e mi disse: scusami Valentina, scusami tanto, io non sapevo.
Ieri per domani. Una volta io e Giorgio abbiamo scoperto che ci conoscevamo da bambini. Non è incredibile? Quando sono venuta ad abitare a Milano con la mia balia, siamo andati a vivere in via Settala. Giorgio abitava in corso Buenos Aires, vicino alla farmacia. Andavamo a giocare entrambi ai giardini pubblici, in un gruppo di quattro ragazzini, e io ero la sola bambina, una selvaggia di campagna a piedi scalzi. Ci siamo ricordati, ci siamo riconosciuti.
28 Devono essere quasi le nove, perché sento il passo pesante di Miriam in cucina. Non sopporto di svegliarmi quando lei è già in casa. Nel sonno cercavo invano di tornare al sogno delle poltroncine sparse nel vuoto. Il bosco degli spettatori assenti. È un bel titolo. Per un racconto di Breton, oppure per una fiaba sulle sorti del cinema italiano. Oh, non ho voglia di andare là, stasera. Non voglio muovermi da casa mia. Non voglio alzarmi da questo letto. Non voglio farmi accompagnare da mia figlia, che da anni mi precede e mi asseconda come se fossi un pezzo da museo. A lei piace, invece, che gli altri assistano a questa edificante rappresentazione, un anziano protetto da un giovane, perché il protagonista vero è il giovane. A volte ho l’impressione che la psicologia familiare sia diventata molto complicata, anche se non riesco a figurarmi un progressismo o una involuzione della psicologia. I rapporti familiari sono più contorti di cinquant’anni fa? Può darsi. La famiglia grande, patriarcale, ramificata, non si perdeva in fisime. Era diversa la coesione del gruppo. C’era una solidarietà intensa, pur silenziosa. Eppure, la cosa impressionante è che dubito, sento che potrei sostenere il contrario. La famiglia patriarcale poteva essere austera e poco affettuosa. Il rispetto era dovuto, raramente conferito. Sempre il cinema, mi viene in mente. La famiglia, di Ettore Scola, è per me il film più complesso sulla natura ambigua della famiglia italiana. Il lungo corridoio di questa casa, che prende luce soltanto dalle porte delle stanze, aperte e vive, quando lo erano, assomiglia tanto al corridoio percorso avanti e indietro dalla cinepresa in quel film, nei decenni, nelle stagioni, nel cumulo di generazioni e nelle età della vita.
ETTORE SCOLA C’eravamo tanto amati Il neorealismo non è stato soltanto un fenomeno cinematografico. È stato uno stile, un modello, una tensione culturale che ha investito scrittori, pittori, musicisti, cineasti. Il dialogo tra gli artisti era un valore, era fondamentale la consuetudine di incontrarsi. Ai giovani delle generazioni seguenti è mancata la conversazione con i padri. Anche in casa, quando ci si riuniva a tavola, oppure intorno alla radio, il padre raccontava le sue esperienze, ritrovava i suoi ricordi di bambino. E quelle memorie storiche influenzarono la formazione dei figli, per identificazione o per opposizione. Nella mia infanzia e anche nella mia adolescenza, c’era sempre uno spazio dedicato a questo scambio di sapere.
Ieri e oggi. Il cinema per la mia generazione è stato il senso del tempo. Tutte le nostre discussioni sui film che andavamo a vedere e sui film che volevamo realizzare erano un modo di conoscere e confrontare i rispettivi sguardi sulla società e i rispettivi orientamenti. Non credo che oggi, per fare un esempio, Calopresti sia informato di quello che fa Mazzacurati, non credo che s’incontrino e si scambino informazioni sul lavoro, sulle novità e sulle speranze comuni. Oggi i cineasti sono personalità più introverse, isole accessibili solo a qualche collaboratore di fiducia. Anche le critiche vengono accolte con difficoltà dai giovani registi, che spesso si aspettano di sentirsi dire soltanto che quello che hanno fatto è perfetto. Se con loro sei critico, ti ringraziano anche, ma poi restano convinti che sei tu a non aver capito.
Il ’68, avanti con la cinepresa. Perché le cose sono cambiate? Per limitarci alla narrativa cinematografica, mi sembra sia prevalso uno sguardo autobiografico, mentre è quasi scomparso il racconto della nostra società. Quando noi eravamo giovani autori l’autobiografia era praticamente proibita. Non avendo fatto la guerra, non avendo praticato né la boxe né la corrida, non essendo Hemingway, ci sembrava più importante la biografia di un paese che aveva ricostruito tante cose e ne aveva dimenticate tante altre. Tra i giovani cineasti di oggi c’è un certo narcisismo che noi non avevamo? Forse. Anzi, magari è legittimo. La centralità dei giovani... Non dimentichiamo che in mezzo c’è stato il ’68. Un grande spartiacque: il ’68 ha fallito in certi progetti, ma ha cambiato veramente una certa mentalità. Il giovane è diventato soggetto di diritto, è diventato protagonista come noi non siamo mai stati nella società dei padri. Basta essere giovani per fare un film... Nel fulgore del ’68 all’Anac si diceva che ognuno doveva avere una cinepresa, gli studenti, gli operai, i minatori, al di là di qualsiasi vocazione o sapienza tecnica. Sì, concetti democraticamente corretti, ma specificamente non aiutavano la professione, non aiutavano il cinema. E il cinema italiano ha pagato tutto questo. Forse soltanto negli ultimi anni qualche giovane regista ha ritrovato la curiosità di scoprire e raccontare il suo paese, la gente che conosce, le cose che vede intorno a sé.
Il manifesto sulla razza. Io ero figlio della lupa ai tempi che racconto in Una giornata particolare. Balilla era mio fratello, che aveva tre anni più di me. Quella mattina siamo andati come tutti ad assistere alla sfilata in onore di Hitler in via dell’Impero. Le donne erano rimaste a casa, a parte le più giovani, anche loro in divisa. Non credo che quel giorno mia madre abbia incontrato un omosessuale come accade a Sofia Loren , ma il contesto, l’atmosfera, i suoni e la luce erano proprio quelli che ho tentato di ritrovare nel film. Erano gli anni del consenso, la gran parte dei cittadini non si faceva domande. Poi, nel luglio del ’38, uscì il manifesto sulla razza e da allora ogni settimana la “Gazzetta Ufficiale” pubblicò nuove disposizioni di limitazione delle attività e della dignità degli ebrei, e queste venivano accolte dalla popolazione con una indifferenza che era in realtà anticamera del razzismo. I medici ebrei dovevano lasciare gli ospedali, studenti e professori le scuole. Non si valutavano abbastanza gravi quei provvedimenti? Si pensava che era un modo per assecondare le pretese degli alleati nazisti? Sta di fatto che proprio nell’omissione di pensiero consiste la responsabilità collettiva di quello che succede a un paese. È bene ricordarlo anche in queste pagine di memorie. E in tempi di “revisioni” storiche.
Un telone tra due tigli. Il mio primo film è stato... il disegno. Ricordo la mia passione di bambino per le figure. Riempivo ogni foglio che mi capitava davanti, facevo il ritratto a ogni persona che veniva in casa, ed erano già delle caricature. Ma il primo film vero e proprio della mia vita lo vidi a quattro, cinque anni, Fra’ Diavolo, a Trevico, un paesetto di montagna a mille e duecento metri. Faceva freddo anche d’estate, la sera. Si montava il telone tra due tigli. Ogni spettatore arrivava con la propria sedia. Già dal pomeriggio, per conquistare il posto migliore, noi ragazzini prendevamo posizione. E incominciava un’attesa frenetica. Una volta l’anno! Anche nell’adolescenza, però, fu il disegno la mia passione. Il mito era il “Marc’Aurelio”, che leggeva mio zio. Diventò la mia meta ambita. A quindici anni mi presentai prima al “Travaso” e poi al “Marc’Aurelio”. Durante i tre anni di liceo all’Umberto I (che poi si chiamò Pilo Albertelli, un nostro professore fucilato alle Fosse Ardeatine), appena suonava la campanella, alle dodici e mezza, correvo a via Barberini, alle riunioni di redazione del “Marc’Aurelio”, due volte la settimana, il lunedì e il giovedì, per consegnare le vignette fresche. Dopo un po’, fui assunto come disegnatore, poi come scrittore di rubriche. Come avranno già raccontato Age e Scarpelli, i fari della sceneggiatura del cinema comico erano Metz e Marchesi, veri principi della satira popolare, scrittori di tutti i film di Totò, di Macario, di Tino Scotti.
La fabbrica delle sceneggiature. Quando Metz e Marchesi mi chiesero se volevo lavorare con loro, be’ mi sentii un ragazzo felice. Il primo film al quale collaborai fu Totò Tarzan. Mi consegnarono il copione nel quale
dovevo aggiungere battute e gag, anonimamente. Me lo sarei scritto sul biglietto da visita... Cosa impossibile oggi. Nessuno direbbe: portami queste battute che te le pago alla consegna, ma le firmo io. Oggi nessun giovane è disposto a lavorare senza un riconoscimento immediato del suo lavoro. Invece per me fu una scuola. Anche di vita. Andavo all’hotel Moderno, dove Metz e Marchesi avevano una matrimoniale fissa che usavano per lavorare, e poi la sera ciascuno si ritirava a casa sua... C’era una stanza con tutti i copioni distribuiti sul letto: tre per Totò, uno per Macario, due per Scotti. Quando portavo le battute Metz le valutava e ne decideva la destinazione: questa la diamo a Macario, funziona meglio per lui, questa va bene per Totò perché è un equivoco di parole. Da negro avevo fatto esperienza di sceneggiatore, senza vedere da vicino neanche uno dei produttori che mi pagavano indirettamente.
A casa di Totò il principe. Fu un evento quando Metz mi portò a casa di Totò, credo in via Gramsci. Non so se fosse principe o no, ma si meritava quel titolo, per lo stile, per l’eleganza, per la gentilezza. Ero un ragazzetto di sedici anni, ma fu lui che mi servì il caffè. Metz leggeva, marcando le battute di ogni personaggio (cosa che gli piaceva molto), e Totò ascoltava fumando una sigaretta col bocchino: ogni tanto prefigurava un intervento, un lazzo, una ripetizione di parola fino a farle perdere senso: improvvisazioni che poi avrebbe precisato e ampliato durante le riprese. Io non frequentavo mai il set. Lo feci soltanto per i film di Pietrangeli, che pretendeva la presenza degli sceneggiatori sul set anche per cambiare soltanto una battuta. Una volta mi convocò a Parma, dove stava girando La parmigiana, con la Spaak, per modificare un paio di righe.
Flaiano, Amidei, i maestri e il metodo. Con Pietrangeli, Risi e Zampa incontrai altri sceneggiatori (Age, Scarpelli, Maccari), dai quali imparai ad approfondire il racconto e la psicologia dei personaggi, il senso della storia, la definizione delle atmosfere. Ho firmato anche con Flaiano qualche film di cui lui non ha mai scritto una parola, ma raccontava, descriveva i personaggi, dava i toni delle situazioni. Per Fantasmi a Roma, che ho scritto con Pietrangeli e Maccari, ricordo due, tre riunioni con Flaiano. Parlava della differenza dei fantasmi nel Veneto, nel Piemonte, nel Lazio, secondo episodi di letteratura e storie antiche popolari. Ampliava il discorso, esplorava fuori dal giardino del film che si stava facendo. Ci si arricchiva, anche se poi si tornava al punto di partenza. Per Il mondo nuovo, il mio film sui tre giorni della fuga di Luigi XVI a Varennes, credo di aver letto più di un centinaio di volumi; forse nessun esperto della Rivoluzione francese ha letto tutto questo per capire quelle giornate. A questo metodo di lavoro, alla necessità di documentazione, si aggiungeva il piacere di sapere, il gusto per la ricerca. Ogni sistema di lavoro appartiene al suo tempo, alla natura di una società e dei suoi modelli culturali. Non credo che oggi ci siano né vecchi che vogliono trasmettere le loro esperienze, né giovani che abbiano voglia di ricevere e trasformare quelle esperienze. Non per difendere i giovani autori a tutti i costi, ma ho l’impressione che abbiano soltanto un altro modo di comporre il loro lavoro, un altro modo di essere narratori, con risultati spesso altrettanto buoni.
Il dialogo tra cinema e società. Col volante. L’automobile fu un bisogno primario indotto. A un certo punto, esplose: non come incremento di modernità, di comunicazione, d’incontro e conoscenza. Prevalse piuttosto come immagine del piccolo potere, come metafora dell’arroganza quotidiana. Un tempo pre-berlusconiano, un modo aggressivo di vedere il mondo. Il sorpasso, che scrissi con Maccari per Risi, credo abbia centrato il clima di prepotenza e di ambizione individuale, più di quanto avrebbe fatto un racconto approfondito, esplicitamente critico, dalla parte del personaggio di Trintignant. Il personaggio negativo, lo sbruffone che interpretava Gassman, ha delle intuizioni maggiori dello studente, che è più scrupoloso, ma più lento. Gassman è più superficiale, ma più veloce, e questo gli permette di cogliere bene lo spirito del tempo. La vita facile, l’ansia di cambiare, di prevalere, di farsi strada. Forse il successo immenso del film aiutò la fortuna delle industrie automobilistiche e dei progetti di autostrade, chissà. È uno dei casi evidenti in cui il cinema dialogò con la società del suo tempo.
Sentimento del tempo. Ho incominciato facendo film comici, tra farsa e satira, a partire dal primo, che era un film a episodi, secondo la consuetudine del tempo, Se permettete parliamo di donne. Ma poi, l’osservazione della mia generazione e di quella precedente, la progressiva presa di coscienza politica, la visione più attenta della società che si era costruita nel dopoguerra, hanno contribuito a formare una sorta di “sentimento del tempo” che mi ha portato a vedere i personaggi nella prospettiva più complessa del loro destino, anche doloroso. Senza perdere mai di vista la satira, perché sono convinto che la dimensione del gioco fa parte dell’uomo. Non c’è tragedia senza comicità. De Sica è uno dei miei modelli, perché con lui c’era Zavattini, che significava l’umorismo, l’ironia, la poesia. La Storia, la Grande Storia Ufficiale, quella che determina e cambia le storie private e personali, è stata il tema di gran parte dei miei film. Le grandi decisioni non le prendono i singoli individui, ma gruppi sociali ed economici che condizionano la vita dei singoli.
La classe operaia va al cinema. Trevico-Torino, rappresentazione della classe operaia in un preciso momento della sua storia, appartiene a una fase del mio lavoro nella quale facevo anche dei film-documento sulle realtà della cronaca. Ricordo un episodio filmato, che mi piacerebbe ritrovare, assai divertente. Ero andato nella sede di Lotta Continua a Napoli dove avevo scoperto che i telefoni erano controllati e che i ragazzi usavano uno stratagemma per mantenere attivo il telefono, nonostante non avessero una lira per pagare le bollette della Sip. Quando, dopo le regolari ingiunzioni di pagamento, la Sip stava per tagliare la linea, i ragazzi, ogni tanto, fingevano di scambiarsi telefonicamente istruzioni segrete sulle prossime manifestazioni di piazza in modo da mantenere viva l’attenzione degli intercettatori e, soprattutto, la linea telefonica. A quel punto riattivata gratuitamente... In Trevico-Torino seguivo l’esperienza di un ragazzo che, da un paesino (il mio), dal quale prima si emigrava per il Belgio, andava a Torino come operaio. I
soldi, pochi, credo 45 milioni, me li prestò mio fratello, che fa il medico. Non ero riuscito a vincere la diffidenza dei produttori, i quali non volevano i film “sugli operai”. Era il 1970. I compagni, bellissimo, non era considerato un modello. La classe operaia va in paradiso e Mimì metallurgico, sarebbero venuti dopo. La commedia all’italiana, e direi un po’ tutto il cinema italiano di quel tempo, ha trascurato i temi della classe operaia.
Terrorismo e droga. Anche sul terrorismo c’è stata un’omissione di rappresentazione pressoché totale. Uno storico francese, Pierre Villard, sostenne addirittura che i cineasti italiani, con il loro silenzio, erano responsabili culturali del terrorismo. Questa era solo una fragorosa sciocchezza. È invece vero che il disagio di raccontare può bloccare la creatività. Anche il tema della diffusione delle droghe è stato trascurato, forse per timore degli autori di commettere reato, di “lesa gioventù”. In un film che ho scritto con Steno, Un americano a Roma, Alberto Sordi, già prima che in Italia arrivasse Marlon Brando con Il selvaggio, irrideva magistralmente la tendenza filoamericana della gioventù del tempo: esempio forte della satira che individua le debolezze della società e ne condanna i falsi miti. Sordi ebbe il coraggio, con la forza della sua ironia, di andare anche “contro” i giovani. E i giovani lo amarono come nessun altro è stato mai amato.
Vivere in crisi. L’ironia, da Swift in poi, è la forza che può affrontare vittoriosamente qualsiasi tema. A un certo punto, ci è mancata. E si è parlato così di crisi del cinema italiano, di fine della commedia, di perdita di contatto col pubblico a vantaggio della televisione, delle televisioni private nascenti. Devo dire, però, che la crisi del cinema è un fenomeno che ha accompagnato sempre la mia carriera, a partire dai primi anni ’50, quando mio padre mi diceva: vuoi fare il cinema, ma non leggi che è in crisi? Forse il cinema, sistema misto, non solo industriale, non solo artistico, “deve” essere in crisi. Forse è la sua natura, il suo destino, la sua necessità.
29 Mia figlia è arrivata puntuale, alle due del pomeriggio. L’auto alle tre, come previsto. L’autista è un ragazzino, avrà vent’anni, un impiegato del festival recuperato alla guida di una vecchia vettura del comune di Pescara. Esiste una scala di valori nella società dello spettacolo che corrisponde alle stelle degli alberghi, ai cavalli fiscali delle automobili, alle “forchette” dei ristoranti, alla scelta dei posti a sedere, perfino al numero e all’intensità dei sorrisi dei capi uffici stampa e delle hostess. Nonostante il mio scetticismo verso i premi, sono un po’ eccitata. Dovrei essere grata alla vita che mi offre una giornata con autista e una serata con applausi, un onore in parte derivato dal successo del mio romanzo, anche se ormai è passato più di un lustro. Sul sedile in pelle della macchina ho trovato la cartella stampa del Premio Artigianato nella Comunicazione. Mi ero dimenticata che la giuria artistica (perché ci sono anche le giurie tecnica e industriale) conta sulla presidenza dei due Fratelli Taviani. Conoscevo Lionello Massobrio, il montatore dei primi film dei fratelli, che poi fecero squadra con Perpignani. Lionello mi parlava di una fusione artistica paragonabile a un duo orchestrale, per cui se togli un elemento lo spartito è inutilizzabile. Questi due ragazzi restano un enigma poetico. L’energia idealistica che spinse la generazione dei Taviani a istigare la nostra, addormentata sugli allori della fine della guerra e del fascismo, non ha ancora eredi.
FRATELLI TAVIANI Un’aggressiva fiducia nel domani Paolo: Ma noi preferiamo che non si precisi chi dei due sta parlando. Vittorio: Quello che diciamo a questo punto della vita... son cose che abbiamo pensato e poi sviluppato sempre insieme, e lavorato insieme, se così si può dire. Magari quello che dice lui è quello che penso anch’io, allora, è inutile... Paolo: Comunque al primo film della nostra vita eravamo insieme. Vittorio: Più che il primo film fu il primo teatro.
Il trovatore coi mestoli di cucina. Paolo: Quando andavamo bene a scuola, mio padre, che era un melomane, ci portava da San Miniato, la nostra cittadina d’origine, a Firenze a vedere il Maggio Fiorentino. Quindi l’opera per noi è stato il primo incontro con lo spettacolo, l’amore immediato per lo spettacolo nasce da lì. Il trovatore ci colpì subito. Molto. Ed è poi l’opera che mettemmo in scena a casa, da bambini, con mia sorella. Facevamo il terzetto... no, cos’è? Vittorio: Un trio? Paolo: Ecco, il trio, col Conte di Luna, Manrico e Leonora. I mestoli da cucina al posto delle spade: così ricostruivamo quella grande emozione. Ma perché ci colpì in quel modo? Trovarsi davanti al telone rosso, che improvvisamente si apriva su un mondo che t’invadeva, che ti faceva soffrire, ti faceva godere, era un’emozione così forte. E cioè, dietro quel telone rosso poteva accadere di tutto. Alla nostra vita e a quella degli altri. Ecco, direi che il primo incontro vero con lo spettacolo fu quello. Anche perché al cinema ci andavamo raramente, a Firenze, ed era un viaggio. A San Miniato c’era un cinema dove passava ogni tanto qualcosa. Proprio il primo film che ci abbia emozionato da ragazzetti, non so. Vittorio: Non c’era quel film di paura...? Paolo: Ma in questo impatto con lo spettacolo, adesso parlo soltanto per me, una volta accadde una cosa illuminante. Ci portarono a vedere una Forza del destino con un grande basso, Tancredi Pasero. Mi ricordo ancora, come fosse ieri, la battaglia, i duelli, le passioni. Ma usciti dal teatro, mio padre mi disse: be’, te hai dormito sempre. E probabilmente io avevo dormito veramente! Tra l’altro è un’opera un po’ farraginosa. Ma questo non significa niente, assolutamente niente, perché io ero dentro lo stesso, con la musica, il canto, l’immaginazione. Mi aveva invaso, ero stato rapito ugualmente. Vittorio: E una cosa allora, a proposito della Forza del destino, la dico io. Avevamo sette, otto anni: per la prima volta sentiamo la parola regia. Quando ci sono tutti i frati che escono e arrivano nel blu della scena, be’, in cima c’era fra’ Galdino con la candela accesa come tutti gli altri, ma la sua fiamma tremava, essendo lui il più fragile. E allora mio padre ci dice: vedete bambini, quella fiamma significa che c’è un regista che ha detto: quella candela deve tremare per esprimere un messaggio. Questa cosa ci è rimasta impressa. Ecco perché diciamo che più che il cinema, ci ricordiamo l’opera, come prima esperienza. Anche se c’era quel film del terrore, com’è che si chiamava? c’era quello con il gas...
Paolo: Ma ne ho un’altra bella, aspetta. Vittorio: Scafandro infernale, si intitolava. È un film che avevamo visto a San Miniato, potevamo avere nove, dieci anni. E quando siamo tornati a casa (noi abitavamo in un enorme palazzo del ’700) eravamo terrorizzati. Ci dissero: ma che avete? Non riuscivamo più a muoverci per casa, il terrore durò per molti giorni. Paolo: Ma allora, un altro film che ci sconvolse e ci lasciò per lungo tempo nell’angoscia fu Pel di carota. Quel ragazzino che fuggiva e la sua ombra che lo seguiva, inesorabile, senza scampo, che poi è di Duvivier, mi pare... Vittorio: Sì, è di Duvivier. Paolo: Il bambino, l’attore protagonista, morì combattendo per la Resistenza. Una cosa che mi impressionò. Ecco, Pel di carota è un film che ci è arrivato dentro perché metteva in discussione il rapporto con i genitori. Diceva che la madre poteva essere una tua nemica. Cosa impossibile per noi. Uno squarcio su una realtà che non era la nostra, ma che proprio per questo ci riguardava, e ci faceva paura. Più che il suicidio del ragazzino o la testa immersa nell’acqua. Vittorio: Direi un’altra cosa su questo film. Se mi ricordo bene, perché non l’ho più visto: a volte il personaggio ricompare come il fantasma di se stesso. Questo sdoppiamento, con un bambino che aveva due anime, due momenti della sua realtà, uno quello quotidiano che tu vedi e l’altro più nascosto, con il fantasma che stava sempre addosso al vero Pel di Carota, ci impressionò. In una scena il fantasma usciva da sotto il letto. Quando io e Paolo volevamo farci i dispetti, uno usciva improvvisamente proprio da lì sotto, balzava su e urlava: Pel di Carota! Che colpo. Paolo: Sul piano del sesso, e teniamo presente che parliamo degli anni ’40 quando sul mercato c’era praticamente soltanto il cinema tedesco, ci sconvolse La città d’oro. Per la prima volta sullo schermo si vedeva una scena di sesso in cui lei è a letto e lui le va addosso. Con la mano sulla coscia di Noi vivi, quella scena era la cosa più discussa con i nostri compagni di scuola. Li vedevamo di nascosto perché eravamo minorenni.
Il mistero del dito tagliato. Vittorio: Tutti e due questi film erano arrivati a San Miniato. Una città che fino alla guerra era una città feudale. Una città aristocratica, con famiglie blasonate. Ancora negli anni ’30, i benestanti erano conti, marchesi, discendenti di principi. C’era la vedova del governatore della Libia, con i figli e tutti i parenti. Ogni famiglia aveva un giorno in cui riceveva. E la gente di San Miniato stava alla finestra a vedere questi cortei che passavano. La nostra famiglia invece apparteneva alla borghesia in ascesa. Nostro padre era un avvocato, però anche noi avevamo un giorno di ricevimento, meno decisivo... Ma insomma, c’era una divisione feudale per classi. Paolo: Con un federale amico..., anche se questa storia l’abbiamo già raccontata, no? Vittorio: Il federale era un compagno di scuola di nostro padre, di famiglia povera, il Novi. Un uomo di fede e onestà assoluta, qualità che aveva totalmente affidato al fascismo. Lui credeva nel fascismo come si poteva credere nella Madonna. Mio padre era un grande antifascista, uno dei pochissimi non iscritti della borghesia di San Miniato, con le minacce e i
pericoli del caso. Lui lo salvava sempre e gli permetteva di lavorare. E a San Miniato il fascismo c’era. La classe medio borghese, i maestri, gli impiegati, erano diventati dirigenti istituzionali e facevano il bello e il cattivo tempo. Mi ricordo dopo la guerra di Spagna, una notte, quando tornavano questi fascisti che erano andati volontari a combattere, con le fiaccole in giro per le strade a caccia di quelli come mio padre. A volte succedeva che nostro padre, che per noi era un mito, un gigante, di notte lasciasse la casa d’improvviso. Spariva negli orti. Poi mia madre avvisava che poteva tornare. Scappava? Non capivamo. A noi dicevano: un giorno capirete. Quando arrivò la guerra ci spiegarono tutto. Anche se noi avevamo intuito delle cose. Per esempio un processo del Tribunale Speciale a Bologna. C’eravamo anche noi. Papà gridava che condannare il suo assistito era come condannare un innocente. E vinse la causa. Mio padre era il solo a difendere quella povera gente. Recentemente a San Miniato ho chiamato una persona per un lavoro in casa che poi ha preteso di farle gratis. Era un parente di quell’“innocente”. Paolo: Ecco però bisogna dire che c’era un rapporto con la gente della campagna... Vittorio: Questo è un aspetto fondamentale. Paolo: Però correggiamoci, Vittorio, perché non abbiamo mai fissato bene i due aspetti... Vittorio: Sono cose che pensiamo ma che non abbiamo mai focalizzato bene. Ci sono due aspetti: uno era terribile, cioè che anche noi, figli della borghesia, consideravamo i contadini, i loro parenti, i figli, come un mondo “altro”, un mondo a sé, che stava sotto; dall’altro lato mio padre era l’avvocato di queste famiglie contadine, era un loro idolo, perché aveva vinto delle cause come quella di Bologna. Eravamo colpiti dalla loro dignità, dalla stratificazione della famiglia, col capoccia, i figli maggiori, le donne, i bambini. Ma la cosa incredibile era che li consideravamo anche una specie a metà tra gli uomini e gli animali, e anche loro si sentivano così. Paolo: Qui bisogna spiegare, perché noi... Vittorio: C’era una casa di contadini che frequentavamo in particolare. Un giorno un ragazzo, diciassette, diciott’anni, molto più grande di noi, parlava del suo futuro. E diceva che non c’era un futuro in rapporto alla città. Disse: non so se avrò figli mai, perché siamo considerati non-uomini dalle ragazze, e finiremo sempre qui. Avevano orari incredibili, vivevano senz’acqua, né luce. Per noi erano uomini di un altro pianeta. E anche loro si sentivano così. Per noi bambini vederli così era un modo per dare un senso a una differenza che ci sembrava incomprensibile, ecco. Paolo: All’epoca del taglio del grano andavamo sempre ad aiutare i ragazzi alla raccolta, quelli con cui magari ci era capitato di giocare. Altre volte aiutavamo nella raccolta delle ciliegie. Erano giornate straordinarie. Spariva completamente quel senso di distanza e di differenza di classe. C’era Corrado, della famiglia Scardigli, quelli che ci portavano il latte e che nominiamo anche nella Notte di San Lorenzo. Be’, un giorno dice: guarda questa mano. E gli mancava un mezzo dito. L’aveva perso potando le viti. Ma non l’ho buttato via il dito, spiega. E ci porta nel retro della casa. Dietro un mattone aveva riposto, in una nicchia, il pezzetto tranciato. Disse: perché io quando vado in paradiso voglio arrivarci tutto intero. Alcuni anni dopo ci fu la tragedia del duomo di San Miniato, coi nazisti, quella carneficina. Corrado morì in chiesa. Noi, che stavamo andando incontro agli americani, quando ci arrivò la notizia della morte, pensammo subito al dito. Dopo la guerra siamo tornati alla cascina, abbiamo spostato il mattone e il dito non c’era più, almeno, noi non l’abbiamo più trovato. È
l’episodio da cui partiva il nostro primo documentario sul luglio ’44 a San Miniato, che adesso è introvabile. Vittorio: Aspetta, perché prima tirammo fuori le bottiglie di champagne, il 25 luglio del ’43. Quella fu una data memorabile per noi, ci segnò. Nostro padre ci aveva ormai spiegato tutto. E per noi, vederlo esultare quando arrivò la notizia, quella gioia politica e umana, fu un’emozione forte, liberatoria. E quando tornarono i fascisti, perché poi tornarono, dissero: sappiamo che lì in casa avete stappato lo champagne. Ma fu un grande momento, perché capimmo che quella cappa di piombo che aveva accompagnato un po’ tutta la nostra vita sociale fin lì, era diventata protagonista di un momento di gioia e d’allegria. Annunciava un periodo diverso, una possibilità. Poi però non fu così. Ricordo che sentivo nella notte gli scarponi dei giovani della Resistenza che venivano a parlare con mio padre, la cattura di un fascista, i tedeschi che passavano coi camion, i canti nel buio. Venne il momento della morte. Quando sapemmo della strage del duomo. Il vescovo ci aveva consigliato di andare tutti in chiesa, perché i tedeschi non avrebbero mai assalito una chiesa. Mio padre invece disse: se dobbiamo scappare, andiamo verso gli americani. Ci fu la divisione, chi con noi, chi in chiesa. Marciammo tutta la notte, preoccupati per i nostri amici, avevamo delle cugine, molto carine... Era il luglio ’44. Il vescovo si sbagliava. Se mio padre non avesse deciso di andare incontro agli americani... I tedeschi uccisero tutti. Abbiamo sentito l’alito della morte. I tedeschi occuparono le case. Anche la nostra. La minarono, la casa. Facevano saltare tutto. Fu un momento buio, di angoscia ancestrale, direi. Poi arrivarono gli americani.
Quando tutto sembra perduto ci si può ancora salvare. Paolo: La Liberazione fu un momento fondamentale per noi. Vittorio: Avevamo ormai l’impressione di aver toccato il fondo. E quando poi però arrivò la notizia della fine della guerra avvenne quel fenomeno che ci portiamo dietro ancora oggi, che ci spinge, che ci ha sempre accompagnati e continua anche ora: quando sembra tutto perduto ci si può ancora salvare, se siamo insieme, se vogliamo veramente salvarci, e in questo senso non è vero che il male è ineluttabile, anche quando sembra che lo sia. È stata un’esperienza formativa. Infatti io dico ai miei figli: mi dispiace per voi che non avete vissuto quell’esperienza unica. Perché la realtà era quella. Nera. Sicura. Chiusa. E certa. Credo di aver scritto una volta, a sei, sette anni: speriamo di morire prima del duce, perché dopo come si fa a vivere? E poi vedere che tutto si sarebbe rovesciato, vedere che il mondo poteva assumere una faccia completamente diversa: per dei giovani è una cosa incredibile. Paolo: Comunque la differenza tra me e lui c’è stata. Ed era questa: che io ero figlio della lupa e lui era già balilla, per ragioni di età, e un giorno il dirigente della Gil gli disse: Vittorio ti diamo la croce al merito. Vittorio: Che in genere si dava ai figli della borghesia. Paolo: E teniamo presente che non partecipavamo quasi mai alle adunate. Bisognava mettere la divisa, con i calzettoni che pizzicavano, le marce e tutto il resto. Insomma, quando Vittorio andò a ritirarla, dopo un bel discorso tutto retorico e altisonante, davanti agli altri ragazzi, il dirigente gli disse sottovoce: tre lire, ora devi portarmi tre lire. Vittorio: E tutta la nostra illusione di eroismo sparì immediatamente.
Paolo: Quella croce non significò più niente. Vittorio: Comunque, in realtà per noi il giorno della Liberazione non c’è stato. Paolo: Ce la siamo conquistata, la Liberazione. Perché noi siamo andati verso gli americani. Durante un giro negli Stati Uniti un critico ci disse che la Notte di San Lorenzo aveva avuto successo perché gli americani, che individuano le cose per genere, avevano trovato che era una specie di John Ford, ma diverso, un western con la carovana che andava verso una terra promessa, ed è vero, perché si andava verso uno scopo attraverso la morte, l’amore, il dolore.
La storia del cinema parola per parola. Vittorio: Per noi la scoperta del cinema è legata a questa esperienza diretta di vita. Quando uscì Paisà siamo rimasti folgorati. Vedendo questo film italiano, sconosciuto, negletto da tutti, ci siamo resi conto che l’esperienza di vita, di sangue e di paura, dello schermo era pressoché la nostra, anche a livello spirituale, ideologico, e che lo schermo ci faceva intendere quello che avevamo vissuto meglio di quanto avessimo capito. Se si pensa un po’ alla maggioranza dei nostri film, in genere noi raccontiamo delle dolorose, a volte tragiche, sconfitte. Eppure secondo noi non sono film che negano la vita. Allonsanfan: vengono tutti ammazzati; Un uomo da bruciare; Salvatore viene ammazzato dalla mafia; Sovversivi : c’è la sepoltura di Togliatti; Il prato: il ragazzo muore. Eppure è proprio da questa disperazione, da questo buio che nei nostri film rinasce il bisogno di vita. La Bibbia dice che in fondo la storia dell’uomo è una storia di sconfitte. E mi sembra che sia stato Bobbio a scrivere: il dolore, nella storia dell’umanità, ha vinto sulla gioia, la morte sulla vita, la sconfitta sulla vittoria, la sofferenza sulla felicità, eppure c’è un cono di luce dentro il quale, se tu riesci a entrare, puoi ripartire di nuovo. Paolo: La storia di Gesù Cristo. Vittorio: Io direi che nei nostri film mi sembra che ci sia sempre questo percorso. Qualcosa per cui poi il film alla fine... Certo, qui è importante il linguaggio. Per esempio Allonsanfan. Finale tragico. Si prega addirittura che i bambini vengano uccisi. Eppure abbiamo girato immagini che lasciano, con la musica, un senso di possibile ricostruzione. Quel finale di morte ha un ritmo sanguigno che, abbiamo verificato anche col pubblico, lascia un’energia tragica importantissima. Paolo: Comunque Paisà ci convinse che volevamo fare cinema. In prima liceo mio padre ricevette dal preside il conto di un banco che, secondo lui, avevo sfregiato. Mio padre volle vedere il banco, prima di pagare. Avevo scritto: Rossellini, Ejzenštejn, Dreyer. È stata una malattia che veramente ci ha travolto, il cinema. In nome del cinema dimenticammo tutto. Anche l’opera. Anche la letteratura. Parlavamo solo di cinema. Cercavamo le storie del cinema, che allora non c’erano. Siamo andati fino a Pisa, in biblioteca, a leggere la storia del cinema di Pasinetti. L’abbiamo trascritta tutta. Ma proprio parola per parola. Sapevamo i nomi. Tutti. Svedesi e russi, americani e francesi. Vittorio: Roba da matti. Quando tornavamo a casa dopo la proiezione di un film ci mettevamo lì a scrivere come era girato. Abbiamo trascritto per intero Ladri di biciclette e Spasimo di Sjöberg, sceneggiato dal giovanissimo Bergman, così lontano da tutto il cinema che conoscevamo. Per capire come ci si poteva esprimere con le immagini.
Paolo: E poi quando li andavamo a rivedere, per verificare se ci ricordavamo bene, cazzo, ecco che avevamo sbagliato tutto. E capivamo però perché era stato girato in un modo piuttosto che in un altro. Per esempio, scrivevamo “lunghissimo carrello”. Poi rivedendo il film, sì, il carrello c’era, ma brevissimo. Così abbiamo capito che se arrivi muovendo la cinepresa al punto giusto, nel momento giusto, sull’emozione, diventa un chilometro di carrello. E invece sono tre metri. Eravamo colpiti dal rapporto tra il ricordo dell’emozione enorme e i mezzi semplici impiegati per raggiungerla.
Casiraghi spara, Amendola para. Vittorio: E qui bisogna dire che siamo arrivati alla nostra dimensione ideologica e politica del cinema. Non c’era un pregiudizio politico. Vedendo però il cinema italiano che scendeva tra la gente, andava in Sicilia, raccontava la Roma del popolo e certe mancanze sociali, ci siamo trovati poi con la classe operaia nelle lotte che sono seguite. Paolo: Ci siamo salvati dall’orrendo cinema sovietico perché siamo nati prima al cinema che in qualche partito. I cosacchi e tutto il resto: ci dicevano al cineclub, ma voi non capite, è un nuovo modo di pensare, siete borghesi. Per noi semplicemente non era cinema. Ci piaceva La terra trema, che era tragico e impopolare. Ci piaceva Il cammino della speranza. Tant’è vero che quando abbiamo fatto il primo film, Un uomo da bruciare, e lo abbiamo proiettato alla direzione del partito comunista, alla fine, silenzio glaciale. Poi si alzò Alicata e disse: voi avete cercato di infangare la memoria di un grande uomo, avete mostrato i suoi difetti. Ha parlato e se ne è andato, non è stato possibile neanche rispondergli. Noi gli davamo dello stupido, con tutto il rispetto che avevamo ai tempi per i dirigenti. Sei stupido perché il nostro personaggio era grande non malgrado i suoi difetti, ma grazie a quei difetti, che gli davano la possibilità di decifrare se stesso nei confronti degli altri. E loro non capivano. In questo senso il cinema ci ha salvato da certi danni dell’ideologia. Vittorio: Perciò quando sentiamo dire del ’68, che sarebbe una stagione del nostro cinema in cui abbiamo fatto cinema politico, ci si rivoltano le budella. Da molto prima vagliavamo nel nostro cinema le scelte, drammatiche anche, che si facevano in quegli anni. Noi abbiamo sempre cercato, fin dal primo film, di raccontare noi stessi in mezzo alle persone che conoscevamo, con cui vivevamo un momento. La politica è un modo di essere, di vivere, di intendere se stessi. Se poi parliamo di Sovversivi, con la morte di Togliatti, allora c’era un nostro amico, un direttore di edizione, un compagno, Bertuccioli, che quando lesse il copione disse: no, scusate, non lo posso fare. C’è la battuta del protagonista, che quando passa la bara di Togliatti dice: “Era l’ora.” Be’, disse Bertuccioli, o la togliete o non lo posso fare. Tutto questo ci ha resi liberi dagli schematismi. Non a caso non abbiamo quasi mai amato i film di altri registi, non facciamo nomi, che sono bravi registi ma che seguivano non le contraddizioni del reale, ma... Paolo: Pur avendo molto talento, intendiamoci. Vittorio: Insomma noi potenzialmente eravamo soggetti a una doppia censura: perché volevamo essere di sinistra in quegli anni, ed esserlo in modo non allineato. Paolo: Finito Un uomo da bruciare lo abbiamo fatto vedere a Ugo Casiraghi, che era il critico dell’“Unità”. Casiraghi disse che gli era piaciuto molto e aveva fatto un pezzo sul film.
Era bravo Casiraghi. Be’, si va a Venezia col film. Intanto si era diffusa la voce che noi avevamo distrutto un mito, che era questo sindacalista. In sala col pubblico è un successo. Tra la gente che ci circondava si era fatto avanti anche Amendola, ci venne incontro, quest’omone gigantesco, ci strinse la mano e disse: bravi, bravi, m’è piaciuto. Il giorno dopo aspettavamo le critiche, in particolare quella di Casiraghi. Ebbene, il pezzo stroncava il film. C’incazzammo da morire. Ma come, era il contrario di quello che aveva detto! Ci ribellammo. E andammo a cercare Amendola. Amendola stava in spiaggia, al Lido. Sotto l’ombrellone c’erano la figlia e la moglie. Lui stava uscendo dall’acqua, questa specie di balena che veniva avanti... Vittorio: Insomma, gli diciamo, ti sembra giusto che ci dicono una cosa davanti e ne fanno un’altra dietro? Paolo: Lui si fa raccontare tutto e dice: no, non è giusto, ma voi sapete che l’“Unità” non è un giornale indipendente; è un giornale di partito, e un giornale di partito ha delle sue verità a cui deve adeguare le altre verità, così la sua è sempre una verità molto relativa; se non capite questo non capirete mai perché è potuta accadervi una cosa del genere, che probabilmente è anche sbagliata, ma per noi c’è il rispetto di queste regole. Soltanto molto tempo dopo, ce lo raccontò Trombadori, sapemmo che Amendola, tornato a Roma, aveva riunito le persone responsabili e aveva fatto un casino su questo errore di valutazione. Vittorio: Il film uscì in agosto al cinema Fiamma a Roma, e basta.
Stalin maestro di linguistica. Paolo: E in tutte queste vicende, naturalmente, c’era anche Valentino Orsini. Vittorio: Valentino è stato il tramite del nostro incontro con la classe operaia. Figlio di operai, un marmista che amava il cinema come noi, un giovane grosso che, alle proiezioni dei film neorealisti, protestava contro chi protestava. Io scrivevo qualche pezzo di cinema sulla “Nazione” e segnalai un giovane documentarista molto bravo. Un giorno questo qua viene da noi per fare qualcosa insieme e dice: mi porto un altro appassionato. E arriva quello che protestava contro chi protestava, Valentino Orsini. Attraverso lui abbiamo incrociato la nostra formazione borghese e, semmai, mazziniana, che veniva dal partito d’azione, con il comunismo. Valentino ci fece capire che cosa significava il partito comunista in Italia, il senso della solidarietà e le contraddizioni, con una strada che sul piano culturale incontrava Marx e Lukács da una parte e Croce dall’altra. Noi ricordiamo di essere entrati con Valentino nelle case della gente, di aver compreso il vissuto competitivo ed egoista della borghesia davanti, invece, a persone che vivevano per la solidarietà e ne facevano una bandiera. E aver vissuto in Toscana quegli anni lì è stato importante. Con tutte le illusioni anche culturali. Per noi, per loro, Stalin era la giustizia, la libertà, perfino la cultura. Mi ricordo la cosa più eclatante, quando Einaudi pubblicò il libro di Stalin sulla linguistica: noi eravamo colpiti, perché pensavamo che quest’uomo aveva veramente a cuore la cultura come l’economia! E lui era per noi il contrario di quello che era in realtà. Paolo: Comunque la gente con cui abbiamo imparato a stare... Vittorio: Ecco questa è una cosa importantissima. Paolo: Quella gente che viveva per costruire qualcosa insieme, che sentiva il bisogno della solidarietà, ci ha dato, col cinema che avevamo scoperto per conto nostro, un amore profondo
dell’uomo e fiducia negli altri. Nel senso di un umanesimo classico. Vittorio: Noi borghesi avevamo vissuto invece la meschinità...
Di notte da Zavattini. Paolo: Il documentario su San Miniato, la nostra prima cosa, partiva con questo spirito. E se non c’era Zavattini non l’avremmo mai fatto, probabilmente. La storia che si racconta sul nostro incontro con Zavattini è vera. Avevamo letto su “Cinema” che lui era molto aperto con i giovani. Aveva fatto Ladri di biciclette. Per noi era un mito. Siamo partiti da Siena, viaggiando tutta la notte in macchina a nolo per Roma, via Sant’Angela Merici 22, dove abitava Zavattini. Quando si arrivava a Roma da quella parte, vicino alla centrale del latte c’erano delle staccionate con la campagna che nell’alba sembrava un paesaggio di Ombre Rosse, e noi cantavamo il refrain della musica del film. La-ra-la-laa, la-lalaaa... Una volta lo abbiamo raccontato a Fusco. Quando il protagonista di Sovversivi ritorna a casa a Roma, c’è un pezzo di musica, Fusco trovò il modo di fare la citazione. Insomma, quando arriviamo davanti a casa di Zavattini, ci viene ad aprire lui. Erano le nove. Zavattini era un insonne, e non sapeva neanche chi eravamo. Gli diciamo perché vogliamo fare il cinema. E lui: alle nove del mattino? Be’, almeno potevate avvertire con una telefonata. Ma invece di cacciarci ci fa entrare. Fu bravissimo. Quando incominciamo a raccontargli del documentario, come lo vogliamo girare, le immagini, il paese, le strade eccetera, ci interrompe improvvisamente: l’idea in sei parole, dice, se no vuol dire che non c’è nessun film. E questa è una banalità importantissima che ci ha guidato sempre. Riusciamo a dirla, gli piace e dice: spendete pure il mio nome. Veramente, a pensarci oggi, è stato straordinario. Torniamo in provincia e troviamo un po’ di soldi per fare il film. Zavattini seguì il progetto nella prima fase. Vittorio: Poi vide il materiale, ma non fu molto presente in seguito. Paolo: Vide il materiale, ci diede dei consigli forti. Vittorio: Poi, al festival di Pisa, a Zavattini andò il secondo premio per il nostro documentario. Paolo: Era contento, anche per noi. Ma anche per se stesso, intendiamoci, e tanto. Vittorio: Però non è che abbiamo frequentato molto quei padri del cinema. Paolo: Pedinati molto, incontrati poco. Vittorio: Con Visconti per esempio. Avevamo amato tantissimo La terra trema. Ma lo abbiamo amato anche di più per Senso. Per chi si era appassionato all’anima trasgressiva del neorealismo, non era più interessante seguire lo sviluppo naturalistico e bozzettistico, quando bene e male non erano più due fronti e la realtà era diventata molto più complessa. Paolo: Solo una precisazione. Scusa Vittorio. Quella scena iniziale nel teatro d’opera, con la camminata del Trovatore ... Per noi fu la congiunzione tra il cinema che amavamo e tutte le emozioni teatrali e musicali dell’infanzia. Sguainava la spada e le infilzava insieme tutte e due. Ho finito, Vittorio. Vai. Vittorio: E appunto quando arrivò Visconti con quella sua capacità di attualizzare Tolstoj e Stendhal, Verdi e la letteratura, in un discorso anche politico, be’ per noi... Era di nuovo il cinema che diventava il coagulo di tante forme espressive, di tante tendenze e ricerche. Dopo Rossellini, il nostro grande amore, ecco che arrivava Visconti. Abbiamo fatto di tutto per
incontrarlo. In mille maniere. Abbiamo fatto l’impossibile. Una volta ci fu una possibilità. Io ero a Pisa. Paolo a Roma. Andai alle poste per mandargli un telegramma: battiti per Visconti. E l’impiegato mi fermò: guardi che i duelli ormai sono proibiti in Italia. Paolo: Per noi Visconti voleva dire incontrarlo per la strada e sentirsi male perché non potevamo stare un po’ con lui, non c’era un modo per parlargli di lavoro. Siamo soltanto riusciti a nasconderci nell’ombra, quando faceva le prove con Santuccio, che gli diceva: ma insomma Luchino, ieri mi hai detto che dovevo fare in un altro modo, adesso il contrario. E Visconti: sto cercando la verità. Vittorio: Con Rossellini invece ho avuto occasione di lavorare un po’. Avevo fatto l’aiuto di Biagetti in un film supervisionato da Rossellini, soggetto di Pietrangeli. Una volta a tavola a Castiglione della Pescaia, con l’incoscienza dei giovani, gli dissi che c’era un film che noi amavamo molto, La terra trema. Sì mi hanno detto che è un bel film, disse, per questo non sono andato a vederlo.
L’immaginazione, l’utopia. Paolo: Comunque noi abbiamo frequentato pochissimo il cinema ufficiale. Eravamo filmaker. Era una nuova generazione. Negli anni ’60 abitavamo a Monteverde, camera a due letti, e lavoravamo da Piero Nelli, che aveva fatto La pattuglia sperduta, l’unico pisano che eravamo riusciti ad agganciare. In quel palazzo, sopra di lui, abitava Bertolucci con i figli, li incontravamo sempre sulle scale, e anche Pasolini veniva sempre lì. Ma non c’era, purtroppo per noi, nessuna relazione. Nei primissimi anni ’60 eravamo legati a quelli che sentivano che bisognava reinventare il cinema, ma questo avveniva per strade assolutamente indipendenti e diverse l’una dall’altra, se non diametralmente opposte. Non era una nouvelle vague, né un gruppo. Vittorio: Dopo i primi film, invece, si formò intorno alla casa di produzione e di montaggio di Giuliani un centro di incontri, a via Donizetti. Eravamo noi, Rocha, Ferreri, Solanas, che era in Italia. Non c’era una lira. Più che le discussioni parlavano i film, per cui si litigava molto sulla politica. Ferreri faceva il grande cinico. Abbiamo fatto le prime manifestazioni insieme. Abbiamo occupato l’Istituto Luce. Una volta Giuliani ci fece riunire un po’ tutti. C’era Bertolucci... Paolo: No, Bertolucci mandò a dire tramite Pasolini che non veniva. Vittorio: No, Pasolini mandò a dire, tramite Gianni Amico, che non poteva. Paolo: Be’ c’erano Bellocchio, Amico appunto, Ferreri e altri. Vittorio: In questa riunione si voleva formare una sorta di Artisti Associati, come quella di Chaplin. Parlammo dei programmi. E Ferreri a un certo punto viene fuori e dice: ma, guardiamoci in faccia, siete sicuri che ciascuno di voi sarà felice e contento se io faccio un bellissimo film? Paolo: Abbiamo interessi comuni, è vero, diceva Ferreri, ma non facciamo discorsi di poetiche varie e quelle robe lì. Vittorio: Per cui la cosa rimase sospesa e poi non se ne fece niente. Ferreri ci aiutò però moltissimo per Allonsanfan, mettendoci in contatto con Mastroianni, che era in un momento di decadenza, ma andava benissimo per il nostro film, dove c’è comunque un discorso di
fiducia nel domani... Paolo: Ugo Pirro scrive che la generazione di Rossellini e gli altri aveva una “struggente fiducia nel domani”. Per noi invece, per la nostra generazione di cineasti, si trattava di “un’aggressiva fiducia nel domani”. Vittorio: Aggressiva e polemica. Eravamo molto più ribelli e inquieti. Ciascuno cercava sempre un po’ la sua strada. Per esempio, con Olmi abbiamo avuto un rapporto profondo e intenso. Ci siamo scritti molto. Lui diceva che per stare insieme bastavano i nostri film. A differenza della generazione di Rossellini e De Sica, che si trovavano tutti quanti al Rosati, piuttosto che nelle case, noi non avevamo questa frequentazione, questa coesione di gruppo, salvo attraverso le opere, o certi momenti politici, e con l’eccezione del Terzo Mondo, con certi giovani. Forse perché siamo in due. Eravamo già una compagnia. Paolo: La spinta ce la davamo da soli. Vittorio: Si va nel banale, adesso, ma l’utopia che avevamo era il semplice rifiuto dell’esistente in nome di qualcosa che, per il fatto stesso che tu ora lo desideri, è già una realtà. Questa è una riflessione di Fortini. Esatta. Se pensi, diceva Fortini, che possa esistere una dimensione diversa del vivere e del convivere, già questa è la tua nuova realtà, la tua rivoluzione. Paolo: L’immaginazione... Vittorio: L’immaginazione di una dimensione diversa. Ma quale? L’utopia porta con sé anche il tragico, lo sforzo di raggiungere qualcosa che ha dentro un grande potenziale drammatico. Paolo: Oggi non penso che quel cinema ha contribuito essenzialmente all’emancipazione della classe operaia. Semmai erano altre cose. Lo pensavamo, lo speravamo in quel momento. Il pubblico a quel tempo era tradito dallo spettacolo che gli veniva propinato. Mi ricordo Bertolucci che diceva: io odio il pubblico perché non capisce. Proprio perché lo rispettiamo pensiamo che possa seguirci, gli diamo quello che ancora non sa. I nostri film sono i più semplici del mondo, dicevamo (e poi non era proprio vero, eh). Pensavamo: noi diamo al pubblico quello che ancora non sa. Una volta all’Holiday alla proiezione di Sotto il segno dello scorpione abbiamo telefonato per sapere quanta gente c’era andata e ci rispondono: tantissimi, ma dovete pagare due file di sedie perché le hanno spaccate tutte. Volonté aveva fatto i film con Sergio Leone, quindi era già una star, e loro col nostro film erano rimasti molto delusi. E Volonté era bravissimo. Vittorio: Volonté per noi è uno dei grandi artisti del secolo cinematografico. Un creatore vero. Detto questo era anche un personaggio distruttivo e autodistruttivo. Doveva essere lui il “padre padrone” del nostro film. Ci eravamo lasciati a Malta, dove lui era in vacanza, col copione pronto venti giorni prima di incominciare. Poi, improvvisamente, ha incominciato a negarsi, sempre. Tornato a Roma aveva avuto il sospetto che noi amassimo più Gavino di lui. Paolo: Ma poi chissà perché. Vittorio: Era grande e imprevedibile. Un carattere molto difficile. Ma coglieva le contraddizioni, le ambiguità. Proprio la nostra strada. Noi cercavamo la verità, che poi sappiamo che sfugge, che non c’è, e tutto il resto, ma questa era la nostra strada. Avevamo come esempio i grandi poeti. Se prendi l’Iliade, non so, dove sta il bene e dove sta il male? Non è facile. Riuscire a trovare la sgradevolezza della verità... Questo però è molto negativo ai fini commerciali.
Tv grandi speranze. Paolo: Il neorealismo aveva cambiato il cinema nel mondo, ma erano in pochi in Italia a conoscere quei film. Allora noi avevamo un atteggiamento verso il pubblico, che era giusto, per certi versi, ma non per altri. In fondo avevamo amato tantissimo anche Shakespeare che aveva coniugato i suoi grandi pensieri con l’audience e l’incasso. Dal neorealismo in poi quest’aspetto di parlare più semplicemente al pubblico non c’è stato, per tutti gli anni ’60. Il primo che ha agganciato il pubblico è stato Bernardo. Che a un certo punto ha fatto un salto. I nostri film erano conosciuti dalla Corea agli Stati Uniti, davvero, non facciamo per vantarci. Ma pochissimo, quasi niente in Italia. San Michele aveva un gallo ha atteso due anni per uscire. Vittorio: È uscito grazie alla televisione. La televisione ha un po’ aiutato tutti noi. Strategia del ragno di Bernardo Bertolucci, che era già un film diverso, è stato il primo aiutato dalla televisione. E credo che a posteriori, mai a priori, il fatto che milioni di persone a un certo punto vedessero tutti i nostri film abbia influenzato, non un cambiamento di rotta, ma la riflessione: adesso cerco una trasparenza. Mantenendo lo stesso rigore. E questa cosa qui ci ha portato a intraprendere la strada dell’affabulazione, che è un po’ il nostro secondo momento, la nostra seconda fase di lavoro. La tv doveva diventare il nuovo fuoco intorno al quale trovarsi, c’erano grandi speranze nella prima fase del cinema in tv, verso la fine degli anni ’70. Paolo: Poi comunque non è andata così. Vittorio: Be’, non è andata così perché c’erano troppi fuochi. Comunque prima pensavamo che dovevamo essere eroici, che il nostro compito era risvegliare gli altri dal sonno, tutto era più glorioso, indispensabile. Ora, invece, con la televisione ci sembrava che tutto fosse più stratificato, e questo dà una grande forza a un autore, dà anche una responsabilità nella comunicazione. Aumenta la responsabilità. E ti fa trovare quel disegno importante: unire le parti basse alle parti alte, che è il sogno raggiunto dai grandi. Paolo: Comunque, gli anni ’70 hanno dato film bellissimi, di Bertolucci, di Bellocchio. E L’albero degli zoccoli , che per noi è importantissimo. E alcuni nostri, forse. La generazione degli anni ’60 si è realizzata pienamente negli anni ’70. Vittorio: Il terrorismo, è vero, ha creato un grande sbandamento, anche nel cinema. Ma allora la stessa televisione ha influenzato negativamente il cinema a livello formale, in certi casi. E poi c’è stato il ritorno di Hollywood a livello mondiale con Lucas, Spielberg. Ma è difficile agganciarci, noi, a questa svolta di difficoltà e crisi del cinema italiano, per la produzione d’autore e la distribuzione. Perché noi abbiamo forse fatto i nostri film migliori in quel periodo. La notte di San Lorenzo, per fare un esempio. Il prato, poi, portava già al nocciolo la questione dello scontro delle generazioni che veniva dal ’68 e aveva trovato nel terrorismo la sua forma più eclatante e assurda.
Terrorismo e resistenza passiva. Paolo: La cosa che ci colpiva era che noi, già padri, giovani padri, vedevamo che era invertito il termine dello scontro: in genere il figlio è aggressivo naturalmente nei confronti del padre,
per tutta una serie di motivi. Anche nel ’68. Invece, a quel punto i giovani erano presi dalla stanchezza, perché tutto quello in cui noi credevamo, il lavoro, la politica, tutte cose per cui avevamo lottato: no, niente, non si è realizzato niente, loro lo sapevano, lo sentivano, e scattava un meccanismo di passività. Che è la cosa più tremenda. Non era un’affermazione per cambiare, ma una negazione, perché si sentivano vuoti di ogni desiderio che fosse lontanamente simile alla nostra ribellione. E la realtà era molto complessa, perché insieme a questa stanchezza convivevano ancora le Brigate Rosse, apice di quell’altro momento ribellistico. Nel Prato c’è il personaggio di Placido, che ha questa funzione. L’aggressività del figlio lì era semmai nella resistenza passiva, fino alla morte. Adesso non sta a noi dirlo, ma Il prato, forse, già alla fine degli anni ’70 annunciava il decennio seguente.
Domani, che sorpresa! Paolo: Per noi è difficile ricostruire l’attualità. Per esempio, Fiorile. È un film degli anni ’90, ma che partiva semplicemente dal desiderio di raccontare una storia (fare cinema è raccontare una storia). Una vicenda che avevamo sentito da ragazzi al nostro paese. Ci aveva emozionato moltissimo il soldato che, venendo fucilato, partoriva ricchezza, questo figlio della rivoluzione che praticamente, con la sua morte, faceva diventare ricchi quei borghesi. Vittorio: La parte che abbiamo amato di più di questo film era quella contemporanea, cioè con il personaggio che era andato a cercare qualcosa della sua vita e restava con la profonda amarezza, la profonda solitudine di chi ha trovato soltanto qualcosa che si è dissolto. E, chiuso in se stesso, nonostante il silenzio di cui si è circondato, improvvisamente, con uno scherzo di bambino, sente rinascere qualcosa che lo ricongiunge alla vita, alla speranza. Amiamo molto quell’ultima parte del film. Poi invece come spettatori possiamo dire a noi autori che è stato uno sbaglio mettere un episodio come quello alla fine di un film un po’ lungo... Paolo: Artigianalmente lì forse abbiamo commesso degli errori. Vittorio: Ma quel silenzio dolorosissimo del nostro personaggio attraversato, interrotto, da una voce lontana... ci rappresentava molto, ecco. Paolo: Ma allora dirò di più. Quel personaggio l’abbiamo scelto, e mia moglie l’ha vestito, esattamente come Giuliani, il produttore, grande partigiano, che era morto recentemente. Ci appassionava perché quel personaggio per noi conteneva un sentimento del tempo. Il passaggio delle epoche, certe differenze, poi legate al cinema italiano, alle nostre esperienze, a quello che è stato e a quello che ci attende. Vittorio: Ecco io non so che cosa ci attende; Moravia diceva che l’unica cosa che aspetta uno scrittore dopo cinquant’anni è se stesso. Né che cosa sarà del cinema italiano. E vero che non c’è più una strada maestra, ma casi isolati, per esempio Moretti, Virzì. E anche Benigni, di cui sento un certo tipo di potenza del cinema, cioè che la sua mascherata possa funzionare dalla Corea al Sudamerica. Paolo: Benigni a prescindere dai film esiste come maschera, come maschere erano Totò e Chaplin, una forza della tradizione boccaccesca. Vittorio: Però è vero, quello che dici. Perché alla fine oggi si parla di casi e non di tendenze. Non c’è la comunità, forse. Questa globalizzazione sta trasformando tutto nei mass media, è un’enorme confusione, sopra l’esistente è arrivato un materiale enorme, ci sta quasi
seppellendo, ma forse da tutto questo, qualcuno, qualcosa, arriverà a fare ordine, o alcuni ordini diversi che saranno il nuovo, il nuovo cinema, la nuova televisione. Paolo: Perché tu che cosa ti aspetti? Vittorio: Ah, io non lo so, e non voglio saperlo. Preferisco essere sorpreso.
30 Nel sottofondo di chiacchiere tra mia figlia e l’autista, mi sorprende la risposta di questo ragazzo, studente del secondo anno di lettere a Pesaro, a una domanda su Giuseppe Pontiggia: “Sì ho letto due romanzi. Ma per me resta lo scrittore che ha raccontato la storia di mia nonna senza saperlo. O lo sapeva? Insomma è una coincidenza assurda.” Laura chiede spiegazioni. “Nella Vita di uomini non illustri di Pontiggia si legge di una donna che nacque a Santa Margherita Ligure, si sposò con un notaio che non le piaceva e lasciò la famiglia per convivere con un’amica, suscitando scandalo. È la storia di mia nonna, che però è ancora viva, ha settant’anni e abita a Camogli, mentre la signora del racconto è morta di angina pectoris. C’è un’altra cosa incredibile: mia nonna, non solo soffre di angina, ma, come il personaggio, aspirava a diventare scrittrice. Quando racconto questa storia ai miei amici, nessuno ci crede. Ci credono i registi. L’ho raccontata qualche settimana fa a Ermanno Olmi, accompagnandolo a Pesaro per la retrospettiva dei suoi film. Era divertito. E mi ha suggerito: ‘Forse Pontiggia era innamorato di tua nonna!’ Ci siamo messi a ridere. Ma poi ha aggiunto: ‘La cosa più importante è che questa storia ti ha sorpreso, e che da questa sorpresa ti viene la voglia di dubitare delle cose, e di farti delle domande e cercare delle risposte, perché questo, se vuoi, è il senso di una vita davvero illustre.’”
ERMANNO OLMI Il mestiere di vivere Il senso del mio lavoro? Devo risalire all’infanzia. Ogni giorno siamo diversi dal precedente. Le realtà si modificano in relazione ai cambiamenti che ciascuno ha in atto nella mente e, in senso più vasto, nell’interiorità. Le sollecitazioni esterne e le risposte che ci vengono da dentro modificano proprio la percezione della realtà, e quindi il senso che diamo alle cose. Da bambini, da adulti, a ogni età. Se pensiamo al momento dell’innamoramento, questo evento cambia tutta la realtà, dentro e fuori di noi. Che cosa è successo dentro di me quando, a cinque anni, per la prima volta i miei genitori mi accompagnarono all’oratorio? Mio fratello partecipava a una recita. Quella sera, uscire dopo cena, cosa mai accaduta, ed entrare in un teatro, dove conveniva tutta quella gente, era già un’esperienza eccezionale. Vedere le lampade al muro perimetrale della sala e il sipario di velluto rosso, il chiacchiericcio, il buio, le luci della ribalta, il silenzio della platea, e... si apre il sipario! Da quel momento la mia vita è cambiata. Ebbene, nonostante tutto il percorso fatto, le esperienze compiute, la conoscenza di una disciplina, lo spettacolo, i successi e gli insuccessi (perché è così: non è che uno si garantisce ogni volta l’esito di un film), ancora adesso, alla mia età, dopo cinquantadue anni di cinema, il senso del mio lavoro fa riferimento a quell’istante magico di stupore. Lo stupore ti pone davanti a un’emozione che al momento non puoi controllare razionalmente, ma poco dopo, e in alcuni casi per sempre, la risonanza, l’eco di quell’emozione è capace di sollecitare tante di quelle domande, di curiosità, di slanci. Necessari per vivere. Vivere vuol dire porsi dei perché e tentare di dare delle risposte. Lo stupore non finisce mai di stupirmi.
Poveri. Ho scoperto il cinema sempre all’oratorio, a Milano. Negli anni ’30, un quartiere come la Bovisa era abitato da un mondo contadino trasferitosi in città per la richiesta di braccia che il mondo industriale rivolgeva alla campagna. Allora i quartieri si chiamavano rioni, el rion de la Bovisa. Le istituzioni erano: la scuola elementare, perché per le medie bisognava già andare in centro, e la chiesa, quindi per noi ragazzini l’oratorio. Proprio per quel mondo operaio che doveva fare i conti con una busta paga misera (la prima cosa che faceva mia madre il giorno di paga era mettere da parte i soldi per l’affitto), l’oratorio era un luogo prezioso. Potevi trovarci un pallone, il calciobalilla, a volte il ping pong, cose che non ci si poteva permettere mai. Io abitavo in via Costanzo Cantone. Nessuno di noi possedeva un pallone. Qualche palla di gomma, che è cosa ben diversa. Andavamo a piedi in fondo a via Jenner. C’era un campo da tennis. Avevamo scoperto che sotto la siepe, fitta, andavano a cacciarsi le palle dei signori che giocavano a tennis. Si potevano permettere di perderne qualcuna ogni tanto. Quello diventava il nostro football, ma qualche volta calciavi il sasso invece della palla, troppo piccola. Le mance della domenica non superavano i cinquanta centesimi. In terza elementare incominciai a dover scegliere se comprare la liquirizia, il gelato, oppure il biglietto del cinema e restare senza niente. Anche se, poi, all’oratorio, quelli che stavano lì, davanti all’entrata, e aspettavano mogi, li facevano entrare tutti. Mai frequentato un’organizzazione giovanile
fascista. Mio padre era un antifascista che perse il posto alle ferrovie perché non si era voluto iscrivere al partito. Per fortuna venne assunto dalla Edison al Gas Bovisa, come macchinista all’interno delle officine del gas. Esattamente la storia del Ferroviere di Germi. Una volta incontrai Germi in via Veneto, al Rosati, e gli dissi: non hai idea di cosa rappresenta per me questo film, perché è la storia della mia famiglia. La locomotiva della Edison era un giocattolo rispetto a quelle che aveva guidato mio padre. La 691. Il massimo. Come oggi dire un jumbo. Mio padre non frequentò mai la Casa del Fascio, dove c’era l’obbligo di onorare il sabato fascista. Mio fratello andò qualche volta. Dovevamo acquistare la divisa. Io ero figlio della lupa. Lui, maggiore di quattro anni, balilla. Il sabato mattina, per andare a scuola, nostra madre ci faceva indossare quella divisa obbligatoria. Mio padre si voltava dall’altra parte. A causa del fascismo, come ho detto, papà restò disoccupato per due anni. A scuola eravamo considerati poveri. Non si diceva “indigenti”. Poveri. Una volta, all’inizio di un anno scolastico, entrò il bidello con una borsa e proclamò: la cancelleria dei poveri! Davano il pennino, il quaderno, l’inchiostro. E chiamò alcuni nomi, tra cui, scandito: Olmi Ermanno.
Una passione infiammabile. Dicevo che per andare al cinema dovevo rinunciare al resto. A volte sceglievo il gelato, ma spesso andavo al cinema, nella sala dove avevo scoperto il teatro. Il film veniva dopo la benedizione, quindi intorno alle quattro del pomeriggio. Per vedere un film intero a volte ci volevano tre ore: ogni venti, trenta minuti si rompeva la pellicola e aspettavi, aspettavi. Poi sembrava ripartire, ma subito ecco il classico fotogramma che s’incendia. Fu tra queste interruzioni che vidi un pezzo del Sigfrido di Fritz Lang. Una scena rimasta integra mostrava Sigfrido che uccide il drago e poi va a lavarsi del getto di sangue, mentre cade una foglia. Questo però lo capii quando avevo ormai vent’anni, rivedendo il film. Il cinema mi colpiva come il teatro perché ripeteva il rito del buio e dell’attesa in sala, cosa che, invece, decade nello spettacolo televisivo. Un giorno la mia passione diventò... infiammabile. Dalla finestrella della vecchia chiesa il proiezionista buttava i fotogrammi tagliati, quando si rompeva la pellicola. Una volta mi accorsi che, tra la terra, ai piedi della chiesa, brillavano spezzoni di celluloide. Come i miei amici collezionavano le figurine, io raccoglievo i ritagli di pellicola. Guardavo i fotogrammi in controluce, nella mia stanza, dicendo a me stesso: ecco, questo è il cinema. Contemplavo l’immagine fissa, convincendomi che poi, al cinema, si muove. Avevo otto anni. Una sera pensai di fare il cinema a casa. Avevo capito, e qualcuno me l’aveva detto, che il cinema era lo scorrere di queste immagini. Con una scatola da scarpe ritagliai un riquadro grande più o meno come le strisce dei fumetti. Avevo incollato le strisce di pellicola e pretendevo di fare il cinema muovendo la striscia riquadro per riquadro davanti a una candela. Tra la porta a vetri smerigliata e il portoncino d’entrata di casa avevo messo uno sgabello, sul quale avevo appoggiato la scatola da scarpe che fungeva da proiettore. Facevo scorrere le strisce e dicevo qualche didascalia. Mia madre era preoccupata, e una volta avvenne quello che paventava: la candela riscaldò troppo la pellicola e incendiò la celluloide. Dal vetro smerigliato salì una fiamma. Tra le urla di mio padre fu il mio addio al cinema. Per il momento.
Gioie e nefandezze del 25 aprile. Nel ’51, appena giovanotto, allestivo spettacoli teatrali alla Edison, tra cui Zoo di vetro (sentivo il pungolo dell’innovazione) e Un cappello di paglia di Firenze, e anche spettacoli di varietà, con balletti e sketch che scrivevo io. Gli attori erano gli impiegati e le impiegate. La classe dirigente della Edison era di altissimo livello, come gli uomini politici di quel tempo. Alla Triennale del Parco, a Milano, siamo riusciti a mettere in piedi uno spettacolo dove avevamo in scena asini, carrozze, scenografie. Nelle nostre previsioni, bastavano tre repliche, invece lo spettacolo continuò per alcune settimane. Frequentavo il teatro quasi tutte le sere, e anche il varietà. La gente popolava le sale. L’Italia che ricordo in quegli anni viveva in uno stato di stupore. Ecco che ritorna un elemento importantissimo della vita: lo stupore. Improvvisamente avevamo di fronte un futuro di pace illimitata. In quel momento il mondo aveva finalmente conquistato la pace, si diceva. Mai più guerre. Il 25 aprile fu la più grande festa collettiva di questo paese. Quando esci da una galleria gli occhi hanno bisogno di restringersi e aprirsi più volte finché non trovi il diaframma giusto, no? Ebbene, sembrava di uscire da una galleria e gli occhi non riuscivano a capacitarsi. La mia casa era stata distrutta. Vivevo in via Cantoni nell’appartamento di un’altra persona che aveva abbandonato Milano. I muri erano pieni di schegge provocate dalle bombe. Mio padre era già morto, vivevo con mio zio, e lui era già andato al lavoro. Scendo al mattino per comprare il latte, con la tessera, e vedo un mio amico in fondo alla via che urla: è finita! È finita! Era la parola magica. La gente, al momento, era sbalordita, intontita, ma nel giro di poche ore è esplosa una reazione che andava dall’esaltazione gioiosa alla nefandezza. Dalla ringhiera di casa mia vedevo i camminamenti antimitragliamento, per buttarti quando non riuscivi a raggiungere il rifugio se suonava l’allarme. Ho visto trascinare lì un fascista in borghese, che aveva ancora gli stivali di pelle della divisa, e ho sentito urlare delle donne in modo isterico (ho capito che doveva essere così durante la Rivoluzione francese). Dei partigiani di città, che non avevano niente a che fare con i partigiani di montagna, arrivati improvvisamente con tricolori, fasce, armi, lo trascinavano di peso, perché quell’uomo non riusciva a camminare da solo. Le donne urlavano come belve: accoppalo! porco! Donne che mi sembravano normali fino al giorno prima, massaie del popolo, incitavano a ucciderlo. Lo buttarono nel camminamento e dall’alto gli spararono addosso. Non lo comprendo. Sentivo che è come un uragano, tale è la devastazione delle menti. Tra le urla venne avanti uno che ebbe il coraggio di togliere gli stivali al morto e infilarseli, ancora caldi. Sono immagini che non dimenticherò mai. Ma c’erano gli antecedenti... C’è sempre qualcosa per cui si fa qualcos’altro... Per andare a Treviglio da mia nonna prendevo un tram, in via Padova, vicino a piazzale Loreto, che arrivava a Cassano d’Adda, e poi a piedi per sei chilometri. Un giorno vidi i martiri di Loreto, c’era un assembramento di armati fascisti con le vittime. La gente non osava guardare, passava e tirava via. Questi uomini e queste donne erano lì con i soliti cartelli appesi: noi siamo degli assassini. Era il ’44, avevo tredici anni e facevo la terza media dai Salesiani in via Copernico. Sono passato vicino a questi morti, una quindicina di cadaveri sorvegliati dai fascisti. Erano i fucilati di San Vittore, uccisi dai tedeschi. Ho avuto la sfrontatezza di avvicinarmi, consapevole che un ragazzo non correva pericolo. Non riuscivo a vedere i volti, ma la mia attenzione si concentrò su un piede che sporgeva dai pantaloni, con i suoi calzini e la scarpa. Mi ricordo che pensai: guarda questo disgraziato che questa mattina si è allacciato per bene le
scarpe, non sapeva che andava a morire. Ebbene, queste immagini è come se la memoria te le restituisse un istante dopo che le hai viste, cosicché restano impresse per tutta la vita. Esposero il duce, la Petacci e gli altri a piazzale Loreto per quei morti. Vidi anche loro, quando erano già appesi da un po’. Vidi portare Starace in tuta da operaio e in pantofole. Lo fucilarono, ma no, non l’ho voluta vedere la fucilazione. La cosa che mi resta impressa, indelebile, è l’urlo della folla inferocita. Uno può dire che le donne avevano perso i mariti, le madri i figli, ma devo fare comunque uno sforzo di razionalità per giustificare l’accanimento. Alla scuola di via Bobbio, che si chiamava Rosa Mussolini, la mamma del duce, ho visto le collaboratrici fasciste, cosiddette ausiliare in divisa, che finivano rapate, col catrame in testa. Alcune le fucilarono. Altre le mortificavano e basta, poi magari le mettevano in prigione. Mi ricordo un energumeno, forse un intellettuale dall’aspetto rozzo, con la faccia rossa da avvinazzato, che urlava: nudeee!, le vogliamo nude! Poi la follia si è trasformata, dalla violenza è uscita l’euforia. A un certo punto è successo che ogni sera, in ogni piazza della città, nei cortili, si ballava, si chiacchierava, si stava insieme. Intanto arrivavano i sopravvissuti, quelli che venivano dall’America si riconoscevano subito dall’odore e dalla parlata. Ritrovai un contadino di Bergamo che non sapeva parlare italiano, ma che ora sapeva farsi capire in inglese. Quelli che venivano dal fronte, dalla Russia e dai campi di concentramento, erano larve. Increduli, non capivano, guardavano noi felici come a dire: ma come si fa? Come si fa a tornare a essere felici? Un mattino, era settembre ormai, vidi uno di questi sopravvissuti nel suo cappottone, dove ci sarebbe stato anche suo fratello. Era dal fruttivendolo, che gli offrì un grappolo d’uva. E lui incominciò lentamente a mangiare, acino per acino, come se stesse cercando di ricominciare a vivere. Ma il paese era già ripartito.
L’orgia di Robin Hood. Dopo la violenza e le ritorsioni, dopo la gioia e l’euforia, era partita la battaglia per il guadagno. Si comprava e si vendeva qualsiasi cosa. Tutti erano sia compratori che venditori. Tutti! Un attimo, e ci siamo trovati nel boom economico. Un mondo impensabile. Appena finita la guerra, e fino al ’47, vedevamo soltanto film americani. L’occupazione cinematografica è più grave dell’occupazione poliziesca, perché lo spettatore s’identifica col paese che ha prodotto i film. L’America era un sogno molto lontano, ma possibile. Guardavi questo film e dicevi: ma tu pensa, in America anche lo spazzino ha l’automobile. Come dire che oggi ognuno di noi ha una rampa di lancio per il missile. Cinque, sei anni dopo, anche lo spazzino, da noi, aveva la Vespa. Un fiduciario della Warner mi raccontò, anni dopo l’occupazione cinematografica americana, qual era nelle sale italiane la scena più apprezzata dal pubblico durante il film Robin Hood, uscito appena dopo la guerra. Be’, non era la scena d’amore o quella dove il ladro rubava ai ricchi per dare ai poveri, ma la scena del banchetto nella foresta, dove tutti si abbuffavano di porchette, polli, tagli di bue, in un’orgia di cibo. A quei tempi era più importante una coscia di pollo della coscia di una bella donna.
La prima cinepresa. Il 17 gennaio del ’47 sono entrato alla Edison. Non avevo ancora sedici anni. Scoprii per prima
cosa l’ufficio dattilografe. Credo di essermi innamorato di tutte, non solo erano deliziose, ma facevano parte del sogno del mondo operaio che entrava nel mondo impiegatizio. Per andare a lavorare partivi con le mani pulite e tornavi con le mani pulite. Era una conquista. Non sapevi di grasso di macchina, che era l’odore di mio padre. Per un quindicenne le dattilografe erano una delizia. Subito dopo scoprii la filodrammatica della Edison. Mi presero per piccole particine. Quando feci la rivista, di cui parlavo prima, il personale organizzò una raccolta di firme per ripetere lo spettacolo e lo portarono in giro in tutt’Italia nelle sedi della Edison. Alla fine di questo glorioso ciclo di rappresentazioni, il presidente della Edison Volta, il dottor Bobbio, un uomo di grande cultura umanistica, non solo manageriale, disse al mio capo che la direzione voleva farmi un regalo per ringraziarmi. Io chiesi una cinepresa professionale a passo ridotto. Il mio capo pensava fosse un regalo esagerato. Costava come una buona telecamera di oggi, diciamo intorno agli otto milioni. A quei tempi una spesa enorme. Proposi di creare una sezione di cineamatori. La spesa allora risultò giustificata. Ho incominciato a fare i primi documentari sulle attività lavorative della Edison. Mi aveva sempre interessato il mondo del lavoro. Credo che mi derivi dalla mia origine contadina, più che dal mondo operaio che vedevo intorno a me. Finita la scuola, le mie vacanze da povero le trascorrevo in campagna dalla nonna, dove il mondo era ancora totalmente rurale. Partecipavo alla vita dei campi, la stalla, le coltivazioni. È un dialogo con la natura, il lavoro del contadino, non con la macchina. La mia famiglia aveva questa doppia natura: mia madre contadina, mio padre macchinista di ferrovia. L’odore della campagna contrastava con l’odore di macchina di mio padre che, se aveva tempo, mi faceva fare un giro sulla canna della bicicletta prima di portarla su in casa, ed era come salire su una Ferrari, per me.
Dall’Edison alla Titanus. Centrale di Baveno, centrale Fondo Toce. Vedevo arrivare lettere da mondi lontani, dove sapevo che si fabbricava l’energia elettrica, ma dove non pensavo sarei mai andato. E invece, con gli spettacoli quei paesi li raggiunsi tutti. Capitai perfino a Ligonchio, dove la piccola Iva Zanicchi scoprì nei nostri spettacoli il mondo della rivista. In quei viaggi notai che alcuni cantieri aperti per la costruzione di dighe erano spettacolari. Per lavorare meglio sull’imponenza dell’immagine allora decido di affittare una macchina da 35 millimetri. Il documentario realizzato in quell’occasione lo mandai a un concorso ministeriale, e vinsi il premio. Il film fu distribuito nelle sale (a quei tempi vigeva l’abbinamento tra lungometraggio e film documentario). Lasciai l’ufficio approvvigionamenti convincendo la direzione ad aprire e affidarmi una sezione cinematografica. Con l’aiuto di alcuni colleghi nacque una vera attività produttiva. Prima di uscire definitivamente dalla Edison girai due lungometraggi, Il tempo si è fermato e Il posto. Nel caso del primo film, volevo fare un cortometraggio, ma mi era venuto molto più lungo. Era il ’59. Lo mandai alla sezione documentari del festival di Venezia, dove in giuria c’era Guerrasio. Il film non poteva partecipare al concorso perché era in realtà una storia con attori. Allora il direttore del festival, Ammannati, lo passò nella sezione informativa, dove andavano i veri appassionati di cinema. La sezione ufficiale, quella del Leone d’oro, era il festival dei produttori, l’informativa quello degli autori. Vinsi alcuni premi. Fu la consacrazione. Rossellini riunì tutti i giovani di quella sezione per una fotografia.
Una banda di ragazzi tra cui Truffaut, Lizzani, Pontecorvo, stretti intorno a Rossellini patriarca. Quanto a Il posto produssi il film con alcuni amici, chiedendo alla Edison di usare le cineprese e il parco lampade. Goffredo Lombardo (la Titanus), sapendo che il film interessava ancora alla Mostra di Venezia, dopo aver visionato una copia di lavorazione, mi chiese di finirlo in quindici giorni per partecipare al festival. Gli spiegai che non avevo più neanche una lira per le musiche e il resto. Lui chiamò Bonotti e disse: Olmi deve finire il film, costo una lira! Il film partecipò alla Mostra e vinse altri premi. Fatti tutti i conti, dopo Venezia, risultò che era costato ventun milioni, pochissimo anche per quei tempi. Sapevo che i soldi che mi aveva dato la Titanus servivano per ripagare la Edison, e infatti, stavo per restituire alla Edison cinque milioni, e tutto finiva in pari. Sorpresa, la Edison rifiuta i soldi e li regala a me come compenso del mio lavoro, per il quale io non avevo previsto nulla. Per me il risultato era l’esito positivo del film.
Milano rinascimentale. L’Italia dei galantuomini. Per questa generosità e per il sentimento, quantomeno l’umore, di fiducia nell’avvenire, definisco “rinascimentale” il clima culturale di Milano in quegli anni. Il “fare” conteneva sempre l’aggettivo “bene”, cioè fare bene. Perché il Rinascimento fu importante? Si esce dal chiuso dei chiostri, si esce dall’oscurità di un mondo sacrificato entro certi confini. E, con la scoperta dell’America, si aprono orizzonti impensabili. Ebbene, in quegli anni per noi era come scoprire un mondo nuovo al di là di confini che nessuno aveva mai varcato. Per capire questa palpabile differenza di momenti storici bisogna pensare alla classe politica dirigente: Parri, De Gasperi, Togliatti, Amendola, Terracini, Camilla Ravera, La Malfa. Una classe di galantuomini. Nel giro di cinque anni sono incominciate le insidie per farli fuori. De Gasperi cade nel ’54 a Napoli. Per volontà del Vaticano. Quelle sono per me le figure rinascimentali. Vogliamo confrontarli con quelli di oggi? Il signor De Gasperi, nonostante tutto, aveva stima del signor Togliatti, e viceversa. Togliatti fermò l’insurrezione dopo il suo attentato e salvò la situazione e De Gasperi. Poteva avere tutti i legami che vogliamo con i russi, ma porca miseria, che statura! Se pensiamo agli uomini della rinascita del cinema italiano, i nomi sono qui in questo libro. Quando usciva un film nuovo si faceva una proiezione a Roma per i cineasti, alle sei del pomeriggio, si discuteva, si criticava. E tu vedevi tutti, da Blasetti ai giovani. Che civiltà! Ma prendiamo anche l’editoria e la letteratura. L’Einaudi, la Bompiani, Moravia, Vittorini, la nuova generazione di scrittori, Bianciardi, Parise, Mastronardi, Pasolini, i ragazzi di allora. E gli scrittori di cinema. Perché tali erano gli sceneggiatori. Soltanto verso la fine degli anni ’50 gli scrittori su carta incominciano a lavorare anche per il cinema. Perché si guadagnava molto. Uno scrittore che passava al cinema con un soggetto o una sceneggiatura si beccava il compenso di dieci anni di editoria.
Script con Pasolini, passeggiate con Bianciardi. Da spettatore che incominciava a fare il cinema, i riferimenti per me furono Rossellini, De Sica e alcuni altri, a seconda delle occasioni e dei risultati. Fino a tutta la metà degli anni ’50 io sono un uomo di azienda, che non ha una cultura scolastica e che avvicina le forme di
pensiero e di narrativa leggendo disordinatamente e andando a teatro e al cinema. Però, il mio primo documentario, lo scrivo nel ’53, a Milano, con Pier Paolo Pasolini. Passo le mie serate e scrivo un copione mai fatto, con Goffredo Parise. Incontro Mastronardi. Quando Bianciardi viene a Milano, nel ’55, diventiamo amici frequentando la casa di un mio carissimo amico. Parise era geniale a rappresentare la realtà attraverso la metafora. Pensiamo a Il prete bello e a come si scopre l’Italia della provincia. Ho vissuto invece il rapporto con Bianciardi soltanto da amico, non da aspirante regista a letterato. Un uomo di grande saggezza ironica. La sua ironia tagliente affondava nella verità delle cose. Per dire quanto a volte ero fuori dal lavoro letterario di Bianciardi: quando uscì La vita agra non ne sapevo niente. Frequentavo Bagutta, s’andava a mangiare nella saletta di fronte alla casa dove si riunivano tutti gli intellettuali di Milano, Piero Zuffi, De Marchi, l’editore Tofanelli, Giancarlo Fusco, Montanelli. Stavo preparando I fidanzati. Un giorno torno in ufficio e mi chiama la Titanus. Mi dice Lombardo: allora compriamo i diritti. Quali diritti? I diritti di La vita agra di Bianciardi. Perché, ha scritto un nuovo libro? Lombardo mi consiglia di aprire la pagina letteraria del “Corriere”. Si leggeva: un grande libro, una storia da cui Olmi dovrebbe fare un film. Chiamo Luciano, leggo il libro, che ha un successo trionfale. Ma i diritti erano già stati acquistati. So che Lizzani, un cineasta molto rigoroso, misurato, un vero signore, ebbe dei problemi con Tognazzi. Quando non ci s’intende con l’attore protagonista è dura.
Produttore di Rossellini. Ho conosciuto bene Rossellini quando incominciava a credere fortemente alla televisione come strumento di civiltà. E diceva: il cinema diventerà sempre più spettacolo da sala, ma per far crescere i popoli bisogna raccontare al pubblico la storia dei popoli, ed è un compito della televisione. Mi ero buttato sulla produzione con una società, la 22 Dicembre, a cui partecipava anche Tullio Kezich, che fungeva da direttore editoriale, diciamo. Abbiamo fatto i film della Wertmüller, di Eriprando Visconti, Il terrorista di De Bosio, il mio I fidanzati. Avevamo acquisito anche una quota Titanus e avviato progetti con Lattuada. Eravamo poco più che trentenni. Ma la cosa di cui siamo orgogliosi è aver fatto il primo film televisivo di Rossellini intitolato L’età del ferro dove, con delle tecnologie inventate da lui, tenta di fare effetti speciali, trucchi. Un genio. Venne a cena da me per parlarne. Mia moglie Loredana aspettava il primo figlio. Mi ricordo che restò affascinata da quest’uomo elegante che arrivò con un mazzo di rose rosse.
E venne un flop. La critica mi bastonò pesantemente quando realizzai E venne un uomo, il film su Papa Giovanni con Rod Steiger. L’unico a levarsi come voce forte, sincera, a sostegno del film, fu Pasolini, che decise di scrivere l’introduzione alla sceneggiatura. Due anni dopo incontrai Pasolini in Svizzera, in una rassegna di film italiani. Lui portava Uccellacci e uccellini. Restò un giorno in più per rivedere E venne un uomo e pretese che Ninetto Davoli lo accompagnasse. Mi disse: “Rivedendolo mi piace ancora di più.” Ricordo che mi lamentavo, perché la pellicola era rigata. Tu sei soprattutto uno scrittore, gli dissi, ma chi come me fa soltanto il
cineasta vive la tragedia del logoramento e della sparizione della sua opera. E lui mi disse: guarda, se un film è un film poetico pochi fotogrammi sono i fotogrammi di un’opera poetica. Peccato aver perso una persona così. Ma il decennio seguente, il decennio in cui morì Pasolini, fu un’epoca infelice.
I cretini e i furbi, il ’68. A un certo punto l’Italia impazzisce da “male di ricchezza”. Comincia l’orgia del denaro e della carne. Ma questa deformazione sociale era incominciata già negli anni ’50, con “l’inquietudine da ricchezza”, che sfociò nel ’68 come reazione, con dei comportamenti che i benpensanti stupidi giudicano nella forma, invece di percepirne la sostanza. I ragazzi lanciavano le pietre, rompevano le vetrine. E allora? Quando un bambino fa i capricci, ti metti a giudicare quei capricci o ti chiedi perché piange? Se non fai questa domanda sei un cretino, e di questi cretini ne abbiamo avuti una valanga. Attenzione però. Nell’area di questi cretini, c’erano anche i furbi, che ne approfittavano e vendevano qualsiasi cosa fosse vendibile come parte della rivoluzione culturale. I giovani politicizzati volevano che ogni ragazzo avesse prima di tutto interesse per la politica piuttosto che per le altre attività umane di un ragazzo di venti, venticinque anni: divertirsi, guardare gli occhi di una ragazza. Tutti dovevano avere l’eskimo. Fare le occupazioni. Fu l’orgia delle chiacchiere. Cominciavo ad avvertire che le cose si stavano rompendo. Mastronardi va in crisi e tenta il suicidio, Bianciardi si dà ai Campari soda. Pasolini passa attraverso la tragedia greca, Medea, e un mondo favolistico, per arrivare a Salò. Ripeto questo titolo: Salò! Ti faccio mangiare la merda! È un film straziante, un delirio di dolore. Parise, che soffriva il mal d’aereo a livello patologico, molla tutto e va a fare l’inviato speciale, scappando dal luogo dove era nato come uomo e come scrittore.
La mia storia d’Italia. Tra quel caos io ho fatto un percorso sommesso. Ho evitato di fare il cinema a Roma per non partecipare al mondo del cinema, ma per stare con la gente che avrei rappresentato nei miei film. Avevo fatto dei caroselli, con un paio riuscivo a vivere un anno. Così potevo preparare le sceneggiature e le mie produzioni. Ebbene, se metto in fila i titoli dai primi anni ’60 a metà ’70: Il tempo si è fermato, Il posto, I fidanzati, Un certo giorno, Durante l’estate, La circostanza, è la storia d’Italia, che passa dal mondo operaio al mondo borghese, quel borghese che proveniva dal mondo operaio. Il figlio dell’operaio era diventato ragioniere, a volte architetto, dentista. A cavallo degli anni ’70 vivo il cinema come se filmassi ritratti di famiglie. Mi rendevo conto che non facevo film per la sala tout court. Non fu facile. Ottenni il sostegno dell’Ente Cinema e della televisione: Alessandrini, Romanò, Emanuele Milano, Fabiani, Gallo, Pasquale Lancia. Mi davano gli avanzi, ma a me bastavano.
Arte e filosofia del vecchio. A un certo punto non è stato più il tempo della scoperta della realtà, ma il tempo della
riflessione sulla realtà. E anche l’età, certo. Man mano che passano gli anni, dici: quella roba lì l’ho già vista, quella l’ho già incontrata. Quindi, o rinunci definitivamente allo stupore, oppure lo cerchi altrove. Non più nella realtà della cronaca, ma nella realtà riletta. Ecco perché negli ultimi anni ho fatto film più segnatamente spirituali, film in costume, apologhi. Cammina cammina, La leggenda del santo bevitore, oppure Il mestiere delle armi. Quello che sto facendo adesso, Cantando dietro i paraventi, è un altro apologo sulla violenza nel mondo, sul fatto che la vera decisione coraggiosa, in merito alla guerra, è non farla. Non ci rendiamo conto di quanto il cielo sereno di oggi nasconda uno spaventoso uragano. La memoria, combinata con la riflessione... Non è una caratteristica negativa dei vecchi ricordarsi più del passato che di ieri mattina. Questo succede non perché sono rincoglioniti (anche per quello), ma perché di quello che è successo ieri mattina non te ne frega più niente. Che cosa è più importante? Scoprire ciò che allora non avevi capito. Ci sono delle cose, se rivedi la tua vita, che è meglio scoprire adesso. Al punto che, con la fantasia, modifichi quella realtà. Nella riscoperta è come se tu ritrovassi un valore depositato in banca. Ma quanto è cresciuto con gli interessi. Ti trovi un capitale. Per questo che, da vecchio, non sono triste. Semmai mi arrabbio se mi rompono le balle, sottraendomi il tempo della solitudine, il tempo per riflettere e godere della relazione che la memoria permette col passato. Non è mortifero. È vivificante.
L’albero dell’amore. L’albero degli zoccoli è il mio congedo dal mondo contadino, il mondo da cui ho ricevuto gran parte di ciò che sono oggi. Ossia io... I miei meccanismi razionali, di comportamento e ragionamento, sono improntati a un modello che fa riferimento al mondo contadino. Come le persone che dialogano con la natura, ho sempre bisogno di avere davanti un soggetto da interrogare e da cui essere interrogato. Se apro il computer, accendo lo schermo e digito qualcosa, ho davanti un risultato che corrisponde a quel me stesso che so già chi è. Se io sto qui di fronte a questi alberi, davanti ai quali passo molte ore senza far niente (guardo, i pensieri vanno dove vogliono, a volte sembra quasi s’interrompano proprio), ho la certezza di non perdere niente. Quante volte stai ore davanti a uno schermo televisivo o altre manifestazioni con la netta sensazione che ti stanno rubando del tempo. Alla fine sei sempre quello di prima, se non peggio. Può sembrare un punto di vista un po’ esagerato... Io ho bisogno di una pianta, di un animale, da interrogare. Come diceva Sant’Antonio: l’unico mio dovere è l’amore, quando ho assolto questo dovere, nessuno venga più a scocciarmi. Essere in rapporto “silenzioso” con una piantina, anche in un appartamento, è già un rapporto d’amore. Resta nella memoria, lavora nel tempo. Come quell’emozione di stupore che, provata a cinque anni, e rivissuta con la coscienza d’oggi, è ancora più forte, ancora più bella. Come quando ricordi una persona che hai amato, e così l’ami per sempre.
31 Parcheggiata in questa camera d’albergo, in attesa del ricevimento, contemplo il porto dal balcone. Vedo due navi da guerra. In mano stringo un libretto che ho portato per sorreggermi: Montale in 41 poesie. Sulla quarta di copertina leggo “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”, la mia poesia segreta sul cinema. Nell’atrio dell’albergo, entrando con mia figlia, ho scorto Mario Monicelli seduto a un divano, capelli e barba color latte intorno al volto pallido. Gesticolava davanti a una telecamera, circondato da addetti e giornalisti in attesa. Dalla parte opposta della sala due hostess preparavano cestini regalo. In un angolo vuoto, il manifesto strappato del festival si perdeva nel fondo bianco di un immenso cartellone. Mi sento sola in mezzo ai sopravvissuti. Vorrei voltarmi un istante e vedere davvero, improvvisamente, il nulla alle mie spalle, il vuoto, come per miracolo, per provare il gusto di rivoltarmi e assistere, davanti a me, come su uno schermo, alla ricomposizione del mondo, con le case, il mare, gli uomini, questo porto sgraziato, e tutti noi.
Enrico Ghezzi Passato-morto e sparizione Non ho ricordi di fondazione del cinema italiano. In qualche modo il cinema italiano, per me, ha avuto il pregio (lo definisco pregio forse ideologicamente, così per entusiasmo, pregio che mi resta come difetto) di non essere stato un cinema contemporaneo. Nel senso che il cinema per me contemporaneo, essendo io nato nel ’52, quindi nell’anno di Europa ’51 (il film di Rossellini all’uscita meno compreso e quello che sicuramente alzava una sorta di clamorosa lapide sul senso di un cinema detto neorealista, molto impegnato eccetera), è altro. Quindi, il ricordo che ho dei primi film del cinema italiano è legato alla televisione, credo dal ’62, ’63, mentre il primo film in assoluto, che poi sono riuscito a ricordare nella mia vita, dev’essere di Stevenson, un film della Disney sulla guerra di secessione. Se dovessi dire il nome che mi ricordo di più per primo, è Fellini. Ricordo mia mamma discutere dei film di Fellini, a partire da... ero bambino. Poi, una sospensione improvvisa. Mio fratello, nato nel ’59, ebbe un problema serissimo, stava per morire, e mia madre, piamente, amando molto il cinema, dedicò un anno e mezzo, o due, di non-cinema alla sua guarigione. Una sorta di voto.
Memorie di un delirio. Negli anni successivi arrivò improvvisamente il nome di Truffaut (per me era Truffoll), che incominciai a sentire seguito dal nome di Godard, e quasi subito ancora Fellini, perché mia madre stava recuperando i film perduti, nelle “seconde visioni” che si facevano a quei tempi. A questo punto il primo film italiano che ricordo di aver visto consapevolmente è Banditi a Orgosolo, e un Totò, ma vecchio. Poi ho visto dei Rossellini senza ricordare quali fossero. In un certo senso il cinema italiano per me è stato subito o cinema d’autore o cinema molto meno contemporaneo del cinema americano che mi capitava di vedere, come Spartacus per esempio. Il nome che invece, ripeto, si è fissato nella prima memoria è Fellini. Tra i nove e i dodici anni sentivo le discussioni di mia mamma su La dolce vita e 8 e 1/2. Io poi ho una formazione talmente delirante di cinema... Anche il cinema americano che mi capitava davanti l’ho visto senza riconoscerlo per anni. Semmai ho visto e compreso prima i Bergman, i Dreyer, con la coscienza di vederli, voglio dire. Dico delirante perché è una formazione, la mia, già inizialmente scissa: ho visto Bergman a otto anni, La fontana della vergine per esempio, di cui probabilmente non capivo niente, e altri suoi film, che poi, però, devono avermi aiutato a ritenere Il settimo sigillo (appena lo rividi in stato di coscienza, ma presto, a quattordici anni direi) una sorta di western, un film a suo modo piuttosto banale. Quei film visti in età così giovane mi hanno rivelato altri aspetti di Bergman, il suo essere mago per altre cose, un mago dello sguardo in macchina. Diciamo che il versante tematico, avendolo subito preso di petto o sfiorato, magari senza comprenderlo (ma leggevo moltissimo, è allora che ho letto e visto), non è stato più così importante; mi sono liberato, nel senso che trovo molto più magico Persona, il volto che ti guarda, che non tutte le sue storie strindberghiane, che trovo per certe cose banalissime, soggettivizzate, espressionistizzate. Mi piace l’ultimo Bergman. In questo delirio in età di adolescenza, per tornare al cinema italiano, Rossellini era un nome come
Fellini, ma non era nella pratica quotidiana delle visioni. Allora, perché curiosamente eleggo Fellini...
Fellini, il catalogo italiano. Risi astratto. Perché, in qualche modo Fellini, che poi ho conosciuto tardi come autore (abbastanza recentemente ho visto per la prima volta Il bidone, che attualmente ritengo un capolavoro assoluto), è il cineasta italiano che io credo, sebbene non lo ami in modo particolare, potrebbe bastare da solo a rispondere a tutte le domande... l’età del cinema italiano, il mito del cinema italiano. E questo, non perché è il cineasta italiano più celebre nel mondo. È anche triste. Me ne sono reso conto in epoca televisiva (facendo per un paio d’anni dei montaggi con Luciano Emmer, lavorando fino alle cinque di notte) che alla fine, per documentare il costume, Fellini è un catalogo italiano... Anche Roma: c’è tutto, proprio tutto. C’è più in Fellini che nei film di genere, che sono tutto sommato più astratti, perché hanno, appunto, l’astrazione del genere. Poveri ma belli, per esempio (ne parlo un po’ impressionisticamente, ma ne ho appena rivisti diversi), be’ lì c’è meno, c’è più distacco. O i film di Risi (appena rivisti alla Cinémathèque). Sono impressionanti per quanto sono astratti, molto vuoti... probabilmente è commedia dell’arte completamente reinventata. Il suo capolavoro, diciamo considerato tale, Il sorpasso, è un film nudo, un nudo in cui incontri delle cose, dico anche nelle immagini. È iperscritto. Il bellissimo Un amore a Roma, forse uno dei più belli, più felliniano di Fellini, di notte, nel vuoto, il Campidoglio... Ho trovato Risi, che si direbbe d’istinto un cineasta molto più “vivente” e più vivace di Fellini, meno ricco in rapporto all’Italia. È chiaro che se prendi tutti i film di Risi per certi versi ti raccontano un pezzo d’Italia. In nome del popolo italiano vale tutti i film che la Sacher potrà produrre in vent’anni di regime (eventuale, spero da scongiurare) berlusconiano: parlo ovviamente del Portaborse.
Exotica. Siccome partiamo comunque da un punto di vista molto personale, addirittura di biografia, ebbene il cinema italiano io l’ho vissuto, e continuo a viverlo, come una cinematografia esotica. Ma perché? Essendo una cinematografia più lontana da me rispetto al cinema americano o giapponese (vedevo fin da piccolo Mizoguchi o Kurosawa), essendo meno distante, geograficamente, culturalmente, la sua distanza di cinema astratto era più evidente, più flagrante, al punto che poi ho trovato Rossellini estraneo a questo “voler essere quotidiano”. Mentre Rossellini è l’unico che risulta davvero quotidiano ogni volta che lo vedi: Europa ’51 è del ’52 , ma è del ’51, ’61, 2003; quindi mi sento abbastanza spiazzato rispetto a questo, anche se personalmente penso che il cinema sia più questo modo di Rossellini e che sia così in tutti i “cinemi” del mondo. Adesso, in quel cinema che era per me risolutamente spiazzato, Fellini è inevitabilmente un documento, un’enciclopedia. Prima avrei detto Risi, rispetto al discorso che stiamo facendo, e invece, ma lo so soltanto adesso, Fellini è... Trovo anche che Lattuada sia un cineasta astratto, un altro di quelli che ho incontrato per primi, ma in certi film minori tipo La banda Casaroli, che avrei dovuto vedere in un’arena estiva, atteso per due giorni di seguito perché pioveva, e invece poi, quando l’ho rivisto più avanti, mi
deluse un po’, e Omicron, anche. Quindi, Fellini...
Quelli che mancano. Fellini al Polo. Fellini per me non è neanche sintomatico del cinema italiano, è il grande momento di esplicitazione di un surplace non soltanto italiano, con questa lunghissima morte sospesa, quaranta giorni, è un passaggio buddistico, il caso estremo di “quelli che mancano”, no? Non riusciva più a fare film, e non c’era il lamento, non tanto suo, ma degli altri: era generale che Fellini non era più messo in condizioni di fare film, ma non c’è da meravigliarsene, e non poteva che essere così... A un certo punto venne da Guglielmi alla Rai. Stavamo per aderire a un suo progetto, bello, davvero. E dovrei recuperare... Era una sorta di troupe che fa un documentario, una sorta di seguito de L’intervista, e c’erano tre scene al Polo Nord, e lui papale papale, secondo me quasi per “non farlo”, disse: naturalmente poi bisogna andare al Polo, e non sarà possibile, perché figurati le assicurazioni con un vecchio come me... Cioè aveva esaurito anche quella fonte totale che era lo Studio 5, doveva passare ad altro. Tutti i suoi film finali sono film di impotenza, di non-cinema. Anche in questo trovo che l’unico grande realista era lui. È uno dei motivi per cui, come cinema italiano “oltre” per me c’è Rossellini, e parlo del cinema d’autore. Visconti, come autore si conduce in modo mimetico rispetto a quello che ci si aspetta sia la figura di un autore. Ma in mezzo c’è Fellini, che è infinitamente più affascinante di Visconti, non a caso è il cineasta che ha più senso fuori d’Italia. Capisco che Visconti... All’inizio mi intristiva che cineasti come Cimino, Scorsese, perdessero tempo ad amare Il gattopardo, o Senso, un cinema così secco, così pigro, fotoromanzesco nel senso... allora vedi Matarazzo. Mi ha deluso moltissimo il fatto che Scorsese abbia saltato De Santis nel suo documentario sulla storia del cinema italiano. I suoi consiglieri mi hanno detto: non potevamo mettere mica tutto. Be’, se pensiamo che manca De Santis... Ecco, De Santis, questo è un altro nome. Devo dire che questo cinema italiano l’ho ritrovato e/o scoperto a Pesaro, quando avevo venti, ventuno anni. Nelle retrospettive trovavo il cinema italiano estremamente affascinante. Se dovessi dire la cosa che ho trovato più fascinosa, è la contraddizione forte del passaggio alla presa diretta in un cinema neorealista che è il cinema dell’invenzione sonora, il cinema che, per farsi rapidamente, abbandona il suono diretto. Che poi il cinema italiano, fino a dieci anni fa, non recuperò più, abbandonandosi a un’orgia di facilità. E qui c’è la questione degli attori. Ma non perché non fossero grandi attori, gli attori del neorealismo... Faccio un salto: secondo me Mastroianni non è un grande attore, è semmai un grande cineasta; allo stesso modo è evidente che Gualtiero De Angelis e almeno una decina di altri doppiatori, sono grandi cineasti-attori del cinema italiano, più della maggior parte degli attori che doppiano, perché la loro voce è lì nelle sale, lì nella televisione, è come un momento... anzi, grazie all’astrattezza fisica della voce è come se fossero paesaggi. Più degli attori, che si muovono. La voce, invece, resta...
Il cinema italiano non esiste. Per me il cinema italiano di quegli anni, il cinema italiano considerato “grande”, rispetto alle cose che ora possiamo considerare finite, iniziate e finite, è un cinema di ricostruzione, cioè
che io ho ricostruito, nel senso che per me è stato “archeologia”. Ho visto un po’ di Rossellini (i film televisivi, e comunque negli anni in cui era già il Rossellini televisivo), ma il resto non era contemporaneo, parlo ancora di Risi, Lattuada, Fellini, visti nei cineclub di Genova, e c’è da dire che questi cineclub non erano tanto “linea Cahiers du Cinéma”. Già a quel tempo Rossellini per me era qualcosa di potente, avendo visto Francesco giullare di Dio e, soprattutto, le serie televisive, le prime, quelle lunghe, noiose. Mi sembrava un modo di fare televisione folle. La prima volta ho visto La lotta di un uomo per la sua sopravvivenza; forse non avevo neanche capito che era lui, ma era talmente personale... (Non avevo ancora visto India, l’ho ritrovato felicemente riesumato in Rai, un momento sublime.) Vedendo quelle cose ho pensato che era una televisione folle, perché con due canali, quindi con un tono di autorevolezza che s’imponeva, i film di Rossellini sembravano totalmente arbitrari. Non che i miei genitori non fossero critici verso la televisione, mio padre era contro, la prese tardi (io andavo a vedere tutte le serie americane dagli amici, nel pomeriggio, Ivanhoe eccetera, quindi poi si decise), però c’era una attività media da imbonimento didattico che funzionava: la tv di Bernabei. In questa tv arrivano i lavori di Rossellini che partecipavano dello stesso mezzo, avevano un’estrazione apparentemente simile, ma erano totalmente diversi, una sintesi delirante... Ricordo comunque Francesco, il primo film di Rossellini per me, visto in un cineclub di Genova a cui devo visioni di ogni tipo di film. Ecco, devo dire che quel cineclub lo ringrazio perché mi ha “difettosamente” permesso di vedere film in maniera spiazzata; vedere nello stesso giorno Sul fiume d’argento di Raoul Walsh e Venezia la luna e tu di Risi, con Sordi, mi permetteva di godere di un’enciclopedia diversa del cinema, di un rianagrammare segni. In questo senso, legando il discorso alla società italiana, i film italiani mi apparivano poveri, poco incisivi. E ho capito poi che cosa doveva essere invece La dolce vita; al di là della bellezza, dell’evidenza, era un film di una portata enorme. Per essere chiaro, per me il cineasta italiano contemporaneo più politico (che non è Bellocchio, che mi piace, e non è Amelio, che mi piace) è Bernardo Bertolucci, che fa film pochissimo italiani, e non sono praticamente di nessuna parte; da dove vengono quasi non si capisce. Mi è venuto in mente adesso, parlando della Dolce vita, perché rivedendo Ultimo tango, con Marlon Brando che mette segni di un cinema di tutti i tempi e gli spazi, che è un segno come la voce dei doppiatori, ho capito che, con attori francesi e tutto il resto, è un film smaccatamente italiano, quanto di meno internazionale si possa pensare; Ultimo tango e La dolce vita sono due film pochissimo interessati alla loro contemporaneità sociale; La dolce vita è più visionario, intendiamoci, con quel finale, ma di una dissoluzione che non apparteneva alla realtà di quel momento in Italia, se non a quello che credeva qualche intellettuale apocalittico... e infatti fu il successo internazionale di Fellini. Il cineasta postumo italiano, dopo la morte protratta, anche cinematografica, di Fellini, è proprio Bertolucci, che comincia con un film (lasciamo perdere La commare secca, un cineasta nuovo che parte da una costola pasoliniana che poi abbandona completamente) dove s’inalbera la nostalgia del presente, conclamata in una battuta del film, con “dopo” nel titolo, Dopo la rivoluzione, un cinema che fin dall’inizio sa di non essere presente, un cineasta che è italiano in quanto non lo è per nulla.
Destini.
Secondo me il destino del cinema di cui stiamo parlando, il cinema che esce da quello che consideriamo finito, o morente, è Bertolucci, il destino “alto”. Il destino “basso”, invece, è il non accorgersi di quanto si perda contatto con la realtà affidandosi al quotidiano, come atto di volontà, credendo nel cinema che recupera il rapporto col pubblico perché si occupa del quotidiano, e magari ogni tanto ti riesce, ma perdi molto di più... E mi sembra un po’ patetico il tentativo delle scuole di scrittura che applicano le cosiddette “griglie” per avere successo, l’attenzione ancora a questo spettro del “quotidiano”; allora meglio le soap. Dico anche che il neorealismo nel dopoguerra è più interessante come fallimento che come successo, il neorealismo è come se tra quindici anni ci si raccontasse la favoletta che il cinema che è contato in Italia negli anni che stiamo vivendo è quello di Moretti, di Lucchetti, Mazzacurati... Non voglio ora esprimere tutti i dubbi che ho su questo cinema, ma c’è un altro cinema, Martone e Ciprì&Maresco per capirci, ma anche altri. E allora, siccome stiamo parlando da Cannes, durante il festival, ebbene è proprio qui che da tempo si perpetua quest’immagine del cinema italiano: esportazione di civile opposizione da una parte o recuperi di cinema di iperpapà dall’altra. Già da quando ho incominciato a rivedere consapevolmente il cinema italiano “storico”, dai primi anni ’70, ho visto che, mentre c’era il neorealismo, Genina continuava a fare film; Matarazzo continuava a fare film; insomma se si estrae il cinema neorealista dal tutto, si vede che questo era una parte, molto generosa, certo, ma povera, del cinema italiano, film che perdono molto di ambiguità, e così te la devi andare a trovare tu l’ambiguità...
Etichestetiche. C’è un’Italia sognata/sognante nel cinema neorealista? Mettiamo da parte Rossellini (lasciando perdere De Robertis, un cineasta immenso), che con Roma città aperta (non il migliore), ri-palesemente s’oppone al dilagare di un ipermacchiettismo, e lo fa con la figura che sappiamo rilevante nel valore storico del film (cioè Fabrizi, il prete) e che ritroviamo in parecchi altri film neorealisti (infatti è molto più evidente il passaggio dal neorealismo alla commedia all’italiana che non la fratellanza/filiazione del neorealismo con Rossellini). Anche con Blasetti c’è discontinuità rispetto al neorealismo. I grandi autori si distaccano. Infatti la forza del neorealismo, che era sicuramente unito dalle motivazioni ideologiche di un gruppo, a vederla oggi, è sempre o quella di genere o di alcuni attori o di alcuni sceneggiatori. In questo senso il più preciso è uno dei più intellettuali, De Santis. Fa un discorso estremo, di fotoromanzo esplicito, che però vorrebbe essere socialmente critico, ma poi i suoi film funzionano in quanto sono compiutamente... Non c’è pace tra gli ulivi è un film che ti appassiona come ti può appassionare un film cinese degli anni ’70 di cui non capisci quasi nulla ma vedi l’intensità. Riso amaro piace per certi schemi, cioè non è il lavoro delle mondine, l’ingiustizia, eccetera, piace per come riesce a essere un film musicale. Il cattivo, Gassman, ha pesanti ombre nere sulla faccia, quasi imbarazzante, involontariamente comico. Le cose interessanti sono invece i corpi, la danza, quel mambo primario, ma questo succede grazie a questa forza fisica del film in un contesto riconoscibile. È il più onesto, De Santis. È uno che sconta sempre il quadro che decide di utilizzare. Già Non c’è pace tra gli ulivi, che sembra un film estremista, maoista, è un film forzato, eccessivo, esemplare. Anche certi Lizzani sono interessanti in quanto tentativi di film noir, non perché possono strapparti la
complicità ideologica del momento. E poi le voci. Le voci dei film di Zampa, Lizzani, De Santis, le trovi anche nei film di Genina, di Matarazzo, che erano tutt’altro che neorealismo, ritrovi quasi sempre metà delle voci da un film all’altro. E Lattuada che cos’è? Un altro autore che si distacca, non è né neorealista, né altro, anche se poi diventa un cineasta che fa molte commedie “all’italiana”. Lattuada è un cineasta della captazione visiva del cinema americano, e più avanti è il cineasta che realizza il film più bello di Sordi, e uno dei più belli della storia del cinema italiano, Mafioso, un film americano, di folgorazioni, così poco incentrato sulla mafia, ma proprio per questo capace di cogliere in due scene (New York e la vita in fabbrica) la scissione delirante della società italiana, che è già società dove la mafia, retrograda (Sicilia, onore e tutto il resto), è però quella che ti porta in America. Così la mafia, ripeto, retrograda, diventa la possibilità di un viaggio nel tempo, un’apertura, e in mezzo c’è però la fabbrica, il lavoro, il tran tran del boom che non vede niente. Questa comunque è sociologia, mentre resta ancora quella forza... Ma il discorso vale anche per Rosi, e qui direi Rosi e Zeffirelli, i nipotini di Visconti per dire, insomma i due assistenti di La terra trema (realismo/neorealismo, le polemiche...) che poi cominciano a insultarsi a partire dal film successivo. Zeffirelli fece Camping, un film eccentrico, che apparentemente non sembra un film d’autore. Rosi. Se vogliamo trovare un testardo che continua lo spirito del neorealismo è lui. Però bisogna dire che comincia a fare neorealismo quando è morto e sepolto, dopo essere stato l’assistente di un cineasta come Visconti che, con il suo primo film, Ossessione, viene considerato iniziatore del neorealismo dalle decostruzioni di comodo. Ecco, Ossessione, che sta al principio del nostro discorso: in questo film, che non amo particolarmente, trovi Girotti, con quel volto, trovi la Calamai, trovi la provincia, trovi delle cose che, viste, hanno più senso, non solo degli schemi storiografici a posteriori, ma proprio degli schemi d’autore che tendono a definirli. Tanto meno sono grandi i registi, tanto più è interessante la disseminazione delle cose che contano. Per questo dico che il cinema italiano di quegli anni, e il neorealismo in particolare, non è un cinema particolarmente ricco. Lo diventa per certi autori. E la stessa cosa succede nel cinema francese degli anni ’40 e ’50, giustamente disprezzato per certi versi, ma poi trovi autori che prendono una strada originale. Certe commedie... C’è una tale diffusione di temi, personaggi, una tale ricchezza. Se prendiamo venti film turchi degli anni ’60 e ’70 si resta di nuovo colpiti da come gli autori facessero anche le commedie sociali, i comici, con personaggi folli, con dei Totò insospettabili, e infatti Totò viene visto in Turchia, in Egitto. Siamo noi che poi non vediamo i film egiziani. Invece sono troppo mescolate le culture mediterranee, perché uno possa trovare il neorealismo italiano ricco... Non abbiamo mai visto il cinema italiano dentro il Mediterraneo. Se pensiamo all’abbondanza di temi, facce, il neorealismo non è molto diverso dal cinema albanese. Voglio dire che il cinema italiano di quegli anni non spicca particolarmente. Magari il cinema giapponese, sì. Certo, esiste una sola cinematografia veramente ricca, ricca industrialmente, parlo proprio di soldi, ed è Hollywood. Ma se parliamo degli autori invece, il discorso cambia. Ce ne sono pochi al mondo di Matarazzo. Anche di Genina. Di De Robertis non ce ne sono. Genina resta il vero Visconti. Il cielo sulla palude, tema edificante e naturalistico, di “regime” e di valori. E più bello ancora, Maddalena, un film stupefacente. Si ristampano film mediamente interessanti e non si vede questo bellissimo film a colori da decenni. Sono sicuro però che Genina sia stato preso dal pubblico avvertito del tempo come un cineasta o cinico o troppo popolare. Che è quello che uno avrebbe potuto dire di Matarazzo, se avesse saputo che era un fine intellettuale. Invece, così, era considerato trash.
Matarazzo è il più grande cineasta di genere italiano, con Freda. In realtà, quello che colpisce ogni volta che cerchi di afferrare un cinema (parlo, lo so, da una posizione non so quanto utile in questo caso, troppo spiazzata, credo) è come riesci a coglierlo veramente dove, in genere, non ti dicono che c’è. Se dovessi dire un cineasta che ha l’intensità politica del neorealismo, la serietà, e un po’ di ribalderia della commedia, che in realtà veniva diffusa dagli stessi autori del neorealismo, direi Pietrangeli, un cineasta quasi sconosciuto che fu sceneggiatore apprezzato. Un altro ottimo sceneggiatore che diventa un modesto regista è Scola. Naturalmente lo vedi, può piacere o non piacere. È cinema letteralmente da esportazione. Invece Pietrangeli non fa cinema per ottenere un risultato di successo, da esportare. Ho fatto proiettare un paio di volte Io la conoscevo bene e ho visto gente che o piangeva o diceva, con gli occhi di fuori, ma che cos’è questo capolavoro? Un film del ’66, ma di quando è veramente? E qui torniamo all’inizio. Qual è il cinema che parla veramente dell’Italia? I cineasti più decisivi, allora, se togliamo il discorso di certi autori, sono quelli che a un certo punto sembrano sparire, si compromettono con la televisione. Tra i maggiori, Cottafavi e Blasetti. I trapassati in tv. Il primo, quello che l’ha fatto volutamente, teoricamente, a partire da riflessioni personali, è Rossellini. Però Blasetti e Cottafavi sono decisivi, in questo senso; pochi lo sanno. Cottafavi per la quantità: prima di tornare al cinema, molti anni dopo, si dissolve nella televisione. E Blasetti perché, prestissimo, fa un intervento “d’autore” sulla televisione, quando non esisteva una via italiana al telefilm. La tv non commerciale, anche in Europa, la concorrenza del cinema l’ha incontrata molto più tardi. In Italia chi faceva cinema faceva cinema. Magari qualche carosello. Ecco, il caso Emmer, per esempio. Gli autori eccentrici. Con Emmer, Germi. Gli autori riconosciuti, Pasolini, Bellocchio, eccetera, lasciamoli da parte. Per motivi biografici, caratteriali (e poi per motivi di famiglia, di salute), Emmer a un certo punto, al settimo film, scompare, dopo aver girato uno dei film più affascinanti dell’epoca, La ragazza in vetrina, sceneggiatura scritta con Pasolini. Non voglio parlare del rientro, che è molto interessante. Ma quella sparizione, come se non ci fosse più qualcosa per cui fare cinema, ma che ha motivazioni prettamente personali, chiama un salto in un link tra l’altro importante nella storiografia ufficiale, il “neorealismo rosa”, e queste buffonate. Ma se vediamo qualsiasi film di Emmer troviamo una tale precisione, nitidezza, crudeltà visiva, che te la sogni in Zampa, in Lizzani, più crudele anche di De Santis, uno dei cineasti italiani più importanti di tutti i tempi. Emmer cerca di seguire le situazioni, evita le inquadrature opprimenti, così che sia la realtà da sola, nell’inquadratura, che diventa opprimente. È veramente uno dei più spietati, altroché “rosa”... Trovo Emmer assolutamente realistico. E lì, proprio sul suo film più “realistico”, dice basta. Quindi dove va a finire poi il cinema italiano? Poi esiste un cinema d’autori. Che non è una rottura col passato. Esiste un cinema di intervento culturale sul cinema, che non ha però niente a che vedere con la “nouvelle vague”, e infatti incide, dura di più. Bertolucci, Bellocchio. Gli esordi non sono film di strepitosa originalità, sono film abbastanza pesanti, un po’ claustrofobici, ma si pongono subito come piccoli classici. Ancora Rossellini, però, a questo punto dice: del cinema non m’importa un tubo. Quello che vede Rossellini (il mondo fatto come il cinema, come una enciclopedia, il suo sogno didattico, che sembra un sogno bernabeiano, democristiano) in realtà è un sogno delirante, nel senso che vede il mondo come fatto di segni, di parole. Non a caso usa il trucco e chiama Bava. Ecco il nesso Rossellini-Bava, un nesso di macchina produttiva più interessante che non Lizzani-Rossellini, dove Lizzani è importante perché gli
girava il film, Germania anno 0 e soprattutto Dov’è la libertà?. Pensiamo al gesto di dare il compito di girare a qualcun altro. Un film, quest’ultimo, che racconta proprio la questione della libertà massima, dentro, fuori, in prigione, ci sei, non ci sei: il cineasta che ha fatto il massimo, in questo senso, è il turco Guney, che ha girato il suo ultimo film dal carcere. Non è importante dove sei, ma i “frame” che ti fai. È un indizio, alcuni dicono che è enfatizzato. Poi Rossellini aveva in mente altro, era l’inizio della storia con Sonali, o forse aveva delle storie d’albergo, e andava via, ecco. Fate voi, tanto la scena è quella. Al montaggio, se parli con i montatori, era quasi la stessa cosa, e poi sono i film più personali della storia del cinema italiano. Rossellini è qualcosa “al di là” del cinema italiano. Credo che come “entità” il problema del cinema italiano sia proprio questo: di essere segnato da grandi cineasti che prendono una via personale, Rossellini addirittura di “non cinema”, il cinema è ovunque, “giralo dove vuoi”, come diceva Vidor. Libertà. Ho fatto Roma città aperta rubando l’elettricità, faccio i film con la Rai e Mario Bava che mi fa i trucchi con lo specchietto...
Mito? E poi c’è questa cosa del mito del cinema italiano, che pesa, opprime, dico il cinema italiano di cui stiamo parlando. Se si leggono le dichiarazioni di Muccino... Povero ragazzo. Costretto a paragonarsi a Risi. Moretti “troppo autore, ma lo amo molto”. E tutto artificioso, indotto appunto da un mito. I tre film italiani dell’anno, di questo anno, sono tre film che trovo terrificanti. Muccino, Ozpetek e Avati. Alla fine, però, il cinema che odio di più, perché lo odio, dico il cinema di Muccino, è quello più spoglio, con meno difese. Insomma questi sono i film del pubblico dei premi, in questo clima che tenta sempre di trovare l’identico, o quello che avremmo perduto...
Lutto e asincronia. C’è un tale bisogno di ricerca di antenati, di origini, di radici, per cui il cinema italiano, che è questa specie di favola, di bolla di sapone (non è mai stata neanche una vera industria), mitizzato (la forza di Risi è quella di essere un grande ribaldo, mai stato un “maestro”), con questi vecchi che sopravvivono, alcuni vegetano, ma esistono, “sempre”, Comencini che non parla più ma è sempre intenso, Lattuada annullato ma vivo con la sua “folgoranza”, Antonioni che è così da quindici anni, ma lui è virtualmente sempre stato assente dal set, come Rossellini, Antonioni che fa un grugno per dire “stringi” l’inquadratura e un altro per dire “allarga”, e devono fare tre prove prima di capire, quello è il cinema (e i suoi film ultimi sono bellissimi proprio perché sono impersonali, anche se non sono...); ebbene, questo bisogno di antenati ci porta in una civiltà ormai banalmente televisiva di ripresa, di mito artificioso, appunto, come ovunque, ma più che ovunque. Perché, abbiamo detto, il cinema italiano non ha avuto la “nouvelle vague”, e non l’ha avuta per il cinismo degli autori e di quella specie di industria. Questo ha consegnato (nel passaggio successivo) il cinema alla televisione, con una resa senza condizioni, grazie al pubblico. Siamo passati da una televisione iperdidattica, a causa di alcuni geni che abbiamo nominato, a una televisione che inizialmente è fatta di brutto varietà, poche news, ed essenzialmente di cinema. Non si è mai visto in un paese di cinquanta
milioni di abitanti, non di duecento milioni come gli Stati Uniti, tanto cinema tutto insieme in tv. Rispetto a ciò, il tentativo, vuoi storiografico, vuoi politico (molto), è quello di ritrovare una sacralità del cinema italiano. In questo, il cineasta chiave in senso secondo me negativo, con una sua nobiltà (e credo non ne sia inconsapevole) è Ettore Scola, che è un cineasta di scarsa intensità filmica, molto legato a una certa fattualità televisiva, però con l’attenzione a un cinema di buona qualità, con buoni sceneggiatori, e questo gli permette di riguadagnare sempre quello che c’è di negativamente televisivo (come ne La famiglia). Così, da una parte la televisione distrugge il rapporto col film, perché vedi tutto, tutto il cinema americano, il cinema italiano degli anni ’30, arriva Matarazzo, che torna in qualche modo nel progetto Berlusconi; dall’altra, questo afflusso di fiction, di narrazioni (dimostrazione che il cinema non è legato al “quotidiano”, semmai lo risente semplicemente, ma non può volersi legare al quotidiano, perché lo è già, “quotidiano”, e sempre meno della televisione, che quotidiana lo è continuativamente), questo afflusso, dicevo, fa perdere improvvisamente la contemporaneità del cinema, negli anni ’70 e ’80. Ci sono i film di Natale, ma per il resto c’è cinema d’autore di produzione televisivo-statale. In mezzo c’è un limbo lunghissimo di cinema quasi invisibile, una terra di nessuno, perché davvero il “set Italia” in quel momento è di nessuno. Non può essere di “un” cinema. La televisione rende tutto un set, incluso il cinema del passato. Ecco che, rispetto a questo discorso c’è oggi un bisogno fortissimo di riproiettarsi sempre sul passato. Un bisogno fortissimo di radici. Enorme. Molto tenero, anche. Ma molto pericoloso, perché può farci perdere il senso della storia contemporanea. C’è un momento recente esemplare in questo senso, anche se ce lo siamo già dimenticato, simile a quello dei funerali di Togliatti, che è il momento dei funerali di Sordi. L’unanimità allucinante. Un personaggio sublimemente negativo (perché questo è Sordi, o lo prendi così, oppure...) diventa l’idolo di tutti, destra, sinistra, Veltroni eccetera, in quanto passato-morto. In quanto icona. È tremendo, secondo me. E quanto poco è stato “risentito”, invece, Fellini, se non come l’autore classico. E invece la morte di Fellini è stato un vero momento di lutto, la fine di una possibilità d’autore vera. Fellini è stata una vera sparizione.
EPILOGO Chiudo la porta di casa appoggiandomi con le spalle: questa giornata mi ha sfinito. Accarezzo il velluto della scatola che incornicia la targa d’argento. Suona il videocitofono: “Mamma, tutto bene? Sei sicura che non vuoi che salgo? È stata una sciocchezza viaggiare questa notte. Non puoi più fare queste cose. Riposati. Ti chiamo domattina.” Schermata dalla pioggia, vedo mia figlia in bianco e nero che corre verso l’auto, dove l’attende il giovanotto di Pescara. La macchina parte, resta il marciapiede vuoto. Da qualche ora ho un solo pensiero. Stavo scendendo dal palcoscenico, un’immensa tavola di legno che avevo attraversato pazientemente mentre si spegnevano gli applausi. Dalla scala, proprio di fronte a me, improvvisamente sono balzati fuori alcuni attori. Indossavano le maschere tradizionali, pronti per una pantomima. Tra Arlecchino e Pulcinella, mi colpisce Pantalone, che sosta un istante davanti a me, come riconoscendomi. Il sogno della Duse! Ecco che cosa declamava Eleonora Duse nel mio sogno: Pantalone e “l’età sesta”, il pezzo finale del monologo sulle età della vita, pronunciato da Jacques nella commedia di Shakespeare Come vi piace. Ho deciso di lasciare l’albergo e tornare a casa questa notte, contro i consigli di mia figlia, proprio per rileggere il passo e ritornare all’enigma del sogno. Sul comodino ho appoggiato la tisana e gli occhiali. In grembo ho il volume delle opere. Il silenzio questa volta mi conforta. Metto gli occhiali, sfoglio, trovo il secondo atto e leggo questa antica traduzione: “Tutto il mondo è teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che attori. Essi hanno le loro uscite e le loro entrate. Una stessa persona nella sua vita rappresenta parecchie parti, poiché sette età costituiscono gli atti...” Scorro la pagina cercando il passo del sogno. Con uno spostamento significativo lo attribuivo alla Duse, che prova la parte sul balcone di fronte al mare. Nella commedia di Shakespeare, invece, il personaggio che pronuncia il monologo è un maschio e si trova in un bosco davanti a una tavola imbandita: “L’età sesta ti cambia l’uomo in un rimbambito Pantalone, magro e in pantofole, con gli occhiali sul naso e una borsa al fianco: i suoi calzoni portati da giovane e ben conservati sono infinitamente troppo larghi per le sue gambe stecchite; la sua grossa voce d’uomo, ritornata al falsetto fanciullesco, risuona stridendo e zufolando. La scena finale che chiude questa storia strana e piena di eventi è una seconda fanciullezza e un completo oblio, senza denti, senza vista, senza gusto, senza nulla.” Apro gli occhi sul tonfo della porta d’entrata. Ho dormito a lungo, forse ore. È quasi mattina. Riconosco i passi sul parquet, nel corridoio, il suono delle chiavi sul comò, la pausa davanti allo specchio. Sei tu? dico. Nella penombra la sua figura attende sulla soglia del salone. Batte i piedi per non sporcare il tappeto. “Mi hai svegliata,” sospiro. Sento le ginocchia tremare. “Mi spiace. Ti lascio tra un momento. Sono venuto a portarti una cosa.” “Ma io non posso ricevere niente da te,” dico in un fiato. Entrando nella stanza accarezza la vecchia radio, poi gira intorno al tappeto e raggiunge la mia poltrona. Sento freddo, una corrente che sale dalle gambe alla testa. Nella sua mano destra distinguo una scatola. Si siede sul divano, a un soffio. “So che l’hai pensato, ma non è una scatola.”
Trattengo il fiato. Cerco di mettere a fuoco il dorso dell’ oggetto. Mi sembra di vedere un foglio di carta sul quale scivolano alcune lettere dell’alfabeto. Mi sento proprio svenire. “È il tuo libro.” “Come il mio...?” “Il libro che scriverai.” Mi porge la mano, poi lentamente la ritrae. “Ti ho portato anche il titolo.” Sento il sangue riscaldarsi, le gambe riprendere forza, il cuore battere con gusto e la mia pelle, oh la mia pelle! liscia e lucida come a vent’anni. Vorrei alzarmi e ballare, cantare, fare l’amore. Mentre lo percepisco svanire nella penombra del corridoio, sul frontespizio del volume poggiato sul bracciolo del divano leggo: Anni fuggenti.
POSTFAZIONE Un pomeriggio guardo Mario Monicelli appoggiato a un muretto, in una piazzetta di provincia, le mani in tasca, la coppola sulla barba bianca, in pausa al sole di una domenica di primavera. Lo vedo anche sopra una cassetta della frutta, 40 anni prima, di fianco a una Arriflex, appena sotto il bastone del microfonista. La stessa coppoletta, ma con i baffetti, le mani in bocca per lanciare un fischio da ragazzaccio, un ordine forse, in una foto sul set dei Compagni. L’età di Monicelli. E l’età di Antonioni. E quella di Sordi e Dino Risi, Comencini e Lattuada, Emmer e Pontecorvo. È domenica 25 aprile 1999. Stiamo lì, sono lì loro, davanti al teatro Concordia di San Marino, per un convegno intitolato “Cinema e Storia”. Sui gradini Age scandisce un discorso, circondato da un paio di principianti gonfi di dattiloscritti. Tonino Delli Colli sta in combutta con Piero De Bernardi, che ha qualcosa da dire sulle triglie in guazzetto del pranzo. Tra le due vetrate, magro come l’asta di una bandiera, confuso con gli infissi, c’è di vedetta Carlo Lizzani. Non partecipano, ma sono certo di vederli, Leo Benvenuti e Suso Cecchi d’Amico, Zeffirelli, Alida Valli e Gina Lollobrigida, Antonioni e Pinelli, Scola e Rosi, e poi vedo Fellini appoggiato alla sua ombra e la Magnani nel tailleur a quadretti, Rossellini col cappottone di cammello, e la Mangano col foulard annodato, certo. Tognazzi e Gassman allo sportello di una Giulietta, Peppino Amato in vestaglia, Visconti sul podio appoggiato al bastone, Mastroianni disteso sulla sabbia in attesa del ciak, Ferreri incipriato dal barbone a punta, De Sica nello scheletro di Adone, Germi col mezzo sorriso, Petri assorto, e Volonté, che da un cesto lancia rabbioso una raffica di arance, e laggiù, lontano, Totò in marcia con la truppa di totoizzati. Non so bene di chi è questo libro. Non è mio. O quantomeno non riesco a stabilire un confine. Sono partito dal bisogno di incontrare e ascoltare alcune persone. Interviste, diciamo. Interviste ai vecchi. I fondatori del cinema italiano sullo sfondo dei decenni di gesta e illusioni, guerre e ricostruzioni. Allora, i registi e gli scrittori, quanti più possibile, che degli sceneggiatori non si dice mai niente. Qualche quercia d’interprete. Poi, uno dei loro occhi fotografici, e almeno un musicista, e uno dei potenti produttori. E poi l’esperienza degli spettatori nello sguardo di qualche fiancheggiatore polemico, critico, politico, censore, uomo tra gli uomini nella storia italiana, tutti nell’impresa di costruire e usare oggetti salvati al tempo e creati da uomini e donne invecchiati col vizio di fermarlo, il tempo, ogni 24 secondi. I vecchi, dopotutto, sono sempre nuovi. Loro non fanno un compendio della vita per figurarsi in un punto, in un passaggio. Non hanno più passaggio. Sono definitivamente presi dal tempo, come l’istante fotografico che racconta tutto il prima e tutto il dopo. Regola di base, dunque: vietato ai minori di 80 anni, salvo nobili eccezioni. Come ha sentenziato un carissimo sostenitore: “Un bel libro di bacucchi”. Al momento di trascrivere le prime interviste, però, vedo che le domande pesano, rompono un ritmo, un passo autonomo. Una musica, forse. Tolte le domande, tutto fila liscio. Più mi levo di torno, più esce il libro. Monologhi sollecitati. Autoritratti istigati. Sculture scritte. Non so francamente come definire il movimento di queste “voci dentro” del cinema che ci parlano da decenni allineando l’emozione di un’origine al senso grottesco e insieme epico della nostra storia. Le ho raggiunte come per provarne l’esistenza, per riempire il vuoto che il cinema
lascia quando tutto è passato eppure documentabile, raggiungibile, nell’estasi della comunicazione e nella vanità della Biblioteca, mentre certe fotografie, sospese e remote, valgono, appunto, tutto il prima e tutto il dopo. La risata satanica di Sordi e Mangano che si avviano furtivi lungo il marciapiede, flashati di notte da Licio D’Aloisio, scontornati nel buio nell’eco di mondine e vitelloni, di Giocaste e sceicchi bianchi, mogli da spiaggia e vedovi-mariti-medici-soldati-detenuti in attesa di giudizio. E il cha-cha-cha di Maria Callas e Vittorio Gassman al Rancio Fellone di Ischia: lei con la gonna di seta plissettata spinta dal giro, e lui, che l’ha appena lanciata, la lascia tornare, alzando la mano per schermirsi, la testa appena piegata verso il cielo, rapito dal piacere di quel nulla che è il ballo, in bilico sulle gambe piegate come un re che ha perso gravità: finalmente liberato, tra Amleti pensosi e farabutti italici. Da un misterioso sentimento di appartenenza, fuggevole e radicale, allo scorrere di tutto questo, vengono le pagine di questo libro. Monicelli bambino al balcone dei d’Amico, impressionato dal teschio delle camice nere che marciano su Roma. E Risi che entra al castello del principe del Liechtenstein mostrando la tessera del tram di un amico. Rustichelli che fischietta al piano mentre Germi sonnecchia. E Manfredi con Billi e Riva a cantare “tre per tre Nava”. Poi succede un’altra cosa. In mezzo a tutte queste voci, alla ricerca di un’impaginazione, esce una voce monologante che ribalta la tradizione numerica del coro: un solo personaggio che contrappunta, commenta, partecipa, istiga, ma resta tuttavia parallelo, in risonanza narrativa. Come una lancetta, stabilisce il giro delle ore, tocca i limiti del quadrante. La speranza è che liberi e illumini l’idea di questi uomini e donne come una comunità operosa. Gli incontri sono incominciati nella primavera del ’99 a Roma, a casa di Dino Risi, nel salone dell’appartamento al residence Aldrovandi, e sono finiti a metà giugno del 2003 ad Asiago, a casa di Ermanno Olmi. Risi era seduto su un angolo dell’immenso divano color panna, la mano sinistra infilata tra le gambe accavallate, le spalle rivolte alla porta, pronto a scappare appena possibile, anche da casa sua, confortato appena dalla silenziosa presenza di Corrado Corradi, il mio Virgilio. Emmer mi ha ricevuto in uno stanzino freddo di due metri quadri a un tavolino che sembrava un banco di scuola, all’ora della prima campanella, negli uffici di ferro e linoleum della sua produzione a Saxa Rubra. Maglione simil-Missoni e una bariola di lana in testa: poche palle, ha accettato soltanto perché la moglie sosteneva che avevo una voce particolare e che sembravo gentile. Ostinato e idealista come nessun giovane mai incontrato. Un paio di ore dopo, tocca a Dino De Laurentiis a Cinecittà, Studio 5, dove i corridoi di moquette e le porte laccate in verde ardente ambientano un ufficio di management. Dalle finestre, l’imponenza ospedaliera degli studi guarda la povertà dell’austero Emmer, il cineasta che lavora tra gli orti delle baracche e la tangenziale. Sulla poltronissima girevole di pelle nera, De Laurentiis in azione risponde aulico, tra una telefonata in napo-americano e una visita giù al set di U-571. Ugo Pirro, invece, parla scandendo tutto, seduto alla scrivania di casa. Tonino Delli Colli siede come Kagemusha in un salottino con centrini e divano consunto, di fianco a una sfilza di Nastri d’argento e Globi d’oro, piccolo, modesto e romano: le tre caratteristiche insieme fanno un uomo di qualità. Difficilmente si riesce a scalfire la vocazione all’oggettività di Carlo Lizzani, in una casa apparecchiata da un moderato,
novecentesco gusto piccolo-borghese. Legno nobile, libri d’arte e premi nell’attico-superattico dove Francesco Rosi, toccando ogni tanto Trinità dei Monti con lo sguardo, sembra guidato da una volontà, seria, contegnosa, di precisione didattica sui passaggi della vita, anche sui tuffi nel Golfo di Napoli. Suso Cecchi d’Amico, una nonna ampia e ancora agile, mi ha ricevuto nel padiglione della cultura del Novecento che lei crede ancora la sua casa, eretta in poltrona, tra quadri di futuristi e schizzi firmati, la mano su un panchetto che continua ad accarezzare come un fedele cagnetto. Monicelli vorrebbe una cosa sbrigativa, ma resta seduto per ore su un divano rosso, nella casa che non riesce più neanche a enumerare tra tutte quelle che ha avuto e lasciato inseguendo nuove mogli. Alberto Sordi preferisce lo studio, un ufficio nei pressi della Dolce Vita, silenzioso e austero come quello dei commercialisti. Un’enorme scrivania di rappresentanza troneggia, ordinata con cartella in pelle, calamaio e assorbente, per impressionare. La sua agiografia, però, la dice da un’altra stanza, intorno a un tavolo da riunioni per dieci persone, sorseggiando una bevanda d’intenso color paglierino che sostiene essere tè freddo invece è whisky. I Taviani si entusiasmano come due commilitoni rifacendo l’esistenza mentre vanno e vengono cani e gatti, pregando, inascoltati, di unificare le dichiarazioni. Nino Manfredi non riesce a nascondere gratificazione e rancori, da un meraviglioso salotto della villa sull’Aventino dove però i divani sono disposti per parlarsi senza vedersi. In villa anche per Zeffirelli che, imbozzolato in una tuta blu di pile al profumo di rose, tra ritratti firmati di Liz Taylor e Maria Callas poggiati su un’interminabile galleria di mogano e ricordi, accende l’imponente stufa a due caldaie come un pilota che scalda i motori. Secondo accordi toccherebbe a Pietro Ingrao, ma il Natale permette l’ennesimo rimando, mentre puntuale, con gli auguri di pugno, arriva il testo di Andreotti, il solo, con Morando Morandini, che ha preferito risposte scritte, un po’ laconiche, diciamo di garbata brevità. Ingrao ha chiesto due volte i fax con le domande e le motivazioni dell’incontro e ha impiegato otto mesi per fissare un appuntamento, con una diffidenza acuta, onesta ed educata: ho incontrato questo pezzo di secolo nell’appartamento di un edificio popolare anni ’50, le coperte a protezione dei divani e pile di libri intorno alle quali il senatore si muoveva lento, ma con una forza da mulo. Furio Scarpelli è una furia, in una mano un volume da citare, nell’altra antichi bozzetti satirici, dominato da progetti da realizzare e dall’allegria di ricordare. Ettore Scola si è prestato alla Mas Film Produzioni, con cauta e affettuosa prosopopea, dietro una scrivania. L’incontro con Carlo Rustichelli, nell’attico sopra il quale funziona ancora la sala di registrazione dove suonò anche Miles Davis, finisce al pianoforte, lo Stainway a coda accanto alla vetrata sui palazzi dell’Eur. Ho incontrato l’ultranovantenne Tullio Pinelli (capace di ricordare le vedove di Caporetto sotto i portici di Torino), nella mansarda di una sua casa romana: le veneziane filtravano la luce obliqua di un lento tramonto tra infiniti lapilli di polvere, tra noi, coltre e cortina. Age Agenore Incrocci ha rivoltato la casa per mostrare i disegni dell’infanzia e certe antiche lettere del padre. Leo Benvenuti e Piero De Bernardi raccontavano nella casa di Piero fronteggiando l’impazienza di Chiambretti, a cui rivedevano una sceneggiatura. L’incontro con Lucherini non poteva che avvenire al festival “Schermi d’Amore”, tra manifesti della Magnani e celebrazioni di Nazzari, nel salottino di una suite d’hotel. Nonostante il busto ortopedico a causa di un incidente, Franca Valeri non ha mai lasciato dalle sue braccia Roro III, sorvegliante pigro di un salottino da cocotte. Gillo Pontecorvo avrebbe delegato qualcuno, se avesse potuto. Luigi Malerba non ha smesso un istante di essere “confortato” dai suggerimenti della moglie, vivacissima e informatissima.
Rodolfo Sonego, amabile fumatore e inesauribile viaggiatore, è uno che qui è già di là, come Leo Benvenuti. Natalia Aspesi ha preteso il privilegio della registrazione telefonica, appassionata e lucida. Valentina Cortese ha impiegato un paio di mesi prima di ricevermi nel sontuoso appartamento milanese, dove ha ricordato Spencer Tracy e la Monroe sorseggiando champagne, versato da un cameriere in livrea. Con Ermanno Olmi si stava in giardino, di fronte alle montagne, lasciando spazio alla musica degli uccelli. Il prezioso testo di Luigi Comencini esiste grazie alla collaborazione della famiglia. Sono sfuggiti agli incontri Freda, Attilio Bertolucci, Vittorio Gassman, Ciccio Ingrassia, impegnati definitivamente altrove. Manca Raf Vallone, che da Sperlonga disse “forse in primavera”. E Lattuada, tra quelli che sono qui, ma non possono più. E Gina Lollobrigida, gagliarda vanitosa che si nasconde dietro l’imitazione maldestra della sua cameriera. E Tonino Guerra, che è capace di prendere a pesci in faccia il dovere di esistere. E Vianello, che ha perso contatto con la realtà per eccesso di televisione. E Antonioni, che via Carlo Di Carlo e signora Fico ci manda immagini invece di parole. E Alida Valli, barricata nella sua ostinata vecchiaia. Mancano quelli che mancano. La piazza è sempre là, immobile, viva, fluttuante. Ho chiesto al “medium” Enrico Ghezzi di visitarla, e raccontarci. Forse è l’unico che poteva farlo. Dalla fine della prima guerra mondiale, ogni racconto è un viaggio svelto, una scorribanda individuale, un montaggio dell’esistenza. Ciascuno riscrive lo stesso tempo, a volte gli stessi fatti, eppure diversi, eppure per ognuno inesorabilmente unici, redige una velina della storia come traccia dell’uno nell’altro, del sé nel noi, l’emozione personale nel palinsesto collettivo. So ora di aver raccolto queste voci per un bisogno, addirittura privato, di “nascituro” senza patria, e per patria in questo caso intendo il Tempo. E per Tempo intendo il cinema.
RINGRAZIAMENTI A Marina Sanna, divoratrice di romanzi e racconti di ogni specie e tempo, che ha suggerito tagli e aggiustamenti di prima lettura. A Elisabetta Sgarbi, che ha accompagnato l’idea nel corso degli anni. A Corrado Corradi, Virgilio silenzioso ed esperto. A Mario Nicolao, il guardiano del faro col sigaro in bocca. E ai pazienti e impazienti personaggi dell’indice, in particolare a coloro che hanno voluto rileggere i testi: Suso Cecchi d’Amico, Piero De Bernardi, Dino Risi, Ettore Scola, Luciano Emmer, i fratelli Taviani, Gillo Pontecorvo, Furio Scarpelli, Enrico Lucherini, Francesco Rosi, Carlo Lizzani, Luigi Malerba.
Indice Copertina Trama Biografia Frontespizio Copyright Dedica PREFAZIONE 1 TULLIO PINELLI - Auguri di capodanno al Duca d'Aosta 2 LUIGI COMENCINI - Pinocchio si nasce 3 MARIO MONICELLI - La libertà al settanta per cento 4 DINO RISI - Ma quanta fatica la lira e la f.... 5 GIULIO ANDREOTTI - Il neorealismo al settanta per cento 6 CARLO LIZZANI - Su e giù dal neorealismo 7 BENVENUTI & DE BERNARDI - Amici per la pellicola 8 ALBERTO SORDI - Sembra ch'è passato un giorno 9 RODOLFO SONEGO - A Venezia con le scarpe chiodate 10 DINO DE LAURENTIIS - Sogni colossal. La mia Rosebud 11 AGE - Generale, non vi suonerò più la liana SCARPELLI - La palla al piede: far ridere 12 ENRICO LUCHERINI - I dolci inganni 13 LUCIANO EMMER - La notte che ho inventato la pubblicità 14 UGO PIRRO - Nascita (incerta) di una nazione 15 PIETRO INGRAO - I "tempi moderni" del cinema italiano 16 GILLO PONTECORVO - Da Saint Tropez ad Algeri 17 SUSO CECCHI D'AMICO - Il panchetto di Luchino
18 FRANCESCO ROSI - La vita come impegno 19 FRANCO ZEFFIRELLI - Shakespeare e il bushbaby di Liz 20 CARLO RUSTICHELLI - Andiam filibustier, ohi ohi ohi 21 TONINO DELLI COLLI - So' sparite le lucciole 22 MORANDO MORANDINI - Non sono che un critico 23 LUIGI MALERBA - Cronaca di uno scrittore 24 FRANCA VALERI - Storia di un'italiana 25 NINO MANFREDI - Mio nonno paraculo, maestro d'ironia 26 NATALIA ASPESI - Maschi e moralisti 27 VALENTINA CORTESE - Confesso che ho vissuto 28 ETTORE SCOLA - C'eravamo tanto amati 29 FRATELLI TAVIANI - Un'aggressiva fiducia nel domani 30 ERMANNO OLMI - Il mestiere di vivere 31 Enrico Ghezzi - Passato-morto e sparizione EPILOGO POSTFAZIONE RINGRAZIAMENTI