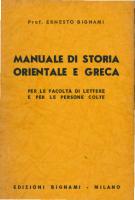Musiche dell'Asia orientale. Un'introduzione 8843033786, 9788843033782
Il libro fornisce gli strumenti per la comprensione della musica dell'Asia orientale, introducendo alle peculiarità
308 75 10MB
Italian Pages 185/189 [189] Year 2005
Polecaj historie
Citation preview
STUDI SUPERIORI
f 498
SPETTACOLO
[. .. ] quando mai hanno saputo cosa fosse la passione dei suoni! F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra
I lettori che desiderano informazioni sui volumi pubblicati dalla casa editrice possono rivolgersi direttamente a: Carocci editore via Sardegna 5 0, ooi87 Roma, telefono o6 42 8 I 84 I 7 , fax o6 42 74 7 9 3I
Visitateci sul nostro sito Internet: http://www.carocci.it
Luciana Galliano
Musiche dell'Asia orientale Un'introduzione Prefazione di Giovanni Morelli
Carocci editore
ra edizione, maggio 2005 © copyright 2005 by Carocci editore S.p.A., Roma Finito di stampare nel maggio 2005 per i tipi delle Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino
Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. r 7 r della legge 22 aprile r 94 r , n. 63 3 ) Senza regolare autorizzazione, vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico.
è
Indice
I.
Questa non è una prefazione di Giovanni Morelli
II
Premessa
I5
Introduzione
I7
Musica e cultura Uno sguardo agli studi etnomusicologici Difficoltà intrinseche allo studio etnomusicologico (Etno)musicologia e Asia orientale Riflessioni suscitate dal confronto fra diverse esperienze musicali
I7 20 24 29
Il suono
43
32
Definizione del suono Percezione del suono Significato del suono
2.
Gamme, scale, modi
6I
Definizioni di scala, modo, gamma Gli intervalli Il ciclo delle quinte, la scala naturale , m onici Le scale temperate
63 70
7
rapporti ar7I 77
' M U S I C H E D E LL ASIA ORIENTA L E
3·
I l tempo Misura Metro Ritmo
4·
5·
9I 92 95
Il colore
IO I
Il timbro Il gusto Classificazione dei timbri strumentali Espressione
IOI I05 I 08 II7
Sintassi e significato
I2 I
Musica come linguaggio Organizzazione e significato Melodia Livelli di strutturazione del linguaggio musicale
6.
La forma musicale
I43
Forma e contenuto Forma come organizzazione Tessuto (polifonia, eterofonia, armonia) Forme musicali e strutture sociali: apprendimento, dominio, competenza Il contesto esecutivo
I43 I46 I5 5
Glossario cinese
I 65
Glossario giapponese
I 67 8
I5 8 I 6o
INDICE
T abelle cronologiche Storia cinese Storia giapponese Storia coreana
Tavole
1 73
Bibliografia
r8r
9
Questa non è una prefazione di Giovanni Morelli
N el corso di quel magnifico rodeo di retorica, vuoi freudiana, vuoi argomentativa, diretta a far girare in folle le plurime credenze incli nanti alla giustificazione dei fatti e dei misfatti della supponenza del l' autenticità legale delle " civiltà " , che è il Candide volterriano, ricorre per ben sette volte sulla bocca di altrettanti diversi personaggi (evi dentemente tutt'altro che sorretti, nelle loro reiterate affermazioni di congruità al vero delle aberrazioni che narrano in prima persona, dal vero narrante esterno, l' autore) un richiamo alle proprietà d'usanza, al rispetto di leggi non scritte, alla legittimità delle dure tradizioni, che dovrebbero essere sotto- o sovraimposte a sette fattacci, fatti pas sare così, enunciativamente, per " normali " . Sette canoniche invenzioni d'estrema pittoricità. Si può ricordare infatti l'assalto al castello e lo stupro della illiba ta figlia nobile, anticipato dal massacro durante il quale viene fatta a pezzi la madre baronessa della ragazza ( «je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le chà teau était une chose d'usage»); l'intrusiva digitazione di ricerca di dia manti eventualmente nascosti dai prigionieri nei loro sigma , operata dai corsari («c'est un usage établi de temps immemorial parmi le na tions policées qui courent sur mer») ; lo sverginamento della figliola di un pontefice da parte di un abominevole capitano negro («ce sont de choses si communes qu' elles ne valent pas la peine qu' on en parle») . Così come si potranno ricordare gli attributi di normalità riferiti a casi decisamente estremi come la degustazione antropofagica di un pezzo di natica femminile ( «dans plusieurs sièges pareille chose était arrivée : c'était la lois de guerre») , il taglio "legale " della gamba dello schiavo della piantagione, fuggitivo e ricatturato («Oui, monsieur, c'est l'usage») , la cena all'osteria veneziana di sei monarchi detroniz zati («Il est très commun que des rois soient détronés») , la destinazio ne alla galera, previa sessione punitiva di cento sciabolate sotto la II
' M U S I C H E D E LL ASIA ORIENTA L E
pianta dei piedi, ai colti in flagrante di attenzioni sessuali rivolte a donne arabe in moschea («Il y avai t dans cette galère qua tre jeunes gens de Marseille, cinq pretres napolitains et deux moines de Corfou qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours») . L' accettazione del " discorso" ricevuto sull'evidenza e necessità dell'usuale legalità della tradizione , da parte del celebre filosofo illu minista, per come risulta tanto, troppo enfaticamente frettolosa, tan to, troppo ossequiosa dell'ovvietà dei portati, innesta un giro di c riti ca della tradizione ferocemente indotta dalla compressione e dalla re ticenza allegoricamente dimostrata nel racconto. Un procedimento che va ad allinearsi, a futura memoria, con la chiamata alle armi della rivoluzione come critica dell'appello brechtiano, di senso e segno de cisamente inverso: Osservate bene quel contegno. Trovatelo strano, anche se consueto, inspiegabile anche se quotidiano, in decifrabile anche se regolare. Anche il più piccolo gesto , apparentemente semplice, andate ad osservar lo con dz/fidenza. Studiate se sia proprio necessario quel suo modo d'essere usuale. E, vi prego, quel che accade tutti i giorni non trovatelo naturale.
Mi sono rifatto così dilungatamente ad un apologo doppio e incapsu lato, tanto lontano dal tema e dal titolo di questo libro, per consen tirmi di insinuare nel discorso prefattivo un po' di pathos intenziona le connesso al proposito di non anticipare direttamente i contenuti del libro stesso e tantomeno di anticipare il programma dell'avventu ra intellettuale per la quale l'autrice ha il diritto di chiamare in prima persona alla condivisione il lettore sensibile, sul tempo reale della sua scrittura. Lo stesso lettore forse mi sarà riconoscente di questo abuso di rievocazioni di fantasmi dei "lumi" per il quale , perfezionando la ca denza, mi accingo a dichiarare, à la manière di Diderot, che «questa non è una prefazione», in quanto il carattere più meritorio della co municazione scientifica che qui si pubblica consiste proprio nelle sue proprietà di movimentazione concettuale interna alla prospezione di un " sistema musica " aperto, vivente, disposto a sottomettersi non solo ad uno, ma a tutti i principi della termodinamica : una sorta di autobiografia della processualità dell'esperienza musicale cosciente , ri vissuta dall'autrice in un assetto partecipativo particolarmente orien tato a ri-narrare al lettore e collettore , assieme al lettore, un esperi mento di movimentazione di policentriche revisioni, storicamente e " geograficamente " assistite, applicato a molte credenze metodiche, a 12
QUESTA N O N È U N A PREFAZION E
molte abitudini ermeneutiche , a molte pregiudiziali dell' " acculturazio ne " musicale e delle sue rigide autodefinizioni. È su questo aspetto che insiste l'allusività imposta alle prime righe di questa mia breve prefazione all'eloquente ed articolata " introduzio ne " al libro quale figura, evidente nell'indice, proposta dall' autrice (e che esprime al meglio i proponimenti squisitamente educativi/riedu cativi di cui si fa carico) . Attraversando i campi ed in specie i dubbi confini dei campi stes si, della musicologia storica, della musicologia sistematica, della etno musicologia, dell'antropologia (e, commisuratamente ai suoi potenzia li di emancipazione, dell' antropologia musicale) , della bi-musicalità (ovvero delle esperienze di coscienza intricata dei domini affrontati dagli osservatori della propria e dell'altrui musica, ovvero della musi ca del proprio tempo e di quella del passato, per non dire di quella dell'avvenire) , dell'esperienza canonica del discorso sulla musica e del discorso sul fare/farsi della musica, Luciana Galliano realizza qui una guida mobile al confronto fra le modalità della differenza della rap presentazione categorialmente incrociata di plurime presenze di sog gettività metodiche nell'estrinsecazione dei destini interculturali evol venti nella sempre crescente determinazione dell'istanza della musica a dominare un crescente numero di processi di blackingiana umaniz zazione. La quale umanizzazione a sua volta, compare sollecitata, da se stessa, a definirsi permutativamente, come storicamente determina ta dalle istanze storiche della determinazione , e non meno storica mente indeterminata dalle istanze storiche dell'indeterminazione, gio cando così più di una partita, su più tavoli. Per lo sviluppo di supe riori facoltà cognitive dei soggetti umani diffusibili nella pratica socia le, ovvero, contrariamente desunti dalla pratica sociale, secondo fini rituali, reiteratamente mitopoietici, significativamente (ma anche insi gnificantemente) simbolici. Per la verifica della verità o della proibi zione delle glorie o delle derive della riproducibilità del tempo nello spazio (e viceversa) . Per la ri- degnificazione della sapienza orale e anonima, e per la revisione rafforzante della dignità delle sapienze au toriali. Per l'amplificazione cosmica o per la riduzione entropica, sino alle estasi del grado zero, del "barocco " cimento fra i miti dell'archi scrittura e i miti dell'iperrealtà dell'antologia sonoristica del mondo, oppure, in altre parole e forse anche tutt'altro senso, del cimento del totalizzante oblio della forma nell'esperienza d'ascolto come totale abbandono alla dimensione essenziale evenementale opposto alla tota lizzante memoria formale del differimento della evenementalità nella dimensione essenziale della testualità.
' M U S I C H E D E LL ASIA ORIENTA L E
Il confronto si fa ben nutrire, nel libro di Luciana Galliano, da un imponente apparato di nozioni per così dire fresche, irrompenti da un repertorio di idee e pratiche musicali " esotiche " , non simulanti una deriva arcaistica, recepite non più in aure di sussiegoso comparativi smo, in più occasioni sentite come interrogazioni su una questione che la stessa introduzione al libro lascia intravedere come una pres sione euristica ineludibile connessa alla problematica della «vera com prensione del linguaggio» (per esempio laddove scende a perpendico lo l'ipotesi che un pubblico moderno sta forse «capendo di più» un incognito genere cinese di musica per seta e bambù di un quartetto brahmsiano) o alla problematica degli incrementi della voracità uditi va contemporanea, inversamente proporzionata alla coscienza esisten ziale dell'esserci nell'ascolto e dell'ascolto.
Premessa
In questo libro vengono affrontati sistematicamente i concetti della musica nelle culture musicali dell'Asia orientale: l'organizzazione del discorso n1usicale e il suo significato a partire dalla struttura del suo no, la definizione delle scale , l'idea di tempo/ritmo, gli strumenti. L'intento è quello di fornire una chiave di accesso alla comprensione della musica dell'Asia orientale, che costituisce uno dei grandi mo menti della cultura musicale asiatica accanto alla musica indiana e alla musica arabo/persiana. Riesaminando gli elementi di fondo della teoria musicale, ho cerca to di spiegare le peculiarità delle concezioni della musica, del suo si gnificato e della sua bellezza nelle culture appartenenti alla grande area di influenza cinese, dunque Cina, Giappone, Corea e parzialmente In donesia. La vasta zona dell'Asia orientale comprende antiche e raffina te civiltà dotate di caratteri, tradizioni e valori propri anche in campo musicale, ha subito influenze e apporti da civiltà straniere confinanti o anche lontane, ma costituisce un territorio relativamente unitario dal punto di vista dei fondamenti del pensiero musicale, in contrapposizio ne al limitrofo grande bacino di cultura musicale indiana, con cui gli scambi furono naturalmente molti, soprattutto ai confini. Il centro irradiante di questa variegata concezione musicale è stata la cultura cinese, e gli apporti dall'esterno furono vitali per l' arric chimento e per uno sviluppo non autoreferente delle forme del pen siero musicale. L'ipotesi di una impronta dominante della raffinata ci viltà musicale cinese è testimoniata da varie circostanze; accanto alle evidenti similitudini e derivazioni del pensiero anche il permanere , nelle zone più estreme dell'area, di concezioni e pratiche musicali da tempo abbandonate al centro, come i complessi di idiofoni indonesia ni o la musica di corte giapponese. La materia è enorme e magmatica; ho cercato di darne una espo sizione relativamente succinta: molti concetti sono enunciati e vengo no trattati nel modo più chiaro e compiuto possibile ma, non avendo
' M U S I C H E D E LL ASIA ORIENTA L E
speranza di essere " uomo di sintesi" I, sono lontana da qualsiasi pre tesa di esaustività. Lo scopo è che i lettori trovino in questo testo chiavi per avvicinarsi alle musiche dell'Asia orientale o che, nello stu dio di altre musiche, anche della musica europea, trovino stimoli per considerare le cose da un punto di vista differente. Forse l'immagine della musica dell'Asia orientale che viene qui delineata può sembrare nai/ a fronte dei radicali cambiamenti dovuti soprattutto all'assimila zione di canoni occidentali in corso nell'area da oltre un secolo, ma è pur sempre quella preservata nella letteratura e costitutiva di una sen sibilità fisiologica che non può essere soppiantata in così breve perio do, soprattutto nelle vaste aree che poco contatto hanno con i pro cessi della modernizzazione. Talvolta, onde non appesantire il testo, ho preferito dare in nota più riferimenti non solo bibliografici, al fine di stimolare una ricerca personale mossa da specifici interessi; per fornire un quadro chiaro dello svolgersi del dibattito è indicata, nei limiti del possibile, la data della pubblicazione originale di un testo quando ne venga data la tra duzione italiana. Ove non esplicitamente indicato, le traduzioni delle citazioni da lingue straniere sono mie. Sempre per facilitare il percorso, ho scelto di privilegiare la lette ratura in lingue occidentali, tralasciando l'importante letteratura cine se, giapponese ecc . I nomi asiatici sono dati nell'ordine cognome-nome . Le translitte razioni sono pynin per il cinese e Hepburn per il giapponese (tranne " Tokyo" , translitterato " Tokyo " , come invalso nell'uso) . Ringrazio quanti mi hanno sostenuto nelle difficoltà e nei dubbi nel corso della stesura di questo libro e, fra questi, Pippo Manzone, Gio vanni Morelli e Francesca Tarocco . Ringrazio Stefano Pierini per l'aiuto tecnico nell'inserimento degli esempi; ringrazio di cuore Rug gero Gallimbeni, Maria Teresa Silvestrini e soprattutto Francesca Ta rocco per l'intelligente rilettura e i preziosi suggerimenti. Mi scuso per l'incompletezza e gli eventuali errori nella trattazione, di cui sono in toto responsabile .
Note r.
Come].-]. Nattiez,
1 9 89 (ed. or. 1 9 87), p.
Prefazione a Musicologia generale e semiologia ,
XVII.
I6
EDT ,
Torino
Introduzione
Musica
e
cultura
Dall'inizio del Novecento, la ricerca filosofica e le scienze umane si sono interrogate sul modo e le forme della cultura e ci hanno fatto comprendere come la specie umana acceda al reale solo attraverso la mediazione - e quindi la creazione - di un insieme di sistemi signifi canti quali i miti, i riti, la musica, il linguaggio I. Le ricerche antropo logiche hanno ulteriormente dimostrato che l'organizzazione di siste mi di segni per l'orientamento, la comunicazione e l'autocontrollo dell'individuo nella comunità dei suoi simili, in una parola i processi di evoluzione culturale, sono, come sostiene l'antropologo Clifford Geertz, inseparabili dai processi di evoluzione biologica : «la cultura [ . . ] fu un ingrediente e il più importante nella produzione [dell'homo sapiens] >> 2• I sistemi di segni organizzati sono inoltre, evidentemente , peculiari altappartenenza culturale. La conclusione è dunque che non esiste un essere umano a prescindere dalla sua indentità culturale: in che lingua si esprimerebbe ? con che modalità si accoppierebbe? quali insegnamenti tramanderebbe ai suoi figli? E anche, ciò che qui ci in teressa, che musica amerebbe ascoltare e suonare? Alla fondamentale domanda posta da J ohn Blacking su quale ruo lo abbia la musica nell'aiutare gli esseri umani ad essere umani, la risposta può essere differente a seconda degli itinerari di ciascuna cultura, posto che ogni cultura ha una sua differente idea di ciò che si dica umano in una persona. All'interno di ogni cultura la posizione della musica, come di ogni altro organismo simbolico, è quella di un mattone nella costruzione che la società fa della propria umanità; il criterio di costituzione del sistema " musica" - o meglio (poiché non tutte le culture hanno una parola complessiva come "musica " ) del si stema " espressione attraverso dei suoni dotati di un codice diverso da quello del linguaggio verbale " - è coerente con tutti gli altri aspetti .
I7
' M U S I C H E D E LL ASIA ORIENTA L E
della cultura e quindi peculiare a quella cultura e sostanzialmente pri vo di diretti legami simbolici con un'altra . Per questo è difficile dare una definizione universale del concetto di musica; le parole che dico no "musica" in lingue concettualmente lontane non sono esattamente coincidenti e traducibili l'una nell'altra . Così come non esistono l'uo mo e la donna - esistono uomini e donne giavanesi, cinesi, francesi o forse, con una certa astrazione, europei - non esiste la musica, esi stono le musiche europea, cinese, giapponese, bantu ecc . Non ha sen so parlare di musica come linguaggio universale ; ogni musica è l'e spressione locale di un precisissimo sistema linguistico elaborato da una certa cultura a partire da certe condizioni e in vista di certi fini. La musica partecipa all'interazione con l'ambiente e le sue circostan ze - un bell'esempio sono le canzoni dei Kaluli, " composte " intera gendo con i suoni e le presenze della foresta pluviale 3. A proposito delle considerazioni relative al concetto di cultura, Bruno Netti segnalò come gli etnomusicologi usassero il termine " cul tura" diversamente dagli antropologi, probabilmente per via di una contrapposizione frontale fra musica e tutto il resto all'interno di una società 4. La definizione del rapporto fra i termini " cultura " e "musi ca " negli studi etnomusicologici è stata a lungo quella data nel r 9 6 4 da Alan Merriam in un libro paradigmatico, The Anthropology o/ Music, in cui si perorava l'indagine della