Il neorealismo cinematografico italiano 8831772376, 9788831772372
Nel settembre 1974, nell'ambito della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, a Pesaro, si svolse un'ampia ras
292 53 15MB
Italian Pages 446 [438] Year 1999
Polecaj historie
Citation preview
Il neorealismo cinematografico italiano a cura di Lino Micciché
.fl
© 1999 BY MARSILIO EDITORI * S.P.A. IN VENEZIA
ISBN 88-317-7237-6
INDICE
ix
Sul neorealismo, oggi
(l.m.) IL NEOREALISMO CINEMATOGRAFICO ITALIANO
1
Nota alla seconda edizione
7
Per una verifica del neorealismo
(l.m.) di Lino Miccichè IL CONTESTO CULTURALE E POLITICO DEL NEOREALISMO
31
' 61
Per una nuova definizione del rapporto politica-cultura
di Alberto Abruzzese La problematica gramsciana e la questione del neorealismo
di Saverio Chemotti 67
Iconologia del realismo
di Nicoletta Mister 76.
Il modo di produzione del neorealismo
di Michele Conforti e Gianni Massironi 82
L’industria cinematografica italiana nel primo dopoguerra
di Claudio Zanchi 90
Neorealismo e associazionismo 1944-1953: cronaca di dieci anni
di Callisto Cosulich 98
II neorealismo: quando è finito, quello che resta
di Carlo Lizzani REALISMO E NEOREALISMO
109
Realtà, realismo, neorealismo, linguaggio e discorso: appunti per un approccio teorico
di Gianfranco Bettetini 141
« Poiché realismo c’è... »
di Gianni Scalia 163
La restaurazione dell’occhio
di Antonio Prete
175
Struttura della ripetizione e restaurazione del verosimile nel cinema neorealista
di Paolo Bertetto 185
Tra critica e teoria: alcune aporie del discorso neorealista
192
Neorealismo. Istituzioni e procedimenti
205
Considerazioni sul realismo: teoria e pratica
di Camilla Colaprete, Carlo Marietti, Giuliano Rossi e Massimo Vannucchi di Maurizio Grande e Franco Pecori di Giuseppe Gatt
215
Cesare Zavattini teorico del neorealismo
di Sandro Petraglia 222
Neorealismo: quale realismo?
di Pascal Bonitzer IDEOLOGIE E STILI DEL NEOREALISMO
229
La « coscienza di sé »: ideologie e verità del neorealismo
di Adelio Ferrero
250 262
Stile e stili del neorealismo
di Giorgio Tinazzi Cenni sulla critica marxista e il neorealismo
di Ugo Finetti 274
« Ossessione » contro il neorealismo
di Ellis Donda 284
La maniera di Visconti
di Tommaso Chiaretti 288
Rossellini oltre il neorealismo
di Adriano Apra 500
De Sica neorealista
di Tino Ranieri 507
« De Santis »
di Andrea Martini e Marco Melani 518
Renato Castellani in periodo neorealista
di Gianni Menon IL NEOREALISMO E IL CINEMA ITALIANO DEGLI ANNI TRENTA
551
Neorealismo e cinema italiano degli anni *50
di Francesco Caselli, Alberto Farassino, Aldo Grasso e Tatti Sanguinea 586
Primato degli intellettuali e neorealismo
di Vito Zagarrio 594
Ideologia e propaganda nella commedia degli anni trenta
di Claudio Carabba 405
L’utilizzazione degli ambienti naturali nel cinema italiano dal 1950 al 1944
di Jean A. Giti 410
Blasetti dal periodo fascista al neorealismo
di Sergio Grmek Germani
SUL NEOREALISMO, OGGI
Circa cinque lustri fa, scrivendo il saggio «Per una verifica del neorealismo », introduttivo alla prima edizione del presente volume (e, con poche, marginali differenze — anzi, semmai, con pronunciata pole mica nella stessa direzione — licenziando, tre anni dopo, la «nota introduttiva » alla seconda edizione, 1978, della stessa opera), mi sembrò giusto e doveroso sottolineare come « fare i conti con il neorealismo » fosse il grande atto mancato del cinema italiano. Gravido di conseguenze, naturalmente: ché, come ogni atto mancato, questo gesto non compiuto aveva bloccato e/o deformato molti altri gesti successivi, impedendo alla cinematografìa italiana, dopo quell’esemplare « cinema del sottosvilup po », di costruire un saldo e stabile « cinema dello sviluppo ». Lo si era, d’altronde, ben visto tra la estrema fine degli anni ’50 e le prime stagioni degli anni ’60. In tutto il mondo, dalla Cecoslovacchia al Giappone, dalla Francia al Brasile, dalla Germania (allora r.f.t.) alla Russia (allora u.els.s.), le « nuove ondate » nascevano in polemica con il cinema dei padri: i nuovi autori rifiutavano quelli della generazione immediatamente prece dente e stroncavano sistematicamente il « cinema de papà » prima ancora di praticare il proprio. In Italia, invece, il rinnovamento partiva da un primo episodio del 1959 (Venezia, settembre) che vedeva due padri (R. Rossellini e M. Monicelli) protagonisti, con due film (Il Generale della Rovere e La grande guerra, vincitori ex-aequo nel Leone d’Oro alla xx Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica) che sembravano ambire a tematiche proibite fino ad allora, ma con il linguaggio che era stato delle stagioni postbelliche; si confermava nel 1960 con il triplice trionfo di altrettanti « padri » (l’Antonioni de ^avventura, il Fellini de La dolce vita, il Visconti di Rocco e i suoifratelli}, che sapevano mirabilmente rinnovarsi ed offrire tre capolavori; veniva ribadito nelle primissime stagioni del nuovo decennio dall’attestarsi di questi stessi « padri » su linee ispirative (tematiche, stilistiche, spettacolari) di autorevolissima autorialità (si pensi al complessivo splendore dei cinque film dell’Antonioni anni ’60, alla affascinante modernità dell’# e felliniano, alla intensa spettacolarità de Il gattopardo viscontiano). Insomma, mentre il cinema era in Brasile dei
X
Sul neorealismo, oggi
Rocha, in Germania dei Kluge, a Mosca dei Tarkovski, a Praga dei Forman, a Tokyo degli Oshima, a Bruxelles dei Delvaux, a Madrid dei Saura e a Parigi dei Godard, dei Truffaut e dei Resnais — ovvero di generazioni, tutte, divenute similmente operative tra l’ultima stagione degli anni ’50 e la primissima del decennio successivo — da noi regnava ancora incon trastata la generazione che aveva esordito negli anni ’40. Si dirà che anche da noi vi era una « nuova ondata » e che le diecine di esordi ’60/’65 (Petri, Olmi, Vancini, Damiani, Pasolini, B. Bertolucci, Montaldo, il trio P. e V. Taviani, V. Orsini, De Seta, Pasolini, Leone ecc., fino a quelli di metà decennio di Bellocchio e della Cavani) costituirono un indubbio quadro di (parziale) rinnovamento, destinato a crescere, e a pienamente affermarsi, successivamente, tra la seconda (e la conclusiva) parte del decennio e il prosieguo fìlmografico degli anni ’70. Ma il grosso del cinema italiano continuò a lungo ad essere costituito dalla « vecchia guardia » neorealistica o immediatamente postneorealistica: non soltanto quanto a registi, ma anche quanto a sceneggiatori (si pensi alla funzione che Age e Scarpelli, Scola e Maccari — nonché Vincenzoni, De Concini, S. Cecchi D’Amico — ebbero nel cinema italiano degli anni ’60), quanto ad attori (non furono i Sordi, i Gassman, i Tognazzi, i Manfredi, i Mastroianni accanto alle Vitti, alle Mangano, alle Loren i grandi protagonisti del cinema nazionale del decennio?), quanto a produttori (a parte il soltanto più giovane Cristaldi, non fu, quello italiano degli anni ’60, il cinema dei Lombardo, dei De Laurentiis, dei Ponti a fare aggio merceologico su quasi tutto?) e quanto a strutture (che la legge 1213, del 1965, rinnovò, aggiornò e migliorò ma certamente non ribaltò). E, d’altronde, anche fermandoci alle sole « questioni di stile » (ovvero di scrittura fìlmica e di costruzione narrativa), pochissimi fra i gesti espressivi realizzati lungo il decennio dal giovane cinema italiano appaiono radicalmente innovativi nei confronti del cinema nazionale preesistente, come, per non fare che un esempio, A bout de souffle lo appare nei confronti dei film del cinema qualité francasse che lo precede; e i pochi radicalmente innovativi (come, ma solo negli avanzati anni ’60, il cinema di Grifi e dei « filmakers » italiani, il cinema di M. Schifano, il cinema di C. Bene) rimasero del tutto isolati, vere e proprie eccezioni a conferma di una regola, dove il più sistematicamente innovativo, il più esemplarmente avanzato, il più coe rentemente moderno dei registi fu una grande figura « storica » del ci nema nazionale, Michelangelo Antonioni, classe 1912, esordio 1943! Non sento di dovere cambiare molto del senso fondamentale di questo ragionamento introduttivo del 1975: quello che accadde, o (a differenza di quanto avveniva quasi dappertutto altrove) non accadde nel cinema italiano degli anni ’60 — oppure, se accadde, assunse caratteristiche molto, molto particolari e comunque del tutto diverse dalle nouvelle vague / nueva ola / new wave / nova vlnà, insomma delle « nuove ondate » di
Sul neorealismo, oggi
XI
tutto il mondo — ebbe, in quei « mancati conti con il neorealismo » la propria prima e principale ragione. Tuttavia, riproposto oggi agli albori del Duemila e quando quegli ormai lontanissimi anni *60 appaiono la mitica ultima grande epoca d’oro del cinema italiano, questo ragionamento a proposito del neorealismo non sembra essere né la cosa più urgente, né la cosa principale da pre mettere a una rievocazione del « nuovo cinema italiano » del dopoguerra. Così come, per estinzione stessa delle polemiche, mi parrebbe inutile rintuzzare ancora gli opposti estremismi critici che, all’indomani dei convegni « pesaresi » del 1974 — al neorealismo e a una sua revisione critica dedicati — si manifestarono: fra, da un lato, le vestali neorealistiche, e intellettual mente tetragone come prefetti del Santo Uffizio, che emettevano austere bolle di scomunica nei confronti di quanti osassero entrare nel Tempio del magistero neorealistico senza prima levarsi le babbucce e coprirsi il capo, e, dall’altro, la monelleria iconoclasta di quegli sbarazzini un po’ ignoranti, e certo intellettualmente alquanto approssimativi, che si diver tirono per qualche caduca stagione, in consessi, convegni e perfino in qualche immemorabile libretto, a contrapporre Matarazzo ad Antonioni, Casa Ricordi a Senso, la trilogia rosselliniana della guerra antifascista alle commediole postbelliche di Mario Mattoli Altro, dunque, mi sembra oggi il ragionamento necessario, quando il mezzo secolo di distanza ci consente una ben maggiore (e maggiormen te documentata) serenità storiografica. Il primo dato è quello che può apparire, e per certi versi è, come una contraddizione: ragione prima (non unica, comunque) del nostro ritardo rispetto alle « nuove ondate » degli anni *60, il neorealismo cinematogra fico italiano è certamente anche la ragione prima della nostra posizione di avanguardia rispetto a tutte le cinematografie mondiali immediatamen te postbelliche: sia rispetto al nulla che per qualche stagione allignò fra le cinematografie dei vinti Giappone e Germania, che dovevano rompere con il passato, sia rispetto alla continuità acritica che regnò nelle cinematografìe dei vincitori usa, Francia, Regno Unito. Forse la nostra stessa condizione storico politica di « vinti cobelligeranti con i vincitori » contribuì a dare al cinema italiano uno statuto molto particolare. Dove si richiedevano rotture e continuità ambedue parziali. Rottura con la tradizione evasiva e consolatoria del cinema imbonitore di platee e nar ratore di favole, confezionatore di commedie « ungheresi » e di « telefoni bianchi», di sogni piccolo-borghesi che abbellivano l’esistente per con1 A proposito degli « opposti estremismi », cfr. quanto scrivevo (in particolare nel terzultimo e nel second’ultimo capoverso) nella « Nota alla seconda edizione », 1978, nota che qui ritengo opportuno ripubblicare, anche quale contribuito ad una ricostru zione del dibattito « postpesarese » sugli incontri neorealistici di Pesaro 74.
XII
Sul neorealismo, oggi
tribù ire affinché, indisturbato, continuasse a esistere: ovvero con il limac cioso grande fiume scoperto che, dal rampante divismo anni ’10 e ’20, attraverso il piccolo divismo provinciale dd cinema italiano sotto il fasci smo, sfociava nella farsa e nel « larmoyant » postbellici; e continuità con la tradizione veristica, con la connotazione sapida, con i sentimenti au tentici, con le pulsioni proibite, con i desideri forti, con i personaggi popolari: ovvero con il piccolo ma significativo fiume carsico che, da alcuni episodi del « muto » anni ’10 e ’20, attraverso taluni film anni ’30 e ’40, sfociava nel cinema postbellico come istanza al realismo, ansia di verità, cinema di conoscenza, denuncia dell’ingiustizia sociale, aspirazio ne a un mondo dove « Buongiorno » volesse dire « Buongiorno », come istanza al realismo insomma; nel senso per cui appartengono al « reali smo » quei sistemi formali e quei correlativi procedimenti narrativi intesi a fare apparire più « realtà » sullo schermo2* . In questo senso il neorealismo cinematografico italiano anticipa di un abbondante decennio tutti i rinnovamenti tra la seconda metà degli anni ’50 e le primissime stagioni degli anni ’60, dal « free cinema » britannico alla « nova vlnà » praghese, dal cinema dell’ottobre polacco al Manifesto di Oberhausen: esso è insomma, sotto molti aspetti, la prima e la più precoce delle « nouvelles vagues ». Non a caso, i suoi principali esponenti hanno nei confronti del cinema precedente la stessa idiosincrasia che, di lì a non molto, avrebbero avuto i Truffaut e i Rocha nei confronti del cinema di casa propria5. E parimenti non a caso esso appare, a distanza, più un’«etica dell’estetica» che una semplice estetica comune a molti autori o un congiunto di poetiche tra loro vicine e consonanti; non dissimilmente da quanto poi accadde alle vere « nouvelles vagues », dal « free cinema » britannico al « cinema novo » brasiliano, che non misero in discussione soltanto le « forme » del « cinema de papà », ma anche, se non soprattutto, la sua funzione: sarà il Godard anni ’60 a dire che « una carrellata è un fatto morale », ma è Rossellini ad affermare, nel ’52, che « il [neo] realismo è la forma artistica della verità »4 ed è lo Zavattini delle stagioni neorealistiche a sottolineare, più volte e in varie occasioni, 2 Cfr. il saggio di Andre Bazin, Le realisme cinématograpbique et l’école italienne de la libération, apparso nel gennaio 1948 su « Esprit » (poi in A. Bazin, Quest ce que le cinema, iv. line esthétique de la réalité: le néo-realisme, Parigi, Editions du Cerf, 1962, p. 22). 1 Si pensi all’invettiva zavattiniana: « La colpa è solo dei produttori: principalmen te dei produttori. Sostengo che in venti anni di cinematografìa protetta come nes sun’altra, libera molto più di quanto non si creda ... questi uomini non hanno dato un solo film, dico uno e cioè tremila metri di pellicola su trenta milioni di pellicola girati » (da Poesia solo affare del cinema italiano, in « Film d'oggi », n. 10, 25 agosto 1945). 4 Cfr. R. Rossellini-M. Verdone, Colloquio sul neorealismo, in « Bianco e Nero », n. 2, febbraio 1952.
Sul neorealismo, oggi
XIII
l’« impulso morale » del neorealismo ’. E, similmente a quanto accadrà negli avviati anni ’60 con le « nouvelles vagues » — quando, in Francia come altrove, i « nuovi cinema » si diffondono, si espandono e si impon gono in poche stagioni come il [rinnovato] cinema nazionale, trasforman dosi (come sempre, c da sempre, tutte le avanguardie) da cinema di punta in cinema corrente — anche l’avanguardia neorealistica, dopo le prime stagioni di rottura con [e di superamento del] cinema italiano preesistente (stagioni che la isolano in una posizione incommensurabilmente più avan zata di tutto il restante cinema nazionale), contribuisce a mutare in qualche modo l’immaginario, le prassi formali, le consuetudini narrative, le ispi5 Cfr. il lemma « Morale » (scritto da Mino Argentieri) in Guglielmo Moneti (a cura di), Lessico Zavattiniano, Venezia, Marsilio, 1992. Ma in Zavattini non soltanto la concezione neorealistica, nelle sue varie scansioni, bensì tutta la riflessione sul cinema è caratterizzata da una costantemente ribadita spinta ad una nuova « mora lità » dell’essere cineasti e del filmare: ora parlando dei « doveri » del cinema (« Noi consideriamo il cinema, anziché una zona socialmente privilegiata come l’arte in carica di doveri per la sua costante funzione articolare », 1944/45), ora parlando della « real tà » come fine supremo dello spettacolo cinematografico (« La nostra lotta e la nostra novità consiste in questo sforzo pressoché eroico di fare coincidere lo spettacolo con la realtà... », 1949), ora parlando esplicitamente di « morale » (« Quali conseguenze di carattere narrativo, costruttivo e morale ha portato questa presa di coscienza della realtà che caratterizza il neorealismo? », 1952; « ...neorealismo come atteggiamento morale di fronte alla realtà », 1954), ora parlando di « responsabilità » e di « utilità » del cinema verso la «conoscenza » e la « verità » (« Il cinema tutto... si dibatte in una crisi... [che]... investe la funzione stessa del cinema e la sua responsabilità... Occorre creare le condizioni e gli strumenti che rendano possibile un cinema diverso, che abbia una continua coscienza civile... Bisogna creare una nuova unità ed un nuovo slancio per una perentoria utilità del cinema. Chiunque con la macchina da presa operi per allargare l’area della conoscenza e della verità ha diritto... » 1968) [per le indicazioni di data che seguano le citazioni mi avvalgo delle note di M. Argentieri curatore di Cesare Zavattini, Neorealismo, Milano, Bompiani, 19791. Credo, d’altronde, che ad un atteggiamento morale alludesse anche André Bazin, quando affermò «Vedrei volentieri nell'umanesimo degli attuali film italiani il loro principale merito di sostan za» (corsivo mio: l’umanesimo di cui parla il critico francese è, in questo caso, soprattutto una posizione morale) (cfr. A. Bazin, Le réalisme cinématographique, cit., p. 16). Cfr. anche quello che, in una sua « lezione magistrale sul Neorealismo » disse Giuseppe De Santis, nel febbraio 1997, poco prima della morte, quando, proprio alludendo al neorealismo cinematografico italiano, affermò « Io sostengo sempre che la mia generazione può vantare l’orgoglio di avere fatto un cinema al servizio dello stato » In questa locuzione, « al servizio dello stato » appunto, vi è, detta altrimenti, quella che io ho definito « l’etica dell’estetica » neorealistica: ovvero il comune im pegno dei cineasti, pur tra loro così diversi per temperamento e per collocazione ideologica, a realizzare un cinema che costituiva uno dei modi di partecipazione attiva alla crescita della società: al « servizio dello stato », perché al servizio del pubblico, del progresso democratico, della maturazione civile e della coscienza (cfr. Giuseppe De Santis, Lezione magistrale sul neorealismo, in aa.w., Omaggio a Giuseppe DeSantis, Collana I quaderni deU'Vniversità di Teramo, Teramo 1998).
XIV
Sul neorealismo, oggi
razioni tematiche, le abitudini dialogiche, il comportamento attortale, la costruzione del profilmico di tutto il cinema italiano, riversando la pro pria forza dirompente di fiume tumultuoso nel grande lago della cinema tografia italiana anni ’50, che diventa ipso facto tutta « postneorealistica », nel duplice senso che essa succede al neorealismo e che lo presuppone, del tutto a prescindere dai risultati dei singoli prodotti e dei singoli autori. Il secondo dato è che il neorealismo ebbe le proprie premesse teori che e culturali, le proprie prime affermazioni, il proprio sviluppo e la pro pria involuzione fra le iniziali stagioni degli anni ’40 e le iniziali stagioni degli anni ’50, quando il nostro Paese — colpito dalla guerra mondiale, percorso dalla guerra civile, diviso dallo scontro frontale che nelle primis sime stagioni della ricostruzione caratterizzò la scena politica nazionale — attraversò quella fase particolare che, con gentile eufemismo intemaziona le, viene ora definita «in via di sviluppo». Il che è come dire che il neorealismo fu un « (nuovo) cinema del sottosviluppo », tipico di una società a struttura ancora prevalentemente agraria, con scarsi poli industriali e una ordinaria fisiologia del capitale molto più vicina a quella, elementare, dell’accumu lazione primitiva che a quella, complessa, delle società industriali avanza te: quelle che si andarono formando negli avviati anni ’50 e del cui novero, a partire dalla fine degli anni ’50 e dall’inizio degli anni ’60, prese a fare parte — sia pure tra molte contraddizioni — anche l’Italia del « miraco lo », che andava lentamente trasformandosi, appunto, da società prevalen temente agraria in società industriale moderna. Tanto che anche tra le « nouvelles vagues » degli anni ’60, il neorealismo cinematografico italia no venne esplicitamente assunto come modello di riferimento (non soltan to etico ed estetico, ma anche più direttamente tematico, narrativo e for male) da molte cinematografie di paesi « in via di sviluppo »: si pensi a quanto siano indebitati con il neorealismo la nascente cinematografia afri cana (in particolare il cinema maghrebino, ma non soltanto), il cinema latinoamericano (in particolare il cinema argentino, cileno, cubano e boliviano, ma anche, per molti aspetti, la maggiore cinematografìa del subcontinente americano, quella brasiliana), le cinematografie asiatiche (il cinema indiano, soprattutto, ma anche cinematografie asiatiche minori come l’indonesiana e la filippina, per non dire delle cinematografìe nazionali delle repubbliche sovietiche asiatiche e transcaucasiche). In realtà questo capitolo che potremmo idealmente intitolare « Il Neorealismo oltre i confini nazionali » è uno dei più colpevolmente igno rati o dei più sbrigativamente affrontati nelle rievocazioni del fenomeno neorealistico e, in generale, nelle storie del cinema del secondo cinquantennio del secolo. Dove appare più agevole collegare alcune personalità del « nuovo cinema » degli anni ’60 alla generale nozione estetica di « realismo » — un generico macrocontenitore dove può entrare tutto, da Ejzenstejn a Welles, da Dreyer a Visconti — che alla particolare nozione storica di
Sul neorealismo, oggi
XV
«neorealismo» da cui esse, invece, furono esplicitamente (e spesso programmaticamente e confessatamente) dipendenti pur nelle loro dina miche di alcuni anni dopo. Penso, per non fare che qualche nome, all’argentino Fernando Birri, ai cubani Tomàs Gutiérrez Alea, Julio Garcia Espinosa e Humberto Solas, per non dire di come Cesare Zavattini partecipi personalmente ai primi atti fondativi del nuovo cinema cubano; al boliviano Jorge Sanjinés, come punta di diamante di un cinema latinoamericano che tende ad immergersi nei fatti, a ricostruirli e a trame una « morale » come molto cinema italiano postbellico intese fare; al brasiliano Nelson Pereira Dos Santos i cui film precursori, Rio 40 graus e Rio zona Norie e il successivo, e pienamente « cinemanovista », Vidas secas, sono di aperta ispirazione neorealistica; o a taluni esponenti del « cinema novo » carioca, come il « rosselliniano » Paulo Cezar Saraceni di O desafio (per non dire di Glauber Rocha e della sua esplicita ispirazione viscontiana in Barravento e in Deus e o diabo na terra do sol); agli indiani Bimal Roy (Do bigha zamin) e Mrinal Sen (soprattutto ai suoi inizi filmografìci); al senegalese Ousmane Sembene, al praghese Milos Forman, al magiaro Istvan Gaal; al greco Thodoros Anghelopoulos, il cui film d’esordio Anaparastasi, ha ancora una volta una chiara — quanto esplicita e confessa — ispirazione viscontiana; allo spagnolo Carlos Saura e a tutta la sua produzione di fine anni '50/inizio anni ’60, ai britannici Edgar Karel Reisz e Lindsay Anderson, ad alcuni film del filippino Lino Brocka, ecc. In altri termini, molta prassi formale e molte premesse teoriche di concreta ascendenza neorealistica fanno strettamente e indissolubilmente parte del « nuovo cinema » intemazionale degli anni ’60, sia pure mesco landosi, intrecciandosi e fondendosi, in una dinamica complessivamente unica, con dinamiche parziali di diversa origine: segnatamente quella che potremmo definire « francese » (è soprattutto nelle premesse teorico-cri tiche dei « Cahiers du cinema », nonché nel cinema degli esordi di Godard, Resnais, Truffaut, Rivette, Rohmer, Varda ecc.), che accentua la rottura generazionale in direzione tematica e narratologica, e solo residuamente formale; e quella che potremmo definire « americana » (è soprattutto sulle colonne di « Filmculture » che essa trova spazio nonché nel New American Cinema e nelle opere di Cassavetes, Mekas, Brakhage, Anger, Markopoulos ecc.), che punta essenzialmente a rinnovazioni linguistiche ed espressive, e solo residuamente tematiche. Va peraltro segnalato che questa piena fusione dinamica fra componenti innovative complementari e diverse è quasi esclusivamente riscontrabile nelle cinematografie dei paesi indu strialmente avanzati: a cominciare dalla stessa Francia, e più generalmente in Europa. Mentre nei paesi « in via di sviluppo » del Secondo e, più che mai, del Terzo Mondo, come già si è accennato, la componente dinamica nettamente dominante è proprio quella « italiana », ovvero neorealistica, essendo soprattutto le strumentazioni di origine — e, più che mai, quel
XVI
Sul neorealismo, oggi
l’« etica dell’estetica » che del neorealismo è fondamento irrinunciabile e primario — le più consonanti a quel fare apparire « più realtà » sullo schermo, in paesi dell’Est e dell’Ovest, del Nord e del Sud del mondo, i cui governi, a fini di potere, hanno praticato e/o imposto alle proprie cinematografìe una sistematica occlusione di realtà, una continua fuga dal reale e dalla sua potenziale esplosività. D’altronde, dalla Francia al Brasile, in questo senza distinzione fra paesi industrialmente avanzati e regioni del Terzo Mondo, nonché fra autori incomparabilmente diversi come il francese Francois Truffaut e il brasiliano Paulo Cezar Saraceni oppure l’indiano Mrinal Sen e gli italiani Paolo e Vittorio Taviani, è proprio uno dei maestri neorealistici, Roberto Rossellini, ad essere considerato tra i massimi founding fathers del nuovo cinema mondiale anni ’60: ora con riferimento alla drammatica trasparen za di Paisà — film che A. Bazin considera, accanto a Citizen Kane di Orson Welles, fra gli episodi di fondazione del cinema moderno 6 —, ora con riferimento alla spiritualistica densità di Viaggio in Italia, altro film di fondazione della modernità7. Mi è ormai accaduto più volte, e in diverse sedi, di riprendere e ribadire una formula: quella che il neorealismo perse quando vinse e vinse quando perse. Nel senso, ovviamente, che la dinamica rinnovatrice del l’avanguardia cinematografica italiana del dopoguerra perse buona parte della propria forza propulsiva e « rivoluzionaria » quando il « fiume » si espanse nel «lago», modificando sensibilmente l’« immaginario »8 di tutto il cinema italiano, incluso quello più serialmente commerciale e meno autoriale, ma depauperandosi di identità specifiche e di autenticità innovativa. Per la verità il neorealismo, soprattutto quello utopistico di marca zavattiniana, avrebbe voluto rinnovare tutto il cinema italiano: ma, non avendo un vero e proprio progetto per ottenere tale risultato, nutriva questa spinta più come astratta velleità utopistica che come concreta volontà politica. Esso vi riuscì, dunque, in qualche misura suo malgrado: proprio perché come tutte le vere avanguardie, avrebbe ambito ad un mutamento radicale e profondo non di facciata e di esterna forma. Che fu invece ciò che accadde, quando la rinascente industria cinematografica 6 Cfr. Bazin, Le realisme cinématographique, eie., pp. 23-37. 7 Una « paternità » che Roberto Rossellini non disconosceva affatto e che anzi, direttamente rinascerà poco prima di morire, quando — presidente della giuria di Cannes 1977 — si adopererà per fare assegnare il massimo premio del Palmarès ai fratelli Taviani di Padre Padrone. 8 II termine è in qualche misura improprio, che io stesso (vedi il paragrafo n. 3 del mio saggio introduttivo al presente volume) metto in discussione la perspicuità della nozione di « immaginario » [unico] attribuita alla dinamica neorealistica. Ma non ne trovo altri parimenti efficaci. Esso è dunque discorsivamente funzionale.
Sul neorealismo, oggi
XVII
italiana degli avviati anni ’50 prese ad usare i personaggi popolari, gli sfondi periferici, il parlato vernacolare, gli esterni autentici, la conflittualità quotidiana, la problematica della gente ordinaria (case, pensioni, rate, affitti, carriera, figli da educare, amori da vivere, tradimenti da nascon dere, debolezze da farsi perdonare, marachelle da far dimenticare ecc.) e i volti non divistici, non già, rossellinianamente, per raggiungere « la forma artistica della verità » mediante « la maniera documentaria di os servare e analizzare » 9, bensì unicamente per confezionare aggiornati pro dotti d’intrattenimento. Così, proprio malgrado, ripeto, il neorealismo riuscì a vincere questa sua (sotto molti aspetti non voluta, certamente non programmata) battaglia, perdendo tuttavia se stesso (che era poi la im plicita, e sotto molti aspetti inevitabile e necessaria, condizione della « vittoria »): perdendo perché aveva vinto, o vincendo perché aveva perso. D’altronde, questo fenomeno — come, anche in tale caso, mi è già accaduto di rilevare — non solo è tipico di qualsiasi movimento di avan guardia — intesa come la comunicazione della negazione della comuni cazione esistente (G. Scalia) — ma sarà la caratteristica comune di tutte le « nouvelles vagues » degli anni ’60 l0: a cominciare dalla più famosa fra tutte, quella francese, che, dopo il fatidico 1959 e le primissime stagioni degli anni ’60, prese anch’essa a riversare il « fiume » della propria innovatività nel grande « lago » del cinema parigino, trasformandosi nella nuova cinematografia transalpina e lasciando (come era accaduto ai Rossellini, ai Visconti, ai De Sica, agli Antonioni, ai Fellini, ai De Santis ecc.) che le singole personalità che agli inizi avevano collettivamente con tribuito a quella dinamica (i Truffaut, i Godard, i Resnais, i Rivette, i Rohmer, gli Chabrol, le Varda ecc.) proseguissero, ognuna per suo conto, il proprio itinerario autoriale. Anche la « nouvelle vague » francese, in somma, e sia pure mutatis mutandis, perse quando vinse e vinse quando perse. La differenza, semmai, è che — contrariamente al « nuovo cinema italiano » — il « nuovo cinema francese » aveva una decisamente maggio re progettualità produttivo-industriale e la prassi che esso fìn dall’inizio seguì fu abbondantemente meno utopisticamente palingenetica di quella neorealistica e molto più attenta alla questione dei « modi di produzio ne » H. Anche alla seconda, in ordine di tempo, fra le dinamiche di rinno vamento del cinema postbellico, quel « free cinema » che, dopo il neo realismo, aveva anch’esso anticipato le « nouvelles vagues » anni ’60, era 9 Cfr. Rossellini - Verdone, Colloquio sul neorealismo, cit. (il corsivo è nel testo). 10 Cfr. anche l’estrema conclusione del mio L. Micciché, Teoria; y poetica; sul
nuevo cine, in aa.w., Historic generai del cine, voi. xi, Madrid, Ed. Catedra, 1995. 1 * Cfr. Jean-Michel Frodon, L’àge moderne du cinéma franqais/de la nouvelle vague à nos jours, Parigi, Flammarion, 1995.
XVIII
Sul neorealismo, oggi
accaduto di perdere vincendo o di vincere perdendo. Quando, dopo la fiorescenza dei secondi anni ’50 e dei primissimi anni ’60, il cinema dei Richardson, dei Reisz e degli Anderson si era ormai affermato sugli scher mi inglesi e intemazionali, i fermenti e le effervescenze degli angry men cinematografici si erano annacquati nel cosiddetto free cinema-kitchen sink, il « free cinema del lavello da cucina », versione edulcorata e indu strializzata, delle rabbie e dei furori che avevano animato le origini del movimento ,2. Pure nel caso britannico, dunque, il « nuovo cinema » fu un’avanguardia determinante per la modernizzazione del « vecchio cine ma », ma proprio quando la sua influenza si espanse a ogni livello perse buona parte della sua iniziale forza d’urto. La precoce vittoria/sconfitta del « neorealismo cinematografico ita liano », pur rientrando nelle regole quasi fisiologiche di qualsiasi dinami ca d’avanguardia — come attesteranno, con inevitabili varianti, ma so stanziali analogie tutte le successive « ondate » di rinnovamento dei se condi anni ’50 e degli anni ’60 — creò tuttavia nell’orizzonte cinemato grafico italiano una situazione molto particolare. Adatto, come attesta anche l’eco terzomondista che esso per anni ebbe, ad una società « in via di sviluppo », lo « sguardo neorealistico » non era funzionale nei confron ti di una società a capitalismo maturo, qual è quella italiana degli anni ’60 e oltre: quando le cose non parlano più da sole, la realtà visibile non esibisce più le chiavi della propria decifrazione e la complessità dei pro blemi non lascia spazio ad alcuna evidenza e trasparenza. Tant’è che quello « sguardo » viene nei fatti abbandonato: da chi, tra i grandi autori, come Fellini, lo volge verso i fantasmi dell’interiorità; come Visconti, lo sublima nell’epica e/o nel melodramma; come Rossellini, lo muta in di dattica storica; come Antonioni, lo indirizza verso i fremiti dell’anima e le inquietudini della coscienza; e, nel cinema di genere, da chi, dopo i fasti dei « pepla » che cancellavano radicalmente il presente mediante il mi tologico, opta per le scenografie artificiose del « western », in una sorta di programmatico rifiuto a confrontarsi con il presente e con il reale; o, come gli autori della « commedia all’italiana », lo filtra attraverso la lente deformante dello sberleffo, del gesto iconoclasta, della satira incattivita; e da chi, fra i nuovi autori, lo « strania » brechtianamente, come i Taviani, o lo occulta attraverso il manierismo francesizzante, come Bertolucci, o lo estremizza in una sorta di parossismo cronachistico come il primo Olmi e il primo De Seta, o lo connota di venature macabro-grottesche come il Ferreri reduce dalla Spagna. « Abbandonato », tuttavia, si diceva: e dunque sempre in qualche modo presente, sia pure sotto specie fantasmatica.
12 Cfr. Emanuela Martini, Storia del cinema inglese (1930-1990), Venezia, Marsilio, 1991.
Sul neorealismo, oggi
XIX
Non, « superato »: ovvero consapevolmente tesaurizzato per quel che ancora di prezioso può dare, e accantonato nei vezzi e nelle scorie, e nella sua scarsa disposizione a leggere la nuova complessità del presente; « as similato », insomma, come fanno del Corvo saccente e predicatore il Totò e Ninetto di Uccellacci e uccellini. Ciò non comincerà a verificarsi, per altro senza del tutto concludersi, che nella nuovissima generazione di fine anni ’70 (penso, e valga l’esempio per tutti, al cinema di Nanni Moretti), ma il prezzo sarà quello di lasciare venire avanti una « generazione senza padri » la quale, nella consueta e fisiologica « guerra del maiale » ge nerazionale, dovendosi liberare del tutto di « padri » scomodi in quanto, a loro volta, troppo padre-dipendenti, finirà talora per rendersi volonta riamente orfana di passato, « erede del nulla » e come accecata dai ba gliori del presente. Confesso di essere stato a lungo incerto sulla ripubblicazione, in terza edizione, del presente volume. A quasi cinque lustri di distanza dal dibattito pesarese del 1974, ho avuto per molto tempo la tentazione o di un volume di studi neorealistici completamente nuovo o di una pubbli cazione che avesse più o meno la stessa scansione tematica ma richieden do a tutti gli autori del ’74/’75 un ripensamento del loro contributo: in molti casi « datato » e comunque quasi sempre legato alle circostanze storico-culturali di allora, rispetto alle quali non poche cose sono andate meglio definendosi, non pochi equivoci chiarendosi, non pochi grovigli (soprattutto ideologici) sciogliendosi. Se, dopo un ripensamento financo eccessivo, ho ceduto alle insistenze dell’editore e dei molti amici e col leghi nell’insegnamento universitario, che intendono ancora giovarsi di questo testo per un proprio corso sul neorealismo, è per due diverse e concomitanti ragioni. La prima ragione è che, a ben guardare il pur cospicuo rigoglio dell’editoria cinematografica italiana da allora a oggi, il panorama bibliografico sul neorealismo appare ancora relativamente povero. A parte la fioritura di interventi sul tema avutasi all’indomani del convegno pesarese (e dei suoi cinque volumi di studio: i « quaderni informativi » nn. 56, 57, 58 e 59 e la presente raccolta di interventi), e da me segnalati nella « Nota alla seconda edizione » del presente volume, e a parte i capitoli dedicati al neorealismo dalle Storie del Cinema (italiano e non) edite nel frattempo in Italia e all’estero — da quella di Gian Piero Brunetta a quella di Mira Liehm — i nuovi specifici apporti sulla questione del cinema italiano del dopoguerra sono rari, anche se è enormemente aumentata la documen1 * Cfr. Lino Miccichè, Gli eredi del nulla: per una critica del giovane cinema ita liano, in « Belfagor », in, maggio 1987 (e successivamente in F. Montini [a cura di], Una generazione in cinema, Venezia, Marsilio, 1988).
XX
Sul neorealismo, oggi
tazione sull’argomento (analisi di film, profili critici di autori, raccolte di critiche, memorie d’epoca, statistiche e documenti vari). Tanto che nel l’unica circostanza — dopo quella pesarese — in cui si è avuto un ampio dibattito sul Neorealismo, quella di Torino 1989, Alberto Farassino, curatore del ricco volume-catalogo sul neorealismo cinematografico italiano w, edito in occasione della manifestazione (da lui stesso animata), si è limitato ad aggiornare, alla luce del trascorso decennio la bibliografia sul tema pub blicata a suo tempo dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. E ha elencato un’ottantina di titoli, di cui circa la metà sono però dedicati ad autori e a film delle stagioni neorealistiche e non più di una ventina investono specificamente gli aspetti complessivi e generali del fenomeno: per circa metà stranieri (quasi tutti, con poche eccezioni — penso agli studi di Millicent Marcus — divulgativi delle polemiche italiane, « pesaresi » incluse, in materia), per l’altra metà italiani, alcuni con fini meramente divulgativi, altri di (spesso preziosa) documentazione; ma tutti — italiani e stranieri — lontani da una trattazione monografica del cinema neorealistico che partisse dai dati acquisiti e dalle posizioni ormai definitivamente chiarite, per « fare i conti » definitivamente, almeno in sede critica, con quel pe riodo glorioso e controverso della nostra storia cinematografica. Sicché, tutto sommato, e dopo venticinque anni (che l’apporto bibliografico ’90/ ’98 non ha arricchito molto il panorama), il contributo più significativo a fare avanzare il discorso « pesarese » sul neorealismo, appare appunto quello, documentativo e di opinioni, costituito, appunto, dal menzionato volume-catalogo di Alberto Farassino. Il quale, per altro, nel saggio più ampio, e per molti aspetti più lucido, del volume 14 15 consentiva, direttamente o indirettamente, a molti degli approdi critici «pesaresi» sul neorealismo (approdi cui egli stesso, d’altronde, aveva contribuito), affer mando semmai con maggior forza l’esistenza di una stagione d’oro neorealistica, quella ’45/’49, e di una stagione del « neorealismo.. .d’assedio » (anche chi scrive aveva parlato di uno spirito, neorealistico, di « cultura d’assedio »), e riconoscendo che l’« apparato scritto della retrospettiva pesarese era costituito in massima parte da testi teorici e critici, ancora molto validi », mentre, a suo dire, più scarsamente rappresentati « o ancora approssimativi e oggi insoddisfacenti » erano « gli studi storici o meglio di storia e geografia del neorealismo » (molti aspetti e molte storie — chiariva — che, al di là della storia dei film, delle istituzioni, degli stili « restano ancora da raccontare »). Osservazione, quest’ultima, che si può in buona parte condividere, ma rispetto alla quale, a dirla tutta, risulta carente (pur con qualche apporto significativo, anche se parziale, in questa
14 Alberto Farassino, Neorealismo. Cinema italiano 1945-1949, Torino, edt, 1989. 15 Id., Neorealismo, storia e geografia, Torino, edt, 1989, pp. 21-44.
Sul neorealismo, oggi
XXI
direzione) lo stesso volume torinese, al di là del saggio di Farassino, che appare così enunciativo di un enunciato poi insufficientemente sviluppa to, pur se taluni contributi del volume (sull’industria, sulla tecnica, sul cinecommercio, sulle professioni, sui poteri, sui saperi e sulla « quotidianità » neorealistici) possono comunque apparire illuminanti. Ma insomma, per concludere, è mai possibile che, a mezzo secolo dalla conclusione del fenomeno, non si possa ambire ad avere non più (o non più soltanto) un panorama di opinioni sfaccettate e programma ticamente parziali su autori, film c problemi ma (almeno anche) una compatta monografia unitaria che, tralasciando l’analisi dei singoli epifenomeni (le opere, gli autori, gli episodi, appunto) analizzi, e ricostruisca storicamen te, l’insieme del fenomeno, che fu certamente complesso ma altrettanto certamente unitario pur nella sua composita ricchezza? Il fatto che — al di là di coloro che vi sono costretti, diciamo così, per dovere d’ufficio, in quanto autori di una « storia del cinema (italiano) » 16 — nessuno si sia finora preso la briga di stendere un affresco unitario di quella stagione cinematografica, mettendo a partito i molti (questi sì) lavori monografici ormai esistenti su Rossellini, Zavattini, De Sica, Visconti, De Santis, Lattuada, Germi, minori e minimi, nonché le scaffalate di documentazione ormai raccolta su industria, mercato, commercio, divismo, spettatori, consumi, gusti, incassi, leggi, dibattiti, interventi, critiche degli anni ’45/’53, dalle primissime stagioni rampanti del dopoguerra agli anni della «fortezza assediata », questo vero e proprio « atto (storico-critico) mancato » non è chiaro indice che l’incapacità a « fare i conti », definitivamente, con il neorealismo non è soltanto di generazioni di cineautori ma anche di generazioni di cinecritici? Nell’attesa che qualcuno risponda concreta mente alle due domande retoriche, e forse anche a sollecitare la concreta risposta mi sembra che la pubblicazione di una terza edizione de II neorealismo cinematografico italiano, che riproponga senza correzioni e/ o variazioni tutti e trentuno i testi delle due edizioni precedenti, sia, a conti fatti più che opportuna.
16 E non entro nel merito di queste « storie » italiane e straniere: dove, manco a dirlo, c’è chi si avvicina al problema e ne rievoca le stagioni con competenza, come Brunetta nel n voi. della sua Storia del cinema italiano (Roma, 1982, pp. 19-432), cui va il merito di essere finora la migliore e la più ampia trattazione unitaria del periodo, e chi vi si avvicina con tutta la sommarietà informativa e critica dell’estraneo non documentato che ha poco visto e ancora meno letto, come il duo David BordwellKristin Thompson che, nella loro film History: An Introduction (1994), inopinatamente tradotta in italiano come Storia del cinema e dei film (Milano, Il Castoro, 1998, cfr. in particolare il n voi., pp. 70-98), abbondano in inesattezze e approssimazioni (e naturalmente non è con i due pur bravi studiosi statunitensi che bisogna prendersela, ma con il provincialismo di chi li propone a studenti e studiosi italiani).
XXII
Sul neorealismo, oggi
Vi è poi una seconda ragione a motivare la riedizione di questo libro ormai introvabile. Con trentuno saggi firmati da quaranta studiosi (cin * que sono a più mani), su un tema chiave della nostra storia culturale, Il neorealismo cinematografico italiano costituisce un capitolo non irrilevan te, e un documento oggettivamente rilevantissimo, della finora non scritta (ma da molti auspicata) « Storia della critica cinematografica italiana ». Troviamo fra gli autori almeno tre generazioni di critici, storici e studiosi: la generazione di coloro che vissero da vicino gli eventi neorealistici, come Callisto Cosulich e Carlo Lizzani, quella di coloro che presero ad operare nella critica e negli studi sul cinema tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 quando il neorealismo era già gloria passata, come Adelio Ferrero e Giorgio Tinazzi, e infine quella di coloro che, nei primi anni ’70, come Francesco Casetti e Alberto Farassino, uscivano appena dagli studi uni versitari, o, come Ellis Donda e Vito Zagarrio, dalla frequentazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, ed ebbero a Pesaro ’74 una sorta di « battesimo critico »: tre generazioni dalla cui concomitante, e neces sariamente differente, attenzione al neorealismo si confidava, evidente mente, di ottenere un più articolato discorso su un fenomeno che aveva avuto, e aveva, un diverso impatto generazionale. Inoltre fra i quaranta autori e coautori dei saggi non mancano, accanto agli studiosi di cinema, studiosi — come Saveria Chemotti, Nicoletta Misler, Gianni Scalia, An tonio Prete, Giuseppe Gatt — operanti in altri campi disciplinari, dalla letteratura all’arte: segno evidente, quest’ultimo, di come i promotori della riflessione pesarese sul neorealismo fossero convinti che, per una maggiore comprensione di un tema così rilevante, fosse assolutamente necessario uscire da ogni eccessiva rigidità specialistica e giovarsi, nei fatti, delle sinergie di quella « interdisciplinarità » che, di lì a poco, sa rebbe divenuta una formula obbligata di qualsiasi eloquio, e soprattutto di ogni vaniloquio, ma che nel caso di una dinamica culturale complessa ed espansa come il neorealismo è effettivamente condizione prima di una corretta ricostruzione storica e di una plausibile interpretazione critica. Si aggiunga che, a completare le sfaccettature del panorama studioso pesarese del ’74, fra i giovani partecipanti agli incontri, e fra gli autori dei saggi qui in volume, figurano un sociologo della cultura (Alberto Abruzzese), un semiologo (Gianfranco Bettetini) e un paio di studiosi (Paolo Bertetto e Maurizio Grande/Franco Pecori) che si aspettava des sero, furono richiesti di dare ed effettivamente dettero al dibattito un apporto eminentemente teorico: poiché era evidentemente implicito che a rendere fino ad allora approssimativo il discorso storico sul neorealismo vi fossero, da un lato, un eccesso di Ideologia (contro cui si schierarono molti fra i relatori « pesaresi », a cominciare da chi scrive) e, per conver so, dall’altro, una forte carenza di teoria sia dei fenomeni socioculturali (sociologia), sia dei fenomeni di comunicazione linguistica (semiologia),
Sul neorealismo, oggi
XXIII
sia infine di vera e propria Teoria del Cinema. Insomma, dietro i nomi dei relatori « pesaresi » del ’74, e dunque degli autori del volume che ebbe la prima edizione nel ’75, vi erano un gesto di metodologia storico critica e un gesto di politica culturale, che queste pagine attestano e documentano e che fanno parte della storia culturale, e in particolare della storia della cultura cinematografica, del nostro paese. Non fosse che per questo (in realtà è soltanto anche per questo) una terza edizione de II neorealismo cinematografico italiano sarebbe più che giustificata.
Pur a venticinque anni di distanza dagli incontri « pesaresi » del ’74, sento il dovere di ringraziare ancora una volta tutti coloro che vi lavo rarono e vi contribuirono, nei quattro volumi editi nell’occasione dalla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema [Alberto Abruzzese che curò il quaderno n. 56, Politica e cultura nel dopoguerra. Con una cronologia 1929/1964 e una antologia, pp. 178; Stefano Rulli e Sandro Petraglia, che curarono il quaderno n. 57, Il neorealismo e la critica. Materiali per una bibliografia, pp. 206; Lorenzo Quaglietti, che curò il quaderno n. 57, Il cinema italiano del dopoguerra. Leggi produzione esercizio', mentre l’anto logia Sul neorealismo. Testi e documenti (1939-1955), pp. 276, fu curata direttamente dalla Direzione della Mostra] e nel quinto, quello degli «Atti», che qui rieditiamo. E poiché sei fra i collaboratori de II neorealismo cinematografico italiano sono nel frattempo scomparsi17 è a questi amici della « camera verde » — a Maurizio, ad Adelio, a Gianni, a Marco, a Tino, a Tommaso — che dedico il presente volume.
Lino Miccichè
17 In ordine di apparizione nell’indice del libro: Maurizio Grande, Adelio Ferrero, Gianni Menon, Marco Melani, Tino Ranieri, Tommaso Chiaretti.
IL NEOREALISMO CINEMATOGRAFICO ITALIANO
NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE
Aprendo e chiudendo, quasi tre anni fa, il saggio introduttivo alla prima edizione di questo volume sottolineavo l’esigenza di « fare i conti con il neorealismo » e di « ricostruire l’itinerario » nel convincimen to — ovvio, se si vuole, ma, dati i tempi, mai sufficientemente ribadi to — della necessità di volgerci indietro, senza furenti iconoclastie e aproblematiche mitologie, a capire ciò che eravamo per meglio intendere ciò che siamo e più concretamente operare verso ciò che dovremmo essere. In occasione di questa riedizione de II neorealismo cinemato grafico italiano mi sembra un doveroso atto di sincerità riconoscere che quell’auspicio è stato, se non del tutto vano, quanto meno ec cessivamente ottimistico. Dalla Mostra di Pesaro del ’74, che appunto al neorealismo fu dedicata con una retrospettiva e un convegno di cui questo volume riunisce le relazioni e comunicazioni, sono passati circa quattro anni. E da tempo sono esauriti i quattro « quaderni informativi », densi di studi e documenti, che in quella occasione la Mostra pesarese editò: Politica e cultura nel dopoguerra (n. 56), Il neorealismo e la critica (n. 57), Il cinema italiano nel dopoguerra: leggi produzione distribuzione esercizio (n. 58) e Sul neorealismo (n. 59), un’antologia di scritti, in terventi, dibattiti a proposito del neorealismo che, per quanto edita in una tiratura superiore agli altri «quaderni», si esaurì per prima. Se si aggiunge a quei « quaderni » la prima edizione del presente volume, si arriva a circa diecimila copie di scritti e/o antologie di scritti sul neorealismo cinematografico che sono state diffuse: una quantità che altrove — in Francia, in usa, o in Gran Bretagna, ad esempio — potrebbe apparire appena soddisfacente ma che, in Italia, appare sotto molti aspetti cospicua. Eppure non mi sembra che queste oltre mille pagine di opinioni, punti di vista, messe in questione e conferme neorealistiche abbiano prodotto quanto avrebbero potuto e dovuto. Dal ’74 a oggi molta acqua è passata sotto i ponti, anche del cinema. Basti accennare in questa sede — e a voler tacere del manifestarsi della crisi mondiale del « Cinema » tradizionale e di quella italiana che assom
2
Il neorealismo cinematografico italiano
ma la generale patologia del « Cinema » alla particolare patologia delle strutture cinematografiche nazionali — al « boom » editoriale che al meno quantitativamente, ci ha fatto passare, in tre anni, da uno degli ultimi a uno dei primi posti al mondo quanto a pubblicazioni cine matografiche in volume (mentre resta critica, e anzi lo è forse più di prima, la situazione delle riviste specializzate). Tanto che è divenuto ormai quasi impossibile, c in ogni caso non tristemente facile come un tempo, tenere dietro alle varie collane di studi cinematografici, agli studi e ai « pamphlet », alle raccolte saggistiche e alle monografie (che sovente escono, contemporaneamente, dedicate ad uno stesso autore e in re ciproca concorrenza). E ciò a prescindere dai dati qualitativi, certamente assai meno confortanti di quelli quantitativi. Ma in tanta fiorescenza di studi sul cinema non si può dire che la « questione » neorealista abbia fatto molti passi avanti rispetto a dove l’avevamo lasciata con Pesaro ’74. Se sul piano generale, e dunque di un neorealismo non soltanto cinematografico, dobbiamo registrare utili antologie come quelle di Gian Carlo Ferretti (Introduzione al neorealismo, Editori Riuniti, Roma, 1974), o raccolte di scritti come quella di Carlo Muscetta (Realismo Neorealismo Controrealismo, Garzanti, Milano, 1976), sul piano specifico del cinema abbiamo anche qui alcune antologie e raccolte — come quella degli scritti di Umberto Barbaro, riuniti da Gian Piero Brunetta (Neorealismo e realismo, 2 voli., Editori Riuniti, Roma 1976) e la riproposta di una delle « trincee » neorealistiche degli avviati anni cinquanta, fatta da Guido Aristarco (Antologia di « Cinema Nuo vo», Guaraldi, Firenze, 1975) — ma nessun studio che riconsideri a fondo il problema, non potendo certamente essere considerati tali i due volumi di Canziani (Alfonso Canziani e Cristina Bragaglia, La stagione neorealistica, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bologna, 1976; Alfonso Canziani, Gli anni del neorealismo. La Nuova Italia, Firenze, 1977) che si propongono ambedue, immaginiamo, fini sbrigativamente didattici (oltre tutto il secondo ripubblica la prima parte del primo; mentre la seconda parte del primo è sostituita, nel secondo, da « ap pendici » documentarie, fìlmografiche e bibliografiche); il più recente volumetto di Verdone (Mario Verdone, Il cinema neorealista, Celebes Editore, Palermo, 1977) che, per altro, al di là del titolo, spazia, in 127 pagine, oltretutto doviziosamente illustrate, dagli anni trenta agli anni settanta e che dunque — è anche qui immaginabile — ha solo propositi divulgativi verso i totalmente ignari del cinema italiano; il « pamphlet » a quattro mani su Matarazzo, dove, in realtà, al di là del titolo (Neorealismo d’appendice, Guaraldi, Rimini-Firenze, 1976) Adria no Aprà e Claudio Carabba si impegnano seriamente a discutere su una questione assai poco seria come quella della profonda genialità, o meno, dell’autore di Catene; o il volume di Oldrini (Guido Oldrini,
Nota alla feconda edizione
3
Problemi di teoria e di storia del cinema, Guida Editori, Napoli, 1976), dove vengono ripubblicati scritti dell'autore già noti, fra cui alcuni sul neorealismo, variamente editi fra il ’62 e il ’73. Un insieme di titoli, insomma, fra cui l’unico che sia arricchito da un ripensamento con « il senno del poi » è la già citata Antologia di « Cinema Nuovo », nella cui ampia introduzione (non a caso intitolata: Del senno del poi son piene le fosse) Aristarco si sofferma anche sulla « questione » neorealistica, ma più che altro riconsidera la propria posizione e la « battaglia per il realismo» di «Cinema Nuovo» negli anni cinquanta (con l’ovvio limite, rispetto alla accennata « questione », che la rivista di Aristarco inizia le pubblicazioni nel dicembre 1952, quando del neorealismo si sono già avute anche le estreme propaggini). Non si può dire nemmeno che da Pesaro ’74 (e dai documenti successivi di quella iniziativa) siano uscite polemiche particolarmente feconde. Neppure in sede recensiva dove, a parte i quasi unanimi consensi ed elogi (di cui rendo qui grazie ai recensori anche a nome di tutti i coautori del volume), v’è soltanto da registrare un dissenso di poche righe su un quotidiano provinciale del nord e una stizzosa nota polemica su un mensile gesuitico, nonché qualche sporadico intervento sparso, nel periodo immediatamente successivo allo svolgimento della rassegna pesarese. Tutto questo per dire che, a colmare il vuoto critico sul neorealismo esistente prima di Pesaro ’74 — nonché a superare le false alternative già accennate fra le inutili iconoclastie e le pigre mitologie — non ci sono altro, anche oggi, che le pubblicazioni (ormai solo reperibili in biblioteca) di Pesaro ’74 e il presente volume che dell’incontro pesarese pubblica le relazioni e le comunicazioni in una nuova edizione, corretta in parte dagli stessi autori. Si potrà certamente discutere la trentina di saggi e interventi qui pubblicati e che rimettono altrettanti punti di vista, e metodologie, e giudizi, inevitabilmente diversi fra loro e con i quali lo stesso curatore del volume è, non di rado, in radicale di saccordo. Né altrimenti poteva essere poiché allora (a Pesaro ’74) come oggi (a quattro anni da quell’incontro) non si tratta di deliberare, all’unanimità o a maggioranza, ciò che il neorealismo fu o non fu; bensì unicamente di produrre un materiale conoscitivo sufficientemente ampio e articolato da fare sì che ciascun studioso — secondo la propria metodologia e il proprio giudizio — possa contribuire a restaurare dalle molte deformazioni un campo d’indagine fondamentale per capire il nostro cinema di ieri e di oggi, assumendosi personalmente la respon sabilità della propria analisi e della propria opinione. Sbaglia chi crede sempre necessario procedere guardinghi come in terreni perigliosamente minati, sussurrarsi a mezza voce parole d’ordine e di riconoscimento avendo paura anche delle ombre, serrare sempre
4
Il neorealismo cinematografico italiano
le rade fila come se dietro ogni albero ci fosse un cecchino e in ogni fosso un guastatore. Il rischio minimo, in questi casi, è di finire come quel soldato nipponico scoperto pochi anni fa nelle foreste del Borneo che, ridotto a pelle e ossa ma ancora armato e bellicoso, oliava quo tidianamente il suo fucile convinto che, dietro le frasche, ci fosse il nemico. Non sapeva che la guerra, quella storica, era finita. O meglio che si era spostata altrove. E non avveniva più a fucilate. Quando, a forza, lo riportarono in patria, nell’odierna Tokyo, finì in una clinica per malattie mentali e lì rimase per sempre. Non capiva nulla della realtà di oggi. Sapeva solo fare la guerra. Anzi sapeva fare solo quella guerra. E sbaglia, per converso, chi confida nell’urlo scomposto, nell’agi tazione parossistica contro i « valori costituiti », nella sistematica « guer ra del maiale » contro i « padri », nella quotidiana sostituzione delle « vecchie glorie » con i fondi di magazzino elevati a nuove glorie, nella camaraderie culturale con il primo collezionista di farfalle che incrocia la strada, nella definizione lapidaria delle nuove bandiere e nella « alternatività » dei disvalori di un tempo rispetto ai valori ormai non più (o non più miticamente) creduti. Il rischio minimo, in questi altri casi, è che un così folkloristico « anticonformista » venga invitato a cenacolo, e perfino retribuito, fra le spese di rappresentanza, un po’ per far vedere che la ditta è aggiornata alle ultime novità del mercato, un poco perché, presi a piccole dosi, gli iconoclasti sono divertenti. Come sempre, in un mondo oppresso dalla Ragione (quella dell’Aufklarung adomiana), gli irragionevoli confessi. Mentre il rischio più corrente è di fare, magari in nome di una « nuova critica », da ufficio stampa di un mercato che, ansioso solo di vendite e di profitti, non crede ai propri occhi di fronte alla prospettiva di tirare fuori vecchie scarpe seriali e di presentarle, con così doviziosamente colta illustrazione, come modelli di a suo tempo sottovalutata bellezza e di non appariscente ma per turbante finezza. Senza dire che, a forza di sostenere senza battere ciglio (e anzi con superciliosa sicurezza) che, poniamo, non è La terra trema il film che contrassegna l’ultima stagione degli anni cinquanta, come banalmente credono taluni, ma Catene, oppure che i due film alternativi del 1954 non furono Senso e La strada, come immaginarono in quei tempi oscuri i poveri di spirito, ma Senso e Casa Ricordi, a forza di frequentare questo modo goliardico di rivisitare il passato, si finisce per contrabbandare — magari perfino in aule universitarie — una contrapposizione fra la scuola di Lukàcs c la « scuola » dell’aw. Mo naco, o fra l’estetica di Della Volpe c l’« estetica » del comm. Italo Gemini; e per scoprire che il maggior teorico cinematografico del Novecento è Adolph Zukor, al quale andrebbe benissimo di vedere così ratificato, da Via col vento a Guerre stellari (via Catene / Tormento / Core 'tigrato} l’ideologema che « il pubblico ha sempre ragione ».
Nota alla seconda edizione
5
Lo spirito con cui, alla fine del ’75, proponemmo gli « atti » di Pesaro ’74 sul neorealismo intendeva appunto sottrarsi a questo tipo di alternativa fra la mitologia conservatrice, all’insegna dell’arroccamento difensivo, e l’iconoclastia schizoide, all’insegna del luddismo culturale. È ancora in questo spirito che riproponiamo quegli « atti » in questa nuova edizione de II neorealismo cinematografico italiano. Persuasi che in anni in cui ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, nelle grandi come nelle piccole cose, a noi spetti quella, circoscritta ma precisa, di non credere mai nei numi né in coloro che li infrangono e di ritenere che non nelle sdegnose o rumorose solitudini (o nei dialoghi all’interno della chapelle) ci sia da fare affidamento, ma nel l’incontro — e se necessario nello scontro, perché culturalmente fondato — fra diverse opinioni e metodologie. E convinti, nel caso concreto, che il vuoto critica sulla « questione » neorealistica esistente nel ’74, non sia stato ancora in nulla colmato; e che pertanto il materiale de Il neorealismo cinematografico italiano (congiuntamente a quello edito a suo tempo dalla mostra pesarese) costituisca, a tutt’oggi, l’unico tentativo organico di riaprire un dialogo, e un dibattito, su un cinema di ieri da cui dipende molto cinema di oggi.
Lino Miccichè
PER UNA VERIFICA DEL NEOREALISMO di Lino Miccichè
1. Fare i conti con il neorealismo è, credo, un’esigenza sentita da molti. Non da tutti, ovviamente, poiché non mancano coloro che reputano di averli già fatti e ritengono che quanto a proposito di neorealismo si disse e si scrisse nei tardi anni ’50 sia sufficiente e valga ancora oggi a collocare storicamente quell’esperienza. Non fosse che per questo l’esigenza va ribadita e il problema affrontato. Anche perché, in assenza d’una cor retta valutazione di quel fenomeno, vanno inevitabilmente prendendo piede le provvisorie iconoclastie di « quanti oggi tendono a liquidare quegli anni con petulanza, credendo che le cose avrebbero potuto andare molto diversamente da come andarono» all’equivoco del mito, con i suoi numi aureolati e collocati in un immoto Olimpo, succede l’equivoco inverso, con statue magari immeritoriamente scheggiate e nuovi idoli dai piedi d’argilla eretti al loro posto. Ciò accade anche (e, s’intende, non soltanto) per un problema che è metodologico e generazionale insieme. Lungo gli anni ’50 e in parte gli anni ’60, ha avuto netta prevalenza e maggiore udienza una genera zione di critici cinematografici formatasi parallelamente all’insorgere del fenomeno neorealistico: circondata da schiere ostili che spesso passavano dalle scaramucce di trincea ai veri e propri assalti (usando il potere economico dei meccanismi finanziari, il potere amministrativo degli strumenti censori, il potere persuasivo di una pubblicistica in buona parte asservita), essa è stata troppo sovente costretta ad una « cultura di assedio » perché ciò non avesse conseguenze, anche in commistione con la « politica culturale » dei partiti di sinistra di cui essa era al contempo protagonista e vittima. Non raramente, e talora anche nei suoi esempi migliori, questa critica si specializzò nel « parlar d’altro » a proposito delle opere, che venivano ridotte a mero pretesto di discorsi più generali sulla storia e sul mondo. Né il fenomeno fu solo italiano. Si pensi ai due film « neorealistici » di Germi, In nome della legge e II cammino della 1 Italo Calvino, Ma ne sapevamo tutti poco, in « Corriere della sera » del 13 ottobre 1974.
8
Il neorealismo cinematografico italiano
speranza e a come l’equivoco su di essi — considerati campioni di progressismo neorealistico — sia nato, sì, in Italia (dove pochi, come Carlo Doglio, osarono muovere obiezioni di fondo) ma abbia avuto larga eco all’estero, perfino in un critico assai poco conformista nei giudizi sul neorealismo come il Bazin2*5. Oppure si pensi a un film volonteroso e mediocre, come Vivere in pace di Luigi Zampa, apprezzato da molti come una « summa » neorealistica e come tale superpremiato in Italia e al l’estero. Oppure ancora si pensi a quanto la pubblicistica neorealistica caricò di responsabilità il Castellani di Due soldi di speranza nel farlo progenitore dello sfaldamento bozzettistico dell’ispirazione neorealistica, quando invece tale linea — di cui un Castellani, in realtà da sempre assai poco « neorealistico », fu al massimo uno dei molti portabandiera — aveva radici assai più profonde e antiche, visibili (a saper vedere) anche in taluni capolavori neorealistici apparentemente « puri » come Roma città aperta o Ladri di biciclette. Forse non a caso questa generazione di critici cinematografici — cui spettarono responsabilità e doveri che, se non giustificano, certamente spiegano gli « errori » e le distorsioni — non ha saputo poi produrre, ad esperienza neorealistica conclusa, una « storia » del cinema italiano neorealistico (o semplicemente postbellico) al di là di quella del Lizzani che è in realtà una « storia del cinema italiano » dal punto di vista neorealistico e quindi più un documento del fenomeno che un documentato punto di vista critico sul fenomeno. Lungo la seconda metà degli anni ’60, invece, è andata prendendo piede una nuova generazione di critici cinematografici formatasi successivamen te alla « verifica dei poteri » di metà decennio, alla crisi delle avanguardie e delle sperimentazioni dei primi anni ’60 e parallelamente all’immissione di nuove metodologie analitiche, come quelle strutturalistiche: avendo davanti a sé l’eredità non più credibile della generazione neorealistica (che sovente continuava ad applicare a una realtà diversa — e certo non meno guerreggiata, ma assai più sottilmente e tortuosamente — le vecchie metodologie della « cultura d’assedio » e della « politica culturale » che ne era stata al contempo sintomo e prodotto), essa si è troppo meccanicamen te immersa in un’operazione di azzeramento metodologico per non incor rere nel vizio opposto a quello dell’antico vezzo di « parlar d’altro » a pro 2 Cfr. André Bazin, Qu’estce que le cinéma?. Vol. IV. Une esthétique de la réalité: le néorealisme, Parigi, Editions du Cherf, 1959, pp. 65 e ss. Il giudizio di Bazin su 11 cammino della speranza è in realtà temperato da una corposa serie di riserve, ma è purtuttavia sempre positivo. Il capitolo in questione è omesso nell’edizione italiana, Che cosa è il cinema?, a cura di Adriano Apra, Firenze, Garzanti, 1973. 5 Carlo Lizzani, Il cinema italiano, Firenze, Parenti, 1953. Ripubblicata nel ’61, aggiornata, come Storia del cinema italiano 1895-1961, Firenze, Parenti [e nuova mente ripubblicata, con ulteriore aggiornamento, come C. Lizzani, Il cinema ita liano 1895-1979, 2 voli., Editori Riuniti, Roma, i ed. 1979 (Nota alla ni ed. 1999)].
Per una verifica del neorealismo
9
posilo delle opere. Non raramente, e talora anche nei suoi esempi migliori, questa critica si è specializzata nel creare una sorta di tunnel, senza sfiata toi e senza uscita, dentro l’opera: nell’ipotesi, davvero infondata, che le leggi formali e strutturali che la costituiscono siano autonome o irrelate dal mondo e dalla storia e stabilendo, al massimo, collegamenti diacronici non già con la Storia, quella degli uomini, ma con la « storia », quella del cinema, e fi nendo per confondere il « profilmico » con la realtà e, quel che è peggio, la realtà con il « profilmico ». E, certo non a caso, neppure da questa genera zione di critici — cui spettano meriti di « mise en question » che, anche in questo, se non giustificano, certamente spiegano gli « errori » e le deformazioni — è finora venuta una « storia » del neorealismo e tanto meno del cinema italiano postbellico in generale \ essendo evidente che non basta scavare cunicoli dentro le opere per giungere a una sistemazione storica del più largo discorso di cui esse sono parte. Il fatto è che né appiattirsi sull’« opera » e ignorare tutto quell’* altro » da essa che pure è condizione della sua esistenza, né parlare dell’« altro » e ridurre l’opera a una sorta di occasionale incidente, può portare a un’ope razione di rigorosa critica e di fondata storiografia. « Esercitare la critica — scriveva Fortini nel ’60 — svolgere il discorso critico vuol dire allora potere parlare di tutto a proposito di una concreta e determinata occasio ne »5; vuol dire essere colui che « discorre sui rapporti reali fra gli uomini, la società e la storia loro, a proposito e in occasione della metafora di quei rapporti che le opere... sono »4 56; vuol dire essere diverso dallo specialista e dal filologo e porsi come mediatore « non già fra le opere e il pubblico di lettori ma fra le specializzazioni e le attività particolari, le “scienze” parti colari, da un lato, e l’autore e il suo pubblico dall’altro »7; vuol dire, in somma, prendere le opere in un primo momento vietandosi di sapere sul mondo più di quanto l’autore in esse ne dica, ma subito dopo operando una « verifica [...] della provenienza loro, cioè della legittimità del manda to sociale e storico in nome del quale chiedono il diritto di testimoniare »8. 4 Va comunque aggiunto che questa generazione di critici ha indubbiamente la giustificazione aggiuntiva, rispetto all’altra generazione, di operare da assai meno tempo. Con l’occasione: credo di dover precisare, a scanso di equivoci, che (se non altro per ragioni di età) non appartengo né alla prima né alla seconda delle due generazioni, ma mi trovo nella (s)comoda posizione intermedia. [Naturalmente, quando facevo tale osservazione non era ancora uscita la i edizione in 2 voli. (Editori Riuniti, Roma, i voi. 1979, n voi. 1982) della Storia del cinema italiano di Gian Piero Brunetta, successivamente riedita, aggiornata e accresciuta, in 4 voli., nel 1993, per lo stesso editore (Nota alla ni ed. 1999)]. 5 In « Nuovi argomenti », n. 44/45, 1960. E successivamente in Verifica dei poteri, Milano, 11 saggiatore, 1965, p. 50. 6 In Verifica dei poteri, op. cit., p. 12. 7 Ivi, p. 50. 8 Ivi, p. 59.
10
Il neorealismo cinematografico italiano
D’altronde, più che mai, nel caso del cinema italiano parlare di ieri signi fica cercare di capire meglio l’oggi. Certo non è letteralmente vero che, come ha scritto recentemente la « Pravda », Ceravamo tanto amati di Ettore Scola sia « un altro ramo verde dello stesso albero » ncorealistico, o può apparire discutibile quanto è stato da taluno affermato a proposito del Diario di un maestro di De Seta, come di un’opera che applica, a più di venti anni di di stanza, alcuni presupposti di poetica neorealistica. Ma nell’un caso e nell’altro il neorealismo è comunque un riferimento obbligato come lo è, in generale, per quasi tutto il cinema italiano odierno, nelle sue glorie più alte e nei suoi più riprovevoli abomini, poiché, per analogia, per contrasto o per distacco è sul neorealismo che si fonda la realtà attuale della nostra cinematografia. D’altronde tutto il nostro presente, non solo quello cinematografico, è fondato su quel recente passato: « Sono persuaso—scrive Fortini in pie ni anni ’60 — che non è possibile decifrare il senso del presente se non si criticano i termini ideologici e politici entro i quali si svolge la discussione del periodo 1945-1953 ». Soltanto, aggiunge sempre Fortini, « quando si chiarirà fino a qual punto la debolezza intellettuale degli usciti dal fascismo [...] abbia cospirato obbiettivamente con talune debolezze morali e con la politica culturale stalinista, polemizzando contro quest’ultima da destra e cioè da posizioni radical-liberali invece che da posizioni marxiste, allora sarà possibile farsi un’idea meno mitica di certi tentativi, come quelli del neorealismo cinematografico, del “Politecnico”, ecc. Ma già fin d’ora si può affermare che l’orizzonte del dopoguerra — dapprima spontaneamente e poi artificialmente — fu come bloccato dall’immediato passato, cioè dal fascismo e dall’estensione accecante di rovine e massacri »910 . Riaprire dunque il discorso sul neorealismo cinematografico italiano senza mitiche riverenze e senza irruenze iconoclaste — rifiutando cioè al contempo la petulanza dissacrante e la sacralità codificata — significa disvelare e definire tutta una serie di realtà dietro il cui occultamento stanno molti degli equivoci attuali e delle odierne « impasses » del nostro cinema e del discorso attorno ad esso. Non certo a caso tale esigenza è andata sempre più affermandosi a partire dalla seconda metà degli anni ’60; quando, ad esempio, due autori di punta come Paolo e Vittorio Taviani parlavano dei loro Sovversivi come di un’opera il cui « leitmotiv » c « avere le mani libere per ricominciare a cercare » e dove il « funerale di Togliatti ... è il funerale del padre (il padre come mito, come padre naturale, come momento storico, come neorealismo) » ,0; quando, cioè, 9 ivi, p. 114. 10 II corsivo è mio. Cfr. Entretien avec Paolo e Vittorio Taviani, in « Cahiers du cinema », n. 228, marzo/aprile 1971; ora in Cinema e utopia: i fratelli Taviani, ovvero il significato dell'esagerazione, a cura della Cooperativa Nuovi Quaderni, Parma, 1974.
Per una verifica del neorealismo
11
nel cinema italiano si ebbe, dopo la crisi di metà decennio, un tentativo di fondare un « nuovo cinema », che corrispondeva d’altro canto a quello, più generale, di fondare una « nuova politica », e che si contrapponeva alla fìorescenza cinematografica d’inizio decennio (di abbondante deri vazione « neorealistica »: si pensi, a tacer d’altri, agli esordi di Olmi e di De Seta), più o meno come la « nuova sinistra » intendeva contrap porsi alle pratiche riformistiche cullate dalla sinistra tradizionale nello stesso periodo. Quella « impresa luttuosa, ma anche liberatrice » ebbe in realtà scarso seguito, poiché attorno allo scoglio del « ’68 » “ se ne incanalarono altrimenti, e se ne esaurirono, le spinte. Sicché, nelle sta gioni del riflusso, a partire da quella ’69/70 in cui prese avvio il cosid detto « cinema civile », fu nuovamente il riesumato « impegno » neorealistico ad essere il punto di riferimento, sia pure mediato e filtrato dalle nuove furbizie consumistiche dell’industria cinematografica. Tanto che, se si vuole capire gli equivoci (e, perché no?, anche i meriti) di questo filone cinematografico in cui nelle stagioni postsessantottesche hanno operato molti cineasti italiani, è appunto al neorealismo — e a ciò che esso fu, al di là di quanto apparve — che bisogna rifarsi. Tuttavia la pietra — quella dell’« impresa luttuosa, ma anche liberatrice » — era ormai lanciata e nel corso degli anni ’60, come in più recenti stagioni, non ne mancarono tracce e impronte, anche se discontinue, anche se sovente faticose a cogliersi e, soprattutto, a leggersi. Da qui la consape volezza — nel campo letterario e artistico già anticipata da qualche anno — che un discorso cinematografico nuovo potesse sorgere, soltanto una volta, fatti davvero i conti con l’esperienza neorealistica e compiuta nei suoi confronti una operazione sotto tutti gli aspetti simile a quella dei protagonisti del pasoliniano Uccellacci e uccellini: liberarsi del « mae stro » mangiandolo, cioè appropriandosene e andando oltre. Da qui la riapertura di un discorso che, come quello avviato a Pesaro ’74, intende essere un contributo a quell’opportuna opera di appropriazione.
2. In verità, proprio l’esperienza di Pesaro '74 è valsa a chiarire un equivoco di non poca rilevanza che, se non superato, rischierà ancora a lungo di pesare su qualsiasi ripensamento e qualsivoglia « sistemazio ne » dell’esperienza neorealistica. Ed è che accettare meccanicamente in sede storiografica il « terminus a quo » ricorrente nelle esegesi neorealistiche anche più accorte significa in realtà basare ogni « revisione » su una visione obsoleta del fenomeno, i cui termini storiografici furono definiti in epoca neorealistica non soltanto all’insegna di quell’autodifensiva n Cfr. Lino Micciché, Il cinema italiano degli anni '60, Venezia, Marsilio, 1975 * [19955 (Cinema italiano: gli anni '60 e oltre) pp. 296 e sgg. (Nota alla ni ed., 1999)].
12
Il neorealismo cinematografico italiano
« cultura d’assedio » che, come si è detto, la caratterizzò, ma anche, ovviamente, senza la necessaria distanziazione dagli eventi. Quella linea storiografica, come è noto, puntava a stabilire una sorta di « filo rosso » attraverso la storia del cinema italiano e le esperienze realistiche (o supposte tali) che l’avevano caratterizzata fino agli anni ’40: da Assunta Spina e Sperduti nel buio fino al documentarismo del De Robertis di Uomini sul fondo, attraverso le esperienze blasettiane di Sole e 1860. La stagione della svolta — preannunciata dal « lungo viaggio » compiuto dal gruppo di « Cinema », vecchia scric, c contrappuntata dalla fronda teorica di Barbaro e degli ambienti del Centro Sperimentale di Cinematografìa — sarebbe stata il ’42/43 con la trilogia Quattro passi fra le nuvole (Blasetti), Ossessione (Visconti), I bambini guardano (De Sica). Su tale protostoria, a partire da Roma città aperta, si sarebbe avviata la breve storia felice del neorealismo cinematografico italiano l2, la quale dunque avrebbe svi * luppato e ampliato, trasformandoli in « movimento », sintomi e tendenze preesistenti; non diversamente da quanto il Bcrnari di « Tre operai », il Bilenchi de « Il capofabbrica », il Vittorini di « Conversazione in Sicilia » e il Pavese di « Paesi tuoi » avrebbero preceduto e preannunciato il neorealismo letterario; e l’« espressionismo romano » degli anni ’30, i « sei pittori » di Torino, i giovani di « Corrente » avrebbero preceduto e preannunciato il neorealismo artistico. Orbene, tali indicazioni di protostoria neorealistica possono essere considerate nel complesso (nel dettaglio non tutte) esatte, soltanto a condizione di non essere considerate esclusive e soprattutto a patto che si respinga la tesi aprioristica (in esse implicita) della quasi assoluta estraneità tra il cinema italiano sonoro del periodo fascista e il cinema neorealistico; del quale si privilegia unicamente l’aspetto di rottura con la tradizione, ignorando totalmente quello — certamente segreto e indubbiamente minore, ma purtuttavia esistente e tutt’altro che privo di implicazioni e conseguenze — di continuità con essa. Questa tesi — portata avanti all’insegna di una condanna globale del cinema italiano 1929/1943 e dell’affermazione (in taluni approcci storiografici esplicita e in tutti gli altri implicita) che non un fotogramma si salva dei circa 720 film italiani sonori del periodo, ad eccezione dei « preannunci realistici » e di due personalità come Camerini e Blasetti — ha condotto a talune vistose distorsioni, indubbiamente sintomatiche 12 Su tale posizione sono in sostanza attestate le uniche due « storie » del cinema italiano: quella, già citata del Lizzani, e il compendio del Gromo (Mario Gromo, Cinema italiano (1903-1933), Milano, Mondadori, 1954), nonché le monografie di Castello (Giulio Cesare Castello, Il cinema neorealista, Torino, Edizione Radio Italiana, 1956) e di Ferrara (Giuseppe Ferrara, Il nuovo cinema italiano, Firenze, Lemonier, 1957).
Per una verifica del neorealismo
13
di come i presupposti e i dati su cui essa si fonda debbano essere riverificati (ammesso che siano mai stati verificati), il più scientificamente possibile. Basti pensare quanto a lungo si è taciuto, o insufficientemente parlato, del fatto che la legge cinematografica del ’49 — generalmente conside rata una conquista sia pure soltanto parziale del movimento neorealistico e del fronte per la difesa del cinema italiano che aveva prodotto nel comizio di Piazza del Popolo la propria massima manifestazione di unità e di forza — aveva tutte le proprie premesse nei meccanismi legislativi ed economici della legislazione fascista sul cinema, meccanismi che essa riprendeva con appena qualche aggiornamento n. Basti pensare quanto a lungo si è parlato, invece, di 1860 di Blasetti come di un film trasgressivo nei confronti dell’ideologia e della storiografìa fasciste, nel quale « forse inopinatamente, la retorica si incrinava, e la pas sione nazionale dell’unità veniva fuori nella sua natura più vera, come lotta di popolo anelante alla libertà e all’unità della propria terra » ,4; igno rando come l’interpretazione del Risorgimento riflessa in quel film di Blasetti sia invece, per altro assai sottilmente, del tutto consona (in populismo, antiparlamentarismo, antipoliticismo, antiborghesismo) a un punto di vi sta fascista, e per poterlo meglio ignorare, occultando che il finale del film non mostrava i campi di battaglia garibaldini dell’800, ma la Roma mussoliniana degli anni ’30 dove giovani ginnasti fascisti salutavano romanamente un gruppo di commossi ex garibaldini, a dimostrazione della continuità fra « rivoluzione nazionale » e « rivoluzione fascista » *5. Purtroppo qualsiasi nuova verifica di ciò che fu la realtà cinemato grafica italiana del periodo 1929/1943 dispone ormai di un terreno di ricerca limitato: non molto superiore, quanto a copie di film disponibili a circa 4/7 dei film prodotti in quel periodo e per di più con una netta prevalenza di quelli che dalla storiografia e dalla critica immediatamente postbelliche furono ritenuti i « valori » del cinema italiano sotto il fa scismo; dimodoché ogni operazione di contestualizzazione dei singoli film, di riesame di quei « valori » e di eventuale individuazione di altri « valori » fino ad oggi negletti o ignorati o negati, appare non ardua ma impossibile. Tuttavia, pur senza nutrire particolari illusioni sulla possiB Come ha dimostrato Quaglietti. Cfr. Lorenzo Quaglietti, Il cinema italiano del dopoguerra / leggi produzione esercizio, Pesaro, Quaderno informativo n. 58 della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, 2/19 settembre 1974. [Cfr. anche Lorenzo Quaglietti, Storia economico-polilica del cinema italiano 1945-1980, Editori Riuniti, Roma, 1980 (Nota alla in ed., 1999)]. 14 In Carlo Lizzani, op. cit., p. 58. 15 Questo finale, certamente significativo dell’ideologia del film, è stato sem plicemente eliminato dalle edizioni del 1860 messe in circolazione a partire dal l’avviato dopoguerra. Ma, quel che è più grave, viene ignorato da tutta la storiografia cinematografica neorealistica.
14
Il neorealismo cinematografico italiano
bilica di un’operazione filologica globale, il cammino di chi intenda comprendere appieno la realtà del neorealismo, nella sua grandezza e nei suoi limiti (ma, soprattutto, nel suo sfaldarsi bozzettistico e piccolo borghese dopo le iniziali stagioni degli anni ’50), deve prendere avvio dal cinema degli anni ’30, pur se è poi sul cinema successivo al 1945 che dovrà concentrarsi l’attenzione; anche in questo caso, sottoponendo a nuova verifica i « valori » da tempo consacrati e i « disvalori » da tempo dissacrati. Non si tratta insomma di modificare il «terminus a quo» del neorealismo, che resta indiscutibilmente coincidente con la nuova sta gione storica dell’Italia liberata dal fascismo. Si tratta però di non de finire mediante tale termine il campo di ricerca, applicando invece alla ricerca stessa il principio marxengelsiano che « nella società borghese... il passato domina sul presente» e cercando di individuare e definire quale fu e quanto pesò, nell’ambito del cinema, il « passato » preneorealistico sul « presente » neorealistico dell’Italia del dopoguerra. Questa attenzione agli aspetti diacronici del neorealismo cinemato grafico, ovvero al suo donde e al suo dove non mitici ma effettivi, è condizione per il chiarimento dei molti equivoci, generali e particolari, esistenti attorno ad esso. Risulterà in altri termini chiaro, ad esempio, che l’immagine del neorealismo come di una rivoluzione cinematografica mancata, a causa della repressione operata dal moderatismo centrista fin dall’immediato dopoguerra e soprattutto fra il ’48 ed il ’52, è un’immagine ampiamente infondata, non perché la repressione non ci sia stata, ma perché è in questo caso applicabile — con analogia certamente non casuale — quanto Guido Guazza osserva a proposito della Resistenza: « Non può essere rivoluzione mancata ciò che non è mai stato rivoluzione »16. Risulteranno altresì chiari, per fare un altro esempio, certi « tradi menti » del neorealismo come quello fosselliniano a partire da Germania anno zero, il quale altro non fu che la prosecuzione di un discorso ca ratterizzato dal pessimismo storico e dall’ansia verso il metafisico che già avevano contraddistinto la produzione rosselliniana preneorealistica, da La nave bianca (dove questo dato è assai « in nuce ») a Duomo dalla croce e a Desiderio / Scalo Merci / Rinuncia (dove il dato è assai più evidente). Avere ignorato, o sottovalutato, l’emergenza di questo discorso nel Rossellini preneorealistico ha portato a sottovalutarne la sopravvivenza — assai netta, a saper leggere — nel tipo di adesione che Rossellini dava alla lotta resistenziale e alla tragedia dell’occupazione e della guerra in Roma città aperta e in Paisà-, film in cui risulta saliente il motivo dell’unità antifa scista come unità morale e spirituale (« Volevate la sua anima — dice 16 In Guido Guazza, « La politica della Resistenza italiana » in Italia 1943-1945 / La ricostruzione, a cura di Stuart J. Wolff, Bari, Laterza, 1974, p. 33.
Per una verifica del neorealismo
15
don Pietro ai nazisti torturatori di Manfredi — non avete avuto che il suo corpo ») e della dualità fascismo/antifascismo come contrasto tra Male e Bene, in un orizzonte dove la torva concretezza della Storia ha inquinato la serenità dei semplici che aspirano alle assolutezze dello Spirito (l’episodio del convento di Paisà, vero e proprio preannuncio dell’« ideologia » di Francesco, giullare di Dio), e nel quale è la morte in quanto martirio (quella di D. Pietro e di Manfredi, come quella della ragazza siciliana e dei partigiani polesani) a dare il senso di un comune riscatto nell’eternità. Alla luce di questi dati —tutti, si intende, da ve rificare analiticamente — risulta, insomma, chiaro che il suicidio di Edmund — con il quale, secondo buona parte della critica neorealistica, prende avvio la fase « spiritualistica » di Roberto Rossellini (quella, per inten derci, del « tradimento » al neorealismo) — è profondamente collegato con le morti dei protagonisti dei precedenti film rosselliniani, da quella del cappellano militare e del soldato russo ne L’uomo dalla croce a quella del militante comunista e del prete in Roma città aperta, dal suicidio della protagonista di Desiderio alle morti di Paisà. Si arriva, cioè, a scoprire che l’autore del primo film neorealistico (Roma città aperta) e di uno dei capolavori della produzione neorealistica (Paisà), lungi dall’essere al centro di quella « ideologia » neorealistica di cui fu per tre anni considerato il simbolo per antonomasia, si mosse in realtà — e al di là delle apparenze — collateralmente ad essa o meglio in una coincidenza con essa che non andò oltre l’unanimismo delle primissime stagioni postbelliche quando le varie componenti dell’« ideologia della Resistenza » convissero, fati cosamente ma unitariamente, all’interno della nascente « ideologia della ricostruzione ». Ma al di là del caso Rossellini — che è per altro certamente uno degli esempi più probanti della necessità di un esame diacronico del cinema postbellico italiano nelle sue inevitabili connessioni con il « pri ma » preneorealistico e il « dopo » postneorealistico — molti altri aspetti del neorealismo sono destinati a restare oscuri, o peggio ad essere distorti o male intesi, in assenza di un percorso critico che prenda avvio dal cinema degli anni ’30 e in presenza, invece, della immagine mitica con segnataci su quel periodo dalla storiografia neorealistica. Difficile, ad esempio, intendere la svolta dcsichiana successiva a Umberto D senza rifarsi alla produzione del primo De Sica, da Rose scarlatte a l bambini ci guardano, e alle sue connessioni con il camerinismo; arduo capire l’origine e la funzione di un film come Miracolo a Milano in piena fiorescenza neorealistica senza tenere conto della produzione zavattiniana, letteraria e cinematografica, nei secondi anni ’30; impossi bile comprendere il dapprima lento e poi precipitoso sfaldarsi bozzettistico dell’ispirazione neorealistica ad avviati anni ’50 senza stabilire le sue connessioni con la commedia piccolo borghese degli anni ’30. E non si
Il neorealismo cinematografico italiano
16
tratta che di alcuni esempi: i primi che vengono in mente fra i tanti possibili. La realtà è che attorno alla questione del neorealismo cinematogra fico italiano ha giocato un altro fattore. Ed è che, mentre al cinema neorealistico spetta una sorta di primato culturale fra le varie pratiche artistiche dell’immediato dopoguerra l7, il cinema italiano preneorealistico era indubbiamente un fenomeno di retroguardia nella cultura italiana del periodo almeno rispetto ai fermenti, sporadici se si vuole ma salienti, che si avevano, poniamo, nella produzione pittorica o nella produzione let teraria: risultato questo non soltanto dell’evidente maggiore controllo che il regime esercitava su un mezzo di comunicazione di massa come il cinema, e dell’owiamente maggiore dipendenza che il cinema ha sia dalla struttura sociale che dalla propria specifica struttura produttiva, ma anche del fatto che, dopo la grande crisi cinematografica degli anni ’20, il cinema italiano visse proprio sotto il fascismo la propria adolescenza, portandosi poi dietro, nell’età adulta — vale a dire dal neorealismo ad oggi — tutte le tare di una gioventù malvissuta. Il fatto è che, quando nel ’45 si ebbe la fiorescenza neorealistica che pose il cinema in prima linea nella cultura postbellica, fu fin troppo naturale andare a ricercare le origini di quel fiorire in semine avvenute altrove che non nella sottocultura cinematografica del periodo fascista. L’operazione era certamente in parte giusta — se non altro perché, ri spetto al cinema del periodo fascista, il neorealismo ebbe anche un aspetto niente affatto secondario di « disconoscimento della paternità » e di ri cerca di paternità putative, cinematografiche (ma non italiane) e non (letterarie soprattutto). Ma venne assolutizzata con un paradosso solo apparentemente storicistico (in realtà assai poco dialettico), il cui risul tato fu di fare apparire poco meno che angelica la nascita del neorealismo e certamente diabolica la sua fine, laddove e l’una e l’altra avevano — e non potevano non avere — spiegazioni anche (e s’intende, non sol tanto) nella diacronia del cinema italiano e all’interno dello stesso feno meno neorealistico che nacque già con le stimmate della propria morte. Orbene ripercorrere, in vista del neorealismo — cioè della prima età adulta del nostro cinema e anche della sua finora più vigorosa sta gione — la realtà del cinema del periodo fascista non significa unica mente andare scoprendo, o verificando, o definendo altri « preannunci » neorealistici: come la scoperta del paesaggio italiano (poniamo ne La peccatrice di Palermi), le eco del melodramma veristico (poniamo in Fossa degli angeli di Carlo Ludoviso Bragaglia), l’uso del dialetto (poniamo in Via delle Cinque Lune di Chiarini), i primi accenti di « realismo » po 17 Tanto da portare Pavese al suo celebre giudizio su De Sica « maggiore
narratore italiano del dopoguerra ».
Per una verifica del neorealismo
17
polare (poniamo in Treno popolare di Matar azzo), la proposta di una rilettura attuale di plot classici e popolari (poniamo in Cavalleria rusticana di Palermi), le riprese in ambienti reali (poniamo in La tavola dei poveri di Blasetti); preannunci (questi e altri: se ne sono esemplificati solo al cuni) che allargano alquanto la serie dei presentimenti neorealistici. Significa anche immergersi in una disamina attenta e puntigliosa di quella che fu la « corporazione » cinematografica del cinema fascista per documentare che — con alcuni defunti in meno e alcune nuove leve in più — essa rimase abbondantemente immutata e che, anche tralasciando i più noti casi di Blasetti e Camerini, taluni fra i registi più attivi del periodo preneorealistico continuarono ad essere attivissimi nel periodo neorealistico e successivamente: come Mario Bonnard (22 film fino al ’43; 10 fino al ’53; 9 successivamente), Carlo Loduvico Bragaglia (29 film fino al ’43; 17 fino al ’53; 17 successivamente), Guido Brignone (35 film dal ’30 al ’44; 13 dal ’46 al ’53; 6 successivamente), Carlo Campogalliani (14 film dal ’30 al ’43; 6 dal ’45 al ’53; 14 successivamente), Carmine Gallone (18 film dal ’35 al ’43; 14 fino al ’53; 10 successivamente), Augusto Genina (6 film dal ’36 al ’42; 4 dal ’49 al ’53), Camillo Mastrocinque (17 film fino al ’43; 12 dal ’46 al ’53; 35 successivamente), Raffaello Matarazzo (15 film dal ’33 al ’43; 9 dal ’46 al ’53; 12 successivamente), Francesco De Robertis (5 film tra il ’41 e il ’45; 7 dal ’45 al ’53; 4 successivamente), Pietro Francisci (numerosi documentari e un lungometraggio a soggetto dal ’34 al ’43; 6 lungometraggi a soggetto dal ’46 al ’53; 8 successivamente), Gennaro Righelli (35 film dal ’30 al ’43 e solo 3 dal ’45 al ’48, essendo sopravvenuta la morte nel ’49), Giorgio Simonelli (13 film dal ’33 al ’43; 14 dal ’46 al ’53; una quarantina successivamente), Mario Soldati (9 film dal ’38 al ’43; 14 dal ’46 al ’53; 6 successivamente), fino a quel Mario Mattoli che, durante gli anni finali del fascismo, aveva simboleggiato a giudizio della critica più attenta una sorta di malattia nazionale del cinema italiano (il « mattolismo », appun to) e che, avendo realizzato 32 film tra il '34 e il ’43, ne realizzerà poi una sessantina nel dopoguerra fra cui 26 (e tra essi, significativamente un buon « remake » di Assunta Spina) nel periodo « neorealistico » 1945/ 1953; e fino a quell’Aldo De Benedetti (per non citare che uno fra i tanti sceneggiatori attivi « prima » e « dopo ») che, essendo stato il soggettista e sceneggiatore principe della commedia borghese e piccolo borghese degli anni ’30 (coinvolto, direttamente o indirettamente, in una cinquan tina di film, fra il ’32, anno in cui sceneggia Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini, e il ’42/43, quando scrive i copioni di Quattro passi fra le nuvole di Blasetti, di Un garibaldino al convento di Vittorio De Sica e di altri dodici film), continuerà, senza soluzione di continuità, nel dopoguerra, essendo coinvolto, direttamente o indirettamente, in 24 film tra il ’45 ed il ’53. Dati, questi, assai significativi poiché a un così cospicuo
18
// neorealismo cinematografico italiano
proseguimento di attività delle vecchie leve che avevano operato sotto il fascismo non corrispose che un numero proporzionalmente esiguo di nuove leve, di cineasti cioè che iniziassero un’attività cinematografica nell’Italia liberata o che l’avessero iniziata nella stagione ’42/’43 in cui si colloca il « terminus ad qucm » del cinema del fascismo, prima della « no man s land » del ’43/45. Parliamo di cineasti come Antonioni (esor dio 1950), Comencini (esordio 1948), Germi (esordio 1946), Gora (esor dio 1950), Lizzani (esordio 1951), De Santis (esordio 1948), Emmer (esordio 1950), Fellini (esordio 1950), Risi (esordio 1952), Pietrangeli (esordio 1953) che si aggiunsero a quelli che avevano esordito nelle ultime bieche stagioni del fascismo, come — a parte i già citati De Sica e Rossellini — Renato Castellani, Alberto Lattuada, Gianni Franciolini, Marcello Paglieto, Aldo Vergano, Luchino Visconti, Luigi Zampa. Ripercorrere la realtà del cinema sotto il fascismo significa, comun que, soprattutto verificare, tenendo presente la sintomaticità di dati come quelli accennati, ma basandosi essenzialmente su una rilettura non ideologistica e non aprioristica dei film, quale fu in realtà l’« immaginario cinematografico » del film italiano sotto il fascismo e quale fu l’« immagi nario cinematografico » del film italiano postbellico; nonché fino a che punto il primo riflesse (e dove invece trasgredì) l’ideologia del fascismo, e fino a che punto il secondo riflesse (e dove invece, andando oltre o restando indietro, trasgredì) l’ideologia dell’antifascismo. È d’altronde in questo senso che il ruolo della trilogia Quattro passi tra le nuvole / Ossessione /1 bambini ci guardano è essenziale, anche se lievemente diverso da quello solitamente attribuitole. Pur nella diversità dei risultati e delle ispirazioni, i tre film hanno in comune non già (anzi niente affatto) elementi di preludio al neorealismo, bensì elementi di rottura con il cinema italiano sonoro dell’epoca, rispetto al quale inter rompono la linea di continuità che lo aveva caratterizzato dal ’29/30 in poi. Essi costituiscono in altri termini il confine, la linea di spartizione, il punto di separazione tra quelli che più sopra definivamo l’« immaginario cinematografico » preneorealistico e l’« immaginario cinematografico » neorealistico. Ma più con gli occhi volti al passato da negare che al futuro da fondare. In Quattro passi tra le nuvole Blasetti sottolineava il contrasto fra la dura e grigia realtà dello status piccolo borghese (la sequenza iniziale e la sequenza finale del film; gli smorti interni, i rumori stridenti, i gesti ripetuti, l’irritazione dei due coniugi) e la sua « reverie » idillico agreste connotata, per altro, all’insegna dell’atto mancato e dell’impotenza (l’irrealizzato rapporto tra il commesso viaggiatore Gino Cervi e la ra gazza madre Adriana Benetti) e racchiusa, come una sognante parentesi, fra le due sequenze « realistiche » d’apertura e di chiusura. Ne 1 bambini ci guardano De Sica faceva irrompere il dramma nel-.
Per una verifica del neorealismo
19
l’ambiente caro al sorridente bozzetto piccolo borghese di derivazione cameriniana (del quale De Sica stesso si era mostrato l’erede nei suoi primi film) e, descrivendo il mondo degli adulti come prigioniero della propria irresponsabilità e del proprio conformismo e incrinato nel pro prio maggiore caposaldo, la famiglia, delineava nel personaggio di Pricò la solitudine delle nuove generazioni (che poi sarà il « Leitmotiv » di Sciuscià). In Ossessione Visconti dava spazio all’occultato, orchestrando con duttile articolazione moderna una finzione in cui tutti i topoi dell’imma ginario cinematografico degli anni ’30 venivano assunti e rovesciati: il sesso, da eterea sublimazione spirituale, in densa carnalità fisiologica; la famiglia, da cellula della « socialità », in disumana prigionia; il popolo, da interprete della coralità beatificante, in aggregato di aspre solitudini individuali; il mondo contadino, da centro dell’unità, in centro della frantumazione; il paesaggio, da fondale idilliaco, in scenario torbido; il delitto, da infrazione negata, in negazione portata in primo piano; la vita, da luogo dell’appagamento, in luogo del desiderio: un film insomma sul « tutto in discussione », che procede a una sorta di azzeramento totale, con una funzione prevalentemente distruttiva nei confronti di tutti gli stereotipi precedenti e in questo senso assai più radicale che non quelle rappresentate dai film di Blasetti e di De Sica *8. Più sottile, ma anch’essa certamente nuova e « azzerante », la po lemica di Gente del Po di Michelangelo Antonioni, che a buon diritto (e non solo per una questione di date) può essere inserito, accanto alla trilogia I bambini ci guardano / Quattro passi tra le nuvole / Ossessione, fra i film che, nella stagione ’42/43 18 19 contrassegnano una sorta di 25 luglio del cinema italiano. Qui l’opera di azzeramento e di distruzione dei preesistenti stereotipi era condotta esclusivamente a livello del pae saggio, come preannunciava d’altronde uno scritto significativo che il giovane regista aveva pubblicato nel ’3920. In Gente del Po Antonioni rovesciava, infatti, l’uso « scenografico » del paesaggio reintegrando l’uomo nell’ambiente, nella natura, nel mistero del suo essere tra le cose: il paesaggio, insomma, non come « un’accozzaglia d’elementi esteriori e decorativi » ma come « un insieme di elementi morali e psicologici »; qualcosa di simile, ma più per complementare antitesi che per analogia, all’uso del paesaggio nel viscontiano Ossessione. 18 Cfr. Lino Miccichè, Visconti e il neorealismo, u ed., Marsilio, Venezia 1998,
pp. 27-72. [Nota alla in ed., 19991. 19 Anche se, come è noto, il documentario di Antonioni, pur girato nel ’43,
non vide la luce che nel ’47. 20 Cfr. Michelangelo Antonioni, Per un film sul fiume Po, in « Cinema », v.s.
n. 68, 25 aprile 1939. Le citazioni seguenti sono tratte da questo articolo.
20
// neorealismo cinematografico italiano
In tutti questi film, come si è accennato, il riferimento, sia pure tenuto presente soltanto come dato da trasgredire, fu il cinema italiano preesistente, senza il quale non solo il discorso « indiretto » di Blasetti e quello « moderato » di De Sica ma lo stesso discorso « frontale » di Visconti risulterebbero incomprensibili. Mentre nessuno dei tre (lieve mente diverso semmai il discorso a proposito del documentario di Antonioni) prelude, in senso proprio, a quello che sarà di li a poco il cinema neorealistico, qualsiasi cosa si intenda per esso. Proprio per questo, forse una delle chiavi per meglio penetrare il rapporto tra il cinema italiano preneorealistico e il cinema italiano neorealistico sta in quelle opere e nella loro duplice caratteristica: quella intrinseca di punto di rottura del cinema sotto il fascismo e quella storica di punto di apertura verso il cinema del dopofascismo. Tuttavia, se è proprio questa duplicità che dà loro un’effettiva funzione di « ponte » tra questi due momenti del cinema italiano, il carattere specifico dei tre film è soprattutto quello di una negazione del passato, dell’introduzione nell’« immaginario cine matografico » preesistente di elementi critici {Quattro passi fra le nuvole} o trasgressivi (I bambini ci guardano} o addirittura di negazione e ribaltamento totali {Ossessione}, senza che peraltro in alcuno dei tre sia possibile individuare elementi di fondazione di quello che sarà l’« im maginario cinematografico » neorealistico.
3. Ma vi fu, un vero e proprio « immaginario cinematografico » del neorealismo? La domanda che può apparire a prima vista del tutto pe regrina, risulterà forse meno oziosa (e più chiara) di fronte a un’ipotesi che qui si enuncia come proposta di una analisi e di una rilevazione tutta ancora da compiere: l’ipotesi, cioè, che il cinema neorealistico non abbia avuto in realtà un proprio « immaginario » identificabile e netto ma che, con soltanto apparente paradosso, su di esso si fondino tutte le basi dell’« immaginario cinematografico » postneorealistico, vale a dire di quel periodo complessivo del cinema italiano che — con vari assestamenti, spostamenti e ripensamenti — va dalla morte del neorealismo ad oggi. In altri termini, il neorealismo non riuscì (non fece in tempo) a fondare se stesso, trasformandosi da « atteggiamento morale » in « atteggiamento estetico », ma riuscì a fondare quella negazione (e quel prolungamento) di sé che è il cinema italiano postneorealistico, dove la norma (cioè una « regola » con « eccezioni »} è stata l’abbandono di quell’« atteggiamento morale » e l’assunzione a « modello estetico » di alcune figure (stilistiche, tecniche, ambientali, ecc.) della produzione propriamente neorealistica. Questa ipotesi di lavoro non è puramente teorica, ma viene suggerita da alcuni dati estremamente significativi. Generalmente si opera una certa confusione fra « neorealismo » e « cinema italiano del dopoguerra », implicando fra il primo e il secondo
Per una verifica del neorealismo
21
una identificazione che da tutti i punti di vista appare impropria, soprat tutto se si conserva al termine « neorealismo » il significato che esso ebbe (e ha) nell’accezione più classica. La realtà è che, nel periodo che va dal 1945 al 1953, vennero realizzati in Italia 822 lungometraggi e che il « neorealismo » classico ebbe tra essi una posizione del tutto minoritaria. Basti pensare che in quei nove anni i registi della « vecchia guardia » più sopra citati (Blasetti, Bonnard, Bragaglia, Brignone, Camerini, Campogalliani, Gallone, Genina, Mastrocinque, Matarazzo, De Robertis, Francisci, Righelli, Simonelli, Soldati, Mattoli: vale a dire soltanto alcuni tra i più attivi cineasti del cinema sotto il fascismo) realizzarono 169 lungometraggi; mentre nello stesso periodo i registi della « nouvelle vague » neorealistica (non solo De Sica, Rossellini, Visconti, Castellani, Lattuada, Franciolini, Paglieto, Vergano, Zampa — già attivi nelle ultime stagioni del cinema sotto il fascismo — ma anche gli esordienti del dopoguerra come Antonioni, Comencini, Germi, Gora, Lizzani, De Santis, Emmer, Fellini, Risi, Pietrangeli: vale a dire quasi tutti gli autori solitamente identificati in qualche modo come « neorealisti ») non ne realizzarono che 90. E, se è vero che fra i 169 film di quella vecchia ondata non mancarono taluni tentativi di approccio in qualche modo neorealistico, (basti pensare a Un giorno nella vita di Blasetti, a Molti sogni per le strade di Camerini a Cielo sulla palude di Genina), è però altrettanto vero che, fra i 90 film della nuova ondata, non pochi si discostarono notevolmente dal nucleo centrale dell’ispirazione neorealistica, anche nella sua acce zione più larga (basti pensare a 11 delitto di Giovanni Episcopo di Lattuada, a Processo alla città di Zampa, oltreché al Rossellini successivo a Ger mania anno zero e agli esordi di Antonioni e di Fellini). Né limitandosi ai 224 film prodotti nel periodo 1945/48 — vale a dire alle stagioni di maggiore fioritura neorealistica — la proporzione appare diversa. Tanto che l’identificazione del « cinema italiano del dopoguerra » con il « neorealismo »21 o appare del tutto arbitraria o comporta un’accezione completamente diversa dal termine di « neorealismo ». Un altro ordine di dati riguarda le statistiche degli incassi e le graduatorie commerciali. A parte il caso di Roma città aperta, che con 162 milioni di in casso ebbe il primo posto nella classifica della stagione cinematografica 1945/ 21 Tale identificazione non fu soltanto opera dei « neorealisti ». Si veda, ad esempio, Il neorealismo italiano. Quaderni della Mostra Internazionale d’Arte Ci nematografica di Venezia, 1951. Qui, dopo un saggio di G. L. Rondi, che si apre affermando che « la storia del cinema italiano del dopoguerra — la storia cioè del migliore cinema italiano — è la storia di quel movimento estetico ed umano che, impropriamente, taluni teorizzatori hanno chiamato neorealismo », si ha un’appen dice filmografìca, a cura di G. Carancini, che raccoglie tutti i film italiani tra il 1945 e il 1951, sia pure con l’avvertenza che essa comprende «non soltanto quelli detti neorealisti ».
22
Il neorealismo cinematografico italiano
1946 (e un ampio successo di critica: il che smentisce dunque, doppiamen te, quell’aura da « Nemo propheta in patria » con cui Rossellini e i rosselliniani hanno sempre voluto circondarsi), pochi tra i film neorealistici entrano fra i maggiori successi stagionali del periodo 1945/1953: anzi, se si esclude Paisà (nono classificato nella stagione ’46/47 con oltre 100 milioni), In nome della legge (terzo classificato nella stagione ’48/49, con oltre 400 milioni), Ladri di biciclette (undicesimo nella stagione ’48/49 con oltre 250 milioni) e Riso amaro (quinto nella stagione *49/50 con quasi 450 milioni), praticamente nessuno. Mentre veri e propri disastri furono capolavori come La terra trema, Sciuscià, Germania anno zero che assieme a Miracolo a Mila no, L’amore, Caccia tragica, Il cielo è rosso, Roma ore 11, Achtung Banditi!, Umberto D, Bellissima, e altri (ora famosi) titoli neorealistici, occuparono gli ultimi posti nelle classifiche di « gradimento » dell’epoca. Questa realtà appare tanto più significativa se contrapposta ai nomi e ai titoli che in quelle stagioni occuparono la vetta delle classifiche degli incas si, attestando dunque il maggiore « gradimento » del pubblico. Nel 1946 Aquila nera di Riccardo Preda, Genoveffa diBrabante di Primo Zeglio, Avanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone, Furia di Goffredo Alessandrini. Nel 1947 Come persi la guerra di Carlo Borghesi© (con Erminio Macario), O.K. John di Ugo Fasano e Gianni d’Erasmo, La figlia del capitano di Mario Ca merini. Nel 1948 Fifa e Arena di Mario Mattoli (con Totò e Isa Barzizza), Natalealcampo 119 di Pietro Francisci, L’eroe della strada di Carlo Borghesie, Il diavolo bianco di Nunzio Malasomma. Nel 1949 La sepolta viva di Guido Brignone, Fabiola di Alessandro Blasetti, prima del già citato terzo posto di In nome della legge e del quarto de Ipompieri di Viggiù di Mario Mattoli. Nel 1950, accanto a due invasioni di campo dalla Francia (le coproduzioni Gli ultimi giorni di Pompei, supervisione, cioè regia mascherata, di Marcel L’Herbier e Domani è troppo tardi di Leonide Moguy), Catene di Raffaello Matarazzo e II Brigante Musolino di Mario Camerini. Nel 19511figli di nes suno e Tormento di Raffaello Matarazzo, seguiti da Trieste mia di Mario Costa e da Enrico Caruso di Giacomo Gentilomo. Nel 1952 (a parte il Don Camillo di J. Duvivier, Anna di Alberto Lattuada, Totò a colori di Steno, Canzoni di mezzo secolo di Domenico Paolella, Core ’ngrato di J. Duvivier) il « boom » di Pane amore e fantasia di Luigi Comencini che, nella stagione ’53/54, su pera di oltre 450 milioni Giuseppe Verdi di Raffaello Matarazzo seguito a sua volta da Puccini di Carmine Gallone, Perdonami di Mario Costa e Aida di Clemente Fracassi22. Questi dati non solo « danno la misura esatta del fal 22 Nelle indicazioni dei film di successo talune differenze rispetto ad altre « classifiche » esistenti, derivano dal fatto che qui (salvo diversa indicazione) si è preso in considerazione, per maggiore comodità, l’anno solare, laddove è prevalente l’uso di considerare la « stagione cinematografica » che va dal settembre di un anno
all’agosto dell’anno successivo.
Per una verifica del neorealismo
23
limento dell’operazione neorealistica nel suo punto programmatico più am bizioso e delicato: la volontà di indurre un mutamento radicale nei rappor ti fra cinema e pubblico, quali si esplicano negli spettacoli strutturati indu strialmente »2i; confermano altresì come la « chiave di volta » del nostro cinema postbellico non possa essere ricercata in quei film neorealistici che ne costituirono l’aristocrazia culturale24. Ciò che comunque tali dati attestano con inequivoca evidenza è che una corretta storia, non si dice del cinema ita liano del dopoguerra, ma anche soltanto del neorealismo non può essere fatta che tenendo conto del contesto cinematografico in cui la produzione si in serì, cioè quello di un cinema dove, « mutatis mutandis », tutte o quasi le malattie della cinematografia italiana sotto il fascismo continuarono a esistere e dove il grosso dell*« offerta » cinematografica (pur con diversi — e spes so appariscenti—assestamenti di tono, di linguaggio e di repertorio tematico) proseguì secondo una logica che era, indiscutibilmente, quella della conti nuità. Ciò muta radicalmente la prospettiva storiografica in cui molta esegetica neorealistica si è finora mossa: il neorealismo cinematografico italiano non fu la realtà brevemente felice del cinema italiano postbellico, combattuta e distrutta dalla restaurazione moderata del centrismo; il neorealismo cinema tografico italiano fu invece, fin dall’inizio, un episodio ricco di trasgressività25 rispetto alle tendenze generali dell’offerta e della domanda cinematografi ca dell’epoca, ma produttivamente assai circoscritto e merceologicamente del tutto marginale, anche se culturalmente vistoso. La restaurazione mode rata non fece che accelerare il processo di emarginazione, giocando non tanto, o non soltanto, sui meccanismi direttamente repressivi di cui disponeva, quanto sulla stessa reazione di rigetto di un « mercato », cioè di una « società » trasformata in « mercato », dove al di là dei paramenti esterni, poco era cam biato e che continuava, quindi, ad amare gli stessi cantastorie — e le stesse 2 ) In Vittorio Spinazzola, Cinema e pubblico / Lo spettacolo filmico in Italia 1945-1965, Milano, Bompiani, 1974, pp. 11-12. Il libro di Spinazzola è un’eccel lente analisi socioeconomica del cinema italiano postbellico, e, in tale ambito, anche uno dei pochi seri tentativi di ripensamento del neorealismo. 24 Cfr. Callisto Cosulich, Le battaglie delle idee, in « Cinema Nuovo », n. 98, 15 gennaio 1957. In questo articolo Cosulich, dopo aver riportato ed esaminato gli incassi delle prime dieci stagioni cinematografiche del dopoguerra, ne fa « di scendere due conseguenze: 1) Ogni film ha una propria storia, è un prototipo, anche se all’apparenza sembra un prodotto in serie. Di conseguenza bisogna andare assai cauti nelle generalizzazioni. 2) La chiave di volta del nostro cinema, mi sembra la si possa trovare in un esame accurato non tanto dei dieci o quindici film di Visconti, De Sica e Rossellini, quanto dei film popolari, dai napoletani ai veneziani, da quelli di Matarazzo a quelli di Brignone e Mario Costa». 25 Almeno nelle sue espressioni migliori, poiché nel complesso — tenendo cioè conto dei minori e dei minimi, la cui trasgressione era spesso soltanto esterna e corrispondeva piuttosto ad una semplice sostituzione di « contenuti » — fu invece ambiguo. Ed ebbe in questa sua ambiguità una delle ragioni della sconfitta.
24
Il neorealismo cinematografico italiano
storie—che l’avevano deliziata negli anni del fascismo prima del ciclone della guerra. Di qui, come si accennava, l’ipotesi che il neorealismo abbia vinto pro prio quando ha perso (nelle iniziali stagioni degli anni ’50) e, viceversa, che abbia perso quando ha vinto quella che indubbiamente fu una vittoria di Pirro. Singolarmente, infatti, il primo grande successo di pubblico della « vague » neorealistica, dopo Roma città aperta, è quel Pane amore e fanta sia di Luigi Comencini che riducendo a bozzetto l’ispirazione popolare neorealistica (e dunque negandone il presupposto estetico fondamentale), depurandola di ogni afflato ideologico (e dunque negandone il presuppo sto etico fondamentale) ed eliminandone ogni aspirazione al mutamento (e dunque negandone il presupposto politico fondamentale) porta per la pri ma volta l’immaginario neorealistico—così riciclato, sintetizzato e unificato — a livello di immaginario di massa. La sconfìtta della vecchia guardia del cinema sotto il fascismo, c il tramonto definitivo dell’« immaginario cine matografico » che l’aveva caratterizzato, cominciano proprio qui e vengo no completati nel corso degli anni ’50 ad opera del filone che va dalla serie dei Pane amore e... a quella dei Poveri ma belli e derivati. Dove cioè il neorealismo fallisce, vince invece quella sua forma ba starda che pure è il sintomo principale e più appariscente del suo falli mento. Naturalmente, la sconfìtta del vecchio cinema, più che una sosti tuzione (culturale) è una successione (industriale), in questo del tutto omologa a quanto andava verificandosi nella società civile. Come poteva d’altronde non corrispondere alla pratica politica dell’ottundimento una pratica cinematografica che non fosse anch’essa grigiamente, e magari fìnanco allegramente, ottusa? Trionfò così, fìliato direttamente dal neorealismo sia pure come un fi glio degenere, una sorta di gigante disossato, un cinema piccoloborghese, che si cullava sulla contraddizione addolcendola di acquiescente sorriso. « In una società progredita — scrive Marx nella lettera ad Annenkov — il pic colo borghese è necessariamente, per la sua stessa posizione, socialista da un lato ed economista dall’altro; cioè egli è abbagliato dalla magnificenza del la grande borghesia e simpatizza con le miserie del popolo. Interiormente si lusinga di essere imparziale e di avere trovato il giusto equilibrio che — egli pretende—è qualcosa di diverso dalla mediocrità. Un piccolo borghese di questo tipo divinizza la contraddizione perché la contraddizione è la base stessa della sua esistenza. Egli stesso non è altro che una contraddizione in atto ». Ebbene il cinema degli anni ’50, con i suoi legami, distorti ma preci si, con il neorealismo e al contempo con la sua negazione/surrogazione del vecchio « immaginario cinematografico » formatosi negli anni ’30, fu il por tatore — anch’esso « imparziale », « equilibrato » (e « mediocre ») — di quella ideologia: finito il rimescolamento di carte, ai vecchi film della vec-. chia piccola borghesia succedevano i nuovi film della nuova piccola borghe
Per una verifica del neorealismo
25
sia. Il cinema dell’illusione, cioè il neorealismo, aveva (de)generato il cine ma della restaurazione.
4. Questa ipotesi comporta automaticamente altre ipotesi. Prima fra tut te quella che il neorealismo fosse in realtà nato con questa vocazione a (de)generare, sempreché per neorealismo si intenda, come è giusto in tale caso intendere, non tanto e non soltanto i film che così furono etichettati, ma il dibattito che si ebbe sul movimento, la sua appartenenza ideologica all’antifascismo ciellenistico, la gestione che se ne attuò in sede di « politi ca culturale », le battaglie cinematografiche che si fecero in suo nome, il modo con cui esso si iscrisse nella pratica politica dei partiti democratici, l’atteg giamento che la critica cinematografica (anche quella « neorealistica ») adottò nei suoi confronti, la coscienza di sé che esso ebbe; e così via. Ma, per fermarci un attimo soltanto sui film, certo è che, viste oggi, con il comodo vantaggio del « senno di poi » (e quindi senza neppure un barlume di quel tono iconoclasta con cui taluni giovani turchi della cinefilia nostra na danno soltanto prova di scarso storicismo), talune etichettature di allo ra appaiono davvero imperscrutabili. « Scrutando » ad esempio tra quei 90 film realizzati dalla « vague » neorealistica, e di cui più sopra si è detto, è agevole accorgersi che all’interno dell’etichetta « Neorealismo », disinvol tamente applicata, convivevano mille anime e posizioni radicalmente opposte, che poi, ulteriormente perseguite nel corso degli anni ’50 e oltre, hanno ri velato (destando talora immotivati stupori) la loro antitetica inconciliabilità. Se è neorealistico Umberto D—dove, per dirla con le parole dello sceneg giatore, « il fatto analitico è assai più evidente » e dove, più che altrove, si ha la sparizione dell’evento, la rarefazione del plot, la riproduzione della durata reale, l’eliminazione totale dell’eccezionale e dell’eroico, l’esaltazione del « banale » come « infinitamente ricco » — perché mai sarebbe neorealistico In nome della legge, dove, nel ritmo narrativo, nel taglio di mon taggio, nella definizione dei personaggi, nell’enunciazione del conflitto, nella scelta ambientale, si recupera a tutto spiano i modelli della fiction cinema tografica sul West fino a fame, appunto, un « western siculo », che soltan to in questa chiave (non certo come film di denuncia della mafia poiché, paradossalmente, e certo involontariamente, si tratta di un film « mafioso ») può essere (assai relativamente) apprezzato? E, se è neorealistico Paisà — che è un film sulla dialettica morte/vita, sulla eternità dell’attimo, sull’ano nimo morire nella Storia, fondato tutto sull’abolizione dello iato fra realtà e rappresentazione in una continua, immediata, drammatica adesione alle cose—perché mai sarebbe neorealistico Vivere in pace, che infioretta idilli agresti e bozzetti strapaesani in una atmosfera da tavoletta pacifista condi ta di perbenismo vanamente qualunquistico? E se è neorealistico A more in città — dove l’unico vero teorico del neorealismo, Cesare Zavattini, realiz za, sia pure per delega, le proprie teorie sul pedinamento del personaggio,
26
Il neorealismo cinematografico italiano
sulla cinepresa nel « luogo del delitto », contro l'invenzione soggettistica, contro lo spettacolo, per la ricostruzione del fatto di cronaca, per l’abolizione della « grammatica filmica »—in che senso sarebbe neorealista un film (un capolavoro, per altro) come La terra trema, dove tutto è « vero » non già perché tutto è « reale » ma, paradossalmente, perché tutto è « falso », essendo il « vero » viscontiano raggiunto mediante un’altissima finzione di realtà che esclude ogni meccanico rispecchiamento, ogni appiattimento sull’accadu to, ogni identificazione sul « così come è »26 ? Altri esempi certamente potrebbero essere fatti. E c’è davvero da du bitare che reggano a un’analisi anche solo minimamente approfondita le pre tese etichettature neorealistiche del Castellani di Miofiglio professore, àìSotto il sole di Roma e di È primavera, film che sono tutti l’inequivoco preludio di quel Due soldi di speranza, che era tanto (cioè tanto poco) neorealistico quanto gli altri precedenti film dell’autore; oppure la cittadinanza neorealistica di un melodramma itinerante come II cammino della speranza di Germi per non dire de La città si difende de La presidentessa e de II bri gante di Tacca del lupo che oscillano fra il drammone, la commedia e il we stern; oppure ancora le supposte « enclave » neorealistiche della filmografia di Lattuada, come II bandito, o Senza pietà, che sono del sapiente « grand guignol » con misurate oscillazioni verso il fumetto. D’altronde, senza andare troppo in là, basterebbe soffermarsi su quelli che a parere dei più sono i maggiori esponenti della fiorescenza neorealistica: Roberto Rosellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, i maestri di quegli anni, cui va aggiunto Giuseppe De Santis, un cineasta coerente nella propria ricerca. Non sembra ci voglia molto per accorgersi che si tratta di quattro vere e proprie « divergenze parallele ». Nel di scorso neorealistico Roberto Rossellini prende la parola due volte, con Roma città aperta e Paisà e già con Germania anno zero viene considerato fuori della linea. Il che è tutto sommato giusto, a patto che si tenga presente che i due discorsi « in linea » — come già si è rilevato — avevano, anche se meno evidenti, gli stessi interessi « spiritualistici » e lo stesso « pessimismo storico » di quelli successivi. Due volte entrerà nel discorso anche Luchino Visconti. Ma se con il primo film, La terra trema, come fu detto con felice formula, « il neorealismo diventa stile », cioè si estremizza — e si realizza — in una 26 Tanto che l’irrisolta aporia del capolavoro viscontiano è soprattutto nel fatto che esso è una rappresentazione dell’ingiustizia secolare, ma anche il documento della sua contemplazione. Come se l’« aristocratico » Visconti denunciasse ad un tempo e il crudele ordine esistente e la propria incapacità a fare altro che con templarlo esteticamente se l’ordine sociale delle cose c determinato dalla logica borghese, l’ordine formale della loro rappresentazione è determinato dall’estetica borghese.
Per una verifica del neorealismo
27
nuova (altissima) retorica, con il secondo, Bellissima, il regista si pone già in posizione critica verso il neorealismo e una serie di suoi stereotipi. Se Rossellini e Visconti appaiono come due entità incomunicabili, non meno appartata, rispetto alle loro due linee, appare quella di Giu seppe De Santis che è l’unico a tentare un’operazione che non è solo «estetica» ma anche «politica» in quanto volta a fondare un’epica nazionalpopolare (sia in Caccia tragica che in Riso amaro; ma più che mai in Non c'è pace tra gli ulivi), tesa al recupero di passioni, sentimenti, e conflittualità primordiali, cioè più ad un « rappresentare » per il popolo che ad un « rappresentare » il popolo. Forse appare così accettabile l’ipotesi che il cinema di De Sica (cioè di De Sica/Zavattini) rappresenti « l’espressione più pura » del discorso neorealistico e che anzi, Ladri di biciclette sia « il luogo geometrico, il punto zero di riferimento, il centro ideale intorno al quale gravitano entro la loro orbita particolare le opere degli altri grandi registi »27; anche perché De Sica è colui che con maggiore continuità cerca di mantenersi, fino alle estreme stagioni, nell’alveo neorealistico. Ma come conciliare il carattere completamente aprogettuale del solidarismo desichiano e il suo illuminato umanesimo « borghese » con l’ansia di palingenesi spirituale di un Rossellini, con l’aristocratico marxismo di un Visconti, con la ricerca populistica di un De Santis? Tanto vale dirlo, insomma. Quanti furono i neorealisti, tanti furono i neorealismi. Il che equivale, pressappoco, ad affermare che il neorealismo, essendo un’aggregazione di fenomeni, non fu un fenomeno, e che anzi, come fenomeno ben definito e bene individuabile, non fu affatto, poiché a livello dei risultati espressivi (cioè dei film) esso apparve—e soprattutto appare ora —scomponibile c ricomponibile quasi a piacimento. Sicché in questo sen so ha ragione (e ha torto al contempo) e chi lo riduce ai pochi grandi « mae stri », e chi lo allarga a dismisura, dal Visconti de La terra trema al Matarazzo della trilogia « larmoyante ». Questo però vale soltanto e fino a quando si pensa che il neorealismo fu un’« estetica » e che dunque sia nella pratica formale dei singoli cineasti, nei loro film, che lo si debba ritrovare e lo si possa ricostruire; e che le varie « poetiche » da quella « estetica » derivate siano come i rami di uno stesso albero, estesi, sì, in direzioni diverse fino ad abbraccia re un intero orizzonte, ma poggiati tutti su uno stesso tronco. Ma il neorealismo, appunto, non fu un’« estetica » e una delle ragioni della sua sconfitta (una delle tante) fu proprio nel credere di esserlo, peg gio nel volerlo essere. Il neorealismo fu invece un’« etica dell’estetica »: la risposta, implicita, di una nuova generazione di cineasti alla domanda vittoriniana « Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l’uo 27 In André Bazin, Vittorio De Sica, Parma, Guanda, 1953, p. 15.
28
Il neorealismo cinematografico italiano
mo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? »2S. In questo, solo in questo, i Visconti e i De Sica, i Rossellini e i De Santis, per quanto « esteti camente » lontani, furono « eticamente » vicini. « Neorealismo » fu, soprattutto, il nome di una battaglia, di un fron te, di uno scontro: quello che i fautori di quelT« etica dell’estetica » con dussero contro i fautori di un’« estetica (apparentemente) senza etica », cioè di una pratica artistica che, fìngendosi autonoma dalle cose del mondo, è funzionale alla loro conservazione poiché è lo « spettacolo » che « distrae » dalla pena che esse generano. Da qui, ad esempio, la a volte feroce antispettacolarità che caratterizzò alcuni dei più alti risultati neorealistici, da La terra trema a Umberto D. Tuttavia, un’« etica dell’estetica » che non sa pervenire ad un’« estetica », o peggio che crede di esservi pervenuta, non può che soccombere. L’unità etica dei neorealisti si incrinò in primo luogo con il crollo della « grande speranza » delle prime stagioni postbelliche di cui essa era, a suo modo, parte; si ruppe poi nei continui scossoni che essa subì tra la volontà restauratrice di moderatismo centrista e le contraddizioni di una sinistra marxista italia na dove « s’cra riprodotta, in scala minima se vogliamo, tutta la teratologia stalinista » 28 29 ; si dissolse quindi definitivamente di fronte alla pressione eser citata da quell’« estetica » che non era mai tramontata, neppure con il crollo del fascismo cui era così ben servita; che sembrava, appunto, non avere un’« etica »; che però, invece, di fatto l’aveva, nell’accettazione dell’esistente e nelle funzioni consolatorie che assolveva perché continuasse ad esistere, ed era dunque una « etica dell’estetica » anch’essa, ma fornita di una prati ca estetica precisa e questa volta unitaria, anche se variegata e non conclamata, anche se rinnovata e lungimirante, anche se apparentemente preterinten zionale e occasionale. La beffa fu, come già si è detto, che l’ormai indisturbato cinema della consolazione si permise il lusso di indossare paramenti neorealistici e di condurre con essi una lotta per il proprio rinnovamento che fu poco meno d’una lite in famiglia tra il vecchio e il nuovo cinema del la borghesia. Per questo, ripensare il neorealismo, ricostruirne l’itinerario, riesaminarne la realtà, fuori da ogni mitologia e da ogni iconoclastia, vuol dire anche impadronirsi degli strumenti atti a capire i camuffamenti e il volto autentico di un doponeorealismo che dura tuttora. Vuol dire conoscere quello che fummo per capire ciò che siamo.
28 Elio Vittorini, Una nuova cultura, in « Politecnico », n. 1, 29 settembre .1945. 29 In Franco Fortini, Dieci inverni, Milano, Feltrinelli, 1957, p. 15.
IL CONTESTO CULTURALE E POLITICO DEL NEOREALISMO
PER UNA NUOVA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO POLITICA-CULTURA di Alberto Abruzzese
1. Ciò che ha interessato lo studio e la teoria del rapporto tra politi ca e cultura, all'interno della nostra tradizione di civiltà industriale euro pea, è dipeso dalla progressiva costruzione di una interdipendenza socia le tra due campi di diversa natura ed entità. Il primo campo riguarda il rapporto generale tra organizzazione sociale della vita umana (ivi « com preso » il lavoro) e organizzazione dell'attività intellettuale, articolata se condo vari livelli qualitativi e quantitativi. All'interno di questa gene ralità storica, di questa struttura socio economica determinata, si collo cano i fatti culturali isolatamente intesi, semiologicamente definibili se condo una suddivisione strutturale, che deriva dal sistema produttivo nel suo complesso. Il secondo campo riguarda, appunto, il rapporto in terno, che può essere osservato tra dati sociali (nel senso correttamen te marxiano di prodotti della divisione del lavoro) e dati ideologico-estetici (come prodotti specifici della divisione del lavoro intellettuale) nel l'ambito di un fatto culturale determinato. Al rapporto politica-cultura è stata, dunque, assegnata la funzione di collegare questi due campi in modo tale da garantire sempre uno scambio operativo tra ideologia del sistema produttivo (nel senso di astrattone dei suoi modi di produzione a legge universale) e ideologia del singolo intellettuale, oppure tra struttura della società civile e strut tura dell’opera o del fatto culturale. Tra il primo livello macrostrutturale e quello microstrutturale (che si può spingere sino alla definizione di una unità minima del fare intel lettuale) intercorrono, infatti, innumerevoli stratificazioni, che vanno dal la spartizione in settori sociali di tipo orizzontale o verticale, alla suddivisione in ambiti funzionali, sino ai circuiti culturali, o ai generi artistici tradizionalmente intesi. Ma questo criterio orientativo sul binomio politica-cultura, per quan to in Italia rappresenti un notevole salto di qualità rispetto alla tradi zione pre-marxista, ci sembra ormai non reggere né da un punto di vista teorico né tantomeno da un punto di vista operativo. Esso, pro babilmente, non va più cercato nella distinzione tra produzione, come
32
Il neorealismo cinematografico italiano
livello strutturale, e ideologia, come livello sovrastrutturale, e neppure tra modi di produzione a livello generale e modi di circolazione a li vello culturale. La via da percorrere è un’altra, e sicuramente parte da una nuova netta discriminante con cui separare la politica dall’informa zione politica e Vinformazione politica dalla prassi. È interessante nota re, a questo proposito, quanto storicamente e culturalmente siano appar se divaricate le valutazioni sul rapporto informazione-prassi nella sfera capitalistica rispetto alla sfera istituzionale occupata dal movimento operaio. Nel primo caso, l’informazione assume tutte le sue qualità, da quel la ideologica a quella cibernetica, nel secondo caso essa viene definita come semplice articolazione della prassi. Mentre, dunque, nel primo ca so l’informazione viene scissa in modo corretto dalla produzione (che è la prassi del capitale, anche quando essa deve esprimersi a livello di con trollo sociale), viene cioè vista come momento necessariamente subordi nato, nel secondo caso essa tende ad essere un doppio della prassi, quan do addirittura non la precede in quanto strategia o propaganda. Per altro, ci sembra evidente che, oggi, una informazione politica può essere allo stesso tempo ideologica, merce, produzione, così come può esserlo ogni altra informazione, e, dunque, anche l’espressione cul turale. Ma è altrettanto evidente che, di volta in volta, si stabiliscono rapporti di produzione tali da provocare uno scambio a catena tra quel le stesse stratificazioni di cui abbiamo detto prima, oppure da organiz zare settori della cultura in modo da far loro produrre informazioni poli tiche, e settori della politica in modo da far loro produrre fatti culturali. In quest’ottica cade ogni possibile confine tra politica e cultura: le due sfere, se tradizionalmente intese, appaiono oggi ambedue prodot te, ambedue il risultato di rapporti di forza che le sovrastano. Il grande dibattito del marxismo sul rapporto tra struttura e sovrastruttura, così importante per il rapporto « militante •» tra prassi e ideologia, non a ca so ha incontrato un momento di arresto con il suo stesso ribaltarsi nella scoperta di una reciprocità perenne tra elementi strutturali ed elementi sovrastrutturali. La logica interna a questa reciprocità, a questa circolarità apparentemente hegeliana, l’aveva già tutta rivelata Marx nella sua teoria della produzione. A noi oggi spetta il compito di verificarne la giustez za e ricavarne una nuova teoria. Il discorso va, infatti, ricondotto interamente al rapporto tra capi tale e lavoro, riportando, dunque, la molteplicità dei fatti sociali, in quan to strutture fondamentali e loro linguaggi, ai modi di produzione. Solo così potremo ritrovare una discriminante valida, capace di superare il li vellamento realizzato dal processo di mercificazione del capitale, cioè dal la socializzazione della fabbrica. Solo così possiamo recuperare il significato oggettivo di politica e.
Il contesto culturale e politico del neorealismo
33
rispetto a questo, cercare di definire la sfera culturale. Si tratta, allora, di valorizzare non tanto le distinzioni classiche tra produzione e ideologia o tra politica e cultura, ma piuttosto le distia * zioni qualitative e quantitative, che possono essere praticamente tra l’oggettività dello scontro di classe (rappresentata dal livello, questa volta real * mente politico, raggiunto dai modi di produzione) e mediazione sociale di tale scontro, comunicazione del suo valore, uso informatico del suo « sistema ». Ad una semplice osservazione dei dati storici, appare evidente che quanto più avanzata è la conflittualità tra capitale e lavoro, quanto più sono spinte in avanti, dunque, le energie produttive, quanto più, infine, esaltate le contraddizioni del modo di produzione capitalistico, tanto più ciascuna d’esse tenderà ad essere organizzata produttivisticamente. Al con * trario, quanto più il livello produttivo è arretrato, quanto più la conflit tualità è costretta ad esprimersi all'esterno della produzione, tanto più le mediazioni si riducono e irrigidiscono, appaiono strumenti grossolani, comunicazioni univoche, spazi improduttivi. Emerge a questo punto un’altra discriminazione fondamentale, da cui è bene partire, e rispetto alla quale il binomio politica-cultura assu me nuovi contenuti e nuovi possibili orientamenti. Infatti, se accettia mo la definizione di politica, nel senso del livello conflittuale oggettiva mente rappresentato dal capitale e dal lavoro in ogni momento e luogo della produzione, cioè nel senso di livello politico espresso dalle forze sociali nello sviluppo concreto dei rapporti di classe, dovremo allora immediatamente porci il problema della merce. Vale a dire che dobbiamo risolvere il rapporto tra politica e merce prima di quello tra politica e cultura, per il semplice fatto che il primo rapporto è più generale del secondo, è di per sé più avanzato, dunque teoricamente più valido. Ancora una volta, in base alla semplice osservazione dei fenomeni del mercato, ci sembra evidente che quanto più maturo è il rapporto tra capitale e lavoro, tanto più la merce arricchisce le proprie funzioni, tendendo essa stessa a organizzarsi come produzione. Quanto più, dun que, le forze produttive si esprimono politicamente nei modi stessi del la produzione, tanto più la mercificazione esprime a livello generale la stessa originaria politicità. Al contrario, proprio laddove la produzione non riesce a raggiungere un livello apprezzabile di conflittualità politica, assi stiamo a un rapporto ancora estremamente meccanico tra produzione e merce, dunque tra politica e merce; e proprio in questi casi, è Videologia ad avere alcuni compiti sociali sostitutivi delle merci, almeno in sede promozionale. Ma vediamo ora, sulla scorta di queste prime valutazioni e propo ste di lavoro, di tracciare uno schema del nostro ragionamento, facendolo dipendere da alcuni precisi riferimenti storico-culturali, e di giungere
34
Il neorealismo cinematografico italiano
così ad una definizione corretta anche del secondo termine del binomio in questione: la cultura. 2. Riandiamo, strumentalmente, ad una definizione di lavoro data da Marcuse nel 1933 (in Sui fondamenti filosofici del concetto di lavoro nella scienza economica, pubblicata in « Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik », ora nella traduzione italiana Cultura e società, Torino 1969): in essa il lavoro appare, nella sua dimensione contemporanea, to talmente alienato. Scrive Marcuse: Un fenomeno d’importanza decisiva è il fatto che lo sganciamento della produzione e della riproduzione materiali dalle dimensioni della « libertà » che le completano e le realizzano si ripercuote su queste dimensioni stesse e sulla prassi in esse conte nuta. Una volta staccate dalle sfere che la completano e al tempo stesso la limi tano, la prassi della « dimensione economica » gira a vuoto e inghiotte in sé la totalità dell’esistenza, oggettivandone anche la prassi libera [...]. Anche al di là della produzione e riproduzione materiale il lavoro è ormai privato del suo senso autentico: esso non è più unito essenzialmente all’accadere reale, alla prassi reale dell’esistenza; né può più realizzare la sua possibilità suprema, che è quella d’inter venire nell’accadere della totalità dell’esistenza per darle senso c scopo. Privato della sua realtà piena, la prassi, il lavoro finisce in fondo col non essere più lavoro.
Per quanto Marcuse citi Marx, il suo discorso non ha nulla di marxia no, e tuttavia riesce a definire storicamente un certo modo di intendere il lavoro — dunque la politica — da parte del ceto intellettuale. Sociolo gicamente la versione marcusiana della alienazione del lavoro ci sembra essere stata quella prevalente, capace di accogliere al suo interno prospet tive ideologiche e culturali diverse, capace — ed è ciò che in questa sede maggiormente ci interessa — di costituire il « polo opposto » di un’altra definizione, ricavata quasi per antitesi dal concetto di lavoro. In questo senso torna ad essere illuminante Marcuse quando, nello stesso scritto sopra citato, affronta la distinzione tra lavoro e gioco da un punto di vista concettuale, ed elenca alcune fondamentali differenze: Anche nel gioco l’uomo può (ma non deve) avere a che fare con oggetti, occuparsi di oggetti. Ma l’oggettività ha qui tutt’altro senso e tutt’altra funzione che nel la voro. Giocando, l’uomo non si conforma agli oggetti, alla loro regolarità per così dire immanente (data cioè dalla loro oggettività specifica) né a ciò che richiede il loro «contenuto oggettivo» (mentre il lavoro nel trattare, utilizzare, dar forma al suo oggetto deve conformarsi al contenuto oggettivo di esso); al contrario, il gioco sopprime, nei limiti del possibile, questo contenuto e regolarità «oggettivi» degli oggetti per mettere al loro posto una regolarità diversa, creata dall'uomo stesso, a cui chi gioca si lega liberamente per volontà propria: le « regole del gioco » (nel senso più alto; a regole del gioco si attiene anche chi gioca da solo; le regole del gioco non devono essere necessariamente esplicite e possono essere applicate ad hoc in un caso singolo). L’oggettività degli oggetti con i suoi effetti e le realtà del mondo oggettivo, con cui gli uomini sono altrimenti costretti a contendere, imparando così a rispettarla, vengono nel gioco quasi abrogati per alcuni attimi, l’uomo una volta tanto fa degli oggetti quel che gli pare, si pone al di sopra di essi, è, tra gli oggetti, « libero » da essi. Decisivo è il fatto che in questo porsi al di sopra dell’oggettività l’uomo giunga proprio a se stesso, in una dimensione della sua libertà che gli * è negata nel lavoro. Un singolo lancio di palla da parte di un giocatore rappresenta
Il contesto culturale e politico del neorealismo
35
un trionfo della liberti umana sull’oggettività che è infinitamente maggiore della conquista più strepitosa del lavoro tecnico. In rapporto al significato ed al fine del gioco, l’uomo, giocando, è presso se stesso e non presso gli oggetti (che sono l’altro da sé): egli riversa sugli oggetti la sua libertà, si trastulla con essi o li fa trastullare con sé. Per esprimere in linguaggio comune la funzione del gioco nella vita dell’uomo, elenchiamo certi eventi propri dell’io e non degli oggetti: parliamo di un distrarsi, di un rilassarsi, di un dimenti carsi, di un riposar-si dell’uomo. Con ciò è già indicata un’altra caratteristica del gioco, che rimanda direttamente al lavoro come fenomeno contrario. Visto nell’insieme dell’esistenza umana, il gioco non ha durata né costanza: si rivolge per sua essenza « temporaneamente », « tra » i tempi di un altro agire che domina stabilmente e continuamente l’esistenza umana. E il modo in cui la vita avviene nel gioco, non costituisce un avvenimento com piuto in sé e per sé, ma un avvenimento essenzialmente eteronomo e dipendente, che rinvia automaticamente ad un altro fare. Il gioco rappresenta un distrarsi, un rilassar-si, un ritemprar-si da uno stato di concentrazione, di tensione, di tra vaglio, di intensa percezione di sé, ecc. ed è un distrar-si, un rilassar-si, un ritem prar-si con lo scopo di una nuova concentrazione, una nuova tensione ecc. Il gioco è quindi, in quanto fenomeno complessivo, riferito necessariamente a qualcosa d’al tro da cui deriva e a cui mira, e questo qualcosa d’altro è già stato indicato antici patamente come lavoro dalle caratteristiche della concentrazione, della tensione, dal travaglio, ecc. [...]. ... la durata del lavoro significa che il compito che il lavoro pone all’esistenza umana non può essere mai assolto in un singolo processo lavorativo o in vari processi lavo rativi singoli; a questo compito corrisponde quindi un perdurante essere-al-lavoro ed essere-nel-lavoro. Al contrario, il gioco ha carattere essenzialmente singolo, è sol tanto temporaneamente, di tanto in tanto.
È abbastanza accertabile che Marcuse — e con lui chiunque abbia osservato con interesse « culturale » il rapporto tra lavoro e libertà, la voro e bisogni dell’uomo libero, lavoro e non-lavoro, lavoro e tempo-li bero ecc. — quanto più verificava la sostanziale perdita di totalità nella prassi del lavoro, tanto più era tentato di spostare il lavoro intellettuale dalla sfera del lavoro produttivo (ma «diviso» per la logica stessa del suo essere economico) a quella del lavoro ludico. Possiamo anzi dire che gran parte delle teorie sulla cultura, nate dopo gli anni Trenta, presentano una struttura tipicamente derivata dall’esigenza del ceto intellettuale di ricostruire le modalità e i valori del lavoro intellettuale « fuori » dello spazio lavorativo tradizionalmente inteso. Scriveva Marcuse, ancora nello stesso saggio: La permanenza del lavoro può essere definita preliminarmente così: dal lavoro «deve venir fuori» qualcosa die, per il suo senso e la sua funzione, sia più duraturo del singolo atto lavorativo e faccia parte di un accadere « universale ». Ciò che è ma teria ovvero risultato del lavoro viene inserito dal lavoro stesso nel « mondo * di chi lavora, così come è stato ricavato ed estratto da questo « mondo » per mezzo del lavoro. Deve trattarsi di qualcosa che è in sé « permanente », che esiste ancora ed esiste per altri anche dopo la conclusione del singolo atto lavorativo.
Quindi quanto più il lavoro, come viene organizzato e si organizza nella divisione economico-sociale delle società a capitalismo avanzato, per de la sua qualità originaria, tanto più è necessario organizzare ogni gesto libero, dare continuità e durata alla dimensione del gioco, rendere perma
36
il neorealismo cinematografico italiano
nenti gli istituti della libertà. Sempre più, allora, questo processo, alter nativo rispetto alla forma generale del lavoro, si fa teorizzazione di due culture, di cui una resta integrata alla parzialità di una prassi svuotata di contenuto, di una economicità svuotata di etica, e l’altra si ricompone, invece, come produzione di libertà, come lavoro intellettuale che non pro duce alienazione, come recupero del singolo nella collettività e nel tempo, come recupero infine della vera prassi. Abbiamo ricostruito questi passaggi del pensiero marcusiano perché essi ci sembrano, nel bene e nel male, il supporto storico e teorico di al cune convinzioni generali, che possono, di volta in volta, derivare o dal l’idealismo o dal marxismo volgare o da precise scelte di politica culturale, ma che si unificano solamente su un punto: una separazione più o meno dialettica tra sfera pratica del lavoro produttivo o dell’impegno politico propriamente detto, e sfera intellettuale del lavoro impiegato appunto nel soddisfare bisogni, che si definiscono non indotti dalla produzione ma libe ramente espressi dall’uomo. Non che manchino coloro i quali sanno bene vedere l’arbitrarietà di una simile distinzione (ogni volta che la si voglia confrontare con le figure sociali e le istituzioni che fanno cultura), ma que sta stessa distinzione funziona come tendenza, come valore, o più sempli cemente come criterio orientativo di fondo. Del resto se ci si lamenta del progressivo estendersi dei valori del lavoro alienato, del capitale c dei modi di produzione industriale ai valori del lavoro intellettuale, della cultura e ai modi di produzione culturali; vuol dire, evidentemente, che la storia del rapporto tra lavoro e cultura viene misurata a partire da una ipotetica « separazione » tra lavoro e cul tura a causa dell’industrializzazione, e viene vista lungo il percorso di una continua ricomposizione, mediante il progressivo riassorbimento da parte del primo nei confronti della seconda e non certo della seconda nei con fronti del primo. Sta di fatto, dunque, che è opinione corrente (ma anche vastamente sostenuta da quadri intellettuali qualificati, operanti cioè sia all’interno della organizzazione del lavoro, sia all’interno dell’impegno po litico, sia dentro le istituzioni della cultura), che esistono due diversi modi di produrre, due diversi modi di esprimersi a livello sociale, due ordini diversi di bisogni. La violenza (a livello generale e anche su opposti fronti ideologici) con cui la cultura viene difesa da un suo uso troppo politico o troppo produttivo, è sintomatica della convinzione, tutta intellettuale — tut ta appunto « speculativa » nel senso marcusiano — tutta ideologica, che sia possibile conservare una ipotesi di sviluppo delle forze produttive, conservando il carattere « libero » della cultura, mantenere distinti i bi sogni sociali da quelli « astrattamente » umani, oppure, che è la stessa cosa, liberare i bisogni senza poter negare la produzione. In Marx, invece, la risposta veniva già data come analisi e prefigura zione di un processo ciclico ineluttabile, fermi restando i modi di produ-
Il contesto culturale e politico del neorealismo
yi
zione del capitale; il rapporto tra lavoro e cultura, e dunque tra politica e cultura si dissolve come rapporto reale, perde di significato, si riduce ai momenti particolari dello sviluppo e al rapporto tra livelli produttivi e totalità della società civile. Nessuna distinzione nella teoria marxiana tra bisogno materiale e bisogno spirituale, tra bisogno economico e bisogno culturale: per questo e soltanto per questo la celebre domanda che Marx si pone nell’introduzione ai Lineamenti fondamentali della critica del l’economia politica sul perdurare quasi eterno di un certo tipo di bisogno estetico, è interessante. Altrimenti sarebbe una banale questione d’origine idealistica, un problema di tradizione, una riproposta del rapporto veritàstoria. Non a caso, sempre nella stessa Introduzione, Marx conclude così una delle sue pagine più note e importanti sul significato storico e sociale della produzione: La produzione fornisce non solo un materiale al bisogno, ma anche un bisogno al materiale. Quando il consumo emerge dalla sua immediatezza e dalla sua prima rozzezza naturale — e l’attardarsi in questa fase sarebbe ancora il risultato di una produzione imprigionata nella rozzezza naturale — esso stesso come propensione è mediato dall’oggetto. Il bisogno che esso ne avverte è creato dalla percezione del l’oggetto stesso. L’oggetto artistico — e allo stesso modo qualsiasi altro prodotto — crea un pubblico sensibile all’arte e capace di godimento estetico. La produzione produce perciò non soltanto un oggetto per il soggetto, ma anche un soggetto per l’oggetto. La produzione produce quindi il consumo 1. creandogli il materiale; 2. de terminando il modo di consumo; 3. producendo come bisogno nel consumatore i pro dotti che essa ha originariamente creato come oggetti. Essa produce perciò l’oggetto del consumo, il modo del consumo e la propensione al consumo.
Questa citazione serve non soltanto come supporto teorico ad una impostazione del rapporto politica-cultura in termini adeguati al momento presente dello sviluppo delle forze produttive in Italia, ma anche come punto di riferimento a quanto diremo sul rapporto tra teoria, o poetica, e produzione, o creazione, nel neorealismo. Questa citazione, infatti, ci costringe a una revisione abbastanza sostanziale di significati terminologici troppo spesso abbandonati alla loro « tradizionale » fluidità. Da questa revisione, il termine politica viene appunto ricondotto al significato che abbiamo detto all’inizio di queste brevi note metodologiche; essa, cioè, riconferma la propria appartenenza tùl'oggettivilà della produzione e non alla soggettività dei suoi antagonisti ideali. Per altro verso, il termine cul tura viene già a rappresentare il significato oggi assunto dalla organizzazione sociale dei beni culturali, e dei bisogni ad essi relativi; viene cioè inevita bilmente assimilato al termine più corretto (e che non a caso ci ostiniamo a relegare in uno spazio particolare e delimitato del lavoro intellettuale) di industria culturale. E, dunque, nc\Vindustria culturale, nella cultura come oggi esiste e può essere considerata e valutata, potremo ritrovare un livello politico direttamente proporzionale — come abbiamo già accen nato — ai livelli produttivi che essa è in grado di offrire.
38
Il neorealismo cinematografico italiano
3. Resta ora un ultimo importante problema da definire nelle sue linee fondamentali e dalla soluzione del quale dipende uno dei significati che vogliamo dare al binomio politica-cultura. Resta, infatti, da definire la qualità del lavoro intellettuale, impiegato nell’industria culturale, cercando di non lasciarsi intimidire dai profondi dislivelli produttivi che essa pre senta, e che ancora oggi giungono alla più totale improduttività. Rimane dunque da definire il soggetto storico e sociale del rapporto — questa volta tutto reale, tutto economico, tutto incorporato nella produzione — tra politica e cultura (nel nuovo e particolare significato che abbiamo as segnato a questi due termini). Ad una grossolana, ma abbastanza efficace suddivisione della massa dei lavoratori intellettuali, secondo i diversi settori sociali in cui il loro lavoro viene utilizzato in forme specifiche, risultano, ci sembra, tre componenti fondamentali: da un lato abbiamo il lavoro intellettuale organizzato nella produzione di tradizione, prevalentemente assegnata agli istituti scola stici, dall’altro il lavoro intellettuale direttamente inserito nella produzione dei mass-media, e infine, in una posizione tutta particolare, ma non meno sottoposta a processi di proletarizzazione industriale, il lavoro intellettuale organizzato negli istituti sociali che fanno politica. I diversi livelli produttivi che ciascuno di questi tre settori rappre sentano, sono estremamente significativi, e andranno tenuti sempre pre senti nel corso della nostra analisi del neorealismo, perché rappresentano naturalmente tre diversi tipi di rapporto tra politica e cultura in fasce temporali sincrone. Al livello più arretrato, da quésto punto di vista, ab biamo il lavoro intellettuale di qualità « scolastica », quasi interamente privo di reali conflitti produttivi, dunque, anche se irrigidito da funzioni di « potere », estremamente vicino nei suoi modi e nelle sue funzioni al lavoro intellettuale pre-capitalistico. A questo livello il rapporto politicacultura è estremamente carente, qualitativamente ideologico. Al livello più avanzato, invece, sta il lavoro intellettuale, organizzato nell’industria cul turale (dunque le diverse stratificazioni e classificazioni di « aziende » cul turali: dall’editoria al cinema, dal giornalismo alla TV). A questo livello il rapporto politica-cultura è invece estremamente maturo, ma natural mente in termini esattamente opposti a quelli osservati nell’ambito del lavoro intellettuale « scolastico ». Al livello, infine, del lavoro intellettuale applicato alla politica noi possiamo osservare il rapporto tra politica e cultura solo laddove questo viene realmente e correttamente posto come tale (ad esempio, le com missioni culturali dei partiti operai o gli istituti o fondazioni di parte cat tolica, democristiana o padronale, con precisi intenti di teoria e organiz zazione della cultura ai fini di egemonia politica ecc.), altrimenti esso fini sce per rientrare nelle qualità di lavoro sopra analizzate e negli infiniti livelli intermedi.
Il contesto culturale e politico del neorealismo
39
Con questi brevi cenni crediamo di aver chiarito l’ipotesi di fondo, da cui vogliamo muovere per osservare il rapporto politica *cultura nel neorealismo: da un lato individuare il livello politico raggiunto dal lavoro intellettuale nelle sue espressioni sociali più significative, e dall’altro l’in * dustria culturale nel suo evolversi socio-economico e nel suo valore isti tuzionale. GRAMSCI E I NEOREALISTI
1. O siamo convinti che il neorealismo rappresenti un grande fatto cul turale — e allora una sua qualsiasi valutazione dovrà coinvolgere alcuni li velli dello sviluppo generale delle forze produttive, impegnate nei vari settori dell’ideologia, della cultura e dell’arte, c dunque riguardare alcuni nodi fondamentali, teorici e storici, che la tipicità di tale sviluppo com porta — o siamo convinti che il neorealismo sia un episodio isolabile, da tato, circoscrivibile — e allora, già da tempo, ci si sarebbe dovuti decidere a chiudere il discorso una volta per sempre. Evidentemente, sull’importanza oggettiva del neorealismo concordano sia coloro i quali tendono ancora a considerarlo una delle esperienze intel lettuali più alte della nostra civiltà nazionale, sia coloro i quali ne hanno — giustamente secondo noi — ridimensionato il significato ideale, e anzi « criticato » l’incidenza storica. In ogni caso, sia coloro che vedono nel neorealismo un progresso, sia coloro che vi vedono un sostanziale regresso, una conservazione di ideologie decadute, tendono a perpetuarne il valore ben oltre l’ambito socio-economico che l’ha prodotto. Come spesso accade, due discorsi opposti su uno stesso oggetto sono la reciproca proiezione speculare di uno stesso insieme di meccanismi, « scientifici » e ideologici, che di fatto si trovano concretizzati proprio nell’oggetto d’analisi, nella sua struttura, nel coordinamento cioè dei suoi — o di alcuni suoi — significati. Vale a dire che il neorealismo, osservato dai suoi sostenitori o dai suoi antagonisti, non è il neorealismo, ma sem plicemente un cerio neorealismo, cioè un particolare oggetto d’analisi che gli uni e gli altri hanno visto, isolato, circoscritto nell’insieme di feno meni storici e culturali degli anni del neorealismo, e poi hanno generalizzato come unico oggetto possibile, come realtà di cui rendere finalmente palese il significato nascosto, come storia rispetto alla quale ricavare, in positivo o in negativo, un’ideologia. Noi vorremmo, in questa sede, riuscire a sospendere la tradizione della critica, o della storiografia, sul neorealismo. Sulla scorta storica, tracciata nella prima parte del nostro discorso, vorremmo cioè trovare, nella ca tena di fatti e protagonisti, che caratterizza il fenomeno neorealista, altri e nuovi oggetti d’analisi. Non staremo, dunque, a ripercorrere l’intero arco di posizioni di intellettuali, gruppi culturali, ceti sociali, partiti e
40
Il neorealismo cinematografico italiano
classi sul rapporto politica-cultura dentro e fuori delle centrali di tra smissione neorealista; tanto meno staremo a individuare questo rapporto all’interno delle strutture significanti di ciascuna opera o delle più impor tanti. Siamo convinti non soltanto che questo genere di analisi siano state condotte — se pur parzialmente — e dunque le si possano ritenere acqui site, ma anche che valga la pena di dimenticarsele. Molto meglio è concentrare i nostri sforzi nell’analisi di alcune que stioni fondamentali, non a caso strettamente legate alle scelte che andia mo discutendo e facendo in questi anni, e non a caso appunto riconduci bili a un periodo storico che ha segnato in modo strutturale il nostro svi luppo. La questione è praticamente una, ma articolabile in due momenti distinti: a. l’opposizione — incredibilmente non emersa sino ai giorni no stri — tra la concezione gramsciana del rapporto politica-cultura e la pra tica o teoria neorealistica; b. l’opposizione oggettiva tra la pratica neorealista, lo sviluppo della sua produzione e del suo mercato, e la teoria neorealista o dei cri tici neorealisti. Con questa tematica investiamo un arco cronologico che va dagli anni Trenta, cui i quaderni gramsciani fanno riferimento, agli anni Sessanta, che rappresentano in qualche misura la punta della critica di marca neo realista. Da questa tematica, dal suo chiarimento, anche da un suo cor retto rilancio, potremo allora tornare all’analisi dei singoli eventi, rico struire — senza esserne schiavi — il pulviscolo delle posizioni, la va rietà dei prodotti, le particolarità soggettive. 2. Seguiamo punto per punto le pagine gramsciane sul rapporto tra in tellettuale-politico e cultura, raccolte « disordinatamente » in Letteratura e vita nazionale. Il ricorso ad esse è pienamente giustificato dal fatto che, quando la critica vorrà sanzionare la pur breve esperienza del neorealismo tra il 1945 e il 1950 e vorrà rilanciarne il significato in chiave teorico ideologica, uno dei puntelli storici, per convalidare pienamente l’operazione all’interno della nostra più splendida esperienza democratica, sarà proprio la pubblicazione dei quaderni gramsciani che avevano affrontato i problemi della produzione intellettuale. In questa sede vogliamo tentare una lettura di Gramsci totalmente diversa sia dall’interpretazione, che neorealisti e critici neorealisti, vollero darne, sia dai processi di revisione del gramscianesimo, che, in qualche misura proprio opponendosi a quella tradizione, ne perpetuavano — seppure per brevissimo tempo — l’ottica di fondo. È innegabile che anche nel Gramsci più politico, più capace di far derivare l’analisi e la teoria dall’osservazione spregiudicata del volto storico della classe ma anche della figura nazionale e internazionale dell’imprendi-
Il contesto culturale e politico del neorealismo
41
tore, permanga sempre viva la convinzione — originaria per quanto riguar da il suo ceto e la sua cultura — in un bagaglio di valori umanistici, con siderati di per se stessi validi e autonomi. Questi valori originari della cul tura — secondo uno schema che rivedremo nel « Politecnico » e ad onta delle avanzate prospettive raggiunte nell’impegno politico — tendono in ogni punto cruciale del discorso teorico a identificarsi con il lavoro intel lettuale. Tuttavia, come vedremo, ciò accade non tanto perché al lavoro intellettuale Gramsci assegni semplicemente la produzione di quei valori, perché anzi egli tentò sempre di negare la figura dell’intellettuale come depositario statico di una verità, quanto piuttosto perché nel pro porre una dinamica di sviluppo, capace di superare la crisi della civiltà moderna, sentì il bisogno di rifarsi ai precedenti momenti ideali di un realizzato equilibrio tra uomo e società; tra intellettuale e natura, tra ragione e storia, quando ancora ciascuno di questi elementi non appariva sconvolto dalla produzione industriale. Ma è altrettanto innegabile che, su questo fondo inevitabilmente umanistico (che continuamente fa sostegno, da un lato, al rapporto con l’idealismo crociano, garantito dallo storicismo desanctisiano, dall’altro lato, alla ideologia populista e alla tradizione giobertiana), s’aprono pro spettive incredibilmente nuove e originali, tuttavia scarsamente accolte dal pensiero e dalla politica culturale del movimento operaio. È, intanto, estremamente importante (vedi le pagine de Gli intellet tuali e l’organizzazione della cultura sulla formazione degli intellettuali) il fatto che Gramsci ponga all’origine del lavoro intellettuale l’iniziativa di un gruppo già tutto organizzato alVinterno della produzione economica, con un suo preciso livello produttivo, con una sua determinata colloca zione nell’assetto sociale. È importante perché questa prospettiva consente al teorico di superare spesso i confini ideologici del problema strategico di una egemonia intellettuale organica al « blocco storico » e di vedere in vece la questione innanzi tutto nei termini di capacità tecniche di forma zione dirigenziale, di crescita organizzativa all’interno dei meccanismi pro duttivi veri e propri. Per questa via, in cui maturità borghese e coscienza di classe si intrecciano sapientemente, possiamo vedere come una parte del discorso gramsciano tenda a capovolgere i suoi stessi poli tradizionali e a subordinare il contenuto politico della egemonia intellettuale alla con quista « civile » di un nuovo livello tecnico. Meglio ancora: la politica, reinventata all’interno del lavoro intellettuale organizzato nelle istituzioni culturali, diviene il mezzo più idoneo e avanzato per far funzionare tecni camente e produttivamente l’intellettuale nella società. Vale la pena di rileggere una pagina in questo senso estremamente ricca di indicazioni: Quando si distingue tra intellettuali e non-intellettuali, in realtà a si riferisce solo alla immediata funzione sociale della categoria professionale degli intellettuali, cioè
42
Il neorealismo cinematografico italiano
si tiene conto della direzione in cui grava il peso maggiore dell’attività specifica professionale, se nell’elaborazione intellettuale o nello sforzo muscolarc-nervoso. Gò significa che, se si può parlare di intellettuali, non si può parlare di non-intellettuali, perché non-intellettuali non esistono. Ma lo stesso rapporto tra sforzo di elaborazione intellettuale-cerebrale e sforzo muscolarc-nervoso non è sempre uguale, quindi si hanno diversi gradi di attività specifica intellettuale. Non c’è attività umana da cui si possa escludere ogni intervento intellettuale, non si può separare Vbomo faber dalVhomo sapiens. Ogni uomo infine, all’infuori della sua professione esplica una qualche attività intellettuale: è cioè un «filosofo», un artista, un uomo di gusto, partecipa di una concezione del mondo, ha una consapevole linea di condotta mo rale, quindi contribuisce a sostenere o a modificare una concezione del mondo, cioè a suscitare nuovi modi di pensare. Il problema della creazione di un nuovo ceto intellettuale consiste pertanto nell’elaborare criticamente l’attività intellettuale che in ognuno esiste in un certo grado di sviluppo, modificando il suo rapporto con lo sforzo muscolare nervoso, in quanto elemento di un’attività pratica generale, che innova perpetuamente il mondo fisico e sociale, diventi il fondamento di una nuova e integrale concezione del mondo. Il tipo tradizionale e volgarizzato dell’intellettuale è dato dal letterato, dal filosofo, dall’ar tista. Perciò i giornalisti, che ritengono di essere letterati, filosofi, artisti, ritengono anche di essere i « veri » intellettuali. Nel mondo moderno, l’educazione tecnica, strettamente legata al lavoro industriale, anche il più primitivo e squalificato, deve formare la base del nuovo tipo di intellettuale.
Troviamo raccolti qui una serie di concetti fondamentali, pur emer genti dal « doppio » livello speculativo del pensiero gramsciano: tanto più interessanti perché il gramscianesimo tradizionale appare, in questa sede, il punto d’arrivo del discorso piuttosto che la sua pratica effettiva, la sua possibilità di espressione storica, la sua indicazione di prassi imme diata. Non conta, qui, rilevare alcune debolezze teoriche di fondo e l’eredità certo sensibile di un certo materialismo positivista, ma piuttosto i dati generali che ne scaturiscono come individuazione di veri e propri campi sociali di azione politica. Le massime qualità delle discriminanti gramsciane tra lavoro « meccanico » e lavoro intellettuale deriva dalla capacità di sepa razione tra tempo lavorativo e tempo non-lavorativo (potremmo già dire tempo libero) a livello di tutta la società civile. Ogni prassi politica, a questo punto del discorso, si riferisce alla massa, è cioè una prospettiva non ideologica e maggioritaria nel momento in cui traccia una strategia interna alla generalità dei rapporti sociali e non alla parzialità in fieri del blocco storico. Si delineano così due operazioni distinte e coordinate: prima la co struzione, problematica, perché di fatto storicamente e praticamente dif ficile, di un ceto intellettuale, cioè di un gruppo che può trovare la sua omogeneità in determinate capacità tecniche, fondate su un corretto rap porto tra politica e lavoro intellettuale; poi la elaborazione, grazie allo sforzo produttivo di questo stesso ceto e della sua stessa mansione istitu zionale, dei contenuti intellettuali dell’MOwo massa. È chiaro che, a questo livello, il discorso è spregiudicatamente rife rito al consumo intellettuale da parte della massa (e ne vedremo la riprova
Il contesto culturale e politico del neorealismo
43
nel discorso sul giornalismo, sul romanzo d’appendice e sul cinema, cioè sui mass-media conosciuti da Gramsci). È chiaro cioè che per Gramsci una cosa è dire che i nuovi contenuti intellettuali derivano dal lavoro in senso marxiano, cioè dalla classe operaia, e altra cosa è dire che il conte nuto tecnico del lavoro intellettuale deve costituire il modello di fruizione della domanda intellettuale, presente, seppure a diversi gradi, in tutta la società. In questo secondo caso, dunque, il lavoro non viene considerato come alterità viva del capitale, non in quanto forza-lavoro sfruttata nella produzione, ma come unico modo concreto e reale con cui l’individuo-massa (dall’intellettuale all’operaio) ha modo di intervenire come agente attivo della società. Si apre così una delle punte più sorprendentemente moderne dell’ana lisi gramsciana, laddove viene sentito tutto il limite storico, istituzionale, teorico e pratico, che relega la figura del letterato, e con essa quella del filosofo c dell’artista, a un ruolo ormai subordinato, perché arretrato ri spetto alle tecniche prodotte dallo sviluppo industriale, dunque arretrato rispetto al livello generale della produzione. Solo a partire da questa acquisizione della spaccatura storica, che si è creata tra i modi di produ zione del lavoro intellettuale e i modi di produzione del lavoro, come atti vità pratica generale, progressivamente uniformata al modello industriale, solo a partire da questa individuazione dell’obsolescenza progressiva del ceto tradizionale degli intellettuali, si può giungere a una nuova teoria: il nuovo modello di intellettuale, richiesto dallo sviluppo sociale e, dunque, richiesto dalla crescita del proletariato (che di questo sviluppo è la molla fondamentale) dovrà assommare in sé la capacità sia di corrispondere ai livelli tecnici più avanzati, sia di adeguarsi (essere consumato, fruibile, fun zionale) ai diversi gradi dello sviluppo, alle diverse « misure » culturali della società civile. È, finalmente, da questa prospettiva — di cui vedremo in ultimo le proposte concrete, il risultato che ci interessa e che sarà da confrontare con la produzione neorealista — che emerge un nuovo, più maturo, rap porto tra politica e cultura. Leggiamo ancora nelle stesse pagine citate: II modo di essere del nuovo intellettuale non può più consistere nell’eloquenza, mo trice esteriore e momentanea degli affetti e delle passioni, ma nel mescolarsi attiva mente alla vita pratica, come costruttore, organizzatore, « persuasore permanente » perché non puro oratore — c tuttavia superiore allo spirito astratto matematico; dalla tecnica-lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla concezione umanistica storica senza la quale si rimane «specialista» e non si diventa «dirigente» (specialista+ politico). Si formano così storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della fun zione intellettuale, si formano in connessione con tutti i gruppi sociali ma specialmente in connessione con i gruppi sociali più importanti e subiscono elaborazioni più estese e complesse in connessione col gruppo sociale dominante. Una delle caratteri stiche più rilevanti di ogni gruppo che si sviluppa verso il dominio è la sua lotta per l’assimilazione e la conquista « ideologica » degli intellettuali tradizionali, assimi
44
Il neorealismo cinematografico italiano
lazione e conquista che è tanto più rapida ed efficace quanto più il grappo dato elabora simultaneamente t propri intellettuali organici.
Vi troviamo espressa, in forma palese, la teorizzazione di un intel lettuale dirigente, che usa il proprio umanesimo « storico » per trasfor mare la tecnica in scienza, in conoscenza universale, ma vi troviamo an che, in forma implicita, una profonda distinzione tra la politica come di mensione del lavoro intellettuale, applicato alla sfera istituzionale della cultura, e la politica come dimensione generale entro cui inserire anche ogni altra forma di lavoro intellettuale, anzi scegliere i diversi modi della sua organizzazione, le diverse necessità tecniche della sua socializzazione. Ecco allora che la proposta ideologica, ch’è poi quella teoricamente più debole e politicamente più povera (poiché di fatto non qualifica in termini di classe il binomio tecnica-scienza), trova la sua indicazione più organica non a caso nell’ambito della critica, non a caso cioè nei gruppi intellet tuali che perpetuano istituzionalmente la qualità arretrata (proprio anche nel senso gramsciano che abbiamo visto) del lavoro intellettuale. Nei criteri di critica letteraria, espressi nella raccolta di Letteratura e vita nazionale, troviamo infatti una significativa distinzione « strutturale » tra politica e letteratura: D'altronde, per il rapporto tra letteratura e politica, occorre tener presente questo criterio: che il letterato deve avere prospettive necessariamente meno precise e defi nite che l’uomo politico, deve essere meno « settario » se così si può' dire, ma in modo «contraddittorio». Per l’uomo politico ogni immagine «fissata» a priori è reazionaria: il politico considera tutto il movimento nel suo divenire. L’artista deve invece avere immagini « fissate » e colate nella loro forma definitiva. Il politico immagina l’uomo come è e, nello stesso tempo, come dovrebbe essere per raggiun gere un determinato fine; il suo lavoro consiste appunto nel condurre gli uomini a muoversi, a uscire dal loro essere presente per diventare capaci collettivamente di raggiungere il fine proposto, cioè a « conformarsi » al fine. L’artista rappresenta ne cessariamente ciò che c’è, in un certo momento, di personale, di non confor mista, ecc., realisticamente. Perciò, dal punto di vista politico, il politico non sarà mai contento dell’artista e non potrà esserlo: lo troverà sempre in arretrato coi tempi, sempre anacronistico, sempre superato dal movimento reale. Se la storia è un con tinuo processo di liberazione e di autocoscienza, è evidente che ogni stadio, come storia, in questo caso come cultura, sarà subito superato e non interesserà più.
L’acquisizione di un rapporto tutto politico tra politica e cultura è notevole: vedremo poi come gli intellettuali del neorealismo e quelli del « Politecnico » si mostreranno arretrati rispetto ad essa e continueranno a dimostrarsi tali anche dopo la pubblicazione delle note gramsciane. Su questa fondamentale distinzione tra politica e cultura, che prevede la massima strumentalizzazione della seconda a vantaggio della prima, il discorso giunge ad articolarsi sul rapporto tra lavoro intellettuale e indu stria culturale. Anche se Gramsci non può ancora fondare su basi reali la politicità del lavoro intellettuale, il « quadro » che egli propone all’in terno dell’industria culturale riesce ad essere la prefigurazione di un lavoro intellettuale qualitativamente maturo, perché pienamente consapevole Sei
Il contesto culturale e politico del neorealismo
45
livelli produttivi più avanzati. La sua è dunque una indicazione politica che intende trovare la sua prassi nei modi stessi della produzione. Non a caso, nella stessa pagina sopra citata, leggiamo: Mi pare che il problema sia questo: come creare un corpo di letterati che artisticamente stia alla letteratura d’appendice come Dostojevskij stava a Sue e a Soulié o come Chesterton, nel romanzo poliziesco, sta a Conan Doyle e a Wallace, ecc. Bi sogna a questo scopo abbandonare molti pregiudizi, ma specialmente occorre pen sare che non si può avere il monopolio, non solo, ma che si ha di contro una formidabile organizzazione d’interessi editoriali. Il pregiudizio più comune è questo: che la nuova letteratura debba identificarsi con una scuola artistica di origine intellettuale, come fu per il futurismo. La premessa della nuova letteratura non può non essere storica, politica, popolare: deve ten dere a elaborare ciò che già esiste, polemicamente o in altro modo non importa; ciò che importa è che essa affondi le sue radici neU’Au/»«s della cultura popolare così come è, coi suoi gusti, le sue tendenze, ecc., col suo mondo morale e intellet tuale, sia pur arretrato e convenzionale.
Cioè Gramsci ha piena coscienza dei meccanismi produttivi dell’in dustria culturale, dei suoi modi diretti e indiretti di socializzare l’inte resse capitalistico come sensibilità artistica, come uso del tempo libero, come forma generale del consumo estetico e intellettuale. Si vedano, a questo proposito, le analisi su i miti anti-operai della letteratura popolare realmente esistente, cioè « realmente » consumata e richiesta. Ma il problema fondamentale per Gramsci è partire da un livello mi nimo, per quanto riguarda i valori tradizionali della qualità del lavoro in tellettuale, e tuttavia, generalizzato per quanto riguarda la sua dimensione sociale. Ad esempio, in occasione di una proposta « popolare » per storie romanzate di personaggi illustri, scrive: Si tratta del solito schema biografico, spesso filologicamente corretto, che può tro vare al massimo qualche migliaio di lettori, ma non diventare popolare.
Se ne desume — ma con questo rimandiamo sempre alla più complessa tematica del « nazionale-popolare » — che la qualità essenziale del popo lare è la sua massa numerica: non dunque il vecchio grumo di valori ro mantici idealizzati, ma semplicemente il ben più vasto mercato di acqui sto. In questo Gramsci si discosta, non soltanto per l’ambizione ma anche per la sostanza del progetto, dalla abbastanza vasta organizzazione pre fascista di una letteratura propagandista socialista, notevolmente inner vata nei modi risorgimentali della letteratura popolare. Si discosta anche dal modello gobettiano di editoria intellettuale, che pure rappresenta una avanzatissima esperienza di parte borghese. Non che i modelli socialisti e gobettiani, sommersi dalla repressione e riorganizzazione fascista, non contino o non pesino nella teoria gramscia na, ma certo sono nettamente superati dalla gigantesca dimensione di una operazione culturale che per volere essere politica a livello produttivo, cioè tecnicamente funzionante nei confronti di tutta la società civile, propone livelli di massa mai conosciuti, strutture ben più complesse dello schema
46
Il neorealismo cinematografico italiano
propagandistico, « industrie » ben lontane dai margini di una diffusione individuale, o dopolavoristica, o anche partitica. Naturalmente, la doppia natura del discorso gramsciano non viene meno e, dunque, la base reale di tale prospettiva del lavoro intellettuale, cioè la collettività (considerata come pubblico del prodotto culturale indu strializzato), il popolo (considerato come mercato e non come valore), tende ad essere recuperata dalla tradizione risorgimentale-idealistica ita liana. E tuttavia è interessante l’anticonformismo con cui Gramsci collega quei fondamenti tradizionali con la sua concezione politica di letteratura d’appendice o di giornalismo e con i livelli industrialmente produttivi, che essa oggettivamente rappresenta. In ogni caso il processo reale di trasfor mazione di una cultura di massa (quale essa sia sempre del capitale) verso una cultura popolare, quale può essere correttamente quando la massa so ciale si identifica negli interessi delle classi proletarie, si compie attraverso una serie di livelli intermedi la cui gestione e successione strategica e tec nica può dipendere soltanto da un lavoro intellettuale politicamente orga nizzato (lo specialista + il dirigente) e mai semplicemente da un « let terato », cioè da una forma di lavoro intellettuale autonoma, parziale, separata sia dalla prassi politica che dai modi di produzione industriale. La semplice creazione culturale, dunque, la produzione « astratta » di beni e bisogni disgiunti dalla determinatezza socioeconomica della società civile, è fuori di un corretto rapporto tra politica e cultura. Le forme industrializzate della letteratura, dell’informazione, e del l’immagine, in quanto « sistema » della cultura di massa sia per quanto riguarda l’emissione, che la circolazione, che il consumo, rappresentano il linguaggio-comunicazione del « popolo », tanto quanto le forme letterarie tradizionali rispecchiano gli interessi, il gusto e i valori della classe domi nante e di alcuni gruppi sociali. Ne consegue che il lavoro intellettuale, nel momento in cui matura nella direzione del lavoro proletario, trova indica zioni molto precise: fondare sul terreno dell’oggettività storica (cioè dove realmente esistono gli istituti di produzione culturale e la massa sociale da essi organizzata) una cultura che sia in grado di partire da ciò che i livelli produttivi della civiltà capitalistica già garantiscono come stretto, organico, reciproco nesso tra opera e pubblico, cioè in grado di partire non fuori dal mercato ma dall’interno della sua produttività sociale. È bene, a questo punto, ricordare che il superamento della prassi sociale del lavoro intellettuale in prassi tecnica e sólo allora anche politica è individuato da Gramsci nel lavoro industriale. Ci si allontana, dunque, nettamente sia da una concezione « artistica » del lavoro intellettuale, sia dalle bipolarità « tendenziose » tra arte e politica, libertà e necessità, ecc. (per quanto esse non manchino in altre pagine del suo pensiero più stret tamente « umanistico »); si perviene a una concezione abbastanza consa pevole di intervento politico nell’industria culturale, valorizzazione dei suoi
Il contesto culturale e politico del neorealismo
47
livelli produttivi, proletarizzazione del lavoro intellettuale, professionalizzazione dell’impegno. Come vedremo meglio nel paragrafo successivo, la scelta politica e strategica per l’estensione della lotta di classe oltre la linea discriminante del proletariato, sino a comprendere i ceti medi e la piccola proprietà non monopolistica, provocò, pur essendo sostanzialmente collegata al pen siero gramsciano sul blocco storico, e alla sua attenzione teorica alla col lettività, risultati ben diversi in alcune scelte della politica culturale di si nistra, dopo la seconda guerra mondiale. Gramsci, nei momenti più riusciti e avanzati della sua riflessione du rante gli anni del carcere, riuscì a. a non dare sempre l’utopico valore di popolo al campo di azione della politica culturale, superando per certi tratti lo stesso concetto di pub blico in quello di mercato-, b. a tenere separato il mondo « statico » dell’arte (anche se pro gressista o « realista ») dal mondo dinamico della politica, a distinguere cioè il semplice lavoro intellettuale dalla sua organizzazione generale; c. a scindere la crescita di massa di una ideologia alternativa dal pre giudizio luddista nei confronti dei canali industrializzati dell’informazione; d. ad evitare la concezione rozza e precapitalista per cui il livello di massa può essere raggiunto attraverso la propaganda in ipotetici spazi vuoti del mercato; e. a precisare, infine, che il contenuto, che l'intellettuale-politico, cioè quello « organico » al proletariato, deve imporre e generalizzare, at traverso una programmazione di strumenti e livelli, non è una volgarizza zione della teoria marxista, cioè scadimento qualitativo a fini compromis sori, ma capacità tecnica di creare consenso, dunque una qualificazione nuova e più avanzata. AI contrario, la successiva generazione gramsciana praticò per molti anni l’identità perfetta tra contenuti (ideali e progressisti) della lotta di classe e massa sociale (nuovamente idealizzata come popolo), tra conte nuti (letterati-popolari) e formazione del blocco storico, tra letterato auto nomo (ma democratico) e impegno sociale, tra opposizione al mercato e vittoria politica, tra massificazione dei contenuti e propaganda, tra appiat timento delle indicazioni « scientifiche » del marxismo e scelta dei livelli « oggettivi » dell’informazione. È da questo punto di vista che crediamo di poter leggere il neorealismo, cioè non come conquista di un nesso reale tra politica e cultura, ma invece come sua frattura, anche se verso un neces sario momento di ricomposizione delle forze produttive proprio attraverso il recupero di alcuni livelli arretrati.
3. Ai neorealisti della prima fase, quella, potremmo dire, spontaneamente creativa, le strutture culturali appaiono certamente più disgregate di quan-
48
Il neorealismo cinematografico italiano
to potessero apparire a Gramsci. Inoltre Gramsci aveva costruito un di scorso di lunga durata, di vaste capacità prospettiche, di prefigurazione strategica del futuro, mentre ai giovani intellettuali dell’immediato do poguerra la dialettica tra passato e futuro affoga tutta nella brutale « po vertà » del presente. Tuttavia, tra Gramsci e la giovane generazione neorealista esiste un elemento di congiunzione oggettivo; tra la politica del primo e Vantifasci smo dei secondi esiste, cioè, una costante più o meno consapevole, e so stanzialmente estranea sia ad una tematica proletaria sia all’ideologia an tifascista, ma invece propria di un ceto, della sua crisi storica, della sua conflittualità con il sistema produttivo generale. Riteniamo, cioè, che dietro all’antifascismo, come forma unificante e ideologica del neorealismo, esi stano realtà ben più « limitate », ma forse anche ben più significative, più reali, più storiche, intimamente più dinamiche. Dunque ci sembra che i temi, espressi dal fronte degli intellettuali più maturi e informati contro l’organizzazione civile del ventennio fascista, non si esauriscano nella contrapposizione tra libertà e autorità, tra pluralità e accentramento, tra popolo e caste, ma, pur manifestandosi sempre come ideologie libertarie e progressiste, rivelino una serie di bisogni oggettivi, presenti in tutto l’arco della cultura nazionale, come interessi specifici, momenti tardivi, ma necessari, di adeguamento teorico, tecnico e prospettico alla nuova con dizione sociale del lavoro intellettuale, ma certo non momenti d’avan guardia dell’assetto civile globalmente inteso. Essenzialmente, infatti, die tro allo scontro tra passato fascista e futuro democratico, la letteratura ita liana militante (e non militante) nascose il conflitto, per se stesso molto più bruciante e finalmente esploso in tutta la sua pienezza, tra intellettuale e società. Nessuna delle esperienze della tradizione nazionale, utili a intendere e superare l’acquisizione di queste nuove contraddizioni, viene assunta nel la sua giusta misura. Non la tradizione socialdemocratica d’origine trie stina, non il nostro francofortese ante litteram Michelstaedter, non — e la cosa è di maggiore rilievo — Croce (di cui gli uomini di cultura seppero perpetuare soltanto il punto di vista ideologico, moralistico e critico-este tico, ma non certo quello politico), non — come abbiamo già più volte anticipato — Gramsci (di cui l’intellettuale di sinistra censurò in gran parte il contenuto pratico). Piuttosto ci si rifece a Verga (e ciò ha negativamente condizionato le prospettive del dibattito culturale fino ai nostri giorni), oppure a Svevo (che, ad onta di alcune sue maturità espressive costituisce un modello di intellettuale estremamente inadeguato al quadro novecentesco), oppure, infine, a un certo tipo di letteratura americana. Scriveva Vittorini, a proposito della formazione americana di alcuni neorealisti:
Il contesto culturale e politico del neorealismo
49
Penso che abbiano avuto influenza e abbiano addirittura contribuito a determinare il mondo dei più giovani tra i nostri narratori La via del tabacco di Caldwell, Uomini e topi di Steinbeck e i romanzi sociali dello stesso Steinbeck ...
E aggiungeva: Hemingway, Faulkner, Fitzgerald e Thomas Wolfe avrebbero potuto indicare una strada infinitamente più ricca di sviluppi, anche se più difficile. Ma non si sareb bero confusi agli avvenimenti come Steinbeck e Caldwell e non sarebbero serviti allo scopo di rompere gli indugi cui Steinbeck e Caldwell sono serviti.
A ben vedere, le cose andarono diversamente e sottolineano la no stra tesi. Il recupero della letteratura esemplificata da Steinbeck e la pro posta dei suoi contenuti sul mercato italiano attraverso opere nazionali che ne riproducevano moduli ideologici e narrativi, solo in parte era dipeso da una richiesta spontanea del pubblico. Quella letteratura d’oltre oceano era nata come poderosa reazione della tradizione collettiva contadina ame ricana contro l’altrettanto massiccia ascesa dell’organizzazione industriale, e si era articolata in modi spesso nostalgici, tesi a recuperare, contro le troppo meccaniche contraddizioni dello sviluppo sociale ed economico, i valori dell’uomo, delle sue singole mani, dei suoi singoli sentimenti: era usa a privilegiare il rapporto uomo-natura rispetto al rapporto uomosocietà o a ricondurre ideologicamente il secondo al primo. Tutto questo repertorio letterario-ideologico risultò estremamente or ganico alle esigenze specifiche, soggettive e particolari del ceto letterario italiano. I nostri intellettuali nazionali non potevano ridurre la garanzia della loro sopravvivenza al legame resistenziale con le forze popolari, poi ché ben scarse erano le intese, in senso correttamente politico, con il pro letariato; sentivano dunque il bisogno di rappresentare il mondo preca pitalista come un riflesso di se stessi, il mondo anti-industriale e contadino come immagine riflessa del loro lavoro, della qualità del loro lavoro. L’ideologia della cultura diviene ideologia del sottosviluppo: l’indi cazione gramsciana, che abbiamo estratto dai Quaderni, appare qui capo volta. I neorealisti sono proprio il ceto di letterati che Gramsci vedeva inadeguati ai nuovi bisogni. Ma cosa c’è dietro immagine del lavoro intellettuale dei neorea listi, cosa c’è nella loro poetica, nel modo cioè di organizzare la propria produzione? Quali sono le antinomie fondamentali che regolano i modelli organizzativi e formali dei processi creativi? Quale la destinazione e fun zione dei canali e dei modi di consumo? Il rapporto politica-cultura, nella prima generazione del neoreali smo, è totalmente sbilanciato tra politici e artisti: proprio per la scarsa elaborazione teorica del rapporto, e la totale assenza di « istituti » capaci di gestirne la funzionalità sociale, le carenze degli uni spesso equivalgono alle carenze degli altri. Così un Alicata equivale a un Vittorini: alla poli tica manca un discorso politico — dunque specifico — sull’arte e la produ
50
Il neorealismo cinematografico italiano
zione artistica, alla cultura manca un discorso specifico sulla politica. Alla prima, dunque, ritorna una concezione tradizionale della cultura e del * l’arte, pur repressa dalle giuste necessità politiche; alla seconda ritorna una concezione « separata » della politica. Solo dopo aver penetrato questo complesso intreccio, possiamo cercare di rispondere alle domande che ci siamo poste. Ricostruiamo lo schema interpretativo: aWideologia della cultura, che pretendeva l’imposizione del suo valore onnicomprensivo a tutte le fun zioni sociali, ivi comprese quelle della produzione e della politica, e voleva tracciare la sua stessa finalità persino alla lotta di classe, corrispose dun que l'ideologia del sottosviluppo, cioè il tentativo di rendere produttiva la propria arretratezza, di rendere avanguardia la retroguardia. Questo processo di appropriazione da parte de) lavoro intellettuale di tutte le qualità produttive socialmente scadute si risolse dunque nel recupero delle aree geografiche, economiche e culturali arretrate rispetto alle punte dello sviluppo capitalistico, e nell’immagine di un movimento di forze storiche volto alla riconquista delle qualità non alienate dell’uomo. La cultura, concepita come struttura di funzioni c valori in se stesse ori ginarie cd eterne, viene teorizzata come estranea e antitetica ai modi di produzione industriale, e anche ai processi di socializzazione del lavoro. Per questo stesso motivo la cultura, come modo di produrre e modo di consumare, viene di fatto contrapposta al mercato, che è ritenuto espres sione del decadimento dei valori dovuto alla massificazione e all’industria. Per opposta c intimamente necessaria ragione, la cultura cerca il suo ter reno di sopravvivenza come rappresentazione e contenuto delle classi subalterne, della massa priva di potere o « fuori » di esso. Così lo scrittore neorealista, il pittore, il cineasta, ritenendosi garan titi socialmente dal fatto di schierarsi con chi difende gli interessi di quanti vengono sfruttati dal sistema, recuperando la propria individualità, il pro prio stato di diritto, il proprio mandato, su ciò teorizzano l’egemonia del ceto, cui appartengono ed il suo destino. Essi contrappongono le capacità artigianali del loro fare estetico al fare meccanicizzato, rivestono di pro gressismo utopico la nostalgia del passato contadino, ipotizzano uno svi luppo che ha i contenuti della staticità paleocapitalista, in polemica con lo sviluppo industriale « fuori » della fabbrica, che sempre più restringe i margini d’espressione dell’individuo isolato, e con essi i confini dell’inter vento artistico. Questo stesso processo, sino ad ora analizzato, trovò due suoi fonda mentali sostegni nel decadentismo e nel meridionalismo: l’uno nascosto, mistificato, mascherato, proprio laddove più acuto sembra esprimersi l’at tacco ai simboli palesi dell’esperienza decadente, l’altro rivelato in ogni punto, come garanzia di appartenere alla storia, di volere il suo riscatto su basi e risorse reali, vive ed agenti.
Il contesto culturale e politico del neorealismo
51
Non abbiamo qui lo spazio per svolgere nella loro complessità questi temi. Ma tentiamo di toccarne almeno uno, quello dell'autonomia del l'arte. Aver detto, infatti, che dietro alla produzione neorealista ci fu la necessità di percorrere le stesse contraddizioni tra arte e tecnica, artista e collettività, che furono del decadentismo europeo, aver detto che vi fu la riorganizzazione della dimensione formale del messaggio estetico, aver detto infine che vi fu un adeguamento violento agli squilibri sociali della na zione e alle classi emerse, non significa aver detto che il primo neorea lismo risolvesse, con questo, storicamente e teoricamente il problema della forma e del suo rapporto con la società, che cioè risolvesse o superasse il problema dell’autonomia artistica. La soluzione di questo problema (il modo stesso di interpretarlo e organizzarlo) è fondamentale per intendere il rapporto generale tra politica e cultura negli anni del neorealismo e l’implicito nesso tra lavoro intel lettuale e mercato. Ora, analizzando la produzione neorealista letteraria è abbastanza evidente che il rapporto tra opere e pubblico trova ancora nella forma — in quanto soluzione conchiusa tra ideologia ed espressione stili stica — il suo momento centrale. Possiamo dire che la rinuncia da parte dell’arte ad essere autonoma (scelta compiuta in Europa molti decenni prima) rispetto alla vita sociale, collocandosi in Italia in tempi e modi sostanzialmente diversi da quelli presenti in paesi a capitalismo più avan zato, si mantiene ad un primo livello, per non dire in un ambito nettamente superficiale. In ogni caso, l’intellettuale si dimostra incapace di praticare, nella riorganizzazione del proprio lavoro intellettuale da parte di se stesso, uno scatto qualitativo, che in seguito dovrà essere l'industria a compiere quasi interamente da sola e in base al suo esclusivo interesse. Infatti, le componenti principali del processo creativo neorealista re stano fondamentalmente le stesse della tradizione nazionale post-risorgi mentale e crociana, impedendo la ricerca di strumenti stilistici capaci di programmare il rapporto tra prodotti culturali e nuovo mercato popolare. L’artista, pur negando nelle sue « immagini », nella qualità apparente del suo prodotto, l’autonomia dell’arte, non nega assolutamente l’autonomia del proprio lavoro intellettuale, la separatezza della sua figura tecnica e sociale. Tale artista sottopone il linguaggio ad una operazione di filtro ideo logico e lemmatico, organizza l’informazione secondo la sua misura, rior ganizza il reale secondo il suo progetto. Egli fa sì che il materiale lingui stico e semantico elaborato si accosti ad un valore identificato nel popolo come parte separata dal capitale, dalla fabbrica, dall’industria, dal denaro, dal consumo ecc.; questo valore è moralmente e stilisticamente collocato in posizione egemone, ma non riesce a farsi strumento concreto, rapporto reale, presenza politica. Il popolo è quindi una presenza stilistica, ma per uno stile che è an-
52
Il neorealismo cinematografico italiano
cora la forma tradizionale del lavoro intellettuale. La struttura formale dell’opera resta immutata. Essa rappresenta l’inserimento di nuovi dati nello sviluppo sociale, l’ingresso di un pubblico intermedio e ben più am * pio di quello tradizionalmente letterario o paraletterario, e anche, di con seguenza, l’ingresso di una strumentalizzazione sintattica e lessicale più dif fusa, applicabile, riproducibile, commercialmente disponibile; ma tutto questo nuovo materiale viene organizzato con meccanismi intellettuali e sistemi creativi che conservano un carattere fortemente autonomo, non si preoccupano di verificare un sistema di informazioni più complesso o di costruire una situazione più produttiva al mercato culturale. In questa prospettiva il nesso tra politica e cultura non poteva porsi, e la sua immagine estetica è completamente opposta alla sua reale consi stenza economica. Anche se — come vedremo nell’ultima parte del nostro discorso — la poetica del sottosviluppo offrì una sua dinamica e un suo mercato, poiché la piccola borghesia nazionale ebbe bisogno di misurare, per almeno un decennio, il suo avanzamento rispetto alle classi non ancora inserite nello sviluppo. L’ideologia del sottosviluppo, come forma orga nizzata di spazi non produttivi e falsa coscienza del rapporto politica-cul tura, impedì e rallentò di molto l’organizzazione degli istituti necessari alla formazione e controllo del consumo culturale, della circolazione e del mercato, contrapponendosi spesso ai processi di trasformazione che il pub blico, la piccola borghesia e alcuni livelli proletari andavano praticando per altra via e sotto la spinta di altre forze produttive. Così, quando con l’inizio degli anni ’60 assistiamo all’ingresso industria nel settore cul turale, è lo sviluppo economico e il suo bisogno di controllo sociale sulla produttività generale che consente, e rende necessario, l’intervento diretto sul consumo letterario e spettacolare. La cultura individualistica e antiindustriale dei neorealisti viene, così, duramente colpita e posta in crisi dal neocapitalismo, che necessita ora di nuovi spazi di espansione del mercato culturale, di nuovi canali, nuove prospettive (ad esempio, le neoa vanguardie) per un più vasto controllo del tempo libero e della sua pro duttività più o meno diretta.
POETICA, CRITICA E MERCATO DEL NEOREALISMO
1. Abbiamo già più volte accennato, o ritenuta implicita, una distin zione tra artisti e critici neorealisti. A nostro avviso essa è fondamentale per intendere il fortissimo divario che si crea in diversi campi di produ zione intellettuale, quando essi siano diversamente collegati ai meccanismi produttivi dell’industria e alla circolazione di messaggi in un sistema di comunicazione già mercificato. A nostro modo di vedere, cioè, possiamo osservare quanto lo sviluppo, a cui è sottoposto il prodotto intellettuale,
Il contesto culturale e politico del neorealismo
53
indipendentemente dalla sostanza del suo contenuto (cioè anche al mas simo del suo potere frenante), una volta che entra a far parte dì una dina mica, che ha tutti i caratteri della produzione industriale vera e propria, sia diverso dallo sviluppo di un prodotto sostanzialmente affine ma desti nato o condannato a una circolazione esterna agli spazi produttivi. Ora ci sembra, appunto, che tra la produzione artistica del neorealismo e la pro duzione critica ad essa coeva, e soprattutto ad essa posteriore, esista que sta essenziale differenza: la prima, pur opponendosi nel contenuto della sua poetica alle leggi dello sviluppo capitalista ne entra a far parte, anzi informa l’inizio della nostra industria culturale secondo un modello diret tamente relativo alle proprie contraddizioni; la seconda, pur valorizzando il contenuto di quella poetica, non riesce a integrarsi né soggettivamente né oggettivamente allo sviluppo. Su questa linea possiamo sviluppare più temi d’analisi. Vediamone alcuni. 2. Il più facile e scontato discorso che si può fare a proposito del neo realismo, come una delle forze, che hanno, non solo condizionato, ma so stanziato di sé l’industria culturale nazionale, è quello sul cinema. È un discorso che può essere risolto sociologicamente, osservando l’organizza zione del lavoro intellettuale nelle primissime strutture dell’industria ci nematografica dopo la liberazione, e seguendone lo sviluppo sino ai nostri giorni: la continuità tra neorealismo e industria culturale è riscontrabile sia nella presenza di un quadro intellettuale sostanzialmente immutato, sia nel perdurare di alcune tecniche di produzione, sia, ancora, in alcune carat teristiche della composizione dei capitali investiti e dei circuiti interessati. Inoltre, lo stesso discorso può essere risolto semiologicamente, analizzando i linguaggi presenti nelle prime opere di Visconti, De Sica, De Santis, Ros sellini, ecc. e confrontandoli con i sistemi linguistici usati tra gli anni Cin quanta e Sessanta, non soltanto dal cinematografo nella sua evoluzione verso la commedia all’italiana, come genere tipico di una standardizzazione di marca americana, ma anche dalle altre comunicazioni audiovisive come RAI-TV, pubblicità, fotoromanzi, fumetto. Attraverso lo strumento ermeneutico costituito dalla semiotica sa remo probabilmente in grado di scorgere, dietro alla limitatissima pro spettiva delle biografie di registi o delle storie culturali, l’arricchimento progressivo di informazioni dovuto all’incrocio tra messaggi, selezionati secondo un’ottica artistica di matrice populista, e messaggi, organizzati da una economia di mercato tesa a usare il populismo in chiave consumistica, come incentivo al « piccolo » benessere dei ceti medi; oppure tra mes saggi, ancora sostanzialmente derivati da una tradizione teatrale, pitto rica e letteraria, e messaggi relativi a un assetto sociale scarsamente cor rispondente ai modelli di quella tradizione; o ancora tra messaggi di
54
Il neorealismo cinematografico italiano
stretta osservanza estetico-ideologica e messaggi emessi dalle merci del l’industria culturale americana direttamente distribuite e fruite sul nostro mercato ecc. Vi è tuttavia un altro modo, per così dire intermedio tra la sociologia e la semiotica, con cui analizzare il cinema neorealista come base del no stro cinema di consumo. In certa misura esso è relativo proprio al rap porto politica-cultura, al modo distorto e arretrato in cui si rivela nel neorealismo e si perpetua nell’industria culturale, essenzialmente in fun zione atrofizzante del potere informatico della merce. Intendiamo, cioè, dire che dietro alle strutture economiche generali e dietro ai particolari sistemi linguistici o contenuti, temi, motivi, stereotipi, modelli estetici, soluzioni narrative, tecniche filmiche, modi di recitazione, concepimento del prodotto, ideologia del suo consumo ecc., esiste la possibilità di iso lare e analizzare alcuni contenuti, per così dire nascosti, ma fondamentali per intendere il funzionamento dell’industria culturale italiana nel suo com plesso, il divario ancora netto tra merce e informazione, le difficoltà di crescita del mercato, l’assenza di una qualità superiore di lavoro intellet tuale, la separatezza tra tempo libero e lavoro produttivo, il moralismo sul consumo e il corrispondente vuoto di iniziativa politica su questo campo. Vi sono, infatti, nel cinema italiano alcuni elementi strutturali incon fondibili, da cui discendono le singole storie, personaggi, situazioni, scelte linguistiche, che trovano il loro nucleo originario proprio nei modi ideologici con cui la produzione neorealista vide il rapporto tra arretratezza e sviluppo, tra società civile e capitale, tra popolo e classe operaia, tra potere e isti tuzioni, tra uomo e merce, tra artigianato e industria culturale. Ciascuno di questi rapporti specifici (e altri ancora ne potremmo forse elencare) fu tale da improntare di sé non solo i vari contenuti tematici ed espressivi ma anche ciascuna giuntura interna o esterna all’opera, quasi a costituire la dimensione autentica, « altra », dell’opera stessa. Così, ad esempio, proprio seguendo la stessa successione di bipolarità sopra elencate, ossia indi care alcune strutture fondamentali della nostra industria culturale e prima o con essa del nostro neorealismo: la comicità, ottenuta mediante il con flitto « interno » di livelli arretrati, solitamente espresso tra il ceto pic colo-borghese e quello contadino, mai spostato, come fu per il cinema co mico classico angloamericano, sul fronte delle contraddizioni più avanzate dello sviluppo; il denaro come elemento dominante in ogni analisi della civiltà capitalista, valore sostitutivo o onnicomprensivo del capitale, della classe operaia, della produzione, dello sfruttamento ecc.; Vinterclassismo non tanto come programmazione del prodotto su un mercato di fatto inter classista, quanto piuttosto come limite invalicabile di un’ottica che non sa trovare nessuna valida discriminante di classe e tantomeno quella, fonda mentale anche per un buon managerialismo industriale, tra popolo e classe operaia; il potere, come concezione rozza e primordiale, incapace di rap
Il contesto culturale e politico del neorealismo
55
presentare il potere reale e tantomeno il tessuto istituzionale con cui il capitale organizza a livello sociale il suo potere di controllo e di prefi gurazione dello sviluppo (ne consegue un malcostume politico, continuamente destinato al qualunquismo anti-istituzionale non fondato su nessun riferimento di classe); la merce, come un mondo separato dalla sfera « uma na », un espediente che denuncia l’alienazione del « commercio », ma non penetra nei modi espressivi dell’uomo, oppure come un sistema di segni, che può uniformare i gesti delle quotidianità sino alla più assoluta mimesi, ma non riconduce mai alla produzione; il lavoro, come dimensione singola, artigianale, individualistica, cioè determinato ancora nel suo conflitto con la generalità sociale del lavoro proletarizzato, dunque ancora interpretato come « invenzione » di fatica e sofferenza, e non come produzione di lavoro. Alla luce di questa traccia possiamo proporre lo studio e la discus sione di una serie abbastanza ricca di analogie. Ad un alto livello espressivo potremmo, ad esempio, osservare i nessi organici che legano la concezione dell’uomo nella prima e soprattutto nella seconda produzione rosselliniana alla concezione della cultura presente nei suoi televisivi a scopo « didat tico». A un più basso livello espressivo per quanto riguarda la dimen sione individuale della produzione estetica, ma, secondo noi, estremamente più ricco per quanto riguarda la produzione di valori e informa zioni estetiche a livello sociale, potremmo osservare come e quando le esperienze di un De Santis, di un Germi, di un Rosi siano confluite nel cinema di consumo di un Petri, e come questo cinema rappresenti gli stessi margini di considerevole arretratezza non soltanto da un punto di vista di classe ma anche e soprattutto da un punto di vista « civile ».
3. Ma il ragionamento fatto sul cinema neorealista non è applicabile sol tanto ai diversi quadri operai, tecnici e intellettuali, che nella produzione cinematografica trovano forme lavorative specifiche. Vale a dire che il discorso, che qui tentiamo sul nesso organico tra neorealismo e industria culturale, non è valido soltanto per il lavoro intellettuale presente nell’indu stria filmica. Certo in essa il lavoro intellettuale, d’origine e tradizione « letterarie », si trova immediatamente inserito in una serie di condiziona menti, dovuti all’innesto diretto con altre figure sociali dei meccanismi produttivi, e l’evidenza di questo innesto appare nelle stesse fortissime analogie, che temi e personaggi, prodotti dagli sceneggiatori-letterati, sem pre più avranno con modi di comportamento e personale dell’azienda cine matografica, della sua quotidianità lavorativa. Tuttavia, i motivi per cui il neorealismo è all’origine del nostro mercato culturale vanno ben oltre gli spazi « meccanici » di confluenza tra lavoro intellettuale tradizionale e lavoro industriale, e possono essere riscontrati anche in altri campi, non ultimo, anzi estremamente significativo, quello della letteratura (o del teatro). Ma va anche detto che, per la stessa crescita della comunicazione
56
Il neorealismo cinemato&afico italiano
audiovisiva rispetto a quella scritta, la progressiva formazione di un’in dustria editoriale della letteratura, trova numerosi innesti, diretti o indi retti, con il cinema e la televisione. Tenendo presenti gran parte di quelle stesse antinomie, che nel pa ragrafo precedente abbiamo visto come antinomie irrisolte del neorealismo cinematografico, possiamo proporre in questo caso l’analisi di un Moravia, di un Pasolini, e per aspetti quasi inversi, ma perfettamente speculari, di un Visconti: essi rappresentano, infatti, oggetti di studio particolarmente suggestivi, poiché spesso la loro originalità formale corrisponde, da un lato, a una grossolana resa intellettuale e persino estetica, e, dall’altro, a una vocazione consumistica priva di consapevolezza politica (quand’an che non ideologica e professionale). Ciascuno di essi, pur facendo riferi mento a ceti culturali distinti e a tradizioni estetiche molto lontane, non a caso trovarono nel neorealismo un terreno comune di ispirazione, non a caso ne perpetuano il significato, non a caso infine, costituiscono i mo delli più significativi della nostra industria culturale, per quanto ancora arroccata sulla difesa di se stessa in quanto vera e propria cultura in senso umanistico. Alberto Moravia — dopo l’esperienza pre-neorealista de Gli indiffe renti — persegue con sistematicità e coerenza un modello di lavoro intel lettuale intimamente legato alla sorte e sviluppo dell’editoria. Proprio nella costante ricerca di moduli narrativi standardizzati — che trovano la loro più felice espressione nei racconti, veri e propri bestiari del comportamento umano ai vari livelli della scala sociale — possiamo verificare la coesi stenza perfettamente organica tra una concezione assolutamente umanistica della cultura — proprio nella sua disponibilità per Freud e Marx — e un valore medio, espresso dal pubblico ideale, per cui Moravia scrive, e che è lo stesso di cui scrive — di volta in volta travestendolo con le sem bianze di ceti e classi diverse. È significativo il fatto che Moravia, pur non avendo voluto, anzi pro prio perché non ha voluto essere un tecnico dell’immagine, cioè trasfe rire il suo lavoro intellettuale nel campo dell'organizzazione registica, è riuscito ad essere un punto di riferimento quasi costante per il cinema. Il suo stile letterario, infatti, rappresenta già in se stesso un prodotto dell’indu stria culturale, anzi questo si pone in funzione reciproca con gli altri mass media, e quindi realizza storicamente una precisa azione di stimolo, introdu cendo nel mercato, soprattutto nella fase neorealista e al suo concludersi, al cune « consapevolezze » letterarie esterne all’esperienza media del personale intellettuale cinematografico. Tuttavia, proprio nella rigidità della forma zione umanistica, e nella fissità della sua visione dei rapporti di classe (da cui deriva una concezione superficiale dei margini « dialettici » del pub blico), Moravia sempre più rivela una circolarità improduttiva non a caso accentrata sul rapporto sesso-merce: è questo Vunico binomio realmente
Il contesto culturale e politico del neorealismo
57
operante nella poetica moraviana al posto di quello cultura-politica. Così questo scrittore — capace di ereditare la tradizione « dilettantesca » di uno Svevo e farsi « professionista » del romanzo e del racconto con una applicazione ininterrotta sino ai giorni nostri — esemplifica in modo per fetto il livello medio o medio-alto della nostra industria culturale, ma si innesta anche ai livelli più arretrati per la sostanziale impoliticità dei suoi contenuti tecnici. In Pier Paolo Pasolini assistiamo ad esiti originalissimi, eppure an cora più emblematici di alcuni caratteri endemici della cultura neorealista e post-neorealista. In questo poeta-scrittore-cineasta-moralista il contrasto più violentemente espresso è quello sesso-sviluppo, con una forte tendenza a identificare la passionalità culturale, ormai definibile soltanto in termini eterodossi, appunto al sesso, e la politica — come potere in fieri — nella distruzione della civiltà contadina. L’originario assunto della poetica neo realista, tutta sbilanciata verso il sottoproletario e gli « esclusi » dallo svi luppo industriale, torna rabbiosamente ad agire attraverso la letteratura e soprattutto (non a caso, data l’origine cinematografica del neorealismo) attraverso il cinema di Pasolini. Tuttavia Pasolini ha praticato una lucidissima operazione eclettica tra raffinatezze stilistiche del suo moralismo estetizzante e immagini sociali ancora scarsamente penetrate nei circuiti dell’informazione. Mentre i deboli messaggi di Poveri ma belli non potevano creare che brevi cicli di consumo, le immagini forti e sensitive di Pasolini avrebbero svolto tutt’altro ruolo. A Pasolini si deve, ad esempio, la tarda ma massiccia operazione impren ditoriale per cui l’industria culturale ha fatto oggi entrare sul mercato, in termini assolutamente nuovi e più estesi, temi, archetipi, e modelli della tradizione letteraria. Ma molto interessante è osservare il procedere tec nico di questa operazione e il suo risultato effettivo: saldamente abbarbi cato alla sua cultura, Fautore-regista non ha fatto dell’industria culturale, integrando nell’opera i diversi referenti sociali, adeguandone i diversissi mi messaggi ad un unico significato complessivo, realizzando quindi — come accade in altri modelli di produzione culturale attraverso i mass media — reciproche funzioni tra la massificazione di valori artisti ci tradizionali e nuovi valori sociali, di classe, interclassisti ecc. Per Pa solini vale forse la pena di ricordare l’immagine del contadino solitario, che semina al tramonto, trasmessa a noi dalla pittura dell’ottocento: il regista, infatti, semina nel campo della sua cultura, già tutta risolta in se stessa nel bene e nel male dei suoi tradizionali ed evangelici conflitti, la carne umana dei suoi attori, la loro sostanza reale di eterni sottopro letari. Ad essi il poeta, e l’utopista, fa percorrere i meravigliosi spazi del tempo e della fantasia estetica, fa indossare i panni della favola boccac cesca e orientale, divina o greca, senza accorgersi che a questi suoi eroi, a questa sublimazione eccezionale dell’attore preso dalla strada, delle
58
Il neorealismo cinematografico italiano
poetiche zavattiniane, del cattolicesimo rosselliniano, egli assegna il com pito di una sotto-cultura, non perché raffrontata con la grande cultura borghese, con cui il confronto è ormai improponibile, ma piuttosto tale benché al di sotto dei livelli raggiunti, in altro luogo e tempo, dall’in dustria culturale stessa. Per Visconti, come abbiamo già detto, il discorso è diverso: esso torna a riguardare il cinema, anche se parte dalla cultura letteraria. Con Visconti, infatti, assistiamo a un tecnico dello spettacolo, che ha sin dal l’inizio voluto « sceneggiare » filmicamente il patrimonio artistico tradi zionale. Questa volontà si è espressa in modo adeguato ai livelli cultura li, appunto, del pubblico intellettuale, praticando poi, di volta in volta, i processi amplificatori o riduttivi propri dello spettacolo: ad esempio, parte da Verga e arriva a Thomas Mann con una sfasatura praticamente costante tra modelli spettacolari e comprensione del testo. Anche in questo caso assistiamo a un inserimento nell’industria cul turale di portata quantitativa notevole, ma qualitativamente disomoge nea: Visconti, dopo aver assimilato il naturalismo francese di Renoir, e averne tradotto in chiave nazionale alcuni messaggi con una resa tecni ca indubbiamente inferiore, continuò a concepire il film secondo una di namica di rapporti interni molto simile a quella teatrale. Le conseguen ze di ciò possono essere verificate non soltanto sulla scarsità di invenzioni fìlmiche, che il suo cinema ha offerto e offre, ma anche sul limitato campo d’azione culturale di cui il suo prodotto dispone. Tentando di annullare ogni conflittualità tra livelli culturali e livelli politici nella struttura della grande opera d’arte borghese, egli ce ne ha sempre data una pallida immagine, mai interamente riscattata dalle frequenti raffina tezze teatrali. 4. La discussione sulla critica ci sembra non possa essere condotta se paratamente da quella sulla politica culturale del Movimento operaio: cioè crediamo che non si possa parlare del problema di una valutazione del mercato neorealista in modo scisso dal problema di un controllo po litico sul suo sviluppo e sul suo funzionamento. Inoltre, 'per quanto il lavoro intellettuale, operante negli spazi istituzionali *della critica, sia cosa diver sa e spesso opposta dal lavoro intellettuale, svolto all’interno delle organiz zazioni politiche della sinistra, è storicamente provabile la frequenza con cui alcuni « quadri » della critica hanno pesato, direttamente o indiret tamente, nelle scelte politico-culturali. In altre parole, critica e politica culturale riproducono alcune contraddizioni generali tra cultura e politica. In questa direzione è possibile accentrare l’attenzione su alcuni mo menti fondamentali in cui critica letteraria, o cinematografica, e scelte politico-culturali hanno assunto una loro precisa configurazione. Si trat ta di un terreno d’analisi già più volte percorso, e in cui ci sembra
Il contesto culturale e politico del neorealismo
59
soprattutto interessante praticare alcune inversioni del ragionamento tra dizionale, volto a salvaguardare la razionalità della critica o la superiori tà della politica dalla determinatezza del mercato. Si veda, a questo pro posito, anche i cenni fatti nell’introduzione al volumetto curato dalla Mostra di Pesaro. Nel complesso, ci pare di poter tracciare due linee divergenti, l’una, quella della critica, profondamente involutiva, regressiva, antistorica, an tisociale, ecc., e l’altra, quella della politica culturale dei partiti di sini stra, e tra essi in particolare, per il suo peso quantitativo, il pci, gra dualmente evolutiva, progressivamente capace di adeguarsi alla storia e alla società, di superare i suoi stessi ritardi e le sue stesse contraddizioni. Tali linee non a caso hanno un punto di congiunzione intorno alla fine degli anni Cinquanta, alla fine, cioè, del ciclo creativo del neorealismo e all’inizio della sua deflagrazione verso i meccanismi della mercificazione culturale e della massificazione intellettuale. È il momento in cui da un lato il PCI rappresenta, ancora, un tentativo della politica culturale del movimento operaio, volto a garantire uno spazio alla cultura proprio co me forza «civile» emarginata (tanto quanto minoranze, sottoproletari e contadini), la critica, dall’altro lato, tocca la punta massima della sua ini ziativa restauratrice, volta a salvaguardare la sopravvivenza della propria funzione e del proprio ceto. Sono i tempi in cui le teorie del realismo so stengono sia la teoria deH’impegno politico nel campo culturale sia la teoria dell’impegno culturale nel campo sociale. Sono i tempi in cui, tut tavia, sul fronte anti-censura si costruisce una dinamica liberatoria del l’informazione, ad onta dei tentativi sistematici, profondamente retrivi, presenti sia da parte borghese che da parte comunista, e sul fronte anti decadente della critica si assiste al provincialismo nazionale di un siste matico rifiuto di tutta l’esperienza novecentesca che conta a livello europeo. Non è un caso che dall’iniziale conflitto tra intellettuale e politico dei tempi del Politecnico, si sia giunti alla costituzione di un fronte de mocratico, in cui l’intellettuale, il letterato, l’artista occupano un posto particolare ma definito. Il lavoro intellettuale viene, infatti, a trovarsi, come abbiamo già detto, nella zona arretrata del lavoro improduttivo, su cui la strategia del movimento operaio, a partire dalla ricostruzione, aveva fondato alcune sue scelte generali. Non è un caso che la critica si presenti — da un certo punto di vista — più avanzata nel ’50 (si ricordino le acutissime critiche di N. Gallo al neorealismo) di quanto rie sca ad essere nel decennio successivo (si ricordi l’ofieso arroccamento di posizioni provinciali e impolitiche provocato dalla pubblicazione di Scrit tori e popolo): non è un caso perché, mentre un Niccolò Gallo poteva permettersi di parlare ancora in un cenacolo critico abbastanza convinto nel suo passato e nel suo futuro (che dunque poteva permettersi di dubi tare sul presente)^ già dieci anni dopo l’esito dell’industria culturale è defi
60
Il neorealismo cinematografico italiano
nito, i critici non possono più raccogliersi intorno a un oggetto d'analisi con la mente sgombra da preoccupazioni: devono invece raccogliersi in torno al proprio ceto, devono difendere il passato e soprattutto il presente che essi vedono in se stessi. Sia per lo sviluppo della critica che per i primi anni di politica culturale della sinistra (stiamo chiaramente semplificando le posizioni, che nella realtà furono molto più articolate), c'è un punto di vista co mune sulla cultura: esso, rifiutandosi di considerarla come produzione, ma anche come istituzioni (si pensi allo straordinario ritardo con cui il movimento operaio cercherà di organizzarsi all’interno della Scuola), non riuscirà a ottenere alcun risultato politicamente apprezzabile. Con l’intervento del neocapitalismo italiano ai vari livelli dell’infornazione culturale e artistica, con la progressiva proletarizzazione del la voro intellettuale, con la tendenza ad accentuare l’improduttività di alcu ni istituti e a esaltarne la dinamica industriale in altri, assistiamo a un in serimento della figura del critico nel campo dell’editoria, non più con funzioni « tradizionali » ma assolutamente manageriali, e a una svolta delle scelte di partito sulla cultura. Le conseguenze sono abbastanza evidenti. Il ramo secco della cri tica costituisce, oggi, il livello più arretrato del lavoro intellettuale, quel lo più neorealista nel significato deteriore del termine, quello assolutamente incapace di istituire qualsiasi rapporto organico tra cultura e po litica. La politica culturale, invece, quanto più è presente ai livelli mag giormente avanzati del lavoro intellettuale, a quei livelli che giustamen te Gramsci aveva visti uniformati alla produzione industriale vera e pro pria, tanto più ha iniziato un corretto rapporto politico non soltanto con il settore che gli compete direttamente, ma anche con quelli affini, cir convicini, socialmente collegati. Si apre, a questo punto, la discussione di questi ultimi anni: i modi in cui la lotta di classe agisce ai livelli istituzionali, in cui il lavoro intellettuale si organizza sindacalmente e politicamente, in cui la lotta di fabbrica si generalizza e conta ai livelli dell’informazione, della scola rizzazione ecc. In questo senso, la tematica del neorealismo sembra final mente superata; e, per quanto riguarda l’ideologia, ci sembra esserlo. Tuttavia, a nostro modo di vedere, continua ad essere operante il terzo elemento « occulto » che avevamo individuato dietro il rapporto tra politica e cultura nel neorealismo: la concezione della merce. In que sto senso ci sembra che l’ideologia e la prassi neorealista pesino ancora in modo estremamente negativo non solo sul lavoro intellettuale singolo, di cui comincia a non interessarci nessuna scelta, ma anche sul lavoro in tellettuale organizzato, appartenga esso alla politica, all’industria cultu rale o anche alla scuola. Gramsci può ancora servire.
LA PROBLEMATICA GRAMSCIANA E LA QUESTIONE DEL NEOREALISMO di Saveria Chemotti
Nei riguardi dell’opera di Gramsci persistono a tutt’oggi atteggiamenti antitetici (per molti aspetti parimenti mistificanti) che da un canto ne evi denziano la sospetta eterodossia rispetto alle tesi marxiste-leniniste, dal l’altro manifestano una incondizionata adesione (acritica perché misticheggiante) alla sua attività politico culturale, oppure ne sviliscono la complessa problematica in discussioni sterili (perché dogmatiche) sulla valenza poli tica o estetica o sulla pertinenza critico-letteraria delle note dei Quaderni e delle Lettere. Come stigmatizza Massimo Salvatori a Gramsci capita davvero di essere una fonte alla quale tutti attingono l’acqua di cui hanno bisogno: per alcuni è il padre di una concezione di autentica demo crazia proletaria, per altri è uno staliniano di stretta osservanza, per altri ancora è il padre spirituale di Giorgio Amendola o tout-court un socialdemocratico magari anche di destra, vi è chi lo considera un marxista-leninista ortodosso, agli occhi di altri, per finire, è un idealista impenitente che non ha mai capito niente di mar xismo o quasi. Troppa grazia sant’Antonio!.
Ci si trova quindi sempre dinnanzi a un « Gramsci di tutti », a descri zioni o definizioni che in termini generici assimilano del suo pensiero quanto può servire da un supporto per dissertazioni accademiche o pole miche settarie: e questa mistificazione ha nuociuto non poco alla sua com prensione storico-critica offrendo il destro a troppe e sbrigative conclusioni. Nel denso dibattito sviluppatosi dopo la pubblicazione delle Lettere e dei Quaderni (apparsi in brevi stralci a partire dal ’44 su « La Rina scita », « Società », « Il Politecnico », e poi sistematicamente dal 1947) emerge la tendenza ad assimilare la problematica gramsciana alle posi zioni di engagement che vengono teorizzate nell’immediato dopoguerra e a porre l’accento sul significato di lotta culturale come proposta di conte nuti alternativi all’arte (da tutto ciò, negli anni Sessanta scaturirà l’alibi per una identificazione della Weltanschauung gramsciana con il realismoneorealismo e con la politica culturale e « riformista » del pci). Diviene anche per questo assai arduo stabilire con certezza quanta parte delle notazioni gramsciane sia stata assorbita (non assimilata) dalla generazione neorealista: si può semmai parlare di travaso, non di innesto.
62
Il neorealismo cinematografico italiano
Le stesse date di edizione dell’opera pongono seri interrogativi sulla pos sibilità di una loro influenza nel dibattito sulla funzione del realismo-neo realismo; del resto la stessa storia interna del movimento neorealista (se così si può implicitamente chiamare), già difficilmente connotabile data l’estrema labilità dei suoi contorni etico-culturali-artistici, sembra dimo strare l’incongruenza di un accostamento diretto Gramsci-neorealismo an che perché la presenza teorica del gramscismo si nota quando il dibattito è arrivato a scindersi in correnti allotrie rispetto alla matrice originaria, l’ewgtfge/weff/, da cui parve scaturire. La scoperta di Gramsci suscita un’eco immediata in molta parte dell’intellighentia italiana; si verifica uno slancio spesso irrazionale verso i Quaderni, una specie di identificazione religiosa soprattutto da parte di chi si sente gramsciano ante litteram, per vocazione. La strumentalizza zione dell’opera dell’intellettuale sardo fu cosa facile (favorita senza dub bio anche dalla situazione editoriale in cui furono oggettivamente presen tati i Quaderni): si innestò nelle discussioni sul ruolo dell’intellettuale e della cultura e per certi aspetti parve suffragare emblematicamente le tesi dell’estetica socialista-zdanoviana. Gli intellettuali di « sinistra » videro nella Weltanscbauung gramscia na la « legittimazione » delle loro aspirazioni all’impegno, inteso come partecipazione all’etica della ricostruzione nazionale, alla mistica della let teratura popolare in cui il termine « popolo » diveniva significativamente il fruitore di una serie di messaggi tradizionali che tendevano a coprire il « ritardo » accumulato dalla nostra cultura nei confronti di un rap porto organico con le esigenze della massa. L’ideologia dell’antifascismo interclassista, la tematica dell’umana so lidarietà e del progresso morale nazionale parvero essere mutuate già in nuce da Gramsci che a sua volta subì l’ostracismo di quella parte della cultura italiana che, severa con ogni tentativo di imposizione di politica culturale, non seppe leggere (non volle leggere?) in Gramsci la presenza di un’antitetica concezione dell’arte e del rapporto arte-vita-pubblico. Quan to questo sia stato (e sia) erroneo (per usare un termine medio) è chiaro ormai ai critici e ai militanti più circostanziati e a qua.iti vanno operando una rilettura dell’opera gramsciana in prospettiva sincronico-diacronica, politica e culturale densa di risvolti ideologico-organizzativi sul piano della prassi. A questo proposito va anche notato che mancano documenti che pos sano provare l’influenza diretta del gramscismo sulla narrativa neorealista (e sulle altre forme di espressioni artistiche quali il cinema, la pittura, la musica) del dopoguerra che tende sostanzialmente a perseguire indicazioni stilistiche e contenutistiche già emerse negli anni Trenta (gli accenni a-posteriori che si possono dedurre non sono probanti in dimensione corretta). Il neorealismo italiano si pose come assunto antiretorico e antilette
Il contesto culturale e politico del neorealismo
63
rario mediando o assumendo il contrasto tra rondisti e realisti che si deli neava in quel periodo complesso. Si può dire senza dubbio che Gramsci partecipò alla discussione in atto tra contenutisti e calligrafi, tra strapaese e stracittà, ma le acquisizioni a cui pervenne vengono rese note a-posteriori (quasi sassi tirati forzatamente nel buio) e sono ideologicamente e poli ticamente stridenti con la cosidetta concezione « neorealista ». Infatti, il principio unitario che sottende o organizza le note gram sciane sulla letteratura si può estrinsecare nell’afiermazione di un prin cipio di responsabilità-libertà del critico (cfr. i saggi di G. Scalia) nell'eser cizio della sua attività: va altresì ribadito che l’interesse che stimola Gramsci a occuparsi con preminenza dei fatti culturali e letterari non si può identificare in quello del teorico estetico o dello storico letterario specia lista (in senso accademico) ma in quello dell’organizzatore di cultura, del critico militante. Parimenti, egli nega la pretesa del critico politico di pro nunciare il valore artistico atto a provocare tendenze o inversioni di ten denze, sia quella dell'artista di trasformare la sua attività in intervento politico diretto. L’artista partecipa alla conoscenza della realtà, non la predetermina e non la trasforma: il critico non è un filosofo o un pedagogo-, egli tende a conoscere le condizioni e le strutture del fatto letterario inteso nel suo « circolo » non solo stilistico e psicologico, ma storico sociale e culturale. Se quindi il politico non può imporre determinati contenuti all’opera d’arte, la critica artistica non va confusa con le esigenze di una politica culturale, non si limita a un’individuazione estetica, ma si precisa nella ricostruzione culturale di un’epoca, delle tendenze intellettuali che ne ca ratterizzano lo sviluppo storico. Anzi, secondo Gramsci la confusione tra i due ruoli (se così si possono definire) è la causa del non conseguimento dei fini inerenti alla lotta culturale.
Egli scrive: Il concetto che l’arte è arte e non propaganda politica voluta c proposta è poi in se stesso un ostacolo alla formazione di determinate correnti che siano il riflesso del loro tempo e che contribuiscano a rafforzare determinate correnti politiche? Non pare, anzi pare che tale concetto ponga il problema in termini più radicali e di una critica più efficiente c conclusiva. Posto il principio che nell’opera d’arte sia solo da ricercare il carattere artistico, non è per nulla esclusa la ricerca di quale massa di sentimenti, di quale atteggiamento verso la vita circoli nell’opera stessa [...] ciò che si esclude è che un’opera sia bella per il suo contenuto morale c poli tico, e non già per la sua forma in cui il suo contenuto artistico si è fuso o imme desimato.
La prospettiva gramsciana (come questa nota evidenzia) è sempre e in ogni momento politico-organizzativa, ma la sua lotta culturale per una "Weltanschauung proletaria non è mai assimilabile alla pragmatica imposi zione di contenuti all’opera d’arte; il concetto crociano di autonomia su bisce una scomposizione ideologica c viene superata in una unità politica
64
Il neorealismo cinematografico italiano
e dialettica altrimenti feconda della circolarità dello spirito assoluto. La confusione paventata da Gramsci si è verificata nel dopoguerra, proprio quando realismo e neorealismo (termini indistinti data la comune matrice) divengono una nozione ambigua, indefinita, spesso impiegata come sistema estetico di un superficiale marxismo. Nella problematizzazione critica di questa nozione si avverte la deficienza di rigore metodologico e storiografico che consente agli intellettuali italiani genericamente mar * xisti di scoprire nel nazionalpopolare gramsciano il nesso logico-artistico che aveva ispirato e doveva ispirare la pratica culturale. Tutto ciò sempre procedendo equivocamente al di là e al di qua delle indicazioni puntuali (nonostante l’oggettiva frammentarietà e la loro apparente disorganicità) che si possono ricavare dai Quaderni e dalle Lettere. Il nazional-popolare gramsciano sembrò collaborate alla diffu sione di una letteratura provinciale che mutuava dal tardo-romanticismo e dal tardo-verismo (quando non dal realismo socialista) le istanze populi stiche: il mondo dei contadini e degli operai venne fissato in figurazioni mitiche, sovrapposte staticamente a un sostrato cronachistico in cui hanno larga parte le nostalgie piccolo borghesi. Ci si limitò a descrivere la realtà storico-politica in termini di mimesi, passivamente, quasi applicandole categorie carismatiche atte a suscitare qualche plauso da parte di note esi genze « burocratiche ». La prova dell’inanità di questo recupero di tradizioni stantie (più tardi avallate dal credo « nazional-popolare ») viene fornita indirettamente dalle opere di chi andava arricchendo con l’esperienza di un difficile con tatto con la nuova realtà (al di là di prefigurazioni retoriche) il pano rama complesso della narrativa italiana. AI di là degli schemi, solo chi aveva preso conoscenza della crisi propria nella crisi della cultura europea e na zionale (crisi di miti e di ruoli) e aveva tentato di formulare una risposta offriva un contributo efficace e storicamente rappresentativo. In particolare, il concetto di nazional-popolare gramsciano veniva ad essere applicato (« usato » tout-court) come definizione di una realtà cul turale già delineata: diveniva vuota formula di un contenuto preesistente (in questo caso la produzione neorealistica) con cui la connotazione origina riamente attribuitale da Gramsci cozzava violentemente. Va osservato, in fatti, che storicamente l’importanza che Gramsci assegna al termine « na zionale » è riconducibile in un primo luogo alla discussione in atto in seno al movimento operaio tra rivoluzione nazionale e rivoluzione intemazio nale. Egli precisa: Certo lo sviluppo è verso l’internazionalismo, ma il punto di partenza è nazionale ed è da questo punto di vista die occorre prendere le mosse. Ma la prospettiva è intemazionale e non può essere che tale. Occorre pertanto studiare esattamente la combinazione di forze nazionali che la dasse intemazionale dovrà dirigere o svi luppare secondo le prospettive e le direttrici intemazionali. La classe dirigente è tale solo se interpreta esattamente questa combinazione di cui essa è componente.
Il contesto culturale e politico del neorealismo
65
E anche l’analisi della funzione culturale e politica assunta dal romanfeuilleton si può configurare in certo senso come pars-distruens di una ricerca che ha come oggetto la dimensione non popolare della letteratura tradizionalmente definita tale e per soggetto la lotta per l’egemonia della classe popolare anche attraverso un nuovo ruolo (non burocratico) assunto dalla cultura nazionale. Un’opera d’arte è tanto più « artisticamente popolare » quanto più il suo contenuto morale, culturale, sentimentale è aderente alla moralità, cultura, ai sentimenti na zionali, e non intesi come qualcosa di statico, ma come un'attività in continuo sviluppo ...
E, in un altro passo, Gramsci precisa: Che si debba parlare, per essere esatti, di lotta per una , là, nel discorso reale, non ideologizzato, degli autori e dei film, si proce deva in tutt’altro senso. In Rossellini, la delusione etico-politica si rovesciava nel rifiuto astrat to dell’istituzione, mentre prendeva corpo una ricerca altrettanto generi ca e atemporale della « autenticità »; e « natura » e « storia », provviso riamente saldate, negli anni della trilogia iniziata con Roma città aperta, in una stretta di violenza e di furore, tornavano a separarsi e contrapporsi. La « nuda disperazione », esorcizzata dalle tribune dei congressi, ispira va i momenti più alti e la concezione stessa del film più rigoroso e com patto di De Sica, Umberto D. L’evocazione del passato e la riscoperta del « negativo », certo ben altrimenti ricche e complesse di quanto non vorrebbero alcuni manichei di andata e di ritorno, sarebbero divenute, in Visconti, molto più autentiche e persistenti della flebile declamazione del futuro. In quanto al futuro del cinema, sarebbe stato, a lungo, degli Antonioni e dei Fellini. E tuttavia, il neorealismo non fu un’invenzione normativa di Alicata o una generosa velleità di Zavattini. Nel cinema — nel primo Ros sellini, in Sciuscià e in Ladri di biciclette, in Visconti da Ossessione a Bel lissima, in alcuni momenti di altri — il neorealismo, oltre a volerlo, riu scì anche a essere, in modi e a livelli diversi, aggressione e furore conosci tivo, scoperta del tragico quotidiano, rovesciamento della dimensione « grande » della storia e testimonianza accesa e indignata dei suoi risvol ti di oppressione individuale e collettiva. Ma, profondamente fuso e intrecciato a questo, ci fu, e sin dall’ini zio, anche altro, che l’« ideologia » neorealistica continuava a rimuovere o a esorcizzare con volonterosi appelli, nel migliore dei casi, alla « fidu cia » e alla « speranza »: il senso dello scacco e la coscienza di una dolo rosa, irreparabile sconfitta storica. Non è certo un caso che i due soli autori diversamente immuni dal populismo, Rossellini e Visconti, fosse ro anche quelli in cui la liberazione dal populismo si attuava attraverso la scoperta di una misura tragica, senza futuro, del personaggio popolare: Elio Vittorini, Politica e cultura, lettera a Togliatti, in « Politecnico », n. 35, gennaio-marzo 1947 (in La polemica Vittorini-Togliatti, dt., p. 47).
Ideologie e stili del neorealismo
249
la mone della Magnani in Roma città aperta, la sigla lancinante e impie tosa delle conclusioni dei quattro « episodi » maggiori di Paisà, il lungo dopoguerra preannunciato da Germania anno zero, la solitudine certo non fatale, come si è scritto tante volte, ma non per questo meno disperata di ’Ntoni Valastro nell’ultima inquadratura di La terra trema. L’« umile » diventa « personaggio » nel momento e nella misura in cui vive sino in fondo la propria tragedia individuale così carica, però, di echi e di rimandi collettivi. Si direbbe che, ne siano più o meno consa pevoli gli autori, il « neorealismo » si realizza davvero nell’atto in cui avverte la propria « impossibilità » e fissa in desolate radiografie la co scienza di non avere futuro, in un paese che viene rapidamente restauran do il suo volto di sempre. La verità del neorealismo o almeno la sua faccia non consolatoria, è nella « sudicia ragazza italiana » di Rossellini (ma anche nelle immagini degli anglo-americani che osservano con il bi nocolo, dalle colline, la « battaglia » di Firenze). Gli altri, soprattutto quel li che ripetevano in pubblico le formule del catechismo, erano, o tenta vano di essere, suonatori di piffero. Poco convinti, per giunta, e presto o tardi ripresi dal « vecchio gioco » di cui parlava Fortini.
STILE E STILI DEL NEOREALISMO di Giorgio Tinazzi
L’opportunità di un lavoro critico di revisione e verifica del neo realismo appare evidente, sia da un punto di vista storico, come studio sull’estensione e l’incidenza in un certo momento, sia in prospettiva, per il significato e gli equivoci per il dopo, esaminando i pieni e i vuoti anche per quello che hanno voluto dire per il cinema italiano posteriore. Sono due versanti naturalmente complementari, per evitare che il riesame, oggi, perda il senso del rapporto storico. Si tratta quindi anche di vedere la genesi del movimento (se di mo vimento si è trattato), di collocare le opere in un contesto che conosce va ramificazioni anteriori anche per osservare se e come ci siano state riprese del cinema precedente. Scrive Asor Rosa, a proposito della conti nuità del filone populista: nel cinema l’assenza di una forte tradizione nazionale permette un'invenzione piti libera e spregiudicata anche da un punto di vista stilistico — ciò che non elimina la debolezza dell'impianto ideologico e culturale, ma in un certo senso la trascende nella immediatezza delle impressioni, nella «verità» nuda del racconto;
e ciò è vero, ma non del tutto. Perché se la mancanza di una tra dizione fu di giovamento, è anche da dire che alcuni filoni (il cinema « regionale », ad esempio, o la « commedia » che il cinema italiano riaf fronta già nel ’46) avevano lasciato prima una traccia, magari non marcata; e poi occorrerebbe verificare come le istanze « realistiche » aves sero trovato posto, sia pure genericamente, anche all’interno del cosid detto « fascismo di sinistra »; senza con ciò cadere nella suggestione, per il cinema, di affermare una continuità che sarebbe costruita per elegante ipotesi. Ma \yimmediatezza cui si faceva cenno torna fuori al momento del la crisi neorealista, quando il retroterra era necessario per articolare pro poste di superamento; e pure la limitata attenzione ai problemi dello stile (non formalisticamente inteso) diventa un fattore non secondario. Perciò, dopo la genesi e lo sviluppo del neorealismo, è ovviamente impor tante puntare l’analisi sulla situazione venutasi a creare attorno agli anni ’50; perché — si sa — fu crisi dovuta a fattori esterni determinanti
Ideologie e stili del neorealismo
251
(l’involuzione sociale, l’assestamento perseguito dalle nuove risultanze po litiche), ma anche interni, per insufficienze ideologiche o culturali. La pre ponderanza dei primi portò a difficoltà nell’individuare a favore di chi, e cioè per quale cinema, e per quale pubblico (ecco un punto nodale) occorreva fare proposte, dopo essersi raccolti contro qualcosa e qualcu no. Troppo facile, già allora evidentemente, parlare di crisi come « fine dello stato di grazia ». Occorreva non solo la consapevolezza derivante dal neorealismo, ma anche la consapevolezza del neorealismo (quella che, almeno in parte, ebbero Rossellini e Antonioni, per opposti versanti). Anche per questo, parlando del movimento, è opportuno non iso lare le punte (gli « autori »), ma considerare assieme il dima in cui si mossero e le sue ramificazioni. Occorre però fare qualche precisazione; è necessario superare un approccio al neorealismo fatto per « monografie », che ignora le componenti storiche complessive e il contesto, ma è altret tanto necessario, poi, effettuare distinzioni, per non finire (come troppe volte) col « saltare » le opere in nome dei principi generali. Anche per non cadere poi nell’equivoco unitario, che si riallaccia ideologicamente al concetto di Resistenza come movimento anch’esso unitario, senza spaccature o divergenze. Da un punto di vista teorico, vi può essere l’errore di osservare quel le opere alla luce di una nozione « globale » di realtà, un’ontologia che nasconde pericoli abbastanza evidenti, e da cui non fu immune nemmeno chi, come Bazin, diede contributi di primo piano per la comprensione di autori. L’equivoco unitario primario, storico prima che teorico, rischia ef fettivamente col non considerare tra l’altro (per arrivare al tema che ci interessa) la diversità dell'apporto stilistico, la diversa consistenza che eb be la considerazione del momento costitutivo (e perciò conoscitivo) delle opere, la possibilità di superare, anche su queste basi, l’inevitabile fase di riflusso. A questo punto gli autori diventano pochi. Non a caso sono quelli che subiscono maggiormente l’impatto col pubblico; certo, il neorealismo dovette fare i conti anche con l'impopola rità delle opere (gli incassi ne sono testimonianza) che non facilitava ten tativi o esperimenti, ma occorre dire che ciò fu sicuramente un ef fetto indotto (ancora, le troppe censure, i veti politici) ma anche inter no. L’equivoco di cui giustamente parla Spinazzola («Il neorealismo [...] progettava di rivolgersi ai ceti subalterni, ma trovava gli interlocutori elet tivi nell’ala radicale dell’intellettualità borghese ») era frutto anche di scel te non fatte, o non fatte a tempo: quello di un aggancio ad una precisa visione politico-culturale, dietro la quale stesse non già (o non solo?) un’ autocritica borghese ma un rapporto — in termini diversi — con gli stra ti popolari. Lo spazio vuoto tra autori e pubblico era conseguenza inoltre delle spinte differenziate, e spesso generiche, che provocarono il clima po
252
Il neorealismo cinematografico italiano
litico nel quale si muovevano gli autori. Dovendo sintetizzare, credo si possa affermare che la « rottura » mantenne in realtà il movimento all' interno-, è opportuno allora analizzare come nel suo complesso si sia trat tato, appunto, di un atteggiamento che si qualificava all’interno delle strutture borghesi, anche se con particolari capacità di individuare e sfrut tare le lacerazioni che esse palesavano. Probabilmente per questo, dal punto di vista storico, ci si può accor gere che il momento della crisi non portò, o portò raramente, a rinnovare le proprie posizioni di fondo, a fare quel processo che non era stato fatto nell’immediato dopoguerra, ad una cultura e alla sua dimensione politica; cultura — si è detto giustamente — che si trattava non tanto di esten dere (per guadagnare quantitativamente) quanto di far diventare altra ( mutare qualitativamente ). Verifica, dunque, a vari livelli, attuata, come vedremo, in una misu ra che incise abbastanza marginalmente. Era necessaria per i destinatari, perché il pubblico della cui organizzazione si parlava, prendesse una con figurazione non generica: per chi fare cinema doveva essere un interroga tivo essenziale, che presupponeva scelte primarie anche relativamente al come. Il passaggio dai pochi ai molti — non sono io a dirlo — non è un passaggio di quantità ma di qualità. Lo sforzo teorico doveva ser vire anche a questo; e non si trattava (come non si tratta, ovviamente) di una teoria che fosse di guida, che venisse prima (il momento ideo logico) ma che si sviluppasse in un ricambio con la pratica del cinema, come chiarificazione e presa di coscienza: sul cinema, sul proprio ruolo (il dibattito sull’impegno), superando le false antinomie tra « autono mia creativa » e arte « che serve ». Verifica infine anche sul linguaggio, per sottrarsi ad una concezione strumentale, che porta alla fiducia che certi contenuti, per la loro pregnanza, possono camminare da soli. Prendere in esame il linguaggio significava uscire dalla sua pretesa neutralità, ren dersi conto delle precise matrici politico-culturali di questa scolastica con cezione, coinvolgere altri aspetti, non isolando gli uni dagli altri. Chi fece queste considerazioni, anche nella critica, si trovò specie in seguito a poter fare un’accettazione del neorealismo che mettesse contem poraneamente in luce i punti deboli, soprattutto ideologici (l’interclassi smo ecc.), e addirittura alcuni errori (le distinzioni spesso non fatte nei confronti di un « progressismo » visto e analizzato genericamente); e di rei che questo esame appariva opportuno specie per la critica che era, o si professava, « di sinistra ». Per questa via si arriverebbe a parlare di quella critica alla critica del neorealismo che potrebbe presentare spunti utili, al di là di facili suggestioni verso negazioni totali. Si osserverebbe allora la scarsa capa cità di anticipazione che ebbe in linea generale; ma, per restare ai nostri obiettivi, conterebbe vedere la permanenza di una matrice idealista, so
Ideologie e stili del neorealismo
253
prattutto per il ripudio o la messa a margine della « tecnica » come elemento secondario o spurio: la costituzione materiale, la messa in opera venivano dopo. Eppure quella stilistica era una via per cogliere, dove c’erano, le riprese « ideologiche »: il populismo, il bozzettismo, presenti sin dall’inizio, e anche in autori di primo piano; per vedere come « l’an dare agli umili » aveva il suo corrispondente in una falsa semplicità di schemi (preludio alla commedia « rosa »). L’uso del dialetto, per esempio, costituì un fatto probante, e non mancò chi lo sottolineò: da elemento di adesione, cioè di rottura di imposizioni intellettualistiche, divenne compo nente idillica, che faceva ritornare al non sepolto clima strapaesano. L’ideologia del consenso — dell’« ognuno al suo posto » — trovava consono l’uso di moduli narrativi garanti (L'onorevole Angelina, tanto per fare un esempio). L’intervento attraverso lo stile avrebbe permesso (e ad alcuni permise) di parlare della « crisi » o dei « tradimenti » passando at traverso le opere anziché servirsi del grimaldello dei principi generali; le formule si sciolgono tuia volta che il cinema si collochi nella sua fisica (il retroterra storico-economico) e nella sua materialità. E credo sia chiaro come parlare di stile a proposito della crisi non significa affatto ribattere il tasto della crisi « creativa », per cui sarebbe bastata una nuova ispira zione, una ripresa dello stato di sintonia, quanto considerare il momento della costruzione come un fatto conoscitivo, come il modo di trasmissione dell’ideologia, come primo costituente il rapporto col pubblico. Dopo queste brevi premesse, penso si possa esaminare rapidamente: a. il significato generale dello stile nelle opere neorealiste; b. l’apporto teorico che ne venne, e gli equivoci; c. le concrete indicazioni e le possibilità di sviluppo.
a. La « rottura » neorealista fu soprattutto in direzione antiretorica, cioè contro gli schemi che erano gravati sul cinema italiano costringendolo entro direttive; ma era anche, più in generale, tentativo di esplorazione delle possibilità della macchina da presa, contro l’ancoraggio alle soluzioni costruite, e perciò garantite (la polemica contro lo « spettacolo », il no alle cose pensate di Zavattini); il rischio di fronte alla realtà diventava aper tura. Il supporto della « storia », cioè la fiducia in una narrazione che si sentiva canonizzata, era visto come ostacolo, era la sconfitta di fronte al reale di cui — ancora — parlava Zavattini. Ma anche in questo caso l’analisi unitaria rivela le pecche della genericità, perché anzi sarebbe da vedere come molti autori sentissero il bisogno di introdurre elementi e schemi di rinforzo, articolazioni alquanto rigide; in tal senso si potrebbe allora osservare quali legami col cinema precedente ci fossero, ad esempio, in Lattuada o Germi oppure, e pour cause, in Blasetti. D’altronde la teoria della « spontaneità », detta o forse suggerita, poteva portare al falso corollario dell’irriflessione stilistica, della non ne
254
Il neorealismo cinematografico italiano
cessiti del momento razionale della costruzione. Oppure, per altro verso, se di stile si parlava lo si metteva in relazione ad una generica « moralità », per cui esso diventava, secondo ascendenze scolastiche, un « atteggiamento morale », facilmente visto in funzione di una « condizione umana » che perdeva la sua concretezza storica; in fondo — in molti casi — era co modo superare le opere e le distinzioni parlando di un « nuovo rapporto col mondo » che volutamente non ne specificava le articolazioni. Erano de rivazioni ideologiche, di autori e critici, che venivano a galla anche loro malgrado. Il discorso è più complesso se riallacciato a una più ampia politica culturale alla quale le opere neorealiste erano in qualche modo collegate. Per cui il privilegio del momento « sociale » del film, pure indubbio, andò a scapito degli altri elementi, e la socialità era spesso unita ad una visione globale che avrebbe lasciato conseguenze. E alcuni film, attraverso le loro componenti specifiche, possono essere il test, non secondario, dell’ideologia dello sforzo comune, (l’ideologia della ricostruzione, secondo una perti nente definizione), del nuovo umanesimo; il retroterra basato sulla ricom posizione del tessuto connettivo sociale portava anche a dosare gli ele menti: la parabola narrativa dava ragione al populismo, il personaggio positivo garantiva, il sentimento copriva le falle. La visione unitaria della società italiana (che ebbe una ragione storica) non lasciò il posto che occorreva alle analisi e quindi alle spaccature; e ciò si riflesse nella problematica Ae\\'impegno come concetto unitario. Resta allora da verificare quanto scriveva Adorno per il problema generale: la discussione sull'impegno non ha riflettuto sull'efficacia di opere rette da una legge formale specifica che non si proccupa affatto dei nessi effettuali: è questa una delle debolezze più rilevanti della discussione stessa.
Il cinema che serve con ogni probabilità ne risentì. Il rapporto tra cinema e « engagement », direttamente proposto o riproposto dalla letteratura, mi sembra interessante da studiare, perché serve a chiarire il difficile rapporto con la prassi. Il neorealismo, infatti, rappresentò per un verso la fine del cinema come fatto autonomo, dell’arte separata tanto funzionale al fascismo; ma, forse proprio per questa acqui sizione, ripensò poco alle sue possibilità ulteriori, per sottrarsi all’ipoteca di una ipertrofia delle funzioni, di un allargamento del momento di me diazione « sociale ». Ancora nel ’53 si scriveva: il neorealismo è insomma lo strumento di una tale possibile presa di coscienza, e tale presa di coscienza si risolve, in sede extraestetica, in educazione politica, in educa zione democratica, in coscienza finalmente sgombra da sovrastrutture tradizionali, irrazionalistiche e romantiche, c peggio.
b. Occorre distinguere tra l’apporto dato, magari non esplicitamente, in modo diretto, e l’apporto che viene da un riesame, oggi, in sede sto
Ideologie e stili del neorealismo
255
riografica o di analisi oggettiva. Un primo fatto può colpire, ed è la scarsa quantità di contributi teorici data dal neorealismo; se da un lato ciò testi * monia la preminenza del fare, il rifiuto o il timore di precettismi, dall’altro fa da spia a quella mancata elaborazione cui facevo cenno, al difficile ricambio teoria-prassi. Spesso, poi, i contributi teorici erano in realtà di chiarazioni di poetica. Tralascio, per non superare i limiti imposti a queste considerazioni, i contributi che potrebbero riguardare l’elaborazione di una politica cul turale o la definizione del ruolo e della funzione del far cinema. Mi limito quindi a spunti relativi agli elementi compositivi specifici, entrando all’in terno del fatto o oggetto cinematografico. Cinema e realtà volevano anche dire analisi dei fattori di approccio, al di là (o, talora, malgrado) delle ricorrenti suggestioni mimetiche: dalla nozione di realtà e di « immagine », alle utilizzazioni delle componenti spazio-temporali, alla costruzione narrativa. Si può iniziare dai possibili equivoci di alcune riprese, più o meno larvate, della polemica sullo specifico filmico, per osservare come solo in certi casi (e nella pratica) si sia arrivati a concepire la messa in atto degli elementi come studio dei loro rapporti, e dei rapporti tra elementi lingui stici propri e gli elementi (i codici) extracinematografici. Era la nozione di realtà ad essere preminente, con i possibili equivoci dei significati che sono là, che stanno prima del linguaggio: Zavattini e la sua concezione della realtà che da sé rivela i propri connotati. L’interesse allora per alcune componenti il discorso era primario, in altri casi secondario, per una im plicita subalternità. Ed erano la realtà e la sua resa cinematografica invece che chiarivano una dialettica fondamentale: quella tra la preminenza del dato « comunicativo » dell’immagine e la sua « novità » per l’inserimento in un contesto che necessariamente la modifica; così anche il fatto, ogget tivo per sé, si qualificava nella sua poliedricità significativa proprio per l’ordinamento che se ne faceva in coordinate spazio-temporali. Tutto questo, naturalmente, si rifletteva nella narrazione. Il rapporto tra narrazione e descrizione (nel De Sica del primo dopoguerra e in Ros sellini soprattutto) si complica, e ancor più tende a perdersi la distinzione tra fatti o elementi « significativi » e « non significativi »: è questo recu pero alla significazione di zone della realtà considerate inutili o marginali uno dei dati stilistici rosselliniani maggiormente interessanti; si pensi, per fare un esempio, allo sviluppo di questa intuizione attuato da alcuni esponenti della « nouvelle vague » oppure, con maggiore consapevolezza, da Antonioni. Il montaggio lungo, o la mancanza di effetti di montaggio, che fu rono caratteristica di molti film, divennero più chiaramente in Rossellini una chiave della sua « disponibilità », della sua « concretezza e apertura ». Ma queste caratteristiche furono di alcuni autori; per altro verso il neo
256
Il neorealismo cinematografico italiano
realismo sentì spesso il bisogno di sostenere i fatti, di introdurre ele menti artificiosi, di spingere la narrazione in una direzione. Con frequenti forzature: non è secondario il rapporto tra parecchie opere del periodo e le strutture melodrammatico-popolari (d’altronde l’uso della musica — quasi sempre mediocre — è spesso una prova di questo bisogno di sot tolineare o marcare dall’csterno). Anche per questa via possiamo notare due tendenze; da un lato i fatti sono visti come supporto alla loro concatenazione, al loro sviluppo in senso causale, e se ne attua perciò in qualche modo una restrizione, dall’altro — talora contemporaneamente e per contrapposto — li si os serva nella loro estensione (cioè dilatazione), nelle onde eccentriche che ne derivano. La perdita dell’evento che caratterizza una parte del cinema po steriore era sì un distacco dal neorealismo, ma anche lo sviluppo di una tendenza di qualche autore. Per il quale il tempo di narrazione non è solo tempo di azione, ma adesione al tempo « reale » per un salto espressivo: penso a certe pagine di Umberto D, dove il tempo vissuto diventa tempo « creato », e ciò attraverso (ecco l’« impressione di realtà ») l’uso delle relazioni obiettive spazio-temporali di personaggi, azioni, gesti. Più ampiamente, anche attraverso operazioni stilistiche veniva ripro posta in termini nuovi la problematica del « realismo ». Ma con quali ri sultati? Vi era indubbia, per molti, la reazione a quel realismo indotto che già il fascismo aveva propugnato, e più ancora un’apertura e un bisogno di particolare che reagivano alla realtà come indistinto. Ma c’era anche il rischio di ideologizzare il rapporto col reale (penso per esempio al « non intervento » zavattiniano), e quindi anche i modi per porlo in atto; in questa direzione l’ampliamento della nozione di neorealismo poteva arri vare ad una restrizione del concetto di realtà. Si restava allora piuttosto lontani — per fare una citazione calzante — da quell’« essere concreti e rendere possibile l’astrazione » di cui parlava Brecht. Guardare problemati camente al rapporto col reale degli autori del dopoguerra italiano non si gnifica, oggi, cadere nelle facili equazioni per cui ogni forma di realismo è conferma dell’esistente, con la conseguenza che ogni linguaggio non realistico è di per sé contestativo; le facili infatuazioni « politiche » per il momento linguistico non devono far perdere di vista la complessità di un’operazione che, allora come adesso, passa per stadi e mediazioni di verse. Ma è pure vero che la difficoltà a intendere l’aspetto — appunto « politico » — del momento formale (e si spogli definitivamente il ter mine di ogni suggestione formalistica) comincia per molti aspetti col neo realismo. Si ritorna allora al concetto di impegno di cui si parlava; l’inclinazione (di molti o pochi non importa) a sentire in termini di identificazione il rapporto arte-vita fece sì che in seguito, al momento dell’inevitabile crisi
ideologie e stili del neorealismo
257
e rielaborazione, non si arrivò chiaramente alla differenziazione che doveva essere l’asse di sviluppo, alla fortiniana revisione del mandato.
c. Conviene fare una osservazione che forse può avere carattere ge nerale. I film del dopoguerra, nel complesso, sembrano spesso muoversi in una zona di incertezza sui propri mezzi, derivata da due aspetti conco mitanti. Da un lato essi dimostrano fiducia nel cinema, nelle sue auto nome possibilità, nella capacità di scoperta, dall’altro sentono spesso il bi sogno di un sostegno sentimentale o di un ancoraggio episodico (germi pre senti già in Roma città aperta e in Paisà); oppure ricorrono ad altre forme (la narrativa a contrasti accentuati, il pamphlet o l’invettiva) che aiutino la strada verso il pubblico, in quanto più abituali e probabilmente più col laudate negli effetti. Si potrebbe vedere come, in seguito, questi aspetti eteronomi si sviluppino, fino a staccarsi e a costituire filoni o generi di larga diffusione. Rientriamo allora nelle indicazioni specifiche, per accennare alle linee tracciate da Rossellini, dal binomio Zavattini-De Sica (con le opportune distinzioni e limitazioni cronologiche), da Visconti. Isolare questi autori, per comodità ma anche per scelta tendenziale, non significa ricadere nel vizio monografico, ma cercare appunto di scendere a distinzioni, di analiz zare il concreto. Così si potrebbe (e non rientra nei limiti tracdati a que sta esposizione) vedere i rapporti o l’eredità anche stilistica per alcune forme di cinema « moderno ». Dico Antonioni come esempio, anche della necessaria ambivalenza di questo rapporto: il personaggio e la sua « crisi », la psicologia e il prolungamento nelle cose, l’allentamento dell’azione. In dicazioni spesso solo in nuce, riprese e autonomamente sviluppate. È troppo nota la falsificazione della « doppia anima » rosselliniana di cui si comindò a parlare dopo Germania anno zero, del « distacco sempre più sensibile dalle ragioni del realismo» che causò l’avversione pressoché generale dopo la « svolta », quando si trattava di vedere la coerenza (e magari anche i cedimenti, ovviamente) di un discorso personale, che non era quello attribuitogli — non senza forzature — sulla base di una formula astratta e generica. Partiamo dalla fredda obiettività riscontrata nelle prime opere (e in particolare in Germania) e che avrebbe lasciato il posto alle dispersioni sog gettive della fase involutiva. Non entriamo nel merito delle singole opere, cerchiamo delle linee di tendenza. Rossellini, già con i film del *45- ’48, rivela che non si tratta di cogliere oggettivamente i fatti, ma di rivelare la loro disponibilità, quindi la suscettibilità di descrizione: l’oggettività è una diversa attitudine verso le cose, la possibilità di ridurre -(per lo spet tatore) il margine tra presenza dei fenomeni e intervento dell’autore. Ma (occorre dirlo?) di intervento si tratta; certo, « dare un senso agli eventi è una cosa, introdurli di forza in uno schema premeditato un’altra ». Per
258
Il neorealismo cinematografico italiano
ciò il rapporto causale rimane, ma interessano anche le diramazioni, fino a che diventano in un certo senso preminenti: al di sopra di un’apparente adesione episodica si articola la dialettica tra invenzione e dato. La disponibilità può essere, ed è, il limite ideologico di Rossellini, ma è anche la sua chiave stilistica; alla luce di questa nozione mi pare si possa osservare la sua oggettività, cioè da un lato il peso dato alle cose e alla loro fisicità (Francesco), verso quel paesaggio mentale di cui par lava Bazin a proposito di Viaggio in Italia, dall’altro la registrazione di comportamenti. In linea generale c’è però di più; Rossellini avverte l’ambivalenza tra la realtà « che basta » e la problematicità del dato, tra l’esterno come possibilità di registrazione (far « apparire » le cose) e la contemporanea necessità di agire a significarlo. L’alternanza di soggettività e oggettività parte da qui. Da un punto di vista narrativo si può osservare (al di là della mito logia, oggi frequente, dell’incompiuto e del provvisorio) come Rossellini nello sviluppo della sua opera tende a non privilegiare aspetti del reale rispetto ad altri, a dar loro «l’uguale densità concreta» (Vimage-fait di cui parlava Bazin), ad appiattire piuttosto che ad accentuare le punte, convinto dell’aggressività del reale e della non drammaticità esteriore. In molti film la narrazione è per distensione episodica, il collegamento è tra eventi rappresentativi ma non consequenziali. Quando Rossellini invece accentua o costruisce si avverte l’impaccio della struttura, il peso della « storia », magari nello stesso film in cui vi sono « aperture » estremamente significative. Per De Sica (e Zavattini) è probabilmente Umberto D il film scoper tamente di crisi, punto di arrivo e di decantazione. Zavattini è uno dei pochi « teorici » del neorealismo, anche se è chia ro che la sua, più che una teoria, è una dichiarazione di poetica; si possono seguire quindi per grandi cenni lo sviluppo delle opere fino al film citato, e Te corrispettive considerazioni generali che andava elaborando. Un’osservazione preliminare cade forse opportuna: c’è una continuità non secondaria tra lo Zavattini anteriore al ’45 e quello « neorealista ». Ciò vale senz’altro a chiarire e sottolineare l’alternatività della sua proposta durante il fascismo, il suo discorrere per concreta metafora, ma anche a far intravedere il filo che unisce la sua « rottura » del dopoguerra, a giu stificare la sua panica ingenuità ma anche a limitarla. Non tanto, o non solo, nel momento di « esplosione », ma piuttosto dopo, nel momento di crisi, quando il retroterra ideologico-stilistico (così onestamente perse guito e dichiarato) trovò la verifica di una svolta difficile. Credo che l’am bivalenza nasca proprio dalla sua « superstizione » per l’occhio cinema tografico, dal senso « totale » della macchina da presa, che ha lasciato traccia e ha una sua attualità: il « film luce di se stessi », ostinatamente ri
Ideologie e stili del neorealismo
259
proposto, aveva più che i germi di un tempo ritrovato, svincolato dalla subordinazione in funzione di narrazione, con un massimo di rigore « cro nologico » per un salto stilistico, per un tempo metaforico. Alcuni aspetti del cinema contemporaneo sembrano risentirne, anche se gli sviluppi sono stati variegati, le diramazioni sottili o patenti, fino alla forma autogiustificantesi. L'evento rivelava la sua forza centripeta, la sua dilatazione, la sua fluidità temporale, la durata come segno-, « le cose [...] secondo noi meritano di essere mostrate nella loro "quotidianeità", che vuol dire nella loro più lunga, più vera durata ». In Umberto D la durata è il tempo dram matico, la sua coordinata oggettiva è anche il vissuto; perciò il racconto tende alla « banalità », cioè alla distinzione, all’allentamento dei momenti emergenti. Ma in De Sica e Zavattini la descrittività analitica tendeva a un ro vesciamento « mitologico », la banalità stilistica doveva essere un punto di arrivo, un risultato di spogliamento, ma c’era assieme un residuo persi stente di adesione intellettualistica, in qualche modo precostituita. La con fusione era tra fenomenismo, in cui si ritrovavano gli elementi di iden tificazione arte-vita cui accennavo (« bisogna che lo spazio tra vita e spet tacolo diventi nulla »), e invece una originartela fenomenologica. Il tutto complicato anche — come spinta e come riflusso — dal ri versamento « pratico », daH’wZzùzà implicita o esplicita, dal momento so ciale dato per immediato. L’ambivalenza venne fuori, ancora, quando si parlò di crisi; si diceva della necessità di superare la cronaca, di cogliere l’essenziale nel particolare (e la terminologia tradiva ascendenze non confessate), e si intravedeva con difficoltà che questo passaggio era sì ideologico, ma anche — ap punto — stilistico. Dopo Umberto D (ma con radici che chiaramente nascevano prima) questo divenne evidente: la maniera (e non si parla de gli intenti), il frastagliamento aneddotico, la «stanchezza» trovavano ori gine abbastanza indietro. Anche per Visconti è stato usato il criterio critico delle due anime, vedendo magari nelle sue opere due momenti giustapposti, col risultato alle volte che si cercavano più consonanze ideologiche nella poetica che ele menti di analisi nei film, finendo con l’applicare alcuni elementi ritenuti essenziali della poetica al concreto delle opere; come, per esempio, quando si è privilegiato l’aspetto storicista (o « sociale » o « popolare »), visto addirittura come « riscatto » del momento decadente. Al quale, quindi, si attribuiva una connotazione negativa. Mentre si trattava, naturalmente, di analizzare nel vivo dei testi quanto vi fosse di strutturalmente coerente, cogliendo magari nella dialettica dei due momenti il nucleo stilistico. Lo stile, appunto, è una chiave interpretativa anche per le chiare « anticipazioni » di Ossessione. Il tono « basso » e la collocazione rom pevano col cinema della consolazione; il paesaggio diventava una dimen
260
Il neorealismo cinematografico italiano
sione essenziale di quel cinema antropomorfico di cui Visconti stesso ha parlato, proiezione ancora lirica ma già oggettivata, luogo di azione, di sco perta « storica ». L’espressività dello spazio viscontiano comincia senz’al tro da qui. I personaggi mantenevano l’accentuazione simbolica dell’ori gine (il romanzo di Cain), ma acquistavano inoltre una dimensione « co mune », i contrasti narrativi erano cercati, ma molte descrizioni erano la sciate andare, diventavano riscoperta di realtà, si allentavano le maglie della tragedia per un nuovo respiro corale. Sono due linee di tendenza che si sviluppano nella Terra trema, l’o pera nella quale si precisa il complesso rapporto di Visconti col neorea lismo, non lineare come in De Sica-Zavattini. Da un lato si problematiz zava il rapporto tra struttura, cioè solidità narrativa, impianto, e realtà come apertura di concretezza storica, dall’altro si profilava l’indinazione decadente che in seguito prevarrà. Ma è sul primo punto, struttura e inse rimento del reale, che si qualifica l’indicazione stilistica. Basti pensare al diverso rapporto col testo letterario di De Sica (il Bartolini di Ladri di biciclette) e Visconti (Verga): dal pretesto all’ossatura, all’impianto sul quale si innesta il dato, cioè i luoghi e i personaggi, con un senso vivo di avvolgimento del reale (la decantazione dell’inquadratura fissa o del pianosequenza). L’ossatura tenderà poi a dilatarsi, fino all’esito particolarmente si gnificativo di Senso, ormai chiaramente fuori dal neorealismo, in cui l’ope razione stilistica sembra completarsi. È stato il tentativo di cogliere la decadenza borghese dall’interno, e questo ha trovato una sua esplicazione più che in una supposta adesione immediata (di origine biografica), nel modo in cui veniva fatta l’analisi, cioè attraverso la forma di espressione tipicamente borghese, vale a dire il melodramma; si creava insomma una serie di consonanze, per cui l’innesto nello storicismo avveniva sia attra verso la « tipicità » dei personaggi, sia mediatamente attraverso il recu pero della forma artistica. La consapevolezza stilistica era allora la via per superare la crisi del neorealismo. Fin qui però le indicazioni sono di singoli autori. E per non perdere di vista lo sfondo, storico ed espressivo, occorrerebbe anche — e proba bilmente prima — un’indagine sul complesso dei film del primo dopo guerra, quelli almeno in qualche modo legati alla problematica neorealista; un’indagine quantitativa (e Pesaro può essere l’occasione) che si risolve rebbe in un’esplorazione qualitativa, sia di ordine « sociologico » che ideologico-stilistico. Si verrebbe così non solo a determinare lo sfondo sul quale si collocano le opere definite « maggiori », per intenderne sia il retroterra che l’effettivo « scarto » stilistico; ma forse con maggiore interesse si coglierebbero le linee generali di sviluppo lungo le quali analizzare l’ap porto del neorealismo alla narrazione cinematografica. Per questa via si
Ideologie e stili del neorealismo
261
potrebbe (e questi cenni sono solo un auspicio di un’indagine) osservare come si sono venuti consolidando alcuni schemi, o formando i generi, se e come riflettessero un « clima »; ma anche — di converso — si vedrebbe come riuscirono a crearlo, fino a influenzare anche le opere di rilievo. Sarebbe quell’esame proprio dei generi che, spesso a torto, l’indagine « estetica » sembra voler ignorare. Ci si accorgerebbe però poi delle differenziazioni all’interno, delle divisioni, della diversa consistenza; anche in questo modo quindi ci si sottrarrebbe al mito « unitario » del neorealismo.
CENNI SULLA CRITICA MARXISTA E IL NEOREALISMO di Ugo Finetti
« La ripresa di una cultura consapevole nel *45 — ricorda Eugenio Garin — tendeva a collocarsi tutta al punto d’incontro di due esigenze: quella di comprendere e valutare il fenomeno fascista nella storia italiana; e quella di intervenire decisamente nella trasformazione del paese ». £ in questo quadro che va ricordato criticamente, collocato storica mente e giudicato culturalmente il neorealismo e la battaglia civile che intorno ad esso promosse e svolse la critica militante. Il neorealismo cinematografico e la mobilitazione critica e culturale intorno ad esso risultano uno dei momenti più importanti deH’impegno civile del dopo guerra italiano e acquistarono una portata indubbiamente più avanzata rispetto a quanto accadeva, per esempio, in campo letterario e in quello dell’arte figurativa. Urgevano alle porte decine, centinaia di progetti — ricorda Zavattini — e per quanto uno diverso dagli altri, tutti ruotavano intorno a un’unica necessità, i con tatti con la realtà del paese, la realtà che confluisce al Parlamento. Scendevamo tutti come dal limbo e c’era in noi quella confusione mista di dolcezza e persino d'angoscia di chi vuol improvvisamente fare tutto, dire tutto, e parte per godere di questo dono, attardandosi solo un momento davanti aJl’immensità del possibile.
Con questo non si negarono certo i limiti del neorealismo. Come ebbe a osservare uno dei suoi maggiori « difensori », Aristarco, che quei limiti sottolineò, si può dire per il cinema del dopoguerra quanto De Benedetti affermò per la letteratura: il movimento parve sì per eccellenza il « dover essere » del cinema dopo la Liberazione, ma forse la parola neorealismo era un po’ ambiziosa perché si trattava in realtà di neoverismo. « A occhio e croce — aggiungeva De Benedetti — il neorealismo si è dimostrato red ditizio quando è servito di copertura a una superstite narrativa della me moria, o quando ha confermato quella vocazione a trasfigurarsi nel simbolo e nell’emblematico, *-propria di ogni arte naturalistica ». E così si riassume la conclusione di De Benedetti: Quella certa compattezza, quel carattere di sforzo e di lavoro comune, fino a un certo punto concorde, che si è potuto vedere nel neorealismo, è da attribuirsi in gran parte all'opera di incoraggiamento, di commento svolta intorno ad esso da una critica a volte acutissima, a volte nobilmente interessata e fautrice: nobilmente, perché
Ideologìe e stili del neorealismo
263
desiderava davvero che quella fosse arte realistica, cioè che esistessero le condizioni morali, sociali e civili per un’arte realistica.
E a questo proposito va ricordato quanto scriveva Umberto Barbaro nel ’54 e che assai efficacemente precisa il quadro della critica marxista di fronte al neorealismo. Una unanimità di valutazione sui film neorealistici non esiste neanche in Italia, dove (anche a prescindere dalla lotta, accanita e senza limitazione di colpi, che la reazione conduce contro questi film) il disaccordo è massimo, anche tra coloro che fervidamente li sostengono.
E quindi così sintetizzava i punti del dissenso nell’ambito della stessa critica militante: a. denominazione « neorealismo » e significato del « nuovo »; b. origine di questa fioritura improvvisa che non può essere intesa come un fungo nato dopo la pioggia benefica della Liberazione; c. disaccordo e dissidio sul concetto generale di realismo e sulla sua estensione (realismo come tendenza o come identità unica dell’arte); d. dissenso nella valutazione interna de) cinema neorealista e in particolare su Visconti e Senso. « Per orientarsi in questa Torre di Babele — concludeva Barbaro — occorre anzitutto trovare chi parli la propria lingua: il marxismo-lenini smo ». È però, a questo punto, da chiedersi cosa volesse dire il marxismo italiano dell’immediato dopoguerra. Esso era innanzitutto un marxismo senza il Gramsci dei Quaderni che sarà pubblicato solo più tardi e non ■senza censure seguendo un disegno — come lo ha definito recentemente Eugenio. Garin in un’intervista al « Mondo » — essenzialmente « monu mentale » e che ne privilegiava unilateralmente il rapporto di filiazione da Croce. Nel campo del « marxismo ufficiale » la « lettura » è essenzialmente quella togliattiana quale essa emerge sinteticamente in due significative « lettere aperte »: quella a Benedetto Croce (del ’44) e quella a Elio Vit torini (del ’46). Sono queste le coordinate che ne definiscono il disegno: linea di trapianto « nazionale » al marxismo inteso come erede e prose cutore diretto dell’idealismo e dello storicismo crociano; diffidenza e ri fiuto nei confronti dei movimenti estranei e autonomi di ricerca alternativa che, come nel caso del « Politecnico », sembravano presentare nell’indi pendenza di disamina « eresie » sia di destra che di sinistra nei confronti del tracciato dell’ideologia ufficiale. In primo luogo il « Politecnico » ap pariva pericoloso (« trokzista », come si scrisse sulle riviste ufficiali del pci) in quanto non riconosceva il « primato » del partito nella ricerca cul turale ed estetica. Vittorini nel ’46 pubblicherà, condividendolo, Particolo di Garaudy Non vi è un'estetica del partito comunista. Ma quelle due « lettere aperte » di Togliatti, pur nella diversità di tono, sono le due facce di una stessa medaglia che si nutrì, e si nutre, sempre per usare termini
264
Il neorealismo cinematografico italiano
di Eugenio Garin, al tempo stesso di.« sicurezze inesistenti » e di « aper ture troppo molli ». Fatto sta che il marxismo italiano nella sua versione ufficiale è in diretto e univoco rapporto con Croce, con un Gramsci scono sciuto, caratterizzato nel senso, come scrive Natalino Sapegno su « So cietà », di uno « storicismo integrale ». L’impostazione è tale che Luigi Russo scriverà, nel ’46, replicando ironicamente a « Rinascita »: « Ahimè, io ero marxista e non lo sapevo! Ahimè, anche il Croce era marxista e anche lui non doveva saperlo ». Anche nel campo della critica cinematografica uguale è l’impostazione per cui finalmente si comincerà a pubblicare Gramsci presentandolo se condo « letture forzate » attraverso antologie composte, avendo già in mente la tesi, che doveva servire a convalidare per cui « Letteratura e vita nazionale » viene presentato e fatto accogliere come un testo « cro ciano ». Scriverà infatti Luigi Chiarini: L’ultimo volume uscito delle opere di Antonio Gramsd, Letteratura e vita, nazio nale, mostra chiaramente l'influenza dell’estetica di Benedetto Croce, è in virtù di questa influenza che il Gramsci, discorrendo di arte e di letteratura, non cade nei grossolani equivoci di certi « esteti » del marxismo
ma arriva persino a parlare di arte pura.
Alle cosiddette « aperture troppo molli » fanno seguito le « sicurezze inesistenti », la filiazione crociana va di pari passo con l’imbalsamazione zdanovista. « L’insegnamento di Zdanov » è l’altra coordinata di questa politica culturale che influenzò la definizione e l’uso delle metodologie della critica marxista « ufficiale » di quegli anni. « Zdanov — scrive Sereni su ’’Rinascita” nel ’48 — ha dato un contri buto essenziale al rinnovamento della cultura italiana. Egli è fondamen tale per « l’innalzamento del livello ideologico dei nostri quadri comunisti e del tono generale della polemica culturale in Italia ». E quindi si sof ferma appunto sul « tono » degli scritti di Zdanov osservando che non è certo quello « dei nostri cortesi critici da salotto ». In pari tempo, sempre su « Rinascita », appare l’attacco ai Fratelli di Serapione. La sintesi dell’« insegnamento di Zdanov » è nell’indicazione di un « vasto fronte cul turale » nazionale e contro decadentismo e cosmopolitismo. In questo quadro è ripresa l’affermazione di Stalin circa gli scrittori come « inge gneri di anime ». Sereni conclude infine sottolineando il carattere nazio nale e popolare della cultura contro la « stravagante ed artificiosa ricerca del nuovo e dell’originale » nel senso che essa deve essere « adeguata al grado di sviluppo storico raggiunto dal nostro popolo ». « Popolare » si gnifica cioè linguaggio elementare e illustrativo. Cesare Luporini, da parte sua, commentando su « Società » il Con
Ideologie e stili del neorealismo
265
gresso di Wroclaw riprende la polemica contro il « piatto americanismo » e « l’aristocratico cosmopolitismo ». Si esalta così il contributo portato in quella sede dalla delegazione sovietica che aveva definito in quell’occasione Dos Passos « un rinnegato » ed Eliot un « mistico ed esteta, campione dei decadenti inglesi ». Anche se in quegli anni « lettura ufficiale » e « lettura alternativa » nell’ambito del marxismo italiano non possono essere divise con un taglio netto come due entità separate e impermeabili, va però tenuta presente (oltre al già ricordato « Politecnico ») una ricerca marxista non ufficiale in campo culturale e artistico che veniva portata avanti da Cases, da Fortini e da « Cinema » e « Cinema Nuovo » di Aristarco. Que sta direzione alternativa faceva riferimento essenzialmente a Lukacs e qui va precisato il senso di questa impostazione di fronte alla disinvolta e su perficiale identificazione che viene fatta nel catalogo della Mostra tra Zdanov e Lukàcs, chiarendo la posizione del Lukàcs con riferimento, ov viamente, ai suoi scritti di quegli anni. Si tratta cioè di riassumere i capo saldi dell’impostazione lukàcsiana quale essa emerge nei due libri fonda mentali di quegli anni: l'introduzione agli scritti di estetica di Marx ed Engels (che è del ’45) e poi soprattutto, Narrare o descrivere del *36, en trambi tradotti e pubblicati all’epoca in Italia. La polemica contro il cosid detto « materialismo volgare » del primo scritto è sintetizzata dallo stesso Cases assai significativamente nei seguenti quattro punti: 1. insistenza sulla legge dell’ineguaglianza di sviluppo tra arte e società per cui si contesta il ruolo-guida degli scrittori e dei cineasti so vietici e l’esemplarità del realismo socialista; 2. il trionfo del realismo nel senso della « completa rottura con il derivare meccanicamente il valore dell’opera dalle concezioni politiche dell’autore » per cui si contesta il primato dell’ideologia enunciata, della poetica programmata rispetto alla poetica in atto; 3. la contrapposizione della figura del tribuno a quella del burocrate; 4. l’attribuzione dell’ottimismo della « letteratura ufficiale » ai « re sidui del capitalismo ». È inoltre da sottolineare la tesi centrale di Lukàcs sull’essere la for ma artisticamente valida nella misura in cui essa è coerente a un deter minato contenuto. Questo significa che non ha alcun valore l’introduzione di nuovi contenuti in una forma vecchia per cui si contesta l’interpreta zione del realismo socialista e insieme della letteratura nazionale-popolare come mera propaganda di parole d’ordine « adeguandosi » al « grado po polare ». Di Narrare o descrivere è nota la tesi base: « il racconto distingue e raggruppa, la descrizione livella ogni cosa ». Tre sono i punti centrali dell’impostazione lukàcsiana: 1. il rifiuto dell’« eroe positivo » e l’indicazione del personaggio tipico in quanto contraddittorio: « lo scrittore deve vedere il mondo nella
266
Il neorealismo cinematografico italiano
sua mobile contraddittorietà, scegliere a protagonista un uomo nel cui destino s’incrociano i contrari »; 2. la polemica contro Zola e contro il «naturalismo impegnato»; 3. la polemica con i sovietici. A proposito di quest’ultimo punto, visto che si insiste nella identificazione Zdanov-Lukàcs, vale la pena citare alcuni passi scritti dal filosofo ungherese proprio nel ’36. La battaglia per liquidare la decadenza è ben lungi dall’esser conchiusa anche nelTUnione Sovietica [...] la letteratura sovietica non ha completamente superato i residui delle tradizioni della borghesia decadente.
E rilevato come vi sia una sostanziale confusione tra « forma » e « tec nica » nel dibattito organizzato dall’Unione degli scrittori così Lukàcs precisa le sue critiche al realismo socialista di marca zdanoviana: La maggior parte dei romanzi sovietici concernono per lo più un ambiente mate riale, sul modello naturalistico del romanzo documentario alla Zola. Non mettono in primo piano vicende umane, rapporti tra uomini illustrati mediante le cose, ma danno monografie di un colcos, di una fabbrica. Gli uomini costituiscono per lo più soltanto un « accessorio », un materiale illustrativo che integra la situazione di fatto [...]. Il metodo descrittivo priva questi romanzi di ogni tensione, L'uomo nuovo appare come un accessorio delle cose, come elemento umano di una natura morta assunta a dimensioni monumentali.
E quindi Lukàcs lamenta che « si ricorre all’introduzione del "simbolo" come "un povero surrogato dell’intima poesia" ». Lukàcs conclude quindi su questo punto dando un giudizio negativo su questo tipo di letteratura in cui emerge « un atteggiamento da reporter di fronte ai problemi dell’epi ca, la descrizione da "mandato di cattura" delle figure, secondo la maniera zoliana ». Anche in campo cinematografico essere lukàcsiani significò Balzac e non Zola, il rifiuto del « naturalismo impegnato » e del « realismo so cialista », significò cioè la scelta del « trionfo del realismo ». Appare allora chiaro il senso dell’alternativa cui si accennava all’ini zio a proposito della critica marxista sul neorealismo: se farne una filia zione diretta del realismo socialista oppure considerarne lo sviluppo in modo più articolato e guardando anche al di fuori di meri riferimenti cinematografici. Quale fu infatti la lezione da parte del « marxismo uffi ciale » del neorealismo in quegli anni? Leggiamo Barbaro. Egli, in una direzione nettamente diversa da quella lukàcsiana, tende a non accettare il discorso sulla validità artistica e il carattere realista di certa « fantasia » e del «linguaggio esopiano» («Il marxismo-leninismo — dice infatti Bar baro — offre una compiuta e profonda teoria dell’arte quale realismo e la distingue con efficace precisione dalla pseudo-arte che è sempre irrealistica nei suoi camuffamenti formalistici, naturalistici, e così via ») e a non ac cettare la tesi del « trionfo del realismo » (« Il marxismo-leninismo permette di definire il grado di realismo delle opere in base al terreno sociale in cui nascono e alla posizione degli autori di fronte alla realtà »)
Ideologie e stili del neorealismo
267
E quindi si arriva alla teorizzazione di un rapporto meccanico tra neorealismo e realismo socialista. L’interesse per i film si riaccese intorno agli anni ’30, anni in cui ci fu [...] un vasto fervore di studi e di ricerche tecniche sul film. Apparvero i primi saggi teo rici di Pudovkin ed entrarono in Italia i primi film sovietici. Quei film furono proiettati quasi esclusivamente ai Festival veneziani e in sedute private ma eserci tarono una grandissima influenza sui cineasti italiani: le teorie e i film sovietici indi carono ai cineasti italiani la strada maestra del realismo.
E ancora: La caratteristica essenziale del film neo-realista è il nuovo spirito che lo pervade e il linguaggio nazionale con cui ha potuto esprimerlo. Questo linguaggio non è die lo sviluppo e l’approfondimento di quello di Sperduti nel buio, ritrovato e vivificato per la grande lezione del film sovietico. Di qui la forza morale e artistica del neo realismo italiano [...]. Questa prima origine spiega anche la denominazione di neorealismo, denominazione che bene esprime questo suo riconnettersi al miglior passato cinematografico italiano, alla sua tradizione popolare e nazionale.
In verità, la ricerca di precedenti italiani e cinematografici fu assai unilate * rale nel cercare di ricavare il cinema solo dal cinema. Si pensi, per esempio, alla « nouvelle vague » la cui « base di partenza » va cercata essenzialmente sul terreno letterario. D’altra parte va ricordata l’attenzione con cui Barbaro guardava al neorealismo respingendo atteggiamenti puramente formalistici o, com’è il caso oggi di maldigerita semiologia, per cui la tendenza mistica e poi apertamente reazionaria di Rossellini diventa non appunto misticismo ma « purismo » cinematografico. « Non si può intendere pienamente il neo realismo del film italiano — avvertiva Barbaro — se non ci si rifà allo spirito dell’antifascismo e alla sua storia ». Altrimenti si va incontro a un sostanziale fraintendimento quale emerge in taluni critici che lo vedono essenzialmente « come prodotto di alcune innovazioni nei metodi tradizio nali del lavoro cinematografico, come il prodotto, da parte di alcuni cinea sti italiani, nell’immediato dopoguerra, di alcune tecniche particolari... La riduzione del problema del neorealismo a termini angustamente tecni cistici e formali trascura i più veri aspetti del problema e i valori di quella produzione ». Momento di esemplificazione dell’impostazione di Barbaro e della lezione del « marxismo ufficiale » fu in particolare il Convegno di Perugia del settembre del ’49 in cui, appunto, si procedette a una riflessione paral lela sul realismo socialista e sul neorealismo con una nutrita presenza di delegazioni delle cinematografie dei paesi dell’Est e con solo alcuni francesi ed esponenti dei « dieci di Hollywood ». Aprendo i lavori, Zavattini, che era stato chiamato alla presidenza del Convegno, enunciò una tesi che provocò una significativa replica, sia pur isolata, da parte francese (AurioI e Sadoul). Si tratta di una discussione secondaria ma illuminante a pro posito della concezione del realismo dominante il Convegno. Aveva detto
268
Il neorealismo cinematografico italiano
Zavattini: « Il cinema ci ha spesso distolto dalla realtà: ha seguito Méliès e non Lumière ». « In questo convegno — replicò Auriol, direttore della « Revue du Cinema » — si dà troppo l’ostracismo a tendenze e a generi die non sono realistid e non si ricorda che essi hanno dato autentiche opere d’arte ». E quindi, alla filiazione dal realismo socialista sovietico, contrap poneva la « tesi » del neorealismo come continuatore del « realismo poe tico» del cinema francese dell’anteguerra di Carnè, Renoir e Duvivier. Forse I’« antipatia » per Visconti da parte di Barbaro discendeva appunto dal fatto che Ossessione rappresentava proprio la più vistosa contraddi zione della sua tesi nel rimando al cosmopolitismo mitteleuropeo. Con più incisività Georges Sadoul fece osservare come « la Casa Lumière registrò passivamente la visita dello zar a Parigi, il varo delle corazzate, ecc. » mentre « il primo grande film di Méliès il cui realismo non può essere contestato fu un Affare Dreyfus, dominato da un impegno appassionato verso la giustizia e la democrazia ». « Méliès — sottolineò Sadoul — è vero, si affidò all'immaginazione, alla poesia, alla favola; ma seppe scegliere con spirito critico. Non abbandoniamoci quindi a giudizi assoluti. La poesia, la metafora, l’immaginazione, il sogno sono essi pure, in un certo senso, validi mezzi per la conoscenza della realtà ». Ma la prospettiva che incombeva per la definizione generale dell’arte come realismo era appunto rappresentata dalla lezione restrittiva e ortodossa delle delegazioni dell’Est. Il contenuto è l’elemento determinante: Tutte le opere cinematografiche che non si fondino su un valido contenuto sono costruite sulla sabbia. Il nostro eroe nuovo è il lavoratore cecoslovacco che realiz za il piano quinquennale [..Gli eroi di Chaplin sono ora del tutto scomparsi dal nostro mondo (A. M. Brousil); Una chiara meta è la caratteristica del nostro eroe (Boris Cirkov).
E Pudovkin dirà: La comune tendenza dei film sovietici è la tendenza a mostrare sullo sdiamo la figura dell'uomo positivo, a mostrarlo come esempio vivente, che incita all’imitazione.
Né manca la condanna moralistica: A chi serve l’avvelenamento della gioventù con l’esibizione di una impunita crudeltà?
È il caso di ricordare che Eisenstein era morto l’anno prima in piena disgrazia politica per La congiura dei Boiardi e « scomunicato » per la se conda volta (la prima fu in occasione del congresso dei lavoratori del ci nema sovietico che segnò la riabilitazione della sceneggiatura rispetto al montaggio in cui il principale imputato era appunto Eisenstein). In questo quadro vanno calati in particolare gli interventi di Bar baro che riprendeva il concetto dei registi come « ingegneri dell’animo umano » e di Della Volpe che dava una spiegazione assai riduttiva del realismo e del carattere nazionale e popolare. Accettato il dualismo MélièsLumière di Zavattini, Della Volpe lo esemplificava contrapponendo alla
Ideologie e stili del neorealismo
269
letteratura fotografata (La Belle et la Bete) la « poeticità documentario * fìlmica (Ladri di biciclette)», escludendo qualsiasi possibilità di realismo nell’accezione lukàcsiana che si esprima attraverso un « linguaggio esopiano ». « Il cinema — precisa Della Volpe — si rivela, per la sua tec nica analitica "sui generis" mezzo espressivo fra i più idonei, se non addi rittura il più idoneo, a registrare la vita reale, quotidiana collocata entro limiti esatti di spazio e tempo, dell’uomo moderno insieme coi suoi pre cisi problemi reali, concreti: ad es. i problemi del lavoro connessi inscin dibilmente alla nostra vita quotidiana ». Dopo aver quindi contestato una direzione di ricerca marxista che farà poi riferimento all’Hauser per cui la nascita del cinema è legata alla negazione del naturalismo, così Della Volpe sintetizza il concetto di linguaggio « popolare », facendolo cioè di scendere dal « carattere di massima comunicatività o universalità che è proprio della rappresentazione realistico-filmica, mezzo espressivo collet tiro, democratico ». « Popolare » significa cioè « elementare », « compren sione facile e immediata ». Questa lettura del « neorealismo » comporta come corollario imme diato il rifiuto di Visconti in seno al neorealismo e di autori come Dreyer nel cinema in generale. Di Dreyer dirà appunto Barbaro (sempre nel contesto del convegno di Perugia): Dreyer, si sa, è un regista reazionario, dal cervello fumoso e ingombrato da pre giudizi ridicoli: la maggior parte dei suoi film è roba da rigattiere [...]. Un regista che a raffronto letterario è assai più vicino all’ex capo dell’ufficio stampa nazista, Hans Einz Ewers, che non a Poe o a Hoffman [...]. Come dall’animo fumoso e torbido di Dreyer sia nato queirindiscusso capolavoro che è Giovanna d’Arco dovrà mostrarsi un giorno e si dovrà farlo cercando sulla linea dell’apporto fran cese al soggetto di Duttril, la stupenda fotografia di Maté, l’inarrivabile interpreta zione di Madame Falconetti. Mettere dunque accanto la Gxotwjwa d'Arco col ridi colo Vampiro o con lo stupido Dies Irae è quasi un’iniquità.
E il giudizio su Dreyer fu appunto uno dei motivi di polemica rispetto alla diversa posizione di « Cinema » e « Cinema Nuovo ». Analoga la « querelle » su Visconti. Contestando il rapporto diretto tra neorealismo e cinema francese, scrive Barbaro: È forse vero che certi film italiani mostrano qualche parentela con certi film fran cesi dell’anteguerra, ma solo nei loro aspetti deteriori e più condannabili: è un certo dima erotico, che, attraverso Renoir, è calato in Luchino Visconti, specie di Ossessione’, Luchino Visconti che, cercando di liberarsene, si è avvicinato poi a una tal qual « platitude » di « Ferrabique », in La terra trema, dove manca chiarezza di idee.
E quindi ironizza sul « fotografismo di Aldò » (con l’accento finale appunto per « francesizzarlo »). Anche dopo il ’56, recensendo un libro di Rondi, Barbaro riassume i capi di accusa contro Visconti (che per altro hanno continuato a essere recepiti da certa critica di sinistra fino ad oggi stesso): « L’opera di Visconti — afferma Barbaro — in verità e ad onta dei suoi valori, cade fuori del realismo », risente del « carattere letterario-
270
Il neorealismo cinematografico italiano
irrealistico della produzione francese tra le due guerre (cui) risalgono i motivi e le forme essenziali dell’opera di Visconti », vi è in lui un « frain tendimento della realtà e dell’arte » che ha « fuorviato le capacità creative del Visconti: colla stessa lente d’ingrandimento Visconti (ha) glacialmente guardato i pescatori di Acitrezza (La terra trema), gli operai romani (Bel lissima) e la forsennata Serperi (Senso) ». Testo esemplare del livello e del contenuto della mobilitazione antiVisconti da parte del « marxismo ortodosso » è indubbiamente lo scritto di Pio Baldelli su « Società » nel ’55. La liquidazione è totale e sicura: Ossessione-. «... non esiste nel film alcun rapporto con la forza, la violenza e la serietà popolare ». Bellissima: « nel film risulta la deformazione dei caratteri del popolo romano come se anche qui al regista la realtà non si offra che in veste di occasione per compiaciute esercitazioni stilistiche ». La terra trema: « manca quel calore, quella partecipazione senza i quali qualsiasi storia è destinata a restare solo un gioco più o meno intellettua listico. La polemica anticapitalista viene condotta con una approssima zione, cui fa riscontro, nel piano formale, il troppo ordine della composi zione ». Val la pena ricordare che sugli stessi numeri di « Società », in polemica con « Cinema Nuovo » si sosteneva tra l’altro che andava stigma tizzato Dreyer per il « suo continuare ad occuparsi di vampiri e di stre goneria nel momento in cui si sta pensando ai voli interplanetari » e si rimproverava ad Antonioni « un vender l’anima al diavolo degli psicolo gismi ». La linea « sciolta dal giuramento » seguita dai marxisti « non uffi ciali » fu in sostanza diversa e soprattutto si distingueva per il rifiuto di ogni parallelismo tra neorealismo e realismo socialista e per le conse guenze cui arrivava secondo tale rifiuto. Innanzitutto veniva sottolineato il rapporto con gli americani, argomento considerato pressocché « tabù » sull’altro versante. Scriveva in termini assai significativi Gaime Pintor nel ’43 a proposito dell’« Americana » di Vittorini: Nato come industria di lusso, sottoposto alle più dure leggi dell’economia capitali stica, il cinema americano doveva presto diventare il nutrimento di una massa ano nima, esprimere i suoi bisogni e le sue preferenze, instaurare il primo colloquio tra le grandi folle di tutto il mondo. Allora il cinema (americano) entrò nella nostra vita come una presenza insostituibile; cresciuto con la nostra stessa giovinezza ci insegnò a vedere e a comporre secondo nuove misure, modificò la storia e la geografia dei nostri cervelli, fu insieme scuola e polemica, divertimento e mitolo gia [...]. Questa certezza era indispensabile per uscire da un mediocre estetismo e, più o meno palesemente secondo le affinità del gusto, la lezione americana fu assimilata da tutti i popoli civili.
A sua volta Calvino ricorda come nella polemica letteraria, gli autori nordamericani rappresentarono l’antitesi ideale al clima della prosa d’arte e dell’ermetismo: un movimentato spettacolo d’energie poe tiche che cercano di farsi letteratura nazionale; e insieme una ricerca di linguaggio
Ideologie e stili del neorealismo
271
parallela a quella europea, ma impostata su un tronco fantastico più giovane e vi goroso.
E quindi sottolinea il legame tra le pagine americaniste di un Pavese e la ripresa di interessi per la lezione di Verga. Pavese ebbe un ruolo centrale in questo contesto e ne vanno, in par ticolare in questo ambito, ricordati diversi punti: un’unica considerazione culturale che abbraccia cinema e letteratura rilevando come i vari mezzi di espressione artistica non vadano considerati come autogenerantisi e inco municabili; il rifiuto del cosiddetto « realismo socialista »; il rimando alla letteratura realistica americana; il recupero della poetica del mito nel l’ambito del neorealismo; la polemica contro i « cascami » del neorea lismo e la comparsa in esso di una poetica « angelica ». Verso il 1930 — ricordava Pavese nel ’47 — quando il fascismo cominciava a esse re « la speranza del mondo » accadde ad alcuni giovani italiani di scoprire nei suoi libri l’America, un’America pensosa e barbarica, felice c rissosa. Per qualche anno questi giovani lessero, tradussero e scrissero con una gioia di scoperta e di rivolta che indignò la cultura ufficiale. Eravamo il paese della risorta romanità dove perfi no i geometri studiavano il latino. Ci si accorse, durante quegli anni di studio, che l'America non era un altro paese, un nuovo inizio ma soltanto il gigantesco teatro dove con maggiore franchezza che altrove veniva recitato il dramma di tutti. La cultura americana ci permise in quegli anni di vedere svolgersi come su uno scher mo gigante il nostro stesso dramma. Ci mostrò una lotta accanita, consapevole, in cessante, per dare un senso, un nome, un ordine alle nuove realtà e ai nuovi istinti della vita individuale e associata, per adeguare ad un mondo vertiginosamente tra sformato gli antichi sensi e le antiche parole dell’uomo.
Insieme al rapporto con gli americani, vale la pena ricordare quanto Pavese precisava a proposito del riferimento all *« esempio » dei sovietici che è tutt’uno in lui con il rifiuto di un linguaggio « popolare » in quanto « elementare ». Si pretende die esista oggi — osservava Pavese nel ’46 — un dovere verso il nuo vo pubblico dei lettori: fare una realistica, oggettiva letteratura parlata, perché i mi lioni di lettori vi possano accedere. Secondo l’esempio dei sovietici che hanno in ventato il .« realismo socialista ». Lascio stare il realismo socialista, che aspetto di giudicare sui testi e che comunque per ora riguarda gli scrittori di laggiù.
E quindi difendeva la ricerca di una espressività di significato non imme diato e naturalistico. Se uno scrittore — scriveva per esempio nel ‘45 — sceglie certe parole, certi toni c pigli insoliti, ha per lo meno il diritto di non esser subito condannato in nome di una precedente lettura dove i pigli e le parole erano più ordinati, più facili o anche soltanto diversi.
E in uno scritto del 5*0 troviamo ribadita l’indicazione che non si tratta di scrivere a livello « popolare » ma di compiere semmai un’operazione inversa: C’è [...] un solo mezzo per « popolarizzare » la cultura: mettere in grado il po polo, tutto il popolo di produrre questa cultura, di farsela per suo conto [...]. Una cultura che non costi fatica, che non sia, vale a dire, lavoro vivo, non significa
272
Il neorealismo cinematografico italiano
nulla. £ quindi chiaro che, secondo noi, la nuova cultura democratica e popolare non dovrà nutrirsi di «cognizioni» umanistiche di tipo volgarizzativo.
Ecco quindi come Pavese sottolinea l’importanza del recupero del « mito » derivata dal « rinascimento americano nell’ambito neorealista »: La nostra teoria del mito, che spinge alla elaboratone fantastica, non pregiudica per nulla siffatta poetica (neorealista): nessun tema umano è per principio precluso al neorealista per quanto nell’impostazione della sua opera egli tenga un conto impli cito della determinante economica (come del resto delle leggi naturali o psicologiche).
È anche significativo come Pavese critichi nel ’50 la poetica « angeli ca » con termini simili a quelli in cui su « Cinema » si critica la tendenza « mistica » che prende corpo in senso reazionario da parte di Rossellini in seno al neorealismo. Pavese rileva die tra neorealismo e tendenza « ange lica » si verifica un « fatale intrecciarsi genetico ed evolutivo di due poe tiche così apparentemente contrastanti » ed arriva a una messa a fuoco della necessità del superamento del neorealismo che sarà appunto soste nuta da « Cinema Nuovo ». Si può osservare — scrive Pavese — che quando là consapevolezza storica si fa, da condizione della realtà, tema esclusivo di poesia allora comincetà la stortura ..]. Così è accaduto a suo tempo della poetica del verismo — ottocentesca formulazione del neo-realismo — quando ciò che era in principio stupore divenne cliché. Ma al lora si sarà entrati nella superstizione, e l’economicismo, raggiungerà l’angelismo nel limbo della retorica. Inutile dire che quel giorno gli spiriti attenti avranno già tro vato altrove, in un’altra e più avanzata teoria della realtà, la condizione del lavoro fantastico.
Queste parole chiariscono bene il senso del « superamento del neo realismo » sostenuto da « Cinema Nuovo » e ciò che viene infantilmente definito nel quaderno della Mostra « famigerata verifica critica » *. Conclu dendo questi cenni su certa critica marxista di fronte al neorealismo mi sembra doveroso fare due precisazioni su alcuni giudizi presenti in questo quaderno della Mostra. In modo alquanto sbrigativo a proposito di quanto sostenuto circa il rapporto tra fantasia e realismo su « Cinema Nuovo » si scrive che « non va cercata nell’articolazione introspettiva dei personaggi ma in quella "fantasia" dell’autore» per cui «si tratta, tutto sommato, di una defini zione di "fantasia” chiaramente idealistica, ben lontana dalla rigorosa definizione proposta di lì a pochi anni da Galvano della Volpe ». I redattori della nota introduttiva, che nemmeno fanno cenno esplicativo al contenuto dell’impostazione dellavolpiana, ignorano o dimenticano il rimando espli cito fatto in proposito da Aristarco a quanto osserva Lenin sulle « due fan tasie» nei «Quaderni filosofici». Allo stesso modo, quando si scrive che «l’i1 Cfr. ideologia e bibliografia Cinema di
Sandro Petraglia e Stefano Rulli, La critica cinematografica neorealista: storia, nota introduttiva a « Il neorealismo e la critica, materiali per una », « Quaderno informativo » n. 57 della Mostra Intemazionale del Nuovo Pesaro (N.d.c.).
Ideologìe e stili del neorealismo
273
dealismo cacciato dalla porta rientra dalla finestra attraverso la scissione del momento estetico (il bello) da quello culturale (l’utile) », si ignora o si dimentica, nell’orgasmo polemico, che tale discorso viene fatto da « Cinema Nuovo » con un preciso rimando a Gramsci là dove nei « Quaderni » osserva che « ci sono artisti che si ammirano e si amano e artisti che si ammirano e non si amano », con particolare riferimento nel primo caso a Balzac e nel secondo a Flaubert così come secondo tale impostazione in termini antizdanoviani di « Cinema Nuovo » si rifiutano l’identificazione grossolana tra « contenuto impegnato » e « valore artistico », appunto perché gramscia namente veniva distinto il momento del giudizio estetico dalla valutazione di politica culturale.
« OSSESSIONE » CONTRO IL NEOREALISMO di Ellis Donda (allievo C.S.C.)
1. Porsi oggi di fronte al neorealismo con una volontà critica di va lutazione complessiva del ruolo economico e politico giocato dal neoreali smo stesso nello sviluppo della cinematografia (mondiale), significa com prendere la specificità dell’operazione cinematografica, distinta dall’ingor go della critica e dalle immagini (miriadi) e concetti che l’hanno costitui to. Perciò vorremmo chiarire che il nostro tentativo muove verso una definizione che vada al di là sia di una valutazione immediatamente ideo logica, sia dalla astratta (epistemologica) misurazione che l’ultima critica ha proposto. Pur ritenendo ancora utile e necessario l’approfondimento strut turale delle letture dei film (e degli autori e correnti), riteniamo asso lutamente necessario e inderogabile per la situazione della critica oggi, la determinazione e valutazione del piano culturale (e la sua valenza economico-poiitica) che ogni film è e contiene-, e come questo piano « extra filmico » implichi poi in effetti una vera riformulazione del linguaggio e dello strumento (immagine), fuori e a più vasta scadenza delle solite analisi: euforie tecnologiche (scritturali o stilistiche che siano). In que sto senso vogliamo proporre una lettura e una analisi politica di Ossessio ne-, non in quanto mitico primo film « neorealista », apertura di una scuola stilistica, o ideologica, o ideale addirittura come si è inteso e frain teso, ma come primo film di un piano culturale, che da anni stava matu rando, contenendo in sé molti degli sviluppi e delle negazioni che di esso piano sarebbero state attuate. Cerchiamo dunque di definire, al di fuori delle sovrastrutture del la critica, la reale portata deli * innovazione Ossessione, e il nuovo model lo teorico che esso conteneva. Per fare ciò dobbiamo prima definire il valore del realismo cinematografico, definire cioè il rapporto tra cinema e realismo (come modello ideologico derivato dalla letteratura, e come la voro letterario stesso) e definire insieme un itinerario, all’interno del di scorso cinematografico (non una scuola), piani intrapresi, deviazioni ecc., che spieghino e determinino la nuova formulazione, il nuovo passaggio nella storia del cinema di questa figura. Chiariamo subito, a questo pro posito, che il problema del neorealismo è assolutamente secondario, con
Ideologie e stili del neorealismo
275
sistendo in un problema di storia di modelli della critica e dell’ideologia, o al più come sviluppo di tecniche della ripresa e della tecnologia cine matografica in genere (che comprende in sé molto di più dei neutrali strumenti, ma è e si propone come tecnologia del rapporto sociale; leggi: la furbizia di Rossellini rispetto al capitale). La definizione del realismo è la maggiore preoccupazione del grup po di intellettuali che lavorano intorno alla rivista « Cinema » intorno al ’40: le ragioni complessive che muovono questo discorso sono la necessi tà di individuare uno sviluppo della cinematografia nazionale che la por ti all’altezza del sistema hollywoodiano e del cinema di stato sovietico; bisogna avere ben presenti queste intenzioni per capire la qualità delle analisi e delle proposte di un cinema nazionale. L’analisi dello svilup po del realismo nel cinema ce la dà chiara M. Alleata, in un suo artico lo apparso nel numero 127; innanzitutto si tratta di chiarire la dipen denza e il legame diretto che il cinema deve avere con la letteratura, cosa che in effetti significa: la necessità di una precisa e inconfondibile struttura ideologica dell’opera cinematografica (che si opponga risolutamente ad un cinema per il cinema, un cinema del movimento) e inoltre, la ristrutturazione dei valori e dei pesi specifici all’interno dell’équipe ci nematografica. Affrontare la letteratura (e non solo usarla come uno stru mento, un elemento compositivo, nel film) significa affrontare il proble ma dell’ideologia che si costituisce nel film stesso, e ciò risulta possi bile solo dopo che il cinema ha perso la sua primitiva innocenza, dopo che il cinema d’arte si è scontrato ed è stato risucchiato dall’industria cinematografica americana; la storia del cinema è una storia di emigra zioni e di grandi squilibri, questo lo vedeva chiaramente il gruppo « Ci nema », ponendosi non come critica separata ma interna alle necessità del la produzione, legata ad un’ipotesi di sviluppo (anche se non ne condi videva affatto il punto di vista ideologico). In Pabst si realizza la liberazone dal cinema espressivo, la letteratura non è solo pretesto ma og getto totale dell’analisi; in seguito, negli americani, il profondo legame a Faulkner-Anderson costituisce quel filone di cinema « sociale », quella risposta immediata allo sviluppo della società che nessun’altra cinemato grafia conosce; fino al grande realismo francese dei Renoir e dei Carnè che hanno saputo riscoprire una loro letteratura (Zola) e creare una nuova ipotesi di cinema. Da questo discende la proposta di una rilettura ed as sunzione di Verga come momento integrale della coscienza del cinema ita liano; tutto il gruppo di « Cinema » portava verso questa innovazione; del resto anche nella cultura in generale si stavano sviluppando movimen ti analoghi. Ma cerchiamo di comprendere meglio il valore del realismo cinema tografico, cosa impone e cosa implica il « rispecchiamento » della realtà e quale differenza di fatto corra tra la riproduzione del reale in letteratura
276
Il neorealismo cinematopafico italiano
e nel cinema. Si potrebbe quasi parlare di un rovesciamento delle funzioni tra il realismo in letteratura e il realismo cinematografico. L’operazione let * teraria (il grande realismo dell’800) infatti si può definire come un lavoro di classificazione e distinzione nell’insieme percettivo dell’autore, che lo porta a una gerarchia di pulsioni oggettuali che, organizzate, vanno a for * mare il « carattere » del personaggio, della situazione, o di un’azione stes sa; si tratta cioè di una frantumazione che proprio nella sua precisione e ossessività in sé porta la sintesi, il senso: l’ideologia. Cosa avviene nel cinema nuovo test dell’occhio del capitale? Ciò che subito colpisce e stupisce è che la stessa intenzione (e apparentemente lo stesso « risultato ») aprono su meccanismi e rapporti sociali compietamente differenti: la minuziosità e la precisione del particolare, in quanto oggetto, se non si risolve nella magnificenza dell’oggetto scenografico e surreale di Clair (e una linea dairiana esisteva nel gruppo di « Cinema ») deve per forza diventare accumulazione di frammenti del reale oggetto morto, e, più preciso è questo assemblaggio, più « realistico » il set, più consumo si dà dell’oggetto e del capitale che permette questo oggetto. L’operazione da sintetica si è in qualche modo rovesciata in una ana lisi delle valenze-danaro contenute negli oggetti, in una dèpense, esaustione, combustione, del valore nostalgico (ultimo valore d’uso) degli og getti stessi per renderli (ironicamente) al cinema, vale a dire all’imma gine stessa del capitale. L’oggettiva ricostruzione contiene dunque in sé un elemento frivolo insondabile (e lo sapeva bene il Visconti regista di teatro degli anni ’46-’5O), questo elemento frivolo è anzi il momento pre ciso del costituirsi del cinema stesso, prima nell’innocenza dell’epopea (americana e sovietica: Griffith e Eisenstein: cfr. le note di Sklovskij) poi nel distacco da essa (e non possiamo non riconoscere a von Stroheim que sto inizio) e infine nella ricerca di una unità di discorso ideologico, di un realismo come puro eros-consumo; questo elemento frivolo, questo vuoto, che è vuoto di ogni valore d’uso (e di ogni famiglia, costituzione nel so ciale del valore d’uso) fondano il cinema di Visconti (anche in quella ri cerca dell’impossibile che è stata La terra trema', sapendo già di cercare l’impossibile, tentando di costituire una continuità, una rappresentazione dell’impossibile come positivo) e, lanciamo una intuizione, il cinema mo derno, post-hollywoodiano stesso: non come cinema impegnato, natural mente, ma come cinema totalmente erotico. La totalità immaginaria di Hollywood lascia il posto alla totalità erotica del neorealismo?
Come situare Ossessione all’interno di questo discorso? Ossessione, è la figura deUa famiglia assente, e dell’impossibilità della famiglia stessa, in una dimensione di sviluppo e di composizione di strut ture sociali che hanno consumato ogni valore del reale che non sia il de naro, che non sia stato assimilato nel denaro e dal denaro.
2.
Ideologie e stili del neorealismo
277
Quello che ci è proposto è la fine inarrestabile del mondo conta dino-pagano, ultima voce del pre-industriale; il segno di questo inabissarsi è la mancanza, la disfatta dell’unità costitutrice di quel mondo stesso: la famiglia, intesa come unità di economia ed eros. Naturalmente, non si tratta di una « sacra » famiglia, non c’è in essa valore simbolico e questo valore simbolico non viene neppure posto come ricerca, come tensione: Ossessione è una constatazione, in questo sta la sua cifra più intimamente realistica, è l’occhio che registra. La famiglia è dunque « ogni » immagineframmento che contenga in sé la lotta di eros con il capitale (la struttura economica che impone la scelta) e che contenga anche il compromesso tra eros e capitale; non è la solita enunciazione della caduta dei valori, deca denza del mondo contadino, decadenza della memoria stessa: anzi è l’ana lisi precisa del passaggio di tutte queste unità, famiglia, terra, memoria, da una realtà di valore di uso, allo scambio, all’equivalente. L’ossessione, la scissione, la paranoia, diventa con ciò non la rottura, apertura su qualcosa d’altro (umanità perduta o da ritrovare), ma la continuità stessa, e il ri torno in questa continuità dell’occasione dell’esplodere, fino alla consuma zione del trauma, e l’affiorare di un nuovo trauma. Il cinema è la più lucida espressione di questo incessante passaggio delle cose nel « loro » equivalente; l’immagine, nel suo essersi costituita, nel lavoro che nasconde in sé, è proprio la contraddizione sempre pre sente di questa trasformazione; l’intesa, che è il solvente del film e lavoro del regista, è la finzione (ricreazione) dell’eròtica familiare, dei suoi odi e immediatezze nell’équipe cinematografica: questa è l’uscita dal cinema specializzato hollywoodiano, questa è la conseguenza precisa di una vo lontà di presupposto ideologico e realistico; come abbiamo sopra detto, questo passaggio non può avvenire e consumarsi però se non in una in tima frivolezza: la contraddizione del cinema « politico » è questa. Il cine ma realistico deve dunque conservare la necessità dell’analisi interiore (ero tica, non psicologica) di una società immessa nello sviluppo, attirata dal capitale; analisi che liberi i soggetti da ogni pesantezza dell’oggetto, da ogni residuo libidico investito nell’oggetto (naturale), per riversarlo inte ramente sul denaro come rappresentante del rapporto sociale. Conviene guardare a fondo tutte le relazioni tra economia e famiglia che si sviluppano in Ossessione. Ciò che più colpisce è il rovesciamento che più volte si attua tra i tre personaggi (Gino - Gianna - il Bragana) delle funzioni familiari: ognu no è agli altri, padre madre figlio, e questo in quanto l’unità del problema economico e della relazione affettiva (e di identificazione di sé e del futuro) non è assolutamente scindibile nel loro percepire e costruire la vicenda; la sua scissione effettiva (nodo gordiano) è il film stesso. Gino arriva da figlio, senza lavoro e senza futuro, vagabondo; Bracana gli è oggettiva mente padre, possessore di beni e della donna; la seduzione della donna
278
Il neorealismo cinematografico italiano
è l’arrivo ad una sicurezza quasi impossibile, eppure tutto è nello stesso momento anche l’opposto: l’arroganza di Gino, l’euforia di Bracana per il nuovo amico-camerata-esperto-padre, l’essere rapita di Giovanna dalla bel lezza dello straniero. In effetti non è la analisi del meccanismo famiglia, del meccanismo identità erotica che è la famiglia; questa c’è nel suo nonesserci, c’è in quanto ideogramma della finzione-apparenza sotto cui si cela la paura comune dei tre: il denaro, la sicurezza, l’identità vera. Il denaro non è solo l’ossessione di Giovanna, il piano nascosto che Gino sospetta, la strumentalizzazione del suo stesso amore fino all’uccisione per l’assicurazione finale, ma è anche di Gino nella sua fuga dal problema, nella facilità con cui lo risolve (apporto con lo Spagnolo) che lo portano ad una ambiguità tale dei rapporti fino alla denuncia finale; ed è anche del Bracana, come quotidianità positiva, come inizio di ogni suo possibile rapporto, come sua stupidità infine: essere rapace, senza averne coscienza ... cantare. Il film si sviluppa, è possibile (e taglia e irride ogni lettura, bacata mente morbida, di Visconti) strutturalmente possibile e logicamente, solo nell’intreccio di questi elementi: per Gino la scelta ossessione tra econo mia e spreco, e la paura di Giovanna come accumulazione, e il sospetto di cadere, di essere un elemento e pretesto di questa avidità; per Bracana l’os sessione dell’altro dal suo quotidiano-lavoro che è il canto, l’opera, l’illu sione di una città libera dal suo quotidiano, e di Gino stesso libero, senza vedere la realtà fino alla morte idiota; per Giovanna l’ossessione della sua stessa ossessione, il dubbio di non voler altro che il denaro, di essere lei stessa il legame, l’obbligo, la necessità, fino all’allegria insicura e piena di sguardi su Gino del finale e il presentimento? che il rendersi al vaga bondaggio, allo spreco, al rischio, pur in una solida alleanza e identità, nuovo corpo, famiglia-finalmente-realizzata, figlio, non possa che condur re — di fatto — alla morte. È interessante notare come il vagabondaggio del protagonista del ro manzo di Cain, vagabondaggio assoluto, tramp, si trasformi in Gino solo in una paura tra lavoro e lavoro, come spostamento del lavoro e del radi camento che esso implica. In Visconti l’Altro non è possibile, l’Altro pro clamato dallo Spagnolo è l’assunzione dell’ambiguità totale che porta in fine nel centro stesso del denaro con la sua « altra » faccia, quella della polizia e dello Stato: è elemento chiave per la struttura del film e troppo spesso sottaciuto, il fatto che sia lo Spagnolo a denunciare Gino e defi nire il « destino » dell’indecisione nella fuga. Dunque l’opposizione tra economia e famiglia (un caso di sceneggia tura come grammatologia dei ragionamenti e dei piani di vita dei perso naggi) non può conoscere soluzioni, ogni illusione su un modo altro di vita riconduce di fatto al denaro; allora è questa l’opposizione che il ci nema realistico deve affrontare? Nel porsi come passaggio continuo, siti
Ideologie e siili del neorealismo
279
licidio tra valore d'uso e valore di scambio delle forme sociali e dei valori (cosiddetti) sociali, il cinema può porsi come intervento e piano culturale, come riconoscimento continuo della trasformazione che muove la società contemporanea. Ma siamo lontani dal voler interpretare questo progetto come progetto non ideologico, esso è anzi il massimo progetto di una continuità «nazionale» del cinema, di un cinema dello spirito e non della critica (dell’economia politica), come invece la « sinistra » ha prima voluto, poi temuto, infine negato; riconoscere questo non può essere che riconoscere una intelligenza precisa, e il significato di questa ragione stessa e delle sue possibilità, e delle sue concrezioni, perdendo ogni voluta interpretazione della rottura e della diversità ad ogni costo. L’opera di Visconti è e non può non es sere un’opera che si inserisce nel cinema del capitale, com’è, in quanto il cinema stesso, ogni cinema, è un itinerario dentro il capitale, o meglio nella sua « depense », nel suo trascolorare, degli oggetti fuori dal loro valore d’uso, nell’equivalente. Cadono dunque tutte le paure e le critiche di Visconti traditore, e le sottili false coscienze (Giuseppe Ferrara uno per tutti) dei sottili distinguo, fin qui sì, qui no, qui sì, qui no è tradimento! Ma se il piano era così chiaro, com’è che il neorealismo è nato cre sciuto esaltato (dai tecnologi francesi) all’ombra di preti panciuti, e di popolane isteriche? qualche mistero cattolico di transustanziazione oppure una più intima e celata necessità? Molto è nell’incertezza degli equilibri politici come si presentavano dopo la Liberazione, molto nella crociata quarantottesca, ma in più? 3. Pur in periodo di guerra il cinema italiano conosce uno sviluppo abba stanza grosso verso il 1941-1942, ed è in questa logica politica che viene prodotto Ossessione. Le reazioni sono immediate, si percepisce la portata del lavoro: Serandrei, in una lettera a Visconti, la definisce « neo-reali stica »; è l’inizio del mito, vale a dire dei problemi definitori della critica. È dunque Ossessione il primo film neorealistico? oppure ne è solo l’intro duzione? Non sono questioni così marginali come possono sembrare; si tratta di definire in effetti il valore e il piano culturale del nostro cinema attraversato dalla Resistenza. Se per neorealismo si deve intendere il cinema libero dagli schemi di ripresa hollywoodiani, libero dagli studios, e dalla « finzione » degli at tori, un cinema spontaneo delle strade di Rossellini, Ossessione non può (se non parzialmente) essere annoverato al suo interno. Ma se neorealismo è solo un problema idealistico di classificazione storiografica, il senso di una rottura che di fatto a ben guardare non c’è stata se non nell’illusione, solo un problema della critica come sopra abbiamo indicato, allora bisogna concepire una ristrutturazione più ampia di quanto questo termine e la sua mitologica portata implichino: definire il problema più correttamente
280
Il neorealismo cinematografico italiano
e più alla radice, verificare la ritotalizzazione dell’immaginario cinemato grafico che passa verso l’inizio degli anni ’40 e che come fenomeno più acuto vede la rinascita del cinema italiano, ma non è certo definita solo da esso. Il problema era esattamente il passaggio dal cinema americano come totalità ideologica ad un cinema che risolvesse in un suo specifico « invi sibile » il suo territorio e il suo popolo; in termini precisi, lo sganciamento del cinema da una sua particolare « città » (suo corpo) per, attraverso un ri versamento e una rinascita nelle specifiche cinematografie, una fissazione dell’immagine-desiderio slegata da ogni terra e lingua, una pura immersione del cinema nel capitale. Ed è questo lo sviluppo che il « neorealismo ita liano » ha conosciuto, grazie agli aiuti economici degli americani. La que stione si apre chiaramente sull’operazione Rossellini — sul riconosciuto maestro nel mettere insieme capitali — come lo definisce con arguzia G. C. Castello già nel 1956 nel convegno su: Il cinema postbellico e la Resi stenza. In effetti è proprio Rossellini ad assumere in sé i risultati dell’inno vazione, e ad aprirli al mercato internazionale; su di lui si impernia la tra duzione e l’integrazione dei mercati specifici nel mercato mondiale; lui verifica per primo il neorealismo come scontro di mentalità, di culture e di lingue in quei film (Stromboli, Europa 51 ecc.) che furono definiti il suo tradimento mistico-spiritualistico e che segnano invece il salto e la consapevolezza del mercato mondiale. Rossellini deriva da una formazione interamente e puramente cine matografica, quella scuola di documentaristica del regime che si era spinta più avanti in un rinnovamento tecnologico dei modi della ripresa. La sua innovazione specifica consiste proprio nella « negazione » dell’apparato di finzione del set cinematografico, e l’uso della macchina con una nuova im mediatezza e spontaneità. Ora si è confuso molto spesso in questi ultimi tempi (« tecnologici ») tra cinema e suoi strumenti tecnologici (la « nou velle vague » stessa si inscrive interamente in questo « errore-presuppo sto »): detto questo si capisce la realtà dell’esaltazione di Rossellini. Ma, come abbiamo cercato di mostrare e come in ogni caso bisogna cominciare a prendere seriamente in considerazione, il cinema non è riducibile alla sua funzione tecnologica, alla estraneazione della riproduzione tecnica (peg gio che mai se essa consiste poi solo in tecniche di ripresa come era ed è per Rossellini); anzi, il cinema si definisce in un ambito che è tutto fuori dalla tecnologia in uno spazio dell’immaginario che non si deve e non si può ridurre alla spontaneità populistica. (Rossellini di fatto attua nel suo « realismo » una specie di depense del popolo e della sua emozione: patemalisticamente lo riprende). Il cinema è questo campo totale in cui si giocano termini come l’identità, il transfert, la sospensione logica, e so prattutto la grande uguaglianza sicurezza-denaro: sono questi i parametri
Ideologie e stili del neorealismo
281
che definiscono la ristrutturazione teorica di Ossessione, risolverlo in ristrutturazione tecnica è solo una risposta da regime. Si apre a questo punto la questione del dopo Ossessione; essendo chiaro che per noi Ossessione non è il problema di un autore ma è un film collettivo, un film che è un piano culturale e in quanto tale deve essere letto e valutato; non solo Visconti dunque ma Alicata, De Santis e tutto il gruppo di « Cinema », e ancora, il significato della politica di sviluppo portata avanti da alcuni elementi (gli ultimi) progressisti del regime fascista. Questi elementi della nuova classe intellettuale (purificatasi nella Resistenza) di fatto sono rimasti chiusi nella logica oppositiva, e in una riproposta impossibile dello spazio altro, rosso, comunista hanno perso la capacità dell’intervento piano, ricadendo in una dialettica della critica (quella della fine e del tradimento del neorealismo appunto) che ha reso ineffettuale ogni definizione della positività dell’intervento, accettando la gestione del nuovo regime; nessuno vuole mettere tra parentesi le diffi coltà reali e le nuove contraddizioni, il ripristino dello status-quo-ante grazie alla legge Andreotti; ciò che si deve oggi criticare, però, è l’incapa cità imprenditoriale rispetto all’oggetto cinematografico (o di ricerca se qualcuno preferisce rimuovere il Rapitale): sicché la critica è diventata esegesi, ed è sparita, assorbita da poche divinità, ogni velleità di piano culturale. Le domande si aprono sui misteri degli anni ’50, sui silenzi di De Santis, Puccini, e del partito comunista dietro di loro, sulle aperture fal limentari al cinema europeo e francese in particolare. L’astuzia della ra gione stava dalla parte del rinnovamento tecnologico?, si doveva esaurire l’illusione di un mondo totalmente fotografato, di un popolo totalmente cinemizzato?, oppure di fatto non si era consapevoli di ciò che si aveva prodotto, e per mancanza si lasciava vincere alla fine (e forse con umiltà) i volti levigati e ruvidi di Marilyn, Ava Gardner, James Dean? forse, la ristrutturazione realistica poteva servire solo al capitale e al cinema ame ricano-mondiale per costruirsi quella identità che oggi passa attraverso i figli di questo realismo o neorealismo se volete? Tutto è possibile, e però è sempre interessante vedere fino a che punto ci si era spinti (nella ricer ca) e come sia facile dimenticare, tutto sommato. 4. Vorremmo aggiungere alcune note relative ai temi di Ossessione e alle fughe che essi aprono; e far trasparire la sfiducia che (congenita) nutriva il progetto stesso. Il peccato è stato forse di euforia e di illusione; dopo la ricerca impossibile, la pura castrazione dell’intellettuale (e resa al popolo: naturalmente immaginaria, cinematografica, com’è ogni resa al popolo — figura inconscia e colpa — della borghesia) che fu La terra trema, la ripresa del realismo come consunzione, la critica dell’illusione neo realista che è Bellissima, e l’approdo alla totalità-melodramma di Senso.
282
Il neorealismo cinematografico italiano
Tutto questo era già, come cifra della disillusione, in Ossessione: si apre con ciò un piano ancora diverso della lettura dell’opera, e dell’ambi guità di Visconti (lui, non più il gruppo « Cinema » — 1942) quello della totalità-popolo come colpa della borghesia, e della fuga da essa, nella « filosofìa » materialistica, in un illuminismo che congiunge Kant e Sade (come nuovi grandi maestri ci insegnano); questa « filosofia » materialistica convive facilmente con il marxismo (e suoi adepti: in qualche salotto ro mano) soprattutto perché si pone nell’alcova dell’irregolare artisticità. Il popolo era (il proletariato c’è): questa la proposta di totalità, che si rassegna, anzi si impone come perenne opposizione, nichilismo tra vestito di emendamenti. Il melodramma e l’ironico riconoscersi in esso dei popolari « i più sensibili » (malati forse? di potere magari? nascosto!) traducono l’occa sione (parola rosselliniana ' come nessuna) della frivola congiunzione di canto-bel canto e realtà-miseria. La figura perno di Ossessione sarebbe allora il bravo Bracana, nella sua innocente e certamente inconscia per versione, lampante e subito presente agli occhi di chi « ami la bellezza »; il corpo deformato sottratto ad ogni possibile desiderio, e proprio per il suo essere naturalmente dentro il denaro unico valore d’uso, congiun zione di denaro-natura non sottomesso all’idealizzazione (e cioè alla scis sione di eros/kapitale). Il problema del film: eliminare questo in-più, arri vare al corpo flessuoso della ballerina-puttana, perdersi nella banalità. E avanti nell’opera di Visconti, i corpi irragiungibili dei pescatori di Aci Trezza (un capitolo a parte, il sommo di una volontà di illudersi), poi invece i corpi delle ballerine di avanspettacolo di Siamo donne (opposti al corpo della Magnani incarnazione della storia del cinema e dei suoi kapitali), la disfatta Clara Calamai di Le notti bianche (che assiste esterna come se già sapesse tutto), fino alle tumefazioni degli ultimi film, nel kitsch assoluto del Ludwig (in cui unico lontano ricordo di bellezza è per gli spet tatori una Romy Schneider-Lola Montez, e per l’autore la petite-frase di Wagner) è anche questo un discorso sul neorealismo, e sul vuoto di poli tica culturale delle sinistre: potrebbe darsi. Ma forse questo discorso si situa in un orizzonte più ampio di al lusioni, che è la materia più nascosta di ogni film (e di ogni corpo) al di là del problema critico del neorealismo e del realismo stesso: sull’ero tismo dell’immagine, e sulle nuove valenze che a questo erotismo ha offerto Visconti. Tutto sommato questa lettura ultimamente strutturale, e che ri nuncia ad ogni immediato contenuto politico, ci porta a rivalutare la per sistenza della linea e degli umori dell’avanguardia (sotterranei eppure, a nostro avviso, molto vivi) che esisteva nel gruppo di « Cinema ». L’arti colo di Chiari e Puccini sul valore della scenografia ne è forse la presenza più esplicita, ma anche la definizione dell’opera di R. Clair come realismo letterario (data da Alicata stesso), stanno a indicare un nodo irrisolto nel
Ideologie e stili del neorealismo
283
progetto teorico e un equivoco di fondo del realismo, un suo inconscio legame all’avanguardia. In questo caso il cinema di Visconti (ma non forse anche quello di De Santis?) rimane in qualche modo un cinema che esiste solo all’interno dello schermo; un cinema che riecheggia sempre di più negli anni (ma basta la sequenza insistita, e significativa nelle sue differenze interne, nelle citazioni che la compongono, del concorso operistico di Ossessione a indicare...) situazioni Haitiane, e, anche se solo da un punto di vista figurativo, sternberghiane. Dunque, rimescolamento di tutte le carte? Certamente no; il discorso e la linea ideologica rimangono nettamente determinati, ma proprio il loro « fallimento », la loro relativa realizzazione ci stimola a sentire e per cepire echi più lontani e taciuti e contraddittori di questo cinema, senza scandalo né grida di tradimento, anzi facendone occasione di conoscenza e di sviluppo della ricerca.
LA MANIERA DI VISCONTI di Tommaso Chiaretti
È fin troppo facile, con il senno del poi, stralciare il discorso di Vi sconti, del primo Visconti di Ossessione e della Terra trema, e natural mente anche quello di Bellissima, dal contesto del neorealismo come poe tica. Ma altrettanto naturale è ridefinire il neorealismo non come poetica bensì, più umilmente e forse più generosamente, come un momento poli tico di opposizione e di lotta. Insomma, ben videro chiaro gli avversari del neorealismo, nella loro grettezza di conservatori dello status quo ante, a individuare nel movimento un nemico da colpire con ogni mezzo soprat tutto per questo: perché era riuscito a stabilire una unità tra forze dispe rate, di diversa origine culturale, di fragili motivazioni espressive, pronto a mille imprestiti, aggrappato più ad una concezione del mondo, della so cietà e di una industria da mettere in crisi, che teso all’approfondimento di un discorso di linguaggio e di stile. Le immaginose intuizioni zavattiniane fondavano tuttavia su alcuni punti fermi. Ma quella che, in certo momento, con qualche malizia, fu definita la « poetica del coinquilino » non fu mai di Visconti, che coinqui lino non conosceva. L’incontro di Bellissima fu del tutto casuale, e non fertile: e anche quello fu un film che, per l’alchimia della sceneggiatura, la scelta degli attori, la stessa sua struttura spettacolare, la tentazione pienamente accettata del professionismo, apparteneva in pieno alla rifon dazione della industria cinematografica italiana sulle antiche basi, mai completamente distrutte. I documenti di cui comunemente ci si serve per giustificare il primo Visconti appaiono, alla rilettura, assai rozzi, e non poteva essere altrimenti: la rivolta di Visconti, formatosi alla scuola di un certo verismo-formalista francese, con gli apporti provinciali, talvolta paesani, del gruppo AlicataDe Santis-Ingrao, era una rivolta di gusto, di piglio esclusivamente anti retorico. Ingrao scriveva una tesi su Pascoli, De Santis si dichiarava per il folklore, Alicata leggeva De Sanctis (quello con la c, come ironicamente avrebbe scritto Chiarini). Gramsci aveva lavorato nell’assoluto isolamento, e la sua conoscenza, più o meno distorta, era di là da venire. Verga, attra verso la lettura che già ne faceva Luigi Russo, costituiva un mito da non
Ideologie e stili del neorealismo
285
discutere. Ma, accanto a Verga, equivocamente, l’America altrettanto mi * tologica di scrittori culturalmente scadenti, e la Francia « raffinata », e il melodramma verdiano, quello che veniva a Visconti dalla Milano di Toscanini. Tutte queste suggestioni ebbero una prima sistemazione in quel mo nocorde discorso del nazional-popolare che doveva costituire, per molti anni allo stesso tempo, un inciampo, un ricatto e un circolo vizioso da cui era difficile uscire. Venne, a favore di Visconti, l’interpretazione di del discorso lukacsiano e leniniano sul borghese e sul conservatore che, per forza della ricerca sul « tipico », riesce a rappresentare la realtà sociale, il popolo, e perfino ad essere specchio della rivoluzione, da Balzac a Tolstoi fino al «Gattopardo». E certamente alcuni mezzi adoperati da Visconti ap parivano, a prima lettura, come delle vere rivoluzioni linguistiche: la sco perta del paesaggio in Ossessione, e l’uso del dialetto nella Terra trema. Ma il dialetto era già, o era ancora, qualcosa da registrare e non da stu diare, era un piacere fonetico, era un feticcio da intellettuali che alla sua realtà rimanevano estranei: come di fronte a un miracolo incomprensibile.. In Bellissima, dove non si può più parlare neanche di dialetto, sono già presenti, esplicite, le trappole di quello che doveva essere appunto, poi, il cinema dialettale e gergale tanto amato dalla piccola borghesia italiana come surrogato epigone e cialtronesco del neorealismo. L’idea guida di una letteratura e di un cinema e di un’arte in genere, che fossero, dichiaratamente nazional-popolari, ha portato, come prima conseguenza, al rifiuto dell’avanguardia: quella storica innanzitutto, e poi le esperienze dei nuovi e liberi cinema in ogni paese. Ora, in realtà, è possibile trovare, in alcune opere del neorealismo, ad esempio in un certo Rossellini (ma non davvero in Roma città aperta) elementi di avanguardia incompresa, osteggiata, fraintesa. Ma non in Visconti, che è invece per fettamente inserito nella politica culturale ufficiale della sinistra condotta da Togliatti e da Alicata, pronto ad accettare su di sé il peso niente affatto oppressivo ma orgoglioso, della tradizione: intendendo per tradizione quel la ottocentesca del romanzo, e soprattutto del romanzo verista. Visconti non ha mai sentito la crisi del romanzo: anzi, lo ha amato in quanto tale, ne ha amato la struttura, l’ha costruita laddove non era del tutto esplicita. Visconti passa da Cain a Verga, da Camus a Thomas Mann, da Dostojevsky a Boito, da Tornasi di Lampedusa a Testori, considerando tutti, anche quando potrebbero non esserlo, dei romanzieri. Non lo interessa di Boito l’appartenenza alla scapigliatura, bensì, appunto, Videa di un romanzo che v’è dentro l’esile intreccio. L’affrancamento dalla struttura romanzesca non è mai un’ipotesi da verificare: al contrario, l’ambizione è alla saga, al ciclo, alla trilogia, alla conclusione, al finale drammatico o melodramma tico, secondo partizioni esatte, atti e capitoli, ouvertures ed epiloghi. I suoi appoggi musicali sono, quasi per un’esigenza naturale, della medesima
286
Il neorealismo cinematografico italiano
origine: cioè Verdi e Frank e Bruchner e Mahler e anche Donizetti. E già dai suoi primi film, la suggestione figurativa viene dalla tradizione icono grafica: cioè la sua Sicilia è in qualche modo parente e coeva di quella di Guttuso. Del resto la stessa critica più devota ha subito eliminato il neo e ha parlato tout court di realismo, intendendo attribuire Visconti proprio alla grande restaurazione del romanzo russo e francese. Ma le carte si imbrogliano quando si cercano le radici più vicine e più proprie. Ed è evidente che Visconti in Ossessione adopera James Cain allo stesso modo con cui un certo cinema francese ha adoperato Zola piuttosto che Balzac, e Mac Orlan piuttosto che Céline: cioè non il romanzo ma piuttosto l’in treccio romanzesco, non il popolo ma il populismo, non il romanticismo ma la romanticheria periferica e nebbiosa, anarchicheggiante, morbida. E non è nemmeno il caso di parlare di classe o di rapporti di classe, per un cinema che è alla ricerca di eroi solitari ed emarginati. L’entusiasmo che suscitava l’oggettiva rottura degli schemi provinciali del cinema fascista in Ossessione, indusse a sostituire con formule di enco mio la valutazione critica. Si parlò, ad esempio, della nascita di uno « stile italiano », nozione imprecisa, oscura e deviante. In realtà era già del tutto evidente, accertabile sulla base della cronaca, dell’ostentazione e dell’esame stilistico, la parentela con quello stile che da Renoir a Carne decade in Duvivier e Prèvert. Ma ancora più insidiosa di trappole critiche è l’idea di un Visconti che offre finalmente uno stile al neorealismo. In realtà, accettando questa tesi e questa strada il neorealismo dichiara proprio il suo fallimento come tendenza, e si prepara a quella inversione che è stata definita come pas saggio al realismo. Sarebbe, in ogni caso, un passaggio all’indietro: in quel neo vi era, per definizione, qualcosa in più, che sarebbe andato perso. Cioè la ricerca di uno stile, e diciamo pure di un linguaggio di cui non è arduo riconoscere i segni: concetti come la « poetica del banale », l’idea che la realtà possa essere espressiva di per sé, la contrapposizione Lumière-Méliès, documento-fantasia, il riferimento a vecchie esperienze della avanguardia russa, tutto ciò appartiene a un mondo, a un sistema che si definisce, e si apre molte strade: si chiameranno poi cinema-verità, candid-eye, o addi rittura, in un ribaltamento vanificante, ccole du regard. Ma è certo che, invece, lo stile, il linguaggio di Visconti appartengono a un altro tipo di esperienza, a un’altra posizione estetica. I pescatori di Aci Trezza non parlano liberamente il proprio dialetto, bensì mimano, traducono, reci tano, in una splendida maniera se si vuole, un copione che Visconti, e Verga prima di lui, hanno scritto in lingua (e Sciascia sostiene, non paradossal mente, che questa dello scrivere in lingua sarebbe operazione più moderna dell’altra). Il neorealismo, tentando di annullare il ruolo dell’autore in un oscuro
Ideologie e stili del neorealismo
287
presentimento di arte servizievole e collettiva, chiedeva ai protagonisti di essere se stessi. Visconti chiede ai suoi attori di mimare una realtà che viene presentata come elaborazione letteraria; Visconti non è per l’improv visazione e la confusione dei ruoli, è invece per una spartizione canonica ove le dramatis personae abbiano tutte la loro maschera. E se in taluno vi è ambiguità (come nello spagnolo di Ossessione) è perché la situazione obbiettiva negava maggiore chiarezza. Ma il modello era letterariamente chiaro: era quello degli eroi francesi, erano i volti di Gabin o Jouvet, punti di riferimento certi per una injerprctazione romantico-anarchicheggiante dell’antifascismo italiano. La distribuzione dei ruoli non lascia margini al dubbio: si fonda davvero sulla collaudata casistica del romanzo « popolare », che è poi la noiosa partizione degli eroi in positivi e negativi. È qui, in questa classi ficazione, che ha sempre inciampato la critica italiana, negli anni Quaranta e Cinquanta, attratta dal vortice del comportamento di questi eroi a petto di un modello ideale e morale e politico da non discutersi. E allora si è arrivati, addirittura, a parlare del ruolo di Ussoni in Senso, che età invece, a tutte lettere, una squallida, e per questo splendida, storia di canaglie. Si è discusso di emigrazione e di verosimiglianza, di fronte al tentativo di una coralità tragica e morbosa in Rocco. Si è sempre stati tentati di identificare il discorso di Visconti con quello di Mann, come interpreti dall’interno della crisi dello spirito borghese in Europa. Ora, certo, questo è quasi sem pre il tema di Visconti. Ma sarebbe più giusto dire che è il suo libretto. Nella scelta dei libretti vi è certo coerenza, ma il modo della rappresen tazione appare ad ogni passo più eclettico, spesso derivato da quello tea trale, ed ha bisogno di continui appoggi ad altro. La realtà che Zavattini voleva cogliere al volo, senza aggiungervi o togliervi nulla, ha bisogno, per Visconti, di essere calata in epoche, am bienti, scenografie. Lo trascina il gusto della datazione, la voglia di fare sempre qualcosa à la manière de... E allora Franz e Livia sono come in Hayez, Girotti in Ossessione è come Michelangelo, Bogarde è come Klimt, Senso è come Fattori. Il gusto di Visconti ha una gamma sterminata, non ha la sicurezza calvinista di scelta che c’è, per esempio, in Testori. Ma in questo esiste una coerenza: l’attrazione per l’esperienza suggestiva del manierista. Oltre le classiche definizioni di neorealista realista espressionista, Visconti è dunque, e soprat tutto, come Stroheim, un aristocratico grande manierista del cinema.
ROSSELLINI OLTRE IL NEOREALISMO di Adriano Aprà
Sono usciti di recente in Italia un certo numero di libri su Rossellini (saggi, sceneggiature, interviste), nonché un libro di Rossellini (con un titolo straordinario e illuminante: Utopia Autopsia 10") intanto, l’in teresse per questo regista si è esteso a Inghilterra, Stati Uniti, Canada, dopo la « scoperta » francese (che però ormai data di molti anni, e che lì non ha avuto prolungamenti di rilievo)1 2* . Per limitarmi qui agli studi ita liani, va detto che essi riempiono vuoti, hanno la funzione di recupero tardivo di un autore mal assimilato, quando non sono semplicemente opere di circostanza accademica: a questo livello, Baldelli e Rondolino non si distinguono. Come dire che poco o nulla si è contrapposto da noi a quanto hanno detto da vent’anni in qua Bazin, Rivette, Godard o Fieschi sui 1 Pio Baldelli, Roberto Rossellini, ed. Samonà e Savelli, 1972 (contine, oltre a una lunga parte saggistica, due interviste e la sceneggiatura — non realizzata — del Caligola). Roberto Rossellini, La trilogia della guerra, a cura di Stefano Roncoroni, ed. Cappelli, 1972 (contiene le sceneggiature, ricavate alla moviola, di Roma città aperta, Paisà e Germania anno zero). Roberto Rossellini, La mia TV, Coines edizioni, 1972 (contiene le sceneggiature di Socrate, Pascal e Agostino d'Ippona). Rossellini Antonioni Bunuel, Marsilio Editori, 1973 (contiene il saggio di Giuseppe Ferrara « L’opera di Roberto Rossellini », letto in occasione del «Premio Fiesole » del 1967). Roberto Rossellini, Cartesius, Coines edizioni, 1974 (contiene la sceneg giatura del telefilm omonimo). Gianni Rondolino, Roberto Rossellini, La Nuova Italia, 1974, n. 4 della coll. « II castoro cinema ». Roberto Rossellini, Utopia Autopsia IO10, ed. Armando, 1974. Va aggiunto il Dibattito su Rossellini, a cura di Gianni Menon, Partisan edizioni, 1972, ricavato dalle registrazioni di un seminario svol tosi a Pisa nel maggio 1969, e al quale anch’io ho partecipato; nonostante, anzi grazie al carattere largamente improvvisato del dibattito, sono emersi in qudl’occasione elementi radicalmente nuovi per una lettura di Rossellini, anche se viziati da spontaneismo. 2 Vedi José Luis Guamer, Roberto Rossellini, London, Studio Vista, 1970; le riviste inglesi «Cinema» (Voyage to Italy di Fred Camper, n. 9, 1971), «Mono gram» (n. 2, 1971), «Screen» (inverno 1973-74), nonché, meno recentemente « Movie » (Vanina Vanini di Paul Mayersberg, n. 6, gennaio 1963); le americane « Film Culture» (intervista con Rossellini, n. 52, primavera 1971, e Man's WelLbeing, Behavior and the Spread of Knowledge di Rossellini, n. 56-57, primavera 1973), « Cinema» (The Rise of Louis XIV di Paul Schrader, vol. 6, n. 3, primavera 1971), « Film Comment » (Rossellini di Robin Wood, Recent Rossellini di John Hughes — sul Rossellini televisivo —, luglio-agosto 1974); la canadese « Take One » (vol 4, n. 3, 1974).
Ideologie e stili del neorealismo
289
« Cahiers du Cinéma », che nessuno per esempio ha saputo seriamente cri ticare l’idealismo e la metafisica che spesso fondano la scoperta francese (Godard ha sintetizzato tali posizioni in una frase-chiave: « l’immagine non è altro che il complemento dell’idea che la provoca »)3. L’incidenza di Rossellini nel cinema è però ben più che problema culturale e libresco. Rossellini ha promosso lo sviluppo stesso di un cinema; tale incidenza non è di stile (come per esempio potrebbero essere per i figli di Visconti, De Santis, Antonioni o Fellini) ma di metodo: supe ramento della finzione romanzesca e dello « spettacolo », proposta di nuovi modi di produzione, modernità del discorso d’autore (sua incidenza sulla vita moderna piuttosto che sulla « cultura »: cinema di esperienza per lo spettatore oltre che di sperimentazione espressiva). Così che oggi rosselliniani possono dirsi non solo Ermanno Olmi o Gianni Amico (per restare ai « realisti » espliciti) ma Pasolini, Bertolucci (che stilisticamente è viscontiano), Ferreri, i Taviani; e per uscire dall’Italia, sono rosselliniani non solo la nouvelle vague, che gli ha sempre reso l’omaggio che si fa al maestro, o il cinéma-vérité (con cui Rossellini si è peraltro trovato in polemica), ma il « cinema nòvo » brasiliano e soprattutto, sorprendente mente, il cinema underground americano, che oggi scopre il suo cinema tele visivo « espanso » così come prima aveva scoperto la spregiudicatezza speri mentale rispetto al cinema tradizionale di un film come Francesco giullare di Dio 4. Come dire che l’influenza di Rossellini sul cinema moderno, esplicita o sotterranea, è stata enorme, certo superiore a quella di cineasti italiani ben più pubblicizzati di lui, e che ha generato figli assai diversi fra di loro. Invece lo studio della sua opera da noi è a livelli a dir poco semplicistici. Ci sono stati (siamo stati) i suoi propagandisti, coloro che ne hanno im posto il nome e il valore in Italia, ma ancora con lo spirito della « difesa » e con un certo culto della personalità, con atteggiamento troppo spesso spontaneistico e terroristico, anche se produttivo. Questo vuoto che carat terizza la ricezione della sua opera da noi è quello stesso che distingue una cultura cinematografica che ha paura del nuovo, che avanza con prudenza sul terreno già coltivato, che guarda al futuro con ottica riduttiva e con attitudine difensiva. Parlare dunque di Rossellini a proposito del neorealismo, oggetto di J Si vedano almeno i saggi di Bazin tradotti nel volume Che cosa i il cinema?, ed. Garzanti, 1973; il saggio di Rivette « Lettera su Rossellini », tradotto nel qua derno informativo n. 62 della Mostra di Pesaro (Il cinema di Jacques Rivette); la nota di Godard a « India », tradotta nel volume II cinema è il cinema, ed. Gar zanti, 1971; nonché il saggio di Jean-André Fieschi «Dov’è Rossellini?», in « Cahiers du Cinéma » n. 131, maggio 1962. 4 L’Anthology Film Archives, una sala newyorkese gestita dall'underground, ha nella propria collezione di film (gli unici proiettati, per la maggior parte di tipo sperimentale) due Rossellini: il Francesco e il Louis XIV.
290
Il neorealismo cinematografico italiano
questo convegno, può generare equivoci: si rischia di restringere i testi di questo autore entro un contenitore che non li contiene, che è da essi ampia mente superato; o si rischia di tornare a un cauto recupero di film « non poi così brutti come si era detto » cercando di trovare loro un posto in una storia del cinema italiano ormai ufficiale, ma che è stata tracciata senza di lui. Sarei tentato di dire, la cosa è peraltro un luogo comune: Rossel lini non c’entra niente con il neorealismo. Ma resta un fatto, che questo convegno mette in chiaro, e cioè che non si può oggi non fare i conti con la nostra eredità culturale; e che, bello o brutto che sia, ridicolo come de finizione unitaria, in pauroso ritardo sul resto della cultura europea, il neo realismo però c’è stato e ha funzionato (forse, più che in ogni altro mo mento, nel definire e formare quelle strutture estetico-produttive che sono alla base del cinema « politico » degli anni postsessantotteschi: Rosi, Petri, Vancini, ecc.). Dirò perciò che Rossellini traversa il periodo neorealista (che non è solo cinematografico) facendone la storia, cioè tracciandone le linee di for za, definendo le idee generali che lo reggono e lo muovono; e che nel fare ciò parte dalle apparenze stesse di questa storia, che sono innanzitutto il cinema come il medium espressivo più avanzato dell’epoca (epoca della riproducibilità tecnica), il medium che già di per sé pone in crisi la nozione di arte. Rossellini utilizza poi il cinema come « specializzazione » reali stica, e questa non è tanto una scelta a priori quanto la conseguenza del l’uso di una tecnologia determinata contro le regole fino a quel momento codificate, che si possono riassumere nella ideologia dello spettacolo e che si specificano nello star system, nella finzione romanzesca, nel rapporto « teatrale » col pubblico. Il cinema esce per le strade, diventa « reali stico », quando elimina una serie di diaframmi rispetto a una sua speci ficità tecnica (ideologicamente privilegiata, certo), quando si riafferma — per fare un discorso più generale — come il medium che porta a compi mento tutte le tecnologie della « riproduzione della realtà », tecnologie che non sono soltanto artistiche, ma proprie, per esempio, così della tradi zione alchimistica — con il suo « sogno » della pietra filosofale — come della ricerca cibernetica — che ora studia i « cervelli » chimici —. Come tecnologia di riproduzione della realtà, il cinema costituisce il punto d’in crocio fra magia e scienza. In questo senso, si può dire che il cinema è tanto più magico quanto più è « scientificamente » realistico; e che Rossellini, facendo riemergere nel cinema un realismo originario a cui il pubblico era diventato insensibile per via del « realismo » codificato hollywoodiano a cui aveva fatto l’abitudine, Rossellini dicevo ricarica il cinema di energia ma gica, ed è questo il residuo « artistico » che alla fine degli anni ’50 egli criticherà non so quanto giustamente. Già allora, comunque, il cinema diventa per Rossellini realistico quando non viene più usato perché è anch’esso un’arte, come tutte le altre (battaglia, questa, che mobilitò come
Ideologie e stili del neorealismo
291
si sa tutto un fronte di allora; battaglia vecchia in partenza, degna di Be * nedetto Croce). Il cinema diventa per Rossellini realistico perché permette qualcosa di assolutamente nuovo, e cioè la trasformazione dell’arte in infor mazione, intesa in senso lato; o, se si vuole, l* abbattimento della tradi zionale separazione fra arte e informazione. Il cinema è realistico così come lo è il giornale, come lo sarà la televisione. Questa informazione è, innan zitutto, informazione del medium stesso: l’uomo vede oggi non solo at traverso i suoi occhi ma anche con quella estensione di essi che è la nuova tecnologia meccanico-elettrica. L’« accecante » realismo di un film come Paisà ci dice — o ci annuncia — proprio questo: che oggi possiamo ve dere più che con i soli nostri occhi; e quello di Roma città aperta, peraltro ancora innestato nei residui della finzione classica, ci dà una memoria « reale » di qualcosa che non abbiamo vissuto: le nuove generazioni « ri cordano » la guerra perché hanno vissuto Roma città aperta. (La magia del realismo rosselliniano sta anche nella scoperta e nella sorpresa per queste nuove possibilità ed estensioni della « visione »). Il cinema è dunque per Rossellini una propedeutica del vedere moderno, proprio della nostra epo ca: è autopsia, che per Rossellini, come per Stan Brakhage5, vuol dire etimologicamente « l’atto di vedere con i propri occhi ». Questi occhi com prendono oggi anche obiettivi, lenti, vetri che rendono (scientificamente) « freddo » il suo cinema (in contrasto con la sua specificità, e con l’uso « caldo » che ne ha fatto tutto il neorealismo). Questi occhi precorrono, vedremo, la televisione. D’altra parte Rossellini si serve del cinema come mezzo di comuni cazione di massa, comunicando alle masse (rispetto a media più vecchi, sono masse anche gli spesso pochi spettatori dei suoi film di allora) ciò che con le tecnologie precedenti era privilegio di pochi: non il romanzo nè il teatro, dunque, ma il saggio, in particolare il saggio di filosofia della storia. Va da sé che questa « filosofia della storia » comprende la tecnologia del cinema — da cui viene trasformata facendosi così filosofia della storia contemporanea. La tecnica del realismo e la tematica del neorealismo sono per Ros sellini i materiali per tracciare, in quest’ottica filosofica, le linee di forza dell’Italia e poi dell’Europa della guerra e della ricostruzione. Nell’affrontare altre situazioni, una diversa storia, li abbandonerà logicamente. La tematica del neorealismo, i suoi modi e i suoi tic (che fecero agli inizi entrare Rossellini nella benedetta triade con Visconti e De Sica-Zavattini), sono l’oggetto della sua analisi. Il popolo, la società divisa in classi, la città vengono da lui non solo descritti o « guardati » ma, per così dire, spettrografati. Il realismo « globale » di Rossellini è un modo di supe 5 Stan Brakhage ha realizzato nel 1972 un film « documentario » su un obi torio (un impatto molto produttivo fra un tipico cineasta « visionario » e un ma teriale « realistico »), intitolato appunto The Act of Seeing with One’s Own Eyes.
292
Il neorealismo cinematografico italiano
rare la « specializzazione » stilistica (il cinema « teatrale » respinge la realtà, il cinema realistico comprende sempre il « teatro »). Il codice « aperto » che esso istituisce, contro quello « chiuso » del cinema classico, fonda questa nuova lettura della realtà a un tempo specifica e generale. Nello stesso periodo Visconti raccontava molto bene con una coscien za storicistica avanzata delle vecchie storie (ora racconta solo vecchie storie). De Sica adattava, con un’ideologia umanitaria e cristiana, strutture classiche a oggetti inediti, democratici e popolari. Ma già De Santis « gioca », in Riso amaro, sul terreno scottante dello scontro fra culture opposte nel dopoguerra italiano; mentre in Non c’è pace tra gli sdivi propone il recu pero del potenziale così sociale come magico-mitico della cultura contadina, se non addirittura dei suoi archetipi. De Santis, il miglior erede nel nostro cinema della cultura popolare, spettacolare e barocco, si situa in questo senso come l’opposto di Rossellini, erede della « grande » cultura borghese, cattolica e idealistica, e « realista » perché partigiano della realtà nel di lemma classico arte-realtà. Entrambi accomunati dal loro sospetto nei confronti dell’Arte, possono essere definiti, col senno di poi, le autenti che « due anime » che traversano il neorealismo e, quindi, il cinema ita liano dal dopoguerra ad oggi. Quanto a Zavattini, va detto almeno che lo caratterizza un’insofferenza se non addirittura una paura nei confronti del cinema in quanto tecnica. Questo fatto rende improduttivi i suoi spun ti teorici, che pure spesso preannunciano movimenti d’avanguardia (da Rouch a Perrault, da Shirley Clarke a Andy Warhol, dal super 8 al videotape). Zavattini è diviso fra la prostituzione della propria abilità di sceneggiatore classico in film commerciali; il compromesso delle sue colla borazioni col « narratore » De Sica o dei suoi paterni contributi alle sce neggiature dei più svariati film « neorealisti »; e il purismo teoricistico mai attuato nella pratica se non ancora con compromessi e risultati mediocri (Amore in città, Siamo donne, Lo spettatore cinematografico - Documento mensile, e poi Le italiane e l’amore, I misteri di Roma, i « cinegiornali li beri »). Le sue proposte d’avanguardia sono, insomma, viziate dal più profondo idealismo. In Roma città aperta il titolo stesso rivela un’apertura inconsueta: la gente, non i borghesi (che vivono nascosti nei loro uffici) ma la gente del popolo, vive all’aperto, nella città. Se il film è la storia di un caseggiato, lo è in quanto questo è un microcosmo che sintetizza (come un palcosce nico en plein air) la città intera: le nostre case già sono per Rossellini, nel *45, le nostre strade, e non più degli interni; la vita privata, le storie d’amore, coinvolgendo gli altri, si svolgono alla luce del sole; e la clande stinità della lotta partigiana è una nuova prassi, che passa attraverso i tetti e non si cela nel basso delle cantine, e che collega in una rete arti colatissima ciò che il nemico fa fatica a percepire, con le sue più vecchie
Ideologie e stili del neorealismo
293
coordinate culturali (ma già il nazista meglio del fascista: si veda la scena del maggiore Bergman che « legge » la città nel suo ufficio attraverso le fotografie quotidiane: il suo è però un sapere improduttivo). Rossellini, già oltre la guerra, vive nello spazio della modernità. Il centro, l’accentra mento e l’accerchiamento sono combattuti e battuti: alla fine del film i bambini hanno ereditato l’esperienza di un decentramento, e la cupola di San Pietro non funziona più da meta ma da sfondo per un cammino « aperto », poiché bisogna sempre tenere presente la nostra eredità cul turale, che per Rossellini è soprattutto quella cattolica. In Paisà il nemico è virtualmente battuto, e già siamo alla ricostru zione. Il plurilinguismo di questo film (girato per buona parte in presa diretta) mostra il superamento dei confini e delle culture, il loro impatto e la produttività di tale impatto: la ragazza siciliana e il soldato ameri cano, il bambino napoletano e il G. I. nero, la prostituta romana e un altro soldato americano, l’infermiera inglese e i partigiani fiorentini, i cat tolici, i protestanti e gli ebrei, e infine i partigiani di varie regioni d’Italia e la realtà intemazionale della resistenza. Soprattutto, la struttura inedita del film episodico, con i collegamenti fatti di materiale di repertorio che introducono « verità » immediata nell’apologo, ci dicono questa presa di retta e moderna dello spazio, la traversata continua e la distruzione di quelle apparenze che sono ormai, per Rossellini, le regioni, i confini lin guistici, le differenze culturali, la « linea gotica ». Egli analizza la condi zione e l’esperienza dell’uomo moderno, la conquista dello spazio urbano, la percezione « elettrica » dei diversi ambiti culturali, il decentramento del « villaggio globale ». Rossellini è già oltre l’Italia. In Germania anno zero, che già venne malvolentieri considerato un film neorealista, Rossellini lancia un grido (non emette un lamento: si sa quanto egli abbia sempre detestato questo atteggiamento, die assimilava alla sterile « denuncia » di tanti film impegnati tipicamente neorealisti). Questo grido, d’allarme, è provocato dalla riflessione « in negativo » su ciò da cui partiva il progetto di ricostruzione: le macerie, la città distrutta, bucata, lo sventramento che è la faccia « infernale » di quella estensione della casa alla strada e alla città che abbiamo visto in Roma città aperta; ed è provocato dall’eredità culturale profonda, anch’essa di colorazione « infernale », con cui devono fare i conti le nuove generazioni, rappresen tate da Edmund. Questa cultura che Rossellini analizza e critica con emo tività tutta particolare può essere riassunta nel maestro nazista e omoses suale: è il grido d’allarme (non privo di ambiguità che fanno di questo film uno dei più complessi ideologicamente di Rossellini) contro la per versione politica e sessuale, contro il dittatore, contro il prevalere degli istinti (bestiali) sulla ragione (umana), contro il superuomo nazista che sfida il mondo (in Stromboli, nel corso della lotta finale fra Karin e il vulcano-Dio, non c’è sfida e uccisione di Dio, ma sua accettazione e incor
294
Il neorealismo cinematografico italiano
porazione). Sulle macerie non si ricostruisce, né su ciò che ha prodotto queste macerie: cioè il culto del dittatore che dirige bambini che non sanno né vogliono o possono sapere. Culto che però si manifesta anche come culto del padre-, ed è qui che si produce un’ambiguità in Rossellini, poiché i suoi rapporti con la cultura patriarcale sono complessi, e sostan zialmente egli è un patriarca, nonostante l’altra sua « anima », quella socra tica che lo vuole né padre né madre ma puerpera, maieuta. Ma questo è uno dei discorsi importanti da fare su Rossellini e che qui per ragioni di spazio non posso sviluppare. Uccidendo suo padre, Edmund sancisce la vittoria del padre malefico, del demone ispiratore (non tanto il maestro quanto la « voce » del suo Mabuse — Hitler, che sentiamo attraverso un disco); suicidandosi, egli si dà come vittima sacrificale, senza che un’alter nativa sia posta se non dalla glaciale lunarità del film, dal suo essere un’esplicita radiografia dell’inferno. La « colpa » di Edmund e la conse guente espiazione stanno nel parricidio; ma questo parricidio è mostrato nello stesso tempo come il gesto più avanzato, a livello morale (ma forse anche oltre la morale: si sente un’eco di Nietzsche), che un individuo potesse compiere di fronte all’apatia e al vittimismo imperanti. Edmund « resiste » a questa apatia e a questo vittimismo, ma « va all’inferno ». E Rossellini, che dovrebbe logicamente condannare Edmund, scandalizzato dall’ipotesi di un tale verdetto ribalta le cose, e ne fa un santo, commette a suo modo una eresia e anticipa quelle sante-eroine che saranno le protagoniste di II miracolo, Stromboli, Europa SI. (La donna di Una voce umana invece è «dannata»: ma alla sua arte è dedicato il film). Con Germania anno zero Rossellini si stacca, per così dire, da terra. La caduta di Edmund — il suo « volo » sarei anche tentato di dire — sancisce Timpossibilità di costruire sulle macerie, l’impossibilità, per un orientamento che guarda al futuro, di restare attaccati alla poetica del neo realismo, di ostinarsi a una descrizione di fatti, di « accaduto » e di « vis suto » senza inserirlo in una prospettiva generale: che non è per Ros sellini, o non solo, una generalità « oggettiva », « politica » fra virgolette (va comunque detto che anche da questo punto di vista il cinema italiano dell’epoca non forniva indicazioni ma, tutt’al più, appelli). Lo « scandalo » della morte di Edmund alla fine di Germania anno zero è lo scandalo dell’occhio tagliato. Lo sguardo di Edmund sul palazzo bucato che era la sua casa, prima del salto nel vuoto, riassume lo scan dalo della soggettività tradita, è lo scandalo dell’impotenza dell’individuo a ritrovare una strada che l’oggettività davvero non gli offre. Macerie da una parte, occhio tagliato da queste macerie dall’altra. Il futuro è senza prospettive, in questi termini. Ma Rossellini non è di quelli che si arren dono. Si tratta, partendo dall’occhio tagliato, di ricostruire un modo di visione che comprenda i tagli, che sappia intenderli e controllarli. Tutte le sue visioni dell’« inferno » sono indagini antropologiche sulla condi
Ideologie e stili del neorealismo
295
zione umana che preludono a una costruzione positiva, o a un tentativo di sintesi. D’ora in poi (fino a La paura, per la precisione), Rossellini indaga tutto ciò che taglia l’occhio, tutte quelle lame che impediscono di vedere con l’occhio della ragione, come egli ritiene sia degno dell’uomo. Anche se questo punto necessiterebbe un discorso più ampio, si può riassumere questo superamento dello sguardo neorealista nel segno « campo-contro campo », che caratterizza soprattutto i film con la Bergman: introduzione dell’occhio — o dello spirito attraverso l’occhio — che guarda la realtà oggettiva, « vista da... » appunto, cioè non più data come sguardo gene rico e idealizzato di « tutti », del popolo, sguardo democratico e illusorio, « oggettivo » fra virgolette; il nuovo sguardo di Rossellini coinvolge un corpo e un’anima, passa attraverso una biologia, si determina materialmente, e si estende come sguardo dello spettatore, che compie l’esperienza, emo tiva e conoscitiva, di vedere film così inconsueti e in fase con la realtà globale che lo circonda; esperienza a sua volta in sincrono col « viaggio » di ogni film (viaggio che è di volta in volta calvario, salita verso o al cielo, discesa agli inferi, immersione nella mondanità, scavo nel passato vivente). All’occhio « aperto » Rossellini presenta dunque o oppone un reale di sgregato, frantumato, e privo di coscienza, che lo ferisce, e in cui tut tavia è urgente trovare un orientamento e una via d’uscita. Mi rendo conto qui di schematizzare opponendo implicitamente ra gione a istinto, ordine a caos. Ma voglio citare Rossellini, che esplicita mente nel 1971 afferma qualcosa che può chiarire i suoi complessi film degli anni ’50: Noi possediamo due cervelli: l’antico cervello, l’encefalo, che è proprio l’antico cervello animale che [...] guida i nostri istinti. Poi questo cervello è stato « coiffé » [...] da quest’altro cervello che è tutta la nostra materia grigia, che è quella che ci dà la possibilità d’intendere. [...] Noi viviamo continuamente fra questo nostro vecchio cervello animale, che è un rifugio abbastanza sicuro perché è la mancanza di responsabilità, e quest’altro cervello. Questo spiega perché Noè, che ha inven tato U vino, è celebrato: perché è il modo di rifugiarsi nel cervello animale. Questo è l’uso delle droghe di oggi. È sfuggire a tutta la parte nostra più eletta, cioè la coscienza delle cose, per rifugiarsi nelle nostre radici più animali, che sono le ra dici istintive6.
A parte la considerazione, che meriterebbe una certa attenzione, del fatto che Rossellini (si veda il suo recente libro, che riassume scritti e di chiarazioni di quindici anni almeno) è uno dei rari uomini di cultura che abbia compreso l’importanza di fare i conti col sapere scientifico; merita interesse il fatto che tutto il cinema cosiddetto « spiritualistico » o « mi stico » di Rossellini, che ha attirato il dispregio o l’ironia dei critici italiani, è stato realizzato proprio in vista di una diagnosi che mettesse a fuoco e combattesse questi residui del cervello umano. In quei tempi, i registi neorealisti, quelli meno « ingenui » di lui, si davano da fare per proda * 6 Cfr. l’intervista riportata nel volume di Baldelli, p. 245.
296
Il neorealismo cinematografico italiano
mare il loro credo razionale («la maturità è tutto »), salvo aver dimen ticato, o svicolato, il problema non certo piccolo per un'Italia cresciuta nel cattolicesimo, poggiata sulla famiglia e uscita dalla barbarie fascista, di ciò che questo razionale rimuove o denega nel momento in cui si af ferma. Questa presa di posizione per il « giorno » non ha mai tolto nulla alle forze del sonno, del sogno e della veglia: e la cronaca italiana non ha mancato di dirci (quando non le abbiamo vissute) le conseguenze di una tale dimenticanza, le rivelazioni di questo mastodontico lapsus. Rossel lini, con L'amore, commette il peccato mortale di interessarsi, proprio perché guarda avanti e ha già analizzato il « giorno », dei residui irra zionali, della condizione globale dell’uomo nel dopoguerra italiano e poi europeo. La sua non è immediatamente una critica. Si tratta sempre di conoscere prima di giudicare. Rossellini tenta quindi di verificare se in questi dati irrazionali è possibile trovare elementi di guida per un orienta mento verso il futuro. Rossellini crede in un uomo totale, in un uomo biologico, e il futuro verso cui guarda è quello fatto da tutto l’uomo, an che se sotto la guida del razionale che lo sovrasta biologicamente e stori camente (è questa, naturalmente, la sua lettura della biologia e della sto ria). Sono i « poveri di spirito » come la Nannina del Miracolo, quindi, a interessarlo, poiché questo mondo è anche dei pazzi; sono i corpi che pul sano e tremano, ma che proprio per questo continuano ad agire, di Karin e Irene e Katherine (in Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia), corpi di donne che « sentono »: e cosa sentono se non quel « futuro » che, per loro, si presenta ancora come mistero e irrazionale, infinito e utopia, ma che la mente lucida di un uomo potrà ben presto rischiarare e far uscire dalle tenebre? Il futuro — come infinito matematico — è di questi uo mini (nel cinema di Rossellini si chiameranno — preannunciati da Fran cesco — Garibaldi e Luigi XIV, Socrate e Cartesio, uomini che non sono vittime passive delle donne, come invece i mariti-ombra e i « padri puta tivi » di tanti film precedenti, o come il « rivoluzionario » Pietro Missirilli più attratto dal letto della vampirica Vanina che dai suoi compagni di lotta). Insomma, detto molto sommariamente (è anzi proprio questa la parte che ho dovuto rinunciare a sviluppare per ragioni di spazio convegnistico), la donna, con la sua carica fisica e terrestre, annuncia il futuro: questo deriva dal suo essere madre terra, origine profonda. Ma tale an nuncio (tale annunciazione) non basta. Non bastano le lacrime di Irene, la sua « santità » alla fine di Europa 51, a salvare chicchessia. La donna, nella misura in cui Rossellini l’assimila con gesto patriarcale all’istinto, è illusione. La sua sensibilità è anche impotenza. Essa indica il percorso del viaggio in Italia, in Europa, nel Mondo, viaggio esterno e interno. Ma solo la coscienza razionale, che non si fa irretire dalle lusinghe dell’irra zionale, potrà percorrerlo. E questa coscienza è da Rossellini attribuita al maschio. Con la sola eccezione di un film, è il caso di dirlo, fondamentale,
Ideologie e siili del neorealismo
297
e non solo da questo punto di vista, cioè Giovanna d’Arco al rogo, la strada di Rossellini è quella dell’uscita dal labirinto dei sentimenti e del * l’istinto indicata — ancora dentro la problematica istintuale — nella co munità dei fratelli di Francesco giullare di Dio (un film « maschile », ap punto), e sviluppata anni più tardi con un salto che non si limita a questa casistica uomo, donna, famiglia, di stampo tutto sommato contenutistico, e va dritta al nodo del problema. Poiché non si tratta soltanto dei film che hanno a protagoniste que ste donne che sentono e soffrono, assai più dei loro uomini. Ma si tratta del cinema stesso, che è, per Rossellini, un medium « femminile ». Dirà nel 1965, per spiegare il suo passaggio alla televisione (che è del 1957-58, con la serie L'India vista da Rossellini): Non mi interessa il cinema di per sé. Non si può andare avanti per allusioni. Ormai ci sono delle cose talmente urgenti nella vita che le allusioni non servono più a niente. Qui bisogna fare i discorsi espliciti78 .
Questa urgenza, questa assenza di allusione, questo carattere esplicito del medium, in altre parole questa « freddezza » e questa « elettricità » gliele darà appunto la televisione. La critica severa che Rossellini ha fatto, nei suoi anni televisivi, al suo cinema « neorealista » è quella di essere, anche perché « cinema », ancora troppo « caldo » per i bisogni dell’epoca. La sala oscura e il fascio luminoso proiettato su uno schermo bianco gli appaiono ancora strumenti magici e fascinatori: e tali in effetti sono. (Fra parentesi, quanti cineasti propugnatori del razionale, dell’impegno, del « cinema che serve » si sono posti nella pratica, e non solo in teoria, questo problema? che è poi il problema del pubblico). Rossellini assimila addirittura il cinema al ventre materno, definendolo quindi come medium regressivo, in quello che è di fatto il suo ultimo film, e cioè l’episodio Illibatezza di Rogopag . * (È a questo punto evidentemente interessante vedere come Rossellini giustifi cherà il suo ritorno al cinema con Italia anno uno). Rifiuto quindi del cinema, e del suo rapporto caldo e proiettivo con lo spettatore, e scelta della televisione, medium freddo e sferico. All’autore succede l’antenna, alla soggettività commossa la « fraterna », stavolta de mocratica, comunità. Questo « cinema » perde ogni residuo realistico (qui si rivela quanto fascinatorio fosse quel realismo, che faceva sembrare 7 Cfr. l’intervista con Adriano Aprà e Maurizio Ponzi, « Filmcritica », nn. 156157, aprile-maggio 1965. 8 Anche Illibatezza appartiene, visibilmente, ai film di Rossellini che interro gano il cinema da un punto di vista teorico; il film è preceduto da una frase rive latrice di Alfred Adler, che cito forse con qualche inesattezza: « Oggi, l’uomo si sente spesso turbato da un’indefinibile angoscia, e mentre è al lavoro il suo incon scio lo spinge a trovare un rifugio che lo nutra e lo protegga: il ventre materno. Per questo genere d’uomo, anche l’amore diventa una lamentosa ricerca del ventre protettivo ».
298
Il neorealismo cinematografico italiano
vere le cose, come una diavoleria fieristica: e si veda quel film teorico sulla riproduzione fotografica che è La macchina ammazzacattivi). I tele * film sono « piatti », didascalici, e si rivolgono a un pubblico circolare. Hanno come modello la «voce» socratica («Socrate, l'uomo che non scrive »), anticipata dall’irradiamento dei frati alla fine del Francesco. È questa voce, sporca perché « viva » (sono note le accuse di sciattezza fatte a Rossellini), a prendere il posto del « realismo », che rischiava di essere solo mimesi della vita, la quale mimesi, come per Platone (che si riferiva alla memorizzazione che precedette la lettura), mette l’accento non sull’azione creativa dell’artista, ma piuttosto sul potere che egli ha di immergere il suo uditorio in uno stato d’identificazione quasi patologico e senza dubbio simpatico col contenuto del suo enunciato [...] ciò che [Platone] vuol dire è che ogni enunciato poetico dev’essere concatenato e recitato in maniera che si produca un autentico dramma nell’animo così del recitante come del suo uditorio. Per Platone, questo genere di dramma, questa maniera dì rivivere l’espe rienza attraverso la memoria piuttosto che analizzarla e comprenderla, è il «ne mico » 9.
Per Rossellini la proiezione del film ha sostituito, nella pratica del pub blico, la memoria platonica; ma ugualmente urgente è analizzare e compren dere la realtà e individuare il « nemico », che è il cinema come fascina zione e opera d’arte: l’alternativa è la televisione, mass medium freddo e didascalico. Ma, chiamando in causa Socrate e Platone, ho introdotto l’ultimo degli argomenti che qui non posso sviluppare, e cioè il dilemma voce/scrit tura che traversa l’opera di Rossellini. Il suo cinema è stato spesso accu sato di sciattezza, di « sporcizia »: è la traccia di un realismo che vuol essere voce piuttosto che scrittura, che vuol essere in presa diretta con la contingenza della vita piuttosto che mettere in scena il teatro di tale vita. Il cinema, e in particolare il cinema realistico, propone un rapporto di immediatezza fra lo spettatore e l’autore, un rapporto quasi dialogico. Ma, nello stesso tempo, il cinema di Rossellini è traversato dalla faticosa espe rienza della scrittura, dal lavoro — non sempre palese — sul materiale cinematografico. Esiste addirittura un film quasi teorico sulla problematica voce/scrittura, risolto in favore della scrittura, e cioè Giovanna d’Arco al rogo. Ma la verità è che sempre più spesso Rossellini si è dichiarato in favore di Socrate, che dice ai suoi discepoli nel cerchio vivo della comu nità fraterna la filosofia della storia contemporanea con la voce televisiva del nuovo medium elettrico. Essere « scrittore » significa per Rossellini es sere anche « artista », padre e padrone dell’opera, erettore di monumenti: e il monumento immobilizza il flusso vitale, interrompe col suo mutismo fascinatorio ogni dialogo. La scrittura è la morte che, come il sole, non può 9 E. Havelock, Preface to Plato, cit. da Marshall McLuhan in Du cliché Ì l'archétype, Maison Mame, 1973, p. 153.
Ideologie e stili del neorealismo
299
essere guardata in faccia, non può essere esibita. « Quelli che vogliono vedere il sole si bruciano gli occhi se lo guardano in faccia. Devono stu diarlo guardandolo riflesso nell’acqua. L’anima diventa cieca se vuole sco prire la verità dai dettagli, deve rifugiarsi nel mondo della ragione »; così dice Socrate. Il Rossellini televisivo vuol essere questa mediazione, come se l’occhio fosse stanco delle ferite inflittegli dai « viaggi » dei film pre cedenti. La televisione, per Rossellini, è una voce tendenzialmente inno cente, lontana così dalla morte come dalla scrittura, senza padre né madre, senza conflitti; l’occhio e l’orecchio televisivo sono incorporei e senza autore. Ma, sappiamo, anche la televisione ha dei padri, anch’essa è tra versata dalla problematica della scrittura, anche se in modi completamente diversi dalle « opere d’arte ». Se è vero che Rossellini teorizza ima televisione-voce, è però anche vero che la problematica della scrittura è co stantemente presente, anche se più spesso al livello di lapsus, come ritorno di un rimosso. Il « cinema saggistico » ha trovato nella televisione il suo medium ideale, ma anche un rifugio da problemi (la morte, l’eros, l’incon scio, il corpo) che anche i suoi film più saggistici e « freddi » (Francesco giullare di Dio, Viaggio in Italia) non cessavano di interrogare. Si tratta quindi, tradendo Rossellini, di leggere la scrittura latente dei suoi telefilm, e di trarne gli insegnamenti che egli tende a celare.
DE SICA NEOREALISTA di Tino Ranieri
Il primo moto, a riparlarne, è di irrigidimento, il secondo potrebbe essere di affettuosità: esistono dei miti simpatici e De Sica ne fa parte. Se Rossellini e Visconti, gli altri due autori con cui si aprì nel 1945 il nuovo cinema italiano, rappresentano oggi il « cinema di papà », De Sica è il cinema del nonno, e il nonno, evidentemente, si contesta meno, si sente che contestarlo è più vano e ingeneroso. Al momento sarebbe perfino trop po facile. Quindici anni di brutti o mediocri film — diciamo regie, non ci interessano qui le interpretazioni — sono tanti da invogliare a un riesame del De Sica maggiore per trovare già in quello le radici, gli errori del lungo decadimento che è seguito. C’è già stato chi si è provato a farlo. Il De Sica neorealista è stato revisionato abbastanza brutalmente. È stato affer mato addirittura che il suo non fosse nemmeno neorealismo (per anni e anni si è spaccato il capello sopra un’etichetta di comodo, morta comun que prima delle opere cui la si riferiva). Di rado invece si è voluto rico noscere che, come il movimento cinematografico che lo aveva messo in luce, De Sica è declinato prima del tempo soprattutto perché anch’esso è stato messo in disparte, è stato combattuto e sconfitto. Hanno giocato astutamente sulla sua vecchia illusione coloro che nelle cose del cinema hanno meno fama ma più potere; dopo gli insuccessi finanziari dei suoi film importanti De Sica aveva detto: reciterò nei film altrui, accet terò le regole della cassetta una volta sì e una no, pur di trovare i mezzi per fare al momento opportuno i film che mi piacciono. Ragionamento troppo semplice. Espediente che non è riuscito mai, ad alcun grande re gista del mondo. È un’altalena impossibile, i mezzi non si trovano, come non si trova mai il momento opportuno. I nemici del cinema (non solo quelli politici o religiosi o censori, ma anche quelli interni al cinema, co me molti produttori) sanno perfettamente che ritardare la nascita di un film equivale a ammazzarlo. Fare II giudizio universale nel 1960 non è lo stesso che farlo nel ’50. De Sica avrebbe dovuto captare questi segnali d’allarme. Soprattutto avrebbe dovuto capire che è proprio al regista « for tunato » che non è dato più mutare strada, sfuggire al sistema. Il cineasta di successo è il più legato di tutti. Al tempo di Ladri di biciclette, De Sica
Ideologie e stili del neorealismo
301
poteva ancora rifiutare Cary Grant. Ma per Stazione Termini, sebbene gli americani fossero venuti a cercarlo proprio perché entusiasti di Ladri di biciclette, non può più rifiutare Jennifer Jones e Montgomery Clift. De Sica non è un carattere complicato. Tuttavia al tempo del cinema neorealistico i suoi film non erano semplici, ma deliberatamente e accura tamente semplificati, perché volevano arrivare lontano. Era tipicamente sua quella curiosità da dare e da ricevere, il modo di illustrare la vita dimessa affinché la coscienza collettiva completasse poi la scoperta e continuasse il dialogo. L’attenta cordialità di chi vuole trasfondere il ci nema negli uomini e non viceversa. « Gii attori sono pochi, mentre vi sono milioni di personaggi », ha scritto una volta. Il periodo neorealistico di De Sica va da 1 bambini ci guardano (1943), che serve da prologo, a II tetto (1956), passando per Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1958), Miracolo a Milano (1951), Umberto D. (1952). Non trascureremmo del tutto I bambini ci guardano, bene sviluppato dalla sceneggiatura di Cesare Zavattini come bozzetto critico sulla piccola bor ghesia italiana sotto il fascismo, e coltivato da De Sica nel personaggio del ragazzino con la cura che il regista poi rivolgerà sempre ai problemi e alle figure dell’infanzia. È certo un piccolo film, una coperta gara — al terz’anno di guerra, con i fascisti più avvelenati che mai — tra ciò che si può e ciò che non si può dire. Ma già qui De Sica conferma di voler affrontare il nuovo lavoro di regista (iniziato pochi anni prima con Rose scarlatte, Maddalena zero in condotta, Teresa Venerdì e Un garibaldino al convento) in opposizione alle proprie esperienze professionali prece denti. Lo aiuta, come si è detto, Zavattini. È un’amicizia destinata a durare col buono e il cattivo tempo; un rapporto mai totalmente sviscerato dalla critica, che subisce in seguito varie alterazioni ma non si spezza mai. Negli anni neorealisti la fusione era perfetta, tanto che riesce pressoché impos sibile stabilire dove cominciasse il lavoro dell’uno e finisse quello dell’altro. Vien fatto di pensare che a volte i due amici si divertissero a scambiarsi le parti. Restando al paragone del caffè e latte, da loro stessi suggerito, si è ritenuto da principio che il caffè, nero bollente e frustanervi, fosse lo scrittore di Luzzara, mentre il quieto e candido latte fosse De Sica. In verità la mistura si è fatta meno decifrabile col passar del tempo. Forse dopo un poco è stato Zavattini a rivestire il bianco dei suoi angeli mat ti e poveri, ed è toccato a De Sica di diventare il provocatore nero, o me glio « rosso », come dicevano i benpensanti degli anni Cinquanta, gli stessi che avevano constatato con raccapriccio che i barboni di Miracolo a Milano, volando via a cavallo delle scope, puntavano verso Est. Da La ciociara (1960) in poi è stato comunque De Sica a reggere la barra, con Zavattini come secondo di bordo (e infatti in La ciociara Ie gags zavattiniane spiccano, graziose ma isolate, come citazioni da film prece denti).
302
Il neorealismo cinematografico italiano
A guerra finita, il neorealismo si è dato prima i film che il nome e le regole. È stato un cinema di esplicita trasgressione, nemico dei tabù tanto a lungo imposti, desideroso di proporre alT« italiano quotidiano » una maggiore indipendenza di ragionamento nel paese uscito dalla guer ra ma per nulla tranquillo. Le vie, il passante, la parola parlata sono i suoi obiettivi immediati: la scoperta cinematografica dell’Italia. Vi si sono accinti Luchino Visconti, Roberto Rossellini e De Sica. Visconti, lo storico, aveva prefigurato modi e ambienti in Ossessione. Rossellini, il « grande cronista », ha raccontato per primo la Resistenza. Tocca a De Sica il compito di narrare la sofferenza del dopoguerra, con Sciuscià. Ripetiamolo per l’ultima volta: questi tre registi non formano una scuola, di rado si sfiorano, e non sarebbero in grado di scambiarsi le parti. Sono tre esploratori che percorrono l’Italia tanto a lungo proibita, cercandovi la libertà dei fatti (Rossellini), la libertà di interpretare i fat ti (Visconti), la libertà di dare ai fatti il gesto, il volto, il comporta mento giusto (De Sica). Che questa indagine si sia chiamata neoreali smo non è dato bastante per conciliare e aggregare tre temperamenti così diversi — più qualche altro che si aggiungerà al gruppo tra il 1946 e il 1951. Zavattini, che di quegli anni è il quarto uomo (o il primo) preferisce, parlando anche a nome di De Sica, considerare il fenome no dal di fuori: « Devo molto al neorealismo, mi ha aiutato a uscire dal vago ». Il fatto è che De Sica e i suoi colleghi di lavoro, in quel mo mento, non stanno ancora facendo un cinema per spiegare gli italiani agli italiani, ma per spiegare problematicamente il proprio mondo a se stessi. Molto di frequente la critica del tempo ha desiderato e voluto che — poiché erano in pochi — si assomigliassero. A volte ci è parso che si assomigliassero. Chi scrive non è stato immune dall’errore, negli anni del cinema antropomorfico, del felice disordine e del filo rosso del l’entusiasmo. Nel 1946, al teatro Quirino, si toccano per la prima e in pratica per l’unica volta le orbite di Visconti e De Sica: De Sica impersona Fi garo nelle Nozze di Beaumarchais per la regia di Visconti. La radice di Visconti era largamente europea, superba, rivoluzionaria, senza perdoni possibili. Quella di De Sica, popolareggiante, umanitaria, mediterranea, d’inevitabile commozione. Il loro Beaumarchais tuttavia è stato eccezio nale anche perché nettamente anticinematografico. In ciò, almeno, Viscon ti e De Sica erano simili. Sapevano che si trattava di due battaglie diverse. Il 1946 di De Sica si ricorda ad ogni buon conto più per la regia di Sciuscià che per l’interpretazione di Figaro. Sciuscià, come del resto Roma città aperta di Rossellini, è film d’istinto. L’ansia di De Sica è se mai liricizzante e conduce — specie a film riveduto oggi — verso un
Ideologie e itili del neorealismo
303
che di contemplatività, di estenuatezza (due termini che sono stati usa * ti uguali per 11 giardino dei Fingi Contini). Senza dubbio le ragioni delle vittime, i ragazzi di strada della Roma postbellica, sono sentite con ca lore, su personaggi molto vitali. Non tutto è realtà, il cavallo bianco di Zavattini attraversa il film come fosse il suo ennesimo angelo. Anche in queste aperture — o deviazioni — sussiste tuttavia ciò che Vittorini definiva allora l’incoercibile bisogno di riattaccarsi alla vita dopo essersi nutriti per decenni del raffinato solipsismo della letteratura in cifra, in una atmosfera di generoso e impa ziente fervore, di fame della realtà.
Vittorini parlava del neorealismo in letteratura, ma riconoscendo al cine ma priorità d’indirizzi. E dopo Ladri di biciclette, De Sica non è stato forse chiamato da Pavese il maggior poeta italiano? Ladri di biciclette non è il capolavoro del neorealismo, perché negli stessi mesi Visconti termina La terra trema. Ma ne è di gran lunga il messaggero più famoso in giro per il mondo. È il neorealismo postbel lico nel pieno delle sue istanze, con i pregi e i difetti che lo rendono oggi « storico » più di Assunta Spina. Scrupolo nell’avvicinamento all’uo mo, avvertito legame fra individuo e società, ripulsa del romanzo, eco diretta delle problematiche del giorno, con stile, argomenti, testimonian ze dal vero che non temono di apparire « scandalose ». La cosiddetta « pic cola psicologia » di De Sica produce due personaggi zavattinianamente per fetti, ma più aspri del solito, perché nella lineare vicenda, apparentemen te aperta, non c’è uscita. Altro che De Sica crepuscolare: qui c’è di nuo vo la notte. Negato allo spessore tragico, che è positivo, il regista sorri dente non nasconde il suo pessimismo, che è negativo (una distinzio ne fatta, se non erriamo, da Pasolini). Ma la sua voce va ascoltata an che così perché De Sica, tra i registi del dopoguerra italiano, è il pri mo a sentire e a comunicarci che molte cose non sono cambiate, che la differenza sta solo nella libertà di dire che non sono cambiate. In fondo al film, e ad onta di certe dichiarazioni in contrario dello stesso regista, c’è questo: che l’Italia del 1948 è il paese delle biciclette, ma Ricci non avrà la sua bicicletta; come dieci anni prima l’Italia era la patria dei telefoni bianchi, ma la gente non aveva telefono. Vengono su intanto Germi, Zampa, Castellani. Litigano vocazioni e convinzioni oltremodo dissimili, certe secessioni s’indovinano imminen ti, l’ideologia ora aiuta ora tradisce. Il neorealismo d’impulso non può più bastare di fronte all’importanza degli impegni, ora che — dal 18 aprile *48 — le elezioni hanno portato alla vittoria la DC. Il pubblico di De Sica si sgela con lentezza, e sul conto dell’insuccesso vengono posti ipo critamente altri rancori che il neorealismo è andato suscitando negli strati più reazionari della nostra politica. La polemica si accentua dopo Miracolo a Milano, in cui l’ago della bilancia si sposta visibilmente ver-
304
Il neorealismo cinematografico italiano
so l’ispirazione zavattiniana del libro originario. Curiosa — e anche sug gestiva — operazione cinematografica, Miracolo a Milano è al tempo stesso mascheramento e rarefazione del neorealismo, ma anche in quest’ aria « truccata » riesce a suggerire alcune cose (per esempio che Milano più di Roma sarebbe stata la sede naturale del neorealismo cinematogra fico) e a profetizzarne ironicamente altre (il fragile boom degli anni Ses santa, con troppa edilizia e poco petrolio). Ma è anche innegabile che Miracolo è già film in bilico. De Sica e Zavattini insistono sull’impalpabile poetica dell’Uomo Buono, la cui protesta giunge, nei casi migliori, a dilatarsi emotivamente anche al di là della sfera individuale, in un discorso pacato ma inequivocabile di responsabilità tradite. La vittima però assume generalmente la fisiono mia del povero, senza mai assumere quella dello sfruttato. Miracolo a Mi lano è esemplare in tal senso, sebbène i reietti siano qui una comunità. Tenuto al limite della fumisteria, con trucchi ottici più o meno riusciti, vanta una carica polemica niente affatto astratta. Nondimeno il duplice Zavattini da cui deriva, quello letterario sognante e furbesco, quello ci nematografico allusivo e corposo, hanno forzato entrambi l’esperimento, e la regia di De Sica vi si adegua. Come scriveva Fabio Carpi: Se è vero che nella coppia Zavattini ha sempre rappresentato la parte della co scienza, bisognerà pur dire che qualche volta egli è stato anche la cattiva coscienza di De Sica.
I tempi cambiano. Nello stesso anno in cui Totò il Buono applaude i ricchi milanesi davanti alla Scala, Antonioni in Cronaca di un amore guarda quegli stessi ricchi, nello stesso luogo, senza applaudire affatto. Sorge il neorealismo borghese. Ma non è più neorealismo, è un altro volto più gelido e disincantato dello scontento. Se lo si vuole ancora considera re neorealismo, diciamo che ne costituisce la « grande illusione » finale. De Sica e Zavattini comunque suggellano il loro percorso con un film bellissimo, Umberto D.t sintesi di successi e insuccessi precedenti messi a frutto con estrema dignità civile. Non frange sentimentali, non rifugi nella favola, ma il gelo dei soli e perfino quella scontrosità sgradevole del personaggio « antipatico », che è probabilmente per De Sica il dato più ostico da esprimere. È, come si ricorda, il momento in cui Andreotti, dalle colonne del giornale Liberlas, rimprovera il regista di mettere a nu do « il male » in modo settario, sì da rendere un pessimo servigio alla sua patria, che è anche la patria di Don Bosco, del Forlanini e di una progredita legislazione sociale.
Polemiche vecchie, d’accordo, ma non superate del tutto. Intanto quel « pessimo servigio » è diventato un classico del nostro cinema. In ma teria di « progredita legislazione sociale », le manifestazioni dei pensiona ti non sono ancora terminate nel 1974, hanno solo acquistato una mag
Ideologie e stili del neorealismo
305
giore consapevolezza. E per l’accenno a Don Bosco, ricordiamo che il suo film lo aveva già avuto nel 1935. Peccato che a farlo fosse stato Goffredo Alessandrini, passato poi dalla celebrazione dei santi a quella dei mascalzoni con Luciano Serra pilota e altri film fascisti. Resta il fatto che De Sica, assai amareggiato, decide di far fronte ai tempi duri rimettendosi a recitare nei film « teneri ». Diventa il ma resciallo Carotenuto di Pane amore e fantasia di Comencini. Sentendo aria di compromesso si rifanno avanti gli americani, che lo corteggiavano da tempo, e Darryl Zanuck riesce a portarlo negli Stati Uniti per affidargli un soggetto di Ben Hecht, Miracolo sotto la pioggia. De Sica sa dire di no, e il film viene poi diretto da Rudolph Mate, grande, operatore e ano nimo regista (s’intitola, in Italia, Incontro sotto la pioggia). Ma De Sica non può scansare Stazione Termini, elaborato — è un connubio da far paura — su un’idea di Zavattini per l’interpretazione di due divi hollywoo diani — la Jones e Clift — validi in tutt’altra area e con ben diversi presupposti. Le varie concessioni di De Sica mirano in quel momento a uno scopo: un film chiamato II tetto, in cui il regista prende nel 1956 con gedo dal neorealismo con una parola di schiva, quasi timida, solidarietà con il mondo popolare che attornia i due protagonisti. È un commiato, ma fra le righe anche una rivincita, perché ci troviamo nella fase cri tica dell’economia cinematografica che accarezza come soluzione tauma turgica la formula — di per sé insufficiente, è ovvio — dei «bassi co sti ». Sono in parecchi a Cinecittà che patiscono, dichiaratamente o me no, la nostalgia del periodo neorealistico, sia pure dal verso sbagliato, cioè non per i suoi valori ma per i suoi prezzi: i bei tempi nei quali i registi andavano al lavoro in bicicletta e gli attori non erano attori. Di questo rimpianto interessato approfittano De Sica e Pietro Germi per varare due film vecchio stile, Il tetto e II ferroviere. Risentono però specie De Sica, di un ché di riutilizzato; la raffigurazione « familiare » cede spesso alla lacrimosità. Eppure II tetto è, per l’ultima volta, neo realismo non fantomatico, che ammette l’errore, non la falsità. Su ciò che segue De Sica in persona ha fatto l’autocritica: Non si può dar torto ai produttori — ha dichiarato a Federico Frascani. — Non si può pretendere che Ponti, per esempio, metta a repentaglio sette-ottocento mi lioni, che rappresentano oggi il costo di un grosso film, senza la sicurezza di recu perarli, almeno, e con la speranza legittima di ogni uomo d’affari, di ricavarne un guadagno. Perciò io mi sono adattato. L'oro di Napoli, La ciociara, Boccaccio '70, Ieri oggi e domani, che ho girato per Ponti con la presenza insostituibile di Sophia Loren nel cast, sono stati grossi successi commerciali, ma manca ad essi il rigore, l’animo, dei miei primi film; e questa è la mia spina. Sono precisamente i film che non avrei dovuto fare.
Certamente. E più arrivano gli Oscar e i quattrini, più gli viene negata la possibilità di girare i film che avrebbe voluto, come fosse an-
306
Il neorealismo cinematografico italiano
cora il regista novizio di trent’anni prima: altri originali di Zavattini, e Cecov e Flaubert. Parte della critica considera una rivalsa, sia pure fuori tempo massimo, Il giardino dei Finzi Conlini, che noi a stento va lutiamo solo come manifestazione d’una nostalgia onirica ed esangue. Da un pezzo, nessuno può negarlo, De Sica difende la sua dignità sul velluto, castigandosi in certo modo quando recita, con quella sua ormai convenzionale e prelatizia bonomia che sappiamo. In tutti i casi è ben finita la sua forma di felice malinconia cinematografica, di « inesorabile amicizia di un autore per i suoi personaggi » che incantava André Bazin e gli faceva scrivere La sua delicata cortesia napoletana diviene grazie al cinema il più alto messaggio d’amore che i nostri tempi abbiano avuto la fortuna di ascoltare dopo Chaplin.
Parole che si rivolgono evidentemente a un De Sica che più non esiste, non a quello che in questi giorni comincia a filmare D’Annunzio. Parole che non sono un giudizio di storia, e nemmeno un epitaffio per il neo realismo italiano. Le citiamo lo stesso qui in chiusa a questi appunti, in ricordo di una presenza amica nel panorama degli anni ingrati, e in omaggio alla fantasia con pochi allievi e senza maestri.
« DE SANTIS » di Andrea Martini e Marco Melani
Esistono opere che con il passare del tempo cambiano di segno come talvolta gli stili. Ciò che era considerato « basso » e di cattivo gusto dal giudizio estetico diviene improvvisamente di una raffinata eleganza secondo nuovi criteri di fruizione. L’oggetto kitsch viene d’un tratto rilanciato dalla moda e fruito come arte sofisticata. È la storia della fortuna del liberty. La fortuna attuale della moda degli anni ’50. È sull’onda di questa moda che si sta realizzando un remake di Riso amaro (e, seppure collocan dosi in un altro settore dell’industria culturale, non si iscrive in questo stesso fenomeno « retro » anche il presente convegno sul cinema neorea lista?). Ai film di Giuseppe De Santis accade di essere stati concepiti per un pubblico popolare e di essere oggi comprensibili ed apprezzabili nella loro segreta bellezza soltanto ad una attenta osservazione della loro costru zione. È il piacere che solo oggi possiamo concederci di gustare l’arte popu lista, essendosi ormai persi nel tempo quei valori che la rendevano « im pegnata ». L’arte populista è caratterizzata (come tutta la cultura di massa) dalla serialità con cui produce sempre gli stessi temi, gli stessi materiali, gli stessi significati e dalle variazioni che riesce a introdurre (le più elaborate e le più folli) all’interno del proprio ristretto territorio. Riso amaro è una delle più evolute variazioni che il cinema populista abbia prodotto nel do poguerra. È un’evoluzione stessa dell’arte populista che (forse per la prima volta) si rinnova in un pastiche di generi e di tipologie provenienti dal re pertorio elaborato dall’industria dello spettacolo per la fruizione collet tiva. Strappato il sipario del realismo impegnato, Riso amaro ci appare come un gioco di specchi fra due culture popolari o di massa (quella italiana-neorealista-contadina e quella americana-hollywoodiana-tecnologica) che si riflettono ambiguamente l’una nell’altra, come una costruzione ba rocca dove alle forme sinuose dell’acqua si è sostituito il movimento con tinuo e altrettanto sfuggente dei modelli di cultura. Questo film barocco ha per oggetto le forme codificate e le mitologie contemporanee divulgate dai mass media: le sue figure sono tanto più formalizzate e intellettualiz zate quanto più gli elementi primari sono emotivi e sensuali. Il suo mes
308
Il neorealismo cinematografico italiano
saggio elementare (comunista/cristiano) è trasformato dalla prospettiva storica in una morale dell’ambiguità. Il suo progetto ideologico originario è sconvolto e mutato. La costruzione delle strutture prende il posto della costruzione del socialismo. Un’operaia, una contadina così « bella e sensuale », così « perversa » come Silvana Mangano assomiglia più all’immagine di un arabesco che al proprio personaggio. Essa è l’incontro di due codici diversi e l’inserzione parallela dell’uno nell’altro piuttosto che la somma di alcuni attributi. L’« operaia », la « contadina » definiscono una condizione sociale conno * tata positivamente secondo il codice di valori del realismo socialista, la bel lezza perversa e fatale è un’imitazione del modello della « femme mau dite », supermaggiorata di ascendenza hollywoodiana (Silvana Mangano, dopo questo film divenne immediatamente la Rita Hayworth italiana). L’immagine di due codici che si sovrappongono senza mai intersecarsi tro va il proprio referente non in un originale « reale », ma nel riflesso dei processi ideologici e delle contraddizioni che si producono nella « realtà ». Il film esibisce la contraddizione che in genere tutto il neorealismo subisce passivamente: la contraddizione fra l’accelerato sviluppo dell’in dustria culturale e il conservatorismo della cultura tradizionale — orale ed insieme gutenberghiana — di un paese contadino. La teoria neorealista è ancora legata alle concezioni tolstoiane dell’arte (il messianico progetto di identità tra opera e popolo di comprensibilità universale) e ai modelli nar rativi dell’estetica verista (il recupero dei vecchi modi di formare e della loro ideologia pre-capitalista), quando ormai la cultura europea ha prodotto Duchamp e Eisenstein e quando Hollywood ha già diffuso a livello di massa tutti i temi e le strutture del romanzo naturalista e ha inventato da tempo il romanzo di consumo con tutti i suoi sottogeneri « realisti » (la gangster story, il western, la fantascienza). Il ritardo della cultura italiana pesa sul cinema neorealista e lega anco ra i suoi prodotti al passato, lontani dall’attualità e dallo sviluppo accelerato del presente. Vittorio De Sica, « il miglior narratore italiano del dopoguer ra » secondo Pavese, racconta gli ultimi personaggi dell’era meccanica. Anche De Santis è legato ad una struttura romanzesca che segua l’evoluzione di « eroi » nettamente individualizzati in situazioni familiari e socialmente dense secondo la tradizione del romanzo ottocentesco. Ma questa strut tura appare aggiornata dalle nuove possibilità semantiche che il cinema le apporta. Lo sfondo emerge in primo piano: la profondità di campo mette a fuoco ciò che finora era stato coro e scenografia, evidenziando la teatra lità e la finzione. Basta ricordare la scena di Caccia tragica dove i bambini giocano mascherati e dove la tenda che sostituisce la parete fa da sipario alla realtà. Il ritmo della narrazione è rapido come quello di un racconto poliziesco essendo aboliti tutti i tempi psicologici. Ma il modello che pro duce questa velocità è ancora un mezzo meccanico: il treno. Anche De
Ideologie e stili del neorealismo
309
Santis, come Orson Welles, pensa che il cinema sia come un trenino, un giocattolo con cui baloccarsi, e scrive in Confessioni di un regista1: uno che all’improvviso se lo trova tra le mani, come avvenne a me, si comporta al modo dei bambini che i giocattoli scompongono e ne frugano le interiora per cercare di capirne ogni singola parte e il congegno.
Il treno appartiene alla storia delle origini del progresso e il suo ritmo scandisce l’epopea di questa storia in un altro genere narrativo: il western. In esso il treno appare come simbolo del progresso, della conquista, della colonizzazione: si pensi a due film esemplari in questo senso, Union Pacific di Cecil B. De Mille, dove il treno unisce i due poli della civiltà americana correndo dall’Atlantico fino al Pacifico, e C'era una volta il West di Sergio Leone, che mette in luce i legami tra il treno e l’espansione eco nomica e ideologica del capitalismo. In Caccia tragica, che del western ri calca la struttura dell’azione, il treno è ridotto da valore a funzione e ap pare non più come simbolo ma come veicolo dell’ideologia. La scena in cui i reduci tengono comizi ai contadini dal treno in corsa che traversa la campagna, lo mostra in questa sua funzione di mezzo di propaganda poli tica e di controinformazione, secondo la lezione della storia e del cinema sovietici. De Santis dunque è un autore neorealista. Uno dei possibili comuni denominatori dei registi neorealisti è nella loro volontà di mostrare la classe degli sfruttati, di svelare l’altra faccia della realtà italiana che il fascismo aveva censurato e rimosso dagli scher mi. Di questa volontà De Santis si era fatto interprete sulle pagine di « Cinema » a nome di tutto il nascente movimento, che peraltro fin da al lora appariva caratterizzato dall’incurabile abbinamento (tipico delle posi zioni borghesi di sinistra) della prassi politica con una morale idealistica. Scriveva in un famoso testo firmato insieme a Mario Alicata2: [...] anche noi più di tutti gli altri, vogliamo portare la macchina da presa per le strade, nei campi, nei porti, nelle fabbriche del nostro paese: anche noi siamo con vinti che un giorno creeremo il nostro film più bello seguendo il passo lento e stanco dell’operaio che toma alla sua casa, narrando l’essenziale poesia di una vita nuova e pura, che chiude in se stessa il segreto della sua aristocratica bellezza.
La peculiarità neorealista del suo cinema è nella costante e quasi esclusiva attenzione verso « il mondo degli umiliati e degli offesi », dal quale traggono materia i suoi film. Ma di questo mondo non sono né il tipico né il quotidiano ad interessarlo, sono all’opposto gli avvenimenti straordinari e le figure eccezionali che si elevano al di sopra della ero * naca. In Roma ore 11 la «cronaca» è tutta contenuta ed esaurita nei titoli di testa, che anticipano gli eventi e il loro sviluppo. Centro privile 1 In « La rivista del cinema italiano », n. 1-2, gennaio-febbraio 1933. 2 Ancora di Verga e del cinema italiano, in «Cinema», prima serie, n. 130, novembre 1941, pagg. 314-315.
310
Il neorealismo cinematografico italiano
giato del film non è l’inchiesta sociologica (risolta in senso spettacolare con l’introduzione della Radio) o il pedinamento dei personaggi come vor rebbe il progetto zavattiniano, ma il momento sensazionale del crollo della scala, che appare dilatato nel tempo come fosse filmato al rallentatore. Né De Santis vuole, come Visconti, ricondurre la materia popolare (per definizione « bassa ») all’altezza della tradizione decadente della cultura europea. Non è soltanto l’oggetto delle sue opere che egli vuole popolare, ma anche il livello della fruizione. Per questo i suoi film si iscrivono nelle forme romanzesche dei generi di consumo: Caccia tragica è un film d’azione, Riso amaro un melodramma. E neanche ha la vocazione dello storico e dello scienziato, come Rossellini. La sua pratica antropologica si limita alla formazione di un repertorio di miti e di mitologie raccolte nella tra dizione della cultura contadina o elaborate a partire da essa, cosa evidente nel processo costruttivo di Non c’è pace tra gli ulivi. Il mondo contadino è la materia dei suoi primi film (della trilogia: Caccia tragica, Riso amaro, Non c’è pace tra gli ulivi). Egli lo restituisce nelle forme e nei modi di un’ampia epopea, dove la vicenda e i conflitti sociali sono ridotti a uno schema essenziale, i costumi e gli usi tradizionali fungono da convenzioni della psicologia e del comportamento e gli ele menti « naturali » del paesaggio si fanno simboli; la terra che di film in film diviene zolla, fango, roccia. I personaggi di pastori o di mondine sono gli eroi di un universo reso astratto e formalizzato dalla messa in scena, mossi dai temi generali dell’inconscio collettivo quali il possesso, la soli darietà, la vendetta, la passione, l’eros, la superstizione ecc. (temi le cui connessioni apparirebbero esplicite ad una lettura psicanalitica che qui non possiamo fare). Il progetto di De Santis è di sintetizzare in una forma mitica le vicende di una realtà divenuta troppo complessa per la tradizione orale della cultura contadina — vicende che si chiamano economia capi talista, tecnologia, lotta di classe — e di comunicare con il mezzo del cinema una nuova mitologia, una mitologia popolare e socialista. Non c’è pace tra gli ulivi è una leggenda incidentalmente accaduta, che è data dall’autore come vera ma che egli narra come una novella. Il protagonista di Storia immortale di Orson Welles tenta di uccidere un mito trasferendolo dalla tradizione orale al piano dell’accadimento. De Santis procede nella direzione opposta: fa rivivere una storia mortale (cioè già accaduta) e le dona una vita immortale. Dopo « la voce del padrone » (la voce off del regista che apre e presenta il film) appare la scena: una scena naturalista dove la natura è possente, la società è arcaica e gelosa, la vicenda è una storia drammatica e violenta di sesso e di possesso, l’intrecccio è semplice e carico di insegnamenti morali come quello di una pa rabola. Ma dietro l’apparenza (la finzione naturalista) scorgiamo una strut tura architettonica di tipo classico che racchiude tutto il senso tragico del film. La storia è proiettata in una atemporalità popolata di semidei e di
Ideologie e stili del neorealismo
311
demoni che vivono passioni primitive e compiono riti pagani e pratiche magiche. I personaggi si muovono come su un palcoscenico tragico, la loro gestualità è ieratica e statuaria. Non sono che puri simboli. Le loro azioni sono il dipanarsi di un destino che appare inevitabilmente segnato: lo stupro che la sorella del protagonista (Maria Francia) subisce all’inizio del film dal personaggio di Folco Lulli preannuncia il successivo coito mortale del finale. Ma in realtà il destino non è sempre marcato dallo stesso segno, anzi accade che si ribalti completamente. Se all’inizio esso appare determinato da una fatalità ineluttabile, nella conclusione sembra invece nascere dalla volontà del popolo che si identifica in quella dell’au tore. Come nella tragedia greca, la giustizia è il tema centrale: dalla giu stizia individuale imposta dalla necessità della tradizione (« non è ladro chi si riprende ciò che gli è stato rubato ») a quella sancita dalla legge dello stato (che è asservita agli interessi dei ricchi) fino a quella espressa dalla collettività e dalla sua lotta (che è buona e trionfatrice). La prima parte del film rappresenta in forma semplificata la logica spietata di un mondo dominato da un potere ingiusto e predatore: il conflitto tra Raf Vallone e Folco Lulli è la rappresentazione della lotta delle classi o meglio il suo riflesso in seno al popolo dal momento che la classe al potere non è mai mostrata. Essa è presente sulla scena solo attraverso i suoi rappresen tanti delegati, i carabinieri c la magistratura. È possibile dunque identi ficare il potere assente con il deus ex machina della narrazione che deter mina l’arresto e la condanna di Raf Vallone. Ma è la volontà dell’autore che nella seconda parte inverte il corso di questo destino con un atto di fiducia nella solidarietà degli uomini. Non c'è pace tra gli ulivi, film wagneriano, vive all’interno di un uni verso schermico che si contrappone frontalmente al mondo (al pubblico, alla società) e propone la mitologia di un altro mondo, del mondo nuovo che il comunista De Santis auspica. Pur partendo da un racconto accaduto, si rivela alla fine come un film utopico che propone un modello utopico. Riso amaro, invece, analizza il « negativo » del mondo contemporaneo *: in esso miti e realtà si fondono e si confondono, sovrapponendosi le une agli altri e generando nuovi miti; è il riflesso del caos semiologico su una scena in continua mutazione. Film espanso, Riso amaro intrattiene un rap porto diretto con il contesto (con il pubblico, con la società): non soltanto inserisce nel proprio tessuto la mitologia hollywoodiana dell’epoca (con J « Perché il tema centrale di Riso Amaro è questo: la denuncia della corru zione che, con mezzi apparentemente innocenti, una certa ideologia americana ha diffuso in Europa Occidentale; tale ideologia è riuscita a diffondere i suoi veleni anche tra gli strati più sani del popolo, specialmente in mezzo alla gioventù, cui essa si è presentata con l’amabile volto del boogie-woogie, del chewing-gum e del facile lusso. È stato, ed è certamente un oppio per la parte meno cosciente della gioventù che, dopo le distruzioni materiali e morali della guerra, s’accanisce a voler vivere disperatamente ». Giuseppe De Santis in Confessioni di un regista, op. cit.
312
Il neorealismo cinematografico italiano
i suoi modelli comportamentali, le sue tipizzazioni, i suoi ritmi) ma crea esso stesso nuovi divi e nuovi modelli da imporre alla fruizione: attra verso il personaggio di Silvana Mangano, fa delle mondine vercellesi le nuove star del pubblico italiano e internazionale. Con il successo di questo film il neorealismo può a buon diritto iscri versi nella mitologia dello spettacolo come genere di consumo. De Santis non fa la propaganda di una ideologia: la strategia di Riso amaro fa del pubblico il contenuto stesso dell’opera, realizzando l’identità fra la mito logia del pubblico (la mitologia dell’industria cinematografica, lo star system) e la mitologia del suo film (la mitologia populista, la mitologia comunista). Il risultato finale è la produzione e la messa in scena di un nuovo pubblico, il neopubblico del neorealismo. (Si può osservare che sempre l’industria dello spettacolo esibisce il pubblico nei propri prodotti: lo spettatore si aliena nello spettacolo; è a partire da questa constatazione che Hitchcock costruisce le sue opere e perviene a quella che egli chiama «una vera e propria regia degli spettatori». Riso amaro non mette in corto-circuito l’industria culturale, piuttosto im mette nel circuito dell’industria nuovi spettatori, spettatori neorealisti). Ciò che prima di tutto colpisce in Riso amaro è la presenza appari scente dei modelli di vari generi cinematografici. La forma complessiva che abbraccia tutta l’opera è il melò (il melodramma fiammeggiante alla King Vidor ambientato nella patria di Giuseppe Verdi). All’interno di questa più vasta categoria si iscrivono le altre referenze: al film di gangster per quanto riguarda l’intreccio e il personaggio di Walter (Vittorio Gassman), al musical per i balli di Silvana (Silvana Mangano) e i canti delle mon dine; e poi, più in dettaglio, le citazioni di Renoir, di Eisenstein, di Vidor, o di situazioni canoniche e di luoghi privilegiati della scena cinematografica (la fuga, il treno, il travestimento, la rissa, la festa, il tradimento). L’universo di Riso amaro è un universo cinematografico, il suo spa zio è definito dal cinema e dai film prima ancora che dai confini dell’am biente contadino delle risaie vercellesi. Il mondo contadino si iscrive nel l’universo cinematografico e su di esso si modella, la realtà adegua le pro prie regole e convenzioni alle regole e convenzioni del cinema: i canti delle mondine sono prima di tutto una convenzione del film musicale, poi una forma espressiva della tradizione popolare. Questo non significa che il film tradisca la « realtà » cui si riferisce. Semplicemente la rappresenta de-formandola ovvero connotandola con i mezzi e le forme del cinema. Mo strare le risaie dall’alto di un movimento panoramico di gru, salendo dal dettaglio di un getto d’acqua al totale di un ampio specchio lacustre, piatto e lucido, tagliato dai segni degli argini, vuol dire che questo luogo è so prattutto il luogo di una rappresentazione, la scena di un film, uno spazio del cinema. E quest’idea si conferma e si rafforza quando le mondine cominciano a cantare in coro per esprimere l’immagine di un conflitto rela
Ideologie e stili del neorealismo
313
tivo all’azione4. Allora siamo certi di trovarci davanti ad uù palcosce nico dove si sta rappresentando una commedia o un dramma musicale: i movimenti di macchina e il ritmo del montaggio sostituiscono i movi menti e il ritmo di una danza che le mondine non possono danzare per ché i loro piedi sono immersi nel fango della risaia. Ma è un ben strano musical quello cui stiamo assistendo. Dei musical che siamo abituati a vedere conserva soltanto Videa. Non le apparenze. Il motivo che ascoltiamo non è orchestrato e arrangiato all’ultima moda, è un motivo tradizionale cantato dalle voci delle mondine. L’azione non si è interrotta per essere prolungata nelle canzoni e nella danza, come av viene nei film hollywoodiani del genere: le mondine non si distraggono dalla loro fatica, il conflitto si sviluppa nelle parole del canto che accom pagna il lavoro. La verosimiglianza e la continuità naturalistica sono con servate. La scena mantiene tutto il suo sapore realistico. Forse non è un musical, ma il film neorealista che ci aspettavamo. Infatti dopo un po’ scoppia una rissa. Il canto cessa. La coreografia dei corpi riflessi nell’acqua e dei gesti cadenzati di lavoro si spezza. Le donne si accapigliano nel fango, scomposte e sporche. Una di loro è indicata come colpevole, tutte si gettano al suo inseguimento. Sembra quasi che la vogliano linciare. È il western. Colpo di scena. Veramente sorprendente. Lungo la strada arrivano correndo e ondeggiando delle grandi sagome di cartone. È un altro teatro, un’altra rappresentazione, un’altra compagnia: i soldati che mettono in scena la guerra. Il loro comandante è giusto e saggio, un eroe positivo. Interviene a mettere pace. Il realismo socialista salva la situazione. Scriveva De Santis nel 1947: La mia posizione sul realismo implica una trasfigurazione della realtà. L’arte non è la riproduzione di semplici documenti. Accontentandoci di piazzare la macchina nella strada o fra veri muri non si può pervenire che a un realismo del tutto este riore. Secondo me il realismo non esclude affatto una finzione, né tutti i mezzi clas sicamente cinematografici.
Lontano, dunque, dal ricercare un « realismo esteriore », De Santis gioca continuamente con gli elementi della finzione e con i mezzi tecnolo gici del cinema. La riproduzione del reale è un documento, il cinema nasce dalla trasformazione del documento. Riso amaro ci appare come un siste ma di segni e di codici articolati tra loro. Ogni « documento » ha assunto la sua connotazione precisa. La vita delle mondine è essa stessa ridotta a segno, a cultura, regolata com’è dalle leggi della vita comunitaria, dai ritmi e dai tempi del lavoro, dalle convenzioni e dai costumi tradizionali: la ri saia è un microcosmo sociale. E in cultura appaiono trasformati gli elementi 4 « Non si parla sul lavoro. Se hai qualcosa da dire, dilla cantando. Si usa così », spiega una mondina alla giovane compagna ignara dei costumi della risaia. La convenzione imposta dalla tradizione è assunta nel film come modo della rappre sentazione.
314
Il neorealismo cinematografico italiano
« naturali »: i campi si ridispongono davanti alla macchina da presa per divenire paesaggio scenografico, scene dell’azione. L’ambiente, il décor, i costumi non « colti dal vivo » ma rielaborati in funzione espressiva: tal volta assumono la qualità di un simbolo, come le calze nere di Silvana o la cascina che funge prima da caserma per i militari e poi da dormitorio per le mondariso. Ed è proprio un oggetto simbolico di derivazione favo listica, la collana rubata, che dà l’avvio alla sequenza degli avvenimenti e passando di mano in mano percorre tutto il racconto provocandone la tra gica conclusione. Situazione ricorrente e « tipica » dei film neorealisti è la morte come suicidio. Dal tentato suicidio di Umberto D a quelli di Antonioni, fino al salto nel vuoto di Germania anno zero e di Europa .51, di Riso amaro e di Non c'è pace tra gli ulivi. Nei film di De Santis, come in quelli di Ros sellini, la morte appare sempre come caduta, morte per caduta, caduta mortale. L’immagine conclusiva mostra la caduta fuori dalla scena, l’uscita di scena finale: Silvana Mangano precipita dall’alto dell’impalcatura di una macchina teatrale e il suo suicidio segna il termine dello spettacolo. Questa immagine, che nell’economia morale della narrazione è la rap presentazione esplicita di un gesto diabolico, di una caduta agli inferi, è posta al centro di Roma ore II. La città compare per la prima volta, dopo la trilogia contadina, nell’opera di De Santis: essa è la scena del crollo, la scena distrutta dove i valori e lo spazio della collettività sono sostituiti dai frammenti di vita di una folla solitaria. La dialettica campagna-cit tà si risolve in una opposizione schematica (bene-male). Nella collettività contadina il male può essere vinto ed estirpato ovvero espulso dal corpo sociale, nella città il male identificato con il potere responsabile della cata strofe — quel potere invisibile che appunto qui ha la sua sede — opprime direttamente la scena e la distrugge. Contro di esso la solidarietà è ormai impossibile, irrappresentabile, perché la città è il luogo maledetto della frammentazione e della detribalizzazione. In questo senso Roma ore li è l’opposto di Roma città aperta. La città dunque è un’immagine dell’in ferno: al suo centro è collocata la rappresentazione simbolica della pro pria distruzione e morte; il crollo della scala è il suicidio della città. La presenza della città pone direttamente in primo piano il tema della cultura di massa, dei suoi mezzi e messaggi: dalla partitura musicale per macchina da scrivere e orchestra che accompagna i documenti giornalistici e le fotografie di Roma sui quali scorrono i titoli di testa, fino alle inter viste radiofoniche ed alla loro trasmissione. Il film nasce da una cronaca giornalistica come la cultura di massa nasce dal giornale. E del giornale, della città, della cultura di massa — termini che appaiono a De Santis omologhi e contigui — il film riproduce la struttura frammentaria e cellulare e gli argomenti « quotidiani » e antieroici, spezzando la linearità della narrazione e moltiplicando la storia in tante banali vicende indivi
Ideologie e stili del neorealismo
315
duali. Anche De Santis come molti cineasti intellettuali apocalittici (non escluso il Rossellini « tedesco ») nutre oltre l’amore proclamato per le masse minacciate dalla catastrofe anche un amore segreto per la catastrofe — solo la sua fiducia nel mondo contadino gli ha permesso di allontanare continuamente l’evento finché l’incontro con la città lo provoca. Roma ore 11 è la cronaca della catastrofe e la rappresentazione dell’apocalisse della cultura di massa. Per la prima volta nella sua opera la dialettica fra cultura popolare e cultura tecnologica si interrompe radicalizzando il giudizio dal suo statuto ambiguo in un severo moralismo. Roma ore 11 è un film senza pubblico, ha davanti a sé solo una folla indifferenziata e muta. Sembra dunque che ogni film di De Santis dia di volta in volta una diversa immagine del mondo e soprattutto dei suoi rapporti con il mondo (cioè del suo modo di porsi in relazione con il pubblico e con la società): dal film politico al film espanso, dal film wagneriano al film apocalittico. Congiuntamente, è il rapporto con il medium (cinema) che è di continuo messo in questione. Il cinema non è rappresentato direttamente ma con l’inserzione di altri media all’interno del film. In particolare assume signi ficato la presenza ricorrente della radio, medium caldo e coinvolgente, emotivo, subliminale, come il cinema profondamente legato al remoto pas sato tribale dell’umanità ma anche al più recente passato fascista di culture ad un basso livello di alfabetizzazione s. Da Caccia tragica a Roma ore 11 essa percorre il cinema di De Santis, e vi appare come simbolo della tecnologia dell’informazione, in opposi zione dicotomica del teatro, mezzo della rappresentazione classica. Ma essa subisce varie trasformazioni. Nel primo film più che la radio sono i microfoni e gli altoparlanti (quelli che nei cinegiornali fascisti vediamo ancora dislocati nelle piazze d’Italia per trasmettere i discorsi di Mussolini) a cambiare di segno, a divenire mezzi di un nuovo messaggio (il comizio fuori campo nella scena delle biciclette), mentre la radio come tale — che è presente nella scena dei fascisti nel casolare — continua imperterrita a trasmettere i suoi caldi messaggi di .massa e di memoria collettiva: dopo aver trasmesso Lili Marlene la voce commenta: « la guerra è ormai lon tana, ma le sue canzoni, ci riportano a quell’epoca, ecco la guerra! », e segue un inno americano, e poi una canzone partigiana. C’è nel film la con trapposizione fra l’uso moderno e « politico » della radio « in diretta » (megafoni e altoparlanti) e un uso tradizionale e «reazionario» (revo cazione mnemonica). Come l’Orson Welles di L'orgoglio degli Amberson si identifica nella voce off narrante e nel finale si rappresenta nell’immagine di un microfono, così il De Santis « neorealista » si traveste nei panni del 5 Cfr. Marhall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, 1967 («Radio. Il tamburo tribale», cap. XXX, pag. 316).
316
Il neorealismo cinematografico italiano
radiocronista all’inizio di Riso amaro. Ma è un avvertimento per il pub blico, l'introduzione a un racconto che, partendo da una informazione socio logica la sviluppa come « messa in scena » della realtà e con una morte teatrale. Se in Now c'è pace tra gli ulivi lo speaker è sostituito dalla voce fuori campo dell’autore che interviene in prima persona, ciò non fa che confermare l’identità tra De Santis e la radio, tra l’autore e la voce, affer mando l’identità del Narratore. In queso caso la radio, assente, rappre senta il modello e il principio dell’affabulazione e della costruzione narra tiva. Nella orale cultura contadina « in principio era il verbo », e il narratore-Dio. Quale migliore oggetto-simbolo che la radio per esprimere l’idea di una cultura orale che si sta tecnologizzando (la radio è la parola tecnologica). Nella civiltà massificata di Roma ore 11 anche la protesta di un piccolo impiegato (Paolo Stoppa, che dichiara agli intervistatori della RAI: «si dovrebbe aumentare lo stipendio agli impiegati») viene cen surata, tagliata nel momento in cui l’intervista-vcrità va in onda. La radio è di nuovo uno strumento del potere. Il sistema dell’industria culturale pone una serie di condizionamenti reciproci tra cultura di massa e cultura popolare, tali che anche la nozione di cultura « tout court » ne viene coinvolta. Gli unici autori neorealisti che sembrano rendersi conto che una nuova nozione e una nuova pratica di cultura si va affermando, segnata da una parte dall’evoluzione dell’arte in spettacolo e del pubblico in mercato e dall’altra dall’introduzione di tecniche della comunicazione più moderne e veloci (la presenza sorgente dell’informazione elettrica e globale della televisione), sono De Santis e Rossellini. De Santis affronta direttamente la contraddizione introducendo i modelli del passato nel nuovo contesto e facendoli reagire fra di loro: gli clementi caldi di un paese riscaldato dal fascismo e reso incandescente dalla guerra sono portati al massimo della loro intensità, secondo la logica di un cinema di intervento politico diretto e immediato sulla realtà nazio nale. Rossellini coglie invece i primi segni di un raffreddamento della si tuazione («la guerra fredda »), e rifiutando le esigenze del pubblico e del mercato6 e l’ideologia della comunicazione universale propone l’idea di un cinema saggistico e antispettacolare e analizza il contesto dal punto di vista di un filosofo della storia. 6 Cfr. Colloquio sul neorealismo, intervista a cura di Mario Verdone, in « Bian co e Nero», n. 2, 1952: «Non posso credere al film di "trattenimento" quale è in teso presso certi ambienti industriali, anche extraeuropei, se non come ad un film parzialmente capace di raggiungere la verità. Oggetto vivo del film realistico è il "mondo", non la storia, non il racconto. Esso non ha tesi precostituite perché na scono da sé. Non ama il superfluo e lo spettacolare, che anzi rifiuta; ma va al sodo. Rifiuta i lenocini e le formule, cerca i motivi che sono dentro ognuno di noi. È, in breve, il film che pone e si pone dei problemi. Scriveva un giornale americano attaccando il mio Miracolo: "siccome il cinema è trattenimento (entertainment) non deve porre dà problemi”. Ecco invece che cosa è per noi il film realistico: il film che vuol fare ragionare».
Ideologie e stili del neorealismo
317
II cinema di De Santis è un test sociologico che coglie i sintomi macro scopici ed esibisce i simboli evidenti della situazione storica che gli è con temporanea; quello di Rossellini è un testo storico che sintetizzando pre sente e passato preannuncia il futuro. Questa è una lettura di De Santis tra virgolette, un’altra se ne do vrebbe fare analizzando testualmente i film e ponendo in primo piano gli elementi erotico-sessuali, con tutti i loro prolungamenti psicanalitici. Ma questa è un’altra storia.
RENATO CASTELLANI IN PERIODO NEOREALISTA di Gianni Menon
Per situare e quindi tentare di comprendere un autore cinemato grafico abbastanza lontano da noi non soltanto nel tempo è indispensa bile — mi pare — che vengano prima chiarite (o quantomeno, come fac cio io ora, segnalate) due questioni preliminari. Chiarite in termini anche minimi, capillari; sono cose che, tra l’altro, esigerebbero delle vere e pro prie indagini di quartiere, del resto per altri problemi già tentate. E sono: la situazione della legislazione e dell’organizzazione cinematografiche (pro duzione ma soprattutto distribuzione), e dei modi del loro funzionamento « allora » (in questo caso fra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50); la questione del pubblico. Non è facile né tutto sommato deve sembrare, ai più, interessante. È la nota questione dell’impostazione dei modi della nostra critica, che ha origini assai lontane nel tempo, origini per cui sia mo quasi del tutto immuni da tentazioni di questo genere. Pensate che ignoriamo persino pubblico e regole del melodramma ottocentesco, ge nere fondamentale per capire che cosa rappresenti lo spettacolo di fin zione in Italia. Come e per chi scrivevano Rossini o Verdi, non si sa. E quindi si fa fatica a capire. Problemi tutt’altro che facili da approfondire, pare. Prova ne sia il fatto che indagini di questo tipo sono state così poco tentate, e per una ragione o per l’altra gli scarsi risultati ottenuti hanno avuto poca pubblicazione e limitata circolazione. Non interessano eccessi vamente; potrebbero complicare le cose, disturbare la comodità delle idee acquisite. Io spero che da questo convegno possa essere confermata una necessità talmente primaria, indispensabile per avviare una riforma della pubblicistica cinematografica attuale italiana, come si sa assai carente. Co munque mi pare certo che, senza questi presupposti, a fare critica si ri cada inevitabilmente nel « gusto », per raffinato che possa essere. E in una sorta di evocazione, almeno in casi come questi. Limite a cui certamente non sfuggirà nemmeno questa mia informa zione su Castellani in periodo neorealista. Preferisco parlare senz’altro di periodo neorealista piuttosto che di neorealismo tout-court\ mi pare più pertinente. Infatti non sono per niente sicuro che il neorealismo, al ci
Ideologie e stili del neorealismo
319
nema, sia esistito. La fìtta visione e revisione di film che questa rassegna prevede me Io sta confermando giorno per giorno. Ecco, questi sono i problemi più importanti, e largamente irrisolti; oltre a un altro paio che accennerò in conclusione. Ma questi sono preli minari ad ogni altro discorso su opere e autori. Ora, Castellani in questo periodo è autore di tre film: Sotto il sole di Roma (1948), È primavera! (1949), Due soldi di speranza (1951). Prima c’erano stati: Un colpo di pistola (1941) da Puskin, il film del debutto nella regia; Zazà (1942), tratto per la Isa Miranda da un soggetto che ispirò pure Leoncavallo (Isa Miranda che nella stessa parte a Hollywood pochi anni prima era stata rifiutata da Lewin e da Zukor, ma non da Cukor, e sostituita con Claudette Colbert); lo sconosciuto almeno per me La donna della montagna (1941), di cui è stato scritto che lì andava cercata « la chia ve della vera personalità di Castellani », tratto comunque da un romanzo di Salvator Gotta; Mio figlio professore (1946) con Aldo Fabrizi. Dopo verranno: Giulietta e Romeo ( 1954), Leone d’oro « scanda loso » a un Festival, dove se non ricordo male, c’erano Senso, La strada, Fronte del porto, L’intendente Sansho; nel *57 I sogni nel cassetto, che ricordo invece benissimo come fece addirittura delirare Marotta sulle co lonne de «L’Europeo»; Nella città l’inferno (1958); Il brigante (1961), che fece subito parlare di « ritorno » al neorealismo, ma sarebbe anche bene fare un po’ il conto dei vari « ritorni » e di quando si sono verificati (per cominciare Achtung banditi!, nel ’51, è già un ritorno «alla tematica prima del neorealismo, la Resistenza »; sono salutati come ritorni, sta volta un po’ del figlio! prodigo, Il generale della Rovere e Era notte a Roma; è un ritorno Rocco dopo la pretesa « parentesi decadente » de Le notti bianche; è un ritorno II tetto, naturalmente; così come sono ri torni tutti i film più o meno resistenziali a cavallo degli anni ’60; secondo me, ora stiamo proprio rientrando in una fase di altri e nuovi ritorni); infine Mare matto (1967) e via via varie cose minori fino alle recenti im prese televisive di alto costo. Perché è chiaro che in TV Castellani è ritenuto maestro e dà garanzia di sicurezza sotto molti aspetti. Ora, dovendo occuparsi, a più di vent’anni di distanza, di tre film di un autore privo di una recente presenza attiva nel cinema di oggi che abbia qualche importanza, che cosa si fa? Si raccolgono i ricordi personali (visivi e non, e comunque lontani nel tempo e nella giovane età); si va a leggere il poco (in questo caso) materiale critico esistente, tanto per farsi una idea; si vedono e/o rive dono i film, possibilmente in moviola. Dalla prima operazione alla memoria risulta che Castellani è stato quasi o forse senza quasi un protagonista, con toni talvolta di provo cazione e di scandalo, e che comunque l’uscita dei suoi film veniva seguita con attenzione e rispetto almeno fino a II brigante, che è del *61; dalla
320
Il neorealismo cinematografico italiano
seconda operazione si ricava ben poco che non sia l’ennesima conferma di un nostro (mio) atteggiamento invincibilmente diverso da quello della critica che ci ha preceduti, e questo anche là dove siano singolarmente possibili delle convergenze di gusto e di misura. Dalla terza si apprende finalmente qualcosa, ed è l’unica traccia da seguire. Con i limiti che di * cevo in apertura. E li spiego meglio: come posso io fissare con decente approssima zione i termini di un possibile giudizio su un autore come Castellani se non ho le pezze d’appoggio rappresentate dai risultati di quell’indagine di cui dicevo? Cioè « come » faceva cinema Castellani? Come lo si faceva al lora, e perché? con quali agevolazioni, con quali crediti? per quale mer cato? in quale situazione nazionale e internazionale (perché almeno da Due soldi di speranza, Palma d’oro sia pure ex-aequo a Cannes, la ribalta è internazionale)? E tutto ciò senza troppe approssimazioni, ma con suffi ciente esattezza? E soprattutto, per quale pubblico lo faceva? aldilà dei miti, chi era lo spettatore-cittadino dell’Italia del dopoguerra e della co sidetta ricostruzione? Si tratta di un accertamento del mercato e del gusto ancora da fare; e il tema, lo sottolineo volentieri, mi sembra molto im portante per arrivare, quando sarà possibile, a una storia del cinema ita liano che non sia provvisoria. Insomma io voglio sapere perché da bam bino mia madre mi portava ogni giorno al « cinema » (questo cinema, e quello americano) e non, per esempio, a teatro. Tenendo presenti i tre film in questione mi pare che i primi problemi da affrontare siano appunto « prima » (prima dei film). E sono: 1. la « cultura » cinematografica di Castellani, per cui si potè addi rittura scrivere di « ossessione sternberghiana » e per cui Castellani passò sempre per un gran raffinato; a me pare che il tipo di ossessioni di Ca stellani sia stato molto più modesto: aldilà di certe raffinatezze nei primi film e dell’eleganza Marzotto di Giulietta e Romeo, forse l’unica chiave potrebbe essere quella Isa Miranda recuperata da Hollywood dove era stata rifiutata dopo esservi stata convocata nientemeno che per rinvendire il mito Marlene; ma, come si sa, Marlene il proprio mito sa benissimo tenerlo verde da sé; 2. i rapporti con Camerini e Blasetti, oltreché con il proprio cinema precedente: cioè il rapporto con cineasti che rappresentavano il più so lido mestiere in anni fascisti; 3. la realtà effettiva di quella fronda calligrafica che troverebbe in Castellani Soldati Lattuada i propri esponenti e in De Sanctis, fin dal ’42, lo scatenato critico in nome del « risveglio delle coscienze a un indirizzo realistico »; ma poi da un lato Lattuada giovane è redattore di « Cor rente » a Milano e appena può fa film « impegnati » mentre Soldati gira
Ideologie e stili del neorealismo
321
diecine e diecine di film sempre ostentando il suo disprezzo per il mezzo rispetto alla letteratura. Tutto ciò riconduce a un’altra indagine fondamentale, quello sui rapporti fra cultura neorealistica e cultura in periodo fascista; se non al tro perché fatta spesso dagli stessi uomini (ma dell’altro ovviamente c’è). O almeno su quella parte della cultura che in.periodo fascista si oppo neva o solo prendeva le distanze dalle direttive del regime, sia pure lavo rando all’interno delle strutture e dei canali che il regime consentiva o tollerava. In questo senso nomi e posizioni di uomini, di libri, di riviste non mancano. Scrive, mi pare benissimo, Romano Luperini in apertura del suo sag gio su Gli intellettuali di sinistra e la ideologia della ricostruzione nel do poguerra che una simile indagine deve muovere dall’anteguerra, dallo studio degli atteggiamenti culturali degli scrit tori « fascisti di sinistra » dopo il ’30 e in particolare del populismo die « sub specie» neorealistica, continuerà sino alla soglia degli anni Sessanta.
E sottolinea che c’è la necessità di allargare il discorso, anzi di fondarlo.
Bene, io credo che se da questo convegno uscisse anche soltanto l’evi denza della necessità di una « fondazione » di questo genere per quanto attiene le vicende del cinema italiano, sarebbe già un risultato importante. Bisogna vedere se i tempi sono ormai maturi perché prevalga la volontà politica di procedere in maniera meno schematica e rozza o solo strumen tale di quanto non sia avvenuto in passato. Parliamo un po’, ora, dei tre film; più che altro per ricordarceli as sieme. È con Sotto il sole di Roma che l’ex calligrafo ed ex intimista si inserisce nella corrente neorealistica, nel 1948. E lo fa senza dimenticare né intimismo né calligrafia. Ci sono dei carrelli incredibili in terreni loro estranei: appare cioè evidente che Castellani si porta dietro in un terreno che non è il loro dei movimenti di macchina e delle angolazioni che ap partengono più ad Assia Noris che a Liliana Mancini, la giovane prota gonista « non professionista » e presa dalla strada. Come appare evidente che Castellani apprendista neorealista non ignora affatto il Rossellini del primo dopoguerra e ancor meno il De Sica di Sciuscià. Ma lo fa in super ficie. Se si pensa che Ladri di biciclette è dello stesso anno e soprat tutto che Germania anno zero è addirittura dell’anno precedente, si ca pisce bene questa superficialità. Pure c’è qui una freschezza che altrove già non c’è più. E per chi ha dell’attaccamento e magari un po’ d’amore per il cinema italiano il film è da vedere assolutamente. È con una certa ten^re^ che scopriamo in Geppa, l’amico del protagonista, il volto di Francesco Molisano, l’attore che sarà poi Totò il buono in Miracolo a Milano; nella devota Iris quello
322
Il neorealismo cinematografico italiano
di Liliana Mancini, che darà poi nel ’51 una memorabile lezione sul cinema neorealistico e sugli attori « presi dalla vita » alla Magnani di Bellissima (ma queste sono comunque le smanie autolesionistiche di Zavattini, e Bellissima in particolare è un film di autopunizione); infine, in una mac chietta-tormentone (prima commesso di calzoleria, poi borsanerista, poi direttore di dancing) troviamo la grinta di Alberto Sordi. La storia si svolge a Roma, nel popolare quartiere di San Giovanni, tra il '43 e il ’45. È la storia di Ciro (la racconta fuori campo in prima persona: « questa non è una storia inventata, è la mia storia »), un ra gazzo di diciassette anni, e del suo farsi uomo. La madre casalinga, stanca di fatiche e di figli; il padre guardia not turna che rientra ogni mattina con la sua bicicletta e qualcosa da man giare per la famiglia, rimediato qua e là; i fratelli piccoli; Iris, la ragazzetta della porta accanto; alcuni amici che si chamano er Nerone, er Pirata, er Moretto, er Caccolone. Appena possono, loro ragazzi se ne vanno a fare il bagno a fiume, fra le canne, invano perseguitati da militi e carabinieri. Una notte passata fuori casa frutta a Ciro la devota amicizia di Cep pa, un ragazzo che dorme al Colosseo e campa raccogliendo cicche; Geppa cercherà di aiutarlo in tutte le difficoltà che Ciro incontra nel suo farsi uomo. Poi, piano piano, nasce l’amore con Iris, ma senza molto impegno da parte di Ciro. Che è giovane carino spensierato e se la vuole godere, la vita. Fra avventure comiche e meno comiche, la vicenda si snoda sul bi nario di questo doppio affetto di cui Ciro regolarmente approfitta, come se la vita gliele dovesse, queste cose. Gli muore la madre; e la morte, a Ciro arrivato troppo tardi, la narra Iris; e gliela narra, anche se la madre non ha fatto morte eroica, quasi come se fosse quella della Magnani in Roma città aperta. E l’amico Geppa, che piange fuori dai cancelli dell’ospedale, sembra una inquadratura di Sciuscià. D’ora in poi è Iris, ribelle paziente e lungimirante, a curare la casa, i ra gazzi, Ciro, il padre di Ciro. Ciro intanto va a ballare, ci sono gli ameri cani, ha per amante una donna sposata non più giovane, succedono altri incidenti tenuti fra il riso e la commozione. Poi, inevitabilmente, Ciro va a rubare. Partono in due per salvarlo, come sempre: Iris e Geppa momentaneamente alleati. Nello scontro a fuoco il padre di Ciro muore. Ciro allora « mette la testa a posto », eredita il posto di guardia not turna del padre, sposa Iris: Allora capii chi era stato mio padre, mio padre era stato quello che pagava per tutti. La gioventù senza pensieri era finita. Ora tocca a me pagare.
Un finale amaro e rassegnato per un film che, tutto sommato, esprime la gioia di vivere la quale, anche se scarsamente motivata, non è casuale.
Ideologie e stili del neorealismo
323
Solo che si osservino determinate componenti, sia oggettive che del l’autore. Innanzitutto il ’48, l’anno « ufficiale » del cosiddetto ripiegamento delle forze e speranze rivoluzionarie (comunque certo la partenza altret tanto ufficiale della ricostruzione e della sua ideologia). Poi: il « modo » adottato della memoria recente di una vita spensierata e felice già finita; l’assenza di fatti storici (in una Roma che in quegli anni viveva esperienze tremende) se non come sfondo, e solo accennato, degli avvenimenti del pic colo gruppo umano soltanto superficialmente contagiato dal costume e dalla storia (i fascisti, il bombardamento a San Lorenzo, l’occupazione na zista, la borsa nera, gli americani, l’arte di arrangiarsi); infine una curiosa patina di vagheggiamento omosessuale o quantomeno di misoginia, che tinge la vita un po’ di grigio. La « categoria » diciamo che è il Rimpianto. Misoginia peraltro di superficie. A fugarla basta il faccino assai sim patico di Liliana Mancini, che. fa un personaggio notevole di ragazza romana. Ma a confermarla c’è questo atteggiamento virilistico stavolta non fascista, anzi decisamente contrapposto al virilismo di marca fascista (ma perciò ne tiene conto, e quindi anche per questo populistico). Insomma se, dopo l’Italia atletica di massa del sogno mussoliniano, il popolo ha da entrare nel cinema, ha da entrarvi anche il fascismo degli stracci e dei calzoni corti su gambe troppo cresciute. Oh, con prudenza, naturalmente. Le donne comunque in questo film sono trattate molto male: la ma dre (« a’ papà, ma so’ tutte così? »), Tosca, la donna sposata (nome da « peccatrice »), che è una vera e propria caricatura di femmina mangiaragazzi e rovinafamiglie (identica alla padrona del cinemino napoletano in Due soldi di speranza, che addirittura se lo comprerà, il sangue giovane del protagonista); la stessa Iris per tutto il film mira a incastrare Ciro, ed è del tutto priva di fantasia; e per tutto il film Ciro la tratta male; tutte le scene d’amore sono inoltre recitate con forzature da fumetto (che restano forzature, almeno in questo film), tanto che alla fin fine la scena « d’amore » più « vera » è quella al Colosseo tra Ciro e il nuovo amico Geppa. Chissà se Bertolucci se n’è ricordato, nel finale de II conformista, lui che queste cose le ricorda tutte. Di fronte a queste donne-ostacoli viene sublimata la figura del ra gazzo adolescente cui tutto è concesso perché la vita assai presto lo spe gnerà.- Un quasi-pasolinismo ante litteram ma sui generis, rozzo, limitato. Nei film seguenti questa situazione base si ripeterà puntualmente. Con È primavera, l’anno seguente, siamo in piena commedia all’ita liana. Non si capisce perché Castellani sia stato accusato (o solo indicato) come il padre promotore del « neorealismo rosa », delle serie dei Pane amore e ... e dei Poveri ma belli. Lui si limita a continuare un filone molto preciso: pochissimi anni prima È primavera avrebbe avuto per inter preti Élsa Merlini, Nino Besozzi, Adriano Rimoldi, Lilia Silvi, Roberto Villa ecc.
324
Il neorealismo cinematografico italiano
Oggi invece c’è un ragazzo preso dalla strada, e due prossime attrici, Elena Varzi (futura signora Vallone) e Irene Genna (futura signora Nazzari). Tutto qui. Come prima e come dopo: cinque o sei anni dopo, Blasetti farà i film della coppia Loren-Mastroianni edizione prima. Ecco la storiella: un giovane fiorentino parte per il servizio militare e va a finire a Catania; un commilitone siciliano gli presenta la futura sposa; quando il siciliano viene trasferito il giovanotto si introduce in casa della futura sposa e finisce col sposarsela lui; ma anche lui viene trasferito, a Milano; troppo solo, finisce con lo sposare anche lì una ragazza; ter mina il servizio militare e la verità si scopre; il giovane viene accusato di bigamia ma viene assolto perché il primo matrimonio non era stato regi strato; però in fondo è la prima che lui ama, la siciliana, e poi aspetta un bambino; così ritorna da lei; l’ex commilitone si consolerà con la seconda, la milanesina. Si suppone che siano vissuti felici e contenti. E inoltre hanno certamente realizzato una discreta rimescolata di carte nella nuova unificazione nazionale (Nord, Centro, Sud). Per situare il film e il cinema cui appartiene basterà fare attenzione a due soli esempi, « spie » esemplari: l’uso del dialetto e l'uso della mu sica. L’uso del dialetto in funzione di conoscenza, anzi di riconoscimento nazionale, l’aveva inaugurato e chiuso Rossellini in Paisà (non, mi pare, Visconti, che con La terra trema compie un’operazione innanzitutto filo logica, sia per gusto innato che per sottolineare il « debito » culturale italiano nei confronti di Verga). Qui l'operazione, invece, è già diventata gusto del pittoresco e del verosimile, uso « volgare » del vernacolo, favo revole allo smercio del film in almeno tre mercati: il Lombardo Veneto, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie. E come sono visti gli abitanti di questi tre regni compresi nella nuova Repubblica Italiana? I toscani inguaribilmente caciaroni e furbastri; i siciliani appassionatamente stupidi, superstiziosi e violenti; in quanto ai milanesi, lavorano e basta. E il dialetto diventa inflessione, modo di dire, allusione: perché sennò il film diventa antipopolare, come appunto La terra trema. Di Milano, Firenze, Catania si vedono: il Duomo, Santa Maria del Fiore, i Giardini Bellini. Cartoline non ancora colorate. La musica (di Nino Rota): la canzone che dà il titolo al film e che si sente ininterrotta mente dall’inizio alla fine; una banda domenicale che suona la Lucia di Lammermoor di Donizetti; tema « drammatico » base il terzo atto del Rigoletto di Verdi. Il tutto cucito e arrangiato assieme in maniera tale che forse è meglio, per « carità di patria », che ci serva soltanto come segno indicatore (uno dei tanti) della profonda ignoranza musicale di noi ita liani (rimasta del resto immutata, da allora). E inoltre ci serve senz’altro a sottolineare una volta di più quanto Godard ha detto sui cineasti italiani: che devono ancora scoprire l’esistenza della colonna sonora. Due soldi di speranza, certo confezionato molto meglio del precedente,
Ideologie e fidi del neorealismo
325
non fa che confermare le cose dette finora. È il film più famoso di Castellani, e da più di vent’anni si va dicendo che è tin film importante perché segnerebbe l’inizio dell’involuzione e l’inaugurazione del neorealismo rosa diretto a una rapida degradazione. Per arrivare a una qualche sprovincializzazione bisogna infatti arrivare da un lato ai primi seri contatti di Pasolini con il cinema come sceneggia tore, dall’altro al riaffermarsi dello stesso filone, ma aggiornato agli anni del « boom »; l’esempio più rappresentativo è certo II sorpasso. Ma Due soldi di speranza, commedia né migliore né peggiore di tante altre prima e dopo, gode senz’altro fama immeritata: la sua pretesa impor tanza è probabilmente da attribuire alla necessità della critica più pigra di utilizzare facili punti di riferimento per operazioni mai problematiche di suddivisione ed etichettamento. Più che altro il film deve la sua fama a un successo intemazionale seguito al Gran Premio a Cannes: tanto quanto bastava per ricavarne la conferma della « bontà » di un filone produttivo. Per il resto il film non ha niente di nuovo; si inserisce tranquillamente sia nella carriera del suo autore che nel gigantesco filone del cinema di « in treccio » e di bozzetto che è sempre stato una vocazione del cinema ita liano, fascista o democratico che fosse. Vocazione mal servita, comunque, e dalla società che lo esprime e dall’industria che lo realizza, industria « di straccioni ». Pensate solo alla commedia hollywoodiana anni ’3O/’4O/’5O (poi basta). Il film fu concepito e girato secondo canoni rigorosamente « neorea listici »: storia di poveracci, ambiente povero al naturale, stracci e miseria e analfabetismo, attori non professionisti, dialetto (ma non troppo « stret to »). La storia pare sia stata « dettata » agli autori dallo stesso protago nista. È la storia di Antonio, un ragazzo di un paesino sulle pendici del Vesuvio (tranne le sequenze napoletane il film fu tutto girato a Boscotrecase), che torna a casa dopo aver fatto il servizio militare e non intende ingrossare le file dei disoccupati del paese che tutto il giorno « tengono su la cancellata della chiesa ». Pressato da una incredibile madre ladra di galline e conigli e da svariate sorelle da maritare, Antonio accetta di fare vari mestieri. Si improvvisa venditore di gazzose, di verdura. Fa l’« aiu tatore di carrozze », cioè spinge con i cavalli per far superare alle carroz zelle il punto più duro della salita che dalla ferrovia porta al paese. Tenta di fare l’autista della corriera di una cooperativa di ex-vetturini che fallisce sul nascere. Finisce aiutante del sagrestano. Intanto si è messa di mezzo Carmela, una ragazzina assai testarda, che si è innamorata di lui e lo vuole sposare. Pian piano anche Antonio si innamora. Ma Carmela è figlia dell’artificiere del paese, quello che pre para i razzi per le feste, e Antonio è povero e senza lavoro: la famiglia di lei si oppone. Antonio vuole mettere su casa. Così, per guadagnare, di giorno fa il
326
Il neorealismo cinematografico italiano
sagrestano e di notte l'attacchino per il pci a Napoli: a causa di Carmela la cosa si risà e il parroco lo caccia. Nuovi mestieri a Napoli, trasportatore di pizze cinematografiche e donatore di sangue. Questo è l’episodio più divertente del film. La pro * prietaria di tre cinerami di periferia (Gina Mascetti) per risparmiare dà nello stesso giorno lo stesso film in tutti e tre i cinema (si vede un incan tevole vecchio manifesto di Nozze infrante con Claudette Colbert e Ro bert Ryan): Antonio è incaricato di trasferire febbrilmente le pizze da un cinema all’altro durante gli intervalli, mentre gli spettatori tumultuano per il ritardo o perché il terzo tempo viene proiettato prima del secondo. Ma non basta: la signora ha anche un figlio piccolo, debole e malatic cio, che ha bisogno di continue trasfusioni di sangue. Anche a queste prov vede Antonio: così il nutrimento non gli manca, anche se è costretto a bere il vino rosso che non gli piace, perché « fa sangue ». Ovvio che la signora si prenda una cottarella per il robusto giova notto, ma il fatto che ormai il maschio desiderato e il figlio abbiano lo stesso sangue le impedisce di cedere alla tentazione e preferisce consi derare Antonio « un santo ». Quando però scopre l’esistenza di Carmela, scatta la gelosia, e non c’è né figlio né santità che tenga: bisogna vedere com’è brava la Mascetti in questa scena, quando scaccia il « traditore »: probabile che sia un contributo alla sceneggiatura di Titina De Filippo: è, anche se in tono minore, una delle « scene madri » a cui ci aveva abi tuati a teatro, e che Eduardo le confezionava su misura. Fatto sta che Antonio è di nuovo senza lavoro. Nemmeno una fuga dei due innamorati (fuga innocentissima, peraltro: il film è di una castità assoluta, e la scena più « audace » è ricalcata pari pari dal primo atto della Tosca) riesce a smuovere il padre di Carmela. Allora Antonio decide: si sposeranno, e vada come vada. Spoglia Carmela in piazza, davanti a tutti, per non aver niente dai parenti: al corredo, in un’impeto di generosità collettiva, provvedono i venditori ambulanti di quel giorno di mercato. Lui poi pagherà, naturalmente, lo considera un prestito. Il bozzetto è sfrenato, all’insegna di una poetica che sta fra « i po veri sono matti » e « i poveri sono belli » e, appunto, « due soldi di spe ranza », non si sa bene in chi e in che cosa. A meno che non abbia un significato preciso l’ultima inquadratura: una panoramica verticale dai protagonisti al campanile della chiesa: ma probabilmente vuol dire solo matrimonio, o senso della comunità: Castellani è un semplice, in queste cose. La cosa più bella del film è senz'altro Maria Fiore; la « bersaglierà » di Gina Lollobrigida ne sarà solo una brutta copia. In conclusione (provvisoria) e riassumendo, i motivi che mi pare siano da tener presenti, oltre a quelli mèssi in evidenza all'inizio, sono: 1. le ragioni, personali produttive sociali dell'ottimismo che di que sti film è comunque il centro;
Ideologie e stili del neorealismo
327
2. l’ostinato rifiuto nella Storia in un’epoca che nella storia ha *riac quistato fiducia; 3. i modi dell’uso del dialetto; 4. la figura centrale del ragazzetto; 5. quella che ho chiamato misoginia; 6. il « calligrafismo » sopravvissuto in ambiente diverso ed estraneo; 7. l’uso della musica; 8. il moralismo sessuale; 9. la concordanza con i canoni della commedia all’italiana. Inoltre la inesistenza pressoché totale in questi film di un nucleo fisso di collaboratori da un film all’altro. Infine i legami di un cinema come questo (e di molto cinema del periodo) con il fumetto, la « storia » e l’immagine del fumetto italiano del dopoguerra. Probabile che un’inda gine seria e priva di sufficienza sul fenomeno neorealista ci riconduca senza remissione ai testi e alle tavole di Walter Molino sulle prime annate di « Grand Hotel ». E all’opera lirica, quella verista. Da non confondere con la sublime astrazione del melodramma ottocentesco. Anzi sarebbe ora di cominciare a usare il termine « melodrammatico » con più pertinenza e maggior conoscenza di causa. Per finire, oltre a questi, suggerirei di tener presenti nella discussione due altri elementi: l’ansia, l’angoscia, il terrore del « popolare » nella cultura italiana (da Mastriani all’ultima Morante, quella de La Storia-, percorso molto più complesso di quanto si tenda, per tranquillità, a credere); la figura e le responsabilità dell’intellettuale di sinistra in Italia davanti a queste e altre cose. È evidente che a questo punto Castellani è un pretesto e non altro. Per me non è un caso che, contemporaneamente, Rossellini approfitti della situazione per girare un film su De Gasperi (ma non solo; nelle foto di scena, convenientemente truccati, appaiono Togliatti, lotti, Longo ecc.) e Straub, mentre gira il Mosè e Aronne di Schonberg, pensi a un film che riguarda Franco Fortini intellettuale italiano di sinistra di circa cin quantanni.
IL NEOREALISMO E IL CINEMA ITALIANO DEGLI ANNI TRENTA
NEOREALISMO E CINEMA ITALIANO DEGLI ANNI ’30 del GRUPPO CINEGRAMMA (FRANCESCO CASETTI,
Alberto Faras sino, Aldo Grasso
«
nostàlgia
e
Tatti Sanguineti)
»
Poiché non sembra che alcun tipo di regolarità ciclica o commemo rativa imponga nell’anno 1974 un convegno sul neorealismo (siamo in ritardo di un anno per celebrare il ventennale di quel Convegno di Parma che, sanzionando definitivamente l’esaurirsi del neorealismo, lo consegnava alla storia del cinema, e un anno in anticipo per commemorare il trenten nale di Roma città aperta), bisognerà anche chiedersi perché il neorealismo ritorni oggi, con tanta insistenza, a far parlare di sé o addirittura tenti di rinascere dalle sue ceneri. Perché, stiamo ben attenti, questo convegno pesarese non è né la riproposta di un vecchio gioco di famiglia (di che cosa dovrebbero parlare dei cineasti e critici italiani che si riuniscono a convegno se non di neorealismo?) né però, come ancora poteva sembrare quando l’iniziativa fu lanciata, un raffinato gesto snobistico. Questo con vegno si inserisce invece in un quadro di sintomi e indizi ormai abbastanza delineato per poter diagnosticare già la malattia. Quali sono questi sin tomi? Potremo cominciare col ricordare quell’albergo di Ultimo Tango a Parigi in cui, ma naturalmente la burocritica non se ne accorse, Berto lucci richiuse — per esorcizzare il ricordo o per farlo rivivere nel fanta sma? — i cadaveri neorealistici, da Massimo Girotti a Maria Michi. Po tremo registrare poi le notizie di questi ultimi tempi: Rossellini dopo tanti anni ritorna al cinema, e non solo: con un film su De Gasperi, e non solo: dal titolo Italia anno uno; Massimo Mida — come annuncia un gior nale — farà I due fratelli Puccini; ecc. E tanto per concludere con un macrosintomo riassuntivo, basterà infine accennare, solo per accennare, per carità, al romanzo della scrittrice dagli occhi dolci, vera epopea del neo realismo, dei suoi tempi, dei suoi temi, dei suoi eroi e dei suoi miti. Insomma, il revival neorealistico è ormai in pieno svolgimento, e il meccanismo funziona ormai con le regole -che guidano ogni recupero no stalgico, con variazioni temporali in fondo poco significative: che siano gli anni ’50 di Bogdanovich o gli anni ’60 di Dreyfuss o gli anni ’20 del grande Gatsby la malattia, una malattia dolce e insinuante, è sempre la
332
Il neorealismo cinematografico italiano
stessa: è quella cosa che in America si chiama, con un italianismo reso languidamente sdrucciolo, la « nostalgia ». Nella diffusione a livello mon diale delle mode nostalgiche anche la cultura di sinistra rischia di farsi coinvolgere: ritorna col ricordo ai propri anni d’oro, ripensa alla sua « belle époque », e in Italia incontra il neorealismo e gli anni che ne videro la fioritura. Quale oggetto più esemplare del resto? Perché no stalgia del neorealismo significa anche nostalgia della sinistra unita, del blocco storico, del PCI al governo, e per la gente di cinema, nostalgia del tempo in cui il cinema era in Italia la cultura e la avanguardia. È dunque facendo i conti con questa « nostàlgia » che il nostro te sto nasce; per cercare come minimo di liberarci dai suoi rischi parlere mo infatti del cinema neorealista insieme al cinema italiano degli anni ’30, insieme al cinema fascista. Con ciò non vogliamo solo rendere conto di una ricerca che è stata fatta o di un certo numero di film dell’epoca fa scista che abbiamo avuto modo di vedere non occasionalmente; è per evitare ogni approccio nostalgico e ogni tentazione revivalistica che ab biamo scelto di parlare del cinema italiano degli anni « d’oro » insieme al cinema di quegli anni per i quali non può esservi, in nessun modo camuf fata, nostalgia alcuna.
FRATTURA, CONTINUITÀ, CITAZIONE
Un discorso sui rapporti fra cinema neorealista e cinema italiano de gli anni ’30 incontra subito un tradizionale problema critico e storiogra fico che non per il fatto di essere mal posto può essere accantonato o dif ferito. Il problema, che può essere letto o intravisto in tutta la lette ratura sul neorealismo, si può schematizzare in questi termini: fra que sti due momenti, cronologicamente successivi, della storia del dnema ita liano vi è una netta frattura oppure esistono, più o meno mascherate e segrete, delle forme di prosecuzione e di continuità? E doè: il neoreali smo è qualcosa di radicalmente altro rispetto al cinema del decennio pre cedente, è l’apparizione improvvisa e fragorosa di una serie di caratte ri originali e inediti, è nato contrapponendosi violentemente, grazie allo sconvolgimento prodotto dalla guerra, al dnema del periodo fasdsta, op pure esso è la logica risultante di dò che in quel periodo era stato se minato, e sotto alcuni caratteri dichiarati frettolosamente rivoluzionari cela invece, e conserva tutto l’apparato di convenzioni, di formule, di codid del cinema degli anni ’30? Problema, si è detto, che emerge dai testi, concretamente esistenti sul neorealismo, anche se spesso non è possibile, e comunque non è in teressante farlo, elencare in due liste contrapposte i partigiani della frat tura e i fautori della continuità, far scontrare Lizzani con Ferrara, Grò-
Il neorealismo e il cinema italiano degfi anni trenta
333
mo con Chiarini ecc. Piuttosto si potrebbero individuare periodi di mag giore o minore fortuna dell’una o dell’altra ipotesi: dall’immediato do poguerra in cui interessava soprattutto sottolineare gli elementi di rottu ra e distacco fino — per fasi alterne — agli anni più recenti in cui risul tava facile ai dotati di qualche malizia semiologica leggere le molte com ponenti, assai poco neo e assai poco realistiche, di Roma città aperta o Ladri di biciclette. Naturalmente ognuna delle due ipotesi ha prodotto i suoi miti: da quello di un cinema « girato nelle strade » con il metteur en scène trasformato quasi in un giovanotto che fa del cinema militante con una vecchia Paillard a quello dei fili sottili ma saldissimi che leghereb bero i due periodi, fili costituiti da film segretamente anticipatori, e che risalgono ad anni sempre più lontani fino a sperdersi nel buio dei ricordi o degli equivoci. Miti che trovano anche una sintesi esemplare, perché frattura e continuità spesso vengono fatte coesistere, nel racconto che nar ra di un mediocre regista di pellicole di propaganda fascista che doveva girare un film dal titolo Rinuncia, ambientato allo scalo merci S. Lorenzo di Roma. Il bombardamento del quartiere, il 19-7-1943 l, interrompendone le riprese, instaura una rottura materiale nel film e nella carriera di quel cineasta, che, di lì a poco, sarebbe divenuto il regista della Resistenza, della lotta antifascista e anche del cinema d’autore. Ma non saranno i miti a salvare un’impostazione riduttiva ed erra ta del problema. Alla questione che ha diviso la critica e la storiografia neorealista non intendiamo aggiungere una nuova, anche se più motivata e più consapevole, risposta, che sigilli in uno slogan — continuità o frat tura — i risultati di un lavoro di ricerca. O meglio, non intendiamo rispon dere al problema che ci troviamo di fronte se non dopo averlo ricollo cato in un nuovo campo teorico. Già i pochi accenni che si son fatti consentono di individuare qual è il campo teorico in cui si situava lo pseudoproblema dei rapporti fra neorealismo e cinema italiano degli anni ’30: esso è quello che vede la storia delle pratiche simboliche come un universo di determinazioni e/o di affrancamento da esse: ed ecco le pro blematiche delle fonti, delle cause, delle anticipazioni e, altra faccia della stessa moneta, delle eccezioni, dei capolavori, delle irruzioni ecc. Di fronte a questo modello e a questa batteria di nozioni si vuole affermare risolutamente, prima di iniziare qualsiasi analisi, l’esigenza di costruire un campo teorico in cui il rapporto fra i testi e la storia passi non per vie deterministiche ma per percorsi citazionedi-. l’universo dei rap porti fra cinema neorealista e cinema degli anni ’30 costituisce per noi un campo di citazioni, e cioè di relazioni semiotiche. Il riferimento teorico più diretto è qui il concetto, proposto da Julia Kristeva, di intertestualità o, secondo una formulazione più recente, di trasposizione. Con esso si * Cfr. E. Morante, Lo Storia, Torino, Einaudi, 1974, pp. 168-172.
334
Il neorealismo cinematografico italiano
intende definire quell’interscambio fra sistemi di segni diversi che, for malizzato con strumenti retorici e semiotici, consente di definire, esso solo in maniera corretta, i fenomeni di relazione fra due diversi testi o sistemi testuali quali sono nel caso nostro il cinema degli anni '30 e il cinema neorealista. Ma il rifiuto di un’ottica storicistica, che riduce a rapporti determini stici anche le relazioni intertestuali, non significherà un nuovo tipo di riduzionismo, l’affermazióne cioè che tutto è testo e che esistono solo rap porti semiotici: significherà invece non accettare comode e scontate gerar chie che funzionino come uscite di sicurezza sempre aperte per evacuare un testo non appena si senta puzza di bruciato.
RETROTERRA
Il quadro teorico che si vuole abbandonare dovrà però ancora per un istante essere tenuto presente per poter ricordare nel suo naturale contesto l’atteggiamento concreto della cultura cinematografica italiana del primo dopoguerra nei confronti del cinema degli anni precedenti. Il cinema italiano degli anni ’30 (conserviamo questa formula anche se propria mente il decennio deve essere spostato un po’ più avanti: il cinema dell’ epoca fascista — come si dirà meglio più avanti — costituisce una unità storiografica solo dal 1934 al 1943, ed è di fatto questo il periodo che analizzeremo più sistematicamente) è vissuto dai critici e dai cineasti atti vi nell’epoca del neorealismo attraverso una fondamentale ambivalenza: da una parte esso è il cinema in cui tutti si sono formati (come critici, come tecnici, come lettori, come organizzatori culturali, o già come regi sti. Bisogna ricordare, infatti, che il neorealismo non è affatto un cinema di debuttanti e tanto meno di naìfs). Dall’altra parte, esso è il cinema di un periodo con cui, attraverso la lotta di liberazione e la militanza nei partiti antifascisti, si sono definitivamente tagliati i ponti. Potremmo dire che gli anni ’30 sono vissuti nell’immediato dopoguerra proprio come un retroterra’, un territorio che si è percorso, chi a fronte alta e chi a car poni, ma che ora è stato lasciato alle spalle e verso cui non ci si vuol più nemmeno voltare indietro. Quest’ultimo atteggiamento — come è ov vio del resto — è la prima evidente costante: l’antifascismo è immedia tamente anche distacco dal cinema del fascismo e una metafora pro grammatica incontra subito fortuna: tagliare i fili dei telefoni bianchi. La guerra e la Resistenza, nel loro statuto di concreti fenomeni di sconvol gimento e di rottura, sono la garanzia che l’allontanamento è avvenuto e che una differenza profonda ormai esiste, e tangibilmente. Ma ecco che i modelli deterministici e storicistici impongono ben presto le proprie di storsioni: e la guerra e la Resistenza, da garanzie di una rottura che isti
Jl neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
3)5
tuisce in un campo discorsivo due diverse unità, diventano tout-court la causa della seconda di queste; guerra e Resistenza diventano cioè matrici del neorealismo. Sono pochi i critici e gli studiosi che nei consue ti elenchi di « fonti » o di matrici, a compilare i quali la storiografia ci nematografica disperde così tante energie, si limitano a citare testi o co munque antecedenti discorsivi. Quasi tutti fra le origini del neorealismo collocano invece la reazione al fascismo e la lotta di liberazione. Con ciò non vogliamo dire che questi fenomeni non abbiano alcun ruolo nel pro cesso di generazione del neorealismo; vogliamo però sottolineare che il modello che fa di ogni circostanza una causa lascia sopravvivere tra due testi un solo tipo di rapporto, quello della determinazione, appunto; una volta imboccata questa via non si potrà far altro che accrescere a dismi sura il numero delle matrici, trovandone di sempre più inedite, improba bili e lontane, dato che questo rimane l’unico modo per dire qualcosa di nuovo. Nell’operazione di rincorsa alle fonti, si esaurisce dunque gran parte dell’interesse che il cinema degli anni *30 riveste per la cultura neo realista e in genere per gli storici del cinema italiano che scrissero anche in tempi più vicini a noi. Il terreno retrostante il neorealismo è visto come un campo non dissodato ma in cui, fra la molta sterpaglia, emergono germogli buoni, polloni di piante da frutto che con qualche opportuno innesto daranno ottimi raccolti. Per la storia del cinema italiano il neo realismo, età aurea, diviene dunque la misura delle cose e il cinema degli anni *30 non potrà essere significativo se non nella misura in cui con tiene in germe, o anticipa, o prepara gli esiti neorealistici. Così l’altra faccia del precorrimento è, in epoca post-fascista, l’ideologia dell’ adem pimento. Quanti film sono fatti per completare lacune che il fascismo non aveva consentito di colmare, per adempiere gli obblighi politico-mo rali dell’anti-fascismo. E ciò anche nel dopo-neorealismo, dai Fratelli Cer vi al Delitto Matteotti o a Bronte, il «completamento» di 1860 di Bla setti. Modello teleologico e modello deterministico vengono così, com’è giusto, a sovrapporsi e coincidere. Questa convergenza si manifesta chia ramente in una problematica viva e costante in tutti coloro che hanno scrit to sul neorealismo e che riassume nella sua limitatività tutto l’interesse del neorealismo per il cinema degli anni che lo hanno preceduto, e degli anni ’30 in particolare: il problema cioè dei « padri » del neorealismo. In dividuare dei « padri » per il cinema neorealista è qualcosa di più che cercare delle fonti o delle matrici testuali. Parlare di padri vuol dire, infatti, individuare una linea generativa, scoprire le pietre miliari di un cammino provvidenziale: i padri sono concretamente certi film che hanno anticipato e prefigurato l’età d’oro del cinema italiano, sono quelli che, nel retroterra di cui si diceva, hanno aperto un cammino che tocca ai figli di completare. Tra questi uno è particolarmente mitico e non vi è studioso di neorealismo che, in un senso o nell’altro, dimentichi di citarlo: è quello
336
Il neorealismo cinematografico italiano
Sperduti nel buio di Martoglio, sperdutosi a sua volta nelle vicende che accompagnarono l’evacuazione da parte dei tedeschi e fascisti di Cinecittà e del CSC e il trasferimento di attrezzature e materiali, e che non si sa bene quanti abbiano visto e quanti fingano semplicemente di avere visto. È noto che fu Umberto Barbaro ad additare in questo film e nel film cu gino Assunta Spina gli esempi di un cinema realistico regionale che avrebbe poi avuto col neorealismo la sua fioritura e la sua affermazione a livello nazionale. Meno noto e più interessante è ricordare l’occasione in cui Bar baro fece questa « scoperta », e cioè una retrospettiva del primo cinema italiano organizzata da Freddi e Chiarini nel 1933 nel corso di una mani festazione celebrativa del 40° anniversario della nascita del cinema. La finalità della manifestazione era chiaramente di affermazione nazionalistica: non potendosi trovare un Meucci del cinema, che accanto a questi e a Marconi stabilisse la supremazia del genio italico nel campo dei nuovi media ed essendo comunque ormai impossibile negare il ruolo dei due troppo celebri fratelli francesi, si cercò di sanzionare in quell’occasione una serie di priorità tecniche che sarebbero spettate al cinema italiano: la prima panoramica con Ma l'amor mio non muore, il primo carrello con Cabiria, ecc. Quanto a Cabiria, che certamente non sarebbe poi stato riconosciuto dal neorealismo fra i suoi padri, tutt’altro, ad esso si attri buisce tuttavia una peculiare parentela col cinema italiano « di qualità ». Esso viene presentato come il film che avrebbe fornito ispirazione e sug gerimenti tecnici a Griffith, padre riconosciuto del cinema-linguaggio. Ca biria insomma, se non è un padre, è qualcosa come uno zio d’America, lo zio poco serio spaccone ma coraggioso emigrato in America e che lì ha fatto fortuna. La scoperta di Sperduti nel buio si collocava dunque in un’operazione di fondazione di una precisa ideologia che accompagnerà, dallo scorcio degli anni ’30 fino a tutta la stagione neorealistica, le problematiche delle « origini » e dei « padri », e cioè quella che potremo chiamare {'ideologia della prima volta-, la storia del cinema viene percorsa per individuare tutte le « prime volte che », la storia dei padri è insomma la storia di tanti Adami, di padri che a loro volta non sono figli di nessuno, o meglio sono figli solo di un Progetto Provvidenziale. Per un più ampio inquadra mento teorico c ideologico della nozione di « prima volta » così come viene impiegata nella storia del cinema rimandiamo ad alcune pagine di J. L. Comolli sul n. 231 dei « Cahiers du Cinéma»; qui ci si limiterà a sottolineare — anche se l’osservazione è quanto mai ovvia — che le « pri me volte » di cui più volontieri si mette alla caccia il critico e lo storico italiano sono quelle in cui si manifesterebbe qualcosa che ha che fare in qualche modo col realismo, con la « verità », con l’impegno sociale. Fra le prime volte degli anni che precedono di poco il neorealismo («II primo vero mercato realistico del cinema italiano non è quello di Porta
Il neorealismo e il cinema italiano degfi anni trenta
357
Portese in Ladri di biciclette ma quello del corso Principe Oddone a Ge nova in Sissignora » (Solatoli), « In Piccolo Mondo Antico per la prima volta nel nostro cinema abbiamo visto un paesaggio non più rarefatto, pac chiano-pittoresco, ma finalmente rispondente all’umanità dei personaggi » (De Santis), « In Ossessione c’è per la prima volta il ritratto di un’Italia in crisi e di ima borghesia problematica, di un popolo inquieto e insod disfatto» (Carpi) ecc.) e le prime volte propriamente neorealistiche («Sciuscià mostrò per la prima volta agli schermi nazionali... degli "italiani cattivi" » (Ferrara), « Per la prima volta con il neorealismo si esclude la separazione tra cinema e realtà » (Lattuada)), vi è una so stanziale concordanza di soggetti e contenuti. Con ciò vengono riconosciuti fra i più immediati antecedenti del neo realismo un gruppo di film degli anni tra il ’40 e il *43 come — oltre a quelli già citati — Quattro passi tra le nuvole, Uomini sul fondo, Pari nella nebbia, Giacomo l’idealista, La Peccatrice, Piccolo Mondo Antico, Un colpo di pistola, La nave bianca, Quelli della montagna-, film tuttavia troppo immediatamente vicini, e forse troppo numerosi, per vedersi riser vare un vero e proprio ruolo di paternità. I « veri » padri sono invece un po’ più attempati e si addensano per la maggior parte appunto negli anni ’30 propriamente detti: Sole, Terra Madre e soprattutto 1860 di Blasetti, per alcuni aspetti Gli uomini che mascalzoni!, e anche II Cap pello a tre punte di Camerini (quest’ultimo a detta di Mida, perché si ispirava a Masaniello) e qualche altro film « disperso » e atipico (Ragazzo di Perilli, Acciaio di Ruttmann, Ho visto brillare le stelle di Guazzoni). Di alcuni di questi film daremo in seguito qualche ulteriore notizia e qualche accenno di lettura; qui importa osservare che essi o appartengono agli unici due registi degli anni ’30 cui si riconosce dignità di autore, o rappresentano episodi di ricerca di un film di qualità e di alta dignità letteraria, o fanno parte di un filone social-lavorativo assai poco rappre sentato in quegli anni. Il tratto comune a tutti questi film è dunque il loro essere eccezioni rispetto alla produzione corrente dell’epoca, o me glio all’immagine che ci si faceva di essa. Si può dire, senza tema di esagerare, che praticamente ogni buon film del periodo fascista, ogni film che per qualità artistiche o per originalità tematiche si staccasse dalla produzione standard ha le carte in regola per essere proclamato fra i padri del neorealismo. Ecco dunque delinearsi il quadro di un’altra ideologia ben viva nel l’epoca neorealistica e perfettamente solidale con quelle già descritte: l’ideologia dell’eccezione e del capolavoro. L’interesse del cinema degli anni ’30 sta nelle sue eccezioni, in ciò che in qualche modo emerge dal grigiore diffuso e con ciò si riscatta e può aspirare a una discendenza libera. Il cinema neorealistico non cerca origini nobili, anzi le rifiuta: si accontenta di essere figlio di liberti. L’ideologia dell’eccezione è così forte da agire
338
Il neorealismo cinematografico italiano
anche nei confronti degli avversari: è assai diffusa l’opinione che non esi sta negli anni '30 un cinema propriamente fascista se non in pochissime eccezioni: per alcuni solo tre: Vecchia Guardia, Camicia nera, Redenzione e, al più, pochissimi altri; opinione che si può smentire con molta facilità. Essa, tuttavia, ha dovuto essere conservata, anche a costo di gravi equivoci critici, per sostenere e difendere un carattere pecu liare del cinema realista: quello di essere appunto un cinema di eccezioni e di capolavori. Non è solo una questione di entusiasmi critici, per cui si gridò al capolavoro più spesso nei quattro o cinque anni di neo realismo « stretto » che non forse in tutta la storia della critica cinema tografica. Bisogna anche ricordare che è col neorealismo che si evidenzia in Italia la figura dell'autore (Rossellini è forse il primo regista che di viene anche un personaggio da rotocalco) e che si innesca quel cammino critico che condurrà in Francia alla politique des auteurs. Ma la prova più esemplare di quanto realismo e ideologia del capolavoro siano connaturati sta nel fatto che si è potuto affermare da molti, a neorealismo concluso, che in realtà il neorealismo non è che il buon cinema italiano, anche degli anni ’50 e *60, anche oggi (v. l’ultimo libro di Chiarini). Così che il neo realismo, di cui tutti negano infatti lo statuto di « scuola », è, fra tutti i grandi episodi della storia del cinema mondiale (espressionismo, avan guardia sovietica, nouvelle vague ecc.) l’unico ad avere confini elastici a piacere, perché viene fatto coincidere con il cinema d’arte italiano, tout court. Se dunque il cinema italiano degli anni ’30, antecedente immediato del neorealismo, è un cinema di eccezioni e di sprazzi isolati, può accon tentarsi il modello storicistico di ridurre a quei pochi e sperduti padri l’apparato di cause e di origini che starebbe alla base di un cinema così artisticamente e umanamente ricco come quello neorealista? Evidente mente no, ed ecco allora i due corollari opposti ma convergenti dell’ideo logia dell’eccezione: del primo si è detto: i capolavori nascono solo dai capolavori, o per lo meno dai film non di genere e non di evasione. Il secondo corollario è che, alla ricerca di origini più ampie e più differen ziate, non si può fare a meno che cercarle non nel cinema direttamente precedente, ma altrove, nel tempo e nello spazio. Quali sono, infatti, le fonti unanimemente riconosciute del neorealismo italiano? Ma appunto il verismo letterario di settant’anni prima, il naturalismo dialettale nel ci nema degli anni ’10, il « realismo francese » dei Renoir e dei Carnè, quel fantasmatico « realismo sovietico » che starebbe tra Eizenstein, Pudovkin e Vertov, la letteratura nordamericana tra Hemingway, Caldwell e Faulkner ecc. Insomma origini lontane, a distanza di sicurezza dal fascismo. Proviamo allora a riassumere e inquadrare teoricamente l’atteggia mento della cultura cinematografica italiana nei confronti del cinema degli anni ’30. L’operazione di rifiuto e distacco da questo cinema si attua attra
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
339
verso quel meccanismo di negazione che in psicanalisi si definisce diniego o denegazione (Verneinung) che Freud ha descritto a proposito della costituzione del feticismo e dell’angoscia di castrazione. Il diniego è la conseguenza della scoperta dell'assenza del pene nel corpo della madre, ciò che è per il bambino in questa fase il luogo di ogni realtà. Ma questa smentita che la realtà infligge alle credenze del bambino viene appunto denegata, disconosciuta per poter conservare la credenza nel fallo ma terno. La conseguenza è — attraverso passaggi ed elaborazioni successive della teoria che qui saltiamo — la formazione del simbolico e, nei casi patologici, del feticismo. Il diniego della realtà si presenta nel nostro caso come diniego del realismo: ci si accorge che alla grande madre e matrice — il cinema degli anni '30 — manca il fallo realistico e allora da un lato si cerca di evitare l’angoscia della castrazione attraverso l’insulto rabbioso e disilluso, la parolaccia: cinema dei telefoni bianchi, cioè più o meno cinema-puttana; dall’altro lato si mette in atto un processo di diniego e si istituiscono una serie di feticci compensativi che, in quanto tali, possono svolgere una funzione gagliardamente riproduttiva: i padri del neorealismo appunto, i pochi film letteralmente « coi coglioni » in un panorama di commedie rosa o di ricostruzioni di carta-pesta. Insomma, il retroterra che si è percorso e che si è traumaticamente scoperto nella sua aridità e mancanza di forze vitali viene irrorato in forme sostitutive e appunto feticistiche: è la nota metafora del fiume carsico di Luigi Chiarini che risolve la drammatica scissione nell’io neorealista, la scissione fra continuità e frattura: La più viva tendenza dell’odierno cinema italiano sgorga sì improvvisa dopo i venti anni di fascismo ma, come certi fiumi carsici che si inabissano per riemergere assai lontano, porta nelle sue acque tumultuose quello slancio vitale impresso fin dai tempi del muto dalla tendenza che ha in Sperduti nel buio una delle sue opere più signi
ficative.
Al di sotto dell’incolto terreno fascista scorrono dunque le acque lim pide del realismo, capaci magari di alimentare qualche fonte isolata. Ma il prezzo da pagare per esercitare la denegazione non è da poco: è la teo ria del fascismo come parentesi, come retroterra recintato e con ciò cre duto inoffensivo. La via per uscire da questi equivoci e da questi ondeggiamenti è, come si è detto, di trasformare radicalmente il campo teorico in cui le no zioni di origine, fonte, paternità, capolavoro, eccezione ecc. trovano ali mento. È di parlare non più di retroterra ma di retrotesto. RETROTESTO
La sostituzione di una parola con un’altra non è semplicemente il frutto di un gioco di assonanze: la nozione di retrotesto rompe con ciò
340
Il neorealismo cinematografico italiano
che si intende per retroterra, o se si vuole lo trasforma radicalmente. Con retrotesto si designa (ma la definizione è solo approssimativa) quel cumulo di esperienze di tipo simbolico che nella loro esistenza, ora avvertita ora dissimulata, ora rispettata ora tradita, « pesano », letteralmente, sulle nuo ve esperienze che si stanno tentando. La definizione è solo approssimativa perché lascia scoperti dei problemi cruciali: ad esempio quello del « tem po » di queste esperienze (misurato da una cronologia esterna o model lato secondo una legge immanente?) o quello della «novità» delle espe rienze che si sovrappongono alle precedenti (trasformazione di condizioni di esercizio o « salto di qualità »?). Tuttavia questa definizione è suffi ciente a inquadrare il problema che qui ci sta a cuore: essa ci suggerisce da una parte che non si tratta più di confrontare tra loro dei fatti qua lunque, ma di isolare ciò che ha a che fare col simbolico; dall’altra che non si tratta più di istituire dei confronti qualsiasi purché definiti da rela zioni di semplice determinazione, ma di stipulare dei patti o sancire dei conflitti di tipo complesso. Molteplicità e simbolicità sono due aspetti che il retroterra non considera particolarmente importanti; il retrotesto ne fa invece due postulati di base, in accordo con la propria natura di « tessuto di segni », o di « programma di scrittura » in accordo insomma con la propria natura di oggetto semiotico, frutto di una serie di rapporti e di equilibri, dentro di sé (tra il dire e il non dire, tra enunciati diversi ecc.) e fuori di sé (tra ciò che si dice e ciò che si sarebbe potuto dire, tra ciò che si dice e ciò che altri diranno ecc.). (Ma qui dentro e fuori sono due nozioni di comodo). Il mutamento di parola, insomma, rivela un muta mento di oggetto di analisi, parallelo al mutamento di campo teorico', muta mento che si è visto all’opera nelle pagine precedenti a proposito di una problematica critica diversa, così come lo si vedrà di nuovo, nelle prossime pagine, a proposito di un’ottica, di un modo di osservare i fatti diverso. È lo sguardo che muta: non si tratta più infatti di operare su presenze più o meno rilevanti o su nessi più o meno immediati; non si tratta più di rico piare un terreno dalla geografia già assestata o di misurare distanze con grandezza definite e definitive, stando in un posto di osservazione riparato e neutrale; si tratta invece di fare i conti con una data esistenza e insieme di porsi al centro di una serie di rapporti. Se dunque si studia il cinema degli anni ’30 come retrotesto del neo realismo, ciò vuol dire, come minimo, che si devono cercare quelle grandi relazioni tipiche che in ogni universo simbolico strutturano un testo e lo legano ad altri; ma vuole anche dire che non si possono osservare i due periodi che ciascuno con gli occhi dell’altro, sapendo che se l’uno si pre senta in un dato modo, è perché l’altro lo sorveglia e lo precede, insomma lo determina, e viceversa (in ogni caso con una certa gerarchia: e anche questo è un problema cui si cercherà di dare una risposta). Dunque le pagine che seguono cercheranno di descrivere da questo
Il neorealismo e il cinema italiano degfi anni trenta
341
punto di vista il cinema degli anni ’30: vi individueranno, in quanto retrotesto, tre diversi ambiti materiali di enunciazione, i film, gli apparati tec nico-ideologici, i discorsi « verbali », e in quanto re/ro-testo, una serie di «figure» (risolte come «figure tematiche»), che stabiliscono dei ponti non univoci con il periodo successivo. Le descrizioni appariranno forse « spostate » rispetto alla loro abituale formulazione: dei film, ad esempio, si diranno le condizioni di sopravvivenza, e non il catalogo completo di ciò che è stato prodotto. Ma questo, per quanto si è discusso, non solo è inevitabile, ma è anche necessario.
I FILM
Le difficoltà materiali di accesso, le figure intermedie (il catalogo, lo schedario, il cellario, il conservatore, l’addetto al trasporto) che gestiscono il rapporto tra lo storico del cinema e la cineteca, il desiderio archeologico del film, vecchio, raro, inedito, infiammabile, l’irritazione e la frustrazione che accompagnano in Italia queste ricerche, oltre a naturalmente una generale carenza di strumenti teorici, impediscono per lo più di consi derare nella giusta prospettiva storica l’esistenza residua dei film, la con servazione e lo stato delle copie. L’aneddottica che circonda il salvataggio o la sparizione della singola opera occulta il fatto che è sempre in ultima istanza una pratica critica che ha contribuito a determinare questa situazione: l’esistenza, o più spesso l’inesistenza dei film, la possibilità di disporne. La pratica critica che ha collaborato storicamente a produrre una grave situazione delle cineteche italiane, situazione che, seppure paradossal mente, pare in grado di evolvere ancora al peggio, sembra essersi ispirata nel suo modello di funzionamento, nella sua concreta politica di recupero e conservazione, a quella « ideologia del capolavoro » che uniformava, al di là di divergenze occasionali e insignificanti, la metodologia della cul tura cinematografica italiana del secondo dopoguerra. I risultati nel campo della cineteconomia sono stati disastrosi. Henry Langlois, in una lunga intervista ai « Cahiers du Cinéma », dichiarava nel 1962 che « l’ideologia del capolavoro » aveva portato alla simultanea salvazione di sterminate edizioni e copie di preziosi capolavori internazionali e aveva perso irreparabilmente la maggior parte delle singole produzioni cinematografiche nazionali. Il cinema italiano, ricordava Lan glois, offriva una situazione tra le più contraddittorie e desolanti, a cui nemmeno la passione degli storici e dei cinefili francesi era riuscita a por tare soccorso. Gli storici del cinema italiano che hanno dedicato occasionali appunti a questo problema sogliono avanzare un’attenuante individuando un pre-
342
Il neorealismo cinematografico italiano
ciso colpevole. Proprio come in un film resistenziale dell’immediato dopo guerra neorealista la connotazione negativa più forte e spregevole tocca anche in questo caso ai tedeschi. Responsabili di stragi e di eccidi, i tede schi hanno tra l’altro reso orfano anche il cinema italiano: la perdita di Sperduti nel buio è senz’altro colpa loro. L’immagine dei tedeschi predatori del glorioso patrimonio storico del cinema italiano fa pendant con quella degli americani intenti, non molto tempo dopo, ad « allargare » il mercato nazionale con « fondi di magazzino » che aspettavano dal ’38 lo smercio nella penisola. Anche questo stereotipo, sebbene l’immagine dell’allaga mento liberi forse un’inconscia metafora antidemocristiana (erano gli anni in cui nel prezzo del biglietto cinematografico era contenuto il soccorso invernale per gli alluvionati del Polesine) andrebbe forse ribaltata e sarebbe l’ora di ricordare i negativi dei materiali documentari antifascisti (oggi aggiungerebbero militanti) sottratti « manu militari » dagli americani ai laboratori di sviluppo e stampa della cinematografia documentaria svolta sotto il coordinamento del Psychological Welfare Brench, solo per conto della quale organizzazione Luchino Visconti potè filmare il processo Caruso. La storiografia dell’età neorealista ci ha mostrato come il Centro Spe rimentale di Cinematografia e l’annessa Cineteca, anziché funzionare da apparato ideologico dello Stato fascista, fosse divenuto una fucina di ela borazione teorica antifascista che ha forgiato dei quadri che prepararono la Resistenza e collaborarono con essa. Insomma, da un negativo è stato stampato un positivo. Forse anche questa è l’occasione per ricordare che nei sotterranei della Cineteca Nazionale, centinaia di inaccessibili copie di film italiani, di positivi infiammabili, di negativi, di copie lavandera si stanno spappolando. La constatazione da noi recentemente effettuata di questo stato di cose implica, oltre alla necessità di un intervento politico immediato, una complessa gerarchia di problemi metodologici prima fra tutti la questione di una « critica delle fonti » nei confronti di una storio grafia del cinema italiano che mai si è preoccupata di interrogarsi sui tempi, sui modi, sulla responsabilità della « perdita » dei film e che, a partire da questa condizione, non ha tuttavia rinunciato ad almanaccare ricostruzioni e ipotesi. Valga per tutti l’esempio, che interessa direttamente l’area della nostra indagine, di quel critico che, sulla base di alcune fotografie di Sole, la scomparsa opera prima di Alessandro Blasetti, ricostruì che Blasetti avrebbe, a suà volta, lavorato dietro la suggestione di fotografie di film di Eisenstein e di Pudovkin: [...] da questo suo primo film non è difficile notare la particolare espressione dei volti, la personale utilizzazione visiva dell’espressione; sono le facce che egli aveva senz’altro visto in fotogrammi di Eisenstein e di Pudovkin: le facce del popolo. Egli si sentì in un certo senso incaricato dell'alto compito di dare al fascismo una nuova cinematografia. Una cinematografia che avrebbe dovuto avvicinarsi al popolo per ri flettere l’immagine fascista.
In fondo Sole era un film sui butteri, sui mandriani, sui cow-boys
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
343
delle paludi Pontine, per quel che ne sappiamo. Come mai in tutta la letteratura critica dell’epoca non si trova nemmeno in negativo, l’instaura * zione di un parallelo con il cinema western? Ma su questo, sulla produ * zione, sui generi e sulla critica degli anni ’30 riparleremo presto. Premesso tutto questo, non è facile tentare di catalogare il rimasto: certo « l’ideologia del capolavoro », la mitologia dell’autore, la fama del precorrimento neorealista hanno giocato un ruolo di prima importanza nella sopravvivenza e nella decimazione di film. Il caso avrà anche lui fatto la sua parte. Volendo riunire a tutti i costi i film superstiti in una categoria fittizia possiamo dire che sono rimasti i film senza telefoni bianchi. D’altronde la stessa fortuna internazionale del neorealismo oltre ad averlo cristallizzato in una formula critica, sembra averne paradossalmente complicato la conoscenza e lo studio in patria: le copie dei film neorea listi sono impegnate in perenni tourneés estere. Il neorealismo che rimbalza dall’estero in Italia, il neorealismo a cui Sadoul tributa il primo posto nella seconda parte della sua storia del cinema mondiale, il neorealismo che sembra porsi per i paesi della lotta anti imperialista e della decolonizzazione culturale come un modello di « via nazionale al cinema », sembrerebbe rafforzarci inconsciamente, con la forza d’urto anti storica del mito, nella tesi della « frattura ».
I GENERI
Le varie accezioni di lettura del neorealismo come di un fenomeno di umanesimo nascondono in realtà un atteggiamento positivistico rispetto alla questione dei generi cinematografici. II genere, questo organismo naturale e biologico che si riproduceva evolvendosi fin da quando fu luce ad opera di due industriali francesi, sarebbe giunto con il neorealismo ad uno stadio finale del suo processo. La realtà, dopo avere miracolato la tecnica, convertiti i registi, am mazza i generi cattivi. Il realismo è uno e totalizzante. Non può conoscere l’alveo del genere e l’oltraggio del filone. Quando cercheranno di salva guardarne la nozione, l’essenza, il profumo, appiccicandogli delle etichette classificatorie, scoprendogli dentro qualcosa che nessuno ha il coraggio di rapportare alla nozione di genere, non si tratterà che della redazione di un certificato di morte. Il neorealismo nega ogni rapporto con i generi e si costituisce pro prio come irriducìbile alterità linguistica da essi, come un’isola che spezza e interrompe il flusso della continuità tra i generi degli anni Trenta e il cinema post-bellico che appunto per questo legame viene definito non realista, anzi, poiché il neorealismo ha ereditato dai tempi un carattere battagliero, antineorealista.
344
Il neorealismo cinematografico italiano
Nella realtà storica, quella critica che di lì a poco avrebbe prodotto concretamente il neorealismo, aveva utilizzato assai poco la nozione di genere. Si era di fatto sdegnata di analizzare i rapporti intertestuali tra le opere di una produzione media, per leggerne la composizione morfologica, gli scarti e le trasformazioni. Aveva inventato una formula liquidatoria (« film di convenzione », « film di evasione »), proponeva una metonimia (il telefono bianco), non rendendosi conto che denunciare la « pars » non esimeva dalla necessità di analizzare il « toto ». Era stato individuato un grande genere, nefasto e onnicomprensivo: « la commedia sentimentale ». Da questa definizione venivano fatte discendere alcune varianti, ad esem pio quella di « commedia ungherese », che denunciavano la antitalianità di questi prodotti sciagurati e ne riconoscevano una ascendenza straniera: la commedia tedesca, dapprima, quella americana in seguito. La nozione di genere è negata da quel tipo di pratica critica. Esiste soltanto la precet tistica di alcuni film caposcuola che producono instancabili imitazioni. Da un prototipo industriale nascono delle copie, una infinita produzione se riale, un cinema che conosce solo il remake di se stesso. L’esecrazione topica de La segretaria privata di Alessandrini anticipa la nostalgia mitica di Sperduti nel buio o l’evocazione ricorrente di 1860. Nel racconto della discesa agli inferi del cinema fascista per ricono scere ed abbracciare il proprio padre, il neorealismo incontra sempre il film « realistico », le nuove « prime volte » della Cines di Cecchi: La tavola dei poveri, 1860, Acciaio. In realtà la scoperta dei semi neorealisti dei film sopra citati o comunque di tutto il cinema pre-freddiano occulta completamente la loro struttura linguistica sperimentale. Il cinema muto italiano era stato soprattuto un cinema di generi a base industriale regio nale (donde la preminenza degli adattamenti della letteratura « reali stica » regionale) con una integrazione fra produzione c distribuzione costruita su prevalente scala locale. L’invenzione del sonoro e la costitu zione di un mercato cinematografico nazionale impongono la ricerca di nuovi indirizzi produttivi. Pittaluga aveva creato un’industria che però in concreto non sapeva cosa produrre. Di qui una estrema prudenza degli indirizzi realizzativi, il che spiega ciò che la .politique des auteurs non può spiegare, perché, ad es., il Nerone di Blasetti-Pittaluga costituisca un passo indietro rispetto all’esperimento a base cooperativistica di Sole, e perché ci si mantenesse sotto l’ombrello delle produzioni plurilingui delle pellicole, con la perdita di quei caratteri di italianità che tutti aspettavano e auspicavano. Cecchi, lo studioso e l’ammiratore di Hollywood e di Keaton, l’intellettuale che conosceva benissimo il cinema dei generi per eccellenza, eredita e amministra per 18 mesi alcune condizioni produttive ottimali (la proprietà dei mezzi di produzione, il controllo diretto della distribuzione che gli permette fra l’altro di tentare di sganciarsi dalle richieste divistiche che salivano dal noleggio) a partire da cui egli im
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
345
pianta, in maniera non unilaterale, alla ricerca simultanea di più strade, alcuni esperimenti produttivi. In realtà, la sperimentazione delle nuove possibilità linguistiche del cinema sonoro è consustanziale anche al cinema italiano delle origini. La lotta dichiarata di Blasetti ai « paradossi futu risti avanzati » e l’accantonamento dei tentativi dell’avanguardia diventa per la critica posteriore la falsa dimostrazione « realista » c antisperimen tale del cinema di quegli anni. Invece già La Canzone dell’amore di Ri ghelli sembrava avere esaurito, come in una rassegna, tutti le possibili utilizzazioni del sonoro fuori campo: le sicure acquisizioni fìlmiche di questi professionisti consumati pongono le basi per alcune esplorazioni spe rimentali. La segretaria privata di Alessandrini c sempre stato analizzato come un modello sociologico anziché come un tentativo linguistico. Ales sandrini, che era stato a Hollywood a studiare le tecniche di registrazione sonora, costruisce il suo film su una colonna musicale completamente asin cronica. Il suo è un esperimento italiano proprio perché cerca di adattare c di trapiantare un genere radicale e innovativo come pochi altri, che stava facendo il suo debutto in America. Cecchi che crea alla Cines una sezione documentaristica proprio per accentuare contemporaneamente la direzione sperimentale delle sue produzioni a soggetto, riprende e radicalizza questi esperimenti e queste ricerche. La tavola dei poveri è per ammissione di Blasetti, che era giunto al suo sesto lungometraggio, la sua prima sceneg giatura e segna probabilmente l’ingresso del lavoro di sceneggiatura nella storia del cinema italiano. L’intenzione di trasporre cinematograficamente un testo di Viviani, di un autore cioè certo meno noto a livello nazionale del Petrolini di Nerone, scritto in un dialetto, il napoletano, più periferico e marginale del romanesco, impose un grosso lavoro sulle strutture nar rative del racconto (l’eliminazione delle canzoni e la storia d’amore della figlia del protagonista come deus ex machina che utilizzi modelli narrativi convenzionali e cari al pubblico) e su quelle propriamente linguistiche di Viviani (stemperamento della dialettalità, rapporto tra gag verbali e gag gestuali) tant’è vero che al lavoro compiuto da Cecchi, Viviani, Soldati e Blasetti corrispose lo sconcerto della critica che non riusciva a catalogare il film in nessuna delle categorie preesistenti ed era stupefatta per la di stanza dal teatro filmato. Nacque un’accusa di ipercinematograficità. Ana logo discorso andrebbe condotto su 1860 e Acciaio-, sulla presa diretta della registrazione sonora, sull’uso degli attori non professionisti, sul mon taggio dialettico, sul nuovo ruolo narrativo del carrello, sull’uso di modelli narrativi ripresi dal romanzo, sul riadattamento metalinguistico delle strut ture narrative del cinema western, sull’uso del soggetto industriale e del « paesaggio italiano », su un cinema che inventa nuovi rapporti e nuove combinazioni fra se stesso, la letteratura e la politica. I 18 mesi della gestione Cecchi, che sarà di fatto interdetto come incapace, mentre la Cines cercherà di darsi un nuovo assetto industriale at-
346
Il neorealismo cinematografico italiano
traverso la locazione degli impianti, furono dunque e soprattutto un pe riodo di sperimentazione linguistica. L’ingresso in campo della Direzione generale della Cinematografia segna indubbiamente una discontinuità al l’interno degli anni Trenta e l’inizio di un cinema di generi fortemente codificati. La storiografia classica interpreta l’atteggiamento di Freddi e del regime come la prescrizione di una normatività tutta negativa (l’egemonia dei film rosa, dei telefoni bianchi, la scarsità di una produzione di propa ganda, un cinema fascista non nell’enunciazione di contenuti positivi ma nella ripetizione dell’anestesia e della stupidità). A nostro giudizio il ruolo di Freddi è giocato sulla normalizzazione linguistica, sulla cessazione della sperimentazione, prima che nella promulgazione di una normatività re pressiva e conformatizzatrice. Il riassestamento critico dei generi degli anni Trenta è un’operazione complessa e che postula una impossibile conoscenza dei testi. Al livello attuale delle conoscenze è possibile solo formulare delle ipotesi e indicare delle esigenze. Innanzitutto dovrà essere completamente ridiscusso il quadro dei rapporti con il cinema americano che la critica di quegli anni tendeva sempre a delegare e a occultare. La pratica stessa del doppiaggio stabiliva invece dei contatti e delle infiltrazioni sottili e sotterranee che vanno messe alla luce. Due esempi per tutti: la suggestione dei rapporti con Clair ha nascosto il rapporto di rilievo che esiste, specialmente per quanto concerne i primi film, tra Camerini e Keaton. Gli indussi di Capra su Zavattini ci paiono pure ancora tutti da studiare. Vi è, invece, un genere fortemente autarchico e che non a caso nasce in età di protezionismo cinematografico: il cinema di guerra di De Robertis e Rossellini. Questo cinema scambiato per pre-neorealista, e in cui le connotazioni realistiche vanno lette invece come elementi di più credibile persuasività propagan distica, nasce invece, caso abbastanza unico, da una doppia privazione di modelli: non solo il cinema contemporaneo di guerra americano non più importato, ma nemmeno quel cinema di guerra retrospettivo di Renoir e Milestone, vietato dalla censura. La sottrazione di questi modelli giustifica e le relative innovazioni di De Robertis e le ridicole scoppiazzature dei classici sovietici di Rossellini. Un altro genere autarchico che andrà letto a partire non dalla sottrazione dei modelli storici, ma dalla ignoranza e dal mancato riconoscimento del proprio padre legittimo, è il cinema coloniale. Il cinema coloniale per antonomasia è ovviamente il cinema western, ci nema su un continente di coloni che vanno a colonizzare una regione del territorio. In senso stretto si deve distinguere il cinema coloniale (di cui Lo squadrone bianco di Genina e II grande appello di Camerini sono i due esempi più noti) che produrrà un cospicuo numero di opere anche in pe riodo di guerra, fino a Bengasi il cui piano di lavorazione fu sconvolto dall’avanzata delle truppe alleate, dai film dell’emigrazione (Passaporto
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
347
rosso, Terra di nessuno, Montevergine). Tutti questi film sono caratteriz zati nel loro complesso da un’accumulazione eterogenea di materiali lingui stici e ideologici: dal melodramma di Monte vergine, al socialfascismo anti borghese del mediocre Passaporto rosso, alla morfologia per eccellenza del racconto politico, il motivo, ricavato dal cinema sovietico, della pre sa di coscienza (i film di Genina e Camerini). Tra i generi più importanti vanno almeno ricordati oltre al fiorentissimo genere storico (Condottieri, Un'avventura di Salvator Rosa, Ettore Fieramosca), al teatro filmato che alimenta incessantemente tutta la produzione degli anni Trenta, alle numerose riduzioni di capolavori della letteratura nazionale, il piccolo filone del cinema collegiale (Seconda B, Maddalena, Zero in condotta, Ore 9, lezione di chimica). Comunque il criterio della normalizzazione linguistica sembra essere tratto pertinente che caratterizza tutta la produzione degli anni Trenta. Anche nei ritagli del sistema inventato da Freddi, non sono certo pochi imprenditori truffaldini che possono portare avanti 1’innovazione e la ricerca. Alcuni generi, come il fantastique sgangherato di O la borsa o la vita!, si perdono per strada. Altri, come il cinema nero, sono inter detti e la loro essenza produrrà, secondo il rispetto puntuale del mecca nismo dell’ideologia dell’adempimento, uno dei filoni più ricchi dell’età neorealista. Ossessione era stato un film sintomatico proprio nel rap porto con i temi proibiti dell’adulterio e del delitto. Gli anni Trenta, che vedono una ripresa organizzata della critica e della lotta teorica sul cinema, nel disprezzo per il genere smarriscono una distinzione molto im portante già effettuata da Canudo: quella tra film storico e film in co stume. La corona di ferro è affrontato con gli stessi parametri critici di Ettore Fieramosca. La non operatività critica della nozione di genere non può evidentemente riconoscere un esperimento di supergenere.
GLI APPARATI: 1
Nel cinema degli anni Trenta, se lo si guarda con l’ottica del genere, possiamo dunque cogliere l’esistenza di una discontinuità che divide uno sperimentalismo « di qualità » da una produzione che si avvia a puntare sul prodotto « medio ». La discontinuità non è visibile solo a livello dei film: essa ha dei rapporti ben precisi anche con il complesso tecnico-indu striale del cinema, e in definitiva con quegli apparati che agiscono nel cinema come in un luogo in cui si produce dell’ideologia. Passiamo dunque a esaminare un secondo livello del retrotesto, un secondo ambito di enun ciazione, quello appunto degli apparati tecnico-ideologici: si chiariranno così alcune cose rimaste — nelle pagine precedenti — soltanto implicite. La situazione di partenza è a dir poco anormale: la Cines-Pittaluga è l’u-
348
Il neorealismo cinematografico italiano
nica casa di produzione razionalmente strutturata, ed è essa che, durante la gestione Cecchi, tenta di dare un ruolo agli intellettuali e di favorire una linea di buon « sperimentalismo ». Al di fuori della Cines regna l’improv visazione: le case di produzione non stabiliscono programmi di lavoro a lunga durata, ma si organizzano, volta per volta, attorno ad un solo film; l'impiego di capitale limitato ad un solo prodotto fa sì che ogni casa debba attendere che il film realizzato completi il suo reddito prima di poter iniziare un nuovo lavoro. Tradizionalmente si dice che è il fallimento commerciale di Acciaio a provocare l’intervento dello Stato: ma di fatto i primi obbiettivi su cui si punta sono di ordine morale. Di fronte al dila gare dei « telefoni bianchi » e degli « snobidiotismi » della produzione corrente, ci si chiede « e il popolo, dov’è il popolo fascista? ». Emargi nato dallo schermo, il popolo attendeva nelle sale, nell'anno XII dell'Era fascista, che il cinema del regime rispondesse infine ad alcuni programmi più volte sbandierati dall'alto: a) educazione estetica ed etica delle folle, b) divulgazione delle idee fondamentali e dei principi di vita del popolo italiano, c) dimostrazione della potenzialità intellet tuale, morale, artistica, politica della civiltà italiana.
Per fare questo occorre un duplice intervento: totale ristrutturamento degli apparati di produzione e, come suggeriva il ministro Alfieri, « abban donare ogni falso esotismo ed orientarsi essenzialmente su personaggi tipici della gente italica ». Insomma, il cinema deve diventare specchio della realtà fascista e riflettere, in piccolo, lo stile che il fascismo ha adottato su scala nazionale: ordine, organizzazione del lavoro, intervento ideologico. Deve fare in modo che i suoi apparati diventino solidali e costituiscano un sistema integrato ai tre stadi della produzione, del noleggio e dell’eser cizio; contemporaneamente anche l’iniziativa privata deve uniformarsi alle direttive ufficiali. Si costituisce così quello che potremmo chiamare il sistema-Freddi, dal nome del suo principale protagonista: vera e propria città ideale, segno visibile per il « visibile », da percorrere secondo itinerari prefissati. Anche se c impossibile rinunciare a qualche « cicerone », il viaggio non vuole essere una passeggiata archeologica fra i ruderi per ricostruire « come si faceva il cinema fascista », o descrivere la lotta clandestina per il 25 luglio del cinema. Si cercherà piuttosto di cogliere, nell’ottica di un rapporto intertestuale, il funzionamento di una complessa figura reto rica: l’abbandono della città del cinema per il mondo della realtà. Direzione Generale per la Cinematografia Il 21 settembre 1934, alle dipendenze del Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda, retto da Galeazzo Ciano, viene istituita la Dire zione generale per la Cinematografia, il cui compito principale è quello,
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
349
che abbiamo già detto, di far « decollare » l’industria del cinema italiano. Direttore è quel Luigi Freddi che ha presentato al Duce il progetto di ristrutturazione dopo un’accurata visita a Hollywood, trovandosi in Ame rica « inviato speciale » al seguito del trasvolatore Italo Balbo. Nel cir cuito chiuso delle metafore del tempo Freddi così sintetizza il suo pro gramma: « bonifica, fertilizzazione, semina, coltura; e soprattutto disci plina, ordine, consapevolezza, volontà [...] Nel campo cinematografico — egli afferma — non si fanno miracoli ». La riforma Freddi mira a due scopi: a. Favorire il regime di libera concorrenza per giungere a un miglio ramento della solidità industriale degli organismi più consistenti e per la sciare affondare quelli parassitari: è il classico modello «legge della giungla», che viene reso attivo con una serie di provvedimenti atti a disciplinare e stabilizzare i quadri direttivi, tecnici e artistici delle singole aziende, in modo da poter elaborare programmi organici a lunga scadenza. Viene altresì istituito il Registro cinematografico, primo censimento globale del l’industria cinematografica italiana, e reso obbligatorio il nulla-osta pre ventivo per la realizzazione dei film. b. Incrementare la cinematografia nazionale con Enti gestiti diret tamente dallo Stato (luce, Cinecittà ecc.) L’ideologia di questa riforma la si può agevolmente dedurre da un’in tervista a un giornale americano rilasciata dallo stesso Freddi. È una serie di slogans. « Lo Stato inquadra ». Legislazione, disposizione e regolamenti per organizzare la cinematografia nazionale. «Lo Stato aiuta». Anticipazioni, credito bancario, proiezioni obbli gatorie in tutte le sale del Regno, buoni di doppiaggio, ecc. « Lo Stato premia ». Premi speciali, riconoscimenti ufficiali, Mostra di Venezia o altre forme di pubblicità indirette e gratuite. « Lo Stato controlla ». Rigida programmazione del lavoro, controllo delle singole lavorazioni, disciplina dei lavoratori. « Lo Stato sprona ». Indicazioni « artistiche », ricerca di soggetti, « consigli » in fase di elaborazione delle sceneggiature, scelta dei registi, attori, tecnici. « Si pongono a disposizione della cinematografia le più belle opere d’arte italiane, si spalancano i palazzi privati, si aprono le porte delle Regge... Si lancia largamente il film nella stampa ... gli si fa una equilibrata ma vasta propaganda attraverso la radio ». Il cineasta « perfet to » ha l'ingresso gratuito nella città visibile che il regime va costruendo. Vediamo ora più dettagliatamente come funzioni il sistema Freddi. Co minciamo con il modello « legge della jungla », in particolare nei suoi rap porti con lo Stato.
1.
Produzione. « Lo Stato non fa il produttore — dice il Ministro
350
Il neorealismo cinematografico italiano
della Cultura Popolare, Pavolini — ma disciplina la produzione che resta affidata all'iniziativa privata ». In base a questo principio — e nell'attesa di avviare una propria organizzazione — lo Stato incoraggia la produ zione predisponendo aiuti sotto quattro forme: se ne segna la cronologia, dato che essa è un elemento sintomatico. a. I buoni di doppiaggio (1933). I film esteri per essere proiettati devono essere doppiati, perciò si deve pagare una tassa allo Stato che è l’unico depositario del patrimonio linguistico nazionale. La stessa legge solleva dalle tasse i produttori italiani, in ragione di tre « esoneri » per ogni film nazionale, prodotto e proiettato. Il produttore può anche cedere i buoni all’importatore monetizzando così un certo capitale, reinvestibile in un nuovo film. b. Anticipazioni finanziarie (1935). La legge autorizza il Mini stero a concedere ai produttori degli anticipi per i film in cantiere fino a un terzo del costo preventivo, previa presentazione dei piani tecnici, arti stici e di sfruttamento. Il sistema si rivela ben presto esposto a specula zioni e fa rinascere dei produttori « selvaggi ». c. Banca del lavoro (1935). La legge autorizza la costituzione presso la Banca di una Sezione autonoma per il credito cinematografico con capi tale a partecipazione statale. I finanziamenti servono per il commercio e lo sfruttamento di pellicole nazionali e estere, per l’esercizio di sale cinema tografiche, per anticipazioni delle vendite all’estero, per produrre film, in misura non superiore al 60% del costo globale della produzione. d. legge Alfieri (1938). La legge Alfieri prevede l’abolizione degli anticipi statali, stabilisce che per ogni film nazionale di metraggio non in feriore ai 1500 metri si corrisponda al produttore un premio pari al 12% dell’incasso lordo, e oltre un certo limite d’incasso è poi previsto un pre mio supplettivo, progressivo, concede premi speciali a insindacabile giu dizio del Ministero. Il provvedimento ovviamente sollecita quei progetti il cui unico scopo è di fare « cassetta », provoca un’inflazione produttiva, la quale a sua volta fa scattare l’inflazione dei complessi in tutti i settori annullando praticamente i benefici della legge. (Nel ’31 ci sono tre case di produzione, nel ’35, trenta, nel ’38, trentatrè; ma nel *40 esse diventano una settan tina). A questo punto va segnalata e la ferma opposizione di Freddi alla legge Alfieri, — tanto che lascia l’incarico della Direzione — e il fatto che nel dopoguerra la medesima legge venga completamente riesumata sotto il nome di « legge Andreotti ». 2. Mercato. L’intervento dello Stato ha anche qui una funzione risanatrice. a. Dal ’35 in poi scatta una serie di leggi sulla proiezione obbliga toria dei film italiani nelle sale del Regno: prima in ragione di un film ita
Il neorealismo e il cinema italiane degli anni trenta
351
liano per ogni tre stranieri, poi di uno ogni due, e infine il rapporto diventa di parità. Le leggi non vengono sempre rispettate ma una certa normaliz * zazione dei rapporti è raggiunta. Affronteremo in seguito il problema del * l’importazione. b. Albo dei noleggiatori (1935). Viene costituito un Albo per eli minare ogni forma speculativa e una distribuzione « selvaggia ». Le case autorizzate al noleggio sono solo sedici. 3. Censura. « La censura deve tendere con ogni mezzo a sviluppare un'opportuna funzione ispiratrice. È ovvio che essa, revisionando i copioni prima che questi siano realizzati, può valersi della sua influenza per otte nere che i soggetti siano informati a concetti e propositi più prossimi allo spirito vero della nazione ». (Luigi Freddi) GLI APPARATI:
2
Abbiamo visto come lo Stato non intenda solo limitare il proprio in tervento a una serie di disposizioni che tutelino la produzione cinemato grafica nazionale, ma inizi una politica di presenza attiva mediante la costituzione di propri Enti di produzione e distribuzione. Oltre al Centro direzionale, per definizione munito di dono dell’ubi quità, si edifica materialmente una città con strutture e infrastrutture e regole di funzionamento. Non tutto però corre liscio: ad una opera zione oculata e attiva come quella dell’ENJC ne corrisponde, ad esempio, una grossolana e in perdita come quella del monopolio film esteri. Ma que ste sono anticipazioni del discorso che ora svolgeremo. Al Km. 9 della Tuscolana un giovane esce dalla sede del Centro sperimentale e, attraversata la strada, può scegliere di entrare nella destra a Cinecittà, oppure, sulla sinistra all’istituto Luce. Luce
Viene fondato nel 1925 con concorso finanziario di Istituti statali e parastatali. Sorto sulle basi de L’Unione Gnematografica Educativa (contratta nella sigla luce) esso costituisce il primo atto concreto d’inte ressamento del governo fascista per la produzione cinematografica. Duran te il regime svolge due compiti principali: il «giornale d’attualità» set timanale informativo, visionato molto spesso dal Duce e documentari di propaganda, di cui detiene il monopolio. Ma curiosamente tutte le volte che i fatti sollecitano un intervento tempestivo il Luce mostra la sua incapacità di intervenire e assolvere le sue funzioni. Così Freddi è co stretto a favorire la creazione dell’iNCOM, per poter appaltare alcuni ser vizi d’attualità.
352
Il neorealismo cinematografico italiano
Nel dopoguerra l'attività del Luce si orienta verso nuovi servizi (svi luppo e stampa, edizione, doppiaggio e montaggio ecc.) non rinunciando a compiti « educativi » e « documentaristici ». Non innocentemente il Luce cessa l’« attualità » nel dopoguerra: intanto perché ora sono i film a par lare di attualità e poi, esaurita la vena neorealistica, sarà la tv a ripristi nare giornalmente quello che il Luce produceva una volta alla settimana. Il nuovo medium eredita dall’Ente la sua funzione principale, quella di essere apparato ideologico del governo, strettamente controllato dal potere, ma ovviamente lo sopravanza tecnologicamente. La tv è il Luce, più I’incom, più tutti i cinegiornali. E con una marca stilistica caratterizzante: alle forse un po’ statiche riprese su cavalletto del Luce, ben inquadrate come la mascella del Duce, sostituisce la forsennata e spesso indecorosa, attività dello zoom, lunga mano del dominio democristiano. Cines 4- Cinecittà
Il regime ama l’immagine della Fenice. Sulle ceneri dei due maggiori teatri della Cines — andati a fuoco nel settembre del '35 — nasce l'idea di ricostruire la Cines — ormai « irizzata » — in una zona più vasta, fuori dal centro abitato. Si decide quindi di vendere i terreni di via Vejo — red ditizi perché zona fabbricabile — e iniziare al Quadrato la costruzione di Cinecittà, che avrebbe dovuto ereditare, come vedremo, le attrezzature e la ragione sociale della Cines. Nell’aprile del '37 entrano in funzione gli stabilimenti di Cinecittà ma la Cines, fino al ’41, non produce film perché la nuova gestione di Cinecittà si limita solo ad affittare stabilimenti. Con Cinecittà si mette in piedi il più grosso complesso industriale cinematografico esistente in Italia: seicentomila mq. di superfice, con teatri di posa, edifici industriali, laboratori, impianti, terreni per gli « esterni ». Una Hollywood costruita in periodo di sanzioni. Dall’inaugurazione al luglio del '43 negli stabilimenti del Quadrato vengono prodotti circa trecento film, con una media di quasi cinque film al mese, più ottantacinque cortometraggi e duecentoquarantotto doppiaggi. Con il ripristino produttivo della Cines la città funziona organicamente: realizza i film nei suoi stabilimenti, li colloca attraverso le sue organizzazioni di noleggi, li lancia nel circuito delle sue sale. Scrittura attori con contratto permanente, si serve di una vasta gamma di registi, sceneg giatori, direttori di fotografia, scenografi, (tutti operanti nel neorealismo, come è facilmente documentabile), può permettersi di lanciare esordienti e soprattutto di pianificare una delle attività che per natura è irregolare e caotica. Durante l’occupazione tedesca a Roma, gran parte dell’attrezzatura di Cinecittà viene portata in Germania e solo in parte (i famosi otto vagoni recuperati da Freddi) è trasferita a Venezia.
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
353
Cinecittà subisce altri gravi danni e per i bombardamenti e per una prolungata destinazione a « Centro di raccolta » e per « residenza di pro fughi e sfollati ». Sembra, così, che codesta istituzione, già sinistramente consacrata dalle avventure e dalle ruberie di gerarchi e profittatori, abbia ora a subire un bagno di salutare puri ficazione e la necessaria espiazione della nuova miseria e fra tanta povera gente. (Silvano Castellani, «Mercurio», maggio 1945).
Solo dopo questo bagno purificarono e il volontario esilio nelle strade d’Italia i cineasti del dopoguerra possono ritornare nella città del Cinema. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC) L’enic sorge nel ’35 col prelievo attraverso Futi delle attività di stributive della sa Pittaluga, ampliato nel ’36 con l’assorbimento del gruppo Leoni, e perfezionato in seguito con nuove acquisizioni. L’Ente ha per finalità l’acquisto, la vendita, il noleggio di film ita liani ed esteri e la gestione di sale cinematografiche. L’esercizio è costituito di circa 100 sale in Italia e all’estero. (Nel 1940 controlla 26 locali di prima visione assoluta sui 48 delle 10 « città chiave» dell’esercizio italiano; 50 locali sui 110 di prima categoria; il 25% degli incassi dei film di prima visione provengono esclusivamente dall’ENic). Il noleggio si basa su una fitta rete di agenzie e sub-agenzie, sull’organizzazione di servizi a bordo dei piroscafi, sulle filiali di Addis Abeba, Asmara, Tirana e sulle numerose affiliate all’estero. Questa struttura permette all’Ente di attuare una sua politica in materia di noleggio e di intervenire con i suoi capitali — unico apparato in attivo — nella produzione nazionale con « i minimi garantiti » e altre forme di partecipazione.
Monopolio film esteri Il « monopolio » dell’importazione e distribuzione dei film prove nienti dall’estero viene costituito nel ’38 e affidato all’ENic, con il com pito sostanziale di ridurre al minimo l’esodo di valuta italiana all’estero ed eliminare la mediazione dei noleggiatori. Ma i risultati non corrispondono propriamente alle aspettative. a. Le quattro grandi case americane (Metro, 20th Century Fox, Paramount, Warner Bross) che distribuivano direttamente i loro film si ritirano con un rimarchevole danno al mercato (non dimentichiamo che i film americani piacevano molto al pubblico, con Vittorio Mussolini in testa). b. Si indebolisce perciò l’esercizio a danno anche delle proiezioni obbligatorie dei film italiani (che l’esercizio accettava anche in perdita, dato il largo margine di guadagno sui film americani) e dei reinvestimenti
Il neorealismo cinematografico italiano
354
produttivi (i minimi garantiti dai noleggiatori). c. Si rompono praticamente i rapporti con Pesterò, compromettendo anche le coproduzioni, gli scambi di attori, di maestranze ecc. d. Il monopolio tiene segrete le cifre d’acquisto, dando libero cam po alla speculazione. e. Unico punto positivo è il forzato aumento della produzione ita liana per tenere saturo il mercato. Alcuni dati: ’38
Prod. 59 Import. 230 (1’80% sono americani)
’40
’42
’45
81 190
120 110
78 120
’48
54 874 (668 americani)
Ancora una volta va segnalato come Freddi si opponga energicamente alla costituzione del Monopolio, perché intuisce come esso turbi il suo piano regolatore.
Centro Sperimentale di Cinematografia Il Centro nasce perche « il Governo fascista vuole preparare i cineasti di domani, coloro che dovranno rinnovare i quadri della cinematografìa italiana» (L. Chiarini). Esso perciò si struttura per tenere corsi di pre parazione e specializzazione per registi, attori, sceneggiatori, direttori di produzione, operatori, fonici, montatori c truccatori. Ha sede di fronte a Cinecittà e al luce, in un complesso di fabbricati che comprende le aule per i corsi, due teatri di posa, una sala per proiezioni, alcune moviole e tutta l’attrezzatura necessaria. Il Centro è ideato da Chiarini nel 1936, forse sulla suggestione della Scuola Nazionale di Cinematografìa, 1930, diretta da Blasetti. Viene co stituita una Cineteca per la conservazione « di quei film che, dalla nascita del cinema, avessero rappresentato nel tempo uno sforzo singolare per intenti artistici e tecnici ». Si pubblica anche una rivista, « Bianco e Nero », che « mira alla formazione di una coscienza cinematografica che pren desse finalmente il posto del distratto e incoltivato interesse che si suole avere per il cinematografo ». (Freddi) Ma le cose più interessanti del Centro stanno altrove: nella sua na scita e nel suo — per così dire — « ricordo ». Nel ’37, durante il Festival di Venezia, Freddi esce dalla proiezione di un « noiosissimo film » e finisce nell’attiguo Casinò. Al tavolo della roulette scorge Francesca Bertini e Angelo Rizzoli, al trente et quarante Douglas Fairbanks e ai banchi dello chemin de fer altri illustri nomi del mondo del cinema. È folgorato da un’idea: se il cinema porta soldi al Ca sinò, il Casinò deve restituire soldi al cinema. Con un’apposita convenzione, dai redditi annuali del Casinò di Ve
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
355
nezia si traggono i fondi per attrezzare il Centro Sperimentale di Cine matografia. Il meccanismo ideologico che sottostà all’operazione è il se guente: il gioco d’azzardo è uno di quei temi non rappresentabili in Regime Fascista — se non in chiave esplicitamente anti-borghese, come in Rotaie o II signor Max di Camerini (film comunque pre-Freddiani) —; allora dal non-rappresentabile escano le sostanze per produrre la « rappresenta zione ». In altre parole se Gina Lollobrigida, come sostiene il Leprohon, dà qualche milione all’ANPt per girare Achtung banditi, ben vengano! Quando la letteratura neorealistica parla del Centro ricorda immanca bilmente una pattuglia di giovani, agli ordini di Barbaro, che, chiusa a chiave e sperduta nel buio di una moviola, visionava e revisionava il Potemkin. Il meccanismo del « ricordo » è analogo a quello della nascita. Non potendo ricordare ciò che è visibile alla luce del sole, il Centro nella sua struttura globale, che, tutto sommato, ha fornito i quadri specializzati per il cinema del neorealismo, si ricorda ciò che non è visibile, il buio della moviola. Venezia Il viaggio attraverso la città visibile del cinema fascista si conclude a Venezia: lussuosa dépendance dello Stato, che dal ’32, nel periodo dell’anno in cui la stagione turistica stancamente langue, vi organizza un concorso internazionale di bellezza. Già matrigna del Centro Sperimentale, Venezia diventa poi nel 143 il luogo di « villeggiatura » degli apparati cinematografici del regime, che intanto ha preso residenza nella vicina Salò. Si tenta anche di mettere in cantiere qualche film, come ad esempio La buona fortuna, Peccatori, Posto di blocco, Senza famiglia, I figli del la laguna, L’ultimo sogno. Ma, dopo Ossessione, il cinema fascista non poteva altro che tro vare la sua morte a Venezia. Con Venezia dunque si chiude letteralmente il percorso all’interno del sistema freddiano, termina la visita a quella città, materiale e fan tastica a un tempo, e concepita forse non proprio nell’ossequio dell’an golo retto e della nuda muraglia come allora si edificava. Il neorealismo, dopo vari esorcismi, si reimpossessa della città. Al cuni edifici vengono lasciati intatti come la « vetrina » veneziana o il « la boratorio » del Centro, ma in generale si cerca di sconvolgere la carta topografica della roccaforte occupata. £ un singolare gioco di smontaggio e di decontestualizzazione, è una sfida a creare una figura nuova con i pezzi di un vecchio puzzle. La città del cinema non ha più percorsi obbligati (e così abbiamo i registi che vengono dalla « scuola » del documentario), i suoi portali si
356
Il neorealismo cinematografico italiano
aprono a tutti, con grimaldelli «ellenistici, le sue strade si dilatano dalla Sicilia alle foci del Po e infine i suoi apparati diventano « servizi pub blici » reintegrati e miracolati, come si diceva prima, nel mondo della realtà.
I DISCORSI
L’ottica della ricontestualizzazione, cioè della ripresa mediata da un riaggiustamento, ci permette anche di esplorare l’universo dei discorsi, e di esplorarlo come componente (la terza) del retrotesto. Qui, è evidente, il campo da studiare è più vasto e insieme più indefinito degli altri: sot to la voce discorsi andrebbero rubricati sia la chiacchiera che l’interven to ministeriale, sia l’analisi che il progetto, sia la critica che la pubbli cità; nulla di ciò che « si dice » a proposito del cinema potrebbe essere, in linea di principio, considerato escluso. Per l’esame di questo campo — che, sia detto per inciso, è pure tanto cruciale: in esso si fissano e si manifestano con maggiore concretezza che altrove certi modi tipici; in esso si possono cogliere con maggiore evidenza ad esempio lo spessore di una questione teorica così come il risvolto di un’idea fissa — per l’esa me di questo campo, si diceva, seguiremo qui il destino di certe parolechiavi. In pratica, cercheremo di sondare la presenza nella pubblicistica — e di riflesso nel cinema degli anni Trenta — di temi quali il rea lismo, Vimpegno, il popolo ecc. Questo, lo si ripete, non per fissare poi delle facili analogie con i discorsi che il neorealismo produsse e coltivò; non per scoprire « alla fine » ciò che ci guida « dall’inizio »; ma per vedere alla lunga a quali trasformazioni e riprese si sono prestati o sono stati sottoposti certi temi quasi canonici. Quanto al problema del realismo, tre ci paiono i contesti in cui la parola, nel corso degli anni Trenta, svolge un suo ruolo. Il primo è quello dei discorsi sulla natura estetica del film: lì il realismo designa il fonda mento fotografico del cinema, la funzione meramente riproduttiva della « camera », quel momento di base che poi deve essere riscattato da una sorta di trascendenza o trasfigurazione della realtà nell’immagine. Si no ti, ciò che viene discusso non è il meccanismo di « impressione di real tà », cioè quel complesso di condizioni che fanno sì che allo spettatore che vede un film sembra vedere una scena reale, ma il fatto che il cinema sia costretto per propria natura a copiare la vita. Per propria natura: meglio, a causa della tecnica di cui si serve. Il dibattito, riprendendo puntualmente alcuni dei temi tipici dell’estetica idealista, riconosce in questo realismo di base, in questa « tara realistica o fotografica » (sono parole dell’epoca), un momento negativo, l’attimo in cui la tecnica avan za le proprie ragioni e le impone. Ad esso si deve opporre l’azione dello « specifico » cioè del montaggio (trasformato, per evitare paradossi, da
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
357
tecnica in assenza): è il montaggio che riscatta il cinema dalla schiavitù della riproduzione pura c semplice creando uno spazio-tempo ideale e soggettivo; è il montaggio che permette al cinema di essere qualcosa di diverso da « una macchina per stampare la vita », secondo la definizio ne di Thomas Mann negli anni Trenta, sovente ripresa e discussa; è il montaggio che in altre parole garantisce, al di là del realismo riprodutti vo, la purezza e l’autonomia dell’espressione artistica. I termini del dibatti to, come si può vedere, saranno in gran parte ripresi anche nell’ambito del neorealismo: essi ritorneranno in piena evidenza quando, ad esempio, si opporranno grazie a motivazioni estetiche il neorealismo al naturalismo, o il realismo critico alla poetica del pedinamento, o il realismo vero e proprio al neorealismo come esperienza imperfetta. Anche nel dopoguerra, insomma, si riconoscerà un «realismo » di base estraneo al « realismo » come arte: il silenzio sulla tecnica e l’ossequio all’estetica idealista rimar ranno due momenti fissi ancora per lungo tempo. Il secondo contesto in cui la parola realismo agisce negli anni Tren ta è quello dei discorsi sullo stile cinematografico. Viene infatti designata come realistica, anzi specificamente realistica, una serie di esperienze che vanno dal cinema americano, quello soprattutto di un King Vidor, al ci nema sovietico nel suo complesso, dal cinema tedesco, rappresentato qui soprattutto da Pabst, al cinema francese, dapprima quello di René Clair, poi quello di Carnè, di Feyder, di Duvivier c di Renoir. Certo non può che stupire l’ampiezza dei riferimenti: vengono fatti alloggiare sotto gli stessi tetti realistici (meglio poi se sono quelli di Parigi) la commedia borghese e il musical sociale, il film di mobilitazione e quello di finzione, il Potemkin e Alleluia. Ma, per rendersi conto di come l’ampiezza dei riferimenti sia motivata da un’ampiezza di significati della parola « stile realistico », basta ricordare ad esempio ciò che Vinicio Paladini, esplo ratore italiano del cinema sovietico, scrive da Mosca a proposito della Madre di Pudovkin: Il realismo di questa pellicola riesce ad esprimere sensazioni delle più metafisiche, che solo il nostro subcosciente, se vogliamo adottare il linguaggio freudiano, era fin d’ora in grado di farci provare.
O ancora, basta ricordare uno dei tanti interventi, ad esempio quello di Nicola Chiaromonte, a proposito del cinema americano: Il famoso realismo e naturalismo che distinguerebbe lo stile cinematografico ameri cano non è in sostanza che un linguaggio molto semplice per esprimere cose molto semplici, spesso elementari e povere, un tener d’occhio soprattutto gli elementi este riori della narrazione.
Ma qui non vogliamo tanto sottolineare l’ampiezza di riferimen ti e di significati — da quello massimamente inclusivo, Freud compreso, a quello massimamente riduttivo, solo semplicità — della nozione di sii
358
Il neorealismo cinematografico italiano
le realistico-, vogliamo piuttosto accennare come questa nozione, nonostan te tutto, abbia prodotto delle divisioni e dei contrasti. Da una parte, in fatti, possiamo riconoscere una difesa di principio, centrata sull’opposi zione arti Tizio/verità (ad esempio: «che il realismo sia la tendenza più vitale del cinema europeo ci sembra un fatto assodato: tutte le volte che il cinema, sdegnando la cartapesta, le corazze, gli elmi e Ie durlin dane, ha preso contatto con la vita difficilmente ha fallito il suo scopo ». E. M. Margadonna, Il realismo nel cinema europeo, 1932); dall’altra pos siamo riconoscere invece una diffidenza motivata da ragioni di prudenza e di opportunità (ad esempio: « Un cinema realistico? Certo, ma senza l’equivoco che il realismo debba per forza riflettere gli aspetti deterio ri di una società... Resta la nostra esigenza fondamentale che la vita italiana sia rispecchiata sì, anche nel suo male parziale, ma soprattutto nel suo bene collettivo e di tanto prevalente ». Pavolini, Rapporto sul cinema italiano, 1941). È inutile farlo notare: certo è che questa pola rità di interventi — difesa legata al disprezzo del finto, accusa legata al la paura di una parzialità del vero — si ripeterà puntualmente anche in ambito neorealistico, spostando però il proprio registro, ancora più de cisamente, su toni politici. C’è da aggiungere piuttosto che il riconosci mento e la designazione di uno stile realistico comporterà anche per il cinema del dopoguerra — così come per il cinema degli anni Trenta — la possibilità di servirsi di « prestiti » evidenti, la possibilità di rifarsi esplicitamente ad esperienze altrui. Come per Blasetti di Vecchia guardia (precedente riconosciuto del neorealismo) fu decisivo un film sovietico come Verso la vita •— lo di chiarò lo stesso regista —, così per il Lattuada de II bandito il fatto di riprendere certi luoghi canonici del realismo diventa chiave di co struzione del film: ricordiamo la macchietta del burocrate che può rin viare ad una analogia in La linea generale, le sequenze dei bassifondi che riprendono il « neorealismo nero » francese, la figura di Nazzari capoban dito che ricorda il cinema d’azione americano; perfino Anna Magnani rifà il verso a Jean Harlow, in ogni caso con una buona dose di ambiguità
in più. 11 terzo contesto in cui la parola « realismo » svolge il suo ruolo, durante gli anni ’30, è in rapporto ad una sorta di progetto globale: non si tratta più di difendere uno stile piuttosto che un altro, ma di lavorare per un cinema da farsi, o di esaltare come esemplari certi film o certi aspetti di un film proprio in rapporto a questo cinema del futuro. Tra i vari progetti, quello realistico non è degli ultimi: le sue emergenze sono abbastanze frequenti e abbastanza significative. Se toccherà poi al neorealismo privilegiarle e quasi mitizzarle (piegandole ai propri scopi, beninteso, facendone cioè i primi sussulti di una coscienza che alla fine si imporrà), ciò non sarà senza fondamento. L’aspirazione al realismo
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
553
è un punto tematizzato con sistematicità negli anni Trenta: i rinvii pos sibili sono numerosi; si può leggere, ad esempio, un articolo di Leo Lon ganesi apparso nel 1933 sull’« Italiano », in seguito più volte citato e ri* prodotto, che comincia così: Non credo che in Italia occorra servirsi di scenografi per costruire un film. Noi do vremmo mettere assieme pellicole quanto mai semplici e povere nella messinscena, pellicole senza artifizi, girare quanto si può dal vero. È appunto la verità che fa difetto ai nostri film. Bisogna gettarsi alla strada, portare la macchina da presa nelle vie, nei cortili, nelle caserme, nelle stazioni ...
Non sarà difficile vedere in questo testo, in seguito, una « prima volta » del pedinamento zavattiniano, né sarà difficile cogliere nelle parole di Lon ganesi l’emergere non casuale di un’esigenza condivisa da molti. Quello che allora si deve dire è che questa esigenza è fatta agire da ciascuno per fini propri, chi in senso semplicemente antiretorico, chi con scopi di rin novamento estetico, chi in chiave popolaresco-folclorica ecc. Ciò che si deve dire, meglio, è che l’esigenza di realismo non si manifesta in un ter reno franco, o insolato dal resto, o in una astratta purezza; anzi essa si pre senta come un raggrupparsi o un ordinarsi di temi diversi. Ci spieghiamo subito. I luoghi in cui si riconosce I’cmergerc del pro getto realistico sono, tradizionalmente, il gruppo di « Cinematografo » e il gruppo di « Cinema ». Tuttavia, fra le due riviste esistono alcune diffe renze: non solo di ordine cronologico — l’inizio e la fine del decennio — né solo in rapporto ad una diversità di esiti — il cinema di Blasetti e Ossessione — esse rilevano piuttosto di una diversa accentuazione, « Ci nematografo » in un senso che potremmo dire nazionale-popolare o co munque strapaesano, « Cinema » nel senso di una problematica sostanzial mente « altra » rispetto alla cultura fascista ufficiale. Accanto a « Cinema tografo » e a « Cinema » si fa poi intervenire un’altra rivista, e cioè « Bianco e Nero »: ciò che di essa si privilegia è la dimensione di « labo ratorio », di « studio »; la si recupera in quanto luogo in cui il progetto realistico incontra da una parte delle esigenze teoriche, dall’altra delle esperienze straniere « esemplari » (la lezione, teorica e pratica, del cinema sovietico). La schematizzazione qui è un po’ grossolana, ma in ogni caso serve a mostrare come il progetto realistico sia un’area di collegamento di tematiche diverse, come esso provochi e viva su accostamenti sintoma tici. La nostra indagine si sposta allora verso nuove parole-chiave: tanto per cominciare, verso quel problema di una cultura popolare che abbia mo agganciato, per un attimo, a « Cinematografo ». Un aggancio più pre ciso, qui, forse è necessario: a una rivista che non si occupò direttamen te di cinema, ma che tuttavia rappresentò una presenza di rilievo nel pa norama italiano, a « Il Selvaggio », cioè, la rivista di Maccari, punta di diamante del movimento di strapaese, impersonava la coscienza critica del lo squadrismo provinciale contro l’ufficialità di un regime ormai conso
360
Il neorealismo cinematografico italiano
lidato, era il tentativo di ritrovare e difendere le origini popolari e con * tadine del fascismo, voleva essere la barriera della provincia contro ogni fatto che potesse corrodere l’autentica tradizione e i costumi « sobri » della natura italiana. Tentativo ingenuo, soprattutto nelle sue punte pole * miche più scoperte — la denuncia del connubio fascismo-grande indu stria, l’indignazione per il «. tradimento » romano, la messa in guardia contro i pericoli del militarismo —, tentativo che si trovò ben presto iso lato e che si concluse con l’espulsione di Maccari dal partito fascista; ma ad esso conviene rivolgersi non solo per trovare il luogo in cui si elabora un concetto di popolo, o di cultura popolare, che in assenza del la riflessione gramsciana è l’unico ad agire nel corso degli anni Trenta e oltre, ma anche per ricostruire il contesto polemico in cui questo con cetto agisce. Tracce di queste riflessioni sono rinvenibili, si è detto, nel gruppo di « Cinematografo »; esse del resto non scompariranno mai del tutto dal cinema di Blasetti. Si pensi ad esempio a Vecchia Guardia, a 1860, viaggi alla ricerca delle origini popolari dell’Italia Unita e del fa scismo. Ma Blasetti non è solo: lontani e depotenziati accenti strapae sani possono essere colti anche — mettiamo — in Campo de * Fiori o in II Signor Max. Quanto alla costituzione di un orizzonte « altro » rispet to alla cultura fascista dominante, già il rinvio a « Cinema » permette rebbe la compilazione di un « catalogo degli scarti ». I temi sui quali si gioca per « differenziarsi » sono un circolo chiuso: ecco ad esempio l’op posizione giovani/vecchi (« Verrà mai quel giorno sospirato in cui alle giovani forze del nostro cinema sarà concesso di dire: I cadaveri al cimi tero? » - L. Visconti); ecco l’intenzione antiretorica (« Io penso ad un film sulle donne di servizio... Solo occupandoci del costume con maggiore coraggio noi faremo del cinema antiretorico » - C. Zavattini); ecco l’omag gio al cinema francese (la recensione di Puccini della Grande Illusione) ecc. Ma il rinvio di nuovo potrebbe essere a tutto un contesto, potrebbe portare a quegli interventi nei quali si è soliti riconoscere l’emergenza di una fronda al fascismo. Sarebbero da ricordare riviste come II Bargello, in cui l’opposizione al regime si svolse nel quadro di una complessiva ufficialità, e dove tuttavia apparvero testi — i titoli sono già indicativi — quali Storia dei socialisti di Colle o Per una coscienza politica ai conta dini di Romano Bilenchi, Letteratura e fini sociali o Lavoro manuale e la voro sociale di Elio Vittorini, Linguaggio e responsabilità di Berto Ric ci o Italia proletaria nell'impero di Vasco Pratolini; sarebbero da esa minare ancora esperienze quali quella di Primato, la rivista di Bottai che tentò un’alleanza tra intellettuali dissidenti e fascismo « di sinistra », che contò su collaborazioni sintomatiche — da Gaime Pintor a Mario Alicata — c manifestò esigenze cruciali — dall’inserimento europeo co me gesto antiautarchico alla richiesta di una risposta al disagio giovani le — così come si dovrebbero riprendere quelle riviste che agirono al li
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
361
mite dell’ufficialità — dall’« Universale » a « Corrente di vita giovani * le » —, o, più importanti per gli addentellati con il cinema, quei fogli dei guf più scoperti per la loro tendenziosità o la loro autonomia — da « Rivoluzione » di Firenze al « Bo » di Padova —. Quello che ne verrebbe fuori sarebbe il quadro complessivo in cui nasce un risoluto impegno alla revisione del fascismo come si era andato consolidando: impegno in cui agiscono da costanti l’appropriazione di esperienze anche non ortodosse e il ricordo delle origini perdute del movimento fascista, e i cui sbocchi preannunciati, che solo la guerra renderà inevitabili, sono l’opposizione esplicita e il rinvenimento di una sorta di punto zero da cui poter ricomin ciare. Altro nodo tematico, diffuso questo a livello di tutta la pubblicistica, è quello della ripresa o del rilancio o comunque della rinascita del cine ma italiano. Si tratta di un problema ricorrente, s’è detto; ma le sue punte più esplicite sono all’inizio del decennio: il cinema italiano deve ritrova re quel primato che negli anni Dieci fu già suo, deve rinnovare la propria qualità artistica e la propria capacità produttiva, deve adeguarsi alla pre sente grandezza politica dell’Italia fascista. Si vedano, ad esempio, i mo tivi che portano la critica ad emettere un giudizio complessivamente po sitivo su Sole e su Acciaio. Dei primo film si disse che dimostrava come anche in Italia ci fossero i motivi folkloristici che, se sfruttati, potevano trasformare la produzione corrente e portarla ai risultati cui erano giunti Moana e i film simili (Alberti, ex critico del gobettiano « Baretti ») o ancora che indicava come il cinema italiano passasse dall’imparare dagli altri all’elaborare posizioni proprie (Ferrata su « Soiaria »); del secondo si disse che ritrovava un fondo di genuina popolarità e lo saldava su di una vena di poesia, in modo tale da porsi come capofila di un « nuovo » cinema italiano (ancora Alberti). Non si tratta che di due esempi, ma, co me si vede, i temi del progetto realistico ci sono già tutti: ci sono quelli che abbiamo suggerito essere gli assi portanti, il tema della popolarità e quello dell’apertura all’« altro »; ci sono quelli che ci paiono i motivi ricorrenti, la necessità di una ripresa e il bisogno di guardare al reale con occhio insieme impegnato e poetico; ci sono, sullo sfondo, pronte ad essere chiarite e a provocare indicative opposizioni, le ambiguità di ba se, il non sapere se la propria azione serva a una purificazione e a una radicalizzazione del regime o se invece porti ad un’opposizione più decisiva della fronda. Il tema della ripresa, insomma, si rivela come uno dei « cor to circuiti » più significativi. Sia chiaro, la geografia dei discorsi andrebbe colta meglio. Ma a questo punto forse risulta più utile dipanare la ma tassa in un altro modo, isolando e definendo quelle figure tematiche di base che possono riproporre, ad un alto livello e con una maggior specificità il problema dei rapporti tra cinema degli anni Trenta e cinema neoreali sta proprio nei termini dell’intertestualità.
362
Il neorealismo cinematografico italiano
FIGURE DELI.’INTERTESTUALITÀ
La proposta che verrà ora fatta di alcune « figure » tematiche attraverso le quali analizzare i nodi che intrecciano il cinema degli anni Trenta e quello neorealista non comporterà alcuna formalizzazione retorica o semiotica. All’esigenza già più volte enunciata, di istituire in termini sim * Eolici ciò che per noi è il rapporto fra due testi si è parzialmente opposta nel corso del lavoro, per le esigenze specifiche di questo discorso e dell’oc casione in cui viene fatto, un’esigenza di ulteriori descrizioni, di più articolate analisi di quel retrotesto del neorealismo che è il cinema degli anni Trenta. Cade ora tuttavia, rispetto alle pagine precedenti, un tipo di descrizione che produceva, con la settorialità dei singoli approcci, re sidui obbiettivistici e illusioni di rispecchiamento. Ciò che vorremmo ora fare è mischiare un po’ le carte, sottolineare come i diversi livelli del re trotesto contribuiscono a fornire elementi che si aggregano attorno a nuclei significativi, quelli appunto che individuano dei ponti idcologico-retorici fra il cinema italiano degli anni Trenta e il neorealismo. Ponti non neces sariamente analogici e che non per essere definiti con tale metafora sta biliscono continuità di percorsi. Anzi, è il più spesso nello spiazzamento, nella decontestualizzazione, nella disponibilità a esiti nuovi e diversi che l’intertestualità si stabilisce c si giustifica. L’elenco di tali figure intertestuali è forse più esemplificativo che esaustivo: ma è comunque a migliorare e arricchire questo, e non ad ac crescere il numero delle fonti o delle determinazioni che a nostro parere si dovrà, in futuro, lavorare.
LA « QUESTIONE DELLA LINGUA »
All’arrivo del sonoro in Italia, nel disinteresse per il cinema che carat terizza, ancora per poco, 1’atteggiamento del regime nei confronti di es so, la presenza della lingua parlata non è subito intuita come un possi bile suo elemento di riscatto e ri valorizzazione. Anzi sono quelli gli an ni delle edizioni plurilingui dei film, girati più volte sullo stesso set con attori di nazionalità diverse. La lingua nazionale è prostrata e offe sa: non serve nemmeno a garantire dell’origine produttiva di un film. La chiusura dell’universo discorsivo totalitario, la macchina fraseo logica della lingua della propaganda fascista, con le sue « parole a corso forzoso », con la pietrificazione delle coppie sintattiche, con la mummifi cazione delle metafore unisce poi, come in una colata di cemento, la lin gua de! film, quella delle lodi della critica di regime e quella degli appa rati che stanno nascendo. Di Sole Mussolini dice che esso è « l’alba della cinematografia fascista ». Lo stesso film irradia d’altronde il tema della
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
363
bonifica e Luigi Freddi, nel momento in cui prende in mano la dgdc (Direzione generale della Cinematografia) dichiara solennemente che oc corre « bonificare » il cinema italiano. Se le metafore si mordono la coda, Freddi intuisce comunque la possibilità di utilizzare il doppiaggio dei film stranieri ai fini di una po litica demografica del film nazionale. Una fase di riconversione merceo logica di un prodotto viene sfruttata industrialmente attraverso il mec canismo dei buoni di doppiaggio che garantiscono una protezione del mercato e una incentivazione produttiva. Nel teorizzare il proprio inter vento legislativo, Freddi investe ideologicamente la lingua: lo stato ne detiene il monopolio giusnaturalistico. L’istituzione del buono di doppiag gio diventa più legittima della tassa sui sali e sui tabacchi. Inoltre, men tre per il destino dell’impero la lingua dei film diventa uno strumento di colonizzazione dell’Albania, del Canton Ticino, dell’Africa Orientale, ci si accorge che i film stranieri doppiati forniscono uno strumento non me no efficace per il territorio metropolitano, proprio per il loro timbro me dio, sovraregionale e adialettale. Anche se il teorico dell’autarchia lingui stica del cinema italiano non sapeva di usare, con la parola « doppiaggio », un « forestierismo linguistico orribile » che si sarebbe dovuto sostituire con « doppiato » o « doppiatura ». Così, nel cinema italiano, il dialetto diviene un reato contro lo stato, proprio come il contrabbando (e se durante il regime sarà interdet ta sullo schermo la rappresentazione del contrabbandiere, come avvenne per II grande appello, l’ideologia neorealistica dell’adempimento ripor terà nel cinema, assieme al dialetto, i film sul mercato nero e sul contrab bando: Senza pietà, Tombolo paradiso nero, La terra trema). La negazione del dialetto, la rigida sottrazione dell’impalcatura dialettale che era sta ta, come diremo subito, uno dei tratti del cinema di Pittaluga e della Cines di Cecchi, cala la lingua in un modello astorico e artificiale. La lin gua del cinema di Freddi non aveva alcuna realtà linguistica concreta su cui fondarsi se non quella della burocrazia fascista. Non si deve dimenti care che l’italiano come koinè sovraregionale non esisteva e non era cer to possibile inventarlo a colpi di veline. Come ha dimostrato Tullio De Mauro nella sua Storia linguistica dell’Italia unita, la dialettofonia era la condizione linguistica della maggioranza degli italiani negli anni Trenta. Per cospicue percentuali della popolazione meridionale della penisola, ma non solo per esse, il cinema sonoro fu la prima occasione di contatto, prima che di conoscenza, con la lingua nazionale. Tuttavia questa lin gua nazionale era un organismo fragile, delicato, perennemente sottoposto, a causa della sua artificialità e della sua creazione burocratica « ex nihilo », al ridicolo e alle iper-correzioni dei puristi. (Si veda l’articolo di E. Al lodoli, Cinema e lingua italiana, in « Bianco e Nero », aprile 1938). La lingua « nazionale » si presentava sugli schermi adorna dei fregi autori
364
Il neorealismo cinematografico italiano
tari del regime: « Per mezzo del film si possono educare quelli che ancora hanno l’orecchio c la bocca abituata al suono del servilissimo lei e abi tuarla al voi fascista in attesa di passare al tu romano » scriveva su « Ci nema » Vittorio Mussolini. Ma torniamo alla lingua degli inizi degli anni Trenta, di quel cine ma non ancora normalizzato dall’avvento ordinatore di Freddi. Abbia mo innanzitutto due film significativi, Nerone con Petrolini e La tavo la dei poveri con Raffaele Viviani, entrambi diretti da Blasetti. Nel pri mo caso una lingua di calembours e arditezze combinatorie che si fondava sul dialetto più conosciuto e diffuso in Italia, il romanesco, consolida ta dalla tradizione del varietà e dalla mimica mattatoriale dell’interprete; nel secondo caso un dialetto già più circoscritto e non a tutti compren sibile. Si avvia allora un’operazione di riconversione che fa tra l’altro della Tavola dei poveri un epitaffio al teatro dialettale e a quel cinema degli anni Dieci e Venti che era cresciuto sopra di esso. L’operazione fu né più né meno che l’invenzione della sceneggiatura in senso moder no, come ebbe a dichiarare lo stesso Blasetti giunto già al suo sesto lun gometraggio. L’impresa di « stemperare », normalizzare e tradurre la lin gua di Viviani si risolse insomma nella messa a punto di un elemento por tante del « linguaggio » cinematografico: dal copione si passò propria mente alla sceneggiatura, operando significative modifiche sul testo tea trale di partenza: eliminazione delle canzoni, maggiore articolazione del la struttura del racconto e fedeltà a modelli narrativi conosciuti ecc. Un altro film importante dal punto di vista della lingua è, sempre nel periodo pre-freddiano, 1860. Questa volta la lingua di cui Blasetti disponeva per raccontare, attraverso un protagonista contadino, l’impresa dei Mille vi sta dalla parte delle masse meridionali, era un dialetto periferico, chiuso e semincomprensibile. Un investimento metaforico del tema della parola consente allora al regista di aggirare l’ostacolo che invece 15 anni dopo Visconti, con La terra trema, affronterà frontalmente attirandosi accuse di snobismo aristocratico ed estetizzante. Il contadino siciliano di Blasetti parla pochissimo e il suo silenzio diviene l’incarnazione del mito squadri sta dell’azione. II silenzio e le frasi brevi e smozzicate del protagonista si oppongono nel corso di tutto il film alle chiacchiere dei politici, rap presentati secondo le convenzioni del qualunquismo fascista, alla loro carta stampata che un soffio di vento può disperdere, alle effigi pom pose degli uomini illustri. La lingua del silenzio troverà semmai un suo compimento retorico in una superiore dimensione di parola collettiva, l’inno patriottico e la preghiera che gli spari delle fucilazioni non posso no coprire. L’attenuazione e lo stemperamento dei tratti linguistici regionali sa rà accentuata anche dalla commedia cameriniana. Ne Gli uomini che ma scalzoni!, prima tappa pre-freddiana dell’itinerario di Camerini nel mon
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
365
do della piccola borghesia, i caratteri regionali del décor e delle situazio ni coprono alcune operazioni di trapianto linguistico (De Sica, Fattore di origine romano-napoletana che fa l’autista milanese e che sarà d’ora in avanti solo un bravo ragazzo italiano per ritornare solo nel tardo neo realismo a ricoprire ruoli caratterizzati regionalmente) e di emarginazio ne delle poche frasi dialettuali nel contorno macchiettistico dei personag gi minori. L’attenuazione del purismo linguistico si avrà solo dopo la caduta di Freddi, in pratica agli inizi degli anni Quaranta, anche se alcune avvi saglie già si manifestano con un articolo di Paolo Milano su « Cinema » nel 1938 in cui si auspica che il cinema contribuisca alla «creazione di una lingua italiana di tutti i giorni ». Si assiste al ritorno dei dialetti (i due film fogazzariani di Soldati, il cinema di Amleto Palermi e anche La nave bianca di Rossellini in cui tuttavia l’accentuazione delle varie cadenze dialettali solo per i soliti pregiudizi della critica potè essere letta come un indice di realismo: in realtà essa ha una funzione esclusivamen te simbolica e ideologica: serve cioè a significare, facendo ricorso a un vero e proprio codice, l’integrarsi nella superiore unità della marina italia na dei singoli personaggi di diversa estrazione geografica). Ben diversa sa rà l’eterogeneità linguistica dei successivi film di Rossellini in cui la pre senza degli stranieri, con le loro voci reali sarà, quando non occultata dal doppiaggio, un tratto costante e una violazione continua delle armo nie burocratiche o crepuscolari. Il « passaggio » alle dialettalità neorealistiche non è insomma trop po brusco. Ecco allora che l’ideologia neorealistica della « prima volta » viene fatta propria dai linguisti oltre che dai critici e il cinema neorea lista viene accostato come una riserva di caccia in cui puntare il fucile sulle fin troppo abbondanti apparizioni di parole inedite nei linguaggi « artistici ». II neorealismo viene letto come il cinema della permissività, delle « licenze » e delle « sciatterie », quando non come la fiera della pa rolaccia. Dal « vammoriammazzato! » di Anna Magnani in Roma città aperta al « ci ha traditi quella puttana! » del Bandito fino al « Va, a dà via ’1 cii » de II sole sorge ancora, i puristi (vedi, ad esempio, il libro di Mcnarini) trovano continue occasioni di scandalo e poco varrà che il pro fessor Carlo Battisti, interprete, preso non dalla strada ma dalla catte dra, di Umberto D., difenda la lingua del neorealismo su « Lingua no stra », la rivista ufficiale della linguistica italiana. Come sempre, l’indi viduazione, sia pure in numero sovrabbondante, di « prime volte », di emergenze eccezionali, di neologismi e di coniazioni-fantasma occulta e proibisce lo studio della lingua media del cinema del dopoguerra, del lento formarsi di una koinè sovraregionale, di un linguaggio che più che erompere violentemente sugli schermi dal fondo dell’anima popolare è il prodotto di un lento lavoro, svolto in gran parte in quei laboratori lin
366
Il neorealismo cinematografico italiano
guistici che sono le sale di doppiaggio. È forse la popolazione stessa che chiede una nuova lingua e che protesta di fronte ai film americani che giungono in Italia già doppiati da italo-americani dal linguaggio siculobrookliniano. In ogni caso ciò che si avrà sarà, almeno per tutti gli anni Cinquanta, fino all’avvento di quella discussa koinè tecnologica di cui parlò Pasolini, un compromesso fra una lingua regionale e una parlata certo meno retorica ma non meno burocratica di quella del passato regi me; il cinema neo-romano di Andreotti ne sarà uno dei primi sostegni. Da esso si dipartiranno i due filoni, non troppo dissimili forse nel rap porto tra informale e formale, della lingua dello spettacolo degli anni Cinquanta: quello della commedia all’italiana e quello della Televisione Italiana. l’italianità
Se i « direttori » erano migrati all’estero e se nei teatri di posa ormai decrepiti gli aristocratici, come racconta uno storico, si battevano a duello, il cinema italiano era vivo nei discorsi, negli auspici dei lette rati e nei preparativi di una rivista romana di cinema. Non solo il « rinascimento » era preconizzato, ma si indicavano le strade da battere, i generi peculiari, « nostri », « italianissimi ». Eviden temente la letteratura sull’argomento è, sebbene di non facile reperimen to, numerosa e si potrebbe raccogliere una nutrita collezione di materiali. Estremamente significativa è, ad esempio, questa invocazione che chiude Cinematografo. Profili, biografie, aneddoti di 90 attori dello schermo, un libro del 1928 di un critico, Mino Doletti, perdutamente innamorato del cinema d’oltre oceano: [...] bisogna fare qualche film coloniale: gli attori capaci di interpretare una calda vicenda non mancano: il film, dopo, lo potremmo mandare all’estero, dove piacerà senza dubbio. Il secondo si venderà a scatola chiusa. E si faccia un film marinaresco: di mare ce n’è tanto! La cinematografia è, in gran parte, un problema estetico: di suggestione e di estetica: e la divisa dei nostri ma rinai è troppo bella nella sua semplicità perché non debba affascinare il pubblico. Si faccia un film aviatorio: non di acrobazie aeree, ma dove ci sia il palpitare di un’elica: piacerà anche quello. E serviamoci, dopo che se ne sono serviti gli altri, della nostra storia: c'è tale tesoro di «soggetti» e di «scenari» italianissimi; che si potrà anche scegliere [...].
Mino Doletti aveva singolarmente indovinato i generi più tipicamen te italiani degli anni Trenta. La battaglia critica sul cinema degli anni Trenta ruoterà perennemente attorno alla nozione di italianità: i generi italiani, quelli di Doletti, contro i generi antitaliani, e cioè le comme die: per queste ultime la specificazione delle nazionalità (tedesca, unghe rese, americana) è indifferente. Di qui il riconoscimento che quasi tutti i cineasti dell’epoca della
Il neorealismo e it cinema italiano degli anni trenta
367
rinascita tributano al soggettista, riconoscendogli un ruolo primario quale nessuna teorizzazione sul cinema aveva mai decretato: si sentiva che, pa radossalmente, il soggetto di un film era già tutto, che una buona idea di partenza con uno spunto « italiano » costituiva l’esigenza primaria. L’italianità si configurerebbe quasi come una sfera metaideologica: il fa * scista Blasetti accetta con entusiasmo il soggetto italiano che Fantifascista dichiarato Vergano gli propone per Sole. Blasetti dichiarerà appunto nel 1933: Il primo requisito di un soggetto per film italiano è d’essere italiano; italiano nel contenuto, nello spirito, nelle conclusioni; oltre e più che nei luoghi e nelle persone della vicenda.
Tant’è vero che su ciò che non è « italiano », sul tempo delle edi zioni plurilingui e dei remake dei successi stranieri congiura un unanime silenzio storico. Pochi sanno che, nella filmografia di Blasetti, 1860 è pre ceduto e seguito da due rifacimenti di successi stranieri, Il caso Haller c La fidanzata di papà. La perdita conseguente delle copie di questi due film nasce da una sorta di stato di rimozione collettiva: quasi che lo straniero, sconfitto a Calatafimi dal contadino Carmelo e da Garibaldi si serva di una finestra degli stabilimenti della Cines per poggiare il tal lone sul suolo patrio. Gli apparati, scomparsa la vecchia e polverizzata struttura regiona le, si edificano secondo un progetto nazionale. La mappa di Cinecittà è disegnata con l’occhio a quella di Hollywood, il Centro sperimentale porterà a Roma quello che i sovietici hanno fatto a Mosca, la censura sorveglierà affinché i film stranieri non infanghino il decoro della storia patria, come ad esempio un certo filmaccio americano di Marco Polo che viene censurato e le scuole di recitazione dovranno privilegiare « i tipi italiani ». Anche lo sconcio dei registi italiani all’estero deve ormai cessare: anzi, come nel caso de Lo squadrone bianco di Genina, dirigeranno pel licole particolarmente significative. Con frequenza regolare gli intellettuali e i critici reclamano la sco perta del paesaggio italiano che permette di sposare la realtà alla Storia. Tra le venti, le cento, le mille d’Italia, c’è sempre una regione, una città, una piazza che chiede di essere filmata una « prima volta ». Tutti concla mano la necessità di un cinema « italiano »; le petizioni astratte si scon trano con le richieste concrete: all’esaudimento di una richiesta di dislo cazione, a supplire alle carenze paesaggistiche del cinema di finzione non sembrano assolvere più a sufficienza le riprese del luce che illustra le infaticabili tappe italiane delle ricognizioni di Mussolini. Il neorealismo cercherà ovviamente altri intermediari, altri garanti per il suo libero commercio con la realtà italiana. Il problema colletti vo dell’identità nazionale è filtrato attraverso un riconoscimento effettua-
368
Il neorealismo cinematografico italiano
to da stranieri: soldati americani, critici francesi, spettatori cinematogra fici di tutto il mondo. Sorge il problema di una definizione del neorealismo. Bazin, e non per aggirare l'ostacolo teorico, individua il tratto caratterizzante nell’ita lianità: « fècole italienne de la Libération ». L’italianità affermata da Bazin è vissuta dal neorealismo innanzitutto come una pluriregionalità: il cinema italiano ritrova se stesso e la pro pria matrice originaria, quella dei mitici anni Dieci delle case regionali, negando la staticità e l’immobilità del cinema dell’era fascista. Non a ca so, per rappresentare emblematicamente il cinema fascista, viene scelta l’immagine di Scipione VAfricano. Un colosso è appunto qualcosa che si muove male e a fatica, che ha un’autonomia e un raggio d’azione limi tati. Se il cinema post-bellico è rinato a Roma, cercherà di crescere nel decentramento e agli antipodi della capitale: la Sicilia di Visconti, di Zampa, di Castellani, di Germi e di Vergano è la sua latitudine ideale. La totalitarietà fenomenologica del neorealismo è intesa letteralmen te come ubiquità geografica. La sua italianità è una panitalianità: la som ma di infinite ricognizioni condotte su base regionale. Il neorealismo è un programma di perlustrazione c pattugliamento continui della penisola: Renzi, dalle colonne di « Cinema nuovo », de nuncia, per « gli impegni del realismo », il pericolo della fossilizzazione e della sedentarietà, accusando i registi italiani di viaggiare poco. Tuttavia, proprio come a scuola, il controllo dell’italianità non può esaurirsi nel voto di geografia. Quindi anche la Resistenza è recuperata come un fenomeno di neo-Risorgimento dopo la neobarbarie fascista. Il metodo dell’inchiesta, di cui Zavattini propone un uso generaliz zato, oltrepassa l’importanza del riconoscimento dell’insufficienza segna letica della cronaca per riandare rXPInchiesta Parlamentare di Sonnino e Franchetti, cioè alle origini del verismo, della letteratura italiana tout court. Ed è quindi proprio sull’italianità, sulla gara a chi è più « italiano » dell’altro, che il cinema combatterà il suo duello impari con la censu ra. Infatti l’instaurazione sempre più generalizzata delle coproduzioni e la negazione dei visti per l’esportazione ai film neorealisti costituiranno le due facce della definitiva messa a morte del cinema neorealista, attraverso la sottrazione violenta di uno dei suoi cardini strutturali: quell’ideologia non meglio specificata dell’italianità, ingrediente da cui era impossibile prescindere, e che poteva giungere ormai solo come un riverbero estero. MERIDIONALISMO
La prima immagine con cui si può introdurre il tema del meridio nalismo è quella di un’appropriazione quasi paradossale:
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
369
Dicono di King Vidor: è un americano al cento per cento. Sarà, ma io non lo credo. Io lo sento come un uomo del sud, mio consanguineo, forse, più di un piemontese, d’un lombardo, d’un veneto. I suoi connotati meridionali sono evidenti: la bocca larga, sensuale, premuta da un leggero prognatismo, lo sguardo dolce ed ermetico, linimenti arrotondati da una lievissima pinguedine. Quando ho visto Folla, un'incon scia, fulminea associazione di idee mi ha ricordato i Malavoglia di Verga.
Ma quest’immagine ne copre un’altra, più radicale: quella dell’espropriazione del Sud. La discontinuità tra il cinema di Cecchi c quello di Freddi significa anche progressiva eliminazione del Meridione dal film: I860 potrà allora apparire come un’esperienza limite sia per il suo con tenuto che per la sua collocazione cronologica. Non solo il cinema meridionale, ma ogni cinema regionale sarà poi ostacolato, così come l’accentrazione a Roma degli apparati produttivi ave va cancellato del tutto la possibilità di produzioni periferiche. Il cinema regionale potrà allora riapparire solo come elemento del tutto integra to nell’ordine del genere: non potrà che essere un cinema di maschere (e si ricordano Totò e Angelo Musco) o un cinema di canzoni. Ma la ve ra riappropriazione del Sud si appoggia piuttosto al grande modello della « Conversazione in Sicilia », dove si accordano in un’unica nota il ritorno al la terra madre, il senso della mediterraneità come sovra-cultura, la percezio ne di astratti furori e di nuovi doveri. In questa luce si può forse collocare — è un nesso puramente sintomatico — il recupero di Verga del gruppo di « Cinema »: avvisaglia più che di un vero e proprio filone che il neo realismo, con la logica dell’« adempimento », privilegierà, di un’esperien za come quella de La terra trema. Ma proprio il film di Visconti ci mo stra come la contraddizione sia solo spostata: il neorealismo, nel suo ten tativo più radicale, nel suo viaggio più profondo, deve anche registrare la sua delusione più cocente. La terra trema è un insuccesso: il film si ferma al primo episodio, viene accusato di snobismo da una parte della sinistra, è difficile da vedersi a causa di una difficile circolazione. Meglio allora il compromesso: il film viene doppiato e riportato a una durata commerciale; meglio allora il compromesso esemplato dal patteggiamen to di Germi dentro e fuori In nome della legge, ma attivo ben prima di Germi. Dopo O sole mio, dopo cioè che si son fatti convivere la forma del film musicale folklorico e il racconto resistenziale, dopo che si sono fatte le quattro canzoni di Napoli, il filone meriodionalistico si spezza in due: da una parte chi insiste sul modello neorealista (Germi, De Santis ecc.) dall’altra chi sfrutta le tematiche nella loro valenza di genere (Ben venuto Reverendo, Terra senza tempo, Il lupo della Sila fino a coprodu zioni italo americane quali Vulcano). Ma è proprio in margine a questo meridionalismo diventato genere che si possono rilevare almeno due fat ti interessanti: la rinascita se non di una produzione, di una distribuzio ne regionale (certi film sono così sfruttati in rapporto a un pubblico geo grafico che può essere illimitato come delimitato il cinema italiano a tut-
370
Il neorealismo cinematografico italiano
to il mondo, al meridione il suo cinema) e l’applicazione « altrove » di modelli ritenuti specifici (sforzando un po’, ad esempio la questione agra * ria « trasferita al nord »: Caccia tragica o Riso amaro).
SOCIALITÀ E POPULISMO
Il tema della socialità costituisce un’altra figura intertestuale, ma una figura simile a quelle che si ottengono con il caleidoscopio: la sfac cettatura e la giustapposizione vi celebrano uno dei loro trionfi. Socialità come? Innanzitutto come storia di una comunità che il fascismo trasfor ma o cui il fascismo insegna qualcosa (Camicia nera, Vecchia guardia). Si tratta di un aggiornamento del tradizionale schema del Deus ex machina, che a ben guardare anche il cinema neorealista utilizzerà, con una dire zione però rivolta « all’interno » (le soluzioni non vengono dal fuori, ma dal riconoscersi proprio come gruppo). Le comunità tipo, nel cinema fascista, sono quelle militari e quelle rurali: il riconoscimento è equamen te distribuito tra « l’Italia che combatte » e « l’Italia che lavora ». Ma questo secondo caso ci porta anche ad un’ulteriore specificazione del con cetto di socialità; ci porta a definirne una delle latitudini, la campagna in cui agiscono i butteri di Sole o l’officina in cui lavorano gli operai di Acciaio. Ci porta ancora a fissarne delle varianti: da una parte il riscat to degli umili e degli sfortunati (gli emigranti di Passaporto rosso o quel la che avrebbe dovuto essere secondo Barbaro — se ne confronti la re censione — la servetta di Sissignora)-, dall’altra il riconoscimento di un proprio dovere e il recupero di una tradizione (Terra madre, Squadrone bianco). La dimensione che allora confluisce in questa socialità è quella del populismo: le sue suggestioni si ripropongono continuamente secon do figure fisse (dalla valorizzazione generica del lavoro all’interclassismo, dal sogno di una terra di nessuno da conquistare e bonificare all’idea di una piccola proprietà come rifugio c nido). Il discorso andrebbe allarga to: i temi del populismo ci permetterebbero dei collegamenti significativi, unendo dei punti di origine, il discorso del socialista Pascoli a favore del la guerra di Libia (La grande Proletaria si è mossa) ad uno dei luoghi canonici, il neorealismo umanistico di uno Zavattini o i! cinema rifor mista di un Germi; e questo passando attraverso una terra resa zona franca, il fascismo « di sinistra » imbevuto di temi come quelli già citati a proposito di Strapaese (l’antiborghesismo, l’antimilitarismo, la popo larità ecc.) o disposto ad avallare (il salto al cinema non è casuale) ope razioni quali Scipione solo perché con le comparsale si dà lavoro ai sot toccupati di Sabaudia (e l’argomentazione non sarà diversa di molto da quella che porta ad una assoluzione di principio di Fabiola, nel dopoguer ra, solo perché per due anni la produzione ha utilizzato dei tecnici ita
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
371
liani). Dato che si è parlato di antiborghesismo, si dirà anche che esso costituisce una sorta di prova del nove della socialità del cinema fasci sta. I suoi topoi sono le conversioni (L'assedio dell’Alcazar, Giarabub) e le delusioni (Il signor Max, Cavalleria): entrambe, staccando dal mondo borghese, fanno trovare dei legami più autentici. Percorsi simili, è appena il caso di dirlo, saranno consueti anche al cinema neorealista, ma lì la so lidarietà trovata si specificherà essenzialmente come una solidarietà anti burocratica. Quanto ancora all’antiborghesismo, bisogna anche dire che lo si ritrova negli anni Trenta in affermazioni di principio (« Esiste una lotta antiborghese nella quale il cinema è il grande assente » - Zavattini) o in certe letture critiche (« ... in conclusione René Clair, che ha pro fondamente intuito il valore collettivista del cinema, spiega il suo senti mento in una critica antiborghese » - Alberto Consiglio): di nuovo dei modelli che nel neorealismo diventeranno standard. Ultima faccia della socialità, il cinema come arte del proprio tempo. Il motivo è tematizza to soprattutto da Barbaro (e il personaggio è sufficiente a suggerire la fi gura di passaggio al neorealismo): ed è svolto sia come esaltazione del film come lavoro di gruppo, di contro una nozione d’autore isolato e auto nomo, sia come ritrovamento di una marca quasi ontologica (« Il cinema [...] questa grande arte fatta per il popolo [...] sarà dunque l’arte della civiltà collettivistica »). Ma la socialità, appoggiandosi all’idea di gruppo, può anche diluirsi e stemperarsi: si vedano i film scolastici e collegiali, con il loro camera tismo adolescenziale e rosa, scolorimento della figura forte della sociali tà fascista, il corporativismo; e pronti di nuovo ad essere ripresi come genere del neorealismo.
LA RICOSTRUZIONE
Il cinema neorealista si presenta, in Italia ma soprattutto all’este ro, come il cinema della ricostruzione morale e materiale del paese. Il riacquisto di una dignità democratica va di pari passo con l’edificazio ne dell’Italia nuova dopo la distruzione della guerra. La tematica della ricostruzione è una delle componenti fondamentali anche c in particolare dell’ideologia della sinistra. L’editoriale n. 3 di «Rinascita» (1944) fa appello alle forze sane della nazione perché la distruzione del fascismo sia una stessa cosa della « ricostruzione dell’Italia in uno spirito di soli darietà nazionale e negli interessi della totalità del popolo » e Togliatti intitola Ricostruire innanzitutto il suo discorso al Convegno economico del PCI del 21-23 agosto 1945 in cui chiama gli italiani a una ripresa della produzione ed esclude risolutamente una politica che conduca a so luzioni « catastrofiche ». Nella pubblicistica cinematografica la battaglia
372
Il neorealismo cinematografico italiano
è condotta contro le due metafore che più minano il progetto ricostrut tivo: l'allagamento dei film americani e più tardi lo smantellamento de mocristiano del circuito pubblico. Ma questo tema della ricostruzione, co me si è già accennato, è per lo meno altrettanto presente in tutto il cor so degli anni Trenta. Esso si inizia col ritorno dei registi italiani in pa tria, dopo che negli anni Venti molti erano stati costretti a lavorare all * estero: Genina, Camerini e Righelli che viene chiamato per girare il pri mo film sonoro italiano, incominciano a edificare una cinematografia con l’animo dei pionieri della sperimentazione. Sole è considerato, come si è detto, il film della rinascita del cinema italiano, nel 1929. L’anno dopo si avrà La canzone dell'amore, e nel 1931 la fondazione, da parte di Bragaglia e di Blasetti, della prima scuola nazionale di cinematografia, oltre a un film emblematico già dal titolo, Resurrectio, in cui la sperimentazione tecnica è particolarmente importante e in cui si annuncia, a livello dei contenuti, un peculiare aspetto dell’ideologia della ricostruzione: la ri costruzione morale dell’uomo e del carattere, la rinascita spirituale del l’uomo nuovo. Questo tema ritornerà in Lo squadrone bianco, Cavalleria, Luciano Serra Pilota, e marginalmente, in altri film di guerra (L'assedio dell'Alcazar e Giarabub) accompagnando quello della ricostruzione del l’industria e del territorio: Acciaio, Camicia Nera o dell’indipendenza eco nomica nazionale (Passaporto rosso). Soprattutto Cavalleria è esempla re per far coesistere le due facce, morale e materiale, dell’opera di rico struzione: la « guarigione » di Nazzari da un amore impossibile accom pagna e aiuta l’edificazione dell’aereonautica, arma nuova dell’esercito ita liano. Quanto all’operazione di ricostruzione, condotta attraverso la Dire zione Generale della Cinematografia, già se ne sono descritte le finalità e gli strumenti: resterebbe da completarne l’ideologia, se non fosse già troppo facile lasciarsi trasportare dall’ironia quando si legge di una « Vo lontà che non conosce soste », naturalmente quella del Duce a cui va il merito finale della ricostruzione del cinema italiano o dei « formidabili mezzi dello Stato Fascista », pari forse a quelli, altrettanto potenti, che una battuta di moda qualche anno fa attribuiva alla televisione italiana. Dal periodo freddiano in poi ogni affermazione sull’industria e sulla cinematografia in genere si ammanta di quell’ideologia della magniloquen za che, guardando sempre a un passato di grandezza (Cabiria) da rein tegrare, ha il suo esito (filmico) nel kolossal (da Scipione l'africano alla Corona di ferro a Noi vivi). Se la ricostruzione fascista è autocompiaciuta e narcisistica, più tor mentata è invece la psicologia della ricostruzione neorealistica. Da una parte essa (e in ciò qualche analogia con il cinema di Cecchi effettivamen te permane) chiama a raccolta le forze fresche, i nuovi letterati, gli uo mini veri non bacati dal tarlo divistico (la fine del divismo è anche un
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
yiy
atto politico: la fucilazione degli attori fascisti Osvaldo Valenti e Luisa Fetida); dall’altra il cinema pare compiacersi di frugare nelle piaghe della nazione, come se la redenzione non potesse avvenire che dopo aver sce so fino in fondo la scala della distruzione e del putridume. (« Siamo strac ciati? Mostriamo a tutti i nostri stracci. Siamo sconfitti? Guardiamo in faccia i nostri disastri [...] Paghiamo a tutti i nostri debiti con un fe roce cuore di onestà » scrive Lattuada nel ’45). La sintesi di queste due vie della ricostruzione non tarda però a ve rificarsi, il coraggio d’aver mostrato il proprio vero volto viene ricompen sato dall’afflusso di nuove forze fresche: il capitale americano, gli attori stranieri (la Bergman, all’apice della carriera, che scrive a Rossellini chie dendo di fare un film con lui). Il cinema ricostruito, e non solo con la cartapesta, ha ora un mercato, avrà presto una legislazione e un’in dustria efficiente: potrà così, anche se sarà la fine del neorealismo, com piacersi di se stesso con i film sul cinema (Bellissima, La signora senza camelie) privilegio delle cinematografie solide e fiorenti.
PROFESSIONISMO E NON PROFESSIONISMO
L’immagine corrente di un cinema neorealista fatto di improvvisa zione, scarsità di mezzi, furti alla realtà e fede incrollabile ha come co rollario un’immagine del cinema degli anni Trenta connotata con segno opposto. Ma l’indiscutibile alta professionalità del cinema del Regime è un risultato ottenuto soltanto al termine del suo cammino. Gli inizi degli anni Trenta, infatti, conoscono una fase di imprenditoria ora effimera ora abborracciata ora trufialdina, caratterizzata anche da debutti incontrol lati: insomma c’è più pionierismo che mestiere. Anche la solida impre sa artigianale della Pittaluga presenta qualche smagliatura da cui affio ra improvvisazione professionale. Ma qui almeno il dilettantismo è ampia mente ammortizzato da esiti sperimentali, che ne rappresentano appunto l’altra faccia. Il sistema instaurato da Freddi (che per ironico gioco delle parti arriva quasi casualmente al cinema, lui aviatore frustrato e inviato spe ciale ai raids intercontinentali) professionalizza i cineasti a due livelli: a. con il Centro (Il Centro sperimentale [...] se dà la possibilità di riuscita a coloro che sono attratti verso il cinematografo da una vera passione e non da futili esteriori motivi, rende anche un grande servigio alla società disilludendo per sempre i fanatici, gli inetti, gli squilibrati e tutta quella specie di ingenui che, come farfalle volano attorno al fascio luminoso correndo il rischio di bruciarsi le ali. Per gli altri, invece, il cinematografo, con la istituzione di questo originale organismo, diviene una professione come tutte le altre, da affrontarsi con la stessa serietà e con la stessa volontà. • Chiarini);
374
Il neorealismo cinematografico italiano
b. con la pianificazione del lavoro che permette una continuità ope rativa, conditio sine qua non della specializzazione. Contemporaneamente e a lato dell’organismo freddiano sorgono luo ghi capaci di assorbire approcci non propriamente professionali col mon do del cinema (l’amatorismo dei Cineguf o la cinefilia del gruppo mila nese che giunge a costituire una cineteca) ma che tuttavia testimoniano dell’ampiezza e della partecipazione specifica che il fenomeno ha ormai raggiunto. Alla fine degli anni Trenta il cinema italiano raggiunge indubbia mente un alto livello di specializzazione, tanto che dalle pagine di « Ci nema » si tuona con disprezzo contro i « mestieranti ». Il neorealismo riceve dunque una preziosa eredità fatta di quadri tecnici e artistici qualificati. Ma a questo punto scatta una delle sue com ponenti ideologiche che è quella di mascherare la professionalità per non negare alla realtà la capacità autonoma e provocatoria di parlare. Naturalmente la situazione è molto più complessa e contradditto ria di quanto si tenti di tratteggiare. Ad esempio è vero che durante il neorealismo si mettono in piedi produzioni non professionistiche ma sono casi che costituiscono più l’eccezione che la regola. Al termine di questa breve scheda vorremmo proporre due esempi che sono abbastanza paradigmatici ai fini del nostro problema: gli « at tori presi dalla strada » e il caso Zavattini. Una delle prove del nove esibite con più frequenza dal cinema neo realista per documentare la marca realistica del prodotto è appunto quel la degli attori presi dalla strada. A parte il fatto che si tratta di casi mol to reclamizzati ma poi non così numerosi come comunemente si crede, essi non sono affatto discriminanti tanto è vero che negli anni Trenta si contano parecchi film con attori non professionisti. Si pensi a Sole, Acciaio, 1860, Stadio, I trecento della settima, Camicia Nera e i film di De Robertis e di Rossellini. Forse sarebbe più interessante impostare il discorso sull’uso di un diverso tipo di professionalità attorica. Negli anni Trenta il teatro è il na turale serbatoio per il cinema, mentre nel neorealismo si cominciano ad usare attori nati nel cinema. Ma l’excursus devierebbe di troppo il sen so di questa nota. Quanto a Zavattini, è interessante notare la dissociazione che carat terizza la sua personalità e che può veramente simbolizzare, nella sua dialetticità, il rapporto che stiamo affrontando. Zavattini è senz’altro uno dei pochi sceneggiatori italiani fornito di legittima patente professionale: ha lavorato con moltissimi registi, ha scritto per tutti i generi, sia negli anni Trenta che nel dopoguerra. Eppure dal ’45 in poi Zavattini teorizza conti nuamente il proprio suicidio professionale: rogo dei soggetti, morte dei generi, teoria del pedinamento, la realtà che parla da sola ecc....
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
yjj
È questo un altro aspetto di quelle tendenze masochiste che percor rono il cinema neorealista, gesti autopunitivi per la verità più esibiti che sofferti, come un cilicio indossato sopra la camicia.
DEFINIZIONI
La descrizione, sia pur affrettata e incompleta, del quadro interte stuale che rende conto dei rapporti tra cinema degli anni Trenta c neorea lismo, l’individuazione di figure che, attraverso prelievi da registri diversi di un testo, mediano i rapporti fra questo e il testo storicamente succes sivo, consentono di vedere chiaramente la riduttività dell’alternativa frat ture-continuità, la sua sostanziale inadeguatezza per spiegare il passaggio tra questi due momenti della storia del cinema italiano, per quanto ampio sia il ventaglio delle fonti che viene indagato. Ma l’operazione di analisi e di rapporto fin qui condotta risulterebbe monca se non osasse affrontare, almeno in via di ipotesi, un primo tentativo di definizione del neorealismo proprio in base al suo statuto intertestuale. Occorrerà qui aprire una breve parentesi che prenda in esame le definizioni che sono state date finora del neorealismo. Senza la pretesa — né la ne cessità — di doverle elencare tutte, basterà osservare che esse tendono tutte verso due poli apparentemente opposti: del neorealismo oggi sono disponibili solo, ma in compenso in grande quantità, definizioni positivi stiche o definizioni umanistiche. Quanto alle prime, sono quelle che mettono l’accento sul carattere sociale del film neorealista, cosicché il passaggio a un cinema di messaggi murali ne determinerebbe la fine (Aristarco e in genere molta critica di sinistra). Essa è costituita da opere « in presa diretta » con la realtà sociale (Borde e Bouissy), è uno « specchio spietato dei nostri tempi » (Serandrei), è « una grande partita con la verità » (Lattuada), « inaugura lo studio di un vero mondo di relazioni » (Ferrara), è « l’obbiettività, in tesa come ricerca e scoperta delle relazioni organiche della natura e del l’esistenza », è la sua « grande parola » (Brunello Rondi). Per non par lare, naturalmente, di tutti i riferimenti alla cronaca, alla registrazione del reale ecc. Ancor più abbondanti, e non solo presso la critica idealisticocattolica ma anche in molti studiosi « laici », oltre che nelle dichiarazioni degli autori, le definizioni di tipo umanistico. Bazin: « Il cinema italiano è certamente il solo che salva nel cuore dell’epoca che esso dipinge, un umanesimo rivoluzionario ». Agel: « Il neorealismo è legato al canto profondo dell’anima italiana ». Howald: « Quando si cerca di definire il neorealismo [...] una parola sola sempre la stessa propone ossessivamente la sua presenza calda e fraterna. Questa parola è la parola Uomo ». Gian Luigi Rondi: « Il neorealismo non è
376
Il neorealismo cinematografico italiano
un’interpretazione servile della realtà, ma una visione umana; esso non è democratico o marxista ma essenzialmente cristiano ». De Sica: « Ciò che mi interessa è l’uomo, il cuore dell’uomo ». Bernari: Il neorealismo è « l’amore dell’uomo per l’uomo, l’amore dell’uomo per la storia dell’uo mo ». Tallenay: « La chiave del neorealismo è l’amore degli uomini ». Zavattini: « Il neorealismo mi ha aiutato a pormi il problema di Dio, dei buoni e dei cattivi ». Fellini: « Esiste un legame comune alle varie ten denze neorealistiche [...] ed è l’amore per l’uomo concreto e per la sua vita ». Non abbiamo intenzione di fare un discorso sulle ideologie del neo realismo e quindi non ci interessa propriamente commentare queste defi nizioni quanto osservarne alcune costanti di struttura. Alcune osservazioni tuttavia si impongono: innanzitutto esse solo apparentemente fanno ricorso a diverse aree concettuali e ideologiche; in realtà la via positivistica e la via umanistica conducono entrambe alla stessa meta e spesso corrono ap paiate (Brunello Rondi « Si trattò di un nuovo rapporto dell’uomo con la realtà storico-naturale, di nuove relazioni umane, di nuove forme orga niche e narrative, etiche ed estetiche attraverso le quali un uomo nuovo vuole affacciarsi e formarsi con la propria realtà, con nuove disposizioni organiche », o più sinteticamente Rossellini stesso: « Il neorealismo è soprattutto l’arte della constatazione. È quindi prendere un diretto con tatto con l’uomo »). Positivismo e umanesimo sono infatti da sempre la coppia ideologica dell’idealismo e nel campo dei discorsi sulle pratiche artistiche essi si rivelano sempre come tendenze di fuga dal testo e dalla sua concretezza materiale. Ciò fu particolarmente evidente nel caso della riflessione sul neorealismo: la linea di sviluppo del cinema sulla via del realismo, una volta raggiunto il suo esito estremo, non poteva che attra versare l’ultimo esile diaframma che separava il cinema dalla realtà (o dal l’uomo) per disperdersi in essa: la teleologia idealistica era un’uscita dal testo e dal cinema (Bazin: « Ladri di biciclette è uno dei primi esempi di cinema puro. Niente più attori, storia, messa in scena, cioè finalmente nell’illusione estetica perfetta della realtà: niente più cinema »). Ma, si è detto, ciò che ci interessa delle definizioni elencate è anche la loro struttura: esse, col loro individuare un carattere essenziale, suffi ciente a definire l’intero fenomeno, spesso racchiudibile in una parola-chiave dimostrano come in definitiva tutte accettino la nozione di rottura totale nel suo senso più esteso. E cioè: si parli pure delle altre cinematografie per cercare fonti e origini, ma quando si tratta di dare una definizione, il neorealismo è sufficiente a se stesso, contiene in sé, e solo in sé i carat teri che bastano a definirlo. Le definizioni essenzialisticbe escludono ogni definizione in termini relazionali. La nostra opinione è che — e per chi ancora ci crede ciò valga come affermazione di una certa continuità — non si può definire il neorea
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
yn
lismo senza fare riferimento al cinema degli anni Trenta. I mutamenti di problematica che si erano annunciati all’inizio e che sono stati di volta in volta un nuovo campo teorico o una diversa ottica si presentano ora come una diversa definibilità dell’oggetto. Già le pagine dedicate all’ana lisi delle figure intertestuali avevano mostrato come i caratteri del neo realismo si generino dal prelievo differenziato e dalla decontestualizzazione di molti elementi propri del cinema degli anni Trenta. Queste differenze di assetto potranno ora, in sede di prima ipotetica definizione, essere rias sunte nell’affermazione che il neorealismo è la messa in disordine degli anni Trenta. Non solo per il fatto di essere un cinema fascista, quello degli anni Trenta fu un cinema d’ordine: si è già detto come, alla rigidità della legislazione e all’efficienza delle strutture industriali c degli apparati si accompagnasse la fine di una certa sperimentazione, una ferrea articolazione per generi, un ruolo del cinema non casuale rispetto agli altri media, ma anzi ben incastellato in una gerarchia di dominanze e dipendenze (cfr. l’azione di Freddi nei confronti della stampa e della pubblicità a servizio del cinema). ORDINE E DISORDINE
Dire che il neorealismo nasca in una situazione di disordine non è certo una novità, è anzi quasi un luogo comune. Il disordine cui si fa di solito riferimento è non solo quello sociale e morale prodotto dalla guerra e dalla lotta di liberazione intesa come guerra civile (e l’ideologia ciellenistica è un ulteriore elemento di confu sione) ma è spesso un disordine cinematografico: Cinecittà inagibile, man canza di mezzi e attrezzature dopo le razzie dei tedeschi, legislazioni con traddittorie (l’unico atto legislativo del dopoguerra immediato, il decreto luogotenenziale del 5 Ottobre ’45, Governo Parri, è un atto di totale abrogazione della legislazione fascista sul cinema, ma che fa così coesistere la legge del ’23 con le ancora valide norme fasciste di PS e in pratica pro duce una situazione di anarchia, aprendo le porte all’eterogenea invasione dei film americani) ma lo stereotipo critico vuole che da questo disordine diffuso nasca l’ordine del singolo film, il capolavoro per definizione classico e armonioso, magico equilibrio fra realtà e immagini, luogo di ricompo sizione — nella superiore armonia dell’arte — dei conflitti e delle contrad dizioni. Un’ideologia miracolistica che costella tutto il neorealismo, il quale ben potrebbe essere considerato, al contrario del cinema freddiano, un cinema di miracoli (basti pensare a Rossellini, alla sua « conversione » prodotta da un evento venuto dal cielo, ai miracoli di cui sono pieni i suoi film alla « guarigione » dei rivistaioli Magnani e Fabrizi in Roma Città Aperta ecc.).
378
Il neorealismo cinematografico italiano
Pensiamo invece che il cinema neorealista non si limiti a nascere dal disordine ma che sia esso stesso il cinema del disordine, il livello a cui più ci interessa verificare questa ipotesi è quello linguistico che si accentra at torno alla nozione di genere. Si è detto che il carattere d’ordine, dal punto di vista semiotico, del cinema degli anni Trenta, è la sua strutturazione in genere. In che cosa dunque il cinema neorealista non è un cinema di generi? Bisogna dire innanzitutto che la critica e la storiografìa mostrano di essere almeno con fusamente consapevoli di questo carattere in almeno due occasioni. Primo, quando si tratta di giudicare quali siano i film neorealisti rispetto alla to talità della produzione del dopoguerra; ecco allora che l’altro del cinema neorealista è considerato appunto il cinema di genere, cioè la continuazione lineare e senza scarti dei generi dell’anteguerra: i film operisti di Gallone, il varietà-burlesque di Totò, i film musicali, le commedie, i film in costume ecc. Secondo, quando si tratta di indicare l’esaurirsi del neorealismo; e si osserva allora che il neorealismo diventa un’altra cosa appunto quando de-genera in « filoni », quello « rosa », quello « pauperistico », quello pro vinciale ecc; ma è l’analisi dei singoli film neorealisti che può dimostrare (e qui ci limiteremo a qualche accenno sulla base dei ricordi, in attesa di una rilettura di tutti i film) la costante inter-genericità del neorealismo. Ricordiamo per ora Roma città aperta, che per quasi tutta la sua prima parte è una commedia e addirittura un film comico prima di diventare un film drammatico, una tragedia classica e un film resistenziale. Pensiamo a quel pastiche di film bellico, di pittura sociale, e d’av ventura con un perfetto finale western che è II sole sorge ancora. E, quanto a Paisà, l’eterogeneità di alcuni episodi rispetto ai moduli del film di guerra (primo fra tutti l’episodio dei frati, giudicato spesso un’avvisaglia della commedia all’italiana) è senz’altro riferibile a una compresenza di più generi del già spezzettato mosaico del film. (Bazin parla di episodi buffi — patetici o tragici che non hanno in comune che il fatto di riallacciarsi alla Resistenza). Di solito, quando la critica ha osservato — ma i casi sono stati rari — questo carattere del neorealismo, di non essere cioè un cinema di generi o di costituire qualche cosa come un supergenere, ha motivato il suo giudizio nella maniera più ovvia: il cinema neorealista si fonderebbe direttamente sulla realtà e non su un repertorio di convenzioni qual è quello dei generi. Bazin afferma che « l’estetica stessa del neorealismo gli impedisce per essenza di ripetersi, come accade per i generi tradizionali ». Alla con siderazione di un neorealismo non di genere perché ogni volta originale e irripetibile noi contrapponiamo invece quella di un neorealismo che uti lizza ampiamente i materiali e le formule dei generi tradizionali, ma in aggregazioni inedite e con fondamentali decontestualizzazioni.
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
379
Non diversamente avveniva, in quegli anni, anche in altre « serie » diverse di quella artistica, per esempio in politica: il cln è appunto un’ag gregazione provvisoria di generi (partiti) quasi tutti preesistenti, il togliattismo è l'aggregazione e la solidarietà provvisoria (ma questa è stata una provvisorietà di più lunga durata e non se ne vede ancora la fine) delle classi sociali tutte chiamate a collaborare alla ricostruzione del paese. Già Bazin osservava in fondo che in tutti i film neorealisti c’è sempre un marxista e un prete, e Borde e Buissy descrivono su basi politico-ideo logiche la dissoluzione del neorealismo che dopo il ’50 si dividerebbe nei tre filoni: umanista (De Sica), cristiano (Rossellini, Genina, Fellini) e marxista (Lizzani, De Santis, Visconti, Maselli ecc.). Il disordine del cinema neorealista consiste insomma, ci pare, in una sostanziale eterogeneità ideologica (su cui ci sarebbe da dire molto di più), semiologica (la questione dei generi), produttiva (il coesistere di profes sionismo e non professionismo, il ritorno delle produzioni cooperativi stiche e miste), politica (tra gli sceneggiatori di un film « si trovano rego larmente i nomi di un comunista c di un democristiano », Bazin), tecni ca (la crisi della sceneggiatura, dell’illuminazione classica, del « sistema » panoramica-carrello, della figurazione ecc.), estetica (« crisi delle poetiche e delle grammatiche »), critica (in « Bianco e Nero », « Cinema », « Se quenza » si ha un totale pluralismo critico. La critica di tendenza si avrà solo dopo il ’50 con « Cinema Nuovo », « Filmcritica », ecc.). Ancora una volta l’immagine più adeguata è di origine baziniana: Phot jazz pare essere effettivamente un riferimento pertinente per il ci nema neorealista. Ciò che stupisce è che in questo periodo di eterogeneità così totale abbiano potuto prosperare le teorie dello specifico filmico e che l’illusione realistica abbia giocato un ruolo così forte da far affermare (per esempio, a Chiarini) che il cinema era tornato a Lumière, era final mente un cinema puro. Ci sentiamo invece di condividere maggiormente, di fronte al neorealismo, la frase dei qualunquisti e dei reazionari di fronte ad ogni tentativo nuovo, a ogni proposta di avanguardia: « ma questo non è cinema! ». TOTALITÀ E INTER MEDIO LOGIA
Il neorealismo come « non cinema » o « non solo cinema », il neo realismo come « cinema totale »: due tesi che, ancora una volta, sono unite da una solidarietà più forte di quanto indichino le apparenze. La no zione di totalità, in epoca neorealistica, non agisce solo negli scritti di Bazin (in cui appunto essa congiunge il punto di massima specificità del cinema con la sua fine in quanto cinema) ma è viva in molti critici del dopoguerra a indicare insieme un cinema che nulla esclude dal suo sguardo,
380
Il neorealismo cinematografico italiano
che non preselezione né a livello ideologico né a livello di stile e di scrit * tura, e un cinema che rappresenta « una sintesi storica della nostra epoca » (Ferrara), « la storia di tutti » (Lizzani), la « verità totale del reale », (Rondi) ecc. La tesi è poi particolarmente presente a livello culturologico: il cinema neorealista non è più sentito come un campo di cui hanno respon sabilità i soli cineasti, ma come un patrimonio di tutti gli uomini di cul tura, in cui tutti devono impegnarsi (e lo faranno: il vero fenomeno dei letterati al cinema ci pare più neorealista che entre deux guerres) perché il cinema è divenuto ormai una totalità culturale, assorbendo succhi dalla filosofia, dalla letteratura e dalle altre arti. Si trovano così a coesistere nella critica e nella riflessione teorica dell’epoca neorealista due coppie concettuali: quella di cinema totale dal punto di vista ontologico — teo riche dello specifico — e quella di cinema totale dal punto di vista cultu rologico — teoriche della sintesi. La vecchia idea di Canudo del cinema come « sintesi delle arti » conosce infatti in questo periodo un certo rilancio. All’ipotesi di una totalità ontologica e a quella di una totalità cul turologica noi vogliamo invece opporre un’ipotesi di totalità che non con traddice alla nozione di disordine sopra descritta e che anzi, nel portare a termine la definizione di neorealismo, trova, di quel disordine che ci pare così costitutivo di essa, nuovi aspetti e specificazioni. Parleremo allora di una totalità mediologica descrivendo e definendo il cinema neo realista come una totalità eterogenea di più media, come il provvisorio aggregarsi di vari media tecnologici che erano nati e si erano perfezionati nel loro impiego sociale nel decennio precedente e che, dopo il neoreali smo, si istituiranno in specifici apparati ideologici, di nuovo relativamente isolati gli uni dagli altri. L’affermazione che il cinema neorealista non è solo cinema, o non è più cinema, perché esso è insieme cinema, radio, rotocalco, e anche televisione, è forse paradossale ma non scandalosa, se non altro perché vogliamo proporla solo come ipotesi, fornita di certe pezze di apoggio, ma non ancora compiutamente suffragata da una rilettura completa dei film fatta in questa prospettiva. Essa ci interessa tuttavia, e faremo fatica a lasciarla cadere, perché consente una defini zione del neorealismo peculiarmente antiessenzialistica, in cui le specificità sono reciprocamente contraddette e in cui si radicalizza la descrizione intertestuale. La differenza più evidente fra l’ipotesi intermediologica e la nozione di « sintesi delle arti » sta nel fatto che i media che il neorealismo fa coesistere non sono quelli tradizionali: pittura, scrittura (letteratura), mu sica, teatro, ecc. ma sono appunto, come si è accennato, i nuovi media tecnologici, i media della registrazione. Questa parola, così frequente nella letteratura sul neorealismo e così densa di connotazioni idealistiche, vo
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
381
gliamo accettarla solo nel suo senso tecnico, quando essa indica una traspo sizione mediologica e mater iologica: la luce diviene colore, il suono diviene grafo o incisione ecc. Il problema del realismo, e cioè dell *« Hi-Fi », è solo un problema successivo. Il carattere tecnologico dei media del neo realismo è sottolineato dal fatto che nel dopoguerra i media non tecno logici diventano soggetti, canoni, marche di genere, per i film non neorea listici, specie quelli che ne costituiscono la controparte più diversa e più disprezzata: i film musicali, sia d’opera sia di canzonette, i film-varietà (Totò, Macario, Taranto ecc.) i film letterari (Soldati), il teatro filmato, (il circo, ecc.) Saremmo costretti ora, per le esigenze accademiche della « dimostra zione » a spezzare l’unità mediologica del cinema neorealista e a est rame, artificialmente, le componenti. Potremmo cominciare dal medium più tra scurato dagli storici e dai critici, almeno italiani, e cioè la Radio. L’impor tanza della componente radiofonica nel cinema del neorealismo deriva da un fatto banale, ma che non è mai stato osservato: è la radio e non il cinema, il vero medium della Resistenza. Un cinema della Resistenza, che nc accompagnasse le fasi e la crescita e che in seguito la documentasse per chi non c’era, in Italia non si è avuto che in scarsa misura. Nulla corri sponde ai Why We Fight di Capra, gran parte dei materiali documentari fu controllata o addirittura sottratta dagli americani (il pwb si disinteressava abbastanza di cinema, sostiene Ferrara, e, ci pare, più nel senso di un’ar chiviazione che di una reale produzione). Non si formò insomma un valido repertorio filmato sulla lotta di liberazione e i documentari della resi stenza, da Giorni di gloria che dovrebbe esserne la summa a L'Italia s’è desta di Paolella sono per buona parte film di finzione, anche se tutti sem brano dimenticarlo. La Resistenza, dal punto di vista mediologico, fu invece soprattutto radiofonica. Ascoltare radio Londra era già un atto di « radio militante » e fu la radio, non le ricetrasmittenti militari, ma proprio la nor male radio, a consentire l’organizzazione della guerra partigiana, fino a quell’ultimo messaggio, Aldo dice 26 x 1, che fece scattare l’ultimo atto della liberazione. Il cinema del neorealismo non mancò di rievocare que sti episodi (Aldo dice 26 x 1 di Fernando Cerchio, O sole mio di Gentilomo, e anche II sole sorge ancora) ma soprattutto fece suo quello che può essere considerato il più specifico codice radiofonico, cioè la voce off. I film degli anni Trenta che abbiamo visto non hanno mai fatto ricorso all’uso sistematico della voce fuori campo, che diviene invece assai fre quente nel cinema neorealista (da Paisà a Giorni di gloria fino a Sotto il sole di Roma, Germania anno zero e Non c’è pace tra gli ulivi la voce del racconto orale, quella che ci presenta ancora oggi le immagini più vive e autentiche delle storie dei tedeschi e dei partigiani è ciò che sostituisce nel cinema neorealista le inquadrature di raccordo, i passaggi narrativi, la
382
Il neorealismo cinematografico italiano
sceneggiatura di ferro, le didascalie, insomma gran parte del « linguaggio » cinematografico degli anni precedenti). Quanto alla fotografia, il suo rapporto col cinema neorealista pare addirittura risalire a una mitica matrice comune: Roma città aperta, film in cui le fotografie hanno del resto un certo peso nel determinare lo svi luppo narrativo (i tedeschi riconoscono l’ingegnere sulla base di foto se gnaletiche), fu girato con pellicola acquistata presso i fotografi e usata per le Leica. Ma i rapporti più interessanti e concreti si istituiscono, pur con qualche ambivalenza, con i due media che utilizzano siste maticamente la fotografia e che proprio nel dopoguerra acquistano una loro identità: il rotocalco e il fotoromanzo. Il padre riconosciuto del ro tocalco italiano è, come è noto, Leo Longanesi, di cui si è ricordato il ruolo di anticipatore di poetiche zavattiniane: ma se il suo « Omnibus » fu, con « Tempo », un fenomeno breve e isolato nella stampa illustrata dell’anteguerra, dopo il ’45 il rotocalco conobbe una grande fortuna e un periodo di notevole qualità giornalistica non disgiunta da un certo impe gno democratico e di denuncia (cfr. « L’Europeo » di Arrigo Benedetti). Prima che il rotocalco divenisse sinonimo di evasione e di pettegolezzo divistico-monarchico, esso fornì al cinema un esempio di tecnica narrativa per immagini non ancora sufficientemente studiato ma che ci pare, intui tivamente, non trascurabile. Oltre a presentare un’indubbia analogia di « impaginazione »: basti pensare alla nascita, nel neorealismo, del film a episodi e a firma collettiva. Cinema neorealista e rotocalco hanno anche in comune, assai spesso, il principio di una cronaca differita (non imme diata cioè come quella della radio e del quotidiano) su cui già si innestano osservazioni di ordine morale, sociale ecc. e che « fanno della notizia ro manzo » (l’osservazione è fatta a proposito del rotocalco da un critico cinematografico: Pietro Bianchi). Più ambiguo il rapporto neorealismofotoromanzo. Quest’ultimo, com’è noto, è un fenomeno tipicamente ita liano e postbellico, ma bisogna almeno ricordare una grande sperimen tazione fumettistica operata in Italia sullo scorcio del Ventennio: il film di Alessandrini No/ pivi. Esso era stato il primo esempio di fotoromanzo non solo nel tipo di storia-feuilleton ma soprattutto, per il suo uso siste matico dei primi piani, per il rilievo dato al volto degli attori (A. Valli, R. Brazzi, F. Giacchetti) usati in maniera statica senza recitazione e senza regia, per il paesaggio schematico e approssimativo. Il cinema neorealista, beninteso, si autodefinisce proprio in opposizione al cinema-feuilleton (che infatti risorgerà con la crisi del neorealismo alla fine degli anni *40: Ma tarazzo, Brignone, Freda, ecc. e offrirà i primi temi ai due principali registi post-neorealisti: Antonioni e Fellini); ed è anche vero che è più il foto romanzo a « prendere » dal cinema che viceversa. Eppure, oltre al fatto che esso rappresenta l’unico tipo di fotografia di finzione prodotta solo parzialmente in studio (a differenza delle foto pubblicitarie e di moda che
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
383
allora non conoscevano gli esterni), bisogna considerare attentamente il rapporto tra immagine e parola che c'è nel fotoromanzo e nel cinema neo realista. Quest’ultimo, a differenza del cinema degli anni Trenta, fa un uso sistematico della voce off, come si è detto, ed è totalmente un cinema doppiato (negli anni Trenta, in maniera totale agli inizi e nel cinema di Cecchi ma in grande misura anche più avanti, vi è un uso corrente della presa diretta del suono); Roma città aperta fu addirittura girato muto, in fondo proprio come il fotoromanzo che, oltre ad usare sistematicamente la parola off e la parola in, è appunto l’unico altro medium audiovisivo che venga girato muto e sonorizzato in seguito. Insomma, una certa presenza del fotoromanzo in un certo cinema neorealista è tutt’altro che da esclu dere a priori. Vorremmo concludere indicando un’altra, apparentemente assurda ma in realtà fondamentale, componente dell’eterogeneità mediologica del neo realismo: la televisione. Che la televisione non esistesse nell’immediato dopoguerra come apparato ideologico di stato non è un’obiezione ma sem mai una prova a favore della nostra tesi. Essa in Italia diviene un’istitu zione attiva esattamente un mese dopo il Congresso di Parma sul neo realismo, una delle possibili date per segnare la fine del periodo neorealista. Essa di fatto esisteva come possibilità tecnica e tutti gli anni Trenta ne avevano accompagnato il perfezionamento f« Cinema » aveva pubblicato articoli sulla televisione e nel 1939 era stato fatto un film totalmente ambientato in un Ente Televisivo sia pure ungherese e che mostrava le possibilità e i « pericoli » della nuova invenzione: Mille lire al mese di Neufeld). Ora, se un discorso cronologicamente deterministico ci porterebbe al massimo a dire che il neorealismo è fra i padri della televisione italiana, un’ottica attenta ai fenomeni dell’intertestualità ci permette legittimamente di considerare la televisione come un elemento del testo neorealistico. Vi è soprattutto un film (e non a caso esso è, assieme a Roma città aperta, il film che detiene ogni record per quanto riguarda i suoi passaggi televisivi) che ci consente di vedere il rapporto tra i due media, ed è Paisà. Esso ci si presenta oggi come un grande viaggio-inchiesta per l’Italia, un servizio in sei puntate sulle condizioni del paese durante l’avanzata alleata. Servizio realizzato con grande impegno e grande dispendio di mezzi, come una grossa produzione televisiva di oggi: non lasciamoci ingannare dagli stereotipi e dalle leggende: Paisà fu il film più costoso fra quelli prodotti nel 1946, e aveva precise ambizioni di discorso rivolto alla nazione. La sovraregionalità del cinema neorealistico è appunto anche una sovraregionalità televisiva, e come questa venata di neo-romanesimo linguistico, ideo logico e produttivo. Ma Paisà è soprattutto televisione nelle condizioni di ripresa; racconta Rossellini: Ho cominciato con l’installare il mio operatore nel mezzo del paese nel quale contavo
384
Il neorealismo cinematografico italiano
di realizzare un episodio della mia storia. I curiosi si sono raggruppati intorno a me e ho scelto i miei attori tra la folla.
Insomma, ci si aspetta solo che l’« autore preso dalla strada » saluti con la manina. Queste caratteristiche della ripresa determinano anche lo « sti le » del film neorealistico, così precisamente descritto da Bazin: « La foto grafia assumerà un debole ruolo espressivo » (potremmo dire una « bassa definizione»?). Le carrellate e le panoramiche non avranno «il carattere quasi divino che dà loro a Hollywood la gru americana, quasi tutto viene fatto ad altezza d’occhio o a partire da punti di vista concreti come potreb bero essere un tetto o una finestra ». « La macchina da presa italiana con serva qualcosa della Bell-Howell da reportage inseparabile dalla mano e dall’occhio, quasi identificata con l’uomo ». Siamo di fronte, insomma, alla tecnica di ripresa televisiva, in que sta fisiologia della cinepresa che con la simbiosi uomo-macchina porta nel cinema neorealista l’uso della macchina a mano e dell’occhio estensibile dello zoom, cioè il corredo dell’operatore televisivo. Ma Bazin fa anche, sparsamente, altre felici osservazioni, come quando sottolinea che tutti i film italiani del dopoguerra portano nei titoli di testa, alla voce sceneggiatura, una buona decina di nomi: un democristiano, un comunista, uno che sa costruire una storia, una che trova la gag, uno che fa buoni dialoghi, uno che ha « il senso della vita » ecc. Insomma il mo dello del « rullo » televisivo, in cui tutti hanno diritto di firmare il proprio lavoro, (ricordiamo quanto si è detto sullo stabilirsi della nozione d’autore in epoca neorealista) e magari anche un non-lavoro, una presenza mo tivata da dosaggi politici, consulenze del tutto formali ecc. Un ultimo elemento che vorremmo indicare è l’uso del repertorio. Esso può venire inteso come intrusione documentaristica, cioè indistin zione e indistinguibilità fra documento reale e fiction. (Non a caso il boom del documentario come genere a sé si avrà con la stessa legge, quella andreottiana del 1949, che uccide il neorealismo; e comunque non è certo una novità parlare della natura documentaristica del neorealismo). Ma, se si pensa all’uso che del materiale documentario fa il cinema neorealista in relazione alla funzione che esso aveva nel cinema prebellico, già l’ana logia con l’impiego televisivo dei materiali di repertorio si accentua. Le riprese documentaristiche erano praticamente assenti nel cinema italiano degli anni Trenta, oppure avevano un ruolo di materiale bruto da elaborare artisticamente e ideologicamente nel cinema sovietico, o servi vano a integrare e arricchire economicamente il racconto nel cinema ame ricano. Nel film neorealista esse sono invece più che altro veri e propri marchi di garanzia realistica: si pensi a Paisà in cui ogni episodio si pre senta con un’introduzione documentaristica, immediata e squillante di chiarazione di realismo, o al caso di Ladri di biciclette che nell’edizione sovietica fu distribuito con l’aggiunta di uno sciopero di disoccupati tratta
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
355
da un cinegiornale, come una garanzia a posteriori, un’autentica fatta dalla critica per un quadro che l’autore aveva dimenticato di firmare. Nell’elenco dei media che compongono il quadro eterogeneo della cinematografia neorealista ne manca forse uno solo, e l’assenza è particolar mente significativa perché racchiude in sé il giudizio che il neorealismo dà su se stesso e sul cinema del decennio precedente e individua l’avversione mediologica del neorealismo, la sua falsa coscienza di sé e del proprio corpo diviso, le sue proiezioni schizo-paranoidee. Questo medium è il te lefono, il bianco capro espiatorio del sacrilegio intermediologico neorea lista.
PRIMATO DEGLI INTELLETTUALI E NEOREALISMO di Vito Zagarrio (allievo C.S.C.)
Un esperimento: proviamo a cogliere la fecondazione del neorea lismo prima della fondazione della scuola, nell'acquisizione di coscienza della nuova generazione intellettuale. Gli strumenti e i modi della crescita ideologica e della consapevolezza culturale e politica si inseriscono nelle strutture pericolanti del regime che gioca l’ultima carta — l’alibi bottaiano dell’apertura ai giovani in funzione del contenimento e dell’irregimentazione. In questa prospettiva, « neorealismo » diventa superparola: vuol dire una generazione che vede nel cinema uno strumento essenziale per espri mere i contenuti rivoluzionari, non soltanto i motivi profondamente antifa scisti ma anche gli stimoli contraddittori antiborghesi del giovanilismo fa scista — cinema come arma più forte per un primato della cultura ita liana o come antidoto controspazio da saturare di antifascismo; recupero del dato nazionale da contrapporre alla cultura anglosassone o utilizzazione di quella stessa provincia per scardinare dal di dentro le aspirazioni im perialistiche di una cultura e, in particolare per il cinema, di un modo di produzione. Prendiamo come esempio « Primato », rivista non specializzata e neanche organo ufficiale delle organizzazioni giovanili, ma voce politico-cul turale dei giovani intellettuali fascisti, centro di raccolta della cultura più fresca dell’Italia in guerra, filtro di tendenze contraddittorie e catalizzatore della maturazione ideologica antifascista e marxista. Il cinema può essere usato, secondo « Primato », come cartina di tornasole per mettere in risalto prima le contraddizioni della rivista e diventare poi esperimento-exemplum, funzionare da lente di ingrandimento, trasparenza del problema più vasto della cultura fascista. L’itinerario degli intellettuali del cinema lungo la rivista e la guerra può far pensare a un neorealismo in nuce, seppure incerto nel doppio bi nario: rispecchiamento delle direttive di regime e critica che dal mora lismo generico giunge alle punte estreme della fronda. Dal moralismo parte per esempio Enrico Emanuelli per portare avanti l’ipotesi combattiva di un dover essere del cinema contro i
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
387
pericoli della retorica del luogo comune, della sciatteria gabellata con molte pretese; [...] gli schermi hanno portato davanti ai nostri occhi le immagini di una vita trascorsa da secoli, e secoli, uomini e donne in costume, e tutta la cianfrusaglia già cara a certo teatro di grosso effetto nei primi anni del '900.
Dalla critica cinematografica, insomma, Emanuelli allarga il campo al problema della politica culturale. La polemica sul film in costume, che coinvolge anche altri intellet tuali del cinema e della letteratura, è un’indicazione importante che con duce al problema della forma (sarà un tema importante per la rivista e una battaglia personale di politica cinematografica di Chiarini e Pasinetti). Proviamo però a scoperchiare il moralismo emanuelliano, e possiamo ve dere come dietro ci siano delle precise direttive di vertice. Una segnala zione del MinCulPop esprime tutta la preoccupazione per un genere misti ficatorio come il « film in costume » che, se poteva servire in tempo di pace a distrarre il pubblico dai problemi reali e addormentarlo in uno spen sierato letargo, si presenta al momento della crisi, quando il fascismo ha bisogno della massima adesione e del più largo consenso, un’arma a doppio taglio pericolosissima. A monte del moralismo di « Primato » c’è quindi una precisa diret tiva di regime; difficile è se mai definire i limiti che corrono tra la linea di vertice e l’interpretazione personale che ne può stravolgere i contenuti politici e (anche inconsciamente) ribaltare i significati. Ne è prova la concezione più generale del cinema che matura in Emanuelli, un cinema nazionale sì, tipicamente italiano come pretende la retorica di regime, ma che può significare anche valorizzazione e riscoperta di un realismo nazio nale antiretorico e antimperialistico: Le pellicole americane piacciono perché, tra le molte altre loro doti, riflettono una vita americana; e le francesi hanno successo perché rispecchiano una sensibilità fran cese; e cosi sarà delle nostre quando ci decideremo a mettere sullo schermo paesaggi italiani, cose italiane, sentimenti italiani (il modo d’intendere l’amore, l’odio, la felicità, il dolore all’italiana) e soprattutto, idee italiane.
Da qui l’elaborazione teorica di un modo di far cinema che passa non a caso da Renoir: (...) Renoir dice che la salvezza del cinema nostro consiste nel fare pellicole ita liane nello spirito e nella tecnica; e aggiunge a sua giustificazione: « Il nostro lavoro deve essere nazionale [...] ». Aveva ragione quel tale che, parlando in sede lette raria, del Werther c dell’Ortis, diceva essere le due favole vicine all’apparenza, ma diverse nella sostanza come il cielo della Grecia e dell’Italia è diverso da quello della Germani^. Una questione di cielo: questo bisogna decidersi a capire.
È da notare come più si entra nel terreno della battaglia etico-ideo logica, più il discorso si colora di accenti, seppure ambigui, di fronda. Parlare di una necessaria differenziazione ideologica (e addirittura razziale: è una questione di cielo) tra Italia e Germania diventa necessariamente mo tivo di disagio politico e di insoddisfazione. Renoir impersonifica per con trasto il mito di un cinema autonomo dalle convenzioni ideologiche e dalle
388
Il neorealismo cinematografico italiano
costrizioni economiche dei rapporti di produzione celati dietro al cinema. Renoir è il cinema d’autore contrapposto al cinema di fiancheggiamento; Renoir è la poesia contro le « miserie » del cinema italiano. Ma c’è di più: Renoir vuol dire anche la coscienza dei modi di produzione che stanno dietro al fatto artistico individuabili nella grande crisi del cinema francese alla partenza di Clair, nel dissolvimento dei « cadaveri viventi » delle grandi società, nei fallimenti che permettono film a costi relativa mente bassi, nelle produzioni senza capitali, nel cinema-artigianato. Il richiamo a Renoir si allarga così a un nuovo modo di concepire il cinema, come poesia e come lavoro, cioè come espressione individuale e modo di produzione; e attraverso la scuola francese, attraverso la nazio nalità d’espressione di Pagnol e la riscoperta del disegno dei RougonMacquart e della Bète humaine, attraverso l’ingenuità suggeritrice di temi eversivi di Le del est à vous di Grémillon, porta al nuovo realismo ita liano. Ce lo fa intravedere questa nota di Emanuelli che riassume in sé la storia delle origini e il destino futuro del neorealismo: Il luogo comune, cioè il piò meschino modo di manifestarsi della retorica, impove risce questo momento cinematografico. Nuove fantasie e fresche un giorno troveranno un nome nuovo all’inizio di una bella pellicola; poi un secondo, poi un terzo [...] gli assimilatoti caveranno immediatamente una « formula »; e quindi i rifacitori, di nuovo, rovineranno ogni cosa.
La profezia dell’avvento di una nuova generazione e subito la predi zione dell’irretimento sono in fondo la storia dell’illusione e della delu sione del gruppo di Alicata-Visconti e compagni. E qui il tema Renoir si arricchisce di contenuti politici dai contorni meglio definiti: è alla base della stessa maturazione poetica e politica di Visconti: Fu proprio il mio soggiorno in Francia e la vicinanza di un uomo come Renoir che mi aprirono gli occhi su parecchie cose. Compresi che il cinema poteva essere il mezzo per avvicinare certe verità dalle quali eravamo assai lontani, specialmente in Italia, òli ricordo che La vie est ì nous di Renoir, che vidi appena arrivato in Fran cia mi fece una profonda impressione, è un film che può ricongiungersi alla stessa vena di Roma cittì aperta. Durante questo periodo ardente — era quello del Fronte Popolare — ho aderito a tutte le idee, a tutti i principi estetici e non solamente estetici ma anche politici. Il gruppo di Renoir era nettamente a sinistra e Renoir stesso anche se non era iscritto era certamente vicino al partito comunista.
Da La vie est à nous a Roma città aperta, da Renoir a Rossellini, dal nuovo realismo francese al neorealismo, il tramite è Verga. Il répechage del verismo verghiano e la sua elaborazione con la ricetta di Duvivier e di Renoir porta avanti gli stimoli eversivi di un’Italia reale diversa da quella ipotizzata dalla retorica di regime. L’altra linea culturale, l’altro strumento di coscienza critica è De Santis, che coinvolge e impegna al dibattito tutta la cultura tendenzial mente di fronda della fine degli anni Trenta. In questa prospettiva, con la mediazione dell’estetica crociana, va vista la battaglia di Chiarini sulla forma, il rifiuto di contenutismi e formalismi,
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
389
l’ipotizzazione di un’art pour l’art nel senso di una ricerca armonica del fatto artistico (è vero che il recupero chiariniano di De Santis non va al di là di questo piano, non procede cioè sulla strada che ha percorso in carcere Gramsci qualche anno prima). Prendiamo l’articolo Ritornare alla forma, intervento dai toni e dalle ambizioni da editoriale che parte dalla situazione di crisi del cinema e da un’analisi del rapporto arte *industria per giungere a formulare una specie di manifesto dell'arte nel cinema: Il film come fatto creativo è esclusivamente arte: solo tenendo fermo questo punto sono possibili un’industria e un commercio cinematografici. La cinematografia ame ricana, quella francese, Io hanno dimostrato.
Il riferimento al cinema d’arte europeo e americano si cala però su bito nel terreno delle tradizioni nazionali e dell’insegnamento della let teratura dei maestri, e così la parola d’ordine di Chiarini diventa: Tornare a De Sanctis! -. [...] e tornare a De Sanctis significa ripudiare formalismi e contenutismi per quella sola forma e quel solo contenuto che contano in arte e che sono inscindibili: il sen timento dell’artista e la sua espressione [...]. L’arte, del resto, non si fa su ordina zione e si sa quanto fraintese siano state certe polemiche per un’arte fascista. [...] Un cinema senza artisti è come una città morta dove corvi e cani randagi van razzolando tra le macerie.
Partendo da questo finale orrido e profetico che sembra presagire il crollo del colosso fascista, bisogna riconoscere che gli spunti polemici sono parecchi: critica al sistema della produzione cinematografica fascista, alle scelte di politica culturale del regime, alla morale del profitto, critica per un cinema nazionale, antiretorico, capace di toccare alti livelli artistici. Il tutto, è chiaro, inquadrato e mimetizzato nella prospettiva giovanilistica di un fascismo riformatore e altamente patriottico, capace di toc care ovunque i più alti livelli del primato-, in nome di un cinema fascista nel senso più profondo della parola-. Nel quadro c sul piano dell’arte tutti i problemi seri saranno risolti, compreso quello importantissimo specie in questo momento, che attiene alla sua funzione politica. Una cinematografia fascista nel senso profondo della parola e non del lamentato, superficiale energico patriottismo. Non può, cioè, non toccare i motivi più intcriori del popolo, le sue aspirazioni, la sua vita.
Ma anche l’ossequio chiariniano al regime, se scandagliato nelle sue strutture, si scarica prima dei contenuti retorici e si ribalta poi in un fascismo di fronda, umoroso e insofferente, e comunque di taglio giovanile, convinto della necessità di un mutamento radicale della cultura e del si stema. Per finire col ricongiungersi alle elaborazioni teoriche del marxismo latitante. Il pericolo dell’ambiguità rimane, naturalmente, e non pone Chiarini — e i critici cinematografici della rivista in genere — al livello di un Pintor;
390
Il neorealismo cinematografico italiano
nessuno di loro si pone mai apertamente fuori della dottrina e delle indi cazioni del regime. Per esempio, l’impostazione teorica desanctisiana, nel senso di riliuto del contenutismo, porta Chiarini a giustificare la linea raz zista di certe pellicole italiane e tedesche e quindi la direzione comune verso una politica culturale antiebraica, i cosiddetti film « di tendenza ». Famoso per esempio Jùd Sùss, che rappresenta bene gli intenti propagan distici e il rapporto con i mass-media del nazismo. Quello che ha colpito l’osservatore acuto non è tanto la materia trattata, di evidente ispirazione nazional-socialista [...] ma la ricerca e la conquista senza la quale non vi è arte.
Dietro vi è chiaramente percepibile l’operazione culturale dei respon sabili del MinCulPop, tutti tesi ma inutilmente a tener dietro ai camerati tedeschi. Anche questo si può vedere nelle parole di Chiarini. Insomma, l’impostazione della critica chiariniana può offrire spazio a un perfetto inserimento negli schemi teorici del fascismo, sino alla giu stificazione della propaganda razziale. La funzione veramente positiva del critico si deve semmai cercare fuori della rivista, in primo luogo nell’attività di operatore e di organizza tore culturale che Chiarini svolge, insieme con altri giovani, nell’ambito del Centro Sperimentale di Cinematografìa. Il Centro e la sua rivista, « Bianco e Nero », fanno bene da pendant a « Primato »: anche per « Bianco e Nero » e lo staff che lo pubblica (che fa capo al Centro) si potrebbe parlare di un coraggio della concordia che riunisce in quadrato gli intellettuali nel momento cruciale e opera verso l’Europa alla ricerca di una credibilità culturale del fascismo; ma soprat tutto le due riviste descrivono una parabola comune della concezione del primato per un verso e dell’arma più forte per l’altro, sino alla sottile e corrosiva funzione di carie delle strutture fasciste. La scuola di Umberto Barbaro diventa fucina di esperienze teoriche e tecniche che coinvolgono direttamente o indirettamente tutta una ge nerazione, finendo per trasformare gli spazi di apertura culturale in mo menti di battaglia politica. Per il Centro passano i tragitti dei giovani più impegnati nel dibat tito culturale e nell’organizzazione politica: Gianni Puccini, per esempio, frequenta il Centro tra il ’38 e il ’39. E di là passa anche la strada di Antonioni. Altro collaboratore di « Primato » e altro importante animatore del Centro Sperimentale (insegnante prima, direttore poi) è Francesco Pasinetti, « che dal 1940 è presente quasi costantemente con la sua rubrica di cinema, a far coppia fissa col teatro di Fulchignoni. Loro due sono l’accoppiata vincente della fronda antifascista. La presenza di Enrico Ful chignoni ha un suo preciso significato ideologico: è uno dei giovani che
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
391
gravitano attorno al periodico « Corrente », altra rivista tornata alla ri balta per la sua funzione di filtro delle energie più mature in senso già lucidamente antifascista. Ebbene, dal settembre 1940, quando « Corrente » ha già subito l’operazione di polizia (dalla sorveglianza alla chiusura), Fulchignoni entra come collaboratore fisso delle pagine di spettacolo di « Pri mato ». Pasinetti collabora invece ad altre due riviste di fronda, « Domani » di Roma e « Ventuno » di Venezia, ma soprattutto è l’educatore della generazione giovane del cinema, quella cosiddetta degli « anni difficili ». Un abbinamento felice, dunque: il primo si occupa di teatro dal punto di vista della politica culturale con articoli dal taglio spregiudicato e pro vocatorio facendo leva su motivi di fronda giovanile, riassumibili sì nel l’ambito della politica bottaiana, ma carichi anche di spunti già antifa scisti (saremmo tentati di dire marxisti): Nello svincolamento delle Arti dalla tirannide dei criteri borghesi, il teatro e il ci nematografo costituiscono una palestra degna delle più valide postulazioni ideali. Quando, nel futuro, sarà fatto un bilancio di chi ha transatto con quei criteri, non serviranno — come da parecchi si va blaterando — né resipiscenze né giustificazioni. Chi ha ceduto alla Sirena dei borghesi, sparirà; come sparirà l’ambiente che lo ha espresso. E la cacciata dei Filistei dal tempio sarà per tutti un giorno di sospirata giustizia.
Dove si vede come la parola borghese va qui molto al di là della formula da « corporativismo di sinistra » del cosiddetto fascismo rivoluzio nario: borghese va sempre più identificandosi con fascista} e la « Sirena dei borghesi » ricorda troppo da vicino la definizione di Amendola del mass-medium del fascismo. In effetti, Fulchignoni procede su due linee: da una parte si batte per la concretizzazione di una politica culturale del fascismo tesa a recuperare e a potenziare gli stimoli giovanili nelle strut ture tradizionali; dall’altra, punta sui giovani come avanguardia del mo vimento rivoluzionario, indipendentemente e addirittura contro le strut ture borghesi: I giovani non chiedono altro che di cooperare con tutte le loro forze al migliora mento d’una situazione che (...) rischia, ogni giorno di più, di ridurre le Muse della Scena alla umiliante condizione di sguattere della borghesia.
La presenza di Pasinetti, rispetto a Fulchignoni, ha minor peso, è comunque più discreta; prevale nei suoi interventi il tecnico del cinema, il teorico del film inteso come organizzatore d’équipe e come lavoro; i suoi problemi sono il doppiaggio, il suono, il montaggio, il dosaggio degli effetti; il suo tema fisso è la collocazione del film come fatto artistico sì ma soprattutto come collaborazione di varie tecniche e di varie arti, ognuna autonoma eppure interagente con le altre. Dall’impostazione « tecnicistica » Pasinetti però allarga l’orizzonte del la sua critica al panorama del cinema nel periodo bellico. Dalle sue crona che emergono un po’ tutti i motivi di dibattito del cinema fascista, con
392
Il neorealismo cinematografico italiano
tutte le sue ambiguità. Nell’ossequio al regime si inquadra la contrappo sizione evasione-impegno civile: da una parte i filmetti e le commediole comico-sentimentali di importazione straniera, dall’altra i film della pro paganda fiancheggia trice. La concezione di un cinema fascista si riallac cia cosi a quella bottaiana del « Primato », e risente quindi di tutte le contraddizioni della parola e dell’ambiente giovanile che se ne fa alfiere: Noi pensiamo che per dar luogo al primato della cinematografia italiana sia neces sario lasciare rivelare gli ingegni più vivi nell’ambito di un’arte cinematografica incitandoli a dar libero avvio, senza reticenze di sorta, alla loro fantasia.
Partito da questioni squisitamente teoriche e tecniche, anche Pa si netti arriva dunque alla politica culturale e alla polemica sull’industria cinematografica: [...] un periodo in cui dilaga il luogo comune, a tutto vantaggio dell’industria, a tutto svantaggio dell’arte.
Dalla critica delle scelte di politica culturale, alle soluzioni alterna tive: il motivo di punta è l’americanismo. L’interesse per l’esperienza ame ricana che impregna significativamente la rivista da un punto di vista lette rario (Faulkner, Steinbeck, le traduzioni di Vittorini, Pavese ecc.) trova in Pasinetti il suo corrispondente. In un momento in cui l’America rappre senta il nemico, appaiono scorci del mito d’oltreoceano: Frank Capra, William Wyler, John Ford. Lo Stagecoach di Ford, un film arricchito oggi di sensi e segni mo dernissimi, si colora nella sua presenza in « Primato » di significati pro fetici e apocalittici: le ombre rosse dell’angoscia bellica e dell’esplosione rivoluzionaria. È questo il senso che si può dare a un articolo di Vice (An tonioni) su « Cinema », in cui Ombre Rosse diventa un simbolo di oriz zonti perduti, di terre mitiche dell’anima come il vecchio West: La vecchia America, nata dalla fusione tra lo spirito dei puritani e quello dei pio * nieri, la vecchia America tormentata dal bisogno di crearsi una sua verità, è in Stagecoach di John Ford. [...]. Parte la diligenza dell’Arizona, da un meraviglioso paese puritano dato con poche inquadrature, e il viaggio comincia.
Insieme al cow-boy e alla prostituta, insieme agli eroi della diligenza dell’Arizona, comincia anche il viaggio della generazione di Antonioni, che diventa una sorta di presenza-presagio del nuovo cinema italiano, quello del neorealismo e quello ancora successivo. Prendiamo l’intervento di Antonioni del 1943, l’unico articolo di ci nema nell’annata della disfatta (della rivista e del fascismo); una fugace presenza che ricollega però tutti i fili del nuovo cinema italiano per por tarne avanti le ansie liberatorie. Antonioni ribalta la visione ortodossa, sug gerita dal fascismo, di un cinema francese in disfacimento come specchio delle crisi e dei vizi di una società: quel cinema è sì direttamente legato alla società francese in quanto rappresenta quelle contraddizioni che dove
Il neorealismo e il cinema italiano degfi anni trenta
393
vano portare la Francia alla guerra e alla disfatta, ma la riassunzione della realtà sociale nella forma dell’arte è proprio lo scatto in più che fa del cinema francese un modello per i giovani italiani. Non solo, ma proprio in quel modello di cinema sono contenuti tutti i fattori di rilancio per un nuovo cinema « nazionale » in un senso antinazista e antifascista. Dal ribaltamento della posizione ufficiale della critica fascista, Anto nioni parte alla riscoperta ammirata del cinema dei maestri, Carnè, Duvivier, Renoir, quest’ultimo al centro del trittico con la sua ricerca zolaiana sull’uomo e sull’uomo nella società, il Renoir di Les bas fondi e di La grande illusion. Antonioni riallaccia immediatamente « Primato » alla battaglia d’idee che continua a portare avanti « Cinema ». Qui lo stesso Antonioni aveva scritto poco tempo prima: non è dii non veda quanto grande possa essere, anche oggi che il cinema francese è probabilmente esaurito, la lezione per il cinema italiano: dove la produzione non ha ancora una faccia, appunto perché nessun audace artista glielo ha saputo ancora modellare.
L’intervento su « Primato » suona però più amaro, risente in qualche modo del clima di disfacimento della rivista: Difatti oggi molte cose sono mutate. Renoir Duvivier Clair e Chenal, con Gabin Boyer e la Morgan varcarono l’oceano durante il conflitto, Feyder si rifugiò in Sviz zera, dov’è tuttora pressocché inoperoso Perduta l’unità d’interessi e di riso nanze che sembrava la caratteristica inintaccabile del cinema francese, questo risultò smembrato, esautorato. I rimasti, nello smarrimento generale, non sapevano trarre un senso dalla tremenda avventura; fra il rimpianto dei vecchi simboli repubblicani, nel cinema rappresentati dal realismo, e la necessità di un compromesso, mancava a loto il coraggio di guardare entro di sé per risolvere innanzitutto il problema della propria coscienza, e trovare un accento di personale, virile sincerità.
È la formula di una paziente resistenza sotterranea, il ripiegamento interiore, la ricerca della coscienza, il far leva su stimoli che sono con tenuti dentro l’uomo oppresso per continuare a lottare: Si attendeva; c intanto, nel vigoroso riordinamento della produzione ad opera del governo tedesco, fallivano opere di giovani che pure promettevano I loro film sono brutti, irrimediabilmente brutti. La guerra ha disperso in Francia i poeti del cinematografo, non resta che attenderne pazientemente di nuovi. [...] cosi, come a suo tempo la cinematografia tedesca, oggi quella francese dimo stra che quest’arte, come tutto, non di climi abbisogna ma di travagli individuali.
È appunto nei travagli individuali, nella maturazione delle coscienze •dei giovani, che sono i presupposti per uscire dallo stato di angoscia e di frustrazione del cinema, francese e italiano. Dalla rivalutazione dei mae stri francesi, da un’operazione culturale di accademia, Antonioni è sceso sul terreno della storia e della politica; perché il far riferimento a quel cinema vuol dire fame propri i contenuti e valorizzarne nel presente il sen so che se ne coglie; il senso di un’altra Europa, quella delle vittime.
IDEOLOGIA E PROPAGANDA NELLA COMMEDIA DEGLI ANNI TRENTA di Claudio Carabba
Dalla fine della guerra erano passati soltanto pochi anni, o addi * rittura qualche mese, ma i carissimi maestri della vecchia guardia ave vano già ricominciato a suonare le antiche sinfonie: le prosperose « bel lezze in bicicletta » dell’intramontabile Campogalliani erano chiaramen te le legittime eredi delle candide segretarie per tutti tanto simpatiche ai decaduti gerarchi di celluloide; Carmine Gallone, imperturbabile, se guitava a intonare le sue gonfie melodie, dando l’impressione di non essersi accorto di tutto quello che era avvenuto aH’esterno del suo liri co universo cristallizzato. E Blasetti, che di tutto il mazzo veniva non ingiustamente considerato l’autore più bravo e corretto, dopo aver in dotto a bene sperare per il cauto segno d’amara presa di coscienza negli anni della guerra (Quattro passi fra le nuvole), celebrata a botta calda e senza troppa convinzione la Resistenza con una equivoca e assai discu tibile parabola « evangelica » (Un giorno nella vita), già nel ‘48 si ribut tava a capofitto nel vuoto affascinante delle amatissime ricostruzioni sto riche riproponendo un’ennesima Fabiola, non certo salvata dal generico « messaggio pacifista ». Passata la bella tempesta, i soliti augelli erano insomma tornati a far festa: tutto era ormai accaduto e si poteva tranquillamente far fin ta di niente. I grandi protagonisti del cinema di maggiore smercio e de gustazione restarono i medesimi non solo fra gli autori ma anche fra i produttori e gli attori mattatori. La circostanza non è secondaria, ché, al di là del cerchio limitante delle vere o presunte opere di alta qualità, proprio i grandi filoni commerciali segnano in maniera inequivocabile la continuità tutta negativa che lega fra di loro il cinema d’ante e dopo guerra. Né il punto di saldatura è rappresentato soltanto dalla presenza fisica dei soliti personaggi. Al contrario, quando qualcuno dei professio nisti veterani esce di scena per limiti di età, subito spunta pronto un erede in grado di continuare, peggiorandolo, l’antico discorso eversivo. Sotto tale angolatura l’analisi scandagliata delle vane commedie degli an ni Trenta permetterebbe di stabilire vari punti di contatto con i brutti e cattivi filoni di strepitoso successo del « trentennio democratico », dal
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
395
deprecato bozzettismo manieristico dei « poveri ma belli » all’insincero moralismo falsamente accusatore dei « Sorpassi » alla Gassmann. Più travagliato e contraddittorio risulta inevitabilmente l’esame di quel gruppo di film sostanzialmente eterogenei e diversi, ma abitualmen te riuniti per storica tradizione e comodità temporale nel cosiddetto « neo realismo». Non pare giusto oggi negare l’esistenza di un’esplosione ri voluzionaria, che effettivamente ci fu ed ebbe clamorosa funzione oppo sitrice nei confronti del nero passato. Pure l’onda ringhiarne, rivelatasi con Ossessione e I bambini ci guardano e poi cresciuta non senza rabbia sino alla memorabile e quasi inaspettata maturazione rosselliniana, ci può sembrare in una prospettiva postuma una circostanza circoscritta ec cezionale e irripetibile, e infatti non ripetuta, pertanto non sufficiente a spazzare la devastata spiaggia di un cinema da tanti anni sprofondato negli schemi pigri dell’inerzia culturale fascista. Così vizi ed equivoci del passato tornarono presto a posarsi a riva, o forse non se ne erano mai andati. In effetti le parabole radiose tracciate per scontata consuetudine dai manuali — una sorta di lungo viaggio attraverso la notte, dall’asservimento al regime alla gloriosa liberazione del nuovo realismo — non sono così costanti e lineari come a prima vista si sarebbe tentati di credere. Se la potenza disordinatrice del giovane Visconti e lo svilup po innovatore di Rossellini sono innegabili episodi rivoluzionanti, più difficile è verificare la durata di quegli eroici furori, il loro rapporto con i giorni passati e quelli futuri. Ad esempio, secondo gli schemi critici progressivi, i racconti veristici di un Poggioli o di un Franciolini sareb bero diretta anticipazione deH’Oww/one viscontiana, i mediocri docu mentari di De Robertis avrebbero aperto la strada alla potenza crona chistica di Roma città aperta, o ancora gli esercizi formali dei Soldati e dei Castellani andrebbero catalogati tra gli oppositori silenziosi al fa scismo. Non manca qualche fondata motivazione per simili giudizi otti mistici: ma rigirando la medaglia, altri aspetti esattamente opposti pos sono emergere. Allora Poggioli, con i terribili drammi dei suoi prota gonisti sempre rinchiusi nel cupo cerchio di disperati e tragici amori, diventa non un meritevole anticipatore di Visconti, ma l’inconsapevo le capostipite di quel filone narrativo pseudo-popolare degenerato alla lunga nei fumettacci di Matarazzo (paralleli filmati dei fotoromanzi di carta proprio in quegli anni entrati in voga) oggi rivalutabili solo da una critica stravagante e a corto di idee, in vena di snobistiche evasioni. E a rivedere il pur molto lodato Uomini sul fondo, si avverte bene, dietro l’effettiva asciuttezza di alcuni passi, quell’assenza di una coscienza ideo logica che porterà il comandante De Robertis ad approdare tristemente fra i fantasmi veneziani richiamati dai repubblichini di Salò. O infine lo stesso Fari nella nebbia di Franciolini, da alcuni recensori considera to entusiasticamente per l’insolita ambientazione nel mondo povero e de
396
Il neorealismo cinematografico italiano
solato dei camionisti, risulta maledettamente arcaico e antiquato per il goffo e pesante impasto tematico non controllato dal regista; i cui falli * mentori sbocchi successivi inducono a ritenere che quella atmosfera pia cevolmente inconsueta rispetto alla stereotipata oleografìa del ventennio, è forse in gran parte dovuta alla casuale scelta della novella da raccon tare. Il comodo giudizio col senno di poi permette di rivedere i panni anche ad altri autori balzati in prima fila nella drammatica stagione ’45-’5O. Passati gli anni della lotta e della fame, i limiti culturali, o peg gio le sotterranee vocazioni reazionarie portano fatalmente a sentieri privi di uscita. A una a una si contano le cadute dei maestri creduti rivoluzionari, i quali sprofondano nella contemplazione suntuosa di se medesimi o tornano a quella concezione assolutamente mercantile del ci nema da cui erano partiti. I minori e i comprimari, usciti dal momenta neo stato di grazia, si smarriscono al servizio della produzione più gros solana sino alla totale degradazione dei « Serafini », delle « garsonnière », delle « Ciociare »; molti dei presunti tradimenti e fallimenti, puntual mente verificatisi, erano forse prevedibili, se non già sottintesi, nei gior ni luminosi. E il rapporto che salda il cinema fascista ai film dell’era nuova non è soltanto di rifiuto o di rigetto. Persino in alcune non im meritevoli opere sulla Resistenza (dal Sole sorge ancora di Vergano a Achtung banditi! di Lizzani, per non parlare dei più recenti slanci epici alle Quattro giornate di Napoli), affiorano rigidezze retoriche proprie dei racconti bellici della propaganda fascista, ricalcati sullo stile degli Ales sandrini o dei Genina. Né basta il fatto che la distinzione manichea fra buoni e cattivi sia ora fatta secondo giustizia per ribaltare veramente la prospettiva ideologico-poetica. Se qui si tratta soltanto di analogie, ancor più evidente sono le similitudini col passato nel trionfante fiorire della cosiddetta commedia all’italiana, cucita a doppio filo ai non dimen ticati telefoni bianchi. Messa da parte la retorica dell’aquila romana e de gli invincibili arditi (anche se film di guerra incredibilmente fortunati negli anni Cinquanta, tipo I sette delVOrsa Maggiore o Sotto dieci ban diere non hanno perso un forte sapore littorio) proprio la raffigurazione rosata di un cosmo unicamente interessato a sommessi mormorii e batti becchi amorosi rivela un’immutata volontà di una degradazione deviante dello spettatore, il quale povero cristo addormentato va al cinema per divertirsi e dimenticare le pene quotidiane, quindi non deve essere an gustiato da grossi e gravi problemi. Ecco così spiegato il ritorno ciclico delle leziose mistificazioni, dei giochi di specchi lietamente deformanti, a uso e gloria di una pigra società farisea, che esige soltanto piacevoli lazzi dai suoi servizievoli giullari, i quali non mutano mai anima ma semplicemente le colorate penne. L’analisi della produzione « leggera » cresciuta e prosperata duran-
[I neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
397
tc il ventennio non è dunque un’operazione meramente archeologica; l’esat ta determinazione dei vecchi errori può aiutarci nella comprensione dei peccati con temporanei. Tentando un primo rozzo accenno di smontag gio ideologico va tenuto presente che la prospettiva, coscientemente uni laterale, non tende a ribadire o ribaltare un giudizio di merito poeticocmozionale (bello o brutto, viva o abbasso) ma soltanto a verificare nel nostro cinema di più vasto mercato la presenza o l’assenza di una posi zione culturale che si schieri contro le linee direttive indicate dal regi me. In questo senso, anche al di là della commedia, genere qui privile giato, risulta abbastanza arduo trovare concreti riferimenti e punti di ag gancio con le opposizioni più o meno battagliere e militanti, presenti nel cinema a livello teorico con la fondamentale apertura verso i migliori esempi stranieri (l’approfondito studio della scuola sovietica e il ricor rente mito dell’industria americana poli opposti di una medesima aspi razione). Mentre nella narrativa scritta il peso dei concreti contributi per la formazione di un nuovo « realismo », già chiaramente individuabile ne gli anni Trenta, è ormai addirittura canonizzato, a proposito dei film la traccia si perde e si scolora. Non perché sia stata la critica cinespe cializzata ad arrivare con colpevole ritardo rispetto a quella letteraria, ma perché in ritardo furono effettivamente i nostri registi di allora, non capaci di collegarsi alle esperienze e alle ricerche che avvenivano fuori d’Italia, nonostante quei lunghi forzati esili di lavoro all’estero che carat terizzarono la formazione professionale di quasi tutti gli autori, durante la depressione dell’ultimo periodo muto. Per l’appunto il recupero di una professionalità adeguatamente coltivata dall’esercizio tecnico, sembra in definitiva essere l’unico sentiero possibile per cogliere nella numeri camente vastissima produzione fascista delle dirette c sicure anticipazio ni delle cose che verranno dopo, stavolta in senso positivo. L’individua zione di queste matrici comuni sarà senz’altro preziosa, a patto che lo studio delle disinvolte « forme », astratte dai valori contenuti dentro e tramite esse, non diventi pretesto per ardire rivalutazioni, pericolosa mente sospese sul filo della riconsacrazione, sì che paradossalmente l’uso di finissimi strumenti per operazioni di lettura in profondità rischia di trovare una stravagante congiunzione con la nostalgia becera di un com pianto passato, rivagheggiato dagli stolti spettatori inconsolabili di quel carosello cantabile, che non per caso era stato scelto dai gerarchi del Minculpop come emblema della loro bella società. Del resto, già alla fine della radiosa era mussoliniana, si erano accorti di tutto questo gli spettatori più intelligenti. E resta esemplare il numero 170 di « Cine ma », datato 10 agosto ’43, uscito poco dopo la fatale caduta, in cui i pugnaci redattori scelsero uno dei più attivi ascari zelanti del regime, Nunzio Malasomma, e sotto una sua fotografia pubblicarono un sostan
398
Il neorealismo cinematografico italiano
zioso commento, accompagnato da un titoletto di sapore moraviano, Gli indifferenti'. Perché Malasomma segue, con aria tanto tormentata il filo della pellicola? Vuoto e falso, da dodici anni egli sforna senza posa quelle meschine, nauseanti bugie che sono le commedie comico-sentimentali. Dalla Telefonista a In due si soffre meglio attraverso Eravamo sette sorelle la formula è sempre quella: Malasomma non ha neppure più bisogno di recarsi a Cinecittà, è uno dei maggiori esempi di come si possa con metodica indifferenza seguitare a ingannare se stessi e il pubblico.
Non era quella la prima denuncia apparsa sulle pagine di « Cinema », faticosamente svincolatesi dall’egemonica supervisione di Vittorio Mus solini. A De Santis, Puccini e gli altri giovani spettatori critici era parso abbastanza chiaro che non era stato certo un caso se la grande stretta au tarchica con i fieri proclami di Mussolini (« il cinema sarà l’arma più forte ») aveva coinciso con l’apogeo dei balletti sentimentali. Il fatto non era dovuto alla colpevole distrazione dei gerarchi, ma costituiva al con trario il risultato di una linea, a suo modo di politica culturale, precisa e meditata. La denominazione tradizionale, di solito attribuita a tutto il « complesso leggero » prodotto nel periodo fascista, è in effetti filologi camente impropria. Di « telefoni bianchi » in senso stretto si dovrebbe parlare soltanto dal ’37 in poi, con precoci e chiari segni di decadenza già nel ’40, e una faticosa sopravvivenza fra gli stenti sino al crollo to tale. Pure se intesa come l’indicazione generica di un certo clima e di una stordita atmosfera intellettuale, l’etichetta può essere applicata sen za incerti rimorsi anche a gracili operine di parecchio antecedenti. Pro prio la rivoluzione sonora, col clamoroso lancio delle marionette gor gheggiami « Solo per te Lucia » nella fortunatissima Canzone dell’amo re (1930) di Gennaro Righelli, può essere presa come dato di comodo per segnare l’inizio del grande valzer. Da allora le mutazioni del panora ma sono quasi impercettibili, il viaggio in avanti è più che altro appa rente. La nascita dell’immenso filone di « deviazione occulta » è casuale-, Mussolini e i suoi dirigenti, interessatisi con notevole ritardo del cine ma (più che di ventennio si dovrebbe parlare di decennio) non compren dono subito l’utilità di quelle banalità sentimentali, sorte per parto spon taneo e indolore, senza bisogno di spinte dall’alto, c puntano sui canti e gli inni semiufficiali del giovane Blasetti all’inizio della carriera (Sole, Terra madre) o addirittura sulle bieche rievocazioni del rozzo Forzano (Camicia nera). Sono i ripetuti fallimenti delle opere di più diretta pro paganda (da Vecchia guardia a Scipione) e il parallelo successo crescente delle novelle rosate, a convincerli della positività della produzione diva gante, specchio, solo all’inizio inconsapevole, della fragile ideologia fa scista e dell’angusto respiro culturale di un regime, che nonostante gli imperiali sogni trionfalistici non riusciva a disancorarsi dalle sue profon de radici intimiste e borghesi, restando chiuso nel piccolo cerchio di un
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
399
provincialismo goffo e straccione. Tutta la folta schiera di seduli mae stri di bottega, venuti dietro a Righelli (non solo i Malasomma e i Brignone ma anche i più « rispettabili » Alessandrini e Camerini) fu l'esat ta interprete delle meschine aspirazioni di un popolo dolorosamente ad dormentato, rallegra galleria documentaria della tristissima assenza di tensione vitale. Volendo distinguere diversi sapori entro l’unico immenso caldero ne, si potrà individuare una primaria direzione strettamente sentimen tale, — con l’accentuazione dei sussurranti battibecchi amorosi e del dolce batticuore — che partendo appunto da La canzone dell'amore, ca postipite base dei vari filoni secondari, passa attraverso le telefoniste di Malasomma, la Zaganella di Gustavo Serena, la paprika dell'austriaco Emo, gli idilliaci collegi di Alessandrini per arrivare fino alle Terese Venerdì e alle Violette di Bragaglia, illusori fiori leggiadri degli aspri anni di guer ra (non per niente fra gli estensori dei soggetti troviamo sempre ì medesimi autori, valga per tutti il nome dell’onnipresente Aldo De Benedetti, col laboratore di Camerini e Mattoli, Malasomma e Brignone, Blasetti e di De Sica). Indulgente a effetti più patetici fu la serie « cantabile » aper ta sempre dalla citata Canzone dell’amore e poi continuata specialmente dall’astuto Brignone (Vivere! col trionfante Tito Schipa, La mia canzo ne al vento, Mamma e cosette del genere) o con maggior garbo dal più dotato Carlo Ludovico Bragaglia (Fuga a due voci), tutti imparentati più o meno strettamente col buon Carmine Gallone, il quale, a parte la bruciante parentesi scipionica, marciò imperterrito sulla sua strada scan dendo il passo a forza di Giuseppe Verdi e Manon Lescaut. Nello sgan gherato quadro d’assieme vengono abitualmente salvati pochi autori, di solito facenti parte della « nuova guardia », affacciatasi con l’avvento del sonoro e non consumatasi nella lunga e faticosa militanza pionieristica. Ad esempio l’Alessandrini, lodato per la sua scrittura diligente nel calli grafico Seconda B (1934), un raccontino che se era invero più garbato della precedente Segretaria privata (esecrabile fra l’altro per avere aperto radiose strade al duo Besozzi-Merlini) rimaneva pur sempre in limiti più che convenzionali, se non proprio sciatti e melensi. Puntando sulle do ti di eleganza, critici con temporanei, come il fine Gili, uno studioso fran cese molto sensibile e attento alle cose italiane, rivalutano specialmente Cavalleria, tessendo l’elogio della ricostruzione dei salotti primo Nove cento e dell’uso accorto delle sequenze all’aperto, le passeggiate al Pincio, la scuola di cavalleria di Pinerolo, accorate immagini trasudanti una pacata nostalgia. Così il Gili ha addirittura l'impressione che lo sfondo nazionalistico e militarista del film si perda nello splendore formale e nel sentimentalismo dell’idillio amoroso che lega sino alla magnifica mor te Amedeo Nazzari ed Elisa Cegani. Ma la sensazione appare alquanto
400
Il neorealismo cinematografico italiano
azzardata, se si guarda gli sbocchi ulteriori delI’Alessandrini che di lì a poco diventerà il cantore preferito della virtù guerriera della nostra ita lica stirpe (Luciano Serra pilota, Giarabub) e dello sfrenato anticomuni smo lacrimoso (Noi vivi e Addio Kyra). Analoghe considerazioni vengono spontanee davanti alla tradiziona le valutazione di piena stima per cui sono « saltati », grazie ai loro alti meriti professionali, Blasetti c Camerini, ambedue circondati da un’aura gloriosa, incredibilmente resistente negli anni, sopravvissuta al diluvio uni versale del ’45, rimasta zona di pieno rispetto anche per i critici della Resistenza. Non per niente la coppia viene trattata a parte, e discretamen te elogiata nella sua Storia del cinema, da Lizzani, il quale con una defi nizione da molti citata, vede in Blasetti l’attento « predicatore dell’onesto ceto medio », delicato pittore dei miti e dei sogni del suo gregge, e in Camerini « il confessore » di quella borghesia minuta e frastagliata, il poeta che sa scrutare con arte cauta l’animo dei suoi fedeli. Ma al di là del riconosciuto decoro stilistico che caratterizza gran parte della filmo grafia dei due autori, resta da vedere se essi con le loro opere offrirono o no dei modelli alternativi, facendo proposte di rottura, anche soltan to sul piano linguistico. La risposta è nel complesso negativa, ché essi non prospettarono quasi mai (come eccezioni relative citerei 1860 per Blasetti, Il cappello a tre punte e Darò un milone — giudicando da alcu ni suggestivi passi della sceneggiatura zavattiniana — per Camerini) al cunché di diverso, né per lo stile né per il grezzo contenuto. Furono an zi i modelli da imitare ed effettivamente imitati dai loro colleghi meno capaci. Sì che in definitiva non è paradossale affermare che, grazie alla loro maggiore correttezza creativa, Blasetti e Camerini sono i più esemplari rappresentanti del cinema del ventennio, non le punte da salvare. A pro posito di Camerini resta indicativa la supervalutazione della « pentalogia borghese » e in particolare de Gli uomini che mascalzoni!, in cui ancora i critici degli anni Cinquanta vedevano lo slancio polemico verso un mon do migliore, una controllata ma mordente critica sociale con la sarcasti ca rappresentazione dei ricchi snob contrapposti al sano e modesto po polo morigerato, l’efficace pittura di una tipica situazione italiana, fuori dagli schemi correnti e stereotipati della produzione di quei tempi. Rivi sto oggi, Gli uomini che mascalzoni! (con la sua sorta di seguito ideale, Il signor Max) non conforta tali interpretazioni benigne. Gli spunti ge nericamente antiborghesi e populisti si inseriscono perfettamente in un tipico settore della propaganda fascista, che amava sbeffeggiare i gonfi impiegati panciuti, contrapposti alla virile agilità ginnastica delle ardite camicie nere. Tale polemica era insomma approvata e condivisa dal fie rissimo « duce rivoluzionario », il quale semmai auspicava che alla fine, dopo lo scherzo, tutto tornasse al posto giusto, non mettendo in crisi l’ordine costituito. E in questo senso i film di Camerini vanno a me
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
401
raviglia, col rifiuto di ogni promiscuità di classe: i giovani poveri e sim patici sposeranno le buone fanciulle proletarie, le quali dopo le caste fri volezze dell’adolescenza, diventeranno mogli-madri perfettamente inquadra te e comprese della loro missione di angeli domestici. Ogni velleità di arrampicata perturbatrice deve essere scoraggiata. Così nel Signor Max il povero protagonista, sdoppiato nel suo schizofrenico travestimento (giornalaio nella vita di tutti i giorni e bel gagà nell’impossibile sogno di evasione) brucerà velocemente le sue smanie di ascesa in cieli superiori, scoprendo che la felicità è rappresentata dalla quieta accettazione della pro pria condizione di partenza. Ancor più che ne Gli uomini, che mascal zoni! Camerini sembra mettere alla berlina gli sciocchi privilegi dorati dei salotti mondani. Ma la satira si ferma alla prima pelle e la morale di fondo è sempre la medesima, inevitabilmente a favore di coloro che stanno sopra: dopo la breve vacanza gli umili ritorneranno al posto loro nel ribadito rispetto delle sociali differenze. Non furono allora queste le frecce nel fianco del regime. Casomai accenni di rottura ci vengono dall’improvvisa apparizione di comiche ex stravaganti e slegate da ogni ambizione realistica, ma proprio per que sto felicemente disinserite dal conformismo collettivo. Come si è detto, a voler trovare un Camerini « da salvare », è preferibile indicare la sca tenata farsa con i fratelli De Filippo del Cappello a tre punte e non la stereotipata serie da camera interpretata dal tandem De Sica - Noris. E nel settore « leggero » la punta più interessante di Blasetti è Nerone, un film di impianto teatrale che viveva degli estri di Pctrolini. Più tar di, sulle soglie della guerra, l’inquietante presenza del primo Macario (Imputato alzatevi!) e specialmente dell’allucinante maschera di Totò (Animali pazzi), porterà anche registi quasi sempre convenzionali come Mattoli e Bragaglia in una elettrizzante atmosfera di originalità. Mentre un autore più dotato, Amleto Palermi — proprio nell’ultimo periodo della sua vita entrato in uno straordinario stato di grazia — arriverà, ap punto lavorando con Totò a vertici di eccellenza col memorabile San Giovanni decollato. Sono forse questi scampoli rari e sporadici di una comicità clownare, inconsapevolmente rivoluzionaria, i più veri e concreti modelli alterna tivi rispetto agli imperturbabili romanzetti romantici che avevano suona to la sinfonia del regime. Lì, in quelle filastrocche zeppe di dolci illu sioni, piacevoli inganni, pupi rosa, care mogliettine, lauti stipendi da mille lire al mese e amori non svanibili insieme all’oro dei capelli, la molto piccola borghesia che alle camicie nere aveva aperto affettuosamen te le braccia, obbedendo magari senza saperlo all’alto volere dei bor ghesi più grandi e potenti, celebrava i suoi fasti meschinelli, i sogni opa chi non illuminati dalla fantasia. L’arida similitudine di tutte le storie aveva provocato la piatta identificazione di ambienti e arredamenti, co
402
Il neorealismo cinematografico italiano
struiti in serie secondo un ideale cristallizzato di casa città lieta e familia re, confortevole ma senza sfrenati lussi. Fu così che gli scenografi si co piarono a vicenda, ammaliati dal candore abbagliante degli interni: e nacque la mitica giostra dei telefoni bianchi, apparecchi rampanti assunti stra namente a simbolo di una società che aveva nel nero il suo colore preferito.
L’UTILIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI NEL CINEMA ITALIANO DAL 1930 AL 1944 di Jean A. Gili
A partire dal 1945, sotto la doppia influenza delle distruzioni della guerra e delle nuove opzioni stilistiche, il cinema italiano abbandona spesso i teatri di posa per scoprire gli ambienti naturali e le riprese all’aria aperta. Questa capacità di filmare ambienti autentici sarà anche uno degli elementi caratteristici del neorealismo: allontanandosi da una realtà ar tefatta, i cineasti vogliono scoprire un realismo che inglobi non soltanto gli esseri ma anche le cose e i luoghi. Questo gusto per l’ambiente naturale non è nato nel 1945; molto prima di questa data, si può constatare che parecchi cineasti preferiscono disertare i teatri di posa per andare a installare la macchina da presa nelle piazze, nelle città e nelle campagne. Questo fenomeno merita tanto più di essere segnalato in quanto il regime fascista ha fatto grossi sforzi per sviluppare gli impianti tecnici e per mettere a disposizione dei registi numerosi teatri di posa. Nel 1940, nel momento in cui la produzione italiana sta per rag giungere le sue cifre record, si possono contare circa 30 teatri di posa, distribuiti fra Torino (fert), Tirrenia (Pisorno), e soprattutto Roma (Ci necittà, safa, Farnesina, Titanus, Centro Sperimentale). Cinecittà, inau gurata nell’aprile del 1937, conta non meno di 16 teatri di posa. Ora, malgrado l’efficacia delle attrezzature, parecchi cineasti non si accontentano di ricreare in studio ciò che offre loro la natura, e preferi scono trovare in esterni una maggiore autenticità. Se si considerano le opere tradizionalmente ritenute precorritrici del neorealismo — Quattro passi fra le nuvole di Blasetti, I bambini ci guar dano di De Sica e Ossessione di Visconti — si può costatare che un aspetto fondamentale della novità di questi film consiste proprio nel l’importanza assegnata alle sequenze girate in ambienti autentici. Quattro passi fra le nuvole è in primo luogo questa fuga stupefacente fuori dall’uni verso tradizionale dei teatri di posa: la piazza del villaggio dove i viaggia tori attendono che nasca il figlio dell’autista della corriera, il viaggio nella campagna, la corriera che si ribalta nel fossato e la gente che si sparpaglia nella natura in attesa che qualcuno venga a ripararla, sono tutti elementi
404
Il neorealismo cinematografico italiano
di una freschezza meravigliosa. Senza entrare nel dettaglio delle intenzioni di Blasetti — senza dubbio una rimessa in causa dell’immagine del padre, con in secondo piano un'allusione politica — non c’è dubbio che la sco perta di un’Italia più autentica di quella che normalmente veniva offerta sugli schermi, funzioni prima di tutto grazie all’utilizzazione di ambienti naturali. Nel momento in cui il viaggio in corriera ha termine, quando Gino Cervi e Adriana Benetti arrivano alla fattoria e entrano nella vecchia casa, qualunque sia la qualità delle scenografie di Virgilio Marchi, il film perde immediatamente un po’ della sua autenticità e della sua inventiva. Nello stesso modo, il dramma de I bambini ci guardano — dramma dell’adulterio e delle sue conseguenze su un ragazzo — trova nel frequente ricorso ad ambienti reali una qualità di verità che una narrazione intera mente confinata fra le mura di uno studio non gli avrebbe conferito. La prima sequenza in un giardino pubblico di Roma, con il bambino che pur continuando a giocare guarda la madre che incontra l’amante, pone già il problema con l’acutezza che il senso dello spazio permette. Più avanti, il soggiorno presso la nonna in campagna dimostra ugualmente la preoc cupazione di De Sica di aerare in continuazione il film. Tuttavia, è nella parte della storia che si svolge ad Alassio che il senso dell’aria aperta trova la sua migliore giustificazione. Sotto l’occhio cattivo dei villeggianti che si annoiano, il ragazzo assiste alla partenza del padre e al ritorno dell’amante: ferito nella propria sensibilità, egli fugge lungo la ferrovia, e, caduta la notte, si rifugia sulla spiaggia; alla fine, viene raccolto dai carabinieri che lo riportano alla pensione dove la madre Io attende ansiosa. Alla fine del film, quando il bambino lascia suo padre e rivede un’ultima volta la madre, le scale monumentali, l’immensa sala nella quale troneggia la scrivania del direttore, sono altrettante scenografie reali. Così, è evidente che la novità del film non è soltanto di contenuto — mostrare nel 1942 un adulterio e un suicidio è propriamente rivoluzionario — ma anche di stile: utiliz zando molto spesso la profondità di campo per mettere in scena i suoi per sonaggi gli uni in rapporto agli altri, De Sica trova in un’abile utilizzazione degli ambienti naturali, lo spazio necessario all’affermazione di uno stile. Tuttavia, è chiaro che è con Ossessione che si misura meglio l’im portanza degli ambienti reali nella genesi di un atteggiamento nuovo da cui uscirà il neorealismo. Sebbene sia inutile rifare l’analisi di un film no tissimo, si può sottolineare che Ossessione trova gran parte del suo conte nuto innovatore nella ricchezza e nella precisione realista dei luoghi nei quali il film è girato. La locanda sulla diga del Po, il quartiere popolare del porto di Ancona, le strade e le piazze di Ferrara, i banchi di sabbia del fiume, tutti questi luoghi non sono soltanto scenografie, partecipano inti mamente all’azione e le danno il suo sapore particolare. Con Ossessione la verità degli esseri comincia con la verità dei paesaggi; questi disoccupati, questi locandieri, questi venditori ambulanti, queste donne innamorate,
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
405
assumono tutta la loro forza drammatica nella descrizione stessa dei luo ghi in cui si svolge la loro vita. Basta « vedere » la povertà di questi luoghi per comprendere come una donna è stata spinta a sposare un uomo che non ama nella sola speranza di sfuggire alla miseria. Così, senza nemmeno alludere alla situazione dell’Italia nel 1942, Visconti mostra per la prima volta su uno schermo un paese che non è una costruzione convenzionale: il paese reale si mette a vivere, con i soldati nelle strade, i balilla in un giardino pubblico, gli ubriachi e i disoccupati, le prostitute e i poliziotti, gli assassini e gli adulteri. Insomma, la verità dei paesaggi ha liberato la verità degli esseri. Malgrado la sua mancanza di perspicacia, la censura fascista questa volta non poteva sbagliarsi: il film fu proibito molto presto. Così, con questi film di Blasetti, De Sica, Visconti, vediamo affermarsi una nuova estetica della quale uno degli elementi costitutivi è il ricorso all’aria aperta e alla verità dei paesaggi. Già la scelta di luoghi così di versi quali le colline a nord di Roma, la spiaggia di Alassio, la pianura pa dana nella zona di Ferrara, testimonia d’una tendenza che troverà con ferma nel cinema italiano; la volontà di non confinarsi nei luoghi conve nuti in cui si girano la maggior parte dei film ma, al contrario, il desiderio di andare alla ricerca di posti diversi assunti non per il loro non confor marsi superficiale, il loro aspetto folcloristico o aneddotico, ma al con trario per il loro valore di suggestione, il loro contenuto di informazione in rapporto ai personaggi che li occuperanno e vi vivranno. Si può notare che questi tre film mettono in scena gente del popolo o piccolo-borghesi (al contrario dei film « mondains » che si svolgono nell’universo dell’aristo crazia o della grande borghesia) e che ogni volta si trova rimessa in causa la morale ufficiale che ignorava gli assassini, gli adulteri (soprattutto quelli femminili) i suicidi, i concepimenti illegittimi. Quattro passi fra le nuvole, I bambini ci guardano, Ossessione, sono i tre film più caratteristici; ma non bisogna pensare che essi costituiscano degli esempi isolati. All’inizio degli anni ’40, numerose sono le opere nelle quali almeno con una sequenza importante la macchina da presa esce fuori dagli studi. Inoltre, quasi tutti i film sanno trarre abilmente partito da questo ingresso nei luoghi reali: diversamente dai film realizzati quasi interamente in studio e in cui gli esterni sono spesso dei trasparenti (per esempio, Campo de' fiori di Mario Bonnard) o rapidi inserti che vengono ad arieggare lievemente un’azione che si svolge sempre — quale che sia il soggetto — tra le quattro mura di uno spazio chiuso, questi film utiliz zano spesso gli esterni con un senso esatto delle necessità dell’opera. Ven gono in mente numerosi esempi. Senza neppure parlare dei film di De Robertis, o di La nave bianca (1941) di Rossellini, film nei quali l’utilizza zione dei luoghi autentici delle riprese non è veramente una scelta estetica nella misura in cui i soggetti trattati richiedono obbligatoriamente l’ab bandono dello studio (la scelta del décor reale non è veramente signifi
406
Il neorealismo cinematografico italiano
cativa che quando il cineasta adotta questo partito preso proprio quando avrebbe potuto trovare soluzioni di regia che avrebbero potuto adattarsi allo studio), altri titoli vengono in mente. Fari nella nebbia (1941), di Franciolini, si svolge nell’ambiente popolare dei camionisti che percorrono le strade fra La Spezia, Genova e Savona. Su queste strade, in particolare, nel tratto sinuoso del Colle del Bracco si svolgono alcune sequenze dram matiche, mentre altre scene hanno come quadro le strade di Acqui o il porto di Savona: la passeggiata sul molo fra Fosco Giachetti e Luisa Fenda offre un buon esempio di utilizzazione di un décor naturale. Certo il film è un po’ rovinato da un moralismo invadente ma è certo che la vita degli operai è espressa piuttosto bene grazie alla giustezza dei luoghi nei quali si svolge l’azione. Aldo Tonti, capo operatore del film racconta addirittura che Franciolini esigeva del vero caffè — allora reperibile solo sul mercato nero — in una scena in cui Mariella Lotti doveva macinarne dei grani '. Fra i cineasti che hanno indicato la linea da seguire per ritrovare il contatto con la realtà, è il caso di riservare un posto importante a Pog gioli. Già a suo agio in melodrammi storici come Addio giovinezza (1940) e Gelosia (1942), due film che si svolgono alla fine del diciannovesimo secolo-inizio ventesimo secolo, e che sono situati il primo a Torino e il secondo in Sicilia (da notare subito il gusto dei luoghi variati), Poggioli dà tutta la sua misura in opere contemporanee come Sissignora (1942) e Le sorelle Materassi (1943). Se ne Le sorelle Materassi la zona di Firenze è soprattutto una cornice decorativa, in Sissignora invece Poggioli utilizza la città di Genova con molta precisione: il ballo domenicale in un dancing in riva al mare, il « Montenegro », le case popolari coi loro tetti a ter razze sui quali le donne stendono la biancheria, i quartieri del porto con le sue stradine e i suoi mercati all’aperto, tutta una città raramente mo strata sullo schermo si mette a vivere davanti a noi. Così, a fianco di ci neasti la cui importanza è meglio riconosciuta, Poggioli merita attenzione: è vero che il regista morì tragicamente nel 1945 senza aver avuto, senza dubbio, la possibilità di dare tutta la propria misura nella ricerca del realismo. Infine è interessante constatare che anche i film classificati sotto l’eti chetta di « calligrafici » hanno largamente utilizzato gli ambienti naturali, com’è il caso delle opere di Soldati, Castellani o Lattuada. Per limitarsi a due esempi, Piccolo mondo antico (1941) di Soldati deve molto del suo fascino all’impiego dei paesaggi del lago di Como. Ugualmente Lat tuada nota a proposito di Giacomo l'idealista (1942): le cose più vere che ho portato sullo schermo — la campagna lombarda d’inverao, il fiume Adda — sono cose che avevo visto io stesso. Mi sono rifatto a sensazioni che risalgono alla mia infanzia e vi ho trovato accenti più veri, più autentici1 2.
1 Aldo Tonti, Odore di cinema, Firenze, Vallecchi, 1964. 2 Estratto da un’intervista inedita.
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
407
A guardare la produzione italiana degli inizi degli anni ’40, si ha dunque I’iinpressione che l’utilizzazione dell’ambiente naturale, dei pae saggi autentici, cominci a prendere un’ampiezza che troverà il suo spazio vero e proprio dopo la guerra. Tuttavia — almeno su questo punto —, il gusto per i luoghi reali non è cominciato negli ultimi anni del regime fascista: lungo tutti gli anni Trenta circola una corrente che indica che an che nel periodo in cui i segni precorritori di ritorno alla realtà sono tenui, il contatto con la strada, con la campagna, non è mai andato comple tamente perduto. Fin dal 1929, con Sole e malgrado una certa enfasi e un certo formalismo (come testimoniano le fotografie che restano del film), Blasetti installa la macchina da presa nelle paludi pontine e si ser ve di autentici contadini per recitare a fianco di alcuni attori professio nisti che hanno i ruoli di protagonisti. Durante gli anni Trenta Blasetti non rinuncerà mai a girare in ambienti naturali. Di film in film sfilano un po’ tutte le province italiane, Siena in Palio (1932), Napoli in La tavola dei poveri, la Sicilia in 1860 (1934), la Romagna in Vecchia guardia (1934): da questo punto di vista. Quattro passi fra le nuvole non è dun que un’innovazione ma l’approfondimento di un’attitudine coerente. Ugualmente, tutta l’opera di Mario Camerini è segnata dal gusto del le sequenze girate in esterni: i paesaggi nella campagna veneta (Figaro e la sua gran giornata, 1930), a Milano (Gli uomini, che mascalzoni!, 1932), nella campagna napoletana (Il cappello a tre punte, 1934), a Roma (Il signor Max, 1937), a Verona (Grandi magazzini, 1939), per non prende re che alcuni esempi, sono altrettanti momenti privilegiati. Rivedendo que sti film quarant’anni più tardi, ci si rende conto — è in ogni caso la mia sensazione — che gran parte della loro freschezza, e quindi del pia cere che si ha nel vederli, derivi appunto da questa atmosfera leggera, da questa sensazione di cinema en plein air. Perfino i drammi di Came rini — film come T'amerò sempre (1933), o Come le foglie (1934) — sono l’occasione per il cineasta di cogliere dei luoghi reali e di portarli sullo schermo senza cercare di travestirli con una messa in scena vistosa. Una ricostruzione storica come I promessi sposi (1941), anche se un po’ convenzionale, è salvata da alcune belle sequenze girate sulle colline che dominano il lago di Como. In questi anni, i casi di Blasetti e di Camerini non sono isolati; si potrebbero ancora citare altri cineasti, così Matarazzo (Treno popolare, 1933), Carlo Ludovico Bragaglia (O la borsa o la vita, 1933), Elter (Le scarpe al sole, 1935), Palermi (Cavalleria rusticana, 1939), ecc.J. Ales sandrini ha spesso arieggiato i suoi film con un’abile utilizzazione degli am bienti naturali; da questo punto di vista, il suo film più rappresentativo è certamente Cavalleria (1936) grazie alle sequenze girate alla scuola di 3 Benché realizzato da un cineasta tedesco, si può ugualmente citare il film prodotto da Emilio Cecchi, Acciaio (1933) di Walter Ruttmann.
408
Il neorealismo cinematografico italiano
cavalleria di Pinerolo o nei giardini del Pincio. Ugualmente, Genina ha tratto buon partito dai paesaggi desertici della Libia in Lo squadrone bian co (1937). A proposito di quest’ultimo film, si può notare che tutti i lun gometraggi che su incitazione del regime fascista vennero girati in Libia o in Africa Orientale furono l’occasione per affrontare uomini, paesaggi, una realtà opposta alle ricostruzioni fabbricate in studio. I film « coloniali », malgrado il loro carattere di propaganda, hanno spesso avuto come con seguenza di riabituare i registi a lavorare in esterni. In fondo, se un aspetto del cinema italiano degli anni Trenta con serva un certo sapore, è perché i cineasti non hanno rinunciato a utilizza re le possibilità loro offerte dal fatto di girare fuori degli studi. D’altron de, se si pone il problema in termini politici, si constata che il fatto di non rinchiudersi completamente fra le quattro mura del teatro di posa rappresentava già una scelta politica: girare « en plein air », malgrado tutti i travestimenti possibili, significava accostare una realtà che rischia va ben presto di sfuggire alle norme governative. Non è un caso se il re gime ha incoraggiato, soprattutto durante la permanenza di Luigi Fred di a capo della Direzione Generale per la Cinematografia, lo sviluppo degli studi — Cinecittà naturalmente, ma anche aiuto alla modernizzazione de gli studi esistenti. È qui in effetti che possono essere girati film perfet tamente asettici. Il lavoro in studio permetteva di portare sullo schermo un’Italia irreale, un’Italia borghese, ricca, preoccupata soltanto di proble mi sentimentali, insomma la famosa produzione dei « telefoni bianchi ». D’altra parte, rinunciare, anche parzialmente, alle scenografie di gesso e di cartone, significava reintrodurre una società che sullo schermo poteva sfuggire a momenti alle linee dell’ideologia al potere. Nella misura stessa in cui un gran numero di film, e non dei mi nori, sono stati in parte realizzati in esterni, la cosa implicava che il tono generale delle opere ne sarebbe stato influenzato: passando da un pae saggio reale a un interno in studio, diventava impossibile ricadere in una scenografia convenzionale e bisognava per forza cercare una coerenza di stile tra il dentro e il fuori. Questo imperativo avrebbe obbligato gli sce nografi, i costumisti, gli operatori, a trovare un tono che potesse rendere plausibile una realtà fabbricata in studio. È in questo contesto che si sa rebbe formato un insieme di collaboratori creativi, di uomini di grande valore che avrebbero reinvestito la loro esperienza nel cinema italiano dell’immediato dopoguerra. Così, è evidente che operatori come Ubaldo Arata (Luciano Serra pilota, Roma città aperta), Anchise Brizzi (Lo squadrone bianco, Sciuscià), Arturo Gallea (Piccolo mondo antico, Lo sceicco bianco), Otello Martelli (Darò un milione, Paisà), Carlo Montuori (Condottieri, Ladri di biciclet te), Aldo Tonti (Abuna Messias, Il sole sorge ancora), scenografi come Guido Fiorini (Lo squadrone bianco, Miracolo a Milano), Virgilio Marchi
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
409
(La corona di ferro, Europa 51), e soprattutto Gastone Media (Cavalle ria, L’oro di Napoli), costumisti come Guido Sensani e Maria De Matteis, hanno sperimentato in pieno periodo fascista soluzioni espressive che sareb be stato facile far fruttificare dopo la guerra in seno a un movimento in presa diretta con la realtà. Fin dal 1941, in un celebre articolo, Giuseppe De Santis reclamava la ricerca di un paesaggio italiano: L’importanza di un paesaggio è la scelta di esso come elemento fondamentale dentro cut i personaggi dovrebbero vivere recando, quasi, i segni dei suoi riflessi [..Ma come altrimenti sarebbe possibile intendere e interpretare l’uomo, se lo si isola dagli clementi nei quali ogni giorno egli vive, con i quali ogni giorno egli comunica, siano essi ora le mura della sua casa, ora le strade della città dove egli si incontra con gli altri uomini; ora il suo inoltrarsi timoroso, il suo confondersi nella natura che lo circonda e che ha tanta forza su di lui da forgiarlo a sua immagine e somiglianza4.
La linea indicata da De Santis si sarebbe sviluppata dopo il 1945. Tut tavia ben prima di questa data, erano state poste delle pietre miliari. 4 Giuseppe De Santis, Per un paesaggio italiano, in «Cinema», n. 116, 25 aprile 1941.
BLASETTI DAL PERIODO FASCISTA AL NEOREALISMO * di Sergio Grmek Germani
In linea generale vorrei premettere che mi sembra sbagliato guar dare al cinema del periodo fascista solo in funzione di quanto esso ha anticipato o meno il neorealismo. Alcuni dei migliori film italiani del perio do fascista, come ad esempio molte opere di Camerini e Poggioli, sono agli antipodi di ciò che si concepisce generalmente per neorealismo, sono dei film a struttura chiusa, la cui messa in scena non rimanda immediata mente ad alcuna realtà al di fuori del film stesso. E, se in essi si possono vedere, come si sono visti, riflessi della situazione storica o di certe clas si sociali (il luogo comune del Camerini « poeta della piccola borghe sia » o del Poggioli « piccolo borghese crepuscolare »), queste sono con notazioni sociologiche a posteriori di alcuni elementi di questi film, che non entrano nel merito della loro pratica artistica. Cionondimeno questi sono tra i migliori film del periodo fascista, anche per il loro significato storico, che però sta meno nei « barlumi di realtà » che vi si possono scorgere che non nella costruzione d’insieme, di cui la realtà è un refe rente molto indiretto, nella linea di tutto il cinema classico, a comincia re da quello hollywoodiano. Il discorso su Blasetti è forse un po’ più complesso, anche se pure qui mi sembra doverosa la premessa che lo stabilire quanto vi è in esso di anticipatore o meno del neorealismo non comporta un giudizio di va lore sulla sua opera o sui singoli film. La differenza della posizione di Blasetti rispetto agli altri autori italiani del periodo fascista si può de dune anche dalla sua fortuna critica. Egli è forse l’unico autore non giovane, la cui opera sia stata seguita anche nel dopoguerra con note vole interesse, almeno fino a un certo momento, mentre per Camerini non si è tardato a definirlo « un regista ormai fuori dalla storia » (Aristar co su «Cinema» del 1951). Se per Poggioli non si possono fare para * Questa comunicazione, basandosi soprattutto su uno studio più vasto del cinema sonoro italiano del periodo fascista e in particolare dell’opera di Alessandro Blasetti, non intende approfondire in questa sede questi due elementi e tantomeno il cinema del neorealismo. Intende piuttosto stabilire il rapporto che intercorre tra l’opera del regista e i due periodi del cinema italiano in cui si è prevalentemente svolta.
I! neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
411
goni, data la sua morte prematura, e se per Genina può valere come parziale eccezione solo l’accoglienza al Cielo sulla palude, allora bisogna davvero concludere che Blasetti è stato l’unico regista della « vecchia guardia » (!) che si è continuato a seguire con un certo interesse. Lo pro va il primo Nastro d’argento per la regia a Un giorno nella vita (1946), l’accoglienza tutto sommato rispettosa a Fabiola (1948), nonostante fos se un film quasi agli antipodi del neorealismo ancora predominante, e poi nel 1950-51 uno dei premi alla Mostra di Venezia e due Nastri d’argen to a Prima comunione-, infine Altri tempi nel 1952 ha fatto parte della selezione italiana a Venezia. Solo in seguito, con un film di transizione come La fiammata (1953), con la ripresa dello schema a episodi in Tempi nostri (1954), con tre commedie come Peccato che sia una canaglia (1955), La fortuna di essere donna (1956) e Amore e chiacchiere (1957) nonché i documentari di varietà Europa di notte (1959) e Io amo tu ami (1960) l’attenzione per questo regista è andata gradualmente scemando; tuttavia essa ha ancora in parte saputo risollevarsi nel 1965 per il film-testamento Io io io... e gli altri. Inoltre Blasetti ha scritto saltuariamente su varie riviste lungo tutto questo periodo. Nel complesso si può dire che non è stato il neorealismo a seppellire Blasetti bensì il cinema « d’autore » postneorealista. Le ragioni possono essere molteplici. Innanzitutto la fama che ave vano alcuni suoi film del periodo fascista come « anticipatori » del neo realismo; l’ultimo di essi, Quattro passi fra le nuvole (1942) è stato ad dirittura scambiato in Francia per un film del neorealismo. Quindi il fat to che nel dopoguerra egli abbia esordito con un film di partigiani come Un giorno nella vita e abbia ripetutamente collaborate con Zavattini. Infine certamente la sua fama di animatore culturale, dalla promozione delle riviste « Lo Schermo » e « Cinematografo » nel 1926-27 sino all’in segnamento al Centro Sperimentale. Cionondimeno, come vedremo, non c’è un solo film blasettiano del dopoguerra che possa veramente inserirsi nel movimento neorealista. Ma vediamo prima i film « anticipatori », per i quali il discorso de v’essere più articolato. Naturalmente bisognerebbe prima mettersi d’ac cordo sul concetto di neorealismo, ma questo è il compito del convegno e non di questa comunicazione. Io mi limiterò a precisare che credo che a questo termine si debba abbinare sia una connotazione estetica (che forse più d’ogni altro ha saputo definire Bazin, parlando tra l’altro del carattere non predeterminato della messa in scena — che non esclude l’estrema costruzione della sceneggiatura —, della macchina da presa qua si inseparabile dalla mano e dall’occhio, della « indifferenza » del profes sionismo o meno degli attori ecc.), sia una connotazione storica (una precisa realtà sociale, quale quella della ricostruzione) sia una connotazione politico-culturale, legata alla precedente (personalità del neorealismo sono
412
Il neorealismo cinematografico italiano
gli autori di un gruppo abbastanza determinato, in buona parte prove niente dall’esperienza di « Cinema » e parzialmente di « Bianco e nero »). È chiaro che l’opera di Blasetti del periodo fascista va confrontata col neo realismo soprattutto sul primo punto, quello estetico, mentre rispetto al l’ultimo la formazione di Blasetti e indubbiamente di tutt’altro genere sia sul piano politico-culturale che generazionale. Questo metro andreb be a mio avviso applicato anche a personalità come Rossellini; solo Viscon ti, De Santis c alcuni minori fanno chiaramente parte della matrice fon damentale del neorealismo, mentre la figura di Zavattini presenta alcune varianti. Dicendo ciò non intendo confondere il periodo neorealista, che sempre più si rivela pieno di sfaccettature, con una norma astratta del neorealismo. Voglio soltanto affermare che, per capire ciò che il neo realismo è stato realmente, va tenuta presente la differenza tra ciò che è stato e ciò che ha voluto essere. Nondimeno va osservato come sin dal l’inizio il fascista Blasetti abbia avuto modo di collaborate con degli antifascisti, come Vergano, autore del soggetto del suo primo film Sole (1929); di Vergano, che realizzerà con II sole sorge ancora (1947, il ti tolo sembra una citazione del vecchio film) una delle opere più ideolo giche del neorealismo, Blasetti ha anche supervisionato nel 1942 il film Quelli della montagna. Infine va rilevata la collaborazione con Zavattini, iniziata nel 1942 con Quattro passi fra le nuvole e proseguita nel dopo guerra con Un giorno nella vita, Fabiola, Prima comunione sino ad Amo re e chiacchiere (1957). E questi dati sono significativi per un regista che ha particolarmente sottolineato l’importanza degli sceneggiatori, con più intelligenza di quanto non si creda, anche se divenendo normativa la sua concezione porterebbe a un cinema di confezione generalizzato. Sul piano estetico mi sembra abbastanza collegata al neorealismo l’esi genza di un cinema totale, con referente diretto la realtà, senza la media zione di generi e retoriche. Esigenza che si è poi spesso mediata o con il « demone del melodramma » di cui parla Bazin o con la commedia, alla quale appartengono parzialmente o integralmente molte opere neoreali ste. Con quali risultati non è qui il luogo per dibattere. Comunque, già a questo proposito si può osservare come tutto il cinema di Blasetti sia intimamente legato ai generi e ad essi debba molta della sua vitalità. Diversamente dal cinema di Camerini, che ha saputo penetrare più in profondità in determinati generi (oltre alla commedia anche il melodram ma di Una romantica avventura), si direbbe che Blasetti li abbia tocca ti tutti e con distacco, forse con qualche caduta, però nel complesso con una concezione generale del cinema come strumento di riproduzione, prima che della realtà, di altre forme di riproduzione o di espressione artistica. La sua spesso affermata ammirazione per l’arte figurativa, l’at tenzione agli aspetti figurativi e scenografici è al proposito altrettanto importante quanto il ricorrente desiderio di riprodurre e salvare nel ri
Il neorealismo e il cinema italiano degli anni trenta
413
cordo con il cinema le esibizioni di attori teatrali, che vanno dal Petro li™ di Nerone (1930) alle vedettes del varietà di Europa di notte e Io amo tu ami-, e così pure la fedeltà a certi testi teatrali, da La tavola dei poveri di e con Viviani a La cena delle beffe di Benelli. In quest’ottica, a prescindere dal mitico Sole, 1860 (1934) si rive la anche per la concezione del film storico come genere; ed è proprio il finale fascista, che si riteneva spesso appiccicato dall’esterno, che con tribuisce a mio avviso a dare al film anche un’altra dimensione, quella di film-indagine, come il successivo Vecchia guardia dello stesso anno. Indubbiamente sono questi i due film di Blasetti più apparentati ad un uso non del tutto predeterminato della messa in scena, ad un rapporto non rigido tra individuo e storia (soprattutto nel primo film). In nessu no dei due, comunque, Blasetti tralascia le sue ricerche figurative, che non contraddicono il resto. Entrambi i film testimoniano anche la pre senza all’interno del fascismo stesso di una corrente che auspicava un’ arte legata alla realtà e che non per questo era estranea al fascismo. In Quattro passi fra le nuvole, di cui unanimemente e a ragione si rileva un calo nella seconda parte, si potrebbe invece osservare che nel la prima è proprio un uso attento dei codici della commedia che dà al film quella singolare vitalità che gli è stata riconosciuta, mentre suc cessivamente il film cade veramente in un « abbandono alla realtà », che però è una realtà falsa, ricostruita, teatrale. Sono questi essenzialmente i film del periodo fascista che la critica del dopoguerra (c in parte quella contemporanea) ha privilegiato, con la parziale eccezione della tetralogia fantastica (Ettore Fieramosca, Salvator Rosa, Corona di ferro, Cena delle beffe), tutt’altro che spregevole, e del Nerone (per la fama di Petrolini). La tavola dei poveri (1932) è meno considerato, sebbene unisca alla fedeltà all’originale teatrale parecchie in venzioni cinematografiche e una messinscena spesso più imprevedibile che in Quattro passi fra le nuvole. Tutti i rimanenti film sono ormai invisi bili (di alcuni si è conservato il negativo ma non sono stati ristampati); il che ripropone il problema del funzionamento della Cineteca, ma fa an che pensare a un possibile legame tra la sorte materiale di certi film e la loro fortuna critica, come rilevano gli amici di Cinegramma. Passando alle opere del dopoguerra, mi sembra che Un giorno nella vita (1946), nonostante Zavattini, sia estraneo al neorealismo sia ideo logicamente (un rifiuto della violenza al di sopra della storia) che stili sticamente. Basterebbe confrontarlo con l’episodio del convento di Pai sà, ma si potrebbe anche rilevare il ruolo semidivistico degli attori (Nazzari, Girotti, Cegani ecc.) e la retorica del tutto. Fabiola, una sorta di con tinuazione della tetralogia fantastica-avventurosa (di cui il pacifismo è, come ne La corona di ferro, l’elemento meno interessante), ricorda il neo realismo solo per la massa degli sceneggiatori, quasi portasse agli estremi
414
Il neorealismo cinematografico italiano
quella caratteristica che Bazin ha rilevato in molti film italiani del pe riodo a differenza dei film americani, [«vi si trova regolarmente il nome di un democristiano e di un comunista (come nel film un marxista e un prete). Il terzo cosceneggiatore è reputato per saper costruire una storia, il quarto per trovare le gags, il quinto perché fa dei buoni dialoghi, il sesto "perché ha il senso della vita" ecc. ecc.»]. Infine Prima comunio ne (1950), a proposito del quale Blasetti su «Film» ha esplicitamente considerato esaurita la funzione dell’attore-uomo della strada, esso è una commedia che non assurge all’astrazione che probabilmente voleva darle Zavattini, né rimanda ad una realtà vera e propria. La risposta al perché del calo che innegabilmente c’è stato nella produzione del dopoguerra di Blasetti (come in quella di Camerini), ri sposta che spesso si è data in termini troppo semplicistici, andrebbe vice versa formulata seguendo in dettaglio l’evoluzione interna della sua ope ra. Proprio in questo, forse, il rapporto di Blasetti col neorealismo sem bra avere una sua «tipicità»: anch’egli, come altri registi, vi ha «par tecipato » per ragioni sue, di evoluzione interna dell’opera (senza igno rare, naturalmente, ma in ultima istanza, l’influenza unificante del mo mento storico), ragioni alla cui idealizzazione ha egli stesso partecipato. Alle soglie dell’evoluzione successiva di Blasetti, ormai del tutto estranea al neorealismo, si colloca la partecipazione come attore-inter prete di se stesso in Bellissima (1951). Questo film di Visconti mi sembra avere, oltre a tantissimi altri meriti, quale quello di essere un documen to del passaggio dal cinema neorealista a quello posteriore, anche il merito di una delle più acute puntualizzazioni critiche su Blasetti regi sta, autore di un cinema tradizionale che si è accostato alla realtà (più che al neorealismo) dalla stessa posizione da cui nel film cerca una bam bina-attrice non professionista. Ma oltre ad essa pare esserci anche una puntualizzazione critica « di Blasetti »: prestandosi a questa interpretazione egli sembra voler ricor dare anche agli altri registi la condizione di professionalità da cui han no partecipato al neorealismo.
Durante il settembre 1974, nell'ambito della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, a Pesaro, si svolse un’ampia rassegna del neorealismo cinematografico italiano, illustrata da quattro volumi di «quaderni di documentazione *», e parallela a un seminario sul neorealismo suddiviso in quattro temi (e luoghi) di dibattito, poi chiuso da una seduta di riepilogo generale. Scopo del seminario non era quello di giungere a conclusioni definitive, ma soltanto di offrire la possibilità di alcune verifiche testuali (sui film) e di alcune elaborazioni su cui si potesse aprire un dibattito, nazionale e internazionale, tale da dare un serio contributo alla prospettiva, né semplice, né immediata, di una «sistemazione» * storica del neorealismo, dei suoi autori, dei suoi film. Il seminario non rispose, ovviamente, a tutte le questioni per cui era convocato; né, quando rispose, dette risposte univoche, esaustive e improntate a uno stesso rigore. Eppure segnò una svolta nella storiografia critica sul neorealismo e costituì un evento storico da allora insuperato sia per la mole dei suoi apporti interpretativi e documentativi sia per la vivacità delle polemiche che ne seguirono e delle diecine di studi che su di esso, nel consenso e nel dissenso, si fondarono. Ripubblichiamo, in terza edizione, i testi integrali delle trenta fra relazioni e comunicazioni - con l’introduzione di chi allóra promosse e difesse l’evento - convinti che, da un lato, si tratri del contributo anche quantitativamente più rilevante al discorso storico e critico sul cinema italiano del dopoguerra e che, dall’altro, il volume dòcumeuti un episodio importante della storia della cultura cinematografica italiana e di un’istituzione - la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - che di questa storia è stata, dal 1965, ed è tuttora, una realtà rilevante. Scritti di (in ordine di indice); Lino Micciche, Alberto Abruzzese, Savoia Chemotti,
Nicoletta Mister, Michele Conforti-Gianm Massironi, Claudio Zanchi, Callisto Cosulich,
Carlo Lizzani, Gianfranco Bettetini, Gianni Scalia, Antonio Prete. Paolo Bcrtctto, Camilla Colapn.te-Carlo Merletti-Giuliano Rossi-Massimo Var.r.ucchi, Maurizio Grande-Franco
Pecori, Giuseppe Gate, Sandro Petraglia. Pascal Bonitzer, Adelio Ferrero, Giorgio Tir.azzi, Ugo Finerti, Fllis Donda, Tommaso Chiaretti, Adriano Apri, Tino Ranieri. Andrea Martini-
Marco Melani, Gianni Menon, Francesco Casetti-Alberto Farassino-Aldo Grasso-Tatti Sanguineo, Vito Zagarrio, Claudio Carabba, Jean Giil, Sergio Giinck Germani.
Lino Micciché, studioso e docente universitario (a Trieste. Siena, Parigi iti c Roma mj di cinema, ha svolto intensa attività pubblicistica come critico dnemati'gkfico
c ha pubblicato, oltre a numerosi saggi; una trentina di volumi su autoii, opere, periodi e movimenti della cinematografia mondiale. È aie talmente presidente della Scuota Narionalc
di Cinema c direttore della rivista «Bianco &c Nera *.





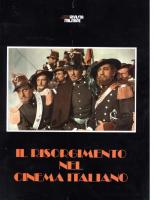
![Il sonetto italiano [I ed.]
9788843086467](https://dokumen.pub/img/200x200/il-sonetto-italiano-inbsped-9788843086467.jpg)



