Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico 8815089071, 9788815089076
La figura del legionario romano, il fante cittadino che domina i campi di battaglia dell'antichità è strettamente l
312 74 5MB
Italian Pages 206 [204] Year 2002
Polecaj historie
Citation preview
La figura del legionario romano, il fante cittadino che domina i campi di battaglia dell'antichità, traduce valori che sono espressione di un profondo senso del dovere nei confronti dello Stato. A partire dagli archetipi omerici del guerriero e dall'analisi delle battaglie e degli armamenti oplitici, il libro segue l'evoluzione della figura del soldato, nel contesto degli ordinamenti militari prima greci, poi romani, cogliendo le trasformazioni di età monarchica, repubblicana e imperiale. Tra battaglie, guerre e pace, sono descritte tattiche, armi ed equipaggiamenti dei legionari, nonché il loro universo culturale, politico e sociale, in un ampio quadro dell'evoluzione storica degli eserciti nei mondo classico.
Giovanni Brizzi è professore ordinario di Storia romana nella Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Bologna.
È stato
professore alla Sorbona. Tra i suoi lavori ricordiamo ·Annibale: come un'autobiografia» (Rusconi, 1994; Premio •Di Nola» dell'Accademia dei Lincei) e •Storia di Roma. l: Dalle origini ad Azio» (Patron, 1997).
€ 1� SO Cover design: Miguel Sal & C.
Società editrice il Mulino
ISBN 88-15-08907-1
l l Ili
9788815 0 89076
Questo volume fa parte di una Serie promossa dal Dipartimento di Storia antica dell'Università degli Studi di Bologna, pubblicata in diverse collane del Mulino.
Nella collana ((Universale Paperbacks il Mulino»: Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico di GIOVANNI BRIZZI
La donna romana. Modelli e realtà di FRANCESCA CENERINI
Nella collana Jisseo - rimase loro estranea a lungo: in quest'ambito, infatti, essi erano frenati dal rispetto di un ethos ancestra li' e tenacissimo. Per riprendere il parallelo proposto in un passo pre n�Jentemente citato, è degno di nota, secondo Plutarco vie
35
(Marcello, 22) «il fatto che a Sparta il legislatore abbia di sposto i sacrifici in ordine inverso rispetto a Roma». Du rante quello che il biografo chiama «il trionfo maggiore», concesso ai generali che abbiano vinto i nemici in batta glia con grande spargimento di sangue, i Romani sono in fatti soliti, «per antica usanza, sacrificare un bue»; in oc casione di quello minore, attribuito a quanti abbiano as solto con successo la loro missione senza bisogno di ri correre alle armi, usano invece sacrificare una pecora. Pur dovendosi sottolineare preliminarmente sia alcune imprecisioni contenute nel testo (è fraintesa, per esempio, la reale natura del trionfo, che sembra essere stato, in ori gine, solo una cerimonia di purificazione per il sangue versato; per cui è ovvio, in fondo, che il ricordo di una minore caedes si cancelli con una vittima meno nobile), sia un più generale travisamento (l' ovatio, infatti, non premia mai, neppure in seguito, la rinuncia all'uso della forza; distingue solo una vittoria di portata ridotta o sot tolinea la natura di un evento, comunque bellico, di im portanza e prestigio minori), non si può però discutere la sostanziale fondatezza del rilievo plutarcheo; e appare evidente il diverso atteggiamento assunto da Greci e Ro mani nei confronti della metis. Privilegiato, come si è visto, all'interno del mondo elle nico, questo prezioso requisito sembra invece essere stato, più ancora che penalizzato, addirittura escluso a priori dal più antico codice bellico romano. Non solo, infatti, esso non figura dapprima tra le arti della mente che i Romani sempre secondo Plutarco - considerano legittime (sono in qualche modo ammesse homilia, la trattativa, e peith6, la persuasione; ma, per esempio, non apdte , l'inganno, che pure di métis è una componente non secondaria e diviene successivamente un sinonimo); ma contrasta apertamente con la virtù romana per eccellenza, e cioè con la /ides. Tale nozione - che definisce originariamente, in lati no, il corretto e leale comportamento - sembra avere rap presentato, almeno per il Romano dell'età arcaica, il pre supposto teorico essenziale ad ogni tipo di rapporto, tam privatim quam publice, in pubblico non meno che in pri-
36
vato. Divinizzata secondo la tradizione fino dall'età di Numa Pompilio, Fides è collegata da sempre con la mano destra, che ne costituisce, secondo i p hysici, i naturalisti, l'autentico santuario corporeo. Apertamente sottintesa nella pregnanza del gesto compiuto da Scaevola, la sacra lità della mano destra ha, non a caso, autorizzato per an tifrasi un parallelo con la prassi dei flamini maggiori, che proprio alla Fides sacrificano manu ad digitos usque invo luta, con la mano coperta di panno bianco onde preser vare la necessaria purezza rituale. Il ricorso ad essa come arra di ogni impegno, come tramite di ogni azione che esprima la volontà di assumersi un obbligo comporta mentale di qualunque genere verso una controparte, è una costante simbolica che trascende di gran lunga i limi ti stessi del mondo romano. All'etimo di fides, comunque, vengono generalmente ri condotti anche i termini /oedus e /etiales. Sono proprio i feziali - il collegio sacerdotale preposto alla custodia del fas, del precetto divino e della religione in tutto ciò che concerne i rapporti con gli altri popoli - a ratificare con un giuramento solenne i trattati (/oedera) internazionali. Strettissimo sempre, il rapporto tra la /ides e il giuramento, che la pone in essere anche là dove di per sé non esiste rebbe, è tanto più intimo e cogente nel caso di un trattato tra due Stati, del quale il ius iurandum rappresenta il car dine e la premessa; e la preghiera rivolta a luppiter duran te il sacrificio, di colpire chi violi il patto con la stessa vio lenza con cui si percuote la vittima rituale, chiama a garan te la divinità, la cui folgore è simboleggiata nella stessa arma di selce impugnata dal sacrificante, il pater patratus, capo, precisamente, dei feziali. In questo modo la /ides che i contraenti si scambiano non è la semplice affermazione di un proposito umano che, anche se sincero, è però volubile e potenzialmente caduco; ma è garantita dallo stesso dio che sanziona i giuramenti e castiga il fedifrago. Sulla /ides il Romano delle origini sembra dunque avere costruito tutta la sua concezione del rapporto tra i popoli; e anche la guerra, che di questo rapporto rappre senta una fase, un momento sia pure anomalo, va sogget37
ta alle stesse regole. Anche alla dichiarazione di guerra sono preposti i fetia les, e l'apertura delle ostilità è prece duta da una vastissima serie di cautele, morali e di proce dura, che hanno lo scopo di verificare eticamente e di rendere sacralmente iustum il bellum, il conflitto che sta per avere inizio; e di garantire così l'appoggio degli dei il quale, solo, stabilisce la differenza tra i contendenti e as segna la vittoria. La fides deve, dunque, essere prerogativa, in primo luogo, proprio di un capo militare, console o pretore che sia: chiamato a continuare con la guerra l'opera dei fezia li, il magistrato che comanda gli eserciti della Repubblica è partecipe di ben precisi caratteri religiosi, e deve per tanto possedere in sommo grado questo requisito, che giustifica il suo stesso imperium, la facoltà di guidare i concittadini contro il nemico. Come ricorda Cicerone (De o/ficiis, I, 4 1 ) , nel segno della vis, della violenza, o della fides violata si cominciano le ostilità; nel segno del ripri stino della /ides si possono concludere, con il ricorso ad essa da parte dei vinti, cui resta questa sola alternativa al bellum internecivum, allo sterminio. In tal caso, lo stesso uomo che ha interrotto la pace è chiamato a ricomporla, accettando in /idem gli sconfitti con l'imposizione - anco ra una volta - della mano destra: per assicurare la vittoria al suo popolo egli deve però mantenere inalterato lo spe ciale rapporto con gli dei, rispettando anche durante la guerra i limiti precisi che essi hanno fissato. Ogni conflitto è, inevitabilmente, pura violenza, una violenza che ricade anche sui civili; ed esistono atti i qua li, pur dolorosi per coloro che ne sono le vittime, non re cano tuttavia alcun biasimo a coloro che li compiono (Li vio, XXXI , 30, 3-4). Almeno in presenza di un iustus ho stis, di un nemico regolare, tuttavia, la guerra non deve essere frode sotto nessuna forma: la fides, cioè, dev'essere rispettata non solo nell'intraprenderla, ma anche in. . . ge rendo et deponendo, nel condurla e nel porvi termine (Ci cerone, De legibus, II, 14, 34), mantenendo una continui tà di comportamento che, sola, garantisce a chi la rispetti il favore divino. 38
Tornando per un attimo, qui, allo spregiudicato afori sma di Lisandro, che in ragione del suo valore esemplare abbiamo scelto per aprire questo volume, il concetto che esso esprime sembra echeggiare anche nella «parallela» vita plutarchea, quella di Silla. Riferendosi al carattere del suo grande avversario, infatti, Papirio Carbone rileva come, nell'animo di Silla, coesistano il leone e la volpe; e delle due forze che lo muovono afferma di temere assai più la seconda che non la prima (Plutarco, Silla, 28). A ben vedere, tuttavia, rispetto al motto pronunciato dallo Spartano l'ottica della frase appare qui completamente rovesciata: lo chiarisce, al di là di ogni dubbio, il paralle lo con un passo di Cicerone. Secondo costui, infatti, vi sono due modi di commettere iniuria di violare, cioè, il ius, il diritto -, aut vi aut /raude, con la violenza o con l'inganno; atteggiamenti che sono la fraus quasi vulpecu lae, la vis leonis, caratteristici cioè l'uno della volpe, l'al tro del leone. A suo avviso, tuttavia, benché entrambi sia no homine alienissimum, /raus odio digna maiore, benché entrambi siano contrari all'umana natura, è la frode a de stare ripugnanza maggiore (Cicerone, De of/iciis, I, 4 1 ) . Il quadro è sostanzialmente coerente; m a comporta una constatazione che non può non sorprendere. I Roma ni reputano evidentemente disonorevole condurre la guerra more latronum. Cum iusto enim et legitimo hoste..., adversus quem et totum ius /etiale et multa sunt iura com munia, contro un nemico regolare, rispetto al quale vige la nonna feziale ed è comune gran parte del diritto ( Cice rone, De of/iciis, III, 29, 108), l'etica impone infatti di combattere faccia a faccia, senza ricorrere ad insidie, im boscate, tradimenti, attacchi notturni, inganni o espedien ti di qualunque genere (Livio, XLII, 47, 5; si veda anche Polibio, XXXVI , 2). Quella tracciata qui non è, naturalmente, che la for mulazione di una serie di principi, morali e giuridici, i quali - come, del resto, le nonne di ogni etica e i precetti di ogni religione - vanno soggetti ad innumerevoli viola zioni. Più ancora, siamo di fronte alla cristallizzazione ul tima del pensiero romano: frutto di incrostazioni successi-
39
ve e di una formalizzazione religiosa a posteriori, almeno sul piano concettuale il quadro è stato perfezionato in via definitiva forse solo dai teorici dell'ultima Repubblica. Senz'altro originale e antichissimo è, viceversa, il concetto informatore, quello di fides, che si collega in modo indis solubile a riti sicuramente arcaici, come il sacrificio dei flamines maggiori, o alla nozione (non solamente latina) di bellum iustum; e del pari autentico (ed esso pure anti chissimo) sembra essere quindi anche il particolarissimo rapporto instaurato con il nemico. Non si può non rilevare, a questo proposito, come il latino, che tanto deve agli apporti della lingua ellenica, e in particolare il suo lessico militare e politico, nato nel solco di una tradizione storiografica i cui primi esponenti scrivono tutti in greco, manchi di un'espressione atta a tradurre letteralmente il vocabolo stratégema, stratagem ma, la cui estensione semantica si estende, nella lingua el lenica, ad abbracciare tutta la vasta gamma di espedienti e scorciatoie morali, di accortezze e inganni diversi, utili e comunemente impiegati in diplomazia come in guerra. Vi è, tuttavia, ancora una domanda almeno alla quale occorrerebbe cercar di rispondere: che cos'era, inizialmen te, «quella fides il cui culto preesisteva da tempo tra le po polazioni latine»? (Piccaluga, Fides nella religione romana di età imperiale, p. 707). Pur se molto probabilmente natu ra e funzioni originarie del concetto non saranno definite mai con assoluta certezza, si può tuttavia avanzare, in pro posito, qualche congettura. Al di là della versione ufficiale, frutto di incrostazioni successive e di una formalizzazione a posteriori, all'interno del sistema che si suole, per conven zione, definire «romano» si intuisce, persistente a lungo, la traccia di un valore antichissimo, istintivo ed originaria mente individuale. Ben prima che esistano le p6leis, prima che si fissino per iscritto le leggi e i /oedera , prima persino che la sacralità abbandoni il suo stadio primordiale, l'idea di fides sembra essersi affermata come fondamento essen ziale di una parte almeno della primitiva società italica. Nel momento stesso in cui due uomini si porgono la de stra in segno di intesa - un'intesa che entrambi intendono 40
rispettare - nasce il più antico sodalizio civile, koinonia tra individui, dapprima, non tra Stati, e istintivamente aristo cratica perché aperta ai migliori soltanto. Fides, il corretto e leale comportamento, costituisce, secondo me, la base, il presupposto stesso di questo codice di condotta; un codice che regola inizialmente il rapporto tra i nobili indipenden temente dall'appartenenza o meno a una stessa città, per ché delle città è più antico; e che dall'ambito personale o gentilizio passa poi ad informare di sé il primitivo diritto delle genti. Come già si è detto, questo atteggiamento coinvolge, in linea teorica almeno, anche il campo dell'attività belli ca. Si è parlato, in proposito, delle «buone regole della cavalleria antica», che condizionano il comportamento ro mano. Si è detto che «l'osservanza di certe regole di con dotta della guerra» è tenuta in onore «non soltanto come segno di appartenenza al mondo civile, ma come segno di rispetto per una tavola di valori etici che sottostà al rigo re delle forme» (Frezza, In tema di relazioni internaziona li, pp. 353 -354; Id., Le relazioni internazionali di Roma, pp. 348-349); e, in effetti, con il nemico sembra instau rarsi un rapporto che, nell'ostentato ripudio di ogni fello nia, richiama in qualche modo alla mente l'etica cavalle resca di età medievale. Tale rapporto, tuttavia, non è sempre, né universal mente, valido. Dal vincolo individuale le relazioni tra gli Stati mutuano infatti poco a poco tutti i loro caratteri; non solo i presupposti teorici e le modalità operative, ma gli stessi limiti ideali, che esistono e sono determinati soprat tutto dalla natura degli uomini, diversi tra loro per estra zione o patrimonio culturale. Come, nel Medio Evo, non tutti saranno uguali di fronte ai precetti dell'etica cavallere sca, così non tutti sono uguali ora di fronte alla /ides: l' ap plicazione di questo requisito sembra infatti condizionata fin dall'inizio da ben precisi criteri. Sia pur con qualche eccezione, infatti, la loro piena lealtà gli aristocratici la ri servano soprattutto a quanti riconoscano come loro pari; e la estendono, per conseguenza, alle realtà politiche che ne siano in certa misura rappresentate o espresse. 41
Il vincolo di fides (e quindi l'obbligo di condurre un bellum iustum) è dunque naturalmente operante di per sé fino dalle origini nei confronti di quelle comunità che i Romani sentono politicamente e culturalmente affini: es senzialmente, cioè, le popolazioni dell'Italia tirrenica - i Latini, per esempio, poi gli Etruschi e i Campani, che a formare la composita identità romana hanno contribuito fino dai primi secoli, che sono uniti ad essa dai vincoli di parentela tra grandi clan e famiglie nobiliari e che, attra verso questo vettore, si sono poi integrati appieno nella cit tadinanza. In seguito, probabilmente, questo rapporto si estende attraverso la definizione di un ius comune, quello /etiale, ad altre genti ancora, quelle che, pur in qualche modo difformi, come i Sanniti, sono però legate alla Re pubblica da un /oedus, da un regolare trattato (o dalla rot tura di esso); e, più tardi, a tutte quelle che, comunque, siano formalmente riconosciute dallo Stato romano. Là dove, per qualche motivo, questa condizione non esista o venga a mancare, la res publica reputa, in fondo, possibile ogni compromesso; e un'eventuale guerra costi tuisce, in questo caso, non un bellum iustum, ma un la trocinium. Non è credibile quindi che i Romani - forse neppure agli inizi della loro storia - abbiano veramente ignorato del tutto la guerra per espedienti. Si può notare come, nel rapporto con fides, gli aristocratici dell'Urbe (i quali rappresentano soprattutto le p6leis dell'Italia tirreni ca) abbiano ben presto stabilito eccezioni, talvolta estre mamente significative, nei confronti di chiunque non rite nessero loro simile e come - verso nemici quali i Celti, per esempio, con cui non vi erano rapporti di affinità im mediata, o verso realtà politicamente anomale, come quelle democratiche, nella cui natura non potevano in al cun modo riconoscersi - si siano sentiti spesso liberi di impiegare metodi di lotta diversi da quelli consueti. Si può tuttavia ritenere con altrettanta verosimiglianza che, pur considerate inevitabili, queste forme di lotta continuassero nondimeno a ripugnar loro profondamente; e fossero sentite come attività inferiori, spesso indegne persino di esser menzionate. Anche i conflitti per così 42
dire plebei debbono essere combattuti; e hanno regole a sé, meno facilmente confessabili. Ad esse ci si piega, dun que, se costretti dalle circostanze o da nemici di natura particolare; ma si cerca poi subito dopo di tornare alla normalità e di rimuovere persino dalla memoria le tracce di un operato che, in ultima analisi, resta comunque bia simevole o, almeno, ignobilis. Dell'esistenza (e della sincerità di fondo) di un simile atteggiamento è, secondo me, molto difficile dubitare, ove si ricordi che al pensiero romano delle origini manca precisamente il concetto di stratégema; o, meglio, manca, fino alla fine del III secolo almeno, un'accezione positiva di esso, che viene recepita solo più tardi. I termini inizial mente usati per tradurre questa parola (/raus o perfidia, dolus o calliditas) ne ricoprono infatti solo parzialmente larea semantica; e possiedono, in latino, una valenza pro fondamente negativa, del tutto sconosciuta all'originale. Sembra certo, perciò, che la vocazione della Repubblica alla guerra per espedienti fosse, in origine, limitata, rivol ta ad ambiti ben definiti e, comunque, contrastata da re more etiche assai più forti di quelle che, pure, esistevano anche nel mondo greco. 3 . La legione alla prova. Tra i Sanniti e Pi"o Affrontando le genti appenniniche e in particolare la più temibile tra esse, i Sanniti, sul loro terreno, i massicci montuosi del Molise, i Romani furono costretti a muover si e ad operare all'interno di teatri estremamente difficili; e soprattutto dovettero adattarsi a forme nuove di lotta, come quella guerriglia che, in montagna, trovava il - suo spazio privilegiato. Non tutto il territorio sannitico aveva, certo, i caratte ri scoraggianti dell'altopiano del Matese, il mons Tz/ernus dell'antichità, che costituiva lacropoli naturale della tribù dei Pentri. Qui il limitato numero di accessi dal piano, l'asprezza dell'ambiente naturale, l'orlo elevato conferiva no alla montagna requisiti difensivi particolarmente effi43
caci, tali da costringere l'attaccante a tentare o una diffi cilissima scalata delle pareti o la conquista dei varchi aperti dall'erosione delle acque e dall'opera dell'uomo: varchi che erano, però, quasi tutti strettoie lunghe e im pervie, agevolmente difendibili con poche forze soltanto. Ai difensori, invece, I'estesa rete di mulattiere permetteva facili spostamenti per linee interne, mettendoli in grado di fronteggiare ogni minaccia. Per contro, il cuore dell' al topiano non poneva loro che problemi minimi, di natura soprattutto logistica, legati per lo più alla scarsità di risor se propria della montagna; problemi, però, che le forme di difesa prescelte in antico sembrano avere risolto in sé. Anche altrove, tuttavia, il problema militare si presen tò, per i Romani, di non facile soluzione. In montibus vi catim habitantes (Livio, IX, 13, 7), disseminati ovunque, tra le loro montagne, in insediamenti sparsi, i Sanniti non conobbero un autentico processo di urbanizzazione se non nel corso del I secolo a.C., dopo essere entrati defi nitivamente a far parte della confederazione romana, e cioè al termine della guerra sociale (90-88 a.C.) e del ter ribile pogrom sfilano (82 a.C.); la loro realtà si identifica va dunque, in origine, non con una o più p6leis maggiori, e quindi con pochi impianti urbani ben definiti soltanto, che si sarebbero potuti agevolmente conquistare e tenere, ma con una miriade di centri minori, dispersi su tutto il territorio. Se gli insediamenti civili talvolta mal si presta vano ad essere muniti di mura, sia per la loro posizione, esposta e non arroccata, sia per una dislocazione fin trop po irregolare, a partire soprattutto dal periodo delle guer re contro i Romani e fino all'invasione annibalica almeno i Sanniti presero a dotarsi in misura crescente di strutture fortificate specifiche, che con le entità vicane non sem brano aver avuto se non rare corrispondenze e apparten gono per lo più a tipologie nuove. Anche quando, poi, vi sia una coincidenza topografica tra centro fortificato e realtà insediativa il luogo difeso sembra essere stato, per i Sanniti, una pertinenza non del vicus, bensì della comunità intera. Questa popolazione sembra, cioè, aver concepito la propria realtà come forma44
ta di più ambiti territoriali, che andavano protetti nel loro complesso. Tutta la parte montuosa del Sannio venne dun que disseminata di punti fortificati e di opere difensive di vario genere che, come si è detto, non sembrano di solito coincidere con i centri abitati. Poiché oggetto della difesa - o, meglio, dell'interdizione attiva - era la regione nel suo insieme, si disponevano al suo interno ostacoli di natura e di carattere diversi, che, bloccavano gli accessi e presidia vano i passaggi intermedi. Sul territorio si disponeva una serie estremamente composita di infrastrutture strategiche, che consistevano, tra l'altro, in una rete di collegamento vi sivo efficiente lungo direttrici ottiche individuate con cura; in una catena di capisaldi estenii, destinati all'avvistamento e all'allarme; in un fitto intreccio di mulattiere per la co municazione interna, lungo il cui percorso erano poi di sposte in successione più opere di sbarramento, destinate a frazionarle, probabilmente con fortificazioni e ponti mobili, oggi scomparsi, posti a cavallo dei tratti obbligati. Questo sistema definiva, di fatto, una sequenza di com partimenti stagni e ritagliava alcune grandi aree protette. L'efficienza militare va dunque cercata nelle caratteristiche dell'insieme assai più che nella capacità di resistere dei sin goli impianti cintati: e, reciprocamente, la validità di questi deve essere valutata sulla base della loro concatenazione, dell'interdipendenza cioè e dell'appoggio che essi potevano offrirsi reciprocamente. Disposti a catena in posizioni do minanti, gli oppida, i centri in altura, erano collocati in modo da controllare ampi settori di territorio o interi com plessi montuosi. Provvisti spesso di più ordini concentrici di mura, alte e massicce anche se non impenetrabili, essi avevano la funzione o di punti provvisori per la raccolta dei difensori (che, tuttavia, si disperdevano poi verso i sin goli settori minacciati); o di rifugio per i profughi e per le masse armentizie (le quali, per inciso, garantivano lauto sufficienza di approvvigionamento dell'intero complesso). Ove si accetti di riconoscere loro queste funzioni, è possibile forse ipotizzare, per gli altipiani sannitici, strate gie di difesa ben precise. Nel caso in cui i centri di avvi stamento segnalassero lavvicinarsi di un esercito invasore, 45
oltre che entro queste particolari strutture i fuggiaschi trovavano rifugio entro le più vaste aree protette ricavate all'interno dell'altopiano. Composto, come si è detto, da un gruppo di fortificazioni collegate tra loro e disposte in serie a proteggere l'intero territorio, il sistema creato dai Sanniti ricorda in certo qual modo le regioni fortificate del XIX secolo, grandi abbastanza perché le truppe desti nate alla difesa non potessero esservi bloccate, ma non così estese che l'invasore potesse attaccarvele oltre il rag gio protettivo delle piazzeforti che le componevano. Tale sistema prevedeva, del resto, ampie possibilità di scampo per i difensori. Grazie a percorsi e a passaggi ce lati al nemico, i Sanniti erano spesso in grado di sottrarsi alla pressione dei legionari, abbandonando di nascosto e alla spicciolata i capisaldi attaccati; ma erano poi sempre pronti a rioccupare quelli che non fossero stati adeguata mente presidiati, costringendo i Romani a chiedersi se convenisse disperdere le proprie forze in tante piccole guarnigioni, a rischio di essere annientate una per una, o rinunciare ai vantaggi conseguiti nelle operazioni militari di più vasta portata. Ciò condizionò a lungo la condotta della guerra nel Sannio. Malgrado la diffusione del kardiophylax, il pettora le metallico presente soprattutto nella forma a triplice di sco, questo popolo, come le altre genti dell'Italia appenni nica, prediligeva un armamento leggero, basato principal mente sull'uso del giavellotto, che non ne pregiudicasse l'agilità; ma era perciò stesso assai poco votato alla batta glia campale. Durante le guerre sannitiche, questa rimase un evento raro, se non proprio inesistente: contro un ne mico sempre presente e minaccioso, ma pronto ad evitare il contatto, che costringeva ad inseguirlo senza accettare la lotta tranne che in condizioni vantaggiose, le operazioni consistevano quindi per lo più «de marches, de contremar ches, d'embuscades, d'assauts contre des villes ou des for teresses» (Saulnier, L'armée et la gue"e chez les peuples samnites, p. 85), di finte, cioè, di attacchi, di ritirate e so prattutto di ritorni offensivi, di operazioni poliorcetiche, spesso ripetute contro i medesimi obiettivi, che furono 46
conquistati (ed evidentemente perduti) più volte da Roma nel volgere di pochi anni soltanto. Certo, i Romani giunsero infine a vincere la resistenza del Sannio; ma - pare - non a risolvere il problema che esso poneva. Benché la regione fosse interamente circon data di colonie; benché, con l'interruzione dei vettori del la transumanza interna, fosse tagliata fuori da ogni con tatto con gli Etruschi, con i Galli e con le altre popola zioni appenniniche, che avevano partecipato spesso alla lotta contro Roma, tra i Sanniti continuò a fermentare la resistenza; lasciati a margine del vasto processo di osmosi che aveva coinvolto quasi tutti gli altri Italici, essi rispose ro poi sempre, in seguito, ad una sorta di vocazione, che li poneva sistematicamente in rotta di collisione con lo Stato egemone; e si schierarono via via con Pirro e con Annibale, prima di prendere la guida degli alleati ribelli durante il bellum sociale e di innervare l'ultima resistenza della fazione mariana, spenta tragicamente nel sangue da Silla alla Porta Collina (82 a.C.). Per muoversi con qualche possibilità di riuscita in un ambiente simile occorreva, ai Romani, una legione ben Jiversa rispetto alla rigida struttura oplitica delle origini; e l'unità manipolare (v. supra) era pienamente adeguata allo scopo. Non era ancora adeguata, invece, al problema che le si sarebbe posto qualche anno dopo, quando avrebbe dovuto misurarsi per la prima volta con una fa lange di tipo macedone, guidata da Pirro, re dell'Epiro, che era venuto in Italia in soccorso di Taranto. Proprio nelle modalità di attacco stava il limite più �rave della formazione romana. Votata ad uno scontro solo frontale, essa fu, infatti, subito in difficoltà contro la manovra avvolgente di scuola ellenistica: ancora estrema mente ripetitiva e meccanica nei movimenti basilari, la le lo(ione poteva opporre all'azione dei pezeteri solo i reitera i i attacchi diretti dei suoi scaglioni, attacchi coraggiosi fino al suicidio, ma, di fatto, destinati ad infrangersi come onde su di uno scoglio contro un blocco massiccio di uomini il quale, di fronte almeno, risultava completa mente impenetrabile. Il sovrano epirota, inoltre, poteva 47
schierare in battaglia eccellenti cavallerie; e portava con sé, per la prima volta in Italia, venti elefanti indiani. Le prime due battaglie combattute contro Pirro si ri solsero quindi, per i Romani, in altrettante sconfitte, che costarono loro 7 mila e 6 mila caduti rispettivamente; ma, secondo il resoconto più plausibile, Pirro lasciò a sua vol ta 4 mila uomini, quasi tutti dei migliori - lo avrebbe ammesso, secondo Plutarco (Pi"o, 17, 7-8) lo stesso so vrano -, sul campo di Eraclea (280 a.C.), e ne perdette altri 3 .500 ad Ascoli Satriano (279 a.C.). Sebbene il bio grafo greco dipinga, non senza enfasi, la lotta impari tra le spade e le sarisse, la minaccia più grave per le forze epirote sembra essere venuta, però, dai pesanti pila da lancio in dotazione all'esercito romano. Non è un caso, infatti, che Pirro abbia mescolato ar cieri e lanciatori di giavellotto reclutati tra le popolazioni italiche sia agli elefanti, sia alla falange. Tra le funzioni svolte dalle truppe leggere, lo abbiamo detto, figurava da tempo oltre alla ricognizione e all'inseguimento, anche la protezione delle truppe di linea contro le punzecchiature degli ausiliari nemici; compito che era tanto più essenzia le in Italia, poiché mai, in passato, le armate ellenistiche avevano dovuto misurarsi con fanterie pesanti che fossero dotate al tempo stesso di armi da getto; e, soprattutto, mai avevano dovuto affrontare strumenti che avessero un'efficacia paragonabile a quella del pilum romano. Me scolando ai suoi pezeteri truppe italiche, certo difficili da raccordare ad una formazione serrata, Pirro mirava pro babilmente non tanto - come si è sovente sostenuto - a rendere più flessibile il proprio schieramento (il che, del resto, sarebbe stato di un'utilità per lo meno dubbia); quanto a creare, grazie ai dardi di cui queste erano prov viste, un'area di rispetto che in qualche modo protegges se la sua preziosa falange dai missilia dei legionari. Malgrado il trionfalismo delle fonti romane, neppure quella di Benevento (275 a.C.), l'ultima combattuta con tro Pirro, fu un'autentica vittoria. Secondo quanto è dato capire, in realtà, l'Epirota tentò di distruggere l'esercito di Manio Curio Dentato prima che si congiungesse con 48
quello dell'altro console, ma senza riuscirvi; e, al termine di una giornata incerta, quando seppe che Lucio Cornelio Lentulo era vicino, decise di ritirarsi. Le forze che gli re stavano non erano più in grado, infatti, di affrontare le due armate consolari riunite. Tatticamente uno stallo, Benevento rappresentò inve ce un indiscutibile successo strategico. Nelle battaglie cui si è accennato più sopra l'esercito di Pirro aveva subito petdite pesanti, alle quali vanno aggiunte quelle, non quantificabili ma certamente gravi anch'esse, riportate in Sicilia (dove il re era passato a combattere contro i Car taginesi, allora alleati di Roma) e soprattutto nella rotta navale subita durante il ritorno attraverso lo stretto di Messina; e molti dei caduti, se non addirittura la maggior parte, dovettero contarsi proprio tra i suoi falangiti. Pre ziosi per la loro funzione in battaglia, costoro rappresen tavano però una componente impossibile da rimpiazzare, almeno in tempi brevi. La ragione del fallimento di Pirro è dunque strategi ca, e va cercata, secondo me, nel progressivo esaurirsi delle sue forze migliori; in particolare nella quasi totale scomparsa delle fanterie scelte che aveva portato con sé dall'Epiro. Le truppe di élite impegnate a Benevento sembrano infatti essere state composte ormai in prevalen za di Italici, provvisti di un armamento inadeguato al combattimento in ordine chiuso; così, quella che le legio ni costrinsero infine a cedere il campo non era più, o al meno non era più integralmente, una falange di tipo ma cedone. La situazione del suo esercito, gravemente logoro e, ad un tempo, la fronda sempre più pronunciata degli nlleati greci e la sostanziale stanchezza degli Italici furono i fattori che indussero infine il sovrano epirota ad abban donare la partita, ritirandosi dalla penisola. Bibliografia 1 . Al problema del duello giudiziale accenna genericamente Dumézil, Gli dei dei Germani, cit., p. 84; per il risvolto romano
49
di questa pratica rituale si veda, oltre allo stesso Dumézil (Hora ce et !es Curiaces, Paris 1942), anche R Bloch, App. N. Combats singuliers entre Gaulois et Romains: /aits veçus et traditions celti� ques, in Tite-Live, Histoire romaine, Livre VII, Soc. d'édition «Les Belles Lettres», Paris 1968, pp. 108-1 17. Sulle «spoglie opi me»: RM. Rampelberg, Les depouilles opimes à Rome des débuts de la République à Octave, in «Revue Française de Droit Français et EtrangeD>, LVI (1978), pp. 191-2 14. Cfr. anche Mi chel, La /olie avant Foucault, cit., 1981, pp. 5 17-525. Sull 'ordinamento centuriato, oltre ai classici lavori di P. Fraccaro (uno per tutti: La storia dell'antichissimo esercito ro mano e l'età dell'ordinamento centuriato, in Atti del II congresso nazionale di studi romani, III, Roma 193 1 , pp. 91 -97 [= in Id., Opuscula, II, Pavia 1957, pp. 287-292]), cfr., tra gli altri: F. De Martino, Territorio, popolazione e ordinamento centuriato, in «BIDR», LXXX (1977), pp. 1-22; J.-C. Richard, Classis-in/ra classem, in «RPh», LI (1977), pp. 229-236; Id. , Proletarius. Quelques remarques sur l'organisation servienne, in «AC», XL VII (1978), pp. 438-447; Id., Notes sur la participation militaire dans la Rome archai'que, in «DHA», XII ( 1986), pp. 185-204; C. Ampolo, La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana, in Storia di Roma, I, Torino 1988, pp. 203-259. Sull'esercito arcaico e sull'evoluzione dalla struttura oplitica a quella manipolare si vedano, tra gli altri: Garlan, La gue"e dans l'antiquité, cit., p. 100; Ed. Meyer, Das romische Manipu larheer, seine Entwicklung und seine Vorstu/en, in Kleine Schrif ten, II, Halle 1924, pp. 193-329; A. Alfoldi, Der /riihromische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen , Baden-Baden 1952; P. Fraccaro, L'ordinamento manipolare, in Opuscula, IV, Pavia 1975, pp. 41-57; Id., Livio VIII.8, ibidem, pp. 59-64; ]. Cels Saint-Hilaire e C. Feuvrier Prevotat, Gue"es, échanges, pouvoir à Rome à l'époque archaique, in «DHA», V (1979), pp. 104- 136; W. Markov e H. Helmert, L'histoire à travers !es batailles de Ka desh à Hiroshima, Leipzig 1980, p. 63 ; J. Martinez-Pinna Nieto, Los origenes del ejército romano, Madrid 198 1 ; Id., La introduc ci6n del ejército hoplitico en Roma, in «CTEER», XVI (1982), pp. 33-44; Chr. Saulnier, L'armée et la gue"e dans le monde étrusco-romain (VIII•-IV• siècles), Paris 1980; R Bloch e Ch. Guittard, Introduction à Tite-Live, Histoire romaine, Livre VIII, Soc. d' édition «Les Belles Lettres», Paris 1987, in particolare CXIV ss. Sugli aspetti militari del sistema romano di alleanze: V. Ilari, Gli Italici nelle strutture militari romane, Milano 1974. Sul
50
mutamento di prospettiva anche ideologica, P.M. Martin, Muta tion idéologique dans les figures de héros républicains entre 362 et 269 avant ].-C. , in «REL», LX (1982), pp. 150 ss. Alla base del mutamento di struttura si è voluto vedere tal volta il contributo del modello militare sannita. Sui rapporti tra le due differenti strutture esistono ottimi lavori recenti. Agnès Rouveret (Tite-Live, Histoire romaine IX, 40. La description des armes samnites ou les pièges de la symmétrie, in Guerre et so ciétés en Italie au V' et IV' siècles av. ].-C. Les indices fournis par l'armement et les techniques de combat. Table ronde E.N.S., Paris 5 mai 1984, textes réunis par A.-M. Adam et A. Rouve ret, Paris, Ecole Normale Supérieure, 1986 [1988] , pp. 91-120) mette in guardia contro le simmetrie fittizie e le rappresenta zioni di maniera del resoconto liviano, ed evidenzia, viceversa, la percezione dei nessi esistenti tra strutture e mentalità diver se; Dominique Briquel (La tradition sur l'emprunt d'armes sam nites par Rome, ibidem, pp. 65-89) sottolinea come l'origine sannita di parte dell'armamento (scutum, pilum) resti un dato che non porta, in realtà, ad alcuna conclusione certa sulle tra sformazioni della struttura militare romana. Quanto a Charles Guittard (Les sources littéraires et historiques concernant l'arme ment du légionnaire romain, ibidem, pp. 5 1 -64), alla tradizione che colloca l'introduzione dello scutum in età di poco anteriore alle guerre sannitiche egli preferisce quella che la collega con l'origine dello stipendium, in un'epoca di poco posteriore all'in cendio gallico. Quand'anche ciò fosse, tuttavia, labbandono del clipeus non sarebbe di per sé un elemento decisivo per rial zare cronologicamente la modifica della legione: a mio avviso, infatti (cfr. G. Brizzi, I Man/zana imperza e la riforma manipola re: l'esercito romano tra /erocza e disciplina, in «Sileno», XVI/1 2, 1990, pp. 1 85-206, soprattutto pp. 205-206), l'adozione dello scudo rettangolare non comporta di necessità la fine della for mazione oplitica, che è da collegarsi viceversa alla scomparsa dell'basta, la lancia da urto, e alla sua sostituzione con il pilum da lancio. 2. I passi riportati nel paragrafo 2 sono tratti da: G. Picca luga, Fides nella religione romana di età imperiale, in ANRW, II, 17, 2, a cura di W. Haase, Berlin - New York 198 1 , p. 707; e da P. Prezza, In tema di relazioni internazionali nel mondo greco e romano, in «SDHI», XXXIII (1967), pp. 353-354; Id., Le relazioni internazionali di Roma nel terzo e secondo secolo a. C. , in «SDHI», XXXV (1969), pp. 348-349.
51
Sul trionfo lopinione prevalente è quella che si sia trattato, in origine, di un rito di purificazione. Cfr., ad esempio: G. Wissowa, Religion und Kultus der Romer, Miinchen 19122 (rist. 197 1), p. 104; W. Ehlers, Triumphus, in «PW», VII A (1948), c. 496; G.-Ch. Picard, Les trophées des Romains, Paris 1954, pp. 124- 13 1 ; G. De Francisci, Primordio civitatis, Roma 1959, p. 303 . Solo il Versnel (Triumphus. An Inquiry into the Origin and Meaning o/ the Roman Triumph, Leiden 1970) ha voluto vedere, nell'ingresso del vincitore in città, il ritorno del guerrie ro che porta su di sé il mana dei nemici uccisi. La sua propo sta sembra, nondimeno, essere rimasta sostanzialmente isolata. Su /ides fondamentale (pur se non sempre ne coglie tutti gli aspetti) è il volume di G. Freyburger, Fides. Etude sémantique et religieuse depuis les orzg/nes jusqu'à l'époque augustéenne, Paris 1986; e ancora da leggere sarebbero, benché datati, i lavori (tutti in francese) di Boyancé e Piganiol, di Heurgon, Grimal, Helle gouarc'h (che mi esimerò dal citare, perché reperibili nella bi bliografia di riferimento riportata). Sui diversi livelli di applica zione di questo valore, eccellente è larticolo di M.A. Levi, Ma nus, /ides, /ides publica, in > (e, naturalmente, di altrettante unità alleate), 80 mila uomini circa tra Romani e socii, rac colti per schiacciare il nemico sotto il peso del numero. Per avere una speranza di vincere, Annibale deve, af frontando una forza simile, contenere ad ogni costo la pressione che le massicce colonne legionarie eserciteranno sul suo centro per il tempo necessario a permettere che le sue superiori cavallerie prendano il nemico alle spalle. Egli divide dunque i veterani libici - forse 10 mila uomi ni in tutto - in due unità di pari consistenza numerica, ordinate in ranghi assai più profondi del consueto; e li schiera agli estremi del suo centro, tenendoli però in po70
sizione alquanto arretrata. Dispone poi il resto delle fan terie pesanti, Iberi e Celti, a formare una sorta di mezza luna, la cui parte convessa è rivolta verso il nemico. Po tendo contare su truppe numericamente assai inferiori ri spetto a quelle romane (che hanno sul campo - pare almeno 65 mila fanti), Annibale viene assottigliandone progressivamente i ranghi verso le estremità dello schiera mento; dove, con il convergere dei nemici verso il mezzo anche dai fianchi non impegnati, l'urto sarà meno violen to e diretto. Occorre, però, che tutto il suo centro arretri insieme, senza spezzarsi; una volta contenuto lo slancio dei legionari, infatti, i due corpi di fanteria libica potran no agire come le mascelle di un'immensa tagliola, pren dendo ai fianchi la formazione nemica. Ogni cosa si svolge esattamente come egli ha previsto. Mentre la cavalleria pesante punica, dopo avere annienta to, sulla sinistra, le forze montate romane, passa dietro le linee dei combattenti a piedi per portare soccorso ai Nu midi, che, sull'altra ala, sono alle prese con i socii di Roma, il centro punico comincia piano piano a flettere, incalzato dalle pesanti colonne romane, sempre più com presse sul centro a causa del progressivo convergere dei legionari, all'istintiva ricerca di un contatto con il nemico. Con il ripiegare lento e continuo di Galli ed Iberi, lo schieramento punico mantiene sostanzialmente la sua conformazione; ma viene mutandone l'aspetto, fino a pre sentare ai Romani, che premono come un formidabile cu neo, il cavo e non più la convessità della falce. Ad impedire che il fronte punico, pericolosamente teso, si spezzi intervengono prima le fanterie leggere, che, affluendo da dietro le linee degli Iberi e dei Galli , ne sor reggono la resistenza; poi, a tempo debito, i veterani libi ci, i quali, per l'inconsulto ammassarsi dei nemici sul cen tro, vengono a trovarsi, senza essere stati minimamente impegnati, sui fianchi della formazione romana, che ha assunto la forma di un immenso quadrato. Ad un ordine preciso, quasi fossero in manovra, basta ora ai Libì effet tuare una semplice conversione per chiudere in una mor sa lo schieramento nemico; · e l'accerchiamento viene poi 71
2o
Tempo
Romani
Cartaginesi
;··· ···. ;;.
-
. ·.
.
__
;J
·i:· : :::.:::: : : :
::. ·-. ::: .. :: ,
::���; � :, XIII-XIV, 1983/84, pp. 43 -68) hanno però il merito di sottolineare (fin troppo) le sopravvivenze orientali all'interno degli eserciti punici. Sulle armate di Cartagine prima di Annibale: C.M. Wells, The De/ense o/ Carthage, in New light on Ancient Carthage, a cura di J.S. Pedley, Ann Arbor 1982, pp. 47-65; P. Bartoloni, L'esercito, la marina, la guerra, in I Fenici, cit., pp. 132-138; V. Ameling, Karthago. Studien zu Militiir. Staat und Gesellschaft, Miinchen 1993 ; G. Brizzi, L'armée et la gue"e, in HdO. La ci vilisation phénz'cienne et punique, cit., pp. 302-304 e 306-3 12. 2. Assai contestata fino a una ventina di anni or sono, l'esi stenza del processo di ellenizzazione che, pur senza farne una polis greca, modificò in parte il volto di Cartagine sembra esse re oggi per lo più comunemente riconosciuta. Il dibattito ha prodotto una bibliografia vastissima, per cui mi limiterò a cita re qui alcuni «classici» di riferimento: G.-Ch. Picard, Annibale, il sogno di un impero, trad. it. Roma 1968, p. 63 ; G.-Ch. e C. Picard, Vie et mort de Carthage, Paris 1970, p. 205; S. Moscati, Il tramonto di Cartagine, Torino 1993, VIII. Piuttosto che come un'autentica «rivoluzione popolare» (per tutti: G.-Ch. Picard, La révolution démocratique de Cartha ge, in Con/érences de la société d'études latines de Bruxelles 1965-1966, pp. 120- 129), l'azione dei Barcidi è vista oggi, tal volta, come il tentativo di dar vita ad un potere militare final mente capace di sottrarsi al controllo del senato cartaginese: cfr. L. Loreto, La grande insu"ezione libica contro Cartagine del 241-237 a. C. Una storia politica e militare [= Collection de l'Eco/e /rançaise de Rome, 2 1 1] , Roma 1995, pp. 204 ss. Da quest'ultimo studio (che costituisce il miglior saggio sulla cosiddetta «rivolta dei mercenari») è tratta, per somme li nee, anche la ricostruzione dello scontro al Bagradas (pp. 137148). Oltre allo stesso Loreto (La grande insurrezione, cit., p. 15, p. 1 18 e nota 1 1 ), su Santippo, si vedano, tra gli studi più re centi: M. Fantar, Regulus en A/rique, in Punic Wars. Proceed ings o/ the Con/erence Held in Antwerp /rom the 2Jlh to the 261h o/ November 1 988 [= Studia Phoenicia X] , Leuven 1989, pp. 75-84; ].F. Lazenby, The First Punic War, London 1996, pp. 102 ss.; Y. Le Bohec, Histoire militaire des gue"es puni ques, Lonrai 1996, pp. 88-89 (in particolare, della battaglia co-
92
siddetta «di Tunisi» e della sua localizzazione Le Bohec tratta alla p. -89; Lazenby alla p. 104; Fantar alle pp. 84 ss.). Per il fil rouge tattico che unisce i personaggi tra loro e con Annibale e per l'iniziale atteggiamento dei Romani nei con fronti di Amilcare dr. G. Brizzi, Amilcare e Santippo: storie di generali, in La première guerre punique, cit., pp. 29-38; Id., La conquista romana della Sardegna: una riconsiderazione?, in Dal mondo antico ali'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia offerti dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sas sari, Roma 200 1 , pp. 43-52 (in particolare p. 50). 3. Il passo riportato nel testo è tratto da: A. Momigliano, Saggezza straniera. L'Ellenismo e le altre culture, trad. it. Torino 1980, p. 7. Su Annibale la bibliografia è quasi infinita. Tra i lavori più recenti G. Brizzi, Annibale, strategia e immagine, Città di Ca stello 1984; J. Seibert, Hannibal, Darmstadt 1993 ; Id., For schungen zu Hannibal, Darmstadt 1993; S. Lancel, Hannibal, Paris 1995. Oltre che nel già citato lavoro di Le Bohec, la sto ria della guerra annibalica è stata trattata da G. De Sanctis, Storia dei Romani, III, 2, Firenze 19682 (in una ricostruzione che, pur datata, rimane tra le migliori ed è senza dubbio la più ampia e completa); e da J.F. Lazenby, Hannibal's War. A Mili tary History of the Second Punic War, Warminster 1978. Sul l'esercito di Annibale, per tutti, Brizzi, Annibale, cit., pp. 1 1 12; Id., L'armée et la guerre, cit., pp. 3 12-3 15. Il tema della «barbarie punica» è stato toccato, per esem pio, da V. Merante (Sui rapporti greco-punici nel Mediterraneo occidentale nel VI sec. a.C. , in «Kokalos», XVI, 1970, pp. 98138; Id., La Sicilia e i Cartaginesi dal V sec. alla conquista roma na, in «Kokalos», XVIII/XIX, 1972-73 , pp. 77- 103); e ripreso da Luisa Prandi (La

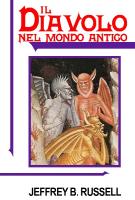



![Il diritto nel mondo dello spirito. Saggio filosofico [1ª Edizione]](https://dokumen.pub/img/200x200/il-diritto-nel-mondo-dello-spirito-saggio-filosofico-1-edizione.jpg)




