Il cinema muto italiano 8842087173, 9788842087175
Il cinematografo arriva da noi nel 1896, a pochi mesi dall'invenzione dei fratelli Lumière, ma bisogna attendere il
302 115 3MB
Italian Pages 483 [246] Year 2008
Polecaj historie
Citation preview
i Robinson / Letture
Gian Piero Brunetta
Il cinema muto italiano Da “La presa di Roma” a “Sole”. 1905-1929
Editori Laterza
© 2008, Gius. Laterza & Figli
Edizione digitale: novembre 2015
www.laterza.it
Proprietà letteraria riservata
Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari
Realizzato da Graphiservice s.r.l. - Bari (Italy)
per conto della
Gius. Laterza & Figli Spa
ISBN 9788858113820
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata
Sommario
Introduzione Le origini in principio fuit lumière prima dei lumière dalla «fiera delle meraviglie» alla conquista di una sede stabile
Nascita e sviluppodel sistema produttivo. 1905-1918 i pionieri e i loro primi passi tra mecenatismo e gioco d’azzardo la crisi del 1909 giulio cesare, spartaco e maciste alla conquista del mondo
La censura e le istituzioni sorvegliare e reprimere le prime leggi il censore al lavoro
Il divismo vaghe stelle dell’orto giolittiano… «femmes fatales» e donne angelicate dive e divine
Il ruolo dei letterati e dei modelli letterari nell’industria cinematografica la grande migrazione il ruolo di d’annunzio attrazione fatale
Le origini della critica il cinema scritto la scuola del popolo i primi passi della critica alla ricerca di una legittimazione artistica
Nascita e sviluppo del racconto costituzione del sistema narrativo «la presa di roma», evento e monumento laico i primi passi con i classici alla conquista dell’impero dei sogni i codici genetici e i caratteri fondamentali dalla biblioteca alla filmoteca dell’italiano dai «tableaux vivants» al racconto fuori l’autore apoteosi del film storico «cabiria», il vertice della parabola il cinema come documento, testimonianza e archivio della memoria
lo splendore del vero il clown in salotto i fuochi delle passioni tra feuilleton e commedia sofisticata il cinema cantato il cinema futurista la guerra sul set paralisi progressiva
La crisi del dopoguerra verso la catastrofe, con allegria
Ascesa e caduta dell’Unione cinematografica italiana un gigante dai piedi d’argilla la crisi e le sue cause
La produzione dal 1923 al 1929 verso lo zero assoluto
La fascistizzazione del cinemanegli anni Venti la marcia su roma degli uomini del cinema nascita del luce la riscossa dei cattolici il cinema e la costruzione dell’italiano di mussolini verso la «rinascita»
Critica e teoria nascita della teoria nascita della critica
Il racconto dal 1919 al sonoro
Introduzione
Sono trascorsi quasi trent’anni dalla prima edizione, presso gli Editori Riuniti, di questo volume e quindici dalla sua seconda edizione riveduta, ampliata e corretta: un’era per quanto riguarda la ricerca storica e filmografica sul cinema italiano. Una fase importante per la mia esperienza di studioso e ricercatore, in cui si sono alternate spinte centrifughe e di allargamento di orizzonti fino ad abbracciare la superficie dell’intero cinema mondiale e continui ritorni in un territorio che non cessa di esercitare il suo richiamo, di affascinarmi e sorprendermi. In questi anni, grazie alla confluenza di più fattori favorevoli, sono cambiate molte prospettive nello studio della storia del cinema muto: la quantità d’informazioni è cresciuta in proporzione geometrica, il quadro di riferimento bibliografico è mutato grazie anche a non pochi importanti contributi internazionali e sta, poco a poco, maturando l’esigenza di osservare e misurare qualsiasi fenomeno del cinema italiano in un’ottica comparatistica e alla luce della possibilità di un controllo di prima mano delle fonti, filmiche e non. Fonti rese sempre più accessibili grazie ai sistemi informatici e alla più aperta e lungimirante politica delle cineteche e delle istituzioni pubbliche e private. Chiunque intenda avviare un nuovo lavoro d’insieme, individuale o collettivo, può passare oggi in rassegna le fonti filmiche salvate, ritrovate e restaurate con uno sguardo a 360 gradi e misurarne le caratteristiche e l’ampiezza come non era mai successo ad alcuno studioso del passato. I sentimenti che la visione comunica mi sono sembrati, in varie occasioni, assai simili a quelli del re persiano Ciro di fronte alle sue truppe alla vigilia della battaglia contro Creso così come li aveva descritti Senofonte nella Ciropedia. Di anno in anno ho assistito con entusiasmo alla moltiplicazione delle ricerche analitiche, al reperimento e restituzione a nuova luce e vita pubblica di centinaia di titoli considerati perduti, alla crescita di una nuova generazione di ricercatori in Italia e all’estero, allo sviluppo lento, certo, ma irreversibile, di una diversa coscienza storiografica. Il cinema italiano, che è riuscito in qualche modo a sopravvivere, può tornare a nuova vita e a emozionare i pubblici del Duemila con una forza non inferiore a quella di cent’anni fa. In Italia il cinematografo arriva a pochi mesi dall’invenzione dei fratelli Lumière, nel marzo del 1896. I programmi Lumière prima, e poi quelli di Edison, entrano nella vita delle città divenendo da subito i cantori per eccellenza della modernità. Se dal 1909 si assiste a una crescita malthusiana delle sale cinematografiche, nei primi anni di vita il cinema si diffonde, in Italia e in Europa, grazie ai padiglioni ambulanti di imprenditori come i Roatto, i Salvo, gli Zamperla, che riescono a portare ovunque la nuova meraviglia scientifica e spettacolare. I primi programmi mostreranno riprese dal vero e scenette comiche, ma anche scene di carattere più pruriginoso nelle «Serate nere» per soli uomini. Bisogna però attendere una decina d’anni per festeggiare la nascita del cinema italiano: nel settembre 1905 migliaia di persone si affollano a Roma in via Nomentana per assistere, proprio nel luogo in cui sono avvenuti i fatti, alla Presa di Roma di Filoteo Alberini: in dieci minuti e sette quadri, viene ricostruito l’episodio della Presa di Porta Pia che ha dato luogo all’Unità d’Italia. Nel primo decennio la produzione cresce impetuosamente al Nord come al Sud, ovunque, con capitali minimi, nascono sigle cinematografiche. Da un lato le nuove «fabbriche delle films» hanno il carattere di piccole imprese a conduzione familiare, dall’altro cercano di raggiungere un assetto in linea con la contemporanea industria tessile e meccanica. Le capitali del cinema all’inizio sono quattro: Torino, Roma, Milano e Napoli, poi di fatto, quando si aprono i mercati mondiali, la leadership si restringe a Torino e Roma. Grazie al coraggio imprenditoriale di alcune case, che riusciranno ad assicurare una solida base al sistema produttivo, il cinema italiano può avviarsi verso uno dei periodi di maggiore fioritura della sua storia.
In effetti si tratta di una cinematografia che pensa subito in grande, che attinge i suoi soggetti dalla storia, dalla letteratura universale all’intera tradizione artistica e al teatro di tutti i tempi. Con pochi tableaux vivants si cerca di distillare lo spirito dei più conosciuti capolavori letterari. Il cinema diventa per le masse popolari che si affacciano da protagoniste sulla scena della storia il mezzo più rapido ed efficace per acquisire conoscenze storiche e letterarie. E serve anche a innescare le prime forti cariche di spirito nazionalistico e a piantare bene in vista i simboli di una nuova identità nazionale.In breve tempo si costituisce una filmoteca circolante alla cui creazione concorrono, in egual misura, Dante e Omero, Verdi e De Amicis, Tiziano e Canova, Shakespeare e Manzoni, Rossini e Gozzano, Verga, Mascagni e D’Annunzio… Questi ultimi, attirati soprattutto dalle sirene di guadagni mai immaginati con la loro attività letteraria, vengono coinvolti a vario titolo nell’ideazione di soggetti, musiche o riduzione delle proprie opere. Accanto a D’Annunzio nume tutelare e primo letterato capace di certificare l’artisticità del cinema, una schiera di scrittori, artisti e intellettuali emigra verso il cinema contribuendo ad elevarne la qualità e a farne l’arte di tutte le arti. Mentre tra i primi operatori, come Comerio, Omegna o Vitrotti, predomina il desiderio di allargare i poteri dell’occhio fino a coprire l’intera superficie terrestre, tra i direttori artistici delle più importanti case di produzione torinesi o romane si diffonde una crescente volontà di andare alla conquista di tutti gli spazi e di tutti i tempi e di fare del cinema una sorta di grande scuola visiva per il popolo. La megalomania visiva si mescola al bisogno di creare spettacoli sempre più grandiosi con scene di massa in cui agiscano migliaia di comparse. Le immagini dei trionfi romani divulgate da Quo Vadis?, Marcantonio e Cleopatra, Giulio Cesare, Gli ultimi giorni di Pompei, Cabiria riportano alla luce le radici di una storia lontana da cui si vuole trarre forza per alimentare le ambizioni del presente. Un piccolo insieme di film storici contribuisce alla vigilia della prima guerra mondiale a fissare alcuni simboli guida e interpreta lo spirito di un risorgente panromanesimo che ha il massimo cantore in D’Annunzio. Il poeta-vate vive la sua breve esperienza cinematografica in uno stato di esaltazione in quanto vede nel cinema il luogo privilegiato per la realizzazione di una moderna epopea e dell’«Opera d’arte totale» teorizzata da Wagner e Nietzsche. Grazie ai moderni transatlantici e all’iniziativa di imprenditori intelligenti come George Kleine, le truppe di Cesare e Augusto conquistano tra il 1912 e 1914 i pubblici americani e poi vanno alla conquista degli spettatori di tutto il mondo e modificano luoghi e modi della visione, oltre che strutture narrative e durata del primo cinema. A cavallo della prima guerra mondiale si assiste alla nascita, all’ascesa e al declino del divismo. Il divismo italiano solca il cielo cinematografico e lo illumina con l’intensità e lo splendore di una stella di prima grandezza che esplode in una miriade di frammenti destinati a fecondare il cinema mondiale. Questo fenomeno di grande potenza radiante muove i primi passi proprio in Italia con Ma l’amor mio non muore con Lyda Borelli, ha un enorme potere dinamizzante sul sistema produttivo e un ruolo chiave nella modificazione della geografia immaginativa di milioni di persone in tutto il mondo negli anni della guerra. Servendosi dei «corpi gloriosi» delle dive, da Francesca Bertini a Lyda Borelli, da Pina Menichelli a Hesperia, a Leda Gys, a Eleonora Duse, in film come Rapsodia satanica, Tigre reale, Odette, Il fuoco, La signora delle camelie, Malombra, Cenere e decine di altri il cinema costruisce un gigantesco monumento alla cultura visiva e letteraria contemporanea e agisce da modificatore profondo e visibile nei comportamenti collettivi. La Borelli e la Bertini, ma anche le altre dive che fanno loro da corona, irradiano una luce che va al di là dello spazio della sala e appaiono come le vere vestali della cultura simbolista e dannunziana. Le donne fatali del cinema italiano amano e muoiono come le eroine del melodramma e come angeli neri accompagnano verso la morte, ma i pubblici di tutto il mondo sembrano preferire una morte per soffocamento tra le loro labbra che finire colpiti da una pallottola di un cecchino in una trincea del Pasubio o dell’Adamello. Paradossalmente la guerra risulta essere molto lontana dal cinema di finzione e le storie immaginate, salvo qualche eccezione (Maciste alpino, ad esempio, per alcune straordinarie riprese dal vero), parleranno non della guerra reale, ma di una guerra ancora di tipo ottocentesco. In ogni caso l’esercito delle dive, unito a quello dei forzuti, capitanati dal Maciste di Bartolomeo Pagano e dei ladri gentiluomini, guidati da Za-la Mort di Emilio Ghione, costituisce il più solido sistema difensivo della cultura liberty e simbo-lista contro gli attacchi del futurismo.
In effetti, in assenza di documenti filmici, il ruolo del futurismo e di Marinetti è piuttosto legato alle idee e alle enunciazioni del Manifesto della cinematografia futurista nelle quali è possibile oggi riconoscere le basi poetiche e programmatiche per il cinema di tutte le successive avanguardie europee. Mentre, anno dopo anno, una cinematografia che aveva esportato i propri prodotti in tutto il mondo vede chiudersi i mercati e affonda fino a toccare quasi lo zero assoluto, si registrano sul piano produttivo, dell’esercizio e del consumo fenomeni nuovi che vanno dai primi tentativi di fascistizzazione alla marcia su Roma delle Majors americane, dai catastrofici tentativi di tornare all’antico (con La nave, Messalina, Cirano di Bergerac, Gli ultimi giorni di Pompei) all’emigrazione massiccia di registi, attori e tecnici in tutta Europa. Non basteranno gli eroi della forza, da Maciste a Sansonia, da Astrea ad Ajax, per sostenere una produzione che, nel giro di pochi anni, passa da centinaia di titoli a poche unità, ma il territorio è attraversato da molte tensioni e da un primo vero ricambio generazionale. Gli anni Venti sono anni in cui il cinema italiano non produce titoli in grado di misurarsi da pari a pari coi capolavori, ma anche con la produzione media degli altri paesi. È appena il caso di ricordarlo, ma in questi anni nascono e si sviluppano l’espressionismo tedesco e il surrealismo, il cinema sovietico esplode con Vertov, Pudovkin, Ejzenštejn, la Francia diventa la culla di molte esperienze d’avanguardia e vede esordire Clair e Renoir, nel cinema americano trionfano i film di Chaplin, Fairbanks, Vidor e Buster Keaton. Ma proprio mentre il cinema italiano giunge a toccare il punto più basso della sua storia un gruppo di giovani, capitanato da Alessandro Blasetti, realizza, alle soglie dell’avvento del sonoro, un film che si intitola Sole e che nel titolo sembra contenere oltre che la speranza anche la scintilla e la volontà di rinascita. Gian Piero Brunetta Padova-Asiago maggio 2008
Le origini
in principio fuit lumière In principio fu Lumière: una simile affermazione, allo stato attuale delle ricerche sulle origini del cinema e dopo i primi seri tentativi di storiografia comparata (Mitry, Deslandes) avviati una trentina d’anni fa, non esclude certo il riconoscimento che l’invenzione del cinema «ha più di un padre» ,> che vari paesi ne rivendichino i diritti di primogenitura, dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna alla Germania, che si sia tentato di riscrivere la storia delle origini del cinema ora attribuendone la paternità a Edison, ora a Marey ora ai fratelli Max ed Emil Skladanowsky. E che l’apparizione del Cinématographe Lumière sia il punto d’arrivo di un complesso processo di sviluppo di tentativi d’animazione della fotografia e di una serie di ricerche analoghe condotte in più paesi, di cui i Lumière riescono tecnicamente ad anticipare, allo sprint, le soluzioni conclusive. Dare però ai Lumière ciò che loro compete significa riconoscere alla loro invenzione il merito di avere attuato, sia nel campo dei mass media che in quello dello spettacolo, una vera e propria rivoluzione e di aver, per primi, dominato tutti i problemi tecnici di realizzazione e riproduzione del film e rapida diffusione mondiale del cinema. Tra tutte le arti il cinema è stata la prima e la sola ad aver goduto dell’iscrizione in un registro anagrafico, la prima ad aver avuto testimoni della sua nascita distribuiti su un arco di tempo di alcuni decenni, forse, come ha osservato Jerôme Prieur «rimasti tutto quel tempo sotto lo choc della ‘prima volta’» . Indubbiamente il cinema eredita luoghi, modi, forme dello spettacolo anteriore e, al tempo stesso, ridefinisce tutte le modalità visive, iconografiche, narrative delle forme di spettacolo ottico che l’hanno preceduto. Per tutto l’Ottocento si era assistito a un senso di attesa dell’avvento di una nuova era in cui alla vista si potessero dischiudere nuovi orizzonti, dati dalla possibilità di combinare la perfezione riproduttiva col senso del movimento: «Le temps des spectacles purement oculaires est arrivé» aveva del resto annunciato profeticamente Théophile Gautier nel 1841 di fronte alle nuove meraviglie scenografiche del teatro . Questa attesa mette a fuoco idealmente già alcuni decenni prima dell’invenzione del cinematografo l’immagine di un nuovo mezzo in cui accanto alle immagini in movimento vi sia anche il senso di simultaneità o di bilocazione. Le date parlano chiaro: il 13 febbraio 1895 Auguste e Louis Lumière brevettano, col numero 245032, un apparecchio «servant à l’obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques» e il 28 dicembre dello stesso anno organizzano la prima proiezione pubblica alla presenza di 33 spettatori a Parigi al Salon Indien del Grand Café des Capucines. Prima del cinematografo ci imbattiamo in nomi come Telettroscopio, Lampascopio, Lucifono. A partire dal 1896 la corsa ai brevetti produce neologismi a catena. Tra le oltre duecento invenzioni francesi possiamo trovare, per esempio, il Cinegrafo, il Fototeatrografo, il Fotopoligrafo, il Cinegrafoscopio, il Fototropo, lo Zografo, il Pantomimografo, il Cromovivigrafo e così via. E ancora si possono ricordare l’Artografo, il Badizografo, il Centografo, il Cosmonografo, il Cosmoscopio, il Diaramiscopio, il Kinebleposcopio, il Movimentoscopio, il Panoramografo, il Pantobiografo, lo Stipetiscopio, il Varioscopio, il Virescopio, il Visionoscopio, il Vitamotografo… I nomi delle macchine della visione, verso la fine dell’Ottocento, assumono due suffissoidi in -grafo e in -scopio «per evidenziare – ha osservato Sergio Raffaelli – le ricerche scientifiche della ‘scrittura’ e quelle spettacolari della ‘visione’» . Anche se di fatto si confrontano con la pittura degli impressionisti, e ne riprendono in più occasioni temi e luoghi, i Lumière vogliono «scrivere» con la luce del cinematografo e «dipingere» con i colori degli autocromi, le fotografie a colori, di cui hanno inventato e brevettato la tecnica. In molte occasioni – dal 1921 al 1948 – Louis Lumière ha ricordato come l’ispirazione a inventare il cinematografo gli sia venuta vedendo in particolare il Kinetoscopio di Edison, che aveva però il difetto di 1
2
3
4
5
6
offrire solo una visione individuale: «Una sera del 1893 osservavo tra le baracche di una fiera un curioso apparecchio che presentava a una sola persona per volta e attraverso un vetro, una rapida successione di immagini fisse. Questo apparecchio oggi si potrebbe chiamare cinematoscopio. In mancanza di termini precisi lo si considerava come una lanterna magica un po’ raffinata» . E ancora molti anni dopo, nel 1948, in una memorabile intervista televisiva a Georges Sadoul Louis riconosce i meriti delle scoperte anteriori alle sue sull’animazione della fotografia, fissando all’estate del 1894 l’inizio delle proprie ricerche assieme al fratello: «A quell’epoca le ricerche di Marey, Edison, Demenÿ, avevano condotto questi autori a certi risultati, ma nessuna proiezione di film su uno schermo era ancora stata fatta» . Riconosciuti a Edison, Marey e altri i meriti di aver per primi arato il terreno dell’animazione fotografica, Louis Lumière rivendica in più occasioni a se stesso quello di aver studiato e trovato la soluzione finale dell’invenzione del cinematografo, ma con ogni probabilità non considera questo brevetto come la più originale delle sue invenzioni (tra l’altro è messo al corrente da Carpentier, qualche giorno prima del 28 dicembre, dell’esistenza di uno spettacolo del tutto simile al loro, in corso a Colonia) . Le polemiche sulla priorità e sui meriti di Marey, Edison, Skladanowky, continuano per decenni. Il solo Marey, fin dal 1899, riconosce ai Lumière di aver risolto per primi e in modo geniale il problema della sintesi del movimento . Il problema della priorità dal punto di vista storiografico, come si capisce, è comunque oggi assai poco rilevante, dal momento che non modifica di un centimetro il mito dei Lumière. Mito che si è imposto da subito: in effetti è merito loro, forse anche della felicità della loro invenzione linguistica, oltre che della capacità di utilizzare al meglio i mezzi di comunicazione di massa, che un frutto di una ricerca internazionale ottiene una consacrazione pubblica e un battesimo certo. È giusto, comunque, a più di centodieci anni di distanza dalla prima proiezione pubblica, riconoscere ai Lumière meriti non limitati a semplici scoperte tecniche: grazie a loro si aprono frontiere sconosciute alla visione popolare, vengono avviate rivoluzioni profonde sul terreno della memoria, del sapere e dell’immaginario collettivo, muove i primi passi un linguaggio capace di agire su scala universale e di unificare emozioni, percezioni del mondo, dello spazio e del tempo nel giro di pochissimi mesi e in una misura del tutto inedita. L’invenzione del cinematografo non appare ai due fratelli, che si possono considerare come un’entità creativa unitaria, composta da due esseri eguali e distinti, come una vera e propria innovazione. In fondo, come abbiamo visto, entrambi sono consapevoli di non aver fatto altro che sviluppare e perfezionare ricerche condotte in vari paesi: senza esaltarsi e senza sottovalutare l’importanza della loro scoperta decidono di occuparsene per qualche tempo, anche se i loro veri interessi in quegli anni saranno rivolti soprattutto alla possibilità di riprodurre la realtà con lastre fotografiche a colori. Alla loro prima invenzione fanno seguito, il 10 marzo e il 6 maggio 1895, il 28 marzo e il 18 novembre 1896, quattro modifiche volte soprattutto a ottenere un migliore svolgimento e riavvolgimento della pellicola. A soli pochi mesi di distanza, l’11 novembre 1895, un ricercatore italiano, Filoteo Alberini, impiegato all’Istituto geografico militare di Firenze, brevetta un apparecchio cinematografico per la ripresa, sviluppo e proiezione del tutto simile a quello francese. «Il direttore capo della Divisione I (Sottosegretariato di Stato) – dice il testo del brevetto – dichiara e certifica che nel giorno undici del mese di novembre 1895, alle ore 11.30, il signor Filoteo Alberini ha presentato alla prefettura di Firenze la domanda e i documenti prescritti dalle leggi 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864 per ottenere il presente Attestato di privativa industriale della durata di anni uno, a datare dal 31 dicembre 1895 (salvo i casi di nullità, annullamento e decadenza previsti dalla legge) per un trovato designato dal titolo Kinetografo Alberini. Il presente attestato non garantisce né l’unicità né la realtà del trovato» . L’invenzione di Alberini, che ha lavorato un paio di mesi – secondo la sua stessa testimonianza – alla messa a punto del brevetto, non può vantare, dunque, alcuna pretesa di primogenitura, ma consente al suo ideatore di entrare di diritto nel ristretto gruppo di pionieri e ricercatori che, in ogni paese, dagli Stati Uniti alla Germania, lavorano su ipotesi di animazione della fotografia analoghe a quelle dei Lumière. Del Kinetografo Alberini sappiamo che né è stato fabbricato un prototipo («ma è fondato il sospetto – dice Aldo Bernardini – che non funzioni nemmeno bene»), né ci risulta ne sia stata avviata alcuna produzione regolare. E anche se, a distanza di tempo, la macchina è descritta in tutte le sue caratteristiche («L’Alberini 7
8
9
10
11
ha ideato un apparecchio che, come quello dei fratelli Lumière può servire come macchina fotografica, kinetografo e al tempo stesso come kinetoscopio e lanterna di proiezione […] col Kinetografo Alberini si possono ottenere fino a mille immagini al secondo») , l’arrivo dell’apparecchio francese ha certo l’effetto immediato di bloccare sul nascere ogni futuro commerciale all’invenzione di Alberini. Come i Lumière, Alberini è spinto nelle sue ricerche dallo stesso tipo d’interesse scientifico per l’animazione della fotografia: la differenza sostanziale consiste non tanto nel ritardo della messa a punto della sua invenzione, quanto nella mancanza di capitali e di un assetto industriale capace di trovare uno sbocco immediato di mercato per il suo apparecchio. I Lumière, al momento dell’invenzione del Cinématographe, hanno già realizzato ben diciassette brevetti nel campo della fotografia, della preparazione dei bromuri d’argento per le emulsioni sensibili, degli otturatori e della camera oscura e, grazie alle loro invenzioni, la Fabbrica di Lione di materiali e apparecchi fotografici ha avuto uno sviluppo decisivo. Filoteo Alberini, ricercatore in proprio, si può dedicare part time alle sue ricerche («molti e vari – ricorderà in seguito – sono stati gli apparecchi che io ho ideato e costruito nei successivi anni»), e non avendo l’appoggio né di capitali, né di strutture industriali, è costretto a rinunciare alla sua invenzione e a occuparsi nuovamente del cinema, a distanza d’alcuni anni, seguendo un processo esattamente opposto e complementare a quello dei Lumière: dall’invenzione, all’esercizio e alla produzione. Per realizzare del tutto questa sorta di ciclo integrato gli saranno necessari dieci anni, ma è bene riconoscere ad Alberini, accanto alle buone capacità scientifiche, di cui peraltro non è mai stato capace di sfruttare i risultati, una notevole capacità imprenditoriale che gli ha consentito – rispetto ai Lumière – di capire la potenzialità del mercato e di puntare, con molta decisione, la sua attenzione verso le possibilità di sviluppo del cinema come spettacolo. In Italia, il Cinématographe Lumière è preceduto dal Kinetoscopio Edison, che giunge nei primi mesi del 1895 con tutti i suoi più noti pezzi di repertorio, ma all’entusiasmo per queste macchine che consentivano la visione individuale segue, nel giro di pochi mesi, l’indifferenza più assoluta, dal momento in cui giungono i primi apparecchi Lumière . Le riviste fotografiche, che costituiscono le fonti privilegiate e più attendibili di documentazione sulla nascita e sulle prime manifestazioni cinematografiche in Italia, nonché alcuni quotidiani nazionali o a diffusione locale, dal «Corriere della Sera» al «Messaggero», fino alla «Patria del Friuli», registrano, con perfetto tempismo, sia gli aspetti tecnici e scientifici dell’invenzione dei Lumière sia i loro effetti sul pubblico. Il 13 marzo 1896 il Cinématographe Lumière fa il suo ingresso ufficiale in Italia presso lo studio fotografico Le Lieure di vicolo del Mortaro di Roma . Dopo le proiezioni romane organizzate dal fotografo Henry Le Lieure, anche a Milano, con l’aiuto di Giuseppe Filippi, che poi continuerà per la sua strada, il fotografo Vittorio Calcina, che ha ottenuto dai Lumière un apparecchio e ne è diventato il rappresentante italiano, presenta in anteprima la nuova invenzione: «Il Cinematografo Lumière, la nuova fotografia del movimento, è stato inaugurato ieri al circolo fotografico […]. Chi ha visto il Kinetoscopio Edison può farsi un’idea di ciò che sono queste nuove proiezioni fotografiche, le quali verranno ripetute in questi giorni al teatro milanese. Sono quadri animati, riproduzioni vive di scene svariate quali le possono vedere e seguire i nostri occhi in qualunque luogo dove siavi del movimento, a teatro, in istrada, in casa: è la fotografia che si sostituisce all’occhio umano ripetendone le percezioni successive e porgendogliele poi nuovamente su una tela bianca mediante la proiezione» . Richiamato dalle voci degli imbonitori , il pubblico confluisce in massa a Torino, come a Trieste, a Milano come a Venezia, a Rimini come a Este, a Messina come a Livorno . Nelle primissime testimonianze dei quotidiani e della stampa specializzata l’attenzione è portata, prima di tutto, sull’identità tra lo sguardo della macchina da presa e l’occhio umano e sulle grandi potenzialità delle rappresentazioni sul piano dello spettacolo di massa: «Il Cinematografo dei signori Lumière è un ingegnoso apparecchio che permette non solamente di raccogliere […] tutte le scene animate […] ma eziandio di riprodurle fedelmente in grandezza naturale proiettandole sopra uno schermo e rendendole così visibili a tutta un’assemblea di spettatori […]. L’illusione perfetta della vita! Basterebbe ciò per immortalare lo scopritore» . Il dato di partenza sembra essere questo: il cinema può avviare la più grande trasformazione nei modi di visione di massa, ma, almeno nelle sue prime manifestazioni, l’aspetto scientifico prevale e le prime riprese rispondono pienamente alle intenzioni degli inventori. I codici di verità e realtà sono l’elemento più importante 12
13
14
15
16
17
18
19
di richiamo dei primi pubblici: l’accoglienza – secondo gli echi della stampa – è ovunque entusiastica e le immediate previsioni di una rapida circolazione del cinematografo in tutte le città italiane si realizzano nel giro di pochi mesi dello stesso anno . A Torino, poco dopo la prima milanese – ma un manifesto ritrovato dal grande collezionista e industriale filatelico Alberto Bolaffi annuncia una proiezione torinese nel marzo 1986 – lo stesso Calcina organizza delle proiezioni in un locale ricavato dall’ex ospedale di carità di via Po ; nei mesi successivi le proiezioni si moltiplicano e si estendono a macchia d’olio in tutta la penisola . E ovunque le reazioni dei cronisti e del pubblico non fanno che riprendere e variare le reazioni del primo pubblico nella serata del 28 dicembre 1895. Stupore, galvanizzazione e ammirazione sono ovunque identici. In questo primo periodo il cinema cerca e inventa da zero il suo spazio e i suoi pubblici: la sua diffusione ha un andamento pendolare, dalla città alla campagna, per tornare di nuovo alla città dopo una decina d’anni e assumere definitivamente una propria fisionomia e una propria ben distinta autonomia rispetto alle altre forme dello spettacolo con cui ha coabitato a lungo come curiosità o forma di rappresentazione subalterna. La penetrazione del cinema è capillare, lenta, quasi inavvertibile nei primi anni: il suo, dopo la prima fase di curiosità, non è un ingresso trionfale nel campo dello spettacolo. Rispetto alle altre forme più nobili e con una tradizione secolare o millenaria alle spalle (teatro, melodramma, opera lirica) il cinema suscita immediate curiosità, ma non trova poi un appoggio sistematico nei vari organi di stampa. Tuttavia, alcuni tratti distintivi sono individuati fin dall’inizio e soprattutto la stampa di derivazione positivistica, che fonda gran parte dei suoi messaggi sulla integrazione tra discorso verbale e rappresentazione iconografica, sembra trovarvi un’importante manifestazione di un progetto di divulgazione enciclopedica del sapere universale. Ma non sono da trascurare anche altre forme più basse di editoria popolare (come la «letteratura di colportage») che intendono far presa solo sulle funzioni emotive del messaggio e contribuiranno a costruire un’immagine del cinema come di una macchina capace di produrre visioni fantastiche, creare e rappresentare fenomeni unici, irripetibili e «mostruosi». La prima novità del cinema è dunque quella di essere, nelle forme alte di rappresentazione, nella produzione iniziale dei fratelli Lumière e in quella di tutti gli operatori di attualità che si formeranno alla loro scuola, il corrispettivo visivo di un giornalismo che sta organizzando le sue strutture di conoscenza e di trasmissione del-l’informazione su scala mondiale, con in più, a suo favore, l’impressione di immediatezza di realtà e di verità. I primi documentari hanno una durata standard di 15-17 metri: la realtà che rappresentano è quella dei grandi avvenimenti, dei grandi personaggi storici, ripresi soprattutto nella loro ufficialità, ma è anche quella della rappresentazione quotidiana degli stessi grandi personaggi, colti quasi di sorpresa, e infine quella di ambienti sociali, urbani e industriali, capaci di costituire una sorta di immagine speculare rispetto allo spazio vitale del pubblico. Gli operatori Lumière, nel giro di qualche mese, sono in grado di raggiungere le località più sperdute dei cinque continenti con lo spirito degli avventurieri, dei missionari e dei portatori di un nuovo verbo. Cosciente della propria novità tecnologica il cinema rappresenta, di preferenza, i prodotti della civiltà industriale, le automobili, le ferrovie, la realtà delle fabbriche, e privilegia, additandole come modello, le forme di vita sociale urbana e quelle del lavoro industriale. La campagna sarà a lungo cancellata o rimossa o le si riserverà il privilegio – in seguito – di divenire il luogo per eccellenza di pastorellerie bucoliche, di belle cartoline animate, senza mai offrire sufficienti motivi di interesse per una rappresentazione articolata del mondo del lavoro contadino. Per capire meglio quanto detto finora, prendiamo i titoli di un programma di film proiettati a Roma nel gennaio-febbraio 1897: 1) Una questione infantile; 2) Dimostrazione popolare alle LL. AA. i Principi di Napoli al Pantheon (musica: Inno di Mameli); 3) Le LL. MM. il Re e la Regina al Real Castello di Monza (musica: Inno Reale); 4) Arrivo a Roma dei Principi di Montenegro (musica: Inno di Montenegro e Reale); 5) Piazza Reale a Stoccarda; 6) Corrente del Niagara (Nord America); 7) Il bagno dei Sudanesi (Insuperabile); 8) La danza del Bébé . Questo programma è un esemplare programma Lumière con la sua equilibrata distribuzione di notizie d’interesse locale, di riprese dirette dei grandi personaggi e di località sparse in tutti gli angoli della terra. Si intende trasmettere anzitutto il senso del surrogato di un viaggio intorno al mondo da compiersi in pochi 20
21
22
23
24
minuti, viaggio già posto come ideale e transfert del desiderio collettivo nel giornalismo e nella letteratura (si pensi ai romanzi di Verne), e reso certamente legittimo dalla rapida evoluzione dei mezzi di comunicazione terrestre, marittima e aerea. Il cinema, rispetto alla letteratura e al giornalismo, gode del vantaggio di poter eliminare, grazie al suo sincretismo, le distanze spazio-temporali e di riuscire a unificare, nella medesima visione, i luoghi più eterogenei e distanti tra loro. Al tempo stesso non va trascurata, specie all’inizio, la curiosità del pubblico per la riproduzione speculare della propria immagine e della propria vita. La categoria del lontano non prescinde mai da quella del vicino, che favorisce in modo sicuro il riconoscimento e l’identificazione. Questi filmati trasmettono certo informazioni, senza produrre conoscenze: in genere si fondano sull’eccezionalità della visione offrendo però immagini che il giornalismo aveva già divulgato. Soddisfano pertanto delle attese, presuppongono un livello di alfabetizzazione del pubblico e la possibilità di un riconoscimento diretto. Degli eventi storici fissano i grandi momenti e le grandi personalità sono seguite nelle manifestazioni pubbliche e in quelle private. Il cinema rompe la barriera che separa le masse dai grandi uomini e offre al pubblico la conoscenza dell’album di famiglia di tutti i maggiori protagonisti della storia. Viene anche a cadere, a opera di quest’occhio onnipresente, ogni forma di separazione tra pubblico e privato. Il fatto che, ad alcune riprese, si associ la musica dell’Inno di Mameli facilita il consenso e l’adesione immediata del pubblico e pone forse le prime basi per indicare su che piani è possibile nobilitare il cinema. Questo programma, e la sua «impaginazione», può essere indifferentemente un programma Lumière o un programma realizzato già col contributo degli operatori italiani: la duttilità dell’apparecchio Lumière, la sua maneggevolezza e facile trasportabilità, la sua triplice funzione (ripresa, proiezione e sviluppo) consentono di far pressoché coincidere l’arrivo del cinema con l’inizio di un’attività produttiva . È naturale che i primi operatori siano ex fotografi che vedono realizzarsi nel cinema il sogno dell’animazione della fotografia inseguito ormai da esperimenti di alcuni decenni . Come si è detto, dopo le prime proiezioni romane e quelle milanesi e torinesi di Calcina il cinema giunge, nel corso del 1896, in tutte le maggiori città italiane. In alcuni centri lo spettacolo Lumière segue a ruota quello di Edison e i giornalisti non mancano di registrare la superiorità del primo sul secondo: «Il cinematografo dei fratelli Lumière non va confuso – si legge sul ‘Giornale di Udine’ del novembre 1896 – con quello che abbiamo visto recentemente al Minerva. Non ne ha le molte imperfezioni» . Come ha osservato Bernardini «nel confronto con la concorrenza il Cinématographe si dimostra quasi sempre vincente, per la stabilità, la nitidezza, la qualità delle immagini che è in grado di proiettare» . Ciò che interessa è però vedere come, tra le prime proiezioni e le prime riprese di operatori locali (Calcina, o il milanese Italo Pacchioni), non ci siano soluzioni di continuità. Da sottolineare anche il fatto che la nascita del cinema in Italia non è un fenomeno di tipo monocentrico: esiste – è chiaro – il monopolio dei Lumière, ma si vengono realizzando, in parallelo, altre iniziative che testimoniano della volontà di muoversi nella stessa direzione, cercando, al tempo stesso, di sottrarsi al tentativo Lumière di gestione monopolistica, su scala mondiale, di tutte le iniziative cinematografiche. Italo Pacchioni, un fotografo che aveva già al suo attivo vari tentativi di animazione della fotografia, vistosi rifiutare dai Lumière il loro apparecchio, effettua egualmente delle riprese con un apparecchio da ripresa e proiezione che utilizza pellicola Lumière a due perforazioni laterali. Rispetto al Cinématographe l’apparecchio di Pacchioni è dotato di due finestrelle con relativi obiettivi appaiati per eventuali riprese a effetto stereoscopico. Uscito assai presto dalla fase sperimentale Pacchioni presenta, nello stesso 1896, alla fiera annuale dei bastioni di Porta Genova a Milano, il suo «baraccone delle meraviglie», dove «tra tanti stendardi e pochi centesimi è finalmente possibile vedere il cinematografo». Per alimentare la sua sala improvvisata realizza alcuni brevi film documentari, comiche di quindici metri, come Il finto storpio del castello, «realizzato con un cane, una dama, un finto storpio, dinanzi alla Torre del Filarete» . Con Pacchioni si entra in contatto con un contesto diverso di pubblico e di concezione dello spettacolo; con lui si apre al cinema la lunga strada dei successi popolari nelle fiere, nei mercati, nelle sagre paesane, o almeno si allinea e continua una grande tradizione di spettacoli di piazza e viaggianti. 25
26
27
28
29
prima dei lumière
Molto prima che i Lumière imprimessero una svolta definitiva alle ricerche sulle immagini in movimento, o sulla possibilità di animare l’immagine, nel corso di centinaia d’anni si era venuto costituendo e predisponendo un pubblico interessato alle meraviglie e ai viaggi fantastici che potevano offrire apparecchi in grado di proiettare immagini. Per secoli migliaia e migliaia di anonimi viaggiatori ambulanti con la semplice dotazione di una lanterna magica a tracolla (ed è alle caratteristiche delle lanterne magiche che si ispira per maneggevolezza e formato anche l’apparecchio tuttofare dei Lumière), con un organetto, una ghironda o un tamburo, avevano intrecciato le loro strade e i loro destini con i venditori di almanacchi, di pianeti della fortuna, di lunari, coi venditori di stampe che partivano spesso dalle montagne del Veneto e del Trentino e si spingevano fino alle più remote località dell’Europa settentrionale e orientale. Il loro naturale punto d’orientamento era la stella polare, ma anche la costellazione delle Perseidi da cui d’estate vedevano scendere come lucciole le stelle cadenti, il loro spazio d’azione era l’intero territorio europeo dagli Urali alle foci del Douro in Portogallo: sapevano decifrare i segni anche minimi che la natura inviava loro, il mutare dei venti, gli abbassamenti della temperatura, l’arrivo della pioggia o della neve… L’aria era molto spesso il loro unico alimento, il cielo la loro coperta, e il loro tetto. La piccola «cassela» di stampe o la lanterna che portavano sulle spalle racchiudeva tutta la loro ricchezza e tutti i sogni per il futuro. Vedendoli muoversi leggeri e percorrere decine di chilometri al giorno, ci sembrano quasi creature angeliche e quella protesi sulle spalle vista in lontananza ha l’aspetto di un paio di piccole ali che consentono di affrontare e superare spavaldamente ogni condizione atmosferica e ogni ostacolo naturale. Assieme i lanternisti e i venditori di stampe sono i primi a creare un commercio di beni impalpabili, i cui valori sono soprattutto immateriali, legati ai sogni e ai desideri. Non avevano cavalli, né altre bestie da soma, perché la legge prescriveva che il trasporto delle merci non comportasse «una bestia da soma o un carro tirato da forza animale»: rischiavano di perdere le proprietà dei campi di famiglia se la missione non fosse andata a buon fine, ma, nel loro piccolo, erano mossi dallo spirito d’avventura e di conquista, dal desiderio di andare verso l’ignoto, addirittura di spingersi «in partibus infidelium», non con lo spirito missionario dei gesuiti, ma, egualmente per distribuire il loro carico della «buona novella» religiosa o laica. Oggi si parla della Rete universale di cui volenti o nolenti facciamo parte: le migliaia di anonime figure in movimento lungo il territorio europeo sono di fatto le prime a stabilire una rete di immagini che collegano i punti estremi del continente. Lanternisti e venditori di stampe dagli inizi del Settecento, scelgono l’Europa come «mercato comune» orizzonte e territorio di una vera e propria predicazione di una sorta di nuova buona novella visiva capace di unire popolazioni e culture tra le più diverse e distanti. All’interno dell’ordito delle grandi vie di comunicazione, del fitto reticolo di strade e sentieri che unisce i paesi europei, i venditori di immagini hanno avuto modo di creare, nell’arco di quasi due secoli, una robusta e durevole trama di forme simboliche e significati stabili, di «comportamenti condivisi», orizzonti di attese, emozioni e passioni comuni e di diventare veri e propri mediatori tra mondo contadino e civiltà urbana, tra produzione artistica e manufatti artigianali. Questi viaggiatori infaticabili non mancavano ad alcun appuntamento popolare e partecipavano, in modo non certo marginale, alla costruzione di quel sistema di trasmissione della cultura popolare di cui si sono per ora indagati alcuni aspetti e caratteristiche ideologiche, ma non si è ancora definita l’articolazione e la morfologia, anche se, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, da parte di chi scrive, in collaborazione con Alberto Zotti Minici, è stato avviato e sviluppato un progetto di ricerca sulla formazione della visione popolare e sul ruolo delle macchine ottiche dal Rinascimento alla nascita del cinema . Una caratteristica marcata della lanterna magica è tuttavia, rispetto alle altre forme di cultura e di editoria popolare, la sua capacità di penetrazione interclassista e la sua progressiva presenza anche in luoghi tradizionalmente riservati a forme di spettacolo alto. Per molto tempo la visione offerta dalle lanterne magiche si presenta come una variante di forme di spettacolo più nobile e affermato, senza voler rinunciare al fascino e all’aura che le deriva dal presentarsi come una vera e propria pratica magica. Di magia naturalis parlano sia Giambattista Della Porta nel 1500 che padre Athanasius Kircher nel 1600 . Un segno della scalata e della penetrazione della lanterna magica nei luoghi più tradizionali dello spettacolo, come i teatri, può essere ritrovato in una locandina che descrive al «colto pubblico e inclita guarnigione» della città di Modena un programma di Fantasmagoria presentato il 24 marzo 1827 nel locale teatro: «I fantasmi sono fatti con la massima accuratezza, in 30
31
conseguenza bellissimi e l’esperienza della fantasmagoria avrà principio da tuoni e lampi […] in seguito verranno i Fantasmi, le apparizioni illudenti in più forme, cioè Maghi, Larve, Mummie, Teschi, Serpi, Draghi e simili; scorrendo qua e là per il teatro, si avvicineranno e ora si allontaneranno, parte sorgeranno dalla terra e altri nasceranno per l’aria e scorreranno in apparenza lo spazio di mille miglia» . Come si può capire il cammino che precede la nascita del cinema è lungo, affascinante, estremamente ramificato e soprattutto ricco di terreni tuttora solo in minima parte esplorati entro cui si possono individuare le caratteristiche dei pubblici, i modi della visione, le caratteristiche delle immagini e l’idea di cultura a esse connessa. Si tratta ancora di studiare a fondo i meccanismi di modificazione progressiva della visione popolare, la formazione di una competenza visiva già assestata e predisposta quando il cinema fa le sue prime apparizioni e l’intreccio tra tutte le diverse forme della cultura viaggiante. Le immagini in movimento del cinema sono la continuazione di una memoria visiva e il corrispettivo di una memoria orale ben radicata nelle tradizioni popolari, ma sono anche, nello stesso tempo, uno dei viatici più potenti per l’ingresso nella modernità. Il cinema ha il potere e la capacità di rappresentare, meglio di altre conquiste scientifiche contemporanee, più e meglio della fotografia, il passaggio dall’era della creazione individuale del prodotto artistico a quella della produzione in serie. Come ha indicato Benjamin in un frammento di Parigi capitale del XIX secolo, il cinema è «estrinsecazione (risultato?) di tutte le forme di visualizzazione, dei tempi e dei ritmi prefigurati dalle macchine moderne, di modo che tutti i problemi dell’arte contemporanea trovano solo nell’ambito del cinema la loro formulazione definitiva» . Per molto tempo gli storici del cinema, proiettati alla ricerca di un degno blasone culturale, hanno fatto a gara a retrodatare il più possibile gli antecedenti della nascita delle immagini in movimento: se i più ingenui, con aria trionfante, hanno presto scoperto che alle origini del cinema ci sono i bisonti delle grotte di Altamira e Lascaux, non è certo da rifiutare il tentativo di analisi della lenta modifica dei modi della visione popolare iniziata fin dalle ricerche teoriche sulla camera oscura da parte di Leonardo in pieno Rinascimento. Leonardo descrive analiticamente le caratteristiche della camera oscura e mostra come, attraverso un «picholo spiraculo rotundo», si possa proiettare un’immagine capovolta su una superficie bianca in una «camera forte oscura» . Il cinquecento sarà poi il secolo d’oro delle ricerche e delle applicazioni della lanterna magica, figlia diretta della camera oscura : le proiezioni vengono organizzate con successo sia per i signori nelle corti che per il popolo nelle chiese. I gesuiti individuano il potere di questo apparecchio come supporto e dimostrazione nelle omelie domenicali e quaresimali e introducono nelle chiese immagini di fiamme del purgatorio, di apparizioni della morte e di anime all’inferno. Questo tipo di visioni mescolava realtà di provenienza assai eterogenea: dai motivi religiosi si passava a quelli magici o fantastici, alla rievocazione di figure o fatti del passato con delle messe in scena che s’ispiravano alle pratiche magiche e spiritiche. Nei secoli successivi la lanterna magica diventa un apparecchio sempre più maneggevole e tuttofare: lo usano gli scienziati e i professori ed entra nelle case private come gioco per i bambini, anche se il suo luogo per eccellenza resta la piazza, il momento della grande socializzazione popolare come la festività religiosa, la sagra, il mercato, la fiera. Frati e ciarlatani, signori e bambini, nobili e popolani usano o si accostano alle immagini offerte dalle lanterne magiche attratti dalla promessa di viaggi meravigliosi nello spazio e nel tempo. C’è di tutto nei programmi delle lanterne magiche o nelle lastre del «Mondo niovo» (sulla cui fortuna esiste una ricchissima documentazione che va dai Sermoni di Carlo Goldoni alle tavole di Alessandro Longhi, alle incisioni di Zompini, Volpato, Pinelli, ad arazzi, statuette di porcellana, stampe…) che consentivano una visione individuale: «Nerone che infierisce contro il ventre della madre con piede snaturato» e «il sole che scontrando con la luna ha paura delle corna e cambia strada», ci sono caricature e fiabe, «figure dilettevoli» e «meraviglia della scienza e del microscopio» . Gli spettatori iniziano i loro viaggi attorno al mondo grazie anche ai nomi degli apparecchi che mostrano visioni fantastiche: Pantoscopio, Diorama, Cosmorama, Polyrama, Ciclorama… Nasce una nuova figura o una nuova specie, che ho voluto chiamare Icononauta, che si alimenta di immagini, le divora, le assorbe quasi nelle proprie cellule genetiche e fissa i caratteri ereditari che saranno propri dell’Homo cinematographicus. Mutano profondamente le forme di spettacolo, coinvolgendo masse di pubblici sempre più vaste ed eterogenee. Dal canto loro gli scienziati e studiosi che fanno progredire con grandissima rapidità il sistema sono individui che giocano su più tavoli nello stesso 32
33
34
35
36
tempo e che abbandonano, senza eccessivi sensi di colpa, il loro campo disciplinare, o perché mossi da semplice curiosità, o perché attirati dal senso dell’avventura in terreni sconosciuti.
dalla «fiera delle meraviglie» alla conquista di una sede stabile Il Cinématographe Lumière, che nasce come prodotto della scienza, deve trovare e inventarsi il suo pubblico sul piano della narrazione e della riproduzione della realtà, ma gode già di tutta l’esperienza anteriore della lanterna magica in tutte le sue forme e su questo terreno non fa che continuare una tradizione perfezionandola e arricchendola. Se confrontiamo i primi cataloghi Lumière con gli ultimi delle case specializzate in programmi per lanterna magica vediamo che su certi soggetti esiste una coincidenza quasi perfetta. Al di là delle intenzioni dei suoi inventori e della loro capacità di individuare le funzioni e i destinatari privilegiati, il cinematografo, dopo il primo stupore e il successo iniziale, per anni troverà la sua diffusione privilegiata nelle fiere e nei luna park, come attrazione eccezionale, come luogo delle meraviglie. E questo tipo di spettacolo sarà, assai diverso, sia sul piano della produzione d’immagini che del consumo, da quello delle sale urbane. Gli spettacoli da fiera mirano a sostituirsi alle forme di trasmissione orale dei cantacronache, a quelle visive del «padiglione delle meraviglie» o della lanterna magica e a quelle di una letteratura illustrata che tentava di agire sul desiderio sessuale, sulla repressione, cercando di combinare e mescolare realtà lontane ed esotiche, con realtà più vicine e proibite. L’accesso dei pubblici popolari agli spettacoli da fiera è regolato, più che dalla curiosità e dal desiderio di aumentare la propria cultura, dalla ricerca di emozioni violente, dall’accesso al proibito, dall’infrazione di alcuni tabù assai forti in una società contadina e conservatrice che stava conoscendo i primi vistosi fenomeni di urbanizzazione e di emigrazione di massa e che riusciva a trovare nel cinema, accanto a un’occasione tutto sommato innocua di «peccato», anche una delle forme di mediazione più importanti rispetto al mondo e ai modelli della cultura e della società urbana e industriale. Ma questo aspetto per il momento non è ancora produttivo. Nei contesti delle fiere, il cinema, pur dichiarando la propria novità, utilizza dunque codici, esperienze e forme di cultura popolare circolanti per secoli lungo i medesimi canali di trasmissione. I programmi cinematografici di questi fieraioli hanno lo stile, i colori e le forme grafiche dei foglietti di canzoni popolari, dei pianeti della fortuna, che, ad esempio, tipografie popolari come quella dei Pennaroli facevano circolare in grande quantità nelle campagne . Il loro punto di forza è nell’enfasi delle promesse, nell’accumulazione degli eventi eccezionali, nell’enormità delle esperienze che prospettano: i destinatari sono – per alcuni anni – pubblici appena alfabetizzati. Lo sviluppo parallelo di un cinema urbano e di spettacoli viaggianti implica, oltre che la scoperta e la genesi di due diverse forme d’ideologia del pubblico, anche la formazione di due modi di trasmissione dell’immagine e del senso connessi alla rappresentazione. Nelle città, per qualche tempo, gli spettacoli Lumière sono spesso appaiati ai Kinetoscopi Edison, la cui maggiore attrattiva è data dalla riproduzione in diretta di spettacoli di successo (dal circo di Buffalo Bill al bacio di May Irwing e John Rice tratto dal dramma teatrale The Widow Jones). Il cinema come surrogato o sostituto di altre forme di spettacolo è la terza strada che si apre alla rappresentazione cinematografica: a questo modello si collegano in Italia le prime esperienze di Leopoldo Fregoli, che, dal 1898, registra alcuni numeri del suo repertorio di trasformista, grazie alla concessione, da parte di Louis Lumière, conosciuto durante una tournée, del diritto di rappresentare film durante il suo spettacolo . La serie di brevi scenette che lo vedevano come unico protagonista (Fregoli al caffè, Fregoli al ristorante, Una burla di Fregoli, Fregoli dietro le quinte) vengono presentate in una sezione apposita del suo spettacolo – che prende il nome di Fregoligraph – in tutte le maggiori città europee. In Italia l’attività regolare di Fregoli inizia soltanto dal 1899: «Congiungendo quattro pezzi di pellicola che scorrevano senza interruzione, arrivò anche a fabbricare due lungometraggi, Impressioni di Ermete Novelli e Fregoli illusionista» . Una volta creato un suo repertorio di scenette Fregoli ne affida la gestione e la distribuzione al suo amministratore Virgilio Costanzi, che li farà girare per alcuni anni in Italia. Con Fregoli lo spettacolo di illusionismo dal vero si associa a quello cinematografico riprodotto a grandezza superiore rispetto ai primi spettacoli Lumière. L’idea e l’atteggiamento iniziale di Fregoli nei confronti del cinema è pertanto assimilabile all’idea del cinema di Méliès: il limite di Fregoli è dato dall’arrestarsi al contatto immediato della macchina da presa con i suoi 37
38
39
esercizi, senza alcuna capacità di intuire le possibilità narrative del mezzo a sua disposizione. In ogni caso, pur costituendo un momento minimo della sua attività, il cinema serve a Fregoli a mostrare come funzionano i suoi spettacoli, a svelare i suoi trucchi, portando la macchina da presa dietro le quinte . Il successo dello spettacolo è legato alla sua presenza fisica in scena, a un contesto complessivo di rappresentazione di cui il cinema non costituisce che una variante, a un virtuosismo capace di raggiungere vertici tali da modificare le condizioni stesse della rappresentazione. L’idea e l’uso del cinema di Fregoli verrà ereditata, nelle città, dal café chantant e dal music hall, come numero di attrazione all’interno di un programma assai articolato ed eterogeneo. Sarà soprattutto la Ideal Company della ditta Malignani a usare il Fregoligraph come clou dei suoi spettacoli fino al 1904. Nelle campagne invece, si può pensare che il cinema riesca a raggiungere il proprio successo proprio puntando sulla sua originalità e individualità: nonostante le apparecchiature siano piuttosto imperfette e pericolose e i programmi limitati , la stessa struttura itinerante degli spettacoli, la distanza tra una proiezione e l’altra, fanno di queste rappresentazioni eventi eccezionali di grande richiamo popolare. Quali sono i programmi dei fieraioli? Il repertorio, i cui antecedenti naturali vanno ricercati nella Bibliothèque de campagne o nella famosa Bibliothèque bleue di Nicolas Oudot, è aperto e sterminato: comiche e drammi, magia e religione, viaggi e documenti di realtà vicine e conosciute si mescolano come ingredienti, tutti necessari a trasformare comunque ogni elemento del reale in una realtà fantastica e a far muovere l’immaginario popolare puntando più sulla fascinazione che sulla conoscenza . Il 1° maggio 1901 nasce «L’Aurora», l’organo ufficiale della Società internazionale tra i proprietari di spettacoli viaggianti in sostituzione di altre riviste: «La Bussola» e «La rivista degli spettacoli» che nei decenni precedenti hanno contribuito a formare un sodalizio a difesa degli interessi di categoria sul modello delle società di Mutuo Soccorso. Il motto scelto per «L’Aurora» è «Lavoro, onestà, fratellanza» e in uno dei discorsi programmatici del presidente Guglielmo Cattaneo, si afferma che gli impresari ambulanti sono «industriali come tutti gli altri, impresari di novità, che lungi dall’essere zingari, vivendo di rapina, sporchi untuosi, dalle facce incolte e patibolari, arrischiano vistosi capitali mantenendo una vita onestissima». L’associazione ha una natura internazionale: i problemi, il percorso, le caratteristiche economiche – di queste imprese si assomigliano in tutto il territorio europeo. Il libro dei conti di Carmine Riozzi, operante con il suo Electric Imperial Bioscope nei Paesi Bassi, potrebbe essere del tutto eguale a quello di Salvatore Spina o di Luigi Roatto. I baracconi e i padiglioni dei primi impresari cinematografici ai primi del Novecento trovano posto durante il carnevale, le fiere, le feste del santo patrono, i mercati accanto a tutte quelle strutture mobili che fanno periodicamente la loro apparizione nelle periferie o nelle piazze delle città. I circhi, che partecipano solo in parte del tempo delle feste e delle fiere, ospiteranno il cinema e ne faranno una delle loro attrazioni meravigliose (vedi gli Zamperla nel Veneto). Pur apparendoci oggi come espressioni residuali di civiltà in via di sparizione, forme di spettacolo destinate a morire e rivivere sotto altre forme, gli spettacoli ambulanti hanno avuto un ruolo chiave nella costituzione della moderna civiltà dello spettacolo. Il cinema viene adottato, svezzato e si muove all’interno di questi insiemi come in uno spazio placentare. Se allarghiamo lo sguardo e consideriamo il fenomeno degli ambulanti come un fenomeno da studiare nelle sue caratteristiche internazionali, è possibile osservare che i problemi sono del tutto simili per tutti i proprietari dei baracconi ambulanti che operano sia in territorio europeo che italiano. Le autorità pubbliche pongono identici vincoli, gli spettatori si precipitano attratti da identici richiami che agiscono sui sensi, ma anche in profondità sul piano dell’immaginazione e dell’inconscio, le locandine hanno gli stessi caratteri, gli imbonitori si servono dei medesimi richiami, i padri di famiglia e le istituzioni religiose ostacolano le proiezioni con identiche armi nei paesi di religione cattolica o protestante. In ogni caso il cammino, le gesta, i segni lasciati da questi spettacoli hanno qualcosa di epico: gli spettacoli hanno a che fare con il senso della vista, ma sembrano soprattutto una traduzione sul piano visivo della poesia orale: la luce che esce dall’apparecchio dei Lumière o di Edison non è altro che la voce della Musa e il proiettore sostituisce la cetra dell’aedo dilatando a dismisura il suo potere comunicativo. Si rischia di affogare e di essere travolti da ondate di fonti simili esplorando gli archivi comunali o le biblioteche per ricostruire quest’epopea se non si chiarisce in via preliminare che il loro comun denominatore è dato dal coraggio con cui questi piccoli imprenditori sfidano, come i loro predecessori, apostoli e portatori 40
41
42
del nuovo Verbo visivo, le leggi e la morale corrente e dalla carica d’energia sociale ed emotiva che si sprigiona dal pubblico prima, durante e dopo le proiezioni. Per almeno una decina d’anni il cinema ripercorre e utilizza gli stessi itinerari e si mescola e confonde con gli spettacoli ottici o da circo che si sono visti crescere, moltiplicarsi, muoversi con maggior rapidità, grazie a carrozzoni ambulanti, dalla seconda metà dell’Ottocento e unire le grandi città e i piccoli centri di tutta Europa. In svariati casi sono gli stessi ambulanti che abbandonano, a cavallo del secolo, gli spettacoli di Teatro Meccanico, di Cosmorama o Lanterna magica per far posto al Cinematografo . Gli Archivi di Stato e quelli comunali, la stampa locale, le fotografie, nonché i manifesti, le locandine coi programmi ci consentirebbero di delineare un quadro molto dettagliato dei movimenti degli ambulanti in Inghilterra come in Italia e Francia e di disegnare il paesaggio dello spettacolo popolare (di cui il cinema costituisce solo una delle tante meraviglie) e delle sue metamorfosi con notevole accuratezza. Il mercato da una parte è già costituito da secoli e dall’altra è tutto da conquistare e i baracconi cinematografici diventano subito un punto di attrazione molto forte nella piazza dello spettacolo delle grandi fiere popolari. Poi, lentamente i proprietari dei cinematografi ambulanti si staccano dagli altri esercizi per tentare da soli di richiamare e creare i propri pubblici. È un’avventura di breve durata che opportunamente raccontata ha a che fare con l’epopea. Qui di seguito si vuole solo sottolineare come il cinema, prima di trovare la sua completa autonomia, abbia ancora bisogno di ricevere da quel luogo caotico e vitalizzante che è la piazza, ancora utilizzata nei primi decenni del Novecento come spazio dell’effimero, quella fleboclisi di sangue e sogni che gli consentono poi di tagliare il cordone ombelicale con lo spettacolo popolare anteriore e di trovare in breve tempo una propria strada. A Trento, per la fiera di San Vigilio confluiscono ogni anno molti baracconi popolari in Piazza Vò e Piazza Fiera «oltre al Circo equestre Zamperla (che in seguito accoglierà anche il cinema) e Zoppé stabilitosi sulla Piazza Vò e che è frequentato assiduamente, in Piazza della Fiera incominciano del pari a sorgere le solite baracche che in queste due settimane danno a quella piazza quell’aspetto gaio e quell’animazione chiassosa che formano la delizia del nostro popolino. Così per intanto vi sono in esercizio due altalene, una europea a ruota e una americana, a navicella. In una baracca si fa vedere Moina, la donna bruciata viva: poi c’è un Panottico contenente diverse curiosità». Assai presto i proprietari di baracconi ambulanti presentano richieste di autorizzazioni a «impiantare» padiglioni per poter mostrare «vedute cinematografiche». Giuseppe Gresti, Arcangela Filigrana, il Circo Victor, Giovanni Bläser giungono a Trento sul finire dell’Ottocento e i giornalisti dell’«Alto Adige» ne celebrano le gesta . I primi impresari di cinematografi ambulanti che operano in Italia hanno sempre più una fisionomia, un nome e cognome e di alcuni si possono ricostruire, grazie agli archivi comunali e ai giornali locali, in modo abbastanza analitico le imprese: nella foto di gruppo di distinguono Luigi Roatto , Oreste Covini, Taddeo Küllmann, Vittorio Todescato, Paride Tentolini, Alfonso Masi, Rosa Santoli… I loro baracconi multicolori si confondono con molti altri nelle Fiere o nelle feste popolari, vengono illuminati da gruppi elettronici alimentati da motori a vapore, a gas o a petrolio e sono del tutto simili a quelli che in Inghilterra alle fiere di Nottingham, a Oxford a Birmingham, con gli splendidi organi Marenghi, le facciate che per il numero di statue lignee sembrano competere con i frontoni delle cattedrali gotiche o romaniche e di cui conosciamo i volti degli impresari e dei dipendenti (vedi il Crecraft Bioscope Show, o il Murphys Show fotografato a Newcastle nel 1907, o il baraccone di Anderton o quello di Randall William di cui nel 1904 è fotografato tutto il gruppo di lavoratori). Nei primi anni spesso per non abbandonare del tutto la competenza e il lavoro anteriore i gestori dei baracconi mescolano nei diversi paesi spettacoli di varietà (è il caso dell’Arnold Electric Bioscop operante nel 1905) di leoni ammaestrati con proiezioni di «moving pictures» (com’è il caso in Inghilterra del baraccone del capitano Rowlands, che offre questo spettacolo misto in Cornovaglia nel 1896 o il Crecraft’s Show che nel 1902 presenta uno spettacolo di Wild Beast and Living Pictures). Proprio osservando un consistente insieme di fotografie di baracconi presenti nelle fiere europee tra la fine dell’Ottocento e il 1910-1912, oltre che per merito della vasta iconografia raccolta da Bernardini, possiamo avere un contatto ravvicinato con i frontoni dei cinematografi ambulanti, con le troupe degli impresari con le fisionomie dei pubblici popolari, ripresi quasi con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo del fotografo e con il contesto della Fiera entro cui questo tipo di spettacoli per almeno una quindicina d’anni assumono un ruolo di guida. Per l’Inghilterra citare i baracconi dell’Electric Haggar Coliseum, quelli del Simon 43
44
45
Electrograph, di Kemp & Sons, di Enoch Farrar, di William Symonds, di Tom Norman, di Patrick Collins, e ancora il Bioscope di Alf Ball, il Wingate’s Cinematograph, o il Palace of Light Show di Crightons, o il Chipperfield’s Cinematograph Show, o il Dantor’s Coliseum… Decine e decine di palazzi con facciate di almeno una quindicina di metri di lunghezza, una decina di altezza e una trentina o quarantina di profondità si spostano e si formano magicamente in pochissimo tempo all’interno di quelle città delle meraviglie che sono le Fiere le giostre e i luna park. Finalmente nei nuovi spazi dell’effimero nascono insiemi di spettacoli che possono sostituire per i nuovi protagonisti della scena sociale le cerimonie religiose, i matrimoni, i funerali, le esecuzioni capitali, gli ingressi trionfali di autorità, capi di stato, generali… Ai baracconi e ai loro richiami multicolori le piccole città, con le loro fiere periodiche dedicheranno sempre più accoglienze trionfali. I baracconi che viaggiano per l’Europa e frequentemente varcano i confini passando dall’Impero austroungarico all’Italia, dalla Francia al Belgio e all’Olanda, alla vista sono simili: si assomigliano oltre che per gli organi, le cariatidi che rappresentano per lo più corpi di prosperose ragazze nude dalla cintola in giù, le scritte multicolori, gli abiti degli impresari, i richiami degli imbonitori, che possono addirittura venire multati (è il caso di un cinema a Treviso per gli «schiamazzi ad alta voce») . André Gaudreault, lo storico canadese del cinema muto che ha studiato la figura degli imbonitori in vari paesi, dopo una rapida inchiesta presso alcuni studiosi italiani, ha concluso che l’Italia faceva eccezione rispetto agli altri paesi in quanto non sembrava documentata la figura dell’imbonitore . Di fatto non conosceva il lavoro di Sergio Raffaelli sul cinema ambulante, in cui appaiono svariati nomi, da Gennaro Attanasio, a Giovanni Sardini «el Coco», a Fureghin, imbonitore al Ponte della Piavola a Venezia, altrimenti avrebbe avuto idee meno parziali e imprecise . La tradizione dello spettacolo ambulante che affonda le radici nella commedia dell’arte fa sì che per quanto riguarda il cinema delle origini in Italia ci si adegui subito agli standard degli altri paesi europei. In una piazza importante come quella di Porta Genova a Milano nel 1901 – ricorda ancora Raffaelli – su 56 imprese vi sono 2 cinematografi, ma già l’anno successivo sono 5. Nel giro di poco tempo su circa 130 aderenti alla Società il gruppo di proprietari di padiglioni cinematografici diventa uno dei più compatti e consistenti: i burattinai Salvi, gli Zamperla, i Leilich, Salvatore Spina, Carlo Luzzato, Paride Tentolini, Taddeo e Franz Küllmann. E tutti gli altri così accuratamente censiti dalla straordinaria ricerca di Bernardini . Nel 1907 nelle fiere i padiglioni – come apprendiamo da notizie dell’epoca sulla fiera milanese di Porta Genova – hanno un peso quantitativo superiore a tutti gli altri, presentandosi con ben 12 padiglioni, contro i 3 padiglioni fotografici o le 5 giostre (c’è anche un «Cine e bersaglio») e tra questi si notano i cinematografi di Giovanni Zamperla, il «Cinematografo e pista» di Arnaldo Dell’Acqua, quello di Annetta Zena e Rosa Santoli… Cinque anni dopo tra 53 baracconi «sopravviveva isolato» solo quello di Taddeo Küllmann. Il vero sforzo dei proprietari di questi padiglioni è quello di poter disporre di un baraccone autonomo capace di garantire un profitto offrendo solo spettacoli cinematografici. Nel giro di qualche anno dunque i padiglioni cinematografici diventano una delle attrazioni di punta delle fiere e propongono spettacoli sempre più affascinanti e carichi d’intenzioni trasgressive. Le «serate nere», con proiezioni di scene dal titolo La nascita di Venere, Il membro del comitato, Notte d’amore di un vecchio libertino, costituiranno il clou e il momento di massima fortuna nell’epopea degli ambulanti, e ne consentiranno la sopravvivenza anche dopo l’insediamento delle sale stabili. La crisi degli spettacoli ambulanti si avverte come si è detto già alla fine del primo decennio: molti impresari corrono ai ripari divenendo proprietari di sale urbane (una sala Splendor nasce a Ivrea nel 1910 grazie a Giuseppe Boaro) , solo pochi decidono di continuare, ma le loro storie entrano in una zona d’ombra e le loro grida, i loro suoni appaiono ancora per qualche tempo come i segnali e le tracce residuali di una civiltà scomparsa che oggi abbiamo l’impressione di studiare con strumenti analoghi a quelli degli archeologi. Il cinema ha appena mosso i primi passi, sta appena compitando le sillabe più elementari del suo lessico ma è già onnipresente e la sua marcia sembra inarrestabile. Ha ancora bisogno di apostoli che portino in giro per le campagne e le fiere il suo messaggio luminoso, ma rispetto alle macchine ottiche del passato non ha più bisogno di mediatori e aspira al più a conquistare dei luoghi stabili, capaci di assumere da subito caratteristiche di luoghi di culto. Il processo di urbanizzazione del cinema, la sua trasformazione da spettacolo di cultura viaggiante e improvvisata in spettacolo stabile, non è soltanto connesso con la scoperta di un terreno d’investimento 46
47
48
49
50
produttivo ancora del tutto vergine e di grande sviluppo possibile, ma va analizzato nel quadro di trasformazione generale dell’Italia da paese agricolo a paese industriale, nel quadro dei primi passi della modernizzazione a cui il cinema si accoda da testimone e protagonista, come seconda «nuova arma» dopo l’automobile. Questo significa vedere le scelte economiche fatte dai primi imprenditori cinematografici e la trasformazione delle strutture iniziali, il tipo di investimenti, la provenienza dei capitali, il rapporto tra la modernizzazione industriale e i tentativi di razionalizzazione dei primi processi di produzione cinematografica, e il tipo di discorso economico-ideologico presupposto rispetto ai prodotti offerti. Questo discorso è ancora prematuro, ma importa già anticiparne i termini, in quanto l’industria cinematografica non riuscirà mai a raggiungere i livelli, né a darsi un assetto paragonabile alla produzione della grande industria. Se da un certo momento l’ipotesi comune a tutte le maggiori case di produzione sarà quella di allargare il consumo dei prodotti cinematografici, i produttori risulteranno non come espressione di una nuova imprenditorialità borghese emergente, quanto piuttosto come il prodotto di vari tipi di figure, tra cui spiccheranno sempre più, negli anni precedenti alla guerra, i rappresentanti di un potere economico costituito da rendite fondiarie, parassitario, non certo in linea con la politica economica e con le scelte del nascente capitale industriale. In sostanza il cinema non abbandonerà mai, sul piano della sua politica economica generale, quel senso di precarietà, di improvvisazione, che ne accompagna la nascita e la prima diffusione. Il conservatorismo ideologico che caratterizzerà gran parte della produzione a tutti i livelli di generi (salvo qualche eccezione) è la naturale risultante di un’ideologia degli imprenditori che raramente sposa la causa del socialismo e del cinema come scuola d’educazione popolare mentre in maniera più spontanea si ritrova compatta a trasmettere i valori nazionalistici negli anni di massimo sviluppo industriale. Questi valori hanno il potere di annullare alcune manifestazioni ideologiche divergenti, l’emergere di produttori che abbracciano le idee progressiste e scoprono la possibilità di differenziare il messaggio a seconda dei pubblici. Negli anni che precedono la guerra si assisterà a un processo di massima identificazione degli interessi economici con quelli ideologici. Nel 1897 sorgono, in alcune città italiane, sale con pretese di stabilità: la prima, aperta a Roma, in via del Mortaro, offre «fotografie viventi», l’anno successivo Ezio Cristofari e Luigi Topi aprono, in piazza S. Lorenzo in Lucina, una sala per proiezioni (del Kinetoscopio Edison però) in uno spazio che riproduce al coperto le meraviglie del luna park . A Napoli, Venezia, Bergamo, nascono, contemporaneamente, altre sale che offrono una programmazione cinematografica regolare, ma che, data la brevità degli spettacoli (20-30 minuti), sono costrette a integrare lo spettacolo cinematografico con altre performance. Il breve, ma importante periodo di coabitazione negli spazi del music hall, del varieté, del café chantant, se da una parte favorisce il rifiuto dei benpensanti, dall’altra riesce a ottenere, per il principio dei vasi comunicanti, non trascurabili influssi da queste forme di spettacolo e non da ultimo scopre un potenziale di futuri quadri di attori e tecniche recitative, per alcuni anni inutilizzate, e usate in seguito in modo massiccio, non appena si cominceranno a costituire le prime elementari strutture produttive. L’esercizio urbano, rispetto all’attività dei fieraioli, gode dunque di questa superiorità e di queste indubbie spinte collaterali: la coesistenza obbligata e necessaria con altre forme di spettacolo offre un potenziale di idee, modelli narrativi e recitativi destinati a costituire il patrimonio iniziale del cinema italiano, restio, per molti anni, a ricercare una propria specificità linguistica ed espressiva. Questo fenomeno – grazie alle ricerche condotte in quest’ultimo decennio in vari altri paesi, dagli Stati Uniti, all’Inghilterra all’Unione Sovietica – appare come un punto di passaggio, quasi un «fattore della crescita», inevitabile e indispensabile. A Napoli nascono diverse sale prima della fine del secolo, per iniziativa dei fratelli Troncone, dei Marino e di Mario Recanati e tutte concentrate in uno stesso spazio, la Galleria Umberto I, nata alla fine dell’Ottocento. Tutto comincia dal Salone Margherita, situato nei sotterranei della Galleria, che proprio in quegli anni era già diventato il più conosciuto e celebrato café chantant italiano . Una delle caratteristiche specifiche dello spettacolo napoletano, che entrerà direttamente in seguito nella produzione, è quella di concepire il programma cinematografico come facente parte dello spettacolo di varietà: nella maggior parte dei casi ne costituisce il gran finale. Queste prime esperienze, a cui vanno aggiunte quelle di Alberini, che apre una sala prima a Firenze e poi a Roma agli inizi del Novecento, saranno la base di partenza per la scalata verso la produzione. Intanto giunge 51
52
in Italia, nel 1898, il Mutoscopio Dickson che consente un tipo di proiezione su uno schermo assai più ampio dell’apparecchio Lumière : questo apparecchio favorisce lo sviluppo dell’esercizio urbano e migliora nettamente la qualità delle proiezioni. Nei primi anni la figura dell’esercente è ancora piuttosto anomala: più che il manager di una piccola impresa commerciale, l’esercente è un po’ il factotum, come ben possiamo capire da questo ritratto di uno dei primi esercenti, Rodolfo Remondini, che apre una sala a Firenze, negli stessi anni di Alberini: «Remondini faceva di tutto: imbonitore elegante sulle soglie del locale, operatore di fortuna quando il titolare nicchiava e soprattutto eccellente pianista […]. In seguito diventò fotografo cinematografista ufficiale dei conti di Torino, andò a corte e ottenne il brevetto reale» . In questa descrizione è condensato, in modo esemplare, il senso di contatto e interferenza tra i modi e la cornice dello spettacolo nelle fiere e la funzione urbana dello spettacolo stesso. L’approdo degli operatori alla casa reale sembra essere la consacrazione ufficiale dell’importanza storica del cinema. Già questo onore era toccato a Vittorio Calcina prima e a Luca Comerio poi: a entrambi era stato concesso di riprendere i regnanti oltre che nelle cerimonie ufficiali anche nella vita privata quotidiana. Calcina aveva filmato nel 1896 a Monza Umberto e Margherita di Savoia e, negli anni successivi, aveva organizzato spettacoli a Monza, per gli stessi Savoia . Calcina è stato l’unico operatore a cui sia stato concesso, nel 1900, di riprendere i funerali di re Umberto. Comerio, fotografo milanese a cui dai primi anni del secolo la casa regnante concede ufficialmente il diritto di ripresa, fa incidere, sulle sue bobine, lo stemma sabaudo e inizia la sua fortuna commerciale vendendo le sue attualità, contrassegnate dal marchio regale, ai produttori e distributori francesi . Nel decennio che va dalla prima proiezione pubblica all’inizio di una produzione regolare, si può registrare, in varie città d’Italia, a Torino, Milano, Firenze, Roma, un lavoro degli operatori di attualità che non si discosta molto dalle regole codificate dagli operatori Lumière e divulgate da subito attraverso appositi corsi di preparazione promossi presso la sede di Lione della casa francese . Il lavoro dei primi operatori è comunque circondato da un alone quasi leggendario e non sembra tener conto che, in molti casi, l’operatore non fa che variare di durata un tipo di presenza e di documentazione di certi avvenimenti, già ampiamente collaudato dai fotografi d’attualità dalla seconda metà dell’Ottocento. I primi operatori italiani degni di essere ricordati accanto a Calcina, e Comerio sono Roberto Omegna , Giovanni Vitrotti, Luigi Fiorio. Nel momento in cui iniziano un’attività regolare, che, in alcuni casi, avrà una durata di oltre cinquant’anni – e una volta esaurita la curiosità nei confronti del reale quotidiano e dell’informazione sui dati della realtà circostante – questi operatori iniziano ad assimilare il loro lavoro a quello delle imprese sportive. Mentre è presumibile che le prime attualità fossero sostanzialmente anonime da un certo momento, Omegna, Calcina, Comerio, sembrano non accontentarsi più della documentazione di tipo giornalistico in terza persona e le loro riprese vogliono trasmettere il senso di una esperienza vissuta in prima persona. Quanto più la ripresa comporta un rischio tanto più l’operatore diventa consapevole di essere non lo spettatore passivo di un’azione, ma, in molti casi, il testimone e protagonista unico di qualcosa di eccezionale. Ciò spiega come gli operatori vogliano essere presenti a certe imprese sportive e intendano viverle dall’interno. Niente di più soggettivo e vissuto delle riprese di questi operatori: quasi tutti sembrano lucidamente consapevoli della novità e dell’importanza del loro ruolo . Alcuni di loro (Vitrotti, Fiorio, Omegna) costituiranno i quadri professionali di base per l’avvio di un’industria capace di reggere con dignità alla concorrenza straniera, altri, come Luca Comerio, cercheranno di controllare direttamente tutto il ciclo di produzione. Certo è che la formazione di una competenza professionale ad alto livello degli operatori è un anello fondamentale per capire il primo decennio di storia del cinema. Il fatto poi che alcuni di loro fossero anche esercenti, che alcuni esercenti venissero raggruppando lentamente più sale, che dai primi anni del Novecento si scoprisse la potenzialità del mercato e ci si accorgesse che i materiali forniti dalle case di produzione francesi erano sempre più insufficienti a far fronte alla domanda interna, sono tutti elementi che favoriscono il passaggio graduale dall’esercizio improvvisato e casuale a quello stabile e alla produzione. Il primo ad accorgersi della reale potenzialità del mercato, in un momento di crisi per la produzione cinematografica mondiale , è Filoteo Alberini che, dopo aver gestito con intelligenza dal 1899 al 1901 una sala a Firenze , ne inaugura, nel 1904, una a Roma (il cinema Moderno, in piazza dell’Esedra) al prezzo popolare di 20 centesimi: «Dovete sapere – scrive lo stesso Alberini a qualche anno di distanza – che il mio 53
54
55
56
57
58
59
60
61
progetto prevedeva non solo l’apertura di più sale a Roma, ma sibbene molte succursali in altre città d’Italia e ciò perché prevedevo la concorrenza» . Anche su questo piano Alberini si rivela una figura chiave: la sua iniziativa imprenditoriale gli consente di immaginare una rapida scalata verso il controllo verticale del processo produttivo e di puntare decisamente alla realizzazione dello spettacolo cinematografico. Mentre per i fieraioli «improvvisati dilettanti, quello con il cinema fu un incontro occasionale, un affare da dilettanti che venne sostituito da altri marchingegni» , per uomini come Alberini, o Comerio, per cui l’esercizio era un momento di un’esperienza di cui si possedeva una competenza assai elevata, l’attività segue un certo processo e approda, quasi naturalmente, a esiti più vasti. È necessario, a questo punto, per capire le tappe di evoluzione tecnologica, tener presente che, già sul finire dell’Ottocento, l’invenzione dei Lumière sembra aver consumato tutte le sue potenzialità. Solo grazie all’ingresso sul mercato dei Mutoscopi Dickson prima e degli apparecchi Pathé poi, vi saranno decisive trasformazioni tecnologiche indispensabili a far compiere un netto salto di qualità ai materiali cinematografici e a creare nuove e ben distinte categorie professionali di operatori, e proiezionisti. Mentre gli apparecchi Lumière richiedevano all’operatore compiti assai diversi e favorivano la sua mobilità, gli apparecchi Pathé erano stati concepiti in modo da tener ben distinte le operazioni di ripresa da quelle di proiezione. All’operatore si chiedeva di potenziare la sua capacità professionale e accanto a lui, con funzione certo meno gratificante, ma altrettanto precisa, nasceva la figura del proiezionista che, nel giro di poco tempo, avrebbe assunto un’identità altrettanto definita grazie anche al progressivo sviluppo di sale urbane sempre più esplicitamente dedicate al cinema. Pathé andava alla conquista degli Stati Uniti entrando in concorrenza con Edison e sostituiva i Lumière nei primi anni del Novecento, in molti paesi europei, Italia compresa, sia per quanto riguarda le forniture di apparecchi, che nell’attività di regolare produzione vera e propria . Rispetto ai Lumière, interessati soltanto all’attualità, la nuova casa francese immette subito sul mercato prodotti assai diversi, capaci di prevedere una domanda a vari livelli e di soddisfare ogni tipo di curiosità. Abbandonate le fiere e gli spettacoli viaggianti il cinema muove, nei primi anni del secolo, alla conquista dei pubblici urbani e alla ricerca dei propri statuti culturali. È chiaro che il salto tecnologico impresso dall’era Pathé comporterà anche un diverso tipo di investimenti e una maggiore circolazione di capitali, anche se si tratterà sempre, in questa fase, di costituzione più stabile dell’esercizio, di rischi assai modesti rispetto alle altre attività imprenditoriali che stavano mutando, proprio in quegli anni, la fisionomia economica di alcune importanti zone del paese. 62
63
64
65
1
L. Solaroli e L. Bizzarri, L’industria cinematografica italiana, Parenti, Firenze 1958, p. 14.
2
V.J. Prieur, Le spectateur nocturne, Cahiers du cinéma, Paris 1993, p. 19.
3
T. Gautier, Histoire de l’art dramatique en France, tome XVI, Paris 1858.
M. Coissac, Histoire du cinématographe, Éd. du Cinéopse, Paris 1925, p. 181. Due lavori recenti dedicati ai Lumière hanno enormemente allargato le conoscenze sull’attività generale dei due fratelli di Lione: B. Chardère, G. e M. Borgé, I Lumière, Marsilio, Venezia 1986 e R. Redi (a cura di), Lumière, Di Giacomo, Roma 1986. 4
In un articolo del 1908 sulla «Cinematografia italiana» intitolato Per chi cerca un nome Gualtiero Fabbri pubblica una serie di nomi come Animatoscope, Biograph, Cinoscope, Kineograph, Lifeoscope, Optigraph, Panoramoscope, Phantibiograph, Phonendoscope, Stroboscope, Vitagraph, Zoopraxinoscope. Deduco l’informazione da S. Raffaelli, Introduzione all’onomastica del cinema, in «Rivista Italiana di Onomastica», a. II, n. 1, 1996, p. 114. 5
6
Si veda in particolare le pp. 284-292 di B. Chardère, Le roman des Lumière, Gallimard, Paris 1995.
7
La dichiarazione è rilasciata il 31 dicembre 1935, su «Minerva» a Régis-Leroi, citato in Chardère, Le roman des Lumière, cit., p. 284.
8
L’intervista del 6 gennaio 1948 è pubblicata nella monografia di G. Sadoul, Louis Lumière, Seghers, Paris 1964.
9
In una lettera di Carpentier del 22 dicembre raccolta in A. e L. Lumière, Correspondences 1890-1953, Cahiers du Cinéma, Paris 1994.
10
É.J. Marey, La Chronophotographie, Gauthier-Villars, Paris 1899, cit. in Chardère, Le roman des Lumière, cit., p. 190.
La riproduzione fotografica del brevetto originale è in XL anniversario della cinematografia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1935, p. 82. 11
12
L. Sassi, Le proiezioni, Hoepli, Milano 1897, p. 181.
In appendice al citato volume di Coissac è raccolto un elenco di tutti i brevetti francesi nel campo della fotografia e del cinema tra il 1890 e il 1900. 13
Una significativa raccolta di voci della stampa si trova in S. Raffaelli, Cinema, film, regia, Bulzoni, Roma 1978, p. 22. Per la diffusione del Kinetoscopio si veda A. Bernardini, Cinema muto italiano. I. Ambiente, spettacoli e spettatori 1896-1904, Laterza, Roma-Bari 1980, pp. 1322. Sulla difficoltà a stabilire la paternità di alcuni titoli nella prima fase di lotta tra i due sistemi si veda R. Redi, L’arrivo di un treno: Edison o Lumière?, in V. Angelini e F. Pucci (a cura di), Materiali per una storia del cinema delle origini, Studio Forma, Torino 1981. Un bel profilo 14
di Giuseppe Filippi è stato scritto da L. Luppi, Ritratto di un pioniere, Giuseppe Filippi, in R. Redi (a cura di), Cinema muto italiano (19051916), CNC edizioni, Roma 1991, pp. 11-32. Questa data è stata stabilita dalle ricerche di Bernardini e almeno per il momento non ha subito anticipazioni (Cinema muto italiano, cit., p. 316). Il 29 marzo dello stesso mese lo spettacolo è visto a Milano. In questo caso la data è fissata da Raffaelli, nel volume citato Cinema, film, regia, in base allo spoglio di alcuni giornali che parlano di anteprima. In M.A. Prolo, Storia del cinema muto italiano, Il Poligono, Milano 1951, p. 16, si parla genericamente di prime proiezioni cinematografiche pubbliche a Torino nell’inverno del 1896 e di successive proiezioni milanesi in primavera. 15
La recensione appare sul «Corriere della Sera» del 30-31 marzo 1896, p. 3 ed è riportata nel lavoro di Raffaelli, Cinema, film, regia, cit., p. 29. 16
Qualcuno condanna «il vociare rumoroso e molesto che ricorda, anche nel bel mezzo di Milano, il sistema primitivo dei banditori delle fiere rurali», commento apparso su «Il Sole», 18 novembre 1906 e ripreso in «L’Aurora», n. 16, 1906, p. 6. 17
Ormai la bibliografia sulle prime proiezioni copre in pratica tutto il territorio nazionale: citiamo senza un ordine di importanza alcuni testi usciti in questi anni, includendo anche una monografia sul cinema del Tirolo: G. Rondolino, Torino come Hollywood (capitale del cinema italiano, 1896-1916), Cappelli, Bologna 1980; V. Angelini e F. Pucci (a cura di), Materiali per una storia del cinema delle origini, Pesaro 1981; A. Bernardini (a cura di), Cinema e storiografia in Europa, Comune di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1984 (la terza sezione in particolare); F. De Lucis (a cura di), C’era il cinema. L’Italia al cinema tra Otto e Novecento, Edizioni Panini, Reggio Emilia 1985; S. Salvagnini (a cura di), La scena e la memoria, Biblioteca comunale di Este, Este 1985; L. Fantina, Tempo e passatempo, Il Poligrafo, Padova 1988; M. Quargnolo, Quando i friulani andavano al cinema, Biblioteca dell’immagine, Gemona 1989; G. Calzolari, I cinematografi di Parma, Segea, Parma 1989; D. Kosanović, 1896-1918: Trieste al cinema, La Cineteca del Friuli, Gemona 1995; R. De Berti, Un secolo di cinema a Milano, Il Castoro, Milano 1996; P. Caneppele, Il Tirolo in pellicola, Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano 1996; L. Jacob e C. Gaberscek, Il Friuli e il cinema, Cineteca del Friuli/Biblioteca dell’immagine, Gemona 1996; L. Cuccu (a cura di), Il cinema nelle città, Livorno e Pisa nei 100 anni del Cinematografo, ETS, Pisa 1996; L. Morbiato, Cinema ordinario, Il Poligrafo, Padova 1998; S. Scandolara, Nostro cine quotidiano. Le Gorizie al cinema, Kinoatelje, Gorizia 2001; M. Bonetto e P. Caneppele, Inizi lo spettacolo! Storia del cinematografo a Trento (1896-1918), Museo storico di Trento, Trento 2001; R. Bovani e R. Del Porro, La fotografia animata a Lucca, ETS, Pisa 2001. 18
C. Nasi, Fra uomini e cose, in «La Gazzetta di Torino», 6 aprile 1896, p. 1. Nel citato volume sui Lumière curato da Riccardo Redi è raccolta una significativa antologia di voci e reazioni giornalistiche in varie parti d’Italia all’indomani della prima proiezione del Cinématographe. 19
«Questi spettacoli di fotografia animata hanno fatto furore ovunque e a Milano il pubblico accorse in gran folla tutti i giorni ad ammirarli. E presto in tutte le città d’Italia sarà dato di ammirarli». N., Il cinematografo Lumière, in «Il progresso fotografico», aprile 1896, p. 61, cit. in Raffaelli, Cinema, film, regia, cit., p 30. Grazie a tanti piccoli contributi e a microricerche molto simili come procedimento e in pratica interscambiabili quanto a risultati, sappiamo oggi quando e come sono arrivati i primi spettacoli cinematografici a Trieste e a Catania, a Udine e a Rimini, a Cesena, a Padova e ad Ancona… Un riuscito tentativo di osservare il fenomeno all’interno della complessità sociale e dei mutamenti a cavallo del secolo, in una città come Treviso, è in Fantina, Tempo e passatempo, cit. Il quadro è tutt’altro che completato, ma le informazioni sono molte e attendibili. Sulle figure dei primi gestori e sul tipo di macchine e di programmi si veda R. Redi, Cinema dell’Ottocento. I primordi del cinema in Italia, in De Lucis (a cura di), C’era il cinema, cit. 20
Il ritrovamento di questo manifesto consente di anticipare la data della prima italiana a soli pochi mesi di distanza dalla proiezione parigina del dicembre 1865. Cfr. P. Poncino, Breve storia dei cinema torinesi, Giulio Bolaffi Editore, Torino s.d. ma 1996. 21
Si veda il volume della Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., p. 16, dove tuttavia sembrerebbe che le proiezioni torinesi di Calcina fossero anteriori a quelle milanesi. E.G. Valperga, Splendori del cinema muto, in G.V. Amoretti et al., Cultura e lavoro in Piemonte, Eda, Torino 1984, pp. 157-162. 22
In appendice al suo lavoro sugli ambulanti Aldo Bernardini ha raccolto un’accurata e fondamentale cronologia delle prime proiezioni pubbliche italiane: A. Bernardini, Cinema italiano delle origini. Gli ambulanti, La Cineteca del Friuli, Gemona 2001, pp. 153 sgg. 23
24
Il manifesto di questo programma è conservato al Museo del cinema di Torino, la riproduzione si può vedere in M.A. Prolo e L. Carluccio,
Il Museo nazionale del cinema, Cassa di risparmio di Torino, Torino 1978, p. 175. A. Bernardini, Naissance et évolution des structures du premier cinéma italien (1896-1912), in «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979, p. 15. A p. 57 del citato volume di Bernardini sono raccolti i titoli delle riprese italiane dei cataloghi Lumière negli anni 1896-1897. 25
Per l’evoluzione del processo di animazione della fotografia si possono vedere tutte le storie generali del cinema, da Sadoul a Mitry a Deslandes, anche se ottima resta sempre la storia di Coissac a cui tutti gli autori successivi hanno attinto a piene mani. Ricca di notizie è anche la Historia del cine in 3 volumi di G.F. Cuenca, Aguado, Madrid 1948-1950. 26
M. Quargnolo, Vecchi cinema udinesi, La nuova base, Udine 1977, p. 49. Dello stesso autore si veda anche l’ottimo Quando i friulani andavano al cinema, Biblioteca dell’immagine, Pordenone 1990. 27
28
Bernardini, Cinema italiano delle origini, cit., p. 14.
Il cinema a Milano, Comune di Milano, Milano 1966, p. 9. Su Pacchioni si veda anche N. Giannitrapani e R. Persichini, Le vere origini del cinema italiano, in «Cinema», a. VII, n. 142, 25 maggio 1942, p. 277. 29
È d’obbligo citare A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, Roma 1977. Tra i testi più recenti si vedano almeno: AA.VV., La vie populaire en France du Moyen Âge à nos jours, Diderot, Paris 1965; G. Bollème, Les almanachs populaires au XVII et XVIII siècle. 30
Essai d’histoire sociale, Mouton, Paris-La Haye 1969; M. Soriano, Les contes des Perrault. Culture savante et tradition populaire, Gallimard, Paris 1968; fondamentale per l’ampiezza di visione e per la ricchezza di spunti metodologici M. Bachtin, L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Gallimard, Paris 1970; sulla linea di quest’opera e con un’attenzione storica più centrata sulla letteratura rinascimentale e secentesca le opere di P. Camporesi e in particolare Il paese della fame, Il Mulino, Bologna 1978. M. Brusatin e A. Costa, Visione, in Enciclopedia Einaudi, vol. XIV, Einaudi, Torino 1981, pp. 1060-1120. E. Silvestrini (a cura di), La piazza universale, Mondadori-De Luca, Roma 1988. A. Costa (a cura di), La meccanica del visibile, La Casa Usher, Firenze 1983. Per Giambattista della Porta si veda L. Muraro, Giambattista della Porta, mago e scienziato, Feltrinelli, Milano 1978; a Kircher dedica ottime pagine Coissac nel primo capitolo della sua storia intitolato Les prophètes. Su Kircher si veda soprattutto, per l’alta qualità dei contributi, AA.VV., Enciclopedismo in Roma barocca, Marsilio, Venezia 1986. 31
32
Il manifesto originale è riprodotto in Prolo e Carluccio, Il Museo nazionale del cinema, cit., p. 55.
33
W. Benjamin, Parigi capitale del XIX secolo, Einaudi, Torino 1986, p. 516.
34
Si veda il saggio di Maria Adriana Prolo in Prolo e Carluccio, Il Museo nazionale del cinema, cit., in particolare pp. xii-xiv.
Nel Cinquecento e Seicento oltre agli scritti di della Porta (Della magia naturale) vanno ricordati gli studi di Daniele Barbaro e di Giovanni Cristoforo Sturmius. La bibliografia sull’argomento è ormai consistente. Segnalo tra i molti saggi I. Remise et al., Magie Lumineuse, Ballaud, Paris 1979; I. Prieur, Séance de lanterne magique, Gallimard, Paris 1985. Si vedano anche i miei Il Pre-cinema, in Cinema e Film, vol. I, Curcio, Roma 1986 e Il viaggio dell’Icononauta, Marsilio, Venezia 1997. 35
Prolo e Carluccio, Il Museo nazionale del cinema, cit., p. xiii. Per una più ampia trattazione del ruolo delle lanterne magiche e dei Mondi Nuovi rinvio ai miei saggi e a quelli di Alberto Zotti in A. Zotti (a cura di), Le lanterne magiche, Marsilio, Venezia 1988 e Id. (a cura di), Il Mondo nuovo, Mazzotta, Milano 1988; per il passaggio dello spettacolo popolare dal Settecento all’invenzione del cinema cfr. G.P. Brunetta, La grande cavalcata. Cinquant’anni di spettacolo popolare nel Veneto, in «Venetica», n. 5, gennaio-giugno 1986, pp. 138-158 e Id., Il lungo viaggio dell’Icononauta, in AA.VV., Cinéma et littérature, Vubpress, Brussel 1991. 36
37
E. Carrà e L. Mosconi, I pianeti della fortuna, canzoni e vignette popolari, Scheiwiller, Milano 1974.
M. Corsi, Fregoli pioniere del muto e precursore del sonoro, in «Cinema», n. 11, 10 dicembre 1936 e L. Fregoli, Fregoli raccontato da Fregoli, Rizzoli, Milano 1936. Da segnalare anche il più recente J. Nohain e F. Caradec, Fregoli, sa vie et ses secrets, Le Jeune Parc, Paris 1968. Inoltre il netto profilo tracciato da A. Bernardini, Leopoldo Fregoli «Cinematografista», in G.P. Brunetta e D. Turconi (a cura di), Cinema & Film. La meravigliosa storia dell’arte cinematografica, vol. I, Curcio, Roma 1986, pp. 90-92. 38
39
Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., p. 18.
Su Fregoli si veda anche A. Sainati, La personnalisation du cinématographe: Fregoli et son «Fregoligraph», in AA.VV., L’aventure du Cinématographe. Actes du Congrès mondial Lumière, Université Lumière, Lyon 1999, pp. 181-185. 40
41
Per la programmazione degli ambulanti la fonte più significativa è quella del bollettino «L’Aurora», si veda Bernardini, Naissance et
évolution des structures du premier cinéma italien, cit., p. 20. Oltre al libro citato della Bollème, P. Brochon, Le livre de colportage en France depuis le XVI siècle, Grund, Paris 1954, e ancora di G. Bollème, La Bibliothéque bleue, Julliard, Paris 1971. Grazie alle ricerche di Bernardini e a più recenti analisi in profondità, come quella condotta sulle riviste «La Bussola», «La rivista degli spettacoli» e «L’Aurora» nella tesi di Carlo Zilio (Dalla fiera al cinematografo. Lo spettacolo viaggiante in Italia (1889-1911), discussa a Padova nell’anno accademico 1988-1989, si può dire che le conoscenze sullo spettacolo viaggiante consentano di avere un quadro relativamente esauriente delle figure e dei problemi. Di questa tesi di Zilio un capitolo è apparso su «La cosa vista», nn. 14-15, 1990 col titolo Fieranti invisibili. Appunti per una storia di un’associazione di ambulanti dell’età giolittiana, pp. 26-30. 42
Il Comune di Venezia rifiuta nel 1885 la concessione degli spazi pubblici per il carnevale a vari ambulanti tra cui Luigi Roatto, che presentava spettacoli di lanterna magica e che sarà uno dei primi a convertirsi al cinematografo. Si veda Archivio Municipale di Venezia, 1890-1895, XI-5-12. 43
P. Caneppele, Le vie del cinema: i pubblici spettacoli viaggianti e le prime proiezioni cinematografiche a Trento, in «Archivio trentino di storia contemporanea», n. 3, 1996, pp. 121-136. 44
45
C. Montanaro, Gli ambulanti e impresari veneti Luigi e Almerico Roatto, in Bernardini (a cura di), Cinema e storiografia in Europa, cit.
46
Fantina, Tempo e passatempo, cit., p. 188.
A. Gaudreault, Mais où est le bonimenteur italien, in M. Canosa (a cura di), A nuova luce. Cinema muto italiano, vol. I, Clueb, Bologna 2001. 47
S. Raffaelli, Quando il cinema era mobile, in «La ricerca folclorica», a. X, n. 19, 1988, pp. 103-112 ora in Id., La lingua filmata. Didascalie e dialoghi nel cinema italiano, Le Lettere, Firenze 1992, pp. 21-43. 48
49
A. Bernardini, Cinema italiano delle origini. Gli ambulanti, La Cineteca del Friuli, Gemona 2001.
50
Ivi, p. 53.
G. Livoni, I primordi del cinema a Roma, in «La cinematografia italiana ed estera», 15 marzo 1918. Oltre al volume di Bernardini (Cinema italiano delle origini, cit.), si veda di R. Redi, I primordi del cinema a Roma, in De Lucis (a cura di), C’era il cinema, cit. Cfr. anche Luoghi dello spettacolo e immaginario urbano tra Otto e Novecento in Italia, in Costa (a cura di), La meccanica del visibile, cit., pp. 47-63. 51
52
G. Fusco, Napoli 1896. Le prime forme di esercizio, in «Cinemasessanta», a. XXXXIV, n. 6, novembre-dicembre 2003, pp. 23-32.
53
Lo descrive in una rivista torinese («Il Silvio Pellico») Giuseppe Flecchia nel settembre 1898: il testo è riportato in Prolo, Storia del
cinema muto italiano, cit., p. 18. 54
F. Tettoni e R. Remondini, in «Notiziario del Museo nazionale del cinema», a. IV, n. 10, maggio 1969, p. 7.
55
Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., pp. 94-95.
A Comerio è stato dedicato un volume riccamente illustrato a cura di C. Manenti, N. Monti e G. Nicodemi, Luca Comerio fotografo e cineasta, Electa, Milano 1979. Si veda soprattutto la recente raccolta di saggi E. Dagrada, E. Mosconi e S. Paoli (a cura di), Moltiplicare l’istante. Beltrami, Comerio, Pacchioni tra fotografia e cinema, Il Castoro, Milano 2007, e in particolare il saggio di A. Bernardini, La società di Luca Comerio, pp. 93-112. 56
Incaricato di formare i nuovi quadri fu l’operatore M. Promio di cui la storia di Coissac ha riportato ampi stralci di autobiografia con precisi riferimenti all’Italia, dove vengono scoperte le possibilità di riprese in movimento: «C’est en Italie que j’eus pour la première fois l’idée des vues panoramiques. Arrivé à Venise et me rendant en bateau de la gare à mon hotel, sur le grand canal, je regardais les rives fuir et je pensais alors que si e cinéma immobile permet de reproduire des objets mobiles, on pourrait peut-être retourner la proposition et essayer de reproduire à faide du cinéma mobile des objets immobiles. Je fis de suite une bande que j’envoyai à Lion avec prière de me dire ce que M. Louis Lumière pensait de cet essai. La réponse fut favorable» (Coissac, Histoire du cinématographe, cit., p. 197). Per il legame tra Calcina e i Lumière si veda, oltre al I volume della Storia generale del cinema di Sadoul (Einaudi, Torino 1965, pp. 139 sgg.), anche la sua monografia Louis Lumière, cit. Le recenti ricerche di Bernardini hanno messo in luce in maniera esemplare i rapporti tra gli operatori italiani e la casa di Lione. 57
Il profilo più documentato di Omegna si deve a V. Tosi, Il pioniere Roberto Omegna (1876-1948), in «Bianco e Nero», a. XL, n. 3, marzo 1979, pp. 1-68. 58
Si può vedere, a questo proposito, l’affettuosa ricostruzione biografica dedicata a Giovanni Vitrotti da Marucci Vascon Vitrotti: M. Vascon Vitrotti, Un pioniere del cinema: Giovanni Vitrotti, Coana, Trieste 1970. 59
60
Si veda G. Sadoul, Storia generale del cinema. Il cinema diventa un’arte (1909-1920), Einaudi, Torino 1967, p. 219.
A. Bernardini, I pionieri. Le occasioni mancate, in L. Giannelli (a cura di), La Toscana e il cinema, Banca Toscana, Firenze 1994, pp. 155163. 61
F. Alberini, Il primo impulso al cinematografo, in «La rivista cinematografica», a. IV, 10 febbraio 1923. Una breve commemorazione di Alberini di M.A. Prolo nel «Notiziario del Museo nazionale del cinema», a. II, n. 6, settembre 1967. 62
Bernardini, Naissance et évolution des structures du premier cinéma italien, cit., p. 24. Il testo italiano è quello originale dell’autore. Le ricerche più recenti di Bernardini stesso, ma anche di altri giovani studiosi che hanno esplorato la diffusione del cinema nel primo decennio con saggi o tesi di laurea, da Nino Genovese a Gianfranco Miro Gori ad Antonio Gesualdi, da Carlo Montanaro a Sileno Salvagnini, da Albano Trevisan a Rosanna Maule, al già ricordato lavoro di Carlo Zilio, mettono in luce il ruolo importante di alcuni ambulanti nel percepire anche le potenzialità del mercato stabile. In particolare si vedano le comunicazioni di G.M. Gori, P. Micalizzi, A. Gesualdi, C. Montanaro, P. Cherchi Usai e G. Valperga, in Bernardini (a cura di), Cinema e storiografia in Europa, cit. e G.M. Gori, Il cinema arriva in Romagna, Maggioli, Rimini 1987. 63
64
R. Abel, The Red Rooster Scare: Making Cinema American,1900-1910, University of California Press, Berkeley 1999.
Si veda J. Mitry, Histoire du cinéma, vol. I, Éd. Universitaires, Paris 1967, pp. 134 sgg. Si veda R. Redi (a cura di), Pathé, Di Giacomo, Roma 1988. Inoltre si veda A. Bernardini, La Pathé Fréres face au cinéma italien, in P. Guibbert (a cura di), Les premiers ans du cinéma français, Institut Jean Vigo, Perpignan 1985, pp. 88-98. 65
Nascita e sviluppodel sistema produttivo. 1905-1918
i pionieri e i loro primi passi L’avventura industriale del cinema italiano si svolge su due fronti: da un lato un’industria a conduzione familiare, assai povera di mezzi, produce per coprire i bisogni di una domanda locale e dall’altro un’organizzazione che nasce su basi finanziarie più consistenti cerca di assumere, al più presto, i ritmi regolari e i modi di produzione della nascente industria capitalistica. Industria comunque marginale, il cinema, in Italia, non riuscirà mai a darsi una struttura economica e commerciale stabile come invece, nel giro di pochi anni, riesce a fare l’industria cinematografica americana. E tuttavia, questa industria marginale, per alcuni anni, assume un ruolo di guida e modello per il cinema e domina, con i suoi prodotti, la scena e i mercati internazionali. Miserabilismo e manie di grandezza, cura artigianale e spirito di conquista, sviluppo irregolare e miopia economica segnano dai primi passi il corpo produttivo di questa industria, ne costituiscono quasi le stimmate distintive e caratterizzanti sul piano internazionale. I produttori sono figure di provenienza assai eterogenea: nei primi anni rischiano i propri capitali, in una misura peraltro assai modesta, liberi professionisti e piccoli imprenditori e, in un tempo relativamente breve, vengono attratti anche gruppi finanziari, banche e capitali privati sempre più consistenti. Il cinema a conduzione familiare non ha certo alcuna vocazione alla sperimentazione, ma alcuni indubbi effetti riesce a ottenerli comunque. La produzione copre una serie di terreni assai vasti: dalla documentazione dei grandi avvenimenti, ereditata dai Lumière, alla ricostruzione del passato, dalla rappresentazione del quotidiano alla messa in scena della comica o del dramma, dallo spettacolo scientifico a quello con intenti didattici più scoperti, il sistema di rappresentazione non nasconde le sue ambizioni e non intende porre limiti alle sue possibilità. Se limiti vi sono, riguardano il campo della finzione e del dramma, dove, ben presto, interverranno le istituzioni pubbliche a frenare la libertà di rappresentazione e a denunciare i pericoli morali e sociali del cinema, ma non di certo il campo delle applicazioni scientifiche e didattiche. Oggi, grazie soprattutto alle esplorazioni analitiche di Bernardini e a una serie di altre ricerche di microstoria su tutto il territorio nazionale, ma anche a contributi originali che vengono dai giovani studiosi non solo italiani , possediamo un quadro molto dettagliato sulle fisionomie di tutte le case di produzione e dei singoli produttori e ne conosciamo anche le mosse e le dinamiche culturali ed economiche sia nei confronti del mercato interno che di quello europeo e americano: la nascita policentrica di varie case di produzione, in almeno quattro città italiane, fa sì che fino alla guerra mondiale vi siano più «capitali dello spettacolo» distribuite lungo la penisola, tutte, a vario titolo, capaci di realizzare prodotti in grado di competere con la concorrenza straniera. Tuttavia la nascente industria cinematografica non vive, anche nel suo periodo più splendente, un’avventura economica di tipo capitalistico, quanto piuttosto un’avventura piccolo-borghese, in cui il rischio e il miraggio di guadagni facili e rapidi s’intreccia costantemente con l’assenza di una previsione economica, con la fragilità, se non inesistenza, nella maggior parte dei casi, delle basi economiche su cui si fonda l’impresa. La prospettiva di profitti rapidi e assai elevati spinge personaggi, spesso privi di coperture economiche minime, ad abbandonare la propria professione per inventarsi una nuova carriera, di produttore, distributore, esercente, regista. In ogni caso, proprio grazie al coraggio e alla capacità di rischio di alcuni piccoli imprenditori, affluiranno, nel giro di qualche anno, capitali finanziari più consistenti. A Torino, Arturo Ambrosio capisce presto la possibilità del noleggio, e nel Veneto i fratelli Roatto – la cui importanza è stata messa in luce grazie alle ricerche di Montanaro e Zilio – fin dai primi del Novecento, controllano le fasi del 1
noleggio e dell’esercizio e passano da un’attività di organizzazione di spettacoli viaggianti, all’apertura di più sale in un’area che da Trieste va fino a Verona . I fratelli Troncone a Napoli seguono un analogo processo passando dall’esercizio alla produzione. Non è possibile, e diventa irrilevante, in questo quadro, stabilire con assoluta certezza un primum in un sistema che, già nel 1904, entra tutto in tensione: a Torino, il fotografo Arturo Ambrosio, dopo il successo di due documentari, La prima corsa automobilistica Susa-Moncenisio (operatore Roberto Omegna) e Le manovre degli alpini al colle della Ranzola, andrà, l’anno successivo, in Calabria a riprendere il terremoto. Da via Napione, dove ha il suo primo laboratorio, Ambrosio si sposta nel 1907 in via Nizza, dove, grazie ad attrezzature più moderne, può iniziare una produzione regolare . Napoli, prima ancora di Roma, Milano e Torino, si presenta come uno dei luoghi dove il cinema trova le migliori condizioni per la sua nascita e diffusione come industria redditizia a tutti i livelli. La produzione che inizia nel 1905, con i fratelli Troncone, identifica subito il suo pubblico, creando, sul piano locale, prodotti di immediata riconoscibilità, ma anche riuscendo a raggiungere all’estero pubblici di emigrati, come farà con grande successo, qualche anno dopo, la Dora film . Come si vede bene dalla distribuzione fin dall’inizio è importante tener conto che storia e geografia s’incrociano nella storia del cinema italiano e che pur godendo ora di molti contributi di storia locale nessuno ha ragionato bene sulle caratteristiche economico-culturali di questa divisione dal nord al sud dell’industria cinematografica. Benché ancora non ci si sia interrogati a fondo sui rapporti tra economia cinematografica e territorio basterà offrire pochi dati per capire il diverso grado di sviluppo e concentrazione nell’arco dell’intero periodo del cinema muto: a Roma l’anagrafe produttiva registra – tra il 1905 e il 1930 – ben 245 sigle, mentre a Torino sono 103, a Milano e Napoli poco più della metà. Poi 24 a Genova, 9 a Firenze e, in ordine sparso, si possono trovare sigle vissute lo spazio di un film a Treviso, Foligno, Viareggio, Montecatini, Cefalù… Molte case nascono – come nel caso delle torinesi Alpina, Ars, Biblia, Fenix, Elium… – e non riescono neppure a portare a termine o a commercializzare il primo film. È evidente che nel primo decennio lo sviluppo produttivo è più equilibrato, mentre la guerra mondiale opera una sorta di spartiacque, favorendo la concentrazione delle attività a Roma. Le diverse capitali del cinema danno vita a produzioni che ora tendono a differenziarsi, e ora si imitano: la produzione torinese intende confrontarsi con quella d’oltralpe, mette in scena testi letterari e teatrali del repertorio internazionale, quella romana punta in primis alla celebrazione dei propri fasti imperiali, mentre quella napoletana ambisce al controllo quasi egemonico del territorio e, in pari tempo, recupera temi della letteratura e del teatro naturalista . Non è peccare d’eccessivo orgoglio nazionalistico se si sostiene oggi che, per qualche anno, Torino «città della fantasticheria», come l’aveva definita Pavese nel Mestiere di vivere, assume il ruolo di capitale mondiale del cinema, con le sue centinaia di titoli, migliaia di persone impiegate e con il consistente afflusso di capitali provenienti dall’aristocrazia industriale cittadina . C’è un momento in cui anche Giovanni Agnelli entra, all’inizio del 1914, come socio della Cenisio Film, ma il progetto non va avanti per lo scoppio della guerra mondiale. Nel 1905 nasce a Roma, presso porta San Giovanni, la «Manifattura di pellicole per cinematografi della ditta Alberini Santoni» che realizza, tra le sue primissime cose più significative, La presa di Roma, primo vero film a soggetto della produzione cinematografica italiana. È importante sottolineare il legame tra il soggetto di questo film e la provenienza culturale del produttore dal mondo militare. La cultura dei militari gioca un ruolo tutt’altro che trascurabile nella rappresentazione e nell’ideologia comune ai vari generi e consente di abbandonare di colpo la dimensione dello spettacolo da fiera. Alberini, che ha già accumulato una buona esperienza come esercente e quindi conosce i pubblici, soprattutto urbani, sembra sapersi organizzare più e meglio degli altri produttori e si può dire che, subito, con un occhio guardi al mercato nazionale, con l’altro punti decisamente al mercato americano . Nell’aprile del 1906 la ditta Alberini Santoni si trasforma in società anonima per azioni Cines, con capitale iniziale di 250.000 lire. Il beneficio netto, dopo il primo anno di attività, sarà di mezzo milione . Lo sviluppo assai rapido della Cines, la sua capacità di penetrazione nei mercati esteri, le sue possibilità di offrire prodotti di buona qualità, dipendono dagli interventi finanziari combinati del Banco di Roma e di un giovane industriale, Adolfo Pouchain. Questi interventi consentono una netta trasformazione del livello produttivo. È la prima volta che il capitale finanziario partecipa a un’impresa di cui si ignorano del tutto, per mancanza di 2
3
4
5
6
7
8
termini di confronto, le reali capacità di profitto. Per accelerare la formazione dei propri quadri Alberini recluta dalla Francia un regista della Pathé, Gaston Velle, ex prestigiatore. Il contributo tecnico di questo regista e di altri «oriundi» è decisivo per ridurre, in questa fase, il divario tecnologico ed espressivo esistente nei confronti della produzione francese, con cui i produttori italiani intendono entrare in diretta concorrenza. Nel 1907 la produzione è ormai assestata e la Cines può diramare un importante comunicato che segna il primo netto salto di qualità nel suo piano di espansione: «In considerazione del nuovo sistema di vendita che talune case estere cercano di imporre ai cinematografisti d’Italia, teniamo a informare la S.V. che con la prossima stagione autunnale inizieremo regolare pubblicazione settimanale di più soggetti cinematografici di grande interesse. Questa maggiore produzione è resa possibile dai nuovi e vasti laboratori che abbiamo attualmente costruiti, corredandoli del macchinario il più completo e perfezionato e dai nostri nuovi teatri di posa, affidati a valenti direttori artistici. Nutriamo fiducia che la S.V. non vorrà stringere contratti che limitano ogni libertà, offendono ogni interesse e minacciano lo sviluppo dell’industria cinematografica in Italia» . Il richiamo alla difesa del prodotto nazionale è, tutto sommato, velleitario, ma assai coerente con il forte spirito nazionalistico che guida l’attività della casa romana. In mancanza di case di produzione di pellicola vergine e con un mercato delle sale in continua espansione, il cinema italiano ha sempre dovuto subire, per l’approvvigionamento di pellicola vergine, il ricatto dei prezzi stabiliti dalle maggiori produttrici straniere (la Kodak, la Eastman) e, per quanto riguarda i bisogni dell’esercizio, la produzione nazionale copre evidentemente una parte minima della domanda. La Cines, in ogni caso, col suo comunicato, non nasconde le proprie ambizioni di soddisfare i bisogni di pubblici diversi e garantire un buon livello per tutti i suoi prodotti. Ma l’elemento distintivo e discriminante, nell’impostazione del programma con criteri industriali, è dato dall’impegno alla «pubblicazione» regolare e settimanale di novità. Solo l’Ambrosio, qualche tempo dopo, riuscirà a garantire egualmente, e in misura maggiore, una regolare immissione settimanale di novità sul mercato. Il primo obiettivo da raggiungere è quello del conseguimento di ritmi regolari di produzione. Il problema della qualità sarà affrontato solo dopo alcuni anni . Se per i soggetti drammatici e storici si fanno sondaggi in varie direzioni, prima di trovare il prodotto più adatto al tipo di pubblico che si intende raggiungere, con le comiche si cerca già di realizzare un tipo di «manufatto» che, una volta ottenuto il successo, lo possa ripetere all’infinito, attraverso un’opportuna distribuzione di minime variazioni. Mentre per la produzione contemporanea americana il racconto, nel giro di poco tempo, tenderà alla serialità e omogeneizzazione, riuscendo a raggiungere ottimi standard per ogni tipo di prodotto, in Italia più facilmente si assisterà a una continua scomposizione dei modelli, a una costante interferenza tra esigenze diverse, dipendente dall’estrema variabilità delle condizioni produttive e dalla presenza di diverse competenze culturali e ideologiche sul piano della produzione stessa. Una conseguenza pressoché immediata, sul piano internazionale, del comunicato Cines è che la casa romana apre, nello stesso anno, a New York, una propria succursale al numero 145 della 23 Street East, mentre solo dall’anno successivo la Biograph distribuirà nel territorio americano i film Ambrosio, Rossi e Aquila. La prima pubblicità dei film Cines che appare nel 1907 su «Moving Picture World», la più autorevole rivista americana di cinema, dice testualmente: «Same artistic quality as the French with wearing quality hitherto unknown» . Dopo il successo dei primi film (La figlia del barbiere e un film di Fregoli) entro la fine dell’anno la Cines distribuisce già una ventina di opere, documentari, drammi, comiche e tra questi spicca la prima versione del Fornaretto di Venezia. Nel 1908, sulla copertina della medesima rivista, appare un lungo testo pubblicitario della Cines di cui vale la pena riportare alcuni passi: «Noi ci siamo specializzati nei classici e abbiamo costruito le nostre storie nell’impareggiabile splendore dell’arte italiana, per offrirvi un prodotto che sarà lodato da oceano a oceano. Uno studio accuratissimo del mercato americano nei dodici mesi precedenti è stato fatto da noi con attenzione alla produzione per la stagione che inizia e di conseguenza noi saremo in grado di produrre un film ogni e tutte le settimane. Il passato è pieno, con tutta evidenza, della storia e grandezza dei maestri italiani: Michelangelo, Leonardo, Andrea del Sarto, Correggio. Le conquiste di quel periodo si riflettono sul presente» . Con il suo dichiarato impegno produttivo e la sua produzione storica la Cines punterà a diffondere sempre più ambiziosamente nel mondo, dal 1909, il verbo della cultura, della storia e dell’arte italiana e in un certo 9
10
11
12
senso i suoi registi – e in seguito anche quelli dell’Ambrosio, Pasquali, Itala – si sentiranno sempre più investiti dalla missione di poter far rivivere i sogni di dominio del mondo della Roma imperiale. I segni della penetrazione della Cines sul mercato americano non tardano ad attirare l’attenzione della stampa americana. Nello stesso 1908 già si sottolineano alcune caratteristiche specifiche della cinematografia italiana emergente e per qualità si assimilano ormai i prodotti italiani a quelli francesi: «Notiamo che gli attori francesi e italiani sono più portati di quelli di qualsiasi altra nazionalità a parlare con le mani, le spalle, con tutto il corpo e le espressioni della fisionomia […] e le produzioni Cines sono tra le migliori della produzione italiana. La fotografia è sempre eccellente e i soggetti sono generalmente ben raccontati» . L’immagine di efficienza, di programmazione, di studio rigoroso del mercato rischia però, se assunta come metro reale delle condizioni produttive, di fornire uno specchio deformante o una serie d’indicazioni fuorvianti. Per compensare questa impressione e vedere l’altra faccia del sistema, non meno importante per capire il senso dell’improvvisazione assoluta di cui si è parlato, è bene riflettere su un annuncio pubblicitario a pagamento apparso nel 1907 sulla rivista napoletana «Cinematografo», il cui testo è il seguente: «Cercasi socio capitalista, disposto impiegare denaro per speculazioni cinematografiche. Massima serietà. Avvenire assicurato» . 13
14
tra mecenatismo e gioco d’azzardo Alla fine del 1907 operano in Italia ben 9 «manifatture cinematografiche», di cui tre sono a Torino, l’Ambrosio, la Carlo Rossi & C., l’Aquila; due a Milano, Luca Comerio e la S.A. Baratti; due a Roma, Cines e S.A. fratelli Pineschi; due a Napoli, fratelli Troncone & C. e Manifatture cinematografiche riunite . La storia di queste case di produzione si è cominciata a definire, grazie all’enorme lavoro di perlustrazione degli archivi fatto da Bernardini, nelle sue coordinate e in molti aspetti particolari, relativi ai nomi dei soci fondatori, ai capitali iniziali, agli atti di costituzione delle società. Ma ce n’est que le début: la mancanza di bilanci ufficiali, la difficoltà delle ricerche, la mancanza di una storia economica rigorosa e scritta da specialisti, costruita sulla base di ricerche d’archivio sistematiche presso gli uffici del lavoro, le camere di commercio, gli archivi di Stato, consentono solo di avere un primo quadro con un censimento affidabile e rigoroso delle case di produzione e della loro durata più o meno effimera, di progredire di qualche passo e di documentare in modo meno improvvisato alcune ipotesi, ma non di mettere a fuoco con sicurezza un campo di problemi che sfuggono, per la perdita di gran parte dei materiali, a documentazioni sicure . Questo è un handicap storiografico molto forte rispetto alle possibilità offerte agli storici del cinema americano che in genere hanno a disposizione in archivi efficienti e funzionali, tutti i materiali per ricostruire la storia, giorno per giorno delle majors o delle piccole sigle indipendenti. I risultati ottenuti dagli storici italiani, per quanto insufficienti hanno comunque del miracoloso e sono il frutto di una combinazione felice di tenacia, capacità di bricolage, curiosità e doti di segugi e detective. In ogni caso non è certo possibile accontentarsi di un censimento che si limiti a registrare il numero delle case e tutte le informazioni di base per l’identificazione delle caratteristiche finanziarie e la collocazione topologica delle società in quanto proprio l’esempio Cines del 1907 ci dice che alcune di queste case possiedono già una fisionomia industriale, dei caratteri distintivi e una politica produttiva e distributiva abbastanza differenziata e articolata. A Milano il primo a far nascere degli stabilimenti di produzione, alla Bovisa, è Luca Comerio. Nei primi tempi i suoi film non sono realizzati in base a un preciso programma, hanno titoli eterogenei e ambiziosi, alternano l’interesse per l’attualità al tentativo di recuperare la cultura più alta. Nel giro di poco tempo la Comerio si fonde con un’altra casa sorta nel frattempo, la Saffi (Società anonima fabbricazione films italiana), legata ad alcuni noleggiatori di pellicole ed esercenti. Il capitale sociale della Saffi-Luca Comerio è portato a 600.000 lire e i programmi produttivi cercano subito di allinearsi con la produzione nazionale e di offrire dei film con una certa regolarità. Da segnalare tra i titoli iniziali un Amleto, la Sepolta viva e Francesca da Rimini, nonché la prima di molte versioni dei Promessi sposi. La storia di questa casa ha breve vita nonostante Comerio offra prodotti ottimi e di grande interesse soprattutto sul piano documentario. Con la crisi del 1909 mentre «Comerio compiva lunghi viaggi in paesi 15
16
lontani per girare i suoi documentari, la gestione effettiva della casa passava così, a poco a poco, in altre mani. E quando, nel settembre 1909, si arriverà alla trasformazione della Saffi in Milano Films, Comerio rimarrà tagliato fuori dall’operazione e tornerà a produrre in proprio con criteri artigianali» . Milano non presenta una storia produttiva di particolare rilevanza, i pochi altri tentativi di dar vita ad attività di produzione durano molto poco ed hanno una portata minore rispetto alle iniziative contemporanee in altri centri. Di maggior interesse, con ogni probabilità, la storia del consumo del cinema, dei pubblici e delle sale che hanno uno sviluppo e un successo molto alti. La Milano Films e la Comerio puntano comunque a produzioni di grande impegno accanto alle comiche e ai documentari. I due momenti culminanti della produzione milanese prima della guerra sono l’Inferno e il Ballo Excelsior. Dopo il 1910 hanno un certo sviluppo iniziative produttive o distributive di case come la Musical film con la serie di Tecoppa (l’attore è Edoardo Ferravilla), la Labor e la Giovanni Pettine, ma non si potranno mai paragonare queste iniziative, di modesto respiro economico e culturale e di limitata portata sul piano della diffusione, con la capacità di far circolare i prodotti in Italia e all’estero delle case degli altri centri, Napoli compresa. Bisogna però ricordare che la storia del cinema italiano è anche storia di manifatture municipali, di avventure produttive bruciate in un solo film, d’iniziative sparse che solo un paziente e combinato lavoro di più ricercatori può ricostruire. Se, per esempio, dei film realizzati nel 1905 a Napoli dai fratelli Troncone si conoscono solo i titoli (Camorra, di 300 metri, e la comica Marito distratto e moglie manesca) , non vanno dimenticate iniziative locali, tentate nello stesso periodo in altre città, che nascono con obiettivi assai simili: penso ad alcune pellicole realizzate a Venezia dal perito d’annona Camillo Sebellin, che, dopo aver aperto nel 1907 una sala cinematografica in campo S. Margherita, gira un documentario intitolato Traslazione delle reliquie del doge Sebastiano Venier da Murano a Venezia, o i tentativi dell’avvocato Luigi Vasilicò proprietario della sala Massimo e direttore dell’Unica (Unione nazionale industrie cinematografiche), e soprattutto va ricordato il progetto dei fratelli Almerigo e Luigi Roatto di controllare l’intero ciclo dalla produzione all’esercizio, che li porta a produrre, fin dal 1906, una comica, Le disgraziate avventure della signora Marietta da Belluno, a cui seguiranno altri film proiettati anzitutto nelle quattro sale di loro proprietà sparse nella città . Se per ricostruire le linee generali della produzione si sono mossi soltanto i primi passi, il problema dell’esercizio resta ancora del tutto sconosciuto, nonostante le ricerche di Bernardini anche in questa direzione ci aiutano a distinguere tra le diverse forze in campo. Lo sviluppo di imprese commerciali che puntano al controllo dell’e-sercizio stabile nelle città e nei grandi centri riceve una spinta decisiva dal sorgere delle prime manifatture stabili e, al tempo stesso, garantisce un mercato sicuro per i prodotti nazionali. Le nuove sale urbane si integrano naturalmente con l’habitat, diventano punti di riferimento luminoso del paesaggio quotidiano. Le prime sale cittadine di cui si ha notizia si chiamano Iride, Lux, Radium, Cristallo, Smeraldo, Astra, Cinematografo Solare… Il primo Cinematografo Splendor è torinese e viene aperto in via Roma da Michele Sala nel 1898. I nomi sono esche e le radiazioni che emettono agiscono come fluidi galvanici e magnetici per pubblici proletari e borghesi. Oltre che per la loro radianza e il disporsi nel tessuto urbano come piccole costellazioni, le sale sembrano simili alla deamicisiana «carrozza di tutti» in quanto nelle loro platee o gallerie trovano posto, fianco a fianco, rappresentanti di tutte le classi sociali e di tutte le età. Nel buio della notte le luci con i nomi delle sale cinematografiche costituiscono non solo un forte richiamo, ma vanno a formare insiemi connessi alla storia di superficie e quella profonda di una comunità o di una nazione come quella italiana, per cui questi nomi s’intrecceranno profondamente e in modo rappresentativo con gli eventi della storia e i modelli culturali e ideali. La sala cinematografica diventa sì igloo o cattedrale del desiderio collettivo, spazio topologico capace di svilupparsi indefinitivamente, primo autentico paradiso dei poveri, ma anche ambiente in cui, a partire dall’atto del battesimo, si manifestano e costituiscono segni, indici e caratterizzanti di una storia inclusa già nel nome e di realtà circostanti. La teatronomastica cinematografica – come la chiama Raffaelli – traduce e conserva la memoria letteraria e culturale e segna tappe molto emblematiche della storia ideale e materiale dell’Italia giolittiana prima, 17
18
19
20
mussoliniana poi, e democratica nell’ultimo cinquantennio. Questa onomastica appare sensibilissima alle variazioni delle correnti e temperature storiche, e si può considerare come uno dei numerosi indicatori visibili e tangibili delle mutazioni dei sistemi ideologici e ideali di riferimento. All’inizio del secolo i nomi avevano avuto valenze diverse e sovranazionali: in primo luogo insegne in cui si mescolano forme italiane e latine come Eden, Astra, Smeraldo, Lux, Stella, Radium – o anche Edison e Volta, assieme a Progresso – risplendono già nel primo decennio come piccoli lumi accesi sull’altare della modernizzazione. I primi nomi delle sale sono simili in tutto il mondo: le luci dell’Eden brillano e producono lo stesso «effetto Nirvana», o come si è detto «Paradiso dei poveri», per i cittadini di Marengo, Illinois, come per quelli di Este e Massalombarda, Valeggio sul Mincio, Trebaseleghe, Borgo San Dalmazzo e Cagnes sur Mer. Prima che il cinema e gli spettatori regolino definitivamente i propri orologi sulla meridiana di Hollywood le sale sembrano aver voluto sincronizzare i loro piccoli annunci luminosi prima sulle frequenze provenienti dalla Francia. Più che di indicatori geografici i nomi delle sale acquistano la funzione di spazi utopici nel cuore della città. Dall’indomani della loro nascita gli spettatori sanno di rischiare la dannazione eterna varcando la soglia del Palladium Lucifer o del Mephisto di Roma. A Torino si apre un Eden nuovo in concorrenza con un Eden vecchio. In tutte le grandi città italiane e del mondo si troveranno ben presto dei Cinema Paradiso, Excelsior, Eden. In Italia, quando le sale stabili cominceranno a moltiplicarsi negli anni Venti anche in provincia, in maniera indipendente dalla drammatica crisi della produzione, l’onomastica sembra suggerire campi e orientamenti più legati alla geografia e alla storia patria. Molti esercenti sembrano aver pescato il nome della sala nell’orario ferroviario, o nel calendario dei santi e delle glorie nazionali care al regime. Così troviamo il Trento, il Milano, il Trieste e il Magenta di Brescia, il Roma di Bologna e il Brescia di Torino… E poi, in ordine sparso, molti Dante, Silvio Pellico, Manzoni, Mazzini, Garibaldi, Don Bosco, Cristoforo Colombo, Marconi, Paganini, Verdi, Rossini, Goldoni… Beati gli abitanti di Alba, Apricena, Cannobio… e di cento altri piccoli paesi di provincia perché almeno una volta la settimana per una quarantina d’anni hanno potuto accedere al regno dell’Eden!… In prevalenza e con l’eccezione dei programmi pruriginosi delle «serate nere», il pubblico è composto da donne, ragazzi e bambini. La proliferazione delle sale nelle città (a Livorno si contano ben 15 sale stabili nel 1907, a Milano sono 70 nel 1908) e nei piccoli centri è tanto rapida e prepotente che solo qualche anno dopo, nel 1913, l’onorevole Luzzati, in un intervento sul «Corriere della Sera», ipotizza un grandioso scenario possibile sulla base dei dati a disposizione e di ragionevoli previsioni di sviluppo: «Nelle piccole e grandi città il cinematografo è divenuto l’onesto passatempo di tutte le classi sociali. E si avanza persino nei piccoli centri, nei villaggi… In più che ottomila comuni non è presuntuosa l’ipotesi secondo la quale non meno della metà abbia il cinematografo. Né sarebbe eccessiva la presunzione di una media di tre cinematografi per duemila comuni riducendo per somma prudenza i comuni utilizzabili; il che darebbe seimila cinematografi, né parrebbe indiscreta la congettura che li frequentino in media duecento persone al giorno: il che darebbe il prodotto di un milione e duecentomila spettatori al giorno e nei trecento giorni dell’anno si avrebbe un totale di trecentosessanta milioni circa». In effetti il cinema, in pochi anni, è divenuto lo spettacolo popolare per eccellenza, un bene di prima necessità, uno spazio di culto laico, dove su robuste panche di pioppo, si ritrova un pubblico sempre più composito: «In mezzo al pubblico del cinematografo vi sono dei tipi così diversi dall’ordinario, così nuovi e ameni da divertire più dello spettacolo in se stesso. A parte gli innamorati, che della film spesso non vedono e non capiscono nulla, c’è il militare anziano […] c’è l’habitué che conosce gli artisti di tutte le case, c’è il meccanico che dà ad alta voce consigli all’operatore […] la signorina aristocratica che fa appunti sulle mode e sulla etichetta da salotto… e infine il fotografo, il pittore, l’architetto, la sarta, la modista, tutte le posizioni sociali» . 21
Già dal 1907 si è già sviluppata una consistente attività commerciale e si possono identificare, con una certa esattezza, gli operatori culturali e non che partecipano e ruotano, a vario titolo, attorno alle imprese cinematografiche contribuendo, in maniera decisiva, a conferire al cinema le caratteristiche sia di attività artistica che di impresa commerciale. Operatori cinematografici, direttori d’orchestra, pianisti e musicisti,
canzonettiste, direttori di sale, compositori di musica per film, impresari, rappresentanti di case produttrici italiane ed estere sono soltanto alcuni dei soggetti più significativi indispensabili a un perfetto funzionamento dello spettacolo cinematografico . In tutte le maggiori città d’Italia, tra il 1907 e il 1908, si inaugurano sale cinematografiche e solo verso il 1911 si assiste all’apertura di sedi stabili anche in provincia . Secondo la Prolo, alla fine del primo decennio, esistono circa cinquecento sale distribuite strategicamente nei quartieri delle maggiori città. Nella sola Milano se ne contano una quarantina, secondo quanto riferisce il primo rapporto consolare degli Stati Uniti: «Milano, capitale d’Italia per le macchine cinematografiche ha ormai quaranta sale. Ogni café chantant finisce il suo programma con alcuni film e, durante l’estate, anche i grandi teatri diventano sale cinematografiche» . Anche a Roma e a Torino il numero di sale è assai elevato, a Napoli le sale sono una ventina, le ricerche più recenti ne hanno identificate ventinove nella sola Venezia agli inizi del 1909, due a Livorno, tre a Catania e così via. In queste sale, come si è appena visto, molto spesso il programma cinematografico da solo non è ancora sufficiente ad attirare il pubblico. La formula del cinema chantant sembra essere la più opportuna per fondere l’interesse di due tipi di pubblico, convogliandolo verso un’unica manifestazione. La maggior parte delle sale all’inizio presenta programmi di canzonette o di compagnie teatrali e, in chiusura, secondo l’esempio inaugurato da Fregoli, li completa con proiezioni cinematografiche. Nello spettacolo cittadino viene ereditato, in questi anni, prima che precisi decreti prefettizi ne vietino la presenza, l’imbonitore, l’uomo che, con tutti i mezzi verbali, richiama il pubblico, promettendogli un viaggio unico nel dramma, nella realtà o nel meraviglioso. «Oh solamente che otocento vinticinque metri, gnente altro che squasi mile metri de drama» gridava il veneziano Fureghin, imbonitore al Ponte della Piavola, e aggiungeva «Oh che belo, che bel drama, oh che magnifico! Oh che spettacolo! Oh che drama dramatico!» . Osservando la pubblicità di alcune sale napoletane vediamo anzitutto che le sale sono dislocate strategicamente in punti nevralgici della città (piazza Municipio, galleria Umberto I, dove come abbiamo visto c’è la massima concentrazione di sale, riviera di Chiaia) e che il tipo di pubblicità di ogni sala può servirci, attraverso la semplice distribuzione e variazione degli aggettivi, o la descrizione degli elementi del décor, a capire il tipo di spettacoli offerti e il tipo di pubblico. I Cinematografi riuniti appaiono come le sale più prestigiose, «possiedono bellissime sale d’aspetto e proiezione munite di ventilatori e ozonatori. L’impresa acquista le migliori films […] sceltissime orchestre […] rallegrano l’immenso pubblico, al quale spesso l’impresa regala oggetti di grande valore e utilità» . Del salone Olimpia, dove accorre un pubblico «enorme e aristocratico», possiamo vedere che tipo di programmi vengono proiettati in una sera: Arrivo a Milano dei vincitori della corsa Pechino-Parigi, Due volatili (film drammatico), Rougé il bracconiere (drammatico), Uova di Pasqua, Il sogno di Totò (novità fantastica), Idillio nelle Indie, Caccia all’automobilista (comica). All’Eldorado il pubblico è «aristocratico ed eletto», la sala Elgé, ogni sera, cambia il programma e il pubblico che ogni sera accorre soltanto «numeroso» al cinema Marcadante e al Recanati ci dice che ci troviamo già di fronte a sale per pubblici popolari e piccolo-borghesi. Decisamente popolare è il cinema Marconi che risulta «gremito» di pubblico, senza ulteriori elementi di qualificazione . A Venezia viene tentato, dai fratelli Roatto, il primo esperimento di concentrazione dell’esercizio: nel 1908 i Roatto possiedono il Marconi, il Gigante, il Re; a Napoli, i fratelli Troncone, proprietari della sala Elgé, dopo il successo dei primi film tentano la strada della produzione che li vede attivi fino almeno al 1921 . La situazione del mercato è dunque, alla fine del 1907, così florida e in espansione, che viene avanzata la proposta, per disciplinarne lo sviluppo caotico, di «gettare le basi di una società anonima internazionale, l’Unione cinematografica, con sede a Napoli e con filiali in ogni città d’Italia e all’estero» . Al di là della megalomania del progetto e della modestia della figura del proponente, esiste la percezione della vastità del mercato e della necessità di razionalizzare, al più presto, le tecniche di controllo e diffusione dei prodotti. Un’iniziativa simile, anch’essa naufragata sul nascere, tenta di vararla, quasi nello stesso periodo, il noleggiatore milanese Pietro Tonini che riesce a dar vita, per qualche mese, a una Unione di noleggiatori . Mentre in Italia questi progetti restano soltanto sulla carta, in America i produttori non tardano a realizzarli, consapevoli della vastità degli interessi che l’industria cinematografica, nel suo futuro sviluppo, sarebbe stata capace di mobilitare. «Nei paesi più industrializzati, come gli Stati Uniti, la Germania, l’Inghilterra, le case di produzione 22
23
24
25
26
27
28
29
30
cinematografica hanno avuto una storia ben diversa: le loro capacità e possibilità di sopravvivere a momentanee avversità, la loro pronta rispondenza allo sviluppo tecnico di questa industria, l’adeguata struttura che si sono date per competere, sul piano della concorrenza, nel mercato internazionale, che, come vedremo, è il mercato naturale della cinematografia, hanno conquistato una fama e una tradizione di attività che ancora oggi giocano a loro favore» . I motivi della fragilità costituzionale delle strutture industriali del cinema italiano in tutta la sua storia dipendono dall’improvvisazione, dalla mancanza di un progetto organico, capace di tener presenti le possibilità reali del mercato, di prevedere in anticipo costi e profitti, senza dover di continuo far fronte a situazioni impreviste. Ma anche dalla dipendenza dall’estero per quanto riguarda l’approvvigionamento di pellicola vergine, dipendenza che rende assai precaria l’attività produttiva e continuamente soggetta a variazioni non controllabili dei prezzi, dall’estrema parcellizzazione dell’esercizio, nonché da tutta una serie di rivalità e concorrenze sul medesimo terreno che danneggiano non poco il regolare sviluppo dell’industria. L’ostacolo primo è dato comunque dalla presenza massiccia delle case straniere e dalla necessità di contendere loro il terreno sul piano della qualità dei prodotti, dei soggetti e dei prezzi. Per un curioso fenomeno di provincialismo, come si è visto, alcuni film della produzione più significativa si affermano all’estero prima che in Italia. Il Nerone di Luigi Maggi, del 1909, vende quasi trecento copie all’estero. Il mercato interno, nonostante le case abbiano raggiunto una discreta capacità concorrenziale e il numero di film prodotti sia più che sufficiente a far fronte alla domanda, è ancora dominato, in gran parte, dalla produzione straniera. L’industria cinematografica non sembrava in grado di produrre pellicola vergine: i tentativi fatti finora di calcolare i costi e i profitti medi di un film non sembrano molto verosimili se si tiene conto dei dati forniti da Bizzarri e Solaroli che indicano costi medi oscillanti tra le 5 e le 10 mila lire (calcolando una base di costo della pellicola di 30 centesimi al metro) e un profitto impossibile da raggiungere calcolando una vendita media di trenta copie a una lira al metro . In realtà bisogna pensare che il mercato riuscisse ad assorbire almeno un centinaio di copie delle case con prodotti di maggiore qualità e che, all’inizio, i costi fossero più limitati e andassero distribuiti su tutta la produzione, ivi compresa quella documentaria, che per molti anni, almeno fino alla nascita del lungometraggio, contende da pari a pari con la finzione i favori del pubblico . L’aumento e l’allargamento del mercato favoriscono un maggiore rischio nell’investimento di capitali: così al prodotto realizzato con criteri paraindustriali e in base almeno a una precisa previsione di costi si viene sostituendo un prodotto nei confronti del quale si rischiano capitali variabili, tentando di caratterizzarlo in maniera più individualizzata. Aumentando la concorrenza e con la nascita di grossi distributori in grado di offrire cataloghi ricchissimi di titoli, il margine di profitto si viene ancor più assottigliando sulla singola copia, ma aumenta nel complesso per il netto incremento delle vendite. Così, se nel 1907 si può vedere che a Napoli un film in media viene venduto a 70-80 centesimi a metro per copie in bianco e nero e a 1 lira, 1 lira e 20 per le copie a colori, a tre anni di distanza la ditta Giovanni Pettine può permettersi di mettere in vendita delle copie di film italiane e straniere a prezzi che al massimo raggiungono i 70 centesimi per le copie a colori e al minimo toccano i 10 centesimi (!) per quelle in bianco e nero . Di fronte a queste cifre è evidente che il mercato è stato completamente ristrutturato e il numero delle copie in circolazione è diventato altissimo e ormai la figura del distributore è venuta assumendo un ruolo centrale nel controllo del mercato e nella determinazione della politica dei prezzi. 31
32
33
34
la crisi del 1909 Nel 1909 si comincia a parlare di crisi: «Il pubblico – scrive la Prolo – non s’accontenta più di tutto quanto si realizzava nei teatri di posa europei e americani, fino allora sicuri di vendere pellicole» . Raggiunti determinati livelli di produzione e identificati i pubblici e le caratteristiche più generali della domanda, l’ideale sembrava, in Italia, come in America, quello della riproduzione dei medesimi modelli mediante processi automatici. Si scatena la corsa all’imitazione, la concorrenza avviene sui medesimi terreni, sugli stessi soggetti. Il fenomeno è particolarmente evidente nella produzione delle case milanesi e torinesi, dove, in molti casi, si realizzano, nello stesso periodo, gli stessi soggetti e si cerca, con tutti i mezzi, di battere la concorrenza, sottraendo le idee, il personale e creando prodotti del tutto simili tra loro. Incurante del mutamento tecnologico il cinema italiano fa proprie le tecniche produttive e distributive che nei secoli 35
passati avevano favorito la crescita e la diffusione dell’industria delle immagini popolari, dagli ex voto alle vedute d’ottica. Tuttavia questo aspetto non va visto soltanto per le sue conseguenze negative, in quanto sarà in molti casi proprio lo spirito di emulazione e la stretta concorrenza tra alcune case a favorire l’evoluzione del sistema espressivo: la competitività furibonda che si sviluppa, a partire dal 1909, tra le maggiori case torinesi, Ambrosio, Pasquali e Itala, lo sforzo costante di dar vita a forme e a scenografie ricche, il frenetico attivismo che domina queste case, soprattutto sul piano delle soluzioni spaziali, sembrano quasi far dipendere l’invenzione visiva di alcuni autori dall’eredità del parossismo razionale delle grandi costruzioni ottocentesche di Alessandro Antonelli . La crisi è aggravata dalla ristrutturazione economica della cinematografia americana e dai primi interventi delle istituzioni religiose e statali che vedono nel cinema una minaccia assai temibile per la moralità delle masse popolari. Non ultima tra le cause è la mancanza di crediti bancari o di prestiti per l’acquisto all’estero di pellicola vergine. Altre cause sono, come ricorda Bernardini, «il numero eccessivo dei film in circolazione e le insufficienze tecniche che si facevano sentire negli stabilimenti di produzione come nelle sale di proiezione» . Il tipo di perforazione delle pellicole era ancora diverso da casa a casa e ciò produceva continui sfarfallii che creavano disturbi sulla vista degli spettatori, dopo un periodo di visione abbastanza breve. In questa situazione, con un mercato caotico e disordinato, una produzione scatenata in una gara di autodistruzione e incapace di riconoscere gli interessi comuni di fronte alla penetrazione dei prodotti stranieri, le case continuano a lasciare scoperta una grossa parte del mercato interno e non sono capaci di costruire alcun programma a media e lunga scadenza. Il cinema torinese e milanese, costruito in base a criteri industriali meno improvvisati, verrà però travolto dalla guerra prima ancora di riuscire a coordinare gli sforzi e trovare i criteri più idonei di razionalizzazione del lavoro produttivo. La forte competitività; che negli anni precedenti la guerra mondiale i prodotti italiani hanno sul mercato internazionale, dipende soprattutto dai costi di produzione assai bassi per l’estrema modestia delle spese di manodopera. A Torino, città influenzata, se non dominata, dallo stile di vita e dai ritmi produttivi imposti dall’industria automobilistica, i cui nomi più significativi sono Fiat, Lancia, Antoniotti, Lux, Taurinia, proprio negli stessi anni lo sforzo di trasformazione dei modelli industriali coinvolge e influenza indirettamente anche fenomeni collaterali e in apparenza lontani come quelli legati all’industria cinematografica. Il cinema torinese, che pure per primo affronta i maggiori rischi della produzione kolossal, intende mantenere il gusto e la cura per la realizzazione di ogni singolo prodotto, pur nella logica del lavoro in serie e della programmazione, ed è dominato dal gusto per la continua sperimentazione tecnologica e per la maggiore disponibilità verso ogni tipo di rappresentazione del passato e del presente. Grazie all’intreccio tra diverse storie e al ruolo sempre più importante dell’industria cinematografica la fisionomia sociale e la struttura urbana del capoluogo piemontese mutano in modo molto netto nel giro di un decennio. Nel 1986 è uscito, a cura di Bernardini e Martinelli per i tipi delle edizioni Coliseum di Roma, un elegante volume dedicato alla Titanus, che costituisce anche il primo tentativo di storia complessiva di una casa di produzione cinematografica italiana sul modello dei lavori americani dedicati alla Mgm, Universal, Rko. La crisi non mette dunque in ginocchio tutta la produzione, ma favorisce di certo la scomparsa dei tentativi più improvvisati e l’inizio di un lavoro sottoposto a una certa razionalizzazione e previsione, sia sul piano produttivo che su quello del controllo di mercato. Sempre nel 1909, per iniziativa della rivista napoletana «Lux», viene avanzata la prima proposta di un convegno dei «cinematografisti aperto a tutti gli operatori del settore», dai produttori agli esercenti, e nel quale tutti possano trovare un momento di reale collaborazione e riuscire a far valere, in modo coordinato e organizzato, gli interessi delle diverse categorie. Al primo punto dell’ordine del giorno è «l’organizzazione nazionale della classe» e, nei punti successivi, «le tasse, la proprietà artistica, il problema dei trasporti» . L’iniziativa parte da Gustavo Lombardo, una delle più interessanti figure emergenti dell’industria cinematografica italiana di questo periodo: nel 1909 Lombardo è rappresentante, per Napoli e per le province meridionali, della Gaumont, Eclair, Comerio, Vitagraph, Itala, Croce, Aquila e Latium, nel 1910 costituisce una società anonima, la Sigla (Società italiana Gustavo Lombardo anonima). In questa delicata fase di sviluppo industriale, Lombardo, per primo, tenta la strada della concentrazione monopolistica sul piano del noleggio, cercando di riuscire a fare in modo di raggiungere un potere tale nel noleggio da orientare e 36
37
38
influenzare sia la produzione che l’esercizio. Oltre al suo esempio per l’Italia meridionale, tentativi analoghi vengono fatti a Milano e in Lombardia, da Giovanni Pettine, nel Veneto dai fratelli Roatto, e accanto a questi nomi alcuni altri noleggiatori e distributori riescono a ristrutturare la logica del mercato, gestendo in proprio il noleggio delle pellicole, che, fino a quel periodo, venivano direttamente vendute dal produttore all’esercente. I noleggiatori che riescono a disporre di cataloghi articolati in cui appaiono, fianco a fianco, produzioni italiane e straniere, raggiungono in breve tempo un potere effettivo di controllo del mercato e possono, in molti casi, decretare il successo o l’insuccesso di una pellicola . La proposta di un convegno nazionale avanzata da Lombardo è, in un certo senso, una risposta al congresso internazionale di Parigi nel febbraio dello stesso anno, a cui avevano partecipato tutti i rappresentanti delle maggiori case produttrici italiane, da Filoteo Alberini ad Ambrosio, da Comerio a Pineschi. Questo convegno aveva registrato il successo della volontà dei maggiori produttori, ma gli accordi presi in quella sede erano destinati, almeno sul piano italiano, a restare lettera morta. Nonostante la crisi della produzione il mercato è abbastanza vasto e in piena espansione dal punto di vista della distribuzione e dell’esercizio: le sale sono diffuse su tutto il territorio, le case di produzione sono ormai una ventina e quasi tutte hanno propri canali di vendita, propri rappresentanti e, grazie a distributori efficienti, sono presenti in modo stabile tutte le maggiori case straniere, la Vitagraph, la Pathé, la Gaumont, l’Eclair, la Urban, la Raleigh e Robert, ecc. 39
giulio cesare, spartaco e maciste alla conquista del mondo Il 1909 è anche l’anno in cui i film cominciano ad allungare la loro durata. Se la media è ormai assestata sui 250-300 metri, appaiono, in ordine sparso, opere che superano i 400-500 metri (La dama di Monserau, prodotto già tre anni prima, e I tre moschettieri della Cines, l’Ettore Fieramosca della Pasquali) e la Saffi di Milano inizia la lavorazione dell’Inferno, opera che, fin dall’inizio, si prevede di una lunghezza superiore ai mille metri. In questa fase di ristrutturazione produttiva e di nascita di nuove «manifatture», entrano in modo massiccio, al sud come al nord, figure di nobili che investono i propri capitali nel cinema, terreno in cui la speculazione appare assai più redditizia e, al tempo stesso, più gratificante degli investimenti immobiliari e fondiari su cui, in genere, le grandi famiglie continuavano a basare le proprie fortune. È fin troppo ovvio osservare che l’ingresso di queste figure di aristocratici condizionerà in modo decisivo le caratteristiche e la politica culturale successiva di molte tra le maggiori case. Così non è da stupirsi se la Società italiana per la film d’arte, costituita nel 1909, con sede sociale a Roma, dichiari come scopo «quello indicato dal titolo» e non fini commerciali o di lucro. Sarà questo – nel breve e nel lungo periodo – elemento di forza e di ipotonia costituzionale di tutto il sistema. La Cineteca di Bologna, in collaborazione con la locale università, ha da qualche anno avviato un lavoro di salvataggio, restauro e studio della Film d’Arte italiana, nata nel 1909 dalla costola della Film d’Art francese: questo progetto ha portato al recupero di alcune decine di titoli nell’arco di quasi un decennio e alla messa a fuoco delle dinamiche tematiche, stilistiche, narrative di una casa di produzione nata con lo scopo di trasferire sullo schermo alcuni capolavori del teatro e della letteratura, utilizzando il più possibile il plein air e i veri luoghi in cui le storie erano ambientate. Da un certo momento in poi – grazie alla Film d’Arte Italiana – gli autentici palazzi e le piazze delle grandi città rinascimentali (già nel 1909 il primo Otello della Film d’Arte è girato a Venezia) usati come sfondi e ambientazioni per rendere più verisimile la rappresentazione e la ricostruzione di figure ed episodi legati «alle grandi casate nobiliari che avevano dominato l’Italia dei secoli passati – si pensi ai Borgia (Cesare Borgia, Lucrezia Borgia, 1912) agli Este (Beatrice d’Este, 1912), ai Medici (Un dramma a Firenze, Il Falco rosso, 1912)» , cessano di essere un semplice sfondo e assumono valori simbolici o si animano per divenire coprotagonisti della vicenda. La Film d’Arte Italiana dal 1912 deciderà di affrontare storie moderne, drammi di catastrofi economiche e sentimentali, di rovine familiari, di adulteri o passioni distruttive, come Dall’amore al disonore di Ugo Falena del 1912 o Usuraio e padre (1914), o Effetti di luce di Ercole Luigi Morselli e Ugo Falena (1916) . La sua è una morale e una visione del mondo ancora ottocentesca, ma l’insieme dei film mostra in maniera significativa l’azione di più forze disgregatrici nei confronti dell’istituto familiare. 40
41
Certo il consolidamento produttivo e la costituzione di nuove e solide basi finanziarie consentono di varare subito iniziative molto ambiziose che contribuiranno in maniera decisiva a dare al cinema italiano fama e successo internazionale. La Milano Films, casa che nasce dalla Saffi-Luca Comerio, nel 1910 dispone di un terreno alla Bovisa di 10.000 ettari, di un capitale di 500.000 lire e vede nel suo consiglio d’amministrazione tutta una serie di personaggi blasonati come il conte Pier Gaetano Venino (presidente), il barone Paolo Airoldi di Robbiate (vice presidente) e tra i consiglieri il principe Urbano del Drago, i conti Mario Miniscalchi, un Visconti di Modrone e il marchese Raniero Rosales D’Ordogno. Nel 1911 alla Cines è nominato amministratore e direttore il barone Alberto Fassini. La Cines conta nel suo consiglio d’amministrazione una notevole quantità di aristocratici, tra cui vale la pena di ricordare almeno don Prospero Colonna e il conte Giulio Antamoro. Nel 1912 il conte Negroni costituisce a Roma la Celio film, che ha un capitale di 100.000 lire con azioni del valore nominale di 25 lire l’una, e nello stesso anno, sempre a Roma, nasce la Sac, con presidente il marchese Alfredo Capece Minutolo e consiglieri Carlo Dentice del Frasso e il marchese Carlo Antici. Nel 1914 il conte Francesco Antamoro costituirà la Napoli film di cui sarà presidente e Giulio Antamoro amministratore delegato . In alcune di queste case, come la Celio e la Napoli film, la figura del produttore presidente o amministratore delegato della società è anche quella dell’autore regista. Sono questi i casi in cui è più facile identificare il senso della politica culturale di una casa di produzione, in quanto non esistono conflitti di competenza. Oltre al consistente aumento di capitali la presenza di questi aristocratici ha un peso determinante nello sforzo della qualificazione culturale del film. Grazie al cinema gli esponenti di una società ormai del tutto ai margini dello sviluppo economico e culturale del paese trovano ancora motivi di gratificazione e hanno modo di apparire come avanguardie illuminate e diretti responsabili del processo di crescita culturale del cinema. L’atteggiamento pressoché unanime dei maggiori produttori italiani è quello di far fronte alla crisi aumentando gli investimenti e la qualità del prodotto e facendo compiere all’industria un grosso salto qualitativo, senza comprimere la spesa e cercando di sfruttare al massimo i materiali già esistenti. Il salto è possibile anche perché esistono pubblici interamente da conquistare e perché, nel giro di pochi anni, la politica delle case, tesa a una maggior qualificazione culturale del prodotto, si dimostra assai redditizia sul piano nazionale e internazionale. Le maggiori case non solo iniziano a mettere in scena opere assai impegnative, come i classici delle letterature e del teatro di tutti i tempi, ma cominciano a reclutare, tra i letterati, i giornalisti, i poeti e gli uomini di cultura, figure in grado di elevare la qualità del prodotto e di conferirgli il marchio dell’artisticità. Si tratta di un progetto industriale ben caratterizzato rispetto alle iniziative di altri paesi e, tutto sommato, è forse proprio questo progetto, unito alla grande invenzione scenografica, a imporre sui mercati stranieri i film italiani negli anni successivi. L’Ambrosio, la Milano Films, la Lombardo si assicurano, dal 1909, la collaborazione di letterati come D’Annunzio, Gozzano, Di Giacomo, Bracco, Verga, ecc. . Non bisogna però attribuire a questo progetto la capacità globale di rispondere in modo moderno alle attese del pubblico, né, tanto meno, quella di trasformare e gestire l’industria secondo metodi imprenditoriali avanzati. Oscillanti tra il mecenatismo di tipo rinascimentale e la logica del rischio dei giocatori d’azzardo, questi produttori aristocratici non cercano certo di allineare e gestire le strutture produttive con le tecniche dei moderni capitani d’industria: «L’aristocrazia romana o milanese che vuole elevare l’Italia al rango delle grandi potenze industriali si appassiona per le cose in cui è ancora tutto da fare, dove pensa di poter arrivare prima, brillare, farsi valere […] gli aristocratici e gli alto borghesi che sono a capo delle principali case di produzione si rivolgono a un pubblico scelto. In rapporto al suo spirito e ai fini che persegue la produzione italiana punta ai mercati stranieri. Per conquistarli è necessario fare dei film più ambiziosi, più clamorosi di tutti gli altri» . L’apparente disinteresse economico di queste figure di produttori non nasconde la volontà programmatica comune di realizzare opere di cultura, l’intenzione di far circolare nel mondo prodotti dell’ingegno italiano che avrebbero gratificato lo spirito nazionalistico e rimosso, almeno momentaneamente, l’attenzione da una serie non piccola di problemi che imponeva il paese reale. Osservando tutta la breve, ma esaltante parabola dell’avventura produttiva tra il 1909 e la guerra non si può – oggi – non sottolineare il fatto che il cinema diventa il luogo privilegiato e capace della più ampia ricaduta e diffusione comunicativa entro cui confluiscono e vengono esibiti orgogliosamente alcuni simboli «forti» dell’identità nazionale. Un «luogo della memoria», un iperluogo, un collettore di più sistemi culturali, iconoligici e ideologici anteriori e un punto di raccordo e 42
43
44
congruenza tra luoghi reali e immaginari, tra ricerca delle radici e proiezione verso il futuro di un paese che si sta affacciando alle soglie della modernità . I produttori delle maggiori case romane e torinesi sentono che la carta della ricostruzione storica è vincente e consente un immediato capovolgimento dei rapporti di forza nei confronti della concorrenza straniera. Nella grandeur della Roma imperiale, che lo schermo farà rivivere per alcuni anni, si trasferiscono rapidamente i sogni di conquista della piccola Italia giolittiana che si affaccia a soli quattro decenni dalla sua unità sulla scena internazionale. Decisive per far superare quella fase di stallo e di crisi del 1909, altrettanto importanti nel tentare di convertire tutta la letteratura alta nel cinema e nella capacità di imporre al mondo questa idea dello spettacolo cinematografico, queste figure sono anche uno dei punti di massima debolezza, a medio e lungo termine, del sistema industriale del cinema muto italiano. Del tutto indifferenti alle leggi di mercato vivono la loro avventura industriale continuando, senza rendersene conto, a imprimere una svolta decisiva all’industria in un periodo in cui i capitali privati si ritirano. Il capitale finanziario che comincia ad affluire, e consentirà l’aumento assai rapido degli investimenti produttivi, sarà assai meno coraggioso e sempre pronto a ritirare il proprio appoggio a ogni accenno di crisi e, com’è comprensibile, verrà meno dall’inizio della guerra. All’aumento della durata dei film, alla maggiore cura nella realizzazione di ogni scena, alla variazione delle tecniche di ripresa, va anche aggiunto lo sforzo di creazione di figure professionali, capaci di qualificare, in maniera unica e assai caratterizzata, i diversi prodotti. Così, se da un lato emergono, per l’alto livello professionale, operatori come Giovanni Vitrotti o Roberto Omegna, che viaggeranno in tutto il mondo alla scoperta di realtà sensazionali, dall’altro si formano attori che riescono a trovare nel cinema eguali gratificazioni rispetto al teatro e, poco per volta, un successo che, negli anni successivi, si rivela superiore, sia in termini di diffusione della propria immagine, sia, soprattutto, in termini economici. Anche i primi interventi censori, messi in moto da una circolare ai prefetti per il controllo del buon costume e della sicurezza, costituiscono un duro colpo all’esercizio cinematografico, ma favoriscono l’aumento della professionalità nella conduzione delle sale, una maggiore sicurezza e agibilità e la scomparsa progressiva di quel-l’alone di spettacolo da fiera che continuava a circolare. Assieme alle forze politiche si muovono anche quelle religiose, che dimostrano un doppio atteggiamento di consenso-dissenso. Per quanto riguarda la produzione, dopo il primo tentativo pionieristico isolato di Rodolfo Kanzler del 1903, lo stesso Kanzler realizza nel 1909, per la Milano Films, un San Paolo con la regia di Adolfo Padovan (il regista dell’Inferno) e con Luca Comerio come operatore. La pellicola è voluta dal cardinale milanese Andrea Ferrari . Nello stesso anno, a Torino, prende avvio un’iniziativa produttiva cattolica, la Unitas, che avvia subito una produzione di documentari e film a soggetto. Nel biennio successivo l’Unitas produce 15 film a soggetto e quattro comiche (tra i titoli Angelo, Il buon angelo della casa, Carità ricompensata, Il libro delle preghiere, Anime perdute), mentre a Milano comincia a funzionare un primo circuito di sale cattoliche che si unisce in Federazione. Per realizzare tutto un ciclo integrato manca solo un distributore capace di garantire la moralità di tutti i prodotti. Il distributore è trovato nella ditta Protti e Tonini di Milano: «La Federazione cattolica dei teatri e cinematografi comunica che la ditta Protti si impegna ad acquistare film morali e di fornire oltre che il macchinario e i film morali, anche tutto ciò che può occorrere per divertimento e istruzione, specie religiose» . La struttura di queste prime associazioni cattoliche è già delineata fin dal suo nascere e potrà trasmettere molto a lungo il suo modello. Accanto a un atteggiamento di sospetto e di condanna, che si manifesta mediante precise prese di posizione ufficiali, si fa anche strada un atteggiamento di base, molto interessante, che mira a una immediata utilizzazione del cinema, sia a scopi edificanti, che di puro divertimento. Questo secondo atteggiamento rivela, soprattutto, accanto alla lungimiranza, le capacità immediate di gestire in proprio il controllo del nuovo mezzo, sfruttandone le possibilità educative, ricreative, catechistiche e pastorali nel senso più esteso possibile. «I film catechistici – osserva G. Cereda – venivano proiettati all’interno delle chiese, ponendo così il nuovo mezzo, quasi si trattasse di una moderna e più aggiornata Biblia pauperum, nel solco della più schietta e ricca tradizione iconografica cristiana» . Sarà proprio contro le iniziative di proiezioni fisse e animate nelle chiese a intervenire l’alta gerarchia ecclesiastica. Con il decreto «Una delle principali» del 15 luglio 1909, s’impedisce a qualsiasi appartenente al clero, sia regolare che secolare, di assistere a spettacoli, anche di carattere religioso, a Roma. Nel 1912 un decreto della sacra congregazione concistoriale vieta nelle chiese «ogni sorta di proiezioni e spettacoli cinematografici» . La polemica sulle 45
46
47
48
49
proiezioni cinematografiche nelle chiese era esplosa già nel 1909 anche in America, dove tuttavia sembrava prevalere una posizione più aperta e tollerante, se prendiamo come rappresentativa la dichiarazione di un prelato, il reverendo Brusher, in cui si dice che «tutto ciò che può essere utile a Dio è da raccomandarsi se le intenzioni sono buone» . L’effetto immediato, comunque, è quello di veder nascere tutta una serie di salette cinematografiche attigue alle chiese, che costituiranno, fin da questi anni, un nucleo consistente di esercizi nettamente caratterizzati e orientati al controllo del divertimento giovanile. Se i cattolici possono aggregarsi attorno alle organizzazioni religiose nel tentativo di gestire in proprio una delle forme più importanti di divertimento collettivo, emerge, nello stesso tempo, l’esigenza di superare gli interessi e unire le diverse forze per difenderle sia dagli attacchi governativi che dall’avanzamento dell’industria straniera che trovava un accesso facilitato nel mercato per l’assoluta mancanza di coordinamento tra la produzione e l’esercizio. Tutti i tentativi di richiamare le diverse categorie al riconoscimento degli interessi comuni sono destinati a fallire: «Uniamoci! – scrive Alfredo Centofanti nel 1911 sulla «Vita cinematografica» – ridiamo alla nostra industria il possesso di se stessa […] rompiamo ogni ritegno […] diamo un calcio all’industria estera» e, un anno dopo, sullo stesso giornale, interviene a rilanciare la proposta, il direttore, Alberto Cavallaro: «Organizziamoci e il sindacato cinematografico sia presto un fatto compiuto». Il 7 novembre 1912 c’è la prima riunione dei «cinematografisti» e sono rappresentate tutte le categorie, dai produttori, ai noleggiatori, ai concessionari, agli esercenti. I partecipanti intendono affermare il proprio diritto a esistere come categorie professionali, vogliono organizzarsi contro le forze che ne limitano l’espansione e intendono soprattutto coordinare, per la prima volta, l’azione tra le diverse branche dell’industria dello spettacolo. Gli esiti di questa iniziativa sono più formali che sostanziali e forse la cosa più degna di essere ricordata è il fatto che nasce da questo incontro un progetto di autocensura e controllo della moralità della produzione poi ripreso nel 1913 in sede governativa. Il successo internazionale di film, come Nerone dell’Ambrosio, o La caduta di Troia dell’Itala (con la regia di Pastrone), o la Gerusalemme liberata, della Cines, e l’allungamento assai netto della durata delle pellicole costituiscono un’ulteriore e decisiva trasformazione del sistema produttivo e apriranno la strada alla breve, ma intensa stagione dei film «storici», alla cui realizzazione tenderanno tutte le maggiori case cinematografiche, sicure di poter vendere, con enormi profitti, centinaia di copie all’estero . A partire da un certo momento intervengono consistenti anticipi da parte dei distributori americani, soprattutto di George Kleine, che distribuisce con grande successo i maggiori film storici, dagli Ultimi giorni di Pompei a Quovadis?, a Spartaco, a Marcantonio e Cleopatra, a Giulio Cesare e che stipula i contratti per ottenere in anticipo prodotti con precise caratteristiche . Questo in pratica è ciò che si intende per l’«acquisto a scatola chiusa» dei film italiani da parte dei distributori e produttori stranieri: i prodotti non sono acquistati alla cieca, ma in base ai presupposti di alcuni requisiti (gran numero di comparse, grandiose scene di massa, azione drammatica, ecc.). Tutta l’avventura di conquista da parte del cinema italiano dei mercati internazionali comincia con una lettera scritta il 5 luglio 1912 dal barone Alberto Fassini – direttore della Società Italiana Cines – a George Kleine il cui testo contiene le seguenti informazioni e proposte: «Desidero informarla che è mia intenzione realizzare, due volte l’anno, un lungometraggio che richiederà grandi spese e servirà da traino pubblicitario per tutta la nostra produzione. In considerazione di questi costi eccezionali vi chiedo se siete in grado di farci condizioni migliori nell’acquisto dei negativi rispetto a quelli attuali […]. Comincio già la prossima settimana la produzione di uno di questi film, il cui titolo è Quovadis? A questo scopo ho affittato venti leoni che rimarranno nei nostri teatri di posa per circa quattro settimane. Per farvi capire la meraviglia di questo film mi limito a dirle che il costo del negativo sarà di circa 80 mila lire e che la sua lunghezza oscillerà tra 1.500 e 2.000 metri». Comincia in questo modo il periodo aureo della produzione italiana sul mercato mondiale. Il successo di Quo vadis? è così imponente che, fin dalle successive realizzazioni Kleine entrerà direttamente nella produzione anticipando somme gigantesche per l’epoca. Nella fase espansiva e di conquista del mercato internazionale è vero che i contratti stipulati con i distributori stranieri, americani in primis, prevedono acquisti massicci di prodotti, non solo di tipo storicomitologico. Dopo il successo del Quo vadis? tra la Cines di Roma e la società diretta da George Kleine di 50
51
52
53
Chicago viene siglato un secondo accordo mediante il quale il distributore americano acquista i diritti esclusivi per il territorio americano (incluse le Filippine, il Canada e l’Alaska) di vendere, esibire, affittare, stampare, ristampare, pubblicare e utilizzare tutti i prodotti della Cines. La Compagnia italiana si impegna a sottoporre a Kleine una copia di ogni titolo prodotto e Kleine a sua volta si impegna a versare per ogni film una somma di 75 centesimi di dollaro per metro. Questo contratto chiarisce le strategie della produzione italiana e le ragioni del suo successo negli Stati Uniti e si aggiunge ad altri in cui Kleine versa sostanziosi anticipi per produzioni più impegnative sul modello del Quo vadis? . Per alcuni anni i prodotti italiani travolgono la concorrenza. Il raggiungimento della durata standard superiore ai 1.000 metri non è però un merito prioritario del cinema italiano: quando arrivano in Italia, nel 1911, distribuite dalla Florentia film, alcune importanti opere della casa svedese Nordisk con Asta Nielsen, come Il sogno nero, la durata di 1.000 metri diventa l’obiettivo della produzione media di carattere drammatico. La pubblicità di un altro film della Nordisk dello stesso anno, La tratta delle bianche, ci dice che si tratta di un’opera di 1.000 metri, 40 parti e 180 quadri. Nel biennio che va dal 1912 al 1914 la produzione media italiana sembra comunque aver raggiunto una durata standard superiore a quella delle altre cinematografie. È naturale che questo nuovo mutamento ha come effetto immediato un’ulteriore modifica dei modi di visione, della composizione sociale del pubblico, del tipo di interpretazione e di risposta, dei costi di produzione e di gestione, dei costi di allestimento delle sale (negli Stati Uniti, in seguito ai grandi successi dei film italiani sono costruite nelle maggiori città sale della capienza di 5.000 spettatori), dei prezzi dei biglietti d’ingresso, dei rapporti con la stampa. Gli effetti più immediati di questa diversa politica industriale non tardano a farsi sentire: la ricerca della «qualità» sociale degli spettatori produce immediate perdite in termini di quantità, intere fasce di pubblico popolare si sentono escluse dalla fruizione di certi film in spazi e a costi che non hanno nulla a che invidiare al teatro: «La fortuna e lo sviluppo enorme della cinematografia, in breve spazio di tempo acquistati – si legge in un editoriale del 1914 della ‘Vita cinematografica’ – dobbiamo attribuirli a questi due coefficienti: brevità dello spettacolo, prezzi alla portata di tutte le borse […]. Il lungometraggio sta decimando tutti i piccoli locali e la maggior parte dei noleggiatori, non solo in Italia, ma in tutti i paesi del mondo […]. La nostra industria, progredita per il favore popolare, ha bisogno di essere benvista da tutte le classi sociali e non diventare la favorita delle sole classi abbienti, le quali possono permettersi di pagare, per entrare al cinematografo, un prezzo pressappoco eguale a quello del teatro. Senza contare che il cinematografo deve essere un divertimento di breve durata e vario, mentre con gli spettacoli odierni chi intende entrare in una sala deve attendere un bel pezzo il suo turno, per poi digerirsi una proiezione che può durare due o tre ore!». Il punto d’arrivo di questa fase produttiva è costituito dalla realizzazione degli Ultimi giorni di Pompei e di Quovadis?, film che ottengono clamorosi successi di critica e di pubblico all’estero e fanno aumentare enormemente i profitti. L’importanza del Quovadis? è messa in rilievo in questi termini sul «New York Times» del 22 aprile 1913: «Il film rappresenta l’opera drammatica più ambiziosa che si sia mai vista nel cinema». Il Quo vadis? negli Stati Uniti verrà proiettato a Cleveland in una nuova sala come il Keith Ippodrome capace di contenere alcune migliaia di persone, mentre a New York le proiezioni avverranno ancora in sale normali. Consultando i documenti dell’archivio di Kleine oggi sappiamo che il Quo vadis? rimane ben 22 settimane in cartellone all’Astor di New York, 14 al Garrick di Philadelphia, 13 al Tremont di Boston, 8 a Chicago al Mc Vichers e 5 settimane in altre tre sale cittadine. Osservandone la distribuzione negli Stati Uniti nel corso del 1913 si può dire che non vi sia importante città americana o canadese che non lo accolga almeno per sei giorni (solo a Butte nel Montana il film terrà il cartellone per 5 giorni). Gli ultimi giorni di Pompei richiede già un apposito contesto capace di valorizzarne al massimo la spettacolarità. Non si capisce l’evoluzione dello spettacolo cinematografico se non si tiene anche presente il valore fondamentale dell’evoluzione dello spazio di rappresentazione, dai baracconi e dalle sale improvvisate alle sale gigantesche . A questa evoluzione film italiani come Quovadis? e Cabiria hanno certo dato un contributo decisivo in tutto il mondo, imprimendo già al sistema una tale spinta da far sì che a favorire la realizzazione dei grandi colossi di David Wark Griffith (La nascita di una nazione e Intolerance) erano già sia predisposti gli spazi che mutati profondamente i modi della visione da parte del pubblico. Dal 1914-1915 nessuno dei bilanci delle maggiori case di produzione sarà più in attivo, ma nel frattempo 54
55
grazie a Quo vadis?, Scuola d’eroi, Spartaco, Marcantonio e Cleopatra, Otello, Cabiria e alcuni altri titoli, si è attuata una tale rivoluzione tecnica, realizzativa, linguistica, e percettiva da far entrare la storia del cinema in una nuova era. L’aumento del metraggio e dei costi di produzione contribuisce a ristrutturare in modo decisivo, oltre che l’esercizio, anche il noleggio. I distributori in esclusiva di alcuni film possono fare la loro fortuna grazie allo sfruttamento intensivo di alcuni titoli di successo. Le conquiste tecnologiche migliorano lo standard espressivo, la pubblicità diventa ben più sofisticata e martellante, si studiano tecniche più moderne di battage pubblicitario, ci si accorge che l’aumento della durata dello spettacolo ha modificato il livello del pubblico: «Il pubblico – dichiara Baldassarre Negroni nel 1915 sulla ‘Tribuna’ – una volta si accontentava della scena panoramica, della comica fatta di corse […] ora tutto ciò può servire soltanto come complemento del programma il quale vuole esser formato di un grande lavoro di grande intreccio e grandi emozioni». Gli anni che vanno dal 1912 al 1914 segnano la grande espansione e il consolidamento delle strutture: l’industria italiana gode del suo momento di massimo successo negli Stati Uniti nel 1912 quando esporta 12.681 kg di pellicola per un introito di lire 1.384.910. Negli anni successivi si nota subito la risposta dei produttori americani e la curva dell’esportazione tende a diminuire in modo assai netto già prima della fine della guerra. Pur di fronte alle misure protezionistiche dei mercati del Nord America e al netto miglioramento della qualità dei prodotti statunitensi, i film italiani continuano a essere esportati con successo crescente, almeno dal 1912 al 1915, in Spagna, Francia, Argentina, Brasile, mentre in Gran Bretagna, Russia e Svizzera, l’esportazione decresce. Negli anni di guerra l’unico mercato che continua ad assorbire i film italiani senza registrare flessioni è quello spagnolo. Nel 1914, alla vigilia della guerra il numero delle case operanti sul territorio nazionale è ormai abbastanza alto, e si aggira sulla cinquantina: a Torino agiscono l’Ambrosio, l’Aquila, la Bonnard, la Cenisio, la Centauro (ex Unitas), la Fotocelere, la Gloria, l’Itala, la Leonardo, la Pasquali, la Savoia e la Vidali; a Roma la Cines, la Strassera, l’Eletta, la Helio, l’Italica Ars, la Latium, la Maskera, la Roma, l’Antoni, la Celio, la Vera, la Vittoria; a Milano la Milano Films, la Comerio, la Musical, la Mediolanum, la Talia; a Firenze la Firenze Film; a Napoli la Dora, la Napoli film, la Partenope; a Catania l’Etna film; a Palermo la Palermo manifattura cinematografica; ad Albano la Psiche film; a Velletri la Volsca… Verso la fine dell’anno un ampio saggio della «Vita cinematografica» tenta di fare il punto della situazione identificando la qualità e il tipo del prodotto offerto dalle maggiori case e denunciando come limite di diffusione e di successo della maggior parte dei prodotti il fatto che «i film che noi fabbrichiamo non vanno per questo o quel pubblico, per questa o quella nazione […] non vanno per il mercato mondiale… non siamo universali, non sappiamo trovare il tipo universale» . Un quadro completo e abbastanza attendibile dell’esportazione nei paesi più importanti tra il 1912 e la fine della guerra risulta dalla tabella riportata alle pagine seguenti . 56
57
Nel 1914 emerge, accanto a quelli già ricordati, una nuova figura di giovane distributore destinato ad avere in seguito un ruolo di protagonista nella storia del cinema italiano degli anni Venti, Stefano Pittaluga, che, almeno all’inizio, ha l’esclusività per il Piemonte dei film della Celio, Cines, Milano Films e Aquila. Mentre negli anni successivi tutta la struttura industriale comincia a registrare una crisi sempre più marcata, e la parabola economica, che inizia la sua curva discendente negli anni di guerra, tocca il fondo nel 1922, la fortuna e l’ascesa economica di Pittaluga non conoscono soste e gli consentono, nel giro di un decennio, di divenire la figura più importante di tutta l’industria italiana. Nel 1919 a Torino Stefano Pittaluga costituisce la Società Anonima Stefano Pittaluga . All’indomani dell’inizio della guerra, prima ancora della partecipazione italiana al conflitto, ossia dall’agosto del 1914, si cominciano a chiudere gli stabilimenti di molte case. Questo spiega la caduta a zero delle esportazioni e anche lo squilibrio improvviso che si crea nel mercato: «Il 4 agosto 1914 segna la data nera della cinematografia italiana, – con queste parole si apre un editoriale della «Vita cinematografica», che così prosegue: – allo scoppio della guerra le nostre case erano travagliate da dissesti gravissimi ed espiavano le conseguenze della loro pazza concorrenza, delle paghe enormi, dell’errata loro organizzazione finanziaria, dei difettosi sistemi di vendita… oggi ognuno sa come molte case avrebbero chiuso lo stesso i loro battenti senza la crisi della guerra» . I motivi della chiusura sono dettati anzitutto, com’è ovvio, dal panico, poi vanno ricercati in cause differenti da casa a casa: la Cines chiude gli stabilimenti in quanto le vengono a mancare i capitali della sua banca interessata nei Balcani e per un motivo assai più banale la Morgana film, nata a Palermo, fa appena a tempo a produrre tre film con Giovanni Grasso, Sperduti nel buio, Capitan Blanco e Teresa Raquin, che il suo produttore è richiamato alle armi . Il triennio che precede la guerra segna la fase di maggior espansione e consolidamento delle strutture: l’industria italiana raggiunge il massimo successo nel mercato americano (rinvio per questo aspetto al saggio di Giorgio Bertellini nel primo tomo del volume sul cinema degli Stati Uniti della Storia del cinema mondiale da me curata ), ma conquista, sia con le dive, che con gli eserciti di Marcantonio e Cesare che con quelli dei comici, i mercati della Russia, dell’Argentina, della Francia, Spagna e Gran Bretagna… . Si tratta di una serie di storie correlate di cui oggi sono state fissate le coordinate sempre per merito di Bernardini. Manca però ancora un riflessione d’insieme che sappia mettere a punto in maniera autorevole e convincente le relazioni tra l’economia cinematografica, le sue caratteristiche e i suoi rapporti con gli sviluppi contemporanei dell’economia del paese. Grazie a una ricerca capillare e sistematica sui luoghi di lavoro dell’industria del cinema a Torino nel periodo del muto e sulla storia architettonica delle diverse imprese – condotta da Alberto Friedemann – oggi conosciamo l’ubicazione di tutte le industrie torinesi, le caratteristiche degli impianti, i progetti esecutivi, le misure e le distribuzioni dei teatri di posa e degli stabilimenti di sviluppo 58
59
60
61
62
63
e stampa ecc… Possiamo capire bene, dalla semplice distribuzione di queste imprese nel territorio, come la loro ubicazione sia abbastanza casuale e non si raggiunga alcun tipo di concentrazione paragonabile a quella di altri settori industriali sorti ad esempio in prossimità della Dora Riparia e concentratisi tutti in una zona della città. È forse proprio la disseminazione e l’isolamento dei singoli stabilimenti a segnalare l’estrema fragilità delle imprese, l’incapacità a creare un sistema, a muoversi alla conquista dei mercati mettendo in opera tecniche proprie di un gioco di squadra. La debolezza dell’industria italiana è costituzionale ed è subito visibile, anche a un semplice contatto superficiale, nonostante gli archivi aziendali non esistano e sia difficile comporre un quadro d’insieme riunendo i frammenti sparsi di vicende cancellate o sepolte. Le prime avvisaglie di crisi si hanno alla vigilia della guerra e già da quel momento i mercati internazionali cominciano a chiudersi uno dopo l’altro. Con la guerra e l’avvento, dal 1913, del lungometraggio, i titoli realizzati a Torino sono 268, a Roma 184 e a Milano 64. Nel 1917 i poteri risultano rovesciati e Roma diventa capitale produttiva coi suoi 159 titoli contro i 59 di Torino e i 40 di Milano. Nel 1923, quando ormai la crisi è galoppante, a Torino si producono 26 film, contro i 74 di Roma e gli 8 di Milano. A Napoli, dove 4 case nel 1912 producono 30 titoli, ci si assesta su questi numeri, riuscendo a reggere anche alla crisi degli anni Venti e a realizzare, tra il 1923 e il 1925, 57 titoli contro i 47 prodotti a Torino (che però nel 1925 raggiunge appena le 4 unità). Accanto alle sigle più note – Cines, Milano Films, Aquila, Itala, Caesar, Ambrosio, Pasquali – troviamo nomi di società mai analizzate per la loro fragilità e il passaggio meteorico sulla scena produttiva e per la difficoltà a districarsi in una selva di nomi affini, se non identici. Tra il 1913 e il 1914, per esempio, esistono ben tre società che si chiamano Superfilm, una a Napoli, una a Genova e una a Torino. A Torino, nel periodo del muto, vengono create oltre centoventi case. Tra queste si possono ricordare, a titolo di pura curiosità, la Photo-Emporium, società con capitale di 60.000, che aveva come scopo sociale «l’industria e il commercio in ogni ramo della fotografia, ottica, cinematografia e produzioni e applicazioni inerenti», o la Società Italiana Films e affini, nata nel 1908 e poi convertita in Unitas, nata con lo scopo di produrre film cattolici, la De Giglio, in un primo tempo società di noleggio, o la Giano Film, che produce quattro pellicole nel 1914. Tra il 1907 e il 1910 appaiono sempre a Torino, sigle come la Films Italia, poi trasformata in Navone Films, la Roma Film e negli anni successivi i tentativi di dar vita a un’impresa cinematografica si moltiplicano in proporzione geometrica. Con l’entrata ufficiale dell’Italia in guerra la stella economica del cinema italiano inizia dunque la sua inarrestabile caduta di cui, peraltro, i maggiori produttori non sembrano affatto consapevoli per molto tempo. Anche se è chiaro a tutti che il mercato nazionale può assorbire poche copie per ogni film e che i mercati esteri si stanno chiudendo uno dopo l’altro, che si rischia di produrre in perdita qualsiasi film, e che, a queste condizioni, per i distributori e gli esercenti è assai più favorevole procurarsi i film all’estero, non viene fatta alcuna diagnosi, né avanzata alcuna ipotesi di terapia. Solo nel giugno 1917, in un’intervista al «Sole», il presidente della Milano Films sembra cogliere, accanto ad alcuni motivi ovvi della crisi, anche un dato nuovo, di cui finora si era sempre sottovalutata l’importanza, l’ingresso trionfale del cinema americano: «A questa situazione poco confortante si è aggiunta la concorrenza americana, che sta invadendo tutti i mercati, in modo tale che dovrebbe seriamente dar da pensare agli industriali italiani». Nonostante questo grido d’allarme e le difficoltà sempre maggiori per l’esportazione, la produzione non sembra affatto voler prendere coscienza della crisi. E continua, in progressione geometrica e catastrofica, ad aumentare i compensi degli attori e a produrre a pieno ritmo senza porsi il problema della destinazione di un cinema, che rimane, nel giro di pochi anni, quasi completamente senza pubblico. Si vedano gli articoli su Pastrone, sull’Ambrosio, la Cines, la Milano Films e altri contributi nell’importante numero monografico di «Film History» dedicato all’Early Italian Cinema (a cura di Giorgio Bertellini), vol. XII, n. 3, 2000. 1
C. Montanaro, Gli ambulanti e impresari veneti Luigi e Americo Roatto, in A. Bernardini (a cura di), Cinema e storiografia in Europa, Comune di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1984. C. Zilio, Dalla Fiera al cinematografo. Lo spettacolo viaggiante in Italia (1889-1911), Tesi di laurea, Università di Padova, a.a. 1988-1989. 2
Oltre alle notizie che si possono trovare in M.A. Prolo, Storia del cinema muto italiano, Il Poligono, Milano 1951, si vedano anche M. Gromo, Ascesa del cinema subalpino, in «Scenario», a. II, n. 6, giugno 1933 e M.A. Prolo, Torino cinematografica prima e durante la guerra, in «Bianco e Nero», a. II, n. 10, ottobre 1938. Per capire la politica industriale di Ambrosio sono utili alcuni suoi scritti raccolti in un significativo Omaggio nel «Notiziario del Museo nazionale del cinema», a. V, nn. 14-15, maggio-dicembre 1970. Un saggio sullo sviluppo 3
e sui fasti dell’industria torinese è di G. Rondolino, Torino come Hollywood (capitale del cinema italiano, 1896-1916), Cappelli, Bologna 1980. Si vedano V. Paliotti ed E. Grano, Napoli nel cinema, Azienda autonoma di soggiorno, Napoli 1969 e Cinema popolare napoletano, catalogo curato in occasione del Festival nazionale dell’«Unità», del settembre 1976, dalla Cineteca Altro. Un contributo ricco di documenti è di E. Troianelli, Elvira Notari, pioniera del cinema napoletano (1875-1946), Euroma, Roma 1989. Il lavoro più recente e articolato di ricostruzione del sistema culturale dei film di Elvira Notari è di G. Bruno, Streetwalking on a Ruined Map, Princeton University Press, Princeton 1992. Cfr. anche G.M. Gori, Il cinema arriva in Romagna, Maggioli, Rimini 1987. Della stessa Bruno si veda Storia di una manifattura culturale, in E. Magrelli (a cura di), Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia 1986. 4
A questo proposito si vedano i saggi di Bernardini e Martinelli in A. Aprà (a cura di), Napoletana, Images of a City, Fabbri, Milano 1993 e G. Bruno, Rovine con vista, La Tartaruga, Milano 1995. 5
Si veda il già citato lavoro pionieristico di Rondolino, Torino come Hollywood. E il più recente D. Bracco, S. Della Casa, P. Manera e F. Prono (a cura di), Torino città del cinema, Il Castoro, Milano 2001. 6
Ma forse – come suggerisce Aldo Bernardini nel suo Naissance et évolution des structures du premier cinéma italien(1896-1912), in «Cahiers de la cinémathèque», nn. 26-27, 1979, p. 30 – non sono estranei i capitali americani nel favorire la sua rapida ascesa produttiva. 7
A. Cades, Storia della Cines, in «Cinema», a. II, n. 20, 25 aprile 1937. Le vicende iniziali della Cines, come del resto di tutte le altre case di produzione, sono analizzate nel volume di Bernardini Cinema muto italiano. II. Industria e organizzazione dello spettacolo 1905-1909, Laterza, Roma-Bari 1981, pp. 83-95. Il lavoro più recente e documentato è di Riccardo Redi, che grazie alla possibilità di accedere agli archivi storici del Banco di Roma e della Banca Commerciale Italiana ricostruisce i momenti chiave della storia della Cines con dati assai più attendibili di quelli raccolti finora: R. Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italiana, CNC, Roma 1991. 8
Il testo del comunicato appare su «Cinematografo», a. I, nn. 4-5, 8 settembre 1907. Alle fortune del cinema italiano sui mercati stranieri ha dedicato un saggio A. Bernardini, L’avventura internazionale del primo cinema italiano, in R. Redi (a cura di), Cinema muto italiano (1905-1916), CNC edizioni, Roma 1991, pp. 33-46. 9
Si veda l’importante articolo di Oreste Fasolo, Il cinematografo… svelato che su «Natura e arte», a. XVI, n. 5, febbraio 1907, pp. 331-341, guida per la prima volta il lettore di una prestigiosa rivista illustrata italiana alla scoperta di uno Stabilimento cinematografico, quello appunto dell’Ambrosio, con l’intenzione di svelare il mistero di come si costruisce un prodotto cinematografico. 10
11
«Moving Picture World», vol. I, n. 25, agosto 1907.
12
«Moving Picture World», vol. II, n. 15, aprile 1908.
Earmarks of Makers. Films from Different Studios May Be Recognised by Certain Peculiarities, in «New York Dramatic Mirror», v. III, 14 novembre 1908, citato in D. Turconi, I film storici italiani e la critica americana dal 1910 alla fine del muto, in «Bianco e Nero», a. XXIV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1963, p. 41. 13
14
«Cinematografo», a. I, nn. 4-5, 8 settembre 1907.
Questi dati del libro della Prolo sono ancor oggi abbastanza attendibili, anche se ora conosciamo in modo meno critico anche la storia di tutti i piccoli produttori periferici. 15
Il lavoro di Aldo Bernardini oltre ai molti meriti già sottolineati, sollecita ricerche più approfondite su singole case di cui si continuano a riprendere soltanto dati generali. 16
17
Bernardini, Naissance et évolution des structures du premier cinéma italien, cit., pp. 36 e 43.
Si veda il lavoro citato di Vittorio Paliotti ed Enzo Grano, Napoli nel cinema. Bernardini contesta in parte questi dati in base alle fonti d’epoca. Si veda anche S. Masi e M. Franco, Il mare, la luna, i coltelli. Per una storia del cinema muto napoletano, Pironti, Napoli 1988. 18
F. Zangrando, Vecchio cinema a Venezia, in «Giornale economico della Camera di commercio», n. 6, novembre-dicembre 1971, pp. 753 sgg. Si veda anche G. Bertolini, Italia, Le categorie sociali, Venezia nella vita contemporanea, Ist. arti grafiche, Venezia 1912, vol. II, p. 423. Il contributo più completo e documentato è nella citata tesi di Carlo Zilio sugli ambulanti. Si veda però C. Montanaro, Gli ambulanti e impresari veneti Luigi e Almerico Roatto, in Bernardini (a cura di), Cinema e storiografia in Europa, cit., pp. 189-204. 19
Si veda in particolare S. Raffaelli, Introduzione all’onomastica del cinema, in «Rivista Italiana di Onomastica», a. II, n.1, 1996, in part. pp. 117-118. 20
21
***, Il giudizio del pubblico, in «La vita cinematografica», 28 febbraio1913.
22
Si vedano gli annunci economici sulla rivista napoletana «Cinematografo» fin dai primi numeri del 1907.
Tutte le maggiori riviste di cinema informano sull’apertura di nuove sale: sulla rivista di Napoli «Il programma» diretta da E. Correnti, negli anni precedenti col nome di «Cinematografo» e di «Cinéma-chantant», si trovano notizie sulla nascita di nuove sale in tutto il territorio nazionale. 23
La nota è riportata in «Moving Picture World», vol. II, n. 14, aprile 1908. Sui cinematografi milanesi esiste anche un libro: A. Lorenzi, I cinematografi di Milano, Mursia, Milano 1970. L’unico titolo di merito di questo libro consiste in un buon corredo fotografico, mentre 24
l’aneddotica un po’ frivola su cui è costruito non lo rende leggibile se non come un’operazione di pura nostalgia. G. Bertolini, L’Italia, l’ambiente fisico e psichico, Istituto veneto di arti grafiche, Venezia 1912, pp. 159 sgg. Sugli imbonitori richiamo gli esempi riportati nel mio Buio in sala, Marsilio, Venezia 1989, pp. 76-77 e l’importante saggio di S. Raffaelli, Quando il cinema era mobile, in «La ricerca folclorica», n. 19, 1989, pp. 103-112. 25
26
In giro per i cinema-chantants, in «Cinematografo», a. I, nn. 4-5, 8 novembre 1907.
27
Ibidem.
Zangrando, Vecchio cinema a Venezia, cit., e dello stesso, Gabriele D’Annunzio e il documentario, in «Bianco e Nero», a. XXV, n. 1, gennaio 1964. Inoltre si veda C. Montanaro, Appunti per una storia del cinema muto a Venezia, in AA.VV., L’immagine e il mito di Venezia nel cinema, Comune di Venezia, Venezia 1983, pp. 181-199. 28
29
E. Correnti, Uniamoci!, in «Cinematografo», n. 0, 4 agosto 1907, p. 1.
30
G. Fabbri, Palestra di chiacchiere deleterie, in «La cinematografia italiana ed estera», 15-20 agosto 1911.
31
L. Bizzarri e L. Solaroli, L’industria cinematografica italiana, Parenti, Firenze 1958, p. 17.
32
Ivi, p. 20.
33
A. Bernardini, Cinema muto italiano. I film dal vero 1895-1914, La Cineteca del Friuli, Gemona 2002.
I costi di vendita di copie di film senza particolari marchi si trovano nei primi numeri delle riviste napoletane «Cinematografo» e «Cinéma-chantant». Il catalogo del 1910 della ditta Giovanni Pettine di Milano è riprodotto in Lorenzi, I cinematografi di Milano, cit., pp. 168-172. 34
35
Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., p. 35.
Si veda E. Caballo, Cavalcata torinese, Tallone, Torino 1960, pp. 225 sgg. Al primo decennio di storia del cinema torinese Rondolino ha dedicato un ampio saggio, Torino come Hollywood, cit. 36
Bernardini, Naissance et évolution des structures du cinéma italien, cit., p. 45. Per quanto riguarda le caratteristiche internazionali della crisi e i primi tentativi di confrontare i propri interessi da parte degli industriali, culminati nel congresso parigino del 1909, si veda anche il lavoro di Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., p. 36. 37
Per un convegno dei cinematografasti, in «Lux», a. I, n. 7, 12 dicembre 1909. Grazie all’intreccio tra diverse storie e al ruolo sempre più importante dell’industria cinematografica, la fisionomia sociale e la struttura urbana del capoluogo piemontese mutano in modo molto netto nel giro di un decennio. Nel 1986 è uscito, a cura di A. Bernardini e V. Martinelli, per i tipi delle edizioni Coliseum di Roma, un elegante volume dedicato alla Titanus, che costituisce anche il primo tentativo di storia complessiva di una casa di produzione cinematografica italiana sul modello dei lavori americani dedicati alla MGM, Universal, RKO… 38
Nel catalogo della ditta milanese Giovanni Pettine troviamo film italiani della Comerio, dell’Itala, della Cines, dell’Ambrosio, dell’Aquila, ma anche di tutte le maggiori case di produzione francesi e americane, Vitagraph, Pathé, Urban, Gaumont, Eclair, e della casa danese Nordisk. 39
40
A. Navantieri, Film d’Arte, ma italiana, in «Cinegrafie», a. X, n. 15, 2002, p. 209, p. 205.
41
Ibidem.
I dati sulla consistenza patrimoniale delle case e sull’organizzazione dei primi consigli d’amministrazione si trovano in quasi tutte le riviste specializzate, da «Lux» a «La vita cinematografica»: uno strumento complessivo di consultazione è R. Mattozzi, Rassegna generale della cinematografia, Soc. Ed. Rassegne, Roma 1920. 42
Nel numero di aprile del 1909 la rivista napoletana «Lux» informa del contratto tra D’Annunzio e la Saffi per una serie di lavori cinematografici che il poeta di fatto non consegnerà mai e sulla stessa rivista veniamo a sapere dell’ingresso nel cinema come sceneggiatori di altri scrittori di fama (Di Giacomo, Bracco). 43
44
J. Mitry, Histoire du cinéma, vol. I, Éd. Universitaires, Paris 1967, p. 298.
45
Si veda il mio Il cinema, in M. Isnenghi, I luoghi della memoria, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 225-251.
46
F. Zangrando, Rodolfo Kanzler, uno sconosciuto pioniere del cinema, in «Lazio ieri e oggi», n. 12, 1973, pp. 280-281.
47
La notizia appare su «La vita cinematografica», a. II, n. 1, 5 gennaio 1911.
48
G. Cereda, Materiali per un discorso autocritico, in AA.VV., Cinema e cattolici in Italia, Massimo, Milano 1974, p. 134.
49
M. Arosio, Cinema, comunicazione sociale e magistero ecclesiastico, ivi, p. 11.
50
Moving Pictures to Invade the Church, in «Moving Picture World», vol. II, n. 26, giugno 1908.
51
A. Centofanti, Uniamoci!, in «La vita cinematografica», a. II, n. 16, 25 settembre 1911.
Si vedano i due volumi curati rispettivamente da V. Martinelli, Cinema italiano in Europa, 1907-1929, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1992 e F. Bono, Cinema italiano in Europa 2: 1907-1929, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1995. 52
Alla sezione Motion Pictures della Library of Congress di Washington esiste un fondo di 70 casse di documenti lasciati da George Kleine che testimonia della sua lungimiranza come distributore e del suo sforzo di imporre negli Stati Uniti la cinematografia italiana tra il 1911 e la guerra. Di Kleine è stato tracciato un significativo profilo in base ai documenti della Library da parte di R. Horwitz, G. Kleine and His Role in the Early Motion Pictures, in R. Horwitz e H. Harrison, The George Kleine Collection of Early Motion Pictures in the Library of Congress. A Catalog, Library of Congress, Washington 1980. Inoltre rinvio a due miei contributi: L’evocation du passé. Les années d’or du film historique, in A. Bernardini e J. Gili (a cura di), Le cinéma italien 1905-1945, Centre George Pompidou, Paris 1986, e No Place Like Rome, in «Artforum», a. XXVIII, Summer 1990, pp. 122-125. Si vedano anche il ricco dossier e i documenti raccolti da P. Cherchi Usai, Un americain à la conquéte de l’Italie, in «Archives», nn. 22-23, avril-mai 1989, e nn. 26-27, décembre 1989. 53
54
Il fondo che conserva tutti gli archivi cartacei e filmici di Kleine costituisce una vera miniera d’oro per gli studiosi del cinema muto italiano
ed è stato da me molto utilizzato per la redazione della prima edizione di questo volume consentendomi di effettuare la prima vera full immersion nel territorio allora scomparso del cinema italiano delle origini, grazie soprattutto all’esistenza di una cinquantina di titoli perfettamente conservati e a tutta la documentazione che accompagnava la nascita e la vita di ogni singolo film italiano distribuito da Kleine. Si veda il catalogo curato da Horwitz e Harrison, The George Kleine Collection, cit. E sono proprio i film italiani di massa a imprimere una svolta e una spinta decisiva alla trasformazione delle sale cinematografiche negli Stati Uniti in grandiosi palazzi capaci di ospitare un pubblico di migliaia di persone e per niente inferiori come sfarzo ai maggiori teatri dell’epoca. Un interessante lavoro americano sull’epoca d’oro dei grandi palazzi cinematografici è di B.M. Hall, The Best Remaining Seats, Bramhall House, New York 1961. 55
56
E. Rossi, Il tendine di Achille, in «La vita cinematografica», a. V, 10 luglio 1914.
A. De Marco, La produzione e l’esportazione delle pellicole dal 1912 al 1918, in «La rivista cinematografica», a. III, 25 agosto 1922, pp. 57. 57
58
T. Sanguineti (a cura di), L’anonimo Pittaluga. Tracce carte miti, Transeuropa/Cinegrafia, Ancona 1998.
59
«La vita cinematografica», a. V, 4 agosto 1914.
Il produttore è Roberto Danesi, ma la Morgana è di proprietà di Danesi e Martoglio. Danesi muore in guerra e la casa viene sciolta immediatamente. Si veda M. Quargnolo, Les premiers auteurs du cinéma italien, in «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979. 60
G. Bertellini, Epica spettacolare e splendore del vero. L’influenza del film storico italiano in America (1908-15), in G.P. Brunetta, Storia del cinema mondiale, II*, Einaudi, Torino 1999, pp. 127-266. Si veda anche AA.VV., Cinema italiano nel mondo, Associazione Flaiano, 61
Pescara 2002. 62
V. Martinelli (a cura di), Cinema italiano in Europa, Associazione per le Ricerche di Storia del Cinema, Roma 1992.
63
A. Friedemann, Appunti per una storia dell’industria cinematografica a Torino, F.E.R.T., Torino 1999.
La censura e le istituzioni
sorvegliare e reprimere Fino a che il cinema mantiene il suo carattere di spettacolo viaggiante è assimilato dalle autorità alle manifestazioni popolari dei circhi e delle fiere e l’interessamento per la sua moralità non sembra turbare troppo gli organi di polizia, né sollevare particolari movimenti d’opinione pubblica. In ogni caso è bene ricordare che le attività degli ambulanti cinematografici rientravano nel quadro di una legge di pubblica sicurezza del 1889 che unificava tutti i mestieri da girovaghi e li sottoponeva a una serie di controlli, limitazioni, divieti, tasse molto vessatori. Prima ancora di entrare nel merito della moralità degli spettacoli, gli organi di polizia o le istituzioni civili e religiose prendevano ogni tipo di attività ambulante ad esempio di immoralità, sporcizia, impresa truffaldina, focolaio di risse e di disordini sociali. Tuttavia nessuno aveva fatto del cinema l’obiettivo principale di un’eventuale campagna di moralizzazione. I primi segni di opposizione, le prime condanne e denunce dei pericoli e della sua presunta immoralità iniziano nel momento in cui nascono e si moltiplicano, in tutte le città, sale stabili di proiezione o sale che vivono in ambiguo connubio con gli spettacoli dei café chantant e dei variété. Ma preliminarmente c’è da considerare la paura nei confronti di questa nuova arma della modernità. «Ogni nuovo meccanismo che entri nel congegno della vita umana aumenta le cifre e le cause della delinquenza e della pazzia; così la elettricità e il magnetismo si sostituirono alle azioni diaboliche nei delitti persecutori dei paranoici» . Così scrive Cesare Lombroso nel marzo 1900. Forse senza essere ancora mai stato in una sala cinematografica. I suoi discepoli, gli interpreti e divulgatori del suo verbo, diretti e indiretti, non perderanno certo l’occasione di farlo al più presto e di riconoscere – a colpo sicuro – nel cinema lo strumento più diabolico e pericoloso dei tempi nuovi, il veicolo privilegiato di immoralità, il modello vincente di tutte le forme possibili di criminalità. Nel 1906 la Lega per la Moralità, nata nel 1902 a opera di Rodolfo Bottazzi, insegnante al Liceo classico Cavour di Torino, decide di combattere l’immoralità del cinema. Ci piace immaginare che la Lega faccia parte di una covata il cui seme fecondante si possa riconoscere nel pensiero lombrosiano. Per quanto possa sembrare paradossale il cinema non trova nella cultura positivistica un sostegno unanime e una forma di legittimazione come strumento del progresso. Saranno piuttosto la cultura simbolista e i rappresentanti del decadentismo a scorgervi uno strumento privilegiato di allargamento dei poteri conoscitivi. C’è comunque in questa nuova forma di spettacolo popolare qualcosa che da subito si sottrae al potere istituzionale e sfugge al controllo delle élites intellettuali che va combattuto lancia in resta: i messaggi visivi hanno una velocità di diffusione straordinaria e sembrano funzionare quando si sottraggono a qualsiasi intenzione pedagogizzante assumendo funzioni antagonistiche temibili. Gli attacchi più violenti provengono non tanto dagli intellettuali affetti dalle sindromi del grillo parlante, quanto da quelli che manifestano il complesso di Cassandra e disegnano assai presto scenari catastrofici di proporzioni imprecisabili . Alle spinte distruttive si contrappongono voci e azioni che mirano a fare al più presto del cinema uno strumento didattico e di elevazione culturale per il popolo indispensabile. Lo stato italiano, per esempio, fin dal bilancio per il Mezzogiorno del 1908 stanzia fondi per i cinematografi scolastici . A dispetto degli sforzi propositivi e costruttivi ottengono per qualche tempo crediti e attenzione i profeti di sventure, il cui ruolo sarà comunque fondamentale nella costituzione degli organismi di censura. Da quando approda alle sedi stabili nel cuore e nelle periferie urbane, il cinema unisce i pubblici popolari e piccolo borghesi e divide le autorità civili e religiose, i maestri e i pedagogisti, gli scienziati, i giornalisti e gli 1
2
3
intellettuali, indipendentemente dal credo politico, culturale o religioso. Da una parte compatti si ritrovano i detrattori, i nemici giurati di questa nuova forma di spettacolo, dall’altra, in ordine sparso, i suoi cantori e sostenitori, che non hanno paura di mescolarsi al grande pubblico, di confessare di essere andati in estasi di fronte alla magia delle immagini. Ancora in una seconda variante del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo si possono veder riunite, per una foto di gruppo, le schiere di neo inquisitori, di cinefobi fondamentalisti, che marciano compatte sotto i vessilli religiosi e si augurano di veder bruciare in piazza le pellicole degli spettacoli immorali assieme ai proprietari delle sale, ai nuovi untori di una pestilenza che miete, sul piano della morale comune, vittime in misura superiore all’epidemia della spagnola e alle ecatombi in corso nei vari fronti della guerra mondiale. «Abbasso il cinema, scuola di vizio e di crimine…» scrive un libello nel 1918 dal titolo Contre le cinéma. Ecole du Vice et du Crime… il cui incipit si può ritrovare in molte altre pubblicazioni contemporanee europee: «Il cinema si segnala in genere per il cattivo gusto e l’immoralità. Distilla il veleno morale ai bambini e alla gente del popolo. I film polizieschi, criminali, licenziosi… formano, col concorso dei manifesti pubblicitari fortemente evocatori, dei futuri ladri, dei futuri imbroglioni, dei futuri banditi» . Sugli stessi passi si muovono, proprio nello stesso periodo, decine di studiosi autorevoli: per l’Italia possiamo ricordare gli studi del professor Masini e professor Vidoni dell’Istituto di Medicina legale di Genova (Il cinematografo nel campo delle malattie mentali e della criminalità) , lo studio psico-sociale dell’avvocato Andrea Vitelli dedicato a Cinematografia e criminalità («Al coro d’indignazione che dalla parte più sana e illuminata del pubblico si leva in questi giorni soprattutto contro l’efficacia criminale del Cinematografo aggiungo la mia voce modesta…») e l’intervento di Piero Pesce-Maineri Les dangers sociaux du cinématographe («la scienza specializzata ci insegna che l’influenza nociva degli spettacoli cinematografici si manifesta soprattutto nel campo della criminalità») . Anche se questi nomi oggi non dicono nulla, si tratta pur sempre di voci che parlano in rappresentanza di istituzioni, gruppi, associazioni e di persone che forse ottengono i loro trenta secondi di notorietà grazie a queste prese di posizione pubblica e al consenso di cui riescono a circondarsi. 4
5
6
le prime leggi Fino al 1913 non esistono leggi specifiche, valide per tutto il territorio nazionale, che regolino l’esercizio, ma dal 1908 l’iniziativa parte dagli organi locali di pubblica sicurezza: in data 2 luglio e 24 luglio i prefetti di Milano e Torino emanano regolamenti speciali che stabiliscono precise norme «per coloro che intendono impiantare ed esercitare spettacoli cinematografici». Queste norme prescrivono caratteristiche necessarie alla costruzione di una sala cinematografica, le condizioni di agibilità, in base a una certa cubatura, il numero massimo di spettatori, le uscite di sicurezza e gli opportuni dispositivi, l’aereazione, l’illuminazione, i sistemi di prevenzione degli incendi . Quanto alla difesa della moralità, tra l’emanazione del ricordato testo unico di P.S. sugli spettacoli pubblici del 1889 nel quale rientrano gli spettacoli cinematografici per un lungo periodo e l’avvento del fascismo (con la legge del 18 giugno 1931), vengono definiti criteri d’intervento censorio da parte del Ministero degli Interni e si emanano una serie di disposizioni per il controllo della moralità degli spettacoli che creano non poche limitazioni all’industria cinematografica . «Nel 1910 l’on. Vittorio Emanuele Orlando, ricollegandosi a una legge del 1907, si fa autore di un provvedimento che prescrive l’autorizzazione prefettizia per la proiezione in pubblico. Alla sottocommissione della Camera, per la delinquenza minorile spetta di aver proposto, nel progetto di legge da essa elaborato, la prima casistica del lecito e dell’illecito… Tra i catoni più intransigenti fa sentire la sua voce il commendatore G.B. Avellone, che rimprovera al cinema di ‘attirare le folle con le più malsane e pervertite curiosità, con spettacoli orridi riproducenti adulteri, omicidi, disastri finanziari a base di truffe, di falsi, di frodi, amori inverecondi, tresche lascive, imprese brigantesche, assalti alle vetture corriere, frodi audaci con seghe circolari e con contorno di strage dei derubati’» . Non sono semplicemente voci isteriche o isolate queste di singoli cittadini che si levano a difesa dell’idea di una moralità pubblica che si identifichi tout court col cattolicesimo più conservatore, o almeno se ne serva come copertura, ma sono le voci più significative di una cultura e di un’ideologia che vedono, per la prima volta, in concreto, profilarsi i pericoli di un profondo mutamento dei modelli culturali nelle classi proletarie, e 7
8
9
vedono nel cinema l’espressione di una cultura antagonista (anche se ciò sarà vero in minima parte per il cinema italiano). Il governo attuerà una politica economica repressiva e non a favore dell’industria cinematografica, anche a causa dell’incidenza di queste voci e della loro capacità di aggregare consenso in certe fasce sociali e governative. E questo fatto può essere interpretato come una delle tante manifestazioni dell’ambivalenza della politica giolittiana. Infatti la prima circolare del Ministero degli Interni, in cui si fissano i criteri che le autorità devono seguire per la tutela della morale, del buon costume e dell’ordine pubblico nel concedere licenze ai soggetti cinematografici e il nullaosta di circolazione su tutto il territorio nazionale ai film di produzione italiana e straniera, è del 20 febbraio 1913 e mostra come il braccio di ferro tra produttori e potere pubblico inizi proprio quando l’industria cinematografica compie il primo salto di qualità e incrementa la durata delle pellicole scoprendo gli enormi poteri di rappresentazione del cinema. Già da tempo è iniziata, su vari organi di stampa, la polemica guidata dal commendatore Avellone, procuratore generale alla Corte d’appello di Roma, contro i pericoli del cinema e si è cominciato a invocare l’intervento delle autorità per il controllo e la difesa della moralità: «L’autorità pubblica deve compiere pieno il dover suo di sorveglianza dei pubblici spettacoli e di tutela della moralità pubblica» , altri, sulle pagine della stessa rivista, sull’onda della polemica, rincarano la dose definendo senz’altro il cinema come «scuola di delitto, incitamento e preparazione al suicidio, causa di tante morti violente». Altri ancora assumono decisamente compiti di difesa sostenendo ironicamente che «la retorica da educande ha fatto il suo bravo tempo… che la vita non è scuola e non è collegio e non è sempre una professione di austerità, di morigeratezza assoluta e inflessibile» . Non bisogna però credere che si tratti di voci soltanto italiane; un vero e proprio esercito di moralizzatori è già al lavoro prima del 1910 su scala mondiale, e i pericoli o le prospettive catastrofiche ipotizzate da un pedagogista in Francia, vengono riprodotte e ripetute da avvocati, giudici, sacerdoti, professori in Spagna, Inghilterra, Germania, e Stati Uniti. Col favore dunque degli stessi produttori, che sollecitano a loro volta interventi governativi per regolare tutta la materia, viene emanata la circolare ai prefetti in cui si chiede di prestare attenzione perché il cinematografo non dia in «pascolo agli spettatori rappresentazioni di famosi atti di sangue, di adulteri, di rapine e altri delitti, rendendo odiosi i rappresentanti della pubblica forza e simpatici i rei; con ignobili eccitamenti al sensualismo, provocati da episodi nei quali la vivezza delle rappresentazioni alimenta immediatamente le più basse e volgari passioni, e altri da cui scaturisce un eccitamento all’odio tra le classi sociali ovvero un’offesa al decoro nazionale». Già in questa circolare sono stabiliti e raggruppati, secondo una morfologia ancora confusa, i tipi di scene e di vicende di cui non è consentita la circolazione: a qualche mese di distanza viene emanata una legge, costituita da un articolo unico (legge n. 785 del 25 giugno 1913, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 14 luglio 1914) in cui si autorizza il governo al controllo centralizzato delle produzioni cinematografiche italiane ed estere e si affidano i pieni poteri esecutivi di questo controllo nelle mani di funzionari di pubblica sicurezza: «Per assecondare il Movimento della pubblica opinione – esordisce l’8 maggio il ministro Facta nel presentare la legge alla Camera – sempre più concorde nel richiedere che venga impedito alla produzione cinematografica di toccare il campo della pornografia e della gratificazione della delinquenza… è autorizzato il governo del re a esercitare la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all’interno, siano importate dall’estero, e a stabilire una tassa per ogni metro di pellicola… Tale servizio è iniziato il 10 maggio, dalla quale data tutte le pellicole cinematografiche prodotte nel regno o importate dall’estero, che si intendano esporre al pubblico, vengono preventivamente esaminate dalla predetta direzione e munite, qualora non concorrano motivi di divieto, di apposito nullaosta» . Un articolo di questa legge (il 10°) crea inconvenienti in quanto prevede la possibilità di rinnovare l’esame in casi di dubbio. Così, nel giro di pochi anni, si può verificare, in molte occasioni, il fatto che a un film venga concesso il visto e a breve o lunga scadenza venga poi revocato (casi limite da ricordare potrebbero essere, in anni successivi, Ritorno delle aquile e Scialle lucente a cui il visto è concesso nel 1922 e revocato nel 1928 e Fango egualmente posto in circolazione nel 1922 e ritirato nel 1930). Preso atto, prima ancora di entrare nel merito dei tipi di intervento, del potere molto ampio conferito all’organismo censorio è bene riconoscerne anche subito la funzione essenzialmente politica e non tanto giuridico-amministrativa: «La nostra censura – hanno osservato Mino Argentieri e Ivano Cipriani – fu 10
11
12
13
caratterizzata, fin dal suo nascere, da una struttura burocratica, sensibilissima ai cambiamenti d’ordine politico in atto nel paese e passibile di modificarsi in rapporto a tali sovrastrutture e non invece in rapporto ai cambiamenti della struttura cinematografica italiana» . A partire dal 1913 (5 dicembre) e con un regio decreto del 31 maggio 1914 (n. 532) si istituisce la censura preventiva e si fissano almeno nove punti in base ai quali è possibile autorizzare il ritiro del film o impedirne preventivamente la circolazione. Si deve procedere contro opere che risultino: «1) offensive della morale, del buon costume e della pubblica decenza dei privati cittadini; 2) contrarie alla reputazione e al decoro nazionale o all’ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali; 3) offensive del decoro e del prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti delle forze pubbliche; 4) scene turpi, ripugnanti o di crudeltà anche a danno di animali; 5) delitti o suicidi impressionanti, azioni perverse o fatti che possono essere scuola o incentivo al delitto ovvero turbare gli animi o eccitare al male; 6) scene o fatti che possano compromettere gli interessi economici, politici, il decoro e il prestigio della nazione, delle istituzioni e autorità pubbliche; 7) scene o fatti che possano compromettere il decoro e il prestigio dei funzionari e agenti della forza pubblica, del R. esercito e della R. marina; 8) film che non presentino sufficienti garanzie di dignità pubblica». La commissione comincia subito a lavorare a tempo pieno: dal 31 maggio 1913 al 10 aprile 1914 sono esaminate 3.978 pellicole giungendo a vietare la circolazione a 46 e ammettendo, solo dopo tagli e modificazioni, 128 tra corto e lungometraggi . Proprio nello stesso periodo, con qualche anno di distanza rispetto ad altri paesi, come gli Stati Uniti e la Francia , accanto ai problemi di moralità e censura cominciano a sorgere quelli di paternità dell’opera e di attribuzione dei diritti d’autore: la prima sentenza che affronti la materia è del 22 novembre 1913 e stabilisce che «la cinematografia, indipendentemente dallo speciale mezzo o procedimento meccanico di sua esecuzione… è essenzialmente rappresentazione e riproduzione significativa di un’opera dell’ingegno letterario e artistico… di arte scenica e figurativa che può creare o produrre un’opera artistica autonoma e nuova, capace di tutela giuridica come tutte le opere dell’ingegno» . Il problema era nato proprio in rapporto all’utilizzazione di soggetti tratti da opere di autori viventi (come Dumas figlio ad esempio), o di cui correvano ancora gli obblighi di pagamento dei diritti d’autore, e si era rapidamente esteso alla necessità di giungere, anche in sede giuridica, a definire la paternità e l’attribuzione dell’opera cinematografica a una singola personalità. Riprendendo ora il discorso sulla regolamentazione del servizio di controllo e di censura è necessario ricordare che tra la legge del 1913 e il T.U. di P.S. del 1926, le circolari interne, gli ordini di servizio, i regi decreti, i decreti legge e le leggi vere e proprie si susseguono a raffica e in pratica senza soluzioni di continuità, tanto che tra il 1915 e il 1919 si possono contare almeno 12 interventi che introducono continue modifiche e precisazioni analitiche sui tipi di censura da effettuare. Il 4 maggio 1917 viene emanato l’ordine di servizio più completo, che descrive analiticamente, in dodici punti tutti i tipi di soggetti che possano riuscire di scuola di delitto o si configurino come contrari alla pubblica moralità: «1) film che mettano in luce simpatica il delinquente; 2) opere in cui si riproducano ambienti di depravazione; 3) o esaltino sentimenti di odio; 4) facciano trionfare la perversità sulla virtù; 5) mettano in luce l’adulterio determinato da pura abbiezione sessuale; 6) non rispettino il culto dei morti; 7) diano veste di credibilità a sortilegi, fatture, stregonerie, ecc…». Dal 1920 è emanato un decreto ministeriale (n. 531, 22 aprile 1920) col quale la revisione è sottratta ai funzionari di P.S. e affidata a una commissione costituita da sette rappresentanti di gruppi diversi, due funzionari di P.S., un magistrato, una madre di famiglia, un educatore, un artista, un pubblicista, che naturalmente, pur nell’estrazione sociale e culturale diversa, si sentiranno così investiti delle loro funzioni da applicare col massimo rigore la lettera della legge. Il fascismo erediterà questo insieme di decreti e di leggi e nei suoi interventi successivi non farà altro – trovandole perfettamente funzionali alle sue esigenze – che sostituire il pubblicista con un rappresentante del Pnf e aggiungere ai membri della commissione un rappresentante dell’Istituto Luce e uno dell’Ente nazionale per la cinematografia. Alla fine della guerra l’azione della censura, che nei suoi primi anni di vita aveva applicato burocraticamente la volontà del legislatore, non sembra subire profonde modificazioni né dall’alterazione della composizione sociale e 14
15
16
17
culturale dei membri di una commissione, né dalla modificazione successiva dell’assetto politico del paese. La categoria della continuità – ieri come oggi – si applica in modo assai pertinente a tutta l’azione della censura.
il censore al lavoro Anche se dalla composizione delle commissioni del 1919 sono esclusi i rappresentanti degli operatori del settore e la stampa di categoria non manca di denunciare questo fatto, la logica d’intervento, prima e dopo il 1919, presuppone un’ideologia e un punto di vista assolutamente unitari. Così se negli ultimi anni di guerra, in molte occasioni, la manifesta incapacità dei funzionari di P.S. aveva avuto modo di rifulgere («sopprimete tutte le scene in cui si beve champagne!» o «eliminare i cadaveri in pose macabre») ciò che interessa è cogliere, fin dalla genesi, un atteggiamento e una mentalità capaci di sopravvivere a lungo a tutte le modificazioni politiche e sociali della realtà italiana. Uno dei terreni privilegiati d’intervento è quello della sessualità: la commissione di funzionari prima e quella creata dopo il 1919 presentano tendenze sessuofobiche così forti da intervenire per eliminare qualsiasi elemento esplicito – o anche sottaciuto o alluso – che possa non solo mostrare, ma anche suggerire, l’idea di un rapporto sessuale o qualsiasi manifestazione di sessualità. Tutte le scene di baci prolungati in genere vengono soppresse ma anche quelle di danze e quelle in cui si assiste a timide svestizioni femminili o alla semplice alzata delle gonne. Questo atteggiamento può giungere, nello stile dei censori, a forme gergali del linguaggio da caserma («Togliere la scena di Attila che palpa Vittoria e poi sale sul letto», Attila) , così come la moralità censoria si accanisce, in prima battuta, contro tutte le scene che possano minimamente turbare un’idea anacronistica e da società vittoriana del comune senso del pudore: «Sopprimere la scena eccessivamente brutale in cui il governatore, preso da un impeto bestiale, rovescia Sonia su una poltrona» (Anima slava, p. 18), o in Amore che uccide, dove si vedono «coppie di amanti sdraiate per terra o sui divani in atteggiamenti inverecondi», o per le scene di Artista in cui si vede «l’artista che si abbandona ad atti di feticismo con le calze, le scarpe, il piumino da cipria» (p. 23). Se questo tipo di interventi appare tutto sommato comprensibile e prevedibile, qualche perplessità, se non assoluta incomprensione, solleva l’ordine di soppressione, in Addio mia bella Napoli, della scena «in cui si vede Carlo che con aria svenevole suona il violino» (p. 6), o quella del Club degli ossessi («sopprimere la scena dell’incrocio delle gambe sotto il tavolo subito dopo il baciamano», p. 60), e la preoccupazione per i turbamenti del pubblico alla vista della scena di miss Diana a cui nel film Cena dei dodici bricconi «nello scendere dalle scale si alzano le gonnelle» (p. 57) appare per lo meno eccessiva. Non potrà stupirci quindi se viene imposto di sopprimere anche in Chiffonette «la scena in cui si vede la protagonista seduta sul letto mentre si infila le calze» (p. 59). L’occhio del censore è così attento che tutto il rituale erotico della vestizione e della svestizione femminile è sottoposto ai più rigidi controlli, tutte le scene di bagni vengono per lo più eliminate, ma giungono anche a infastidire, oltre alle parole, anche scritte come questa «Ella aveva il buon profumo della giovinezza» (in Donna funesta, p. 99) di cui si ordina la drastica soppressione. La logica complessiva che anima il censore sembra dominata comunque da uno sguardo per lo più miope e ottuso: lo offendono i titoli (La danzatrice ignuda deve diventare La danzatrice ignota) lo colpiscono singole parole, scene o gesti, ma non di rado la morale complessiva del film sembra sfuggirgli del tutto o non interessarlo. Certo tra la produzione nazionale e quella internazionale la commissione censoria deve effettuare un duro lavoro di arginamento di un’idea di cinema che risulta, fin da quegli anni, del tutto anacronistica. Un secondo livello, assai compatto, di interventi riguarda scene o opere in cui vi possa essere, in qualche misura, scuola di violenza o di delitto. Anche su questo piano lo sguardo del censore non si segnala per doti particolari di elasticità o intelligenza: «La censura – ha scritto Roland Barthes – è detestabile a due livelli, perché è repressiva, perché è stupida; in maniera che si ha sempre voglia, contraddittoriamente, di combatterla, di farle la lezione» . In effetti se l’occhio del censore in materia di sesso poteva incorrere in qualche svista, o lasciar passare qualche scena, la volontà del governo in materia di scuola di delitto non poteva lasciar dubbi e l’attenzione doveva moltiplicarsi: dai film andavano soppresse tutte le scene in cui si 18
19
vedevano tagli di vetri, effrazioni, scassi a scopo di rapina, aperture e chiusure dei rubinetti del gas, firme di assegni veri o falsi, rappresentazione di ambienti in cui fosse rappresentato il consumo di oppio, borseggi e così via. Esiste, a questo scopo, una precisa circolare emanata nel 1919 dal Ministero degli Interni in cui si dice che si deve impedire che «il film rappresenti l’ambiente, i tipi e consuetudini e quanto concerne sotto ogni aspetto, la teppa, la camorra, la barabba, la mafia, la mano nera, gli apache e ciò anche quando non si raggiunge l’estremo del ripugnante, del turpe e non vi sia stretta e immediata scuola di delitto». Per cui se si scorrono gli elenchi dei film ammessi alla proiezione nelle sale e le relative condizioni che provocano la concessione del nullaosta ci si imbatte in una fascia compatta di interventi di questo genere: «Sopprimere la scena del taglio del vetro» in l’Amante incatenata (p. 12), «Eliminare la scena in cui il protagonista per sopprimere la moglie ricorre a mezzi che possono riuscire di scuola di delitto» (Amazzone macabra, p. 12); «sia soppressa la scena in cui si vede una mano che falsifica una cambiale» (Ape); «sopprimere la scena in cui si vede aprire la cassaforte con la fiamma ossidrica e quella in cui si vede aprire il rubinetto di un contatore e poi quello di una lampada a gas» (Le avventure di Sfortunello Fortuna, p. 30), «sopprimere la scena in cui si vede Mezamet che con la creta prende l’impronta di una serratura», «eliminare la scena in cui si narcotizza, con un batuffolo sotto il naso, l’avvocato» (Banda dei Rossi). Abbastanza interessante anche la proposta di sostituzione linguistica di una didascalia come «Simula un’estorsione» in I cavalieri delle tenebre (p. 55) con un’altra didascalia del tipo «Simula una distorsione». Vi sono molti interventi tesi a eliminare, per lo più dai film americani, le scene in cui si rappresenti il consumo della droga in città d’oriente, o nei bassifondi delle grandi città dove spesso l’azione porta nelle fumerie d’oppio: «Sopprimere tutte le scene in cui si vedono i fumatori d’oppio sdraiati» (Cinque gentlemen maledetti, p. 62), «eliminare tutto ciò che indica l’uso e gli effetti dell’oppio» (La bella giardiniera). Per quanto riguarda invece specificamente la rappresentazione di gruppi o bande di delinquenti sembra che gli unici a farne le spese siano gli «apaches» dei film francesi. Su questo terreno il censore ha vita dura: Rocambole, Arsenio Lupin, Judex, Za-la-Mort, Zala-Vie, riscuotono grandissimi successi di pubblico in quegli anni e il controllo viene spesso allentato rendendo inutili gli sforzi nei confronti di altre opere. Inoltre è indispensabile isolare un altro campo privilegiato d’intervento, dove si può ben qualificare l’ideologia dei censori e la difesa di un potere che predilige le tecniche dell’occultamento e dell’ipocrisia a quelle di una franca rappresentazione della realtà in tutti i suoi aspetti, nelle sue contraddizioni sociali e politiche. Il prestigio delle istituzioni non deve essere attaccato, neppure nei modi più innocui, e si teme che a comprometterli, in piena guerra mondiale, possano essere un’innocua didascalia, o un’immagine ironica o grottesca: nella Fidanzata dei dollari si ordina che «invece del consolato degli Stati Uniti d’America si sostituisca il consolato di un paese immaginario» (p. 126). Per il Fantasma senza nome «sopprimere le scene che si svolgono nell’ufficio di polizia, perché offensive del decoro e del prestigio delle autorità» (p. 121). Quanto alla Fanciulla del West non deve apparire «la scena in cui i policemen percuotono brutalmente l’arrestato» (p. 120). C’è già ben chiara anche la preoccupazione di evitare ogni riferimento a possibili corruzioni e clientelismi ai vertici dello Stato: «Le persone che speculano sulla conoscenza dei segreti di Stato non devono essere presentate come figlia e nipote del presidente del Consiglio dei ministri» (Dopo, p. 101) e ancora in Cugina: «Sopprimere il titolo; che fortuna avere un prefetto come amico» (p. 83). Si viene dunque profilando, se si interpreta bene l’intervento su questo piano, il disegno dai contorni molto più netti e definiti che fa scattare i meccanismi di repressione censoria. I più semplici accenni all’azione governativa vanno soppressi, anche se del tutto indolori come questo in Diritto d’amare dove si impone di sopprimere la didascalia «E quando si pensa che il governo vorrebbe impedire di bere questo nettare» (p. 94). Non devono sorgere dubbi sulla perfetta efficienza di tutte le macchine statali e non si può certo, sia pure con minimi accenni innocui, suggerire immagini di parassitismo burocratico («Sopprimere la scena in cui si vede il cancelliere del giudice istruttore che sta baloccandosi con una barchetta di carta», La commedia dal mio palco, p. 71) e neppure si consente che l’istituto monarchico possa sviluppare al suo interno qualche ramo di follia anche in reami di fantasia («In Verlandia, piccolo regno della grande Slivogravia, i dissensi politici, gli odi di parte, le diverse fazioni tenevano sul trono un re folle. Sopprimere il re folle e nella parte quarta della didascalia ‘E su quel momento d’intrighi, d’ambizioni, di delitti, il re folle’ eliminare la parola folle sostituendola se mai con semplici puntini», La corsa al trono, p. 77).
Ma la cosa che i censori sembrano temere di più è certamente la storia: non soltanto quella presente, ma anche quella anteriore (altrimenti non si spiega l’ordine di mutare la collocazione temporale di Daphne and the Pirate «facendo figurare che l’azione si svolge nel 1718 e non nel 1878», p. 87). È naturale quindi che i riferimenti politici contemporanei, e a maggior titolo i riferimenti alla rivoluzione russa o le semplici evocazioni della parola comunista, provochino un automatico riflesso di tipo repressivo nel censore. Dal film Alba si ordina di sopprimere la didascalia «scene drammatiche di Lenin» (p. 8), in Angeli e demoni devono essere eliminate «tutte le scene e didascalie relative al propagandista, in modo che di esse non resti traccia nella pellicola» (p. 17). La parola comunista non può venir evocata neppure in senso negativo, è una parola tabù, come si vede nell’intervento su un numero di «Attualità»: «Le parole ‘delle vittime della violenza comunista’ siano sostituite dalle seguenti ‘dei nazionalisti’» (p. 26). Nettissimo diventa l’intervento ideologico nei Figlidi nessuno, dove, oltre alla soppressione della parte «che rappresenta l’insurrezione degli operai», si deve «modificare la scena in cui si vede la commissione degli operai recarsi dal conte in modo che dall’azione vengano eliminati tutti gli operai» (p. 128). Non si devono inoltre rappresentare incidenti sul lavoro, omicidi bianchi: in Angeli e demoni si ordina di «sopprimere la scena in cui si vede il trasporto dell’operaio ferito nello scoppio della miniera» (p. 17), e ancora nei Figli di nessuno va ridotta «la scena in cui si vede l’operaio che rimane vittima delle mine». Saranno proprio alcuni film popolari, in particolare quelli napoletani prodotti dalla Lombardo film, che, pur con la loro ideologia paternalistica e conservatrice, o con la loro denuncia di ingiustizie sociali che non impedisce la ricomposizione finale tra le classi, riusciranno ad aprire una breccia e a denunciare problemi sociali con una funzione del tutto analoga a quella della letteratura d’appendice. Questa produzione, come per l’appendice, proprio per la quantità e la concentrazione di tutti gli elementi censurabili e da censurare, risulterà essere un terreno privilegiato per l’intervento censorio, anche se, proprio per l’ottusità del censore di cui si è parlato, i singoli tagli non riusciranno affatto a menomare il senso dei diversi piani di trasmissione del messaggio, e soprattutto la fortissima produzione simbolica e immaginativa nei confronti del destinatario. Da questi tipi di film si può dire che vengano capovolti moduli e ideologie delle opere dell’anteguerra, dove molto spesso una morale deamicisiana regolava la rappresentazione del finale conciliativo e lungo tutto l’evolversi dell’intreccio e nella definizione del contesto. Appare dunque chiaro, al di là dell’indubbio effetto di divertimento che alcuni interventi possono produrre (ma questo divertimento non deve impedirci un contatto reale di riconoscimento dei meccanismi ideologici che regolano l’azione censoria), che la logica di repressione risponde maggiormente a una esigenza politica che a una effettiva esigenza morale, dove le oscillazioni e i tipi di intervento non appaiono regolamentati, ma lasciati alla libera iniziativa individuale. Mentre la moralità, la difesa del comune senso del pudore, sembra colpire senza una coerenza identificabile con precisione assoluta, ma dipende piuttosto da contingenze umorali del singolo censore, l’intervento politico assume una evidenza e una motivazione assai più rilevante. Il censore cinematografico, nel quadro della politica delle istituzioni, ha un potere assoluto, anche se è evidente che, proprio per la sua ottica ristretta e la sua funzione puramente esecutiva, è uno strumento passivo e ottuso di una volontà politica, in questi anni fluttuante e, in seguito, dall’avvento del fascismo, ben più netta e cogente. Il perfetto allineamento, in tutta la storia del cinema italiano, della figura del censore agli interessi dei gruppi e delle classi più reazionarie fa sì che, anche lavorando sulle epoche successive, il materiale non offra significative prove di evoluzione e trasformazione dell’idea di moralità del censore e un suo maggior adeguamento alle esigenze del paese reale in continua trasformazione. Si può – in via di conclusione provvisoria, ma capace di proiettarsi anche lungo tutto lo sviluppo successivo della storia del cinema italiano – individuare una «tripla strategia differenziata nel lavoro dei censori», corrispondente agli interessi dei gruppi di cui si compone una commissione. Se ai letterati e giornalisti viene demandato il compito per lo più di protezione dell’istituto linguistico (e non sono rari gli interventi o i consigli sul piano delle modificazioni linguistiche e grammaticali) e alle madri di famiglia è affidato quello di protezione della moralità, ai funzionari del Ministero degli Interni e ai magistrati si chiede di vigilare sul buon nome delle istituzioni e sui pericoli derivanti dalla troppo facile circolazione di nuove teorie politiche e sociali. Una divisione del lavoro che riesce a funzionare come una macchina perfettamente oliata ancora per qualche anno, in quanto, già dal 1922, il lavoro diminuisce non tanto perché il fascismo sale al potere, quanto piuttosto perché scende di molto la produzione nazionale. In ogni caso il regime pensa assai presto a una
ristrutturazione della commissione di censura dandole un peso ancor più nettamente caratterizzato in senso politico e prevedendo piuttosto una maggior elasticità su tutte le questioni d’altro genere, su cui interverranno, in uno spazio lasciato scoperto, i censori cattolici – in seconda istanza – fin dall’inizio degli anni Trenta. C. Lombroso, Il ciclismo nel delitto, in «La Nuova Antologia», 1° marzo 1900, riportato in «Lancillotto e Nausicaa», a. III, n. 1, 1986, pp. 76-87. 1
Per le caratteristiche degli intellettuali nella nascente industria culturale italiana a cavallo dell’Otto e Novecento si veda il primo capitolo del bel lavoro di F. Colombo, La cultura sottile, Bompiani, Milano 1998. 2
3
M. Cardillo, Cinematografo o proiezioni luminose, in «Il Sapere», n. 11, 1980, pp. 28-33.
4
E. Poulain, Le cinéma école du vice, Besançon 1918 riportato in M. L’Herbier, Intelligence du cinématographe, Corrêa, Paris 1946.
5
M.U. Masini e G. Vidoni, Il cinematografo nel campo delle malattie mentali e della criminalità, Bocca, Torino 1915.
6
P. Pesce-Maineri, Les dangers sociaux du cinématographe, Lattes, Torino-Genova 1922, p. 10.
P. Liesegang, Il cinematografo, Bocca, Milano 1909, pp. 396 sgg. Se manca una legislazione non mancano i primi interventi dei giuristi a cercare di interpretare o di riunire alcuni fenomeni sotto una stessa ottica. Si vedano in particolare: G. Bucciante, Il grammofono, il fonografo e il cinematografo nel diritto, Ist. Tip. Cooperativo, Ancona 1908; M. Turletti, I cinematografi e il diritto d’autore, ed. Torinese, Torino s.i.d.; C. Laguna, Il cinematografo, Soc. editoriale milanese, Milano 1909; G. Dina, Le cinématographe et le grammophone dans la legislation italienne et dans les legislations étrangères, Panizza, Torino 1910; G. Vincenzoni, La cinematografia, Sonzogno, Milano s.i.d. 7
Manca a tutt’oggi una storia della politica e delle istituzioni nel cinema italiano simile a quella di cui sono apparsi per ora i primi due volumi in Francia a cura di P. Leglise, Histoire de la politique du cinéma français, Lherminier, Paris 1970 e 1977. Il lavoro complessivo più ricco e organico sul funzionamento della censura è quello di M. Argentieri, La censura nel cinema italiano, Editori Riuniti, Roma 1974. Si veda anche per la descrizione ordinata del curriculum delle leggi fino al dopoguerra E.G. Laura, La censura cinematografica, Ed. Bianco e Nero, Roma 1961. 8
O. Caldiron, La censura in Italia dagli inizi del secolo al dopoguerra, in «Il Ponte», a. XVII, n. 11 novembre 1961, p. 1501. L’intero numero della rivista è dedicato alla censura nello spettacolo, con particolare riferimento al dopoguerra: si segnalano tra gli altri gli articoli di Bobbio, Argentieri e Cipriani, Miccichè e Di Giammatteo. Per quanto riguarda la polemica sollevata dal commendator Avellone si veda Argentieri, La censura nel cinema italiano, cit., pp. 11-14. Per un’analisi più dettagliata delle leggi giolittiane, M. Quargnolo, La censura cinematografica da Giolitti a Mussolini, in «L’Osservatore politico e letterario», luglio 1979, pp. 65-76. 9
10
Il testo della circolare è pubblicato sulla «Rivista penale», vol. 77, n. 767.
L’intervento del commendator Avellone era stato pubblicato, sotto forma di lettera aperta, sul «Giornale d’Italia» del 18 ottobre 1912 ed è ripreso col titolo di Moralità su «La vita cinematografica», a. III, n. 20, 30 ottobre 1912. 11
Questa voce, di un certo D. Borrelli, appare nello stesso numero della «Vita cinematografica», ma evidentemente è l’espressione di un lettore isolato e non ha la capacità di aggregare alcun consenso successivo. 12
13
Cfr. Caldiron, La censura in Italia dagli inizi del secolo al dopoguerra, cit., pp. 1502-1503.
14
M. Argentieri e I. Cipriani, Censura e autocensura, in «Il Ponte», a. XIII, nn. 8-9, 1957, p. 1338.
Cfr. Argentieri, La censura nel cinema italiano, cit., p. 21. Un lavoro importante di analisi sulle strategie linguistiche messe in atto dalla commissione di censura è S. Raffaelli, Un trentennio di censure linguistiche, in Id., La lingua filmata, Le Lettere, Firenze 1992, pp. 163216. Questo articolo era già apparso in «Comunicazioni sociali», a. I, n. 4, 1979, pp. 45-52. 15
Utili indicazioni per una storia comparata delle istituzioni censorie e degli interventi governativi si trovano nei libri di Coissac, Sadoul, Mitry, Deslandes e Richard, Leglise, ecc. 16
17
F. Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935, p. 46.
18
Indice alfabetico delle pellicole approvate dal ministero, dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1921, Roma 1923, p. 26.
19
R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Einaudi, Torino 1977, p. 169.
Il divismo
vaghe stelle dell’orto giolittiano… Con una sincronia quasi perfetta rispetto alle teorie del Superuomo di Nietzsche e con quasi trent’anni di anticipo rispetto al fenomeno di cui stiamo per occuparci, si sviluppa sul finire dell’Ottocento una teoria della Superdonna, fantasma e proiezione del desiderio maschile, il cui prototipo si trova nelle pagine del romanzo di Villiers de l’Isle-Adam, Eva futura e in particolare in queste parole di Thomas A. Edison, prometeico creatore di un nuovo essere femminile totipotente: «Al posto dell’Eva della leggenda disprezzata dalla Scienza, io vi offro un’‘Eva scientifica’, la sola degna, a quanto sembra, di quel viscere flaccido che per un rimasuglio di sentimento del quale siete i primi a sorridere, continuate a chiamare il vostro cuore. Lungi da me l’idea di sopprimere l’amore verso le spose, almeno fino a nuovo ordine, alla perpetuazione della nostra razza. Propongo invece di assicurarlo e rinvigorirlo e garantirne la durata, l’integrità, con l’aiuto innocente di mille e mille meravigliosi simulacri; in essi le vostre belle amanti, deludenti, ma diventate allora inoffensive, saranno doppiate in un tipo perfezionato ancora dalla scienza e il loro aiuto salutare attenuerà, per lo meno, i torti e le sventure sempre provocati dalle vostre ipocrite diserzioni coniugali… In conclusione… propongo ai mortali di questi tempo nuovi ed evoluti, ai miei simili in Attualissimo, insomma, di preferire ormai alla menzognera, mediocre e sempre incostante Realtà, un positiva, prodigiosa e sempre fedele illusione». Queste parole si possono considerare come il viatico migliore per annunciare la nascita della nuova Eva, di una donna virtuale, partorita come Minerva dall’immaginazione dell’uomo, capace di sostituire in tutto e per tutto la donna reale, di dar corpo alle fantasie maschili per mezzo di una stupenda macchina di visioni che proietta immagini in movimento più vere del vero. Grazie al Kinetoscopio e al Cinematografo l’uomo assume di colpo poteri taumaturgici, prima cattura e ricrea il mondo, poi crea dal nulla, mescolando fango e polvere di stelle, una nuova Eva. Questa figura messa insieme grazie ai lacerti e ai frammenti di corpi diffusi nello spazio iconografico coevo, destinato a divenire, simbolo, transfert e vittima sacrificale del desiderio collettivo, farà assaporare al pubblico maschile e femminile i piaceri dell’ascesa verso dimensioni paradisiache, in sale che non a caso si chiameranno Astra o Excelsior o Eden e della caduta verso baratri peccaminosi e infernali. La diva, fin dal momento della sua nascita produrrà forme di dérèglement de tous le sens e di immediata diffusione di fenomeni di culto laico come non si erano mai visti. Diciamo subito che il divismo nasce come fenomeno italiano ed europeo affonda le sue radici nella cultura europea simbolista e liberty e trapiantato in America in un momento successivo troverà ad Hollywood l’habitat ideale per svilupparsi e manifestare tutta la sua potenza lungo l’intero Novecento. Torniamo alla realtà italiana: il primo divismo italiano fu un fenomeno «disordinato» e un tantino «provinciale». Fu soprattutto un fenomeno «effimero» . Con questi aggettivi Giulio Cesare Castello, uno degli interpreti più autorevoli del divismo, liquidava ingiustamente e superficialmente un fenomeno che a cavallo della guerra mondiale assume rilevanza internazionale dimostrando tutta la potenza del cinema e la sua capacità di influenzare i comportamenti sociali e l’immaginario collettivo e che deve proprio al disordine e all’improvvisazione (che gli permette peraltro di svilupparsi e raggiungere il suo zenith proprio in un arco di tempo brevissimo) i suoi maggiori punti di forza e distinzione. Il divismo cinematografico italiano non è il prodotto di una volontà e di un progetto industriale e neppure un fenomeno indotto, in modo meccanico, da altre manifestazioni sociali e culturali. È piuttosto la risultante di una serie di fattori variabili interni ed esterni alla macchina cinema . La sua massima fioritura avviene nel momento in cui giunge all’acme il flusso migratorio di milioni di 1
2
3
contadini e proletari verso gli Stati Uniti e l’America del Sud, negli anni in cui la guerra di Libia ha ripagato solo moralmente le ambizioni imperialistiche dell’Italia giolittiana. Il divismo nasce come immagine di qualcosa di non realizzato: né sul piano nazionale, né sul piano delle élites. I suoi presupposti e i suoi modelli esistono nella società, ma l’immagine e le realtà cinematografiche hanno legami pressoché nulli con la realtà del paese. Si può affermare che ne costituiscano – fin dai primissimi passi – dei transfert o delle proiezioni simboliche, più che dei mondi possibili, distanti, ma dotati di una qualche realtà materiale. E, in ogni caso, hanno invece legami molto più ramificati e dilatati con le realtà di tutta la cultura figurativa, letteraria e recitativa europea. Oggi non è più possibile osservare il fenomeno del divismo italiano con un’ottica da cannocchiale rovesciato e veder brillare le stelle divistiche nostrane soltanto sull’orto municipale giolittiano. I corpi delle dive attraversano come comete il firmamento del cinema mondiale e ne modificano l’intera topologia e morfologia. Com’è noto il fenomeno divistico non è mai stato al centro degli interessi della critica e della storiografia. Bisogna attendere fino agli anni Cinquanta, ai saggi di Morin (e, in Italia, di Castello che abbiamo citato) per imbattersi nei primi timidi tentativi di osservare il fenomeno nella sua vastità e specificità. Per fortuna negli ultimi anni le cose sono molto cambiate ed è sempre più facile imbattersi in studi interessanti, condotti su fonti di prima mano e sviluppati in funzione di interpretazioni nuove e intenzionate a osservare il fenomeno per la sua rete complessa di legami e influenze. Il tentativo più recente di osservare il divismo nel suo aspetto sovranazionale ha portato alla realizzazione di una ricca retrospettiva dal titolo Star al femminile, coprodotta dalla Cineteca di Bologna e dal Centre Pompidou, accompagnata da un catalogo, simile ma non identico, nelle due edizioni italiana e francese curate da Gian Luca Farinelli e Jean-Loup Passek . La genesi del divismo, grazie agli apporti e agli studi di studiosi di differenti discipline, ci appare oggi come il frutto più completo e maturo di una manipolazione genetica, di una metamorfosi o di una contaminazione di elementi sparsi nella cultura figurativa, letteraria, teatrale e musicale a cavallo del Novecento. Finora se ne sono accentuati i caratteri di dipendenza e filiazione diretta dalla recitazione teatrale ottocentesca, ma sempre più si avverte l’esigenza di riconoscere la specificità e i modi in cui il fenomeno si è emancipato dalla scena teatrale e del melodramma, pur ereditandone dei caratteri ed ha attraversato il cielo dello spettacolo nel secondo decennio del Novecento con una ricaduta sociale di una gittata incommensurabile rispetto a qualsiasi altra forma di spettacolo. A noi interessa qui affrontare il divismo italiano che nel giro di poco tempo diventa fenomeno guida sul piano internazionale: nell’arco di poco più di un quinquennio, a cavallo della Grande guerra, si assiste al battesimo, all’ascesa rapidissima e trionfale e al suo declino catastrofico e irreversibile. Almeno nel suo aspetto iniziale appare sempre più come una dimostrazione da manuale delle Teorie del Caso: un fenomeno non previsto da un’industria che investe contemporaneamente su diversi tavoli, che si diffonde con grandissima velocità e diventa decisivo nel conferire al cinema il ruolo di spettacolo guida, di modificatore di comportamenti, immaginazione e mentalità collettiva. Un fenomeno che trascende qualsiasi disegno e progettualità, le cui proprietà, caratteristiche e conseguenze, sono tuttora ben lontane dall’esser state capite e studiate sia nella specificità italiana che nel più ampio quadro della cultura internazionale del primo Novecento. Va riconosciuto a Vittorio Martinelli, che di recente ha scritto per la Storia del cinema mondiale da me diretta il capitolo sulla nascita del divismo nel cinema muto europeo, il merito, tutt’altro che secondario, di avere contribuito negli ultimi decenni a ristabilire un vero contatto materiale con le dive del cinema muto italiano, di aver riassegnato i ruoli che loro competevano, di averne distinte le carriere e contribuito in modo decisivo a rendercele familiari, a farcele conoscere nella specificità dei loro comportamenti. Interessato principalmente alla storia evenemenziale, affetto da una bulimia inesauribile nei confronti del cinema muto e guidato da capacità fisionomiche e di detection che avrebbero fatto invidia a Giovanni Morelli, storico dell’arte ottocentesco prepotentemente tornato alla ribalta grazie a Carlo Ginzburg, Martinelli ha contribuito, in maniera che non esito a definire fondamentale, a ridar nuova luce e vita a un territorio da tempo considerato perduto e oggetto in passato di facili ironie o pesanti derisioni. Dopo aver ricomposto con certosina pazienza le filmografie del cinema degli anni di guerra e degli anni Venti ha puntato la sua attenzione sugli attori e soprattutto sulle attrici . Il proto-divismo appare all’improvviso nel firmamento cinematografico del secondo 4
5
decennio del secolo (la scintilla è quasi unanimemente individuata al di fuori del cinema italiano nella danza di Asta Nielsen nel film danese Afgrunden, L’abisso, del 1910) e lo accende con l’intensità d’una supernova, esplodendo presto in una miriade di frammenti destinati a ricadere, in un arco di tempo brevissimo, su tutto il cinema mondiale, andando a costituirne quasi il nucleo vitale, il plancton la particola per la comunione e la più perfetta celebrazione del rito con tutti i tipi possibili di pubblico. La diva dello schermo, in apparenza, sembra emergere dal nero assoluto, dal Chaos primordiale di uno spettacolo ancora allo stato informe, dall’incontro di Erebos e Nux, in realtà prende vita dalle costole del teatro, dell’Opera lirica, della pittura e da questi incontri nasce come Hemera, come luce di un nuovo giorno per la scena spettacolare. Questo fenomeno caotico dotato di uno spirito decisamente cosmopolita, d’un blasone e d’un albero genealogico ramificato e con radici culturali profonde ha prodotto un’enorme energia immaginativa, sociale e affettiva la cui memoria è stata però rapidamente rimossa, quasi in base a un patto sottoscritto dalle nuove generazioni, e a orizzonti d’attese che la guerra aveva mutato di colpo. Per cogliere nel modo più pertinente alcune categorie che ci permettano di distinguere la genesi e la parabola di un fenomeno di massa, in un periodo dell’Italia giolittiana chiuso tra la guerra di Libia e la fine della guerra mondiale, bisogna tener conto di quei presupposti destinati a giocare un ruolo tutt’altro che secondario nella formazione dell’ideologia divistica e nella costruzione parallela di una ideologia del pubblico. Dato come scontato il fatto che il cinema comincia già a produrre, in quegli anni, evidenti trasformazioni nel contesto sociale e modifiche nel comportamento di massa, o consente, attraverso l’imposizione delle sue figure di divi-idoli, fughe dal presente e dal reale, per il desiderio collettivo di masse piccolo-borghesi, il cinema eredita, o favorisce, la circolazione e la rapida diffusione di comportamenti esterni, destinati a loro volta a esercitare una grande influenza nel sociale. Il cinema «non tendeva a riprendere l’uomo della strada, ma l’uomo simbolo. La presenza dell’uomo simbolo è una istintiva tendenza alla fotografia di prima pagina del ‘quotidiano’ o del periodico alla moda, e quindi al divismo. E accanto ai re e agli imperatori vedremo come uomini simbolo anche L. Tolstoj e M. Gorkij, G. D’Annunzio, suffragette, combattenti e uomini politici» . Al di fuori del cinema, ma con una perfetta consapevolezza del potere dei mass media di moltiplicare e imporre un’immagine, Gabriele D’Annunzio, fino alla vigilia della guerra, durante e dopo, inventa, con una fantasia inesauribile, una serie di ruoli divistici destinati a diffondersi anche nel cinema come modelli di un’ideologia generale della vita, teoricamente «inimitabile», in realtà, moltiplicabile e riproducibile, sia pure su scala ridotta, in modo assai facile: «Ciò che interessa in D’Annunzio – osserva Ezio Raimondi – è proprio questo aspetto di dramma, di rito sentimentale, così come si proietta all’esterno, tra il grande pubblico che ammira, che sogna esistenze straordinarie […per D’A. c’è sempre] consapevolezza della propria funzione esemplare di eroe, ossia di divo, di fronte a una cultura di massa, solo in apparenza disprezzata. Il mito che egli costruisce di se stesso diviene così un modello, un centro di proiezione e di identificazione, come dicono i sociologi, un transfert del reale e dell’immaginario, che si richiama, in primo luogo, alla giovinezza, secondo un altro schema classico della mass-culture» . Vate di questo passaggio è ancora una volta D’Annunzio, uno dei primi intellettuali europei, a comprendere il potere mitopoietico dei mass media e inventore di una serie di eventi pubblici spettacolari e di ruoli destinati a diffondersi, anche nel cinema, come modelli riproducibili e imitabili di una «vita inimitabile». Accanto a D’Annunzio e ai modelli offerti da personaggi come Andrea Sperelli ed Elena Nuti, i protagonisti del Piacere del 1889, i referenti privilegiati possono essere Alphonse Mucha (per Ma l’amor mio non muore, Il fuoco, La serpe…), Arnold Böcklin (Rapsodia satanica), Gustav Maeterlinck, Hugo von Hofmansthal, James Whistler, Gustave Moreau, Alberto Martini o Augusto Majani, i tessuti di Mariano Fortuny, le opere di Fogazzaro, e di Dumas figlio, la poesia simbolista e crepuscolare di Fausto Maria Martini, le sculture di Rodin o le tele storiche dei preraffaelliti. I frammenti, i lacerti del corpo di decine d’artisti, gli atomi fluttuanti di un’iconografia mistico-erotica, alimentano o fanno da sfondo alle apparizioni divistiche. Che ci possono apparire anche ora come figlie delle protagoniste della pittura preraffaellita ora come sorelle delle donne create da pittori come Burne-Jones, o Arthur Hacker, illustratori come Mucha, Dudovich, Cappiello o scultori come Rutelli e Canonica. Un Olimpo cinematografico abitato, comunque, solo da donne. Gli uomini sono e restano per tutto il periodo 6
7
8
di ascesa trionfale del divismo italiano figure sfocate, secondarie. Al «fattore D», inteso come D’Annunzio, che non è certo l’unico, ma che esercita, per la sua forte capacità di circolazione nei mass media, una indubbia influenza, vanno aggiunti una serie di fattori più specifici. Anzitutto l’evoluzione tecnologica della macchina da presa, l’adozione di obiettivi e di pellicole assai più potenti, e la scoperta della sua mobilità rispetto all’oggetto. Si dilata, in un tempo assai breve, il potere della visione, e il singolo volto, o corpo, o dettaglio, viene ad assumere, nel contesto narrativo, una nuova capacità di concentrazione del senso. In secondo luogo il divismo cinematografico, anche sul piano di pure concezioni dello spettacolo, non nasce certo per partenogenesi: è un fenomeno che, nel campo dello spettacolo, ha alle spalle una lunga tradizione nel teatro e nell’opera lirica e affonda solidamente le sue radici nell’Ottocento. Diretti eredi delle primedonne, dei mattatori, dei «sovrani della scena» i divi cinematografici attivano però una serie di fenomeni sostanzialmente nuovi: il loro ruolo e la loro immagine si sostituiscono con forza, nell’immaginazione popolare e di massa, a quelle più distanti e indistinte dei grandi protagonisti della storia, di quegli uomini simbolo della storia ufficiale di cui si è parlato. Il fatto che, dopo il 1910, importanti attori teatrali come Ermete Novelli o Ermete Zacconi accettino con naturalezza il cinema e così anche alcuni attori teatrali di successo, come Giovanni Grasso, o attrici come Giacinta Pezzana o Eleonora Duse, ha conseguenze assai importanti nella modificazione delle tecniche recitative nel creare, in una fase intermedia, identificazione e riconoscimento tra attore e pubblico. Questo è un gradino intermedio in quanto il divismo cinematografico, nei suoi primi passi, non è altro che una variante o sottocodice di comportamento rispetto al teatro, ma ben presto scopre, grazie alla sua diversa diffusione, un potere assai differente e superiore di trasmissione, anche nel sociale, di modelli di comportamento. Ancora tutte da studiare le influenze sulla recitazione teatrale e cinematografica in Europa di un attore come Ermete Zacconi, la cui portata innovativa è enorme. Le dive o i divi (ma il fenomeno sarà, nel suo aspetto più macroscopico, quasi esclusivamente femminile per quanto riguarda l’Italia) e, pur senza rinunciare a ciò che il teatro aveva in qualche modo canonizzato, tutti i maggiori protagonisti del fenomeno, prendono coscienza, poco alla volta, delle diverse condizioni del lavoro cinematografico e della diversa possibilità di costruzione pubblica della propria immagine. Grazie all’azione combinata e parallela di tutti i mass media, ogni piccolo fenomeno rimbalza a vari livelli e acquista un’evidenza e una capacità di penetrazione del tutto sconosciute al teatro. I ben noti processi di identificazione di cui i sociologi si sono ampiamente occupati creano la possibilità di imitazione e riproduzione del gesto divistico nella vita quotidiana: la pettinatura, gli abiti, il movimento del corpo, delle braccia, diventano fenomeni di degradazione e riproduzione dei modelli cinematografici attorno a cui l’aura magica di determinati ruoli non esclude il pubblico profano dall’accostamento e dalla possibilità di espropriazione di alcuni aspetti del modo di essere del divo. Un altro elemento caratterizzante è la continuità e la trasformazione del sistema gestuale e recitativo: per gli attori che verranno ad assumere un ruolo di primo piano nel periodo aureo del fenomeno, tra il 1913 e il 1919, la novità recitativa è data dallo spostamento dell’asse comunicativo sul piano della corporeità e fisicità. Si tratta di una sorta di continua epifania: l’apparizione del divo comporta l’automatica trasmissione di messaggi di cui si presuppongono le attese. L’occhio della macchina da presa, stabilito un contatto quasi fisico col volto e col corpo dell’attore, ne è totalmente condizionato, l’azione e l’intreccio sono pressoché indifferenti. Il processo di sdoppiamento della personalità dell’attore può raggiungere, come assai bene coglie Pirandello, livelli di alienazione assoluta . La macchina cinema sottrae del tutto l’attore a se stesso e ne crea un’immagine vissuta dal pubblico come reale. Il divo è rappresentato al tempo stesso nella sua distanza e inimitabilità di idolo e nella sua vicinanza fisica, quasi tangibile con lo spettatore. Per un gioco di metamorfosi che affascina D’Annunzio il gesto dell’attore si assimila agli oggetti dell’ambiente e la scenografia a sua volta si anima e si fonde simbioticamente con il corpo divistico in un continuo movimento di degradazione e di ascesi. La riduzione progressiva della distanza, fino all’imposizione del volto e del dettaglio, l’eliminazione degli elementi dello sfondo che non siano funzionali al senso generale del messaggio, che il volto o il corpo intendono trasmettere, la decisa produzione di senso erotico che sprigiona lungo tutto il film: l’immagine della diva o del divo crea una specializzazione della visione, una specie di subordinazione gerarchica di tutti gli 9
elementi alla rappresentazione del corpo dell’attore. Anche le presenze collaterali, le comparse, sono destinate a essere assimilate allo sfondo, o a scomparire come elementi di disturbo. È bene tenere presente che la coscienza del potere significante della microfisionomia non viene mai codificata, e balena solo a sprazzi nella pratica recitativa e registica. Quasi tutti i maggiori divi del muto – a eccezione della Bertini – preferiscono la trasmissione dei propri messaggi attraverso il linguaggio totale del corpo. Quanto alla didascalia, da quando il divismo assume un carattere di fenomeno ufficialmente riconosciuto, viene relegata, nonostante il grosso sforzo di conferirle forti poteri simbolici e significanti, al ruolo di comunicazione interstiziale, di puro indice. Il gesto riesce a portare con sé tutto il carico della comunicazione, ma il gesto è anche collegato a tutto il sistema semiotico, che si sovrappone, degli elementi dell’abbigliamento e dell’ambiente, che vengono sempre più a far corpo unico con la significazione dominante. Il fenomeno assume coscienza di sé quando le attrici cessano di costituirsi come dramatis personae, interpreti capaci di adattarsi a uno spettro assai ampio ed eterogeneo di ruoli, e preferiscono specializzare le proprie performance giungendo alla costruzione di una serie di caratteristiche che si possono riprodurre di film in film e possono essere esportate, con poche varianti, anche in contesti extrafilmici. L’attore – secondo regole già sperimentate con successo nel teatro dell’Ottocento – fonda rapidamente i propri moduli e, a partire da questi, produce una serie di successivi stereotipi. Ciò in omaggio anche alla logica industriale interna al cinema, che vuole identificare e differenziare i propri prodotti. Nella recitazione di un divo conterà soprattutto l’identità e non la differenza, la ripetizione e non la metamorfosi. Tutto ciò può concorrere alla spiegazione del meccanismo divistico, sia nelle forme più eccezionali delle grandi dive, che in quelle più basse del comico e dei serial che non rinunciano certo all’ambizione di essere assimilate al fenomeno, e, di fatto, in alcuni casi, raggiungono analoghi effetti di massa. A dive possono essere promosse, comunque – una volta che il cinema ha cominciato a prendere coscienza dei propri mezzi – donne qualsiasi, oltre che attrici con qualche esperienza e conoscenza teatrale. In ciò un altro aspetto di novità. Emerse a caso da diverse classi sociali le dive assumono un ruolo sociale, incarnano il senso del comportamento di una classe che ha perduto la sua egemonia politica ed economica, ma rimane un modello e punto di riferimento per tutta la cultura europea, teatrale e cinematografica. Ciò che si chiede alla loro individualità è di stabilire un rapporto aggressivo con lo spettatore, di assoggettarlo al loro dominio. Sarà facile ironizzare sul carattere spesso familiare e casereccio di certo erotismo divistico di allora, ma non è certo possibile sottovalutarne la portata sociale. Finora si è puntata l’attenzione sui caratteri per così dire autoctoni del fenomeno divistico, ma è bene, pur senza avere alcuna pretesa di esaurire la casistica delle forze e degli elementi interagenti, tener conto di modelli cinematografici provenienti dall’estero: in effetti giungono in Italia, proprio nel biennio 1911-1912, i film della Nordisk con Asta Nielsen. Dell’importanza di questi film aveva parlato Umberto Barbaro in un saggio ancor oggi assai ricco di suggestioni: «Già nel 1912 Alla porta del carcere ci mostra di Asta Nielsen 60 metri di primo piano. 60 metri di primo piano! Significava aver compreso il cinema come linguaggio nuovo, significa aver scoperto che, con la macchina vicinissima al volto umano, si entra in una dimensione nuova: che al di là dell’espressione visibile a distanza esiste un’espressione più intima e segreta: che esiste una microfisionomia e una micromimica» . Certo l’enormità di alcune soluzioni espressive produce spinte non indifferenti in tutta la produzione a carattere psicologico e drammatico che comincia a muovere i suoi passi più importanti a partire dal 1913. Se osserviamo la produzione precedente vediamo che la recitazione predivistica è improvvisata e abborracciata: i suoi antecedenti sono la pantomima, il circo, il varietà . I primi attori sono guitti dell’avanspettacolo, del circo, o attori improvvisati senza alcuna esperienza. Tutte le forme di spettacolo popolare offrono il loro patrimonio attoriale e il primo cinema vi attinge a pieni mani. Molto presto ci si accorge che la domanda e la diversa misura di scala dello spazio cinematografico rispetto a quello teatrale superano di gran lunga l’offerta. Una vera e propria specializzazione si richiede quando i generi vengono codificati e i film drammatici, più che quelli storici, hanno bisogno di una serie di attori capaci di esprimere i grandi sentimenti. La recitazione iniziale è quella dei manuali dell’Ottocento e si assiste, per alcuni anni, a un vero e proprio travaso della 10
11
12
recitazione teatrale nel cinema. Con questo il cinema viene nobilitato culturalmente, ma stenta a trovare la propria strada, come avviene invece in altri paesi, dove, mancando di una solida tradizione teatrale, si creano subito, da zero, quadri di attori che lavorano soltanto nel e per il cinema.
«femmes fatales» e donne angelicate Il divismo italiano, nei suoi fenomeni più appariscenti – la Borelli forse in misura maggiore della Bertini – è perfettamente funzionale al contesto semiotico e ideologico in cui si colloca. La diva non è dunque solo un corpo, uno sguardo, un insieme di gesti caratterizzati e ripetuti, è, anche, al tempo stesso, l’incarnazione più emblematica di tutto un mondo su cui viene a esercitare un dominio assoluto. Le femmes fatales del primo cinema italiano muoiono e sono dispensatrici di morte («Al primo bacio ella tornò / la pallida vestale della morte, / giunta per la via d’amore / s’incoronò dell’ultimo diadema», Fausto Maria Martini), ma i pubblici di tutto il mondo in quegli anni sembrano preferire una dolce morte tra le loro braccia piuttosto che una morte gloriosa in una delle tante battaglie dell’Isonzo. I gesti delle dive si caricano degli stessi attributi e connotazioni della poesia simbolista: Eros e Thanatos vanno allegramente a braccetto («E l’amò fino alla morte e più in là», Ma l’amor mio non muore) e se da una parte ricorrono simboli erotici come il serpente, il cavallo, l’anello, le armi da fuoco e da taglio, il fuoco, dall’altra vi sono immagini e oggetti che richiamano esplicitamente il sesso femminile: pellicce, la luna, conchiglie, fiori… La donna-diva, grazie al suo fascino, al suo potere sessuale, domina e può distruggere un mondo che possiede il potere economico e politico. In questo motivo abbastanza diffuso risiede certo uno degli elementi di maggiore identificazione del pubblico borghese che trova, oltre al piacere della visione, una sorta di compensazione che lo ripaga delle proprie frustrazioni e sensi di inferiorità. Questo tipo di messaggio, e la cultura che presuppone ed esprime non può avere, in ogni caso, che un destinatario circoscritto che ritrova nel cinema temi e motivi del teatro, della letteratura e poesia simbolista e dannunziana, del melodramma e in senso più ampio della cultura liberty. Viene a cadere il fascino interclassista del film storico, o dei film a carattere decisamente popolare. La condanna morale che accompagna questo tipo di film non può che restringere il destinatario reale. Il pubblico popolare sembra essere escluso dalla fruizione di queste opere; di fatto la fruizione del cinema si allarga proprio grazie ai nuovi modelli di comportamento femminile che questo tipo di film trasmette in alternativa al film storico o mitologico. Tuttavia se misuriamo il fenomeno sul piano internazionale ci si accorge che proprio grazie al divismo italiano i pubblici borghesi di più continenti si convertiranno in via definitiva al cinema. La diva è comunque, per tutto il periodo, il prodotto di una tensione ideale e intellettuale, incarna valori supremi della bellezza, e quanto più la storia preme alle porte tanto più si fa portatrice di valori astorici e assoluti, si fa interprete di una cultura che non intende essere coinvolta nella storia. Il suo corpo diventa il punto notevole o il nucleo entro cui si fondono le forze e le tensioni culturali, letterarie e iconografiche del primo Novecento. Il punto di massima culminazione critica di un discorso sul divismo, funzionale all’idea di cultura e al mondo di cui si è parlato, mi pare raggiunto in un articolo apparso nel 1916 su «Apollon»: «Noi l’attendiamo ancora la creatura sovrana, la creatura ideale, foggiata dalle passioni e dai sogni che saprà darci, nell’arte nuova, col muto linguaggio che a essa è proprio, la rivelazione suprema della bellezza… sarà pure essa umana creatura di carne caduca, ma una smisurata potenza di vita ideale si esprimerà da lei, pulserà col ritmo stesso del suo respiro» . Quanto alle fondamentali tipologie e morfologie di derivazione letteraria, artistica e teatrale se ne possono individuare almeno le seguenti che rispondono anche a degli esseri rappresentativi dei quattro elementi, la terra, l’aria, l’acqua e il fuoco: La femme fatale, la donna dominante e distruttiva, la donna pura, angelicata e sottomessa e la madre, ossia la rappresentazione della femminilità nella sua forma più alta e completa, la donna capace dei sacrifici più sublimi. La femme fatale, o la donna gufo, la donna vampiro, la donna cacciatrice e animale notturno, la donna serpe o tigre reale, la donna Sirena, la donna mantide, la donna piovra, la donna diabolica, la donna affetta da sindrome di Don Giovanni, la «donna delinquente» lombrosiana, l’essere dotato d’uno sguardo che paralizza, un bacio che avvelena e di un abbraccio che soffoca e precipita negli abissi del peccato, è 13
senz’altro la figura vincente nel momento del massimo splendore divistico, quella che irride alle leggi morali, disprezza la maternità, trasgredisce le convenzioni sociali, «fa mille e mille follie», come la protagonista di Thaïs di Bragaglia. Questa donna sessuata in ogni minima parte del corpo («Tota foemina sexus»), in grado di svuotare l’uomo di ogni creatività, di levargli oltre che il sangue anche la linfa vitale (vedi Il fuoco di Pastrone), è capace di dar vita ai propri sogni giungendo a realizzare le più nascoste, inconfessabili e primitive pulsioni erotiche, disgiungendole da qualsiasi impulso riproduttivo. La sua «follia» è data dall’eccesso di sessualità repressa e sempre pronta a esplodere. Simili alle donne fatali le figure della bella sconosciuta, vestale dell’eterno femminino, possono anche in alcuni casi avere funzioni salvifiche e non solo ctonie e comunque non aspirano alla distruzione dell’uomo. La belle dame sans merci, o femme fatale su cui Colette ha scritto un articolo memorabile sulla rivista «Excelsior» del 1918 («1. La femme fatale è quasi sempre scollata. 2. È spesso armata di una siringa di Pravaz, o d’un flacone di etere. 3. Gira sinuosamente il suo collo di serpente verso lo spettatore…»), quella che verrà definita poi come donna vampira (la Vamp che troverà in Theda Bara la propria rappresentante ideale ), la crudele e spietata dominatrice dei destini degli uomini che per loro sfortuna entrano nel raggio del suo sguardo di essere rapace e spietato (Pina Menichelli rifulge in questi ruoli, come vediamo benissimo nel Fuoco o in Tigre reale, ma sa anche trasformarsi, come Turandot in un’amante dolcissima e sottomessa o in una donna disperata che chiede aiuto per non precipitare nel baratro e questo aiuto le viene negato, come in Storia di una donna di Eugenio Perego del 1920). La donna angelicata è la figura antitetica e complementare della donna fatale è per lo più un essere asessuato (come Fede del Fauno), è fragile, indifesa, casta e pura, in lei si possono riconoscere tutte le virtù dell’angelo del focolare, ma anche quella della docile vittima, che offre ingenuamente l’immacolato candore del suo corpo e della sua anima ed è destinata al sacrificio (l’esempio più evidente, oltre a quello di Dorina di Addio giovinezza!, è quello di Elda di Caino). È una donna che si presenta come dolce discendente di Ofelia o di Cenerentola: è l’innamorata che soffre nell’ombra ed è pronta a sacrificare il suo amore sull’altare delle leggi sociali e che, in alcuni casi, può anche essere premiata (nel cinema italiano basti ricordare da una parte Addio giovinezza!, dall’altra Scampolo). Una variante intermedia è data dalla figura di Lolette Cassagne della Donna nuda di Gallone, in cui la giovane modella interpretata da Lyda Borelli è pronta a ogni tipo di sacrificio e accetta il tradimento esibito sfacciatamente pur di salvare il suo amore, fino a decidere di darsi la morte («Ebbe l’idea di finirla con la vita»). Alla fine però opta per la vita, tornando ad accettare il corteggiamento dell’uomo che l’aveva amata per primo («E ritornò alla vita, sorretta e compresa da chi non l’aveva scordata mai»). Poi c’è lafemme de nulle part, la bella sconosciuta e misteriosa, la donna priva di radici e di un’identità sicura (oltre ai personaggi interpretati da Musidora, Lil Dagover mi sembra l’attrice che ha amato rivestire ruoli di questo tipo, ruoli che nel cinema italiano ha assunto Elena Makowska). La sposa di Satana, la donna che scende a patti con il Demonio, la Carmen di Mérimée e Bizet interpretata da Pola Negri, La lupa di Verga, l’Alba d’Oltrevita di Rapsodia satanica, la donna serpe del film omonimo con la Bertini, che conduce alla perdizione secondo i buoni principi della morale cattolica. La donna-madre, depositaria e garante a ogni costo dei valori della famiglia e addirittura della Patria (la galleria qui è consistente si va dalla Duse di Cenere, a Soava Gallone di Maman Poupée a Henny Porten in decine di ruoli, alla grande Bernhardt di Mères françaises). La donna-madre è per qualche tempo la figura meno popolare, quella che le dive in ascesa evitano di interpretare, anche se la sua tipologia rientra perfettamente nella sindrome pucciniana: questo ruolo richiede il più delle volte il totale sacrificio di sé per il bene del figlio (Cenere, Odette) e in ogni caso la maternità non è quasi mai vissuta come completa e naturale realizzazione di sé, ma come una colpa da espiare o vedendosi sottrarre il proprio figlio potendo al massimo rivederlo dopo anni senza rivelare la propria identità (Odette), o accogliendolo tra le proprie braccia per assistere alla sua morte (La piovra). In genere le madri vengono private dei figli per i motivi più diversi e il dramma nasce proprio dalla sottrazione e dalla perdita. Le madri nel cinema giolittiano sono le maggiori produttrici di pietas, prima che di pathos e sono per lo più vittime privilegiate che piegano il capo e accettano le leggi del destino con pochissimi moti di ribellione. 14
Le femmes fatales muoiono, ma non sono mai vittime e non cercano nella morte la redenzione. Sono piuttosto dispensatrici di morte come le eroine del melodramma. Tenendo conto che proprio gli anni di guerra vedono l’apoteosi in Italia e nel mondo delle grandi dive è fin troppo ovvio sintetizzare una sensazione dominante di fronte alla disparità dei poteri tra i corpi d’armata e i corpi gloriosi delle dive e sostenere che la geografia dell’immaginazione di una parte consistente del pubblico cinematografico è più modificata dalle panoramiche ravvicinate sui corpi divistici piuttosto che da quelle sui campi di battaglia. Inoltre – anche se i grandi fenomeni di immedesimazione e di modificazione dell’immaginario si producono sul pubblico femminile – non c’è dubbio che, se proprio potesse scegliere, il pubblico maschile preferirebbe la follia d’amore o la «petite morte» tra le fiamme della passione o le braccia avvolgenti come i tentacoli di una piovra piuttosto che impazzire per lo scoppio di una granata, o subire una morte anonima tra le forre o negli spazi labirintici delle trincee del Monte Fior, dell’Ortigara o della Somme. I corpi delle femmes fatales, o degli «idoli della perversità», come li ha chiamati Bram Dijkstra , subiscono però, in prossimità della guerra, alcune profonde e significative metamorfosi, prestandosi a divenire oltre che gli involucri effimeri delle sacerdotesse di morte, anche le rappresentazioni gloriose di divinità protettrici e salvifiche, o madri dolorose (Mater dolorosa di Abel Gance del 1917 sarà il più grande successo cinematografico francese di quell’anno). Gli stessi corpi femminili, che non temono di aprirsi a patti con Satana, possono dunque anche protendersi deitticamente verso la strada dell’eroismo e della gloria. Anche se la nostra attenzione si concentrerà sulle dive che conservano ancora a distanza di quasi cent’anni la loro «aura», ci troviamo di fronte a un vero e proprio esercito di Eve tentatrici, di Sirene, di Ofelie, di Circi, di Diane, di Salomè, di figure flessuose, dalle labbra prensili di un fiore carnivoro, e dagli occhi capaci di uccidere e paralizzare come Medusa, giunge a cavallo della luce, converge verso gli spazi dello schermo e prende possesso del cuore della produzione e degli spettatori. Da Ma l’amor mio non muore a Storia di una donna, a Fior di male, il cinema distilla gli umori, restituisce i profumi, lo spirito di superficie e profondo del proprio habitat culturale e artistico: le lunghe chiome della Borelli sembrano ritagliate dalla Beata Beatrix di Dante Gabriele Rossetti, mentre certi primi piani della Bertini ci appaiono come riproduzioni di quadri di Klimt (la Salomè, ad esempio). Se i movimenti borelliani in Rapsodia satanica richiamano gioielli o composizioni di Lalique, immagini ricorrenti di donna tigre, o donna leopardo sono citazioni di quadri di Fernand Khnopff (come La Sfinge, per esempio). Altre apparizioni della Borelli, in film come Carnevalesca, trasportano di peso sullo schermo le protagoniste di quadri di Boldini, De Nittis, e ancora la morte di Francesca Bertini in Odette i gesti di passione di Pina Menichelli nel Fuoco o in Tigre reale o di Soava Gallone e Maria Jacobini e delle altre dive possono richiamare l’Ofelia di John Everett Millais, le Salomè di Beardsley o La toeletta di Goodward, i manifesti di Chéret o Mucha, o le forme dei rappresentanti più significativi dell’Art Nouveau, da Hoffmann a Guimard a Horta. Se tutto il fenomeno si riducesse però a un puro travaso di forme o a un processo di metamorfosi da un sistema iconografico o poetico non ne capiremmo la portata e l’influenza internazionale. Di fatto a scatenare la macchina desiderante collettiva è la serie di celebrazioni della forza dei sensi, del sesso e delle leggi di natura, che la donna riesce a interpretare, diventando sacerdotessa e consapevole vittima di tutti i riti in onore di Eros. Da ultimo la possibilità di imitare anche parti minime del corpo divistico: un gesto, un modo di vestire, brindare, abbracciare, baciare. La donna che si metamorfizza di continuo: che diventa indifferentemente farfalla o libellula, o fiore o fiamma, la donna vestale, la donna libera di esprimersi attraverso il linguaggio del corpo, un corpo tutto dedicato alla religione della danza e dell’arte la cui massima rappresentante sarà Loie Fuller (le cui danze serpentine sono immortalate dal cinema già nel primo decennio del Novecento): grazie al suo esempio si passerà poi ai movimenti delle braccia come ali di farfalla di Lyda Borelli come abbiamo visto in Rapsodia satanica alle danze di Mistinguett, di Paulette Paulaire o di Josephine Baker negli anni Venti. Il cinema delle dive, nonostante una lunga tradizione critica cerchi di minimizzare questo aspetto, ha modo, esplorando i primi piani e cercando il contatto ravvicinato, di intravvedere l’«oltre» di cui parla Serafino Gubbio, l’operatore del romanzo di Pirandello I quaderni di Serafino Gubbio operatore del 1916, di percepire elementi significativi del paesaggio interiore, di tentare di scandagliare i misteri dell’anima a cui da qualche 15
tempo si dedica la scienza sua coetanea creata dal dottor Freud, ha il privilegio, unico tra le arti, di cogliere quelle caratteristiche di «fotogenia» messe in luce da Louis Delluc all’indomani della guerra mondiale proprio parlando delle dive italiane. Per Pietro Bianchi, che alle dive italiane del muto ha dedicato alla fine degli anni Sessanta il primo tentativo di ripescaggio e di risistemazione del fenomeno in un libro ancor oggi godibile per qualità della sua scrittura, e utilizzabile per la sua ricchezza di riferimenti e di aneddoti (un saggio che è anche un viaggio à rebours nel proprio vissuto infantile), il successo divistico inizia già con la guerra di Libia. In altri termini, quando la produzione si assesta su una durata media di duemila metri e il cinema comincia a esplorare, a tutto campo, le proprie possibilità narrative. La periodizzazione di Bianchi o di altri storici che si sono occupati del divismo è ancora accettabile – con qualche correttivo che sposta il fenomeno in avanti di un paio d’anni per quanto riguarda la sua «esplosione» e affermazione internazionale – così come assai utili sono le impostazioni di opere come quella appena citata che ricorrendo a una vasta aneddotica non sono troppo attendibili sul piano storiografico, ma hanno il merito di suggerire le relazioni tra gli oggetti del discorso ripescati dalla memoria, e non più rivisitati concretamente, e il contesto storico. 16
dive e divine Il divismo italiano è ricco di nomi, ma vive e raggiunge i suoi fasti grazie soprattutto alla presenza di Lyda Borelli e Francesca Bertini. Queste due attrici esprimono, al livello più alto e rappresentativo, tutti i motivi dominanti di un fenomeno che solo in parte l’industria saprà e riuscirà a sfruttare nella pienezza delle sue possibilità. L’apparizione sulla scena cinematografica della Bertini e della Borelli produce vari effetti: dal mutamento delle strutture produttive, a quello dell’atteggiamento della critica, alle risposte del pubblico. Non è tanto la qualità della loro recitazione a colpire critica e pubblico, quanto la forza della carica simbolica del loro linguaggio corporeo. Della specificità di questo linguaggio si accorge, nel 1916, Antonio Gramsci : in uno dei pochi riferimenti al cinema di tutta la sua opera scrive di Lyda Borelli: «Questa donna è un pezzo di umanità preistorica primordiale. Si dice di ammirarla per la sua arte. Non è vero. Nessuno sa spiegare l’arte della Borelli perché essa non esiste. La Borelli non sa interpretare nessuna creatura diversa da se stessa… La Borelli è l’artista per eccellenza della film in cui la lingua è il corpo umano nella sua plasticità sempre rinnovantesi» . Della Borelli, dell’unicità del suo gesto hanno parlato tutti coloro che si sono dedicati al cinema muto, da Sadoul («la sua gesticolazione appassionata è espressiva e forte come le danze sacre giavanesi») a Castello, da Montesanti a Palmieri a Verdone e a Gerardo Guccini. Antonio Chiattone ha avuto tra i primi il merito di essere riuscito a collegare il gesto della Borelli al sistema semiotico complessivo dello spazio della sua recitazione: «I gesti, i passi, i movimenti del capo della Borelli, vero arabesco vivente, erano calcolati non solo per l’espressione di un sentimento, ma anche per armonizzarsi con i volumi delle scenografie e i gesti del partner e delle comparse» . L’influenza della Borelli sulla recitazione cinematografica successiva è paragonabile a quella esercitata verso la metà dell’Ottocento dal Prontuario delle pose sceniche di Alamanno Morelli. Con, in più, il valore aggiunto d’aver attizzato nel fuoco dello schermo, per la prima volta, disponendoli quasi con azione concentrica, i raggi dell’immaginazione romantica, melodrammatica, decadente e simbolista. In pratica Lyda Borelli entra in scena, una scena ancora di tipo teatrale, invoca e convoca, attraverso la macchina da presa gli sguardi degli spettatori e delle spettatrici, con un solo gesto accende la scintilla del desiderio collettivo: ed è subito e per sempre diva. La Borelli passa naturalmente dal teatro al cinema e nei suoi confronti i fenomeni di culto collettivo esplodono fin dal primo atto cinematografico in cui il suo modello divistico è perfettamente definito e formato. Da subito incarna nel modo più rappresentativo il ruolo di sacerdotessa di una nuova religiosità. Lyda Borelli segna una tappa fondamentale nell’evoluzione del cinema muto italiano: dal suo modello di recitazione, dai suoi gesti più ricorrenti nasce una tipologia del gesto destinata a riprodursi, a ripetersi e a moltiplicarsi lungo l’arco di tutto il sistema cinematografico. «Splende, nell’Italia di Giolitti – scrive E.F. Palmieri – la suprema, divina Borelli» . Più che su ogni altra diva contemporanea agisce, attorno alla Borelli, un’aura culturale ricca di echi e di riferimenti, dal liberty alle forme più facili e vulgate del decadentismo e del 17
18
19
20
21
simbolismo, agli indubbi influssi preraffaelliti: «Il diffuso gusto figurativo, era frutto di un preraffaellismo mal digerito e anche il nostro cinema si ispirava ai principi estetici di quella scuola, diventati luogo comune, tanto che una bella fotografia di Lyda Borelli, in languida posa, poteva suscitare le medesime sensazioni di una Beata Beatrix di Dante Gabriele Rossetti» . Più che con i preraffaelliti Lyda Borelli va correlata con la cultura figurativa e l’immenso repertorio iconografico che emerge dai manifesti di Alphonse Mucha e Dudovich e dai gioielli di Lalique, dalle torsioni di una natura in costante metamorfosi che emerge dai ferri battuti e dalle vetrate di Luis Comfort Tiffany. Il suo corpo traduce e distilla tutti gli umori della cultura europea che precede la guerra mondiale. Un esercito di Eve fatali, di Sirene, di Pandore, di dolci Ofelie, di Circi, di Diane, di Salomè, di Lulù, di Carmen, di Nanà, di figure flessuose come una pianta di clematide, o dalle braccia prensili di un fiore carnivoro, fluttua verso gli spazi dello schermo e prende possesso del cuore della produzione, oltre che di quello dello spettatore. Il fascino della sua recitazione, quel suo frenetico aggrapparsi alle tende, se può a distanza di tempo apparire come il portato di una civiltà sepolta e far «tener la pancia al pubblico dal gran ridere» (come ricorda Antonio Baldini in una impietosa recensione a Ma l’amor mio non muore in «Scenario» nel 1933) non può impedirci di riconoscere che il suo modo di recitare costituì un archetipo, un modello capace di codificare e produrre una morfologia di gesti, di tic e di situazioni diffuse in centinaia di opere successive. È la Borelli, forse, che per prima – più ancora della Nielsen – crea e diffonde il rito laico della comunione con il corpo e col sangue del divo a cui si sottoporranno dalla seconda metà degli anni Dieci, milioni di persone settimanalmente in tutto il mondo. In una fase della storia culturale europea che stava per essere prepotentemente travolta da nuove esigenze, favorite, su piani diversi, dalla prepotente diffusione della psicanalisi e della furia dissacratrice delle avanguardie, il gesto della Borelli e delle altre dive, che certo appartiene a quel «cinema isterico» di cui parlava Salvador Dalí , riesce a coagulare, produrre e divulgare, sul piano di massa, atteggiamenti ideali, modi di vita, desideri coscienti, proiezioni inconsce, di un mondo che cerca di ritrovare nel cinema il prolungamento fittizio di riti e comportamenti privilegiati che la guerra cancella di colpo e per sempre. Un atteggiamento comune agli storici del periodo – preoccupati soprattutto di collocare «la donna fatale» entro ambiti casalinghi e di privarla di quell’alone di maledettismo che ingenui scenari e pompose didascalie (si pensi al Fuoco di Pastrone, o a Thaïs di Bragaglia) cercavano di suggerire – è quello di difendere la propria intelligenza (o quella del lettore) mediante il filtro costante dell’ironia. Oggi – per fortuna – gli storici e studiosi delle nuove generazioni non provano più alcun complesso, né devono pagare alcun tributo all’eredità crociana e il divismo assume un ruolo chiave per le loro ricerche e per la possibilità di ricomporre un tessuto culturale e storico più ricco possibile. Anzi si tende sempre più a riconoscere ad alcune dive nazionali un ruolo di leader sul piano mondiale. In effetti il divismo italiano, espressione di un mondo che la guerra travolge, celebra i suoi anni d’oro e si afferma potentemente in molti paesi – dalla Francia e Spagna al Brasile e Argentina, dall’Olanda alla Russia – proprio tra il 1915 e il 1918. Poi, con la fine della guerra trova, sulla sua strada, l’ondata di marea montante del cinema americano da cui verrà inesorabilmente travolto. La filmografia della Borelli, rispetto a quella della Bertini o di altre dive del muto, non raggiunge la ventina di titoli e va dal 1913, l’anno di Ma l’amor mio non muore, al 1918 (La leggenda di Santa Barbara) un film di propaganda bellica. I suoi registi preferiti sono Carmine Gallone (La donna nuda, 1914; Il bosco sacro, Fior di male, Marcia nuziale, 1915; La falena, Malombra, 1916 e La storia del tredici, 1917), Mario Caserini con cui raggiunge subito il successo in Ma l’amor mio non muore del 1913 e chiude quasi la carriera in Una notte a Calcutta del 1918. I suoi partner preferiti Mario Bonnard, Amleto Novelli, Livio Pavanelli, Ugo Piperno. La galleria dei personaggi a cui dà vita la Borelli è sostanzialmente omogenea, il satanismo dei suoi gesti e dei suoi sguardi, l’esaltazione dell’amour fou, la sua recitazione in vicende torbide e costantemente cariche di sensualità, ne fanno l’interprete ideale non tanto e non soltanto del clima dannunziano, quanto di una letteratura che da Wilde poteva giungere fino a Henry Bataille e a Luciano Zuccoli. La possibilità di vedere oggi la maggior parte dei film da lei interpretati ci consente di capire il suo tentativo di servirsi dell’occhio della macchina da presa per esplorare non solo le superfici del corpo, ma le dimensioni più profonde e invisibili dell’anima e della psiche, per cercare di dare visibilità ai turbamenti, agli sconvolgimenti interni 22
23
prodotti dalle passioni, ma anche dalla follia, o da forme di vera a propria possessione come in Rapsodia satanica e Malombra. Con ogni probabilità è con Fiore di male di Gallone che la Borelli tocca il registro più ampio delle sue possibilità interpretative all’interno di una storia melodrammatica che declina il sentimento d’amore in vari modi, che parla di colpe, lotta per riscattarsi, agnizione e morte. Con Oxilia gira nel 1915 Rapsodia satanica riuscendo a combinare perfettamente il senso della fisicità della passione, del dérèglement de tous les sens e della volubilità e leggerezza di alcuni sentimenti. Un contemporaneo di Gramsci, Ottorino Modugno, nel sottolineare negativamente fisicità ed erotismo della Borelli, ne condanna proprio gli elementi che più la caratterizzano: «Lyda Borelli ha creduto, ma non ha compreso, come alla parola debba supplire il gesto. E non si è persuasa che anche il gesto debba essere contenuto entro determinati limiti di verità… altrimenti si fa concorrenza ai contorsionisti dei circhi equestri… Lyda Borelli si è ostinata a voler creare una originale psicologia muta, ma tutte le sue eroine, da quelle di Bataille alla Malombra di Fogazzaro sono semplicemente donne fisiche… che svengono per un bacio, e che per un altro bacio si danno incoscienti all’uomo… che le bacia. Resta la maccanica del suo corpo flessuoso…». Aveva in parte ragione Gramsci quando spostava l’attenzione dalla chiave estetica a quella sociale. Oggi di fatto non possiamo non ammirarne l’intelligenza nell’adattare la sua recitazione al nuovo mezzo (a questo proposito rinvio al bel saggio di Francesco Guccini Tecnicismi borelliani apparso sul n. 7 di «Cinegrafie»), lo sforzo interpretativo di tradurre e trasmettere le tensioni interiori, quello di rendere visibili, attraverso il linguaggio del corpo, movimenti della psiche, dissociazioni della personalità, tempeste dell’anima. Le donne interpretate da Lyda Borelli non rappresentano mai del tutto la femminilità primitiva, cannibalesca, quella temuta da gran parte del pensiero maschilista del primo Novecento: i richiami del corpo sono spesso imbrigliati e assoggettati a più forti esigenze dell’anima. E insieme la Borelli fissa alcuni canoni della moda, indica come indossare un vestito o un cappello, come far risaltare il suo corpo e come passare dal gesto comune a quello di più vaste intenzioni simboliche. Con la Borelli il corpo femminile non è solo una centrale di energia erotica e di passioni travolgenti, ma la soglia che deve condurre all’esplorazione dell’anima femminile.Vale la pena di ricordare anche quello che diceva di lei Matilde Serao, che ne esaltava così la varietà di espressioni: «Mai essere umano, mai essere femminile, seppe tramutarsi così profondamente nelle linee, nelle espressioni…». Senza abbandonare la frontalità della recitazione, anzi quasi riproponendo alcuni moduli recitativi già collaudati a teatro fin dal suo film d’esordio cinematografico, Ma l’amor mio non muore di Caserini, la Borelli esegue una serie di movimenti delle braccia e del corpo, che ne modulano la gamma dei sentimenti e comunicano, in modo esemplare, il trascorrere dall’innamoramento all’amore alla passione travolgente e irrefrenabile. In Rapsodia satanica la diva riesce ad aggiungere alla materialità della passione fisica anche la rappresentazione della levità e caducità di alcuni sentimenti. Quando le sue braccia si allargano quasi a liberare il corpo dai veli e a imitare i gesti della farfalla, a divenire giglio o nuvola, si può dire che raggiunga un grado di stilizzazione imprevisto – che richiama Loie Fuller e Isadora Duncan – e che, fino a quel momento, è stato espresso dalla grafica, dalle arti applicate e dalla poesia. Nella parte centrale, quando la protagonista sente che il «desiderio batte alle porte del cuore» e si abbandona al «delirio di giovinezza» i suoi gesti e il suo corpo, che sembra aver riacquistato la forza e il fuoco dei sentimenti e la purezza perdute, riescono a produrre nella maniera più solenne ed emblematica una comunione rituale col pubblico. E la sua interpretazione della dissociazione della personalità di Marina di Malombra, la protagonista del romanzo di Fogazzaro, richiama una teoria di eroine dannunziane dalla Gioconda alla Fiaccola sotto il moggio alla Città morta. La stessa Borelli, nel 1917, parlando della possibilità di portare sullo schermo Forse che si, forse che no, così scrive al suo produttore: «Io vedo già Isabella appoggiata alla fusoliera dell’aeroplano, mezzo guantata nella tunica grigia, tutta chiusa nel grande mantello grigio a mille pieghe morbidissime, che la fa assomigliare alla Vittoria di Samotracia o a una miracolosa farfalla dal volto ermetico sotto le due alette di mercurio nell’ondeggiare del gran velo grigio». La Borelli è la diva che meglio riesce a condurre gli spettatori nei labirinti e nelle zone oscure dei sentimenti, a dar consistenza fisica ai fantasmi del desiderio femminile, rispondendo alle voci interiori, giocandosi sempre tutto, anche la vita, per un attimo d’amore. Nella maggior parte le sue eroine sono proprio le Superdonne di cui si è parlato, degne di competere col Superuomo dannunziano (ma anche di Nietzsche,
Lombroso, Nordau, Wagner) talmente affette da bulimia vitale, pur nei loro languori e nelle loro crisi esistenziali, da non temere faustianamente, come avviene in Rapsodia satanica, di stringere un patto col diavolo per riconquistare l’eterna giovinezza. C’è nella sua prismatica rappresentazione di un unico personaggio che incarna il mistero dell’eterno femminino la capacità di coglierne le essenze più profonde. Anche se – rispetto ai personaggi interpretati da Asta Nielsen, quelli della Borelli e in gran parte della Bertini, non risulteranno mai pienamente padroni del proprio destino. La Borelli e la Bertini sono attrici che inventano un nuovo stile cinematografico perfezionando o trasferendo, con opportune modifiche, un modo di recitazione già messo a punto nel teatro, dove continuano una regolare e parallela attività. Nei loro corpi si concentrano al grado più alto le essenze di un’epoca che la guerra mondiale spazzerà in maniera definitiva e irreversibile. Si potrebbero definire delle sorte di creature angeliche che possiedono in sé sia il bene che il male e che si affacciano alle soglie della modernità indicando una strada che ancora non possono percorrere. Entrambe queste dive rimangono le teste di serie del divismo del cinema muto italiano: il loro potere sul pubblico procede di pari passo col potere contrattuale acquistato nei confronti dell’industria ed è continuato anche in una fase in cui l’industria inizia la sua parabola discendente. Francesca Bertini ha – rispetto alla Borelli – un’esperienza recitativa in un certo senso più ampia e completa: da una parte, come la Borelli, la Menichelli e altre è l’interprete del demi-monde e del mondo del decadentismo, dall’altra porta un contributo decisivo alla recitazione naturalistica («In Assunta Spina – scrive la Bertini nelle sue memorie – seppi essere modernissima e introdussi nel cinema il realismo») , ma si può muovere a tutto campo, dal dramma alla commedia alla pantomima musicale (Histoire d’un Pierrot di Negroni del 1913 in cui recita la parte maschile di Pierrot) . La Bertini accompagna il cinema muto italiano dalla sua nascita e i ruoli che ricopre risultano per anni molto eterogenei. Il primo film in cui appare con un ruolo significativo è Salomè del 1910 (un mese prima aveva interpretato il ruolo di Eleonora nel Trovatore) e oltre che per l’esibizione nella danza del ventre viene notata da Lucio D’Ambra nella scena della crocifissione quando «abbandona sulla spalla destra la sua bella testa dalla quale precipita a terra una meravigliosa pioggia di capelli d’ebano». Anche nel momento del suo massimo fulgore la sua gamma di ruoli oscilla tra le grandi donne fatali e i personaggi popolari della letteratura post verista. I suoi registi preferiti sono, in ordine cronologico, Baldassarre Negroni (Idillio tragico, 1912, L’arma dei vigliacchi, Histoire d’un Pierrot del 1913), Emilio Ghione che aveva avuto accanto come partner per alcuni anni (Idolo infranto, 1913; Nelly la gigolette, 1914; Don Pietro Caruso, 1916), Gustavo Serena (Assunta Spina, La signora delle camelie, Ivonne la bella della «danse brutale», 1915), Giuseppe De Liguoro (La perla del cinema, Nel gorgo della vita) e negli ultimi anni il suo regista preferito diventa Roberto Roberti (Anima allegra, La contessa Sara, La serpe, La sfinge, 1919; Ultimo sogno, La giovinezza del diavolo, 1922; La blessure e La fanciulla di Amalfi, 1925). Per certi aspetti più moderna della Borelli (che però con i suoi pochi titoli apre la strada all’esplorazione degli abissi dell’anima), con un ventaglio di possibilità recitative a sua disposizione molto ampio, la Bertini porta nel cinema la logica delle mattatrici del teatro naturalista, la capacità di entrare e uscire con estrema naturalezza dai suoi personaggi e di dominare una vasta gamma di comportamenti. E se la sua recitazione ha una forte componente naturalistica che le consente di entrare nei ruoli più diversi ci lascia anche, in Mariute di Bencivenga (1918), uno degli esempi più interessanti di parodia divistica e di metacinema di tutta la storia del cinema muto. Non solo l’attrice riesce a rifare il verso a se stessa, ma a offrirci tutta una serie di elementi indispensabili per capire i modi di realizzazione cinematografica e il funzionamento del meccanismo divistico. E inoltre, come del resto ha fatto la Borelli, con questo film offre un suo personale contributo alla causa bellica. Il cinema esalta la fotogenia (secondo la definizione di Delluc) di Francesca Bertini, la macchina da presa si accosta al suo volto per esplorarne le dimensioni interiori. L’energia interiore che questo volto sprigiona in memorabili sequenze, da Assunta Spina a La Serpe a Odette offusca rapidamente nel mondo il ricordo del modello Asta Nielsen. Nel 1916 il critico francese Paul Féval così scrive di lei: «È strana, è unica, e si può dire senza paura di sbagliarsi che se qualcuno l’eguaglierà un giorno, nella molteplicità delle sue metamorfosi, sembra impossibile che potrà superarla». Se la Borelli è l’interprete più significativa della cultura liberty e simbolista, la Bertini è attrice più duttile, dotata di una sensibilità più moderna, il cui esempio continuerà a vivere a lungo 24
25
e a trovare ideali eredi in Greta Garbo o in Anna Magnani, ad esempio. Alcune delle sue eroine, a partire da Assunta Spina, tentano come possono di diventare padrone di se stesse e del proprio destino. In un ultimo confronto diretto si può anche dire che la Bertini è un essere legato alla terra e all’acqua che si muove orizzontalmente in ambienti diversissimi, ma per lo più reali, mentre la Borelli è piuttosto legata ai segni del fuoco e dell’aria e le sue sono traiettorie verticali in quanto dinamiche interiori dei suoi film la spingono verso l’estasi amorosa o verso il descensus ad inferos e gli abissi dei sensi. Se i modelli di riferimento per la creazione dell’iconografia e iconologia divistica sono molti, è curioso – ma tutto sommato ovvio – come il cinema liberty e simbolista ignori quasi del tutto le contemporanee eroine dei romanzi di Colette, Claudine per tutte, le cui caratteristiche sembrano proiettarsi talmente in avanti da costituire un modello per un tipo di donna destinato a entrare nell’immaginazione cinematografica solo alcuni decenni più tardi. La descrizione che fa Claudine di se stessa in Claudine à l’école del 1900, oltre a colpire per la sua modernità, ci mostra una strada divistica che il cinema imboccherà solo dopo alcuni decenni, grazie a Roger Vadim e alla sua capacità di creare dal nulla il mito di Brigitte Bardot: «Anche i miei capelli valgono la pena di essere mostrati, giacché formano una massa irrequieta di riccioli, il cui colore muta, secondo il tempo, dal castagno scuro all’oro bruno e contrasta in modo non brutto con i miei occhi color caffè scuro. Benché ricci i miei capelli mi arrivano quasi fino alle reni e non ho mai portato la treccia né la crocchia, perché la crocchia fa venire il mal di capo e le trecce non mi incorniciano bene il viso; quando ci esercitiamo alle parallele raduno la massa dei miei capelli che mi farebbero acchiappare subito e li annodo a coda di cavallo». Fa eccezione, in questi anni, Maria Jacobini della seconda edizione di Addio giovinezza! (Carmen Boni sarà l’interprete della terza edizione) in cui contrappone la sua freschezza e semplicità di sartina innamorata di uno studente al fascino vampirico della donna alto-borghese dal corpo fasciato di lamé, o avvolto da un boa di piume di struzzo, che irretisce il giovane nelle spire delle sue volute di fumo e lo paralizza con i suoi semplici battiti di ciglia. L’innegabile effetto della sindrome pucciniana appare come uno dei denominatori comuni nella filmografia di diverse dive e come un modo per legare la tradizione melodrammatica ai problemi della modernità, cercando di arginare insieme le teorie evoluzionistiche e quelle psicanalitiche. La sindrome pucciniana è stata felicemente definita da Daniele Martino in Catastrofi sentimentali come «quell’intreccio perfetto e perverso di sentimenti, di conflitti, di sofferenze e di catarsi, che preesiste alla drammaturgia pucciniana, sopravvive in forma nuova anche dopo Puccini e viene travasato nel cinema ed è uno straordinario elemento propulsivo» . Le altre dive o divi che contribuiscono e partecipano allo sviluppo del fenomeno hanno, per lo più, un successo e un’influenza assai più circoscritti. Tra tutte le altre dive con ogni probabilità quella che brilla per una luce di poco inferiore è Pina Menichelli di cui possiamo ricordare sinteticamente (Scuola d’eroi, 1913; Retaggio d’odio, 1914; Il fuoco, 1915; Tigre reale e Più forte dell’odio è l’amore, 1916; Noris, 1919; Malafemmina, 1923; La dame de Chez Maxim’s, 1923 e Occupati d’Amelia del 1925). Pina Menichelli nei due anni in cui lavora per la Cines, tra il 1913 e il 1914 interpreta e recita in ben trentacinque pellicole, come ci dice il suo biografo più attento, Vittorio Martinelli . Ma è solo a partire dai personaggi interpretati per l’Itala (Il fuoco e Tigre reale) che la sua figura di colpo si impone alle platee per la carica di erotismo, la seduzione degli sguardi e la provocazione dei movimenti del corpo, ora contratto e pronto a scattare come un felino, ora febbricitante di passione ora estenuato quasi a trasmettere il raggiungimento di piaceri assoluti (non a caso i censori ordinano di tagliare per intero tutte le scene precedenti e seguenti didascalie di questo genere: «Sul suo corpo passarono soffi di convulsione spaventosa, sì che le sue ossa par che scricchiolassero›› e giungono addirittura a vietare la proiezione del film La moglie di Claudio motivandolo con il fatto che l’attrice era «troppo affascinante»). Con ogni probabilità la Menichelli – suo malgrado in quanto è una donna minuta che avrebbe potuto benissimo passare inosservata nella folla di attrici del periodo – diventa la Donna tigre mangiatrice di uomini per eccellenza del cinema di quegli anni. Di fatto senza mai pretendere di usurpare il trono alle due sovrane della scena italiana la Menichelli è stata un’attrice moderna, dotata di una eccezionale intelligenza della complessità e potenzialità della macchina cinema. Mentre le due massime dive consideravano tutto l’apparato cinematografico, dal produttore al regista, all’operatore come puri accessori, 26
27
utili ma non indispensabili e soprattutto interscambiabili, e si ritenevano di fatto come le vere autrici del film, la Menichelli capisce da subito l’importanza del regista e dell’operatore e dichiara la sua completa disponibilità ad assoggettarsi del tutto sia alla volontà del regista che al potere della macchina da presa. Alcuni primi piani del suo volto, anche se non raggiungono lo stesso livello di intensità di quelli di Asta Nielsen, rivelano, forse per la prima volta, inedite dimensioni del volto umano, raggiungono quei risultati che Eleonora Duse avrebbe voluto ottenere con Cenere se non avesse avuto troppa paura della macchina da presa. Pina Menichelli non si lascia imprigionare dai ruoli che il cinema pretende di imporle e, grazie al suo temperamento inquieto, vuole cambiare di continuo, esplorare il più possibile tutte le proprie possibilità e cercherà di farlo anche negli anni della crisi, abbandonando il cinema a soli trent’anni nel 1924. Già collocate in secondo piano, da ricordare non in ordine di grandezza, Italia Almirante Manzini (Cabiria, 1914; Patria!, 1915; L’amazzone macabra, 1916; Femmina, 1918; La maschera e il volto, Hedda Gabler, 1920; La statua di carne, 1921; La piccola parrocchia, 1923); Hesperia alias Olga Mambelli (Signora delle camelie, 1915); Lina Cavalieri (Sposa nella morte, 1915), che assai presto emigrò negli Stati Uniti, così come hanno fatto, a partire dagli anni Venti, quando la crisi fa crollare la produzione, attrici come Rina De Liguoro, Soava Gallone, Carmen Boni, Diana Karenne, Maria e Diomira Jacobini, che prendono la strada della Francia e della Germania. Ma l’elenco delle attrici del muto è assai più lungo: meritano ancora di essere ricordate Leda Gys, Mary Cleo Tarlarini, Elena Sangro, Gianna Terribili Gonzales, Vera Vergani, Alda Borelli, Mercedes Brignone, Bianca Camagni, Elena Makowska, per la varietà di immagini e di ruoli che riuscirono a trasmettere . Il divismo maschile è un fenomeno che, pur possedendo le caratteristiche generali di cui si è detto, vive parassitariamente di riflesso e con un ruolo subalterno rispetto a quello femminile. Pur raggiungendo spesso un grande successo di pubblico i divi non riescono a proporsi come modelli di comportamento. Anche se – come si è detto – si è ancora lontani dall’aver messo in luce l’influenza di Ermete Zacconi sul teatro e sul modello recitativo di Stanislavskij e il peso della sua ricerca sul cinema muto . Zacconi, Emilio Ghione, Febo Mari, Mario Bonnard, Luigi Serventi, Alberto Collo, Alberto Capozzi, Ermete Novelli, Gustavo Serena, Lido Manetti, Tullio Carminati, Ruggero Ruggeri, Ugo Piperno, Giovanni Grasso, Livio Pavanelli, Dillo Lombardi, Camillo De Riso, Alberto Nepoti, André Habay, pur con il prestigio che spesso dà loro la fama di grandi interpreti teatrali, raramente riescono a superare il ruolo di spalla della diva e a essere i soli protagonisti del film. In realtà mentre le dive dello schermo non hanno grandi concorrenti nella storia e nella società, i divi non possono certo pretendere di soppiantare la fama di personaggi storici, di letterati, di artisti, che, come si è detto, sono divenuti, grazie alla potenza dei mass media, uomini-simbolo universalmente riconosciuti. Al fenomeno divistico comunque partecipano, in varia misura, tutti gli attori a tutti i livelli della produzione. Gli stessi attori comici, che fino al periodo bellico occupano uno spazio privilegiato nella produzione di tutte le maggiori case, si considerano, o vengono riconosciuti come divi a tutti gli effetti: «Con questa meravigliosa film – scrive una rivista napoletana a proposito di Cretinetti e gli stivalidel brasiliano – Cretinetti assume il suo rôle di divo, e la sua figura già grandeggia a fianco degli astri maggiori dell’Olimpo da tremila metri di pellicola. Cretinetti si esibisce a noi ormai come il Francesco Bertini, il Pino Menichelli dell’attuale cinematografia comica» . Per inciso va detto che proprio nello stesso periodo Charlie Chaplin in America entra nell’orbita del divismo nascente con un ruolo trainante. In questo contesto, di cui non si è cercato di isolare separatamente i caratteri distintivi delle decine di divi che assumono una certa importanza, si staccano, per ragioni diverse, dalla massa e si differenziano dalle due dive che abbiamo considerato come teste di serie del sistema, Eleonora Duse, Emilio Ghione e Bartolomeo Pagano. Eleonora Duse, si colloca all’estremo opposto delle due dive dominanti: lei che è stata la sovrana della scena teatrale e che da tempo ha abbandonato le scene e ha scelto il silenzio all’improvviso intravvede nella luce cinematografica una possibilità di palingenesi e di riaffermazione della sua poetica recitativa. La Duse cerca di capire le esigenze e le possibilità interpretative in rapporto al nuovo mezzo e inventa una 28
29
30
recitazione quasi da teatro giapponese, rinunciando all’enfasi del gesto e neutralizzando il più possibile la presenza del suo corpo. Anziché sfidare la macchina da presa, offrendole il primo piano del volto, opta per una specie di gioco a rimpiattino, vestendosi anche di nero, in modo da neutralizzare qualsiasi possibilità di intervento della luce nei confronti del suo corpo. L’attrice celebra il suo incontro con il cinema in Cenere (di Febo Mari del 1917), che resta un unicum nella sua carriera artistica, come una vera e propria rinascita artistica. L’opposizione del bianco e nero consente, secondo le sue testimonianze edite e inedite, una marcia conoscitiva ed espressiva verso valori profondi e assoluti: nella sceneggiatura di un suo film mai realizzato, Angela da Foligno, ideato e scritto interamente di sua mano, il contrasto tra luce e ombra è reso da tutta una serie di materiali verbali organizzati da una parte attorno al campo semantico della notte (penombra, silenzio, ombra) e dall’altra a quello della luce verso cui doveva concludersi il cammino della protagonista e il film (i termini sono cielo stellato, alone di luna, finestra illuminata, mite splendore, aureola di luce, l’alba s’imbianca, e l’invocazione finale, luce! luce! luce!) . Molto importanti, per quanto riguarda la sua interpretazione, e il suo ruolo di coautrice di Cenere sono le note scritte alla stessa Deledda e a Febo Mari, le postille al romanzo, la sua speranza di raggiungere nuovi obiettivi: «Quando penso a questo lavoro che invoco, cerco di chiudere gli occhi e non ascolto che il mormorio della voce interiore» . In cosa consiste l’importanza della recitazione della Duse in Cenere, il suo muoversi in direzione vettorialmente opposta alla linea recitativa dominante nel decennio 1910-1920? Consiste anzitutto nell’annullamento del corpo e nel rifiuto più totale del gesto enfatizzato. La Duse cerca di capire la necessità di una recitazione pertinente al nuovo mezzo: «Il cinematografo è un campo tutto nuovo… e il primo errore consiste nel fatto che versiamo vecchio vino negli otri nuovi. La maggior parte di noi è gente già guastata dal teatro, abituata all’aiuto della parola… È molto più facile d’esprimere un sentimento quando abbiamo l’aiuto della parola, della voce… Il cinematografo ha bisogno di tutt’altri mezzi, ma offre delle possibilità che il teatro non può dare» . Di fatto è la stessa Duse ad assumersi il ruolo di coautrice del film: sua è la sceneggiatura di ferro, sue sono le scelte generali di recitazione interiore, di senso di annullamento e di sacrificio totale. La chiave della sua presenza scenica si può cogliere anche in una breve nota del regista («breve, breve, brevissima apparizione, piccola nel fondo, come prologo, come lontana nello sfondo della memoria»). In effetti Mari non fa che rispettare la volontà dell’attrice che così gli ha scritto alla vigilia delle riprese di Cenere, cercando di convincerlo a imboccare una strada del tutto centrifuga e controcorrente rispetto a quella ormai percorsa vittoriosamente dalle dive italiane e non: «Mi aiuti lei. Mi veda quale sono. Mi metta nell’ombra. Mi metta nell’ombra la prego. L’episodio delle mani al prologo (perché la mano denota il viso) – è pari a ciò che posso offrire. Il primo piano mi fa terrore. Preferirei a questo – tornarmene nella mia solitudine. Ho visto (in certi film) – ho visto certe penombre certi scorci che farebbero al caso mio. Mi metta dunque nell’ombra – mi tenga di scorcio, a passaggio…». Questa scelta complessiva dell’attrice non è integrata nella struttura generale del film in modo altrettanto coerente e felice. A parte alcune forti immagini in esterni con una natura pietrosa e violenta, dove persino i contorcimenti dei tronchi d’ulivo comunicano il senso del dolore e del male di vivere, il film manca proprio nella regia, nella capacità di sviluppare la storia in tutti i suoi elementi. Anche se tutta tesa all’annientamento del sé in scena la Duse illumina le sequenze in cui appare di una forza interiore, di una potenza tragica che pone distanze incomparabili rispetto al gesto drammatico e melodrammatico delle grandi dive dell’epoca. La Duse ha molto lavorato sul soggetto della Deledda prima di consegnarsi nelle mani di Febo Mari e come ci documentano alcune lettere alla figlia ha cercato l’ispirazione iconografica di molte scene chiave nella pittura giottesca in particolare di Assisi e Padova: questi prestiti, o questi veri e propri calchi iconografici che vengono fatti dal cinema sono stati indicati dalla stessa Duse nelle lettere alla figlia: gli affreschi giotteschi sono una fonte primaria di ispirazione per la costruzione delle scene e la plastica delle pose del film. Così scrive l’attrice alla figlia presumibilmente nel 1917: «In Cenere ciò che è così bello (lasciamelo dire) non è la tua vecchia madre, ma il tono calmo (ombre) e tragico e dolce delle inquadrature. In Cenere io ho avuto la fortuna d’un bambino bellissimo e, dopo la morte di Rosalia, le ultime inquadrature tutte impostate esattamente su Giotto, e vedere questa nobilità senza posa, questa dolcezza calma come l’aria d’estate, 31
32
33
quella tristezza rassegnata, quel dolore che non urla e non fa nemmeno un gesto – infine Giotto! Quello ho ben capito e fedelmente riprodotto e ciò è così riposante, proprio al cinema dove tutti non fanno che correre» . Mi sembra che l’intenzione dell’attrice non sia quella della semplice citazione colta, ma che cerchi di riproporre il valore assoluto di un gesto e di animare la pittura cogliendone i ritmi interni e la loro traducibilità in una sorta di cursus planus sullo schermo. Purtroppo l’esempio della Duse, straordinario nella sua modernità di concezione, ma evidentemente troppo sofisticato e antispettacolare, rimarrà senza seguito: le dive non potevano alimentare il proprio culto che attraverso l’esibizione continua e ravvicinata del proprio corpo, la comunione periodica del corpo e del sangue col pubblico dei catecumeni e non cercando di evitare il contatto. Incide non poco, nel suo successivo abbandono di questa strada appena intrapresa, sia l’insuccesso commerciale e di critica del film, che il silenzio della Deledda nei confronti dell’attrice. Un silenzio che ricaccerà la Duse definitivamente in quella zona d’ombra protettiva in cui da qualche anno si era rifugiata. In ogni modo si tratta di un caso esterno al fenomeno divistico e così controcorrente da non essere neppure assorbito dal sistema . Quanto a Ghione, fin dalle prime interpretazioni di rilievo è chiaro che immette sulla scena cinematografica ancora statica e teatrale un corpo estraneo, un tipo di recitazione tutta affidata a una tensione interna e a una fisicità ignote a un cinema che cercava come abbiamo detto i suoi modelli recitativi nei canoni della trattatistica teatrale ottocenteschi, nella gestualità dell’opera lirica o che, come alternativa poteva proporre i grandi interpreti del teatro naturalista o dialettale come Giacinta Pezzana o Giovanni Grasso. Per capire quanto detto basta una sola scena dell’ Histoire d’ un Pierrot di Baldassarre Negroni, film celebrato da tutti gli storici del cinema. La scena è quella in cui Pochinet (Ghione), il buon portinaio della casa di Louisette, la ragazza amata da Pierrot, insegna a Pierrot (di fronte a un busto di legno) come si deve fare una dichiarazione d’amore. L’eccezionalità della recitazione è aumentata dal fatto che nella parte di Pierrot recita Francesca Bertini, portando il suo personaggio a un livello di stilizzazione espressiva e astrazione gestuale del tutto inedite rispetto alla ormai già affermata capacità di interprete drammatica e naturalistica. Ghione marca ogni suo gesto e soprattutto riesce a caricare di espressività il movimento delle sue mani e a modulare una gamma di sentimenti attraverso la semplice espressione degli occhi. «Già si trovano – ha scritto Umberto Barbaro in una recensione che ancor oggi è da ammirare per la sua intelligenza e rigore – in questi film i gesti troppo ampi da megalomane, gli scatti nervosi che caratterizzeranno poi la recitazione di Za-la-Mort». Oggi grazie al ritrovamento di frammenti e copie intere di diversi suoi film è possibile capire meglio le caratteristiche di modernità e cinematograficità della recitazione di Ghione che da subito – fin da titoli come Il circolo nero, da lui diretto (1913) o L’amazzone mascherata di Baldassarre Negroni, dello stesso anno – appare come perfettamente padrone del volto e del corpo e lavora sulla microfisionomia e per sottrazione più che per enfatizzazione dei movimenti. Anche se alla mobilità del suo volto era affidata una parte importante della sua recitazione Ghione non avrà mai realmente bisogno dei primi piani per valorizzare al massimo gli effetti della sua maschera, ma negli ultimi episodi dei Topi Grigi e soprattutto in tutta la sequenza del processo di Mezza quaresima, l’ottavo e ultimo episodio, i primi piani abbondano e la macchina da presa sembra voler indugiare sulla microfisionomia. In effetti le sue apparizioni, come sarà poi per la recitazione dell’espressionismo, richiedono una comunicazione attraverso la totalità del corpo e la maschera del volto scheletrico di Za-la-Mort fa tutt’uno con il suo vestito e il suo berretto, ma anche si mimetizza col paesaggio assumendone l’aspetto materico, divenendo pietra o corteccia d’albero. Secondo Savio: «La sua maschera arsa, scavata, trascorre con sorprendente volubilità dalla ferocia al sarcasmo alla dolcezza schiva e maledetta… mentre sul valore dei film diretti da Ghione la critica è profondamente divisa». In effetti la divisione della critica e della storiografia è tutta fondata sul mantenimento di una tradizione vulgata e mai rimessa in discussione fino a qualche anno fa, in quanto generalmente fondata sulla citazione di seconda mano o sui pallidi barlumi o scandagli all’interno di una memoria completamente perduta. Tra tutti i personaggi maschili che attraversano la scena cinematografica è forse quello che rivela all’inizio una gamma di possibilità che progressivamente si restringono in quanto come vedremo il successo lo 34
35
condannerà a rimanere prigioniero del suo personaggio più popolare, Za-la-Mort. Quanto a Bartolomeo Pagano (Maciste), più ancora di Emilio Ghione, è l’unico attore nettamente popolare in grado di costituire, da solo e molto a lungo, un fenomeno divistico alternativo. Mentre le grandi dive sono le interpreti di un mondo in via di sparizione e trasmettono, spesso in una forma casalinga e familiare, le esigenze trasgressive dei codici della morale e delle istituzioni delle classi medio-piccolo-borghesi, e pertanto non riescono a divenire le interpreti del desiderio popolare, Maciste è l’autentico eroe positivo popolare. Nasce dalla testa di D’Annunzio come Superuomo in controparte rispetto agli eroi delle sue avventure intellettuali. Tutta fondata sull’azione e su continue e sempre più audaci dimostrazioni di forza, la sua recitazione è ridotta al minimo ed ha il merito di non possedere quella caratterizzazione enfatica dei grandi divi. Il suo personaggio, da Cabiria fino alle soglie del sonoro, diventa uno dei veicoli privilegiati per la trasmissione degli ideali nazionalisti, accanto a quelli più pertinenti ai grandi archetipi degli eroi della tradizione letteraria e fantastica di giustizia, di difesa e protezione dei deboli e delle fanciulle indifese. Maciste può sopravvivere alla crisi del divismo e generare, già dalla fine della guerra, altri personaggi capaci, come lui, di grandi performance spettacolari, ma non altrettanto in grado di costituire e di produrre un senso ulteriore e offrire un punto di riferimento ideale per l’immaginario popolare. Da Maciste discendono Luciano Albertini (Sansonia), Domenico Gambino (Saetta), Alfredo Boccolini (Galaor), Mario Guaita (Ausonia), Carlo Aldini (Aiax) tutti personaggi di acrobati che trasferiscono nel cinema le loro capacità, riuscendo per alcuni anni a competere coi film americani . Tutta la stampa d’epoca, sia quella di categoria che quella con maggiori ambizioni intellettuali (con l’unica eccezione di «Apollon» che condanna il fenomeno), concentra la sua attenzione sulle interpreti femminili per cui vengono mobilitate (in uno stile che ricorre a tutti i sottoprodotti linguistici dannunziani) le più forti iperboli verbali e viene esaltata la distanza assoluta rispetto alla massa, i valori di aristocrazia e di nobiltà immediatamente percepibili dal portamento, dal profilo, dal gesto: «Una testa come quella di Anna Fougez – è scritto su ‘In Penombra’ – fine nelle linee come un cammeo, intensa nelle luci e ombre, tutta soffusa di soave amarezza, infantile e indimenticabile, dice subito: ‘ecco una creatura’ che non è salita dal basso, ma è discesa dall’alto, da una razza singolarissima» . Diana Karenne è «una donna dotata di una eccezionale personalità, di una fine cultura e di molta intelligenza» , Claretta Rosaj è «un nome pieno di luce e di colore… pare che ella venga incontro portando nell’urna delle mani la Primavera, ed è ella stessa una botticelliana immagine della Primavera» , e il punto forse più evidente di rielaborazione della prosa dannunziana (del D’Annunzio della Vergine delle rocce) può essere dato da questo profilo della principessa di Viggiano: «E allo stesso modo che la cima dell’albero compendia in sé tutta la vita del tronco fino alle estreme radici, così ella ci apparisce realmente depositaria delle virtù della stirpe: bellissimo esemplare di una superiore umanità, manifestante, in ogni suo atto, la sua essenza diversa e la sua natura che nettamente la separa dalla folla mediocre» . Spariscono le mezze figure, in questa scalata inarrestabile e sfrenata alla celebrazione e, a questo punto, interessa osservare gli effetti di questo discorso, o la sua traducibilità in termini di discorso economico. È evidente che, se dal punto di vista teorico il divismo doveva nascere proprio per offrire dei prodotti differenziati, a questo punto di lievitazione complessiva di tutto il sistema si tende a far sparire le differenze, o almeno a renderle omogenee ai livelli più alti. Ciò produce un aumento del potere contrattuale, sia pure per poco tempo, di tutti i divi, ma al gonfiarsi delle paghe comincia a prodursi, in parallelo, con un andamento esattamente eguale e contrario, uno sgonfiarsi della domanda, anche sul mercato interno. Bisogna anche dire che dalle frequenti interviste concesse dalle attrici traspare, per ignoranza, per incapacità autocritica, per eccesso di euforia e di autostima, un giudizio e una valutazione di sé, che porta anche le dive di secondo piano a confrontarsi con le maggiori attrici del cinema mondiale. Diana Karenne trova che l’unico paragone possibile per lei è con Asta Nielsen, con la differenza però che, «mentre la Nielsen è soprattutto un’intuitiva, ella intende diversamente stabilirsi nella sua qualità precipua di cerebrale» . Il divismo, fin dai suoi primi rilevanti successi, innesca dei processi a catena di aumenti delle paghe dei maggiori attori che saranno una delle cause non secondarie dell’accelerazione della crisi industriale. Incuranti della chiusura dei mercati i divi aumentano di anno in anno le loro richieste, favoriti dalla dissennata concorrenza dei produttori, che proprio su questo piano danno fondo alla loro natura di mecenati e rivelano la loro assoluta incompetenza industriale. Alcune riviste – come «Apollon» – tentano di condurre una battaglia 36
37
38
39
40
41
moralizzatrice contro il divismo imperante e contro la diffusione di compensi astronomici che nessun successo del film sarebbe stato in grado di bilanciare. Bisogna tener però presente che il fenomeno non è solo italiano: si pensi a Charlie Chaplin, che, in soli due anni, passa dalla paga settimanale di 1.250 dollari alla Essenay nel 1915, ai 10.000 dollari con la Mutual, e quando nasce la First National nel 1917 firma un contratto iniziale di un milione di dollari. «Chaplin, chi è costui?» si domandano forse i divi italiani nella loro presunzione di essere ancora dei punti di riferimento per il cinema mondiale e, sentendosi perfettamente inseriti in una situazione internazionale, senza tener conto delle modifiche intervenute nel corso della guerra, chiedono e ottengono compensi che, per la situazione nazionale, non hanno nulla a che invidiare alle paghe americane. La Duse, proprio alla fine della guerra, potrà permettersi il lusso – come sappiamo dalle lettere alla figlia – di rifiutare un contratto da un milione di dollari offertole da Griffith. Anche facendo la tara sulla cifra, il compenso americano non sarebbe stato comparabile con alcun compenso ottenibile in Italia negli stessi anni. Non ci sarà più, in tutta la storia successiva del cinema italiano, un momento di priorità e potere assoluto del divo come in questa fase del cinema muto. 1
P.A. Villiers de l’Isle-Adam, Eva futura, Bompiani, Milano 1966, p. 74.
2
G.C. Castello, Il divismo, ERI, Torino 1957, p. 12.
La letteratura sul divismo è enorme e anche per quanto riguarda il cinema italiano il materiale bibliografico è consistente, anche se mancano vere analisi sociologiche d’insieme capaci di interpretare, in maniera soddisfacente, i rapporti tra industria divistica, modelli culturali e ideologici, trasformazione del pubblico, rapporti di proiezione e identificazione, riproduzione di massa di determinati comportamenti, ecc. Così, utile per un inquadramento generale può ancora essere il saggio di E. Morin, Les stars, Éd. du Seuil, Paris 1972. Si vedano per la situazione italiana: V. D’Incerti, Vecchio cinema italiano, in «Ferrania», a. V, n. 10, ottobre 1951 e R. Paolella, La decadenza del divismo in Italia, nel fascicolo monografico sul divismo di «Sequenze», a. II, n. 11, giugno-luglio 1950. Vittorio Martinelli si è occupato – nell’ultimo decennio – di molte dive di cui ha contribuito a restituire profili biografici accurati e filmografie attendibili. Grazie alle sue ricerche, personalità come quelle di Leda Gys o di Lina Cavalieri e di molte altre hanno goduto di una più attenta e giusta collocazione nel sistema complessivo. Due contributi di Claudio Camerini spiccano per capacità di sintesi e intelligenza dei problemi: Les formes italiennes du divisme: les années du muet, in A. Bernardini e J. Gili (a cura di), Le cinéma italien 1905-1945, Centre George Pompidou, Paris 1986, pp. 61-68 e Verso il divismo, in R. Redi (a cura di), Cinema muto italiano (1905-1916), CNC edizioni, Roma 1991, pp. 47-60. Si veda anche il recente C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’epos, Palermo 2006. 3
G.L. Farinelli e J.-L. Passek, Star al femminile, Transeuropa/Cineteca, Bologna 2000. L’edizione francese è pubblicata lo stesso anno (Stars au féminin dal Centre Georges Pompidou). 4
Tra i vari lavori di V. Martinelli ricordo: Pina Menichelli. Le sfumature del fascino, Bulzoni, Roma 2002 e Le dive del silenzio, Le Mani, Recco 2001, dedicato al divismo femminile di tutto il cinema muto. 5
In quegli anni la pubblicità cinematografica comincia a proporre i divi come modelli di comportamento e il consumo di massa di determinati oggetti, o la circolazione di abiti, gesti, atteggiamenti è favorita da questi costanti punti di riferimento e confronto. 6
M. Verdone, Sulla recitazione nei film del primo cinema italiano, Grado 1970; il testo è riprodotto su «Il Dramma», a. III, nn. 1-2, gennaiofebbraio 1971, col titolo Maciste l’unico antidannunziano. 7
8
E. Raimondi, Dal simbolo al segno: il D’Annunzio e il simbolismo, in «Strumenti critici», a. IX, n. 28, ottobre 1975.
Una prima importante lettura in chiave psicanalitica di questo motivo nel romanzo pirandelliano Quaderni di Serafino Gubbio operatore è in G. Debenedetti, Romanzo del Novecento, Garzanti, Milano 1971, pp. 257 sgg. (ma lo scritto è del 1962 ed era già stato pubblicato su «Cinema Nuovo»). Si veda ancora la mia lettura linguistica in G.P. Brunetta, Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Patron, Bologna 1972, pp. 23-27 e il più recente E. Lauretta (a cura di), Pirandello e il cinema, Centro nazionale studi pirandelliani, Agrigento 1978, che raccoglie gli atti del convegno omonimo del dicembre 1977. Nell’ultimo decennio le analisi sul Si gira si sono moltiplicate ed hanno portato a risultati importanti e in alcuni casi – come quello di un saggio di Umberto Artioli – stupefacenti. Tra gli altri mi limito a ricordare: G. Moses, Gubbio in gabbia: Pirandello’s Cameraman and the Entrapments of Film Vision, in «Modern Language Notes», a. XCIV, n. 1, 1979, pp. 36-60, il mio La conquista dell’impero dei sogni, in AA.VV., Pirandello e D’Annunzio nel cinema, Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Agrigento 1988, pp. 9-30 e U. Artioli, L’officina segreta di Pirandello, Laterza, Roma-Bari 1989. 9
U. Barbaro, Il 1913 e il cinema italiano, in «Società», a. VI, n. 3, 1950, ora raccolto in Id., Servitù e grandezza del cinema, Editori Riuniti, Roma 1961, pp. 172 sgg. V.L. Renzi, Grandezza e morte della «femme fatale», in Id. (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo 1905-1930, Cappelli, Bologna 1991, pp. 121-130. 10
È una tesi che Mario Verdone ha sviluppato a più riprese: per tutti, oltre al saggio citato si veda Preistoria del film storico, in «Bianco e Nero», a. XXIV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1973. 11
Per una trattazione del problema della recitazione nei manuali teatrali dell’Ottocento, a partire dal trattato di Marrochesi, si veda G. Calendoli, L’attore, Ed. dell’Ateneo, Roma 1961. 12
13
Colei che attendiamo, in «Apollon», a. I, n. 2, 1° marzo 1916.
Si vedano a questo proposito i fondamentali lavori di B. Dijkstra: Idoli di perversità, Garzanti, Milano 1988 e Perfide sorelle, Garzanti, Milano 1994. 14
15
Dijkstra, Idoli di perversità, cit.
16
P. Bianchi, La Bertini e le dive del cinema muto, Utet, Torino 1969, p. 7.
Per una interpretazione generale del pensiero di Gramsci sul cinema si veda G.C. Ferretti, Gramsci e il cinema, in «Cinema Nuovo», a. IV, n. 60, 10 giugno 1955, p. 427. 17
18
A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 336-337.
F. Montesanti, La parabola della diva, in «Bianco e Nero», a. XIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1952; E.F. Palmieri, Vecchio cinema italiano, Zanetti, Venezia 1940; E. Mazzuoli, Attori e attrici nei film dannunziani, in AA.VV., D’Annunzio e il cinema, in «Quaderni del Vittoriale», n. 4, agosto 1977, pp. 36-44. 19
20
A. Chiattone, La dive muette, in «La Revue du cinéma», n. 13, mai 1948.
E.F. Palmieri, Vecchio cinema italiano, in L. Malerba e C. Siniscalco (a cura di), Cinquant’anni di cinema italiano, Bestetti, Roma 1954 p. 21. Questo saggio riproduce, in pratica, il volume del 1941. 21
22
Montesanti, La parabola della diva, cit., p. 61.
«Ricordo quelle donne dal passo vacillante e convulso, le loro mani di naufraghe dell’amore che andavano accarezzando le pareti lungo i corridoi, aggrappandosi alle tende e alle piante, quelle donne la cui scollatura scivolava in continuazione dalle più nude spalle dello schermo, in una notte senza fine, tra scalinate marmoree e cipressi. In quell’epoca critica e turbolenta le magnolie venivano letteralmente prese a morsi, strappate coi denti da queste donne il cui aspetto fragile e pretubercolare non escludeva tuttavia forme audacemente modellate da una gioventù precoce e febbricitante». Il testo è ripreso in Bianchi, La Bertini e le dive del cinema muto, cit., pp. 140-141. In origine è apparso nel 1932 presso le Éd. des Cahiers libres col titolo Abregé dune Histoire critique du cinéma. 23
F. Bertini, Il resto non conta, Giardini, Pisa 1969, p. 90. Se le autocelebrazioni a posteriori sono certo ingenue e patetiche può invece valere ancora quanto ne scriveva Barbaro in un famoso saggio del 1937: «Francesca Bertini è stata, senza dubbio, un’attrice eccezionale e non soltanto una bella donna; e il suo talento naturale le ha fatto raggiungere a volte un alto livello artistico. Quelli che ne hanno scritto di recente non sono certo i critici che le profetizzava il, non certo indulgente, Delluc, quando ancora nel 1919 (cfr. Cinéma et Cie, Grasset, Paris 1919, p. 316) scriveva: ‘On ne saura que plus tard qu’il fallait étudier les oeuvres complètes de Francesca Bertini’»: U. Barbaro, Histoire d’un Pierrot, in «Bianco e Nero», a. I, n. 1, gennaio 1937, ristampato in Id., Servitù e grandezza del cinema, cit. Un bel profilo e un’accurata filmografia sono stati messi a punto da Vittorio Martinelli e Aldo Bernardini in Francesca Bertini, 1892-1985, Centro sperimentale di cinematografia, Roma 1985. Nel 1982 il regista Gianfranco Mingozzi ha realizzato un programma televisivo sull’attrice e sul fenomeno divistico italiano dal titolo L’ultima diva, che costituisce a tutt’oggi un modello di storiografia orale e di cinema sul cinema. 24
25
A Francesca Bertini Gianfranco Mingozzi ha dedicato nel 1982 uno straordinario documentario (L’ultima diva) e un libro: Francesca
Bertini, Le Mani, Recco 2003. 26
D. Martino, Catastrofi sentimentali, EDT, Torino 1993.
27
Martinelli, Pina Menichelli. Le sfumature del fascino, cit., p. 24.
Delluc, che al cinema italiano dedica nella sua attività critica molte pagine con alterni atteggiamenti, scrive su Francesca Bertini e sulle dive del muto degli articoli memorabili. Sulla Bertini ecco due ulteriori citazioni: «Voila une personnalité cinématographique qui mérite sa gloire. Je ne saurais vous dire si elle a du talent. Elle a ce qu’il faut à l’écran: une impassibilité, une ligne, une sincerité. Qui peut en montrer autant?», Notes pour moi, in «Le Film», 26 novembre 1917; «Elle personnifie en son individu les qualités usuelles et la féminilité extériorisée d’une héroine pour ciné-drames d’amour», Cinema et Cie, cit. Per un’informazione utile a capire come l’industria culturale costruisse l’immagine degli attori del primo cinema giocando al tempo stesso sui modelli delle biografie delle primedonne del teatro ottocentesco e sul doppio binario della vita inimitabile e della perfetta identità con l’uomo della strada si vedano: T. Alacci, Le nostre attrici cinematografiche, Bemporad, Firenze 1919; A. Giovannetti, Figure mute, Quartara, Torino s.d. In questo libro si tenta anche una elementare classificazione tipologica delle dive mostrando la progressiva ascesa della donna fatale rispetto alla fidanzata di tutti: «Il cinematografo, dopo i primi passi, saccheggiando tutta l’anticaglia del teatro di posa, s’impadronì anche dei suoi ruoli antiquati, e si affezionò particolarmente alla «seconda donna», denominandola donna fatale, perché si prestava a meraviglia ad appassionare la folla. E ne aggravò i difetti. Le attrici cinematografiche dal canto loro aggravano ancor più le tinte del personaggio, comportando esso l’esagerazione della femminilità, il fasto delle vesti, l’ostentazione della vanità», p. 189. Si vedano anche A. Varaldo, Profili di attrici e di attori, Barbera, Firenze 1926 e la collana periodica di pubblicazioni popolari «I grandi artisti del cinema», pubblicata come un periodico settimanale verso la fine degli anni Venti dalla editrice Gloriosa di Milano e che, accanto ai profili di pochi attori italiani (Maciste, Maria Jacobini, Rina De Liguoro), dedica la maggior parte dei suoi numeri ai grandi attori popolari americani. 28
Un primo notevole saggio sul rapporto tra Zacconi e il cinema è di G. Guccini, Il grande attore e la recitazione muta, Cappelli, Bologna 1991, pp. 87-98. 29
30
Cretinetti e gli stivali del brasiliano, in «Film», 1915.
Il manoscritto originale inedito di questa sceneggiatura così come quello di Cenere, con tutto l’epistolario relativo, sono conservati nell’archivio della Fondazione Cini di Venezia. 31
32
O. Signorelli, L’epistolario di Cenere, in «Bianco e Nero», a. XIX, n. 12, dicembre 1958.
33
O. Signorelli, Eleonora Duse, Signorelli, Roma 1938, p. 284.
34
La lettera è riportata da J.-L. Courtault-Deslandes, Eleonora Duse, attrice cinematografica, in «Notiziario del Museo nazionale del
cinema», nn. 34-35-36, 1977-79. Sull’esperienza cinematografica della Duse si vedano inoltre: M. Serao, E. Duse e il cinematografo, in «L’arte muta», a. I, 1916; O. Signorelli, E. Duse e il cinema nel XXV anniversario della sua morte, in «Bianco e Nero», a. X, n. 5, maggio 1949; E.F. Palmieri, La Duse protagonista di Cenere, in «Bianco e Nero», a. XIX, n. 12, dicembre 1958; U. Barbaro, La Duse e il film come arte, in «Filmcritica», a. IX, 81, novembre 1958; G. Calendoli, Le bianche mani di Eleonora Duse, in Id., Materiali per una storia del cinema italiano, Maccari, Parma 1967, pp. 137-147; R. Paolella, Eleonora Duse in «Cenere», in «Bianco e Nero», a. XIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1952. L’analisi più recente sui documenti conservati nella Fondazione Cini di Venezia è di A. Cara, Cenere di G. Deledda nelle figurazioni di E. Duse, Isre, Cagliari 1984. 35
M. Verdone, Il film atletico e acrobatico, in «Centrofilm», n. 17, 1961 e M. Quargnolo, Luciano Albertini, un divo degli anni venti, Csu, Udine 1977. Al fenomeno si è guardato con più attenzione in questi ultimi anni grazie alla possibilità di vedere un discreto numero di film e di studiarne con maggior cura debiti, relazioni e influenze. Una serie di importanti contributi sono raccolti in A. Farassino e T. Sanguineti (a cura di), Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983. Si veda anche il saggio di M. Dall’Asta, Le surhomme à l’italienne. Les hommes forts de l’ecran (1913-1915), in «Archives», n. 19, janvier 1989. Cfr. della stessa Un cinéma musclé, Yellow Now, Crisnée 1991. 36
37
Florizel, Anna Fougez, in «In Penombra», a. I, n. 7, dicembre 1918, p. 258.
38
F.M. Martini, L’esule delusa: Diana Karenne, ivi, a. I, n. 2, luglio 1918, p. 61.
39
M. Flamma, Claretta Rosaj in Giorgine, ivi, a. II, n. 1, gennaio 1919, p. 13.
V. La Rocca, La principessa di Viggiano, ivi, a. II, n. 9, settembre 1919, p. 3. La rivista «In Penombra» è una delle testate che più danno spazio al fenomeno del divismo: nei quasi due anni di vita si possono trovare – costruiti tutti in base a un identico tipo di discorso – ventun profili di attori. Interessa anche ricordare lo scritto di F. Bertini, Sensazioni e ricordi, apparso quasi programmaticamente nel primo numero del giugno del 1918. 40
41
Martini, L’esule delusa: Diana Karenne, cit., p. 63.
Il ruolo dei letterati e dei modelli letterari nell’industria cinematografica
la grande migrazione «Il genere vive del presente; ma ricorda sempre il suo passato, il suo principio. Il genere è il rappresentante della memoria creativa nel processo dello sviluppo letterario» . La nascente industria cinematografica si pone, fin dai suoi primissimi passi, nei confronti della letteratura, come di fronte a un unico testo a cui attingere senza limiti per la transcodificazione di tutta la memoria letteraria e la produzione di un nuovo tipo di memoria capace di raggiungere pubblici mai raggiunti dai testi letterari. Nel processo di trasformazione e riduzione, in termini visivi, dei grandi motivi dei testi letterari è seguita una logica che, a seconda dell’intervento di determinati fattori extratestuali, privilegia diverse fasce o livelli narrativi e favorisce ben precisi processi di canonizzazione e transcodificazione dei generi letterari in generi cinematografici. Ma seguire i processi di transcodificazione, riduzione, traduzione o analizzare il lavoro intertestuale significa offrire solo un punto di vista limitato rispetto alla complessità dei rapporti tra il cinema, la letteratura, il lavoro sui differenti modelli testuali e le interazioni e modificazioni delle scritture e delle funzioni intellettuali. È un cinema, quello italiano, in cui avvengono fenomeni che non si riscontrano in nessun’altra cinematografia, dalla conversione massiccia dei letterati al nuovo mezzo, alla fiducia di poter educare tramite lo schermo, alla lettura e conoscenza dei classici e delle grandi figure storiche, dall’assunzione da parte dei letterati stessi di svariati ruoli all’interno della macchina creativa, al dichiarato riconoscimento del debito della propria scrittura e poetica nei confronti del cinema, all’influenza del cinema sulla lingua, alla massiccia presenza di neologismi legati al nuovo mezzo, alla conservazione di una memoria forte dell’esperienza cinematografica, all’ibridazione di cinema e letteratura nelle poetiche e nell’opera di alcuni registi… La grande industria culturale si è mossa fin dal primo decennio del nuovo secolo, si potrebbe dire parafrasando Pascoli, e osservando i tentativi di perfetta congruenza tra i sistemi produttivi della grande industria meccanica e quelli della nascente industria cinematografica intende ridurre, al più presto, la varietà e molteplicità dei modi e delle forme letterarie a un numero canonico di motivi e luoghi rigidamente strutturati. Il fatto che ci si ponga con assoluta libertà – e senza alcun complesso di inferiorità – di fronte alla letteratura di tutti i tempi, vista all’inizio come un unico e indifferenziato gran testo isomorfico, apre il problema dell’esistenza di un modello di biblioteca anteriore, di cui si parla altrove, elaborato dall’industria letteraria alla fine dell’Ottocento, che si tenta di convertire in una corrispondente filmoteca a uso nazionale e internazionale. Il cinema diventa da subito, nella logica dei produttori, un mezzo di allargamento degli orizzonti culturali, un potenziale e privilegiato produttore di una cultura di massa e un veicolo di trasmissione nazionale e internazionale della cultura italiana. Una particolare attenzione va dunque portata ai modi, alla cura con cui avvengono questi processi di conversione tra sistemi diversi e alla coscienza che, gli stessi letterati, assunti nel processo di produzione, vengono ad avere di questo loro ruolo. In effetti l’industria chiede, assai presto, dal 1909, accanto alla conversione del testo anche quella del letterato a un diverso tipo di scrittura e di funzione. Gli intellettuali, come si è visto, rispondono alle sollecitazioni in ordine sparso. Una cosa sono gli interventi espressi in via più o meno ufficiale a favore o contro il cinema e una cosa molto diversa l’assunzione di un ruolo, la firma di un contratto, la partecipazione, in veste di lavoratori, alla produzione e realizzazione materiale del film. Su questo piano il discorso è assai più complesso, in quanto il lavoro richiesto al letterato è di due tipi: da una 1
parte lo si vuole come effettivo e intercambiabile riduttore di testi letterari altrui, dall’altra gli si chiede di essere, con piena responsabilità, produttore reale di forme visive in cerca di una dignità pari a quella letteraria . La coscienza di questo doppio ruolo si può già trovare chiaramente espressa in due interventi (uno scritto e un’intervista) di Guido Gozzano, rispettivamente del 1910 e del 1911 (e va tenuto conto che fin dal 1907 Gozzano si era accostato, grazie al cugino Roberto Omegna, al cinema) . In un’intervista concessa nel 1910 alla «Vita cinematografica», Gozzano afferma: «Io che ho resistito alle lusinghe pecuniarie dei massimi fogli quotidiani… io che ho resistito e resisto alle prove del teatro… ho accettato con piacere di rivelare le mie fantasie in una pellicola vertiginosa… ma soprattutto ho già ridotto per il cinema i temi più originali di un mio volume di fiabe… ogni pellicola, col suo quadro favoloso e il suo commento in versi, mi è cara come il mio lavoro letterario e non esiterò a firmarla e tutelarla come i miei volumi di prosa e poesia» . Ma nel 1911 (26 settembre) lo stesso Gozzano scrive in una cartolina a Salvator Gotta: «Sono a Torino da vari giorni per mettere in scena La statua di carne, le appendici di Zévaco e altre simili delizie… Coloro che godono di vedere la poesia e i poeti profanati possono esultare…» . Il proletariato intellettuale – e non solo quello – dal primo decennio del Novecento comincia a dirigersi, prima in ordine sparso e poi in maniera massiccia, verso il Nuovo Mondo del cinema. Oggi in ogni caso l’osservazione non può più essere ristretta all’ambito del cinema italiano e si può tranquillamente dire che in vari paesi d’Europa, dalla Francia alla Germania, all’Inghilterra il cinema ha agito come un magnete, ha esercitato su scrittori e intellettuali un’«attrazione fatale» che li ha subito costretti a mutare natura, statuti, coscienza del Sé . James Joyce in una lettera della Rubrica alfabetica nelle sue Epifanie, scritte tra il 1900 e il 1904 rivela la tensione verso nuove forme artistiche sconosciute («Et ignotas animum dimittit in artes» ) che si può tranquillamente identificare nel cinema. In Italia il fenomeno ha quasi un carattere endemico: non c’è scrittore o letterato che, costretto a rivelare questi rapporti, non abbia denunciato il proprio senso di colpa, o provato un senso di sdoppiamento della personalità, alla dottor Jekyll e Mister Hyde. E non abbia confessato di aver comunque provato una qualche forma di piacere e gratificazione nel corso della relazione. Giuseppe Petronio ha scritto che «gli scrittori finivano per ‘fornicare col cinema’». In un certo senso verrebbe voglia di dire che questi letterati e umanisti del primo Novecento il cinema era ciò che per il borghese (piccolo, medio, alto) era la prostituta. Era questa, o pareva, un male, ma un male necessario ad attirare e scaricare su di sé, quasi un parafulmine, la concupiscenza maschile… egualmente il cinema, scaricando su di sé le basse voglie del volgo, poteva consentire al teatro di mantenere intatta la verginità artistica. Il che ovviamente non doveva impedire allo scrittore di fornicare qualche volta col cinema a fini di rinomanza o di guadagno, proprio come il disprezzo per la prostituta non impediva la borghese di fornicare con essa» . Che fin dall’inizio della storia del cinema – e ben prima dell’ingresso trionfale di D’Annunzio in Cabiria – esista un lavoro salariato di intellettuali, più o meno famosi, che si prestano alla riduzione di testi letterari e alla elaborazione delle didascalie si può vedere benissimo anche nella corrispondenza inedita tra Ricciotto Canudo e D’Annunzio per un progetto, poi non realizzato, nel 1911, di trascrizione cinematografica in Francia, dell’Innocente e del Giovanni Episcopo: «Io ho lavorato accanitamente giorni e notti – scrive Canudo – per compiere la riduzione che oggi vi piace chiamare deformazione… Io dovetti leggere e notare minutamente le sue opere e le ridussi come in Francia si riducono, cioè dando tutte le indicazioni psicologiche che devono solo servire di orientamento preciso agli autori e hanno cioè il compito di didascalie o rubriche. Ho dato le films al cinematografo da un anno e ne ho scritta ancora una ultimamente sulla giovinezza di Dante. Conosco il mestiere… Non so quali siano le regole italiane, so che il mio lavoro è stato aspro e coscienziosissimo» . Il fatto inevitabile che, a partire dal 1909, e, a varie riprese, negli anni successivi, si cerchi di ingaggiare D’Annunzio, e che con Cabiria gli si affidi il ruolo di tutore e sponsor del più grosso sforzo produttivo e realizzativo di tutta la storia del cinema muto ha conseguenze oggettive su tutto il sistema: proprio a partire dal ruolo giocato da D’Annunzio e dalla sua presenza si producono effetti di trasformazione nella morfologia dei rapporti fino ad allora di dipendenza e soltanto parassitari del cinema dalla letteratura. «Non io fui vinto da cavalieri, da fanti, non da navi, ma da una novissima forza che scaglia dardi per gli occhi…» : questa è l’ultima didascalia scritta da D’Annunzio per Cabiria, e, per molti aspetti, si può considerare la sua dichiarazione pubblica di sottomissione, ammirazione, amore di riconoscimento della 2
3
4
5
6
7
8
9
10
forza della nuova forma d’arte. Nell’uso pubblico di queste parole, nell’entrare come soggetto dell’enunciazione proprio nella scena finale del film, D’Annunzio suggella un nuovo e forte patto creativo con l’arte neonata e idealmente si pone alla testa di tutti coloro che si mettono in viaggio verso i nuovi Mondi delle immagini. La scena cinematografica viene fecondata dall’apporto dei letterati, ma sollecita anche in loro inedite energie creative . E ne comincia da subito a influenzare le scritture. Già nel primo decennio del secolo si potranno registrare, anche in Italia, all’indomani della nascita del cinema, segnali precisi di diffusione di una sorta d’epidemia sull’invenzione letteraria, sull’immaginazione e sui modi della scrittura di autori noti, meno noti, o al limite dell’anonimia. Come se l’«effetto cinema» producesse segni sparsi d’immediata alterazione diffusa della temperatura stilistica e prosodica e l’avvento della nuova forma di spettacolo potesse essere la via più breve per produrre una palingenesi nel sistema delle arti. Ricciotto Canudo, l’autore e profeta delle nuove possibilità del cinema fin dalla fine del primo decennio, ne esplora anche gli sviluppi sul piano lessicale partendo dal prefissoide «Cine-», che esplode come un fuoco d’artificio ed ha una ricaduta a largo raggio, o viene sventolato come un vessillo da piantare in territori assai diversi, in cui si agitano plurime pulsioni e tensioni artistiche, psicologiche, emotive: «Cinégraphie, Cinéologie, Cinémanie, Cinéphilie, Cinéphobie, Cinépoesie et Cinédie, Cinématurgie, Cinécromie…» . Sarà ancora lo stesso Canudo a scrivere qualche tempo dopo: «Il cinema ricomincia, in effetti, l’esperienza della scrittura. È essenzialmente un linguaggio universale… Rinnova la scrittura» . Negli anni che precedono la realizzazione di Cabiria l’industria cinematografica non è stata certo alla finestra: se fin dai primi contratti offriva per i letterati gratificazioni economiche assai superiori a quelle editoriali, e nuove possibilità di impiego delle proprie capacità per modeste che fossero, come osservava anche Renato Serra , di fatto, bisognava prendere atto – come abbiamo visto in Gozzano – che, alla fine del processo di realizzazione, il ruolo del letterato veniva a essere compresso se non del tutto neutralizzato. Che Gozzano scriva il testo del documentario di Omegna sulle Farfalle o scriva vari soggetti da film, tra cui un San Francesco , che Salvatore Di Giacomo, Roberto Bracco, Grazia Deledda, Guglielmo Zorzi, Marco Praga, Giuseppe Adami, Giovanni Verga offrano i loro soggetti o progettino un intervento, ha certo una grande importanza, ma nessuna di queste presenze assume il ruolo di trasformatore in un sistema che mostra da subito il suo potere di schiacciare e modificare l’immagine dell’autore letterario. È naturale, quindi, che molti di questi letterati vivano la loro esperienza in modo dissociato: Verga affida le sue sceneggiature a un’amica, raccomandandole il silenzio assoluto sulla sua collaborazione «Vi prego e vi scongiuro di non dire mai che io abbia messo le mani in questa manipolazione culinaria delle cose mie» . Quasi tutti considerano la loro esperienza come degradata e degradante . Il sistema narrativo – ormai era evidente – poteva muoversi con indifferenza e macinare e riciclare qualsiasi testo. Non c’era classico capace di reggere alla macchina cinema: da Dante a Shakespeare, da Omero a Manzoni e Ariosto, tutti i testi capitali della letteratura in poco tempo erano stati ridotti e consumati da platee bisognose di materiali sempre nuovi. I letterati più accorti, pur avvertendo una profonda modifica attuata dal cinema nell’imporre al loro lavoro tempi, modi e regole di realizzazione, all’interno di un processo già avviato a imitare i ritmi dell’industria, capiscono anzitutto che la battaglia si gioca nei confronti del contiguo spettacolo teatrale a cui il cinema è avviato trionfalmente a contendere spazi, spettatori, attori e autori: certo le distanze culturali tra le due forme sono ancora abissali ai loro occhi, ma il processo in atto offre una serie di elementi significativi per il futuro: si è già visto come il fronte del rifiuto nei confronti del cinema tendesse a spezzarsi nelle inchieste condotte dal «Nuovo Giornale» di Firenze e dalla «Vita cinematografica» nel 1913 e, qualche anno dopo, questo fronte è molto modificato: un atteggiamento più attento alle trasformazioni sociologiche in atto nello spettacolo e più pronto a vedere nuove mediazioni si nota in Gramsci quando coglie le superiori capacità spettacolari del cinema nel soddisfare determinati bisogni: «Non vi è dubbio che gran parte del pubblico ha bisogno di divertirsi… con una pura e semplice distrazione visiva: il teatro, industrializzandosi, ha cercato in questi ultimi tempi di soddisfare solo questo bisogno… Il cinematografo, che quest’ufficio può compiere con più agio e più a buon mercato, lo supera nel successo e tende a sostituirlo» . Quasi nello stesso periodo, Gozzano offre un’ulteriore pezza d’appoggio, in un suo saggio di grande interesse, mettendo in gioco la propria esperienza 11
12
13
14
15
16
17
18
19
di «spettatore comune»: «Ci sono sere vuote, quando si consulta invano la lista dei teatri… sere in cui il cervello stanco non ha forza di attenzione e non desidera la buona commedia e il buon libro, sere negate al cervello e all’arte. E si pensa allora a una cosa leggera, non faticosa, che non sia il teatro, ma che sia un pochino di più del caffè e dei club con le sue riviste e i suoi amici annoiati, o delle pietose turpitudini del caffè di varietà; e allora il cinematografo offre questo quid medium» . Il cinema ha conquistato almeno un suo spazio, non può ancora per questo tipo di letterati – vi troveremo anche Bracco – aspirare alle vette sublimi dell’arte, ma almeno è assestato su una posizione di medietà riconosciuta e accettata. Il riconoscimento di questo passo molto importante ha però un presupposto fondamentale, quello di una serie progressiva di contratti cinematografici firmati da letterati importanti, culminata con la collaborazione di D’Annunzio a Cabiria. 20
il ruolo di d’annunzio Il passaggio di D’Annunzio ha il valore anche di un gesto inaugurale, dell’apertura di una strada che ormai i letterati possono percorrere senza timori e non col senso di un lavoro antagonistico, ma in uno sforzo di travaso di integrazione creativa: «Il teatro può, anzi deve, esserci d’aiuto. Il teatro darà in prestito al cinematografo il suo grande bagaglio di esperienza e di pratica sulla psicologia del pubblico e delle masse… Vengano i Bracco, i Praga, i Traversi, i Testoni, ci portino i lavori nuovi, originali, speciali per il cinematografo, – scrive Matilde Serao nel 1914. – Seguano quanto hanno fatto e stanno facendo Gabriele D’Annunzio, Matilde Serao e pochi altri. Non diamoci, noi del cinematografo a saccheggiare il repertorio teatrale. Sia la nostra una nuova letteratura, puramente cinematografica» . Da ricordare – sia pure en passant – che nelle lunghe gallerie di nomi di letterati che collaborano alle sceneggiature di vari film si segnalano per un contributo di rilievo Oxilia, Chiaves, Fausto Maria Martini, Frateili e Fracchia. L’assunzione di D’Annunzio e la sua promozione ad autore di Cabiria introduce non pochi elementi di discontinuità nel sistema che si era venuto dilatando seguendo una certa logica di sviluppo genetico. Il cinema aveva finora messo in crisi la funzione carismatica e sacerdotale dello scrittore e dell’intellettuale, ne aveva cancellato l’identità nella produzione dei soggetti e lo aveva costretto a un lavoro bracciantile o da salariato del tutto assoggettato alle esigenze del mezzo. D’Annunzio, fin dai suoi primi contatti, rifiuta questa logica e cerca di rivendicare e mantenere la propria «aura» di creatore e di autore, pur venendo, di fatto, a rivestire, nel processo di produzione filmica di Cabiria, poco più di un ruolo di prestanome. In un certo senso, anche materiale, D’Annunzio ottiene il massimo risultato col minimo lavoro, in quanto l’opera, per molto tempo, verrà unanimemente attribuita a lui. Suo diventa il soggetto, sua la regia, sua la paternità di tutte le fasi organizzative e realizzative. In uno dei tanti articoli usciti all’indomani della prima di Cabiria, possiamo trovare, accanto ai prevedibili accenni entusiastici, anche veri e propri inni a D’Annunzio poeta della parola e ora consacrato anche poeta del silenzio. Se prendiamo poi in considerazione, per un attimo, il senso e l’effetto generale dell’esaltazione iperbolica da parte di tutti gli organi di stampa, nazionali e internazionali , vediamo che si crea, anche su questo piano, un fenomeno del tutto inedito dal punto di vista giornalistico. Il cinema raggiunge le prime pagine dei quotidiani e al film vengono dedicati ampi articoli. Ciò che colpisce, come minimo comun denominatore, è la mitizzazione immediata del ruolo di D’Annunzio: «D’Annunzio stesso – si legge sulla rivista napoletana ‘Film’ alla vigilia della prima di Cabiria – ha curato personalmente i più minimi particolari: giungendo persino a stabilire i tessuti speciali oltre che le fogge e i colori di ciascuna classe di costumi… persino nella réclame la Itala ha inteso di conservare un altissimo e purissimo sentimento di arte che il nome di D’Annunzio imponeva» . Il nome di D’Annunzio viene usato dunque strumentalmente dai mass media in un momento chiave della formazione, in seno alla industria culturale, di una vera e propria ideologia del pubblico. E nonostante D’Annunzio, nelle sue dichiarazioni pubbliche, dia l’impressione di volersi dissociare dall’ideologia del pubblico formatasi nei produttori («I fabbricanti a ogni tentativo oppongono l’esecrabile ‘gusto del pubblico’. Il gusto del pubblico riduce oggi il cinematografo a un’industria più o meno grossolana in concorrenza col teatro») ci rendiamo ormai conto del peso decisivo del suo ruolo a questo punto dello sviluppo dell’industria cinematografica . 21
22
23
24
25
Egli viene a esercitare, così, una prevaricazione di fatto nei confronti di Pastrone, cancellandone l’identità e divenendo l’autore materiale del film (anche se grazie agli studi più recenti l’autorialità di Pastrone in generale è molto ridimensionata, rispetto alla sua genialità di imprenditore e produttore all’americana): questo mutamento di ruolo di autore che concede che le proprie opere siano trasposte e ridotte per il cinema, a soggetto effettivo dell’emissione, ha come effetto immediato di provocare i primi interventi teorici sulla paternità reale dell’opera cinematografica. Se negli anni precedenti dimostra poco interesse nei confronti delle offerte che gli vengono fatte dall’industria cinematografica è perché avverte il senso dell’anonimato del suo ruolo e il suo stesso rifiuto di assistere dall’esterno alla messa in scena dei film tratti da sue opere nel 1911 dalla casa Ambrosio rientra nella stessa logica. Nei confronti di Cabiria mantiene certo qualche distanza affermando di aver intascato le 50.000 lire oro per la rielaborazione delle didascalie per dar «carne rossa ai miei levrieri», ma, al di là della battuta, Cabiria gli ha offerto un’occasione per essere reintegrato nel ruolo di autore. E questo ruolo gli viene a lungo riconosciuto: «A Gabriele D’Annunzio – scrive Salvatore Di Giacomo nel 1916 – spetta il merito di essere stato il primo a curare davvero la plasticità della colorazione del quadro cinematografico, rinnovando, con maggiore efficacia, i lodevolissimi tentativi del genere che già aveva fatti a teatro» . Oggi noi sappiamo, grazie al contributo pionieristico del lavoro della Prolo e a tutte le ricerche successive che hanno condotto al più recente restauro del 2006 – che ha avuto oltre al merito filologico di tentare un’ipotesi di testo ideale quanto più possibile vicino a quella voluta da Pastrone e quello di produrre anche un catalogo ricchissimo di contributi che fa avanzare realmente le conoscenze sul film, sulla sua genesi, sulla sua influenza e sulla rete di relazioni con la cultura anteriore e la storia coeva – che Cabiria è tutto in testa di Pastrone, che le stesse didascalie dannunziane seguono una scaletta predeterminata e che quindi l’apporto creativo del poeta in apparenza è minimo. Ma non è forse questo il punto: il problema semmai è chiedersi cosa avviene nel testo filmico, che tipo di forze sono attivate a partire dal lavoro materiale di rielaborazione delle didascalie da parte di D’Annunzio, che conseguenze complessive si producono sul sistema e si ripercuotono sul contesto. La redazione delle didascalie in una lingua alta ha una serie di effetti notevoli: muta la struttura testuale, muta la forma della enunciazione, muta i singoli enunciati. Un esame delle varianti tra lo schema di Pastrone e il testo dannunziano mostra anzitutto la scelta costante, sia sul piano lessicale che sintattico, di un linguaggio letterario alto e più modellato su strutture metaforiche o strutture sintattiche latine o su una sintassi italiana corrente. Ora mentre tutte le didascalie del primo cinema muto italiano avevano finora assolto a una dominante funzione referenziale e informativa, il sistema linguistico della didascalia e della parola dannunziana va in direzione contraria allo sviluppo linguistico medio delle didascalie del cinema che si erano poste in sintonia con lo sviluppo di altri media, spesso anticipandone le forme . Si crea in pratica con Cabiria un vistoso e inedito fenomeno di doppia testualità: si vengono a combinare due testi di cui quello verbale, prevalentemente assunto finora con prevalenti scopi di indice di riconoscimento, allarga il potere oltre la sua referenza immediata e produce una connotazione autonoma. Si intende promuovere il pubblico a un tipo di esperienza privilegiata, assolutamente inedita rispetto ai suoi standard linguistici e non più fondata su una serie di dati di carattere informativo. C’è semmai da esaminare il senso della divaricazione tra gli enunciati linguistici e quelli visivi, e, al tempo stesso, si deve osservare la coerenza assoluta del linguaggio dannunziano che costituisce un unicum, malamente imitato, in tutto il sistema del cinema muto. Ciò che bisogna mettere in rilievo è l’incoerenza tra i materiali visivi e quelli verbali, la loro continua divaricazione. Un semplice confronto tra una didascalia di Pastrone e una di D’Annunzio chiarisce in modo definitivo il senso del discorso: 26
27
28
29
30
Pastrone Esterno: Via di Catana, con vista entrata di palazzo. Giunge marito di ritorno da visita campi.
D’Annunzio È il vespero. Già chiude la tenzone dei caprai che la musa dorica ispira su flauti dispari a cui la cera diede l’odore del miele. E Batto ritorna dai campi alla città, al suo giardino di Catania in vista dell’Etna.
Tutto un sistema metaforico, un’aggettivazione iperbolica e tesa a produrre un’enfasi costante, e una serie
di altri procedimenti retorici, manifestano, in ogni didascalia, lo sforzo di dar vita a parole morte e di coinvolgere, contemporaneamente, tutti i sistemi dei sensi. In alcuni casi, il recente restauro ha messo in luce alcuni piccoli correttivi di Pastrone alle didascalie dannunziane per renderne meno difficile la comprensione. Vediamone alcuni esempi: «A cui la cera diede l’odore del miele», «Come il vento di Primavera che valica il deserto con Piedi di Nembo, recando l’odor dei leoni e il messaggio di Astarte»; «Massinissa, venuto a notizia», «Mai rocca in travaglio d’assalto…» . Il materiale linguistico prodotto da D’Annunzio per Cabiria resta un fatto unico che se non costituisce un elemento di spinta espressiva va pur sempre analizzato come fattore di modificazione del testo cinematografico. Grazie alla semplice presenza ufficiale di D’Annunzio, si producono una serie di spinte che, a onde concentriche, coinvolgono tutti i livelli della produzione. Il dannunzianesimo viene a esercitare – come modello letterario – una sorta di egemonia tematica e culturale su tutta una fascia della produzione e, al tempo stesso, attua una specie di diga di sbarramento nei confronti della spinta impressa dalle avanguardie, da un lato, e del cinema comico dall’altro. Una delle più vistose conseguenze dell’avvento di un cinema che si muove sotto il segno di D’Annunzio è anche l’aumento della carica simbolica e significante che coinvolge ogni minimo elemento che entra nell’azione . Anche tutto il sistema recitativo viene a essere modificato: da una parte si riconduce il gesto in direzione del quotidiano – qui però l’influsso maggiore è da ricercare nel teatro naturalista – dall’altra se ne estende al massimo la portata in direzione simbolica. Questi elementi sono disseminati lungo tutta la produzione che si può definire dannunziana: i simboli della donna gufo o della donna serpe nel Fuoco di Pastrone, l’analogia della serpe che inghiotte il pulcino nella Serpe di Roberto Roberti (1919), la statua di Galatea che si anima nel Mistero di Galatea, film di Aristide Sartorio del 1919, che risulta essere una specie di centone di motivi dannunziani. Già partendo dagli stessi titoli, Il fuoco, La serpe, si vede come vengano evocati titoli dannunziani. Le didascalie contengono richiami espliciti: «ed esce nella città morta» (Mistero di Galatea) e per tutti i film circola, come minimo comun denominatore, il motivo del fuoco che, a partire dal film omonimo e dalla triplice ripartizione narrativa in capitoli emblematici (la favilla, la vampa, la cenere), rilancia questo topos della poetica dannunziana, già posto come motivo centrale simbolico di Cabiria e ripreso come simbolo per eccellenza dell’amore passione in tutti i film successivi. Una didascalia del Fuoco di Pastrone sintetizza meglio il senso del discorso: «L’amore che tu sei è come questa lampada… essa dà poca luce… e dura tutta la notte… Vedi! Come la passione la tua fiamma s’innalza fino al cielo. Scegli tra amore e passione! Bruciami! …bruciami l’anima». Ma la penetrazione e l’influenza si estende anche al sistema degli oggetti di cui si vuole mettere in luce la funzione rituale. Appaiono i letti, i divani, gli specchi, certe medicine (in Tigre reale quella che ha il potere di ridare, se presa a piccole dosi, la giovinezza e la salute) che hanno soprattutto il potere di far respirare al pubblico borghese l’atmosfera proibita dei paradisi artificiali. E infine certe didascalie dal valore assoluto come la clausola finale della Memoria dell’altro: «E l’amò fino alla morte e più in là!» o certe figure come il senso del trionfo e dell’apoteosi (le corone d’alloro del Mistero di Galatea) e il passaggio della rappresentazione del rito dalla forma di esperienza a carattere privato a quella di aggregazione e partecipazione di massa. Nel finale del Mistero di Galatea tutta la comunità del paese partecipa al rito, per cui il motivo sacrale sembra ricondotto alle sue radici originarie e di massa. Il cinema può modificare le forme del comportamento collettivo: di questo D’Annunzio si rende conto, in una fase successiva, durante la guerra, e soprattutto a Fiume, quando elabora i rituali che accompagnano i discorsi e le celebrazioni. E le didascalie, scritte in questa occasione, per alcuni documentari non mancano di sottolineare il suo nuovo ruolo carismatico: «Ma il poeta soldato, arso dalla sua santa passione, chiede ai legionari fiumani, alla città di Fiume, la resistenza all’applicazione del trattato che ne riconosce la reggenza» (nel Paradiso all’ombra delle spade). Di colpo D’Annunzio riesce a essere, in pari tempo, soggetto dell’azione e protagonista di storia e di spettacolo, con un potere politico finora inedito. Il gesto e la parola elaborata a Fiume appaiono già come gesti che formano nuovi modelli nei rituali di massa. Anche in questo caso D’Annunzio avvia un processo destinato a passare di mano e trasmettersi con grande rapidità. È questo il massimo raggiungimento dello spettacolo dannunziano, in cui attore e autore si fondono: l’arte e il gesto diventano vita, il gesto individuale e 31
32
33
inimitabile può essere, a partire da questo momento, imitato e riprodotto, divenire un costume di vita. Se la stagione del cinema che deriva dalla letteratura dannunziana tra gli anni Dieci e Venti è dominata dalla ripresa di un fenomeno ormai ritardato ed epigonico di un mondo culturale, negli anni successivi, la scena si allarga e tutta l’Italia si trasforma in un enorme palcoscenico nel quale per vent’anni il fascismo reciterà e ripeterà dei rituali a cui D’Annunzio ha dato una spinta non indifferente.
attrazione fatale Se D’Annunzio costituisce e gioca un ruolo chiave nella trasformazione del sistema, nel bene e nel male, e se la letteratura dannunziana che passa nel cinema del periodo bellico gioca un ruolo pressoché egemone, non bisogna dimenticare l’azione e il tipo di intervento o di presenze di altri autori, quali i futuristi, i rappresentanti del verismo, da Bracco, alla Deledda a Verga . Verga, che in pratica vive in silenzio e isolamento da quasi vent’anni, denuncia la propria impotenza manipolatoria e affida il lavoro a un’amica, la contessa Dina di Sordevolo, spingendola, fin dal gennaio 1912, a trarre delle libere riduzioni dalle sue novelle e opere teatrali: «Magari potessi aiutarti, Dinuzza. Metto perciò a tua disposizione quelli dei miei drammi, novelle e romanzi che ti servono e facciamoli pure cinematografare, ben inteso a tuo totale beneficio. Credo che realmente si possa cavare qualcosa… Figurati che di Cavalleria rusticana ne fecero una rappresentazione che io non arrivavo a capire quando andai per curiosità a vederla… A sceneggiare le mie novelle o romanzi o anche il mio teatro non sono …non so, non posso e non posso far altro per te che lasciar fare e darti carta bianca… Anche per cinematografare Cavalleria fecero loro. Lasciali fare e al più aiutali scegliendo il soggetto e sceneggiandone i quadri». E in una lettera successiva: «Il cinematografo oggi ha invaso talmente il campo e ha bisogno di soggetti o temi con i quali abbrutire il pubblico e accecare la gente, che io spero che Giannino ti abbia aiutato a collocare qualcuna delle nostre fiabe. Basta: il punto è che paghino e poiché del genere si fa un consumo enorme spero che qualcosa verrà a te di questi famosi diritti d’autore e del lavoro di messa in opera, il quale del resto è poco, fortunatamente, e si riduce a illustrare i punti segnati colle due righe che appaiono in bianco sul cartellone nero: «Hanno ammazzato compare Turiddu». Poco dopo si decide a collaborare anche lui alla redazione delle didascalie. Tutta la corrispondenza degli anni successivi ha come motivo conduttore i soggetti cinematografici che Verga via via elabora anonimamente per l’amica, i guadagni e il tipo di degradazione che questi soggetti attuano rispetto ai testi originali. Poco per volta Verga entra nel meccanismo del racconto cinematografico e, in alcuni casi, osserva anche con soddisfazione i frutti di questo suo lavoro anonimo: «Sto pensando di mandarvi un altro bozzetto di Caccia alla volpe, che se mi riesce bene farà un buon paio con Caccia al lupo. La galoppata della prima parte di quei cacciatori eleganti per la campagna romana mi par venuta e bene, sino alla finta caduta del giovane che vuol servirsene per restare solo con la bella amazzone. La difficoltà rimane nel rendere «senza parola» le scene seguenti nel casotto di caccia. Ma ci sto pensando e vedremo». E in una lettera successiva. «Dunque gli artisti parlano anche per cinematografo? Tanto meglio. Basterà aggiungere quelle battute che saranno necessarie per la prima parte… appena avrò abbozzato a buon punto il lavoro che sembra venire discretamente, ve lo manderò». Nel giro di quattro anni, tra il 1912 e il 1916, si può registrare una vera e propria parabola nell’atteggiamento di Verga, tra diffidenza iniziale e timida adesione, curiosità e sospetto, partecipazione e speranza e delusione progressiva: «Dello sviluppo enorme che ha preso lo spettacolo cinematografico e del bisogno sempre crescente che avranno perciò di soggetti cinematografici, più o meno noti, qualcosa deve arrivare». Negli anni che precedono la guerra c’è una sorta di scalata di entusiasmo, favorita anche dall’interessamento attivo di De Roberto, ma già con le prime avvisaglie del conflitto, tutti i progetti cadono di colpo: «L’amico De Roberto s’è occupato della Caccia al lupo e della Storia di una capinera, che gli ho affidato per il cinematografo… Ma come potete immaginare per ora non se ne fa nulla, con i tempi che corrono… Non vi mando di nuovo quelle mie trame cinematografiche per non trovarci in qualche imbroglio tutti quanti siamo. Non ve ne occupate più». Qualche mese dopo la sua presa di distanza e la sua amarezza si fanno più forti: «Cercate di evitarmi il ridicolo di vedermi pupazzettato anche in cinematografo… Adesso ho una questione con altri che vorrebbero mettere il mio nome sul cartellone di Cavalleria rusticana in 34
cinematografia, altro che come autore della novella e del dramma e basta. Io fo il cantastorie e non il burattinaio. E badate soprattutto a non lasciarvi prendere in qualsiasi modo ad assumere impegni in queste faccende cinematografiche sempre gravide di sorprese, anche fuori di scena» . In una delle sue ultime lettere così scrive infine l’autore dei Malavoglia: «Anche quel cinematografo che ha preso il posto del teatro, è proprio una fantasmagoria» . Verga si può considerare il più significativo esempio del letterato con la sindrome di Fantomas e questa duplicità di atteggiamenti (lo schermo gli appare come una trappola infida, ma anche come un miraggio che fa balenare le luci di facili guadagni) ne fa l’archetipo di un tipo di comportamento destinato a durare a lungo. Per anni ha voluto in pratica rimanere al di fuori del contatto con la sala e lo schermo come un catecumeno: il battesimo cinematografico vero e proprio per lui non c’è mai stato, sebbene abbia continuato ad aggirarsi nei paraggi, attratto e al tempo stesso bloccato, dal proprio orgoglio e da un super io artistico e professionale. Eppure è anche grazie a questo atteggiamento che le sue opere, con sistemi quasi di contrabbando, hanno raggiunto lo schermo e cominciato a porsi come punto di riferimento fondamentale per un tipo di accostamento alla realtà siciliana. Sia per gli scrittori veristi che per i futuristi il rapporto col cinema non produce alcuna sostanziale modifica linguistica o strutturale. L’assorbimento dei primi è progressivo e in alcuni casi (vedi Bracco) si traduce anzitutto nella collaborazione più attiva e in una sorta di copertura culturale al saccheggio vero e proprio di tutto il repertorio teatrale, nel secondo caso non avviene alcun tipo di incontro tra industria e poetica futurista capace di realizzarsi. I futuristi elaborano un manifesto sul cinema a molti anni di distanza rispetto al primo manifesto di tutto il movimento: questo ritardo è il segno che anche nei confronti di un movimento d’avanguardia il cinema incontra non poche difficoltà e diffidenze, anzitutto quella di essere soltanto «la precisa meccanica, glaciale riproduzione della realtà» come osserva già Bragaglia nel 1911 . «Fino al 1916 – nota Franca Angelini – Marinetti e i futuristi non sembrano percepire appieno la reale portata della funzione della macchina nel cinema né i problemi connessi a questa identità, cioè la nascita col cinema di un’ideologia nuova del pubblico e del «consumo» dell’arte da parte del pubblico. Sembra che cinema e futurismo corrano su strade parallele: l’ideologia della macchina futurista si arresta di fronte alla produttività linguistica della macchina cinematografica e alla trasformazione che implica nei rapporti sociali quindi nel rapporto tra arte e pubblico: l’ideologia del pubblico è praticata dai futuristi solo in modo artigianale, individualistico, legato al gesto del protagonista; il gesto si realizza nel comizio e nella serata, provoca direttamente il pubblico affermando per il provocatore «la voluttà d’essere fischiato» e negando così la socializzazione di questo circuito, la sua pianificazione, la sua riproducibilità, la collettività dell’operazione, la sua omologia con altri processi produttivi della società industrializzata» . Marinetti, in effetti, aveva già osservato la funzione antropologica del cinema in un suo intervento di qualche anno prima e già aveva sottolineato la possibilità di compiere, grazie al cinema, esperienze altrimenti impossibili. Riprendere dunque in considerazione il problema del cinema futurista, sia dal punto di vista delle teorie e delle poetiche e dell’influenza dei futuristi sul cinema – anche se oggi la letteratura, grazie soprattutto agli studi di Mario Verdone e Giovanni Lista è consistente – vuol dire in ogni caso occuparsi di una realtà virtuale, di un fantasma utopico . In effetti i futuristi per primi affermano con forza l’autonomia artistica del cinema: «Il cinematografo è un’arte a sé. Il cinematografo non deve dunque mai copiare il palcoscenico. Il cinematografo, essendo essenzialmente visivo, deve compiere anzitutto l’evoluzione della pittura: distaccarsi dalla realtà, dalla fotografia…» . La luce, grazie alla presenza attiva di Giacomo Balla nel movimento futurista, si è così concretizzata in immagine nel film Vita futurista: «Altra novità – troviamo scritto nell’articolo citato sull’‘Italia Futurista’ del 10 febbraio 1917 dal titolo La prima del mondo della Cinematografia futurista – è quella di aver tentato nuovi effetti di luce con riflessione di raggi in movimento. Non più i chiari di luna e le giornate di sole spaccante, da dei razzi, degli scherzi, delle fiumane di luce in movimento» . E poco prima scrive ancora lo stesso Settimelli «Per mezzo delle deformazioni si arriva a lanciare, suggestivamente, i cervelli degli spettatori in zone d’irrealtà che ci permettono le scene più bizzarre» . Il cinema è dunque la nuova arma che Morasso aveva celebrato nell’automobile e si presenta come il più 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
straordinario modificatore di tutte le forme artistiche, quella nuova forma d’arte e nuova Musa da tempo profetizzata e attesa, ma anche, secondo Marinetti è uno «dei luoghi abitati dal divino» in quanto incarna il senso della velocità. Nel Manifesto tecnico della letteratura futurista Marinetti pensa evidentemente al montaggio cinematografico quando scrive come si è già detto che «la poesia deve essere un seguito ininterrotto d’immagini nuove» e soprattutto ipotizza la creazione di «strette reti di immagini o analogie». È il movimento della pellicola, la possibilità di accostare tra loro oggetti simili e difformi nella più totale libertà, per cogliere lo spirito e l’anima del movimento della materia, a ispirare i suoi lavori poetici, a consentirgli di dar vita alle catene d’immagini. Qualsiasi tipo di approccio s’intenda effettuare e qualunque ipotesi si adotti è certo che le esperienze dell’avanguardia cinematografica degli anni Venti formano un insieme entro cui affluiscono tutti i linguaggi visivi, poetici, architettonici, musicali e interagiscono con una velocità e una ricchezza e complessità non riscontrabili in alcun altro terreno artistico o dello spettacolo. Ma bisogna anche riconoscere che il cinema è al lavoro precocemente e opera modificazioni visibili sulle scritture letterarie, poetiche e narrative in una misura superiore a quanto non si sia mai finora osservato. Un passaggio fondamentale è dato – come abbiamo più volte detto – dal riconoscimento dell’influenza del cinema sulla creatività degli artisti del primo Novecento. Le dichiarazioni in questo senso si moltiplicano e non solo in Italia. Nel secondo decennio del Novecento un insieme di poeti, da Marinetti a D’Annunzio ad Apollinaire e a molti altri immaginano, quasi all’unisono, che il cinema assuma un ruolo di arte guida, capace di distruggere e rinnovare tutto il sistema delle arti. Quanto ai rappresentanti italiani del verismo, da Verga a Bracco, da Martoglio a Di Giacomo, alla Serao, alla Deledda, sono gli autori che hanno rapporti più contraddittori col cinema: ne colgono la portata sociale, ma sentono i pericoli della perdita di immagine della loro opera. Intervistato da «Lux» (nel primo numero del 1908) Roberto Bracco aveva sostenuto che i suoi lavori difficilmente si sarebbero adattati al cinematografo, ma in generale la conversione di molti di questi autori non nasce da una scelta precisa di poetica, quanto piuttosto da motivi assai più banali di ottenimento di guadagni facili senza eccessivi compromessi con la propria immagine pubblica. Gli autori veristi consumano un loro lavoro anteriore, non producono opere appositamente per il cinema. La Morgana film di Catania sembra un’unica eccezione in questo quadro nel senso che vara un programma di film a carattere realistico e a questo programma risponde anche Luigi Pirandello «proponendo alcuni temi minutamente compiuti e sceneggiati» di cui non si farà poi più nulla per il fallimento della casa siciliana che aveva appena fatto a tempo a realizzare tre film tra cui Sperduti nel buio. Il cinema resta comunque, per autori crepuscolari, dannunziani, simbolisti, veristi o futuristi il prodotto di una macchina che favorisce il divertimento, ma non può certo ambire a essere arte: «Il solo torto che si può fare e che va fatto al cinematografo è quel suo pretendere ad arte. Ciò lo danneggia e danneggia realmente l’arte… che la macchina comandi sia, ma che uccida l’arte, no, né può essere» . L’autore o lo scrittore che inizia a lavorare per il cinema rileva i suoi timori per la macchina allineandosi con tutta una tradizione letteraria tardo romantica. Lo scrittore e l’opera letteraria vogliono mantenere la loro superiorità e al tempo stesso dichiarano la loro estraneità pur paventando ogni sorta di pericoli. Tra tutti gli intellettuali e scrittori del Novecento però la figura di Pirandello è quella che si muove e viene coinvolta a vari livelli negli ingranaggi della macchina cinema e che vede il cinema entrare in modo sempre più significativo nella sua biografia culturale. È soltanto però nel 1916, per la prima volta, con Iquadernidi Serafino Gubbio operatore che avviene grazie a Pirandello un rovesciamento del rapporto tra cinema e letteratura e il cinema diventa oggetto di racconto e irrompe a sua volta nella narrazione, presentandosi a tutto campo, nell’ampiezza dei suoi problemi . La rappresentazione del mondo del cinema, ormai perfettamente definito nelle sue leggi e nei suoi funzionamenti è ottenuta grazie a un punto di vista interno alla realtà descritta (l’io narrante, Serafino Gubbio è un operatore cinematografico), di cui proprio per la particolare professione del narratore si intende soltanto registrare con un’obiettività omologa a quella della macchina da presa, il comportamento. Tutti i problemi relativi ai processi di realizzazione filmica vengono coordinati entro le grandi categorie pirandelliane della realtà e della finzione, dell’autentico e dell’inautentico, della recita e della verità. L’occhio impassibile della 45
46
47
48
macchina da presa scompone e ricompone il reale secondo procedimenti che ne rispettano le leggi. L’uomo, schiacciato in una visione apocalittica da un ingranaggio di progressiva meccanizzazione, non ha più alcun sentimento, non ha più anima. Il romanzo è importante anche per il fatto che un letterato riesce a raccogliere e a definire, per mezzo di un linguaggio assai pertinente, tutta la terminologia specifica di questa nuova forma di spettacolo . Quest’opera non modifica né aggiunge nulla al sistema linguistico del cinema, ma segna certo un’ulteriore presa di coscienza di una serie di problemi specifici molto ampia. Pirandello pone sul tappeto i temi fondamentali che regolano il campo cinematografico e promuove un’opera di fiction a una piena dignità di opera di critica e teoria del cinema. Ma constatato questo si può allargare lo sguardo per cercare di capire qualcosa di più ampio e profondo legato all’incidenza complessiva dell’opera di Pirandello sul cinema e sulla cultura del Novecento. Per quanto riguarda l’influenza sul cinema si può parlare inizialmente di una perfetta dimostrazione delle teorie del caos e del caso: Pirandello si affaccia timidamente, ultimo di una schiera cinematografica, nella nuova piazza dei mestieri dello spettacolo agli inizi del secondo decennio del Novecento. La sua, rispetto a quella di D’Annunzio è una presenza che si può definire quasi invisibile. Eppure I quaderni di Serafino Gubbio operatore agiscono in maniera stereoscopica non solo sul cinema, ma sulla lingua, sulla teoria, sulla letteratura cinematografica, sul divismo nascente prima ancora che lo stesso Pirandello adotti consapevolemente il cinema come arte e mezzo privilegiato per trasmettere la memoria di sé . Pirandello inaugura con I quaderni di Serafino Gubbio operatore – come ha indicato Gavriel Moses – un nuovo genere letterario internazionale in cui cinema e ripercussioni «epistemologiche ed esistenziali» di questo nuovo mezzo sono descritte con i mezzi della narrativa in un modo ibrido che mescola il diario e il racconto . IQuaderni di Serafino Gubbio operatore, per dirla con Franco Moretti, sono un’«opera mondo», i cui effetti si notano sia subito che nel lungo periodo, sul piano dei modi narrativi, dell’invenzione linguistica, della produzione teorica e della pratica cinematografica a partire dalle teorizzazioni del Cineocchio da parte di Dziga Vertov negli anni Venti. La dichiarazione di Serafino di essere «una mano che gira una manovella» sembra influenzare in maniera assolutamente diretta il manifesto del Cineocchio di Vertov quando afferma: «Io sono il Cineocchio. Sono l’occhio meccanico. Sono la macchina che vi mostra quell’aspetto del mondo che può vedere soltanto lei» e, in maniera altrettanto evidente, gli scritti di Walter Benjamin sull’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica o di Siefried Krakauer. Effetti dell’onda lunga del pensiero pirandelliano si vedranno lungo tutto il Novecento, sia nella letteratura, che nel teatro e nel cinema. Gubbio, in pratica, segnala e registra la genesi di quella condizione post umana di cui si sta occupando il cinema di Cronenberg o dei film con Arnold Schwarzenegger come Terminator. Il cinema entra come luogo privilegiato e transfert di sogni, ideali e percezioni dell’immaginazione creativa, quasi fosse la perfetta dimostrazione delle teorie e del pensiero di Schopenhauer. Non solo vengono modificati i meccanismi percettivi dell’autore, la sua scrittura, ma viene addirittura riplasmata la funzione del letterato, il suo ruolo, la sua identità, il suo senso del sé. La rappresentazione del cinema diventa una via per la presa di coscienza, anzi la via privilegiata di presa di coscienza di questa trasformazione. Il romanzo sul cinema diventa una sorta di autoriflessione, un modo per capire cosa sta effettivamente cambiando nel lavoro del letterato a causa dell’avvento del mezzo cinematografico. Non si contano, in effetti, i romanzi del Novecento che si pongono all’interno della macchina dei sogni cinematografica per smontarne e rivelarne i meccanismi, o la capacità di dar luogo da una parte solo a mondi fantasmatici, fragili e illusori, destinati a dissolversi come bolle di sapone, dall’altra a processi metamorfici. Da Cinema & Cie di Delluc a L’Adams di René Clair, a Moneta del sogno di Marguerite Yourcenar, dal Giorno della locusta di Nathanael West a Gli ultimi fuochi (The Last Tycoon) di Francis Scott Fitzgerald, a Laughter in the Dark di Vladimir Nabokov, dal Disprezzo di Moravia a Lancelot di Walker Percy, fino a romanzi di Gore Vidal o Manuel Puig, la narrativa europea e americana, senza parlare del cinema, hanno cercato di osservare i modi di realizzazione di un film a Hollywood come a Roma, Parigi o Berlino e di raccontare la lotta dell’individuo per difendere la propria integrità e non essere cannibalizzato dalla macchina. L’opera pirandelliana si offre come insieme così vasto di temi, di situazioni, di riflessioni sulla precarietà e assurdità dell’esistere, sul gioco delle maschere e dei ruoli sociali, sull’apparire e sull’essere dell’uomo 49
50
51
comune da divenire alimento naturale, plancton per l’immaginazione cinematografica internazionale di tutto il secolo che ne metabolizza e metamorfizza di continuo novelle, romanzi e drammi teatrali. Anche se ben mimetizzata e assorbita nel territorio la presenza dello spirito pirandelliano è sempre ben registrabile senza ricorrere ad apparecchiature sofisticate Pescando a strascico, sembra evidente che all’opera di Pirandello si ispirino o attingano in maniera diversa Lucio D’Ambra – che del drammaturgo era amico – dell’Illustre attrice Cicala Formica e Augusto Genina di Prix de beauté del 1929, o Mario Soldati al suo esordio con Dora Nelson (Soldati ha lavorato in Acciaio nel 1933) o Chaplin degli anni Trenta, sia per l’atteggiamento assunto nei confronti del sonoro che per elementi specifici, quali quelli dello sdoppiamento di personalità in Luci della città, della trasformazione dell’uomo in una parte dell’ingranaggio della fabbrica in Tempi moderni (un richiamo esplicito), o nel motivo del doppio in Il grande dittatore. Ma anche Orson Welles di Quarto potere o Kurosawa di Rashomon tentano di ricostruire una realtà cercando di districarsi nel gioco di specchi delle apparenze. Pirandello sembra essere il genio della lampada che guida verso nuovi orizzonti il cammino del vagabondo chapliniano. Dell’influenza su Fantasia di Walt Disney del pensiero di Pirandello sulla cinemelografia si è già detto e scritto anche da parte di Mario Verdone. Scegliendo a caso nel cinema del dopoguerra si può vedere come si è detto l’ombra pirandelliana sul cinema di Antonioni e Bergman, di Fellini, Pasolini, Kurosawa, Kubrick e Woody Allen… Discendenti degli eroi pirandelliani sono i John Doe di Capra, o i Forrest Gump di Zemeckis, o i Truman Burbank di Weir o il personaggio di Benigni nella Vita è bella che riesce a costruire un mondo alternativo per il piccolo Giosué, perfetto e più vero del vero. Non è la riduzione, il sommario o il centone del dramma e della novella pirandelliana che ci dà la misura della sua influenza e della sua capacità di operare una sorta di fissione nucleare, quanto piuttosto la naturalezza con cui immagini, situazioni e problemi passano e vengono ripresi e quasi dissolti in altri contesti da parte di altri autori. Quanto delle polveri, dei frammenti dei Sei personaggiin cerca d’autore o del Fu Mattia Pascal viene più o meno riutilizzato in film diversissimi come Il bandito senza nome (Somewhere in the Night di Jioseph L. Mankiewicz, 1946) o come 81/2, Professione: reporter, Gattaca, Dave, The Game, Il ritorno di Martin Guerre, Sommersby, Forrest Gump o in buona parte dei film di Allen (nelle sue memorie Ejzenštejn ricorda un’idea di Pirandello per un soggetto da fare insieme nel contratto con la Paramount in cui «lo schermo scambia ingiurie con la cabina di proiezione. Gli uomini sullo schermo non vogliono sottostare alla volontà che li ha mandati lì», che ritroviamo nella Rosa purpurea del Cairo di Allen o in The Truman Show di Peter Weir), è un’operazione tutta da verificare, ma legittima e sicuramente redditizia. Per capire il senso del tragitto e della gittata della cometa pirandelliana è forse opportuno confrontarla ora rapidamente con l’apparizione improvvisa nel firmamento cinematografico della stella dannunziana. È vero che nei confronti del corpo letterario di Pirandello il cinema ha compiuto un’azione di smembramento e massacro analoga a quella da lui descritta in Si gira…, ma mentre la storia di D’Annunzio è di breve durata e praticamente si spegne assai presto dopo aver raggiunto rapidamente il suo climax, quella di Pirandello agisce sul tempo lungo, ne vede il modificarsi progressivo delle posizione, l’adottare la nuova arte come mezzo privilegiato di trasmissione della propria poetica e della propria concezione del mondo e dello spettacolo. La storia di Pirandello – come sappiamo – è intessuta di paure, rifiuti, negazioni e negoziazioni, fallimenti, ma anche di un grande investimento affettivo e di entusiasmi che periodicamente si accendono e fanno intravvedere mondi possibili mai percepiti da nessuno in precedenza. Pirandello nei confronti del cinema appare una creatura angelica proprio perché quando spicca il volo le sue ali sembrano dotate di molti occhi, della polioftalmia. Se D’Annunzio entra trionfalmente nel cinema e viene promosso ai gradi di guida ideale di un progetto di colonizzazione del pubblico di tutto il mondo, Pirandello all’inizio invece sembra un personaggio kafkiano, fermo e indeciso sulla porta di servizio, assume il punto di vista dell’ultimo dei personaggi nella scala gerarchica e non è animato da alcun desiderio apparente di conquista, anche se il cinema si rivelerà poi il farmaco più efficace e potente per soddisfare per qualche tempo le sue ambizioni di riconoscimento universale che troveranno comunque la consacrazione definitiva con l’assegnazione del premio Nobel nel
1936. M. Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, Einaudi, Torino 1975, p. 139. Ho ripreso e sviluppato i temi di questo capitolo in un saggio apparso nel 1980: La emigrazione dei generi dalla biblioteca alla filmoteca dell’italiano, in «Italian Quarterly», a. XXI, n. 81, Summer 1980, pp. 83-90. Si veda anche l’ampia sintesi di A. Abruzzese e A. Pisanti, Cinema e letteratura, in AA.VV., Letteratura italiana, vol. II, Einaudi, Torino 1983, pp. 807-836. 1
Di recente è uscito l’importante lavoro di Silvio Alovisio che sulla base di una perlustrazione sistematica di documenti degli archivi dell’Ambrosio, a cui hanno collaborato importanti scrittori italiani negli anni del muto, disegna un quadro analitico in gran parte nuovo sui modi di realizzazione di una sceneggiatura e sulle modifiche progressive del ruolo e della funzione creativa e autoriale dello sceneggiatore: S. Alovisio, Voci del silenzio. La sceneggiatura nel cinema muto italiano, Museo nazionale del cinema/Il Castoro, TorinoMilano 2005. 2
Il rapporto tra Gozzano e il cinema è stato studiato da Sergio Raffaelli dal punto di vista linguistico in Il cinema di Gozzano: presenze linguistiche, in F. Pierangeli (a cura di), Studi in onore di Emerico Giachery, Vecchiarelli Editore, Manziana 2001. 3
4
C. Casella, Poesia e cinematografo, Conversando con G. Gozzano, in «La vita cinematografica», a. I, n. 2, 20 dicembre 1910.
Il testo è citato in F. Pertile, G. Gozzano cineasta, in «Bianco e Nero», a. III, n. 1, gennaio 1939. Si veda anche M. Gromo, G. Gozzano cineasta, in «La Stampa», 24 maggio 1932. 5
6
G.P. Brunetta, Identità e radici culturali, in Id. (a cura di), Storia del cinema mondiale, vol. I, Einaudi, Torino 1999. p. 2.
7
J. Joyce, Epifanie (1900-1904), a cura di G. Melchiori, Mondadori, Milano 1982.
G. Petronio, Pirandello e il cinema, in E. Lauretta (a cura di), Pirandelloe il cinema, Centro nazionale studi pirandelliani, Agrigento 1978, p. 35. 8
La lettera, datata 14 settembre 1911, fa parte di un fondo di 82 lettere, 20 telegrammi, 10 biglietti, 4 cartoline e alcuni biglietti da visita conservato presso gli archivi del Vittoriale. Su Canudo si vedano almeno G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, Einaudi, Torino 1960; M. Verdone, Introduzione all’Officina delle immagini, Ed. Bianco e Nero, Roma 1966; P. Sorrenti, Ricciotto Canudo fondatore dell’estetica cinematografica, Laterza e Polo, Bari 1967. 9
10
G. Pastrone, Cabiria, a cura di R. Radicati e R. Rossi, Museo del Cinema, Torino 1977, p. 202.
Cfr. il mio La conquista dell’impero dei sogni, in C. Catania (a cura di), Pirandello e D’Annunzio nel cinema, Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Agrigento 1988, pp. 9-30 e A. Costa, Dante, D’Annunzio, Pirandello, in R. Renzi (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo 1905-1930, Cappelli, Bologna 1991, pp. 59-69. 11
12
In R. Canudo, L’usine aux image, a cura di J.-P. Morel, Seguier, Paris 1995, p. 126.
13
Ivi, p. 34.
Renato Serra coglieva alla vigilia della guerra la moltiplicazione di occasioni di lavoro per il letterato in termini di apertura di un mercato dell’industria culturale che stava allargando al massimo i suoi limiti: «C’è il teatro, la fabbrica dei libretti d’opera, il cinematografo, che finiscono per mettere in valore, come si suol dire, l’opera dei nostri scrittori. Per poco che uno abbia d’ingegno e di produttività, è sicuro di ricavarne qualcosa dal mercato», R. Serra, Le lettere, in Id., Scritti, vol. I, Le Monnier, Firenze 1958, p. 243. 14
G. Gozzano, Opere, vol. V, Treves, Milano 1937. Si veda anche l’ampio saggio introduttivo di ricostruzione dei rapporti tra Gozzano e il cinema di M. Masoero a G. Gozzano, San Francesco d’Assisi, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1997, pp. vii-xxxvii. 15
G. Calendoli, Giovanni Verga soggettista e sceneggiatore, in Id., Materiali per una storia del cinema italiano, Maccari, Parma 1967, pp. 115-121. V.M. Cardillo, Tra le quinte del cinematografo. Cinema cultura e società in Italia 1900-1937, Dedalo, Bari 1987. 16
17
In G. Raya (a cura di), Verga e il cinema, Herder, Roma 1984, p. 33.
«In un certo senso, verrebbe voglia di dire che per questi letterati umanisti del primo Novecento il cinema era ciò che per il borghese (piccolo, medio, alto) era la prostituta. Era questa, o pareva un male, ma un male necessario ad attirare e a scaricare su di sé, quasi un parafulmine, la concupiscenza maschile sicché le ‘vergini belle e pure’… potessero gelosamente custodire la loro verginità; egualmente il cinema, scaricando su di sé le basse voglie del volgo, poteva consentire al teatro di mantenere intatta la sua verginità artistica», Petronio, Pirandello e il cinema, cit. p. 35. Si vedano inoltre i fondamentali contributi di G. Raya a cui si deve la raccolta di lettere verghiane Lettere d’amore, Tindalo, Roma 1971 e Verga e il cinema, Herder, Roma 1984. Inoltre si veda l’ottimo lavoro di S. Zappulla Muscarà, Contributi per una storia dei rapporti tra letteratura e cinema muto (Verga De Roberto Capuana, Martoglio e la settima arte), in «La rassegna della letteratura italiana», a. LXXXVI, n. 3, settembre-dicembre 1982 ripreso in Ead., Letteratura teatro cinema, Tringale, Catania 1984. 18
19
A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 307.
20
G. Gozzano, Il nastro di celluloide e i serpi di Laocoonte, in «La donna», 1916, ora in Id. Poesie e prose, Garzanti, Milano 1961, p. 1089.
21
M. Serao, recensione a La mia vita per la sua, in «Il giorno», 1914.
Per la critica italiana si possono vedere vari contributi scorrendo le bibliografie degli atti del convegno su D’Annunzio e il cinema in AA.VV., D’Annunzio e il cinema, in «Quaderni del Vittoriale», n. 4, agosto 1977; per le reazioni straniere si veda ancora una volta il saggio di D. Turconi, I film storici italiani e la critica americana dal 1910 alla fine del muto, in «Bianco e Nero», a. XXIV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1963. 22
23
Sempre Cabiria. L’avvenimento massimo, in «Film», a. I, n. 8, 29 marzo 1914, p. 1.
24
Il testo è nell’intervista A colloquio con G. D’Annunzio del «Corriere della Sera», del 28 febbraio 1914.
Per la prima volta un organo della cultura borghese riconosce a Cabiria la perfetta fusione di elementi d’arte e di interessi industriali e sottolinea come il successo nasca da questa ottimalizzazione di tutte le energie intellettuali ed economiche: «La fusione degli elementi cinematografici musicali e vocali è riuscita veramente perfetta e lo spettacolo della grande visione storica di D’Annunzio, che costituisce il più grande tentativo d’arte del genere fin qui compiuto, è veramente magnifico. Il nobile sforzo dell’Itala film di Torino, che per allestire Cabiria ha profuso un milione, è stato coronato da un successo degno dell’avvenimento d’arte», in «Corriere della Sera», marzo 1914 e riportato anche in «Rassegna contemporanea», a. VII, n. 4, aprile 1914, p. 349. Cfr. anche V. Attolini, Dal romanzo al set. Cinema italiano dalle origini a oggi, Dedalo, Bari 1988. 25
26
Salvatore Di Giacomo e il cinematografo, in «Cinema illustrato», a. I, n. 1, 16 giugno 1917.
27
G. Pastrone, Cabiria, a cura di M.A. Prolo, Museo nazionale del cinema, Torino 1977.
S. Alovisio e A. Barbera (a cura di), Cabiria & Cabiria, Museo nazionale del cinema/Il Castoro, Torino-Milano 2006. Il catalogo raccoglie l’insieme di contributi più significativi sul cinema muto italiano che siano stati pubblicati nell’ultimo decennio che pure ha registrato il proliferare e la maturazione crescente di una saggistica di qualità interpretativa e non solo descrittiva. Si veda anche il volume uscito in occasione del primo tentativo di restauro dell’edizione del 1914: S. Toffetti (a cura di), Il restauro di Cabiria, Museo nazionale del cinema, Torino 1995. 28
Si veda il capitolo Evoluzione della lingua delle didascalie nel mio Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Patron, Bologna 1972, pp. 63-77 e il saggio di S. Raffaelli, Ipotesi per ricerche sul linguaggio verbale nel cinema muto, in «Annali della Scuola superiore di comunicazioni sociali», a. I, fasc. 1-2, 1973, pp. 42-68. 29
30
S. Raffaelli, Il D’Annunzio prosatore nelle didascalie dei suoi film, in AA.VV., D’Annunzio e il cinema, cit., pp. 27-36.
Il testo completo della sceneggiatura e un ricchissimo corredo fotografico con tutte le inquadrature del film è nel citato volume di Pastrone su Cabiria curato dalla Prolo. Si veda inoltre Omaggio a Giovanni Pastrone, in «Centrofilm», a. II, n. 14, ottobre 1960. 31
Questo motivo dell’opera d’arte che prende vita è ripreso dallo stesso D’Annunzio in un soggetto mai realizzato, L’uomo che rubò la Gioconda, del 1920, il cui testo, apparso nelle opere complete, è stato ripubblicato da M. Verdone, in Poemi e scenari cinematografici d’avanguardia, Officina, Roma 1975, pp. 74-85. Sui rapporti tra D’Annunzio e il cinema italiano Mario Verdone è intervenuto a più riprese; di lui segnalo la relazione al convegno su D’Annunzio e il cinema e quella al convegno nel 1963 su L’arte di Gabriele D’Annunzio, i cui atti 32
sono usciti da Mondadori nel 1968. 33
Il testo è ricordato in un intervento da Sergio Raffaelli al convegno in AA.VV., D’Annunzio e il cinema, cit., p. 95.
34
Cfr. S. Zappulla Muscarà, Contributi per una storia dei rapporti tra letteratura e cinema muto, in Id., Letteratura teatro e cinema, cit.
35
Ivi, p. 74.
36
Ivi, p. 89.
37
A.G. Bragaglia, Fotodinamismo futurista, Einaudi, Torino 1970, p. 27.
F. Angelini, Dal teatro muto all’antiteatro. Le teorie del cinema all’epoca di «Si gira», in Lauretta (a cura di), Pirandello e il cinema, cit., p. 71. 38
Verdone è l’autore che più ha studiato i rapporti tra futurismo e cinema: della sua vasta bibliografia vanno almeno ricordati Gli intellettuali e il cinema, Ed. Bianco e Nero, Roma, 1952, Cinema e futurismo, in «La Biennale di Venezia», XIV, n. 54, settembre 1964, pp. 15-25, Anton Giulio Bragaglia, Ed. Bianco e Nero, Roma 1965, Cinema e letteratura del futurismo, in «Bianco e Nero», a. XXVIII, n. 10-12, ottobre-dicembre 1967, ripubblicato a Rovereto dall’editore Manfrini nel 1990, Futurismo: film e letteratura, «Annali d’italianistica», VIII, 39
1988, pp. 68-79. Dell’attività più che ventennale di Giovanni Lista mi limito a citare il più recente Cinema e fotografia futurista, Skira, Milano 2001, edito in occasione di una mostra al Museo d’Arte moderna di Trento e Rovereto, che costituisce una summa e una messa a punto delle sue ricerche corredata di una ricchissima bibliografia e filmografia. 40
Molto ricca nella documentazione o in molte parti innovativa la tesi di dottorato discussa ad Anversa nel gennaio 2000 di Wanda Strauven, F.T. Marinetti e la cinematografia futurista, tra attrazione e sperimentazione ora pubblicata da Campanotto, Udine 2006. 41
F.T. Marinetti et. al., Cinematografia futurista. Manifesto, in «L’Italia futurista», a. I, n. 10, 15 novembre 1916, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1968, p. 104. 42
43
Ibidem.
44
Ibidem.
45
Ora ivi, p.114.
46
N. Martoglio, Come nacque Pensaci Giacomino, in «Cinema», a. I, n. 12, 25 novembre 1936.
47
Gli avvenimenti, in «Apollon», a. I, n. 5, giugno 1916.
È d’obbligo richiamare il titolo di Cinematografo cerebrale di Edmondo De Amicis del 1909, ma si tratta di un racconto il cui sviluppo narrativo intende essere il corrispettivo onirico di una visione cinematografica. Il racconto omonimo appare per la prima volta sull’«Illustrazione italiana» nel dicembre del 1907. Una serie di studi e ricerche hanno fatto in questi anni avanzare la conoscenza dei rapporti tra Pirandello e il cinema in modo decisivo: cfr. N. Genovese e S. Gesù (a cura di), La musa inquietante di Pirandello: il cinema, Bonanno, Palermo 1990 e F. Callari, Pirandello e il cinema, Marsilio, Venezia 1991. 48
49
Si veda pp. 23-27 nel mio Intellettuali, cinema e propaganda, cit. Gavriel Moses vede nel romanzo l’inaugurazione di un vero e proprio
nuovo genere letterario, la film-novel: Pirandello e il cinema nei generi letterari, in Catania (a cura di), Pirandello e D’Annunzio nel cinema, cit., pp. 33-45. La letteratura su quest’opera si è negli ultimi anni enormemente arricchita: si vedano, tra gli altri, F. Angelini, Serafino e la tigre. Pirandello tra scrittura e cinema, Marsilio, Venezia 1990, Genovese e Gesù (a cura di), La musa inquietante di Pirandello: il cinema, cit., Callari, Pirandello e il cinema, cit., M.A. Grignani (a cura di), Pirandello e il cinema, La Nuova Italia, Firenze 1991, L. Termine, Pirandello e la drammaturgia del film, Fiorinovelli, Torino 1997. 50
51
Moses, Pirandello e il cinema nei generi letterari, cit.
Le origini della critica
il cinema scritto La nascita del cinema è favorita dal giornalismo d’impronta positivistica della fine Ottocento, che per la sua duplice natura onnivora e onnipresente è sempre pronto, con perfetto tempismo, a esaltare ogni nuova conquista scientifica e tecnologica. Le prime testimonianze sul cinema appaiono – come si è visto – su riviste fotografiche specializzate: il discorso in queste sedi è fatto sia tenendo conto delle esigenze divulgative, che di quelle più propriamente scientifiche. Su periodici come «Il progresso fotografico», «Il dilettante di fotografia», «La società fotografica italiana», «Fotografia artistica», troviamo le prime dettagliate descrizioni della nuova invenzione, dei suoi effetti, della sua importanza scientifica e delle sue possibili applicazioni. Mentre su questi periodici strettamente specializzati, nonostante le intenzioni divulgative, prevale l’interesse per gli aspetti scientifici dell’invenzione e non se ne prevedono le possibilità di applicazione sul terreno narrativo o espressivo, sulla stampa d’informazione, sui quotidiani, si colgono, fin dalle prime proiezioni pubbliche, le potenzialità d’uso sociale del nuovo apparecchio. Anzitutto viene suggerita la possibilità di usarlo come deterrente e prova testimoniale a carico dei dimostranti nelle manifestazioni di piazza: «Tra le tante applicazioni possibili, una mi viene in mente. Dotare di una macchinetta ad hoc i funzionari di P.S. destinati a presenziare, ad esempio, le fasi di certe dimostrazioni piazzaiole… Per certe dimostrazioni in America hanno già adottato il sistema della pompa idraulica a getto persuasivo. Perché non combinare insieme i due sistemi? La fotografia per reprimere e l’acqua per prevenire! L’ideale della tranquillità sociale» . È logico che al fervore di interventi e all’entusiasmo iniziale per la novità della scoperta segua poi, per alcuni anni, in mancanza di una produzione regolare, il silenzio pressoché totale, o un’attività sparsa di pure informazioni sulle programmazioni cinematografiche saltuariamente realizzate nelle città. La nascita delle prime riviste appositamente dedicate al cinema è di poco posteriore alla nascita delle prime case. La prima rivista che si occupa con una certa frequenza dei programmi cinematografici è una rivista napoletana di teatro, «Il Tirso», che fin dalla sua nascita (1904) ospita una rubrica fissa, Il Tirsoal cinematografo, dove sono raccolte informazioni sulle programmazioni, sui film, sulle case cinematografiche . Il fatto che per molti storici e critici del cinema la nascita di una critica cinematografica di tipo moderno, dotata di una precisa qualifica professionale, sia molto posteriore e si possa riconoscere soltanto alla fine degli anni Venti , è giustificato dall’estrema dispersione, improvvisazione e casualità dei primi materiali, dal disinteresse apparente degli intellettuali più rappresentativi, dalla loro marginale partecipazione ai dibattiti sul cinema e dalla evidente dipendenza, nella maggior parte dei casi, della critica dagli interessi delle case di produzione. In realtà gli intellettuali giungono al cinema non con una adesione compatta e unanime, ma in ordine sparso, cercando il più delle volte di dissimulare la propria presenza, o intervenendo quasi sempre a sottolineare, in modo ben preciso, la loro azione extra moenia e il loro giudizio di non addetti ai lavori. Non bisogna inoltre trascurare un altro presupposto fondamentale: le forme della cultura intellettuale del primo Novecento, in buona parte dominate dalla presenza egemone di Benedetto Croce, si trovano inizialmente spiazzate di fronte a un fenomeno di cui non possiedono alcuna precisa e pertinente categoria interpretativa. Rispetto alle manifestazioni più autorevoli dello spettacolo e della letteratura, quelle proiezioni traballanti e incerte di una decina, o al massimo ventina di minuti, alla cui realizzazione concorreva la presenza determinante della macchina da presa, e non quella meno dimostrabile dell’intuizione lirica o del sentimento dell’artista, non avevano ancora in sé garanzie sufficienti per potersi inserire, con pieno diritto, nell’empireo 1
2
3
delle arti. Il fenomeno di spostamento progressivo degli intellettuali verso il cinema si svolgerà dunque ai margini della storia dell’intellettualità egemone del primo Novecento e potrà goderne solo di momentanee e individuali simpatie e adesioni. Però l’industria cinematografica, fin dai suoi primi passi, ha bisogno di un consistente appoggio da parte della stampa e inventa bollettini pubblicitari che hanno la veste e la dignità formale delle riviste contemporanee. Non è forse un caso che la maggiore concentrazione delle testate sia a Napoli, Milano e Torino, le tre città che accentrano nei primi anni il maggior numero di iniziative produttive. Le riviste nascono dunque all’ombra delle case di produzione, ne sono degli organi pubblicitari alla progressiva ricerca di una propria autonomia e qualificazione culturale e sempre più vengono a costituirsi come fonti primarie per la ricostruzione analitica dei diversi insiemi che compongono il sistema. Per almeno un decennio – in ogni caso – non si deve cercare la funzione estetica in queste fonti, bensì una serie di altre funzioni che ci aiutano a percepire grazie alla giusta posizione di materiali semplici, la complessità del quadro generale. In queste riviste entrano, ogni tanto, come ospiti, alcuni intellettuali importanti: l’industria ne sollecita l’intervento cercando, al tempo stesso, di creare, di far nascere, dal suo interno, intellettuali «organici» e funzionali alle proprie esigenze. Sono pertanto i tecnici che spiegano le caratteristiche delle macchine da presa e da proiezione, i problemi della perforazione delle pellicole, o gli economisti che affrontano la situazione del mercato, ad apparirci come le prime voci di notevole interesse. Gli interventi sparsi, o casuali, di scrittori, poeti, filosofi, professori universitari, hanno il valore più che di veri e propri contributi conoscitivi, o di autorevoli riconoscimenti della dignità culturale del cinema, di sintomi di un processo di accostamento e di interesse per un fenomeno culturale che conquista, di anno in anno, sempre nuovi proseliti e rivela, alle intelligenze più aperte, non tanto il valore della sua realtà immediata, quanto l’enorme potenzialità di sviluppo e miglioramento proiettata nel futuro. Il fatto infine che singoli intellettuali comincino a rilasciare dichiarazioni ufficiali e a intervenire in prima persona soltanto dal 1907 non esclude che ve ne siano molti altri che, in silenzio, si accostano al cinema mescolandosi, per la prima volta, nell’anonimato di folle popolari. Nelle sale cinematografiche l’intellettuale non si sente più sacerdote e mediatore dell’opera d’arte rispetto ai suoi pochi destinatari; come qualsiasi spettatore si accosta al film da profano, si unisce, per la prima volta, gomito a gomito, a persone sconosciute, in uno spazio che, favorito dal buio, neutralizza le distinzioni di classe, ancora presenti con evidenza negli altri rituali pubblici (si pensi non soltanto al teatro, ma anche alle cerimonie ufficiali, alle funzioni religiose e così via). Uno dei primi articoli che rivendica al cinema il diritto di aspirare – sia pure con molte riserve – alla dignità delle altre arti, è pubblicato nel 1906 su «La Lettura»: «Una vera arte nuova, sebbene di ambizioni estetiche modestissime – la definisce l’autore dell’articolo, G. Ferri – abbreviazione e contraffazione d’altri spettacoli, ma insomma nuova e giunta all’ora sua perché i nostri contemporanei se ne contentano come di tutto ciò che è rapido ed economico. Il cinematografo sta al teatro come il bar sta al caffè di vecchia maniera. Né il teatro, né il caffè rischiano troppo i danni della concorrenza». Alle categorie della rapidità e della economicità si collega, a un anno di distanza, anche l’intervento – ben più autorevole e significativo – di Giovanni Papini, su «La Stampa». Secondo Papini il cinema si adegua alle esigenze della vita moderna, soddisfacendola soprattutto «nella tendenza all’economia. Per un film bastano pochi soldi, poco tempo, poco sforzo». Oltre a consigliare «gli uomini gravi e sapienti ad andarci più spesso» Papini pensa che il cinema sia già, fin dai suoi primi passi, superiore al teatro «per la riproduzione, nel tempo, di avvenimenti vasti e complicati che non potrebbero essere riprodotti neppure dai più abili macchinisti… per l’aiuto nello sviluppo dell’immaginazione… oltre che per la capacità di riprodurre grandi avvenimenti reali pochissimi giorni dopo che sono accaduti» . Inoltre secondo Papini «Il cinematografo […] è un aiuto allo sviluppo della immaginazione; una specie di oppio senza cattive conseguenze; una realizzazione visiva delle fantasie più inverosimili. Grazie ai suoi stratagemmi fotografici esso ci permette di pensare a un mondo a due dimensioni assai più meraviglioso del nostro» . Papini, sarà il divulgatore italiano del pensiero di Henry Bergson fissa alcuni punti notevoli della riflessione sul cinema, dai quali non si potrà prescindere. Nel febbraio del 1907 così il giornalista Oreste Fasolo, in un articolo già ricordato su «Natura e arte» (Il cinematografo svelato), registra, con perfetto tempismo, la fulminea presa di potere da parte del cinema dello spazio urbano e la sua diffusione, a macchia d’olio, in qualsiasi luogo pubblico e privato. 4
5
6
«Cinematografo… Cinematografo! Dove non è ormai stampata questa magica parola? Non possiamo fare un passo, svoltare una grande e affollata arteria cittadina o un buio viottolo di sobborgo, senza vedercela, lì dinnanzi, stampata e riprodotta in tutti i modi, in tutte le misure, in tutti i caratteri, in tutte le forme, sugli affissi, nei quadri della pubblicità ufficiale, sulle imposte dei negozi chiusi, sui muri, sul lastrico della via, sui tetti, a lettere di scatola, a lettere di fuoco, in alto, in basso, dovunque. E dove non si installa, non si annida, non si rannicchia il Cinematografo? Nei grandi teatri, nei caffè, nelle birrerie… nei baracconi dei quartieri popolari e dei saloni delle famiglie signorili! In basso, in alto della scala sociale, dovunque». Tra l’apparizione del cinema e il suo radicarsi stabilmente nel tessuto urbano le voci giornalistiche e le fonti disperse nella stampa locale e nazionale aiutano a ricostruire i movimenti dei primi operatori e organizzatori di spettacoli e a percepire il formarsi dei pubblici fondamentali e vere miniere di notizie in questo senso i fogli della «Rivista degli spettacoli» e dell’«Aurora» che, nel primo decennio del secolo mostrano l’irresistibile ascesa dello spettacolo cinematografico all’interno del multiforme e proteiforme mondo degli ambulanti. Il 1907 è l’anno del boom delle riviste cinematografiche e anche in altre riviste comincia a essere dedicato molto spazio ai problemi del cinema. In marzo, a Milano, nasce «La rivista fonocinematografica», diretta da Pietro Tonini, a Napoli, in settembre «La lanterna» e in luglio «Il cinematografo» che, a pochi mesi di distanza, muta titolo diventando, dal 20 ottobre, «Cinéma-chantant» e in seguito «Il programma». L’allargamento del campo di interessi da parte del «Cinematografo», fino a coprire anche lo spazio del variété e del café chantant, mostra come fosse ancora prematuro e, tutto sommato, abbastanza utopico, il progetto del suo direttore, Edoardo Correnti, di creare un organo unitario di informazione per tutta la produzione nazionale. Il numero di copie stampate che la rivista dichiara è piuttosto alto (35.000), tanto più se si tiene conto che nei primi numeri è distribuita gratuitamente davanti alle maggiori sale cinematografiche di Napoli. Nel 1907 la funzione di mediazione tra gli interessi dei produttori e degli esercenti viene riproposta in un dettagliato programma dallo stesso Correnti in un editoriale della nuova testata: «L’Italia cinematografica, oggi nel più vivo rigoglio, sentiva il bisogno di un giornale speciale che potesse seguirla nei suoi grandi passi alla conquista del pubblico… rendere più facili le relazioni tra consumatori e produttori, diffondere e far conoscere meglio all’estero la nostra produzione, offrire una cronaca esatta, a brevi periodi, di quanto avviene in Italia, portare a conoscenza di tutti, e presto, quanto di interessante si produce all’estero, usare di una giusta critica e di un benevolo inneggiamento, difendere gli interessi generali e particolari dell’ormai grande famiglia dei cinematografisti… ecco quanto ci proponiamo in queste pagine dedicate al cinematografo». Il programma è dunque di offrire un servizio informativo e un esplicito appoggio alla produzione. L’intervento mira a sostenere tutto il campo, anche se non sembra che, per il momento, domini alcun interesse culturale e artistico. Nel gennaio 1908, intervistato dal «Corriere della Sera», all’indomani della prima della Nave così il giornalista Ettore Janni riferisce di quanto gli ha raccontato D’Annunzio a proposito del cinematografo: «Qualche parola del poeta ha eccitato vivamente la mia curiosità. Diceva di essere entrato qualche volta nel cinematografo e di aver provato un profondo disgusto della stupidità e del carattere grossolano degli spettacoli. Mentre il pubblico di certe città […] diserta i teatri per affollarsi nei cinematografi, mentre da per tutto questo genere di spettacolo attrae gente, agli spettatori non s’offrono che scempiaggini: un vero avvelenamento del gusto popolare si sta compiendo […]. Il poeta – egli mi diceva – ha tanto più valore e tanta più vitalità la sua opera quanto più vasto il dominio degli uomini ch’egli conquista, che induce alla sua maniera di sentire e di vedere, che suggella di sé, che fa vivere come con compagne inseparabili, come con tenaci guide spirituali, con le più vive immagini e le più significative del mondo espresso dalla sua arte […]. Ora il cinematografo, così gradito al pubblico, è all’anima popolare un’infezione di grossolanità, di bruttezza. E può diventare uno strumento efficacissimo di elevazione del gusto e di pensiero, di rafforzamento estetico e d’istruzione. Il popolo ignora tutto di sé, della sua storia, del suo paese, della innumerabile vita. Il cinematografo può molto contro questa mortificante ignoranza. E il poeta si compiace un istante nell’idea di dare qualche saggio della bella trasformazione […]. Si pensi di quali effetti potrebbero essere sull’animo popolare delle biografie cinematografiche d’eroi […] con gli infiniti mezzi di cui si può oggi disporre, i miti, le leggende, nella più ricca varietà di paesaggi, fra mura storiche, negli infiniti abissi del mare, rinnoverebbero la 7
pura gioia estetica del meraviglioso. Il poeta comporrebbe nuovi canti senza parole, col gesto, con la figura bene scelta all’evocazione, con la elegante composizione del quadro, con la efficace drammatica dell’azione» . Ancora nello stesso anno, un discepolo dannunziano, Ricciotto Canudo, che qualche anno dopo scriverà alcune delle pagine teoriche che ancora oggi si possono considerare fondative per la nascita del pensiero cinematografico scrive su un giornale fiorentino («Il Nuovo Giornale» del 25 novembre 1908) e, al contrario del maestro, così si esalta descrivendo la sua esperienza di contatto con il cinema in una sala popolare: «Noi eravamo nel vestibolo di un teatro, certo di un teatro nuovo. Ma l’impressione spontanea dell’attesa in un pronao mi occupava e mi faceva guardare tutte quelle facce per scoprire lo spirito. E questo spirito non era religioso […]. Compresi che erano uomini nuovi che non hanno più un tempio perché non hanno più la fede che animava per gli uomini i vecchi tempi, e cercano una forma nuova e profetica dello spirito templare […]. Tra le meraviglie dell’invenzione moderna il cinematografo appare subito come la suprema. Esso le riassume tutte in simbolo e in realtà. Noi abbiamo creato una nuova dea per l’olimpo nostro, questa dea è la velocità» . Canudo attribuisce al cinema quei poteri che solo pochi anni prima il già ricordato Morasso («poligrafo disordinato e geniale, antenna sensibilissima alle correnti sotterranee e non ancora sbocciate della cultura contemporanea» ) ne La nuova arma (1905) aveva attribuito alla macchina e al suo capo . Ed è ancora Canudo che ha parlato di cinema come «sogno del meraviglioso, imposto dalla scienza, che ispirerà i maestri del domani» . Dello stesso 1908 è anche un importante articolo di Enrico Thovez che oltre a profetizzare la vocazione del cinema a diventare l’arte capace di dare il nome al secolo («che non sarà per i posteri né quello di Marconi, né quello di D’Annunzio, sarà semplicemente il secolo del cinematografo» ), così fissa prosodia e metrica della nuova arte: «Il cinematografo ha alleggerito l’azione scenica […]. Ridotta al suo puro schema drammatico, essa trasporta lo spettatore con la velocità dell’automobile dalla causa all’effetto: egli non ha più da correre a leggere l’ultima pagina del romanzo o da aspettare con impazienza la scena finale del dramma per sapere lo scioglimento finale della favola. Dell’azione non è rimasto che l’intreccio, il che è a dire l’unica cosa che interessi i novantanove centesimi di coloro che aprono un libro ed entrano in un teatro. […] Le gesta del più fantasioso dei delinquenti sono sbrigate in cinque minuti. In cinque minuti il ladro può uccidere la serva, legare un asciugamano al collo della padrona, svaligiare la cassaforte, fuggire dalla finestra ed essere acciuffato dai gendarmi, tradotto in prigione, giudicato dall’Assise, trasportato alla nuova Caledonia, può segare le sbarre del carcere, evadere dal penitenziario, rivoltellare i guardiani, vagare nelle foreste vergini, assassinare un viandante, sfuggire all’inseguimento dei cow-boys, essere colto col lazo come un cavallo riottoso, venir lanciato ad un albero» . 8
9
10
11
12
13
14
la scuola del popolo Nel gennaio 1908 nasce «La cinematografia italiana», diretta da Gualtiero Fabbri, e ben presto trasforma il titolo della testata in «La cinematografia italiana ed estera», trasferendo la sua sede da Milano a Torino. A ottobre dello stesso anno nasce a Milano la rivista «La Cine-Fono» diretta da Francesco Razzi: anche questa rivista emigra presto trasferendo la sua sede a Napoli . Entrambe le testate si segnalano, fin dai primi numeri, per una maggiore presenza critica nei confronti della produzione. Alcuni articoli avanzano già proposte culturali e indicano strade da battere o da abbandonare: «Bando ai drammacci stupidi esageratori del bassofondo umano! […] Sopprimete le pellicole a base di trucco – scrive Ego sulla ‘Cinematografia italiana’ – non insegnano nulla, fanno restare a bocca aperta i gonzi, mentre disgustano gli intelligenti […] non mettiamo più in mostra i precipitatissimi inseguimenti a finale di scontri e catastrofi visibilmente impossibili, come pure tagliamo corto ai contorcimenti spasmodici e alle grimaces grottesche» . Si tratta dunque di abbandonare le strade della finzione e di seguire, secondo la strada indicata dai Lumière, il reale, di riprodurlo limitando al massimo l’invenzione fantastica. Su questo punto è chiaro che assisteremo ben presto a una netta biforcazione del discorso dei critici: da una parte i teorici e seguaci del realismo, dall’altra i sostenitori del potere e delle capacità di produzione fantastica dell’immagine cinematografica. I due termini non vanno certo visti come realtà inconciliabili, ma come posizioni di una costante dialettica, critica e poetica, 15
16
che, in alcuni casi, è riuscita a tradursi anche in pratica registica, raggiungendo (nel neorealismo) la massima congruenza e integrazione tra momento poetico e momento operativo. Mentre però la poetica del fantastico e dell’immaginario resta disseminata a livello di ipotesi, ma non riesce a tradursi in un filone dotato di una sua continuità, e neppure in un discorso teorico abbastanza complesso, l’ipotesi realista, che accompagna la storia del cinema italiano in tutte le sue manifestazioni, appare come uno dei discorsi di massima continuità . Seguire la strada del realismo, concepire il cinema come uno specchio del reale e non come luogo di liberazione dell’immaginario pare, fin dai primi interventi, la strada più giusta da battere per fargli acquisire meriti culturali e funzioni pedagogico-morali-sociali. Si ha già l’impressione che molte possibilità di rappresentazione siano state saturate e sia necessario un rinnovamento profondo dei modelli narrativi. Ecco dunque un secondo tipo di discorso, complementare e funzionale al tentativo di far compiere allo spettacolo cinematografico un salto di livello culturale, per metterlo a contatto di nuovi pubblici: «I signori direttori se hanno coscienza artistica dovrebbero rifiutarsi alla esecuzione di soggetti che non siano storici […] non sarebbe bello che il popolo imparasse la storia del proprio paese dalle proiezioni cinematografiche?» . Su un altro fronte, aperto in parallelo, si comincia a indicare nel contributo diretto dei letterati alla elaborazione del processo realizzativo del film un fattore decisivo per aumentarne la portata sociale: «Il cinema ha un avvenire luminoso e brillantissimo – troviamo scritto sul ‘Café-chantant’ nel 1908 – e quando scrittori come Gabriele D’Annunzio scriveranno scene per i cinematografi i locali dove si proiettano tali opere non saranno frequentati solo da ragazzi o da serve […] ma anche dalla parte più intellettuale del pubblico». Emerge dunque il problema del destinatario in modo sempre più diffuso: se ne cerca di individuare la fisionomia sociale, il condizionamento della visione, e la possibilità di sostituire le forme di visione passiva ed elementare con strumenti culturali e con immagini più capaci di produrre senso e conoscenza: «Il pubblico ama osservare – nota Tullio Panteo su ‘La Cine-Fono’ – più che ascoltare. Evidentemente il pubblico preferisce essere più passivo che attivo» . Ma la passività della visione non esclude un diverso livello di trasmissione dei contenuti. A partire dal 1909 questi discorsi, che emergono sporadicamente da fonti diverse, cominciano ad acquistare una frequenza assai intensa e periodica, del tutto in sintonia col mutamento dello standard culturale della produzione: la parola d’ordine che circola in tutte le riviste di categoria è quella della conquista al cinema delle classi più elevate. Ciò significa, evidentemente, far compiere alla merce film un salto di qualità, attribuirle uno statuto culturale accettato e riconosciuto, sottrarla alla dimensione sensazionale e fantastica e ancorarla più solidamente a una riconosciuta tradizione culturale. Il salto tecnologico attuato proprio in quel periodo per superare la crisi che rischiava di travolgere il cinema sul piano internazionale, grazie all’aumento della durata dei film, all’unificazione delle perforazioni nelle pellicole, all’immissione sul mercato di macchine da ripresa e da proiezione più perfezionate, consente di avventurarsi con una certa dignità all’assalto della tradizione letteraria. Ciò comporta investimenti produttivi assai più massicci e richiederebbe forme di appoggio e di pubblicità, diretta e indiretta, molto più articolate. In fondo queste prime riviste di categoria costituiscono certo un punto di appoggio importante, ma non sono strumenti capaci di offrire un aiuto consistente per la conquista e l’allargamento del mercato – né raggiungeranno mai la professionalità di consorelle americane come il «Moving Picture World» – e, in ogni caso, continuano ad agire come corpi separati rispetto al lavoro degli intellettuali più rappresentativi di cui è sempre più importante chiedere un intervento diretto . Il cinema sembra avere ormai le carte in regola per muoversi alla conquista delle classi colte e per offrire nuovi e più moderni strumenti per l’allargamento della cultura popolare. A questo secondo aspetto della funzione sociale del cinema sono sensibili soprattutto riviste più caratterizzate sul piano sociale, come «Lux», organo di Gustavo Lombardo, che non nasconde le sue simpatie socialiste. «Lux», fin dai suoi primi numeri, sembra volersi far carico di una serie molto ampia di problemi: lo spirito positivistico e la collocazione ideologica possono cogliersi fin dai titoli degli articoli che spaziano da Il cinematografo e la scuola, a Cinematografo e cultura popolare, Cinematografo e medicina, Cinematografo e chirurgia, Il cinematografo, l’educazione sociale e la scuola, Il cinematografo e la sua influenza sulla cultura del popolo, La funzione demoestetica della cinematografia. Il potere sociale del cinema, così come viene inteso dalla rivista, si può trovare ottimamente sintetizzato in questa affermazione: «Ieri la cultura veniva trasmessa quasi unicamente dal libro, dalla rivista, dal giornale, oggi il cinematografo, col suo fascino immenso, ha accresciuto e superato in efficacia questi mezzi» . 17
18
19
20
21
Nel giro di pochi anni l’industria si assesta a un nuovo livello ed è in grado di tentare nuove soluzioni tecnologiche e di allargare ulteriormente il proprio potere narrativo ed espressivo riuscendo a ridurre, in modo assai rapido, la distanza che continua a separarla dalle forme più alte della cultura e dello spettacolo. La sfida e l’obiettivo principale fin dall’inizio è questo. Il contributo di una rivista come «Lux», su cui appaiono periodicamente scritti e interviste con letterati ed economisti, viene a saldarsi in modo funzionale alla logica imprenditoriale, che, per raggiungere i propri obiettivi, ha bisogno di una mobilitazione costante e qualificata di più media. Sono anche questi gli anni in cui vengono pubblicati alcuni manuali tecnici (il Re, il Liesegang): la destinazione primaria di questi manuali dovrebbe essere volta alla formazione degli operatori e dei tecnici cinematografici, ma in effetti la loro portata culturale è più vasta. Il volume di Liesegang, che gode di un vasto successo editoriale, diventa una specie di «testo» per antonomasia e alle sue pagine ci si rivolge per una serie di accorgimenti e di indicazioni non soltanto tecniche . L’entusiasmo che accompagna, da questo momento, alcune prese di posizione e la lungimiranza critica di certe intuizioni, consentono di riconoscere al cinema il pieno diritto di considerarsi come una forma di divertimento alternativo, non subalterno e assimilabile al circo e al luna park, ma piuttosto ormai in aperta concorrenza con le forme più nobili del teatro e dell’opera lirica. «Balza evidente – scrive Cesare Mansueti a proposito della nuova invenzione di Edison che accoglie l’immagine e il sonoro – la conseguenza deleteria che porterà al teatro il cinematofono […]. Ma è una conseguenza diciamo così morale, in quanto permetterà la volgarizzazione artistica della tragedia classica, della commedia, della farsa presso le masse che non avevano finora potuto nutrire il proprio intelletto alle fonti pure del pensiero universale, ostacolate in ciò dai prezzi d’entrata nei teatri di prosa e in quelli di musica non adatti a tutte le borse» . Un po’ più radicale e meno conciliante è un articolo di Bovarini in cui il confronto col teatro è ormai risolto a favore del cinema: «La cinematografia è talmente penetrata nei gusti e nelle consuetudini d’ogni classe di persone che ogni altro spettacolo, per quanto grandioso, è passato in seconda linea e ben può affermarsi oggi che il cinema abbia ucciso il teatro, come la rivista e il teatro hanno ucciso il libro». Detto questo l’autore continua a domandarsi in che modo «potrà il cinematografo diventare un prezioso strumento di cultura popolare e dirozzare le menti e istruire le masse inconsapevoli. Il cinematografo è lo specchio della vita, come la storia. Può attingere anche dalla storia naturale, dalla civiltà, dagli usi e costumi dei popoli del mondo, dalle officine, dalle industrie, dai commerci, dai miracoli della scienza. Strumento di progresso il cinema reciderebbe davvero le radici dell’ignoranza italiana, sgombrerebbe il nostro cammino dall’inviluppo intricato che attarda l’umana ascensione» . Di questo potere culturale del cinema ci si rende conto anche all’estero, come dimostrano le reazioni americane alla prima dell’Inferno nel 1911: «È possibile – scrive Stephen Bush – che finalmente il cinema, questo tradizionale servo di clowns e di cow-boys, possa rendere accessibile a milioni di spettatori l’immenso tesoro che attualmente, eccezion fatta per un pugno di studiosi, giace inviolato nelle biblioteche di tutto il mondo» . È questo riconoscimento di poter raccogliere e riproporre su scala mondiale tutta la tradizione culturale del passato che fa automaticamente conferire al cinema i primi quarti di nobiltà culturale, ma è evidente, per il pensiero positivistico, che il potere di questo nuovo mezzo è ben più vasto e funzionale a nuove concezioni di trasmissione e circolazione della cultura. Un intervento assai importante è quello di Arturo Labriola, che, per primo, mostra di cogliere in pieno le potenzialità che si aprono al di là della concezione e dell’uso del cinema come pura forma di divertimento e di spettacolo: «Le case cinematografiche si sono curate troppo del pubblico grosso e delle curiosità più elementari […] il lato scientifico del bisogno cinematografico è stato poco usato […]. Perché non chiedere il concorso degli zoologi, dei botanici, degli economisti nella scelta di un materiale destinato alle scuole […] io vagheggerei un cinema al servizio della cultura […]. Pensate che sviluppo per l’industria se ogni scuola avesse, come dovrebbe avere, un gabinetto cinematografico […]. I capitalisti fanno come le quaglie, le quali quando canta una cantano tutte […]. Il cinema prospera? Dagli a piantare cinema e case produttrici […]. Gli inconvenienti dei quali soffre la cinematografia sono i medesimi dei quali soffrono tutte le industrie in balia della speculazione. Quello a cui si pensa è allettare i capitali, poi si spera di potersi ritirare in tempo vendendo le azioni […] l’industria fiorirà tanto meglio quanto più ne sarà provata l’utilità. Senza tante comiche finali riproduceteci le nostre grandi gallerie artistiche, non ci date la pornografia. Rivolgetevi agli scienziati. Le scuole avranno bisogno di voi. Purificate il 22
23
24
25
cinema e le vostre entrate cresceranno» . 26
i primi passi della critica La trama portante dei problemi entro cui dovrà muoversi il cinema, le relazioni fondamentali, il riconoscimento dell’opera cinematografica come opera dell’ingegno, la tutela del diritto d’autore, le potenzialità e il campo d’applicazione, il cinema come mezzo di divulgazione della letteratura e del sapere scientifico e come nuova civiltà della visione, sono tutti motivi posti sul tappeto fin dal 1909, prima ancora dunque che si costituisca una pratica critica regolare e consapevole del proprio ruolo specifico. Nel 1909 vedono la luce diverse nuove testate, «Il cinematografo» a Firenze, «Luce e cine» a Brescia, «L’Eden» a Milano, ma bisogna attendere fino al 1910, alla nascita della torinese «Vita cinematografica» per trovarci di fronte a una delle più importanti testate di tutto il cinema muto. Protagonista, fin dai suoi primi anni di vita, del dibattito critico sul cinema e sul ruolo della critica nei confronti degli interessi industriali, la rivista costituisce, anche per la sua longevità (è morta agli inizi del sonoro, nel 1934), uno degli strumenti di consultazione più utili e attendibili sul piano dell’informazione per lo storico e il ricercatore. Fin dai primi interventi il direttore A.A. Cavallaro dichiara a più riprese che la rivista vuole essere uno strumento di informazione e pubblicità, ma anche un organismo in cui vengono dibattuti i problemi del cinema, non ultimo quello estetico, al di fuori di ogni condizionamento da parte dell’industria. Se sfogliamo sistematicamente le pagine delle prime riviste capita di imbattersi in un coro di giudizi entusiasti e di esaltazioni iperboliche per ogni tipo di film. Utili spesso per avere un’idea delle trame, i primi articoli sui film sono semplici soffietti pubblicitari il cui interesse critico è pressoché nullo. La grande stampa, dopo la sortita di Papini, rimane in stato d’attesa, o decide di muoversi all’attacco denunciando I pericoli del cinematografo («La Gazzetta del popolo», 6 marzo 1908), o addirittura lanciando un attacco frontale alla nuova forma di spettacolo e a tutte le invenzioni che vi ruotano attorno: «Che età ha Edison? – ci si domanda sul «Corriere della Sera». – Non si può fargli, infatti, un cattivo augurio, ma se la sua vecchiaia è ancora, come sembra, assai vegeta, chi sa quali altre invenzioni sono da temere dalla sua implacabile fantasia di scienziato […]. Dopo l’invasione degli Unni non si ricorda invasione più formidabile di quella del cinematografo. E il teatro, che si dibatteva contro gli assalti del caffè-concerto, langue ora sotto i colpi del cinematografo; e la storia, la leggenda, la poesia del passato, le glorie dell’arte gettate in preda a manipolatori di film, a istrioni di quart’ordine, attestano dalla bianca tela, nelle sale oscure, il nuovo trionfo della volgarità e la crescente tirannia del cattivo gusto» . Queste posizioni sono destinate a essere travolte dal successo popolare del cinema, dalla conversione dei letterati secondo un processo che, dopo D’Annunzio, sembra di reazione a catena, ma in effetti non scompariranno mai del tutto restando come un atteggiamento di presa di distanza da parte di gruppi intellettuali che riescono ad aggregare a lungo atteggiamenti analoghi da parte di esponenti della cultura e delle istituzioni ufficiali. Dal 1910, grazie alle dichiarazioni programmatiche della «Vita cinematografica» e all’attenzione crescente nei confronti del fenomeno, in tutte le sue articolazioni, chi si occupa di cinema con una certa continuità tende a uscire dal ruolo di cinghia di trasmissione pubblicitaria dell’industria e ad acquisire una propria indipendenza, autonomia culturale e riconosciuti statuti professionali. «La Gazzetta del popolo» per prima, fin dal 4 febbraio 1908, crea un’apposita rubrica cinematografica fissa e l’affida a Mario Dell’Olio («Il sempre crescente sviluppo dell’industria cinematografica e la speciale predilezione che il pubblico dimostra di avere per gli spettacoli cinematografici in genere, ci hanno consigliato di iniziare la presente rubrica che ha lo scopo di trattare tutto quanto alla cinematografia ha attinenza») e, dal 1912, inaugura una pagina dedicata interamente al cinema con articoli e pubblicità. Altri quotidiani ne seguono, a ruota, l’esempio. Dalle pagine del «Giorno» di Napoli, Matilde Serao interviene a più riprese su film che costituiranno avvenimenti culturali, dall’Inferno al Quo vadis? o a Ma l’amor mio non muore. Negli anni successivi il numero delle testate di riviste specializzate anziché stabilizzarsi continua ad aumentare. Davide Turconi osserva che «questo corpus imponente non è utile ai fini della valutazione estetica dei film dell’epoca, ma è da tener presente, studiare e valorizzare ai fini di una storia del cinema italiano vista come storia di una industria culturale nell’insieme dei suoi rapporti con il momento e l’ambiente sociale entro cui nasce e si afferma» . 27
28
29
Non a caso dunque, negli anni tra il 1909 e 1911, che sono gli anni di ascesa del cinema italiano, i problemi fondamentali del cinema vengono percepiti e percorsi a tutto campo dalla critica nascente che trova una prima forma di autonomia e dignità culturale e professionale e conquista i propri spazi all’interno di alcuni organi di stampa. Della necessità di avviare una regolare critica cinematografica per affinare i gusti del pubblico parla anche, ma solo nel 1913, Edoardo Boutet, dalle pagine di un’autorevole rivista letteraria, «La nuova antologia» . Le altre riviste di maggior prestigio, da «Leonardo» al «Regno» fino in pratica alla «Ronda», non si occupano di cinema. Unica eccezione l’intervento di Giuseppe Prezzolini sulle pagine della «Voce». Nel 1914 egli saluta l’avvento del cinema e inneggia all’occhio cinematografico augurandosi che il cinema abbandoni al più presto «la facile lacrimosità e l’ottimismo imbecille per fare strada a un cinema che faccia conoscere agli italiani il nostro paese, le sue glorie, le sue vergogne, le sue gioie e i suoi dolori». Prezzolini vuol mostrare al cinema narrativo una precisa strada da seguire, suggerendo addirittura i temi, l’emigrazione, le industrie lombarde, le grandi bonifiche del veronese e, nel quadro del suo nazionalismo, il problema delle terre irredente. Si sollecita in pratica il cinema a «esporre le nostre miserie perché si ripari» . Anche «Lacerba» interviene a proposito di un falso film futurista di Molinari. L’aumento della durata del film, il miglioramento di tutto lo standard produttivo, il plauso di molti esponenti della cultura ad alcune opere (da Inferno a Quovadis?) consentono di portare decisamente l’attenzione verso il momento narrativo, di coglierne le caratteristiche specifiche, di porre sul tappeto problemi di vario tipo, non ultimo quello estetico. Il confronto con il teatro, fino a qualche tempo prima improponibile, o attuato solo in termini di pura contrapposizione, viene ora rilanciato in maniera più argomentata e c’è anche chi, anticipando i futuristi, indica nel cinema, per la sua rapidità e varietà, «il simbolo della vita contemporanea» e riconosce ormai come un dato di fatto che «il cinema gareggi vittoriosamente con lo spettacolo teatrale. E le cause sono […] la rapidità e la varietà delle sensazioni. Bisogna aggiungere a queste il temperamento speciale del tempo nostro, febbrile e mobilissimo, che vuole rapidamente produrre, rapidamente vedere, rapidamente godere» . 30
31
32
alla ricerca di una legittimazione artistica Nel novembre del 1913 «Il Nuovo Giornale» di Firenze apre un’inchiesta sul cinema, chiamando a rispondere Nino Martoglio, Roberto Bracco, Sabatino Lopez, Guido Podrecca, Giuseppe Prezzolini, Walter Grazzini, Saverio Procida, Gino Damerini, Cesare Levi, Fausto Maria Martini. Le domande a cui si deve rispondere sono: «1) Il cinematografo fa una concorrenza dannosa al teatro, e, in caso di risposta affermativa, come perché quanto […]? 2) Potrà avvenire una fusione artistica tra teatro e cinematografo? 3) Crede ella che le film cinematografiche (!!) giovino […] allo sviluppo intellettuale e morale del popolo? 4) Ha mai lavorato per il cinematografo? 5) Quali sono industrialmente e artisticamente le classi sociali che possono aver maggior vantaggio o maggior danno dal vittorioso progredire del cinematografo? 6) Qual è l’avvenire del cinematografo? Quale sarà la sua evoluzione?» . Le risposte, pur con le eccezioni prevedibili di Prezzolini e Marinetti («Il cinematografo non soltanto fa concorrenza al teatro attuale, ma lo nega e lo distrugge quotidianamente e di ciò ci rallegriamo, poiché il teatro attuale, ondeggiando stupidamente tra una ricostruzione storica e la riproduzione fotografica e minuziosa della vita quotidiana non risponde più alla nostra sensibilità. Teatro passatista condannato a morte» ), non vedono alcun futuro per il cinematografo e non vi riconoscono alcun serio statuto culturale. A questo primo tentativo di sondare e soprattutto di raccogliere il consenso degli intellettuali verso la nuova forma di spettacolo, ormai lanciata nel mondo a mietere successi presso tutte le classi sociali, gli scrittori e soprattutto gli uomini di teatro, intervistati in gruppo per la prima volta, oppongono ancora un atteggiamento di rifiuto, sia pure non totale e non unanime. Su un altro fronte, dalle pagine della «Vita cinematografica», altri scrittori, come Luciano Zuccoli, Nino Oxilia, Grazia Deledda, Luigi Capuana, rispondono a un’inchiesta promossa quasi contemporaneamente con un atteggiamento nel complesso assai favorevole. L’inchiesta tende appunto a mettere in luce la disponibilità degli scrittori e autori teatrali a scrivere per il cinema. Il punto più qualificante dell’inchiesta è certamente il terzo: «L’opera di un autore drammatico, riprodotta in cinematografo, ferme restando le esigenze dello scrittore, perde il valore intrinseco letterario, considerato che 33
34
il cinematografo non fa della letteratura, pur potendo fare opera di poesia, di insegnamento, di diletto?» . Dopo queste due inchieste la circolazione delle idee dei letterati sul cinema e la loro presenza sulle riviste di cinema o i loro interventi su temi cinematografici diventano un fatto abbastanza comune: una consacrazione definitiva è data dalla citata intervista a D’Annunzio del 1914 apparsa sul «Corriere della Sera» . Se il problema dell’artisticità del cinema resta ancora a lungo aperto sulle riviste letterarie, la stampa di categoria, visti i successi internazionali di Quo vadis? e Cabiria, lo considera ormai un problema obsoleto: «Non è più il caso di chiedere se la fotografia sia o no un’arte. Ormai una lunga serie di magnifiche films ha dimostrato a quanta bellezza di composizione, a quale perfezione di chiaroscuro, a quanta varietà di mezzi espressivi essa possa pervenire» . Dal 1913-1914 si comincia a porre e a discutere il problema dell’autore del film cercando di giungere in sede teorica a una precisa attribuzione di paternità dell’opera e in sede di analisi alla scoperta e distinzione delle diverse caratteristiche stilistiche: «Il direttore artistico – scrive Enrico Rossi in un importante articolo – è il centro attorno a cui la film svolge la sua trama; è un poco il soggettista, un poco l’interprete, un poco il pittore, un poco il concertatore» . Da una parte, nel dibattito che si sviluppa a partire da questo periodo, si cercherà di identificare un’individualità creativa specializzata o capace di offrire i propri prodotti al cinema con la stessa capacità professionale messa in campo in altri settori, dall’altra si tende a far compiere al prodotto un salto di qualità, nascondendone il marchio di fabbrica, o almeno subordinandolo all’aura di prodotto unico e irripetibile dell’ingegno creativo che l’opera d’autore può dare. Anche in questa fase la presenza di D’Annunzio e l’attribuzione al suo intervento della paternità di Cabiria, gioca un ruolo decisivo, come si è già visto . Polemizzando contro l’improvvisazione della quasi totalità dei cinquanta e più direttori artistici operanti sul mercato, Rossi afferma: «In cinematografia, sino a oggi, l’autore non esiste: i direttori artistici dell’avanguardia hanno impresso per conto loro le tre orme fondamentali dell’arte nuova (il verismo, l’estetismo, il romanticismo)». A un paio d’anni di distanza un intervento del produttore Arturo Ambrosio sull’«Arte muta» sembra confermare il sostegno al riconoscimento dell’autonomia e della creatività del regista. «Io sono del parere – scrive Ambrosio – che il direttore di scena debba essere il primo artista, il primo creatore del film» . Il critico gli fa eco nello stesso tempo: «Al cinematografo devono servire le concezioni uscite dal cervello di autori che, nati espressamente per la cinematografia, per questa scrivono con tutte le migliori energie. L’arte è nuova. Ci vogliono autori nuovi» . Accanto a questi interventi che, in varie sedi, contribuiscono a formare la consapevolezza del problema del film come prodotto di una creazione individuale, o meglio legato alla volontà artistica di una personalità singola e responsabile di tutto il processo espressivo, vanno segnalati, nel 1913, i primi contributi di Sebastiano Arturo Luciani grazie ai quali, per la prima volta, sono posti sul tappeto i problemi della specificità del linguaggio cinematografico e dei suoi legami con le altre arti . Uno dei punti più deboli, anche se di grande utilità come corpus descrittivo, è quello dell’analisi critica dei film. Qui domina, salvo poche eccezioni, la routine per tutto il periodo preso in considerazione: gli interessi produttivi fanno sì che l’esaltazione e la stroncatura dipendano più dalla logica di scuderia della rivista che dall’interesse effettivo per la qualità del film. Tra le caratteristiche più evidenti la celebrazione iperbolica di tutte le novità, l’accumulazione enfatica di aggettivi come grandioso, straordinario, eccezionale, fantastico, la descrizione letteraria della trama e la generica esaltazione dei caratteri individuali dei singoli quadri, la lunga incomprensione per la dinamica del sistema espressivo in senso cinematografico. Poco importa, in questo contesto, segnalare singoli spunti critici degni di rilievo e ricordare che, dopo Quo vadis?, e soprattutto dopo il lavoro di D’Annunzio in Cabiria, la critica allarga le sue analisi e cerca di far intervenire categorie più sofisticate e pertinenti . La sciattezza, il condizionamento del giudizio, l’enfasi continuano a essere gli elementi caratterizzanti nella maggior parte delle analisi di singoli film. Il critico comincia però ad avvertire, nel momento in cui il discorso teorico conquista nuove categorie e le singole opere richiedono maggiore impegno, la necessità di una propria specifica qualificazione e autonomia professionale: «Il posto del critico d’arte – scrive Guido Di Nardo 35
36
37
38
39
40
41
42
43
sulla ‘Vita cinematografica’ nel maggio del 1915 – non è soltanto nella platea del teatro, ma anche nel modesto posto del cinematografo». Quanto all’autonomia rispetto agli interessi della produzione, Piero Cacace interviene in questi termini: «Le nostre riviste sono state in origine degli eccellenti cataloghi di cinematografo. Mancava a esse, quindi, quell’autorità che si può avere soltanto con l’indipendenza e la libertà e severità di giudizio che a una stampa organicamente costituita sono devoluti. A che cosa sono serviti sinora i nostri cataloghi e riviste? Alla pubblicità e non altro. La critica, la discussione, le campagne a favore dell’industria e dell’arte sono venute più tardi e non ancora, si può dire, si sono liberate dal peccato d’origine» . In realtà la richiesta di una critica specializzata si dimostra per ora soltanto un’esigenza proiettata nel futuro: «Il giorno nel quale un certo ordine di produzione cinematografica si sarà stabilito, quando le case non dovranno più lambiccarsi il cervello per eseguire lavori contorti e limitati a seconda delle esigenze dei mercati, quel giorno soltanto il critico sarà una necessità ed è bene che si prepari da ora con assennati esperimenti a quello che dovrà essere un giorno il suo ministero» . Si viene facendo strada l’esigenza che, a difesa di una categoria dispersa in decine di riviste, ma già dotata di una discreta consistenza numerica, si crei un sindacato della stampa cinematografica. La possibilità di costituire un organismo autonomo rispetto alla volontà dei produttori e ai loro interessi è direttamente collegata alla reale indipendenza delle varie riviste di categoria, che, alla vigilia della guerra, si sono ulteriormente arricchite di nuove testate («L’Eco cinematografico» a Bari, «Il Tirso e il cinematografo» a Roma, «Filmando» a Napoli… in tutto fino alla fine della guerra se ne possono contare quasi un centinaio): «Noi non ci pieghiamo a nessuna imposizione palese o occulta – afferma nel novembre del 1915 un editoriale della «Vita cinematografica» – e seguiteremo a battere la nostra strada informando l’opera nostra a quei criteri di obiettività che ci valsero finora non poche soddisfazioni morali. La parte commerciale, reclamistica della rivista è perfettamente estranea e separata da quella artistica: perciò è stolto pensare e pretendere che basterà ordinarci o intensificare la pubblicità a pagamento per legarci le mani e metterci nella impossibilità di dissentire in quello che cercheremo di non approvare» . La critica può continuare a godere del suo boom anche negli anni di guerra, per il fatto che alla descrizione ordinata delle trame dei film si sostituisce la celebrazione altrettanto stereotipa e iperbolica della massa di dive che in quegli anni dominano la scena polarizzando tutta l’attenzione. Soltanto nel maggio 1916 tutto il dibattito e la polemica sull’autonomia o asservimento delle riviste di categoria agli interessi dei produttori sembra trovare una soluzione – peraltro momentanea – nella nascita di un sindacato della stampa cinematografica, a conclusione di una riunione a cui partecipano tutti i direttori delle riviste più affermate. La bonaccia degli anni successivi è però anche il segno della stagnazione di determinati problemi, del mantenimento di un’ottica parziale e limitata al piccolo cabotaggio della routine quotidiana. Questa critica che aspira a un maggiore riconoscimento professionale, anche se prendiamo gli esempi più interessanti, continua a usare, nella sua pratica corrente di recensione ai film, le categorie della verisimiglianza, della bella fotografia, del quadro animato, del tutto scisso dalla comprensione di una possibile esistenza di una grammatica e di una sintassi propriamente cinematografica. È certo comunque che finora la coabitazione, nelle riviste di categoria, di problemi di vario tipo, e la maggiore attenzione per quelli d’ordine tecnico o economico avevano certo soffocato o subordinato l’indagine e l’attenzione verso i problemi specificamente estetici, e avevano, d’altro canto, favorito la creazione di una serie di quadri giornalistici potenzialmente attrezzati ad analizzare la situazione del mercato, le novità tecnologiche, i problemi della concorrenza. Di fatto però questa capacità, fino a che permane il rapporto di dipendenza reale delle riviste dagli interessi delle case produttrici, non viene certo espressa e le poche analisi o diagnosi di mercato che appaiono nel corso della guerra non sembrano preoccupare i produttori. Il terreno per l’analisi estetica è pressoché vergine fino ai primi anni di guerra e non è certo la pubblicazione del Manifesto della cinematografia futurista del 1916 a generare una pratica critica o a vedere realizzato, nell’immediato, alcuno dei suoi punti programmatici. La novità editoriale si può cogliere, piuttosto, nella pubblicazione di una nuova rivista, «Apollon», diretta da Goffredo Bellonci , che costituisce un primo reale tentativo di rinnovamento e di mobilitazione profonda della critica, ma al tempo stesso di netta separazione, idealistica, tra i problemi estetici e quelli «extraestetici». Alcuni letterati cominciano part time a trasferire le 44
45
46
47
loro categorie estetiche e critiche sull’oggetto cinema, partendo dal presupposto di cogliere identità e differenze del nuovo mezzo nel sistema generale delle arti. Non è che la rivista appoggi una sola prospettiva o una sola idea di cinema, in quanto, fin dai suoi primi numeri, ospita contributi vari, da Impressionismo scenico di S.A. Luciani, a Quel che dovrebbe essere il dramma moderno da cinematografo di A. Rosso, e vi appaiono almeno due importanti contributi a favore del naturalismo, una lettera di Émile Zola e un articolo di Pietro Solari, intitolato Naturalismo, dove si condanna la produzione corrente e si chiede una rappresentazione più vicina alla natura e alla realtà: «La natura e il paesaggio entrano in minima parte nei cinedrammi al dì d’oggi, dove in compenso sono molti salotti, molti saloni, molti giardini. Il dramma e il pathos non sono solo nei drammi – ammesso che ci siano – che rappresentano uomini in frack e donne in décolleté, ma anche in quelli nei quali agiscono i poveri e gli umili, i sani e i forti che con la natura hanno continui contatti» . Sulla stessa rivista appare un importante articolo di Alfredo Masi in cui si cerca di fare il punto teorico sul film come opera d’arte e dove per la prima volta, forse, il pubblico è visto come protagonista «è chiamato a partecipare come forza attiva allo spettacolo, completandolo con elementi soggettivi a lui propri» . La prospettiva realistica coabita, senza apparenti conflitti, con quella fantastica a cui è più vicina la posizione dello stesso direttore, che fin dai primi articoli sembra collocarsi sulla linea aperta dalla famosa intervista dannunziana al «Corriere della Sera» e ai riferimenti nobilitanti alle Metamorfosi ovidiane: «La tecnica cinematografica consente l’espressione dei più strani mondi fantastici che la parola o il pennello non potrebbero significare o significherebbero in modo incompleto […]. Potete far tutto: il cinematografo è un’arte magica, che nei suoi laboratori muta le forme una dall’altra e una nell’altra» . Grazie al contributo di Luciani e Alfredo Masi vengono analizzati per la prima volta alcuni fondamentali fattori del linguaggio cinematografico, come la luce, il ritmo visivo e musicale, il rapporto con il montaggio, gli elementi caratterizzanti del cinema rispetto al teatro . La rivista si rivela un punto di passaggio obbligato per la valorizzazione contemporanea di tutti i problemi di estetica cinematografica finora disseminati diacronicamente in varie altre testate. In modo del tutto omologo alle caratteristiche dell’industria cinematografica «Apollon», nella sua breve stagione, vive senza essere minimamente toccata dai problemi della società e della guerra: nessun sospetto di crisi sembra sfiorare le sue splendide pagine patinate almeno fino al 1918. Nessuna reale conoscenza e attenzione per i problemi del mercato, in una rivista fatta esclusivamente da letterati che si propongono, in ultima analisi, il progetto di una prima fondazione e definizione dei massimi problemi dell’estetica cinematografica, appare certo un limite non indifferente, non solo in prospettiva storica, ma anche ai critici contemporanei. La polemica contro «Apollon» e il suo direttore, non tarda a denunciare proprio questa separatezza rispetto ai problemi specifici del cinema: «Voi non potete assolutamente impiegare la vostra penna rugginosa – tuona contro Bellonci la ‘Vita cinematografica’ nell’ottobre del 1917 – nella trattazione dei moderni problemi estetici […] lasciate correre […] fate il postillatore di storie bibliche, non di cinematografo». Al di là di questa polemica contingente si può però riconoscere che sia pure in modo disperso e disordinato, la critica è approdata a un livello di consapevolezza maggiore dell’ordine complessivo dei problemi che pone il cinema. Basterà prendere per le mani una rivista di poco successiva «In Penombra» (all’inizio «Penombra») uscita tra il 1918 e il 1919 per accorgersi del salto di qualità e della integrazione ormai quasi perfetta del discorso cinematografico in un contesto culturale, letterario ed estetico. «In Penombra» segna il punto più alto e maturo raggiunto in questa fase da una categoria e da un tipo di stampa alla ricerca di una propria identità e legittimazione. Questo allargamento della competenza consente il progressivo capovolgimento del discorso avviato all’inizio, quando i veri problemi della comunicazione cinematografica erano quelli dell’identificazione del destinatario e del massimo allargamento dell’area di influenza del messaggio. Ora il centro d’interesse sembra essere, quello dell’identificazione della figura dell’autore, la rimozione, in quanto extraestetica, secondo il pensiero idealistico, dell’influenza del momento produttivo, la legittimazione del cinema nel sistema delle arti, e sua potenziale capacità di divenire arte egemone per eccellenza. Quanto al messaggio e all’analisi del testo non sembra ancora giunto il momento in cui la critica riesce a individuare la coerenza e la specificità del sistema espressivo, quanto piuttosto il discorso è riuscito a estrapolare un elemento, l’attore, e 48
49
50
51
52
53
ad attribuirgli un ruolo simbolico e sociale assai ampio. La conquista di alcune categorie estetiche significa rimozione o subordinazione degli interessi economici, sociali e tecnologici e perdita pressoché totale di contatto con la situazione del mercato. Questo spiega come la critica venga colta di sorpresa dalla crisi del dopoguerra, come non sia metodologicamente attrezzata a farvi fronte. E come i suoi strumenti si rivelino assolutamente inadeguati a prevedere e analizzare i primi preoccupanti sintomi di crisi che già si manifestano nell’ultima fase del periodo bellico, quando ormai i mercati esteri si sono chiusi e, attraverso le frontiere italiane, transitano massicci contingenti di pellicole americane. 1
C. Nasi, Fra uomini e cose, in «La Gazzetta di Torino», 6 aprile 1896, p. 1.
D. Turconi, La stampa cinematografica in Italia e negli Stati Uniti dalle origini al 1930, Amministrazione provinciale di Pavia, 1977, p. 5 e dello stesso Cinema scritto, in «Immagine», n.s., n. 11, estate 1989, pp. 1-4; G. Fabre, D’Annunzio nelle prime riviste del cinema italiano, in AA.VV., D’Annunzio e il cinema, in «Quaderni del Vittoriale», n. 4, agosto 1977, pp. 55-92. L’Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema ha curato nel 1992 un nuovo censimento delle riviste italiane degli anni del muto. 2
G. Viazzi, Il decennio delle origini. Storia, opinioni e tendenze dei precursori, in «Ferrainia», a. X, dicembre 1956, ristampato in «Bianco e Nero», nn. 3-4, marzo-aprile 1973. Un tentativo di riordinamento organico delle teoriche delle origini è di P. Del Monte, Le teoriche del film in Italia dalle origini al sonoro, in «Bianco e Nero», a. XXX, nn. 1-2, gennaio-febbraio, 5-6, maggio-giugno, 7-8, luglio-agosto 1969 e quasi contemporaneo è lo studio di O. Caldiron, L’evoluzione della critica cinematografica in Italia dalle origini al 1920, Grado 1970 (ciclostilato), ora in Id., La paura del buio, Bulzoni, Roma 1980, pp. 15-55. Si veda anche E. Ceretti, Storia della critica cinematografica italiana, in «Cinema», a. IV, nn. 61-62-63, 1939 e M. Verdone, Origini della critica cinematografica in Italia, in «Rivista del cinematografo», a. XXVII, n. 5, maggio 1954, pp. 11-12. 3
4
G. Ferri, Tra le quinte del cinematografo, in «La Lettura», ottobre 1906.
5
G. Papini, La filosofia del cinematografo, in «La Stampa», 18 maggio 1907.
Ibidem. Sul rapporto tra Bergson e il cinema si vedano i due volumi di G. Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, e L’immagine-tempo, Milano, Ubulibri, 1989. 6
7
Programma, in «Cinéma-chantant», a. II, n. 1, gennaio 1908.
E. Janni, Un colloquio con Gabriele D’Annunzio, in «Corriere della Sera», 29 maggio 1908 riportato in I. Ciani, Fotogrammi Dannunziani, Ediars, Pescara 1999. 8
R. Canudo, Lettere d’arte. Trionfo del cinematografo, in «Il nuovo giornale», 25 novembre 1908, p. 3 ora in G. Dotoli, Lo scrittore totale. Saggi su Ricciotto Canudo, Schena, Fasano 1986, pp. 129-138 e in R. Canudo, L’usine aux image, a cura di J.-P. Morel, Seguier, Paris 9
1995, pp. 23-25. 10
R. Tessari, Il mito della macchina. Letteratura e industria nel primo Novecento italiano, Mursia, Milano 1973.
11
M. Morasso, La nuova arma(La macchina), a cura di C. Ossola, Centro Studi piemontesi, Torino 1994.
12
Uno dei primi tentativi di ricollocare la teoria di Canudo nella giusta luce è di G. Rondolino, La teoria cinematografica di Ricciotto
Canudo, in «Quaderni del Novecento francese», n. 3, 1976, pp. 123-172. 13
E. Thovez (Crainquebille), L’arte di celluloide, in «La Stampa», 29 luglio 1908; ora in L’arco di Ulisse, Ricciardi, Napoli 1921, p. 64.
14
Ibidem.
Una prima importante ricognizione bibliografica delle riviste di cinema in Italia è stata curata da D. Turconi e C. Bassotto, Il cinema nelle riviste italiane dalle origini a oggi, ed. Mostra del cinema, Venezia 1972. Di recente, come si è detto è stata effettuata una più completa ricognizione grazie all’Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema: R. Redi (a cura di), Cinema scritto. Il catalogo delle riviste italiane di cinema, 1907-1944, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1992. Questo volume ha il merito di offrire, 15
assieme a una descrizione analitica delle riviste, anche la loro reperibilità nelle biblioteche italiane. 16
Ego, Non trascurabili consigli e appunti, in «La cinematografia italiana», a. I, n. 2, 15 febbraio 1908.
17
Si veda il capitolo Il reale e il fantastico, nel mio Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Patron, Bologna 1972, pp. 29-33.
L., I soggetti della cinematografia, in «La Cine-Fono», a. I, n. 1, 1° ottobre 1908. Per un quadro analitico delle pubblicazioni relative alle possibilità didattiche del cinema cfr. S. Raffaelli, Il cinema per la scuola nei primordi. Per una bibliografia italiana sul cinema didattico e formativo, in «Prospettiva EP», a. XIII, n. 1, gennaio-febbraio 1990, pp. 45-53. 18
19
T. Panteo, Il cinematografò, in «La Cine-Fono», a. I, n. 2, 16 ottobre 1908.
20
D.O. Marrama, La stampa quotidiana e il cinematografo, in «Lux», a. II, n. 3, marzo 1909.
21
R. Mastropaolo, Cinema e cultura popolare, in «Lux», a. II, n. 5, maggio 1909.
G. Re, Il cinematografo e i suoi accessori, Hoepli, Milano 1907; F.P. Liesegang, Il cinematografo. Manuale di cinematografia, Bocca, Torino 1909. 22
23
C. Mansueti, Il cinematografo e le sue conseguenze nelle arti, in «La Cine-Fono», a. III, n. 124, settembre 1910.
24
G.C. Bovarini, La funzione demoestetica della cinematografia, in «Lux», a. IV, n. 13, 16 aprile 1911.
25
S. Bush, Dante’s Divina Commedia in Moving Pictures, in «Moving Picture World», vol. VIII, n. 27, 8 luglio 1911, p. 1572.
26
A. Labriola, La crisi della cinematografia, in «Lux», a. II, n. 11, ottobre 1909.
27
Il cinematografo, in «Corriere della Sera», 30 agosto 1910.
28
Il testo è in M.A. Prolo, Storia del cinema muto italiano, Il Poligono, Milano 1951, p. 32.
Turconi, La stampa cinematografica, cit., p. 10. Tornando sull’argomento anche in tempi più recenti Turconi ribadisce in sostanza le osservazioni di allora. 29
30
E. Boutet, Il cinematografo, in «La Nuova Antologia», 16 agosto 1913.
31
G. Prezzolini, Paradossi educativi, in «La Voce», 22 agosto 1914.
32
Brand, La cinematografia artistica, in «La fotografia artistica», a. IX, n. 2, febbraio 1912.
33
Inchiesta sul cinematografo, in «Il Nuovo Giornale», dal 21 novembre al 9 dicembre 1913.
34
La risposta di Marinetti esce il 30 novembre.
35
Prolo, Storia del cinema muto italiano, cit., p. 35.
Si vedano anche P. Cherchi Usai, G. Pastrone. Gli anni d’oro del cinema a Torino, Utet, Torino 1986 e lo scritto di D’Annunzio riportato in Appendice: Del cinematografo considerato come strumento di liberazione e come arte di trasfigurazione, pp. 115-122. 36
37
A.G., Quale dovrebbe essere l’intento della cinematografia, a. IX, n. 5, maggio 1914.
38
E. Rossi, Il tendine d’Achille, in «La vita cinematografica», 10 luglio 1914.
39
Si veda in questo senso l’ampio saggio di G. Fabre, D’Annunzio nelle prime riviste del cinema italiano, cit.
40
A. Ambrosio, La mise en scene, in «L’arte muta», a. I, n. 6-7, 15 dicembre 1916.
41
A. Menini, Lo scrittore da cinematografo e il metteur en scène, in «La Cine-Fono», a. IX, 1916.
42
S.A. Luciani, Il cinematografo e l’arte, in «Il Marzocco», 10 agosto 1913.
Una discreta raccolta di esempi di recensioni significative si trova nel saggio citato di Turconi, La stampa cinematografica, cit. Si veda anche l’antologia di testi in Tra una film e l’altra. Materiali sul cinema muto italiano 1907-1920 (con una introduzione di Lino Miccichè), Marsilio, Venezia 1980. 43
44
P. Cacace, Per un sindacato della nostra stampa, in «La Cine-Fono», a. IX, ottobre 1916.
Lo scritto di O. Vassallo appare su «La Cine-Fono», nel 1916. «Fin dal 1909 – ricorda Giorgio Fabre – le riviste cinematografiche avevano fatto osservare come al cinema mancasse il supporto della critica quotidiana, l’arricchimento della interpretazione critica e dell’informazione sui giornali che aveva invece il teatro… La critica sui quotidiani veniva vista da alcuni come possibilità di ricevere un controllo e una qualificazione pubblica che poteva sancire il valore generale dello spettacolo cinematografico. Da altri come una specializzazione di un’altra applicazione di tipo intellettuale intorno al cinema o come un adeguarsi del mezzo cinematografico alla rapidità del mondo dell’informazione. La nascita di una critica cinematografica quotidiana era ritenuta indispensabile allo sviluppo del cinema perché solo essa poteva socializzare il nuovo spettacolo ai livelli a cui ormai aspirava», Fabre, D’Annunzio nelle prime riviste, cit., p. 91. 45
46
I diritti della critica, in «La vita cinematografica», a. VI, n. 40-41, novembre 1915.
47
«Apollon» nasce nel febbraio del 1916 e termina le sue pubblicazioni nel 1921.
48
É. Zola, Una lettera, in «Apollon», a. I, n. 6, luglio 1916.
49
P. Solari, Naturalismo, in «Apollon», a. I, n. 3, aprile 1916.
50
A. Masi, Un programma, in «Apollon», a. I, n. 7, 1 agosto 1916.
51
G. Bellonci, Manifesto per una rivoluzione cinematografica, in «Apollon», a. I, n. 8, settembre 1916.
52
A. Masi, Un programma, in «Apollon», a. I, n. 7, agosto 1916.
S.A. Luciani, Impressionismo scenico, in «Apollon», a. I, n. 3, aprile 1916, e Id., Poetica del cinematografo, in «Apollon», a. I, n. 4, maggio 1916. A Luciani sono stati dedicati vari contributi: si possono vedere le pagine che ha scritto P. Del Monte nel saggio citato sulle teoriche delle origini, il volumetto di V. Attolini, Sebastiano Arturo Luciani teorico del film, Ed. Centro Librario, Bari 1971, le pagine del mio Intellettuali, cinema e propaganda, cit., pp. 42-51. Per i saggi storici più interessanti si vedano almeno: U. Barbaro, Ricordo diS.A. Luciani, in «Filmcritica», a. I, n. 2, febbraio 1951, pp. 43 sgg., ora anche in Id., Servitù e grandezza del cinema, Editori Riuniti, Roma 1961; M. Verdone, S.A. Luciani, in «Bianco e Nero», n. 2, febbraio 1951 e C.L. Ragghianti, Luciani e Canudo, in Id., Cinema arte figurativa, Einaudi, Torino 1957, pp. 187-192. 53
Nascita e sviluppo del racconto
costituzione del sistema narrativo Il fenomeno del cinema muto italiano è stato per almeno cinquant’anni una di quelle vistose manifestazioni di ciò che gli antropologi della cultura chiamano caduta al di fuori della memoria sociale. La memoria di tutta una produzione enorme, assai articolata, ben periodizzabile e scomponibile, non si è trasmessa che attraverso un numero assai limitato di testi esemplari, mai analizzati nella loro specificità, attraverso opportuni prelievi, o nella loro rappresentatività di un sistema dallo sviluppo se non coerente almeno fortemente coeso. L’immagine che si è continuata ad avere del cinema italiano – almeno fino ai primi anni Ottanta quando è iniziata una vigorosa riscossa storiografica e un’azione sistematica di recupero – è stata legata a una serie di luoghi comuni storiografici, di ricordi d’infanzia degli autori, o di incontri casuali con un numero di film che spesso superavano di poco la decina. Oggi dal buio sono riemerse molte opere (molte di più di quanto ci si potesse aspettare quando sono cominciate le ricerche di questo libro) e altre premono per tornare a far muovere le loro immagini su uno schermo. Se negli anni Settanta il «luogo comune» e il punto d’incontro e scontro erano stati gli anni Trenta e Quaranta, nel decennio successivo il cinema muto ha prodotto una vera e propria «gold rush» storiografica e, in questo senso i recuperi e i restauri di decine e decine di film hanno un’importanza critica e storica non inferiore a quella delle decine e decine di contributi fioriti in Italia e all’estero. Se agli inizi degli anni Ottanta, nella densa introduzione all’antologia Tra una filme l’altra, Lino Miccichè quantificava in un 5% il numero di film muti italiani sopravvissuti, oggi la percentuale può sfiorare ottimisticamente il 20%. E non passa giorno che qualche nuovo film non venga avvistato. Il lavoro prodotto dalle cineteche «giovani» come quella del Friuli e quella di Bologna ha giocato un ruolo decisivo mentre per quanto riguarda la Cineteca nazionale di Roma va ricordato il grosso lavoro di ristampe e restauri a partire dal cinema sonoro. Ultimo ma non minore il contributo al salvataggio, all’identificazione e a un restauro filologicamente corretto dato dall’«Associazione per le ricerche di Storia del cinema». L’assenza di una produzione iniziale non significa – come si è detto – assenza di film, di esplorazione del mercato: nel decennio 1895-1905 il vuoto produttivo non è più grave di quello di altre cinematografie e se si tiene conto della situazione industriale ed economica, la rapidità con cui nasce e si sviluppa un’industria è stupefacente. In questo decennio di latenza produttiva, di sondaggio, preparazione e formazione di un pubblico assai differenziato, il cinema cerca di raggiungere una sede stabile nelle città, creando una reale forma di divertimento alternativo per le masse popolari prima, e poi, poco alla volta, per i pubblici urbani. All’inizio cambia non il tipo di spettacolo, la cui tipologia e morfologia si può definire con grande precisione, ma lo spazio della visione e i pubblici riescono a trovare dei locali che mantengono, fin quando è possibile, le divisioni di classe. In ogni caso, mancando di una storia anteriore, il cinema fonda le sue regole, la sua sintassi, costruisce i suoi tecnici e crea le competenze sia negli emittenti che nei pubblici, grazie alla ripetizione-variazione ipertrofica dei medesimi atti. Si cerca di raggiungere un livello della merce-film che consenta di non sfigurare in rapporto alla concorrenza straniera e, fin dai primi esempi di elementari forme di narrazione, si vuole recuperare il ritardo tecnologico: la rapidità dello sviluppo tecnico ed espressivo è favorita dalla consistente rete di sale che consente un immediato assorbimento del prodotto. I produttori, guardando fin dall’inizio con un occhio al mercato nazionale e con l’altro a quello internazionale, tentano di entrare in concorrenza con prodotti qualitativamente allo stesso livello e assai più convenienti sul piano dei prezzi. Le difficoltà che si presentano per la nascente industria non sono in effetti insormontabili, sia perché i
prodotti stranieri entrano e circolano nel mercato nazionale con una certa facilità, a formare la base di un sistema che dev’essere inventato da zero, ma soprattutto perché c’è stata una prima dinamizzazione proprio a partire dai primi anni del Novecento e i risultati raggiunti non sono tali da risultare inimitabili. Una delle strade più seguite è quella di reclutare direttamente tecnici stranieri. La Francia offre un parco di operatori a cui attingere a piene mani. Si tratta, per esempio, di servirsi del vivaio della Pathé, che, pur con pochi anni di esperienza, ha già una produzione affermata sul piano internazionale. Se, grazie a Georges Méliès, alla féerie e al cinema fantastico si sono sondati ed esplorati tutti i trucchi e le possibilità di trasformazione interne alla singola inquadratura, il montaggio ha appena mosso i primi passi alla conquista della nozione consecutiva di azione nello spazio e nel tempo. I produttori del primo cinema muto non sembrano avere alcuna coscienza delle regole che organizzano il loro elementare sistema di testi. Nei primi esempi di racconto non si mira tanto a generare regole di costruzione narrativa, drammatica e sintattica, quanto piuttosto a riprodurre le strutture di testi preesistenti. In un momento di crisi di tutte le scritture istituzionali (del romanzo come del teatro naturalista, della poesia, della musica, della pittura) il cinema riesce ad attraversarle tutte, le riduce, le semplifica, ma riesce anche a farle coabitare le une vicino alle altre, dando l’impressione di realizzare quella sintesi delle arti, quell’«opera d’arte totale» (la Gesamtkunstwerke) ipotizzata negli scritti wagneriani. D’altra parte il cinema non ha, né intende realizzarla, una sua immediata autonomia o specificità: mobilita piuttosto una serie enorme di codici, verso cui ha, per lo più, un rapporto di subalternità o comunque parassitario. Mentre lo spettatore è escluso dalla partecipazione culturale alla produzione del testo, l’emittente del messaggio appartiene a una comunità culturale definita, e ciò che si tratta di vedere è il processo di differenziazione ideologica e formale attraverso cui si vengono elaborando le prime forme elementari di messaggio rispetto ai modelli genetici del linguaggio dei Lumière in Francia, o di Edison negli Stati Uniti, e come, nel giro di pochi anni, si cerchino di fissare degli statuti molto individualizzanti e dei procedimenti di scrittura altrettanto definiti. Da una parte il racconto cinematografico evolve secondo linee di sviluppo possiamo dire, impropriamente, genetico, che mirano alla conquista, passo per passo, di una sintassi narrativa, dall’altra questo tipo di sviluppo è legato a tutta una serie di relazioni dirette e referenziali tra testo filmico e contesto sociale. Dare ragione sempre dei due tipi di legami non è certo facile, ma interessa qui sottolineare il principio generale della storicità di ogni segno, della possibilità di ritrovare sempre nel testo le determinazioni storiche del contesto . Tra tutte le cinematografie il cinema italiano evolve molto più lentamente sul piano sintattico e sembra proporsi dei modelli culturali che tengono solo in parte presente la realtà extracinematografica. Per anni l’espansione temporale non avviene secondo regole combinatorie, quanto piuttosto per semplice accumulazione e giustapposizione di quadri. Lo spettacolo dei «tableaux vivants» è un antecedente importante per capire le dinamiche iniziali del racconto cinematografico. Sono le sequenze di racconti delle lastre delle lanterne magiche, oltre agli spettacoli di «tableaux vivants» i modelli anteriori più contigui e affini. Confrontando il cinema italiano delle origini con le altre cinematografie ci si accorge che la trasformazione e la conquista di una sintassi è più lenta per il ritardo iniziale, per una vera e propria dinamizzazione interna minima del sistema e per una tendenza abbastanza diffusa di mantenimento delle unità narrative distinte e autosufficienti tra loro per alcuni anni. Il reale contiguo sembra interessare in misura assai modesta il cinema italiano nei suoi primi anni di vita, mentre il passato, la storia, le grandi opere e le grandi figure di tutti i tempi, appaiono come un oggetto privilegiato di rappresentazione. Il ritardo nei modi narrativi ed espressivi nasce dalla volontà di mantenersi anzitutto sul piano della letteratura illustrata («L’atmosfera di questi film – ha scritto Roberto Paolella – è quella dei quadri murali di Paravia e Vallardi per le prime classi elementari») . Il cinema italiano ha sempre vissuto e si è diffuso grazie a un’intima e quasi naturale vocazione pedagogica: la sua storia è storia di una liberazione progressiva, e mai completa dall’influenza di codici, forme e modelli letterari e culturali antecedenti. 1
2
«la presa di roma», evento e monumento laico Nel 1903 viene realizzato, dal segretario della pontificia commissione per le catacombe Rodolfo Kanzler, un documentario ricostruito che, pur al di fuori dell’attività produttiva regolare, è già un interessante tentativo di
identificazione dei codici di finzione con la realtà. Il titolo del documentario è Deposizione del corpo di una martire: «la ricostruzione si rese necessaria perché, a quell’epoca, a riprese con illuminazione artificiale nemmeno si arrivava con l’immaginazione. Sull’area esterna del cimitero di Domitilla sull’Ardeatina, così, fu costruito un cubicolo nel quale, oltre ai diversi tipi di loculi chiusi con lastre di marmo con relativa iscrizione o con tegole, era anche un arcosolio dipinto […] tutti i particolari dei cimiteri sotterranei erano stati fedelmente riprodotti, perfino le lapidi annerite dal fumo delle lampade, perfino le mense degli olii» . La finzione tende dunque, da subito, al massimo di verisimiglianza. Le successive esperienze di Omegna o di Ambrosio hanno un valore limitato agli effetti della dinamica narrativa, per cui il punto di partenza rimane, per la sua ricchezza e ambizione, La presa di Roma realizzato dall’Alberini e Santoni nel 1905. Se adottiamo subito un’ottica storiografica allargata di tipo comparatistico constatiamo che, tra tutte le cinematografie, quella italiana nasce ritardata. Di una decina d’anni. La cosa, tuttavia, anziché costituire un handicap e creare complessi di inferiorità nei confronti delle cinematografie già sviluppate e capaci di concepire e articolare le prime forme di racconto ne diventa, quasi paradossalmente, il punto di forza, quello che consente al cinema italiano un immediato decollo sul piano internazionale. Un po’come per la nascita di Ercole i primi segni di vita di questa cinematografia neonata ne rivelano subito potenza e ambizione di sfidare in campo aperto la produzione altrui nell’atto stesso di emettere il primo vagito. La presa di Roma si può considerare il primo «colosso» della storia del cinema, la prima opera capace di confrontarsi ambiziosamente con la grande storia e con i simboli e le strutture fondanti di una nazione che ha ritrovato la sua unità dopo quasi due millenni. Alberini fissa una diversa misura al racconto cinematografico: la storia-monumento e la storia-documento si animano e rivivono facendo sentire fuori per sinestesia gli odori degli spazi oltre che i suoni e le grida dei bersaglieri all’assalto di Porta Pia. La copia originale della Presa di Roma ha una lunghezza di 250 metri di cui oggi sopravvivono soltanto 75, e le copie vengono vendute alle sale cinematografiche a 500 lire l’una. Con questo film Alberini tenta di far compiere un netto salto di qualità al suo prodotto: non più scene dal vero e neppure comiche fondate su una sola idea, come circolavano normalmente nei programmi, ma sviluppo della rappresentazione in quadri distinti e scelta programmatica di un argomento capitale per la storia dell’Italia contemporanea. Vi sono state diverse possibilità e occasioni di studiare questo film nei decenni passati. Una fonte indispensabile per la ricostruzione non solo della struttura del film, ma delle modalità di proiezione, del colore dei viraggi, delle interruzioni a ogni quadro, alle azioni contenute in ognuno dei sei quadri d’azione (a cui si aggiunge il settimo con l’apoteosi) è indispensabile il racconto di Gualtiero Fabbri Al Cinematografo, pubblicato nel 1907 e ristampato di recente a cura di Sergio Raffaelli: «Improvvisamente, non so per quale collettivo impulso, si fa un sepolcrale silenzio, poi un gran buio: il bottone elettrico che toglie la luce, ha funzionato. E sul gran quadro, nel vasto campo della tela di calicot, appare vivamente illuminata dal proiettore della cabina e a lettere cubitali rossicce la scritta seguente: La presa di Roma […]. Poi la scritta scompare, e al suo punto, emerge nitidissimamente, con una grande vivezza di realtà e con pochi o punto tremolii, la marziale figura del generale Carchidio, conte di Malavolta, quegli che il 18 settembre 1870 è stato inviato dal generale Cadorna agli avamposti. Accanto gli è l’ufficiale di Stato Maggiore pontificio, Carlo Bartolini, e il tenente dei dragoni Cesare Visconti […]. A quel punto il Carchidio, come è già stato fatto a un suo predecessore, il colonnello Caccialupi, viene bendato […]. Questo è il primo quadro, sparito il quale fattasi la luce e poi tornate le tenebre ». Aldo Bernardini ne ha offerto alcuni anni fa, nel già ricordato La meccanica del visibile, una lettura analitica. Il successo del film è garantito dall’esperienza ormai raggiunta sul piano della ripresa, dall’importanza storica dell’argomento, dalla cura con cui erano riprodotte le uniformi e dalla verisimiglianza delle azioni. L’Alberini e Santoni scopre, in ogni caso, fin dal suo primo film impegnativo, la propria vocazione narrativa: i quadri, pur rimanendo staccati, seguono la cronologia degli avvenimenti secondo la loro disposizione logica e temporale. La lunghezza è quella media della produzione internazionale: si sta sotto i dieci minuti, ma si riesce a sintetizzare una narrazione. I quadri sono sette e alternano riprese in interni ed esterni. L’ultimo mostra l’apoteosi con la realizzazione del sogno di Cavour, Vittorio Emanuele II, Mazzini e Garibaldi. Rispetto allo sviluppo raggiunto dalla produzione contemporanea americana e francese si cerca di sfruttare al massimo 3
4
non gli elementi combinatori e sintattici, ma quelli rappresentativi e recitativi del singolo quadro. Ogni quadro è un’unità autonoma dal punto di vista del senso dell’azione rappresentata. La didascalia, che per ora precede il quadro, funziona quindi da indice e da elemento di identificazione. Della Presa di Roma oggi conosciamo una cospicua serie di dati : dal luogo della prima proiezione pubblica a Roma (all’inizio della via Nomentana, in corrispondenza della breccia di Porta Pia) , alla data del battesimo ufficiale (il 20 settembre 1905, nel 35° anniversario dell’attacco vittorioso da parte del 12° battaglione bersaglieri della Brigata Modena), alla lunghezza (250 metri), alla collaborazione da parte del Ministero della Guerra, alle concordanze coi quadri della Gran battaglia e presa di Magenta rappresentata al Circo Olimpico Africano a Reggio Emilia l’11 marzo 1860 , alle fonti iconografiche e fotografiche (i dipinti di Michele Cammarano, o le fotografie coeve del Fuminello), all’autore delle scenografie (il professor Cicognani), alle testimonianze di applausi a scena aperta documentate dalla «Tribuna»… E siamo in grado di riconoscere nell’evento alcuni caratteri e i geni di una cinematografia che pur nascendo con una decina d’anni di ritardo rispetto a quella francese non dimostra nei confronti di nessuna delle cinematografie già esistenti alcun complesso di inferiorità. «Il cinema italiano sembra nascere sotto il segno del Risorgimento», come ha osservato Guido Cincotti . Se l’incremento d’informazioni ci spinge a rendere omaggio al buon lavoro d’esplorazione del territorio delle origini, ciò che colpisce di più è lo spirito laico e unitario che anima l’opera, il suo porsi come nell’atto di costituirsi già monumento e memoria di un evento che ha portato, dopo secoli di divisioni e dominazione straniera, alla nascita della nazione. Questo si vede soprattutto nell’ultimo quadro in cui risplende una luce potente sulla figura femminile che personifica l’Italia – con stendardo tricolore in pugno, e ai cui lati sono disposti Cavour e Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Crispi – nel pieno rispetto della tradizione oleografica risorgimentale. Oggi, però, per merito del giovane studioso Giovanni Lasi le nostre conoscenze hanno compiuto un decisivo passo in avanti e ci consentono di fissare meglio i dati relativi al testo, di stabilire delle connessioni inedite con il contesto e di formulare nuove considerazioni e avanzare nuove ipotesi. Inoltre possiamo sapere anche qualcosa di più sulle intenzioni profonde ideologiche e pedagogizzanti che guidano il film. Alberini è massone, è iscritto a una loggia fiorentina di cui fan parte anche il presidente del Consiglio e tre ministri, tra cui quello dell’Istruzione e riceve aiuti da ogni parte (dall’esercito e dal Comitato dei Festeggiamenti per l’anniversario della presa di Roma) per portare a termine la sua opera e per la proiezione pubblica a Porta Pia. Con questo film che per impegno ricostruttivo e investimento materiale e ideale non ha comunque eguali sul piano internazionale, il cinema italiano manifesta sul nascere una natura e dei caratteri che non gli sarà facile mantenere negli anni successivi. In conclusione sintetizzando quanto detto finora e osservando il film sotto la nuova luce degli elementi offertici anche dalle ricerche di Lafi possiamo indicare i seguenti punti d’interesse: 1. Rispetto al cinema francese il cinema italiano nasce come grande evento collettivo laico: alla sua nascita assistono non 33 persone come gli spettatori del Salon Indien della prima proiezione del dicembre 1895, ma alcune migliaia che applaudono entusiasti alla proiezione all’aperto del settembre 1905. 2. La volontà degli autori e dei committenti è quella di creare, già all’atto di nascita del cinema, un’operamonumento della storia nazionale in cui ogni elemento è ricostruito in modo da offrire il massimo della verisimiglianza con l’avvenimento rappresentato. 3. Alberini apre e indica la strada della possibilità di servirsi del cinema come di un mezzo privilegiato per viaggiare in senso antiorario nel tempo e far rivivere le glorie del passato, il senso della grandezza e potenza di un paese appena riunificato. 4. Rispetto agli operatori Lumière, ma anche ai registi che stanno esplorando nei vari paesi la petite histoire événementielle e promuovono o registrano all’anagrafe della storia migliaia di persone destinate all’anonimato, Alberini si confronta invece con la grande storia e intende servirsi delle immagini sullo schermo come di un luogo privilegiato della memoria del paese. 5. Il cinema è il luogo ideale in cui poter far rivivere le dimensioni della realtà e quelle simboliche. 6. Anche se siamo a un livello molto elementare di prosodia, sintassi narrativa e metrica La presa di Roma sviluppa i suoi quadri come lasse di un poema epico e mostra un tipo di narrazione e che conduce 5
6
7
8
all’apoteosi. 7. L’attacco dei bersaglieri a Porta Pia è l’archetipo di centinaia di scene di massa che costituiranno nel decennio successivo uno dei caratteri identitari forti del cinema italiano. 8. Alberini nel concepire La presa di Roma pensa evidentemente a un vero e proprio prototipo dalle caratteristiche culturali e drammaturgiche alte per cui cerca di confrontarsi con le arti figurative e la Grande Opéra, ma ignora del tutto il cinema destinato ai padiglioni degli ambulanti o delle sale dei café chantant. 9. A giudicare dalla commossa partecipazione agli episodi che trentacinque anni fa fecero palpitare i cuori di tutti gli italiani si direbbe che la folla di spettatori riunita in via Nomentana ad assistere alle proiezioni della Presa di Roma non avverta affatto la presenza dello schermo steso proprio di fronte alla breccia di Porta Pia e provi come soggetto unico quella straordinaria condizione di perdita dei confini dell’Io e di partecipazione diretta all’evento assieme alla possibilità di marciare e combattere a fianco dei bersaglieri e di celebrare al loro fianco l’apoteosi della nascita dello Stato Unitario. 10. Nel lanciare la sfida alla cinematografia francese Alberini realizza un prodotto spettacolare, accurato nella ricostruzione, celebrativo e didattico e un evento che rende reale e verisimile la finzione, quasi ricordandosi della lezione manzoniana sulle caratteristiche del romanzo storico, o dell’allocuzione foscoliana «Italiani, vi esorto alla storia!». La vocazione al film storico è nel codice genetico del cinema italiano. Il film attua un taglio netto nei confronti del cinema ambulante e va subito alla conquista del pubblico urbano. Nulla di tutto questo è finora avvenuto in nessuna cinematografia internazionale.
i primi passi Nel 1906 il reclutamento di Gaston Velle, sottratto alla Pathé da parte della Cines, introduce, sia pure per un tempo assai breve, quasi legato alla figura dello stesso Velle, il cinema fantastico, costruito sul modello di Méliès . Malía dell’oro o Un viaggio in una stella sono due film che tentano di riproporre i moduli della féerie e gli stessi trucchi, fondati essenzialmente sul principio della metamorfosi. La Cines tenta alcune strade e si presenta con una produzione iniziale limitata, ma di buona qualità e fattura e di durata superiore alla media. In pratica si punta, fin dalle prime esperienze, sulla distintività di ogni singolo prodotto. Se i film Cines realizzati tra il 1905 e il 1906 sono soltanto poche unità, l’Ambrosio film offre un catalogo di un’ottantina di titoli attraverso i quali si cerca di saturare qualsiasi tipo di domanda e di curiosità. Studiando i cataloghi delle prime case cinematografiche ci si accorge che i modelli di riferimento sono quelli delle lastre per lanterna magica, in molti casi ripresi sia nel numero di quadri, che nell’articolazione dei temi religiosi, o di conoscenza del mondo. Vi sono le comiche, i documentari in cui si alternano con equilibrio curiosità, folklore e cronaca, una trentina di film drammatici di breve durata, che, nella varietà dei temi, sembrano esplorare le possibilità narrative e gli interessi del pubblico. Film a carattere edificante come L’angelo della famiglia, Cuore e dovere, Cuor di soldato, si affiancano a opere dal titolo e dal contenuto più drammatico, in cui sono suggerite passioni forti, si rappresentano il delitto e la delinquenza, si animano dei «faits divers» che già hanno alimentato l’immaginazione popolare attraverso la stampa illustrata o le canzoni dei cantacronache (Briganti in Sardegna, Camorra napoletana, Il delitto di Beinasco, La ladra, Dramma in caserma, Vendetta alsaziana). Lo spettacolo Ambrosio si caratterizza per la sua varietà di motivi, con il dramma che pesca dalla cronaca nera o richiama dal titolo i classici del feuilleton, e i racconti dei cantacronache, si mescola al documentario di attualità e alla comica, e tenta, da subito, di giocare non solo sul registro dell’azione, ma anche su quello dell’ambiguità lessicale (Cornuto [suo malgrado]) e della satira sociale. Oltre alla comica finale, Ambrosio inventa una figura cinematografica di chiusura di spettacolo che si chiama «congedo» (Buona sera fotografo, Buona sera alla finestra, Buona sera fiori… anche questo preso dagli spettacoli di lanterna magica), che può avere sia una funzione di saluto, come indicano i titoli, che di anticipazione (Domani nuovo programma del 1907). Il ventaglio piuttosto ampio di soggetti offerto da Ambrosio indica già il tentativo di individuare la potenzialità della domanda in un pubblico in cui sia prevista la presenza di tutte le classi sociali. Ma, al di là delle possibilità di scoprire, in questa fase, una morfologia assai embrionale, ci si può già porre, 9
con assoluta legittimità, il problema se sia possibile tracciare o riconoscere strutture soggiacenti che unificano la pluralità dei testi e ne determinano una coerenza interna a vari livelli. Un dato è certo, almeno per quanto riguarda questi primissimi anni: non c’è frattura o discontinuità o conflitto nell’ideologia dell’emittente. Per cui ciò che va messo in luce sono le corrispondenze tra ideologia e cultura dell’emittente e quelle dei destinatari. All’inizio la distanza è molto netta (con qualche eccezione per alcune piccole iniziative di gestori di sale a Napoli o a Venezia), poi, a partire dal 1911, si cerca di ridurre questa distanza senza peraltro assumere mai un punto di vista popolare. I produttori non rimuovono di certo il mondo popolare, ma lo accostano, secondo canoni figurativi e narrativi che appartengono alla cultura ottocentesca, al feuilleton, più che all’esigenza di percepire il presente di realizzare una rappresentazione che sia frutto di una testimonianza, di una condivisione o di una reale conoscenza del mondo popolare. Non c’è intenzione conoscitiva o accostamento partecipe ai problemi sociali, non c’è soprattutto assunzione del punto di vista e della cultura dei personaggi popolari. Il mondo popolare, di preferenza urbano, appare in maniera massiccia secondo stereotipi che derivano sia dall’illustrazione popolare che da quella catechistica. La composizione finale degli eventuali conflitti sociali o del ritorno alla famiglia del figlio o del marito colpevole fanno trionfare la morale perbenistica di una visione del mondo che prende atto di nuove situazioni e le rappresenta dapprima come esempi da fuggire, poi come realtà possibili di un sociale in fermento entro cui si avvertono svariati sintomi e segni di crisi. L’influenza del naturalismo e del verismo sarà comunque marginale rispetto al trionfo della cultura simbolista e dannunziana. Nella realtà sociale si vedono circolare idee in forte contrasto con la morale della rassegnazione e dell’accettazione fatalistica della propria condizione: quale fosse l’ideologia dei produttori di fronte ai fermenti sociali si può vedere benissimo in questo articolo di una delle prime riviste di categoria: «Oggi l’operaio ha cresciuto i suoi bisogni a misura che ha lasciato sulla soglia della sua casetta nel paese natio, la religione, la temperanza, l’economia, la sobrietà […] negli opuscoli non si legge più la felicità dell’operaio che divide il suo pane con la tenera famigliola, che si rallegra alla chiesetta del villaggio per la festa del patrono, che aspira a una patria comune, che vive e invecchia all’ombra del faggio nella piazzetta, accarezzando i propri nipoti, ma legge la dottrina dei maestri comunisti, socialisti, anarchici, che inneggiano al furto, al saccheggio, all’odio, che dicono la proprietà essere un furto […]. Nella loro riscaldata immaginazione non sono più Giuseppe, Michele e Teobaldo, santi del calendario cristiano che insegnano il lavoro e promettono la pace della coscienza, ma sono Lassalle, Proudhon, Mars [sic!]. Tolta l’idea di un mondo futuro dalla coscienza dell’operaio, chi può arrivare a persuaderlo che deve contentarsi del suo stato?». Lo stesso si può dire del mondo femminile, che altrettanto pericolosamente non sembra volersi accontentare del suo stato. Tutto il primo cinema muto sembra farsi carico, in modo unanime, di questa esigenza, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione del presente. Ogni possibile forma di conflittualità è riportata a motivi personali, lo sfondo, anche nei film di carattere più realistico, non è l’elemento che nei primi anni partecipi al dramma e lo qualifichi nella sua specificità. Una serie di situazioni narrative topiche possono accadere contro un qualsiasi sfondo. In questo modo si favorisce l’ingresso progressivo della storia passata che ha la funzione di nobilitare l’intreccio, ma di non mutarne i rapporti in senso dialettico. I drammi sociali non prevedono la richiesta di un diverso assetto, semmai confermano lo status quo, invitano il proletario – nei pochi casi in cui lo promuovono a protagonista dell’azione – ad accontentarsi della propria condizione e gli fanno intravedere i pericoli infernali e le conseguenze terribili di un eventuale mutamento di status sociale. Per Paolella l’intenzione narrativa è solo di tipo edificante («Il primo film italiano nasce come essenziale moralità. Il suo contenuto è un catechismo che una specie di immagineria popolare, sommaria, ma non priva di suggestione, illustra con ingenua automaticità. Non una scena di siffatta produzione è concepita per uno scopo che non sia di edificazione morale» ), mentre non è infrequente la possibilità di intravedere, dietro alla morale più ingenua, una logica che orienta il messaggio non soltanto a favore dell’ideologia conservatrice del produttore, ma anche a favore di una figura di committente che usa il film a scopi commerciali e pubblicitari. È il caso di Anima santa, operina realizzata nel 1907 a Venezia per conto della Cassa di Risparmio, dove si assiste alla storia di una bambina che chiede l’elemosina e deposita il frutto dei suoi guadagni in un libretto di risparmio. Malmenata dai suoi genitori viene difesa alla fine dai cassieri e uscieri della banca che mostrano 10
11
alla famiglia con quanta saggezza la bambina abbia raccolto un piccolo capitale . Una produzione edificante di carattere sociale o parasociale si trova nei cataloghi di tutte le case di produzione tra il 1906 e il 1912: i bambini sono uno dei soggetti privilegiati per le possibilità di sfruttamento dei motivi patetici sullo sfondo di forti drammi o di eventi storici. Nei cataloghi Cines troviamo titoli che riecheggiano e ripropongono motivi deamicisiani, come Piccolo garibaldino, Piccolo violinista, Congiura di bimbe, Piccola modella, Piccolo cantoniere, Orfana riconoscente, Il tamburino di Austerlitz. Tematiche religiose, drammi familiari, malattie incurabili, orfani e bambini abbandonati, ritrovamenti e agnizioni, tutto l’armamentario del romanzo popolare, temperato dalla letteratura edificante, si mescola con tematiche nazionaliste e antioperaie producendo una sorta di coabitazione di intenzioni diverse, ma mostrando ben chiara la funzione dominante del sermone e della morale conservatrice appena schermata dal pathos drammatico della vicenda. Nel Natale di Pierino (Arrigo Frusta, 1910) c’è la rappresentazione dell’accattonaggio dei minori e delle violenze e sfruttamento ai loro danni. Il presupposto narrativo è naturalmente La piccola fiammiferaia, ma anche Cenerentola (i fiammiferi che si animano, con un continuo gioco di metamorfosi e dalla scatola di sigarette esce la buona fatina), e il risveglio per il bambino è roseo almeno quanto il sogno poiché, grazie alla bontà di un ricco signore, può entrare nella sua casa e accedere alla visione dell’albero di Natale. In tutte le opere di questo tipo il mondo alto-borghese raramente interessa per i suoi vizi, piuttosto è rappresentato nella sua bontà, nel suo senso di carità, nella sua capacità di elargire doni, di concedere il beneficio del perdono. La medesima logica si continua, anche se viene sempre più compressa dall’avanzare della marea di derivazione dannunziana, e, a distanza di alcuni anni, possiamo trovare nel 1914 un Piccolo cerinaio (regia di Genina, produzione Cines) dove il piccolo protagonista viene ritrovato sui gradini della cattedrale dai nonni nobili, che perdonano la madre peccatrice malata e ridotta in miseria e ricompongono l’unità familiare. Ma qui c’è già un pathos che segnala la presenza di alcuni motivi firma di un autore che sta nascendo. I motivi dell’abbandono dei figli, del ritrovamento, dell’agnizione e del ritorno alla propria classe d’origine, della colpa e del perdono, la cui tradizione narrativa millenaria era stata ripresa dalla forte concentrazione drammatica del feuilleton, vengono rifunzionalizzati, non sulla base di una morale laica o positivistica, ma alla luce di una morale rovesciata, cattolica e conservatrice. Soltanto le lunghe sofferenze possono produrre la catarsi finale, come nel caso del Venditore di statuine della Cines (1911), così presentato dalla pubblicità della casa: «Una povera donna, per lenire la miseria, è costretta ad andare a servizio, lasciando il suo piccolo a un amico di famiglia […] il bimbo è inviato in una città vicina dove si mette a vendere statuine» . Più evidente l’ideologia quando lo sfondo del dramma affronta problemi sociali, come in Una giornata di sciopero della Pasquali (1911), dove la morte del figlio dell’operaio appare come conseguenza diretta del fatto che il padre è il capo degli scioperanti e impedisce al dottore, che vorrebbe accorrere, di andare dal figlio. È qualcosa che si trova anche nella produzione di Griffith alla Biograph negli stessi anni . Una variante, più legata alla rappresentazione della crisi della famiglia e delle conseguenze che ne possono derivare, è data dal ruolo del bambino come elemento di ricongiunzione dei coniugi. In un dramma della Milano Films del 1910 (La luce della speranza) , una mano provvidenziale guida nel finale la bambina a uscire a piedi scalzi nel giardino e pregare per il ritorno del padre. Il padre passa casualmente da quelle parti e, commosso, chiede perdono alla moglie per le sue colpe: avvia dunque la riconciliazione e la ricomposizione del nucleo familiare. In Il figlio della sirena (1912) è ancora una bambina a impedire, con le sue iniziative, un conflitto tra il padrone e gli operai che minacciano un assalto alla fabbrica se un loro compagno licenziato non verrà riassunto. Sul corpo del bambino passa o viene firmata la pace sociale nel cinema che guarda all’industrializzazione. Anche se la famiglia va salvata a ogni costo, la crisi c’è e le tentazioni sono molte e il primo cinema, se si salva con la morale edificante dei finali, riesce anche a rappresentare e a comunicare i brividi del peccato compiuto da persone appartenenti a classi diverse. In questi casi il ruolo di mediazione viene affidato non tanto ai bambini, ma ai padri, ai nonni, ai depositari più autentici dei valori familiari, che l’iconografia vuole sempre con grandi barbe e con passo cadente e, il più possibile, in punto di morte. Una summa di tutti questi motivi si ritrova nella trama della Sirena, un film Ambrosio del 1910: «Il pescatore Beppe incontra una donna 12
13
14
15
al tramonto mentre sbarca il pesce dalla sua paranza. Affascinato diventa un cattivo marinaio, trascura i suoi doveri, è svogliato al lavoro, fa piangere la moglie […]. Appena la voce della sirena si fa udire il giovane balza fuori di casa come un ossesso. Il vecchio padre giura alla moglie: ‘Per la Madonna santissima io te lo riporterò a ogni costo’ […]. E si butta sotto l’automobile guidata dalla malvagia sirena. Beppe salta sulla via e va a raccogliere il padre ferito. L’automobile corre lontano […] e Beppe, davanti al babbo coperto di sangue si picchia il petto e giura che ritornerà a essere buon figlio e buon marito. Lontano, lontano la sirena canta invano» . Un grande successo avranno nell’evoluzione successiva del genere storie di bambini abbandonati, di racconti picareschi e di agnizioni finali con riscatto e compenso per tutti i guai subiti: ecco come viene raccontato l’inizio del Barcaiolo del Danubio di Roberto Roberti (1914): «Alba di una notte di bufera, sulle montagne della Slavonia, un bimbo ha rinvenuta abbandonata, sul fondo di un burrone, una povera piccina di pochi mesi». Un allargamento ulteriore a tutti i problemi sociali esiste e non sempre – è bene dirlo – viene risolto secondo un moralismo rinunciatario o una falsa ricomposizione dei conflitti di classe. Se, come ritengo, il cinema vuole essere da subito l’erede della letteratura popolare dell’Ottocento, bisogna ricordare che, in questa letteratura, si trovano forti e drammatiche denunce di mali sociali diffusi, di violenze e ingiustizie, soprattutto ai danni dei personaggi femminili. Così Sacrificata! (1910) dell’Itala denuncia «la storia di tante povere ragazze sedotte e abbandonate al loro destino», La figlia del Vesuvio (1912) della Dora Film di Napoli racconta una storia di stupro fatto sulle pendici del Vesuvio da un nobile a una povera ragazza che si è offerta come guida, Madre ignota, film realizzato nello stesso anno, parla delle traversie della povera Egle, figlia abbandonata di Sonia e del conte Roberto […]. Ritrovata la madre continua a subirne le malversazioni, sino a che, per sua fortuna, assieme al suo futuro sposo, trova Sonia nella villa del suo vecchio amante «caduta vittima dell’ira brutale del suo drudo». Questa produzione registra delle aperture e dei fenomeni da un punto di vista parzialmente diverso, anche se non in antitesi a quello della produzione precedente. Qui i problemi sociali sono implicati, ma subordinati a intrecci più complessi in cui esplodono di continuo i motivi patetici, e il coinvolgimento affettivo del pubblico lascia certo poco spazio all’interpretazione. Nel momento in cui lo sfondo comincia a prevalere sull’intreccio, appaiono prevedibilmente le prime critiche, progenitrici di una morale che ha accompagnato il discorso sul cinema italiano per molti decenni, fino quasi ai giorni nostri. Si vedano, come esempio, le reazioni della «Vita cinematografica» nel 1911 a Camorra, un film Ambrosio: «Purtroppo, al di là delle Alpi, l’eco delle nostre cronache cittadine ha una ripercussione dolorosa. Perché a tanto voler aggiungere una prova lampante di come avvengono presso di noi i delitti e quali le cause che generano gli stessi nella bassa classe del popolo?». 16
con i classici alla conquista dell’impero dei sogni La produzione che va dal 1905 al 1909 consente il raggiungimento di uno standard figurativo tale da porre i film italiani in grado di competere con i prodotti francesi e americani. Il ritardo non sembra costituire un handicap per una cinematografia che cerca da subito ambiziosamente una propria strada e una propria identità. I generi sono praticati senza particolari preclusioni, anche se è proprio nel 1908 che la produzione fantastica subisce una prima crisi. Negli anni successivi il cinema non viene mai usato come transfert di grandi paure collettive, quanto piuttosto come transfert del desiderio e del represso collettivo. Nel giro di pochi anni, dalle origini alla guerra, gli oggetti del desiderio mutano e si moltiplicano e i codici morali vengono addirittura rovesciati. La produzione, nei suoi aspetti dominanti e più rilevanti, sembra essere ordinata e orchestrata da un bravo esercito di maestri e professori di scuola media, preoccupati solo di far crescere culturalmente il destinatario senza minimamente intaccare gli stereotipi della cultura scolastica. Nel momento in cui – a partire dal 1908 – ci si muove alla conquista della borghesia, lo spettacolo di magia, la féerie, il film fantastico, appaiono come prodotti infantili e culturalmente subalterni. I pochi esempi rintracciabili qua e là nella produzione non fanno pertanto testo (c’è un film del 1908 della produzione Ambrosio intitolato Leggenda medioevale tutto realizzato su un continuo gioco di metamorfosi magiche, coi pinguini che tirano la carrozza, i leoni che si trasformano in bambini ecc.). Assai significativo è il fatto che, con una specie di inversione di
causa ed effetto, nel primo rapporto consolare degli Stati Uniti sulla situazione del cinema italiano, questa tendenza venga attribuita a una vera e propria scelta del pubblico: «Gli italiani amano vedere scenari naturali, ad esempio una visione delle cascate del Niagara ebbe un grande successo […]. L’italiano non ama le scene fantastiche e le fiabe» . Nel suo fondamentale saggio sull’evoluzione della regia cinematografica nei primi anni Victor Jasset puntava l’attenzione, fin dal 1911, sulla scelta già effettuata nel periodo 1906-1907 dalla produzione italiana a favore di una specializzazione verso il film storico: «L’Italia si stava muovendo e stava per assumere, a sua volta, un posto importante nel mercato. L’Italia possedeva degli elementi meravigliosi, una luce tra le più favorevoli per la cinematografia, che permetteva di lavorare con tutti i tempi, dei volti splendidi, la produzione e la mano d’opera meno cara, e dei capitali a volontà […]. Il temperamento dei loro artisti li spingeva a scene di movimenti esagerate, magniloquenti. D’altra parte il costo relativamente minimo del personale li fece specializzare in grandi scene in costume. L’Italia monopolizzò il film storico. Si formò una scuola» . Nel momento in cui si affrontano i classici il cinema comincia a prospettarsi come uno strumento assai efficace di una possibile diversa forma di egemonia culturale. Vengono ridefiniti, in termini visivi, tutti i grandi motivi ridotti ai loro stereotipi fondamentali. Rispetto all’ampiezza del campo della letteratura, rispetto ai documentari, la cui ipotesi generale è quella della scoperta totale del mondo, nella definizione visiva di opere letterarie, il numero di realtà viene ristretto e si creano funzioni e situazioni pertinenti ai vari livelli di occorrenza. La variazione o l’invenzione di una specificità visiva o di una libertà di descrizione è in rapporto al paesaggio, non ai meccanismi dell’intreccio. Il sistema di segni è comunque regolato da combinazioni assai limitate, anche se cerca di allargare il proprio potere significante e di presupporre una tradizione letteraria e figurativa capace di nobilitarlo. Per quanto riguarda i film storici, o tratti da opere letterarie, non si introducono, in questa prima fase di costituzione e dinamizzazione del sistema, oggetti nuovi, ma la riduzione del testo agli elementi minimi consente di produrre, nello spettacolo culturalizzato a sufficienza, la possibilità di un immediato riconoscimento di testi noti e di contemporanea acculturazione, sulla base di un lessico visivo e figurativo già circolante, dello spettatore analfabeta o appena alfabetizzato. Il fatto che si scelgano motivi e testi noti, di facile identificazione, o riproducenti realtà già rappresentate e conosciute, apre il problema della biblioteca dell’italiano e di come si trasformi in modo molto rapido in una sorta di filmoteca corrispondente, a destinazione non soltanto nazionale. La novità consiste inoltre nel fatto che il cinema è usato come mezzo di allargamento degli orizzonti culturali, come potenziale e privilegiato produttore della cultura di massa, come veicolo di trasmissione anche internazionale della cultura italiana, sia pure spezzata nelle forme più semplici. Nella costruzione di un eventuale modello capace di rappresentare la conversione, la riduzione e la perdita dei segni nel processo di trasformazione dei testi letterari in testi cinematografici, ci si accorgerebbe che per diverso tempo si attua, con crescente consapevolezza e determinazione, un processo di riduzione dei testi che si mettono in scena a tutti i livelli, semiotici, semantici, ideologici, narrativi e visivi. La quantità di informazione dei messaggi visivi è minima e spesso ridondante nella sua relazione con gli enunciati delle didascalie informative e indicative. Una particolare attenzione – per capire il ruolo che vengono ad assumere i letterati – va dunque portata ai modi in cui si trasferiscono e si riducono certi testi della letteratura classica, popolare e contemporanea. Per i classici il processo di riduzione e la perdita totale del senso lascia ben presto il posto a un’inversione di tendenza, a un investimento più massiccio di capitali, allo sfondamento assai rapido della durata standard dei dieci minuti e al contemporaneo sfondamento delle scenografie teatrali e della bidimensionalità spaziale. Nella produzione dei primi anni la riduzione esclude le funzioni narrative: il quadro prevale sul racconto e solo una triplice sovrapposizione di informazioni (del sistema delle didascalie, di quello spaziale e scenografico e di quello gestuale) consente il riconoscimento dell’azione e la comprensione del testo. La riduzione e selezione di tutti gli elementi presenti nell’immagine, oltre a testimoniare della povertà dei mezzi di produzione, e del prevalere di una codificazione proveniente da sistemi contigui, come opera lirica, teatro, pittura, illustrazione popolare, oleografia, fotografia, grafica pubblicitaria, fa sì che gran parte degli oggetti sia affidata al caso e abbia pertanto una certa indeterminatezza semantica. La dinamica da cogliere, nell’uso di certi elementi in funzione simbolica, sarà la progressiva emergenza da uno sfondo indeterminato e 17
18
l’assunzione di una funzione espressiva o significante venendo così ad assolvere, a un tempo, un doppio ruolo, sia di segni di oggetti (il reale in tutte le sue manifestazioni), sia di segni di segni (il simbolismo, di cui si sentirà il peso proprio in seguito all’ingresso ufficiale di D’Annunzio). Tutto il progetto complessivo che domina la concezione di un cinema colto, o erede di una tradizione letteraria, risponde a una precisa politica delle case, a una suddivisione dei livelli e a una vocazione in apparenza pedagogico-didattica, che serve da copertura alla produzione per tutta una serie di scelte tematiche entro cui si riversano alcuni transfert del desiderio di affermazione e riconoscimento sul piano internazionale attraverso la cultura e la storia del passato. La biblioteca ideale dell’italiano, a uso interno, ma anche per esportazione, è non certo ricchissima di titoli, ma abbastanza articolata: certe variazioni o la recursività di determinate trascrizioni ci permettono di identificare alcune tendenze emergenti.
i codici genetici e i caratteri fondamentali La struttura di una unità minima di significazione all’inizio del sistema narrativo ha pertanto queste caratteristiche: una didascalia iniziale che agisce da indice e da primo livello di enunciazione, e l’inquadratura che visualizza l’enunciato espandendo alcuni motivi e puntando tutto su un’ulteriore identificazione dell’azione data dal gesto, che viene giocato entro regole preformate. La prima fase ha un carattere indicativo, di deissi, e non narrativo. La funzione indicativa è contenuta nella didascalia che rappresenta un enunciato con tutti gli elementi utili al riconoscimento. Il quadro prevale sul racconto. Manca la diegesi, il film è il risultato di una serie di unità logicamente concluse e, per lo più, indipendenti. Anzitutto cominciano a crescere gli elementi paranarrativi rispetto allo sviluppo del racconto. Esiste una triplice sovrapposizione delle informazioni che porta a una comprensione del testo: la didascalia, la scenografia che stabilisce il luogo dell’azione (già identificato peraltro nella didascalia) in base a una stilizzazione e simbolizzazione assai grossolana a un numero di elementi minimo, e a una grammatica del gesto che si richiama ai manuali di recitazione ottocentesca. Movimenti di raccordo e congiunzione (entrata e uscita dei personaggi), movimenti di deissi (il mostrare, l’indicare), gesti che impongono un’azione (vietare, ordinare), gesti emblematici o assoluti (morire, piangere, esultare) sono esibiti potenziandone al massimo l’intensità. Ogni gesto fortemente sincretico riassume ed esprime il senso di tutta un’azione e di tutto un insieme di sentimenti. C’è poi il sistema dei segni che costituiscono e delimitano lo spazio significante: solo in qualche ripresa in esterni si può assistere a una qualche incongruenza rispetto all’azione. Il sistema si muove dal momento in cui i gesti, i motivi dello spazio e della scenografia, si svincolano da un tipo di codificazione anteriore dominante e si costituiscono in una codificazione autonoma. La combinazione contemporanea di più codici, fondati ognuno su proprie specifiche categorie dell’evidenza, contribuisce alla dinamizzazione del sistema semiotico ed espressivo che riceve le spinte decisive da questa maggiore interferenza di codici diversi. Il lavoro sulla scenografia – che si innesta direttamente lungo la tradizione del teatro, della tradizione pittorica neoclassica, dell’opera lirica e del music hall – cerca di dilatare e di arricchire progressivamente le proprie capacità. Ciò a cui si mira, ben presto, è la conquista della verisimiglianza anche per le opere d’argomento storico. Questa scelta unanime potenzia al massimo la ricerca in questa direzione e fa dello spazio il centro di propulsione significante del primo cinema muto italiano. Il fascino del vero è uno degli elementi dominanti, nel senso che tutto il rappresentato, pur nell’evidenza delle sue convenzioni scenografiche e recitative, nella modestia della costruzione narrativa, è dato come ricostruzione fedele di una realtà, riproduzione del vero. Il passato è fatto rivivere, i luoghi sono «autentici» e così il verosimile diventa vero. Il cinema, a tutti i livelli, di ricostruzione del passato o di rappresentazione del presente, diventa il luogo privilegiato di produzione di realtà. La conoscenza della storia anteriore, il viaggio a ritroso alla scoperta delle proprie radici è anche percezione inedita dello spazio italiano, incontro di una geografia reale con un’oleografia e una santificazione della storia patria, quale nessuno strumento di produzione di immagini era mai riuscito a offrire. Anche se le conquiste espressive coinvolgono tutto il sistema, è utile distinguere sia la politica delle case, sia i diversi orientamenti semiotici che caratterizzano i vari generi, stili e livelli. All’interno degli indirizzi delle case c’è, assai presto, una rigida divisione, per cui la dinamica espressiva non coinvolge, in egual misura, e
nello stesso tempo tutti i generi. All’inizio c’è un maggior rispetto delle caratteristiche di ogni genere, sia dal punto di vista degli stereotipi visivi, delle strutture formali, che da quello del modello ideologico ed etico. Un programma cinematografico tipo mescola i tre livelli (stile alto, medio e basso) cercando di soddisfare esigenze emotive e conoscitive assai varie: 1) Lo stile alto, a cui corrisponde una più accurata messa in scena, un impiego maggiore di capitali (tanto da far variare in maniera sensibile il costo della pellicola) è quello della traduzione di opere letterarie di carattere storico. Nel breve arco di un quinquennio nel cinema confluisce e si sistema un’iconografia distribuita lungo la storia dell’arte e dello spettacolo per almeno due millenni. Il processo di riduzione e distillazione non annulla il senso dei legami e del gioco di interazioni multiple che diventerà una caratteristica costitutiva e un forte limite allo sviluppo narrativo e diegetico. I film storici, o la traduzione dei classici della letteratura, occupano la posizione di testa dei programmi cinematografici, sono il clou delle serate del cinema di città che si pone, al più presto, in aperta concorrenza col teatro. Tutti i codici e tutti gli elementi vengono marcati e lo stile riesce a trasmettere, nel modo più compatto, l’immagine della cultura e i simboli di un’identità nazionale non ancora confluiti in nessun altro evento pubblico. Per capire anche secondo una diversa prospettiva l’altra faccia di questo discorso, è bene pensare all’opera lirica, al melodramma, che, con la sua scenografia e la sua tradizione di spettacolo popolare, diventa l’autentico tramite tra teatro e cinema. Proprio l’opera lirica riesce a unificare, in senso interclassista, cultura popolare e cultura alta e questa tradizione antecedente si travasa nel cinema, dura a lungo e conquista, all’interno della stessa produzione, un proprio spazio che consente sia la messa in film di tutte le maggiori opere e il reclutamento di grandi interpreti, sia di trasferire tecniche di messa in scena in altri generi, coinvolgendo il gesto, la disposizione dei personaggi e delle masse, e il loro uso come materiale plastico all’interno di uno spazio che si viene rapidamente arricchendo del massimo delle sue possibilità. 2) Lo stile medio cerca di rispettare di più la realtà: lo caratterizza un minore sforzo produttivo, un’attenzione maggiore per i drammi borghesi, per la letteratura popolare e per il feuilleton, per i melodrammi e le opere di derivazione naturalistica. C’è una maggiore integrazione dei codici, in quanto si tende alla verisimiglianza e all’identificazione (spesso gli interni sono dal vero). Girato con mezzi più limitati e in spazi più angusti, questo livello rivela una maggiore dinamicità narrativa, un uso delle didascalie meno enfatico. Il realismo che caratterizza in parte i generi che si formano lungo questa fascia favorisce, quasi naturalmente, l’assunzione dei problemi delle classi medie e di quelle subalterne: è il genere ideologicamente più oscillante tra esigenze di ricomposizione finale di tutti i conflitti e forti tendenze trasgressive di tutti i codici etici e sociali. 3) Lo stile basso-comico è riservato per eccellenza alla comica finale. Qui siamo di fronte a una povertà generale di mezzi e di invenzione profilmica: la comica nasce e ruota, per lo più, attorno a una sola idea e si affida, per l’esecuzione e le variazioni, interamente all’interprete e alla dinamizzazione parossistica dell’azione. Il suo sviluppo, nella storia del cinema italiano, è così limitato nel tempo da non permetterle di esprimere che una minima parte delle sue possibilità. Tra tutti i generi la comica di colpo si è interrotta ed è stata travolta dalla concorrenza americana. Per quanto si possano ormai distinguere le diverse figure dei comici e individuarne i tratti caratterizzanti e si conoscano, grazie a ritrovamenti degli ultimi anni, centinaia di titoli, non troviamo alcuna tendenza reale a uscire dallo spazio povero di un’invenzione che pesca le sue idee dalla stampa satirica, dal circo, dall’avanspettacolo e dalla pochade, per le sue forme più sofisticate e intellettuali. Il fatto che la stagione del cinema comico italiano termini – grosso modo – con la guerra, non ci consente di prevedere le possibili evoluzioni in rapporto all’evoluzione del comico di altre cinematografie. Pur occupando uno spazio assai rilevante nella politica produttiva di tutte le case (il comico lavora a tempo pieno e recita in decine di film l’anno) non si pensa per qualche tempo a un’espansione in direzione del significato. Certo le situazioni comiche nascono da un’intenzione satirica nei confronti della società presente, ma questa intenzione non riesce a diventare discorso. Il gesto comico non vuole essere caricato (salvo qualche rara eccezione) di intenzioni superiori alla sua capacità espressiva immediata. Tuttavia, nel giro di pochi anni, alla comicità di derivazione diretta dal circo si affianca anche quella che dipende dal vaudeville. In alcuni comici i motivi caratterizzanti sono il gusto del doppio senso, degli equivoci, dei travestimenti, della satira sociale che si apparenta in modo stretto alla tradizione della commedia e, appunto, della pochade. Gli scarti molto netti si vedranno però soltanto a partire da Petrolini. Negli anni tra il 1909 e il 1914 il lavoro
del corpo dell’attore, la sua capacità di produrre un sistema di comunicazione di effetto immediato è maggiore nel cinema comico che in quello drammatico. Sul primo in effetti gravano i modelli della recitazione teatrale, sul secondo i codici contigui sono più modesti e l’attore inventa il suo spazio e il suo linguaggio in modo autonomo, senza bisogno di una storia o del supporto letterario e referenziale delle didascalie. Il film comico diventa da subito film d’attore mentre per il film drammatico questa identificazione dell’attore con l’opera è molto più lento. Non c’è nel film comico un punto di vista nettamente definito in senso popolare, ma le classi borghesi e aristocratiche fanno le spese, in genere, dello spirito delle comiche. Tutti i valori e i comportamenti più rilevanti dei rituali e dei cerimoniali borghesi sono ridicolizzati, così come tutti i simboli della modernità, la loro irruzione nella vita dell’uomo comune, diventano oggetto di racconto.
dalla biblioteca alla filmoteca dell’italiano Nei primi anni si può registrare coerenza e rispetto dei generi, sia dal punto di vista iconografico, delle strutture formali che di un modello etico e ideologico. A ognuno dei tipi di discorso prospettati corrisponde un genere. Se nei filoni storici si sublima l’idea di cultura delle classi dominanti, nel comico, e nei filoni realistici, può essere accolto il punto di vista delle classi subalterne, anche se ciò avviene per lo più sul piano di alcune produzioni marginali (come i film napoletani) e si potrà riconoscere, da parte del produttore, un’identificazione e un rispetto ben preciso per il suo pubblico. La produzione centro-settentrionale ambisce piuttosto a uno spettatore «universale». Mentre nella produzione napoletana, tutto sommato marginale rispetto alla produzione del triangolo Roma, Torino, Milano, si può individuare una testimonianza macroscopica della estrema interscambiabilità dei codici e delle forme dello spettacolo, dalla sceneggiata alla canzone, al café chantant, al teatro dialettale e della costante inclusione nel cerchio del messaggio di un destinatario locale di cui non si vogliono deludere le attese. I filoni storici, le trascrizioni in quadri dei grandi poemi e delle tragedie classiche e dei romanzi rientrano piuttosto nel quadro di ristrutturazione della cultura popolare di fine Ottocento-inizio Novecento, per cui l’immaginario collettivo è unificato e il sapere prodotto dai libri illustrati diffusi a dispense. Accumulazione, sincretismo, riduzione, caratterizzano questa prima fase in cui ci si pone di fronte – senza limiti – alla letteratura universale di tutti i tempi. Più che ai processi seriali della nascente industria ci si continua però a ispirare, nelle confezioni dei primi manufatti cinematografici alle regole artigianali di trascrizione millenaria delle copie o varianti popolari di forme alte. Il cinema sembra volersi ricongiungere alla tradizione dei centoni medioevali e dei sommari. La tecnica dominante è quella dell’abbreviatio, i momenti da riprodurre sono solo quelli corrispondenti a un’iconografia diffusa nei testi scolastici e nella letteratura catechistica. Al primo livello si collocano di diritto sia le trascrizioni dei classici che alcuni film del filone storico. Sia che i classici vengano rappresentati per l’accrescimento della cultura nazionale, che per l’esportazione di un’immagine della cultura italiana nel mondo, il fenomeno è direttamente collegato a una fase più moderna dell’organizzazione della cultura di massa e all’inizio di una regolare esportazione di prodotti culturali connessa all’emigrazione che, agli inizi del Novecento, è altissima . L’opzione per questo livello risponde anche, in prima istanza, alle esigenze di un pubblico alto-borghese e non popolare che disdegna o vede con sospetto il melodramma o il comico. La vocazione pedagogico-didattica serve comunque da alibi per tutta una serie di scelte tematiche che non sono esterne alla trasmissione di un’ideologia. Il successo di tutto il filone storico o della traduzione dei classici non dipende soltanto dal principio dei vasi comunicanti (il successo popolare delle opere drammatiche di Pietro Cossa, Nerone , Messalina, Giuliano l’apostata), ma si collega anche ad alcuni fattori storici contigui. È legittimo chiedersi quanto la grande ripresa dell’ideologia nazionalistica negli anni della guerra di Libia abbia un peso importante nell’incrementare il filone di film sulla romanità? Su un piano di progetto generale è evidente, come si è già osservato, l’intenzione di trasferire soprattutto la biblioteca dell’italiano in una corrispondente filmoteca. Questa biblioteca non è ricchissima di titoli, ma piuttosto articolata e vi coabitano opere molto eterogenee: Dante, Petrarca e Boccaccio convivono, in buona compagnia con Carolina Invernizio, Eugène Sue, Alexandre Dumas, Pietro Cossa, opere religiose di carattere edificante appaiono fianco a fianco con libri di «divulgazione storica» del tipo Vita e avventure di Pio 19
20
IX di Adami. Sull’esistenza di questa biblioteca, sulla sua circolazione in Italia e all’estero si fonda la scelta degli argomenti del primo cinema e il massiccio travaso di titoli. Il Pietro Micca dell’Ambrosio del 1907 ha come antecedente un’opera di Bencivenni, Il fornaretto di Venezia della Cines dello stesso anno sfrutta l’enorme successo popolare del dramma di Dall’Ongaro, la tetralogia sul Risorgimento di Domenico Tumiati viene tutta riutilizzata. Nel 1908 troviamo la prima versione degli Ultimi giorni di Pompei (regia di Luigi Maggi, produzione Ambrosio) dal romanzo di Edward George Bulwer Lytton, e un Conte di Montecristo (Ambrosio) mentre, sempre nei cataloghi della casa torinese, un Rigoletto inaugura il filone di trascrizione delle opere liriche e un Galileo Galilei si inserisce nel filone sulle vite degli uomini illustri . L’anno successivo è la volta di Shakespeare (la Cines realizza un Romeo e Giulietta e all’Amleto pensano contemporaneamente la Cines e la Saffi di Milano). Quest’ultima tenta di muoversi lungo tutta la letteratura pescando sia nei titoli dei classici che in quelli del feuilleton e realizzando, nello stesso anno, la prima versione dei Promessi sposi e una versione della Sepolta viva di Francesco Mastriani. Nella produzione Ambrosio dell’anno successivo un soggetto è tratto da Xavier de Montépin (Il ventriloquo diretto da Arrigo Frusta), mentre la produzione Cines si muove con estrema decisione al saccheggio indiscriminato: Beatrice Cenci (tratto dal dramma di Venosta), Bianca Cappello, da un altro autore di letteratura popolare de Kock, un film «manzoniano», L’Innominato derivato con tutta probabilità dal romanzo omonimo di Luigi Gualtieri, due film shakespeariani, Macbeth e Otello, e un film tratto da Dumas padre, I tremoschettieri. La Film d’Arte di Roma è la versione italiana della Film d’Art francese, e i suoi pochi titoli sono molto impegnativi, Otello, Signora delle camelie e Carmen (tratto dalla novella di Mérimée). L’Ettore Fieramosca, tratto dal dramma di D’Azeglio, è realizzato dalla Pasquali e, nello stesso anno, possiamo ancora trovare un Cirano di Bergerac tratto da Rostand, un Capitan Fracassa da Gautier e una terza versione dell’Otello realizzata dalla Latium film. La stessa casa gira anche uno Spartaco derivato dal dramma di Giovagnoli. Tutte queste opere ritornano ciclicamente negli anni successivi. Dal 1909 si affronta anche l’epica: La caduta di Troia, l’Odissea, La Gerusalemme liberata costituiscono le prime grandi occasioni per la realizzazione di messe in scena spettacolari della Milano Films, dell’Ambrosio, dell’Itala, della Cines. Interi cataloghi di alcune case editrici, o intere collane, come quella del «Teatro italiano contemporaneo» dei fratelli Treves sono trasferiti direttamente al cinema, spesso utilizzando interpreti e messinscene teatrali di successo. E in seguito le riduzioni dei romanzi o delle più note opere liriche da parte di case editrici come la Nerbini appaiono come vere e proprie sceneggiature che serviranno da modello per le successive collane di cineromanzi popolari. Nelle collane Salani specializzate nel lavoro di riduzione dei classici è raccolto, in pratica, il più consistente giacimento di racconti e modelli narrativi a cui il cinema possa attingere a piene mani dalle origini fino a tutti gli anni Cinquanta. Il primo cinema attinge dunque ben presto a piene mani ai cataloghi delle edizioni Salani e punta a conquistare gli stessi pubblici, riuscendo a distillare ulteriormente il succo di storie che hanno già subito un processo di concentrazione e riduzione: il costo del biglietto di una sala di terza visione è assai competitivo rispetto a quello di 25 centesimi dei romanzi di Carolina Invernizio, o di Francesco Dall’Ongaro (ma ne esistono versioni ulteriormente ridotte al prezzo di 5 centesimi) e consente a un pubblico, in gran parte analfabeta, di provare emozioni forti, analoghe a quelle di un pubblico acculturato. E di praticare forme elementari di «bilinguismo», promuovendolo a una rapida conoscenza della lingua per immagini. Il processo avviato nell’Ottocento dell’illustrazione dei libri popolari che ha consentito la circolazione a dispense dei classici della letteratura riceve una spinta ulteriore: il cinema si propone con capacità narrative e rappresentative equivalenti rispetto alla letteratura fin dall’indomani della sua nascita. 21
dai «tableaux vivants» al racconto Tra il 1907 e il 1909 la produzione – pur stretta tra la morsa della crisi nazionale e internazionale – compie un deciso scarto stilistico e narrativo. La Luca Comerio gira in 17 quadri Parisina (un amore alla corte di Ferrara del XV secolo) dove si ripropone un tema chiave della letteratura drammatica: il dramma di amore e morte richiama tutta una tradizione che va da Tristano e Isotta a Paolo e Francesca, a Giulietta e Romeo, ed è un’occasione per collegare grandi motivi narrativi con le prime intenzioni precise di promozione culturale . 22
Nello stesso periodo la Cines realizza ed esporta Romeo e Giulietta, e Giuditta e Oloferne. L’Ambrosio gira Gli ultimi giorni di Pompei, che viene salutato come una pietra miliare nella storia del cinema: «Presque à ses débuts – scrive Victor Jasset – l’Italie produisit un chef d’oeuvre qui, trois ans après, malgré la rapide evolution faite en ce laps de temps, apparait encore comme une des meilleures oeuvres de la mise en scène cinématographique. Je veux parler des Derniers jours de Pompei, qui, dès sa représentation revolutionne le marché par son sens artistique, sa mise en scène soignée, l’habilité de ses trucs, sa largeur de conception et d’exécution, en même temps que par son exceptionnelle qualité photographique» . Questo film, assieme al Nerone di Luigi Maggi, si afferma sul piano internazionale. Inoltre la produzione è in grado di esportare diverse altre opere di notevole impegno: oltre ai film appena citati bisogna includere Giulio Cesare, Macbeth, La dama di Monserau e Giovanni dalle bande nere e tutta una produzione di tipo biografico come Giorgione o Giulia Colonna, Isabella d’Aragona, Luisa Strozzi, Agnese Visconti, Didone abbandonata. Soprattutto a partire dal 1909 si assiste a un primo netto scarto di livello, che consente di superare la crisi e la saturazione di un certo tipo di prodotto. Non soltanto la durata dei film subisce una netta trasformazione, ma varie case tentano tutte insieme, e nello stesso tempo, un ulteriore passo più ambizioso nella scalata ai classici antichi e moderni. La Saffi realizza sei film tratti da D’Annunzio, inizia la lavorazione dell’Inferno e gira un Promessi sposi che, nei quindici anni successivi, conosce almeno cinque ulteriori versioni. Nerone può essere considerato, accanto agli Ultimi giorni di Pompei, come il capostipite del filone storico o pseudostorico che consentirà nel quinquennio seguente, al cinema italiano di celebrare i suoi fasti internazionali. Nella biblioteca dell’italiano a cui ci si rivolge, il gruppo di titoli collegati alla rappresentazione della romanità e a un’ideologia di tipo imperialistico costituisce uno dei fenomeni più evidenti. Il culto della romanità non è comunque omogeneo all’interno del filone: per tutto un gruppo di film si tratta di una buona occasione per rappresentare gli intrighi del potere, le passioni sfrenate e morbose che la cornice storica nobilita, ma questo filone lascia il posto ben presto, a partire dal 1911-1912, a una sua variante più specializzata e spettacolare, i cui film più rappresentativi sono quelli di Guazzoni, e la grande mobilitazione delle masse è funzionale al rilancio dell’ideologia nazionalistica che trova e riconosce, fin da questo periodo giolittiano, i propri miti nell’imperialismo romano. Il Nerone di Maggi non è ancora partecipe di questo progetto: il suo referente più immediato è quello dell’evento storico nell’iconografia popolare o nella pittura del neoclassicismo. Ogni scena racchiude una completa e autonoma unità di senso e di azione: i codici prevalenti sono quelli del teatro, ma vi sono pure effetti figurativi di grande fascino, i viraggi in rosso dell’incendio di Roma, l’alternanza di sfondi teatrali e di scenografie di cartapesta con riprese in esterni. La quantità di convenzioni scenografiche, recitative e narrative convergenti, favorisce una decisa rottura con l’ordine naturale degli avvenimenti e l’adozione di un ordine narrativo artificiale che, ben presto, oltre alla compresenza di realtà e sogno, si articolerà in flashback (pensiamo a Nozze d’oro di Maggi), nell’assunzione dei punti di vista dei vari personaggi, in un uso assai più sofisticato delle categorie spazio-temporali. Il film ottiene un grande successo di critica internazionale (basti pensare alla recensione americana su «Moving Picture World»: «Sfarzo di cortei, splendore di costumi e di recitazione e infine la grande conflagrazione di Roma: un tale meraviglioso realismo di effetti che, nel vedere questa parte del film a colori ci sembrava, per così dire, di udire le parole delle vittime» ), ma sul piano nazionale i pareri non sono così entusiastici. Degna di segnalazione la recensione di «Lux» che lo definisce sciatto dal punto di vista dell’organizzazione scenica e così prosegue: «Ambrosio ha visto mai Nerone nell’orgia di Arrivabene? In esso si vede il fremito della carne abbrutita dal vino e dagli accoppiamenti. La scena desta schifo, mentre quella di Ambrosio ci lascia freddi» . Nel 1909 è varato, alla Milano Films, il progetto dell’Inferno (la cui direzione è affidata a Francesco Bertolini e Adolfo Padovan), opera che si può considerare come il punto culminante, sia per il soggetto, che per l’impegno produttivo, registico e pubblicitario, di questa fase di utilizzazione della letteratura, per dare uno statuto culturale al cinema e permettergli una definitiva consacrazione presso i pubblici di tutto il mondo accanto al teatro e alla letteratura . A conferma del fatto che la trascrizione cinematografica è fondata su una tradizione figurativa antecedente il film segue, passo passo, l’iconografia più vulgata della commedia dantesca, ossia quella dell’opera del Doré. Un perfetto dominio dei trucchi e della tecnica di sovrimpressione consente di raggiungere in molti casi effetti grandiosi. La lezione di Méliès risulta perfettamente assimilata e 23
24
25
26
resa più verisimile e meno fantastica. Gli esterni sono girati sulla Grigna, a Mandello, ad Arenzano e a Carimate . I procedimenti sono quelli del quadro animato, tutti gli incontri fondamentali del poema dantesco sono rappresentati. La macchina da presa è mobile e, grazie alle sue frequenti panoramiche orizzontali, si scoprono progressivamente i dannati e l’atrocità delle loro pene. I versi scandiscono all’inizio il ritmo e generano una forma, sia pure elementare, di metrica visiva. È il primo film, a quanto mi risulta, che tenti una organizzazione dell’elemento scritto e di quello parlato. Grazie al racconto dei personaggi il punto di vista muta di continuo e i parlanti diventano soggetti della narrazione consentendo di aprire sempre il racconto nel racconto e di visualizzarlo. I trucchi sono continuamente variati: volano Paolo e Francesca o Beatrice, volano le schiere dei lussuriosi, Cerbero con le tre teste è reso in modo assai verisimile, sono modificate le proporzioni umane, personaggi giganteschi si muovono accanto a personaggi minuscoli e tutte le maggiori figure del poema appaiono, da Minosse a Flegias, dalle Arpie a Pier delle Vigne, a Farinata e al conte Ugolino. Corpi nudi sono sparpagliati a profusione (e questa è certo una carta vincente con la copertura del divin poema). Il mostrato, comunque, non è mai nuovo: il film rispetta rigorosamente le attese e il cinema, in questo caso, non appare come strumento di modificazione dei modelli culturali preesistenti o di invenzione di nuovi, quanto come punto di maggior evidenza dei fenomeni in atto di trasmigrazione e riduzione da un sistema semiotico a un altro. L’opera supera la lunghezza dei mille metri ed è una tra le prime a mobilitare gli intellettuali, a provocare una risposta assai vasta e un consenso unanime nei giudizi della stampa. A Parigi Ricciotto Canudo la presenta con una conferenza all’École des hautes études, a Napoli è proiettata alla presenza di varie spiccate personalità come Benedetto Croce, Roberto Bracco e Matilde Serao. Bracco la giudica «troppo bella per il pubblico» e Matilde Serao, che torna a vederla, ne scrive in questi termini sul «Giorno»: «Un grande spettacolo […] e se Gustavo Doré ha scritto con la matita del disegnatore il miglior commento grafico al divino poema, questa cinematografia ha fatto rivivere l’opera di Doré» . Giustamente Aldo Bernardini considera l’Inferno il primo «capolavoro» del cinema muto italiano; un’opera maestra che aprì davvero nuovi orizzonti ai cineasti di tutto il mondo. A distanza di qualche tempo gli stessi autori tentano un’operazione analoga con Omero portando sullo schermo l’Odissea. Nonostante vi siano trucchi di grande effetto (l’accecamento di Polifemo, la tempesta con gli effetti ottenuti rigando direttamente la pellicola, l’invenzione di Scilla e Cariddi come mostri a più teste) i risultati sono inferiori e il film risulta statico e non ottiene che un successo molto modesto. Una piccola casa cinematografica, la Helios, sfruttando l’attesa pubblicitaria, brucia sul tempo la Milano Films e realizza una pellicola omonima riuscendo a conquistarsi alcuni mercati stranieri. Qualche tempo dopo la stessa Helios realizza il Purgatorio (e la Psiche-Film Il Paradiso. Visioni dantesche, 1912) che, senza avere la capacità di invenzione visiva e plastica dell’Inferno della Milano, tenta una serie di effetti visivi abbastanza interessanti. La tecnica di sovrimpressione ha ormai raggiunto ottimi livelli, mentre manca quella cura nella regia che si sentiva nel film della Milano. Qui Dante ogni tanto benedice qualche peccatore e la ricostruzione delle scene o i movimenti dei personaggi sono piuttosto approssimativi. Il flashback comunque funziona da elemento conduttore e il continuum narrativo è spezzato da un variare dei piani, dei punti di vista e della unità spazio-temporale. Trionfano, più che nell’Inferno, i moduli iconografici e figurativi del simbolismo e della pittura liberty. Le metamorfosi sono continue e gli effetti visivi sono il vero punto di interesse del film che culmina, nel gran finale, con la visione della trinità e l’apparizione di Cristo all’interno della croce. È chiaro che, rispetto all’impegno visivo dell’Inferno, non soltanto i film della Helios, ma anche il Nerone, o La caduta di Troia, girato da Pastrone nel 1910, raggiungono un livello espressivo assai più modesto, anche se quest’ultimo fa compiere al cinema un passo decisivo verso l’affrancamento dai moduli figurativi e recitativi di tipo teatrale. La caduta di Troia è un film colossale per movimento di masse di decine e decine di comparse all’interno dell’inquadratura, cura nella ricostruzione scenografica e nei costumi, effetti speciali e sequenze spettacolari come quella del movimento del cavallo verso Troia o della distruzione di Troia messa a fuoco dai guerrieri achei. Comunque tutto lo sforzo produttivo intende nobilitare, proprio attraverso la grandiosità della ricostruzione e la cura scenografica in cui vengono ibridati vari stili senza troppe preoccupazioni filologiche, anche gli spettacoli di fiction, promuovendoli sul piano dei classici. Ciò che effettivamente si verifica per quanto riguarda le risposte del pubblico. A partire da queste opere, in ogni caso, 27
28
il costo d’ingresso dei biglietti subisce un’impennata. In tutta la produzione a carattere storico anteriore a Cabiria e ad alcuni film di Guazzoni, la macchina da presa è statica (anche se Pastrone la fa muovere nella Caduta di Troia), ma lo sforzo di dinamizzazione del sistema si svolge in direzione della luce, della manipolazione del tempo, dell’invenzione di trucchi, dello sforzo di passare da una dimensione reale a una onirica o immaginaria, della mobilitazione delle masse e della scoperta del ruolo drammatico e significante dello spazio reale o ricostruito.
fuori l’autore La nascita della discussione teorica, poetica, critica e giuridica della nozione d’autore diventa una sorta di punto nodale e di confluenza di più forze e soggetti. Prima di procedere all’analisi delle diverse strade prese dal racconto cinematografico vediamo di coglierne i momenti salienti dello sviluppo e di indicare i più interessanti soggetti coinvolti, fin dall’autorevole intervento del giurista Ascoli nella rivista «Diritto commerciale» del 1913 : «Alla formazione di una film concorrono molte persone che prestano opera di diverso carattere e diversa importanza. Un riduttore cinematografico Un fotografo cinematografico Un direttore di scena Vari attori Vestiaristi e scenografi. Non tutti certamente prestano opera di eguale valore e di egual importanza; alcuni hanno una funzione creativa che, integrandosi colla funzione parimenti creativa degli altri coartefici, dà luogo alla produzione di un risultato intellettuale (la film) che è somma, compendio e fusione delle attività creative dei singoli; altri invece hanno una funzione meramente accessoria». Di qui la distinzione che Ascoli traccia, dicendo che i primi possono considerarsi coautori della film e come semplici aiutanti i secondi. Egli pone tra i coautori il riduttore cinematografico e gli artisti, mentre considera «come semplici aiutanti il fotografo, il direttore di scena, vestiaristi e scenografi» . Nell’elencare i possibili aspiranti al riconoscimento del ruolo di autore dell’opera cinematografica il giurista Ascoli pecca sicuramente per difetto. Gli sfugge, ad esempio, il ruolo del marchio di fabbrica come firma autoriale del film – ruolo importantissimo in Francia, ma anche in Italia se pensiamo che almeno fino al 1913 è normale che sul manifesto risulti, assieme al titolo del film, solo il logo della casa di produzione, senza altre informazioni – né può ipotizzare, come farà di lì a poco Pirandello, l’espropriazione di tutte le energie creative da parte della cinepresa, il trionfo della macchina sull’uomo. Inoltre Ascoli non parla della locazione d’opera, aspetto ampiamente dibattuto dai giuristi negli anni 1910-1915. Ascoli riconosce però il prodotto cinematografico come opera collettiva e mette in campo, in un territorio giuridico che tuttavia sconfina in quello estetico, la definizione di coautore . In effetti nel nuovo spazio topologico creato dal cinema si affollano una serie di soggetti che, per varie ragioni, in tutto o in parte avanzano dei diritti di paternità dell’opera. Per certi aspetti si ha l’impressione che il campo di forze entro cui si definisce la nozione d’autore sia instabile e, per qualche tempo, incapace di coagularsi e senza punti di riferimento giuridici ed estetici certi. Ma che, a seconda delle circostanze, possa prevalere e assumere, sia pure precariamente, la leadership creativa questo o quel soggetto capace di polarizzare l’attenzione, dall’operatore (Giovanni Vitrotti e Roberto Omegna a tutti gli effetti sono autori in tutta la prima parte della loro attività) all’attore, dal produttore al direttore artistico, o metteur en scène. Al tempo stesso, proprio per i problemi inediti che l’opera cinematografica pone dal punto di vista del lavoro culturale, oltre che del diritto, esistono una serie di forze eguali e contrarie a quelle che cercano l’autore, che negano al film qualsiasi legittimazione sul piano artistico e culturale e quindi il diritto di riconoscerlo come un prodotto dell’ingegno. Vale la pena, comunque, di sottolineare che, in questo scontro, o in questa contesa, non si lotta solo per il riconoscimento (o il disconoscimento) di paternità, per l’affermazione di una semplice proprietà intellettuale, ma per il riconoscimento di aver saputo immettere il soffio vitale, l’animus, nell’opera e più di tutto per la 29
30
31
conquista e il possesso del nucleo profondo del film, per la proprietà della sua anima. Questo unanimemente traspare dalle pagine di Si gira di Pirandello, in cui è la macchina da presa a succhiare la vita agli attori, come dalle lettere di Eleonora Duse o dagli scritti di Ricciotto Canudo . La conquista della nozione d’autore ha il carattere di una illuminazione e di una rivelazione. Il cinema italiano – sul piano internazionale – appare in ogni caso come il territorio in cui più presto che altrove, e in forma più complessa ed esemplare, la nozione d’autore subisce un processo di morfogenesi e si articola secondo una figura che potremmo definire politopica. Certo fenomeni simili si possono osservare anche in Francia, ma per quanto riguarda il cinema italiano si ha l’impressione che sia dal punto di vista quantitativo che della varietà di sfaccettature il problema investa in pieno la società letteraria, coinvolgendola da subito a vari livelli e soprattutto modificandone alcuni comportamenti. La migrazione dei letterati è un potente elemento iniziale di accelerazione del problema sul piano giuridico ed estetico contemporaneamente. Poi verrà l’attore. Del direttore artistico, in un primo tempo si distingueranno le qualità artistiche più per la sua capacità di animare dei tableaux vivants alla maniera della grande pittura, che per le capacità di filmare la vita com’è. Anzi proprio questo potere riproduttivo è un elemento a sfavore della sua creatività, mentre il Manifesto del futurismo costituirà il vero momento di variazione nella bilancia dei poteri a favore dell’identificazione dell’autore col regista. Nel volgere di alcuni anni, fin dall’indomani della nascita del cinema italiano, le fonti giornalistiche, giuridiche, produttive e i primi autori che affrontano il problema sotto il profilo estetico individuano le seguenti figure: 1) L’autore, una entità dal profilo indistinto (pensano agli scrittori evidentemente alla Morgana film quando coniano il motto «I migliori autori, i migliori attori»), che deve prevalere tra diversi aspiranti al titolo, ma che, fin dall’inizio, è vista nelle sue potenzialità di innovatore dello spettacolo, piuttosto che in quelle dell’esecutore. Della possibilità di vedere il passaggio o la metamorfosi dall’attore letterario o dall’artista figurativo in una nuova figura d’autore, capace di incarnare il grande sogno estetico del creatore dell’«Opera d’arte totale», si occupa per primo e assai precocemente fin dal 1908 Ricciotto Canudo. Solo di recente, grazie alla già ricordata pubblicazione di una nuova edizione francese dell’Usine aux image, ricca di inediti e filologicamente accurata, possiamo apprezzare l’importanza e la genialità delle intuizioni estetiche di colui che per primo ha parlato di «Settima arte»: «I facitori di spettacoli tendono già ad altro: tendono puramente e semplicemente all’affermazione sempre più potente della nuova mimica rappresentativa della vita totale. Il sogno di un grandissimo artista che ha la qualità di essere pancronistico nel suo paese e la facoltà di rinnovarsi continuamente nel senso della vita estetica del mondo epperò di essere sempre più giovane di giovani nati vecchi, sarà presto realizzato: Gabriele D’Annunzio ha sognato una pantomima eroica e italianamente tragica per cinematografo» . E ancora: «La complessità dello spettacolo nuovo appare dunque meravigliosa. Tutti i secoli dell’attività umana l’hanno composta. Quando artisti geniali la svilupperanno in ritmi vasti, in veri ritmi d’arte, l’estetica nuova sarà affermata […]. Ci avviamo verso un’era gloriosa, verso un apogeo dorato» . A quest’aspirazione sembra voler rispondere fin dalle dichiarazioni programmatiche Rapsodia satanica, opera in cui si intende «adunare […] le sensazioni di tutte le arti; la possibilità di fare d’una sala di proiezione un magico crogiuolo di tutte le sensazioni artistiche in un insieme nuovissimo, mai tentato e oggi ottenuto per la prima volta» . Volendo si potrebbero trovare in questo film tutte insieme le caratteristiche che stiamo elencando separatamente, in quanto in effetti a formare un’unica personalità artistica concorrono con pari titolo Fausto Maria Martini, Pietro Mascagni, Lyda Borelli e Nino Oxilia, come ci dice la copertina stessa della brochure pubblicitaria del film. 2) Il coautore: nel momento stesso in cui si riconosce che il film è un prodotto dell’ingegno collettivo si manifesta un’ampia convergenza a favore della figura del coautore. Sempre nell’introduzione alla brochure con il testo di Rapsodia satanica viene enfatizzato il ruolo creativo paritetico di vari artisti che contribuiscono a fare del film un’opera nuova: «Nomi altamente significativi si sono stretti intorno al titolo di quest’opera come attorno a un segno simbolico levato tra l’arruffio delle consuete produzioni del cinema a rappresentare il desiderio che a questo mezzo efficacissimo di espressione artistica sia data quella dignità e quella novità che finora non ha mai raggiunto. Il più grande musicista moderno, uno dei più nobili poeti drammatici, un’attrice di profondo temperamento nella sua finezza fascinatrice, la vibrante e appassionata personalità 32
33
34
35
36
d’artista-industriale del direttore della casa editrice dell’opera e ancora il talento e il gusto d’un altro fortunato commediografo nostro hanno creato Rapsodia satanica» . 3) La comunione d’autore: ne parlerà in modo convincente Finocchiaro nel 1918 in «Diritto commerciale»: «Allorché una compagine di idee obbiettivatesi è il frutto di più persone o in forza di un negozio giuridico unilaterale o bilaterale i diritti su un’opera spettano a parecchi sorge la comunione del diritto d’autore» . «Avvertasi – scrive Tiranty nel fondamentale La cinematografia e la legge del 1921 – che la creazione in comune dell’opera intellettuale può avvenire anche in dipendenza di una locazione d’opera. L’ingerenza intellettuale – dice il Piola Caselli – nella creazione dell’opera fonda un diritto di comunione anche se si esplichi in seguito o nel corso di un contratto di commissione o di locazione d’opera» . Anche nel caso dell’attore rispunta comunque il motivo della locazione d’opera: «Il rapporto che lega gli artisti cinematografici alle Case editrici di films nella grande maggioranza dei casi è precisamente una locazione d’opera; di guisa che, nel silenzio o nell’ambiguità del contratto, si deve presumere che l’opera prestata da un artista nella creazione di una films sia prestata a titolo di locazione d’opera» . 4) La figura che potremmo chiamare dell’attore cre-attore: negli anni del massimo fulgore del divismo l’attore, erede dei sovrani della scena teatrale e melodrammatica, afferma il proprio ruolo di elemento di trasfigurazione della materia narrativa, letteraria e drammatica in materia artistica. Questo lo si vede benissimo sia negli scritti contemporanei, ma anche in dichiarazioni successive e recenti, della Bertini, o nelle lettere della Duse e nella percezione e affermazione del suo ruolo nel film Cenere. Per qualche anno la situazione è aperta e il personaggio dotato di minori atouts di riuscita sembrerebbe il direttore artistico di cui, da vari punti di vista, si misconosce – o si cerca di ridimensionare – il contributo creativo a favore di quello esecutivo e di servizio. Dal 1913 in poi, anche il direttore artistico trova i suoi sostenitori e in questo senso saranno vincenti le argomentazioni estetiche a favore della necessità di una mente creatrice unica per poter consentire al cinema il diritto d’accesso nei territori dell’Arte. Nel 1916 troveremo in ogni caso una spinta e un orientamento decisivo grazie anche al già ricordato Manifesto sulla cinematografia futurista del 1916 che considererà il cinema come «il mezzo d’espressione più adatto alla plurisensibilità di un artista futurista». Nel 1919, dopo che si è dibattuto a lungo e c’è stata una sorta di eliminazione progressiva nello scontro diretto tra diversi aspiranti autori, restano comunque ancora tre figure a contendersi il primato: ormai però il ruolo d’autore sembra identificarsi invece proprio con quello del direttore artistico, o come si vede da un testo di J. Filly B. (Piccola storia di una Gorgone, nel numero di aprile-maggio di «In Penombra»): «Il cinematografo è una grossa testa di Medusa. Strana e ragguardevole coiffure questa della Gorgone […] tre forze che la poetica metafora ha chiamato serpenti e che noi chiameremo l’autore, l’inscenatore, l’interprete» . Gozzano che per primo, come abbiamo visto in un capitolo precedente, rivendicherà la paternità delle sue opere cinematografiche e la pari dignità rispetto a quelle letterarie, tenderà comunque a separare le ragioni dell’arte da quelle dell’industria cinematografica: «Ma che arte – risponde a un intervistatore nel 1916 – è una industria di celluloide. È una cortigiana molto ricca che sa camuffarsi […]. I suoi antenati restano pur sempre la lacrimevole istoria di Genoveffa, di Rosina, del bersagliere infedele. Arte da piazze e mercati, da rettangolo di tela dipinta. Se facciamo tacere in noi l’affarista e consultiamo soltanto la nostra intima coscienza d’artisti, bisogna convenire che la nostra produzione cinematografica non è altro che una delle nostre vergogne artistiche» . Nello stesso anno, ancora sul numero di maggio di «La Donna», Nino Oxilia, che ha già alle spalle una lunga esperienza cinematografica, così ne indica le prospettive future nel senso di unificazione del molteplice sotto una sola personalità creatrice: «Occorre ch’esso, il cinematografo, diventi come tutte le altre forme d’arte, il sogno o la vita vista attraverso il temperamento di un solo. La collaborazione discute e la discussione non conduce mai all’arte». Ancora nel 1918 Verga, che si vede fotografato all’inizio di Caccia al lupo così scrive al regista Giuseppe Sterni: «Questa di far figurare anche l’autore nella pellicola di Caccia al lupo è un brutta sorpresa che Lei mi ha fatto, perché sapeva la mia ripugnanza a battere il tamburone… La prego vivamente di riparare facendo tagliare da per tutto e in tutte le rappresentazioni cinematografiche di Caccia al lupo questa figura» . Poco dopo si deciderà di collaborare anche lui alla redazione delle didascalie chiedendo un assoluto silenzio e 37
38
39
40
41
42
43
continuando a considerare il cinema «contraffazione artistica, buona soltanto a cavarne qualche utile». Pirandello, a sua volta, interviene non certo per riconoscere il ruolo creativo dell’autore o dell’attore, quanto piuttosto per negarlo. Il suo protagonista assoluto, l’autore a cui tutte le forze in gioco devono sacrificarsi è la macchina da presa destinata a ingoiare l’anima di attori, inscenatori, soggettisti… Il personaggio impassibile di Serafino, che fa corpo con la sua macchina, ne diventa un ingrediente aggiunto, smantella gli edifici di cartapesta su cui altri edificano il monumento alla nuova arte. È una vendetta nei confronti di un’industria che in pochi anni cancella i resti di secoli di storia anteriore, li miniaturizza degradandoli e conduce l’umanità verso l’apocalisse; Serafino «la mano che gira la manovella», diventa sacerdote di un nuovo rito sacrificale, terribile e ineluttabile: «L’uomo si è messo a fabbricare di ferro e d’acciaio le sue divinità ed è diventato servo e schiavo di esse. Viva la macchina che meccanizza la vita!» . Tra gli scrittori sarà comunque D’Annunzio a entrare nel film con un peso specifico e un ruolo superiore a tutti gli altri acquisendo il ruolo di autore di Cabiria di cui si attribuisce, in perfetto accordo con la casa produttrice, la piena paternità: «La recente industria cinematografica […] deve essere considerata come un’ausiliaria provvidenziale di questi artisti coraggiosi e severi che nell’ignobile decadenza del teatro d’oggi aspirano a distruggere per riedificare […]. Che i poeti seguano il mio esempio attribuendo al cinematografo una virtù di liberazione e distruzione» . Secondo la mitica, ma, per quanto ci interessa, assai verisimile testimonianza di Tom Antongini, segretario di D’Annunzio, confermata da Pastrone, le cose vanno in questo modo. Pastrone si presenta con queste parole: «Ho terminato una pellicola grandiosa che può occupare lo schermo per tre ore. Se senza modestia mi sento di affermare che il mio film è quanto di meglio come tecnica si possa produrre nel campo cinematografico non posso dire altrettanto né del titolo né delle didascalie. Inoltre mi manca il nome di un autore: mi occorre un nome grande, indiscutibile, mondiale; avrei pensato a Gabriele d’Annunzio. Per questo lavoro certamente poco divertente del rifacimento delle didascalie e ancor più per la paternità del film, che vorrei ornato del suo immenso nome, io sono disposto a sborsare cinquantamila lire» . È la prima volta che una casa di produzione investe sul nome di uno scrittore e organizza tutta la sua pubblicità attorno a questa mossa. Vi sono alcuni manifesti in cui il marchio produttivo è scritto sotto al nome di D’Annunzio a caratteri più piccoli, altri, tra cui il più famoso manifesto di Metlicovitz in cui in alto è scritto il nome di D’Annunzio e in basso il titolo del film. «Tutta la pubblicità batteva sul suo nome – testimonia Pastrone –. Con un carattere molto più piccolo feci comparire lo pseudonimo di Piero Fosco che mi ero scelto come regista». In effetti le prime due didascalie dicono: «Cabiria. Visione storica di Piero Fosco. Di Gabriele D’Annnunzio, 1913». È lo stesso D’Annunzio che scrive di suo pugno il proprio nome e cognome come atto di autentificazione creativa del film. Quando firma il contratto con Pastrone per le didascalie di Cabiria D’Annunzio, con una sola mossa, si assume la piena paternità dell’opera: si offre, diremmo oggi, come testimonial della qualità del prodotto e gli conferisce un marchio di legittimità artistica e culturale che modifica, in modo decisivo, l’equilibrio dei rapporti tra cinema e letteratura. D’Annunzio vede nello schermo il luogo privilegiato di realizzazione dell’«Opera d’arte totale» teorizzata da Wagner e Nietzsche e vede in Cabiria, dopo La nave, la possibilità di celebrare i fasti dell’ideologia nazionalista e bellicista per cui sta battendosi da anni. Anche lui potrebbe fare proprie le parole di Abel Gance, degli stessi anni: «L’ora per me è venuta di fare nel cinema la grande epopea popolare che tra un secolo sarà la nostra Chanson de Roland». Finora, come si è visto, il diritto d’autore poteva riconoscere al massimo agli scrittori un rapporto di «locazione d’opera» e il rapporto come tale lo consideravano anche molti scrittori. Dopo Cabiria si comincia a riconoscere un ruolo artistico dominante e, nello stesso tempo, a teorizzare tra gli esperti di diritto la figura della «comunione del diritto d’autore» di cui si è detto. Che avrà un peso importante sul piano economico e invece sempre meno rilevante su quello estetico. Importante, invece, proprio per la sua centralità nei territori contigui del teatro e del melodramma e per il suo ruolo dominante fin dal 1913 la figura dell’attore che, consapevolmente, rivendica il suo ruolo creativo: l’attore cre-attore, come l’abbiamo chiamato forzando un poco l’ortografia. Basterebbe rievocare qualche riga delle lettere di Eleonora Duse. Per esempio quando rifà la prima parte di Cenere spiegandone così le ragioni alla figlia Enrichetta: «Quella 44
45
46
col bambino, quella composta dal Mari era semplicemente ridicola, assurda e senza cuore. L’ho rifatta in solitudine con quell’operatore Omegna e spero più conforme all’anima del film, che pure ha un’anima» . O quando scrive nello stesso periodo una notazione come questa: «Una finestra che non s’apre a modo mio e che deve aprirsi su una certa luce e non a un’altra». Ma il suo ruolo creatore è molto complesso e interessante perché tende a minimizzare il suo ruolo d’attrice, a renderla quasi invisibile sulla scena e a potenziare la consapevolezza delle scelte iconografiche, dei debiti nei confronti con la grande pittura: «Non lo so – scrive ancora alla figlia, ma una certa austerità dentro di me, Giotto, mi sono stati di base per tutte le inquadrature […]. In Cenere, ciò che è così bello (lasciamelo dire) non è la tua vecchia madre, ma il tono calmo (ombre) e tragico e dolce delle inquadrature» . Ultimo tra tutti, ma non certo minore, sarà il direttore artistico, figura nei confronti della quale si esercita una forte resistenza ad accettarne il ruolo dominante proprio perché a lungo il suo ruolo viene assimilato a quello del direttore d’orchestra o del direttore teatrale. Ancora nel 1921, in Francia, Blaise Cendrars in un metafilm (A propos de La Roue) definisce in più occasioni Abel Gance animateur, mostrando ancora una evidente resistenza da parte dell’intellettuale a riconoscere nel regista il vero creatore del film. Nonostante le parole di Canudo il regista è ritardato nella sua corsa da molti handicap, giuridici, estetici…: prendiamo ad esempio quanto scrive ancora Ascoli: «L’opera del direttore di scena è molto modesta, perché la sua funzione principale consiste nel dare consigli pratici all’operatore e agli artisti. Egli fa, né più né meno di quello del direttore di scena dei teatri ordinari per cui si comprende facilmente che l’opera sua non può ritenersi lavoro intellettuale; sarà senza dubbio necessario un uomo intelligente, che conosca bene la tecnica dell’arte, ma non si può dire che costui crei qualcosa» . «A mio avviso – scrive Tiranty alcuni anni dopo, senza ancora aver raggiunta alcuna certezza, ma solo riuscendo a mettere in gioco nuove e consistenti argomentazioni a favore del regista – non è esatto che l’opera del metteur en scène sia molto modesta; lo prova il fatto che i più abili fra i metteurs en scène ricevono dalle Case stipendi lautissimi, pari o superiori a quelli dei più acclamati artisti, e altresì il fatto che uno stesso soggetto, affidato a un mediocre metteur en scène darà vita a una film mediocre che non troverà compratori e affidato a un abile metteur en scène riuscirà un eccellente lavoro che i noleggiatori si disputeranno a suon di denaro. Questa differenza di risultato dipende precisamente dall’essere la funzione del metteur en scène non solamente esecutiva, ma creatrice» . Come bene ha mostrato Raffaelli, nel suo pionieristico e fondamentale studio sulla genesi e sulla vicenda linguistica di alcune parole chiave della storia del cinema, il termine «direttore artistico» «è già presente fin dall’estate del 1906 sia pure nella forma francese (directeur artistique), ma è dal 1910 che inizia ad apparire in forma articolata, cercando di conquistarsi un ruolo e farsi largo tra la folla di aspiranti autori» . Enrico Rossi, in un importante articolo sulla «Vita cinematografica», afferma in modo perentorio: «Il direttore artistico è il centro attorno a cui il film svolge la sua trama: è un poco il soggettista, un poco l’interprete, un poco il pittore, un poco il concertatore: è, o almeno dovrebbe essere. E noi domandiamo: quanti sono oggi in Italia i direttori artistici che valgano veramente questo nome» . Nel numero della settimana successiva lo stesso Rossi elenca i nomi di coloro che, nel panorama del cinema italiano, gli sembrano ormai presentare un profilo di autori: «Negroni, Oxilia, Caserini, Vidali, Guazzoni, Antamoro, Paradisi, del Colle, Ghione, de Liguoro». Rossi tenta anche di accostarsi ai singoli autori e di definirne le specificità stilistiche: «Caserini e Antamoro sono dei veristi, le loro storie sono molto simili alla vita […]. In un film storico Caserini si preoccuperà di più dell’effetto delle masse e otterrà la suggestione scenica facendola nascere dall’azione stessa, mentre ad esempio Guazzoni cercherà il medesimo effetto estetico con una composizione di figure e di controluce». Nel 1916 su «Apollon» Alfredo Masi, puntando sul carattere visivo del cinema (nel punto 6 dell’articolo Un programma parla di «giusta posizione della luce e dei piani, secondo un’occulta facoltà lirica»), sposta decisamente l’attenzione dall’attore al regista, sottolineando con forza che il cinema non riproduce, ma trasforma e trasfigura la realtà secondo i canoni dell’artista-regista. Dal 1916 in poi, dall’indomani della pubblicazione dell’ultimo manifesto del futurismo, alcuni direttori artistici – penso a Guazzoni in primis – prenderanno la parola per enunciare i fondamenti di una vera e propria poetica e stilistica («Vedevo – scrive Guazzoni nel 1918 su «In Penombra» altri e più vasti orizzonti per la cinematografia: ma allora si rideva quando qualcuno osava parlare d’arte applicata al cinematografo»). 47
48
49
50
51
52
Piero Antonio Gariazzo in uno degli ultimi capitoli del Teatro muto del 1919 in cui, dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi creativi del film, giunge a domandarsi se vi può essere uno stile «a nobilitare il film cinematografico». E così risponde: «Apparentemente no, troppe persone e troppi elementi disparati concorrono alla costruzione: l’autore, l’inscenatore, l’operatore fotografo, gli artisti». Aggiunge poi: «Però se si considera l’autore come un direttore d’orchestra capace di imprimere ai diversi elementi dello spettacolo un’anima sola, la sua anima, noi potremmo ammettere che anche nello spettacolo cinematografico si possa assurgere alla dignità dello stile e dell’arte. Lo scenario ben fatto con tutte le didascalie precise […] con l’idea generale ben evidente e condotta a snodarsi dalla progressione delle scene con misurata esperienza, permettono all’inscenatore di vedere veramente prima tutta la commedia su uno schermo interiore coi suoi minuti particolari […] allora egli saprà condurre i suoi artisti pel giocondo o tragico mondo della sua avventura con mano certa, moderare e incitare volta a volta il loro gesto, suggerire il loro stato d’animo, risvegliare la loro sensibilità nel momento giusto; ricordandosi che gli attori non hanno un’anima, non devono averla, ma essere solo dei risonatori a cui egli trasmette il senso dell’ideale […]. Si ricordi bene l’inscenatore che nel film non si vede che lui, vestito degli abiti dell’autore. Attraverso i mille casi e le facce belle o ignobili dei suoi personaggi appare la sua faccia, il suo spirito, il suo gusto. Abili o no gli attori sono burattini e quando qualcuno sfugge all’inscenatore subito lo spettatore lo ‘sente’ […]. Il gusto dell’inscenatore, la sua affannosa ricerca di omogeneità, di progressione, di energia persuasiva, lo portano in una serie di accorgimenti tecnici il cui uso, con maggiore o minore frequenza e simpatia, determinano il risultato finale, una fisionomia che si può veramente chiamare ‘lo stile’» . Ancora nel 1919 Carlo Tridenti su «In Penombra» parte dal confronto con i grandi teatralizzatori del primo Novecento per indicare la strada: «Penso che il cinema si possa ispirare alle ricerche e alle realizzazioni di Max Reinhardt o di Appia, dirette a produrre un effetto generale, sacrificando ogni macchia e ogni dettaglio locale all’espressione fantastica dell’insieme […]. Disgraziatamente in nostri metteurs en scène sono spesso dei dilettanti sprovvisti di gusto sicuro, di cultura o se hanno questo gusto devono accettare la collaborazione di gente sorda alle norme generali che regolano ogni opera d’arte […]. Per ora è assai difficile che si comprenda la necessità di una sola mente direttrice che regoli ogni particolare di gesto, di costume e di messa in scena. Ma non si predicherà mai abbastanza e sin da adesso, un lungo tirocinio per coloro che sono e saranno chiamati a dare a un film quel tal grado di forza rappresentativa che faccia del film stesso un’opera d’arte» . E finalmente giungono i primi scritti di Sebastiano Arturo Luciani: ancora su «In Penombra» nel gennaio del 1919, assimilando i processi di creazione del cinema a quelli della musica, scrive alcune righe illuminanti e che pongono in maniera quasi definitiva il problema del regista in una luce favorevole e vincente e assimilano il riconoscimento della personalità creatrice con quello della legittima aspirazione del cinema a essere riconosciuto come arte: «Chi idea una film si trova in conclusione a portata di mano, nella stessa maniera che un musicista, i suonatori d’orchestra una materia viva da plasmare e da ordinare. Ma la condizione essenziale perché possa fare questo è che sia nello stesso tempo l’esecutore del suo progetto. In altri termini il poeta deve identificarsi col metteur en scène. Finora questo non è avvenuto mai. I poeti si limitano a scrivere dei racconti che un altro riduce per lo schermo. Essi disdegnano come cosa materiale l’opera del direttore di scena […]. Quando i poeti, superando il disgusto che dà lo spettacolo di un teatro di posa, sapranno realizzare la loro visione praticamente, quanto la concezione estetica sarà così alta da superare col suo interesse trascendente l’interesse immediato […] allora soltanto il cinema potrà essere arte in tutto il significato della parola» . L’estetica idealistica, buttata dalla finestra, ritorna dalla porta principale nel giro di breve tempo per costruire la pista del decollo definitivo del regista. Con la benedizione di Benedetto Croce dall’inizio degli anni Venti, i nuovi catecumeni dell’arte cinematografica potranno finalmente essere introdotti nella nuova cattedrale laica dell’Arte e comunicare col corpo dell’autore. 53
54
55
apoteosi del film storico
Il film storico costituisce un genere nel genere destinato a imporsi per un breve periodo e a costituire la punta di diamante della produzione di questi anni e della sua capacità di affermarsi su tutti i maggiori mercati internazionali. Il problema è stato a lungo trattato con sufficienza, o in termini riduttivi se non addirittura negativi, per la sua magniloquenza sospetta, per l’eccesso di enfasi, perché si sono visti in quei rituali, in quelle sfilate, in quelle rappresentazioni di massa i geni dei successivi riti del fascismo, per l’assenza o quasi di motivi realistici. «Fatte le debite eccezioni – scrive G.C. Castello – la fioritura del film storico in Italia […] assume l’aspetto di una lunga carnevalata, nell’ambito della quale non è possibile salvare, sul piano artistico, un solo film nella sua interezza, ma solo brani più o meno significativi» . Per Savio, che con maggiore attenzione ha percorso alcuni film chiave del muto, «il cinema italiano non era in grado di alimentare un’esperienza così aggressivamente scolastica» per cui «alle oneste gigantografie dei primi anni Dieci sarebbero subentrate dopo la guerra le opere farraginose, ingombranti e abortive, nelle quali la monumentalità degenera in fasto circense e il gusto della storia in tetro antiquariato» . In realtà, se ci liberiamo, una volta per tutte, dei complessi idealistici nei confronti della qualità artistica dell’opera e cerchiamo di capire come funziona un insieme omogeneo all’interno di un più articolato e complesso sistema narrativo e spettacolare, ci accorgiamo che, proprio per la centralità nello sviluppo e nell’affermazione produttiva degli anni che precedono la guerra mondiale e per la quantità di codici che entrano in contatto e di problemi che si intersecano, il filone merita di essere osservato, per quanto è possibile, con estrema attenzione. In effetti riuscire a coglierne i meccanismi figurativi e culturali diventa un presupposto indispensabile per capire la rapida e incontrastata egemonia culturale esercitata e la forte capacità di trasmissione di significati e di ideologia, oltre che di emozioni. Anzitutto la complessità della messa in scena, la necessità di sfondare lo spazio e di dominare le folle di comparse e tutti gli elementi interagenti nello spazio stesso è un elemento fondamentale nella individuazione ed emergenza della figura del regista, rispetto al cinema dei divi che punta decisamente a far pendere l’ago della bilancia a favore dei sovrani della scena. Il progetto di una cultura capace di raccogliersi attorno a una serie di valori nazionali passa, soprattutto per quanto riguarda il cinema, per la romanità, ma trova anche altri momenti storici in cui si riconosce. L’immaginazione figurativa si muove lungo binari obbligati, ma con un allargamento progressivo dello spazio della rappresentazione, parallelo alla ricerca di una sempre maggiore verisimiglianza. Se i motivi della romanità o del dominio veneziano servono all’esportazione dell’idea del dominio del mondo, lo spirito nazionalistico viene tenuto vivo all’interno con una serie di film risorgimentali inaugurati dalla Presa di Roma. Di notevole importanza, per le soluzioni espressive adottate, Nozze d’oro realizzato dall’Ambrosio nel 1911 con la regia di Luigi Maggi . Ed è ancora Maggi a realizzare – con Giovanni Vitrotti operatore reduce da un primo viaggio in Russia – Il brigadiere Roland, opera di grandi ambizioni spettacolari e stilistiche, e a mettere in scena, sempre nel 1911, La Gioconda, La fiaccola sotto il moggio e Sogno di un tramonto d’autunno tratti da D’Annunzio. Il film narra un episodio della storia della seconda guerra del Risorgimento attraverso il ricordo del protagonista, il nonno, che, in occasione delle nozze d’oro, lo rievoca per i nipoti. Si tratta di uno dei primi esempi di narrazione in prima persona da parte dello stesso soggetto dell’azione: un lungo flashback è introdotto da una didascalia che storicizza con esattezza l’azione («Quel giorno, 30 maggio 1859 il nemico ci teneva assediati»). L’immagine del Risorgimento è quella della partecipazione interclassista concorde e soprattutto popolare alle guerre d’indipendenza. La macchina da presa è già molto più vicina ai personaggi negli interni (secondo un principio di accostamento progressivo che giunge al massimo di contatto fisico tra l’obiettivo e il volto dell’attore soltanto tre anni dopo) e negli esterni sfrutta in pieno la profondità di campo e le possibilità spaziali per i combattimenti o gli inseguimenti. I trionfi di Roma e di Venezia – in misura comunque più rilevante rispetto alla celebrazione delle glorie risorgimentali – vengono naturalmente assimilati alle ambizioni del presente, alimentate a partire dalla guerra di Libia e servono quasi da prima esibizione pirotecnica e manifestazione incruenta della frenesia combattentistica che contagia interi gruppi di giovani nazionalisti. Il cinema da questi anni amplifica e irradia temi, parole d’ordine e aspirazioni dell’ancor esigua falange di corifei della riscossa nazionalistica e di cantori del nascente «pan-romanesimo». Come vedremo l’elemento che più caratterizza questa produzione è dato dalla mescolanza tra dilatazione 56
57
58
ipertrofica della rappresentazione dello spazio e affermazione della propria natura di «arte figurativa» prima che di forma di spettacolo e rappresentazione. Da un certo momento in poi non sembreranno esserci più limiti ai poteri della macchina da presa, anche se i protoregisti italiani non raggiungeranno mai, rispetto agli autori di altri paesi una piena capacità di dominare e di inventare assieme al lessico visivo e alla paratassi anche la sintassi. Ma le spinte conferite dalla loro invenzione a tutto il sistema narrativo e spettacolare giocheranno un ruolo fondamentale. Il filone risorgimentale è ripreso da altre case produttrici a partire dal Tamburino sardo della Cines dello stesso anno e negli anni successivi da I Mille e dalla Lampada della nonna del 1913 di Luigi Maggi (entrambi dell’Ambrosio), quest’ultimo concepito come copia perfetta di Nozze d’oro con il passaggio del punto di vista della nonna, e da un’altra casa torinese, la Gloria, che sforna una serie di film deamicisiani dal Tamburinosardo al Piccolo patriota padovano. Una notevole influenza viene esercitata anche dai quattro drammi scritti a partire dal 1910 da Domenico Tumiati (Giovane Italia, Carlo Alberto, Il tessitore, I Mille), che, con il loro infiammato nazionalismo, cercano di far rivivere al presente gli ideali risorgimentali. Scorrendo con maggior attenzione i titoli e osservando ciò che resta ci si rende sempre più conto che, come per la letteratura, anche per la storia lo sforzo è quello di rappresentare tutti i periodi dalla guerra di Troia fino al Risorgimento. Il genere, per alcuni anni, non vanta grandissime ambizioni culturali: e un film in costume che offre per lo più materiali di riporto dello spettacolo, dalla recitazione all’uso delle masse come materiale plastico: gli echi del melodramma verdiano, o di Boito, delle messe in scena della Scala, sono evidenti, come aveva sottolineato Rognoni , di cui però sono solo in parte accettabili le conclusioni, che vedono questa esperienza «senza continuità di rapporto col linguaggio cinematografico» . In rapporto all’evoluzione realistico-mimetica del racconto ciò è vero, ma non si può dire che la macchina da presa non partecipi alla costruzione di un nuovo tipo di messaggio visivo e che le soluzioni spaziali adottate e la dinamica dell’azione non producano spinte su tutto il sistema. Il processo di trasformazione e di arricchimento del senso e la conquista di specifiche soluzioni cinematografiche gioca forse su questo piano le sue carte più significative, grazie anche all’alto grado di professionalità raggiunto dagli operatori. Si può senz’altro affermare che, nel 1912, gli operatori sono ormai in grado di ottenere qualsiasi effetto luminoso, di dominare in pieno i trucchi – un ruolo decisivo lo avrà il reclutamento da parte dell’Ambrosio di Segundo de Chomón – di dislocare la macchina da presa lungo assi non perpendicolari all’oggetto, e di lavorare negli interni liberandosi, poco alla volta, dai codici teatrali. Un sistema in apparenza unitario viene così articolato su due assi, uno di caricamento massimo e progressivo degli interni, che diventano contenitori sempre più ristretti per il numero crescente di elementi e personaggi, l’altro di scoperta della dialettica spaziale interni/esterni e di invenzione di uno spazio cinematografico nato dalla progettazione di specifiche soluzioni scenografiche per il cinema. Per gli interni il sistema è più statico, anche se si avvertono in termini quantitativi e qualitativi le motivazioni sempre più funzionali dei materiali che entrano nell’immagine e il loro aumento. Per alcuni anni la recitazione dei protagonisti è frontale e il racconto è prodotto dapprima dai soli gesti e poi anche dal discorso che spezza la linearità della visione attraverso gli innesti delle didascalie. Tra il 1909 e il 1910 possiamo indicare come esempi di accurata ricostruzione scenografica accanto ai film già ricordati anche Napoleone e la principessa di Hatzfeld (Itala), o Lo schiavo di Cartagine di Luigi Maggi, o Marin Faliero,doge di Venezia o Bruto di Enrico Guazzoni, o Catilina di Mario Caserini, o La regina di Ninive di Luigi Maggi che affrontano periodi storici diversi, raggiungendo un’ambientazione assolutamente verosimile. Lo spazio è ancora usato secondo la codificazione teatrale: i personaggi si muovono lungo gli assi verticali e longitudinali fino a fermarsi e recitare rivolgendosi in direzione del pubblico. Nello Schiavodi Cartagine si può tuttavia cogliere una consapevole ricerca di effetti luminosi (controluce o contrasti tra buio e fonti luminose assai forti) e un iniziale tentativo di utilizzare le masse in scene di grande effetto spettacolare (l’assedio a Cartagine). L’ingenua iconografia del sacrificio a Moloch rende improponibile un confronto con le soluzioni visive adottate per una scena analoga in Cabiria da Pastrone. Lo stesso Pastrone realizza, nel 1910, per l’Itala, La caduta di Troia, dove esperimenta alcune soluzioni scenografiche innovatrici , anche se bisogna riconoscere che il primo regista a porsi in maniera originale e totale il problema dello spazio e della prospettiva è Enrico Guazzoni . In uno scritto apparso su «In Penombra» nel 1918 Guazzoni ricostruisce a posteriori la propria «poetica spaziale» cercando di 59
60
61
62
conferire alle sue intenzioni un blasone culturale assai nobile e vasto: «È da Shakespeare che trassi la convinzione che una grande polifonia potesse sostituirsi al monotòno, all’a solo […] e, sempre attenendomi ai canoni dei maggiori drammi shakespeariani, ho mirato soprattutto a far sì che il protagonista vero fosse la folla, la grande folla variopinta che alberga sentimenti diversi, passioni più disparate, fede e fanatismo […]. Ma bisognava dare un’estetica a questa folla, un’estetica cinematografica. Il cinema […] può sfruttare su larga scala il movimento delle masse, necessariamente troppo angusto nelle limitazioni sceniche […]. Ho sempre voluto che ogni figura vivesse liberamente nell’ambito del suo gioco scenico, persuaso che la ricerca del ritmo e dell’armonia collettiva sarebbe stata soddisfatta dalla libertà lasciata a ogni individuo di agire e gestire come volesse» . Guazzoni, in realtà, pur mettendo bene a frutto la propria cultura figurativa non rivoluziona il sistema, tuttavia è il più rigoroso nell’applicazione di determinati procedimenti e con ogni probabilità è da considerare il primo vero autore del cinema italiano, il primo capace di porsi problemi di orchestrazione delle masse, di costruzione dell’immagine, di organizzazione dello spazio, di sintassi narrativa, di valorizzazione degli elementi scenografici … La scoperta delle possibilità spettacolari dello spazio che, via via, si libera dei fondali di cartapesta e consente a migliaia di comparse di muoversi, scontrarsi, sfilare, decretare la vita e la morte dei gladiatori e dei cristiani nei circhi e nelle arene romane e, più di tutto, di dar vita a una politica di potenza virtuale, ha il merito di trasmettere energia ed esemplare vitalità a una concezione del tempo statica, monumentale, ripetitiva. In parallelo alla dilatazione dello spazio dell’azione sullo schermo si espandono lo spazio della sala e quello immaginativo degli spettatori. Il film di Guazzoni che muta lo standard del filone dei drammi storici è la seconda versione di Quo vadis?, realizzato nel 1913 per l’Ambrosio: il romanzo di Sienkiewicz è seguito in tutti i suoi capitoli fondamentali, ognuno dei quali, secondo il principio già osservato per l’Inferno, riceve la sua riduzione visiva. La storia resta sullo sfondo e la vicenda di passioni e gelosie si intreccia a motivi psicologici e patetici. I personaggi agiscono liberamente nello spazio e lo percorrono fino al primissimo piano. Lo stesso mondo popolare acquista una forte evidenza figurativa. Nel finale si scopre nelle scene del circo, la funzione ad alto quoziente emotivo e spettacolare della dialettica individuo/folla. Un personaggio popolare, Ursus, il progenitore dei forzuti, si esibisce per la prima volta nelle scene di combattimento del circo e da questa scoperta delle funzioni complementari dell’eroe forte e della folla scaturiranno per anni i meccanismi spettacolari e ideologici. Uno dei motivi di maggiore successo di questo filone è dato proprio dalla rappresentazione della continua permeabilità del sociale: una schiava può innamorarsi di Marcantonio e divenire rivale di Cleopatra, un’altra può preferire l’amore di un pastore a quello del faraone e ciò nonostante ricevere egualmente in eredità il regno d’Egitto. In Cabiria il personaggio di Maciste è promosso ad autentico protagonista, anche se il suo ruolo subalterno resta ben definito. Il crollo delle barriere sociali non nasce certo da istanze sociologiche, quanto piuttosto è ancora una volta un frutto indiretto del melodramma e dell’opera lirica («Tu puoi distruggermi o uccidermi – dice la schiava a Cleopatra – ma non dimenticherai mai che Antonio mi ha baciata») ed è al tempo stesso un forte elemento di aggregazione nazionalistica («E ora, se volete, morite per la Francia» dice Napoleone in persona, al protagonista nel finale di Scuola d’eroi di Guazzoni, dopo averlo condannato per l’accusa di alto tradimento e graziato in extremis). Nello stesso anno del Quo vadis? l’Ambrosio realizza, con la regia di Eleuterio Rodolfi, Gli ultimi giorni di Pompei, film a un livello grammaticale e sintattico più modesto del precedente, per quanto riguarda la prima parte e privo di quelle ambizioni ideologiche che verranno sempre più caratterizzando i film di Guazzoni, regista che più di ogni altro riesce a far vibrare e rivivere sullo schermo i fantasmi di un’idea nazionale forte, che viene da lontano e vuole diventare il primo punto d’orientamento comune per lo Stato che si affaccia sulla scena internazionale. È certo però che proprio su questo piano della ricostruzione scenografica ambiziosa, del confronto con opere letterarie di successo, il film inizia ad apparire come opera d’autore. Le didascalie sono predannunziane e interessano anche per la grammatica piuttosto approssimativa («La via Domiziana, una delle arterie più commerciate della città», «Nydia contempla di scappare», «Lo spaventoso disastro ritorna le facoltà mentali di Glauco»), le riprese sono per lo più in figura intera, la 63
64
macchina è fissa, i costumi sono spesso improbabili e tutto il film si svolge per quadri staccati. In qualche scena viene applicato il procedimento del campo controcampo, come in quella dell’adorazione di Iside con l’alternanza sacerdote-fedeli, e, verso la fine, quando muta il ritmo narrativo e scatta anche una sorta di montaggio parallelo. La salvezza dei protagonisti, grazie al sacrificio di Nydia, è una sorta di approdo alla vita dopo un viaggio di purificazione («Attraverso la stigia oscurità Nydia conduce a salvamento Ione e Glauco»). Nella rappresentazione del suicidio di Nydia e del suo corpo che galleggia in mezzo ai fiori è evidente il richiamo figurativo alla Morte di Ofelia di J. Everett Millais, una delle opere preraffaellite più riprodotte dalle stampe popolari. Statico nel complesso, il film è privo di scarti in direzione drammatica o visiva fino alle scene del circo e all’eruzione finale del Vesuvio che costituisce il vero clou drammatico e spettacolare. Nel finale il ritmo di montaggio congiunge scene di riprese documentarie e dal vero (la lava del Vesuvio) con grandi scene di folla impazzita che si riversa per le strade e viene seppellita sotto la lava e i lapilli. C’è, in questa catastrofe finale, la prima rappresentazione di grandi scene di paura collettiva e il mutamento di ritmo è forse una delle prime manifestazioni consapevoli delle possibilità del cinema non solo di utilizzare lo spazio come elemento drammatico, ma di inventare nuove ritmiche e prosodie interne all’azione. Tra il 1913 e il 1914 si raggiunge il livello ottimale del genere, anche se, negli anni precedenti, si erano fissate molte linee e procedimenti generali di rappresentazione. Allo spezzettamento in quadri, che coniuga in maniera ordinata ed elementare informazione, descrizione e rappresentazione, si sostituisce, a un certo punto, la narrazione che elimina il rapporto parola/immagine e si fonda unicamente sull’azione e sulla pura concatenazione narrativa dei fattori visivi. Ciò avviene secondo tecniche di distribuzione di elementi comuni. Di questo livello, che raggiunge con Cabiria il suo punto di massima culminazione, non si registrano poi significativi progressi fino al sonoro. Il cinema degli anni seguenti utilizza, per lo più, in maniera parassitaria, le scoperte di questo periodo, anche se il racconto si fluidifica e le tecniche di montaggio si fanno più sofisticate. La recitazione resta ancora per qualche tempo frontale, la disposizione delle figure è quella dell’opera lirica, da cui il cinema attinge modi, temi e linfa in misura superiore al teatro, con il protagonista che recita frontalmente e il coro che si dispone ai lati della scena, la verisimiglianza è ottenuta grazie a veri leoni o veri serpenti ripresi in primo piano ma anche questi effetti si possono far derivare dal teatro naturalistico. Si possono però cogliere momenti soprattutto nel cinema di Guazzoni, in cui, all’improvviso, i codici teatrali, o quelli iconografici vengono sconvolti dalla modifica del rapporto tra elementi luminosi spaziali, macchina da presa e oggetto (in Marcantonio e Cleopatra ad esempio si può vedere il primo piano del viso di Cleopatra, illuminato dalla fiamma, mentre interroga l’oracolo). Il passaggio di piani dai totali al primo piano diviene frequente e si intensifica mano a mano che il divismo acquista un peso maggiore. In ogni caso la vera dinamizzazione è data soprattutto dalle scene di massa, dallo sfondamento della simbolica parete teatrale. Visto il successo dei primi film a carattere storico tutte le case si muovono per rispondere alla domanda straniera e cercano di produrre opere al medesimo standard. In questo gruppo di film è senz’altro da ricordare Spartaco, realizzato dalla Pasquali nel 1913 (la regia è di Vidali) in cui, a una modesta trasformazione di tutto il sistema recitativo, corrisponde invece un grande allargamento della visione: le scene del circo, i combattimenti dei gladiatori sono, ancora una volta, il momento più forte nella tensione emotiva e accanto a Ursus e Maciste, anche Spartaco non sfigura nelle esibizioni di grande potenza fisica. Sul piano delle soluzioni visive il film si ricorda almeno per una sequenza memorabile: quella della discesa mediante corde dei gladiatori dal Vesuvio. Vengono attivate contemporaneamente due iperboli, una verbale («la storia non ha registrato un più glorioso momento della fuga dei gladiatori dalle pendici del Vesuvio») e una visiva, con la ripresa a grande distanza, entro un mascherino ovale, di centinaia di uomini che si calano lungo la parete del monte mediante lunghissime funi. L’utilizzazione dei grandi piani totali e la novità ed efficacia spettacolare della profondità di campo rivelano, in questo film, un potere assoluto, mentre ancora la combinazione dei segmenti narrativi in racconto è piuttosto elementare. «La storia – scrive ‘Moving Picture World’ – ha la dignità di un classico anche se è pura fiction» . Sono questi gli anni in cui comincia a scatenarsi la battaglia per il cinema d’autore: una spinta decisiva viene forse da un articolo di Enrico Rossi sulla «Vita cinematografica» in cui sono elencati tutti i nomi dei 65
direttori artistici operanti in quel momento, ma per capacità professionali ne vengono salvati soltanto una decina (Vidali, Guazzoni, Caserini, Antamoro, Maggi, Ghione, De Liguoro, Negroni, Paradisi e pochi altri) . Tra questi autori i primi a rivelare una fisionomia abbastanza caratterizzata sono Maggi e Caserini. Maggi, oltre ai due film della serie d’oro dell’Ambrosio sul filone risorgimentale, notevoli per la struttura del racconto nel racconto, è autore di un’opera molto ambiziosa destinata a lasciare un segno nella cinematografia successiva: Satana (con Mario Bonnard e Mary Cleo Tarlarini) girato nel 1912 . Questo film tratto dal Paradiso perduto di Milton si struttura in momenti rappresentativi della presenza demoniaca in quattro periodi diversi della storia umana. Intolerance di Griffith è ancora lontano. Tra i proto registi bene riconoscibili Mario Caserini si pone dietro alla macchina da presa fin dal 1906-1907, lavorando alla Cines accanto a Gaston Velle . Sue sono le prime riduzioni shakespeariane, suoi alcuni ambiziosi film di ricostruzione storica come Beatrice Cenci e La battaglia di Legnano e alcune riduzioni di opere letterarie di grande successo come I tre moschettieri, opere che varcano i confini nazionali e consentono al primo cinema italiano di imporsi per alcune sue caratteristiche legate alla ricostruzione storica o alla riduzione di classici o testi conosciuti della letteratura. Il suo massimo successo è legato a Ma l’amor mio non muore che segna la glorificazione divistica di Lyda Borelli, ma mostra anche decisamente l’affrancamento del suo linguaggio dalla dipendenza della scatola teatrale. Sui set da lui diretti si formerà Enrico Guazzoni, il primo vero direttore artistico a cui possa spettare la qualifica di regista. Guazzoni raggiunge, già dopo Quovadis? con Marcantonio e Cajus Julius Caesar e Scuola d’eroi, il livello ottimale di regia per quanto riguarda la concatenazione sintattica delle azioni che non vengono più spezzate dalle didascalie e per quanto riguarda l’alternanza dei piani, l’uso della luce in funzione drammatica, il movimento delle masse. Accanto al motivo nazionalistico, ha un peso non indifferente quello erotico: le attrici usano il loro corpo in lunghe scene di seduzione. I motivi esotici, connessi alla rappresentazione di tutta una serie di riti iniziatici, magici, misteriosofici, sfociano a loro volta nei motivi erotici. L’equazione esotismo-erotismo mobilita la fantasia scenografica, informa tutto il sistema dei gesti, coinvolge ogni elemento, non esclusi valori propriamente cinematografici come quelli luminosi. L’amore si ottiene non di rado col favore delle pozioni magiche e il fascino, pervaso di occultismo e pratiche magiche, che circolano nella cultura figurativa di quegli anni, viaggia di pari passo con i motivi dell’iniziazione erotica. La dimensione alta si mescola al quotidiano: amore e ragion di Stato, cospirazione e intrighi, personaggi popolari e nobili intrecciano molto spesso il loro destino. Accanto ai motivi privati c’è una continua interferenza delle istituzioni pubbliche (si vedano le scene del senato in Marcantonio e Cleopatra, Cajus Julius Caesar e Cabiria) e della partecipazione popolare alle decisioni di governo. C’è inoltre l’uso degli inserti della dimensione onirica (il sogno di Cleopatra che si vede sfilare prigioniera nel trionfo tra gli insulti del popolo romano) o dei parallelismi con preciso senso simbolico o ideologico (l’esercito romano in marcia e Antonio che continua la sua vita di piacere). Grazie a una sapiente utilizzazione della profondità di campo si ottengono grandi scene di massa con figure perfettamente a fuoco dal primo piano fino all’infinito. Qualcosa del genere si era già visto nelle scene della campagna di Russia del Brigadiere Roland di Luigi Maggi dove l’occhio della macchina da presa spaziava su grandi distese coperte di neve e attraversate in tutte le direzioni da eserciti in marcia o in fuga. Dal 1911 in poi nelle produzioni torinesi o romane l’immagine si riempie di centinaia di comparse che si muovono con naturalezza. In Cajus Julius Caesar si assiste anche allo sfondamento dei limiti convenzionali della scenografia, si eleva sistematicamente il punto di vista della macchina da presa per ottenere il massimo di inclusività dello sguardo. Le scene di battaglia con i galli hanno un ritmo spettacolare e un’animazione interna del tutto inediti fino a quel momento. Poco importa che in modo più o meno ingenuo si mescolino le carte della storia (il detto «veni, vidi, vici» è attribuito, per esempio, alla battaglia di Alesia): la potenza figurativa è, in alcuni casi (come nella lunga ripresa della montagna di cadaveri), di una potenza impressionante. Il cinema storico italiano fa delle iperboli visive il suo punto di forza. Schermo e platea diventano spazi cerimoniali e rituali dai poteri tutti da scoprire. Il punto di vista ha una continua mobilità e le scene di massa sono distribuite lungo tutto il film e non ne costituiscono solo il momento di massima spettacolarità del finale. In Scuola d’eroi la macchina da presa acquista ulteriore mobilità: nelle scene della battaglia di Austerlitz tutte le riprese del bosco vedono la macchina da presa in 66
67
68
continuo movimento, inoltre mutano gli angoli e c’è una dialettica costante tra primi piani e piani generali, tra il punto di vista soggettivo (lo sguardo di Napoleone) e l’oggetto osservato. Le vicende individuali si mescolano in modo naturale agli eventi storici. Lo spazio chiuso della scenografia teatrale, di cui si apriva solo la parte di fondo, si dilata, poco alla volta, fino a essere sostituito dallo spazio reale. Inoltre bisogna notare che i motivi scenografici e teatrali sono abbandonati a favore del rito militare. L’ideologia che sottende questi film trova una precisa sublimazione in determinati argomenti. Giustamente si è visto nella celebrazione delle glorie romane un transfert evidente delle frustrazioni e delle ambizioni imperialistiche rimesse in moto dalla guerra di Libia . La guerra italo-turca prima e quella di Libia poi, sono, per l’ideologia nazionalista, due grandi banchi di prova, due ottime occasioni di aggregazione e di chiamata alle armi di tutte le forze della nazione. Le glorie passate dell’Italia sono assimilate in trasparenza alle situazioni presenti. Per gli spettatori i motivi dei film antiarabi, tratti dai classici della letteratura come Il Cid, La Gerusalemme liberata, I cavalieri di Rodi, realizzati tra il 1910 e il 1912, non possono non richiamare, in egual misura, quelli del nazionalismo che stava nascendo alla cui crescita D’Annunzio stava dando una spinta non indifferente. Il cattolicesimo distrutto nei circhi è rappresentato trionfante, nell’affermazione della civiltà cristiana contro la barbarie del mondo arabo e pagano, e diventa un buon punto di appoggio e una cinghia di trasmissione altrettanto importante dei messaggi di conquista. A questo punto bisogna notare che esiste confluenza e incrocio di diversi codici anteriori, che partecipano di un progressivo slittamento semantico e variano il senso dei propri messaggi al di là del processo di traduzione visiva, grazie alla rappresentazione di certi motivi, come quelli fondamentali del rito. Qui non intendo solo riferirmi al rito sacrificale che si nota in Marcantonio e Cleopatra, nello Schiavo di Cartagine, in Ramsete, re dell’Egitto, in Salambò, in Cabiria. È piuttosto la presenza e il coordinamento ideologico di altri elementi rituali sparsi in modo più ampio nei vari generi che coinvolge il comportamento dei singoli e quello delle masse e assume una funzione del tutto nuova. Lo stesso uso della folla, in questa prospettiva, il tentativo di disciplinarne il movimento, l’opposizione tra il caos delle insurrezioni e dei terrori popolari (Nerone, Gli ultimi giorni di Pompei, Quo vadis?) e l’ordinato sfilare delle truppe per celebrare i trionfi bellici (Marcantonio e Cleopatra), o la partecipazione popolare a un rito che mescola elementi pagani e cristiani (come nel Mistero di Galatea di Aristide Sartorio del 1919) diventano funzioni ben precise di un’argomentazione ideologica e retorica. Mentre nella rappresentazione di ordine-disordine popolare, nella progressiva partecipazione all’ordine si può individuare il punto di sublimazione della violenza e l’apice drammatico dei film storici. La composizione finale dei conflitti significa accettazione e ristabilimento di un ordine sociale e politico che è stato sconvolto. Ma nel caso dei film più significativi, l’ordine di tipo imperialistico significa, come si è visto, appoggio all’idea nazionalistica di un rilancio del mito del dominio romano nel mondo. In questa fase il ruolo di D’Annunzio, anche se non diretto è da considerarsi fondamentale. In quest’ottica, pero, è bene evitare di vedere solo lo specchio di un rinascente spirito nazionalistico confinato nell’età giolittiana: in realtà la produzione simbolica è tale da riuscire a costituire prefigurazioni ben precise di un’ideologia che, in buona parte, confluirà nel fascismo e verrà rifunzionalizzata a partire dalla seconda metà degli anni Trenta. Possiamo pertanto vedere dalla trasformazione degli elementi scenografici e spettacolari la trasmissione di ideologia dallo spettacolo alla realtà. I documentari di guerra che si realizzeranno negli anni successivi risentiranno anche di un ordine retorico e di una disposizione dimostrativa già stabilita grazie ad alcuni film di finzione che si sono fatti carico della trasmissione di una ideologia. Se dell’importanza dei film sull’imperialismo romano sono state in vario modo intuite e definite le caratteristiche generali, assai minore è l’attenzione dedicata ai film dell’imperialismo veneziano, che costituiscono una variante abbastanza significativa e intimamente connessa alla prima. Mentre la rappresentazione della grandeur romana è il veicolo di una sola funzione, l’immagine veneziana gioca da subito su un doppio registro. La città diventa, al tempo stesso, l’immagine da esportazione per eccellenza della realtà italiana e il luogo autentico in cui si possono rappresentare i motivi dello scontro ideologico e della lotta per il potere. Venezia è un topos in cui confluiscono i motivi della congiura, dei tradimenti e dove la letteratura è il tramite per capire i meccanismi della politica. Si tratta di un sistema di rappresentazione unitario, dato fin dall’inizio (dal Fornaretto di Venezia girato dalla Cines nel 1907 e poi ripreso periodicamente), che si tramanda intatto fino agli anni Quaranta nei film della Scalera . 69
70
Tutti gli aspetti più tipici del paesaggio veneziano sono percorsi e rappresentati senza alcun ricorso alla ricostruzione: da piazza San Marco al Canal Grande, dal bacino Orseolo alla laguna, al Palazzo Ducale, fino alle corti e campielli popolari della Venezia minore. Senza perdere il loro fascino e il loro richiamo turisticoculturale le pietre di Venezia parlano di storia presente, materializzano i sogni di conquista dell’Italia giolittiana in misura non inferiore ai marmi degli archi trionfali e delle colonne romane. Anche in un’ambiziosa versione dell’Otello shakespeariano, realizzata con il contributo di George Kleine, sono presenti i motivi finora indicati. Il momento dell’apoteosi si celebra nella sfilata finale delle gondole e del Bucintoro in Canal Grande. Tutti questi motivi li troviamo nel Leone di San Marco dove la totalità delle riprese dal vero mostra il ruolo dominante, o almeno equivalente, dello sfondo rispetto all’intreccio.
«cabiria», il vertice della parabola Raggiunto assai presto il suo livello standard il cinema italiano si trasforma in modo minimo e sembra rifiutare di prendere atto della rapidità con cui il sistema evolve, dal 1913 in poi, sul piano mondiale: pago della priorità di certe scoperte, pensa ancora di costituire un punto di riferimento per le cinematografie straniere e non si interroga sulle trasformazioni in atto. Data l’esistenza di un processo ininterrotto di produzione cinematografica si può riconoscere che il mutamento graduale dei modelli culturali, o meglio l’attivazione progressiva di più modelli, passa attraverso alcuni momenti qualificanti che possono venir percepiti come manifestazioni di culture diverse e spesso contrapposte. Tra il film storico e il film dannunziano o decadente o simbolista il punto di confluenza e di contiguità esiste ed è Cabiria . In Cabiria vengono condotti a livello ottimale tutti gli elementi formali e narrativi sparsi nei film precedenti: la disposizione del racconto che abbraccia più spazi e un arco di tempo molto vasto, i livelli della recitazione, la grandiosità dell’invenzione scenografica ne fanno il punto d’arrivo della produzione spettacolare del muto italiano . Con Cabiria si cerca di unificare una serie di miti sparsi, da quello della gloria imperiale romana, a quello basso dell’eroe popolare, semplice e protettore dei deboli. Tutte le funzioni narrative sono dilatate. Il disegno generale tiene presenti e cerca di implicare più riferimenti storici (da Annibale, all’assedio di Siracusa, dall’eruzione dell’Etna alle fasi salienti della guerra punica), ma è soprattutto l’intreccio che tenta di combinare il massimo di motivi: le peripezie, i riconoscimenti, il rapimento di una fanciulla venduta come schiava, sono alcuni tra i motivi di base della commedia classica innestati in una struttura con ambizioni molto più elevate. La combinazione dei livelli è anche combinazione dell’invenzione scenografica spinta al limite delle sue capacità e i momenti culminanti dal punto di vista spettacolare sono anche i momenti culminanti del discorso cinematografico. I grandi totali, o il dettaglio delle mani del sacerdote, la ricostruzione dei templi, delle statue, le scene di battaglia, i movimenti di macchina e l’uso del carrello, sono soltanto alcuni dei fatti espressivi più marcati del film, che ancor oggi, nella sua enfasi spettacolare, rimane un punto di riferimento per tutta la storia del cinema . Fondamentale per l’invenzione visiva è il ruolo di Segundo de Chomón, accanto a quello di Pastrone. Nei momenti alti si cerca di raggiungere una sintonia tra le immagini e le didascalie e di accordare i due piani secondo una sorta di ritmo prosodico. La didascalia perde il suo valore di pura indicazione, per acquistare quello sostitutivo di metaforizzazione, di allargamento e di riempimento di vuoti. Nei momenti di massima presenza di D’Annunzio la didascalia sembra diventare un testo autonomo e proporsi come modello irripetibile e anche inutilizzabile, come si può vedere in alcuni passi dell’invocazione a Moloch del sacerdote: «Re delle due zone, t’invoco, / respiro del fuoco profondo, / gènito di te primo nato! / […] Odimi, creatore vorace / che tutto generi e struggi, / fame insaziabile, m’odi! / Eccoti la carne più pura! / eccoti il sangue più mite! / Karthada ti dona il suo fiore / Consuma il sacrificio tu stesso / nelle tue fauci di fiamma, / o padre e madre o tu Dio e Dea / o padre e madre, o tu padre e figlio / o tu Dio e Dea! creatore / Vorace! fame ardente ruggente» . In quanto «Autore» del film il poeta intende far assumere alla parola scritta su un piano di stile alto un ruolo analogo a quello di un cantare epico: una sorta di funzione para-omerica, come quella che vediamo quando lui stesso, nel finale di Cabiria, fa in modo che voce implicita e parola scritta entrino come voce d’autore, motivo-firma. Fino alla didascalia finale il testo letterario riesce a creare un mondo parallelo rispetto 71
72
73
74
all’iconosfera pastroniana. All’inizio il film aveva una durata di 3 ore e 20 minuti: la grandiosità dell’apparato scenografico, le musiche composte da Ildebrando Pizzetti e suonate nelle maggiori città italiane (Milano, Roma, Torino) da orchestre di una settantina di persone, gli applausi a scena aperta del pubblico, ne fanno un avvenimento che promuove, con tutti i crismi, lo spettacolo cinematografico alla dignità delle altre forme di spettacolo. Negli altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, i toni di Stephen Bush sono elogiativi al massimo e coinvolgono un riconoscimento a tutta la cinematografia italiana, che, in quegli anni, aveva ottenuto grandiosi successi sul mercato americano: «Siamo testimoni della nascita d’un nuovo stile nella drammaturgia cinematografica […] non posso omettere un tributo all’Italia, il paese che ci ha dato tutti i nostri maggiori classici dello schermo» . Carlo Lizzani ha visto in Cabiria un punto di partenza e di arrivo della produzione italiana del muto «perché la strada che indicava – lo spettacolo grandioso nelle forme, retorico e letterario nella sostanza – era priva di sbocchi e di prospettive» . Di fatto, a mano a mano che le nostre conoscenze sul cinema muto si fanno meno precarie e più attente alla varietà e complessità dei sistemi di rapporti Cabiria appare come una delle sette meraviglie del mondo del cinema delle origini. D’Annunzio vi irradia e dissemina il suo Verbo e la Luce e Aura della sua personalità, mentre a Pastrone è stata restituita in pieno la paternità stilistica, la metrica, il senso della scansione dei volumi e delle architetture, l’inventio scenografica… Ideale «alter ego» di Marco Gratico, l’eroe della Nave dannunziana è lui che «arma la prora (del film)» e salpa per l’ultima grande impresa del cinema muto italiano di conquista del mondo. Grazie al modello di spettacolo realizzato da Pastrone il cinema dispiega e riconosce la potenza dei suoi mezzi e delle sue possibilità, anche se è costretto a rinunciarvi. Eppure la produzione degli anni successivi tenta di restare ancorata ai fasti di questo tipo di spettacolo, anche se non potrà più permettersi un’analoga profusione di mezzi, in quanto l’inizio della guerra mondiale segna la fine di un modello di cinema basato su grandi investimenti di capitali, sulla grandiosità scenografica e la profusione illimitata di mezzi. Certo il titanismo scenografico di alcuni film prodotti sia in ambiente torinese che milanese o romano sembra non porsi dei limiti né di spazio, né di tempo: l’intero atlante storicogeografico è percorso, come si è visto, in lungo e in largo, tutti i costumi, tutti gli stili e tutte le epoche sono stati messi in scena, utilizzando e mescolando le tecniche prima dei vedutisti e dei pittori di corte dell’Ottocento, poi quelle degli scenografi teatrali e dell’opera lirica e infine dando spazio all’invenzione figurativa e ricreando luoghi e città fantastiche. Penso in questo caso non soltanto a Cabiria, ma a Salambò, realizzato a breve distanza dalla Pasquali e influenzato in modo decisivo da Cabiria, e anche a un altro progetto non realizzato di Pastrone, per un film successivo ispirato alla Bibbia, a cui dovette rinunciare per l’inizio della guerra. La sola ricostruzione della torre di Babele avrebbe superato la Mole antonelliana e in ogni sua parte il film mirava a una grandiosità senza confronti: seimila comparse, trecento cammelli, cinquanta elefanti, colline, uomini e carriaggi di interi paesi del Piemonte. Era la mobilitazione di massa. Senonché gli interpreti, prima ancora di indossare i primi costumi d’epoca, devono partire come alpini per il fronte delle Alpi orientali . Anche se negli anni di guerra Guazzoni, Antamoro, tentano il grande affresco storico-spettacolare e letterario (la seconda edizione della Gerusalemme liberata del 1917, o il Christus del 1916 entrambi di grandi ambizioni spettacolari e figurative) i risultati non eguagliano quelli di Cabiria, che a sua volta, nel giro di poco tempo, viene superato dalla rapida evoluzione linguistica del cinema internazionale di cui sembra che i registi italiani stentino a rendersi conto negli anni di guerra. Il Christus di Antamoro (e Guazzoni) – il cui testo per le didascalie è scritto da Fausto Salvadori – che ci è stato restituito da un recente restauro in condizioni assai vicine a quelle della prima copia, appare ancor oggi come un’opera dalle grandi ambizioni, alla cui realizzazione non si è badato a spese, andando a girare a lungo in Egitto, oltre che a Cori in Sabina. Un’opera che mette in scena la più alta concentrazione di immagini e quadri animati ispirati alla grande pittura rinascimentale (da Perugino a Correggio, da Raffaello al Beato Angelico a Rembrandt, da Michelangelo a Veronese a Leonardo e così via…), ma che forse fallisce proprio per l’eccesso di citazionismo pittorico non ben metabolizzato nel ritmo del racconto e per il ritardo nell’uscita a causa di una vertenza giudiziaria risolta a oltre un anno di distanza dalla fine della post-produzione del film . Così Louis Delluc potrà 75
76
77
78
scrivere, a pochi anni di distanza, questo giudizio complessivo che suona anche come un’epigrafe su Cabiria e il genere che aveva imposto il cinema italiano sul piano internazionale: «Si ritroveranno in Cabiria tutti gli sbagli del cinema italiano di vecchio stampo. Ora è solo un documento. Il film ha sei anni e da allora si è abbandonato questo tipo di lavoro, o almeno il pubblico non riesce più a divertirsene. Christus, Giulio Cesare, Marcantonio e Cleopatra, Quo vadis?, Caligola non valgono Cabiria, e Cabiria non vale Intolerance. I registi americani e Griffith hanno ripreso, trasformandolo vigorosamente, questo procedimento del grande affresco storico […]. Andate a trascorrere un’ora in compagnia di Maciste e di questo neo-classicismo di cui D’Annunzio fu il prestanome e renderete omaggio a tutto ciò che ha creato in sei anni il genio tecnico degli americani. Le folle italiane hanno avuto le loro attrattive. Non hanno seguito però il progresso violento della cinematografia» . 79
il cinema come documento, testimonianza e archivio della memoria Anche se non rientra negli schemi dei generi, o negli stili entro cui, per scopi puramente utilitaristici, si sono suddivisi i livelli di produzione, il documentario gioca un tale ruolo nella formazione del linguaggio cinematografico, nella esplorazione del reale attraverso il cinema, che va osservato come modo di rappresentazione dotato di propri codici specifici e come centro propulsore della dinamica espressiva per tutti i piani del racconto. È grazie al documentario più che al cinema di finzione che il cinema prende contatto con il paese reale, con i luoghi e soprattutto con la modernizzazione dell’Italia. Nel documentario dal vero è legittimo riconoscere, fin dai primi anni, una più forte spinta alla sperimentazione: la competenza linguistica si fa con l’uso, per cui la crescita del sistema avviene lentamente, grazie a un continuo intersecarsi di esperienze. In effetti i documentari, che dovrebbero essere i film descrittivi per eccellenza, mirano presto alla narrazione e al discorso. La rigorosa organizzazione temporale degli elementi, l’individuazione dei momenti forti e consecutivi, sia nei documentari scientifici, antropologici o più direttamente d’attualità, nascono proprio dalla disposizione dei materiali in forma di racconto. Il documentario, contrariamente a quanto può sembrare, non è dominato essenzialmente dai codici della realtà, o dall’esigenza della scientificità, quanto piuttosto dal mito della onnipresenza, tipico del giornalismo, dal culto del rischio, della ricerca continua di nuovi soggetti. «Gli operatori da ripresa – troviamo scritto sulla rassegna di Mattozzi del 1920 – non sono semplicemente artisti, ed esperti viaggiatori, spesso pionieri. Essi sono andati in luoghi dove la vita stava nelle loro mani. A essi sono noti i pericoli del soldato e dell’esploratore» . Lo spirito di emulazione dei produttori conta già anche per gli operatori-giornalisti che girano per il mondo e affrontano ora con occhi poetici, ora con quelli dell’antropologo, dell’esploratore, dello scienziato, del giornalista, i molteplici aspetti della realtà. L’uso del documentario significa possibilità di documentazione immediata di eccezionali avvenimenti storici, o sportivi, o produzione di conoscenza estesa a tutto il mondo e a tutte le realtà. Ciò che di solito è privilegio della scienza può trovare un vastissimo pubblico attraverso opportuni sistemi di disposizione. Nelle Farfalle, realizzato nel 1911, con la consulenza di Guido Gozzano, il mondo delle farfalle, le loro metamorfosi fondamentali sono colte in tutte le loro fasi. L’occhio si spinge sempre più vicino all’oggetto, consapevole delle possibilità di avventure conoscitive eccezionali anche nel microcosmo. E un effetto immediato di questo tipo di esplorazione lo si trova subito nella produzione normale, dove gli inserti di corpi microcellulari o di bacilli sono ripresi in varie occasioni. Già nel 1908 si tenta di usare il documentario a scopi scientifici: a Torino il professor Negro presenta, in un film, una serie di tipi di neuropatici che fanno la delizia di Cesare Lombroso, presente in sala, e non fanno che continuare ad allargare quegli orizzonti di applicazione della cinematografia alla ricerca scientifica che era stato uno degli obiettivi principali di tutte le ricerche ottocentesche di animazione della fotografia . Ciò che interessa, tuttavia, è il riconoscimento del fatto che i materiali siano disposti in forma di racconto. L’occhio di un operatore esemplare come Giovanni Vitrotti, in un anno qualsiasi della sua attività iniziale (il 1908), si sposta dalla documentazione dell’Accompagnamento funebre di E. De Amicis, alla realizzazione di una serie di documentari pubblicitari della lunghezza di un centinaio di metri (Cinzano, Cinzano fabbrica di spumante, Cinzano fabbrica di Vermouth, Cinzano vendemmia), alla ripresa di avvenimenti sportivi (Foot80
81
ball, Gioco del pallone, Concorso di ski a Limone) alle riprese di alcune comiche e film a soggetto diretti da Luigi Maggi (un Galileo Galilei e una prima versione degli Ultimi giorni di Pompei). Già nel 1909 e poi alla fine del 1910 e nei primi mesi del 1911 lo stesso operatore allarga il proprio orizzonte e realizza una serie di servizi sulle città della Russia e su usi e costumi degli abitanti: Mosca antica capitale degli zar, I cosacchi della guardia imperiale, La città di Tiflis, Lacittà di Batum… Nello stesso anno si sposta sul fronte della Guerra di Tripoli e nel 1912 riprende le scene dell’Esercito vittorioso. Tra il 1911 e il 1912 gira anche in Russia alcuni film di finzione di cui assume la direzione artistica. Vitrotti parte volontario negli anni della guerra mondiale e diventa operatore presso la sezione cinematografica dell’esercito . Mentre il cinema di finzione si muove cercando di sintonizzarsi con le forme, i metri e i ritmi dell’opera lirica, delle arti applicate, della letteratura e del teatro, il documentario punta decisamente il proprio obiettivo verso i modi in cui la società italiana entra nella modernizzazione. Dalla rappresentazione del lavoro all’interno delle cartiere o delle fabbriche o dell’industria automobilistica o bellica, al contatto ravvicinato con le grandi macchine che sostituiscono il lavoro manuale. Nel grande sforzo che compie l’industria di utilizzare tutte le possibilità del cinema, il fatto che operatori cinematografici come Vitrotti, Florio, Omegna siano anche gli operatori dei maggiori film di finzione favorisce quella circolazione e quella dinamica dell’uso della macchina da presa che porta alla continua esplorazione delle possibilità espressive del mezzo. Tuttavia, mentre nei documentari gli operatori sono autori del testo visivo, nei film il loro ruolo viene dimensionato e il loro occhio diventa l’esecutore di uno sguardo altrui. Al limite, come già aveva colto nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore Luigi Pirandello, il loro ruolo diventa quello di «un braccio che gira la manovella» . È evidente che, nel momento in cui la figura del «direttore artistico» comincia ad assumere un ruolo creativo, finora di pertinenza dell’operatore, il processo di produzione muta profondamente e si cerca di giungere a una più precisa specializzazione e definizione dei ruoli. Ciò non impedisce che se l’operatore nel film è l’esecutore di una volontà, nel documentario egli riesca, almeno fino a un certo punto, a creare le sue regole, né più né meno che nel cinema di finzione. Quando noi vediamo un documentario del 1914, Elezione di Benedetto XIV, ci accorgiamo che l’ordine delle scene e sequenze presuppone già un ordine di racconto con un uso consapevole delle strutture retoriche, ripetizione delle medesime inquadrature e variazioni fino a giungere all’apoteosi con la macchina da presa che sale verso il balcone in San Pietro – dove avviene l’apparizione – e poi si eleva verso il cielo. L’estrema mobilità della macchina da presa è connessa all’idea del cinema come testimonianza diretta, come trasmissione di un’esperienza interna ai fatti. Ciò creerà dei problemi durante la guerra, quando si tratterà di adattare i materiali di ripresa dai vari fronti a un occhio onniveggente, che intende selezionare solo alcune realtà in funzione propagandistica. Se per un certo periodo il cinema documentario aveva scoperto di non aver limiti, dall’inizio della guerra scopre che la visione non è affatto libera. Proprio sui documentari di guerra si comincia ad applicare la logica di mistificazione della notizia, la costruzione dell’informazione subordinata alle versioni ufficiali di descrizione degli avvenimenti. Lo sguardo dell’operatore, testimone e protagonista, viene deprivato ulteriormente delle proprie capacità di guardare: a partire dai film di guerra il mito dell’obiettività documentaria riceve un colpo decisivo. L’operatore non solo vede annullata la propria individualità, ma si trova ad adattare il proprio lavoro e il modo della sua visione a verità precostituite e a un senso già dato, utile per l’interpretazione di qualsiasi rappresentazione. Paradossalmente, la guerra, che sembra offrire all’operatore il massimo di documentazione e di rischio, ne limita e neutralizza la visione e decreta la fine di una figura di autore e di protagonista del primo cinema, ridimensionandone anche su questo piano le funzioni, e assoggettandolo a uno sguardo che usa i valori della visione come una delle tante forme di comunicazione di medesimi testi e medesimi messaggi. 82
83
lo splendore del vero Il filone naturalista e verista che ha i suoi punti culminanti in Sperduti nel buio di Martoglio e Assunta Spina di Serena si pone – nella tradizione critica del dopoguerra – come un modello antitetico rispetto sia alla tradizione del film storico che a quella del filone decadentistico simbolista e dannunziano. «Sul terreno del
cinema – scrive Lizzani – lo scontro tra le due correnti culturali che predominano nel paese, il dannunzianesimo e il verismo, è dunque offuscato, fin dall’inizio, dalla superiorità schiacciante di una di esse. La scuola verista non riesce a esercitare nel cinema italiano un’influenza così determinante come quella dannunziana anche perché il duello è già deciso in partenza» . In realtà la cultura naturalista era già stata sconfitta sul piano artistico e letterario da alcuni decenni e non si può parlare certo di scontro tra due correnti antagoniste. Anche se di importanza capitale le opere di Martoglio e Serena nel quadro culturale generale sono da considerare come manifestazioni epigoniche del verismo. In ogni caso quello di Lizzani è il discorso comune di una tradizione critica che ne ha certo mitizzato l’importanza in funzione della scoperta degli antecedenti del neorealismo e della continuità di una grande linea di cultura nazionale che affonda le sue radici nella pittura del seicento (Caravaggio) e giunge a saldare l’opera dei maggiori rappresentanti del verismo con il cinema . Del film di Martoglio (trasportato in Germania dai nazisti con centinaia di pellicole nel 1943) ci si deve limitare alle indicazioni già fornite da Barbaro nel 1936 e poi riprese a lungo nel dopoguerra senza variazioni sostanziali, mentre, oltre al film di Serena, un piccolo gruppo di opere offre un quadro abbastanza significativo dello spazio occupato da questo tipo di produzione e delle sue intenzioni. Rispetto ai livelli più alti le opere che si possono far appartenere al filone verista presentano caratteri distintivi marcati: c’è in generale un capovolgimento di giudizio, il mondo dei ricchi non è più una realtà distante e positiva, o tale da costituire un transfert per il desiderio e le frustrazioni del pubblico piccolo e medio-borghese, quanto piuttosto è il mondo in cui si raccolgono tutti gli elementi negativi che una morale manichea assai semplificata contrappone alla purezza del mondo popolare. Non viene però ipotizzato alcun mutamento dei rapporti sociali: si denunciano le ingiustizie, in molti casi se ne attua un risarcimento, ma, in generale, non viene affrontato mai un discorso socialmente avanzato né tanto meno sposata un’ipotesi rivoluzionaria o di mutamento che non sia deciso da una superiore volontà provvidenziale. Non è possibile rintracciare un legame diretto nella produzione verista tra realtà e rappresentazione. La categoria del realismo va quindi applicata con molta cautela, in quanto non è certo l’immagine dell’italiano dei primi del Novecento quella che il cinema riflette nelle sue forme drammatiche e con tutta probabilità neppure in quelle documentaristiche. Si tratta, nei documentari, di rappresentare alcune forme di vita associativa dell’italiano, di partecipazione al sociale, come le messe, le fiere, le passeggiate e i divertimenti domenicali, senza peraltro giungere mai alla rappresentazione del mondo del lavoro, della realtà della vita nelle fabbriche e nelle campagne. Mentre per i film drammatici la rappresentazione viene effettuata ricorrendo a strutture narrative e stereotipi propri della letteratura ottocentesca, in cui la morale vincente è sempre e comunque di tipo edificante e consolatorio e la protesta non assume i toni della denuncia e della rivolta, quanto piuttosto quelli dell’accettazione fatalistica del proprio destino. Per vedere l’origine del genere ci si deve dunque ricollegare a quel filone di drammi sociali di cui si è parlato all’inizio del capitolo, vedendo come vada, poco alla volta, diminuendo l’elemento patetico, e lo sfondo partecipi in misura più diretta all’azione e diventi l’elemento drammatico fondamentale. Nella geografia del cinema italiano il paesaggio napoletano è quello che in modo più netto diventa protagonista, elemento chiave del dramma. Assieme a uno spirito molto conservativo per quanto riguarda l’impianto narrativo si sviluppa con prepotenza una specie di «volontà delle cose» che di volta in volta contribuisce a fornire un valore aggiunto originale allo stereotipo narrativo. Il sistema di gioco di specchi mediante il quale la macchina da presa giunge alla rappresentazione solo attraverso una serie di scomposizioni e deformazioni del reale fa sì che l’impatto con la realtà non assuma quasi mai un carattere di particolare violenza e, nel caso in cui la violenza sia oggetto di rappresentazione, la causa dipenda in prevalenza da motivi individuali più che sociali. Nei film che lasciano entrare in misura maggiore la realtà sociale, il testo o l’intreccio non sono condizionati dal contesto. Lo sviluppo drammatico dipende spesso da motivazioni individuali. La forte spinta che viene dal desiderio conoscitivo provocato dal dinamismo degli operatori, la superiorità della verità cinematografica rispetto alla finzione teatrale, fanno si che le categorie di verità e realtà siano estese anche ai film di finzione e ne diventino strutture portanti. La maggiore presenza o vocazione realistica la possiamo già riconoscere in alcune produzioni napoletane, come quelle della Dora, in cui, oltre alla capacità di tradurre in racconto, con perfetto tempismo, fatti storici contemporanei (La guerra italo-turca fra scugnizzi napoletani) e di realizzare melodrammi di denuncia sociale a forti tinte, si riesce anche a essere presenti nei fatti di cronaca, usando il cinema come strumento analogo a 84
85
quello dei cantastorie (penso al film dal vero di 160 metri, Cattura di un pazzo a Bagnoli). Nel ricostruire tutto il materiale visivo che entra da soggetto dell’azione nei film napoletani Paolella rivendica anche la specificità di una cultura che si collega all’anima e agli influssi dell’arte spagnola, sia nelle riproduzioni di ambienti, sia spesso nella costruzione di storie sulla falsariga del racconto picaresco: «Gli altari carichi di ex voto e le luminose mense nuziali, i traballanti carri di Piedigrotta e le tumultuose processioni di santi, le arcate aperte sul mare della trattoria di Posillipo e le lunghe sequenze di pietra dei chiostri e dei monasteri, i vertiginosi trofei natalizi e le tombe liberty fresco infiorate, i tiri impennacchiati di Montevergine e i carri funebri capricciosamente intagliati. E ancora nel minuto dettaglio degli oggetti che intervenivano nei film: la collana, lo scapolare, la maschera, il teschio, l’amuleto, la reliquia» . Nella produzione napoletana assai spesso i modelli narrativi di derivazione popolare lasciano dunque largo spazio alla visione della realtà. La povertà produttiva favorisce che lo sguardo insista su un reale che spesso non consente soluzioni zuccherose e consolatorie. Nella produzione Cines, Ambrosio, Aquila, Pasquali, si affrontano certamente problemi sociali ma si ha l’impressione che, come tendenza dominante, venga mantenuta l’ambigua separazione tra sfondo e intreccio. Il realismo può servire (come nei Due macchinisti, Cines, 1913) a produrre effetti drammatici (la locomotiva che passa sulle gambe di un macchinista, la strage degli operai investiti sui binari dal treno in corsa, il suicidio finale del colpevole). Ma gli sfondi proletari non sono sufficienti a promuovere a protagonisti della scena nuovi soggetti sociali, ancora privi di certificazione all’anagrafe storica. Il dramma popolare può comunque rappresentare le traversie di personaggi e quella sorta di calvario morale e di purificazione che si trovava già nella grande letteratura popolare dell’Ottocento (si pensi ai Miserabili). Saranno piuttosto le masse dei grandi film storici che, partendo dalla guerra di Troia e muovendosi lungo vari millenni, giungeranno a far sentire la loro presenza e pressione anche sulla scena contemporanea, senza riuscire però a impadronirsene del tutto. Il cinema napoletano occupa una posizione di rilievo nella produzione a carattere realistico e a questa sua scelta, di carattere generale, contribuiscono sia i fattori produttivi (la povertà dei mezzi, la possibilità di utilizzare gratuitamente le risorse naturali) sia vere e proprie scelte culturali e ideologiche. Questa produzione è popolare, ma sposa solo in parte il punto di vista della classe a cui si rivolge. Lontana dalle intenzioni edificanti della contemporanea produzione torinese o romana si muove anch’essa nella rappresentazione dei suoi drammi entro le coordinate tradizionali della colpa e della pena. Col cuore, tuttavia, gli autori di questi film sono vicini al traviamento dei loro protagonisti, ne sentono e comprendono le ragioni, e la moralità che conclude assai spesso le opere ancora visibili è più un pedaggio d’obbligo alla moralità e alla censura giolittiana che un’esigenza scaturita dall’interno delle opere. Restano comunque fissi alcuni valori fondamentali quale quello del rapporto genitori-figli della dimensione da tragedia greca dell’amore materno e quello dell’amor patrio. La vicenda drammatica si intreccia sempre e rimane condizionata da questi valori più alti. Se confrontiamo lo sviluppo di questo cinema con quello del cinema nazionale coevo possiamo identificare dei tratti distintivi abbastanza netti: 1) la preoccupazione di conferire, al più presto, valori sinestetici all’immagine facendola parlare; 2) la capacità di conservare il proprio pubblico, anche quando la produzione nazionale non riesce più a comunicare né sul piano nazionale né su quello internazionale. I contenuti, i luoghi, le tecniche di racconto permangono nella produzione napoletana per un lungo numero d’anni. Tuttavia vi sono sempre in questi film, in misura forse maggiore che nella produzione centrosettentrionale, i segni della storia presente; 3) la realtà occupa uno spazio che non si limita a essere lo sfondo o il contesto casuale e interscambiabile dell’intreccio. La realtà e la storia trascinano con sé il senso dell’ideologia dell’autore: questo tipo di produzione ha sempre avuto una sua precisa funzione ideologica che si può cogliere senza eccessive perdite. La scrittura cinematografica povera riceve, dal contatto con la realtà sociale, notevoli spinte e produce scarti nel processo espressivo grazie proprio all’immissione violenta e costante del reale che provoca continue aggiunte autonome di senso. Questa produzione riesce a coniugare le trame e gli intrecci della letteratura popolare (storie di camorra, di perdizione morale, di passioni travolgenti, di eroismi disperati, di ingiustizie sociali e giudiziarie) con una rappresentazione che usa a tutto campo la città e mai in senso turistico. Il destinatario privilegiato è sempre e comunque il pubblico napoletano, come si è detto, per cui i soggetti 86
andranno dalla trascrizione visiva di canzoni popolari di successo, alla sceneggiata, al dramma in dialetto. In napoletano sono spesso le didascalie e gli attori recitano in mezzo a folle autentiche che si rispecchiano e raggiungono una immediata identificazione. I modelli narrativi privilegiati di riferimento sono i romanzi di Mastriani e Carolina Invernizio, e tra gli eroi vi sono maschere come quelle di Felice Sciosciammocca. Pur con la possibilità di identificare, nel quadro complessivo della produzione, alcune personalità più rilevanti (come Alberto degli Abbati, Ubaldo Maria Del Colle, Elvira Notari, Emanuele Rotondo) è possibile riconoscere dei tratti comuni a tutta una produzione, assai più difficilmente identificabili nella produzione romana o torinese. Il film napoletano non esce che di rado dalla rappresentazione del presente ed è un film popolare nella misura in cui presenta un punto di vista assai critico nei confronti delle istituzioni (la giustizia è sempre e solo vista nel suo carattere repressivo, i carabinieri sono onnipresenti, il carcere è il luogo dell’attesa dove, nonostante il passare degli anni, viene tenuta viva e intatta la passione). Una delle sue maggiori novità narrative è che si tratta di una produzione che declina in prevalenza al femminile le sue storie. Le donne attingono la loro forza direttamente dalla natura: Dora è la Figlia del Vesuvio, i suoi sentimenti hanno la durezza e la scabrosità della montagna vulcanica. In nessun’altra produzione i sentimenti femminili e la lotta per lasciare una traccia nella storia sono così centrali. Quanto ai luoghi essi vengono assunti come protagonisti della storia collettiva del popolo napoletano, dai vicoli e dai bassi al cimitero del Verano, dalla riviera di Chiaia al Vesuvio («dramma in 32 quadri, con scene importantissime, svoltesi con pericolo immenso attraverso le contrade più terribili e affascinanti […] del grande e maestoso Vesuvio» dice una pubblicità della Figlia del Vesuvio apparsa sulla «Vita cinematografica» nel 1912), dal porto alla funicolare, dal rione Sanità a Mergellina. Le storie di tradimenti, di colpe e pene espiate per tutta la vita, di nascite di figli illegittimi sono momenti naturali di vicende crude, spietate, di cui la morale religiosa o edificante non è sufficiente a coprire il senso. Inoltre la violenza e l’amore, il senso fisico del desiderio sono rappresentati nella loro immediatezza e brutalità e le ellissi narrative non nascondono certo ciò che avviene tra i personaggi. Non si procede per allusioni, o ambigue simbologie su nessun piano: le disgrazie, la miseria, la malattia, i debiti, i banchi di pegno, l’usura diventano momenti tipici di vicende che percorrono tutta una serie di tappe obbligate. Già nel 1914 Pepeniello (Napoli 1820) di Alberto degli Abbati mostra, sia pure in funzione nazionalistica (quel nazionalismo alla De Amicis che sembra la strada più sicura per riscuotere il consenso popolare), tutti gli elementi stilistici destinati poi a circolare come una sorta di lingua comune nella produzione successiva. La visione del mare, con la fuga dei prigionieri sulla scogliera, le luci negli esterni, l’utilizzazione di pescatori per trasmettere il senso di sentimenti alti e per dimostrare la partecipazione delle classi popolari alla guerra per l’indipendenza («sotto le umili vesti palpitano cuori traboccanti d’amor patrio»), la recitazione diretta e priva di esperienze teatrali fanno già di questo film un importante momento di formazione degli elementi realistici. Nel 1915 Gustavo Serena porta sullo schermo Assunta Spina di Salvatore Di Giacomo e si serve della recitazione di Francesca Bertini. C’è forse, rispetto ad altri film napoletani successivi, una certa angustia nello sguardo e la presenza dominante della recitazione naturalistica della Bertini che assoggetta e subordina tutti i motivi, ma è certo che con quest’opera il cinema intende dimostrare di avere le stesse possibilità espressive del teatro . Gli attori pronunciano e scandiscono visibilmente le battute del dramma di Di Giacomo, ma sono soprattutto lo sviluppo dei codici gestuali, l’immediatezza significativa raggiunta che consentono di recepire il senso delle battute dei personaggi, di cui, è bene ricordarlo, a certi livelli di pubblico si presupponeva una parallela conoscenza teatrale. Il cinema dispiega, proprio nella messa in scena di queste opere, il suo potere concorrenziale e le sue maggiori capacità di significazione generale rispetto al teatro. È vero che manca il sonoro, ma l’azione viene collocata in spazi reali, la macchina da presa acquista una sua mobilità e i personaggi riescono a portare a un livello ottimale la capacità del gesto di trasmettere qualsiasi senso, non solo di carattere alto ed enfatico, ma soprattutto di carattere assolutamente comune e banale. Si veda, in questo senso, la scena del pranzo a casa di Assunta dove i gesti dei personaggi, nella loro quotidianità, rendono perfettamente inutile la funzione delle didascalie: Michele che si toglie la giacca, il padre di Assunta 87
che si pulisce la bocca con la tovaglia, Assunta che serve a tavola, Michele che le porge una patata sono tutti gesti che costruiscono un insieme significante del tutto autonomo e sostitutivo della parola e della didascalia, che, ancora per anni, interviene a spezzare la continuità dell’azione, ma non riesce ad avere una funzione integrata nella struttura ritmica del film. Ma la grandezza del film non è solo negli elementi recitativi, quanto nella forza di interazione tra la presenza scenica di Francesca Bertini e la partecipazione attiva al dramma di tutti i luoghi che fanno da contesto naturale all’azione: i mercati del pesce, i vicoli, i ristoranti all’aperto… Quanto a Sperduti nel buio, in mancanza di prove in contrario, può ancora essere considerato come uno dei film più significativi di tutta la produzione del muto. Realizzato da Nino Martoglio per la Morgana film, che riesce a realizzare appena tre titoli, è un’opera che punta al massimo di intensificazione delle funzioni emotive ed espressive. Il film è girato interamente a Napoli e gli esterni giocano un decisivo ruolo nella drammatizzazione delle funzioni, ma il centro emotivo è dato dalla recitazione di Giovanni Grasso nel personaggio del cieco, Nunzio. «La cecità di Nunzio – scriverà più tardi lo stesso Bracco – simboleggiava il buio sociale in cui si perde, inutile, anche la forza fisica degli esseri umani, ignari, abbandonati a se stessi» . Per la sua forza espressiva, per la crudezza delle scene, la simpatia umana, il film ha sempre impressionato chi lo ha visto nell’anteguerra: «Negli esterni – ha scritto Umberto Barbaro – si sente il sole benigno e implacabile di Napoli che illumina, colla stessa crudezza, il frac di Vallenza e i cenci di Paolina, mettendo in rilievo la scelta particolarmente acuta delle scene, del vestiario e di tutti i dettagli […]. Con perfetta coerenza stilistica il realismo si accentua fino a divenire ossessione e a superare se stesso per farsi significato e simbolo» . L’anno successivo, e per la stessa casa Martoglio realizza un altro film di forte impronta naturalistica, Teresa Raquin, tratto dal romanzo omonimo di Émile Zola. Accanto a Giovanni Grasso questa volta Martoglio chiama una delle grandi protagoniste del teatro ottocentesco, Giacinta Pezzana. Meno osservato e valutato, perché non appartenente a una tradizione italiana, Teresa Raquin segna forse un più maturo e unitario esito espressivo dipendente dall’influenza indiretta anche di alcune opere della cinematografia danese e nordica . Per capire la continuità anche fisica della tradizione teatrale garantita dal passaggio degli attori dal teatro al cinema il caso di Giacinta Pezzana è esemplare, in quanto già quasi quarant’anni prima aveva riscosso un enorme successo per la sua interpretazione del medesimo personaggio della madre («La signora Pezzana, nella parte della madre che si direbbe scritta apposta per lei, si rivela in tutto lo splendore della sua potente intelligenza artistica» ). In quella lontana edizione dell’opera di Zola recitava Eleonora Duse, che, come la Pezzana, tenta, alla fine della sua carriera d’attrice, sull’esempio anche di Ermete Zacconi, o Ermete Novelli, di portare un suo attivo contributo alla trascrizione di Cenere di Febo Mari, tratto dal romanzo di Grazia Deledda. Sue sono le note e le proposte di riduzione del testo della scrittrice sarda, sua la scelta dell’atmosfera e della recitazione. Il romanzo della Deledda è ulteriormente caricato di motivi simbolici e le immagini documentarie, soprattutto iniziali, del lavoro contadino sono raccolte e sottoposte al valore rituale di ogni gesto e di ogni didascalia («Rosalia gli mise al collo la rezetta e gli raccomandò di non separarsene mai»). L’opera scorre su una base naturalistica, ma sviluppa rapidamente il suo tracciato simbolico facendo in modo che ogni gesto e ogni parola pesino con tutta la loro forza significante. La didascalia finale è il momento in cui tutto il senso si raccoglie e cerca di esprimere il senso del religioso fatalismo della scrittrice: «Tutto è cenere. La vita, la morte, l’uomo, il destino». Il gesto della Duse, ormai vecchia, cerca di raccogliere e trasmettere la complessità delle intenzioni della Deledda con un pudore e una straordinaria fotogenia: «La Duse – ha scritto Savio – è esitante e bellissima. Raggomitolata in una fotogenia che la snida, ella si rifugia nei campi medi e lunghi, sempre volge le spalle all’obiettivo, trattiene il gesto, mortifica l’espressione. Fuorché un primo piano, uno solo: dove, il candore dei capelli, gli occhi lucenti nelle orbite profonde, hanno una vibrazione protesa, come d’offerta: grumo di dolcezza estenuata, malinconico arrendersi alla vecchiezza, ma anche, da attrice, un farsi personaggio, un diventarlo per sempre» . L’influsso dannunziano estende la propria ombra anche sulla produzione naturalistica, producendo soluzioni ibride, mescolando codici diversi, facendo in modo che il mondo delle classi popolari venga rappresentato, ma secondo gli stereotipi di una letteratura ottocentesca e non secondo una rappresentazione più vicina al mondo del presente. La realtà contadina e operaia, i meccanismi dello sfruttamento del lavoro e la loro denuncia possono anche apparire, a patto però che si verifichino altrove. 88
89
90
91
92
L’emigrazione, che in quegli anni tocca le sue punte più alte, può divenire un tema privilegiato e un ottimo transfert entro cui riversare una più attenta denuncia di certi problemi dello sfruttamento operaio. In questo senso L’emigrante di Febo Mari con Ermete Zacconi (1915) acquista un valore esemplare: da una parte una rappresentazione molto viva del mondo popolare, dei mercati, della folla di emigranti, dello sfruttamento della manodopera, per la prima volta quantizzato dall’apparizione di un foglio paga con tutte le trattenute, dall’altra, ancora una volta una serie di intenzioni più enfatiche («La marra e la vanga paesane feconderanno le terre d’oltremare»). Ma la denuncia e la protesta sembrano prevalere («Si lavora una settimana per poco pane e poco denaro») e mostrare più da vicino il meccanismo dello sfruttamento, della corruzione (chi vuol ottenere un lavoro deve pagare una tangente), dell’indifferenza del mondo borghese verso quello proletario (l’emigrante dopo l’incidente è ancora inabile, ma viene dichiarato guarito e neppure risarcito). Il filone verista non va dunque molto al di là di questi esempi e tutto sommato mantiene un ruolo marginale nel sistema complessivo. Troppi sono i rischi, i tabù e le forze contro cui bisogna combattere per assicurare la circolazione di film a carattere scolastico: il cinema non è in grado di produrre un mutamento di coscienza civile e sociale e anche se in alcuni casi ci si avvicina al mondo popolare in modo non convenzionale, non si riesce mai a far assumere alla macchina da presa un punto di vista differente e diametralmente opposto a quello mantenuto per tutta questa prima fase. La naturale vocazione realistica viene così modificata di continuo e usata strumentalmente tanto che questi film possono anche a buon diritto costituire un filone, non vogliono entrare in concorrenza col filone storico o con quello della cultura simbolista o del decadentismo, ma piuttosto operano con un’azione in profondità, lasciando un segno destinato a riproporsi come modello vincente soltanto dopo trent’anni.
il clown in salotto Al polo opposto dei grandi drammi storici e del filone dannunziano, senza alcuna ambizione culturale, semplici prodotti di consumo immediato, le comiche finali hanno goduto di una breve, ma intensa stagione tra il 1909 e il 1915. La regolare somministrazione della comiche all’interno di uno spettacolo a forte componente drammatica aveva la funzione di un salutare antidoto contro il pericolo della celebrazione, della galvanizzazione prodotta dall’esaltazione delle virtù, dal culto degli eroi, dalla rappresentazione di imprese edificanti, circonfuse da un’aura ricca di echi e riflessi culturali. Se dal punto di vista narrativo la suddivisione in lunghe unità di narrazione (i quadri) voleva essere l’equivalente della suddivisione letteraria in capitoli o teatrale in atti e scene, il senso del ritmo è certamente la caratteristica più originale del film comico. Come premessa generale a una breve ricognizione soltanto orientativa nella miriade di titoli di comiche prodotte da tutte le case, si può dire che, proprio a questi livelli più bassi di racconto, nasce e si sviluppa la sintassi narrativa. Nei film comici domina l’azione e il racconto non ha bisogno né di informazioni che consentano il riconoscimento dei personaggi, né di elementi descrittivi, né del doppio sistema di rappresentazione (didascalia + immagine): la concatenazione degli inseguimenti, corse, equivoci, travestimenti, cadute, distruzioni non richiede anticipazioni verbali ed è immediatamente riconoscibile. Rimane statico l’uso della macchina da presa: il sistema si dinamizza non perché la macchina da presa assuma un ruolo attivo nella rappresentazione, quanto piuttosto perché la combinazione degli elementi (il montaggio, sia pure in una forma assolutamente spontanea) consente di capire la funzione sintattica e il potere dell’inclusione e dell’esclusione degli oggetti dall’immagine. Dietro alla macchina da presa, comunque, non c’è il soggetto che sceglie l’inquadratura e aggiunge significazione e pertanto non vi sono figure memorabili di registi di film comici nei primissimi anni: la produzione del comico rientra nella routine delle case di produzione ed è tutta di carattere scenico. Ogni casa di produzione ricorre al proprio comico e le «manifatture» più importanti ne possono ingaggiare più d’uno. Ernesto Vaser è uno dei primi attori di teatro che passa al cinema. Il suo successo è legato alla notorietà di attore del teatro dialettale piemontese e la diffusione dei suoi film prende di mira essenzialmente il pubblico locale. Ma in seguito, sia grazie al reclutamento di comici dall’estero, che allo sviluppo del settore, si convertono in molti al genere. Le comiche all’inizio sono legate a un’unica azione e alle sue possibili variazioni. La semplice apparizione dell’attore comico, e il suo riconoscimento da parte del pubblico, è già di per sé motivo di riso. Ma
evidentemente questo non basta: dopo una comica come Vaser perde il treno, che avrà un enorme successo, giungendo a vendere nella sola Inghilterra più di centoventi copie , l’azione si espande e nascono, dal 1907, diverse figure di comici specializzati. Orientarsi tra i loro nomi e riuscire a cogliere la specificità delle caratteristiche di ognuno non è facile, anche perché i materiali sopravvissuti ci documentano l’attività soltanto dei comici che hanno avuto maggiore fortuna. Volendo cercare di offrire una rosa di nomi e di case con l’aiuto delle filmografie esistenti ci si accorge che i nomi sono a decine. Aldo Bernardini e Vittorio Martinelli hanno stabilito una prima filmografia nel 1985 di quarantun attori. L’Ambrosio ha Robinet (Marcel Fabre), la Cines Tontolini (Ferdinand Guillaume) che passerà nel 1912 alla Pasquali col nome di Polidor . I film di Tontolini sono diretti da Giulio Antamoro . All’Itala recita, col nome di Cretinetti, un altro comico francese, André Deed . Prima dell’avvento dei comici tutte le case, sulla scorta del non dimenticato Arroseur arrosé, sviluppano, in un primo tempo, la scenetta comica, senza protagonista destinato a riapparire in veri e propri cicli. Gli argomenti sono molto vari e possono spaziare dal Cane delinquente o Cane poliziotto dell’Ambrosio, all’Asino poliziotto della stessa casa, dalla Scimmia dentista della Cines alla Statua vivente dell’Aquila, o alla Prima uscita di un ciclista della napoletana Cinematografi riuniti. Per produrre il riso basta sviluppare un’azione in progressione catastrofica, introdurre un elemento di disordine in uno spazio o una realtà nota. Questo principio rimane anche quando le figure dei comici specializzeranno, in un certo senso, i tipi di comicità. Accanto ai nomi appena ricordati, che sono anche quelli più importanti dei comici del periodo, il numero di figure secondarie è molto numeroso: all’Ambrosio, oltre a Fricot (Vaser), appaiono Boutalin, Barilot, Firulí, Grosslard, alla Pasquali c’è Ghiringhelli, alla Cines Lea (Lea Giunchi), Cocò (Pacifico Aquilanti), Kri-Kri (Giuseppe Gambardella), all’Aquila Jolicoeur (Armando Gelsomini), Pik Nik (Armando Fineschi), all’Itala Totò (Emilio Vardannes), alla Unitas Rococò (Eusebio Cavalloni), alla Milano Films Cocciutelli (E. Monthus). I titoli di questi film identificano subito il comico e per lo più mediante una semplice coppia di elementi fissano anche il tema: Cocò va soldato, Cocò e il terremoto, Jolicoeur ama il ballo, il salto, la boxe, Ravioli impara a pattinare, Boutalin aeronauta e astronauta, Lea domatrice, Lea e il gomitolo, Lea sui pattini, Cocciutelli eredita, Kri-Kri e il salame, Kri-Kri e il duello, La farfalla di Totò, ecc. Come ha indicato Pantieri i comici provengono dalle «diverse branche dello spettacolo e di conseguenza […] si sono serviti dei mezzi e delle tecniche acquisite nelle precedenti esperienze» . In una prima fase – dal 1908 al 1913 – i comici che lavorano in Italia e, in particolare, Deed ottengono un grandissimo successo in tutto il mondo. Cretinetti è con ogni probabilità il responsabile della fortuna iniziale dell’Itala film e della sua espansione commerciale nei mercati nord e sudamericani. Tuttavia, anche se la produzione comica italiana può contare su centinaia di titoli, il lavoro delle decine di comici non riesce a trasformarsi e a evolvere producendo un’esperienza simile a quella di Keaton, Chaplin, Mack Sennett, ecc. Nessuno dei comici che lavorano in Italia tenta la scalata di vertici del sistema produttivo: le loro figure non sono antagonistiche rispetto al sistema in cui si muovono e non intendono trasgredire, né rovesciare cerimoniali e riti sociali. Il comico italiano accetta il gioco delle parti sociali e produttive e non disdegna di volersi dare obiettivi drammatici. Certo la debolezza costituzionale dell’industria italiana, unita alla sottovalutazione delle possibilità di nobilitare il genere e di promuoverlo dal livello di appendice dello spettacolo a forma di spettacolo autonomo e concorrenziale, fa sì che questo filone, pur estremamente povero, sia uno dei primi a subire le conseguenze della crisi bellica. Ognuno dei comici più importanti ha, come si diceva, alle spalle una tradizione diversa: Guillaume il circo , Deed riesce a introdurre un tipo di comicità surreale, Fabre opta per una comicità più sofisticata e intellettuale e come Deed passa dal cortometraggio al lungometraggio con, Le avventure straordinarissime di Saturnino Farandola, 1913, che traduce sullo schermo l’invenzione grafica di Robida , e parodizza i romanzi di Verne. Giustamente Antonio Costa ha riportato l’attenzione su questo film visibile, ma finora ingiustamente trascurato dagli storici del cinema muto, me compreso. In effetti il film di Fabre cerca di aprire una strada al cinema fantastico poco praticata dal cinema italiano di quegli anni e dal cinema italiano in generale. Ma nel concentrare la sua invenzione sulle meraviglie piuttosto che sulle nuove dinamiche espressive e del racconto fa regredire la macchina narrativa di qualche anno, avvicinandosi più a Méliès che alle nuove frontiere aperte da Segundo de Chomòn. In questo ampio universo narrativo è introdotta, come elemento comune, una 93
94
95
96
97
98
99
100
morale di tipo popolare che fa da contrappeso alla morale dei film drammatici, propinati in genere per tutta la prima parte del programma: la morale è quella dell’esaltazione del caos, del disordine, dell’irriverenza verso ogni forma di autorità costituita, dello sberleffo continuo al potere e alle istituzioni. Le situazioni topiche sono abbastanza limitate: lo sport, il nuoto o i pattini sono una vera fucina di situazioni comiche a catena, poi le cerimonie ufficiali (matrimonio, fidanzamento, pranzi e ricevimenti), i rapporti con le donne, i rituali dell’alta società, i duelli, la tecnologia, i mezzi di locomozione. Mentre le comiche di Sennett sintonizzano i loro ritmi sui tempi del motore a scoppio i comici italiani sono ancora legati a un tipo di rappresentazione il cui tempo è scandito dalle cerimonie e dai rituali borghesi. I comici intendono portare disordine e sconvolgimento all’interno di sistemi di gesti fortemente codificati. La comicità, per lo più dovendo scegliere tra i due sessi, è antifemminista: le donne fanno le spese nel comico delle origini. E quando diventano protagoniste (vedi Lea e il suo Lea e il gomitolo) hanno a disposizione mezzi assai limitati e si basano su una comicità più prevedibile. Cretinetti esordisce utilizzando le esperienze del cinema francese e la comicità delle féeries di Méliès (Come fu che l’ingordigia rovinò il Natale a Cretinetti). Tra tutti i comici del primo cinema italiano Deed è senz’altro il più duttile: gli effetti della sua comicità sono prodotti ora dalla situazione, ora dall’azione, dalla mimica, dal ruolo degli oggetti (Cretinetti ha rubato un tappeto, Il Natale di Cretinetti, Cretinetti e l’ago, I tacchi di Cretinetti), e non ultimo dall’utilizzazione dei trucchi. La comica, da pura espansione di una sola idea, sviluppata sino alle estreme conseguenze, evolve, grazie anche a lui, verso un racconto più sofisticato e approda, nelle forme migliori, alla pochade o al racconto surreale. Labiche, Meilach hanno in comici come Deed, ma anche non sono da meno Polidor e Robinet, interpreti ottimi dello spirito delle loro opere. Cretinetti può essere alle prese con le donne che lo desiderano in massa per la sua eleganza ed essere in seguito fatto completamente a pezzi dopo un frenetico inseguimento (Cretinetti e le donne), anticipando di quindici anni la scena finale di Le sette probabilità con Buster Keaton, oppure, figlio birichino di uno scienziato, divertirsi con l’elettricità e far ballare e mandare coi piedi appesi al soffitto un’intera squadra di poliziotti (L’ultima monelleria di Cretinetti), oppure allenarsi per il suo primo duello. La sfida alla morte dei comici americani non è mai raccolta da quelli italiani: i drammi e i pericoli per loro possono nascere dalle scarpe di vernice troppo strette, da un ago dimenticato nel fondo dei calzoni, da un oggetto caduto nella scollatura di una signora, dalle attenzioni eccessive di donne nerborute e gigantesche. Il momento in cui Deed rinuncia al suo personaggio per assumere il ruolo di Pinocchio nel film omonimo del 1910, il comico esce dal suo territorio limitato e recita in un’opera che ha la dignità di un qualsiasi altro romanzo riproposto dal cinema. Il film reinventa una parte del romanzo (l’episodio degli Indios che fanno prigionieri Pinocchio e Geppetto e nominano Pinocchio capo della tribù). Gli episodi sono mescolati tra loro molto liberamente. La morale finale è in linea con quella di molti drammi sociali contemporanei, il mutamento di Pinocchio, grazie al suo lavoro, non è da burattino a uomo, ma da proletario a piccolo borghese. È questo il sogno di classe che il cinema fa balenare e dichiara possibile a prezzo di lunghi sacrifici e di un durissimo lavoro. Polidor si trova in una serie di situazioni altrettanto ricche che nascono da una precisa intenzione di ridicolizzare i comportamenti borghesi: in Polidor senza colletto deve procurarsi un colletto per lavorare. Prima lo va a chiedere in drogheria, poi cerca di assalire i passanti, poi lo ruba a una ragazza fingendo di corteggiarla e infine, con una progressione distruttiva irresistibile, lo trova in un negozio di colletti dopo averlo completamente buttato sottosopra. I motivi della distruzione vanno di pari passo con quelli dell’inseguimento e delle torte in faccia nelle comiche «iniziali» di tutti i tempi e di tutte le cinematografie. La torta in faccia è già nelle prime comiche Cines (La vendetta del groom, 1909) ed è uno dei procedimenti che rendono la comicità del cinema più contigua a quella del circo tra tutte le forme di spettacolo. In Polidor ha rubato l’oca, Polidor distrugge, con un’oca nascosta sotto il cappotto, tutta una cerimonia di un pranzo di nozze. Dalla folla inferocita di inseguitori si salva montando a cavallo dell’oca che lo fa volare. La componente surreale ante litteram spinge sempre più la comica, all’inizio costruita entro i binari della esasperazione di situazioni tutto sommato prevedibili, in una direzione che giunge fino all’impossibile e all’assurdo . Le centinaia di titoli oggi disponibili consentono di muoverci con una certa sicurezza entro un mondo di maschere in apparenza simili e intercambiabili. Grazie alla ricchezza dei testi è possibile distinguere le varie 101
identità, definirne caratteristiche genetiche e tipologie gestuali e seguirne l’evoluzione all’interno dell’insieme narrativo. Tra le comiche di Robinet degna di essere ricordata per la sua genialità è Amor pedestre del 1914 interamente costruita su una rigorosa applicazione del procedimento di rappresentazione della parte per il tutto. L’incontro, il corteggiamento («Signorina, i vostri piedini mi hanno incantato. Fatemi felice, vi attendo questa sera a casa mia») e il raggiungimento finale dello scopo, dopo un duello col marito della donna, sono interamente rappresentati attraverso la visione dei piedi dei personaggi. È questo con ogni probabilità il punto d’incontro culturalmente più alto della comica con le ricerche espressive parallele condotte dalle avanguardie. Le analogie di questo film con Le basi o con altri drammi di Marinetti quasi contemporanei sono state più volte messe giustamente in luce . La possibilità di visionare centinaia di titoli che i ritrovamenti più recenti hanno offerto ha messo in evidenza anche la componente erotica, il gusto per il doppio senso, l’allusione oscena, lo scambio dei ruoli sessuali, il travestitismo, il voyeurismo, l’adozione e metabolizzazione di situazioni scabrose o trasgressive proprie del vaudeville e della pochade contemporanea. In molte comiche il riso è provocato soprattutto dalla volontà di spingersi visivamente fino alle soglie di un tabù e della possibilità di aggirare divieti invalicabili per gli altri generi cinematografici. André Deed può godere, quasi al punto d’arrivo del genere, della regia di Pastrone per Cretinetti e gli aeromobili nemici, che si collega a un preciso avvenimento della guerra mondiale, e qualche tempo prima tenta di uscire dallo spazio subalterno della comica di dieci minuti per misurarsi col lungometraggio (Cretinetti e gli stivali del brasiliano). Qualche anno dopo, di ritorno in Italia realizza nel 1921 L’uomo meccanico che attinge per i motivi drammatici e narrativi, il ritmo dell’azione e i meccanismi dell’intreccio ai serial, ma introduce curiosamente temi che sembrano anticipare l’immaginazione visionaria di Fritz Lang e Thea von Harbou. In realtà il 1915 è la data oltre la quale il cinema comico viene spazzato dalla crisi economica e dalla concorrenza americana e fa, per primo, le spese della ristrutturazione dell’industria cinematografica che punta tutte le sue carte sui generi drammatici e sul divismo. La scomparsa del comico non è dovuta, in ogni caso, al sorgere di un’improvvisa esigenza di serietà e moralizzazione nel pubblico, quanto anche dal senso di saturazione di un tipo di comicità che non aveva saputo rinnovarsi al ritmo dell’evoluzione linguistica del cinema. «Verso il 1916 – scrive Pantieri – un avvenimento inferse un brutto colpo all’industria comica italiana: facevano il loro trionfale ingresso in Italia le prime comiche di Charlot e verso il 1918 quelle di Ridolini» . In realtà, come in molte altre occasioni anche per Charlot la critica cinematografica, in modo molto ottuso, non è stata in grado di intuire la rivoluzione introdotta nell’universo del comico. Sulla rivista napoletana «Film» possiamo trovare, nel 1915, questa breve ma esemplare affermazione: «Tutti sanno la miseranda fine trovata nei paesi latini da quelle lunghe comiche che pure hanno reso celebre oltre oceano Charlie Chaplin. In Italia non è possibile introdurre con successo una sola delle film di Chaplin». 102
103
i fuochi delle passioni Tra il 1910 e il 1914 assesta anche il suo standard ideologico e narrativo quel genere dai contorni piuttosto ampi che potremmo definire come dramma borghese. Questo genere agisce con una funzione di cerniera tra le opere più ambiziosamente ispirate al decadentismo e quelle legate al verismo e appare come il più capace contenitore di racconto in quanto vi entrano e si sovrappongono tutti i codici possibili. Si penetra nella vita comune, ma si intersecano i motivi della scienza alla cultura liberty e simbolista e quelli dell’arte, le leggi economiche e le affinità elettive. Grazie alla presenza e all’osservazione continua di alcuni ambienti si possono osservare i momenti obbligati dei riti di vita della società medio-borghese, le feste, i ricevimenti, gli incontri in località turistiche, a teatro, al concerto, all’opera… Il dramma borghese o forse più propriamente il dramma della cultura simbolista – in fondo – rimane più di tutti gli altri generi legato ai codici del teatro e non cerca di creare un sistema espressivo con forti tratti distintivi anche se sarà proprio questo genere quello che favorirà la circolazione di una sorta di «lingua franca», di lessico, morfologie, iconologie e topologie narrative
più facilmente riproducibili e trasmissibili da una cinematografia all’altra. Il punto di vista della macchina da presa è quello fisso dello spettatore teatrale: gli attori entrano ed escono di scena rivolgendosi al pubblico. Per il gioco dei vasi comunicanti finora osservato un intero repertorio teatrale passa al cinema nel giro di pochi anni, con tutti i suoi interpreti, tecnici e moduli espressivi e recitativi. La tecnica è comune sia agli attori del film comico (Cretinetti, ma anche Vaser nella deliziosa commedia La Meridiana del convento), che a quelli dei film storici o di ispirazione naturalistica. Il teatro naturalista accetta senza traumi il cinema: gli attori si trovano a loro agio (vedi Ermete Zacconi, Ermete Novelli) nella commedia borghese che consente di valorizzare al massimo il potere del gesto e della mimica facciale. Rispetto ai film di carattere storico nei quali la recitazione alta impone la presenza complessiva dello spazio e di tutta la simbolizzazione degli oggetti che entrano a farne parte, sia il dramma borghese che quello naturalista facilitano l’avvicinamento della macchina da presa all’attore e la drammatizzazione avviene a partire dal gesto comune (vedi il dettaglio della mano di Ermete Zacconi che si fascia accuratamente il braccio in un film dell’Itala del 1912 intitolato La vendetta del destino: proprio un tipo di recitazione come quella di Zacconi ci fa cogliere come l’obiettivo della macchina da presa sia risucchiato dal gesto dell’attore, venga obbligato a stabilire un rapporto più ravvicinato). Alla fine molto spesso l’attore principale, come a teatro, esce su un palcoscenico e si inchina verso il pubblico nel gesto di riceverne gli applausi. Non è detto che siano questi i film che più riescono a raggiungere l’identificazione con la cultura del destinatario borghese, ma è certo che tutto il sistema scenografico, la disposizione degli oggetti, la centralità delle figure nello spazio, la frontalità della recitazione, l’avvicinamento lento della macchina da presa e il mantenimento di tutte le convenzioni teatrali, fanno di molte di queste opere l’esatto corrispettivo di trascrizione cinematografica del teatro borghese. C’è comunque una dinamica ideologica ed espressiva interna da non trascurare. Se prendiamo come termine iniziale un dramma come la Sirena dell’Ambrosio (1910) e lo facciamo rientrare, anche se il suo protagonista è un pescatore, in questa fascia di racconto ci accorgiamo che il vero tema è quello della difesa di un valore borghese fondamentale, quello della famiglia. All’ingenua condanna della donna in veste di ammaliatrice che un sano richiamo ai doveri familiari può ancora esorcizzare, fa riscontro, poco alla volta, una definizione della donna che trasforma il suo volto e, pur incarnando molto spesso i simboli del male, alla fine trionfa. Alla letteratura edificante si viene sostituendo, mediante alcune modifiche di ruoli e funzioni, la letteratura dannunziana e liberty, ma il punto di vista e la morale di fondo restano quelli del destinatario borghese. Già nel 1912, al di fuori dell’influsso specifico del dannunzianesimo si comincia sempre più a diffondere, prima ancora che si formi il fenomeno divistico, il mito della donna ammaliatrice e divoratrice. Dapprima è dunque una sirena o un’Eva tentatrice, da cui ci si può ancora liberare, poi progressivamente diventa, per via di continue metamorfosi, un uccello rapace, un felino, una sorta di serpe che avvinghia la vittima nelle sue spire impedendole di liberarsi, e colpendo a tutti i livelli di classe (si veda la pubblicità di Nelly la domatrice, opera dell’Ambrosio del 1912: «Nelly, la piccola fragile creatura, non esercita soltanto un fascino irresistibile di maliarda sulle fiere che ammansa, ma suscita, con l’irrequieta avvenenza delle sue forme, con l’intrepido gioco di giovinezza che le brucia nei grandi occhi neri, violente passioni nei cuori degli uomini») . Grazie a un continuo gioco di metamorfosi la donna appare come una variante di decine di animali da preda, un essere dotato di carne e sangue e una creatura incorporea, un’apparizione evanescente (come si può vedere già in alcuni titoli di Roberto Roberti: Meteora, La preda, La dominatrice, Chimera). Il dramma borghese sembra dunque evolvere, in via naturale, verso un tipo di letteratura più ambiziosa e, in questo passaggio e trasformazione, gioca un ruolo decisivo la presenza della narrativa e del teatro dannunziano che si comincia a portare al cinema dal 1912. Il perbenismo e moralismo si scontrano con tensioni sempre più forti e cercano di sostituire, nell’immaginario piccolo e medio-borghese, a un mondo di valori stabili e accettati un altro mondo di valori più fragili, continuamente esposti e facilmente aggredibili dall’attacco di corpi estranei. La morale della Signora delle camelie (ve ne sono due versioni, una con Hesperia e una con Francesca Bertini) viene certo dal teatro ottocentesco, ma l’enfasi della didascalia del film del 1915 con Hesperia sottolinea anche la ricerca di un nuovo modo di essere da parte della donna: «Io voglio essere libera di fare ciò che voglio senza dare alcuna spiegazione della mia vita». Questa battuta potrebbe essere l’epigrafe o il motto araldico di alcune eroine del cinema italiano, che con tutti i mezzi cercano di emanciparsi e sono per lo più destinate immancabilmente alla sconfitta. 104
Quando il punto di vista è più decisamente popolare, al mondo borghese può essere addebitata la corruzione, la doppia vita, secondo le regole del romanzo popolare ottocentesco, quando invece il punto di vista e il destinatario sono borghesi, il desiderio e il transfert avvengono a un livello sociale più alto. I modi e i modelli di vita che il cinema italiano propone a cavallo della guerra mondiale sono evidentemente pressoché irraggiungibili e inimitabili per le masse di spettatori, ma creano comunque ondate di desiderio e processi di identificazione senza eguali nello spettacolo. C’è una sorta di slittamento progressivo che porta, negli anni di guerra, all’egemonia dell’opera di derivazione dannunziana. In questa fase intermedia, comunque, le passioni e il vizio appaiono non circondati da alcun alone di maledettismo, ma si collocano in una dimensione quotidiana: la stessa apparizione della droga (l’oppio per lenire il dolore in Lavendetta del destino, ma anche la misteriosa medicina di Tigre reale, 1916, che è tenuta dal medico nella cristalliera del soggiorno, accanto alla bottiglia di rosolio). Il filone dei film derivati dalla letteratura del decadentismo, dalla poesia simbolista, e che da D’Annunzio giungono fino a Bataille, forma un sistema ideologico ed espressivo compatto quanto quello del genere storico, e altrettanto fittizio. A differenza del filone storico più legato a radici nazionali questo filone deve il suo successo ai suoi caratteri sovranazionali, alla sua capacità di parlare un lessico e di mettere in scena riti e comportamenti propri di un intero mondo che la guerra cancellerà di colpo. Il cinema che rappresenta il mondo delle grandi passioni, e nel quale raggiunge il suo massimo successo il fenomeno divistico, inizia a costituirsi come genere attorno al 1913-14 e si spinge almeno fino all’avvento del fascismo, incurante della situazione storica, accumulando titoli su titoli e proponendo l’immagine di una società sempre più marginale, sempre più appartenente a una letteratura spazzata dalla guerra. I drammi di amore e di morte, di passioni sfrenate e totali provengono però non soltanto dalla letteratura dannunziana e decadente, ma anche dal melodramma e dalla letteratura popolare con cui si mescolano liberamente. Le situazioni descritte sono però sempre estreme e non consentono mediazioni di alcun tipo. La passione fatale non è più cantata come nell’opera lirica o nel melodramma, ma rappresentata. Le didascalie non bastano più e il sistema evolve sia per esigenze di allargamento del proprio spazio di rappresentazione, sia per cogliere ed esprimere, grazie all’occhio ravvicinato della macchina da presa, una serie di nuovi sentimenti che impongono una trasformazione sia del gesto che dell’uso del corpo. Nell’insieme il corpo trasmette, per quanto riguarda le dive, fasci di messaggi erotici, di un erotismo che costituisce l’esatto equivalente dell’erotismo letterario e della letteratura liberty. In questo senso gli aspetti dominanti da cogliere non riguardano tanto la regia di questi film, quanto l’importanza del sistema comunicativo ed espressivo del corpo: dall’uso del corpo, dall’elaborazione autonoma di un linguaggio che riprende e ripropone i moduli figurativi della grafica, del cartellonismo (si pensi soltanto a Mucha), della pittura si riconosce la presenza e l’influenza di tutto un contesto culturale e letterario e la congruenza di più codici. La regia di Salomè o alcune messe in scena teatrali sono i presupposti e le basi da cui parte il gesto cinematografico di alcune grandi dive del periodo. Quanto al dramma, se anche trova la sua cornice privilegiata nelle classi più elevate, in realtà non intenderebbe conoscere barriere di classe, ma proporsi come valore assoluto. Nella trasformazione in atto del ruolo femminile di cui si è detto si giunge all’assoggettamento completo dell’uomo alla donna (l’uomo appare quasi sempre come un burattino nelle mani della donna e viene da questa manovrato a suo piacimento); non è però rappresentato un processo in atto nella società italiana, ma una pura ipotesi letteraria. Il gesto della Borelli in Ma l’amor mio non muore di Mario Caserini (1913) o in Rapsodia satanica (1917) si carica di intenzioni emblematiche, diventa assoluto, crea una distanza quasi incolmabile con la vita comune. Gli uomini le si inginocchiano ai piedi. E anche quando in apparenza diventa vittima riesce a far trionfare ancora una volta il suo potere riprendendo il ruolo di dominatrice (vedi il finale della Serpe quando la Bertini si presenta alla casa dell’uomo che dovrebbe odiarla: «Tu qui! Nella casa dell’uomo che tu hai rovinato!», «Sì hai ragione […] calpestami […] uccidimi […] dimentica il passato […] perdonami!»). Nella Signora delle camelie realizzato dalla Tiber nel 1915 con Hesperia come protagonista, il racconto è fatto da un io narrante e per tutto il film viene attuata una consapevole alternanza del punto di vista, tanto che l’attore diventa soggetto di visione, mentre lo spettacolo acquista una struttura metalinguistica ospitando al suo interno altre forme di spettacolo, come l’opera o il teatro. Anche in Tigre reale di Pastrone la struttura lineare lascia il posto al
racconto nel racconto e tutto il sistema narrativo partecipa di una più ampia intenzione simbolica. La struttura di partenza, il romanzo giovanile di Verga, è seguita in alcuni dei suoi momenti importanti, come i rituali mondani, le feste, i venerdì della contessa Nata, ma la struttura espressiva già rivela un maturo dominio dei procedimenti cinematografici. Il racconto si scompone nel lungo flashback che rievoca l’amore di Nata per il guardiacaccia, il montaggio, specie nel finale, è costruito mediante parallelismi molto marcati (l’albergo sta andando a fuoco mentre la folla, nel teatro, applaude la danza del fuoco), l’assunzione del punto di vista dei personaggi produce effetti di visione nettamente cinematografici (lo specchio retrovisore in primo piano attraverso cui, dalla macchina in corsa, Nata osserva Giorgio che corre nella strada). Ma ciò che più importa, come elemento comune in tutta l’ampia serie di titoli che rientra in questa tendenza, è il sovvertimento dei codici morali: l’adulterio è legittimato, Nata spinge il suo amante a suicidarsi («Fallo, è bello!»), i valori borghesi appaiono completamente cancellati. La macchina da presa si avvicina al volto degli interpreti (si veda l’inquadratura finale di Ma l’amor mio non muore), anche se non si intende ancora sondare – come cominciava a fare il cinema danese negli stessi anni con Asta Nielsen – l’orizzonte infinito che la microfisionomia è in grado di rivelare. Ma se in percentuale i primi piani aumentano è soprattutto il linguaggio del corpo a trasmettere con il massimo di forza i suoi messaggi, come notava Gramsci, in quegli anni . La recitazione naturalistica, ma anche quella legata alla cultura liberty, scoprono nuovi registri nel motivo della follia (si veda il finale del Fuoco), nella mescolanza dei rispettivi codici, nello scontro tra ambienti diversi. In Memoria dell’altro di Alberto degli Abbati (1913), Lyda Borelli percorre fino in fondo, per amore, la sua parabola di degradazione, vaga nei quartieri popolari di Parigi, è costretta a ballare in locali malfamati per ottenere un aiuto («Nei loschi clienti nasce vivo il desiderio di una danza con la gentile creatura»). Una parabola molto più complessa di personaggio femminile, «fiore sbocciato nel fango della suburra, vittima delle grandi metropoli», è quella di Lyda in Fior di male in quattro parti (Perdizione, Amore, Redenzione, Sacrificio), in cui Lyda Borelli percorre tutta una via crucis di passione, dolore, sacrificio e morte lungo un ampio arco di tempo della vita («Lyda è il fiore sbocciato nella suburra, la vittima della grande metropoli»). Inoltre tutto l’insieme degli elementi che compongono l’immagine viene sempre più coordinato al valore simbolico del gesto dominante. I simboli che possiamo trovare disseminati lungo tutta la produzione del periodo partono dagli stessi titoli: Tigre reale, Il fuoco, Orchidea fatale, Quando l’amore odia, Odio che ride, Il vortice, Il fiore perverso, Passione fatale, Retaggio d’odio, Colei che tutto soffre, Capriccio di gran signore, L’avvenire in agguato, La voluttà di vendetta, Sposa nella morte, Fior di male, Rapsodia satanica. Dai titoli l’influsso passa lungo il film, coinvolge le strutture visive e quelle verbali in un processo di significazione molto coerente. Il fuoco ad esempio è scandito, già a livello di macrostrutture narrative, da tre grandi unità che appartengono al medesimo campo semantico del titolo e descrivono metaforicamente l’intera parabola dell’amore tra i due protagonisti: la favilla, la vampa, la cenere. Il medesimo motivo passa poi nelle singole didascalie: «L’amore che tu sei è come questa lampada […] essa dà poca luce e dura tutta la notte […]. Vedi! Come la passione la sua fiamma s’innalza fino al cielo […]. Scegli, scegli tra amore e passione. Bruciami! Bruciami l’anima!». E poco oltre: «E dai bagliori della vampa ch’essa gli accese, egli ebbe ispirazione per la sua creazione». Questa presenza intertestuale del motivo del fuoco, che si ritrova in tutta la produzione che si muove sotto il segno di D’Annunzio, a partire da Cabiria dilaga nella simbologia iconica. Negli anni di guerra i pubblici delle grandi città preferiranno immaginarsi morire tra le braccia ardenti di Pina Menichelli, o sotto le fauci delle molte donne tigre piuttosto che soffocare per i gas nervini sulla Marna o bruciare sotto il fuoco dei lanciafiamme in un attacco sul monte Zebio. Vi sono poi tutta una serie di simboli, di metafore, di analogie che partecipano della stessa intenzione: la donna gufo e la donna serpe del Fuoco, la metafora della serpe che mangia il pulcino nella Serpe, la statua di Galatea che si anima nel Mistero diGalatea del pittore Aristide Sartorio (1919). Quest’ultimo film, situato cronologicamente in posizione terminale rispetto allo sviluppo del genere, si presenta come un vero e proprio centone di motivi dannunziani. Agli eserciti di Marcantonio e Cleopatra subentrano negli anni di guerra quelli capitanati da Maciste, Bertini, Borelli e Menichelli. Anche in questo filone, che costituisce il più potente argine contro le esperienze artistiche dell’avanguardia, convergono elementi di rituali borghesi e questi rituali sono, di fatto, ormai chiusi in spazi che non hanno più alcuna permeabilità sociale e non permettono il riconoscimento e la trasmissione di alcun modello ai pubblici a cui intendono rivolgersi. La società di nobili di cui si celebrano le avventure 105
sentimentali inimitabili («E l’amò fino alla morte e più in là» è la didascalia finale di Memoria dell’altro) sollecita sempre meno, per il suo anacronismo, il desiderio dei pubblici popolari. I mercati stranieri si chiudono a questi prodotti, non soltanto a causa della guerra, ma anche perché l’ideologia e la cultura del genere appaiono sempre più come eleganti epigrafi di un mondo che sta sparendo. Certo nel momento in cui il filone dannunziano risulta esaurito ci si rivolge egualmente ad altri autori, ma, poco per volta, ci si rende conto che i fuochi di una società, che vive i suoi amori impossibili incurante della guerra, non è altro che il fantasma di un mondo finito da tempo. La critica attacca in egual misura film, attori e dive e sembra voler chiedere di esplorare nuove strade. Tuttavia, forse anche grazie alla capacità di produzione simbolica dei testi nel contesto, l’illusorio gioco di specchi di una messa in scena sempre più sfarzosa diventa anche uno dei modi più emblematici con cui, la società dominante europea in agonia, trasmette la memoria della propria morte.
tra feuilleton e commedia sofisticata Vi sono alcune personalità che si specializzano in film di genere (come Antamoro o Guazzoni), altri (come Genina o Gallone o Roberti) che si formano passando da un argomento all’altro, altri infine (come Ghione) che presentano un’esperienza eccezionale, alternando l’attività registica con quella di attore e raggiungendo uno strepitoso successo di pubblico grazie all’invenzione di un personaggio preso di peso dal romanzo poliziesco e popolare, Za-la-Mort. «Ghione – come ha osservato Savio – fu, per certo, attore di magnifica ‘presenza’ sulla linea di un Mojoukine o d’un Hanson» . Ghione nasce comunque come attore cinematografico, dotato immediatamente di ottime qualità per lo schermo pur senza avere alcuna esperienza anteriore: fa dapprima la comparsa, ma già nel 1911 recita nella Cines di Roma e nel 1913 compare come protagonista di una ventina di film, per lo più diretti da Baldassarre Negroni (Histoire d’un Pierrot, Circolo nero, La bufera, La cricca dorata, L’anima del demi-monde) ed esordisce nella regia con l’Idolo infranto in cui recita Francesca Bertini. Dirige poi soggetti molto diversi, da drammi storici come Guglielmo Oberdan (1915) e Ciceruacchio (1915) dove offre il proprio contributo nazionalistico, a trascrizioni per lo schermo di opere teatrali, come Don Pietro Caruso del 1916 in cui mette in scena il dramma di Roberto Bracco ricorrendo, ancora una volta, a Francesca Bertini. Ma egli deve soprattutto la sua fama all’invenzione della maschera di Za-la-Mort e al tentativo di riprodurre in Italia il successo dei serial francesi e americani. Za-la-Mort cerca di cogliere e mescolare vari tipi di influenze della letteratura poliziesca e del cinema: Fantomas e Rocambole, Judex e Arsenio Lupin avevano già conquistato il mercato cinematografico con le loro storie di violenza e con l’immagine di un eroe del male che attirava il desiderio. La figura del giustiziere sconosciuto, del delinquente che attraverso le sue imprese eccezionali acquista una dimensione mitica, in effetti non vuole sovvertire l’ordine costituito, quanto piuttosto far rivivere, in un contesto presente, una tipologia di fuorilegge che da Robin Hood giunge fino a Zorro rifiutando le ingiustizie più clamorose della legge e degli ordinamenti sociali. I film di Ghione hanno ben poco di realistico: le ingiustizie sociali mostrate non appartengono alla realtà e alla società, ma alla tradizione letteraria del feuilleton. Lo stesso uso dell’illuminazione drammatica degli ambienti tende piuttosto a caricarli in un senso quasi pre-espressionistico. C’è chi ha visto in questi film – dalle serie della Banda delle cifre o dei Topi grigi fino al lungometraggio degli anni Venti L’incubo di Za-la-Vie – una immediatezza e una obiettività cronistica mancante nel romantico pittoricismo di Assunta Spina : tutto in realtà appare improbabile e costruito in Ghione tanto che oggi forse le categorie del fantastico e dell’immaginario, le trasformazioni visive della letteratura di consumo ne possono spiegare il successo e la capacità di rivaleggiare con Fantômas, Les vampires e Judex, gli eroi del male dei film di Feuillade. Tuttavia gli ambienti popolari che fanno da sfondo alle imprese di Za-la-Mort e soprattutto gli esterni su cui la luce del sole agisce quasi come una forza corrosiva, offrono l’immagine dell’Italia più povera e socialmente arretrata di tutto il cinema muto. «C’è più Italia – scriveva Umberto Barbaro in un articolo del 1943, intitolato Neo-realismo – in I topi grigi di Emilio Ghione e Kally Sambugini che non negli altri film italiani del periodo» . Non è in ogni caso solo l’aspetto realistico a colpirci oggi nei Topi grigi. C’ è anche una regia di tutto rispetto e una recitazione che conferma l’originalità della sua tecnica fondata sulla stilizzazione e sulla sottrazione. Le sue apparizioni, come sarà poi 106
107
108
per la recitazione espressionista, hanno una carica simbolica che prevale su quella realistica e la maschera del volto scheletrico di Za-la-Mort fa tutt’uno col vestito e il berretto, ma anche si mimetizza con il paesaggio divenendo pietra o corteccia d’albero. A partire da alcuni titoli come Nelly la gigolette o la danzatrice della taverna nera, in cui crea il personaggio di Za-la-Mort, Le anime buie del 1915 o La banda delle cifre, in tre episodi dello stesso anno, il successo economico e di pubblico di Ghione sembrano crescere secondo una prepotente progressione geometrica. Zala-Mort sarà presto affiancato da un’inseparabile compagna, Za-la-Vie, Kally Sambugini, attrice su cui anche varrebbe la pena di riportare l’attenzione per l’ottima capacità di combinare femminilità e forza, doti che non la fanno certo sfigurare di fronte alle eroine dei serial americani. La serie più nota, che colloca Ghione nell’ Olimpo divistico del primo cinema italiano, è proprio quella dei Topi grigi, realizzata nel 1918 per la Tiber e suddivisa in otto episodi. Pur rappresentando azioni delittuose di ogni genere i film di Ghione contengono un nucleo di moralità, un rispetto di valori e sentimenti come la fedeltà, l’amicizia, l’amore, l’aiuto ai più deboli, una condanna del mondo dei ricchi, del tutto assenti nella produzione coeva che esalta le passioni fatali e celebra le donne tigri o le Eve fatali. Nei Topi grigi più volte il suo pensiero nei momenti di maggiore drammaticità torna con nostalgia all’idillio agreste («Silente e bianca casetta amica, minestra fumante, scodellata ogni dì, come vi allontanate» dice una didascalia nel secondo episodio). Mentre gli operatori in genere cercano di avvolgere i personaggi negli interni con le luci morbide, modulando i chiaroscuri, facendo vibrare le atmosfere, aureolando le teste bionde delle dive e immergendo i drammi nel tepore accogliente di luci che sanno mantenere la sensualità al giusto grado di temperatura, Ghione ambienta le sue storie contro squallidi paesaggi di periferia, mutando però di continuo sfondo e passando con assoluta naturalezza dalla campagna, dalla dolcezza dei profili delle colline ai bassifondi della metropoli, al demi-monde agli interni dei palazzi nobiliari. E più di tutto si serve della macchina da presa ricorrendo spesso a una luce dura, violenta, priva di chiaroscuri, tutta contrasti netti, capaci di valorizzare la spigolosità degli zigomi facciali e di rendere ancora più cruda e dolorosa la miseria di certi ambienti. C’è chi ha visto in particolare nei Topi grigi un’immediatezza e un’obiettività cronistica mancante nel romantico pittoricismo di Assunta Spina. La categoria del realismo appare oggi meno produttiva nei confronti dell’opera di Ghione, mentre quella dell’invenzione fantastica, è più ricca di prospettive, in quanto permette di interrogarsi sulla contrapposizione di Ghione, bandito dal portamento elegante e nobile, rispetto agli ambienti che costituiscono lo spazio privilegiato delle sue gesta. Lo spazio è spesso promosso a personaggio nel senso di una vera e propria autonomia narrativa. Il valore coloristico e plastico degli ambienti è così marcato da non lasciare pressoché spazio alla denuncia sociale. Ma un’Italia così misera forse non si vede in nessun altro tipo di produzione contemporanea, neppure in quella napoletana. Il successo renderà Ghione prigioniero del suo personaggio e legato a Za-la-Mort come un povero Cristo alla Croce, per usare una espressione dello stesso attore. «Il suo – dirà Curzio Malaparte nel 1937 – era diventato un vero dramma pirandelliano». E non a caso a Petrolini, che col suo Gastone diceva di essere stato rovinato dalla guerra e dalle donne, Ghione rispondeva di essere stato rovinato da Za-la-Mort. Il caso di Ghione resta tuttavia isolato: per tutta la produzione muta si tenta di dar vita a una realizzazione di serial . Tra gli esempi minori si potrebbero ricordare alcuni film prodotti, diretti e recitati da Gastone Monaldi come Il re della notte, Il figlio di Satana, I cavalieri del braccio di ferro, Il bastardo: si tratta nel complesso di tentativi ed esperienze assai modesti sul piano sia spettacolare che narrativo. Un capitolo a parte è invece quello riguardante i forzuti che nascono sulla scia del successo di Maciste e che crescono proprio negli anni della crisi. In questa morfologia in cui tento di distinguere forme e funzioni, pur muovendomi con un andamento labirintico e con frequenti ritorni e recuperi su vari piani, non ho ancora ricordato che, se D’Annunzio e Verga risultano i numi tutelari delle forme più ambiziose, su piani intermedi convergono altri modi che, come si è visto, attingono senza complessi a tutte le forme della letteratura e dello spettacolo. Un significativo segno di svolta, di accostamento al cinema americano e di uso di modi narrativi e comportamenti con intenzioni doppiamente parodistiche – sia verso le passioni fatali che verso le stranezze e i comportamenti iperbolici americani – si vede nella Signorina Ciclone di Genina del 1916, opera che risente dell’apporto di Lucio D’Ambra e che in un certo senso indica a quest’ultimo la via da seguire. Lucio D’Ambra è considerato 109
l’inventore della commedia brillante e sofisticata e per anni gli si è voluto riconoscere il ruolo di precursore di quelle forme di racconto che negli anni successivi avrebbero reso famoso Lubitsch . D’Ambra era un poligrafo e un intellettuale tuttofare: dalla letteratura, dove aveva già collezionato una nutrita serie di romanzi (Oasi, Miraggio, Rivoluzione in sleeping-car), passa al cinema e subito rivela una vena fecondissima riuscendo a realizzare, per la casa di cui diventa fondatore, regista e factotum, quasi una trentina di film. I titoli più noti sono La chiamavano Cosetta, Papà mio, mi piacciono tutti!, La commedia dal mio palco, per poi giungere ai celebri Il re, le torri, gli alfieri, Il girotondo di undici lancieri, Ballerine, Mimí fiore del porto. D’Ambra si specializza in questo genere, lo percorre in tutte le sue possibilità, dal grottesco alla commedia brillante, alla satira. Le sue opere risentono in modo abbastanza stretto di alcuni fenomeni dello spettacolo contemporaneo, dall’operetta viennese, da cui trae il senso del ritmo vorticoso e degli intrecci maliziosi, all’influenza del teatro grottesco di Antonelli, Cavacchioli, Chiarelli e Rosso di San Secondo . D’Ambra, è stato, in ogni caso, uno degli autori meno classificabili per diretta conoscenza in quanto la sua produzione era completamente scomparsa fino a qualche anno fa. Oltre ad aver giocato un ruolo importante nella costruzione di soggetti per Genina, Righelli, Perego, Palermi e aver ideato per primo delle commedie brillanti, pensando a storie originali per il cinema e ponendosi tra i primi i problemi del ritmo, delle possibilità del cinema di esplorare i territori non realistici, della costruzione di storie assurde, surreali o strampalate costruite tenendo presenti i ritmi del balletto, della ricerca di valori formali legati alla specificità del linguaggio cinematografico . D’Ambra ha fissato in tre volumi e in vari scritti, in maniera assai viva il ricordo della fase pionieristica del cinema muto . Negli anni Trenta, nel tentativo nazionalistico di attribuire ai pionieri del cinema italiano i meriti di aver inventato tutti i modi narrativi e aver indicato molte strade dei generi si faceva di D’Ambra l’inventore dei caratteri della commedia borghese dello schermo. D’Ambra respira le atmosfere del teatro grottesco di Rosso di San Secondo e le mescola col balletto e qualche suggestione che gli viene dal futurismo, nell’uso dei mascherini, dei primi piani, nella rottura della linearità del racconto, nella perdita del senso nelle azioni… Oggi, grazie a una serie di ritrovamenti importanti (Le mogli e le arance e L’illustre attrice Cicala Formica), ma anche grazie ad alcune sceneggiature originali, come quella della Signorina Ciclone, conservata nel fondo manoscritti creato da Maria Corti all’Università di Pavia, i discorsi su D’Ambra possono essere finalmente condotti su materiali di prima mano e si può comunque riconoscergli un ruolo importante sia nella legittimazione della figura del soggettista, che in quella del regista e anche di pioniere della riflessione teorica . D’Ambra scrive in modo già moderno le sue sceneggiature su due colonne, disponendo a sinistra le descrizioni relative alla scena e a destra i dialoghi, i testi delle didascalie sottolineati e la descrizione dell’azione vera e propria: «Il vecchio Marchese De Germont adora due cose nella sua vita. La sua magnifica villa e il suo vecchio amico […] (ingresso del duca con panoramica). Vediamo entrare dal fondo della sala un vecchietto tutto impomatato, vero tipo di vieux marcheur, si avvicina al marchese, lo saluta. Dietro di lui è un servo che sopra un tavolo porta una scacchiera con gli scacchi già a posto». D’Ambra regala al cinema degli anni di guerra e di quelli immediatamente successivi una leggerezza di tocco e una capacità di mescolare toni e livelli e di definire con un tocco da caricaturista i personaggi che si perderanno negli anni Venti. 110
111
112
113
114
il cinema cantato Se, come abbiamo visto, non c’è alcun modello letterario e nessuna forma di spettacolo che non si cerchi di convertire nel cinema è evidente che accanto alle influenze alte dell’opera lirica o basse del circo e dello spettacolo di piazza si collochino tutta una serie di influssi intermedi che vanno dal café chantant al melodramma, alla pantomima. Il supporto delle musiche di accompagnamento dei film fa si che in alcuni casi si tenti una trasposizione non ridotta dello spettacolo originale, ma una diversa versione con tutti gli attributi del modello originale. Tra il 1908 e il 1911 vi sono almeno tre versioni della Luciadi Lammermoor (due Cines e una Itala) e si tentano degli esperimenti piuttosto infelici, per la verità, di sincronizzazione sonora. Ma ciò che colpisce, in questi film, è l’estrema eleganza e cura nella ricostruzione scenografica e nei costumi e il largo uso della mimica. Tutto il sistema gestuale è molto elaborato e assai più complesso e ricco di sfumature rispetto al
gesto enfatico dei film storici. Oltre a mettere in scena opere note e di grande successo popolare le case trovano il modo di aprire la strada, proprio su questo piano, alla rappresentazione di situazioni più maliziose, ai doppi sensi della commedia, al gioco degli equivoci, dei travestimenti, alle combinazioni dell’intreccio. Il ritmo narrativo di alcune di queste opere impone un montaggio più stretto tra i diversi momenti del racconto. Prendiamo Il matrimonio di Figaro prodotto dall’Ambrosio nel 1913 dopo che la Cines ne aveva già realizzata una versione (Le nozze di Figaro) nel 1911. La scelta di tutti gli elementi e lo stesso ritmo narrativo danno al film un andamento di balletto: la scenografia è ricostruita con molta cura e si integra con quella naturale di cui viene ormai sfruttata tutta la profondità di campo. L’ottimo livello di resa visiva (l’uso dei dettagli e dei primi piani, o della luce naturale degli esterni che entra negli interni) si combina con un ritmo narrativo molto sostenuto e una maliziosa utilizzazione di doppi sensi e di situazioni equivoche. Per ragioni diverse, due film possono parzialmente rientrare in quest’ambito e costituiscono senz’altro due importanti punti d’arrivo di un filone che non riesce a sostituire il fascino dello spettacolo dal vivo: si tratta dell’Histoire d’un Pierrot e del Ballo Excelsior. Con l’Histoire d’un Pierrot (Celio, 1913) film considerato perduto e di cui già Barbaro aveva dato un’analisi assai fine fa irruzione nel cinema, a un livello assai alto e non più imitato, la pantomima: la recitazione dei protagonisti (da Francesca Bertini a Emilio Ghione) è tutta perfettamente adattata alle esigenze della pantomima di Mario Costa che, in quegli anni, riscuoteva un grande successo. L’uso degli interni è stilizzato e si avvale di un numero minimo di elementi che si accordano funzionalmente ai gesti. Gli esterni sono invece realistici, ma rimangono anch’essi cornice scenografica, non partecipano al dramma. L’attore recita costantemente con il volto e il corpo rivolti verso il pubblico. Soltanto alcuni scarti e inserti di primi piani di Pierrot (quando Francesca Bertini dà la libertà al colombo) rivelano la presenza della macchina da presa, senza però dare l’impressione di voler mutare la dipendenza da un sistema anteriore. La visione non è cinematografica nella misura in cui il punto di vista rimane statico e frontale, non muta di angolatura né di posizione e non si produce in alcun movimento. Il film riesce comunque a riprodurre, a un livello piuttosto alto di trasformazione, i codici di un sistema anteriore: tutto il processo simbolico con le corrispondenze tra il dramma di Pierrot e Luisette e quello dei due colombi in gabbia è tuttavia mantenuto e trasmesso grazie alla perfetta corrispondenza tra motivi della recitazione ed elementi simbolici. Il Ballo Excelsior, ridotto in film nel 1914 dalla Musical film, è un tentativo di rispondere al successo di Cabiria e alle musiche di Ildebrando Pizzetti con uno spettacolo musicale già collaudato. Il film che manteneva le musiche di Romualdo Marenco viene presentato a Roma il 28 aprile del 1914 a soli pochi giorni di distanza dalla trionfale prima di Cabiria e registra un tonfo clamoroso. Tutto un sistema di rappresentazione, che sul palcoscenico riusciva ad affascinare per la sua grandiosità, sullo schermo risulta macchinoso e incomprensibile. La macchina da presa è assolutamente statica e il movimento coreografico interno è goffo e ripetitivo. Lo stesso prologo scritto da Lucio D’Ambra rivela una costruzione retorica ancor più insopportabile delle didascalie dannunziane: «Buona sera Signori! Io son l’Idea. La tela / che qui vedete, candida tesa come una vela / aspetta di visioni magiche un vasto mondo / che uscirà dal foro rilucente là in fondo. / Vedete? La parola di raggiri è maestra […]. / Messa fuor dalla porta, torna dalla finestra / e se il cinematografo la sopprime nel dialogo / la parola ritorna travestita da prologo» . Questa sorta di rappresentazione totale e simbolica dell’intera vicenda dell’umanità, con personaggi fantastici come la Civiltà, la Luce e le Tenebre, o reali come Alessandro Volta, vuol essere soprattutto un inno al progresso della civiltà industriale e all’illimitata capacità di conquista e dominio umano sulla natura («Vinta è la terra e il mare […] all’assalto del cielo!»). Purtroppo le intenzioni del messaggio corrono troppo rispetto alle soluzioni linguistiche, troppo statiche, che appaiono del tutto fuori tempo nel loro apparire come semplice teatro filmato da una macchina da presa restia a modificare il suo punto di vista, rispetto allo sviluppo interno e internazionale. Il rovinoso tonfo commerciale del film può essere considerato, anche se è assai ovvio, uno dei segni più rappresentativi della fragilità e della crisi di una macchina spettacolare che, anziché protesa alla produzione di cultura per nuove masse di destinatari, riproduceva gli ideali di un mondo che avrebbe continuato a comportarsi àla mode del Ballo Excelsior. 115
116
117
il cinema futurista «La cinematografia astratta è un’invenzione italiana» affermava F.T. Marinetti dalle colonne dell’«Impero» nel 1926 e, a lungo, i meriti delle priorità nazionali nell’aver ideato e realizzato molte scoperte non riguardano solo l’esaltazione dell’invenzione tecnica di Pastrone del carrello e della panoramica, ma si estendono, con perfetta circolarità, ad abbracciare qualsiasi tipo di esperienza e di invenzione, dalla commedia brillante (D’Ambra precursore di Lubitsch), alle comiche (Polidor e Cretinetti progenitori di Mack Sennett e Charlot), ai film d’avventura (Maciste e Sansonia padri di Zorro, ecc.), al film astratto e d’avanguardia. Di questo municipalismo ingenuo e ottuso la pratica storiografica ha continuato a fare le spese fino a poco tempo fa, soprattutto per quanto riguarda il cinema delle origini, per la mancanza della formazione di una storiografia comparata, dotata di strumenti filologici agguerriti e rigorosi e soprattutto posta in condizioni reali di revisione e confronto dei testi. Le nostre conoscenze sul cinema delle origini pur ponendoci ora di fronte a un paesaggio completamente diverso devono appoggiarsi in molti casi ancora a fonti di seconda mano e per lo più indirette e se la futura analisi sistematica dei testi e delle fonti forse non muterà completamente il sistema e i punti di riferimento, dimostrerà di certo il procedere parallelo di molti sistemi o il policentrismo naturale di determinate soluzioni narrative ed espressive rispetto al prevalere di innovazioni monocentriche. Questa osservazione si riferisce solo in parte al discorso sul cinema d’avanguardia, che, per la modestia dei risultati raggiunti, sia in termini quantitativi che qualitativi, può vantare una progenitura poco feconda su tempi brevi e limitatamente alla realtà italiana, anche se non del tutto trascurabile e invece una tutt’altro che secondaria influenza sull’avanguardia internazionale sui tempi medio-lunghi . Il cinema futurista che sembra così improduttivo sul terreno di casa produce invece frutti rigogliosi al di fuori dei confini nazionali sul medio e lungo periodo. Ancor oggi, nonostante l’avanzamento delle conoscenze e la mole di documenti pubblicati e in nostro possesso, continua ad apparirci come un paradosso il fatto che il futurismo, cantore della modernità, pur riuscendo a percepire e a intuire sul piano teorico/poetico le potenzialità del cinema, sia pure con ritardo rispetto all’atto di fondazione, non riesca a far proprio questo nuovo mezzo di espressione a servirsene sia come nuova arma che come arte di tutte le arti . Ne viene influenzato, come ha giustamente osservato Giovanni Lista, che ne è stato negli ultimi decenni, dopo le pionieristiche ricerche di Mario Verdone, lo studioso che più ha esplorato superfici e profondità del territorio, portando alla luce materiali inediti e proponendo nuove connessioni tra opere, personaggi e fenomeni distinti e distanti, mettendo in evidenza soprattutto «le assimilazioni multiple del cinema e dei suoi procedimenti» da parte dei futuristi, dall’utilizzazione dei primi piani, alle sovraimpressioni, dal montaggio interno al quadro, alla dinamizzazione dei movimenti, al taglio eccentrico dell’immagine . Qualsiasi ricerca sulle influenze del cinema sulla letteratura e sulle arti figurative del Novecento deve partire dal nodo futurista e dall’apparente sua incapacità di tradurre subito in pratica e in modo coerente e subito visibile le indicazioni di poetica. In ogni occasione, pur non ponendolo al centro dei loro interessi rispetto al teatro e alla letteratura, i futuristi affermano con forza l’autonomia artistica del cinema: «Il cinematografo è un’arte a sé. Il cinematografo non deve dunque mai copiare il palcoscenico. Il cinematografo, essendo essenzialmente visivo, deve compiere anzitutto l’evoluzione della pittura: distaccarsi dalla realtà, dalla fotografia» . Lo schermo appare dunque come il luogo privilegiato del desiderio collettivo di interi gruppi di artisti e intellettuali che intendono, con le loro opere, creare un corrispettivo dei ritmi e tempi della modernità e soprattutto vogliono lanciarsi in avanti, sopprimere le tradizionali coordinate spazio-temporali e abitare il futuro. Dai futuristi ai surrealisti ai costruttivisti, i discorsi sul cinema e sulle sue potenzialità paiono anzitutto riconoscere al film le risposte alla lunga ricerca sull’opera d’arte totale (la Gesamtkunstwerk) e il potere di fondere, in misura superiore a qualsiasi altra espressione artistica, sensazioni tattili, visive, sonore, olfattive. In principio di tutto questo c’è il futurismo: ha in parte ragione pertanto Marinetti quando nel 1920 su «La testa di Ferro» del 26 dicembre, ben prima dunque che su «L’Impero», rivendica il primato della cinematografia futurista sul cinema d’avanguardia contemporaneo sostenendo che «Il film di Marinetti e il Manifesto sono del 1916: anticipano di molto tutte le indicazioni teoriche e pratiche della «trovata» francese. Dove si vede che se 118
119
120
121
122
noi abbiamo tenuto il primato della cinematografia per così dire borghese, possiamo a buon diritto vantare anche quello della cinematografia d’avanguardia. Quei diavoli avevano inventato degli effetti per l’epoca stupefacenti: raggiunto risultati di una comicità assurda che non sembrano essere stati vinti neppure dagli americani […]. Il Manifesto stesso, pur fatto conto delle sue intemperanze e contraddizioni, era ricco di alcune intuizioni così esatte che i teorici stranieri non han potuto se non ripeterle senza aggiungervi nulla di nuovo» Già in un numero del 1916 dell’«Italia futurista» Emilio Settimelli, nel commentare l’anteprima mondiale di Vita futurista a Firenze, proclama con tono esultante: «Per quanto si dica o non si dica, le rappresentazioni che abbiamo dato al Nicolini segnano una data nello svolgersi dell’arte mondiale […]. Il nostro non è che un tentativo. Sia pure un modesto tentativo. Ma il valore del primo volo in questo senso rimane ed è del futurismo […]. Il tempo di coloro che non sanno fare dell’arte che con le rose, il ‘bianco marmo’ l’inclito bronzo è per nostra fortuna scomparso» . Certo le analogie tra fotografia e pittura e l’indubbia osmosi di esperienze alla fine dell’Ottocento (pittori e fotografi grazie all’invenzione dei colori in tubetto e della macchina fotografica molto maneggevole affrontano le medesime esperienze visive e sembrano condizionarsi a vicenda la visione) sono i presupposti che facilitano un ulteriore passo verso la commutazione di un’esperienza in un’altra, senza rinunciare alla specificità delle due rispettive scritture. «Fin dal 1907 – scrive Arnaldo Ginna – avevo capito le possibilità cinepittoriche del cinema […]. Pensai di dipingere direttamente sulla pellicola» . Tra il 1910 e il 1912 Arnaldo Ginna e Bruno Corra realizzano una serie di cortometraggi astratti cercando di dare attraverso i colori un’interpretazione ritmica dei motivi musicali e di realizzare una serie di sinfonie cromatiche (Accordi di colore, Studio di effetti tra quattro colori, Canto di primavera, Arcobaleno, Les fleurs, La danza) . Nello stesso anno Bragaglia pubblica Fotodinamismo futurista che costituisce la cornice teorica di tutta la sua attività di ricerca sulle fotodinamiche . Anche se i fratelli Ginanni Corradini, più conosciuti con lo pseudonimo di Arnaldo Ginna e Bruno Corra, cominciano a effettuare esperimenti di «musica dei colori» che portano alla realizzazione di quattro film astratti nel 1911 in cui si tenta di realizzare accordi cromatici e musica visiva: Accordi di colore, Canto di primavera, Les fleurs, Studio di effetti tra quattro colori. Lo stesso Corra nel 1912 parlerà comunque del cinema come della «vera sinfonia cromatica» e nell’anno precedente Anton Giulio Bragaglia effettua con la fotografia dei tentativi di scomposizione del movimento inventando la parola Fotodinamismo . A ben guardare i fratelli Corradini non hanno ancora compiuto il passaggio definitivo al futurismo e le loro esperienze ci appaiono più impregnate di spirito wagneriano che del verbo marinettiano. Gli esperimenti abortiscono sul nascere in quanto vengono subito sconfessati e accusati con disprezzo di «cerebralità» da Umberto Boccioni. Se rimaniamo nel territorio italiano si può sottolineare il fatto che il futurismo trova i suoi ideali interpreti e interlocutori in operatori come Luca Comerio che, fin dal 1911, vanno a registrare le immagini della guerra di Libia o installano la loro macchina da presa su un aeroplano e si librano, con il loro occhio meccanico – come ha indicato Paul Virilio – con l’intenzione di rimisurare il mondo, scoprire nuovi metri e nuovi ritmi visivi e di rappresentazione. Vi sono sicure affinità elettive tra i poemi di Marinetti come il Monoplano del papa del 1910 e Il bombardamento di Adrianopoli e le prime riprese aeree di Comerio. Prima di cantare le luci e i ritmi delle città, il cinema scopre, grazie ai suoi operatori, la bellezza dello spettacolo notturno dei fuochi delle mitragliatrici o dei lampi dei colpi di cannone e, con ogni probabilità, quando Marinetti effettua il suo primo volo sul fronte della Libia nel 1912 le sue emozioni e la sua immaginazione trovano una perfetta concordanza con il gesto dell’operatore Comerio che aziona la manovella nello stesso periodo nell’alto degli stessi cieli. Sono poi state osservate delle concordanze tra film come Amor pedestre di Fabre (1914) e Le basi di Marinetti (1915) ed è proprio l’osservazione cronologica che ci spinge a considerare sempre più il cinema come un vero e proprio oggetto d’ispirazione per i futuristi. Un tentativo «non autorizzato» di interpretare lo spirito futurista è quello fatto da Aldo Molinari con Re baldoria, un film uscito nel 1914 e subito condannato da Marinetti, che forse in seguito a questo episodio viene spinto a fissare la propria concezione dei rapporti tra cinema e futurismo nell’apposito Manifesto. Quanto al Manifesto del 1916 la sua caratteristica teorica più rilevante è quella di aver rivendicato 123
124
125
126
127
128
129
130
l’autonomia del cinema, la sua novità e la maggiore inclusività rispetto a tutto il sistema delle altre arti: «Il cinematografo è un’arte da sé. Il cinematografo non deve dunque copiare il palcoscenico […] essendo essenzialmente visivo deve compiere anzitutto l’evoluzione della pittura, distaccarsi dalla realtà […]. Occorre liberare il cinema come mezzo di espressione per farne lo strumento ideale di una nuova arte, immensamente più vasta e più agile di tutte quelle esistenti […]. Il cinematografo futurista crea oggi la sinfonia poliespressiva […] metteremo in moto le parole in libertà che rompono i limiti della letteratura marciando verso la pittura, la musica, l’arte dei rumori e gettando un meraviglioso ponte tra la parola e l’oggetto reale […]. Scomponiamo e ricomponiamo l’universo secondo i nostri meravigliosi capricci» . Elencate le caratteristiche dei film futuristi da realizzare, il manifesto pone l’accento sulle «analogie cinematografiche», sugli «stati d’animo sceneggiati», sui «drammi d’oggetti», sulle «ricostruzioni ideali del corpo umano», «drammi di sproporzioni, drammi potenziali e piani strategici di sentimenti, equivalenze lineari plastiche, cromatiche […] parole in libertà in movimento (pittura + scultura + dinamismo plastico + parole in libertà + intonarumori + architettura + teatro sintetico = cinematografia futurista)». In questa concezione del cinema come arte sincretica ed egemone si realizza, forse, una delle ipotesi poetiche potenzialmente più produttive del discorso futurista su tempi lunghi, ma che non riesce a trovare un’immediata verifica nella pratica registica italiana. Tutti i punti qualificanti del manifesto troveranno, in periodi successivi, e nelle esperienze delle avanguardie cinematografiche sovietiche, tedesche e francesi, una loro realizzazione e applicazione e, poco alla volta, verranno anche assorbiti nelle normali pratiche del cinema commerciale. Infine ciò che affascina nelle dichiarazioni programmatiche del Manifesto è il fatto che il cinema appaia come lo strumento magico capace di creare cosmogonie e aprire prospettive negate alle altre arti. In ambito italiano i film prodotti dal futurismo sono pochi: il solo riconosciuto ufficialmente è Vitafuturista girato a Firenze alle Cascine nell’estate del 1916, distribuito dalla Lombardo film e realizzato collettivamente in base a un’improvvisazione pressoché assoluta di tutti i maggiori protagonisti del movimento, da Marinetti a Balla, da Corra a Carli e Settimelli . Il film aveva una lunghezza di 1.200 metri: la sua suddivisione e descrizione è data da Mario Verdone e mira a offrire una serie di situazioni tipiche nelle quali si trova un futurista: gli episodi vanno da una provocazione di un gruppo di futuristi in un ristorante, a una scena sentimentale, a «come dorme il futurista», a «caricatura dell’Amleto simbolo del passatismo» a «danza dello splendore geometrico» . Con questa sequenza in particolare Ginna «anticipò l’instaurazione di un’atmosfera onirica, totalmente visiva, per mezzo di soluzioni tecniche impreviste e cinematograficamente nuove. Creerà infatti un tessuto di dissolvenze estremamente suggestivo per evidenziare la compenetrazione della danza con l’ambiente in cui si svolge e con i personaggi che vi assistono […] (per esempio) Giacomo Balla assiste atterrito alla ‘danza’ mentre il suo corpo viene lentamente vascolarizzato e dissolto dal percorso ritmico delle vibrazioni che la danza trasmette nell’ambiente in cui si svolge» . Altri tre momenti del film sono: «Poesia ritmata di Remo Chiti», «Ricerca introspettiva di stati d’animo», «Balla mostra alcuni oggetti di legno colorato». Il film comprendeva anche un episodio di satira politica soppresso che si intitolava: «Perché Francesco Giuseppe non muore» , e alcune scene brevi dal titolo «Esercitazioni quotidiane per liberarsi dalla logica», «Cazzottatura futurista», «Come corrono il borghese e il futurista» . È impossibile offrire altre informazioni sul film se non ricordare che per la prima volta nella sua storia una proiezione cinematografica produce delle reazioni attive e violente da parte del pubblico che portano alla sospensione dello spettacolo: «perché il pubblico gettava oggetti, sassi, ecc. contro lo schermo che si rivelava troppo vulnerabile per questo genere di combattutissime rappresentazioni» . L’unico film realmente sopravvissuto è però Thaïs di Anton Giulio Bragaglia e Riccardo Cassano, un’opera che costituisce da una parte il punto d’arrivo della ricerca iniziale di Bragaglia sulle fotodinamiche, integrata da un ampio ventaglio di influenze filosofiche, esoteriche, magiche, pittoriche e visive e dall’altra dimostra lo sforzo di combinare e mescolare due filoni culturali non perfettamente in sintonia, come quello futurista e quello dannunziano. L’integrazione di fatto non avviene, anche se la potente presenza delle scenografie futuriste di Enrico Prampolini nel finale annulla l’interesse per tutto l’intreccio drammatico precedente. In realtà lo spettatore ha il suo primo impatto con un tipico dramma della cultura dannunziana: Thaïs è una donna attraente, al centro della vita mondana, che si comporta in modo da suggerire trasgressioni a non finire 131
132
133
134
135
136
137
(«Danza e fa’ mille e mille follie!») e che, tra la corte di uomini ai suoi piedi, riesce a includere anche un conte amato dalla sua migliore amica. Questa si uccide per la disperazione e Thaïs, dopo aver sentenziato la propria morte («Che la sua morte ricada sulla mia testa»), allestisce volontariamente un’infernale macchina di tortura che le procura una morte lenta e atroce. Come nella più rappresentativa produzione legata al decadentismo tutta la tensione degli elementi narrativi, scenici e recitativi è rivolta alla conquista di una dimensione simbolica. La stessa citazione per intero di due poesie di Baudelaire, oltre che la struttura del racconto, iscrivono, in modo assai netto, i due terzi dell’opera sotto il segno del decadentismo. Nella parte finale tuttavia la macchina da presa, sostanzialmente ferma, muta i suoi punti di vista avvicinandosi al corpo agonizzante di Thaïs, mentre un montaggio ritmico ci pone a contatto col potere simbolico dei diversi oggetti (l’orologio o la trappola con le lame che si allungano sempre più verso il centro della stanza): «Ossessione e vertigine regolano il mondo di Thaïs […] un gufo dentro una ingabbiatura regolarissima di triangoli. Una doppia spirale geometrica. Una serie di sbarre che filtrano la geometria del fondale. Uno scorrimento orizzontale di ovali-rettangoli-coni. Ghirigori geometrici e saettamenti irregolari. Prospettive allucinate. Ambienti tutti composti di cerchi, dalle pareti al pavimento. Un angolo di stanza (con Thaïs al centro) formato di alcuni colossali sistemi di triangoli bianchi su nero, in cui è anche l’idea del labirinto. Uno spazio incrociato a destra e sinistra, davanti e dietro, da una serie di lance aguzze. Un fondale composto con la ripetizione ossessiva di due forme vegetali. Una stanza tutta decorata con occhi umani che diventano occhi di pavone» . Il rigore geometrico della visione e le metamorfosi o simbologie non significano però, come è evidente, innesco di una diversa competenza espressiva, adeguamento stilistico ai punti programmatici della poetica cinematografica futurista, conversione dell’intero sistema di significazione. Le soluzioni visive della scenografia di Prampolini non possono di fatto essere considerate varianti più sofisticate del lavoro scenografico di pittori più tradizionali come Francesco Paolo Michetti, Aristide Sartorio, Duilio Cambellotti, Camillo Innocenti e Caramba : il salto di qualità si coglie soprattutto nel confronto con alcune esperienze scenografiche teatrali europee. In tutta la sua attività registica Bragaglia non giunge mai alla sperimentazione assoluta: in Thaïs e in Perfido incanto, realizzati tra il 1916 e il 1917, cerca di applicare tecniche e meccanismi espressivi senza alterare il sistema comunicativo e la visione tradizionale e, in un film successivo (Il mio cadavere tratto da Mastriani), gioca egualmente su un doppio registro, quello della trascrizione visiva di un feuilleton e di una ricerca più specifica sull’immagine per tutta la serie di scene dell’incubo e dello sdoppiamento del protagonista. I film di Bragaglia respirano solo marginalmente le ipotesi e le intenzioni del futurismo e lo stesso Bragaglia è sempre stato al margine del movimento futurista: in realtà il fallimento sul piano della pratica registica è dovuto soprattutto al fatto che i futuristi, che intendono essere i padroni del loro prodotto espressivo, si trovano a dover fare i conti con alcuni meccanismi industriali così fortemente strutturati rispetto alla loro poetica del caos e del disordine da non consentire alcuna invenzione e neppure la gestione in proprio di spazi alternativi. Bragaglia affida la distribuzione dei suoi film al produttore napoletano Gustavo Lombardo, ma per gli altri futuristi lo spettacolo cinematografico, che pure resta un punto d’approdo teorico, rimane una realtà distante di cui continuano a sfuggire i meccanismi specifici e quelli produttivi. Lo stesso Bragaglia, con notevole senso di understatement, così giudica nel 1919 la sua esperienza: «Gli incerti tentativi da me fatti al cinematografo e con assoluta scarsità di mezzi non vollero, né poterono essere nulla di veramente notevole. Le moderne strade scenografiche dello schermo sono tanto multiformi da ridurre quasi all’aspetto di un grandioso scherzo quella che fu la mia prima opera cinematografica» . Il fallimento del progetto futurista nasce sia dalla mancanza di competenze tecniche che dall’impossibilità di conciliare le ragioni industriali, produttive e distributive, con quelle della poetica del gruppo. Vita futurista costituisce un modello seminale non solo di poetica, ma anche di modalità produttive indipendenti. Pur ponendosi in fase terminale rispetto ai manifesti futuristi quello cinematografico ne costituisce il punto di massima dilatazione e quasi il fulcro ideale da cui partire per la ricostruzione dell’universo cinematografico. In pratica il Manifesto innesca quasi un processo di fissione atomica e, senza produrre effetti comparabili a quelli ottenuti in altri settori della produzione artistica, contribuirà a modificare l’intero successivo paesaggio cinematografico internazionale. 138
139
140
Se si prendono i diversi punti programmatici e li si confrontano con le pratiche registiche degli autori d’avanguardia si ha l’impressione che tutto sia stato enunciato e previsto e che dalla pagina futurista si sia irradiata una luce capace di illuminare nello stesso modo il dadaismo e il surrealismo, le avanguardie sovietiche e l’espressionsimo tedesco, René Clair e Dziga Vertov, Man Ray e Viking Eggeling, Hans Richter, Germaine Dulac e Louis Delluc, Salvador Dalì e Luis Buñuel.
la guerra sul set Se finora si è cercato di dare l’impressione che, fissate determinate linee e alcuni presupposti teorici e metodologici, i maggiori generi si siano sviluppati secondo specifici percorsi generativi e codici di pertinenza, ossia secondo un ordine e delle strutture ben definite, l’avvento della guerra ha un valore di spartiacque nella produzione, in quanto segna la fine di alcuni generi (il filone storico, per ragioni prima di tutto economiche e poi, forse, di opportunità, quello comico perché incapace di tenere il passo con la produzione internazionale e di coagularsi attorno a un sistema capace di produrre un minimo di senso) e l’introduzione nella ripartizione seriale di alcuni motivi di disordine e di una maggiore interferenza e combinazione di codici e di generi. Solo i film che celebrano le passioni fatali continuano imperterriti lungo la loro strada incuranti della pressione del contesto storico, mentre per tutti gli altri generi si assiste a uno slittamento semantico e a una combinazione di più codici eterogenei. Ciò si vede assai bene nei pochi film oggi disponibili in una consistente produzione che parla di guerra, da La paura degliaeromobili nemici, a Maciste alpino, al Canto della fede, Fantasia ‘e surdate o Patria e mamma, tanto per citare alcune opere che rappresentano livelli diversi di produzione. La guerra – sia ben chiaro – irrompe nella produzione, rivelando la sua presenza massiccia soprattutto nel primo periodo, poi visti gli insuccessi clamorosi della maggior parte dei film di finzione si opta per una presenza discreta, sul piano della finzione, che mutua i propri modelli dai generi dell’avventura, più che dalla realtà. Non vi sono – in pratica – immagini di film di finzione contemporanei che brillino o brucino nella memoria e siano diventati patrimonio collettivo. Ritengo che nei confronti di questo sconvolgente evento si possano considerare più vicini ai corpi e allo spirito dei combattenti film di cinquant’anni dopo, come Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick o Uomini contro di Francesco Rosi, di quanto non lo fossero gli operatori cinematografici in azione lungo la linea di fuoco. Il cinema di finzione del tempo è culturalmente, ideologicamente e strutturalmente incapace di adeguarsi alla novità della situazione. «La guerra vera – osserva Cacace fin dall’ottobre del 1915 su ‘La Cine-Fono’ – è diametralmente diversa da quella ideata dall’imbelle fantasia di alcuni maestri di scena, i quali di guerresco non conoscono che le sfilate in parata al campo di Marte. Non è lecito falsificare ciò che è il crisma consacrato del sangue più nobile dei popoli». Così mentre i vari ministeri si preparano a sfornare documentari in apparenza di riprese dirette dal fronte, in realtà costruiti in base a un sistema di informazione tutto preformato, anche la produzione di finzione si allinea lungo lo stesso asse, servendosi di categorie della distanza e dell’assenza (di guerra) rispetto a quelle più prevedibili della presenza e della vicinanza. Bisogna comunque dire che gli operatori cinematografici dei ministeri sono effettivamente scaglionati lungo i vari fronti e accumulano un enorme patrimonio visivo seguendo tutti gli eventi e fornendone una cronaca ininterrotta. Ma, il più delle volte, è più interessante non ciò che gli operatori hanno documentato seguendo un ordine retorico predeterminato, quanto ciò che resta fuori o viene censurato. Ciò che resta dovrebbe essere destinato a infiammare gli animi di un pubblico che in realtà vive la guerra in maniera assai mediata: gli atti di eroismo, i sacrifici, l’attenzione alterna alle alte gerarchie e all’emergenza nella folla anonima di gesti di grande evidenza rivelano in tutta la sua ampiezza il potere del cinema di costruire il consenso. Nel documentario la costruzione della notizia non è dissimile da quella dell’iconografia più popolare: penso alle tavole di Beltrame sulla «Domenica del Corriere» o a quelle di portata più limitata dei giornali di trincea . I pubblici accorrono numerosi a vedere viva l’Italia con la stessa Bertini, «Splendido finale di attualità patriottica» eseguito dalla Sig. Bertini sul Gianicolo, ai piedi del monumento a Garibaldi, o ancora un film realizzato dalla Cines nel 1917 sulla mobilitazione industriale in Italia in cui, nel finale, Lyda Borelli interpreta la leggenda di Santa Barbara. Non è dunque l’afasia l’elemento distintivo della produzione contemporanea, che, come si è detto, si muove lungo tutti i generi e trova anche nuovi committenti (come Per la Patria! 141
realizzato dal Prestito nazionale, o L’anello di guerra prodotto a beneficio dell’Associazione pro mutilati o Roma mater, opera in cui si cerca di raggiungere una perfetta fusione tra scene documentarie e finzione, o Mariute con Francesca Bertini, gustosa parodia del divismo, realizzate per il Prestito nazionale), quanto piuttosto la distanza culturale, l’ottica da cannocchiale rovesciato, il tentativo di appoggiarsi il meno possibile ai dati del reale presente e il più possibile ai modi e alle forme di una cultura antecedente . La categoria dell’eroismo molto spesso qui diventa quella dell’esotismo e le tecniche di distanziamento spazio-temporale vengono ad assumere una funzione tranquillizzante per il destinatario che già vive la guerra nella logica della celebrazione trionfalistica e monumentale del ricordo. Vediamo due film in apparenza opposti, uno drammatico, come La guerra e il sogno di Momi, e uno comico come La paura degli aeromobili nemici con e diretto da André Deed. In entrambi la guerra è altrove, i suoi orrori possono essere evocati mediante una lettera del padre dal fronte, e vissuti poi (dal sogno di Momi) sotto forma di scontro tra soldatini di piombo che vengono – forse per la prima volta – animati con notevole bravura. Quanto al film di Deed si tratta chiaramente di una pochade che prende avvio dall’applicazione delle norme di protezione in caso di attacco nemico, ma in realtà pone in primo piano i tentativi frustrati del protagonista di unirsi giustamente con la moglie la sera delle sue nozze. Il film, per il suo ritmo, la sua ambizione spettacolare, la sua progressione catastrofica è uno dei prodotti comici più complessi e maturi, ma non fa che confermare come la guerra di cui si vuol parlare resti un oggetto lontano e conoscibile solo attraverso stereotipi di tipo ottocentesco, e risorgimentale. La guerra è sempre e comunque un luogo rappresentato dal punto di vista e in funzione del punto di vista di chi sta a casa, di chi vuol viverla come esperienza sentimentale e culturale e preferisce che l’esperienza reale resti al di fuori dei suoi orizzonti conoscitivi. I ministeri inviano dal fronte la loro documentazione che sembra riflettere i testi dei bollettini di guerra, ma le immagini documentano solo i momenti positivi e soprattutto le fasi di preparazione di normalità, rispetto a quelle eccezionali ed eroiche degli assalti. A cura dell’ufficio stampa del comando supremo dell’esercito è pubblicato e distribuito, nel luglio 1917, un bollettino di Norme per i corrispondenti di guerra in cui oltre ai doveri a cui gli operatori devono attenersi sono elencati una serie dettagliata di divieti che vanno dalle riprese che possano informare sulla formazione di guerra, a quelle relative ai comandi, «allo stato sanitario delle truppe», all’«entità e dislocazione delle forze avversarie», al «numero di morti e feriti» e così via. Ogni documentario oggi esistente segue il medesimo schema e si conclude sempre dando l’impressione che con l’azione vittoriosa compiuta e con la cattura di alcuni soldati nemici si sia già in prossimità della conclusione del conflitto. Questo fin dal 1916. Gli operatori risultano effettivamente onnipresenti e scaglionati su tutti i fronti, ma tra il momento della formazione e accumulazione dei materiali e quello della produzione, esistono varie forme di intervento che unificano la molteplicità dei messaggi e la subordinano a una logica centralizzata. Sul fronte si trovano in ogni caso – è bene chiarirlo – operatori inviati da speciali uffici di documentazione del Ministero della Marina, dell’Esercito, della Guerra, e si crea un apposito ufficio che tenta di coordinare la produzione con la distribuzione dei materiali nelle retrovie e viceversa organizzare una distribuzione della produzione normale al fronte . Sembra da escludere in ogni caso che la produzione, sia spettacolare che documentaria, intenda porsi come destinatario privilegiato il soldato al fronte. I titoli di questi documentari alternano l’enfasi trionfalistica all’apparente rappresentazione diretta dei fatti, ma in generale in tutti è presente in maniera implicita l’intenzione di connotare il senso della vittoria: Dalla ritirata d’Albania alle trincee di Macedonia, Guerra sull’Adamello (realizzato dalla Luca Comerio), Tra le nevi e i ghiacci del Tonale, Le retrovie del mare, Combattimento aereo, Supremo grido!, L’insulto, Lo sbarco nelle terre redente, Il re a Trieste. Alcuni di questi film, come quello realizzato da Comerio, hanno la durata di veri e propri lungometraggi (2.237 metri) e vengono presentati in anteprima alla presenza delle autorità militari e civili e, in genere, gli incassi sono devoluti a favore delle associazioni combattentistiche. Anche osservando questa massa di documentari si devono trarre le medesime conclusioni della produzione narrativa: ai motivi e alla rappresentazione dei combattimenti, posti generalmente solo nel finale, sono preferite le scene d’alta montagna, lo spostamento dei battaglioni, la costruzione delle trincee, il trasporto di cannoni e salmerie. L’azione è sempre ripresa nel momento vincente, la distruzione è opera del nemico, i morti sono pochissimi, anche se ogni tanto si è obbligati a mostrarli. Una cura particolare viene portata alle riprese di scene di 142
143
sepoltura dei caduti e viene sottolineata la pietà con cui si mettono in fosse comuni i caduti italiani e austriaci. Ci sono qua e là, lungo questo enorme gran testo omogeneo, momenti di verità che possono agire in modo autonomo rispetto alle interpretazioni ufficiali degli avvenimenti e sono alcuni attacchi all’arma bianca, le visioni delle decimazioni dei soldati in certe azioni (i bersaglieri ciclisti che varcano il greto dell’Isonzo il 6 agosto 1916), la rappresentazione risibile dei loro armamenti (le enormi baionette della Terribile sul Montenero montate su fucili ottocenteschi), ma per lo più l’attenzione è centrata soprattutto sul perfetto funzionamento sia degli armamenti che della macchina uomo, il cui sforzo grandioso e coordinato, il cui sacrificio sono degni da subito della rappresentazione epica. È anche la sproporzione dei materiali a colpire: la documentazione sulle attività di preparazione al combattimento è enorme, così come molto ricco il materiale celebrativo di ogni vittoria. Mancano del tutto le documentazioni delle sconfitte. Prendiamo ad esempio Caporetto: i materiali di documentazione ci sono, ma il senso della disfatta non è mai mostrato, quanto simboleggiato attraverso il rovesciamento di alcune convenzioni visive. Le truppe in marcia sono riprese sempre di fronte? A Caporetto le si riprendono di spalle mentre si allontanano in maniera tutto sommato ordinata. E la distruzione viene mostrata soprattutto nei danni prodotti alle cose. Di questa tecnica di escamotage adottata dalle attualità ricostruite, di questa insignificanza dei materiali, parlano indignati quasi tutti gli organi di stampa contemporanei, sia italiani che stranieri. Non si tratta certo di colpe imputabili agli operatori, in molti casi dotati di grandissima capacità professionale, quanto della attivazione, per la prima volta, di un discorso cinematografico di propaganda prodotto direttamente dalle forze militari e del tutto congruente con le fonti ufficiali di informazione sull’andamento della guerra. Proprio in questo ambito il cinema viene assoggettato a una massiccia tecnica di mistificazione della notizia e la costruzione delle informazioni rende le immagini del tutto subordinate a schemi preesistenti. A partire dai documentari di guerra i miti dell’obiettività e della realtà ricevono dunque un colpo decisivo e la figura dell’operatore come autore viene soppressa per sempre. L’apparente biforcazione dello sguardo reale rispetto a quello della finzione viene pertanto a cadere, e per entrambi i livelli di produzione funzioni e destinatari diventano oggetto di una intenzione assolutamente omogenea. Accettando i risultati della storiografia più recente sulla grande guerra, che hanno messo in luce la dialettica tra l’esistenza di un dissenso di massa durante il conflitto e la costruzione postuma del consenso , vediamo che la produzione contemporanea si colloca sul versante del consenso senza tuttavia farsi carico che di una parte minima della trasmissione propagandistica e costruendo un’immagine spettacolare della guerra con materiali di riporto e non di prima mano. Come poi farà anche il fascismo, la costruzione retorica si appoggia a valori anteriori allo stesso nazionalismo: uno dei punti saldi del discorso narrativo è il dilagante matriottismo rispetto al patriottismo in fondo più prevedibile. La donna o la madre, e quindi la famiglia sono i garanti e i depositari dei valori familiari e di tutte le iniziative utili ad alleviare le sofferenze dei soldati («Ad X, per iniziativa di nobili dame – dice una didascalia del Canto della fede realizzato nel 1917 da Filippo Butera per la Cleo film di Torino – è stato aperto un ospedale»). E inoltre si cerca – per quanto è possibile – di giustificare la condizione dei non combattenti e di mostrarne la solidarietà con le truppe. In questo senso ancora un film come Il canto della fede si rivela esemplare in quanto getta uno sguardo sulla situazione della grande retrovia, accreditando l’impressione di assoluta solidarietà tra la mente nobiliare, mobilitata a produrre conferenze patriottiche, solerti cuciture di bandiere, o sollecite creazioni di ospedali, e il braccio eroico dei combattenti. Questa produzione si situa dunque non al livello di propaganda a favore della guerra, ma a favore dell’azione della «grande retrovia». «Non combattenti – scrive Federico Striglia in un libro intitolato appunto La grande retrovia – ma combattenti anch’essi e combattenti una santa battaglia se la parola si possa usare per designare chi cerca di vincere il nemico in qualsiasi campo, a prezzo di qualsiasi sacrificio. Ogni italiano è combattente oggi, anche se centinaia di chilometri lo separano dalla linea del fuoco […]. Il fascio di tutte le energie forma la volontà della nazione; la concordia tra di esse, la disciplina, la fermezza, costituisce, di questa volontà, la forza» . E a questa ideologia si riporta Il canto della fede quando mostra l’avvocato Sori «che nel circolo di Propaganda nazionale tiene una conferenza patriottica» di questo tono: «L’amore di patria che in questo momento ci unisce […] questa spada che ha difeso la nostra bandiera […] depongo questa spada tra queste bandiere perché eterno tra noi resti il ricordo di questo eroe». E lungo tutto il film mentre le donne lavorano 144
145
per i feriti di guerra gli uomini parlano di «alti ideali». La guerra nella sua realtà materiale non esiste più, o è appena evocata per mezzo di brevi flashback, che fissano l’iconografia più stereotipa dello scontro e del combattimento attorno al personaggio eroico. Ecco come un film marginale e modesto partecipi di un’ideologia diffusa nelle classi medio-alte: il consenso alla guerra è dato dalla partecipazione spirituale o simbolica («Il tricolore che le mie mani hanno cucito ti sia scudo nella perigliosa impresa» troveremo anche in Maciste alpino). Il film di Pastrone cerca di mettere in contatto codici alti e codici bassi nobilitando a eroe il personaggio di Maciste già protagonista di Cabiria. La presenza della regia di Pastrone rende il film assai più ricco e complesso sul piano spettacolare dell’opera appena ricordata: anche qui nobili fanciulle cuciono bandiere, ma l’identificazione avviene col personaggio popolare. Il punto di vista e l’organizzazione del senso dominante, i giochi di parole («voi arrestate me io arresto l’arrosto»), l’uso ironico del linguaggio e la sua produzione di un senso imprevisto nell’incontro con l’immagine («Alla vista del suo offensore Maciste non può trattenersi dal lanciargli un guanto di sfida» e lancia una scarpa al soldato austriaco), la continua sottolineatura dell’ideologia dell’azione («Ma la vita sedentaria non è fatta per Maciste») ne fanno un film che tenta di aggregare il punto di vista delle masse popolari. Maciste è un eroe capace di trascinare folle popolari e di costituirle in masse compatte ed efficienti. Lo stesso linguaggio è diretto, popolare e in alcuni casi ricorre allo stesso dialetto piemontese («Tira nen, bürich […]. I sun Maciste»). Maciste alpino, con la sua mescolanza di codici romanzeschi ben conosciuti, e con la sua forte invenzione a livello visivo (si vedano tutte le scene di montagna e per tutte le due eccezionali riprese della scalata contemporanea di decine di alpini, armi e animali, e dell’attraversamento sulla corda sospesa sullo strapiombo delle decine di alpini che camminano nel vuoto) è un film moderno e anticipatore, in quanto offre il massimo di impressione di verità senza per nulla alterare gli stereotipi conoscitivi e precorre non pochi atteggiamenti funzionali all’ideologia e al populismo fascista. Maciste, con la sua simpatia, con la sua morale che riconduce tutta la questione del conflitto a un fatto quasi privato tra lui e l’odiato soldato austriaco Fritz, realizza un tipo di spettacolo in linea con le tecniche dell’occultamento: le stragi, i battaglioni mandati al macello inutilmente, gli eroismi altrettanto inutili vengono rimossi a favore di una rappresentazione di una guerra vittoriosa e travolgente, nella quale il problema del nemico austriaco si risolve, in apparenza, senza bisogno di centinaia di migliaia di morti, ma con due semplici pugni ben dati o alcuni potenti calcioni nel sedere. «È anche questo un modo per restituire alla guerra un volto umano – nota Isnenghi –. È il linguaggio depoliticizzato della bravura individuale, amato e comprensibile da tutti. È il linguaggio del gioco. Ma la guerra come gioco eterno dei grandi rappresenta – nel momento stesso in cui sembrerebbe isolare la piccola farsa nel ludico cinematografico – il massimo di avvicinamento alla dimensione, appunto, di gioco sontuoso delle membra e degli ordigni attribuito a quel conflitto da tanti illustri scrittori e uomini di cultura. Ne rappresenta, cioè, una variante incolta e plebea, forse non così incondita e ignara come potrebbe apparire» . Al di là del riconoscimento, della compattezza del progetto, della rimozione totale del dissenso, restano comunque qua e là disseminate, in un sistema compatto e funzionale all’ideologia delle classi egemoni, immagini a cui noi oggi possiamo attribuire un diverso valore emblematico e metaforico, immagini che senza produrre effetti boomerang, contrari alla vettorialità dominante del messaggio, costituiscono come un arresto di senso, lasciano aperte delle possibilità di interpretazione diverse da parte dello spettatore. Per tutte citerei solo una sequenza, quella già ricordata dell’attraversamento del baratro su una corda sospesa in Maciste alpino, che, oltre a ricordarci il senso di precarietà di fulminee immagini poetiche contigue (penso a Soldati di Ungaretti) ci mostra oggi, con la coscienza del presente, il senso di attraversamento di un periodo storico da parte delle masse popolari costrette a compiere un passaggio obbligato, con le vite appese a un tenue filo, manovrato a piacere in modo da far apparire tutti i movimenti disperati di sopravvivenza come un unico coordinato movimento eseguito in perfetta sintonia e alla luce della medesima volontà. 146
paralisi progressiva «Quando il film italiano ebbe raggiunto una importanza mondiale con le cavalcate di Giulio Cesare, Marcantonio, Caligola, Christus e con gli imperatori e profeti del mondo latino, si è sentito probabilmente
disgustato della vita ed ha pensato di suicidarsi. Ha trovato il modo giusto nel romanzo francese. Tutti i romanzi francesi sono diventati film italiani. Dumas, Hugo, Balzac sono stati divorati […]. Daudet, Bourget, Prévost e tutti i loro compagni seguiranno. Non è male per i nostri romanciers au miel che prendono così un carattere inaspettato. Quando le loro protagoniste sono realizzate da Pina Menichelli è in effetti molto più interessante anche il romanzo. Ma la cinematografia italiana a parte quello che aveva di buono non può più progredire» . Queste considerazioni di Delluc colgono ancora oggi il senso di blocco di un sistema che ha giocato le sue carte migliori in una sola direzione e non ha poi saputo rinnovarsi ed evolvere il suo linguaggio mantenendo il prestigio internazionale raggiunto nell’anteguerra. Nel 1918 la produzione italiana, in termini quantitativi, non sembra aver risentito di alcuna crisi: il numero dei film prodotti cresce, nascono nuove case, i contratti per i divi raggiungono cifre astronomiche e sono l’unico punto in comune con la produzione americana. Alla dinamica dei fattori esterni non corrisponde però alcuna dinamica interna di tipo linguistico ed espressivo. La recitazione degli attori, che non si è mai liberata del tutto dall’eredità del teatro, comincia a non reggere più al confronto con quella dei film americani o delle scuole nordiche, la sintassi narrativa è ancora fortemente bloccata dalla presenza di un sistema linguistico regolato dai peggiori surrogati della letteratura, quanto agli autori, a parte il caso di Pastrone, che comincia a trovare le prime grosse difficoltà proprio nel dopoguerra, nessuna personalità è capace di adeguarsi a nuovi modi narrativi. Nel decennio successivo il sistema resterà pressoché paralizzato o assestato al medesimo livello. Nel 1919 si tenta ancora qualche film di grande respiro storico (basti pensare al Leonardo da Vinci prodotto dalla Historica film con la regia di Mario Corsi che utilizza le foto stereoscopiche del sistema di Lamberto Pineschi), ma la produzione media è orientata piuttosto verso la traduzione di testi letterari e drammatici francesi (oltre agli autori ricordati da Delluc sono da inserire Sardou e Bataille) del feuilleton o del romanzo popolare e poliziesco (da Eugène Sue a Raphael Sabatini). Raggiunge il suo apogeo la commedia brillante di Lucio D’Ambra (Il girotondo di undici lancieri, Il marito che gettò la moglie dalla finestra, Mimí fiore del porto, La Valse bleu) e tutto il livello della produzione si può dire racchiuso tra commedia, melodramma e avventura. D’Ambra è forse uno dei pochi registi assieme a Genina capaci di concepire delle storie che respirino un’atmosfera internazionale. Non a caso il suo soggetto della Signorina Ciclone poi realizzato da Genina nel 1916 sembra portare una ventata d’aria nuova, uno stile americano, alla commedia italiana. I suoi film attingono da Labiche e Feydeau e si confrontano, come avverrà anche per il primo Camerini e per Genina, con i film americani di DeMille o le commedie di Lubitsch. D’Ambra – almeno a quanto ci è dato capire dai pochi frammenti rimasti e dal breve L’illustre attrice Cicala Formica del 1920 recuperato di recente – cura le geometrie visive, le trame sofisticate, gli arabeschi geometrici. Inoltre gioca sul ritmo, sulle antitesi di montaggio, sulla deformazione caricaturale, sul paradosso, sui doppi sensi e cerca di sfruttare al massimo le possibilità di trucco della macchina da presa. Anche lui sarà nonostante queste qualità una delle vittime più illustri della crisi del dopoguerra. Film come Eva, tratto dal romanzo giovanile di Verga e prodotto dalla Silentium film, o Il perfetto amore (Gladiator film) da Roberto Bracco, risultano appartenere a una tipologia abbastanza spiazzata rispetto al Triangolo giallo della Tiber, a Incantesimo tratto da Henry Bataille (Medusa film), a Maman Poupée (Olympus), al Braccialetto misterioso dell’Armenia film, ai Cancelli della morte della Victoria, o alla Danzatrice ignuda della Tirrena. In via di sparizione le passioni fatali e le grandi simbologie dannunziano-decadenti, si tentano le vie dell’avventura e del melodramma. Ma questa volta la letteratura a cui si attinge non trova più alcun riscontro nel destinatario in quanto non coincide più con alcuna biblioteca e neppure con il reale, o con una realtà creata dal desiderio. Il cinema del dopoguerra non presuppone più né una cultura né un’ideologia all’atto di emissione e non riesce a identificare il suo destinatario. È un cinema senza autore e senza pubblico. Continuerà egualmente a sfornare centinaia di prodotti per alcuni anni, ma per pura forza di inerzia, per la politica autodistruttiva dei suoi maggiori responsabili e nell’ottusa speranza di far rivivere i fasti di un’epoca, che, dati i ritmi di sviluppo del linguaggio nella cinematografia mondiale, pare ormai appartenere a un’era lontanissima. 147
È la soglia a cui giunge Umberto Eco, nel suo Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975. Più decisamente orientati a rintracciare le determinazioni e i condizionamenti storici del segno i semiologi sovietici. In particolare J. Lotman e B. Uspenskij, Tipologia nella cultura, Bompiani, Milano 1975; J. Lotman, Esthètique et sémiotique du cinéma, Éditions Sociales, Paris 1977. Più decisamente 1
aperte ad analizzare questi problemi di integrazione tra testi e storia le opere di C. Segre, fra cui Le strutture e il tempo, Einaudi, Torino 1974 e soprattutto Semiotica storia e cultura, Liviana, Padova 1977. Inoltre il lavoro di M. Corti, Il viaggio testuale, Einaudi, Torino 1978 che testimonia una tendenza in atto in tutto quel settore della critica semiotica italiana che si riconosceva nelle linee metodologiche della rivista einaudiana «Strumenti critici». 2
R. Paolella, Contributi alla storia del cinema italiano, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 3, marzo 1942.
F. Zangrando, R. Kanzler uno sconosciuto pioniere del cinema, in «Lazio ieri e oggi», a. IX, n. 12, dicembre 1973, pp. 280-281. Si veda anche P. Regnoli, Le Vatican figure parmi les pionniers du cinéma, in «Revue internationale du cinéma», n. 1, 1949. 3
4
G. Fabbri, Al Cinematografo, a cura di S. Raffaelli, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1993, p. 18.
Fondamentale, per la quantità di informazioni inedite, il saggio di A. Bernardini, La presa di Roma, prototipo del cinema italiano, in A. Costa (a cura di), La meccanica del visibile, La Casa Usher, Firenze 1983. 5
L’anteprima nazionale vera e propria sembra essere, stando a documenti ritrovati di recente, quella del Cinematografo Artistico di Livorno, avvenuta il 16 settembre: R. Bovani e R. Del Porro, La presa di Roma. XX settembre 1870: contributi alla storia di un film, Livorno 1998. 6
Si veda F. De Lucis (a cura di), La Fiera delle meraviglie. Lo spettacolo popolare a Reggio Emilia nell’Ottocento, Tecnostampa, Reggio Emilia 1981, p. 25. 7
G. Cincotti, Il risorgimento nel cinema, in D. Meccoli, G. Cincotti e G. Calendoli, Il risorgimento italiano nel teatro e nel cinema, Editalia, Roma 1961, p. 129. 8
Si vedano le considerazioni fatte da Sadoul anche a proposito della politica dei prezzi attuata dalla Cines, che poteva immettere sul mercato prodotti del tutto identici a quelli delle case francesi a costi quasi dimezzati. Cfr. G. Sadoul, Storia generale del cinema. Il cinema diventa un’arte (1909-1920), Einaudi, Torino 1967, pp. 239. Si veda anche di Sadoul, La tecnica rivoluzionaria nella Cabiria di Pastrone, in «Cinema», n.s., a. IV, n. 58, 15 marzo 1951. È un problema che ha alle spalle una tradizione quasi secolare e che già si manifesta in maniera esemplare nei sistemi di concorrenza attuati dai venditori di stampe delle tipografie Remondini di Bassano nel Settecento per sbaragliare i concorrenti tedeschi, inglesi e francesi. 9
10
Il Tribuno, La questione sociale, in «Cinéma-chantant», a. I, nn. 1 e 2, 20 e 31 ottobre 1907, p. 1.
R. Paolella, Contributi alla storia del cinema italiano, in «Bianco e Nero», a. VI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1942, ora anche in M. Verdone e L. Autera (a cura di), Antologia di Bianco e Nero, Ed. Bianco e Nero, Roma 1964, vol. III, tomo I, p. 155. 11
12
F. Zangrando, Vecchio cinema a Venezia, in «Giornale economico della Camera di commercio», n. 6, novembre-dicembre 1971, p. 754.
13
Il testo appare su «La vita cinematografica», a. II, n. 1, gennaio 1911.
14
Si veda il mio Nascita del racconto cinematografico, Patron, Bologna 1974.
15
La cui unica copia è conservata – a quanto mi risulta – alla Library of Congress di Washington.
16
La Sirena, in «La vita cinematografica», a. I, n. 2, 20 dicembre 1910, p. 6.
17
Il testo appare su «Moving Picture World», vol. III, n. 14, aprile 1908.
Il saggio di Victor Jasset appare col titolo Retour au réalisme, su «Ciné Journal», 21 ottobre-25 novembre 1911, ed è ripubblicato in M. Lapierre, Anthologie du cinéma, Alcan, Paris 1946, p. 89, da dove ho tratto, traducendola, la citazione. 18
Per i dati si possono osservare, con una certa cautela, quelli riportati dalla voce Correnti migratorie curata da A.M. Ratti per L’enciclopedia italiana, vol. XXIII, 1934, p. 256 e per i risultati più recenti raggiunti da ricercatori americani si veda soprattutto R. Veicoli, Le fonti americane per lo studio dell’immigrazione italiana, in AA.VV., Gli italiani negli Stati Uniti, Istituto di Studi americani, Firenze 1972, con 19
particolare riferimento alle pp. 21-23 dell’Appendice. Il testo di Cossa è del 1872, quello di Boito del 1901. Può essere curioso ricordare che anche Giovanni Pascoli teneva nel cassetto una sua versione teatrale in forma di tragedia su Nerone: cfr. G. Pascoli, Testi teatrali inediti, Longo, Ravenna 1979. Un ampio saggio sulla tradizione del film storico nel cinema italiano è di V. Attolini, Il cinema, in G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina (a cura di), Lo spazio letterario di Roma antica, Salerno, Roma 1990. 20
Mi sono servito, per questi titoli, della filmografia in calce al volume della Prolo. La filmografia curata da Bernardini consente oggi un’analisi molto più approfondita a partire dal semplice censimento e identificazione quantitativa dei titoli derivati da testi letterari. 21
Il testo delle didascalie è riportato in S. Raffaelli, Ipotesi per ricerche sul linguaggio verbale nel cinema muto, in «Annali della Scuola superiore di comunicazioni sociali», a. I, fasc. 1-2, 1973, p. 59. 22
23
V. Jasset, in Lapierre, Anthologie du cinéma, cit., p. 90.
24
In «Moving Picture World», vol. V, n. 19, 6 novembre 1909, p. 635.
Nerone, in «Lux», a. I, n. 1, 3 ottobre 1909. Va detto che sul finire dell’Ottocento nei maggiori circhi che lavoravano in Europa venivano allestiti con grande sfarzo e dispendio di mezzi spettacoli sulla distruzione di Roma. Ne ricorda uno inglese del 1889 M. Verdone in Spettacolo romano, Golem, Roma 1970, pp. 141-147. 25
Il più recente e notevole contributo allo studio di questo film è di J. Welle, Dante’s Inferno of 1991 and the Origins of Italian Film Culture, in A.A. Jannucci (a cura di), Dante, Cinema & Television, University of Toronto Press, Toronto 2004, pp. 21-50. 26
Un’intervista in cui gli autori spiegano i trucchi adottati appare su «Lux» nel numero di aprile del 1911. Per vari mesi la rivista è interamente mobilitata nella campagna pubblicitaria del film di cui si è assicurata i diritti di distribuzione. 27
Un’ampia selezione di giudizi della stampa appare sul n. 89 di «Lux» del 5 marzo 1911. È importante sottolineare, accanto ai giudizi autorevoli che segnano le prime forme di consenso ufficiale da parte di alcuni intellettuali al cinema, anche interventi come quello apparso sul Pungolo, egualmente riportato dalla rivista di Lombardo, in cui si punta l’attenzione sui valori nazionalistici, che, per la prima volta, vengono identificati come punto di convergenza e di riconoscimento, al di là delle differenze di cultura e di classe: «Noi giudichiamo il film dantesco come opera che contribuirà fortemente allo sviluppo della cultura nazionale e della coscienza civile». Un’accurata analisi del film e delle reazioni della stampa è stata fatta da A. Bernardini, L’Inferno della Milano-Films, in «Bianco e Nero», a. XLVI, n. 2, aprile-giugno 1985, pp. 91-111. 28
29
R. Ascoli, Cinematografia e diritto, in «Diritto commerciale», I, 1913, p. 498.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Si veda l’edizione integrale dell’Usine aux image, a cura di J.-P. Morel, Séguier, Paris 1995.
Il Primo manifesto per la cinematografia futurista, firmato da Marinetti e altri, è pubblicato in «L’Italia futurista», n. 9, settembre 1916, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1968, p. 104. 33
Lettere d’arte. Il trionfo del cinematografo, in «Il Nuovo Giornale», 25 novembre 1908, p. 3. Di questo articolo esiste una seconda versione in due parti, rispettivamente firmate BCV e Frac, pubblicata col titolo L’avvenire del cinematografo, in «La rivista FonoCinematografica», nn. 3-4, gennaio 1909 e n. 5, febbraio 1909. Questi due articoli sono stati pubblicati nel volume antologico Tra una film e l’altra. Materiali sul cinema muto itliano 1907-1920 (con una introduzione di Lino Miccichè), Marsilio, Venezia 1980, pp. 65-69 e 69-72. 34
35
Ibidem.
36
***, Introduzione a Rapsodia satanica, Edizioni Cines, Roma 1915.
37
Ibidem.
38
B. Finocchiaro, La comunione del diritto d’autore, in «Diritto commerciale», n. 1, 1918, p. 119.
39
U. Tiranty, La cinematografia e la legge, Bocca, Torino p. 83.
40
Ivi, p. 84.
41
J. Filly B., Piccola storia di una Gorgone, in «In Penombra», n. 4, aprile-maggio 1919, p. 40.
42
G. Gozzano, Il nastro di celluloide e i serpi di Laocoonte», in «La donna», 1916, ora in Poesie e prose, Garzanti, Milano 1961, p. 1089.
43
G. Raya, Giovanni Verga e la censura, in «Vita», 14 febbraio 1979, p. 3.
Per un confronto tra Pirandello e D’Annunzio rinvio al mio La conquista dell’impero dei sogni, in C. Catania (a cura di), Pirandello e D’Annunzio nel cinema, Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Agrigento 1988, pp. 9-30. 44
G. D’Annunzio, Del cinematografo considerato come strumento di liberazione e come arte di trasfigurazione, in P. Cherchi Usai (a cura di), Giovanni Pastrone. Gli anni d’oro del cinema a Torino, UTET, Torino 1986, p. 116. 45
46
T. Antongini, Vita segreta di Gabriele D’Annunzio, Mondadori, Milano 1938
47
In Quaderni di Enrichetta, 12 settembre 1916 (conservati alla Giorgio Cini di Venezia).
Da una lettera databile maggio 1917 in Courtault-Deslandes, Eleonora Duse attrice cinematografica: un’opera incompiuta, in «Notiziario del Museo nazionale del cinema», 34-35-36, 1977-79, p. 28. 48
49
R. Ascoli, Cinematografia e diritto, in «Diritto commerciale», serie 2, vol. V, I, 1913, p. 498.
50
Tiranty, La cinematografia e la legge, cit., p. 78.
51
S. Raffaelli, Regia, in Cinema film regia, Bulzoni, Roma 1978, pp. 201-288.
52
E. Rossi, Il tendine d’Achille, in «La vita cinematografica», 10 luglio 1914.
53
P.A. Gariazzo, Il teatro muto, Lattes, Torino 1919, pp. 255-257.
54
C. Tridenti, Cinematografo di poesia, in «In Penombra», a. II, n. 2, febbraio 1919, pp. 3-4.
55
S.A. Luciani, La idealità del cinematografo, in «In Penombra», a. II, n. 1, gennaio 1919.
G.C. Castello, Realismo, romanticismo e senso dello spettacolo nei film italiani sul Risorgimento a partire dal 1930, in «Bianco e Nero», a. XXIV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1963, p. 94. Cfr. anche G. Cincotti e G. Calendoli, Il Risorgimento italiano nel cinema e nel teatro, Editalia, Roma 1961. 56
F. Savio, Visione privata, Bulzoni, Roma 1972, p. 187. Il saggio di Savio, intitolato Il salotto della contessa Negroni, è uno dei primi tentativi critici di esplorare le differenze stilistiche e di stabilire le ascendenze e le caratteristiche culturali dei testi sopravvissuti e realmente visibili del muto italiano. Ed è un esempio di critica di gusto per molti versi ancora illuminante. Si veda anche G.P. Brunetta, L’évocation du passé. Les années d’or du film historique, in A. Bernardini e J. Gili (a cura di), Le cinéma italien (1905-1945), Centre George Pompidou, Paris 1986, pp. 55-60. 57
Dell’interesse di Maggi come autore dotato di una sua personalità all’interno dei primitivi del cinema italiano ha parlato solo Sadoul nella sua Storia generale del cinema, cit. e di recente Quargnolo nel citato saggio sugli autori apparso sui «Cahiers de la cinémathèque», n. 2627, 1979. 58
59
L. Rognoni, Il cinema muto, Ed. Bianco e Nero, Roma 1952, pp. 65-66.
60
Ibidem.
61
Si veda Sadoul, La tecnica rivoluzionaria nella Cabiria di Pastrone, cit.
Sul problema dell’invenzione dello spazio insiste giustamente R. Paolella nella sua Storia del cinema muto italiano, Giannini, Napoli 1956. 62
63
E. Guazzoni, Mi confesserò, in «In Penombra», a. I, n. 2, luglio 1918, pp. 55-57.
64
A. Bernardini, V. Martinelli e M. Tortora, Enrico Guazzoni. Regista pittore, La mongolfiera, Cosenza 2005.
65
Spartacus, in «Moving Picture World», vol. XX, n. 10, 6 giugno 1914.
Rossi, Il tendine d’Achille, cit. Ho sviluppato questo aspetto in Cent’anni di cinema italiano, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 92-96, cercando di isolare alcune personalità e di identificarne i tratti distintivi più generali. 66
Sadoul è uno dei pochi storici che sottolinea l’importanza del film di Maggi e della sua quadruplice ripartizione per lo sviluppo futuro delle strutture narrative di grande respiro diacronico, si veda la Storia generale del cinema. 67
Si veda la scheda critica che gli ha dedicato Aldo Bernardini in G.P. Brunetta (a cura di), Dizionario dei registi del cinema mondiale A-F, vol. I, Einaudi, Torino 2005, pp. 313-314. 68
La lettura più recente e più interessante in questo senso è di A. Cugier, Discours de l’idéologie et idéologie du discours, in «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979. 69
Attraverso un continuo gioco di metamorfosi estremamente ovvie e trasparenti l’ideologia nazionalistica unisce tutti i periodi del passato, esalta ogni forma di imperialismo, sia romano che veneziano, e dà pari importanza alle affermazioni italiane nel campo della cultura e in campo militare: così parla nel numero del 30.11.1914, a proposito di una versione del Fornaretto prodotta dalla Leonardo film, «La vita cinematografica»: «E nel tragico fatto s’erge e splende, emblema di giustizia, il Leone di San Marco, l’alto simbolo alato che ha portato per il mondo il nome e la gloria della grande Repubblica marinara». Si veda anche G.P. Brunetta, Ilveneto e il suo dialetto nel cinema italiano, in M. Cortelazzo (a cura di), Guida ai dialetti veneti, vol. VI, Cleup, Padova 1984, pp. 121-128. 70
G. Calendoli, Cabiria e il film della romanità, in Id., Materiali per una storia del cinema italiano, Maccari, Parma 1967, pp. 63-111. Il saggio offre alla fine anche una filmografia del film storico. 71
72
Su questo dato di fatto – al di là delle interpretazioni ideologiche – il consenso storiografico è concorde.
È sbagliato metodologicamente identificare tutta la produzione spettacolare con Cabiria, ma è indubbio che i mezzi profusi, i costi, la mobilitazione della stampa, il tipo di circolazione e l’influenza diretta e innegabile sulla cinematografia americana ne fanno comunque un punto di passaggio obbligato da cui non è possibile prescindere. A Segundo de Chomòn ha dedicato un documentatissimo volume S.G. Tharrats, Los 500 films de Segundo de Chomon, Universidad de Zaragoza, Zaragoza 1988. 73
Il testo è riprodotto nel volume G. Pastrone, Cabiria, a cura di M.A. Prolo, Museo nazionale del cinema/Il Castoro, Torino-Milano 2006, pp. 58-59. 74
75
S. Bush, in «Moving Picture World» del 6 giugno 1914 citato da D. Turconi, in I film storici italiani e la critica americana dal 1910 alla fine
del muto, in «Bianco e Nero», a. XXIV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1963, p. 52. 76
C. Lizzani, Il cinema italiano 1895-1979, Editori Riuniti, Roma 1979, p. 23.
77
E. Caballo, Cavalcata torinese, Tallone, Torino 1960, p. 230.
La storia del film è ben ricostruita, grazie al recupero di significativi documenti, da R. Redi, Il Christus di Giulio Antamoro e di Enrico Guazzoni, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 2002, ma prima per l’intelligenza critica è da segnalare il saggio di L. Michetti Ricci, Christus di Giulio Antamoro, in «Bianco e Nero», a. XLIV, n. 4, ottobre-dicembre 1983, pp. 109-121. 78
79
L. Delluc, Cabiria, in «Journal du Ciné-club», n. 2, 23 janvier 1920.
80
R. Mattozzi, Rassegna, Roma 1920, p. 96.
La cronaca giornalistica della serata e la circostanza della presenza di Lombroso sono citate dalla Prolo nella Storia del cinema muto italiano, Il Poligono, Milano 1951, p. 33. Ha analizzato ciò che resta di questi film A. Farassino, Frammenti neuropatologici, in «Immagine», 81
a. II, n. 3 fasc. V, gennaio-marzo 1992, pp. 1-4. Una biografia densa di aneddoti e con una buona appendice filmografica è quella di M.Vascon Vitrotti, Un pioniere del cinema: Giovanni Vitrotti, Coana, Trieste 1970. Si veda anche M.A. Prolo, Un operatore italiano in Russia, in «Cinema», a. VI, n. 125, 10 settembre 1941. La più recente e attendibile ricostruzione della biografia avventurosa del pioniere Vitrotti e della sua filmografia si deve a V. Martinelli, L’uomo con la macchina da presa, in «Griffithiana», a. IX, nn. 26-27 settembre 1986, pp. 11-63. 82
Per i rapporti tra Pirandello e l’avanzante civiltà tecnologica e per la ripresa di alcuni temi pirandelliani a trent’anni di distanza nell’opera di W. Benjamin, cfr. P. Puppa, Fantasmi come giganti, scena e immaginario in Pirandello, Patron, Bologna 1978, pp. 218 sgg. Inoltre C. Marra, Estetica cine fotografica come recupero della realtà, in AA.VV., Estetica e società tecnologica, Il Mulino, Bologna 1976 e R. Tessari, Il mito della macchina. Letteratura e industria nel primo novecento italiano, Mursia, Milano 1973. Nella vastissima bibliografia pirandelliana si segnalano tra gli studi più recenti, oltre a quelli già citati in un capitolo precedente, i saggi di M.A. Grignani, L. Lugnani e G. Aristarco in «Rivista di studi pirandelliani», a. V, n.s., n. 3, giugno 1985 e AA.VV., Si gira. Il romanzo cinematografico di Pirandello, Ed. del Centro studi pirandelliani, Agrigento 1987. Inoltre per l’ampiezza del quadro e dell’arco di rapporti pirandelliani col cinema segnalo N. Genovese, Risvolti cinematografici dell’opera pirandelliana, in AA.VV., Luigi Pirandello: poetica e presenza, Bulzoni, Roma 1987, pp. 567580. 83
84
Lizzani, Il cinema italiano 1895-1979, cit., pp. 22-23.
Il primo articolo emblematico, che pone Sperduti nel buio alla testa di un albero genealogico destinato a produrre i suoi frutti a lungo, è di U. Barbaro, Un film italiano di un quarto di secolo fa, in «Scenario», a. V, novembre 1936 (già ripreso con qualche variazione su «Cinema», con il titolo Vecchi film in museo, a. IV, n. 68, 25 aprile 1939), ora in Id., Servitù e grandezza del cinema, Editori Riuniti, Roma 1961, p. 147. L’accettazione della proposta di Barbaro da parte della generazione di giovani della rivista «Cinema» agli inizi degli anni Quaranta viene discussa in un capitolo successivo. Nel dopoguerra l’ipotesi viene mantenuta e la scomparsa del film contribuisce certo ad aumentarne l’alone mitico. Cfr. F. Venturini, Origini del neorealismo, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 2, febbraio 1950, p. 32; A. Banti, Neorealismo nel cinema italiano, in «Paragone», a. I, n. 8, agosto 1950; G. Aristarco, Alla ricerca del tempo perduto, in «Cinema», n.s., a. V, n. 93, 1° settembre 1952, p. 94; M. Mida, Una tradizione per il nostro cinema, in «Eco del cinema e dello spettacolo», a. V, n. 69, 31 marzo 1954, p. 3; L. Chiarini, Il film nella battaglia delle idee, Bocca, Milano 1954, p. 112. Un modesto tentativo di ridimensionamento critico è stato tentato da G. Ferrara, Mitologia del film muto, in «Inquadrature», nn. 5-6, ottobre 1958-settembre 1959, pp. 1-2. 85
R. Paolella, Contributi alla storia del cinema italiano (Cinema napoletano), in «Bianco e Nero», a. IV, n. 9, agosto 1940, riportato in Verdone e Autera (a cura di), Antologia di Bianco e Nero, cit., vol. III, tomo I, pp. 147-148. Si vedano anche le osservazioni di Savio in Visione privata, cit., pp. 171-172. Si veda anche S. Masi e M. Franco, Il mare, la luna, i coltelli. Per una storia del cinema muto napoletano, Pironti, Napoli 1988. 86
Cfr. P. Bianchi, La Bertini e le dive del cinema muto, Utet, Torino 1969; F. Bertini, Il resto non conta, Giardini, Pisa 1969. Nella seconda puntata del documentario L’ultima diva girato nel 1981 da G. Mingozzi, l’attrice, rivedendo a oltre sessant’anni di distanza una copia del film, ne ricostruisce la storia e i modi di lavorazione. 87
R. Bracco, La cinematografia, Francesca Bertini, Giovanni Grasso e io, in «Comoedia», 15 giugno 1929. Si veda anche per capire l’itinerario politico di Bracco, M. Quargnolo, La lunga contesa fra Bracco e il fascismo, in «L’Osservatore politico e letterario», marzo 1967; L’amicizia Bracco Amendola all’insegna dell’antifascismo, in «Gazzettino di Venezia», 16 aprile 1967; Contributo alle ricerche per la storia del cinema. Roberto Bracco, in «Bianco e Nero», a. XXX, nn. 7-8, luglio-agosto 1969. Dal 1912, fino al 1922-1923, quasi ogni anno un dramma o una commedia di Bracco hanno la loro trasposizione cinematografica, dal Diritto di vivere (1912) a Don Pietro Caruso (1916), Una donna (1917), Nellina (1920), La piccola fonte (1917), La principessa (1917), Maternità (1917), Il perfetto amore (1918), Il piccolo santo (1920), La fine dell’amore (1920). Nel 1987 Alfredo Barbina ha pubblicato la sceneggiatura di Sperduti nel buio (Eri, Torino), nonché un gruppo di lettere e una ricca documentazione fotografica. In precedenza però Sarah Zappulla Muscarà aveva già pubblicato una importante documentazione e una serie di contributi inediti e originali sull’autore del film e sui suoi rapporti col cinema: Verga,De Roberto Capuana Martoglio e la settima arte, in Ead. Letteratura teatro cinema, Tringale, Catania 1984, pp. 285-288 e Sperduti nel buio, un antesignano del neorealismo, in AA.VV., Il neorealismo nella letteratura e nel cinema italiano, Pcc, Assisi 1987, pp. 117-149. Inoltre sono ancora da tener presenti V. Martinelli, Il carteggio Bracco-Troncone, in «Immagine», a. II, n. 3, fasc. V, gennaio-marzo 1982, pp. 11-16, e M. Quargnolo, Bracco e il cinema; primo e secondo tempo, in «Immagine», n. s., n. 4, inverno 1986-87, pp. 25-29. 88
89
Barbaro, Un film italiano di un quarto di secolo fa, cit., e riprodotto anche in Id., Servitù e grandezza del cinema, cit., p. 147.
È un’ipotesi che avanza Savio, in Visione privata, cit., p. 168. Il terreno di una storiografia comparata resta tuttora aperto a ricerche più rigorose, meno affidate a osservazioni empiriche e immediate, ma più fondate sulle fonti, sulla circolazione reale dei film, sull’identificazione della competenza cinematografica dei registi, sulla maturazione di un grado progressivo di consapevolezza del carattere sovranazionale del linguaggio cinematografico. 90
91
Il brano tratto dal numero del 2 agosto 1879 dell’«Arte drammatica» è riportato da G. Ciotti Cavalletto, Attrici e società nell’ottocento
italiano, Mursia, Milano 1978, p. 159. Savio, Visione privata, cit., pp. 174-175. Oltre agli articoli già citati nel capitolo sul divismo si veda anche M. Corsi, Cinema della Duse, in «Cinema», a. V, n. 97, 10 luglio 1940. Un saggio e una descrizione analitica del film, nonché una ricca antologia di materiali inediti, sono raccolti in A. Cara, Cenere di G. Deledda nelle figurazioni di E. Duse, Istituto superiore regionale etnografico, Nuoro 1984. 92
93
M. Gromo, Cinema italiano, Mondadori, Milano 1954, p. 26.
Una filmografia ancora largamente incompleta, ma già con notevoli integrazioni rispetto a quella offerta dalla Prolo, è in J. Pantieri, Gli eroi della risata, Giordano, Milano 1965, pp. 183 sgg. Una svolta decisiva allo studio del fenomeno è stata data dalla retrospettiva della Giornata del cinema muto di Pordenone del 1985 e dai saggi e dalla filmografia del volume P. Cherchi Usai e L. Jacob (a cura di), I comici del muto italiano, in «Griffithiana», a. VII, nn. 24-25, ottobre 1985. 94
Si veda E. Mosconi (a cura di), L’oro di Polidor. Ferdinand Guillaume alla Cineteca Italiana, Il Castoro, Milano 2000. La Cineteca Italiana di Milano conserva il maggior numero di comiche di Polidor. 95
Sarà il futuro regista del film religioso-spettacolare Christus. Il lavoro registico sulle comiche ha comunque per i registi e le case di produzione un’importanza fondamentale nella formazione professionale. L’attore non richiede un regista dall’altra parte della macchina da presa e il regista può impadronirsi di tutti i maggiori meccanismi narrativi e di certi procedimenti tecnici che vengono sempre più esaltati dalla comica. 96
Di recente ad André Deed è stata dedicata da Jean A. Gili una monografia, frutto di un lungo periodo di lavoro, che mette finalmente a fuoco l’importanza di questo pioniere della comicità che ha lavorato con eguale successo lungo più di un decennio in Francia e Italia, André Deed. Boireau, Cretinetti, Gribouille, Toribio, Foolshead, Lehman, Cineteca di Bologna/Le Mani, Bologna-Recco 2005. 97
Pantieri, Gli eroi della risata, cit., p. 43. Il primo lavoro d’insieme sui comici italiani, sulle loro radici e sulla loro presenza lungo tutta la storia del cinema nazionale è di M. Verdone, Umanesimo del comico, in Id. (a cura di), Il film comico, in «Sequenze», a. II, nn. 5-6, gennaio-febbraio 1950, pp. 2-16. 98
M. Verdone, Polidor, l’ultimo dei Guillaume, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 3, marzo 1952 e G. Calendoli, Breve incontro con la comica finale, in «Bianco e Nero», a. XIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1954, ora in Id., Materiali per una storia del cinema italiano, cit., pp. 47-58. 99
A. Costa, Il mondo rigirato: Saturnino versus Phileas Fogg, in P. Bertetto e G. Rondolino, Cabiria e il suo tempo, Museo nazionale del cinema, Torino-Milano 1998, pp. 295-310, ora in A. Costa, I leoni di Schneider, Bulzoni, Roma 2002. 100
101
Si veda anche E. Mosconi (a cura di), L’oro di Polidor. Ferdinand Guillaume alla Cineteca Italiana, Il Castoro, Milano 2000.
Da M. Verdone, soprattutto in Cinema e letteratura del futurismo, Ed. Bianco e Nero, Roma 1968 e Poemi e scenari cinematografici d’avanguardia, Officina, Roma 1975, p. 27. Del film parla anche Pantieri, Gli eroi della risata, cit., pp. 55-56. 102
103
Pantieri, Gli eroi della risata, cit., p. 75.
104
Nelly, in «La vita cinematografica», a. III, n. 14, 30 luglio 1912.
105
A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 336-337.
Savio, Visione privata, cit., p. 173. Su Ghione si vedano anche G.G. Napolitano, Omaggio a Ghione, in «Prospettive», a. I, n. 2, 1937, pp. 23-26; F. Soro, Splendori e decadenza di Za-la-Mort, in «Cinema», a. III, n. 37, 10 gennaio 1938, p. 22; G. Calendoli, L’amabile teschio di Za-la-Mort e il film a dispense, in «Filmcritica», a. II, n. 18, novembre 1952, ora in Id., Materiali per una storia del cinema italiano, cit., pp. 151-161. In questi anni i film recuperati non hanno modificato il giudizio, anche se le conoscenze si sono sicuramente fatte meno incerte: si veda il mio Emilio Ghione, in Catalogo della mostra internazionale del cinema, Biennale, Venezia 1979, pp. 79-83. 106
107
Calendoli, Materiali per una storia del cinema italiano, cit., p. 151.
108
U. Barbaro, Neorealismo, in G.P. Brunetta (a cura di), Neorealismo e realismo, 2 voll., Editori Riuniti, Roma 1976.
109
La prima filmografia dei serial italiani è stata stabilita da V. Martinelli, Filmographie des serials et des film à épisodes du cinéma muet
italien, in «Cahiers de la cinémathèque», n. 48, 1987, pp. 111-120. Il fondatore di questo diffuso luogo comune è Luigi Chiarini che, col suo tentativo di stabilire i primati nazionalistici del primo cinema italiano, dopo la retrospettiva romana del 1935 in occasione del XL anniversario della cinematografia, giunge a ipotizzare addirittura vere e proprie forme di plagio da parte di Lubitsch dell’opera di D’Ambra. L. Chiarini, Cinematografo, Cremonese, Roma 1935, pp. 107-108. Cfr. anche C. Pavolini, L. D’Ambra precursore di Lubitsch, in «Scenario», a. IV, n. 1, gennaio 1935. Va detto comunque che, al di là dei saggi critici, che si fondano per lo più su una memoria assai posteriore (della ricca produzione di D’Ambra non è visibile alcuna opera a quanto mi risulti), il migliore press-agent e interprete dell’opera di D’Ambra fu lui stesso: si vedano Trent’anni di vita letteraria, 3 voll., Corbaccio, Milano 1928-1929 e Sette anni di cinema, in «Cinema», a. II, nn. 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 33, 35, 39 dal 25 gennaio 1937 al 15 febbraio 1938. Giovanni Grazzini ha curato i diari di D’Ambra negli anni Trenta, premettendovi una densa introduzione (Gli anni della feluca, Lucarini, Roma 1989) e in appendice ha ripubblicato I sette anni di cinema. 110
G. Calendoli, Il grottesco roseo di Lucio D’Ambra, in Id., Materiali per una storia del cinema italiano, cit., p. 131. Si vedano anche le pagine di Bianchi in La Bertini e le dive del cinema muto, cit., in particolare pp. 107 sgg. 111
112
Il primo vero importante saggio critico su D’Ambra è di G. Calendoli, Il grottesco roseo di Lucio D’Ambra, in Id., Materiali per una storia
del cinema italiano, cit., pp. 125-133. 113
D’Ambra, Trent’anni di vita letteraria, cit. In particolare si veda il dodicesimo capitolo del secondo volume.
114
A cura di Adriano Aprà e Luca Mazzei è uscito di recente un importante numero monografico di «Bianco e Nero», Lucio D’Ambra. Il
cinema, n. 5, 2002 che costituisce il primo vero contributo allo studio della sua opera. 115
Del film esiste una copia nell’archivio cinematografico della Library of Congress di Washington.
U. Barbaro, Histoire d’un Pierrot, in «Bianco e Nero», a. I, n. 1, gennaio 1937, ristampato in Id., Servitù e grandezza del cinema, cit., pp. 150 sgg. 116
117
Il testo del prologo è riportato nel «Notiziario del Museo nazionale del cinema», a. IX, nn. 25-26-27, gennaio-dicembre 1974, pp. 13-16.
Il testo di Marinetti è pubblicato sul numero dell’«Impero» del 1° dicembre 1926 e ristampato da Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit. e più di recente, con qualche taglio, da G. Rondolino, Il cinema astratto. Testi e documenti, Stampatori, Torino 1977, pp. 118
151-153. I contributi più sistematici su questo terreno sono di M. Verdone: oltre al più volte ricordato Cinema e letteratura del futurismo, si vedano i più recenti Le avanguardie storiche del cinema, Sei, Torino 1977; Poemi e scenari cinematografici d’avanguardia, cit.; La cultura del film, Garzanti, Milano 1977; Teatro e cinema futurista, in «Cinemateca», a. I, n. 1, 1977, pp. 61-68. Si veda inoltre G. Aristarco, Teorica futurista e film d’avanguardia, in «La Biennale», nn. 36-37, luglio-dicembre 1959. In occasione della grande mostra veneziana di Palazzo Grassi, Futurismo e Futurismi, è stato pubblicato un catalogo, Velocittà-Cinema e futurismo, Bompiani, Milano 1986, con vari contributi importanti tra cui quelli di Paul Virilio e Paolo Bertetto. Di vari autori è pure Cinema e futurismo, Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Agrigento 1987. Un saggio con alcune informazioni originali è in G. Lista, Ginna e il cinema futurista, «Il lettore di provincia», a. XVIII, n. 69, pp. 17-26. Si tenga anche presente il volume collettaneo R. De Felice (a cura di), Futurismo cultura e politica, Fondazione Agnelli, Torino 1988 e in particolare il contributo di M. Verdone, Spettacolo politico e 18 BL, pp. 483-487. Infine si veda il libro collettaneo G.P. Brunetta e A. Costa (a cura di), La città che sale, Manfrini, Rovereto 1990. 119
Sui rapporti tra cinema e futurismo esiste una cospicua letteratura, ma i testi di riferimento più significativi sono Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., Poemi e scenari cinematografici d’avanguardia, cit., fino al recente Futurismo e cinema, in AA.VV., La città del cinema, Skira, Milano 1995, e una serie di contributi di Giovanni Lista, tra cui I futuristi e la fotografia, Museo civico d’arte contemporanea, Modena 1985, La scène futuriste, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, Paris 1989, La ricerca 120
cinematografica futurista, in G.P. Brunetta e A. Costa (a cura di), La città che sale, Manfrini, Trento 1990, pp. 30-37, Lo spettacolo futurista, Cantini, Firenze 1991, Un inedito marinettiano: «Velocità», film futurista, in «Fotogenia», n. 2, 1995, pp. 6-25, Cinema e fotografia futurista, Skira, Milano 2001. 121
G. Lista, Futurisme et cinéma, in G. Viatte (a cura di), Peinture, Cinéma, peinture, Hazan, Paris 1989, p. 59.
F.T. Marinetti et al., Cinematografia futurista. Manifesto, in «L’Italia futurista», a. I, n. 10, 15 novembre 1916, ora in F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, Mondadori, Milano 1968, p.104. 122
123
F.T. Marinetti, La cinematografia astratta è un’invenzione italiana, in «L’Impero», 1° dicembre 1926.
124
E. Settimelli, La prima nel mondo della Cinematografia Futurista, in «L’Italia futurista», a. II, n. 1, 10 febbraio 1916.
L’affermazione è riportata in Rondolino, Il cinema astratto, cit., p. 4. Il testo originale si trova in L’arte dell’avvenire, Beltrami, Bologna 1911, p. 36. 125
La teorizzazione di questi esperimenti è pubblicata nel testo di B. Corra, Il pastore, il gregge e la zampogna, Beltrami, Bologna 1912 e ripreso sia nelle antologie citate di Verdone e Rondolino. In questo scritto Corra descrive i suoi esperimenti e il testo ha indubbiamente una grande importanza. 126
Il testo è ripubblicato con tre importanti saggi in appendice di M. Fagiolo, M. Calvesi e F. Menna da Einaudi nel 1970. Si vedano inoltre C.L. Ragghianti, Fotodinamismo futurista, in «Selearte», n. 38, gennaio-febbraio 1959 e anche Balla e la fotodinamica di Bragaglia, in «Critica d’arte», settembre 1965, p. 10; M. Verdone, Anton Giulio Bragaglia, Ed. Bianco e Nero, Roma 1965; il n. 4 del 1966 della rivista austriaca «Maske und Kothurn»; M. Calvesi, Dinamismo e simultaneità nella poetica futurista, Feltrinelli, Milano 1967; M. Verdone, Sommario di dottrine del film, Maccari, Parma 1971, p. 91. 127
L’importante testo di Corra è pubblicato, assieme al Manifesto del futurismo e all’articolo La cinematografia astratta è un’invenzione italiana, da Rondolino, Il cinema astratto, cit., pp. 131-144. 128
Il saggio Fotodinamismo futurista, nonché le fotografie, dopo un’uscita clandestina in opuscolo nel 1911 appaiono in una seconda edizione nel 1913. 129
130
P. Virilio, Guerre et cinéma: logistique de la perception, Éditions de l’Etoile, Paris 1984.
Il manifesto cinematografico del futurismo è pubblicato per la prima volta su Italia futurista, n. 9, 11 settembre 1916 e lo si trova riprodotto in varie antologie sul futurismo, nell’Antologia di Bianco e Nero, cit., vol. I. Cfr. anche il mio Letteratura e cinema, Zanichelli, Bologna 1976, pp. 10-14. 131
132
C. Belloli, Poetiche e pratiche d’avanguardia dalle origini agli anni trenta, in «La Biennale», a. XIV, n. 54, settembre 1964, p. 39.
133
Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., pp. 105 sgg.
134
Belloli, Poetiche e pratiche d’avanguardia dalle origini agli anni trenta, cit., pp. 39-40.
È Arnaldo Ginna a ricordare la sequenza: «Una cariatide seduta, che ha l’effigie di Francesco Giuseppe, viene invitata dalla Morte. La Morte è Remo Chiti, vestito di una maglia nera su cui è dipinto uno scheletro. Ma la Morte non riesce a prendere la cariatide dell’Imperatore: sviene per il puzzo che ne irradia», Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, cit., p. 106. 135
136
Si veda anche J. Comin, Appunti sul cinema d’avanguardia, in «Bianco e Nero», a. I, n. 1, gennaio 1937.
137
Verdone, Anton Giulio Bragaglia, cit., p. 158.
M. Fagiolo, Moderna magia, in Bragaglia, Fotodinamismo futurista, cit., p. 201. V. Martinelli ha affiancato a Bragaglia il nome di Riccardo Cassano come autore materiale del film, attribuendo piuttosto a Bragaglia una sorta di «paternità morale»: Due registi e un produttore, in «Immagine», n. s., n. 2, primavera 1986, pp. 8-10. Nello stesso numero si veda la descrizione analitica di J. Gili, Thaïs, pp. 1-7. 138
M. Verdone, I film di D’Annunzio e da D’Annunzio, in AA.VV., D’Annunzio e il cinema, in «Quaderni del Vittoriale», n. 4, agosto 1977, p. 22. Si veda anche P.M. De Santi, Cinema e pittura, in «Art Dossier», inserto al n. 16, settembre 1987, pp. 7-11. 139
140
A.G. Bragaglia, L’arcoscenico del mio cinematografo, in «In Penombra», a. II, gennaio 1919, p. 24.
141
M. Isnenghi, Giornali di trincea, Einaudi, Torino 1977.
È l’unico punto di parziale dissenso rispetto alle posizioni di M. Isnenghi, L’immagine cinematografica della grande guerra, in «Rivista di storia contemporanea», n. 3, 1978, pp. 341-353. 142
Di questi materiali si è occupato Andrea Fava che ne ha curato la sistemazione e catalogazione all’Archivio centrale dello Stato e ne ha dato informazione al convegno su Contadini e operai durante la grande guerra tenuto a Vittorio Veneto nel dicembre del 1978 (gli atti sono stati pubblicati a cura di Mario Isnenghi da Cappelli nel 1982). In tempi più recenti il tema è stato rifuso più volte – anche da chi scrive – in occasione di convegni storici nella grande guerra: cfr. il mio La guerra lontana, Zaffoni, Rovereto 1985 e le ricerche che ho guidato sulle reazioni del pubblico veneto agli spettacoli cinematografici durante gli anni di guerra. Una considerevole serie di ricerche è stata avviata negli ultimi decenni anche sull’intero sistema iconografico della grande guerra. Mi limito a segnalare, per quanto riguarda la fotografia, il saggio di A. Schwartz, La guerra rappresentata, in «Rivista di storia e critica della fotografia», a. I, n. 1, ottobre 1980. 143
M. Isnenghi, I vinti di Caporetto, Marsilio, Padova 1967 e Id., Il mito della grande guerra, Laterza, Bari 1970, ristampato presso Il Mulino nel 1989. Una sintesi aggiornata di problemi e di indicazioni storiografiche e di posizioni è in G. Rochat, L’Italia nella prima guerra mondiale, Feltrinelli, Milano 1976. Cfr. anche le voci Interventismo e Prima guerra mondiale, curate da Mario Isnenghi, nel primo volume del Mondo contemporaneo, La Nuova Italia, Firenze 1978. 144
145
F. Striglia, La grande retrovia, Treves, Milano 1916. La conseguenza più macroscopica è che nonostante l’enorme quantità di materiali
documentari e di finzione la rappresentazione della guerra non è mai data – se non a partire dal 1917 – nella sua modernità di mezzi e di strategie, ma è sempre vista come un’appendice delle guerre ottocentesche. 146
La citazione è tratta da una rielaborazione ancora inedita del saggio di Isnenghi, L’immagine cinematografica della grande guerra, cit.
147
L. Delluc, Cinéma, in «Paris-Midi», 27 juin 1919.
La crisi del dopoguerra
verso la catastrofe, con allegria La guerra passa senza lasciare tracce sensibili e immediate sul comportamento esterno dell’industria cinematografica che pare intenzionata a vivere di rendita, alle spalle di un’età dell’oro dei grandi trionfi internazionali, senza prendere atto delle condizioni nuove del mercato che richiederebbe una completa ristrutturazione della logica produttiva. Anziché avvertire subito i segni di una situazione che ha mutato in maniera profonda le caratteristiche dei prodotti internazionali e del pubblico e sentire l’esigenza di un rinnovamento dei modi di produzione, gli industriali continuano a produrre con i medesimi criteri dell’anteguerra e l’industria, anziché registrare un arresto, o una contrazione, vede un incremento continuo sia nella nascita delle case di produzione che nel numero di opere immesse sul mercato. Per un paio d’anni la frenesia produttiva sembra voler esorcizzare gli spettri della crisi: quando non sarà più possibile sottrarsi all’evidenza, la reazione sarà simile a uno shock di ritorno di fronte al quale l’unica terapia possibile sembrerà quella del «si salvi chi può». Se si tiene conto dell’estrema parcellizzazione delle case e degli interessi produttivi, al di là dell’ambizioso e megalomane progetto di dar vita a una concentrazione monopolitistica, è chiaro che soltanto alcuni interessi particolari riusciranno a sopravvivere evitando al massimo i danni. Pur ancora in grado di occupare, nel suo insieme, una notevole quantità di lavoratori, l’industria cinematografica, strutturalmente debole, non si sente parte in causa del processo produttivo nazionale e non si è ancora organizzata in modo da riuscire a proteggere i propri interessi e ottenere aiuti governativi nella fase di passaggio dall’economia di guerra a quella di pace. Lucio D’Ambra, proprio per il fatto di essere – al tempo stesso – produttore, regista, soggettista, e critico cinematografico tuttofare, interviene con una delle prime analisi corrette della situazione. Già dall’agosto del 1918, denuncia, in un articolo molto polemico, il fatto che i rappresentanti dell’industria cinematografica non abbiano partecipato all’incontro tra industriali e forze politiche governative e rileva che «mentre artisticamente in pochi anni il cinema italiano ha fatto passi da gigante, industrialmente esso è rimasto al caos demente, all’anarchia iniziale, insomma, alla più completa disorganizzazione» . In effetti la situazione produttiva nei quattro maggiori centri ci presenta un quadro assai ricco di realizzazioni e di film progettati o in cantiere, ma ciò che soprattutto stupisce è l’estrema varietà di nomi, la nascita continua di nuove case dove, ai vecchi industriali di tipo aristocratico e alto-borghese, si affiancano o si sostituiscono industriali improvvisati, che rischiano i propri capitali molto spesso nella realizzazione di un solo film. Un censimento pressoché completo di tutte le case e di tutti i tipi di operatori, dagli attori ai registi, ai distributori, agli esercenti, viene fornito nell’importante Rassegna curata da Mattozzi nel 1920, che, con le sue più di mille pagine, vuole sembrare uno strumento pubblicitario di un’industria ancora in piena salute . Sulla base delle indicazioni di questo volume si può tentare di comporre, almeno nei suoi punti di riferimento più importanti, una mappa orientativa, tenendo presente che, se le maggiori città di produzione continuano a restare Milano, Torino, Roma e Napoli, il maggiore incremento ha ormai scelto, come sede privilegiata, la capitale. Segno questo che l’industria del Nord, gestita con una maggiore e più moderna coscienza imprenditoriale risente in modo più diretto e immediato della crisi e preferisce difendere le posizioni con un atteggiamento che si potrebbe definire «riflessivo» piuttosto che allargare l’area degli investimenti. Per capire meglio il senso complessivo della flessione di vendite all’estero, vale la pena rifarsi ancora una volta ai dati del prospetto dell’articolo di De Marco in cui, oltre alla perdita completa dei mercati dei paesi 1
2
nemici, c’è la rapida contrazione, anno per anno, della domanda anche in paesi neutrali, come l’America del Sud, dove si passa da un’entrata di 800.000 lire nel 1916 (per 8.012 kg di pellicola esportata) a un’entrata di 291.610 lire nel 1919 per 2.651 kg di pellicola impressionati . Così calano in misura altrettanto forte le esportazioni in Francia, Inghilterra, Svizzera, Brasile, oltre che negli Stati Uniti, che, nel 1918, varano leggi protezionistiche per rendere assai difficile e poco produttiva la penetrazione nel mercato come nell’anteguerra. Resta la Spagna, unico paese nei confronti del quale non si registrano flessioni: la constatazione non può essere troppo confortante se si tiene conto del livello di sviluppo della cinematografia spagnola che, in quegli anni, è assai basso. Oltre alle cause generali ne vanno segnalate altre più specifiche, che riguardano l’aumento delle spese di assicurazione, la speculazione dei distributori, l’aumento dei costi dei trasporti a cui vanno aggiunti gli aumenti dei costi a tutti i livelli (da quelli dell’acquisto della pellicola vergine, alle spese di regia, ai compensi per gli attori, ai costi di manodopera e così via). La riorganizzazione industriale del cinema americano e la produzione di opere che si ponevano esplicitamente come destinatari i pubblici di tutto il mondo, la scelta di modelli narrativi elementari, fondati su strutture ripetitive, spesso privi del peso di una cultura anteriore, ma capaci di riuscire a comunicare direttamente anche ai pubblici meno alfabetizzati i valori di nuove mitologie e di nuovi oggetti di culto, emarginano via via la produzione italiana che non offre più alcun punto a proprio favore di reale competitività. La situazione nel 1919 delle case di produzione con un minimo di visibilità, e la loro distribuzione sul territorio nazionale, è all’incirca la seguente. A Torino: l’Audax, l’Ambrosio, la Pasquali, la Savoia, la Latina Ars, la Navone, l’Aquila, l’Electa, la Fabrièges, la Cleo, la Rodolfi, l’Amerio, la Gladiator, l’Itala, la Cenesio, l’Excelsa, l’Albertini; a Napoli: la Lombardo, la Flegrea, la Bouvier, la Medusa, la Poliphilms, la Dramatica; a Milano: la Lombarda, l’Armenia, la Psiche, la Silentium, la Fortuna; a Roma: l’Historica, la Caesar che consorzia la Bertini film, la Cines, l’Olympus, la D’Ambra Film, la Celio, la Palatino, la Rinascimento, l’Etrusca, la Propaganda, la Castelli, la Vera, la Volsca, la Film d’Arte, la Medusa, la Tespi, la Silentium, la Filmagraf, la Colosseum, la Lux artis, la Brenon, l’Arcana, l’Aventino, la Capitolium, l’Appia nuova, la Carminati, l’Azienda nazionale cinematografica, la Chimera, la Cinegrafica, la Fidia, ecc. A queste vanno aggiunte altre case sparse un po’ovunque da Cefalù, a Palermo, a Firenze e in altri centri. Tra le case di tradizione più consolidata in piena attività è ancora la Cines, che mette in cantiere, per l’inizio della stagione 1918, i seguenti titoli: Primerose, Il tesoro d’Isacco, Il castello del diavolo, Il dramma di una stirpe, La preda, Il gioiello di Khama, Reginetta Isotta, L’incubo. Vengono mantenute le caratteristiche già collaudate di una mescolanza di prodotti drammatici con opere a sfondo storico con altre più dichiaratamente avventurose. Su un identico binario procede l’Itala di Torino, portando sullo schermo la prima versione cinematografica di Addio giovinezza! con la regia di Augusto Genina (in omaggio a Oxilia, morto in guerra) e annunciando titoli come Walter Scott, Il matrimonio di Olimpia, I nove milioni di Bonald. L’Ambrosio progetta opere più ambiziose come La nave, la cui regia verrà affidata al figlio dello stesso D’Annunzio, Gabriellino e in cui si cerca di riaffermare la legittimità delle aspirazioni alla riconquista dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Tra le case romane notevole è il tentativo di continuare a creare opere cinematografiche tratte da testi teatrali di successo: Sardou e Bataille, Mirabeau, de Flers e Caillavet, Hennequin e Duquesnel, ma anche Niccodemi e Gerolamo Rovetta vengono saccheggiati. Da Sardou, in uno stesso anno, sono tratti Dora o le spie, Giorgina e Spiritismo, con Francesca Bertini. Si è abbandonato il clima del satanismo e della perversione della letteratura del decadentismo e ci si avvicina di preferenza alla pochade, al dramma borghese: il clima e i mondi rappresentati non comportano un rovesciamento dell’ottica ideologica o una diversa presa di distanza. Non c’è in sostanza né la scoperta né la ricerca di un nuovo pubblico, ma soltanto lo spostamento da un settore letterario e teatrale ormai sfruttato a un altro che riscuoteva ancora successi presso i pubblici borghesi. Lo stile della Caesar, la casa che distribuisce la Bertini («La Caesar è come Cesare: impera!», dice il suo motto), è rappresentato assai bene dalla presentazione divistica dell’attrice Mina D’Orvella: «Un’autentica dama, che gode meritata fama di essere tra le più belle, le più eleganti e le più intellettuali donne d’Italia, debutterà tra poco sulle scene mute». 3
Al Sud alla Lombardo si realizza La donna che inventò l’amore dal romanzo di Guido Da Verona, e si acquista un film futurista di Ginna (si tratta forse di Vita futurista). Anche questa semplice informazione è importante per capire la vivacità e l’apertura di iniziative su più fronti. La Lombardo è una delle poche case italiane che non partecipa al trust dell’Uci e riesce a passare attraverso la crisi senza danni: nel 1920, quando già gli stabilimenti di Torino, Milano, Roma, chiudevano i battenti, Gustavo Lombardo lanciava sul mercato sei film: Un cuore nel mondo, I figli di nessuno, Friquet, Scrollina, Il voto, Mimí fanfara . A getto continuo lavora per un paio d’anni la D’Ambra Film, dove lo stesso D’Ambra accentra su di sé tutti i ruoli del processo di produzione, da quello di produttore a quelli di soggettista, sceneggiatore e regista. Nel 1918, seguendo il suo ritmo frenetico di realizzazione, D’Ambra termina Il barone Cent’anni e il visconte Gioventù, Il bacio di Cyrano, Il girotondo di undici lancieri, La Valse bleu, I cinque Caini. Nel giro di pochi anni D’Ambra ha raggiunto un tale livello di specializzazione nella commedia brillante, e un «tocco» così leggero ma preciso nella rappresentazione che si merita l’appellativo di «Goldoni della cinematografia italiana» . Gran parte della produzione di questo autore come si è detto è andata perduta a eccezione di Le mogli e le arance (1917), ritrovato di recente in Austria al Filarchiv di Vienna e di un breve «scherzo» di 600 metri (L’illustre attrice Cicala Formica) ritrovato alcuni anni fa. Un testo minimo e tutto sommato poco rappresentativo delle qualità e caratteristiche del regista che, come si è detto, godono almeno fino agli inizi degli anni Venti di buon successo e di stima sia presso il pubblico che presso la critica. Tra le case esordienti la milanese Lombarda inaugura la sua attività col Mistero della corona, la Historica film di Roma (società che intendeva specializzarsi solo per «le film storiche») esordisce con un Leonardo da Vinci diretto da Mario Corsi, opera interessante perché si tenta, per la prima volta, l’applicazione della visione stereoscopica secondo il sistema brevettato da Lamberto Pineschi. L’Armenia film di Milano realizza La carezza del vampiro e Delitto mascherato, e la Gladiator di Roma Il principe Zilah. Interessante, tra i molti titoli, Le rose del martirio, messo in scena dalla Tespi film di Roma (su soggetto di Sem Benelli e regia di Mario Corsi) film di propaganda per la Croce Rossa di cui si vuole nobilitare l’opera con un vasto affresco di tipo nazionalistico: «Quadri giganteschi per ricostruzioni storiche, per inusitato movimento di masse, si comporranno in corona votiva ovunque si afferma l’amor di patria – dice l’annuncio pubblicitario che appare su «In Penombra» nel 1918 – dallo Stelvio al mare, dal modesto abituro al palazzo patrizio, dai campi alla Reggia. Genova, Milano, Torino, Roma, tutta l’Italia, ecco lo sfondo dove si snoderà l’austera vicenda di Sem Benelli». La fine della guerra non segna dunque un netto momento di separazione tra periodo d’oro e crisi, in quanto, come si è visto, la produzione continua ad avanzare sfruttando la spinta precedente. Tuttavia non si può procedere all’infinito adottando la tattica dello struzzo. Non appena i responsabili delle maggiori case percepiscono chiaramente i pericoli di una produzione tutta disgregata e tutta proiettata alla conquista di un mercato interno insufficiente, l’unica strada che sembra aprirsi per superare in tempi brevi la crisi e coordinare l’azione sparsa delle case di produzione è quella che si tradurrà, nel giro di poco tempo, nella formazione e realizzazione del primo e unico progetto di concentrazione monopolistica di tutta la storia del cinema italiano. 4
5
1
L. D’Ambra, Il problema industriale del cinematografo, in «In Penombra», a. I, n. 3, agosto 1918.
2
R. Mattozzi, Rassegna generale della cinematografia, Soc. Ed. Rassegne, Roma 1920.
3
A. De Marco, La produzione e l’esportazione, cit., si veda il cap. II.
AA.VV., Cinema popolare napoletano, catalogo curato in occasione del Festival nazionale dell’«Unità», del settembre 1976, dalla Cineteca Altro, p. 7. Si vedano le pagine del volume Titanus di Bernardini e Martinelli (Coliseum, Roma 1986), dedicate agli anni Venti. 4
5
Cfr. a p. 165 della citata Rassegna del Mattozzi.
Ascesa e caduta dell’Unione cinematografica italiana
un gigante dai piedi d’argilla Una breve notizia di cronaca appare su «In Penombra» nel 1918: «Il trust cinematografico italiano lo si annuncia da parecchio tempo. Oggi si dice un fatto compiuto». In effetti il progetto di unire le forze della produzione, indebolite e disgregate, che maturava già durante gli ultimi mesi di guerra, si concreta soltanto all’inizio del 1919: «Auspice il barone Alberto Fassini e col concorso finanziario della Banca commerciale italiana e della Banca italiana di sconto a cui più tardi si unì anche il Credito delle Venezie, fu firmato, in data 9 gennaio 1919, il compromesso per la costituzione della Società anonima Unione cinematografica italiana (Uci); costituzione che fu effettuata con solennità e salutata con parole di plauso e di angoscia dalla stampa il 3 gennaio 1919. L’Uci avente sede a Roma sorse con un capitale di 30.000.000 di lire elevato poi a 50, 60 e 75 milioni!» . Prima della guerra, come si è visto, il cinema era un’industria fiorente: l’intervento dei capitali bancari, effettuato sui modelli dei gruppi Federal Trust e First National Bank, nell’industria del cinema americano nasce dalla speranza di investire con eguali profitti. La nascita dell’Uci e l’indubbia base finanziaria su cui si può contare vanno collocate di fatto in quest’ottica. Il consistente impegno finanziario e le possibilità di disporre di anticipi e di capitali liquidi, uniti all’adesione delle più importanti case produttrici, conferiscono all’iniziativa un carattere apparente di progetto a lungo termine, capace altresì di risolvere le difficoltà immediate, grazie al netto risparmio su tutta una serie di costi e al credito finanziario in apparenza illimitato. C’è anche da tener presente il fatto che le banche si trovano, alla fine della guerra, con grandi quantità di liquido che intendono investire al più presto, dato il momento politicamente incerto. Il cinema appare come una delle imprese più solide, floride e redditizie e le banche appoggiano più facilmente le industrie cinematografiche rispetto alle grandi industrie metallurgiche la cui produttività si è di colpo ridotta con la fine della guerra. L’iniziativa sembra inoltre garantita dalla partecipazione, in prima persona, di alcuni prestigiosi esponenti del mondo politico e finanziario, come il sindaco di Roma Prospero Colonna, Pietro Fenoglio e Angelo Pagliari, amministratori delegati della Banca commerciale italiana e della Banca di sconto, Giuseppe Volpi di Misurata, presidente del Credito industriale di Venezia, Pasquale Masciantonio, sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi, e inoltre una serie di personaggi della nobiltà romana che, già da tempo, avevano stabilito dei rapporti col cinema, come il barone Fassini, il conte Enrico di San Martino di Valperga, il conte Antonio Conestabile della Staffa. Direttori generali dell’iniziativa gli avvocati Giuseppe Mecheri e Giuseppe Barattolo, le cui rivalità e divergenze di interessi condizioneranno non poco gli sviluppi futuri dell’Uci. L’Unione cinematografica riunisce undici stabilimenti di cui quattro di proprietà sociale e sette appartenenti a società consorziate: la Caesar e la Film d’Arte di Roma, la Incit e la Pasquali di Torino, e le consorziate Cines, Celio, Paladino, Tiber, Impresa forniture cinematografiche, Photodrama. Gli stabilimenti per lo sviluppo dei positivi sono uno a Roma e uno a Torino . Da questo accordo appare chiaro che, mentre si privilegia ulteriormente l’asse produttivo Roma-Torino, si emarginano le altre città e in pratica si subordina la produzione torinese a quella romana assai più rappresentata a tutti i livelli. All’Uci appartengono tutte le maestranze e gli operatori più rappresentativi del settore: tra i registi si possono citare Diego Angeli, Wladimiro Apolloni, Eduardo Bencivenga, Mario Bonnard, Mario Caserini, Filippo Costamagna, Lucio D’Ambra, Camillo De Riso, Piero Fosco (Pastrone), Domenico Gaido, Carmine Gallone, Augusto Genina, Ferdinando Guillaume (Polidor), Umberto Mozzato, Baldassarre 1
2
Negroni, Amleto Palermi, Roberto Roberti, Enrico Roma, Giovanni Maria Viti… A eccezione della Borelli – uscita definitivamente dal cinema – troviamo, tra le attrici, tutte le dive più rappresentative dell’epoca: Linda Albertini, Astrea, Bianca Bellincioni Stagno, Francesca Bertini, Ornella D’Alba, Bianca D’Amore, Maria Doro, Mina D’Orvella, Fleurette Du Lac, Lia Forni, Valentina Frascaroli, Maria Galli, Soava Gallone, Hesperia, Maria Bianca Hubner, Diomira Jacobini, Diana Karenne, Ines Lazzeri, Vittoria Lepanto, Rina Maggi, Italia Almirante Manzini, Pina Menichelli, Fernanda Negri Pouget, Alba Primavera, Letizia Quaranta, Lidia Quaranta, Renée de Saint Léger, Kally Sambugini, Valeria Sanfilippo, Bella Starace Sainati, Egle Valery, Vera Vergani… E tra gli attori: Luciano Albertini, Mario Bernardi, Riccardo Bertacchini, Oreste Bilancia, Romano Calì, Carlo Campogalliani, Alberto Capozzi, Luigi Cigoli, Alberto Collo, André Deed, Giovanni Grasso, Carlo Gualandi, Duilio Marazzi, Amleto Novelli, Bartolomeo Pagano, Alberto Pasquali, Ettore Petrolini, Ugo Piperno, Polidor, Giovanni Raicevich, Domenico Gambino (Saetta), Gustavo Salvini, Luigi Serventi, Achille Vitti . Il numero dei film prodotti dalle case facenti parte del trust Uci nel 1919 è molto ricco e mira a saturare ogni tipo di domanda: si va dal film d’avventura dell’Albertini film di Torino (Sansone muto, Sansone e la ladra di atleti, I figli di Sansonia, Sansone e i rettili umani, Il ponte dei sospiri, Il re dell’abisso, Il protetto della morte, I quattro moschettieri) a quelli drammatici della Bertini film, che sono, in pratica, le ultime forme di sopravvivenza di modelli di quella cultura dannunziana e simbolista nelle varianti più degradate, che lo stesso poeta-vate aveva abbandonato da tempo (La principessa Giorgio, La contessa Sara, La serpe, L’ombra, La sfinge, Oltre la legge, I sette peccati capitali). Più legata al melodramma e alla letteratura del feuilleton la produzione Caesar (La morte civile da Giacometti, La colpa vendica la colpa, Il più grande sacrificio, L’onore della famiglia). I prodotti della Cines sono, come al solito, più eterogenei e coprono un ventaglio di temi e una morfologia narrativa abbastanza ampia: si va dal Leone mansueto a La stretta, dal Gorgo fascinatore a Il demone del fuoco, da La fiaccola umana a titoli come Mimí fiore del porto, L’ombra implacabile, Fiori d’arancio, Il mare di Napoli. L’Itala è divisa tra lo sfruttamento intensivo del filone popolare di Maciste (Maciste contro la morte, Il viaggio di Maciste, Il testamento di Maciste) e una produzione con forti ambizioni letterarie e culturali: vedi la trascrizione del dramma di Ibsen Hedda Gabler , ad opera di Pastrone, o opere di contenuto e livello assai diverso, come La maschera e il volto, o di carattere edificante e religioso come Martirio o I due crocefissi. Attivissima, come si è detto, la D’Ambra Film, che, sulla scia del successo della commedia brillante degli anni precedenti, riesce a mettere in scena, in un anno, più di dodici film, tra cui Il colonnello Chabert, Amleto e il suo clown, Il bacio di Cyrano, Il reggimento Royal Cravate. Intensa è anche l’attività delle case minori e il furore produttivo di questo primo anno di attività dell’Uci appare del tutto sganciato da un qualsiasi tipo di analisi di mercato. La Rinascimento-Film realizza Storia di una donna, un melodramma interpretato da Pina Menichelli in una delle parti più intense della sua carriera, che racconta in maniera inedita per il cinema italiano partendo dalla fine (dalla morte della protagonista) e sfogliando le pagine di un diario doloroso e tragico, la parabola di una donna che percorre un cammino di discesa morale e sociale e di perdizione non per sua colpa. Il film riduce al minimo gli elementi scenografici e usa il bianco e nero in funzione para-espressionista. Si produce più con lo scopo di accumulare un patrimonio di pellicole che con quello di studiare la qualità della merce e le caratteristiche della domanda. «L’Uci si mosse fin dall’inizio – notano Solaroli e Bizzarri – con la tipica impostazione delle grosse case cinematografiche americane, senza avere però di queste l’ampiezza delle risorse finanziarie necessarie a permettere operazioni a lunga scadenza […]. L’Uci, nel tentativo di monopolizzare la produzione e di consorziare il mercato, cominciò a rastrellare anche tutto ciò che veniva prodotto dalle case non consorziate, pagando bene e immagazzinando film senza badare troppo alla loro bontà commerciale» . Rievocando questo momento Mario Camerini scriverà a qualche anno di distanza: «Cosa importava fare bene un film che era già venduto per una data cifra? Ciò ripeteva giornalmente il partenopeo dirigente dell’Uci, «Non facite l’artista. Faciteme scarpe». Ben presto le famose scatole chiuse diverranno delle vere boîtes àsurprise per i poveri acquirenti che non riuscivano più a far proiettare nei cinematografi stranieri la nuova scaduta merce italiana» . 3
4
5
6
7
La conduzione euforica dell’Uci dura però abbastanza poco: la divergenza e rivalità tra gli avvocati Mecheri e Barattolo si risolvono con la scomparsa del primo e con l’affermazione della politique de grandeur del secondo che dimostrava, oltre alla megalomania dei suoi progetti, anche un’incompetenza assoluta in materia di gestione aziendale di un’industria che avrebbe dovuto agire sul piano internazionale. La crisi non può che essere inevitabile: fin dai primi mesi del 1920 i sintomi sono diventati segni inequivocabili e il fatto che il barone Fassini, da molto tempo inserito nell’attività delle case produttrici e promotore dell’iniziativa, abbandoni l’Uci dal febbraio per divenire consigliere d’amministrazione della Società di navigazione italoamericana appare, agli osservatori delle riviste di categoria, come una prova evidente del vento sfavorevole che ormai ha assunto una direzione stabile e soffia con ritmo crescente: «Da navigatore astuto egli fa come fanno i sorci marinai, abbandona il naviglio che puzza di cadavere e lascia l’Uci, nave senza nocchiero in gran tempesta» . Già nel 1920 l’Uci, ribattezzata da Guglielmo Giannini «unione capannoni di vetro», viene data in punto di morte: gli investimenti, proprio per questo dissennato processo di accumulazione delle merci, non avevano potuto produrre, né lo avrebbero fatto in seguito, alcun tipo di profitto. I film acquistati a scatola chiusa non si riuscivano a noleggiare né a rivendere, come in passato, per cui i capitali investiti in merci, la cui vendita e circolazione risultava difficilissima, finirono per prosciugarsi in un tempo molto breve. Questi film non avrebbero potuto neppure trovare sbocchi in circuiti di sale precostituiti, in quanto all’Uci si era affrontato il problema della produzione, ma non si era pensato che in via subalterna a quello della distribuzione. Quanto all’esercizio il problema non era stato neppure affrontato. Di fronte agli esercenti i film Uci si presentavano con le stesse possibilità e potere contrattuale di quelli delle piccole case non consorziate e dei film stranieri. Si trattava di un handicap non indifferente in quanto l’Uci doveva collocare i propri prodotti a prezzi molto elevati e quindi non concorrenziali, dati i costi altissimi degli investimenti. Il fallimento, nel 1921, della Banca italiana di sconto, dà un colpo definitivo alla situazione, di fatto ormai compromessa. Nel dicembre del 1921, parlando dell’istituto nato dal fallimento della Banca di sconto, ossia la Banca nazionale di credito, l’onorevole Belotti fa la seguente dichiarazione alla Camera dei deputati: «L’industrie cinematografiche, alle quali la Banca di sconto partecipava ampiamente, dovranno essere messe da parte» . Anche quando la crisi avanza con un andamento irreversibile, a partire dal 1921, l’Uci riesce a produrre ancora film ambiziosi, ripercorrendo la strada del kolossal all’italiana (Il giro del mondo di un birichino di Parigi o il remake del Quo vadis? nel 1924, che si rivelerà un clamoroso insuccesso, o Messalina di Guazzoni nel 1923) o quella della trascrizione di classici della letteratura popolare (Il ponte dei sospiri, Cirano di Bergerac). Nel 1923 viene decisa dall’assemblea dell’Uci una svalutazione del capitale e un successivo aumento a 75 milioni che consentirebbe la trasformazione dei debiti in capitale. Poco tempo dopo vi saranno altre svalutazioni che ridurranno progressivamente il capitale dell’Uci a 15 milioni. Questa fase estremamente oscura e intricata è stata brillantemente messa in luce da Riccardo Redi grazie a una ricerca negli archivi della Banca commerciale italiana . Ancora nel 1922, prima che inizi il tracollo vero e proprio, si producono quasi centocinquanta film, molti dei quali non trovano però una regolare distribuzione sul mercato interno, mentre diventa sempre più evidente che il mercato italiano è territorio di conquista non solo per le Majors americane, ma anche per le grandi case europee. In quell’anno vengono concessi i visti dalla censura a ben 550 titoli stranieri! Anche se la crisi avanza, bisogna riconoscere che non mancano, dal 1920 in poi, iniziative in diverse direzioni: nel 1920 viene istituito il Consiglio per le industrie cinematografiche che dovrebbe farsi portavoce degli interessi dell’Uci, e da parte del Ministero dell’Industria è creato, dal novembre dello stesso anno, il Comitato per l’industria cinematografica col compito di coordinare un programma comune per tutte le iniziative delle case produttrici. Si istituisce anche il Sindacato internazionale cinematografico, con sede a Roma, che aveva come principale obiettivo la riconquista dei mercati internazionali. Il Consiglio per le industrie cinematografiche, istituito mediante un apposito decreto governativo, aveva, tra gli altri, i seguenti compiti istituzionali: «1) Studiare lo svolgimento generale della cinematografia, allo scopo di attuare il commercio delle film nazionali in Italia e all’estero; 2) Istituire concorsi per stimolare la composizione di soggetti e la ricerca di paesaggi nazionali più adatti all’esecuzione dei film; 3) Istituire scuole e corsi speciali diretti a formare il personale cinematografico; 4) Attuare un programma di cinematografia educativa da far 8
9
10
11
circolare in Italia e all’estero» . Queste istituzioni rimangono sul piano delle buone intenzioni perché, in realtà, non realizzano alcun programma. Nel dicembre del 1921, col fallimento della Banca di sconto, l’industria cinematografica subisce il tracollo definitivo. E, a un anno di distanza, in piena crisi, dopo il funebre annuncio dell’onorevole Belotti del ritiro del capitale finanziario dall’industria cinematografica, A. Mallet osserva con molto realismo: «È naturale che il capitale non ritorni spontaneamente alla cinematografia se non gli si dimostra che questa, anche da noi, come nei paesi concorrenti, può venir regolata con criterio industriale» . 12
13
la crisi e le sue cause La crisi è certo il prodotto di una serie piuttosto elevata di cause concorrenti e interagenti tra loro: 1) improvvisazione industriale e disorganizzazione; 2) aumenti dei costi; 3) perdita dei mercati stranieri; 4) concorrenza sempre più forte delle cinematografie americana e tedesca; 5) arresto dello sviluppo tecnico ed espressivo e incapacità di adeguare il prodotto a nuovi pubblici e ai nuovi modi di vita del dopoguerra. A queste cause, che avevo già sommariamente individuato in un mio precedente saggio , si potrebbero aggiungere: 6) mancata produzione nazionale di pellicola vergine e prosecuzione della dipendenza assoluta dall’estero per l’approvvigionamento di questo tipo di prodotto; 7) mancato rinnovo delle maestranze, degli attori e dei registi; 8) sviluppo dell’esercizio nazionale del tutto insufficiente, da solo, a garantire la copertura dei costi di produzione; 9) tassazione governativa eccessiva e mancanza di leggi capaci di favorire lo sviluppo dell’industria mediante la creazione di nuove forme agevolate di credito; 10) mantenimento artificioso di un sistema divistico che continuava a gravare, in modo decisivo, sui costi di produzione senza essere fonte di profitti. Se già Lucio D’Ambra – fin dal 1918 – è uno dei primi a lanciare, come si era già detto, sulle pagine di «In Penombra», inascoltate grida d’allarme: «Gran popolo noi italiani: americani, tedeschi, inglesi, congiurano, tramano, complottano contro il cinema italiano, e noi beati, tranquilli, solitari, continuiamo a guardare in bocca la fortuna della nostra prima donna e a lamentare il costo della pellicola col nostro operatore […]. Trust, invasione, chiusura del mercato, veti di esportazione, roba grossa in verità, pericoli gravi, spade di Damocle pendenti sul capo del nostro avvenire» , a qualche mese di distanza la stessa rivista pubblica un saggio postumo di L. Marchetti che interessa sia per i dati sulla situazione industriale che, e soprattutto, per la miopia di certe osservazioni, non lontane, è presumibile pensarlo, dalle opinioni comuni degli ambienti industriali: «Durante la guerra le case italiane hanno preso il sopravvento in quasi tutti i paesi alleati e neutrali» . La realtà da tempo stava contraddicendo queste affermazioni, ma la miopia non era solo nell’analisi, era anche di tipo previsionale con affermazioni di speranza sulle possibilità di rapida riconquista del primato perduto per l’indiscussa superiorità culturale del nostro cinema. Si noti, per inciso, che il mito del primato del cinema italiano su tutte le cinematografie mondiali nel periodo muto non nasce durante il fascismo, ma si forma proprio nel periodo della crisi del dopoguerra e continua ad alimentare a lungo tutti i fondamentali luoghi comuni della successiva storiografia fascista e non. Analizziamo ora, punto per punto, i fattori della crisi. 1) Per quanto riguarda l’improvvisazione industriale e la disorganizzazione produttiva, il tentativo di dar vita al grande monopolio capace di battere la concorrenza estera può essere considerato l’esempio più clamoroso. Lo stesso pullulare di case di produzione, in grado economicamente di durare l’espace d’un matin, prive di un proprio circuito di noleggio e distribuzione e prive di capitali continua a essere un dominante fattore di debolezza strutturale dell’industria cinematografica. È questo un fatto denunciato a più riprese dalla stampa di categoria: «È l’apoteosi dell’improvvisazione – scrive Baldassarre Negroni in ‘Pollice verso’ – siamo in piena cinematografomania» . E negli anni successivi la polemica sulle riviste di categoria sarà impostata in modo da scindere le responsabilità dei produttori da quelle più propriamente artistiche e da scaricare tutte le colpe sui produttori. Un punto fisso di questa polemica si può trovare nelle seguenti affermazioni: «In Italia abbiamo tutto, autori, direttori, operatori, attori, attrici, luci, ambienti, panorami. Per far bene l’industria ci manca un solo genere: gli industriali […]. Noi non abbiamo gli elementi atti a capire l’alto commercio, ma solo dei piccoli bottegai» . 14
15
16
17
18
Nel 1920 si cominciano a trarre i primi bilanci dell’esperienza dell’Uci e ci si accorge che la creazione di un monopolio non ha certo determinato un salto nella conduzione industriale, nella produzione, nel mercato e nel lavoro cinematografico. «L’Uci, alla quale hanno aderito le maggiori case, non ha saputo organizzare la nostra produzione. Le altre case hanno continuato e continuano a inscenare film senza un vero programma artistico e senza una direttiva» . E ancora su «Kines» troviamo denunciata la disorganizzazione industriale: «La causa di tutte le incertezze fra cui cammina la nostra industria è la mancanza di organizzazione […] gli organi di produzione, quelli di vendita, quelli della réclame e della diffusione sono non solamente separati fra loro, ma il più delle volte si combattono aspramente» . 2) Alla voce aumento dei costi concorrono i seguenti elementi: aumento complessivo dei costi delle maestranze dovuti alla svalutazione della lira, aumento vertiginoso dei contratti degli attori, aumento dei costi dei trasporti. Se colleghiamo in maniera organica questo punto con i successivi (perdita dei mercati e concorrenza) possiamo accorgerci che mentre il margine di rischio nella produzione è enormemente aumentato, la possibilità, non tanto di avere profitti, quanto di recuperare soltanto le spese, è diventata minima. Una voce a parte riguarda, come vedremo, il capitolo di spesa per i divi, che incide in misura molto elevata sui costi di produzione. Inoltre è da tener presente che uno dei punti di forza del film anteguerra era dato dalla possibilità di reclutare, per cifre irrisorie e fuori da qualsiasi riconoscimento sindacale, migliaia di comparse, mentre negli altri paesi tutto il meccanismo di reclutamento di lavoratori era già regolamentato da precisi contratti di lavoro. Manca nella storia del cinema italiano una storia sindacale che riveli la presenza organizzata di tecnici e maestranze. Al senso di precarietà produttiva del vertice corrisponde un altrettanto preciso senso di precarietà dei rapporti di lavoro e l’incapacità di coordinare gli interessi tra le diverse categorie. Questo fatto dipende, com’è ovvio, dalla specializzazione, parcellizzazione e diversità di tutti i processi lavorativi, dei ruoli e delle competenze. 3) Le esportazioni avevano raggiunto, come si è visto, il loro massimo incremento attorno al 1914-1915, e poi, negli anni successivi, si erano ridotte, a partire dalla chiusura dell’importante mercato russo causata dalla rivoluzione del 1917, sino a raggiungere quote di poco superiori allo zero. Si tenta quindi di stabilire alcuni accordi, in particolare con la tedesca Ufa, per arginare la penetrazione galoppante dei prodotti americani. Comunque, grazie a questi accordi commerciali e alla costituzione della Cito cinema (Compagnia italiana traffici per l’oriente), si intende formare una sorta di blocco europeo capace di frenare la concorrenza americana e di rilanciare l’esportazione, che, tenuto conto della svalutazione, si aggira ancora, nel 19191920, tra i 7 milioni e gli 8 milioni e trecentomila lire . Non bisogna però dimenticare che, in quegli anni, la produzione era ancora assestata su valori numerici molto elevati, superiori ai centocinquanta lungometraggi annui. La costituzione della Cito cinema dovrebbe portare, con l’appoggio finanziario della Banca italiana di sconto e del Credito italiano, alla conquista dei mercati balcanici e di quelli orientali, ancora da colonizzare e sui quali l’Ufa poteva contare su una rete precostituita di circa duemila sale. Questi mercati – in particolare quelli orientali – avrebbero dovuto assorbire tutta la produzione a basso livello, altrimenti invendibile altrove. Che nelle intenzioni dei responsabili predomini quella di portare la buona novella cinematografica è dimostrato da un manifesto della fine del 1919 in cui una cometa – sulla cui coda è scritto Cito cinema – mostra la strada ai tre Magi orientali che accorrono portando doni. La Cito cinema è affidata al conte Ignazio Thaon di Revel, che, fin dalla costituzione della società, dichiara programmaticamente che la sua organizzazione «si propone di penetrare nei nuovi mercati d’Europa i quali diventeranno i più ricchi clienti degli editori di films» . Si intuisce dunque subito la potenzialità di un mercato del tutto vergine e si capisce che per conquistarlo non sarà necessario sottilizzare troppo sulla qualità. L’iniziativa, ai suoi primi passi, cerca di interessare varie personalità, nel suo organico entrano successivamente Luciano De Feo e il figlio del presidente del Consiglio dei ministri Orlando. Il primo obiettivo, del tutto omologo a quello dell’Uci, è di costituire una sorta di monopolio per l’esportazione, comprando, a scatola chiusa, i diritti in esclusiva di sfruttamento per l’oriente di tutte le case italiane, piccole e grandi. Il discorso sulla qualità non sfiora neppure i responsabili della casa. Che – sia pure per poco tempo – si dia vita a un’iniziativa di questo genere, non sostenuta da alcun contemporaneo progetto di riconquista dei 19
20
21
22
grandi mercati dei paesi più avanzati, è un’ulteriore prova della degradazione non solo artistica, ma imprenditoriale, in atto in tutto il sistema. Uno dei fiori all’occhiello dell’attività diplomatica e di ripresa di relazioni economiche internazionali della Cito cinema riguarda un breve contatto che una delegazione italiana ebbe agli inizi degli anni Venti, con l’auspicio dello stesso Lenin, con esponenti del cinema sovietico per avviare una regolare forma di scambio. Su questa pagina esistono pochissimi documenti, per lo più di tipo privato . Parlando nel 1920 della Cito cinema su «Kines», Giannini si augura che sorga al più presto un organismo «analogo per il mondo intero e non limitato all’Oriente e a paesi che, in gran parte per le miserrime condizioni del loro cambio, si trovano in condizioni di non poter comprare o di comperare male». La seconda iniziativa di cui si è parlato è quella dell’accordo con l’Ufa per l’assorbimento di tutta la produzione italiana. Questo accordo doveva suggellare la nascita di un blocco europeo contro l’invasione americana. Il fallimento di questa seconda iniziativa dipende, oltre che dalla flessione produttiva, anche, e soprattutto, dalla limitata capacità dei prodotti italiani di interessare i pubblici balcanici e dalla qualità sempre più scadente dei prodotti . D’altra parte questo tentativo di breve durata, circoscritto all’Italia e alla Germania, di arginare l’ondata di piena dei film americani, è una forma, in perfetta economia di libero mercato, di controllo e difesa di certi canali di distribuzione dei prodotti e prevede pure la conquista combinata di nuovi mercati, oltre a quelli sicuri garantiti dall’Ufa. Mentre gli europei varano questi accordi minimi di difesa dei propri interessi, negli Stati Uniti viene approvata una legge che applica dazi fortissimi sulle pellicole importate e in pratica chiude i mercati nazionali alle pellicole straniere . È chiaro ormai che la crisi matura in progressione e viene a coincidere con una obiettiva impossibilità di trovare sfoghi in uno dei mercati in passato più ricchi e aperti: «Potrà sostenersi – si chiede Giuseppe Lega – un’industria la cui espansione sia limitata al solo paese in cui si svolge? E la parte di produzione esuberante? E per contro, come si comporteranno quei paesi la cui produzione non è sufficiente ai bisogni?». Il problema era quello di prevedere dei sistemi efficaci di arginamento alla produzione americana: «Isolare non ciascuna nazione, ma gli Stati Uniti. Questi agiscano per conto proprio, producano, vendano entro i propri confini e intanto si formi una specie di coalizione cinematografica europea che stia a vegliare a che non venga in alcun modo varcata la linea di demarcazione» . Il discorso continua a essere riproposto anche negli anni successivi, quando la produzione è ormai assestata su una media di una ventina di pellicole prodotte complessivamente su tutto il territorio nazionale, in quanto pare che il rilancio dell’attività produttiva possa passare soltanto attraverso le possibilità di rilancio dell’esportazione. Le analisi spesso sono interessanti perché da una parte continuano a considerare il cinema come mezzo di colonizzazione culturale per i paesi sottosviluppati, e dall’altra perché comincia a diffondersi la coscienza della necessità di mobilitare tutti i media in appoggio all’azione di conquista dei mercati stranieri, in particolare di tutti quelli che risultino ancora vergini: «L’Italia deve proporsi come fine assoluto, se non la conquista di tutti i mercati stranieri l’affermazione su di essi […] tutti. Nessuna regione dev’essere negletta […] assai spesso giungono notizie di località, come certe colonie dell’Africa, dell’America, dell’Asia, ove pure il movimento economico – per l’immigrazione europea – è assai rilevante, come alcuni paesi di second’ordine dell’Europa in cui la popolazione accoglierebbe gli spettacoli cinematografici con lo stesso entusiasmo con cui il primitivo gode della vista di quanto intuisce senza saper imitare. Ogni casa produttrice, ogni noleggiatore, dovrebbe avere, nei centri maggiori, un’agenzia di rappresentanza […] ma ad agevolare l’opera del commerciante occorrono due elementi: lo studio del luogo e la divulgazione» . Si pone l’accento, accanto alle cose che si continuano a ripetere, sulla necessità di una più vigorosa analisi della domanda, sul bisogno di tener conto della diversità dei pubblici e sull’importanza dell’azione pubblicitaria della stampa e di tutti i media che devono essere costantemente attivati per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge. 4) Nonostante che, dal punto di vista quantitativo, la produzione del triennio 1918-1921 non sembri risentire della crisi, i segni di un deciso mutamento dei rapporti di forza nei confronti della produzione straniera non tardano a farsi sentire: l’apertura di case di distribuzione di serial americani, come la Orfeo di Genova, o le prime aperture di filiali italiane di grandi case straniere, indicano il formarsi di grandi vuoti di mercato che 23
24
25
26
27
l’industria dei paesi concorrenti non tarda a individuare e si affretta a occupare. Nel 1920 apprendiamo da una notizia d’agenzia che la tedesca May film ha impiantato in Italia una sua filiale per la vendita diretta dei suoi prodotti . L’iniziativa presuppone il riconoscimento dell’esistenza di un esercizio fiorente e la consapevolezza di una produzione in crisi. Da questo momento inizia, su tutta la stampa di categoria e non, un confronto tra lo sviluppo delle cinematografie straniere, capaci di sfornare capolavori a ritmo incessante, e l’arresto della cinematografia italiana. I segni della progressiva forza e capacità di presa sul pubblico di massa dei prodotti americani sono almeno questi: 1) immediato successo concorde sia di pubblico che di critica, 2) conquista di grandi pagine di pubblicità sulle riviste specializzate e sui quotidiani (sarà sempre più frequente la pubblicità, a tutta pagina, di film americani, su grandi quotidiani a tiratura nazionale e anche su organi di stampa fascista – come il «Tevere» – dove nel 1924, accanto ad attacchi antiamericani campeggeranno grandiosi flani pubblicitari di film di Tom Mix o John Ford che porranno le basi per la moltiplicazione di una serie enorme di canali simili per la diffusione e la propaganda, a livello di massa, del mito americano). Sono proprio questi, non dimentichiamolo, gli anni in cui, grazie al vuoto di produzione nazionale, alla scomparsa del divismo, si viene diffondendo, nonostante la grave crisi e la profonda trasformazione politica, il mito americano come mito popolare e di massa. Questo mito non nasce certo spontaneamente: trova un pubblico disposto ad accogliere modelli culturali nuovi, in un momento in cui il fascismo non ha ancora giocato le sue carte migliori per l’aggregazione del consenso di massa. La sua formazione riguarda, almeno nei suoi primi passi, sia la produzione vera e propria sia la stampa di categoria che, non di rado obtorto collo, ma spesso traendone, come nel caso di Giannini e della sua rivista, consistenti vantaggi economici, viene a essere una potente cinghia di trasmissione del mito stesso. Non a caso la torinese «Rivista cinematografica» è uno degli organi che più accolgono, in senso positivo, il modello culturale e industriale del cinema americano. Non a caso in questa rivista, che nell’ampio panorama delle riviste di categoria spicca per le sue battaglie a favore di un’industria efficiente e competitiva sul piano internazionale, il mito americano viene visto come mito di un capitalismo avanzato e vincente, capace di adattarsi a qualsiasi situazione e di programmare tutte le strategie più articolate per la conquista del mercato. È prevedibile che nasca, anzitutto, nella Torino industriale, sia pure in un momento particolare della lotta politica e sindacale, quale quello degli anni che precedono l’avvento del fascismo, e sia proprio nell’ambito dell’imprenditoria torinese e della stampa nata per sostenerla che si assuma il modello americano come modello da seguire e imitare. Si veda, a questo proposito, l’atteggiamento entusiastico assunto dalla rivista per una lettera di Karl Laemmle ai registi europei. Gli industriali, gli intellettuali che ruotano attorno al cinema a Torino, rappresentano, con ogni probabilità, la punta più avanzata e spregiudicata, ma anche quella che pagherà per prima, in termini politici ed economici, la sua apertura e la sua partecipazione al clima della lotta politica di quegli anni. 5) Arresto dello sviluppo tecnico ed espressivo. Volendo delineare, comparativamente, attraverso una serie di diagrammi, lo sviluppo tecnico, linguistico ed espressivo delle diverse cinematografie nazionali, non si può non constatare che tutte le cinematografie più importanti, da quelle dell’Unione Sovietica alla tedesca, francese e americana, raggiungono, proprio negli anni Venti, il massimo di sviluppo e di capacità di esplorazione delle possibilità espressive del linguaggio cinematografico. Il fatto è dovuto alla stretta interrelazione tra il lavoro delle avanguardie con quello dei registi cinematografici , alla formazione di nuove generazioni di registi, capaci di lavorare in stretto contatto con le ricerche più avanzate nel campo delle arti figurative, dello spettacolo, della letteratura e in grado di servirsi di tecnologie molto più sofisticate. Autori come Kulešov, Pudovkin, Ejzenštejn e Vertov giungono al cinema con, alle spalle, una vastissima competenza, sia sul terreno della ricerca scientifica che su quello dei linguaggi poetici e formali. Lo scarto del livello linguistico è dovuto principalmente all’aumentata pressione e incidenza dei codici non cinematografici alla base del lavoro registico. Se il regista ricerca, come obiettivo finale, la conquista di regole e procedimenti che diano al cinema uno statuto di autonomia rispetto alle altre arti, nella determinazione di questi procedimenti interviene una competenza culturale che utilizza un territorio assai vasto. Ciò non avviene nel cinema italiano, dove il futurismo, unico movimento d’avanguardia, ha esaurito la sua stagione senza lasciare tracce apparenti nel cinema e dove agli inizi degli anni Venti – per ovvie ragioni – non c’è stato alcun rinnovamento dei quadri rispetto al cinema dell’anteguerra. Nonostante vi siano stati i tentativi 28
29
di Lucio D’Ambra di modificare prosodia e sintassi il cinema italiano è ancora un cinema lento, scandito e frenato dalle didascalie, in cui il montaggio non è ancora divenuto un elemento fondamentale della prosodia e della metrica. La parola d’ordine non sarà dunque «dimentichiamoci il passato e poniamoci al passo con le altre cinematografie, ma cerchiamo di superare la crisi ritornando all’antico» . Le diagnosi sulle condizioni sempre più gravi della cinematografia non prevedono che raramente un totale rinnovamento dei modelli narrativi e culturali. Il discorso corrente, che si fissa in un luogo comune generalizzato, è quello di riportare il cinema al primato raggiunto nei primi anni Dieci. Non si tiene conto che quel primato era per lo più casuale e nasceva dall’improvvisazione e da un’appropriazione e consumo di fatti culturali precinematografici, che, di rado, riuscivano a contribuire a una reale dinamizzazione e scoperta consapevole delle possibilità del mezzo e della sua autonomia significante. Lo sguardo all’indietro, unito al venir meno degli investimenti, non solo a favore di nuove forze culturali, ma semplicemente a favore delle forze esistenti, fa sì che la memoria perduta del cinema degli anni Venti non provochi di fatto eccessivi rimpianti. In realtà, il cinema italiano di quegli anni è, come si è visto, cinema americano. Resta inoltre da sottolineare il fatto che non c’è rinnovamento neppure negli impianti industriali, non vi sono nuovi investimenti per il rinnovo delle apparecchiature ormai tecnologicamente superate e questo fattore gioca un ruolo non indifferente nel contribuire alla stasi del sistema espressivo. Del tutto tagliata fuori dall’evoluzione produttiva e linguistica la produzione di quegli anni può conservare il suo pubblico soltanto a livello municipale e locale (il caso del cinema napoletano) dove non rischia alcun tipo di confronto sfavorevole. 6) Pellicola vergine. Anche nel dopoguerra si continua a dipendere dall’estero per gli approvvigionamenti di pellicola vergine, ma le pellicole, in maggior parte importate dalla Germania, vengono a mancare dal 1916. I principali fornitori diventano gli Stati Uniti che iniziano a inviare pellicola in quantitativi ridotti e a prezzi molto superiori, per cui le potenzialità industriali vengono naturalmente compresse. Questo fattore diventa la chiave di volta per il regolare funzionamento di tutto il sistema. Interviene sull’argomento «Kines», nel 1920, e dopo aver indicato come fattore importante della crisi la mancanza di un’industria nazionale di pellicola vergine e denunciato l’aumento vertiginoso dei costi della pellicola fornita dalle maggiori case straniere, osserva che se si giungerà alla paralisi della produzione italiana, per mancanza di materie prime, questo fatto non influirà sul mercato del noleggio, della distribuzione e dell’esercizio: «I noleggiatori di cinematografo non chiuderanno i loro locali. Si daranno alla caccia delle pellicole scovandole ovunque esse siano e naturalmente tutta la produzione tedesca e americana, qualunque sia, avrà la possibilità di farsi valere […]. Perché dunque – si chiede Giannini – non si costituisce in Italia una fabbrica di pellicola vergine non riusciamo a comprendere […] tutte le case editrici dovrebbero concorrere alla costituzione di una società di tal genere» . 7) Mancato rinnovo delle maestranze. È una causa in diretto contatto con la precedente. Il blocco progressivo degli investimenti, la quantità sempre minore di pellicola vergine in circolazione non consentono il rinnovamento dei quadri, ma solo il riciclaggio delle forze già esistenti e il loro progressivo impoverimento. La chiusura a catena delle case di produzione e la paura della disoccupazione spingono a una vera e propria emigrazione di massa registi e attori fin dalle prime avvisaglie della crisi. C’è da dire, però, che i quadri esistenti non sembrano spinti da alcuna intenzione di rinnovare e modificare i propri moduli sull’esempio delle cinematografie straniere, e che la penetrazione di nuovi procedimenti espressivi e narrativi si potrà cogliere solo verso la fine degli anni Venti, al ritorno di alcuni registi dal loro soggiorno all’estero. I divi e i registi continuano, per alcuni anni, a combattere una sorta di battaglia di retroguardia a difesa delle proprie caratteristiche di un tempo. E i modelli narrativi continuano a oscillare tra una rappresentazione di un mondo nobiliare e alto-borghese, visto secondo un’ottica ideologica e morale che trasmette gli ultimi fuochi della cultura del decadentismo e una tradizione più decisamente popolare, che fa del cinema il corrispettivo del feuilleton e della trivialliteratur. In via di sparizione la fiorente industria del film comico per l’impossibilità manifesta di competere con i capolavori di Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, la produzione media si rivolge ancora ai modelli spettacolari del passato e al repertorio teatrale. Esattamente il contrario di ciò che il pubblico desiderava. 8) Sviluppo insufficiente dell’esercizio nazionale. Le sale, in Italia, durante gli anni Venti, sono di poco superiori alle duemila unità: un numero che non basta neppure a garantire lo sfruttamento completo e 30
31
redditizio della produzione nazionale. Bisogna produrre tenendo presente il pubblico internazionale: questo è il punto decisivo. E gli industriali che presiedono alle maggiori imprese cinematografiche del tutto incapaci di analizzare le caratteristiche della domanda interna non sono certo in grado di produrre prevedendo la domanda di destinatari di altri paesi. Questi industriali, o meglio gli industriali emergenti (penso al caso di Pittaluga), non vedono, a tutta prima, alcuna redditività nell’impresa produttiva e preferiscono preoccuparsi della distribuzione e dell’esercizio, assai più remunerativi e privi di rischi. La scalata di Stefano Pittaluga verso una concentrazione verticale del controllo di tutte le fasi di produzione e di circolazione del prodotto cinematografico, avviene per gradi, e porta alla produzione solo dopo che egli è riuscito a garantirsi il controllo di una consistente rete di sale in varie zone dell’Italia del nord. Già nel 1920 Pittaluga è diventato una tale potenza distributiva, ha acquistato un numero consistente di sale prestigiose nelle grandi città che sembra in grado non solo di contrapporsi all’Uci, ma di tentarne la scalata . 9) Il prelievo governativo dagli spettacoli pubblici è una delle voci più negative e incidenti nella determinazione dei passivi di bilancio. Le tasse, però, non colpiscono tanto la produzione quanto l’e-sercizio. In un primo tempo tutti gli spettacoli pubblici sono sottoposti allo stesso sistema di tassazione, mentre successivamente la tassa, ridotta per il teatro, i campi sportivi e i varietà, aumenta per il cinema. In questo modo si cerca di sollecitare una ripresa dell’attività teatrale dei cui mali le cause principali sono attribuite alla sleale concorrenza del cinema. Per effetto di una serie di leggi Nitti (n. 567, 4 maggio 1920), Bonomi (Rd 5 giugno 1920, n. 767), Giolitti (Dl 23 febbraio 1921, n. 5), Facta (Rd 29 agosto 1922, n. 1254), le aliquote sono via via aumentate da un minimo di 12,50% a un massimo del 60%. Solo dal 1923 (Dl 26 ottobre, n. 2275) le aliquote massime vengono ridotte e portate al 30%. Le tasse, colpendo indiscriminatamente le piccole sale di provincia e le eleganti sale cittadine, creano forti difficoltà nell’esercizio: sfuggono evidentemente al governo le spese a carico dell’esercizio stesso (noleggio, affitto dei locali, delle orchestre, illuminazione, pubblicità, spese per il personale di sala e di cabina…): i margini di profitto diventano assai esigui. Colpire le entrate, senza tener conto delle diverse caratteristiche degli esercizi, significa condizionarne in maniera violenta l’attività. E in ogni caso questo ramo dell’industria cinematografica, pur restando fondamentalmente sano, non subisce quell’incremento e quella spinta in avanti, che ci si poteva aspettare, proprio per i motivi appena elencati. La concentrazione delle sale avviene nei grandi centri urbani, mentre nel Mezzogiorno e in provincia la situazione resta stagnante. 10) Il sistema divistico. Il divismo cinematografico italiano vive nel periodo 1918-1921 la stagione del suo canto del cigno: è il momento dei massimi guadagni (la Bertini ottiene i mitici tre milioni per la realizzazione di otto film in un anno) , come è pure il momento in cui si cominciano ad attribuire alle dive le cause della crisi della cinematografia. I confronti con i film stranieri risultano spesso impietosi: ci si accorge che molte dive non hanno rinnovato il loro repertorio mimico e continuano a essere utilizzate nei medesimi contesti narrativi e drammatici dell’anteguerra. Per la verità le vicende di amori infelici, di passioni travolgenti, in una società aristocratica e alto-borghese, non sembrano più costituire un modello o un transfert per il desiderio di alcun tipo di pubblico. L’uscita di scena di una delle massime protagoniste (Lyda Borelli, che col suo matrimonio col conte Cini realizza simbolicamente la favola di Cenerentola) è il primo grande colpo all’industria del divismo («e non è senza malinconia – scrive ‘In Penombra’ – che sentiamo che la sua divina maschera di dolore e di amore non appartiene più neppure alle nostre illusioni»). Il reclutamento degli attori e dei divi continua comunque a essere effettuato nei terreni contigui del teatro e della danza classica. L’attore preso dalla vita e dal popolo, senza alcuna esperienza anteriore, è il solo Maciste, in quanto anche la serie degli acrobati e dei forzuti viene dal mondo del circo e dello spettacolo . Non a caso Maciste – a parte l’eccezione di Cabiria – reciterà sempre in film comico-drammatici, ma non si farà mai carico di valori passionali. Viene a mancare, nel sistema divistico italiano, fatta eccezione per la Bertini, una mobilità e disponibilità dell’attrice a recitare ruoli diversi. L’attrice o l’attore, raggiunto il successo grazie a un certo ruolo, cercano di ripetersi all’infinito. Questo favorisce l’esistenza di zone narrative molto ampie, non ricoperte dalla produzione mediante la creazione di appositi divi. E proprio lungo questi vuoti si introducono con forza i film americani, sia con i serial, che con le comiche e i film avventurosi. La penetrazione dei grandi divi popolari americani degli anni Venti, da Chaplin a Tom Mix, da Pearl White a Douglas Fairbanks, è favorita dal vuoto reale nella produzione nazionale. Non bastano certo a ricoprirlo né i 32
33
34
film di Maciste, unico divo autarchico utilizzato fino ai limiti estremi di tolleranza, né quelli della serie di forzuti guidati da Luciano Albertini, ben presto costretti a emigrare all’estero . Lo sviluppo del sistema divistico in Italia si può collegare – con una certa sicurezza – alle restrizioni dei costi dello spettacolo imposte dalla guerra. La stessa concentrazione dell’occhio della macchina da presa sul volto del divo, protagonista assoluto del film, può essere certo la conseguenza della mancata possibilità, a partire dalla guerra, di apertura massima dello sguardo fino ad abbracciare in uno spazio infinito il movimento di migliaia di comparse. Il cinema da camera elimina tutta una serie di costi, ma aumenta enormemente il potere contrattuale del divo. Si tratta, seguendo la direzione di un cinema che riduce al massimo i suoi elementi, di eliminare il divo e trovare l’attore, come farà negli anni Venti il Kammerspiel tedesco. L’avvento del fascismo non sembra avere in apparenza alcun ruolo modificatore di una situazione compromessa, e certo nei primi anni il regime non intende farsi carico di un’industria largamente fallimentare. Tuttavia i rapporti tra fascismo e cinema, analizzati proprio a partire dagli anni Venti, ci permettono di rimettere a fuoco, per quanto è possibile, una fase della storia del cinema interamente rimossa. 35
1
F. Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935, p. 187.
La prima ricostruzione delle vicende dell’Uci è quella di M. Quargnolo e R. Chiti, La malinconica storia dell’Uri, in «Bianco e Nero», a. XVIII, n. 7, luglio 1957, pp. 21 sgg. Oltre a questi saggi da vedere, per la ricchezza di dati, T.O. Relli, Unione cinematografica italiana, in «Lux», gennaio 1920. Si veda l’antologia di testi raccolti da R. Redi e C. Camerini per Cinecittà 1: Industria e mercato nel cinema italiano tra le due guerre, Marsilio, Venezia 1985. Sull’Uci ha scritto in varie riprese Redi raggiungendo oggi la ricostruzione più documentata e attendibile. Si veda in particolare R. Redi, L’Italia: l’UCI e la grande depressione, in G.P. Brunetta e D. Turconi (a cura di), Cinema & Film. La meravigliosa storia dell’arte cinematografica, Curcio, Roma 1987, pp. 345-353. 2
3
Per un elenco più completo dei nomi si veda soprattutto l’articolo di Relli, Unione cinematografica italiana, cit.
4
M. Quargnolo, Luciano Albertina, un divo degli anni venti, Csu, Udine 1977, pp. 15-16.
Omaggio a Giovanni Pastrone, in «Centrofilm», a. II, n. 14, ottobre 1960. Il film era già progettato, fin dal 1918, e viene recensito nel marzo del 1919 da A. Menini su Figure mute di cui «Centrofilm» riproduce interamente il testo. Nello stesso numero Maria Adriana Prolo pubblica un carteggio molto importante di un film di grandi ambizioni spettacolari che Pastrone propone all’Uci e che non verrà mai realizzato per l’eccessivo impegno economico che comportava. 5
6
L. Solaroli e L. Bizzarri, L’industria cinematografica italiana, Parenti, Firenze 1958, p. 27.
7
M. Camerini, Il passato, in «Il Tevere», 4 settembre 1926.
8
Sciocchezzaio, in «Kines», a. II, n. 5, 12 febbraio 1920.
9
A. De Marco, Le industrie cinematografiche e le banche, in «La rivista cinematografica», a. III, 10 giugno 1922.
10
R. Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italiana, CNC, Roma 1991, pp. 55-63.
Vittorio Martinelli ha esplorato l’enorme territorio dei film stranieri entrati in Italia negli anni Venti in: Cuor d’oro e muscoli d’acciaio, La Cineteca del Friuli, Gemona 2001, Dal dott. Caligari a Lola-Lola, La Cineteca del Friuli, Gemona 2001 e L’eterna invasione. Il cinema americano degli anni venti e la critica italiana, La Cineteca del Friuli, Gemona 2002. 11
12
A. De Marco, Il consiglio per l’industria cinematografica, in «La rivista cinematografica», a. I, 10 giugno 1920.
13
A. Mallet, Il problema industriale cinematografico, in «La rivista cinematografica», a. III, 25 ottobre 1922.
14
Cfr. il mio Cinema italiano tra le due guerre, Mursia, Milano 1975, pp. 16-17.
15
L. D’Ambra, Il problema industriale del cinematografo, in «In Penombra», a. I, n. 3, agosto 1918.
16
L. Marchetti, Un primato da difendere, ivi, a. I, n. 6, novembre 1918, p. 217.
17
B. Negroni, Torniamo all’antico, in «Pollice verso», a. I, n. 1, 27 gennaio 1920.
18
La politica degli struzzi, in «Kines», a. II, n. 36, 9 settembre 1920.
19
N. Lodi, Arte muta, in Annali del teatro italiano, Arnaldi, Milano 1920.
20
Organizzare l’industria, in «Kines», a. II, 20 maggio 1920.
J. Petrini, L’exportation des films italiens, in «Lux», novembre 1920. Per il problema della concorrenza americana c’è, agli inizi degli anni Venti, una netta presa di posizione da parte della stampa di categoria. Tra gli interventi più interessanti si vedano almeno: T.O. Relli, L’America e noi, in «Lux», marzo 1920; D. Angeli, Il pericolo americano, in «Lux», marzo 1920; C.M.H., L’invasione dell’America, in «Cinema Music-Hall», a. I, n. 1, gennaio 1920. Riccardo Redi ha ricostruito con documenti di prima mano la storia di questa impresa: La Cito-Cinema: storia di un fallimento, in «Immagine», n.s., n. 6, autunno 1987, pp. 5-12. 21
22
G. Lega, L’organizzazione industriale del nostro cinematografo, in «Apollon», a. IV, n. 3 marzo 1919.
23
V. Martinelli, Silvio Laurenti Rosa, le opere e i giorni, in «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979.
Petrini, L’exportation des films italiens, cit. Si veda anche Ego, La Cito-Cinema alla conquista dei mercati balcanici, in «La rivista cinematografica», a. I, 25 luglio 1920. 24
25
A. De Marco, Boicottaggio o lotta, in «La rivista cinematografica», a. II, ottobre 1921.
26
G. Lega, Sfruttamento americano in Italia, in «L’arte del silenzio», a. II, giugno 1921.
27
I rapporti con l’estero, in «La rivista cinematografica», a. IV, 25 aprile 1923.
28
Notiziario, in «Kines», 15 gennaio 1920.
Il materiale bibliografico su questo argomento è enorme: si veda per tutti l’antologia di A. Barbera e R. Turigliatto, Leggere il cinema, Mondadori, Milano 1978 e le buone indicazioni bibliografiche oltre che i testi antologizzati. 29
30
Negroni, Torniamo all’antico, cit.
31
G. Giannini, La situazione, in «Kines», a. II, maggio 1920.
R. Redi, Il «pericolo Pittaluga», in T. Sanguineti, L’anonimo Pittaluga. Tracce carte miti, in «Cinegrafie», numero speciale, Transeuropa, 1998, p. 49. 32
33
Per tutte le vicende contrattuali della Bertini si veda Soro, Splendori e miserie del cinema, cit., pp. 59-73.
A questo importante capitolo di storia del cinema muto hanno dedicato alcuni saggi di prima esplorazione Vittorio Martinelli e Alberto Farassino in A. Farassino e T. Sanguineti (a cura di), Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983 e qualche anno dopo è uscita, dopo varie anticipazioni, la ricca monografia di M. Dall’Asta, Un cinéma musclé, Yellow Now, Crisnée 1991. 34
Per questo problema si veda l’ottimo lavoro filmografico di V. Martinelli, I Gastarbeiter fra le due guerre, in «Bianco e Nero», a. XXXIX, n. 3, maggio-giugno 1978. 35
La produzione dal 1923 al 1929
verso lo zero assoluto Venuto del tutto a mancare l’appoggio del capitale finanziario, fallite a catena le piccole case di produzione, gli anni che vanno dalla marcia su Roma all’avvento del sonoro vedono un arresto della produzione e un assestamento su una media di poche decine di film all’anno, il tramonto definitivo di tutte le mitologie e dei modelli del cinema del decennio precedente, l’emigrazione di massa di registi, attori e tecnici che trovano spesso allettanti occasioni di lavoro all’estero, l’attenzione sempre più frequente verso il fenomeno cinematografico da parte dei quotidiani e riviste letterarie, il ricambio generazionale e la nascita di una nuova generazione di critici che si aprono alle influenze del cinema straniero e cominciano a concepire l’attività critica come momento propedeutico a quella registica e infine l’incremento degli incassi, che, nel giro di pochi anni, tra il 1924 e il 1927, pur tenendo conto del fattore svalutazione, tendono a raddoppiare. Nel 1927 addirittura gli incassi degli spettacoli cinematografici costituiscono il 50% di tutte le altre forme dello spettacolo messe insieme (dalla prosa alla lirica allo sport compreso). In questa fase, negli altri paesi, il capitale finanziario interviene in appoggio all’industria cinematografica, mentre in Italia non c’è alcun segno di ritorno di capitali bancari per il rilancio della produzione. Il piccolo capitale che torna al cinema continua a coltivare i sogni di guadagni facili e immediati: il cinema è ancora una specie di miraggio: si preferisce appoggiare una produzione a basso costo e corriva piuttosto che ritornare a grandi progetti. Nello stesso periodo in cui, per esempio, la Cines seta abbandona la Cines al suo destino, in Germania troviamo nel consiglio d’amministrazione dell’Ufa l’industriale Wollf, il banchiere Hagen, l’editore Kliztsh, le industrie Ferbein e le edizioni Ellstein. In questo periodo, da una parte, i discorsi e gli atteggiamenti della critica usano toni apocalittici di previsione di morte totale del cinema italiano, in mancanza di urgenti interventi da parte governativa, dall’altra esiste tutta una serie di fautori e di voci che auspicano la rinascita con un ottimismo spesso esagerato e senza alcuna conoscenza oggettiva della situazione. Certo i titoli dei film più interessanti prodotti in questi anni non offrono indicazioni di nuovi corsi intrapresi per far fronte alla crisi. I film Uci di maggior rilievo che rappresentano la produzione media nel 1922-1923 sono I promessi sposi, La congiura di San Marco, Il ponte dei sospiri. La dinamica che attiva, sia pure lentamente, la ripresa passa attraverso l’azione parallela e spesso indipendente di una serie di forze, ma ciò che appare come discorso comune è ormai la coscienza che la produzione è giunta a un livello così basso sotto cui non può esserci che la scomparsa completa: «Il cinematografo italiano è in fin di vita […] – si legge sul ‘Giornale d’Italia’ nel 1925. – E si vive sperando in una rinascita, lottando contro la tentazione di andare all’estero […] ormai è questione di sei mesi, un anno al massimo, e se nessuno avrà preso l’iniziativa di un provvedimento, l’Italia non avrà più industria cinematografica» . Qualche rivista si pone anche il problema di una diversa razionalizzazione dei processi produttivi e si comincia, proprio dalle riviste di categoria, ad assumere come esempio il modello americano la cui produzione è assimilata a qualsiasi altro processo industriale e ne riproduce le fasi di elaborazione e trasformazione del prodotto . Emergono inoltre con più forza – in un momento di assenza delle voci della produzione – gli interessi di quelle categorie come gli esercenti e i noleggiatori che continuano a esercitare la loro attività e vedono le loro prospettive di guadagni subire un consistente incremento indipendentemente dalla situazione sfavorevole. Il primo congresso di queste categorie, indetto dalla Federazione nazionale industriali, commercianti film ed 1
2
esercenti cinema nel 1924, ha anzitutto questa funzione, oltre a quella di richiamare l’attenzione del governo su un’industria in stato di agonia cronica. E le analisi che le riviste di categorie o alcuni quotidiani iniziano a fare della situazione o delle prospettive non puntano soltanto sul potere miracolistico di un intervento governativo. Ci si rende conto della necessità di una ristrutturazione completa e gli obiettivi principali da raggiungere sono: 1) produrre poco e bene; 2) organizzarsi commercialmente all’estero; 3) raggiungere una più stretta collaborazione tra registi e produttori . Ma a questi obiettivi, secondo gli esercenti, è impossibile aspirare senza un opportuno e immediato appoggio del governo. Un anno dopo si tiene, sempre a Roma, il 25 giugno un secondo congresso allargato a tutte le categorie. I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: «1) Richiesta di intervento governativo per il rilancio dell’industria cinematografica; 2) riduzione delle tariffe ferroviarie per attori e macchinari cinematografici; 3) riduzione delle aliquote di tassazione sui biglietti d’ingresso» . Il convegno viene salutato come un concreto passo in avanti verso la giusta soluzione della crisi: «Organizzazione: questo congresso significa la chiamata a raccolta delle forze sparse, l’unione delle singole volontà in una sola […]. Organizzato il commercio, organizzata l’industria la crisi sarà per tre quarti automaticamente superata» . Stefano Pittaluga, presidente della Federazione cinematografica italiana, che raccoglie produttori, esercenti e distributori e che, dopo un anno, organizza a Roma un secondo congresso, si fa portavoce, presso il governo, delle risoluzioni prese e presenta, il 24 settembre, al conte Volpi di Misurata (ministro per le Finanze) e al professor Belluzzo (ministro per l’Economia Nazionale), il documento finale, rielaborato in forma di memoriale a proprio uso e consumo, in cui si affrontano tutti i problemi della «rinascita», dopo aver riconosciuto la necessità di produrre «poco e bene». I punti principali sono i seguenti: 1) nessun protezionismo e nessuna legge speciale di contingentamento può far rinascere per miracolo l’industria cinematografica; 2) non è possibile fare a meno dei prodotti esteri; 3) è necessario organizzarsi commercialmente all’estero e ricercare la compartecipazione di capitali stranieri nella produzione di film italiani; 4) bisogna cercare di migliorare lo standard produttivo allineandosi ai livelli artistici e tecnici della produzione internazionale; 5) bisogna tener conto delle esigenze dell’esercizio; 6) bisogna ottenere un credito bancario come viene concesso a tutte le altre industrie (e qui è necessario un intervento specifico del governo) . La maggiore preoccupazione di questo discorso è che la chiusura doganale, il protezionismo o anche il contingentamento possano compromettere, in modo decisivo, le uniche branche in attivo nell’industria cinematografica, la distribuzione e l’esercizio, in quanto, è detto a chiare lettere, i provvedimenti restrittivi presupporrebbero «l’esistenza di un’industria che si vuol difendere: nel nostro caso l’industria non esiste, bensì deve formarsi» . L’intelligenza e l’abilità diplomatica di Pittaluga sono di riuscire a far passare i propri interessi per quelli di tutte le categorie del cinema italiano, e, in un momento di fondazione dell’ideologia autarchica, l’esigenza di affrontare i problemi economici del cinema non soltanto con un’ottica nazionalistica rivela la lungimiranza oltre che il pragmatismo dell’unica personalità capace di comprendere e di abbracciare tutto l’arco dei problemi dell’industria cinematografica. E non a caso proprio in questi anni ci si trova di fronte alle prime analisi e ai primi tentativi di impostare una politica economica complessiva del cinema italiano con un’ottica abbastanza moderna e proiettata sul piano internazionale. Ben presto cominciano a circolare – a vari livelli – discorsi più consapevoli della situazione. A breve distanza appaiono sul quotidiano fascista di Roma, «Il Tevere», una serie di articoli di Umberto Paradisi in cui si analizza la situazione e si prospettano possibili linee di politica economica da seguire per avviare la crisi verso la sua risoluzione: «Ci troviamo di fronte a una educazione quasi completamente da rifare e soprattutto ci troviamo di fronte a un desolante vuoto di artisti nuovi» afferma come premessa a tutta la sua analisi Paradisi e, dopo aver elencato varie cause della crisi e denunciato il fatto che ormai le maggiori case americane stanno colonizzando l’Italia attraverso la creazione di una fitta rete di agenzie commerciali per la vendita diretta dei film, indica i vantaggi di una legge sul contingentamento che imponga agli esercenti la proiezione obbligatoria di una settimana di film italiani ogni sessanta giorni di programmazione . Negli anni che vanno dal 1925 al 1930 la produzione si assesta numericamente su un centinaio di opere (la stessa cifra che sarà prodotta nel primo quinquennio del sonoro), ma si moltiplicano le forme di partecipazione e pressione delle forze nei confronti del governo, in appoggio all’idea della «rinascita» che 3
4
5
6
7
8
ormai sembra divenuta la parola d’ordine dominante. Il ricorso alla politica protezionistica non riscuote comunque consensi unanimi. L’autore di una proposta per il contingentamento (con cui polemizza nel suo memoriale Pittaluga) è Carmine Gallone che, il 14 agosto del 1925, rilascia al «Popolo d’Italia» questa dichiarazione: «I mezzi tecnici per la produzione nostra sono più che sufficienti. E poi bisogna convincersi che quando si parla di mezzi tecnici non si può intendere che energia elettrica e apparati elettrici. Ebbene, due mesi bastano a trasformare qualsiasi garage di grandi dimensioni e qualunque hangar nel più moderno dei teatri di posa». Questa dichiarazione fotografa – in modo esemplare – i limiti di competenza dei nostri uomini del cinema muto e rivela almeno i seguenti punti negativi: 1) oltre alla più assoluta incompetenza sul piano tecnico anche malafede nell’appoggiare l’idea che un cinema povero nasca per una sorta di «volontà artistica» dovunque; 2) un’ottica ottusa che si rifiuta di prendere atto dello stato di grave obsolescenza e ritardo delle nostre apparecchiature rispetto a quelle straniere; 3) un superficiale ottimismo che porta a credere che i problemi dell’eventuale «rinascita» dipendano soltanto da una serie di piccole migliorie e dal blocco della concorrenza straniera. Basterà l’uscita del film di un esordiente, Sole di Blasetti, opera prodotta in modo molto avventuroso e tutt’altro che esemplare nella sua vicenda produttiva, a far esplodere il coro dei consensi e dei riconoscimenti dell’apertura di un nuovo corso. Il film di Blasetti non ha certo un effetto trainante sulla produzione che rimane assestata ancora per qualche anno su poche unità di film realizzati. Di fatto esiste un vuoto, non soltanto sul piano degli investimenti, quanto su quello della formazione – a tutti i livelli – di nuovi quadri, un vuoto nell’invenzione dei soggetti, che continuano a riproporre, a cicli biennali alternati, le medesime idee, le medesime figure e il medesimo punto di vista ideologico. In queste condizioni, una piccola iniziativa marginale, promossa dal quotidiano «Il Tevere», di offrire un premio di cinquantamila lire per il soggetto di un film italiano, ha come effetto di produrre una serie di reazioni a catena, che favoriscono il rilancio dell’attenzione e l’aumento delle forme di pressione a favore della «rinascita». Il 22 luglio del 1926 appare il primo annuncio del concorso col titolo: Un grande concorso per un film italiano. Oltre alle norme per la partecipazione figurano i nomi della commissione giudicatrice (Bontempelli, Telesio Interlandi, direttore del giornale, Anton Giulio Bragaglia, Augusto Genina, Gabriellino D’Annunzio, Guazzoni e Mario Camerini). Prorogata la scadenza al gennaio del 1927 ogni giorno appaiono sul giornale, nei mesi successivi, annunci e indicazioni su come deve essere il soggetto del film: «Quello che vogliamo è un film che riesca a esprimere il senso della vita attuale italiana […]. Ciò non significa che il film debba essere pazzoide, strampalato, futurista […]. Il film che inquadrasse in linee e ritmo d’epopea la miracolosa rinascita italiana otterrebbe senz’altro i suffragi della commissione» (9 agosto 1926). È la prima richiesta ufficiale di realizzazione in forma epica di un film fascista: ciò che colpisce è la polemica antifuturista, l’associazione dell’attributo futurista con l’idea di pazzia. Il film che si richiede deve già rispondere a dei canoni propagandistici che escludono ogni avventura espressiva e il ricorso alla sperimentazione delle avanguardie. Il successo del concorso è consacrato da un intervento dello stesso Mussolini: «Credo che il concorso bandito da ‘Il Tevere’ possa efficacemente aiutare la rinascita del cinematografo nazionale» (11 settembre 1926), e, dopo alcuni mesi, il quotidiano decide di varare una pagina settimanale interamente dedicata al cinema. La pagina vive per alcuni mesi e vi intervengono, tra gli altri, Giacomo Bontempelli, Aldo De Benedetti, Beltramelli, Corrado Pavolini, Raffaello Franchi. Nell’ottobre dello stesso anno si assiste all’ultima mossa della scalata monopolistica di Stefano Pittaluga, che assorbe l’Uci, con le sue duecento sale e aumenta il capitale sociale da 50 a 100 milioni. Se ormai Pittaluga possiede un ottavo circa delle sale italiane (ma le sue erano quasi tutte di prima visione), attraverso le sedi di noleggio (distribuisce tra l’altro i film americani della First National, della Universal, della Warner Brothers) provvede anche alle richieste di ben duemila sale, ossia l’80% di quanto si proietta in Italia è fornito dalla Pittaluga. Nello stesso ottobre del 1926 viene confermato un accordo con l’Istituto Luce per la distribuzione di cinegiornali da parte della stessa Pittaluga. La produzione di quell’anno vede, tra i suoi titoli di maggior spicco, Anita o il romanzo d’amore dell’eroe dei due mondi e Frate Francesco (entrambi scritti da Aldo De Benedetti), Il cavalier Petagna (tratto da Capuana), una nuova versione di Addio giovinezza! (che uscirà nel 1927) e L’ultimo lord. In pratica tutta la storia della produzione e dell’industria degli anni Venti è dominata dall’ascesa irresistibile
di Stefano Pittaluga, unico imprenditore in possesso di una mentalità moderna e di una lucida consapevolezza dei problemi dell’industria e del mercato. L’azione di Pittaluga non lascia tanto il segno – in questo periodo – nella produzione di film memorabili, quanto si impone per il lavoro di riunificazione e il contributo a una ripresa di tutta l’industria cinematografica su basi economicamente solide. Già nel 1920 «La rivista cinematografica» parla di questo uomo nuovo dell’industria fornito di capitali ed evidente lungimiranza industriale: «Stefano Pittaluga è l’uomo del giorno, il massimo esponente del noleggio in Piemonte e in Liguria […]. Oltre a una potenza finanziaria non comune, possiede quasi cinquanta sale di proiezione tra cinematografi e teatri […]. È un organismo poderoso e complesso che ha dell’americano» . L’attività iniziale di Pittaluga è dunque quella dell’esercente: «All’epoca della débâcle – scrive di lui Giannini – Pittaluga non disponeva che di una piccola azienda di poco più di un milione di capitale con sede a Torino e qualche cinematografo a Genova» . Nel giro di pochi anni, con una serie di acquisti azzeccati, Pittaluga riesce a disporre di un’efficiente e moderna rete di sale in Piemonte, Liguria e Lombardia. Approfittando della crisi delle maggiori case di produzione e dell’Uci Pittaluga interviene, in un primo tempo nel 1924, affittando gli stabilimenti Fert di Roma e acquistando quelli di Torino per dare subito vita a una serie di film (Maciste e il nipote d’America, Saetta principe per un giorno, Voglio tradire mio marito!), opere che, mediante opportuni accordi con l’estero, vengono prevendute in alcuni paesi stranieri. Pittaluga produttore, come si può capire da questi primi titoli, punta inizialmente tutte le sue carte su una produzione popolare e sull’unico filone ancora di successo, quello di Maciste. Nei suoi stabilimenti si è assicurato il lavoro di attori come Oreste Bilancia, Alberto Pasquali, Alberto Collo, Amleto Novelli, Diomira Jacobini, Italia Almirante Manzini e di registi come Gennaro Righelli, Augusto Genina, Luciano Doria e l’esordiente Mario Camerini. La sua produzione, almeno fino al 1927, non ha lasciato una traccia di rilievo nella storia del cinema italiano e tanto meno in quella del cinema internazionale, anche se nel 1926 vi saranno, accanto ai soliti Maciste (Maciste nella gabbia dei leoni, Maciste contro lo sceicco, Il gigante delle Dolomiti, Maciste all’Inferno è un titolo dell’anno precedente), opere più ambiziose come Beatrice Cenci, I martiri d’Italia, L’ultimo lord . Il programma non rivela particolari novità rispetto al passato se non per l’argomento dei Martiri d’Italia, che col suo nazionalismo serve bene come uno dei primi significativi esempi di supporto ideologico esterno al fascismo. Vale la pena soffermarsi un momento su Maciste all’Inferno, film che si è potuto ristudiare grazie al restauro effettuato dalla Cineteca di Bologna: l’opera, pressoché terminale nel percorso divistico di Pagano costituisce una felice ibridazione tra filone popolare dei forzuti, commedia e spettacolo di varietà. Maciste, giunto ormai alle soglie della pensione, irriconoscibile per chi ne ricorda le prime apparizioni, stranamente anticipatrici della parabola del comportamento fascista – quello squadristico con tanto di camicia nera, manganello e olio di ricino – viene spedito nell’aldilà a portare ordine e sedare i tumulti interni, perché in terra, o almeno in terra italiana, c’è ormai qualcuno che si impegna a portare un nuovo ordine politico e sociale. Maciste all’Inferno appare soprattutto come l’ultimo vero tentativo di sfidare la censura con l’aiuto del padre Dante e della tradizione iconografica già utilizzata fin dalla prima versione dell’Inferno del 1911 che il cinema italiano abbia compiuto nell’intero decennio che precede il sonoro. Poche rappresentazioni osées di corpi femminili negli anni Trenta, poche anche di quelli maschili sono paragonabili a quelle messe in mostra nei gironi infernali da Brignone. Ancora a proposito del film: qualcuno lo ha definito «una diavoleria» e questo mi sembra il riferimento più pertinente per tentare di cogliervi una chiave profetica contenuta in ogni diavoleria che si rispetti. A un certo punto Platone produce su un muro dell’Inferno una visione diretta della terra: «È la televisione – dice – sulla terra ne sentirete parlare». Nel 1926, come si è già visto, la Pittaluga assorbe l’Uci e le società associate, ivi compresa la Leoni film, il Sindacato veneto e l’Anonima cinematografi di Milano. Tutti i cinematografi e gli uffici di noleggio dell’Uci passano alla Pittaluga. All’Uci si crea la figura dell’amministratore delegato che l’11 ottobre dello stesso anno verrà assunta dallo stesso Pittaluga con pieni poteri. È questo il definitivo atto di morte dell’Uci. L’esercizio sarà ristrutturato e ceduto in parte a privati, salvo il diritto di poter condizionare una parte dei programmi. Vi sarà, negli stessi anni, un accordo con la Universal per lo sfruttamento per cinque anni dei film di sua produzione, stipulato con L. Berstein direttore della Universal per l’Europa. E questa casa americana, com’è noto, è la maggiore produttrice di film popolari per eccellenza. Assicurarsene la distribuzione significava 9
10
11
garantirsi una serie di sicuri successi. 1
L’Italia deve avere una sua cinematografia, in «Il giornale d’Italia», 9 giugno 1925.
2
R. Florey, Lavorazione americana, in «La rivista cinematografica», a. VI, 15 settembre 1925.
A. De Marco, Il primo congresso nazionale degli esercenti sale cinematografiche, in «La rivista cinematografica», a. V, 25 luglio 1924; A. De Marco, Ai margini del congresso di Roma, in «La rivista cinematografica», a. V, 25 agosto 1924. 3
4
C. Bassoli, Il secondo congresso nazionale cinematografico, in «L’Eco del cinema», a. III, luglio-agosto 1925.
5
M. Magic, Il significato e l’influenza del congresso cinematografico, in «Il cinema italiano», a. II, n. 10, 15 luglio 1925.
6
S. Pittaluga, Memoriale al secondo congresso Federazione industriali e commercianti, in «Il cinema italiano», a. II, ottobre 1925.
7
Ibidem.
8
U. Paradisi, Per la rinascita del film italiano, in «Il Tevere», 6 agosto 1925 e nei numeri successivi del 12 e 26 agosto.
9
S. Pittaluga, in «La rivista cinematografica», a. VII, 10 agosto 1926.
G. Giannini, La funzione politica dell’anonima Pittaluga nella cinematografia italiana, in «Kines», a. IX, n. 24, 9 luglio 1927. Si veda anche M. Salotti, Il volante e lo chauffeur, in C. Bertieri e M. Salotti (a cura di), Genova in celluloide, 3. I produttori liguri, Comune di Genova, Genova 1985, pp. 9-32. 10
11
Cfr. R. Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italiana, CNC, Roma 1991, pp. 65-73.
La fascistizzazione del cinemanegli anni Venti
la marcia su roma degli uomini del cinema Quando inizia la via fascista del cinema italiano? Agli inizi del sonoro, come per molto tempo si è continuato a sostenere passando un netto colpo di spugna sull’attività del decennio precedente, o col fascismo stesso, dal quale, pur senza imboccare subito una direttrice sicura, ha preso le mosse, incrociando, tra contraddizioni e contrasti, i piani dell’intervento politico-governativo con quelli economici e produttivi, con quelli degli operatori artistici e culturali e della critica? L’interrogativo – per quanto ovvio – è stato finora accuratamente evitato dagli storici . Anzi, per una sorta di involontaria ironia, per quasi trent’anni il ventennio fascista è stato studiato, nel settore cinematografico, come se si trattasse di un decennio un po’abbondante che si estendeva dall’avvento del sonoro al 1943, ma era del tutto privo di storia anteriore . Sono i limiti di un lavoro storiografico che continua a identificare la storia del film con la storia del cinema e che, di fronte al vuoto produttivo degli anni 1922-1929, e alla scomparsa pressoché totale delle fonti filmiche, ha preferito aggirare, se non ignorare del tutto, il problema. Considerando invece il decennio che va dalla crisi dell’Uci fino all’intervento a favore del cinema del 1931, ci accorgiamo che emergono, in stretta concatenazione, i segni di spinte diverse, sia sul versante della fascistizzazione e autofascistizzazione dell’industria e della critica, che su quello delle scelte governative nei confronti di questo settore dello spettacolo e dell’opzione, fin dall’indomani della marcia su Roma, per una politica di intervento e di controllo settorializzato che lascia, allo spettacolo di intrattenimento vero e proprio, le più ampie facoltà di sviluppo secondo libere leggi di mercato e senza alcuna intenzione di intervento protezionistico. I segni della presenza fascista nel campo cinematografico non sono di immediata evidenza: si tratta quindi di coglierne la logica di progressiva concentrazione e unificazione in un medesimo processo. La scelta è solo in apparenza contraddittoria in quanto va ricondotta nel quadro di una serie di operazioni politico-culturali che il fascismo compie in rapporto alla progressiva stabilizzazione del proprio potere. Pertanto è necessario riconoscere – in via preliminare – che ciò che importa non è tanto cogliere lo sforzo di dar subito vita a un organico programma di fascistizzazione del cinema, quanto osservare i processi di autofascistizzazione e di allineamento immediato delle forze economiche e degli operatori culturali alla politica vincente del regime. La gobettiana definizione del 1924 del fascismo come «parentesi storica, come fenomeno di disoccupazione nell’economia e nelle idee, connesso con tutti gli errori della nostra formazione nazionale» ha sempre minori proseliti. Sempre di più si è fatta strada, negli ultimi anni, l’idea che il fascismo ha dato una copertura istituzionale a molti fenomeni economici e culturali, derivati dalla realtà giolittiana e così ben radicati nel tessuto sociale e nelle istituzioni da poter poi tranquillamente sopravvivere oltre la fine del fascismo stesso. Per quanto riguarda la produzione, come si è visto, l’industria non entra in crisi per le ragioni dell’instabilità del quadro politico e non subisce alcuna trasformazione sostanziale nelle sue strutture produttive: i vecchi produttori, incapaci di rispondere alle esigenze dei pubblici usciti dall’esperienza della guerra, si sentono alleati per via naturale a una forza politica che li garantisce e scongiura il pericolo della svolta del paese in senso socialista. Il capitalismo cinematografico italiano, avventuroso, incompetente e improvvisatore, trovatosi di colpo alle corde per il crollo dell’Uci cerca da subito coperture istituzionali da parte del fascismo. Per il vertice fascista, sia nel periodo della crisi dei primi anni Venti, che in quello della cosiddetta rinascita, il cinema potrà muoversi secondo le libere leggi di mercato, purché i modelli offerti non creino stati di conflittualità sociale. Si può inoltre presumere che il regime guardi con sospetto e fastidio gli uomini di 1
2
cinema che chiedono, per un’industria del tutto allo sfascio, distrutta dall’ambizioso progetto monopolistico dell’Uci, incapace di riorganizzarsi e navigante sotto il segno della più totale incompetenza, protezioni legislative ed economiche e sgravi fiscali in cambio di una generica dichiarazione di fede e di lealismo. D’altra parte, se si eccettua il caso di Pittaluga, non sono certo i produttori superstiti dal naufragio dell’Uci a fornire le garanzie sufficienti per la ripresa e un tentativo di allineamento con le altre cinematografie. La nuova ondata di industriali sembra comunque più interessata all’importazione, alla distribuzione e all’esercizio, piuttosto che alla produzione. La crisi della produzione nazionale e la crescita della domanda impongono l’importazione massiccia di film stranieri, specie americani, che, se da una parte alimentano e diventano i transfert privilegiati dei sogni dell’italiano piccolo-borghese, dall’altra testimoniano dell’esistenza di un profondo rinnovamento economico nel processo di produzione culturale in funzione di nuovi pubblici, che possono alimentare ingenti profitti senza alcun rischio nell’investimento di capitali. E senza alcun pericolo di turbamento dell’assetto sociale, vista la morale «positiva», dei film americani. Già un primo segno di penetrazione e di presenza del fascismo, anteriore alla marcia su Roma, è quello riguardante la nascita dei primi Fasci artistici nelle maggiori città industriali (a Torino, non a caso) in coincidenza con i primi scioperi e le prime massicce agitazioni sindacali, organizzate in parallelo all’occupazione delle fabbriche. L’avvocato Francesco Soro – nel suo libro di memorie del 1935 – giunge persino a considerare queste prime agitazioni e aurorali prese di coscienza dei diritti, da parte di categorie di lavoratori senza una fisionomia giuridica, una delle cause non secondarie della crisi della cinematografia italiana di quegli anni . Presidente del Fascio artistico torinese è il signor Rossi Pianelli, ma la vicepresidenza è affidata all’attore regista Emilio Ghione, autore del primo sintetico profilo di cinematografia italiana scritto alla fine degli anni Venti. Rievocando quel periodo anche Ghione vede le cose in questi termini: «Nous sommes en 1921. Les affaires cinématographiques periclitent; la situation politique intérieure est, depuis deux ans, très grave; les communistes sont les maîtres du pays et proclament grèves sur grèves, jusqu’à l’apparition foudroyante des chemisesnoires. Tout cela, en attendant, porte à la ruine totale, peu à peu, le cinéma italien» . Accanto a Ghione troviamo, tra gli aderenti al Fascio artistico di Torino, anche altri attori come Alberto Pasquali, Umberto Mozzato e Domenico Gambino, il popolare Saetta, a cui l’associazione rivolge «meritati elogi» per la sua generosa e spontanea offerta di lire 500 . Di lì a qualche anno, nel 1925, proprio a Gambino si penserà per la realizzazione di un Saetta fascista, mai realizzato per la verità. Gli scopi del Fascio artistico sono dunque quelli di offrire aiuto morale e materiale ai produttori nel caso si trovino in difficoltà. Sotto la copertura culturale del programma dell’associazione («Revisione delle domande di ammissione – convalidazione dei soci – delegazione dei capigruppo alla esazione delle quote – campagna contro le scuole cinematografiche e invio di comunicati in merito alla stampa cittadina – funzionamento dell’ufficio di collocamento – comunicazione della costituzione del Fascio artistico e invio di programma e statuto agli industriali – comunicati alla stampa cinematografica sull’azione sociale – ricerca dei locali per la creazione di una sede sociale») è evidente la nascita, anche nel settore cinematografico, come si capisce bene da alcuni punti del programma, di gruppi squadristici con precisi compiti di azione e repressione. Non a caso viene subito dichiarata la copertura legale da parte di due avvocati, Buteri e Cavarra, e «l’assistenza medica sociale (prof. Jachia)». Non intendo scoprire l’ombrello quando affermo che anche per quanto riguarda il campo dell’intervento fascista in materia cinematografica «all’inizio fu il manganello». Certo, già all’indomani dell’avvento del fascismo al potere, si comincia ad attribuire a Mussolini il potere taumaturgico di promuovere la rinascita del cinema italiano. Questo entusiasmo nei poteri miracolistici del nuovo capo del governo («Evviva Mussolini! Perché com’è risorta l’Italia non dovrebbe risorgere anche l’industria cinematografica italiana?») è in realtà smentito dai fatti, in quanto, come si è detto, la produzione tocca, nel decennio successivo, i livelli numerici e qualitativi più bassi dell’intera storia del cinema italiano. La prima preoccupazione del regime sembra quella di garantire una continuità nel controllo della moralità delle pellicole, mediante opportune modifiche dei già efficaci strumenti ereditati dalla legislazione del periodo precedente. Con una serie di interventi successivi (il primo del 24 settembre 1924 n. 3287 e gli altri, nell’ordine, del 16 giugno 1927 n. 1121, del 9 aprile 1928 n. 941 e le successive leggi del 24 giugno 1929 n. 3
4
5
6
7
1103 per giungere a quella del 18 giugno 1931 n. 918, che segna il primo intervento organico anche a favore dell’industria) il regime mira soprattutto a regolamentare la vigilanza governativa sulla produzione e sull’esercizio. Il programma vero e proprio di provvidenze è varato solo a partire dalla legge del 1931: così mentre sul piano dell’azione censoria si garantisce una linea di perfetta continuità col passato, su quello produttivo non si intende esercitare alcuna pressione per ottenere che la produzione si impegni a favore di una celebrazione aperta del regime. Questo non vuol dire che non ci si interessi alle possibilità del cinema come strumento politico educativo e di propaganda e che, da fonti non governative, si comincino ad avanzare proposte di realizzazione di opere di celebrazione del regime. Tra i consigli e gli interventi per il concorso indetto dal «Tevere» nel 1926 per un soggetto cinematografico, spicca questa considerazione: «Se il film fascista non c’è ancora, c’è in noi un film che non ha bisogno se non di uno schermo, il cielo di Roma. E questo film si svolge ininterrottamente da circa otto anni e per esso gira non una manovella, ma milioni di cuori. Questo film ha un nome non scritto, ma un nome cantato Giovinezza! Giovinezza!». Nonostante queste prime manifestazioni di iperboli retoriche che negli anni successivi diventeranno formule comuni del discorso fascista, e nonostante le pubbliche professioni di fede fascista da parte delle riviste di categoria, che, pur tra feroci polemiche interne, fanno a gara a vantare i propri quarti di nobiltà di fascismo della prima ora, il fascismo non si assume, per alcuni anni, un impegno diretto né intende fornire alcuna precisa copertura economica e politica al cinema spettacolare. In nome del fascismo si chiede – da più parti – sulla stampa, la «rinascita», attaccando e denunciando le responsabilità e il disfattismo dei produttori e della critica sospetti di antifascismo. Ma i produttori non restano evidentemente alla finestra: l’avvocato Giuseppe Barattolo, consigliere delegato dell’Uci, e uno dei massimi responsabili, per la sua incompetenza, della caduta rovinosa dell’organismo, decide di presentarsi, in una lista fiancheggiatrice della Campania, alle elezioni del 1924 . Per tutta la durata della campagna ottiene l’appoggio incondizionato della stampa tecnica e di categoria che vede, nella sua elezione, la grande occasione per una tutela effettiva degli interessi dell’industria in seno al parlamento. A questo punto è maturata, negli operatori economici che si occupano di cinema, non soltanto una logica opportunistica di schierarsi a fianco del governo, ma quella di riuscire a far eleggere un proprio rappresentante capace di difendere gli interessi di categoria e rappresentare nuovi organismi da costituire entro breve tempo, in grado di presentarsi con richieste precise e omogenee al governo. I congressi romani del 1924 e del 1925 promossi dagli esercenti e dai commercianti prima e dagli industriali e da tutte le altre categorie, da cui scaturirà il memoriale di Pittaluga, sono il primo reale tentativo di accostamento in modo organizzato tra le forze economiche e quelle politiche. Ciò che importa veramente alle forze economiche, Pittaluga in testa, è ottenere dal governo uno sgravio nella tassazione fiscale e impedire il contingentamento o qualsiasi forma protezionistica nei confronti di film americani che sono la fonte più sicura dei profitti. In effetti, dal memoriale di Pittaluga, emergono i dati ufficiali degli altissimi introiti dello Stato grazie alla tassazione dello spettacolo cinematografico: nel 1920-1921 le tasse erano state di 17.736.000; nel 1921-1922 di 17.216.481; nel 1922-1923 di 17.507.445; nel 1923-1924 di 23.788.558; nel 1924-1925 di 49.357.979. A parte la svalutazione, l’aumento del costo dei biglietti, l’incremento del numero degli spettatori, i dati del memoriale intendevano far presente al governo che, dall’avvento del fascismo, era stata attuata una sorta di logica punitiva nei confronti del cinema per favorire altre forme di spettacolo e che invece era necessario aiutare il cinema, anzitutto riducendo lo sgravio fiscale. Soprattutto se si teneva conto che, nel 1925, il gettito complessivo era stato di circa duecento milioni, troppo poco per essere prosciugato di circa un quarto dallo Stato con un tributo supplementare sui biglietti d’ingresso che si aggiungeva a tutto il sistema di tassazione sulle spese vive di produzione. Quanto alla produzione vera e propria – se ripercorriamo i titoli del periodo che va dal 1922 al sonoro – ci accorgiamo che in mancanza di esplicite richieste non vengono realizzati film di propaganda esplicita diretta (a eccezione del Grido dell’aquila realizzato nel 1923 all’indomani della marcia su Roma), ma che una consistente serie di opere cerca di interpretare lo spirito ideologico del presente, riuscendo a fornire al regime una prima forma di supporto di messaggio ideologico indiretto nel campo dello spettacolo di puro intrattenimento. 8
I filoni che potrebbero rientrare in questo clima sono diversi: anzitutto, per numero di opere e per la sua azione e influenza o capacità anticipatrice di un processo storiografico che si sarebbe messo in moto solo dalla fine degli anni Venti, il filone risorgimentale. Si tratta del momento più colto e alto della cinematografia che si fascistizza, che si vuol liberare dalla letteratura dannunziana e simbolista, offrire materia per una revisione storiografica del passato prossimo e per dimostrare, in anticipo sugli storici ufficiali del regime, che il fascismo vanta, nel suo blasone, tutto l’antecedente storiografico delle guerre del Risorgimento. I fascisti hanno delle difficoltà ad annettere nella loro tradizione anteriore il Risorgimento, tanto che nell’opera di Gioacchino Volpe, L’Italia in cammino, del 1927 si esalta la storia presente, ma si parla assai poco del Risorgimento e non in termini di continuità. Solo dal 1929, in polemica con la storiografia crociana (La Storia d’Italia dal 1871 al 1918 del 1928 presenta il fascismo come un elemento di rottura) gli intellettuali fascisti più autorevoli, Gentile e Volpe, cominciano a sostenere, sull’esempio di Mussolini, che la storia patria dell’Ottocento si salda senza soluzioni di continuità col presente e stabiliscono le prime equazioni tra l’epica garibaldina e l’epica fascista . «Il fascismo è figlio del Risorgimento» scrive Giovanni Gentile, in un articolo apparso nel 1929 su «Critica sociale» e da questo momento tutta la storiografia fascista si muoverà lungo questa strada. Il filone garibaldino del cinema di quegli anni gioca un ruolo anticipatore e contribuisce, con la retorica e l’esasperazione melodrammatica degli intrecci (si pensi al groviglio di passioni della Cavalcata ardente del 1925) a dimostrare e far circolare sul piano di massa la rappresentazione evidente del fenomeno della continuità storica e della analogia tra Garibaldi e Mussolini, tra le camicie rosse e le camicie nere. I martiri d’Italia, Anita o il romanzo d’amore dell’eroe dei due mondi, Redenzione d’anime, Un balilla del ’48, Brigata Firenze, Cavalcata ardente, Garibaldi e i suoi tempi (è questo un genere in cui «rifulge» l’opera di Silvio Laurenti-Rosa, come ha scritto Vittorio Martinelli in un succoso profilo dedicato a questo autore apparso nei «Cahiers de la cinémathèque» n. 26-27, 1979) sono soltanto alcuni dei titoli dei film prodotti tra 1924 e il 1928 che richiamano l’attenzione e richiederebbero un’indagine specifica . Il Risorgimento si salda al presente attraverso la mediazione della prima guerra mondiale, che spesso è oggetto della narrazione documentaria o spettacolare (Da Icaro a De Pinedo, La leggenda del Piave), e che, a partire già dal 1916 e da Maciste alpino, per tutti gli anni Venti propone una serie di opere che hanno lo scopo di tener ben viva la fiamma dello spirito nazionalistico. Quanto al legame con i temi della romanità e ai tentativi di mostrare la continuità tra il passato e il presente il primo esempio di documentario costruito in questo senso mi sembra possa essere considerato Il ritorno di Roma (ne parla G.C. sul «Tevere» del 19 aprile 1926) che mostra l’ideale continuità della colonizzazione dell’Africa dall’impero romano fino al presente. Il documentario si conclude con la visita di Mussolini in Tripolitania ed è destinato a una circolazione capillare in tutti i comuni d’Italia. Per quanto riguarda Maciste, il suo filone si muove su terreni contigui che il fascismo stesso non esiterà a far propri. Da Cabiria, fino alla metà degli anni Venti, Maciste è il protagonista di vicende che lo vedono muoversi non solo lungo tutto l’arco della storia, dalle guerre puniche al presente, ma soprattutto agire in una topografia che ben presto valica i confini nazionali per spingersi fino all’America. Con il suo populismo a buon mercato e la sua immagine di raddrizzatore di torti e di protettore di deboli, donne e bambini, Maciste intreccia il suo destino, nell’immaginazione popolare, con quello del fascismo, giungendo a raggiungere una sorta di identificazione con l’immagine del suo capo a cui fornisce non poche suggestioni per le performance a petto nudo e per tutta una serie di gesti nel repertorio delle sue apparizioni. Maciste è un tramite fondamentale nella formazione del gesto mussoliniano: l’immagine divistica di Mussolini è tributaria, proprio nella sua fase di formazione, nei suoi atteggiamenti più popolari e populisti, di una serie di prestiti abbastanza netti. Se Mussolini è anche il prodotto e l’utente consapevole di certe tecniche dello spettacolo, bisogna tener presente che l’industria, nel suo tentativo di acquistarsi dei crediti presso il regime, progetta di ricorrere allo stesso Mussolini per la realizzazione, non di opere originali che esaltino gli ideali del fascismo, ma di un suo giovanile feuilleton anticattolico, Claudia Particella, l’amante del cardinale , apparso a puntate sul quotidiano trentino di Cesare Battisti «Il popolo», tra il 1910 e il 1911. Del progetto si fa promotrice l’Uci all’inizio del 1923 e Mussolini, che non aveva dimostrato particolari complessi nei confronti dell’uso commerciale della propria firma in calce a slogan pubblicitari (come quello del Vov) , acconsente in un primo tempo alla realizzazione del progetto, come, all’indomani della marcia su Roma, aveva permesso a una troupe americana di riprenderlo dal vivo per 9
10
11
12
un film di propaganda anticomunista . Una seconda proposta, avanzata ancora dall’Uci, mira a ottenere da Mussolini la redazione delle didascalie del remake di Quovadis? girato nel 1924 dal tedesco Georg Jacoby e da Gabriellino D’Annunzio. I progetti falliscono perché – con ogni probabilità – Mussolini si rende conto, ben presto, di quali sono i canali più giusti e pertinenti per la trasmissione dell’immagine politica del fascismo . 13
14
nascita del luce Dal 1926, con una legge apposita, il regime si è assicurato il monopolio dell’informazione cinematografica mediante la statizzazione dell’Unione cinematografica educativa (Luce). Il Luce nasce, fin dall’indomani della marcia su Roma, sotto forma di «sindacato per l’istruzione cinematografica» con lo scopo di produrre e distribuire film a carattere didattico . I primi titoli del 1924 comprendono alcuni documentari di Roberto Omegna, il pioniere della cinematografia scientifica italiana, come La vita dei ragni Epeira, o La vita delle farfalle, oltre a un originale resoconto del viaggio di Guelfo Civinini e Franco Martini in Africa Orientale dal titolo Aethiopia. Già nel settembre dello stesso anno, per intervento diretto di Mussolini, favorevolmente impressionato da un documentario sulla sua attività di governo (Dove si lavora per la grandezza d’Italia), la piccola impresa si trasforma in un organismo sostenuto da vari enti e battezzato dallo stesso Mussolini L’Unione Cinematografia Educativa. Da qui l’acronimo L.U.C.E., il cui capitale iniziale di un milione è presto portato a due milioni e mezzo e sottoscritto da una serie di istituti, tra i quali il Commissariato generale per l’emigrazione, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, l’Opera nazionale combattenti e la Cassa nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro . Presidente, vicepresidente e direttore generale di questo nuovo organismo erano rispettivamente il senatore De Michelis, il marchese Paolucci de Calboli, il grand’ufficiale Luciano De Feo . È presto chiara a Mussolini la possibilità di allargare la funzione di questo ente tanto che il passo successivo si può considerare una lettera datata 14 luglio 1925, indirizzata ai ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Economia Nazionale, delle Colonie e degli Interni. In questa lettera di Mussolini si invitano i ministri a «riconoscere ufficialmente la Luce e utilizzare la sua organizzazione tecnica e i suoi film per fini di istruzione, educazione e propaganda» . E dopo due mesi, lo stesso Mussolini, alla vigilia della presentazione di un decreto legge per la definitiva statizzazione del Luce, scrive una nuova lettera ai vari ministeri, in cui si rendono più esplicite le sue intenzioni ed egli si attribuisce la paternità assoluta dell’iniziativa: «Informo l’E.V. che in uno dei prossimi consigli dei ministri porterò all’approvazione un decreto-legge inteso ad attuare una convenzione che trasformi l’Unione cinematografica educativa da società anonima in ente morale autonomo. Come V.E. sa, la Luce venne costituita, per mia volontà, da alcuni fra i maggiori organismi economici nazionali, al fine di creare un valido organismo diffusore di pellicole culturali, educative, scientifiche, un organismo di cultura e di italianità» . Il provvedimento legislativo fu approvato dal Consiglio dei ministri l’11 ottobre 1925 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 5 novembre 1925. Fin da quei primi mesi sono girati due documentari, La battaglia del grano e La foresta fonte di ricchezza, che dimostrano subito la funzione, tutt’altro che neutrale, del lavoro documentario del Luce e l’appoggio diretto alla politica agricola e all’ideologia ruralista del fascismo ai suoi primi passi di governo. Da questo momento, la storia successiva del Luce fa parte integrante delle tecniche di organizzazione della propaganda e di controllo dei mass media, messe in atto dal regime. Il cinegiornale, assieme alla radio, diventa uno dei fiori all’occhiello della capacità del regime di servirsi, in modo efficiente e avanzato, di tutti i mezzi di comunicazione di massa. Grazie a una serie di contributi apparsi su questo argomento negli ultimi anni ci si può oggi ben rendere conto del ruolo importante di manipolazione e trasmissione dell’informazione giocato per anni dal Luce in maniera del tutto monopolistica e in perfetto accordo con gli altri media usati dal fascismo . In un decreto del 3 aprile 1926, n. 1000 si stabiliva, infatti, l’obbligo di proiettare, in tutte le sale italiane, un cinegiornale a ogni proiezione, sancendo così, in maniera definitiva, il monopolio dell’informazione cinematografica che si intendeva affidare da subito all’ente. L’iniziativa non riscuote peraltro consensi unanimi ed entusiastici: «Asserire che la novità andata in vigore, fin dallo scorso anno, sia stata accolta con molto favore da tutto il pubblico e dalle sale cinematografiche sarebbe un’esagerazione – si legge sulla 15
16
17
18
19
20
stampa specializzata – e non è difficile imbattersi in proteste degli esercenti per il costo sproporzionato delle pellicole Luce (25 lire) che, in molti casi, soprattutto in provincia, non aveva altro effetto che di falcidiare pesantemente l’incasso giornaliero» . Grazie al Luce il fascismo è il primo governo al mondo a esercitare un controllo diretto sulla cronaca cinegiornalistica e Mussolini il primo capo di stato capace di costruirsi, con i Cinegiornali, quasi giorno per giorno, un gigantesco arco di trionfo per le proprie imprese. La propaganda politica sarà naturalmente l’obiettivo principale, ma assieme a essa, verranno sperimentati nuovi modi di comunicazione e informazione giornalistica, legati alla narrazione quasi diaristica della piccola storia quotidiana dell’Italia e degli italiani. Con R.D.L. del 24 gennaio 1929 il Luce verrà dichiarato come unico organo tecnico cinematografico al servizio dello Stato e dall’indomani della creazione del Ministero della Cultura Popolare l’organismo passerà alle dipendenze del Ministero stesso. Il primo numero del cinegiornale è del giugno 1927 e in quel primo anno ne sono prodotti 44, mentre tutta la produzione muta, che si spinge fino al gennaio del 1931, è di circa 900 unità. Dal 1931 al 1943 vengono realizzate due serie di cinegiornali: la prima che si conclude nel gennaio-marzo 1940 e comprende 1693 numeri, la seconda che ne conta 379. Ogni settimana vengono realizzati quattro numeri di cinegiornale della lunghezza di 250 metri circa con servizi riguardanti l’attualità italiana e straniera. Per i servizi stranieri si procede allo scambio di notizie con le agenzie e le case di produzione di vari paesi, salvo poi procedere a una diversa rielaborazione delle notizie stesse. La proiezione dei cinegiornali sarà, come si è detto, obbligatoria per ogni proiezione in tutte le sale italiane e da un certo momento anche nelle sale dell’Impero. Dagli anni Trenta saranno realizzati dei numeri speciali dei giornali Luce per l’estero in varie lingue. Ma il Luce realizza, accanto ai cinegiornali, un’imponente massa di documentari, corto, medio e lungometraggi e, in una seconda fase, entra anche nel campo della finzione. Centinaia e centinaia di titoli, dall’indomani della sua nascita, che vanno dalla Fabbricazione del cappello di pelo di coniglio del 1925 ai Solenni funerali della prima regina d’Italia Margherita di Savoia, da La vita all’aperto, il mezzo di educare i bambini a una sana vita igienica al XV giro ciclistico d’Italia, alla documentazione della spedizione al polo dell’aeronave Italia alla lotta contro la tubercolosi al Concorso pompieristico internazionale di Torino, alla Coltivazione dello zafferano, a titoli dedicati alla lavorazione del cuoio, del legno, delle ceramiche, del vetro di Murano, del marmo… Dalla documentazione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna, alla vita dei topi bianchi delle formiche, della zanzara, sempre realizzati da Roberto Omegna . Titoli che oggi costituiscono, assieme ai cinegiornali, una fonte insostituibile e straordinaria di documentazione antropologica dell’Italia. Se l’Italia povera e sottosviluppata è in pratica invisibile e resta il più possibile al di fuori dell’obiettivo della macchina da presa, i cinegiornali e i documentari vogliono raccontare da una parte con spirito enciclopedico, dall’altra con la voce del cantore epico, la spinta dell’Italia in cammino verso la modernizzazione, senza mai dimenticare le radici nella tradizione. Così, accanto a titoli come L’Italia di domani, lungometraggio del 1928, o a documentari sul varo del transatlantico Conte Grande, o quelli dedicati all’igiene della casa o ai successi nella lotta contro la tubercolosi, o ai lavori di costruzione della diga di Santa Vittoria in Sardegna, o dei lavori dell’industria idroelettrica italiana, vi sono altri documentari rivolti al mondo contadino sull’uso dello zolfo nelle pratiche agricole, o sulla lotta alla filossera in viticoltura, o sulle sagre nel Matese, sulla festa dell’uva a Velletri, o su altre feste popolari e patronali in varie regioni della penisola. Ma a trionfare è forse quella che possiamo chiamare la sindrome titanico-muratoria del regime che dagli anni Trenta sostituirà quella ruralista e che propone, per una miriade di volte, servizi e cortometraggi sull’inaugurazione del cippo marmoreo a Tor Carbonia in memoria di Michele Bianchi, o della ferrovia elettrica del Gargano, o dell’ospedale Costanzo Ciano di Livorno, o di un sanatorio a Torino, o della casa del balilla a Perinaldo in provincia di Imperia, o del monumento ai caduti di guerra di Velletri, del dormitorio pubblico di Primavalle, dell’ambulatorio medico del gruppo fascista nomentano. Una frenesia e un fervore al tempo stesso distruttivo, restaurativo e costruttivo, percorre decine e decine di servizi del Luce e ci aiuta a ritrovare le forme rimaste intatte per secoli di paesaggi modificati di lì a poco in maniera irreversibile e irreparabile. Ma di questi aspetti e dei modi di rappresentazione mussoliniana avremo modo di parlare in un capitolo successivo. 21
22
la riscossa dei cattolici Accanto a questo organismo e alla sua storia – perlustrata, come si è detto, negli ultimi anni abbastanza a fondo – resta ancora da indagare tutto un vasto terreno parallelo, in cui operano una serie di enti che intendono servirsi dei mezzi di comunicazione di massa, del cinema e di altri tipi di sussidi, per svolgere la loro penetrazione capillare nelle scuole, nelle istituzioni culturali, nelle università popolari e negli enti più diversi. Questi enti o organismi riescono a individuare, con notevole esattezza e lungimiranza, sia la vastità di un terreno paracinematografico ancor vergine, sia l’efficacia di una azione di controllo educativo e di propaganda entro questo terreno mediante i sussidi visivi. Gli stessi cattolici, che avevano capito assai presto l’utilità dei sussidi cinematografici e paracinematografici e avevano fondato una serie di organismi per la diffusione dei sussidi audiovisivi, iniziano il loro lavoro di espansione capillare cercando di creare delle specie di cicli integrati di distribuzione, produzione, esercizio coordinati da organismi di distribuzione di film e diapositive e articolati, in varie iniziative, che potevano andare dalla organizzazione di film catechistici nelle scuole alla fondazione di una rete di sale parrocchiali. Era sorta, ad esempio, nel 1924, nell’ambito della Santa lega eucaristica, l’Opera delle proiezioni luminose, che offriva un ricco catalogo di diapositive e di filmine e che proponeva inoltre, in noleggio o in vendita, perfezionati proiettori cinematografici di produzione nazionale a passo normale, battezzati, con una perfetta scelta di tempo, Dux (Dux 1, 2, 3). Muoversi nell’ambito delle istituzioni scolastiche ed educative o delle organizzazioni giovanili voleva dire avere le carte in regola nei confronti del governo, e, al tempo stesso, occupare quasi senza concorrenza grandissimi terreni di bonifica e non perdere il contatto con il controllo dell’educazione dei giovani che il fascismo, di lì a poco, avrebbe cercato di sottrarre all’egemonia cattolica. Se osserviamo, sia pure di scorcio, la storia dell’Istituto italiano per le proiezioni luminose, così come ci viene presentata dal suo fondatore Alberto Geisser, su «La rivista cinematografica», ci rendiamo conto che, oltre a una mobilitazione verso un uso educativo degli strumenti e dei sussidi audiovisivi, che risale fino al 1909, ne sono messi in luce i grandi meriti, sia prima che durante e dopo la guerra (durante la guerra l’opera fu volta naturalmente, e con copiosi frutti, alla propaganda patriottica). Dopo la guerra, l’istituto, che si chiamava in origine Consorzio torinese, si accorda con l’Ufficio tecnico per la propaganda nazionale e si costituisce in ente morale, chiamato appunto Istituto italiano per le proiezioni luminose. L’istituto punta molto le carte del suo sviluppo sul fatto che nel dopoguerra su 2.162 comuni solo quattrocento possiedono apparecchi per le proiezioni luminose nelle scuole e sul fatto che quasi la metà risulta concentrata nel Veneto, lasciando il resto della penisola in condizioni di mancanza pressoché totale di questo tipo di sussidi. Geisser individua anche una serie di enti e di organismi che appaiono come i naturali destinatari e committenti del lavoro dell’istituto: «scuole di ogni ordine e grado, scuole militari, patronati e casse scolastiche, oratori, asili, collegi, scuole libere, istituti benefici, associazioni culturali, sezioni italiane e straniere di grandi associazioni di vario genere (Croce rossa, Dante Alighieri, Leonardo, Opera nazionale combattenti, Opera nazionale orfani di guerra, Opera nazionale madri e vedove dei caduti, Associazione per il Mezzogiorno, Gruppi d’azione per le scuole del popolo, Opera cardinal Ferrari), case del soldato e reggimenti, associazioni varie di cultura (università popolari, case di cultura, biblioteche culturali), società sportive e persino manicomi e carceri» . L’istituto plaude al fatto che a capo della pubblica istruzione sia, accanto a Giovanni Gentile, anche il professor Lombardo Radice, direttore dell’istruzione primaria, e che soprattutto, nei programmi di quest’ultimo, sia fatto esplicito cenno dell’intenzione di diffondere in tutte le scuole l’uso di sussidi cinematografici. Tutto un ampio progetto di diffusione capillare del mezzo cinematografico è dunque elaborato negli anni Venti da organismi allineati alle direttive del regime e questo progetto ha già perfettamente individuato il campo d’intervento. 23
il cinema e la costruzione dell’italiano di mussolini La creazione, verso la metà degli anni Venti, del Sindacato fascista dei lavoratori del cinema, a lungo caldeggiata sulle riviste, aumenta il coro di pressioni nei confronti del governo per un intervento risanatore . 24
Qui si può individuare un ulteriore punto di appoggio e di pressione per l’utilizzazione del mezzo cinematografico in funzione politica e cinematografica: da ogni parte si chiede un rapido intervento governativo per impedire il dilagare della cinematografia e difendere il lavoro delle maestranze italiane e si afferma, in pari tempo, che il cinema è un potente mezzo di propaganda nazionale e questo topos generalizzato finisce con l’avere la funzione di una captatio benevolentiae nei confronti del governo, più che rispondere a una proposta culturale precisa. Si collega assai spesso, in questi discorsi, il motivo della propaganda con quello della rinascita: «Si pensi a quale meraviglioso mezzo di propaganda italiana si perderebbe con esso se dovesse veramente scomparire […] incalcolabili sono i vantaggi che potrebbe portare alla nostra nazione un’industria la quale continuasse in ciò che un tempo essa ha compiuto con onore e gloria: far conoscere a tutti i popoli la terra d’Italia e gli italiani» . E su questa linea continuerà a muoversi per anni tutta quella stampa che vedeva nel cinema la migliore carta per trasmettere all’interno e all’estero i modelli nazionali. Si veda quanto scrive nel 1927 su «Cinematografo» G. Forti: «Insegnamo dallo schermo cinematografico, più didattico di qualsiasi libro, di qualunque maestro, la nostra storia, le nostre glorie ai nostri piccoli, che domani saranno i nostri soldati, e mostriamo loro quali siano gli istinti del nostro sangue, i sentimenti del nostro cuore, gli ideali della nostra mente» . A questo punto, in effetti, è necessario anche rivolgersi più direttamente all’aspetto organizzativo, alla messa a fuoco di tematiche utili al regime. Dal punto di vista culturale è molto significativo che siano proposti i recuperi dell’opera di autori e motivi prefascisti, in primis si individua, nell’opera di Alfredo Oriani, un ottimo terreno da utilizzare «per adempiere a certi scopi squisitamente attuali e della massima importanza nazionale e si propone di pescare dei soggetti dai romanzi di Oriani mirabile rappresentazione della vita nei suoi vari aspetti e con ammaestramenti e presagi per il nostro avvenire, così evidenti che, a buon diritto, è stato proclamato il precursore del fascismo» . Accanto a questo filone, che rimane però alla fase di progetto sulla carta bisogna recuperare, nell’ambito soprattutto della produzione, sospesa tra le intenzioni documentarie e quelle del film a soggetto, tutta una serie di titoli che giocano utilmente a favore del fascismo. Rientrano in quest’ambito Siliva Zulu, girato nel 1927 dalla spedizione Gatti in Zululandia, a scopi antropologici abbastanza distanti dalla politica imperialistica e colonialista non ancora peraltro manifestata in pieno dal regime, e con uno spirito di accostamento a queste popolazioni in apparenza tutt’altro che razzista . Altri titoli sono Alima (girato in Eritrea), Fiamme abissine (entrambi questi film sono realizzati dal comandante Salvatore Nicolini agli inizi degli anni Venti), e documentari veri e propri come Al rombo del cannon, L’agiterò sulle più alte vette, Le eroiche gesta dell’Artide, o film a soggetto, come Kiff Tebbi di Camerini (1928) tratto da un romanzo di Luciano Zuccoli il cui sfondo è la Tripolitania. Qualche opera affronta più direttamente i temi della propaganda antisovietica e anticomunista: come Katiuscia di Silvio Laurenti-Rosa, girato nel 1923 con materiali di provenienza sovietica, rimontati, o Russia (1927) con Marcella Albani, girato in Germania, o Siberia terra di dolore (1929) di Mario Bonnard. Infine, non sono estranee alla logica nazionalistica complessiva funzionale al fascismo anche opere di esaltazione nazionalistica delle glorie della cultura patria dal Frate Francesco (1927), ai Martiri d’Italia (1927), da Le rose del martirio (1928) a Le tappe della gloria e dell’ardire italici (1923) che esplicitamente stabilisce un motivo di continuità ideale tra la prima guerra mondiale e la marcia su Roma. Contemporaneamente all’intensificarsi delle iniziative, alla nascita delle prime istituzioni, al manifestarsi di primi sintomi di sensibilizzazione nei confronti del cinema da parte governativa, e nel quadro del tentativo fascista di darsi, oltre che una cornice istituzionale, anche uno statuto culturale, tentativo che trova un importante punto di aggregazione sulle pagine di «Critica fascista» , attorno all’inchiesta sull’arte fascista, cominciano ad affiorare due tipi di enunciazioni nuove, la prima che vede nel cinema l’arte fascista per eccellenza, la seconda che lancia lo slogan, centrale per la verità in tutta la retorica fascista, del «largo ai giovani». I giovani avanzano, chiedono di assumere delle responsabilità, di liberarsi per sempre dei quadri precedenti, in altre parole chiedono di assumere e di esercitare in maniera diretta un potere: «I giovani hanno fame – dichiara il commediografo Alessandro De Stefani nel suo intervento – non c’è che da invitarli a delle tavole imbandite e dire loro con la vostra voce, o Duce: ‘I vecchi sono stati degnamente ricoverati in comode 25
26
27
28
29
case di riposo. Io ora conto su di voi. Siate i nuovi artefici della nuova Italia’» . E Anton Giulio Bragaglia gli fa eco nel suo intervento: «I vecchi direttori nostri hanno i loro sistemi, non li rinnovano, sono viziati e incalliti, non c’è nulla da fare per loro […]. La difficoltà di dare un’arte dei nostri tempi, ovvero un’arte fascista, si presenta in ogni parte impersonata dai vecchi ormai occupatori delle possibilità artistiche di ciascun ramo […]. Né il fascismo ci ha ancora sbarazzato di questi convitati di pietra […] con gli artisti giovani, affermatisi migliori, si potrà ancora dare impulso a quella che è stata detta arte fascista, vale a dire arte dei giovani. La prima cosa da fare è quella di mettere in posizione ausiliaria quanti guardano ancora al lume del secolo scorso […]. Rinnovare gli uomini e favorire i giovani che devono dare quest’arte dei tempi nuovi e che soli possono darla» . È molto importante sottolineare il senso di questa frattura generazionale che, tatticamente, usa il fascismo come mezzo protettore e si pone, come progetto a breve scadenza, quello di una scalata a posizioni di potere nell’ambito delle istituzioni culturali pubbliche. Il fascismo asseconda, in realtà, fino a un certo punto, questi gruppi giovanili nella loro sete di potere: per un Blasetti che arriva ci sarà l’ex futurista Bragaglia sempre navigante tra umiliazioni e sconfitte, tra anticamere, dichiarazioni di fede incrollabile e continue richieste di sovvenzioni . Interessanti – anche ai fini del nostro discorso – le conclusioni dell’inchiesta, che, oltre a riconoscere in Mussolini, per il momento, «l’unico prodotto artistico del fascismo», chiedono la fine della separatezza intellettuale e un lavoro più preciso degli intellettuali a fianco del regime o in una partecipazione più diretta alla vita popolare: «Ogni periodo di vita ha un’arte corrispondente alla sua propria sostanza morale e la civiltà fascista non ammette che gli artisti costituiscano un gruppo separato moralmente dal complesso della società nazionale […]. La migliore ispirazione artistica si trova partecipando in pieno, alla vita del popolo» . Dal 1927 inizia un effettivo processo di ristrutturazione dei quadri, favorito dall’emigrazione di massa di gran parte di autori, attori e operatori in seguito alla crisi dell’Uci e tutti questi motivi di tensione nel campo fanno sperare nella prossimità di una ripresa: «Fini politici, finanziari, artistici ed economici impongono che l’Italia abbia ormai il suo cinematografo» afferma Blasetti nel numero del 6 marzo 1926 di «Cinematografo» uno dei punti di raccolta più interessanti delle voci nuove del cinema italiano e campo aperto a critici e personalità fasciste e antifasciste. In questo periodo comincia a circolare con insistenza, e a formarsi proprio sulle riviste fasciste il mito sovietico, e i film della rivoluzione e dei grandi maestri sovietici sono posti al centro degli orizzonti ideali di molti di questi giovani, non ultimo lo stesso Blasetti, mostrando come sia possibile, fin dall’inizio, al fascismo neutralizzare e usare con tranquilla indifferenza per la propria politica forme e modelli ideologici del tutto antitetici. Anche se le voci dei giovani si aggiungono ad altri tipi di richieste per una ripresa dell’attività produttiva, non si intenderà mai – neppure da parte di Blasetti, che è l’uomo più allineato col regime – chiedere un intervento diretto dello Stato in campo cinematografico. Su questo punto tutti gli intellettuali fascisti del periodo sembrano concordare, e soprattutto quelli che si fanno sostenitori delle tesi più avanzate di rinnovamento e non difendono interessi economici o industriali. Le cause sono presto dette: «Un’industria cinematografica di Stato dovrebbe sorgere principalmente con uno scopo: propaganda. E lo fallirebbe. La produzione di questa industria, recante palese o no il bollo dello Stato fascista, sarebbe inesorabilmente boicottata, respinta dal commercio, vietata dalla censura estera» . Traspare, da questo tipo di discorso, senza mezzi termini, la difficoltà che lo Stato fascista continua a incontrare nell’esportazione della propria immagine, ma appare subito anche chiara la presenza di una tendenza liberistica, di autofascistizzazione, sostenuta sia dalla critica e dagli industriali, che dagli stessi quadri politici fascisti, primo fra tutti, come vedremo, da Giuseppe Bottai. In attesa che qualcosa si muova in modo più deciso nell’ambito della normale produzione spettacolare, si assiste a una serie di iniziative, sia da parte del fascismo, per un programma d’uso del cinema in appoggio ai propri piani economici a favore dell’agricoltura, sia da parte dei cattolici, che, a seguito di alcuni convegni internazionali, intuiscono – al di là delle solite, e fatte per dovere d’ufficio, riserve d’ordine morale – l’enorme possibilità di incanalare, controllare e gestire in forma diretta il divertimento giovanile nelle campagne, nelle periferie urbane, mediante il cinema. In un congresso tenutosi a Monaco nel 1928, un autorevole prelato tedesco, padre Federico Müchermann, afferma: «È necessario cambiare l’attitudine dei cattolici riguardo al cinematografo. È impossibile risolvere il problema cinematografico insistendo nell’attitudine puramente proibitiva […]. Omnia vestra sunt, ha detto San 30
31
32
33
34
Paolo, dunque anche il cinematografo. Noi potremo influenzare lo sviluppo del cinematografo solo se ci installeremo in pieno movimento cinematografico […]. I cattolici eviteranno di formare un ghetto in campo cinematografico» . L’azione svolta dalla fine degli anni Venti dalla «Rivista del cinematografo» diretta da don Carlo Canziani ha proprio questo scopo e almeno nei suoi primi anni non sembra affatto voler intrecciare il proprio programma con quello del regime, anche se, col passare del tempo, l’alleanza si farà sempre più stretta e il rispetto delle direttive politiche, come vedremo, prevarrà sempre più nei confronti delle esigenze morali . Un’ulteriore importante mossa da parte del regime nel campo dell’uso educativo e propagandistico è la creazione dell’Istituto internazionale del cinema educatore, organo della Società delle nazioni, con sede in Roma, Villa Torlonia, a cui fanno capo varie interessanti, trascurate e spesso dimenticate, iniziative, tra le quali, in particolare, la pubblicazione della «Rivista internazionale del cinema educatore». L’inaugurazione dell’istituto è fatta da Mussolini stesso con un discorso (5 novembre 1928) di cui alcune frasi, più volte estrapolate, appaiono in epigrafe a quasi tutte le dichiarazioni ufficiali o pubblicazioni fasciste di cinema: «Ci sono, tra le mille altre, tre scoperte che segnano un’epoca nella storia della civiltà umana: la scoperta dei caratteri mobili della stampa, che ebbe luogo verso la metà del secolo XV, la scoperta della ‘camera oscura’ che ebbe luogo un secolo dopo e finalmente la scoperta del cinematografo: tre tappe fondamentali nel progresso dello spirito umano, tre formidabili strumenti per la conquista e la diffusione della cultura. La cinematografia che è ancora nel primo periodo del suo sviluppo presenta questo grande vantaggio sul giornale e sul libro: che essa parla agli occhi, cioè che essa parla un linguaggio che è comprensibile a tutti i popoli della terra, donde il suo carattere di universalità e le innumerevoli possibilità che offre per una collaborazione educativa d’ordine internazionale» . L’enfasi della dichiarazione non nasconde l’intenzione del fascismo di servirsi – d’ora in poi – del cinema come strumento del proprio lavoro diplomatico, e di investirvi un impegno politico più diretto. L’articolo 2 dello statuto dell’Istituto del cinema educatore indica la trattazione del tema dell’agricoltura tra i suoi compiti essenziali. Gli obiettivi da conseguire sono in sostanza due: l’insegnamento di nuovi sistemi di coltivazione e d’uso di macchinari più moderni e l’azione frenante nei confronti dell’esodo dei contadini dalle campagne. Una delle fonti più rappresentative per comprendere l’azione del regime e l’uso del cinema con precise funzioni didattiche è da individuarsi proprio in questo settore. Tutto il sistema di trasmissione, lungo la penisola, di nuovi modi di coltivazione a opera dei cineambulanti è un’iniziativa gestita dall’Istituto Luce. Il Luce, in accordo con l’Opera nazionale combattenti, lancia, sulle vie della penisola, prima 25 e poi 32 autocinema, completamente attrezzati, muniti di piccole cineteche, di pellicole d’insegnamento e di propaganda corredate di fogli illustrativi e di illustrazioni. Questi autocinema percorrono tutti i centri agricoli (in particolare del sud) e il governo dispone che i vari direttori delle «cattedre vaganti» di agricoltura spieghino i film mostrando i vantaggi di un’agricoltura razionale : «Nel quadro di questa attività la bonifica integrale è stata seguita con particolare attenzione, e principalmente la bonifica delle Paludi Pontine. La documentazione fotografica e cinematografica fattane dall’Istituto Luce costituisce la testimonianza esteticamente più efficace della gigantesca opera. Sono inoltre state studiate e documentate altre importanti bonifiche, come quelle di Grosseto, Coltano, Comacchio, Piscinara, Sibari, Ostia, Nicastro, ecc.» . L’azione, in campo rurale, della rivista, ha pertanto tre obiettivi fondamentali: 1) conoscenza di temi utili; 2) indagine sui risultati della cinematografia agricola all’estero; 3) catalogo di tutte le pellicole d’argomento rurale realizzate nel mondo. Gli argomenti trattati sono disparati: si va dal tema delle cooperative agricole alle panoramiche sui nuovi film russi, si parla del controllo della cinematografia statale nei paesi stranieri e si dedicano ampi servizi al cinema di cui parleremo più diffusamente nel capitolo dedicato alla critica. Ma il vero obiettivo della rivista è quello di appoggio alla politica ruralista del regime: gli articoli dedicati ai problemi del mondo rurale sono, dal 1929 al 1934, ben 32 e tendono a combattere e frenare l’esodo rurale offrendo un ampio panorama dei vantaggi dell’agricoltura . Viene proposto, in questo sforzo di contenimento dell’esodo rurale, di limitare le proiezioni di film spettacolari nelle campagne: «Appare pericoloso – ad esempio – presentare film che mostrino il fascino della vita cittadina, le commedie brillanti, la sontuosità di certe abitazioni, il mondo femminile di Hollywood con tutta la sua potenza. Bisogna eliminare questi film che fanno sognare una vita del 35
36
37
38
39
40
tutto diversa da quella contadina. La propaganda dev’essere invisibile, quasi desunta dai fatti» . È evidente l’importanza di queste affermazioni per uno studio della politica della distribuzione del prodotto cinematografico sul territorio nazionale, per capire, accanto alle varie forme di censura statale e religiosa, anche le reali manifestazioni di varie forme di censura di mercato, di cui si sono soltanto percepiti alcuni fenomeni. Questo discorso – in ogni caso centrale nella propaganda del regime negli anni Venti – è destinato a uscire dai limiti della rivista che si ammanta di una veste scientifica per investire direttamente il campo della produzione vera e propria. Non a caso tutti i discorsi che si trovano quasi nello stesso periodo su «Cinematografo» costituiscono la premessa o la dimostrazione e l’appoggio parallelo in funzione della produzione di Sole, film che ha come oggetto tematico proprio un motivo centrale della politica ruralista del regime, la bonifica delle paludi pontine. Su questo piano terminale del periodo del muto sarà possibile vedere una sorta di sovrapposizione di discorsi in apparenza diversi e provenienti da contesti diversi, in realtà afferenti entro il medesimo progetto. Anzitutto cominciano ad apparire discorsi che investono il ruolo degli intellettuali, il loro dover essere, il rinnovamento del loro ruolo sociale, ecc. Si veda questo intervento di Alberto Spaini sulla necessità di aprire gli intellettuali ai temi della terra: «Ruralizzare l’Italia. Portare il letterato, l’artista italiano fuori dalla città, fuori dalla chiusa cerchia della piccola borghesia che si specchia all’infinito in se stessa, come il cliente nei due specchi del barbiere […] uscire dalla città dove da venticinque anni ci siamo rinchiusi e andare, una buona volta, a vedere quest’Italia che nessuno sa com’è fatta» . È chiaro che, in questo contesto, il ruolo tradizionale dell’intellettuale crociano, il suo sistema di valori, la sua collocazione nel quadro delle istituzioni culturali diventano elementi e manifestazioni palesi di una inadeguatezza e di un’assenza rispetto a queste nuove esigenze. 41
42
verso la «rinascita» Si arriva dunque, alla fine degli anni Venti, ad un terreno nel quale hanno agito e si sono mosse diverse forze. Se l’esperienza produttiva blasettiana e i suoi successivi tentativi di dar vita a organismi cooperativi, quale quello del Consorzio italiano produttori, o quello del Consorzio italiano cinematografi indipendenti (una sorta di circuito alternativo che consentisse la circolazione della produzione indipendente e di qualità) abortiranno per vari motivi (non ultimo il fallimento dell’Augustus, la casa produttrice fondata da Blasetti con alcuni amici, a cui si deve la realizzazione di Sole), lo stesso Blasetti troverà modo di proseguire il proprio lavoro all’interno della nuova Cines di Pittaluga, unica struttura in grado di far fronte, da subito, alle nuove esigenze imposte dall’avvento del sonoro. In realtà il quadro, che possiamo ricavare dalla situazione, della competenza dei quadri tecnici e del livello della produzione è abbastanza desolante. A titolo di puro divertimento si può ricordare la cronaca della proiezione di uno dei primi film sonori in un «cinema modello» alla fiera di Padova nel 1929: «La sala era indubbiamente bella […]. I guai cominciarono alla proiezione […]. Mi recai più volte in cabina, nella cabina modello. Trovai una squadra di disgraziati, compreso un pompiere, intenti a lottare contro ogni sorta di difficoltà, di manchevolezze di tiri birboni della sorte malvagia […]. Brava gente, perché altrimenti chissà che cosa sarebbe successo là dentro […] l’incendio, il terremoto o l’ira di Dio. Invece il grave danno si limitò ai continui arresti della proiezione e a un abbaiamento irriverente del Duce davanti agli scarponi, a una serie di incidenti […] il tutto accompagnato da imprecazioni in vari dialetti, dal meneghino al romanesco e da brontolii del pubblico […]. In Italia ci vuole la rinascita. Più di tutti la vuole il Duce» . La situazione della macrostruttura radiografa, in modo abbastanza esemplare, quella della macrostruttura. E la denuncia dei mali perduranti giunge da varie parti. Per tutte richiamo la polemica, che si svolge sulle pagine di «Economia nazionale» e di «Argante» tra Eugenio Giovannetti e Alessandro Blasetti, sull’inesistenza assoluta della nostra industria cinematografica, secondo il primo, al quale il secondo risponde passando al contrattacco e lanciandosi in affermazioni trionfalistiche di questo tipo: «Un’industria del film in Italia esiste e lavora. Ha tre teatri di posa, dodici macchine da presa, tre apparecchi di registrazione sonora, centinaia di macchine ultrapotenti, officine vastissime e oltre cinquecento operai, impiegati, tecnici artistici che lavorano […]. Dio voglia che di gente di fegato e di tenacia come Stefano Pittaluga ne vengano fuori altre dieci» . 43
44
Come si capisce, anche Blasetti, che inizia la sua attività con una esperienza cooperativistica del tutto improvvisata, identifica il cinema italiano con la produzione di Pittaluga (e di fatto le cose in quel periodo stanno effettivamente così). Dal 1930 in poi da una parte si chiederà una maggiore fascistizzazione tematica e un maggiore intervento statale: «Perché a fianco del cinematografo ispirato alla rivoluzione comunista non nascerebbe il cinematografo ispirato alla grande rivoluzione fascista?» , e dall’altra si continuerà ad agire e a battersi per ottenere un intervento diretto e un appoggio concreto, in termini economici, da parte del governo. Il governo dichiarerà ufficialmente – mediante Bottai – nella presentazione della legge del 1931, l’indifferenza nei confronti di una pressione tendente a ottenere dal cinema contributi di propaganda diretta. E in perfetta sintonia si troveranno alcune posizioni nella stampa specializzata: «Film di palese propaganda o troppo fortemente moraleggianti forse non incontrerebbero il favore del pubblico. Anche in una produzione che asseconda idee religiose e politiche deve prevalere il fine artistico-commerciale e quindi non si può rinunciare a quei fattori di successo che sono la ragione stessa del cinema» . Quest’ultima affermazione ci dice molte cose sul nuovo corso, sulla nuova immagine del fascismo degli anni Trenta e sull’abbandono progressivo della politica ruralista a favore di un’immagine di stabilizzazione nazionale che, coinvolga il consenso della borghesia, favorisca l’idea di una concordia interclassista a uso non solo interno, ma anche dell’immagine della propria conduzione politica che il fascismo intende esportare all’estero. L’opzione per un film non a tesi, per la linea cui verrà dato il nome di telefoni bianchi alla fine degli anni Trenta, viene dunque da lontano: la scelta di questo tipo di produzione non è estranea o indipendente dalla logica complessiva della politica culturale del regime. L’alleanza e l’integrazione tra il capitale economico e il fascismo emargina e usa, a scopi di propaganda esterna, solo alcuni film più direttamente coinvolti con la politica del regime stesso, ma rimuove di fatto dalle linee dominanti della produzione la priorità del politico. In sostanza se non si può dire che il fascismo affronti di petto e subito il problema dell’industria cinematografica, non si può neppure affermare che il mancato controllo economico e la tolleranza nei confronti delle libere leggi di mercato appaia come un comportamento difforme o in contrasto con la politica economica generale. Né è possibile trascurare il riconoscimento di un contesto e di una serie di interventi convergenti sul piano delle istituzioni, della critica, della produzione, delle attività paracinematografiche, del controllo dell’informazione, che dimostrano come vi siano momenti di incontro ben precisi tra fascismo e mondo del cinema. Se questo incontro non dà i suoi frutti immediati e più evidenti, come per il nazismo, sul piano della produzione spettacolare, la produzione di carattere storico sembra subito sposare l’ideologia nazionalista del fascismo e addirittura anticiparne gli sviluppi storiografici. Pur nelle difficoltà di raccogliere dati molto eterogenei e di unificare elementi sparsi, è possibile riconoscere la presenza di un progetto politico e di una comprensione dei problemi dello spettacolo da parte del regime con cui bisogna continuare a confrontarsi. Con tutta probabilità l’insieme di manifestazioni che contribuiscono a fondare i presupposti della – sia pur limitata – fascistizzazione della cinematografia italiana, non sono che una minima parte esterna rispetto a una serie di fenomeni sommersi ancora da indagare e collegare in un quadro complessivo e organico. Un quadro nel quale si deve riconoscere che le trasformazioni dello spettacolo cinematografico e dei suoi modi produttivi non coincidono e non si convertono in toto in forme specifiche di spettacolarità fascista. Ma neppure si evolvono indipendentemente dal controllo del regime secondo linee autonome a-fasciste in sostanza, che consentirebbero di assolvere quasi tutta la produzione cinematografica dalle sue colpe di connivenza ideologica col regime e non spiegherebbero certo la molteplicità delle forme e delle metamorfosi attraverso cui l’ideologia riesce a trasmettersi e a confermare i suoi modelli attraverso i mass media. 45
46
Questo capitolo sviluppa il testo di un mio intervento a un convegno organizzato dal Consorzio di pubblica lettura di Bologna, parzialmente ripubblicato nei «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979, dedicato al cinema muto. Una versione molto simile a questa è stata pubblicata su «Journal of Italian History», a. II, n. 3, 1979. 1
Nei convegni degli anni Settanta di Ancona, Pesaro, Venezia dedicati al cinema del fascismo il problema del periodo anteriore al sonoro è stato regolarmente rimosso e la stessa cosa è avvenuta in tutti i libri dedicati al cinema del fascismo apparsi negli ultimi decenni (con minime eccezioni). Più di recente, però, si segnalano vari contributi in Italia e all’estero che consentono di fissare molti punti con maggiore precisione nel territorio, grazie al ritrovamento dei testi e a una serie di ricognizioni su terreni contigui e su fenomeni settoriali. 2
3
F. Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935, p. 197.
4
E. Ghione, Le cinéma italien, in «L’Art cinématographique», VII, 1930, p. 55.
5
Il fascio artistico torinese, in «La conquista cinematografica», a. I, nn. 3-4, ottobre-novembre 1921.
6
Ibidem.
R. Merkel, Ripercussioni tra il film italiano e quello tedesco, in «La rivista cinematografica», a. IV, n. 20, 25 ottobre 1923, p. 22. Cfr. R. Redi, Lo stato riluttante: potere pubblico e cinema negli anni venti, in F. Magrelli (a cura di), Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia 1986, pp. 269-279. 7
G. Mastracchi, La candidatura del comm. Giuseppe Barattolo, in «La rivista cinematografica», a. V, n. 4, 25 febbraio 1924, p. 64; U. Corona, Un nome una speranza: Giuseppe Barattolo, in «Rassegna cinematografica», a. II, marzo 1924; Soc. An. Comm. Film, Il significato della candidatura Barattolo, ivi. 8
Si veda su questo problema tutta la discussione e l’analisi fatta da P. Sorlin, Clio a l’écran, ou l’historien dans le noir, in «Revue d’histoire moderne et contemporaine», tome XXI, avril-june 1974, pp. 252-278. 9
Questo lavoro è stato compiuto egregiamente da G.M. Gori, Patria diva, la storia d’Italia nei film del ventennio, La Casa Usher, Firenze 1988. 10
B. Mussolini, Claudia Particella, l’amante del cardinale, in B. Mussolini, Opera omnia, a cura di E. e D. Susmel, La Fenice, Firenze 19511962, vol. XXXIII. Il romanzo fu pubblicato anche nel 1929 senza l’autorizzazione di Mussolini in una edizione americana dal titolo The Cardinal Mistress. Sull’importanza divistica di Mussolini si veda, tra i molti contributi apparsi di recente, R. Renzi, Il Duce, ultimo divo, in Id. (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo 1905-1930, Cappelli, Bologna 1991, pp. 131-139. 11
12
L’immagine dello slogan è riprodotta in AA.VV., Giornali del Veneto fascista, Cleup, Padova 1976.
Mi riferisco alla realizzazione nel 1922 dell’opera The Eternal City a opera del regista George Fitzmaurice, il cui soggetto si serve dello sfondo storico della marcia su Roma e della lotta politica italiana e dove Mussolini e i gerarchi appaiono a più riprese nei giorni successivi alla marcia stessa. 13
Per la diffusione negli Stati Uniti dei simboli di italianità veicolati dalla figura di Mussolini (ma anche da quella di Rodolfo Valentino), si veda G. Bertellini, Duce/divo. Masculinity, Racial Identity, and Politics among Italian Americans in 1920s New York City, in «Journal of Urban History», vol. 31, n. 3, July 2005, pp. 685-726. 14
Alla storia del Luce e alle caratteristiche dei suoi giornali ci si è interessati soprattutto a partire dal 1970, quando tutti i cinegiornali requisiti dagli americani durante la seconda guerra mondiale sono stati restituiti. Tra i documenti d’epoca si vedano in particolare: A. Sardi, Cinque anni di vita dell’Istituto nazionale Luce, Grafica, Roma 1930; Origine, organizzazione e attività dell’Istituto nazionale Luce, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1934 e il numero dello «Schermo», del luglio 1936, interamente dedicato al Luce. Tra gli scritti più recenti, E.G. Laura, Il linguaggio della propaganda in un decennio di cinegiornali, in Settimana internazionale del nuovo cinema, Grado 1972 (ciclostilato); i capitoli dedicati al Luce nei miei Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Patron, Bologna 1972, e Cinema italiano tra le due guerre, Mursia, Milano 1975; la tesi di laurea di S. Zullato, Padova 1972, che pur inedita ha costituito a lungo la più importante catalogazione statistica e per argomenti di tutto il materiale cinematografico esistente; G. Cremonini e F. La Polla, Note in margine ai cinegiornali Luce, 1919-1940, in «Il Ponte», n. 5, maggio 1973; P. Bernagozzi, I cinegiornali Luce, in Id., Propaganda di regime e giudizio della storia, Deputazione Emilia-Romagna per la Resistenza, Steb, Bologna 1973 e, dello stesso, Vincere, Vinceremo, a cura dell’Istituto Luce e Archivio cinematografico della Resistenza, Cirilanda, Roma 1975. Inoltre si vedano M. Argentieri, L’occhio del regime, Vallecchi, Firenze 1979; M. Cardillo, Ilduce in moviola, Dedalo, Bari 1983. 15
16
Cfr. Origine, organizzazione e attività dell’Istituto nazionale Luce, cit., pp. 3-4.
17
Fondamentale per qualsiasi ricerca ulteriore si intenda condurre sul Luce il volume a cura di M. Pizzo e G. D’Autilia, Fonti d’archivio per
la storia del Luce, 1925-1945, Istituto Luce, Roma 2004. 18
Ivi, p. 4.
19
Ivi, p. 5.
Si vedano, oltre ai testi già citati, Ph.V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, Laterza, Roma-Bari 1975; F. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista, Marsilio, Venezia 1976, la nota dedicata da Mario Isnenghi all’Ente Radio Rurale, in Strumenti e pubblico dell’organizzazione culturale fascista, in «Belfagor», a. XXXI, n. 3, maggio 1976, pp. 343-348 e il ricco lavoro di A. Monticone, Il fascismo al microfono, Studium, Roma 1978. Ultimo in ordine di tempo e più ricco di ipotesi, stimoli e documenti è il lavoro di G. Isola, Abbassa la tua radio per favore, La Nuova Italia, Firenze 1990. 20
21
È una lettera pubblicata da un esercente di Ravenna su «L’Eco del cinema», a. III, dicembre 1925.
Un’accurata e completa filmografia è in E.G. Laura, Le stagioni dell’Aquila, Ente dello Spettacolo, Roma 1999, che costituisce anche la storia più documentata e completa dell’Ente. 22
23
A. Geisser, L’Istituto italiano per le proiezioni luminose, in «La rivista cinematografica», a. IV, 25 aprile 1923, pp. 104-107.
Alle voci degli esercenti e distributori e a qualche voce sparsa di registi e produttori si affiancano, verso la metà degli anni Venti, quelle dei critici e dei giornalisti. Il motivo si coagula in una sorta di parola d’ordine o slogan (la «rinascita») che si diffonde a macchia d’olio su tutti gli organi di stampa. A questo proposito si veda anche il primo capitolo del mio Cinema italiano tra le due guerre, cit. 24
25
L’Italia deve avere una sua industria cinematografica, in «Il cinema italiano», a. II, n. 10, 15 luglio 1925.
26
G. Forti, S.O.S., in «Cinematografo», a. I, n. 1, 6 marzo 1927.
27
C. Carli, Possibilità cinematografiche, in «L’Eco del cinema», a. IV, ottobre 1926.
Una copia del film è visibile alla cineteca di Tolosa. Cfr. anche M. Migliavacca, Siliva Zulu, in «Cinemalia», a. I, n. 1, 1° dicembre 1927. Si veda il mio L’ora d’Africa nel cinema italiano nel volume omonimo, da me curato con Jean Gili, Materiali di lavoro, Rovereto 1990. 28
L’inchiesta su «Critica fascista» vede rispondere intellettuali di diverse provenienze, dalle avanguardie a figure più tradizionali (Bontempelli, De Stefani, Soffici, Bragaglia, ecc.). 29
30
A. De Stefani, Per un’arte fascista, in «Critica fascista», 15 novembre 1926, p. 419.
31
A.G. Bragaglia, Lo stile è l’epoca, ivi, pp. 417-418.
A.C. Alberti, Il teatro del fascismo, Bulzoni, Roma 1974 e dello stesso Poetica teatrale e bibliografia di Anton Giulio Bragaglia, Bulzoni, Roma 1978. 32
33
Resultanze dell’inchiesta sull’arte fascista, in «Critica fascista», gennaio 1927, p. 3.
34
A. Blasetti, S.O.S., in «Lo Spettacolo d’Italia», a. II, n. 6, 5 febbraio 1928, p. 65.
35
D.C.C., L’opera dei cattolici per la cinematografia, in «La rivista del cinematografo», a. I, n. 8, agosto 1928, p. 117.
36
Si veda, oltre al capitolo successivo, anche il mio Tattiche della negazione e del consenso nei giudizi del centro cattolico, in AA.VV.,
Retorica e politica, Liviana, Padova 1977. 37
B. Mussolini, Cinematografia educativa, in Id., Scritti e discorsi 1927-28, Hoepli, Milano 1934, pp. 271-272.
38
Cfr. Origini, organizzazione e attività dell’Istituto nazionale Luce, cit., p. 43.
39
Ivi, p. 39.
40
C. Longobardi, Cinema e cooperative agricole, in «Rivista internazionale del cinema educatore», a. III, n. 10, ottobre 1931.
41
C. Legras, Il cinema e l’esodo rurale, in «Rivista internazionale del cinema educatore», a. IV, n. 7, luglio 1932, p. 567.
42
A. Spaini, Bonifica integrale, in «Cinematografo», a. III, n. 22, 10 dicembre 1929.
43
M. Magic, Ammaestramenti, in «Rivista italiana di cinetecnica», a. II, n. 6, giugno 1929, n. 110.
E. Giovannetti, Il cinema come industria, in «Economia nazionale», n. 10, ottobre 1931, e la risposta di Blasetti su Argante, ripresa su «Cinematografo», dicembre 1931. 44
45
G.V. Sampieri, Lo stile e gli indirizzi del nuovo cinema italiano, in «Rivista italiana di cinetecnica», a. III, n. 4, maggio 1930, p. 5.
Dichiarazione di Bottai durante la discussione alla Camera (seduta del 27 maggio 1931) della legge a favore della cinematografia italiana. La dichiarazione e il testo della legge sono riportati in «Lo spettacolo italiano», a. II, nn. 7-8, luglio-agosto 1931, pp. 269-270. 46
Critica e teoria
nascita della teoria Come si è già visto, la stampa tecnica e di categoria affronta, fin dalla sua nascita, tutti i problemi teorici e critici del cinema, raggiungendo, in un tempo relativamente breve, un livello di sufficiente professionalità e competenza. Gli interventi di carattere estetico, gli interventi dei letterati, i referendum, riescono anche a dare l’impressione di un certo movimento di opinione, della formazione di una certa area di consenso, senza però offrire, o riuscire a porre le basi per una autonoma elaborazione sul piano teorico e poetico. Il retroterra culturale dei registi del muto, salvo poche eccezioni, è modesto e senza l’intervento decisivo di qualche autorevole personalità (come D’Annunzio) il cinema farebbe fatica ad ambire a una propria poetica, oltre che al diritto di entrare a far parte del regno delle arti. Il silenzio dell’idealismo ufficiale significa sospetto nei confronti di opere che, per le loro stesse caratteristiche realizzative, lasciano pochi spazi all’«intuizione lirica». C’è poi un’altra difficoltà da superare sul piano teorico che riguarda la presenza «ingombrante» di tutti gli aspetti tecnici nella realizzazione del film di cui non si riesce bene a stabilire il rapporto con l’opera fatta. Così, in mancanza di un intervento autorevole, o di un supporto teorico capace di funzionare da centro propulsore per i discorsi sul cinema, la ricerca sulla genesi e sulla formazione delle prime teoriche del cinema in Italia deve procedere in ordine sparso, cercando di cogliere dei segni di intelligenza, delle illuminazioni in discorsi distribuiti lungo tutta l’area della stampa, dai quotidiani alle riviste alla stampa specializzata o di varia cultura, a quella scientifica e infine a quella tecnica e di categoria . Ultimo nato – nel territorio delle arti – il cinema muove i primi passi e già manifesta, nello stesso tempo, un potere fecondante e distruttivo nei confronti delle forme artistiche che lo hanno preceduto e sembra in grado di far nascere un uomo nuovo, una nuova forma di culto laico a diffusione planetaria. Fin dal 1908, ad esempio, in un articolo su un giornale fiorentino («Il Nuovo Giornale» 25 novembre 1908) Canudo così si esalta descrivendo la sua esperienza di contatto con il cinema in una sala popolare: «Noi eravamo nel vestibolo di un teatro, certo di un teatro nuovo. Ma l’impressione spontanea dell’attesa in un pronao mi occupava e mi faceva guardare tutte quelle facce per scoprire lo spirito. E questo spirito non era religioso […]. Compresi che erano uomini nuovi che non hanno più un tempio perché non hanno più la fede che animava per gli uomini i vecchi tempi, e cercano una forma nuova e profetica dello spirito templare […]. Tra le meraviglie dell’invenzione moderna il cinematografo appare subito come la suprema. Esso le riassume tutte in simbolo e in realtà. Noi abbiamo creato una nuova dea per l’olimpo nostro, questa dea è la velocità» . Canudo attribuisce al cinema quei poteri che solo pochi anni prima Mario Morasso («poligrafo disordinato e geniale, antenna sensibilissima alle correnti sotterranee e non ancora sbocciate della cultura contemporanea» ) ne La nuova arma (1905) aveva attribuito alla macchina e al suo capo . Ed è ancora Canudo che ha parlato di cinema come «sogno del meraviglioso, imposto dalla scienza, che ispirerà i maestri del domani» . Tra tutti i tentativi che vogliono definire le nuove qualità e trovare nuove leggi del mondo contemporaneo, il cinema si offre come arma e strumento alternativo di scrittura, equivalente di un cantore orale in grado di raccontare una nuova epopea, e come «arte totale», punto d’incontro, vaso in cui avviene la fusione e metamorfosi di tutte le arti. I confronti sembrano inevitabili da subito e non c’è consenso nel riconoscere l’inferiorità del cinema. Chi sposa la causa della modernità, ma anche quella della cultura simbolista, ne viene affascinato e presto è 1
2
3
5
4
arruolato alla sua causa. E Giuseppe Prezzolini, parlando della guerra di Libia sulla «Voce» del 22 agosto 1912, scrive del nuovo mezzo in questi termini: «Ecco che, accanto al giornalista di professione o improvvisato lungo le trincee tripoline e cirenaiche, negli accampamenti, alla partenza e all’arrivo delle truppe in marcia verso il nemico, s’è levato un altro occhio, quello del cinematografista, pronto a sorprendere nel loro moto gli avvenimenti […]. Da allora vado spesso al cinematografo. Nat Pinkerton ha cessato d’inseguire col suo revolver da commedia i truci figuri; le coriste d’operetta e le comparse non fingono più con le loro disgraziate maniere i dolori di Maria Antonietta e le orge di Bianca Capello […]. Ecco la guerra davanti ai nostri occhi» . Da una parte il cinema riproduce la realtà, dall’altra, col dinamismo dei suoi fotogrammi, consente di offrire il supporto più appropriato all’arte figurativa (ne parlano Balla e Depero nella Ricostruzione futurista dell’Universo del 1915 e il cinema è implicato, anche se non citato direttamente negli scritti di Boccioni, in particolare suggestiona Pittura e scrittura futuriste del 1914, in cui comunque il dinamismo non implica mai semplice riproduzione cinematica della realtà ), alla poesia e alla musica (nel 1912 Bruno Corra scrive il saggio Musica cromatica, in cui dice che grazie al cinema si può ottenere «la vera sinfonia cromatica» ). I futuristi, in effetti, sono i primi a concepire l’equivalenza assoluta tra un’inquadratura di un oggetto e l’oggetto stesso, per loro l’immagine è la cosa: il cinema si offre come uno straordinario lessico referenziale dell’universo, e tuttavia dotato di un grande potere simbolico e connotativo. Il cinema attrae perché è capace di tradurre sullo schermo il concetto bergsoniano della «durata», del divenire interiore, oltre che di rappresentare le nuove forze e le nuove dinamiche e additare le linee forza di «quella fuga in avanti» teorizzata da tutti i futuristi. Nel Manifesto tecnico della letteratura futurista, Marinetti, che considererà sempre il cinema come «altra zona del teatro», ne sottolinea le funzioni ritmiche e la sua capacità di scomposizione e ricomposizione del movimento: «Il cinematografo ci offre la danza di un oggetto che si divide e si ricompone senza intervento umano. Ci offre lo slancio a ritroso di un nuotatore i cui piedi escono dal mare e rimbalzano violentemente sul trampolino. Ci offre infine la corsa di un uomo a 200 chilometri all’ora. Sono altrettanti movimenti della materia, fuori delle leggi dell’intelligenza e quindi di un’essenza più significativa» . Nel cinema sembra incarnarsi, agli occhi di Canudo, D’Annunzio, Marinetti, una parte dello spirito e del verbo di Nietzsche. Su un piano contiguo, nel 1918, Carmine Gallone, un regista con una formazione artistica, sottolinea nella rivista «In Penombra», in maniera meno ideologizzata e centripeta, l’equivalenza tra parola letteraria e forme della regia: «L’inquadratura, la messa in scena, l’interpretazione hanno in cinematografia lo stesso valore che possono avere le parole in letteratura» . Un primo testo teorico importante da segnalare, pubblicato alla fine della guerra, è Il teatro muto di Piero Antonio Gariazzo . Come primo obiettivo l’autore di questo volume cerca di attribuire al cinema tutta una vasta genealogia di antecedenti illustri che affondi fino negli spettacoli e nelle danze religiose del teatro greco, etrusco e romano. In quest’ottica il cinema non sarebbe altro che una variante moderna di una catena di metamorfosi di un rito collettivo millenario. Nelle sue prime manifestazioni il cinema non aveva ancora trovato i propri ideali e la propria autosufficienza artistica: la sua passiva dipendenza dal teatro era stata la causa principale – secondo Gariazzo – della sua modesta evoluzione espressiva, per cui «se voleva vivere il cinematografo doveva trovare i propri ideali per se stesso, far di se stesso una cosa originale» . Il riconoscimento e l’affermazione che il cinema, per assumere uno statuto d’arte, deve raggiungere la specificità dei propri mezzi, è uno dei punti di convergenza e di novità nel discorso teorico che riprende a muoversi nel dopoguerra (su questo piano sono da segnalare soprattutto gli interventi paralleli di Sebastiano Arturo Luciani e Anton Giulio Bragaglia). Un altro importante centro d’interesse del libro è costituito dal tentativo di individuare, nel racconto cinematografico, di cui è riconosciuta la capacità di rappresentare qualsiasi argomento (dalla finzione alla documentazione scientifica e didattica), quelle 36 situazioni drammatiche cardinali già codificate da Carlo Gozzi e capaci di sostenere tutta la possibile combinatoria narrativa dell’intreccio del film. Pur nella loro estrema eterogeneità queste situazioni, che vanno dalla «vendetta che persegue il delitto» al «tentativo audace», dal «rapimento» all’«enigma», dal «sacrificio per gli ideali» a «quello amoroso», dalla «rivalità» all’«amore per il nemico», dall’«agnizione» al «ritrovamento dei 6
7
8
9
10
11
12
beni o figli perduti», danno la possibilità di indicare come potenziali soggetti cinematografici testi letterari di tutti i tempi, da Omero alla tragedia di Eschilo, al Fuoco di D’Annunzio, passando attraverso La Gerusalemme, Giulio Cesare, Tristano e Isotta, Aida, El Cid, Otello, Il padrone delle ferriere, Don Carlos, Il romanzo del giovane povero e I figli del capitano Grant, nonché una serie infinita di altri soggetti già pronti all’uso. Un ulteriore tentativo di sistemazione riguarda i generi cinematografici, le loro possibili articolazioni interne (commedia allegra, commedia satirica, commedia di carattere, commedia drammatica, dramma dal vero, dramma poliziesco). Gariazzo si rivela particolarmente felice nella definizione di alcuni aspetti dei meccanismi specifici del racconto, da quelli che generano il comico a quelli che producono situazioni drammatiche . E uno dei più sicuri elementi di successo indicati dal suo libro è dovuto ad alcuni «movimenti di catastrofe che generano una sensazione violenta di sospensione». Nello stesso anno, quasi a creare un pendant teorico con le affermazioni iniziali di Gariazzo appare, in un volume miscellaneo di Roberto Bracco, un contributo dimenticato, ma non per questo meno importante, in cui si cerca di riconoscere al cinema una tradizione secolare nello spettacolo antecedente, affermando che «l’elemento peculiare della rappresentazione cinematografica si trova nella pantomima di tutti i tempi» , ma soprattutto si riconosce, come pacifico, il diritto del cinema di appartenere al mondo dell’arte senza per questo creare dei falsi dilemmi o problemi nella critica: «La cinematografia dunque può essere arte. E proprio questo è stato finalmente assodato. Ma ahinoi le faticosissime discussioni per pervenire ad affermare una verità della quale nessuno avrebbe dovuto dubitare, hanno lasciato sul terreno una infinita quantità di idee, di criteri, di cavilli» . Per Bracco non è tanto importante porre il problema dell’artisticità del film, fatto che gli pare ormai porsi come dato indiscutibile, quanto quello di impedire la formazione di una critica che si ponga tra l’opera e lo spettatore guastando, con la sua presenza, il godimento della visione. Ciò che gli pare caratterizzante nello spettacolo cinematografico è l’immediatezza del messaggio, la sua capacità di comunicare senza l’esiziale mediazione del critico. Altro fatto nuovo da segnalare, nel panorama editoriale del primo dopoguerra, riguarda gli interventi dei registi a cui viene chiesto sulle riviste specializzate di esporre i punti fondamentali della loro «poetica». Si vengono a profilare e riproporre, attraverso le voci dei registi, le due tendenze che prospettano per il cinema il solito sviluppo lungo due direttrici che si biforcano: da una parte la difesa di un ideale naturalistico, ricercato nella autenticità dei luoghi e nella presa di distanza rispetto al teatro, dall’altra la scelta decisa di una linea antinaturalistica e aperta alle possibilità fantastiche e immaginative più libere e sfrenate. Questa seconda linea, in mancanza di una fecondazione e di un rapporto continuo e solidale col lavoro delle avanguardie, ha una portata assai limitata, mentre la prima tendenza assumerà un ventaglio di funzioni assai ricco e agirà come un fiume carsico in funzione della progressiva formazione di una poetica e di una prassi registica. Il primo a prendere la parola è Enrico Guazzoni, sulle pagine di «In Penombra». Rievocando i momenti più importanti della sua attività passata, Guazzoni afferma : «Pensavo che il cinematografo, a differenza grande del teatro, consentisse di abbracciare e dare visioni di campi vastissimi e non avere limitazioni di spazio e di tempo». Se l’articolo di Guazzoni interessa, più che per la lucida e ironica rievocazione della genesi della «poetica dello spazio» e del tentativo di massima nobilitazione culturale del film, per la ricchezza aneddotica, e uno scritto di Carmine Gallone pone alcuni problemi di analogia tra «scrittura letteraria e scrittura scenica» (che lui chiama idealisticamente «arte di inscenare») , in un intervento di Anton Giulio Bragaglia, posteriore di soli pochi mesi, è già configurata una ben più solida e argomentata fondazione di poetica. Tutto l’articolo vuol essere un deciso attacco al cinema naturalista: «Violentare la realtà! Noi vogliamo abbacinare la realtà trionfante col sogno di ancor più maliosa e trionfante visione d’artificio» . È qui mantenuta la prospettiva del discorso dannunziano, integrata però dall’attenzione tutta portata sulla scenografia come centro di propulsione del fantastico cinematografico («pretendo che la vera grande strada del cinema sia sconosciuta ancora perché appena esplorata qua e là e che fantasticamente si diriga verso i luminosi e trionfali sfondi della creazione cerebrale, con spettacoli più o meno irreali o immaginari») . Interviene in questa fase di dibattito, con un contributo molto importante, Sebastiano Arturo Luciani, che già negli anni precedenti aveva scritto le pagine teoriche più ricche di intuizioni e di aperture e possibilità di sviluppo: egli riconosce che il cinema non è ancora arte, ma soltanto una forma di spettacolo che «ha in sé tutte le possibilità per divenire tale, per essere anzi l’arte più rappresentativa, e la sola originale del nostro 13
14
15
16
17
18
19
tempo» . Il cinema, secondo Luciani, ha in sé elementi finora inutilizzati per eccesso di dipendenza dal teatro, ma il principio generatore del teatro è del tutto antitetico a quello cinematografico: «Il teatro, generato com’è dalla lirica, è essenzialmente verbale e statico e tende al movimento esteriore […] il cinematografo è essenzialmente visivo e dinamico e tende, con la successione rapida di innumerevoli scene ed episodi che si integrano nel tempo, a costituire una sorta di lirismo che potremmo chiamare visivo […] sono due forme quindi divergenti» . Se non si possono stabilire rapporti col teatro non è neppure possibile farlo tra cinema e letteratura: «Altro errore è quello di voler trarre gli argomenti dai romanzi […]. Il romanzo di solito è un seguito di scene. È chiaro che se si riduce un romanzo a cinedramma le varie scene non siano intelleggibili se non rilegate da leggende esplicative e che quindi la proiezione non diventi altro che l’illustrazione di un racconto. Ora il cinematografo non dev’essere tale se vuole mantenere intatta la propria originalità. Non dev’essere l’illustrazione di un racconto, ma un racconto visivo fatto con immagini, deve cioè essere intelleggibile senza alcuna leggenda esplicativa». Quanto al ritmo, altro punto qualificante nel pensiero di Luciani, esso è l’autentico principio ordinatore del film: «Si tratta – certo – di un ritmo complesso, che potremmo chiamare visivo, perché si svolge non soltanto nel tempo, ma nello spazio e non è percettibile che con una particolare sensibilità musicale e pittorica insieme» . Gli scritti di Luciani, sparsi in vari giornali, vengono, per la prima volta, raccolti in un volumetto pubblicato nel 1920, dal titolo Il cinematografo, verso una nuova arte . A conclusione di quest’opera si possono cogliere, accanto alle categorie già osservate, queste importanti considerazioni sulla sceneggiatura come genere autonomo: «Quando uno scrittore pubblicherà un poema visivo degno di essere pubblicato indipendentemente dalla sua realizzazione cinematografica, non avremo soltanto un nuovo genere letterario, ma l’inizio di un nuovo periodo nella storia del cinematografo» . Rispetto a tutta l’attività critica e teorica finora esaminata, va riconosciuto a Luciani, almeno per quanto riguarda le teoriche italiane , il merito di aver fatto compiere un decisivo passaggio di fase e di aver prospettato in modo pertinente e produttivo molti sviluppi possibili per il discorso teorico. Puntando infine sulla luce come quid specifico e unificatore e rifiutando, come D’Annunzio e Canudo, la dimensione realistica del film, Luciani privilegia le possibilità del fantastico cinematografico: «la sconfinata libertà di tempo e di luogo […] e la facilità con cui si possono ottenere effetti di luce, fa sì che il cinema possa rappresentare argomenti fiabeschi e fantastici, irrealizzabili su qualsiasi palcoscenico» . Luce e ritmo sono i principi generatori e «ordinatori» della nuova arte: «La proiezione cinematografica non è che un’ombra piena di luci […] l’ombra e la luce non determinano come nella pittura, effetti statici, ma dinamici» . Infine è indicato nella musica l’elemento necessario per una perfetta integrazione di tutti gli aspetti finora indicati. Con Luciani il cinema trova la sua forza e la sua originalità nei mezzi formali e nella capacità di produzione fantastica. L’imitazione del reale – dato l’assetto teorico del discorso – costituirebbe un limite all’espansione delle possibilità espressive della «nuova arte». Se i sostenitori di una linea fantastica e antinaturalistica sono giunti a dare un qualche iniziale ordinamento teorico al loro discorso, i fautori di una diretta rappresentazione del reale sembrano vedere, senza ambizioni teoriche, ma in un senso piuttosto pragmatico, l’unica strada da seguire per uscire dalla crisi che si viene profilando. Le loro posizioni anacronistiche e perdenti solo alcuni anni prima vengono rimesse in gioco dalla guerra e dall’esigenza di liberarsi dalla zavorra della cultura simbolista e liberty. Grazie a una più diretta rappresentazione della realtà il cinema verrebbe a realizzare gli scopi più autentici della propria natura e a liberarsi dall’eredità negativa del passato: «Aboliamo tutti i convenzionalismi trapassati che tolgono col loro lezzo l’aria sana e pura al cinematografo – scrive Aldo Gabrielli nel 1920 – aboliamo le anticaglie polverose che hanno fruttato al cinema l’appellativo di ‘mondo di frack e di cilindri’ […] è doloroso pensare che il teatro muto doveva essere lo specchio più sincero della più sincera realtà […] si cerchino ambienti soliti alla media dei tempi e delle menti (non gli ormai scomparsi ambienti di una sorpassata nobiltà che istillano nei cervelli volgari idee false e tristi propositi di rivendicazioni) e si riporti il cinema nell’umanità e nel reale» . La richiesta di realismo non brilla certo per presupposti ideologici progressisti, né per istanze poetiche nettamente delineate, ma soltanto nasce dall’esigenza di una maggior sintonia con il mondo dei possibili destinatari popolari. Sembrano concordare in pieno con queste posizioni, non a caso, il regista e conte Baldassarre Negroni («Il cinematografo è essenzialmente visione, ma è visione non solamente di monumenti o di belle messinscene, ma di fatti umani») e altre voci che si possono isolare scegliendo a caso: «Per la 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
buona riuscita di un film essenziale non è essere originali, ma soprattutto dare riproduzioni fedeli della vita quale la si vive» . Se il senso del messaggio riveste, come si è detto, un punto di vista conservatore nelle voci riportate finora, nella «Rivista cinematografica» di Torino appare un articolo intitolato Cinematografia realistica, in cui si sposa, in funzione del realismo della rappresentazione, una causa di fondo progressista. E, in una situazione come quella che la realtà italiana stava vivendo nei primi anni del 1922, ci dice che la presenza di una critica con forti istanze sociali progressiste, prima che estetiche e degli uomini più rappresentativi del primo cinema muto italiano non è stata ancora studiata e posta nella sua giusta luce: «Riconosciamo che il film ha un’importanza educativa fortissima sulle masse […] quale mezzo migliore per comunicare con l’anima popolare, che non sia quello di procurare emozioni ispirandosi alla verità, alla vita reale. La vita sullo schermo è tuttora troppo lontana dalla vita comunemente vissuta, anzi staremmo per dire che se ne allontani sempre più. Ora ci chiediamo: la nostra cinematografia rispecchia la vita che si vive generalmente? Non esitiamo a escluderlo, perché troppo sovente essa non è che la rappresentazione sintetica d’un mondo d’eccezione, d’una società privilegiata le cui manifestazioni si svolgono oltre una barriera quasi insormontabile che la separa dall’altra parte dell’umanità che costituisce la maggioranza. A giudicare dalle pellicole che ci sono offerte in proiezione si dovrebbe dire che la vita si svolge se non fra principi e duchi tutt’al più tra conti e baroni […]. Eppure io credo che il popolo e specialmente la classe operaia, offra al cinema il contingente più importante […]. Perché questo pubblico di lavoratori non deve trovare ormai sullo schermo la rappresentazione della sua vita […] sono infiniti i temi che può offrire l’esistenza degli umili, l’esistenza che ferve nelle officine, nei campi, negli uffici, nelle scuole» . E forse la prima volta che, dopo l’esperienza di Lux, si parla in una rivista cinematografica con una terminologia sociale così scoperta (l’accenno al mondo degli umili potrebbe dare a tutto il discorso anche un connotato di ideologia cattolica, tutto sommato verisimile, ma non probabile) e non è un caso che il discorso sia fatto a Torino proprio all’indomani dell’occupazione delle fabbriche. Sino alla metà degli anni Venti, i letterati che di tanto in tanto si occupano di cinema continuano a essere ospitati dalle riviste di categoria, a rilasciare interviste e a scrivere articoli in alcuni casi degni di memoria, ma insufficienti a provocare un movimento d’opinione e, tutto sommato, privi della necessaria autorevolezza di una sede che decreti il riconoscimento ufficiale dell’artisticità del cinema anche all’interno del mondo della cultura. Ciò potrà avvenire solo quando le riviste letterarie ospiteranno, con una certa continuità, interventi a favore del cinema di autorevoli esponenti della cultura. Si tratta di attendere una specie di consacrazione ufficiale. 30
31
nascita della critica Nel suo importante saggio sulle origini della critica, e per molti versi ancor oggi ricco di suggerimenti, Glauco Viazzi indica la nascita di una critica non avventurosa né improvvisata nell’ambito delle riviste letterarie come «Il Baretti», «Il Convegno», «Solaria», «Pègaso», «La Fiera letteraria», o in riviste specializzate come «Il Dramma» e «Cinematografo». E segnala come, non a caso, da una rivista rigorosa e tutta immersa nel culto della letterarietà come «La Ronda» il cinema non venga neppure preso in considerazione, ma come dalla fusione di due riviste come «La Ronda» e «Il Baretti» nasca la disposizione a occuparsi di cinema da parte della critica di formazione idealistica . «Il periodo idealistico in estetica – scrive Viazzi – della critica cinematografica italiana, che va all’incirca dal 1926 al 1934, è tributario per presupposti filosofici, per metodologia estetica, per gusto e predilezioni, con il suo culturalismo, il suo stilismo e formalismo, della lezione rondiana» . Oggi bisogna interrogarsi anche sulle modalità di sviluppo di un lavoro culturale disinteressato e quindi perfettamente iscritto nei presupposti idealistici, in un momento in cui, venendo a mancare la produzione, l’attività critica può mutare ruolo e liberarsi dalla funzione sinora assolta di rotella di trasmissione pubblicitaria del tutto dipendente dalla volontà industriale. Certo questa critica idealista deve fare i conti con una serie di problemi di tipo nuovo: come il rapporto tra nozione di autore e il lavoro filmico come prodotto di collaborazione, il rapporto tra l’arte e la tecnica, la necessità di inventare nuove categorie accanto a quelle dell’intuizione-espressione, la relazione tra riuscita 32
33
del livello artistico e influenza economica, e così via. C’è in pratica, proprio su questo campo di problemi, l’accostamento di gruppo di una generazione di letterati. Ed entrano contemporaneamente in gioco una serie di altri fattori che interferiscono con la loro competenza estetica idealistica, e dipendono dal contesto culturale in cui si sviluppa in quegli anni «la battaglia delle idee»: in alcune delle riviste indicate, a cui si possono aggiungere altre testate periferiche, come la novarese «La Libra» si tenta di realizzare una reale opera di sprovincializzazione, mentre una politica di apertura alla cultura straniera e un rinnovamento della politica editoriale vengono tentati, sulla spinta del modello gobettiano, da alcune case torinesi come La Slavia, o la casa dei Fratelli Ribet, infine non pochi intellettuali delle ultime generazioni tentano di entrare in contatto con i protagonisti e le opere della cultura europea, proprio in un momento in cui si tenta di riorganizzare la cultura su basi nazionalistiche. Per capire la spinta che viene dalla critica, la formazione di diverse categorie di giudizio, la ricchezza e la diversa qualità dell’informazione, non si può ignorare il contatto diretto, o l’intersecarsi dei rapporti di gruppi di letterati italiani con la contigua cultura francese. Se Parigi per lo più è, negli anni Venti, l’orizzonte limite della informazione cinematografica, Parigi vuole anche dire contatto con le avanguardie di tutto il mondo, possibilità di conoscere film provenienti da tutti i paesi e soprattutto di entrare in contatto con i film sovietici e con un’attività critica ed editoriale ben più vivace e in sintonia con le nuove espressioni dell’arte e della cultura. Per quanto riguarda invece le riviste specializzate, in questo periodo; bisogna riconoscere che «non furono certo loro a contribuire in maniera rilevante all’evolversi dell’estetica cinematografica» . Le riviste specializzate hanno però in comune questo elemento positivo: senza pretendere di fondare un’estetica e di mobilitare ogni volta i massimi sistemi e senza alcuna capacità, in molti casi, di elaborare perfino strumenti critici pertinenti, offrono sempre i problemi a tutto campo, senza limitazioni o preclusioni. I loro limiti sono quelli di sempre, derivanti dalla dipendenza diretta dalle case produttrici di cui molto spesso sono organi pubblicitari, ma tra i loro meriti c’è quello che, dal loro insieme, si possono ricostruire le vicende e gli sviluppi storici dell’industria cinematografica italiana, c’è la disponibilità verso qualsiasi tipo di problema che intervenga nel campo cinematografico e c’è soprattutto, a partire da un certo momento in cui si tenterà di compiere un decisivo salto di livello qualitativo, l’apertura ai discorsi dei teorici stranieri, che, con tutta probabilità, non avrebbero certo trovato ospitalità sulle pagine delle più autorevoli riviste letterarie. Dal 1925 in poi il tracciato discontinuo tende a unificarsi e gli interventi dei letterati vengono ad acquistare una sorta di motivazione comune, diventano spontanei e non sollecitati e dipendenti da una committenza esterna. Il fatto che il cinema trovi uno spazio stabile piuttosto ampio sulle pagine del quotidiano fascista «Il Tevere» e al cinema sia dedicata, per qualche mese, una pagina settimanale, convalida l’impressione di un processo di partecipazione e di interesse degli intellettuali, ormai diffuso a tutti i livelli. Il primo intervento di rilievo a inaugurare la pagina è di Massimo Bontempelli: «L’arte cinematografica si trova nelle migliori condizioni possibili per poter dominare il più grande, il più vario, il più completo pubblico, per imporre se stessa come arte centrale di un’epoca» . Accanto a lui, scriveranno, come abbiamo già detto, settimana dopo settimana, Mario Camerini e Raffaello Franchi, Jacopo Comin e Corrado Pavolini, Lamberto Grassi e Aldo De Benedetti. Questo è il primo tentativo da parte fascista di far proprio il problema cinematografico e di rilanciare il discorso sulla cinematografia italiana attraverso il movimento d’opinione suscitato dagli interventi dei letterati e registi. Pur finalizzata a questo scopo l’operazione non resta senza conseguenze collaterali. La nascita dell’«Impero», o dello «Spettacolo italiano», e di «Cinematografo», le due riviste, che, in progetto di fondazione di un discorso organico sul cinema, nell’ambito dei giovani intellettuali della sinistra fascista, giocano un ruolo non indifferente di spinta per la rinascita e per il rinnovamento dei quadri della cinematografia italiana è il prodotto più diretto del processo avviato dal «Tevere». Di fatto però lo sforzo di fascistizzare il cinema e di accogliere sotto un organo ufficiale della stampa fascista interventi continui di intellettuali fallisce in larga misura, anche se, come si vedrà, la mobilitazione è notevole negli anni successivi. Il mondo della critica cinematografica che si verrà formando attorno a Blasetti non ha culturalmente le carte in regola per comunicare in maniera diretta con i letterati di formazione rondista o crociana o vociana. In un certo senso quello che poteva apparire un punto a sfavore di questi letterati – la separatezza del loro lavoro rispetto al sociale – il rifiuto di assumere rapporti organici col regime, veniva a 34
35
36
garantire proprio quegli spazi di autonomia e la possibilità di compiere un lavoro di contatto, ma non di compromissione e di integrazione col fascismo. In questo periodo, in una fase di scoperta e mobilitazione, di caduta improvvisa e totale di tutti i tabù, si formeranno, accanto a intellettuali e scrittori che diventeranno accaniti consumatori di film, anche i padri e i capostipiti di intere generazioni di cinefili, specie tra i giovani: intellettuali spesso non di grandi coordinate culturali, ma in possesso di ferree conoscenze specifiche, competenza tecnica e informazione sempre aggiornatissima su tutti i fenomeni della produzione cinematografica mondiale contemporanea. Il cinema diventerà una specie di porto franco entro cui potranno convivere, senza preclusioni o conflitti sostanziali, giovani con formazioni e ideologie molto diverse. E per la prima volta interi gruppi di letterati scenderanno in campo assumendo le difese culturali e artistiche di questa forma d’arte e collocando i loro riferimenti sul piano della cinematografia mondiale. I letterati non si sentono più ospiti di riviste di categoria a cui vanno a dar lustro col loro nome e prestigio, consapevoli dei rischi di perdita di immagine con interventi in rivistine culturalmente subalterne, ma cominciano a giocare in casa e cercano di promuovere culturalmente il fenomeno cinematografico al livello delle altre manifestazioni artistiche e letterarie. Una spinta decisiva viene dall’enorme consenso attribuito dagli intellettuali di tutto il mondo ai film di Chaplin. Di fronte a Il monello (1921) o a La febbre dell’oro (1925) si registra un consenso unanime di intellettuali di tutte le correnti e dei pubblici di tutto il mondo. L’articolo di Guglielmo Alberti sul «Baretti» , o quelli di Piero Gadda Conti o di Alberto Cecchi sulla «Fiera letteraria» , non sono che esempi, presi a caso, di un’attenzione di letterati che mobilitano, per la prima volta, ampie categorie critiche, solitamente riservate ai grandi testi letterari e poetici, per l’interpretazione dei film chapliniani. La recensione periodica al film, a partire dal 1926, viene ad assumere una dignità professionale del tutto identica a quella letteraria e teatrale . Cominciano inoltre a circolare le idee sul cinema degli autori stranieri, soprattutto grazie alle riviste francesi (come «Cinéa-ciné» e «La Revue de cinéma»), e così, accanto a un lavoro della critica, interessato e finalizzato alla creazione di un retroterra ideologico, capace di favorire le condizioni per una «rinascita» produttiva, si diffonde un tipo di lavoro disinteressato, che si articola sia sul piano della recensione che su quello di una progressiva messa a fuoco dei problemi estetici. È questa la fase che Guido Aristarco definisce della «mobilitazione crociana». I passi successivi di questa scalata teorica ai problemi del cinema da parte della critica di formazione idealistico-crociana passano attraverso un primo intervento di Antonello Gerbi sul «Convegno» e la pubblicazione del numero unico di «Solaria» dedicato al cinema . La preoccupazione di fondo di Gerbi, in linea con l’estetica crociana, è quella di rispondere alla domanda se un artista possa avere delle «intuizioni cinematografiche». Naturalmente l’opera dovrà essere di un solo artista e – per il resto – in perfetta sintonia con l’estetica crociana: «Nel poema, come nel film, si deve badare solo a quel tanto di poesia che può esserci: il resto è zero (per l’estetica)». Si tratta, per il momento, di un sasso gettato in una palude stagnante di un’estetica che finora aveva controllato quasi egemonicamente, dall’inizio del secolo, ogni attività critica e che riusciva a emarginare con facilità e in modo perentorio ogni pensiero non perfettamente ortodosso. La non ortodossia è quella che si pratica però in concreto a contatto con il testo filmico, nella pratica critica del recensore. E non mancherà, di lì a poco, chi dichiarerà il proprio piacere di fronte al film e chi riprenderà invece un discorso puramente contenutistico. Segno di una tensione complessa e positiva di una sprovincializzazione culturale tra le più avanzate di tutto il contesto della cultura italiana anni Venti, tensione certo non isolabile al solo cinema, la dinamica teorica e critica sembra vivacizzarsi proprio a contatto con alcuni film esemplari delle cinematografie straniere (si va da Douglas Fairbanks a Germaine Dulac, da Metropolis a Robin Hood) ed è da una frequentazione diretta col cinema americano o mediata (soprattutto da letture francesi come Le cinéma sovietique di Léon Moussinac, edito nel 1928) che si vengono costituendo, nello stesso tempo, ma con funzioni diverse, presso alcuni gruppi di intellettuali, i due miti sovietico e americano. Contribuiscono poi, a latere, a sprovincializzare ulteriormente la situazione e a favorire la nascita di quadri e di operatori di cultura cinematografica locale, l’istituzione di alcuni cineclub, tra cui quello milanese, quello romano e quello torinese . Questi luoghi di circolazione privilegiata di film e di idee agiscono come ulteriore polo di attrazione per gli intellettuali e come momenti fondamentali per la formazione di nuovi quadri. I problemi del cinema italiano sono saltati a pie’ pari e si entra in diretto contatto con i fenomeni 37
38
39
40
41
42
dell’avanguardia storica francese, tedesca e con alcuni film capitali del cinema americano. Il dibattito tra «cinema puro» e «altro cinema», che Giansiro Ferrata cerca di avviare con i suoi appunti parigini su «Solaria» e «L’Italia letteraria», ha breve vita, in quanto, anche dopo la visione diretta nei cineclub di alcuni importanti film d’avanguardia, si ha l’impressione che la stagione delle avanguardie e tutto il mondo poetico, la sperimentazione, le ipotesi di modificazione del mondo che ne costituivano i fondamenti, siano finite per sempre. L’antagonismo teorico tra formalisti e contenutisti sembra risolversi, in questa fase, a favore di questi ultimi. Avanza, oltre «Solaria» e al di fuori di quell’area intellettuale, una nuova generazione di critici, dotati di strumenti teorici nuovi e di competenze specifiche, una generazione divisa tra l’esercizio della critica come pratica ideologica e il lavoro critico come momento propedeutico a quello registico. Questa generazione da una parte trova il suo punto di massima aggregazione nel gruppo di «Cinematografo», dall’altra si può formare in senso teorico per merito della figura di un outsider, Umberto Barbaro, che appare, fin dai suoi primi interventi, come la personalità più capace di aprire, grazie alla sua conoscenza diretta dei testi dei maggiori teorici stranieri, russi e tedeschi contemporanei in senso antidealistico, tutto un nuovo campo di problemi per la critica cinematografica . Esce nel 1928 l’Antiteatro di S.A. Luciani , lavoro sostanzialmente identico al libro del 1920 e ancora centrato sui problemi della luce e del ritmo. Questi problemi e queste intuizioni, che nel frattempo non sono state sistematizzate in modo più rigoroso né aggiornate coi risultati del pensiero dei teorici stranieri (Balázs e Pudovkin), risultano leggermente decentrate e in ritardo rispetto a un dibattito che da una parte continua a proporsi come supporto per la «rinascita» (e trova in Sole del 1929 la realizzazione di una specie di opera manifesto di tutto il gruppo operante attorno a Blasetti) e dall’altra porta al contatto diretto con i testi dei registi sovietici e con gli scritti dei teorici tedeschi, di Balázs, e dei critici francesi. A partire da questa fase terminale del cinema muto il dibattito critico teorico verterà soprattutto su questi temi: 1) definizione dei modelli per la «rinascita» e accettazione dell’ipotesi di un film epico e realistico; 2) acquisizione di nuove categorie teoriche in funzione antidealistica; 3) approfondimento dei caratteri specifici del film e acquisizione del concetto più pertinente di montaggio rispetto a quello generico di ritmo; 4) dibattito sul film sonoro e sulle nuove implicazioni teoriche e sul suo futuro; 5) acquisizione del mito sovietico come mito ideologicamente positivo e funzionale, sia alla critica antifascista che a quella fascista; 6) circolazione del mito americano come grande mito di massa e come mito edenico per una nuova generazione di intellettuali. Il salto di qualità del discorso e della competenza teorica e critica non avviene al di fuori del progetto fascista di formazione di una propria intellettualità organica, una volta raggiunto e consolidato il potere ed eliminate tutte le forme più pericolose di opposizione politica . Le riviste di Blasetti, in particolare, come poi tutto il lavoro di Chiarini, cercano di eliminare ogni rapporto con la critica di derivazione crociana e intendono scopertamente – secondo una linea di politica culturale favorita da Bottai – compromettere e contaminare il discorso estetico con accurate analisi dei processi tecnici, economici e ideologici del film. E lo fanno senza troppe discriminazioni ideologiche nei confronti di intellettuali antifascisti . Si inizia, proprio con «Cinematografo», un tipo di coabitazione tra intellettuali militanti fascisti e intellettuali antifascisti che, negli anni successivi, troverà un’articolazione assai ampia e consentirà ad alcuni quadri antifascisti di occupare posizioni assai importanti per il lavoro politico dall’interno delle istituzioni fasciste. La rivista di Blasetti, vicina alle posizioni dei fascisti di sinistra, di fatto ospita e sollecita a collaborare in varia forma personalità come Umberto Barbaro, Libero Solaroli e Aldo Vergano . Tipica filiazione dei progetti di politica culturale di Bottai, in una fase di trasformazione dell’ideologia fascista e di abbandono deciso dell’immagine squadristica, violenta, ruralista e rivoluzionaria, per far posto a un’immagine del fascismo tendente alla stabilizzazione, alla pacificazione sociale e alla conquista del consenso delle classi medie, «Cinematografo» è anche la prima rivista cinematografica di tipo moderno. L’idea di cinema che si viene elaborando sulle sue pagine e poi si traduce nella realizzazione di Sole, come verifica di una poetica di gruppo, risulta però in leggero ritardo rispetto alla dinamica ideologica del regime e tutto il discorso realista e neorealista a cui si darà vita negli anni successivi, che trova uno dei momenti genetici più importanti proprio sulle pagine di «Cinematografo», è destinato a essere soffocato e non 43
44
45
46
47
48
49
recuperato dal fascismo negli anni successivi, in quanto poco funzionale ai nuovi obiettivi politici e ideologici da raggiungere . Il discorso critico di Blasetti non prescinde mai dai motivi nazionalistici ed è caratterizzato dall’ignoranza o dal disinteresse verso il mondo degli intellettuali non militanti: i suoi scopi più diretti sono quelli di raggiungere i pubblici di massa attraverso una cultura capace di porsi come avanguardia ideologica ed espressiva. Se da una parte i modelli del cinema sovietico influenzeranno i suoi temi e i contenuti populisti dei suoi primi film saranno del tutto congeniali alla sua personalità, il problema del destinatario e dell’idea di cultura come espressione di uno spirito di un popolo si confronta con la cultura americana, che sente circolare con la forza di tutte le sue mitologie sul piano di massa: «Il popolo al quale è riservato il diritto e il dovere di succedere all’americano nel dominio dei mercati, perché nel favore dei pubblici, è l’italiano […] perché l’italiano sano, completo, forte, ricco di sangue, di sole, di fosforo e di mare, di cuore e di cielo, per secolare privilegio stabilito non da sogni o da campanilismi o canzonette, ma più semplicemente da linee di longitudine e di latitudine, ritornato giovane, audace, avido di conquiste per una nuova legge di vita alla quale s’è riplasmato, ha per ciò stesso la capacità (uguale o maggiore dell’americano) di creare un film che esprima vita, gioia, forza: ha cioè, oggi, una struttura e un organismo degno e capace di dominio» . Morte e resurrezione del cinema italiano grazie alle sue doti innate e all’avvento palingenetico del regime: ciò che interessa non sono, di queste affermazioni, né la rimozione di un discorso di mercato, né l’assoluta ingenuità, quanto il meccanismo di proiezione e di confronto con la realtà americana. Quanto alla generazione di letterati di formazione idealistica che si occupa, con ritmo crescente, di cinema, percorrendolo in tutte le sue forme, avrà anch’esso come oggetto privilegiato del proprio esercizio critico il cinema americano, la cui produzione costituirà l’80% di quella circolante sul mercato italiano. Con quasi dieci anni di anticipo, rispetto ai contributi e alle traduzioni importanti di Pavese e Vittorini, alcuni intellettuali militanti del fascismo o critici letterari entrano in contatto con il cinema americano, cercando di usarlo ognuno con intenzioni diverse come tramite privilegiato per la conoscenza del contesto sociale che lo produce . Il rapporto tra film e società, quello tra i miti divistici e le nuove forme della cultura di massa, alimentano i discorsi di Emilio Cecchi e Nicola Chiaromonte; di Alberto Cecchi e Mario Soldati. Il mito americano, così largamente diffuso attraverso un’azione combinata dei film, della stampa di categoria, comincia a essere analizzato anche nelle sue forme di divismo più elevato (Greta Garbo) come in quelle di spettacolarità popolare più bassa (si pensi alla splendida definizione data da Nicola Chiaromonte della recitazione di Lon Chaney: «Ultimo erede di una tradizione d’arte democratica. Dopo Sue, Carolina Invernizio e dopo i mattatori teatrali egli suona da gran maestro tutte le corde dell’entusiasmo popolare» ). Quanto alla genesi dell’idea di neorealismo, come ormai vado sostenendo dalla fine degli anni Sessanta, non si tratta di riconoscerne soltanto la priorità dell’invenzione linguistica , rispetto al periodo della produzione cinematografica del dopoguerra successivo, ma di cogliere la nascita di un’idea di cinema da portare a contatto con le più avanzate esperienze della cultura europea, spezzando – in un terreno abbastanza favorevole – quei limiti provincialistici entro cui il fascismo intendeva sempre più costringere la cultura italiana. 50
51
52
53
54
È la linea che ha adottato Giorgio Fabre nella sua ampia e già citata rassegna della critica a D’Annunzio, e nel suo saggio sulla critica in «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979. 1
R. Canudo, Lettere d’arte. Trionfo del cinematografo, in «Il nuovo giornale», 25 novembre 1908, p. 3, ora in G. Dotoli, Lo scrittore totale. Saggi su Ricciotto Canudo, Schena, Fasano 1986, pp. 129-138 e in R. Canudo, L’usine aux image, a cura di J.-P. Morel, Seguier, Paris 2
1995, pp. 23-25. 3
R. Tessari, Il mito della macchina. Letteratura e industria nel primo Novecento italiano, Mursia, Milano 1973.
4
M. Morasso, La nuova arma (La macchina), a cura di C. Ossola, Centro Studi piemontesi, Torino 1994.
Uno dei primi tentativi di ricollocare la teoria di Canudo nella giusta luce è di G. Rondolino, La teoria cinematografica di Ricciotto Canudo, in «Quaderni del Novecento francese», n. 3, 1976, pp. 123-172. 5
6
Cit. in G. Ferrata, Una generazione letteraria alle sorgenti del «realismo», in «Cinema Nuovo», n. 138, marzo-aprile 1959, p. 116.
7
U. Boccioni, Pittura e scultura futuriste, a cura di Z. Birolli, SE, Milano 1997 (in particolare si veda il capitolo Dinamismo).
B. Corra, Il pastore, il gregge e la zampogna (divagazione sul libro del Thovez), Libreria Beltrami, Bologna 1912, ora in G. Rondolino (a cura di), Il cinema astratto. Testi e documenti, Editrice Tirrenia-Stampatori, Torino 1977, pp. 131-144. 8
9
F.T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di L. De Maria, Mondadori, Milano 1968, p. 45.
10
C. Gallone, L’arte di inscenare, in «In Penombra», a. I, n. 1, giugno 1918, p. 8.
11
P.A. Gariazzo, Il Teatro muto, Quartara, Torino 1919.
12
Ivi, p. 66.
13
Ivi, p. 226.
14
R. Bracco, Tra le arti e gli artisti, Giannini, Napoli 1919, p. 300.
15
Ibidem.
16
E. Guazzoni, Miconfesserò, in «In Penombra», a. I, n. 2, luglio 1918, p. 55.
«L’inquadratura, la messa in scena, l’interpretazione, hanno in cinematografia lo stesso valore che possono avere le parole in letteratura. Occorre che le parole si compongano in uno stile e che questo stile rivesta un contenuto per giungere all’opera d’arte […]. L’arte d’inscenare è ben più complessa di quanto possa apparire a prima vista, è tutto un linguaggio nuovo da applicare a un’opera pur ricca dei più minuti particolari forniti dall’autore […]. Occorre scomporne la concezione, qualunque essa sia, per ricostruirla cinematograficamente […]. Anche l’interprete, per un inscenatore ideale, ha solo il valore di un elemento da plasmare». C. Gallone, L’arte di inscenare, in «In Penombra», a. I, n. 1, giugno 1918, pp. 7-8. 17
A.G. Bragaglia, Arcoscenico del mio cinematografo, ivi, a. II, n. 1, gennaio 1919, p. 22. Qualche tempo dopo interviene anche Depero a indicare il suo progetto per i balli plastici ed è evidente la sintonia culturale con le proposte di Bragaglia: «Rompere con la tradizione, con la tecnica ed espressione impressionistica, ‘vaga, sensuale, sparpagliata’ per seguire uno stile ‘piatto, geometrico, meccanico’. Linea precisa, forma chiara e colore complementare, piatto a curvature sfumate, sferiche o cilindriche», F. Depero, Iballi plastici futuristi, in «In Penombra», a. II, n. 4-5, aprile-maggio 1919, p. 20. 18
19
Bragaglia, Arcoscenico del mio cinematografo, cit., p. 22.
Poetica del cinematografo, in «Giornale d’Italia», 1918. Il primo articolo sui rapporti tra cinema e teatro appare nel numero del 10 agosto 1913 sul «Marzocco» col titolo Il cinematografo e l’arte. La citazione si ritrova nella prima edizione di S.A. Luciani, Il cinematografo, verso una nuova arte, Ausonia, Roma 1920, p. 9. 20
S.A. Luciani, Le idealità del cinematografo, in «In Penombra», a. II, n. 1, gennaio 1919, p. 3. L’articolo nasce anche in polemica con uno scritto di Silvio D’Amico apparso qualche mese prima, che fin dal titolo (Il cinematografo non esiste) prendeva posizione contro il cinema definendolo come una variante della pantomima (posizione non certo nuova), e condannandone lo sfruttamento massiccio ed estremamente banalizzato dei repertori teatrali più dimenticati: «Peggio fu ancora quando rientrando in quelle salette oscure […] io rividi apparire a mano a mano i titoli di tutti i drammoni più antichi e dimenticati, quelli che nemmeno nelle filodrammatiche di provincia attrarrebbero più l’ansito delle piccole borghesi: ovvero le riduzioni dei romanzacci più farraginosi con sottotitoli irti di punti esclamativi: La vendetta del morto! Lacrime di una madre! Miser chi mal oprando si confida… È mio figlio!!» (S. D’Amico, Ilcinematografo non esiste, ivi, a. I, n. 4, ottobre 1918, p. 135). Sui presupposti culturali di Luciani si veda l’intervento di C.L. Ragghianti, Luciani e Canudo, in Id., Cinema arte figurativa, Einaudi, Torino 1957, dove si individuano i legami con la cultura crociana, e la posizione assolutamente antitetica di Barbaro, espressa all’indomani della morte del critico: «Luciani partiva da un presupposto di natura tecnicistica sulla distinzione delle arti e prendeva, ovviamente, le mosse dal Lessing: per lui il cinema era un’arte a sé ‘opposta a quella del teatro’; e anche, giacché egli postulava una graduatoria tra le arti ‘non solo inferiore, ma anzi superiore al teatro’. E come si sa erano già due posizioni anticrociane», U. Barbaro, Ricordo di S.A. Luciani, in «Filmcritica», a. I, n. 2, febbraio 1951, pp. 43 sgg., ora anche in Id., Servitù e grandezza del cinema, Editori Riuniti, Roma 1961. 21
22
Poetica del cinematografo, in Luciani, Il cinematografo, verso una nuova arte, cit., p. 13 (corsivo nostro).
In genere restano poche copie della seconda edizione del 1921 e a questa si riferiscono gli storici. Le citazioni da me fatte si riferiscono a una copia del 1920 con correzioni autografe dell’autore. 23
24
S.A. Luciani, Il poema visivo come genere letterario, in Appendice a Id., Il cinematografo, verso una nuova arte, cit., p. 72.
Per il quadro generale delle teoriche si veda G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, Einaudi, Torino 1960 ; M. Verdone, Sommario di dottrine del film, Maccari, Parma 1971. Questi lavori oggi hanno un puro interesse storico e vanno interamente ripensati, soprattutto per 25
2
quanto riguarda il periodo di formazione, con ricerche sistematiche sulle riviste di categoria e alla luce di nuove categorie interpretative: cfr. D. Turconi, Le riviste di cinema in Usa dalle origini al 1930, in Id., La stampa cinematografica in Italia e negli Stati Uniti dalle origini al 1930, Amministrazione provinciale di Pavia, Pavia 1977, pp. 59-84. 26
Poetica del cinematografo, cit., p. 12.
27
Ibidem.
28
A. Gabrielli, Risorgiamo, in «Kines», a. II, 29 luglio 1920.
29
B. Negroni, Suggerimenti e consigli sulla messinscena, in «Pollice verso», a. I, n. 1, gennaio 1920.
30
R. Wisner, Cronache della quindicina, in «Romanzo-Film», a. II, 21 maggio 1921.
31
A. De Marco, Cinematografia realistica, in «La rivista cinematografica», a. II, n. 2, 25 gennaio 1922.
G. Viazzi, Il decennio delle origini. Storia, opinioni e tendenze dei precursori, in «Ferrania», ripreso ora in «Bianco e Nero», a. XXXIV, nn. 3-4, marzo-aprile 1973. Per «Il Baretti», si veda N. Ivaldi, Tre saggi di cinema sul «Baretti», in «Rivista del cinema italiano», a. IV, n. 1, gennaio-marzo 1955, pp. 74-80. Si vedano anche gli interventi di G. Aristarco, Contributi alla storia delle teoriche del film, in «Cinema Nuovo», a. V, nn. 109-110 e 111, 1957, ora rifusi nella citata Storia delle teoriche del film. 32
33
Viazzi, Il decennio delle origini, cit.
34
A.M. Mutterle, La Libra (antologia della rivista), Liviana, Padova 1969.
35
P. Del Monte, cit. in «Bianco e Nero», a. XXX, nn. 7-8, luglio-agosto 1979, p. 7.
36
M. Bontempelli, Si gira si gira si gira, in «Il Tevere», 14 agosto 1926.
L’articolo apparve con lo pseudonimo di Oreste, nel n. 6 del giugno 1926 del «Baretti», col titolo Charlie Chaplin e la febbre dell’oro, cfr. Ivaldi, Tre saggi di cinema sul «Baretti», cit., p. 76. 37
I testi degli articoli sono riportati nel numero monografico di «Bianco e Nero», a. XXX, nn. 1-2, 5-6, 7-8 dal gennaio all’agosto 1969, dedicato alle origini della critica cinematografica in Italia. 38
39
Lo si può constatare leggendo l’ampia antologia appena ricordata, e anche F. Casetti, Nascita della critica, in R. Redi (a cura di), Cinema
italiano sotto il fascismo, Marsilio, Venezia 1979. A. Gerbi, Teorie sul cinema, in «Il Convegno», a. VII, n. 10, 25 ottobre 1926. Si veda anche Aristarco, Storia delle teoriche del film, cit., in particolare, pp. 133-134 e 267 sgg. 40
Il numero di «Solaria» è del marzo 1927 (a. II, n. 3). Partecipano all’inchiesta molti intellettuali e solo in parte le risposte vengono pubblicate: G. Debenedetti, G. Alberti, U. Betti, E. Montale, M. Gromo, S.A. Luciani, A.G. Bragaglia, L. Ferrero, R. Franchi, G.B. Angioletti, R. Bacchelli, P. Gadda, U. Morra di Lavriano, A. Baldini, P. Pancrazi. Si veda E. Provenzale, Gli intellettuali e il cinema, in «Solaria», a. V, n. 4, aprile 1941, riprodotto anche in M. Verdone e L. Autera (a cura di), Antologia di Bianco e Nero, Ed. di Bianco e Nero, Roma 1964, vol. III, t. I, pp. 644-652. Si vedano anche l’ampia antologia di scritti del numero di «Solaria», in Letterato al cinema, in «Sequenze», a. II, n. 9, maggio 1950 e G. Manacorda (a cura di), Lettere a Solaria, Editori Riuniti, Roma 1979. 41
Cfr. il mio Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Patron, Bologna 1972, pp. 79 sgg. e S. Raffaelli, Cinema film regia, Bulzoni, Roma 1978, p. 87. 42
Della figura e dell’opera di Barbaro mi sono occupato a varie riprese: si vedano soprattutto U. Barbaro e l’idea di neorealismo, Liviana, Padova 1969, i capitoli nei volumi Intellettuali, cinema e propaganda, cit., Cinema italiano tra due guerre, cit., e l’antologia di scritti su letteratura, teatro, cinema e arti figurative Neorealismo e realismo, 2 voll., Editori Riuniti, Roma 1976. Inoltre l’ampia analisi dedicata alla sua opera teorica in Aristarco, Storia delle teoriche del film, cit. 43
44
S.A. Luciani, L’antiteatro, La voce, Roma 1928.
Per il discorso più generale A. Asor Rosa, La cultura, vol. IV, tomo II della Storia d’Italia, Einaudi, Torino 1975, in particolare pp. 1471 sgg. 45
La bibliografia su questo argomento è diventata, soprattutto negli anni Settanta, assai consistente. Tra i titoli più significativi: A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino 1965; Ph.V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, Laterza, Roma-Bari 1975, e i più recenti G.B. Guerri, Giuseppe Bottai, un fascista critico, Feltrinelli, Milano 1976; A.S. De Grand, Bottai e la cultura fascista, Laterza, Roma-Bari 1978 e A. Panicali, Bottai: il fascismo come rivoluzione del capitale, Cappelli, Bologna 1978. Un discorso spostato sull’attività di coordinamento della cultura negli anni Trenta e primi anni Quaranta è in L. Mangoni, L’interventismo della cultura, Laterza, Roma-Bari 1974; Ead. (a cura di), Primato (1940-43), De Donato, Bari 1977 e L. Polato, Prospettive Primato, Canova, Treviso 1978. Per un’indagine più ampia della cultura letteraria tra le due guerre: E. Garin, Intellettuali italiani del XX secolo, Editori Riuniti, Roma 1974; G. Luti, Cronache letterarie tra le due guerre, Laterza, Bari 1966; La letteratura del ventennio fascista, La Nuova Italia, Firenze 1974; G. Manacorda, Letteratura e cultura nel periodo fascista, Principato, Milano 1974; A. Panicali, Le riviste del periodo fascista, D’Anna, Firenze 1978. 46
L’esperimento è già tentato su «Lo Spettacolo d’Italia» dove, accanto a Marinetti, Bragaglia, Carli, Bontempelli, sono chiamati a collaborare Solaroli e Barbaro, quest’ultimo proveniente da esperienze politiche anarchiche. 47
Cfr. il mio Per un’antologia degli scritti di Libero Solaroli, in «Cinemasessanta», n. 121, maggio-giugno 1978, pp. 26-28 e la breve antologia di testi raccolta anche nel numero successivo della stessa rivista. 48
A. Vergano, Cronache degli anni perduti, Parenti, Firenze 1958, in particolare l’ultimo capitolo in cui racconta come avviene l’incontro con Blasetti in occasione del progetto di realizzazione di Sole. Su Vergano si veda anche la monografia dedicatagli da J. Gili, in Anthologie du cinéma, ed. de l’Avant-Scéne, Paris 1970, dove si definisce con notevole intelligenza il contesto contraddittorio entro cui si forma il gruppo di intellettuali capeggiato da Blasetti. A questo proposito si veda anche la testimonianza di Blasetti nel volume Cinema italiano oggi da lui curato con Gian Luigi Rondi, Bestetti, Roma 1950. 49
S.G. Germani, Cinema italiano sotto il fascismo: proposta di periodizzazione e L. Albano, Le riviste di Blasetti e la conquista del cinema, in Materiali sul cinema italiano 1929-1943, in Quaderni della Mostra del Nuovo cinema, n. 63, Pesaro 1975 e nello stesso numero l’antologia di scritti blasettiani e l’accurata bibliografia. A. Aprà ha curato un’antologia e scritto un denso saggio introduttivo agli scritti di Blasetti, Scritti sul cinema, Marsilio, Venezia 1980. Si veda anche F. Prono, Il cinema che ho vissuto, Dedalo, Bari 1982. 50
51
A. Blasetti, Dopo la produzione 1927-28, in «Cinematografo», a. II, n. 9, 29 aprile 1928 riportato in Materiali, cit., p. 133.
52
Lo si vede molto bene rileggendo le critiche raccolte nel numero monografico di «Bianco e Nero» citato supra alla nota 38.
53
La citazione è presa dal saggio di Viazzi, Il decennio delle origini, cit.
In particolare U. Barbaro e l’idea di neorealismo, cit. e il capitolo Neorealismo alle fonti di un mito, in Intellettualicinema e propaganda, cit. 54
Il racconto dal 1919 al sonoro
Nel decennio che va dalla fine della guerra all’invenzione del sonoro la produzione italiana registra un’inarrestabile parabola discendente. La scomparsa pressoché totale dei film, la loro relativa modestia, se si pensa allo sviluppo contemporaneo delle cinematografie americana, tedesca, sovietica, francese e nordica, il ritardo obiettivo nello sviluppo linguistico, fanno sì che di questo decennio non si parli nelle storie generali del cinema, se non per ricordare dei titoli che si contano sulle dita di una mano. In realtà – accettato il dato indiscutibile della modestia della produzione – va anche rilevato che se il numero di film prodotti alla fine degli anni Venti non supera le due decine l’anno e si riduce nel 1929 a poche unità, nel periodo dell’immediato dopoguerra il numero delle opere e delle case in funzione è assai elevato e supera i duecento titoli l’anno, almeno fino al crollo dell’Uci conseguente al fallimento della Banca italiana di sconto del 29 dicembre 1921. Quando questo libro è stato scritto le idee o i dati sul decennio tra la fine della guerra e il sonoro erano molto limitati. Mancavano le fonti filmiche – ora recuperate, sia pure in minima parte, in ogni caso sufficiente a rendere possibili delle ipotesi sullo standard medio, sui modelli dominanti, sullo sviluppo espressivo e sui rapporti con il cinema di altri paesi –, mancavano i più elementari elementi filmografici. Di tutta la storia del cinema muto italiano il cinema degli anni Venti costituiva un vero e proprio buco nero. Era necessario che qualcuno iniziasse a fissarne in modo sicuro la topologia e ne effettuasse un primo censimento sistematico . Gli anni Venti – grazie a una cospicua serie di ritrovamenti, indagini filmografiche e restauri – non sono più una «terra incognita», ma il considerevole aumento delle conoscenze dirette dei testi non muta in modo sostanziale né fa pendere la bilancia a favore del cinema italiano rispetto alle altre cinematografie. Questa produzione, nonostante tutti i tentativi di recupero di singoli fenomeni che si potranno mettere in atto grazie a ricerche, restauri, ritrovamenti e a una collazione organica dei materiali, non ha avuto la forza di superare i confini nazionali, né ha potuto reggere al confronto con la produzione americana, che proprio negli stessi anni ha cominciato a dilagare . Con poche varianti i produttori hanno cercato di riproporre i medesimi motivi dell’anteguerra, senza procedere ad alcun tipo di rinnovamento di quadri e di soggetti. Mentre in America già Griffith appariva superato dall’emergere di nuovi registi, in Italia i quadri rimangono gli stessi, i generi di successo non vengono toccati. Il ritorno all’antico sembra – come si è detto – una delle formule magiche, un toccasana a cui si ricorre per anni nella speranza di riconquistare il prestigio internazionale perduto. Le reazioni ai pochi tentativi di revival sono concordi in Italia e all’estero: nonostante la profusione della spesa i film risultano involontariamente grotteschi e ridicoli e ottengono risposte da parte del pubblico esattamente antitetiche alle attese. I tentativi di dar vita alla grande produzione spettacolare comunque vi sono: dal 1918 si possono almeno ricordare i titoli di Teodora (diretto da Leopoldo Carlucci) che esce solo nel 1922, Frate sole (realizzato da Ugo Falena), per giungere tra il 1919 e il 1921 alla realizzazione della Nave con Ida Rubinstein e lo stesso figlio di D’Annunzio, Gabriellino, come regista, assieme al più competente Mario Roncoroni. Teodora ottiene un notevole successo anche all’estero («Teodora è uno spettacolo eccezionale, immenso, unico» scrive un critico sul «New York American») e in Italia il film viene accolto come l’opera capace di rinnovare i fasti di Cabiria per grandiosità spettacolare, dovuta alle scenografie dell’architetto Armando Brasini. Tra le produzioni colossali degli inizi degli anni Venti accanto a Teodora si colloca anche La nave. Come il precedente anche questo film è lento, enfatico, sconnesso nella struttura, e per di più mal digeribile per il lessico dannunziano («Signore, signore sai che soffero vituperio per te. Abbandonato ho la mia casa e il 1
2
mio retaggio. Il mio sangue s’è rivoltato contro a me»). Barbarico nelle intenzioni, ma ricercato nel taglio delle inquadrature e nelle scenografie, La nave merita comunque uno studio che lo consideri un po’come l’epicedio della grande produzione spettacolare e nazionalista del cinema muto italiano. Se non altro per lo stretto legame ideale con la vicenda dell’occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio, di cui sembra quasi costituire la motivazione ideologica e il transfert. Un discorso a parte merita forse l’interpretazione data da Ida Rubinstein alla figura di Basiliola Faledra: una sorta di distillato di tutti quegli elementi già osservati nel capitolo sul divismo che concorrono a fare della donna una sorta di incarnazione delle forze della natura primitiva e che in un gioco di continue metamorfosi la trasformano da incantatrice in serpente, da felinide in creatura del fuoco, in essere demoniaco che porta fino in fondo la sua vendetta («Basiliola contempla l’eroe vinto dalla sua astuzia femminile, e sorride trionfante. Ma ad altro aspira la sua vendetta»). Parallelamente si possono individuare elementi di forte erotismo nell’interpretazione di Rita Jolivet in Teodora («È una bellissima Teodora, forse più bella che imperiale […] con l’onda fosca dei capelli sciolti […] ella è veramente femmina, la creatura morbida e dolce del voluttuoso amore e la donna audace e violenta dell’amore mortale» scrive Aurelio Spada nel 1922 su «Film»). Nei film storici realizzati dopo la fine della guerra non si bada a spese nella ricostruzione di ambienti e abiti: Fausto Salvadori, che già aveva curato le scenografie di Christus, Nerone, Redenzione, Fabiola, San Paolo, progetta la «visione storica» dei Borgia diretta da Caramba, o il Giuliano l’apostata . Ancora per qualche anno la produzione di film in costume sembra il più sicuro rifugio per controbattere l’offensiva straniera: si possono ricordare, tra gli altri titoli, Il ponte dei sospiri e Dante diretti da Domenico Gaido, I due Foscari e Il povero fornaretto di Venezia (regia di Mario Almirante), Il corsaro di Augusto Genina, Marco Visconti diretto da Aldo De Benedetti, Il sacco di Roma, Messalina, Quo vadis? e Gli ultimi giorni di Pompei che seppellisce definitivamente un tipo di produzione, ormai realizzata con ben altra capacità spettacolare da registi americani come Cecil B. DeMille. Nel Cirano di Bergerac e nel Corsaro di Genina si colgono sia la sintonizzazione del regista con gli standard dei contemporanei film americani ed europei che le sue notevoli doti nella direzione degli attori e delle masse . In tutte queste opere, che pure rivelano ancora momenti di relativa grandiosità spettacolare, il tratto che più colpisce è la stasi del processo espressivo. Le didascalie spezzano l’azione, la recitazione non si distacca dall’enfasi dei codici dell’opera lirica, le scene di massa ripropongono formule già collaudate. Qualche novità si può forse notare nell’avvicinamento della macchina da presa al volto degli interpreti. In Messalina il numero di primi piani della protagonista è notevole e riesce a comunicare, grazie alla recitazione di Rina De Liguoro (ultima diva del muto italiano), una forte carica di sensualità. Ma in certi casi (si pensi a Ida Rubinstein interprete della Nave) il primo piano diventa un elemento negativo a carico del film per l’incapacità dell’interprete di reggere a un rapporto ravvicinato con la macchina da presa. Si può inoltre notare una più coerente utilizzazione del passaggio dei punti di vista, della dialettica individuo-folla, primo piano-campi totali. Anche Fabiola, realizzato nel 1918, è uno degli ultimi grandi successi: se per Messalina si tratta di puntare sui motivi della sensualità e della perversione, in Fabiola si tratta di sublimarli nella finale conversione al cattolicesimo. Sono scomparsi i riferimenti nazionalistici degli anni Dieci e restano soltanto preoccupazioni emotive. In Fabiola, pur nella staticità della macchina da presa, il numero di primi piani è assai elevato, e l’immagine cerca di trasmettere egualmente il valore di una sensualità marcata. In questo quadro c’è ben poco da dire anche della terza versione del Quo vadis? realizzata dall’Ambrosio e diretta a quattro mani dal regista tedesco Georg Jacoby e da Gabriellino D’Annunzio, reduce dall’insuccesso della Nave. Lo stesso Ghione, al quale non si può certo rimproverare la mancanza di orgoglio nazionalistico, è costretto a riconoscere che il film «è molto inferiore ai due che l’hanno preceduto» e lo stesso successo economico, nonostante la grandiosità degli investimenti e il contributo dei capitali tedeschi, è assolutamente inferiore al previsto . Il fallimento commerciale dell’opera accelera il processo di disgregazione dell’Uci e dimostra che la strada della concentrazione è ormai impraticabile. Assistendo a questi film i pubblici dell’epoca forse avevano l’impressione di ritrovarsi di fronte alla produzione di dieci anni prima: soltanto qualche combinazione di montaggio e questo più diretto contatto tra la macchina da presa e il volto dei protagonisti rivelava modeste differenze. L’eredità teatrale e dell’opera 3
4
5
lirica è scomparsa, eppure si compie una specie di moltiplicazione ipertrofica e manieristica di effetti e moduli narrativi e iconografici già sperimentati. Non viene neppure rinnovato il sistema di iconizzazione che, fin dall’inizio, aveva attinto a piene mani per le sue tipologie alla pittura dei preraffaelliti. La carica sensuale che scorre comunque in queste opere si compone e si attenua per la presenza in chiusura di un cristianesimo trionfante secondo i più elementari stereotipi catechistici. Forse in questa direzione di scoperta volontà di trasgressione di divieti si registrano le novità più interessanti del genere storico-colossale. L’impressione di crescita pressoché nulla del sistema si può vedere confrontando le due versioni degli Ultimi giorni di Pompei, quella di Rodolfi nel 1913 e quella realizzata da Palermi e Gallone nel 1926 al costo di sette milioni di lire, che segna il punto d’arrivo e di morte del genere . Gli ultimi giorni di Pompei è – suo malgrado – un film comico fin dalla sua uscita. Per le didascalie, che dovrebbero aggiornare senza cadute ai livelli bassi lo stile inventato nel decennio precedente, si ricorre ad Alfredo Panzini. Vale la pena di estrarre qua e là qualche esemplare del lavoro panziniano. Didascalia iniziale: «Città di delizia la Roma imperiale nell’anno 79 d.C. Sotto pioggia di cenere e fuoco è seppellita. Risorge oggi, dopo 19 secoli meraviglia e ammonimento agli uomini dell’alterna vicenda delle umane cose». Subito, come è facile notare si mescolano vari livelli: una citazione «colta» foscoliana (il verso dei Sepolcri è «l’alterna onnipotenza delle umane sorti») si mescola al discorso sulla verità della finzione e sull’attualizzazione dello spettacolo, sulla sua capacità di far rivivere il passato al presente. E il principio di attualizzazione si può notare anche in situazioni molto più circoscritte: le terme di Stabia sono «il ritrovo della gioventù mondana e sportiva di Pompei» e Nidia, l’infelice schiava tessala, «vende fiori e canzoni» (qui non possono non scattare i codici musicali contigui della Violetera). Anche in quest’opera il cinema non sembra affatto aver raggiunto nuovi livelli rispetto al decennio precedente: i personaggi recitano ancora rivolti verso lo spettatore e la loro disposizione è triangolare. Gallone, anche se riesce bene a dominare i movimenti di massa, resta legato a un uso statico della macchina da presa e a una subordinazione totale rispetto alla scena, nonostante da anni siano giunti in Italia i film americani di Griffith, che hanno rivelato un ben diverso potere della macchina rispetto all’oggetto da riprendere. Secondo Ghione questo film segna la morte definitiva della cinematografia italiana ormai agonizzante da qualche anno . Di fatto dopo il 1922 nel giro di pochissimo tempo l’esercizio italiano appare quasi completamente colonizzato dalla produzione straniera, americana in primis, e questa produzione condanna a morte anche i pochi film che ancora tentano di sfidare l’invasore sul suo stesso terreno senza cercare di riportare in vita i fantasmi di un cinema ormai defunto e uscito dall’immaginario collettivo. Uno dei pochi filoni rimasti in vita senza mai perdere il contatto col pubblico è quello dei forzuti, del film acrobatico, in cui si specializzano tutta una serie di personaggi guidati da Maciste. «Alle perigliose, allucinanti ed esaltanti acrobazie di Douglas Fairbanks e di Tom Mix, già cari al nostro pubblico, la Fert oppone i muscoli e i salti di Luciano Albertini, Bartolomeo Pagano, Alfredo Boccolini e Domenico Gambino» . Il segno di Zorro con Douglas Fairbanks di Fred Niblo è del 1920, il filone dei forzuti e degli acrobati si sviluppa e mantiene un buon successo di mercato almeno fino alla metà degli anni Venti . Tra tutti Maciste è il personaggio più sfruttato e di maggior vitalità. Negli anni Venti il guadagno annuo di Bartolomeo Pagano si aggira sulle 250.000 lire l’anno: non era troppo se confrontato con quelli della Bertini, ma pur sempre una cifra che lo poneva tra i divi più pagati del cinema italiano . Gli ingredienti di questi film restano circoscritti a pochi elementi di base continuamente variati: ma se le performance di Maciste si risolvono in genere a suon di pugni, quelle di altri personaggi, suoi concorrenti, utilizzano anche le capacità acrobatiche professionali per la realizzazione di scene di grande effetto spettacolare. La filmografia di Maciste è molto ricca e in pratica va a suo merito il fatto che la Fert, dopo la crisi dell’Uci e il suo fallimento, non chiuda del tutto i battenti. Ogni anno vengono messe in cantiere due o più opere che lo vedono protagonista: dopo essere stato diretto da Pastrone nei suoi primi film Pagano passa nell’ultimo decennio del muto sotto vari registi, da Borgnetto a Brignone, da Campogalliani a Mario Camerini. I titoli più significativi sono Maciste innamorato (1919), Il testamento di Maciste (1920), Maciste in vacanza (1921), Maciste salvato dalle acque (1921), Maciste e il nipote d’America (1924), Maciste imperatore (1924), Il gigante delle Dolomiti (1926), Maciste contro lo sceicco (1926), Maciste all’inferno (1926) e Maciste nella 6
7
8
9
10
gabbia dei leoni (1926). Bartolomeo Pagano accompagna tutta la parabola del cinema muto italiano dalla sua massima espansione alla sua agonia. In certi casi, da solo, sostiene la sopravvivenza di una produzione ormai priva di mezzi e di idee. Rispetto a Maciste, Sansonia (Luciano Albertini), nella pubblicità del suo produttore, «è l’uomo singolare che sferra un pugno non solo col muscolo, ma col cervello e col cervello più che con le gambe egli sorvola gli abissi. Dotato di nervi d’acciaio, la natura l’ha pure fornito di potere inventivo e di una fantasia mirabile […]. Ecco perché la folla ha trovato in Sansonia il tipo rappresentativo dell’uomo nuovo che riunisce in sé la forza fisica all’energia intellettuale e l’ha subito proclamato il suo eroe» . Albertini, che sarà il più degno e interessante concorrente di Maciste, ma anche quello capace di dar vita a una sua casa di produzione, aveva esordito nel 1917 all’Ambrosio, in un film diretto da Filippo Costamagna (che in seguito sarebbe diventato il suo regista preferito) intitolato La spirale della morte in cui metteva – in luce le sue eccezionali doti acrobatiche. Dal successo già consolidato di Maciste e da quello di Albertini si sviluppa dunque, nel biennio successivo alla fine della guerra, il filone dei forzuti e degli acrobati. I nomi dei maggiori protagonisti sono Carlo Aldini (Aiax), Mario Guaita (Ausonia), Alfredo Boccolini (Galaor), Domenico Gambino (Saetta), Francesco Casaleggio (Fracassa), Giovanni Raicevich, il nano Gennariello, Astrea (che cerca di imitare le gesta delle eroine americane guidate da Pearl White). Luciano Albertini assume il nome mitico di Sansone a partire da un film girato poi per la Pasquali col titolo biblico, Sansone contro i filistei. Poi, da quando fonda nel 1919 la sua casa di produzione, si dedica a una produzione avventurosa articolata che non esclude varianti di romanzi popolari come I quattro moschettieri, o i quattro episodi del Ponte dei sospiri, o film dell’orrore, come Il mostro di Frankenstein (1920), unico tentativo di dar vita a un filone ripreso soltanto quarant’anni dopo . Tra il 1919 e il 1921 Albertini realizza una nutrita serie di film che lo vedono protagonista nelle vesti di Sansone: Sansone muto, Sansone e la ladra di atleti, Sansone e i rettili umani, Sansonette amazzone dell’aria, Sansonette e i 4 arlecchini, I figli di Sansonia, Sansone burlone, Sansone l’acrobata del Kolossal . I due anni di vita dell’Albertini film sono piuttosto burrascosi secondo l’accurata ricostruzione fattane da Mario Quargnolo, ed è proprio per l’aggravarsi delle difficoltà finanziarie che, nel 1921, Albertini decide di chiudere la sua impresa e di partire, tra i primi di una lunga serie di attori e autori, alla volta della Germania, che in quegli anni appare come una sorta di Eldorado per la rapida ripresa e per la consistente quantità di investimenti. Tra i titoli da ricordare degli altri attori-acrobati: Il re della forza (con G. Raicevich), Justitia (con Astrea), Galaor contro Galaor (con Boccolini), Caporal Saetta e Saetta principe per un giorno (con Gambino e la regia di Mario Camerini). Si succedono, in questi film, lotte furiose dell’eroe che sgomina con la sola forza muscolare bande agguerritissime di delinquenti. Tutte giocate sul suspense, su avventure rocambolesche e in cui il margine di rischio è sempre elevatissimo, queste opere non fanno che portare all’aperto tutti i numeri più emozionanti degli acrobati del circo. Quando il successo italiano comincia a declinare quasi tutti i personaggi appena ricordati riescono a trovare, ancora per qualche anno, lavoro in Germania. Negli anni 1924-1925 l’emigrazione dei quadri cinematografici preceduti da Albertini e Gambino assume il carattere «di una vera e propria diaspora» . Questi film d’avventura e d’azione che cercano di arginare il passo ai serial americani, da Robin Hood, al Pirata nero, a Tom Mix e a tutti quegli eroi popolari, che, per anni, domineranno incontrastati sugli schermi di tutti i cinematografi italiani, sono realizzati in un numero abbastanza consistente. I costi di produzione sono bassissimi, il numero dei personaggi limitato, i soggetti si possono variare dato uno schema di base e possono essere tranquillamente presi dalla letteratura poliziesca: Rocambole appare in una serie di 7 episodi con protagonista Margot Pellegrinetti, e per la stessa produzione De Rosa viene realizzato il personaggio di Miss Demonio (1918). Nel panorama di titoli del decennio ne sono emersi negli ultimi anni alcuni che vale la pena di ricordare per la struttura narrativa (abbiamo già richiamato Storia di una donna di Eugenio Perego): per la complessità del montaggio e della fotografia, oltre che per la novità della struttura del poliziesco Il quadro di Osvaldo Mars di Guido Brignone del 1921, prodotto dalla Rodolfi e costruito con un ritmo incalzante e una capacità di creare l’atmosfera che lo avvicinano assai di più alla coeva produzione tedesca che a quella italiana e qualche 11
12
13
14
commedia degli anni successivi, con cui si riesce a tentare il confronto con le produzioni americane. Il cinema napoletano prodotto dalla Dora film, da Emanuele Rotondo, dalla Miramare, da Colamonici e dalla Lombardo film, fondata nel 1919, riesce a mantenersi in vita per tutti gli ultimi anni del muto, assicurando al suo pubblico un rifornimento continuo di opere di sicuro successo. Tra il 1919 e il 1928, data di nascita della Titanus, Gustavo Lombardo realizza quasi una cinquantina di film e li impone sul mercato, grazie anche alla forza della sua distribuzione . Leda Gys – la moglie di Lombardo – è la regina incontrastata della nuova casa di produzione napoletana ed è una delle poche dive capaci di lasciare una traccia nella memoria dello spettatore italiano . Questa produzione non muta rispetto alle caratteristiche generali già individuate nel periodo precedente, anche se, data la ricchezza di titoli, si può vedere come cerchi di coprire vari terreni. I registi che operano in questi anni sono Ubaldo Maria Del Colle, Giulio Antamoro, Elvira Notari, Emanuele Rotondo, ma, al di là delle voci e della curiosità di alcuni titoli, che suggeriscono filoni di commedia destinati a rimanere (Mia moglie si è fidanzata, 1921, Mademoiselle Cocotte, Saitra la ribelle), il gruppo di opere che si è salvato a tutt’oggi si muove esattamente lungo le linee del sistema già descritto nel capitolo sul decennio precedente. Ogni film è come la risultante di un agglomerato di codici eterogenei: il livello di produzione rimane assai povero e basato sempre su conflitti elementari (in Fantasia ‘e surdate la mamma ha due figli, uno buono e lavoratore, l’altro che viene travolto dall’amore di una mala spina e si perde nel fango dell’a-biezione), ma la costante interferenza del reale, la corrispondenza con modelli profondi di cultura popolare fa di questi prodotti una sorta di esemplari realizzazioni di una «mente collettiva». La forza e la disperazione nella rappresentazione delle passioni, che hanno per lo più come modello contiguo privilegiato la sceneggiata, trovano una loro nobilitazione nei testi letterari delle didascalie, non di rado scritte in dialetto con la traduzione italiana a fianco e redatte in uno stile nobile ed elevato. Entra anche in maniera diretta la storia (in Fantasia ‘e surdate appare «fra tanta beatitudine di gloria il monumento al milite ignoto» e soprattutto si rievocano, con flashback, i momenti qualificanti della guerra, la partenza dei reduci, i canti nostalgici in trincea). Tra i codici fondamentali presupposti c’è sempre quello musicale: segno implicato e necessario, non soltanto quando il film non è altro che la trascrizione visiva di una canzone, ma soprattutto perché la recitazione e le vicende lasciano largo spazio al cantato, agli stornelli, alle canzoni… La recitazione è ancora molto marcata (altro evidente segno dell’influenza della sceneggiata) e segnala il ritardo abbastanza netto, ma anche la conservazione di un sistema espressivo utilizzato consapevolmente. In tutto il groviglio di sentimenti e passioni degradanti e violente trionfa sempre, in questo filone, il mammismo (o il babbismo come in Lucia Lucí di Del Colle, 1922), e diventa un elemento distintivo della produzione. La madre-Madonna è la depositaria dei valori religiosi e della moralità sana. Le invocazioni religiose sono l’ultimo e disperato approdo della madre per riportare al bene il figlio perduto («O Madonna, salvalo da tanta infamia, rendimi il figlio mio» oppure «Dio mio, fa scaturire un po’di luce in mezzo a tanta tenebra, restituiscimi il figlio mio innocente»). Ma in controcanto risponde con ben altra forza il linguaggio dei sensi e della passione («Nel suo amplesso ho obliato il primo sogno della mia giovinezza», «Qual è il prezzo del tuo tradimento e della tua vergogna?»). Per questo le invocazioni alla Madonna spesso sono senza alcun effetto («Salvalo, toglilo al fascino di quella maliarda»). Tutte queste battute si ritrovano in Fantasia ‘e surdate dove a un certo punto il fratello buono che uccide quello cattivo verrà assolto per i suoi meriti patriottici, e assieme alla mamma e alla cattiva amante redenta andrà a pregare sulla tomba dell’ucciso. In questo film lo sfondo reale è anche quello della partecipazione alla storia, mentre in altri, come È piccerella, Lucia Lucí, ‘O schiaffo, Napule ca se ne va, le vicende sono tutte vissute nel presente. In È piccerella le didascalie hanno subito la funzione di immetterci nel clima sensuale della vicenda, anche se il mostrato dà l’impressione di riprendere allegri banchetti conviviali («Pandemonio orgiastico di baccanti»), e i messaggi erotici si scambiano subito tra i protagonisti attraverso occhiate brucianti («non ti scottare al fuoco di quegli occhi!») o sono sostituiti dal vorace infilarsi in bocca una cucchiaiata di spaghetti. E nonostante i consigli degli amici («Cagnate strada, chilla guagliona ha fatto chiagnere chiù de nu fijo ‘e mamma») il dramma segue il suo corso, prevedibile. L’interesse del film però non è dato tanto dalle vicende, quanto dall’ormai libero mescolarsi della macchina da presa tra la folla, senza alcuna intenzione precostituita di ripresa. Mentre il protagonista passa «sotto 15
16
l’oscuro dominio di una bellezza malvagia», la città scorre e partecipa, con tutta la sua bellezza non convenzionale, al dramma, sempre più forte («baciami, i tuoi baci sono l’alimento della vita mia»), fino allo scontro tra fratelli e al prevedibile ricongiungimento finale al capezzale della madre. Tra tutti questi registi Ubaldo Maria Del Colle (Lucia Lucí, Napule ca se ne va, Te lasso!…) è l’autore che usa con maggiore consapevolezza tutte le possibilità del mezzo e valorizza le diverse fasi di elaborazione materiale dell’opera, dal soggetto alle riprese e al montaggio. Lo sfondo reale è perfettamente integrato nella vicenda e ne diventa spesso l’autentico protagonista. L’occhio del regista si avvicina al massimo anche ai suoi personaggi e non soltanto ai protagonisti, ma anche ad anonimi personaggi di una cultura popolare in via di estinzione (in Napule ca se ne va il pazzariello, il teatrino delle «guarettelle», ovvero le marionette, il ballo della tarantella…) e rivela, grazie a una serie di primi piani, piani americani, movimenti di macchina, una maggiore coscienza degli elementi fondanti della sintassi cinematografica. Nei film di Del Colle il racconto dipende ormai quasi del tutto dal ritmo visivo, mentre per gli altri registi, come si è visto, è ancora un elemento fondante la didascalia. L’attrice che raggiunge una fama nazionale e che riesce a far uscire i film dalla semplice destinazione locale – come si è detto – è Leda Gys: il suo repertorio è abbastanza vasto, ma i suoi maggiori successi, raggiunti in opere tipicamente napoletane, legate a sceneggiate, a canzoni, a testi dialettali sono Il miracolo (1920), Scrollina (1920), I figli di nessuno (1921), Santarellina (1923), Sole! (1918), La fanciulla di Pompei (1924, di Giulio Antamoro), Vedi Napule eppo’mori! (1924, di Eugenio Perego), Napoli è una canzone (1927, di Eugenio Perego), Napule… e niente cchiù (1928, sempre di Perego). I film sono tutti della produzione Lombardo. In questi film, recitando accanto a partner come Livio Pavanelli e Giampaolo Rosmino, la Gys interpreta ora figure di popolane capaci di affrontare con grande forza tutte le prove della vita ora di giovani coinvolte in situazioni piccanti e spesso pronte a sfidare con piglio sfrontato la morale corrente e i tabù sessuali. Le sue «santarelline» sembrano cedere volentieri alle tentazioni. Questa produzione regionale sopravvive, comunque, alla crisi che travolge l’Uci e continua a mantenere il proprio standard e a soddisfare i propri pubblici. Sarà solo la ristrutturazione imposta dall’avvento del sonoro, lo spostamento di Gustavo Lombardo a Roma, a dimensionarla ulteriormente e a privarla, comunque, di quei caratteri distintivi che l’avevano accompagnata per tutto il periodo del muto. L’emorragia di tecnici, di autori, di attori e maestranze che inizia dai primi anni Venti depaupera il patrimonio creativo dell’industria italiana e la taglia ancor più fuori dallo sviluppo espressivo prepotente di tante altre cinematografie. Del ruolo del fascismo in questo contesto si è già parlato più in dettaglio in un altro capitolo, ma è certo che i tentativi modesti di allineare i temi alle esigenze del regime, sia pure nel senso più ampio di esaltazione nazionalistica, si realizzano in una serie di titoli tutt’altro che trascurabili, che vanno dal documentario A noi!, mostrato fin dal 7 novembre 1922 e realizzato da Umberto Paradisi, regista con alle spalle una decina d’anni di esperienza, al Grido dell’aquila di Mario Volpe, primo film a soggetto, messo in circolazione nel 1923, alla Leggenda del Piave (1923) di Mario Negri; tutti film e documentari che già all’indomani della marcia su Roma tentano di stabilire il motivo della continuità ideale tra guerra e fascismo . Per la verità Il grido dell’aquila, primo vero film di propaganda è una sorta di instant film realizzato all’indomani della marcia su Roma, mescolando insieme materiali documentari e resti di un film non terminato sulla prima guerra mondiale e sulle delusioni del dopoguerra per i reduci. Il film di Volpe, pur di qualità modestissima, è attraversato da un forte spirito unitario e fissa quegli elementi di continuità tra Risorgimento e fascismo che saranno alla base del lavoro storiografico del suo omonimo Gioacchino Volpe. E le impressionanti scene di massa finali in montaggio parallelo, pur nel loro rozzo richiamarsi al montaggio griffithiano, riescono ancora a trasmettere il senso allo stato nascente di un’energia sociale e politica nuova nel paesaggio italiano. C’è inoltre tutta la produzione di Silvio Laurenti-Rosa che spazia dal «cinedramma antibolscevico» Katiuscia (1923) realizzato con materiali presi in Russia dopo un soggiorno di alcuni mesi per conto dell’Unione cinematografica, a titoli più decisamente propagandistici e nazionalistici (Le tappe della gloria e dell’ardire italici, I martiri d’Italia, realizzato assieme a Domenico Gaido), a una serie di film risorgimentali (Dalle cinque giornate di Milano alla breccia di Porta Pia, Garibaldi e i suoi tempi). Nei Martiri d’Italia la storia italiana viene ripercorsa con una serie di flash dal Medioevo e Dante attraverso 17
l’aneddotica più vulgata, come un unico progetto di tensione verso l’unità: si ritrovano pertanto fianco a fianco Masaniello, Garibaldi e Pietro Micca, e Cola di Rienzo, Maroncelli e Goffredo Mameli, Balilla e Cavour, Oberdan e Mazzini, l’alpino della prima guerra mondiale e sua madre. Garibaldi e l’epopea garibaldina sono visti come antecedenti di Mussolini e dello squadrismo, come abbiamo già segnalato, e lo stesso Garibaldi è il personaggio che garantisce un minimo di legittimità di cornice storica alla trama passionale della Cavalcata ardente realizzato nel 1925 da Carmine Gallone (tra gli interpreti Emilio Ghione e Soava Gallone). Abbandonati i pepli e le toghe i film in costume tentano la ricostruzione di epoche più vicine e lo fanno con tutta la esperienza scenografica che viene dal teatro e dall’opera lirica. Gallone e, d’altro canto, Genina, continueranno ad applicare la loro competenza professionale a opere con caratteristiche molto diverse. Gallone e Genina sono gli autori meglio pagati, che più respirano le atmosfere e il clima del cinema europeo e che meglio riescono ad assorbire la crisi creando opere spesso di grande qualità e richiamo (Genina gira La maschera e il volto, Il focolare spento, Il corsaro e Addio giovinezza!, negli anni della grande crisi) senza perdere di vista un’idea di film in cui si coagulino dei valori nazionali. Questa loro rappresentatività nazionale e sovranazionale spiega perché negli anni Trenta saranno loro commissionate opere di propaganda come Scipione l’Africano o L’assedio dell’alcazar. Dalla metà degli anni Venti entrambi i registi hanno modo di acquisire nuovi elementi espressivi nel lavoro che realizzeranno all’estero. Il rispettivo contributo alla ripresa produttiva alcuni anni dopo risulterà pertanto importante e indispensabile a riallacciare i ponti e i legami con la produzione dei paesi europei confinanti . Manca, perché ancora monopolizzata dal futurismo, in fase però di disgregazione interna, una elaborazione sul materiale cinematografico da parte di un’avanguardia che sia paragonabile a quella di altri paesi. La produzione cinematografica degli anni Venti presenta pochi scarti in direzione espressiva, e modeste aperture verso nuove dimensioni narrative o tematiche. Vive di rendita, assorbe e riproduce quello che viene fatto altrove, non arricchisce il suo sistema che in misura minima o pressoché nulla, anche per la crisi che colpisce tutte le strutture. Le maestranze e gli uomini di cinema sono gli stessi del decennio precedente. Per quanto si possa essere generosi, ben poche opere del decennio Venti-Trenta reggono al confronto del film medio straniero. Ci si trova di fronte a contributi che si sovrappongono, ma non si unificano o non inventano una nuova tendenza in un momento in cui tutte le altre maggiori cinematografie subiscono la massima tensione interna. Non dimentichiamoci che nel decennio in cui in Italia Pittaluga mantiene in piedi la produzione a suon di Maciste e Gustavo Lombardo porta Leda Gys al suo massimo successo divistico, in Germania escono uno dopo l’altro i capolavori dell’espressionismo di Wiene, Lang, Murnau, negli Stati Uniti Chaplin realizza Il monello e La febbre dell’oro, von Stroheim Rapacità, Keaton Il generale, Vidor La grande parata, in Francia Léger gira Il balletto meccanico e Clair Entr’acte, nell’Unione Sovietica Vertov, Ejzenštejn, Pudovkin, Aleksandrov, Dovženko, Kozintsev e Trauberg realizzano le opere che tutti conoscono, Dreyer gira Giovanna d’Arco, Buñuel Un chien andalou. Gli anni Venti sono gli anni di massima espansione espressiva e produttiva del cinema muto mondiale, quelli in cui il cinema italiano tocca il massimo della sua afasia e della sua regressione linguistica. Il decennio di crisi segna un inevitabile slittamento nei soggetti della produzione media. Spariscono le grandi avventure produttive dispendiose e incapaci di riattizzare un revival redditizio, sparisce la letteratura dannunziana, sostituita da Guido Da Verona e Luciano Zuccoli, rimane in vita il romanzo popolare, il feuilleton, il dramma borghese, il vaudeville, la pochade, il repertorio teatrale che da Dumas figlio porta fino a Sardou e agli italiani rappresentanti del grottesco. Ci si comincia anche a ispirare a Pirandello. La trasformazione del repertorio la si può vedere seguendo gli ultimi fuochi delle parabole delle maggiori dive, Bertini, Menichelli, Boni, De Liguoro, ecc. La Bertini inizia forse la sua parabola discendente a partire da La piovra di Eduardo Bencivenga del 1919 in cui interpreta il personaggio di Maria Tarnowka una nobildonna veneziana assurta qualche anno prima ai fasti della cronaca nera per aver assassinato il proprio amante. In questo caso la piovra non è la protagonista femminile bensì il malvagio barone Petrovic. Pina Menichelli dai drammi del Padrone delle ferriere di Eugenio Perego (1919) e di Storia di una donna e del Romanzo di un giovane povero di Palermi (1920), giunge a Feydeau di La dame de Chez Maxim’s diretto nel 1923 da Palermi. Guido da Verona fornisce il soggetto a La donna che inventò l’amore (1918), autori del teatro 18
dell’Ottocento come Testoni, Torelli, Giacometti vengono avvicinati al pari di esponenti contemporanei del teatro grottesco (Antonelli, Chiarelli, Sem Benelli). Tra il 1918 e il 1921, la Bertini realizza un film dopo l’altro, rinnovando il suo repertorio, ma rimanendo ormai decisamente fuori dalla comprensione del momento storico che la circonda. Le sue ultime fortune coincidono con quelle dell’Unione cinematografica. La sua rottura del contratto, in seguito al matrimonio, coincide emblematicamente con la fine del progetto suicida dell’Uci e con la morte della cinematografia italiana muta. Il repertorio si rinnova, ma come si vede non riparte da zero, non scopre nuovi orizzonti, non rinnova le proprie tematiche: i nuovi sceneggiatori si chiameranno Alessandro De Stefani, Aldo De Benedetti, Guglielmo Giannini, Gioacchino Forzano, Enrico Roma, ma, dal loro lavoro, l’ottica sul sociale verrà di poco spostata. Al centro dell’obiettivo non sono più i nobili, ma la loro presenza è comunque assicurata. Il demi-monde acquisisce i vizi e le caratteristiche proprie dell’alta aristocrazia del cinema precedente. Appaiono, in modo più massiccio, i mezzi della nuova civiltà tecnologica, l’aereo soprattutto (si pensi al Mistero dell’aviatore di Eduardo Bencivenga del 1920), ma i produttori superstiti continuano a ignorare la cultura del destinatario e a lasciarsi soppiantare sul mercato dalla produzione americana, nessun film d’avventura si pone come modello i film con Douglas Fairbanks, nessun divo riesce a competere con Rodolfo Valentino, nessun titolo aspira a contendere veramente al cinema americano la leadership narrativa e spettacolare. Curiosa e del tutto ignorata fino a che Vittorio Martinelli non l’ha riportata alla luce l’esperienza cinematografica di Pietro Silvio Rivetta, meglio conosciuto come Toddi, scrittore, pittore, cartellonista, e non ultimo regista nei primi anni Venti di una quindicina di titoli di lungo e corto metraggio di vario successo da Il castello delle cinquantasette lampade del 1920 a Italia, paese di Briganti? e Dva sagapà parà (Due scarpe fanno un paio) del 1923 . Il mancato rinnovo dei quadri a tutti i livelli fa sì che le acquisizioni espressive delle altre cinematografie, sia sul piano linguistico, che narrativo e recitativo, penetrino piuttosto lentamente e non dinamizzino il sistema, ma siano assimilate nelle singole opere. In questo senso di singolare interesse il remake di Le confessioni di una donna: realizzato da Amleto Palermi nel 1927 rivela non pochi prestiti sul piano dell’illuminazione e dell’inquadratura dall’espressionismo. Quanto al racconto, la sua struttura spezzata da continui flashback con passaggi del ruolo dell’io narrante, dalle pagine del diario della protagonista alla rievocazione da parte di personaggi di contorno. Le didascalie sono ridottissime e il montaggio organizza una narrazione visiva servendosi in modo totale delle possibilità e della dinamica della macchina da presa. Il regista che negli anni Venti allarga la sua competenza e meglio regge alla sfida con il cinema di altri paesi è Genina. La sua filmografia è variegata e il suo stile si sa mettere al servizio della storia con grande semplicità. Genina può passare con scioltezza dal melodramma alla commedia brillante, dalla trascrizione di un importante testo del teatro del grottesco come La maschera e il volto (1919) , tratto dall’omonima commedia del 1916 di Luigi Chiarelli o Lo scaldino (1920) su testo di Pirandello, o del capolavoro letterario o del film storico, ma ciò che gli interessa è l’esplorazione della lotta eroica del mondo femminile per emanciparsi, per affermare contro tutto e tutti le leggi del cuore e della sua sconfitta a opera dei condizionamenti sociali, religiosi… La maschera e il volto gli dà l’opportunità di esplorare nuove possibilità di salvezza, per quanto paradossali. La critica – anche quando rifiuta gli intrecci o le storie – dimostra di apprezzare la regia per «la rara perizia e il notevole buon gusto», per il «garbo», per «l’ottima messa in scena», ma sottolinea anche la difficoltà a rendere con le sole immagini lo spirito di un’opera teatrale sostanzialmente fondata sulla parola. Per Il corsaro (1923) la sua regia ha avuto agli occhi di un critico il merito di dare «un’anima vibrante» all’interpretazione, e a segnare una grande vittoria per l’arte cinematografica nazionale. Di fatto – se osserviamo l’insieme dei film del periodo – ci si accorge che hanno ragione i suoi esegeti più autorevoli, Martinelli e Germani, nel chiarire come «i suoi film svelano ossessioni private, continuamente ritornanti, che interessano perché coincidono sorprendentemente con le ossessioni del cinema». Se osserviamo la sua filmografia lungo l’arco del decennio si constata facilmente come a lui la produzione affidi tutti i progetti più ambiziosi e impegnativi e come lui ripaghi questa fiducia con una serie di successi: La maschera e il volto, Le avventure di Bijou, Lo scaldino, Cirano di Bergerac… Di grande intensità e modernità stilistica Il focolare spento del 1925, sospeso tra il rispetto di valori arcaici e 19
20
il mito dell’artista e della vita parigina di bohème. Addio giovinezza! del 1927, film tuttora molto fresco, suscita l’entusiasmo del giovane Blasetti e Scampolo dell’anno successivo di produzione tedesca, tratto da una commedia del 1915 di Dario Niccodemi e interpretato da Carmen Boni, in una ricerca sempre più evidente di nuovi modelli interpretativi. Sarà Genina che con Prix de beauté del 1929, girato in Francia, riuscirà ad agire da pontifex del cinema europeo, sia legando il muto al sonoro, il divismo americano a quello europeo, a trasferire sullo schermo nel modo più convincente un nucleo importante del pensiero pirandelliano sulla modernità, a interpretare le nuove forme del divismo e a effettuare un innesto del melodramma in una storia realistica, ripresa quasi con gusto documentario. Nonostante il successo di molti film di Genina il cinema italiano si inabissa comunque anno dopo anno. La produzione del quinquennio che precede il sonoro non lascia che modeste tracce nel quadro dell’evoluzione del cinema mondiale: tra i titoli che si possono recuperare (un Frate Francesco di Antamoro, Beatrice Cenci e Giudittae Oloferne) per dimostrare come l’invenzione sia ormai paralizzata assieme alla produzione, sono da ricordare per ragioni diverse due film: Kiff Tebbi di Mario Camerini del 1928 e Il vetturale del Moncenisio del 1927. Del Vetturale che costituisce uno dei vertici dell’impegno produttivo della Pittaluga è opportuno riportare un giudizio d’epoca che coincide con il senso di tutto questo discorso: «Il Vetturale […] – è scritto su ‘Cinemalia’ – è senza dubbio un film fatto con molta larghezza di intenti e di mezzi. Per tutto il resto è un ottimo film di dieci anni fa, impenetrabile, impermeabile alle nuove correnti che dall’America e anche dalla Germania urgono ogni giorno più vive» . Kiff Tebbi, tratto dal romanzo omonimo di Luciano Zuccoli, si collega invece a quel filone della letteratura coloniale assai fiorente negli anni Venti . Il suo modello cinematografico di riferimento è Atlantide di Jacques Feyder del 1921. Il film prodotto dall’Adia viene girato in esterni dal vero in Tripolitania e l’operatore, Ferdinando Martini, rivela una discreta conoscenza delle tecniche del cinema straniero contemporaneo. Dalla stampa dell’epoca viene giudicato ora come «il canto del cigno della nostra cinematografia» («La vita cinematografica») ora come «il primo film della rinascita» («Cinemalia»). Di fatto segna l’emergere di una nuova personalità registica destinata ad assumere un ruolo di protagonista fin dai primi concreti sintomi di ripresa produttiva. Camerini per la verità aveva già avuto modo di mettere in luce le sue qualità soprattutto con Voglio tradire mio marito! del 1925, una sorta di versione italiana del film di successo di Cecil B. DeMille con Gloria Swanson Why Change Your Wife?. Il film ha anche un buon successo all’estero e oltre al consenso critico ottiene un premio governativo, una tantum, di 50.000 lire. Un paio d’anni più tardi Camerini realizza per la Sacia Rotaie, opera che, assieme a Sole, conclude il periodo del muto e già si può porre all’inizio di una nuova fase della storia del cinema italiano. Rotaie esce nel 1931 in una versione sonorizzata, ma la sua importanza è proprio in questo essere un’emblematica opera di confine: chiude tutta un’esperienza storica mostrando un tipo di cultura cinematografica in questo giovane regista già influenzata dalle contemporanee esperienze del cinema europeo, americano e sovietico. «Se nel 1929 il cinema italiano non fosse stato in piena decadenza probabilmente – ha scritto Francesco Pasinetti – Rotaie non sarebbe mai nato» . Chiaro esempio di produzione povera il film sa mettere a frutto la lezione espressiva del Kammerspiel, anzitutto, impostando tutta la prima parte della vicenda nel chiuso di una stanza d’albergo in cui la giovane coppia di innamorati, condotta alla disperazione dalla mancanza di lavoro, decide di suicidarsi. Entra in quest’opera l’unico accenno di tutto il cinema italiano alla situazione della crisi economica mondiale del 1929, anche se il problema sembra di carattere individuale e non si manifesta in modo esplicito nel sociale. La struttura narrativa del film è divisa in tre parti e a ognuna corrisponde una diversa scelta e influenza stilistica: se la prima parte risente della lezione espressionista sia nell’uso delle luci e delle ombre che nella valorizzazione simbolica degli oggetti, la seconda parte è influenzata dalla commedia sofisticata americana degli anni Venti e rivela già quel tocco di brillante satira sociale e quella capacità di osservazione del demi-monde che saranno tra le caratteristiche più tipiche del lavoro successivo di Camerini . I due giovani a cui la fortuna ha messo in mano casualmente un’insperata ricchezza la perdono al gioco in un Casinò della Costa Azzurra e vedono poi messi alla prova i loro stessi sentimenti. Tornati senza una lira decidono di trovare lavoro in fabbrica e su questa prospettiva sociale il film trasmette la sua morale positiva. Tutta l’ultima parte, per la netta caratterizzazione dei volti degli operai e per la rappresentazione del lavoro 21
22
23
24
all’interno della fabbrica, risente, sia pure indirettamente, di influssi del cinema sovietico. Per la prima volta appaiono degli autentici operai nel cinema italiano, così come nello stesso periodo appaiono i contadini nel film di Blasetti. Rispetto a Blasetti il film di Camerini rivela già un buon livello professionale, una cultura cinematografica aggiornata e una particolare abilità di ambientazione (oltre alle riprese in fabbrica vanno segnalate le riprese della riviera dal treno in corsa e quelle dei passeggeri all’interno della carrozza di terza classe). È buona norma metodologica, fin d’ora, non riconoscere a forza una controstoria del cinema italiano fatta di volti di personaggi popolari, o di tematiche proletarie in quanto non è un atto di opposizione al fascismo avvicinarsi, almeno in certi periodi, al paese reale, anzi. Rotaie e Sole, pur nella relativa modestia dei loro risultati (i due film escono quando in Germania Fritz Lang ha già raggiunto la maturità espressiva con Metropolis, 1927 e Die Frau im Mond, La donna sulla luna, 1929 e sta per imbarcarsi per gli Stati Uniti, o Pudovkin, Ejzenštejn e Vertov hanno realizzato i loro capolavori, le avanguardie hanno giocato le loro carte migliori, Dreyer realizza il suo capolavoro su Giovanna d’Arco…), segnano comunque una svolta nel cinema italiano e interessano anche per la loro improvvisazione produttiva, che pur senza sviluppi ha il merito di imporre all’attenzione due figure di giovani dalle caratteristiche molto ben definite. Dopo l’uscita e il successo di Sole (la casa produttrice del film, l’Augustus, costituita in società anonima con una pubblica sottoscrizione, di un capitale iniziale di 500.000 lire, coperto mediante l’emissione di 5.000 azioni da 100 lire l’una, fallirà in seguito per mancanza di crediti e per il crollo della Banca italo-britannica che aveva garantito fidi bancari per il futuro) , Blasetti, forte del suo successo di critica, tenta degli esperimenti cooperativistici con due progetti di concentrazione di produzione e di esercizio: nel 1929 si forma, per merito suo, il Consorzio italiano produttori, a cui aderiscono la Sacia, l’Adia, la Suprema, e l’Augustus, in parallelo, il Consorzio cinematografi indipendenti. Entrambi questi progetti non hanno alcuna vita, abortiscono dopo poco, sia perché l’Augustus fallisce, sia perché Pittaluga offre, di lì a poco, a Blasetti, di entrare a far parte della sua casa di produzione. A pochi mesi di distanza dalla prima di Sole, Blasetti scrive un ennesimo rapporto sulla cinematografia italiana ed elenca tutta una serie di mali: sul piano dell’esercizio: 1) crisi per il ritardo culturale e spettacolare della produzione; 2) eccessivo aumento del numero delle sale; 3) eccessiva pressione fiscale. Sul piano della produzione: 1) quadri vecchi e sorpassati; 2) discredito amministrativo (è ancora nell’aria oltre al ricordo dell’Uci quello di uno scandalo per una speculazione fondiaria che pone fine alla vita dell’Ente nazionale per la cinematografia); 3) scarse possibilità di utilizzazione del mercato nazionale; 4) scarse possibilità di esportazione; 5) modesto interesse da parte degli organismi economici a investire in una industria non remunerativa. Quanto alle cause della crisi dell’importazione e del noleggio per Blasetti sarebbero le seguenti: 1) sistemi commerciali antiquati; 2) numero eccessivo di ditte; 3) concorrenza formidabile delle maggiori case americane e della Pittaluga . La diagnosi non porta nuovi elementi rispetto ai motivi individuati lungo tutto il decennio precedente e tutto sommato le proposte avanzate risultano piuttosto macchinose . Il lavoro di Blasetti, sul piano della battaglia critica, si spinge fino alle soglie del sonoro attivando però una serie di forze e di reazioni a catena che, integrandosi in un sistema produttivo organizzato poco alla volta, avranno la possibilità di produrre delle reali modifiche e di favorire l’attesa e invocata «rinascita». Grazie soprattutto a lui da una parte e a Pittaluga dall’altra emerge una volontà di trovare nuove vie italiane e diverse spinte imprenditoriali per una forma di spettacolo che, grazie all’invenzione del sonoro, costringe all’improvviso tutte le cinematografie – in crisi o in piena salute – e tutti gli autori a reinventare le regole del gioco e a riprendere il cammino da un’ideale linea di partenza comune. 25
26
27
1
Ha compiuto questa impresa V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film del dopoguerra, 4 voll., Ed. Bianco e Nero, Roma 1980-1981.
Anche se si sono moltiplicati i contributi critici e le ricerche storiche che hanno fatto avanzare le conoscenze, non si è ancora tentato un lavoro di confronto con le diverse cinematografie concorrenti, per vedere soprattutto come, nonostante la crisi e l’arresto linguistico, la produzione italiana non fosse del tutto all’oscuro degli esiti delle altre cinematografie e come i debiti e le interazioni o le influenze si potessero cogliere molto bene nei film di Genina o di Camerini. 2
Il film, diretto da Ugo Falena, si avvale delle scenografie di Duilio Cambellotti che aveva lavorato anche per Frate sole di Mario Corsi. Cfr. R. Redi (a cura di), Giuliano l’Apostata di Ugo Falena, in «Bianco e Nero», a. XLVI, n. 3, luglio-settembre 1985. 3
La prima vera monografia sul regista è di V. Martinelli e S.G. Germani, Il cinema di Augusto Genina, Biblioteca dell’immagine, Pordenone 1990. 4
5
F. Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935, pp. 211-223.
In occasione del restauro del film a opera della Cineteca nazionale è uscito un catalogo assai illustrato e ricco di informazioni: R. Redi (a cura di), Gli ultimi giorni di Pompei, Electa, Napoli 1994. 6
E. Ghione, La parabole du cinéma italien, in «L’Art cinématographique», VII, 1930, p. 68. Si vedano anche le pagine dedicate a Roma antica in G.M. Gori, Patria diva, la storia d’Italia nei film del ventennio, La Casa Usher, Firenze 1988, pp. 16-19. Il saggio di Ghione è ampiamente ricordato da P. Cherchi Usai, Le dernier jours… cit. p. 32. 7
8
E.F. Palmieri, Vecchio cinema italiano, in AA.VV., Cinquant’anni di cinema italiano, Bestetti, Roma 1954, p. 31.
9
Cfr. A. Farassino e T. Sanguineti, Gli uomini forti, Mazzotta, Milano 1983.
10
G.C. Castello, Il divismo, ERI, Torino 1957, p. 49.
11
V. Martinelli, Bartolomeo Pagano, l’incarnation d’un mythe, in M. Dall’Asta, Un cinéma musclé, Yellow Now, Crisnée 1991, pp. 209-213.
12
M. Quargnolo, Luciano Albertini, un divo degli anni venti, Csu, Udine 1977, p. 22.
13
La filmografia è ivi, pp. 15-16.
14
V. Martinelli, Silvio Laurenti Rosa, le opere e i giorni, in «Cahiers de la cinémathèque», n. 26-27, 1979.
Gustavo Lombardo è l’unico produttore a non essere travolto dalla crisi del dopoguerra: con discreta intelligenza realizza dei prodotti che hanno successo e una buona rete di distribuzione nazionale e impone, per quasi un decennio, l’immagine divistica della moglie. Cfr. P. Bianchi, La Bertini e le dive del cinema muto, Utet, Torino 1969, pp. 179-183. 15
A. Bernardini e V. Martinelli, Leda Gys attrice, Coliseum, Roma 1987; si veda anche A. Bernardini, La nascita della Titanus di Gustavo Lombardo, Marsilio, Venezia 1986, pp. 201-210. 16
17
V. Martinelli, Primi approcci tra cinema e fascismo, in «Immagine», a. IV, n. 2, fasc. X, aprile-giugno 1985, pp. 7-12.
18
Sul lavoro di Genina in Germania negli anni Venti si veda il capitolo di F. Bono, Italianer a Berlino. Augusto Genina e la Nero-Film, in Id.,
Casta Diva & Co., Sette città, Viterbo 2004, pp. 15-38. 19
V. Martinelli, Toddi e il cinema, in «Archives», nn. 41-42, mai-juin 1991.
Si veda A. Costa, La maschera e il volto. Genina, Chiarelli e il teatro del grottesco, in Id., I leoni di Schneider, Bulzoni, Roma 2002, pp. 101-125. 20
21
Martinelli, Silvio Laurenti Rosa, le opere e i giorni, cit.
22
P. Cherchi Usai, Mario Camerini in Africa, Maciste contro lo sceicco e Kiff Tebbi, in «Cinegrafie», a. I, n. 2, II semestre 1989, pp. 93-102.
23
F. Pasinetti, Rotaie, in «Cinema», a. III, n. 59, 10 dicembre 1938.
A Camerini il Festival di Locarno ha dedicato nel 1992 la più ampia e rigorosa retrospettiva mai organizzata. Ai curatori, Alberto Farassino e Sergio G. Germani si deve anche il catalogo, Mario Camerini, Yellow Now, Locarno 1992 con saggi di Steve Ricci, Jean Gili, Guido Fink, Bernard Einsenschitz e testimonianze e materiali d’archivio di prima mano. 24
L. Quaglietti, Il cinema degli anni trenta in Italia, Quaderno informativo n. 63 della Mostra internazionale del cinema di Pesaro, 1976, p. 287. 25
A. Blasetti, Diritto di commercio al produttore, in «Il Tevere», 29 settembre 1929, e anche in «Cinematografo», a. III, n. 19, settembre 1929. 26
Blasetti propone di concedere una sorta di biglietto di commercio e di diritto di importazione ai produttori di film italiani in una certa proporzione rispetto ai film realizzati. Il discorso è del tutto utopico, perché mirerebbe a ridare ossigeno alle piccole produzioni indipendenti consentendo loro di importare un certo numero di film stranieri, nel momento in cui sono tutte o fallite o in via di fallimento. 27
Bibliografia
Opere di carattere generale R. Mattozzi, Rassegna generale della cinematografia, Roma 1920. M. Coissac, Histoire du cinématographe de ses origines à nos jours, Ed. du Cineopse, Paris 1925. E.M. Margadonna, Cinema ieri e oggi, Prefazione di A. Gerbi, Domus, Milano 1932. Ist. N. Luce, Origini, organizzazione e attività dell’Istituto Nazionale Luce, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1934. L. Madaro, Bibliografia fascista, Mondadori, Milano 1935. F. Pasinetti, Storia del cinema dalle origini ad oggi, Ed. Bianco e Nero, Roma 1939.
J. Comin, Cinematografo, in Partito nazionale fascista. Dizionario di Politica, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 1940. N. Ottavi, L’industria cinematografica e la sua organizzazione, Ed. Bianco e Nero, Roma 1940. E.F. Palmieri, Vecchio cinema italiano, Zanetti, Venezia 1940. F. Pasinetti, Mezzosecolo di cinema, Il Poligono, Milano 1946. G. Sadoul, Histoire générale du cinéma, 6 voll., Denoël, Paris 1946-1975 (trad. it. Storia generale del cinema, Einaudi, Torino 1965-1978). C.F. Cuenca, Historia del cine, Aguado, Madrid 1948. L. Freddi, Il cinema, 2 voll., L’Arnia, Roma 1949. C. Vincent, Storia del cinema, Garzanti, Milano 1949. N. Frank, Cinema dell’arte, A. Bonne, Paris 1951. V. Jarrat, The Italian Cinema, Falcon Press, London 1951. M.A. Prolo, Storia del cinema muto italiano, il Poligono, Milano 1951. AA.VV., Cinquant’anni di cinema italiano, Bestetti, Roma 1952. L. Rognoni, Cinema muto, Ed. Bianco e Nero, Roma 1952. M. Verdone, Gli intellettuali e il cinema, Ed. Bianco e Nero, Roma 1952. C. Lizzani, Il cinema italiano, Parenti, Firenze 1953. C. Vincent, Bibliografia generale del cinema, Ateneo, Roma 1953. AA.VV., Enciclopedia dello spettacolo, Le maschere, Roma 1954-1962. M. Gromo, Cinema italiano, 1903-1953, Mondadori, Milano 1954. A. Menarini, Il cinema nella lingua. La lingua nel cinema, Bocca, Milano 1955. R. Paolella, Storia del cinema muto, Giannini, Napoli 1956. P. Bianchi e F. Berutti, Storia del cinema, Garzanti, Milano 1957. G.C. Castello, Ildivismo, Eri, Torino 1957. AA.VV., Filmlexicon degli autori e delle opere, Ed. Bianco e Nero, Roma 1958. G.C. Castello, Storia del cinema, Il cinema muto, I vol., Centro sperimentale di cinematografia, Roma 1958. L. Solaroli, Storia economica dell’industria cinematografica italiana, in L. Solaroli (a cura di), Cinema come industria, Feltrinelli, Milano 1958. L. Solaroli e L. Bizzarri, L’industria cinematografica italiana, Parenti, Firenze 1958. L. Ghirardini, Storia generale del cinema, Marzorati, Milano 1959. C. Lizzani, Storia del cinema italiano, Parenti, Firenze 1961. F. Sacchi, La stampa italiana e il cinema nel ventennio, in Fascismo e antifascismo, Feltrinelli, Milano 1962. B. Migliorini, Saggi sulla lingua del novecento, Sansoni, Firenze 1963. J. Mitry, Filmographie universelle, Idhec, Paris 1963. G. Sadoul, Louis Lumière, Seghers, Paris 1964. D. Turconi e C. Bassotto, Il film e la sua storia, Cappelli, Bologna 1964. C.W. Ceram, Archeologia del cinema, Mondadori, Milano 1966. P. Leprohon, Le cinéma italien, Seghers, Paris 1966. R. Paolella, Storia del cinema sonoro, 1926-1939, Giannini, Napoli 1966. D. Turconi e C. Bassotto, Le vite e i film, Ed. Mostra del cinema, Venezia 1966. AA.VV., Storia del cinema, 4 voll., Vallardi, Milano 1966-1967. J. Mitry, Histoire du cinéma, Ed. Universitaires, Paris, vol. I, 1967; vol. II, 1969; vol. III, 1973. D. Turconi e C. Bassotto, Economia, diritto, sociologia del film, Ed. Mostra del cinema, Venezia 1969. D. Turconi e C. Bassotto, Il cinema nelle riviste italiane dalle origini ad oggi, Ed. Mostra del cinema, Venezia 1970. J. Mitry, Storia del cinema sperimentale, Mazzotta, Milano 1971. R. Gubern, Storia del cinema, Liguori, Napoli 1972. E.G. Laura, Il linguaggio della propaganda in un decennio di cinegiornali Luce (ciclostile), Settimana del Cinema di Grado, 1972. ***, Catalogo della biblioteca, Centro sperimentale di cinematografia, Roma 1973. C. Carabba, Ilcinema nel ventennio nero, Vallecchi, Firenze 1974. G.P. Brunetta, Cinema italiano fra le due guerre, Mursia, Milano 1975. C. Bragaglia, Crisi della cultura e dialettica delle idee, in AA.VV., L’Emilia Romagna nella guerra di liberazione, De Donato, Bari 1976. G. Rondolino, Il cinema astratto. Testi e documenti, Stampatori, Torino 1977. G. Rondolino, Storia del cinema, 3 voll. Utet, Torino 1977 (1988). D. Turconi, La stampa cinematografica in Italia e negli Stati Uniti, Amministrazione provinciale di Pavia, Pavia 1977. A. Aprà, Notes on the Unknown Cinema, Museum of Modern Art, New York 1978 (ciclostilato). A. Ferrero (a cura di), Storia del cinema, 2 voll., Marsilio, Venezia 1978. A. Barbera e R. Turigliatto, Leggere il cinema, Mondadori, Milano 1979. C. Lizzani, Il cinema italiano, 1895-1979, Editori Riuniti, Roma 1979 (1992).
D. Turconi, Catalogo dei libri italiani di cinema 1898-1960, Amministrazione provinciale di Pavia, Pavia 1979. A. Bernardini, Cinema muto italiano. I.Ambiente spettacoli e spettatori 1896-1904, Laterza, Roma-Bari 1980. V. Martinelli, Ilcinema muto italiano. I filmdel dopoguerra, 4 voll., Ed. Bianco e Nero, Roma 1980-1981. AA.VV., Il cinema, De Agostini, 10 voll., Novara 1981-1984. A. Bernardini, Cinema muto italiano. II.Industria e organizzazione dello spettacolo 1905-1909, Laterza, Roma-Bari 1981. A. Bernardini, Cinema muto italiano. III.Arte divismo e mercato 1910-1914, Laterza, Roma-Bari 1981. U. Carpi, Bolscevismo immaginista, Liguori, Napoli 1981. H.P. Manz, Internationale Filmbibliographie, Filmland, Monaco 1981. G. Bernagozzi, Fascismo violenza consenso, in A. Cottafavi (a cura di), Cinema e storia, Comune di Modena, Modena 1982, pp. 14-23. D. Turconi e A. Sacchi, Bianconero rosso e verde, Immagini del cinema italiano, 1910-1980, La Casa Usher, Firenze 1983. V. Tosi, Il cinema prima dei Lumière, Eri, Torino 1984. AA.VV., Cinema & Film, Curcio, 8 voll., Roma 1986-1988. A. Bernardini e J. Gili (a cura di), Le cinéma italien 1905-1945. De La prise de Rome à Rome ville ouverte, Centre Pompidou, Paris 1986. E. Magrelli, Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia 1986. ***, Leggere il cinema. Le storie, i generi, Editrice bibliografica, Pavia 1987. R. Ellero, Venezia città del cinema, in AA.VV., Venezia Arti, Università di Venezia, Venezia 1987. E. Toulet (a cura di), Bibliografie internationale du cinéma des premiers temps, (ciclostilato), s.l. 1987. ***, Leggere il cinema. I registi, Editrice bibliografica, Pavia 1988. G. Bendazzi, Cartoons: il cinema d’animazione 1888-1988, Marsilio, Venezia 1988. G. Fofi, M. Morandini e G. Volpi, Storia del cinema, 4 voll., Garzanti, Milano 1988. E. Spiess, Direttori di Fotografia, Scenografi e Costumisti del cinema italiano dalle origini al 1986, G.H. Saur, München 1988. ***, Leggere il cinema. Dieci anni di libri 1979-1988, Editrice bibliografica, Pavia 1989. G.P. Brunetta, Buio in sala, Marsilio, Venezia 1989. ***, Leggere il cinema: gli attori, Editrice bibliografica, 1990. F. Di Giammatteo, Dizionario universale del cinema, 2 voll., Editori Riuniti, Roma 1990. P. Micheli, Il cinema di Blasetti parlò così, Bulzoni, Roma 1990. ***, Leggere il cinema: soggetti e sceneggiature, Editrice bibliografica, Milano 1991. A. Bernardini, Ilcinema muto, Anica, Roma 1991. G.P. Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, Laterza, Roma-Bari 1991. P. Cherchi Usai, Una passione infiammabile. Guida allo studio del cinema muto, Utet, Torino 1991. V. Martinelli, Il cinema muto italiano.I film della grande guerra. 1917, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1991. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film della grande guerra. 1918, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1991. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film della grande guerra. 1915, prima parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1992. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film della grande guerra. 1915, seconda parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1992. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film della grande guerra. 1916, prima parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1992. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film della grande guerra. 1916, seconda parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1992. R. Redi, Cinema scritto. Il catalogo delle riviste italiane di cinema 1907-1944, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1992. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1914, prima parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1993. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro, 1914, seconda parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1993. A. Bernardini e V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1913, prima parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1994. A. Bernardini e V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1913, seconda parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1994. A. Bernardini, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1912, prima parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1994. A. Bernardini e V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1911, prima parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1995. A. Bernardini, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1912, seconda parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1995. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film del dopoguerra, 1919, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1995. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti, 1920, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1995. A. Bernardini e V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni d’oro. 1911, seconda parte, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1996. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti, 1921, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1996. V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti. 1922-1923, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1996.
V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti. 1924-1931, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1996. A. Bernardini, Il cinema muto italiano. I film dei primi anni, 1905-1909, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1996. A. Bernardini, Il cinema muto italiano. I film dei primi anni, 1910, Nuova ERI CSC, Torino Roma 1996. G.P. Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, I-V, Einaudi, Torino 1999-2002. G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, Einaudi, Torino 2003.
Monografie e saggi apparsi in volume G. Re, Ilcinematografo e i suoi accessori, Hoepli, Milano 1907. G. Guadagnini, La censura degli spettacoli cinematografici, Tipografia delle Mantellate, Roma 1918. T. Alacci, Le nostre attrici cinematografiche, Bemporad, Firenze 1919. L. Delluc, Cinema et Cie, Grasset, Paris 1919. E. Giovannetti, Figure mute, Quartara, Torino 1919. L. Delluc, Photogenie, Brunhof, Paris 1920. F.N. Lodi, L’arte muta, in Annali del teatro italiano, a cura di M. Ferrigni, vol. I, 1901-1920, C. Aliprandi, Milano 1920. U. Tiranty, La cinematografia e la legge, Bocca, Milano 1921. A. Varaldo, Profilidi attrici e attori, Bemporad, Firenze 1926. G. Ardau, L’eloquenza mussoliniana, Mondadori, Milano 1929. M. Doletti, Cinematografo. Profili, biografie e aneddoti di novanta divi dello schermo, Stab. Pol. Riuniti, Bologna 1929. M. Baffico, Dei e semidei del novecento, Forlini, Milano 1930. L. De Feo, L’activité de l’Institut international de cinématographie educative, Roma 1930. A. Sardi, Cinque anni di attività dell’Istituto nazionale Luce, Grafica, Roma 1930. AA.VV., XLAnniversario della cinematografia (1895-1935), numero unico, Sottosegretariato per la stampa e propaganda, Roma 1935. L. Chiarini, Cinematografo, Cremonese, Roma 1935. U. Ferrari, La legislazione italiana sul cinematografo, in Moralità e cinematografo, Milano 1935. F. Soro, Splendori e miserie del cinema, Consalvo, Milano 1935. U. Barbaro, Nascita del film d’arte, ivi. ***, Il cinematografo e il teatro nella legislazione fascista, C. Colombo, Roma 1936. L. Cavalieri, Le mie verità, Soc. Anonima Poligrafica Italiana, Roma 1936. D. Paolella, Il cinema sperimentale, Casa Editrice Moderna, Napoli 1937. T. Antongini, Vitasegreta di Gabriele D’Annunzio, Mondadori, Milano 1938. V. Araldi, Cinema arma del tempo nostro, La Prora, Milano 1939. F. Mazzotti Biancinelli ed E. Scarpa, Venti anni di arte muta, Alari, Milano 1939. AA.VV., Vita dei Guf (a. XVI-XVII), s.e., Roma 1940. E. Ceretti, Pagine scelte sul cinema, s.e., Milano 1940. N. Ottavi, L’industria cinematografica italiana, Ed. Bianco e Nero, Roma 1940. AA.VV., Cinema italiano Anno XIX, Direzione generale per la cinematografia, Roma 1941. AA.VV., Stile italiano nel cinema, Daria Guarnati, Milano 1941. H. Ellwanger, Sulla lingua di Mussolini, Mondadori, Milano 1941. D. Lazzaro, Cineguida, Soc. Anonima Poligrafica Italiana, Roma 1941-1942-1943. E.F. Palmieri, La frusta cinematografica, Il Resto del Carlino, Bologna 1941. L. Civardi, Cinema e morale, AVE, Roma 1945. M. Lapierre, Anthologie du cinéma, La Nouvol Edition, Paris 1946. G. Martello, Ferravilla e il cinema, in Ferravilla, Bestetti, Milano 1946. A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi 100 anni, Einaudi, Torino 1948. S. Guarnieri, Cinema e letteratura, Parenti, Firenze 1955. ***, Cines 1906-1956, Mezzo secolo di cinema italiano, Servizio stampa della Cines, Roma 1956. E. Morin, Les Stars, Ed. du Seuil, Paris 1957. U. Barbaro, Servitù e grandezza del cinema, Editori Riuniti, Roma 1961. Ben M. Hall, The Best Remaining Seats, C.N. Potter, New York 1961. E.G. Laura, La censura cinematografica, Ed. Bianco e Nero, Roma 1961. D. Meccoli (a cura di), Il Risorgimento italiano nel teatro e nel cinema, Editalia, Roma 1961. G. Cincotti, Risorgimento nel cinema dalle origini agli anni cinquanta, ivi. E. Stringa, La legislazione prefascista (1913-1922), in AA.VV., La porpora e il nero, Ed. Cinema Nuovo, Milano 1961. E. Baragli, Cinema e cattolici, Ed. Lice, Padova 1962. AA.VV., Il film storico italiano e la sua influenza sugli altri paesi, Ed. Bianco e Nero, Roma 1963. F. Alberoni, L’élite senza potere. Ricerca sociologica sul divismo, Vita e pensiero, Milano 1963. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Bari 1963.
E. Baragli, Gli strumenti della comunicazione sociale, Udaci, Roma 1964. A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino 1965. E. Baragli, Cinema cattolico, Città Nuova, Roma 1965. O. Caldiron, Il lungo viaggio del cinema italiano, Marsilio, Padova 1965. K. Mac Gowan, Behind the Screen, Delta, New York 1965. J. Pantieri, Gli eroi della risata, Giordano, Milano 1965. R. De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere, Einaudi, Torino 1966. F. Fornari, Psicanalisi della guerra, Feltrinelli, Milano 1966. L. Salvatorelli e G. Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino 1966. G. Tinazzi (a cura di), Ilcinema italiano dal fascismo all’antifascismo, Marsilio, Padova 1966. G. Calendoli, Materiali per una storia del cinema italiano, Maccari, Parma 1967. M. David, La psicanalisi nella cultura italiana, Boringhieri, Torino 1967. F. Gambetti, Gli anni che scottano, Mursia, Milano 1967. R. Renzi, DaStarace ad Antonioni. Diario critico di un ex balilla, Marsilio, Padova 1967. R. Papa, Storia di due manifesti, Feltrinelli, Milano 1968. M. Verdone, Cinema e letteratura del futurismo, Ed. Bianco e Nero, Roma 1968. E. Baragli, La Chiesa e il cinema, Ed. Paoline, Roma 1969. E. Baragli, L’Inter mirifica, Studio romano della comunicazione sociale, Roma 1969. F. Bertini, Il resto non conta, Giardini, Pisa 1969. P. Bianchi, La Bertini e le dive del cinema muto, Utet, Torino 1969. G.P. Brunetta, Umberto Barbaro e l’idea di neorealismo, Liviana, Padova 1969. R. De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Laterza, Bari 1969. D. Fernandez, Il mito dell’America negli intellettuali italiani, Sciascia, Roma 1969. P. Leglise, Histoire de la politique du cinéma français, Lherminier, Paris 1969. V. Paliotti ed E. Grano, Napoli nel cinema, Azienda autonoma di soggiorno, Napoli 1969. G. Salvemini, L’Italia vista dall’America, voll. I e II, a cura di E. Tagliacozzo, Feltrinelli, Milano 1969. V. Castronovo, La stampa italiana dall’unità al fascismo, Laterza, Bari 1970. G. Le Bon, Psicologia delle folle, Longanesi, Milano 1970. V. Lindsay, The Art of the Moving Pictures, Liveright, New York 1970. C. Pathé, De Pathé frères à Pathé cinéma, Serdoc, Lion 1970. M. Vascon Vitrotti, Un pioniere del cinema, Giovanni Vitrotti, Trieste 1970. A. Enzi, Lessico della violenza nella Germania nazista, Pátron, Bologna 1971. R. Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della Ricostruzione, Ed. di Ideologie, Roma 1971. F. Paulon, La dogaressa contestata, Paulon, Venezia 1971. G.P. Brunetta, Intellettuali, cinema e propaganda tra le due guerre, Pátron, Bologna 1972. C.F. Cuenca, Segundo de Chomon, Editora National, Madrid 1972. A. Hamilton, L’illusione fascista. Gli intellettuali e il fascismo: 1919-1945, Mursia, Milano 1972. F. Savio, Visione privata, Bulzoni, Roma 1972. R. Villari, Il capitalismo italiano nel Novecento, Laterza, Bari 1972. G.P. Bernagozzi, Propaganda di regime e giudizio della storia, Deputazione Emilia Romagna, Bologna 1973. G. Calendoli, Il cinema italiano dagli inizi del sonoro alla fine della guerra (ciclostile), Padova 1968 e poi in volumetto, Verona 1973. N. Carducci, Gli intellettuali e l’ideologia americana nell’Italia letteraria degli anni Trenta, Lacaita, Manduria 1973. E. Guidorizzi, Il cinema e la narrativa, Sansoni, Firenze 1973. B. Lawton (a cura di), Italian Cinema, Literary and Socio-Political Trends, Center for Italian Studies, Los Angeles 1973. M. Ledeen, Il fascismo universale, Laterza, Bari 1973. U. Silva, Ideologia e arte del fascismo, Mazzotta, Milano 1973. P. Zanotto e F. Zangrando, L’Italia di cartone, Liviana, Padova 1973. AA.VV., Riservato a Mussolini, Feltrinelli, Milano 1974. AA.VV., Settant’anni di cinema, Titanus 1904-1974, Roma 1974. G.P. Brunetta, Nascita del racconto cinematografico. Griffith 1908-1912, Patron, Padova 1974. E. Camurani (a cura di), Rapporti a Mussolini sulla stampa clandestina, Forni, Bologna 1974. C. Carabba, Il cinema del ventennio nero, Vallecchi, Firenze 1974. E. Crispolti, B. Hinz e Z. Birolli, Arte e fascismo in Italia, Feltrinelli, Milano 1974. G.C. Ferretti, Introduzione al neorealismo, Editori Riuniti, Roma 1974. A. Panicali, Fascismo e comunicazioni di massa, in Comunicazioni di massa, a cura di P. Baldelli, Feltrinelli, Milano 1974. M.A. Maciocchi, Elements pour une analyse du fascisme, vol. II, Paris VIII, Vincennes 1974-1975. AA.VV., Materiali sul cinema italiano, 1929-1943, Mostra del Nuovo cinema, Pesaro 1975-76. AA.VV., Retorica e politica, Liviana, Padova 1975.
A. Asor Rosa, La cultura, in Storia d’Italia, vol. IV, Einaudi, Torino 1975. W. Audisio, In nome del popolo italiano, Teti, Milano 1975. G.P. Bernagozzi, Vincere, vinceremo, Deputazione Emilia Romagna, Bologna 1975. C. Bordoni, Cultura e propaganda nell’Italia fascista, D’Anna, Messina-Firenze 1975. G.P. Brunetta, Cinema italiano tra le due guerre, Mursia, Milano 1975. Ph.V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, Laterza, Roma-Bari 1975. J.P. Faye, Introduzione ai linguaggi totalitari, Feltrinelli, Milano 1975. M. Ferro, Analyse de film, analyse de sociétés, Hachette, Paris 1975. S. Guarnieri, Condizione della letteratura, Editori Riuniti, Roma 1975. M. Morandini Il cinema nel decennio, in AA.VV., Arte e fascismo in Italia e Germania, Feltrinelli, Milano 1975. G. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Il Mulino, Bologna 1975. E.R. Tannenbaum, L’esperienza fascista, Mursia, Milano 1975. U. Barbaro, Neorealismo e realismo, a cura di G.P. Brunetta, Editori Riuniti, Roma 1976. F. Bolzoni (a cura di), Un anno di cinema italiano. La teoria e la pratica, Biennale di Venezia, Venezia 1976. F. Bolzoni (a cura di), Il progetto imperiale, La Biennale di Venezia, Venezia 1976. G.P. Brunetta, Letteratura e cinema, Zanichelli, Bologna 1976. G.P. Brunetta, Miti,modelli e organizzazione del consenso nel cinema fascista, Consorzio di pubblica lettura, Bologna 1976. F. Casetti e A. Farassino (a cura di), Libri italiani di cinema, in Nuovimateriali sul cinema italiano, 1929-43, Mostra del cinema di Pesaro, Pesaro 1976, pp. 372-396. R. Corner, Il fascismo a Ferrara, Laterza, Roma-Bari 1976. R. Faenza e M. Fini, Gliamericani in Italia, Feltrinelli, Milano 1976. M.A. Maciocchi (a cura di), Eléments pour une analyse due fascisme, ed. 10/18, Paris 1976. D. Marchesini, La scuola dei gerarchi, Feltrinelli, Milano 1976. E. Monteleone, La radio italiana nel periodo fascista, Marsilio, Venezia 1976. R. Renzi, Il fascismo involontario e altri scritti, Cappelli, Bologna 1976. M.A. Saba, Il dibattito sul fascismo, Longanesi, Milano 1976. S. Chemotti (a cura di), Gliintellettuali in trincea, Cleup, Padova 1977. T. Gasparri (a cura di), La Resistenza in Italia, Guaraldi, Firenze 1977, pp. 214-219. G. Pastrone, Cabiria, a cura di R. Radicati e R. Rossi, Museo del cinema, Torino 1977. P. Puppa, Fantasmi come giganti, Patron, Bologna 1977. M. Quargnolo, Luciano Albertini, un divo degli anni Venti, CSU, Udine 1977. M. Quargnolo, Vecchi cinema udinesi, La Nuova Base, Udine 1977. G. Rondolino (a cura di), Ilcinema astratto. Testi e documenti, Tirrenia stampatori, Torino 1977. D. Turconi (a cura di), La stampa cinematografica in Italia e negli Stati Uniti dalle origini al 1930, Amm. prov. di Pavia, Pavia 1977. ***, Catalogo del Museo nazionale del cinema, Cassa di Risparmio, Torino 1978. E. Lauretta (a cura di), Pirandello e il cinema, Centro di studi pirandelliani, Agrigento 1978. P. Bianchi, L’occhio di vetro, Il Formichiere, Milano 1978. M. Cesari, La censura nel periodo fascista, Liguori, Napoli 1978. M. Corti, Il viaggio testuale, Einaudi, Torino 1978. F. Giocondi, Lettori in camicia nera, D’Anna, Messina-Firenze 1978. A. Lyttelton, La conquista del potere – Il fascismo dal 1919 al 1929, Laterza, Roma-Bari 1978. G.G. Migone, Gli Stati Uniti e il fascismo alle origini dell’egemonia americana in Italia, Feltrinelli, Milano 1978. A. Monticone, Ilfascismo al microfono, Studium, Roma 1978. A. Panicali (a cura di), Bottai. Il fascismo come rivoluzione del capitale, Cappelli, Bologna 1978. T. Perry, Before Neorealism, Museum of Modern Art, New York 1978. S. Raffaelli, Cinema, film, regia: saggi per una storia linguistica del cinema italiano, Bulzoni, Roma 1978. AA.VV., La città del cinema. Produzione e lavoro nel cinema italiano 1930-1970, Napoleone, Roma 1979. AA.VV., Lingua, sistemi letterari, comunicazione sociale, Cleup, Padova 1979. M. Argentieri, L’occhio del regime, Vallecchi, Firenze 1979. G.P. Brunetta, Emilio Ghione, in Catalogo della Mostra internazionale del cinema, La Biennale, Venezia 1979, pp. 8794. J.P. Faye, Critica e economia del linguaggio, Cappelli, Bologna 1979. M. Isnenghi, L’educazione dell’italiano, Cappelli, Bologna 1979. M. Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 1979. R. Monti, Les Macchiaioli et le cinéma, Edition Vilo, Paris 1979. R. Redi (a cura di), Cinema italiano sotto il fascismo, Marsilio, Venezia 1979. AA.VV., Tra una film e l’altra, Marsilio, Venezia 1980. G. Bernagozzi, Ilcinema corto, La Casa Usher, Firenze 1980.
O. Caldiron, La paura del buio, Bulzoni, Roma 1980. R. Campari, Hollywood-Cinecittà, il racconto che cambia, Feltrinelli, Milano 1980. V. Castronovo, L’industria italiana dall’ottocento a oggi, Mondadori, Milano 1980. O. Del Buono e L. Tornabuoni, Era Cinecittà, Bompiani, Milano 1980. C. De Michelis, Alle origini del neorealismo, Lerici, Cosenza 1980. P. Sorlin, The Film in History. Restaging the Past, Blackwell, Oxford 1980. S.G. Germani, Mario Camerini, La Nuova Italia, Firenze 1980. AA.VV., Anselmo Ballester. Le origini del manifesto cinematografico, Csac, Parma 1981. V. Angelini e F. Pucci, 1896-1914,Materiali per una storia del cinema delle origini, Studio Forma, Torino 1981. G.P. Brunetta, Cinema perduto, Feltrinelli, Milano 1981. J. Gili, Stato fascista e cinematografia, Bulzoni, Roma 1981. G.M. Gori e S. Pivato (a cura di), Glianni del cinema di parrocchia, Maggioli, Rimini 1981. P. Micalizzi, Ciak sulpoeta, in A. Bruzzoni (a cura di), Torquato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative, Nuova Alfa Editoriale, Ferrara 1981. D. Turconi e A. Sacchi, Divi e divine, La Casa Usher, Firenze 1981. M. Isnenghi, Operai e contadini nella prima guerra mondiale, Cappelli, Bologna 1982. F. Prono (a cura di), Il cinema che ho vissuto, Dedalo, Bari 1982. E. Scotto Lavina, 1927-1936. Frammenti di un decennio di politica culturale tra Roma e Venezia, in Venezia 32-82, La Biennale di Venezia, 1982, pp. 17-65. M. Verdone, Gliintellettuali e il cinema, Bulzoni, Roma 1982. G. Bernagozzi, Ilmito dell’immagine, Clueb, Bologna 1983. P. Bertetto (a cura di), Ilcinema d’avanguardia (1910-1930), Marsilio, Venezia 1983. C. Bertieri, E. De Miro, M. Giusti e M. Salotti (a cura di), Genova in celluloide. Luoghi, protagonisti, storie, Comune di Genova, Genova 1983. M. Cardillo, Ilduce in moviola, Dedalo, Bari 1983. A. Costa (a cura di), La meccanica del visibile, La Casa Usher, Firenze 1983. R. De Felice e L. Goglia, Mussolini. Il mito, Laterza, Roma-Bari 1983. F. De Lucis (a cura di), C’era il cinema. L’Italia al cinema tra Otto e Novecento, Panini, Modena 1983. R. Ellero (a cura di), L’immagine e il mito di Venezia nel cinema, Comune di Venezia, Venezia 1983. A. Farassino e T. Sanguineti (a cura di), Gliuomini forti, Mazzotta, Milano 1983. A. Gesualdi, Le origini del cinema nel Veneto, Padova, anno accademico 1983-1984. G. Aristarco, L’utopia cinematografica, Sellerio, Palermo 1984. G.P. Brunetta, La cinematografia come industria, in AA.VV., L’economia italiana tra le due guerre, Ipsoa, Roma 1984, pp. 320-323. A. Cara, Cenere di Grazia Deledda nelle figurazioni di Eleonora Duse, Istituto superiore regionale etnografico, Cagliari 1984. M. Cardillo (a cura di), DaQuarto a Cinecittà. Garibaldi e il Risorgimento nel cinema italiano, Amministrazione provinciale di Frosinone, Frosinone 1984. A. Farassino e T. Sanguineti, La Lux. Esthétique et système d’un studio italien, Éditions du Festival, Locarno 1984. M. Furno e R. Renzi (a cura di), Ilneorealismo nel fascismo, Quaderni della Cineteca, Bologna 1984. P. Fussell, La grande guerra e la memoria moderna, Il Mulino, Bologna 1984. M. Liehm, Passion and Defiance. Film in Italy from 1942 to the Present, University of California Press, Berkeley 1984. M. Malthète Méliés, Méliès et la naissance du spectacle cinématographique, Klincksieck, Paris 1984. G. Pretini, La grande cavalcata, Trapezio, Udine 1984. G.S. Zappulla Muscarà, Letteratura teatro cinema, Tringale, Catania 1984. A. Trevisan, L’altro teatro a Venezia(dal 1890 al 1915), Bologna, anno accademico 1984-1985. C. Bertieri e M. Salotti (a cura di), Genova in celluloide. I registi liguri, ivi, 1984. Id., Genova in celluloide. I produttori liguri, ivi, 1985. AA.VV., La cinepresa e la storia, fascismo, antifascismo, guerra e resistenza nel cinema italiano, Bruno Mondadori, Milano 1985. A. Bernardini, Le dive, Laterza, Roma-Bari 1985. A. Bernardini e V. Martinelli, Francesca Bertini (1892-1985), Centro sperimentale di cinematografia, Roma 1985. G.P. Brunetta, La guerra lontana, Materiali di lavoro, Rovereto 1985. B. Chardère, Les Lumières, Payot, Lausanne 1985. P. Cherchi Usai, Giovanni Pastrone, La Nuova Italia, Firenze 1985. L. Codelli, A. Percavassi e R. Pisciotta Piccotti (a cura di), Un regard retrouvé. Auteurs, acteurs du cinéma de Trieste, Electa, Trieste 1985. A. Dalle Vacche, From Protean to Statuesque: The National Body in the Italian Cinema, Iowa 1985. J. Gili, L’Italie de Mussolini et son cinéma, Veyrier, Paris 1985. E. Leed, Terra di nessuno, Il Mulino, Bologna 1985.
E. Mancini, Struggles of the Italian Film. Industry during Fascism, 1930-1935, Umi, Ann Arbor 1985. G. Pretini, Dalla fiera al Luna Park, Trapezio, Udine 1985. R. Redi e C. Camerini (a cura di), Cinecittà 1: industria e mercato nel cinema tra le due guerre, Marsilio, Venezia 1985. P. Sorrenti, Il cinema e la Puglia, Schena, Bari 1985. M. Argentieri, L’asse cinematografico Roma-Berlino, Libreria Sapere, Napoli 1986. G. Barlozzetti, S. Parigi, A. Prudenzi e C. Salizzato (a cura di), Modi di produzione del cinema italiano, La Titanus, Di Giacomo, Roma 1986. A. Bernardini e V. Martinelli, Titanus, Coliseum, Roma 1986. P. Bertetto e G. Celant (a cura di), Velocittà. Cinema & futurismo, Bompiani, Milano 1986. P. Virilio, L’aeromitologia futurista, ivi. G.P. Brunetta, I segni della storia e la delimitazione del campo cinematografico, in D. Ellwood (a cura di), I mass media e la storia, ERI, Torino 1986. R. Campari, Parma e il cinema, Banca del monte, Parma 1986. P. Cherchi Usai (a cura di), Giovanni Pastrone: gli anni d’oro del cinema a Torino, Utet, Torino 1986. P. Crivellaro e P. Ferrero, Cabiria, Cretinetti & C., Teatro Carignano, Torino 1986. M. Landy, Fascism in Film, Princeton University Press, Princeton 1986. E.G. Laura, L’immagine bugiarda. Mass media e spettacolo nella Repubblica di Salò, Annci, Roma 1986. D. Leoni e C. Zadra, La grande guerra. Esperienza memoria immagini, Il Mulino, Bologna 1986. E. Magrelli (a cura di), Sull’industria cinematografica italiana, Marsilio, Venezia 1986. G. Nowell Smith, The Italian Cinema under Fascism, in D. Forgasc (a cura di), Rethinking Italian Fascism: Capitalism, Populism and Culture, Lawrence and Wishart, London 1986. G. Pretini, Ambulante come spettacolo, Trapezio, Udine 1986. M. Quargnolo, La parola ripudiata, La cineteca del Friuli, Gemona 1986. R. Redi, Ti parlerò… d’amor, Eri, Roma 1986. G. Rondolino, Cultura e spettacolo nel cinema muto italiano, in G. Schepisi (a cura di), Il primo Novecento in Italia, Istituto Italiano di cultura, Barcellona 1986, pp. 79-85. AA.VV., Sigira, Il romanzo cinematografico di Pirandello, Edizioni del Centro nazionale di studi pirandelliani, Agrigento 1987. A. Barbina (a cura di), Sperduti nel buio, Eri, Torino 1987. G.P. Brunetta, Cinema e letteratura, in Dizionario critico della letteratura italiana, vol. I, Utet, Torino 1987, pp. 595-600. U. Brusaporco, Ilcinema a Verona 1930-1943, ES, Verona 1987. M. Cardillo, Tra le quinte del cinematografo: cinema cultura società in Italia 1900-1937, Dedalo, Bari 1987. P. Dal Cengio, Il cinema italiano e la grande guerra. Vicenza e lo spettacolo cinematografico in una città delle retrovie, Bologna, anno accademico 1987-1988. N. Genovese, Risvolticinematografici dell’opera pirandelliana, in W. Geerts, F. Musarra e S. Vanvolsen (a cura di), Poetica e presenza, Bulzoni, Roma 1987, pp. 567-580. G.M. Gori, Ilcinema arriva in Romagna. Ambulanti, sale permanenti, spettacoli e spettatori tra otto e novecento, Maggioli, Rimini 1987. J. Hay, Popular Film Culture in Fascist Italy, Indiana Univol. Press., Bloomington 1987. G. Pretini, Fanacapa e gli altri, Trapezio, Udine 1987. R. Redi (a cura di), Méliès, Di Giacomo, Roma 1987. E. Toulet (a cura di), Bibliografie internationale du cinéma des premiers temps (ciclostile), 1987. S. Zappulla Muscarà, Sperduti nel buio, un antesignano del neorealismo, in R. Brambilla (a cura di), Ilneorealismo nella letteratura e nel cinema italiano, Pro Civitate Christiana, Assisi 1987, pp. 117-149. V. Attolini, Dalromanzo al set. Cinema italiano dalle origini ad oggi, Dedalo, Bari 1988. G. Calzolari, Icinematografi di Parma. 100 anni di cinema a Parma, Sagea, Parma 1988. F. Casetti e R. De Berti (a cura di), Il cinema a Milano fra le due guerre, Vita & Pensiero, Milano 1988. E. Banfi, Attività dei CineGuf a Milano, ivi. C. Catania (a cura di), Cinema e futurismo, Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Agrigento 1988. C. Catania (a cura di), Pirandello e D’Annunzio nel cinema, Centro di ricerca per la narrativa e il cinema, Agrigento 1988, pp. 29-37. R. De Felice (a cura di), Futurismo, cultura e politica, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1988. M. Verdone, Spettacolo politico e 18 BL, ivi. G. Fink (a cura di), Critici eccentrici a Ferrara, Liberty House, Ferrara 1988. N. Genovese (a cura di), Barbaro e Chiarini. I teorici del cinema dietro la macchina da presa, De Spectaculis, Messina 1988. J. Gili, L’Église et le cinéma pendant la période fasciste, in Hommes, Idées, Journaux, Mélanges en honneur de Pierre Guiral, Publications de la Sorbonne, Paris 1988. G.M. Gori, Patria diva. La storia d’Italia nei film del ventennio, La Casa Usher, Firenze 1988. L. Malvano, Fascismo e politica delle arti, Bollati-Boringhieri, Torino 1988.
A. Marrese (a cura di), Vincitori e vinti. Quarant’anni della Biennale cinema di Venezia a Taranto, Consorzio cooperativo per lo spettacolo, Taranto 1988. S. Masi e M. Franco, Ilmare, la luna, i coltelli, Napoli, Pironti 1988. M. Verdone, Umberto Barbaro tra immaginismo e neorealismo, ivi. L. Miccichè, Cinema italiano sotto il fascismo: elementi per un ripensamento possibile, in Modelli culturali e stato sociale negli anni Trenta, Le Monnier, Firenze 1988, pp. 173-198. M. Mida, Compagni di viaggio. Colloqui con i maestri del cinema italiano, Nuova Eri, Torino 1988. R. Redi (a cura di), Pathé, Di Giacomo, Roma 1988. J.G. Tharrats, Los 500films de Segundo de Chomon, Prensas Universitaria de Zaragoza, Zaragoza 1988. C. Zilio, Dalla fiera al cinematografo. Lo spettacolo viaggiante in Italia (1889-1910), Padova, anno accademico 19881989. U. Artioli, L’officina segreta di Pirandello, Laterza, Roma-Bari 1989. A. Bernardini, Perspectives et tendances de la recherche sur le cinéma italien muet, in J. Aumont, A. Gaudreault e M. Marie (a cura di), L’Histoire du cinéma, Nouvelles tendances de la recherche, Publications de la Sorbonne, Paris 1989, pp. 39-48. G.P. Brunetta, Le comete e le lucciole: grandi e piccoli sogni luminosi di quarant’anni di cinema, in P. Hulten e G. Celant (a cura di), Arte italiana. Presenze 1900-1945, Bompiani, Milano 1989. G.P. Brunetta e J.A. Gili, L’ora d’Africa del cinema italiano, Materiali di Lavoro, Rovereto 1989. G. Casadio, Il Grigio e il Nero. Spettacolo e propaganda nel cinema italiano degli anni Trenta, Longo, Ravenna 1989. A. Costa, La morale del giocattolo. Saggio su G. Méliès, Clueb, Bologna 1989. P.M. De Santi (a cura di), Immagini in movimento. Memoria e cultura, La meridiana, Roma 1989. A. Gili, Les rapports entre la France et l’Italie de 1896 à la fin des années vingt, in Le cinéma franpais dans le monde, Institut Jean Vigo, Perpignan 1989. G.M. Gori (a cura di), Rimini et le cinéma, Centre Pompidou, Paris 1989. P. Hulten e G. Celant (a cura di), Arte italiana 1900-1945, Bompiani, Milano 1989. S. Masi, Costumisti e scenografi del cinema italiano, 2 voll., Istituto cinematografico dell’Aquila, L’Aquila 1989-1990. S. Milioto, Pirandello e D’Annunzio, Palumbo, Palermo 1989. M. Quargnolo, Quando i friulani andavano al cinema, Edizioni Biblioteca dell’immagine, Pordenone 1989. E. Troianelli, Elvira Notari, pioniera del cinema napoletano (1875-1946), Euroma, Roma 1989. F. Angelini, Serafino e la tigre, Pirandello tra scrittura teatro e cinema, Marsilio, Venezia 1990. V. Attolini, Il cinema in Lo spazio letterario di Roma antica, Salerno editrice, Roma 1990, pp. 431-493. M. Beynet, L’image de l’Amerique dans la culture italienne de l’entre deux-guerres, 3 voll., Publications de l’Université de Provence, Aix en Provence 1990. C. Bragaglia e F. Di Giammatteo, L’Italia 1900-1990. L’opera al cinema, La Nuova Italia, Firenze 1990. G.P. Brunetta e A. Costa, La città che sale. Cinema, avanguardie, immaginario urbano, Manfrini, Rovereto 1990. N. Genovese e S. Gesù (a cura di), La musa inquietante di Pirandello: il cinema, 2 voll., Bonanno, Palermo 1990. J.A. Gili, Le cinéma italien à l’ombre des faisceaux (1922-1945), Institut Jean Vigo, Perpignan 1990. G. Isola, Abbassa la tua radio per favore…, La Nuova Italia, Firenze 1990. P. Lughi (a cura di), Paprika. La commedia fra Italia e Ungheria nel cinema degli anni Trenta, Editoriale, Trieste 1990. L. Quaglietti, Ecco i nostri!, Eri, Torino 1990. M. Argentieri (a cura di), Risate di regime. La commedia italiana 1930-1943, Marsilio, Venezia 1991. F. Callari, Pirandello e il cinema, Marsilio, Venezia 1991. P. Gibelli, L’officina della guerra, Bollati-Boringhieri, Torino 1991. M. Isnenghi, Mamma. Il ruralismo nella cultura italiana, in Storia dell’agricoltura italiana a cura di P. Bevilacqua, Marsilio, Venezia 1991. L. Passerini, Mussolini immaginario, Laterza, Roma-Bari 1991. C. Pavone, Una guerra civile, Bollati-Boringhieri, Torino 1991. L. Quaglietti, Ecco i nostri. L’invasione del cinema americano in Italia, ERI, Torino 1991. R. Redi (a cura di), Il cinema muto italiano, Cnc, Roma 1991. R. Renzi (a cura di), Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo (1905-1930), Cappelli, Bologna 1991. I. Schenk, Der Italienische Historien Film von 1905bis 1914, Bremen 1991. P. Zanotto (a cura di), Veneto in film, Campus, Padova 1991. AA.VV., Cinema scritto. Il catalogo delle riviste italiane di cinema, 1907-1944, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1992. AA.VV., La signora delle Camelie, Lindau, Torino 1992. A. Aprà (a cura di), Scritti di cinema, Marsilio, Venezia 1992. G.P. Brunetta e L. Fantina, L’Italia al cinema. Manifesti della raccolta Salce 1911-1961, Marsilio, Venezia 1992. G. Bruno, Streetwalking on a Ruined Map, Princeton University Press, Princeton 1992. M. Calistro, Elmonopolio fascista y el cine argentino en Italia, in C. Espana e L. Volta (a cura di), La realidad obstinada, Corregidor, Buenos Aires 1992, pp. 123-140.
M. Dall’Asta, Un cinéma musclé, Yellow Now, Disnée 1992. A. Dalle Vacche, The Body in the Mirror. Shapes of History in Italian Cinema, Princeton University Press, Princeton 1992. V. Martinelli, Le fortune napoleoniche nel cinema italiano, Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1992. S. Raffaelli, La lingua filmata. Didascalie e dialoghi nel cinema italiano, Firenze, Le Lettere, 1992. S. Raffaelli, La lingua dalla piazza al cinematografo, ivi. A. Baldi (a cura di), I Ventimiglia, tre generazioni in cinema, Società italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1993. F. Bolzoni, Mino Maccari. Un selvaggio nel paese dei bugiardi, ERI, Torino 1993. C. Bragaglia, Il piacere del racconto. Narrativa italiana e cinema (1895-1990), La Nuova Italia, Firenze 1993. P. Gobetti (a cura di), Metamorfosi. Il cinema tra il fascino del muto e la tentazione del parlato 1928-1930. Archivio Nazionale della Resistenza, Torino 1993. R. Renzi (a cura di), Il cinema dei dittatori, Cappelli, Bologna 1993. AA.VV., Cinema e Chiesa. Una storia che dura cent’anni, ITL, Milano 1994. A. Boschi, L’avvento del sonoro in Europa. Teoria e prassi del cinema negli anni della transizione, Clueb, Bologna 1994. R. Campari, Il fantasma del bello. Iconologia del cinema italiano, Marsilio, Venezia 1994. F. Mariotti e C. Siniscalchi, Il mito di Cinecittà, Mondadori, Milano 1994. S. Masi ed E. Lancia, Stelle d’Italia. Piccole e grandi dive del cinema italiano dal 1930 al 1945, Il Castoro, Milano 1994. E. Palmieri, Vecchio cinema italiano, Neri Pozza, Vicenza 1994. R. Redi (a cura di), Gli ultimi giorni di Pompei, Electa, Torino 1994. C. Robotti, Reggio al cinema, Bizzocchi, Reggio Emilia 1994. P. Zenoni (a cura di), Dizionario cinematografico di Milano, Comune di Milano-Agis Lombardia, Milano 1994. AA.VV., Ciak sul ’900. Il XX secolo nell’occhio del cinema italiano, ANCCI, Roma 1995. AA.VV., La città del cinema.I primi cent’anni del cinema italiano, Skira, Milano 1995. AA.VV., Il grande sogno. Piccola storia del cinema Eliseo, Lindau, Torino 1995. AA.VV., L’Italia al cinema. Manifesti della raccolta Salce 1911-1961, Marsilio, Venezia 1995. AA.VV., Vivere il cinema. Sessant’anni del Centro Sperimentale di Cinematografia (1935-1995), Ist. Poligrafico dello Stato, Roma 1995. P. Bertetto, Schermi di carta. La collezione di manifesti del museo nazionale del cinema di Torino. Il muto italiano 19051927, Fratelli Pozzo, Torino 1995. I. Bignardi, F. Ferzetti e G. Gosetti (a cura di), Ieri, oggi e domani. Cento anni di cinema italiano, Zephiro, Roma 1995. P. Caneppele, Il cinema a Bressanone (1896-1918), Museo storico di Trento, Trento 1995. G. Casadio, Opera e cinema: la musica lirica nel cinema italiano dall’avvento del sonoro ad oggi, Longo, Ravenna 1995. G.B. Cau, I pionieri del cinematografo in Sardegna. 1987-1907, Arci Nova, Orzieri 1995. M.C. De Crescenzo, A. Lucadamo, C. Masiello e A. Muti (a cura di), Napoli, una città nel cinema, Biblioteca universitaria, Napoli 1995. F. Di Giammatteo, Dizionario del cinema italiano. Dall’inizio del secolo ad oggi. I film che hanno segnato la storia del nostro cinema, Editori Riuniti, Roma 1995. N. Genovese e S. Gesù, E venne il cinematografo. Le origini del cinema in Sicilia, Maimone, Catania 1995. G. Grignaffini, Signore e signori il cinematografo! La nascita del cinema e il suo mito, Venezia, Marsilio, 1995. D. Kozanovic, 1896-1918.Trieste al cinema, La Cineteca del Friuli, Gemona 1995. V. Valentini, Un fanciullo delicato e forte. Il cinema di Gabriele D’Annunzio, Biblioteca del Vascello, Roma 1995. A. Vigano e C.M. Martini (a cura di), Chiesa e cinema. Una storia che continua, ITL, Milano 1995. S. Zappulla Muscarà e E. Zappulla, Martoglio cineasta, Editalia, Roma 1995. G. Aristarco, Il cinema fascista prima e dopo, Dedalo, Bari 1996. P. Bertetto e S.Toffetti (a cura di), Cinema d’avanguardia in Europa (dalle origini al 1945), Il Castoro, Milano 1996. F. Bolzoni, Emilio Cecchi tra Buster Keaton e Visconti, CSC, Roma 1996. G.P. Brunetta, Cinetesori della Biennale, Marsilio, Venezia 1996. P. Caneppele, Il Tirolo in pellicola, Manfrini, Calliano 1996. G. Casadio (a cura di), Dante nel cinema, Londo, Ravenna 1996. L. Cuccu (a cura di), Il cinema nelle città. Livorno e Pisa nei 100 anni di cinematografo, Edizioni ETS, Livorno 1996. R. De Berti, Un secolo di cinema a Milano, Il Castoro, Milano 1996. M. Emanuelli, Cent’anni di storia italiana attraverso il cinema, Greco e Greco, Milano 1996. E. Grano, Cent’anni di cinema napoletano e dintorni, Bellini, Napoli 1996. G. Imarisio, D. Surace e M. Marcellino, Una città al cinema. Cent’anni di sale cinematografiche a Torino, Neos, Rivoli 1996. L. Jacob e C. Gaberscek, Il Friuli e il cinema, La Cineteca del Friuli, Gemona 1996. P. Poncino, Breve storia dei cinema torinesi, Bolaffi, Torino s.i.d. (ma 1996). L. Quaresima (a cura di), Il cinema e le altre arti, Marsilio, Venezia 1996.
P. Sorlin, European Cinemas European Societies, Routledge, London/New York 1996. P. Sorlin, Italian National Cinema, 1896-1996, Routledge, London/New York, 1996. AA.VV., Le fabbriche della fantasticheria. Atto di nascita del cinema a Torino, Testo e immagine, Torino 1997. F. Bono (a cura di), Cinema italiano in Europa 2 (1907-1929), Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema, Roma 1997. G.P. Brunetta, Il viaggio dell’icononauta. Dalla camera oscura di Leonardo alla luce dei Lumière, Marsilio, Venezia 1997. G. Casadio, La guerra al cinema. I film di guerra nel cinema italiano, Longo, Ravenna 1997. C. Ceresa e D. Pesenti Campagnoni (a cura di), Nero su bianco. I fondi archivistici del Museo Nazionale del Cinema, Museo Nazionale del Cinema, Lindau, Torino 1997. R. Chiti, Dizionario dei registi del cinema muto italiano, Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo, Roma 1997. A. Franceschetti e L. Quaresima (a cura di), Prima dell’autore, Edizioni Forum, Udine 1997. G. Marlia, Polidor, Ibiskos, Empoli 1997. V. Ruffin e P. D’Agostino, Dialoghi di regime, Bulzoni, Roma 1997. D. Viganò, Un cinema per ogni campanile. Chiesa e cinema nella diocesi di Milano, Il Castoro, Milano 1997. G. Spagnoletti (a cura di), Francesco Misiano o l’avventura del cinema privato nel paese dei bolscevichi, Dino Audino, Roma 1997. M. Wyke, Projecting the Past, Ancient Rome, Cinema and History, Routledge, New York 1997. AA.VV., Divas y divinas. Figuras del cine mudo italiano, Cineteca del Comune di Bologna, Bologna 1998. M. Argentieri, Il cinema in guerra. Arte comunicazione e propaganda in Italia 1940-1944, Editori Riuniti, Roma 1998. P. Bertetto e G. Rondolino (a cura di), Cabiria e il suo tempo, Il Castoro, Milano 1998. M. Bonomo, Salò news: cinegiornali della RSI, ANCCI, Roma 1998. A. Boschi, Teorie del cinema. Il periodo classico (1915-1945), Carocci, Roma 1998. P. Cavallo e P. Iaccio La riscoperta dell’America in L’immagine riflessa, Napoli, Liguori, 1998, pp. 70-152. L. Fantina, Le trincee dell’immaginario, Cierre, Sommacampagna 1998. L. Gaiardoni (a cura di), Mario Serandrei. Gli scritti e un film. Giorni di gloria, Il Castoro, Milano 1998. N. Genovese (a cura di), Febo Mari, Papageno, Palermo 1998. N. Genovese e S. Gesù, Vittorini e il cinema, Romeo, Siracusa 1998. P. Iaccio, Cinema e storia. Percorsi immagini testimonianze, Liguori, Napoli 1998. M. Landy, The Folklore of Consensus. Theatricality in the Italian Cinema, 1930-1943, State University of New York Press, Albany 1998. S. Luzzatto, Il corpo del duce, Einaudi, Torino 1998. L. Morbiato, Cinema ordinario, Il Poligrafo, Padova 1998. F. Pitassio e L. Quaresima (a cura di), Scrittura e immagine. La didascalia nel cinema muto, Forum, Udine 1998. T. Sanguineti (a cura di), L’anonimo Pittaluga. Tracce carte miti, numero speciale di «Cinegrafie», Transeuropa, Ancona 1998. L. Termine (a cura di), Il cinema e la vergogna negli scritti di Verga, Bontempelli, Pirandello, Testo & Immagine, Torino 1998. AA.VV., Divine apparizioni, Transeuropa, Ancona 1999. AA.VV., Film d’Africa. Film italiani prima, durante e dopo l’avventura coloniale, Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Torino 1999. M. Canosa (a cura di), A nuova luce. Il cinema muto italiano, Clueb, Bologna 1999. I. Ciani, Fotogrammi Dannunziani, Ediars, Pescara 1999. F. Deriu (a cura di), Lo schermo e la scena, Marsilio, Venezia 1999. A. Friedemann, Appunti per una storia dell’industria cinematografica a Torino. Stabilimenti e teatri di Posa, F.E.R.T., Torino 1999. A. Friedemann, Il periodo del muto.Quaderni Fert della ricerca storica, n. 1, F.E.R.T., Torino 1999. A. Gatti (a cura di), I Cineoperatori. La storia della cinematografia italiana dal 1895 al 1940 raccontata dagli autori della fotografia, vol. I, AIC, Roma 1999. M. Giordano, Giganti buoni: da Ercole a Piedone (e oltre) il mito dell’uomo forte nel cinema italiano, Lindau, Torino 1999. E.G. Laura, Le stagioni dell’aquila, Luce, Roma 1999. L. Pellizzari, Critica alla critica. Contributi a una storia della critica cinematografica italiana, Bulzoni, Roma 1999. R. Redi, Schermi muti. Cinema italiano 1906-1930, Marsilio, Venezia 1999. C. Taillebert, L’Institut International du cinématographe éducatif, L’Harmattan, Parigi 1999. S. Toffetti (a cura di), Un’altra Italia. Pour une histoire du cinéma italien, Mazzotta, Milano 1999. B. Valli, Il film ideale, Milano, Franco Angeli, 1999. AA.VV., Un secolo di cinema italiano, Il Castoro, Milano 2000. R. Ben-Ghiat, La cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2000.
R. De Berti, Dallo schermo alla carta. Romanzi fotoromanzi rotocalchi cinematografici. Il film e i suoi paratesti, Edizioni di Vita e Pensiero, Milano 2000. S. Della Casa e L. Ventavoli, Officina torinese, Lindau, Torino 2000. A. Farassino (a cura di), Lux film, Il Castoro, Milano 2000. A. Friedemann, Tra Torino e Venezia. Quaderni di ricerca storica, n. 3, F.E.R.T., Torino 2000. M. Landy, Italian Film, Cambridge University Press, Cambridge 2000. S. Luzzatto, L’immagine del duce, Editori Riuniti-Istituto Luce, Roma 2000. E. Mosconi (a cura di), L’oro di Polidor. Ferdinand Guillaume alla Cineteca Italiana, Il Castoro, Milano 2000. R. Renzi, La bella stagione, Bulzoni, Roma 2000. M. Bonetto e P. Caneppele, Inizi lo spettacolo!, Museo storico di Trento, Trento 2001. G.P. Brunetta, Avventure nei mari del cinema, Bulzoni, Roma 2001. O. Caldiron (a cura di), Luigi Chiarini 1900-1975. Il film è un’arte, il cinemaun’industria, CSC, Roma 2001. A. Friedemann, Verso il viale del tramonto. Quaderni Fert di ricerca storica, n. 4, F.E.R.T., Torino 2001. G. Lista, Cinema e fotografia futurista, Skira, Milano 2001. V. Martinelli, Kolossal. Storia fotografica del cinema epico, Cosmopoli, Roma 2001. G.P. Brunetta, Il colore dei sogni. Iconografia e memoria nel manifesto cinematografico italiano, Testo & Immagine, Torino 2002. P. Caneppele e A. Rigon, Fra luci e ombre. Intrattenimento e propaganda sugli schermi cinematografici a Bolzano (1919-1945), Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano 2002. L. Caramel e A. Molesani (a cura di), Luigi Veronesi e Cioni Carpi alla Cineteca Italiana, Il Castoro, Milano 2002. E. Castellani (a cura di), Il doppiaggio, Aidac, Roma 2002. A. Costa, Il cinema e le arti visive, Einaudi, Torino 2002. A. Costa, I leoni di Schneider. Percorsi intertestuali nel cinema ritrovato, Bulzoni, Roma 2002. M. Fanchi ed E. Mosconi (a cura di), Spettatori. Forme di consumo e pubblici del cinema in Italia. 1930-1960, Biblioteca di Bianco & Nero, Roma 2002. A. Friedemann, Le case di vetro. Stabilimenti cinematografici e teatri di posa a Torino, F.e.r.t., Torino 2002. A. Friedemann, I nomi sullo schermo. Quaderni Fert di ricerca storica, n. 5, F.e.r.t., Torino 2002. J. Reich e P. Garofalo (a cura di), Re-vieuwing Fascism. Italian Cinema, 1922-1943, Indiana University Press, Bloomington 2002. D. Viganò, Cinema e chiesa: i documenti del magistero, Effatà Editrice, Cantalupa (Torino) 2002. P. Zanotto, Veneto in film, Marsilio, Venezia 2002. G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano, Einaudi, Torino 2003. A. D’Anelli (a cura di), Giovanni Pastrone (Asti 1882-Torino 1959). Contributo astigiano al cinema muto italiano, Provincia di Asti, Asti 2003. A. Friedemann, Celluloide e argento. Le società tecniche torinesi, F.e.r.t., Torino 2003. A. Friedemann, Come e perché morì il cinema a Torino in AA.VV., Torino 1920-1940, Archivio Casorati, Torino 2003, pp. 197-204. I. Gambacorti, Storie di cinema e letteratura, Verga, Gozzano, D’Annunzio, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2003. P. Iaccio (a cura di), Non solo Scipione. Il cinema di Carmine Gallone, Guida, Napoli 2003. E. Lauretta (a cura di), Il cinema e Pirandello, Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento 2003. F. Bono, Casta Diva. Percorsi del cinema italiano tra le due guerre, Edizioni Sette Città, Viterbo 2004. G.P. Brunetta, Gli intellettuali italiani e il cinema, Bruno Mondadori, Milano 2004. G.P. Brunetta e A. Faccioli (a cura di), L’immagine di Venezia nel cinema del Novecento, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia 2004. V. Buccheri, Stile Cines. Studi sul cinema italiano, 1930-1934, Edizioni Vita & Pensiero, Milano 2004. V. Martinelli e M. Tortora, I promessi sposi al cinema, La Mongolfiera, Cosenza 2004. G. Muscio, Piccole Italie, grandi schermi. Scambi cinematografici tra Italia e Stati Uniti 1895-1945, Bulzoni, Roma 2004. M. Pizzo e G. D’Autilia, Fonti d’archivio per la storia del Luce, 1925-1945, Istituto Luce, Roma 2004. V. Zagarrio, Cinema e fascismo. Film, modelli, immaginari, Marsilio, Venezia 2004. S. Alovisio, Voci del silenzio. La sceneggiatura nel cinema muto italiano, Museo nazionale del cinema/Il Castoro, Torino-Milano 2005. G. Beltrame, L. Fantina e P. Romano (a cura di), Luci sulla città Treviso e il cinema, Marsilio, Venezia 2005. L. Cardone e L. Cuccu, Antonio Valente. Il cinema e la costruzione dell’artificio, ETS, Pisa 2005. F. Casetti (a cura di), La cineteca italiana. Una storia milanese, Il Castoro, Milano 2005. E. Mosconi, L’impressione del film. Contributi per una storia culturale del cinema italiano 1895-1945, Edizioni Vita & Pensiero, Milano 2006. W. Strauven, Marinetti e il cinema: tra attrazione e sperimentazione, Campanotto, Pasian di Prato 2006. A. Dalle Vacche, The Silent Sex: Diva, Woman and Early Film Culture, Austin, Texas University Press, 2007.
Critica e teoria A.G. Bragaglia, Fotodinamismo futurista, Nalato, Roma 1911. P.A. Gariazzo, Il teatro muto, Lattes, Torino 1919. V.E. Bravetta, La fabbrica dei sogni. La cinematografia studiata da un poeta, Torino 1920, ora nel «Notiziario del Museo nazionale del cinema», a. X, nn. 28-29-30, gennaio-dicembre 1975. S.A. Luciani, Il cinematografo, verso una nuova arte, Ausonia, Roma 1920. S.A. Luciani, L’antiteatro. Il cinematografo come arte, La voce, Roma 1928. A.G. Bragaglia, Evoluzione del mimo, Ceschina, Milano 1930. A.G. Bragaglia, Nuovi orizzonti della cinematografia. Il film sonoro, Corbaccio, Milano 1930. E. Giovannetti, Il cinema e le arti meccaniche, Sandron, Palermo 1930. A. Consiglio, Introduzione a un’estetica del cinema e altri scritti, Guida, Napoli 1932. G. Lega, Il fonofilm. L’arte e la tecnica, Nemi, Firenze 1932. C.L. Ragghianti, Cinematografo rigoroso, Pisa 1933. L. Chiarini, Cinematografo, Introduzione di G. Gentile, Cremonese, Roma 1935. V. Collina, Il cinema e le arti, Lega, Faenza 1936. A. Consiglio, Cinema. Arte e linguaggio, Hoepli, Milano 1936. C.L. Ragghianti, Cinematografo e teatro, Vie dell’Impero, Pisa 1936. U. Barbaro e L. Chiarini, L’attore. Saggio di antologia critica, Ed. Bianco e Nero, Roma 1938. U. Barbaro e L. Chiarini, Problemi del film, Ed. Bianco e Nero, Roma 1938. U. Barbaro, Film soggetto e sceneggiatura, Ed. Bianco e Nero, Roma 1939. L. Chiarini, Cinque capitoli sul film, Ed. Italiane, Roma 1941. G. Aristarco, L’arte del film, Garzanti, Milano 1950. C.L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, Einaudi, Torino 1952. G. Aristarco, Storia delle teoriche del film, Einaudi, Torino 1953. D. Turconi e C. Bassotto, Il film e le sue teoriche, Ed. Mostra del cinema, Venezia 1965. V. Attolini, S.A.Luciani teorico del film, Edizioni del centro librario, Bari 1971. M. Verdone, Sommario di dottrine del film, Maccari, Parma 1971. G. Dotoli, Lo scrittore totale. Saggi su Ricciotto Canudo, Schena, Fasano 1986. G. Grignaffini, Sapere e teorie del cinema, Clueb, Bologna 1989. R. Canudo, L’Usine aux image (a cura di J.P. Morel), Séguier, Paris 1995. A. Costa, Teorie del cinema dalle origini agli anni trenta, in G.P. Brunetta (a cura di), Storia del cinema mondiale, Einaudi, Torino 2001, pp. 417-443.
Saggi e articoli apparsi su riviste V. Jasset, Retour au réalisme, in «Ciné-Journal», 21 octobre-21 novembre 1911. Veritas, Pina Menichelli all’Itala film, in «La vita cinematografica», a. VI, nn. 34-35, 15-30 settembre 1915. F. Bertini, Sensazioni e ricordi, in «In Penombra», a. I, n. 1, giugno 1918. E. Guazzoni, Miconfesserò, ivi. G. Innocente, Maria Iacobini, in «In Penombra», a. I, n. 3, agosto 1918. F.M. Martini, L’esule delusa: Diana Karenne, in «In Penombra», a. I, n. 2, luglio 1918. D. Dorazio, Del gesto, del dramma e del cinematografo, in «Cronache d’attualità», a. V, n. 8, agosto 1921. F. De Pisis, Il ridicolo del cinematografo, in «Le Maschere», 15 febbraio 1922. R. Franchi, Cinema, scuola e pittura, in «Il Baretti», 15 giugno 1925. A.G. Bragaglia, Intorno al mio cinematografo, in «Comoedia», 20 settembre 1926. Caba (Carlo Bassoli), La Luce e l’industria cinematografica italiana, in «L’Eco del cinema», a. IV, novembre 1926. A. Gerbi, Iniziazioni alle delizie del cinema, in «Il Convegno», 25 ottobre 1926. ***, I film Luce, in «Cinema-film», n. 2, 1927. A.G. Bragaglia, Scenoplastica futurista, in «Comoedia», 20 dicembre 1927. L. Ferrari, A proposito dei film Luce, in «L’Eco del cinema», dicembre 1926-gennaio 1927. E. Ferrieri, Il cinematografo e le sue purità, in «Il Convegno», 19 marzo 1928. E. Ghione, Le cinéma italien, in «L’Art cinématographique», n. 7, 1930. AA.VV., «L’Italiano», a. VIII, n. 17-18, gennaio-febbraio 1933. M. Gromo, Ascesa del cinema subalpino, in «Scenario», a. III, n. 6, giugno 1933. J. Comin, Ilcinema italiano oggi e domani, in «Cinema», a. I, n. 1, 10 luglio 1936. A. Frateili, Pirandello e il cinema, in «Cinema», a. I, n. 12, 25 dicembre 1936. L. Freddi, Discorsoal pubblico, in «Cinema», a. I, n. 7, 10 ottobre 1936. AA.VV., Ilcinema, in «Prospettive», a. I., n. 2, 1937.
E. Allodoli, Cinema e lingua italiana, in «Cinema», a. II, n. 21, maggio 1937. A.R. Cades, Storia della Cines, in «Cinema», a. II, n. 20, 25 aprile 1937. J. Comin, Appunti sul cinema d’avanguardia, in «Bianco e Nero», a. I, n. 1, gennaio 1937. M. Corsi, Giubileo di un decano del cinema (E. Cristofari), in «Scenario», a. VII, n. 11, novembre 1937. L. D’Ambra, Sette anni di cinema, in «Cinema», a. II, nn. 11-39 (14 puntate), 25 gennaio 1937-gennaio 1938. P. De’ Calboli, Problemi fondamentali del cinema italiano, in «Cinema», a. II, n. 27, 10 agosto 1937. N. Ottavi, Organizzazione della produzione, in «Bianco e Nero», a. I, n. 11, novembre 1937. G. Riganti, Perchél’industria del film non si sviluppa in Italia?, in «Cinema», a. II, n. 14, 25 gennaio 1937. ***, Il monopolio dei film stranieri, in «Cinema», a. III, n. 54, 25 settembre 1938. AA. VV., Industria e costi di produzione, in «Cinema», a. III, n. 48, 25 giugno 1938 (e il discorso prosegue nei numeri 51 e 52 della rivista). C. Alvaro, Pirandello e gli sceneggiatori, in «Cinema», a. III, n. 57, 1938. M. Corsi, Un grande film del 1918 (Frate Sole), in «Cinema», a. III, n. 43, 10 aprile 1938. G. Loverso, L’industria del cinema, in «Bianco e Nero», a. II, n. 8, agosto 1938. M.A. Prolo, Torino cinematografica prima e durante la guerra, in «Bianco e Nero», a. II, n. 10, ottobre 1938. M. Puccini, Gli scrittori e il cinema, in «Bianco e Nero», a. II, n. 1, gennaio 1938. F. Soro, L’opera cinematografica di D’Annunzio, in «Cinema», a. II, 25 marzo 1938. M.V., Un momento critico, in «Cinema», a. III, n. 58, 25 novembre 1938. ***, Un mercato conteso, in «Cinema», a. IV, n. 64, 25 febbraio 1939. Anonimo, Risposta al signor Hays, in «Film», a. II, n. 7, 18 febbraio 1939. G.B. Angioletti, La parte dello scrittore, in «Bianco e Nero», a. III, n. 9, settembre 1939. M. Caudana, Vita laboriosa e geniale di Giovanni Pastrone, in «Film», a. II, nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 febbraio-4 marzo 1939. E. Cecchi, Letteratura americana e cinematografo, in «Cinema», a. IV, n. 84, 25 dicembre 1939. E. Ceretti, Storia della critica cinematografica italiana, in «Cinema», a. IV, nn. 61-63, 1939. W. Hays, Dare e avere, in «Cinema», a. IV, n. 69, 10 maggio 1939. V. Mussolini, Importazione ed esportazione cinematografica, in «Cinema», a. IV, n. 82, 25 novembre 1939. F. Pasinetti, Film e arte narrativa, in «Bianco e Nero», a. III, n. 12, dicembre 1939. F. Pasinetti, Ilmonopolio dei film stranieri e la produzione italiana, in «Bianco e Nero», a. III, n. 1, gennaio 1939. U. Barbaro, Bibliografia del cinema, in «Bianco e Nero», a. V, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, da gennaio a ottobre del 1940. F. Cerchio, Il pioniere Omegna, in «Cinema», a. V, n. 92, 25 aprile 1940. E. Ceretti, Il fotografo di S.M. il Re (Luca Comerio), in «Cinema», a. IV, n. 22, 25 aprile 1940. D. Meccoli, Ventisei film di Lucio D’Ambra, in «Cinema», a. IV, n. 85, 10 gennaio 1940. R. Paolella, Contributi alla storia del cinema italiano. Cinema napoletano, in «Bianco e Nero», a. IV, n. 9, settembre 1940. A. Blasetti, Alessandro Blasetti parla dei suoi film, in «Tempo», Milano 1941. Lo Duca, Ghione l’avventuroso, in «Cinema», a. V, n. 109, 10 gennaio 1941. B. Migliorini, Per una terminologia cinematografica italiana, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 5, maggio 1941. N. Ottavi, La organizzazione della produzione cinematografica italiana, in «Cinema», a. VI, n. 132, 25 dicembre 1941. L. Pirandello, Prologo a un racconto cinematografico, in «Cinema», a. VI, n. 120, 25 giugno 1941. E. Provenzale, Un’inchiesta di «Solaria», in «Bianco e Nero», a. V, n. 2, febbraio 1941. U. Barbaro, Il problema della prosa cinematografica, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 8, agosto 1942. U. Betti, Scrittori al cinema, in «Cinema», a. VII, n. 140, 25 aprile 1942. L. Bianconi, Arte muta e letteratura: il verismo e il dannunzianesimo, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 2, febbraio 1942. U. Casiraghi-G. Viazzi, Presentazione postuma di un classico, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 4, aprile 1942. R. Paolella, Contributi alla storia del cinema. Cinema italiano: anno 1909, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 3, marzo 1942. R. Paolella, Contributi alla storia del cinema italiano. Anno 1910, in «Bianco e Nero», a. VI, n. 8, agosto 1942. R. Paolella, Contributi alla storia del cinema italiano. Anni 1911-1912, in «Bianco e Nero», a. VI, nn. 11-12, novembredicembre 1942. A. Viviani, Inediti di Lucio D’Ambra, in «Cinema», a. VI, n. 145, 10 luglio 1942. U. Ivo, Prerafaellismo cinematografico, in «Cinema», a. VIII, n. 175-176, 1° settembre 1943. E.M. Margadonna, Registi nostri, in «Comoedia», a. XVI, n. 4, 1943. M. Mida, I Malavoglia sullo schermo, in «Cinema», a. VIII, n. 166, 25 maggio 1943. V. Mussolini, Anno decisivo, in «Cinema», a. VIII, n. 157, 10 gennaio 1943. C. Varese, Critica d’arte e cinematografo rigoroso in CL. Ragghianti, in «Belfagor», a. I, 1946, ora in Cultura letteraria contemporanea, Giardini, Pisa 1951. R. Renzi, Le inibizioni di un cinema di dittatura, in «Bianco e Nero», a. IX, n. 8, agosto 1948. C. Varese, Cinema arte, non arte e letteratura, in «Bianco e Nero», a. IX, n. 4, giugno 1948, ora in Cinema, arte e cultura, Marsilio, Padova 1963. G. Bezzola, Vecchio cinema italiano, in «Ferrania», a. III, n. 12, dicembre 1949.
R. Paolella, Ivalori dell’opera di Guazzoni nella storia del cinema, in «Bianco e Nero», a. X, n. 11, novembre 1949. G. Sadoul, Il cinema italiano visto da un francese, in «Sequenze», a. I, n. 4, dicembre 1949. L. Caglio, Cinema da baraccone, in «Sequenze», a. II, n. 8, aprile 1950. G.C. Castello, Una pentalogia piccolo borghese, in «Cinema», a. III, n. 31, gennaio 1950. C. Lizzani, Per uno studio sulla storia del cinema italiano, in «Bianco e Nero», a. XI, n. 10, ottobre 1950. AA.VV., Il neorealismo italiano, in «Quaderni della Mostra del cinema di Venezia», 1951. A.G. Bragaglia, Perfido incanto batte Fischinger e Caligari, in «Cinema», n.s., a. IV, n. 73, novembre 1951. V. D’Incerti, Vecchio cinema italiano, in «Ferrania», a. V, n. 6, giugno 1951. A. Frateili, La critica trent’anni fa, in «Filmcritica», a. II, n. 9, 1951. R. Paolella, Vecchio cinema napoletano, in «Cinema», n.s., a. IV, n. 63, giugno 1951. G. Puccini, I tempi di «Cinema», in «Filmcritica», a. II, n. 4, 1951. R. Renzi, La fiamma nera di Za-la-Mort, in «Cinema», n.s., a. IV, n. 68, agosto 1951. U. Casiraghi, Inchiesta sul cinema italiano (23 puntate), in «L’Unità», dal 24 ottobre 1952 all’8 maggio 1953. P. Chiarini, Ilcontributo di CL. Ragghianti, in «Rivista del cinema italiano», a. I, n. 1, dicembre 1952. A. Frusta, Ricordi di uno della pellicola, in «Bianco e Nero», nn. 7-8, luglio-agosto 1952, n. 2, febbraio 1953, n. 5, maggio 1954, nn. 11-12, novembre-dicembre 1954, n. 1, gennaio 1956 e n. 10, ottobre 1956. F. Montesanti, Parabola della diva, in «Bianco e Nero», a. XIII, nn. 7-8, luglio-agosto 1952. D. Paolella, Regia e registi italiani del decennio 1915-1925, ivi. M.A. Prolo, Maria Iacobini, ivi. R. Renzi, Introduzione al film Index di Alessandro Blasetti, in «Cinema», a. V, n. 92, agosto 1952. A.G. Bragaglia, Stefano Pittaluga, in «Cinema», n.s., a. VI, n. 102, 31 gennaio 1953. L. Solaroli, Da Rotaie a Ossessione, in «Cinema Nuovo», a. II, nn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, gennaio-luglio 1953. G.C. Castello, Filmografia ragionata di L. Pirandello, in «Cinema», n.s., a. VII, n. 135, 10 giugno 1954. F. Rocco, Gramsci e il cinema, in «Rivista del cinema italiano», a. III, n. 2, febbraio 1954. M. Verdone, Origine della critica cinematografica in Italia, in «Rivista del cinematografo», a. XXVII, n. 5, maggio 1954. M. Verdone, Per una storia della critica e della letteratura cinematografica, in «Rivista del cinematografo», a. XXVII, n. 1, 1954. O. Fallaci, Le memorie di Genina sono storia del cinematografo, in «L’Europeo», a. II, nn. 48-49-50, 27 novembre-4 dicembre 1955. N. Ivaldi, Tresaggi sul cinema sul «Baretti», in «Rivista del cinema italiano», a. IV, n. 1, gennaio 1955. M. Mida, Passato prossimo del nostro neorealismo, in «Cinema Nuovo», a. IV, n. 66, 10 settembre 1955. L. Solaroli e G. Vento, Vita italiana del cinema sovietico, in «Cinema sovietico», n. 4, 1955. A. Blasetti, Trent’anni di cinema italiano che ho vissuto, in «Cinema Nuovo», a partire dal n. 90-91 del 1956. F. Bolzoni, Il paesaggio italiano nel cinema e nella narrativa italiana del Novecento, in «Bianco e Nero», a. XVII, n. 2, febbraio 1956. G. Moscon, La censura cinematografica in Italia, in «Il Ponte», n. 1, gennaio 1956. M. Quargnolo, Etica e no nel cinema del ventennio, in «Bianco e Nero», a. XVII, n. 4, aprile 1956. G. Viazzi, I primi anni della critica cinematografica italiana, in «Ferrania», a. X, n. 12, dicembre 1956. F. Carpi, Il cinema rosa nel ventennio nero, in «Cinema Nuovo», a. VI, n. 109, 15 giugno 1957. F.M. De Sanctis, Il cinema in «Corrente», in «Cronache del cinema e della televisione», a. III, n. 21, estate 1957. F.M. De Sanctis, Il cinema in «Camminare», in «Cronache del cinema e della televisione», a. III, n. 23, inverno 1957-58. V. D’Incerti, Due signore del muto (Soava Gallone e Leda Gys), in «Bianco e Nero», a. XVIII, n. 12, dicembre 1957. F. Bolzoni, Emilio Cecchi, un letterato al cinema, in «Bianco e Nero», a. XIX, n. 4, aprile 1958. A. Frateili, La divina Eleonora, in «Filmcritica», a. VIII, n. 82, dicembre 1958. R. Jotti, Il primo Novecento di Camasio e Oxilia, in «Cinema Nuovo», a. VII, n. 132, 1958. AA.VV., Cinema italiano, in «Inquadrature», nn. 5-6, ottobre 1958-novembre 1959. M. Arosio, Appunti per una storia della critica cinematografica in Italia, in «Cronache del cinema e della televisione», nn. 30-31, 1959-60. E.F. Palmieri, Eleonora Duse misteriosa come la Garbo, in «Cinema Nuovo», a. VIII, n. 137, 1959. T.W. Adorno, Teoria freudiana e fondamento della propaganda fascista, in «Questioni», n. 6, 1957, ora in E. Zolla, La psicanalisi, Garzanti, Milano 1960. ***, Omaggio a Giovanni Pastrone, in «Centrofilm», a. II, n. 14, ottobre 1960. R. Paolella, Stile e recitazione nel cinema muto, in «Bianco e Nero», a. XXI, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1960. L. Solaroli, Nella nebbia del cinema fascista i fari di Franciolini, in «Cinemasessanta», a. I, n. 1, luglio 1960. M. Argentieri, Come nacque la censura, in «La Fiera del cinema», n. 1, gennaio 1961. V. Morin, Les Olympiens, in «Communications», n. 2, 1962. A. Napolitano, Ilretaggio culturale di «Cinema» vecchia serie, in «Cinema Nuovo», a. XI, n. 158, 1962. L. Solaroli, Ricordo di Barbaro alla vecchia Cines, in «Filmcritica», a. XIII, n. 118, marzo 1962. M. Verdone, L. Daguerre e i primi anni della fotografia in Italia, in «Bianco e Nero», a. XXIII, n. 2, febbraio 1962. G.C. Castello, Realismo, romanticismo e senso dello spettacolo nei film italiani sul Risorgimento a partire dal 1930, in
«Bianco e Nero», a. XXIV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1963. D. De Gregorio, Nascita e morte dell’Ambrosio film, ivi. M. Quargnolo, Le due Rome del vecchio cinema, in «Bianco e Nero», a. XXIV, n. 3, marzo 1963. P. Baldelli, Il mito degli inizi e la parabola di Rossellini, in «Il contemporaneo», a. VII, n. 68, gennaio 1964. G. Oldrini, La teorica cinematografica italiana durante il ventennio, in «Giovane critica», n. 4, 1964, ora in Problemi di teoria e storia del cinema, Guida, Napoli 1976. M. Quargnolo, Un periodo oscuro del cinema italiano, 1925-29, in «Bianco e Nero», a. XXV, nn. 4-5, aprile-maggio 1964. L. Solaroli, Ricordo di Barbaro e della sua elaborazione del concetto di realismo, in «Filmcritica», a. XV, n. 143, marzoaprile 1964. M. Verdone, Cinema e futurismo, in «La Biennale», n. 44, Venezia 1964. R. Calisi, Cinemae strutture socio-culturali (bibliografia italiana 1929-1964), in «Quaderni di comunicazioni di massa», n. 2, 1966. A. Negri, Barbaro e Chiarini tra attualismo e dialetticità del reale, in «Filmcritica», a. XVI, n. 168, luglio 1966. R. Warnier, Compléments à la bibliographie de R. Canudo, in «Studi francesi», n. 30, settembre-dicembre 1966. M. Quargnolo, La lunga contesa tra Bracco e il fascismo, in «L’Osservatore politico e letterario», marzo 1967. M. Quargnolo, L’amicizia Bracco-Amendola all’insegna dell’antifascismo, in «Il Gazzettino», 16 aprile 1967. J.A. Gili, Les revues italiennes de cinéma, in «Cinéma ’68», 1968. P. Del Monte, Le teoriche del film in Italia dalle origini al sonoro, in «Bianco e Nero», a. XXX, nn. 1-2, 5-6, 7-8, dal gennaio all’agosto 1969. G. De Santis, Riguardo ai tempi di «Cinema» prima serie, in «Cinema Nuovo», a. XVIII, n. 201, settembre-ottobre 1969. M. Quargnolo, Contributo alle ricerche di storia del cinema: Roberto Bracco, in «Bianco e Nero», a. XXX, nn. 7-8, luglioagosto 1969, G.P. Brunetta, Metodo e vita in Umberto Barbaro, in «Bianco e Nero», a. XXXI, nn. 1-4, gennaio-aprile 1970. J.A. Gili, Vergano, in «Anthologie du cinéma», n. 55, maggio 1970. J. Gili (a cura di), Fascisme et Résistence dans le cinéma italien, in «Études cinématographiques», nn. 82-83, IV trimestre 1970. M. Quargnolo, La censura cinematografica da Giolitti a Mussolini, in «L’Osservatore politico e letterario», luglio 1970. M. Verdone, Piccola storia della Cines, in «Spettacolo Romano», Ed. Golem, Roma 1970. V. Attolini, S.A. Luciani, teorico del film, in «La rassegna pugliese», a. VI, nn. 1-3, gennaio-marzo 1971. Ph.V. Cannistraro, Il cinema italiano sotto il fascismo, in «Storia contemporanea», n. 3, 1972. N. Carducci, Il mito dell’America e gli astratti furori di Vittorini, in «Studi novecenteschi», n. 3, 1972. G. Turi, Ilprogetto dell’Enciclopedia italiana: l’organizzazione del consenso fra gli intellettuali, in «Studi storici», gennaiomarzo 1972. G. Bachmann, Il film Luce visto da un americano, in «Sipario», n. 320, gennaio 1973. R. Noell, Histoire du spectacle cinématographique a Perpignan de 1896 a 1944, in «Cahiers de la cinémathèque», numero special, 1973. B. Pividori, Critica italiana primo tempo: 1926-1934, in «Bianco e Nero», a. XXXIV, nn. 3-4, marzo-aprile 1973. J.A. Gili, Il fascino discreto del cinema afascista, in «Sipario», n. 336, maggio 1974. G. Sadoul, D. Vertov, i futuristi italiani, Apollinaire e il montaggio delle attrazioni, in «Bianco e Nero», a. XXXV, n. 8, luglio 1974. P. Sorlin, Clio à l’écran ou l’historien dans le noir, in «Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine», a. XXI, n. 2, avriljuin 1974. G.P. Brunetta, Il fascismo nel cinema italiano del ventennio, in «Cinemasessanta», a. XV, n. 101, gennaio-febbraio 1975. G.P. Brunetta, La legittimità della ricerca, in «Cinemasessanta», a. XV, n. 106, novembre-dicembre 1975. G.P. Brunetta, Luigi Chiarini un intellettuale alla ricerca del nuovo, ivi. C. Guenon, Les temps heroiques du cinéma dans le Centre-Ouest. Des pionniers forains aux derniers tourneurs, in «Societé d’Études Folkloriques du Centre-Ouest», gennaio, 1975. J.P. Jeancolas, Ni chemises noires ni téléphones blancs. Cinéma italien 1929-1943, in «Positif», n. 186, octobre 1976. V. Zagarrio, Il fascismo e la politica delle arti, in «Studi storici», a. XVII, n. 2, 1976. AA.VV., D’Annunzio e il cinema, in «Quaderni del Vittoriale», n. 4, agosto 1977. G.P. Dell’Acqua, Una discussione sul cinema dell’epoca fascista, in «Cinemasessanta», a. XVII, n. 113, gennaiofebbraio 1977. R. Odin, Dixannées d’analyse textuelle de films, in «Linguistique et semiologie», n. 3, 1977. G. Aristarco, Filologia delle fonti per una storia comparata, in «Cinema Nuovo», a. XXVIII, n. 254, luglio-agosto 1978. G.P. Brunetta, Per un’antologia di scritti di Libero Solaroli, in «Cinemasessanta», a. XIX, n. 121, maggio-giugno 1978. P. Gardellini, Antonio Valente e il costume di scena, in «Bianco e Nero», a. XXXIX, nn. 5-6, settembre-dicembre 1978, pp. 87-112. J.A. Gili, Aspects de l’idéologie dominante dans le cinéma italien de l’époque fasciste, in «Mélanges de l’école française
de Rome», Rome 1978. M. Isnenghi, L’immagine cinematografica della grande guerra, in «Rivista di storia contemporanea», n. 3, 1978. V. Martinelli, I gastarbeiter tra le due guerre, in «Bianco e Nero», a. XXXIX, maggio-giugno 1978, pp. 3-93. G. Olivo, Vers la sedentarisation: du cinématographe au cinéma, in «Cahiers de la Méditerranée», nn. 16-17, lugliodicembre 1978. T. Perry, The Road to Neorealism, in «Film Comment», n. 14, novembre-dicembre 1978. A. Blasetti, Ai tempi di Cinematografo, in «Cinema Nuovo», a. XXVIII, n. 257, febbraio 1979, pp. 26-31. P. Micalizzi, Antonio Sturla: il pioniere del cinema ferrarese, in «La pianura», n. 4, 1979. V. Tosi, Il pioniere Roberto Omegna, in «Bianco e Nero», a. XL, n. 3, marzo 1979, pp. 3-68. G.P. Brunetta, La migrazione dei generi dalla biblioteca alla filmoteca dell’italiano, in «Italian Quarterly», n. 21, 1980, pp. 83-90. D. Cofrancesco, Appunti per un’analisi del mito romano nell’ideologia fascista, in «Storia contemporanea», a. XI, n. 3, giugno 1980. A. Farassino e T. Sanguineti, Tracce e reperti di cinema pompeiano, in Gli ultimi giorni di Pompei, «I Quaderno del CTR», Milano 1980-81, pp. 22-26. J.A. Gili, Pouvoir politique et intérets économiques: l’industrie du cinéma en Italie pendant la période fasciste, in «Filméchange», n. 9, hiver 1980. I. Ierace, Corrado Alvaro, critico cinematografico, in «Cinemasessanta», nn. 133-134, maggio-agosto 1980, pp. 42-48. J. Lourcelles, Le cinéma italien de 1929 à 1943, in «L’Avant Scéne», n. 246, avril 1980, pp. 23-38. F. Mazzoccoli (a cura di), Un cinema virile per il regime, in «Il nuovo spettatore», n. 2, ottobre 1980, pp. 46-75. A. Schwarz, La guerra rappresentata, in «Rivista di storia e critica della fotografia», a. I, n. 1, ottobre 1980. G. Aristarco, Francesco Pasinetti, una lezione disattesa, in «Cinema Nuovo», a. XXX, n. 271, giugno 1981, pp. 38-41. C. Camerini, Il divismo cinematografico italiano, in «Bollettino per biblioteche», n. 25, aprile 1981. M. Cardillo, Lucio D’Ambra e il cinematografo, in «Rivista del cinematografo», maggio 1981. J. Gili, Le cinéma italien pendant les années vingt, in «Cahiers de la cinémathèque», nn. 33-34, automne 1981, pp. 232238. J. Gili (a cura di), Recherches sur l’Histoire du cinéma italien, numero speciale di «Risorgimento», n. 2-3, 1981. M. Mida, La testimonianza di un allievo, in «Filmcritica», a. XXII, novembre-dicembre 1981, pp. 43-45. R. Milani, Il film assoluto di L. Veronesi, ivi, pp. 467-477. G. Moses, Irrealtà e ironia del fatto filmico in Pirandello, in «Inventario», n.s., a. XIX, n. 1, gennaio 1981, pp. 74-96. F. Zangrando, Quando il cinema si chiamava Venezia, in «Ateneo Veneto», a. XIX, vol. 19, nn. 1-2, I e II semestre 1981. M. Argentieri, Gli anni di guerra. I formalisti italiani, in «Cinemasessanta», a. XXII, n. 147, settembre-ottobre 1982, pp. 26-37. M. Argentieri, I formalisti italiani, in «Cinemasessanta», a. XXII, n. 148, novembre-dicembre 1982, pp. 20-23. A. Bernardini, Gaston Velle alla Cines, in «Immagine», a. I, n. 4, ottobre-dicembre 1982, pp. 1-4. N. Genovese, Storia del cinema a Messina nel periodo delle origini (1896-1908), in «Scritti in onore dell’Istituto Tecnico Commerciale A.M. Iaci», vol. II, Messina, 1982, pp. 7-38. S. Valerio, La nascita della Lux Film, in «Cinemasessanta», n. 144, marzo-aprile 1982, pp. 42-47. M. Argentieri, I formalisti italiani, in «Cinema », a XXIII, n. 149, gennaio-febbraio 1983, pp. 27-31. G.P. Brunetta, La fabbrica del divismo, in «Prometeo», a. I, n. 3, settembre 1983, pp. 92-101. C. Camerini, La formazione artistica degli attori del cinema muto italiano, in «Bianco e Nero», a. XLIV, n. 1, gennaiomarzo 1983. M. Cardillo, Cinematografo o proiezioni luminose, in «Sapere», a. IL, n. 11, novembre 1983, pp. 28-33. A. Farassino, Frammenti neuropatologici, in «Immagine», a. II, n. 5, marzo-giugno 1983, pp. 1-4. L. Michetti Ricci, Christus di Antamoro, in «Bianco e Nero», a. XLIV, n. 4, ottobre-dicembre 1983, pp. 109-121. G. Raya, Lo sceneggiatore Verga nel mercato del cinema, in «Cinema Nuovo», a. XXXII, n. 283, settembre 1983. S. Rhodie, Italian Neo-realismo 1941-1943, in «Australian Journal of Screen Theory», nn. 15-16, 1983. AA. VV., Antonio Valente e la Pisorno, supplemento a «Il Grande Vetro», n. 60, marzo-aprile 1984. N. Genovese, Il cinema delle origini in Sicilia, in «Bianco e Nero», a. XLV, n. 4, ottobre-dicembre 1984. G. Raya, Sceneggiature inedite di Verga, in «Cinema Nuovo», a. XXXIII, n. 289, marzo 1984. G. Visentini, Al cinema con M. Pannunzio, in «Bianco e Nero», a. XLV, n. 1, gennaio-marzo 1984, pp. 7-27. C. Wagstaff, The Italian Cinema during the Fascist Regime, in «The Italianist», n. 4, 1984. G. Aristarco, L’oltre del linguaggio cinematografico in Pirandello, in «Rivista di studi pirandelliani», a. V, n. 3, giugno 1985, pp. 46-51. A. Bernardini, L’Inferno della Milano film, in «Bianco e Nero», a. XLVI, n. 2, aprile-giugno 1985, pp. 92-111. G.P. Brunetta, Autoritratto rurale del fascismo, in «La terra nel cinema e nei media», Catalogo dell’Agrifilmfestival di Orbetello, 1985, pp. 19-23. G.P. Brunetta, La piazza cinematografica: il rito, la festa, le voci, i silenzi, in «50, Rue de Varenne», dicembre 1985, pp. 137-143. P. Cherchi Usai, L’Itala Films di fronte alla censura, in «Immagine», a. IV, n. 9, gennaio-marzo 1985, pp. 16-20.
P. Cherchi Usai e L. Jacob, Icomici del muto italiano, in «Griffithiana», nn. 24-25, ottobre 1985. M. Landy, The Narrative of Conversion and Representations of Men in the Prewar Italian Cinema, in «Journal of Film and Video», n. 37, primavera 1985. V. Martinelli, Primi approcci tra cinema e fascismo, in «Immagine», a. IV, n. 10, aprile-giugno 1985, pp. 7-12. E. Piovano, Il sogno di Freddi, in «Il nuovo spettatore», a. VI, n. 10, dicembre 1985, pp. 38-48. R. Redi, Giuliano l’apostata di U. Falena, in «Bianco e Nero», a. XLVI, n. 1, gennaio-marzo 1985, pp. 109-115. G. Rondolino, Emilio Cecchi e il cinema: il dibattito continua, in «Bianco e Nero», ivi, pp. 67-71. S. Valerio, Lo schermo di San Nicola, in «Cinemasessanta», a. XXVI, n. 161, gennaio-febbraio 1985, pp. 25-31. R. Vittori, Una trama di Pirandello tradita dalla sceneggiatura, in «Cinema Nuovo», a. XXXIV, n. 295, giugno 1985, pp. 32-38. A. Baldi, Roberto Bracco e la Scalera Film, in «Immagine», n.s., n. 1, inverno 1986, pp. 24-28. S. Bernardi, Una Virginland siciliana, in «Cinema & Cinema», a. XIII, n. 45, giugno 1986, pp. 57-58. C. Camerini, E l’attore diventò un divo, in «Bianco e Nero», a. XLVII, n. 2, aprile-giugno 1986, pp. 20-41. J. Hay, Cose dell’altro mondo, in «Cinema & Cinema», a. XIII, n. 45, giugno 1986, pp. 18-21. H. Komatsu, Italia Eiga No Chichi, Giovanni Pastrone, in «Gendai Shiso», n. 7, luglio 1986, pp. 186-196. H. Komatsu, Italia Eiga No Seiritsu, in «Wave», n. 9, settembre 1986, pp. 130-144. V. Martinelli, L’avventura cinematografica di Lina Cavalieri, in «Il territorio», a. II, n. 3, settembre-dicembre 1986, pp. 286-298. V. Martinelli et al., Giovanni Vitrotti, in «Griffithiana», nn. 26-27, settembre 1986, pp. 7-63. C. Montanaro, Un maestro dimenticato, un genere dimenticato: Pasinetti e il documentario, in «La cosa vista», n. 3, 1986, pp. 61-69. AA.VV., Ilfuturismo: arte e civiltà delle macchine, in «Il lettore di Provincia», a. XVIII, n. 69, settembre 1987. G.P. Brunetta, Il cuore diviso, in «Catalogo del 28° Festival dei Popoli», Firenze 1987, pp. 194-199. E. Comuzio, Rapsodia satanica e musica di Mascagni, in «Cineforum», a. XXII, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1987, pp. 714. A. Costa, Ivan Mosiukjne e Mattia Pascal, in «Cinema & Cinema», a. XIV, n. 48, marzo 1987, pp. 47-52. P.M. De Santi, Cinema e pittura, inserto di «Art Dossier», n. 16, settembre 1987. J.A. Gili, Cinecittà au secours du cinéma françaís 1940-43, in «Filméchange», n. 38, 1987. V.E. Marino, Cinema in camicia grigia, in «Filmcronache», a. I, n. 1, maggio-giugno 1987, pp. vi-xi. M. Argentieri, Umberto Barbaro critico, in «Cinemasessanta», a. XXVIII, n. 175, giugno 1987. M. Musumeci, Umberto Barbaro, l’approdo al cinema, ivi. S. Raffaelli, Fra teatro e cinema in Italia: la lingua, in «Quaderni di teatro», a. IX, n. 35, febbraio 1987, pp. 15-29. P. Sorlin, Un fascisme pour rire, in «Cinémaction», n. 42, 1987, pp. 21-28. F. Casetti e R. De Berti (a cura di), Ilcinema a Milano tra le due guerre, numero speciale di «Comunicazioni sociali», a. X, nn. 3-4, luglio-dicembre 1988. P. Cherchi Usai, Cabiria, an Incomplete Masterpiece: The Quest for the Original 1914 Version, in «Film History», a. II, n. 2, 1988, pp. 155-166. P. Cherchi Usai, Il caso di Saffo e Priapo e le origini del cinema porno, in «Bianco e Nero», a. XLIX, n. 1, gennaio-marzo 1988, pp. 109-125. G. De Vincenti, Il Kolossal storico-romano nell’immaginario del primo Novecento, ivi, pp. 7-26. C. Cosulich, I film di Cinecittà, in «Cinecritica», a. XI, numero speciale, maggio 1988. F. Di Giammatteo, Freddi il fascista di Cinecittà, ivi. L. Faenza, Il cinema nella Rimini d’antan, in «Incontri 2000», a. II, n. 7, luglio 1988, pp. 46-51. G.P. Brunetta, Polvere di sogni, in «Cahiers de la cinémathèque», n. 48, 1988. V. Martinelli, Filmographie des serials et des films à episodes du cinéma muet italien, ivi, pp. 111-124. J. Welle (a cura di), Film and Literature, in «Annali d’italianistica», vol. 6, 1988. AA.VV., Il cinema in Padania, in «Padania», a. III, nn. 5-6, 1989. G.P. Brunetta, Ettore Margadonna, critico e storico del cinema, in «Oggi e Domani», a. XVII, n. 6, giugno 1989, pp. 3-7. G.P. Brunetta, Lo sguardo perduto, in «Materiali di lavoro», nn. 1-2, 1989, pp. 165-172. P. Cherchi Usai, Un americain à la conquète de l’Italie(George Kleine, 1914), in «Archives», nn. 22-23, aprile-maggio, 1989. P. Cherchi Usai, Un americain à la conquète de l’Italie(George Kleine à Grugliasco), in «Archives», nn. 26-27, novembre-dicembre 1989. P. Cherchi Usai, Mario Camerini in Africa: Maciste contro lo sceicco (1927) e Kiff Tebbi (1928), in «Cinegrafie», a. I, n. 2, secondo semestre 1989, pp. 93-105. M. Dall’Asta, Le surhomme à l’italienne. Les hommes forts de l’écran (1913-1915), in «Archives», n. 19, gennaio 1989. M. Dall’Asta, Il forzuto futurista, in «Cinegrafie», a. I, n. 1, febbraio 1989, pp. 53-64. J.A. Gili, La vision de l’étranger dans le cinéma italien de l’époque fasciste, in «Révue Européenne des Migrations Internationales», 1989, pp. 7-41. V. Martinelli, I cineasti russi esuli in Italia, in «Griffithiana», nn. 35-36, ottobre 1989, pp. 4-12.
V. Martinelli, I forzuti emigrano, in «Cinegrafie», a. I, n. 2, II semestre 1989, pp. 89-92. S. Raffaelli, Quando il cinema era mobile, in «La ricerca folklorica», n. 19, 1989, pp. 103-112. V. Zagarrio, L’ideologia altrove. Esempio di indagine storica su due film del fascismo, in «La scena e lo schermo», a. I, nn. 1-2, dicembre 1988-giugno 1989, pp. 161-182. G.P. Brunetta, No Place Like Rome. The Early Years of Italian Cinema, in «Artforum», a. XXVIII, n. 10, estate 1990, pp. 122-125. L. Quaglietti, Il mito della Cines e la Cines del mito, in «Cinemasessanta», a. XXXI, n. 190, gennaio-febbraio 1990, pp. 38-42. S. Raffaelli, Il cinema per la scuola nei primordi. Per una bibliografia italiana sul cinema didattico e formativo (18961916), in «Prospettiva EP», a. XIII, n. 1, gennaio-febbraio 1990, pp. 45-53. C. Zilio, Fieranti invisibili. Appunti per una storia di un’associazione di ambulanti in età giolittiana, in «La cosa vista», nn. 14-15, 1990, pp. 26-30. G.P. Brunetta, Un popolo di artisti, pugili, mafiosi, in «Altreitalie», a. III, n. 6, novembre 1991, pp. 130-139. G.P. Brunetta, I sogni in rosa dello spettatore in camicia nera, in «Passato e presente», a. X, n. 25, gennaio-aprile 1991, pp. 101-115. G.M. Gori, Il cinema come strumento della storia immediata. Passato e presente nei film storici del periodo fascista, in «Cineforum», a. XXXI, n. 309, novembre 1991, pp. 29-33. V. Martinelli, L’incanto perfido di Thaïs, in «Immagine», n.s., n. 17, primavera 1991, pp. 1-10. V. Martinelli, Toddi et le cinéma, in «Archives», nn. 41-42, maggio-giugno 1991. P. Iaccio, Roberto Bracco e Lucio d’Ambra: un’amicizia due destini diversi in «Cinemasessanta», a. XXXIII, n. 205-206, maggio-agosto 1992, pp. 46-47. P. Iaccio, Il cinema inedito di Roberto Bracco, ivi, pp. 48-54. P. Iaccio, Il cinema inedito di Roberto Bracco (II), in «Cinemasessanta», a. XXXIII, n. 207-208, settembre-dicembre 1992, pp. 38-46. G. Guccini, Note intorno all’interpretazione di Assunta Spina, in «Cinegrafie», a. II, n. 6, novembre 1993, pp. 114-118. L. Autera, Stefano Pittaluga: commerciante di film, produttore per caso, in «Lumière», a. IV, Terza serie, n. 15, lugliosettembre 1994, pp. 20-24. G. Guccini, Tecnicismi borelliani, in «Cinegrafie», a. IV, n. 7, maggio 1994. V. Martinelli, Il cinema italiano nel 1913, in «Griffithiana», n. 50, maggio 1994, pp. 46-57. V. Martinelli, Il cinema muto italiano: le Case di produzione, in «Lumière», a. IV, Terza serie, n. 15, luglio-settembre 1994, pp. 127-137. R. Renzi, Donne angeliche e demoniache tra cultura europea e cinema muto italiano, ivi, pp. 103-117. G.P. Brunetta, S’aggira ancora Za-la Mort. Emilio Ghione: I topi grigi, in «Cinegrafie», a.V, n. 8, 1995. G. Lista, Un inedito marinettiano: Velocità, film futurista, in «Fotogenia», a. II, n. 2, 1995, pp. 6-14. M. Dall’Asta, La vamp e l’apache. Percorsi iconografici nel cinema nero degli anni dieci, ivi, pp. 132-139. M. Sarnelli, Una lettera inedita di Guido Gozzano ad Arturo Onofri e addenda sul cinema, in «La Rassegna della letteratura italiana», a. XCIX, nn. 1-2, gennaio-agosto 1995, pp. 159-167. M. Verdone, I Bragaglia e le fotodinamiche, in «Immagine», n.s., n. 30, primavera 1995, pp. 17-22. A. Bernardini, Teatro e teatranti alle origini del cinema italiano, in «Ariel», a. XI, nn. 2-3, 1996. F. Bono, La U.F.A. alla conquista dell’Italia in «Immagine», n.s., n. 34, primavera 1996, pp. 1-8. G.P. Brunetta, Fuori l’autore!, in «Fotogenia», a. III, n. 3, 1996, pp. 17-30. S. Celli, La Gazza ladra, film futurista di Corrado D’Errico, in «Cinegrafie», a. V, n. 9, luglio 1996, pp. 129-136. E. De Kuyper, Rapsodia Satanica o il fremito del colore, ivi, pp. 53-60. M. Marcus, Anton Giullo Bragaglia’s Thaïs, in «South Central Review», XIII, nn. 2-3 1996, pp. 63-81. A.G. Alonge, Giocando con i soldatini, in «Il nuovo spettatore», n.s., a. I, n. 1, novembre 1997, pp. 167-178. G. Isola, Alle origini del cinema italiano. L’effimera avventura di Giovanni Faraglia mancato produttore fiorentino, in «Archivio Trentino», n. 2, primavera 1998, pp. 219-226. V. Martinelli, D’Annunziana, in «Griffithiana», n. 64, ottobre 1998, pp. 26-50. R. Merritt, Introduzione a L’uomo che rubò la Gioconda, ivi, pp. 50-59. A. Bernardini, Aquila Films: profilo di una casa «editrice», in «Bianco e Nero», n.s. n. 2, marzo-aprile 1999, pp. 106120. A. Bernardini, Film Artistica «Gloria»: storia di una casa di produzione, in «Bianco e Nero», a. LX, n. 6, novembredicembre 1999, pp. 118-141. M. Dall’Asta, Quale dei due? Za-La-Mort e il film ad episodi italiano, in «Fotogenia», n. 4-5, 1999, pp. 105-117. A. Costa, Tempo passato e tempo storico, in «Bianco e Nero», a. LXI, n. 6, novembre-dicembre 2000. C. Dupré La Tour, Didascalie e narrazione, in «Bianco e Nero», a. LXI, n. 1-2, gennaio-aprile 2000. A. Marow-Mann, Gli ultimi giorni di Pompei or the Evolution of the Italian Historical Epic (1908-1926), in «La valle dell’Eden», n. 6, settembre-dicembre 2000, pp. 67-78. A. Meneghelli, Letteratura del cinema, ma letteratura. Note su Il Romanzo Film, in «Immagine», n.s., n. 43-44, inverno 2001, pp. 27-33.
S. Celli (a cura di), I tesori del LUCE, in «Bianco e Nero», a. LXIII, n. 1-3, fascicolo 5479, inverno 2003. G. Fusco, Le prime forme di esercizio (Napoli 1896), in «Cinemasessanta», a. XXXIV, n. 274, novembre-dicembre 2003, pp. 23-32. A. Friedemann, Note su Ernesto Maria Pasquali. Giornalista, regista, produttore cinematografico, in «Studi Piemontesi», a. XXXIII, n. 2, dicembre 2004, pp. 461-470. C. Jandelli, Novellizzazioni d’autore. Il caso Za-la-Mort, in «Bianco e Nero», a. LXV, n. 548, 2004, pp. 53-70. L. Mazzei, I tre volti della Medusa: storie di novellizzazione negli anni Dieci e Venti, ivi, pp. 35-45. F. Pitassio ed E. Mosconi, Une histoire italienne: Addio Giovinezza!, in «Archives» n. 96, settembre 2004. S. Celli, Luigi Chiarini al capezzale di Ballerine, in «Bianco e Nero», a. LXVI, n. 3 (fascicolo 553), settembre-dicembre 2005, pp. 75-86. A. Faccioli e F. Pitassio, Sergio Tofano. Il cinema a merenda, in «Bianco e Nero», a. LXVI, n. 552, maggio-agosto 2005. B. Vallero e M.G. Peretti, Imarisio Torino, cinema in guerra, in «Il nuovo spettatore cinematografico», n. 10, dicembre 2006.



![A nuova luce. Cinema muto italiano [Vol. 1]
8849116780, 9788849116786](https://dokumen.pub/img/200x200/a-nuova-luce-cinema-muto-italiano-vol-1-8849116780-9788849116786.jpg)
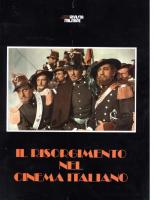


![Cinema muto italiano: tecnica e tecnologia. Discorsi, precetti, documenti [Vol. 1]
8843036831, 9788843036837](https://dokumen.pub/img/200x200/cinema-muto-italiano-tecnica-e-tecnologia-discorsi-precetti-documenti-vol-1-8843036831-9788843036837.jpg)

![Cinema muto italiano: tecnica e tecnologia. Brevetti, macchine, mestieri [Vol. 2]
884303684X, 9788843036844](https://dokumen.pub/img/200x200/cinema-muto-italiano-tecnica-e-tecnologia-brevetti-macchine-mestieri-vol-2-884303684x-9788843036844.jpg)