Lessico del cinema italiano. Forme di rappresentazione e forme di vita [Vol. 2] 8857530736, 9788857530734
II cinema italiano non è stato mai un cinema nazionale, pur essendo profondamente italiano. Ha individuato uno stile e u
409 65 8MB
Italian Pages 537 [556] Year 2015
Polecaj historie
Citation preview
Lessico del cinema italiano II
Lessico del cinema italiano a cura di Roberto De Gaetano
Piano dell’opera Volume I Introduzione del curatore. Amore (Roberto De Gaetano), Bambino (Emiliano Morreale), Colore (Luca Venzi), Denaro (Marcello Walter Bruno), Emigrazione (Massimiliano Coviello), Fatica (Federica Villa), Geografia (Francesco Zucconi). Volume II Habitus (Giacomo Manzoli), Identità (Roberto De Gaetano), Lingua (Fabio Rossi), Maschera (Bruno Roberti), Nemico (Daniele Dottorini), Opera (Francesco Ceraolo), Potere (Gianni Canova). Volume III Quotidiano (Carmelo Marabello), Religione (Alessio Scarlato), Storia (Christian Uva), Tradizione (Luca Malavasi), Ultimi (Alessia Cervini), Vacanza (Ruggero Eugeni), Zapping (Alessandro Canadè). Postfazione di Francesco Casetti.
LESSICO DEL CINEMA ITALIANO Forme di rappresentazione e forme di vita Volume II
A cura di Roberto De Gaetano
MIMESIS
Lessico del cinema italiano a cura di Roberto De Gaetano
C Gianni Canova, Francesco Casetti, Ruggero Eugeni, Giacomo Manzoli, Federica Villa C Alessandro Canadè (responsabile), Francesco Ceraolo, Alessia Cervini, Daniele Dottorini, Bruno Roberti, Luca Venzi R Raffaello Alberti, Simona Busni, Deborah De Rosa, Caterina Martino
MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine) www.mimesisedizioni.it [email protected] Isbn: 9788857530734 © 2015 – MIM EDIZIONI SRL Via Monfalcone, 17/19 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Phone: +39 02 24861657 / 24416383 Fax: +39 02 89403935 L’editore resta disponibile ad assolvere le proprie obbligazioni riguardo le immagini utilizzate per la presente pubblicazione, avendo effettuato, senza successo, tutte le ricerche necessarie al fine di identificare gli aventi titolo.
INDICE
H di Giacomo Manzoli
7
I di Roberto De Gaetano
69
L di Fabio Rossi
141
M di Bruno Roberti
215
N di Daniele Dottorini
283
O di Francesco Ceraolo
361
P di Gianni Canova
429
I
507
I
523
G
M
HABITUS
Siamo nella capitale. In realtà in un piccolo Stato sovrano all’interno dei confini di Roma. Ci troviamo infatti nel cuore della Città del Vaticano, in uno dei corridoi che portano alle stanze del papa. L’anno è il 2011 e l’uomo in borghese che sta camminando è uno dei volti più noti del cinema italiano, Nanni Moretti. Al suo fianco, un altro uomo gli sta spiegando il motivo per cui è stato convocato. Il personaggio che l’attore e regista di Habemus Papam interpreta nel film è infatti il dottor Brezzi, uno psicanalista, e la ragione per cui si trova in quel luogo è una grave crisi che ha colto il cardinale Melville nel momento stesso in cui è stato eletto papa – a sorpresa – da un conclave particolarmente turbolento e indeciso. La cerimonia stessa di proclamazione è stata interrotta per via di un attacco di panico del nuovo pontefice, che siede ora al centro di una stanza circondato dai propri elettori in trepidante attesa. L’uomo è confuso e mortificato e, benché già vestito di bianco, nella veste del discendente di San Pietro, non riesce a capacitarsi di quanto gli è accaduto e attende un intervento che gli consenta di risollevarsi e affrontare la responsabilità che il nuovo ruolo comporta. Si tratta di un momento assolutamente straniante, al contempo comico e patetico. Prima di essere introdotto nella stanza, lo psicanalista viene affrontato da un altro cardinale che desidera rivolgergli una raccomandazione: «Penso non sia superfluo ricordarle che il concetto di anima e quello di inconscio non possono assolutamente coesistere». Il dottor Brezzi è perplesso e rivolge a sua volta una domanda: «Qual è il suo nome? Perché non lo riconosco… chi avete eletto? Come si chiama?». Gli viene risposto lapidariamente: «Lo chiami Santità». Al che egli prova a ribellarsi: «Mah, un po’ troppo… perché il nome, in
8
Lessico del cinema italiano
una relazione terapeutica, può aiutare a far rivivere un po’ il rapporto…», ma la sua obiezione cade nel vuoto. Il dottore allora si accomoda di fronte al nuovo papa e prova a rompere il ghiaccio: «Buongiorno, come va? Come si sente?». L’anziano uomo riesce a replicare solo con un enigmatico «Scusi, non so cosa dire». Il dialogo prosegue in maniera surreale, con lo psicanalista che domanda i limiti degli argomenti che gli sarà concesso trattare e si rende conto che il catalogo dei temi attorno ai quali ruota la psicanalisi classica, ovvero il sesso, il rapporto con la madre, le fantasie non realizzate e i sogni non potranno essere oggetto di discussione in una relazione fra medico e paziente praticamente impossibile: solo l’infanzia può essere trattata, purché “con discrezione”. Da quel momento in poi, il film sarà una storia di guardie e ladri, con il cardinale che fugge e l’intero Vaticano che lo insegue, vivendo una trepidante attesa, fino all’epilogo finale, durante il quale assistiamo a una sconcertante rinuncia al papato che – fatto ancor più sorprendente, in quanto mai verificatosi negli ultimi quattro secoli – sarebbe poi accaduta anche nella realtà della cronaca a poco più di un anno di distanza dal film, con le “dimissioni” di Joseph Ratzinger e l’ascesa di Jorge Mario Bergoglio, eletto papa Francesco il 13 marzo 2013. Il film, dunque, è straordinario per una serie di ragioni, alcune cinematografiche, altre contingenti, ed è stato oggetto di numerose analisi. Come osservato giustamente da Roberto De Gaetano, si tratta di una vicenda paradigmatica che trascende nettamente i confini di una crisi individuale. Il panico e la sottrazione di un uomo al ruolo al quale è stato chiamato, infatti, mettono in causa il funzionamento di una intera istituzione e – per estensione – di tutta una società, giacché: «L’indossare la maschera, l’aderire al ruolo, non dipendono da attitudini o capacità psicologiche e individuali, ma dal potere costitutivo e formativo dei dispositivi o, meglio ancora, dai dispositivi e dai rituali del potere – fondativi della soggettività – che fanno sì che un soggetto sia adeguato al suo ruolo per una pratica di formazione compiuta»1. In altri termini, possiamo dire che l’inconscio ha progressivamente eroso l’anima, ovvero che il soggetto è stato progressivamen1
R. De Gaetano, Nanni Moretti. Lo smarrimento del presente, Pellegrini, Cosenza 2015, p. 213.
Habitus Giacomo Manzoli
9
te ridimensionato dalla consapevolezza della propria instabilità e della propria natura fittizia, fino a diventare del tutto inadeguato ad affrontare la responsabilità di un ruolo di potere trascendente. Dal momento in cui si passa da un modello essenzialista, dove al centro è la natura profonda di un’entità data a priori e precisamente definita nella sua interezza (l’anima) ad un modello relazionale, dove ciò che agisce è un equilibrio di impulsi che nascono dall’incontro fra istinti in costante conflitto fra loro, un ambiente e una stratificazione di esperienze che vengono faticosamente elaborate (l’inconscio), ecco che tutto si risolve in un costante “gioco di ruoli”, per dirla alla Goffman2. Quello che accade al cardinale Melville è di sentirsi al centro di una triste farsa, dove egli è «al tempo stesso cattivo attore e buon pubblico»3, e non è un caso che la decisione venga presa, in fondo, mentre assiste ad una rappresentazione teatrale di Il gabbiano di Čechov. Ma il punto fondamentale è il fatto che, nel momento in cui la Chiesa fa vestire al cardinale l’abito papale, egli dimostra di non essere affatto capace di indossare l’habitus che ne consegue, e il film ci mostra che si tratta di un gioco; che il problema sostanziale è la difficoltà di questa istituzione a costituirsi come un vero e proprio campo, nel senso sociologico del termine. Per la verità, lo psicanalista prova a costringere i cardinali a scendere su un campo di pallavolo per dimostrare, nel corso di un torneo, la loro propensione a identificarsi fino in fondo con le regole di un gioco, riconoscendone la posta in palio. L’atteggiamento dei medesimi però resta quello di chi non perde mai di vista il fatto che si tratta, appunto, di una finzione, nella loro incapacità a prenderlo sul serio, quel gioco, a calarsi in una illusio, riconoscendone la posta su un piano simbolico al di là della materialità degli interessi specifici (il punteggio). Proprio qui sta il nocciolo della questione. Perché – come viene detto a un certo punto – il papa e l’uomo diventino la stessa cosa, c’è bisogno di un universo disposto a riconoscere questa equivalenza, di un ordine simbolico che prenda per buona e dia concre2 3
Cfr. E. Goffman, Espressione e identità: gioco, ruoli, teatralità, il Mulino, Bologna 2003 [ed. or. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction, The Bobbs-Merrill Company, Indianapolis 1961]. P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Seuil, Paris 2002, p. 266.
10
Lessico del cinema italiano
tezza a questa astrazione, fornendo un supporto di oggettività alla responsabilità sovrumana che consegue al divenire il vertice di una immensa piramide. Responsabilità che diventa insostenibile per un soggetto abbandonato a se stesso, alle prese con l’improbabilità delle vesti papali o delle divise delle guardie svizzere (al centro di un’altra importante sequenza musicale del film, scandita dalle note di Todo Cambia di Mercedes Sosa), dei rituali, dei divieti, dell’amministrazione delle anime, del potere temporale. In altre parole ancora, è la struttura che fornisce al soggetto le basi concrete su cui fondare la sua disposizione a interpretare il proprio ruolo con piena convinzione. Una performance che a sua volta andrà a rafforzare la tenuta della struttura, in un rilancio costante. Senza una struttura efficace di riferimento, anche la fede autentica dell’uomo (che non è mai davvero in questione) non sarà sufficiente a spingerlo a compiere efficacemente quel ruolo che egli si è pure scelto e che gli è stato contestualmente attribuito, producendo quella discrepanza fra obiettivi e disposizioni che tecnicamente – come vedremo – prende il nome di hysteresis dell’habitus, vale a dire quella condizione di paralisi e di panico in cui un soggetto o (in questo caso) un’istituzione si rende conto che la sua ragion d’essere dipende esclusivamente dalla propria storia passata, senza più alcuna capacità di far fronte al presente. Quando l’abito fa il monaco Passiamo ora ad un altro esempio, che riguarda un film collocato in una fase cruciale della cultura italiana. Siamo sul crinale degli anni cinquanta e si sta compiendo la prima rivoluzione dell’industria culturale italiana, inestricabilmente connessa all’affermazione di una società di massa. Secondo la tesi magnificamente documentata e argomentata da David Forgacs e Stephen Gundle4, tale rivoluzione – attraverso la quale si assiste ad una progressiva, traumatica e faticosa uscita dell’Italia da strutture sociali e culturali premoderne – sarebbe iniziata già durante gli 4
Cfr. D. Forgacs, S. Gundle, Cultura di massa e società italiana. 1936-1954, il Mulino, Bologna 2007 [ed. or. Mass Culture and Italian Society from Fascism to the Cold War, Indiana University Press, Bloomington 2007].
Habitus Giacomo Manzoli
11
anni trenta e avrebbe trovato compimento negli anni cinquanta. La sua datazione dichiaratamente convenzionale abbraccia un arco temporale che va dal 1936 (anno di presentazione della prima utilitaria Fiat, la Topolina) al 1954 (anno in cui scompare De Gasperi). Ma questa fase di cambiamento profondo, delle strutture come degli habitus italiani, non si è ancora verificata nelle comunità contadine al centro del film che ci interessa. Ci troviamo infatti nella poverissima Italia rurale che era da poco uscita dalle devastazioni del secondo conflitto mondiale e i problemi da risolvere sono quelli della sopravvivenza spicciola del popolo, della distribuzione della ricchezza, della conversione di agricoltura e industria a forme più moderne ed efficienti di organizzazione del lavoro e sfruttamento delle risorse. È di questo che parla un film del 1950, diretto e interpretato da Aldo Fabrizi (alla sua seconda regia) che non risulta praticamente menzionato da alcuna storiografia ufficiale: Benvenuto reverendo!. In questa pellicola, l’indimenticabile interprete del Don Morosini di Roma città aperta scrive, assieme al fido Piero Tellini (già autore di Il bandito e Il delitto di Giovanni Episcopo di Lattuada e L’onorevole Angelina di Zampa), una storia che inizia con la scarcerazione di un ladruncolo qualsiasi. La sola speranza di un futuro, per questo disperato, consiste nella raccomandazione del cappellano del carcere, con la quale spera di trovare impiego presso un parroco di provincia. Il prelato, tuttavia, è in gravi condizioni di salute e l’ex-galeotto, affamato, non vede altra soluzione che cercare di appropriarsi di una parte delle offerte. Sorpreso a rubare in chiesa, l’uomo rischia il linciaggio e sfugge alla cattura sottraendo le vesti del parroco e riparando in un paesino agricolo periferico, dove viene appunto scambiato per il nuovo prete. Qui dovrà fronteggiare una situazione difficile. Il latifondista del paese, infatti, non intende cedere alcuna delle sue terre ai braccianti, che le rivendicano per meglio farle fruttare. La situazione rischia di degenerare allorché viene rapito il figlio del padrone, che fra le altre cose aveva messo incinta una ragazza del popolo, rifiutando di sposarla. Dopo aver verificato le condizioni di vita dei braccianti – ritratte con spietata esattezza – Fabrizi riuscirà a riconciliare le due fazioni, dichiarando a ciascuna il cedimento dell’altra e ottenendo così da entrambe un’apertura di credito (e propiziando
12
Lessico del cinema italiano
persino il matrimonio riparatore fra il giovane proprietario e la popolana). Abbiamo perciò un film che ritrae in modo a tratti perfino scandaloso il ruolo di mediatore sociale che la Chiesa era chiamata a svolgere in quel periodo, sia in quanto tale sia attraverso il suo braccio politico, vale a dire la Democrazia Cristiana. La storiografia, al riguardo, offre una serie di elementi che ci aiutano a capire la situazione che Alcide De Gasperi si trova ad affrontare nel 19485. Latifondisti da una parte, agguerriti, organizzati, forti del sostegno della polizia di Scelba. Dall’altra parte masse di lavoratori affamati che si andavano organizzando in sindacati, con l’appoggio degli stessi americani che non vedevano affatto di buon occhio una pratica – come quella del latifondo – che contribuiva a conservare nell’arretratezza l’economia italiana che il piano Marshall cercava di rilanciare6. Con un colpo al cerchio e uno alla botte, inserendo come ministro dell’agricoltura un latifondista sardo, Antonio Segni, al posto del sindacalista calabrese Fausto Gullo, De Gasperi riuscirà a portare a casa una riforma agricola che abolisce di fatto le concentrazioni della proprietà terriera, in un clima di tensione confermato dall’esito del voto (210 voti a favore su 574 parlamentari) e con un Partito Comunista che si guarderà bene dall’intervenire attivamente nella questione, al di là delle affermazioni retoriche e di principio. Ed è di questo che, fra le pieghe dei moduli tipici della commedia (ovvero di un neorealismo che va colorandosi di rosa) e di un registro comico-grottesco, venato di sfumature patetiche, il film cerca di rendere conto. Ma Benvenuto reverendo! sembra soprattutto affermare il fatto che una Chiesa troppo antiquata non era più in grado di svolgere il ruolo di mediazione sociale storicamente affidatole. Questo viene così assunto da un laico sotto i vestimenti solenni e “super partes” dell’istituzione religiosa e portato a termine grazie a un “senso pratico” estraneo ai prelati e ad una propensione al rischio resa obbligatoria dalle condizioni contingenti. Indossato l’abito talare, Fabrizi si trova progressivamente ad indossare anche l’habitus 5 6
Cfr. P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi, Torino 2006, pp. 162 sgg. Cfr. L.J. Harper, L’America e la ricostruzione (1945-1948), il Mulino, Bologna 1987, p. 164 [ed. or. America and the Reconstruction of Italy, 1945-1948, Cambridge University Press, Cambridge 1986].
Habitus Giacomo Manzoli
13
del prete, ovvero del giudice di pace, elaborando una complessa strategia per raggiungere un duplice obiettivo – individuale (la sopravvivenza) e sociale (la riconciliazione) – da cui deriva un successo personale, ovvero un riconoscimento, che la stessa Chiesa (il cardinale che si reca in visita alla comunità nel finale del film) trova utile confermare. Vediamo quindi l’affermazione del diritto di proprietà ma anche delle legittime aspirazioni di un popolo ridotto allo stremo e le peripezie – contorte e avventurose ma efficaci – con cui l’uomo riesce nell’intento di tenere assieme le due istanze, mettendo in scena una soluzione ottimistica che produce gli effetti sperati. La salvaguardia del principio della proprietà privata ma anche quello di una più equa distribuzione della ricchezza che fosse in grado di soddisfare almeno i bisogni elementari degli individui e rilanciare la produttività del paese. Sullo sfondo, ma sempre presenti, la situazione miserabile dei presìdi polizieschi periferici (gli stessi che Comencini descriverà con altra allegria nella saga di “Pane e amore”) e la denuncia dei metodi dell’autorità centrale, forza ostile alle istanze popolari e il cui intervento, presumibilmente violento, viene considerato irreparabile (Fabrizi deve risolvere tutto prima che arrivi la Celere). Il film termina con un finale ambivalente. Fabrizi spera di essere riuscito a conquistare il cuore della ragazza madre e di poter coronare il sogno di una famiglia, ma recede di fronte al pentimento del padre naturale del bambino. Il sacrificio dei sentimenti, in questo caso, appare perfettamente funzionale alla logica propriamente politica del film. L’hysteresis dell’habitus del prete “reale”, incapace di performare efficacemente il ruolo di punto di riferimento in una struttura che sta collassando, è superata solo nel momento in cui l’impostore incorpora uno dei fattori primari dell’habitus religioso: posporre il soddisfacimento dei propri bisogni, ovvero del proprio punto di vista soggettivo, a quelli della collettività. L’interesse privato del protagonista deve lasciare il posto alla dimostrazione del teorema degasperiano affinché tutto non si risolva in un puro “effetto di titolo” (che pure resta un fattore essenziale). L’opera di riconciliazione è propedeutica a un processo di modernizzazione, rispetto al quale uno dei presupposti è certamente la possibilità di permeabilità delle classi sociali. Quello che fino ad allora non è altro che un poverello figlio di N.N. si rivela una sorta di meticcio della nuova contaminazione interclassista che spezza la rigida stratificazio-
14
Lessico del cinema italiano
ne che fino ad allora aveva riguardato l’intera società italiana. Il processo è compiuto. Il piccolo De Gasperi, che per l’occasione ha assunto le fattezze (in verità antitetiche) di Aldo Fabrizi, ha perfettamente raggiunto il suo scopo – sia pure attraverso una serie di avventurosi stratagemmi – e può ritirarsi in buon ordine. Ma ad interessarci, in questo caso, è la capacità riflessiva dimostrata da un piccolo film, diretto e interpretato da un attore che andava ripristinando una dimensione autenticamente popolare (destinata a consolidarsi con il trionfo immediatamente successivo di La famiglia Passaguai, 1951), nei confronti della quale per ora ci limitiamo ad utilizzare l’accezione elementare (ma non per questo meno vera) del termine, proposta da Vittorio Spinazzola, ovvero la capacità di attivare una forte identificazione nelle masse popolari7. Fabrizi, in qualche modo, mette in scena con le sue mossette, gli ammiccamenti, la sovrapposizione di registri comici e melodrammatici, ciò che effettivamente stava avvenendo nel teatro sociale di quello stesso periodo, e lo fa senza tirarsi indietro di fronte agli aspetti più sconvenienti: enumerando una per una le “ragioni intuitive” ma innominabili cui faceva riferimento lo stesso ministro dell’Agricoltura. La sua è una riflessione acuta sull’Italia del periodo, sui processi drammatici in atto e sulle politiche che venivano elaborate per gestirli nella loro intelligenza e nella loro furbesca improvvisazione. A tale riflessione, come abbiamo visto assai esplicita, si accompagnano almeno due discorsi impliciti sulla contingenza reale del paese (il perché del consenso diffuso alla DC) e sulla natura dell’arte popolare o del prodotto culturale che dir si voglia, in quanto spia, deposito di tracce, di indizi e sintomi di una realtà sociale in atto. L’abito indossato strumentalmente che diviene – senza una chiara coscienza del protagonista – un vero e proprio habitus è una metafora molto articolata della cosiddetta “mutazione antropologica” che sta per cambiare per sempre gli schemi di interpretazione della realtà, i valori, le aspettative, il modo di riflettersi nel sociale del popolo italiano.
7
Cfr. V. Spinazzola, Cinema e pubblico. Lo spettacolo filmico in Italia (19451965), Bulzoni, Roma 1985, p. 12.
Habitus Giacomo Manzoli
15
Una notte gelida, su un ponte Passano appena tre anni e adesso siamo a Pavia, ricca città di provincia in una Lombardia già avviata ad essere il motore di quella modernizzazione che condurrà l’Italia a diventare la settima potenza industriale mondiale. L’anno è incerto. Nel senso che ci troviamo in realtà nel 1952, ma la storia è ambientata negli anni trenta, dunque in un’epoca contemporaneamente vicina e lontana. Vicina cronologicamente ma lontana politicamente. Lo stratagemma è facile da comprendere, giacché nell’Italia dei primi anni cinquanta non c’è particolare simpatia, da parte delle autorità, nei confronti di una rappresentazione delle istituzioni che ne disveli l’ipocrisia e la corruzione. Meglio, molto più prudente, allora, fare riferimento alle istituzioni dell’Italia fascista, un periodo che si può mostrare in una chiave critica e negativa senza timore di incorrere nelle maglie della censura. D’altra parte, retrodatare gli avvenimenti è anche un modo per sottolineare la natura universale, meta-storica della vicenda narrata. Una vicenda che per la prima volta era stata “messa in scena”, sia pure in chiave prettamente letteraria, nella Russia zarista del 1842, grazie alla fantasia diabolica di Nikolaj Gogol. Siamo a Pavia, si diceva, e il protagonista della storia è un povero impiegato degli uffici comunali, interpretato da un comico torinese, fino ad allora noto per commediole senza troppe pretese e per una certa verve satirica espressa principalmente sui palcoscenici del teatro di rivista. Renato Rascel, ovvero Renato Ranucci, è Carmine De Carmine, uomo modesto, diligente, impiegato modello per abnegazione ed efficienza, che deve vivere con i risicatissimi proventi del suo lavoro e conduce perciò un’esistenza estremamente sacrificata. I suoi superiori, in particolare il sindaco e il segretario generale, non perdono occasione per umiliarlo, privatamente e pubblicamente, per la sua modestia e mitezza, concentrandosi in particolare sul suo aspetto esteriore e sulla povertà dei suoi abiti. L’uomo, infatti, vive di poco, in una stanza in affitto, mangiando il minimo indispensabile e rivoltando vestiti ormai logori, lisi, bucati, inadeguati rispetto al clima rigido dell’inverno padano. I suoi interlocutori, tronfi e arroganti, vestono invece in maniera elegante, ricercata, siedono dietro a scrivanie imponenti e
16
Lessico del cinema italiano
su poltrone lussuose, la cui altezza regale è capace di nasconderne all’occorrenza la bassa statura. La vita del povero Carmine subirà una svolta improvvisa grazie a due eventi fortuiti. Il primo è la donazione liberale di una bella signora che lo ha scambiato per un mendicante. Con questa somma, l’uomo potrà dare l’acconto per uno splendido cappotto nuovo. Ma l’acquisto non sarebbe possibile senza un ulteriore colpo di fortuna che si verifica quando l’uomo assiste fortuitamente ad una conversazione da cui si evince chiaramente che il sindaco incassa tangenti per truccare gli appalti comunali. Per farlo stare zitto, il primo cittadino è disposto a versargli una parte della cifra ricevuta, cosa che evidentemente lo rende complice e gli consente di avere finalmente il suo splendido cappotto con il collo di pelliccia. Rascel-Di Carmine, abituato a patire il freddo per le gelide e nebbiose strade della città, può finalmente contare su un oggetto che lo terrà al riparo dalle intemperie, ma quando finalmente indossa il suo soprabito, blandito dal sarto che l’ha cucito su misura per lui, e si guarda allo specchio, si capisce subito che ad agire non è il sollievo per il soddisfacimento di un bisogno materiale. Quella che gli viene restituita, in termini di riflessività, è l’immagine di un uomo nuovo e diverso. Un uomo che ha cambiato status, che può aspirare a ben altri riconoscimenti, più sicuro di sé, libero finalmente di avere accesso a cose che prima gli erano precluse. A ratificare questo cambiamento radicale di prospettiva sarà un ballo con la bellissima e ricca signora, amante del sindaco, interpretata da una colossale Yvonne Sanson, che gli aveva precedentemente fatto l’elemosina. Un ballo che sarebbe stato impensabile solo qualche giorno prima e che l’uomo sente di meritare solo indossando il fatidico cappotto. Quella stessa sera, peraltro, l’impiegato formula uno strano discorso, in cui perora la causa della povera gente di fronte a un gruppo di potenti della città, forte della sua nuova condizione di privilegiato e convinto di poter finalmente dire la sua. Un discorso che viene accolto con estrema freddezza e sancisce definitivamente l’estraneità fra il personaggio e i suoi interlocutori. Quello che accade dopo fa parte della logica del racconto morale: l’uomo viene derubato del cappotto, non riceve più alcun aiuto o comprensione, cade in depressione e muore. Il suo funerale diviene un monito per tutta la popolazione e il suo fantasma tornerà
Habitus Giacomo Manzoli
17
a tormentare la comunità fino a disvelarne l’ipocrisia e causarne il ravvedimento, seguendo il filo di quel realismo magico che è uno sei substrati di tutto il cinema italiano dell’epoca neorealista (Cesare Zavattini, assieme a Luigi Malerba, Giorgio Prosperi e Leonardo Sinisgalli firma la sceneggiatura del film). Ma ciò che rende davvero paradigmatico il film è contenuto in due fattori, uno legato al racconto, l’altro alle condizioni produttive che ne hanno reso possibile la realizzazione. Il cappotto (Lattuada, 1952), infatti, denota una sensibilità particolarissima, molto italiana, per tutti quei significati sociali impliciti che riguardano l’arte del vestire. Il cappotto di Rascel, in altri termini, non è referenzialmente solo un abito, bensì allude direttamente, secondo un’equivalenza perfino troppo trasparente e meccanica, al concetto di habitus. Indossare quel lussuoso capo di vestiario, per il povero impiegato, significa poter accedere ad una diversa posizione sullo scacchiere sociale. Non essere più solo un oscuro poveraccio fra gli altri, ma una persona di cui è riconosciuto lo status e il valore sociale. La prima cosa che egli fa, appena indossato il demiurgico outfit, è una passeggiata per le strade della città – seguito a breve distanza dal sarto, che svolge il ruolo della fatina nella celebre favola di Cenerentola – per verificare l’effetto che il nuovo vestiario produce sui concittadini. Come dire che la sua gratificazione interiore ha immediatamente bisogno di una conferma nelle reazioni degli altri attori sociali. A questo punto, ottenuta la controprova, l’uomo può finalmente agire in maniera più libera e sfrontata, sentendosi come gli altri “potenti” di cui aveva fin lì subito le umiliazioni. Partecipa, insomma, dei privilegi che la nuova condizione comporta, e può confrontarsi da pari con individui che detengono un capitale sociale (la bellezza), simbolico (la carica pubblica) o economico (il capitale degli imprenditori) dal quale egli era escluso. Naturalmente si tratta di un’illusione, perché di questo status e di questa posizione elevata nel campo sociale della città di provincia egli possiede solo i segni esteriori. Infatti, non solo il cappotto gli può essere tolto facilmente da un vagabondo qualsiasi durante il ritorno a casa sul ponte coperto che attraversa il Po (un luogo evidentemente non scelto a caso, che allude ad un attraversamento fermato a metà strada). Soprattutto, anche quando detiene un simbolo di status, Rascel dimostra di non avere introiettato l’in-
18
Lessico del cinema italiano
sieme di disposizioni che caratterizzano l’appartenenza a quella determinata fascia sociale. Parla in maniera inopportuna, non sa stare a tavola, è comunque e sempre un parvenu e incoraggia le condizioni di uno stigma e di una espulsione. La retrocessione di status gli sarà fatale: tornare a indossare l’habitus dell’umile, del piccolissimo borghese anonimo, produrrà in lui un trauma dal quale non potrà riaversi. E questo ci introduce al secondo elemento di interesse del film, legato alle condizioni oggettive che lo hanno reso possibile. Perché Il cappotto viene prodotto dalla Faro Film, casa di produzione siciliana, fondata dall’avvocato Enzo Curreli e da un gruppo di professionisti e imprenditori messinesi, che si rivolge alla produzione di documentari prima e di lungometraggi poi, con l’ambizione di promuovere un cinema culturalmente elevato, d’autore, ispirato preferibilmente a quei capolavori letterari che costituivano per loro la base del cosiddetto capitale culturale legittimo, trasmesso attraverso la scuola e le altre istituzioni culturali ufficiali. Si tratta di un fatto interessante, perché il film affronta – come abbiamo cercato di spiegare – un punto essenziale del rapporto fra individuo e società, ovvero del ruolo delle disposizioni mentali in base alle quali si costruiscono le relazioni fra individui che poi, a loro volta, vanno a costituire il campo sociale propriamente detto, di cui il microcosmo provinciale sembra costituire una perfetta metafora. Eppure, per lo stesso Lattuada, «i caratteri del suo racconto sono caratteri universali ed esemplari e quindi i valori della storia raccontata da Gogol sono validi in qualunque parte del mondo ed in qualunque tempo: la tirannia e la cecità burocratica»8; e questa spiegazione appare del tutto convincente anche alla maggior parte dei critici dell’epoca9. Come dire che il film riesce sì a percepire il problema essenziale che riguarda chiunque – come Rascel – si trovi ad occupare una posizione del campo sociale rispetto alla quale avverte di essere sottostimato, nonché la dialettica fra aspetti soggettivi (psicologici) e oggettivi (le risorse a disposizione) che definiscono la struttura sociale, ma – come accadrà quasi sempre in un 8 9
Così il regista in Intervista ad Alberto Lattuada, in “Cinema”, n. 86 (1952), p. 259. Si veda, al riguardo, la rassegna contenuta in «Il cappotto» di Alberto Lattuada: la storia, lo stile, il senso, a cura di L. Micciché, Lindau, Torino 1995, p. 49.
Habitus Giacomo Manzoli
19
cinema promosso da una ricca borghesia di provincia che mette in scena se stessa – questo problema viene frettolosamente risolto nei termini di un «moralismo politico»10 o del «moralismo umanista» del filosofo esistenzialista cristiano Gabriel Marcel. Vale a dire che, in sostanza, pare che sia la cattiveria degli uomini ad aver prima spinto il povero e puro Renato Rascel sulla via della corruzione e che vi sia una specie di inconscio sociale (la Provvidenza?) ad aver determinato la sua punizione e il suo ritorno fantasmagorico per il ravvedimento dei vivi. È insomma il libero arbitrio del soggetto a causare il precipitare degli eventi, sia quello forzato da fattori esogeni (la malvagità del mondo) della vittima sia quello dei suoi carnefici, corrotto dall’avidità. Sicché, la vecchia logica del sacrificio purificatore che riconduce la comunità sulla retta via dell’onestà e della solidarietà, appare la soluzione naturale del problema posto dal film. Invece, come spesso capita, il reale fa resistenza. Le storie (specie quelle concepite dal genio di Gogol) rivelano un’intelligenza nel captare le dinamiche profonde e invisibili su cui si basano le relazioni umane assai superiore a quella che i loro autori riescono a dimostrare nelle loro concettualizzazioni. Perché “la tirannia e la cecità burocratica” possono spiegare molte cose, ma non certo la vertigine mostrata dal formidabile Rascel nell’indossare un collo di pelliccia o la gratificazione, capace di sanare qualsiasi umiliazione e senso di inadeguatezza, derivante da un ballo fra le braccia di Yvonne Sanson, che non è più “solo” un simbolo erotico ma un simbolo del riconoscimento implicato nella possibilità di accedere al contatto con un simbolo erotico. E se il cappotto è un habitus, il “peccato” di Rascel è allora quello di aver indossato un insieme di disposizioni mentali che non si poteva permettere, non disponendo dei capitali (sociali, simbolici, economici) necessari, e di essersi dunque messo in testa comportamenti che turbavano la struttura del campo. La sua morte, così artificiosa, e le conseguenze altrettanto magiche di questa dipartita, finiscono perciò per alludere al ristabilirsi di un ordine simbolico che sta alla base dell’ordine sociale. Semplificando, sarebbe sufficiente che i sindaci rubassero un po’ meno, che i segretari generali fossero un po’ più gentili 10
Secondo la definizione offerta da P. Bourdieu e J.-C. Passeron in Sociology and Philosophy in France since 1945. Death and Resurrection of a Philosophy without Subject, in “Social Research”, n. 34 (1967), pp. 162-212.
20
Lessico del cinema italiano
coi loro impiegati, che un minimo di distribuzione delle risorse consentisse loro di non patire troppo freddo durante l’inverno, ed ecco che ciascuno potrebbe serenamente indossare il suo cappotto di pertinenza, stare serenamente al proprio posto, senza il timore di decapitazioni zariste. Un po’ di violenza simbolica in meno per garantire la conservazione dei rapporti di forza. Divi da salotto (con un chiarimento metodologico) Quelli che abbiamo descritto fino a questo punto sono esempi relativi a come il cinema italiano ha trattato – con una sensibilità assolutamente peculiare – la complessa relazione che la cultura nazionale, o per meglio dire il soggetto nazionale, intrattiene con l’idea di habitus, ovvero con quell’insieme di disposizioni che determinano il cosiddetto “universo dei possibili” e consentono ad una comunità di accordarsi istintivamente sul senso da attribuire ai fenomeni, alle azioni, ai discorsi. In una sola parola, al reale. Si tratta di una sensibilità quasi obbligata, perché una serie di ragioni storiche – come ha dimostrato Suzanne Stewart-Steinberg11 – hanno fatto dell’Italia, fin dalla sua nascita come Stato unitario, una nazione in cui questo elemento costitutivo della soggettività individuale e collettiva è una questione piuttosto contorta e di difficile soluzione. È necessario a questo punto fare una digressione metodologica e soffermarci un attimo a chiarire la nozione di habitus alla quale stiamo facendo riferimento. Perché il concetto di habitus inizia a circolare nel pensiero sociologico e antropologico già negli anni cinquanta, grazie soprattutto a Marcel Mauss12 secondo il quale il termine, di derivazione aristotelica, è perfetto per indicare: «Le abitudini collettive che variano da una società all’altra. A differenza di Tarde, che vede nel11
12
Cfr. S. Stewart-Steinberg, L’effetto-Pinocchio. Italia 1861-1922: la costruzione di una complessa modernità, Elliot, Roma 2011 [ed. or. The Pinocchio Effect. On making Italians, 1860-1920, The University of Chicago Press, Chicago 2007]. Vedi M. Mauss, Sociologia e antropologia, Newton Compton, Roma 1976 [ed. or. Sociologie et Anthropologie, Presses Universitaires de France, Paris 1950].
Habitus Giacomo Manzoli
21
la comunanza di pratiche il risultato dell’imitazione, per Mauss è attraverso l’educazione e in particolar modo l’addestramento dei corpi, che non soltanto le rappresentazioni sociali, ma anche le regole di comportamento e le pratiche vengono interiorizzate, incorporate»13. A rilanciare il vocabolo sarà quindi all’inizio degli anni sessanta Jürgen Habermas, il quale lo spenderà nel corso di una celebre indagine sugli orientamenti politici degli studenti14 in cui prendeva in esame specialmente la nozione di partecipazione, ovvero di impegno. Secondo il grande sociologo francofortese, tale idea è un tipico prodotto della società borghese e ne rispecchia una delle principali contraddizioni. I giovani, infatti, ritengono di voler esprimere determinazioni che li rappresentano in quanto tali, per lo più in una chiave antagonista rispetto alla struttura sociale esistente. Ma poiché essi stessi sono il prodotto di quella stessa struttura, la loro partecipazione non farà altro che confermarla e rafforzarla, giacché essi giocheranno il ruolo che gli è stato assegnato e che sono programmati per eseguire. Ed è a questo programma che Habermas attribuisce il nome di habitus, al meccanismo che li porta a partecipare con la sincera convinzione di essere rinnovatori radicali laddove materialmente le loro istanze finiscono per svolgere un ruolo conservativo. È a questo stesso termine che farà riferimento invece Erwin Panofsky, allorché lo utilizzerà per indicare la forma simbolica che risulta dalle “percezioni comuni” sia alla filosofia scolastica sia all’arte gotica dalle quali deriva un singolo modus operandi, uno stile (incarnato in una pluralità di opere letterarie, pittoriche e architettoniche) capace di unificare pratiche apparentemente disparate e di dar conto di una intera visione del mondo15. 13
14 15
G. Sapiro, Una libertà vincolata. La formazione della teoria dell’«habitus», in Bourdieu dopo Bourdieu, a cura di G. Paolucci, Utet, Torino 2010, p. 96. Al saggio della Sapiro rimandiamo per una dettagliata trattazione di come il concetto si sia evoluto nella seconda metà del XX secolo. La prima pubblicazione dell’indagine è del 1961 ed è poi confluita in J. Habermas, Cultura e critica, Einaudi, Torino 1980 [ed. or. Kultur und Kritik, Suhrcamp Verlag, Frankfurt 1973]. Cfr. E. Panofsky, Architettura gotica e filosofia scolastica, Liguori, Napoli 1986 [ed. or. Gothic Architecture and Scholasticism, Archabbey Publications, Latrobe 1950].
22
Lessico del cinema italiano
A tradurre in francese l’opera di Panofsky sarà Pierre Bourdieu, che già si andava affermando, alla fine degli anni sessanta, come uno dei sociologi francesi più rigorosi e provocatori. In opere come quelle scritte con Jean-Claude Passeron16, proprio in quel periodo stava mettendo in discussione le stesse basi del sistema scolastico occidentale, ritenendo che la gerarchia dei saperi e il privilegio accordato a tutta una serie di competenze, di capacità (specialmente verbali), di modi di trasmissione della conoscenza, servisse prima di tutto a far introiettare agli allievi l’ordine sociale esistente. Una volta appreso, sia a livello psicologico sia a livello corporale (incorporato), essi a loro volta lo avrebbero riprodotto, garantendone la conservazione. Da qui, Pierre Bourdieu, attraverso un lungo percorso di avvicinamento che passa per un rapporto controverso con autori come Émile Durkheim, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, Ernst Cassirer e molti altri, arriverà ad elaborare un complesso sistema di descrizione della realtà sociale, che ruota fondamentalmente attorno a tre nozioni: capitale, campo e, appunto, habitus. In opere come La distinzione. Critica sociale del gusto o Le regole dell’arte17, Bourdieu descrive tutti gli ambiti in cui si estrinseca la vita sociale degli individui come un ideale campo sportivo, nel quale ciascuno degli attori svolge un ruolo in funzione delle regole del gioco, del valore e del compito che gli è stato attribuito. Perché il campo si costituisca, ovvero perché il sistema funzioni, tali attori devono prendere per vere le regole, provare un interesse reale per la posta, darle una sostanza e cercare di ottenerla col massimo impegno. Sempre ad un alto livello di astrazione, si può dire che il loro scopo ultimo è ottenere un forte riconoscimento e risalire il campo, occupando una posizione di sempre maggiore preminenza. Ma è chiaro che questo provoca una tensione, anch’essa 16
17
Soprattutto in P. Bourdieu, J.-C. Passeron, La riproduzione. Sistemi di insegnamento e ordine culturale, Guaraldi, Rimini 1972 [ed. or. La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement, Les Éditions de Minuit, Paris 1970]. Cfr. P. Bourdieu, La distinzione. Critica sociale del gusto, il Mulino, Bologna 1983 [ed. or. La distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, Paris 1979]; Id., Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario, Il Saggiatore, Milano 2005 [ed. or. Les régles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, Paris 1992].
Habitus Giacomo Manzoli
23
costitutiva del campo, giacché coloro che attualmente occupano posizioni privilegiate adotteranno strategie utili a conservare il loro dominio, specialmente attraverso l’esercizio di una violenza simbolica. Ebbene, gli strumenti che ciascuno degli individui può utilizzare per giocare (le carte che ha in mano) definiscono il suo capitale, che può essere di natura simbolica (il capitale culturale), prettamente economica (le risorse materiali) o sociale (il capitale di conoscenze e di relazioni e quei fattori che contribuiscono ad aumentarlo o conservarlo). Tuttavia, perché questa dinamica si sviluppi in maniera fluida, perché le cose funzionino bene, nel campo sociale come nei tanti sotto-campi che lo compongono, serve che i soggetti si attengano alle regole, che si comportino in maniera appropriata, seguendo un copione complesso, che è dato da un insieme di fattori: percezione delle cose, di se stessi e degli altri, schemi interpretativi che consentano di dare un senso compiuto agli avvenimenti, modi di parlare, di porsi, di vestirsi, di atteggiarsi, di relazionarsi idealmente e fisicamente agli altri, tali da accordarsi con le aspettative con cui ciascuno si cala nelle differenti situazioni. È questo insieme di regole a costituire l’habitus, grazie al quale ci si può inserire efficacemente sullo scacchiere sociale. Si tratta di un impasto estremamente complesso e articolato di precetti e concetti, illusioni che diventano fatti concreti, percezioni e disposizioni intellettuali che diventano facilmente materia fisica, modi di pensare che si convertono in modi di essere e ci determinano per quello che siamo. Questo, peraltro, in maniera generativa18, giacché è nel momento in cui assumiamo tali regole del campo per vere e le mettiamo in pratica, applicandole con un certo contributo individuale di improvvisazione, che andiamo a costituire e rafforzare il campo in questione, secondo il principio apparentemente paradossale della «struttura strutturante e strutturata». È l’habitus che abbiamo assorbito a far sì che, interagendo con altri che lo condividono, possiamo creare il campo sociale e tutti quei sotto-campi di cui si è detto, da quelli politici a quelli profes18
È proprio dall’opera di Noam Chomsky che Bourdieu riesce a dare un aspetto dinamico a una teoria che altrimenti avrebbe avuto un aspetto eccessivamente statico e non sarebbe riuscita a dar conto dei mutamenti sociali.
24
Lessico del cinema italiano
sionali, da quello scolastico a quello culturale, che a sua volta può essere suddiviso nelle sue diverse componenti: il campo letterario, il campo cinematografico, il campo artistico, il campo della ricerca scientifica e così via. Ed è naturalmente l’efficacia di questi habitus a mantenere in piedi un sistema equilibrato, che consente a ciascuno di ottenere le risorse che può ragionevolmente aspettarsi – poche o tante che siano – a determinarne la sopravvivenza e la stabilità, giacché se l’habitus si rivela fallimentare, i soggetti iniziano a manifestare una propensione al suo aggiornamento19. A partire da questi presupposti, crediamo sarà chiaro il motivo per cui, come vedremo, in termini di forme simboliche, la propensione al trasformismo di Fregoli indica un tipo di relazione molto particolare con il principio di incorporazione dell’habitus che contraddistingue il contesto italiano, e non è dunque un caso se «l’Italia è uno dei paesi europei che si sono mostrati più refrattari al pensiero di Bourdieu»20. Come se una serie di fattori storici – dalle Signorie al «familismo amorale»21, fino alla debolezza endemica dell’apparato statale – interferissero con la capacità dei soggetti di costruire un habitus stabile ed efficiente attraverso il quale mantenere solidamente in essere la struttura e la logica del campo di riferimento. Ed è un fattore che caratterizza anche la nascita e l’evoluzione del campo cinematografico e il modo con cui questo – attraverso i suoi prodotti – riflette la realtà italiana circostante. È nota a tutti la profondissima crisi industriale, tecnologica e creativa che investe il cinema italiano nel corso degli anni venti. Il sistema produttivo italiano non arriverà mai compiutamente a costituirsi come un’industria, con apparati tecnologici ed economici in grado di reggere il confronto con la concorrenza straniera, e la controprova si ha quando – dopo la Prima guerra mondiale 19
20 21
È la tesi espressa in W.H. Sewell Jr., Una teoria della struttura: dualità, agency, trasformazione, in Studiare la cultura. Nuove prospettive sociologiche, a cura di M. Santoro, R. Sassatelli, il Mulino, Bologna 2009, pp. 83-114. A. Boschetti, La rivoluzione simbolica di Pierre Bourdieu, Marsilio, Venezia 2003, p. 9. Per il concetto di familismo amorale si veda, ovviamente, E.C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, il Mulino, Bologna 1976 [ed. or. The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, Glencoe 1958].
Habitus Giacomo Manzoli
25
– altri paesi come la Francia, la Germania e soprattutto gli Stati Uniti si presentano con assetti robusti e l’Italia tenta di replicare con la costituzione di un consorzio come l’Unione Cinematografica Italiana, destinato a risolversi con una scriteriata e fallimentare speculazione22. Ma il fenomeno è visibile anche nella matrice sostanzialmente letteraria e teatrale attorno alla quale si sviluppa un cinema “colto”, costantemente in cerca di una legittimazione che rimanda ad una eteronomia del campo, giacché l’appartenenza a quello di competenza non garantiva una posizione sufficientemente alta nel più ampio campo culturale, a fronte delle aspettative di quadri che per lo più provenivano dalle fila della borghesia o perfino dell’aristocrazia23. In questa chiave vanno interpretate le frequenti rivisitazioni cui sono sottoposti i testi danteschi (Il conte Ugolino, 1908, di De Liguoro, L’inferno, 1911, di Bertolini, De Liguoro e Padovan, Il purgatorio, 1911, di Berardi e Busnego, Dante e Beatrice, 1913, di Caserini, Amor ch’a nullo amato, 1917, di D’Accursio, Pia de’ Tolomei, di Zannini, 1921, e la lista potrebbe continuare all’infinito24) o ispirati a opere canoniche della letteratura nazionale o internazionale. Ma, soprattutto, la patologica insistenza sulla trasposizione di opere dannunziane (L’innocente, 1911, e La nave, 1912, di Edoardo Bencivenga, Cabiria, 1914, di Giovanni Pastrone – che di D’Annunzio si limita a utilizzare il brand25 – La crociata degli innocenti, 1917, di Alessandro Blasetti e così via). Ed è proprio La nave (1921) di Gabriellino D’Annunzio e Mario Roncoroni ad aiutarci a capire questa schizofrenia dell’habitus dei cineasti e del cinema italiano più in generale26.
22
23 24 25 26
Al riguardo si veda G. Bursi, G. Manzoli, Tra velleità e speculazione: la produzione postbellica e l’UCI, in Storia del cinema italiano 1924/1933, a cura di L. Quaresima, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Venezia-Roma 2014, pp. 25-41. Giovanni Pastrone, ad esempio, era diplomato al Conservatorio e faceva parte dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Per una filmografia completa si veda G. Casadio, Dante nel cinema, Longo, Ravenna 1996. Sul film di Pastrone si veda il sintetico ma ottimo S. Alovisio, Cabiria. Lo spettacolo della storia, Mimesis, Milano 2014. Cfr. G. Manzoli, Un affollato rito wagneriano. “La nave” di Gabriellino D’Annunzio e Mario Roncoroni, in “La Valle dell’Eden”, n. 6 (2000), pp. 53-65.
26
Lessico del cinema italiano
Mentre il paese vive i traumi e le ferite di una tragica guerra da poco conclusa, dimenandosi in una crisi economica e istituzionale, mentre si vanno profilando quei conflitti sociali che porteranno – appena un anno più tardi – alla marcia su Roma e mentre la cultura italiana è attraversata dalle scosse elettriche del Futurismo, l’UCI (sia pure per il tramite della Ambrosio, una delle sue affiliate) ha la brillante idea di investire capitali ingentissimi nella realizzazione di un melodramma storico-mitologico, dove masse in costume fanno da cornice alle disavventure dei fratelli e tribuni Sergio e Marco Gratico, entrambi innamorati della bella Basiliola, in un oscuro e manierato intreccio di eventi e gesti iperbolici di chiara derivazione simbolista. Un disastro, sia estetico sia, di conseguenza, commerciale, che testimonia l’incapacità del campo cinematografico a costituirsi come tale, restando legato a quei moduli espressivi e a quei modi di rappresentazione che pure – nella logica delle attrazioni – avevano determinato il successo, ma un decennio prima, dei cosiddetti “diva-film”. Perciò, se il core-business del cinema italiano muto è soprattutto la testimonianza della complicata (e perdente) interazione fra un mezzo a vocazione popolare e l’habitus aristocratico dei suoi attori e registi, è al cinema “basso” che conviene guardare per avere un ritratto più realistico delle tensioni reali che caratterizzavano la società italiana del periodo. È nelle comiche mute, legate per lo più a maschere facilmente riconoscibili come quelle impersonate dai vari Ferdinand Guillaume (Polidor), André Deed (Cretinetti), Marcel Fabre (Robinet) e molti altri, che si ritrovano “ultracorpi” capaci di far emergere l’inconscio sociale legato agli habitus con la loro sistematica incapacità di adeguarsi alle circostanze27, ben al di là di quella che ad una prima osservazione era sembrata solo una incursione rumorosa ma innocua, uno scompiglio bambinesco nel salotto buono della borghesia italiana.
27
Al riguardo si vedano, Il comico muto italiano, a cura di P. Cherchi Usai, L. Jacob, in “Griffithiana”, n. 24-25 (1985) e M. Canosa, G.-L. Farinelli, N. Mazzanti, Storie di corpi in estinzione, in Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo, a cura di R. Renzi, Cappelli, Bologna 1991.
Habitus Giacomo Manzoli
27
Basta pensare a film come Totò entusiasta della nuova moda (1911), di e con Emilio Vardannes, della torinese Itala Film, dove il protagonista impazzisce per un nuovo tipo di vestiario visto in una vetrina. Si tratta di mutandoni femminili che oggi ci apparirebbero a dir poco vittoriani, ma che nel repressissimo comico scatenano una libido irrefrenabile, tanto che decide di trovare al più presto una donna così disinibita da indossarne uno analogo. Da qui partono una serie di disavventure, perché come vuole una lunga tradizione feticista, l’uomo è talmente ossessionato dall’indumento da vederlo ovunque: nei finimenti di un palcoscenico dove si esibisce un’orchestra, sotto la sottana di una signora che sta passeggiando assieme al marito, in un turco che indossa il classico pantalone largo ottomano. È chiaro che, nella sua ossessione grottesca, il comico sta esprimendo in realtà l’urgenza di una revisione del disciplinamento della sessualità, ma non può che fallire miseramente nel suo intento, giacché il contesto appare ben poco ricettivo. Al contrario, in La moda vuole l’ala larga (1912) di e con Ernesto Vaser, il corpulento comico è alle prese con l’effetto iperbolico dei cambiamenti della moda e con tutte le conseguenze che possono derivare dall’inadeguatezza di un capo di vestiario nel proiettare un’identità adeguata a quella che il soggetto intende comunicare agli altri. Un problema di rapporto fra sé e il mondo, mediato da un indumento. Nello specifico, si tratta di un cappello, giacché tutto prende le mosse dalle prese in giro che l’uomo è costretto a sopportare a causa di un copricapo troppo piccolo. Per rimediare, allora, indossa un cappellone gigantesco, una specie di disco volante, che lo porta a disavventure paradossali: prima distrugge tutto ciò che gli capita davanti e decapita un passante, quindi provoca una specie di tornado, offre riparo a due signorine dalla pioggia, viene sollevato in volo e poi sbalzato in acqua. Alla fine, il cappello si rivela un’ottima trappola per pesci, e grazie ad esso Fringuelli (così si chiama il personaggio) si procura un ottimo pasto. Il film, in pratica, descrive in una cornice surreale tutti i processi identitari connessi alla moda e ai fattori simbolici incorporati nei vestiti: processi di costruzione e affermazione di un habitus, delle reazioni – positive e negative – che questo nuovo assetto può determinare nel contesto di riferimento, di raggiungimento o meno degli obiettivi socialmente strategici – in termini di risorse sociali
28
Lessico del cinema italiano
e materiali che è possibile ottenere grazie al nuovo habitus – che egli si prefigge. E in questo senso, rispetto ai ruoli sociali, alle identità di genere, alla classe sociale, alla condizione anagrafica e così via, lavorano con acume probabilmente involontario la maggior parte delle comiche finali. E sempre nella logica popolare del comico esiste un momento straordinariamente emblematico che vale la pena citare. All’inizio del lungometraggio Pinocchio (1911) di Giulio Antamoro, il protagonista – che è interpretato dal già citato Ferdinand Guillaume –, il comico si presenta su un palcoscenico teatrale, vestito in maniera elegante, e saluta il pubblico con la più classica delle interpellazioni. Quindi si produce in un salto morale grazie al quale, attraverso il solito trucco dell’arresto e sostituzione, si trasforma nel personaggio Pinocchio; infine, il palcoscenico si trasforma nella casa di Geppetto, mostrata attraverso codici realistici prettamente cinematografici, e la vicenda può cominciare. È un momento pregnante sotto il profilo simbolico, in cui il cinema esprime in maniera quasi programmatica la volontà di emanciparsi da modi di rappresentazione appartenenti ad altri sistemi espressivi per elaborarne uno autonomo, completando il processo di rimediazione28. Proseguendo nella visione dei film, la storia canonica di Pinocchio così come concepita da Collodi, viene costantemente ibridata con aggiunte di ogni tipo, provenienti da diverse serie culturali: Pinocchio finisce in America, viene rapito dagli indiani, salvato dalle giubbe rosse e infine attraversa l’oceano su una palla di cannone, a dimostrazione che il media cinematografico (o coloro che se ne fanno interpreti) sta cambiando habitus e si sta perfettamente integrando nel contesto e nella logica intertestuale e intermediale di quella che più avanti verrà definita cultura di massa29.
28
29
Il riferimento è ovviamente al concetto di rimediazione così come esposto in J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation: competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Guerini, Milano 2002 [ed. or. Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge MA 1999]. Cfr. F. Colombo, La cultura sottile. Media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni Novanta, Bompiani, Milano 1998.
Habitus Giacomo Manzoli
29
In principio era il travestitismo: Leopoldo Fregoli e il Fregoligraph Le origini del nostro cinema sono quanto mai problematiche giacché uno dei momenti fondamentali della diffusione del nuovo apparato nel nostro paese coincide con il suo utilizzo da parte di un artista che ha stravolto il concetto stesso di teatro, espandendolo in direzioni inesplorate, ha operato una fusione involontariamente futurista fra cultura alta e cultura bassa, ruotando attorno alla pratica del trasformismo e del travestitismo, ovvero della intercambiabilità straniante degli habitus. E ha, infine, dato prova di una radicale incapacità ad abbandonare il proprio habitus di uomo di teatro, dimostrando in modo inequivocabile quanto il proprio punto di vista soggettivo di figura di punta del campo teatrale fornisse una resistenza formidabile rispetto all’intraprendere compiutamente la trasformazione in cineasta, rispetto alla quale era stato egli stesso a fornire un possibile manuale di istruzioni. Nato a Roma nel 1867, Leopoldo Fregoli trascorre una giovinezza sregolata fino a quando, appena quindicenne, incontra Pietro Cossa ed entra a far parte della sua compagnia teatrale. La vocazione è forte, ma il talento tarda a manifestarsi. La folgorazione avviene alcuni anni più tardi, lontano dalla patria e dai suoi palcoscenici. Durante la campagna d’Africa si arruola come volontario e, incaricato di allestire spettacoli per allietare il morale delle truppe, si inventa numeri di travestitismo che ottengono immediatamente un clamoroso successo su quel pubblico indubbiamente esigente e composito, colpito dalla maniera innovativa e sorprendente con cui l’attore riesce a ironizzare sul principio della divisa e su quanto essa (più o meno implicitamente) rappresenta. Il nesso fra divisa e ruoli sociali è indubbiamente alla base della futura fortuna di Fregoli, ma la portata innovativa e dunque il successo del suo teatro non consistono certo in questo presupposto, trattandosi di un principio già noto ai tempi della commedia dell’arte. Ciò che Fregoli si è inventato è sostanzialmente una maniera di ironizzare non solo e non tanto sulla contemporanea verità e falsità della già citata massima secondo cui “l’abito non fa il monaco”, quanto sulla maniera sintetica e stereotipata con cui si è soliti leggere la realtà sociale basandosi su alcuni elementi estremamente formalizzati e sulla crisi di questa maniera, “troppo” rigida e statica, di interpretare il reale.
30
Lessico del cinema italiano
Appena un anno dopo (1890) Fregoli debutta nella capitale, con uno spettacolo di trasformismo al caffè-concerto Esedra. Il successo è tale che in brevissimo tempo egli ha la possibilità di costituire una sua compagnia e di ottenere scritture da parte di tutti i principali teatri italiani e internazionali. Fra il 1895 e il primo decennio del Novecento è sicuramente l’attore italiano che ottiene il più ampio e lusinghiero successo di pubblico attraverso una forma teatrale che ha la straordinaria peculiarità di tenere insieme lo spettatore del teatro tradizionale e quello del cosiddetto teatro delle varietà, essendo ugualmente accessibile per entrambi. Evidentemente l’altissima qualità performativa applicata ad un repertorio risaputo attribuisce a questi spettacoli un bizzarro equilibrio, grazie al quale un’idea di sperimentazione consente di trattenerli nell’area della cultura alta senza tagliare i ponti con la matrice popolare da cui provengono. Fregoli è un mito ma soprattutto un divo, nel senso cinematografico del termine: i sovrani si onorano della sua amicizia e gli attori drammatici più austeri ostentano con lui una benevola familiarità, mentre commediografi popolareschi come Eduardo Scarpetta scrivono commedie non per ma su di lui (Fregoli e le sue trasformazioni, messa in scena nel 1898). Senza timore di facili calembour possiamo dire che si tratta di un fenomeno di costume, le cui coordinate sono le stesse che riguarderanno le future stelle dello schermo più che l’aura sacrale dalla quale sono avvolti i grandi interpreti del teatro classico. Senza dilungarci sulla struttura dei suoi spettacoli, composti da più atti, in genere quattro, nel corso dei quali egli si cimenta con numeri eterogenei accumulatisi a centinaia nel corso degli anni (ragion per cui sarebbe insensato cercare di ricostruire il suo repertorio), vale però la pena cercare di capire quali siano i fondamenti del tipo di teatro del quale egli è, di fatto, un inventore e che avrà una serie pressoché infinita di imitatori e successori30. 30
Rispetto agli imitatori rimandiamo a quelli ricordati da Bernardini (Leopoldo Fregoli, “Cinematografista”, in A nuova luce. Cinema muto italiano I, a cura di M. Canosa, Atti del convegno internazionale – Bologna, 12/13 novembre 1999, Clueb, Bologna 2000, p. 187), ovvero attori di cui è rimasto in pratica solo uno pseudonimo assonante, quali Frizzo o Fremo, mentre fra i successori possiamo annoverare una lunga discendenza che va, con esiti chiaramente differenti, da Petrolini a Fiorello.
Habitus Giacomo Manzoli
31
Abbiamo detto che Fregoli è innanzitutto un trasformista. Questo significa che dal teatro, per così dire, tradizionale mutua una spasmodica attenzione per la preparazione della messa in scena fin nei minimi dettagli, declinandola però nella direzione – prettamente performativa – tipica del campione sportivo, la cui componente teatrale sarà uno dei leitmotiv della teoria teatrale novecentesca31. In pratica conta più la spettacolarità dell’atto straordinario in quanto tale della sua funzionalità nell’economia drammaturgica del testo teatrale. Oppure, per meglio dire, il testo teatrale in cui tale atto si inscrive deriva il suo stesso significato dalla successione di questi atti formidabili. Allo stesso tempo, però, l’eredità del café-chantant e del varietà si concretizza nella conservazione di un’arte che «è tutta nell’abilità individuale di relazionarsi al contesto e di agire su di esso»32. Per la verità, secondo uno dei pochi studiosi del teatro delle varietà del periodo, Stefano De Matteis, chi porta al suo massimo splendore questo tipo di teatro sarà Ettore Petrolini, laddove Fregoli ne sarebbe stato più che altro un eccelso precursore33. La tesi pare avere un fondamento, e potrebbe essere illustrata in questo modo: Petrolini è colui che porta a compimento, stabilizza in maniera organica una forma di teatro che costituisce l’anello di congiunzione fra lo spettacolo popolare e il teatro di avanguardia (per esempio quello futurista e dadaista), laddove Fregoli sarebbe colui che per primo l’ha intuita, svelandone le potenzialità ma limitandosi a realizzarne una versione artigianale, spuria, dove l’illuminazione geniale conviveva con numeri di basso profilo, segno di un’attitudine al bric-à-brac, alla selvaggia accu-
31
32
33
Rispetto a tale questione, ma non solo, si veda G. Guccini, Rappresentazione e presenza: l’attore fra teatro e cinema, in L’uomo visibile. L’attore dalle origini del cinema alle soglie del cinema moderno, a cura di L. Vichi, Atti del VIII Convegno Internazionale di Studi sul Cinema, Udine, 21/24 marzo 2001, Forum, Udine 2002. S. De Matteis, Dal teatro delle meraviglie allo spettacolo delle illusioni, in Sperduto nel buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo (1905-1930), a cura di R. Renzi, Cappelli, Bologna 1991, p. 101. La tesi – almeno per quanto riguarda il ruolo di Petrolini – è rafforzata da Giovanni Lista, Petrolini e i futuristi, Edizioni Taide, Palermo 1981. La tesi è ripresa in altri testi: in M. Locuratolo, Invito al Cabaret, Mursia, Milano 2003, a Petrolini viene riservato grande spazio mentre la figura di Fregoli è consegnata – con indubbio eccesso – all’oblio.
32
Lessico del cinema italiano
mulazione di tutto quanto potesse in qualche modo interessare il pubblico, seguendo in egual misura il filo del talento e del caso. Resta il fatto che gli spettacoli di Fregoli affascinano e galvanizzano le masse un po’ in tutto il mondo, da tutti è a lui riconosciuta l’invenzione di un modo nuovo di far ridere e questo riso ha una portata rivelatrice che trascina con sé le stimmate della modernità. E, se è vero che sarà Petrolini a stringere in forma concreta il rapporto con i futuristi34, è altrettanto vero che è proprio Fregoli ad essere citato da Marinetti nel celeberrimo Manifesto del Teatro di Varietà del 191335 come incarnazione vivente delle tre componenti della vita moderna: la velocità, la simultaneità e la trasformazione. E Marinetti non fa che riproporre in chiave ideologica, da avanguardista, sensazioni che in maniera spontanea erano già state ampiamente descritte dai recensori a cavallo fra Ottocento e Novecento, come dimostra la ricca antologia raccolta da Luigi Colagreco36 nella quale una stampa locale entusiasta racconta Fregoli come una “corrente elettrica” o come “cinematografo vivente”. Futurismo di retroguardia Da un lato, dunque, tutto ciò che abbiamo fin qui ricordato fa degli spettacoli fregoliani l’ennesima prova del fatto che il cinema non sfugge alla regola secondo cui le invenzioni epocali non sareb34 35
36
Ad esempio nella messa in scena di Grigio, rosso, arancione di Bruno Corra e Settimelli o nella stesura, con Francesco Cangiullo, di un’opera di evidente impostazione futurista come Radioscopia. Cfr. F.T. Marinetti, Il Teatro di Varietà, in Marinetti e i futuristi, a cura di L. De Maria, Garzanti, Milano 1994. Ci piace riportare almeno il seguente brano, al punto 4 della sezione intitolata Il Futurismo vuole trasformare il Teatro di Varietà in teatro dello stupore, del record e della fisicofollia: «[…] Vivificare le opere di Beethoven, di Wagner, di Bach, di Bellini, di Chopin, introducendovi delle canzonette napoletane. – Mettere fianco a fianco sulla scena Zacconi, la Duse, e Mayol, Sarah Bernhardt e Fregoli. – Eseguire una sinfonia di Beethoven a rovescio, cominciando dall’ultima nota. – Ridurre tutto Shakespeare ad un solo atto». L. Colagreco (Il cinema negli spettacoli di Leopoldo Fregoli, in “Bianco e Nero”, n. 3-4, 2002, p. 42) raccoglie brani di recensioni di spettacoli di Fregoli da “La tribuna” del 13 marzo 1999 e da “Il Paese” del 16 ottobre 1907, nei quali è comune l’utilizzo del cinematografo come metafora, per cercare di rendere l’idea dell’impressione, del tutto inedita nella normale esperienza dello spettatore teatrale, che Fregoli era in grado di suscitare.
Habitus Giacomo Manzoli
33
bero tanto la frattura improvvisa di uno scenario definito quanto il prodotto di una sensibilità che in qualche modo le invoca, essendo pronta per un cambiamento e avvertendo la mancanza di un oggetto in grado di catalizzarlo. L’anno di svolta è il 1897: durante una rappresentazione al teatro Celestin, Fregoli viene a sapere che in sala è presente Louis Lumière, la cui recentissima invenzione è ovviamente già nota a un viaggiatore e uomo di spettacolo come lui. Come vuole il cerimoniale, egli invita il celebre industriale e inventore sul palco e riceve a sua volta un invito a visitare le omonime officine. Fregoli, appassionato di tecnologia e sempre in cerca di innovazioni scenografiche con cui arricchire i suoi spettacoli, accetta l’invito e trascorre un certo periodo di tempo in quel luogo dove si stanno inconsapevolmente gettando le basi della modernità. In pochi giorni apprende i rudimenti del cinematografo e ne esce con un apparecchio tutto suo, un certo numero di copie di vedute prodotte dai due fratelli e il permesso di proiettarli al termine dei suoi spettacoli. Quanto accade dopo è stato ricostruito da Aldo Bernardini con certosina pazienza e integrato poi da Luigi Colagrande. È ai loro testi che rimandiamo, limitandoci a riportare le tappe essenziali. A partire dal 1898 abbiamo le prove certe della comparsa del cinematografo negli spettacoli di Fregoli, prevalentemente nel quarto e conclusivo atto dello spettacolo. L’attore proietta i film dei fratelli Lumière, integrandoli con proiezioni di altri film che egli stesso realizza, proponendo così un programma articolato che subisce continue modificazioni nel corso del tempo, a mano a mano che egli ha modo di sperimentare la nuova invenzione e di impratichirsi nel suo utilizzo. In estrema sintesi, dalle fonti dirette e indirette di cui si dispone al momento, ovvero dal corpus di film fregoliani conservati presso la Cineteca Nazionale di Roma e recentemente analizzati da Adriano Aprà e dalla ricca serie di documenti raccolti dai citati Bernardini e Colagrande, è possibile cercare di riassumere la vicenda secondo il seguente schema. 1) Fregoli assicura al cinematografo una vastissima circolazione nazionale e internazionale, in luoghi deputati alla rappresentazione di spettacoli di valore culturale universalmente riconosciuto. 2) Fregoli compie, sull’apparecchio che gli è stato fornito dai Lumière, una serie di sperimentazioni che gli offrono la possibilità di personalizzarlo a partire dal nome, Fregoligraph, con cui l’at-
34
Lessico del cinema italiano
trazione compare nei programmi di sala e nelle pubblicità già a partire dal 1899. 3) I film di Fregoli si possono suddividere in varie dominanti. Opere “documentarie”, che vedono lo stesso Fregoli impegnato a svelare i trucchi del mestiere. Parodie o caricature, come Fregoli, danza serpentina (1897), in cui rifà il verso a Loïe Fuller e colleghe, o il noto Maestri di musica (1898), dove l’attore impersona, bacchetta alla mano, alcuni grandi della musica, Rossini, Verdi, Mascagni e Wagner, in una girandola che ne mette in risalto la natura di vere e proprie icone di una cultura d’élite che si avvia rapidamente a diventare cultura di massa. Scene comiche, alcune di repertorio (nei programmi figura, per dire, anche L’innaffiatore innaffiato) altre inventate da Fregoli stesso. L’ultima categoria di film che ci pare di poter individuare è forse quella più interessante, perché su di essa si basa il tentativo di integrare la forma spettacolare teatrale con quella cinematografica. Parliamo di quelle pellicole – segnatamente Segreto per vestirsi e Retroscena – in cui l’attore svela i suoi trucchi ma che, soprattutto, sono concepiti in funzione di un’interazione organica fra lo spettacolo in carne ed ossa visto sul palcoscenico e tutti quegli aspetti “segreti” che normalmente si considerano di esclusivo appannaggio degli addetti ai lavori e che il cinema consente di mostrare, mantenendoli in equilibrio tra realismo e illusionismo. Resta da capire se l’esperimento di Fregoli sia riuscito oppure no e provare a riassumere il senso complessivo, la morale dell’esperienza cinematografica da lui compiuta. Per quanto riguarda il primo punto, la questione è controversa. Dal punto di vista dell’efficacia teatrale, Luigi Colagreco, con l’entusiasmo del giovane studioso che prende partito per l’oggetto della sua (pregevolissima) analisi, è categoricamente positivo, giungendo ad affermare che «il cinematografo si integrava perfettamente nei suoi spettacoli in quanto ne costituiva il principio motore. Le sue fulminee trasformazioni, quasi a vista, rappresentavano una chiara metafora del dispositivo filmico»37. Che la seconda parte dell’affermazione sia vera è indubitabile: Fregoli si muove a una velocità prefuturista, è sintetico ed ellittico, si espri37
L. Colagreco, Il cinema negli spettacoli di Leopoldo Fregoli, cit., p. 59.
Habitus Giacomo Manzoli
35
me attraverso il corpo, con un linguaggio di valore universale la cui capacità di introspezione rispetto alle dinamiche sociali è già perfettamente filtrata attraverso quell’ironia tipica di gran parte del teatro d’avanguardia successivo (compreso lo humour nero e una certa dose di crudeltà). Attraverso le repentine trasformazioni e le continue inversioni di prospettiva, in Fregoli è pensabile che lo spettatore ritrovasse, registrata in toni che inclinano verso l’assurdo e condensata come in una serie di sovrimpressioni, l’esperienza dell’abitante della metropoli che tutti i cantori della modernità, da Baudelaire a Benjamin, passando per Kracauer, hanno ampiamente descritto38. Inoltre, ed è forse il dato fondamentale, Fregoli impersona tutti questi personaggi, entra in loro fisicamente e poi li dismette al ritmo vertiginoso di vestizioni studiate al dettaglio. In pratica è un primo e folgorante esemplare di uomo camaleonte, ovvero di uomo massa. Allo stesso tempo – ma potremmo dire di conseguenza – una perfetta metafora dello spettatore cinematografico che, attraverso i meccanismi dell’identificazione primaria e secondaria, deve predisporsi ad entrare psichicamente nei panni degli infiniti personaggi che, attraverso storie filmate sempre più lunghe ed articolate, da lì a pochi anni avrebbero letteralmente invaso il suo immaginario e reso possibile aggiornare l’habitus alle trasformazioni repentine e incessanti dell’epoca moderna. Tuttavia, da qui a dire che il cinematografo si integrasse perfettamente con i suoi spettacoli il passo è lungo. Lo stesso Colagreco riporta infatti una serie di commenti d’epoca, per lo più presi dalla stampa spagnola39, nei quali il Fregoligraph è impietosamente definito «la parte più difettosa del programma» nonché una «ridondanza», sicché «nulla perderebbe lo spettacolo fregoliano sopprimendo interamente le proiezioni». Sono giudizi diffusi e non appartengono solo alla sensibilità spagnola, se è vero che le ultime 38
39
Non è ovviamente questa la sede per provare a tratteggiare, neppure a grandi linee, i tratti salienti dell’idea di modernità che si afferma con l’avvento delle metropoli e che trova nel cinema il suo luogo privilegiato di negoziazione dei cambiamenti. Per tutto questo, anche rispetto agli autori qui chiamati in causa, rimandiamo a F. Casetti, L’occhio del Novecento. Cinema, esperienza, modernità, Bompiani, Milano 2005. Rimandiamo ai giudizi delle riviste “La Lucha”, “La Tribuna” e “El Diluvio” che accompagnano le tournée di Fregoli fra il 1902 e il 1903 (citate in L. Colagreco, Il cinema negli spettacoli di Leopoldo Fregoli, cit., pp. 46-47).
36
Lessico del cinema italiano
apparizioni “on stage” del Fregoligraph di cui si abbia memoria sono datate gennaio 1904, segno inequivocabile dello scarso riscontro che l’attrazione aveva anche rispetto al pubblico italiano. Si potrebbe azzardare, allora, l’ipotesi che il Fregoligraph non si integrerà mai davvero fino in fondo nel teatro di Fregoli, limitandosi ad esercitare il fascino di una potenzialità tanto suggestiva quanto irrealizzabile. Il cinematografo resta un corpo estraneo, in quanto replica fantasmatica, e funziona fintanto che la novità dell’apparecchio è in grado, in se stessa, di sorprendere un pubblico ancora disposto ad affollare fiere, baracconi e café-chantant pur di ammirare il nuovo dispositivo. Con la prima crisi del cinematografo, i primi moti di insofferenza verso una invenzione che pare avere pochi margini di sviluppo e progressione, terminato l’impatto iniziale e la conseguente apertura di credito, il Fregoligraph è fra le prime vittime. A parte Corsi e Paolella40, pronti ad attribuirgli la qualifica di “Méliès italiano”, Verdone ne apprezza più che altro le prospettive futuriste senza troppo sbilanciarsi, mentre Bernardini analizza nel dettaglio le sue possibili applicazioni narrative dei principi del montaggio41. È in fondo la stessa prospettiva di Gian Piero Brunetta, secondo il quale Fregoli rappresenta una specie di terza strada, intrinsecamente senza uscita, fra gli spettacoli itineranti, le “fiere delle meraviglie” che vendono in giro lo stupore prodotto dal cinematografo, e i primi tentativi di trovare al cinema una sede fisicamente e psicologicamente stabile all’interno di quel contesto urbano di cui è in qualche modo il riflesso più organico. Il Fregoligraph sarebbe insomma un uso del «cinema come surrogato e sostituto di altre forme di spettacolo» nelle quali ciò che conta è la presenza fisica dell’attore che coinvolge il pubblico attraverso la presentazione di performance inaudite rispetto alle quali «il cinema non costituisce che una variante»42. C’è insomma, in lui, l’ostinazione dell’uomo di teatro che si serve del cinematografo finché questo mantiene quelle modestissi40 41 42
Cfr. D. Paolella, Debutti del cinema italiano, in “Sequenze”, n. 8 (1950). Cfr. A. Bernardini, Cinema muto italiano I. Ambiente, spettacoli e spettatori 1896-1904, Laterza, Bari-Roma 1980, p. 99. G.P. Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema muto 1895-1929, Editori Riuniti, Roma 1993, pp. 16-17.
Habitus Giacomo Manzoli
37
me caratteristiche che permettono non tanto di integrarlo nello spettacolo teatrale (cosa che, come abbiamo visto, non si realizza mai compiutamente) ma di ospitarlo e giocare con lui all’interno di una rappresentazione che è una finestra aperta sui tempi nuovi. Nel momento in cui la durata di questo gioco mostra la corda, il cinema è subito bandito dai suoi spettacoli. Così, per esempio, rispetto alla produzione di Fregoli e alle patenti che gli sono state attribuite, Antonio Costa concorda nel collocarlo su un ideale binario Méliès-Segundo de Chomón che attraversa il cinema delle origini spingendolo ben lontano dall’originaria funzione prettamente realistico-fotografica per la quale era stato inventato da Auguste e Louis Lumière43. Insomma, tanto per Brunetta che per Costa, Fregoli resta soprattutto un mago del trasformismo, arte tipicamente italiana che può annoverare maestri eterogenei, da Mussolini ad Alberto Sordi44. Arte svolta, però, con un estro ricollegabile forse a una precisa identità nazionale, che prevede la reversibilità della trasformazione. Detto in altri termini, quella in illusione cinematografica è una delle tante trasformazioni della meraviglia teatrale Leopoldo Fregoli, pronto a tornare se stesso al termine della girandola di metamorfosi moderniste che devono sempre riguardare lo strato esteriore della persona, fisica o psicologica che sia: il suo abito e non il suo habitus. Nella prospettiva che ci interessa, possiamo allora dire che Fregoli, più che il “Méliès italiano” è colui che c’è stato in Italia invece di Georges Méliès. Abbiamo deciso di dedicare ampio spazio a Leopoldo Fregoli perché la sua vicenda segna l’inizio metaforicamente perfetto di un rapporto non facile con il dispositivo, al quale si è restii ad attribuire un valore sostanziale, forse perché troppo recente era la costruzione di un campo culturale nazionale. Peccati originali che il cinema italiano dovrà scontare anche per i decenni a venire. Come sostiene Brunetta, «i motivi della fragilità costituzionale delle strutture industriali del cinema italiano in tutta la sua storia dipendono dall’improvvisazione, dalla mancanza di un progetto organico, capace di tener presenti le possibilità reali del mercato, 43 44
Cfr. A. Costa, I leoni di Schneider. Percorsi intertestuali nel cinema ritrovato, Bulzoni, Roma 2002, pp. 26-27. L’accostamento, malizioso e inoppugnabile, è sempre di Antonio Costa.
38
Lessico del cinema italiano
di prevedere in anticipo costi e profitti, senza dover di continuo far fronte a situazioni impreviste»45. Uomini (e donne) forti Si può dire che la sola tipologia di film che davvero funziona sotto il profilo del mercato – nella crisi industriale, tecnologica e creativa del cinema italiano negli anni venti – è il filone dedicato ai cosiddetti forzuti e che la sola vera star del cinema italiano sia quel Bartolomeo Pagano, alias Maciste, che in una serie di film (da Maciste atleta, 1918, di Vincenzo Denizot e Giovanni Pastrone a Maciste all’inferno, 1926, di Guido Brignone) riesce a consolidare il rapporto con un pubblico popolare assai vasto, facendosi interprete di un desiderio diffuso di soluzioni semplici a problemi complessi, che passa attraverso l’autorità e la forza e che molti analisti hanno ricollegato ad un sospetto atavico nei confronti della borghesia e al crescente consenso nei confronti del fascismo e del suo leader, Benito Mussolini46. Dunque, se negli anni venti gli schermi italiani proiettano in larghissima maggioranza film stranieri (americani in particolare), promuovendo nei fatti quella colonizzazione dell’immaginario che sarà un tratto particolare della cultura di massa nazionale, è appunto negli anni trenta, con l’avvento del sonoro, che il cinema italiano – pur restando minoritario sul piano degli incassi – torna ad affermare la propria capacità di esercitare una qualche influenza sulle coscienze dei propri cittadini, riuscendo anche a rifletterne le aspettative, i desideri, le paure, e ovviamente plasmandole, specialmente in chiave propagandista. E non è un caso che per la realizzazione del primo film sonoro italiano, La canzone dell’amore (1930) di Gennaro Righelli, si sia andati a pescare nel repertorio delle novelle pirandelliane, ovvero dell’autore che più di ogni altro nel panorama nazionale aveva saputo descrivere la crisi del soggetto che caratterizza la modernità. 45 46
G.P. Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema muto 1895-1929, cit., p. 38. Si veda al riguardo J. Reich, The Maciste Films of Italian Silent Cinema, Indiana University Press, Bloomington 2015.
Habitus Giacomo Manzoli
39
Se il film di Righelli presenta indubbiamente spunti interessanti, ai fini del discorso che stiamo svolgendo, con la messa in discussione dei tradizionali ruoli accordati ai personaggi femminili, ovvero con una figlia che accetta “in silenzio” lo stigma sociale, fingendosi madre del figlio illegittimo della propria madre, il film della transizione che meglio di ogni altro rappresenta il periodo nell’indagine della determinazione e trasformazione dell’habitus è probabilmente Miss Europa (1930) di Augusto Genina. Tecnicamente, si tratta di un film francese, ma è in effetti una coproduzione europea, destinata a essere distribuita in versione muta e in versioni multiple sonore, secondo uno schema tipico del periodo. Un’impresa dunque articolata, con la sceneggiatura di un francese (René Clair) e di un tedesco (Georg Wilhelm Pabst), una protagonista americana (Louise Brooks), ma guidata saldamente da un italiano47, capace di dimostrare la sua estrema sensibilità proprio nella dimensione che ci interessa. Le parti più significative del film, a parte il melodramma convenzionale e il versante modernista nella descrizione dell’aristocrazia internazionale, riguardano gli slittamenti progressivi della prospettiva sociale del personaggio femminile attorno al quale è costruito l’intero film. Lucienne, infatti, è una ragazza del popolo, un’impiegata che sarebbe destinata al modesto progetto esistenziale che la sua condizione sociale e di genere prevedono per lei. Ha un lavoro, un fidanzato devoto (per quanto a dir poco asfissiante), un matrimonio in vista, da cui dipenderà lo sviluppo di un destino familiare. Tutto questo, però, viene compromesso dalla rivelazione – grazie ad uno dei celebri concorsi di bellezza dell’epoca – e dall’esercizio del capitale sociale connesso alla bellezza della ragazza, vissuta fin lì come un fattore puramente contingente. Dal momento in cui la donna sperimenta quali opportunità si aprano per lei grazie all’utilizzo strumentale (mediale prima e sociale poi) della propria avvenenza, niente sarà più come prima. Ed è proprio in questo che si rivela tutto il talento di Genina. Perché il film ha una fase centrale nella quale viene raccontato il tentativo sentimentale della protagonista di tornare indietro, alla sua vita precedente al concorso, che le ha fatto prova47
Sulle vicissitudini che portano alla realizzazione del film si veda AA.VV., Louise Brooks l’européenne, Transeuropa-Cineteca di Bologna, AnconaBologna 1999.
40
Lessico del cinema italiano
re le gioie materiali e simboliche del lusso, degli alberghi a cinque stelle e dei bei vestiti. Ma, soprattutto, grazie al concorso ha provato l’euforia del potere della seduzione, il benessere della compagnia di persone che hanno incorporato un habitus aristocratico, vale a dire colte, raffinate, ben educate, ben vestite e – come il film riesce a farci percepire attraverso un processo sinestetico – profumate. Dopo aver deciso di seguire il cuore, infatti, la ragazza prova a tornare alla vita che svolgeva col suo fidanzato. Le ore che prima trascorrevano in maniera naturale, ora le appaiono interminabili. La noia diventa la cifra della sua quotidianità, e quando per svagarla il fidanzato la conduce al luna park, quel divertimento popolare che prima l’avrebbe divertita e che pure ella cerca disperatamente di farsi piacere, viene mirabilmente descritto da Genina come un’immersione nell’orrido: la folla, il cibo a buon mercato, i divertimenti ingenui, ma soprattutto i corpi del popolo, il modo di parlare, di gesticolare, di mangiare, viene ora percepito come volgare, sgraziato, sgradevole: in una parola, disgustoso. Ed è difficile immaginare un modo più trasparente e spietato per descrivere la monodirezionalità delle traiettorie sociali. In termini di habitus, l’insieme dei fattori che lo compongono – ovvero di disposizioni incorporate – può andare in un senso solo e non è reversibile. Così come la ragazza incorpora tutto rapidamente e subito si adatta alla nuova situazione, pagando ovviamente il prezzo del senso di colpa per coloro che ha lasciato alle spalle, non è per lei più possibile tornare indietro, rimettere l’habitus (modesto e stropicciato) della popolana, riadattarsi senza patire profondi scompensi in termini di depressione e repulsione. Stati d’animo appena compensati dalla gioia delle lettere degli ammiratori, il solo elemento che testimonia la sua appartenenza ad uno status differente da quello in cui è imprigionata. Ma lo stesso tema informa pesantemente il cinema del periodo fascista, specie per quanto riguarda il genere della commedia, dove la questione diventa un nucleo tematico sul quale si costruiscono una serie di variazioni con una frequenza quasi ossessiva. Fra il 1932 e il 1937, per esempio, la coppia composta dal regista Mario Camerini e dal giovane divo Vittorio De Sica realizza ben cinque film dal registro brillante che compongono l’ossatura del cosiddetto “cinema dei telefoni bianchi” ma che danno del modello originale (la commedia hollywoodiana) una rilettura che pare
Habitus Giacomo Manzoli
41
tagliata apposta per fornire risposte alla grande ossessione della società italiana. A parte il fatto che uno di questi, Ma non è una cosa seria (1936), ha un collegamento diretto ed esplicito con il solito Pirandello, il cui gioco delle maschere e dei ruoli sociali è stato ampiamente analizzato dagli studiosi48, almeno tre film sembrano voler affrontare in maniera diretta il problema dell’habitus, della sua costruzione e della sua dissimulazione in un modo che è evidentemente funzionale alla logica dominante. In Gli uomini, che mascalzoni… (1932), infatti, Vittorio De Sica è un autista che cerca di sedurre una giovane impiegata presentandosi con l’automobile del suo datore di lavoro e dandole ad intendere di essere ricco, avviando una serie di equivoci e di malintesi relativi all’appartenenza – sempre instabile – di questi personaggi ad una classe. Per meglio dire, al compromesso da raggiungere fra appartenenza ad un determinato gradino della scala sociale e aspirazione a salire su uno più in alto. Così, in Darò un milione (1935), il gioco si inverte e ritroviamo De Sica nei panni di un ricco estroso che si finge povero dopo aver fissato una ricompensa di un milione per chiunque si comporterà in maniera umana e caritatevole nei suoi confronti, trovando conforto solo in una ragazza semplice con cui ovviamente inizierà una relazione. Ancora, in Il signor Max (1937), eccolo nei panni di un proprietario di edicola, dunque un piccolo borghese, che ogni anno ha a disposizione il budget per un viaggio, nel corso del quale ha la possibilità di accedere a lussi e stili di vita che non sono quelli della sua classe sociale di appartenenza. Durante una di queste avventure avrà modo di farsi passare per un aristocratico e sperimentare le delizie del bel mondo, iniziando una doppia partita sentimentale con una ricca e sofisticata signora, nei panni del nobiluomo, e con la di lei dama di compagnia, in quelli assai più modesti dell’edicolante, in una girandola di espedienti e cambi di abito e di habitus che avrebbero fatto invidia a Fregoli. Ebbene, a proposito di questo film, Giacomo Debenedetti, si troverà a scrivere:
48
Su Pirandello e i giochi di ruolo si veda G. Macchia, Pirandello, o la stanza della tortura, Mondadori, Milano 1982.
42
Lessico del cinema italiano
Dalla Mostra veneziana in poi, il pubblico è avvertito che Il signor Max è un bel film; il più piacevole, senza dubbio, e il più intelligentemente saporoso tra quanti sono usciti quest’anno in Italia. Merito di Camerini è anche di aver saputo prevenire quell’amaro che è il residuo dell’aver lungamente riso. Evitando tentazioni e vertigini, egli ci ha dato quel che voleva: un racconto tutto gioco e superficie, senza una falla. Effettivamente quella falla avrebbe permesso di guardar dentro, e allora buonanotte49.
Ed è stato giustamente Vito Zagarrio a mettere l’accento e richiamare l’attenzione su questa “falla”50, di quello che per Debenedetti resta un bellissimo film e che pure aveva profondamente irritato il direttore generale della cinematografia Luigi Freddi, secondo il quale, pur trattandosi di un «piccolo capolavoro, quale concetto poteva far sorgere nell’ipotetico storiografo del futuro?». E se il letterato Debenedetti aveva preferito restare nel vago, Freddi invece si premura di specificare quale sia – a suo parere – la pericolosa falla che il film rischia di aprire da un momento all’altro nel pomposo sistema della propaganda fascista rispondendo a un interrogativo retorico: «Quello di una piccola nazione borghese, chiusa nelle quattro mura del suo piede di casa, senza aspirazioni che non fossero quelle di una ristrettissima mentalità antieroica, incapace di elevarsi al di là delle meschine storielle provinciali»51. E l’irritazione del povero Freddi appare piuttosto comprensibile proprio considerando il tema che ci sta a cuore. Dopo circa quindici anni di sforzi, compiuti attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa a cominciare dall’Istituto Luce, i programmi scolastici, un’intensa opera di militarizzazione del paese per costruire l’habitus del perfetto fascista, questo era il risultato. Nonostante film come Camicia nera (1933) di Giovacchino Forzano o Vecchia guardia (1934) di Alessandro Blasetti, fatti per incoraggiare gli italiani ad incorporare una disposizione eroica che li portasse a prendere 49 50 51
G. Debenedetti, Al cinema, a cura di L. Micciché, Marsilio, Venezia 1983, p. 209. Cfr. V. Zagarrio, Cinema e fascismo. Film, modelli, immaginari, Marsilio, Venezia 2004, p. 88. L. Freddi, Il cinema. Il governo delle immagini, Gremese, Roma 1994, p. 436.
Habitus Giacomo Manzoli
43
sul serio la posta in gioco nell’epica imperiale fascista, ovvero a desiderare un riconoscimento in termini di impegno bellico e di sacrifico per la gloria della patria, bastava una piccola commedia di successo come Il signor Max a dimostrare che la questione dell’habitus si giocava ancora tutta all’interno di uno schema borghese, legato al possesso di beni materiali di status, all’appartenenza e alla scalata di classe, al rapporto naturale o artificiale con persone di classi sociali diverse. In altre parole ancora, il film di Camerini sembrava una dimostrazione ante litteram della tesi che in molti (per esempio Pasolini, di cui parleremo) avrebbero sostenuto qualche decennio dopo; vale a dire, che il fascismo era sostanzialmente una sovrastruttura che non aveva intaccato in profondità le strutture della psicologia sociale italiana, che restavano ancorate a modalità tradizionali di interpretazione della realtà. Solo che, a differenza di quanto si sosterrà in seguito, questi schemi interpretativi non riguardavano un arcaico mondo contadino ma al contrario – come aveva intuito già Gramsci – una visione del mondo di impostazione piccolo-borghese. Quanto di più lontano e più avverso al fascismo che si potesse immaginare. Per di più, esattamente nello spirito di quella borghesia che si era affermata come classe egemone in Francia nel corso dell’Ottocento e che – secondo Bourdieu – aveva trovato in Flaubert il suo più acuto cantore52, il racconto morale di Camerini (come del resto tutti gli altri messi in scena da lui, da Goffredo Alessandrini e tutti gli altri) proponeva una visione sostanzialmente conservatrice e deterministica dell’habitus, come una struttura dalla quale non è possibile uscire, tanto è vero che ogni vicenda si concludeva con una restaurazione dell’ordine sociale e simbolico e ogni elemento tornava al proprio posto, e i protagonisti tornavano a disporsi secondo un equilibrio di differenti capitali in base ad un sistema di valori prettamente tradizionale. E se qualcun altro avrebbe potuto celebrare la grandezza del film di Camerini in base al concetto di nazional-popolare, è inevitabile che la cosa suonasse agli occhi di Freddi come una immersione nella palude di un provincialismo retrogrado.
52
Cfr. P. Bourdieu, Campo del potere e campo intellettuale, Manifestolibri, Roma 2002 [ed. or. Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe, in “Scolies”, n. 1 (1971), pp. 7-26].
44
Lessico del cinema italiano
Dopo la caduta La storia, a partire dall’Armistizio, si incaricherà di stabilire chi – fra Camerini e Freddi – avesse avuto una maggiore capacità di riflettere con precisione l’habitus degli italiani. Ma certo è straordinario il fatto che il luogo di elaborazione privilegiata di un discorso antiretorico, nel quale viene messo in scena con assoluta trasparenza – in profondità – la persistenza di un’attitudine piccolo-borghese in via di formazione, siano tre film di propaganda bellica, firmati dal giovane Roberto Rossellini e sponsorizzati direttamente dalla Marina Militare: La nave bianca (1941), Un pilota ritorna (1942) e L’uomo dalla croce (1943). Già nel primo dei tre film, infatti, il regista romano mette in scena la quotidianità di un gruppo di soldati che non manifesta alcuna vocazione eroica e alcuna forte e radicata adesione allo spirito del “perfetto fascista”. Si tratta di uomini comuni, di variegata provenienza geografica e dai limitati talenti, impegnati soprattutto a far passare il tempo scherzando fra di loro, leggiucchiando, giocando, scrivendo lettere alla fidanzata e così via. L’habitus che essi dimostrano nelle loro conversazioni non è certamente quello dell’eroe bellico, bensì del proletario che aspira all’ingresso nel novero della piccolissima borghesia. Una vacanza in licenza, piccoli lussi che confermano una minima distanza dal bisogno, il matrimonio con una brava ragazza di paese. Nessuna sostanziale istanza ideologica traspare dai loro comportamenti, e lo stesso coraggio, spirito di sacrificio e forza interiore che essi dimostreranno nella seconda parte del film, appaiono assai più come un fatto contingente, la reazione agli eventi di persone in possesso di solide basi etiche (anch’esse di stampo sostanzialmente cattolico e borghese) più che la manifestazione di una personalità di tipo nuovo, votata alla gloria personale e collettiva. Si tratta evidentemente di un passaggio importante, che anticipa molti dei cardini della futura stagione neorealista, che si inaugura ufficialmente proprio con la più celebre opera rosselliniana, Roma città aperta. A questo proposito, senza addentrarci in questioni specifiche relative ad uno dei movimenti più studiati della storia del cinema53, è tuttavia interessante sottolineare un aspetto funzionale al nostro discorso. 53
Nella sterminata bibliografia relativa al neorealismo, ci limitiamo a citare due recenti e validissimi contributi: D. Forgacs, Rome Open City, British
Habitus Giacomo Manzoli
45
Infatti, il neorealismo promuove un cinema che si propone (e certamente, almeno nella prima fase, mantiene le promesse) un salto di qualità nella direzione della trasparenza; offrendo una descrizione oggettiva degli uomini, degli ambienti, dei gesti e delle situazioni reali, descrivendo una realtà drammatica e cercando di arrivare al nocciolo delle cose, al di fuori di ogni convenzione e retorica tipiche della rappresentazione cinematografica. E non vi è dubbio che, tanto nella rappresentazione della storia quanto in quella delle relazioni umane, vi sia in film come Germania anno zero di Rossellini o in Ladri di biciclette di De Sica e Zavattini, il racconto di un mutato atteggiamento complessivo dei soggetti, tanto nei confronti della vita quanto di loro stessi e degli altri, cosa che si traduce in costanti agnizioni che mettono in crisi gli schemi interpretativi nei quali i personaggi avevano inquadrato le loro relazioni reciproche (si pensi al soldato americano alle prese con gli scugnizzi nell’episodio napoletano di Paisà, o all’inversione del rapporto padre-figlio nel finale del film di De Sica). Eppure, non mancano voci autorevoli che mettono in discussione questi presupposti e avanzano un’ipotesi da analizzare. Ad esempio, Carlo Emilio Gadda afferma, nel 1950, di non apprezzare affatto questa tendenza, giacché Il modo in cui i neorealisti trattano i loro temi è, di preferenza, quello di un umore tetro e talora dispettoso come di chi rivendica qualcosa da qualcheduno e attenda giustizia, di chi si senta offeso, irritato. Tutti ci sentiamo offesi, irritati da alcunché… Allora la polemica aperta, la diatriba, il grido, l’ingiuria sono preferibili ai termini pseudonarrativi di una supposta obiettività… Sbaglierò… Altra impressione che io ho ricevuto dai pochi esempi delibati è quella di una tremenda serietà del referto: ne risulta al racconto quel tono asseverativo che non ammette replica, e che sbandisce a priori le meravigliose ambiguità di ogni umana cognizione… l’ambiguità, l’incertezza, il “può darsi che io sbagli”, il “può darsi che da un altro punto di vista le cose stiano altrimenti”, a cui pure devono tanta parte del loro incanto le pagine di certi grandi moralisti, di certi grandi romanzieri…54
54
Film Institute, London 2000, e S. Parigi, Neorealismo. Il nuovo cinema del dopoguerra, Marsilio, Venezia 2014. C.E. Gadda, Un’opinione sul neorealismo, in Id., I viaggi e la morte, Garzanti, Milano 1958, ora in Neorealismo. Poetiche e polemiche, a cura di C. Milanini, Il Saggiatore, Milano 1980, p. 124.
46
Lessico del cinema italiano
In pratica, sembra di rilevare che l’imprevedibile idiosincrasia di Gadda, partendo da un fattore di carattere stilistico (del resto, la scrittura barocca di Gadda è agli antipodi dalle istanze di sottrazione del cinema come della letteratura neorealista), approdi a un dato di natura sostanziale, riconducibile all’atteggiamento complessivo verso il mondo che traspare da film come La terra trema (1948) di Luchino Visconti o Umberto D. (1952) ancora di De Sica. È chiaro che da una visione prospettica più attenta, anche questi film sono carichi di tutte le ambiguità di cui Gadda lamenta l’assenza (a cominciare da una certa tendenza estetizzante), ma è vero che esiste probabilmente una maniera, un atteggiamento complessivo nei confronti del mondo e della vita che si cristallizza e finisce per descrivere una sorta di habitus neorealista, dove la denuncia diventa registro dominante e finisce per diventare indiscriminata e per stemperarsi in una specie di mugugno. E dove, soprattutto, l’essere popolo assume una valenza etica intrinseca e sfocia in una visione manichea, con il potere che assume dei contorni quasi astratti e non deriva più dall’insieme dei rapporti di forza, incoraggiando una specie di vittimismo conservatore, quasi che nulla possa mai cambiare nel destino della “povera gente”. Invece, rapidamente, cambiava il paese e cambiava lo stesso neorealismo, che contaminandosi con i generi finisce per offrire un riflesso assai più credibile dei fermenti e delle contraddizioni che attraversano le soggettività di un’Italia avviata verso il faticoso e traumatico cammino della modernizzazione con tutte le pesantissime difficoltà di una guerra mondiale da lasciarsi alle spalle e della ricostruzione. È quanto accade, ad esempio, in L’onorevole Angelina, dove si assiste alla faticosa negoziazione identitaria, legata all’habitus di classe e di genere, di un popolo che cercava appunto una strada per costituirsi come tale dopo la lunga parentesi totalitaria del fascismo. Protagonista del film è Anna Magnani, che interpreta una madre di famiglia, disperata per le condizioni di vita postbelliche, la quale organizza una specie di rivolta popolare che la conduce prima in carcere e poi sulle soglie del parlamento. Il coraggio e la grinta della Magnani sono evidentemente la metafora di una popolazione che – spinta dalla sua parte migliore, femminile e materna – acquisisce consapevolezza della propria “coscienza di classe” e impara come avanzare istanze civili e sindacali per proteggere i propri diritti nel quadro di una dialettica politica tipica
Habitus Giacomo Manzoli
47
di una Repubblica e di una democrazia rappresentativa. Non più, dunque, una massa informe da plasmare a piacimento di un duce, succube di un progetto del tutto estraneo ai suoi reali bisogni, ma neppure l’umile popolo disposto ad accettare passivamente la volontà di un sovrano (o dei suoi vassalli); piuttosto, un insieme di cittadini che cercano – fra mille contraddizioni – di darsi un’organizzazione in grado di far valere le proprie ragioni, fra la resistenza delle istituzioni e le tentazioni del qualunquismo (tanto più sentite nel periodo di Guglielmo Giannini e del suo Fronte dell’Uomo Qualunque, che alle politiche del 1946 prese oltre il 5% dei voti). Certo, la conclusione del film lascia oggi perplessi, perché l’encomiabile consapevolezza della mancanza di competenze, in base alla quale Angelina sceglie di lasciare spazio a candidati più preparati, si affianca ad una serie di considerazioni sulla necessità – in famiglia – di una presenza femminile che ricopra a tempo pieno il ruolo di moglie e di madre. Questo tipo di argomentazioni, dunque, lascia intuire che, pur nell’aggiornamento della società italiana, molta strada doveva ancora essere compiuta in relazione agli habitus di genere e alla revisione del cosiddetto (sempre in termini bourdesiani) «dominio maschile»55, tema sul quale ritorneremo più avanti. Il boom Tornando invece ai rapporti di classe, vale la pena sottolineare che la stessa Anna Magnani sarà protagonista – quindici anni più tardi – dello straordinario Mamma Roma (1962) di Pier Paolo Pasolini, nel quale trova la sua più compiuta espressione il teorema pasoliniano sulla società italiana. Mamma Roma, infatti, è una prostituta che decide di investire i risparmi di una vita nell’apertura di un’attività commerciale come fruttarola. Sono gli anni del boom economico e la donna vuole sfruttare le opportunità che si aprono per garantire al figlio adolescente – che ha dovuto far crescere in brefotrofio – un futuro diverso dal proprio. In pratica, si tratta di una parabola che sintetizza tutto il discorso socio-politico 55
P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 2009 [ed. or. La domination masculine, Seuil, Paris 1998].
48
Lessico del cinema italiano
ed estetico di Pasolini relativo al sottoproletariato e a quello che, per il poeta e scrittore bolognese, è un vero e proprio “genocidio culturale” che conduce ad una mutazione antropologica56. Nella prospettiva di nostra competenza, si tratta dell’allargamento dei presupposti della cosiddetta “rivoluzione borghese” a tutta la popolazione italiana, con conseguente esclusione definitiva di tutti quegli individui che non riescono ad adattare la struttura del proprio habitus a quella necessaria ad essere inseriti nelle fila della piccola borghesia. Quando Pasolini – prima in romanzi quali Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959) e poi in film come Accattone (1961) o La ricotta (1963) – parla di “destino tragico” al quale andavano incontro buona parte di coloro che si trasferivano dalla campagna alla periferia cittadina nel grande processo di urbanizzazione che investiva l’Italia del periodo, pare far riferimento proprio a questo processo di revisione di habitus. Ovvero, l’insieme di disposizioni, aspettative, giochi di ruolo, poste in palio che caratterizzavano il mondo contadino, impostato su tradizioni secolari e su un sistema di valori che prevedeva una concezione ciclica del tempo (da qui l’interesse per il mito), un’idea etnica della cultura e una rigida suddivisione dei compiti e delle funzioni, doveva essere rimpiazzato da un habitus borghese, basato su una visione lineare del tempo, proiettato verso il progresso, l’accumulo di capitale, la scalata di posizioni sullo scacchiere sociale, e tutti i relativi simboli di status. Era fisiologico che una buona parte dei soggetti coinvolti in questa transizione non riuscissero a conformarsi alle nuove sfide – posto che per Pasolini si trattava di un processo nefasto di omologazione – e andassero incontro a un destino da apolidi della società, di esclusione irrimediabile. Ed è appunto quanto accade agli eroi pasoliniani, tanto al figlio di Mamma Roma, Ettore, quanto allo stesso Accattone o alla comparsa Stracci del già citato La ricotta. Figure che si trovano catapultate in un universo borghese senza possedere gli strumenti psichici adatti per incorporarne la logica nel senso pieno del termine, tanto è vero che se da un lato si limitano a sopravvivere di piccoli espedienti da zingari (delinquenza di bassissimo livello, furberie, truffe, come parassiti che si ingegnano di ricavare i residui del corpo sociale), 56
Gli scritti pasoliniani sul tema sono innumerevoli. Per esigenze di sintesi ci limitiamo a citare P.P. Pasolini, Scritti corsari, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti, S. De Laude, Mondadori, Milano 1999, pp. 265-535.
Habitus Giacomo Manzoli
49
dall’altro lato questa loro natura arcaica li rende dei mostri nel senso latino del termine («Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta»57), ovvero creature mirabili nella loro selvaggia purezza, bellissimi, specialmente a fronte del conformismo dei corpi omologati nel ciclo di produzione e consumo. Ed è una prospettiva che si può ritrovare in quasi tutto il cinema coevo, a cominciare da quel Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti, dove l’asse della bellezza e della poesia è totalmente sbilanciato sui due fratelli della famiglia lucana emigrata a Milano che non riusciranno ad integrarsi. Non è certo un caso se Visconti chiede di interpretare i due personaggi ad attori dal fascino innegabile e dalla corporeità prorompente come Alain Delon e Renato Salvatori, mettendo in relazione, in modo bizzarro ma certamente grandioso, la mitizzazione divistica con il destino dei due reietti, votati al fallimento a causa di una nostalgia insanabile o della confusione generata dall’euforia di merci e stili di vita irraggiungibili. Ben più “normale” la scelta degli attori (Spiros Focas e Max Cartier) che impersonano gli altri due fratelli, che invece troveranno una felice integrazione attraverso le due istituzioni alla base della nuova Italia industriale, vale a dire la fabbrica e la scuola. Così, mentre l’istituzione scolastica è oggetto di una profonda revisione, che parte dalle Esperienze pastorali di Don Milani e arriverà a investire tutto il sistema educativo, fino all’università di massa, il cinema preferisce metterne in scena soprattutto le conseguenze in termini di «invenzione della gioventù»58. Anche in questo caso, se da una parte grandi sociologi come Talcott Parsons o Paul Goodman avevano messo in rilevo la questione giovanile nel nuovo ordine sociale che si stava configurando nella società di massa59, l’industria culturale individua un nuovo interessantissimo target e ne promuove la crescita, incoraggiando il fenomeno. Accade perciò che il cinema popolare e quello d’autore si rimpal57 58 59
P.P. Pasolini, Mamma Roma, Rizzoli, Milano 1962, p. 158. Il concetto viene ampiamente spiegato in Il secolo dei giovani, le nuove generazioni e la storia del Novecento, a cura di P. Sorcinelli, A. Varni, Donzelli, Roma 2004. Si vedano al riguardo T. Parsons, I giovani nella società americana, Armando Editore, Milano 2006 [ed. or. Youth in the Context of American Society, in “American Sociological Review”, n. 27 (1967)] e P. Goodman, Individuo e comunità, a cura di P. Adamo, Elèuthera, Milano 1995.
50
Lessico del cinema italiano
lino la riflessione sulla nascita di una composita “classe sociale trasversale”, definita su base anagrafica. Film musicali, concepiti in appoggio alla fiorentissima industria discografica come Urlatori alla sbarra (1960) di Lucio Fulci o In ginocchio da te (1964) di Ettore M. Fizzarotti, i cosiddetti musicarelli, sono un’avvisaglia del fatto che la gioventù non è più solo una condizione anagrafica contingente, ma un vero e proprio modo di essere, con le proprie ideologie, i propri sistemi di valori, un progetto definito (genericamente rivoluzionario, per quanto spesso confuso e ambivalente), e naturalmente una serie di mode, atteggiamenti, linguaggi – verbali e somatici – capaci di descrivere l’incorporazione del proprio status e comunicarne sinteticamente le coordinate agli interlocutori. Ed è naturale che sul tema, cruciale per la politica e la cultura del paese negli anni a venire, si interroghino anche una serie di giovani autori che erano direttamente coinvolti nel processo. Lo fa Bernardo Bertolucci, a partire da Prima della rivoluzione (1964), dove tutta la vicenda ruota attorno al tentativo di ribellione di un giovane di provincia rispetto all’habitus che gli è stato cucito addosso e che passa per il matrimonio con una bella coetanea benestante e la conduzione degli affari di famiglia, al fine di raggiungere un riconoscimento di classe che gli consenta di conservare la posizione di prestigio nel campo dei dominanti che detiene per privilegio ereditario. Il film di Bertolucci descrive una straziante parabola – per certi aspetti sovrapponibile a quella narrata da Flaubert in L’educazione sentimentale – in cui l’ambizione artistica, la frequentazione di ambienti bohémien, l’esplorazione del desiderio secondo percorsi inconsueti e proibiti (perfino di natura incestuosa) e la stessa vocazione rivoluzionaria, non sono altro che forme di ribellione controllata; meccanismi di formazione degli anticorpi necessari ad aderire pienamente, in età adulta, all’habitus che si è destinati ad assumere per far fronte alle aspettative ambientali e familiari, sul modello dell’Enrico V shakespeariano. Paradossalmente ma non troppo, saranno proprio la consapevolezza di sé acquisita durante questo periodo trasgressivo e la verifica della natura altrettanto illusoria degli habitus alternativi a dare al giovane la spinta necessaria a svolgere il ruolo di padre di famiglia e imprenditore con la ferma convinzione della necessità di tutte le strutture che definiscono i ruoli e la posta in gioco.
Habitus Giacomo Manzoli
51
E riflessioni altrettanto amare le ritroviamo in film come I pugni in tasca (1965) di Marco Bellocchio, dove si parla di un fenomeno che potremmo collocare agli antipodi dell’hysteresis, cioè di quella specie di evaporazione dell’habitus, dovuta alla crisi dell’ordine simbolico edipico, che sfocia in nevrosi omicida; e altrettanto accade in I sovversivi (1967) di Paolo e Vittorio Taviani, dove i funerali di Togliatti sembrano alludere proprio allo sgretolamento di un grande progetto rivoluzionario in grado di dare senso ad una revisione programmatica degli habitus, al termine della quale i vari personaggi del puzzle si ritrovano orfani di una qualche struttura in grado di orientare le loro pulsioni e i loro desideri: come dire che un’identità definita – sia quella borghese, sia quella antagonista, di matrice proletaria – è comunque indispensabile al soggetto per trovare il proprio posto nel mondo. E questo clima di confusione non riguarda soltanto la borghesia e quelle che – sempre nel quadro delle logiche di campo – potremmo definire le classi dominanti, ma perfino il mondo operaio e la piccola o piccolissima borghesia. Nel 1957, infatti, Michelangelo Antonioni desta un certo scalpore descrivendo in Il grido, la crisi esistenziale di un operaio, Aldo, la cui relazione sentimentale con la donna da cui ha avuto una figlia si sfalda proprio nel momento in cui avrebbe dovuto diventare definitiva. L’uomo inizia un vagabondaggio che lo conduce a sperimentare l’apertura di un legame con donne diversissime fra loro, ma ogni volta il progetto si interrompe sul nascere, lasciando l’uomo nel vuoto di un’esistenza priva di coordinate. È l’inizio di una riflessione che Antonioni proseguirà nei film successivi, applicandola a figure diverse – ma ugualmente esemplari rispetto alla trasformazione in atto nella società italiana – in opere come L’avventura (1960) o Il deserto rosso (1964), ma si tratta di un discorso non troppo dissimile a quello svolto da altri autori, dal Fellini di La dolce vita (1960) e 8 ½ (1963) al Visconti che va da Vaghe stelle dell’Orsa (1965) a Gruppo di famiglia in un interno (1974) e che era stata di fatto inaugurata da Rossellini, nel 1954, con Viaggio in Italia. In tutti questi film (e molti altri ancora) sembra venir messa in scena ossessivamente la progressiva perdita di contatto con la realtà da parte di un soggetto che progressivamente perde quella che Bourdieu definirebbe l’illusio, ovvero la capacità di credere e conseguentemente prendere sul serio quello che di fatto è un gioco di ruoli. L’illusio, del resto,
52
Lessico del cinema italiano
è una delle componenti fondamentali per il costituirsi di quelle forze che – interagendo fra loro – determinano un campo sociale. Non credendo che i gesti, le parole, le azioni possiedano un senso profondo e concreto, questi personaggi vedono dissolversi i vari campi sociali nei quali sono inseriti e finiscono per ritrovarsi senza obiettivi definiti. A sua volta, questa mancanza di obiettivi e questa uscita di scena li lascia nell’impossibilità di un riconoscimento. Dal punto di vista simbolico, letteralmente, si ritrovano spogliati dall’habitus e dunque nudi, e tale nudità ne fa i perfetti esponenti di una crisi della modernità che in molti avevano già descritto sul piano letterario (da Proust a Pirandello, passando per Joyce e Svevo) e che, paradossalmente ma non troppo, definisce la modernità cinematografica60. In tutto ciò, Il grido pare avere una valenza particolarmente significativa per almeno due ragioni. Da una parte, infatti, stabilisce quali sono le coordinate di un nuovo habitus autoriale, dove l’impegno civile e quello poetico si fondono con le ragioni dello star system (l’operaio padano è interpretato dall’attore americano Steve Cochran, la sua compagna è Alida Valli e nel cast figurano altre star internazionali, da Dorian Gray a Betsy Blair). Dall’altra parte, il fatto che il protagonista sia un operaio, è un fattore di rottura traumatica con una tradizione discorsiva e rappresentativa che tendeva a fare del lavoratore una sorta di figura monodimensionale, esclusivamente proiettata al riconoscimento dei propri diritti e al miglioramento della propria condizione materiale. In questo senso, allora, il film di Antonioni si colloca alla confluenza fra due diverse ipotesi: la prima riguarda l’ampiezza di una crisi dell’habitus che investe ormai strati della società italiana fin lì considerati – attraverso una cristallizzazione tendenziosa di alcune tesi gramsciane – immuni da nevrosi e dubbi tipici della borghesia e di classi sociali sufficientemente distanti dal bisogno materiale. La seconda ipotesi riguarda un cambiamento “antropologico” del proletariato, ormai definitivamente incluso nell’orizzonte sociale (piccolo) borghese, e pertanto destinato ad assorbire tutti i “difetti” e le problematiche tipiche di questa classe. 60
Sul tema della modernità cinematografica, assai stratificato, ci limitiamo a segnalare G. De Vincenti, Il concetto di modernità nel cinema, Pratiche, Parma 1993 e F. Jameson, Firme del visibile. Firme del visibile. Hitchcock, Kubrick, Antonioni, Donzelli, Roma 2003 [ed. or. Signatures of the Visible, Routledge, New York-London 1992].
Habitus Giacomo Manzoli
53
Quanto tale questione sia cruciale, in un paese fortemente polarizzato fra le istanze tradizionaliste della Democrazia Cristiana e il radicale progetto di cambiamento proposto dal Partito Comunista, lo dimostrano anche film come Il posto (1961) di Ermanno Olmi, Chi lavora è perduto (In capo al mondo) (1963) di Tinto Brass o La vita agra (1964) di Carlo Lizzani. Nel primo, per esempio, viene messo in scena con dolcezza e profonda sensibilità poetica l’assorbimento di un giovanissimo provinciale, nato e cresciuto nella prospettiva di vita umile e concreta di una società contadina e/o operaia, da parte del mondo impiegatizio che si avvia a costituire l’ossatura del mondo produttivo moderno, quell’universo del cosiddetto terziario che sarà oggetto della fortunatissima satira di Paolo Villaggio (nell’intera e infinita saga che si apre con il Fantozzi, 1975, di Luciano Salce) e una quindicina di anni dopo sarà a capo di una sorta di pacifica rivoluzione (come vedremo). Ad un livello più alto, lo stesso assorbimento e la stessa progressiva sostituzione dell’habitus sarà al centro della geniale e straziante vicenda autobiografica che Luciano Bianciardi aveva narrato nell’omonimo romanzo e che Lizzani porterà al cinema su sollecitazione dell’attore Ugo Tognazzi. La vita agra, appunto, è la cronaca dei progressivi slittamenti che conducono un intellettuale comunista, approdato a Milano per far saltare in aria il Pirellone e per vendicare i morti di un crollo minerario, a diventare parte attiva di quello stesso sistema produttivo, nel ruolo del pubblicitario di successo, ovvero del creativo al servizio della “persuasione occulta” e di quel processo di manipolazione delle coscienze che serviva a fare degli italiani un popolo di consumatori61. Usiamo queste formule e queste espressioni in ossequio allo spirito del tempo. Francesco Alberoni, nel suo Consumi e società62, ha spiegato in contemporanea come molte delle critiche alla società dei consumi derivassero da una mera funzione riparativa nei confronti del cambio di habitus necessario a sintonizzarsi con i mutamenti sociali in atto: come dire che gli italiani erano ben felici di partecipare ad una società affluente e ai suoi privilegi, ma vi era in loro il fisiologico desiderio di poter cambiare stile di vita restando 61 62
Sul film di Lizzani si veda D. Tomasello, Ma cos’è questa crisi. Letteratura e cinema nell’Italia del malessere, il Mulino, Bologna 2013. F. Alberoni, Consumi e società, il Mulino, Bologna 1964.
54
Lessico del cinema italiano
se stessi, cosa fisiologicamente impossibile. Fatto sta che l’habitus del rivoluzionario e dell’intellettuale organico, coinvolti in un processo di emancipazione dei corpi e delle coscienze che prevedeva un riconoscimento in termini etici e comunitari, si scontrava (secondo lo schema degli apocalittici e integrati) con l’idea di una messa a frutto del capitale culturale e simbolico in termini di incoraggiamento e implementazione del meccanismo di produzione e consumo che rendeva ancora più forte la struttura sociale borghese con tutte le sue aporie e le sue distinzioni. Il riconoscimento diventava allora un fatto individuale, legato al raggiungimento di obiettivi quantificabili e al valore concreto, materiale, che si riusciva a far attribuire al proprio contributo. Inevitabile che questo cambio di programma venisse percepito come una sconfitta esistenziale, la svendita di una veste magari umile ma affettivamente caricata di significati romantici in cambio di un lussuoso habitus impregnato di cinismo. Ed è altrettanto naturale che tale permuta comportasse una crisi profonda della propria soggettività – anche questa connessa all’instabilità del campo di riferimento – e ad un senso di perdita e di vuoto, come sistematicamente raccontato da Marco Ferreri in tutti i suoi film e specialmente in quel La grande abbuffata (1973) che può esserne considerato il manifesto. Gender e genere Gli storici hanno abbondantemente spiegato come, fra i cambiamenti che hanno investito la società italiana a partire dalla fine degli anni cinquanta, un ruolo particolarissimo è stato svolto dai differenti fattori che hanno influito sulla sfera della sessualità63. È stato ampiamente analizzato, in particolare, il difficilissimo iter parlamentare e l’intenso dibattito sociale che ha riguardato l’abolizione delle cosiddette “case chiuse”, cioè i bordelli controllati direttamente dallo Stato, avvenuta nel 1958 per effetto della legge Merlin64. Si è trattato evidentemente di un passaggio epocale e di 63 64
Cfr. P. Sorcinelli, Storia e sessualità: casi di vita, regole e trasgressioni tra Ottocento e Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2001. Come dimostrato in S. Bellassai, La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia degli anni cinquanta, Carocci, Roma 2006.
Habitus Giacomo Manzoli
55
una cesura traumatica che avrebbe trasformato per sempre le stesse coordinate di femminilità e mascolinità. Se fino a quel momento, in generale, la società italiana aveva disciplinato la sessualità secondo procedure e attraverso dispositivi di natura foucaultiana, fornendo anche gli elementi necessari ai soggetti per eseguire quelle che i moderni gender studies definiscono performance di genere, da qui in poi le carte si rimescolano e si dovranno ricucire gli habitus su misura per un teatro di ruoli maschili e femminili da rivedere integralmente. I fattori che giocano un ruolo sono certo molteplici: la fine della famiglia patriarcale, incoraggiata da un sistema produttivo industriale in cui le donne iniziano il difficile percorso verso l’indipendenza economica; la tecnologia medica che – a partire dalla pillola anticoncezionale – favorisce il controllo delle nascite e la separazione dell’attività sessuale dalla funzione riproduttiva; le spinte controculturali, di provenienza americana o nordeuropea, che implicano la liberazione del principio di piacere dal principio di realtà e fondano la cosiddetta rivoluzione sessuale. Ad accompagnare tutto questo, il progressivo aggiornamento della morale comune che conduce ad un clima politico favorevole e – dunque – all’aggiornamento degli istituti giuridici che regolavano le relazioni di genere, con l’abolizione del delitto d’onore e l’introduzione del divorzio e dell’aborto. Il cinema d’autore, naturalmente, affronta questi temi, costruendoci attorno opere complesse, che informano di sé la cultura cinematografica degli anni settanta65. Tuttavia, opere come Zabriskie Point (1970) di Antonioni, Il Decameron (1971) di Pasolini, Ultimo tango a Parigi (1972) di Bertolucci, Il portiere di notte (1974) della Cavani, Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) di Pasolini, Il Casanova di Federico Fellini (1976), Ciao maschio (1978) di Ferreri, fino a Diavolo in corpo (1986) di Bellocchio e molti altri, affrontano il tema in modo estremamente elaborato, intersecandolo con istanze autoriali e politiche66 e colorandolo con una ricerca estetica che interferiscono con la questione centrale e la rendono spesso opaca e poco comprensibile per il grande pubblico. 65 66
Sul tema si veda C. Bisoni, Gli anni affollati. La cultura cinematografica italiana (1970-79), Carocci, Roma 2009. Sul nesso fra dimensione politica e sessuale, specie in campo cinematografico, si veda Erotismo, eversione, merce, a cura di V. Boarini, Cappelli, Bologna 1974.
56
Lessico del cinema italiano
Se si vuole avere un riflesso trasparente delle tensioni che hanno coinvolto gli italiani nel ripensamento del proprio habitus di genere, delle soluzioni – spesso contorte – che si sono andate sperimentando rispetto all’hysteresis degli habitus tradizionali e dell’intero processo di negoziazione (con i suoi successi e fallimenti) di nuove identità riferite al gender, è probabilmente nel cinema popolare che conviene guardare, secondo un suggerimento che già Vittorio Spinazzola aveva fornito nei primi anni sessanta67. Prendiamo ad esempio un film paradigmatico, anche per la sua natura spuria, come Il merlo maschio (1971) di Pasquale Festa Campanile. Il film, scritto da Bianciardi (riadattando il proprio racconto Il complesso di Loth), interpretato da una maschera del cinema popolare come Lando Buzzanca e diretto da un regista “medio” che tuttavia aveva iniziato la propria carriera collaborando con alcuni grandi autori (Visconti, Petri, Bolognini e altri ancora), narra di un musicista di discreto livello che deve scendere a patti con il fatto di non essere un artista di primo piano e con una personalità modesta, che lo rende sostanzialmente uno fra i tanti (la gente fatica a ricordare il suo nome, dunque a riconoscerlo). L’uomo è sposato con una ragazza di provincia, umile e timorata di Dio, devota e piuttosto sciatta. Le cose cambiano quando l’uomo si rende conto che la moglie – opportunamente valorizzata – è in grado di suscitare l’ammirazione e il desiderio degli altri uomini (del resto, si tratta di Laura Antonelli). Da qui in poi, Buzzanca inizia un gioco perverso, esibendo il corpo della donna in circostanze sempre più audaci, per la vertigine del riconoscimento che gli procura il desiderio insoddisfatto degli altri nei confronti di una donna che egli considera sua. La ragazza lo asseconda, per pura obbedienza, ma accade che mentre il marito scivola progressivamente nell’impotenza (l’anomia diventa cronica) e in una nevrosi che lo condurrà in manicomio, la moglie invece impara a controllare autonomamente il desiderio maschile e a trarne vantaggio, facendone il perno su cui far ruotare un percorso di emancipazione per nulla lineare ma certamente efficace. Nel finale del film, dopo essere stato ricoverato per l’aggravarsi delle proprie condizioni, come dimostrano l’escalation delle richieste sempre più bizzarre e la progressiva perdita patologica di memoria (non ricorda più 67
Cfr. V. Spinazzola, Cinema e pubblico, cit.
Habitus Giacomo Manzoli
57
il suo nome e dove abita), Lando Buzzanca riceve la visita della moglie che vediamo ora trasformata anche in termini di “look”, con una pettinatura sbarazzina e dei vestiti colorati, provocanti, alla moda, che testimoniano sul piano materiale – nel modo di porsi e comunicarsi, anche fisicamente, esteriormente agli altri – il cambiamento di habitus che la bizzarra vicenda ha determinato. Non più soggetto passivamente sottomesso ad un’autorità maschile e patriarcale, bensì figura autonoma, capace di gestire gli interessi acquisiti e maturati con l’accumulo di un capitale sociale legato alla bellezza. Studiose americane come Jacqueline Reich hanno dimostrato che il cinema italiano è anche il luogo in cui si edificano veri e propri fenomeni di stardom – legati per esempio a figure importanti come quella di Marcello Mastroianni – che preferiscono legare la condizione maschile al tema dell’inettitudine che a quella della mascolinità tradizionale68, riprendendo la problematizzazione del “gallismo” che già si trovava nei romanzi di Vitaliano Brancati (da Il bell’Antonio, 1960, di Mauro Bolognini a Matrimonio all’italiana, 1964, di Vittorio De Sica). In questo senso, Buzzanca è il corpo emblematico che si incarica di incarnare, all’interno di una produzione popolare, la crisi di questa mascolinità, che derivava da una lunga tradizione e aveva trovato nel fascismo il periodo di celebrazione più enfatica. E lo fa proprio a partire da un altro romanzo di Brancati, Don Giovanni in Sicilia (1967) che nelle mani di Alberto Lattuada diventa una specie di racconto paradigmatico, dove l’identità di genere viene inquadrata nel frame più ampio della revisione degli habitus richiesta dalle nuove condizioni socioeconomiche e geopolitiche che conducono irrimediabilmente a nuovi stili di vita. Nel film, il ricco ragazzo del Sud, trascorre le sue giornate in una sonnolenta Catania coccolato da tre sorelle morbosamente attaccate, sfruttando le proprie rendite familiari e esprimendo la propria libido con le turiste nordiche. La sua vita cambia quando incontra una “mutante”, vale a dire una ragazza siciliana formatasi in Svizzera, la quale coniuga la malizia femminile della propria formazione originaria con una consapevolezza di sé tipicamente 68
Cfr. J. Reich, Beyond the Latin Lover. Marcello Mastroianni, Masculinity and Italian Cinema, Indiana University Press, Bloomington 2004.
58
Lessico del cinema italiano
moderna. Dopo il matrimonio, l’uomo porta la famiglia al Nord, a Milano, dove è coinvolto nella corsa al successo economico che lo costringe a vivere secondo i ritmi frenetici e alienanti del processo produttivo. Si assiste così a una perdita di contatto con le coordinate identitarie su cui si era appoggiato fino a quel momento, che lo conduce ad una nevrosi devastante, il cui segno più inquietante è l’impotenza che consegue al complessivo processo di “svirilizzazione”. E una analoga parabola riguarderà i personaggi di molte altre pellicole di successo interpretate da Buzzanca, da Il prete sposato (1970) a Homo Eroticus (1971), entrambi di Mario Vicario. Per comprendere meglio i termini della questione vale la pena concentrarsi su L’arbitro (1974) di Luigi Filippo D’Amico, dove il protagonista è appunto uno stimatissimo e irreprensibile arbitro di serie A, chiaramente ispirato alla figura reale di Concetto Lo Bello. L’uomo indossa la divisa di una delle figure dell’ordine e dell’autorità più chiaramente connotate all’interno della cosiddetta società dello spettacolo, ed è talmente ossessionato da questo compito da organizzare tutta la sua esistenza (compresa la vita sessuale) in funzione di una disciplina ferrea che gli consente di interpretare al meglio questa sua funzione. Il film si apre con una formidabile intuizione. Siamo su un campo da calcio dove – sotto una pioggia battente – si sta svolgendo una partita che noi non vediamo perché la macchina da presa resta sempre concentrata, in piani ravvicinati, sui gesti e le espressioni del direttore di gara. Quando finalmente si allarga l’inquadratura e un totale arriva a mostrare l’intero stadio, ci rendiamo conto che si tratta di una partita immaginaria, messa in scena dall’uomo per allenarsi sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista – per così dire – teatrale. Ci viene cioè messa in scena dal principio – attraverso una situazione dalle forti valenze simboliche – la condizione paradossale di una figura sempre più isolata e solitaria dell’autorità maschile, costretta a giocare una partita solipsistica, che si interseca in modo sempre meno realistico con la partita vera e propria che si sta giocando sul campo del sociale, rispetto alla quale l’uomo finirà espulso quando – dopo una serie di vicissitudini – proverà a prolungare un derby a San Siro oltre ogni ragionevole recupero. E non sono solo i film di Buzzanca a mettere in scena in chiave comico-grottesca questo traumatico e doloroso processo di revisione dell’habitus maschile. Potremmo anzi dire che si tratta del
Habitus Giacomo Manzoli
59
tema di fondo di tutta la commedia degli anni settanta69, come dimostra anche il film che meglio di ogni altro ha colto lo spirito dei cosiddetti decamerotici, ovvero di quel filone di commedie erotiche popolari che si sviluppò paradossalmente a partire dal successo del Decameron pasoliniano e dall’apertura delle maglie censorie che quel film aveva determinato. Parliamo di Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972) di Mariano Laurenti, che si apre anch’esso con una sequenza che non è esagerato rubricare fra le forme simboliche per eccellenza del cinema italiano del periodo. Durante i titoli di testa, infatti, vediamo il protagonista (interpretato dal comico Pippo Franco) che si trascina stanco e macilento, verso casa. Trattandosi di un film di ambientazione medievale, è normale che indossi un’armatura, ma ciò che colpisce è che si tratta dello scheletro di un’armatura da crociato, composta cioè solo da alcuni pezzi, l’elmo, un bracciale, una spada troppo pesante, un corpetto e così via. In altri termini, l’armatura è piena di lacune, arrugginita, ammaccata, del tutto inutile a svolgere il suo compito protettivo, e questi residui sembrano attaccati ad un corpo maschile – peraltro del tutto inadeguato a sostenerne il peso – solo per abitudine, sicché l’unica conseguenza della loro presenza è quella di rallentare il cammino dell’uomo, appesantendolo e rendendolo una specie di goffo pupazzo. Nel prosieguo della storia, scopriremo che si tratta effettivamente di un crociato che torna al focolare domestico, sperando di ritrovare la propria moglie giovane e bella “intatta” grazie alla cintura di castità che si era premurato di farle indossare prima della partenza. Ma tale accorgimento si è rivelato del tutto inadeguato, giacché la donna ha trovato il modo di evadere e ha intrattenuto relazioni amorose con buona parte dei bei giovani del villaggio. Al contempo, l’unica vittima di questa gelosia ossessiva (che lo ha indotto a trattare il corpo della compagna come oggetto di possesso da custodire) è proprio il marito. Egli infatti ha smarrito la chiave ed è perciò impedito a tornare ad una soddisfacente vita coniugale, e quanto inizierà a progettare evasioni coniugali si ritroverà letteralmente evirato, a cantare nel coro delle voci bianche. Come dire che tutti 69
Cfr. G. Turroni, Viaggio nel corpo. La commedia erotica nel cinema italiano, Moizzi, Milano 1979.
60
Lessico del cinema italiano
i correlativi oggettivi dell’habitus di gender secolarizzato a partire dal Medioevo (inteso come categoria dello spirito) si rivoltano contro coloro che cercano di controllarli, rifiutando in maniera ottusa di aggiornare il proprio status di maschi ad una situazione che ne richiede una versione assai più leggera, più fluida, capace di confrontarsi con figure femminili che non sono affatto disposte a recedere dalle prerogative di indipendenza e soddisfacimento di bisogni fisici e simbolici percepiti ormai come legittimi e irrinunciabili. Non è probabilmente il modo in cui l’aveva immaginata Marcuse, ma è comunque una delle strade con cui una larga parte della popolazione italiana cerca di negoziare l’accesso alla rivoluzione sessuale70. La fine del cinema come arte media È noto come a metà degli anni settanta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che, di fatto, apriva la strada alle emittenti private71, si siano poste le basi per la nascita della neotelevisione72 e per una sorta di rivoluzione che avrebbe mutato in profondità lo scenario mediale italiano. Il cinema come apparato si avviava a subire un brusco ridimensionamento, e tale riduzione avrebbe riguardato in particolare l’industria cinematografica italiana, destinata a contrarsi in maniera drastica e a veder calare la sua influenza sull’immaginario e sulle abitudini di consumo culturale legate al tempo libero. Tali fenomeni spiegano anche il cambiamento dell’approccio complessivo da parte dei soggetti incaricati di utilizzare il mezzo per riflettere sulla realtà sociale circostante. Possiamo dire infatti che il cinema italiano degli anni 70
71 72
In questo senso, gli esempi che si potrebbero citare sono innumerevoli: valgano per tutti alcuni titoli dei film diretti da Salvatore Samperi, da Grazie Zia (1968) a Malizia (1973), dove la dimensione della sessualità e quella politica si saldano con inedita ironia, sullo sfondo del tema delle relazioni intergenerazionali fra individui di sesso maschile. Al riguardo si vedano A. Grasso, Storia della televisione italiana, Garzanti, Milano 1992 e E. Menduni, Televisione e società italiana (1975-2000), Bompiani, Milano 2002. Fra i molti testi dedicati al concetto di neotelevisione, segnaliamo in particolare Tra me e te. Strategie di coinvolgimento dello spettatore nei programmi della neotelevisione, a cura di F. Casetti, Edizioni RAI, Torino 1988.
Habitus Giacomo Manzoli
61
ottanta è contraddistinto da due fenomeni che sembrano scorrere in parallelo senza mai intersecarsi. Da una parte, infatti, si assiste ad una sopravvivenza del cinema popolare legata sempre più ad una integrazione con il sistema mediale e con la televisione in particolare, fenomeno che prosegue ancor oggi73. È dalla televisione, infatti, (magari per il tramite dell’industria discografica) che provengono tutti quei comici che riescono ancora a coinvolgere un vasto pubblico trasversale: Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Enrico Montesano, Francesco Nuti, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Massimo Troisi, fino allo stesso Roberto Benigni e perfino Nanni Moretti, che nella fase iniziale della propria carriera viene incluso nella schiera dei cosiddetti “nuovi comici”. Dall’altra parte, si assiste alla lenta agonia del cinema d’autore, sempre più ripiegato su se stesso e su una lettura malinconica della propria estraneità ad un mondo che non lo prevede. Pertanto il presente viene percepito come epoca di decadenza, dove l’impegno dei decenni precedenti sarebbe stato sostituito da un edonismo e un materialismo di matrice prettamente postmoderna, secondo uno schematismo che la storiografia ha provveduto a smentire74 ma che trova una spiegazione convincente proprio nell’hysteresis dell’habitus dell’intellettuale organico di derivazione gramsciana. L’insieme di disposizioni di una figura cardine dell’industria culturale, che si era visto assegnato il compito di interpretare il reale (ed eventualmente le sue crisi legate alle contraddizioni della modernità) e che si percepiva come funzionale allo sviluppo di uno spirito critico capace di svolgere comunque un ruolo emancipatorio in favore delle masse, si dimostrano sempre più inadeguate a inquadrare la reale condizione degli autori cinematografici. Questi, infatti, non sono più incaricati solo di dare forma e comunicare una visione del mondo ma di guidare un processo produttivo articolato, coordinando la performance di competenze tecniche sempre più specializzate, per realizzare un
73 74
È quanto si sostiene ad esempio in B. Corsi, Produzione e produttori, Il Castoro, Milano 2012. Fra i testi che propongono una lettura più complessa e articolata del periodo, segnaliamo M. Gervasoni, Storia d’Italia degli anni ottanta. Quando eravamo moderni, Mondolibri, Milano 2011 e Anni Ottanta: quando tutto cominciò, a cura di P. Mattera, C. Uva, in “Cinema e Storia”, n. 1 (2012).
62
Lessico del cinema italiano
oggetto concepito secondo gli schemi di quelle che sarebbero poi state celebrate come industrie creative. Si trattava di un cambio di paradigma sostanziale, che richiedeva una revisione di status e di habitus rispetto al quale gli autori già affermati e i loro emuli che stavano esordendo in quel periodo avrebbero offerto una strenua resistenza. Questa attitudine resistenziale diviene allora una delle componenti fondamentali di un cinema che sembra esistere principalmente come contrappeso allo strapotere della televisione e delle istanze ideologiche di cui questa sarebbe portatrice, preferendo chiudersi in uno spazio protetto e accogliente dove coltivare una vera e propria claustrofilia75. Diventa così possibile comprendere il ripiegamento su se stessi che è alla base di pellicole sempre più disperatamente nostalgiche come quelle di Federico Fellini, Ermanno Olmi, Marco Ferreri e altri ancora, impegnati a omaggiare la poesia di forme spettacolari ingenue ma cariche di sentimenti autentici e sottili, a fronte della volgarità dei media contemporanei: una sorta di sineddoche di una società votata ad una prostituzione consumistica diffusa. Film come Ginger e Fred (1986), La voce della luna (1990), Lunga vita alla signora! (1987), La leggenda del santo bevitore (1988), Come sono buoni i bianchi! (1988), La casa del sorriso (1991) e diversi altri, sembrano incarnare esattamente questo spirito di senile riproposizione di una crisi già ampiamente esplorata nel corso degli anni sessanta nella lettura del sociale e ora riproposta in maniera radicale e decadente, soprattutto come riflesso del proprio progressivo allontanamento dal centro del dibattito culturale. D’altra parte, come si diceva, anche i giovani autori più dotati sembrano prediligere una strada votata alla nostalgia del passato, al rimpianto di un paese (reale o immaginario) mancato76, all’elogio di una fuga dal proprio mondo di appartenenza. È il caso del pluripremiato Nuovo Cinema Paradiso (1988) come di altri film di Giuseppe Tornatore (ad esempio, Stanno tutti bene, 1990), ma è anche il caso dei film di Gabriele Salvatores, da Marrakech Express (1989) a Puerto Escondido (1992) passando per Mediterraneo (1991). In 75 76
Cfr. V. Zagarrio, Cinema italiano anni Novanta, Marsilio, Venezia 2001, p. 79. Sul concetto del “mancamento” come categoria storica si veda G. Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Donzelli, Roma 2003.
Habitus Giacomo Manzoli
63
questi film, il discorso di reducismo generazionale retrocede fino a riguardare una generazione di trenta-quarantenni, ma si tratta evidentemente anche di esplorare le potenzialità del vintage che sarebbe divenuta una delle categorie portanti dell’industria culturale degli anni successivi77. Con Salvatores, per certi aspetti, si assiste anche al tentativo di riproporre forme aggiornate di quel cosiddetto “cinema medio” che sembrava essersi drammaticamente estinto con il nuovo assetto di cui si è parlato e che pareva aver definitivamente proiettato il cinema al di fuori del novero delle «arti medie»78, costringendolo a polarizzarsi sui due assi dell’autorialità regressiva o dell’exploitation di fenomeni importati da altri contesti mediali. Negli anni successivi, alcuni registi proveranno a rilanciare un cinema capace di muoversi sul piano di un’analisi sociale, riflettendo gli umori e le tensioni derivanti dai cambiamenti in atto, mettendo in scena le contraddizioni e i tentativi di trasformazione, provando tuttavia ad adottare uno stile narrativo e filmico in grado di coinvolgere un pubblico popolare. È il caso di registi come Daniele Luchetti, che da Il portaborse (1991) a La nostra vita (2010), passando per I piccoli maestri (1998) o Mio fratello è figlio unico (2007), ha indagato in maniera sistematica il modo in cui – nell’Italia contemporanea – le posizioni tradizionali si vengono a trovare costantemente in scacco, obbligando i soggetti a rivedere repentinamente l’habitus con cui erano scesi in campo e a provare e sperimentare soluzioni creative tutt’altro che semplici. Se per Luchetti questo è un portato che segna l’intera vita dell’Italia repubblicana, a partire dalla Resistenza, per il collega Carlo Mazzacurati si è trattato di indagare principalmente la posizione di singoli soggetti in crisi di disposizione, rispetto ad una realtà che cambia secondo coordinate misteriose, come accade nel Nordest di Notte italiana (1987), Il toro (1994) o La giusta distanza (2007), passato rapidamente da una dimensione fortemente legata a valori tradizionali a luogo di frontiera – anche ideale – della produ77 78
E. Morreale, L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel cinema italiano e dintorni, Donzelli, Roma 2009. Utilizziamo l’espressione “arte media” nel senso con cui è utilizzato ad esempio in P. Bourdieu, L. Boltanski, R. Castel, J.-C. Chamboredon, La fotografia. Usi e funzioni di un’arte media, Guaraldi, Rimini 2004 [ed. or. Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Les Éditions de Minuit, Paris 1965].
64
Lessico del cinema italiano
zione globalizzata, con il conseguente senso di spaesamento di soggetti costantemente in crisi, che non hanno ben chiaro come convertire il patrimonio economico, sociale e culturale in identità stabili. Tuttavia, chi più di ogni altro ha indagato la confusione degli habitus, costantemente in bilico fra conferme, hysteresis, meccanismi che ricordano quelle del mondo borghese della Francia del XIX secolo e improvvise accelerazioni, è sicuramente Paolo Virzì79. Nei suoi film, in particolare due autentici saggi di sociologia politica contemporanea come Ferie d’agosto (1996) e Caterina va in città (2003), offrono una prospettiva straordinariamente lucida sull’evoluzione dei rapporti di classe, con un approccio riconducibile perfino alle teorie dell’interazionismo simbolico80. In questi film, come del resto in altri dello stesso regista, assistiamo al cortocircuito degli habitus di classe – attorno ai quali si struttura gran parte della vita simbolica dei soggetti – nel momento in cui persone provenienti da realtà diverse fanno interagire i loro schemi di interpretazione della realtà e l’insieme delle loro disposizioni, dei loro modi di essere, delle reciproche strategie di riconoscimento. Nel primo film, in particolare, ad essere presa di mira è soprattutto la “falsa coscienza” di una borghesia intellettuale di sinistra che dichiara un sincero amore per le masse e proclama una serie di buone intenzioni: il rifiuto della superficialità televisiva in favore dello spirito critico sviluppato da buone letture, musica colta, forme di socializzazione libere e spontanee, rispetto delle altre culture, delle libertà individuali, del patrimonio naturalistico e artistico eccetera eccetera. Tuttavia, quando nella raffinata località marittima in cui trascorrono le vacanze (l’isola di Ventotene) fanno irruzione due famiglie di commercianti, emblema di quel ceto popolare imprenditoriale “arricchito”, che nell’immaginario diffuso della sinistra italiana costituirà l’emblema dell’elettorato berlusconiano per circa un ventennio, allora la situazione si complica e una serie di contraddizioni si manifesteranno in maniera dirompente. Lo sguardo di Virzì e del suo sceneggiatore, Francesco Bruni, è acuto fino alla spietatezza. Se da un lato il popolo è 79 80
Cfr. F. Zecca, Lo spettacolo del reale. Il cinema di Paolo Virzì, Felici, Ghezzano 2011. Su questo concetto si veda il classico H. Blumer, Interazionismo simbolico, il Mulino, Bologna 2008 [ed. or. Symbolic Interactionism, University of California Press, Berkeley 1969].
Habitus Giacomo Manzoli
65
effettivamente divenuto ciò che gli intellettuali avevano paventato da Pasolini in poi, ovvero un insieme di singoli consumatori alla deriva, votati al soddisfacimento di bisogni puramente materiali indotti dalle comunicazioni di massa, non meno mostruoso appare – sull’altro versante – il clan di “radical-chic” capitanati da Silvio Orlando. Si tratta infatti di un gruppo regressivo, passivamente aggressivo, arroccato in una strenua difesa, le cui pretese di impegno e la cui raffinatezza estetica si rivelano essere principalmente pratiche distintive il cui scopo fondamentale sembra essere quello di mantenere il popolo a distanza, per conservare il privilegio minore di poter far stare dalla parte dei dominanti, sia pure sul gradino più basso che spetta a coloro che possiedono esclusivamente un capitale culturale. Analogo conflitto si manifesta allora in Caterina va in città, allorché il professore di liceo interpretato da Sergio Castellitto, utilizza la figlia adolescente per cercare di convertire il proprio (minimo) capitale culturale in un capitale sociale, per veder riconosciuto il proprio diritto a far parte della classe di privilegiati, il cui status è principalmente definito dal capitale economico che garantisce la forma più solida di potere. Un tentativo maldestro, destinato al fallimento, anche perché zavorrato pure in questo caso da falsa coscienza e fatto faticosamente filtrare attraverso una serie di strategie di dissimulazione dell’habitus che la sensibilità critica della figlia riesce a smontare pezzo dopo pezzo. Così, in queste e in altre pellicole (ad esempio, Tutta la vita davanti, 2008, o Il capitale umano, 2014) Virzì riesce a compiere una notevole analisi della crisi della società italiana come luogo di incontro e scontro fra habitus, decostruendo soprattutto quelli della medio-piccola borghesia, la cui inadeguatezza a raggiungere gli scopi prefissi sembra essere divenuta endemica e appare una delle conseguenze più drammatiche della globalizzazione che ha reso immediatamente obsoleti i precedenti frame di interpretazione della realtà, così come la modernizzazione del dopoguerra aveva mandato in cortocircuito quelli tradizionali (come nel caso di Il cappotto di cui si è parlato all’inizio). Se il suo cinema si mantiene in perfetto equilibrio fra istanze autoriali e capacità comunicative tipiche della commedia all’italiana, è ancora al cinema popolare che conviene guardare per avere un ritratto trasparente delle tensioni che agitano i soggetti in relazione all’accordo fra interpretazioni, strategie di affermazione individuale e disposizioni incor-
66
Lessico del cinema italiano
porate. Fra gli innumerevoli esempi che si potrebbero portare, ci limitiamo a tre casi a nostro avviso esemplari. Nell’opera di esordio di Wolfango De Biasi, Come tu mi vuoi (2007), ci si introduce in una delle classiche dinamiche tipiche del cosiddetto “teen-movie” americano81, per raccontare di una giovane studentessa tanto scrupolosa nello studio quanto sciatta e trasandata nel modo di vestire e di porsi agli altri in generale. L’amore per un ragazzino di bell’aspetto, appartenente a una classe sociale superiore alla sua, apparentemente superficiale e ignorante, la indurrà a compiere una vera e propria trasformazione che include un complesso e doloroso meccanismo di emancipazione. In altri termini, il sentimento che la ragazza prova nei confronti del giovane non è altro che il riflesso della volontà di un passaggio di status, per il quale è necessario aggiungere ulteriori forme di capitale (ad esempio sociale) a quello culturale (cioè simbolico) di cui già è in possesso. Per fare questo, dovrà aggiornare i propri schemi cognitivi, rivedere il proprio ethos, per dirla alla Weber, e dimostrare di aver naturalizzato questo cambiamento attraverso il corpo, ovvero ciò che Marcel Mauss82 definiva “lo stare nel mondo dei soggetti”, cioè il trucco, il vestire, la gestualità, l’atteggiamento nel parlare e così via. Dinamiche simili le ritroviamo in commedie come Viva l’Italia (2012) di Massimiliano Bruno, dove la figlia di un uomo politico di destra, aspirante attrice, va a turbare l’ordine simbolico e le relazioni “di classe” consolidate, presentandosi a recitare davanti agli occupanti del Teatro Valle di Roma e mettendo in crisi una contrapposizione in gran parte artificiosa (e non è un caso che l’attrice scelta per interpretare il ruolo sia Ambra Angiolini, ex-diva di un programma televisivo spesso additato come emblema del trash). Ancora, in Buongiorno papà (2013) di Edoardo Leo, tutto ruota attorno al confronto fra un padre che aspira a rimanere eternamente giovane e una figlia adolescente apparsa all’improvviso. È lo spunto ideale per riflettere sia sugli habitus attorno ai quali si costruiscono le identità familiari83 sia su quelli che regolano l’appartenenza a gruppi sociali antagonisti, che si esprimono attraverso i gusti di 81 82 83
In merito al concetto di teen-movie rimandiamo a F. Masoero, Product placement, teenpic e adolescenti 2.0, Kaplan, Torino 2012. Cfr. M. Mauss, Sociologia e antropologia, cit., p. 156. Sul tema delle identità familiari, e in particolare della messa in scena dei modelli di paternità, si veda C. O’Rawe, Stars and Masculinities in
Habitus Giacomo Manzoli
67
consumo culturale e che si dispongono fondamentalmente sugli assi dell’affermazione e della rinuncia, come dimostrato ad esempio da Mary Douglas84. Colui che più di ogni altro è stato capace di adottare una descrizione obliqua della società italiana, svelando l’inconsistenza degli habitus tradizionali ad elaborare efficaci schemi stabili per il riconoscimento, è però il comico pugliese Checco Zalone (alias Luca Pasquale Medici). La sua maschera non è molto diversa da quella regionale adottata ai tempi da Diego Abatantuono, ma in film come Cado dalle nubi (2009) o Sole a catinelle (2013), entrambi diretti da Gennaro Nunziante, Zalone ha utilizzato questa figura di idiota sociale premoderno, calato nell’universo globalizzato dai mass-media, per dimostrare con affettuosa ironia l’assoluta inadeguatezza degli habitus con cui la maggior parte dei soggetti cerca di ripararsi dalla confusione nella quale sono ormai cadute le consuete distinzioni di classe, ceto, razza, religione, schieramento politico, gender, ruolo familiare, cultura e così via. In questo modo, egli rappresenta in maniera estremamente creativa la comunanza di soggetti che – come sostiene Zygmunt Bauman85 – si ingegnano per trovare soluzioni individuali a problemi sistemici come la disoccupazione, l’integrazione, la caduta dei valori tradizionali, la fine delle grandi narrazioni e così via. Quanto sia comune questa condizione e quanto sia apprezzato un cinema capace di mostrare, come Fregoli ai suoi tempi, le tecniche per cambiare abito e habitus con sufficiente agilità, lo dimostra il successo formidabile che i film di Zalone-Nunziante hanno saputo conquistare al box-office86. Un successo che, anche a fronte della crisi che da tempo investe il mercato cinematografico, si presenta come una boccata d’ossigeno per l’intero settore e prelude forse ad un cambio di habitus anche da parte dei suoi operatori.
84 85 86
Contemporary Italian Cinema, Palgrave & MacMillan, New York 2014, in particolare pp. 69-95. Cfr. M. Douglas, Questioni di gusto, il Mulino, Bologna 1999 [ed. or. Thought styles, Thousand Oaks, London 1996]. È una delle tesi centrali di Z. Bauman, Individualmente insieme, a cura di C. Leccardi, Diabasis, Reggio Emilia 2008. Il film di Zalone-Nunziante ha incassato oltre 50 milioni di euro, ed è in assoluto il secondo maggiore incasso della storia del cinema in Italia, dopo Avatar (2009) di James Cameron. Per avere un parametro, negli anni di maggior successo, i cosiddetti “cinepanettoni” non hanno mai superato la soglia dei 25 milioni di euro.
68
Lessico del cinema italiano
Filmografia di riferimento Pinocchio (Antamoro, 1911), La nave (D’Annunzio, Roncoroni, 1921), Miss Europa (Genina, 1930), Il signor Max (Camerini, 1937), La nave bianca (Rossellini, 1941), L’onorevole Angelina (Zampa, 1947), Benvenuto reverendo! (Fabrizi, 1950), Il cappotto (Lattuada, 1952), Il grido (Antonioni, 1957), Rocco e i suoi fratelli (Visconti, 1960), Mamma Roma (Pasolini, 1962), Prima della rivoluzione (Bertolucci, 1964), La vita agra (Lizzani, 1964), Don Giovanni in Sicilia (Lattuada, 1967), Il merlo maschio (Festa Campanile, 1971), Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda (Laurenti, 1972), L’arbitro (D’Amico, 1974), Nuovo Cinema Paradiso (Tornatore, 1988), Ferie d’agosto (Virzì, 1996), Caterina va in città (Virzì, 2003), Come tu mi vuoi (De Biasi, 2007), Habemus Papam (Moretti, 2011), Viva l’Italia (Bruno, 2012), Buongiorno papà (Leo, 2013), Sole a catinelle (Nunziante, 2013).
R
D G
IDENTITÀ
Un uomo anziano attraversa le strade di Roma, sale su un autobus, sguardo smarrito, chiede incerto a chi incontra cose ordinarie (la strada, l’ora). Quell’uomo è fuggito, si è sottratto ad un alto compito che gli era stato assegnato: diventare papa. Piuttosto che accedere al sacro soglio, per cui non si sente pronto, il cardinale Melville si perde in un presente aperto verso il passato dei desideri rimossi (diventare attore, come risponde alla psicoanalista che glielo chiede) e verso un futuro sottratto ad ogni ipoteca. Ciò che il balcone vuoto di San Pietro, quel buco nero segnato da due lembi di tenda rossa svolazzanti dopo l’annuncio dell’elezione del pontefice, segnala è una sottrazione, quella di una identità, collocata nel punto di intersezione tra un sentimento e una prassi, tra un senso di inadeguatezza e un dispositivo di potere incapace di garantire una corrispondenza tra soggetto e ruolo. È Habemus Papam (2011) di Nanni Moretti, dove Melville (Michel Piccoli), rinunciando a rispondere a ciò a cui è stato chiamato, essere papa, rinuncia con ciò stesso ad un processo risolutivo di identificazione di sé, attraverso l’iscrizione in un ordine simbolico affermato nella sua massima potenza, come maschera non più cancellabile fino alla morte1. Melville restando tale contrappone la sua volontà individuale all’impersonalità ed effettualità di un rito di investitura. Questa discordanza è segno di una crisi e fa del film di Moretti un esempio importante della criticità del rapporto fra l’io e il noi (comunità, istituzione, potere) in quanto costitutivo dell’identità. L’io non è mai stato pensato nella nostra tradizione culturale come istanza capace di precedere ed astrarsi dal mondo (ego car1
Le dimissioni di Benedetto XVI sono un atto ben fuori dall’ordinario, che in quanto tale conferma la regola.
70
Lessico del cinema italiano
tesiano), ma sempre come soggetto calato in un contesto vitale, sia esso quello della natura (Giordano Bruno) o della storia e del potere (Niccolò Machiavelli)2. O meglio, tranne rari casi, l’identità non è stata mai pensata come dimensione meramente soggettiva, ma come precipitato di un impersonale, sociale e storico, di cui il nostro cinema ci ha riconsegnato un’immagine unica per forza e incidenza, che è passata per generi (commedia, melodramma, romanzo) e per stili diversi (il realismo, sia drammatico che grottesco). Insomma, il radicamento nell’orizzonte della vita, che significa anche radicamento nelle condizioni materiali di esistenza dei personaggi e delle situazioni, ha collocato il nostro cinema in una posizione originale, che ha fatto dell’io e del mondo due istanze non illusoriamente definite, contrapposte e dialetticamente regolate dall’azione. L’io e il mondo nascono insieme, secondo la formula di un «soggetto mondanizzato»3, da sempre esposto ad un fuori attraverso la “prassi” (Gramsci) o dove il fuori, divenuto istituzione, viene “interiorizzato” (lo Stato in interiore homine di Gentile). Quest’attenuazione dei confini tra l’interno e l’esterno, che diventano inassegnabili e indecidibili, trova riscontro nell’assenza dal nostro cinema della «grande forma d’azione»4, di cui l’epos è il genere dominante. La grande azione è fondata sull’identificazione e distinzione degli elementi che la compongono: il cosa, il chi, il come e il perché dell’azione. È un principio di identità quello che l’azione afferma nella sua forma più cristallina, e cioè nel suo sviluppo “grande”, articolato nei differenti «duali»5. Se nel cinema italiano non c’è grande forma d’azione (neanche nel cinema bellico del regime) è perché non c’è identificazione certa di un mondo (dei suoi elementi costitutivi) e della sua distinzione dall’io. L’impossibilità di determinare una distinzione tra l’io e il mondo (tra il soggetto e l’oggetto), e dunque di individuare una situazione sufficientemente stabile che un soggetto dotato di volontà possa modificare, ha spostato il nostro cinema verso forme generi2 3 4 5
Cfr. su questo R. Esposito, Pensiero vivente. Origini e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, pp. 47-71. Ivi, pp. 178-183. G. Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, pp. 167-186 [ed. or. L’image-mouvement, Les Éditions de Minuit, Paris 1983]. Cfr. ivi, p. 180.
Identità Roberto De Gaetano
71
che orientate ad una presa in carico dell’ambivalenza come tratto costitutivo della vita individuale e sociale, che ha trovato una messa in immagine saliente per esempio nella commedia, ma anche, in senso opposto, nel melodramma. Se l’identità non è data, se l’io non è presupposto e il mondo non è definito, allora l’identità diviene un processo incerto ed aperto, che vede l’io esposto al noi, ad una communitas rispetto alla quale tende, da un lato a corrispondervi, dall’altro a difendersi attraverso pratiche di immunitas6. Ciò che chiamiamo identità è dunque l’arresto precario di un processo costante, dove l’io è definito in rapporto al noi (è questa prospettiva che adotteremo, non toccando invece il rapporto tra il “noi” e gli “altri”). Ma il noi è sia l’insieme relativamente piccolo di coloro con cui abbiamo relazioni dirette e intime come la famiglia; sia la società come insieme ampio, costituito da interessi e desideri; sia lo Stato come insieme di istituzioni che presiedono al mantenimento delle situazioni; sia il potere come insieme di dispositivi tesi a regolamentare vita privata e pubblica; sia la natura come ciò che sovrasta la società, lo Stato, il potere. E quando il mondo si disgrega, quando il noi si dissolve in un retropiano inassegnabile e caotico, emerge un io senza argini, senza limiti, dissolto in frammenti. In questa dialettica io-noi, la questione dell’identità e della sua rappresentazione può dividersi in due grandi tipologie, che ne accentuano: 1) la dimensione sociale, che può determinare a sua volta o stati di identità, cioè dimensioni statiche dove è più forte e rigida la codificazione del ruolo, o processi di identificazione, che tengono conto delle fasi e del percorso compiuto dal soggetto, sia esso irrisolto o definito nella sua conclusione; 2) la dimensione individuale, psicologica, personale, che tende a pensare l’identità in termini di interiorità, spesso astratta dal contesto socio-culturale. Nel primo caso sono le scienze sociali ad essersi ascritte la questione dell’identità, nel secondo è in primo luogo la psicologia. In questa divisione, troppo dicotomica, non sono poche le prospettive 6
Cfr. R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 1998 e Id., Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002.
72
Lessico del cinema italiano
che ne individuano una sintesi, così da pensare che il self, «il senso della propria identità, si chiarisce in una serie di sottotematiche concrete, legate all’immaginazione di sé nella vita quotidiana»7. E dunque il sé, e il suo carattere autopercettivo, è legato al tessuto relazionale e sociale ordinario. Ora, se il cinema ha tenuto in molti casi separate le due dimensioni del sociale e dello psicologico, del comportamento e dell’interiorità, degli habitus e dei sentimenti, collocando nella prima prospettiva i grandi generi del cinema americano (dal western alla commedia) e nella seconda la grande tradizione del cinema d’autore europeo (da Bergman a Tarkovskij), il cinema italiano, nella sua forma più alta, ha spezzato come nessun altro questa polarità riduttiva, spingendo radicalmente il soggetto nel mondo (rendendolo, spesso, indiscernibile da esso), o introiettando fino all’inverosimile il mondo nel soggetto. In entrambi i casi ha creato una zona di indiscernibilità, che ha sottratto l’identità e la sua forma ad ogni idea di relazione e di mediazione. Sono rari nel cinema italiano processi o tappe, crescite o stadi, romanzi di formazione o esperienze acquisite, tutto ciò che definirebbe lo statuto negoziale dell’identità. Nel cinema italiano l’individuo è fin dall’inizio proiettato nel mondo, di cui diventa profilo espressivo o mero prigioniero; oppure rende il mondo una sua proiezione, una sua estensione mentale. In entrambi i casi l’identità trova una restituzione esagerata, corrispondente ai diversi “stati del mondo”, sia nel gioco delle maschere che nelle deformazioni grottesche. Fa eccezione, tra i generi importanti, il melodramma, che si costruisce proprio sull’elisione del mondo, sulla sua messa in parentesi, sulla sua riduzione alla coniugalità e alla famiglia, dove le identità diventano rigide, non modulabili, di fatto sequestrate ed espropriate, e il mondo risulta immodificabile perché aspirato dall’inesorabilità del passato.
7
G. Jervis, La conquista dell’identità. Essere se stessi, essere diversi, Feltrinelli, Milano 1997, p. 123.
Identità Roberto De Gaetano
73
1. L’identità espropriata Non esiste nel cinema italiano identità trasparente, che si autoimpone e si afferma indipendentemente dalla sua relazione con il mondo. Nel cinema muto, data l’assenza di parola udita e dunque con una capacità ridotta di rappresentare relazioni, l’identità assume un carattere più astratto, quasi-mitologico (Quo Vadis? e Cabiria) o passionale (Figli di nessuno del 1921, Assunta Spina o più in generale le figure femminili incarnate dalla Bertini e dalla Borelli). L’identità “mitologica”, di cui l’esempio più significativo in quegli anni è Maciste, è una identità dove la complessità viene restituita nella sua forma più stereotipata: la forza bruta come contrassegno identificativo, che cancella sfumature e sottigliezze. E questo vale anche negli esempi di burlesque, che si sviluppano attraverso una pura meccanica del travestimento (donne che sono uomini ecc.) e in modi schematici e stereotipati, come in Avventura galante di un provinciale (1908) di Luca Comerio o Il gallo nel pollaio (1916) di Guazzoni con Vincenzo Scarpetta. Dalla presenza della parola, il cinema cambia segno e la forma della relazione sociale diviene condizione di esistenza dell’io. Il vincolo sociale fa dell’individuo una proiezione del desiderio altrui e lo espone ad una duplice prospettiva: una che lo vede espropriato di sé, perché ricondotto sotto il potere di una maschera che gli altri lo obbligano ad indossare, un’altra che vede nella stessa maschera non un segno alienante ma una opportunità, quella di una sperimentazione che il soggetto fa con la propria identità, rendendo produttiva la sua costitutiva ambivalenza. Socializzazione significa teatralizzazione della vita, che vuol dire da un lato l’inautenticità a cui si espone il soggetto, dall’altro l’opportunità di vivere altre vite, avventurose e rocambolesche, che diventano una forma di intensificazione e di scoperta della propria identità. La commedia scettica pirandelliana, ereditando dal dramma borghese europeo, ci riconsegna una maschera come travestimento e irrigidimento della fluidità della vita. Le maschere pirandelliane sono le maschere “alienanti”, nelle quali il soggetto non si ritrova se non sotto il segno di un’inautenticità irriscattabile. Il riconsegnare l’immagine di sé nelle mani dell’altro (ciò che di fatto comporta la vita sociale) significa smar-
74
Lessico del cinema italiano
rire il carattere sorgivo e originario della soggettività. La relazione, la vita sociale non diventano le forme proprie dove si realizza il riconoscimento, ma quelle dove si impone “la ragione degli altri”, che arriva a generare i gesti più crudeli e a fare dell’ipocrisia il tratto dominante del comportamento sociale. L’identità è perdita del sé originario, in un processo di alienazione che trova anche nel medium cinematografico un dispositivo centrale (Quaderni di Serafino Gubbio operatore). L’approdo radicale del processo di estraneazione dell’io coincide con la dissoluzione della sua identità, con il “nessuno” dopo i “centomila”. La maschera dell’identità è in buona sostanza una trappola che blocca «il flusso continuo, incandescente e indistinto»8 della vita; la quale non c’è e non c’è mai stata: «Vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data, e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c’è mai stata»9. Questo discorso culmina nell’ultimo grande romanzo pirandelliano, Uno, nessuno e centomila, dove Vitangelo Moscarda radicalizza l’idea di espropriazione sociale dell’identità: «L’idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi conoscevo; uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me [...], quest’idea non mi diede più requie»10. I meccanismi della vita sociale sono, nella visione pirandelliana, in buona sostanza tutti alienanti, e questa alienazione è data dalla riduzione del soggetto (fluido) alla maschera (statica), che è il modo in cui si appare all’altro. È l’apparenza ciò che segna l’identità. Governare le apparenze (dimensione ipocrita della vita sociale) significa (mal) governare, mascherandola, la propria identità. E quando la vita sociale è innervata dalla tecnica diffusa, il potere aspirante dell’immagine-apparenza può transitare dalla maschera e dal doppio speculare (il «teatro dello specchio» di cui ha parlato Tilgher) ai media, al cinema di Serafino Gubbio, dove gli attori non
8 9 10
L. Pirandello, La trappola, in Id., Tutte le novelle II. 1905-1913, a cura di L. Lucignani, Bur, Milano 2007, p. 697. L. Pirandello, La carriola, in Id., Tutte le novelle III. 1914-1936, a cura di L. Lucignani, Bur, Milano 2007, p. 158. L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, in Id., Tutti i romanzi, vol. II, Mondadori, Milano 1973, p. 758.
Identità Roberto De Gaetano
75
sono in carne ed ossa come a teatro, ma sono ombre, immagini11. E in un passaggio chiave viene descritto il sentimento estraniante della Nestoroff davanti alla sua immagine sullo schermo: «Resta ella stessa sbalordita e quasi atterrita dalle apparizioni della propria immagine su lo schermo, così alterate e scomposte. Vede lì una che è lei, ma che ella non conosce. Vorrebbe non riconoscersi in quella: ma almeno conoscerla»12. In questa negazione del riconoscimento e richiesta di conoscenza si annida uno dei sentimenti paralizzanti dei personaggi pirandelliani, uno «scacco della ragione», che lo scrittore impugna per «trovare le ragioni dello scacco»13. Lo schermo diventa la trappola per eccellenza, dove la vita si smarrisce e l’«aura», segno della singolarità e unicità dell’esperienza, si perde, come aveva intuito Benjamin: «Il senso di disagio dell’interprete di fronte all’apparecchiatura, così come viene descritto da Pirandello, è in sé della stessa specie del disagio dell’uomo di fronte alla sua immagine nello specchio. Ora, l’immagine speculare può essere staccata da lui, è diventata trasportabile»14. Ciò che in Pirandello viene omesso, come in molti autori a lui coevi, è che l’“immagine allo specchio” in tutta la sua potenza alienante è costitutiva dell’identità, psicologica e sociale, e che sottrarvisi significa tirarsi fuori da ogni dimensione immaginaria e simbolica, e dunque dal mondo, come accade a Serafino Gubbio, che nel finale si protegge in un silenzio salvifico perché perfetto e “autosufficiente”, non esposto al rischio dell’altro: «Io mi salvo, io solo nel mio silenzio, col mio silenzio, che m’ha reso così – come il tempo vuole – perfetto»15; o come accade a Vitangelo Moscarda che nel finale di Uno, nessuno e centomila si ritira in un ospizio, da dove era partito Serafino. 11 12 13 14
15
«L’azione viva, del loro corpo vivo, là sulla tela dei cinematografi, non c’è più: c’è la loro immagine soltanto», L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in ivi, p. 585. Ivi, p. 557. G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano 1998, p. 277. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino 2000, p. 34 [ed. or. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1955]. L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cit., p. 734.
76
Lessico del cinema italiano
Se l’identità-maschera ci smarrisce è perché ci vincola ad una immagine, ad una forma che sterilizza la vita16. L’identità è illusoria, è arresto del movimento infinito e caotico della vita. In Pirandello l’identità si contrappone alla verità della vita: «Da una parte Pirandello ha messo la verità e la realtà, dall’altra l’ideale e l’illusione, ha inferocito il loro contrasto sino a farne opposizione violenta e totale»17. Ora, l’affermazione della potenza della vita come tratto distintivo della nostra tradizione culturale18 è totalmente misconosciuta dal processo di costruzione illusoria dell’io. E con la “rottura dello specchio” tutto crolla sotto i colpi di un’illusione infranta, soppiantata da uno scetticismo che trasforma l’inibizione all’accesso alla verità in un relativismo radicale (l’uno che diviene centomila), che prelude alla scomparsa dell’io stesso (l’uno che diviene nessuno). Nelle forme della commedia scettica, la vita sociale e i processi di identificazione che la costituiscono non hanno nessuna possibilità di accrescere e dinamizzare l’identità dell’io, ma espropriano, lasciando il soggetto in una morsa tra l’inautenticità della maschera sociale e il nulla come alternativa19. Lo sbaglio di essere vivo (1945) di Carlo L. Bragaglia è un film dove la rinuncia all’identità sociale ribalta l’illusorio desiderio di acquisizione di una libertà totale nell’esatto opposto, che porta di fatto a dover rinunciare al mondo. Un uomo, Adriano Lari (Vittorio De Sica), ritenuto morto (ma il decesso era solo apparente), finge di esserlo veramente per poter ritirare il premio assicurativo e potersela spassare con la moglie Maria (Isa Miranda). Ma questa liquidazione simbolica (essere senza nome, seppur vivente) coincide di fatto con l’impossibilità di esistenza vera. L’uomo scopre che la moglie era da sempre stata corteggiata dal suo datore di lavoro, il signor Guglielmi (Gino Cervi), che ora sapendola vedova intensifica le sue avance. E scopre inoltre che proprio in conseguenza di questo legame lui aveva a suo tempo ottenuto il lavoro. 16 17 18 19
«La vita è il vento, la vita è il mare, la vita è il fuoco; non la terra che si incrosta e assume forma. Ogni forma è la morte», L. Pirandello, La trappola, cit., p. 697. A. Tilgher, Pirandello o il dramma di vedersi vivere, Solfanelli, Chieti 2013, p. 26. Cfr. su questo, R. Esposito, Pensiero vivente, cit. Se si eccettuano alcuni illusori rimedi, come gli “altrove” immaginati.
Identità Roberto De Gaetano
77
Messo nell’impossibilità di proteggere la moglie dalle insistenze di Guglielmi, potendosi solo far passare per il fratello del morto, Adriano Lari non può che assistere alla effettiva dissoluzione della sua vita che l’atto di dichiararsi morto ha comportato. La moglie infatti per proteggerlo dall’umiliazione mente, dicendo di aver da sempre amato il signor Guglielmi. A quel punto, a Lari non resta altro che mandare una lettera ai due, con la quale comunica di volerla fare effettivamente finita, ma di fatto si nasconde nel cimitero dove c’è la sua tomba, a cui fanno visita la moglie e Guglielmi, lavorando come aiutante del becchino. La presenza al mondo, senza rappresentazione simbolica, senza nome proprio identificato e riconosciuto, è trasparente, senza peso. È lo stato di un vivente senza identità, una presenza senza condizioni di esistenza, che sono legate al riconoscimento. È lo stato di clandestinità di una presenza senza nome. Non esiste vita senza riconoscimento sociale, quel riconoscimento che sì ci limita, ci vincola, ci dà forma (sia pur illusoria), ma al di là del quale c’è solo il nulla. Qui vediamo letteralmente esposta la dicotomia tra il potere delle illusioni identificanti e il nulla che resta quando queste si dissolvono. L’ambivalenza che permette all’illusione di farsi fluttuante, escludendo sia l’irrigidimento della maschera che la sua dissoluzione, non è contemplata. Si passa da una identità illusoria e cieca (sulla moglie e sul proprio lavoro) ad un’altra anonima, dopo lo sgretolarsi di ogni illusione sull’infinita libertà del “clandestino”. Dall’ebbrezza di ricchi e liberi alla coscienza di non essere più nessuno, un senza nome, un clandestino della vita. Il riferimento più diretto è qui a Il fu Mattia Pascal, dove il tentativo radicale di Mattia di «immunizzarsi dalla vita»20 spacciandosi per morto, per poterne ricominciare una nuova disfacendosi di quella vecchia, fallisce perché Mattia si sente, ci dice Pirandello, come «sospeso in un vuoto strano». Sottrarsi allo spazio della vita sociale non crea le condizioni per l’affermazione della libertà, semmai le cancella. Il vuoto di Mattia è non essere più Pascal, pur essendolo, e non essere stato mai Adriano Meis anche se così si pone. È dunque l’insanabile contraddizione che emerge quando l’identità smarrisce la sua elasticità ed entra nella morsa tra rigidità della maschera che ci vincola ad un destino, che per di più non amiamo, 20
G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, cit., p. 344.
78
Lessico del cinema italiano
e opportunità di disfarsene del tutto per entrare in un ipotetico ed illusorio territorio preservato, dove l’immunizzazione diviene talmente alta da non contemplare vita alcuna. La disillusione pirandelliana riesce a pensare la questione dell’identità e della sua crisi solo negativamente, a partire da ciò che l’identità non deve essere; ma come deve trovare uno spazio altro, segnato da verità e non da illusione, questo non lo dice. Come immaginare un “altro” distinto dallo “stesso”, oltre quel «vuoto strano» che coincide di fatto con un ritiro a tutti gli effetti dalla vita e dal mondo, non ci viene mai detto21. È solo nel vincolo sociale, nella relazione e negli attriti che la contrassegnano che una qualche (relativa) libertà è immaginabile. Nell’astrazione di uno spazio vuoto che lascia un corpo senza riconoscimento, cioè ne fa una presenza fantasmatica, non può emergere alcuna vita. Adriano Lari, come Mattia Pascal, esiste non esistendo, è presente senza esserlo, si relaziona sottraendosi: l’illusione di una libertà assoluta, libertà da, coincide con la schiavitù più totale, l’assenza di ogni libertà di, perfino quella di tenersi la moglie (come accade ad Adriano Meis che non riesce a sposarsi perché all’anagrafe non esiste, e neanche ad indossare i suoi vecchi abiti di Mattia, perché la moglie si è ormai risposata ed ha una bambina: non gli resta che ritirarsi in biblioteca). La commedia scettica sigilla l’identità in una maschera rigida, che non permette di accedere all’“oltre” del soggetto; e l’illusione di portare allo scoperto quell’oltre, sottraendolo alla maschera e alla vita sociale, è un rimedio peggiore del male. Disfarsi dell’identità sociale con l’illusione di acquisire uno spazio di autenticità apre ad una precipitazione inesorabile. La società a maglie strette è ridotta all’alternativa tra dentro o fuori: il primo è il contrassegno di una rinuncia a vivere sotto la copertura ipocrita di una maschera; il secondo è la sparizione definitiva dalla vita sotto forma del “nessuno” che si è fuori dalla relazione sociale. In film come Fari nella nebbia (1942) di Franciolini o in Tristi amori (1943) di Gallone, tratto da Giacosa, il ruolo sociale diventa l’unica forma di identificazione, e dunque va mantenuto anche se comporta rinuncia al desiderio e alla libertà, e trionfo dell’ipocrisia. Se nel primo caso una giovane donna rinuncia al piacere di ballare e di avere una vita meno monotona per non perdere il 21
Cfr. ivi, p. 340.
Identità Roberto De Gaetano
79
marito, e dunque il suo status di moglie, nel secondo la moglie dell’avvocato Giulio Scarli (Gino Cervi) si innamora di un giovane che lavora nello studio del marito. Tra i due nasce una passione che porta la moglie a fuggire con l’uomo, ma nel mezzo della fuga, prima che la cosa diventi pubblica, la donna ritorna per preservare la figlia e l’onorabilità della casa. E proprio per tale ragione il marito la riaccoglie, dicendole che resteranno insieme solo per salvare le apparenze, ma vivranno separati in casa perché lui starà nello studio. Qui la maschera della rispettabilità salda un’identità risolta in ruolo sociale, uscendo dal quale il soggetto, a maggior ragione quello femminile, rischia di perdere ogni minima condizione di riconoscimento e rispetto. Il percorso qui è significativo, perché il ritorno al punto di partenza della donna, alla sua condizione di moglie e madre, è dettato dall’impossibilità di scegliere altrimenti. Con una amarezza ancora più marcata, Il mondo vuole così (1945) di Giorgio Bianchi ci racconta di una identità, e dunque di un riconoscimento legato esclusivamente al capitale economico che si rappresenta. Quando questo finisce non si conta più nulla. Mario (Vittorio De Sica), impiegato di banca, viene ingiustamente accusato di un furto di tre milioni, compiuto invece dal figlio del direttore della filiale (Massimo Serato), spasimante tra l’altro della moglie di lui (Luisa Ferida). Mario non viene difeso da nessuno, neanche dai suoi familiari, e finisce in galera. Quando esce dopo cinque anni è comunque circondato dall’attenzione di tutti, perché si aspettano che lui abbia ancora quei tre milioni mai ritrovati. Ma le cose non stanno così, il direttore di banca per proteggere il figlio fa simulare a Mario la restituzione del malloppo. A questo punto, per recuperare l’interesse degli altri (perché il credito di uomo “redento” è nullo, e viene deriso: Mario è un fesso e non un uomo retto), a partire da quello della moglie, De Sica si decide a rubare veramente i soldi, pretendendo di farseli riconoscere come diritto, a compenso dei suoi anni di prigione, e fugge insieme alla moglie. L’ipocrisia sociale, il riconoscimento dato solo al possesso del denaro, anche se ottenuto in modo fraudolento, l’assegnazione di un’identità di ladro a chi era semplicemente un grigio ed onesto impiegato, costringono De Sica, per riacquisire rispetto ed amore, a corrispondere a questa identità, mettendosi egli stesso a rubare. Uscire dalla cornice sociale e dai codici che la regolano significa uscire dalla vita, realmente o simbolicamente, come accade a
80
Lessico del cinema italiano
personaggi femminili in film come La freccia nel fianco (1945) di Lattuada o Una donna libera (1954) di Cottafavi. O come accade al Paolo Brancani (Paolo Stoppa) di Prima di sera (1954) di Tellini, assicuratore smarrito in un quotidiano opprimente dal quale prova invano a fuggire ma al quale torna mascherandosi (baffi finti ed occhiali) per costituirsi per colpe mai compiute. Il commissario gli risponderà: «Siamo tutti dentro [una prigione], ognuno è libero di fare solo quello che è lecito fare». Il soggetto in questi film ritorna sia pur dolorosamente nel suo ruolo, si fa una ragione del suo destino di “prigionia”. L’identità diventa qui l’approdo di un percorso di rinuncia al desiderio e di accettazione di un ordine dato che vi si contrappone. Contrariamente alla «commedia ascensionale»22, dove i processi di identificazione tendono a far sì che l’ottativo e il doveroso coincidano, nelle forme della commedia scettica o del melodramma si crea uno iato tra l’istanza del desiderio, che è velleitaria o assoluta, in ogni caso non modulabile, e la vita sociale che si trasforma in una gabbia soffocante ed ipocrita. In questo caso, il potere espropriante è quello di un’identità incapace di essere alimentata e resa elastica dal desiderio, dall’emergere di un soggetto che chiede sempre altro. Qui il soggetto rinuncia a porre nuovamente questa domanda. L’identità espropriata è anche l’identità che espropria: è proprio perché espropria una presunta originaria e sorgiva istanza del desiderio che l’identità diviene una morsa alla quale il soggetto si illude di poter fuggire dissolvendo la maschera stessa. In un certo senso, la forma della commedia scettica, che costituisce il lato epistemologico dello scetticismo emotivo melodrammatico, arresta il processo di identificazione sotto un impatto traumatico, quello che non lascia alternative alla dinamica sociale e alle sue maschere già-date, rifiutate o accolte. Tentare di sottrarsi al carattere vincolante dell’ordine simbolico significa tentare di sfuggire illusoriamente alla morte: il gioco acrobatico non riesce al protagonista di Lo sbaglio di essere vivo (né a Mattia Pascal/Adriano Meis); ma aderirvi senza fiducia rischia di trasformare la vita in una resa al22
Sulla distinzione tra commedia ascensionale e discensionale cfr. M. Grande, La commedia all’italiana, a cura di O. Caldiron, Bulzoni, Roma 2003, pp. 56-88.
Identità Roberto De Gaetano
81
trettanto espropriante: la dialettica sociale inibisce, i processi di identificazione si interrompono. Qualche anno prima, nel 1942, in Se io fossi onesto Bragaglia rappresentava il problema dell’identità sottratta nella forma di un’identità contraffatta e scambiata: quella del bravo ma squattrinato ingegnere Pietro Kovach (Vittorio De Sica) e quella dell’incorreggibile piccolo truffatore, il trentunenne Paolo Vareghi (Paolo Stoppa). Il primo prende il posto del secondo in galera e quest’ultimo si rifugia in campagna sotto le vesti del primo: questa sostituzione di persona alimenta una serie di equivoci, anche di ordine amoroso, che saranno sciolti solo nel riconoscimento finale. Ma il nodo resta: l’identità sottratta è, in questo caso, un’identità comprata (e dunque anche venduta), e il gioco delle maschere sociali passa per il pagamento di un prezzo alto, mesi di galera, anche se poi arriva il compenso finale del matrimonio con quella che si credeva essere la “cugina” del carcerato. I meccanismi che animano le forme dell’identità sottratta e contraffatta, sia nella versione tragica che in quella commedica, eludono ogni processo di identificazione, l’unico che può togliere l’identità allo stato. Il dispositivo identificativo può riguardare tragedia o commedia, ma in entrambi i casi risolve il problema dell’identità nel “riconoscimento” finale che conclude la “peripezia”: nel caso tragico il riconoscimento riguarda l’inesorabilità del già accaduto, nel caso commedico è capace invece di riaprire il tempo. 1.1 Il calco dell’identità: il ritorno dei morti Se il principio di “immunizzazione” che attraversa i personaggi scettici li esclude dalla vita e dalla storia, sono vivi ma di fatto morti, ci sono casi in cui la vita stessa diventa un calco letterale della morte. Un film tutto calato in un assorbimento del vitale sotto il segno del mortuario è Malombra (1942) di Mario Soldati. Il film è particolarmente significativo, perché qui l’identità sottratta è una identità fagocitata, dal morto, tant’è che Marina di Malombra (Isa Miranda) si identifica con Cecilia, la madre del vecchio zio che la ospita in una villa sontuosa sulle rive del lago di Como, ne ricalca i passi, fino a “vendicarsi”, corrispondendo alle parole della morta, lasciate in una lettera ritrovata nella spinetta: spaventa a morte
82
Lessico del cinema italiano
lo zio, e uccide in una deriva sempre più delirante il suo amante. Finirà suicida nel lago in tempesta, remando disperatamente. Il carattere fantasmatico del film qui si enuncia letteralmente come sequestro di una vita, che è sequestro di una identità. O meglio ancora, disponibilità a farsela sequestrare, tant’è che Marina, orfana, portata dallo zio in una villa/carcere, impossibilitata ad uscire se non per sposarsi, scappa identificandosi con un passato non suo eppure suo (entrambe le donne di fatto vivono recluse), e in questa identificazione, che giunge fino alla coincidenza di firma, troviamo il sequestro di ogni futuro e l’assorbimento di ogni principio di realtà nel delirio progressivo della donna. Il punto è che l’identificazione, che fa della vita presente e singolare il calco di una passata, e dunque si iscrive subito sotto il segno di una ripetizione demonica («ripetizione che perde», direbbe Deleuze), azzera il processo di identificazione ed afferma un’espropriazione della vita: il morto assorbe il vivo, perché il vivo è già in qualche modo morto. Ancor di più, l’affermazione della vita, bloccata dai vincoli molto stretti della morale sociale, passa, in forma estrema, attraverso il delirio della donna, che inibita nella scelta di un suo proprio futuro percorre l’unica via d’uscita possibile: la follia. La chiusura narrativa e figurativa di Malombra risponde all’emergere di un sentimento: l’impossibilità di aprire un mondo troppo chiuso determina l’identificazione mortifera con il passato. L’identità diventa “duplicato” del passato, ripreso nei suoi aspetti paralizzanti: vittimizzazione, rancore, vendetta. L’identificazione con il morto comporta scissione fra corpo e anima. Abbiamo due corpi per una “stessa” anima, e il secondo corpo diventa oggetto di una reincarnazione. Il problema dell’identità sottratta diventa il problema di una identificazione negata dal soggetto stesso (per mancanza di coraggio) o dal mondo, e corrisponde in questo caso ad un momento storico ben preciso (la crisi della guerra e del fascismo), dove il presente disarticolato di una comunità con valori completamente dissolti non riesce ad aprire alcun futuro e si rinchiude sulle macerie del passato. Questa saldatura identità-maschera di fatto inibisce le forme della costruzione processuale dell’identità, che risulta dunque scissa tra adesione mimetica soffocante e dissoluzione nella clandestinità o nell’autodistruzione.
Identità Roberto De Gaetano
83
L’identità fagocitata dai morti, dai fantasmi, è privata di ogni scelta e libertà: da un lato i morti “posseggono” i vivi23, che si sentono una sorta di reincarnazione e fanno del presente un calco del passato, dall’altro i morti “inchiodano” i vivi ai loro sensi di colpa. In La donna della montagna (1944) di Renato Castellani, abbiamo il caso di un rapporto tra Rodolfo (Amedeo Nazzari), un uomo la cui fidanzata muore poco prima delle nozze, e Zosi (Marina Berti), una giovane donna, attratta dall’uomo che corteggia fino al matrimonio. Fin dalla sequenza d’apertura del funerale, vediamo come l’insistenza di Zosi sia capace di sfidare la riservatezza che la situazione richiederebbe. Dopo un movimento di macchina che ci mostra la cima delle montagne con una voce off che chiama la donna dispersa, precipitata per una caduta, osserviamo Rodolfo che con sguardo assente porta la bara, e Zosi che, passando tra la folla, lo fissa intensamente. I due si sposeranno, nonostante le iniziali resistenze di lui; ma, tornando in montagna, il ricordo della prima donna sembra essere troppo ingombrante, rendendo impossibile il rapporto della nuova coppia. La liberazione dal passato qui avviene per una perdita di illusioni nei confronti dello stesso. La promessa sposa aveva un amante, e quando l’infedeltà emerge fa perdere al ricordo di lei il carattere ideale e paralizzante. E, cosa ancor più importante, Zosi, pur avendo scoperto il tradimento, non dice nulla al marito, e questo permette a Rodolfo di riconoscere la nobiltà d’animo di lei, consentendogli di ritrovare per la prima volta la moglie. Liberazione dal sequestro del passato (e del morto) attraverso il frantumarsi di una illusione (il carattere ideale della promessa sposa) e l’atto di amore di Zosi, che accompagna tale frantumazione. Liberazione dal passato che non avviene per esempio in Teresa, episodio di L’oro di Napoli (1954) di De Sica, dove un uomo decide di sposare “una di quelle”, la prostituta Teresa (Silvana Mangano), non per amore, ma per scontare la colpa di aver portato al suicidio, illudendola, una sua precedente ragazza. Quando Teresa scopre che l’“anonimo” vuole sposarla solo per espiare pubblicamente la sua colpa («Tutti l’hanno a sape’»), fugge ma, rendendosi conto
23
«Questo è un paese in cui comandano i morti», ci dirà Marco Bellocchio in Il regista di matrimoni (2006).
84
Lessico del cinema italiano
che l’aspetterebbe un’umiliazione ancor maggiore a tornare indietro dalle sue compagne, riprende mestamente il suo posto. Il dominio dei morti sui vivi, del passato sul presente è la forma (melo)drammatica di identità sequestrata, è la forma di un universo demonico non redimibile, dove il passato non riesce a giungere a compimento: il passato non passa, non si redime, e assorbe inesorabilmente il presente; lo vincola ad una ripetizione senza possibilità di far nascere il nuovo. È ciò che ritroviamo per esempio nel Bertolucci di Ultimo tango a Parigi (1972), dove il corpo ancora caldo e composto della moglie suicida toglie ogni libertà all’uomo, spingendolo in una deriva che, attraverso comportamenti iterati e perversi, culmina con la morte. Diverso è il caso di Io ballo da sola (1996), dove la ragazza dopo un percorso nel passato, alla ricerca del padre, e sulle orme della madre e degli uomini da lei frequentati, si libera alla fine di tutto questo entrando nella vita e nel futuro con la perdita della verginità. Il ritorno del morto come fantasma (e come colpa, il cui modello segna la modernità occidentale, a partire dall’Amleto) definisce in prima istanza un movimento “regressivo” verso il passato che le forme melodrammatiche attuano, sottraendo l’identità ad ogni percorso di individuazione e di rapporto con la contingenza del presente, che diventa o calco o espiazione. Questo diventa evidente in Fantasma d’amore (1981) di Risi, dove il ritrovare una donna amata in gioventù (Romy Schneider), prima di un grigio matrimonio, porta Nino (Marcello Mastroianni) a vagheggiare un passato ideale, ad arretrare immaginariamente il tempo, fino al momento in cui viene a sapere da un amico che quella donna è morta tre anni prima; e dunque, ciò che lui ha visto era un fantasma. Il fantasma e il suo carattere allucinatorio realizzano un desiderio impossibile, quello di arretrare il tempo verso l’età dell’oro di un amore di gioventù, con ciò defraudando l’identità della sua possibilità di vivere il presente e modificare la situazione. Quella donna è allo stesso tempo presente/assente: prima vecchia, misura del tempo trascorso, poi giovane, misura del tempo che fu, prima viva pur essendo morta, poi morta pur sembrando viva. E il finale, che vede Nino essere accolto dalla bella giovane in veste di infermiera davanti ad una clinica, testimonia che la sottrazione dell’identità è compiuta: liquidazione della presenza al mondo che oramai ha
Identità Roberto De Gaetano
85
il contrassegno dell’allucinazione, come il telefono che nel finale continua a squillare nonostante la spina staccata. Che i morti non lo siano fino in fondo, che abitino il presente, è un dato che può essere letto in una duplice prospettiva: o in forma di sottrazione della vita ai vivi o in quella di sottrazione della morte ai morti. Nel primo caso, i vivi si rendono disponibili ad essere “sequestrati” dai morti per una “debolezza” che li caratterizza, da dove i medium a cui si affidano (Giulietta degli spiriti), o le scaramanzie e gli scongiuri che governano vite bloccate dalla paura della morte e dei morti nelle forme della “farsa nera” (da Eduardo De Filippo al Totò di 47 morto che parla); nel secondo caso, i morti prendono vita, diventano lo spazio carnevalesco che ribalta l’ordine del vivente, rendendo “reversibile” la morte e rivelando il tratto mortuario della vita (Fantasmi a Roma e Mortacci), e fanno sì che, in forma più radicale, il confine tra vita e morte venga ad abolirsi, come esplicita la didascalia finale di La terra vista dalla luna: «Essere vivi o morti è la stessa cosa». Quest’ambivalenza del ruolo dei morti è interna alla nozione di maschera stessa che direttamente vi rimanda24, e dunque interna all’identità. Gli stati di identità sono sempre sul punto di trasformarsi in stasi dell’identità e dunque sempre sul punto di arrestare i processi di identificazione, o meglio ancora di convertirli in disidentificazione. La vita sequestrata dal morto è vita sequestrabile, depotenziata nella sua spinta creativa, e dunque già in qualche modo morta. A questa linea appartiene anche un film come Professione: reporter (1975) di Antonioni, dove il carattere pirandelliano del personaggio e della storia, prendere il posto del morto per rifarsi una nuova vita, assume toni esistenziali e radicali per assenza di contorno sociale e di profondità psicologica del personaggio. Sappiamo vagamente chi sia David Locke, e la caccia all’uomo che segue la sostituzione iniziale del morto con il vivo è orientata, come spesso in Antonioni, da un interrogativo epistemologico (di cui il nome Locke, esplicito richiamo al filosofo inglese, è indicativo), che porta alla ricerca in primo luogo dell’identità del fuggitivo (dall’Africa alla Spagna, da un deserto all’altro, passan24
«In latino larva vuol dire sia “spettro” sia “maschera”», A. Pizzorno, Sulla maschera, il Mulino, Bologna 2008, p. 32.
86
Lessico del cinema italiano
do per Barcellona e le architetture di Gaudì), segnata fin dall’inizio dal suo tratto logico-anagrafico, di cui il documento d’identità contraffatto è testimonianza. Tant’è che nel finale la moglie, che ha cercato le prove dell’identità del marito nell’uomo in fuga, parla di questo come di un uomo che «non conoscevo», poco prima di riconoscerlo invece da cadavere. Il mistero di un uomo mai conosciuto da vivo, e riconosciuto solo da morto, di fronte ad un ufficiale di polizia, è il mistero in cui ci si ritrova sostando su un piano meramente conoscitivo. È fondamentalmente il “mistero dell’altro” a collocare il soggetto in una zona protetta, preservata da ogni possibile scelta. Ciò da cui fugge Locke, ciò che lo porta ad indossare i panni di un morto, non lo sappiamo, ma forse intuiamo che fugge, come tutti i personaggi di Antonioni, da se stesso, da una relazione amorosa non soddisfacente e da una professione da cui sembra essere distante. Il reporter che segue il fotografo (Blow-up) e anticipa il regista (Identificazione di una donna) è attraversato da una stessa impasse esistenziale, da uno stallo epistemologico, da cui si illude di uscire iniziando una nuova vita, assumendo una nuova identità, quella di un morto; e con ciò stesso destinandosi effettivamente a morire. Prendere il posto del morto non significa darsi una seconda chance, ma operare letteralmente il calco di una vita finita, e dunque morire come lui, disteso sul letto di un albergo di quart’ordine, situato nel nulla. Il mutismo dei personaggi di Antonioni è il contrassegno di una identità sottratta al mondo e ripiegata su se stessa che, non accedendo ad esperienza, si esilia da sé. Mutilato nel suo desiderio e nella sua possibilità di esprimerlo, il soggetto si colloca su un declivio dissolutivo che lo porta, prima a morire simbolicamente assumendo l’identità altrui, poi a morire effettivamente nell’impostura di essere un altro. In Professione: reporter accade dunque qualcosa di ben preciso: il calco di un altro io, che apre anche a un plot giallo (l’inseguimento per il traffico d’armi, la ricerca delle “prove” da parte della moglie), definisce la questione dell’identità sotto il contrassegno dell’attribuzione di un nome proprio. L’interrogativo esistenziale “chi sono io?”, che attraversa Locke e ne motiva le azioni, si trasforma in uno in terza persona “chi è lui?”: il trafficante d’armi o il reporter Locke?
Identità Roberto De Gaetano
87
Il processo messo in gioco da Professione: reporter è il contrario di un processo di identificazione. Ci troviamo di fronte ad un’apparente processualità, che è semmai una forma differita di dissoluzione di sé (come in Pirandello): Locke la fa finita con la sua vita, cancellando prima il suo nome e poi la sua stessa presenza al mondo. 2. L’identità esposta Alle forme dell’identità sottratta, dell’identità scissa fra gabbia e negazione, ipocrisia e scomparsa, si contrappone l’identità esposta, nei vari modi che essa può assumere. L’identità esposta è il modo in cui un io si esprime e si manifesta nella vita sociale. E può manifestarsi essenzialmente in due grandi forme, nei dispositivi della socialità o nelle dinamiche della società. I dispositivi della socialità sono quelli che fanno sì che una identità possa esistere solo se aperta ad una relazionalità sociale (cinema tra le due guerre), che nel suo carattere vincolante garantisce però al soggetto l’alimentazione principe della sua vita, e cioè il riconoscimento sociale; le dinamiche della società sono, invece, quelle che riescono a saldare desiderabile e doveroso, facendo a meno dell’esplicitezza della maschera (commedie anni cinquanta). Nelle commedie della socialità, la società non è il meccanismo ipocrita che costringe il soggetto ad indossare maschere alienanti e rigide, ma la forma estetica, che regola attraverso le apparenze i meccanismi vitali e conflittuali del riconoscimento. Nella socialità non sono in gioco le strutture, le classi, i dati, elementi «molari», ma una «molecolarità» di relazione (per riprendere una distinzione di Deleuze), che alimenta se stessa in uno spazio ludico e creativo. Il travestimento, la maschera, che animano la forma commedia tra le due guerre rispondono ad una spinta profonda, motore della vita sociale, che è il desiderio di riconoscimento. Se si simula è perché si vuole essere altro da ciò che si è, ma se questo accade è perché si vuol piacere, cioè si vuole entrare nell’orbita del desiderio altrui. E questo sforzo risponde al riconoscimento del vincolo sociale come necessario per il raggiungimento della felicità, e in ogni caso per poter corrispondere allo spirito della commedia. E quando il mascheramento riguarda un cambiamento di status, un’ascesa sociale, quest’ultima non viene mai pensata come
88
Lessico del cinema italiano
acquisizione di potere o di denaro, ma come raggiungimento di uno stile di vita contrassegnato da libertà, disponibilità di tempo e vanità, il cui tratto di gratuità diviene contrassegno principale di un’estetica sociale, che permette di definire l’umanità dell’umano proprio in questo tratto di superfluità. I mascheramenti acrobatici di Gli uomini, che mascalzoni... (1932) e Il signor Max (1937) di Camerini, o i fraintendimenti di Contessa di Parma (1938) di Blasetti, o interi mondi e vite inventati come in Quartieri alti (1945) di Soldati, rispondono in primo luogo a questo desiderio di acquisizione di uno status sociale che coincide con uno stile di vita più seducente perché più libero, e più libero perché più apparente (da dove la possibile contraffazione), cioè collocato in una effimera impalpabilità, dove il tempo e la finitezza della condizione umana vengono trascesi nei giochi seduttivi femminili o nelle rincorse affannose maschili (Tempo massimo). I giochi di maschere che molte commedie mettono in scena tra le due guerre sono gli esercizi di una identità elastica alla ricerca, spesso affannosa, di un riconoscimento amoroso e sociale. Questa fluidità dai tratti pirotecnici attraversa un soggetto alla (ipotetica) ricerca del proprio desiderio, e dunque avviato ad un potenziale processo di identificazione, destinato però quasi sempre al fallimento, perché il soggetto di fatto traveste il suo desiderio nelle forme di un’ambizione di ascesa sociale (alimentata da cliché e stereotipi) destinata al fallimento: è la seduzione di uno stile di vita a dominare sulla capacità di trasformare la vita stessa. Il passaggio di status sociale non arriva. Ma il ritorno al punto di partenza presuppone due possibili percorsi: l’identità contraffatta ripiega su un altro oggetto del desiderio, riconoscendo l’impossibilità del proprio (Il signor Max), l’identità contraffatta mette alla prova il proprio desiderio, passando per un’immagine altra (Gli uomini, che mascalzoni...). In ogni caso, la peripezia attraverso il travestimento e il ritorno al punto di partenza testimoniano del carattere indiretto del desiderio e del suo necessario passare attraverso simulazioni e maschere. L’approdo di queste commedie, che passano per il trucco, la contraffazione, il fraintendimento, è garantito dalla risoluzione felice, perché in ogni caso il percorso comporta per il soggetto la scoperta di una verità finale su di sé e sulla situazione. Nei casi in
Identità Roberto De Gaetano
89
cui quest’ultima risulta immodificabile, il soggetto viene condotto ad una presa d’atto di tale stato (Il signor Max); in altri, quando il dinamismo sociale riguarda la figura femminile, la risoluzione diviene, secondo un più tradizionale archetipo di Cenerentola, l’acquisizione di un nuovo status attraverso il matrimonio (La segretaria privata); in altri mascheramento e simulazione generano il desiderio vero e proprio, così vediamo Arlette (Assia Noris), in Batticuore di Camerini, che si innamora alla fine dell’uomo inizialmente corteggiato solo per “lavoro”, per scoprire se è l’amante della moglie di un ambasciatore (e tale si rivela). Che simulazione e travestimento non siano gabbie dell’ipocrisia sociale, ma dispositivi attraverso cui il soggetto passa per riconoscere se stesso e il suo proprio desiderio lo vediamo, per esempio, in Quartieri alti, quando la simulazione messa in atto dall’uomo (amante di una contessa più grande di lui, con i soldi della quale mantiene tutta la famiglia) nei confronti di una giovane studentessa si manifesta in forma plateale. L’uomo è arrivato ad affittare una villa ed i “propri genitori” (assoldando attori) per mostrare ciò che non è: ricco e benestante. Ma a quel punto la studentessa, messa sull’avviso da tutti sul tenore morale dell’uomo e sulla sua inaffidabilità, risponde con grande convinzione che se ha fatto tutto questo per lei vuol dire che l’ama. Il gioco di maschere in questa forma di “commedia del riconoscimento” diventa il mezzo per raggiungere una identificazione di sé attraverso il desiderio dell’altro. La simulazione e il camuffamento della situazione hanno dunque un importante ritorno conoscitivo: il soggetto mette alla prova se stesso assumendo una identità che non gli appartiene, ma in questo trucco, in cui potrebbe perdersi, non c’è il carattere demonico di un mascheramento utilizzato per manipolare l’altro (ci troveremmo in altre forme generiche, giallo, spy story, horror, e non nella commedia), bensì per attrarne il desiderio. Il soggetto non si sente sicuro delle carte che ha in mano, ed il travestimento esplicitamente ideato non è tanto, e solo, una forma di autoinganno quanto il dispositivo adottato per conquistare l’interesse altrui riconoscendone il carattere fondamentale per la propria felicità. Sia per una pianificazione previa (Il signor Max), sia per un equivoco (Gli uomini, che mascalzoni...), sia per una determinazione conseguente all’emergere di un incontro occasionale (Contessa di Parma), l’io percepisce che, presentandosi come “altro”, può acce-
90
Lessico del cinema italiano
dere ad una conquista, e alla conseguente felicità, che altrimenti gli resterebbe interdetta. Questo naturalmente non è detto che accada sempre e nella forma auspicata, ma il passaggio è necessario per far sì che attraverso la simulazione il soggetto sperimenti su se stesso la forza del suo desiderio, che è anche il motore della sua identificazione. E l’approdo del travestimento (da cui il carattere morale di queste commedie), sia esso tornare al punto di partenza oppure avanzare, conquistare l’oggetto desiderato, comporta comunque un’acquisizione conoscitiva. La maschera che i personaggi indossano ha cioè una potenza di rivelazione importante: non cela soltanto, ma permette all’io di trovarsi falsificandosi. E il travestimento non riguarda solo fingere uno status sociale migliore, ma può essere persino animato da un movimento opposto, come in La segretaria privata di Alessandrini, quando l’amministratore delegato della banca finge di essere un semplice impiegato per scoprire quanto è effettivamente desiderato dalla ragazza, a prescindere dal ruolo ricoperto e dalla ricchezza. Questo motivo narrativo lo ritroviamo anche in un film recente, Colpi di fulmine del 2012, nel secondo episodio con Lillo e Greg, dove in gioco è la trasformazione di un ambasciatore in un coatto («Lei mi deve trasformare da ambasciatore a perfetto coatto!») per amore di una pescivendola. In questi casi troviamo la conferma che il mascheramento dell’identità, il fingere di essere altro da ciò che si è, risponde ad una lotta per la conquista del desiderio altrui, e dunque per essere riconosciuti nel proprio. Dal lato maschile questo avviene solo nascondendo lo stasus socio-economico, per poter essere sicuri di essere desiderati per quello che si è e non per ciò che si possiede. Naturalmente, qui è in gioco una mitologia romantica molto radicata che pensa l’amore nell’astrattezza di una cornice ideale separata da ogni contesto sociale ed economico. Quando invece un uomo ricco e potente mette in scena se stesso, la propria maschera, nella conquista, non cerca di fatto di intercettare il desiderio altrui ma di vedere confermato il proprio status; e quando questo non accade ne possono derivare conseguenze nefaste, come per il commissario di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto che, saldato indissolubilmente alla sua maschera (del potere) fin dentro l’alcova, non tollera di essere deriso dalla sua amante che uccide. Il crimine in questo caso è effetto di una maschera troppo rigida e di una identità che vi è troppo salda-
Identità Roberto De Gaetano
91
mente ancorata, che non tollera scarti, tantomeno irrisioni sull’infantilismo delle sue prestazioni nell’alcova. L’identità che si espone in un mascheramento esplicito percorre comunque una strada vivificante. Il camuffamento, architettato e costruito (come nelle commedie anni trenta e quaranta) e dunque sottratto ad un mimetismo trasparente, manifesta nel soggetto il sentimento dell’importanza del giudizio altrui: ciò che il soggetto vuole non è né il denaro né il potere, ma entrare a far parte di una socialità dove la posta in gioco pressoché esclusiva è il riconoscimento. Rispetto alla commedia scettica (di matrice pirandelliana) che priva l’identità di forza, assorbendola in un gioco sociale alienante, la commedia del riconoscimento (esemplificata dal lavoro di Aldo De Benedetti) trova nella socialità, e nel carattere ludico dei rapporti interpersonali, la forma propria di definizione di una identità elastica, capace cioè di affermarsi in una relazione cercata, voluta, con l’aspirazione di essere riconosciuta nella legittimità del proprio desiderio. E qui l’identità (anche in forma contraffatta) non può che essere esposta, espressa e spesa in uno spazio sociale rischioso che, con l’eccezione di alcuni casi (per esempio Trenta secondi d’amore), prevede comunque un approdo morale, cioè il ritorno al punto di partenza del soggetto, che significa in definitiva staticità sociale, compensata da un dinamismo puramente immaginario. 2.1 Il desiderio manifesto Se nel periodo fascista il manifestarsi del desiderio passava per linee traverse e mascherate, per cui l’identità si misurava con una socialità che contribuiva a definirla in una dialettica tra mascheramento e riconoscimento, a partire dagli anni cinquanta, con la commedia, le cose cambiano. L’io si realizza e si manifesta direttamente in una società “popolare”, che ha perso i requisiti elitari e vanesi di una socialità tipica di una (parvenza di) «società stretta», e dunque tende a saldarsi intorno a valori condivisi e comuni, per quanto questa saldatura avrà degli elementi di criticità, dati dalle rapide trasformazioni della vita sociale, segnate dal benessere crescente che sfocerà nel boom. In film come Due soldi di speranza (1952) di Castellani, Le ragazze di Piazza di Spagna (1952) di Emmer, Peccato che sia una cana-
92
Lessico del cinema italiano
glia (1954) di Blasetti, Poveri ma belli (1957) di Risi, la centralità del matrimonio ne fa una meta ambita per garantire l’autonomia del soggetto e il compimento dell’identità, secondo una saldatura tra l’ottativo e il doveroso. L’identità si realizza pienamente attraverso l’interiorizzazione dei valori sociali, e dunque il soggetto tende a definirsi nell’adeguamento all’istanza simbolica. Ciò che un soggetto desidera è ciò che è doveroso fare: e dunque in primo luogo sposarsi per garantirsi l’entrata nel mondo adulto. Questa entrata comporta il pagamento di un prezzo, talvolta alto, il conflitto con la famiglia d’origine (Due soldi di speranza), la rinuncia ad una erranza affettiva, sia pur immaginaria (Poveri ma belli), le illusioni di un avvenire professionale (la moda per la Lucia Bosè di Le ragazze di Piazza di Spagna), e l’accettazione di una “instabilità” della donna, con cui si misura il Mastroianni di Peccato che sia una canaglia (ripromettendosi di lasciare la Loren, attraverso il gesto e il ripetuto enunciato «una croce sopra», che diviene segno esattamente del contrario, di un’attrazione inesauribile per la donna). In ogni caso qui non c’è mascheramento, le mitologie che cominciano a circolare nella società italiana ancora non sono giunte al punto di disgregare il tessuto sociale ordinario, e l’identità riesce a determinarsi nella continuità e costanza di un movimento sociale integrato, per cui la commedia non ha bisogno di mascheramenti, semmai di un esplicito ritrovarsi della comunità intorno alla nuova coppia (come nel finale di Due soldi di speranza e Peccato che sia una canaglia). Se non c’è mascheramento è perché il carattere popolare della «commedia nella società»25, che si sviluppa all’inizio degli anni cinquanta (il cosiddetto “neorealismo rosa”), non lo richiede: si tratta semmai di superare degli ostacoli, evidenti come la resistenza dei vecchi, o più impliciti come il freno dei giovani stessi a compiere il passo d’entrata ma, alla fine, o nella forma del conflitto (con il senex iratus) o in quella della rinuncia (all’erranza giovanile), quel passo viene a compiersi ed è opportuno che si compia. Si indebolisce, rispetto al cinema tra le due guerre, il ruolo delle simulazioni, delle identità acquisite, perché la società ha perso la sua staticità, e dunque la necessità di un dinamismo mascherato. 25
Sulla differenza tra «commedia nella società» e «commedia della società», cfr. F. Dürrenmatt, Lo scrittore nel tempo, Einaudi, Torino 1982, p. 51 [ed. or. Theather-Schriften und Reden, Die Arche, Zürich 1966].
Identità Roberto De Gaetano
93
È in una fase “ascensionale”, per cui l’identità si ritrova nell’acquisizione di valori condivisi (matrimonio, lavoro, famiglia), in una interiorizzazione delle forme dell’oggettività; anche se non sono pochi i casi in cui il “rosa” assume forme inquietanti, ma mai fino al punto di mettere in questione – perlomeno nella forma commedia – la riunificazione finale della comunità intorno all’affermazione di quel dato valore, al costituirsi della nuova unità sociale26. Certo, in alcuni casi emergono le inquietudini di personaggi femminili non più popolari ma borghesi, dove il benessere arriva ad incidere sull’identità stessa. Nell’episodio di Siamo donne (1953) di Franciolini, Alida Valli sente tutto il peso della solitudine di una star che non riesce a partecipare alla vita, se non mettendo alla prova la sua capacità di seduzione. Invitata ad una festa della sua massaggiatrice prova a “rubargli” il fidanzato, pentendosene subito; la voce off ci riconsegna il sentimento di una perdita di identità e di umanità della donna: «Mi muovevo come un automa», «Mi sentivo una statua». Al di là della visione, per molti tratti moralistica, che mette dalla parte dei “poveri” pienezza di vita e di affetti, e dalla parte dei ricchi e famosi solitudine e perdita di umanità, ciò che emerge è il sentimento di una inquietudine femminile, via via più marcata durante il boom, che incrina anche la percezione di sé e della propria identità. Una privazione di “interiorità”, che emerge per esempio anche nel personaggio della Momina in Le amiche (1955) di Antonioni, alla quale viene detto: «Manchi di vita interiore», «Tu che i sentimenti non sai neanche cosa siano». Insomma, il racconto di una trascinante energia giovanile, che portava a superare gli ostacoli frapposti al raggiungimento dell’autonomia e della felicità, e dunque che, in una dialettica sociale che integrava povertà e felicità, amore e matrimonio in forma spesso idilliaca (Giorni d’amore, Pane, amore e fantasia), ritrovava l’affermazione di una identità (individuale e sociale) dinamica era accompagnato non solo dal controcanto melodrammatico con il suo movimento regressivo, ma anche dalle prime inquietudini, borghesi e femminili, che indicavano il manifestarsi di una crisi individuale, l’avvio deciso di un processo di interiorizzazione mancata, 26
Nel melodramma l’affermazione di quei valori può comportare il pagamento di un prezzo molto alto, perfino vita umana, onore e rispettabilità come in Catene di Matarazzo.
94
Lessico del cinema italiano
che diventerà progressivamente più intenso in autori come Castellani (I sogni nel cassetto), Bolognini (Giovani mariti), Zurlini (La ragazza con la valigia), Risi (Un amore a Roma) e naturalmente Pietrangeli. Per giungere poi agli anni sessanta dove, da un lato con Antonioni e Fellini viene a radicalizzarsi il processo di crisi dell’interiorità, dall’altro con la commedia grottesca l’identità esteriorizzata si salda con la maschera, per cui la «commedia di intreccio» tipica del neorealismo rosa diventa «commedia di caratteri»27 e la questione dell’identità viene a coincidere con l’espressività della maschera, assunta in forma naturalizzata e non riflessiva (come accadeva nel cinema tra le due guerre), e dunque talmente aderente da venire a coincidere con l’identità-persona e il suo stato “mostruoso” (un titolo per tutti: I mostri). E per ultimo, proprio a metà degli anni sessanta, con Per un pugno di dollari (1964), l’identità si dissolve nel personaggio “senza-nome” di Leone. La crisi di identità che contrassegna un’epoca appare dunque anche nel “Man with no Name”, non solo nel senso di qualcuno senza iscrizione simbolica, ma di qualcuno che abita uno spazio mediano tra le parti e dunque pronto a giocare in una qualsiasi di esse, o ancora meglio al di fuori di esse: «I Baxter da una parte, i Rojo dall’altra … e io nel mezzo», dice l’Eastwood di Per un pugno di dollari. L’eroe leoniano abita un territorio disidentificato e dunque disponibile ad essere sempre nuovamente identificato dal (dis)identificatore più potente: il denaro, i dollari, il capitale. Con grande forza di anticipazione l’eroe di Leone e del western all’italiana abita il luogo in cui la crisi di identità che contrassegna la modernità si converte nell’apertura di una dimensione ludica che trova nel “senza nome” una parodia dell’Odisseo (“Nessuno”) dell’epos (letteralmente ripreso in Il mio nome è Nessuno di Valerii, prodotto dallo stesso Leone).
27
«Si distinsero due specie di commedie, d’“intreccio” e di “carattere”. Commedia d’intreccio fu detta, dove l’interesse nasce dagli sviluppi dell’azione […]. Si cercava l’effetto nella stranezza e nella complicazione degli accidenti. Commedia di carattere fu detta, dove l’azione è mezzo a mettere in mostra un carattere», F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Bur, Milano 2006, p. 630.
Identità Roberto De Gaetano
95
2.2 La pulsione (s)mascherata Se nel neorealismo rosa emergeva la forza di volontà del personaggio femminile (pensiamo alla Carmela di Due soldi di speranza) come motore della costruzione dell’identità, che si realizzava portando a compimento felice la storia con le nozze, e la commedia era inscritta pienamente nella vita sociale (il matrimonio come fine della storia e fine della vita sociale), con gli anni sessanta e la forma grottesca, la commedia, affidata alle maschere, esce fuori dalla cornice sociale, e diviene invece espressione esagerata e diretta (senza la mediazione dell’intreccio) della società stessa. La commedia non è più racconto di una società in movimento e in “ascesa”, ma è commedia “discensionale”, affidata all’esagerazione della maschera come modalità di creazione di una distanza con il presente non più disponibile a farsi storia. Insomma, la forza di volontà che corrispondeva alla pressione del desiderio femminile di autonomia e di compimento della vita, che aveva segnato tutto il neorealismo rosa, alla fine degli anni cinquanta, con il boom, comincia ad incrinarsi, le figure femminili da un lato entreranno esplicitamente in crisi (Pietrangeli, Antonioni), dall’altro diventeranno mero oggetto del desiderio maschile, di una spinta al godimento che disarticolerà l’istituzione matrimoniale (un esempio su tutti Divorzio all’italiana, ma prima c’era stato Il marito). La galleria di maschere che popoleranno il nostro cinema per tutta la prima parte degli anni sessanta manifesterà una cosa ben precisa: la deflagrazione del corpo sociale dietro l’emergere incontenibile di una pulsione (svincolata dal desiderio), la cui famelicità diviene inarrestabile, trascinando ogni valore (I mostri) ed ogni architettura narrativa (non solo nei film a episodi, ma anche nella struttura episodica dei film, come in Il sorpasso). L’identità maschile (in fondo marginalizzata nelle commedie anni cinquanta) riemerge sotto forma di maschera eccessiva, mimetica o idiosincratica, che diventa lo scudo fragile di un rapporto con il reale completamente dissolto e senza misura comune (il colpo “scientifico” di una banda di scalzacani in I soliti ignoti), che
96
Lessico del cinema italiano
può comportare il pagamento di un prezzo elevato, fino alla vita stessa (Il sorpasso). Le maschere della commedia all’italiana ci restituiscono non solo una galleria di tipi sociali, ma qualcosa di più importante per il nostro discorso, una saldatura esagerata tra persona e maschera, dove quest’ultima non è tanto l’esposizione di un ruolo, quanto lo scudo precario che nasconde la fragilità del soggetto nel suo rapporto incrinato (segnato da pavidità, infantilismo, incapacità di assumersi responsabilità) con il mondo, e da cui conseguono comportamenti aberranti e aggressivi. Se nelle commedie anni cinquanta desiderio e volontà erano i motori di una coesione identitaria, che era allo stesso tempo individuale e sociale, pilotata da un femminile emergente e dinamico, con gli anni sessanta, sotto il segno di un maschile segnato da una pulsione senza più desiderio, da un fagocitamento di facili miti, viene fuori una disintegrazione individuale e sociale che nella maschera trova il contrassegno di una mera sopravvivenza del soggetto nel mondo. Qui la maschera non è più la simulazione consapevole, architettata per piacere all’altro, ma il modellarsi inconsapevole e trasparente (svincolato da posizione, ruolo, classe) di una identità posticcia che nasconde al soggetto la sua vacuità e le sue inadempienze. La maschera del miles gloriosus, incarnata dal Bruno Cortona (Vittorio Gassman) di Il sorpasso, non è nient’altro che questo: l’identità sigillata nella figura del vantone, che allo stesso tempo espone e nasconde. Espone nella vanteria un patetico e ridicolo gesto di dominio sul mondo, ma di fatto nasconde una incapacità (di assumersi responsabilità) e una inadempienza (simbolica, da dove la perenne fuga) di fondo. Questa doppia valenza della maschera, che presenta un io inconsapevolmente lacerato, la ritroviamo per esempio in Sordi, dove la scissione può assumere due forme: o si presenta in un modo pur essendo consapevolmente in un altro (L’arte di arrangiarsi, Il moralista), per poter sfruttare cinicamente questa doppiezza, oppure si presenta in un modo per nascondere anche a se stesso di essere in un altro (Il seduttore, Lo scapolo, Un americano a Roma), facendo emergere l’immagine di un infantilismo irriscattabile.
Identità Roberto De Gaetano
97
Questa frattura nell’identità, esposta e celata allo stesso tempo dalla maschera28 e dalla società che non la sutura ma la alimenta, facendo circolare mitologie corrive, che portano il soggetto o ad adeguarvisi per una volontà eccessivamente mimetica o a distanziarsene in forma dissonante29, è il contrassegno di una società incapace di iscrivere il desiderio nella forma simbolica del riconoscimento, come nelle commedie “ascensionali” ancora accadeva. In queste ultime, era il desiderio del personaggio femminile a far uscire l’uomo dalla sua cuccia, dalla sfiducia e dalla paura che lo attanagliavano, per dargli il coraggio giusto per conquistare la donna e conquistarsi la vita, come Due soldi di speranza manifesta in forma limpida. La forza trascinante del desiderio configurava l’identità, integrandola nel movimento della società stessa, sottraendola ad una oscillazione ambivalente che poi si risolveva in dicotomie (morali) inconciliabili; come accadeva nel melodramma, o in film dove un resistente infantilismo maschile annichiliva ogni piena individuazione e ogni forza del desiderio, riconsegnando la donna al ruolo materno di comprensione e accoglimento di tale infantilismo (È primavera..., Le ragazze di San Frediano); o in quei casi in cui era la donna stessa a ritrovarsi stregata e bloccata in una gabbia illusoria, senza rendersi capace di esprimere il proprio desiderio (Lo sceicco bianco), prima eventualmente di comprendere lo sbaglio fatto e trovare la forza per ricominciare (Un marito per Anna Zaccheo). Divorzio all’italiana di Germi segna distintamente questo cambio decisivo nella forma della commedia e nella scissione dell’identità tra pulsione e ordine simbolico. Il matrimonio come valore riconosciuto non è più il momento di sintesi del desiderabile e del doveroso, ma diventa una gabbia, custodita da una moglie appiccicosa che non lascia respirare. E il marito trova il pretesto dell’attrazione per la giovane cugina Angela, per sconfessare un simbolico troppo pieno, architettando di fatto la sua autodistruzione attraverso un crimine commesso (delitto d’onore), la conseguente car28 29
Grazia Livi parla di due maschere: «Ha perciò due maschere, quella esterna, piena di lazzi servili, e quella interna, paurosa e spregiosa», cit. in G. Fofi, Alberto Sordi, Mondadori, Milano 2013, p. 109. M. Grande, La commedia all’italiana, cit., pp. 86-88.
98
Lessico del cinema italiano
cerazione, e l’impossibile definitivo possesso della nuova giovane sposa (che nel finale fa piedino al marinaio). L’«io infermo»30 è quello il cui stato di claudicante è determinato da una spinta pulsionale troppo forte, che non viene contenuta dal principio di realtà e dalla struttura sociale. L’infermità dell’io è nascosta all’io stesso attraverso le maschere che questo indossa (I mostri), i piani che architetta (Divorzio all’italiana, Sedotta e abbandonata), gli oggetti che insegue e brucia (Il sorpasso). Nella commedia all’italiana la scissione della maschera fra ciò che manifesta e ciò che cela è la scissione dell’identità fra esposizione del ruolo ed istanze soggettive, fra principio di rappresentanza e principio di prestazione31. Questa scissione va nascosta e le strade sono due: o quella della maschera idiosincratica, avida ed aggressiva, che cela inadempienze e inanità (Gassman e Sordi), o quella della maschera eccessivamente mimetica, elastica e flessibile, mossa esclusivamente dal desiderio di farsi accettare (Tognazzi e Manfredi)32. Quello che emerge nella commedia grottesca, a partire dall’inizio degli anni sessanta, è propriamente questo: una teatralizzazione (naturalizzata) dell’identità33 che ne manifesta e ne nasconde allo stesso tempo la profonda frattura, che nasce dalla circolazione di miti a basso prezzo, che si sviluppano nel boom, alimentati da un neocapitalismo precipitato dall’alto su un terreno incapace di sostenerlo. Consumi, ricchezza, potere, successo, mito di una libertà senza vincoli, e di un “tutto e subito” che non lascia tempo d’attesa, costringono un soggetto (oramai definitivamente urbanizzato) ad avventurarsi acrobaticamente in situazioni per cui la stessa sana sopravvivenza può essere a rischio (Il boom). La teatralizzazione dell’identità nella maschera posticcia e “naturalizzata” (e non sfilabile, come quella degli anni trenta) è comunque una forma di tenuta, sia pur iperbolica, dell’identità stessa, perché ad essere teatralizzate sono le spinte pulsionali del soggetto, la sua voracità, la sua brama di possesso (denaro, pote30 31 32 33
Ivi, pp. 50-53. Ivi, p. 51. Cfr. ibidem. Una teatralizzazione che ritroviamo negli stati patologici, per esempio nelle crisi isteriche, portate sullo schermo fin dal muto, come in La neuropatologia (1908).
Identità Roberto De Gaetano
99
re, donne), che eludono ogni istanza di riconoscimento, anche simbolico. Il mondo non esiste che come l’infinitamente divorabile, da consumare, da bruciare (Il sorpasso). Le spinte inarginabili, che attraversano un soggetto avido, trovano traccia nel tic che deforma l’espressività della faccia (Divorzio all’italiana), nel clacson continuamente strombazzato in una perenne corsa (Il sorpasso), nelle architetture improbabili di piani che si rivelano fallimentari per chi li ordisce (Il vedovo). L’identità fragile, inadempiente, inabile, si imbratta, si trucca, si nasconde a se stessa, si sottrae ad ogni vita relazionale se non pensata in termini strumentali ed opportunistici, luogo di appropriazione e scambio di corpi (femminili) e di denaro (Gente moderna, episodio di Alta infedeltà, La mia signora ecc.). Il grottesco della maschera “contiene” l’emergere senza argini del soggetto del godimento, che dagli anni sessanta segnerà parte importante del nostro cinema, a partire dai film di Petri, interpretati da Gian Maria Volonté, dove in gioco è proprio una maschera del potere che corrisponde all’emergere di una spinta pulsionale totalizzante: «Io vorrei essere e avere, ma so che è impossibile, è questa la malattia» dice Lulu in La proprietà non è più un furto (1973). O come in Todo modo (1976), dove il potere diviene assoluto «para buscar la voluntad divina», e l’incontrollabilità della spinta pulsionale di M. passa dalla sessualità (le perversioni nei giochi erotici con la compagna), alla conquista e al mantenimento del potere (che lo porta a sospettare prima e a trovare poi i nemici tra gli amici), alla elevazione spirituale, e il tutto culmina nel sacrificio finale rituale (dal carattere palingenetico). E questo era comparso già con grande forza in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove l’identità era saldata ad una maschera, che da un lato esibiva il senso di onnipotenza e dall’altro nascondeva l’effettiva impotenza, l’infantilismo, del commissario. Togliere la maschera al commissario significa esporlo in tutta la sua inanità. È quello che fa la donna quando lo deride nell’alcova per la sua immaturità sessuale. Derisione che non viene tollerata e che trasforma la casa da set di cronaca nera per i giochi erotici degli amanti a luogo effettivo di un crimine. Quella maschera non sarà tolta al commissario neanche dai colleghi, che sanno come stanno le cose. Nessuna protezione gli viene concessa, nessun riparo sotto l’ombrello della Legge, come richiesto dallo
100
Lessico del cinema italiano
stesso piagnucoloso commissario, che rimarrà in uno stato sospeso e anarchico senza presa sul mondo. L’identità esposta, teatralizzata, in una maschera esagerata, idiosincratica, prosegue fino al grottesco contemporaneo delle maschere di Moretti, che dietro l’istanza giudicante e liquidatoria del mondo cela tutta la sua incapacità di comprenderlo, e che giunge persino a riconsegnarci in Il caimano (2006) una figura pubblica come quella di Berlusconi attraverso tre maschere che scindono l’unità del personaggio. Berlusconi non è il nome proprio di un personaggio ma il catalizzatore di una triplice maschera, che lo riconsegna diviso nella sua unità, nella faccia spudorata (alla ricerca di denaro), in quella seduttrice (a caccia di donne), e in quella nera del finale in cui reagisce a chi ha posto un limite (la giustizia) alla ricerca illimitata del primo e alla caccia delle seconde. Anche Il divo (Sorrentino, 2008), qualche anno dopo, ricalcherà il percorso della riconsegna della singolarità di un personaggio pubblico, Giulio Andreotti, a quella della generalità di una maschera, e della maschera del potere come segreto (di cui le emicranie da cui è colpito Andreotti sono il segno distintivo). La maschera grottesca è quella che ci riconsegna, a partire dagli anni sessanta, il nuovo stato dell’identità, non più orientata al riconoscimento altrui, per il quale attivava, come accadeva tra le due guerre, pratiche di simulazione e di travestimento (si mente con l’obiettivo di piacere), ma, collocata in un regime di trucco trasparente, la nuova maschera assorbe totalmente l’identità. E il suo carattere esagerato, sia nel caso dell’adesione mimetica che della dissonanza idiosincratica, diventa ribalta di teatralizzazione delle pulsioni, che permette al soggetto di differire il suo tracollo e di vivere acrobaticamente nell’intervallo del differimento. In ogni caso la questione dell’identità non si definisce più in termini di socialità (relazione e costume), come nelle commedie tra le due guerre, né in termini di «commedia nella società», come nel desiderio simbolicamente compiuto del neorealismo rosa (desiderio di sposarsi), ma come «commedia della società», dove una intera società senza alcun fuori è ridotta ad un teatrino di maschere e segnata da una logica del godimento e del possesso, di persone e cose, di persone in quanto cose: «Io mi sento ’na cosa, io so ’na cosa, anzi tante cose... Tette, cosce, pancia, bocca,
Identità Roberto De Gaetano
101
io so’ tanti pezzi», dice Anita in un monologo di La proprietà non è più un furto34. È con il boom che la destrutturazione dei valori lascia il passo ad una logica dell’avvicendamento di oggetti, legati ad una dinamica del consumo, che porta da un lato alla loro moltiplicazione come segni ambiti del nuovo benessere acquisito (l’automobile negli episodi Vernissage e Il pollo ruspante, rispettivamente di I mostri e Ro.Go.Pa.G.), e dall’altro ad un soggetto smarrito in una crescita disperatamente grottesca di tale consumo, che giunge a consumare ogni “interiorità”, ogni sostrato affettivo ed emotivo. L’approdo più radicale, perfino apocalittico, di questo percorso, lo ritroviamo nel cinema di Marco Ferreri. Più radicale, perché la devastazione dell’identità che il boom e il neocapitalismo determinano, destrutturando le linee di connessione temporale dell’esistenza, non trova nel cinema di Ferreri neanche l’esile scudo della maschera: senza maschera le pulsioni che attraversano il soggetto, componendone ossatura e nervatura, senza più superficie riflettente, si trasformano in perversioni e gli oggetti in feticci. E la pulsione dominante, quella che attraversa tutte le altre, è la pulsione di morte, che in Ferreri prende la forma di un programma da realizzare, intorno a cui costruire l’iperbole della storia, sia essa quella di una serata trascorsa tra gli oggetti di casa, inclusa una moglie sedata e dormiente, che alla fine viene uccisa con una pistola dipinta a pallini come un giocattolo (Dillinger è morto), sia quella di quattro borghesi che si ritrovano in una villa (anche in questo caso a dominare è lo spazio chiuso dove la pulsione si eleva all’artificio della perversione) per suicidarsi attraverso l’assunzione di un eccesso di cibo (La grande abbuffata). In Ferreri, le spinte di una pulsione distruttrice si manifestano senza alcuna contraffazione ed espongono il soggetto, oramai senza maschera, al suo progetto suicida, e ad una radicale de-umanizzazione, per cui l’essere strumento dell’altro, la sua “oggettualità”, si manifesta letteralmente, come in La famiglia felice (episodio di 34
Goffredo Parise in Il padrone (Adelphi, Milano 2011, p. 85), del 1965, presentava esplicitamente questa idea di oggettualità iscritta nelle relazioni personali e nella vita di fabbrica: «Spesso mi chiedo che cosa farei, anche qui, senza un padrone, cioè senza una persona che mi ritiene di sua proprietà e che mi usa giornalmente come fossi un bicchiere, una automobile, una sedia, un letto».
102
Lessico del cinema italiano
Marcia nuziale) in cui vediamo la felicità passare per l’acquisizione e l’acquisto (con tanto di etichetta) di un coniuge-manichino. L’esposizione dell’identità a partire dagli anni sessanta significa in prima istanza emergenza di un’inarrestabile spinta pulsionale che si subordina e trascina tutto, a partire da un soggetto, in primo luogo maschile, che non riesce a contenerla e ad orientarla, e che utilizza una maschera come fragile e illusoria protezione dalla dissoluzione (fino al disfacimento della maschera stessa). E tutto questo ritrova nel grottesco la forma dominante di restituzione sullo schermo di tale mondo, e determina l’ispessimento delle linee che definiscono il reale, sotto la spinta di una pulsione, che prescinde dalla singolarità di ciò che incontra e brucia tutto ciò in cui si imbatte. La pulsione restituisce il soggetto alla meccanicità avida del suo atto, precludendogli qualsiasi accesso al simbolico, e dunque anche al riconoscimento del suo proprio desiderio. 2.3 L’identità ritualizzata L’identità ritualizzata è una delle forme dell’identità esposta, ma questa esposizione passa attraverso codificazioni e regole che devono garantire il passaggio da uno stato all’altro. È l’altro corno del debito che il cinema contrae con il teatro, o meglio con la teatralizzazione della vita: non la pratica di simulazione per cui qualcosa diviene qualcos’altro (la maschera), ma il meccanismo per cui qualcosa diviene qualcos’altro per poi poter tornare ad essere tollerabilmente quell’“originario” qualcosa. Sono i riti che garantiscono il controllo della «crisi della presenza», che permettono di riattivare un orizzonte di sensatezza, dove tutto sembrava scomparire e dissolversi in forma apocalittica. L’esperienza di De Martino tra anni cinquanta e sessanta diventa un punto irrinunciabile della scoperta antropologica di una società, quella del Sud Italia, la cui crisi non poteva né prendere la forma né essere risolta attraverso i modi della borghesia urbana. Ma questo sarebbe troppo poco, con De Martino non è in gioco solo una teoria etnoantropologica, ma qualcosa in più, una teoria filosofica, che emerge con forza nel suo ultimo incompiuto testo sulle apocalissi culturali, La fine del mondo. La crisi psicopatologica di un individuo, che è crisi del senso dell’esistenza e che trova riscontro nella crisi di una comunità, può essere
Identità Roberto De Gaetano
103
governata ritualmente. Ora, questo governo non prende la forma dell’esorcismo o della negazione, ma dell’assimilazione regolata che accoglie ciò che deve allontanare, e lo orienta. Come nel rito romano del mundus in cui per tre giorni venivano scatenate tutte le forze del caos, per poi ritornare ad un principio d’ordine, così il carattere «destorificato» della dimensione mitico-rituale serve a sospendere, alimentandola in prima istanza, la «crisi della presenza», per poi tornare all’ordine delle cose. Le «apocalissi culturali» sono le manifestazioni collettive di una pratica rituale che tiene insieme caos e ordine, partendo dal primo e approdando al secondo. Come accade con i tarantolati che per rispondere al “morso” della tarantola (crisi) lo riprendono (“ri-morso”) nel momento musicale e coreutico della danza, prima di sedarsi e ritornare all’ordinarietà della vita, così all’angoscia generalizzata, che è «reazione della presenza al rischio di non esserci al mondo»35, le «apocalissi culturali» rispondono ritualizzando fine/inizio delle cose, morte/rinascita, caos/ordine, smembramento/ricomposizione. Questa questione decisiva per pensare una crisi di identità che porta la storia al limite della destorificazione, la civiltà ai confini con la natura, rientra pienamente nel nostro cinema, non solo in quello più direttamente ispirato dalla ricerca antropologica demartiniana (Del Fra, Mangini, Di Gianni, Mingozzi), ma anche, attraverso una metabolizzazione del movimento morte/rinascita, nelle maschere grottesche e nelle feste (il modello circense in Fellini), nella centralità della dimensione del corpo in quanto «teatro primario» di una «dialettica tra io e mondo»36 (dialettica fallimentare nei corpi stanchi di Antonioni), e in quell’«ethos del trascendimento» che diviene la forma attraverso cui l’essere-nel-mondo diventa «doverci essere», misurando lo scarto da una prospettiva meramente esistenzialista: «La struttura trascendentale dell’esserci è il doverci essere nel mondo, in atto di farsi valere contro il rischio di non poterci essere»37. È l’affermazione di un conatus, di una energia, di una spinta ad essere, di una corrispondenza a qual35 36 37
E. de Martino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, Argo, Lecce 1995, p. 110. C. Gallini, M. Massenzio, Introduzione a E. de Martino, La fine del mondo, Einaudi, Torino 2002, p. XXIII. E. de Martino, La fine del mondo, cit., p. 670.
104
Lessico del cinema italiano
cosa che trascende la mera esistenza, e che se mancasse farebbe precipitare tutto nel non senso. Ma questo ethos va sempre riaffermato, anche in arte, e soprattutto nei momenti di crisi. Solo in questo senso può essere letta l’etica dell’immagine neorealista: ricostruire sui frammenti sparsi di individui e società una nuova idea di comunità. Ma è certo che l’autore che sembra aver più assorbito, in forma indiretta e diretta, l’ambito problematico demartiniano è Pasolini38, dove la nostalgia per il mondo contadino e popolare da un lato e la visione apocalittica sulla borghesia neocapitalista e consumista dall’altro ereditano anche da una “valorizzazione” della cultura popolare. In De Martino, la presenza di una dimensione «sacra», «mitico-rituale», che accompagna le pratiche di vita e le tradizioni popolari, serve a sanare la crisi della presenza nella storia: «Funzione della magia, come della religione, è contribuire alla salvezza della presenza nella storia»39. Ora, anche in Pasolini la dimensione storica viene costantemente trascesa verso una di tipo mitico-rituale, che caratterizza anche la religione stessa, libera da elementi dogmatici: «Il mio interesse principale, il mio obiettivo [con Il Vangelo secondo Matteo] non era la storia, ma il mito»40. La sacralità di un livello mitico-rituale, che caratterizza dunque anche la «destorificazione religiosa» perché «l’aspirazione religiosa fondamentale è l’evasione dalla storia»41, permette di sospendere le crisi di identità che nascono nella storia. Le crisi di identità soggettive vengono risolte ritualmente, e in questo senso le «apocalissi culturali» sono i momenti collettivi che riscattano il tracollo della presenza entrata in crisi, perché ne operano una elaborazione rituale: «“La fine del mondo” denota un orizzonte mitico-rituale per entro il quale il rischio del vissuto pri38
39 40 41
Negli anni della composizione del Canzoniere italiano, Pasolini frequenta un gruppo di studiosi di matrice gramsciana, che gravitano intorno al Centro Etnologico Italiano, tra i quali De Martino. Cfr. su questo T. Subini, La necessità di morire. Il cinema di Pier Paolo Pasolini e il sacro, Edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo, Roma 2007, p. 26. P. Angelini, L’uomo sul tetto. Mircea Eliade e la “storia delle religioni”, Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 114. Intervista rilasciata a Maurizio Ponzi, in P.P. Pasolini, Per il cinema, a cura di W. Siti, F. Zabagli, tomo II, Mondadori, Milano 2001, p. 2881. E. de Martino, Prefazione a M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, Einaudi, Torino 1954 [ed. or. Traité d’histoire des religions, Payot, Paris 1948].
Identità Roberto De Gaetano
105
vato e incomunicabile, di un mondo che finisce, viene ripreso e integrato secondo valori intersoggettivi e comunicabili […]; quando invece il dinamismo è di senso opposto, e gli orizzonti culturali si disarticolano e crollano recedendo verso il vissuto privato e incomunicabile di un “finire” senza ripresa efficace, allora siamo nella psicopatologia individuale»42. Il confine non è netto tra crisi individuale (psicopatologica) e momento rituale e collettivo (apocalisse culturale), che diventa la forma pubblica di riscatto di una crisi interiore, un modo per convertire la fine in un nuovo inizio: quando questo accade la destorificazione mitico-rituale sana la storia; quando questo passaggio intersoggettivo fallisce la soggettività precipita nella malattia. Ora, questo «ethos del trascendimento» partecipa in primo luogo di una tradizione popolare che non avrebbe altri mezzi per realizzarsi e per superare le sue crisi. L’anonimato di una presenza al mondo trova nell’impersonalità ed esteriorità di una pratica rituale il modo per superare il rischio di un tracollo, di un’apocalissi, come vediamo in Stendalì (1960) della Mangini su testo di Pasolini, dove è in gioco il lamento funebre delle prefiche per sanare il lutto, il cordoglio per la morte di un giovane di sedici anni. Senza questo pianto la crisi sarebbe intollerabile, il lutto inelaborabile, il cordoglio insanabile. La centralità della dimensione mitica in Pasolini, il suo cercare il sacro oltre la storicità dell’esperienza, ha corrisposto alla ricerca di una «salvezza della presenza», che sembra talvolta poter accadere solo oltre la storia, in un dispositivo sacrificale di tipo tragico e mitico. La nostalgia per la cultura contadina e l’amore per il sottoproletariato definiscono in Pasolini l’interesse per una forma di esistenza e per una condizione di vita capace sempre di riattivare in forma magico-rituale il legame uomo-mondo, che frana quando si entra nell’individualismo del mondo borghese: Direi che l’angoscia è un fatto borghese. Il sottoproletariato ha un altro tipo di angoscia, quella che studia De Martino facendo ricerche nella poesia popolare in Lucania, per esempio, cioè un’angoscia preistorica rispetto all’angoscia esistenzialistica borghese, storicamente determinata. Io in Accattone ho studiato questo tipo di angoscia prei42
E. de Martino, La fine del mondo, cit., p. 74.
106
Lessico del cinema italiano
storica rispetto alla nostra […]. Un’angoscia che ha altre componenti storiche da quelle che prova un borghese come quello della Noia di Moravia per esempio43.
L’«ethos del trascendimento» manca alla borghesia (carente anche dal punto di vista del costume), perché il livello mitico-rituale viene sostituito dalla ritualità dei consumi, dove l’altalena morte/ rinascita, crisi/presenza, è molto più frequente e rapida, e passa per la diffusione e circolazione (feticistica) degli oggetti e per la ritualità (maniacale) del loro utilizzo quotidiano. La «crisi della presenza» nella società neocapitalista urbanizzata si ripresenta ogni giorno (senza distinzione fra feriali e festivi), e ogni giorno viene sanata nei riti del consumo, nel moltiplicarsi degli oggetti-feticcio da acquistare. Il capitalismo è, di per sé, deterritorializzante, rende perenne la crisi e la sua soluzione attraverso il consumo. Ma la perennità della crisi sottrae al rito la sua unicità, il suo perimetro spazio-temporale e la partecipazione collettiva. Teorema (1968) segna il passaggio di Pasolini al mondo borghese (dopo i sottoproletari degli inizi, le forme tragiche, gli episodi comico-grotteschi), dove l’arrivo di un elemento esterno in un nucleo familiare borghese (il capofamiglia è un industriale) determina una crisi insanabile. I componenti della famiglia una volta che l’“intruso” si allontana prenderanno strade distinte e senza ritorno, dimostrando di collocarsi ben distanti dal popolo e dalle “soluzioni” alla crisi che mette in atto. Ma è soprattutto con Marco Ferreri che viene a manifestarsi in forma radicale ed apocalittica la ritualità, svincolata da ogni ethos, di una borghesia segnata dai consumi e dispersa in un mondo pieno di feticci e di idoli (Dillinger è morto, La grande abbuffata, I love you). Qui il “primitivo” prende i contrassegni del “selvaggio” e diviene l’altra faccia di un consumismo capitalistico che nelle forme della filantropia occidentale (distribuzione di viveri e medicine alle popolazioni del Terzo Mondo) viene a risolversi in un rito cannibalico che precipita il tutto in humour nero (Come sono buoni i bianchi!). L’Africa di Ferreri è ben distante da quella di Pasolini, che vi ricercava comunque i fondamenti di una primi43
Incontro con Pier Paolo Pasolini, in P.P. Pasolini, Per il cinema, tomo II, cit., p. 2812.
Identità Roberto De Gaetano
107
tività tragica e mitico-rituale (Appunti per un’Orestiade africana, Appunti per un poema sul Terzo Mondo) come alternativa alle derive occidentali («Africa, unica mia alternativa» scriveva, nel 1960, in Frammento alla morte dedicato a Franco Fortini). La purezza dell’“astorico” in Pasolini diviene ferinità regressiva e grottesca in Ferreri: il Terzo Mondo, sottratto ad ogni astoricità ideale, si trasforma in immagine simbiotica e “resto” del mondo occidentale (il deserto disseminato di “pezzi” della civiltà). Se in Pasolini vediamo la contraddizione viva e cruenta tra il mitico-rituale e la civiltà dei consumi, in uno sguardo scisso tra nostalgia e apocalisse, in Ferreri ci troviamo nello scetticismo più radicale che si tramuta in cinismo. Il suo è uno sguardo post-apocalittico, che ha liquidato ogni rapporto anche con l’idea di “crisi”, perché lo ha liquidato con l’idea stessa di umanità. Un esempio recente, straordinariamente fertile e vitale, di una identità ritualizzata e de-storicizzata capace di risalire la china, lo ritroviamo in Michelangelo Frammartino, nel suo Le quattro volte (2010) e nel più recente mediometraggio Alberi (2013). Non è in gioco in Frammartino nulla come uno sguardo idilliaco su una natura incontaminata e idealizzata (secondo uno stile Piavoli), c’è qualcosa di più che riguarda l’ordine ciclico della vita umana e della natura. In Le quattro volte il ciclo si realizza attraverso le quattro «vite distinte» dell’uomo – minerale, vegetale, animale e razionale – di cui parla Pitagora e a cui fa riferimento il titolo, che nel film passano per la vita di un anziano pastore, per quella di un capretto appena nato, per l’abbattimento dell’albero alla Festa della Pita ad Alessandria del Carretto (filmata anche da De Seta nel 1959 in I dimenticati), e per la combustione dei tronchi d’albero, ridotti in cenere e fumo (a scaldare anche le case dei pastori), con un finale che circolarmente torna sull’inizio. In Alberi abbiamo invece il rito del farsi-albero, vegetale dell’umano, il suo farsi legno, in un processo di disidentificazione e di arboreizzazione dell’umano (con radici antiche, medioevali, come nella foresta del Macbeth). L’identità in gioco qui non è semplicemente colta in un processo di dissoluzione e di spersonalizzazione, c’è qualcosa in più, inscritta nella potenza delle immagini (Le quattro volte) e nella mediazione di un rito (Alberi), e questo qualcosa è la costituzione di un piano impersonale intensivo, che prescinde dalle forme e riguarda le intensità, i flussi e i cicli della vita, che rendono
108
Lessico del cinema italiano
pari gli ordini della natura (umano, animale, vegetale), secondo un processo di metamorfosi continuo che sfida ogni confine dato e codificato. 3. L’io e il potere Ciò che chiamiamo identità non è solo il precipitato del privato della persona e del pubblico della tradizione, della reminiscenza interiore e della memoria storica44. È anche l’effetto del modo in cui questo passato si concretizza nel presente, determinando le forme di “oggettività” del mondo, a partire dai dispositivi di potere con la loro capacità di incidere e modellare l’individuo. Stato, istituzioni, poteri svolgono un ruolo importante nel definire l’io. E questo diventa ancora più decisivo quando le forme di autonomizzazione, di autocoscienza, tendono a indebolirsi e vengono assorbite dai vari modi di resa uniforme degli individui nei regimi totalitari. Il fascismo è stato anche un sistema politico che ha saputo “vendere” all’io debole una protezione, nelle forme di una vera e propria «colonizzazione delle coscienze»45. Protezione e colonizzazione che si sono determinate sulla crisi della coscienza individuale di inizio Novecento, precipitata poi nella Prima guerra mondiale, dove il malessere dell’individuo si riversava prima nell’io-massa delle uniformi e delle trincee di una guerra mai così cruenta, per proseguire poi in quel «mutismo» dei soldati tornati dal fronte (di cui ha parlato Benjamin), corrispondente alla loro incapacità di rielaborazione dell’esperienza, frutto anche del fatto che «il soldato di linea divenne “enigmatico nei confronti di se stesso”»46. Questi soldati muti, incapaci di ricollocarsi nella quotidianità della vita, rispondono 44
45 46
Cfr. W. Benjamin, Il narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in Id., Opere complete. Scritti 1934-1937, vol. VI, a cura di R. Tiedemann, H. Schweppenhäuser, Einaudi, Torino 2004, par. XIII, pp. 332-333 [ed. or. Der Erzahler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Leskows, in Gesammelte Schriften II, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main 1977]. R. Bodei, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002. E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella Prima guerra mondiale, il Mulino, Bologna 1985, p. 53 [ed. or. No Man’s Land. Combat & Identity in World War I, CUP Archive, Cambridge 1979].
Identità Roberto De Gaetano
109
prontamente alle parole d’ordine del regime, che promette loro una trasformazione e una “purificazione” dei dolori della loro anima, restituendola ad una sfera pubblica, condotta da un meneur des foules; il quale è capace di mobilitare, facendo leva su valori e credenze comuni, che rimandano a un sé totale, l’unico in grado di riscattare il disagio e la crisi individuale. Le parole d’ordine del fascismo (obbedienza, sacrificio, eroismo) proponevano l’immagine di una “identità forte”, che permetteva di trascendere quella decadente di inizio secolo, filtrata dall’identità-massa uscita fuori dalla guerra. Ma la coscienza colonizzata e gregaria, subordinata allo Stato e a chi lo rappresenta, cioè il duce, e che viene “educata” dalla propaganda, nel nostro cinema non è di casa. Le grandi masse anonime, contrapposte all’individualità del duce, affacciato al balcone o in sfondi che servono a costruire la mitologia del regime (segni della romanità), sono presenti solo nei cinegiornali del Luce, mentre nel cinema del Ventennio l’identità sembra piuttosto essere restituita in forma critica dal pirandellismo o dalle nostre commedie sullo scambio di identità. E se, dunque, «La dialettica “Mussolini-folla” diventa una dialettica di montaggio “primo piano-campo totale” e si cerca di dimostrare, attraverso un uso più consapevole di questo procedimento, come da questa dialettica nasca il senso di una volontà sola, quella del duce»47, questa dialettica riguarda solo, come dicevamo, i filmati del Luce; e anche un film come Camicia nera (1933) di Forzano, realizzato per commemorare la Marcia su Roma, di camicie nere ne mostra poche, mentre in gioco è un valore (la vita contadina) e una pratica di trasformazione dell’ambiente (la bonifica dell’Agro Pontino). In breve, la propaganda del regime, la massificazione delle coscienze non sembra avere spazio nel cinema fascista, e ne è consapevole anche un cineasta di regime come Blasetti: «Un’industria cinematografica di Stato dovrebbe sorgere principalmente per uno scopo: propaganda. E lo fallirebbe. La produzione di questa industria, recante o non il bollo dello Stato fascista, sarebbe inesorabilmente boicottata, respinta dal commercio»48. Qui emerge l’idea di una refrattarietà del cinema stesso, come dispositivo e come lin47 48
G.P. Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema del regime 1929-1945, Editori Riuniti, Roma 1993, p. 117. A. Blasetti, S.O.S., in “Lo Spettacolo d’Italia”, n. 6 (1928), cit. in ivi, p. 123.
110
Lessico del cinema italiano
guaggio, a trasformarsi in una macchina di propaganda, indipendentemente dai contenuti. Durante il fascismo, il cinema non ha mai corrisposto, in definitiva, ad una modalità diretta di rappresentazione del potere come azione sul singolo e sulle masse per orientarne comportamenti e imporre valori. Sarà invece negli anni settanta, in autori come Pasolini e Bellocchio49, che la questione della trasformazione del soggetto da parte del potere emergerà in modo chiaro. E se in Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) è in gioco l’idea che la violenza del potere la percepiamo nell’esautorazione dell’intimità altrui (la nudità dei corpi dei reclusi, posti vicino ai notabili vestiti, ridotti a “nuda vita”, scarti senza valore sui quali si possono riversare anche gli escrementi), e dove non solo l’identità psicosociale ma anche ogni traccia di umanità viene cancellata, nei film di Bellocchio, Nel nome del padre (1972) e Marcia trionfale (1976), è in gioco invece la questione del disciplinamento dei corpi. E se nel primo, la scuola, la formazione, il collegio cattolico («quieto e repressivo») si subordinano ad un potere che tutti li fagocita e che rende pari rivolta e autorità (mantenendo solo le distinzioni di classe), e dove al centro c’è un vincolo indissolubile tra subordinazione ed esercizio del comando («Per comandare bisogna prima imparare ad ubbidire»), in Marcia trionfale il gioco assume più esplicitezza, e si sottrae al tono “espressionistico” che emerge con forza nella recita finale di Nel nome del padre. In Marcia trionfale in gioco c’è l’esplicito programma di (pretesa) modifica di un soggetto che il potere può operare: «Un uomo lo puoi far diventare ciò che vuoi» afferma il capitano Asciutto (Franco Nero) e, rivolgendosi immaginariamente alla moglie nel bagno della caserma, dice «Io ti cambio». Il potere che pretende di modificare anime, corpi e comportamenti, un potere disciplinare, è in fondo un potere paranoico, animato da una istanza di controllo, che tende a togliere ogni opacità a uomini e cose. Ancora Asciutto, riferendosi alla moglie: «Darei qualsiasi cosa per sapere quello che le passa per la testa». Quando il potere si esercita nell’intimo della coniugalità, della famiglia, l’ambito privato, comunemente ascrivibile alla commedia, si connota invece in termini di 49
Entrambi gli autori si sono, tra l’altro, direttamente misurati, in Salò e in Vincere, con la rappresentazione del potere fascista e dei suoi effetti sulle anime e i corpi degli individui.
Identità Roberto De Gaetano
111
tragedia e di melodramma, e si risolve con la morte. Il potere è ciò che fin dall’inizio si sottrae e nega l’amore, perché si esercita nella subordinazione (anche subdola) dell’altro, ridotto ad oggetto da controllare e disciplinare, e dunque negato nella sua alterità. Si tratta, secondo una lunga tradizione che affonda nella confessione cristiana, dell’istanza di controllo dei più segreti recessi dell’anima dell’altro per portarli alla luce, e con ciò renderli trasparenti e modificarli. La trasparenza come mito, inseguendo il quale il soggetto “esteriorizza” di fatto le sue paranoie cristallizzate nel potere e nel suo esercizio. La linea di continuità tra le istituzioni disciplinari, il loro fondamento cristiano, il costituirsi del soggetto in primo luogo in quanto “assoggettato”, così come emergono nella riflessione di Foucault, trovano nel cinema di Bellocchio uno spazio di esposizione ed espressione senza pari (come emerge anche nel recente Sangue del mio sangue). 4. L’identità in crisi Se l’identità esposta è tipica della commedia, in cui il personaggio, non sapendosi guardare, si fa maschera, la crisi di identità che assume aspetti riflessivi, e che non viene incarnata dalla maschera, trova nel romanzesco la sua forma più propria di racconto. Senza la copertura della maschera il personaggio si trova esposto in un mondo senza orientamento alcuno e senza l’illusione di dominarlo né la tendenza ad adeguarvisi. La crisi di identità è la distanza che il personaggio prende dal mondo e dalla sua propria esperienza, una distanza che non gli permette di appropriarsi di alcunché, che lo rende estraneo a se stesso. Se le figure maschili si sono identificate con le maschere degli anni sessanta, nascondendo artificiosamente questa distanza, le figure femminili hanno esibito in forma più chiara la crisi e lo stato cronicamente inesperienziale del soggetto. Un ruolo centrale in questo l’ha giocato Antonio Pietrangeli e un film di importanza decisiva come Io la conoscevo bene (1965), dove la crisi di identità non riguarda soltanto la “malattia d’amore”, come nel caso di Antonioni, ma una espropriazione più profonda, che colloca il soggetto al di qua della malattia stessa, in una assenza di interiorità e dunque anche di desiderio. Il soggetto si
112
Lessico del cinema italiano
fa oggetto fluttuante, che transita da una situazione all’altra, senza aderirvi ma anche senza resistervi. In questo caso si tratta di una ragazza, Adriana Astarelli (Stefania Sandrelli), che giunge a Roma dalla campagna, sedotta da sogni di successo per ritrovarsi come una sorta di oggetto-testimone che passa da un uomo all’altro prima di cadere, di precipitare, anche qui con un tasso debole di volontà, dall’alto di un balcone. «È sempre contenta, le va bene tutto, non desidera mai niente, non invidia nessuno, è senza curiosità, non si sorprende mai, le umiliazioni non le sente, eppure povera figlia, dico io, gliene capitano tutti i giorni. Le scivola tutto addosso, senza lasciare traccia, come su certe stoffe impermeabilizzate. Ambizioni zero, morale nessuna, neppure quella dei soldi perché non è nemmeno una puttana»: queste sono le parole di uno scrittore, disincantato e scettico sul suo proprio talento, con cui Adriana va a letto e che, attraverso la finzione del personaggio di Milena, la inchioda a ciò che è. E cioè un corpo privo di volontà, desiderio, tensione, energia, la cui bellezza e giovinezza («ragazza bella ed eccitante» è dipinta dallo scrittore) le garantisce di essere al centro dell’interesse degli uomini, senza che quest’attenzione vada oltre un uso sessuale. Di questo vuoto (senza sofferenza, senza sentimento, senza emozione), Adriana morirà, gettandosi a corpo morto nel vuoto. La radicalità e l’assoluta modernità di Adriana risiedono nel fatto che il suo malessere non si sviluppa sotto forma di nevrosi, per la pressione di interdetti o prescrizioni. È un malessere senza apparenti sintomi, che raccoglie quello che con un linguaggio contemporaneo possiamo chiamare l’azzeramento dell’inconscio50, che diventa un punto di non ritorno, perché include in sé la liquidazione del tempo. È ancora lo scrittore a parlare di Adriana, attraverso Milena: «Per lei, ieri e domani non esistono. Non vive mai giorno per giorno, perché questo la costringerebbe a programmi complicati. Perciò vive minuto per minuto. Prendere il sole, sentire i dischi e ballare sono le sue uniche attività. Per il resto è volubile, incostante, ha sempre bisogno di incontri nuovi e brevi, non importa con chi, con se stessa mai». Adriana, dopo le parole
50
Cfr. M. Recalcati, L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina, Milano 2010.
Identità Roberto De Gaetano
113
dello scrittore prende consapevolezza del ritratto: «Milena sono io, vero? Sono così, una specie di deficiente». Il vivere «minuto per minuto» significa cancellare ogni interiorità, fondata comunque su una distensione temporale, sul passato, vicino o lontano, di cui avere memoria e consapevolezza e sul futuro, più o meno prossimo, che orienta desideri e aspirazioni. Niente di tutto questo, il puro presente di Adriana è quel vuoto incolmabile che elude la possibilità del costituirsi di una qualche esperienza e che progressivamente assorbe ogni illusione: dall’umiliazione per la ripetizione meccanica e grottesca in un cinegiornale di una risposta («Non so, speriamo») ad una domanda sulle aspirazioni di “giovane promessa” (cinegiornale che si chiude con un primo piano feroce della calza bucata, ironicamente commentato dalla voce off ), fino alla serie di continui sfruttamenti e umiliazioni: dal “pappone” Cianfranna (Nino Manfredi) al viscido Dario (JeanClaude Brialy) che la lascia in albergo con il conto da pagare; dalla signora (Karin Dor) che si dichiara sua amica e la fa abortire a Bagini (Ugo Tognazzi), che dopo essersi umiliato in forsennate claquettes, intercede per il miserevole Roberto (Enrico Maria Salerno), attore di successo che vuole incontrare la «simpatica» Adriana; fino ad Antonio (Robert Hoffmann) che la usa per farsi chiamare la fidanzata. In tutti questi casi, Adriana, alla disperata placida ricerca di consenso, di cui il successo rappresenta solo l’immagine più artefatta e corriva, si ritrova sottoposta a continue umiliazioni, a falsi amici, ad opportunismi biechi. Tra una canzone ascoltata alla radio, un paio di occhiali da sole alla moda, un servizio fotografico nella speranza di chissà cosa, un saltare al collo del primo che incontra, della prima promessa che le viene elargita, Adriana si “svuota” progressivamente senza essersi mai “riempita”: lo specchio nel quale si guarda compiaciuta subito dopo l’intervista al cinegiornale sembra saldarla illusoriamente in un’immagine ideale di sé (giovane ragazza pronta a raggiungere l’ambito successo), che si rovescia nelle lacrime che scorrono sul suo volto truccato davanti ai due specchi della toilette di casa, uno piccolo e tondo che le incornicia il volto, e uno più grande. Quelle lacrime sporcano una faccia mai veramente truccata, mai capace di giocare un ruolo sulla scacchiera sociale. E il rimmel che tinge le lacrime e scivola sul volto indica il dissolversi di quel fragile, difficile, illusorio stare al mondo per una ragazza senza mondo, distante da
114
Lessico del cinema italiano
quello contadino da cui proviene e incapace di farsene uno suo nel momento in cui la società, in assenza totale di valori, è attraversata da spinte e pulsioni fameliche, segnate dal consumo di tutto. Il film è di una radicalità sorprendente e di un’attualità sconcertante, perché il disagio di Adriana non è segnato da dolore e inquietudine, da frustrazione e rabbia, da illusioni infrante. Se fosse tale il soggetto esisterebbe sia pur dolorosamente, il moltiplicarsi degli incontri risponderebbe all’inquietudine di qualcuno che cambia partner e situazioni per sfuggire agli impegni (come la protagonista di Un amore a Roma di Risi). Qui siamo oltre: Adriana è uno dei più grandi personaggi del cinema italiano, perché restituisce l’impossibilità del costituirsi di una qualsivoglia esperienza, del depositarsi di alcunché, e quando le umiliazioni si succedono ad intaccare una fragile illusione (entrare nel mondo dello spettacolo), quel vuoto nascosto diventa dominante e Adriana gli va incontro gettandosi dall’alto del suo appartamento. Adriana, incapace di perseguire e utilizzare opportunisticamente la sua giovinezza e bellezza, sembra cercare solo rifugio in un attaccamento affettivo. Questo le dice la signora a cui si rivolge per abortire, e che vorrebbe avviarla di fatto alla prostituzione: «Ma tu invece mi pare che vai un po’ allo sbaraglio, tipo pesca benefica dei mutilatini. Ma scusa non sai neanche chi è il padre!» «Sì è vero, però è diverso, io ogni volta mi affeziono, e allora... Ma a mettersi a cercare così, per calcolo... E poi è faticoso. Magari ti capita il vecchio, brutto, che non ti porta neanche a divertire, a ballare» «I reumatismi – chiosa la signora – sono un sintomo di ricchezza». Il dialogo chiarisce la distanza totale di Adriana da qualsiasi possibilità di relazionarsi in forma interessata al mondo; distanza profonda da ogni forma di preservazione dell’io, perché quell’io non esiste, è un deposito di cliché e miti corrivi, che portano ad una forma di ilare apatia, di distanza da sé, in un mondo senza più coordinate (valori, riti, istituzioni) di crescita per il soggetto, e totalmente assorbito dalla spirale del boom. Il punto significativo risiede nella costruzione paratattica del film, nell’e congiunzione con cui si succedono situazioni e personaggi, che opera un duplice scarto sia dall’arco narrativo ascensionale, sia dalla episodicità bozzettistica e grottesca di molto cinema coevo. Detto altrimenti, non si tratta né di raccontare una storia, perché per esserci storia deve esserci azione e cioè dialettica temporale tra passato, pre-
Identità Roberto De Gaetano
115
sente e futuro, né di costruire una maschera, perché Adriana non ha ruolo né identità, quindi neanche maschera. Dice Pietrangeli: Oggi ci sono le ragazze-madri, le lolite, le ragazze all’antica, le ragazze-squillo, le ragazze-milione, le ragazze-diecimila, le taxi-girl, le play-girl, le miss, le reginette, le attrici attricette generiche comparse, le ragazze di famiglia che si uccidono per un cinque in latino, le ragazze insoddisfatte a tredici anni che fuggono da Caserta e telefonano da Milano. E poi ci sono le ragazze come Adriana, che non rientra in alcuna di queste categorie. In più, è difficile metterle addosso un’etichetta che ce la definisca tutta, così com’è, in una parola. Adriana è una ragazza tranquilla, serena, allegra, “spensierata” […]. È una ragazza “riposante”. Le va tutto bene. Dove la mettono resta. Dove la portano, va. È ingenua, è remissiva, è spontanea, dice tutto quello che pensa: forse è per questo che parla così poco. Ha una capacità di immobilità pari a quella di un sasso51.
L’analogia “minerale” di Pietrangeli rivela qualcosa in più del personaggio di Adriana. La progressiva perdita dei tratti di umanità non prende i modi, più tipicamente maschili, dell’animalità brutale, neanche quelli di una passività vegetale dotata comunque di un suo “respiro”. Niente affatto, Adriana perde la sua umanità nascondendola dietro un’“allegra spensieratezza”, perché perde il tempo, e con ciò stesso il desiderio, di reinventarlo, di sognarlo, di animarlo, di immaginarlo altrimenti da quel succedersi regolare e indifferente di situazioni ed incontri al fondo tutti uguali, senza aspettative e senza scarti, senza sogni e senza vere aspirazioni (se non quella di essere coccolata dal primo che capita), e con il risultato di mettersi in condizione di perenne umiliazione. Il puro presente di Adriana è la forma che prende l’indifferenza ilare, una mobilità apparente che conferma invece l’impossibilità di cambiare, di modificarsi, come un sasso. E senza parole che possano indicare il formarsi di una qualche esperienza. Adriana nasconde tutto, in primo luogo a se stessa, accumula senza sommare, transita senza spostarsi e la struttura del film, che abbiamo definito paratattica, restituisce bene questo movimento sur place del personaggio: 51
A. Pietrangeli, Il secondo soggetto, in “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli. Infelicità senza dramma, a cura di L. Miccichè, Lindau-Associazione Philip Morris, Torino 1999, p. 87.
116
Lessico del cinema italiano
Questo vogliamo raccontare di Adriana. Non è proprio una storia, perché non ha – come del resto tutto il personaggio di Adriana – un inizio preciso, né uno sviluppo ragionato e conseguente. Racconteremo alcuni “momenti” della sua vita casuale e un po’ sconclusionata, con grandi intervalli in mezzo. Come quando si sfoglia un album di fotografie, dove forse mancano quelli più importanti […]. Dei ritratti di Adriana, quello che viene prima non è certo causa di quello che succede dopo, ma tutti insieme forse sono la causa di quello che viene per ultimo52.
L’assenza di storia, il suo carattere episodico, l’intercambiabilità delle situazioni, il mutismo del personaggio, non danno vita alla sintesi fulminea del bozzetto e alla costruzione della maschera, che prevede comunque una identità del “ruolo”, ma a una sorta di accumulo senza progresso che corrisponde al progressivo slittamento del personaggio verso un’animazione inanimata, verso un essere “sasso”, cosa tra le cose. Lo slittamento dell’umano verso la “cosa” è contemplato come una delle possibilità dell’umano stesso, fin dal diritto romano, ma qui emerge come la possibilità più propria per un mondo segnato dalla mercificazione di tutte le cose. Ed è così che per la prima volta nel cinema italiano compare un personaggio (ilare, leggero), che non è al fondo separato da uno stato di “cosa”, adagiata in un puro presente senza sviluppo, sottoposta alle intemperie del mondo che la portano a morire. Quando il desiderio viene ad essere cancellato, il soggetto arretra fino alla “cosalità” vera e propria; e se le cose negli anni del boom si trasformano in merci, oggetti di consumo, il soggetto che vi si rapporta vi corrisponde rendendosi ad esse equivalente. Ma Adriana sente, pur non comprendendolo, l’arretramento di una umanità che manca di riconoscimento. È alla ricerca di un affetto che non giunge, di una vicinanza da cui non sentirsi abusata. Ma inutilmente: in un certo senso è lei stessa ad abusare di sé, riconsegnandosi come ragazza incapace di immaginarsi un qualche futuro. O meglio, Adriana realizza pienamente l’espropriazione di sé che il presente del boom richiede, alla quale resistono, invano, i malesseri delle donne di Antonioni o le spinte pulsionali delle maschere grottesche, che ribaltano l’inazione in un’azione eccessiva. In questi ul52
A. Pietrangeli, R. Maccari, E. Scola, citati in A. Maraldi, Tra le carte di un regista. I materiali preparatori per “Io la conoscevo bene”, in ivi, p. 75.
Identità Roberto De Gaetano
117
timi casi, il soggetto e il suo comportamento, sintetizzabile da un lato in una sorta di “autocoscienza” (consapevolezza del malessere), dall’altro nell’adesione totale al ruolo (indossare la maschera), comunque resistono. Adriana è non solo una figura senza ruolo, e dunque senza identità, ma è anche una ragazza che nasconde a se stessa i propri “sentimenti”. O meglio, la sua necessità di affezionarsi (come dice) risponde all’esigenza di un’adesività che eluda i rischi del formarsi di un mondo (desiderare qualcuno da amare, i figli da crescere53 ecc.), del costituirsi di una relazione; ma non è neanche una seduttrice opportunista che manipola gli uomini perseguendo un suo proprio fine. La sua condizione radicalizza e manifesta nel sorriso vuoto un processo compiuto di derealizzazione che culmina nel suicidio54. Come Io la conoscevo bene costituisce un unicum tra le grandi figure dell’identità in crisi degli anni sessanta, perché arretra le inquietudini e le nasconde nella superficialità e nel vuoto di un desiderio assente, così l’anno successivo Un uomo a metà di De Seta presenta la crisi di un personaggio maschile che non passa per la maschera e il grottesco (che tendono a celare, in primo luogo al soggetto, la sua insufficienza), ma per una nevrosi, una malattia che porta il protagonista Michele (Jacques Perrin) ad essere ricoverato in ospedale e sottoposto ad elettroshock. E qui si moltiplicano i ricordi, frammenti di tempo passato che si confondono con il presente. La malattia di vivere, l’incapacità di relazionarsi, i sensi di colpa, le gelosie e le invidie, le paranoie, bloccano il soggetto ad un passato dal quale non riesce a sciogliersi e che lo vincola. Lo abbiamo visto nella “vita sequestrata dai morti” (modello Malombra), ma morto è anche un passato che non riesce a rivivere, a 53 54
Con i bambini gioca, e sembrano piacerle, come il neonato che la vicina le lascia da vedere; ma per lei non è facile accogliere il figlio che porta in grembo e dunque si piega alla volontà della signora che la “consiglia”. Un ritratto femminile di qualche anno successivo, che ribalterà questo modello, sarà Anna (1975) di Grifi e Sarchielli. Un intreccio di grande forza tra l’individualità di un destino di ragazza (la marginalità di una minorenne incinta e lasciata sola dalla famiglia) e uno sguardo “leggero” (che passa dalla pellicola al videotape) capace di starle addosso anche negli atti più intimi (come farsi una doccia). Desiderio di vita e di cinema si intrecciano (anche in forma dolorosa) in una operazione dove il secondo mostra tutta la singolarità e la potenza di uno sguardo ravvicinato, capace di individuare un soggetto.
118
Lessico del cinema italiano
rianimarsi, ancorato a traumi, nodi, sensi di colpa non risolti che aspirano inesorabilmente il soggetto. A partire da quello per la morte del fratello in un incidente di moto. Fratello odiato per una profonda rivalità («Lo odiavo, era il preferito, odiavo tutto di lui»), perché era il più amato dalla madre e perché gli sottrae anche Rina, la giovane ragazza di cui è innamorato, che rimane sedotta dalle capacità del militare gallonato di ritorno dalla guerra, a confronto della perenne indecisione di un giornalista scontento come Michele. Ma per quella morte, Michele si sente in colpa: «Non avevo provato pena, compassione, solo rimorso, come se lo avessi ucciso io». E la sua vita prosegue sotto il segno di un’“autoreferenzialità” animata da un complesso di inferiorità che prende la forma di una pretesa di autosufficienza, come dice all’inizio all’amico Ugo: «Non ho bisogno di aiuto, di amicizia, sono sempre bastato a me stesso». Autosufficienza che sembra trascinarsi anche nel rapporto d’amore con Elena (Ilaria Occhini), portando ad una inevitabile crisi, come lei dice: «Non potevamo vivere sempre così, isolati dal resto del mondo» e prosegue: «Non sei capace d’amore». Ma la crisi si radicalizza nella forma di una “soggettivazione” di tutto, anche dello sguardo altrui che rifrange, nei modi dello stile libero indiretto, quello di Michele. La destrutturazione dell’identità da un lato («Non sono mai stato come gli altri, non sono mai stato giovane, non sono stato niente, non ho vissuto»), combinata alla idealizzazione di una figura femminile sfuggente dall’altro («Vorrei essere le cose che ti sono vicine, il pettine, lo specchio […]. Vorrei che fossi perfetta come ti immaginavo») portano al tracollo, alla domanda che apre il film, e che accompagna il ferimento del piede con le forbici: «Come è potuto accadere questo? Perché? Perché? Perché?». Ma il film, percorso nella coscienza malata di un borghese inibito nell’accesso alla vita, è un viaggio di scavo, di comprensione e di conoscenza delle ragioni di questa malattia, come la citazione di Jung che chiude il film conferma: «Ciò che prima dava origine a feroci conflitti e a paurose tempeste affettive, appare ora come una tempesta nella valle, vista dalla cima di un’alta montagna. Non per questo la tempesta è meno reale, ma si è sopra, non dentro di essa»55. Ma qui vediamo anche i limiti di un 55
C.G. Jung, Commento al “Segreto del fiore d’oro”, in Id., Opere, vol. XIII, Bollati Boringhieri, Torino 1988, pp. 26-27 [ed. or. Kommentar zu “Das
Identità Roberto De Gaetano
119
percorso, dove la chiarezza di fatto è solo apparente, come mostra l’ultima immagine del film con Michele apparentemente inchiodato all’albero. Il processo di individuazione viene costantemente impedito e si trasforma in un percorso dissolutivo, nella combinatoria di frammenti che a fatica si ricompongono in unità. L’«Ombra di famiglia», secondo l’espressione dello psicoanalista junghiano Bernhard, a cui il film è dedicato56, è ciò da cui Michele si deve progressivamente liberare. Una madre castrante, la seduttività di un femminile che lo ammalia e lo strega (da Rina ad Elena), l’ancoraggio doloroso ad uno sguardo-voyeur che scopre e rimane segnato dall’abbraccio tra la sua ragazza e il fratello, la rivalità atroce con quest’ultimo (immagine di una virilità vincente), il sospetto e la sensazione di essere continuamente spiato, bloccano la sua trasformazione, e il suo io cade in frantumi; ricomponendo i quali dice (senza che si vedano riscontri) di essere guarito, «tornato alla vita una seconda volta». Ma questa rinascita, questo partorirsi da sé e accedere alla luce, che definiscono la lotta per una individuazione e singolarizzazione sono sempre sottoposti al rischio di fallire, perché sono frutto di una battaglia durissima: Se si definisce l’individualità partendo dal negativo essa è ciò che ci distingue da “gli altri”. In questo senso essa è anche l’anormale, l’insolito, il mostruoso. Così – da questo punto di vista – l’individualità diventa un valore negativo. Ma questo è realmente uno stadio di trapasso nello sviluppo di una “personalità” […]. È la fuga nel deserto, il viaggio verso l’isola, l’isolamento (da ogni riconoscimento e apprezzamento interno ed esterno). I due grandi pericoli in agguato sono qui la crocifissione da parte della “moltitudine” o
56
Geheimnis der Goldenen Blüte”, in R. Wilhelm, C.G. Jung, Das Geheimnis der Goldenen Blüte. Ein chinesisches Lebensbuch, Dornverlag, München 1929]. Di Ernst Bernhard, che muore tra l’altro un anno prima dell’uscita del film, è messa all’inizio una citazione: «Non nascondere le tue piaghe agli occhi tuoi e degli altri poiché verranno a cancrena e sarà la morte. Esponile piuttosto alla luce del sole e sarà la salute».
120
Lessico del cinema italiano
la follia. Solo chi si espone a questi due pericoli e vince, ha in sorte “l’individuazione”57.
La solitudine, che come stadio mediano di un processo dialettico dovrebbe permettere al soggetto, distintosi dalla “moltitudine”, di potervi ritornare con una identità più consolidata, può farlo precipitare però nell’autoreferenzialità totale e dunque nella follia. Ed è quest’ultimo il rischio che corre Michele: precipitare nella follia. Ma questo viaggio conoscitivo del soggetto, isolato dal mondo, nella propria anima, è astratto, e non misura il fatto che il processo di individuazione porta costantemente con sé quella “moltitudine” (il «transindividuale» di Simondon58) che lo tiene sempre aperto e ne orienta dinamica e continuità. Non è in uno scavo nel sé che l’io si chiarisce, non è secondo una mera istanza conoscitiva che il soggetto supera lo stallo. Non è isolandosi dagli altri, ai quali Michele è di fatto sempre legato attraverso lo sguardo (che indirizza alle donne amate, alla madre temuta, al fratello invidiato, all’amico sospettato), in una introspezione che metta insieme i frammenti della coscienza, che si può arrivare a “identificarsi”. È solo nel “fuori” che il “dentro” si può ritrovare, è nel mondo e attraverso gli altri che una individuazione è pensabile e possibile. L’alternanza tra la vicinanza degli altri, tenuti insieme attraverso i primi piani di volti e corpi, e l’isolamento totale, dove il volto di Michele si fa, secondo una efficace espressione di Moravia, «volto-ambiente», segno della «pura soggettività»59 che è in gioco, è un’alternanza che dovrebbe portare dall’oscurità alla chiarezza, ma il cui percorso resta di fatto irrisolto. Lo specchio nel quale si riflette la coscienza di Michele è uno specchio rotto e tale resta, anche quando l’«ombra della famiglia» non c’è più e ne rimangono i ricordi. E quando questi ultimi ci fanno comprendere le ragioni dello stallo, questa comprensione rimane troppo astratta, il soggetto troppo solo, 57 58
59
E. Bernhard, Mitobiografia, Adelphi, Milano 1969, p. 100. G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, a cura di P. Virno, DeriveApprodi, Roma 2006 [ed. or. L’Individuation psychique et collective: à la lumière des notions de forme, information, potentiel et métastabilité, Aubier, Paris 1989]. A. Moravia, Cinema italiano. Recensioni e interventi 1933-1990, Bompiani, Milano 2000, pp. 633-636.
Identità Roberto De Gaetano
121
ancora incerto e spaventato, come “inchiodato” al tronco d’albero a cui si appoggia nell’immagine che chiude il film. L’originalità di Un uomo a metà rispetto alla tradizione cinematografica italiana (risuonano modelli di cinema europeo, da Bergman a Resnais) ne mostra anche il limite, in uno scavo di sé, attraverso un’“auto-percezione”, che toglie le “ombre” ma lascia luci inquietanti, misteriose o accecanti, perché lo «spazio tutto interiore nel quale si svolge la vicenda»60 non mette in condizione il soggetto di riallacciare effettivamente i rapporti con il mondo. Il film si limita alla riconsegna di una «identità soggettiva», nel tentativo di risolvere, debolmente, nell’«autocoscienza in quanto autodescrivibilità»61 la questione dell’identità. Diversa la situazione di un film di qualche anno precedente, di un grande autore il cui legame con la psicoanalisi junghiana dello stesso Bernhard era forte, essendone stato tra l’altro paziente. Parliamo di Fellini e di 8 ½ (1963). Qui la crisi di identità, le incertezze, le nevrosi di un regista quarantenne non assumono nessun processo di “interiorizzazione”, esattamente l’opposto. Tutto il mondo interiore, l’insieme di fantasie, ricordi, desideri, paure, ispirazioni, persone che popolano la vita di Guido (Marcello Mastroianni), viene proiettato in un “fuori” e reso spettacolare, secondo modi che appartengono ad un’imagerie onirico-fantastica, di un grottesco popolare: la «gran quantità di donna»62 della Saraghina, i contriti preti che esorcizzano il diavolo, l’ingenua e stupida amante, l’intelligente e sofisticata moglie, e tutto quello che finisce nel carnevale finale, in un girotondo dove non ci sono più spettatori ma solo attori. Il sì alla vita, il sentimento di accettazione del caos dell’esistenza da parte di Guido, perché «la vita è una festa, viviamola insieme», è tanto più potente in quanto non assume un carattere astratto ma si concretizza in uno “spettacolo” capace di riscattare la confusione delle cose. Il mondo interiore di Guido (e di Fellini) si “oggettivizza” in un mondo esterno che viene investito da una potente visionarietà, dove il punto di vista di un uomo e di un artista rifluisce nel mondo e lo trasforma in spettacolo. La di60 61 62
Ivi, p. 635. G. Jervis, Il mito dell’interiorità. Tra psicologia e filosofia, Bollati Boringhieri, Torino 2011, p. 128. F. Fellini, Fare un film, Einaudi, Torino 1980, p. 83.
122
Lessico del cinema italiano
stinzione fra soggettivo ed oggettivo perde di senso, l’intensificarsi dell’«identità soggettiva» si ribalta nel massimo dell’oggettività e tutto riprende vita nel girotondo finale. Lo scarto con il film di De Seta di tre anni successivo è decisivo su un punto: il film di Fellini risolve la crisi umana e creativa di un artista con un atto di fiducia nel mondo, un sì alla vita così com’è, che significa accettazione di sé e del mondo senza che questo passi per un processo conoscitivo. Guido non chiarisce nulla a se stesso, come crede di fare il Michele di Un uomo a metà, ma accetta quella confusione da cui è abitato, perché è la vita. E le impasse, i tradimenti, le bugie, le indecisioni, quella serie di figure che lo circondano, che lo attraggono e lo respingono, vanno accettate senza pretendere di conoscerle e tantomeno di chiarirle. Sarà un baluginio imprevisto e non un progresso conoscitivo a far riemergere la vita: «Che cos’è questo lampo di felicità che mi dà forza, vita» dice Guido poco prima del girotondo. Il girotondo finale di 8 ½ non è altro che questo: la vita e un’identità affermate non nonostante tutto quello che è accaduto, ma proprio per quello che è accaduto. La vita non può essere trascesa se non attraverso la sua immanenza e dunque affermata in tutta la sua follia. Ma a Fellini e al suo Casanova (1976) dobbiamo l’immagine di una delle grandi figure, dopo Don Giovanni (e insieme ad Amleto, Don Chisciotte, Faust), della modernità europea in cui, crollata letteralmente la maschera, che ad inizio film si inabissa nella laguna di Venezia durante la festa di Carnevale, al soggetto non resta che passare da una donna all’altra come da un oggetto all’altro, da un feticcio all’altro. Il tutto ritmato dall’uccello meccanico che scandisce gli accoppiamenti, anche quello con la bambola semovente, il ballo con la quale chiude il film nel ricordo nostalgico di un Casanova oramai vecchio. Nella ripetizione meccanica degli amplessi, nel succedersi del sempre uguale, l’esperienza si nega e si sottrae nel momento del suo apparente farsi e differenziarsi. Il romanzesco felliniano, contaminato da elementi di commedia, ha saputo percorrere tutte le forme di una osmosi tra soggetto e mondo, quest’ultimo inteso come precipitato di cliché, stereotipi, modi di vita, depositi di un immaginario mediatico (fotoromanzi, stampa, cinema, televisione), e il primo come ipertrofico universo immaginario, composto di ricordi e fantasie. Il loro appaiamento definisce una delle forme più radicali nella nostra tradi-
Identità Roberto De Gaetano
123
zione cinematografica e culturale di cancellazione di ogni confine possibile tra l’interno e l’esterno: il primo essendo fin dall’inizio estroflesso nel mondo, il secondo immaginato sempre come proiezione del primo. 5. L’io come memoria Identità è memoria. Ciò che siamo è ciò che siamo stati e ciò che abbiamo fatto, ma solo in quanto la nostra coscienza può estendersi a tale passato, fino a lì ci dice Locke può giungere l’identità di una persona63. Ma se questo legame si interrompe? Se la nostra memoria si sfalda? Se non ricordiamo più chi siamo? Allora le cose si complicano, e il presente non diventa più la contrazione di un tempo passato e l’apertura (eventuale) di uno futuro, ma un ora senza più spessore, o meglio dove lo spessore è affidato allo sguardo e alla parola altrui. Accade così a Totò, in Lo smemorato di Collegno (1962), soggetto senza memoria e senza identità, che fugge da un ospedale psichiatrico e chiede a chi incontra l’attribuzione di una identità, un nome proprio e una storia che lo identifichino. E naturalmente qui Totò si trova ad essere una sorta di foglio bianco, “scritto” da chi lo abborda e lo usa per soddisfare i propri interessi: da un lato una donna (Yvonne Sanson) che lo fa passare per suo coniuge per non mettere a repentaglio l’eredità, rivendicata dai fratelli del vero marito scomparso da molto tempo; dall’altro un ladro che lo ricatta, accusandolo di aver rubato insieme a lui. Insomma, rovesciando dall’interno il gioco di maschere tipico della commedia, il film di Corbucci, fondato su una storia vera, racconta di come l’identità, collocata all’incrocio tra una maschera (dinamica sociale) e una storia (dimensione temporale), è lontana da ogni ipotetica medesimezza (idem) per ritrovarsi frutto di una proiezione sociale, che qui viene letteralmente esposta nelle forme fraudolente di attribuzioni false. In Palombella rossa (1989) di Moretti, il trauma di un incidente che occorre al parlamentare comunista diventa metafora di una 63
J. Locke, Saggio sull’intelletto umano, Laterza, Roma-Bari 2011, cap. XXVII [ed. or. An Essay Concerning Human Understanding, 1690].
124
Lessico del cinema italiano
crisi di identità più generale, crisi esistenziale e politica di un’intera società e di un partito. La perdita di memoria qui non azzera la dimensione psicosociale del soggetto come in Lo smemorato di Collegno, facendone uno schermo di proiezione del desiderio altrui. Il trauma dell’identità qui riguarda in primo luogo il tracollo di un mondo, quello comunista, il suo dissolversi, il tramontare del “sol dell’avvenire” che chiude il film; ma anche il dissolversi con tale crollo delle forme istitutive del vivere insieme, a partire dal linguaggio, disseminato di cliché e frasi fatte che lo alienano da ogni presenza “soggettiva” e da ogni istanza veritativa. La saldatura tra perdita della memoria e crisi di identità riguarda qui un aspetto socio-politico: l’azzeramento di valori, credenze, pratiche, istituzioni, che prende anche la forma di una loro restituzione stereotipica, porta il soggetto ad una vita senza più orizzonte, che significa anche senza più passato. L’ammollo nel liquido “amniotico” di una piscina in cui circolano motivi d’infanzia, elementi pubblicitari, figure di una cronaca sociale e politica trasformate in maschere, diventa ciò che riempie il vuoto lasciato dal trauma, ciò che resta quando il futuro si è azzerato. Radicalizzato, il discorso assume questo aspetto: il trauma diventa occasione per giustificare la regressione nell’“ammollo” quando l’orizzonte si è dissolto. L’entrata in uno spazio-tempo fuori dall’ordinario (la piscina, la partita, il pubblico) individua una fluidità “intemporale” che protegge dall’elisione del presente per cancellazione del futuro e del passato; protegge dal vuoto di una restituzione stereotipata dell’attualità, come emerge durante la trasmissione televisiva in cui il politico converte una parola che sente sempre più priva di senso in una canzone di Battiato. Ora, quando l’essere in comune del linguaggio si trasforma nella circolazione infinita di cliché, che vanno oltre la cristallizzazione del senso nell’“ovvio”, che in quanto tale consente comunque una comprensione immediata anche se semplificata, allora il “noi” diventa lo spazio di smarrimento dell’“io”, che si salda e si ritrova solo in forma regressiva. Cancellazione della memoria significa cancellazione del passato, ma anche del futuro, perché quest’ultimo è tale solo a condizione che un passato (il depositarsi di una esperienza) lo possa aprire; significa cancellazione del linguaggio o sua riduzione a insieme di sofismi e cliché. Tant’è che il tracollo di ogni tenuta nel rapporto con il mondo, il segno di un trauma o di una crisi profonda, passa
Identità Roberto De Gaetano
125
per l’inibizione dell’atto di parola: la ragazza di Ecce bombo (1978), chiusa nel suo mutismo doloroso e patologico, o, più di recente, la bambina che smette di parlare in L’uomo che verrà (2009) di Diritti, in seguito al trauma della visione della morte del fratello durante l’eccidio nazista64. Ma la memoria è anche quella bloccata dal trauma, che non si scioglie, fatta oggetto di rimozione, che vincola il soggetto ad una ripetizione, privandolo di ogni libertà. In L’amore molesto (1995) di Martone, Delia (Anna Bonaiuto) torna a Napoli in seguito alla morte della madre Amalia, archiviata dalla polizia come suicidio. Il suo viaggio nel passato della madre è anche, e soprattutto, un viaggio nel suo proprio passato, fino a scoprire il trauma rimosso, la molestia subita. Ma questa scoperta arriva attraverso un processo identificativo con chi l’ha generata. Da bambina Delia aveva “confuso” se stessa con la madre, accusando quest’ultima di tradire il marito con un altro uomo, rimuovendo così la violenza subita, e causando le violenze del marito geloso. La scoperta della verità arriva nel finale, quando Delia indossando i panni della madre rivede la scena in cantina con l’arrivo dell’uomo, ma al posto della madre immaginata allora, ora vede lei. Con questo risalimento memoriale al fondo del rimosso, Delia trova la sua verità e anche quella della madre, “attribuendo” così due identità65. E in questo risalimento che porta Delia a identificarsi completamente con la madre, “prendendosi” anche il suo nome, vediamo all’opera un contro-movimento rispetto a quello melodrammatico: l’identificazione totale con la madre morta qui non è risalimento mortifero della linea generativa della vita, tutt’altro; il ritorno indietro di Delia è la condizione per poter fare un passo avanti ed affacciarsi per la prima volta alla vita, liberata da un sorriso su cui si chiude il film. 64
65
Nelle commedie di Eduardo il tracollo del linguaggio e dei suoi usi in seguito alla crisi nel rapporto con gli altri e con il mondo è un elemento decisivo, per il modo in cui orienta teatralmente il tema della diffidenza e della sfiducia: dal farfugliamento in Natale in casa Cupiello al gioco pirotecnico in Le voci di dentro, dal mutismo di Mia famiglia a quello di Gli esami non finiscono mai. Cfr. A. Cervini, Identità. “L’amore molesto”, in Mario Martone. La scena e lo schermo, a cura di R. De Gaetano, B. Roberti, Donzelli, Roma 2013, pp. 101-108.
126
Lessico del cinema italiano
6. Individuazione senza identità L’identità negata, esposta, ritualizzata, testimonia di uno stato cangiante, inquieto, dove il gioco delle maschere diviene la forma specifica di una teatralità che si incide sul corpo vivo del soggetto. Nessuna identità forte, consegnata e suturata dalle forme dell’azione nel nostro cinema, ma solo stati instabili e processi incompiuti. Ma se fosse solo questo, ci troveremmo di fronte solo ad una problematizzazione, per quanto radicale, di una identità che non è stata mai un dato. Ma il cinema italiano ha fatto qualcosa di più, ha saputo riconsegnarci in un momento storico-sociale ben preciso, il secondo dopoguerra, qualcosa di più importante e più significativo. Ha fatto emergere con il neorealismo italiano, per la prima volta in una prospettiva universale, un processo di individuazione distinto da ogni identificazione. Quel bisogno «di riconoscerci e di individuarci», di cui parla Rossellini, liberando l’individuazione da ogni identità di popolo, di nazione, di classe, risponde all’esigenza di ritrovamento di un’“umanità” al di fuori di ogni cornice sociale. Ma cos’è questa umanità che passa attraverso le macerie materiali e spirituali? Nel primo episodio, quello siciliano, di Paisà (1946), una giovane ragazza viene presa da una sparuta pattuglia di soldati americani. Lasciata con uno di loro, tra le rovine turrite di fronte al mare, lentamente trasforma la sua diffidenza e sospettosità in apertura e disponibilità, che la simpatia del soldato (mima tutto ciò che deve dirle, perché la distanza linguistica è insormontabile) riesce a farle scattare; tant’è che quando lo trova ucciso dai tedeschi, che li avevano scoperti, imbraccia il fucile e si fa uccidere. Una motivata diffidenza iniziale nei confronti di quel soldato straniero si ribalta imprevedibilmente, nel giro di poche ore passate insieme (che trasformano una situazione bellica in un contesto romantico, con la luna che si riflette sul mare ecc.), in una simpatia ed attrazione che portano la ragazza a farsi uccidere. Ciò significa che in un contesto disgregato, lacerato, senza punti di appoggio e di forza, dove il quotidiano si è fatto estraneo (per la ragazza) o da tempo inesistente (per il soldato americano), la vita emerge nel punto inaspettato, nell’incontro fra eterogenei non traducibile in relazione sociale, ma che proprio in questo impedimento,
Identità Roberto De Gaetano
127
che determina una distanza, è possibile trovare la condizione di una prossimità; quella di una umanità che nello smarrimento di una condizione di vita riesce a ritrovarsi nel desiderio di un incontro, in cui la vita si sottrae alla sua erranza dispersiva e caotica, ad un abbandono che sembra irriscattabile, e prende la forma di una promessa (inaspettata) di felicità. È in questa promessa che il soggetto si individua senza identificarsi, trasformando l’alea di un breve incontro in qualcosa a cui sente di non poter che corrispondere. Qui l’identità non è né quella granitica (di fatto mai esistita nella nostra tradizione, se non sotto forma di maschera), né quella modulabile (segnata dalla temporalità dell’esperienza), ma è ciò che emerge nell’ecceità dell’incontro, sciolta dalla temporalità continua e che in tutta la sua singolarità radicale fa emergere, per la prima volta nel cinema, il soggetto come ciò che si ritrova in questa emersione contingente (che poteva non essere, o poteva essere altrimenti). André Bazin in alcune pagine note, ma non sempre colte nella loro radicale innovatività, sottolinea come la forza, anche politica, di un film come Ladri di biciclette risieda nell’aver utilizzato il modo della contingenza come dispositivo centrale di costruzione del film: Un film di propaganda cercherebbe di dimostrarci che l’operaio non può ritrovare la sua bicicletta e che è necessariamente preso nel cerchio infernale della sua povertà. De Sica si limita a mostrarci che l’operaio può non ritrovare la sua bicicletta e che perciò tornerà senza dubbio ad essere disoccupato. Ma come non accorgersi che è il carattere accidentale della sceneggiatura a fare la necessità della tesi laddove il minimo dubbio sulla necessità degli avvenimenti in una sceneggiatura di propaganda renderebbe la tesi ipotetica66.
Quello che qui è in gioco è l’idea che la forza del film si ritrova nel restituirci (anche attraverso una sceneggiatura accuratamente scritta) il senso del possibile, e dunque dell’occorrere casuale degli avvenimenti (svincolati da ogni necessità), che definiscono l’individuazione instabile di un soggetto. Se il bambino diventerà grande nel finale, raccogliendo il cappello del padre umiliato, è perché quel bambino era potenzialmente già un adulto (come 66
A. Bazin, Che cosa è il cinema?, Garzanti, Milano 1973, p. 308 [ed. or. Qu’est-ce que le cinéma?, Éditions du Cerf, Paris 1958-1962].
128
Lessico del cinema italiano
vediamo all’inizio del film, quando chiude la finestra per non far prendere freddo al fratellino). Questa potenza si attualizza in seguito ad incontri, capaci di trasformare il soggetto e renderlo esattamente ciò che è: effetto di una serie di contingenze, che lo hanno cambiato. Se il neorealismo è l’«arte degli incontri», come Deleuze ci ha detto, è perché l’incontro è il modo d’essere della contingenza (contrapposto all’azione, che risponde alla volontà), ed è ciò che definisce l’esposizione del soggetto ad un “fuori” imprevedibile. Tramite l’incontro e l’emergere della contingenza, che implica la disponibilità del personaggio ad accoglierla, vediamo entrare dunque con grande forza nel cinema l’immagine della potenza, che è possibilità di essere in quanto è anche possibilità di non essere. La possibilità si incarna dunque pienamente nel contingente, e quest’ultimo trova negli incontri il suo segno generativo. Il soggetto che deriva da tutto questo esclude ogni identificazione sia di tipo statico che dinamico, ogni adesione a un insieme di valori (individuali, sociali, nazionali), ogni presa in carico (anche critica) dell’esperienza. Niente di tutto questo: il neorealismo costruisce per la prima volta un’immagine dove sono gli eventi singolari, impersonali, gli incontri tra eterogenei, lontani da ogni idea di persona/maschera (impossibile per esempio in un film come Paisà), che fanno accedere ad una individuazione lontana da ogni identità, e dunque al fondo lontana da ogni dialettica attivo-passivo. Quando Bazin parla per Umberto D. dell’incontro della servetta in cucina, dopo aver scacciato le formiche e preparato il caffè, con il suo ventre gravido, non racconta tanto la presa di coscienza di un problema quanto l’incontro di uno sguardo e di un corpo da cui nasce un effetto di pathos (le lacrime): è questo sentire che incarna l’essere transitorio (cioè senza sviluppo) del soggetto. Così come nel finale lo scodinzolare del cane davanti ad Umberto devia imprevedibilmente la sua volontà di suicidio. Il soggetto qui non prende coscienza, non si fa persona (e dunque non indossa maschera), ma il suo stato di debolezza sociale crea le condizioni per farlo emergere per quello che è: un mero composto di incontri aleatori, che in quanto tali definiscono quella singolare modalità di individuazione che è l’“umanità” neorealista, un’umanità senza umanesimo, senza identità e uniforme, composta di intensità emotive.
Identità Roberto De Gaetano
129
Ma abbiamo un altro esempio di questi incontri “emotivi”, è il finale di Le notti di Cabiria (1957), quando «Cabiria, spogliata di tutto, del suo denaro, del suo amore, della sua fede, si ritrova, svuotata di se stessa, su una strada senza speranza. Appare un gruppo di ragazzi e ragazze che cantano e ballano camminando, e Cabiria, dal fondo del suo nulla, risale dolcemente verso la vita; ricomincia a sorridere e un po’ a ballare»67. È di nuovo un incontro aleatorio a collocare il soggetto su una linea di vita piuttosto che su un’altra, senza ragioni particolari e senza cambiamenti della situazione. È una sorta di evento meteorologicamente favorevole che accade (senza modificare nulla dal punto di vista della logica della storia) e che definisce il soggetto come colui che, dalla marginalità di una posizione sociale, sa corrispondervi, lontano da ogni processo di identificazione. Tant’è che quest’incontro si ripete nell’immagine finale e riguarda lo spettatore, quando Cabiria «si volta verso la macchina da presa e il suo sguardo incrocia il nostro […]. Ma il fine ultimo di questo tocco di regia, e quel che mi fa gridare al genio, è che lo sguardo di Cabiria passa più volte sull’obiettivo della macchina da presa senza mai esattamente fermarvisi. La sala si riaccende su questa meravigliosa ambiguità»68. Questo incontro con lo spettatore, che spezza ogni ordine illusorio e finzionale, non è il contrassegno di una interpellazione veritativa, ma quello di un contatto ambivalente, che è uno dei grandi segni di composizione della nuova immagine coniata dal cinema italiano69. Ora, la «meravigliosa ambiguità» dello sguardo di Cabiria non è altro che un effetto di eventi singolari che sostituiscono l’azione («il primato dell’avvenimento sull’intrigo»70) e conducono la narrazione verso un’ambivalenza capace di restituire tutta l’opacità del reale. Una sequenza centrale di Ladri di biciclette, quella in cui Antonio Ricci crede di aver individuato il 67 68 69
70
Ivi, p. 333. Ibidem. «La stagione neorealista ha definito una diversa maniera di partecipare al cinema e di entrare in contatto con la pellicola. Lo spettatore non era più un ricettore passivo, piuttosto sembrava scivolare nelle ombre delle scene, penetrare – quasi – nel grande schermo. Era come stare in teatro. La stessa cosa non avvenne in letteratura. Fu un miracolo che si compì per immagini», A. Camilleri, Il mio amico cinema, in “Micromega”, n. 6 (2011), p. 12. A. Bazin, Che cosa è il cinema?, cit., p. 331.
130
Lessico del cinema italiano
ladro, testimonia tutto questo con evidenza. All’inizio crediamo anche noi che quel ragazzo incontrato per le strade di Roma sia il ladro. Poi, man mano che andiamo avanti, ci accorgiamo che le nostre certezze iniziali, come quelle di Antonio Ricci, vacillano, e quel ragazzo difeso dagli amici del quartiere non ci sembra più “sicuramente” colpevole. Il ragazzo rivendica la sua innocenza e viene colpito da una crisi epilettica, che non sappiamo se sia vera o simulata. L’effetto straordinario di questa situazione risiede tutto nella sua indecidibilità, che sospende ogni certezza conoscitiva e ogni credenza (sospensione impossibile da pensare nel cinema classico): non sappiamo e non sapremo mai come stanno le cose. Indecidibilità che tiene insieme personaggio e spettatore. Gli incontri che fa il personaggio sono gli stessi che facciamo noi attraverso lo sguardo della macchina da presa (che sta-con il personaggio71), condividendo l’opacità di una esperienza che non può rendersi trasparente. Il personaggio intercede per l’autore, il cui sguardo incontra il mondo attraverso quello del personaggio. Il risultato di questo incontro con il mondo di personaggio ed autore, questo essere-insieme dello sguardo, si può sintetizzare nelle due famose formule coniate per pensare l’immagine neorealista, quella di «immagine-fatto» (Bazin) e quella di «immagine ottico-sonora pura» (Deleuze), che individuano entrambe, ferme restando le loro differenze, la sospensione del movimento orizzontale e narrativo delle immagini e il loro farsi evento allo sguardo di chi le osserva. L’immagine si fa evento concatenandosi con uno sguardo senza mobilità narrativa, e il soggetto è colui che abita questo concatenamento. Zavattini ha coniato una espressione efficace che sintetizza tutto questo con l’idea di “restare nella scena”: «Mentre prima il cinema da un fatto ne faceva nascere un altro, poi un altro ancora, e ogni scena era fatta e pensata per essere subito abbandonata […] oggi, pensata una scena, sentiamo il bisogno di “restare” in quella scena poiché sappiamo che ha in sé tutte le possibilità di echeggiare lontanissimamente»72. Questa sospensione, questo restare, questa interruzione del concatenamento senso-motorio, questo circuito per cui una situa71 72
G. Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 92. C. Zavattini, Polemica col mio tempo, Bompiani, Milano 1997, p. 79.
Identità Roberto De Gaetano
131
zione si fa evento incontrando lo sguardo dello spettatore, e dunque diviene scena, è ciò che fa emergere la potenza inscritta nella situazione e nel soggetto ad essa concatenato. Quello che comunemente si è detto sulla scomparsa della storia, della recitazione, della messa in scena nel cinema neorealista, non risponde che a questa scoperta radicale: a certe condizioni, cioè in una situazione storica ben determinata, senza più illusioni individuali e sociali, il soggetto diviene un composto di singolarità evenemenziali segnate da una intensità che disfa ogni identità, sia essa pensata sotto il profilo dell’attività dell’io che della passività del sé. Ora, ciò che inventa il neorealismo è la potenza di una individuazione senza identità, per cui il personaggio è segnato da quei “fenomeni naturali” che sono gli incontri che fa: «Egli [il personaggio] non evolve, si converte, oscillando, alla fine, come gli iceberg il cui centro di galleggiamento si è invisibilmente spostato»73. Dunque, l’avventura del cinema moderno che il neorealismo avvia, e che poi nella tradizione italiana è proseguita con la cosiddetta crisi del soggetto nel cinema degli anni sessanta, è l’avventura che liquida e destituisce ogni idea identitaria e “personalistica”, fino a dissolverla negli “spazi vuoti” di Antonioni, nelle “scene” di Fellini o nella radicalità dei “feticci” di Ferreri. E il grande impatto del cinema neorealista è legato al fatto che per la prima volta ha messo in immagine l’evento, cioè l’accadimento singolare che sospende l’ordine logico e causale del mondo, regolato dall’azione, e determina un intervallo nell’ordine delle cose, abitato da un soggetto che diviene effetto di quell’evento, e che non si pone a nessun titolo un problema di identità e di controllo dell’esperienza. L’erranza e la veggenza di cui parla Deleuze definiscono propriamente le condizioni di presenza di un soggetto, che diviene ciò che vede ed incontra, costituendo con questo una zona di indiscernibilità e indistinzione. L’incontro visivo con qualcosa di intenso e di forte porta il soggetto ad essere toccato e colpito, talvolta fino alla caduta e alla morte (Pina in Roma città aperta, Edmund in Germania anno zero), sempre fino all’alterazione dello stato d’animo (la grotta della miseria nell’episodio napoletano di 73
A. Bazin, Che cosa è il cinema?, cit., p. 332.
132
Lessico del cinema italiano
Paisà, la visione allucinata della bicicletta nel finale di Ladri di biciclette, la mattanza dei tonni in Stromboli, gli operai come “condannati” in Europa ’51). Certo, in questo, Rossellini ha giocato un ruolo di radicale innovazione, disfacendosi nella forma più radicale dei modelli drammaturgici tradizionali, presenti ancora nel “melodrammatico” di Visconti o nella “teatralità” di De Sica. Ed è Rossellini che conduce e realizza la dissoluzione più radicale di ogni identità “personalistica”, consegnando poi tutto questo nelle mani di Antonioni e Fellini. Per il primo, il personaggio scompare in uno spazio totalmente svuotato (sia insulare, L’avventura, che urbano, L’eclisse), per il secondo, il personaggio entra nella scena, diventa egli stesso spettacolo (come nel finale di 8 ½). E qui c’è la linea di una modernità “romanzesca” che, avviata dal neorealismo74, ha segnato buona parte del cinema europeo moderno (dalla Nouvelle Vague al Nuovo cinema tedesco), arrivando nel nostro cinema a film come Il ladro di bambini, dove il personaggio del carabiniere, incontrando i due bambini, cambia programma, e si “perde” in un paesaggio del Sud per molti versi inedito; o al primo episodio di Caro diario, In vespa, dove lo sguardo si perde e diviene l’oggetto guardato, gli appartamenti vuoti di una Roma estiva attraversata in vespa. Il neorealismo è stato questo, e le macerie sono state solo la precondizione per la liberazione dello sguardo su un mondo che, senza ossatura, ha reso possibile far nascere gli eventi, e cioè gli incontri (straordinari nella loro ordinarietà), e ha fatto del soggetto, non più vincolato all’azione, l’effetto di questi eventi (da dove il potenziale carattere patetico dell’immagine neorealista) e colui in grado di corrispondergli (da dove il carattere etico). L’immagine neorealista, forse la prima immagine individuata (composta di singolarità differenziate ma non identificate75) del cinema, è quella che ha dato vita al più potente processo di individuazione di un soggetto e di una collettività, in definitiva di un intero popolo (come ci ha detto Godard nelle Histoire(s) du cinéma). E tutto questo è finito sotto il termine-ombrello di realismo, che 74 75
Ancora una volta è anticipatrice l’intuizione baziniana sui rapporti tra neorealismo e grande tradizione del romanzo americano (Faulkner, Dos Passos ecc.). Di cui la palude del delta del Po di Paisà, il confine inassegnabile fra acqua e cielo, è un’immagine icastica.
Identità Roberto De Gaetano
133
ha significato molto, forse troppo, ma che di fatto ha riguardato l’idea che l’immagine avesse a che fare con qualcosa di non immediatamente rappresentativo, così come il soggetto con qualcosa di non immediatamente traducibile né nell’oggettività della maschera né nell’interiorità di un’anima. Se il lavoro della maschera, così centrale nella nostra tradizione, ha incarnato una linea della modernità italiana tesa a problematizzare l’identità, oltrepassandola in una direzione che ne superasse la plasticità mimetica verso una pendenza istrionico-camaleontica, o verso una rigida e ingessata, il processo di individuazione, avviato dal neorealismo, ha posto la questione ad un livello preliminare, che concerne un piano di composizione di accadimenti (incontri e soggetti) prima che si inscrivano in una dimensione sociale. Il neorealismo ha dato vita alla modernità europea, collocandosi in un punto di svolta decisivo nella storia delle forme cinematografiche, la commedia ha incarnato una modernità italiana, ereditata da una tradizione molto antica: in entrambi i casi la saldatura pacifica tra io e mondo, fondata sulla determinatezza della situazione e sulla capacità del soggetto di modificarla, è mancata. L’avventura dell’identità italiana è stata un’avventura basata proprio sulla messa in questione di ogni identità, intesa sia in senso personalistico, sia in senso nazionalistico, e questa messa in questione è stato il suo contrassegno inimitabile. 7. L’identità destituita La questione dell’identità e della sua crisi, che ha trovato nei primi decenni del Novecento un suo decisivo sviluppo (saldandosi con la questione della maschera), e che a partire dal secondo dopoguerra prende una nuova fisionomia, sembra oggi progressivamente perdere di valore e scomparire, insieme alla questione stessa della maschera. O meglio, l’identità non sembra essere più un problema, non è posta sotto il segno di alcuna crisi, ma non perché si è trasformata in una solida struttura e tantomeno perché è entrata in una complessa dialettica sociale, ma perché i meccanismi di funzionamento della società contemporanea hanno destituito e sottratto importanza ai tradizionali dispositivi identificativi, riducendo in molti casi la questione dell’identi-
134
Lessico del cinema italiano
tà di una persona o alla “nuda vita”, mera individuazione di dati biometrici e genetici76, o alla “liquidità” di tessuti fisici e psichici senza alcuna tenuta. Se un’identità ridotta al “biometrico” si sottrae ad ogni dimensione estetica rientrando sotto l’egida del potere poliziesco, l’identità “liquida” porta con sé invece una nuova immagine (sia pure aberrante) del possibile. La posta in gioco oggi non è quanto mi possa identificare con valori, istanze, posizioni, maschere, esattamente il contrario: ogni principio identificativo farebbe da attrito alla capacità di sviluppare un orizzonte illimitato di possibilità, che significa anche possibilità di recedere dalle (eventuali) scelte compiute. La permanenza nell’“infanzia” come condizione emotiva e psicologica che preserva dalla possibilità di vere scelte, e che le rende comunque con facile diritto di recesso, definisce buona parte di una commedia incentrata su personaggi o staticamente bloccati, o dove l’entrata nel gioco della vita si caratterizza per l’adesione debole a modelli confusi proposti dalla società, dove possono essere presenti anche i resti delle “classi” (dopo la definitiva scomparsa dei “ceti”) e di un immaginario ad esse legato, come in Virzì (Ovosodo, Caterina va in città, My Name is Tanino); o dove troviamo come lo stato di confusione emotiva e valoriale si risolva in una spinta alla fuga, presente nei lavori di Salvatores (Marrakech Express, Turné, Mediterraneo), o in un mancarsi-ritrovarsi attraverso gli anni, come in La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo. La questione dell’identità tende a prendere anche la forma di una dinamica “debole” sia in un’adolescenza alla ricerca impossibile di un modello identificativo certo, sia in quella di una maturità inibita, che arretra l’orologio facendosi o restando “gruppo”, divisa tra opacità dei valori e dei modelli da un lato, e confusione dei desideri dall’altro, con dei finali al fondo conciliativi e di accettazione ultima della situazione77. Un esempio lo troviamo nelle commedie “scolastiche” (Notte prima degli esami, Notte prima 76 77
Cfr. G. Agamben, Identità senza persona, in Id., Nudità, Nottetempo, Roma 2009, p. 79. Sentimento lontano, per esempio, da quello doloroso che chiudeva il “gruppo” morettiano di Ecce bombo.
Identità Roberto De Gaetano
135
degli esami – Oggi, Immaturi), dove il passaggio all’età adulta o l’arretramento all’adolescenza definiscono il movimento di una identità che oscilla tra una istanza regressiva ed un adeguamento conformista all’insieme dei valori, senza che né la regressione né l’adeguamento assumano l’aspetto di una conflittualità violenta nell’io e nel suo rapporto con il mondo. Solo in pochi esempi, sia pur significativi, troviamo come l’adolescenza diventi il contrassegno di una fase critica, incerta, ma che si rende disponibile a scoperte: Corpo celeste (2011) di Alice Rohrwacher e Bellas mariposas (2012) di Mereu. La questione dell’identità torna esplicitamente tematizzata in alcuni film, ma in forma macchinosa, come nella chirurgia estetica facciale di Il volto di un’altra di Corsicato o nel ritorno del morto in Mi rifaccio vivo di Rubini, o nel pirandellismo di Magnifica presenza di Ozpetek. Più interessante è quando torna sotto forma di doppio in Viva la libertà di Andò, dove l’identità di sembiante associata alla differenza di sentimento viene orientata verso una domanda che riguarda il presente della politica. Ma in gioco in questi film non c’è mai un interrogativo vero sul “chi sono io”, c’è solo il tema dell’identità truccata per truffa o interesse; o anche per ragioni sociali e culturali, quando per esempio in Vergine giurata di Laura Bispuri, Hana (Alba Rohrwacher), un’orfana albanese, decide di rinunciare alla propria femminilità e diventare Mark per una vita meno subordinata alle regole e ai dispositivi di una società maschilista. Una domanda sull’identità (individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo, di comunità), affermata in forma insistita e complessa, la ritroviamo invece in modo netto nel cinema di Nanni Moretti, dall’impossibilità di vivere che si traduce in giudizio e azione criminale (il professore di Bianca) o in fuga (il prete di La messa è finita), all’intreccio tra vita privata e dimensione pubblica, che emerge con forza in Caro diaro e Aprile, al sentimento di smarrimento che attraversa Il caimano per giungere alla crisi di identità di Habemus Papam e Mia madre. In quest’ultimo film, il confronto non è con la morte come disgrazia che irrompe in uno status quo, alterandone l’equilibrio (come accadeva in La stanza del figlio), ma con la morte come dato naturale, la cui prossimità (la malattia della madre) lascia il soggetto, incapace di accettarla, in uno stato di spaesamento e di confusione. Se nei film precedenti, Moretti
136
Lessico del cinema italiano
misurava la questione dell’identità rapportandola all’istanza simbolica del ruolo pubblico (professore, prete, politico, cardinale) e al senso di inadeguatezza che accompagnava il soggetto nel suo tentativo di ricoprirlo, Mia madre espone una crisi più radicale, che misura lo smarrimento rispetto ai sentimenti che accompagnano i momenti decisivi di una vita, come la morte della propria madre. Anche in Paolo Sorrentino troviamo gli effetti di una deriva identitaria, che portano il personaggio ad una condizione di solitudine e di crisi: da Le conseguenze dell’amore a L’amico di famiglia a This Must Be the Place (dove la crisi e il disagio si misurano con l’eclissi e il recupero della figura paterna) fino a Youth – La giovinezza, passando per La grande bellezza. In quest’ultimo film, la crisi di identità di Jep Gambardella accompagna un declino individuale, generazionale, sociale, in un mondo segnato da vecchiezza nel corpo e nell’anima, e che ha cancellato ogni rapporto con la gioventù e la sua forza. In una sorta di estetica della decadenza, il film è il racconto di un personaggio/maschera, che da un lato incarna i tratti singolari e unici di un destino di eccentricità individuale e sociale (a cui presta corpo e faccia uno straordinario Toni Servillo), dall’altro generalizza i tratti tipici e gli stili di vita di una fetta di società (radical chic) incapace di spinte vitali. Ma ciò che sembra caratterizzare il cinema italiano recente è di fatto l’elisione della questione dell’identità, del problema della maschera78, che non sembra più centrale con la sua dialettica nascondimento/rivelazione in un momento in cui tutto è affidato ad una presunta trasparenza, e la flessibilità del soggetto diventa il requisito fondamentale per un adeguamento senza attriti al mondo, o dove l’attrito è sottratto al suo potenziale drammatico. E qui abbiamo film che non si sottraggono a finali “concilianti” nel raccontare uno stato di crisi, anche profonda, del soggetto e delle istituzioni (per esempio famiglia e ospedale in Il grande cocomero); e che restituiscono lo smarrimento per una vita dove la libertà, svincolata dalla scelta, diviene incapacità di esserci, di stare sulle cose, di assumer78
Che invece è ancora presente nel recente cinema americano, dove la questione dell’identità rimane urgente e intensa e si lega alla funzione della maschera, come nel recente Birdman (2014) di Iñárritu, dove è in gioco la crisi di un attore giunto ad una presunta maturità, ma che richiede a sé e agli altri continue conferme.
Identità Roberto De Gaetano
137
si responsabilità. Incapacità che viene raccontata senza lasciarne emergere tutto il potenziale drammatico, evidenziandone semmai quello comico. In Habemus Papam il tema passa nella sua forma capovolta, cioè nell’idea di una scelta definitiva (diventare papa) dalla quale rifuggire. Se è il potere simbolico di una scelta irreversibile a spaventare Melville, è il potere dell’immaginario ad aspirare pericolosamente il protagonista di Reality (Garrone, 2012), che dal vendere il pesce passa piano piano ma inesorabilmente ad essere assorbito, fino alla follia, dalla possibilità di entrare in un reality, iniziando a partecipare alle prove di selezione. L’accostamento dei due film (rari esempi nel cinema contemporaneo italiano dove è esplicitamente presente un problema di identità) fa emergere nel modo più limpido e forte i segni attuali della crisi di identità: da un lato il crollo della cornice simbolica, che porta il soggetto ad arretrare immaginariamente il tempo alla giovinezza e al suo desiderio di diventare attore, invece di intraprendere la carriera ecclesiastica; dall’altro il crollo di una situazione e di un contesto concreti, semplici ma vitali (la teatralizzazione della vendita quotidiana del pesce in un mercato e quella messa in atto nelle piccole truffe per la vendita di un robot tuttofare in cucina), aspirati da un immaginario mediatico che intreccia successo e notorietà. In entrambi i casi, vicini nella loro distanza, il soggetto fugge o distrugge il suo rapporto con il mondo che lo circonda e con la situazione che lo definisce, perché sente il simbolico come una gabbia e vuole sottrarsi al carattere definitivo delle scelte compiute o da compiere, al destino tracciato e segnato una volta per tutte. Ma in tutto questo non c’è più la maschera (che ha accompagnato fino agli anni settanta il nostro cinema), che garantiva una sorta di interfaccia fra l’io e il mondo, li metteva in comunicazione, sia pur in forma dialettica. Qui la maschera è saltata, sostituita dal trono vuoto del papa o dall’obiettivo di una telecamera che non rimanda che alla sua vacuità: l’identità è destituita. Ma se per Melville di Habemus Papam la destituzione è letteralmente sottrazione ad un destino che si sarebbe compiuto definitivamente sotto i riflettori e sul teatro più importante (il soglio di Pietro), per Luciano di Reality il percorso è esattamente l’opposto: dall’iniziale anonimato che gli garantiva però un’integrazione piena con il mondo di riferimento (l’affetto dei familiari e dei clienti della pescheria) alla perdita di tutto questo in un movimento di deriva, che lo vede precipitare in un uno stato ca-
138
Lessico del cinema italiano
tatonico, posto davanti ad un televisore che trasmette un “Grande Fratello” da cui lui è assente, come diventa progressivamente assente a se stesso. Lo sguardo di Garrone accompagna lateralmente il muoversi del personaggio, lo affianca e ne coglie la progressiva perdita di identità, che non prende più la forma teatrale e carnevalesca del suo abituale travestirsi da “vecchia” durante le feste (come vediamo nella cerimonia di nozze iniziale), ma, all’opposto, quella di un uomo segnato dal sentimento paranoico di sentirsi guardato da tutti; spiato da uno sguardo attribuito a chi incontra, che lo controlla e lo giudica per riscontrarne eventuali meriti o demeriti per partecipare alla trasmissione. È in questa paranoia, sul capovolgimento totale della quale si struttura il “Grande Fratello” (l’occhio vitreo di chi guarda tutto, e di chi sapendosi guardato piuttosto che sentirsi minacciato si mette in scena), che il soggetto si cristallizza e si perde, fuoriuscendo da un orizzonte vitale che, per quanto determinato e concreto, si percepisce come limitato e soffocante. Il vuoto (galattico) nel quale rimbomba la risata che accompagna il movimento di macchina finale verso un’altezza e una distanza impossibile, lasciando Luciano lì, in quel set raggiunto comunque, ma che a questo punto diviene il set di una realtà allucinata, corrisponde al vuoto dietro la tenda rossa di un papa che non si affaccerà. Quest’ultimo è un vuoto nella tessitura del simbolico, il primo è un buco nell’immaginario: con due percorsi diversi, l’identità ci viene restituita comunque come lacerata. 8. L’identità del cinema italiano L’identità nel cinema italiano è stata anche l’identità del cinema italiano. Il cinema italiano ha cioè misurato l’evoluzione delle sue forme anche in rapporto all’immagine dell’identità che ci hanno riconsegnato. Nel processo di individuazione neorealista abbiamo visto la potenza massima di un cinema che ha saputo accedere all’impersonalità di un piano composto di singolarità («fatti» e «incontri ottico-sonori») come tratti di formazione di un soggetto mai identico a sé e in perenne divenire. Questo processo ha riguardato anche lo sguardo e il suo entrare in metamorfosi con l’oggetto visto, sia dal personaggio sia dal regista, da quest’ulti-
Identità Roberto De Gaetano
139
mo attraverso il primo e viceversa, secondo il concatenamento enunciativo della «soggettiva libera indiretta», fondativa del romanzesco cinematografico, di cui ci ha parlato Pasolini79. Questo sguardo che diviene nel mondo e in esso si dissolve, istituito dal neorealismo, lo abbiamo visto proseguire nei due grandi autori che hanno segnato la seconda modernità italiana, Antonioni e Fellini. Se il “libero indiretto”, che corrisponde da un punto vista enunciativo all’individuazione prima di ogni identificazione costituisce il tratto di più forte originalità del nostro cinema, una messa in questione dell’identità, che affonda le sue radici in tutta una tradizione teatrale e letteraria, l’abbiamo vista anche nella saldatura impossibile tra persona e maschera, che ha portato quest’ultima a svincolarsi dalla prima e a metterla in questione fino al punto di renderla irreperibile. Dagli anni trenta agli anni sessanta e oltre l’identità si è fatta, sotto la potenza del comico, perennemente instabile, sempre differita, esposta in forma pirotecnica all’interno di dinamiche sociali (anni trenta) o gonfiata, esagerata e resa “mostruosa” (anni sessanta). Da qualsiasi punto di vista si voglia vedere la cosa, l’“io” nel cinema italiano non entra mai in forma attiva nel mondo, interagendo dialetticamente con il contesto e con gli “altri”. Nessuna trascendenza valoriale o illusione lo guida, piuttosto abbiamo la presenza di un “piano monologico”, dove sguardo del personaggio e dell’autore si rendono indiscernibili e aperti al mondo: l’immagine neorealista e la sua eredità fino all’attuale emergenza dell’istanza documentaria; o dove troviamo l’indistinguibilità di personaggio e mondo, che lo sguardo dell’autore ci riconsegna in forma esagerata e grottesca: la commedia all’italiana. Nessun romanzo di formazione, semmai l’opposto (come nelle “regressioni” in Moretti), nessuna illusione epica, semmai il suo ribaltamento commedico (come in Monicelli, I compagni e La
79
Cfr. P.P. Pasolini, Empirismo eretico, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti, S. De Laude, tomo I, Mondadori, Milano 1999, pp. 14611488; G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., 167. Una esplicita enunciazione del “libero indiretto” la ritroviamo in Mia madre di Moretti, nel precetto che la regista Margherita dà agli attori, quello di stare accanto ai personaggi, e di non risolversi totalmente in loro. Cfr su questo, R. De Gaetano, Nanni Moretti. Lo smarrimento del presente, Pellegrini, Cosenza 2015, pp. 223-236.
140
Lessico del cinema italiano
grande guerra), nessuna identità solida, semmai granitica, come nel melodramma. In definitiva, la questione dell’identità nel cinema italiano è stata sempre posta sotto il segno di un divenire, che l’ha sottratta ad ogni status logico, morale, rappresentativo, ad ogni carattere distinto. Se la grandezza del cinema italiano è stata quella di essere vicino alla vita e alle forze che l’attraversano, questa vicinanza ha significato, dal punto di vista dell’identità, la messa in questione di ogni forma di rappresentazione, e delle dinamiche d’azione ad essa connesse, a vantaggio di una potenza di espressione, che ha trovato nella metamorfosi (le maschere della commedia) e nell’emergere di singolarità contingenti (romanzesco neorealista) il segno forte di individuazione.
Filmografia di riferimento Cabiria (Pastrone, 1914), La segretaria privata (Alessandrini, 1931), Camicia nera (Forzano, 1933), Il signor Max (Camerini, 1937), Malombra (Soldati, 1942), La donna della montagna (Castellani, 1944), Lo sbaglio di essere vivo (Bragaglia, 1945), Paisà (Rossellini, 1946), Il mondo vuole così (Bianchi, 1949), Siamo donne (Franciolini, Guarini, Rossellini, Visconti, Zampa, 1953), Stendalì – Suonano ancora (Mangini, 1960), Il sorpasso (Risi, 1962), Per un pugno di dollari (Leone, 1964), Io la conoscevo bene (Pietrangeli, 1965), Un uomo a metà (De Seta, 1966), Dillinger è morto (Ferreri, 1969), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Petri, 1970), Professione: reporter (Antonioni, 1975), Marcia trionfale (Bellocchio, 1976), Fantasma d’amore (Risi, 1981), Il ladro di bambini (Amelio, 1992), L’amore molesto (Martone, 1995), Le quattro volte (Frammartino, 2010), Habemus Papam (Moretti, 2011), Reality (Garrone, 2012).
F
R
LINGUA
Un ragazzo parla al cellulare con sua madre, camminando per le strade di Roma: L : (rispondendo al telefono, con marcato accento romanesco) Ma’! Come stai? Io tutto a posto. Ma dimme ’n po’, com’è ’sto Mali? Spacca, ve’? Se, io sto bene, te l’ho detto. Eh?! Se, a scola tutto a posto. Se, se, scialla, a ma’, li faccio i compiti. Co Bruno ce sto bene, è simpatico. Sì. L’apparecchio lo metto. A ma’, però ’n t’accollà! Dimme quarcosa pure te! Eh?! No, ’n vojo che torni, ma che sta’ a di’, oh! Sì, va be’, me manchi, ma n’è che... eh?! A ma’, però nun te sento. Dai, se ribbeccamo. Se. Se, ti vojo bene. Se. Ciao. Ciao. (Chiude la telefonata e poi si rivolge a un’anziana passante) Mi’ madre. S’accolla ’na cifra1.
Una moglie litiga con il marito, dopo averlo colto in flagrante adulterio: O : Ti ho visto! Ti ho visto, che la baciavi. Le davi le slinguazzate nell’orecchio. Mi fai schifo, con quella faccia da finto buono. Da imbecille, da mollusco. Con che coraggio hai potuto tradirmi, con quella faccia da protozoo! G : Che dici! Ma aspetta, fammi parlar... Ti... Ti spiego un attimo. Guarda che non è come pensi. Proprio... O : Non mentire, Gabriele! Non mentire! G : Ti prego, aspetta, posso spiegarti. Fammi parlare. Perdonami, ma certe cose possono succedere!
1
Tutti i brani filmici citati sono il frutto della mia personale trascrizione desunta dalla visione del film e non tratti dalla sceneggiatura (cfr. anche nota 16). La punteggiatura serve soltanto a restituire, al minimo indispensabile, il ritmo e l’intonazione degli enunciati. Il corsivo (oltre a contrassegnare le didascalie) mette in evidenza le forme linguisticamente rilevanti.
142
Lessico del cinema italiano
O : Amore... Amore! Amore un cazzo! Amore un cazzo! Amore un cazzo! Amore un cazzo! Adesso sai cosa faccio? Non solo non ti perdono, ma io me ne vado da qui! Faccio le valige! E vado fuori dai piedi! Perché se questa casa fosse stata mia, io ti avrei preso per quel geco che hai in mezzo alle gambe e ti avrei già buttato giù dalla tromba delle scale. Invece, siccome questa stamberga di merda te l’ha comprata quella strega di tua madre, coi soldi della pensione di quel decerebrato di tuo padre, hai capito, allora io da te non voglio niente! Niente, hai capito? Non voglio niente, di tuo! Hai capito? Lurido porco! Minchione!
Queste due scene, tratte la prima da Scialla! (2011) di Francesco Bruni, la seconda da Manuale d’amore (2005) di Giovanni Veronesi, mettono in evidenza alcune caratteristiche, antitetiche, tipiche del parlato filmico italiano, di oggi come di ieri: la ricerca del realismo, da un lato, ovvero la mimesi quasi perfetta del parlato spontaneo, così diversa da altre riproduzioni mediatiche quali quella letteraria o teatrale; la normalizzazione, e dunque in un certo senso l’antirealismo, dall’altro, ovvero l’ineludibile retaggio di quelle forme scritte (per l’appunto, letterarie e teatrali) di cui il parlato filmico è debitore, in quanto più o meno diretto discendente. Entrando nello specifico dei dati, solo quanto basta per non lasciare nella genericità le precedenti osservazioni, è facile appurare come, nel primo brano, il ragazzo (interpretato da Filippo Scicchitano) esibisca tutti gli ingredienti di un autentico parlato giovanile romano (a partire dai gergalismi: accollarsi “essere appiccicoso, invadente”; ’na cifra “molto”; ribeccarsi “rivedersi o risentirsi in un altro momento”; scialla! “rilassati!”; spaccare “essere bello, molto interessante e simili”, per non parlare dei numerosi romaneschismi fonetici, morfosintattici e lessicali) e nella fattispecie del parlato telefonico (gli enunciati brevissimi e giustapposti, le interruzioni, i cambi di progetto e i segnali fàtici di incomprensione per problemi di linea: «Sì, va be’, me manchi, ma n’è che... eh?! A ma’, però nun te sento»). Il fatto che tale elevato coefficiente realistico si riferisca a una scena telefonica è ancora più sorprendente, dal momento che la stereotipia e l’antirealismo linguistici delle telefonate sono un tratto tipico del cinema dalle origini ad epoche recenti. Viceversa, la sfuriata di Ornella (interpretata da Luciana Littizzetto) al marito mostra più d’un elemento appartenente al polo scritto piuttosto che a quello parlato, a partire dalla ricercatezza del lessico (decerebrato, mollusco, protozoo, stamberga), per ar-
Lingua Fabio Rossi
143
rivare alla sintassi complessa (con periodi bimembri tipici dello scritto argomentativo e con una perfetta consecutio temporum: «Non solo non ti perdono, ma io me ne vado da qui»; «Perché se questa casa fosse stata mia, io ti avrei preso per quel geco che hai in mezzo alle gambe e ti avrei già buttato giù dalla tromba delle scale»), alla lunghezza degli enunciati e all’assenza di esitazioni e cambi di progetto, passando per l’uso del nome proprio come allocutivo («Gabriele!»), tratto tipico della letteratura e del teatro, ma ben poco spontaneo, nel dialogo tra pari, in particolar modo in situazioni di scarso controllo, com’è il caso dei litigi. Abbiamo, non a caso, scelto questi primi due esempi da film molto vicini nel tempo, nel genere e nello stile (due commedie, non prive di qualche tratto di analisi psicologica e sociale), per far risaltare meglio la diversità delle soluzioni adottate. Nel primo, sceneggiatore e regista (che in questo caso coincidono) optano per una quasi integrale illusione di realtà, sottolineando continuamente, nel modo di parlare dei personaggi, la loro provenienza (oltre al romanesco di Luca ricordiamo almeno anche il milanese di suo padre, interpretato da Fabrizio Bentivoglio), il loro status (professori/studenti, genitori/figli) e la situazione comunicativa. Nel secondo caso, invece, senza nulla togliere alla bravura dell’interprete, il brano recitato è come se fosse solo scritto, o meglio teatrale, privo com’è di tutti quegli elementi che rendono “sporco”, traballante e ridondante il parlato faccia a faccia, specie se ad alta gradazione emotiva. Il doppio (o triplo) binario della lingua del cinema Ebbene, il cinema italiano si è sempre trovato, dalle origini ad oggi, a doversi confrontare con queste due possibili soluzioni, talora mescolandole (ora con disinvoltura, come nelle migliori commedie all’italiana, ora con estrema forzatura, come in certo neorealismo rosa), altre volte optando rigidamente per l’una o per l’altra. È il medium filmico stesso, da un lato, e la situazione storico-sociale e geografica dell’Italia, dall’altro, a indurre questo bipolarismo. La frammentazione dialettale, infatti, e la forte stratificazione sociale hanno, fin dall’epoca del muto, incoraggiato l’impiego, parco dapprima, dei regionalismi, dei gergalismi e dei popolarismi. Tale istanza realistica e plurilingue, ineludibile nella più mimetica delle arti
144
Lessico del cinema italiano
(«la lingua scritta della realtà», secondo la definizione di cinema fornita da Pier Paolo Pasolini2), è tanto più forte nel cinema italiano. Esso è improntato, per eredità letteraria, alla poetica del Vero (e ben prima del verismo: «Il santo vero mai non tradir!», vagheggiava Manzoni3), propugnata – con paradosso soltanto apparente – nelle nostre arti (in Dante non meno che in Michelangelo o Caravaggio, in Verdi non meno che in Monti, Parini o Alfieri) anche, e direi soprattutto, quando lo stile abbraccia l’armamentario retorico del travestimento (metaforico, mitologico ecc.) della realtà. D’altro canto, però, il cinema vive di pubblico e, proprio per un pubblico eterogeneo e in gran parte dialettofono come quello italiano, la ricerca di un monolinguismo, o quantomeno di una normalizzazione della varietà, diventa vitale, ai fini di un’ampia comprensibilità. Dunque l’istanza mimetica (ma anche espressionistica) è controbilanciata dalla reductio ad unum, quasi a riproporre la dialettica tra monolinguismo petrarchesco e plurilinguismo-espressionismo dantesco di continiana memoria (ma potremmo ben dirla anche dialettica stasi/movimento, o monocolore/cromatismo)4. Ad essa si aggiunga l’aspirazione a certa supposta elevatezza stilistica e all’ossequio (ai limiti dell’intento didattico) della regola grammaticale, dettata dai complessi di inferiorità di tanti cineasti. Né va trascurata la ricerca, da parte di 2
3
4
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti, S. De Laude, tomo I, Mondadori, Milano 1999, pp. 15031540. Nella medesima raccolta, Pasolini torna più volte sul tema, per esempio alle pp. 1541 sgg. A. Manzoni, In morte di Carlo Imbonati, vv. 213-214. E si confronti anche il Leopardi della Ginestra: «Nobil natura è quella / Che a sollevar s’ardisce / Gli occhi mortali incontra / Al comun fato, e che non franca lingua, / Nulla al ver detraendo, / Confessa il mal che ci fu dato in sorte, / E il basso stato e frale» (vv. 111-117). Ma il richiamo al Vero caratterizza la letteratura italiana fin dai suoi albori, non certo nel solo romanticismo, se il poeta antirealistico per antonomasia, Francesco Petrarca, dal vero si allontana nello stile e nella lingua (recalcitrando alla designazione diretta di oggetti e persone, per esempio), non certo nei contenuti e negli ideali della sua poesia: «fa che ’l Tuo vero, / qual io mi sia, per la mia lingua s’oda», «Io parlo per ver dire», «le voglie son piene / già de l’usanza pessima et antica, / del ver sempre nemica» (Italia mia, benché ’l parlar sia indarno, vv. 15-16, 63, 116-118). Cfr. G. Contini, Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi (19381968), Einaudi, Torino 1970, pp. 169-192.
Lingua Fabio Rossi
145
autori e produttori, di un supercodice espressivo in grado di far sognare gli spettatori-ascoltatori tanto quanto gli eroi di celluloide che lo parlano. Sia l’aspirazione a uno stile elevato ed esemplare (inversamente proporzionale al livello socioculturale del destinatario ideale e reale di questi testi), sia la ricerca di una lingua da eroi onirici accomunano i nostri cineasti alla gran parte degli autori paraletterari, dal fumetto al fotoromanzo, dalla letteratura d’appendice a quella di genere, passando per l’opera lirica5. Vedremo come il cinema italiano abbia sviluppato una sorta di lingua endogena, per dir così, a mero uso schermico, un codice del compromesso in grado di dare l’illusione del parlato spontaneo, senza tuttavia toccare quasi mai (almeno prima dell’ultimo trentennio) i tratti più difficilmente digeribili di quest’ultimo (dai dialettalismi estremi alla frammentazione sintattica, dalla bestemmia all’anacoluto, dal gergo alla ridondanza), fino ad arrivare, in taluni prodotti, a un vero e proprio ibridismo linguistico, una lingua creata a tavolino, inesistente nella realtà extraschermica. E del resto, anche in un cinema, come quello nostrano, da sempre recalcitrante alle sceneggiature di ferro e aperto all’improvvisazione non meno che al realismo, come trascurare il fatto che un film è per definizione un testo multimodale (ed esteticamente motivato), a più risorse semiotiche, con comunicazione a senso unico mittenti-destinatari, che nasce come scritto per poi diventare recitato (e perlopiù postsincronizzato) e che quindi ha nel suo stesso DNA il marchio dell’antirealismo, o meglio dell’antispontaneità6? 5
6
In prodotti siffatti, «il più delle volte l’elemento emergente è la letterarietà ostentata. Nei prodotti più squalificati, come il fotoromanzo, agisce una sorta di complesso di inferiorità (o di ipercorrettismo diafasico) che porta a considerare disdicevole e volgare oltre il giusto qualunque tratto parlato o informale; in altri casi è la prioritaria spinta educativa a irrigidire il controllo della scrittura, che deve configurarsi come un modello da imitare; infine quello stesso procedimento che punta all’evocazione di mondi onirici e distanti – non a caso altre etichette a disposizione sono quelle di “letteratura amena” o “d’evasione” – influisce sulla fuga dal realismo linguistico», L. Ricci, Paraletteratura. Lingua e stile dei generi di consumo, Carocci, Roma 2013, p. 18. Lo stesso accade nella quintessenziale poeticità e nell’antirealismo dell’eloquio dell’opera lirica, cui pure il linguaggio cinematografico delle origini è strettamente imparentato. Su tutte queste caratteristiche semiotiche della testualità filmica mi permetto di rimandare, una volta per tutte, a F. Rossi, Il linguaggio cinematografico, Aracne, Roma 2006, pp. 11-35 e Id., Discourse analysis of film dialogues. Ita-
146
Lessico del cinema italiano
Ecco dunque che il bipolarismo sopra evocato diventa in realtà un sistema a tre poli: il dialogo cinematografico è infatti una sorta di specchio dal potere, al contempo, riflettente (nei film più realistici e in presa diretta), deformante (in quelli comici o espressionistici) e uniformante (quasi sempre e ovunque, in presenza del doppiaggio). Nelle pagine che seguono vedremo come, seppure in modo irregolare e altalenante, nella storia del parlato filmico italiano sia stata la tendenza all’uniformità a prevalere, almeno fino ad epoca recente. Anche nelle correnti solitamente ritenute più vicine al polo della riproduzione della realtà (dal neorealismo alla commedia all’italiana) – quantomeno sul piano delle scelte registiche, della sceneggiatura e soprattutto dell’interpretazione degli attori – daremo contezza del fatto che tale riproduzione – almeno sul piano della lingua – non è mai integrale, soprattutto per quanto riguarda la resa delle varietà dialettali, ma quasi sempre tendente alla stereotipia, al bozzettismo, a soluzioni compromissorie tra lingua parlata e lingua scritta. Naturalmente non si può generalizzare: vi sono autori più inclini di altri alla riproduzione del plurilinguismo, vuoi con funzione espressionistico-deformante, vuoi con funzione metaforica: l’indecodificabilità dei dialoghi è spesso figura del caos, delle difficoltà di adattamento al mondo, dell’alienazione, dell’impossibilità di abbracciare il reale. Quel che emerge chiaramente dalla nostra panoramica è che dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso sempre più frequenti sono state le incursioni dei nostri cineasti nei terreni del multilinguismo, con l’opzione di lingue e dialetti prima raramente assurti all’onore degli schermi, dall’arabo al francoprovenzale, dal lucano alle lingue slave e Rom, dagli idiomi delle periferie campane a quelle siciliane e così via. Come si tenterà di dimostrare, tanto la spinta all’uniformità quanto quella più recente all’inscenamento del caos babelico sembrano omologhe a precise dinamiche della società e soprattutto a peculiarità del pensiero italiano.
lian comedy between linguistic realism and pragmatic non-realism, in Telecinematic Discourse. Approaches to the Language of Films and Television Series, a cura di R. Piazza, M. Bednarek, F. Rossi, John Benjamins Publishing, Amsterdam-Philadelphia 2011, pp. 21-46. Sui concetti di realtà e realismo sono fondamentali le osservazioni di M. Grande, La commedia all’italiana, a cura di O. Caldiron, Bulzoni, Roma 2003, pp. 5-18 et passim.
Lingua Fabio Rossi
147
La questione della lingua (filmica ma non solo) Come dovrebbe ormai essere chiaro, il termine lingua qui declinato va inteso, stricto sensu, come componente verbale del film, e non come linguaggio cinematografico nel suo complesso, frutto dell’intreccio di più codici (verbale, musicale, iconico), ciascuno dei quali, al proprio interno, pluristrutturato (parole scritte, dette, cantate, diegetiche o extradiegetiche; rumori o musiche, diegetiche o extradiegetiche, e, nel caso di queste ultime, più o meno evocative del senso del film e dunque più o meno ancorate alla diegesi). Soltanto per un’astrazione da laboratorio, euristicamente motivata, possiamo isolare una sola componente dalle altre, consci, tuttavia, che nel film «la colonna sonora non esiste»7, perché esiste soltanto il linguaggio cinematografico tout court. Ma diamo per acquisiti una volta per tutte tali principi semiologici. Né intendiamo qui ripercorrere le tappe della polemica tra Pier Paolo Pasolini e Christian Metz sulla linguisticità del cinema: film come lingua o come linguaggio? Con un singolo o un doppio livello articolatorio8? Qui ci interessa soltanto ripercorrere i momenti salienti della storia linguistica del cinema italiano9. Ne analizzeremo i prodotti più significativi, non soltanto perché celebri o esemplari, ma talora proprio perché unici, o rari, oppure indicativi di una tendenza o di un aspetto interessante della riproduzione schermica della realtà linguistica nazionale o regionale. Richiameremo anche alla memoria alcune tappe importanti del dibattito culturale intorno alle peculiarità del parlato cinematografico rispetto ad altre modalità espressive. E partiamo proprio da quest’ultimo aspetto, o meglio dai prodromi che condurranno alle speculazioni sulla lingua filmica: vale a dire, la questione della lingua. 7 8 9
M. Chion, La voce nel cinema, Pratiche, Parma 1991, p. 13 [ed. or. La voix au cinéma, Cahiérs du Cinéma, Editions de l’Etoile, Paris 1981]. Cfr. C. Metz, Le cinéma: langue ou langage?, in “Communications”, n. 4 (1964), pp. 52-90 e P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., pp. 1503-1540. Senza prendere in considerazione, per esigenze di spazio, salvo eccezioni, il documentario e il cortometraggio. Né considereremo, in questa sede, il caso del lessico e della fraseologia del cinema, intesi come parole o espressioni proprie dell’ambito semantico, più o meno tecnico, della filmologia del cinema nel suo complesso, per i quali si rimanda ai numerosi lavori di Sergio Raffaelli sotto citati (cfr. soprattutto nota 15).
148
Lessico del cinema italiano
Antonio Gramsci riconduceva con lucidità (nell’ultimo Quaderno 29, del 1935) ogni riflessione metalinguistica a un più generale riassetto sociologico tra «gruppi dirigenti» e il resto della nazione: Manzoniani e “classicisti”. Avevano un tipo di lingua da far prevalere. Non è giusto dire che queste discussioni siano state inutili e non abbiano lasciato tracce nella cultura moderna, anche se non molto grandi. In realtà in questo ultimo secolo la cultura unitaria si è estesa e quindi anche una lingua unitaria comune. Ma tutta la formazione storica della nazione italiana era a ritmo troppo lento. Ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale. Oggi si sono verificati diversi fenomeni che indicano una rinascita di tali quistioni: pubblicazioni del Panzini, Trabalza-Allodoli, Monelli, rubriche nei giornali, intervento delle direzioni sindacali, ecc10.
E ciò almeno a partire dal De vulgari eloquentia di Dante, atto di nascita della secolare questione della lingua. Se delle ultime battute significative di tale questione (ad opera di Pasolini, Calvino e altri) molto è stato scritto11, quasi nulla si sa invece delle penultime, di paternità, curiosamente, non di linguisti, bensì di cineasti, filmologi e cinefili. E proprio da uno di loro, il critico letterario Paolo Milano, occorre partire, per capire l’urgenza della questione linguistica nel rinnovamento filmico italiano: Che lingua, che italiano devono parlare quelle larve danzanti, quelle siluette impalpabili e frementi che sono i personaggi del Cinema? C’è il caso che la “questione della lingua”, viva e verde con tanti secoli addosso […], ottenga finalmente un paragrafo nelle estetiche dello schermo italiano? [...] 10 11
A. Gramsci, Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerretana, Einaudi, Torino 1975, p. 2346. Si tratta di una serie di interventi (da quelli sulla morte dei dialetti, a quello sul «nuovo italiano tecnologico» salutato da Pasolini, a quello sull’«antilingua» temuta da Calvino, ecc.) noti come «nuova questione della lingua», raccolti in La nuova questione della lingua, a cura di O. Parlangeli, Paideia, Brescia 1971.
Lingua Fabio Rossi
149
Che linguaggio sceglierà il Cinema, fra i molti che ogni lingua possiede? Il più semplice, il più documentario, il più legato all’esistenza spicciola e quotidiana. Qualunque altro linguaggio più sostenuto, letterario o (come si suol dire) aulico, rischierebbe d’assumere un valore artistico proprio, a tutto scapito della visione filmica, in ibrido e sterile connubio. Basta ricordare i versi di Shakespeare scanditi da Howard o dalla Shearer nel Giulietta e Romeo filmato (mentre la macchina da presa tentava di ingannare il tempo passeggiando sugli oggetti e sulle persone), per convincersi che sullo schermo si deve parlare poco, e il linguaggio di tutti i giorni. Così stando le cose, gli americani sono a cavallo. Quando si loda il dialogo dei loro film, si pensa di solito al frizzante delle battute, alla mirabile (sebbene un po’ frigida) loro tecnica della ripetizione, dell’analogia, del richiamo. Ma assai più notevole, e meglio efficace, è la lingua che i personaggi parlano: quel gergo disossato e breve che sembra fatto di ammiccamenti e di urti più che di parole, quell’inglese d’oltresponda diventato irrispettoso e pregnante. È la lingua cinematografica per eccellenza, sia detto senza complimento: cioè la lingua più lontana dalla poesia12.
La particolare sensibilità di chi – come il Milano e anche tanti sceneggiatori, dialoghisti e registi dell’epoca – ha della lingua una visione più pratica che teorica (come farsi capire e apprezzare dal grande pubblico di uno spettacolo di massa come il cinema, salvaguardando verosimiglianza, gradevolezza e funzionalità scenica?), condusse taluni, ben prima di noti glottologi, a metter a punto concetti cruciali della linguistica novecentesca quali l’italiano regionale e l’italiano dell’uso medio («la creazione di una lingua italiana di tutti i giorni», nelle parole di Milano): Ora, sarebbe tempo che anche il dialoghista cinematografico si associasse con lena e buon diritto a un’opera che si prosegue da più di un secolo, alla quale hanno contribuito e Manzoni e Verga e Pirandello, e a cui lavorano più o meno inconsapevolmente giornalisti e padri di famiglia e uomini della strada: la creazione di una lingua italiana di tutti i giorni. A che punto sta quest’opera collettiva? Un pezzo avanti, mi sembra. Intanto, i rapporti sempre più fitti fra regione e regione hanno creato una specie di fondo linguistico comune, a mezza strada fra lingua e 12
P. Milano, L’italiano del cinema, in “Cinema”, n. 49 (1938), pp. 10-11.
150
Lessico del cinema italiano
dialetto. [...] Perché questo è il problema del linguaggio cinematografico: il personaggio dello schermo deve parlare come quello che lo spettatore incontra ogni giorno a un angolo di strada, al caffè, in ufficio, in un salotto. Propongo una multa per il primo sceneggiatore che ancora una volta metterà in bocca a un personaggio di film una frase come “Ho detto loro...”. Vergogna! Sullo schermo si dice, anche al plurale e in barba alla Crusca, “gli ho detto”, e si resta in ottima compagnia, visto che Manzoni l’ha scritto tante volte. E propongo un diploma di benemerenza per quel doppiatore della Columbia che, a riscontro di non so quale vocabolo di slang americano, ha creato la parola “picchiatello”. E in genere questi “traduttori di dialogo”, benché abbiano letteralmente le sillabe contate e debbano stendere ogni frase su un letto di Procuste, azzeccano qualche volta un italiano molto più spregiudicato e fantasioso di quello di certi burocratici dialoghisti di film nostrani13.
Se lo scopo del film è quello di essere credibile e piacevole insieme, e soprattutto accessibile al più ampio pubblico possibile, gli autori debbono avere il coraggio di rinnovarsi, svecchiando la lingua. Non sfuggirà il fatto che tale invito passi per l’apprezzamento dell’esempio hollywoodiano, proprio negli anni che anticipano il conflitto antiamericano. Ma a queste contraddizioni il cinema italiano è ben avvezzo, dal momento che tra i principali estimatori del cinema d’oltreoceano e tra i fautori del ritorno al realismo c’è proprio il figlio del duce, Vittorio Mussolini, direttore della rivista “Cinema”. E, per tornare a Gramsci (fascisti sono anche gli esempi grammaticali e lessicali da lui addotti: Panzini, Trabalza-Allodoli e Monelli), si tratta pur sempre di «riorganizzare l’egemonia culturale» tramite il mezzo di maggior impatto sul pubblico. Lo stesso già citato Allodoli, critico letterario, giornalista e grammatico, guarda caso userà proprio l’esempio del cinema, per 13
Ibidem. Sui concetti di italiano regionale e italiano dell’uso medio cfr. almeno, rispettivamente, M.A. Cortelazzo, Dialetto, italiano regionale, italiano popolare, in AA.VV., Lingua sistemi letterari comunicazione sociale, Cleup, Padova 1977, pp. 71-89 e F. Sabatini, L’“italiano dell’uso medio”: una realtà tra le varietà linguistiche italiane, in Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, a cura di G. Holtus, E. Radtke, Narr, Tübingen 1985, pp. 154-184. Per un aggiornamento su entrambi i concetti cfr. ora T. Poggi Salani, Italiano regionale, in Enciclopedia dell’italiano, vol. 2, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2011, pp. 726-729 e G. Berruto, Italiano standard, ivi, pp. 729-731.
Lingua Fabio Rossi
151
caldeggiare un “sano” (e fascista) svecchiamento linguistico, consapevole che la partita del compromesso tra scritto e parlato, norma e uso, ossequio letterario e franca espressione popolare, si può vincere soltanto sullo schermo di massa: La simultaneità scorrevole delle cose sullo schermo non tollererebbe nel linguaggio nessuna riesumazione filologica e nessun fantasioso anticipo. Il popolo che affolla le sale vi si deve riconoscere in quel preciso affermarsi della personalità che è il parlare. Se si continuasse a rendere stabile una forma di espressione sbiadita, poco colorita, fatta di svenevolezze tra borghesi e aristocratiche né carne né pesce e cosparsa di sfarfalloni, grave sarebbe il danno sull’animo del pubblico il quale va al cinema fiducioso, con l’intento di divertirsi anzitutto, ma è lieto di uscirne come da una scuola piacevole dove ha imparato molte cose e sarà purtroppo tratto ad imitare, esprimendosi, certe superfluità ridicole che potranno sembrare oro colato, avendole sentite in bocca a quei signori in frak o a quelle signore scollate che ha ammirato con occhi luccicanti nel buio della sala di proiezione […]. [I]l linguaggio corrente dei nostri film è ormai da un certo tempo molto intonato all’evoluzione generale della lingua e dello stile nazionale che va verso il semplice e la franchezza, verso la istintiva aderenza al pensiero senza fronzoli ipocriti, senza ornamenti insulsi14.
L’inattualità e la tendenziosità di simili osservazioni non deve occultare il nocciolo della questione, di là dal facile populismo e paternalismo di matrice fascista, ovvero l’esigenza di una maggiore aderenza del parlato filmico non tanto al parlato reale, quanto a una sua decantata e dedialettizzata astrazione (d’indiscutibile potenziale didattico, perché il popolo esce dal cinema «come da una scuola piacevole dove ha imparato molte cose»), o, se si preferisce, di una maggiore distanza dei dialoghi cinematografici dai virtuosismi letterari e dai vezzi del teatro borghese. Tale ricerca di medietas linguistica del cinema accompagnerà la produzione nostrana fino ai giorni nostri, pur con progressivo aumento di soluzioni espressive fortemente inclini al dialetto e al plurilinguismo, come vedremo.
14
E. Allodoli, Cinema e lingua italiana, in “Bianco e Nero”, n. 4 (1937), pp. 3-11.
152
Lessico del cinema italiano
Lingua parlata / lingua scritta / lingua filmata I linguisti, benché si siano interessati di rado e tardivamente ai dialoghi cinematografici (con alcune vistose eccezioni: Alberto Menarini e soprattutto Sergio Raffaelli15), hanno individuato la peculiarità del parlato filmico nella sua natura intermedia tra la lingua scritta, propria delle prime fasi del film (soggetto e varie tappe della sceneggiatura, definita giustamente come un tipo di «scritto per essere detto come se non fosse scritto»16), quella recitata (come nel teatro) e quella parlata, cui sostanzialmente ogni film intende avvicinarsi: Non v’è dubbio che il dialogo cinematografico si distingue da quello teatrale per il carattere specifico dell’immagine filmica e per il valore che in essa viene ad assumere la parola in rapporto col visivo. Si tratta di un dialogo più immediato, aderente alla condizione sociale dei personaggi e all’ambiente, assai vicino al parlare comune e alieno da qualsiasi artificio letterario. Un dialogo che, a differenza di quello teatrale, essendo un’integrazione del linguaggio unitario del film, non ha un proprio autonomo valore espressivo né una piena funzione narrativa17.
A questo proposito, è ancora utilissima la tripartizione diamesica di Giovanni Nencioni, che invita all’attenzione al continuum tra le diverse tappe del parlato-parlato, parlato-scritto e parlato-recitato18, così come utili sono la categoria di lingua trasmessa, messa 15
16
17 18
Cfr. almeno A. Menarini, Il cinema nella lingua, la lingua nel cinema. Saggi di filmologia linguistica, Bocca, Milano-Roma 1955 e S. Raffaelli, La lingua filmata. Didascalie e dialoghi nel cinema italiano, Le Lettere, Firenze 1992. Tra la ricca produzione di quest’ultimo, cfr. ora anche la raccolta postuma Parole di film. Studi cinematografici 1961-2010, a cura di M. Fanfani, Cesati, Firenze 2015. C. Lavinio, Tipologia dei testi parlati e scritti, in “Linguaggi”, n. 1-2 (1986), p. 16. Sul piano non linguistico, bensì semiologico, Pasolini definiva «la sceneggiatura come “struttura che vuol essere altra struttura”» (Empirismo eretico, cit., pp. 1489-1502). Sceneggiatura (prefilmica) e testo filmico (ovvero versione definitiva del film) vanno considerati modalità testuali assolutamente differenti tra loro. L. Chiarini, Dialogo, in Enciclopedia dello spettacolo, IV, coll. 628-634, Le Maschere, Roma 1957. Cfr. G. Nencioni, Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato, in “Strumenti critici”, XXIX (1976), pp. 1-56, da recepirsi con le osservazioni di E. Pistolesi sulla necessità di una riconsiderazione critica dei concetti di continuum e di variazione diamesica: Diamesia: la nascita di una dimensione, in Parole, gesti, interpretazioni. Studi linguistici per Carla Bazzanella, a cura di E. Pistolesi, R. Pugliese, B. Gili Fivela, Aracne, Roma 2015.
Lingua Fabio Rossi
153
a punto da Francesco Sabatini, e quelle di parlato riprodotto e di lingua filmata, fornite da Sergio Raffaelli19. Naturalmente il genere del film, la tradizione produttiva di una determinata epoca o di un determinato paese (per esempio, è notoriamente più incline alla presa diretta e all’ossequio delle sceneggiature cosiddette di ferro il cinema hollywoodiano rispetto a quello italiano), la personalità del regista e degli attori (più o meno inclini all’improvvisazione e ai cambiamenti di rotta durante la lavorazione del prodotto) e soprattutto il fatto che l’opera sia girata in presa diretta oppure postsincronizzata situano il film stesso in una posizione molto diversa del continuum, approssimandolo al polo dello scritto piuttosto che a quello del parlato o viceversa. Cionondimeno, anche nei film dichiaratamente realistici e vicini al parlato, più o meno vistose tracce scritte permangono sempre, tanto più se il film è postsincronizzato. Gioverà qualche esempio chiarificatore. Quando si trascrive uno stralcio di parlato reale, per programmato che sia (per esempio, una lezione universitaria), colpisce la gran quantità di elementi che attentano alla fluidità, alla coesione e alla buona tenuta sintattica: cambiamenti di progetto, autocorrezioni, parole ripetute, sintagmi interrotti o spezzati, inversioni vistose al consueto ordine dei costituenti frasali, incisi mai conclusi, subordinate prive di reggente, intromissione di riempitivi (parole zeppa come fatto, cosa, cioè, praticamente) e segnali discorsivi che hanno l’unico scopo di mascherare l’incertezza di chi si trova a programmare un discorso via via che lo esegue20. Raramente tut19
20
Il cinema, secondo Sabatini, rientra nella categoria della lingua trasmessa, ovvero «la comunicazione fonico-acustica, e a volte anche visiva, indiretta (mediante telefono, radio, cinema, televisione, registratori, ecc.)», Id., La comunicazione orale, scritta e trasmessa: la diversità del mezzo, della lingua e delle funzioni, in Educazione linguistica nella scuola superiore: Sei argomenti per un curricolo, a cura di A.M. Boccafurni, S. Serromani, Provincia di Roma e CNR, Roma 1982, p. 106. Per parlato riprodotto e lingua filmata intendiamo l’«interazione dialogica che, precostituita di solito in sede di sceneggiatura, avviene in una situazione più o meno fittiziamente ricostruita nelle fasi che vanno dalla ripresa al montaggio al missaggio, e che è emessa attraverso il canale fonico artificiale della riproduzione meccanica» o digitale, S. Raffaelli, La lingua filmata, cit., pp. 152-153. L’intrascrivibilità integrale del parlato-parlato è esemplarmente simboleggiata in una scena di Il cappotto (1952) di Alberto Lattuada, film dalla par-
154
Lessico del cinema italiano
to questo filtra nelle simulazioni del parlato, anche in presenza di palesi tratti orali (dialettalismi, gergalismi, turpiloquio), dal momento che, di norma, l’obiettivo precipuo del dialogo filmico è quello di riuscire a condensare entro l’arco delle due ore la massima informazione possibile. Proprio per questo, anche un brano apparentemente improntato alla spontaneità, come il seguente monologo di Anna Magnani in L’onorevole Angelina (1947) di Luigi Zampa, lascia trapelare, nella pur credibile mimesi orale, numerosi tratti “scritti”: Vedete, mentre stavo dentro me so’ venute in mente tante idee. Il governo dovrebbe fà fà alla gente la galera obbligatoria. Come ’l servizio militare. Hm, eh già! Un po’ perché tutti quanti ’n’annetto almeno ce lo meritiamo. E un po’ perché lì dentro te se rischiarano le idee. Così io lì me so’ accorta che so’ solamente una come voi. Una ch’ha passato la vita a mette assieme il pranzo co la cena, a combatte co le finestre senza vetri, co l’umidità, co tutti i guai che sapete meglio de me. E anche se, come dite voi, è merito mio se cj abbiamo ’na casa, che manco ce sognavamo d’avercela, ho capito che questo non è el sistema pe fà l’onorevole. Per quello che me riguarda, poi, me so accorta che, per fà la politica, la famiglia m’andava per aria. E io ai regazzini miei ce tengo! Io me li vojo tirà su come me pare! E poi, anche senza diventà onorevole, cj ho da fà tanta de quea politica, a casa! Fra ’n marito, i guai, i regazzini... Certe discussioni, che a la cammera manco se le sognano! Io so sicura che non rimpiangerete se lascio il posto a qualcuno più bravo, più preparato de me. A qualcuno che ve possa veramente aiutà! A qualcuno che co più calma, co più sistema, non se lascerà fregà. Perciò... perciò ve dico addio! Ve saluto! Però, quando me chiamerete pe baccajà, sarò sempre pronta, perché questa è l’unica cosa che me viè naturale. Così er partito nostro non se sciojerà, no! Ma manco ala cammera andrà. Resterà fra noi: baccajeremo in famiglia. Così saremo tutti quanti onorevoli. Ma onorevoli sul serio, però!
Tacendo dell’assenza di cambi di progetto (di là dai deboli regionalismi, il brano ha una sintassi pressoché ineccepibile, in cui ogni titura linguistica sensibilissima, nello scolpire il burocratismo dell’Italietta postbellica. Allorché Rascel, verbalizzatore della giunta comunale, riporta fedelmente il discorso del sindaco, genera un testo incomprensibile, in quanto fatto di mozziconi di parole e sintagmi. Viene così accusato di aver alterato il verbale, mentre l’errore (pragmatico e sociale) da lui commesso è stato proprio quello, opposto, di non aver edulcorato le parole (e soprattutto la sintassi e lo stile) del sindaco.
Lingua Fabio Rossi
155
proposizione giunge al suo regolare compimento), il perfetto bilanciamento testuale, ribadito dal segnale discorsivo bipartito un po’ perché... un po’ perché, è tipico dello scritto; così come l’introduttore tematico per quello che me riguarda; lo stesso valga per l’elevato numero di futuri (9), che notoriamente, nel parlato italiano a qualsiasi livello, vengono sostituiti dal presente, e per il segnale discorsivo vedete, tipico dello scritto che imita il parlato (teatro, dialoghi di romanzi, sceneggiature), piuttosto che di quest’ultimo. Verrebbe quasi da pensare che, così come abdica alla vita politica e alla lotta di classe a favore di quella privata, familiare e devota alla tradizione, la sora Angelina, non più onorevole, e con lei Zampa, abdica al parlato-parlato di matrice neorealistica, per rifugiarsi nella rassicurante tradizione dell’italiano filmato, con scialbe (mai disturbanti, né tantomeno perturbanti) chiazze dialettali. Esse non fanno altro che agevolare la rassegnazione e la consolazione degli orizzonti ristretti. Se volessimo menzionare altri due elementi di distacco del parlato filmico ordinario dal parlato-parlato, basterebbe pensare al ridottissimo uso delle sovrapposizioni di turno dialogico (nel cinema doppiato quasi mai i personaggi parlano l’uno sull’altro, interrompendosi e accavallandosi), ineliminabili dal parlato spontaneo a più voci. Chiaramente, la polifonia mette a repentaglio la completa decodificazione delle battute, che vengono dunque tutte forzatamente linearizzate o, per meglio dire, “monodizzate”. Si pensi pure al frequente ricorso filmico ai nomi propri in funzione allocutiva: nella vita di tutti i giorni, ci si chiama raramente per nome (in italiano), mentre al cinema (per eredità teatrale, direi) tale prassi è consolidata, quasi a rammentare continuamente allo spettatore i partecipanti all’azione scenica. In L’onorevole Angelina, per esempio, il nome della protagonista, usato in funzione allocutiva (Angelì), è attestato 72 volte e per ben 12 volte Angelina chiama suo marito per nome (Pasquà). Bisogna attingere a brani di cinema-verità, se vogliamo incontrare tutte le “sporcature” del parlato-parlato, come per esempio il seguente dialogo di Anna (1975) di Alberto Grifi e Massimo Sarchielli, nel quale riscontriamo interruzioni, sovrapposizioni, ripetizioni, incertezze, ecc.: S : No, ma io ti volevo domandare a te, con la storia te tu hai lavorato per... per l’unione, insomma, un’organizzazione politica,
156
Lessico del cinema italiano
un po’, capisci, se c’era una possibilità, per questa ragazza, come diceva anche Ivano, di... D : Cioè, di un’assistenza. S : Sì.
Soltanto un cinema che decida di sacrificare la trama e la sintesi (225 minuti, la durata di Anna!) all’altare del radicale rispecchiamento della realtà può restituirci la piena natura ridondante e frammentata della lingua orale, tanto diversa da quella scritta e recitata. Un’altra caratteristica distintiva della lingua filmata rispetto ad altri tipi di comunicazione risiede in certa ridondanza semiotica, che può essere spiegata solo come integrazione informativa all’immagine, per agevolare la decodificazione del pubblico. Un testo che non prevede il feedback dei destinatari, in effetti, deve prevenire eventuali dubbi di questi ultimi, snellendo la gestione dei frames. Tale gestione è tanto più agevolata quanto più il film si rivolge ad un pubblico medio. Possiamo averne un chiarissimo esempio nella scena clou di I soliti ignoti (1958) di Mario Monicelli. Poco prima che crolli il muro della casa dalla quale lo spiantato gruppo di ladri si illude di irrompere nella banca, ma che invece li immetterà soltanto nella cucina del medesimo appartamento, Peppe, il personaggio interpretato da Vittorio Gassman, chiede a Capannelle di portargli un bicchiere d’acqua. La battuta è apparentemente inutile, se non dannosa, nel rallentare il ritmo concitato della scena. Ne capiremo l’utilità segnica pochi secondi dopo, allorché, al crollo del muro, la macchina da presa stringerà su Capannelle, in cucina, col bicchiere in mano. Senza quel riferimento, che è dunque una sorta di glossa per il pubblico, lo spettatore avrebbe impiegato molto di più a capire l’errore strategico dei rapinatori. Molto frequenti sono i casi in cui brani di discorso non sono indirizzati tanto ai personaggi del film, quanto al pubblico, come avviene nella seguente battuta rivolta dal tranviere Alvaro, ad apertura di Poveri ma belli (1957) di Dino Risi, a Salvatore, che rivendica il proprio letto («Ma a te il turno di giorno non te lo danno mai?»): «E metti che me lo danno? Che letto v’affittate? No, dico, se mi danno il turno di giorno, voi perdete l’inquilino. O ti dovessi credere che io la notte vengo a dormire abbracciato con te?!». Salvatore sa bene che cosa prevede l’accordo d’affitto con Alvaro:
Lingua Fabio Rossi
157
l’uno dorme quando l’altro lavora e viceversa. È il pubblico a non saperlo: la battuta di Alvaro è dunque ridondante per Salvatore (al quale sarebbe stato sufficiente rispondere: «E metti che me lo danno? Che letto v’affittate?»), mentre è necessaria al pubblico per seguire la trama del film. Scene siffatte danno conto a pieno della doppia natura semiotica di qualunque interazione riprodotta ad uso scenico (teatro, cinema). Doppiezza raddoppiata, per dir così, nel caso del cinema italiano, per via della presenza della postsincronizzazione. Tentando di sintetizzare il più possibile, diciamo che ogni testo basato sull’inscenamento dell’interazione tra personaggi è strutturato su due livelli comunicativi. Il primo, il più superficiale, è detto dei «represented participants», ovvero il piano diegetico della comunicazione ficta tra personaggi/attori (a loro volta sostituiti dai doppiatori, nel caso della colonna sonora della gran parte dei film italiani, di norma postsincronizzati). A livello più profondo, tuttavia, il testo filmico nel suo complesso (al pari di ogni altro testo) comunica con un pubblico: è questo il piano della comunicazione non più ficta, bensì reale, ovvero tra «interactive participants»21. Paradossalmente, però, mentre nel primo livello viene inscenato anche il feedback tra gli interlocutori (a meno che non si tratti di un monologo, ovviamente), in questo secondo piano la comunicazione avviene invece a senso unico, senza possibilità di replica (almeno nell’immediato) da parte del pubblico cinematografico, diverso, in questo, da quello teatrale che, almeno teoricamente, ha la possibilità di interagire con gli attori sul palcoscenico (mediante applausi, fischi ecc.). È proprio questa doppia struttura a giustificare, come s’è visto, certa ridondanza conversazionale dei copioni cinematografici. Tale rifrazione prismatica dell’interazione, infine, com’è inevitabile, non può che allontanare più o meno sensibilmente la lingua filmata da quella reale. 21
Ulteriori osservazioni sul doppio livello comunicativo (tra soggetti interattivi e soggetti riprodotti, cioè ricreati dal mezzo) si possono trovare in G. Kress, T. van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of Visual Design, Routledge, London-New York 1996 (in partic. a p. 46), S. Kozloff, Overhearing Film Dialogue, University of California Press, Berkley 2000 e C. Bubel, Film audiences as overhearers, in “Journal of Pragmatics”, n. 40 (2008), pp. 55-71.
158
Lessico del cinema italiano
Lingua, lingue, dialetti: il realismo prima del neorealismo La consistente presenza dei dialetti sul grande schermo precede non soltanto il neorealismo, ma anche il cinema sonoro. Disponiamo ormai di numerose testimonianze che ci documentano l’esistenza di didascalie dialettali in molti film, e addirittura, durante la cosiddetta fase orale del cinema, la prassi della recitazione in dialetto, dal vivo durante la proiezione, di compagnie di attori nascosti dietro lo schermo, così come avvenne a Venezia, in Biaso el luganegher (1907) di Almerico Roatto22. La prassi della recitazione dal vivo accompagnò in realtà tutta la fase del muto (che dunque del tutto muto non fu mai), se nel 1926 il cinematografo Iride di Napoli ingaggiò una coppia di attori per la recitazione, in sincronia con le immagini, delle didascalie di Il fu Mattia Pascal (1926) di Marcel L’Herbier23. Le riserve estetiche e filosofiche di pressoché tutti gli intellettuali contro l’aggiunta della parola all’immagine erano fortissime, com’è noto. Essi ravvisavano in ogni tentativo di sonorizzazione del film uno scimmiottamento del teatro (Pirandello), un peggioramento della recitazione degli attori, una deprivazione della componente onirica e antirealistica del cinema e, soprattutto, un attentato al principio estetico del «mezzo dominante» (come a dire: un senso alla volta, nell’arte; mai integrarne più d’uno a meno che non sia ben chiaro quale dei due debba prevalere sull’altro: Arnheim)24. Cionondimeno, al pubblico, e conseguentemente ai produttori, erano estremamente graditi gli esperimenti di sonorizzazione del film, quali quelli del notissimo Fregoligraph, descritti dallo stesso ideatore Leopoldo Fregoli25. Molte delle ragioni di questo apprezzamento, almeno in Italia, derivavano dall’elevato tasso di analfabetismo, che ostacolava a gran parte del pubblico la lettura delle didascalie. Per questa ragione, infatti, oltre alla post22 23 24
25
Cfr. S. Raffaelli, La lingua filmata, cit., pp. 63, 150. Cfr. ivi, p. 63. Cfr. L. Pirandello, Se il film parlante abolirà il teatro, in “Corriere della Sera”, 16 giugno 1929, p. 3; R. Arnheim, “Ma che cosa è questo cinema?”, in “Cinema”, n. 33 (1937), p. 306; Id., Nuovo Laocoonte, in “Bianco e Nero”, n. 8 (1938), pp. 3-33. Cfr. A. Bernardini, Cinema muto italiano. Ambiente, spettacoli e spettatori 1896-1904, vol. 1, Laterza, Roma-Bari 1980, pp. 100-101.
Lingua Fabio Rossi
159
sincronizzazione dal vivo, un altro espediente assai praticato era quello del lettore in sala. Inoltre, di là dalle difficoltà della lingua scritta, il pubblico ricercava un ausilio dialogico per meglio decodificare la trama e il carattere dei personaggi, nonché un aggancio alla realtà, nella quale ai movimenti labiali degli attori non possono che corrispondere parole orali. Lo stile tipico delle didascalie (che, com’è noto, iniziano a infittirsi e allungarsi proprio con il progressivo intrecciarsi e allungarsi delle trame dei film, a partire dalla metà degli anni dieci) oscilla perlopiù tra l’aulico (ancorché fatto di poetismi e arcaismi inerziali, propri di ogni produzione di consumo coeva, dalla canzonetta al melodramma, dalla letteratura d’appendice alla poesia encomiastica) e lo scolastico, non privo di qualche incertezza: 14) Serenata funebre. «Una notte camminava | Di primavera l’amore; | E delle stelle mirava 15) L’ardore, | E cascò dentro una fossa | Piena d’ossa | L’amore»26.
Quintessenza di retorica dannunziana gronda dalle didascalie di Cabiria (1914) di Pietro Fosco (pseudonimo di Giovanni Pastrone), sebbene il Vate si fosse limitato alla loro supervisione, oltreché ad apporre la firma milionaria, di tale prestigio da occultare ogni altra maestranza del film: Il vespero. Già si schiude la tenzone dei caprai, che la Musa dorica ispira su i flauti dispari «a cui la cera diede l’odor del miele». Dispersi dalla fame per la piaggia sconvolta, tuttavia incalzati dal terrore, i fuggiaschi scendono verso il mare. Una nave è là, abbandonata, come offerta dal favore degli Iddii. S : Di’ com’è egli? A : Come il vento di primavera, che valica il deserto con piedi di nembo recando l’odor dei leoni e il messaggio di Astarte. Il “buon evento” seconda il romano. 26
Didascalie di Parisina (Un amore alla Corte di Ferrara nel XV secolo), 1909, di Giuseppe De Liguoro, con brani tratti dal poema omonimo di Domenico Tumiati.
160
Lessico del cinema italiano
Fulvio Axilla contrasta invano al panico che lo travolge. Ogni speranza di salvezza è vanita. Non vive più. Fu spenta. Massinissa, venuto a la notizia dell’assedio singolare, vuol conoscere i due audaci.
Sebbene l’ostentato scarto dalla lingua comune fosse, dunque, la cifra distintiva della gran parte della produzione filmica nostrana fino all’avvento del sonoro (del resto, i divi non potevano che emettere parole olimpiche, distanti dalla realtà tanto quanto l’alfabetizzazione della maggior parte degli italiani), non tardarono, tuttavia, timide ma progressive aperture al parlato, come nel seguente scambio dialogico in Assunta Spina (1915), film giustamente celebrato non soltanto per aver consacrato la diva Francesca Bertini, ma anche per il robusto stile realistico: G : Se il vostro amico resta a Napoli, lo potrete vedere almeno due volte al mese… A : E quanto ci vuole? Quanto devo darvi? G : Ah, niente… Grazie tante…
La lingua scritta delle didascalie italiane non poteva non suscitare le preoccupazioni dei puristi, che vi ravvisavano non poche mende27. Turbavano soprattutto le forme in dialetto o addirittura in lingua straniera, che finirono, ben prima del Ventennio fascista, sotto l’occhio della neonata (1913) censura: I titoli, i sottotitoli e le scritture, tanto sulla pellicola quanto sugli esemplari della domanda, debbono essere in corretta lingua italiana. Possono tuttavia essere espressi in lingua straniera, purché riprodotti fedelmente e correttamente anche in lingua italiana28. 27 28
Bastino le pesanti accuse di A.M. Salvini, …e la grammatica?, in “L’illustrazione cinematografica”, 5-10 febbraio 1913, p. 10. «Regolamento per l’esecuzione della legge 25 giugno 1913, n. 785, relativa alla vigilanza sulle pellicole cinematografiche», approvato con Regio decreto 31 maggio 1914, n. 352 e pubblicato nella “Gazzetta ufficiale”, 9 luglio 1914, n. 162, S. Raffaelli, La lingua filmata cit., p. 170. Tale norma, con
Lingua Fabio Rossi
161
Non mancano, in effetti, esempi di didascalie in dialetto, inverosimilmente commiste con lacerti di lingua iperletteraria, soprattutto a Napoli, nelle celeberrime sceneggiate filmate, e financo esportate oltreoceano, da Elvira Notari: L’onda di popolo frenetico di chiasso e desideroso di baldoria gremisce ogni via che percorrono i reduci di Montevergine. ’A carrozza ’e Tore. ’A carrozza ’e Margaretella. Pandemonio orgiastico di baccanti. Il diapason del chiasso. A T : Non ti scottare al fuoco di quegli occhi, ’a figlia ’e donna Carmela ’nnammuratu lassa e ’nnammuratu piglia!… M : Il vino non lo abbiamo bevuto e lo vuoi essere pagato. T : [a Margaretella] Come sei bella! Z R …E ’n ’ato! Z R : [a Tore] Cagnate strada: chella guagliona ha fatto chiagnere chiù de ’nu figlio ’e mamma29!
Ma anche altrove: «Tira neñ bôrich! At girlo la bocia? I sôn Maciste!»30. Talora i film uscirono in doppia versione: con didascalie dialettali per il mercato locale e italiane per quello nazionale, come accadde per il San Giovanni decollato (1917) di Telemaco Ruggeri, con Angelo Musco, italianizzato fuor di Sicilia. Tra i registi più versatili, anche linguisticamente, del nostro primo cinema spicca Alessandro Blasetti, il quale, già nelle didascalie di Sole (1929), passava dalle inversioni sintattiche dello stile letterario più trito («Passano i guadi le mandrie di bufale per il cambio dei pascoli e tutto schiantano e travolgono»; «Miserabile è l’animo vostro come le vostre menti… Guardate!»), ai pleonasmi e i colloquialismi di una parca mimesi del parlato spontaneo:
29
30
qualche aggiustamento, rimase nella sostanza invariata anche nell’epoca del sonoro. È piccerella (1922) di Elvira Notari. A ’Nfama! (1924), della stessa Notari, la censura non solo impose la riscrittura delle didascalie «in corretta lingua italiana», ma negò, eccezionalmente, «il nulla osta per l’esportazione all’estero», S. Raffaelli, La lingua filmata, cit., p. 211. Maciste alpino (1916) di Luigi Maggi e Romano L. Borgnetto. L’intera trascrizione del film, con qualche battuta in piemontese, si può leggere in S. Raffaelli, L’italiano nel cinema muto, Cesati, Firenze 2003, pp. 195-204.
162
Lessico del cinema italiano
Questa volta glielo voglio far vedere io, a Marco, che cosa vuol dire essere uomini; Nulla di grave. Un urtone di certe bufalette poco educate; Ehi, amico! Dove ti sei cacciato?; Dì, buttero, non hai mica una sigaretta asciutta?
Sempre aperto ai dialetti, Blasetti ne inscena il maggior numero in 1860 (1934): siciliano («Òra tu te ne vai in paise co’ patre Costanzo a pigghiari istruziòni precisi»; «Site picciòtti, tempo n’avete»; «Ritòrno subbito, Gisuzza, tantu arrivu au paisi»; «Va’ a pigghiarmi ’u cavallu»; «Figghiu mèu!»; «Garibbaldi ha dettu ch’amu fattu l’Italia!»), toscano («Anche te tu vieni a Genova?»; «Oh, bisognava vvedere a Firenze l’accoglienza he gl’è stata fatta al nostro re!»; «Io ’un so come la la pensa lei»; «Oh, intendiamoci, come uomo io gli fo tanto di cappello»), piemontese (’nduma ‘andiamo’; suta ‘sotto’; la canzone La bèla Gigogìn), veneto («No sta a piànser, mama») e altri. Nel film compaiono anche altre lingue: latino, tedesco e francese. Proprio su questo caleidoscopio linguistico poggia l’ideologia del film, che è quella di mostrare il Risorgimento come un fenomeno socialmente trasversale e panitaliano, corale come la fiera dei dialetti esibiti, e soprattutto anticipatore del fascismo, come dimostra il conclusivo saluto romano delle camice nere sulle tombe dei garibaldini. Talora al dialetto, nonostante le prescrizioni fasciste, è assegnata una valenza decisamente positiva, quale simbolo dell’identità italiana: I : Sono veramente contento che propi chì a Milàn int’el me teàter, dopo tanto repeloto, ghe sia staa un così grande sucesso dovuto a un volontario bolognese... V : Grazie, grazie... I : E a uno napoletano! Con tuti questi dialeti... l’è propi una festa italiana31!
31
Amo te sola (1935) di Mario Mattoli.
Lingua Fabio Rossi
163
Il dialetto è anche un buon antidoto alla dominazione straniera: U : Voi non conoscete questo conte Appiani? P : Sior no... int’el me locàl l’è mai vegnü! U : Come dice? U .: Dice che non l’ha mai visto. U .: Quelle idée de parler patois! Ma nel vostro locàl si riuniscono giovanotti che cantano canzoni sediziose! P : Com’el diss? U .: Rivoluzionarie! P : L’è ch’int’el me locàl, a ghè un vinéto ch’el mete alegrìa, che se l’asagiase anca lü el canta alter che la sediziosa! U .: Ah, molto convincente! Peccato però che io non beva, e allora in questo caso tu fili diritto a S. Vittore! Vedremo se la prigione ti farà sciogliere la lingua! P : Mi ho fa nagòta! Non ho fatto niente! U .: Ah, adesso parli anche italiano! Vedrai che là dentro finirai per parlare anche francese32!
Dalla tolleranza mostrata dalla censura nei confronti di questi lacerti dialettali, trapela la natura ancipite del regime fascista, che da un lato intendeva dare di sé, soprattutto all’estero, un’immagine moderna ed efficiente (un’unica e illustre lingua per una nazione compatta e forte), peraltro discordante con la ruralità e la frammentazione dialettale propriamente italiane; dall’altro, non intendeva alienarsi il consenso popolare, né rinunciare al sentimentalismo populistico garantito dal dialetto: Si è tuonato molto, in questi ultimi anni, contro i dialetti: ma c’è stata forse una piccola confusione. S’è scambiato cioè il dialetto — la più innocente delle intonazioni — con lo spirito dialettale — la più odiosa e la più intollerabile sopravvivenza di epoche asfissianti, quando nessuno vedeva più in là del proprio naso e la cronaca dell’Italia meschina si svolgeva sonnecchiando tra il farmacista e il segretario comunale. Combattere il regionalismo è opera santissima: ma voler distruggere i dialetti è non solo praticamente impossibile ma idealmente errato. Nei dialetti è il lievito stesso della lingua unitaria; essi sono i vivai inesauribili che arricchiscono e mantengono giovane la lingua. 32
La compagnia della teppa (1941) di Corrado D’Errico.
164
Lessico del cinema italiano
Perché dunque fingere che esista un italiano che non esiste, e parlare sulla scena o sullo schermo un esperanto da filodrammatici33?
Anche il parco realismo plurilingue dei telefoni bianchi, che continua la ricchissima tradizione comica italiana, da sempre incline alla mescidanza, è, contraddittoriamente, funzionale al regime: odora appena di progressismo nel mostrarci il bel popolano De Sica in grado di padroneggiare italiano formale, registri regional-popolari, francese e inglese («A che cosa vuoi che mi serva il greco […]. Ho pensato che è più utile un po’ d’inglese», Il signor Max, 1937, di Mario Camerini), d’essere al contempo Gianni e Max Varaldo, ma è sostanzialmente reazionario (antiborghese nella direzione populistica e strapaesana), come torneremo a dire sotto, nel dissuadere ogni mescolamento di classe34. L’ideologia neorealistica Non è, dunque, l’uso dei dialetti l’elemento di novità del cinema neorealistico, bensì il radicale mutamento d’ottica con la quale i dialetti vengono adoperati. Non si tratta più d’un impiego perlopiù ludico, consolatorio e come macchia di colore locale, del cinema preneorealistico (con qualche eccezione: 1860 di Blasetti), bensì d’un valore solo in parte documentaristico, ma soprattutto ideologico. La ricostruzione dell’Italia postbellica e postfascista deve, nell’intento di registi e sceneggiatori, partire dal popolo, e soprattutto deve essere un’azione corale e non il frutto di un singolo eroe o di pochi eletti. Pertanto il dialetto – o meglio, più spesso, l’italiano regionale – è il codice di questa coralità, fino ad ora raramente assurta agli onori cinematografici. Per la prima volta al dialetto 33
34
C. Pavolini, (1934) citato in P. Micheli, Il cinema di Blasetti, parlò così… Un’analisi linguistica dei film (1929-1942), Bulzoni, Roma 1990, pp. 76-77. Sulla lingua del cinema del Ventennio e le contraddizioni della politica linguistica fascista, oltre al volume della Micheli appena citato, cfr. anche V. Ruffin, P. D’Agostino, Dialoghi di regime. La lingua del cinema degli anni trenta, Bulzoni, Roma 1997. La prospettiva linguistica e ideologica de Il signor Max viene ribaltata nel secondo episodio di Colpi di fulmine (2012) di Neri Parenti, nel quale il borghese perfettamente italofono ambisce all’apprendimento del romanaccio e dello stile di vita coatto per far presa su una ragazza.
Lingua Fabio Rossi
165
è riconosciuta una sua dignità, viene messo, senza vergogna, al centro della comunicazione, in tutte le sue funzioni, così come al centro della scena viene data la parola a tutti quei personaggi che, nella cinematografia precedente, avrebbero potuto interpretare soltanto ruoli da comparsa. Tale rinnovamento generale non azzera peraltro la componente ludica ancora presente in certe scenette dialettali, anche nei film più fedeli agli intenti mimetici. E del resto, ben sappiamo la versatilità e l’eterogeneità del neorealismo, che quasi tante anime ebbe quanti ebbe autori, oltre alla pluralità delle soluzioni linguistiche adottate. Ecco dunque che tanto nella scena della santona, quanto in quella della casa d’appuntamento, in Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica, è soprattutto il romanesco teatralmente affettato a strapparci più d’una risata. Saranno, com’è noto, proprio scene consimili a creare il trait d’union tra neorealismo e commedia all’italiana, per il tramite del neorealismo rosa. Né si deve mai dimenticare che, salvo rare eccezioni (La terra trema, 1948, di Luchino Visconti), il dialetto dei film neorealistici, così come quello di ogni altro film almeno fino agli anni settanta, non è vero dialetto in presa diretta, bensì «un dialetto elaborato, annacquato, arbitrario, è un dialetto che nessun parlante “reale” di quell’ambiente in verità parla»35: un dialetto ricreato dai doppiatori nella fase della postsincronizzazione del film. Come vedremo più in dettaglio nel capitolo successivo, è infine necessario distinguere l’uso del dialetto come lingua del popolo, orgogliosamente contrapposta alla lingua dei padroni, rivendicato fin dalla didascalia proemiale di La terra trema («La lingua italiana non è in Sicilia la lingua dei poveri»), dall’uso, altrettanto simbolico, del dialetto come lingua empatica, nel trilinguismo di Roma città aperta (1945) di Roberto Rossellini: «Il tedesco come codice della belluinità, l’italiano della consapevolezza, il dialetto degli affetti»36. La breve parentesi neorealistica sembra dunque realizzare quanto già da un decennio si auspicava, vale a dire l’inscenamento di un parlato credibile e il ritorno al vero. Oltre alle già citate parole di Paolo Milano, si pensi al culto per Giovanni Verga, praticato dalla cerchia di intellettuali della rivista “Cinema”, ovvero i 35 36
P. Pucci, Impasto dialettale nel linguaggio del cinema, in “Società”, n. 15 (1959), p. 824. S. Raffaelli, La lingua filmata, cit., p. 107.
166
Lessico del cinema italiano
padri del neorealismo37, e alle intuizioni di Luigi Comencini, che nel 1938 scriveva: È necessario ritrovare la vita italiana, e non nei libri e nelle antologie […]. Gli italiani non parlano l’italiano; generalmente parlano un dialetto; ad ogni modo sempre una lingua che è parlata e non scritta […]. Il dialoghista è una persona di primo piano; deve essere una persona geniale, che sappia parlare come gli operai, come gli impiegati e pensare come un grande scrittore, che non abbia paura delle parole […]. Il più bel film italiano si svolge ancora nelle piazze e nelle vie d’Italia dove la gente parla a crocchi, decide dei propri affari; nei campi dove lavora e nei caffè [...] dove si riunisce la sera38.
La poetica zavattiniana del pedinamento diventa dunque pedinamento linguistico: anche quando si ricorre al doppiaggio, bisogna dare l’impressione della coralità, della voce di tutto un popolo. In questo senso, la scena del mercato di Piazza Vittorio, in Ladri di biciclette, è assolutamente esemplare e inimitata. Plurifunzionalità del dialetto Se il ricorso al dialetto ha caratterizzato il cinema italiano fin dalle origini, le sue funzioni sono state molto diverse. Occorrerà dunque fare chiarezza non tanto dal punto di vista storico, quanto da quello tipologico e funzionale, forse ancora poco indagato. Segue, pertanto, una sintetica disamina dei principali usi dialettali, da non intendersi in diacronia (anche se i dieci punti sono più o meno ordinati dal più comune e antico, al più recentemente affermatosi) né in gradatum (se non per esigenze ermeneutiche), bensì su uno sfumatissimo continuum: più funzioni, infatti, possono coesistere non soltanto in uno stesso periodo o autore, ma addirittura in un medesimo film. I punti salienti del seguente schema decapartito saranno sviluppati nei capitoli successivi. 37 38
Cfr. M. Alicata, G. De Santis, Verità e poesia. Verga e il cinema italiano, in “Cinema”, n. 127 (1941), pp. 216-217; Id., Ancora di Verga e del cinema italiano, in “Cinema”, n. 130 (1941), pp. 314-315. L. Comencini, La mostra cinematografica di Venezia, in “Vita giovanile”, n. 15 (1938), p. 6. Sull’importanza di un cinema attento al vero, anche linguistico, si era già espresso il precoce L. Longanesi, Sorprendere la realtà, in “Cinema”, n. 7 (1936), pp. 257-260.
Lingua Fabio Rossi
167
1. La prima funzione, e direi anche la più antica, ancorché predominante tuttora, è quella di contorno e di macchia di colore. Il tessuto verbale del film è fondamentalmente in italiano standard, o al massimo debolmente regionale, e qualche personaggio (perlopiù secondario) pronuncia qualche battuta in dialetto, sia per restituire la couleur locale del film, sia, soprattutto, per strappare il coinvolgimento e prima ancora la risata del pubblico. È una funzione perlopiù consolatoria del dialetto, magistralmente esemplificata in tante commedie dei telefoni bianchi o dei generi limitrofi: basti pensare a Gli uomini, che mascalzoni... (1932), Darò un milione (1935), Il signor Max (1937) di Mario Camerini; Maddalena... zero in condotta (1940) di Vittorio De Sica o Ore 9: lezioni di chimica (1941) di Mario Mattoli. Quest’ultimo sosteneva: «Io sono sempre stato un fautore del dialetto nel personaggio secondario, perché credo dia vita alla vicenda»39. La componente simbolica non è certo completamente esclusa da questi film (soprattutto le commedie di Camerini): l’italiano impettito dei “signori” è da un lato invidiato (tanto quanto i loro soldi: «perché per lei ci vogliono i signori», esclama stizzito Bruno-De Sica, allorché la fidanzata Mariuccia lo smaschera per impiegato, anziché ricco possidente quale egli si spacciava, in Gli uomini, che mascalzoni...), dall’altro deriso, così come le perle dialettali incastonate nelle battute di taluni comprimari, più gli uomini che le donne, il cui onore, anche linguistico, va preservato, a questa altezza cronologica, Magnani e poche altre a parte. Perle che in fondo debbono far ricordare al pubblico che il salto sociale è impossibile e dannoso: il popolano verace è bene che rimanga tale e quale, senza tanti grilli per la testa, giacché i soldi (e il parlare come un libro stampato) in fondo non portano altro che infelicità. Signori si nasce, insomma, e la sora Gioconda è molto più simpatica e felice di Donna Gioconda (entrambe interpretate dalla regina del bilinguismo simbolico italiano-dialetto, Anna Magnani, in Abbasso la miseria!, 1945 e Abbasso la ricchezza!, 1946, di Gennaro Righelli). La gran parte della comicità di cassetta attuale séguita questa funzione coloristica e consolatoria del dialetto. Basterebbe uno 39
G. Tinazzi, Un rapporto complesso, in Cinema e letteratura del neorealismo, a cura di G. Tinazzi, M. Zancan, Marsilio, Venezia 1983, p. 24.
168
Lessico del cinema italiano
qualunque dei film dell’ultimo Verdone, per dimostrarlo (un titolo per tutti: Il mio miglior nemico, 2006). Ma anche Benvenuti al Sud (2010) e Benvenuti al Nord (2012) di Luca Miniero40, che tuttavia, già nel titolo, giocano con gli stereotipi in modo meno passivo. O le tre puntate di Manuale d’amore di Giovanni Veronesi. Non sarà difficile appurare, rivedendo, o meglio riascoltando, gli ultimi film citati, come regga ancora la predilezione per l’italiano standard (o solo debolmente tinto di fonetica regionale) dei protagonisti e delle donne, a fronte del dialetto per i comprimari e i caratteristi maschili, ancora una volta in linea con quanto avviene nella paraletteratura. 2. La seconda funzione è quella realistico-documentaristica, che prende piede compiutamente con certo neorealismo, anche se non mancano esempi precedenti, come il già citato 1860 di Blasetti. In film siffatti, a parte casi rari di cinema-verità, sarà impossibile (oltreché inutile) pretendere di isolare l’intento mimetico da altri intenti (simbolico-ideologico, almeno). E, com’è ovvio, andrà sempre tenuto conto dei limiti del realismo filmico, come meglio d’ogni altro ha sottolineato Giorgio Raimondo Cardona: Come deve parlare un personaggio sullo schermo? Deve simulare la realtà, ed allora sarà ben difficile che un copione preparato a tavolino possa alla fine trasformarsi in un parlato attendibile; oppure sarà un’operazione metaforica, e allora la verosimiglianza non ha più molto senso. Spesso si oscilla fra questi due poli: ci si aspetta la verosimiglianza assoluta, come se il cinema fosse la registrazione di un’intervista sociolinguistica, ma poi, giustamente, ci si ricorda che il cinema è ombre elettriche, è finzione, e quindi parla d’altro41.
3. Non dissimilmente da tanta letteratura, il dialetto ha spesso al cinema una funzione lirico-nostalgica, vuoi sul piano individuale, come reminiscenza proustiana dell’infanzia, non priva di colori psicanalitici e misterici, com’è il romagnolo felliniano di Amarcord (1973) ma più ancora quello del ricordo della nonna in 8 ½ (1963): 40 41
Del medesimo regista, si veda anche la comica rimozione del napoletano da parte della protagonista (emigrata al Nord) interpretata da Paola Cortellesi, in Un boss in salotto (2014). G.R. Cardona, Comunicazione, in AA.VV., Atti della Rassegna–Seminario “Cinema e dialetto in Italia”, a cura di A. De Martino Cincotti, in “Bollettino dell’Associazione italiana di cinematografia scientifica”, giugno 1985, p. 37.
Lingua Fabio Rossi
169
Azidèn d’un azidèn! La legna l’è tuta bagneda, st’an! Le vagabòn de gat l’è com vos non. El ciapa la port de chesa e l’al torn solamènt per magnèr. Tet vergògn! Vat a lè! Oh! Al’ultima volta aio sbatté la porta in tla fazaza. Ah ah! E l’ho lassé fora par du dè. So che […] potù spusarme un’altra volt. E a putia sté sicura ch’al’avria a truvèr ben! Do! chi l’era megl che vos no, burdèl? Ma poi so’ proprio rinvurnida! Eh, i aveo a pensé che s’aveo a ciapé un etr marìd, lui de fond l’infèrn o el paradìs in dò l’è mess non m’avria […].
Vuoi come memoria storica, come lingua di una società rurale ormai tramontata e rimpianta, com’è il bergamasco arcaico di L’albero degli zoccoli (1978) di Ermanno Olmi, ma in fondo anche i dialetti dei sottoproletari pasoliniani. 4. L’obiettivo principale di certi usi dialettali al cinema, ancor più che in teatro e in letteratura, pare quello simbolico, o ideologico, di scolpire immediatamente un tipo sociale o umano, talora un disagio comunicativo. Il romanesco di Alberto Sordi sembra ben più simbolico che mimetico: la lingua sfatta di chi non ha remore morali, mal dissimula, o talora ostenta, indolenza e disonestà. Anche certo cinema di impegno civile si serve di quest’uso: è ancora una volta il romanesco, stavolta di Ugo Tognazzi, in La proprietà non è più un furto (1973) di Elio Petri. Prossimo alla farsa, l’uso di Petri; pienamente farsesco, sempre nel simbolo autoironicamente esibito, quello di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto (1974) di Lina Wertmüller, con il siciliano di Giannini, codice dell’istinto irrefrenabile del proletariato, contro il milanese della Melato, codice della sopraffazione capitalistica, ansiosa d’essere stuprata dal primo. Mero simbolo e doppia metonimia, come vedremo, è il siciliano dei mafia movies. Su tutt’altro piano, in fondo mostra tutta la sua ineliminabile natura simbolica anche il napoletano sfilacciato, endofasico e incomprensibile del primo Massimo Troisi, un vero e proprio «balbettio dell’anima»42, tanto più credibile e mimetico quanto funzionale a esprimere il disagio di comunicare, oltreché di vivere nel mondo.
42
Cfr. G. Sommario, Massimo Troisi. L’arte della leggerezza, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 55 e Id., Il balbettio dell’anima di Massimo Troisi conquista l’Europa, in “Humanities”, n. 3 (2013), pp. 189-195.
170
Lessico del cinema italiano
Il valore simbolico più spiccato del dialetto è quello di marcatore dell’identità, valore che si fa quintessenziale quando al dialetto è abbinata la musica, o quando il dialetto stesso stempera nella musica, ancor più se con funzione corale. Uso storicamente appannaggio della produzione napoletana, dalla sceneggiata ai film con Nino D’Angelo, passando per il mélo di Matarazzo, che in Catene (1949) fa cantare Roberto Murolo e compagni sotto le immagini del Vesuvio. La musica nel cinema italiano concorre spesso, alla pari o più della lingua e delle immagini, a scolpire storie (e anche la Storia), ambienti sociali e situazioni sceniche, fin dalle origini del mezzo. Un’applicazione più recente, e interessante, del binomio musica-dialetto (emiliano) si ha in Radiofreccia (1998) di Luciano Ligabue, con una credibile ricostruzione della temperie degli anni settanta. Funzione corale, si diceva. Di là dall’accompagnamento musicale, in molti film (comici o drammatici) il vociare della massa indistinta è sovente trattato a mo’ di coro da tragedia (e commedia) greca, con un dialetto a volte estremo, prossimo alla musica, che si fa istanza talora del semplice colore locale, talaltra, più sensibilmente, delle posizioni ideologiche dell’autore del film, che parla mediante la voce del popolo. Numerosi gli esempi, da Germi a Tornatore a Crialese. 5. Alla prima funzione, quella di contorno, ma direi ancora più specializzato ad usum schermico, e quella simbolica (la quarta), ma con minor consapevolezza ideologica e più convenzionalità del medium, è l’impiego del dialetto come maschera, che in un certo senso diventa anche mascheramento del dialetto reale, sulla scorta della commedia dell’arte. È l’uso tipico della commedia all’italiana, nella quale il poliziotto, o il carabiniere, tonto parlerà lombardo e veneto (o napoletano, se è di cuore schietto come in Pane, amore e fantasia), né più né meno del facchino della commedia dell’arte; il sopraffattore, lo speculatore, il fannullone che ti vuole fregare a tutti i costi non possono che essere romani (o in subordine napoletano, quest’ultimo), il sessuomane siciliano, da Germi in poi, il tiramm’ a campà e vogliamoci bene nonostante tutto napoletano; ricco (o povero, ma sempre sopraffattore), antipatico e snob il milanese (o la milanese, Franca Valeri in primis); tardivo e originale il vitellonismo lucano-pugliese di I basilischi della Wertmüller, ecc., pochissimo rappresentati, fino agli anni ottanta, tutte le altre
Lingua Fabio Rossi
171
varietà regionali. Si tratta sempre, si badi bene, di pallidissimi italiani regionali, ancora tutti postsincronizzati naturalmente, non certo di dialetti veramente parlati. Dal punto di vista della credibilità linguistica, infatti, siamo più o meno dalle stesse parti dell’ibridismo linguistico del neorealismo rosa, portato all’apice consolatorio da Poveri ma belli (come vedremo più dettagliatamente), con maggiore verve comica, non priva di affondo sociale (castigat ridendo mores), nei titoli migliori (Risi, soprattutto). L’effetto, di sicura presa sul grande pubblico, e molto dopo anche della critica, non può che velare, mascherare, appunto, il dialetto propriamente detto, ritardandone di qualche decennio la piena affermazione filmica (in presa diretta, fine anni ottanta, come vedremo). 6. Limitrofo all’uso precedente, è quello espressionisticoteatrale, dai toni più esasperati rispetto agli usi edulcorati della commedia all’italiana. Accade nel miglior Totò (e compagni), che stravolge più dialetti per il puro piacere infantile e prelinguistico del gioco verbale. Ne deriva, oltre alla risata liberatoria, anche non poco straniamento, tale da rendere particolarmente azzeccata l’etichetta continiana di espressionismo linguistico (sulla linea antipetrarchesca Dante-Gadda), per questi usi43. Basterebbero il duetto in pugliese Totò/Guglielmo Inglese (il giardiniere che pota «lo gelsomene, lo tulepene, l’orchetette») e le derisioni del cognato siculo (Rocco D’Assunta), in Totò a colori (1952) di Steno, o lo scontro italo-franco-napoletano tra Totò e Enzo Turco (charcutier, sciacquettiere, pizzicagnolo, salumiere, cassadduoglio), in Miseria e nobiltà (1954) di Mario Mattoli, tra i moltissimi esempi possibili, per darne qualche prova. 7. Sempre di matrice espressionistica, e metalinguistica (ma non per questo meno ludica), è l’operazione di stravolgimento dei dialetti condotta da Lina Wertmüller (almeno in Mimì metallurgico ferito nell’onore, Film d’amore e d’anarchia e Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto), e soprattutto da Monicelli, Age e Scarpelli nei due Brancaleone. Entrambe le operazioni sono possibili soltanto in quanto gli italiani sono ormai completamente affrancati dalla vergogna del parlare in dialetto, e anzi possono 43
Cfr. C. Meldolesi, Fra Totò e Gadda. Sei invenzioni sprecate dal teatro italiano, Bulzoni, Roma 1987 e F. Rossi, La lingua in gioco. Da Totò a lezione di retorica, Bulzoni, Roma 2002.
172
Lessico del cinema italiano
guardare a quest’ultimo con rinnovato interesse inventivo e creativo, anche mettendolo en abîme, per far risaltare tanto le difficoltà comunicative, quanto il recente passato dell’estrema frammentazione italiana. 8. La funzione caricaturale, macchiettistica o grottesca si attua nelle farse dialettali sullo stile di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (o del Totò deteriore), ma anche nelle produzioni successive: i fratelli Vanzina, Neri Parenti e simili. Si tratta della versione meno impegnata, meno inventiva e meno graffiante delle funzioni individuate ai punti 5, 6 e 7, perlopiù parassitaria, a partire dagli anni ottanta, della comicità cabarettistico-televisiva, a sua volta derivata da quella dell’avanspettacolo. Da questo consegue il carattere frammentario delle trame, cucite addosso a monologhi e scenette degli attori comici più in voga, quasi un pretesto per le loro battute più amate dal pubblico. Anche se si tratta di prodotti di cassetta, senza alcuna ambizione critica, ciò non toglie che alcuni di questi film aiutino a capire meglio di altri la temperie (anche linguistica) di un determinato periodo, com’è il caso dello yuppismo ritratto da molti film dei Vanzina, a partire dal film eponimo, Yuppies – I giovani di successo (1986). Taluni registi hanno sfruttato gli interpreti della farsa decontestualizzandoli totalmente dalla lingua e dallo stile a loro consoni. Il risultato migliore di un’operazione siffatta è senza dubbio il corto Che cosa sono le nuvole? (1968) di Pier Paolo Pasolini. 9. Tinte giovanili e neogergali assume il dialetto a partire dalla fine degli anni settanta, soprattutto con Nanni Moretti, che sbugiarda, almeno a partire da Ecce bombo (1978), molti usi cristallizzati, gli stereotipi, le espressioni idiomatiche, i neologismi, i forestierismi di cui non c’è reale bisogno e che spesso nascondono l’assoluta incapacità di esprimere un libero pensiero. Il film rivendica una dignità al nuovo italiano giovanile a base romana e al contempo ne critica gli abusi (i successivi film del regista saranno sempre meno regionalizzati e sempre più critici contro il romanesco di maniera: «Ma che siamo in un film di Alberto Sordi? [...] Te lo meriti Alberto Sordi»), le parole e le pronunce alla moda, i plastismi, le espressioni senza senso e dette solo per darsi un tono. Così si rivolge alla madre, biasimandone i settentrionalismi:
Lingua Fabio Rossi
173
Silvia, non la Silvia. Fortunatamente mamma siamo a Roma, non a Milano: la Silvia, il Giorgio, il Pannella, il Giovanni. Cacare, non cagare, fica non figa. Queste non sono parolacce, è linguaggio dei giovani. Noi giovani parliamo così.
Analogamente, se la prende con l’amante Flaminia perché osa dire: «Sta d’un male». E ancora, contro la moda dei diminutivi: «Dada, Deda, Dudù, Dudu, Dinda, Danda, come stanno tutti i tuoi amici?». Per giungere alla celeberrima sparata contro l’evanescenza giovanile del «Faccio cose, vedo gente»: – Senti, me n’ero dimenticato, che lavoro fai? – Beh, mi interesso di molte cose: cinema, teatro, fotografia, musica, leggo… – E concretamente? – Non so cosa vuoi dire. – Come non sai? Cioè, che lavoro fai? – Nulla di preciso. – Beh, come campi? – Mah, te l’ho detto: giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose…
La banalità e la decontestualizzazione delle metafore televisive è impietosamente messa alla berlina nel cronista di Telecalifornia, che proferisce amenità quali «sei un filo di cotone», «i tuoi capelli hanno il profumo degli agrumi di Sicilia». In un altro momento del film, è l’espressione, ossessivamente iterata, dare atto a innescare l’ironia. Moretti continuerà in ogni suo film a criticare il distacco del linguaggio irriflesso (soprattutto dei media e dei politici) dalla realtà, a smascherare gli inganni della lingua e le mistificazioni che dietro di essa si nascondono. Sembra proprio questo, parallelamente alle ossessioni moraleggianti del regista, ben più che la cura delle immagini, il pregio principale dei suoi film. Tocca l’acme nella scena, ormai proverbiale, di Palombella rossa (1989), contro la giornalista che infioretta il proprio eloquio a base di tensione morale, matrimonio a pezzi, rapporto in crisi, alle prime armi, fuori di testa, kitsch, cheap e l’ineffabile trend negativo, al quale il protagonista reagisce con stizza, fino alla violenza fisica:
174
Lessico del cinema italiano
Lei parla in modo un po’ superficiale. Chi lo sa come scrive? [...] Dove l’andate a prendere queste espressioni?! [...] (urlando) Ma come parla?! [...] Come parla?! Come parla?! Le parole sono importanti! Come parla?! [...] Non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili. Noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. [...] Chi parla male pensa male! E vive male. Bisogna trovare le parole giuste! Le parole sono importanti! [...] Trend negativo! (ridendo) Trend negativo! Io non parlo così. Non penso così. Trend negativo44!
Del primo Troisi, anche lui fine ritrattista del parlato giovanile, s’è già detto. Così come la lingua dei bambini (non di rado doppiati da donne, fino a pochi decenni fa, a conferma della scarsa attenzione alla riproduzione realistica di questa fascia d’età), anche quella dei ragazzi più o meno giovani è stata di rado rappresentata in modo credibile, prima dei film di Francesca Archibugi: soprattutto con Mignon è partita (1988), ma anche in Il grande cocomero (1993), L’albero delle pere (1998) e Lezioni di volo (2007), la regista spicca per uno sguardo originale e credibile, non edulcorato né consolatorio, sul mondo dei bambini e degli adolescenti, e anche sul loro modo di parlare (perlopiù romano). Negli anni più recenti, il cinema sui mondi giovanili (e giovanilistici) oscilla tra usi estremamente realistici (Come te nessuno mai, 1999, di Gabriele Muccino; Scialla!, fino ai casi estremi dei giovani problematici, come in Certi bambini, 2004, di Andrea e Antonio Frazzi), usi farseschi (Immaturi, 2011, di Paolo Genovese) e usi oltremodo annacquati del dialetto e del gergo giovanile (Tre metri sopra il cielo, 2004, di Luca Lucini; Parlami d’amore, 2008, di Silvio Muccino). 10. Concludiamo la rassegna con quei film nei quali la trama, l’ambientazione e lo status dei personaggi implicherebbero l’uso del dialetto, che invece lascia tutto il campo (o quasi) all’italiano standard. Fame chimica (2003) di Antonio Bocola e Paolo Vari e Il seme della discordia (2008) di Pappi Corsicato sono casi evidenti di dialetto negato, evitato, atteso ma assente. L’italiano standard 44
Sulla lingua di Nanni Moretti, cfr. E. Picchiorri, Le parole sono importanti. Appunti sulla lingua dei film di Nanni Moretti, in “Studi linguistici italiani”, n. 1 (2007), pp. 109-125 e P. Trifone e E. Picchiorri, Lingua, dialetto e creatività nel cinema italiano, in Dialetto, memoria e fantasia, a cura di G. Marcato, Unipress, Padova 2007, pp. 115-126.
Lingua Fabio Rossi
175
del protagonista Claudio e di quasi tutti gli altri personaggi del primo film stride fortemente con il contesto sociale della periferia malfamata di Milano. Eppure il dialetto, cacciato dalla porta, rientra inevitabilmente dalla finestra. In effetti all’ineccepibile (e innaturale, “doppiaggese”: anche i colloquialismi vengono pronunciati con ostentazione teatrale) italiano della voce narrante iniziale (quella del protagonista) si contrappongono tanto le scritte sui muri (tra le quali campeggia suca), quanto la canzone parzialmente napoletana del rapper Luca “Zulù” Persico, della band “99 Posse”. La sigla iniziale combina, infatti, assai liberamente, superstandard (progettualità), dialetto (faticà “lavorare”), substandard (nessuno non ce l’ha) e gergo dei tossicodipendenti (a partire dall’espressione fame chimica “senso di fame indotto dall’assunzione di sostanze stupefacenti” e il classico roba “droga”), come a dire che il plurilinguismo atteso nel film è delegato interamente al rap proemiale. Il motivo del rifiuto del dialetto risiede forse in una precisa scelta produttiva e di target, per abbracciare il pubblico più ampio possibile (qualcosa di analogo alla paraletteratura e all’alleggerimento ammiccante del dialetto nei film tratti dai romanzi di Moccia). Oppure, nei casi migliori (Corsicato), per contrapporsi alla tendenza maggioritaria del cinema italiano, vale a dire quella dell’adozione indiscriminata dell’italiano regionale, fuggire dalle insidie della farsa e accostarsi, invece, a una ricostruzione di ambiente con maggiore consapevolezza critica. Se il dialetto indica una certa adesione emotiva ai personaggi descritti, l’italiano, di contro, ne marca tutta la distanza. Si potrebbe concludere che l’uso del dialetto in contrapposizione all’italiano riflette almeno due atteggiamenti contrapposti, ma non sempre facilmente separabili: da un lato, quello progressista, per dir così, della rivendicazione di una lingua vera, autentica, contrapposta all’omologazione e all’ipocrisia della lingua nazionale. È quanto accade, direi esemplarmente, nella scena della messa di beneficienza di Ladri di biciclette, in cui, pur senza negare il macchiettismo e la facile risata, De Sica e Zavattini assimilano efficacemente il latino della messa all’italiano impettito delle dame di carità e dei loro aiutanti, nella loro natura di lingue altre, distanti dalle reali esigenze della gente, lingue mistificatorie e oppressive, rispetto al romanesco verace del derubato Ricci, di suo figlio Bruno
176
Lessico del cinema italiano
e anche del vecchio macilento amico del ladro. D’altro canto c’è il dialetto come codice della non consapevolezza, lingua precivile e prepolitica, in contrapposizione all’italiano nazionale, l’unica lingua che possa garantire un reale cambiamento. Una lingua (e una coscienza critica), in verità, più vagheggiata che conseguita. È quanto accade nel già commentato trilinguismo di Roma città aperta, in cui l’italiano standard si contrappone tanto al tedesco quanto al romanesco e la stessa Magnani, quando parla di politica col suo Francesco (doppiato in un italiano quasi immacolato), romaneggia molto meno che in altre scene. Giacomo Debenedetti, pur parlando di letteratura anziché di cinema, aiuta a capir meglio quest’ultimo impiego del dialetto come forma di vita e visione del mondo: Il dialetto è il linguaggio caldo e conservatore di una vita accettata, senza sorprese, mentre la lingua della più vasta koiné nazionale è il linguaggio che deve affrontare i problemi nuovi, la creazione coraggiosa della vita al di fuori delle abitudini [...]. Il neorealismo [,] con il suo ricupero di un dialetto fotografico e complice, è nella storia della narrativa una parziale retrocessione storica: naturalmente, bisogna distinguere tra dialetto fotografico e dialetto inventivo: dialetto critico come in Gadda, che è un negatore del neorealismo, dialetto psicologico come in Paolini [,] che se ne serve per esternare un momento storico della periferia dell’uomo non ancora arrivato al centro della sua consapevolezza45.
Su analoghe posizioni, stavolta specificamente riferite al dialetto cinematografico, è Pucci. Il lavoro di svecchiamento iniziato dal cinema e dal romanzo neorealistici si è fermato prima della discussione critica della realtà rappresentata e ben prima della creazione di un personaggio nazionale veramente nuovo, differentemente da quanto accaduto in altre cinematografie e in altre letterature (è l’annosa questione, inaugurata da Salinari e Aristarco, del passaggio dal neorealismo al realismo critico, sulla scorta di Metello e Senso): Ma per quanti compiti espressivi abbia realizzato, il dialetto non ci ha portato al linguaggio nazionale-popolare, alla dimensione nazio45
G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento. Quaderni inediti, Garzanti, Milano 1983, p. 315.
Lingua Fabio Rossi
177
nale degli eroi, alla sfera etico-ideologica del “personaggio” realistico, ed è evidente perché. La ricerca di un linguaggio parlato nuovo, di un linguaggio nazionale-popolare avrebbe dovuto svolgersi attorno all’intuizione di un personaggio nazionale popolare, ma questa non ci è stata. Si capisce dunque perché il cinema si sia rivolto alla lingua popolare in modo documentario e materiale, perché siano mancati tentativi che la stessa letteratura stenta a darci […]. S’intenderà perché abbiamo detto che anche nei grandissimi films neorealistici v’è stata una riduzione “dialettale” dell’eroe, e ritorniamo a esemplificare con Paisà. Nel primo episodio, lingua, siciliano e americano, siciliano e tedesco sono, secondo noi, funzionali, perché la babele linguistica esprime coerentemente il contenuto dell’episodio: l’incontro e lo scontro di civiltà così diverse e incomunicabili, l’estraneità assoluta del popolo dalla vita nazionale e in qualche modo la sua completa mancanza di responsabilità nella guerra, ed infine anche la capacità “spontanea” di comprendere da che parte stiano i suoi amici. Qui l’eroina è una ragazza siciliana, di uno sperduto paese; e il contenuto dell’episodio espresso attraverso la sua figura ci pare coerente. Non così invece nell’ultimo episodio, quello dei partigiani del delta del Po (in parte anche in quello fiorentino), ove il dialetto e la babele linguistica (i partigiani hanno bisogno di un interprete) continuano, come abbiamo già rilevato, lo stesso contenuto (il puro istinto delle masse nella loro scelta, la “spontaneità” della loro azione, ecc.) e dove approdiamo così a una interpretazione non realistica, ma dialettalepopulista del movimento partigiano46.
Assai opportunamente, Pucci non limita le sue considerazioni sugli usi dialettali all’ambito cinematografico, né tantomeno a quello estetico, coinvolgendo bensì anche le produzioni, per certi versi analoghe, della letteratura, anch’essa, come il cinema, figlia di scelte ideologiche, vale a dire dell’incapacità degli intellettuali italiani di concepire personaggi nazionali realmente nuovi, frutto di una considerazione complessiva della società, critici, realistici più che neorealistici, ovvero liberi da semplificazioni stereotipate e macchiettistiche. Da un lato, infatti, la produzione neorealistica (e ancor più quella immediatamente successiva, diremmo noi) ha eccessivamente annacquato la realtà sociolinguistica del paese, guardandola con sospettoso distacco e accostandosi preferibilmente agli aspetti più populistici, di falsa spontaneità e coreografici del dialet46
P. Pucci, Impasto dialettale, cit., pp. 828-830.
178
Lessico del cinema italiano
to; dall’altro, invece, cinema e letteratura non sono stati in grado di operare il distacco necessario per capire e criticare la realtà descritta, rimanendo, pertanto, su un piano meramente documentaristico: Con tutte queste osservazioni non si vuole evidentemente invalidare il valore estetico-culturale di questi films, ma soltanto definirne la sfera ideologica. Del resto queste considerazioni non sono più nuove: si allineano a quelle più volte ripetute per la letteratura, sulla mancanza di un “personaggio” nazionale nuovo […]. Non sfuggirà infatti che il nostro film neorealista non ci ha dato alcun personaggio intellettuale (mentre così frequentemente il giornalista, il medico, l’avvocato ecc. hanno un ruolo realistico nel film americano); e non sapremmo spiegare questa assenza se non ricorrendo alla spiegazione che abbiamo ora dato, cioè all’interpretazione corporativo-dialettale che l’intellettuale italiano ha dato per lo più del mondo popolare con la conseguente impossibilità di cogliere i nessi essenziali della vita nazionale47.
La dicotomia della resa del dialetto riflette quella, tipica della filosofia e prima ancora della società italiana, del rapporto tra pensiero e mondo: un rapporto senza dubbio più vitalistico, più libero da vincoli ideologici e statali, da idee forti e da schemi precostituiti, più attento a cogliere il caos del reale e ad enfatizzare i contrasti e i conflitti, e dunque anche più disincantato nei confronti delle illusioni date da miti e lumi, rispetto ad altre tradizioni filosofiche. E tuttavia, proprio per questo, spesso incapace di (o forse semplicemente disinteressato a) grandi panoramiche, considerazioni sistematiche e a tutto tondo, più incline al particolare che all’universale, più all’immanenza (o meglio alla «relazione tra immanenza e conflitto») che alla trascendenza. La civilizzazione imperfetta (figlia del tardivo conseguimento di un’unità nazionale e linguistica e della incompleta costituzione di una solida e unitaria classe borghese) tipica della società italiana48, insomma, può essere ravvisata anche 47 48
Ibidem. I caratteri di tale civilizzazione imperfetta (che rendono la mentalità italiana al contempo più acuta, in quanto diffidente dei grandi sistemi ideologici e proclive alla disillusione, ma proprio per questo, o in quanto, priva di collanti sociali e di spinta al miglioramento), precocemente diagnosticati dal Leopardi nel 1824 (cfr. G. Leopardi, F. Cordero, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani seguito dai pensieri d’un italiano d’oggi, Bollati Boringhieri, Torino 2011), sono stati successivamente analizzati da
Lingua Fabio Rossi
179
nelle scelte linguistiche del nostro cinema, sempre in bilico, per dir così, tra norma e vita, tra visione uniformante e distaccata del reale e accostamento troppo coinvolto e poco critico nei confronti del reale stesso. Del resto, alto e basso, letterario e popolare, o per meglio dire finzione di letteratura e finzione di parlato, percorrono tutta la storia del nostro cinema, con frequenti quanto irregolari riemersioni di istanze realistiche. Inoltre, per via del culto della forma, inestirpabile a ogni altezza cronologica dalla nostra tradizione culturale, ogni tentativo di ricostruzione della realtà non può non passare al setaccio del bello stile. E ciò non può che riflettersi nella preferenza a lungo accordata all’italiano standard, o scarsamente regionalizzato, rispetto a riproduzioni più credibili dei dialetti e dei popolarismi. Andrà, d’altra parte, riconosciuto, a favore dell’interpretazione dell’italiano come lingua del realismo critico, rispetto al primitivismo bozzettistico del dialetto, che i momenti di maggior impegno civile e politico del nostro cinema (per esempio il Rosi di Le mani sulla città, 1963, o il Bellocchio di Sbatti il mostro in prima pagina, 1972) hanno optato per l’italiano, magari appena colorito foneticamente, piuttosto che per il dialetto. Anche se occorre ricordare che il cinema d’impegno politico-sociale si è sempre mosso su un doppio binario: da un lato adottando il dialetto o l’italiano regionale, con G. Bollati, L’italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi, Torino 2011 (I ed. 1983; soprattutto le pp. 35-127) e da R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010 (in partic., da p. 27 proviene la citazione). Un film recente sembra esprimere al meglio tali caratteri dell’italianità: La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino, in cui il lieve napoletano indolente, cinico e sornione dell’eccelso Toni Servillo, non meno del romanesco disincantato della Ferilli, sembrano dare voce e corpo ai malesseri italici e alle nostre ataviche disfunzioni. Appena di passata ricordiamo che il cinismo, che tanta parte gioca nel nostro miglior cinema, è considerato come una delle marche distintive del carattere italico da parte di Leopardi (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, cit., p. 29): «Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico di tutti i popolacci». Di grande interesse la “riscoperta” di Leopardi filosofo da parte di Mario Martone, Il giovane favoloso (2014). Il film, tra l’altro, offre, in presa diretta, scelte linguistiche apprezzabilmente variegate e credibili, tra realismo e stilizzazione artistica, che spaziano dall’inevitabile (ma stavolta filologicamente accorto) italiano letterario delle citazioni leopardiane, alle varietà regionali (marchigiana, fiorentina, romana e campana) dei personaggi di contorno.
180
Lessico del cinema italiano
finalità ora realistiche ora simboliche (Elio Petri), come già visto, dall’altro l’italiano standard. La medesima dicotomia si ha nelle produzioni più recenti, che oscillano tra l’italiano di Piazza delle cinque lune (2003) di Renzo Martinelli, Buongiorno, notte (2003) di Marco Bellocchio, il già commentato Fame chimica, e il dialetto, per esempio, di Romanzo criminale (2005) di Michele Placido o di La mafia uccide solo d’estate (2013) di Pif e in moltissimi altri casi49. Il rapporto tra realtà e finzione è mirabilmente così sintetizzato nell’originale didascalia conclusiva (dal sapore manzoniano) di Le mani sulla città: «I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce». Alcuni registi tematizzano efficacemente le ambiguità del rapporto dialetto/italiano. Nel mediometraggio televisivo La fine del gioco (1970) di Gianni Amelio, un giornalista (Ugo Gregoretti) invita il protagonista, un bambino che vive in riformatorio, a non parlare in dialetto; il bambino, così, usa l’italiano per raccontare particolari mitigati e poco significativi della propria vita, ma si esprime in dialetto per narrare i disagi profondi del riformatorio: G : Tu mi rispondi rapidamente, in italiano, perché sennò la gente non capisce […]. B : A chest’inverne che nun esce fòra. Che nun esce fòra eo… Pecché… G : Perché non parli italiano, per favore? B : È da quest’inverno che io non esco fuori dall’istituto, perché mia madre, eh, a Natale, no, dopo quei giorni che m’hanno dato la licenza, ha… ha protestato con la scusa che io la… la sera non rientravo a casa per dormire.
Il dialetto mostra qui tutta la sua forza di lingua emozionale, l’unica con la quale è possibile esprimere il disagio. Ma è un’espressione isolata e isolante, che non consente una reale presa di coscienza (e quindi un tentativo di cambiamento) della realtà. Il 49
Sul ritorno all’uso del dialetto (realistico, e non espressionistico alla Petri) e del plurilinguismo nel cinema italiano impegnato più recente cfr. A. Angelucci, Parlato, lingua, dialetto nel nuovissimo cinema italiano d’autore, in “Lingua italiana d’oggi”, n. 1 (2004), pp. 113-117 e Id., Il cinema civile non parla italiano: Saverio Costanzo (“Private”) e Roberto Faenza (“Alla luce del sole”), in “Lingua italiana d’oggi”, n. 2 (2005), pp. 295-305.
Lingua Fabio Rossi
181
regista, tuttavia, saggiamente e come di consueto in Amelio, non assume una posizione netta o preconcetta: sono qui assolutamente comprensibili, infatti, tanto la posizione del bambino (nel recalcitrare ad abbracciare una lingua che non sente propria), quanto quella del giornalista (nell’invito alla coscienza critica). La contrapposizione tra un dialetto specifico ed altri dialetti (oltreché l’italiano standard) è impiegata con estrema verosimiglianza, ma anche con raffinato gusto simbolico, in Salvatore Giuliano (1962) di Francesco Rosi, che, forse per la prima volta, segna un rinnovamento del siciliano filmico, non più farsesco (alla Germi), ma neppure irretito e reso incomprensibile dagli sperimentalismi della presa diretta viscontiana. È notevole, infatti, come, pur trattandosi di un film integralmente doppiato, il ventaglio delle varietà del Salvatore Giuliano risulti perfettamente credibile. All’italiano regionale (con lievi tinte fonetiche) dei notabili si contrappone il siciliano stretto dei picciotti. L’italiano dei giornalisti e il siciliano del popolo sono incommensurabili, come ribadisce un venditore di bibite a un giornalista che sta lavorando sulla morte del bandito Giuliano: – Che ne pensa lei di Giuliano? – Levava ai ricchi e dava ai poveri. – E basta? – Sissignore e basta. Di dov’è lei? – Di Roma – E che ne può capire lei della Sicilia?
Né tantomeno i soldati, tutti settentrionali, riescono in alcun modo a capire la realtà nella quale stanno rischiando la vita per sedare la rivolta autonomistica di Giuliano e dei suoi picciotti: – Porco can, dopo tanti ani de guerra! I me devo far cupar de sti zulù, in mezo a sti quatro sasi! – Ma perché sparano, ma i ghe se, banditi o partigiani? – Ma che aspetta l’Italia a darghe la libertà a sta zente? – Perché ha mandato noialtri quassù? Bastava un apparecchio per far scapar sti quatro ragazi!
Né, d’altro canto, i picciotti hanno chiara coscienza delle strumentalizzazioni di cui son fatti oggetto dai politicanti italiani. Dif-
182
Lessico del cinema italiano
ficile immaginare usi linguistici più funzionali al senso profondo del film, il quale, più che fare chiarezza, vuol proprio porre l’accento sulle ambiguità e le strumentalizzazioni dell’irrisolto caso Giuliano. Com’è noto, tuttavia, bisognerà attendere oltre venticinque anni, perché l’esempio di Rosi venga recepito e applicato. Il dialetto esprime anche l’estremo attaccamento alle radici locali contro i danni della globalizzazione. È quel che accade in Terraferma (2011) di Emanuele Crialese, film nel quale l’aspetto deteriore dell’italianizzazione (figura della globalizzazione, in questo film) è rappresentato dal fratello del protagonista, interpretato da Beppe Fiorello, che infatti parla italiano. Il dialetto, invece, ha un duplice valore: strumento identitario forte e handicap (il protagonista alterna il dialetto criptico di Lampedusa a un quasi mutismo, contrapposto soprattutto all’iperparlato dei turisti settentrionali con cui entrerà in relazione e in conflitto) che inibisce il riscatto, la ribellione, il cambiamento. La giovane madre (Donatella Finocchiaro), molto più emancipata del figlio, prova a scuotere il ragazzo proprio invitandolo a passare dal dialetto all’italiano: «Manco l’italiano sai parlare». Viene così ribaltato uno stereotipo del passato, che vuole i genitori come avvinghiati alla lingua d’origine, differentemente dai figli, integrati ai nuovi valori, anche linguistici. In Terraferma il cerchio si chiude, con il nipote molto più vicino alla prospettiva “locale” del nonno che a quella “globale” dello zio, con la madre in certo qual modo nel mezzo e con funzione di mediatrice. Sarà proprio la collaborazione tra madre, nonno, nipote e migranti (il nuovo local) a determinare, in un’ideale prospettiva glocal (la fuga dal micro al macromondo, ma con l’orgoglio del proprio bagaglio identitario), la rottura e il cambiamento che, stavolta, quasi inaspettatamente, arriverà, alla fine del film. Antirealismo, con qualche annotazione sulla televisione Posto che i film in vero e proprio dialetto sono un’esigua minoranza, nello storia del nostro cinema, mentre quelli in italiano regionale o in forme ibride, come vedremo, ne rappresentano una fetta consistente, il primato spetta senza dubbio ai film parlati in un italiano standard talmente pulito foneticamente, regolare morfosintatticamente e selezionato lessicalmente da risultare presso-
Lingua Fabio Rossi
183
ché inesistente, nella vita reale, se non sulle labbra dei doppiatori. Una lingua, dunque, fondamentalmente antirealistica, secondo una consolidata tradizione culturale italiana: quella attratta dal polo petrarchesco, per intenderci. È la lingua dei film di genere, soprattutto: mélo in primis, ma anche spaghetti western, giallo ecc., con qualche deroga per l’erotico, che, prossimo al comico, si accosta talora all’italiano regionale, dal romanesco di Alvaro Vitali al barese di Lino Banfi; e per il poliziesco comico della saga “der Monnezza” (Thomas Milian/Ferruccio Amendola); qualche altra eccezione per il romanesco doppiato di certi peplum (metafora semiludica del latino) e per il dialetto di pochissimi film d’animazione (da Gli Aristogatti ai romani di Asterix). È, ovviamente, anche la modalità espressiva di tutti i film doppiati da una lingua straniera ed è, soprattutto, la lingua della fiction televisiva. Ma è anche, con esiti e scopi comprensibilmente antitetici, la lingua di molto cinema d’autore, del cinema di poesia o filosofeggiante (Pasolini), che sicuramente in Italia dà meno frutti che in Francia e altrove50. Insomma c’è tutta un’amplissima fetta di cinema che non vuole affatto tentare di imitare il modo di parlare comune, ma vuole competere con teatro e letteratura nell’esibizione di una lingua colta, alta, letteraria, superstandard, non specifica dello schermo. Il caso più eclatante (che segue, come già detto, le consuetudini stilistiche della paraletteratura) è quello dei film di Raffaello Matarazzo, nel cui prototipo, Catene, le immagini pauperistiche degli ambienti dimessi (neorealistici) e le vicende quotidiane di un meccanico, un ladro e una casalinga confliggono con le musiche (alle canzoni è interamente delegata l’esigua presenza del dialetto nel film) e gli stereotipi visivi di una Napoli cartolinesca e soprattutto con la lingua libresca pronunciata da Lidia Simoneschi (che doppia Yvonne Sanson), Emilio Cigoli (che doppia Aldo Nicodemi) e il divo Nazzari, che doppia sé stesso. La scelta linguistica di 50
«Che meravigliosa occasione! Facendo parlare i miei personaggi anziché una lingua naturalistica o puramente informativa, solo prudentemente dotata di punte di espressività e di vivacità – facendo parlare i miei personaggi, anziché questa lingua, il metalinguaggio della poesia, risusciterei la poesia orale (andata da secoli perduta anche nel teatro) come una tecnica nuova, che non può non costringere a una serie di riflessioni: a) sulla poesia stessa, b) sulla sua destinazione», P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., p. 1599.
184
Lessico del cinema italiano
Matarazzo fu vincente, tanto che Catene fu il primo film italiano a superare la soglia del miliardo di lire di incasso. L’identificazione con i personaggi dello schermo era ingannevole: lo spettatore medio dialettofono e semianalfabeta, infatti, sognava di parlare quella lingua da “persone per bene”, illudendosi che «la Sanson pote[sse] essere una [sua] vicina di casa e Amedeo Nazzari [...] uno che avev[a] intravisto»51. La (dis)simulazione era perfetta: un’Italia in dissesto dava di sé non più l’immagine (acustica) della depressione e dell’ignoranza (come nei mille dialetti del neorealismo), bensì quella della capacità di competizione con realtà meno svantaggiate (soprattutto quella americana: Cigoli era il doppiatore di John Wayne e di mille altri divi hollywoodiani, la Simoneschi della Bergman e di cento altre). Il rapporto tra realismo e antirealismo, tuttavia, è sempre fluido, dialettico (frutto del patteggiamento tra attese del pubblico e scelte produttive), mai rigido. E non riguarda mai soltanto il codice verbale bensì l’intero intreccio semiotico del testo filmico. Pertanto può succedere che un prodotto linguisticamente iperrealistico, quale, tra gli altri, il dialettale e in presa diretta La terra trema o il sottoproletariato urbano filmato nel distico pasoliniano Accattone (1961) e Mamma Roma (1962), finisca per essere nella sostanza molto più antirealistico (poiché simbolico, infarcito di estetismi pittorici, filosofeggiante, ben prima che mimetico) di un prodotto nato proprio all’insegna dell’espressionismo, della falsificazione, dell’esibizione della finzione filmica contrapposta alla realtà, quale, ad esempio, tanto cinema felliniano, da 8 ½ a Amarcord e altri. Da questi ultimi film, infatti, la componente mimetica (dal dialetto alla frammentazione dialogica, per non parlare della verosimiglianza delle modalità realizzative e produttive del mondo cinematografico ritratte nel primo film) è inestirpabile. Fino a giungere al paradosso, intrinseco al cinema stesso, del sogno più reale della realtà. Che cosa c’è di più realistico (proprio nel senso di mimetico, nella dettagliata riproduzione dei meccanismi del linguaggio onirico) della messa in quadro del sogno di Mastroianni ad apertura di 8 ½? E cosa c’è di meno realistico delle rivendicazioni sindacali del pescatore ’Ntoni di Acitrezza (in La terra trema), ben più simi51
G. Amelio, Amelio secondo il cinema. Conversazione con Goffredo Fofi, Donzelli, Roma 1994, p. 32.
Lingua Fabio Rossi
185
le a un eroe risorgimentale che al personaggio verghiano, per non dire ai veri pescatori52? Posto che ogni parlato filmico non può mai essere più di un come se fosse parlato-parlato, il più dialettale dei film può essere ideologicamente viziato (i contadini bergamaschi di L’albero degli zoccoli come proiezione della nostalgia preindustriale di Olmi), almeno quanto l’italiano standard può essere al servizio di una visione critica della realtà (Germania anno zero di Rossellini, Umberto D. di De Sica e tanti altri). La scelta, in questa sede, di Catene come emblema di antirealismo linguistico si giustifica proprio in virtù del paradosso di una lingua così vicina, per certi aspetti, agli stilemi letterari, applicata a trame, personaggi e pubblico così popolari, tanto distanti dal polo della letterarietà. Non c’è tempo qui di approfondire altre soluzioni iperletterarie (e più consapevoli, in quanto sposano espressamente le modalità della letteratura) all’interno della storia filmica italiana, dallo Straub vittoriniano (Sicilia!, 1999; Operai, contadini, 2001, ecc.), a quello dantesco (O somma luce, 2010). Né v’è spazio per dedicarsi al Pasolini regista (qui volutamente messo in secondo piano rispetto al Pasolini saggista, più pertinente ai fini di un discorso sulla lingua), i cui film di ascendenza più letteraria (anche linguisticamente) concretizzano l’idea desanctisiana di un Medioevo (Boccaccio, Chaucer, Le mille e una notte) al contempo vicino alla vita (soprattutto nella fattispecie della sessualità) – e dunque al caos – e all’ordine iperestetizzante dell’eleganza formale, corporeo e spirituale insieme. C’è infine un altro tipo di allontanamento, sempre antirealistico, dalla mimesi della realtà. Dagli anni ottanta, il cinema spesso non riproduce la realtà, bensì la sua copia televisiva, più o meno deformata. Ecco dunque tanti film dei Vanzina con tutto l’armamentario linguistico (i tormentoni) dei comici del tubo catodico: Jerry Calà, Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio. Lo stesso
52
Sul laboratorio linguistico di La terra trema (operazione «più espressiva che documentaria, più espressionistica che naturalistica», contro «qualsiasi idea di neorealistica improvvisazione o di supposta spontaneità popolare»), cfr. S. Parigi, Il dualismo linguistico, in La terra trema di Luchino Visconti. Analisi di un capolavoro, a cura di L. Miccichè, Associazione Philip Morris Progetto Cinema-Centro Sperimentale di CinematografiaCineteca Nazionale-Lindau, Torino-Roma 1994, p. 142.
186
Lessico del cinema italiano
geniale Paolo Villaggio proviene dalla televisione e prima ancora dal cabaret. I tentativi più riusciti di questo connubio piccolo-grande schermo hanno sicuramente fotografato nodi fondamentali della nostra storia sociale, e dunque anche linguistica, come già negli anni precedenti (l’osmosi tra i due mezzi risale alla fine degli anni sessanta), e più acutamente, gli svarioni dei congiuntivi del ragionier Fantozzi. Si ricordi infine che molti dei migliori attori-registi comici italiani provengono dalla televisione: Benigni, Troisi, Verdone. Il rapporto tra cinema e televisione fa dunque migrare, da un mezzo all’altro, non soltanto personaggi, maestranze, generi e stili, ma anche usi linguistici, com’è inevitabile. Nel costante rapporto di dare/avere che il cinema intrattiene con la vita reale, infatti, il suo triplice potere di specchio (già commentato nel primo capitolo), riflettente, deformante e uniformante, irradia anche (di ritorno, dopo esserne stato irradiato) la lingua dell’uso quotidiano, sotto forma di frasi fatte, antonomasie o semplici modi di dire che, soprattutto dai titoli, entrano a far parte del vocabolario italiano: smisurata sarebbe l’esemplificazione, da sciuscià a dolcevita, da paparazzo all’armata Brancaleone, da sedotta e abbandonata a al di sopra di ogni sospetto. Parole e frasi che, talora, il cinema restituisce all’italiano comune dopo averle prese da altri ambiti (per esempio dal giornalismo o dalla burocrazia: sedotta e abbandonata, al di sopra di ogni sospetto), talaltra regala alla lingua dell’uso dopo averle create più o meno dal nulla: dolcevita, paparazzo da cognome a nome comune; altre volte ancora deformandone la pronuncia da una lingua straniera: sciuscià. Anche in questo processo neologico e divulgativo, dunque, la lingua filmica rimane fedele alla sua natura bifronte realistica/antirealistica, mimetica/espressionistica. Forme ibride In film come Poveri ma belli, L’impasto dialettale è stato abilmente elaborato in modo folcloristico […] in modo da far risaltare quanto vi è di più tradizionale e di più acquisito nel piccolo mondo dialettale del borgo o del quartiere.
Lingua Fabio Rossi
187
Naturalmente però ha qualcosa di popolare, di folcloristicamente popolare ed è quella sua patina di falsa freschezza e di falsa spregiudicatezza che manda in visibilio le folle piccolo-borghesi. È il dialetto che abbassa i popolani a macchietta, nel migliore dei casi a personaggi divertenti e che ha un rivelatore riscontro con certi personaggi dialettali dei programmi regionali della RAI53.
È, la lingua di Poveri ma belli, una sorta di romanesco, o meglio un «neoitaliano» (fintamente) sfatto, che diventa «suggello di democraticità linguistica [...], uno strumento espressivo ibrido e composito, ma dotato di notevole duttilità e di un efficace potere unificante»54. Per depurare il nostro discorso da un alone impressionistico, caliamolo nei dati concreti di una piccola verifica linguistica, sulla base delle prime scene di Poveri ma belli, dalla quale la componente di ibridismo e di artefatta combinazione di tratti tra loro difficilmente conciliabili, in uno stesso parlante in carne e ossa, si evince chiaramente. I giovani romani interpretati da Maurizio Arena, Renato Salvatori, Marisa Allasio, Alessandra Panaro, Lorella De Luca e gli altri personaggi del film (tutti rigorosamente doppiati da altri interpreti, ad eccezione dei fratelli Carotenuto, che doppiano sé stessi) agiscono nel cuore della capitale e, nella finzione scenica, provengono tutti da ambienti proletari o piccolo-borghesi, privi o quasi di basi culturali. Tanto più sorprendente, pertanto, ravvisare nelle loro battute vistosi tratti antiromaneschi, toscani o scolasticamente standardizzati (dei veri e propri “doppiaggismi”), quali il dittongo al posto del monottongo (buongiorno); la laterale palatale in luogo della semiconsonante («L’avete svegliato?», vogliamo); l’apocope vocalica in luogo della sillabica («Lo vogliamo far dormire»; «deve lasciar libero»); le e gli in luogo di je, forme piene insieme con forme apocopate, pleonasmi sintattici unitamente a una morfologia e una pronuncia da manuale conflagrano 53 54
P. Pucci, Impasto dialettale, cit., p. 827. Su temi analoghi cfr. anche L. Chiarini, La questione del dialetto, in “Cinema nuovo”, n. 80 (1956), pp. 213-214. V. Spinazzola, Lingua e film: dal romanesco al neoitaliano, in “Il Contemporaneo”, n. 1 (1965), pp. 13-14. A definire il nuovo romanesco (o romanaccio) mediatico, più che un vero dialetto, un «italiano sfatto» fu Alberto Moravia, nella quinta puntata della trasmissione di A. Giannarelli, Come parla il cinema italiano, RAI 3, 1982.
188
Lessico del cinema italiano
nella seguente battuta pronunciata da Salvatore: «Non le bastavo io, a mamma, che le volevo tanto bene? Dagli a fà figli. Guarda che disgraziati che sono venuti fuori!»; chiusura della e protonica in i («se mi danno il turno di giorno voi perdete l’inquilino. O ti dovessi credere che io la notte vengo a dormire abbracciato con te?!»), anche commista a romaneschismi di bandiera come mo, ’sta e ahó, nonché alla solita apocope vocalica far, inesistente a Roma, che conosce soltanto l’apocope sillabica fà “fare”: «Mo ti fai ’sta mesata di sonno! Ti saluto!»; «Ahó, se ti ricapita nel letto, non gli far male, al grillo, che quello è il grillo di Iolanda». E ancora: sintassi e pronuncia innaturalmente ricercate (per il contesto, la fraseologia e lo status dei personaggi), con incastonate alcune pietruzze romanesche: «Ah! È il grillo de Iolanda. Poverello! Credevo che se ne fosse andato. Vieni qua, bello!» (poverello è toscano, o letterario, a fronte del romano poraccio). E l’analisi potrebbe andar avanti molto a lungo, dalla s intervocalica sempre sonora (in luogo della sorda romana), alla pronuncia aperta del condizionale (-èbbe), a Roma sempre chiusa. La forzata (ma efficace, a giudicare dal successo di pubblico) convivenza di singoli tratti regionali con tratti superitaliani in bocca doppiata è la cifra distintiva di gran parte dei film del neorealismo rosa (si pensi anche alla saga inaugurata da Pane, amore e fantasia, in napoletano ibridato), e poi di gran parte delle commedie all’italiana. La comprensibilità delle più vaste platee era garantita, senza per questo rinunciare al colore locale. Il consenso del pubblico premiava forse anche un altro merito, di questi film, quello cioè «di attenuare negli italiani, e in particolare negli inurbati “senza lingua”, il timore di “parlare male”, e di incoraggiarli quindi a esprimersi comunque, anche in difformità dalla norma»55. Dialetto ma non troppo, si potrebbe dunque riassumere; parche deflessioni dalla norma, che non intacchino l’ordine costituito. L’ottica consolatoria e potentemente reazionaria di questi film trova nello stile dei dialoghi un perfetto corrispettivo alla loro morale: mai mettere in dubbio la rigida separazione tra le classi sociali, se non si vuole soffrire inutilmente; i poveri, ancorché belli, è bene 55
S. Raffaelli, La parola e la lingua, in Storia del cinema mondiale. Teorie, strumenti, memorie, a cura di G.P. Brunetta, vol. V, Einaudi, Torino 2001, p. 884.
Lingua Fabio Rossi
189
che rimangano poveri, come ricchi i ricchi. E la politica (o la critica sociale) porta solo guai, come riassunto dalla battuta emblematica di Antonio, che così si schermisce dai rimproveri del maresciallo d’essersi messo strane idee (sociali) in testa: «State tranguillo, signor maresciallo. Io so’ nu buono guaglione, e ’o saccio che idee in testa non ne devo tené» (Due soldi di speranza, 1952, di Renato Castellani). I mascheramenti linguistici della commedia all’italiana Non c’è bisogno di ascoltare il finto siciliano di Divorzio all’italiana (1961) o di Sedotta e abbandonata (1964), per rendersi conto dell’operazione di mascheramento operata da quelle commedie. Basta soffermarsi su alcuni dettagli delle locandine o dei fotogrammi del primo film. Primo piano del maschio italico (Mastroianni, reso meno freddo e anonimo dal regista), baffi e capelli nerissimi, impomatati, anello al dito, sguardo tra il sornione, il sensuale e il rapito da un sogno, schivo con la moglie (baffuta e allontanante) quanto audace con l’amante. Gli stereotipi del gallismo siculo alla Brancati ci sono tutti e tutti sono adeguatamente sottolineati, messi in maschera e derisi dal regista, che chiede e ottiene in questo la complicità del pubblico. I dialoghi del film non fanno che confermare la maschera: un siciliano (catanese) tutto ricostruito (nel doppiaggio), che mantiene i tratti fonetici più riconoscibili e comprensibili (dal vocalismo alle cacuminalizzazioni: curnutu, beddu, figghia...), incastona alcuni lemmi autoctoni, adeguatamente glossati («alt! indovinato: le chiocciole, i babbaluci» “lumache”, Sedotta e abbandonata), e italianizza quasi tutto il resto (morfologia, lessico e sintassi, a parte i passati remoti e qualche inversione: «durante l’attu lussuriusu nun ne provasti schifu eh?», «fimmina è», Sedotta e abbandonata)56. La 56
Il siciliano dei film di Germi è stato analizzato da C. Scavuzzo, Il siciliano filmico di Pietro Germi tra italianizzazione e ibridazione, in “Rivista Italiana di Dialettologia”, n. 35 (2011), pp. 85-108. Sui mascheramenti (anche linguistici) della commedia all’italiana cfr. Commedia all’italiana. Angolazioni e controcampi. La lingua e i dialetti della commedia, a cura di R. Napolitano, Gangemi, Roma-Reggio Calabria 1986 e M. Grande, La commedia all’italiana, cit.
190
Lessico del cinema italiano
risata è assicurata, la critica all’infame legge sul delitto d’onore e il matrimonio riparatore pure, il colore locale è garantito. Tale negoziazione, riprodotta all’infinito, rafforza lo stereotipo del siciliano sanguigno, geloso e sessuomane, quello stesso stereotipo che Bolognini, sempre grazie a Brancati, oltreché a Pasolini, aveva già infranto con l’impotente Mastroianni di Il bell’Antonio (1960) e che, sul piano linguistico, lo stessi Germi aveva evitato, postsincronizzando i suoi primi due film siciliani in un italiano quasi impeccabile: In nome della legge (1949) e Il cammino della speranza (1950). Procediamo nell’esemplificazione. La grande guerra (1959) di Mario Monicelli dispiega almeno le seguenti varietà, oltre all’italiano standard: milanese, romano, veneto, pugliese, siciliano, tedesco. Esibisce inoltre, fin dall’esordio, numerosi stereotipi linguistici emblematici della commedia all’italiana. In nessun altro film il romanesco di Sordi incarna meglio l’indolenza, l’elasticità morale e la capacità di cadere sempre in piedi del piccolo borghese (e anche del proletario) italiano, che l’attore interpreta, da par suo, fin dall’entrata in scena; in divisa, si taglia le unghie svogliatamente, incurante dell’orda di futuri soldati alla visita di leva, che dovrebbe sorvegliare e che si limita ad apostrofare con un distratto: «Shhh! Bboni! Shhh! State bboni! Shhh!», subito prima di essere facilmente corrotto da Gassman. Il detto (State bboni), diventato immediatamente proverbiale, sarebbe stato rinverdito, anni dopo, dal Maurizio Costanzo televisivo, che così apostrofava il suo pubblico del Teatro Parioli. Al Sordi monicelliano così si rivolge Gassman, a conferma dello stereotipo: «Romano, eh? [...] L’italiano in fanteria, il romano in fureria». Più volte il Busacca (il personaggio milanese interpretato da Gassman) ribadisce il suo razzismo antimeridionale, per esempio durante le esercitazioni belliche, rivolgendosi al “sicilianissimo” (di Oristano, ma sempre doppiato in siciliano, a partire da I soliti ignoti) Tiberio Murgia, apostrofato con: «Romano! Da Parma in giù, tutti romani, e camorristi anche!». E, poco dopo, in riferimento al fatalismo di un soldato pugliese: «Quello che vi frega, a voi altri popoli non emancipati e che mangiate il sapone, è il fatalismo rinunciatario». Per arrivare, a metà film, al duetto Gassman-Sordi, che declinano entrambi l’offerta di sparare per primi al soldato austriaco: «Sei un pelandrone, sei! Altro che miope! Come tutti i romani». «Appunto. Spara tu che sei milanese».
Lingua Fabio Rossi
191
Come si vede, La grande guerra si serve di tutti i cliché linguistici della tradizione comica teatrale e avanspettacolare. Lo stereotipo è spesso confermato, dalla commedia all’italiana (Germi), altre volte ribaltato (in modo un po’ superficiale e consolatorio, da italiani brava gente, come nella chiusa di La grande guerra), ma raramente messo in discussione criticamente57. La commedia all’italiana fa un uso della lingua direi paradigmatico, mettendone in evidenza proprio la doppia natura. La maschera linguistica dei nostri comici (prima dell’arte e poi dello schermo), insomma, da un lato sottolinea (come una caricatura) i tratti locali, dall’altro li standardizza, stereotipizza, tende a confonderli annacquandoli in una ricostruzione volutamente imperfetta. La maschera ha insomma una natura ossimorica e paradossale: amplifica la voce velandola, nasconde i connotati della persona enfatizzandoli. Il ruolo dell’italiano comico postsincronizzato sembra simile, per certi aspetti, a quello che, in letteratura, Pier Paolo Pasolini attribuiva al discorso indiretto libero. Quando un autore, nella creazione di una storia, anziché dar la parola a un personaggio per farlo parlare in modo verosimile, s’appropria della sua lingua, ricreandola (un po’ come il Manzoni dell’Addio ai monti), abdica al proprio ruolo di voce narrante imparziale, per indossare i panni di qualcun altro. Tuttavia: Un autore può rivivere i pensieri e non le parole che li esprimono, solo in un personaggio che abbia almeno la sua educazione, la sua età, la sua esperienza storica e culturale: in altre parole, che appartenga al suo mondo. Allora accade un fatto terribile: che quel personaggio è unito all’autore dal fatto sostanziale di appartenere alla sua ideologia. La cosa più odiosa e intollerabile, anche nel più innocente dei borghesi, è quella di non saper riconoscere altre esperienze vitali che la propria: e di ricondurre tutte le altre esperienze vitali a una sostanziale analogia con la propria. È una vera offesa che egli compie verso gli altri uomini in condizioni sociali e storiche diverse. Uno scrittore borghese, anche nobile, anche alto, che non sappia riconoscere i caratteri estremi della diversità psicologica di un uomo dalle esperienze vitali diverse dalle sue – e che anzi, creda di impadronirsene cercando 57
Sulla lingua della filologia dei principali film di Monicelli cfr. ora F. Franceschini, Monicelli e il genio delle lingue, Felici, Pisa 2014.
192
Lessico del cinema italiano
delle sostanziali analogie, quasicché altre esperienze che la sua non fossero concepibili – compie un atto che è il primo passo verso forme di difesa dei privilegi e addirittura di razzismo: in tal senso egli non è più libero, ma appartiene deterministicamente alla sua classe: non c’è soluzione di continuità tra lui e un commissario di polizia o un boia dei Lager. Nel caso che un autore sia costretto, per rivivere i pensieri del suo personaggio, a rivivere le sue parole, vuol dire che le parole dell’autore e quelle del personaggio non sono le stesse: il personaggio vive dunque in un altro mondo linguistico, ossia psicologico, ossia culturale, ossia storico. Egli appartiene a un’altra classe sociale. E l’autore dunque conosce il mondo di quella classe sociale solo attraverso il personaggio e la sua lingua58.
Da un lato, solo il dialetto (e non sempre: La terra trema), il parlato-parlato e la presa diretta dell’attore preso dalla strada consentono un vero discorso diretto, contrapposto al discorso indiretto libero (o talora solo indiretto) di tante commedie all’italiana, ma anche di tanto neorealismo e di tanto cinema d’autore: i bambini di Comencini, o di De Sica, non parlano come i veri bambini, i migranti di Rocco e i suoi fratelli (1960) di Visconti non parlano come i veri migranti. Solo il documentario, o comunque il cinema non di consumo, può riuscire, forse, nell’impresa vagheggiata da Pasolini: «Non mi consta, infatti, che sia stato ancora “rivissuto” il discorso interiore di un operaio col suo linguaggio in quanto linguaggio specifico dell’operaio»59. La commedia all’italiana, insomma, si inserisce perfettamente nell’andamento altalenante del rapporto, già commentato, tra norma e vita tipico del nostro cinema. Un andamento irregolare, a singhiozzo e non necessariamente coerente con il procedere cronologico delle correnti e degli eventi, ora più sbilanciato verso la riproduzione della vita (neorealismo, ma con numerose eccezioni), con le sue sfaccettature e le sue contraddizioni, ora soggetto a picchi di normalizzazione del codice (neorealismo rosa, mélo, anch’essi con eccezioni). L’enfasi della diversità, delle varietà e dei conflitti, la sottolineatura della disillusione e soprattutto il precocissimo – rispetto alle altre forme espressive – av58 59
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., pp. 1356-1357. Ivi, p. 1374.
Lingua Fabio Rossi
193
vertimento della crisi (economica, intellettuale, sociale, morale, psicologica), al punto da snidarla già nelle pieghe del boom economico – più avvertito, costruito e parodiato che realmente vissuto – caratterizzano senza dubbio questa felice stagione del nostro cinema60, anche se, sul piano della lingua, come abbiamo visto, tale feconda attenzione al caos sembra cedere il passo alla negoziazione coi gusti e le aspirazioni del grande pubblico piccolo borghese, nella consueta spinta paraletteraria verso la standardizzazione del codice. Non va peraltro trascurato un altro importante merito linguistico della commedia all’italiana, quello di aver deriso, smascherandola, l’antilingua burocratica come Luogo principe della mistificazione: si pensi alle arringhe degli avvocati (Divorzio all’italiana), alle prediche del clero (“Tantum ergo”, episodio di I nuovi mostri), agli arzigogoli dei burocrati (“Il cittadino, lo stato, la chiesa”, episodio di Made in Italy), in cui il potere nelle sue varie forme esprime il proprio volto manipolatorio. Questo italiano altisonante e criptico [...] palesa un uso anticomunicativo e specioso della lingua, utilizzato a difesa di interessi particolari. [...] Quello che la commedia all’italiana sembra dirci è che nella finzione della lingua si nascondono verità inconfessate che riguardano tanto l’immagine pubblica quanto l’intimità più privata. È forse per questo che si cerca la rassicurazione dello stereotipo61?
Iperrealismo o espressionismo, con qualche riferimento al silenzio La fine degli anni ottanta costituisce un momento cruciale del cinema italiano, in quanto si affermano con vigore nuove istanze realistiche nella messinscena filmica della parola. Dopo mezzo secolo, si torna a preferire la presa diretta alla postsincronizzazione, e questo dato immette nel nostro cinema una tale ventata realistica (già anticipata dai cosiddetti nuovi comici: Benigni, Nuti, Verdone e Troisi), da far gridare molti critici all’avvento di un
60 61
Sul cinema e la letteratura della crisi cfr. D. Tomasello, Ma cos’è questa crisi. Letteratura e cinema nell’Italia del malessere, il Mulino, Bologna 2013. M. Comand, Commedia all’italiana, Il Castoro, Milano 2010, p. 44.
194
Lessico del cinema italiano
neo-neorealismo62. Ampia parte di questo rinnovamento spetta ad autori siciliani, o quantomeno a film ambientati e girati in Sicilia e in siciliano. Nel 1989 esce Mery per sempre di Marco Risi, film che, «al di là dei suoi limiti che oggi ci appaiono con più chiarezza, è stata davvero una bomba nel cinema italiano dei nostri anni»63. Con questo e con il film successivo del medesimo regista (Ragazzi fuori, 1990), ci si allontana abissalmente dal siciliano posticcio delle commedie di Germi, da quello metonimico e simbolico dei mafia movies e da quello farsesco dei film della Wertmüller o della coppia Franchi-Ingrassia. Per la prima volta (dopo gli esempi, altissimi ma non fruttiferi, di La terra trema e di Salvatore Giuliano) il siciliano si scrolla di dosso non tanto l’italianizzazione forzata dettata dal doppiaggio e dalle esigenze distributive, quanto la patina di falsità e di strumentalizzazione, per diventare il primo dialetto impegnato d’Italia, che farà presto da traino per altri rinnovamenti: il napoletano anticanzonettistico di L’amore molesto (1995) di Mario Martone, il nuovo romanesco e altri casi sotto citati. L’accostamento del cinema alla lingua spontanea, il meno mediata possibile (apparentemente), prossimo alla ricerca dell’immagine pura, non modificata, mero piano-sequenza (da Warhol a Lars Von Trier, meno evidenti ed estremi gli esempi italiani: Antonioni, Olmi, Agosti, Grifi e Sarchielli), mostra in tutta la sua evidenza come iperrealismo ed espressionismo possano essere due facce della stessa medaglia. Assuefatti, come siamo, alle manipolazioni del montaggio, delle luci, dell’azzeramento delle varietà indotto dal doppiaggio, ogni tentativo di restituzione della realtà così com’è ci sembra forzatamente artistico, artefatto, espressionistico proprio in quanto iperrealistico. Non a caso, infatti, molte avanguardie cinematografiche (dalla Nouvelle Vague al progetto 62 63
Cfr. M. Sesti, Nuovo cinema italiano. Gli autori, i film, le idee, Theoria, Roma 1994, p. 14 e L. Coveri, Film in versione napoletana con sottotitoli, in “Il Secolo XIX”, 25 maggio 1995, p. 8. E. Morreale, Lampi sull’isola. Nuovo Cinema Siciliano (1988-1996), Priulla, Palermo 1996, p. 7. Lo stesso Morreale individua negli autori siciliani del periodo una vera e propria «nouvelle vague» italiana (p. 6). Analogamente potrebbe dirsi per il recente cinema sardo (sotto citato), come se, anche in questo caso, l’isolanità incoraggiasse l’inscenamento (ora critico, ora orgoglioso) della marginalità linguistico-culturale. I dati più aggiornati sul nuovo cinema sardo si possono ricavare dal volume Lingue e linguaggi del cinema in Italia, a cura di M. Gargiulo, Aracne, Roma 2015.
Lingua Fabio Rossi
195
Dogma) nascono con l’intento di riaccostarsi alla realtà senza (o con diversi) filtri. Difficile spiegarlo meglio di Pasolini, a proposito di Godard e del cinema di poesia: Sotto le vicende dei suoi film, sotto le lunghe “soggettive libere indirette” che mimano lo stato d’animo dei protagonisti, scorre sempre un film fatto per il puro piacere della restituzione di una realtà frantumata dalla tecnica e ricostruita da un Braque brutale, meccanico e disarmonico64.
Tralasciando ora l’aspetto iconico, concentriamoci sugli usi verbali di tanta cinematografia dell’ultimo ventennio, per tacere delle (non numerose) precedenti messe in scena di dialetti estremi: La terra trema, L’albero degli zoccoli, Maria Zef (in friulano, ancorché adulterato, a detta dei friulani e dei friulanisti) di Vittorio Cottafavi. Si pensi al franco-provenzale o all’emiliano straniante, rispettivamente, di Il vento fa il suo giro (2005) e di L’uomo che verrà (2009) di Giorgio Diritti; anche l’ultimo film del regista, Un giorno devi andare (2013) assegna al plurilinguismo – italiano, portoghese e lingue degli Indios – un ruolo molto importante, nel ritratto delle inquietudini della protagonista e della sua difficoltà di adattamento. Al napoletano misterico di L’amore molesto e a quello allontanante di Certi bambini (Frazzi, 2004) o di Gomorra di Matteo Garrone; al palermitano postpostmoderno di Ciprì e Maresco. Ma l’elenco potrebbe seguitare, all’indietro e in avanti, toccando pressoché tutti i dialetti italiani, anche quelli che raramente hanno trovato spazio sullo schermo nei decenni precedenti: le diverse varietà della Puglia (il barese di Alessandro Piva: LaCapaGira e Mio cognato; il salentino di Edoardo Winspeare: Pizzicata, Sangue vivo e, più italianizzato, Il miracolo e ancor più estremo e gergale quello di Fine pena mai di Davide Barletti e Lorenzo Conte); il lucano (Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo); il calabrese (Il ladro di bambini di Amelio); il sardo (Ballo a tre passi e Bellas mariposas di Salvatore Mereu, ovviamente con l’illustre precedente di Padre padrone dei Taviani); il livornese di Ovosodo (1997) di Paolo Virzì e il trionfo 64
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., p. 1482.
196
Lessico del cinema italiano
dei dialetti toscani in genere, da Benigni e Nuti in poi (prima degli anni ottanta ritenuti, erroneamente, inadatti alla commedia, in quanto non dialetti, bensì prossimi all’italiano letterario, con l’eccezione di Amici miei di Mario Monicelli). L’esibizione in presa diretta di varietà forse mai prima di allora (fine anni ottanta, appunto) rappresentate così crudamente costituisce una rottura pari a quella delle trame di questi film, che intendono mostrarci l’altra faccia della realtà regionale, edulcorata fino a quel momento. E infatti l’operazione è tanto più riuscita nei film che rivitalizzano dialetti consunti: il napoletano di Martone, Frazzi e Garrone è abissalmente distante da quello di De Filippo, di Totò o della Loren, da quello di Pino Daniele non meno che da quello di Troisi, pur nell’innegabile rinnovamento linguistico operato da questi ultimi. Il familiare diventa straniante. Così come è accaduto, già da anni, col romanesco ipergergalizzato di Amore tossico (1983) di Claudio Caligari. L’opzione del dialetto estremo genera spesso la necessità (antieconomica e mai premiata dal pubblico) di sottotitolare il film (L’amore molesto), o addirittura di ridoppiarlo annacquando lo scarto dall’italiano (come per Baarìa di Tornatore, uscito in versione parzialmente italianizzata, fuor di Sicilia). Non in tutti i film la palingenesi linguistica è parallela a quella iconica. In taluni si sente del nuovo ma si guarda del vecchio (pur nell’innegabile originalità dei contenuti: Marco Risi, ma si pensi anche a Ricky Tognazzi di Ultrà), mentre in altri l’attenzione alla realtà delle parole, che è sempre il lato oscuro della luna, offre il destro per filmare in modo nuovo, per distorcere volti e oggetti proprio nel momento stesso in cui li si riprende senza veli. È quello che accade, tra gli altri, nei film di Ciprì e Maresco65. Per questi film, che enfatizzano la componente verbale almeno tanto quanto tendono alla distorsione dell’immagine, calza a pennello, come già anticipato, la definizione pasoliniana di cinema di poesia:
65
Sui quali cfr. E. Morreale, Lampi sull’isola, cit., pp. 19-23. Anche nell’ultimo film di Daniele Ciprì, È stato il figlio (2012), la deformazione visiva è omologa a quella acustica, resa ancora più efficace dall’interpretazione del palermitano esagerato da parte del campano Toni Servillo.
Lingua Fabio Rossi
197
La prima caratteristica di questi segni costituenti una tradizione del cinema di poesia, consiste in quel fenomeno che normalmente e banalmente vien definito dagli addetti ai lavori con la frase: “Far sentire la macchina”. Insomma, alla grande massima dei cineasti saggi, in vigore fino ai primi anni sessanta: “Non far sentire la macchina!”, è successa la massima contraria66.
Ebbene, se in film come Poveri ma belli, o come tutti i film in italiano standard o appena regionalizzato, la massima era «non far sentire la lingua» (in una sorta di montaggio classico hollywoodiano dei dialoghi: il montaggio c’è ma non si vede), nei film iperdialettali da Wertmüller a Ciprì e Maresco è come se la massima fosse: «Fare sentire la lingua!». Farla sentire in tutte le sue distorsioni, in tutte le sue variazioni, i suoi eccessi e soprattutto la sua distanza non tanto dall’italiano standard (ammesso che esista), quanto dallo standard filmico del “doppiaggese”, ovvero quella lingua ingessata, tanto verosimile quanto non vera, dei film postsincronizzati. Ma, come si diceva, talora non c’è bisogno di accortezze particolari, di enfasi del dialetto (come nel siciliano consapevolmente eccessivo, e quindi macchiettistico, del Giannini diretto dalla Wertmüller), per ottenere una nuova realtà linguistica filmata. Basta anche il primo vero trionfo del parlato-parlato filmato senza filtri, con tutte le sue ripetizioni, anacoluti, lacune, segnali discorsivi, parole incomprensibili, parolacce, bestemmie, aggrovigliamenti e accavallamenti di battute, come accade nel già citato film-verità Anna, in cui davvero l’italiano (con lievi ma sempre credibili sfumature toscane, romane, settentrionali o meridionali, pronunciate da attori non attori che interpretano sé stessi in presa diretta) per la prima volta, se si escludono precedenti documentari televisivi, viene filmato in tutta la sua gamma espressiva. Diverso (e a sé stante) il caso dei film-documentario e dei filmintervista: anche nel pasoliniano Comizi d’amore (1964), infatti, sono spesso presenti diverse sfumature dialettali in presa diretta, sebbene questo non sia garanzia di iperrealismo, dal momento che la lingua, non meno delle idee, degli intervistati risulta fortemente condizionata dalle domande e soprattutto dalla personalità dell’intervistatore, oltreché dalla situazione stessa (il grado di re66
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, cit., p. 1484.
198
Lessico del cinema italiano
alismo di fronte a un microfono e a un’équipe di ripresa non può che essere relativo). Espressionismo come altra faccia del realismo, dunque. O meglio, come nuovo modo di far risaltare la realtà. Un’altra strategia per farla risaltare, la realtà, apparentemente antitetica all’iperparlato, all’iperdialetto e al plurilinguismo dei film finora menzionati, è quella di inscenare il silenzio, il mutismo. La sottrazione della parola per protestare contro l’esibizione della parola finta di tanto cinema leggero italiano, che, differentemente dalla comicità di altri paesi (basti pensare ai mimi francesi, ai film di Tati o alle scenette di Benny Hill o di Mr. Bean), è tutto sbilanciato sul gioco di parole e sugli eccessi della parole. Sia detto di passata, il fatto, facilmente comprovabile, che il film comico italiano (lontano erede della commedia dell’arte e vicino erede dell’avanspettacolo, generi nei quali la commedia è sempre commedia delle lingue) sia decisamente più povero di silenzi del film d’autore, drammatico o di impegno civile (in Ladri di biciclette, per esempio, si parla pochissimo) non è né di poco conto né inevitabile, visto che ad altre latitudini (Francia, Gran Bretagna) sembra accadere esattamente l’opposto. Lo stesso Totò, che dichiarava di aspirare a parlare il meno possibile («Vorrei essere, come maximum, il protagonista di un cartone animato. Anche perché vorrei parlare pochissimo»67), ha invece una comicità (pur anche fisica) nettamente sbilanciata sulla parola. La lingua che si sente diventa dunque silenzio che si sente, in tanto nostro cinema di poesia – che enfatizza, insieme con l’immagine pura, la rarefazione della parola – e in celebri personaggi muti della cinematografia italiana, dal protagonista dello psicanalitico Il sogno della farfalla (1994) di Bellocchio, al ragazzo (Pietro) di Nuovomondo (2006) di Crialese. Lo stesso Crialese (che combina spesso plurilinguismo, iperrealismo, espressionismo e mutismo: mutismo come componente del plurilinguismo) ama sottrarre la 67
C. Zavattini, I pensieri di Totò, in “Scenario”, n. 9 (1940), p. 404. «Io non ho il dono della parola e nel caso mio il dialogo smonta e immeschinisce tutto. Sono un comico muto, né antico né moderno perché non esiste la comicità antica o moderna, esiste la comicità, punto e basta. E meglio che con i dialoghi so esprimermi con la mimica», G. Romeo, Totò e il metalinguaggio, in “Italiano e Oltre”, n. 2 (1987), p. 108. Rarissimi i casi di film italiani parzialmente “muti”: Ratataplan (1979) e Ho fatto splash (1980) di Maurizio Nichetti, Ballando ballando (1983) di Ettore Scola.
Lingua Fabio Rossi
199
parola dei suoi “diversi”, come in Grazia (nomen omen, dal momento che la grazia si manifesta senza parole) di Respiro (2002) e in Filippo (interpretato dal medesimo attore di Nuovomondo, nonché di Respiro: Filippo Pucillo) di Terraferma. Oppure nel vecchio di Lamerica (1994) di Gianni Amelio. Qualche parola in più occorre spendere sull’ultimo film, che presenta usi linguistici particolarmente raffinati e funzionali ai contenuti, giocando soprattutto sull’ambiguità della comunicazione verbale. All’italiano medio, debolmente meridionalizzato, dei neocapitalisti interpretati da Michele Placido ed Enrico Lo Verso, si contrappongono l’italiano con tinte albanesi del loro complice, l’italiano come lingua franca (mediata dalla televisione) in Albania e soprattutto l’apparente (e iniziale) mutismo del vecchio protagonista, italiano (siciliano dialettofono puro) ma scambiato dapprima per albanese. La lingua del nuovo colonialismo globalizzato emerge in tutta la sua rudezza negli squallidi stereotipi di Placido, ad apertura di film: Ma dove volete andare? Ma che ve pensate, che in Germania, in Italia, stanno aspettando a voi? La libertà, troppa, tutta assieme, fa male [...]. Siete stati viziati. Lo stato ha sempre e solo pensato a tutto. La verità, è che adesso è il momento di rimboccarsi le maniche, darsi da fare. Per carità, con questo non voglio dire che dovete fare da soli [...]. Ma quale dittatore! È la testa che vi manca, il cervello! Ma come cazzo fate a morirvi di fame? Tutto questo terreno, tutto il petrolio che c’avete, l’acqua, il mare.
E di Lo Verso, poco prima della conclusione: Corruzione, fucilazione, che cosa significa? Che ancora non siete pratici dei metodi occidentali. In Italia si fa sempre così. Per sveltire la burocrazia. Si aiutano le pratiche ad andare avanti. Così. C’è più efficienza. Meglio. Noi siamo imprenditori. L’economia qua in Albania è in crisi. La gente sta morendo di fame. Allora noi rischiamo i nostri capitali. Investiamo, di tasca nostra.
La lingua come specchio identitario è temuta dai giovani albanesi in fuga verso l’Italia e desiderosi di abiurare per sempre le proprie radici. Lo confida al cinico Lo Verso un ragazzo ansioso di approdare a Bari e di metter su famiglia: «Non voglio mai parlare
200
Lessico del cinema italiano
la lingua albanese, coi figli miei. Voglio parlare sempre la lingua italiana. E così i figli scordano che io sono albanese». La conclusione del film lascia la parola al vecchio, convinto di fuggire per Lamerica piuttosto che tornare in Italia, il quale chiede a Lo Verso: «Paisà, ma vui sapite parrare ammerrecano? Io nun saccio manco l’italiano! Che diciti? Ci ’u trovano lu stesso lu lavoro?». Un Lo Verso attonito, che, poco prima di imbarcarsi, ha assistito al paziente e volenteroso apprendimento dell’italiano da parte dei bambini albanesi. Ma il pregio principale del film risiede proprio nel mutismo iniziale del vecchio, che è segno di trauma, di protesta ma anche di inganno: il mutismo maschera infatti la vera identità, italiana e non albanese, dell’uomo. Gianni Amelio ama far parlare poco i suoi protagonisti, proprio come Crialese: lo stesso Lo Verso, in Il ladro di bambini, e anche il piccolo protagonista parlano pochissimo, disadattati. Così come la protagonista cinese di La stella che non c’è (2006), i cui lunghi silenzi sono incompatibili con l’iperparlato di Sergio Castellitto. Anche i maestri del cinema classico italiano talora si sono avventurati nella fase espressionistica mediante l’accostamento alle opposte tendenza dell’iperparlato e della sottrazione della parola. Accadde per esempio al Fellini di La dolce vita e di 8 ½. Nel primo film (di cesura tra la prima fase, realistica, della produzione felliniana e la seconda, pienamente espressionistica), il silenzio della prima sequenza (gli operai che salutano muti la statua del Cristo) e dell’ultima (la donna angelo Paola) incornicia l’abuso del brusio e della confusione (così verosimili, ancorché doppiati) dei paparazzi, dei giornalisti e dei dandies. Tutto il film, poi, si presta ad essere interpretato come un vero e proprio monumento ai danni della comunicazione, esibendone tutti i filtri falsificatori: dal parlato telefonico imperfetto, che impedisce a Marcello di comunicare con Emma, al registratore che restituisce in modo alterato le parole di Steiner, oltreché i suoni mostruosamente artefatti della natura, ai microfoni e agli schermi televisivi che, nella scena del falso miracolo, trasformano la fede in un business da farsa. Anche a un’innocua autoradio il regista riesce a conferire un valore straniante: accade nella scena di Marcello e Maddalena in macchina con la prostituta, allorché la musica di
Lingua Fabio Rossi
201
sottofondo passa bruscamente da extradiegetica a diegetica, con tutto il suo potere acusmatico68. Nel secondo («film puro» e di poesia, per la libera, non narrativa, combinazione delle immagini come delle parole), il mutismo del sogno iniziale e della conclusiva passerella incastonano gli abusi della confusione babelica che animano il set metafilmico69. Con la lingua e con la voce (notoriamente sempre doppiata), del resto, Fellini giocherà sempre, da La dolce vita (ma anche prima: con l’italiano dei fotoromanzi, realistico quanto deformato, di Lo sceicco bianco, 1952) a La voce della luna (1990). Ma l’espressionismo linguistico, nel cinema come in letteratura, non è appannaggio esclusivo delle avanguardie, dei generi impegnati e del cinema d’autore (il magma linguistico del Carmelo Bene regista, non meno di quello di Ybris, 1984, di Gavino Ledda, o di Nostos: Il ritorno, 1990, di Franco Piavoli). Può anche reperirsi in prodotti comici e popolari, come già adombrato nella citata Lina Wertmüller. Com’è anche il caso di quel geniale «pastiche gaddiano per le grandi platee»70 dei due Brancaleone, o della lingua primitiva inventata da Pasquale Festa Campanile (e dalla cosceneggiatrice Wertmüller) in Quando le donne avevano la coda (1970) e Quando le donne persero la coda (1972). Ma, senza scomodare casi così estremi di inventiva, basti pensare all’operazione “gaddiana” di Totò, tanto più realistico quanto più deforma la lingua: il monologo del maestro Scannagatti in Totò a colori e i duetti con Peppino De Filippo (la dettatura della lettera, «Signorina, veniamo noi con questa mia addirvi», e il colloquio col vigile urbano, «Noio volevan savuar l’indris»), da Totò, Peppino e... la malafemmina (Mastrocinque, 1956), possono bastare a emblema di decine di casi. O anche gli svarioni nei film di Ettore Scola, un regista particolarmente sensibile, così come i suoi compagni di sce68
69 70
Sul suono acusmatico cfr. M. Chion, La voce nel cinema, cit., pp. 31-46, et passim. Sull’analisi linguistica (e semiologica) de La dolce vita cfr. F. Rossi, Uno sguardo sul caos. Analisi linguistica della “Dolce vita” con la trascrizione integrale dei dialoghi, Le Lettere, Firenze 2010 e A. Costa, Federico Fellini. “La dolce vita”, Lindau, Torino 2010. Su 8 ½ come film puro cfr. E. Bispuri, Federico Fellini. Il sentimento latino della vita, il Ventaglio, Roma 1981, pp. 31, 104, et passim e Id., Interpretare Fellini, Guaraldi, Rimini 2003, pp. 53-68, 107-112. S. Raffaelli, La lingua filmata, cit., p. 136.
202
Lessico del cinema italiano
neggiatura Age e Scarpelli, al ritratto linguistico sempre funzionale all’approfondimento psicologico e sociologico. I dialoghi di Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) (1970) e C’eravamo tanto amati (1974) hanno il triplice effetto di far ridere, far riflettere sui meccanismi della lingua (e sulla storia dell’italiano, nella sua secolare messa a punto da lingua letteraria a lingua parlata, passando attraverso il sostrato dialettale e le soluzioni intermedie dell’italiano regionale e popolare), oltreché della società italiana, ed enfatizzare la variazione espressiva, che risalta maggiormente dalla contrapposizione rispetto allo standard (anche filmico) nazionale. Dal primo film, spiccano le aspirazioni di Monica Vitti all’italiano scritto (fotoromanzesco): «Sì, amo riamata Serafini Nello e lo appartengo!»; «Ora che il mio cuore è spaccato in due è più facile imputarsi un braccio»; «Con Nello si amavamo». Nel secondo film, il lungo apprendistato sociale e grammaticale di Elide (Giovanna Ralli) manifesta tutte le incongruenze (e i drammi) dell’italiano popolare, oltreché del passaggio dal proletario al borghese; lo spettatore è portato a solidarizzare con lei proprio perché si identifica con la sua innocente ignoranza e con l’infelice (quasi verghiano) tentativo di affrancarsi dai genitori popolani arricchiti (i dialettofoni puri Aldo e Lella Fabrizi) per accedere alle vette dell’intellettuale borghese (falso e corrotto) Vittorio Gassman: R (Fabrizi): Tu mo stai lottando co la coscienza. Lotti ma nun t’arende. Da’ retta a me. Aricordete che chi vince la battaja co la coscienza, ha vinto la guera de l’esistenza. E adesso fermamese che semo arivati [...]. La fermata der tramme è laggiù. Me rincresce ma la macchina me serve a mene. G (Gassman, ironico): Grazie. M (Lella Fabrizi): A Ro, venghi! R : Sine. E (Ralli): Lei non salisce? G : (ironico) None. E : Tanti ossequi. G : Arrivederla. E : Oh grazie! G : (mettendola in guardia da un pezzo di legno cui Elide va a sbattere) Attenta! E : Ah! (Salutando Gianni) Nuovamente. (Al padre) Ho intruppato.
Lingua Fabio Rossi
E
203
: Ho visto l’Eclisse dell’Antonioni e sono rimasta stranita.
E : So di farti soffrire, ma devo dirti tutto, per sincerità verso me stessa. Io... non volevo. Mi sono schernita... G : Schermita, meglio, magari, no? E : Schermita, sì. Ma quando ho ceduto al suo amplesso, io pensavo a te, Gianni. Avrai certo letto di questa contraffazione erodica [sic] che induce la donna a visualizzare nell’uomo che le sta indosso altri personaggi, attori famosi, cantanti, condottieri. E io, visualizzavo a te, Gianni. Era lui che tradivo, non te71.
L’italiano popolare (ovvero quel codice traballante e pieno di calchi, ipercorrettismi, malapropismi, semplificazioni analogiche, tipico di chi ha per madrelingua il dialetto, senza riuscire ad accedere pienamente allo standard) di queste commedie, proprio perché stigmatizzato ad uso ludico, costituisce un osservatorio privilegiato sui tratti salienti di transizione della nostra lingua dal dialetto all’italiano standard, parallela alla transizione sociale italiana dal mondo rurale a quello postindustriale. Personaggi come Elide o Totò, insomma, sono la caricatura del neoitaliano, e le caricature, si sa, rendono ancora più evidente, perché sintetica, la somiglianza con l’originale. Le altre lingue e il plurilinguismo Un tratto distintivo del cinema italiano degli ultimi decenni, rispetto alle epoche precedenti, è senza dubbio la propensione al plurilinguismo, frutto del cambiamento dei tempi e delle ideologie. Le 71
Sulla lingua dei film di Scola cfr. P. Micheli, Ettore Scola, i film e le parole, Bulzoni, Roma 1994. A proposito dell’ultimo brano citato, a conferma della contraffazione linguistica di Elide che tenta di non sfigurare agli occhi del marito colto, ricordiamo che la sua voce è registrata e che l’antilingua posticcia da lei utilizzata è «un modello difensivo, addirittura nevrotico [...], a protezione delle proprie paure e insufficienze emotive e affettive», M. Comand, Commedia all’italiana, cit., p. 44. Quanto al secondo brano, invece, la vocazione metafilmica (in chiave sarcastica e dissacratoria) della commedia all’italiana ai danni del cinema “impegnato” (Antonioni) era già evidente in Il sorpasso (1962) di Risi, allorché Gassman dice a Trintignant: «L’hai vista L’eclisse? [...] Io c’ho dormito: ’na bella pennichella. Bel regista, Antonioni».
204
Lessico del cinema italiano
nuove istanze realistiche e/o espressionistiche, infatti, hanno a tal punto dilatato lo spettro comunicativo dei personaggi filmici, da riuscire a dar voce pressoché a ogni categoria sociale, professionale, etnica ecc. Il cinema italiano non rinuncia, dunque, al confronto con la realtà delle migrazioni, resa ancor più credibile, linguisticamente, dal progressivo abbandono della postsincronizzazione a favore della presa diretta. Anche qui gli esempi sarebbero innumerevoli. Per risalire alle fonti del fenomeno, ricordiamo che le ambientazioni belliche e militari favoriscono, da sempre, il melting pot (da 1860, a Paisà, a La grande guerra). Non così, invece, contro ogni attesa, i (rari) film italiani sull’emigrazione, interna ed esterna, che invece tendevano, fino ad epoca recente, a neutralizzare la variazione diatopica (da Emigrantes, 1948, di Aldo Fabrizi, a Rocco e i suoi fratelli). Viceversa, il nuovo cinema italiano pesca a piene mani nel plurilinguismo migrante di ieri e di oggi (Un’anima divisa in due di Soldini; Vesna va veloce di Mazzacurati; i già citati Nuovomondo e Terraferma; La sconosciuta di Tornatore; Io sono Li e La prima neve di Segre; Alì ha gli occhi azzurri di Giovannesi)72. Ma, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il cinema italiano non ha mai lesinato nell’accoglimento dei forestierismi, neppure in pieno Ventennio fascista. Così come per i dialettalismi, tuttavia, l’ottica dell’accoglimento era profondamente diversa; non mimetica, né espressionistica (la babele delle lingue omologa all’indecodificabilità del mondo), come oggi, sibbene ideologica: la lingua straniera simboleggiava i difetti del nemico, nei film di guerra; le tentazioni capitalistiche da evitare, nei telefoni bianchi; lo sradicamento dai sani valori nostrani ecc. Un’attenzione particolare è data oggi alle lingue semitiche: arabo e israeliano, in presa diretta, concorrono sensibilmente allo straniamento dato dall’insensatezza della guerra in Private (2005) di Saverio Costanzo (parlato anche in inglese e in italiano)73. 72
73
Altra cosa è l’italiano contaminato con altre lingue a mero scopo ludico, per ritrarre il funambolismo anche verbale degli italiani all’estero, da sempre presente nel nostro cinema di consumo (soprattutto da Tòtò e Sordi in poi). Tra gli esempi più felici (con verosimili fenomeni di codemixing italiano-inglese: floro “pavimento”), spicca Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata (1971) di Luigi Zampa. Tra i più recenti: My name is Tanino (2002) di Paolo Virzì e Italians (2009) di Giovanni Veronesi. Su cui cfr. A. Angelucci, Il cinema civile non parla italiano, cit.
Lingua Fabio Rossi
205
L’iperrealismo plurilingue si presta a due opposte interpetazioni: rispetto dell’alterità, senza addomesticamenti traduttivi etnocentrici, da un lato; o, viceversa, isolamento dell’altro, messo in cornice proprio dalla sua irriducibile diversità linguistica. Il rischio di incorrere nel secondo, discriminante, atteggiamento è alto soprattutto nella filmografia post 11 settembre, in cui il diverso è spesso arabofono e non tradotto, a marcare la non integrabilità culturale del nemico. Accade così che lo spiazzamento linguistico (dato dal sentire uno straniero parlare l’inappuntabile italiano dei doppiatori), cacciato dalla porta (della sociosemiotica del medium schermico, oggi ostile al doppiaggio), rientra dalla finestra (dell’ideologia della demonizzazione dell’altro). L’esito esterofobico ed etnofobico, più ancora che al cinema, è conclamato nella fiction televisiva americana, a partire dai numerosi arabofoni in 24, in Homeland e in serie simili. Il doppiaggio, in conclusione Ogni adattamento produce una perdita di informazione e una dose di semplificazione rispetto all’originale adattato. Il testo filmico nasce perlopiù all’insegna dell’adattamento, della trasposizione e della riscrittura: adattamento dal parlato spontaneo a quello filmato e postsincronizzato, transcodificazione o traduzione intersemiotica74 nei casi di film trasposti da opere letterarie o teatrali, traduzione (libera, o meglio vincolata, più che ai movimenti labiali, alle attese del pubblico) nel caso di film doppiati da una lingua diversa dall’italiano. Per questo, come abbiamo mostrato fin dall’attacco di questa voce, il cinema, nella fattispecie quello italiano (molto più esposto rispetto ad altre cinematografie, per la sua storia, a tutte e tre le forme di adattamento), è fatalmente un buon candidato alla semplificazione, alla riduzione delle varietà, alla normalizzazione e, talora, alla banalizzazione. Oltre ai numerosi casi di adattamento letterario75, sono i film doppiati da una lingua straniera a dare sostanza a questo assunto. 74 75
Cfr. R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, a cura di L. Heilmann, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 57 e 64 [ed. or. Essais de linguistique générale, Les Éditions de Minuit, Paris 1963]. Impossibili da considerare, per ragioni di spazio, in questa sede, ma per i quali cfr. almeno G. Manzoli, Cinema e letteratura, Carocci, Roma 2003.
206
Lessico del cinema italiano
Tra i due diversi approcci traduttivi, source-oriented, o filologico, e target-oriented, o naturalizzante o etnocentrico, il nostro doppiaggio (ma già la traduzione delle didascalie del muto76) ha sempre optato per il secondo, nell’illusione di migliorare l’originale, talora con l’intento di censurarlo e, di norma, di renderlo più digeribile al pubblico italiano, mediante l’adattamento dei frames culturali77. Ne derivano fenomeni ricorrenti, nei doppiaggi di ieri e, in misura minore, di oggi, quali il frequente ricorso a pratiche di glossa, l’abuso di calchi soprattutto dall’inglese, la frequenza di retaggi arcaico-letterari quali il passato remoto, l’elevata frequenza del futuro, l’allocutivo voi, certi lemmi ricercati o tradizionalmente gergali, d’acchito riconoscibili come doppiati (sgualdrina, sbirro, grana, pupa, ehi amico, dannato e dannazione), e molti altri ancora. Ma più di ogni altro l’innalzamento diafasico e l’azzeramento delle varietà diatopica e diastratica. Ne consegue, nella media dei film americani di largo consumo, che il doppiato dello scaricatore di porto sia identico a quello dell’accademico: stessa politezza fonetica, da manuale di pronuncia toscana, stesso rispetto della morfosintassi, stesso lessico selezionato e privo di eccessive escursioni in alto e in basso ecc. Tutti tratti che contribuiscono a collocare la lingua del doppiaggio italiano in una posizione di più spiccata specificità rispetto alla lingua filmica tout court, contrassegnata dall’etichetta, perlopiù spregiativa di doppiaggese, coniata dagli addetti ai lavori. Il massimo dell’allontanamento dall’originale si ha nei film in cui compaiono scene metalinguistiche o plurilingui. Tra i numerosi esempi possibili, basti ricordare il passaggio dall’italiano allo spagnolo (quasi inevitabile per far risaltare una lingua rispetto al contesto totalmente italiano), come lingua erogena, nel doppiaggio di Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton. Ma si pensi 76
77
Sulla cui prassi cfr. le preziose testimonianze del traduttore G. Giannini, sotto lo pseudonimo L. Tucci, Il riduttore di films, in “Il Corriere dello spettacolo”, 5 maggio 1931, p. 2. Un po’ più fedele, ma mai interamente, la versione dei sottotitoli, che tuttavia, almeno sul grande schermo, non hanno mai attecchito pienamente presso il pubblico italiano, viziato com’è dal rifiuto della lingua scritta, dal predominio dell’italiano e dall’estetica omologante della bella voce impostata dei doppiatori. Il massimo grado di infedeltà traduttiva (anzi, di vera e propria riscrittura dell’originale) si ha nei titoli dei film, per i quali si rimanda a F. Rossi, La traduzione dei titoli dei film: adattamento o riscrittura?, in “Lingua Italiana d’Oggi”, n. 3 (2006), pp. 271-305.
Lingua Fabio Rossi
207
anche a tutti i mafia movies, a partire da Il padrino, nei quali lo scarto dell’originale tra American English dei non mafiosi e Italian American dei mafiosi diventa italiano standard vs siciliano. In questo modo il cinema doppiato sancisce e rimette in circolo lo stereotipo metonimico emigrati italiani = tutti siciliani = tutti mafiosi, con la Sicilia pars pro toto per l’Italia tutta78. La potenza dello stereotipo è tale da determinare, nell’ultimo ventennio, scelte di radicale abbandono del siciliano filmico, in quanto, appunto, troppo connotato. È quanto è accaduto con il doppiaggio di Big Night (1996) di Stanley Tucci e Campbell Scott, che avrebbe semmai richiesto, da esigenze di sceneggiatura, un parlato siciliano, sostituito invece, dall’adattatore Filippo Ottoni, con l’abruzzese, «perché ormai il dialetto calabrese-siciliano al cinema è irrimediabilmente associato alla Mafia»79. Analogamente, nel nuovo doppiaggio di Lilli e il vagabondo (1955), del 1997, il siciliano dei personaggi italiani (Tony e Joe) del primo doppiaggio diventa napoletano. Proprio alla luce dell’equazione siciliano = mafia si spiega l’orgogliosa opzione (che è dunque, in questo caso, anche metalinguistica e metafilmica) dell’italiano standard da parte di Peppino Impastato, interpretato da Luigi Lo Cascio, in I cento passi (2000) di Marco Tullio Giordana. Curiosamente lo stesso Lo Cascio conclude il suo esordio registico (La città ideale, 2012) con il percorso inverso: il fallimento della giustizia ideale lo farà optare per il rifugio nello stereotipo, anche linguistico, dell’avvocato mafioso Scalici, interpretato da Luigi Maria Burruano. L’inevitabile appiattimento delle varietà operato dal doppiaggio fa sì che, di norma, siano soprattutto i film sull’emigrazione o sullo sradicamento linguistico a risentirne. Basta mettere a confronto gli originali con le copie doppiate di La rosa tatuata (1955) di Daniel Mann, Stromboli, terra di Dio (1950) di Rossellini, ma anche dei già citati Big Night e Lilli e il vagabondo. A proposito di Stromboli, l’ossequio all’estetica della voce doppiata, unitamente alla necessità di eliminare i sottotitoli, per non deludere le attese del pub78 79
Il primo e più lucido interprete del processo di metaforicizzazione della Sicilia fu L. Sciascia, La Sicilia come metafora. Intervista con Marcelle Padovani, Arnoldo Mondadori, Milano 1989. Secondo le parole dello stesso Ottoni in P. Casella, Hollywood Italian. Gli italiani nell’America di celluloide, Baldini & Castoldi, Milano 1998, p. 454.
208
Lessico del cinema italiano
blico nostrano, fa sì che i film più interessanti di Rossellini, sotto il risvolto del plurilinguismo come metafora dello straniamento e delle difficoltà di adattamento ai luoghi e alla vita, come Stromboli e Viaggio in Italia (1954), siano molto più interessanti nella versione in presa diretta che in quella doppiata. Quest’ultima, oltretutto, stempera anche alcuni aspetti scabrosi, per l’Italia dell’epoca, della trama (crisi di coppia, divorzio, autonomia della donna ecc.). Peraltro, nonostante le critiche generali rivolte al doppiaggio sia dal punto di vista semiologico ed estetico, in quanto scinde, ricomponendola arbitrariamente, l’immagine dal suono, sia da quello linguistico, in quanto innaturale, artefatto e ibrido, non mancò chi attribuì a questa pratica traduttiva il merito di aver snellito e svecchiato certo ingessato italiano filmico, d’estrazione teatrale, degli anni trenta80 e addirittura chi, forse non a torto, le riconobbe un rilevante ruolo didattico81. La pervasività del “doppiaggese” – nel suo statuto di codice artificiale, asettico e dunque polifunzionale e adatto a tutti i destinatari – nella lingua di tutti i giorni, ivi compresa quella dei film italiani, è confermata dalle decine di forme propagate, se non partorite, dal cinema straniero trasposto in italiano: dacci un taglio (cut it out, invece di smettila o piantala); non c’è problema (no problem e simili, dov’è il problema, è un tuo problema, invece di va bene); sono fiero di (I’m proud of, invece di sono orgoglioso, mi fa piacere); tranquilli! (be quiet!, invece di zitti!, silenzio!); bene (well, ad apertura d’enunciato in luogo di altri segnali discorsivi più tipicamente italiani: ecco, veramente); prego (please, invece di per favore); celebrare (to celebrate, invece di festeggiare); realizzare (to realize, invece di accorgersi, rendersi conto di); posso aiutarla? (can I help you?, inve80
81
Cfr. G. Briareo [pseud. di G. Debenedetti], Il doppiaggio in Italia, in “Cinema”, n. 29 (1937), pp. 154–156. Tra le annose polemiche sul doppiaggio in Italia si ricordi almeno quella ospitata dalla rivista “Cinema” nel 19401941, con interventi di Antonioni (Vita impossibile del signor Clark Costa, in “Cinema”, n. 105, 1940, pp. 328–330) e altri. Secondo il regista Luigi Magni (in A. Giannarelli, Come parla il cinema italiano, cit., V puntata), nel secondo dopoguerra i doppiatori insegnarono agli italiani (che affollavano le sale dei film americani) a passare dal dialetto all’italiano. D’altro canto, non è trascurabile neppure la messe di anglicismi (infinitamente ripetuti) propalati nella nostra lingua dai film doppiati: baby, cowboy, drink, Far West, lady e lord, miss e mister, ok, saloon, squaw, western, yankee ecc.
Lingua Fabio Rossi
209
ce di desidera?); suggestione (suggestion, invece di suggerimento); l’hai detto (you said it, invece di proprio così); ci puoi scommettere! (you bet!, o you can bet!, invece di senza dubbio! e simili)82. Il cerchio sembra così chiudersi, ancora una volta, sulla natura prismatica del parlato cinematografico che, nel doppiaggio, mostra tutta la sua specificità. Riflesso, calco e nuovo conio, realismo e antirealismo, impressione di spontaneità ed esibita artificiosità sembrano conflagrare in una lingua continuamente ri-mediata (ma, proprio per questo, speciale, diversa da ogni altra, sia parlata, sia scritta): se nei bambini di oggi è frequente cogliere espressioni come dacci un taglio o ci puoi scommettere (tra i “doppiaggismi” più recenti), sarà soltanto il naturale panta rei della lingua parlata, a dover essere invocato, o, piuttosto, il peso inavvertito dei media che si richiamano gli uni con gli altri? E, soprattutto, saranno quei bambini, e quegli adulti, a parlare come i doppiatori, o i doppiatori a mimare i parlanti comuni? Di là da ogni intento puristico, dunque, non si può non rilevare la consistente ricaduta del cinema sulla lingua italiana, dalle origini fino ai giorni nostri (e indipendentemente dai mezzi attraverso i quali i film vengono fruiti). Un reciproco scambio, quello tra cinema e italiano dell’uso, forse meno evidente rispetto ad altri media, oggi più studiati, ma più profondo e meno effimero. Sempre più numerosi, tuttavia, almeno a partire dalla fine degli anni ottanta del Novecento, sono stati anche i tentativi di riprodurre quello stesso caos, senza smussarlo né edulcorarlo, né relegarlo a funzione di contorno o di macchietta. Anzi, la carica vitale mostrata talora dal nostro cinema nell’enfatizzare gli elementi di crisi e di frammentazione ha assunto sempre più spesso anche le tinte della deformazione espressionistica. Ma, in un certo senso, l’enfasi della frammentazione può essere anche intesa come l’altra faccia della volontà di negazione della frammentazione stessa: entrambi gli atteggiamenti, infatti, sembrano ottenere come risultato l’allontanamento dalla piana esibizione (nei limiti del possibile) della realtà così com’è.
82
Alcuni dei calchi qui riportati risalgono già al doppiaggio delle origini, come ben documentato da R. Patuelli, Il “Dipartimento dell’educazione” ovvero: Il gergo dei film tradotti, in “Lo schermo”, n. 5 (1936), pp. 28-31.
210
Lessico del cinema italiano
Benché sia indubbia tuttora la sovraesposizione filmica del romanesco (dialetto polifunzionale per antonomasia, oltreché già consunto storicamente, per il suo precoce trascolorare da dialetto a italiano regionale a semplice italiano popolare degli inurbati e dei migranti interni ed esterni, almeno a partire dal Cinquecento), non esiste oggi varietà regionale o vernacolare che non vanti più o meno numerose cristallizzazioni schermiche. Anche le varietà del Nord e toscane, a lungo minoritarie almeno fino a tutta la stagione della commedia all’italiana, sono oggi ampiamente rappresentate, sebbene spesso in contrasto con le meridionali (come nei già citati Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord). C’è peraltro chi considera ancora troppo minoritario e discriminatorio, rinverdendo così annose polemiche dei decenni scorsi, l’uso fatto dai media visivi dei dialetti settentrionali, a tutto vantaggio del romanesco. È il caso, tra gli altri, del giornalista Aldo Cazzullo. Prendendo spunto, in un recente articolo, dall’ultimo film di Paolo Virzì, Il capitale umano (2013), che, contrariamente all’opinione di molti, il giornalista non considera «un film contro il Nord», bensì «un film severo sull’Italia di oggi» e un «capolavoro di uno tra i migliori registi europei», egli scrive: L’industria cultura italiana, e in particolare la televisione e il cinema, è troppo romanocentrica, e sovente è segnata da un pregiudizio antinordista. Se senti un’attrice parlare, fuori dal set – e sempre più spesso pure sul set –, parla in romanesco. Se c’è un veneto o un piemontese in un film, è sempre un pirla. Colpi di fulmine, il cinepanettone del Natale 2012, è stato girato in Trentino, presumibilmente con i soldi del Trentino: l’unico trentino in scena recita appunto la parte del ciula. E se il Sud è raccontato ora in chiave familista e consolatoria da artisti comunque di sicuro talento come Rocco Papaleo o Checco Zalone, ora con un taglio di apparente denuncia ma in realtà di compiaciuta ammirazione per la violenza camorrista, il racconto del Nord cede facilmente allo stereotipo negativo83.
La presenza oggi sempre più consistente delle regioni, dei dialetti e delle microrealtà locali smentisce senza alcun dubbio ogni previsione catastrofistica sulla morte dei dialetti che, negli anni sessanta e settanta, dominava nella pubblicistica di tanti intellettuali (Paso83
A. Cazzullo, Il cinema ce l’ha con il Nord, in “Sette”, supplemento del “Corriere della Sera”, 3 febbraio 2014.
Lingua Fabio Rossi
211
lini in testa). Oggi, e gli ultimi censimenti Istat ce lo confermano, i dialetti sono vivi e vegeti, naturalmente come varietà opzionali e non più come unica scelta di fasce sociali marginalizzate84. E sono affiancati, ad arricchire il complesso diasistema glottologico nazionale, da numerose lingue straniere e da varietà intermedie. Tutto questo si riflette nel cinema e ancor più nella rete, popolata, nelle sue ramificazioni italiane, da lingue e dialetti almeno tanto quanto dall’inglese e dall’italiano. Tale (salutare) vitalità è confermata anche dalle nuove strategie produttive e distributive del nostro cinema, che prevedono le sovvenzioni organizzate dalle varie Film Commission regionali. È questa, peraltro, un’arma a doppio taglio, perché, se da un lato incentiva l’opzione dei dialetti, dall’altro, per un ritorno di immagine e di guadagni, incoraggia (specialmente nei prodotti meno di nicchia) la solita rassicurante soluzione dell’ibridismo italoregionale edulcorato e del bozzettismo cartolinesco consolatorio a scopo divulgativo e promozionale. Numerosi sono i prodotti multimediali che dimostrano questa nuova – tuttora in corso – propensione alla pluralità dei punti di vista e alle mille sfaccettature del reale, questa nuova volontà dei nostri cineasti di compromettersi col quotidiano (apparentemente) senza filtri e con l’ottica della storia minuta o minuscola, senza alcuna ambizione alla panoramica, alla sistematizzazione e alla reductio ad unum; si pensi al rinnovato interesse per il documentario (spesso docufiction) e per il film a episodi (talora microepisodi, o meglio stralci di vita), come dimostra, tra i numerosi esempi, il Leone d’oro a Sacro GRA (2013) di Gianfranco Rosi. Film, quest’ultimo, nel quale al plurilinguismo è assegnato un ruolo rilevante, e non potrebbe essere altrimenti, dato l’iperrealismo esibito fino ai limiti dello straniamento: la Roma periferica e marginale ivi rappresentata è infatti quasi irriconoscibile nella sua plurima identità, e già s’è visto più volte come, nel nostro cinema recente, i concetti di marginalità sociale, iperrealismo e plurilinguismo tendano a implicarsi reciprocamente. In questo nuovo corso il cinema è stato senza dubbio aiutato non soltanto dai mutamenti sociali, dal vivere in un mondo che è al contempo sempre più globalizzato e anglofono ma anche sempre 84
Cfr. M.S. Rati, In Calabria dicono “bella”. Indagini sul parlato giovanile di Reggio Calabria, Società Editrice Romana, Roma 2013, pp. 2-4.
212
Lessico del cinema italiano
più multietnico e policentrico, dal ritorno alla presa diretta, dalla maggiore maturità e senso critico del pubblico, ma anche dal nuovo rapporto con i media elettronici, che selezionano tipi di utenti e modalità di fruizione diversi rispetto ai media tradizionali. Si pensi, per esempio, ai fenomeni del mashup e del ridoppiaggio di film e serie celebri (innumerevoli gli esempi in YouTube), che assegnano al dialetto una funzione fondamentale, sempre ludica, d’accordo, ma con evidenti aspetti di gergo e di collante comunitario. In questo rinnovato scenario, occorrerà aggiungere anche la presenza sempre più frequente sul mercato di prodotti plurilingui, dalle varie tracce dei dvd alla prassi dilagante della sottotitolatura, in varie lingue del mondo, di film e serie Tv ad opera dei fan (fansub). Tali fenomeni, con buona pace dei nostalgici del film come testo monolitico da consumarsi esclusivamente su pellicola e sul grande schermo, sembrano legittimare previsioni di consumi sempre più ampli di prodotti audiovisivi e, soprattutto, linguisticamente caleidoscopici. Il polo del caos vitale e del policentrismo sembra dunque sempre più attraente, rispetto a quello della norma monocentrica, per i nostri cineasti e per il pubblico. Il pensiero italiano, per parafrasare Esposito, così come trapela dal nostro cinema recente, sembra sempre più vivente e corporeo, sempre meno dicotomico rispetto al mondo reale85.
85
Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente, cit., soprattutto i capitoli III (“Filosofia/ Vita”) e IV (“Pensiero in atto”), pp. 99-191.
Lingua Fabio Rossi
213
Filmografia di riferimento Cabiria (Pastrone, 1914), Assunta Spina (Bertini e Serena, 1915), 1860 (Blasetti, 1934), Roma città aperta (Rossellini, 1945), L’onorevole Angelina (Zampa, 1947), Ladri di biciclette (De Sica, 1948), La terra trema (Visconti, 1948), Catene (Matarazzo, 1949), Poveri ma belli (Risi, 1957), La grande guerra (Monicelli, 1959), La dolce vita (Fellini, 1960), Divorzio all’italiana (Germi, 1961), Salvatore Giuliano (Rosi, 1962), 8 ½ (Fellini, 1963), La fine del gioco (Amelio, 1970), C’eravamo tanto amati (Scola, 1974), Anna (Grifi e Sarchielli, 1975), Ecce bombo (Moretti, 1978), Mery per sempre (Risi, 1989), Palombella rossa (Moretti, 1989), Lamerica (Amelio, 1994), Fame chimica (Bocola e Vari, 2003), Manuale d’amore (Veronesi, 2005), Scialla! (Bruni, 2011), Terraferma (Crialese, 2011).
B
R
MASCHERA
Mura calcinate di bianco fanno da quinta allo scorcio di uno squallido stanzone. È il luogo di lavoro di una ditta di artigianato sacro nella Palermo del dopoguerra, quella dei fratelli La Marca (destinati a fondare la “Trinacria film” producendo improbabili horror avventurosi e irresistibilmente grotteschi). Con uno stacco in asse fa capolino Salvatore La Marca (Franco Scaldati), maschera pallida e stralunata con baffi, sopracciglia e capelli tinti, seduto a un tavolo, guardando in macchina, protestando («Cazzo ca v’abballa ’nculu, staiu faciennu i cunti, cu è sta vucciria!?») per l’animato dialogo che sentiamo over sound. È in corso una contestazione per una statua maschile da parte di un prete nano e gobbo, Padre Lo Bue, accompagnato da una zitella in gramaglie (interpretata da un uomo), che guarda a bocca aperta, come ipnotizzata, qualcosa fuori campo. Salvatore raggiunge i due accanto alla statua, il suo buffo testone si posiziona a nascondere le parti basse della statua. Chiede imbambolato: «Che c’è che non va? A mia mi pare tutto a posto», «Zu Totò un’o vide chello che nun va?... Si mettisse ’a lente!» gli ingiunge il prete. Zu Totò si ostina a non vedere, anche se ora l’angolazione della camera rivela l’enorme fallo della scultura, inforca gli occhiali e dice «Io non vedo niente», «Taliasse megghiu» gli fa il prete, «Sto taliannu» risponde e ispeziona da vicino l’inguine della statua, finché resta a fissare il fallo che gli pende proboscidale proprio sotto il naso. È l’apertura di Il ritorno di Cagliostro (2003), ultimo film girato in coppia da Daniele Ciprì e Franco Maresco, i registi italiani che più radicalmente hanno portato a compimento un tragitto della maschera nel cinema italiano, spingendone la figurazione verso l’esasperazione grottesca e nichilistica. L’assimilazione del fallo al volto (il volto della statua è costantemente fuori dell’inquadratura) viene addirittura metabolizzata dall’interferenza tra vedere e non
216
Lessico del cinema italiano
vedere: il fallo è inscritto nello sguardo oltre che nel volto. La dissimulazione e la forclusione (come direbbe Lacan) del significante in bella vista, così visibile da risultare invisibile, così letterale da segnare il suo vuoto, apre il versante tutt’assieme demoniaco, dissimulatorio e fantasmatico della maschera. La maschera nasconde. […] la maschera realizza il vuoto sotto di sé, s’instaura unica realtà sopra un’assenza. […] si tratta di un nascondere che abolisce e identifica. Un modo, cioè, di realizzare l’essere che la maschera rappresenta. Ciò che appare e vive, infatti, sono gli atti di una nuova identità, immediatamente inserita nella presenza degli altri, fatta essere dagli sguardi degli altri. I gesti dell’essere mascherato sono nudi, hanno ritrovato una necessità essenziale: di essere in funzione del loro esser veduti come autonomi da ogni preoccupazione, da ogni riferimento alla storia quotidiana della persona. […] Ma se nascondere è una condizione di assorbimento e di assenza, esso è pure condizione di presenza di altri: nascondere è sempre a qualcuno, e così rivelare1.
Una tripartizione della maschera Esiste un tratto italiano della maschera che ha radici nello stile antitragico, di sotterranea indiscernibilità tra comico e tragico, che segna (come aveva compreso Pasolini) la «commedia dell’innocenza» del cristianesimo: Uno dei tratti che più tenacemente caratterizzano la cultura italiana: la sua essenziale pertinenza alla sfera comica e il suo conseguente rifiuto della tragedia. […] Così il mito del Cristianesimo, fin dalla drammaturgia dantesca che ne inscrive nello stile italiano la ritualità (che si fa volgare sussumendo il suo fondo latino e pagano), ci appare essenzialmente antitragico. Così Dante “rappresenta la possibilità comica che la passione di Cristo ha aperto all’uomo”2.
Se nel pensare la maschera non si può non tener presente il sostrato antropologico che la accompagna diacronicamente e sin1 2
A. Pizzorno, Sulla maschera, il Mulino, Bologna 2008, pp. 50-51. G. Agamben, Categorie italiane, Marsilio, Venezia 1996, pp. 3-14.
Maschera Bruno Roberti
217
cronicamente, come pure lo «stile demoniaco che talora ci sembra contrassegnare la maschera come prodotto culturale»3, punto di partenza necessario ci appare la riflessione classica di Michail Bachtin sul carnevalesco e sulla genealogia delle sue pratiche e forme, dalla maschera arcaica alle declinazioni del grottesco, che pone anzitutto la possibilità di pensare la maschera secondo due vie, due grandi categorie. Da un lato la maschera rituale e carnevalesca, vitale e rigenerativa (in cui però il carattere festivo-ciclico testimonia di una coalescenza della maschera con i demoni della natura, gli spiriti totemici, i fantasmi degli antenati). Qui la maschera riprende una linea di vita oltre la morte, rinasce perennemente. Esito estremo, ed ambiguo, di questo versante sono le maschere della commedia dell’arte, la cui presenza lungo una profonda tradizione teatrale parte dal carnevale giullaresco e conserva almeno fino al Cinquecento le radici vitalistiche per rifluire, a partire dal manierismo, nel capriccio, cioè in una deformazione che la spinge fino al grottesco (che pure parte da radici antiche, come nelle decorazioni della Domus Aurea neroniana, e si configura nella decorazione a grottesche che apre all’immaginario barocco), arrivando fino all’ambiguità delle maschere attoriali del Novecento cinematografico italiano, che coniugano la corporalità con la fantasmaticità (è il caso di Totò «ameno spettro», come è stato definito da Anile4 in un libro rivelatore, ma anche degli attori della commedia all’italiana, tutti segnati da un lato sinistro e deformato, a partire dal Sordi più crudele al Mastroianni “Snàporaz”, che si veste da Mandrake per Fellini, o diventa fantasma per Pietrangeli, al Tognazzi feticista di Lattuada o Ferreri, fino a Benigni dove la comicità bassa assume tratti maniacali o compulsivi). Dall’altro la maschera gotica, nera, critica, che ha perso la sua spinta rigenerativa per farsi maschera di morte. Qui l’ascendente è nella tradizione romantica, gotica, nella maschera che cela il vuoto inquietante. E il cinema ha, fin dalle origini, attraverso generi e filoni, dal fantastico all’horror, messo in immagine i vari aspetti (ripre3 4
B. Callieri, L. Faranda, Medusa allo specchio. Maschere fra antropologia e psicopatologia, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2001, p. 21. Cfr. A. Anile, Il cinema di Totò. L’estro funambolo e l’ameno spettro (19351940), Le Mani, Recco (Ge) 1997.
218
Lessico del cinema italiano
si anche da un immaginario letterario, a partire da Poe) della maschera gotica. Questo aspetto se trova nel moderno (dalla stagione romantica fino all’espressionismo) una declinazione di “coscienza infelice”, segnata dall’ambiguità e dalla melanconia saturnina, è nondimeno presente fin dalle radici apotropaiche del carnevale (festa del ritorno dei morti e della rigenerazione sacrale del tempo come ha mostrato Mircea Eliade). Ciò fin da una delle sue ipotesi etimologiche: quella di maska (nome dato a una figura femminile di strega) e dalla figurazione del gorgoneion (maschera di Medusa e bocca dell’inferno, come hanno mostrato gli studi di psicologia storica della scuola di Vernant)5. Una ripresa moderna di tale immaginario si configura nell’ambito del cinema italiano nel grottesco nero, nel lato fantasmatico e feticistico con cui le maschere del potere sono state trattate da Petri a Ferreri, da Moretti a Sorrentino. Se queste due vie ci appaiono come sentieri che si biforcano, ciò che proveremo a mostrare è come si venga intersecando e aprendo però una terza via italiana della maschera, che trova nel nostro cinema uno specchio rivelatore. Il discrimine di tale via può essere rintracciato nella grande stagione del barocco, che ha nella nostra penisola un terreno espressivo e di pensiero, artistico e filosofico, segnato da una tensione formale, oltre che dalla capacità di mantenere in fertile contrasto gli opposti: la luce e l’ombra, la verità e la finzione, il vuoto e il pieno, la vita e la morte, il tragico e il comico, il tutto e il nulla. Non è un caso in tal senso se una caratteristica fondamentale dello stile barocco, e cioè il metalinguaggio spettacolare, la mise en abyme dissimulatoria delle forme e il gioco infinito e labirintico della “maschera sotto la maschera”, insomma la duplicità e l’ambiguità dello statuto di mascheramento, sottenda spesso i film italiani che prenderemo in considerazione. Emerge dunque un meccanismo, un paradigma tripartito: maschera rituale di tipo carnevalesco, maschera barocca di tipo dissimulatorio, maschera nera di tipo grottesco/fantasmatico. Ci sembra opportuno partire dal punto mediano di questa tripartizione, dal carattere barocco della maschera che trova nel cinema italiano, in 5
Cfr. M. Eliade, Il mito dell’eterno ritorno, Borla, Roma 1989 [ed. or. Le mythe de l’éternel retour. Archétypes et répétition, Gallimard, Paris 1949] e J.-P. Vernant, Figure, idoli, maschere, Il Saggiatore, Milano 2001 [ed. or. Figures, idoles, masques, Julliard, Paris 1990].
Maschera Bruno Roberti
219
una sua declinazione precipuamente scettica e illusoria, un sorprendente doppio registro, che ha a che fare con lo statuto dell’identità e del soggetto, sospeso tra vita e morte, credenza e illusione, capacità metamorfica di eterna reviviscenza e precipizio apocalittico e spettrale nel vuoto dissimulato dietro la maschera, in modo tale da tenere in tensione i due poli del mascheramento: quello rituale di eterno ritorno ciclico del fondo animale connesso alla condizione umana nel suo rapporto con il numinoso e quello grottesco nero, che sfocia nell’orrore, nello spettrale, oppure nell’abisso scettico delle maschere vuote del potere, e che trova scoronamento e conferma nel doppio movimento del suo inganno/disinganno, nel tratto dissimulatorio. Maschere barocche La cultura italiana è stata fortemente segnata dal barocco, dalla sua visione del mondo in maschera, dalle sue teorie della simulazione e della dissimulazione, dalle nuove prospettive ottiche che si aprivano nella rappresentazione della realtà6. Il sentimento barocco della maschera attiene alla sua funzione paradossale di nascondimento e di rivelazione, di rapporto tra il fuori e il dentro, di eccesso ostensivo e di piegatura interna entro cui il segreto esplica le sue metamorfosi e i suoi inganni: un processo di dissimulazione dell’illusione, che troverà poi esito intorno al tema profondo della maschera nel mondo visivo, immaginario, e nelle strutture narrative in un momento cruciale come quello del nostro cinema degli anni trenta-quaranta. Lo spazio della maschera nel barocco non è più quello iterativo, fisso, epifanico, totemico dell’antropomorfizzazione rituale del demonico, dell’animale, del divino, ma diviene obliquo, ambiguo e ambivalente spazio di déplacement, come ha notato Starobinski7. In questo senso agli inizi del Sei6
7
Nella cultura barocca la maschera, come del resto la metafora, è l’oggetto preferito di quello che Richard A. Lanham ha chiamato homo rhetoricus, «l’uomo che pone al centro della propria esistenza il linguaggio e lo manipola come un attore sempre pronto a cambiare travestimento», M. Lollini, Le muse le maschere e il sublime. G.B. Vico e la poesia nell’età della “Ragione spiegata”, Guida, Napoli 1994, p. 166. Cfr. J. Jallat, Le masque ou l’art du déplacement. D’après un article de Jean Starobinski, in “Poétique”, n. 2 (1971), p. 482.
220
Lessico del cinema italiano
cento assistiamo a una dislocazione visuale, a un sovrapporsi e interferire di piani e punti di vista, a una dinamica del gesto, in connessione con le raffigurazioni della tarda commedia dell’arte, delle scene di piazza, dei gesti delle maschere e del formicolìo del carnevale, dalle stampe di Callot (che giocano sul contrasto fra i primi piani e la profondità dello spazio visivo) a una celebre incisione di Giacomo Franco, che ritrae i ciarlatani a Piazza San Marco e «che moltiplica il punto di osservazione su un luogo in cui si replica, sotto angolature differenti, un evento globale e collettivo, fuori dai limiti temporali; proprio come in una classica sequenza cinematografica»8, fino ai campi lunghi dei quadri di Micco Spadaro con le piazze napoletane popolate dai rivoltosi di Masaniello, dalle processioni di San Gennaro, dai carnevali e parate barocchi. La figurazione di maschera e mascherate del barocco italiano traspone il festivo e il teatralizzato già verso una cinematica, una dinamica cinematografica, in cui si proiettano mutazioni sceniche, schermi, inganni dell’occhio, sfondamenti di prospettive, invasione e proliferazione di maschere e lingue e dialetti (come nel teatro e nella scultura del Bernini), ma introduce anche un contromovimento, quello di una ragione che smaschera e scardina dall’interno le forme. In una poesia del 1723 intitolata Origine, progresso e caduta della poesia Giambattista Vico riconosce il carattere vuoto e dissimulatorio delle maschere e del teatro barocco […]. La maschera moderna, tematizzata in un importante quadro di Salvator Rosa dal significativo titolo di La menzogna (1649 ca.), rimanda appunto a una idea di inganno che ha una fonte decisiva nella cultura barocca. […] si era diffusa la convinzione che sono le menzogne, le falsità espresse attraverso maschere e veli di vario tipo a fondare la civiltà e i rapporti sociali. […] In Vico è più forte la consapevolezza ermeneutica della distanza incolmabile tra il mondo primitivo e il mondo moderno. […] Alla rigida alternativa proposta da Gravina tra la decadenza barocca e la riproposizione dello stile antico, Vico oppone una più lucida consapevolezza storica del destino della poesia nell’età della ragione spiegata9.
8 9
C. Alberti, La scena veneziana nell’età di Goldoni, Bulzoni, Roma 1990, p. 3. M. Lollini, Le muse le maschere e il sublime. G.B. Vico e la poesia nell’età della “Ragione spiegata”, cit., pp. 155-157.
Maschera Bruno Roberti
221
L’idea di maschera presso gli antichi viene tematizzata da Vico in una lettera a Giuseppe Pasquale Cirillo, ripresa poi nella Scienza nuova. Nella lettera Intorno alle maschere degli antichi (che sarà pubblicata e commentata più tardi da Benedetto Croce)10 da una parte si accenna al fatto che la prima maschera fu quella del Satiro, e dall’altra si ricostruisce l’etimologia della voce persona che per i primi latini (nella ipotesi di Vico) significava vestir di pelli. Scrive Vico che i satiri: «In quella rozzezza e semplicità dovettero ritrovare la prima maschera col vestire i piedi, le gambe e cosce di pelli caprine, che dovevan aver alla mano e tingersi i volti e ’l petto di fecce d’uva ed armar la fronte di corna»11. Se Vico da un lato sottolinea come i primi uomini «per forte inganno di robustissime fantasie» credevano veramente di vedere gli dèi in terra, e fa risalire alla maschera animale di tipo rituale le origini del teatro al di là della dicotomia comico/tragico, dall’altro coglie nella maschera moderna il «venir meno della sostanza delle immagini create dalla fantasia, ora ridotte a pure “maschere”, parole prive di alcun valore “religioso” e metaforico: …or son maniere di laudar volgari/ qual maschere talor senza subbietto/ di Diane, di Veneri e di Alcidi»12. Cioè enuclea, con singolare preveggenza, la “caduta del soggetto” nella maschera moderna13. È la nascita teorica della solidarietà tra maschera moderna e uomo senza contenuto, il conferimento dell’improprio a un atto di mascheramento come dissimulazione di un vuoto. Ma questa prefigurazione della maschera come spettro del nulla, con una connotazione nera e orrorifica (che caratterizzerà la maschera romantica) passa necessariamente per un punto di conversione barocco che lega la maschera all’idea di inganno, di menzogna, di illusione e al piacere, forse già feticistico, che si esplica con l’ostensione di tale illusorietà. 10 11 12 13
B. Croce, Di una lettera del Vico, che si credeva perduta, intorno alle maschere degli antichi, in “La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce”, pp. 389-391. G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni 1725, 1730, 1744, Bompiani, Milano 2012, par. 910. M. Lollini, Vico, Salvator Rosa e le maschere del barocco, in “Forum Italicum”, n. 29.2 (1995), p. 247. «Vico intende sottolineare il carattere necessario e naturale delle maschere degli antichi, il loro rinviare a miti autentici e a riti di fertilità, a differenza delle maschere moderne, che gli apparivano vuote di contenuto», M. Lollini, Le muse le maschere e il sublime. G.B. Vico e la poesia nell’età della “Ragione spiegata”, cit., p. 163.
222
Lessico del cinema italiano
In un dipinto di Salvator Rosa un uomo solleva con la mano una maschera, che somiglia al soggetto ma vi conferisce una fissità inespressiva, come svuotata. Nell’episteme moderna del barocco, come ha notato Foucault, avviene una sorta di elisione del soggetto. Il soggetto è decentrato e in tal modo tenuto da parte e sottoposto a una “inquadratura” in cui il gioco di specchi, nella tipica moltiplicazione dei punti ottici del barocco, implica un gioco di maschere, tendenzialmente infinito, che fa saltare la distinzione tra maschera e faccia. L’ontologia del volto, la sua radice kenotica e cristiana, la dialettica tra natura e persona, salta in un gioco anamorfico di rinvii di maschere a maschere. La figurazione del mascherarsi da un lato assume una dinamica metamorfica, fabulatoria, dissolvente, e dall’altro emblematizza quel carattere scettico degli italiani, su un fondo antitragico e già postmoderno, rilevato prima da Leopardi, e che poi De Sanctis spiega con la dinamica controriformistica che in Italia porta a rifuggire l’etica protestante e ad assumere la “dissimulazione onesta”, la divina bugia, del gesuitismo: un’ipocrisia che teatralizza la vita civile, assimila il mondo all’illusione e dell’illusione fa mondo, e fonda l’osservanza della forma in disaccordo con la coscienza. Divenne regola di saviezza la dissimulazione e la falsità nel linguaggio, ne’ costumi, nella vita privata e pubblica: immoralità profonda, che toglieva ogni autorità alla coscienza, ed ogni dignità alla vita. Le classi colte, incredule e scettiche, si rassegnarono a questa vita in maschera con la stessa facilità che si acconciarono alla servitù e al dominio straniero14.
Il “riso bianco” degli anni trenta e la teatralizzazione dello spazio filmico Il processo di disinganno e la sua dialettica con un immaginario dell’illusione, cominciato con il barocco, trova il suo punto di conversione in una certa modernità del cinema italiano. Un tipo di mascheratura barocca ha percorso lo spazio innovativo e rischioso del dissolvimento dissimulante, fin dal nostro cinema 14
G. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1996, p. 546.
Maschera Bruno Roberti
223
anni trenta-quaranta. Tre secoli prima, nel 1641, Torquato Accetto tesseva un elogio della dissimulazione, pratica onesta che adoperava l’inganno, la finzione, la metafora del sogno, le forme del bizzarro e del capriccio, come la pratica di un transito nelle forme, facendo passare la visione barocca «da forma artistica a pratica antropologica a sottile tecnica di potere sino a tattica resistenziale e rivoluzionaria»15; e inaugurando, nel «Gran secolo della dissimulazione» (così Macchia nomina il Seicento), un’ambiguità tra scena politica e scena teatrale, una reversibilità tra poteri e contropoteri, che in Italia si muove su una linea che dalle estetiche della Controriforma conduce fino allo stile di regia dei cosiddetti “formalisti” italiani. Laddove la cifra dissimulata del costume, della maschera, del doppio, e perfino di un certo clima magico, inquietante, occulto (nel senso, richiamato da Fortini in Verifica dei poteri, di «poetiche dell’occulto e dell’ermetico», che possono fornire paradossalmente la chiave, nel confronto con i poteri, di una tecnica tutta politica di confondere le piste, le identità) può configurare Una tendenza, anzi un modus, che potremmo chiamare […] della dissimulazione […] come finzione (nel triplo senso di falsità, di recitazione e di fiction), come maschera, come doppio, come fondale: un filo rosso di tutto il cinema degli anni ’30 […] il filo della dissimulazione crea nel cinema italiano degli anni ’30 una particolare tessitura di sottotesti, produce una zona di ambiguità non completamente risolvibile nell’evasione; e trionfa soprattutto, assumendo la dignità di uno stile, con la stagione, breve ma fortemente caratterizzata, del calligrafismo16.
Uno scetticismo connesso al gioco di maschere e di travestimenti del potere comporta nel cinema italiano uno scardinamento, una destituzione dell’identità, che prende avvio appunto con il cinema degli anni trenta-quaranta, in un tempo in cui la parata e la mascherata del potere esornavano nella retorica fascista. Nella tipologia commedica di quel periodo, il mascheramento è legato al tema comico del sosia e allo scambio di perso15 16
V. Zagarrio, Malombre ovvero della dissimulazione onesta, in La bella forma. Poggioli, i calligrafici e dintorni, a cura di A. Martini, Marsilio, Venezia 1992, p. 44. Ivi, pp. 46-46.
224
Lessico del cinema italiano
na, complicato quasi sempre da una metanarrazione. Esempio eclatante di mise en abyme resta Fuga a due voci (1943) di Bragaglia, mentre Validità giorni dieci (1940) di Mastrocinque si apre in uno studio di doppiaggio di Cinecittà e termina con un lieto fine nel quale i protagonisti avvisano il pubblico in sala che la scritta “Fine” sta per sopraggiungere. Si tratta dunque di una derivazione dal meccanismo metateatrale barocco, che si legge anche nel film avventuroso in costume, dove quasi sempre viene tematizzata in questo senso la mascherata del potere, spesso nel travestimento da buffone o da villano dello stesso potere sovrano, topos che si protrae dal Camerini di Il cappello a tre punte (1935), interpretato non a caso da Eduardo e Peppino De Filippo, fino al suo remake degli anni cinquanta, dello stesso Camerini, La bella mugnaia (1955), e di Ferdinando Io re di Napoli (1959) di Franciolini (ancora con Eduardo, nelle vesti di Pulcinella, e Peppino, in quelle del sovrano travestito). Già a conclusione degli anni trenta in un film come La granduchessa si diverte (1940) di Gentilomo, il travestimento del potere (la sua dissimulazione dietro una maschera che lo raddoppia e lo mimetizza) assume toni alla Lubitsch nella figura della granduchessa che si unisce al popolo in incognito, travestendosi e scambiandosi d’abito con una ballerina sua sosia. Meccanismo che in Dora Nelson (1940) di Soldati fa slittare metacinematograficamente la stessa messinscena, fin dall’inizio in cui il set del dramma in costume si rivela una finzione filmica riteatralizzata nello scivolamento fulmineo in farsa, e dove la sostituzione della diva capricciosa con la modista popolaresca serve per sfondare lo specchio e smascherare i poteri del cinema stesso. Fingersi ciò che non si è, usare la maschera, nelle commedie anni trenta, con il loro gioco di velature e schermi, con il mondo di equivoci, sostituzioni, scambi di persona, è il modulo dissimulatorio di un meccanismo iniziatico di ingresso nello spazio privilegiato, e ambiguo, del potere; non soltanto per “revanscismo di classe” (che legittimerebbe la ricchezza e i codici dei poteri costituiti), ma soprattutto per ri-velarne l’irrealtà, per mutarne l’“indice del reale”. L’ambiente sociale, gli interni, le architetture della città, si danno come travestimenti di spazi, zone intermediali tra scena (spesso teatrale) e schermo (nel senso sia di spazio proiettivo del desiderio, sia di dispositivo filmico), e ciò viene sempre più
Maschera Bruno Roberti
225
in luce (luce trasognata ma che infine spietatamente illumina la cartapesta delle illusioni) verso gli anni quaranta. Il signor Max, sdoppiato nel giornalaio e nel conte (nel film omonimo di Camerini del 1937), traspone ed eccede la simulazione in un gioco che alla fine lo porta a disingannarsi, fino al punto di gettare la maschera; i genitori finti ricchi di Giorno di nozze (1942) di Matarazzo allestiscono una “scenografia” essenzialmente diegetica e metalinguistica, costruiscono e materializzano in modo disperato i fantasmi desideranti della figlia, assimilano simbolicamente la propria maschera allo spazio di rêverie in cui muoversi; il giovane debosciato di Quartieri alti (1945) di Soldati immagina un ambiente in cui traspone il lusso e l’ozio in cui è vissuto impropriamente, e lo traveste di modestia e di décor antiquato, fino al punto, per inscrivervi la storia d’amore cui vuol dar vita, di inscenare letteralmente un set-teatro assoldando degli attori, salvo restare fisicamente imbrigliato nelle maglie di quella finzione; il giovane disoccupato di I nostri sogni (1943) di Cottafavi si finge miliardario, salvo mostrare alla ragazza ingenua l’impostura cinica e allucinatoria. In questo modulo di dissimulazione della “commedia bianca” è insita la cifra barocca della piegatura, dei mondi imbricati gli uni negli altri, dei doppi fondi, di una ottica anamorfica che «costringe l’occhio a spingersi al di là delle quinte e degli arredi»17 nel momento stesso in cui si esibisce e si espone il soggetto in maschera, incrinandone dall’interno la propria identificazione nei confronti dell’Altro. I percorsi interni negli spazi-maschere danno accesso a una fascinazione, ma insieme a un disinganno, dissezionano, anatomizzano il congegno: un moto tipicamente barocco. La macchina della finzione fantasmizza il quotidiano, e all’inverso rende quotidiana la fantasticheria, espande l’artificializzazione, il “fantasma delle merci” (i sogni di telefoniste e cameriere, di studentesse e impiegati) dentro la “spirale di luce” del cinema, il luccichìo o la nebulosa già insita nel diorama delle città moderne, laddove coincidono fantasmagoria e derealizzazione. In questo senso film come Retroscena (1939) e Contessa di Parma (1938) di Blasetti o I grandi magazzini (1939) di Camerini sono di una grande modernità sia 17
M. Grande, La commedia all’italiana, a cura di O. Caldiron, Bulzoni, Roma 2003, p. 22.
226
Lessico del cinema italiano
per lo stile che per l’assunto: la grafica visiva adottata per filmare magazzini, case di moda, teatri lirici si diffonde nel modo di imbricarne ed estenderne la finzione negli esterni urbani. Attraverso lo scambio di persona, l’adozione di un’altra identità, l’equivoco e l’inganno, passa uno sfondamento ottico e sonoro della “società finta” di quell’epoca, messa in abisso nel circuito visivo e dissimulatorio della regia. Ma gli esempi del trucage degli spazi, delle loro maschere, si diffondono in tutto questo cinema: in Villa da vendere (1941) di Cerio, la villa diventa uno spazio ubiquo, equivoco, popolato in modo interclassista da identità scambiate (ladri che fanno i guardiani e proprietari scambiati per ladri) che si proiettano e defigurano l’ambiente; in Eravamo sette sorelle (1937) di Malasomma le ballerine che si fanno passare per figlie illegittime trasformano la villa del conte in un’oasi di finzione; in Cose dell’altro mondo (1939) ancora di Malasomma e in Se io fossi onesto (1942) di Bragaglia è addirittura una prigione a “truccarsi” in spazio di lusso; in 4 ragazze sognano (1943) di Giannini l’appartamento sontuoso di un grattacielo è in tutta evidenza un set: in un frigorifero si trova del cibo “dipinto”. I personaggi e gli spazi di questi film raddoppiano il proprio stato finzionale, vivendo come una scena il film e mettendo in evidenza la maschera che dovrebbe nasconderli. E, come avviene in I grandi magazzini, questa dissimulazione coincide alla fine con lo smascheramento. Porte scorrevoli, vetri smerigliati, biancore di tendaggi, scalinate, linee déco (nelle scenografie di Gastone Medin e di altri architetti dell’epoca) mascherano baroccamente i sogni e il loro rovescio. Sono gli arredi dove, come scriveva Benjamin, «si cullano le illusioni», e i salotti del quotidiano sono «palchi nel teatro universale»: la grande villa dove si muovono (tra camerieri e giardinieri, con un affastellarsi mobile di oggetti nella traiettoria della camera) la Noris e De Sica in L’uomo che sorride (1936) di Mattoli non ha nulla da invidiare allo stile delle commedie di Hawks e Lubitsch. Così il processo di teatralizzazione dello spazio filmico, oltre al dato metalinguistico, espone l’ambiguità tra natura e artificio, in modo tale che il cinema sorprenda nel bel mezzo della rete, dell’intrigo, la presenza dissimulata della maschera sociale.
Maschera Bruno Roberti
227
Il teatro in quanto palcoscenico e, per definizione, luogo di rappresentazione, sembra esercitare una sorta di pressione per invadere e “colmare” di sé lo schermo. Sono numerosi i film in cui è presente un palcoscenico di teatro, spesso giustificato dal contesto narrativo che prevede, tra i protagonisti, aspiranti o professionisti attori, cantanti, compositori, ballerine. Ma in molti altri casi, il senso del palcoscenico si cela dietro altri “luoghi teatrali”, come i locali notturni, le sfilate di moda, le feste private ed anche tutti quei momenti in cui i personaggi assistono a spettacoli o a forme di rappresentazioni. Così il set diventa un ambiente-cardine dove si vanno a congiungere il teatro e il cinema18.
La costruzione di volti/maschere, di trucchi facciali, di sovrapposizione posticcia di protuberanze o segni grotteschi che esaltano l’astrazione devisagista, che caratterizza il varietà degli anni venti (e che si riflette nei corpi/volti dei comici del muto “adottati” dall’Italia come Ferdinand Guillaume o André Deed, Polidor e Cretinetti) funziona a meraviglia in questo clima onirico e “bianco” del cinema commedico degli anni trenta. Il ricciolo sulla fronte di Macario era stato suggerito da Petrolini19 e certo nei film che Macario girò con Mattoli (che veniva anche lui dalla rivista, avendo inventato la compagnia Za-Bum), si sente un’aria “sperimentale” in cui passa l’amore dei futuristi per il varietà e il gusto slapstick dei Marx, per cui la faccia gommosa, incipriata, da “fantasmino” del comico piemontese si allinea con le spettralità surreali della maschera petroliniana di Nerone (1930) filmata da Blasetti e richiama le erranze anodine di Charlot. In un film come Lo vedi come sei… Lo vedi come sei? (1939) di Mattoli, la potenza metalinguistica e dissimulatoria, la frenesia trasformistica, le “gag non-sense” svelano la sua cifra sperimentale, come nella sequenza del testamento filmato, cinema nel cinema (così avveniva anche negli andirivieni tra schermo e sala, illusione e vita in un film geniale e misconosciuto come Fuga a due voci). Pure nel film d’esordio dei De Filippo, Tre uomini in frak (1932) di Bonnard c’è un 18 19
M. Teodoro, La scena dei sogni. Interni della commedia cinematografica italiana degli anni Trenta, in “Il Nuovo Spettatore”, n. 1 (1997), p. 209. Cfr. E. Giacovelli, Non ci resta che ridere. Una storia del cinema comico italiano, Lindau, Torino 1999, p. 36.
228
Lessico del cinema italiano
aspetto sperimentale connesso alla dissociazione voce-volto e al metaspettacolo, laddove il cantante che ha il terrore di cantare in pubblico presta (come Cyrano) la propria voce a un bamboccio di bell’aspetto e Eduardo e Peppino sono i burattinai di questo trucco. E i trucchi falliti di una maschera proveniente dall’avanspettacolo quale l’eduardiano Sik-Sik sono il motore di Quei due (1935) di Righelli e vi si riscontra tutta la sua abilità e inventiva nell’uso delle ombre come nella costruzione degli spazi dove i due si introducono trovandosi perennemente fuori posto e imbrigliati in commedie degli equivoci (la villa del ricco pazzo, le terrazze del caseggiato che immettono nella stanza da letto di due amanti). E con Ti conosco, mascherina! (1943) lo stesso Eduardo esplora dall’interno, svelandone i meccanismi, dissezionandone i retroscena dei trucchi e del gioco di maschere ed equivoci, il teatro scarpettiano da cui proviene. La libertà surreale e insieme le astrazioni ironiche di una riflessione dei meccanismi patetico-comici del primo segno grottesco, lunare, quello di inizio Novecento, traspaiono anche in un film come L’amor mio non muore! (1938) di Peppino Amato, scritto direttamente (e forse obliquamente “diretto”) dai De Filippo, che «termina con un finale in cui Eduardo e Peppino si allontanano sopra un fondale quasi surrealista col passo sonnambolico caro ai film d’avanguardia»20. La mascherata del potere in Blasetti Nel ciclo di film in costume che Blasetti inaugura nel 1938 con Ettore Fieramosca e conclude nel 1942 con La cena delle beffe le forme del travestimento e delle maglie del potere, il costume, l’abito, l’uniforme, la corazza, fino alla vera e propria maschera dell’arte, dissimulano le forme ambigue attese o disattese della propaganda, si muovono entro un’ambivalenza significativa soprattutto laddove il travestimento, storico o fantastico, opera in partenza sul film una manipolazione metaforica. Lo statuto immaginario dei tre eroi più fantastici che storici dei film blasettiani 20
Cfr. F. Sacchi, L’amor mio non muore, in “Corriere della Sera”, 26 ottobre 1938.
Maschera Bruno Roberti
229
successivi al Fieramosca, rispettivamente il Signor Formica/Salvator Rosa, Arminio e Giannetto, riverbera sulla figura (certo più storica, ma la cui costruzione drammaturgica nasce pur sempre dal travestimento romanzesco di D’Azeglio) del tipo italiano di un eroe sotto mentite spoglie, ciò che nelle maglie del tessuto visivo del film del 1938 resta dissimulato all’interno del dettato metaforicamente implicito dell’enfasi sull’italianità e sull’orgoglio autarchico. Anzitutto il carattere di ambivalenza si esplicita nei tre personaggi dei film successivi in un rapporto drammaturgico con la figura del doppio, e insieme in una dualità (al limite della doppiezza), insita nel loro stesso statuto eroico. Accade come se il tragitto che conduce il corpo drammaturgico del protagonista al gesto eroico, o meglio alla sua rappresentazione scenica, passi necessariamente attraverso le maglie del travestimento, inteso anche proprio come costume (abito che si fa segno schermico del suo abitare lo spazio filmico), ma soprattutto implicato in un gioco, manierista e barocco, di dissimulazione visiva rispetto al potere, rispetto alle pretese di quest’ultimo di regolare i corpi e le immagini “ufficiali”, la loro “divisa”. E ciò in Un’avventura di Salvator Rosa (1939) si compendia proprio nell’uso apotropaico della maschera/personaggio di Formica, indossata da Salvator Rosa nella funzione di smascheramento del potere (la maschera “smaschera” secondo una modalità tipicamente barocca); un film che lo stesso Blasetti considerava uno sberleffo rivolto al potere a favore delle classi popolari. Anzitutto Salvator Rosa deriva dalla suggestione di un racconto hoffmaniano, memore delle incisioni di maschere di Jacques Callot, Il signor Formica, dove il pittore napoletano si traveste e si raddoppia sotto la maschera da attore-saltimbanco del Signor Formica, «incarnazione popolarissima del Rosa amico e difensore del popolo» (come recita la didascalia di apertura), e che ha un fondamento storico dal momento che la condizione dissimulatoria dell’attore/maschera fu esperienza personale del Rosa nel 1639, quando nella sua ricerca di contatto con il mondo altro da quello intellettuale in cui viveva, «aveva assunto una maschera buffonesca, quella di un supposto Pasquariello, e aveva cominciato a vagabondare per le piazze delle città italiane, dando vita assieme a un gruppo di ciarlatani a una serie di rappresentazioni teatrali improvvisate
230
Lessico del cinema italiano
nello stile della commedia dell’arte»21. La regia “mimetica” blasettiana è allora atta insieme a mascherare e smascherare proprio il potenziale di trucco e di finzione della retorica di regime. Al di là delle intenzioni la forza rappresentativa e l’ornamentazione retorica della visività blasettiana, nel suo essere tendenzialmente indomabile e intrinsecamente destabilizzante (anzitutto del sistema oleografico e normativo della imagerie fascista), inoculavano un contravveleno alla retorica di cartapesta imperante, proprio esasperandone ed enucleandone il potenziale finzionale di travestimento, intessendone le maglie e i tessuti dei segni visivi, dell’“abbigliamento”, in ogni senso, del set. È qui, nel paradigma barocco della maschera che si evince il punto di conversione che incide sulla dicotomia tra la ritualità della maschera antica, del carnevalesco, e la spettralità della maschera moderna. Questa dissimulazione insita nella maschera moderna contiene certo in sé ciò che Freud chiamerà perturbante, l’incertezza tra familiare ed estraneo, tra vivente e non vivente, tra reale e fantastico, ma, per ciò che riguarda un’antropologia italiana, la svolta barocca espande al mondano intero il paradigma illusorio, per cui lo scetticismo assume, proprio con l’uso della maschera e la coscienza della menzogna, un modus vivendi che permette di svuotare il potere piuttosto che metterlo a morte ritualmente. Il carnevale festivo e la sua estrema sopravvivenza nella commedia dell’arte non servono più a sospendere e riaffermare nel ciclo vitale un ordine naturale, ma piuttosto a estendere un’intrinseca artificialità, illusorietà, all’intero mondo, nei suoi aspetti civili come in quelli del mondo alla rovescia, che non è mai rivoluzione ma guerra civile, rivolta interna, spesso fratricida, ai micropoteri. Il travestimento si estende al sociale intero22.
21 22
M. Lollini, Le muse le maschere e il sublime. G.B. Vico e la poesia nell’età della “Ragione spiegata”, cit., p. 165. «La stessa lotta politica del Seicento è caratterizzata dalla dissimulazione e dal travestimento e le corti dei principi appariranno al Traiano Boccalini dei Ragguagli del Parnaso come botteghe di maschere, dove non si mercanteggia se non roba finta fabbricata per servizio dell’inganno», ivi, p. 166.
Maschera Bruno Roberti
231
Un flashback nel carnevale muto In un clima da carnevale, nei baracconi delle meraviglie, nelle fiere, nei luna-park troviamo l’epifania del cinema comico italiano: Il finto storpio (1896) di Pacchioni, fotografo da fiera che gestiva un padiglione delle meraviglie a Milano. E il comico si accoppia al trasformismo metacinematografico, presente fin dalle bobine girate da Fregoli e proiettate in teatro per svelare i trucchi trasformistici alla Méliès «dietro le quinte» (Fregoli dietro le quinte, 1903), non esenti da spericolate sperimentazioni (film proiettati a rovescio, “doppiaggi” dal vivo dietro lo schermo). Fregoli, come un’immortale maschera da commedia dell’arte, fu il primo ad apporre il proprio nome nei titoli dei film (Fregoli dopo morto, 1898, Una burla di Fregoli, 1899). In Tontolini è triste (1911) vediamo Tontolini uscire da un teatro con un’espressione triste per infilarsi in una sala cinematografica per risollevarsi il morale. In Cretinetti al cinematografo (1911) il comico entra in un cinema, fa a brandelli lo schermo e manda in frantumi il dramma passionale, provocando una rissa. Il carattere “attrazionale” di questi film è avvicinabile al dinamismo comico dei futuristi, al loro amore per il Teatro di Varietà: in Amor Pedestre (1914) Robinet racconta una storia d’amore inquadrando solo i piedi, come in una vera e propria «comica futurista»23. Furono clown e attori di varietà i primi comici muti del cinema italiano: Barilot, Cinessino, Firulì, Fregolino, Kri-Kri, Pistolino, Rococò, Tartarin, Fricot, Fringuelli, nomi da maschere dell’arte. Lo stesso Petrolini interpreta nel 1913 un film dove già è evidente il carattere grottesco, tra comicità e disperazione, che è un tratto tipicamente italiano: Petrolini disperato per eccesso di buonumore. André Deed, Ferdinand Guillaume, Marcel Fabre, comici di origine francese, furono adottati dal muto italiano come prime maschere del cinema: Tontolini, Cretinetti, e quel Polidor che Fellini richiamerà come archetipo del clown in Le notti di Cabiria (1957) e La dolce vita (1960). Cretinetti/Deed è un clown dal volto bianco le cui origini sono nel circo, nel caffè-concerto, negli spettacoli di 23
Il cinema comico, soprattutto nel muto, si può intendere come «un cinema di puro sperpero gestuale, gambe che si agitano, braccia che sbattono per aria e occhi che roteano (ossia, che non guardano)», P. Bonitzer, Le champ aveugle, Cahiers du Cinéma, Paris 1999, p. 37.
232
Lessico del cinema italiano
illusionismo di Méliès (con cui lavorò), e nella sua maschera si rintraccia tanto la radice “sacrificale” e dionisiaca del kòmos, quanto la lunarità alla Pierrot o la meccanicità dell’automa cara alle avanguardie. In Cretinetti troppo bello (1909) viene, come Orfeo/Dioniso, fatto letteralmente a pezzi da un’orda di femmine assatanate, come fosse un fantoccio carnevalesco e rituale e poi ricomposto automaticamente. In L’uomo meccanico (1921) André Deed diventa Saltarello (nome che rimanda ai balli carnevaleschi di Sfessania) e, in modo esemplare, traghetta la funzione della maschera verso esiti di macchineria futurista e perfino espressionista (non lontani da Lang). Ma è Lucio D’Ambra ad essere definito dalla critica coeva il «Lubitsch del muto italiano». La consapevolezza autoriflessiva dei suoi film è sempre presente e coniugata con giochi di mascheramento, che sembrano assimilare riflessioni pirandelliane e giochi di specchi del “teatro del grottesco”. Si veda la sequenza proiettata al contrario o le ombre cinesi che proiettano su una parete i sogni filmici di Lia Formia in L’illustre attrice Cicala Formica (1920), inscritto in un dispositivo dichiaratamente metacinematografico, o il soggetto scritto per Il bacio di Cyrano (1920) di Gallone, che non a caso riprende, in una myse en abime spettacolare, la figuramaschera di Cyrano de Bergerac, a cui, al pari di Capitan Fracassa (che sarà anche il titolo di uno degli innumerevoli rotocalchi cui collaborò D’Ambra), il cinema italiano fin dal muto farà riferimento24. Film come Il Re, le Torri, gli Alfieri (1917) di Illuminati, La signorina Ciclone (1916) di Genina, Emir cavallo da circo (1917) di Illuminati, La commedia dal mio palco (1918), Amleto e il suo clown (1920) di Gallone e soprattutto Carnevalesca (1918) di Palermi, scritto da D’Ambra (suddiviso in quattro episodi: Carnevale 24
Nel cinema italiano la maschera, il carnevalesco, la commedia dell’arte, il nesso maschera/viaggio nel topos del Picaro, vengono esplicitati fin dal muto: Sogno di Don Chisciotte di Palermi del 1915, Cirano di Bergerac di Genina del ’25. Negli anni trenta-quaranta, oltre all’esemplificazione blasettiana di Salvator Rosa, è intorno a quel Capitan Fracassa (ripensamento della commedia dell’arte da parte del Gautier decadente e parnassiano che guarda alle maschere melanconiche di Watteau) che troviamo due significativi film, quello di Coletti del 1940 (con Elsa De Giorgi, Osvaldo Valenti, Luisa Ferida e Clara Calamai) e quello “quasi taliano” di Abel Gance, del 1943, che ha un titolo significativo come La maschera sul cuore (ancora con Elsa De Giorgi).
Maschera Bruno Roberti
233
bianco, infanzia gaia e spensierata; Carnevale azzurro, giovinezza, amore; Carnevale rosso, le passioni violente; Carnevale nero, la morte, la follia), definiscono una oscillazione tra commedia e melodramma in cui il palcoscenico, la maschera, la clownerie sono figure centrali, con un gusto barocco della messinscena25. L’idea della “scatola scenografica” invogliò Puccini a vagheggiare un melodramma da Il Re, le Torri, gli Alfieri, che è ambientato dentro una scatola di scacchi (come La scacchiera davanti allo specchio di Bontempelli), anticipando le “scatole lubitschiane” di La bambola di carne (1919), precorrendo De Chirico e Savinio. L’isocronia, il grafismo spaziale di cerchi e linee nella strutturazione dei bianchi e neri, i movimenti meccanici, le coreografie quasi di automi, la spazialità da «sogno implicato» (Deleuze) e geometrie da musical, ricorrono in D’Ambra, anche nei film non diretti ma supervisionati e progettati da lui. Si pensi alla costruzione coreografica a raggiera nella strutturazione dei movimenti dei corpi assimilati a elementi architettonici e degli spazi in cui i toni di luce si metaforizzano in colori, nella sequenza circolare con Lyda Borelli del “Carnevale rosso”, o al gioco di porte e tappeti e carrozzine disposte ad arco e raggiera, sospinte da ancelle in variazioni di intensità di bianchi che compongono una macchia circolare nella sequenza della stanza nel “Carnevale bianco”. La figura umana diventa oggetto, maschera, feticcio: nello stesso film una mano fa passare da un Carnevale all’altro attraverso un prisma. In Il Re, le Torri, gli Alfieri un’inquadratura (testimoniata da una foto) è un disco ruotante come una roulette, ripreso dall’alto, al cui interno stanno quattro donne seminude disposte variamente, e in Effetti di luce (1916) di Morselli e Falena, le scene danzate appaiono perfette anticipazioni nell’ortogonalità luministica dei film del regista-coreografo americano Busby Berkeley. Nella sua attività di critico del resto D’Ambra si richiama a quei registi di area francese o mitteleuropea in cui lo stile di messinscena, il mascheramento e l’artificio coincidono con la struttura stessa della narrazione (Clair, Gance, 25
Nel muto italiano «appare ricorrente l’identificazione vita-teatro, e quindi vita come rappresentazione, recita o mascherata». In Tutto il mondo è teatro (1919) di Gariazzo «due marionette scendono tra gli uomini prima di comprendere che la felicità è sulle tavole del palcoscenico», A. Meneghelli, Lucio d’Ambra: ipotesi per un’indagine isocronica, in “Fotogenia: storie e teorie del cinema”, n. 4-5 (1997-1998), p. 179.
234
Lessico del cinema italiano
Lubitsch, Duvivier, Pagnol, Guitry). D’Ambra fu una figura chiave per leggere il clima culturale di quegli anni letteralmente ossessionato dalla maschera, dal fantoccio, da una teatralità vuoi spettrale, vuoi grottesca e dal loro potenziale avanguardistico (a cominciare dai fratelli Bragaglia). Lo si evince dai rapporti di D’Ambra con Petrolini, che ridusse una sua pièce per il teatro, Ambasciatori; dalla “leggenda” per cui lo spunto del Si Gira (o Quaderni di Serafino Gubbio operatore) di Pirandello nasce dalla frequentazione di un set dambriano; dai rapporti con Ginna e coi futuristi. E tutto ciò segna in modo decisivo il muto italiano, in cui la discendenza barocca accede, proprio tramite la maschera, a una prefigurazione della maschera moderna, automatica, spettrale, senza però risolversi in essa, e anzi mantenendosi dentro la dissimulazione delle maschere vestite, al di qua di quelle nude, che in Pirandello hanno una connotazione espressionista. C’è un perduto film fantasma (non a caso acclamato da Bragaglia) del 1919 di Masi e Pozzati, Fantasia bianca, che pare fosse una sorta di sperimentale poema visivo, una sinfonia filmica il cui soggetto attinge alle maschere della commedia dell’arte da un lato, e dall’altro al versante “fumista” e spettrale del carnevalesco di matrice simbolista ed europea, attraverso la figura centrale di un Pierrot, maschera qui più che mai fantasmatica e tragica, se arriva ad uccidere la sua Colombina e poi a impazzire e morire mentre «addossato ad un albero suona sul suo liuto l’inno alla morte, mentre viene sepolto dalle foglie che cadono dall’albero. Dal sepolcro poi uscirà un nugolo di tortore, che ci mostrerà il triste volto di Pierrot risorto, che ora suonerà l’inno della vita, andandosene lentamente verso l’infinito»26. L’imagerie mescola il barocco al gusto simbolista. Si vedano il “bizzarro cortile” abitato da Pierrot in cui i fiori si aprono e si chiudono come per magia e il pozzo e le colombe compongono un’atmosfera da féerie favolistica; si veda l’uccisione di Divette/Colombina mostrata attraverso le ombre proiettate sul 26
C. Giordani, The Copy Vanishes, ovvero il film senza film. Note su “Fantasia bianca”, in “Fotogenia: storie e teorie del cinema”, n. 4-5 (1997-1998), p. 136. Gli esterni furono a Villa d’Este a Tivoli; interprete fu una raffinata diva intellettuale come Bianca Virginia Camagni (en travesti come la Bertini di Histoire d’un Pierrot) già attrice di D’Ambra; Vittorio Gui, musicista poeta e scrittore di gusto simbolista, amico di Debussy, Pirandello e Papini, compose e diresse le musiche.
Maschera Bruno Roberti
235
terreno, dove «si veste di qualcosa d’occulto»; le tende che cadono addosso a Divette cui si aggrappa voluttuosamente: «Il film ci sembra oscillare fra parodia, dramma e pantomima, fra comicità e lirismo»27. La polarità Pulcinella/Pinocchio C’è nella tradizione italiana della maschera una polarità che segna la divaricazione tra maschera carnevalesca e maschera moderna: quella tra Pulcinella e Pinocchio28. La prima sembrerebbe la maschera che nella radice rituale-demoniaca rintraccia la propria continua reviviscenza: Pulcinella non muore mai; mentre la seconda, il burattino Pinocchio (che in Collodi riceve proprio da Pulcinella e Arlecchino una sorta di viatico) invece sembra la pura artificialità che deve essere smascherata, che porta inscritte in sé la morte, il nulla, la dissoluzione nel suo stesso paradosso di spirito-feticcio (è un pezzo di legno che si anima), destinato a morire a se stesso per lasciare il posto “al bambino per bene” (ma qui Collodi pone proprio la fine stessa di quella panoplia dell’artificio e del piacere della menzogna, dello scetticismo della bugia, che è il suo romanzo). Tale polarità può essere letta alla luce del “mediatore barocco”, turning point tra maschera premoderna e moderna. È nel barocco, e in quello italiano principalmente, che si ha da un lato il sentimento del mondo come teatro, della vita come illusione che esorcizza e umanizza il lato demoniaco e dall’altro 27 28
Ivi, p. 141. Sono annunciati o da poco usciti due film che appaiono in tal senso significativamente sincronici. Il primo è un progetto di Michelangelo Frammartino dedicato proprio alla figura di Pinocchio, riletta “a rovescio” con un itinerario che ne rintraccia, com’è proprio del suo cinema, sia le radici antropologiche, legate al paesaggio italiano, sia la pregnanza attuale. Il secondo è un film di Pietro Marcello, Bella e perduta, dedicato alla Reggia borbonica di Carditello, vicino Caserta, che mette in gioco proprio la figura di Pulcinella, anche qui con un occhio al retaggio storico e l’altro all’orizzonte contemporaneo di un territorio commisto di memoria di antichi splendori e degrado criminale, come quello dell’agro casertano. Due giovani cineasti italiani che rimettono in gioco le due maschere “polari” in una forma che slitta tra documentario e finzione.
236
Lessico del cinema italiano
l’artificializzazione della morte, l’automazione dello scheletro, l’esposizione ottica dello spettrale, indotti (come in Bernini o in Salvator Rosa) a un ipermascheramento29. Si opera un taglio trasversale, ripiegando in senso barocco e dissimulativo la dicotomia della maschera oltre la separazione tra vita e morte, tra vitalità rigenerativa, rituale e premoderna, e spettralità nullificante moderna e postmoderna. Allora se la terza via italiana della maschera costituisce una sorta di mediazione tra la ciclicità della maschera premoderna che affonda le radici nel rituale misterico di “morte e rinascita” (e che proprio tra rinascimento e barocco trova la sua formalizzazione nel primato dell’illusionismo carnevalesco e del trasformismo della commedia dell’arte) e l’affacciarsi sulla scena della maschera moderna che rovescia l’illusione nella deformazione grottesca, nell’automa, nel burattino, nella solidarietà della maschera sociale con il passaggio nella morte come vanitas spettrale (ciò che in Il fu Mattia Pascal di Pirandello si esplica in un modo che non a caso affascinerà il cinema, da L’Herbier a Chenal a Monicelli), possiamo vedere nelle maschere “emblematiche” di Pulcinella e di Pinocchio di nuovo un’antinomia, lungo la quale il cinema italiano sviluppa una propria declinazione della maschera. E questo sviluppo si può rintracciare nell’evoluzione del commedico italiano fino a leggere quella antinomia nella trasformazione delle maschere che sono emerse nella commedia italiana, fin dentro i suoi esiti nel grottesco nero, che segna la maturazione, e insieme il disfacimento, dell’insistenza, fino ad oggi, della maschera nel cinema italiano. Mario Perniola pone nel suo Enigmi la maschera di Pulcinella a epitome di un enigma del sentire italiano, su un versante disidentitario e impersonale per cui la caratteristica di Pulcinella consisterebbe nel non avere identità30. La sua inesauribile performatività 29
30
Paolo Toschi nel suo Le origini del teatro italiano sottolinea con forza le origini demoniache anteriori alla commedia dell’arte della maschera di Pulcinella e di quella di Arlecchino e Zanni. Tutte le maschere, per Toschi, hanno origine demoniaca e ultramondana, come è testimoniato dalla stessa etimologia longobarda della parola masca, che in origine significava morto, e che poi è passata a significare strega: la parola “maschera” fin dalle sue origini ha dunque indicato un essere infernale, l’anima di un morto. M. Perniola, Enigmi. Il momento egizio nella società e nell’arte, Costa & Nolan, Genova 1990, p. 158.
Maschera Bruno Roberti
237
viene ben rappresentata dal disegno di Tiepolo Il plotone di esecuzione, dove tre gruppi della stessa maschera pulcinellesca vestono gli abiti di giustizieri, giustiziati e spettatori. La sua enigmaticità consiste nella coincidenza di una totale esteriorità con una totale affettività, racchiudendo ciò che del paesaggio italiano ha suggestionato i viaggiatori del Grand Tour: L’essere insieme il paese dei morti e la scena di un’azione frenetica […] l’enigma di questo modo di essere che unisce una grandissima vivacità e una non meno grande insensibilità è oggetto di riflessione per Giacomo Leopardi che nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani (1824) si interroga circa le cause di tale sorprendente ed eccentrica disposizione affettiva31.
Nell’italiano c’è il paradosso di una iperspettacolarizzazione in continuo fermento («il divertimento e la dissipazione che proviene da una vita sprecata in spettacoli e feste»32), congiunto a una sorta di atarassia indifferente e cinica che fa sì che «ciascun italiano è pressappoco ugualmente onorato e disonorato», l’adesione tutta esteriore a un fuori mondano si accompagna a una indifferenziazione che svuota l’interiorità disidentificandola, facendo del sentire italiano “pulcinellesco” qualcosa di impersonale e dissipativo, «l’esempio di uno spettacolo senza società»33, per cui rispetto alle maschere sociali il soggetto risulta inassimilabile e dissipato o per eccesso di adattamento o per eccesso di disadattamento, o per ipermimesi oppure per trasgressione, dando luogo alla «specificità di un sentire senza soggetto, di un’affettività anonima, di una emozionalità impersonale, che costituisce il nucleo dell’esperienza italiana che resta ancora non pensata»34. Ecco perché il sentire italiano oltrepassa la maschera nuda (quella declinazione del ruolo e della forma sociale che per Pirandello cristallizza e rende cadaverica, mortuaria, la stessa pulsione performativa della vita, e che caratterizza la formula melanconica, lugubre, nera del grottesco europeo novecentesco) verso una spoglia, una maschera ve-
31 32 33 34
Ivi, p. 159-160. Ivi, p. 161. Ibidem. Ibidem.
238
Lessico del cinema italiano
stita35, che fa aderire la stoffa alla pelle, la “mezza maschera” nera alla mobilità del mezzo volto di pelle umana, e che fa coalescenza tra volto e maschera sedimentandovi le trasformazioni. Insomma un sentire liminare, di interscambiabilità indifferente tra verità e finzione, che fa la paradossale differenza italiana. Il barocco radica nel sentire italiano l’idea paradossale che la verità non sia il denudamento di un fatto, ma anzi il suo travestimento, qualcosa di essenzialmente vestito. Il mondo “spettacolare” del sentire italiano allora è in continuo transito, il suo ipercinetismo coincide al limite con l’immobilità della statua, del calco, per cui la sua tonalità emotiva è un transito continuo tra la melanconia e l’allegrezza, un confine tra la vita e la morte36. Sotto la prima veste c’è un’altra veste e la pelle è ancora tessuto, una maschera sotto la maschera. Il mondo stesso, l’ambiente tutto si fa veste e maschera, fino a un parossismo cinico, esteriorizzato, per cui l’umano si fa automatico, marionettistico, e spettrale, e l’accesso all’identità e al paesaggio italiano moderno passa per l’assunzione dell’enigma dei manichini, delle statue, della spoglia di un burattino abbandonato su una sedia: Pinocchio. Dunque dal finale di Pinocchio ai quadri di De Chirico37. È su questo crinale 35
36 37
«Mentre le “maschere nude” tagliano i ponti con l’ambivalenza costitutiva della vita, collocandosi in una dicotomia paralizzante tra fissità e ipocrisia del ruolo sociale e dismissione dello stesso con un ritiro dal mondo, le “maschere vestite” regolano nel trionfo dell’apparenza e dell’illusione la circolazione e la definizione del desiderio sociale e il piacere del vincolo», R. De Gaetano, Maschere nude, maschere vestite, maschere nere, in “Fata Morgana”, n. 22 (2014), p. 25. Come notava nel XIX secolo un viaggiatore colto quale Wilhelm von Humboldt: cfr. M. Perniola, Enigmi. Il momento egizio nella società e nell’arte, cit., p. 163. «Nel momento in cui gli uomini diventano statue, manichini, marionette, la loro sensibilità si trasferisce all’esterno, all’ambiente, al paesaggio, di cui essi stessi sono tuttavia parte integrante: l’enigma italiano consiste nel fatto che l’elemento umano è dotato di una emozionalità esterna, che non gli appartiene intimamente, ma a cui pur sempre partecipa. Gli attori, gli spettatori fanno parte della scena allo stesso titolo delle quinte e dei fondali: se la scena è intrisa di emozionalità, anch’essi ne sono inzuppati. Ad un occhio forestiero che va alla ricerca dell’interorità, del singolo, del soggetto, essi sembrano tanti Pulcinella, oppure esemplari di un estremo cinismo: ma questa considerazione isola troppo drasticamente la persona dall’ambiente, dal mondo circostante, che l’avvolge e la protegge come un vestito», ivi, p. 162.
Maschera Bruno Roberti
239
che si passa da Pulcinella, maschera che mantiene il trasformismo continuo su un orizzonte illusionistico, ambivalente, passibile di mille travestimenti pur restando a suo modo immortale, riconoscibile come quella maschera, a Pinocchio il cui tragitto è quello di un denudamento pedagogico della bugia, del mondo in maschera, del “paese dei balocchi”, e in cui il vestitino di carta o la metamorfosi in ciuchino sono le spoglie spettrali che ne denunciano l’automatismo, i bisogni indotti, le movenze marionettistiche, continuamente minacciate dalla morte e che solo nella morte del burattino, nelle sue spoglie, trovano la soluzione e insieme l’ipostasi della formazione dell’identità italiana nel Moderno, in tutta la sua ambiguità38.
38
«Nel 1872 […] Francesco De Sanctis aveva chiesto ai suoi studenti dell’Università di Napoli di creare una composizione orale su Pulcinella. Uno dei contributi, realizzato da Giorgio Arcoleo, viene pubblicato nell’agosto del 1872 all’interno di un saggio dal titolo La scuola, su La Nuova Antologia. Secondo Arcoleo, mentre per Amleto, Faust e Prometeo la realtà è un travaglio che va affrontato con la concentrazione del pensiero e la profondità dei sentimenti, per Pulcinella la realtà non è che un balocco: le difficoltà della vita quasi non lo scalfiscono. […] Ma Pulcinella è una strana formazione di compromesso tra il vecchio e il nuovo, perché non è solo mosso meccanicamente, ma è anche uno di quei personaggi popolari che sono il prodotto di una ribellione istintiva alla ragione. Non toccati dall’arte, questi personaggi esistono in uno stato liminale tra dentro e fuori, essi sono “mezzo uomini e mezzo burattini, idoli della plebe quando vive di latte e miele, giocattoli che spezza quando si addentra nell’intimità della coscienza”. […] Metà animale, metà uomo, Pulcinella è sopravvissuto in teatro come un deus ex machina, negando la rappresentazione e regnando di persona. Una maschera copre il suo volto ma mai la sua anima. […] Crede nelle illusioni, nelle apparenze, nella resurrezione dei morti, nella magia, nel lotto e nel diavolo, ma non crede in se stesso. Pulcinella è dunque tutto, tranne se stesso», S. Stewart-Steinberg, L’effetto Pinocchio. Italia 1861-1922. La costruzione di una complessa modernità, Elliot, Roma 2011, pp. 47-48 [ed. or. The Pinocchio Effect. On Making Italians, 1860-1920, University of Chigago Press, Chicago, 2007]. Da cui si evince un trascolorare della maschera pulcinellesca in quella pinocchiesca, attraverso il dato dell’animalità e del burattinesco, con una differenza però sostanziale: Pulcinella non può morire ed è destinato a rinascere perché è già di per sé un morto, una maschera/larva che viene dal sostrato carnevalesco, e non sembra avere identità, mentre Pinocchio è destinato a morire, a dismettere le sue spoglie, ad aderire a un destino di destituzione spettrale proprio per accedere ad una identità “umana”.
240
Lessico del cinema italiano
Totò da Pulcinella a Pinocchio Negli anni trenta-quaranta il cinema comico italiano aveva anche messo in figura la maschera anonima e impersonale dell’“omino qualunque” charlottiano (Totò, Macario, il Bonaventura di Tofano), maschere che si assimilavano alle movenze burattinesche, spettrali e “pinocchiesche” ma che conservavano ancora l’incantesimo anarchico e resurrezionale di maschere della commedia dell’arte come Arlecchino, la loro doppiezza nel rapporto servo-padrone, nella relazione con l’ingresso nell’ordine ri-costituito. Da un lato l’impersonalità conforme che dopo la difformità scoronante riconferma il ruolo, dall’altro l’irriducibilità anarchica e il trasformismo magico e consapevole del trucco e della finzione. Ciò che era stato delle comiche metacinematografiche di Fregoli è riversato ad esempio nel frenetico trasformismo del Totò diretto da Bragaglia in Figaro qua, Figaro là (1950), dove non a caso il “principe della risata” veste l’abito bianco e la maschera nera di Pulcinella. Del resto fu Campanile a scrivere per Bragaglia un film come Animali pazzi (1939)39 dove Totò è simile a un “assemblaggio” fantoccesco surrealista alla Picabia40 e in cui il suo corpo snodato è più che mai un animale/ameba, un sinistro spettro pinocchiesco. Il dato rituale e arcaico, demonico-animale, della maschera di Totò ha radici profonde (lui nato in un vicolo che si chiama S. Maria Antesæcula, alla Sanità, quartiere dell’antica città dei morti napoletana, dove sorge quel Cimitero delle Fontanelle filmato dal Rossellini di Viaggio in Italia), ma d’altra parte nella sua maschera si riscontra una modernità vertiginosa, non solo e non tanto di matrice futuristica (come per Petrolini) e nemmeno melanconica-sentimentale o astratta (come nella maschera spettrale di matrice simbolista ed estetizzante), ma fondamentalmente 39
40
Esempio di film italiano il più vicino all’avanguardia surrealista e all’anarchismo di Vigo, e non a caso in parte girato a ridosso di un film che risente dell’avanguardia sovietica come Tutto il mondo ride (1934) di Aleksandrov, memore dell’“attrazionalità” e del divenire-animale dei film di Ejzenštejn. La vena folle da varietà avrà anche un esito più tardo con il Rascel “surrealista” di Pazzo d’amore (1942) di Giacomo Gentilomo. Campanile scrive anche un altro film per Bragaglia, L’amore si fa così (1939) in cui l’ossessione del trucco facciale (come del vestito inteso come mascheramento: il film si svolge in una casa di mode) induce al “delirio di sembianze” il topos dell’equivoco di identità.
Maschera Bruno Roberti
241
eversiva, consapevole del carattere feticistico e fantasmagorico della maschera moderna come “grillo della merce”, come simulacro: «È così che, naturalmente, Totò condensava l’improvvisazione con la fissità e la serialità della maschera, la meccanicità dell’automa con la fluidità dei comportamenti, tutti gli elementi della modernità insomma»41. È lo stesso Totò (discorrendo con Cesare Zavattini) a sintetizzare questa “atmosfera” della sua maschera come metamorfosi demonica, totemica, con inusitata lucidità (e con immagini che mettono insieme un fondo italico di demonismo metamorfico con le allucinazioni delle maschere nere e degli incubi espressionisti di Ka a o di Kubin): La mia non è una situazione originale, ho intuito che anche i miei simili nascostamente si trasformano con il pensiero – quante volte al giorno! – in un albero, in un gatto, in una lucertola. Io sento nelle vene le parentele più remote, per questo un illustratore mi accontenterebbe cambiandomi di colpo un braccio in un giglio, un occhio in un ranocchio, e petali di girasole per capelli. […] Qualcuno ha scritto che io sono un’ameba. Giusto, se si pensa che il fluttuare della forma sia il desiderio di essere sempre diverso. Vista l’impossibilità di identificarsi stabilmente, subentra l’ansiosa ricerca della cosa o dell’essere che più ci assomiglia. O una marionetta o un uccello. Mettete un po’ insieme queste due metamorfosi42!
Pasolini incontra il corpo-maschera marionettistico di Totò facendone risuonare la melanconia spettrale e nullificante, e insieme la natura animale. Ciò è evidente in due esempi: Che cosa sono le nuvole? (1969) e Uccellacci e uccellini (1966). Nel primo film c’è la marionetta, il baraccone, la commedia, all’improvviso ricondotte al “capriccio all’italiana” in senso metateatrale e barocco (la citazione all’inizio, come affiche cinematografica, di Las Meninas di Velázquez è indicativa), nel secondo la coppia comica, la dualità commedica (Totò e Ninetto) viene condotta verso un’assimilazione del dato naturale e animale alla commedia dell’umano, alla 41 42
M. Brinducci, Cinema-teatro-cinema: Totò-Charlot, le maschere del corpo scenico, in Totò. Parole di attore e di poeta, a cura di P. Bianchi, N. De Blasi, Dante & Descartes, Napoli 2007, p. 230. Cfr. F. Faldini, G. Fofi, Totò: l’uomo e la maschera, Feltrinelli, Milano 1977, p. 240.
242
Lessico del cinema italiano
tradizione itinerante e picaresca della “maschera in viaggio”, del buffone di strada (da Lazarillo a Don Chisciotte e Sancho Panza). Totò e Ninetto qui portano i loro nomi propri come delle maschere che aderiscono al loro corpo inscritto nella commedia dell’innocenza (del resto proprio Innocenti è l’invenzione pasoliniana del loro cognome), e la scelta di Totò si configura esattamente per Pasolini come quella di una maschera già assimilata dal cinema e dal teatro di varietà («Totò è Totò come Pulcinella è Pulcinella» diceva Fellini, regista del resto con cui Totò avrebbe amato lavorare: lo considerava un «regista comico», anzi il più adatto a «dirigere una pellicola comica d’alta classe»). Totò teneva “cara” la sua maschera come fosse un blasone: «Con questa maschera qua ho lavorato nelle farse della commedia dell’arte, nel varietà, nel cafèchantant, nella rivista, nelle operette, nella prosa dialettale e nel cinema»43. Come per Pasolini la maschera di Totò assumesse una valenza demonica e spettrale risulta da una sua definizione di Totò come «ricca statua di cera», designandolo altresì come animale. In Uccellacci e uccellini ciò risulta dallo sdoppiamento di Totò in frate Ciccillo (francescano “giullare di Dio”) che mima e quasi diventa un uccello, e nell’episodio poi espunto dal film Totò al circo, in quel domatore-pagliaccio dal nome che riecheggia una maschera cornuta, monsieur Courneau, assimilato alla bestia da domare, un’aquila in cui lui stesso si trasforma. Del resto la voce interna al film è il corvo parlante, versante autoreferenziale e ironico della maschera (come il grillo di Pinocchio). Pasolini attribuisce alla maschera di Totò una natura doppia, congiunta in un fondo primigenio, che sta tra il troppo umano e l’inumano-demonico: «Da una parte c’è il sottoproletario napoletano, e dall’altra c’è il puro e semplice clown, il burattino snodato», dove emerge qualcosa che è soprattutto «innocenza, distacco dalle cose, estrema saggezza, decrepita saggezza»44. Insomma dal fondo premoderno e animale della maschera di Totò emerge e si emancipa il senso moderno, spettrale, automatico, del burattino snodato, per cui Totò appare un punto di convergenza tra il sostrato immortale della maschera pulcinellesca e l’orizzonte moderno dell’“ameno spettro”. 43 44
R. Escobar, Totò. Avventure di una marionetta, il Mulino, Bologna 1998, p. 110. Ivi, p. 111.
Maschera Bruno Roberti
243
D’altra parte se la marionetta sta prima del discorso e della storia, se incontra il senso solo per irriderlo e gettarlo nel panico, come la si può ridurre a una valutazione morale, discorsiva e storica? Chi avrà mai l’ardire di chiamare buona o cattiva l’innocenza di un rivolgimento tellurico, per quanto aggressivo ci appaia?45
Che Totò emerga da un fondo folle e animale della maschera e si addentri verso un grottesco demonico e spettrale, si evince anche dalle sue prime apparizioni, visionarie, come in Animali pazzi e L’allegro fantasma. Il Totò di Pasolini ritorna a quel primo Totò, a una epifania della maschera che riconduce il cinema al rituale vitalistico di un piano-sequenza continuo come la vita, ma al cui termine si trova la morte che ne “rimonta” il senso46. Nella riflessione pasoliniana, il cavare il film dalla vita-cinema è lavoro della morte, e se il cinema “esprime la realtà con la realtà” è la fissazione sullo schermo delle ombre-maschere, il montaggio e la proiezione del film a ricondurre tutto nell’illusione, a svelare e rivelare sotto la maschera, dietro i fili della marionetta, la morte e il nulla, l’“ineffabile bellezza nullificante del creato”, le nuvole illusorie che velano il vuoto. Che cosa sono le nuvole?, dove i corpi comici degli attori (Franchi e Ingrassia, Totò) sono riassunti nella forma della marionetta (come in un teatrino di Mangiafuoco cavato più da Collodi, e dalle maschere della commedia dell’arte ridotte a burattini, che hanno ispirato Shakespeare) doveva far parte di un film-palinsesto che avrebbe dovuto intitolarsi bazinianamente Che cos’è il cinema. Dal Totò lunare pasoliniano emerge chiaramente la sua natura di marionetta (che sulle scene del varietà si snodava nella polimorfia di Pinocchio, ripreso in Totò a colori), incarnazione di un grottesco che «dà vita ai morti e morte ai vivi», che «ha reso finta e ina45 46
Ivi, p. 112. «Questo infinito piano-sequenza soggettivo, un doppio del nostro sguardo, termina quando termina la nostra vita. Allora, il cinema diventa film. Come la morte, mettendo fine a una vita, definisce una biografia, così il montaggio mette fine al cinema e definisce un film. Dopo questo e dopo quella, dopo il montaggio e dopo la morte, non c’è più una continuità “infinita”, non c’è più la circolarità beata della marionetta, che ancora non sia stata cavata fuori. […] Significa scegliere, tagliare, uscire dall’incanto dello sguardo infinito e innocente del piano-sequenza, esserne espulsi e gettati nella serietà del film, ormai irrimediabilmente bambini per bene», ivi, p. 114.
244
Lessico del cinema italiano
nimata la carne e animata la materia», che «fa rinascere i morti», che rende indiscernibile, e non più ricorsivo-stagionale, l’archetipo del ciclo morte-rinascita: ciò soprattutto in La terra vista dalla luna (l’esergo del film è «Essere vivi o morti è la stessa cosa») e in Che cosa sono le nuvole? (il carro del monnezzaro/Modugno è carro funebre ma anche carro carnevalesco, currus navalis): «Una maschera posta ai confini, costantemente valicati e quindi resi inassegnabili, della vita e della morte, dell’uomo e della marionetta, dell’organico e dell’inorganico, dell’animato e dell’inanimato, dell’angelo e del demone»47. Figura paradossale, in cui il paradosso consiste nel fatto che il dato ectoplasmatico di Totò, come “similnatura”, evanescenza demonica, viene da Pasolini continuamente differenziato e vanificato, la maschera riconoscibile, anche se anarchicamente proteiforme, costruita da Totò negli anni, viene decostruita, frammentata, schermata, e mentre la sagoma di Totò è quintessenziale nei film pasoliniani, allo stesso tempo è irriconoscibile, come spostata. «In sostanza il Totò di Pasolini appare diverso da quello che evidenziava ora la marionetta, ora la maschera farsesca e pulcinellesca, ora la maschera malinconica e persino tragica»48. Eppure in Pasolini Totò è tutto questo: un Pulcinella assorbito dal lato “mamo” e dolcemente triste, un povero matto, un Pierrot-clown bianco, un Augusto e un cartone animato, una marionetta pinocchiesca un po’ lugubre, ma infine anche uno spirito elementale, un monaciello, un demone faunesco. Il volto verde della marionetta-Iago costretta ad essere perfida, così come le ciocche arancioni da Sor Pampurio di Ciancicato Miao ne sono l’emblema onirico. Pulcinella e un inedito di Rossellini Esiste una sceneggiatura inedita, e sorprendente, di quello che doveva, nel 1974, diventare un film di Rossellini: Pulcinella, o le passioni, le corna e la morte, scritta con Jean Gruault. Protagonista 47 48
R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, Bulzoni, Roma 1999, p. 79. E. Bispuri, Pasolini e Totò: un incontro, un amore, in Totò. Parole di attore e di poeta, cit., p. 275.
Maschera Bruno Roberti
245
è quel Michelangelo Fracanzani, che eredita la maschera di Pulcinella dal vecchio Calcese e compie un “viaggio in Italia” al contrario (da Sud a Nord) alla volta di Parigi, partendo dalla Napoli di Masaniello e di Salvator Rosa. Il rapporto tra mondo e teatro, tra credenza e illusione viene messo in forma in modo inaspettato. Al contrario di quello che ci si potrebbe attendere da Rossellini, non è il mondo e la vita a fagocitare il teatro, ma il contrario, se: Nelle prime scene il teatro faceva parte della vita cittadina, alla fine invece […] è la vita stessa a far parte del teatro, assorbita e fagocitata dal palcoscenico […]. Così Rossellini e Gruault raccolgono puntualmente l’eredità di Renoir che, nel suo film La carrozza d’oro (1952), indicava nella commedia dell’arte una delle forme più affascinanti della relazione biunivoca e reversibile fra la vita e il teatro, fra la recitazione scenica e quella quotidiana49.
In La carrozza d’oro50 la maschera scivola continuamente nella vita. La stessa carrozza d’oro è vista come teatro: l’uscita del viceré dalla carrozza è accolta da applausi. Tutto diventa messinscena e mondo insieme, vita e finzione inscindibili. È il medesimo assunto del Pulcinella di Rossellini. Pensare la maschera in termini di immagine, per Rossellini (così come in La presa del potere da parte di Luigi XIV) significa certo mettere in questione il mondo, “tagliare” 49 50
S. Bernardi, Rossellini, Renoir e la commedia dell’arte, in “Biblioteca Teatrale”, n. 16 (1989), p. 32. La carrozza d’oro di Renoir fu un’avventura produttiva italiana. Il racconto di Mérimée su cui si basa (La carrozza del Santissimo Sacramento) avrebbe voluto girarlo Visconti. Con la Magnani nelle vesti della comica dell’arte irrompe nel film la cifra italiana, e il “dialogo” con Rossellini. L’amore conteso tra il Vicerè, il Cavaliere e il Torero è anche una sfida al potere, e si svolge, dall’inizio, sulla scena. È il teatro con le sue maschere a smascherare il potere, quando Colombina/Magnani canta di spalle al pubblico per sottolineare lo sgarbo fatto ai comici dall’occupare la scena da parte del Toreador Ramon. Il gioco del ribaltamento e dei “doppi fondi”, l’uso della profondità di campo come sfondamento e rovesciamento tra vita e teatro, l’insistenza sugli specchi e sulle cornici, il teatro nel teatro, sono motivi molto presenti anche nella sceneggiatura inedita di Rossellini. Nel presentare le maschere Renoir privilegia la maschera di Arlecchino, chiamata “anima del teatro”: l’Arlecchino flautista che appare in scena rimanda a Picasso, come a Severini, Prampolini, Depero, e il gruppo di bambini della compagnia “caprioleggia” per le strade in veste di Arlecchino.
246
Lessico del cinema italiano
la Storia secondo una rivelazione dei meccanismi di mascheratura del potere, ma significa soprattutto assimilare la teatralità e la maschera a una verità della mise-en-scène, cioè a uno “splendore e miseria” del cinema che permette, proprio attraverso la presa diretta e la presa di coscienza dell’illusione, di redimere il reale, riscattandolo in una reinvenzione che ne muove le potenze (anche le potenze del sogno). L’esergo della sceneggiatura sulla maschera di Pulcinella recita (con una citazione da Novalis): Le monde se fait rêve et le rêve se fait monde. È la reversibilità tra mondo e scena, tra mondo e illusione, infine tra mondo e cinema che interessa Rossellini, e non (come per Fellini) per risucchiare il mondo dentro il suo sogno, ma per sprigionare e metabolizzare il sogno, il cinema, la messinscena nel fuori, e mostrare come anche quando la vita irrompe (e viene fagocitata) nel/dal teatro (e dal cinema), noi assistiamo a un movimento di redenzione. Il “viaggio iniziatico” di Michelangelo Fracanzani per trasportare la maschera di Pulcinella da Napoli a Parigi, si configura nel progetto di film come un romanzesco viaggio di formazione, un apprendistato al mistero (della vita e della verità), e questo mistero risiede paradossalmente nella maschera, un oggetto “magico” che (come la macchina da presa) si fa “macchina della verità” e dunque oltrepassa la funzione, barocca, di dissimulazione, rovesciandola. Nella prima parte del film, quella in cui, baroccamente, il teatro è nel mondo e del mondo, i cadaveri impiccati e scorticati servono a Salvator Rosa (zio di Fracanzani) per ritrarre un San Sebastiano; la vita e la morte sono un modello per la pittura e il teatro. Nella baracchetta del teatrino sul molo, la rivolta di Masaniello viene “doppiata” dalla baruffa di Matamoro, Tartaglia e Pulcinella; il corteo di maschere attraversa la spiaggia napoletana, di fronte al mare e alla natura, per dare sepoltura al Maestro Ciuccio-Andrea Calcese detentore della maschera di Pulcinella travolto dalla folla nei tafferugli e caduto in mare: e infine la maschera passerà nelle mani di Michelangelo, «perché possa fare il vero Pulcinella» cioè dire sempre la verità, come recita la battuta di Salvator Rosa. Nel progetto di film ritorna ciò che già Blasetti negli anni quaranta e Franciolini negli anni cinquanta (e se non fosse stato censurato per ordine di Mussolini stesso anche il Camerini anni trenta di Il cappello a tre punte) avevano agito filmicamente a proposito della maschera e del travestimento come “rivelatore” di verità, come
Maschera Bruno Roberti
247
oggetto metafilmico che mette in evidenza e scardina le impalcature del potere attraverso un primato della finzione resa specchio obliquo, lente deformante e demistificante rispetto ai simulacri del potere51. Ma l’analogia col progetto rosselliniano di quei film sfuma nella seconda parte della sceneggiatura, quando il mondo è nel teatro, e irrompe con tutta la sua forza esperienziale un momento lancinante dove la verità non viene più svelata e ri-velata dal teatro ma è il teatro stesso che diventa verità, facendosi mondo. Il viaggio della maschera, come gli esiti a Parigi, prima espandono e poi rovesciano ciò che nella prima parte, in accordo con l’inserimento del teatro nel mondo come smascheramento, è un gioco ambiguo di contaminazione teatrale (teatralizzazione del mondo versus mondanizzazione del teatro). Il mondo del viaggio teatrale di Fracanzani espande dunque la simulazione teatrale nel mondo, illumina ciò che di illusorio c’è nella vita. «La vita è forse un’illusione… la sola realtà» è la prima rivelazione che Pulcinella-Fracanzani mormora a se stesso e a Caterina, la donna di cui si è innamorato (e che si mascherava dietro il travestimento da ragazzo), nella scena che Rossellini voleva girare dentro la bocca del mascherone al Parco dei Mostri di Bomarzo. Nella scena 105 il finale del film vede un piccolo palcoscenico all’aperto e un pubblico di contadini, la sceneggiatura rappresenta carnevalescamente il Paese di Cuccagna… di chi cucca, cagna…, e non più i “mondi possibili”, quanto quelli fantastici che rovesciano il mondo nel teatro. Qui la morte di Pulcinella avviene tramite la maschera come dispositivo sonoro, come dice Michelangelo/Pulcinella: «Dicevo che è il paese di chi…». La didascalia della sceneggiatura recita: Il “chi” è pronunciato così acuto che Michelangelo ingoia la pivetta cioè quella specie di lastrina di metallo che aderendo al palato rende la voce acuta come quella di un “pulcino”. Michelangelo si sente soffocare. Fa seriamente il gesto per indicare che l’ha ingoiata. I suoi 51
Sia in Un’avventura di Salvator Rosa, che in Ferdinando I° re di Napoli, la maschera di Coviello/Cervi o di Pulcinella/Eduardo funziona da detonatore di rivolta e nello stesso tempo da filtro di verità, paradossale “vetro” o “velario”, palco o finestra, piazza o strada o balcone, attraverso cui la maschera del reale riesce a dire la verità e a smascherare, decostruire il potere di contraffazione.
248
Lessico del cinema italiano
compagni, come il pubblico, credono che sia una nuova trovata comica. Gli attori, abituati all’improvvisazione gli si affollano intorno e lo spingono di qua e di là, fingendo di curarlo. Gli mollano degli schiaffoni, dei calci nel sedere, delle bastonate in testa, ecc. Il pubblico ride fino alle lacrime vedendo i contorcimenti di Pulcinella che tenta di risputare la Pivetta. Improvvisamente Michelangelo crolla a terra, è inerte, è come uno straccio nelle mani dei comici che continuano la commedia52.
È Caterina ad annunciare alla ribalta che «Pulcinella è morto», accarezzando dietro le quinte con tenerezza il viso mascherato di Michelangelo senza vita, per poi toglierli la maschera e darla al piccolo Lello, il bambino avuto da Fracanzani, che gli ridarà vita: «Tieni… Ecco la sua eredità… La Verità». Il colpo di genio rosselliniano è così quello di conferire alla maschera stessa l’epitome della verità53. Eppure, al di fuori di ogni ambiguità, in tal modo Rossellini opera una coalescenza tra credenza e illusione in nome di un primato della verità del mondo, nel progetto di un film scritto in modo così vivido da lasciarne trasparire tutta l’icasticità delle immagini e la pregnanza ritmica dei fatti. Da Pinocchio a Carmelo Bene È una qualità “meccanica” che differenzia Pinocchio come maschera moderna rispetto alla natura animale e corporea delle maschere tradizionali. «Nel 1923 Giuseppe Prezzolini dichiarava che se si fosse compresa la bellezza di Pinocchio, si sarebbe compresa l’Italia. […] Pinocchio è dunque un luogo in cui la crisi del soggetto liberale viene a essere mediata e in cui i contorni di quello che ho
52 53
R. Rossellini, J. Gruault, Pulcinella o le passioni, le corna e la morte, in “Filmcritica”, n. 374-375 (1987), p. 375. La verità sta nella realtà, come aveva precedentemente affermato Caterina, oppure sta nella maschera, come afferma ora, alla fine, dopo che Michelangelo è morto? Questa ambiguità finale definisce la sostanza dell’attore e forse anche tutta la concezione del reale nella fenomenologia rosselliniana, secondo cui la verità si manifesta nel suo stare nascosta», S. Bernardi, Rossellini, Renoir e la commedia dell’arte, cit., p. 38.
Maschera Bruno Roberti
249
definito soggetto post-liberale trovano forma espressiva»54. Quando Pinocchio incontra le maschere della commedia dell’arte nel teatrino di Mangiafuoco, queste lo accolgono al grido di fratello («È Pinocchio! È il nostro fratello Pinocchio!») e il dispositivo del teatro di marionette in questione è stato letto (sulla scorta del freudiano Totem e tabù), come metafora di una società di fratelli che si contrappongono al Padre nella dimensione primitiva dell’orda, chiamando in causa quello Yorick (l’avvocato Ferrigni) amico di Collodi55. Ma quando i fili vengono spezzati, quando, come succede nella società italiana a più riprese, il Padre viene messo a morte si instaura una “società di fratelli”, che spezza il giogo, salvo a impancarsi (come per Cola di Rienzo, Masaniello e Mussolini) a “padri fantoccio” a loro volta. In tal senso lo spirito italiano sembrerebbe assimilato a una matrilinearità, al complesso della Grande Madre, che tutti accoglie come una “Lupa/Prostituta”. Come scrive Ernst Bernhard56, grande psicoanalista junghiano, che ha studiato in profondità l’inconscio collettivo italiano: Si tratta qui di un problema di Ombra […]. L’Ombra italiana dà subito nell’occhio al “rappresentante della civiltà occidentale”. Dal suo punto di vista l’“italiano” è un uomo del quale non ci si può fidare, senza principi, ipersessuale, incontrollato, vanesio, viziato, sentimentale. [...] La chiave che permette di schiudere l’enigma dell’anima italiana è la constatazione che in Italia regna la Grande Madre mediterranea, la quale […] non ha perduto nei millenni né di potenza né di influenza. Come un simbolo vivo cela sempre in sé un intero mito, 54 55
56
S. Stewart-Steinberg, L’effetto Pinocchio, cit., pp. 37-39. «Fino al Rinascimento, i burattini, la cui nascita Yorick fa risalire alla creazione degli idoli religiosi, erano sempre stati saldamente legati alla chiesa cattolica. Le marionette, afferma Yorick, derivano etimologicamente dalle mariettes, cioè le statuine che rappresentavano Maria. I burattini recitavano, anzi rappresentavano, il messaggio della Chiesa sotto forma di drammi misterici; emulando le sofferenze terrene si legavano, alla morte di Cristo sulla croce lignea. Il burattinaio è un dio e ha un rapporto di filiazione con i suoi figli burattini, che quotidianamente mettono in scena per il padre la loro morte e resurrezione. Anche i burattini sono attaccati alle loro croci e i fili sono inchiodati ai loro corpi, a rappresentare le stigmate», ivi, p. 43. Analista di uomini di cinema come Fellini o De Seta, di scrittori come Manganelli, di uomini centrali per la cultura politica ed economica italiana come Adriano Olivetti.
250
Lessico del cinema italiano
così la Grande Madre rappresenta un’ampia rete di relazioni di cui la madre è protagonista. La grande Madre non è però vincolata alla figura di una madre concreta, essa agisce endopsichicamente […]. Questa attitudine “materna” pervade ogni aspetto della vita italiana […] essa è sostanzialmente sistematica, aliena da ogni generalizzazione, contro legge e regola, “anarchica” si potrebbe dire57.
Si tratta della formazione endopsichica di un’Ombra del carattere italiano che modella le persone sotto l’archetipo impersonale e indifferenziato del materno e produce una società debole in cui i padri vengono scoronati. Di ciò Pinocchio sarebbe l’epitome con il suo divenire-animale, il suo non-nascere, il suo meccanismo e la sua metamorficità, il suo ipercinetismo e la sua stasi, la sua emotività e la sua atarassia, il suo staccarsi come ombra dall’abito e dalla carne del bambino cui accede solo a patto di una sua destituzionecostituzione paradossale di corpo ligneo: «All’ombra di tale atteggiamento prosperano naturalmente anche corruzione e inganno di ogni genere. Ma dietro a questo si nasconde un grande cuore umano, spesso fin troppo umano, che getta su tutte queste deficienze una luce che le attenua»58. La “fuga” del burattino, il suo dinamismo cinetico, è una disseminazione di maschere “scollate” dall’ombra, le quali: Pare che, come Pinocchio, fuggano nelle piazze e per le strade italiane e si mescolino pian piano alla tradizione della commedia dell’arte, sulla quale avranno infine il sopravvento. Yorick è certo che questi siano gli anni d’oro dei burattini italiani (e anche della mascolinità italiana); gli anni del loro massimo fulgore grazie alla riforma goldoniana del teatro, anni in cui tengono vive la cultura popolare e la satira sociale. È qui che essi acquisiscono, al di là delle differenze regionali, un carattere di soggetti nazionali59.
Per Yorick è l’“ombra” del Padreterno che esce di scena, e cioè il diavolo, il lato demonico della maschera a guadagnare la ribalta. E in tal caso il “diavolo” sarebbe una macchinazione, una instaurazione della civiltà moderna delle macchine rispetto a cui l’Italia 57 58 59
E. Bernhard, Mitobiografia, Adelphi, Milano 1977, pp. 168-170. Ivi, p. 170. S. Stewart-Steinberg, L’effetto Pinocchio, cit., p. 43.
Maschera Bruno Roberti
251
(vedi il futurismo) assume un atteggiamento obliquo, di convergenza e fuga insieme, industrializzazione imperfetta, di cui il cinema italiano come transito continuo tra artigianato e industria, autorialità e genere, potrebbe essere un indicatore. Dalla “danza” libera dei corpi si passerebbe a un burattino-automa. Allora se nel teatro di Mangiafuoco è il napoletano Pulcinella a perorare la causa di sopravvivenza del “fratello di legno” Pinocchio, la dicotomia tra le due maschere si situa nel segno del transito paradossale tra impassibilità della carne e passione del legno, tra personificazione metamorfica e depersonalizzazione momentanea, da cui risulta una analogia oppositiva: Due personaggi archetipici, dei quali l’uno sembra sotto certi aspetti l’analogo corrispettivo dell’altro secondo un livello contiguoascendente: Pinocchio nel regno vegetale e Pulcinella nel regno animale. […] Pulcinella, carnalità istintiva che si fa legno marionettesco; Pinocchio, marionetta di legno che si fa carne. Nella compresenza di tali caratteri, preponderante sulla diversità, ambedue sono maschere60.
È indicativo come contemporaneamente alla pubblicazione di Pinocchio sul “Giornale dei bambini”, si pubblichi un Governo e governati in Italia frutto della penna del napoletano Pasquale Turiello, il quale, come ci ricorda la Stewart-Steinberg Scopre un carattere nazionale, la cui incarnazione più pura è rappresentata dal napoletano. Ciò che definisce l’italiano […] è il suo individualismo, il suo rifiuto a sottomettersi a una definizione collettiva perché questa vorrebbe dire accettare delle limitazioni e una disciplina imposte dall’esterno. […] L’“io” italiano è troppo prominente, troppo eccessivo; e questo comporta una diffidenza, non solo nell’ambito della sfera sociale e civile, ma anche verso il sé. La parola chiave che secondo Turiello descrive il carattere nazionale italiano è scioltezza: una mollezza o rilassatezza del corpo e della mente. La scioltezza è contemporaneamente un eccesso e una mancanza di affezione o immaginazione che denota un sovrasviluppo dell’individualismo e la sua assenza. Questo paradosso conduce a uno stato di 60
M.T. Gentile, L’albero di Pinocchio. I precedenti culturali de “Le avventure”, Studium, Roma 1982, p. 106.
252
Lessico del cinema italiano
perenne guerra civile, non solo tra individui ma anche all’interno degli individui stessi […], da cui derivano il rifiuto di ogni limite sociale e il culto del potere61.
È la maschera grottesca, paradossale, anfibia, dell’italiano, dove un ego ipertrofico sfocia nell’identificazione con la maschera, e fa coincidere credenza e illusione, scetticismo e superstizione, come riassume il geniale titolo di una commedia di Peppino De Filippo Non è vero... ma ci credo (1952), dove di pulcinellesca gobba portafortuna si tratta. La maschera di Peppino al cinema (anche come altra faccia dis-adattata dell’anarchico Totò) è emblematica di tale carattere napoletano-italiano62. Quella scioltezza è il segno allora di una maschera disciolta che indoviniamo anche in Roberto Benigni: nella sua anfibia motilità, nell’impersonalità diavolesca che trascorre di corpo in corpo in Il piccolo diavolo (1988), nello scambio di persona di Il mostro (1994) e Johnny Stecchino (1991), che connette un solo corpo e una sola maschera in uno sdoppiamento, nei versi carnevaleschi e rabelaisiani della sua canzone L’inno del corpo sciolto, e infine nella sua pervicace assimilazione del corpo burattinesco in Pinocchio (2002). Questo “corpo elastico” dell’italiano, questa scioltezza di legami sociali che tendono a slegare e insieme a solidarizzare al di là del vincolo sociale, farebbe derivare una serie di controspinte in transito tra naturalità e meccanicità, di cui il cinema potrebbe essere esempio, generando un «effetto Pinocchio», per usare la dizione della Stewart-Steinberg: dispositivo celibe, schizoide, «macchina influenzante» come l’apparato inventato da un allievo di Freud, Viktor Tausk, all’inizio del Novecento.
61 62
S. Stewart-Steinberg, L’effetto Pinocchio, cit., p. 49. Peppino firma nel 1952 l’unico suo film da regista, insieme a Sergio Grieco, proprio da quella commedia, in cui emerge tutta la doppiezza italiana, e non a caso crea per la Tv la maschera insubordinata e servile a un tempo di Pappagone; così come firma il soggetto nel 1950 del film di Soldati Quel bandito sono io, dove un feroce bandito è identico a un mite cassiere di banca, o ancora interpreta per Fellini l’impagabile Antonio Mazzuolo in Le tentazioni del dottor Antonio, episodio di Boccaccio ’70 (1962), che da grottesco moralista, pieno di tic facciali che ne deformano in maschera il viso, si muta in dionisiaco paredro di una grande Madre pettoruta, l’“Anitona” discesa da un cartellone pubblicitario.
Maschera Bruno Roberti
253
La natura inorganica, l’impersonalità, l’automatismo di Pinocchio, li si ritrovano in quel «circuito barocco» (Grande) che è l’opera di Carmelo Bene, nella sua ricorrente fascinazione per il burattino. Bene dice che per lui «Pinocchio diventa un micromega universo, dove il pianeta Terra non ne esce poi tanto bene illuminato… l’ho dedicato all’infanzia e a coloro che si rifiutano di crescere» e la sua Fata Bambina ammonisce: «Ma tu non puoi crescere perché i burattini non crescono mai». La frase della Fata è ripresa in una sequenza di Don Giovanni (dove si seduce una bambina)63, che contiene le immagini di un teatrino di burattini64. «È la gioia di una reversibilità ancora possibile nell’infanzia, gioia dell’artificiale, della marionetta, della crisalide, della Puppe, ben evidenziata nel Don Giovanni da quel minuscolo Pinocchio dal naso lungo, accovacciato immobile tra fili, quei fili che cingeranno lo stesso C.B.»65. Per Pinocchio si tratta di un deleuziano divenire animale66. Sono le protuberanze grottesche a crescere o diminuire, allungarsi o accorciarsi, come nei sogni: «Il sipario dello Spettacolo della provvidenza si apre comunque su uno scenario onirico […] dove burattini e maschere animate si stagliano in una luce sospesa, come all’ingresso d’un sogno infantile che manchi poco a trasformarsi in incubo»67. In Bene, Pinocchio fatto uomo sussurra: 63 64
65 66
67
La bambina del racconto di Barbey D’Aurevilly, Il più bell’amore di Don Giovanni, cui rimanda il film, crede di essere stata ingravidata dallo sguardo di Don Giovanni. «Don Giovanni non fa che porre domande, reiterando i travestimenti successivi nel teatrino domestico e negli occhi della bambina che si rifiuta di guardare: è il demonio, è il Cristo delle processioni di paese o dell’âge d’or, è San Sebastiano e Don Chisciotte, è maschera e burattino. Aiutatemi a crescere” invoca Don Giovanni-Pinocchio», A. Aprà, Carmelo Bene oltre lo schermo, in AA.VV., Per Carmelo Bene, Linea d’Ombra, Milano 1995, pp. 156-157. R. Censi, Anamorfosi. Don Giovanni, in “Cineforum”, n. 437 (2004), p. 40. «Non si tratta più di seguire e inseguire il corpo quotidiano, ma di farlo passare attraverso una cerimonia, di introdurlo in una gabbia di vetro o di cristallo, di imporgli un carnevale, una mascherata che ne fa un corpo grottesco, ma ne estrae anche un corpo grazioso o glorioso, per giungere infine alla scomparsa del corpo visibile», G. Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, Milano 1989, pp. 111-112 [ed or. L’image-temps, Les Éditions de Minuit, Paris 1985]. A. Cappabianca, Carmelo Bene. Il cinema oltre se stesso, Pellegrini, Cosenza 2012, p. 33.
254
Lessico del cinema italiano
«Addio mascherine!» in voce off. La macchina attoriale, le sonorità di legno della scena come maschera vocale, l’ombra grottesca del gesto, il suo svanire nell’eco vocale, la postura di “sparizione”, si fanno punto di equilibrio precario della marionetta divina (di cui scrive Kleist), sulla soglia del “nulla”. In Bene la maschera si fa medium dell’uscire di scena, dello spogliarsi nell’atto del travestirsi. È la piega del barocco per Deleuze, la forma delle “vanitas”. Bene abbozzò per il cinema un Pinocchio ambientato ai nostri giorni, e molto liberamente adattato, in cui si può immaginare una disseminazione dell’identità del burattino, nella frantumazione del montaggio subliminale, in frammenti di pellicola come frammenti di specchio-identità, tipica di Bene, ma con l’apporto di «maschere cinematografiche», a cominciare da Totò68. In Bene c’è un lavoro sul volto “calcinato”, spellato, in cui il trucco e la maschera assumono i connotati barocchi di una deformazione sulla stessa pelle del viso («il trucco è meditazione, il trucco è interno»). Concezione moderna del maquillage che dal barocco si trasferisce al dandysmo di Baudelaire. Il clown, l’automa divengono nel moderno segni sublimati, accedendo a una sorta di divina trascendenza della maschera, che però sconfina in una spettralità. Un’estasi cosmetica conduce Bene a rovesciare gli occhi (occhi senza volto e volto senza occhi), a “spellare” il volto e magliare-smagliare l’“abito-pellicola”: «È una questione di ingrandimento cutaneo (e ottico-visivo): quello attuato sulla pellicola, con il trattamento subito dall’emulsione e dal fotogramma; ma anche quello dei volti, devastati, in cui l’eccesso di trucco pare abbia infine accelerato, per reazione chimica, la distruzione del tessuto stesso, lasciandolo in preda di bolle pestilenziali»69. Una deleuziana «logica della sensazione» pervade il lavoro di Bene sui primissimi piani e sulle colature di luce-colore che li defi68
69
«Sipario pubblica nel n. 244-245 agosto-settembre 1966, con una presentazione di Corrado Augias e un’introduzione di Bene […] Con Pinocchio sullo schermo (e fuori): tre blocchi di scene (scena 16, scene 25-28, scena 37) di Pinocchio dappertutto, film sceneggiato da Bene col poeta e regista cinematografico Nelo Risi, fratello di Dino, che doveva essere diretto da Risi e prodotto da Franco Cancellieri […] con un cast d’eccezione: Bene come Pinocchio, Totò come Geppetto, Giancarlo Cobelli come l’omino di burro e Brigitte Bardot o Virna Lisi o Claudia Cardinale come la fatina dai capelli turchini», A. Aprà, Carmelo Bene oltre lo schermo, cit., pp. 124-125. R. Censi, Anamorfosi. Don Giovanni, cit., pp. 39-40.
Maschera Bruno Roberti
255
gurano. Un uso del colore come alterazione e annullamento, come velatura: «Il termine latino color è correlato a celare, nascondere, in inglese medio to colour è abbellire o ornare, mascherare, rendere specioso o plausibile, travisare»70. Si tratta di un processo anamorfico, che ancora una volta parte dalla dissimulazione barocca. E forse nell’intitolare «spettacolo della provvidenza» il suo Pinocchio, Bene ha presente uno scrittore secentesco come J.B. Bossuet che scrive in Sulla Provvidenza (1662) a proposito dell’effetto anamorfico come conversione dello sguardo da un disordine a un ordine solo che lo si guardi di sbieco. Il carnevalesco felliniano (e quello pasoliniano) Non è un caso se nel cinema italiano si può incontrare la figura di Pinocchio fin dal muto (il Pinocchio di Antamoro, 1911) e, attraverso la quasi identificazione con il burattino da parte di Totò (come in Totò a colori), si giunge all’ossessione pinocchiesca del cinema di Fellini, forse fin dal pupazzo umanizzato di Gelsomina, che trova esito nel Pinocchio/Leopardi cui rimanda il matto lunare in La voce della luna (1990), quel Benigni che da parte sua realizzerà poi il Pinocchio vagheggiato dal maestro riminese. La condizione pinocchiesca di “mai nato”, e insieme quella spettrale di “non morto”, viene figurata, sul versante automatico/fantasmatico, in Il Casanova di Federico Fellini (1976), da una maschera che dal Carnevale iniziale a poco a poco si trasforma in automa. Un sinistro Pinocchio che si rifiuta di diventare bambino per bene. […] Un balletto meccanico, frenetico da museo delle cere elettrificato […]. Mi sono disperatamente aggrappato a questa “vertigine del vuoto” come al solo punto di riferimento per poter raccontare Casanova […]. Questo occhio di vetro che erra sulla realtà e si lascia sorpassare e annullare da essa, senza intervenire con un giudizio, senza interpretarla con un sentimento, mi è parso emblematico dell’inerzia drammatica ed esuberante con la quale oggi ci si lascia vivere71.
70 71
D. Batchelor, Cromofobia. Storia della paura del colore, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 58 [ed. or. Chromophobia, Reaktion Books, London 2000]. F. Fellini, Fare un film, Einaudi, Torino 1980, pp. 174-176, passim.
256
Lessico del cinema italiano
Questo movimento doppio, di rif lesso acquatico che rovescia ogni cosa e instaura contemporaneamente due poli opposti, percorre tutta la figuratività del film, identificando a poco a poco Casanova con il proprio doppio sinistro, automatico, meccanico: un manichino lugubre e una maschera funebre. La testa medusèa, il mascherone/polena della sequenza iniziale (girata al termine del piano di lavorazione di Fellini) era realizzata dai maestri artigiani dei carri carnevaleschi di Viareggio e sulla piazza si apriva il boccascena di un teatrino di saltimbanchi, e allineati sul ponte di Rialto c’erano un centinaio di manichini con i volti coperti da maschere e ombrellini cinesi, così come si accalcavano i figuranti con bautte e campanacci, candelotti e lanterne, l’atmosfera risultava sinistra e inquietante, burattinesca, da “balletto meccanico” (sei maschere erano chiamate sul set da Fellini gli «uomini lunghi» come fossero spauracchi fantasmatici). Il Carnevale notturno dell’inizio è tutto un affacciarsi di maschere che guardano verso l’obiettivo, ammiccando, come affacciandosi all’inquadratura. Casanova è vestito da Pierrot. Il segno vuoto della maschera dissolvente torna alla fine del film: gli occhi vuoti del mascherone-polena, ipnotizzanti, trapelano sotto il ghiaccio. La scena iniziale del film è indicativa di un’identità che copre l’angoscia di morte, la dissimula. La maschera-polena dell’inizio prefigura anche l’altra grande scena carnevalesca del film: quella del circo di Londra, dove l’apparizione della gigantessa è assimilata alla grande bocca della balena annunciata dai saltimbanchi come «Grande Mouna», origine e fine di tutto, utero materno e nullificante. L’automa-burattino trova la sua vera unio mystica, le sue vere “nozze alchemiche” nell’incontro con la bambola meccanica, rif lesso femminile dell’anima impersonale di Casanova. Tutto è già qui presente: il rito mortuario e sinistro del carnevale e quello nuziale e di nascita dal fondo marino, il “grande feticcio” del femminile nella testa della polena (come fosse una sirena gigantesca e coronata senza coda), volto medusèo dagli occhi iridescenti e vuoti e insieme grande pupazzo, idolo feticistico che contiene in sé già la fissità dello sguardo della bambola meccanica. Nel film tutto sembra sinistramente meccanizzato, un avvaloramento di meccanismo autoscopico e autoerotico. Indicativa in tal senso la scena dell’orgia nell’osteria, con
Maschera Bruno Roberti
257
la compagnia dei comici dell’arte, dunque con delle maschere, che dall’opera buffa tralignano in maschere sinistre, su un letto semovente e stantuffante che le riproietta in una pandemonìa tutta biomeccanica e fantoccesca, così come una ossessione dei meccanismi, in quanto dispositivi scenici, costella il film. Gli automatismi spettrali sembrano sfaldarsi, polverizzarsi nel “nome improprio” che diviene Casanova, in quanto macchina celibe e protesi erotica (tali sono i suoi vestiti, la palandrana, il mantello, il cappello, così come la valigetta con l’uccello meccanico): «Il protagonista, le sue donne, i cortigiani, le comparse sono maschere, automi, né più né meno dell’uccello e della bambola meccanici. Come se tutto il film fosse nient’altro che un prolungamento del carnevale della sequenza iniziale»72. Casanova-Pinocchio, come maschera del moderno ritrova ciononostante i caratteri larvali (e magico-demoniaci) della maschera rituale che sta alla base della commedia dell’arte, ma, attraverso una piega barocca che ne converte il valore, li nullifica. Rovesciando Pinocchio, il Casanova felliniano da uomo si trasforma in burattino, un fantoccio spettrale e funebre. Il film si chiude su un primissimo piano degli occhi vuoti e acquosi di Casanova che fissano il vuoto. Fellini stesso parla di «occhio vitreo» e di «vertigine del vuoto». «Nella sceneggiatura originale, guardando lungamente il vuoto davanti a sé, il veneziano borbottava: “Io sono fiero poiché non sono nulla”»73. È a partire da questo film che si può rileggere tutto il cinema di Fellini come una sorta di vanitas barocca, di meditazione sul sembiante che mentre “vela” la morte di fatto la riconduce a un tempo ciclico, a un carosello/ritornello circolare. Si tratta sempre per Fellini di inventare un mondo, sotto il segno di una teatralità carnevalesca. I tratti dell’eccedenza caratteristici del grottesco, le protuberanze e le deformazioni del reale estraggono una ipotesi di Reale, cioè una parvenza di fede o credenza che scaturisce dalla stessa illusione, come dalla carcassa puzzolente dell’orca sulla spiaggia di La dolce vita, nell’alba livida che succede al “carnevale orgiastico”, come nell’analogo “car72 73
G. Consoli, Federico Fellini, Giacomo Casanova e Pinocchio, in “L’illuminista”, n. 10-11 (2004), p. 355. Cfr. ivi, p. 350.
258
Lessico del cinema italiano
nevale triste” di I vitelloni (1953), quando il mattino brumoso sorprende Sordi abbracciato al proprio mascherone. Si può riscontrare come il carnevalesco si accompagni a un movimento di “rituale perduto” tanto in Fellini–Satyricon (1969), quanto in due film di Pasolini, Medea e Porcile, girati nello stesso periodo di quello, tra 1969 e 1970. Nel film petroniano di Fellini, ciò si legge in particolare nel nesso morte-rinascita che pervade il film a partire dalla sequenza centrale di Trimalcione. La Cena Trimalchionis in Petronio è segno di baldoria carnevalesca, e il suo testamento somiglia a quello di un Re-Carnevale, laddove perfino il suo progettato Sepolcro assume le sembianze di un «mitico campo Elisio o restaurato regno di Saturno, di cui il Paese di Bengodi o di Cuccagna sarà la versione per il medioevo»74. In Fellini l’arredo funebre si accompagna a un allucinante carnevale che assumerà connotazioni rituali, di kòmos sacrificale, nella chiusa del film con l’altro testamento, quello di Eumolpo, che non a caso è doppio. Dopo la cena di Trimalcione (dove scoppia una diatriba tra il liberto arricchito e il poeta a proposito di un significativo verso rubato a Lucrezio: «Ma appena la commedia è finita scompare il volto finto, ritorna quello vero») Eumolpo lascia ad Encolpio il mondo, la natura che sempre ritorna dopo la “sospensione” carnevalesca: Ti lascio la poesia, ti lascio le stagioni, soprattutto la primavera e l’estate, ti lascio il vento, il sole, ti lascio il mare, il mare che è buono, e anche la terra è buona… le montagne, i torrenti, i fiumi, e le grandi nuvole che passano, solenni e leggere. Tu le guarderai, e forse ricorderai questa nostra breve amicizia.
In una scena che ricorda, nell’epifania della natura congiunta al sogno e all’illusione, la scena finale dei burattini che guardano il cielo e le nuvole come la prima alba del mondo, dopo lo sparagmòs carnevalesco, in Che cosa sono le nuvole? di Pasolini. Nel finale sulla spiaggia (perfetta chiusa commedica che suggella lo scacco dei senex e il primato primaverile dei puer), mentre i giovani salpano per altri lidi, invece il testamento di Eumolpo recita: «Tutti coloro per cui ci sono dei legati nel mio testamento, ad eccezione 74
G.B. Bronzini, La dimensione carnevalesca del Satyricon, in “Studi e materiali di storia delle religioni”, vol. 62 (2007), p. 66.
Maschera Bruno Roberti
259
dei liberti, potranno entrare in possesso di quello che ho lasciato, a patto che facciano a pezzi il mio corpo, e alla presenza di tutti, lo mangeranno [...] divorino il mio corpo con lo stesso ardore con cui avranno mandato all’inferno la mia anima», il che sembra una prefigurazione/caricatura dell’eucarestia che, sulla base del rovesciamento sacrificale, fonderà la nuova religione, ma in questo caso le anime, irredente, saranno, paganamente, al di qua della dannazione come della salvazione75. Nei due film di Pasolini girati uno dopo l’altro, Medea e Porcile, si ritrova una analoga meditazione carnevalesca e coscienza infelice di un moderno pervaso dalla decadenza cattolica. Le letture pasoliniane di quel periodo sono testi di antropologia religiosa (Eliade, Lévy-Bruhl, De Martino, Frazer) e in Medea si tratta precisamente del passaggio da un “vecchio mondo religioso” a un “nuovo mondo laico”. È il sacrificio umano di un giovane (in cui è riconoscibile Attis) circondato e messo in croce da un nugolo di maschere tribali, connesso con la rinascita primaverile, che costituisce una delle prime lunghe sequenze mute del film, è Medea ad ucciderlo con una lama rituale, mentre il corpo del ragazzo viene smembrato e sparso nei campi, nel rituale di fecondazione della Madre Terra: «Vi si accennerà a un’orgia, a una danza in cui ai vivi si mescolano promiscuamente i morti, i morti sono uomini mascherati, e infine a una detronizzazione dei Regnanti, che vengono ritualmente maltrattati e scherniti»76. È la morte, e la derisione, del Re Carnevale, filmata sulla scorta, quasi letterale, della descrizione del sacrificio vittimale in Ecuador e nel Bengala, e tra gli indiani Pauni, da parte di James Frazer77. In Porcile le due storie che si intersecano sono accomunate dal rituale cannibalesco e sacrifi75
76 77
«L’atto di tagliare a pezzi il cadavere per usarne a fini propiziatori e fecondativi si inscrive nei sacrifici animali e umani dei culti della divinità della terra (Dioniso, Demetra, Attis e Adone) e si riscontra sia nelle religioni delle culture primitive in connessione con l’uccisione orgiastica dei maiali all’inizio del nuovo ciclo annuale, sia nelle grandi religioni con funzione simbolica per il passaggio ritualizzato dalla morte alla rinascita: la comunione cristiana come ripetizione mitica dell’offerta fatta da Cristo del suo corpo e del suo sangue nell’ultima Cena ne è l’esempio più sublime», ivi, p. 68. P.P. Pasolini, Medea, Garzanti, Milano 1970, p. 34. G. Zigaina, Pasolini e l’abiura. Il segno vivente e il poeta morto, Marsilio, Venezia 1993, pp. 98 sgg.
260
Lessico del cinema italiano
cale: da un lato il giovane nel deserto che uccide e divora i soldati ed è a sua volta condannato a diventare cibo per animali, dall’altro il rampollo dell’industriale tedesco che fa l’amore con i maiali e si fa divorare da loro. Il nume della vegetazione, lo “spirito del grano” evocato in forma carnevalesco-rituale nel primo film, viene nel secondo illuminato di una luce apocalittica, in cui il tramonto della civiltà cristiana-occidentale viene sentito da Pasolini in relazione a un ritorno alla primitiva civiltà contadina, vista anche come ritorno all’innocenza sacrificale della passione cristica, al di là del tragico e immersa invece in un carnevalesco di tipo grottesco (la presenza di attori come Tognazzi, Lionello e Ferreri va in questo senso), commedico (l’insistere sul riso, sul gioco, sul trallalà, da parte del rampollo destinato a farsi mangiare dai maiali). Per le società antiche il maiale era l’incarnazione vittimale, e insieme il carnefice, dello “spirito del grano”, e Attis/Adone, che apparirà in Medea come ragazzo sacrificato e smembrato, viene nel mito sbranato da un maiale. Ora, la raccomandazione a fare a pezzi il proprio corpo è scritta in un testamento carnevalesco che conosce una trasmissione orale e scritta dal IV secolo d.C. all’alto medioevo: il Testamentum porcelli, tematizzando la categoria del carnevalesco nei termini che si riscontrano già in Petronio. Si tratta sia nel caso di Fellini che in quello di Pasolini di una restituzione obliqua del carnevalesco, nel segno o di una sua trascrizione straniata e onirica in un tempo tanto ancestrale quanto “futuribile” (Fellini) o di un suo “impossibile” ritorno dal passato nel dissidio moderno tra poesia e vita, tra pezzi del reale e loro inscrizione sotto il diaframma, la maschera dell’obiettivo-macchina da presa (può essere questo il senso della «soggettiva libera indiretta» in Pasolini: lo scollamento necessario, sacrificale, insito nella stessa volontà di coalescenza con il corpo-segno vivente, del mondo con l’illusione). Si tratta pur sempre di un movimento parodico, nel senso del trasferimento di uno schema da un contesto culturale a un altro, in sostanza di un mascheramento di cui il cinema diventa l’operatore. In sostanza, in Fellini come in Pasolini il carnevalesco premoderno in senso bachtiniano viene trascinato da questo movimento parodico sull’orizzonte funebre della maschera moderna: partendo dal barocco, in Fellini, e dalla nostalgia romantico-decadente di un sostrato rituale ormai perduto, in Pasolini. La maschera e il grottesco vengono spinti nel “nero” spettrale dietro cui traligna
Maschera Bruno Roberti
261
il nulla, e questo processo prende piede a poco a poco nella lunga stagione della commedia all’italiana. Una genealogia della commedia all’italiana L’etimologia lega la maschera al lessico della persona78, che varia dall’ambito propriamente teatrale, alle origini rituali del personare a quello giuridico, come ci dice Cicerone, a quello teologico, come ci dicono i Padri della Chiesa. Ma il determinarsi sociale del soggetto, nel momento in cui questa identità viene affermata, instaura anche tutti i processi possibili di smascheramento, che sono anche processi di disidentificazione e sdoppiamento79. Si è visto come il cinema italiano ha raccontato e ripreso in forma unica e sotto diversi aspetti questo tema, ereditandolo da tutta una tradizione, teatrale ed estetica. La maschera-persona, con le questioni dell’identità ad essa connesse, porta con sé un problema capitale delle forme rappresentative, quello che la differenzia dal personaggio. Se quest’ultimo si sviluppa e varia nel tempo, la prima tende a ripetersi e rimanere la stessa nell’iterazione degli atti. E questo ha un effetto importante nell’elaborazione dell’intreccio: le maschere “annullano” l’intreccio, che discende da queste come susseguirsi iterativo di atti e situazioni che confermano i tratti della maschera (da Molière fino alla galleria di maschere di Sordi); i personaggi invece discendono dagli intrecci, ne sono diretta emanazione, da cui l’inscindibilità tra l’essere di un personaggio e la sua appartenenza 78 79
Su questo cfr., tra gli altri, R. Esposito, S. Rodotà, La maschera della persona, in Impersonale. In dialogo con Roberto Esposito, a cura di L. Bazzicalupo, Mimesis, Milano 2008. La scissione tra natura e persona rende la vita umana una fabula, una comoedia. In una condizione paradossale di unità-dualità di natura e persona, che nasce con il cristianesimo, la commedia (lo statuto comico) intrattiene ancora una ambiguità: l’oscillazione tra l’impersonare un carattere e la non identificazione con la maschera che si usa. E nel primato comico dello stile italiano, messo in luce da Agamben, si verifica una fondamentale impossibilità del tragico o una sua emersione in negativo proprio nell’antitragico che vi risulta (in questo, la commedia nera italiana, la linea del grottesco e i suoi esiti estremi risultano tragicomici e assumono su di sé un atteggiamento morale o etico-politico, nei caratteri della satira).
262
Lessico del cinema italiano
ad una storia, ad un intreccio. Questa distinzione ripercorre lo sviluppo italiano della commedia cinematografica: ci sono commedie di intreccio, fondate su equivoci e simulazioni, che hanno al centro personaggi inscindibili dalle storie a cui danno corpo (le commedie anni trenta) e ci sono commedie di maschere che assorbono l’intreccio in uno schizzo caricaturale e nel grottesco, bozzetto o episodio, rapsodia satirica, deformazione “nera”, ritratto di costume: è la commedia all’italiana, dal bozzettismo anni cinquanta, e poi, dagli anni sessanta, la costruzione di una galleria di maschere, e lo sviluppo, sempre più parossistico, dei tratti grotteschi (di cui I mostri di Risi è film-emblema). «Il comico istituisce il nonunivoco, il non-personale, l’indeterminato e l’indefinito […] il soggetto qualunque come protagonista “spontaneo”, inconsapevole, post-eroico della vita sociale; costituisce la vita quotidiana come modello e come fonte della rappresentazione»80. Sancendo il rovescio del tragico, la commedia instaura un movimento contrario all’espulsione, quello dell’adattamento inclusivo caratterizzato da maschere di prestazione, assimilate al carattere anonimo, in cui si proietta il corpo collettivo. Questo movimento emerge da quel carnevale paranoico in cui precipita il protagonista di un film come Reality (2012) di Garrone, Pinocchio contemporaneo che “allucina” il proprio Paese dei Balocchi nello studio televisivo, astrazione del “teatrino” comunitario che è il rione napoletano in cui abita e che viene appunto figurato come una sorta di non-luogo, dove la “piazza” alla De Sica di L’oro di Napoli (1954), è assimilata ad un affastellato ipermercato disseminato di copie e contraffazioni. La commedia all’italiana mette in evidenza il doppio legame di questo adattamento all’habitus sociale, il suo paradosso: la maschera rispetto all’abito eccede, diventa grottesca: come dice Bachtin ogni veste si fa stretta (e dunque comica) addosso all’uomo. L’anonimato trova rappresentazione nel tipico; e ciò diventa tragico nel momento in cui l’esclusione si genera dallo stesso eccesso di inclusività e adattamento. Fin dagli anni cinquanta questa condizione patetico-grottesca è presente: da Il cappotto (1952) di Lattuada, al pirandelliano Marsina stretta, episodio girato e interpretato da Fabrizi per Questa è la vita (1954). Il movimento basso-mimetico del corpo “eccede” proprio 80
M. Grande, La commedia all’italiana, cit., p. 5.
Maschera Bruno Roberti
263
nell’elasticità “dismisurata” dell’adattamento nel passaggio verso l’impersonalità della maschera sociale, producendo (come mostra Maurizio Grande) un’incrinatura, un’infermità del corpo oppure una pulsione eccessiva all’impostura, al travestimento, al millantare e imporre la propria «maschera dissonante». La costruzione delle maschere commediche allora bilica e si divarica tra integrazione e dis-integrazione, in un movimento interno alla maschera, dove Manfredi e Tognazzi ad esempio si omologano in modo autodistruttivo con esiti surreali, lugubri e onirici (per esempio in Il pollo ruspante di Gregoretti, episodio di Ro.Go. Pa.G., 1963, e in L’impiegato, 1960, di Puccini, in entrambi i casi le “maschere di prestazione” eccedono in un mondo di desiderio, o in un mondo sognato dove incontrano solo l’autoannullamento, così come avverrà per il pescivendolo di Reality); o dove Sordi e Gassman usano l’istrionismo del mascheramento nel senso di una insubordinazione o di un abuso rispetto alla illusorietà insita nel sociale, che però rivela tutta la fragilità di fondo di quell’eccesso “vantone” (come in Un eroe dei nostri tempi di Monicelli o in Il mattatore di Risi). «La commedia all’italiana ha proposto al pubblico una pluralità alienata di maschere e trucchi dell’adattamento comunque eccedente: o perché troppo ben riuscito o perché fallito»81. Si tratta di un doppio legame (autistico o isterico) della maschera: identificarsi eccessivamente con la maschera sociale col risultato di scollare la stessa maschera-ruolo dal proprio comportamento oppure sottrarsi anarchicamente alle maschere sociali solo per dissimulare meglio la propria aderenza per inganno a quelle stesse maschere sociali. Disadattamento e disidentificazione come risultanza comica: ciò che Grande chiama maschera inferma con un’intuizione che incide sul grottesco italiano riscontrando i vari personaggi “demonicamente” zoppi o infermi o balbuzienti o mutilati o storpiati della commedia all’italiana (I mostri, Brutti, sporchi e cattivi, Il boom, I complessi, Cafè Express). La maschera comica mette in crisi la pratica dell’indossare maschere, mediante una forzatura paradossale e incontrollabile dell’affidamento della soggettività al travestimento. La maschera comica 81
Ivi, p. 163.
264
Lessico del cinema italiano
denuncia l’imprendibilità e l’estraneità del soggetto portatore di maschera, facendo crollare le regole di ammissione al reale nel momento in cui vengano travolte perché prese alla lettera e estremizzate nel travestimento. C’è una specie di esagerazione dell’adattabilità del soggetto nell’indossare la maschera comica, una dismisura servile nell’assimilare passivamente modi e leggi dall’esterno (ma anche nell’essere assorbiti dal mondo) che produce effetti disastrosi82.
Annientamento e dissolvimento dell’identità italiana, dissipazione ineffettuale della maschera e sua aporia, inanità del trucco, mascherone posticcio assimilato allo schermo Tv (di cui il “Dentone” di Sordi, in I complessi, personaggio di annunciatore televisivo dalla maschera deforme che ha un grande successo nonostante l’eccesso corporeo, così debordante da essere invisibile, fu prefigurazione): se, fin dalla commedia dell’arte, la maschera viene sganciata e scollata rispetto alla trama che si riduce a gag, situazione, canovaccio, intralcio dell’intreccio, viene dissolta nella ripetizione inesauribile della maschera in vari destini, in innumerevoli casi, allora la maschera come travestimento, come imprendibilità, fuga, trucco dell’individuazione sconfessa la rappresentazione stessa in quanto istanza di rappresentanza e scardina il riconoscimento sociale, smaschera il ruolo-maschera, ri-vela il nulla, il vuoto, o le geremiadi incessanti di maschere, sotto la maschera. È ciò che accade, negli anni sessanta-settanta, nel caso di due tipologie burattinesche e insieme parossistiche, in cui l’“uomo qualunque” assimila l’“immortalità” delle vecchie maschere in una iterazione per così dire svuotata: la coppia Franchi/Ingrassia, maschera bifronte dei “resti” del vecchio tipo del servo/buffone che sgretola l’intreccio in una serie di gag a precipizio, e l’ultima grande maschera cinematografica italiana, quel Fantozzi nel cui nome risuona il “fantoccesco” che fa deviare l’impersonalità nella spettralità, e che ha spinto l’eroicomico in una sorta di disindividuazione dell’“io sociale”, che nel suo essere “troppo uguale” diviene anche l’epitome del “differenziale impazzito”, del proliferare delle maschere (non a caso Fantozzi in sé è seriale). Troviamo qui l’archeologia della neocommedia.
82
Ivi, pp. 169-170.
Maschera Bruno Roberti
265
Ciò che emerge è una commedia dei ruoli che la nuova comicità riproduce in una doppia prospettiva: o accentuandone fino in fondo le regole, prendendo alla lettera valori mutevoli e mitologie alla moda, fino a metterne in luce gli effetti catastrofici di distruzione comica nel soggetto (Verdone e Moretti); oppure percorrendo le superfici mobili senza più anima o volto (Benigni e Troisi). In una adattabilità estrema al mutare delle maschere che non è più neanche drammatica o traumatica ma ormai definitivamente indolore, mestamente innocua, come di chi non ha perso la faccia, solo perché si trova nella condizione di non averla mai acquisita (Verdone); oppure perché si trova nella condizione di chi si arrocca dietro la maschera dura, lo scafandro di gesso dell’aggressività festaiola, brutale, irriverente della buffoneria più scanzonata e viscerale (Benigni); o perché si camuffa dietro l’ingenua, attonita, spaesata arrendevolezza del quiproquo esistenziale (Troisi); o, infine, perché adotta il sorriso infantile, noncurante e morbosamente ebete del finto tonto (Nuti)83.
Una commedia “senza faccia” e “senza maschera” proprio nell’esasperazione seriale delle facce e delle maschere “vuote”: in fondo il cinepanettone è I mostri ricondotto alla serialità parossistica che vi era inscritta in partenza, e non a caso I nuovi mostri (1977), e I mostri oggi (2009) ne hanno accompagnato l’affermazione. Non si tratta più di un adattamento impedito, di un inciampo, di un sottrarsi al riconoscimento che moltiplica la società mascherata (e ne costituisce scarto critico o nero esorcismo), ma si tratta di una sottrazione totalizzante della maschera del mondo stesso; il mondo è irriconoscibile e incredibile, perché la sua contraffazione si è fatta indiscernibile, il bianco e il nero (della maschera) non sono più distinguibili, oppure si equivalgono nella loro esasperazione debordante. L’ambivalenza del comico a doppio taglio è diventata sterilizzazione, nell’orizzonte postmoderno. Si tratta della funzione di pharmakon della maschera, che nella contemporaneità trasforma la melanconia saturnina della maschera moderna in ebetismo, demenzialità, sublime idiozia da un lato, o in “allegria del naufragio”, carnevale apocalittico privato non solo della vis rigenerativa ma perfino della forza eversiva, dall’altro. Il parossismo dell’“adattamento”, delle maschere iperboliche di mimetismo emerge nel trasformi83
Ivi, p. 197-198.
266
Lessico del cinema italiano
smo-opportunismo e nel suo rovescio incarnato dal medesimo Sordi in L’arte di arrangiarsi e Un eroe dei nostri tempi e poi in Una vita difficile. Emerge l’ambiguità delle forme del potere e dell’ordine costituito: Sordi-eroe del nostro tempo si arruola per vigliaccheria nel corpo della polizia, Totò è un ladro che slitta verso la guardia o una guardia che slitta verso il ladro (ambiguità dell’uniforme come maschera dissimulatoria) rispettivamente in Guardie e ladri (1951) di Steno e Monicelli e Totò e Carolina (1955) di Monicelli. L’ambiguità delle maschere di adattamento, il bilico tra integrazione ed espulsione si muove però ancora negli anni cinquanta in uno spazio di ricorsività, in cui l’iterativo si risolve in una festosa sarabanda. Con gli anni sessanta la commedia all’italiana comincia a trattare storie tragiche in modo comico, la morte dei protagonisti irrompe a virare il riso nell’amaro e a farlo sfociare in un fondo nero, che va al di là della critica di costume. L’iperbolico nero e mostruoso letteralizza sui corpi lo spirito metamorfico e metaforico della maschera di cui può essere emblema l’“occhio della testa” estratto dal faccione di Sordi in Il boom di De Sica. Gassman in Il mattatore di Risi inaugura la sfilata di travestimenti e di truffe, di dissimulazioni mascherate che dissimulano una pulsione di morte e si inscrivono in una struttura che sempre più travalica il tempo, rompe dall’interno gli intrecci, vuoi in forma di itinerario di fuga in un tempo che si annulla nell’orizzontalità dello spazio, vuoi in forma di racconto spezzettato che rende il romanzesco frammentario andirivieni nella sospensione del fallimento che smaschera la coazione a fingere e a dissimulare e la destina all’improvvisa sincope di una morte farsesca o amara, o di un disfacimento violento dell’abito sociale. Dalla morte sotto il tram di Memmo Carotenuto in I soliti ignoti (1958), all’incidente finale in Il sorpasso (1962) di Risi, dalla fucilazione dei protagonisti in La grande guerra (1959), al suicidio della Sandrelli in Io la conoscevo bene (1965), dallo schianto finale dell’auto del piccolo borghese nel finale di Il pollo ruspante al pestaggio di Tognazzi “bardato” della divisa fascista che diventa sinistra maschera imprigionante nel finale di Il federale (1961) di Salce (pensato per Totò e De Sica), allo sfogo di Sordi tra le automobili in Una vita difficile, in cui crolla e si disfa la maschera di adattamen-
Maschera Bruno Roberti
267
to. Il sorpasso in inglese era Easy Life, vita «facile», riecheggiamento tanto del “difficile” quanto del “dolce” delle precedenti “vite italiane” del 1960 e del 1961, condotte sull’orlo del baratro (Gassman che guarda giù in fondo al baratro dell’incidente che interrompe brutalmente la fila di dissimulazioni) a occhieggiare il nulla di un’“ultima spiaggia” (quella stessa livida che si svuota dopo un temporale in Il giovedì). I connotati del mondo sono diventati da “rosa” (com’erano nel commedico “primaverile” e di inclusione degli anni cinquanta) grigiastri e melmosi, contrastati in un bianconero violento oppure del tutto neri (come in certi contrasti che privilegiano il buio nella fotografia di Di Venanzo), notturni (come molte scene, a ben guardare, della commedia all’italiana) e si sono deformati fino a diventare mostruosi. Il mondo allora diventa il corpo stesso dei personaggi-mostro e assimila le loro parvenze in un estremo, crudele disinganno, inducendo uno scetticismo estremo dietro i tratti vuoti, disidentitari, grotteschi delle maschereattori (I mostri). Negli anni sessanta la commedia italiana comincia a praticare il disfacimento e il disconoscimento dell’uniforme, della veste sociale: una sorta di pratica aporetica della maschera per via omeopatica, in cui le maschere della commedia dell’arte, dopo aver trascorso ed essersi diluite nella de-ritualizzazione, nell’inserimento del tempo profano dentro i loro abiti, spoglie borghesi e indifferenti dell’habitus che parte da Goldoni e sfocia nel romanzo della borghesia novecentesca, soprattutto in Moravia, ormai sono soltanto tipologie svuotate. Le maschere sociali non sono più né nude né tra-vestite ma vanificate nell’inefficacia paradossale e grottesca della loro parte, ridotte a pura e vana parata, a galleria attrazionale. Il vigile (1960) di Zampa, Il corazziere (1960) di Mastrocinque, Il carabiniere a cavallo (1961) di Lizzani, Il commissario (1962) di Comencini, Il comandante (1963) di Heusch, disconoscono le maschere-uniforme: Rascel indossa la divisa da corazziere solo in uno spot, il commissario resta una promessa dei superiori, illusoria, il carabiniere a cavallo perde il cavallo e lo cerca invano, e il comandante diventa tale solo nel momento in cui viene destituito, messo a riposo. Altrettante maschere svuotate, inani, condotte al fallimento del loro ruolo sono, a partire dagli anni cinquanta, Il seduttore (1954)
268
Lessico del cinema italiano
di Rossi, Lo scapolo (1955) di Pietrangeli, Il bigamo (1956) di Emmer, Il marito (1958) di Loy e Puccini, Il vedovo (1959) di Risi, Il moralista (1959) di Bianchi, Il mantenuto (1961) di Tognazzi. È stato Monicelli, e la sua vena nero-grottesca, a minare il terreno della commedia all’italiana, di cui pure fu artefice, in un film sulfureo e sottovalutato come Toh, è morta la nonna! (1969) e nel successivo Parenti serpenti (1992) in cui il carnevale dell’illusione e dei sogni borghesi salta letteralmente in aria con l’appartamentoset (come la cucina del finale di I soliti ignoti): il carnevalesco si fa definitivamente macabro. Ma fin dai suoi inizi con Steno, Monicelli manifesta una vena macabra come nella scena di Totò che segue il proprio funerale a piedi per risparmiare le spese del carro funebre in Totò e i re di Roma (1951). E in un film tardo di Monicelli, Panni sporchi (1999), buona parte del film è girata durante un funerale che altro non è che una sfilata grottesca di maschere sociali della contemporaneità. Negli anni settanta-ottanta lo sberleffo lugubre, l’esorcismo della morte, si fa più significativo: in Amici miei atto II (1982) di Monicelli le beffe, in perfetto stile boccaccesco, sono raccontate nell’hortus conclusus di un cimitero. Buona parte del cinema di Sergio Citti è una poetico-comica elaborazione del lutto, e sotto il suo sguardo la trafila di maschere della commedia italiana (da Gassman a Tognazzi, da Proietti a Pozzetto, da Benigni a Verdone) diventano (nel ricordo di Totò) altrettanti spettri, maschere funebri-rituali, restando feticci carnali, e carnevaleschi, in preda ai sogni e bisogni, alla fame e al sesso. Citti «guarda all’Italia e al cinema come dalla luna […] è significativo che l’elaborazione del lutto passi […] attraverso il riso […] tra un cinema di vagabondaggio, picaresco e libero, ed una costrizione spazio-temporale estrema, claustrofobica e lugubre»84. C’era un progetto di prologo, poi non realizzato da Pasolini per Brutti, sporchi e cattivi di Scola (cui pure collaborò come consulente Citti) dove i borgatari non sono più né innocenti (Pasolini) né filosoficamente cinici (Citti), ma sono, a cominciare da Manfredi, deformazioni grottesche e maligne, versioni nere dei poveri matti di Zavattini e De Sica, che ormai non hanno più bisogno di mascherarsi da capitalisti, dal momento che la loro stessa de84
E. Morreale, Che verifica sono, i Citti!, in Mi chiamo Sergio Citti, racconto storie, a cura di A. Macis, S. Naitza, Cuec, Cagliari 1999, pp. 85-87.
Maschera Bruno Roberti
269
formazione facciale maschera una avidità tutta postmoderna (quella delle Tv e dei computer nei bassi, nelle baraccopoli, nelle Scampie delle Sodoma e Gomorra di oggi). Se c’è un pregio nella metacommedia claustrofobica di Scola (e nelle tarde commedie all’italiana, sempre più ghignanti e spietate, di Risi e Monicelli) è l’aver compreso come l’espandersi dello spettacolo nella società impediva ormai una commedia nel senso classico di “ingresso”, di accesso alle maschere sociali, perché la disseminazione mediatica del mascheramento rendeva indifferente una pratica del travestimento, della “dissimulazione onesta”, e il nulla non era più disingannato dalla maschera, ma trapelava in modo micidiale, indistinto. Il fotoromanzo, le canzonette, la Tv, insomma i mass media che costituivano, agli albori della società dei consumi negli anni cinquanta-sessanta, un dispositivo affabulatorio capace di sintetizzarsi ancora graficamente nei tratti apocalittici-infernali di Fellini (Lo sceicco bianco e La dolce vita) o in quelli puramente commedici (nel senso proprio del mythos primaverile di Frye) dei “poveri ma belli” o dei musicarelli, a partire dagli anni settantaottanta assume tratti sinistri, saturnini, melanconici o addirittura metafisici, e al fondo nichilisti, “neri” in film come Straziami ma di baci saziami (1968) di Risi, Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) (1970), Romanzo popolare (1974) di Monicelli: dove la memoria del puro-comico (i Marx, Chaplin, il varietà) viene dissolta nel contropelo patetico delle derivazioni melò, che per forza di cose sfocia nel grottesco più disperato. Nel “metacommedico” di Scola, da C’eravamo tanto amati (1974) a La terrazza (1980), è già leggibile un approccio teorico in cui più che maschera e commedia vengono sottoposte a dissezione (come su un letto di autopsia) gli stessi stilemi della commedia all’italiana classica, per cui ciò che emerge è un controromanzo balzacchiano sul cinema italiano, sulla sua stessa capacità di costruzione-distruzione di maschere, allineandole e dissolvendole in un paesaggio “alla seconda” (ciò che in fondo farà ancora Sorrentino nel suo cinema). «Ormai siamo tutti così: personaggi drammatici che si manifestano solo comicamente», recita una battuta di La terrazza. Certo di fronte alla putrescenza e alla corruzione del costume italiano l’approccio commedico e l’uso dei volti di attori/maschere ormai identificatisi, e pirandellianamente imprigionati, nella loro tipizzazione, esaspera moralisticamente il grottesco, ricavando-
270
Lessico del cinema italiano
ne necessariamente il contenuto tragico e il fondo scettico: allora letteralmente lo smascheramento della corruzione deve passare di necessità per l’indice raddoppiato della maschera, una sorta di contrappasso: Gassman travestito da antico romano in In nome del popolo italiano (1971) di Risi, Sordi tra i cappucci e i grembiuli dei massoni in Un borghese piccolo piccolo (1977) di Monicelli. I loro volti-maschere non sono più comici, ma soltanto truci. Naturalmente la commedia all’italiana conferma (anzi vi accede ancor di più) una capacità oracolare, di preveggenza, proprio per via di una decostruzione e palingenesi del corpo-maschera: sono le maschere di Craxi e Berlusconi e quella di Gelli (che entreranno in scena dopo qualche anno) ad essere pre-figurate. Si tratta di «teschi, scheletri di commedia»85. I mostri sono usciti allo scoperto, non hanno più (bisogno della) maschera. Monicelli dichiara che con quel film del 1977 ha posto una “pietra tombale” sulla commedia all’italiana. Verso la maschera nera: Ferreri La funzione del cibo, quella del “carnevale conviviale” che si rovescia in un’apocalisse in cui il corpo è deflagrato in resto sacrificale e in frammento-feticcio, quella del banchetto dionisiaco che inverte l’estasi vitale in estasi mortale, serve al cinema di Ferreri per sfondare la «norma corporale» (come dice Maurizio Grande) nel senso dell’eccesso grottesco e nero. Eppure la radice rituale di tale iperbole della carne, e il suo dato appunto carnevalesco (che risale alla festività rigenerativa che Bachtin rintraccia in Rabelais), non ha più nulla del “rigenerativo” ma si spinge verso un “dissipativo” che incontra il nero, la morte, il nulla. Ciò si rivela in due film di Ferreri per la televisione francese, pressoché ignorati: Faictz ce que vouldras (1994) dedicato all’utopia “thelemica” di Rabelais e ambientato in mezzo ai mascheroni, agli immensi pupazzi, alle cibarie pantagrueliche degli annuali festeggiamenti francesi in onore di Rabelais; Il banchetto di Platone (1988) dedicato (dopo Rossellini) alla “maschera” di Socrate, alla sua natura 85
E. Giacovelli, Non ci resta che ridere. Una storia del cinema comico italiano, cit., p. 119.
Maschera Bruno Roberti
271
silenica, e ad una filosofia, e una pratica, di uso e cura del corpo che, foucaultianamente, mette in questione un dispositivo legato alla rappresentazione e alla performatività dei corpi in rapporto alla mente. In Il banchetto di Platone lo statuto dei corpi funziona come iperbole, transito, trasformazione e la dialogicità platonica si converte in teatralità, in polimorfia grottesca e mostruosa segnata da un sentimento cosmico del nulla: il singhiozzo e i pidocchi di Socrate, il racconto dell’ermafrodito come eccesso mostruoso da parte di Aristofane, la psyché che lascia il bel corpo dell’eroe Achille in forma di animale alato, i corpi nudi evocati da Diotima, nudi di donne incinte, nudi di cadaveri sezionati, squarci cosmici di astri orbitanti e di cicogne. E in ciò il cinema diventa maschera del nulla, precipizio nero: «Non avrebbe avuto ragione, Platone, di considerare il cinema invenzione diabolica, consegnata a un destino ineluttabile di specchio dell’avanzata delle cose e degli uomini verso il nulla, magari sotto le maschere rassicuranti, ma precarie, dell’affabulazione?»86. Capiamo meglio allora il lato comico-filosofico di La grande abbuffata (1973), dove le tracce della commedia si disfano in un cupio dissolvi, disseminate e dissipate in una allegria sinistra, in una baldoria convulsa che procurano una apocalissi e un disfacimento dei corpi che è anche il dissolvimento delle maschere della commedia italiana, di quelle dell’eccesso di consonanza (Grande), caratterizzate da una morbida, e al fondo autodistruttiva, capacità di assorbire e lasciarsi assorbire fino alla cancellazione dal travestimento sociale (Tognazzi, Mastroianni) e che non a caso Ferreri destina a un congelamento (i volti impassibili che guardano da una cella frigorifera) o a un sinistro sberleffo di ingurgitamento del dolce-feticcio-cupola (assimilato al volto di Tognazzi come travestimento e imitazione del dispositivo mascherato di potere, dal momento che Tognazzi imita il volto distorto e grottesco di Il padrino). «Ferreri impone a questi attori il volto in luogo della maschera, il corpo in luogo della persona, una flagranza psicosomatica “deviante” rispetto ai ruoli abituali»87. L’atto mancato dell’adattamento alle maschere sociali, o l’atarattico rifiuto del 86 87
A. Cappabianca, L’immagine estrema. Cinema e pratiche della crudeltà, Costa & Nolan, Genova 2005, p. 159. M. Grande, La commedia all’italiana, cit., p. 154.
272
Lessico del cinema italiano
mascheramento sociale portato a uno svuotamento dall’interno e per eccesso, in Ferreri si destina a uno scivolamento nella decomposizione che riporta, invertendo il meccanismo regressivo, alle radici animali e feticistiche della maschera e insieme la spingono a un disfacimento apocalittico. In questo modo la scissione tra soggetto e mondo, l’inadattabilità comica del soggetto, la funzione commedica della maschera come eccedenza o difetto, integrazione o rigetto, delle maschere di prestazione tipiche della commedia all’italiana, vengono fagocitate da Ferreri fino all’indistinzione tra visione del mondo e grottesco, fino a una empatia paradossale tra credenza nel mondo e sua dissoluzione scettica («Io non credo, d’altra parte, che si possa vedere il mondo se non con la lente del grottesco», ha detto il regista). Il nesso tra processo mentale e pulsionalità corporea tra loro intercambiabili e confusi fa sì che si operi uno svuotamento dell’espressione interiore, della psicologia, dell’impersonare, dell’agire le maschere sociali nel senso di «una ritualità maniacale e ossessiva che giunge fino all’alterazione del volto. La mimica facciale deformata in una smorfia (accompagnata dalla simulazione di grugniti) di fronte alla visione del filmino e di fronte allo specchio»88, come avviene in Dillinger è morto (1969). Ed è significativo che in questo film l’apertura sia dedicata a una riflessione-conferenza sul senso della maschera89, diventata però null’altro che una maschera antigas: oggetto, feticcio svuotato dal desiderio e quindi nullificato, adesione del mostruoso allo stesso volto dell’uomo e del mondo. E se una volta tolta la maschera, il velo che ci difende e ci posiziona nel mondo, non emerge che il vuoto più inquietante, l’assenza di ogni desiderio? È l’assenza
88 89
R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, cit., p. 66. «L’incipit di Dillinger è morto è dunque una meditazione sul “vuoto” della maschera nella società contemporanea. Michel Piccoli prova delle maschere antigas, nel laboratorio un tecnico lo invita a guardare attraverso un oblò il volto mascherato e incappucciato avvolto da una nube: “guarda la tua maschera”, gli dice, e poi, con uno stacco, in un salotto borghese, alle cui pareti ci sono gigantografie di quelle stesse maschere, l’amico fa ascoltare al distratto Piccoli il lungo brano di un suo scritto sulla teoria della maschera come simbolo della spersonalizzazione nel mondo contemporaneo», M. Fusillo, Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, il Mulino, Bologna 2012, p. 168.
Maschera Bruno Roberti
273
che, ancora una volta, il cinema italiano ha saputo rappresentare in modo impareggiabile, come il cinema di Ferreri dimostra. I mostri di Ciprì e Maresco Il rifluire della tradizione del grottesco cinematografico italiano in un orizzonte in cui le maschere sconfinano nel nero, nel mostruoso, nell’apocalittico si manifesta soprattutto nelle immagini di Ciprì e Maresco. Il lato mostruoso della maschera viene in questo caso antropomorfizzato. L’eccesso mostruoso dei corpi traligna nel sublime e la deformazione (naniforme, gigantesca o distorta in gobbe e protuberanze, in protesi oculari e in tratti escrementizi) piuttosto che fluire nella metamorfosi della rinascita dribbla la morte in una “cattiva eternità” e si “calcina” nel simulacro immobile, nel calco/maschera, nel fantasma feticistico del significante, nella ripetizione rituale del gesto. «C’è la riduzione monoplanare ad un mondo dove la brutalizzazione e l’“animalità” dell’umano non sono forme di abbassamento, ma dati costitutivi di un mondo che, a partire da questo livello di subumanità, può solo accedere ad una sacralizzazione rituale»90. Anzi le immagini rovesciate di Ciprì e Maresco introducono a una vertigine posta sul “fondo delle altezze” in cui la tradizione romantica che unifica grottesco e sublime assimila tanto il corpo quanto il paesaggio. L’animato e l’inanimato, il maschile e il femminile, l’umano e l’animale, il corpo e il paesaggio pietrificati vengono assimilati in una zona indiscernibile dove la maschera investe non solo il volto ma l’intero corpo fattosi simulacro e statua, significante assoluto. C’è come una interferenza della maschera rituale-animale arcaica con quella nera moderna che sospende il tempo e insieme circoscrive uno spazio che è come un “resto”, un residuo della vanitas barocca nell’immondezzaio del dopo-storia ma ne conserva anche il dato metavisuale, come risulta dalla predilezione di Ciprì e Maresco per una teatralizzazione en abyme, una metarappresentazione che passa non solo nella iconicità raffinata e distanziata del bianconero e della cura anamorfica dell’inquadratura, ma anche nell’inscrizione del film nel film, dei 90
R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, cit., p. 109.
274
Lessico del cinema italiano
rimandi citazionali a Buñuel o Pasolini o Ford, nell’interpellanza dello spettatore e nello sguardo in macchina. In questo senso la maschera non solo aderisce e si espande alla corporalità, che si fa volto totale ma, segna, mostrandola, la cavità vuota che la costituisce: è il volto mostruoso che si cava un occhio dall’orbita di quel Santo-Polifemo che ritorna tanto in A memoria quanto in Totò che visse due volte (1998). E d’altronde nel finale di Lo zio di Brooklyn (1995) il festivo carnevalesco, la sarabanda rituale che converte i morti in vivi e i vivi in morti, la danza macabra e il mondo alla rovescia, il paese di cuccagna e la festa dei folli, il kòmos dionisiaco e lo charivari, insomma tutta l’imagerie grottesca come visione del mondo, viene convocata in una metarappresentazione dove però il cinema, l’atto stesso del filmare si fa gesto nullificante, smascheramento totalizzante attraverso l’ipermascheramento, inabissandosi nel nero. In un film come Totò che visse due volte trova conferma lo statuto “commedico” della passione cristologica, la colpa personale come riscatto dell’innocenza naturale, il carattere di maschera comica della stessa figura cristica, di un “sacro riso” di puro folle e di santo-idiota che non a caso viene figurato dalla postura di derisione dell’Ecce Homo, e ciò guadagnando l’aura sacra della statua/maschera. All’inizio del film il destino di Paletta è quello di assimilarsi a una statua vivente, a un morto-vivo in un tabernacolo che ne racchiude il busto-voltomaschera con gli attributi dell’Ecce Homo, e nel finale il calvario e il Golgota con i tre cristi pasoliniani ridotti a puri significanti (in cui la pietas subentra nel lato animale) il tragico del capro espiatorio si “dissolve nell’acido commedico”, e la statua (questa volta di un femminile cultuale tipico della Sicilia, una Madonna/Santuzza) viene insieme abbassata/innalzata alla funzione di feticcio. In Il ritorno di Cagliostro non è un caso che le due maschere grottesche elette a protagonisti, i fratelli La Marca, nell’epilogo del film si pietrifichino in due bianchi simulacri, quasi fossero statue viventi che hanno osato guardare il volto-maschera medusèo in un abisso della visione, “messa in abisso” che presiede a tutta la grottesca figurazione del film, punteggiato da finti spezzoni e riprese, provini esilaranti, truci parodie dell’horror, e ricondotto poi a un metafilm che sberleffa, sotto le spoglie di un nano buñueliano, sul proscenio di un teatro, la stessa pretesa di messinscena tra finto e reale svelandone il vuoto agghiacciante sotto la maschera comica. In Ciprì
Maschera Bruno Roberti
275
e Maresco è il cinema, il suo bianconero costitutivo, il mascherino dell’inquadratura, il diaframma della profondità di campo, la funzione dello schermo, che vengono assimilati alla maschera, estesa al corpo-simulacro e intesa nel vuoto orbitale e abissale dello sguardo in macchina91. Maschere nere del potere: da Petri a Sorrentino Se la commedia grottesca attiene più al “fabulare” che all’“intrecciare” storie, più alla creazione di maschere e caratteri che all’intreccio con soluzione finale, e se negli anni cinquanta, e prima ancora negli anni trenta del cinema italiano l’intrico risolve le maschere, spesso coordinate in figure doppie o di doppio, è negli anni sessanta-settanta che l’episodicità, il frammento, la rapsodia dissolvono le maschere nel tratto propriamente grottesco. È il versante funebre, nero, fantasmatico che in questo caso viene implicato. Il grottesco nero di Petri, di Moretti, di Bellocchio, di Sorrentino, in un’opera di svuotamento delle maschere del potere, attiene alla rigidità moralistica dell’emblema-maschera di carattere melanconico e di ascendenza romantica. In una certa modalità del grottesco nel cinema italiano, modalità morale che passa per l’uso del paradosso etico-politico, il farsi maschera del personaggio si esplica tramite «l’attraversamento di situazioni che confermano il personaggio-maschera»92. Questo slittamento paradossale che smaschera mascherando, che traccia il vuoto della maschera trova esempi in film come Il divo (2008) di Sorrentino, Il caimano (2006) di Moretti, Vincere (2009) di Bellocchio, e un prototipo in Todo modo (1976) di Petri. Ciò che viene a rappresentazione è un personaggio plasmato direttamente sulla persona, sul suo vissuto, sul suo corpo e sulla sua faccia. «Si viene a costituire uno spazio 91
92
Mettendo in forma gli apparati mascherati del potere contrapposti alla potenza della vita, usando repertorio, schegge reali e messinscena, il solo Maresco con Belluscone. Una storia siciliana (2014) realizza un film potentemente rivelatore dell’agghiacciante nullità della maschera contemporanea, con geniali prelievi dal patetico carnevale televisivo (il pentito che testimonia con il volto coperto da una maschera bianca). R. De Gaetano, Nanni Moretti. Lo smarrimento del presente, Pellegrini, Cosenza 2015, p. 72.
276
Lessico del cinema italiano
di indiscernibilità fra vita e finzione, fondato sulla simulazione dell’attore, sul suo essere tra la persona e il personaggio: il farsi personaggio della persona e il radicamento del personaggio nella persona. È la simulazione attoriale ad occupare lo spazio instabile fra la persona e il personaggio»93. È il caso del cinema di Moretti dove assistiamo a un duplice movimento di scardinamento e di osmosi, disconferma e conferma, della maschera tramite uno slittamento autore-attore-personaggio-persona e infine riconfigurazione nullificante della maschera: «L’autore diviene con l’attore e questo a sua volta con il personaggio, che è calcato direttamente sulla persona, e cioè, in un senso più generale, come indica l’etimologia, sulla maschera»94. Questo slittamento, riscontrabile nell’itinerario del grottesco morettiano, inscritto in uno sganciamento narrativo dall’intreccio a favore di una fabula svuotata dalla sua consequenzialità, trova in un film come Il caimano un esito destrutturante proprio attraverso la conferma, il «trionfo della maschera, delle maschere, utilizzate anche per dissolvere l’unità del personaggio e della persona»95. Ciò è tanto più significativo nel finale “nero” del film dove lo scardinamento della maschera berlusconiana (moltiplicata e decostruita) viene riassorbito nel volto senza trucco di Moretti stesso (entro una metanarratività vertiginosa che scardina dall’interno la stessa struttura metafilmica), che assume su di sé il nulla della maschera berlusconiana e riconduce all’etimo giuridico della persona, come figura del diritto, ma rovesciandone la figura di ruolo. La sentenza di colpa personale coincide con il trionfo apocalittico del mondo alla rovescia e il riso della maschera diventa ghigno. La costruzione della maschera coincide con la sua decostruzione e la maschera del potere coincide con il suo vuoto: come sarà chiaro per il successivo Habemus Papam (2011), con il trono vuoto del potere, e questo vuoto trova solo nella teatralizzazione, tra le quinte di un teatro, nell’iterazione di un discorso falso come nel mandare a memoria una parte, il suo splendore e la sua miseria umana96. Il potere 93 94 95 96
Ivi, pp. 80-81. Ivi, p. 81. Ivi, p. 84. «Una verità che attraversa la maschera, l’attacca dall’interno, la disfa: dietro l’ossessione di perfezione […] si nasconde la lacerazione di chi non accetta l’incompiutezza dell’esistenza. È affermazione comico-tragica di una
Maschera Bruno Roberti
277
deve indossare maschere per esercitare la sua efficacia e la sua dissimulazione, il suo ruolo. Il potere ha bisogno del segreto del suo “camerino” per truccarsi: «Il posticcio, l’artificiale come una ipernatura carica ed esagerata, ribalta di una maschera che nasconde e soffoca, eccita e pesa»; è la maschera del potere, e l’illimitatezza e l’infinità del desiderio che la anima a sfidare, per affermarla, l’impersonalità della legge97. In Todo modo di Petri gli antri neri del luogo degli “esercizi spirituali” del potere democristiano diventano il teatro delle maschere della politica (una tipologia di commedia dell’arte come dice lo stesso Petri, ma evidentemente devitalizzata di ogni carattere resurrezionale) in modo da rovesciare il rituale sacrificale in un grottesco che segna l’impotenza del tragico, in un carnevale espressionista che ne estrae il crisma apocalittico. La rigenerazione, la palingenesi carnevalesco-apocalittica mentre si inscrive nel lessico della maschera come persona giuridica, colpa personale sottoposta a un giudizio, nella «congiunzione tra teologia e politica», non approda al tragico ma a una «commedia grottesca del desiderio e dell’affanno, di satira del dolore e della morte stessa, di raccapricciante fusione di pathos e di comico nel martirio degradato, degenerato»98. L’uso di una maschera mimetica come quella di Volonté nel ruolo di Moro, di una maschera fantasmatica come quella di Mastroianni nel ruolo del prete, e di un corpo comico come quello di Ciccio Ingrassia nel ruolo del politico masochista, compone una “commedia dell’arte nera” in cui la morte-
97 98
dissonanza. […] ciò a cui i principi morali tendono a mettere argine sono, da un lato, i principi vitali, quelli che affermano la vita nel suo continuo divenire indifferente al senso, nella sua incompiutezza e ambiguità (ciclo di morte e rinascita, fine e nuovo inizio) […] dall’altro lato, i principi morali vengono a determinarsi come difese contro le degenerazioni dei comportamenti privati e pubblici. […] il moralismo di Moretti, che in questo si riallaccia a parte importante della nostra commedia degli anni sessanta, appartiene a questa seconda direttrice, e si definisce nelle forme di un grottesco critico, aggressivo, nero. Un grottesco morale senza alcuna spinta rigenerativa, che giudica il mondo, di cui fa parte lo stesso soggetto giudicante», ivi, pp. 118-119. R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, cit., pp. 88 sgg. M. Grande, Eros e Politica. Sul cinema di Bellocchio, Ferreri, Petri, Bertolucci, P. e V. Taviani, Protagon, Siena 1995, p. 83.
278
Lessico del cinema italiano
resurrezione della maschera si risolve in una perpetuazione del potere fondata su un nulla sterile e non sul ciclo naturale, per cui l’iterazione rituale (la pratica degli esercizi) diventa ineffettuale, la morte viene sterilizzata in una «commistione tragico-comica, sublime-ridicola, che gli fa assumere la forma del raccapricciante come tratto distintivo di un grottesco nero»99. Sia in Moretti che in Petri si accede a un controritualismo. In Moretti i cerimoniali papali (Habemus Papam) sono segnati da velari, ombre, tendaggi (la “finestra” col tendaggio rosso del papa e l’ombra del sostituto, fanno il paio con i palchetti del teatro e i suoi sipari di velluto), i cerimoniali cinematografici e le apparizioni televisive (Sogni d’oro, Aprile, Il caimano) sono “messi in abisso”, sogni e immaginazioni inscritti autoriflessivamente come gesti apotropaici (il set “freudiano”, la gara televisiva, oppure lo slittare, quasi come per dei provini, degli attori che “somigliano” al Caimano e le fantasie “musical” per pasticceri trotzkisti); e gli oggetti feticistici mascherano compulsivamente la mancanza (il pullover in Il caimano, gli oggetti della stanza o la tazzina da caffè sbreccata in La stanza del figlio) oppure galleggiano nel “vuoto di memoria” come “vuoto politico” trasferito nello schema di squadra ritualmente ineffettuale (Palombella rossa). Mentre in Petri l’iterazione del potere si nasconde nel buio di sotterranei (Todo modo) oppure nel chiuso della camera da letto (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto), o ancora negli anfratti di una macelleria, di un cabaret o di una banca dove le “maschere del ladro” sono bifronti e truccate (come nel doppio corpo dell’attore), e traspone all’esterno un’azione ridotta a coazione, ripetizione, compulsione (le assisi della DC in ritiro, gli interrogatori di polizia, i monologhi paradossali). Ciò che si perpetua è il nulla del potere, anzi il suo segreto che la maschera dissimula e che coincide con il vuoto, con il niente. E in questo grottesco nero, compulsivo, vanificante «c’è sempre al centro la maschera, sottratta alla sua dimensione gioiosa e carnevalesca (l’avvicendamento e il divenire), e affermata nella sua “valenza lugubre”, che cela spesso un vuoto terribile, il “niente”»100. Nei film di Sorrentino Il divo e La grande 99
R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, cit., p. 95. 100 Ivi, p. 97.
Maschera Bruno Roberti
279
bellezza l’esornativo, il tratto manieristico, l’affastellamento di sequenze, lo sganciamento dall’intreccio a favore del frammento icastico (che può avere i modi dello sketch, del numero circense, del siparietto del varietà) vengono recuperati dalla tradizione della commedia all’italiana (e di quegli elementi di tale tradizione già fagocitati da Fellini e da Petri), e messi in circuito in modo iterativo e svuotato, in cui il gesto controrituale coincide con i tic e i cliché delle stesse maschere sinistre e nichiliste messe in scena al punto da assimilarle ai tic e ai cliché dello stesso stile di ripresa, restituendone la valenza biopolitico-teologica nell’assimilazione stretta tra persona e personaggio, nella sua riduzione a maschera votata al nulla, al gran ballo in maschera del niente, e però in ciò ne svela oltre che l’orrore il dolore, anzi il nesso volgarità-dolore. La maschera di Andreotti ha lo splendore e la miseria propria di una divinità degenerata, il divo Giulio riprende la maschera neroniana, un ritratto frontale da basso impero (non lontano dal simulacro di potere nel tardo-antico, riscontrabile ad esempio nell’inquietante sguardo immoto dei ritratti funebri di Al-Fayum), ma lo prosciuga in una mummificazione impassibile, in una maschera di cera. Se il carnevalesco che in Petri era ridotto a un sinistro teatro funebre, un’apocalisse del potere che perpetuava se stesso in una illusoria rigenerazione, nei due film di Sorrentino si riduce a secca e agghiacciante esibizione del festivo: la festa dei politici che ballano sul sacrificio di Moro in Il divo, la festa iniziale di La grande bellezza e in generale nei due film l’iterazione dei gesti automatici delle maschere burattinesche in ogni loro grottesca metamorfosi. Si pensi alle camminate esorcistiche di Andreotti, agli arrivi e all’incedere posturale dei politici della corrente andreottiana, al misurare nel buio il corridoio vuoto da parte dell’ombra larvale del Divo, oppure, nella Roma mascherata che rovescia la dolce vita in una amara agonia, ai furiosi gesti pulsionali della body-artist o della bambina, alle ombre disegnate sulle superfici vetrose o velate, a partire da quelle femminili come la striptiseuse o le “veline”, agli “accenti” e alle “posture” ossessive, alle cadenze sbracciate e alle pose di Jep Gambardella, alla sua assimilazione all’abito, al sartoriale che assume il valore di sembiante sinistramente complice o criminale. È significativo che un attore come Toni Servillo sia l’epitome di questi film. Un attore che lavora in teatro con grande prespicacia su una sorta di anatomia della tradi-
280
Lessico del cinema italiano
zione italiana della maschera (dalle sue radici atellane a Goldoni a Eduardo). Servillo nel cinema sembra l’erede critico da un lato del mimetismo grottesco di Volonté, dall’altro delle iperboli, spesso fantasmatiche, che sulla maschera-carattere hanno disegnato i virtuosi della commedia italiana, da Sordi a Tognazzi e da Mastroianni a Gassman. Eppure il ruolo e il lavoro di Servillo, lo si vede bene in un film come Viva la libertà (2013) di Andò, contengono rispetto al grottesco e alla maschera un dato di distacco critico, che diventa politico, una malinconia connessa alla coscienza dell’essere doppio, dimidiato in una indiscernibilità tra comico e tragico, insita nella apparente dicotomia di Jouvet tra acteur e comédien. E in ciò risulta incorporare, nel suo essere profondamente attore italiano, l’orizzonte europeo, la coscienza infelice della modernità, il lavoro romanzesco rispetto all’illusion comique, quella “coscienza del nulla” insita nel gioco di maschere che assume il dato della finzione inscrivendolo nel reale. È un dissidio questo, una aporia che pone la maschera, come cifra commedica, a confronto con il tramonto, o l’impossibilità, del tragico, e che dischiude un territorio, al di là della maschera-persona, qualcosa che potremmo definire impersonale romanzesco. Nel cinema italiano questo dissidio tra grottesco impotente del potere e impossibilità del tragico (e quindi sua valenza lugubre e spettrale), asimmetricamente dismisurata di fronte alla potenza (femminile) della vita è stato illuminato da Marco Bellocchio, per ciò che riguarda il nesso teologico-politico della persona (nelle sue maschere/volto della follia e della santità) in L’ora di religione (2002) e più specificamente nella fisiognomica della maschera di potere (del suo fondo folle come di quello che illusoriamente coincide con il suo schermo) in un film come Vincere. In questo film il volto di Mussolini slitta implacabilmente nella sua maschera dapprima enfatizzata dalle esibizioni teatralizzate nella temperie futurista, poi dallo schermo dei cinegiornali (e prima ancora da quello parodico e ancora una volta commedico, del Cristo, visto con il film muto di Antamoro proiettato sul soffitto dell’ospedale da campo, dove è riverso il giovane Mussolini), infine stravolto nei suoi tic grotteschi dalla facies folle del figlio illegittimo (interpretato come un doppio dallo stesso Filippo Timi), infine schiacciato come busto scultoreo, maschera posticcia e decorativa, dalla pressa meccanica. In questo modo il corpo del capo, il suo feticismo
Maschera Bruno Roberti
281
ritualizzato, si rivela come una doppia faccia che ne dissimula il posto vuoto, e lo rivela come corpo doppio del sovrano (messo a morte e sdoppiato nel buffone). Sia in Sorrentino che in Bellocchio si tratta di un corpo-facciata, di una maschera diventata trucco totalizzante che investe il corpo come schermo di se stesso101. Che sia Berlusconi in Moretti, che sia Andreotti in Sorrentino, che sia Mussolini in Bellocchio, l’unica declinazione nella modernità della nozione rituale e giuridico-politica della maschera e della persona è quella di un vuoto, di un nulla, di un segreto senza segreto, in definitiva di uno schermo che fa coincidere il volto del potere con la maschera dell’hystrio, dell’hypocritès, e che mostra in definitiva la sua cavità risonante (personante) “a vuoto”. E qui pensiamo al ruolo anodino che la voce della maschera assume nelle tre maschere del potere: l’urlo disarticolato di Mussolini, la voce chioccia di Andreotti, la parlata stridula e diabolica di Moretti, che rende perfettamente i lapsus vocali che stridono dietro la voce mascherata suadente di Berlusconi. E in fondo anche l’urlo predicatorio, ma altrettanto imbonitore, di Grillo, attraverso le immagini diffuse della rete come della televisione, sembra essere l’esito nero, la maschera svuotata, delle antiche giullarate carnevalesche. Il nero permea ormai un cinema che confonde i generi, che sposta il comico nell’orrore e il politico nel grottesco, perché comincia a permeare come pulsione tutto l’inconscio sociale, la coralità di un «ordine cannibale» (come lo chiama Gianni Canova). Ma qui il grande apotropaico carnevale esorcistico è totalmente svuotato, azzerato, nullificato, e si rende sfinito e dissipatorio, fino all’inerzia “finale” di La grande bellezza e Reality, dove le maschere protagoniste si annullano in un abbandono all’ibrido, grande brivido del vuoto, e alla sua polifonia, cui si affida in toto il dispositivo del cinema, il suo ghirigoro grottesco, ormai solo macabra decorazione 101
«Ci troviamo davanti a una faccia che assume con versatilità la maschera come secondo volto […]. Il politico si è trasformato cioè nella maschera di se stesso, attraverso un processo molto simile a quello che ha coinvolto molti degli attori della commedia italiana degli anni ’80 e ’90, ma in questo caso […] non si tratta più di far vedere la scollatura tra il volto e la maschera, così come accadeva con la commedia all’italiana, ma di rendere evidente la mancanza di qualsiasi distanza fra un dentro e un fuori, tra un davanti (il proscenio) e un dietro (il camerino)», S. Ghelli, La tradizione grottesca nel cinema italiano, L’orecchio di Van Gogh, Falconara Marittima 2009, pp. 101-103.
282
Lessico del cinema italiano
che coincide con il mondo, dove illusione e reality fanno tutt’uno. La maschera assurge a forma di vita e precipita nel vuoto, nella vertigine psicotica o beante, dove il reale è un buco nero, la bocca di una maschera da cui risuona un riso dissolvente. Filmografia di riferimento Pinocchio (Antamoro, 1911), Carnevalesca (Palermi, 1918), Nerone (Blasetti, 1930), Il cappello a tre punte (Camerini, 1934), Animali pazzi (Bragaglia, 1939), Un’avventura di Salvator Rosa (Blasetti, 1940), Carosello napoletano (Giannini, 1954), Ferdinando I° re di Napoli (Franciolini, 1959), I mostri (Risi, 1963), Il boom (Risi, 1963), Uccellacci e uccellini (Pasolini, 1966), Che cosa sono le nuvole? (Pasolini, 1967, ep. di Capriccio all’italiana), Medea (Pasolini, 1969), Fellini–Satyricon (Fellini, 1969), Don Giovanni (Bene, 1970), Il Casanova di Federico Fellini (Fellini, 1976), Todo modo (Petri, 1976), Il banchetto di Platone (Ferreri, 1988), Il ritorno di Cagliostro (Ciprì e Maresco, 2003), Il caimano (Moretti, 2006), Il divo (Sorrentino, 2008), Vincere (Bellocchio, 2009), Reality (Garrone, 2012), La grande bellezza (Sorrentino, 2013), Belluscone. Una storia siciliana (Maresco, 2014).
INSERTO FOTOGRAFICO
Habitus
Fregoli dietro le quinte (1903) di Leopoldo Fregoli Fregoli dà vita a diversi personaggi, entra in loro fisicamente e poi li dismette al ritmo vertiginoso di vestizioni studiate al dettaglio. In pratica è un primo e folgorante esemplare di uomo camaleonte, ovvero di uomo massa.
Benvenuto reverendo! (1950) di Aldo Fabrizi L’hysteresis dell’habitus del prete “reale” è superata solo nel momento in cui l’impostore incorpora uno dei fattori primari dell’habitus religioso: posporre il soddisfacimento dei propri bisogni a quelli della collettività.
Il cappotto (1952) di Alberto Lattuada Il cappotto di Rascel non è referenzialmente solo un abito, bensì allude direttamente al concetto di habitus. Indossare quel lussuoso capo di vestiario, per il povero impiegato, significa poter accedere ad una diversa posizione sullo scacchiere sociale.
Habemus Papam (2011) di Nanni Moretti Il punto fondamentale è il fatto che, nel momento in cui la Chiesa fa vestire al cardinale l’abito papale, egli dimostra di non essere affatto capace di indossare l’habitus che ne consegue.
Identità
Lo sbaglio di essere vivo (1945) di Carlo L. Bragaglia Un uomo, ritenuto morto, finge di esserlo veramente per poter ritirare il premio assicurativo e potersela spassare con la moglie. Ma questa liquidazione simbolica (essere senza nome, seppur vivente) coincide di fatto con l’impossibilità di esistenza vera.
Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli Queste lacrime sporcano una faccia mai veramente truccata, mai capace di giocare un ruolo sulla scena sociale. E il rimmel che tinge le lacrime e scivola sul volto indica il dissolversi di quel fragile, difficile, illusorio stare al mondo per una ragazza senza mondo.
Professione: reporter (1975) di Michelangelo Antonioni Prendere il posto del morto non significa darsi una seconda chance, ma operare letteralmente il calco di una vita finita, e dunque morire come lui, disteso sul letto di un albergo di quart’ordine, situato nel nulla.
Le quattro volte (2010) di Michelangelo Frammartino Inscritta nella potenza delle immagini e nella mediazione di un rito, qui c’è qualcosa in più: la costituzione di un piano impersonale, che riguarda le intensità, i flussi e i cicli della vita, che rendono pari gli ordini della natura, secondo un processo di metamorfosi continuo.
Lingua
1860 (1934) di Alessandro Blasetti Qui il plurilinguismo corale entra per la prima volta nel linguaggio cinematografico italiano: tutte le principali varietà regionali accompagnano il viaggio del protagonista dalla Sicilia al Piemonte.
L’onorevole Angelina (1947) di Lugi Zampa Così come abdica alla vita politica e alla lotta di classe a favore di quella privata, la sora Angelina, non più onorevole, e con lei Zampa, abdica al parlato-parlato di matrice neorealistica, per rifugiarsi nella rassicurante tradizione dell’italiano filmato.
Catene (1949) di Raffaello Matarazzo In questo film la lingua, perfetto esempio di italiano standard, scolastico e privo di qualsiasi inflessione regionale, omologo a quello di tanta paraletteratura, svela la dissimulazione di questo cinema che intende scacciare le immagini e i suoni del neorealismo per veicolare un’inesistente Italia colta e competitiva.
Scialla! (2011) di Francesco Bruni Il film inscena realisticamente molte varietà del doppio sistema linguistico odierno: dall’italiano standard a quello regionale settentrionale, dal neoromanesco ai gerghi giovanili, dal parlato telefonico all’italiano usato dagli stranieri.
Maschera
Ferdinando Io re di Napoli (1959) di Gianni Franciolini Fingersi ciò che non si è, usare la maschera, il gioco di velature e schermi, con il mondo di equivoci, sostituzioni, scambi di persona, è il modulo dissimulatorio di un meccanismo iniziatico di ingresso nello spazio privilegiato, e ambiguo, del potere.
Il Casanova di Federico Fellini (1976) di Federico Fellini Tutto è qui presente: il rito mortuario e sinistro del carnevale e quello nuziale e di nascita dal fondo marino, il “grande feticcio” del femminile nella testa della polena dagli occhi iridescenti e insieme il “grande pupazzo”.
Il boom (1963) di Vittorio De Sica L’iperbolico mostruoso letteralizza sui corpi lo spirito metamorfico e metaforico della maschera di cui può essere emblema l’“occhio della testa” estratto dal faccione di Sordi.
Il ritorno di Cagliostro (2003) di Daniele Ciprì e Franco Maresco Le due maschere grottesche protagoniste, i fratelli La Marca, nell’epilogo del film si pietrificano in due bianchi simulacri, quasi fossero statue viventi che hanno osato guardare il voltomaschera meduseo in un abisso della visione.
Nemico
Lo squadrone bianco (1936) di Augusto Genina Le truppe coloniali italiane sparano immerse nel polverone sollevato dal vento del deserto, verso qualcosa che non è visibile, non ha quasi concretezza. Certo, si muore nel film di Genina, si viene colpiti dai proiettili, ma gli unici nemici con cui il tenente Ludovici dovrà combattere veramente sono i propri tormenti interiori.
Il terrorista (1963) di Gianfranco De Bosio La Resistenza ha rimesso in gioco la concretezza del nemico, e al tempo stesso ha dispiegato e mostrato le nuove divisioni interne che costituiranno la dinamica della lotta politica nell’Italia repubblicana.
Colpire al cuore (1982) di Gianni Amelio Per tutti i personaggi la realtà diventa una zona d’ombra in cui si consuma un conflitto dove non è più possibile comprendere chi è amico e chi è nemico, dove si collocano i due poli della dialettica del Due.
Il mestiere delle armi (2001) di Ermanno Olmi In un film dove si narra di guerre e di battaglie, di condottieri e mercenari, di un’Italia lacerata dai conflitti, ciò che rimane fuori fuoco, oscura e nebulosa, è proprio l’immagine del nemico.
Opera
La corona di ferro (1941) di Alessandro Blasetti Blasetti lavora con la forma melodrammatica per costruire una temporalità astratta, universalistica, sempre tesa ad esaltare in forma di propaganda il presente fascista.
Avanti a lui tremava tutta Roma (1946) di Carmine Gallone Cinema e opera si fondono dando vita ad un organismo ibrido, i cui segni referenziali sono costantemente intrecciati, e che mira a tradurre la grammatica melodrammatica in una forma neorealista.
Senso (1954) di Luchino Visconti Il film definisce un tratto tipicamente italiano del rapporto tra forme rappresentative e divenire storico: il prevalere di una forma musicale su una narrativa, e il conseguente organizzarsi dell’epopea storica cinematografica in forme melodrammatiche piuttosto che drammatiche
Vincere (2009) di Marco Bellocchio La pazzia di Ida, come quella di Lucia di Lammermoor, riflette un’individualità eroica che se prima non può accedere al ruolo che il suo percorso di vita, in modo violento, le ha assegnato (essere la moglie di Mussolini), poi si ribella alle leggi del mondo, fino a porvisi in totale contrapposizione.
Potere
Camicia nera (1933) di Giovacchino Forzano Il film lavora sull’immagine del duce solo evocandola in absentia: prima del “trionfo” finale, Mussolini non lo si vede mai. Lo si sente, si avverte la sua presenza, si leggono le sue frasi marmoree riportate con enfasi su cartelli e proclami, si sente la sua voce in un discorso, ma il suo corpo è di fatto invisibile.
Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi È il film che meglio di ogni altro rappresenta il punto di vista fortemente critico del cinema italiano sui politici di professione. Lo è perché non si limita al ritratto grottesco di un singolo esponente del potere, ma perché mette in scena un sistema, colto con ricchezza di sfumature in tutti i ruoli e gli snodi che presiedono al suo funzionamento.
Il potere (1972) di Augusto Tretti È come se in questo piccolo film indipendente e maledetto fosse condensato e liofilizzato tutto l’immaginario italico del potere e sul potere, con i suoi due tratti costitutivi che la beffarda allegoria di Tretti lascia intravvedere: la paura e la rappresentazione.
Il divo (2008) di Paolo Sorrentino Non dorme mai. Gira con la scorta per le vie deserte di una Roma fantasma in lunghe e solitarie passeggiate notturne. E passa il tempo a spegnere gli interruttori di casa. I veri divi non sono quelli che godono all’accendersi delle luci, ma quelli che decidono quando le luci si possono spegnere.
D
D
NEMICO
Una stanza di un palazzo cinquecentesco. Ai lati opposti della stanza vi sono due porte. Sulla soglia di entrambe ci sono degli uomini, in piedi, immobili. Alcuni guardano all’interno, altri danno la schiena a ciò che si trova dentro la stanza. All’interno della stanza c’è un letto, ma la visione è in soggettiva, e noi non sappiamo chi stia giacendo su quel letto. Uno degli uomini si volta verso la macchina da presa e racconta la storia di quell’uomo che giace, moribondo, sul letto a baldacchino. Chi racconta è Pietro Aretino e l’uomo di cui sta narrando la storia è Giovanni de’ Medici, condottiero per conto del papa, meglio noto con l’appellativo di Giovanni dalle Bande Nere. È lui l’uomo che si trova disteso sul letto, anche se non ne vediamo ancora le fattezze. Tra gli uomini che guardano verso il letto c’è Federico II Gonzaga, Marchese di Mantova. Giovanni è stato ferito ad una gamba da un colpo di falconetto e in pochi giorni, nonostante l’intervento e l’amputazione della gamba ferita, morirà per via della cancrena. Federico II ne osserva l’agonia, chiedendogli cosa può fare per lui: «Vogliatemi bene, quando sarò morto», risponde Giovanni. E, più avanti, lo stesso condottiero chiederà a Federico Gonzaga di essergli amico. Eppure, la causa della morte di Giovanni è in fondo attribuibile allo stesso marchese, che decide di far passare le truppe dei lanzichenecchi sui suoi territori, al fine di concludere al più presto la guerra. È in questo modo che i soldati mercenari di Georg von Frundsberg sono riusciti a tendere una trappola alle Bande Nere e a ferire mortalmente Giovanni. Strana, eppure lucida, rappresentazione, quella di Ermanno Olmi nella sequenza iniziale di Il mestiere delle armi (2001). Lucida anzitutto perché in un film dove si narra di guerre e di battaglie, di condottieri e mercenari, di un’Italia lacerata dai conflitti, ciò che
284
Lessico del cinema italiano
rimane fuori fuoco, oscura e nebulosa è proprio l’immagine del nemico. Chi è o cosa è il nemico in questo film? E il nemico di chi? Lo stesso Von Frundsberg, il condottiero che guida i lanzichenecchi verso Roma dovrà ritirarsi ad un certo punto, stanco e malato, e l’impresa sarà compiuta dai suoi luogotenenti. Le inquadrature a lui dedicate ritraggono un uomo anziano e stanco, più che un fiero avversario di Giovanni de’ Medici, il cui mestiere, come sottolinea Morando Morandini: «È quello di dare la morte e di riceverla, di uccidere per non farsi uccidere»1. Quello delle armi è un mestiere, appunto, sottoposto alle trasformazioni tecnologiche (le armi da fuoco che causeranno la morte di Giovanni e che cambieranno il senso e la forma della guerra nella modernità) e soprattutto sottoposto alle manovre della politica, come sottolinea il Palafreniere del condottiero: «Di questi tempi è usanza procedere, più di tutto, con intrighi e inganni della politica». La guerra, se mai lo è stata (e di certo così credeva Giovanni), non è più nobile arte, ma meccanismo politico, strumento in cui oltre alla sua assurdità e barbarie, ciò che emerge è l’assenza di uno scopo, di un vero nemico che ne giustifichi le atrocità. Ecco, l’assenza di un nemico. È questo il punto da cui partire per un percorso che riattraversi le forme del cinema italiano proprio seguendo questa figura mancante (o sfumata, fluttuante, mutante come si vedrà), che di fatto caratterizza in modi diversi, e con diverse modalità, anche opposte, la storia del cinema italiano e, di conseguenza, l’immagine stessa di un’identità italiana. Nella dialettica amico/nemico si è voluto spesso costruire un’identità di un popolo, di una nazione, di una comunità. Eppure questa dialettica ha assunto altre forme nelle pratiche dell’immagine che il cinema italiano ha sviluppato nel corso della sua storia. Perché l’immagine, o meglio, la mancanza di un’immagine chiara e definita del nemico caratterizza un pensiero e una forma che il cinema italiano ha costantemente costruito lungo la sua storia; e il compito di questo lavoro è appunto quello di ricostruirne le tracce, indagarne le modalità, interrogarne le differenze. Che cos’è un nemico dal punto di vista di una teoria politica, di una teoria del politico, o ancora, cosa rappresenta dal punto di vista di una teoria delle immagini? Quale dialettica si instaura tra due forme di rappresenta1
M. Morandini, Ermanno Olmi, Il Castoro Cinema, Milano 2009, p. 80.
Nemico Daniele Dottorini
285
zione potenti come quella politica e quella cinematografica? Sono le domande da cui si può e si deve partire per affrontare un nodo centrale di una storia particolare delle immagini come quella del cinema italiano. La costruzione del nemico Una delle più potenti ed incisive riflessioni sul concetto di nemico proviene senz’altro dal pensiero di Carl Schmitt, e in particolare da uno dei testi chiave della filosofia politica contemporanea, Le categorie del politico, come ricorda Derrida: «Che il politico come tale, che l’esser politico del politico sorga, nella sua possibilità, con la figura del nemico, costituisce l’assioma schmittiano nella sua forma più elementare»2. Il nemico è per Schmitt non una categoria ontologica, ma una costruzione necessaria, per quanto essa determini un conflitto reale, non astratto. L’altro, lo straniero, il nemico deve essere esistenzialmente reale perché possa contro di lui scatenarsi un conflitto («I concetti di amico e nemico devono essere presi nel loro significato concreto, esistenziale, non come metafore o simboli»3). Il conflitto è necessario per la costituzione, aggiunge Schmitt, di una identità comunitaria. Ma la dialettica Amico (Freund)/Nemico (Feind) in Schmitt si configura soprattutto come costruzione di un nemico che deve essere “reale” e “pubblico”. Il nemico è l’“altro” nel senso più radicale del termine, da non confondere con il nemico privato, l’avversario, il concorrente: «Il nemico è l’hostis, non l’inimicus in senso ampio […]. La lingua tedesca, come altre, non distingue fra “nemico” privato e politico, cosicché sono possibili, in tal campo, molti fraintendimenti e aberrazioni»4. Per articolare il concetto di nemico, ed evitare quello che secondo la sua prospettiva può essere un fraintendimento e una aberrazione, Schmitt fa riferimento alla lingua latina, alla distinzione tra il nemico pubblico (hostis), e il nemico privato (inimicus). È solo il primo che può essere chiamato 2 3 4
J. Derrida, Politiche dell’amicizia, Raffaello Cortina, Milano 1995, p. 104 [ed. or. Politiques de l’amitié, Éditions Galilée, Paris 1994]. C. Schmitt, Le categorie del “politico”, a cura di G. Miglio, P. Schiera, il Mulino, Bologna 1972, p. 110. Ibidem.
286
Lessico del cinema italiano
“politico” in senso proprio, perché è solo di fronte alla costruzione di un nemico reale e totalmente altro che una dimensione politica collettiva può aver luogo. Ma la dimensione pubblica, reale, esistenziale del nemico in Schmitt non impedisce il fatto che quella del nemico sia un’invenzione, una costruzione appunto che ha profondamente i tratti di un’immagine, o meglio, per dirla più precisamente, si tratta di una dialettica che costruisce un’immagine, una immagine doppia, che per esistere ha bisogno di raddoppiarsi. Si potrebbe pensare allora che questa dialettica sia profondamente cinematografica, e possa essere considerata, in un certo senso, la base stessa del montaggio, in una prospettiva organica come quella sviluppata da Ejzenštejn, di un’immagine che per essere tale deve essere sempre montata, o di Godard, per cui un’immagine è sempre un rapporto, un campocontrocampo, per giungere alle riflessioni di Marie-José Mondzain, sull’immagine come inseguimento e perseguimento5 e alla famosa definizione di Deleuze della grande forma dell’immagine-azione, l’immagine come duale o duello, in quanto «l’azione in se stessa è un duale di forze, una serie di duali: duello […] con l’ambiente, con gli altri, con sé»6. Certo, la storia del cinema è stata attraversata costantemente da questa tensione, dalla necessità di riconoscere che l’immagine non è mai una, ma presuppone sempre un’altra immagine, con cui si scontra, entra in nuovi rapporti, riceve qualcosa, si trasforma. Ma le modalità con cui può essere costruito il rapporto tra due immagini (o tra due elementi all’interno della stessa immagine) varia, ovviamente, si trasforma in continuazione. Schmitt costruisce in fondo una grande teoria del montaggio, fondata sulla radicale contrapposizione dei poli, sulla costruzione di un nemico reale che può e deve essere causa di conflitto e dunque di costruzione del politico come categoria, della comunità come soggetto politico. Quanto esiste (o resiste) di tale forma del montaggio nella cultura italiana? Quella di Schmitt è una teoria fondatrice? È una dialettica che ha di fatto attraversato il Novecento? In parte sì, e per molte ragioni. Ma allo stesso tempo, proprio riattraversando 5 6
M.-J. Mondzain, L’image (à suivre), Bayard, Montoug Cedex 2011. G. Deleuze, L’immagine-movimento, Ubulibri, Milano 1984, p. 168 [ed. or. L’image-mouvement, Les Éditions de Minuit, Paris 1983].
Nemico Daniele Dottorini
287
la storia delle immagini che il cinema ha creato, e confrontandosi con altre riflessioni, il paradigma fondante di Schmitt si rovescia paradossalmente in altro. Nel pensiero di Machiavelli e Leopardi, o nella prospettiva teorica inaugurata da un autore come Giorgio Agamben, la dialettica amico-nemico sfugge – come si vedrà nel proseguo di questo testo – al modello di montaggio proposto dallo studioso tedesco. Si tratta di vedere come si sviluppa questo rovesciamento. Esiste una teoria e una pratica del nemico che ha caratterizzato il secolo, come ricorda Badiou: il Novecento «è il secolo della guerra. […] Il secolo ha decretato che la sua legge era il Due, l’antagonismo, e in questo senso, la fine della Guerra Fredda (l’imperialismo americano contro il campo socialista), che è l’ultima figura totale del Due, è anche la fine del secolo»7. Difficile non essere d’accordo con questa fulminante sintesi. E al tempo stesso, non ritrovarne (forse proprio all’interno) le anomalie, le eccezioni. È in questo senso che il campo teorico si sposta necessariamente, incrociando altre immagini e altre possibilità di montaggio, in cui la dialettica del nemico e dell’antagonismo trovano nuove configurazioni. Anno 1905: Filoteo Alberini, pioniere e artigiano del cinema realizza La presa di Roma, forse il primo film a soggetto del cinema italiano, o forse la prima proiezione pubblica di un film a soggetto, che ne fa un film prototipo del nostro cinema8. Un film che racconta un conflitto fondante per la storia italiana, la presa di Roma il 20 settembre 1870, l’annessione di Roma al Regno d’Italia e la fine dello Stato Pontificio. Momento simbolico e politico, soprattutto momento che si condensa intorno ad un gesto bellico. Dunque il cinema italiano, si potrebbe dire, ha come momento inaugurale proprio l’immagine della guerra, del conflitto. Ma se entriamo all’interno delle forme che Alberini costruisce nei sette quadri che costituiscono il film, qualcosa colpisce. Dei dieci minuti (250 metri) che costituiscono la durata del film, ne rimangono ad oggi 7 8
A. Badiou, Il secolo, Feltrinelli, Milano 2006, p. 76 [ed. or. Le siècle, Éditions de Seuil, Paris 2005]. Sul film, cfr. M. Canosa, H.C. Doyle, M. Vecchietti, 1905. La presa di Roma: alle origini del cinema italiano, ed. Cineteca Bologna, Bologna 2006; A. Bernardini, La presa di Roma, prototipo del cinema italiano, in La meccanica del visibile. Il cinema delle origini in Europa, a cura di A. Costa, Casa Usher, Firenze 1983, pp. 117-127.
288
Lessico del cinema italiano
circa quattro, che condensano l’evento storico. Ciò che salta immediatamente agli occhi è proprio l’assenza di quella dialettica del Due di cui si parlava sopra. O meglio, non tanto l’assenza, ma una sua presenza più sfumata, meno netta. Il nemico è assente. L’unico incontro “reale” è quello tra l’emissario delle truppe dei Savoia e il generale a capo della difesa di Roma. Incontro diplomatico, caratterizzato di fatto da una gestualità esasperata nella lunga inquadratura che riprende una stanza e i due uomini, uno di fronte all’altro, separati dalla scrivania del generale. Il codice della comunicazione è basato anzitutto sul rispetto reciproco (il saluto, la cortesia tra ufficiali), e sull’inevitabilità dello scontro di cui (come si evince dai gesti disperati del generale e dal tranquillo atteggiamento dell’emissario) entrambi conoscono già l’esito. La presa di Roma è un film oleografico, commemorativo, certo. La costruzione delle inquadrature – fino all’inquadratura finale, in cui, come sospesi tra le nuvole stanno i quattro protagonisti della retorica del Risorgimento (Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele e Cavour) e in mezzo l’Italia, dalle sembianze di donna – deve molto all’immaginario retorico del periodo risorgimentale, ma marca, in un certo senso, una decisione netta, una scelta che caratterizzerà (pur se in modi diversi e articolati, si vedrà) una diversa dialettica del “politico”, e una diversa logica della guerra e del nemico. Il nemico è assente, così come lo scontro fisico, “reale” tra i contendenti, così come i morti. Le cannonate dei bersaglieri aprono una sola, grande ferita: la breccia nelle mura di Porta Pia, che verrà attraversata dall’esercito italiano. Gianfranco Miglio, nella presentazione alla raccolta dei saggi di Schmitt, sottolinea con veemenza che «Schmitt ha “scoperto” e dimostrato […], che ovunque c’è “politica” là si incontra l’antitesi “amico-nemico”, e che ogni raggruppamento politico si costituisce sempre a spese di, e contro un’altra porzione dell’umanità»9. Scoperto e dimostrato, come appunto un teorema matematico (l’assioma di cui parlava Derrida); l’affermazione è forte e proprio per questo può costituire un punto di partenza per questo lavoro, come si è detto. Proprio per mostrare, come si diceva sopra, lo scarto, la differenza, l’anomalia di un pensiero e di una forma che hanno di
9
G. Miglio, Presentazione, in C. Schmitt, Le categorie del “politico”, cit., p. 13.
Nemico Daniele Dottorini
289
fatto rovesciato o stravolto la teoria del montaggio schmittiana (la dialettica del nemico). Se la costruzione dell’immagine (a cui corrispondono corpi “reali”) di un nemico è il criterio di distinzione del concetto di “politico”, e se l’alterità (l’essere esterno del nemico stesso, straniero e nemico) ne è condizione necessaria, cosa accade all’interno di una pratica politica e di costruzione dell’immagine dove l’alterità è anzitutto interna, dove la divisione interna prevale sulla contrapposizione esterna? È ciò che si domanda ad esempio Umberto Eco in un saggio dal titolo emblematico, Costruire il nemico: «Gli italiani non hanno nemici esterni, e in ogni caso non sono mai in grado di mettersi d’accordo per stabilire quali siano perché sono continuamente in guerra tra loro»10. La profonda relazione tra costruzione del nemico, possibilità reale della guerra e costruzione di un’identità collettiva, relazione alla base del concetto di “politico” in Schmitt, è presente naturalmente lungo tutta la storia della riflessione teorica politica. Machiavelli torna più volte sul rapporto tra sovranità e guerra sia in Il Principe che nei Discorsi sopra la Prima deca di Tito Livio: l’arte della guerra «è la sola arte che spetta a chi comanda»11, ricorda il segretario fiorentino, ma è proprio nell’identificazione del nemico che la riflessione di Machiavelli sposta gli elementi in gioco. Nella dialettica amico/nemico, i ruoli sono fluttuanti e soprattutto sono in primo luogo interni all’organizzazione delle dinamiche del consolidamento del potere da parte del principe. I nemici sono o possono essere anzitutto “interni”, il popolo e i potenti della città: Preterea, del popolo inimico uno principe non si può mai assicurare, per essere troppi; de’ grandi si può assicurare, per essere pochi. El peggio che possa aspettare uno principe dal popolo inimico, è lo essere abbandonato da lui; ma da’ grandi, inimici, non solo debbe temere di essere abbandonato, ma etiam che loro li venghino contro12.
10 11 12
U. Eco, Costruire il nemico e altri saggi occasionali, Bompiani, Milano 2011, p. 10. N. Machiavelli, Il Principe, in Id., Tutte le opere, Sansoni, Firenze 1971, p. 278. Ivi, p. 271.
290
Lessico del cinema italiano
La dialettica è anzitutto interna e soprattutto mobilissima, perché è l’identificazione stessa del nemico a cambiare continuamente, in funzione anche della dinamica stessa del potere, a partire dall’immagine stessa del principe, che può essere, al tempo stesso, amico e nemico: «È ancora stimato uno principe, quando elli è vero amico e vero inimico, cioè quando senza alcuno respetto si scuote in favore di alcuno contro ad un altro»13. Nella costruzione del “politico”, il nemico, la sua identificazione è fondamentale anche per Machiavelli, ma secondo una logica diversa. Tutti (a partire dal principe) possono essere amici e nemici, in momenti diversi e in condizioni diverse. Il nemico in Machiavelli non può essere mai solo ed esclusivamente l’altro da sé, lo hostis, così come lo intende Schmitt, perché, come nella stanza di Il mestiere delle armi di Olmi, tutti possono essere, come si è detto, amici e nemici al tempo stesso. Proprio il termine su cui Schmitt insiste (hostis) è al centro anche delle riflessioni di un autore fondamentale come Giacomo Leopardi. Il poeta di Recanati si sofferma per molte pagine, in quello straordinario, modernissimo e complesso testo che è lo Zibaldone di pensieri, sulla necessità del nemico, sulla differenza tra la forma antica e quella moderna della guerra e, anzitutto, sull’ambiguità stessa del termine hostis, che, ricorda Leopardi, era anticamente il termine che indicava lo straniero e l’ospite. Questa ambiguità (o complessità) semantica accompagna la storia del termine, fino a spostare l’ago della bilancia verso la connotazione negativa del termine. La parola latina hostis «disusata ai tempi di Cicerone, [...] avrà avuto anche il significato di albergatore, come oste oggidì, e come hospes ed ospite in latino ed in italiano hanno lo stesso doppio senso di albergatore e albergato. Straniero ossia ospite si prendeva per nemico anche nell’antica lingua celtica [...]. E così appoco appoco si sarà cambiato il significato di hostis, cioè considerando lo straniero come nemico»14. Leopardi, come Schmitt, fonda sulla necessità del conflitto (e della dicotomia amico/nemico) l’istaurazione del “politico”, ma rovescia, di fatto, il presupposto schmittiano: per il filosofo e giurista tedesco, la dialettica amico/nemico fonda un regolamento 13 14
Ivi, p. 291. G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, Garzanti, Milano 1991, p. 196.
Nemico Daniele Dottorini
291
razionale, una logica della contrapposizione tra gli Stati che permette la politica stessa; per Leopardi invece, la modernità stessa, introducendo la forma-nazione, il regolamento tra gli Stati, annichilisce l’antica e radicale contrapposizione tra amico e nemico, che Leopardi attribuisce ad una sorta di antichità mitica, ad una classicità che non esiste più nel XIX secolo: «Le guerre moderne sono certo meno accanite delle antiche, e la vittoria meno terribile e dannosa al vinto […]. Chi vince non vince quel tal popolo, ma quel tal governo. I soli governi sono nemici tra loro»15. Se la guerra moderna annulla la radicalità del nemico, lo fa proprio in nome di quella razionalità che invece fonda la logica della guerra secondo Schmitt. Dunque, prosegue Leopardi, l’hostis non presenta più quella identificazione totale tra straniero e nemico (che ne fonda la radicalità), ma è sfumato, quasi indifferente: «Lo straniero, al contrario ci è per lo meno indifferente, e spesso più sfumato dei conoscenti, perché la stima è fomentata dalla lontananza, e dall’ignoranza della realtà, e dallo immaginario che ne deriva»16. Nella riflessione di Leopardi, il concetto di nemico slitta lentamente ma inesorabilmente dal radicalmente altro (l’hostis, lo straniero) al prossimo, al vicino, al conoscente (l’inimicus privato): «Anticamente combatteva il nemico contro il nemico, oggi l’indifferente coll’indifferente, forse anche coll’amico, il compagno, il parente»17. Per quanto apparentemente simili, le riflessioni di Schmitt e Leopardi inaugurano in realtà due visioni del nemico (e del suo rapporto con il “politico”) antitetiche, contrapposte. Ed è a partire da questa dicotomia, da questa contrapposizione che il discorso relativo alle forme e alle immagini del cinema italiano deve svilupparsi. Cosa significa dunque, a ben vedere questa contrapposizione? Partendo da Schmitt, il discorso si mostra sempre più complesso. Il suo paradigma si mostra incapace18 di portare fino in fondo 15 16 17 18
Ivi, p. 642. Ivi, p. 645. Ivi, p. 644. Sul confronto tra Schmitt e Machiavelli, cfr. anche L. Baldacci, Leopardi: estetica della guerra, in Leopardi e l’età romantica, a cura di M.A. Rigoni, Marsilio, Venezia 1999. Per quanto in Teoria del partigiano, Adelphi, Milano 2005 [ed. or. Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, Duncker und Humboldt, Berlin 1963], lo stesso Schmitt apra costitutivamente il suo
292
Lessico del cinema italiano
una riflessione sul paradigma che Machiavelli e Leopardi individuano chiaramente: quello della guerra civile come forma fondante del politico. In un libro prezioso19, Giorgio Agamben pone con forza un’ipotesi che, come emergerà nello sviluppo di questo testo, si mostra come il vero scarto rispetto al punto di partenza schmittiano: se una teoria della guerra è parte integrante della tradizione di pensiero occidentale, una teoria della guerra civile è invece mancante; ed è a partire da questa necessità che una nuova immagine della dialettica del Due può formarsi. La stasis, la guerra civile nega in un certo senso, o per meglio dire complica la dialettica amico/nemico, perché essa è stasis emphylos, conflitto proprio del phylon, della parentela di sangue. E proprio per questo è parte integrante della politica, spezza l’unità e l’isolamento della famiglia per sfociare nella città, nella polis, e diventare così il passaggio fondamentale alla costruzione di una politica comune: «Ciò che è in gioco nella relazione fra oikos e polis è la costituzione di una soglia di indifferenza in cui il politico e l’impolitico, il fuori e il dentro coincidono. Dobbiamo cioè concepire la politica come un campo di forze i cui estremi sono l’oikos e la polis: tra di essi la guerra civile segna la soglia transitando attraverso la quale l’impolitico si politicizza e il politico si “economizza”»20. Si tratta allora di partire da tutto questo, riprenderlo e ripensarlo attraverso le immagini del Due che il cinema italiano non ha mai smesso di produrre per trasformarle, mutarle, mostrarne l’intima ambivalenza o contraddizione. Dunque il cinema. Il Novecento è stato il secolo della guerra, ricordava Badiou, il “secolo breve”, secondo la famosa e felice formula di Eric Hobsbawm, e il secolo del cinema. Come si ricordava sopra, il cinema è stato spesso accostato alla guerra, associato al conflitto, quasi quest’ultimo fosse un modello per una certa concezione della messa in scena
19 20
discorso al conflitto di chi si pone fuori dall’inimicizia, dalla dialettica del due, per entrare in quella della inimicizia assoluta, che scardina la logica della guerra, non è tra le pagine del filosofo tedesco che si ritrova una teoria della guerra civile come paradigma politico. G. Agamben, Stasis. La guerra civile come paradigma politico. Homo sacer, II, 2, Bollati Boringhieri, Torino 2015. Ivi, p. 30.
Nemico Daniele Dottorini
293
cinematografica21; di fatto, l’atto inaugurale del secolo, l’evento che ne ha segnato le sorti e le immagini – la Prima guerra mondiale – riconfigura e orienta la storia delle immagini22 a partire proprio da quella particolare figura del Due che è la dialettica amico/nemico. La negazione del Due: il fuori campo, il montaggio del reale Nei primi anni del muto, in Italia, più che in altri paesi, come ricorda Gian Piero Brunetta: «Il cinema, più che chiave d’accesso alla modernità, è mezzo magico di ideale unificazione nazionale e di locomozione per viaggi di ogni tipo»23. La costruzione di una identità nazionale passa anche se non soprattutto attraverso il cinema, attraverso le forme di un’immagine che attinge a piene mani da racconti, iconografie, miti fondativi e oleografici. Lo stesso Alberini costruisce le sue inquadrature attingendo dai dipinti di Michele Cammarano, pittore realista specializzato in quadri di argomento militare. Nei primi anni del Novecento, l’immagine cinematografica di una nazione (la cui identità è in fieri) passa anche attraverso un cinema che riprende il periodo risorgimentale, attento però a costruirne una immagine in cui il conflitto non attraversa pienamente la figura del Due. Nei film dedicati a due figure mitiche del risorgimento, Garibaldi (1907) e Anita Garibaldi (1910), Mario Caserini mostra i due personaggi mentre attraversano bagni di folla, mentre bivaccano con i compagni, mentre incontrano altri personaggi storici, mentre arringano i combattenti o il popolo e, naturalmente, mentre combattono. Ma le inquadrature delle battaglie colpiscono non solo per l’assenza di un controcampo (l’inquadratura rimane fissa sui personaggi che sparano verso qualcosa che è fuori campo), ma in ogni caso, per l’as21 22
23
Cfr. J.-L. Leutrat, Il cinema in prospettiva: una storia, Le Mani, Recco (Ge) 1997, p. 53 [ed. or. Le cinéma en perspective: une histoire, Nathan, Paris 1992]. La guerra segna la fine di un cinema mondiale inteso come scambio continuo tra nazioni e costituisce il vero inizio di un cinema nazionale: cfr. H. Langlois, Trois cent sans de cinéma, Cahiers du Cinéma/Cinémathèque française, Paris 1986, p. 28 sgg. G.P. Brunetta, Cinema muto italiano, in Storia del cinema mondiale. L’Europa. Le cinematografie nazionali, vol. III, tomo I, a cura di Id., Einaudi, Torino 2000, p. 40.
294
Lessico del cinema italiano
senza di corpi che siano quelli del nemico. La rappresentazione del nemico è sottratta allo sguardo, quasi non necessaria. Inutile, perché la sfilata dei corpi gloriosi che caratterizza queste «micce di spirito patriottico»24, come le chiama Brunetta, si pongono già come corpi sacralizzati, glorificati appunto dalla storia oleografica che rilegge il Risorgimento da una prospettiva laica e ufficiale. Il nemico è assente perché non c’è più, perché austriaci, francesi, borboni sono ormai scomparsi all’orizzonte di una nazione che non ha nemici. La loro presenza non è quindi necessaria. Il nemico è inattuale, sospeso e immerso in una storia che, proprio perché agiografica, non ne sente il bisogno. Ma cosa accade quando il nemico è attuale, perché attuale è la guerra? Cosa accade cioè quando il cinema e le sue immagini fanno i conti con la realtà della Grande Guerra? Il cinema, ricorda Kevin Brownlow, diventa maggiorenne proprio con la Prima guerra mondiale25, anni in cui la produzione cinematografica mondiale cambia radicalmente e in cui si assiste ad un mutato sistema di alleanze tra stati maggiori dell’esercito e industria cinematografica. Il pubblico aumenta rapidamente e sensibilmente negli anni della guerra in tutto il mondo. Questo perché il cinema è uno spettacolo poco costoso che distrae dalle angosce? Forse, o forse perché il cinema offriva, perlomeno nella sua dimensione documentaria, qualcosa che la stampa ufficiale non poteva dare, come ricorda Sorlin: Per la stragrande maggioranza dei civili, per il “fronte interno”, la Prima guerra mondiale fu una realtà dolorosa ma lontana, impalpabile, della quale la stampa offriva un’idea imprecisa, fatta di incomprensibili bollettini delle operazioni. […] Cinegiornali e documentari introdussero una sensazione diversa, l’impressione di una qualche franchezza e di un vero rispetto tanto per i soldati quanto per il pubblico. […] Il dato importante è che i contemporanei ebbero la convinzione di vedere “la cosa reale”, la lotta sul fronte “così com’era”26.
24 25 26
Ivi, p. 39. Cfr. K. Brownlow, The War, The West and the Wilderness, Random House, New York 1979. P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Marsilio, Venezia 2013, p. 32.
Nemico Daniele Dottorini
295
Soprattutto, ciò che inizia a mutare rapidamente nell’esperienza dello spettatore è la consapevolezza della potenza del cinema di articolare il visibile, di offrire nuove prospettive di visione che ri-orientano lo sguardo, riconfigurano lo spazio del reale secondo strategie retoriche nuove o permettono di vedere altrimenti un reale solo immaginato: La Prima guerra mondiale consente di osservare un identico oggetto con una visione plurima e vederlo raccontato in base a strategie affabulatorie ora rispettose di una tradizione anteriore, ora consapevoli della necessità di inventare nuovi moduli e ridiscutere tutti i processi comunicativi, ora simili ora difformi. Difformi perché queste strategie discorsive e comunicative risultano in pochi punti assimilabili tra loro in quanto dipendenti da modelli iconografici e sistemi retorici e culturali molto differenti. […] Grazie allo sguardo di tipo nuovo, viene modificata anche la logistica dell’immaginazione dello spettatore. La guerra diventa la prima e la più diffusa esperienza visiva comune27.
Il cinema dunque permette sì in quegli anni una nuova esperienza visiva, ma pur sempre all’interno di strategie retoriche e rappresentative che variano di paese in paese. «L’esperienza visiva comune» presenta delle varianti dunque, varianti che nel caso del cinema italiano si concentrano spesso proprio sulla particolare configurazione di una logica del Due, di una dialettica amico/nemico. La parola stessa, “nemico”, circola ossessivamente nel panorama mediatico dell’epoca, ricorre in più di un film28. Una presenza ossessiva, quasi a mostrare la necessità di dare corpo e immagine all’altro, allo straniero che costituisce, di nuovo, la concretizzazione dell’hostis come nemico radicalmente “altro” da sé. Concretizzazione “reale” che il cinema può offrire, forse. L’immagine del nemico e della guerra può finalmente diventare tangibile, visibile. Grazie al cinema, si legge in “L’arte muta”, settimanale di cinema napoletano, il 15 luglio 1917, ci si può avvicinare al fronte 27 28
G.P. Brunetta, Cinema e Prima guerra mondiale, in Storia del cinema mondiale. L’Europa. Miti, luoghi, divi, vol. I, tomo I, a cura di Id., Einaudi, Torino 1999, pp. 259-260. Solo per ricordare qualche titolo, basti pensare a film come Il nemico occulto (1916) di Edoardo Bencivenga, Il nemico (1915) di Giuseppe De Liguoro e L’occhio del nemico (1919) di Eleuterio Rodolfi.
296
Lessico del cinema italiano
e «vedere la strage che giorno per giorno si compie […], vedere gli obici che polverizzano, le mitragliatrici che mietono, le bombe che squarciano, le fucilerie che atterrano il rigoglio della vita»29. Il secolo è animato dalla passione del reale, come dice Alain Badiou, e la guerra ne costituisce l’apoteosi. La passione del reale, il bisogno quasi ossessivo di reale che caratterizza il XX secolo, è accompagnato necessariamente da una operazione parallela e complementare, quella del montaggio della finzione: «La finzione è il vero principio di collocazione del reale, ciò che localizza e rende visibili i brutali effetti della contingenza del reale. […] C’è una funzione di misconoscenza la quale fa sì che la brutalità del reale operi solo all’interno di finzioni, montaggi e maschere. Il secolo dispiega il tema dell’efficacia della misconoscenza, mentre il positivismo del XIX secolo affermava il potere della conoscenza»30. Tanto più forte si sviluppa la “passione del reale”, per la sua brutalità («la strage […] gli obici che polverizzano […] squarciano […] atterriscono»), tanto più le forme della finzione lo organizzano, lo costruiscono, lo rendono visibile. Nel cinema italiano si configurano allora diverse modalità di quello che, sulle tracce di Badiou, abbiamo chiamato montaggio della finzione. Modalità che, non a caso, operano un continuo spostamento, una continua riconfigurazione della terribile oscenità del reale. Si può dire allora che sono tre le modalità che si presentano con più forza all’interno del cinema italiano. La prima modalità è quella che possiamo chiamare della privatizzazione dello sguardo. Anzitutto, nei film italiani realizzati durante la guerra, il movimento dello sguardo sembra ripiegarsi su se stesso, attingere a piene mani dal repertorio della narrativa popolare ottocentesca, costruire narrazioni in cui ciò che è pubblico, esterno (la guerra di massa), non può essere reso visibile se non attraverso il privato (gli affetti, la famiglia, il dolore, la sofferenza, il sacrificio, gli stenti). È un’immagine riflessa quella della guerra cinematografica, deviata e resa prismatica dallo sguardo di personaggi intimi e dolorosi, che sempre di più allontanano dalla concretezza dello scontro reale. In Sempre nel cor la Patria! (1915) di Carmine Gallone, uno dei primi film che mettono in scena il 29 30
Citato in P. Sorlin, Ombre passeggere, cit., p. 34. A. Badiou, Il secolo, cit., pp. 64-65.
Nemico Daniele Dottorini
297
conflitto, una donna italiana, sposata ad un austriaco, si sacrifica per salvare dei soldati italiani da un’imboscata tesa dagli austriaci comandati proprio dal marito. La figura femminile si sostituisce a quella maschile e al combattimento, allo scontro sanguinario si sostituisce l’estremo sacrificio di sé. Lo sguardo si riflette allora al femminile (alla donna che è madre, compagna, figlia) più che al maschile; il nemico perde qualsiasi connotato reale e diventa solo una sorta di orizzonte regolativo, presupposto del gesto che viene mostrato in primo piano (il dolore, l’abnegazione, il sacrificio). Nel cinema italiano, soprattutto nella prima fase del conflitto, la guerra: «Non differisce troppo da quelle del Risorgimento. Le immagini paiono voler animare l’oleografia tardo-ottocentesca […], o tradurre lo spirito dei racconti deamicisiani»31. La guerra di fatto è tenuta fuori campo, il nemico rimane invisibile, esso non può costituire, in senso schmittiano, il criterio di costituzione della sfera politica, perché le forme della rappresentazione convergono tutte verso un’interiorità dei rapporti umani che privilegiano: «Una volontà di riduzione delle misure della guerra a una scala molto modesta, localistica, cercando di sottolineare i legami tra il soldato, la famiglia, la casa e identificando, spesso per metonimia, il focolare domestico con l’idea di patria»32. La seconda modalità è ciò che appare come il nemico sognato. In questa forma, il montaggio della finzione avviene attraverso una virata decisa di alcuni sguardi filmici verso una dimensione immaginaria. L’oscenità del reale si trasforma in una dimensione onirica, che può oscillare, tendere al fiabesco o al registro comico. È il caso di La guerra e il sogno di Momi (1917), di Segundo de Chomón (operatore di Giovanni Pastrone), film straordinario in quanto a capacita di slittamento dello sguardo e di costruzione di una finzione che evoca e maschera insieme il reale33. In una famiglia borghese, durante la guerra, arriva una lettera dal fronte scritta da un soldato. A leggerla ci sono il padre, la moglie e il figlio Momi. Ciò che la lettera racconta diventa immagine e lo spettatore assiste alla storia eroica di un soldato che divide il suo rancio con un orfano affamato e asse31 32 33
G.P. Brunetta, Cinema e Prima guerra mondiale, cit., pp. 263-264. Ivi, p. 264. Sul film, cfr. G. Alonge, Giocando con i soldatini. “La guerra e il sogno di Momi” tra propaganda e mercato, in “Il Nuovo Spettatore”, n. 1 (1997), pp. 167-178.
298
Lessico del cinema italiano
dia insieme ai suoi commilitoni una fattoria dove i nemici (perlopiù ombre invisibili) tengono prigionieri alcuni civili. Il nemico sfuma nell’invisibilità e in primo piano, evocati dalle parole del soldato lette dal padre di fronte al camino, emergono i volti di un adulto e di un ragazzo, direttamente fuoriusciti dalla letteratura popolare ottocentesca, tracce di un secolo scomparso. La notte stessa, Momi, che ha ascoltato il racconto del padre attraverso la lettera, sogna. Sogna la guerra che non può vedere e non conosce, e la sogna come una battaglia tra giocattoli34, mostrando di fatto un’operazione di mascheramento straordinaria, quasi paradigmatica: il reale terribile della guerra si dà come maschera nel senso quasi letterale del termine. Il nemico non può essere che sognato, mascherato. Il doppio sogno che costituisce la struttura del film è anche caratterizzato da uno slittamento temporale. Il modello narrativo di riferimento ottocentesco della prima parte si trasforma in una sorta di meccanica rappresentazione della modernità tecnologica della guerra nella seconda parte. I giocattoli si sfidano e si combattono con cannoni, mitragliatrici, bombe, aeroplani: «Ne La guerra e il sogno di Momi si può mostrare tutto, perché a morire sono solo dei fantocci. […] La tecnica dell’animazione […] dà conto della natura tecnologica della Grande Guerra e della riduzione dell’uomo ad automa»35. Ma un’operazione ulteriore di mascheramento, di costruzione della finzione del reale può essere rappresentata da un film particolarissimo come Maciste alpino (1916) di Luigi Romano Borgnetto e Luigi Maggi, in cui l’eroe del film di Pastrone, interpretato dallo stesso attore, Bartolomeo Pagano, letteralmente arriva dal mondo dell’immaginario cinematografico per arruolarsi e partecipare al conflitto. Il registro del film, visionario ed eccedente, immerge la guerra e il rapporto con il nemico in una girandola farsesca e soprattutto trasforma la dialettica amico/nemico in una tenzone individuale, la lotta tra Maciste e il soldato austriaco Fritz. La morte, il sangue, le menomazioni, l’orrore della guerra sono banditi. Gli scontri tra i due individui umani e al di là dell’umano al tempo stesso si risolvono in pugni, sberle e calci, in una narrazione che sembra anestetizzare ogni costruzione estrema del nemico, ogni radicalità. L’inimicus non si trasforma in hostis. 34 35
È tra l’altro una delle sequenze più affascinanti del film, perché la guerra tra i giocattoli è realizzata con la tecnica dell’animazione a passo uno. G. Alonge, Giocando con i soldatini, cit., p. 171.
Nemico Daniele Dottorini
299
Infine, la terza modalità che attraversa il cinema bellico italiano – e che si può sussumere sotto la formula la traccia dell’umano – si sviluppa soprattutto a partire dal 1916, a partire cioè da quella fase di immobilità a cui la guerra va incontro nella fase centrale del suo sviluppo. È in questo momento che, dopo moltissimi film a soggetto, cominciano ad emergere sempre di più opere a carattere documentario (seppure con una precisa e guidata costruzione narrativa). I film di Luca Comerio sono da questo punto di vista esemplari. Le riprese di Comerio, che documentano momenti di vita quotidiana, di attività giornaliera dei soldati italiani al fronte e sulle retrovie, mostrano una dimensione assolutamente umana del conflitto, proprio perché è il conflitto stesso ad essere assente. In Tra le nevi e i ghiacci del Tonale (1916), tutta la narrazione si concentra su una serie di spaccati di vita del fronte, dal trasporto dei rifornimenti alla vita negli accampamenti. I corpi sono ripresi mentre compiono gesti ripetuti, mentre preparano il rancio o giocano a carte, perlustrano le vette alpine o trasportano merci e munizioni. Comerio riprende anche la preparazione di un obice mentre viene caricato e mentre spara, ma il colpo finisce fuori campo, in uno spazio non visibile allo sguardo, verso quel punto zero occupato da un nemico senza volto né materialità. Il vero scarto geniale del film è situato nel momento in cui un cartello ci avverte che la posizione attuale degli alpini era fino a poco tempo prima occupata dagli austriaci e ciò che stiamo vedendo – la macchina da presa mostra una serie di lunghe e lente panoramiche del paesaggio alpino della Val Camonica – è ciò che gli austriaci stessi vedevano prima della riconquista italiana della vetta. Lo scarto è straordinario, come se proprio di fronte all’assenza dell’altro, del nemico, invisibile, infilmabile, l’unico gesto possibile sia quello di mimarne lo sguardo, replicandolo e, letteralmente sostituendosi ad esso. Ciò che emerge da questo, come da altri film di Comerio o dei cineoperatori di guerra di questo periodo è sì, come ricordava Sorlin, la sensazione di assistere a qualcosa di vero, ad una traccia di vita colta in flagrante; ma, al tempo stesso, emerge anche una sorta – ancora una volta – di negazione della logica della guerra e della presenza reale del nemico (per quanto più volte evocato dai cartelli carichi di retorica patriottica). La forma del Due è ancora una volta negata. Lo sguardo che si rifugia nel privato, o nella fantasmagoria, o in un reale che lavora per sottrazione o sovrapposizione. Sono queste le
300
Lessico del cinema italiano
modalità, le dinamiche di un’immagine che, nel cinema italiano, nel momento in cui diventa “maggiorenne”, negano con forza la dialettica del Due. Ma una tale frattura, nelle e delle immagini, dovrà fare i conti con un ulteriore scarto storico, vale a dire con l’avvento del fascismo, con il confronto con un’altra (nuova?) dialettica del nemico. Fantasmi e visioni. La costruzione immaginaria del nemico Scritto nel 1914, nella temperie della guerra imminente e debitore dei dibattiti accesi tra neutralisti e interventisti, Filosofia della guerra (poi raccolto in Guerra e fede, che riunisce gli scritti politico-filosofici del periodo della guerra) di Giovanni Gentile36 è un testo centrale per comprendere una teoria e una pratica della guerra che attraverserà poi il fascismo e ne condizionerà le immagini e le forme. Gentile individua tre concetti di “guerra”: quello metafisico, quello empirico e quello storico. Se il secondo, quello empirico, che riguarda la guerra come condizione umana è «privo di ragion d’essere», perché astratto, è il rapporto tra il primo e il terzo ad interessare Gentile: il concetto metafisico di guerra, «quell’unità di contrari in cui consiste il ritmo dello spirito, quando il nemico è in ciascuno di noi e la lotta è inevitabile – e quello storico, la guerra in atto che realizza il principio metafisico dell’unità dei contrari»37. La guerra come evento storico è la realizzazione necessaria, reale di un momento della storia dello spirito, dello sviluppo della stessa realtà universale. Ed è qui che si colloca con chiarezza lo scarto di Gentile rispetto ad una teoria del nemico necessario. Se la guerra come realizzazione del movimento universale della realtà è necessaria, necessario è anche il nemico, ma nella consapevolezza che occorre amarlo e riconoscerlo come un fratello, come colui che è uguale a noi: «Il nostro essere non si chiude nella nostra patria egoisticamente intesa» e «ogni vita recisa sul campo di battaglia è un anello infranto nell’aurea catena dello spirito […]. È questo il vero tesoro che la guerra sperpera»38. Non c’è odio verso il nemico in Gentile, anzi, c’è il riconoscimento che l’altro non è 36 37 38
G. Gentile, Guerra e fede, Riccardo Ricciardi Editore, Napoli 1919. G. Turi, Giovanni Gentile: una biografia, Giunti, Firenze 1995, p. 223. G. Gentile, Guerra e fede, cit., p. 22, 24.
Nemico Daniele Dottorini
301
che un fratello. La necessità della guerra (che è storica e metafisica al tempo stesso) sta nella capacità di ricompattare una nazione, attraverso pratiche di purificazione, in un certo senso, di espulsione dei corpi estranei, di “rinnovamento” e “restaurazione” di uno Stato che non è ancora nazione, secondo le parole di Gentile, e sulla necessità quindi di combattere ed espellere il nemico più potente: «Il nemico interno o il nemico che è in noi»39. La dimensione interna, se non interiore, del nemico si riflette in modo particolare nelle pagine di Gramsci. Durante la sua attività di giornalista politico di “Ordine Nuovo”, Gramsci più volte utilizza il vocabolario bellico per analizzare la lotta politica, in un continuo rovesciamento di prospettive. In un articolo del 31 gennaio 1921, dal titolo La guerra è la guerra, che analizza lo sviluppo dello squadrismo fascista, l’incipit è eloquente: «Comprendere e saper valutare con esattezza il nemico, significa possedere già una condizione necessaria per la vittoria. Comprendere e saper valutare le proprie forze e la loro posizione nel campo di lotta, significa possedere un’altra importantissima condizione per la vittoria»40. Quella che sembra una massima dell’arte militare, diventa in Gramsci l’apertura ad una continua sovrimpressione linguistica, in cui la dimensione bellica si sposta dai campi di battaglia alla situazione conflittuale di Torino e allo scontro tra le forze operaie e le squadre fasciste. Lo slittamento terminologico è in Gramsci uno spostamento concettuale. Il ricorso alla terminologia bellica non serve per rendere più colorato o epico il discorso, ma ha la funzione di spostare l’attenzione sulla dimensione del conflitto come dimensione peculiare del politico. Nei Quaderni del carcere, Gramsci ritorna spesso su questo aspetto, evidenziando anche la differenza tra le due dimensioni: Nella guerra militare, raggiunto il fine strategico, distruzione dell’esercito nemico e occupazione del suo territorio, si ha la pace. […] La lotta politica è enormemente più complessa: in un certo senso, può essere paragonata alle guerre coloniali o alle vecchie guerre di conquista, quando cioè l’esercito vittorioso occupa o si propone di occupare stabilmente tutto o una parte del territorio conquistato41. 39 40 41
G. Turi, Giovanni Gentile: una biografia, cit., p. 241. A. Gramsci, La guerra è la guerra, in “Ordine Nuovo”, 31 gennaio 1921. Id., Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, p. 122 (Quaderno 1).
302
Lessico del cinema italiano
Gramsci, negli anni venti e trenta, come Gentile nel 1914 e 1919, pensa il rapporto guerra-politica nei termini di un conflitto interno. Pur essendo profondamente diversi nell’impostazione teoricopolitica e nella configurazione dei termini del rapporto, entrambi sono consapevoli della profonda divisione interna che attraversa e lacera la situazione italiana. Per i due autori, il riconoscimento dell’esistenza del nemico come parte integrante della società assume un ruolo fondamentale. Ma lo scarto fondamentale, di idee, prima ancora che ideologico, si riflette profondamente nella duplice visione della guerra che separa profondamente i due autori; se la guerra per Gentile è e deve essere parte di un movimento metafisico, essa è necessaria affinché un processo di unificazione e di purificazione, di bonifica, come vedremo, possa avere luogo. Nella riflessione gramsciana, guerra è il movimento del conflitto reale, della lotta di classe che attraversa le società, al di fuori e al di là di ogni distinzione nazionale. È questa dicotomia che attraverserà il dopoguerra e che condizionerà, in una direzione ben precisa, la storia delle immagini del fascismo. Le due riflessioni segnano, in un certo senso, un passaggio fondamentale, che caratterizza – e influenzerà anche in seguito – la trasformazione del nemico, della sua immagine come della sua funzione di operatore concettuale in figura fantasmatica, fluttuante, che il cinema raccoglie e dissemina, produce e riflette a volte in modo ossessivo e visionario. Immagini da adorare Un viaggio particolare. Immagini tremolanti, rituali. Un feretro che viene portato da un luogo all’altro, in un treno, accompagnato da parate, ufficiali in alta uniforme, ali di folla in rispettoso silenzio. Sono le immagini (di autore anonimo) di Gloria – Apoteosi del milite ignoto (1921), che documentano il trasporto del feretro di un soldato non identificato. Le sue spoglie saranno portate a Roma, e il suo corpo sarà sepolto ed esposto (invisibile) sull’Altare della Patria. Film-documento, realizzato per permettere la visione di un viaggio simbolico a chiunque, Gloria è anche un film che segna un passaggio, che chiude simbolicamente la dialettica impossibile del nemico nella storia delle immagini della Prima guerra mondia-
Nemico Daniele Dottorini
303
le. L’immagine è quella di un viaggio inteso come trasfigurazione. Il corpo di un uomo viene omaggiato, ricoperto, nascosto tanto quanto esposto. Il corpo (non più) vivente diventa corpo glorioso. La fine della guerra determina un nuovo regime delle immagini, che è anzitutto caratterizzato dalla resa fantasmatica dei corpi, da una sorta di trasformazione dello statuto stesso delle immagini. Il realismo degli operatori di guerra scompare, perlomeno momentaneamente, e l’immagine inizia a mostrarsi come immagine visionaria, desiderante. Il corpo del soldato morto non compare in Gloria - Apoteosi del milite ignoto, proprio perché l’immagine della sua “apoteosi” ricopre l’eccedenza di reale che esso rappresenta. La storia passata, appena passata, diventa celebrazione che annulla la tragedia della guerra, soprattutto, ne annulla artificialmente la dimensione reale, della morte e del conflitto. Il nemico scompare dall’orizzonte, perlomeno, come si è detto, scompare il nemico esterno. La conflittualità si rileva altrove, al proprio interno. Il dopoguerra si caratterizza, per quanto riguarda la storia delle immagini, anzitutto come ripensamento, rimessa in scena del proprio passato. Si tratta di un’operazione di riscrittura della storia, di annullamento dei corpi o della loro trasformazione in corpi gloriosi, a volte spettrali. Dagli anni venti, in Italia, come nel resto d’Europa, si assiste ad una quasi morbosa esplosione di immagini, di nuove visioni capaci di offrire nuove identificazioni simboliche. L’avvento dei fascismi è accompagnato da questo fenomeno quasi ossessivo, in cui con forza inedita, il potere politico si lega indissolubilmente ad immagini da adorare, sacralizzate, oggetto di culto42. È alla forza di seduzione mitica dell’immagine che si rivolge il fascismo, ricercando in esse la potenza e la fede. È ciò che sintetizza una figura controversa come quella di Robert Brasillach, critico di cinema raffinato e antisemita, aderente fino alla morte al fascismo: «La calamita della democrazia consiste nell’aver privato la nazione di immagini, di immagini da amare, da rispettare, da adorare. La rivoluzione del XX secolo le ha restituite alla nazione»43. 42 43
Cfr. J.-L. Nancy, P. Lacoue-Labarthe, Il mito nazi, Il melangolo, Genova 1992, pp. 19 sgg [ed. or. Le mythe nazi, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues 1991]. R. Brasillach, Les leçons d’un anniversaire, in “Je suis Partout”, 29 gennaio 1943, citato in ivi, p. 19.
304
Lessico del cinema italiano
Immagini da adorare. In I martiri d’Italia (1927) di Domenico Gaudio44, probabilmente uno dei primi film a lavorare consapevolmente e politicamente in questa direzione, l’obiettivo è quello di ripensare appunto la storia d’Italia, attraverso la scelta di alcuni momenti salienti (da Dante alla presa di Roma). Ogni momento storico (e ogni spazio vuoto, ogni ellissi tra i momenti storici scelti) diventa nel film quadro agiografico, trasfigurazione quasi astratta. Nell’episodio ambientato durante la Prima guerra mondiale, il contadino che si arruola abbraccia la madre prima di partire, ne accoglie la benedizione, dopo che una donna, abbigliata con gli elementi dell’iconografia classica della madre-patria appare sulla scena, in sovrimpressione, come uno spettro, immateriale ma potente. Raddoppiamento fantasmatico della madre, la donnamatria sposta gli equilibri, chiama a sé con una forza irresistibile. Una volta soldato, il contadino muore in un’azione sulle cime innevate delle alpi. Un’esplosione, fumo, la scomparsa. In uno stacco di montaggio, la madre si trova di fronte ad una edicola con l’immagine di Cristo. Ella prega per suo figlio. L’immagine si anima e le comunica la sua morte, come sacrificio quasi religioso. La morte dell’uomo avviene nel fumo dell’esplosione, senza un vero scontro con un nemico in carne ed ossa; tutto avviene all’interno, in una dialettica di corpi (il figlio e la madre) e di fantasmi (la Matria e il Cristo), che al tempo stesso raddoppiano le figure reali e ne spostano il significato. Entrambe sacre, entrambe oggetto di adorazione. Il nemico infinito: l’immagine del fascismo La dialettica del Due sostiene la teoria del nemico: lo afferma Schmitt, certo, ma lo testimonia ogni riflessione sulla teologia politica che fonda da secoli il concetto e la pratica della sovranità in Occidente. Lo è nella filosofia della storia hegeliana, che «ruota intorno all’asse che articola e disgiunge dentro e fuori»45; lo è nella visione foucaultiana, in cui la macchinazione teologico-politica 44 45
È interessante notare che nello stesso anno esce un film dallo stesso titolo (diretto da Silvio Laurenti Rosa), quasi a voler raddoppiare il successo dell’opera di Gaudio, moltiplicare le nuove immagini del culto. R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, Einaudi, Torino 2013, p. 5.
Nemico Daniele Dottorini
305
sdoppia continuamente la vita in due parti, mostra la «presenza del Due all’interno dell’Uno, la prepotenza di una parte che si vuole tutto cancellando l’altra»46. Sulla dimensione duale di ogni formazione politica insiste anche Bataille, sottolineando come la struttura di ogni società si basi sulla costruzione di una omogeneità sociale, la quale presuppone una eterogeneità che, proprio perché irriducibile, proprio perché radicalmente altra, fuori da ogni comune misura, deve essere censurata, resa inconscia, per quanto esistente all’interno della società intesa come totalità47. È proprio questa dialettica che segna la dinamica delle società nella storia. L’avvento del fascismo, continua Bataille, cambia radicalmente questa dinamica. Il fascismo è l’eterogeneità che, in termini foucaultiani, è l’altro che si vuole tutto. In quanto eterogeneità che si assume come totalità, il fascismo condensa in sé una forza religiosa e una forza militare, forze inscindibili l’una dall’altra. Assume il fondamento fideistico dell’autorità e la pratica della sovranità come conquista militare. È in questo senso, come aveva intuito Brasillach, che il fascismo ha bisogno ossessivamente di produrre immagini da adorare, di farsi spettacolo. La dinamica del fascismo è allora quella della concentrazione, del pensarsi come movimento che si concentra intorno ai suoi culti e che dunque non può neanche lontanamente tollerare una eterogeneità che possa convivere con l’Uno: «Per il fascista tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tantomeno ha valore, fuori dallo Stato»48. Il rovesciamento allucinatorio della dialettica del Due – nei termini di Bataille, del rapporto tra omogeneità ed eterogeneità – si compie nel fascismo come crescita totalizzante dell’eterogeneità: la dinamica concentrazionaria del fascismo non prevede più un Due, né lo produce; essa si sviluppa attraverso la costruzione ossessiva e ogni volta cangiante di una identità unitaria fittizia e sul terrore quasi altrettanto ossessivo verso ogni altro, verso ogni eterogeneità. 46 47 48
Ibidem. G. Bataille, La structure psychologique du fascisme, in “Hermès”, n. 5-6 (1989), pp. 137-138. B. Mussolini, G. Gentile, voce Dottrina del Fascismo, in Enciclopedia Italiana, vol. XIV, Istituto per L’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1932, p. 847.
306
Lessico del cinema italiano
L’immagine camaleonte si accompagna allora non alla fine del nemico, ma al contrario alla sua moltiplicazione incessante. Ogni potenziale altro deve essere eliminato, espulso, negato. Ma tale moltiplicazione è appunto la negazione della concretezza del nemico di cui parla Schmitt. Il nemico non è più concreto, ma mutevole, onnipresente, invisibile. Assumendo su di sé l’eterogeneità sacrale del religioso e al tempo stesso la dinamica della conquista della logica militare, il fascismo crea e al tempo stesso distrugge immagini, le desidera e le combatte o, come nel caso del cinema, ne rivela l’impossibilità. È questa dinamica duplice che risulterà poi fondamentale per comprendere lo sviluppo particolare della dialettica del Due nella storia delle immagini del cinema italiano. Nel cinema italiano del fascismo (e in forme diverse, nelle società totalitarie o a spinta totalitaria dell’immediato dopoguerra), la dimensione mitopoietica dell’immagine emerge ben presto come un elemento centrale per la creazione e diffusione del consenso. Come scrive Gian Piero Brunetta: I dittatori incrementano, grazie alla rappresentazione cinematografica, i fenomeni parareligiosi di fideismo e di culto che hanno legami profondi con le religioni dei rispettivi paesi […]. Sullo schermo confluiscono, si mescolano, si ordinano, secondo parametri nuovi, temporalità diverse: il tempo della festa e il tempo della lotta, il tempo del dolore e del sangue e quello della catarsi, i tempi della liberazione e quelli dell’assoggettamento a rigide discipline, i tempi e i ritmi della vita di un uomo e quelli di una nazione, i tempi cerimoniali e quelli del mito, i tempi circolari e reversibili e quelli irreversibili49.
L’immagine si lega profondamente al mito, si fa artefice e custode di nuovi rituali, di nuove mistiche, nonché di nuove modalità di costruzione immaginaria di identità. Tra il divismo cinematografico di Mussolini50 e le apparizioni spettrali di figure mistiche 49 50
G.P. Brunetta, Divismo, misticismo e spettacolo della politica, in Storia del cinema mondiale. L’Europa. Le cinematografie nazionali, vol. III, tomo 2, a cura di Id., Einaudi, Torino 2000, p. 534. «Una sorta di mattatore assoluto, onnipresente e onnipotente, una figura capace di rivestire tutti i ruoli, in un lunghissimo assolo che lo vede esibirsi nei luoghi più diversi e – come se fosse affetto da una parossistica sindrome di Fregoli – a indossare indifferentemente gli abiti borghesi e i costumi da bagno, la tuta da aviatore e la divisa da cavallerizzo, tutti i tipi di divise
Nemico Daniele Dottorini
307
e mitiche (come in I martiri d’Italia), c’è un filo rosso, un legame profondo: il trauma della Prima guerra mondiale che rimane profondo, scuote gli animi della collettività europea, che sente minacciata la propria egemonia: In questo contesto, i mutati equilibri nelle gerarchie di genere e di razza divennero metafore della degenerazione sociale e del tramonto della civiltà stessa. Da ultimo, la percezione di una crisi del principio di autorità indotta dalla guerra e dall’avvento della società di massa generò vaste aree di sostegno per movimenti politici che promettevano di disciplinare tutti quegli invasori verticali che, nelle parole di José Ortega y Gasset, erano apparsi sulla scena […] emergendo da una botola51.
Le parole di Ruth Ben-Ghiat si legano profondamente a quanto si è detto prima, ripercorrendo alcuni scritti di Gentile e di Gramsci. Nella nuova ipertrofia delle immagini (immagini nuove, da adorare, da trattare con spirito liturgico) che ossessiona i totalitarismi del XX secolo, il fascismo vede una strada non solo per la creazione e la stabilizzazione del consenso, non solo per la ricostruzione fantasmatica della realtà, ma anche per operare un significativo spostamento e riconfigurazione del concetto di nemico. La studiosa americana, infatti, evidenzia con forza che uno dei concetti centrali dell’idea di modernità che il fascismo propugna ruota intorno al termine bonifica: il termine, diffusosi a partire dai progetti di bonifica delle zone paludose, estende ben presto il suo significato, assumendo di volta in volta il significato di bonifica agricola, umana e culturale. I tre significati si intersecano tra loro all’interno di un progetto organico, teso a «strappare le erbacce cattive e a ripulire il terreno», per un rinnovamento radicale della società italiana52. La presentazione dei personaggi in un film inaugurale del fascismo sotto molti punti di vista, Sole (1929) di Alessandro Bla-
51 52
militari e i caschi da motocicletta o l’abbigliamento sportivo da tennista», ivi, p. 537. R. Ben-Ghiat, La cultura fascista, il Mulino, Bologna 2004, p. 11 [ed. or. Fascist Modernities: Italy, 1922-45, University of California Press, Berkeley 2001]. Ivi, p. 13.
308
Lessico del cinema italiano
setti – secondo una modalità diffusa nel cinema muto, in cui gli attori principali compaiono nei panni dei loro personaggi nella sequenza dei titoli di testa – è da questo punto di vista esemplare. I volti bianchi e puliti, belli e sorridenti dei personaggi positivi (i bonificatori, gli abitanti che accettano la novità della bonifica), si contrappongono ai volti deformi o arcigni, accigliati o inquietanti di quei personaggi che proveranno a contrastare l’operazione di bonifica. Il movimento del film è appunto quello di una bonifica, di una purificazione, di una graduale espulsione del nemico che cresce all’interno, mentre la moderna società fascista avanza53. La nuova dinamica del potere non può più allora fare a meno delle immagini, siano esse direttamente prodotte dal regime, siano esse un suo riflesso. Immagini che costruiscono un mondo bonificato ed efficace o che sono sottoposte allo sguardo come forme da adorare e celebrare: «Il potere come governo e gestione efficace e il potere come regalità cerimoniale e liturgica»54, è qui, come ricorda Agamben, che si gioca la relazione tra Oikonomia e Gloria, tra gestione politica e immagine gloriosa del potere. È qui che si gioca l’immagine del nemico che tale dinamica insidia. Il nemico fluttua, si trasforma, si moltiplica, come un virus. Non si trova più in uno spazio definito, esterno, riconoscibile (per quanto, come si è visto, invisibile, nascosto, irrappresentabile), ma assume varie facce, vari aspetti, varie dimensioni. Non si tratta qui di pensare il nemico interno come dinamica necessaria dello scontro di classe, come nella prospettiva gramsciana, e non si tratta ancora di pensare la guerra come annullamento delle differenze interne, come trasformazione del nemico interno in specchio di sé; si tratta invece di pensare la società come sottoposta ad un processo di purificazione, di omogeneizzazione. Operazione chirurgica e ossessiva che si configura in modo particolare nella fantasmagoria delle immagini del Ventennio55.
53
54 55
Sul film, sulla sua importanza come sforzo di rinnovamento iconografico ed espressivo del cinema del fascismo, cfr. “Sole”. Soggetto, sceneggiatura, note per la realizzazione, a cura di A. Aprà, R. Redi, Di Giacomo, Roma 1985. G. Agamben, Il Regno e la Gloria, Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 10. Si vedano ad esempio le politiche del regime nella repressione delle minoranze, di ogni forma di “devianza” dalla costruzione illusoria dell’uomo
Nemico Daniele Dottorini
309
L’immobilità dell’Uno concentrazionario è anzitutto negazione della Storia. Nel cinema degli anni trenta è la storia come proiezione retroattiva, non tanto secondo la formula crociana della Historia magistra vitae, quanto secondo l’idea che la storia sia una anticipazione dell’evento del fascismo, lo anticipi e lo riproduca proiettandosi all’indietro nel tempo, ne sia il vero doppio. Doppio fantasmatico, proiezione visionaria nel passato del desiderio di gloria. La forma ricorrente è quella della ripetizione: tutta la Storia si ripete “nel” fascismo, in quel “fascismo perenne” (per usare la formula di Gian Piero Brunetta56) che costituisce il sogno immaginario del regime. Una teleologia particolare, che di fatto nega la storia come divenire, come movimento, e la congela in un unico atto (il fascismo) che porta a compimento se stesso e che è già anticipato lungo gli eventi ritenuti cardine della storia d’Italia. In Scipione l’Africano (1937) di Carmine Gallone, film fortemente voluto dal regime57, l’immagine si fa portatrice, in modo quasi eccedente, di tutte queste tendenze. Lo sfarzo delle scenografie – basti pensare all’arrivo a Roma di Scipione, al senato, in inquadrature in campo lungo che lo vedono scendere una enorme gradinata circondato da due ali di folla osannanti, o alla postura quasi inumana nella sua fissità di Annibale Ninchi/Scipione – la volontà quasi ossessiva di costruire una “grande immagine” ne fanno un film sospeso tra l’illusione e il desiderio. Illusione e desiderio di grandezza appunto, illusione e desiderio quasi messianico. Il movimento di Scipione nel film è quello di un agente del destino, di una funzione della Storia, di una storia che non è altro che la ripetizione, il raddoppiamento dell’evento che il fascismo (auto)rappresenta. Scipione deve annullare i suoi nemici interni (i senatori corrotti o avidi di potere) a Roma, purificare, bonificare lo
56
57
nuovo fascista. Cfr. L. Benadusi, Il nemico dell’uomo nuovo: l’omosessualità nell’esperimento totalitario fascista, Feltrinelli, Milano 2005. Insieme al coevo Condottieri (1937) di Luis Trenker, costituisce il più grande sforzo (anche economico) da parte del regime nella produzione di film esplicitamente propagandistici: cfr. S. Celli, Le guerre del LUCE, in Storia del cinema italiano, vol. V, 1934-1939, a cura di O. Caldiron, MarsilioEdizioni di Bianco & Nero, Roma-Venezia 2006, p. 67. Sul film come operazione ideologica e propagandistica, come tentativo di costruzione dell’immagine da adorare, cfr. L. Freddi, Il cinema – Il governo dell’immagine, CSC, Gremese, Roma 1994, p. 162; M. Salotti, Al cinema con Mussolini. Film e Regime 1929-1939, Le Mani, Recco (Ge) 2011, pp. 182-187.
310
Lessico del cinema italiano
spazio intorno a sé e assumere così il suo ruolo, che la folla intorno a lui gli riconosce. Un movimento messianico in cui lo sguardo della folla deve riconoscere Scipione come condottiero, militare ed etico, fin dal momento in cui appare, quasi come un’epifania, in cima ad una enorme scalinata. Questo riconoscimento basta, in fondo, ad annullare il potere e la minaccia di chi, dall’interno, è nemico, si oppone alla volontà unica. I contrasti interni, le divisioni sociali e politiche all’interno dei confini nazionali vanno disciolte, annullate, bonificate. Ma il compito non è quello di pensare o ipotizzare una guerra civile, perché il conflitto (e quindi il nemico) si annulla appunto tramite una pratica del riconoscimento: «Aesthetically, conflicts could not exist within Italian borders, because homogeneity was a necessary element in the development of a beatiful fascist Italy»58. Il film di Gallone è allora l’espressione di un destino metafisico, di quello che viene definito «fascismo perenne»59, l’immagine cioè di una Storia che non fa altro che ripetere se stessa, di negare ogni diversità o mutamento. Scipione raddoppia la figura di Mussolini nell’atto della conquista del potere a Roma, la battaglia di Zama duplica la conquista territoriale in Etiopia iniziata nel 1935, l’immagine del nemico ucciso (il campo brulicante dei cadaveri dei cartaginesi alla fine del film), duplica e rovescia l’immagine di apertura, i cadaveri dei soldati romani uccisi dopo la battaglia di Canne. La Storia non è più concatenamento di eventi, ma fede deterministica nel passato che si fa presente, immobilità, pura statica teleologia, alternanza senza movimento della Luce e delle Tenebre, del Bene e del Male, della Civiltà e della Barbarie. Il nemico e la nebbia Se il fascismo costruisce le proprie immagini sotto il segno della gloria e della moltiplicazione esponenziale dei nemici, è proprio il cinema a rovesciarne il senso, a mostrarne il vuoto di senso. È 58 59
S. Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy, University of California Press, Berkeley 1997, p. 40. G. Muscio, Il film più fascista è il film storico, in Schermi di regime. Cinema italiano degli anni trenta: la produzione e i generi, a cura di A. Faccioli, Marsilio, Venezia 2010, p. 47.
Nemico Daniele Dottorini
311
a partire soprattutto dagli anni trenta, dall’inizio dell’avventura coloniale italiana, che nuove immagini iniziano a circolare, a mettere in gioco la problematica dialettica del Due che caratterizza ogni conflitto, ogni rapporto amico-nemico. L’immagine ricorrente nella costruzione della fantasmatica identità pura dell’Italia è quella del nemico come virus, infezione, batterio o sporcizia da eliminare, bonificare, ripulire. Nel 1935, due mesi dopo l’inizio delle ostilità in Etiopia, L’Unione per la Cinematografia Educativa (Luce), organismo produttivo posto direttamente sotto il controllo statale, realizza una serie di documentari e cinegiornali tesi a fondare e giustificare l’intervento italiano in Africa. La logica sottesa è quella dello scontro di civiltà, tra la modernità italiana e l’arretratezza etiope, una missione fondata sul “diritto storico”, che le immagini presentano come una nuova declinazione della dialettica del Due (la forza della modernità contro lo stato di natura, l’eredità di Roma conquistatrice contro lo stato tribale). Per rendere in immagini tale dicotomia, c’è bisogno di immagini in grado di mostrare efficacemente il conflitto (o meglio, la necessità “metafisica” – per utilizzare le parole di Gentile – del conflitto). Direttore della “Rivista LUCE” è ora Corrado D’Errico, autore di lunga militanza futurista e particolarmente sensibile alle possibilità del cinema come strumento della modernità. Il documentario diventa laboratorio visivo, strumento di indagine delle possibili immagini della guerra e del nemico, sia dal punto di vista direttamente propagandistico che dal punto di vista estetico. Tra i circa trenta documentari prodotti nel biennio 1935-1936, ciò che emerge con forza è il tentativo di costruire un’immagine che trascenda la documentazione degli eventi, ma che inserisca l’evento storico in una cornice metafisica, anche partendo dalle limitazioni che la realtà stessa pone di fronte allo sguardo della macchina da presa: Considerate nel loro complesso, le riprese delle vicende belliche in Africa si rivelano poco spettacolari, date la natura per lo più montagnosa del terreno e la guerra stessa, che non offre scontri in campo aperto fra migliaia e migliaia di uomini. Significativa l’invadenza della voce di commento, che talvolta arriva persino ad “integrare” l’irrilevanza degli episodi ripresi narrando anche quanto non sempre si vede, come, ad esempio, la presenza stessa del nemico. Quello etio-
312
Lessico del cinema italiano
pico è un nemico più evocato che visto, è un nemico che è più facile esibire prigioniero o cadavere60.
Il nemico manca, è sfuggente e invisibile, evocato attraverso l’onnipresente commento, più che attraverso le immagini. È esemplare a questo proposito quello che è probabilmente il documentario più rappresentativo dello sforzo del Luce di produrre nuove immagini del conflitto: Il cammino degli eroi (1936), diretto proprio da Corrado D’Errico e presentato alla Mostra di Venezia. I settanta minuti del documentario sono in gran parte la rappresentazione di un movimento compiuto attraverso il montaggio. Ma quale movimento? Ancora una volta la guerra si maschera, diventa altro. D’Errico attinge alla dimensione estetica del futurismo per ritrovare un serbatoio di immagini disponibili, un dispositivo che dispiega l’idea di una macchina collettiva, necessaria e gioiosa. Un montaggio rapido mostra ogni elemento dei preparativi, della partenza, dell’arrivo in Africa, della vita quotidiana di soldati e coloni. Il montaggio unisce ogni elemento in un flusso regolare, senza soste, senza interruzioni: un unico movimento collettivo, fluido e necessario, naturale. È una grande macchina tecnologica, organizzativa, umana quella che viene dispiegata, in cui la modernità tecnologica (il camion, la nave, l’aereo, il cinema stesso) costituisce un naturale prolungamento del corpo umano, corpo collettivo, o meglio massa che si muove ordinatamente, disciplinata, a tempo. Nulla si oppone a questo movimento gioioso e vitale (la missione civilizzatrice, superiore, messianica), tranne il nemico. Un nemico invisibile, misterioso, di cui non restano che poche tracce. Solo gli ultimi dodici minuti del film mostrano l’esistenza di una guerra, ma non mostrano l’esistenza del nemico. Lo scontro armato è verso un fuori campo non visibile, o visibile solo dopo lo scontro. Le inquadrature finali mostrano i soldati italiani aggirarsi tra le postazioni etiopi, raccogliendo le armi abbandonate. La voce fuori campo ne canta le lodi, ma le immagini disseminano inquietudine, aprono un vuoto nella macchina-dispositivo che D’Errico aveva fino a quel momento disseminato. Quasi ossessivamente, questo elemento ricorre nelle immagini del Ventennio. In Lo squadrone bianco (1936) di Augusto Genina 60
S. Celli, Le guerre del LUCE, cit., p. 68.
Nemico Daniele Dottorini
313
o in I trecento della Settima (1943) di Mario Baffico, la dimensione immateriale del nemico è resa quasi come progetto teorico, manifestazione di ciò che non può essere rappresentato. La battaglia finale del film di Genina si svolge in un’atmosfera surreale. Le truppe coloniali italiane sparano immerse nel polverone sollevato dal vento del deserto, sparano verso qualcosa che non è visibile, non ha quasi concretezza. Certo, si muore nel film di Genina, si viene colpiti dai proiettili, ma gli unici nemici con cui il Tenente Ludovici, il protagonista, dovrà combattere veramente sono i propri tormenti interiori, che non gli fanno accettare fino in fondo, se non alla fine del film, la sua scelta di arruolarsi. Ancora più astratto, fino quasi a diventare metafisico, è lo scenario del film di Baffico, dove una divisione di Alpini difende fino alla morte un passo nelle montagne albanesi. Nel film, a parte una breve inquadratura in campo lungo, non una immagine del nemico è data. I soldati italiani muoiono uno dopo l’altro, spesso fuori campo; le fila della divisione si assottigliano per ellissi. In una delle sequenze più astratte, una fila di soldati viene investita dalla nebbia più volte. Ad ogni passaggio, al posto di un soldato sta una croce. I trecento della Settima diventa così un film che astrae dalla concretezza della guerra e del nemico. La nebbia e la polvere diventano il movimento allucinatorio di un Due senza corpo. Interno/esterno Il fascismo segna sì il ritorno compulsivo del Due, ma sotto forma allucinata, come si è visto seguendo Bataille; tutto perde concretezza, materialità. A partire dalla distinzione tra hostis e inimicus. Il nemico esterno, pubblico (lo hostis) diventa nebbia e polvere, agisce fuori campo, nelle ellissi delle immagini; il nemico interno, privato (inimicus) è invisibile, multiforme, disseminato come un virus. Tutto si confonde, ogni teoria del nemico ha perso i suoi connotati di riconoscibilità. Soprattutto non ha corpo: «Oggi il nemico vero è disarmato […]. Entra in casa nostra coi giornali, colle fotografie, coi libri che ne diffondono la mentalità»61. Nemico 61
M. Maccari, Gazzettino ufficiale di Strapaese, in “Il Selvaggio”, 30 marzo 1928, citato in R. Ben-Ghiat, La cultura fascista, cit., p. 59.
314
Lessico del cinema italiano
fantasma, invisibile, disarmato, dalle molteplici forme: se l’altro da sé è tale, l’immagine non può che creare un altro fantasma, quello di una collettività coesa, di un “comune” che si difende da un “esterno” tanto minaccioso quanto invisibile. Lo sapeva bene Schmitt, che leggeva l’unità politica dello Stato non come qualcosa di universale e senza resti, ma come parte che aspira al tutto, schiacciando l’altra sul margine del niente: «Lo Stato, in quanto unità politica, determina da sé finché esiste, anche il “nemico interno”»62. Ma il nemico interno è determinato da un potere escludente, dalle leggi che bandiscono e dunque danno un’identità al nemico (che è concreto, ribadisce Schmitt) e allo Stato stesso. Ma come si può bandire un fantasma? La dimensione spettrale e allucinata del nemico è parte integrante di un’immagine ossessivamente ricorrente: la figura dell’assedio. Al di là dei generi e delle forme, questa figura attraversa potentemente il cinema del fascismo, ponendosi come espressione di quella sindrome dell’accerchiamento che ossessiona le immagini. Il cinema italiano di quegli anni ritaglia continuamente spazi chiusi, luoghi protetti, sicuri, immuni dagli attacchi di un nemico esterno spesso innominato, invisibile e fantasmatico. Che siano scuole/collegio come in Ore 9: lezione di chimica (1941) di Mattoli o Maddalena… zero in condotta (1940) di De Sica, caserme e scuole militari come in I tre aquilotti (Mattoli, 1942), fortini o fortezze come in Giarabub (Alessandrini, 1942) o L’assedio dell’Alcazar (Genina, 1940), treni come Il treno crociato (Campogalliani, 1943), lo spazio serrato, recintato, protetto è lo spazio dove si mette in pratica il paradigma immunitario, vale a dire quella pratica speculare e parallela alla costruzione di una comunità. L’immagine del fascismo si presenta come una delle più potenti rappresentazioni della comunità come artificio o, meglio, come costruzione di una comunità sulla base della negazione, della paura verso l’esterno, del nemico invisibile, dell’anomalia, della malattia. Come ricorda Roberto Esposito, il senso positivo della comunità nasconde spesso la sua origine negativa, il suo essere la sottrazione di una libertà, la risposta ad una paura, il bisogno 62
C. Schmitt, Le categorie del “politico”, cit., p. 130.
Nemico Daniele Dottorini
315
di immunizzarsi contro ciò che minaccia l’incolumità dei singoli individui63. L’immunizzazione è dunque il movimento parallelo di una comunità che si forma negando qualcosa, sulla base di una perdita. Le piccole comunità del cinema fascista sono le immagini di una piccola, costante e molteplice immunizzazione, di difesa dalla presenza/assenza di innumerevoli nemici senza forma. Sono comunità di vita artificiale, dove l’unico desiderio è quello di recuperare una piccola rappresentazione dell’umano, sotto la forma della famiglia arcaica, della pratica di vita piccolo-borghese, del bonario cameratismo maschile, della falsa spensieratezza di una vita sottratta al rapporto con l’altro da sé. Educande o studentesse, soldati o cadetti, abitanti di piccoli mondi che somigliano ad acquari: sono questi i luoghi artificiali dove le pratiche dell’immagine trovano una costante rappresentazione. La nebbia, la polvere, l’assedio, il virus. Le immagini allucinate che nascono durante il fascismo sono destinate a tornare, a sopravvivere mutando la propria forma anche nel cinema del secondo dopoguerra, come si vedrà. Il nemico ha un corpo? La guerra non è sogno, né allucinato incubo. Può esser sognata e vissuta come spazio visionario o invisibile certo, ed è quello che le immagini del Ventennio hanno spesso prodotto, in uno spazio dove il nemico è il fantasma. Ma la guerra è reale, e le immagini devono, ad un certo punto farci i conti. L’8 settembre 1943 è il punto di svolta di questa particolare storia delle immagini. L’Italia è allo sbando dopo l’armistizio, l’alleato tedesco sì è trasformato in invasore, conquistatore, il Paese è spaccato in due. È il momento della guerra civile, come ha sottolineato Claudio Pavone: è a questo punto che il nemico diventa veramente concreto e le sue immagini cambiano segno e consistenza: «Da tracotante alleato, il tedesco tornava ad essere il “vero nemico”, ben più reale di quanto 63
Cfr. R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino 2002 e Id., Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 2006.
316
Lessico del cinema italiano
non lo fossero mai stati il francese, l’inglese, l’americano e il russo. Le qualifiche negative da attribuire al nemico tedesco, elaborate da una lunga tradizione, potevano condurre a fare del tedesco un “nemico” assoluto, squalificato anche sotto il profilo morale»64. La guerra diventa reale per tutti, non solo per chi la combatte, il conflitto entra all’interno dei confini nazionali. L’immagine fallimentare dello hostis, che rimane invisibile, mutaforma, irreale, rischia però di rovesciarsi in un nuovo nemico metafisico, assoluta rappresentazione del male. Ma qualcosa indubbiamente è ormai cambiato. La Resistenza è il momento in cui l’orrore della guerra restituisce la pregnanza tragica della dialettica del Due, la sua concreta dimensione mortale. Anzitutto essa restituirà alle immagini la dimensione dello hostis, del nemico esterno, assoluto e concreto. Il tedesco invasore è la concretizzazione di un nemico fino ad allora fantasmatico e lontano, senza corpo. Ma non è solo questa dimensione a riaffiorare nella sua concretezza. Come afferma Claudio Pavone, la Resistenza è stata una guerra civile, anzi, una triplice guerra, patriottica, civile e di classe. Riemerge la stasis di cui Agamben individuava la centralità, ma in una forma estrema. La guerra civile introduce la radicalità concreta di un nemico interno, pubblico, a cui destinare un odio irrefrenabile65. Improvvisamente esplode, in un territorio sottratto alla realtà del conflitto, un reale che si configura come orrore, guerra fratricida e di classe, guerra di liberazione e di recupero di una identità perduta. La nebbia, per un breve istante, si dirada, la polvere scompare, gli assedi non sono più possibili, i corpi riappaiono. I corpi del nemico. Il tedesco e il fascista, il doppio corpo del nemico, quello assoluto, invasore esterno, e quello interno che non può essere espulso con un bando sovrano, perché non è lo Stato a determinarlo, ma deve essere combattuto, distrutto a forza. La radicale estraneità del nemico esterno è anzitutto la sua lingua, quella lingua tedesca che Primo Levi ricordava come lingua del comando e del dominio ad Auschwitz, lingua dell’estraneità e dell’arroganza, del terrore e del potere, 64 65
C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 206. Ivi, pp. 214-215.
Nemico Daniele Dottorini
317
come emerge in uno dei primi film resistenziali, Il sole sorge ancora (1946) di Aldo Vergano, e come diverrà comune in tanto cinema successivo66. Rossellini e la prossimità Ma la storia delle immagini continua ad operare torsioni. Proprio quando la versione allucinata del fascismo della dialettica del Due viene meno, il cinema compie un’operazione politica ed estetica unica, costruisce immagini che perlopiù dissolvono il nemico riconoscendolo come umano. Non si tratta di un’operazione ideologicamente umanista, ma di un gesto anzitutto cinematografico: il cinema italiano non vede lo hostis, non vede la concretizzazione del nemico assoluto, ma vede l’inimicus, il nemico vicino, concreto, privato. E lo fa perché il cinema avvicina il mondo, i corpi, le relazioni. Lo sguardo che ha inaugurato questa dimensione della prossimità, che ha inaugurato un modo di vedere, è senz’altro lo sguardo di Roberto Rossellini. Rossellini esplora un mondo in macerie, ne constata l’orrore, ne percepisce l’odio che lo attraversa: compie allora uno scarto attraverso il cinema, uno scarto che inaugura una nuova e più consapevole dialettica del Due. Per capire meglio ciò di cui stiamo parlando, occorre allora iniziare da due figure esemplificative di uno scarto squisitamente cinematografico. Prima figura: ufficio del comando tedesco nella Roma occupata del 1945, il maggiore Fritz Bergmann, a capo del comando tedesco a Roma, mostra al questore della capitale il suo metodo d’indagine. Comodamente seduto nel suo ufficio spoglio, il maggiore si fa portare molte fotografie: «Posso fare delle lunghe passeggiate per Roma senza muovermi dal mio ufficio, e fare così degli incontri interessanti». Bergmann indaga, spia, osserva attraverso le immagini, filtrando la propria esperienza, l’atto di vedere con i propri occhi; negando cioè la prossimità, alle cose, al mondo, all’altro. Il maggiore Bergmann è la prima grande figura del nemico del cine66
F. Cereja, La cinematografia sulla Resistenza nella storia italiana (19441964), in AA.VV., Cinema, storia, resistenza. 1944-1985, Istituto storico della Resistenza in Valle D’Aosta, FrancoAngeli, Milano 1987, pp. 20 sgg.
318
Lessico del cinema italiano
ma moderno, immortalata da Rossellini in Roma città aperta nel 1945. Figura radicale dell’estraneità, Bergmann è l’anomalia, l’alterità assoluta dal mondo rosselliniano. Il maggiore tedesco non guarda il mondo, non esce mai dalla sua stanza, rifiuta l’esperienza. Il suo guardare non è motivato dal desiderio di conoscere, di comunicare, ma dal desiderio del controllo e del dominio. Il suo centro di comando è una sorta di panottico tecnologico (le immagini fotografiche sostituiscono lo sguardo diretto sul mondo): egli è dunque il nemico. Seconda figura: lungo il fiume Po, lentamente, pigramente, ma inesorabilmente trascinato dalla corrente, il corpo di un uomo morto si muove. È agganciato ad un galleggiante e sopra la testa è legato un cartello con su scritto “Partigiano”. Delle donne e dei bambini osservano il corpo dalla riva, in silenzio, mentre alcuni soldati tedeschi indicano il cadavere, commentando sprezzantemente: «Partigiano, bandito!». Due uomini emergono da un canneto nell’acqua, un soldato inglese e un partigiano. Mentre il primo distrae due guardie tedesche facendo esplodere una mina, il secondo recupera il corpo del partigiano. Più tardi, altri soldati americani e inglesi, insieme a partigiani italiani, rapidamente, senza troppe parole, scavano una fossa dove seppelliscono il cadavere, sostano per alcuni secondi in omaggio al caduto e poi si allontanano. Prima che il corpo venga seppellito, il soldato inglese getta uno sguardo sul suo volto tumefatto. Un breve sguardo, un brevissimo campo/controcampo. Un contatto, una vicinanza, una prossimità. È, lo si sarà riconosciuto, l’inizio dell’ultimo episodio di Paisà (1946). Le due figure compongono uno sguardo che costituisce di fatto la forma peculiare del vedere rosselliniano, in cui la concretezza dell’esistere, dell’essere-con emerge proprio come risposta alla separazione, al rapporto di totale alterità che costituisce l’inimicizia. Vedere con i propri occhi è un atto di immersione nel mondo, non di separazione: Comenio, il grande pedagogo moravo del XVII secolo, disse che l’insegnamento è altrettanto necessario delle mappe per il navigatore. Ammise però l’inefficacia dei metodi (allora) disponibili. Perché non si poteva insegnare con immagini dirette, visive, ma solo attraverso discorsi che spesso divenivano lunghi e oscuri. Invece di visione “di-
Nemico Daniele Dottorini
319
retta”, Comenio usò la parola “autopsia” nel suo significato originale […] di “vedere con i propri occhi”67.
Le parole pronunciate si situano all’interno di quell’insieme di scritti e interventi legati al progetto, straordinario e di fatto unico, del cinema come educazione integrale, contenuti nella raccolta di scritti Il mio metodo. Le due figure dei due film inaugurali del cinema moderno, Roma città aperta e Paisà, non finiscono mai di ruotare intorno alla citazione di Comenio (che certo appartiene agli scritti dell’ultima fase rosselliniana, ma è strettamente legata all’esercizio dello sguardo del regista romano lungo tutta la sua attività). Vedere con i propri occhi, la morte, l’altro. Vedere da vicino, approssimarsi. Ecco le parole che descrivono il movimento rosselliniano, che lavorano sulla concretezza della vita. Il rovesciamento è compiuto. Di fronte all’impossibilità di una vera rappresentazione dello hostis, di fronte all’orrore reale della guerra, Rossellini svela il nemico come inimicus, come figura concreta: sono i due cecchini fascisti catturati dopo gli scontri a fuoco a Firenze in Paisà, gettati a terra e fucilati sul posto; è il vecchio professore nazista che vive rinchiuso in una casa fatiscente in Germania anno zero (1948). Nemici individuali, privati, pericolosi, o a volte solo casualmente nemici (la pattuglia tedesca che spara a Carmela nel primo episodio di Paisà). Rossellini apre un nuovo percorso perché restituisce al nemico la sua concretezza e all’amico la sua prossimità. Come l’amicizia, l’inimicizia è concreta in uno sguardo che sembra riprendere la visione ciceroniana: nel piccolo trattato sotto forma di dialogo, L’amicizia, Cicerone considera il rapporto come un bene terreno, raggiungibile praticamente, come espressione della vita pratica e politica68. A differenza di Simone Weil, per cui l’amicizia è fratellanza, sentimento puro, sottratto alla pratica politica e quotidiana, o di Pavel Florenskij, per il quale l’amicizia è vitale e necessaria, ma si presenta come una forma dell’amore divino, quasi come un mira67 68
R. Rossellini, Programma per un’educazione permanente, in Id., Il mio metodo, a cura di A. Aprà, Marsilio, Venezia 1991, p. 427. Cfr. M.T. Cicerone, La vecchiaia - L’amicizia, Garzanti, Milano 2010.
320
Lessico del cinema italiano
colo, Cicerone concepisce l’amicizia come pratica dei corpi e dei soggetti, pratica concreta, forma di vita che deve essere mantenuta e coltivata sulla base delle proprie esperienze. In questo senso Rossellini concepisce e rappresenta il nemico come colui che rifiuta la vicinanza, la prossimità. Che non accetta la diversità. Se anche nei tre film diretti durante la guerra (La nave bianca, 1941, Un pilota ritorna, 1942, L’uomo della croce, 1943), Rossellini mette in pratica ogni volta una “sospensione” del conflitto, mettendo in corto circuito la dialettica del Due che caratterizza il rapporto amico/nemico – in La nave bianca lo spazio del film è una nave ospedale e i marinai ospitati all’interno sono sottratti alla battaglia; in Un pilota ritorna, il protagonista torna alla base dopo che il suo aereo è stato abbattuto; in L’uomo della croce, un cappellano militare si ritrova prigioniero sul fronte russo – è nei film dell’immediato dopoguerra che il “metodo” rosselliniano costruisce una nuova dialettica: Il nemico non è più tale, è un altro da te, non un essere detestabile. L’estraneità degli individui è contrassegnata dal fatto che ognuno ha un suo bagaglio linguistico non accessibile, ma la pena, le traversie sfibranti oltrepassano le differenze e avvicinano, in una più elevata disponibilità umana, anziché separare69.
Quello di Rossellini è allora il gesto inaugurale, il gesto di un nuovo inizio dell’immagine, di sguardo che accetta l’orrore ma anche la bellezza del mondo, che rifiuta la dialettica del Due a favore di un’accettazione della vita come flusso, movimento incessante, prossimità anche rischiosa. Il nemico non scompare, ma si rende concreto, non è più la nebbia di Genina o di Baffico, l’invisibile virus tentacolare evocato da un regime che si pensa come corpo da immunizzare. Il regista romano riprende il conflitto e il nemico come immanenti all’immagine, secondo una tradizione che è assolutamente italiana, del pensiero come del cinema, sempre immanenti, sempre legati alle forme di vita70. 69 70
M. Argentieri, Il cinema in guerra, in Storia del cinema italiano, vol. VI, 1940-1944, a cura di E.G. Laura, A. Baldi, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Roma-Venezia 2010, p. 51. Cfr. R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010.
Nemico Daniele Dottorini
321
Ecco il rovesciamento operato dalle immagini del cinema italiano. Un cinema, ricordava Deleuze71, che inaugura una nuova immagine, un’immagine dove i legami senso-motori sono allentati, sfumati, dove non sono più netti i confini tra un Io e un Altro da sé, dove ogni dialettica è tutta da costruire, interlocutoria, misteriosa, come una realtà vista attraverso il cinema, che produce un “di più di realtà”. È questo che Rossellini inaugura: la concretezza molteplice dei gesti e delle esistenze immanenti al mondo, il rifiuto di una metafisica del Due, l’accettazione di una dialettica che sia ogni volta tra un Io e un Tu. La riconfigurazione del mondo Se con sguardo retrospettivo torniamo a quanto è emerso sin qui, risulta evidente come l’immagine italiana abbia rifiutato di vedere il nemico come hostis, come altro assoluto, riconfigurando ogni volta la logica del Due, determinando una sorta di critica radicale e multiforme (consapevole o meno), alla sua assolutezza. Ogni tentativo in questo senso ha prodotto la rivelazione del vuoto dell’immagine, di un fuori campo che non riesce e non può rendersi visibile. Ma questa forma critica dell’immagine non porta ad un nostalgico ritorno dell’Uno, o peggio ancora ad un’acritica sparizione di ogni forma dell’antagonismo, anzi. Nel processo di riconfigurazione di uno Stato e di una nazione che caratterizza l’Italia del dopoguerra, l’antagonismo moltiplica le sue forme, e l’immagine riscopre la dimensione molteplice della logica del Due, che non cessa in realtà di scindersi in forme di antagonismo sempre diverse, caratterizzate però dalla dinamicità e dalla prossimità del nemico, come si è visto nell’apertura inaugurale dell’immagine rosselliniana. L’apertura delle immagini porta con sé la possibilità di nuove strade, di nuove esplorazioni della logica del Due che accompagnano la costruzione di un nuovo soggetto politico, che è l’Italia che nasce dal dopoguerra. A partire dalla fine della guerra, oltre a mettere in gioco l’immagine come luogo di esplorazione delle 71
Cfr. G. Deleuze, L’immagine-tempo, Ubulibri, Milano 1989, p. 11 [ed. or. L’image-temps, Les Éditions de Minuit, Paris 1985].
322
Lessico del cinema italiano
conflittualità private e parziali di una società in rapida mutazione, l’immagine che il cinema produce non cessa di sdoppiarsi, di dividersi in altre polarità: in forme che da una parte ripensano le immagini della conflittualità del passato, e dall’altra non cessano di riorganizzare il presente. Una riconfigurazione del mondo (reale e delle immagini) è in atto, ed essa produce rapporti nuovi, complessi, nuovi concetti e nuove pratiche del nemico. Ed è questa complessità che occorre ora esplorare. La guerra è finita: sembra questa essere la frase cardine a partire dalla quale le nuove immagini si producono. L’immagine italiana del dopoguerra si pensa come immagine nuova, che non può non guardare al passato come luogo da esplorare retrospettivamente (e sempre più nel corso degli anni, da interrogare come luogo di origine della contemporaneità). Guardare retrospettivamente il passato appena trascorso significa, ad esempio, riuscire ad osservare le macerie lasciate da una guerra, macerie senza più nemici, come accade a Edmund in Germania anno zero di Rossellini, in cui, come si è detto, l’unico nemico, reale e demoniaco insieme, è il vecchio professore nazista, rinchiuso nella villa; ma significa anche osservare il nemico dopo la guerra, ciò che resta di lui e ciò che si trasforma. È quello che fa Giuseppe De Santis in Caccia tragica (1947). Se il film di Rossellini è un film del presente (più che sul presente), il film d’esordio di De Santis è un film sul tempo inteso come intersecarsi di presente e passato72. Se la guerra è finita, negli stessi territori che hanno visto, poco tempo prima, il sanguinoso svolgersi di un conflitto, De Santis, con i mezzi del cinema, mette in scena un raddoppiamento del conflitto, in cui ancora una volta corpi e volti dovranno scontrarsi come amici e nemici. Ma la ripresa dell’antagonismo cambia ora di senso. Non è un proseguimento della guerra, quanto un gesto di doppia resistenza: la resistenza dei nemici del passato che non cessano di infestare, come spettri allucinati, costruiti secondo le forme del western e del noir, i territori di un nuovo mondo che deve essere riconfigurato. Proprio per questo i nemici (i banditi, dipinti secondo le regole del noir da De Santis), sono in realtà forme 72
«Il passato e il presente sono le due dimensioni che si fronteggiano dall’inizio alla fine, i banditi incarnano il nazismo di ieri e i contadini rappresentano l’odierna democrazia. Il passato continua a minacciare il presente. La caccia è ancora resistenza», G. Moneti, Studio su “Caccia tragica”, Nuova immagine, Siena 2004, p. 14.
Nemico Daniele Dottorini
323
del passato, quasi dei revenants inquietanti e al tempo stesso tragici, sopravvivenze del passato ancora in grado di impedire ad un nuovo sguardo di sognare e creare un nuovo mondo. Ecco allora configurarsi una nuova immagine del nemico, che trasfigura lo hostis fino a trasformarlo in una figura tragica, che solo può essere raccontata, per De Santis, con le forme dei generi cinematografici73. La guerra è finita, sì, ma la trasfigurazione del nemico non si limita alla tensione tra passato e presente come in De Santis: man mano che gli anni passano, la guerra diventa sempre di più un luogo privato della sua tragica sofferenza, uno spazio lontano che solo più tardi verrà ripensato. Nuovi antagonismi emergono, il nemico è sempre più privato, concreto, parziale (ancora una volta, più che nel senso schmittiano di parziale come parte della società, nel senso agambeniano di svelamento della stasis, della guerra civile). Una nuova dialettica del Due costruisce un inedito scenario mondiale, in cui non smetterà di riconfigurarsi, lungo tutto il Novecento l’orizzonte del nemico (o meglio, dei nemici). Lo hostis si rivela ormai come la vera figura del fantasma. Lo era durante la guerra, persino nel pieno del conflitto. In un film emblematico come Uomini sul fondo (De Robertis, 1941) la dimensione inorganica dell’apparato (il sottomarino rimasto a fondo per un guasto tecnico), non corrisponde più alla potenza sovrumana della macchina bellica cantata dal futurismo: è semplicemente uno spazio/macchinario che ha cessato di funzionare. Tutto ciò che conta è l’umanità che abita quello spazio, il rischio della morte, l’eroismo quotidiano di chi compie determinati gesti per salvare gli uomini intrappolati. Non c’è più nemmeno il conflitto, la guerra, il nemico. Tutto accade durante un’esercitazione. Laddove la macchina della guerra fallisce, non rimane che l’umano, la sua debolezza e la sua forza. Questa dimensione dell’umano, che non corrisponde pienamente alla prossimità rosselliniana, diventa nel decennio successivo la dimensione che eclissa lo hostis definitivamente, e che lascerà emergere le forme dell’inimicus, degli antagonismi che attraverseranno lo sguardo della tarda modernità. 73
Tentativo tra l’altro portato avanti anche da Lizzani con Achtung! Banditi!, (1951), dove le forme del western e del cinema bellico si mescolano con un nuovo sentimento del reale, di un “nuovo” rappresentato dai corpi dei partigiani, in una visione della resistenza che si vuole già epica e realistica al tempo stesso.
324
Lessico del cinema italiano
In La grande speranza (1954) di Duilio Coletti, il movimento iniziato da De Robertis giunge al suo acme. Anche qui lo spazio che costringe i corpi è quello di un sommergibile, di un sottomarino italiano che raccoglie (o per meglio dire, accoglie) al suo interno i naufraghi delle navi nemiche affondate. Ma se in Uomini sul fondo, il sottomarino era lo spazio che escludeva l’esterno, costringeva gli uomini all’interno a tentare disperatamente di uscire per salvarsi, nel film di Coletti, il mezzo meccanico è come uno spazio permeabile, che assorbe al suo interno i corpi e le esistenze dei nemici, le trasforma e le trasfigura. Ogni ostilità si annulla all’interno dello spazio-set del sommergibile, e tocca il suo culmine nella sequenza della festa di Natale, dove tutti, equipaggio, ufficiali e prigionieri di guerra, collaborano per allestire alla bell’e meglio un albero natalizio all’interno del sottomarino. È il punto culminante di un movimento che nega ogni logica del nemico. Lo hostis non esiste, esiste solo (quasi fosse un movimento metafisico, come voleva Gentile) la guerra. La nuova dialettica Il movimento di trasfigurazione non deve però ingannare. La messa in crisi radicale della figura dello hostis che l’immagine compie lungo tutta la prima metà del Novecento, non annulla, come già si è detto, le logiche dell’antagonismo, anzi. Mentre l’orizzonte geopolitico mondiale si riconfigura in una nuova, mondiale dialettica del Due, con la creazione di due blocchi sovrapposti – quello statunitense e quello sovietico – l’Italia costruisce attraverso le sue immagini una propria personale e complessa logica degli antagonismi. La cui costante, pur nelle differenze che la attraversano, è che il nemico è e sarà sempre nemico interno, privato, si configurerà sempre come “parte” e mai come radicalmente altro. Questa creazione continua di nuovi antagonismi, di inimici che sono sempre diversi e mutevoli costituisce allora la nuova dinamica di una società in profonda trasformazione. È vero: le immagini proliferano. Le elezioni del 1948 sono il banco di prova, l’inizio di un nuovo orizzonte simbolico, di un nuovo dualismo politico (la Democrazia Cristiana versus le Sinistre, gli USA versus l’URSS). Le immagini politiche seguono questo nuo-
Nemico Daniele Dottorini
325
vo Due che si colloca tutto sotto l’orizzonte simbolico, creando l’architettura di un doppio schieramento contrapposto; manifesti politici, trasmissioni radiofoniche e televisive, prodotti della cultura di massa: tutto concorre alla costruzione di una nuova conflittualità, e di nuovi nemici spesso trasfigurati, veri e propri mostri. Ma la cosa più importante è che è il cinema a sottrarsi. L’Italia – il cinema italiano – costruisce immagini delle proprie partizioni interne, le mette a confronto, in una continua rideterminazione del rapporto amico-nemico. Ed è proprio questa dinamica costante e molteplice a costruire il particolare movimento di sviluppo della società italiana. Una dinamica che, da questo punto di vista riprende la particolare tradizione geopolitica italiana. Se Machiavelli, nei Discorsi sopra la Prima deca di Tito Livio, sottolineava la forza dinamica della società romana, che ai tempi della repubblica faceva dell’antagonismo sociale interno il motore stesso della crescita di Roma, il suo discorso anticipava di secoli le riflessioni di Hegel nelle Lezioni di filosofia della Storia, in cui il filosofo tedesco leggeva la storia di Roma come la storia di un movimento di continua scissione, in cui la forza e la grandezza della potenza romana derivava proprio dal cercare e creare nuovi nemici all’interno di se stessa, creando così nuove sintesi74. Lungi dal cercare l’omogeneo, lo Stato romano è caratterizzato invece dalla ricerca continua dell’eterogeneo, e le sue sintesi sono quindi molteplici e parziali. Ma la differenza sostanziale, sotto questo riguardo, tra Machiavelli ed Hegel, sta nel fatto che per il pensatore italiano tale dinamica non è destinata ad essere poi assorbita dialetticamente in una nuova unità, in un nuovo omogeneo (il germanesimo come superamento dialettico, Au ebung, della romanità), ma deve in un certo senso continuare, svuotando così il termine “nemico” da ogni assolutezza, mostrandone il suo ruolo cangiante e mutevole, nella concretezza dei rapporti tra forme di vita. Ed è la direzione machiavelliana che l’immagine moderna del rapporto amico-nemico ha ripreso al suo interno.
74
Cfr. G.F. W. Hegel, Lezioni sulla Filosofia della Storia, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 234 [ed. or. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, a cura di K.L. Michelet, 3 voll., Duncker & Humblot, Berlin 1840-1844].
326
Lessico del cinema italiano
Se, a questo proposito, emancipiamo due film dalla lettura cattolica, umanista o spiritualista (che li interpreta come due grandi film di “conversione” di non-eroi all’eroismo), Il generale Della Rovere di Rossellini (1959) e La grande guerra (1959) di Monicelli si offrono come due operazioni di trasformazione e di scontro tra forme e concetti del nemico. Nel film di Rossellini, De Sica è il corpo che si oppone alla guerra rifiutando la logica del Due, quella dello hostis; egli attraversa il territorio in conflitto ribadendo un’altra logica, che è quella del commercio, della sopravvivenza attraverso la creazione di rapporti “utili”, operativi, contatti che gli permettono di muoversi “tra” due mondi, quello dell’occupazione tedesca e quello della popolazione che la subisce e vi si ribella. De Sica (il protagonista del film) maschera il mondo rileggendolo secondo una prospettiva personale, egli trasforma il mondo in una sua finzione. Ma nella seconda parte del film, l’uomo viene spinto da un ufficiale tedesco a prendere il posto del defunto generale Della Rovere, per poter carpire informazioni utili sulla Resistenza. De Sica è costretto cioè ad adottare in un certo senso una seconda finzione, una finzione di secondo grado: cessa di essere il truffatore che vive alle spalle delle miserie altrui (prima finzione) per diventare fino in fondo la sua seconda finzione. La sua morte (si farà fucilare conservando fino in fondo la sua identità posticcia), sarà allora la logica conseguenza del suo atto. Non si tratta di morire e sacrificarsi per combattere il nemico invasore, ma di seguire fino in fondo un ruolo d’attore, proprio perché identificandosi in esso, “diventando” la propria finzione, De Sica non può non morire. Lo smacco nei confronti dell’ufficiale tedesco è allora più radicale di ogni contrapposizione amico-nemico. L’ufficiale, dopo un ultimo colloquio con lui (in cui non c’è traccia di odio, né nell’uno né nell’altro) si rivolge al suo sottoposto, dicendogli: «Io mi sono sbagliato!». In quella frase c’è sì l’ammissione di una sconfitta, ma soprattutto di una resa ad una logica che rifiuta fino in fondo l’antagonismo dello hostis. De Sica è e non è il nemico, l’ufficiale è e non è il nemico. Il crollo della contrapposizione radicale, smantella l’edificio del conflitto, che avviene, ed è una delle cose straordinarie del film, a partire da una doppia finzione75. 75
Slavoj Žižek radicalizza ancora di più il rovesciamento e mostra come l’ipotesi più radicale sia che in entrambi i casi, quella di De Sica è sempre una finzione, sia quando si presenta come ladro e truffatore, sia quando assu-
Nemico Daniele Dottorini
327
In La grande guerra, l’uno diventa due, si raddoppia. Vittorio Gassman e Alberto Sordi sono accomunati dallo stesso rifiuto della guerra, dallo stesso movimento. Entrambi cercano di sottrarsi in tutti i modi alla finzione (a ciò che essi stessi, per primi, sentono come finzione) della guerra; finzione che li vuole soldati pronti a morire, prima che uomini decisi a vivere. Lungo tutto il film i loro gesti vanno in questa direzione: evitare la finzione della guerra fingendosi soldati e operando “contro” il conflitto. Essi non vedono nemici, perché il loro sguardo è rivolto all’interno (come era rivolto all’interno lo sguardo di De Sica); rivolto cioè alle partizioni del proprio ambiente, alle divisioni e alle differenze. Ma il processo che si svolge lungo il film li porta anche a mettere in gioco fino in fondo la loro finzione. Catturati dagli austriaci, i due saranno fucilati se non rivelano una importante informazione militare. Nessuno dei due lo farà, e sia l’uno che l’altro non parlano portando avanti fino in fondo il loro rifiuto della logica del Due. Gassman, pronto a parlare per salvarsi la vita, si blocca di fronte ad una affermazione di un ufficiale austriaco, che mostra tutto il suo disprezzo per gli italiani. Sordi, rimasto solo, piagnucola semplicemente di non sapere, di non conoscere quella informazione. I due moriranno, ancora una volta, senza riconoscere un nemico, ma per rifiuto, negazione, offesa. I due film mettono in scena allora uno sguardo che costruisce le proprie finzioni all’interno, attento alle partizioni del proprio mondo, della propria realtà. Invasore tedesco o soldato austriaco, nell’uno e nell’altro film, non sono mai propriamente nemici, o meglio, lo sono parzialmente, temporaneamente. L’assoluto è bandito, perché ciò che conta è la fluttuazione della vita. Lo sguardo ritorna a sé L’immagine guarda se stessa. È il movimento caratterizzante il moderno nel cinema italiano. Solo così l’immagine può rendere visibili le proprie “parti”, il proprio inimicus, che è sempre privato, me fino in fondo il ruolo del generale Della Rovere. Cfr. Id., Organi senza corpi. Deleuze e le implicazioni, La Scuola di Pitagora editrice, Napoli 2013, pp. 455-456 [ed. or. Organs Without Bodies, Routledge, London 2003].
328
Lessico del cinema italiano
parziale, concreto e cangiante. È negli anni sessanta che lo sguardo retrospettivo assume un significato particolare, quasi di recupero, di compensazione necessaria. È lo smascheramento della costruzione allucinata del fascismo di nemici infiniti e invisibili, e il ritorno della concretezza corporea dell’inimicus, prima attraverso la prossimità rosselliniana, e in seguito attraverso la sua anestetizzazione, in cui il nemico stesso non è più così chiaramente visibile (o mostra in fondo di non esserlo mai stato). Si tratta allora di richiedere una nuova interrogazione dell’immagine, o meglio richiedere una nuova immagine che sia in grado di riprendere criticamente il passato e interrogare un mondo nuovo, in cui il concetto di nemico è tutto da ripensare. La lunga notte del ’43 (1960) di Florestano Vancini è uno dei film che compie, in uno scarto improvviso, un’operazione di ritorno a sé dello sguardo che consente un ripensamento della forma e della dinamica del nemico e consente di riprendere la dialettica del Due secondo una peculiarità che attraversa la modernità. Il film, che racconta la vicenda dell’eccidio di alcuni antifascisti ferraresi da parte dei fascisti nel novembre del 1943 (episodio che è alla base di uno dei racconti delle Cinque storie ferraresi di Giorgio Bassani, da cui è tratto il film), oltre ad essere uno degli esordi più folgoranti del decennio degli anni sessanta, è anche un film sul rovesciamento continuo dei ruoli e dei corpi. Il racconto degli eventi del ’43 è incastonato in un prologo e in un epilogo ambientati nella contemporaneità, dove Franco (Gabriele Ferzetti) e Carlo Aretusi (Gino Cervi) si incontrano a distanza di anni dagli eventi di cui sono stati direttamente o indirettamente protagonisti. Franco, il cui padre sarà uno degli antifascisti trucidati, non ha mai voluto sapere la verità sull’eccidio. Egli ha rifiutato fino alla fine di scoprire che i fascisti comandati da Aretusi erano stati i responsabili del massacro, e che Aretusi lo ha ordinato per scalare le gerarchie del locale partito fascista. L’evento reale, il massacro, potrebbe essere lo spazio in cui si concretizza il nemico, ma solo quando Franco ritorna dopo molti anni in una Ferrara assolata ed estiva, con una moglie straniera e una nuova vita, incontra Aretusi per caso, di fronte ad un bar, ora anziano e pacifico abitante di una città che sembra aver completamente dimenticato il conflitto sanguinoso che l’ha attraversata, i due finiscono per stringersi la mano, sorridendo. Quando sua moglie gli chiede chi fosse quell’uomo, Franco
Nemico Daniele Dottorini
329
risponde che «era una specie di gerarca fascista… un poveraccio, non credo che abbia mai fatto niente di male». Franco ha ricreato un mondo, un mondo senza più nemici, neutrale (dopo la guerra è andato a vivere in Svizzera), rifiutandosi di vedere altro. Il soggetto che non vede e non vuole vedere l’antagonismo, il conflitto, il nemico. Il personaggio di Franco inaugura la stagione di un cinema che mette in gioco il pericolo della rimozione, della dissimulazione del mondo e soprattutto della dissimulazione dei conflitti. Il cinema vede ciò che il soggetto rischia di non vedere, o di non voler vedere. Vede il nemico, vede il conflitto. Lo sguardo ritorna a sé. Lo fa disseminando le sue visioni e le sue forme lungo tutta la storia dei conflitti della prima parte del Novecento. Lo fa come racconto corale in Le quattro giornate di Napoli (1962) di Nanni Loy, lo fa come commedia in Tutti a casa (1960) di Luigi Comencini, Il federale (1961) di Luciano Salce, La marcia su Roma (1962) di Dino Risi, e continuerà a farlo lungo tutta la storia del cinema del secondo Novecento e degli anni duemila. La linea della Storia come «memoria rivisitata», per usare un’espressione di Brunetta76, diventa dunque una linea feconda del cinema italiano, costruisce una delle strade con cui l’immagine indaga se stessa e la propria storia, non come storia monumentale, ma come indagine sulla conflittualità della e nella modernità italiana, dal Risorgimento alla Prima guerra mondiale, dal fascismo alla Resistenza: gli anni sessanta sono, tra le altre cose, gli anni di inizio di un ripensamento e di una rimessa in scena della Storia, di una storia non più utilizzata come legittimazione di un’origine, come durante il fascismo, o come indicazione di un destino di gloria. La Storia come ripensamento dei conflitti che hanno caratterizzato l’Italia, la sua identità e le sue mutazioni: «Rientrano in scena personaggi e temi considerati tabu: il fascismo, la Resistenza, la realtà delle fabbriche, il ruolo dei fascisti nelle rappresaglie e nelle stragi degli ultimi due anni di guerra, il comportamento dell’Italia nei mesi della Repubblica di Salò»77. È l’inizio di una tradizione che attraversa la modernità del cinema italiano e che riflette in toto le ambiguità e la complessità della dialettica del nemico. 76 77
Cfr. G.P. Brunetta, Guida alla storia del cinema italiano. 1905-2003, Einaudi, Torino 2003, p. 214. Ibidem.
330
Lessico del cinema italiano
Ambiguità, si è detto. Riconoscere lo sguardo che guarda se stesso non significa infatti leggerlo come unico e dotato di univoca intenzionalità. Se gli anni sessanta sono gli anni in cui lo sguardo retrospettivo del cinema si concentra su fascismo, antifascismo e Resistenza (circa quaranta film prodotti sul tema tra il 1960 e il 196378), le cause di tale proliferazione, di questa tendenza, sono spesso da ricercare anche nel mutato scenario politico italiano degli anni sessanta. Per la nuova Democrazia Cristiana che si apre al centrosinistra dopo il fallimento del governo Tambroni, così come per le forze progressiste e riformiste in Italia, l’antifascismo torna ad essere un valore condiviso. Si tratta però di una doppia lettura politica (da sinistra a dal centro) che ha di fatto un unico obiettivo: liquidare il fascismo come sopravvivenza che cozza con la modernità, annullarne la portata, l’eredità nella società italiana contemporanea. Nel binomio fascismo/antifascismo non si riflette l’opposizione amico/nemico ma i tratti di un’anomalia che spesso assume caratteri farseschi, come nei già citati Tutti a casa, La marcia su Roma, Il federale. Il fascismo non produce nemici, ma anomalie, macrovirus da espellere catarticamente dalla contemporaneità, o in fondo da riconoscere come elementi devianti di una stessa matrice (l’identità italiana), in un gesto che ribalta paradossalmente la logica del virus, della malattia da estirpare che aveva caratterizzato la logica del nemico che il fascismo stesso aveva contribuito ad elaborare. Certo, ci sono eccezioni, sguardi che producono invece interrogativi ben più profondi, che rileggono appunto la Storia criticamente, mettendo in questione, in un continuo cortocircuito tra passato e presente, la dimensione politica della Resistenza rappresentata dai comitati CLN, e la componente di azione armata, i Gap, la sua concreta dinamica interna e quindi la complessità di ogni logica del nemico. Una di queste eccezioni, significativa, è Il terrorista (1963) di Gianfranco De Bosio. Nel film, a tutt’oggi ancora poco conosciuto79, la Resistenza veneziana viene analizzata nelle sue forme e nelle sue logiche di azione e di interpretazione della realtà politica. In un’atmosfera plumbea, quasi immobile o lenta come l’ac78 79
L. Micciché, Il cinema italiano degli anni ’60, Marsilio, Venezia 1986, p. 31. L.A. Mendolesi, “Il terrorista” di De Bosio, un film nascosto, in “Patria indipendente”, n. 8 (2009), pp. 54-55.
Nemico Daniele Dottorini
331
qua della laguna veneziana, l’azione “terroristica” (il sabotaggio di una centrale fascista da parte di una cellula del Gap diretta da Gian Maria Volonté) diventa un problema politico per le varie anime del locale comitato del CLN. La lucidità di analisi di De Bosio, ex partigiano che rilegge le varie forme con cui la Resistenza ha pensato ed affrontato le forme del nemico – azione estremista, azione popolare, azione insurrezionale, attendismo – si interroga anzitutto sull’attualità della lotta partigiana. La Resistenza ha rimesso in gioco (appunto come guerra civile, seguendo la linea di Pavone) la concretezza del nemico, e al tempo stesso ha dispiegato e mostrato le nuove divisioni interne che costituiranno la dinamica della lotta politica nell’Italia Repubblicana. Eppure ciò che il film mostra con più forza è il preannuncio (o il pericolo) di una fine, di un’epoca in cui il nemico non sarà più riconosciuto, in cui la libertà non sarà più un valore irrinunciabile. È il monologo di Gian Maria Volonté nel film, monologo profetico, che sembra preannunciare la profonda trasformazione della dialettica del Due che: «Non posso fare a meno di chiedermi se dopo […] ci sarà di nuovo un periodo che la gente si lascerà addormentare, anestetizzare da un po’ di pace e abbondanza. L’abbondanza e la pace fanno comodo a tutti. […] E magari per una questione di pane e minestra si sarà pronti a dare via tutto un’altra volta, la libertà un’altra volta…». Il terrorista è di fatto un’eccezione. Il movimento di espulsione del nemico (interno), dell’anomalia che caratterizza la macchina politica del nuovo Stato repubblicano, sembra muoversi analogamente alla macchina politica del regime fascista: in entrambi i casi l’anomalia va espulsa per riconfigurare una identità nazionale di nuovo armonizzata. Ma la differenza tra i due movimenti in realtà salta agli occhi. La macchina politica che produce la nuova società italiana del dopoguerra non funziona come il Gestell heideggeriano80, l’“impianto”, il dispositivo che costruisce e si muove per inclusione. Nella prospettiva heideggeriana della macchina politica di costruzione della comunità politica, una “parte” della società stessa diventa e si pone come il “tutto” della società e, così 80
Sulla lettura del Gestell heideggeriano come macchina politica del Due, cfr. R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, cit.
332
Lessico del cinema italiano
facendo, elimina o nega tutto ciò che è “separato”, “escluso”. È il movimento della logica del fascismo e delle sue immagini, come si è visto. Ciò che contraddistingue invece la macchina politica che viene sperimentata negli anni sessanta è il fatto che la separazione, la logica del Due che sta dietro ogni macchina politica, viene negata. L’antagonismo perde di reale consistenza a vantaggio di una visione totalmente unificante, conciliante. La macchina politica si fonda allora sulla negazione di ogni dialettica del nemico: l’aberrazione del fascismo deve essere superata in virtù di un nuovo contratto sociale, che a sua volta produce un nuovo scenario delle immagini, in cui la dialettica del nemico scompare ed è tutta relegata al passato, appunto a quel Ventennio che deve essere superato81. Lo sguardo rivolto al passato si configura allora, soprattutto nella prima metà degli anni sessanta, come lo sguardo che, sancendo la necessità di una memoria storica della prima metà del Novecento, finisce per negarla come aberrazione provvisoria, malattia che non intacca però l’identità italiana. In Italiani brava gente (1964) di Giuseppe De Santis, il passaggio è netto, quasi programmatico. In un film velato di cupa drammaticità – il racconto, corale, si snoda come una storia di fantasmi, racconti di soldati italiani in Russia che rievocano la loro morte, guardando, appunto, indietro – il nemico ufficiale (l’Armata Rossa, il popolo russo) non è in realtà il nemico, gli alleati (i nazisti) non sono veri alleati e la guerra perde ogni reale motivazione. Ciò che resta è una mappatura di tipi sociali, di figure che rappresentano un’Italia multiforme e regionalizzata, ma unita da un comune sentire: dal proletario romano al contadino romagnolo, dal muratore pugliese al tipografo toscano, i protagonisti del film di De Santis non sono solo un campionario dell’anti-eroismo che attraversa la rappresentazione dell’italiano nel cinema degli anni sessanta82, ma proprio in quanto spettri, fantasmi, essi diventano il resto, ciò che resta, ciò che non passa, che non si dimentica, di una Storia altrimenti folle, negativa, distruttiva. 81 82
M. Zinni, Fascisti di celluloide. La memoria del Ventennio nel cinema italiano (1945-2000), Marsilio, Venezia 2010, p. 99 sgg. Cfr. A. Vitti, Giuseppe De Santis and Postwar Italian Cinema, University of Toronto Press, Toronto 1996, pp. 119-121.
Nemico Daniele Dottorini
333
In Italiani brava gente, così come in molti altri film degli anni sessanta83, il nemico scompare, così come il fascismo, l’orrore della guerra, l’ottusità del potere. Rimane – ed è l’eredità che una generazione ha lasciato a quella successiva – una sorta di sentimento democratico, umanista, sostanzialmente slegato dalle dinamiche del potere, scettico di fronte alla ragion di Stato. Quella che si configura è allora una duplice faccia del cinema della memoria del secondo dopoguerra: se da una parte l’esigenza di ripristinare un’immagine dell’antagonismo, del Due che seppure in forma spettrale ha attraversato la prima metà del secolo, dall’altra tale antagonismo viene esorcizzato, ricacciato lontano come anomalia appunto, forma da dimenticare a tutti i costi (come il Franco di La lunga notte del ’43) o da negare come estraneo all’identità italiana (come in Italiani brava gente). Quello che manca in questo duplice movimento è la possibilità di ripensare in termini contemporanei una dialettica del Due, di pensare la conflittualità crescente della società italiana attraverso nuove immagini, in grado di riproblematizzare la logica del nemico alla luce delle trasformazioni politiche e sociali che investono l’Italia e il mondo nel periodo che va dal 1968 al 1977. È in questa fase che l’opposizione tra hostis e inimicus, tra nemico esterno e interno esplode, si riconfigura in una dinamica più complessa, capace però di creare nuove immagini e nuovi sguardi. Il ritorno del Due È dunque nella stagione che si apre alla fine degli anni sessanta, e che prosegue lungo tutto il decennio successivo, che il cinema italiano elabora una nuova torsione nella sua personale storia delle immagini. L’antifascismo del decennio precedente si era sviluppato con la finalità di superare un antagonismo visto come anomalia 83
Basti pensare, tra gli altri, a film anche molto diversi tra loro come Il carro armato dell’8 settembre (Puccini, 1960), in cui l’unica ossessione costante è quella di riportare in caserma il carro armato; a I due nemici (Hamilton, 1961), in cui la guerra è lo spazio estraneo di una amicizia speculare tra due ufficiali in campi avversi; a I due marescialli (Corbucci, 1961) e I due colonnelli (Steno, 1962), dove la figura di Totò crea un movimento di immunizzazione rispetto alla radicalità del conflitto e del nemico.
334
Lessico del cinema italiano
e infermità della storia italiana, ma le tensioni sociali e politiche che avevano attraversato gli anni sessanta, e che sfoceranno nella stagione che si apre con il 1968, imporranno con forza un ripensamento delle immagini e, soprattutto, una nuova idea del nemico, nuove forme della dialettica del Due. Se la separazione dal passato, che comprendeva anche l’annullamento del nemico, il suo sprofondamento nella Storia non più ripetibile, aveva caratterizzato, come si è visto, il cinema del secondo dopoguerra, la stagione che si apre ora è invece impregnata di una nuova consapevolezza politica. L’antifascismo e la Resistenza sono ancora valori condivisi, ma essi appaiono ora non come momenti di una anomalia da espellere, ma come: Argomento centrale di una completa messa in discussione della storia repubblicana, alla luce dei tradimenti del suo spirito originario. […] La messa in discussione dei valori su cui si poggiava il sistema di governo venne così compiuta richiamando il passato come punto di partenza per un cambiamento nel presente, utilizzando la lotta al fascismo come fosse un antenato recente della lotta che nei primi anni settanta si doveva combattere contro un nuovo fascismo risorgente84.
La stagione che si apre alla fine degli anni sessanta inaugura allora una nuova dialettica del Due, in cui, nei movimenti culturali e politici che nascono all’interno della sinistra italiana, passato e presente della storia del Paese tornano a saldarsi in una lettura tesa ad evidenziarne le continuità più che le fratture. Non c’è, in questa lettura un vero e proprio cambiamento tra stato liberale, stato fascista e stato democratico, ma una mutazione dei volti e delle immagini del potere. Il nemico ha diverse facce, muta la propria immagine all’interno di un antagonismo che attraversa trasversalmente tutta la modernità. Il nemico ritorna, incarnandosi ora però totalmente in una serie di forme al tempo stesso interne ed esterne. Il nemico è interno, perché si annida nelle strutture stesse dello Stato e degli organismi di potere, ed è esterno perché totalmente e radicalmente altro da ogni ipotesi democratica. L’universo delle immagini si riconfigura allora secondo una nuova logica dell’antagonismo, che rilegge passato e presente lungo una linea di perenne conflittualità interna. 84
M. Zinni, Fascisti di celluloide, cit., p. 180.
Nemico Daniele Dottorini
335
Tutto è conflitto, dunque il nemico si presenta molteplice e multiforme, non sempre e non chiaramente riconoscibile. Compito dell’immagine carica di senso politico è quello allora di riconoscerlo, svelarlo, renderlo visibile, restituirgli un corpo: il cinema politico degli anni settanta assume dunque una doppia finalità: quella di mobilitare, diffondere idee e consenso, e quella di demolire criticamente il “nemico”85. I modelli del cinema politico del decennio sono quindi vari, spesso profondamente diversi gli uni dagli altri. Dal cinema militante che fa dell’immagine stessa un’esperienza e un laboratorio politico alternativo alle logiche dominanti (basti pensare al cinema di Alberto Grifi) passando per il cinema di denuncia di autori come Francesco Rosi o Elio Petri, di un cinema che rilegge presente e passato al fine di costruire una sorta di controstoria, in cui le trame del potere occulto, le forme nascoste e invisibili del nemico possano essere riportate alla luce, svelate e mostrate. L’idea di continuità tra le forme del potere (e quindi di persistenza di un conflitto politico in Italia) emerge nelle nuove immersioni del cinema lungo i solchi della Storia, come già aveva fatto un film come All’armi siam fascisti (1962) di Lino Del Fra, Cecilia Mangini e Lino Micciché. Il film è un found footage ideologico (forma che attraverserà trasversalmente tutto il cinema italiano lungo gli anni sessanta e settanta86) dove il montaggio di immagini di repertorio costruisce la base per un nuovo percorso di lettura della Storia – in particolare della storia d’Italia dal 1911 al 1945 – affidato ad un commento (di Franco Fortini) in cui le forme dell’enunciazione mettono in gioco l’alternanza e l’opposizione tra un “noi” e un “loro”. All’armi siam fascisti si pone allora come film che vuole rendere visibile (attraverso l’uso della parola, più che dell’immagine) la dialettica del nemico, costruendo un discor85 86
Cfr. P. Ortoleva, Cinema politico e uso politico del cinema, in Storia del cinema italiano, vol. XII, 1970-76, a cura di F. De Bernardinis, MarsilioEdizioni di Bianco & Nero, Roma-Venezia 2008, p. 160. Basti pensare a La rabbia (1963) di Pier Paolo Pasolini e Giovanni Guareschi o a Forza Italia! (1978) di Roberto Faenza. Naturalmente, se la forma del found footage accomuna questi lavori, non per questo si tratta di opere analoghe. La parte di Pasolini di La rabbia si rivela ben più che una controlettura ideologia della Storia, e si pone come riflessione poeticopolitica sulla dialettica del Due, sulla conflittualità presente e passata della storia italiana e mondiale, quasi un presupposto del rovesciamento radicale che il regista compirà con Salò, come si vedrà.
336
Lessico del cinema italiano
so capace di rileggere politicamente la Storia, evitando il rischio dell’antifascismo generico e umanista che aveva attraversato gli anni sessanta87. Di nuovo quella del nemico si presenta come una dialettica che mette in gioco la polarità visibile/invisibile, ma tale dinamica cambia radicalmente di segno. Se l’invisibilità del nemico, la sua indeterminabilità ha a che fare, nella prima parte del Novecento, con una immagine che si scontra contro l’impossibilità di individuare uno hostis, del nemico esterno reale e radicale, l’invisibilità del nemico ha ora a che fare con la consapevolezza politica e ideologica di un conflitto che non si presenta come tale, che si nasconde e si maschera all’interno di una falsa pacificazione e coesione sociale. In questo caso il nemico esiste, è reale e parte integrante di un antagonismo feroce, ma esso è nascosto, mimetizzato, interno (cioè inimicus) al tessuto stesso della società, ma di cui non rappresenta che una parte radicalmente altra, la parte del potere. Ma il problema di una tale immagine è il problema della sua visibilità, della sua riconoscibilità. Se il nemico nuovo/vecchio è in apparenza invisibile, riconoscerlo è difficile, se non impossibile. Il rischio di ogni cinema politico è quello di non poter/saper riconoscere il nemico, soprattutto quando questo è mimetizzato, è parte integrante della società, fulcro interno del suo funzionamento. In Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970), Elio Petri teorizza e mette in pratica questo stato sospeso dell’immagine, proprio attraverso la costruzione di un meccanismo in cui l’uomo dello Stato, il funzionario di polizia, si ritrova ad esercitare un potere senza controllo, compiendo un omicidio che non viene scoperto, non viene portato alla luce; l’uomo scopre così non tanto e non solo la propria intoccabilità, ma il fatto di non poter essere riconosciuto come nemico, come criminale, deviante, parte negativa della società. Il poliziotto dissemina dietro di sé miriadi di prove della sua colpevolezza, senza che questo porti al suo smascheramento. Il funzionario di Petri è l’emblema del nuovo nemico, come si diceva interno ed esterno al tempo stesso, figura ambigua e irriconoscibile, a cui occorre disperatamente 87
Cfr. M. Bertozzi, Recycled cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Marsilio, Venezia 2012, pp. 70-71.
Nemico Daniele Dottorini
337
dare un volto. La frase di Ka a con cui si chiude il film esprime con inquietante chiarezza la nuova dimensione potremmo dire ontologica del nemico: «Qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano». Il brano, estratto dal discorso del prete a K. in Il processo, si erge come sorta di barriera metafisica in quella che nel decennio di cui stiamo parlando può essere identificata come la nuova logica del Due. Il nemico esterno è totalmente scomparso all’orizzonte, perché le logiche dell’antagonismo sono ormai viste come parte integrante del funzionamento della società. Il nemico è tale in quanto è il dispositivo stesso (lo Stato, le forze dell’Ordine, le strutture produttive, economiche e finanziarie, il potere legislativo e giudiziario) che per funzionare produce figure che mantengono efficace la dinamica oppressiva della società. Per far ciò il nemico deve essere invisibile e soprattutto produrre capri espiatori, falsi nemici (esponenti della cultura militante e alternativa alla società dominante, figure di outsider, di emarginati) da investire del ruolo di inimicus della società. Non è un caso che la figura su cui si orientano i sospetti degli inquirenti nel film di Petri è quella dello studente anarchico Antonio Pace, che diventa la figura impossibile del capro espiatorio (Pace è l’unico che riconosce il poliziotto come l’autore dell’omicidio, ma non lo denuncia e viene rilasciato). Nell’affresco gelido di Petri, ciò che manca è il riconoscimento del colpevole, proprio perché totalmente interno ai meccanismi del potere. La nuova logica del Due è dunque fondata su una costruzione sistematica del nemico, ogni volta fondata sulla dinamica del potere e del suo mantenimento. Ecco che allora il nemico viene costruito, inventato e reso credibile attraverso la potenza dei media – come accade in Sbatti il mostro in prima pagina (1972) di Marco Bellocchio, dove è la potenza politica di un quotidiano a costruire il “mostro” – un giovane militante extraparlamentare di sinistra – accusandolo di aver assassinato una giovane studentessa. La consistenza del nemico è allora ora strettamente legata alla possibilità di crearne l’immagine. La società mediatizzata si affaccia nella tarda modernità. Nel cinema politico degli anni settanta, sia esso sperimentale, militante o di denuncia, riecheggiano le osservazioni machiavelliane sulla continua mutazione dell’“Inimico”, che non è mai on-
338
Lessico del cinema italiano
tologicamente tale, ma che lo diventa di volta in volta, in funzione della contingenza e della necessità del mantenimento del potere. Ancora: nella nuova configurazione della dialettica del Due si ritrovano chiaramente anche le posizioni leopardiane sull’indifferenza del nemico, la cui individuazione è sempre politica, sempre guidata da una scelta razionale, dalla necessità del mantenimento del potere. Paradossalmente, diventa più facile, allora, spostare lo sguardo, costruire immagini del nemico o letture della dialettica amico/nemico allontanandosi dal territorio italiano, come fa Gillo Pontecorvo, che in film come Kapò (1960), La battaglia di Algeri (1966), Queimada (1969), Ogro (1979), disegna letteralmente una mappa internazionale delle forme del conflitto, costruisce figure di nemici radicali, di vittime e carnefici, di ingiustizia e aspirazione alla libertà rivoluzionaria. E lo fa in spazi altri, reali e irreali al tempo stesso: lo sguardo documentario di La battaglia di Algeri è lo spazio fantastico attraverso il quale poter costruire un’immagine politica del mondo; il corpo divistico, ribelle e stanco di Marlon Brando in Queimada è la possibile incarnazione di un cinema epico e politico insieme; la memoria del western di Sergio Leone riecheggia nel volto stanco di Gian Maria Volonté in Ogro: ogni film si pone allora come tassello di una lettura del passato e del presente sotto forma di lotta rivoluzionaria, di ribellione dalla schiavitù e dall’oppressione. Soprattutto, sotto forma di slittamento spaziale e temporale, dall’Italia al mondo, dal presente al passato. In effetti la mutazione, lo slittamento diventa in questi anni la cifra tematica, prima ancora che stilistica, del cinema. L’immagine italiana mostra chiaramente la riconfigurazione della logica del Due, evidenziandone con forza la struttura dialettica sempre più complessa. Dalla negazione del nemico come hostis, che attraversa in forma molteplice e articolata come si è visto tutta la prima parte del Novecento (e dove il momento dialettico è sancito dallo sguardo rosselliniano che rilancia la dimensione della coesione e della connessione), al riconoscimento della concretezza del nemico come nemico “interno”, che si annida però nella struttura stessa del potere, facendo della capacità mimetica, della potenza dell’invisibilità i suoi strumenti d’azione privilegiati.
Nemico Daniele Dottorini
339
La sutura e la fine della modernità: Salò e Novecento Secondo Jean-Luc Godard e Serge Daney88 la modernità del cinema italiano si apre e si chiude con un doppio sguardo, inaugurale e finale: un doppio sguardo rappresentato, incarnato da due potenti idee di cinema: quella rosselliniana e quella pasoliniana. Se la prima inaugura la seconda metà del secolo con la pratica di un cinema della prossimità – prossimità dello sguardo come dell’incertezza e inquietudine del reale – il secondo lo chiude con una ulteriore torsione che sembra lavorare a fondo la crisi del visibile, che attraversa tutto il secondo Novecento, e che ridetermina, come abbiamo già iniziato a vedere, la figura stessa del nemico. La prospettiva rosselliniana, come si è detto, annulla la dialettica del Due sotto la legge pratica della prossimità. La vicinanza nega l’alterità del nemico, soprattutto del nemico come hostis, esterno e reale. Tutto il cinema italiano del secondo dopoguerra in fondo lavora a partire da questo annullamento, fino a produrre una sorta di anestetizzazione di ogni logica e dialettica del Due o fino a riprodurla in forme interne, parziali e parcellizzate: i percorsi si moltiplicano lungo il passaggio aperto nel decennio dei settanta. Ma non per questo il nemico scompare, anzi. La negazione del riconoscimento del nemico esterno come parte integrante e al tempo stesso trasversale lungo il percorso delle immagini italiane, è il desiderio di svelare le forme attraverso le quali l’antagonismo della storia d’Italia si sia configurato come conflitto interno, come lotta spesso nascosta tra inimici sempre cangianti, al di là di ogni rappresentazione ufficiale. L’effetto della prossimità è allora duplice. Prossimo è sia l’amico, sia il nemico. La macchina da presa della modernità si avvicina al mondo, mostrando la sua complessità, evidenziando la realtà come forma cangiante, in cui è la conflittualità a dominare, e in cui il rapporto amico/nemico è di fatto il meccanismo stesso (interno e mutevole) della società. 88
Questa sorta di parabola della modernità italiana, ai cui poli stanno Rossellini e Pasolini, viene messa in evidenza da Daney in Lo sguardo ostinato. Riflessioni di un cinefilo, Il Castoro, Milano 1995, p. 5, e conclude la sezione sul cinema italiano in Histoire(s) du cinéma – 3A di Jean-Luc Godard (1988-1998).
340
Lessico del cinema italiano
In questa prospettiva lo sguardo del cinema si pone come operazione critica, forma iconica della scuola del sospetto, rovesciamento di ogni immagine pubblica. In Salvatore Giuliano (1962) di Francesco Rosi89, il particolare découpage del film costruisce una trama temporale non lineare sulla vicenda del famoso bandito siciliano. Rosi rovescia continuamente la logica di ricostruzione della storia, aggiungendo ad ogni inserto narrativo, quasi ad ogni blocco, degli elementi in più che mostrano altre prospettive, altre riletture. Tutto si rovescia a partire dal gesto inaugurale del film, il passaggio dal corpo morto di Giuliano – steso a terra, crivellato di proiettili nella prima sequenza – al corpo vivo della banda che, subito dopo la fine della guerra, dichiara un’altra guerra allo Stato italiano, appoggiando i gruppi indipendentisti siciliani. Le sequenze degli attacchi alle caserme dei carabinieri in Sicilia ad opera della banda Giuliano sono di fatto costruite con evidenti riferimenti alla tradizione del cinema western e del cinema bellico, che Rosi mostra di padroneggiare sapientemente e di utilizzare come strumenti di costruzione di uno sguardo-cinema, che rilegga criticamente la storia. La moltiplicazione dei blocchi narrativi, dei centri focali attraverso cui la vicenda è narrata, mostrano quindi la moltiplicazione dei nemici di Giuliano (lo Stato, la Mafia, i movimenti indipendentisti e monarchici, i suoi stessi compagni); nemici che non solo sono interni, non solo sono parte integrante della macchina politica del nuovo Stato Repubblicano, ma rappresentano machiavellicamente90 il motore stesso del suo funzionamento. Nel film tutti (a partire dallo stesso Giuliano) sono amici e nemici al tempo stesso, la dialettica mutevole è funzionale alla costituzione di uno Stato che afferma se stesso attra89
90
Il film di Rosi rappresenta in un certo senso la forma più estrema del filone del cinema sul banditismo come sguardo critico sulla storia d’Italia e sui rapporti con il Meridione: è questo che, al di là delle notevoli differenze, accomuna titoli che hanno scandito gli anni sessanta e oltre, come Banditi a Orgosolo (De Seta, 1961), Il brigante (Castellani, 1961), o Barbagia (Lizzani, 1969). L’elenco potrebbe naturalmente continuare e arrivare fino alla fine degli anni novanta, in una sorta di controstoria cinematografica dell’unificazione italiana al Sud. Nel senso che in Machiavelli, come si è visto, l’ordine stesso della macchina politica si basa sul conflitto costante interno, sempre sul punto di rovesciarsi in tensione irriducibile, ma sempre necessaria al suo funzionamento, cfr. R. Esposito, Pensiero vivente, cit., pp. 56-60.
Nemico Daniele Dottorini
341
verso la negazione parziale dell’altro. E allora, da questo punto di vista, che cos’è quel corpo senza vita posto all’inizio del film, se non la traccia ormai inservibile del nemico/alleato/amico temporaneo Salvatore Giuliano? Ecco che quindi la dinamica del rovesciamento dello sguardo attraversa l’immagine in forme ossessivamente ricorrenti, spesso fin troppo esplicite e ridondanti: è il caso di Uomini contro (1970) di Francesco Rosi, dove l’esasperazione quasi schematica dell’assurdità della guerra (il film, ispirato a Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, è ambientato sul fronte italiano durante la Prima guerra mondiale) si rivela nel gesto (sin troppo melodrammatico) del Tenente Ottolenghi (Gian Maria Volonté) che sprona i suoi uomini a lanciarsi contro il generale Leone – il vero nemico – anziché contro gli austriaci, che sono figure quasi assenti dal racconto filmico, e Ottolenghi morirà per questo atto di ribellione. Ed è il caso anche di Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (1972) di Florestano Vancini, dove i cinque uomini accusati di aver provocato una rivolta vengono condannati a morte dal tribunale istituito da Nino Bixio, ex abrupto, come sottolinea uno di loro, l’avvocato Nicola Lombardo. Ottolenghi dunque, come prima di lui Giuliano, l’avvocato Lombardo e i cinque imputati del processo di Bronte sono quindi “nemici” temporanei, funzionali alle esigenze di un potere che di volta in volta deve affermare se stesso attraverso l’epurazione di ogni anomalia, a volte appositamente creata. Il nemico temporaneo. Ripercorrendo allora quanto detto sin qui, emerge un percorso complesso, in cui l’immagine, a partire dal neorealismo (e soprattutto a partire dalla forma rosselliniana), se da una parte annulla la radicale alterità del nemico, dall’altra ne scopre nuove forme, parziali e soprattutto interne. Il cinema italiano esplora la prossimità dello sguardo, mostra l’intreccio inestricabile tra sfera privata e dimensione politica, evidenzia come la struttura interna della società italiana si sviluppi nel secondo Novecento attraverso una dialettica del Due che non prevede risoluzioni, che non espelle mai una parte a favore di un’altra, ma in un certo senso ingloba continuamente ciò che di volta in volta individua come nemico. Le immagini ci consegnano un nemico quasi necessario, parte integrante dello sviluppo della società. È una dialettica congelata
342
Lessico del cinema italiano
in un certo senso: sia che le immagini siano declinate al passato (il Novecento e la fine dell’Ottocento come matrici storiche di uno Stato che si costruisce attraverso la finzione del nemico), sia che siano declinate al presente, le forme filmiche lavorano su una continua dissimulazione del reale antagonismo, smascherandolo, scoprendone i meccanismi, replicandone a volte le finzioni. Il nemico non esiste se non come funzione, si è detto, dunque non è neanche vero inimicus, nemico privato, singolo. È nemico cangiante, irreale come forma, ma reale come corpo e ormai sempre, radicalmente “interno”91. Il film che compie la sutura definitiva, che si pone come riflessione ultima dell’ambivalenza del nemico è senz’altro Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975) di Pasolini. Ritorniamo allora a quel doppio sguardo rosselliniano/pasoliniano, sempre più intimamente legato, parte di un percorso che rilegge la modernità anche attraverso la dissoluzione del nemico. Salò o la dissoluzione del nemico-altro, appunto. Pasolini testimonia in un certo senso il compimento della visione leopardiana di Lo Zibaldone: nella nazione moderna – scrive Leopardi – non si odia più lo straniero: si odia il vicino, il compagno, il concittadino. La guerra è dentro: «In guerra senza tregua, e in guerra d’ogni giorno, ora, momento, e in guerra di ciascuno contro ciascuno. […] Qual nemicizia dunque è più terribile? Quella che si ha coi lontani, e che si esercita solo nelle occasioni, certo non giornaliere; o quella ch’essendo co’ vicini si esercita sempre e nel continuo?»92. Guerra senza tregua, violenza che costituisce l’andamento stesso della modernità, nel suo punto finale. Ecco allora affacciarsi Pasolini come polo terminale del percorso sin qui affrontato. Salò si pone infatti, da questo punto di vista, come un vero e proprio saggio filmico, con tanto di bibliografia di riferimento posta all’inizio del film, durante i titoli di testa. La geometria dell’inquadratura domina lo spazio della visione. La modernità disegnata more geometrico in Salò è questa: è la guerra continua, il conflitto che è 91
92
È questa sorta di “guerra civile perenne” ad attraversare l’immaginario del cinema moderno che dà corpo ed immagine ad una modernità fondata sulla conflittualità perenne: cfr. Il nemico interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), a cura di C. Bermani, Odradek, Milano 2003. G. Leopardi, Lo Zibaldone dei pensieri, cit., pp. 636-638.
Nemico Daniele Dottorini
343
parte integrante della società. I quattro signori che danno vita alla microsocietà simmetrica di Salò acquisiscono, nella prima parte del film, i corpi necessari alla loro messa in scena. Corpi di ragazzi e di ragazze, destinati ad impersonare o le vittime o i carnefici, quasi con indifferenza. L’indifferenza leopardiana diventa orrore nella villa del film pasoliniano. Pasolini riconduce le forme del dominio e della sottomissione, della prigionia e del controllo totale a spettacolo quotidiano, “rituale normale”. Il potere in Pasolini mira anzitutto ad annullare il desiderio e a mostrarsi come spettacolo ripetuto. Non esiste più alcuna logica del nemico, alcuna opposizione, se non quella tra vittime e carnefici, ma Pasolini mostra come questa opposizione sia in realtà una comune co-appartenenza. Vittime e carnefici, repubblichini e prigionieri, signori e servi sono parte integrante di un unico meccanismo, in cui, di fatto non c’è più alcun conflitto, alcuna guerra, alcun nemico: «Se la sopravvivenza alimenta nelle vittime la speranza di una possibile estraneità futura ai carnefici, allo stesso tempo le trasforma in complici, perché l’assenza di reazione legittima e rende vere le regole sadiche del destino altrui»93. La geometria della visione di Salò sembra rispondere ad un meccanismo, ad un dispositivo di visione raggelante, che di fatto mostra una dinamica immobile. Pasolini trasforma la dialettica del Due (amico/nemico) in una sorta di parodia della figura hegeliana servo/padrone, ma come rileva Jean-Louis Comolli: «Il desiderio dei padroni si scontra costantemente con l’opacità dei “soggetti” che si piegano al loro gioco senza piegarvisi; e che in definitiva, i padroni non riescono a ridurre a propri fantasmi qualsiasi vessazione esercitino»94. Ecco allora che il percorso Rossellini-Pasolini si svela (anche) come il rovesciamento (o prosciugamento) progressivo della forma della prossimità. L’avvicinamento rosselliniano, se da una parte nega la figura dello hostis, del nemico reale esterno come fondamento del politico, dall’altra mostra, nelle trame stesse dell’esistenza, la conflittualità e l’antagonismo come parti inte93 94
S. Murri, Salò o le 120 giornate di Sodoma, Lindau, Torino 2001, p. 110. J.-L. Comolli, Vedere e potere. Il cinema, il documentario, l’innocenza perduta, Donzelli, Roma 2006, p. 117 [ed. or. Voir et pouvoir: L’innocence perdue: cinéma, télévision, fiction, documentaire, Verdier, Paris 2004].
344
Lessico del cinema italiano
granti del tessuto della politica, senza però alcuna riconoscibilità unica e definitiva della figura del nemico. Il nemico funzionale, il nemico intercambiabile, il nemico invisibile o negato, il nemico temporaneo: sono tutte forme della dissoluzione del Due che si intensificano sempre più nella modernità. Pasolini ne sancisce, con Salò, la definitiva trasformazione in falsa dialettica, in pura e immobile (parodica95) figura di dominazione. Salò determina dunque una sutura in senso filosofico96, cioè la fine della libertà dei corpi, il loro assoggettamento alle logiche di un potere sterile e immobile che non fa altro che ripetere se stesso, parodiandosi, balbettando in fondo97. La dialettica del Due si blocca nella sutura che fa di Salò un film ultimo (avallato in questo giudizio dalla morte di Pasolini), ma non per questo terminale. La sutura di Salò è dunque sancita dall’immobilità del film, dalla sua gelida geometria, dal suo essere una pura macchina della visione. Mentre Pasolini realizza Salò, nelle stesse zone dove il regista bolognese sta girando quello che sarà il suo ultimo film, Bernardo Bertolucci è impegnato sul set di Novecento (1976), lavoro che in un certo senso costituisce un ulteriore tentativo di fare i conti con la dialettica del Due. Anche qui, come nel film di Pasolini, la forma della ripetizione domina. Il Due ossessiona la forma stessa del film di Bertolucci: due padri e due figli, due generazioni, due guerre, due classi sociali, due epoche del Novecento; una, fino al 1945, visibile nel film, l’altra, dopo il 1945, 95
96
97
Vedi il concetto di parodia in Agamben, cfr. Parodia, in Id., Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005, pp. 44-52, dove Agamben riflette sul ruolo di Salò come «parodia seria», come forma che costruisce un particolare discorso sulla Storia e il presente. Nel senso che Badiou attribuisce al termine, la sutura è la chiusura dell’orizzonte della circolazione delle verità intorno ad un’unica condizione di verità che diventa onnicomprensiva, escludendo ogni altra possibilità del discorso: cfr. A. Badiou, Manifesto per la filosofia, SugarCo, Milano 1991, p 48 [ed. or. Manifeste pour la philosophie, Éditions de Seuil, Paris 1989]. «La reiterazione è una figura chiave, anche dal punto di vista strutturale e figurativo, in Salò […]. Ed è proprio il gesto annientatore a provocare e ricreare all’infinito la gigantesca pletora corporale. Nel momento che non c’è più corpo non c’è altro che corpo», S. Parigi, I “rifacimenti” di Pasolini, in Il cinema del riflusso. Film e cineasti italiani degli anni ’70, a cura di L. Miccichè, Marsilio, Venezia 1997, p. 113.
Nemico Daniele Dottorini
345
vissuta nel mondo ma non dal film. La sequenza iniziale, posta programmaticamente al centro del secolo breve – nel 1945, a guerra appena finita – mostra la morte inutile di un giovane partigiano che, a guerra finita, sta tornando a casa, cantando. Il ragazzo viene ucciso all’improvviso da un giovane repubblichino che si sta nascondendo nella radura e nel momento in cui viene colpito un’espressione di stupore, più che di dolore, si dipinge sul suo viso. La guerra in Bertolucci finisce all’inizio della narrazione, ma il Due riemerge immediatamente dopo, con la morte di Attila e Regina, la coppia demoniaca di fascisti che tenta di fuggire inutilmente, perché le contadine della tenuta li scoprono e li uccidono. Novecento ripensa la logica del Due attraverso una riconfigurazione della forma cinematografica, che cerca un nuovo respiro epico e attinge a piene mani alla tradizione del racconto hollywoodiano da una parte e alla tradizione del grande romanzo ottocentesco dall’altra. La fine della guerra, la dissoluzione del nemico esterno non cancella il conflitto che è però fondato nella dinamica stessa del Secolo (il secolo del Due, come ricordava Badiou). Padri e figli, generazioni e classi, uomini e donne, contadini e padroni, continueranno ad essere nemici. Ma tutto questo è solo evocabile, immaginabile forse in Bertolucci: Novecento rimane ancorato alla sua frattura visibile, a quel 1945 che inizia e conclude il suo racconto. Ciò che manca è proprio il secondo Novecento, lo spazio/tempo in cui la dialettica del Due inizia ad assumere i tratti incerti di uno stato dell’essere senza più movimento, uno stato di crisi. La sutura pasoliniana e la ripetizione quasi ontologica del Due in Bertolucci costituiscono allora alcune delle forme di una riflessione amara su un secolo che si sta chiudendo senza alcuna pacificazione ma anzi, nel nome di una moltiplicazione quasi incontrollabile dei conflitti, e dei nemici, senza forma e senza definizione. La malinconia del nemico. Colpiti al cuore La seconda metà degli anni settanta è infatti anche il periodo in cui un nuovo conflitto ridisegna la mappa delle immagini del reale: il conflitto Stato/terrorismo. Gli anni di piombo contribuiscono a riconfigurare ancora una volta la percezione del Due, non perché
346
Lessico del cinema italiano
ne restituiscano i confini netti e riconoscibili, ma al contrario perché contribuiscono a renderli ancora più sfuggenti e inquietanti. Gli anni di piombo sono anni oscuri certo, anni di opacità dello sguardo, dove l’immagine scopre e dissemina le forma del timore e della paura. Il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro, nel 1978, l’uccisione di Peppino Impastato, la strage alla stazione di Bologna sono solo alcuni esempi di una strategia della tensione che attraversa l’Italia negli anni settanta e ottanta. Ma la seconda metà degli anni settanta è anche un’epoca di sperimentazione creativa, di libertà delle forme, di moltiplicazione delle strade di uno sguardo cinematografico che esiste anche al di là della crisi, perlomeno in alcune forme, in alcuni spazi. Eppure la sutura agisce nelle dinamiche dello sguardo cinematografico. Agisce mostrando la crisi della visibilità che colpisce un cinema proprio per questo straordinariamente lucido. Il cinema di quegli anni mostra infatti con lucidità estrema e in forme molteplici l’incertezza che domina il proprio sguardo. Incertezza e smarrimento, perdita di equilibrio e di punti di riferimento. Il cinema che nasce e si sviluppa negli ultimi due decenni del Novecento si confronta con la perdita progressiva o la trasformazione, la mutazione delle certezze politiche e sociali. La dialettica del Due torna ad essere avvolta dalla nebbia, non perché non sia più possibile pensare il nemico, ma perché i suoi confini sfuggono, la sua stessa visibilità è a rischio, non è più certa. Ma cosa si intende per incertezza dello sguardo? Cosa provoca in una immagine che non può se non mostrare l’impossibilità di una chiara dialettica del Due, che ruolo estetico/politico assume il rapporto amico/nemico? Alcune parole chiave indicano le tendenze che attraversano il cinema italiano lungo gli ultimi due decenni del Novecento, fino al ritorno di una passione del reale, parole che attraversano e condensano a volte le immagini; parole come chiusura, sconfitta, malinconia e sogno. 1) La chiusura. In un film centrale nella storia delle immagini, quale è Prova d’orchestra (1979), Federico Fellini costruisce uno spazio che sarà dominante nel cinema contemporaneo, quello di un conflitto che implode su se stesso, che permea di sé ogni spazio del mondo, creando però bolle artificiali (lo spazio delle prove dell’orchestra), in cui in fondo rifugiarsi:
Nemico Daniele Dottorini
347
Il conflitto è dappertutto. Tra interno ed esterno: all’inizio del film, sui titoli di testa, il rumore del traffico cittadino, congestionato e attraversato da una sirena spiegata: quindi i primi racconti degli orchestrali che prendono posto di fronte ai loro leggii, trascinando nell’antico auditorium il mondo esterno, fatto di saune, di liti per le precedenze al semaforo, di nevrosi e di ansiolitici; poi, alla fine del film, la grande sfera d’acciaio che sfonda la parete, dopo che l’esterno, ancora una volta, si è affacciato minaccioso attraverso gli slogan che hanno imbrattato la cappella. Ma il conflitto è anche all’interno: tra gli orchestrali, che si odiano l’un l’altro, tra gli strumenti, ciascuno dei quali vuole prevalere, tra il direttore […] e i professori dell’orchestra; e tra il direttore e gli esponenti del nuovo potere democratico, il sindacalista e il responsabile dell’orchestra98.
In Prova d’orchestra il conflitto è onnipresente e lo spazio sempre più ristretto, soffocante. Ma il conflitto disseminato è uno stato dell’essere più che una dinamica di formazione del politico (come voleva Schmitt). Esso determina più lo stato di tensione del singolo, della collettività, della società, del mondo, più che un’identità o un movimento. Soprattutto, esso determina uno stato di ripiegamento in se stesso del mondo – appunto, la fine della dialettica – la chiusura del mondo stesso (dell’immaginario, della storia come progresso e cambiamento, ecc.). Laddove il nemico scompare – e insieme a lui scompare anche la riconoscibilità del conflitto, perché tutto è conflitto, interno ed esterno – il movimento che rivela lo sguardo è in realtà un ripiegamento, una chiusura. Non è un caso che quando il reale irrompe – la gigantesca sfera di metallo che distrugge la parete della sala prove – esso determina il ripiegamento dell’orchestra, il ritorno all’ordine all’interno della sala prove. La chiusura è il movimento che contiene il conflitto ormai non più gestibile e non più riconoscibile, ma che suscita solo terrore. La chiusura diventa allora una cifra stilistica costante e riconoscibile del cinema italiano, forma che condiziona film e corpi, spesso declinata come contromovimento di autoesclusione dal mondo, come nel cinema di Bertolucci (L’assedio, 98
G. De Vincenti, “Prova d’orchestra” di Federico Fellini. Sonorità senza sacralità, in Il cinema del riflusso. Film e cineasti italiani degli anni ’70, cit., p. 415.
348
Lessico del cinema italiano
1999) o come desiderio di fuga esotica dal mondo stesso, come nelle immagini di Gabriele Salvatores (Mediterraneo, 1991). La chiusura come limitazione dello sguardo e perdita di riconoscibilità del mondo. 2) La sconfitta. Quando le immagini si confrontano con i nuovi conflitti della tarda modernità – uno su tutti: il conflitto Stato/ terrorismo – emerge con forza la difficoltà di uno sguardo nel costruire categorie interpretative chiare della realtà. Di più, le forme dell’antagonismo che si disegnano nel panorama politico dell’Italia degli anni settanta e ottanta sembrano essere non tanto la chiave per una nuova trasformazione della realtà, quanto il segno della sconfitta di ogni interpretazione. Colpire al cuore (1982) di Gianni Amelio è, da questo punto di vista, un film esemplare. Se nella sua struttura narrativa portante, il film segue una costante tematica del cinema di Amelio, quella del rapporto adulti-bambini, al cuore della pellicola sta una frattura visibile e tangibile tra una realtà in fermento e un mondo di personaggi cui questa realtà e i suoi contorni sfuggono. Il professore universitario, suo figlio, gli ex allievi passati alla clandestinità: per tutti i personaggi la realtà diventa una zona d’ombra (accentuata dagli spazi vuoti, dai silenzi che attraversano il film, dalle ellissi) in cui si consuma un conflitto dove non è più possibile comprendere chi è amico e chi è nemico, dove si collocano i due poli della dialettica del Due: «Lo sfondo, d’altronde, è proprio quello dell’Italia dei primi anni ottanta, immersa nel “riflusso”, tra reticenze e ambiguità che nel film trovano forma nei silenzi, nei non-detti, nei non-visti con cui Amelio dà sostanza alla narrazione. Una operazione tesa a sottrarre azioni e fatti per puntare decisamente sugli echi e i riverberi che essi hanno sui personaggi»99. Nella non cospicua filmografia italiana sul terrorismo, colpisce come gli anni di piombo siano esemplari per evidenziare una crisi dello sguardo che non è più in grado di dare senso e forma ai conflitti interni alla società italiana. In una ideale parabola, Colpire al cuore si collega allora ad un film terminale come Buongiorno, notte (2003) di Marco Bellocchio, dove la sconfitta si mostra, sin 99
F. Crispino, Gli autori del “nuovo cinema e la televisione, in Storia del cinema italiano, vol. XIII, 1977/1985, a cura di V. Zagarrio, Marsilio-Edizioni di Bianco & Nero, Roma-Venezia 2005, p. 73.
Nemico Daniele Dottorini
349
dal titolo si può dire, come sconfitta dello sguardo, che a posteriori non può vedere la “notte della democrazia” se non come sogno allucinato. Nel finale del film di Bellocchio, la visione ci consegna la “fuga” di Aldo Moro dalla prigionia, un finale controfattuale o meglio allucinatorio, quasi a voler ipotizzare un altro mondo possibile, un sogno a cui consegnare l’unico possibile riscatto dalla sconfitta. 3) Il sogno. Sognare, immaginare spazi e tempi onirici e allucinati. Di fronte alla crisi del visibile, all’impossibilità di leggere i conflitti interni che lacerano la contemporaneità del tardo Novecento, l’immagine crea, inventa, rilegge la dialettica del Due sotto forma di favola o di mito. La notte di San Lorenzo (1982), di Paolo e Vittorio Taviani racconta l’occupazione nazifascista nella campagne toscane come una favola raccontata da una donna ad un bambino in una notte d’estate, come una favola. E lo sguardo che conduce il racconto è proprio quello della donna che ritorna ai suoi ricordi d’infanzia e a volte vede la tragedia (il film prende spunto dal massacro di San Miniato, dove più di cinquanta persone asserragliate dentro la chiesa di un paese furono uccise dal proiettile di un cannone dell’artiglieria statunitense) sotto forma di racconto mitologico e dove il nemico (un miliziano fascista) viene ucciso dalle lance acuminate dei guerrieri greci che emergono improvvisamente da un campo di grano. La dimensione del sogno e dell’allucinazione diventa allora una forma attraverso la quale il cinema riprende la dialettica del Due, non per semplificarla, ma per evidenziare ancora una volta che la crisi del visibile costringe lo sguardo a ripensare i conflitti del passato proprio a partire dall’incertezza e dall’indefinitezza del presente. I Taviani, come anche il Bertolucci di Novecento, e come farà il Bellocchio di Buongiorno, notte reagiscono allora non solo alla perdita del presente, ma anche alla perdita di un passato i cui contorni iniziano ad affievolirsi. Sognare il passato non è dunque arrendersi all’incomprensibilità della Storia e dei conflitti che la attraversano, ma reagire a questa perdita, immaginando nuovamente il reale, riconfigurandolo come possibilità, come mito e, perché no, come allucinazione o delirio (come in Il principe di Homburg, 1997, di Marco Bellocchio). Il sogno della storia non è dunque necessariamente un rifugio o una fuga (o non è solo questo): sognare può significare in questo caso ampliare la potenza del rea-
350
Lessico del cinema italiano
le, la sua possibilità100. Ed è in fondo, quello che ha sempre fatto il cinema101. 4) La malinconia. Lo scollamento tra l’immagine e la comprensione del reale che colpisce il cinema ne sancisce certo lo stato di crisi, ma in fondo si tratta di una crisi feconda. Ed è proprio a partire dal riconoscimento della crisi che le nuove immagini possono portare alla luce, rendere visibile un Novecento in cui la dialettica del nemico è tutto fuorché risolta. L’immagine italiana si impregna di una malinconia particolare, una peculiare Stimmung attraversa corpi e situazioni. Lo sguardo della contemporaneità si volge indietro come l’Angelo della Storia di Paul Klee e vede sì rovine, ma anche un mondo che sembra non aver adempiuto fino in fondo a ciò che aveva promesso. Il “demone meridiano” è il nome, come ricorda Agamben102, della malinconia come malattia dell’esistenza, che qui potremmo rileggere come malattia della Storia, infermità di uno sguardo. La promessa non compiuta è quella del “nuovo mondo” che avrebbe potuto vedere la luce dopo il secondo conflitto mondiale, la Resistenza e la sconfitta del fascismo. È il mondo fatto di movimento incessante e vitale di Rossellini i cui personaggi sono ossessionati dal «demone della mobilità» come ricordava Bazin103. Ma i personaggi rosselliniani, i fraticelli, Edmund, Karin, 100 È interessante notare che l’idea del sogno o della reimmaginazione della Storia, dei suoi conflitti e della dialettica del nemico, abbia attraversato lo sguardo di registi che girano in Italia con uno sguardo che proviene da altrove, come Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, che, nella loro trilogia dedicata a Elio Vittorini, Sicilia! (1999), Operai, contadini (2001), Il ritorno del figlio prodigo/Umiliati (2003), rileggono la storia italiana come storia di resistenza, dei corpi e dei luoghi, alla dominazione del potere, reimmergendo quella storia nel mito e nel gesto arcaico di una cultura della terra e del lavoro. O come fa, pur in una prospettiva completamente diversa, Spike Lee in Miracolo a Sant’Anna (2008), in cui il regista newyorchese reimmagina la strage di Sant’Anna a Stazzema, rivedendo l’evento storico, la tragica logica del Due con gli occhi di un bambino. 101 Cfr. una rilettura del rapporto tra cinema e storia come immaginazione della storia, quale quella che propone S. Arecco, Anche il tempo sogna. Quando il cinema racconta la storia, Ets/Edizioni di Cineforum, Bergamo 2004. 102 Cfr. G. Agamben, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale, Einaudi, Torino 1993, in particolare pp. 5-35. 103 Cfr. A. Bazin, Défense de Rossellini, in “Etudes Cinématografiques”, n. 3235 (1964).
Nemico Daniele Dottorini
351
Ingrid e tutti gli altri, che non fanno che camminare, inciampare, cadere, rialzarsi, osservare e vivere non ci sono più. Il cinema di Rossellini, nel passaggio alla televisione e alla seconda fase del suo lavoro si concentra invece sull’immobilità dei corpi104, quasi a sancire una impossibilità della Storia di pensarsi al presente, quasi rimarcando una frattura rispetto alla prima parte del Novecento, una frattura che impedisce di pensare alla storia come dialettica in atto, al superamento della logica del Due come nuova possibilità per una collettività. È da qui, riprendendo Agamben, che l’immagine si mostra come immagine malinconica. La Melancholia analizzata dal filosofo italiano diventa il modello (l’analogon) per uno sguardo ricorrente nel cinema italiano della fine del millennio e oltre: è lo sguardo che non riesce più a guardare avanti, che rilegge la propria storia come evento già finito, evento condannato a fallire, ma su cui non si può non volgere lo sguardo: «Poiché il suo desiderio rimane fisso in ciò che si è reso inaccessibile, l’acedia non è solo una fuga da…, ma anche una fuga per…, che comunica col suo oggetto nella forma della negazione e della carenza»105. I nuovi conflitti, le nuove dialettiche del Due, molteplici, nascoste eppure reali, totalmente interne e fondamentalmente legate al meccanismo stesso di funzionamento della macchina politica italiana della modernità, come si è visto, finiscono per alimentare nel cinema un malinconico scetticismo nei confronti dei momenti di fondazione di una identità italiana moderna, e, allo stesso tempo, lo inducono a ricercare attraverso altri sguardi, altre modalità dell’immagine le forme attuali del conflitto. La “fuga da”, che permea di sé il cinema di Gabriele Salvatores e attraversa soprattutto quello che è il manifesto di un cinema che sogna la possibilità di fuggire (vale a dire Mediterraneo) diventa una delle caratteristiche di una immagine che sogna malinconicamente la possibilità di fuggire da un mondo che non ha adempiuto al suo compito di liberazione. Ecco che allora il rapporto tra amico e nemico, la dialettica del Due del passato viene riletta alla luce 104 Cfr. J. Rancière, La favola cinematografica, a cura di B. Besana, ETSEdizioni Cineforum, Pisa 2006, in particolare il capitolo La caduta dei corpi: fisica di Rossellini, pp. 173-194 [ed. or. La fable cinématographique, Éditions de Seuil, Paris 2001]. 105 G. Agamben, Stanze, cit., p. 13.
352
Lessico del cinema italiano
del presente, alla luce del fallimento di ogni speranza. Il taglio può essere ironico come in Mediterraneo di Salvatores appunto, freddamente asciutto come in Uomini e no (1980) di Valentino Orsini, o attraversato da una disperazione lieve, consapevole di un mondo immobile, come in Concorrenza sleale (2001) di Ettore Scola. Ma la “fuga (impossibile) da” è sempre accompagnata da una “fuga per”, ricorda Agamben, una necessità di aprirsi comunque ad una nuova speranza, a ripensare la dialettica del Due in altre forme. Anche di fronte alla messa in crisi di una dialettica del Due, anche di fronte alla consapevolezza che le nuove forme del nemico sono troppo complesse per poter diventare chiaramente immagine, anche di fronte al senso di smarrimento di uno sguardo che malinconicamente osserva le mancate promesse del passato, l’immagine malinconica produce nuovi sguardi: «Così dialettica è la natura del suo “demone meridiano”. Come la malattia mortale, che contiene in sé la possibilità della propria guarigione, anche di essa si può dire che “la maggior disgrazia è non averla mai avuta”»106. Il nuovo millennio. Tracce di una guerra (non) finita Eppure le immagini continuano ad interrogare il reale. Il nuovo millennio si apre come continuazione del precedente, proseguendo molte delle linee aperte lungo i solchi del cinema moderno. La dialettica del nemico continua ad essere uno degli snodi centrali di un cinema che cerca di ritrovare il suo equilibrio, le sue coordinate. Gli sguardi si fanno a volte più acuti, a volte riprendono strade già battute, altre volte cercano di interrogare il presente e le nuove declinazioni della dialettica del Due. Il cinema degli anni duemila parte dalla consapevolezza che la figura del nemico è una figura cangiante, che si muove tra esterno ed interno, tra visibilità e invisibilità. È la società stessa a produrre i suoi nemici, proprio per questo mutevoli e non assoluti. Proprio per questo il cinema contemporaneo, più che creare rappresentazioni crea domande, interrogazioni. Perché lo scenario della nuova dialettica del Due radicalizza e al tempo stesso confonde e 106 Ivi, p. 14.
Nemico Daniele Dottorini
353
mescola le forme del nemico. La tradizionale differenza tra hostis e inimicus, che ha attraversato la storia delle immagini del nemico, come si è visto, sembra ora non essere così netta. Quello che è ormai evidente da tempo è che lo hostis (come nemico totalmente esterno ad una comunità) non è più né concepibile né rappresentabile, e che il modello della “guerra civile”, così come viene configurato da Claudio Pavone, è di fatto alla base delle molteplici immagini del nemico nella contemporaneità, contribuendo in questo modo a fondere e annullare le differenze storiche tra le forme del nemico. È anche per questo forse che il cinema italiano del nuovo millennio lavora ancora più consapevolmente sulle immagini del passato da una parte e del presente dall’altra. In entrambi i casi ciò che è dispiegata è la “passione del reale” che ha attraversato il Novecento; in entrambi i casi si tratta di comprendere quali forme di conflittualità (e dunque quale dialettica del Due) sono in gioco nello scenario contemporaneo. Immagini del passato e immagini del presente: il rapporto è molto più stretto di quanto si possa pensare. Tornare indietro con lo sguardo del cinema significa domandare, guardare con gli occhi dell’angelo della Storia per compiere un montaggio tra il tempo passato, il tempo del conflitto e il tempo presente, tempo dei molti, continui e mutevoli conflitti. C’è una linea trasversale lungo il cinema italiano contemporaneo che lavora in profondità la possibilità di fare dell’immagine un luogo dell’interrogazione, appunto un luogo del domandare. Ma cosa significa domandare, creare uno spazio di interrogazione? Domandare dal punto di vista del cinema significa adottare un punto di osservazione differente dal consueto, significa posizionare lo sguardo in uno spazio nuovo capace di creare nuovi rapporti, nuove relazioni. In questo caso, significa pensare il conflitto, e quindi la dialettica del Due, da prospettive completamente nuove. Se nel cinema degli anni sessanta, guardare indietro significa trovare una nuova immagine, nel cinema del nuovo millennio cercare un nuovo sguardo significa porre nuove domande, cercare nuove prospettive, creare nuovi rapporti. In film come Il mestiere delle armi (con cui si è aperto questo percorso) e il più recente Torneranno i prati (2014), Ermanno Olmi ripensa la guerra e la logica del nemico scegliendo ogni volta punti di vista differenti: il divario tra conflitto e tecnologia nel primo, il divario tra il tempo della guerra
354
Lessico del cinema italiano
e il tempo della natura (della montagna in questo caso), nel secondo. La creazione di nuovi rapporti, che sono rapporti di squilibrio, costringe allora il pensiero a riflettere sul rapporto di quelle immagini con il presente, con ciò che noi stessi siamo. Come pensare il conflitto dal punto di vista del rapporto uomo-donna? La costruzione del nemico in una prospettiva femminile è lo spostamento operato da Antonietta De Lillo in Il resto di niente (2004), in cui la figura di Eleonora Pimentel Fonseca è al tempo stesso corpo narrato e sguardo attorno al quale si organizza la narrazione, figura intellettuale e politica e figura umana, sguardo complesso attorno al quale la logica del conflitto – la rivoluzione napoletana del 1799 – viene rivista attraverso nuovi rapporti, nuove configurazioni dello sguardo. Nei film di Olmi come nel film della De Lillo, ciò che scompare è il nemico come rappresentazione concreta di un esercito o di un potere. Il nemico è il diffondersi di un’etica utilitarista in Il mestiere delle armi, il nemico è il non sapere vivere in armonia con i ritmi della montagna in Torneranno i prati; il nemico è nel non saper coniugare accettazione della differenza e anelito alla libertà in Il resto di niente. Ancora nuovi rapporti, nuovi punti di vista attraversano il cinema italiano. Mario Martone, in Teatro di guerra (1998), apre in un certo senso questa nuova prospettiva dello sguardo, creando un montaggio straordinario tra guerra e teatro. Il film di Martone si struttura non a caso intorno alle prove di un gruppo teatrale indipendente, che ha in progetto di allestire una versione dei Sette contro Tebe a Sarajevo, nel pieno della guerra che in quegli anni sta insanguinando l’ex-Jugoslavia. Il film deriva direttamente dal lavoro svolto nel 1996 dal regista, che aveva appunto allestito l’opera di Eschilo al Teatro Nuovo di Napoli. Deriva nel senso che ne riprende le prove, le improvvisazioni degli attori che costituiscono la fase di preparazione dello spettacolo, ma nel senso anche che circonda le riprese delle prove di altri mondi, vicini e lontani. Il gruppo teatrale prova in uno spazio che si trova all’interno di una Napoli popolare, apparentemente lontana dalla guerra, ma in realtà in essa immersa (anche se si tratta di un altro conflitto). Nelle immagini del film, quando gli attori sono fuori, in strada, dopo le prove, o perché le prove stesse li portano fuori, sembra all’improvviso riprendere corpo lo sguardo di Benjamin su Napoli, le parole scritte insieme a Asja Lacis nell’articolo sulla
Nemico Daniele Dottorini
355
città italiana107. Per Benjamin è la vita delle persone a caratterizzare ancora di più l’impossibilità di distinguere luoghi e forme, pubblico e privato, cerimonia e festa, vita quotidiana ed eccezione: La vita privata del napoletano è lo sbocco bizzarro di una vita pubblica spinta all’eccesso. Infatti non è tra le mura domestiche, tra moglie e bambini, che essa si sviluppa, bensì nella devozione o nella disperazione. […] La vita privata è frammentaria, porosa e discontinua. [...] Le azioni e i comportamenti privati sono inondati da flussi di vita comunitaria. L’esistere, che per l’europeo del nord rappresenta la più privata delle faccende, è qui [...], una questione collettiva. Così la casa non è tanto il rifugio in cui gli uomini si ritirano, quanto l’inesauribile serbatoio da cui escono a fiotti108.
Salta qui ogni distinzione netta tra interno ed esterno: tutto è compenetrazione, come ricorda qualche pagina dopo Benjamin, in un movimento in cui è il corpo, non la città a proiettarsi fuori, caoticamente, anarchicamente. Come le voci alte e babeliche delle grida che costituiscono il tappeto sonoro costante della città, come la gestualità unica e continua dei napoletani, afferma il filosofo tedesco. Questo rovesciamento dell’interno in esterno, si riverbera nelle immagini del film di Martone, fa sì che non ci sia una vera distinzione tra gli spazi del teatro dove gli attori provano lo spettacolo e le strade di una Napoli brulicante di vita e di tensioni. Ecco allora configurarsi un montaggio tra spazi e tempi differenti: Eschilo, la ex-Jugoslavia, Napoli, le forme del conflitto che si riverberano l’una sull’altra. Le figure dello hostis e dell’inimicus si confondono, perdono i loro confini, i loro tratti caratterizzanti. Il conflitto va pensato altrimenti, anche rischiando di mettere in gioco l’incomprensibilità del conflitto stesso, l’impossibilità di vedere una nuova dialettica del Due. Rapporti paradossali, nuovi montaggi (e quindi nuovi sguardi). Nella trilogia della guerra di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi – composta da Prigionieri della guerra 1914-1918 (1995), Su 107 Cfr. W. Benjamin, A. Lacis, Napoli, in W. Benjamin, Immagini di città, Einaudi, Torino 2007, pp. 3-13 [ed. or. Neapel, in “Frankfurter Zeitung”, 19 agosto 1925]. 108 Ivi, pp. 7, 13.
356
Lessico del cinema italiano
tutte le vette è pace (1998), Oh, uomo! (2004) – i due artisti/autori riprendono immagini girate durante la Prima guerra mondiale e le sottopongono ad una serie di operazioni di rallentamento, di rimontaggio, di accostamento e riassemblaggio che costringono chi vede ad interrogarsi su quelle immagini, sullo sguardo che le ha prodotte, sulle relazioni di potere tra chi filma e chi è filmato. Rivedere oggi quelle immagini significa ancora una volta annullare la finzione del nemico, la sua costruzione retorica e funzionale alla tradizionale dialettica del Due, e costringe il pensiero a focalizzare la sua attenzione su altri rapporti, su altre relazioni. Costringe appunto il pensiero a interrogare le immagini, sottrarle sì alla distruzione e all’oblio, ma per pensarle necessariamente al presente, tracce della sottomissione dei corpi. Il rapporto paradossale è allora non solo tra luoghi e corpi, ma quindi anche tra tempi diversi. Interrogare, domandare, significa anche chiedersi il senso oggi della dialettica del Due che ha attraversato il Novecento. È quello che mettono in evidenza registi della generazione della fine del XX secolo, come Daniele Gaglianone, che, nel 2008, con Rata nece biti (la guerra non ci sarà) filma la ex-Jugoslavia a partire dalle tracce di un conflitto che una volta finito perde i propri contorni, in cui amico e nemico non sono più riconoscibili, ma l’unica cosa che rimane sono le ferite nascoste, le ombre nelle parole, nei racconti e negli sguardi. Il nemico appare all’improvviso e scompare altrettanto repentinamente, senza che la sua consistenza rimanga materialmente visibile. Costretti a ripensare al loro passato, al loro vissuto, all’esperienza della guerra, i protagonisti di Rata nece biti sembrano chiedersi essi stessi come sia stato possibile improvvisamente che il prossimo possa essere diventato hostis, radicale e concreto. L’inquietudine della domanda è in fondo la stessa di Martone: il conflitto nei Balcani si riflette in ogni conflitto, moderno e del passato, proprio perché in gioco c’è anche la domanda su cosa è possibile ricordare, su cosa rimane lungo le tracce della Storia. Che cosa rimane allora della logica del Due all’aprirsi del nuovo millennio? Il cinema italiano non smette mai di produrre immagini del passato, ossessionato dal ritorno alla propria storia, spesso però con immagini che sono ormai cliché, che non riescono più veramente ad interrogare il rapporto tra i tempi della storia, tra le forme del nemico, a chiedersi veramente cosa
Nemico Daniele Dottorini
357
avvenga alla dialettica del nemico nella contemporaneità. Il cinema italiano produce ossessivamente in questi anni storie già viste, con personaggi standardizzati e artificiali, ossessivamente ripetuti nella convinzione che la Storia debba essere ricordata, che la memoria non debba essere perduta. La Prima guerra mondiale, il Fascismo, la Resistenza, il Risorgimento appaiono a fasi alterne, in immagini che spesso replicano loro stesse. Ma un vero sguardo al passato, uno sguardo che cerchi il rapporto impossibile tra i conflitti del tempo presente e la dialettica del Due del Novecento deve lavorare, come si è visto su altri rapporti, su altre posizioni dello sguardo. Ma piccole tracce appaiono, immagini che aprono al pensiero: ancora Gaglianone, che con I nostri anni (2000) realizza un film caratterizzato dalla volontà di raccontare lo scarto tra due epoche della storia, in cui due ex partigiani ormai anziani, scoprono che nella casa di riposo dove uno di loro alloggia è ospitato, malato e in fin di vita, uno dei capi fascisti che era il loro acerrimo nemico durante la Resistenza. In un bianco e nero sgranato, secco e senza compromessi, due corpi che non appartengono alla contemporaneità, il cui sguardo è perennemente puntato al passato di un conflitto in cui i nemici erano riconoscibili, si ritrovano ora a decidere se portare a termine la loro vendetta, dare libero sfogo all’odio accumulato nel corso del tempo o abbandonare il loro proposito. È insinuandosi in questo interrogativo che il film trova il suo punto di vista come rapporto non risolto tra passato e presente, nella consapevolezza che nuove immagini devono riuscire a raccontare, al di là di ogni sutura, di ogni semplificazione narrativa o iconografica, le nuove forme del conflitto che aprono la contemporaneità del cinema italiano. La necessità di trovare nuovi rapporti e nuovi sguardi esiste ancora, dunque, anche se le tendenze del cinema contemporaneo sembrano guardare altrove. Quelle che emergono allora sono alcune tracce, come si è detto, sguardi molteplici ma a volte dispersi, all’interno di una produzione che sembra in molti casi aver smarrito la capacità di fare i conti con la passione del reale. Il percorso è allora aperto, perché nuove immagini e nuovi sguardi possano aprire un nuovo pensiero del rapporto amico/nemico, ovverosia, un nuovo pensiero della politica capace di pensare la guerra perenne che anima in un certo senso la storia italiana e le sue immagini,
358
Lessico del cinema italiano
perché la dialettica del Due non scompare, a prescindere da ogni pacificazione universale, da ogni universalizzazione artificiale, da ogni pretesa di pensiero unico: Il XX secolo ha dichiarato che lui agiva, qui e ora. È quello che proporrei di chiamare la passione del reale e che, secondo me, bisognerebbe considerare la chiave per la comprensione del secolo. […] Il reale, come ben sanno tutti gli attori del secolo, è orribile ed entusiasmante, mortifero e creatore. Certo è che esso si trova, secondo la splendida definizione di Nietzsche, “al di là del bene e del male”. La convinzione del reale avvento dell’uomo nuovo ci colloca autonomamente in una totale indifferenza per il prezzo pagato, nella legittimazione dei mezzi più violenti. […] Il che mi porta a quella che, dopo la passione del reale, è senza dubbio la principale definizione del secolo: si tratta del secolo della guerra. Il che non significa solo che è pieno di guerre feroci, ma che è posto sotto il paradigma della guerra109.
La passione del reale e il paradigma della guerra: sono ancora queste le immagini da trovare per il cinema del XXI secolo. Ripercorrendo a ritroso il cammino sviluppato sin qui, emerge la possibilità allora di riprendere una delle domande che hanno aperto questo testo: che cos’è un nemico dal punto di vista di una teoria e di una storia delle immagini? L’obiettivo non era quello di tracciare un elenco di rappresentazioni, di incarnazioni della figura del nemico, ma di pensare la dialettica amico/nemico come dialettica politica, e dunque profondamente legata alla storia delle immagini italiane. Se quella di Carl Schmitt è stata una delle proposte teorico-filosofiche più potenti del XX secolo (proprio per la sua radicalità nel legare la costruzione del nemico alla fondazione e al mantenimento della società come corpus coeso), il percorso ha cercato di mettere in evidenza come tale concetto sia stato profondamente rielaborato, mutato, trasformato all’interno della storia delle immagini e della storia del pensiero italiani. Le pagine di Machiavelli o Leopardi, i corpi prossimi di Rossellini o quelli postumi di Pasolini, le riflessioni di Esposito e Agamben, l’invisibilità del nemico in Genina o la sua irrappresentabilità in Olmi e in tanti autori del cinema italiano compongono una potente riflessione alternativa. Una riflessione che non nega la centralità della Dia109 A. Badiou, Il secolo, cit., pp. 46-47.
Nemico Daniele Dottorini
359
lettica del Due come fondamento del politico, ma che è capace di indagarla a fondo, di mostrarne l’intrinseca finzione, la costitutiva ambivalenza. È in questo senso che il cinema italiano si lascia attraversare da quella che Badiou ha chiamato la passione del reale. Filmografia di riferimento La presa di Roma (Alberini, 1905), Tra le nevi e i ghiacci del Tonale (Comerio, 1916), La guerra e il sogno di Momi (De Chomón, 1917), I martiri d’Italia (Gaudio, 1927), Lo squadrone bianco (Genina, 1936), Scipione l’Africano (Gallone, 1937), Uomini sul fondo (De Robertis, 1941), I trecento della Settima (Baffico, 1943), Roma città aperta (Rossellini, 1945), Paisà (Rossellini, 1946), La grande speranza (Coletti, 1954), Il generale Della Rovere (Rossellini, 1959), La grande guerra (Monicelli, 1959), La lunga notte del ’43 (Vancini, 1960), All’armi siam fascisti (Del Fra, Mangini, Micciché, 1962), Salvatore Giuliano (Rosi, 1962), Il terrorista (De Bosio, 1963), Italiani brava gente (De Santis, 1964), Salò o le 120 giornate di Sodoma (Pasolini, 1975), Novecento (Bertolucci, 1976), Prova d’orchestra (Fellini, 1979), Colpire al cuore (Amelio, 1982), La notte di San Lorenzo (P. e V. Taviani, 1982), Teatro di guerra (Martone, 1998), Il mestiere delle armi (Olmi, 2001), Rata nece biti (La guerra non ci sarà) (Gaglianone, 2008).
F
C
OPERA
Dopo aver assistito al discorso filo-monarchico di Francesco Crispi in Parlamento – la rivendicazione ed esaltazione del compromesso anti-popolare sul quale si era voluta fondare la nuova unità d’Italia –, il rivoluzionario Domenico Lopresti si abbandona al suo monologo: In questo Parlamento, non sarà certo permesso discutere su quanto ciascun patriota ha sofferto e fatto. Gli esuli e gli ex-galeotti verranno celebrati tutti allo stesso livello, come dei rottami da enumerare sbrigativamente, i cui discorsi non producono che noia. Sono andato via come sono arrivato, nessuno mi ha notato, ma io non conto. Eravamo tanti, eravamo insieme, il carcere non bastava. Noi la lotta dovevamo cominciarla quando ne uscimmo. Noi: dolce parola. Noi credevamo.
Le note del preludio all’Attila di Verdi commentano le parole di Domenico, su cui si chiude Noi credevamo (2010) di Mario Martone. Come quella di Domenico e dei suoi compagni, quella di Attila è una “rivoluzione” mancata (la presa di Roma). Una rivoluzione che contiene in sé la sua negazione, e che dunque la contraddice: Attila è allo stesso tempo il grande nemico dell’Impero e anche un barbaro conquistatore. Domenico ha combattuto e creduto in un Paese che fosse espressione di un’umanità nuova, ma ha dovuto constatare il fallimento e le contraddizioni di quell’impresa. Eppure, nel suo discorso Crispi si rivolge ad un Parlamento vuoto: entrambi sono dunque immagini di sconfitta, di resa. Ecco allora che quel verbo, credere, che il titolo del film declina al passato, apre interamente il proprio orizzonte al presente e al futuro, rifuggendo da qualsiasi temporalità e definendo lo spazio stesso dell’abitare umano: credere è infatti un imperativo morale, ed è dunque giusto che noi continuiamo a credere.
362
Lessico del cinema italiano
Il parallelismo tra le due vicende che la sequenza restituisce sembrerebbe immediato, diretto, apparentemente quasi scolastico. Come la lettura risorgimentale di Martone, quale metafora del presente, attraversa i valori fondativi di un’unità sempre “rinegoziabile” – un divenire sempre pronto a superare gli esiti stessi del suo divenire temporale –, il melodramma verdiano “utilizza” e reifica la mitologia storica per aprire il proprio discorso sulla realtà (e sul suo superamento). Il modello della narrazione di Noi credevamo è dunque il melodramma di Verdi (e Bellini) non tanto, e solo, in chiave evocativa, per un facile esercizio di prospettive tra il presente dell’opera cinematografica e l’epoca di cui essa fa oggetto; ma perché è la forma melodrammatica stessa, nel modo in cui si è andata a sviluppare all’interno della modernità italiana, ad aver in qualche modo “imposto” – per ragioni trasversali alla cultura e alla società – una sua adesione o rinegoziazione da parte delle forme artistiche successive, in particolare quella cinematografica, come esemplifica bene il film di Martone. L’immagine del finale di Noi credevamo rimanda dunque icasticamente alla possibilità di leggere la forma cinematografica in relazione a quella melodrammatica, che nella cultura italiana moderna è stata indissolubilmente legata a quella operistica1. Un tale attraversamento porrà immediatamente una serie di questioni di ordine teorico, storico-culturale e più prettamente cinematografico, che non si esauriscono in un semplice discorso sull’“opera” e sul “cinema”. Poiché è in quello spazio già oltre questi due linguaggi che è possibile comprendere, indagandoli, i modi di questa vicinanza. Uno spazio che si definisce all’interno di quelle forme di vita dell’“essere italiani” che opera e cinema, rispettivamente i due linguaggi fondativi della modernità otto-novecentesca, hanno saputo esporre, narrare e in ultimo definire. Cronaca di una modernità singolare: dell’eterno amore per il sensibile Spunti di riflessione sui rapporti strutturali tra linguaggio operistico e cinematografico, da cui si parte per indagare i rapporti 1
Pur con eterogenee influenze dal mélodrame francese settecentesco e dal melodrama inglese vittoriano. Cfr. E. Morreale, Così piangevano. Il cinema melò nell’Italia degli anni cinquanta, Donzelli, Roma 2011, pp. 27-32 (cap. “Un genere della modernità e la sua ideologia”).
Opera Francesco Ceraolo
363
formali tra cinema e melodramma operistico, sono presenti, per certi versi in modo fondativo, nel pensiero italiano novecentesco; specialmente, e non a caso, in quello storicistico e neoidealistico di Croce, Gentile e Gramsci, dominante in Italia negli anni di affermazione e successo del linguaggio cinematografico. Ciò che, molto schematicamente, emerge dalla riflessione neoidealistica italiana è una “necessarietà”, seppur a volte implicita e declinata in termini significativamente diversi, dell’interrogazione sulla forma operistica in relazione a quella cinematografica. All’interno della riflessione storicistica cioè, non risulta possibile comprendere il successo commerciale del cinema negli anni trenta, come il suo progressivo emanciparsi dal regime fotografico a cui era stato inizialmente accostato, senza che questo discorso non riporti la questione, direttamente o indirettamente, su di un ruolo congenito della forma operistica al linguaggio cinematografico stesso. Ecco dunque come nel 1934 Antonio Gramsci riconosceva nella prossimità tra melodramma e «cinematografo» un carattere tipico della cultura italiana. Cultura che, al contrario di altre europee, in Italia non aveva trovato nel romanzo la forma rappresentativa privilegiata della modernità ottocentesca ma, appunto, nel dramma musicale. La prossimità riconosciuta da Gramsci non verteva tanto sull’apparato tecnico-strumentale comune ai due linguaggi – ovvero sul fatto che entrambi condividessero un’inevitabile natura tecnica (posizione che poi, notoriamente, sarà di Adorno2) –, quanto su di una errata prospettiva sull’uomo che, in Italia, come 2
Cfr. T.W. Adorno, M. Horkheimer, Dialettica dell’illuminismo, a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino 1997 (in particolare il capitolo intitolato “L’industria culturale”) [ed. or. Dialektik der Au lärung, hektografiertes Manuskript 1944], T.W. Adorno, Immagini dialettiche: scritti musicali 1955-65, a cura di G. Borio, Einaudi, Torino 2004 [ed. or. Musikalische Schriften I-III, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1944], e Id., Wagner, a cura di M. Bortolotto, Einaudi, Torino 2008 [ed. or. Versuch über Wagner, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1959]. Secondo Adorno l’opera lirica tardo-romantica, e specificamente il dramma wagneriano, è antesignana e capostipite di ogni forma industriale di produzione artistica, tipica delle società industriali, poiché con «l’intenzione di annullare i confini delle singole arti in nome dell’infinito onnipenetrante», e quindi di distanziarsi dall’orizzonte positivistico, essa mira ad un «quid pro quo dei mezzi estetici, che attraverso il perfezionamento artificiale deve celare tutte le saldature dell’artefatto, cioè la sua differenza dalla natura»; una simile pratica implica proprio «la alienazione radicale di tale spontaneità
364
Lessico del cinema italiano
conseguenza della mancanza di una forte idea di stato-nazione, aveva assunto prima forme melodrammatiche e poi cinematografiche: «La musica» ha, in una certa misura «sostituito, nella cultura popolare, quella espressione artistica che in altri paesi è data dal romanzo popolare», e i «genii musicali» hanno avuto «quella popolarità che invece è mancata ai letterati»3. Proseguiva poi Gramsci: Perché la “democrazia” artistica italiana ha avuto una espressione musicale e non “letteraria”? Che il linguaggio non sia stato nazionale, ma cosmopolita, come è la musica, può connettersi alla deficienza di carattere popolare-nazionale degli intellettuali italiani? [...] Per stabilire una politica di cultura queste osservazioni sono indispensabili; per una politica di cultura delle masse popolari sono fondamentali. Ecco la ragione del “successo” internazionale del cinematografo modernamente e, prima, del melodramma e della musica in generale4.
Nella riflessione gramsciana il tema di questa filiazione era declinato in termini fortemente critici, nel contesto del ruolo che in essa veniva affidato alla prassi artistica ai fini della costituzione di una coscienza nazionale moderna. Ma se per Gramsci la leggibilità della forma cinematografica, nella sua fase di origine, era direttamente legata alla comprensione di quella operistica, è certo che tale riflessione debba essere considerata nel contesto della critica gramsciana al Risorgimento italiano (una «rivoluzione passiva» o «rivoluzione senza rivoluzione»)5, ma anche, più ampiamente, all’interno delle problematicità che il fondamento hegeliano del pensiero di Gramsci portava con sé, rispetto ad una rilettura del problema dell’arte in relazione ai suoi processi di avvicinamento e allontanamento dal regime sensibile6. In altre parole, oltre che ad una critica dell’esperienza risorgimentale, quella di Gramsci deve
3 4 5 6
di natura, che la creazione unitaria, ponendosi come natura seconda, vorrebbe far dimenticare», ivi, p. 96. A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, p. 1136 (Quaderno 9). Ibidem e ivi, p. 2195 (Quaderno 23). Ivi, p. 2011 (Quaderno 19). Cfr. la descrizione delle forme universali dell’arte in G.W.F. Hegel, Lezioni di estetica, a cura di P. D’Angelo, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 114-198 [ed. or. Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, Berlin 1823].
Opera Francesco Ceraolo
365
essere fondamentalmente intesa come una forma di opposizione, per ragioni ontologiche, e in relazione al rapporto tra opera d’arte e trascendenza, alle forme non razionali e sensibili della prassi artistica. La posizione gramsciana apriva ad una lettura critica che accomunava il destino e la natura del cinema e dell’opera lirica proprio in quanto forme di dispiegamento dell’oggetto estetico nell’ambito del sensibile – tratto tipico della modernità italiana – invece che all’interno di un processo di ripiegamento nella razionalità del puro spirito, come era per esempio il caso della poesia drammatica7. Ecco dunque cosa univa la storia della cultura moderna italiana, nel passaggio dalla pittura, tipica del Rinascimento, all’opera e al cinema: essi erano tutti linguaggi fortemente ancorati al sensibile e la loro unione era sancita da una sorta di amore per il sensibile quale tratto di appartenenza alla stessa tradizione. Per quel che riguarda la posizione di Benedetto Croce, essa si evince invece indirettamente dal suo non essere tale: opera e cinema sono, non casualmente, le uniche due arti assenti nell’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale (1902), nel Breviario di estetica (1912) e in Aesthetica in nuce (1928) – mentre in modo molto marginale Croce rifletteva sulla questione del melodramma e dell’opera in I teatri di Napoli (1891)8, e con altrettanta sufficienza sui problemi posti dal fenomeno cinematografico nella nota lettera a Chiarini su “Bianco e Nero” del 19489. L’assenza e marginalità della riflessione sui due linguaggi nell’estetica crociana si spiega con il fatto che egli riconoscesse indirettamente la dimensione di problematicità di opera e cinema all’interno della sua teoria dell’arte come prodotto dell’«impressione ed espressione»10, in cui il fatto artistico materiale era visto unicamente come una contingenza di una prassi coscienziale. In tal senso, una teoria simile squalificava opera e cinema a non-arte in virtù di quell’imprescindibile necessità del momento tecnico, che si è visto in precedenza, quale “fattore in comune” di entrambi i linguaggi. 7 8 9 10
Cfr. sempre G.W.F. Hegel: sulla poesia drammatica (ivi, pp. 289-302) e sulla tematizzazione del linguaggio musicale (ivi, pp. 254-261). Cfr. B. Croce, I teatri di Napoli, Laterza, Roma-Bari 1916. Cfr. Id., Lettera a Luigi Chiarini, in “Bianco e Nero”, n. 10 (1948). Cfr. B. Croce, Estetica, Adelphi, Milano 2005, pp. 3-16.
366
Lessico del cinema italiano
Ecco dunque che tale assenza nella riflessione crociana risulta di gran lunga più significativa di una eventuale inclusione, poiché stabiliva tra i due linguaggi un legame invisibile. È proprio in nome dell’appello alla componente tecnica dell’arte, che Croce vedeva come semplice derivato dell’intuizione-espressione11 – senza il quale invece opera e cinema non potrebbero esistere – il motivo per cui essi ne erano esclusi. Dal momento che, secondo Croce, l’opera d’arte è immagine irriflessa dell’intuizione dell’animo dell’artista, essa non può essere mediata da alcun diaframma, sia esso intellettuale o tecnico, e quest’ultimo non può che esserne una mera determinazione materiale. Nell’opera e nel cinema, all’opposto, questo diaframma è strutturale al loro estrinsecarsi materiale, e i due linguaggi erano dunque accomunati, per sottrazione, all’interno di un regime materiale che, a parere di Croce, non ne permetteva di valutare l’autenticità artistica. Ma se la componente tecnica nel cinema e nell’opera era riconosciuta da Croce per esclusione, Giovanni Gentile in Il problema estetico del cinematografo riabilitava il cinema in nome della tecnica, attraverso l’assunzione della questione materiale come fattore comune ad ogni linguaggio artistico, e quindi non come una semplice estrinsecazione della sua teoria. Definendo cioè il cinema una forma tecnica in cui la stessa tecnica interveniva per mediazione, nel rapporto diretto che l’immagine ha con la realtà – esattamente come il canto, nucleo centrale dell’opera, è l’espressione tecnica della voce nella sua forma più immediata, della razionalità pura, già tematizzata da Hegel12 –, opera e cinema ritrovavano una relazione, seppur anche qui indiretta, di filiazione. Quasi anticipando la posizione di Adorno, in Il problema estetico del cinematografo Gentile scriveva: Il problema estetico del cinematografo in quanto deriva dall’impiego di una tecnica contenente elementi meccanici, è il problema di ogni arte; e anche in questo caso il problema si risolve nel superamento o annullamento della tecnica: ossia nello spettacolo, in cui lo spettatore non veda nulla più del meccanismo con cui si produce; e 11 12
Ivi, pp. 141-149. G.W.F. Hegel, Estetica, a cura di N. Merker, Einaudi, Torino 2008, pp. 10291030 [ed. or. Vorlesungen über die Ästhetik, vol 1-3, Verlag von Duncker und Humboldt, Berlin 1835-38].
Opera Francesco Ceraolo
367
l’uomo che egli vede, è lì innanzi ai suoi occhi, vivo, non nello schermo, ma nel mondo13.
Era proprio il bisogno di oggettivarsi dell’opera d’arte attraverso la tecnica, intesa come componente essenziale, e non derivata, dell’arte, che faceva rimodulare a Gentile il carattere lirico dell’arte quale prodotto dell’impressione-espressione, in uno musicale e, ancor più, vocale. Com’è sostenuto da Gentile in La filosofia dell’arte, l’arte è infatti lirica in quanto «espressione del sentimento»14; ma «poiché questo sentimento si oggettiva e si configura in qualcosa di oggettivo»15, proprio attraverso la tecnica, essa si definisce principalmente in quella che è la sua espressione “tecnica” immediata, ovvero il canto. Proseguiva ancora Gentile: L’arte non è lirica, se non in questo senso, che è canto. Quel canto che è la prima forma di esprimersi del bambino, ma che, se si attenua via via cogli anni fino quasi a spegnersi nella fioca voce del vecchio, e pare che si venga via via sciogliendo dai vincoli dell’accento e della sua metrica, in realtà non cessa mai16.
Ora chi dice canto, aggiungeva Gentile, «dice musica»17, ovvero quegli apparati tecnico-strumentali che consentono all’uomo, insieme alla sua voce, di restituire, al di là della barriera dei linguaggi, i suoni del mondo, esattamente come fa l’immagine cinematografica con il suo apparire visibile, restituendo appunto il manifestarsi dell’«uomo nel mondo». Per Gentile dunque il problema della tecnica andava configurandosi come questione identitaria prim’ancora che estetica. Era solo attraverso la tecnica cioè che canto e cinema potevano mettere l’uomo al cospetto del reale, attraverso suoni e immagini, in un processo di appropriazione identitaria che, come per Gramsci, si costituiva sempre in un rapporto tra l’individuo e lo spazio cosmopolitico e sovranazionale del “mondo”. 13 14 15 16 17
G. Gentile, Il problema estetico del cinematografo, in Id., Frammenti di estetica e di teoria della storia, vol. 1, Le Lettere, Firenze 1992, p. 173. G. Gentile, La filosofia dell’arte, Le Lettere, Firenze 2003, p. 214. Ibidem. Ivi, pp. 214-215. Ibidem.
368
Lessico del cinema italiano
Ontologia del melodramma ottocentesco. La doppia natura della forma operistica italiana La riflessione estetico-filosofica in Italia mette, direttamente (Gramsci) o indirettamente (Croce, Gentile), il linguaggio cinematografico in relazione a quello operistico. Ma altrettanto fondativa per un inquadramento di questa relazione deve essere una definizione schematica della natura e morfologia della forma melodrammatica in Italia, in particolare nell’Ottocento post-rossiniano. Nello specifico contesto della cultura italiana, la morfologia dell’opera ottocentesca definisce, per sua stessa natura, quella del melodramma, sia esso nella sua derivazione teatrale, letteraria e in ultimo cinematografica. Per quanto schematicamente si possa affrontare questo tema qui, è importante sottolineare il fatto che l’opera italiana ottocentesca sia una struttura complessa, in molti aspetti disorganica, su cui è necessario interrogarsi dando di essa una definizione che non si discosti dalla sua natura, come si vedrà, fondamentalmente dicotomica. Già Giuseppe Mazzini, nella sua misconosciuta Filosofia della musica del 1833, riconosceva con lucidità insuperata il carattere «melodico» della musica italiana, contrapposto a quello «armonico» della musica tedesca, identificando esplicitamente la natura dicotomica del linguaggio musicale europeo. Quella tedesca, scriveva Mazzini, è infatti «armonica in sommo grado, rappresenta il pensiero sociale, il concetto generale, l’idea, ma senza l’individualità che traduca il pensiero in azione»18. In essa, sostiene Mazzini, «l’io è smarrito. L’anima vive, ma d’una vita che non è della terra»19. Quella italiana, al contrario, è «in sommo grado melodica», ovvero è espressione di un’individualità lirica in cui «l’io v’è re: re despota e solo»20. La musica italiana «si colloca in mezzo agli oggetti, riceve le sensazioni che vengono da questi, poi ne rimanda l’espressione abbellita, divinizzata»21. Mazzini concludeva che l’estetica musicale italiana dovesse emanciparsi dalla moda 18 19 20 21
G. Mazzini, Filosofia della musica, in Id., Opere, Rizzoli, Milano 1939, vol. 2, p. 297. Ibidem. Ivi, p. 292. Ibidem.
Opera Francesco Ceraolo
369
rossiniana – ovvero dall’espressione più alta della musica come pura individualità – e aprirsi al mondo inteso come divenire della Storia, armonizzandosi «col moto della civiltà: seguirne o aprirne le vie, [...] esercitare una funzione sociale, [...] riflettere in sé l’epoche storiche ch’ei s’assume descrivere, quando cerca in quelle i suoi personaggi»22. Nel 1833 Mazzini non conosceva ovviamente il teatro di Giuseppe Verdi, che avrebbe debuttato alla Scala con la sua prima opera Oberto, Conte di San Bonifacio solo sei anni più tardi. Ma il senso della riflessione mazziniana è straordinario nella sua consapevole lucidità e nella capacità di anticipare, per molti aspetti, quelli che saranno i passaggi a venire dell’estetica del dramma musicale in Italia. Ecco dunque, molto schematicamente, la “doppiezza” dell’opera ottocentesca italiana post-rossiniana emergere in qualche modo nel solco lasciato aperto da Mazzini: in primo luogo troviamo una forma romantica, che si identifica con il melodramma di Bellini prima e Verdi poi. Questa forma rappresenta il tentativo di mettere in scena, in maniera stilizzata ed ideologica, la crisi della soggettività astratta e “cartesiana”23 che era ancora alla base del tardo-illuminismo di Rossini. Il melodramma romantico italiano di Verdi e Bellini descrive cioè fondamentalmente il passaggio drammatico da una soggettività astratta (la soggettività lirica riconosciuta da Mazzini) ad una storica, all’interno di quello che può essere definito una sorta di vero e proprio idealismo musicale24: esso è la raffigurazione di un disfacimento dell’individualità libera tardo-illuminista, incapace di cogliere la realtà attraverso le leggi semplici del rispecchiamento, proprio a causa di quella mutazio-
22 23 24
Ivi, p. 304. Pur con una serie di importanti ed eterogenee mediazioni, come il teatro di Shakespeare e Mozart e il sinfonismo di Haydn. Ovvero il tentativo di dare corpo, nel teatro musicale, a quella mutazione dell’idea di soggettività, da astratta a storica, che si è compiuta nel passaggio dal razionalismo all’idealismo ottocentesco. Si sostiene questo in coerenza con quanto afferma Peter Brooks quando fa coincidere l’origine dell’immaginario melodrammatico con la fine della Rivoluzione francese, il momento di caduta dell’astrazione del Sacro e il suo innesto nel divenire storico secolarizzato. Cfr. Id., The Melodramatic Imagination, Yale University Press, New Haven and London 1995, pp. 14-15.
370
Lessico del cinema italiano
ne della realtà stessa, a cui invitava ad “armonizzarsi” Mazzini, da “oggettività” pura a “movimento della Storia”. In questa alienazione della soggettività all’interno di un contesto utopico25, in cui la soggettività stessa si ritrova in quanto entità storica e sociale, il melodramma di Verdi rappresenta una «immanentizzazione» del tragico, ovvero una sua “caduta”; non in un regime basso-mimetico, ma in una realtà secolarizzata26. All’interno di una «risposta alla perdita della visione tragica»27, che per sua natura impone l’inclusione nella realtà umana di una dimensione trascendente e a-storica, si gioca la vera forza propulsiva del melodramma romantico nel contesto della cultura italiana. Per questa ragione quelle di Verdi non sono mai semplici storie private, ma veri e propri conflitti etici interni all’orizzonte dell’umano, «sempre giocati a un duplice livello, che coinvolge insieme l’oggettività delle situazioni familiari, pubbliche, sociali, storiche, politiche, esistenziali28. E soprattutto, ecco tracciata una rassegna dei grandi personaggi verdiani, da Attila a Nabucodonosor, da Don Carlo ad Aida, la cui drammaticità non è mai puramente psicologica, ma sempre connessa direttamente all’immanenza del ruolo sociale e politico da essi svolto. Se dunque il melodramma di Verdi rappresenta l’apice di una forma “aperta” dell’opera ottocentesca (con il suo tentativo di smarcamento dall’individualità rossiniana operato attraverso un’apertura nei confronti della Storia e della società), lo sviluppo successivo del melodramma italiano porta ad una forma che invece potrebbe essere definita “chiusa”29; è quella tardo25 26
27 28
29
Cfr. su questo le riflessioni di Luciano Parinetto su Verdi in Verdi e la rivoluzione. Alienazione e utopia nell’opera verdiana, Mimesis, Milano 2013. Per un approfondimento del modo in cui il melodrammatico rappresenti un superamento del tragico proprio in quanto sua «immanentizzazione» si veda il saggio di Enrico Fubini intitolato Figurazione tragica e drammatica del melodramma in Per una fenomenologia del melodramma, a cura di P. D’Oriano, Quodlibet, Macerata 2006, pp. 11-22. P. Brooks, The Melodramatic Imagination, cit. p. 15. Come scrive Gabriele Scaramuzza in Il brutto all’opera. L’emancipazione del negativo nel teatro di Giuseppe Verdi, Mimesis, Milano 2013, p. 146. Che poi aggiunge: «Ogni situazione [...] risulta sempre dalla relazione tra le persone e gli eventi, le istituzioni, l’ambiente; non è mai una vicenda solo oggettiva, né privata», ibidem. Con i termini “aperta” e “chiusa” non si fa riferimento alla forma musicale (che proprio in quegli anni assiste ad un processo di apertura delle sue forme chiuse, ovvero di arie, duetti ecc.) ma ai rispettivi modi in cui la sog-
Opera Francesco Ceraolo
371
romantica, decadente e verista della fine dell’Ottocento e della prima metà del nuovo secolo. È infatti sotto l’influenza del tardo-wagnerismo europeo, soprattutto per mediazione francese, che il melodramma torna a farsi portatore di quel soggettivismo astratto e a-storico che il teatro di Verdi aveva abbandonato. La soggettività non riacquista più l’individualità semplice (quella di Rossini, come anche di Mozart), libera e tardo-illuminista, ma la ribalta dialetticamente nello scetticismo, nell’illusione, e nel rifiuto del mondo. Non solo l’Io è «re», come scriveva Mazzini: esso è anche solo, e vive in una società trasparente30. Il recupero della solitudine dell’Io – o anche dell’unità simbiotica del due, del maschile e femminile – corrisponde ad un movimento non più interno ad una dinamica politico-sociale, che definisce l’individualità in quanto entità aperta, ma ad una vera e propria fuga da tale dinamica, un’uscita dunque dai flussi della Storia e una chiusura in una dimensione asfittica. I personaggi di Puccini (Butterfly, Mimì, Tosca), come quelli veristi di Cilea (Adriana Lecouvreur), Leoncavallo (Tonio e Canio) e Giordano (Andrea Chénier), sono figure astratte e scettiche: non nel senso che le loro emozioni e i loro pensieri non vi siano rappresentati con una bruciante concretezza, ma in quello per cui essi vivono in un mondo intimo e chiuso, privo di reali conflitti che rimandano all’orizzonte collettivo della realtà. Il melodrammatico è qui una vera e propria “categoria estetica” dello scetticismo verso il mondo31, l’esito della crisi delle prospettive rivoluzionarie della
30
31
gettività che vi è espressa si pone rispetto alla storicità della sua condizione temporale. Secondo quella tensione universalistica del melodramma ben colta da J.N. Schmidt. Il melodramma, secondo Schmidt, fa infatti riferimento «a un’idea presunta presociale di umanità naturale, senza tempo». Cfr. Id., Ästhetik des Melodramas, Winter, Heidelberg 1986, p. 239. Lo scetticismo di chi vive la dimensione pubblica del vivere collettivo come un ostacolo alla propria espressione individuale. Questo aspetto è stato molto ben individuato da Gabriele Scaramuzza in Il melodrammatico come categoria estetica, in Per una fenomenologia del melodramma, cit., pp. 113-140, e anche da Northrop Frye quando iscrive il regime melodrammatico all’interno del tragico basso-mimetico. Cfr. Id., Anatomia della critica, Einaudi, Torino 2014, pp. 49-58 [ed. or. Anatomy of Criticism. Four Essays, Princeton University Press, Princeton 1957].
372
Lessico del cinema italiano
metà del secolo32, e della sostituzione del “politico” con il “privato” quale momento di emancipazione dell’uomo. Si tratta fondamentalmente dell’applicazione al melodramma italiano del modello “scettico” del Tristano e Isotta di Wagner, in cui la morte diviene annichilimento nell’Essere, fuga dal «giorno» del mondo e dalla sua dimensione collettiva, momento di unione anti-drammatico. È il portato filosofico-concettuale, oltre che musicale, dell’Accordo di Tristano – la tensione armonica verso l’annullamento nella cadenza del Finale33 – ad entrare nella storia del melodramma ottocentesco italiano e a definirlo in tal senso; esso viene a descrivere precisamente un processo di ripiegamento della soggettività rispetto alla Storia. Quest’ultima rimane interamente sullo sfondo ed influisce sui personaggi in chiave puramente psicologica – come il Giappone di Iris o Madama Butterfly, la Roma post-repubblicana di Tosca o la Francia rivoluzionaria di Andrea Chénier –, viene inghiottita nella favola teatrale (Pagliacci, Le maschere), oppure interamente annullata (Cavalleria rusticana). Per un’idea di arte alta. Il film d’opera e l’origine del cinema Questo preliminare e sintetico attraversamento di una parte importante dell’estetica otto-novecentesca è servito a delineare i contorni teorici di un rapporto tra due linguaggi che, nel contesto delle varie forme artistiche della modernità, ha visto coinvolgere la cultura italiana al pari e forse più di altre nazioni europee (con la sola eccezione della Germania, in particolar modo se si pensa ai considerevoli retaggi del wagnerismo ottocentesco nel cinema di Riefenstahl fino a Lang, Kluge, Syberberg, Schroeter, Herzog34). 32
33 34
Lo scetticismo ottocentesco, nelle sue diverse e stratificate forme (da Schopenhauer a Wagner), è l’esito di un processo di reflusso verso una verità coscienziale, anche a seguito del fallimento delle prospettive rivoluzionarie e di palingenesi emerse nei moti del 1848. I movimenti sospesi dell’Accordo di Tristano, che disegnano i passaggi della soggettività da e verso la “Nacht” del mondo, sono il vero referente del melodramma scettico italiano. Cfr. Wagner and Cinema, a cura di J. Joe, S.L. Gilman, Indiana University Press, Bloomington 2010.
Opera Francesco Ceraolo
373
È infatti precisamente nel tentativo di affermare il cinema quale forma d’arte che, in Italia, si ricorre all’utilizzo, già sperimentato da altre cinematografie europee35, del canovaccio operistico. Se le prime esperienze operistiche il cinema italiano le deve rispettivamente a Luigi Maggi (Vendetta di pagliaccio, 1907) e al “Fonoteatro” dei fratelli Pineschi – complesso sistema consistente nella sonorizzazione di un film attraverso la sincronizzazione del cinematografo e del grammofono36 –, con la loro realizzazione di Il trovatore (1908)37, è con la fondazione della casa di produzione “Film d’Arte Italiana” nel 1909 che l’opera entra integralmente a far parte del repertorio cinematografico. Nei due anni successivi alla sua fondazione, la Film d’Arte produce consecutivamente le riduzioni filmiche di Carmen (1909), Rigoletto (1910), Ernani (1911), Il ballo in maschera (1911) e in ultimo finanche Tristano e Isotta (1911). L’utilizzo del canovaccio operistico diviene precisamente il modo attraverso cui il cinema cerca di nobilitarsi, ottenere un riconoscimento artistico, emancipandosi dalla sua origine illusionistica (la “lanterna magica”) e puramente spettacolare. Ma al di là dell’impiego narrativo del plot operistico in questa direzione, la caratteristica principale di questi film, come osserva Brunetta a proposito del periodo muto, non è quella di rappresentare «la scena sociale italiana», ma «un mondo sovranazionale»38. In altre parole, la mediazione operistica serve da un lato a innalzare la forma cinematografica al livello di un’arte “alta”; ma dall’altro anche a recuperare, come scriveva Gramsci, la struttura melodrammatica stessa quale regime «cosmopolitico» e universalistico dell’immagine. 35
36
37 38
Si pensi al breve film francese Pagliaccio (1900), presentato con un disco dell’opera di Leoncavallo nei caffè-concerto parigini, viennesi o berlinesi. Cfr. M. Verdone, Drammaturgia e arte totale, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 314. Come scrive un recensore anonimo dell’epoca, «Il pubblico della piccola città e dei centri di media importanza, dove i mezzi per organizzare dei grandi spettacoli scarseggiano, ha ormai la possibilità di conoscere i maestri d’opera del nostro teatro lirico grazie al cinematografo combinato con un grammofono». Cfr. Recensione anonima del 1908, in Metamorfosi della parola tra letteratura e filosofia, a cura di L. Secci, Artemide, Roma 2001, p. 241. Ibidem. G.P. Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, vol. 1, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 86.
374
Lessico del cinema italiano
L’immagine diviene melodrammatica, schiacciandosi integralmente sulla linea operistica, non per riconsegnare un rapporto soggetto-mondo in termini dialettici, come nel romanzo realista39, ma assumendo le categorie di spazio-tempo in una soggettività che da quel mondo è sottratta. Per questa ragione, il cinema muto si muove in totale coerenza con la forma melodrammatica tardo-ottocentesca “chiusa”, per come la si è definita nel paragrafo precedente. L’immagine cinematografica trova cioè nell’opera lo specchio di una sua dimensione pre-politica, pre-nazionale, che la distanzia tanto dal regime illusionistico quanto dalla forma romanzo. Il segno musicale, come quello filmico, al contrario della parola, rimanda ad una soggettività astratta, non in dialogo con l’oggettività storica. Proprio, e non a caso, in relazione a quella che si definisce un’«estetica del mutismo»40, nel suo fondamentale testo The Melodramatic Imagination Peter Brooks ha indagato la funzione della forma melodrammatica, con particolare riferimento a quella del mélodrame francese 41. Il melodramma, scrive Brooks, «appare quale il medium in cui la repressione è stata oltrepassata per permettere una precisa manifestazione, la possibilità di un’espressione di puri codici morali e psicologici»42. Nella storia del melodramma il ruolo del muto è stato prevalente, perché esso ha corrisposto, attraverso il gesto, «all’uso ripetuto di condizioni fisiche estreme atte a rappresentare condizionamenti emotivi e psicologici»43. In altre parole, nota Brooks, il regime melodrammatico è subentrato nella narrazione drammatica all’interno del vuoto lasciato dalla parola. La stessa linea musicale – ovvero il canto – non ha rappresentato un prolungamento tecnico della parola stessa, ma è stata già espressione di quell’individualità rovesciata, chiusa e scettica nei confronti del mondo, che Mazzini aveva individuato lucidamente nel regime melodico della musica italiana. Il cinema muto interpreta esattamente dunque questa istanza “chiusa” di cui era stata portatrice l’opera italiana tardo-romantica 39 40 41 42 43
Che non a caso sarà recuperato come modello dal neorealismo, proprio in contrapposizione a quello operistico. P. Brooks, The Melodramatic Imagination, cit., p. 56. Cfr. ivi, pp. 56-80. Ivi, p. 56. Ibidem.
Opera Francesco Ceraolo
375
e decadente: quella dell’individualità pura, assente dalla società, che rimane invisibile. E se il film d’opera rappresenta una “giustificazione” e contestualizzazione del cinema stesso all’interno del percorso culturale della modernità, questo carattere musicale è presente in una parte importante della produzione generica fino al 1927, anno di passaggio al sonoro. Il canovaccio operistico rimane infatti un significativo riferimento per la produzione cinematografica di quegli anni, basti pensare alle due riduzioni filmiche realizzate dalla casa “La Nazionale”, Lucia di Lammermoor e Manon Lescaut, entrambe del 1908, o alla Cavalleria rusticana di Ugo Falena del 1916. È però il cinema di Giovanni Pastrone (Il fuoco e Tigre reale, 1916), e persino quello “realistico-popolare” di Gustavo Serena (Assunta Spina, 1915), a dare corpo a quella individualità melodica (nelle figure delle dive Francesca Bertini o Pina Menichelli) in cui la recitazione rispettivamente caricata, eccessiva, e in questo senso melodrammatica, ma anche anti-spettacolare e anti-teatrale (si pensi alle pose naturali della Bertini in Assunta Spina), diviene pura espressione di un sentire astratto. Tale produzione si muove interamente «nel segno dell’immaginazione melodrammatica», seguendo il sogno che accompagna la nascita del cinema, ovvero quello di «cantare più che di parlare»44. L’immagine cinematografica non è altro che un’«opera senza canto»45, in cui, citando Brooks, i personaggi filmati diventano astrattamente intersezioni «fra forze etiche primordiali», all’interno «di un contesto apparentemente realistico e quotidiano» dove si inscena «un dramma iperbolico ed esagerato, riconducibile all’assolutezza di contrapposizioni basilari come tenebre e luce, salvezza e dannazione»46. Ciò accade anche nel kolossal che si va affermando in quegli anni (La caduta di Troia, 1911, le numerose versioni di Gli ultimi 44
45 46
E. Sala, Lungo congedo muto dal melodramma, in “Il Giornale della Musica”, n. 111 (1995), p. 14. Cfr. anche il testo di Sala sull’invenzione della colonna sonora al cinema (Id., L’opera senza canto. Il mélo romantico e l’invenzione della colonna sonora, Marsilio, Venezia 1995) e le pagine dedicate al tema dell’allestimento sonoro nel cinema muto in R. Calabretto, Lo schermo sonoro, la musica per film, Marsilio, Venezia 2010, pp. 17-47. Cfr. E. Sala, L’opera senza canto. Il mélo romantico e l’invenzione della colonna sonora, cit. Ivi, p. xiii.
376
Lessico del cinema italiano
giorni di Pompei, 1908-1913, Quo vadis?, 1913, Cabiria, 1914), in cui, come nota Brunetta: «La storia resta sullo sfondo mentre in primo piano si intrecciano amori, gelosie, odi tra i diversi protagonisti»47. Facendo proprio il secondo asse della dicotomia ottocentesca, per come si è appena visto, il kolossal assorbe nuovamente il carattere “individuale” tipico dei wagnerismi italiani tardo-romantici e decadenti, ma non quello fortemente ideologico della stilizzazione storica del primo romanticismo di Verdi e Bellini. Il vero scopo del kolossal muto non è infatti quello di fornire una narrazione dell’epopea della soggettività e di una nazione in termini diretti (come invece accade negli stessi anni in America con Griffith), o attraverso la mediazione di un impianto storicosimbolico (il melodramma di Verdi). Esso si “serve” della Storia – principalmente quella trionfale della classicità romana, simbolo di grandezza imperiale dell’Italia tutta – per aprire una “finestra di immaginazione” ad un popolo/spettatore appena nato: gli consente di immedesimarsi nelle vicende amorose rappresentate (trasfigurando le proprie), sullo sfondo del paesaggio storico che le nobilita attraverso il filtro mitico. Il veicolo storico assume dunque proprio la funzione di “paesaggio” mitico: lavora come contenitore – prodotto diretto della Storia o filtrato dalla modernità letteraria e decadente (si pensi a Cabiria di Pastrone-D’Annunzio) – dell’interazione semplice dell’individualità astratta e, allo stesso tempo, come strumento di celebrazione identitaria del patrimonio storico-culturale italiano nell’orizzonte internazionale. L’individualità che si muove all’interno di questo paesaggio è dunque astratta e lirica, priva di definizioni socio-politiche (l’amore tra Jone e il giovane fidanzato di Gli ultimi giorni di Pompei è una semplice vicenda amorosa contrastata come quella tra Paride e Elena): è quella di L’italiana in Algeri di Rossini, riletta in termini scettici e decadenti. Tentativi di forzatura della forma operistica. Il cinema fascista Negli anni del passaggio al sonoro, il genere del melodramma diviene uno dei più in voga del nascente cinema fascista, paralle47
G.P. Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, cit., p. 67.
Opera Francesco Ceraolo
377
lamente, e per certi versi in opposizione, alla commedia borghese dei “telefoni bianchi”. Film come Rotaie (1929) di Mario Camerini o Montevergine (1939) di Carlo Campogalliani se da un lato si fanno carico dell’eredità “realistica” di Assunta Spina – il soggetto di ambientazione popolare rivolto ad un nascente pubblico di massa –, dall’altro lavorano, trasformandola, l’espressività della recitazione melodrammatica – grazie all’uso enfatico della colonna sonora che permette un alleggerimento della plasticità recitativa –, gettando le basi formali di quello che, nel dopoguerra, prenderà forma nel melodramma “chiuso” di Matarazzo e Gallone. In questi anni, è sicuramente la figura di Alessandro Blasetti a imporsi maggiormente, sperimentando nel modo più originale la forma melodrammatica e l’“individualità” musicale di cui essa fa oggetto; ma, anche qui, se l’operazione di Blasetti sul melodramma è coerente ad un’esaltazione dell’identità italiana in epoca fascista, la dialettica con il presente storico è solo apparente e i codici narratologici “chiusi” della sua forma non vengono sostanzialmente rinegoziati, rimanendo dunque ancorati ad una soggettività i cui regimi psicologici e politici sono lontani dall’intersecarsi in modo indissolubile. Oltre agli operistici e melodrammatici Sole (1929) e 1860 (1934) – il primo una sorta di film-documentario sulla bonifica dell’Agro Pontino, il secondo epopea risorgimentale in cui il genere storico diviene sì intimamente politico, ma solo in modo funzionale all’esaltazione del nazionalismo fascista –, questa operazione è chiaramente esemplificabile in pellicole successive come Ettore Fieramosca (1938) o La corona di ferro (1941). In Ettore Fieramosca, l’amore tra l’omonimo mercenario e Giovanna, signora di Morreale, si intreccia con le vicende della lotta tra spagnoli e francesi nell’Italia dei primi del Cinquecento, che si concludono con la famosa disfida di Barletta in cui quest’ultimi vengono sconfitti. Nell’orizzonte di una dichiarata propaganda antifrancese, attraverso cui vengono letti e narrati i fatti storici, si muovono, in modo estremamente stilizzato, le vicende amorose dei due protagonisti, che sembrano quasi parallele a quelle dei macro-eventi sullo sfondo. Tra le due linee non c’è una reale interazione se non nella maniera in cui l’eroismo di Fieramosca contro i francesi rappresenta un impeto di virilità italica, e il suo amore diventa, per Giovanna, momento di autocoscienza di una femminili-
378
Lessico del cinema italiano
tà astratta e “domestica”, tipica della donna fascista: «Quest’uomo è venuto al mio castello», dice Giovanna al confessore, «a vendersi come un ribaldo, come un padrone, come un nemico. Io ho fermato il braccio di quelli che volevano punirlo e mi si è fatto incontro come una furia, avido di offendere [...]. E mi ha trattata come la figlia di un servo. Ma era la prima volta che sentivo un uomo trattarmi come una donna. Quando voglio condannarlo sento che già l’ho perdonato». Se il cinema fascista rilegge dunque il melodramma in chiave politica, non lo fa attraverso una rinegoziazione della soggettività (da astratta a storica), ma per mezzo di un’operazione tipica del cinema di propaganda (seppur di altissimo livello come quello di Blasetti): ovvero, la costruzione di un orizzonte in cui la Storia viene riletta a giustificazione del presente – il momento di uno scontro etico tra il “bene” del presente fascista e il “male” del nemico interno ed esterno48 – e in cui la soggettività dei personaggi si muove in modo quasi mitico, a-temporale, modello per l’epoca presente che è il vero oggetto di propaganda. Lo stesso impianto mitico-astratto della soggettività, esasperato ontologicamente per mezzo del filtro mitologico, lo si ritrova nel kolossal fiabesco La corona di ferro. Anche qui, pur non richiamandola esplicitamente, Blasetti lavora con la forma melodrammatica per costruire una temporalità astratta, universalistica, sempre tesa ad esaltare in forma di propaganda il presente fascista (in questo caso la purezza ariana della razza). Il fantastico regno di Kindaor è attraversato da una spedizione che trasporta la corona di ferro, forgiata con un chiodo della croce di Cristo. Nel frattempo, il regno è insanguinato da lotte di successione, che si concludono nel momento in cui la corona, che era sprofondata nella terra, riemerge illuminando e portando la pace tra i popoli. È in questo caso il dramma musicale wagneriano (Parsifal su tutti) a rappresentare per Blasetti il modello su cui costruire un percorso referenziale tortuoso, fatto di simboli e 48
Sul modo in cui lo spettacolo fascista intenda la forma del melodramma in relazione ad un’estetica della guerra, quale conclusione inevitabile e necessaria di questo conflitto etico, si confronti S.F. Zamponi, Lo spettacolo del fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 225-270 (cap. “Guerra e melodramma”).
Opera Francesco Ceraolo
379
allegorie, rimandi a tradizioni germanico-pagane e a un misticismo cristiano che è retaggio culturale dell’asse Roma-Berlino in piena lotta contro il “laicismo” anglo-francese. Blasetti costruisce una vera e propria “opera d’arte totale” che, attraverso una esplicita forzatura espressiva del mezzo cinematografico, vuole costruire una mitologia idolatrica fatta di guerrieri e ancelle, che attraversano un piano narrativo sempre consacrato all’agiografia del presente. La Storia e la società sono interamente cancellate in uno spazio simbolico che ammette solo l’esistenza di un sistema di valori politico-ideologico. Il discorso filmico si esplica unicamente in relazione ad una proiezione di un presente valoriale, e la mediazione mitico-favolistica annulla persino quella parvenza di dialettica storico-sociale che era ancora presente nelle stratificazioni narrative (sempre simboliche) di Ettore Fieramosca e 1860. Dal film d’opera alle “opere parallele” Parallelamente alle sperimentazioni sul melodramma di Blasetti, gli anni successivi all’invenzione del sonoro, e con ancor più forza il secondo dopoguerra, vedono proliferare la produzione di film operistici. Dopo alcuni significativi esempi di epoca fascista infatti – su tutti La serva padrona di Giorgio Mannini del 1934 e la Tosca di Karl Koch del 1941 – il regista che inaugura il genere dell’opera filmata è Mario Costa con la sua versione di Il barbiere di Siviglia (1947). La filmografia che va dal ’46 al ’56 è vastissima, basti ricordare alcuni titoli tra i maggiori successi commerciali di quegli anni: Lucia di Lammermoor (1946) di Piero Ballerini, L’elisir d’amore (1947) e Pagliacci (1948) di Mario Costa, Rigoletto (1946), Il trovatore (1949), La forza del destino (1950), Madama Butterfly (1954), Cavalleria rusticana (1955) e Tosca (1956) di Carmine Gallone, La sonnambula (1952) di Cesare Barlacchi, Aida (1953) e Andrea Chénier (1955) di Clemente Fracassi. Ma se con il sonoro la forma operistica trova un impianto più favorevole, l’orizzonte melodrammatico – che del film d’opera è emanazione – rimane fondamentalmente inalterato all’interno della linea “chiusa” dell’individualità tardo-ottocentesca, che aveva caratterizzato il film muto.
380
Lessico del cinema italiano
La figura sicuramente di maggior rilievo di questo “nuovo” genere è quella di Carmine Gallone, il cui cinema racconta una soggettività sempre e comunque ancorata ad una dimensione scettica, priva di aperture, la cui identità è esclusivamente psicologica. Non è tanto la vera e propria opera filmata – non più riduzione cinematografica come nel muto – a rappresentare il vertice di questa istanza chiusa, quanto le cosiddette opere “parallele”, ovvero film originali basati su vicende in qualche modo affini a quelle operistiche. Questa produzione di Gallone copre un arco temporale piuttosto vasto, che impone un salto cronologico in avanti – necessario alla completezza dell’analisi del film d’opera e delle sue derivazioni – rispetto agli anni immediatamente successivi al passaggio al sonoro. Dal ’35 al ’62 Gallone realizza infatti una serie importante di pellicole, tutte ispirate al canovaccio operistico, strutturate però su narrazioni originali, vere e proprie “riflessioni”, all’interno della forma generica, sul rapporto di filiazione tra i due linguaggi. Tra queste le più significative sono: E lucean le stelle (1935), Il sogno di Butterfly (1939), Amami, Alfredo! (1940), Avanti a lui tremava tutta Roma (1946), Addio Mimì! (1947), Carmen di Trastevere (1962). Ad esse si accompagnano le biografie romanzate dei più importanti operisti dell’Ottocento italiano (Casta Diva nella doppia versione del 1935 e 1954, Giuseppe Verdi del 1938, Puccini del 1953) che terminano con il celeberrimo Casa ricordi del 1954, sorta di riassunto complessivo di un’epoca riletta attraverso la dinastia del celebre editore musicale. Il film d’opera si evolve dunque con Gallone all’interno di uno spazio nuovo e originale – da esso stesso aperto – che attraversa, facendoli propri, generi e temi del cinema degli anni trenta (il periodo fascista), quaranta (neorealismo) e cinquanta-sessanta (commedia all’italiana)49, per poi esaurire la sua forza commercia49
Su questa “trasversalità” si confronti quanto scrivono R. Menarini, Il teatro degli avvenimenti. La scena melodrammatica nel cinema italiano di genere, in Imitazioni della vita. Il melodramma cinematografico, a cura di S. Pesce, Le Mani, Genova 2007, pp. 89-94; e G. Pescatore, La voce e il corpo. L’opera lirica al cinema, Campanotto, Udine 2001. Entrambi riconoscono proprio una dimensione eminentemente “performativa” e “fattiva” del melodramma che, a partire dal film d’opera, attraversa le forme più diverse della produzione generica.
Opera Francesco Ceraolo
381
le e spegnersi a poco a poco, anche a seguito del declino del successo dell’opera lirica nei teatri italiani. Questo processo di ascesa e discesa (con poi un tentativo di ripresa negli anni ottanta, come si vedrà), coincide fondamentalmente con un ripensamento del cinema popolare all’interno di una forma musicale reificata, che da operistica (l’opera filmata), diviene ad essa “parallela” (mantenendo dunque una radice “colta”), fino a cadere nel regime bassomimetico dell’operetta o della canzone popolare (si pensi ai numerosi film con attori/cantanti, da Ferruccio Tagliavini a Claudio Villa fino ai più recenti con Gianni Morandi, Rita Pavone ecc.). In questo contesto, il cinema di Gallone si pone come modello, non solo per la sua capacità di attraversamento del genere in tutte le sue forme e derivazioni, ma per il modo in cui esso riesce efficacemente a proporre e formulare codici e personaggi (specialmente figure femminili), intelligentemente colti in relazione alla società e attualità italiana: Tosca diviene dunque archetipo della donna partigiana in lotta contro l’oppressore, esattamente come Carmen è il paradigma della donna proto femminista nell’Italia dei primi anni sessanta. Il cinema di Gallone si gioca tutto, o gran parte, in questa dialettica, non detonatrice di fratture nella forma “chiusa” – che rimane interamente ancorata al suo orizzonte scettico, nonostante i timidi tentativi di forzatura –, ma proficua nel suo saper apprendere, attraverso il filtro della narrazione operistica, temi importanti della realtà italiana di quegli anni. Avanti a lui tremava tutta Roma per esempio, probabilmente la sua miglior opera, pur essendo un film che tenta un’apparente apertura del melodramma nell’orizzonte storico-politico del dopoguerra, piegandolo verso un neorealismo di maniera, nella sostanza non fuoriesce dal perimetro dell’individualità astratta del regime chiuso. Le vicende di una compagnia lirica che sta allestendo Tosca durante l’occupazione nazista di Roma, si intrecciano con quelle dei due protagonisti, Ada e Marco (rispettivamente interpreti di Tosca e Cavaradossi). Sono entrambi membri della Resistenza romana, e la loro relazione è vittima di un equivoco quando Ada, pensando di essere tradita (in realtà Marco nascondeva un soldato inglese nei sotterranei del teatro), denuncia il fidanzato al comando tedesco. La vicenda di Marco (Cavaradossi) si intreccia dunque a quella di Tosca, fino all’arrivo degli alleati che libereranno Roma.
382
Lessico del cinema italiano
La dialettica finzione-realtà che il film instaura è funzionale alla costruzione di un climax melodrammatico che sfocia nel finale (la fucilazione di Marco/Cavaradossi), all’interno di un’operazione sul genere che, nel 1946, faceva forzatamente i conti con l’esperienza neorealista. In altre parole, il risultato è un ibrido, una contaminazione estetica (anche attraverso l’utilizzo del volto di Anna Magnani, appena uscita da Roma città aperta) tra forma melodrammatica e nascente neorealismo, che si risolve in un continuo incrocio di segni referenziali (emblematica la scena nel comando tedesco che ricalca quella del film di Rossellini) attraverso cui la forma operistica viene tradotta in una grammatica neorealista. In modo simile, l’ultimo film di Gallone, Carmen di Trastevere, riscrive la vicenda di Carmen (con protagonista Giovanna Ralli) nel mondo proletario e malavitoso romano, a cui un giovane poliziotto della provincia friulana (Jacques Charrier) è trascinato per amore della donna. Anche qui, alcune aperture del genere melodrammatico, assenti nei suoi film precedenti (si pensi in particolare alla forma esile e teatrale di Amami, Alfredo! o Il sogno di Butterfly), sono funzionali ad una semplice contaminazione estetica, in cui il melodramma cerca di rivitalizzarsi attraverso i codici generici del poliziesco e della commedia drammatica tipica degli anni del miracolo economico (Il sorpasso di Dino Risi è dello stesso anno). Il cinema di Gallone è dunque l’espressione più compiuta del genere “chiuso” – a partire dal passaggio al sonoro – sia per mezzo di una reinvenzione dell’opera filmata, sottratta ai limiti delle riduzioni del muto, sia dell’esaltazione agiografica (su tutti Casa Ricordi), e, in ultimo, come si è visto, del tentativo di fagocitare, attraverso il melodramma, generi e forme diverse e distanti. Il passaggio al neorealismo Il dopoguerra – e la coeva esperienza neorealista – rappresenta uno spartiacque importante nella forma melodrammatica del cinema italiano: da un lato essa prosegue il suo percorso “chiuso” e scettico della soggettività astratta (il cinema di Raffaello Matarazzo negli anni cinquanta, che si vedrà in seguito); mentre dall’altro,
Opera Francesco Ceraolo
383
inizia una progressiva apertura dei suoi codici, che culminerà in una complessiva ridefinizione della sua natura con Visconti. Prima figura significativa in questo senso, già importante esponente del cinema muto e poi fascista, Augusto Genina realizza nel dopoguerra due film fondamentali per il passaggio dal melodramma scettico ad uno aperto: Cielo sulla palude (1949) e Maddalena (1954). Più che di un vero discorso teorico sul melodramma, i due film sono espressione di una forzatura di tale genere, nella direzione di una sua apertura verso un’istanza realista che negli stessi anni troverà nel cinema di Giuseppe De Santis la sua più alta espressione. Nel caso di Genina non si tratta di una semplice contaminazione generica tra neorealismo e melodramma (come in Avanti a lui tremava tutta Roma di Gallone), quanto di una reale e significativa apertura verso una soggettività storica, che se non costituisce in sé una ridefinizione dell’intera forma cinematografica sulla scorta del melodramma “aperto” di derivazione verdiana (operazione che negli anni cinquanta compirà Luchino Visconti con Senso, 1954), rappresenta certamente un suo significativo adattamento all’istanza neorealista esplosa nel dopoguerra. Cielo sulla palude è un film che per la prima volta restituisce, in una pura struttura melodrammatica, una vicenda in cui la soggettività dei protagonisti si costruisce intrecciando la propria vicenda personale con una coscienza storico-sociale, che ne definisce la loro stessa identità. Il film racconta la vera storia di Maria Goretti, povera contadina di inizio secolo, emigrata con la famiglia nella campagna laziale e uccisa da un pretendente che lei aveva più volte respinto. L’orizzonte storico qui non ha la semplice funzione di paesaggio scenografico, ma instaura un complesso rapporto di equilibri con la vicenda privata (la vita e martirio della Goretti). La Goretti è una contadina, alla pari di altre, la cui tragedia personale (istanza psicologica) è speculare e intrecciata a quella della sua classe (istanza socio-politica), le cui dinamiche di vita sono il vero oggetto, per nulla celato, della narrazione. Se questa struttura dicotomica intrecciata – equilibrio prospettico della visione tra piano privato e pubblico – era la cifra della forma cinematografica (e non solo) neorealista, essa non era mai stata fondativa di quella melodrammatica. Con Genina, in altre parole, un’istanza sociopolitica entra nella forma melodrammatica, seppur mutuando le istanze da quella realista, non semplicemente per mediazione
384
Lessico del cinema italiano
culturale (Ettore Fieramosca) o contaminazione linguistica (Gallone), ma per mezzo di una sua definizione ontologica. Allo stesso modo, il successivo Maddalena ricuce l’apertura del melodramma realista con l’aspirazione ad una parabola evangelica (già presente, ma con ancora maggior forza che in Cielo sulla palude), attraverso la narrazione di una processione del Venerdì Santo nell’Appennino campano in cui il ruolo della Madonna è affidato ad una sconosciuta prostituta. Dopo varie vicissitudini ed un miracolo (un bambino si risveglia dal coma), l’inganno viene svelato e la donna viene lapidata dal popolo inferocito. Il cinema di Genina, che si chiuderà non a caso pochi anni dopo con la commedia drammatico-musicale Frou-Frou (1955), racconta una soggettività melodrammatica – dai netti connotati mistico-religiosi – che si apre al reale in un percorso di trascendimento della sua immanenza. Ma quell’immanenza è per la prima volta colta nell’immagine italiana non più in chiave puramente semplice, psicologico-relazionale, quanto complessa e molteplice, aperta cioè al mondo e alle sue connessioni tematico-formali, come al suo divenire complessivo. L’immagine melodrammatica con Genina inizia ad elaborare la generalità delle implicazioni sociali e collettive della soggettività, all’interno di una narrazione che non ha più come oggetto l’“uno” – l’individualità semplice o il doppio simbiotico-materno di Tristano – ma la totalità del reale stesso. Se Genina compie un salto fondamentale, a cavallo degli anni cinquanta, tra forma chiusa e aperta del melodramma, sarà Giuseppe De Santis a portare a compimento questa operazione, inserendola all’interno di una vera e propria prospettiva teorica maturata negli anni di collaborazione alla rivista “Cinema”. Per De Santis il melodrammatico è un mezzo per «affondare le radici nella cultura» italiana; un’operazione politica attraverso cui l’autore vuole «essere al livello del mondo» popolare che egli esprime attraverso la sua opera50. Come quello di Genina, il lavoro di De Santis è interno alla prospettiva neorealista, ma questa volta il melodramma non è più semplicemente, e unicamente, il veicolo 50
Scrive ancora De Santis: «L’Italia è il paese del melodramma. Chi come me, o come Visconti o tanti altri, voleva affondare le radici nella nostra cultura era giusto anche che passasse sul corpo del melodramma». Cfr. J.A. Gili, M. Grossi, Alle origini del Neorealismo. Giuseppe De Santis a colloquio con Jean A. Gili, Bulzoni, Roma 2008, p. 123.
Opera Francesco Ceraolo
385
di un’estasi mistico-religiosa, il codice per operare il passaggio da un’immanenza ad una trascendenza (Cielo sulla palude); quanto la base programmatico-politica su cui ripensare il linguaggio cronachistico del neorealismo, fondamentalmente nella direzione del realismo del cinema classico americano e di quello socialista. Non si tratta dunque di un’operazione mirata a rifondare la forma melodrammatica in sé (Visconti), quanto di renderla funzionale al progetto neorealista. Il vertice dell’opera cinematografica di De Santis vive fondamentalmente di due fasi. La prima, di ambientazione rurale, culminante in Riso amaro (1949) e Non c’è pace tra gli ulivi (1950); la seconda, immediatamente successiva, di ambientazione urbana, che trova espressione in Roma ore 11 (1952) e Un marito per Anna Zaccheo (1953). Se uno sguardo epico-documentaristico, che troverà il più alto esempio nel Luchino Visconti di La terra trema (1948), aveva già attraversato la sua opera nel riuscito Caccia tragica del 1947 – parallelamente all’utilizzo viscontiano della forma generica del poliziesco in chiave realista (Ossessione, 1943, di cui De Santis era stato co-sceneggiatore) –, è con Riso amaro che la poetica di De Santis sul melodramma comincia a emergere in tutta la sua potenza: una lettura didascalica del melodramma, che lo intende quale strumento epistemologico di appropriazione di una coscienza di classe (esemplificata nelle mondine e braccianti piemontesi), attraverso la narrazione di una vicenda tragica da rotocalco e la costruzione divistica dei personaggi (nelle figure della allora sconosciuta Silvana Mangano, la “Rita Hayworth italiana”, e di Raf Vallone) tipica della golden age hollywoodiana. Ma è nel successivo Non c’è pace tra gli ulivi che tale intento, se vogliamo, è reso ancora più evidente, all’interno di una prospettiva didascalica che fa chiaramente riferimento ad un impianto operistico ottocentesco “aperto”: le vicende avventurose di un pastore ciociaro (Francesco, interpretato da Raf Vallone) che, aiutato dall’amante Lucia (Lucia Bosè), cerca di riappropriarsi del gregge che gli era stato sottratto mentre era soldato, diventano il lungo e complesso percorso di autocoscienza di un popolo intero verso la libertà, passando attraverso la consapevolezza di un’appartenenza ad una classe comune, quella dei contadini sfruttati. La costruzione “estraniata” del racconto, fatta di pose plastiche e sguardi in macchina, in cui il regime epico si sostituisce a quello drammati-
386
Lessico del cinema italiano
co-naturalistico – si faccia riferimento emblematicamente alla scena dell’incontro tra Francesco e Lucia nelle sequenze iniziali del film –, muove dal presupposto secondo cui la vicenda del singolo è detonatrice di una catarsi collettiva. Come nel teatro epico, lo spazio del racconto è sempre fuori dal suo specifico orizzonte diegetico; esso include lo spettatore per renderlo parte di quella catarsi. A differenza del teatro epico però, il film vuole anche dare conto di una totalità storico-sociale: la rappresentazione di un paesaggio umano e politico che non si riduce ad un mero rispecchiamento (epicizzato) del reale stesso. In altre parole, l’utilizzo del melodramma diviene sì strumento di appropriazione dei codici formali del mondo popolare che si sta indagando, ma anche, e soprattutto, in chiave tipicamente verdiana, dispositivo per la costruzione di una totalità storico-sociale colta non oggettivamente per mezzo di un rispecchiamento astratto, ma di un rapporto soggetto(autore)oggetto(reale) che è sempre, per sua natura, anti-realistico e alienato. Il melodramma di Verdi è il vero referente storico di un edificio narrativo che, nel tentativo di afferrare una totalità per sua stessa definizione “alienata”, perché colta attraverso il filtro soggettivo dell’autore, «consente a De Santis di operare la saldatura fra amore (o erotismo) e politica», in modo che egli possa condurre «il suo discorso più radicale sulla società»51. L’alienazione dell’immagine di Non c’è pace tra gli ulivi è speculare e complementare al carattere utopistico della sua operazione, ovvero dare conto di una totalità attraverso l’immaginazione melodrammatica, che è appunto un filtro soggettivo. Esattamente come l’amore tra Aida e Radamès (Aida), o Fenena e Ismaele (Nabucco), è il nucleo genitivo da cui si dischiude l’evidenza stessa della tragedia di un intero popolo oppresso, la vicenda sentimentale (Francesco-Lucia) non è solo “apertura” verso la totalità, ma sua parte integrante. Mutuando da Brooks un’espressione fondativa del suo studio, la forma operistica di Verdi, in rapporto “obliquo” con quella realista, nel modo in cui è colta da De Santis, ci dice «che l’ordinario può essere il luogo dell’instaurazione di significato», che viste «nel giusto specchio,
51
A. Farassino, Giuseppe De Santis, Moizzi, Milano 1978, p. 77.
Opera Francesco Ceraolo
387
con il giusto grado di curvatura, le nostre vite contano»52 ed hanno senso in quanto parte di un tutto. È la figura femminile il centro del cinema successivo di De Santis. Roma ore 11 drammatizza un reale evento di cronaca (la rottura di una scala su cui un folto gruppo di donne attendeva alla ricerca di un impiego da dattilografa53), mentre il successivo Un marito per Anna Zaccheo chiude simbolicamente il suo tragitto nel melodramma, raccontando la vicenda di una donna bellissima, Anna Zaccheo (Silvana Pampanini), sedotta e compromessa dal suo datore di lavoro (Amedeo Nazzari), ma in realtà innamorata di un marinaio (Massimo Girotti) che la rifiuta perché incapace di accettare il suo “peccato”. Nel perimetro di uno quadro prospettico, in cui è sempre la soggettività melodrammatica a rappresentare l’accesso ad un cosmos storico-politico, il personaggio femminile fuoriesce dal suo nucleo familiare d’origine, povero ma onesto, per poi tornarci a chiedere conforto e accettazione, una volta subito il rifiuto del mondo esterno. La forma scettica del melodramma È proprio il personaggio di Amedeo Nazzari, in quegli anni volto-simbolo del melodramma di Matarazzo assieme a Yvonne Sanson, a negare la possibilità alla donna di impossessarsi del (e autonomizzarsi nel) mondo in Un marito per Anna Zaccheo. Questa singolare, quanto significativa, presenza trasversale della figura di Nazzari permette di cogliere chiaramente l’elemento fondativo dell’altra linea melodrammatica di questi anni, quella “chiusa” e scettica, che proseguendo idealmente la strada di Gallone e del cinema muto, trova il suo compimento definitivo prima nella cosiddetta “trilogia della povera gente” di Renato Castellani (Sotto il sole di Roma, 1948, È primavera..., 1949, Due soldi di speranza, 1952), e poi, ancor più, nel cinema di Raffaello Matarazzo. Se il coevo neorealismo, sulla scorta del romanzo realista, mette in scena il re-ingresso dell’uomo nella realtà, il suo riappropriarsi del suo progetto storico dopo la perdita del senso di realtà del Ventennio 52 53
P. Brooks, The Melodramatic Imagination, cit., p. IX. Basandosi sullo stesso episodio di cronaca Augusto Genina realizza nello stesso anno Tre storie proibite.
388
Lessico del cinema italiano
fascista54, il cinema di Castellani, qui esemplificato dalla vicenda del protagonista Ciro di Sotto il sole di Roma, allo sbando nella Roma occupata dai tedeschi e conteso da due figure femminili, Iris e Tosca (non a caso nomi tratti dalla tradizione operistica), rappresenta perfettamente l’inadeguatezza del soggetto di fronte alla vita, di cui egli non sa cogliere che un procedere deterministico e un divenire non orientabile. All’interno di un percorso “ascensionale” – il movimento progressivo della società che cresce con l’annessione di nuove unità – Ciro si trova perduto55, oppure fintamente protagonista di una situazione di cui in realtà è vittima. Il finale del film infatti, in cui egli sembra privilegiare una direzione famigliare, scegliendo la fedele Iris, è solo l’adeguamento ad un futuro ineluttabile, obbligato dalla fine tragica del padre che viene ucciso nelle ultime sequenze durante una rapina di cui lui stesso è tra i responsabili. Nei film di Castellani cominciano a intravedersi quelli che poi, esplodendo, costituiranno i codici espressivi “chiusi” del cinema di Matarazzo: il regime melodrammatico viene qui a definire un percorso di fuoriuscita dalla Storia, di fatalizzazione del destino e di sottomissione dell’uomo all’impossibilità di farsi carico del proprio progetto di vita; o, come scrive correttamente Gianni Canova, esso rappresenta «l’enfasi come unica possibile valvola di sfogo in cui lasciar parlare il dolore, la perdita, la sconfitta»56. La forma melodrammatica è coerente con una visione dell’uomo, e della coppia, all’interno di un regime de-politicizzato e, soprattutto, de-temporalizzato. Essa sancisce esattamente quella che potrebbe essere definita un’esclusione del politico dalla vita – riconducendo quest’ultima ad una forza immanente di cui l’individuo è interamente in balia –, che non è mai pensata in termini di universalità, ma sempre di singolarità. Nella maniera in cui il soggetto non ri54
55
56
Cfr. il noto saggio di A. Bazin, Il realismo cinematografico e la scuola italiana della Liberazione, in Che cosa è il cinema?, a cura di A. Aprà, Garzanti, Milano 2000 [ed. or. Qu’ est-ce le cinéma?, Édition du Cerf, Paris 1958]. Si faccia riferimento alla distinzione che Maurizio Grande riconosce tra la fase ascensionale (anni cinquanta) e la fase discensionale (anni sessanta) della commedia italiana in Id., La commedia all’italiana, a cura di O. Caldiron, Bulzoni, Roma 2006, pp. 58, 83. Cfr. G. Canova, L’infiammazione della lacrima: il paradosso del melò nel cinema italiano, in Appassionatamente. Il melò nel cinema italiano, a cura di O. Caldiron, S. Della Casa, Lindau, Torino 1999.
Opera Francesco Ceraolo
389
trova il suo senso più ampio all’interno di un vivere politico e comunitario, ecco che la sua concezione della vita diviene fatalistica (il ritorno del protagonista dalla fedele Iris) e la ricaduta politica di questa concezione diventa appunto una “fatalizzazione della Storia” e del destino. L’impossibilità da parte dell’individuo di proiettare la propria vita verso un futuro intenzionale, si trasforma in incapacità di pensare il futuro stesso come spazio abitabile, luogo aperto al soggetto e alla sua possibilità di esercitare una pressione attraverso le proprie forme di vita57. Se la forma chiusa del cinema di Gallone era stata emanazione diretta dell’estetica operistica tardo-ottocentesca e decadente, che contestualmente in Blasetti aveva trovato espressione ideologica nel carattere “astratto” di un’operazione propagandistica, il cinema di Matarazzo lavora, ancor più di quello di Castellani, sull’ideologia del melodramma, nel contesto della nuova società democratica dei primi anni cinquanta. Il cinema – di grandissimo successo in quegli anni – di Matarazzo utilizza infatti il melodramma per affrancare l’immaginario popolare italiano del dopoguerra da quella parvenza di momento politico che, sullo sfondo, era ancora presente in Sotto il sole di Roma. All’interno di un processo di reflusso dal politico e dal sociale, che di lì a poco, negli anni sessanta, verrà nuovamente invertito58, il melodramma di Matarazzo interpreta la crisi della soggettività storica neorealista e il suo ritorno ad un regime astratto, in cui la classe sociale di appartenenza determina limiti e difficoltà del vivere quotidiano, ma non la posizione dell’individuo rispetto alla Storia e alla società. Per molti aspetti in modo analogo a come il tardo-wagnerismo ottocentesco interpre57
58
Come scrive Stanley Cavell nel suo saggio sulla commedia americana del «ri-matrimonio», riferendosi alle ingerenze scettiche nel racconto della coppia sulla struttura commedica esse consistono «nell’incapacità della coppia di immaginare e desiderare il futuro. Non intendo l’incapacità di immaginare il loro futuro [...] ma piuttosto la loro incapacità di immaginare che ci sarà un mondo sociale abitabile all’interno del quale perseguire la propria avventura». Cfr S. Cavell, Alla ricerca della felicità, Einaudi, Torino 1999, pp. 87-113 (cap. “Leopardi nel Connecticut”) [ed. or. Pursuits of Happiness. The Hollywood Comedy of Remarriage, Harvard University Press, Cambridge 1981]. Pur con alcune sopravvivenze del regime melodrammatico “chiuso”. Si pensi a film come Incompreso (1967) di Comencini e ai suoi epigoni nel cinema di Romano Scavolini e Raimondo Del Balzo.
390
Lessico del cinema italiano
tava ideologicamente la crisi della soggettività rivoluzionaria uscita dai fallimenti delle rivolte del 1848, e il ritorno ad una dimensione puramente astratta del vivere, il melodramma “chiuso” degli anni cinquanta – di cui Matarazzo è il massimo interprete – segna un momento fondamentale di recupero di un’istanza scettica nella forma cinematografica a seguito del disincanto negli sviluppi progressivi della società post-bellica59. L’opera di Matarazzo vede il suo vertice nella trilogia di film con protagonisti Nazzari e la Sanson: Catene (1949), Tormento (1950), I figli di nessuno (1951). L’istanza scettica del melodramma è chiaramente riscontrabile nelle dinamiche familiari di Catene, che descrivono, nel contesto di un’assoluta trasparenza dell’involucro storico-sociale in cui si muovono i personaggi, le forme e i modi di un rapporto simbiotico tra un marito e una moglie, messo in crisi dal ritorno di un vecchio amante di lei. Pur non trovando una corrispondenza reale da parte della moglie, il solo approccio dell’amante, seguito di una serie di banali incomprensioni, ha il potere di far rompere al marito l’unità familiare, che poi verrà ricomposta solo nel finale dopo che la donna, incolpevole e rifiutata, si assumerà la responsabilità dell’accaduto per scagionare il marito che nel frattempo aveva ucciso l’amante. Ci troviamo qui di fronte ad un chiaro crescendo del movimento melodrammatico di affermazione, distruzione e poi ricomposizione dell’unità maschile-femminile (unità simbiotico-materna), tipica dell’opera tardo-romantica che fa chiaro riferimento al paradigma di Tristano. Il processo di unità della coppia si sviluppa in un movimento triadico: essa viene presentata – generalmente in modo illusorio (il “filtro d’amore” di Tristano) – negata – soprattutto ad opera di forze esterne (un amante, un pretendente) – ed infine, una volta negata la negazione, riaffermata. Ma i modi di questa Au ebung finale, seppur non più illusori, sono sempre di stampo simbiotico-regressivo, di cui lo stadio ultimo è la mor59
È da rilevare come questa linea dicotomica del melodramma cinematografico italiano sia stata notata, con accenni significativi proprio al cinema di Matarazzo, da Christian Viviani in Madone aux deux visages. Lyrisme et double dans le mélo populaire italien, in “Positif”, n. 436 (1997). Viviani definisce quello di Matarazzo come un cinema “pucciniano”, contrapposto alla linea “verdiana” di Visconti e, successivamente, di Bertolucci (ivi, p. 86).
Opera Francesco Ceraolo
391
te (reale o simbolica) come momento di astrazione assoluta della soggettività. L’amore si consuma e si afferma nella notte del mondo, invisibili e soli, all’oscuro della ragione che impone una visione prospettica della soggettività nella realtà: Chi amoroso osserva la notte della morte, a chi essa confida il suo profondo mistero: la menzogna del giorno, fama e onore, forza e ricchezza, come vana polvere di stelle innanzi a lui svanisce!... Fuor dal mondo, fuor del giorno, senza angosce, dolce ebbrezza, senza assenza, mai divisi, soli, avvinti, sempre sempre, nell’immenso spazio!..60.
Non è l’amore tragico ed impossibile tra Alfredo e Violetta di La Traviata a rappresentare il paradigma dell’unità maschile-femminile di Catene. È Tristano, nelle sue rielaborazioni decadenti-naturaliste (si pensi soprattutto al Puccini di Tosca, con lo stesso movimento di affermazione-negazione dell’unità culminante nella morte) e veriste (Cavalleria rusticana), a definire l’unità simbiotica che, simbolicamente, solo la morte può restituire: «Nel flusso ondeggiante, nell’armonia risonante, nello spirante universo del respiro del mondo, annegare, inabissarmi, senza coscienza, suprema voluttà!»61. Ecco che Catene di Matarazzo restituisce integralmente il movimento paradigmatico, in tutte le sue componenti tematico-formali, del dramma musicale italiano “chiuso” di influenza tardoromantica. I due film successivi, pur lavorando da angolazioni diverse, rielaborano lo stesso tema: la possibilità/impossibilità per l’unità simbiotica maschile-femminile di ri-affermarsi nella «notte», fuoriuscendo, o negando, il «giorno» del mondo (ovvero le sue componenti relazionali-collettive, vissute come prevaricatrici). Nel primo (Tormento), l’amore tormentato tra una donna, vessata dalla sua famiglia, e un uomo, condannato ingiustamente per omicidio, si ritrova felicemente nel finale. Mentre nel secondo (I figli di nessuno), una vicenda analoga, in cui un uomo ricco è costretto a partire dopo che la madre ha scoperto una sua relazione con una donna povera – nel frattempo alla donna, che si fa suora, viene rapito il figlio sempre dalla suocera – si conclude senza lieto fine (il figlio muore e lei rimane suora) e l’unità non si ricostituisce. So60 61
R. Wagner, Tristano e Isotta, atto II, scena II. Ivi, finale dell’atto III.
392
Lessico del cinema italiano
stanzialmente dunque il percorso di Matarazzo rimarrà inalterato, con una serie di ulteriori incursioni nel genere melodrammatico più o meno riuscite (I figli di nessuno troverà un seguito più a lieto fine nel ’55 con L’angelo bianco), ed una appropriazione indebita, con esplicito tentativo di auto-attribuzione di una filiazione, della figura verdiana con il film biografico Giuseppe Verdi del ’53. L’opera verdiana e la reinvenzione della forma cinematografica: Senso di Luchino Visconti La forma cinematografica intesa come strumento di riappropriazione integrale delle istanze del melodramma “aperto” di Verdi trova la sua massima espressione nell’opera di Luchino Visconti. Già all’interno della fase neorealista, Visconti aveva lavorato ad includere (o anche solo a citare) elementi distintivi dell’opera ottocentesca italiana. Si pensi all’utilizzo dell’aria di La Traviata «Di Provenza, il mare, il suol...» in Ossessione, cantata dal marito di Giovanna (Clara Calamai), poco prima di essere ucciso dai due amanti in un finto incidente stradale, chiaramente con lo scopo di definire i contorni edipici del rapporto tra Giovanna e il padremarito. O anche all’incipit di Bellissima (1951) con l’esecuzione di L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, che ritornerà nel corso del film, a sottolineare il carattere “giocoso” e farsesco del mondo incantato del cinema, attraverso cui la popolare Maddalena Cecconi (Anna Magnani) vuole drammaticamente riscattare il suo destino e quello della figlia. È però con Senso che il discorso viscontiano sul melodramma ambisce ad una vera e propria rifondazione della forma cinematografica italiana su di una operistica, nel tentativo definitivo di fuoriuscire, perlomeno all’interno di una poetica autoriale, da quella neorealista aperta da Visconti stesso undici anni prima con Ossessione. Eppure l’importanza cruciale di Senso nella storia del cinema italiano non risiede unicamente nella tracciabilità di una crisi del neorealismo (e nel suo presunto passaggio al realismo, secondo la nota definizione di Aristarco62), ma nel suo tentativo 62
Cfr. il saggio di Aristarco su Senso di Visconti contenuto in “Cinema nuovo”, n. 52 (1955), e il volume G. Aristarco, Storia delle teoriche del film,
Opera Francesco Ceraolo
393
di perimetrare ideologicamente, attraverso la forma operistica, i tratti di un soggetto-coscienza in relazione al mondo, nella ridefinizione e recupero ideologico dell’istanza “aperta” della forma melodrammatica all’interno della cultura italiana. Rileggere Senso in questa sede è funzionale non solo a segnalare l’influenza decisiva del suo «realismo romantico»63 sul successivo melodramma italiano, come si vedrà in seguito; ma, come per gran parte del primo Visconti (fino a Rocco e i suoi fratelli, 1960), ad evidenziarne quella forma di determinismo radicale che ne sottende ogni immagine (da cui l’inalienabilità tra determinismo della Storia e progettualità esistenziale dell’individuo, già tipica del melodramma di Verdi), che rende Senso il film che più di ogni altro ha voluto e saputo instaurare un dialogo con le forme rappresentative dell’opera lirica, non assimilandone i codici generici in una funzione puramente chiusa (Blasetti, Matarazzo), o all’interno di una poetica neorealista (Genina, De Santis), ma aprendo ad una modernità cinematografica che, attraverso quei codici, è stata capace di instaurare un nuovo rapporto con il reale, inteso nei termini di una totalità storico-sociale64. Senso è cioè un film in cui l’utilizzo di uno stile e una struttura tipicamente melodrammatica (riconoscibilissima, ad esempio, nelle esplosioni semantiche all’interno di singole scene, momenti delimitati della narrazione cinematografica che aprono e chiudono la rappresentazione in tanti piccoli frammenti come arie di un’opera65) oltre ad essere funzionale ad un riavvolgimento/
63 64
65
Einaudi, Torino 1960. Secondo Aristarco Senso rappresentava la fine del neorealismo, avendo il respiro e la profondità del grande romanzo moderno, ovvero una capacità di cogliere le contraddizioni e la complessità degli eventi storici dandone un giudizio che era anche una presa di posizione sul presente. G. Aristarco, Senso, cit. Si pensi soprattutto al cinema di Bertolucci e Martone, che si vedrà in seguito. Si confronti a questo proposito la ricognizione critica del dibattito su Senso svolta da Tomaso Subini in Il difficile equilibrio tra Storia e Melodramma in “Senso”, in Il cinema di Luchino Visconti tra società e altre arti, a cura di R. De Berti, Cuem, Milano 2005, pp. 47-78. Singole unità semantiche tenute assieme proprio dall’incedere del commento musicale, che si apre con Il trovatore di Verdi e prosegue con lo struggente adattamento di Nino Rota della Settima sinfonia di Anton Bruckner.
394
Lessico del cinema italiano
superamento delle forme della narrazione novecentesca, apre ad un nuovo regime musicale del visibile, che se per molti versi è anticipatore di quello che diverrà un nuovo cinema di poesia (nella teorizzazione di Pasolini66), sarà portato a compimento da autori di generazioni successive, nelle forme di una musicalità o degradabilità del visibile stesso (Bertolucci, Bene). La trama del film è nota: l’amore impossibile di una contessa veneziana per un tenente austriaco sconfina nel tradimento degli ideali risorgimentali nella prima, e nel senso di colpa per un destino da disertore nel secondo. Quando, nel finale, l’uomo svela l’inganno di questo doppio tradimento, assieme all’illusione della regressione simbiotica dell’amore vissuto dalla donna verso di lui, lei lo tradisce a sua volta, denunciandolo come disertore al comando austriaco, e condannandolo alla fucilazione. Le vicende narrate chiariscono immediatamente il carattere annichilente della relazione amorosa vissuta – unidirezionalmente – dai due protagonisti, il cui esito tragico è evidente sin dalla prima scena del loro incontro/scontro ambientata nel Teatro La Fenice durante la rappresentazione di Il trovatore. Ma, di nuovo, la manifesta struttura di Senso non rende il film una semplice operazione autoriale operata sulla scorta del melodramma cinematografico precedente e coevo. Il suo “destinalismo” tragico, in altre parole, non è che il prodotto di uno sconfinamento ideologico, in cui l’individuo, pensato al di fuori della Storia, non può che soccombere – per poi infine assecondare – difronte all’incedere degli eventi che, al di fuori si sé, lo chiamano in causa in quanto soggetto politico. Esattamente come i personaggi di La terra trema pochi anni prima non sfuggivano ad uno sguardo melodrammatico-positivistico che li rendeva schiavi di un futuro segnato, così la vicenda di Senso non può che essere vittima dello stesso determinismo storico, che la inchioda ad un destino di morte. Il melodramma con Senso, come già con Verdi, sconfina in una forma di “positivismo reificato”, per il quale l’agire è sempre “prevedibile” secondo leggi che appartengono alla causalità della Storia. Ma la morte qui non rappresenta l’annullamento del soggetto nella «notte» del mondo (Catene), quanto il dramma della soggettività e del suo vivere nel «giorno» 66
P.P. Pasolini, Empirismo eretico, in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti, S. De Laude, tomo I, Mondadori, Milano 1999, p. 1461.
Opera Francesco Ceraolo
395
(come in La Traviata), ovvero nel mondo con le sue componenti sociali e relazionali. L’operazione di Senso definisce, a partire dalla sua uscita e dal dibattito che ne è seguito, un tratto tipicamente italiano del rapporto tra forme rappresentative (cinematografiche) della tardamodernità e divenire storico, come si vedrà meglio in seguito: il prevalere di una forma musicale su una narrativa67, e il conseguente organizzarsi dell’epopea storica cinematografica su forme melodrammatiche piuttosto che drammatiche68. Senso rimette in gioco l’intera storia del melodramma cinematografico, rinegoziandone il carattere basso-mimetico e stilizzandone ideologicamente i codici fondativi, fino a compiere una vera e propria operazione politica, in cui esso è ricollocato all’interno di una cifra stilistica epica, anche qui, come per De Santis, mediata da Brecht e Lukács69. Esattamente come Cielo sulla palude e Non c’è pace tra gli ulivi, 67
68
69
Qui è necessario nuovamente ribadire la radice della dicotomia neorealismo-melodramma in quella fondativa romanzo-opera. Su questo si confronti in particolare la corposa riflessione teorica di Cesare Zavattini (Opere, Bompiani, Milano 2002), da cui risulta significativo come il tema del melodramma ne sia del tutto assente. La poetica zavattiniana, contrapponendo la pratica del “pedinamento” della realtà a quella dell’“approssimazione”, implicava un certo rapporto di frontalità con il reale, e non un suo avvolgimento, che è inteso dall’approssimarsi ad un oggetto nella sua finitezza. Il neorealismo zavattiniano concepiva cioè il mondo come qualcosa di potenzialmente infinito (Cfr. M. Grande, Il soggetto inesauribile, in C. Zavattini, La veritàaaa..., Bompiani, Milano 1983, pp. 7-65), non circoscrivibile e valutabile in quanto oggetto, cosa che è invece alla base dell’operazione di Visconti sul melodramma. La struttura narrativa da cui origina Senso (la novella di Boito) in realtà non è che un espediente letterario alla pari dei drammi shakespeariani per le opere verdiane. In questo Senso è molto vicino a un film successivo come Il tè nel deserto, che si vedrà in seguito, tratto da un romanzo di quel Paul Bowles che aveva lavorato come dialoghista al film di Visconti, e altro esempio straordinario di dramma in costume ad impianto musicale. Cfr. T. Subini, Il difficile equilibrio tra Storia e Melodramma in “Senso”, cit. Come nota bene Subini nel suo saggio, presentando una panoramica esaustiva del dibattito critico sul film all’epoca della sua uscita, quest’ultimo generò «dall’auspicio che il nostro cinema superasse le facili denunce affidate alla superficialità cronachistica del neorealismo, per affrontare una rappresentazione del reale criticamente più complessa» (ivi, pp. 4849). E ancora: «L’apparizione di Senso parve dare (e in parte davvero lo fece) una risposta a tali esigenze, in consonanza con le proposte di György Lukács, da poco conosciute e subito entrate in circolo, che diffidando delle
396
Lessico del cinema italiano
Senso ricuce la vicenda storica della forma melodrammatica che, fino ad allora (nel cinema muto, fascista, e in quello di Gallone e Matarazzo), come si è visto, nel passaggio dall’opera ottocentesca al cinema, aveva assorbito il carattere basso-mimetico tipico dei wagnerismi italiani tardo-romantici e decadenti, ma non l’istanza dialettico-storica del primo-romanticismo di Verdi e Bellini. Ma la differenza fondamentale tra l’operazione di Visconti e quella di Genina-De Santis è che in Visconti tale questione è affrontata in modo diretto, e non più funzionale alla poetica neorealista. In altre parole: il film di Visconti non inscrive più la forma cinematografica in una melodrammatica nel contesto di un discorso sul neorealismo, ma fuoriesce dal neorealismo stesso e, attraverso quella forma, rinegozia l’intero paradigma del rapporto soggetto-mondo in termini di apertura. È questo dunque l’orizzonte fondamentale che il film apre nella storia del cinema italiano, e da cui una parte importante non si discosterà mai del tutto: il suo rimandare ad un’impossibilità da parte del soggetto di emanciparsi da un più ampio orizzonte storico, che trova il suo modello chiaro in una ispirazione verdiana trasfigurata, ovvero nella riproposizione dei temi fondanti il dramma rinascimentale (Shakespeare), mediati dalla teatralità di Mozart e Da Ponte e poi tradotti in musica da Verdi. Non vi è in Senso altro che una trasfigurazione di quella «alienazione e utopia»70 del primo dramma verdiano, in cui il dramma della soggettività cartesiana, a fronte dell’impossibilità di “rispecchiare” e comprendere le leggi dei flussi storici che la sovrastano, non è unicamente sottoposto ad un processo di teatralizzazione ma, come anche in Shakespeare, diviene già modello di una modernità asistematica, quale quella risorgimentale71.
70 71
“avanguardie senza radici” indirizzavano verso le forme narrative del XIX secolo ed in particolare verso il romanzo storico» (Ivi, p. 51). Cfr. le riflessioni di Parinetto sul realismo critico di La Traviata in Verdi e la rivoluzione. Alienazione e utopia nell’opera verdiana, cit., pp. 19-22. Sul ruolo politico della musica di Verdi e su i suoi rapporti con la modernità risorgimentale si confronti il saggio di C. Toscani, Melodramma e Risorgimento. Per una fenomenologia del patriottismo in musica, in Per una fenomenologia del melodramma, cit., pp.189-209.
Opera Francesco Ceraolo
397
Visconti oltre Senso Estendendo per un momento lo sguardo al decennio successivo, altro film chiave di Visconti, prima della svolta di Il gattopardo (1963), è Rocco e i suoi fratelli, ispirato ai racconti di Testori (Il ponte della Ghisolfa) ed epopea di una famiglia di contadini lucani trapiantati a Milano negli anni del boom economico, che si disgregherà quando ogni sua componente prenderà una strada diversa. Anche qui, la forma melodrammatica viscontiana continua ad essere veicolo di un’istanza fortemente ideologica. Come nota Giori nel suo volume sul film, il melodramma «non cresce [...] semplicemente a scapito dell’analisi sociale: le due componenti sono infatti profondamente intrecciate»72. [Se] la parte esplicitamente politica viene progressivamente messa ai margini in favore della parte melodrammatica, non è per lasciare spazio a un’alternativa contraria all’analisi sociale verghiano-gramsciana di partenza, ovvero a un racconto disimpegnato e popolareggiante, ma è solo perché quell’analisi ha trovato una nuova, più confacente e coinvolgente forma di espressione73.
Il melodramma del primo Visconti, sulla scorta di Verdi, racconta esattamente questo: l’impossibilità di emanciparsi dalla forza del destino della Storia, romanticamente o deterministicamente intesa. Rocco e i suoi fratelli, come il precedente Le notti bianche (1957), non possono che essere di Senso dunque l’ideale continuazione: un lavoro verso un nuovo melodramma (su modello aperto), che esiste solo in virtù di quei codici grammaticali formulati nel ’54. Ora, se Senso e Rocco e i suoi fratelli, sulla scorta del melodramma di Verdi, rappresentano l’esito di un percorso che intende leggere la crisi della soggettività che si pone nei confronti della Storia come una coscienza separata, che deve rispecchiare e obbedire alle sue leggi, il cinema successivo di Visconti, con i suoi esiti trasfiguranti, che qui anticipiamo per chiarire i tratti complessivi dell’intera filmografia viscontiana, non si discosta da questa prospettiva. 72 73
M. Giori, Rocco e i suoi fratelli, Lindau, Torino 2011, p. 188. Ivi, pp. 214-215.
398
Lessico del cinema italiano
Al contrario, esso la rovescia nel suo opposto speculare, ovvero in una sfiducia assoluta nelle possibilità per l’uomo di corrispondere al ruolo che la Storia gli ha consegnato. Prolungando ulteriormente lo sguardo ai decenni successivi infatti, se Il gattopardo è il film che rappresenta il primo e più alto momento della svolta del tardo Visconti74, il vero manifesto di questa seconda fase lo troviamo in Ludwig (1972), ultima pellicola della cosiddetta “trilogia tedesca”: perché esattamente come Senso è un monumento a Verdi, Ludwig lo è a Wagner, il cui Tristano e Isotta è il vero modello della forma “chiusa” del melodramma decadente. Le vicende che portano all’ascesa, detronizzazione e morte di Ludwig II di Baviera (1845-1886), monarca-mecenate, patrocinatore di Richard Wagner e dedito alla costruzione di fiabeschi castelli-residenze più che agli affari di Stato, sono l’emblema di quella Verklärung che è l’unica via di fuga dalla condizione tipica dell’uomo decadente, ovvero quella di “straniero” al mondo. L’impossibilità da parte di Visconti di articolare una fuoriuscita dal determinismo melodrammatico (che “apre” definitivamente alla Storia, ma gli impedisce di leggere dialetticamente il rapporto dell’uomo con essa nei termini di una relazione che intercorre sempre tra un soggetto attivo e un oggetto, le cui leggi sono costantemente rinegoziabili, nella dialettica del negativo, secondo un principio di razionalità pratica), automaticamente fa rovesciare l’esaltazione per le sorti progressive della Storia di Senso e Rocco e i suoi fratelli in sfiducia nel reale e nelle sue possibilità di palingenesi: questa è dunque la vera premessa teorica all’opera del secondo Visconti. Rocco e i suoi fratelli si concludeva dunque con un grido di speranza nella Storia – il monologo di Ciro che apre alla speranza/ certezza di un “mondo migliore”75 –, mentre Il gattopardo, come 74
75
I modi e le forme in cui l’istanza melodrammatica sopravvive nel contesto della ridefinizione dell’estetica viscontiana all’interno di un regime neodecadente (successivo a Il gattopardo) possono qui essere solo accennati. Per un percorso storico-analitico nella filmografia di Visconti (e nei suoi attraversamenti della forma melodrammatica) si vedano il testo di L. Miccichè, Luchino Visconti. Un profilo critico, Marsilio, Venezia 2002; A. Bellavita, Luchino Visconti. Il teatro dell’immagine, Ente dello Spettacolo, Roma 2006; Il cinema di Luchino Visconti, a cura di V. Pravadelli, Biblioteca di Bianco & Nero-Marsilio, Roma-Venezia 2000. «Pure al paese nostro la vita cambierà per tutti, perché pure laggiù gli uomini stanno imparando che il mondo deve cambiare. Certi dicono che
Opera Francesco Ceraolo
399
il cinema successivo, mette totalmente in crisi quel paradigma, affermando l’impossibilità di quel cambiamento. La forza “positiva” del destino di Senso e Rocco e i suoi fratelli, lascia spazio ad una “nostalgia per il presente” – quella di Don Fabrizio di Salina alle prese con il disfacimento dell’aristocrazia siciliana a seguito dei moti risorgimentali e dello sbarco di Garibaldi a Marsala – in attesa di un futuro che, comunque, sarà sempre “peggiore”. Non bastano le famose considerazioni del figlio Tancredi («Bisogna cambiare per far rimanere tutto così com’è»), aristocratico e garibaldino allo stesso tempo, a rincuorare e rifondere fiducia nel suo cuore: quella di Don Fabrizio è una condizione antropologica, l’abisso struggente dell’ente-umano, non astratto dal, ma privato del mondo, il cui grande referente è certamente da un lato l’universo proustiano della Recherche, ma anche e soprattutto la duplice cifra del Tristano di Wagner, che proponendo un’astrazione della soggettività nella notte del mondo, la trasfigura in qualcosa che, a quell’idea di mondo, non appartiene più. L’approdo della soggettività viscontiana dunque, rielaborando quella wagneriana, non è semplicemente astraente, come in Matarazzo, ma trasfigurante. Questo è un punto su cui è importante insistere, e che sarà presente anche nell’evoluzione della forma melodrammatica in Bertolucci che si vedrà successivamente: non è la coscienza astratta, interamente separata dal mondo e da una società invisibile (Catene) il centro di Il gattopardo e della cosiddetta “trilogia tedesca”; ma l’uomo che, di fronte agli esiti tragici di un destino in cui si era precedentemente riposta una fiducia assoluta, compie un processo di trasfigurazione della propria soggettività, di sua mutazione antropologica nel tentativo (a volte fallimentare, come in Ludwig) di sopravvivere a tale nuova condizione. Ecco che il cinema di Visconti, oltre agli esempi già citati, colleziona una galleria di personaggi icastici e in questo senso interamente sovrapponibili; uomini che, assistendo impotenti alla crisi di un mondo, abbandonano e trasfigurano la propria individualità nei livelli simbolici del regime erotico-artistico (Gustav von Aschenbach di Morte a Venezia, 1971), o in quelli di una piccola parte di realtà che si vuole costruire a propria immagine il mondo così fatto non sarà migliore, ma io Luca ci credo invece, e so che domani la vita tua sarà più giusta e più onesta».
400
Lessico del cinema italiano
e somiglianza (Arthur Meursault in Lo straniero, 1967, il vecchio professore di Gruppo di famiglia in un interno, 1974). Una preparazione alla morte. Il melodramma modernista Negli stessi anni in cui Visconti con Senso si propone di rifondare integralmente i codici del linguaggio cinematografico sulla scorta del melodramma aperto verdiano, la produzione di due autori – quella dell’allora esordiente Michelangelo Antonioni (Cronaca di un amore, 1950, La signora senza camelie, 1953, Il grido, 1957) e Vittorio Cottafavi (Traviata ’53, 1953, Una donna libera, 1954) – lavora, portandola a compimento, la componente straniante tematizzata da De Santis, emancipandola definitivamente dalla cifra neorealista e aprendo ad un modernismo cinematografico che sarà poi alla base della poetica di una nuova generazione di giovani autori (non solo italiana) negli anni sessanta. Il vero modello cinematografico della produzione di Antonioni e Cottafavi non è tanto il melodramma aperto di Senso quanto quello poliziesco-noir del primo Visconti di Ossessione. Con quest’ultimo Antonioni e Cottafavi condividono la stessa matrice realista francese – dal romanzo ottocentesco al cinema di Jean Renoir – e piuttosto che proporsi come manifesto per un vero e proprio cinema operistico interno alla tradizione italiana (Senso), la loro è un’operazione di «decantazione»76 della forma del melodramma in tipico stile modernista, di sua liberazione e contaminazione all’interno di un registro epico, capace di aprire ad una narrazione critica della nascente classe borghese del nuovo capitalismo italiano. In questa direzione, oltre al già citato utilizzo del genere noir e della commedia, è per entrambi cruciale il sodalizio con Giovanni Fusco – compositore e futuro autore delle colonne sonore dei più grandi film di Antonioni77 –, capace di rendere, attraverso commenti musicali jazzistici, quella tensione verso lo straniamento fondamentale per la proposta di una narrazione epica dell’Italia di quegli anni, e annullare, come invece 76 77
V. Spinazzola, Cinema e pubblico, Bulzoni, Roma 1985, p. 142. Per un’analisi approfondita della musica di Fusco nel cinema di Antonioni cfr. R. Calabretto, Antonioni e la musica, Marsilio, Venezia 2012.
Opera Francesco Ceraolo
401
era il caso in Matarazzo, qualsiasi possibilità di identificazione da parte dello spettatore. Lo spostamento del centro geografico del racconto da Roma (neorealismo) al Nord Italia è strumentale a quella che Franco Fortini, scrivendo su “Cinema Nuovo”, definisce la «direzione sana» del nuovo cinema italiano degli anni cinquanta, a partire dai già citati Antonioni e Cottafavi, fino ai melodrammi di Alberto Lattuada (Il mulino del Po, Anna) e Mario Soldati (È l’amor che mi rovina, La provinciale) e alla commedia di Luigi Comencini (Mariti in città, Mogli pericolose). Direzione che consiste nel considerare «il nodo della realtà italiana» non più nelle vicende del proletariato o sottoproletariato (neorealismo), ma nell’ambiente medio-alto borghese del neo-capitalismo industriale: Il luogo della contraddizione e della tensione è la vita delle classi medie. In campo letterario cioè equivale a dire che “realismo” è Balzac, Tolstoj, Mann e anche Proust o Ka a e non il “romanzo sociale”. [...] La rappresentazione della cultura delle classi medie [...], lì è il mistero, lì si nasconde la realtà meno semplificabile, meno stilizzabile a propri per formule78.
Esattamente come il Rossellini di Europa ’51, i primi melodrammi di Antonioni e quelli di Cottafavi, spesso basandosi su di un canovaccio espressamente verdiano (La signora senza camelie, Traviata ’53), propongono l’affresco di un mondo opulento e in via di costruzione (al cui vertice c’è l’alta società milanese) in cui l’individuo, totalmente consumato all’interno del ruolo sociale imposto dal nuovo regime di vita del capitalismo avanzato, ha interamente smarrito la propria natura psicologica e interiore. Si tratta, in altre parole, di un rovesciamento tanto del paradigma matarazziano quanto di quello del primo Visconti: l’individuo non vive astrattamente nella propria dimensione chiusa, affettiva e familiare (Catene), o si esaurisce nel proprio ruolo aperto alla Storia (Senso), ma è soffocato e incastrato dentro la propria funzione sociale, che gli impedisce di cogliere la propria verità se non come quella di 78
F. Fortini, Il realismo italiano nel cinema e nella narrativa, in “Cinema nuovo”, 15 giugno 1953, p. 12.
402
Lessico del cinema italiano
una solitudine universalizzata (che poi sarà alla base della poetica dell’“incomunicabilità” dell’Antonioni maturo). La cifra tipica del dramma musicale modernista, dall’espressionismo di Schönberg/ Berg (Erwartung, Wozzek) a Stravinskij (Histoire du Soldat)79, viene integralmente assorbita dal melodramma cinematografico; ovvero, la solitudine dell’uomo moderno nella nuova società consumistica, che viene rispettivamente universalizzata o passivamente accettata in quanto condizione ontologica dell’essere umano. Lo stravolgimento modernista della forma melodrammatica – decomposta attraverso l’uso di flashback, ellissi, commenti musicali ossessivi, ripetuti e stranianti – è dunque funzionale alla narrazione di questa nuova condizione dell’individuo, com’è chiaramente visibile nei già citati Il grido e Traviata ’53. Dopo aver indagato la media e alta borghesia milanese in Cronaca di un amore e La signora senza camelie, in Il grido Antonioni porta a compimento il suo percorso nelle forme e nei temi del melodramma modernista novecentesco, impostando una vicenda secondo codici tipicamente operistici che fanno diretto riferimento all’estetica espressionista di Schönberg e Berg80. La storia dell’operaio Aldo che lascia il paese d’origine dopo esser stato abbandonato dalla sua compagna Irma, diviene un lungo viaggio esistenziale di un uomo alla ricerca del proprio posto nel mondo, che egli rifiuta e da cui egli stesso è rifiutato, e dunque, implicitamente, una «lunga preparazione alla morte»81. Secondo un impianto tipicamente espressionista, che recupera strutturalmente il modello 79
80
81
Si confronti la dicotomia fondativa Schönberg/Stravinsky della musica moderna secondo Adorno in T.W. Adorno, Filosofia della musica moderna, a cura di G. Manzoni, Einaudi, Torino 2002 [ed. or. Philosophie der neuen Musik, J.C.B. Mohr, Tübingen 1949]. Con espressionismo musicale si definisce quella corrente novecentesca nata negli anni dieci del Novecento e raccoltasi intorno alla cosiddetta Seconda scuola viennese. Oltre ad una riconsiderazione della forma musicale, secondo Adorno il tema portante dell’espressionismo concerne l’irrazionalità pura dell’emotività dell’individuo in opposizione alla razionalità asfittica del mondo oggettivo. Cfr. ancora T.W. Adorno, Filosofia della musica moderna, cit. Applicando al film di Antonioni la definizione che Vittorio Cottafavi diede del suo Traviata ’53. Si confronti Ai poeti non si spara. Vittorio Cottafavi tra cinema e televisione, a cura di A. Aprà, G. Bursi, S. Starace, Cineteca di Bologna, Bologna 2010, p. 197.
Opera Francesco Ceraolo
403
del Wozzeck berghiano82, Il grido racconta la solitudine dell’individuo, che privato di ogni apertura su di un futuro intenzionale, vive la felicità come un mero e sfuggente attimo: la sua dunque non è più felicità, ma mera transitorietà. Come nel melodramma espressionista, l’individuo universalizza la propria solitudine personale quale condizione stessa dell’uomo nella società moderna: essa – la solitudine – è innalzata a verità dell’esistenza umana. La morte che Aldo si infligge nel finale, una volta tornato al paese, sotto gli occhi di Irma che lo osserva, rappresenta dunque l’esito materiale di un processo di costruzione della soggettività. Un processo che non esclude più il mondo nello spazio chiuso della coppia, o dell’individuo, secondo la dicotomia del giorno e della notte (il Matarazzo wagneriano di Catene). Un percorso in cui, in altre parole, la morte non è astrazione e nemmeno trasfigurazione (quella del tardo Visconti), ma configurazione dell’individuo rispetto al mondo: essa rappresenta l’esito drammatico di uno scontro (soggettomondo) profondo, irrimediabile e senza sconti, che, seguendo ancora la falsariga del melodramma di La Traviata, diviene “ritorno alla vita”83, momento definitivo di configurazione del rapporto tra l’individuo e la realtà. Un medesimo percorso verso la morte, concepita in una chiave configurante la soggettività nel suo rapporto con il mondo, secondo le parole dell’autore stesso, è quello della protagonista di Traviata ’53. Il film, di dichiarata ispirazione verdiana, sottopone l’opera ad un integrale lavoro di risignificazione, sia delle forme, stilizzate e stranianti – fondamentale ancora una volta in questo senso l’apporto delle melodie jazz di Giovanni Fusco –, che dei contenuti, all’interno dei differenti momenti della narrazione, spinti fino all’esasperazione delle loro possibilità espressive. Non potrebbe dunque esserci operazione più distante da quella delle cosiddette “opere parallele” di Gallone, in cui l’impianto operistico funzionava da semplice detonatore e ispiratore della narrazione cinematografica, e in cui l’opera non veniva affatto sottoposta ad alcun processo di ri-mediatizzazione, di vera e propria appropria82 83
Tratto da un dramma di Georg Büchner, è la storia del soldato Wozzeck, soggetto nevrotico in preda ad allucinazioni, che uccide la sua compagna per poi suicidarsi. Si pensi alle ultime parole pronunciate da Traviata morente nell’opera di Verdi: «Ma io... Ma io ritorno a vivere!».
404
Lessico del cinema italiano
zione e manipolazione delle sue strutture tematico-formali nell’orizzonte del nuovo regime cinematografico. La trama di Traviata ’53 racconta la vicenda di Rita, donna dell’alta società milanese e amante mantenuta del Commendator Cesati (interpretato da un Eduardo De Filippo ridoppiato con accento brianzolo), che si innamora, essendone ricambiata, del giovane ingegnere Carlo. Dopo aver lasciato quest’ultimo perché ricattata dal Commendatore, Rita lascia a sua volta anche il ricco protettore, scegliendo una vita di stenti (alla ricerca di un umile impiego in quell’alta società che una volta la vedeva protagonista), fino ad ammalarsi ed essere ricoverata in un sanatorio. Muore assistita dal Commendatore, senza che Carlo riesca a raggiungerla prima della sua dipartita. Dopo una prima parte centrata sulla descrizione della nascente alta società capitalistica milanese, il film racconta la storia di una donna, esattamente come Aldo in Il grido, alla ricerca della propria dimensione umana. La tragedia finale esplode, sempre sulla falsariga dell’estetica melodrammatica modernista, quale ultimo stadio di una “dialettica della solitudine”, ovvero di una condizione non puramente psicologica, ma che connota la condizione dell’uomo stesso nella società moderna. Ecco dunque che l’evento-morte – enfatizzato fino al parossismo della piombatura della bara nella cantinaobitorio del sanatorio, e della lunga marcia funebre finale commentata dai ritmi incessanti della melodia di Fusco (sul modello del Crepuscolo wagneriano) – rappresenta l’esito configurante, e non astraente e trasfigurante, della soggettività storica verso cui l’intero film è proiettato. Verso una nuova forma operistica Se l’esperienza modernista chiude gli anni cinquanta lasciando che ulteriori residui di forzatura della forma chiusa sopravvivano, eterogeneamente, in un certo cinema di Mario Soldati e Alberto Lattuada (i già citati Anna e La provinciale), gli anni sessanta si aprono all’insegna di una rifondazione complessiva della forma operistica sulla scorta di nuovi modelli referenziali, che l’esperienza modernista stessa aveva posto in essere. Mentre l’istanza aperta del melodramma inaugurata da Visconti con Senso continuerà a
Opera Francesco Ceraolo
405
svilupparsi in altri autori, pur con numerose mediazioni (come si vedrà successivamente a proposito del Bertolucci di Novecento e più recentemente del Martone di Noi credevamo), gli anni sessanta operano una ri-tematizzazione dei rapporti referenziali immagine-opera, soprattutto nell’ambito di esperienze autoriali. La dicotomia Verdi-Wagner, che in qualche modo aveva fornito il modello per un doppio utilizzo della forma melodrammatica in termini rispettivamente “aperti” (Senso) e “chiusi” (Catene), dall’esperienza modernista di Antonioni e Cottafavi viene sostanzialmente superata, schiudendo nuove possibilità di ricomposizione della stessa forma in modi nuovi e originali. Tali nuove possibilità, in questi anni, aprono verso direzioni che pertengono soprattutto all’utilizzo dell’opera quale oggetto privilegiato nella costruzione dell’immagine ed elemento portante della colonna sonora. Tale pratica, apparentemente neutra ed espressiva, è in realtà esemplificativa di una più ampia prospettiva sulla tradizione culturale italiana emersa agli inizi degli anni sessanta, non solo a seguito di fattori interni (l’esperienza modernista), ma soprattutto dell’emergere delle nuove politiche culturali che poi sfoceranno nel ’68. L’opera entra dunque in molta parte del cinema della nuova autorialità non come pura linea sonora, ma quale elemento attraverso cui il cinema instaura simbolicamente un vero e proprio dialogo con la “tradizione”, proprio nel momento in cui l’eredità di quella tradizione è interamente rinegoziata. Di questo dialogo, e del derivante costituirsi di una vera e propria nuova “immagine operistica”, si osservano tre orientamenti distinti: da un lato si assiste ad un processo di dialettizzazione della linea musicale e di quella cinematografica, in cui cioè l’opera (o brani da singole opere) viene posta rispetto all’immagine cinematografica in modo strumentalmente contrastivo, lavorando in funzione dell’edificazione di un vero e proprio regime dialettico dell’immagine sonora; in secondo luogo, si osserva un utilizzo coerente, in cui, in altre parole, l’opera viene utilizzata in un rapporto di integrazione con il visibile dell’immagine cinematografica: essa lo deflagra, senza contraddizioni, portandolo alla costruzione di un regime autocosciente della realtà nell’immagine stessa; infine, si registra un utilizzo fortemente espressivo, in cui il visibile dell’immagine viene condotto, attraverso l’opera, all’interno di un regime musicale.
406
Lessico del cinema italiano
Dentro un regime dialettico sembra muoversi un certo cinema di Pier Paolo Pasolini, specialmente negli anni ’63-’66, in particolare con l’episodio La ricotta di Ro.Go.Pa.G. e con Uccellacci e uccellini. Mentre in Accattone (1961) e in Il Vangelo secondo Matteo (1964) la colonna musicale dell’immagine cinematografica, «lingua scritta della realtà», seguiva uno sviluppo interamente orientato ad un lavoro, nell’immagine, verso una forma di autocoscienza della realtà stessa – si pensi all’uso enfatico e ripetuto della Matthäuspassion di Bach in Accattone o della Maurerische Trauermusik di Mozart nella scena della crocifissione del Vangelo84 –, con La ricotta l’opera lirica entra per la prima volta nel repertorio pasoliniano in chiave pienamente dialettica. È la melodia manipolata e stilizzata di «Sempre libera degg’io» da La Traviata a commentare, beffardamente, la corsa tragica all’acquisto della ricotta di Stracci, e poi la scena del banchetto fino alla sua morte sulla croce. La “libertà” di Traviata di «folleggiar di gioia in gioia», specularmente, diviene quella di Stracci di correre libero nella campagna romana del set del film sulla passione di Cristo. Il brano costruisce con il visibile dell’immagine un vero e proprio rapporto dialettico, commentandone, in modo contrastivo e oppositivo, l’oggetto in atto (il dramma della morte di Stracci). A Pasolini dell’opera non interessa tanto l’elemento strettamente melodico – come nel caso della solennità della musica sacra di Bach e Mozart in Accattone e nel Vangelo –, quanto quello “orale”, ovvero, in La ricotta, il senso stretto dell’aria verdiana che canta di una agognata “libertà”. Scrive infatti in Il cinema e la lingua orale a questo proposito: Le parole della Traviata, dicono, sono sciocche e ridicole, esteticamente non solo prive di valore, ma anzi quasi offensive al buon gusto: eppure ciò non conta niente. È la musica che conta, dicono. Questa affermazione sembra così piena di buon senso, e invece è completa84
Scrive Pasolini a questo proposito: «Le immagini cinematografiche, riprese dalla realtà, e dunque identiche alla realtà, nel momento in cui vengono impresse su pellicola e proiettate su uno schermo, perdono la profondità reale, e ne assumono una illusoria» È solo la fonte musicale «che non è individuabile sullo schermo, e nasce da un “altrove” fisico per sua natura “profondo”» a sfondare «le immagini piatte, o illusoriamente profonde, dello schermo, aprendole sulle profondità confuse e senza confini della vita». P.P. Pasolini, La musica del film, in A. Bertini, Teoria e tecnica del film in Pasolini, Bulzoni, Roma 1979, pp. 114-115.
Opera Francesco Ceraolo
407
mente insensata. Chi dice questo ignora la “ambiguità” della parola poetica: l’ineliminabile contrasto in essa tra “senso” e “suono”. [...] La musica distrugge il “suono” della parola e lo sostituisce con un altro. [...] Una volta sostituitasi al suono della parola, provvede poi essa a operarne la “dilatazione semantica”: e che po’ po’ di dilatazione semantica si ha nelle parole della Traviata! [...] Le parole non sono dunque affatto ancillari, nel melodramma: sono importantissime e essenziali85.
Lo stesso smarcamento dalla “musicalità” della musica sacra verso l’“oralità”, esplicita o semanticamente implicita di quella lirica, lo ritroviamo, sempre in funzione dialettica rispetto all’immagine, nel sottofinale di Uccellacci e uccellini, quando Totò e Ninetto, ospiti del “1° Convegno dei Dentisti Dantisti” assistono all’esecuzione camuffata della Siegfrieds Rheinfahrt dalla Götterdämmerung di Wagner. Il senso “orale” della Rheinfahrt di Sigfrido, rovesciato in modo grottesco, è quello del viaggio di Totò e Ninetto verso la Dämmerung wagneriana, il «crepuscolo» delle «grandi speranze» evocato dal corvo-intellettuale togliattiano nel monologo della scena precedente, sullo sfondo di un quartiere Eur che è scenografia icastica di un mondo in rovina. Gli intellettuali, dice il corvo: Sono i primi ad essere lasciati in ombra, magari in compagnia di Rossellini e di Brecht, mentre gli operai continuano in questo crepuscolo ad andare avanti. Sono passate di moda le ideologie! Ed ecco qui uno che continua a parlare, non si sa più di che cosa a degli uomini che vanno non si sa dove.
Non è dunque, e tanto, la dimensione melodica del sinfonismo wagneriano ad essere funzionale alla costruzione della sequenza (che non è portata a coerenza nell’immagine, come nel caso della musica di Bach in Accattone), ma il modo in cui esso interagisce dialetticamente, con il suo portato semantico (il viaggio di Sigfrido), con il vagabondare senza meta di Totò e Ninetto. Due anni dopo La ricotta, l’esordiente Marco Bellocchio utilizza la stessa aria da La Traviata per costruire dialetticamente la 85
P.P. Pasolini, Il cinema e la lingua orale, in Id., Empirismo eretico, cit., p. 1597.
408
Lessico del cinema italiano
sequenza finale di I pugni in tasca (1965), in cui il protagonista Alessandro è lasciato morire in preda ad una violenta crisi epilettica dalla sorella Giulia, mentre ascolta l’invocazione alla libertà di Violetta-Traviata. Ulteriori esempi “dialettici” li troviamo nei film successivi di Bellocchio: La Cina è vicina (1967) e, nei primi anni del nuovo decennio, Nel nome del padre (1972). Non si tratta di semplici citazioni di brani operistici, ma chiavi «per arrivare allo straniamento fantastico e alla commozione autentica»86. Se nel primo film l’effetto straniante – e sarcastico – è raggiunto attraverso il declamato del Don Carlo verdiano «Dormirò sol nel manto mio regal», cantato in bagno dal padre Vittorio, socialista alle prese con il figlio comunista, nel secondo, l’aria di Jago dall’Otello di Verdi, cantata in falsetto, diviene metafora ironica della “crudeltà” delle dinamiche del collegio cattolico a cui è sottoposto il giovane protagonista Angelo. Anche qui, come in Pasolini (e come sarà successivamente in un certo cinema di Fellini), l’aria operistica non è semplice colonna sonora dell’immagine che accompagna il visibile, ma sua contrapposizione dialettica: è una vera e propria risignificazione del brano operistico e del suo portato orale che poi, dialetticamente, viene messo a confronto con il visibile. All’interno di tale regime dialettico, il sonoro operistico rappresenta il portato tematico-formale (la “libertà” di La Traviata, ecc.) di qualcosa di non-visibile, di inesprimibile (da qui la centralità e unicità dell’oralità operistica, che la distanzia tanto dal sinfonismo o camerismo puro che dalla musica sacra), il quale, posto a confronto con il visibile, compone la totalità strutturale dell’immagine sonora. Nello spazio ibrido tra forma chiusa classica e forma modernista del melodramma si muove invece il cinema di Valerio Zurlini, in particolare quello di parte della sua produzione degli anni sessanta (La ragazza con la valigia, Cronaca familiare) e poi anche quella tarda del decennio successivo (La prima notte di quiete, Il deserto dei tartari). Un’autorialità, quella di Zurlini, per molti aspetti di difficile collocazione, non solo perché tesa ad innervare di psicologismi anche un certo racconto storico (secondo dei codici che verranno solo in parte ripresi dall’opera di un regista come Ettore Scola), ma perché capace di produrre uno stile unico e di grande 86
M. Pellanda, Marco Bellocchio tra cinema e teatro, Marsilio, Venezia 2012, p. 113.
Opera Francesco Ceraolo
409
eleganza, che lavora, nel contesto della forma melodrammatica, su di una vena intimista per molti versi atipica nel contesto italiano, per linearità lontana dalle complessità tematico-formali del cinema coevo del giovane Bertolucci. In questa produzione La ragazza con la valigia rappresenta un esempio emblematico di quel regime autocosciente della realtà nell’immagine che caratterizzerà i rapporti tra opera e cinema di parte dei decenni successivi, come si vedrà in seguito a proposito del lavoro dei fratelli Taviani e Marco Tullio Giordana. L’incontro tra Aida (Claudia Cardinale) e il giovane Lorenzo, fratello sedicenne di un ragazzo che precedentemente l’ha sedotta e poi abbandonata, culmina in una nota sequenza in cui, ospite di casa di Lorenzo, Aida scende le scale osservata dal ragazzo al suono dell’aria «Celeste Aida», dall’omonima opera di Verdi. La sequenza, oltre a rappresentare il momento chiave dell’intero film, tematizza in modo evidente cosa si intenda per costruzione di un regime di autocoscienza dell’immagine cinematografica attraverso una linea operistica: qui, infatti, non si può parlare di una funzione prettamente sonora dell’aria verdiana, ma di una sua riappropriazione e impiego semantico-musicale («Celeste Aida, forma divina», recita l’aria), finalizzato a compiere uno scarto narrativo nella trama filmica, un passaggio decisivo in quel processo di autocoscienza che il personaggio compie nell’intreccio del film (in questo caso, il rapporto tra i due protagonisti Lorenzo e Aida che si va finalmente costituendo). L’aria, in altre parole, è detonatrice dell’immagine visiva, assume con essa un rapporto di completa coerenza: non l’“accompagna” come fosse un qualsiasi altro elemento sonoro, ma ne fa esplodere i significati, esattamente come, con la stessa funzione semantica, essa operava nell’opera lirica di origine. Il regime musicale dell’immagine Se da un certo cinema di Pasolini, Bellocchio e Zurlini si evince la volontà di definire un rapporto con l’opera all’interno di un regime rispettivamente dialettico e autocosciente, il tentativo estremo – e personalissimo – di costruire un vero e proprio regime musicale dell’immagine cinematografica è portato avanti, a cavallo degli anni ’60-’70, dal cinema di Carmelo Bene. L’opera cinematogra-
410
Lessico del cinema italiano
fica di Bene – che trova il suo vertice nel primo lungometraggio Nostra signora dei Turchi (1968) e in Salomè (1972) – costituisce l’esperimento limite di superamento dei modi tradizionali di fare cinema (parallelamente a quelli di fare teatro87), attraverso una cifra sovversiva e personalissima, che se da un lato si pone esplicitamente come l’aldilà di qualsiasi forma o tema del canone moderno, dall’altro trova, quasi paradossalmente, nel melodramma di Verdi il suo modello fondativo88. Questo apparente paradosso si spiega nella maniera in cui la forma melodrammatica italiana e francese viene intesa, come fa Bene – sulla scorta dell’infatuazione nietzschiana per la Carmen di Bizet, una volta ripudiato Wagner e il dramma totale –, come massima sospensione del tragico moderno, ovvero come solo possibile scavalcamento di quel canone tragico che, nella modernità, ha trovato suo esito nella “rappresentazione”, prima teatrale e poi cinematografica. Se il tragico è legato intimamente al trascendente e alla sua rappresentazione – non esiste tragedia senza una forza che sovrasta l’uomo e lo annichilisce, che l’atto del rappresentare deve comunicare rendendolo attendibile, credibile, verosimile – il melodramma ottocentesco è espressione di un panteismo immanente. Esso rappresenta la prima forma post-tragica, in cui Dio non eccede l’uomo, ma lo abita89. 87 88
89
Si confronti in questo senso il testo di G. Deleuze su Bene: Id., Sovrapposizioni, a cura di J.P. Manganaro, Quodlibet, Macerata 2002 [ed. or. Superpositions, Les Éditions de Minuit, Paris 1979]. Come scrive Bene a questo proposito: «Il grande riferimento in Italia è il melodramma, non la letteratura, come accade in Francia. La tradizione italiana è musicale. [...] Il mondo mi parla come a un musicista, non come a un cineasta. [...] Nostra signora dei Turchi è un melodramma, non per la melodia che arriva alle orecchie, per la melodia che arriva agli occhi. [...] Verdi creava azioni per le orecchie, io creo musica per gli occhi». Cfr. C. Bene, Contro il cinema, Minimum Fax, Roma 2011, pp. 23-25-34. Su questo si faccia nuovamente riferimento all’importante lettura di Fubini in Figurazione tragica e drammatica nel melodramma, cit. In particolare, scrive Fubini: «Si può considerare il melodramma come una forma di secolarizzazione del senso cristiano della storia e della salvezza. [...] L’orizzonte della trascendenza è in ogni caso escluso [...]. Vi è indubbiamente un nesso tra l’aspetto essenzialmente figurativo in senso lato dell’esperienza artistica melodrammatica e il suo svolgersi in una dimensione storica dominata dall’immanenza. Se la salvezza ha una dimensione essenzialmente storica, se essa si realizza nel flusso storico degli eventi, tutto potrà essere esibito, reso nella figurazione, tutto troverà modo di manifestarsi su questo variegato palcoscenico in cui gli uomini
Opera Francesco Ceraolo
411
È la centralità della musica, intesa come medium dell’inesprimibile, a permettere il vero scarto del melodramma dal regime tragico; la sua rappresentazione è dunque superflua, poiché questa è già contenuta aus dem Geist der Musik90, come accade per esempio, nell’opera di Verdi91. Quello di Bene è dunque un tragitto nella forma melodrammatica parallelo, e non contrario, a quello viscontiano: Visconti inscriveva l’assoluto nella Storia e nella sua prassi (Senso), invece Bene lo fa nel mondo e nell’uomo che, drammaticamente, lo abita. Tendere verso l’immanenza dell’opera verdiana – in cui l’assoluto si dà panteisticamente nel movimento dell’uomo nella realtà –, istituire una forma “anti-cinematografica” irrappresentabile che parli dell’uomo all’uomo e che nasca dallo spirito della musica, vuole dunque essere la doppia cifra di Nostra signora dei Turchi e Salomè. La linearità del racconto cinematografico è sostituita dalla frammentarietà di quello operistico, fatto di aperture semantiche (monologhi e dialoghi come fossero arie, duetti ecc.), ricapitolazioni e anticipazioni di senso (la voce off del narratore come fosse un preludio o un interludio), in cui il testo filmico, come una partitura musicale, diviene pura sonorità. Il puramente visibile è dunque calpestato, sfaldato: ad esso è negato qualsiasi valore ontologico che non sia quello di una esclusiva sonorità. L’intero impianto melodrammatico di Nostra signora dei Turchi, primo film-manifesto, si compendia nel monologo della cosiddetta filosofia del «Vedere la Madonna» – i «cretini» che vedono e quelli che non vedono la Madonna dimenticano che la Madonna esiste, alla pari del resto, nella totalità del mondo – mentre Salomè propone una rivisitazione del testo di Wilde in cui Cristo-Bene, vampirizzandosi, diventa parodia dell’umano e del suo abitare drammaticamente – e goffamente – il mondo. Il melodramma
90 91
si scontrano, si riconciliano, si amano e si odiano, in cui a volte trionfa il bene, a volte il male. Vi è pertanto una teologia cristiana della storia, che trova una delle sue più efficaci secolarizzazioni proprio in questo complesso e variegato genere teatrale-musicale che è il melodramma», ivi, pp. 14-16. Riprendo dal sottotitolo nietzschiano di La nascita della tragedia «dallo spirito della musica». Si confrontino le prime battute dell’intervista video realizzata da Sandro Veronesi per Tele+ intitolata C.B. versus Cinema, Otranto 1995 (http:// youtu.be/aOMK_HqF5IM).
412
Lessico del cinema italiano
diviene la forma cinematografica più adatta a «farla finita con il giudizio di Dio»92; anche i suoi lati “comici”, surreali e parossistici, sono coerenti con la comicità e surrealtà che si nasconde dietro al dramma del vivere, da cui è escluso il trascendente e l’ordine logico del linguaggio. Come nei casi dialettici di Pasolini e Bellocchio, l’infinita serie di citazioni operistiche contenute nei film di Bene non rappresenta dunque un semplice contributo al portato sonoro di questo nuovo regime musicale dell’immagine. Esse sono il vero oggetto di un cinema in cui l’immagine è un semplice, e coerente, corollario visivo del suono. Santa Margherita appare al protagonista di Nostra signora dei Turchi, ripetendo come litania la frase «Ti perdono, ti perdono», al suono della romanza Musica proibita di Gastaldon; nel finale di Salomè, Cristo-Bene esclama «Non voglio vedere più nulla, non voglio che nulla mi guardi», e l’immagine diventa interamente bianca, mentre risuona il «Te Deum» di Tosca. Il visibile deflagra in una raffica di colori e traiettorie geometriche di corpi che sostengono, con il loro movimento, le fluttuazioni della melodia o di una frase (Nostra signora dei Turchi). Oppure esso depone definitivamente le sua possibilità di significazione, si esautora – non nel nero del non-visibile, ma nel bianco della luce che i colori, e i significanti, li contiene tutti (Salomè) – lasciando alla musica esprimere ciò che è già al di là del linguaggio e delle sue gabbie semantiche. Verdi è morto, Viva Verdi Se il cinema di Bene rappresenta l’esito estremo della forma melodrammatica uscita rifondata dal modernismo degli anni sessanta, l’esperienza cinematografica che, a partire dagli stessi anni, e dopo quella di Visconti, fa interamente i conti con il melodramma operistico nelle sue varianti “aperte” e “trasfiguranti” è quella di Bernardo Bertolucci. Il lavoro di Bertolucci sul melodramma, che nei suoi passaggi fondamentali copre un arco di quasi trent’anni, 92
Mi riferisco al testo di A. Artaud, Per farla finita col giudizio di Dio, a cura di M. Dotti, Nuovi Equilibri, Roma 2000 [ed. or. Pour en finir avec le jugement de Dieu, K éditeur, Paris 1948].
Opera Francesco Ceraolo
413
non rappresenta unicamente un attraversamento delle numerose istanze (di derivazione ottocentesca) che tale forma è stata capace di aprire nel contesto italiano, quanto, specularmente ma diversamente dal tragitto viscontiano, una vera e propria operazione di rifondazione del linguaggio cinematografico prima su di una forma aperta e verdiana (Novecento), e poi su una wagneriana e trasfigurante (che culmina con Il tè nel deserto). Come già per Visconti, momenti operistici sono presenti sin da subito nel cinema di Bertolucci. Prima della rivoluzione, suo secondo lungometraggio, culmina in una lunga sequenza ambientata nel Teatro Regio di Parma durante la prima del Macbeth di Verdi, in cui i due protagonisti amanti (Fabrizio e la zia Gina) si rincontrano dopo lungo tempo, e dopo che Fabrizio, abbandonata ogni aspirazione politica, ha ormai deciso di sposare la fidanzata borghese Clelia. Qui la “prima all’opera”, con i suoi sfarzi e le sue ostentazioni, è l’emblema dei rituali di un mondo borghese93, mentre nel successivo Strategia del ragno (1970) essa lavora in funzione della costruzione di quel regime autocosciente della realtà nell’immagine che si è già osservato in Zurlini. L’intera trama di Strategia del ragno è pensata attraverso scarti e progressioni di autocoscienza dell’immagine organizzati attorno a brani musicali (l’Attila, Il trovatore, Un ballo in maschera di Verdi, ma anche la seconda Kammersymphonie di Schönberg), che si risolvono semanticamente nel finale, quando il protagonista Athos Magnani scopre finalmente la verità sul padre, allo stesso tempo eroe e traditore, durante una prima del Rigoletto. L’opera dunque esercita una funzione di costruzione dell’immagine, diviene metafora stessa della messinscena cinematografica e delle sue capacità di dare conto di una verità attraverso il suo portato illusorio; è momento evenemenziale di appropriazione di senso dell’intera struttura narrativa del film (e proprio per questo dunque di “autocoscienza”). Se i successivi Il conformista (1970) e Ultimo tango a Parigi (1972) lavorano, sempre in chiave melodrammatica, rispettivamente sui 93
«Verdi, che rappresentava alla fine del XIX secolo lo spirito della rivoluzione, incarna bene oggi lo spirito della borghesia. La grande scena dell’Opera, con il Macbeth, si trova nel film proprio per mostrare un tempio della borghesia, insieme grandioso e beffardo», B. Bertolucci, La mia magnifica ossessione, Garzanti, Milano 2010, p. 41.
414
Lessico del cinema italiano
significati stessi di tale messinscena attraverso le possibilità illusorie del cinema inteso come metafora della Storia (il fascismo di Il conformista), o del mondo chiuso della coppia (l’appartamento di Ultimo tango a Parigi, che poi tornerà, con le stesse valenze metacinematografiche, in The Dreamers, 2003), i due atti di Novecento aprono in modo compiuto, per la prima volta dopo Senso, ad una riconsiderazione dei rapporti tra cinema e Storia visti da una angolazione esplicitamente aperta. L’annuncio della morte di Verdi (27 gennaio 1901) inizia il Novecento nella fattoria Berlinghieri94, lo stesso giorno in cui nascono Alfredo, primo discendente maschio dei ricchi proprietari terrieri, e Olmo, figlio dei contadini che lavorano nella fattoria. Le due vicende di Alfredo e Olmo attraversano, come le stagioni dell’anno, quelle dell’Italia giolittiana, poi dell’Italia fascista, concludendosi con la primavera della Liberazione e l’inizio dell’Italia democratica. I due sono fratelli, amici e nemici, uniti non dal sangue ma dalla condivisione di un mondo comune. Le loro avventure personali, gli amori come le lotte su fronti opposti, sono indistinguibili: perché la loro vita, in perenne movimento tra privato e pubblico, si esaurisce nel destino che equipara l’umanità intera, che è sempre parte di uno stesso progetto e abita il medesimo spazio. L’intero Novecento italiano è visto dunque attraverso un microcosmo chiuso, il “dentro” della fattoria, che interagisce dialetticamente con il “fuori” del mondo che inesorabilmente avanza. La prospettiva di Novecento è distante dalla visione deterministica del primo Visconti di Senso e Rocco e i suoi fratelli: nel movimento della Storia non è riposta infatti alcuna speranza di fuoriuscita da un orizzonte di conflitto (quello tra lavoratori e padroni), e solo l’immensa bandiera rossa che avvolge l’intera scena nel finale del secondo atto è in grado auspicabilmente di risolvere e annullare la lotta che si consuma tra “sfruttati” e “sfruttatori”, nella prospettiva – già disillusa nel ’76, anno di realizzazione del film – di un mondo migliore e più giusto. 94
L’omaggio a Verdi è esplicito nelle parole dello stesso regista: «Abbiamo girato Novecento a pochi chilometri dalla casa dove è nato e vissuto Giuseppe Verdi, quindi nel luogo in cui Verdi ha scritto la sua musica guardando la stessa campagna di Novecento, le stesse facce di contadini, le stesse luci», ivi, p. 89.
Opera Francesco Ceraolo
415
In altre parole, il determinismo positivistico (e verdiano) che portava il primo Visconti ad una fiducia incondizionata nel futuro (con cui si chiude Rocco e i suoi fratelli), qui è sostituito da un impianto dialettico (le dicotomie Alfredo/Olmo, il dentro e il fuori della fattoria-mondo), quasi interamente interno all’individuo, in cui si risolvono le contraddizioni di un universo ideologico costituitosi proprio a partire da quel conflitto. In quanto rappresentazione e metafora del presente, cioè di un conflitto ancora in atto (quello degli anni settanta), Bertolucci non crede nella Storia quale luogo di emancipazione ottenibile esclusivamente obbedendo alle sue leggi oggettive. È invece lo spazio aperto della soggettività, simbolicamente rappresentato dalla fattoria Berlinghieri, che si approccia al mondo proprio in quanto individualità (emotiva, psicologica ideologica), a rappresentare il vero epicentro per una possibile emancipazione dell’uomo. Esattamente come il microcosmo del convento di San Giusto nel Don Carlo di Verdi riassumeva le dinamiche di una contrapposizione tra bene e male, giusto e sbagliato, quello chiuso della fattoria di Novecento, che della sala teatrale e cinematografica è una grande metafora, apre ad un regime melodrammatico e al suo costituirsi non nell’ineluttabile procedere deterministico del reale (Senso, Rocco e i suoi fratelli), ma in uno dialettico, che più che appartenere alla Storia, è dunque interno all’individuo. Lo smarcamento dal determinismo di Senso in nome di una prospettiva dialettica, lirica e soggettivistica, rappresenta dunque la vera grande novità dell’operazione di Bertolucci, che sarà poi ripresa da Martone nel suo Noi credevamo. La caratteristica fondamentale della forma melodrammatica “aperta” di Novecento è quella di costruire un’individualità (l’universo privato della fattoria quale grande metafora dell’individuo), pensandola problematicamente nell’immagine, al di fuori di un legame vincolante con il mondo, con il dato. Questa è la funzione della contrapposizione tra lo spazio finito della fattoria e quello infinito della realtà: la possibilità di pensare e valutare assiologicamente il mondo, implica un lavoro intimo e psicologico di costruzione di una soggettività pensata quindi in rapporto con il reale, ma non in sua funzione. L’umanità, descritta da Novecento, è aperta al mondo e alla Storia, ma si pone rispetto ad essa in quanto agente potenziale di un cambiamento radicale; non è cioè schiava delle sue leggi oggettive. Se
416
Lessico del cinema italiano
la verità del mondo e del suo divenire è pensata, nell’immagine, sempre come prodotto di un rapporto tra un soggetto ed un oggetto, e mai come un’approssimazione al mondo stesso attraverso l’immagine, ecco che il vero limite del melodramma di Senso, ovvero il paradigma positivistico su cui era fondato, con Novecento è definitivamente superato. Bertolucci dopo Novecento Il ben noto tratto psicologistico e intimistico tipico dello stile cinematografico di Bertolucci va inteso unicamente all’interno di questa funzione: quella di definire un momento ideologico soggettivo, svincolato da un rapporto costitutivo col mondo, ma aperto ad esso, attraverso l’uso indiretto del o dei personaggi protagonisti. Se Novecento rappresenta il vertice di un lavoro sull’individuo inteso storicamente quale luogo aperto di una possibile emancipazione, il successivo La luna (1979) tematizza con ancor più nettezza la filiazione operistica di una tale prospettiva95. Una madre, cantante d’opera, alle prese con un figlio tossicodipendente, instaura con lui un rapporto incestuoso, per poi iniziare un viaggio lungo l’Italia alla riscoperta del loro passato. Quest’ultimo emerge in una notte a Caracalla quando, mentre lei è impegnata nelle prove di Un ballo in maschera di Verdi, un uomo, a cui il ragazzo aveva precedentemente parlato della morte di un suo coetaneo, svela di essere suo padre. La famiglia promette di ricomporsi mentre il primo piano della donna che canta sulla scena sembra mettere simbolicamente fine all’asfissia del rapporto chiuso ed incestuoso tra la madre e il figlio. L’opera dunque costituisce il leitmotiv di un percorso dell’individualità all’interno della propria dimensione claustrofobica (l’incesto già sfiorato in Prima della rivoluzione e che poi tornerà in The Dreamers) ma anche di una sua possibile fuoriuscita ed apertura al mondo; le due cose non sono in contraddizione, ma rappresentano il passaggio inevitabile che ogni processo di libera95
«La luna si riferisce esplicitamente all’opera lirica, al melodramma, e non è un caso se la protagonista è una cantante; il film è costruito su una serie di giochi di specchi, dove la vita e la rappresentazione della vita si confrontano con la scena dell’opera», ivi, p. 96.
Opera Francesco Ceraolo
417
zione deve compiere attraverso gli stadi che necessariamente portano da una condizione di chiusura ad una di apertura, in quanto nessuna liberazione si dà come immediatezza. La tragedia di un uomo ridicolo (1981) esaurisce l’attraversamento melodrammatico dei rapporti padri-madri-figli iniziato con La luna – la vicenda di un imprenditore alla ricerca del figlio rapito da terroristi contiene anche un ideale omaggio a Ossessione, quando il padre (Ugo Tognazzi) canticchia «Di Provenza il mare e il suol» come il padre-marito della Calamai –, laddove il melodramma-kolossal L’ultimo imperatore (1987)96, come Il gattopardo per Visconti, segna l’inizio di un processo scettico che giungerà alla forma trasfigurante di Il tè nel deserto e all’approdo buddista di Piccolo Buddha (1993). Ma il pessimismo di Bertolucci, in coerenza con il suo percorso, e contrariamente a quello di Visconti, non riguarda più il mondo, ma la soggettività. Lo scetticismo bertolucciano non si spalanca infatti a partire dalla sfiducia ideologica nella sinistra a cavallo del Sessantotto – che pure era emersa in Prima della rivoluzione e Ultimo tango a Parigi –, o a seguito della paralisi politico-culturale a cui era approdato il compromesso storico – che egualmente aveva fornito l’ispirazione a Novecento –, quanto a partire dalla crisi culturale degli anni ottanta. È, in altre parole, la crisi dell’individuo nella nuova società consumistica e televisiva di quegli anni a portare Bertolucci verso una prospettiva in cui la soggettività, lungi dal risolversi, seppur problematicamente, in relazione al mondo, da esso rifugge in una morte reale o trasfigurata. Ancora il movimento del Tristano wagneriano fornisce la base su cui lavora un film come Il tè nel deserto, come già aveva fatto in parte Ultimo tango a Parigi, pur con le sue valenze ampiamente politiche qui invece assenti. Tratto da un romanzo di Paul Bowles, il film racconta di una coppia americana che compie un lungo viaggio in Africa sperando di rinsaldare il loro legame. In realtà si tratta di un lungo percorso verso l’annientamento, in cui il legame paradossalmente si ritrova nel reciproco annichilirsi di fronte al mondo, la cui unica fonte di accoglienza è rappresentata dal cielo blu “protettore” del deserto («Qui il cielo è quasi solido, come se ci proteggesse da quello che c’è oltre... Oltre non c’è niente», è una 96
Primo film della cosiddetta “trilogia americana” di Bertolucci, che comprende anche i successivi Il tè nel deserto e Piccolo Buddha.
418
Lessico del cinema italiano
delle battute chiave del film). Lui, assistito da lei, morirà a seguito di un’epidemia; mentre lei, ormai perduta, si unirà ad un gruppo di nomadi, guidati da un giovane di cui diverrà amante, per poi fuggire e tornare nel luogo da cui il viaggio era iniziato. Il movimento circolare del film, sottolineato dalla melodia altrettanto circolare di Ryuichi Sakamoto che risolve la sua cadenza solo nel finale (come nel Liebestod di Tristano), segue operisticamente un andamento in tre atti distinti: l’arrivo-il viaggio, la morte di lui, la morte simbolica di lei. L’incapacità di vivere nel mondo diventa idealità assoluta, ascesi mistica dell’uomo. Precisamente come l’ultimo Wagner di Religione e arte proiettava qualsiasi forma di possibile redenzione umana nell’alienazione buddista della soggettività97, il percorso trasfigurante di Bertolucci non può che protrarsi, nel film successivo, con una tensione verso la religiosità: non quella cristiana, materica e umana, ma, ancora una volta, un buddismo ascetico (Piccolo Buddha). Nuove immagini operistiche negli anni della crisi Mentre con il cinema Bertolucci si allontana volontariamente dall’Italia approdando ad una forma di religiosità trasfigurante buddista, gli anni ’80-’90 vedono risposte eterogenee alla crisi culturale e alle politiche del riflusso che caratterizzano l’epoca dell’intensa mass-mediatizzazione, e conseguente commercializzazione dei regimi produttivi, a cui è soggetta l’intera società italiana. È infatti all’interno di questo contesto che deve intendersi, per esempio, un certo recupero del film d’opera, delle cosiddette “opere parallele”, o di soggetti a tema operistico, che se nei primi anni del secolo avevano trovato giustificazione in una determinata volontà di emancipare il mezzo cinematografico dalla sua natura illusionistica, qui diventano una forma di reazione alla reificazione del prodotto artistico largamente dominante. La prima alla Scala è infatti sì assunta come evento principe della “Milano da bere”, che in quegli anni è il grande specchio del 97
R. Wagner, Religione e arte, a cura di E. De Angelis, M. Simonetti, Il Melangolo, Genova 1987 [ed. or. Religion und Kunst, Sämtliche Schriften und Dichtungen, Volume X, 1880].
Opera Francesco Ceraolo
419
paese (si pensi alle sequenze iniziali del documentario di Ermanno Olmi Milano ’83), ma è già simbolo di un capitalismo senza freni e in disfacimento, non più sorretto da quei valori borghesi che, se avevano tenuto al terremoto culturale del boom degli anni sessanta, niente avevano potuto contro la contestazione del decennio successivo98. Nel tentativo dunque di riaffermare il carattere “alto” del cinema, salvarlo dalla massificazione dominante, l’opera torna in voga in quanto modello di riferimento di un’arte colta e per un largo pubblico, allo stesso tempo esaltazione di un modello-Italia (soprattutto milanese) che, seppur in modo effimero, in quegli anni sembra trionfare. Troviamo dunque i più o meno riusciti esperimenti dei viscontiani Francesco Rosi (Carmen, 1984) e Franco Zeffirelli (Pagliacci, 1982, Cavalleria rusticana, 1982, La Traviata, 1982, Otello, 1986), La Bohème (1988) di Luigi Comencini, l’horror di ambientazione operistica di Dario Argento (Opera, 1987), il canzonatorio uso dell’aria verdiana nei lazzi dei tre atti di Amici miei (Monicelli-Loy, 1975-1985), fino alle biografie Il giovane Toscanini (Zeffirelli, 1988) e Rossini! Rossini! (Monicelli, 1991). Ma il regista che in questi anni fa i conti in modo diretto e originale con la forma operistica è certamente Federico Fellini con E la nave va (1983). Già sperimentatore di un regime musicale dell’immagine sonora (si pensi alla sovraesposizione visiva della musica di Nino Rota, ma anche della Cavalcata delle Valchirie di Wagner, in un film come 8 ½) con E la nave va Fellini prende direttamente in esame i legami tra i due linguaggi, costruendo un vero e proprio dispositivo intermediale in cui opera e cinema sono accomunati, con i loro rispettivi parossismi sonori e visivi, in un medesimo orizzonte di senso. La traversata di un gruppo di cantanti lirici su una nave diretta verso l’Egeo per spargere le ceneri di una grande cantante morta, diventa un lungo viaggio verso l’origine del cinema, in particolare nel suo portato onirico-finzionale. Dalle prime sequenze girate parodiando il film muto, alle scene finali in cui il piroscafo viene affondato, la nave di Fellini sembra trasportare l’intero repertorio del (suo) cinema passato, fatto di figure dilatate, esasperazioni semantiche che proprio nell’opera trovano il loro modello. Dal momento in cui l’essenza del cinema e dell’ope98
Si confrontino in questo senso le acute osservazioni di M. Perniola nel suo pamphlet Berlusconi o il ’68 realizzato, Mimesis, Milano 2011.
420
Lessico del cinema italiano
ra è però solo finzione, questa non può che soccombere di fronte alla realtà e alle tragedie che la sovrastano. A Sarajevo, il granduca Ferdinando è infatti ucciso e la Prima guerra mondiale ha inizio; il comandante della nave si trova costretto a dover soccorrere dei naufraghi serbi, fino a quando una corazzata austriaca non la incrocia e la affonda. Il sogno si infrange, il definitivo e personale percorso felliniano attraverso l’opera verso l’origine del (suo) cinema è compiuto, dialetticamente, senza possibilità di ritorno, anche se l’immagine finale di un rinoceronte che mangia l’erba su di una scialuppa sembrerebbe volerlo far proseguire. Sempre a cavallo di quegli anni, mentre il percorso della forma chiusa procede senza significative esperienze – soprattutto ri-mediatizzata dai nascenti codici della televisione seriale99 –, laddove un personalissimo lavoro sul melodramma attraversa il cinema di un grande regista come Sergio Leone (C’era una volta in America, 1984), esempi di utilizzi dell’opera nell’immagine in funzione autocosciente sono presenti nel cinema dei fratelli Taviani e dell’esordiente Marco Tullio Giordana. Mentre quest’ultimo si limita a sigillare il sacrificio cosciente del protagonista nel finale del suo primo lungometraggio Maledetti vi amerò (1980) con l’amaro arioso di Rigoletto «Quel vecchio maledivami», l’opera gioca un ruolo drammaturgico essenziale nel cinema dei fratelli Taviani e soprattutto in Allonsanfàn (1974) e in La notte di San Lorenzo (1982). Film interamente strutturato su cadenze e stilemi operistici (dal suono dell’orchestra durante i titoli di testa allo scoprirsi dell’immagine aperta come da un sipario sulla scena, fino a vere e proprie sequenze musicali che scandiscono il movimento del film100), Allonsanfàn è portatore di un pessimismo rispetto alle sorti progressive della Storia, incarnato dall’aristocratico ed ex-giacobino Fulvio Imbriani, che segue, benché riluttante, un gruppo di rivoluzionari impegnati in una rovinosa spedizione nell’Italia meridionale durante l’epoca della Restaurazione. Il film compie un percorso personale nella storia europea del primo Ottocento, usata come 99
Si considerino le aperture melodrammatiche in un certo cinema drammatico-intimista, da Francesca Archibugi (Mignon è partita e Il grande cocomero) a Giacomo Campiotti (Come due coccodrilli) fino, e in modo diverso, al Gianni Amelio di Così ridevano. 100 Si pensi solamente alla tarantella che cadenza la marcia-ballo dei giovani rivoluzionari nel finale.
Opera Francesco Ceraolo
421
metafora degli anni settanta – la lotta tra i “veri” rivoluzionari e quelli che invece si arrendono disillusi alla realtà –, e attraverso i numerosi ed espliciti riferimenti operistici compie un ibrido tra un’estetica rosselliniana del potere ed un’epopea costruita attraverso momenti di pura musicalità modernista (fondamentale in questo senso il contributo di Ennio Morricone). Le aperture della forma di Allonsanfàn – esattamente come già i significativi attraversamenti di melodie operistiche, da Rossini a Verdi e Puccini, nelle colonne sonore di San Michele aveva un gallo (1972) e dei più recenti Tu ridi (1998) e Maraviglioso Boccaccio (2015) – trovano infine in La notte di San Lorenzo il loro esito definitivo, portando a compimento l’intero percorso del regime autocosciente dell’immagine operistica inaugurato da Zurlini, principalmente grazie all’uso ripetuto e straordinariamente pregnante della teatrale Messa da Requiem di Verdi, attorno alla quale gran parte del film è costruito101. Le immagini sonore della Messa commentano l’epilogo dell’ecatombe nella chiesa di San Miniato bombardata dai tedeschi; attraverso di esse un dolore collettivo diventa un dolore cosmico, viene innalzato al livello più alto di universalità, sulla falsariga di quel processo di autocoscienza del reale che la Matthäuspassion di Bach già attivava in Accattone. Con la stessa intensità della Messa verdiana, sempre quale strumento per un divenire autocosciente della realtà nell’immagine attraverso la forma musicale, l’aria dal Tannhäuser di Wagner «O du mein holder Abendstern» («O tu, mia dolce stella del vespro») – già utilizzata da Visconti nella scena della grotta di Venere del castello di Linderhof in Ludwig – guida invece la drammatica presa di coscienza di un soldato tedesco che accompagna un mezzo stipato di cadaveri accatastati dopo il bombardamento. Ed è qui che l’inno all’amore di Wolfram «si trasforma [...] in un accorato pianto sulla sventura di un popolo»102. L’oralità operistica, ancora una volta, definisce il portato inesprimibile del reale, l’idealità assoluta, che, accostata al visibile, dà senso all’immagine visiva e consegna verità alla realtà stessa. Non è lo spazio di interazione tra regime 101
Che agisce «sulla scena come un perno, come un elemento fondamentale di sceneggiatura», scrive Pier Marco De Santi. Cfr. Id., I film di Paolo e Vittorio Taviani, Gremese, Roma 1998, pp. 115-123. 102 Ibidem.
422
Lessico del cinema italiano
visivo (il bombardamento e le sue conseguenze) e sonoro (Verdi, Wagner, come già Bach in Pasolini) a definire la complessità dell’immagine in questo processo di autocoscienza, ma il modo in cui, proprio attraverso questi due regimi, aderendo alla realtà l’immagine la innalza, dando forma ad una soggettività in divenire, che è il prodotto stesso di quella rappresentazione. L’immagine è in tal modo capace di trasformare il reale, dal suo darsi puramente in quanto essere al suo elevarsi, nell’immagine stessa, in quanto soggetto (la barbarie del bombardamento nazista che si universalizza come tale solo grazie all’impianto musicale dell’immagine che la coglie). Emanciparsi dal suo valore puramente testimoniale di un dato espressivo è quanto l’opera consente – con il suo fondamentale contributo – all’immagine di fare. Il melodramma del futuro, ovvero il melodramma futurista Gli anni duemila proseguono in buona parte sulla traccia dei due decenni precedenti. Al progressivo estinguersi di film con soggetti operistici e “opere parallele” di matrice galloniana – che ritornano nell’oblio103 dopo l’exploit degli anni ottanta –, si accompagnano da un lato tipi diversi di sopravvivenza della forma chiusa (film come Il compleanno di Marco Filiberti del 2009, che rilegge in chiave gay la vicenda del Tristano di Wagner, o anche pellicole di grande successo commerciale, come nel caso di un certo cinema di Ferzan Ozpetek), e dall’altro ulteriori esempi di struttura melodrammatica aperta, nel tentativo diretto di dare nuovamente corpo ad un epos storico (si pensi ancora al Giordana di La meglio gioventù, 2003, o a pellicole come Il resto di niente, 2004, di Antonietta De Lillo). Brani operistici rimangono una parte integrante delle colonne sonore – ad esempio l’uso ripetuto della sinfonia di La forza del destino in Viva la libertà (2013) di Roberto Andò – e più in generale l’opera mantiene il suo ruolo fondamentale di modello a cui il cinema continua a ispirarsi per costruire nuove strutture di senso che, affondando le radici sul terreno dei decenni precedenti, 103 Di “rilevante” si ricordano solo Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti, 2008, e ancora Franco Zeffirelli con Callas forever, 2002.
Opera Francesco Ceraolo
423
aprono ad originali possibilità del mezzo cinematografico stesso. Le figure che si stagliano in modo più significativo, in questi anni che arrivano fino al presente, sono nuovamente quella di Marco Bellocchio e quella di Mario Martone. Il primo, dopo essersi simbolicamente affrancato dalla sua terra d’origine con un personale Addio del passato104 (mediometraggio-documentario del 2002 e struggente omaggio all’Emilia e a Verdi che ritorna, questa volta in chiave nostalgica, su La Traviata, che aveva cadenzato il finale tragico del protagonista di I pugni in tasca), con Vincere (2009) realizza un «melodramma futurista»105, un vero e proprio melodramma “ri-mediatizzato” secondo codici estetici marinettiani che, alla pari di E la nave va di Fellini, rappresenta un viaggio verso l’origine del (suo) cinema e della sua straordinaria potenza illusoria. La vicenda tormentata di Ida Dalser, amante non corrisposta di Benito Mussolini, che la conduce prima alla pazzia e poi alla morte, si intreccia dialetticamente con quelle reali del duce, in cui il regime storico e immaginario dell’Italia fascista – spesso rievocato attraverso la ri-mediatizzazione di materiali d’archivio, o di immagini icastiche mussoliniane, con brani d’opera106 – si fondono all’interno di un unico dispositivo melodrammatico di chiara impostazione verdiana, che muove le detonazioni interiori dei personaggi come quelle del mondo in cui essi vivono. Il potere illusorio dell’immagine cinematografica, che ha la capacità di rinegoziare integralmente tanto il portato immaginario della Storia e dei suoi valori (come già nel precedente Buongiorno, notte, 2003), quanto quello psicologico della soggettività, esatta104 Ed anche se in modo differente con Sorelle Mai (2010) – in cui il personaggio pucciniano Gianni Schicchi nel finale intona un addio al mondo sulle note di Vecchio Frack di Modugno – e con il Rigoletto televisivo sempre del 2010. 105 Secondo la definizione dello stesso Bellocchio: «Vincere è un melodramma futurista. Il film affonda le radici nella struttura dell’opera lirica, su cui mi sono culturalmente formato. Ho però cercato di girare questo melodramma con la velocità, lo stile, del futurismo», A. Crespi, Bellocchio: “Ci sono analogie tra il duce e Berlusconi…”, in “l’Unità”, 20 maggio 2009, p. 41. 106 Si pensi al «Te Deum» di Tosca che accompagna le immagini del cinegiornale che annuncia la notizia della firma del Concordato, oppure al coro «Guerra, guerra!» dalla Norma che suona mentre il giovane Mussolini si affaccia alla finestra (quasi preannunciando le adunate oceaniche di Piazza Venezia).
424
Lessico del cinema italiano
mente come nell’opera romantica “aperta”, costruisce un ponte tra queste due dimensioni, rendendole drammaticamente indistinguibili. La pazzia di Ida, come quella di Lucia di Lammermoor nell’omonima opera di Donizetti, riflette quella di un’individualità eroica che, se prima non può assurgere al ruolo che il suo percorso di vita, in modo violento, le ha assegnato (quello di essere la moglie di Mussolini), poi alle leggi del mondo si ribella, fino a porvisi in totale contrapposizione. Come nella precedente rilettura dell’affaire Moro di Buongiorno, notte, e ancora nel caso della contessa Livia Serpieri in Senso, è soprattutto femminile il luogo in cui si apre una possibile opposizione alle leggi del mondo e al suo movimento deterministico. Ma questa opposizione è sempre annichilente (si pensi ai grandi personaggi operistici, da Tosca ad Aida, Lucia, Donna Anna), secondo quel tratto tipico del melodramma ottocentesco e mozartiano che, usando le parole di un famoso testo di Catherine Clement, si identifica con una costante «disfatta delle donne»107. Il potere che condanna Ida al suo percorso di morte è dunque quello della Storia, da cui la soggettività non può in alcun modo fuoriuscire se non, ancora, attraverso il proprio annullamento. Ma è l’interezza delle questioni tradizionali del melodramma verdiano ad essere rielaborata in Vincere, come lo era già in Senso, verso un nuovo orizzonte di possibilità, che è aperto al melodramma, non già come una forza del passato, ma come ancora uno spazio per il “cinema del futuro”: il determinismo alla base dei rapporti uomo-mondo, che rende la soggettività incapace di appropriarsi di uno spazio su cui esercitare liberamente il proprio progetto di vita; il divino che, al contrario che nella tragedia, non corrisponde a Dio (o a gli dèi) ma è iscritto positivisticamente nel mondo e nelle sue leggi, che incombono sull’uomo senza possibilità di scampo; il procedere della narrazione secondo aperture di senso all’interno di forme chiuse e autosufficienti, in cui non esiste altra forza se non quella dirompente ed esplodente della realtà stessa, che a quella potenza schiacciante del positivo si oppone. Ecco ciò che rende la cifra stilistica del melodramma di Verdi, in modo diretto o transitivo, sempre e comunque drammaticamente attuale: la sua 107 C. Clement, L’opera lirica o la disfatta delle donne, Marsilio, Venezia 1979 [ed. or. L’Opéra ou la Défaite des femmes, Grasset, Paris 1979].
Opera Francesco Ceraolo
425
capacità di dare conto, tragicamente, di uno scontro irrimediabile, in cui l’uomo, scalzando Dio, innalza le proprie oggettivazioni, i propri impianti e le proprie leggi, a verità assolute di fronte alle quali egli è impotente. Un processo, tanto attuale, in cui l’uomo deve adeguare se stesso in funzione del mondo e non viceversa. Noi cantavamo Ma se Vincere di Bellocchio rimane l’esito ultimo della forma aperta del melodramma di Verdi, riletta attraverso la lezione viscontiana, Noi credevamo di Martone, film da cui questo percorso è cominciato e che ora lo conclude, facendo propria la lezione di Novecento, definisce invece un percorso dialettico in cui il melodramma non rappresenta lo schiacciamento della soggettività di fronte al determinismo del divenire oggettivo, all’interno di un lungo percorso verso la morte, ma la sua apertura ad una vera e propria “ontologia della speranza”. Questo è possibile nella maniera in cui il reale non è visto quale regime autonomo a cui l’uomo deve adeguarsi obbedendo alle sue leggi, ma in quanto l’esito del suo operare – il prodotto degli uomini e dunque dagli uomini costantemente rinegoziabile – all’interno di una dialettica in cui la soggettività definisce l’oggettività e non è da quest’ultima limitata nel suo agire. Se dunque quella di Vincere è una individualità storica il cui (melo)dramma è ancora il prodotto del suo rapporto con delle leggi oggettive, Noi credevamo apre, con una potenza sconosciuta, ad un orizzonte di speranza che scarta dalla forma melodrammatica tradizionale ma che, allo stesso tempo, solo il regime melodrammatico è in grado di consegnare in tutta la sua forza108. 108 A questo proposito risultano chiarificatrici le parole dello stesso Martone sull’importanza del rapporto tra opera e cinema all’interno del suo percorso artistico: «È successo nel mio caso che sia stato il regista d’opera a orientare quello di cinema e non viceversa [...]. Mentre scrivevo (Noi credevamo) [...] ho messo in scena diverse opere di Verdi e Rossini. L’opera mi ha dunque nutrito. [...] Il rapporto con l’opera del film non si limita però alla colonna sonora: i dialoghi, scritti e recitati in senso antinaturalistico, diventano una sorta di libretto e l’insieme della messa in scena dialoga con l’estetica ottocentesca del melodramma». Cfr. M. Martone, Autoscatti, in
426
Lessico del cinema italiano
In questa direzione certamente fondativa risulta essere l’influenza rosselliniana sul film di Martone109, per certi aspetti già evidente nel suo primo lungometraggio Morte di un matematico napoletano (1992), che dietro al suo esplicito lirismo romantico (il Notturno op. 15 n. 2 di Chopin utilizzato come leitmotiv emotivo dell’intero film) già denunciava una matrice melodrammatica che poi esploderà solo con Noi credevamo110. Ma è l’intero impianto del film, che su questo terreno lirico muove le sue mosse portanti, ad aprire a quella che si può definire una vera e propria “etica della credenza nel mondo” attraverso il melodramma. Poiché se il melodrammatico, nella sua variante “aperta”, è il tragico “senza Dio”, come già voleva Bene, ovvero il tragico iscritto nel regime interamente immanente della vita umana, quella vita si definisce all’interno di un orizzonte comune e temporale che noi chiamiamo Storia. Un movimento finalmente libero, privo di condizionamenti oggettivi, che l’uomo è sempre capace di orientare dialetticamente attraverso la sua opera e il suo credere. Ed è forse nel film di Martone – esito ultimo della forma melodrammatica italiana – che l’opera stessa ritrova compiutamente la sua radice idealistica, l’autentico superamento dell’astrazione lirica di Rossini a cui invitava Mazzini, che aveva dato origine al lavoro del primissimo Verdi di Attila, come si è visto nei paragrafi iniziali. Credere nella possibilità di consegnare una forma al mondo, scrive Fichte in La dottrina della scienza111, non significa fare leva su di una certezza epistemologica – ovvero su di una appropriazione dell’effettività di un dato oggettivo da parte del soggetto – ma è più semplicemente Mario Martone. La scena e lo schermo, a cura di R. De Gaetano, B. Roberti, Donzelli, Roma 2013, pp. XXVI-XXVII. 109 A partire dal tema della credenza nel mondo sviluppato in Viaggio in Italia. Cfr. R. De Gaetano, “Viaggio in Italia”. La credenza oltre l’illusione, in “Fata Morgana”, n. 19 (2013), pp. 205-211. 110 Lo stesso lirismo, questa volta sia implicito che esplicito – privo cioè della maschera e del sottotesto melodrammatico, e anzi coerente con l’eternità e l’astrazione lirica della vita e dell’opera del suo poeta/protagonista –, che tornerà prepotentemente in Il giovane favoloso (2014), sottolineato, oltre che dalla musica di Rossini, dagli anacronismi sonori di Sascha Ring e Doug Van Nort. 111 Cfr. J.G. Fichte, Prima e Seconda Introduzione alla dottrina della scienza, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1999 [ed. or. Gesamtausgabe, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1962].
Opera Francesco Ceraolo
427
una scelta di vita. Credere significa compiere uno scarto esistenziale, diventare consapevoli della propria autonomia, della propria indipendenza da tutto ciò che, fuori di noi, ci vorrebbe mettere imprescindibilmente di fronte a un dato. La forza della credenza dà forma ad un melodramma cinematografico che dunque, forse per la prima volta, si libera interamente dalla sua doppiezza fondativa: quella che vede l’uomo schiavo dell’oggettività, o da essa affrancato in una libertà che si limita a negare il mondo, in cui l’io sostituisce interamente il noi. Credere, aprire ad un futuro intenzionale in un mondo che è riconosciuto ma di cui non si è schiavi, è invece la grande forza eroica del melodramma romantico di Martone. Perché «il punto non è che tutto è finito, il problema è che tutto è da cominciare»112. Verso un mondo che è fatto a nostra forma e immagine; un mondo che siamo noi. Quel noi a cui l’opera e il cinema, da Verdi a Martone, in modi tanto diversi quanto straordinari, hanno saputo dare corpo. Noi, dice Domenico Lopresti in Noi credevamo, è una «dolce parola». Perché noi, italiani, cantavamo. Filmografia di riferimento Carmen (Lo Savio, 1909), Assunta Spina (Bertini, Serena, 1915), La corona di ferro (Blasetti, 1941), Sotto il sole di Roma (Castellani, 1948), Cielo sulla palude (Genina, 1949), Catene (Matarazzo, 1949), Non c’è pace tra gli ulivi (De Santis, 1950), Traviata ’53 (Cottafavi, 1953), Senso (Visconti, 1954), Il grido (Antonioni, 1957), Rocco e i suoi fratelli (Visconti, 1960), La ragazza con la valigia (Zurlini, 1961), Carmen di Trastevere (Gallone, 1962), La ricotta (Pasolini, 1963), I pugni in tasca (Bellocchio, 1965), Nostra signora dei Turchi (Bene, 1968), Ludwig (Visconti, 1972), Allonsanfàn (Taviani, 1974), Novecento (Bertolucci, 1976), La luna (Bertolucci, 1979), La notte di San Lorenzo (Taviani, 1982), E la nave va (Fellini, 1983), Il tè nel deserto (Bertolucci, 1990), Vincere (Bellocchio, 2009), Noi credevamo (Martone, 2010).
112
M. Martone, Noi credevamo, Bompiani, Milano 2010, p. LV.
G
C
POTERE
C’è chi li ha definiti «un’accozzaglia di zombie»1. Infelici, disperati, disorientati, i parlamentari e i senatori italiani rappresentati da Marco Bellocchio in Bella addormentata (2012) vagolano sullo schermo fra l’etere e il nulla, ora abulici ora isterici, si fanno somministrare farmaci contro la depressione e si conformano agli ordini che vengono loro impartiti da chi – di fatto – li ha “nominati” nel loro ruolo. Lo psichiatra che li cura li descrive con icastica precisione: «Si devono nascondere, ma dove? Non hanno un collegio, non hanno un rifugio. Sembrano dei ricercati, o vagano per il centro». Così privi di un luogo, così drasticamente delocalizzati, così deprivati di carisma e funzione, solo in una sequenza ritrovano un senso e una ragione: quella in cui si mettono in posa per la foto istituzionale, facendosi fotografare davanti a uno schermo su cui scorrono immagini di manifestazioni del loro partito (Forza Italia) e del loro leader (Silvio Berlusconi). Solo sovrapponendosi a quelle immagini essi sentono in qualche modo di inverarsi, di uscire dall’indeterminatezza, dalla mancanza di ruolo e di identità. Ma nello stesso tempo, così facendo, trasformano i loro corpi in schermo, e fanno di sé il luogo in cui le immagini si manifestano e si concretizzano. Vero esempio grottesco di transustanziazione mediatica, quella sequenza – una delle più pregnanti di tutto il cinema di Bellocchio – ci dice come i corpi “veri” non siano che il supporto su cui far vivere le immagini. Non sono più – come nel Novecento – il profilmico che lascia traccia e impronta di sé nell’immagine filmica, ma – molto più radicalmente – il supporto senza cui le immagini non sarebbero visibili. Detto altrimenti: i corpi non generano le immagini, le accolgono; non le ingravidano di sé, si fanno ingravidare dalla loro sostanza fantasmatica. In 1
I. Moliterni, La notte più lunga, in “Duellanti”, n. 78 (2012), p. 16.
430
Lessico del cinema italiano
questa prospettiva, Bella addormentata si offre come una delle più lucide e lungimiranti riflessioni sul potere prodotte dalla cultura italiana all’inizio del nuovo millennio: non tanto per le scene pur sociologicamente rilevanti in cui i Senatori della Repubblica appaiono mollemente intenti a rilassarsi in una sauna, mentre il loro strizzacervelli dipinge con icastiche parole la loro condizione di pedine di un gioco che li sovrasta, quanto piuttosto proprio per la chiarezza con cui ci dice come il potere ormai risieda nell’ibrido generato dal connubio fra corpi e immagini, e come proprio lì, e solo lì, si materializzi la possibilità di incontrare e di vedere ciò che il potere è diventato, e di riconoscere le maschere con cui si nasconde, e di capire il gioco con cui colonizza i corpi per far vivere se stesso nelle immagini che lo costituiscono e, al tempo stesso, lo inverano. Solo in pochi casi – prima di questo film – il cinema italiano era andato così in profondità nell’anamnesi e forse anche nell’archeologia del potere. Anche perché, per quasi un secolo, il cinema italiano ha fatto molta fatica a trovare una forma condivisa e convincente (anche per se stesso) attraverso cui rappresentare il potere. Spesso, più che rappresentarlo, lo ha evocato in absentia. O ha confessato la sua sostanziale difficoltà nel dargli un volto riconoscibile e una forma definita2. 1. Fantasmi del potere Sembra quasi un paradosso, ma più che con il potere il cinema italiano sembra aver avuto a che fare con la natura fantasmatica del potere. O con la sua inafferrabilità. Con la sua invisibilità. La cultura che ha prodotto alcune delle più importanti teorie e riflessioni sul potere – da Niccolò Machiavelli a Giambattista Vico fino a Norberto Bobbio – è anche quella che più si è trovata a disagio nel momento in cui la società mediatica ha posto il problema della rappresentazione del potere. Lì il cinema ha deragliato. Si è profuso in smorfie e – come dicevamo – ha inseguito fantasmi. 2
Di un cinema italiano alle prese con «un potere che si presenta privo di identità, privo di volto» parla anche Dario E. Viganò nel suo La maschera del potere. Carisma e leadership nel cinema, Edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo, Roma 2012, p. 17.
Potere Gianni Canova
431
Fra le teorie classiche del potere (quella sostanzialistica di Hobbes, secondo cui il potere è qualcosa che si ha e che si usa come qualsiasi altro bene per conseguire un determinato scopo, quella soggettivistica di Locke per cui il potere è la capacità di un soggetto di ottenere determinati risultati, e quella relazionale di tanti studiosi contemporanei, secondo cui il potere è una relazione fra due soggetti in cui uno dei due ottiene dall’altro comportamenti che in assenza di potere non avrebbe ottenuto)3, il cinema italiano ha praticato forse con maggior frequenza la teoria più arcaica, quella sostanzialistica (il potere o lo si ha o non lo si ha), ma mescolandola e ibridandola in maniera molto libera con le altre due. Intendo dire che non c’è una “teoria del potere” tipica del cinema italiano, e non c’è neppure un’immagine dominante e ricorrente del potere. Quel che c’è, e che torna in un numero impressionante di film, è piuttosto un atteggiamento, o un punto di vista, che si approccia al potere sempre e solo con reticenza e diffidenza, se non addirittura con una deliberata volontà di denuncia e con uno stato d’animo di intensa indignazione. È bene precisare da subito che per “potere” – in questo saggio – si intende soprattutto il potere politico. Potere economico, ideologico, religioso, giudiziario e militare sono analizzati e chiamati in causa – se e dove necessario – per illuminare taluni aspetti del potere politico che spesso non può prescindere da un rapporto molto stretto con queste altre forme di potere. Inoltre, pur tenendo conto delle teorie che propongono un’analisi più articolata del tema – a cominciare dalla foucaultiana «microfisica del potere» – il saggio prende atto di come il cinema italiano abbia poco frequentato – per dirla metaforicamente – “la prospettiva della rana” (cioè il punto di vista dal basso) e abbia prediletto invece la “prospettiva a volo d’uccello”, ovvero l’ambizione di fornire un punto di vista sinottico (e dall’alto) sulla questione della sovranità. In questa prospettiva, pur non trascurando le acquisizioni foucaultiane (a cominciare dall’idea che il potere non è posseduto da un individuo o da un altro, ma è implicito nei soggetti e nella
3
N. Bobbio, Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Einaudi, Torino 1985.
432
Lessico del cinema italiano
loro forma mentis, ed è al contempo esercitato e subìto)4, il lavoro che segue prende le mosse dalla constatazione di come il cinema italiano sia dominato (e talora perfino ossessivamente “posseduto”) da un’idea sostanzialmente negativa del potere. Rispetto alla classica tripartizione di Aristotele, che nella Politica distingue fra un potere paterno (padre/figlio) che si fonda su un dato naturale e quindi non modificabile, un potere dispotico (padrone/schiavo) che deriva da un delitto o da una colpa commessa e un potere civile (governante/governato) che si fonda su un patto o su un contratto sociale, il cinema italiano sembra aver privilegiato, per lo più, una percezione dispotica del potere, o un’idea del potere – appunto – come colpa o come delitto. L’idea che il potere possa avere a che fare con la democrazia, e che possa consistere prima di tutto nel governo delle istituzioni in vista del raggiungimento del bene comune, non ha mai avuto grande presa su registi, sceneggiatori e produttori, che hanno preferito raccontare il potere inteso come arbitrio, come controllo, come dominio. Oppure come macchinazione, come segreto, come congiura. Il potere, nella maggior parte dei film italiani, non è mai “buono”. Nasconde quasi sempre qualcosa. È spietato, feroce, malvagio. Oppure mellifluo, viscido, felpato. L’immaginario a cui attinge non è quello delle grandi democrazie occidentali, quanto piuttosto quello delle congiure di Palazzo, dei tradimenti, dei doppi giochi. La politica è vista insomma come arte dell’inganno, dell’intrigo, della simulazione e del complotto più che come costruzione del consenso in funzione del bene della polis. Nel nostro cinema Stato e cittadino sono due entità spesso in conflitto, sia perché lo Stato si ostina a trattare l’individuo come suddito invece che come cittadino, sia perché l’individuo medesimo – legato a particolarismi campanilistici e a egoismi municipali – è poco propenso a delegare alcunché, e si crogiola in un ribellismo anarcoide insofferente di qualsivoglia regola e limitazione all’arbitrio personale. Di nuovo: il potere è cattivo perché limita e chiede rinunzia e limitazione. Per cui chi lo incarna e lo detiene è raffigurato con una maschera di volta in volta ridicola, dispotica, antipatica o grottesca. E tuttavia, proprio per questo, ogni volta che si trova ad affrontare il potere, o 4
M. Foucault, Microfisica del potere, a cura di A. Fontana, P. Pasquino, Einaudi, Torino 1977.
Potere Gianni Canova
433
a inseguirne il fantasma, il cinema italiano non può far conto sui consueti canoni “realistici” o “naturalistici” che hanno segnato e egemonizzato la sua storia, ed è indotto anzi a forzare i limiti del linguaggio, e a inventare di volta in volta soluzioni linguistiche, formali ed espressive di notevole originalità e spesso anche di sorprendente ed eterodossa novità. Già l’idea che il potere sia comunque legato a un regime di visibilità – come si è visto poc’anzi a proposito di Bella addormentata – e che abbia a che fare quasi ontologicamente con la rappresentazione e con lo spettacolo, ha radici lontane, si manifesta nell’idolatria del corpo del duce celebrata dal cinema negli anni del fascismo e poi – nel dopoguerra – trova un’espressione per molti versi paradigmatica in un film che è quasi il punto di partenza necessario e imprescindibile per qualsivoglia riflessione sul “fantasma” del potere nel cinema italiano: La presa del potere da parte di Luigi XIV (1966) di Roberto Rossellini. 1.1 Lo spettacolo del potere, il potere dello spettacolo Il Re, la mattina, si alza dal letto alla presenza dei cortigiani. Il lever du roi è lo spettacolo con cui si inaugura la vita quotidiana alla corte di Versailles. Il Re si veste, il Re sbadiglia, il Re si lava. La corte guarda. La corte contempla. In silenzio. La stessa cosa accade più tardi, quando il Re pranza. Il Re mangia da solo, sopra un tavolo che sembra un altare, di fronte a tutta la corte che lo osserva mangiare. Non usa posate, il Re. I cortigiani lo guardano mentre porta il cibo alla bocca con le mani. È il Re che lo vuole: vuole che la sua vita si svolga tutta sempre sotto gli occhi dei sudditi. La “presa del potere” di Luigi XIV – suggerisce Rossellini – si fonda proprio su questo: sulla trasformazione della vita in cerimonia, sulla teatralizzazione del quotidiano nella direzione dello spettacolo e del rito. Ciò che mostra davvero il film di Rossellini – ha efficacemente osservato Francesco Zucconi – è che «non si ha instaurazione di un’egemonia senza la creazione di uno specifico ed efficace regime di visibilità: la passerella del sovrano imbellettato in mezzo alla nobiltà – una delle ultime sequenze del film – è l’apparizione di un sole che orienta l’attenzione centripeta degli sguardi. Il Re, nella sua esteriorità sfolgorante costituisce una forma di presenza alla
434
Lessico del cinema italiano
quale è proibito sottrarsi»5. In singolare sintonia con la riflessione di Louis Marin sul potere delle immagini di Luigi XIV6, il film di Rossellini mostra come Luigi non sia Re se non nelle immagini che lo rappresentano in quanto tale, intendendo per immagini non soltanto i suoi ritratti, ma tutte le rappresentazioni che lo identificano, appunto, come Re. La rappresentazione e il cerimoniale come fondamento del potere? Per il Rossellini di La presa del potere da parte di Luigi XIV sembrerebbe proprio di sì: Luigi XIV non ha bisogno di colpi di Stato, di congiure, di combattimenti e duelli a fil di spada (basta vedere come relega quasi all’insignificanza il ruolo – pur così rilevante nella letteratura popolare e nella storia del cinema – di D’Artagnan e dei “moschettieri del re”). Gli basta lanciare una moda e rendersi canone vivente dello spettacolo di corte. Come scrive lo storico Paolo Alatri, Rossellini «ha giustamente messo l’accento sull’importanza del costume. Gli abbigliamenti sontuosi in voga sotto Luigi XIV ebbero sulla nobiltà più effetto dei patiboli di Richelieu. Più che di farsi tagliare la testa i nobili temevano di non avere un abito alla moda»7. Bruno Fornara è ancora più esplicito nella sua lettura del fondamento del potere nel film di Rossellini: «Luigi XIV cambia il mondo perché impone un cambio nella moda. E grazie alla moda, cambia se stesso: è anche con i tacchi, le trine, le parrucche, nastri, pizzi, cerimoniali e riti, che diventa re, che si dà un aspetto regale, si mostra come non è e come deve essere per esercitare il suo potere»8. Conquista degli sguardi, imposizione del canone, controllo del cerimoniale: tutto questo è il potere. Ma tutto ciò non sarebbe sufficiente – in un film sul potere, e sulla “presa” del potere – se non si accompagnasse anche con la conquista dello schermo, cioè con l’occupazione totalizzante del visibile. Lo sottolinea con acutezza Stefano Roncoroni quando rileva – nel film di Rossellini – la progressiva scomparsa dalla scena di tutti gli interpreti che non siano Luigi XIV: «Damigelle, servi, soldati, ministri, medici, preti, cardinali, nobili, Fouquet, Colbert, Le Tellier, M.me du Plessis, M.lle de La 5 6 7 8
F. Zucconi, La presa del potere da parte delle immagini di Luigi XIV. Videocrazia e sopravvivenza delle immagini, in “Alfabeta2”, 13 ottobre 2011. L. Marin, Le portrait du roi, Minuit, Paris 1981. P. Alatri, Luigi XIV, in “Filmcritica”, n. 172 (1966). B. Fornara, Le cose come erano, in Avventurarsi nella storia, a cura di Id., Feltrinelli, Milano 2011, p. 12.
Potere Gianni Canova
435
Vallière, la regina madre Anna d’Austria, che avevano beneficiato di qualche primo piano tutto per loro, lasciano a poco a poco il posto all’invadente persona del Re»9. La prise de pouvoir coincide dunque con la conquista dell’immagine, e con la capacità di essere il polo centripeto di attrazione dello sguardo. Già alla metà degli anni sessanta, Rossellini individua nella spettacolarità e nella visibilità l’essenza stessa del potere. Quasi anticipando quel lapidario passaggio delle Histoire(s) du cinéma (1989-1998) in cui Jean-Luc Godard ricorda come l’invenzione del primo piano risalga all’economia (e alla numismatica) prima che all’arte e alla cinematografia («L’origine del primo piano è nelle immagini dei re sulle monete»), Rossellini suggerisce che il potere è nella capacità del sovrano di essere sempre visibile: anche quando comprano, scambiano o vendono, popolo e cortigiani devono avere sempre sotto gli occhi l’immagine del Re. 1.2 Il corpo del duce e l’erotismo del potere In realtà, per un Ventennio, gli italiani hanno avuto sempre davanti agli occhi l’immagine del duce. Quel regime di visibilità che Rossellini individuava alla base della presa del potere di Luigi XIV era stato di fatto anche alla base del carisma e del potere di Benito Mussolini. Ha scritto Sergio Luzzatto: «Per quasi vent’anni dopo la marcia su Roma, il corpo del duce è stato amato, perdutamente amato dalla maggioranza degli italiani. Il carisma personale di Mussolini ha costituito la chiave di volta del consenso popolare al regime. Favorito dalla mediocrità fisica e politica del re Vittorio Emanuele III, il duce è riuscito ad occupare la scena pubblica come un’incarnazione benefica del potere»10. Occupare la scena pubblica: Mussolini si è insediato nel paesaggio reale e immaginario degli italiani non solo e non tanto esercitando il potere, quanto piuttosto recitandolo. E la recita si è avvalsa da un lato di un sistema articolato – al contempo elementare ed efficacissimo – di comunicazione non verbale, dall’altro di un apparato 9 10
S. Roncoroni, Situazione “66”. La prise de pouvoir par Louis XIV, in ivi, p. 38. S. Luzzatto, Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, Einaudi, Torino 1998, p. 18.
436
Lessico del cinema italiano
e di un dispositivo mediatico che ha consentito al corpo del duce di diventare di fatto instrumentum regni. Scrive ancora Luzzatto: «Roteando gli occhi, contraendo le mascelle, sporgendo il labbro inferiore, divaricando le gambe, poggiando le mani sui fianchi, il duce ha parlato un eloquente linguaggio corporale. Per giunta, il romagnolo di Predappio non si è vergognato di mostrarsi né di farsi ritrarre a torso nudo, come gli antichi romani dei quali si pretendeva l’erede»11. Ma l’efficacia della recita, la possibilità che la rappresentazione fosse davvero persuasiva, nel Ventennio fascista era affidata in gran parte al cinema: è il cinema (“l’arma più potente”) che codifica e rende pubblica l’immagine del duce intento alla trebbiatura o alla posa della prima pietra, del duce che nuota o del duce che piccona, campione di vigore fisico e di audacia ginnicosportiva, oltre che di una mascolinità insistentemente ostentata ed esibita. Ma se questa ossessione narcisistica produce lo scherno espressionista di uno scrittore come Carlo Emilio Gadda (che arriva a vedere nel duce l’incarnazione perfetta di uno sfrenato ipernarcisismo in cui «tutto viene relato alla erezione perpetua e alla prurigine erubescente dell’Io-minchia, invaghito, affocato, affogato di sé medesimo»12), nei numerosi cinegiornali Luce che lo vedono protagonista13, il duce è semplicemente una sorta di dio in terra, spesso inquadrato dal basso, con un’inclinazione obliqua che produce effetti statuari e monumentalizzanti, ed è quasi sempre circondato da un coro di popolo o di gerarchi che gli fanno da corona. Qui sta una delle principali differenze rispetto a Luigi XIV raffigurato da Rossellini: per Re Sole, la conquista del potere coincide con la conquista dell’immagine. Luigi XIV espelle tutti gli altri dall’inquadratura, esige per sé (e per sé soltanto) il ruolo di oggetto 11 12 13
Ivi, p. 20. C.E. Gadda, Eros e Priapo da furore a cenere, Garzanti, Milano 1967, pp. 170-171. I cinegiornali Luce vengono realizzati a partire dal 1927. Si veda in proposito G. D’Autilia, Una rappresentazione di cui non si conosce la trama: il documentario italiano degli anni trenta, in Schermi di regime. Cinema italiano degli anni trenta: la produzione e i generi, a cura di A. Faccioli, Marsilio, Venezia 2010, p. 66. Per una sintesi delle immagini dei cinegiornali Luce dedicate alla messinscena del corpo del duce si veda anche il documentario Il corpo del duce (2011) di Fabrizio Laurenti, prodotto da Istituto Luce e costruito sulla falsariga del saggio di Luzzatto precedentemente citato.
Potere Gianni Canova
437
scopico. È il sovrano l’unico degno di essere guardato, la visibilità è prerogativa della sovranità. Per il duce del fascismo invece non è così: il duce ha bisogno del coro. Il duce si fa ritrarre fra la gente. Vuole che il cinema mostri il popolo che lo guarda. L’atto del guardare il duce (e dell’ammirarlo, adorarlo, apprezzarlo) fa parte dello spettacolo. Anche perché il duce, a differenza del re nell’interpretazione di Rossellini, non pretende che il popolo si faccia simile a lui: al contrario – secondo la direzione di marcia tipica di tutti i populismi e di tutte le dittature – è lui che finge di farsi simile al popolo. Di essere come il popolo. In sella a un trattore come davanti a un muro da picconare, Mussolini – con il suo cranio liscio e rasato, con il suo elmetto calzato in testa come una blindatura, con i suoi sguardi grifagni e le sue smorfie facciali – mette in scena il riscatto dell’uomo qualunque con un machismo intriso di sfrontatezza plebea. Se il Luigi XIV imponeva ai dignitari di provare ad assomigliargli, il duce comunica al popolo che è lui – il duce – ad assomigliare a loro, ad essere come loro. Ed è questo meccanismo che contribuisce in modo così evidente a erotizzare il suo corpo, a farne un oggetto di desiderio collettivo e a facilitare i processi di identificazione di massa («Il duce si identificava fisicamente con il potere e il popolo si identificava fisicamente con il duce»14). È tuttavia interessante notare come questo regime di assoluta visibilità e di pervasiva teatralità costruito con coerenza e pervicacia dai Cinegiornali Luce e dai documentari d’epoca non rappresenti l’unica strategia di raffigurazione del potere perseguita dal fascismo. Se un film di propaganda come il kolossal Scipione l‘Africano (1937) di Carmine Gallone proietta a ritroso, nella Roma del III secolo a.C., «l’immaginario monumentale e iconologico del fascismo»15 e riscrive nel passato mitico della Roma repubblicana quel gusto delle adunate oceaniche e della partecipazione di massa alla vita pubblica che erano tanto care alla retorica del regime, quasi inebriandosi delle immagini con migliaia di comparse in piedi col braccio teso nel saluto fascista, intente a celebrare nel console Publio Cornelio Scipione (il vendicatore della sconfitta di Canne nonché distruttore di Cartagine) un evidente ed esplicito 14 15
S. Luzzatto, Il corpo del duce, cit., p. 19. G. Muscio, Il film più fascista è il film storico, in Schermi di regime. Cinema italiano degli anni trenta: la produzione e i generi, cit., p. 48.
438
Lessico del cinema italiano
antenato del duce16, un altro film dichiaratamente di propaganda come Camicia nera (1933) di Giovacchino Forzano lavora invece sull’immagine del duce solo evocandola in absentia: per quasi tutto il film, prima del “trionfo” finale, Mussolini non lo si vede mai. Lo si sente, si avverte la sua presenza, si leggono le sue frasi marmoree riportate con enfasi su cartelli e proclami, si sente la sua voce in un discorso, ma il suo corpo è di fatto invisibile. Con un uso spregiudicato e oggettivamente “moderno” delle tecniche e delle retoriche del cinema di propaganda, Forzano scrive una sorta di metafisica del potere: la decisione delle cancellerie europee che nel 1914 portano l’Europa alla guerra, ad esempio, è resa visivamente con inquadrature ripetute delle mani dei potenti che appongono la loro firma in calce alle dichiarazioni di guerra e sugli ordini di mobilitazione, quasi a suggerire l’idea di un potere senza volto, cieco, meccanico, burocratico, inidentificabile. Poco dopo Forzano risolve con soluzioni d’avanguardia, per certi versi debitrici della lezione di Dziga Vertov e del cinema sovietico, la rappresentazione del disordine del dopoguerra e ricorre ad allegorie visive per esprimere la visione fascista del potere e dello Stato (la ciminiera con la scritta “Lavoratori” che crolla addosso alla ciminiera con la scritta “Datori di lavoro” e la travolge, fino a che un architrave denominato “Corporazione” non tiene insieme saldamente l’una e l’altra, diventando la struttura portante dello Stato fascista). Quindi, dopo la “rivoluzione” delle camicie nere, lo schermo si riempie di immagini di folle disciplinate, schierate in parate militari, marce, manifestazioni sportive o coreografie. Il potere del duce si manifesta e si rende visibile nei risultati conseguiti, assunti come epifania del nuovo ordine fascista. Finché nell’epilogo appare Lui in persona, mostrato nell’atto di pronunciare il discorso per l’inaugurazione di Littoria nel 1932: un lungo pianosequenza, interrotto solo da controcampi sulla folla che ascolta, in cui il duce offre una sintesi impagabile della sua tecnica oratoria
16
Nel film storico degli anni trenta – scrive Giuliana Muscio – «gli eroi di ieri mimano, anticipandolo, l’unico eroe popolare che la cultura del regime fascista abbia prodotto: Benito Mussolini. […] slogan mussoliniani o caratteristiche e tratti pubblicamente associati al duce sono attribuiti a ogni eroe del cinema storico» di quegli anni. Cfr. ivi, p. 47.
Potere Gianni Canova
439
e comunicativa17. Mani sui fianchi e aspetto marziale, Mussolini costruisce il discorso in crescendo: inizia lento, poi a un certo punto accelera e scandisce il ritmo con il movimento della mano che colpisce con il dorso la balaustra che ha davanti a sé: «Abbiamo/ cioè vinto/ la nostra battaglia…/». La mano guida il movimento, il corpo si protende in avanti, oscilla, l’indice si alza verso il cielo, poi si unisce al pollice a formare un cerchio, quindi il duce rovescia indietro la testa ispirato, spinge il petto in fuori, si sfiora il naso con la mano, riporta le mani sui fianchi e ricomincia. Qui il corpo erotico dei cinegiornali diventa corpo demiurgico. O taumaturgico. O anche corpo epifanico che annuncia – mostrandosi – il compimento del miracolo. Mai più – nel dopoguerra – il cinema italiano riapplicherà un simile approccio al tema del potere. Che paradossalmente sarà percepito come sempre più opaco quanto più la società italiana uscirà davvero dall’era del totalitarismo e della dittatura. Come se la vera difficoltà diventasse quella di rendere visibile la democrazia, di trovare una forma adatta a rappresentarla. 1.3 Scenografie del potere «Salute, o fratello dilettissimo in Cristo!». Mentre papa Urbano VIII pronuncia queste parole, Galileo Galilei è chinato ai suoi piedi e compie il rito cerimoniale del bacio della pantofola. L’inquadratura si allarga e mostra il papa seduto sulla “sedia di Cristo” (un massiccio trono sopraelevato), vestito con un abito color oro in un lussuoso salone decorato con marmi preziosi e brillanti. Galileo (1968) di Liliana Cavani è uno dei film italiani che meglio esplicitano l’idea della centralità scenografica nell’esercizio del potere o del potere – prima di tutto – come scenografia. In tutto il film la messinscena della corte papale risponde a una logica spettacolare rigorosa: il potere esprime se stesso mettendosi in scena, e assegnando alla prossemica definita dalle relazioni spaziali il ruolo di 17
Anche in Scipione l’Africano il discorso in cui Scipione a cavallo innalza l’unica insegna sopravvissuta alla disfatta di Canne e galvanizza i soldati facendo leva sull’onore e sull’orgoglio militare è reso visivamente con lunghe inquadrature sui volti dei reduci, che a poco a poco si lasciano sedurre dalle parole del loro “duce”. Il potere si rende visibile attraverso gli effetti che produce.
440
Lessico del cinema italiano
definire e precisare anche i ruoli sociali. Anche qui il potere allestisce la propria visibilità (in questo caso addirittura postuma: si veda la scena in cui Urbano VIII discute col Bernini della struttura del proprio monumentale sepolcro) e determina attraverso gli spazi le strutture verticali e gerarchiche su cui si fonda, e su cui fonda le proprie relazioni di comando e di obbedienza. Si pensi anche solo all’inquadratura finale: una soggettiva dal basso di Galileo, che ha appena abiurato, e che vede sovrastarlo, come un gruppo marmoreo, i cardinali e i padri della Chiesa, rinchiusi fra due colonne che si protendono verso l’alto, vera ipostasi scenografica del dominio che in quella sala ha appena obbligato un uomo a ripudiare le proprie più profonde convinzioni non solo scientifiche ma anche etiche ed esistenziali per conformarsi alla volontà dei detentori del potere. Non a caso, Liliana Cavani dissolve quell’immagine in una più semplice ma anche più nitida e secca: il papa ridotto al suo calco in gesso per il monumento sepolcrale, con una mano alzata come nel classico saluto fascista. C’è un filone abbastanza cospicuo di film, nel cinema italiano, in cui il potere si esprime prima di tutto nella scenografia, e forse arriva perfino ad identificarsi con essa18: si veda anche solo, ad esempio, In nome del Papa Re (1977) di Luigi Magni, in particolare la parte che vede in scena il generale dei Gesuiti (Salvo Randone), quasi un papa nero che vive tra scheletri e teschi, e che non si accontenta che monsignor Colombo (Nino Manfredi) confessi e si penta, ma pretende addirittura che sia quest’ultimo a convincere il papa a negare la grazia ai patrioti 18
Il ricorso alla scenografia come icona del potere è del resto una costante nella storia del cinema. Si veda anche solo come il cinema di fantascienza ha usato l’immagine della città per visualizzare nelle strade, nei palazzi, nell’organizzazione urbana, i rapporti di forza e di potere. Scrive Antonio Caronia: «Il gigantismo è uno dei modi più immediati di rappresentare il potere: in un classico come Metropolis (1926) di Fritz Lang, le immagini smisurate della città futuristica, rapportate alle folle che vi si agitano, suggeriscono l’alienazione dei lavoratori, la loro soggezione alla megamacchina che scandisce i ritmi delle loro vite. Dopo di allora l’immagine della megalopoli tornerà innumerevoli volte nel cinema di fantascienza, e ogni volta un palazzo svetterà sulla città fantastica (come d’altra parte nella città reale) e si imporrà a indicare, con la sua sola dimensione, o lo sfarzo, o la forma inusitata, il luogo del dominio, della concentrazione del potere». Cfr. A. Caronia, Immagini del potere nel cinema di fantascienza, in “Domus”, n. 793 (1997).
Potere Gianni Canova
441
Monti e Tognetti, ritrovando solo in questo gesto di simbolica sottomissione un certificato di obbedienza e di sudditanza sufficiente a garantire la sua forza e a ribadire la sua autorità. Ma si veda anche – con un’ambientazione più recente – un film come Cadaveri eccellenti (1976) di Francesco Rosi, dove le scenografie realizzate con la collaborazione di Mario Schifano e Renato Guttuso, con la loro dominante cromatica nera, disegnano come meglio non si potrebbe quasi una sorta di angosciosa metafisica del potere in un paese in cui non ci sono più idee, principi e valori, ma tutti, maggioranza e opposizione, si accordano per conservare il proprio potere, e per perpetuare i propri privilegi, mentendo su tutto, sui morti e sui vivi, sui fatti e sulle ideologie, in nome di una cinica e feroce ragion di Stato. Nei casi citati il potere si esprime sì in un regime di totale ed esplicita visibilità, ma secondo una modalità molto diversa da quella rappresentata da Rossellini in La presa del potere da parte di Luigi XIV: là il sovrano esigeva condivisione, qui la scena del potere esprime dominio e sottomissione. La straordinaria modernità di Rossellini sta nell’aver mostrato nel suo film su Luigi XIV il superamento del paradigma verticale e impositivo del potere e di aver dato corpo a un’idea di potere che non schiaccia e non reprime, ma che spinge il sottoposto a conformarsi e a desiderare di poter essere ammesso al cospetto del Re, partecipe del suo gusto e del suo stile, recitante nel medesimo cerimoniale. Già negli anni sessanta Rossellini va oltre la visione verticale del potere e prefigura un’idea che sembra anticipare certe modalità postmoderne di esercizio del potere quali quelle analizzate da Marco Belpoliti (in Il corpo del capo) a proposito del più recente ventennio in cui la grande maggioranza del popolo italiano è stata erotizzata dalla ininterrotta visibilità dell’immagine mediatica di Silvio Berlusconi19. 1.4 Oscenità del potere Ma Rossellini – lo si è visto – è un’eccezione. Un’anomalia. Per il cinema italiano del dopoguerra – quanto meno, per la maggior parte di esso – il potere reale è quasi sempre osceno: agisce cioè – letteralmente – fuori scena, si esercita al di là della sfera del visibile. Il potere non si ostenta, si dissimula. Agisce nelle “segrete 19
M. Belpoliti, Il corpo del capo, Ugo Guanda Editore, Parma 2009.
442
Lessico del cinema italiano
stanze”, nelle trame sotterranee, nei rapporti oscuri intessuti in interni spesso in penombra, e al riparo da sguardi indiscreti. Il regime di visibilità mostrato da Rossellini nel suo film su Re Sole è quasi del tutto assente nel cinema italiano successivo. Si preferisce inseguire una visione del potere come Leviatano nascosto, come Moloch crudele, come rete invisibile di interessi e di complicità. Più che alla lezione di Rossellini, il cinema italiano sembra ispirarsi alla diagnosi di Francesco Guicciardini: «Spesso tra ‘l palazzo e la piazza è una nebbia sì folta o un muro sì grosso/ che, non vi penetrando l’occhio degli uomini, tanto sa el popolo di quello/ che fa chi governa o della ragione perché lo fa, quanto delle cose che fanno in/ India»20. Il potere è opaco. Resiste allo sguardo. Non si lascia osservare. L’occhio degli uomini non lo penetra. Fuori dal visibile, il potere è escluso dalla conoscenza. Non è e non può essere oggetto di “sapere”. È interessante notare come le due metafore topologiche usate da Guicciardini per indicare rispettivamente il potere (il “Palazzo”) e il popolo (la “piazza”) si siano talmente radicate nell’immaginario sul (e del) potere, da arrivare sostanzialmente immutate fino ai giorni nostri, e da connotare iconicamente sia il dibattito politico sia le rappresentazioni cinematografiche. La metafora del Palazzo, ad esempio, è notoriamente centrale nella riflessione di Pier Paolo Pasolini, che la esprime in una serie di articoli pubblicati sul “Corriere della Sera” nel corso del 1975, poche settimane prima della sua tragica morte. Scrive ad esempio Pasolini: «Solo ciò che avviene “dentro il Palazzo” pare degno di attenzione e di interesse: tutto il resto è minutaglia, brulichio, informità, seconda qualità. […] I potenti che si muovono “dentro il Palazzo”, e anche coloro che li descrivono […] si muovono come atroci, ridicoli, pupazzeschi idoli mostruosi»21. Pasolini usa Palazzo con l’iniziale maiuscola. I potenti sono “idoli mostruosi”. Dentro questa visione si esprime un’idea del potere come proprietà, come entità “appropriabile” da parte di una classe o di una forza politica esprimente interessi specifici. Questa localizzazione del potere, questa pretesa di identificare il potere con il luogo in cui esso si esercita, è proprio l’idea a cui si è opposto 20 21
F. Guicciardini, Ricordi, 141, 1528 circa. P.P. Pasolini, Lettere luterane, in Id., Saggi sulla politica e sulla società, a cura di W. Siti, S. De Laude, Mondadori, Milano 1999, pp. 619, 621.
Potere Gianni Canova
443
notoriamente e radicalmente Michel Foucault, il quale ha dimostrato che il potere non ha una forma che possa essere contenuta, posseduta, detenuta. Ma la sua proposta di delocalizzazione del potere non ha trovato eco né accoglienza nel cinema italiano, che ha preferito mettere in scena il potere prima di tutto attraverso i luoghi in cui esso si manifesta. Esemplare, da questo punto di vista, un film come L’ultimo imperatore (1987): il kolossal di Bernardo Bertolucci non solo è una delle poche riflessioni sul potere che il cinema italiano abbia prodotto nel corso degli anni ottanta, ma è anche un film in cui l’identificazione fra il potere e il luogo in cui il potere risiede è totale. La figura di Pu Yi trova nella Città Proibita molto più che un semplice “teatro” in cui mettere in scena ritualità e scenografie del potere: l’uscita dell’ultimo imperatore dalla Città Proibita coincide, non a caso, con la perdita del potere medesimo. Luogo dell’interdizione e del segreto, la Città Proibita di Bertolucci è “chiusa” in entrambe le direzioni: non solo sottrae l’imperatore alla vista dei sudditi, ma sottrae anche i sudditi e il mondo alla vista dell’imperatore. Siamo agli antipodi della corte di Versailles nel film di Rossellini su Luigi XIV: nella Città di Bertolucci il “figlio del cielo” non è uno spettacolo per la corte, ma assiste allo spettacolo che la corte inscena per lui, si inebria nei rossi e negli ori delle coreografie di omaggio e di reverenza, e ciononostante, pur in uno spazio così recluso e ritualizzato, sente il bisogno di ribadire comunque il suo “primato” e il suo ruolo, come risulta evidente nella sequenza in cui obbliga un eunuco a bere il sangue per dimostrare il proprio potere assoluto di fronte al fratello. Teatro senza spettatori, o in cui gli attori sono nel medesimo tempo spettatori, luogo cerimoniale del rito e dell’omaggio, la Città Proibita suggella un’idea di potere come dispositivo separato e distaccato dal luogo in cui si esercita: il potere dell’imperatore infatti risiede nel palazzo, ma si esercita fuori da esso, in un “fuori” di cui l’imperatore non solo non ha accesso, ma non ha neppure conoscenza e visione: quando l’avrà, ciò implicherà automaticamente anche la perdita del potere. Pu Yi è come segregato nel luogo labirintico in cui si annida il suo potere. Come dice lo stesso Bertolucci: «In tutto novemilanovecentonovantanove stanze e mezza, non diecimila, perché questo numero appartiene all’Imperatore, Figlio del Cielo e Signore dei diecimila anni». E aggiunge: «Il significato ultimo del grande labirinto è la ripetizione all’infinito dell’assenza-presenza
444
Lessico del cinema italiano
dell’imperatore»22. Ogni volta che si sente imperatore, Pu Yi si scopre prigioniero. Per liberarsi, dovrà fingersi attore, e imparare a recitare la propria vita: prima nella Città Proibita, poi nell’inverno claustrofobico del Manchukuo e infine nelle prigioni di Mao. In generale, si può dire comunque che nel cinema italiano la visibilità dei luoghi è inversamente proporzionale all’invisibilità del potere: tanto più i primi sono visibili, quanto più il secondo si nasconde e si cela allo sguardo. Si veda L’udienza (1972) di Marco Ferreri: interpretato da un attonito e straniato Enzo Jannacci, il film narra di un uomo qualunque che insiste per poter parlare con il papa. Dalle fotografie appese alle pareti o disposte sulla scrivania del commissario Aureliano Diaz (Ugo Tognazzi) si intuisce che la vicenda si svolge negli anni in cui Giuseppe Saragat era al Quirinale e Paolo VI sedeva sul trono di Pietro. All’inizio il protagonista Amedeo (omen nomen?) si intrufola in una comitiva di pellegrini che sta per essere ricevuta in udienza dal papa. Un po’ ingenuamente, però, confessa agli addetti che lui con il papa ci vuole anche parlare. Dopo un attimo di sconcerto, i responsabili della visita lo allontanano dal gruppo e lo accompagnano all’uscita. Da quel momento, Amedeo tenta più e più volte di essere ammesso al cospetto del papa, ma la sua attesa viene sempre puntualmente delusa, in un racconto dai dichiarati echi ka iani (Il castello, soprattutto) che finisce per essere un acido apologo sull’inaccessibilità e l’invisibilità del potere. Il papa, nel film, non si vede mai, se non nelle immagini televisive che mostrano il pontefice alle prese con il suo repertorio rituale di apparizioni pubbliche. A compensare l’assenza del potere (e del suo più alto rappresentante), il film è dominato dalla invadente presenza dei palazzi del potere: dallo zoom iniziale sul cupolone di San Pietro, avvolto in un’inquietante nebbia bluastra, via via alle inquadrature sulla finestra sempre chiusa da cui il papa è solito affacciarsi la domenica per l’Angelus, fino alla recursiva apparizione di statue gigantesche che dominano il personaggio umano, il potere sembra annunciarsi e al tempo stesso occultarsi nella pietra delle architetture o nella gelida burbanza delle Guardie svizzere che, con tanto di alabarda, presidiano gli accessi al Vaticano e im22
B. Bertolucci, La mia magnifica ossessione. Scritti, ricordi, interventi (19622010), Garzanti, Milano 2010, pp. 107-108.
Potere Gianni Canova
445
pediscono al protagonista di passare. Alla fine Amedeo si accascia e muore sotto il colonnato di Piazza San Pietro, luogo soglia fra il potere e il mondo, ma subito all’ingresso del Vaticano un nuovo “postulante” vene bloccato dalle guardie mentre chiede di poter parlare con il papa. Con questo suo impianto circolare, immerso in una folla di aristocratici neri e di alti prelati, di viscidi funzionari e di faccendieri, il film di Ferreri disegna una sorta di moto perpetuo dell’inaccessibilità del potere e delega ai luoghi il compito di surrogare ciò che nel racconto resta volutamente e minacciosamente invisibile. Molti sono i film italiani in cui l’assenza di un potere visibile è compensata dalla presenza surrogatoria delle architetture: basta vedere come il potere fascista si manifesta – in Il conformista (1970) di Bernardo Bertolucci – nella imponenza delle architetture, nei campi lunghissimi dei palazzi romani in cui il protagonista Marcello si intrufola prima di partire per Parigi, con quei grandi spazi vuoti resi ancora più minacciosi dalla freddezza dei marmi alle pareti. Del resto, la tendenza a scaricare sul gigantismo delle scenografie il compito di significare la granitica forza di un potere “osceno” ha per il cinema italiano radici lontane: si pensi anche solo a come Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone delega alle architetture la semantica del dominio, a cominciare dalla potentissima invenzione del Tempio di Moloch nel cui impasto di pietra e di fuoco, di pieni e di cavi, di scivoli e di scale, si celebra l’inumano sacrificio delle fanciulle al potere crudele di un dio invisibile. Ha scritto Paolo Cherchi Usai: «A voler cercare a tutti i costi un protagonista umano nel film, l’unica certezza è nelle folle: le centinaia di fedeli genuflessi di fronte alla statua del mostro celeste, le truppe romane che fanno schiavo Siface, i cartaginesi accecati dall’ira che sciamano nelle vie della città per cercare il gruppo dei sacrileghi»23. Le tumultuose masse di Cabiria sono insomma l’energia motrice di un racconto che trova proprio nelle scenografie e nell’imponenza degli spazi e dei luoghi l’incarnazione di una potenza che nessuna volontà umana riesce ad assumere su di sé e a fare propria, e che solo lo “spiccato senso plastico” e le straordinarie capacità tecniche di Pastrone riescono a rendere drammaturgicamente efficaci. «Gli 23
P. Cherchi Usai, Giovanni Pastrone, Gli anni d’oro del cinema a Torino, UTET, Torino 1986, p. 16.
446
Lessico del cinema italiano
scenografi di Pastrone – ha scritto Georges Sadoul – costruirono delle scenografie armate e ricoperte di stucco, d’imponente grandezza, e rivestirono i pavimenti con lastre di vetro dipinte e lucenti a specchio. Statue colossali e migliaia di accessori scenici e di mobili vennero fabbricati espressamente»24. La stessa celeberrima invenzione del carrello, messa a punto, brevettata e perfezionata da Pastrone con Segundo de Chomón, nacque proprio – prima di tutto – per l’esigenza di dare maggior rilievo plastico e tridimensionale alle scenografie. Del resto, è noto come – anche restando sul piano della produzione più corrente – tutta la costruzione filmica del mito della romanità faccia leva fin dagli anni del muto – da Quo Vadis? (1913) di Enrico Guazzoni, e da Nerone e Agrippina (1914) di Mario Caserini – proprio sulla maestosità delle scenografie. Quasi a confessare che per il cinema italiano è sempre risultato più facile mostrare gli effetti del potere sull’urbs (sulle architetture, sulle infrastrutture, sulla forma materiale della città) che non sulla civitas (cioè sull’insieme dei cittadini e sui modi e le forme del loro vivere associati). 1.5 Allegorie del potere, da Ambrogio Lorenzetti a Pier Paolo Pasolini Non è sempre stato così. All’origine della civiltà urbana in Italia, nella prima metà del XIV secolo, un’importante opera pittorica – con un impianto visuale quasi pre-cinematografico – mostra come sia possibile usare il codice dell’allegoria per provare a rendere visibili proprio gli effetti del potere non tanto sull’urbs quanto sulla civitas, sulla comunità dei cittadini che abitano la città. Il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti intitolato Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo, conservato nel Palazzo Pubblico di Siena e databile tra il 1338 e il 1339, è composto da quattro scene disposte nella sala del Consiglio (là dove si riunivano i governatori) e mostra come il buon governo e il cattivo governo (si noti come Lorenzetti lavori sull’idea di governo piuttosto che quella di potere) producano effetti visibili sulla vita dei cittadini: da un lato una città laboriosa, ordinata e concorde, dall’altro una città in rovina, tetra 24
G. Sadoul, Storia del cinema, Einaudi, Torino 1951, pp. 122-123 [ed. or. Histoire d’un art: le cinéma, Flammarion, Paris 1949].
Potere Gianni Canova
447
e spaventata, dove dilagano crimini e omicidi, cittadini innocenti vengono arrestati e le attività economiche sono miserabili. Secondo il classico procedimento allegorico, Lorenzetti visualizza le virtù del buon governo (sapienza, giustizia, istituzione comunale) e i vizi del cattivo governo (tirannide, superbia, avarizia, vanagloria) personificandoli, dando loro un corpo e un volto. Ed è significativo che spesso – soprattutto nel caso dei vizi – si tratti di corpi zoomorfi. Raramente il cinema italiano ha raggiunto una tale capacità di sintesi rappresentativa. Da un lato ha sempre provato un certo disagio di fronte alla prospettiva di lavorare sulla nozione di “governo” invece che su quella di “potere”. Dall’altro, è spesso apparso refrattario e titubante, se non addirittura spaventato, di fronte alla possibilità di ricorrere a un registro arduo e complesso, anche sul piano dell’elaborazione intellettuale, come quello dell’allegoria. Ci sono alcune eccezioni, è vero. E si tratta di film che fondono il linguaggio allegorico sull’utilizzo di modelli animali (le tre belve che svolgono la funzione narrativa in Il potere, 1972, di Augusto Tretti), di modelli oggettuali (il maglio che colpisce e distrugge in Prova d’orchestra, 1979, di Federico Fellini) o di modelli ambientali (la villa degli orrori in cui si svolge Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975, di Pier Paolo Pasolini). Proviamo ad esaminarli più da vicino. Il film di Tretti si incardina attorno a un classico procedimento allegorico: tre personaggi con in testa la maschera di una belva (un leone, una tigre e un leopardo), seduti su un trono, rappresentano segnatamente il potere militare, commerciale e agrario, e appaiono più volte nel corso del film, in particolare negli snodi di passaggio da un’epoca storica a un’altra, per analizzare i cambiamenti in atto e decidere di conseguenza le strategie più idonee per perpetuare il potere, la ricchezza e i privilegi acquisiti. Le tre fiere non intervengono mai nell’agone della storia, ne restano estranee, ma muovono dal di fuori le fila degli accadimenti restando acquattate nell’ombra. Dietro questa scelta affiora un’idea del potere come entità nascosta, non immediatamente percepibile, oscura. I potenti visibili – di volta in volta i senatori dell’antica Roma, il duce nell’Italia fascista o i rapaci esponenti del neocapitalismo che fanno i soldi con i polli d’allevamento nell’Italia contemporanea – non sono che i “burattini” di cui il potere occulto si serve per perpetuare se stesso. Quanto mai significativa la scelta di “animalizzare” le allegorie del potere: in piena sintonia con una cultura che fin da Machiavelli
448
Lessico del cinema italiano
individuava nella «forza del lione» e nell’«astuzia della volpe» le qualità precipue del Principe, il cinema italiano si fa erede di una tradizione che impone ai potenti maschere animali25, secondo una linea che passa per Tretti, coinvolge Pasolini (che in Petrolio attribuisce al politico la maschera di un gatto)26 e arriva fino all’Italia dei giorni nostri, quando Silvio Berlusconi diventa il “Caimano” nel film di Nanni Moretti del 2006, e l’ex-ministro leghista Roberto Calderoli non trova immagine migliore che quella dell’orango per dileggiare razzisticamente il ministro della Repubblica italiana (ma di origini africane) Cécile Kyenge27. Che sottolineare l’animalità del potere sia un modo per circoscrivere la sua alterità ma anche per giustificare l’incapacità di comprenderlo fino in fondo? Singolare poemetto ideo-comico, oscillante fra l’apologo pasoliniano e l’afflato pedagogico rosselliniano, Il potere sceglie il registro del sarcasmo – un sarcasmo feroce, anarchico, reso ancor più graffiante dal candore naïf dell’enunciazione – per illustrare la tesi secondo cui il potere si fonda sulla paura e il privilegio si radica nell’interdetto e nella proibizione. Realizzato con pochissimi mezzi e con attori non professionisti, con i suoi senatori che tessono trame e imbastiscono intrighi mollemente adagiati al bordo di vasche fumiganti, secondo il luogo comune che vuole il potente non solo privilegiato ed esonerato dalle incombenze dell’uomo comune, ma anche sempre oscillante fra il piacere dell’otium e il gusto del negotium, il film di Tretti trova nell’assoluta povertà della messinscena un elemento esplosivo: costretto a costruire folle di otto persone o eserciti di dodici soldati, sciolto da ogni vincolo di piatto 25
26
27
Si veda ad esempio come Natalia Ginzburg recensisce il film di Roberto Faenza Forza Italia! (1978): «Alcuni di questi protagonisti del potere, li abbiamo trovati rassomiglianti a dromedari grandi e tristi, altri a piccoli cani festosi e ringhiosi, altri a tartarughe. Ci domandiamo se preferiamo i dromedari ai cagnetti, e prontamente decidiamo che di gran lunga preferiamo i dromedari, perché sono malinconici, e la malinconia ci sembra meglio di un vano, rabbioso e giubilante abbaiare», N. Ginzburg, La Dc può far ridere?, in “La Stampa”, 31 gennaio 1978. «C’era anche un uomo politico – era ministro da dieci anni e poi lo sarebbe stato per altri quindici – seduto su una poltroncina rossa, con un viso tondo di gatto ritratto tra le spalle, come non avesse collo», P.P. Pasolini, Petrolio, in Id., Romanzi e racconti, vol. II, 1962-1975, a cura di W. Siti, S. De Laude, Mondadori, Milano 1998, p. 1304. Cfr. i giornali quotidiani del 14 luglio 2013.
Potere Gianni Canova
449
realismo, Tretti riesce a realizzare un testo a suo modo paradigmatico che contiene ed anticipa, anche se embrionalmente, molto del dibattito e delle riflessioni successive. E come se in questo piccolo film indipendente e maledetto, poverissimo ma capace di straniamenti brechtiani e di calembours godardiani, fosse condensato e liofilizzato tutto l’immaginario italico del potere e sul potere. Due i tratti costitutivi del potere che la beffarda allegoria di Tretti lascia intravvedere: la paura e la rappresentazione. Nel film il potere nasce quando tra le pietre e le rocce di un’umanità paleolitica intenta a praticare il comunismo primitivo (tutti condividono una magra gallina appena catturata) appare un fulmine che spaventa e terrorizza. L’uomo che stava accanto al punto in cui il fulmine è caduto immediatamente viene venerato e temuto, tanto temuto che la gallina diventa sua. La paura genera sudditanza e sulla paura nasce la proprietà. Nella sua cristallina evidenza da apologo, il primo episodio del film di Tretti delinea una percezione del potere che vede nel timore dell’ignoto la radice prima del dominio. Ma non basta. Il potere – suggerisce ancora Tretti – si basa sulla messinscena. Sempre. C’è una dimensione di spiccata teatralità e di palese finzionalità in tutte le epoche storiche: nell’antica Roma, quando i senatori spingono il tribuno a “recitare” la parte del difensore della plebe, così come nell’Italia fascista, quando uno striminzito manipolo di scalcagnati soldati mette in scena una parata che intende dimostrare la potenza dell’esercito fascista. Per farlo, i soldati si travestono di volta in volta da alpini, bersaglieri, corazzieri e granatieri, e trasformano le loro biciclette in cannoni o addirittura in finti carrarmati. E così travestiti – mascherati – girano in cerchio davanti al pubblico che applaude e consente. Nel finale, a fronte delle proteste popolari contro le nuove forme rapaci del dominio neocapitalista, le tre belve escogitano l’ennesimo coup de théâtre e inscenano l’ultimo travestimento. Lo annuncia sardonica la Tigre: «Oggi, per conservare il potere è meglio camuffarsi da socialisti». La Tigre e il Leopardo estraggono l’una una falce e l’altro un martello, e li incrociano, mentre sullo sfondo – sulle note di Bandiera rossa – appare un vermiglio “sol dell’avvenire” su cui Tretti sovrimpone una scritta con una frase di Lenin: «Ma chi non sa che ai giorni nostri ogni furfante ama pavoneggiarsi in un vestito rosso?».
450
Lessico del cinema italiano
Fellini – come si diceva poc’anzi – costruisce invece la sua allegoria del potere usando un gigantesco maglio: una palla da demolizione che entra in campo all’improvviso, piomba sul muro perimetrale di un oratorio settecentesco e lo distrugge. Gli orchestrali che all’interno stavano faticosamente provando un concerto abbandonano gli strumenti, impauriti. Non si sa da dove venga, quella palla. Né chi la manovri. Tutti sembrano spaventati, ma non sorpresi. Quasi che se l’aspettassero. Come se lo sapessero. Come se quella distruzione fosse inevitabile. Tra le non molte allegorie del potere proposte dal cinema italiano, quella di Prova d’orchestra di Federico Fellini è senz’altro tra le più potenti. Forse anche tra le più inquietanti. Perché mostra – come pochi altri hanno saputo fare – come la possibile genesi di una forma autoritaria di potere derivi direttamente dal carattere dei sottoposti. Dalla loro cronica litigiosità. Dal loro individualismo. Dall’esasperato interesse per il proprio particulare. Da quella riconosciuta attitudine a protestare, urlare e contestare che sembra potentemente “sfigurata” nel comportamento degli orchestrali felliniani. Il film – non a caso – viene subito accolto come «un apologo sulla storica tentazione autoritaria della vita italiana. Un’allegoria della nostra democrazia storicamente fragile, endemicamente predisposta a risoluzioni violente»28. Oggi potremmo anche dire che forse è un’allegoria della cronica ingovernabilità italiana, o dell’intramontabile oscillazione italiana fra uno strisciante ribellismo nei confronti di ogni potere costituito e un inconfessato desiderio di autorità che faccia tacere quella vocazione al ribellismo. All’inizio del film, intervistati da un invisibile inviato della Tv, tutti gli orchestrali celebrano il proprio strumento come il migliore di tutti. Ma ben presto la situazione precipita, sregolatezza e indisciplina prendono il sopravvento, l’oratorio settecentesco sembra trasformarsi in una bolgia dantesca. Quello che doveva essere il luogo della musica – dell’armonia, del kósmos – diventa il regno del caos. Quando l’anziano custode chiama il direttore per riprendere le prove, l’oratorio sembra un baccanale. Al buio, scortato da un traballante candeliere, il direttore cerca invano di riportare l’ordine. Anche l’ingresso di un gigantesco metronomo non cambia la situazione: 28
A. Minuz, Viaggio al termine dell’Italia. Fellini politico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, p. 189.
Potere Gianni Canova
451
simbolo dell’incombenza del tempo, neanche questo surrogato artificiale dell’inefficace autorità umana riesce a ricomporre l’ordine. Il caos dilaga. L’intonaco cade. La polvere copre tutto. Finché irrompe la gigantesca palla, che come un ariete distrugge il muro e uccide l’arpista. Mentre gli orchestrali brancolano tra le macerie in cerca dei loro strumenti, approfittando di quell’attimo di vuoto, il direttore riprende il suo ruolo e richiama i musicisti al loro dovere: quello di suonare. Gli orchestrali obbediscono e si piegano, in silenzio, agli ordini perentori di un direttore d’orchestra che – anche per l’accento marcatamente teutonico – fa pensare a un ufficiale nazista. L’allegoria felliniana è del tutto evidente: il potere autoritario nasce sulle macerie della democrazia ed è fomentato dalla rissosità, dal ribellismo endemico, dalla confusione di coloro che poi si piegano ciecamente ai suoi ordini. Nel finale – come ha scritto acutamente Andrea Minuz – si intravede l’immagine di un paese «diviso su tutto, sfibrato nella sua rissosità quotidiana, e che soltanto tra le macerie ritrova per un attimo una propulsione collettiva»29. Ma nel maglio di ferro che chiude il film e prelude all’avvento di un nuovo ordine (o al ripristino dell’ordine precedente) si intravvede anche qualcos’altro. Come ha scritto Alberto Farassino, quel maglio forse non è che il simbolo di se stesso: «Nel momento della deriva, quando più nulla è codificato, si afferma l’ipotesi di un ritorno all’ordine del simbolico»30. Ancora una volta, è inseguendo il fantasma del potere che il cinema italiano è indotto a forzare i codici del realismo e a infrangere i limiti del linguaggio. A insediarsi in un altro ordine. A produrre altri modi di configurazione del mondo. Il procedimento è ancora più evidente nella più terribile allegoria del potere che il cinema italiano abbia saputo produrre: Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini. Qui i quattro Signori, notabili della Repubblica Sociale Italiana, che sequestrano in una sontuosa villa di campagna – tappezzata da capolavori di arte moderna e presidiata da repubblichini e SS – ragazzi e ragazze razziati per la strada, per sottoporli a un rituale di sevizie e torture secondo il più classico protocollo sadiano, sono l’espressione di tutti i volti e di tutte le articolazioni del potere: il Duca incarna il 29 30
Ivi, p. 197. A. Farassino, recensione a Prova d’orchestra, in “La Repubblica”, 15 marzo 1979.
452
Lessico del cinema italiano
potere di casta, il Monsignore è espressione del potere ecclesiastico, sua Eccellenza il Presidente della Corte d’Appello è l’espressione del potere giudiziario e infine il Presidente della Banca Centrale rappresenta il potere economico. Non c’è, nel film di Pasolini, un personaggio che incarni specificamente il potere politico. E non c’è perché Salò o le 120 giornate di Sodoma suggerisce che il potere politico prende forma e si struttura non tanto nella convergenza sinergica dei quattro poteri precedenti quanto piuttosto nel rituale o nello spettacolo relazionale che i quattro potenti inscenano nella villa con l’aiuto delle loro vittime, ma anche dei collaborazionisti, dei servi e delle meretrici da bordello che fungono da narratrici. Più che una “dittatura sessuale” basata su una netta distinzione di ruoli fra chi ordina e chi esegue, fra carnefici e vittime, fra dominanti e dominati, Pasolini mette in scena un sistema in cui il potere nasce dalla compartecipazione al medesimo rituale del piacere e dell’orrore. Se per il Re Sole di Rossellini il potere nasceva dalla scelta di fare del sovrano il perenne oggetto scopico di tutta la corte e di tutti i sudditi, mentre nel modello panottico foucaultiano (o orwelliano)31 il potere è il soggetto scopico che dispone di un controllo visivo perenne (e non reciproco) sui sottoposti, Salò o le 120 giornate di Sodoma prospetta invece un modello in cui dominati e dominanti si guardano reciprocamente. Detta in altri termini: nel film di Rossellini Re Sole dice incessantemente ai sudditi «Guardatemi!», nel dispositivo panottico il potere dice al suddito «Attento, ti sto guardando, ti posso guardare sempre», in Salò invece i carnefici dicono alle vittime «Guardiamoci!». Vittime e carnefici, beninteso, non sono sullo stesso piano. Non si mescolano, non si confondono. Restano ben distinti. È essenziale – lo ha affermato con grande chiarezza Serge Daney – che nel dispositivo sadiano permanga una eterogeneità fondamentale: la logica su cui si basa la strategia dei Signori è quella di «esigere l’eterogeneità più violenta: montaggio fra l’alto e il basso, il nobile e il disgustoso, il giovane e 31
Come è noto Michel Foucault assume il panottico benthamiano come figura paradigmatica di un potere che non si cala più sulla società dall’alto, ma la pervade da dentro, nel saggio Sorvegliare e punire: la nascita della prigione, Einaudi, Torino 1976 [ed. or. Surveiller et punir, Gallimard, Paris 1975 ]. Il romanziere George Orwell ipotizza invece un controllo visivo perenne sui sottoposti da parte del “Grande Fratello” nel suo romanzo 1984, pubblicato nel 1949.
Potere Gianni Canova
453
il vecchio, ecc.»32. Ma è proprio il permanere di questa differenza, questa ribadita distinzione di ruoli, pur nella commistione prevista dallo spettacolo, che rende quasi inguardabile (per noi spettatori) il reciproco guardarsi di vittime e carnefici. La reciprocità scopica di Salò non è la reciprocità democratica, dove anche il cittadino comune può scegliere e decidere se guardare o no il soggetto che detiene il potere. A Salò, nella villa delle torture messa in scena da Pasolini, mentre dall’Antinferno si scivola progressivamente nel girone delle Manìe e poi in quello della Merda e infine in quello del Sangue, l’orrore sta nel fatto che le vittime sono obbligate a guardare ciò che i carnefici ordinano di fare affinché loro, i Signori, li possano guardare mentre guardano. Il “guardiamoci!” di Salò è meglio definibile quindi come: «Vi ordiniamo di guardare ciò che noi abbiamo deciso di farvi fare per potervi guardare mentre voi guardate quello che siete obbligati a fare con noi e per noi». Il dispositivo sadiano prevede il perfetto assorbimento del singolo corpo nel funzionamento della macchina rituale/spettacolare: ciò che avviene ad esempio nella Sala delle Orge della villa di Salò è una sorta di Sacra Rappresentazione alla rovescia, dove non si guarda, si partecipa. Ed è proprio nella perversione della partecipazione, nella coazione a partecipare, a far parte dello spettacolo, che il rituale pasoliniano mostra il climax dell’efferatezza e della crudeltà dei carnefici che guidano il gioco e lo orchestrano: essi deprivano i corpi di identità e di soggettività, li riducono a nudi organismi per la produzione di feci, urine, sangue, sperma e organi che vengono continuamente socializzati, spostati da un luogo all’altro, da un corpo all’altro, in un processo che mira a negare ai corpi partecipanti ogni possibilità di desiderio individuale. Adottando in modo lungimirante una prospettiva per certi versi biopolitica, Pasolini intuisce prima di tanti altri la più estrema ed atroce tra le forme del potere: quella che si esercita sulla “nuda vita”, e che annichilisce i corpi rinchiudendoli nello spazio opaco dello scambio.
32
S. Daney, Note sur Salò, in Id., La Rampe, Gallimard, Paris 1983, cit. in S. Murri, Pier Paolo Pasolini. Salò o le 120 giornate di Sodoma, Lindau, Torino 2001, p. 167.
454
Lessico del cinema italiano
2. Maschere del potere Il concerto a cui doveva partecipare con la moglie è saltato per uno sciopero del personale. La moglie gli ha fatto sapere che passerà la serata con le amiche. E lui, solo in auto, mentre l’autista lo accompagna a casa, scorre la rubrica del suo telefonino. Si ferma qualche istante su un paio di nomi, ma poi non fa partire la chiamata. «4000 contatti, nessun amico…», mormora fra sé e sé. E sconta, chiuso nell’abitacolo della sua auto blu, la congenita solitudine del potere. Il ministro - L’esercizio dello Stato (Schoeller, 2011) mette in scena il ritratto di un ministro del governo conservatore francese senza indulgere a nessuno dei registri a cui ricorre solitamente il cinema italiano: satira, caricatura, parodia, apologo. Qui il tono è piuttosto quello del dramma borghese: il ministro dei trasporti, interpretato da un efficacissimo Olivier Gourmet, fiuta gli umori, sonda le alleanze, verifica i rapporti di forza, pianifica le strategie, studia i processi di comunicazione. La regia di Pierre Schoeller mette in scena la quotidianità dell’esercizio del potere senza forzature. Il ministro Saint-Jean è un politico indistinto, come lo definisce la sua consigliera Pauline: fondamentalmente onesto ma senza appeal, capace ma incerto, freddo e poco comunicativo, poco efficace sul palcoscenico mediatico. E tuttavia non caricaturale. Non maschera. Non macchietta. Difficile trovare ritratti analoghi nel cinema italiano. La filmografia intorno al politico di professione conta un gruzzolo di titoli che ben rispecchiano il sentimento sostanzialmente negativo che il cinema italiano ha avuto ed ha del potere. Anche del potere democratico. Anzi: l’idea che il potere abbia a che fare con la democrazia è lontanissima dagli interessi degli autori del nostro cinema. 2.1 Da Giambattista Vico a Cinecittà: per una tipologia del politico italiano Fra le tre figure del potere che – nella lettura di Norberto Bobbio – Giambattista Vico associava alle diverse forme di governo (il dominio associato alla monarchia, la tutela associata all’aristocrazia
Potere Gianni Canova
455
e la libertà associata alla democrazia)33 il cinema italiano sembra intrigato dal rappresentare soprattutto se non esclusivamente le prime due. Non c’è, nel cinema italiano, una tradizione di racconto della democrazia paragonabile a quello che è riscontrabile nel cinema americano (da Mr Smith va a Washington, 1939, di Frank Capra, a Lincoln, 2012, di Steven Spielberg), o nel cinema inglese (da The Queen-La regina, 2006, di Stephen Frears, a The Iron Lady, 2011, di Phyllida Lloyd) o ancora, appunto, nel cinema francese (non solo il già citato Il ministro-L’esercizio dello Stato ma anche il notevolissimo Le passeggiate al Campo di Marte, 2005, di Robert Guédiguian, intenso e partecipe ritratto del presidente socialista François Mitterand, interpretato da Michel Bouquet, nei suoi ultimi mesi di vita e, appunto, di potere). Ma nel nostro cinema non ci sono tracce neanche di raffigurazioni del potere che rinviino alle oscure figure metaforiche del cinema espressionista tedesco (Il gabinetto del dottor Caligari, 1920, di Robert Wiene, o Il dottor Mabuse, 1922, di Fritz Lang), o all’epos di kolossal come Napoleone (1927) di Abel Gance o Ivan il terribile (1945) di Sergej Ejzenštejn o Tre canti su Lenin (1934) di Dziga Vertov, ma neppure – se vogliamo richiamare un riferimento precinematografico – a un’icona fondamentale come il Leviatano di Hobbes, in cui – come è noto – lo Stato è rappresentato simbolicamente come grande corpo le cui membra sono i singoli cittadini34. Se si eccettuano le anarchiche irruzioni “cubiste” di Totò nei confronti dei politici di professione (basta pensare alle capriole verbali, ai calembours, e alla satira feroce dell’onorevole Trombetta nell’episodio del wagon-lit in Totò a colori, 1952, di Steno) o la bonaria rappresentazione di un potere che nasce dal basso e che resta contiguo al “mondo piccolo” che l’ha generato nella saga guareschiana di “Don Camillo e Peppone”, 33 34
Cfr. N. Bobbio, Vico e la teoria delle forme di governo, Bibliopolis, Napoli 1978. T. Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil, 1651. Non è inutile ricordare, sul piano iconografico, che la copertina originale del Trattato di Hobbes raffigurava il Leviatano come un gigante con in mano una spada, simbolo del potere temporale, e un pastorale, simbolo del potere religioso, ma soprattutto con addosso un vestito formato da altrettanti sudditi-cittadini, a significare che l’autorità dello Stato è pari alla porzione di libertà individuale che ognuno gli delega, con la rinunzia – per vivere in pace – a esercitare i corrispondenti diritti collegati a tale libertà.
456
Lessico del cinema italiano
nella tradizione del cinema italiano prevale «il racconto della politica come deformità morale»35. Non solo: l’idea della politica come “visione” e come energia ideale, come azione al servizio di un più alto interesse collettivo, è di fatto assente. Ha scritto bene Luisella Farinotti: Non abbiamo a che fare con la politica come “idea di mondo”, “arte della cosa pubblica” o modello di interpretazione dell’accadere, ma con la politica come mestiere, pratica di vendita, comunicazione e promozione di un’immagine, incarnazione di una casse impegnata nella gestione di un potere e di un privilegio. Il politico – un politico quale che sia, in fondo sono tutti uguali… – è preoccupato non della cosa pubblica, ma del mantenimento della propria posizione e degli indubbi vantaggi che il far parte della casta gli garantisce36.
Per questo l’uomo di potere è raffigurato con una maschera di volta in volta ridicola, antipatica o grottesca. Nelle pagine che seguono proviamo a tracciare le linee-base per una possibile “mappa tipologica” del politico di professione e dell’uomo di potere così come sono raffigurati nel cinema italiano. 2.1.1 L’affarista cinico Il film che meglio di ogni altro rappresenta il punto di vista fortemente critico del cinema italiano sui politici di professione e sulla loro visione del potere è molto probabilmente Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi. Lo è perché non si limita al ritratto grottesco e/o caricaturale di un singolo esponente del potere, ma perché cerca piuttosto di mettere in scena un sistema, colto con ricchezza di sfumature in tutti i ruoli e gli snodi che presiedono al suo funzionamento. Scritto da Rosi in collaborazione con Raffaele La Capria e ambientato in un’imprecisata città del Sud che è in realtà una riconoscibilissima Napoli, con i suoi palazzoni-alveari aggrappati sulle pendici del Vesuvio e con i suoi condomini costruiti su piloni appoggiati dentro scarpate che sembrano sul punto di franare da un momento all’altro, il film mette in scena i politici del 35 36
L. Farinotti, Lo specchio infranto: il disarmo della politica come professione, in “Comunicazione Politica”, n. 2 (2013), p. 284. Ibidem.
Potere Gianni Canova
457
consiglio comunale cittadino impegnati nella campagna elettorale, ma anche e soprattutto nella difesa dei loro interessi speculativi. Nella scena iniziale, l’immobiliarista e assessore Edoardo Nottola (Rod Steiger) traccia con un bastone di legno la figura di un metro quadrato su un terreno incolto, spiegando ai suoi interlocutori come ottenere da quel medesimo metro quadro il 5000% di profitto. Poi, invitando a guardare verso la città che cresce, espone la sua filosofia: «Quello è l’oro! Tutto guadagno e nessun rischio». Nottola è l’esponente paradigmatico dell’uomo di potere nel cinema italiano: devoto e religioso (lo vediamo entrare in chiesa, fare il segno della croce e inginocchiarsi davanti alla cappella della Madonna), è però cinico, spietato e feroce negli affari («In politica si è amici o nemici fino a quando fa comodo») e attentissimo alla gestione della sua immagine (quando vede una fotografia del suo volto scattata con il flash, si infuria e la butta via stizzito «Me fanno ‘na faccia chiatta come Mussolini…!»). Non esita a indurre il figlio a costituirsi e ad assumersi la responsabilità del crollo di un palazzo in vicolo Sant’Andrea perché la cosa finisca sui giornali e consenta a lui di uscire pulito dall’inchiesta in corso e di essere rieletto in consiglio comunale. Il fine ultimo per un uomo di potere come lui è la conservazione e la perpetuazione del proprio potere. 2.1.2 Il corrotto corruttore Entra in scena di spalle, mentre un medico gli prova la pressione. «Non ho mai letto un libro intero in vita mia», è una delle prime cose che dice di sé. Cesare Botero (Nanni Moretti), protagonista del film di Daniele Luchetti Il portaborse (1991), è il più giovane ministro in carica della Repubblica italiana. Non legge, ma leggiucchia i risvolti di copertina, le prefazioni, le introduzioni. Quanto basta per dare l’idea di esser colto e informato. Per mettersi in scena. Arrivista, ambizioso, dichiaratamente cinico, concepisce l’esercizio del potere come forma primaria di distribuzione di favori: non a caso, passa il suo tempo a esaudire richieste, accogliere raccomandazioni, fornire permessi, concedere trasferimenti, far firmare autorizzazioni. Disprezza «le anime belle, le figurine del presepe, le persone oneste»: quel sottoinsieme sociale di moralisti incorruttibili che secondo lui frena lo sviluppo e la crescita del Pa-
458
Lessico del cinema italiano
ese. Lo dice anche, con ruvida esplicitezza: «Io preferisco uomini brillanti ed estrosi anche se un po’ mascalzoni, ad uomini grigi, noiosi ma onesti». Maschera neanche troppo nascosta del ceto politico rampante e aggressivo che reggeva l’Italia nella stagione craxiana immediatamente precedente al crollo di Tangentopoli, il Botero di Moretti sfugge al destino caricaturale con cui spesso il cinema italiano ha rappresentato i politici di professione, ed ostenta anzi anche un certo carisma nella capacità che ha di mettersi sempre in vista, di attrarre su di sé lo sguardo, di esercitare fascino su chi entra in contatto con lui. Il suo “portaborse”, l’insegnante di lettere in un liceo del Sud Luciano Sandulli (Silvio Orlando), non a caso ne è affascinato: gode del privilegio di essere nel suo “cerchio magico”, di approfittare dei suoi favori, di contribuire alla creazione del suo mito. Non è vero che il film si basa su una visione dicotomica e manichea del potere: da una parte il cinismo di Botero, dall’altra l’incolpevole ingenuità di Sandulli. Il pregio del film sta caso mai nel mostrare come Botero sia quello che è anche grazie al modo in cui Sandulli lo costruisce, gli scrive le battute, gli suggerisce tecniche e strategie di comunicazione. Una delle più efficaci e mordaci battute di Botero («Io sono come le giraffe. Guardo bene le cose lontane, ma fatico a guardare in basso») in realtà è un’invenzione di Sandulli. Come dire: il potere si costruisce anche col contributo di chi il potere non ce l’ha. Botero è quello che è grazie a chi gli consente di essere come è. I suoi elettori. I suoi beneficati. I suoi consiglieri. Non ci sono corruttori da una parte e onesti innocenti dall’altra. Nel gioco delle parti corrotti e corruttori si sovrappongono, e coabitano. Quando il moralista Sandulli distrugge nel finale l’automobile rossa che Botero gli ha regalato come prezzo della sua complicità, in realtà si accanisce in maniera autopunitiva su quella parte di sé che è stata ed è connivente col potere, e che lo ha legittimato. Che gli ha dato volto, sostanza e identità. Botero, non a caso, ha un sogno ricorrente: si guarda allo specchio e nello specchio non c’è niente. Il dettaglio è illuminante: perché non solo suggerisce la paura (la consapevolezza?) della perdita di identità dell’uomo di potere, ma perché ribadisce una volta di più come siano sempre gli altri – i cittadini, i sudditi, gli elettori – a conferire al potere il suo vero volto e la sua vera sostanza.
Potere Gianni Canova
459
2.1.3 L’astuto naïf Il modello, in questo caso, è quello del Candide voltairiano: l’ingenuo, il naïf, il semplice, che proprio in virtù del suo sguardo privo di incrostazioni ideologiche, di pregiudizi o di preconcetti, riesce a vedere la realtà molto meglio di chi le si avvicina appesantito da ingombranti armature teorico-concettuali. Il cinema ha spesso utilizzato questo modello come calco o matrice per plasmare personaggi politici portatori di un’altra verità: si pensi anche solo – per limitarci agli esempi più noti e famosi – a Chance il giardiniere, che in Oltre il giardino (1979) di Hal Ashby, diventa presidente degli Stati Uniti, o al già citato Mr Smith va a Washington di Frank Capra. Il cinema italiano ha fatto ricorso a questo prototipo soprattutto in anni relativamente recenti e con l’intento di fare del naïf, o dell’idiot savant, il contraltare del politico di professione: quanto quest’ultimo appare come incapace, inaffidabile e corrotto, tanto invece il “candido” è portatore di uno sguardo nuovo e rivelatore, che aiuta tutto il sistema a vedersi meglio e a rinnovarsi. Almeno tre film italiani recenti riesumano e rivisitano questo modello: Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani, Viva la libertà di Roberto Andò e Viva l’Italia di Massimiliano Bruno. Si tratta di tre film che prendono atto dello scacco della politica trasformata in mera tecnica di conquista e conservazione del potere: niente più idealità, valori, battaglie civili, solo una sordida, cinica ed egoistica cura del proprio “particulare”. In contrapposizione con la senile calliditas dei politici di professione, questi tre film disegnano figurine di ingenui che – proprio per la loro inconsapevolezza – sembrano gli unici in grado di ridare al potere una parvenza di credibilità e di verginità. Il più naïf di tutti è il protagonista di Benevenuto Presidente!: ex-bibliotecario di professione, pescatore dilettante, per errore viene eletto Presidente della Repubblica italiana ed è chiamato a Roma per svolgere il ruolo e i compiti istituzionali assegnatigli dalla Costituzione. È in tutta evidenza inadeguato al ruolo, ignora totalmente le regole più elementari del protocollo e del cerimoniale, è di un’ingenuità disarmante. E tuttavia proprio queste “mancanze” rispetto alla figura consolidata del politico di professione fanno di lui – forse perfino suo malgrado – il candidato ideale per “ripulire” le istituzioni dalle incrostazioni che le hanno ingessate e rese lontane dai cittadini. Destinato
460
Lessico del cinema italiano
fin dal nome (Giuseppe Garibaldi) a una funzione di potere (nomen omen?), applicando al ruolo il sapere pragmatico del pescatore e lo slancio idealista del bibliotecario, il nostro riesce a ridare carisma all’istituzione che rappresenta, e a rilanciare e rinvigorire l’immagine del politico che egli stesso – forse anche in virtù di una «predisposizione genetica alla guida della patria, ereditata da avi sconosciuti»37 – si è trovato alla fine ad incarnare. Negli altri due titoli citati la sostituzione del professionista della politica con un suo surrogato ingenuo ma credibile si articola attraverso il ricorso alla figura del doppio: in Viva l’Italia un deputato ipocrita, corrotto e opportunista, colto da un colpo apoplettico durante l’incontro con una escort, si ritrova all’improvviso incapace di mentire e inizia – nel crescente imbarazzo del suo partito – a smontare di fronte all’opinione pubblica quel teatrino della politica di cui egli stesso era stato uno dei principali interpreti ed autori. In Viva la libertà, invece, dopo che il Segretario del principale partito d’opposizione è volutamente scomparso, preoccupato dai risultati dei sondaggi e fiaccato da una quotidianità ormai vuota di senso, è l’intervento surrogatorio del suo fratello gemello – identico a lui fisicamente, ma opposto a lui sul piano etico ed esistenziale – che consente al suo partito di ritrovare un leader dotato di carisma, energia persuasiva e credibilità. Di auctoritas, non solo di potestas. Il film di Andò è molto lucido nel delineare un quadro in cui la politica è vista come gioco illusorio di false identità, e in cui è il falso leader che riesce a conferire verità al leader vero, che però è percepito come finto ed inautentico: quasi a dire che l’essenza del potere è la maschera, la finzione, e che chi lo esercita rappresenta sempre qualcosa che è altro da sé, ed è come se nascondesse in sé un estraneo. Ma questa suggestiva intuizione della politica come costante impostura, e come perenne invenzione della realtà, si scontra con quello che è il limite di tutti e tre i film chiamati in causa in questo paragrafo: l’idea che l’auctoritas (il potere che accresce e accoglie) sia possibile solo in un contesto di marcato irrazionalismo; è solo nello sragionamento, nell’inconsapevolezza, nell’istintualità, che il potere sembra dimenticare la sua natura predatoria. Quando invece agisce sotto il dominio della ratio (e del 37
M. Buratti, Percorsi di formazione (e di resistenza) alla politica, in “Comunicazione politica”, n. 2 (2013), p. 290.
Potere Gianni Canova
461
calcolo), il politico sembra non poter avere altro destino che quello della prevaricazione e della menzogna. 2.1.4 Il mellifluo untuoso Appare per la prima volta con la corona del Rosario fra le dita. Quando scende dall’auto di rappresentanza e si dirige verso l’eremo di Zafer per gli annuali esercizi spirituali, cammina col capo leggermente reclinato in avanti e con le spalle appena appena curve: quasi a suggerire (a ostentare?) umiltà, spirito di servizio, rassegnazione. Ma anche la fatica di chi deve portare ogni giorno il peso della propria croce. Le mani giunte, l’abitudine di sussurrare frasi e parole all’orecchio dell’interlocutore, il politico interpretato da Gian Maria Volonté in Todo modo (1976) di Elio Petri è mellifluo, sfuggevole, untuoso, ossessionato dall’idea di essere spiato. Costruito da Volonté a immagine e somiglianza di Aldo Moro, in un’interpretazione che è forse uno dei capolavori dell’arte mimetica dell’attore, è abilissimo nel non prendere decisioni, nell’evitare azioni, nel cercare sempre e comunque mediazioni: un antieroe dell’atto mancato, un virtuoso del rinvio, un campione della dissimulazione. Masochista sfrontato, si eccita recitando con la moglie Giacinta (Mariangela Melato) il Pater Noster «nella versione ignaziana» (con un lungo sospiro fra una parola e l’altra) e trova nella preghiera il viatico più immediato per innescare il desiderio sessuale (il verbo che si fa carne?). I suoi colleghi, legati l’uno all’altro in una fitta rete di complicità, connivenze e interessi lo detestano a parole ma lo ossequiano nei fatti, in un rituale di sottomissione gerarchica che ben rende l’idea dell’ipocrisia del potere che assume a poco a poco connotati apocalittici. Gli esercizi spirituali celebrati da Don Gaetano (un insolito, vigoroso e determinato Marcello Mastroianni) si trasformano infatti a poco a poco in una sorta di atroce cupio dissolvi: un suicidio collettivo dei potenti e del potere che sfocia nell’immagine dantesca dei mucchi di cadaveri ammassati all’esterno dell’Eremo, quasi a significare – nei toni aspri di una dolente invettiva – l’inevitabile fine di un’intera classe dirigente38. Anche il Presidente, alla fine, si fa uccidere dal suo segretario 38
Ha scritto acutamente Maurizio Grande: «Il film è un annuncio ed è una profezia: annuncia la rovina della Democrazia Cristiana e profetizza la sua
462
Lessico del cinema italiano
(Franco Citti). Esce di campo dal bordo inferiore dell’inquadratura e il portaborse impugna la pistola e spara nella direzione in cui egli presumibilmente si è accasciato. Ma l’inquadratura è vuota, e la pistola è puntata esattamente verso di noi. È a noi che spara, il portaborse del Presidente. Don Gaetano, del resto, poco prima gli aveva ricordato proprio la sua evidente contiguità (la sua somiglianza) con i suoi elettori. «Sei cinico e feroce come loro», gli aveva detto. Forse è per questo che sparando a lui il segretario in realtà spara a noi. È la più dura chiamata di correo che mai abbia prodotto il cinema italiano. Fra tanti film che assolvono il ruolo di chi li guarda, Todo modo è uno dei pochi che ricorda come il potere, in una democrazia, sia nelle mani del popolo. E come il popolo – cioè noi tutti – siamo responsabili del potere che produciamo. E dei suoi peccati. 2.1.5 L’insabbiatore mimetico Fa colazione in convento. Gliela serve un diacono, in una cella spoglia. Il clima è di sobrietà e austerità. L’onorevole interpretato da Ugo Tognazzi in uno degli episodi più celebri di I mostri (1963) di Dino Risi è un campione del mimetismo. Quasi uno Zelig ante-litteram: un individuo “senza qualità” se non quella di sapersi assimilare a chi gli sta accanto, o adeguare al contesto in cui si trova. Quando sta in convento si dà arie pie e devote, chiama con premura la moglie di prima mattina, la prega di salutare per lui gli 8 figli che ha messo al mondo (alcuni con nomi di battesimo spudoratamente democristiani: Alcide, Amintore, Aldo…). Poi recita a memoria alcuni versi di Dante («Guido io vorrei che tu e Lapo e io/ fussimo presi per incantamento»). Quindi inizia la sua attività: alla cerimonia dei bersaglieri indossa il cappello piumato tipico dell’Arma, a pranzo con una signora tira fuori tutte le sue capacità di galanteria. Si adatta. Si adegua. Fa in modo che coloro che incontra lo sentano vicino, simile, premuroso. distruzione attribuendola a Aldo Moro. La risposta della “politica” italiana è la rimozione di quell’annuncio e il ribaltamento di quella profezia: rinsaldare il potere e uccidere Moro prima che egli uccida gli altri, prima che trascini il partito nel bagno di sangue sacrificale, nella tomba della Storia, nel silenzio dei dimenticati». Cfr. Id., Eros e politica. Sul cinema di Bellocchio Ferreri Petri P. e V. Taviani, Protagon, Siena 1995, pp. 77-78.
Potere Gianni Canova
463
Nel suo ufficio lo aspetta un generale che porta con sé le prove di una colossale speculazione edilizia in cui anche il nostro sarebbe coinvolto. L’onorevole sa bene di cosa si tratta e prende tempo, ritarda, attende, temporeggia. Così, dissipandosi in decine di attività senza alcuna oggettiva utilità, alla fine evita di fare l’unica cosa che in quella giornata avrebbe avuto senso: l’esame di carte processuali che avrebbero impedito un colossale imbroglio ai danni della cosa pubblica. Ma in questo consiste la sua specialità: nell’insabbiare. Nel lasciar decadere. Nell’usare tuto ciò che è possibile – compreso il fattore tempo – per evitare che le malefatte del potere vengano scoperte. Così, dietro la sua maschera di devota rispettabilità, si nasconde una delle qualità precipue del potere nella rappresentazione che ne dà il cinema italiano: la capacità di farla franca, sempre e comunque. A suo modo, è anch’essa un’arte. Forse, la variante più vistosa della nostra proverbiale “arte di arrangiarsi”. 2.1.6 Il pharmakon grottesco Il registro prevalente utilizzato dal cinema italiano per mettere in scena l’uomo di potere è tuttavia quello grottesco-caricaturale. Ad esso rinviano non solo alcune figurine minori del cinema di Fellini (i gerarchi di Amarcord, 1973, il sindaco di La voce della luna, 1990), ma anche veri e propri protagonisti, come il deputato di estrema destra che fa le pernacchie alla Camera e sogna il golpe autoritario come possibile risarcimento o riscatto delle proprie inconfessabili frustrazioni personali in Vogliamo i colonnelli (1973) di Mario Monicelli, o anche il tronfio protagonista di Il federale (1961) di Luciano Salce, fascistello che riesce a diventare gerarca proprio quando il fascismo sta per cadere. L’esito estremo a cui perviene la tendenza all’esasperazione grottesca nella rappresentazione dell’uomo di potere è costituito tuttavia, senza ombra di dubbio, dal personaggio di Cetto La Qualunque, inventato e interpretato da Antonio Albanese nei due film diretti da Giulio Manfredonia Qualunquemente (2011) e Tutto tutto niente niente (2012). Nel suo gioco di eccessi – spudorati già a partire dal look, con i lunghi capelli lisci, i finti gessati, la paccottiglia spavaldamente esibita – Cetto è l’approdo finale di un processo di abbassamento e desacralizzazione che trasforma il politico in fantoccio. Ma si può ancora parlare di “grottesco”, di fronte a un perso-
464
Lessico del cinema italiano
naggio come Cetto? Se è vero che il “grottesco” è l’estetica del raccapriccio che si genera dalla coabitazione del comico con il tragico, allora – non c’è dubbio – il personaggio di Cetto è raccapricciante. Ma lo è al ribasso. Non al rialzo. Il “grottesco” in genere esaspera, amplifica. L’iperbole (l’esagerazione) è la sua figura prediletta. In Cetto no. Quello di Cetto è un grottesco attenuato: un grottesco che non riesce mai non solo a eccedere ma neppure a eguagliare i propri modelli reali. Per quanto Albanese faccia del personaggio un concentrato di razzismo, sessismo, omofobia, corruzione e volgarità, per quanto esasperi il suo elogio dell’abuso e della prevaricazione come unici comportamenti possibili in un territorio ormai del tutto privo di legalità39, Cetto resta comunque lontano dai modelli da cui trae ispirazione. Sono loro che lo eccedono, non il contrario. Quasi a dire – a confessare? – l’impotenza della finzione di fronte al compito di rappresentare – nel raccapriccio tragicomico dell’Italia di oggi – la cosiddetta “realtà”. Perché qui sta il punto. Cetto La Qualunque non è reale. È un personaggio di finzione. Eppure, basta fare un rapido giro in web per trovare centinaia e centinaia di suoi fans reali. Fans che lo invitano a presentarsi veramente («propositamente, senzadubbiamente, tralaltramente, tostamente») alle elezioni. Nel 2011, nei giorni di poco precedenti all’uscita di Qualunquemente, giravano sondaggi, su Internet, che lo accreditavano di un potenziale elettorale di poco sopra al 3%. Più di quello che era allora il partito di Francesco Rutelli. Più di Ferrero e Rifondazione comunista. Solo che Rutelli e Ferrero erano e sono reali, Cetto no. Cetto non lo è. O no? Se fosse invece Cetto a incarnare la residua realtà di un immaginario collassato dentro il gossip e la cronaca, laddove le figure del cosiddetto reale talora parrebbero non essere che gli avatar di un’infinita e irresolubile rappresentazione rituale? Di un’opera buffa con ripetuti slittamenti verso la farsa e la pochade? Trasferito dal teatro e dalla Tv sul grande schermo, il personaggio di Albanese ha quanto meno il merito di obbligarci a riflettere su quello che è uno dei grandi nodi politici irrisolti dell’Italia di oggi: il processo di progressiva sovrapposizione e confusione fra reale e finzionale. Vedi nel film la casa di Cetto, gonfia e tronfia di busti di imperatori 39
Cfr. C. Grizzaffi, Comici politici, politici comici, in “Comunicazione Politica”, n. 1 (2013), p. 167.
Potere Gianni Canova
465
romani, e di statue di giaguari, e di architetture neofaraoniche, e di vasche da bagno dorate, e di capitelli corinzi, e di gigantografie del padrone di casa, e pensi che il tutto sia un eccesso iperrealista dello scenografo, forse in cerca del paradigma del kitsch. Poi però leggi sul pressbook che quella casa non è stata costruita negli studi di Cinecittà, ma esiste davvero, nei pressi di Roma, ed è la residenza “autentica” di italiani “reali”, e lo scenografo del film caso mai l’ha svuotata e alleggerita rispetto alla bulimia oggettuale dell’originale. Cos’è allora il reale? E dov’è? Nella sua opulenza cafona, Cetto La Qualunque non è solo un monumento alla volgarità italiana. È un pharmakon, o un parafulmine. Scarichiamo su di lui tutta la negatività che ci insidia e ci assedia. Ce ne liberiamo. Forse, nel vuoto sospeso del raccapriccio che ci si insinua sotto la pelle, quando ridiamo compiamo un esorcismo. E ci assolviamo dal timore di essere anche noi come lui. 2.1.7 Il fantoccio ridicolo Per una sorta di perverso e involontario paradosso, il film italiano che più di tutti inscena il grande spettacolo del potere, il suo “ballo in maschera” più irresistibile ed esilarante, e lo fa usando come protagonisti e comprimari proprio quegli uomini politici che il potere lo hanno detenuto e incarnato dal dopoguerra agli anni settanta, si intitola esattamente come il movimento politico che ha poi governato il paese a cavallo tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio. Forza Italia! di Roberto Faenza non è solo il prototipo di molte successive operazioni di found footage nel cinema italiano, ma è anche un ambizioso progetto di risemantizzazione delle immagini delle cronache televisive attraverso la forza della narrazione e soprattutto del montaggio cinematografico. «Nel nostro film – ha scritto Roberto Faenza – la vita del “palazzo”, per usare un’espressione cara a Pasolini, veniva svelata in quanto rappresentazione antropologica con le sue cerimonie e i suoi riti, le dichiarazioni e i programmi, i comizi e le tribune, gli spettacoli di massa e l’ossequio ai messaggi pastorali»40. L’effetto, come sottolinea lo stesso Faenza, è assolu40
R. Faenza, Forza Italia! Il ritratto più divertente, spietato e censurato della Prima Repubblica, Rizzoli, Milano 2006, p. 31.
466
Lessico del cinema italiano
tamente ridicolo: «Quando lo schermo si riempì delle immagini di una parata militare e apparve il Presidente della Repubblica Giovanni Leone che canticchiava masticando una caramella, partì un secondo applauso che si trasformò in boato allorché le dita del Presidente si strinsero a mo’ di corna per rispondere ai fischi della folla. Andò avanti così, tra applausi scroscianti e risate prolungate, per l’intera proiezione»41. Reso visibile, il potere è ridicolo. Lo sottolineano tutte le recensioni d’epoca, che parlano di satira e di humour nero. C’è chi tira in ballo perfino Lucilio e Giovenale come numi tutelari ispiratori dell’operazione. L’unico che avanza qualche riserva circa l’efficacia della tattica della derisione è Tullio Kezich: «Per quanto riguarda il dileggio abbiamo qualche dubbio sulla validità dell’operazione. La tecnica non è nuova: si prendono degli spezzoni d’attualità e si doppiano con voci che recitano sciocchezze»42. È un’osservazione che merita di essere meditata: preso come coraggiosa provocazione, e colpito perfino dalla censura, in realtà anche il film di montaggio realizzato da Roberto Faenza non fa che applicare ai politici quelle categorie della derisione e dello scherno che sono da sempre al centro dell’atavica propensione degli italiani a ridere di tutto e di tutti, e a risolvere tensioni e conflitti nella raillerie e nel persiflage, nello schermo perenne, nello sberleffo e nello scaracchio, che alla fine tutto assolve e tutto dimentica, e rende tollerabile o tollerato nella realtà quel medesimo potere che viene carnevalescamente irriso nello spazio dello spettacolo e della finzione. Trasformato suo malgrado in un fantoccio, come messo in mutande, l’uomo di potere diventa “altro” rispetto alle tradizionali categorie a cui il politico dovrebbe render conto. Il politico-fantoccio – per dirla con Max Weber – non risponde più né all’etica dei principi (quella che induce ad agire secondo ciò che il politico ritiene giusto) né all’etica della responsabilità (quella che induce a interrogarsi preventivamente sulle conseguenze delle proprie azioni e decisioni)43, ma risponde solo a una logica di depurazio41 42 43
Ivi, p. 36. T. Kezich, Quando telefona il signor ministro è tanto vero che sembra inventato, in “la Repubblica”, 13 gennaio 1978. Cfr. M. Weber, La politica come professione, Mondadori, Milano 2009 [ed. or. Politik als Beruf: zweiter Vortrag, Duncker & Humblot, Munchen und Leipzig 1919].
Potere Gianni Canova
467
ne sociale. Grazie a lui, e alle risate che suscita, la società scarica tensioni e frustrazioni. Da un film come Forza Italia! alla satira televisiva del nuovo millennio, un filone importante della cultura italiana si è ostinata a fare dell’uomo di potere, al tempo stesso, un mostro e un pagliaccio. Col risultato paradossale di assolverlo: perché il mostro annulla il pagliaccio, e il pagliaccio neutralizza il mostro. L’annullamento reciproco è risultato evidente con il trattamento mediatico dell’immagine di Berlusconi. Ha scritto lucidamente Francesco Piccolo: «Nessuno lo ha mai considerato un vero mostro, perché il disprezzo e la derisione ne abbassavano i connotati, neutralizzavano il senso della tragedia, lavoravano per renderlo poco credibile»44. E ancora: «Il sarcasmo è stato l’elemento distruttivo dell’energia politica oppositiva. È penetrato quotidianamente dentro le anime e le bocche delle persone, ne ha distorto il viso, lo ha modificato, loro credendo a proprio vantaggio, e invece a loro svantaggio, e a svantaggio della comunità. E ha ottenuto un effetto devastante: ha prima disinnescato la tragedia e poi ha reso sopportabile il dominio»45. Francesco Piccolo parla di Berlusconi, ma la sua riflessione può essere agevolmente estesa a tutti gli uomini di potere dell’Italia repubblicana. Resi ridicoli, sono diventati tollerabili. Che il cinema – portato a ridere di ciò che non sapeva altrimenti come rappresentare – abbia contribuito a rendere sopportabile l’intollerabile? 3. Patologie del potere In società e culture caratterizzate da un rapporto con il tragico più solido e meno esorcistico di quanto non accada in Italia la principale e più diffusa patologia del potere è senza dubbio la hybris. Nelle tragedie greche con questo termine si indica il “peccato” commesso dall’uomo che non sa riconoscere i suoi limiti e si sente uguale o superiore agli dei, ignora le loro leggi e alla fine vede punito il suo orgoglio attraverso la cosiddetta “nemesi”. Per estensione, la hybris indica tutti quei comportamenti legati all’esercizio del potere che esprimono sovrastima di sé, arroganza, narcisismo, 44 45
F. Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, Einaudi, Torino 2013, p. 198. Ivi, p. 200.
468
Lessico del cinema italiano
prepotenza e presunzione di onnipotenza46. Il cinema italiano ha dato forma solo occasionalmente alla forma tragica di questa patologia del potere47: non ci sono, nel cinema italiano, personaggi di potere paragonabili a certi grandi archetipi shakespeariani come Re Lear o Riccardo III. Ci sono piuttosto viscidi e melliflui tessitori di compromessi, esperti nell’arte della corruzione, nell’impiego delle istituzioni in funzione nepotistica e familistica, nell’utilizzo privatistico di risorse pubbliche, nel clientelismo e nell’opportunismo, e poi – soprattutto – abilissimi nella tecnica della perpetuazione del loro ruolo e dei loro privilegi. In questo quadro, le patologie più diffuse – e per molti versi croniche – nella rappresentazione del potere fornita dal cinema italiano riguardano quelle pratiche e quei comportamenti che hanno come obiettivo non tanto la conquista del potere (nel cinema italiano non lo si conquista quasi mai, lo si ha già da sempre) quanto il suo mantenimento, il suo accrescimento e la sua conservazione. Figure chiave di questa sintomatologia patologica sono allora il tradimento e il trasformismo, accanto all’arbitrio e alla presunzione di impunibilità. 3.1 Il trasformismo e il tradimento «Libertà è una parola che non significa niente, ma accontenta tutti. Quando comandava il Re noi eravamo amici del Re, ora che governano i pezzenti bisogna essere amici dei pezzenti». Queste parole, pronunciate dal principe Giacomo in I viceré (2007) di Roberto Faenza, liberamente tratto dal capolavoro di Federico De Roberto, ben sintetizzano la fisiologica vocazione trasformistica delle classi dirigenti italiane e la loro disinvolta capacità di operare anche i più acrobatici voltagabbana pur di conservare privilegi, status e potere in una chiave di cinico opportunismo. Lo ribadisce con 46 47
Su questi temi si veda almeno H. Freeman, Le malattie del potere, Garzanti, Milano 1994 [ed. or. The Human Brain and Political Behaviour, in “British Journal of Psychiatry”, n. 159 (1991)]. Tra le parziali eccezioni, vanno ricordati almeno Luna rossa (2001) di Antonio Capuano, e Gomorra – la serie (2014), che riescono a raccontare mafia e camorra secondo i modi e le forme della tragedia greca. Ma sono eccezioni relativamente recenti rispetto a una tradizione che ha sempre mostrato disagio di fronte ai canoni del tragico.
Potere Gianni Canova
469
sfacciata chiarezza sempre il personaggio di Faenza, parafrasando e storpiando il celebre motto patriottico di Massimo D’Azeglio: «Libertà significa anche che ora che l’Italia è fatta noi dobbiamo farci gli affari nostri». Nel racconto di Faenza, l’epopea degli Uzeda – il nobile casato catanese protagonista del film – delinea una parabola per molti versi esemplare: per tutta la seconda metà del secolo XIX, dal 1853 sino alla fine dell’Ottocento, gli Uzeda riescono ad attraversare tutti i cambiamenti politici e sociali – dallo sbarco dei Mille alla nascita del Regno d’Italia – rimanendo sempre uguali a se stessi, riuscendo cioè a conservare – anche nel nuovo stato liberale di cui si fanno presto entusiasti sostenitori – i privilegi e il potere che avevano da reazionari sostenitori del regno borbonico. Dilaniati all’interno da atroci contrasti, da rancori insanabili e da odi viscerali, sono tuttavia uniti nella prepotenza, nell’arroganza, nella propensione al dominio. Pur di conservare il potere sono disposti alle peggiori macchinazioni (come quella ordita da Giacomo per privare il fratello Raimondo della legittima eredità), sempre pronti comunque a riposizionarsi a fianco del vincitore, chiunque esso sia. Con un comportamento che diventa in qualche modo l’emblema della più spudorata sfacciataggine del potere. Tradimento e trasformismo come chiavi di lettura della storia italiana erano del resto già state esplorate in modo lucido e lungimirante da Luchino Visconti almeno in due film: Senso (1954) e Il gattopardo (1963). In Senso, al di là delle numerose interpretazioni che hanno voluto vedere nel film una lettura gramsciana del Risorgimento come «rivoluzione mancata» o «tradita»48, è proprio il tema del tradimento – in tutte le sue possibili e sorprendenti declinazioni – a fare da propulsore drammaturgico della sceneggiatura firmata da Suso Cecchi D’Amico: la contessa Livia Serpieri tradisce la causa risorgimentale (e la fiducia del cugino Ussoni) lasciandosi trascinare da una «fosca passione per un amorale ufficiale austriaco»49, Franz Mahler, il quale a sua volta la tradisce sul piano erotico-sentimentale. Lei lo ripaga con un ulteriore tradimento e con una delazione che lo porta dritto davanti al plotone d’esecuzione. Il tradimento politico si mescola e si confonde con il tradimento 48 49
L. Micciché, Luchino Visconti. Un profilo critico, Marsilio, Venezia 1996, p. 29. Ibidem.
470
Lessico del cinema italiano
sentimentale e sessuale, in un groviglio indissolubile che ben esprime quella dilatazione dei sentimenti, dei gesti e degli atteggiamenti su cui lo stesso Visconti ambiva a radicare l’impianto melodrammatico del film. Né Livia né il torbido e dissoluto ufficiale austriaco incarnano, è vero, figure di potere: e tuttavia sono – l’una e l’altro, a diverso titolo – figure partecipi del potere (lei per nascita nobiliare, lui per collocazione gerarchica nell’esercito asburgico). Sono entrambi parte dell’élite. E proprio questa loro collocazione sociale enfatizza la gravità del loro tradimento: che non è limitato – nella denuncia viscontiana – alla corruzione o all’inadeguatezza di un re, di un generale o di un leader, ma è capillarmente diffuso nel corpo sociale e coinvolge in modo reticolare le figure più disparate della classe dirigente, incapace di assumersi le proprie responsabilità (e di onorarle) di fronte al popolo e di fronte alla Storia. Ha opportunamente sottolineato Giorgio Tinazzi come il tema del tradimento nel film si mescoli con la presenza del denaro, «complice e corruttore», protagonista della scena madre principale, quella ambientata a Verona50. Se è vero che – come ha osservato Tomaso Subini – la Livia del Boito dava all’amante del denaro suo, mentre la Livia di Visconti tradisce la Patria consegnando a Franz lo scrigno dei patrioti51, questa funzione del denaro riconduce la pratica del tradimento a una precisa ossessione proprietaria, un po’ come avviene anche al protagonista di Allonsanfàn (1974) dei fratelli Taviani, ex-giacobino ed ex-ufficiale bonapartista, che sedotto dalle dolcezze della restaurazione tradisce i compagni e la causa rivoluzionaria e ruba il denaro giunto dall’Inghilterra per finanziare la rivoluzione nel Sud Italia per assicurare un vitalizio al figlio. Il tradimento, insomma, non è solo uno sfregio morale o ideale: ha sempre a che fare – etimologicamente – con una pratica che rinvia al verbo latino tradere: cioè all’idea di trasferire qualcosa. Di consegnare, trasmettere, affidare. Ricchezze, ruoli, identità. Il tradimento – suggerisce in definitiva Visconti – è figura leggibile solo dentro un’economia di scambio. Diventa cioè la figura sociale 50 51
G. Tinazzi, Un melodramma in abisso, in Il cinema di Luchino Visconti, a cura di V. Pravadelli, Biblioteca di Bianco & Nero-Marsilio, Roma-Venezia 2000, p. 150, T. Subini, Il difficile equilibrio tra Storia e Melodramma in “Senso”, in Il cinema di Luchino Visconti tra società e altre arti, a cura di R. De Berti, CUEM, Milano 2005, pp. 47-78.
Potere Gianni Canova
471
dominante dentro il sistema di relazioni dei ceti e delle classi dirigenti italiane. E il trasformismo è la maschera prodotta dalla sua infiltrazione sistemica, o dalla sua iterazione parossistica: la tattica secolare con cui le classi dirigenti italiane hanno gestito la conservazione e la perpetuazione del potere adeguandosi con tempestiva prontezza ai cambiamenti sociali ed epocali. Ed è ancora una volta Visconti il cineasta che meglio di chiunque altro mette in scena questa tipica patologia italiana del potere nel suo Il gattopardo. Mentre l’omonimo best seller di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da cui il film è tratto, finiva per essere una sorta di malinconica e nostalgica presa d’atto dell’inevitabile fine di un tempo e di mondo (quello dei “Leoni e dei Gattopardi”, sostituiti dagli “sciacalli” e dalle “iene”: ancora metafore animali!), il film di Visconti aggiunge alla contemplazione della decadenza del Principe e del suo mondo anche la lucida e disincantata rappresentazione degli interessi rapaci dei nuovi ricchi, e dello spudorato trasformismo dei vecchi potenti, disposti – per riprendere la celebre frase pronunciata dal personaggio di Tancredi – a fare in modo «che tutti cambi, perché tutto resti com’è». Così Tancredi, il nipote prediletto di Don Fabrizio, prima abbandona la difesa dei Borboni per combattere tra le vie di Palermo con la camicia rossa garibaldina, poi sveste anche questa e indossa la divisa piemontese. E alla fine del film lo troviamo pronto per entrare nel nuovo parlamento su posizioni che invocano la più dura repressione di ogni moto di rivolta popolare. Come ha notato lucidamente Paolo Bertetto, il punto di vista di Visconti – al di là delle dichiarazioni ideologiche del regista – coincide di fatto con quello del Principe, a cui il film conferisce un sapere e una sensibilità tipicamente novecentesche, poco coerenti con l’universo diegetico: «La rappresentazione critica del nuovo blocco sociale che si costituisce in Sicilia con l’unificazione nazionale è effettuata con la logica del Gattopardo e guarda con maggior simpatia ai residui filo-borbonici che ai personaggi della nuova Italia (si pensi alla comprensione con cui è considerato il borbonico don Ciccio Tumeo e al disprezzo con cui è presentato don Calogero Sedara)»52. Ma proprio per questo – non per il suo dichiarato progressismo, bensì per la sua oggettiva, aristocratica e 52
P. Bertetto, Il simulacro e la figurazione, strategie di messa in scena, in Il cinema di Luchino Visconti tra società e altre arti, cit., p. 219.
472
Lessico del cinema italiano
snobistica distanza dalle posizioni dei nuovi, camaleontici potenti della nuova Italia – Visconti riesce, meglio di chiunque altro, a mettere in scena il trasformismo come peculiare strategia di conservazione del potere delle classi dirigenti italiane. Anche Noi credevamo (2010) di Mario Martone è una sorta di appassionata e disincantata radiografia del potere effettuata sull’Italia ottocentesca, ma con l’intento di cogliere – anche e soprattutto – tratti peculiari e connotativi dell’Italia contemporanea. Nelle prime immagini del film il potere è rappresentato dalle divise bianche dei soldati borbonici. Siamo nel Cilento del 1828, Regno delle Due Sicilie: lì, per gli occhi e le orecchie dei contadini locali, il potere si esprime con le urla minacciose degli ufficiali, e con gli spari con cui vengono fucilati i ribelli. Ma soprattutto il potere è la falce del boia che taglia la testa al capo della rivolta, ed è la mano feroce che infila il capo mozzato e ancora sanguinante su una picca esposta nella pubblica piazza. Il potere officia lo spettacolo del terrore ed espone la morte come deterrente alla rivolta. La decollazione pubblica è privazione dell’identità, è amputazione del corpo e pratica visibile che rinvia simbolicamente a significati invisibili53. E tuttavia, nel film di Martone lo spettacolo della decapitazione sortisce un inatteso “effetto boomerang” e spinge tre giovani del luogo (Domenico, Angelo e Salvatore) ad aderire alla confraternita mazziniana e a prestare giuramento di fedeltà: Io do il mio nome alla Giovane Italia, associazione di uomini credenti nella stessa fede, e giuro di consacrarmi tutto e per sempre a costituire con essi l’Italia in azione, una, libera, indipendente, repubblicana; di uniformarmi alle istruzioni che mi verranno trasmesse nello spirito della Giovine Italia da chi rappresenta con me l’unione dei miei fratelli, e di conservare anche al prezzo della vita inviolati segreti. Ora e sempre così giuro, invocando sulla mia testa l’ira di Dio, l’abominio degli uomini e l’infamia dello spergiuro se io tradissi in tutto o in parte i miei giuramenti54.
53
54
Sui significati simbolici connessi all’atto della decapitazione e alla sua rappresentazione, cfr. J. Kristeva, La testa senza il corpo. Il viso e l’invisibile nell’immaginario dell’Occidente, Donzelli, Roma 2009 [ed. or. Visions capitals, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Paris 1998]. Dai dialoghi del film, scritti da Mario Martone e Giancarlo De Cataldo.
Potere Gianni Canova
473
La fede e il giuramento sono – fin dall’inizio – gli elementi costitutivi del contropotere. E indicano nell’appassionata adesione fideistica a un sogno rivoluzionario una delle motivazioni principali che spingono i giovani protagonisti a sfidare il regime borbonico e il potere costituito. Noi credevamo è un film imprescindibile per rintracciare la retorica e l’ideologia del potere nel cinema italiano perché – al pari dei titoli già citati di Visconti e Faenza – è un film che drammatizza uno scontro di poteri: da un lato il vecchio potere che muore, dall’altro un nuovo potere che nasce e che ambisce a scalzare e a sostituire in fretta il vecchio. Il punto di vista di Martone sposa e adotta – fin dal titolo, mutuato dal romanzo a cui si ispira il film55 – il punto di vista di chi non ha il potere e ambisce a conquistarlo: quel “noi credevamo” non solo insiste sulla dimensione collettiva dell’adesione a un progetto di conquista del potere, ma sottolinea anche – con forza – la dimensione fortemente fideistica che anima l’azione dei giovani rivoluzionari. I mazziniani del film sono a tutti gli effetti dei “credenti”. E il motivo principale della loro azione è la passione. Forse non si è ancora ragionato abbastanza sul ruolo talora fondamentale della passione nell’agone politico, e il film di Martone ha il merito di conferirle una centralità precedentemente impensabile56. Lo dice chiaramente Cristina di Belgiojoso, quando afferma di leggere sul volto dei giovani cospiratori una passione che la affascina. Ha scritto molto opportunamente Valerio Romitelli: In Noi credevamo tutto avviene proprio attorno alle passioni politiche, in parte condivise in parte discriminanti. L’amore non c’è, se non per un ideale, l’amicizia non conta, se non per pensare e agire insieme, l’odio si scatena, e a profusione, ma solo contro i nemici della “causa”. Le divisioni di classe certo compaiono, ad esempio nella grande distanza sociale fra due protagonisti, nobili, ed un terzo, contadino, ma subito trasfigurano, prima, dentro la fede giurata da tutti e tre alla 55 56
A. Banti, Noi credevamo, Mondadori, Milano 1967. Ma sul ruolo della passione nell’azione politica e nelle dinamiche di potere si veda almeno E. Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano 1981 [ed. or. Masse und Macht, Claassen Verlag, Hamburg 1960], e il recente M. Nussbaum, Emozioni politiche. Perché l’amore conta per la giustizia, il Mulino, Bologna 2014 [ed. or. Political Emotions: Why Love Matters for Justice, Belknap Press, Cambridge MA 2013].
474
Lessico del cinema italiano
Giovane Italia, poi dentro il sospetto di tradimento che porterà a una cruenta vendetta57.
Andando controcorrente rispetto a tutta la tradizione iconografica che dai film muti di Filoteo Alberini, Mario Caserini e Augusto Jandolo, fino al Blasetti di 1860 (1934) avevano dato del Risorgimento una visione agiografica e retorica, Martone – ancora una volta – nel momento in cui cerca di afferrare dentro la storia risorgimentale il fantasma del potere, è indotto – di fatto – a rompere i limiti del linguaggio58. Noi credevamo è infatti una sinfonia in quattro movimenti, che ripercorre trent’anni di storia ottocentesca italiana avendo come fonte ispiratrice (sia a livello narratologico che iconologico) quelli che erano gli strumenti espressivi dell’Ottocento (la sinfonia, appunto, e poi il melodramma, e il feuilleton). Nessun intento epico. Nessuna enfasi tardo-romantica. Poco pathos, molto ethos. Più Rossellini che Visconti. Ma anche – ripercorrendo le vicende di un gruppo di amici del Cilento che insieme lottano, sperano, perdono, si dividono e sprofondano nella sconfitta e nel disincanto – un film che da un lato «spezza la coralità del racconto e la messa in scena in profondità di campo in favore di una pluralità di voci che si sovrappongono in contrappunto e di una frammentazione degli sguardi»59 e dall’altro avanza finalmente un paio di idee forti sulla nostra Storia. La prima: ogni nostra scelta – come si diceva poc’anzi – è stata da sempre più fideistica (noi credevamo) che razionale. La seconda: il tradimento è connaturato al nostro DNA fin dalla fondazione del nostro Stato unitario. Ergo: siamo un popolo di traditori e di tifosi. Fedeli, ovviamente. Il tema del tradimento – centrale nello sviluppo diegetico del racconto – si coniuga in più di un’occasione con quello del trasformismo, che del tradimento è a volte la causa e altre volte l’effetto. Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861, il film mostra come trionfino i camaleonti opportunisti: ad esempio Francesco Crispi, che da convinto repubblicano qual 57 58 59
V. Romitelli, Risorgimento e passione politica: “Noi credevamo” di Mario Martone, in “Storicamente”, n. 7 (2011), art. n. 30. Su questo aspetto del film, cfr. anche G.A. Nazzaro, Storia. Su “Noi credevamo”, in Mario Martone, La scena e lo schermo, a cura di R. De Gaetano, B. Roberti, Donzelli, Roma 2013, pp. 149 sgg. F. Zucconi, Fare gli italiani. Il cinema come didattica e come coscienza civile, in “Alfabeta 2”, n. 7 (2011).
Potere Gianni Canova
475
era in gioventù, si trasforma in fervente monarchico e intraprende una disastrosa campagna coloniale e una violenta azione di polizia contro gli ex-amici repubblicani; o Antonio Gallenga (Luca Barbareschi), che già in precedenza aveva “tradito” per non aver portato a termine l’azione omicida contro il re, e che finisce a fare il giornalista per “The Times” e per supportare con i suoi articoli la folle ascesa al potere di Crispi, legittimandone i soprusi e gli abusi di potere. Ma il tradimento alligna anche fra i giovani e appassionati protagonisti, se è vero che il rapporto tra Angelo e Salvatore finisce con un omicidio per sancire un ipotetico tradimento. Alla fine sono le parole di Domenico, unico sopravvissuto dei tre giovani patrioti protagonisti, a concludere: «Noi credevamo…». Ma a chi corrisponde questa prima persona plurale che si coniuga all’imperfetto senza cessare per questo di sentirsi attuale? Scrive Francesco Zucconi: «Il tempo esce dai cardini. Mentre il passato si confonde al presente, lo spettatore è chiamato a una sintesi, a un’acquisizione di consapevolezza della propria posizione civile e politica in un’Italia, ancora, da fare»60. 3.2 L’arbitrio (In nome del popolo italiano, Detenuto in attesa di giudizio) Due film usciti nello stesso anno, il 1971, confermano ed esemplificano in modo quasi paradigmatico l’idea inquisitoria del potere alimentata e nutrita negli anni dal cinema italiano. Si tratta, rispettivamente, di In nome del popolo italiano di Dino Risi e di Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy. Entrambi sono accomunati da una visione della giustizia come pratica arbitraria e vessatoria nei confronti del cittadino: quasi attingendo a una memoria atavica e a un sapere euristico accumulato nei secoli, tanto il film di Risi (sceneggiato da Age & Scarpelli) quanto quello di Loy (sceneggiato da Sergio Amidei e Emilio Sanna, da un soggetto di Rodolfo Sonego) fanno dell’esercizio della giustizia un arbitrio assoluto nella mani della magistratura, che dispone a suo piacere del cittadino inerme, costretto sempre e solo a subire in silenzio. Nel film di Dino Risi, Vittorio Gassman interpreta un tipico esponente della classe imprenditoriale del Nord, l’ingegner Lorenzo 60
Ibidem.
476
Lessico del cinema italiano
Santenocito: presidente della Santenocito Spa, ma anche membro di svariati consigli di amministrazione di società immobiliari e finanziarie, di Spa e di Srl, di volta in volta amministratore unico o consigliere delegato, accumula una pletora di cariche che ne fanno un uomo molto potente e molto influente. La magistratura sospetta che abbia commesso svariate infrazioni della legge (corruzione, concussione, inquinamento) ma non ha le prove. Tanto che il magistrato che si mette a indagare su di lui – Mariano Bonifazi, interpretato da Ugo Tognazzi – lo fa non per eventuali reati connessi alla sua attività imprenditoriale, ma per i suoi rapporti con una “squillo” tossicomane deceduta in circostanze poco chiare. Nel primo interrogatorio con il magistrato inquirente, l’ingegnere reagisce proclamandosi vittima di una persecuzione giudiziaria: «Lei è prevenuto contro di me! Se io fossi delle sue stesse idee politiche, lei troverebbe immediatamente le ragioni della mia innocenza…!». Anticipando con sorprendente lungimiranza il tema della persecuzione giudiziaria come ratio autoassolutoria nei confronti dell’arbitrio della magistratura, secondo un copione destinato a riempire le cronache giudiziarie italiane nei decenni successivi, il film di Risi dà voce alla pretesa di certa classe dirigente italiana di sottrarsi al giudizio della Legge. Ma nello stesso tempo mette in scena anche la pretesa della magistratura (allegoricamente e simbolicamente localizzata in un Palazzo di Giustizia che cade a pezzi e si sbriciola sotto il peso delle troppe cause arretrate, e viene chiuso a tempo indeterminato) di perseguire comunque i propri fini, anche a costo di commettere arbitrio nei confronti dei cittadini. Il finale di In nome del popolo italiano da questo punto di vista è esemplare: il magistrato che indaga su Santenocito trova un diario della ragazza deceduta in cui la giovane confessa la propria ferma intenzione di suicidarsi. Quel diario è la prova che scagiona l’ingegnere da ogni sospetto, è la garanzia della sua innocenza. Il magistrato lo legge camminando per strada, mentre dalle finestre aperte escono le voci della telecronaca della partita in cui la nazionale italiana di calcio batte per la prima volta la nazionale inglese. Il giudice legge la pagina del diario che scagiona Santenocito proprio mentre la voce del telecronista annuncia urlante ed esultante la vittoria della nazionale italiana. Dalle case escono frotte di tifosi in festa, che invadono le strade per celebrare il trionfo sportivo. Ci sono preti e soldati, carabinieri e operai, casalinghe e mignotte: ubriachi e scatenati, i tifosi si abbandonano a un
Potere Gianni Canova
477
carosello grottesco e allucinato, bruciando un’automobile inglese e innalzando bandiere azzurre e tricolori. E alla testa di ogni drappello di esagitati il giudice vede sempre e comunque un personaggio con le fattezze dell’ingegner Santenocito, di volta in volta travestito da gerarca in pensione che urla «Viva Boninsegna!...Viva il Duce!», da militare che inveisce contro «la perfida Albione», da prostituta che balla in modo sguaiato, e così via. Lui è il volto della folla, è la quintessenza dell’italianità cialtrona, arrogante e sbracata. Per questo – quasi mosso da disgusto antropologico per un’italianità siffatta – il magistrato decide di bruciare il diario della ragazza: distrugge la prova dell’innocenza di Santenocito con l’intento evidente di portarlo a processo e di giudicare in lui quel popolo che egli così emblematicamente incarna e rappresenta. Ma per punire in Santenocito quella società corrotta e irresponsabile che intorno a lui ruota e che in lui si riconosce, Bonifazi finisce per commettere proprio quell’arbitrio di cui Santenocito pretendeva di essere vittima: paradossalmente, Santenocito aveva ragione quando accusava il magistrato di «odio ideologico» e di «zelo inquisitorio». Anche se all’inizio degli anni settanta non mancarono posizioni “giustificazioniste” nei confronti della decisione del magistrato, vista non come infrazione della Legge ma come sfida al potere costituito e come rifiuto di continuare ad essere «difensore di leggi che proteggono una società che fa schifo»61, non c’è dubbio che rivisto oggi il film fa della discrezionalità della magistratura una delle forme di arbitrio attraverso cui il potere esercita se stesso. Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy prospetta una diversa ma analogamente brutale forma di arbitrio: quella della giustizia vista come micidiale macchina inquisitoria e persecutoria. Il film – come è noto – racconta le peripezie giudiziarie di un italiano emigrato in Svezia (Alberto Sordi) che al rientro in Italia per 61
Si veda ad esempio quanto scrive Sandro Zambetti: «Quella che si chiama giustizia è in realtà pura e semplice difesa dell’ordine costituito, esercizio degli strumenti “legali” che il potere s’è dato per conservare se stesso e per mantenere la società così com’è. Il dramma di Bonifazi è appunto quello del magistrato che si rende conto di essere addetto a tale funzione e che è quindi costretto a rinnegare se stesso (il proprio ruolo, la propria etica professionale) diventando “ingiusto” per poter fare giustizia nel senso autentico e non formalistico dell’espressione», S. Zambetti, Cinema politico e uso politico del cinema, in “Cineforum”, n. 110-111 (1972).
478
Lessico del cinema italiano
le vacanze viene arrestato alla frontiera, ammanettato, spogliato, perquisito, carcerato e anonimizzato senza che neppure gli venga detto di quale reato e per quale delitto viene privato della sua libertà. La messinscena delle procedure e dei protocolli della giustizia genera nel pubblico un effetto inquietante: trasferito da un carcere all’altro, sorvegliato e punito, perennemente osservato da un occhio che lo spia in cella, perso nei meandri di una giustizia “bendata” perché cieca di fronte alle ragioni e ai diritti del cittadino, il personaggio di Alberto Sordi finisce per apparire come la vittima di un sistema iniquo e vessatorio, e chiama a sé l’identificazione empatica dello spettatore. Detto in altri termini: di fronte alle vicende che lo vedono protagonista, ci si dimentica di chi è il personaggio, non ci si chiede neppure più che cosa ha fatto, né quali reati possa aver commesso, e si resta come attoniti, mossi da una sorta di creaturale solidarietà nei confronti di chi è rimasto schiacciato, umiliato ed offeso da un sistema così ferocemente oppressivo. Di nuovo: la giustizia rappresentata come arbitrio, come vessazione, come abuso. Come macchina punitiva che schiaccia, offende, umilia. A dispetto della loro evidente diversità, i due film qui analizzati sono il sintomo di un analogo disagio del cinema italiano nella rappresentazione della giustizia: ancora prigioniero di un immaginario arcaico, legato a un’idea di giustizia “pasticciona” e inutilmente complicata come nelle grida del manzoniano Azzeccagarbugli, ma anche incapace o poco interessato – se non in rari casi come ad esempio In nome della legge (Germi, 1949) o Il giudice ragazzino (Di Robilant, 1994) – a costruire un epos della giustizia simile a quello celebrato con forza dal cinema americano, il cinema italiano ha privilegiato l’adozione di prospettive fortemente critiche in cui l’azione della magistratura – in quanto potere costitutivo dello Stato moderno – non opera per il bene del cittadino ma in funzione della riproduzione del potere medesimo. Da Porte aperte (Amelio, 1990) a Tutti dentro (Sordi, 1984), la visione della magistratura che emerge è un sintomo di come la società italiana continui a fare fatica nell’accettare uno dei principi fondativi dello Stato moderno come quello della separazione dei poteri. Anche se separati, sullo schermo i poteri esprimono sempre lo stesso volto. Arcigno, severo, vessatorio, feroce. Un potere che non si esercita quasi mai nella legalità ma quasi sempre nell’arbitrarietà e nell’impunità.
Potere Gianni Canova
479
3.3 L’impunibilità (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto) «Il carnevale è finito!». Con il tono brusco di chi non ammette repliche, il commissario protagonista di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) di Elio Petri interrompe il clima festoso con cui colleghi e subordinati stanno esprimendogli le loro congratulazioni per la sua promozione a capo dell’Ufficio Politico della Questura. Il senso letterale della frase è evidente: l’uomo del potere, nel momento in cui assume la responsabilità di un nuovo ufficio, pone fine al “tempo della Festa” e inaugura il “tempo della Legge”. In realtà l’affermazione – in sintonia con la logica che governa tutto il racconto scritto da Ugo Pirro – ha una evidente valenza antifrastica. Non è vero che il carnevale finisce, il carnevale è appena iniziato. Il commissario – l’abbiamo appena visto – è un assassino. Ha tagliato la gola alla sua amante in un’alcova arredata come un boudoir dannunziano. Poi, invece di occultare la propria presenza e di cancellare le tracce della propria colpevolezza, ha disseminato la scena del delitto di indizi che dovrebbero aiutare gli inquirenti a individuare in lui il responsabile del delitto. Quindi, uscito dal teatro del crimine, ha smesso l’identità dell’assassino e ha indossato la maschera del poliziotto. Proclamando la fine del carnevale, egli in realtà celebra l’inizio del regno della maschera: per tutto il film, il personaggio interpretato da Gian Maria Volonté oscillerà – come ha lucidamente osservato Roberto De Gaetano – «fra un sadismo di superficie (trattamento sprezzante dei suoi subordinati) e un masochismo profondo (ricerca dello smascheramento e della punizione)»,62 fra “onnipotenza sadica” e “impotenza masochistica”, in un delirio di ossimori dall’effetto fatalmente grottesco. Secondo alcune tesi recenti, il film di Elio Petri incarnerebbe una visione arcaica e superata del potere. Scrive ad esempio Claudio Bisoni: «Il modo in cui è descritta l’autorità rimanda a una filosofia del potere di stampo tradizionale, quasi tutta interna alla tradizione maggioritaria (marxista) della sinistra storica. Il potere appare concentrato, asimmetrico, smodato, incontrolla62
R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, Bulzoni, Roma 1999, p. 89.
480
Lessico del cinema italiano
bile e, solo talvolta, carnevalesco»63. Ma il postulato del «potere come pura proprietà-essenza-attributo di una parte a svantaggio di un’altra»64 regge solo fino a un certo punto se sottoposto a una verifica testuale puntigliosa. Non è vero che in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto il potere è concentrato: piuttosto circola, si sposta, slitta, si trasferisce. Chi domina e chi è dominato fra il commissario e la signora Augusta Terzi? E chi esercita davvero il potere e il dominio sull’altro nello scontro fra Antonio Pace e il commissario? I ruoli si invertono, il dominio è instabile. Perfino fra gli esponenti dell’autorità costituita e dell’istituzione poliziesca il potere circola, ed è possibile che chi oggi domina domani sia dominato, e viceversa. È proprio questa visione non schematica, non “proprietaria” e non manichea che rende la fenomenologia del potere e del dominio messa in forma dal film ancora assolutamente attuale. Di fatto, come ha osservato Roberto De Gaetano, «Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è un film “sul potere come maschera”»65: non si limita ad applicare al potere esecutivo (la polizia) quella logica dell’arbitrio che nel paragrafo precedente abbiamo vista esercitata – in film come In nome del popolo italiano e Detenuto in attesa di giudizio – dal potere giudiziario. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto va oltre. Ribadisce la teatralità del potere e fa della maschera il linguaggio necessario ad affermare se stesso in quanto forma del dominio. Tutto il film è tramato da giochi di mascheramenti a staffetta e da una paranoica, pervasiva e compulsiva teatralizzazione del quotidiano. Il commissario di Gian Maria Volonté (significativamente privo di nome diegetico, quasi a farne l’ipostasi paradigmatica del potere che egli incarna e rappresenta) teatralizza l’alcova in cui si incontra con Augusta Terzi, ricostruendo le più morbose e scabrose scene del delitto su cui si è trovato a indagare, in un gioco di mimesi ludico-derisoria in cui è sempre lui – il maschio poliziotto potente ed inquirente – a dominare su di lei, sempre relegata al ruolo di vittima sia pure consenziente. Ma il commissario teatralizza anche la sede 63 64 65
C. Bisoni, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Lindau, Torino 2011, p. 45. Ivi, p. 48. R. De Gaetano, Il corpo e la maschera. Il grottesco nel cinema italiano, cit., p. 90.
Potere Gianni Canova
481
della polizia (dove allestisce spettacoli impersonando la retorica dell’ordine e della repressione), recita durante l’interrogatorio del giovane sovversivo Antonio Pace, in un esempio emblematico di prossemica del dominio (lui in piedi, l’interrogato seduto, insultato, strattonato, spremuto, umiliato, intimidito: «Tu non sei un cavallo! Tu sei un cittadino democraaatico…!») e assume un’identità fittizia perfino davanti all’umile stagnaro superbamente interpretato da Salvo Randone, a cui fa credere – nascosto dietro un paio di occhiali scuri – di essere l’impresario teatrale di una fantomatica rivista di avanspettacolo, interessato all’acquisto di uno stock di cravatte color turchese. Il commissario è insomma il tipico “uomo dai mille volti”: un trasformista che gode del fregolismo del potere, o che ricorre al travestitismo identitario per affermare la sua assoluta smania di dominio: sulla donna, sull’uomo del popolo, sui colleghi, sull’istituzione. Solo mostrando di essere “al di sopra di ogni sospetto”, fuori dal possibile giudizio della Legge, può garantirsi l’esercizio del dominio. Che è – in ultima istanza – il dominio su se stesso, sul proprio infantilismo, sulla propria paura di inadeguatezza sessuale. Nei numerosi flashback che strutturano il film66, e che ricostruiscono à rebours – secondo una procedura ben nota al racconto poliziesco – la storia del delitto, il commissario viene deriso dall’amante: e la derisione liquefa e corrode proprio il dominio a cui lui aspirava. L’omicidio, allora, non è che un atto esorcistico rivolto al rituale derisorio allestito da Augusta Terzi nei confronti dell’uomo di potere: iniziato come teatro dell’ossequio (la signora che lo cerca al telefono, e che omaggia la sua autorità di poliziotto), il rapporto fra l’uomo della Legge e la donna del desiderio precipita nel teatro dello smascheramento. «Fai l’amore come un bambino. Sei sessualmente incompetente…!», gli dice Augusta in tono sprezzante. E lui, smascherato nella sua vulnerabilità, cerca un riscatto nella insospettabilità. Quanto più è smascherato, tanto più il potere si mette in maschera. Quanto più è vulnerabile, tanto più si pretende onnipotente. Quanto più è deriso (da Augusta, ma 66
Per un’analisi accurata dell’impianto narrativo e dei sei flashback che strutturano il racconto si veda V. Zagarrio, La fantasia al potere. Indagine su un film al di sopra di ogni sospetto, in L’ultima trovata. Trent’anni di cinema senza Elio Petri, a cura di D. Mondella, Pendragon, Bologna 2012, pp. 59-66.
482
Lessico del cinema italiano
anche da Antonio Pace e dai contestatori post-sessantotteschi), tanto più allestisce un rituale revanscistico di disprezzo e di umiliazione punitiva di chi l’ha offeso. L’aspetto geniale del film sta nel modo in cui Petri e Volonté sanno gonfiare dall’interno l’iperbole del potere, rappresentando la smania di dominio in modo tanto paradossale da renderlo grottesco. L’eccesso, la ridondanza e la dismisura diventano così la smorfia (letteralmente: Volonté recita notoriamente con un batuffolo di cotone nel labbro inferiore della bocca per alterare la mimica facciale e la fonesi) attraverso cui il potere rivela – senza volerlo – il proprio smodato desiderio di dominio. In questa prospettiva, il doppio finale del film (quello allucinatorio e quello verosimile) offrono una chiave in più alla fantasticheria di dominio (e di impunità) del potere: che prima sogna una punizione/assoluzione esercitata dall’apparato con un cerimoniale fatto di sguardi sconsolati, buffetti sulla guancia, mani giunte incredule e complici reprimende come di fronte a uno scolaretto disobbediente, poi lascia intendere che quel regime allucinatorio del desiderio potrebbe di fatto coincidere con l’esito non allucinatorio della vicenda. Il potere si assolve. Il potere non si giudica. Il potere non ammette infrazioni alla propria assolutistica smania di dominio. Nel finale, quando il regime fattuale sembra replicare (a partire dal dettaglio sul calzino del commissario) il regime allucinatorio, si abbassano le veneziane e il luogo del potere si oscura. «La m.d.p. – scrive ancora Bisoni – è collocata fuori dalla vetrata dell’appartamento del commissario e assiste allo sprofondare del potere nel buio. Le faccende relative al cittadino al di sopra di ogni sospetto si risolveranno intra moenia, al chiuso, nello spazio perimetrale e presidiato dall’Autorità»67. Non è dato di sapere cosa accadrà realmente nella stanza in cui il potere si è riunito. Abbiamo visto cosa è accaduto nella camera da letto (che non è più da tempo luogo proibito allo sguardo), ma l’interdetto a vedere si è spostato e trasferito nella camera del potere. Che ancora una volta celebra se stesso, e perpetua la propria fantasia di immunità e di impunibilità, in un regime di fatale e impenetrabile invisibilità.
67
C. Bisoni, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, cit., p. 53.
Potere Gianni Canova
483
4. La riscrittura del reale 4.1 Il biopic politico italiano del nuovo millennio (Il caimano, Il divo, Vincere) Il biopic si colloca nella storia del cinema come quel macrogenere – o quel filone necessariamente transgenerico – che mosso dalla volontà di raccontare le vite di uomini illustri, oscilla fra due tendenze principali: da un lato l’ambizione (o la pretesa) didattica, che talvolta “sfocia in un’ibridazione con forme documentaristiche”; dall’altro lato, la propensione a rielaborare in termini mitici il personaggio prescelto, spesso forzando la complessità storica e comprimendola in una galleria aneddotica o in una inevitabile agiografia68. Se si esclude – come si visto – il cinema fascista nel suo rapporto apologetico con il corpo Mussolini e con il mito del duce, il cinema italiano ha preferito – soprattutto nella messinscena di uomini di potere – la prima strada: da Anno Uno (1974) di Rossellini (biografia del leader democristiano Alcide De Gasperi) a certi film di Francesco Rosi (Il caso Mattei, 1972), il biopic italiano ha privilegiato la strada del cinema-inchiesta, del mockumentary o del cinema verità. E tuttavia, come si è già detto più volte, proprio perché indotto dall’inafferrabilità del fantasma del potere a forzare i limiti del linguaggio, a partire dagli anni zero del nuovo millennio alcuni degli autori più importati del cinema italiano hanno provato a sperimentare forme di biopic innovative legate non a caso alla messinscena dei tre uomini più potenti dell’Italia moderna (Mussolini, Andreotti, Berlusconi). I registi che li hanno raccontati (Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Nanni Moretti) hanno scelto – in singolare sintonia – di abbandonare l’idolatria del cinema-verità e di usare piuttosto la strategia della maschera su un registro espressivo che oscilla fra l’allegorico e il grottesco.
68
Sul biopic in generale si veda almeno M. Argentieri, Il film biografico, Bulzoni, Roma 1984; A. Pesce, Biopic. Una vita, un film, ANCCI, Roma 1993; G.F. Custen, Bio/Pics: How Hollywood Constructed Public History, Rutgers University Press, New Brunswick 1992; F. Arlanch, Vite da film, Franco Angeli, Milano 2008.
484
Lessico del cinema italiano
4.1.1 L’anfibio grottesco: Il caimano Il primo dei tre film a uscire nelle sale, nel 2006, è Il caimano: non un pamphlet su o contro Berlusconi, quanto piuttosto un apologo allegorico che ricorre a una maschera animale per mettere in scena l’inafferrabilità di Berlusconi in quanto ipostasi del potere e, al contempo, la difficoltà di rappresentare l’Italia contemporanea. Più che un personaggio filmico, il Berlusconi di Il caimano è un’ossessione mentale: un pensiero dominante, un parassita dell’immaginario, una tenia dai mille volti proteiformi e cangianti. Sono almeno quattro, i Berlusconi di Il caimano. Il primo è quello evocato dalla sceneggiatura scritta dalla giovane Teresa (Jasmine Trinca) e finita nelle mani del produttore Bruno Bonomo (Silvio Orlando), che la legge in modo frettoloso e trasversale: interpretato da Elio De Capitani, questo primo Berlusconi è il più mimetico e parodistico, quello che si vede piovere dal soffitto valigie piene di banconote («Da dove vengono tutti questi soldi? Da dove vengono?», ripete ossessivo il testo della sceneggiatura), quello che vola in elicottero sui campi di calcio pieni di majorettes e che consola frotte di casalinghe depresse con le sgargianti paillettes e i ricchi cotillons di una Tv commerciale che si può accendere e vedere anche di mattina. Il secondo è il Berlusconi divistico: quello a cui presta volto e corpo un poco convinto Michele Placido, attore di successo, lusingato dall’idea di ripetere la performance di Gian Maria Volonté con Enrico Mattei o con Aldo Moro, ma poi tanto incapace di cogliere il personaggio da rinunciare al progetto per tornare ai lidi più rassicuranti del cinema mainstream in costume (lo vediamo interpretare un film su Cristoforo Colombo). Il terzo è il Berlusconi mediatico: quello “vero”, quello degli insulti ai membri del Parlamento Europeo («Siete dei turisti della democrazia!») trasmessi in diretta Tv in immagini di repertorio che vengono assunte pari pari da Moretti nel suo film. L’ultimo, infine, è il Berlusconi apocalittico e “golpista” del finale, quando è lo stesso Moretti a interpretarlo – a sorpresa – nella scena in cui il Premier viene condannato a sette anni di carcere e si allontana furente dal tribunale incitando il “suo” popolo a prendere d’assalto il Palazzo di Giustizia. Dei quattro Berlusconi che si alternano nel film (il mimetico, il divistico, il mediatico, l’apocalittico), tre sono assolutamente verosimili anche se finzionali, mentre uno solo risulta
Potere Gianni Canova
485
– per quanto lo si osservi – assolutamente “inverosimile”: quello – come dire – “vero”, senza maschera, quello che recita se stesso davanti ai media di tutto il mondo, vanesio e permaloso, vittimista e narciso, spiritoso e gaffeur. Uno, nessuno, centomila: il Berlusconi di Nanni Moretti ha qualcosa di pirandelliano, moltiplica la sua immagine all’infinito, e alla fine sfugge ad ogni tentativo di essere raffigurato. Come se esistessero tanti Berlusconi quanti sono quelli che lo conoscono, lo raccontano, lo odiano o lo amano. Berlusconi plurimo, Berlusconi ubiquo, Berlusconi infinito: come ogni ossessione che si rispetti, il Berlusconi di Moretti dilata la sua presenza in modo pervasivo, e si espande nell’immaginazione fino quasi a scomparire, e a dissolversi, obbligando l’ossessionato Moretti a prendere il suo posto, a incarnarlo, a farsi lui. La cornice narrativa che Moretti mette a punto per far prendere forma alla sua ossessione è, in questo senso, davvero esemplare: un piccolo imprenditore del settore dello spettacolo, già produttore di B-movies anticomunisti come Cataratte e Mocassini assassini, sull’orlo del fallimento, in procinto di essere piantato anche dalla moglie, trova per caso la sceneggiatura di Il caimano e decide di provare a produrre il film – pur essendo stato in passato elettore di Berlusconi – nella convinzione che il progetto possa raddrizzare le sue scarse fortune economiche e reputazionali. Non disponendo di risorse proprie, chiede la partecipazione all’impresa di un coproduttore polacco (Jerzy Stuhr, già attore per Kieślowski e regista in proprio), che accetta di partecipare pronunciando sferzanti giudizi sull’Italia e sugli italiani, un po’ come faceva Orson Welles in La ricotta di Pasolini («Siete un popolo a metà fra orrore e folklore. Ogni volta penso che abbiate toccato il fondo, e invece no, siete ancora lì che scavate, scavate, scavate, e andate ancora più giù, raschiate»). Il caimano finisce insomma per essere un grande film sull’Italia di oggi, sul modo irreversibile in cui Berlusconi l’ha cambiata, sul processo di disgregazione sociale e civile che l’ha colpita, e sulle disjecta membra sopravvissute alla mutazione e alla deflagrazione. Forse non si è notato a sufficienza come tutto l’universo diegetico del film sia disseminato – in singolare analogia con quanto già avveniva in Aprile – da segni di rottura e di separazione: dai mattoncini di Lego che i figli di Bonomo non riescono a tenere insieme, alle lettere d’amore sparse sul pavimento mentre il Berlusconi di De Capitani sta parlando con un giornalista libera-
486
Lessico del cinema italiano
le dissidente (Montanelli?), alle finestre accese ma incomunicanti durante l’annuncio televisivo della “discesa in campo”, Il caimano è fatto di frammenti che non combaciano, di individualità che non si associano, di unità che si spezzano (la famiglia di Bonomo), di oggetti fatti letteralmente a pezzi e quasi sbranati (il golfino azzurro della moglie del produttore). Tutto si rompe e si disgrega, il mondo che Moretti mette in scena sembra davvero un paesaggio di rovine. Per la prima volta nella sua filmografia, Moretti rinuncia a essere l’attore protagonista. Si fa da parte. Ma la sua assenza è surrogata e compensata da una chiamata di correo a tutti i registi amici (Paolo Virzì, Carlo Mazzacurati, Matteo Garrone, Renato De Maria, Francesco Calogero, Paolo Sorrentino, Giuliano Montaldo) chiamati a interpretare ruoli-cameo, e a molti collaboratori storici invitati a interpretare se stessi (lo scenografo Giancarlo Basili). Il “mondo” di Moretti prende il posto del “corpo” di Moretti. Lo sussume. Quasi a trascendere e a negare – nel film più politico che Moretti abbia mai realizzato – il solipsismo autarchico di cui in passato lo stesso Moretti aveva fatto una bandiera. Per la verità, Morettiattore appare comunque due volte nel film: la prima è nei panni di se stesso, quando rifiuta la proposta di Bonomo di interpretare il Caimano, la seconda è quando nel finale – smentendo il rifiuto precedente – scende a sua volta in campo per interpretare – senza nessun mimetismo, restando anzi assolutamente se stesso – proprio Berlusconi. E il suo Berlusconi furente ha una solennità imprevista: proclama la solitudine del potere e denuncia il silenzio e l’ingratitudine degli alleati mentre sullo sfondo si vedono i bagliori delle molotov con cui il suo popolo sta assaltando il Palazzo di Giustizia. Il Berlusconi mediatico del Parlamento Europeo è davvero lontanissimo: questo sembra piuttosto un erede di Riccardo III, ha qualcosa di sinistramente shakespeariano. Tanto diabolico da risultare fascinoso. Ma invano. Non è più Berlusconi, quello del finale di Il caimano. Non può esserlo. Il “vero” Berlusconi non saprebbe pronunciare un discorso così. Se ci provasse, gli verrebbe da ridere. Strizzerebbe l’occhio. Alleggerirebbe il tutto con una barzelletta o una battuta. Qui, dunque, è lo scarto, qui lo iato fra il film e la realtà: nel momento in cui Moretti si fa altro da sé, ed entra nel corpo del suo “nemico”, non lo invera, piuttosto lo falsifica. Berlusconi è geneticamente legato al registro del comico, e non sa
Potere Gianni Canova
487
uscirne, se non occasionalmente, attraverso lo spiraglio del grottesco. Moretti invece ne fa un personaggio tragico: un emblema del nulla da cui viene e su cui ha costruito le sue fortune, un’ipostasi del popolo che in lui ha cercato l’ultima impossibile redenzione, fallendo. 4.1.2 Il vampiro sopravvissuto: Il divo Una maschera grottesca è alla base anche delle strategie linguistiche con cui Paolo Sorrentino sceglie di mettere in scena Giulio Andreotti (Il divo, 2008)69. Ma invece di ricorrere a un’allegoria animale, come Moretti, Sorrentino predilige una maschera in bilico fra il folclorico e il cinefilo: quella del vampiro. Fin dalla prima inquadratura, giù nella profondità di campo, il divo sembra galleggiare in una nicchia di luce sospesa nel buio. La macchina da presa gli si avvicina con un movimento immersivo che equivale a una discesa all’inferno. Lì, a capo chino e con le orecchie storte, insofferente della luce, il divo rivela da subito – in voice over – la sua natura vampiresca, il suo essere un non-morto, un nosferatu: «Alla visita di leva il medico militare mi diagnosticò sei mesi di vita. Seppi tempo dopo che era morto. Io sono ancora vivo». Come ogni vampiro, anche il divo Giulio è immortale. Gli altri – amici e nemici, compari e cortigiani – gli muoiono attorno, accanto, davanti e dietro, lui sopravvive. E lo sottolinea compiaciuto, consapevole di essere uno di quelli che restano per sempre: gli dei, come i vampiri, non muoiono mai. Hanno bisogno del sangue e delle vite degli altri, e se le prendono. E aborrono la luce. Il divo Giulio, non a caso, vive di notte. Non dorme mai. Gira con la scorta per le vie deserte di una Roma fantasma in lunghe e solitarie passeggiate notturne. E passa il tempo a spegnere gli interruttori di casa sua. I veri divi non sono quelli che godono all’accendersi delle luci, ma quelli che decidono quando le luci si possono spegnere. Fin dall’incipit, Il divo di Paolo Sorrentino sembra incarnare quella che per Elias Canetti è l’essenza stessa del potere: la sopravvivenza. Il potente – per 69
Cristina Jandelli parla di una maschera «che raggela, distanzia e aliena i sentimenti» e sottolinea come lo straniamento sia lo strumento usato da Toni Servillo per «trasfigurare un personaggio reale nel simbolo stesso del potere». Cfr. Id., I protagonisti. La recitazione nel film contemporaneo, Marsilio, Venezia 2013, p. 119.
488
Lessico del cinema italiano
Canetti – è prima di tutto colui che sopravvive. Colui che vive più a lungo dell’avversario. Sopravvivere – scrive Canetti in Masse e potere – produce piacere: «La sensazione di forza che scaturisce dal sopravvivere è fondamentalmente più forte di ogni afflizione: è la sensazione di essere eletti tra molti che hanno un comune destino. Proprio perché si è ancora vivi, ci si sente in qualche modo i migliori»70. Non solo. «Il carattere più proprio del grottesco – scriveva S.M. Ejzenštejn – è il raccapriccio»71. Il divo è un film grottescamente raccapricciante e capricciosamente grottesco. Lo è nel suo incessante convertire – in un movimento di perenne andirivieni – il comico nel tragico, il caricaturale nel mostruoso, il ridicolo nell’orrido. Paolo Sorrentino riesuma Elio Petri – quello sublime di Todo modo, quello feroce e ka iano di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto – e lo usa per allestire il più vasto, spericolato, eccessivo e stordente campionario di sosia che si sia mai visto sullo schermo. Roba da far impallidire i sosia di altri autori diversamente grotteschi come Giuseppe Ferrara (Il caso Moro, 1986, e Giovanni Falcone, 1993) o Nanni Moretti (Il caimano). Ma anche i ministri democristiani di Petri, impegnati nel rito annuale degli esercizi spirituali in Todo modo. Così discreti, così felpati, così spietati. La Storia – in Il divo – diventa museo delle cere, défilé di maschere, carnevale del senso. Vengono in mente le pagine di Bachtin sul carnevale vedendo il film. Ma anche, ancora, Ejzenštejn: cinema come montaggio delle attrazioni. Visivo e sonoro cozzano, il divo dorme sotto il ritratto di Marx, il ritmo sbanda, salta, accelera, frena, si blocca. E mentre nella colonna sonora passano hit come E la chiamano estate, La prima cosa bella o I migliori anni della nostra vita, i morti si accumulano, i misteri si accrescono, le trame si aggrovigliano. Ma lui, il Divo, è sempre lì. Nel buio. Non ha rivali («So di essere di mediocre statura, ma non vedo giganti intorno a me»), non ha antagonisti che non siano suoi alleati “traditori”. Dove sono i movimenti, le masse, il Partito comunista, l’opinione pubblica? Dal punto di vista del Divo, sono solo formiche: quelle che zampettano sulla 70 71
E. Canetti, Masse e potere, cit., pp. 274-275. S.M. Ejzenštejn, Stili di regia, Marsilio, Venezia 1993, p. 13 [ed. or. Izbrannye proizvedenija v šesti tomach, Iskusstvo, Moskva 1963-1970].
Potere Gianni Canova
489
sua mano in una delle immagini apparentemente più incongrue, in realtà più pregnanti del film. Raccapriccio. C’è stato o no il bacio raccapricciante fra il Divo e il Mafioso? Ci sono cose, al cinema, che è bene non sapere. Come nella vita. Ipse dixit. Certo, il Mafioso è morto e il Divo è vivo. È il destino dei vampiri, quello di dare la morte baciando. Viene in mente Sokurov (Moloch, 1999), vedendo Il divo. Quel suo Hitler in mutande intento ad ammazzare il tempo in un castello bavarese in compagnia di Eva Braun. Ma Hitler non era un divo, era un mostro. Il divo Giulio, in mutande, non lo si vede mai. Mai senza cravatta, senza occhiali, senza abiti di scena. Grottesco: come se in lui coabitassero, e si fondessero, le anime degli altri film di Sorrentino (l’usuraio gobbo di L’amico di famiglia, il mafioso garbato e innamorato – come il Divo lo è della sorella di Vittorio Gassman – di Le conseguenze dell’amore, il doppio-sosia di L’uomo in più). Corpo senza anima, carne resistente al tempo e al caso, il Divo comunica con un cerimoniale semiotico rigoroso e immutabile (le punte dei polpastrelli che tamburellano, i pollici che girano, l’indice e il pollice della destra che fanno ruotare la fede nuziale sulla sinistra). Codice cifrato, messaggi per iniziati. Un po’ gangster movie un po’ spaghetti western, Il divo è un film necrofilo e necroforo: ama la morte che aborre. E la mette incessantemente in scena, e non sa evitarla perfino quando tenta di inscenare la vita. Il divo e sua moglie Livia, non a caso, si sono incontrati da giovani in un cimitero. E la Storia fa del cimitero il suo punto d’attrazione fatale. Come se l’esercizio del potere implicasse – di nuovo Canetti – un perenne confronto con la morte. Quella degli altri, possibilmente. Perché il divo/vampiro di Sorrentino non è che un pretesto, o un’occasione, per mettere in scena non tanto una «iperbarocca, […] psichedelica satira psicobiografica»72, quanto – molto più brutalmente – i meccanismi del potere. Lo riconosce apertamente lo stesso Sorrentino: il film «vuole scandagliare, analizzare, studiare, rappresentare […] il funzionamento del potere […] i meccanismi del potere, che sono la solitudine, l’arroganza, la tendenza ad in72
G. Crowdus, citato in N. Marini Maio, Non confesso, dunque sono. “Il Divo” di Paolo Sorrentino”, in Strane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, a cura di C. Uva, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, p. 141.
490
Lessico del cinema italiano
staurare una vita basata esclusivamente sui rapporti di forza»73. Come certi grandi tiranni di cui parla Canetti – come Genghis Khan, o come Filippo Maria Visconti – l’Andreotti di Sorrentino vive nella tenebrosa solitudine del potere e applica sistematicamente quella che Canetti ha definito l’«ineguale ripartizione del vedere a fondo. Il detentore del potere conosce le intenzioni altrui, ma non lascia conoscere le proprie. Egli dev’essere sommamente riservato: nessuno può sapere ciò che egli pensa, ciò che si propone»74. Eroe della dissimulazione, anche l’Andreotti di Sorrentino è dunque soprattutto un virtuoso della segretezza, un campione dell’inaccessibilità. 4.1.3 Il corpo e la statua: Vincere All’inizio è un corpo. Corpo che freme e che ringhia, corpo che sanguina e copula, corpo che pulsa e si gonfia. Poi si iconizza e diventa un’immagine: prima fotografica, poi filmica, in bianco e nero, senza più sangue, ma ancora con la capacità di pulsare ed urlare e fremere e ringhiare anche dentro il rettangolo stretto dell’inquadratura. Alla fine diventa una statua. La testa di una statua. Né carne né ombra, ma pietra. La testa marmorea del Duce su cui Marco Bellocchio chiude Vincere (2009) è il punto d’approdo terminale di un lavoro sul corpo mediale del Capo che è tra le cose teoricamente più dense e radicali che il cinema italiano abbia mai realizzato: al contempo microfisica del potere e antropologia del dominio, semiotica della comunicazione di massa e fenomenologia del machismo italico. Non è un film perfetto, Vincere. Ma nonostante questo (o, forse, proprio per questo) è un capolavoro. Anche quando sbanda e tentenna, anche quando prende tempo, o lo perde. Perché tra le righe dello straziante mélo di Ida Dalser, e del suo amore impossibile per un fantasma di pietra, Bellocchio scrive un lucido, dolce e feroce atto d’accusa nei confronti dell’eterno fascismo italiano: cioè quella disposizione – antropologica prima ancora che psicologica, ideologica o sociale – fatta di ribellismo anarcoide e di succube servilismo, di velleitarismo arrogante e di tracotante narcisismo (quello evocato tra le smorfie del linguaggio 73 74
E. Zaccagnini, Intervista a Paolo Sorrentino, in “Close Up”, 11 ottobre 2008. E. Canetti, Masse e potere, cit., p. 353.
Potere Gianni Canova
491
in Eros e Priapo di Carlo Emilio Gadda), di odio nei confronti del diverso e di disprezzo nei confronti delle donne, che da qualche secolo a questa parte attraversa la nostra storia (e il nostro sentire) e che periodicamente produce quei rigurgiti collettivi che portano buona parte dei maschi italiani a farsi possedere dalla smania irrefrenabile di andare in giro per le strade indossando camicie dello stesso colore, organizzando ronde punitive contro chi indossa camicie diverse, contro chi pensa in modo diverso, contro chi adora altri dei o chi si illude ci siano altri, possibili modi di amare. Il duce di Filippo Timi – dalla sua iniziale disfida contro Dio sino al suo terminale destino di statua schiacciata da una pressa – traccia la parabola paradigmatica di ogni potere che ambisca – dalla Santa Inquisizione a Silvio Berlusconi – ad esercitare se stesso prima di tutto nella testa e nell’anima delle persone. Ed è proprio questo, più di ogni altra cosa, che forse interessa a Marco Bellocchio nel suo “melodramma futurista” su Ida Dalser e Benito Mussolini: lo scompenso che si crea fra una donna che è e resta corpo (fremente, piangente, ferito) e un maschio che – grazie al potere che incarna – da corpo si trasforma in fantasma di pietra, perennemente assente e al tempo stesso sempre incombente, pesante, castigante, oppressivo. Vincere rilegge il fascismo come pratica di annientamento dei corpi e come colonizzazione fraudolenta delle menti. Persa nelle ombre spettrali della splendida fotografia di Daniele Ciprì, Ida Dalser affida alle parole la sua estrema ratio, la sua vana e inane speranza di giustizia, senza rendersi conto che il conflitto si è spostato tutto sul terreno delle immagini. Se in Il regista di matrimoni (2006) era un cineasta (Franco Elica, interpretato da Sergio Castellitto) a salvare la principessa Bona da un matrimonio non desiderato e non voluto, qui – in Vincere – è il cinema tout court – senza più bisogno nemmeno della mediazione di un regista – a salvare Ida Dalser dall’abisso di follia in cui vorrebbe precipitarla l’uomo che lei invano si ostina ad amare. C’è tanto cinema, in Vincere. C’è l’Ejzenštejn di Ottobre (1928) e c’è il Chaplin di Il monello (1921), c’è il Blasetti di Vecchia guardia (1934) e l’Antamoro di Christus (1916). Non solo: quasi tutte le scene-madri si svolgono al cinema, quasi a suggerire che è lì, nel luogo novecentesco in cui la realtà si rende visibile attraverso i suoi simulacri, che si scatenano le contraddizioni e si aprono i conflit-
492
Lessico del cinema italiano
ti. C’è una scena, fra le tante ambientate in un cinema, che vale da sola l’intero film. Ed è quella in cui Ida Dalser, prima di essere internata ed annientata dalla cieca ferocia del potere, è seduta in sala e guarda l’immagine dell’uomo che ama – ormai così diverso, anche fisicamente, da come lei l’aveva conosciuto – intento a parlare dallo schermo. A un certo punto i fascisti in sala si alzano in piedi e rivolgono all’icona del duce il tributo del saluto romano. Lei, rimasta seduta, si accorge che quei corpi gonfi e ringhianti le ostruiscono la visione, e quindi si alza a sua volta e va a sedersi in primissima fila, davanti a tutti. Ma poi ci ripensa, si alza di nuovo, si avvicina allo schermo e si gira verso la platea. Il fascio di luce del proiettore colpisce il suo corpo, le disegna addosso le immagini, la ingravida di nuovo con l’iconizzazione del duce. Ida è un corpo di carne che vive tra le ombre del cinema, e al tempo stesso è uno sguardo che dallo schermo ci riguarda, e che guarda i fascisti in platea, i quali – pur guardando lo schermo di cui anche lei è parte – nemmeno la vedono, accecati come sono dall’invadenza pervasiva dell’immagine del Capo. Lì, in quell’immagine, in quel farsi cinema di un corpo invisibile che guarda, Bellocchio lascia intravedere quello che forse è l’obiettivo primario del suo film: mostrarci la nostra cecità di spettatori, incapaci di intuire la vita vera, la nuda vita, nel turbinio di immagini con cui il potere celebra se stesso e prende possesso delle nostre teste e dei nostri cuori. Anche nell’ultima sequenza Ida Dalser ci guarda. Guarda in macchina con i suoi occhi divoranti, e ci interpella. E in quello sguardo, molto più che nelle migliaia di lettere, suppliche e parole che Ida ha inviato invano ai potenti della Terra, c’è il senso ultimo della sua sfida. Dallo schermo, qualcosa ci riguarda: e quello sguardo è un atto d’accusa – o una chiamata di correo – contro il nostro continuare a essere complici – negli anni trenta come oggi – della narcisistica tracotanza e dell’annichilente prepotenza di un potere che continua a far finta che non ci sia nulla da vedere oltre e al di là dell’immagine del Capo. 4.2 Complottismo e paranoia Quanto più il potere è percepito dal cinema italiano come invisibile ed oscuro, tanto più genera fantasmi. E sollecita racconti
Potere Gianni Canova
493
e narrazioni che tendono a ipotizzare – dentro le trame di questo potere inafferrabile – gesti, azioni e interessi altrettanto indicibili e indecifrabili. I tanti “misteri” irrisolti che costellano la storia dell’Italia repubblicana – dalle stragi di Portella della Ginestra, Piazza Fontana, Brescia Ustica e Bologna ai tentati “golpe” De Lorenzo e Borghese via via ai “casi” Mattei, Moro, Ambrosoli e Pasolini, fino alle stragi terroristiche di mafia degli anni novanta e, ancora, al G8 di Genova del 2001 – hanno generato una copiosa e corposa filmografia il cui più evidente denominatore comune è dato proprio dall’idea che dietro a ognuno di questi fatti si celino la volontà inconfessabile e la strategia delirante di un potere segreto, impunito e spietato: una sorta di “dietrologia” ossessiva e compulsiva che evoca incessantemente la presenza fantasmatica di un “burattinaio” non identificabile (un contropotere che spesso coincide o è colluso con il potere vero) come per rimuovere o giustificare l’incapacità della società italiana di individuare i responsabili reali di quei crimini e di trovare una spiegazione razionale per ognuno di quei “misteri” irrisolti. Alcuni recenti studi tracciano un quadro illuminante ed esaustivo non solo dei procedimenti linguistici e narrativi adottati dal cinema politico-indiziario italiano, ma anche e soprattutto di quanto questo cinema sia stato di fatto influenzato da quella che è ormai comunemente chiamata la conspiracy theory75. Ci limiteremo pertanto in questa sede a richiamare un paio di casi esemplari, a modo loro emblematici e paradigmatici di quanto il complottismo abbia inciso nella percezione e nella rappresentazione del potere elaborata e proposta dal cinema italiano. Il primo caso riguarda – quasi inevitabilmente – la messinscena reiterata e ossessiva di quanto avvenne il 16 marzo 1978 in via Fani, a Roma, con il rapimento e il successivo sequestro del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Con la significativa eccezione del film di Marco Bellocchio Buongiorno, notte (2003), su cui torneremo in seguito, la copiosa filmografia esistente sul
75
Si vedano anche solo A.G. Mancino, Il processo della verità. Le radici del film politico-indiziario italiano, Kaplan, Torino 2008, e Strane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, a cura di C. Uva, cit. Più in generale, sull’immaginario legato alle teorie del complotto, si veda R. Ceserani, L’immaginazione cospiratoria, in Cospirazioni, trame: Atti della Scuola Europea di Studi Comparati, a cura di S. Micali, Le Monnier, Firenze 2003.
494
Lessico del cinema italiano
cosiddetto “caso Moro”76 si configura come esempio da manuale di dietrologia narratologica: come ha ben evidenziato Alan O’Leary, la storia di questo sequestro, con il suo tragico esito finale, diventa per il cinema italiano l’occasione privilegiata «per veicolare la sensazione che in Italia il potere politico, economico e ideologico sia controllato in maniera occulta e invisibile dietro le quinte dell’apparato democratico»77. Film come Il caso Moro di Giuseppe Ferrara o Piazza delle Cinque Lune (2003) di Renzo Martinelli vanno esattamente in questa direzione: il primo accreditando l’idea di un complotto secondo cui la loggia massonica P2 e i servizi segreti, appoggiati dagli americani, si sarebbero fatti garanti che la “via crucis” di Moro sarebbe terminata con la morte dello statista, il secondo avanzando invece l’ipotesi – nei modi e nelle forme di un thriller iperspettacolare sul modello di JFK (1991) di Oliver Stone – che il leader delle Brigate Rosse, principale pianificatore del sequestro Moro, fosse in realtà una spia manovrata da una rete di interessi che si estendeva fino alla CIA. In entrambi i casi l’ostentata esibizione di documenti, dati, rapporti e testimonianze, assieme all’adozione di stilemi da cinema-verità, tende a conferire autorevolezza e inconfutabilità alla tesi del complotto e all’idea che ci sia sempre un “grande vecchio” nascosto e onnipotente a tirare i fili della Storia. Molto opportunamente O’Leary ricorda come secondo Popper questo feticismo del complotto abbia in sé qualcosa della visione omerica secondo cui tutto ciò che accadeva sulla piana di Troia non era che un riflesso delle cospirazioni e delle congiure in atto sull’Olimpo tra gli dei78. Commenta O’Leary: «In questa luce la teoria del complotto si rivela essere una funzione dell’impotenza umana e dell’ignoranza sulla natura dei processi storici, oltre che un disconoscimento delle proprie complicità in essi. Ciò che viene fatto passare come accesso privilegiato alla verità non è altro che il suo opposto: la manifestazione, miticamente declinata, dell’incapacità di orientarsi in un sistema sociale complesso»79. 76 77 78 79
Si veda in proposito F. Ventura, Il cinema e il caso Moro, Le Mani, Genova 2007. A. O’Leary, Moro, Brescia, conspiracy. Lo stile paranoico nel cinema italiano, in Strane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, cit., p. 71. K. Popper, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, Routledge, London 1963. A. O’Leary, Moro, Brescia, conspiracy, cit., p. 72.
Potere Gianni Canova
495
Un simile approccio è tutt’altro che occasionale nel cinema italiano e si offre anzi come canone e modello per la maggior parte dei film che provano a indagare su fatti o episodi della nostra storia80. La teoria del complotto trova certo una qualche ragion d’essere nei tanti misteri effettivamente irrisolti e oscuri che – fra “corpi deviati” dello Stato, servizi segreti e agenti provocatori – si incistano nelle tormentate vicende dell’Italia repubblicana. E tuttavia l’idea che nessuna verità sia possibile, e che dietro ogni fatto di cronaca ci sia una trama oscura inaccessibile e indecifrabile per l’opinione pubblica democratica è talmente diffusa e pervasiva, e coinvolge tanto il cinema dei grandi autori (si pensi anche solo alla filmografia di un maestro come Francesco Rosi, da Il caso Mattei a Lucky Luciano) quanto il cinema dei generi di profondità (si vedano anche solo titoli come La polizia ha le mani legate, 1975, di Luciano Ercoli, Morte in Vaticano, 1982, di Marcello Aliprandi fino a Attenti a quei P2, 1982, di Pier Francesco Pingitore)81, tanto la ricognizione sul passato (Segreti di Stato, 2003, di Paolo Benvenuti) quanto quella sul presente (Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni, 2003, di Ferdinando Vicentini Orgnani), da configurare davvero una visione del potere – e forse perfino un “sentimento” del potere, e un immaginario del potere – segnati paranoicamente dall’opacità, dalla segretezza e da una impenetrabilità che tanto più vengono riconfermate quanto più si tenta (o si finge) di volerle infrangere e illuminare. Si veda anche solo, fra i titoli più recenti che vanno in questa direzione, Romanzo di una strage (2012) di Marco Tullio Giordana. In singolare sintonia con i metodi e le procedure adottate 25 anni prima da Giuseppe Ferrara per il suo film sull’affaire Moro, Giordana e i suoi sceneggiatori Stefano Rulli e Sandro Petraglia rileggono l’attentato alla Banca dell’Agricoltura, in Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969, non solo provvedendo a una meticolosa ricostruzione mimetica di volti, corpi e luoghi (secondo quell’estetica dei sosia che dai film di Ferrara e da Il delitto Matteotti, 1973, di Florestano Vancini, si propaga fino 80
81
Per una ricognizione accurata sul corpus di film riconducibili a questo modello si veda C. Uva, I misteri d’Italia nel cinema. Strategie narrative e trame estetiche tra documento e finzione, in Strane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, cit., pp.9-34. Per un’analisi del rapporto fra i “misteri” d’Italia e il cinema di genere, cfr. R. Curti, Cinema di genere e misteri d’Italia, in ivi, pp. 159-171.
496
Lessico del cinema italiano
a Il divo di Paolo Sorrentino), ma calando le “trame oscure” di quei mesi drammatici dentro a una “teoria del complotto”, che trova nel libro Il segreto di Piazza Fontana di Paolo Cucchiarelli – e nella sua discussa tesi di una doppia bomba, la prima anarchica e la seconda fascista – la propria fonte principale82. Costruito come un’inchiesta di Tv-verità che si muove a ritroso nel tempo, il film tanto più simula accuratezza nell’utilizzo delle fonti e delle informazioni, tanto più rivendica autorevolezza e veridicità, quanto più lascia lo spettatore nello sconcerto, presentando un universo diegetico in cui ogni verità ne contiene un’altra, come in un gioco a scatole cinesi, e ogni ipotesi è smentita da una contro-ipotesi analoga e contraria. Insomma: quanti più fatti vengono a galla, tanto più il quadro complessivo diventa oscuro, indecidibile, confuso. È il paradosso di ogni teoria del complotto: come ha detto bene Frederic Jameson in suo illuminante passaggio, la «conspiracy theory […] è la mappatura cognitiva da parte dell’uomo comune nell’era postmoderna»83. I film (o i libri) che la fanno propria, non raggiungono mai quella funzione epistemologico-cognitiva prospettata e promessa dagli autori, ma caso mai danno espressione all’inquietudine e al malcontento diffusi nel corpo sociale. Anche in questo caso, per riprendere di nuovo la lucida analisi di Alan O’Leary, la rappresentazione del complotto «non necessariamente rivela la “verità” alle spalle di quegli attentati anonimi, ma piuttosto offre una metafora per quella diffusa sensazione per cui la società sarebbe organizzata secondo una logica iniqua»84. Dalla visione si esce insomma non con un surplus cognitivo e informativo, ma con la conferma che nella società ci sono “trame oscure” tessute da poteri nascosti che insidiano la trasparenza della vita democratica. Romanzo di una strage non ci fornisce una conoscenza privilegiata dei fatti né una rivelazione incontrovertibile dell’accaduto: ci garantisce piuttosto una rimozione consolatoria del disorientamento che oscuramente proviamo quando ci rendiamo conto di non disporre di nessuna intelligenza oggettiva e indiscutibile dei fatti. 82 83 84
P. Cucchiarelli, Il segreto di Piazza Fontana, Ponte alle Grazie, Firenze 2012. F. Jameson, Cognitive Mapping, in Marxism and the Interpretation of Culture, a cura di C. Nelson, L. Grossberg, Macmillan Education, Basingstoke 1988, p. 356. A. O’Leary, Moro, Brescia, conspiracy, cit., p. 65.
Potere Gianni Canova
497
Insomma, più che una rivelazione o un’illuminazione, una sorta di paradossale terapia. Al tempo stesso, un ulteriore contributo al consolidamento di quell’immagine del potere invisibile e nascosto che connota in modo pervasivo non solo il cinema ma un po’ tutto l’immaginario italiano. In questo quadro, segnato dalla paranoica ossessione di riuscire a rendere visibile un potere che non lo è, e di dargli un volto, un nome, un’identità, risulta tanto più interessante – proprio per la sua evidente eterodossia – un film come Diaz - Non pulire questo sangue (2012) di Daniele Vicari. Nella sua livida e attonita ricostruzione dei fatti accaduti alla Scuola Diaz di Genova nella notte del 22 luglio 2001, in concomitanza con il G8 che si stava svolgendo in città, Vicari non tira in ballo nessuna “teoria del complotto”, né si titilla in dietrologiche fumisterie. Piuttosto mostra come dentro quella scuola, in quella notte, si sia scatenato l’inferno: una vera mattanza, o – come si è detto – una “macelleria messicana”. Accusato da più parti di aver rimosso nomi e cognomi di colpevoli, e di non aver indicato i responsabili di quel che mostra (cioè, in una parola, di non aver rispettato il paradigma “dietrologico”), il film trova invece un afflato potentissimo proprio perché si stacca dalla cronaca, o dall’idea di film-requisitoria, per costruire una scena del crimine che è tanto più sconvolgente quanto più addossa le responsabilità del massacro non a questo o qual funzionariocarogna, ma a un sistema che può permettersi impunemente la sospensione delle garanzie democratiche come forma perversa di controllo e di repressione violenta del dissenso sociale. Quei volti tumefatti, quei corpi illividiti, quel sangue sui pavimenti e sopra i muri, quelle scene di ordinaria barbarie che accadono nella notte di Bolzaneto sono più forti di qualsiasi requisitoria da pubblico ministero e mostrano il volto feroce del potere molto più dei tanti film “complottisti” che segnano la storia del cinema italiano. Il regista Daniele Vicari non cade nell’errore di confondere la sala cinematografica con un’aula di tribunale, né pretende di affidare al suo film una sentenza giudiziaria. Piuttosto cerca di mettere in scena i meccanismi (ma anche i linguaggi, i fantasmi, le mitologie, i fraintendimenti, le ideologie) attraverso cui uno Stato di diritto (e gli uomini che lo rappresentano) possono arrivare a usare la tortura esercitata su persone indifese come mezzo di dominio. Ha scritto bene Ida Dominijanni:
498
Lessico del cinema italiano
Le presunte mancanze o i presunti errori rafforzano, anziché indebolire, il taglio del film: perché l’assenza dei nomi dei carnefici non assolve il potere ma lo spersonalizza, segnalando che quell’orrore è ripetibile; come la presenza dei black bloc alla Diaz non attenua la sproporzione del massacro ma la inchioda, ricordando che in uno stato di diritto le garanzie appartengono, o dovrebbero, a tutti, black bloc compresi85.
E aggiunge, toccando quello che è – forse – il cuore del problema: «Cos’è questo bisogno di new realism che cerca e trova conferma e certificazione dei fatti solo nei nomi, nelle sentenze, nei documenti, nei bolli e nei protocolli, come se la verità del realmente accaduto e del politicamente vissuto non avesse altre vie per imporsi?»86. Come dire: non è con il realismo da anagrafe o da referto giudiziario che il cinema può credere di riuscire davvero a dare un volto e una forma al potere. 4.3 L’immaginazione al potere (Buongiorno, notte) Non è il realismo, infatti, il registro scelto da Marco Bellocchio per il suo film che più di ogni altro cerca di fare i conti con il fantasma del potere, e di afferrarne l’immagine (Buongiorno, notte). Se c’è un volto che emblematicamente incarna il potere (la sua forza mostruosa, ma anche la sua assoluta debolezza) nella storia dell’Italia repubblicana, questo è il volto di Aldo Moro. E il “caso Moro”, con l’infinita bibliografia e mitografia che ha generato, con i sedimenti che ha depositato nell’immaginario collettivo, con i fantasmi che ha scatenato, con i conflitti di cui è intessuto, è forse il paradigma più esaustivo di un “sentimento” del potere che attraversa e segna tutta la società italiana contemporanea. Bellocchio – che secondo la suggestiva lettura proposta da Anton Giulio Mancino da sempre sarebbe stato ossessionato dal fantasma di Moro, non a caso presente un po’ a sorpresa in tutti i suoi film successivi al 197887 – non insegue il “feticismo del documento” caro al cinema 85 86 87
I. Dominijanni, Stato di diritto e memoria senza proprietà. Dove arriva l’impronta di “Diaz”, in “Alias”, supplemento de “il Manifesto”, 21 aprile 2012. Ibidem. A.G. Mancino, La recita della storia. Il caso Moro nel cinema di Marco Bellocchio, Bietti, Milano 2014.
Potere Gianni Canova
499
complottista, né sbandiera dossier esclusivi su cui edificare improbabili controinchieste. Il suo film sceglie piuttosto la strada dell’apologo e dell’immaginazione poetica, fin dal titolo: che è derivato, con una leggera modifica, da un verso di una poesia di Emily Dickinson («Buongiorno, Mezzanotte») e nel suo contrapporre ossimoricamente giorno e notte, introduce in maniera allusiva ma anche sufficientemente esplicita quel gioco di contrasti (fra luce e ombra, fra interno e esterno, fra padri e figli, fra normalità e follia) che struttura di fatto non solo il film, ma anche l’immaginario che al “caso Moro” idealmente si collega. Bellocchio, come è noto, sceglie di raccontare il sequestro di Aldo Moro dall’interno, assumendo come punto di vista privilegiato quello di una terrorista (Chiara, ricalcata sulla figura della brigatista Anna Laura Braghetti) che a poco a poco, proprio nel contatto quotidiano con lo statista rapito, prende le distanze dalla cinica ferocia dei suoi compagni e arriva a sognare – ma solo a sognare – un esito diverso per tutta la vicenda. È una scelta di regia (ma prima ancora di sceneggiatura) molto forte, che induce Bellocchio a concentrare tutto il racconto dentro i muri angusti e soffocanti dell’appartamento romano in cui quattro brigatisti tengono Moro prigioniero, delegando alla Tv il compito di far entrare nella “prigione” brigatista i fatti, le immagini e gli eventi del mondo esterno e le mosse del potere politico-istituzionale di fronte alla più grave crisi che abbia colpito la giovane Repubblica italiana. Come riducendo la realtà storico-politica a una sorta di fuori campo, Bellocchio si concentra cioè sui gesti, gli sguardi e le relazioni chiasmiche che si intrecciano all’interno dell’appartamento fra il prigioniero (il dominante divenuto dominato) e i suoi sequestratori (i dominati che aspirano a essere dominanti). Buongiorno, notte, insomma, non suggerisce alcuna idea di complotto, e non fa dietrologie. Semplicemente, si concentra sulla follia di alcuni personaggi che, animati dal sogno di cambiare il mondo, finiscono per trasformarsi in aguzzini e per decidere la condanna a morte di un Nemico che in realtà sentono quasi come un Padre. Non accade (quasi) nulla nell’appartamento romano in cui è concentrata la vicenda: i brigatisti simulano un’esistenza apparentemente ordinaria e piccolo-borghese, consumano i loro pasti come se fossero una vera famiglia e intrattengono perfino rapporti di fredda cortesia con il vicinato (la madre che lascia il figlio neonato
500
Lessico del cinema italiano
in consegna a Chiara proprio la mattina del sequestro, la vicina che spia curiosa dall’appartamento di fronte e che rivela a Chiara il tradimento del presunto marito). La Storia è fuori, entra ed esce di campo – come si diceva – grazie alla Tv sempre accesa, ma al contempo è dentro, acquattata dietro la parete semovente della libreria che separa la cella di Moro dal resto della casa. Lì, in questa incessante oscillazione fra dentro e fuori, in questo “zapping” fra l’emergenza preoccupata delle cronache dei telegiornali e i consueti varietà televisivi del sabato sera con Raffaella Carrà che sgambetta e canticchia dal piccolo schermo come se nulla fosse, Bellocchio tesse una trama drammaturgica di grande finezza e riesce a cogliere – tanto nell’appartamento dei sequestratori quanto nel mondo esterno che entra ed esce grazie al tubo catodico dal loro covo – il nesso inscindibile che mescola ed unisce normalità e follia, o quotidianità e catastrofe. Ma, anche, il potere e il suo opposto. Il potere e il suo doppio. Il potere e il contropotere che prende il posto del potere. Il personaggio di Chiara è da questo punto di vista assolutamente centrale: unica del gruppo brigatista a non essere del tutto in clandestinità, conduce una doppia vita, esce ogni giorno di casa per andare a lavorare, fa la spesa, mantiene i rapporti con la famiglia e ha una relazione amicale sostanzialmente sincera con un giovane aspirante sceneggiatore che frequenta il suo ufficio. Non solo: a lei Bellocchio delega il compito di usare l’immaginazione come contrappunto alle tragiche vicende reali di cui è coprotagonista e soprattutto corresponsabile. Chiara infatti sogna. Talora ad occhi aperti, talora durante il sonno. Sogna in bianco e nero. E i suoi sogni e le sue visioni si materializzano sullo schermo attraverso immagini di film: prima, quando ancora è convinta della purezza rivoluzionaria dell’azione che sta compiendo assieme ai suoi compagni, Chiara sogna immagini tratte da Tre canti su Lenin (1934) di Dziga Vertov (in particolare la sequenza celeberrima della panchina di Lenin innevata); poi – dopo l’episodio in cui i quattro carcerieri mormorano all’unisono lo slogan «La classe operaia deve dirigere tutto», quasi come esorcismo alla notizia che gli operai nelle fabbriche non appoggiano la loro azione – Bellocchio le attribuisce visioni tratte dal repertorio dei film di propaganda stalinista musicate con la Marcia trionfale dell’Aida di Verdi; infine – quando Chiara comincia a rifiutare l’idea di
Potere Gianni Canova
501
uccidere Moro – Bellocchio usa le immagini delle fucilazioni di partigiani da Paisà (1946) di Roberto Rossellini, come per collegare apertamente la figura di Moro a quella delle vittime e dei condannati a morte della Resistenza. Questo sottotesto onirico e visionario introduce una frattura (una ferita, uno iato, un attrito) nell’universo concentrazionario del carcere brigatista e individua nell’immaginazione l’unica, residua possibilità di salvezza. O di antitesi alle logiche feroci del potere. «L’immaginazione non ha mai salvato nessuno», sentenzia freddamente il personaggio interpretato da Luigi Lo Cascio (modellato sulla figura del leader delle BR Mario Moretti). Ma Chiara non la pensa affatto così: pensa anzi che l’immaginazione sia una parte della realtà. E allora sogna – mentre i suoi compagni portano via Moro bendato, per condurlo a morte – che Moro sia uscito liberamente dal carcere – dopo che lei ha narcotizzato in sogno i suoi carcerieri – e che passeggi liberamente per le vie di Roma, sotto la pioggia, dalle parti dell’Eur. Fosse andata davvero così, forse, l’Italia non sarebbe diventata quella che è. Invece Moro fu giustiziato. Ma Buongiorno, notte lascia anche l’omicidio fuori campo: Bellocchio si limita a usare immagini del repertorio televisivo per rievocare i funerali dello statista, con una panoramica impietosa – sulle note stridenti di un brano dei Pink Floyd – che basta, da sola, a rendere visibile tutta la mostruosità della “ragion di stato” e di coloro che ne furono alfieri in questa sorta di teatro dell’assurdo. Sono tutti mostri, sembra suggerire l’immagine finale sui volti dei potenti – da Andreotti a Cossiga, da Forlani a Colombo, da Craxi a Berlinguer – mentre la musica dei Pink Floyd rievoca nello spettatore gli sguardi e i pianti e le occhiate furtive e le ombre e gli spettri dei lunghi giorni della prigionia di Moro. Poi, di nuovo, Moro saltella libero per la strada, e sorride: si chiude su un falso, il film. O su un’immagine che lascia l’ultima parola all’immaginazione invece che alla realtà, al possibile invece che all’effettuale. Ma Buongiorno, notte è – e vuole essere – proprio questo: un omaggio al potere dell’immaginazione contro il cinismo della Storia e la ferocia del potere. Non a caso, il personaggio del giovane sceneggiatore Enzo Passoscuro, amico di Chiara – quello che ha scritto una sceneggiatura intitolata proprio Buongiorno, notte in cui usa l’immaginazione per prefigurare tutto quello che sarebbe successo dopo il sequestro dello
502
Lessico del cinema italiano
statista – è l’unico ad essere arrestato nel corso del film. Non si dimentichi che nella ricostruzione di Bellocchio Moro aveva fra le sue carte proprio questa sceneggiatura: un’incoerenza nella trama logica del film? Non proprio: forse qui, in questo scambio impossibile, in questo espediente simbolico, Bellocchio concentra il grumo di senso più forte di tutto il film. E ci dice come la tragedia a cui abbiamo assistito sia quella di una generazione che sognava di portare l’immaginazione al potere e che invece ha finito per farsi sequestrare dal potere (dai suoi feticci, dalle sue maschere) ogni capacità di immaginazione. Compresa la sceneggiatura di Buongiorno, notte, che Moro portava nella sua borsa prima ancora che i fatti narrati dalla sceneggiatura fossero accaduti. Con questa scelta antirealistica e “veggente” Bellocchio ribadisce la sua fiducia nel cinema e nel film come dispositivo immaginifico capace di prefigurare e prevedere la realtà. Ha scritto bene Anton Giulio Mancino: «Passoscuro riesce più di qualunque altro personaggio o soggetto inquirente, interno o esterno alla finzione, a controllare il tracciato degli eventi reali e cinematografici, senza distinzioni. Forse è per questo che a sorpresa viene arrestato dalla polizia. Come se fosse lui, portatore sano e neutrale di verità immaginate, e non Chiara, la principale minaccia per lo Stato»88. Come dire: nell’eterna dialettica fra il cinema che ricostruisce ciò che è già accaduto e il cinema che prefigura e immagina ciò che ancora può e deve accadere, è nella seconda strada che si può sperare di intravvedere (o prefigurare? o immaginare?) quel volto oscuro del potere a cui così a lungo il cinema italiano ha dato la caccia invano. Epilogo Il potere nelle immagini: repertorio, archivio e visibilità (La mafia uccide solo d’estate, Belluscone. Una storia siciliana) Il volto del potere, del resto, ormai da tempo è tutt’altro che oscuro. È, al contrario, perennemente visibile e osservabile. La sua visibilità è direttamente proporzionale alla sua attrattività. Ma non è il cinema a dargliela, la visibilità. È piuttosto la Tv. È il sistema mediatico nel suo complesso. Lì – nel rito quotidiano dei telegior88
Ivi, p. 182.
Potere Gianni Canova
503
nali e dei talk show, nelle apparizioni catodiche all’ora di cena, nei reality mascherati da risse notturne – il potere entra nelle case degli italiani e si mette in scena. Si rende perennemente visibile. Come il Re Sole nel film di Rossellini da cui questa analisi ha preso le mosse, anche il potere democratico contemporaneo vuole che la sua vita si svolga tutta sempre sotto gli occhi dei cittadini/sudditi: ed è la Tv a inverare questa volontà. Come Re Sole, la Tv è sempre lì, perennemente accesa, e incessantemente pronta a mostrare i riti e le cerimonie del potere. A renderle autorevoli e desiderabili. Il potere sa di essere lì, nelle immagini che lo presentificano e lo diffondono, lo espandono e lo celebrano. E lì, spudoratamente, si mette in scena. Il cinema non può che prenderne atto. Dopo averci fatto intendere per anni che il potere è invisibile e irrappresentabile, dopo aver sperimentato i registri linguistici più azzardati e coraggiosi per cercare – come si è detto più volte – di afferrare il fantasma di un potere che pareva inafferrabile, da qualche anno a questa parte il cinema italiano ha constatato la propria ontologica impossibilità di competere con la Tv nel rendere visibile in tempo reale la quotidianità del potere (e, in fondo, anche la sua ordinaria banalità) e ha deciso – con lungimirante saggezza – di ripartire da qui. Dalla comprensione che il potere è ormai prima di tutto nelle immagini che quotidianamente lo visualizzano. Così il cinema ha iniziato, sempre più intensamente e convintamente, a lavorare su queste immagini. A riesumarle. A rimontarle. Fino a produrre cortocircuiti di senso inattesi. Anche se non è found footage nel senso più pieno del termine, il lavoro di ricerca e poi di riuso e di “rimediazione” delle immagini di archivio è diventato la strategia più avanzata con cui il cinema italiano ha cercato e sta cercando di lavorare sul potere nell’era in cui esso stesso risiede in gran parte nelle proprie immagini mediatiche. Se è vero che l’uso dell’archivio ha radici lontane, è anche vero che nel cinema italiano è proprio nei film sul potere che tale uso si è rivelato sorprendentemente illuminante, come si è visto poc’anzi a proposito di film imprescindibili come Il caimano di Moretti e Buongiorno, notte di Bellocchio. Ma repertorio e archivio si fanno pratica di visualizzazione del potere anche in film inattesi: si veda ad esempio come l’archivio mediatico si incisti nell’impianto diegetico di un film come La mafia uccide solo d’estate (2013) di Pif, fino a fornire al protagonista il lessico visuale su cui costruire la propria identità.
504
Lessico del cinema italiano
Il giovane Arturo vede per la prima volta le immagini televisive di Giulio Andreotti mentre questi è ospite in una puntata di “Bontà loro” di Maurizio Costanzo in cui dichiara di aver chiesto a sua moglie di sposarlo in un cimitero. Dal piccolo schermo televisivo Andreotti guarda in macchina e proprio questo camera look innesca nel giovane protagonista un processo di identificazione che lo porta a travestirsi da Andreotti durante la festa di classe, e ad andare in giro travestito da Andreotti per la strada, tanto da essere scambiato da due mafiosi palermitani per un figlio segreto di Andreotti. Le immagini mediatiche del potente leader democristiano si intarsiano nel racconto, vi si accomodano, lo indirizzano, lo modificano. Pif non è ossessionato dalla necessità di mostrare il volto del potere: l’ha già fatto la Tv. Il suo film si limita a usare le immagini già prodotte e a risemantizzarle grazie a un ready made che le porta ad esprimere “altro” rispetto a quello che avrebbero dovuto esprimere quando furono realizzate. In questo modo il cinema, scalzato dalla televisione (e ora anche dagli altri media digitali) nella capacità di dare un volto al potere, recupera il proprio ruolo centrale nel sistema dei media rivendicando la capacità di rivedere e risignificare le immagini che altri media hanno prodotto. Non è più la realtà che il cinema sente di dover visualizzare. Gli interessa di più governare il sistema di immagini con cui altri media hanno preteso di rendere visibile e comunicabile la realtà. Esemplare, in questa direzione, il film di Franco Maresco Belluscone. Una storia siciliana (2014). Deformando fin dal titolo l’identità storico-politica di Silvio Berlusconi, e riducendolo alla percezione del suo fantasma nel contesto popolare siciliano, il film di Franco Maresco – indefinibile, indescrivibile, lontano dai generi e fuori dai canoni consueti e consolidati89 – evoca Berlusconi solo sub specie mediatica. Berlusconi non viene mai ripreso dalla camera di Maresco (come accade invece al senatore Dell’Utri, inquadrato e intervistato teatralmente su un palcoscenico, dietro un sipario rosso e seduto su una sorta di trono). Berlusconi è un fantasma dell’etere, una presenza catodica. All’inizio del film, tutti parlano di lui 89
Sulla difficoltà di classificare il film di Maresco dentro parametri tradizionali insiste anche Emiliano Morreale, che arriva a parlarne come di «un Caso Mattei in cui la ricerca della verità però collassi e lasci il posto alla melanconia e alla bile nera». Cfr. E. Morreale, Belluscone politico e neomelodico, in “Domenicale”, supplemento de “Il Sole 24 Ore”, 24 agosto 2014.
Potere Gianni Canova
505
– dall’impresario Ciccio Mira ai cantanti neomelodici palermitani – secondo un procedimento di mitizzazione in absentia che ricorda l’incipit verghiano di quell’altra grande storia siciliana di ascesa e di caduta che è il Mastro Don Gesualdo. Anche Belluscone. Una storia siciliana è un racconto di ascesa e caduta: comincia con la caduta (Berlusconi annuncia in Tv le sue dimissioni da Presidente del Consiglio, mentre la macchina da presa scivola in esterno notte sulle sagome scure dei palazzoni di cemento delle periferie palermitane, dalle cui finestre accese si sente rimbombare l’eco del messaggio televisivo del leader di Forza Italia) e finisce con il ricordo sbiadito dell’ascesa (con un Berlusconi di 20 anni più giovane che pronuncia il celebre discorso della “discesa in campo”). Per il resto, la riflessione sul fantasma di Berlusconi è tutta affidata al repertorio: non solo a quello direttamente berlusconiano, ma anche quello relativo agli effetti che il berlusconismo ha avuto sui corpi e sui costumi della società. È come se Berlusconi vivesse solo nelle immagini mediatiche, nell’archivio del suo mito. E il film di Maresco non può che riconoscere che ormai sono le immagini ad aver preso il potere (tanto che le immagini delle Tv berlusconiane continuano a dominare e ad influenzare l’immaginario collettivo anche se Berlusconi è ormai defilato e in buona parte fuori dai giochi). È a queste immagini che bisogna ricorrere, ed è su di esse che bisogna lavorare, per cercare di capire qualcosa di quel potere che esse disincarnano e, al contempo, rendono immortale. Sullo sfondo, resta comunque aperto un interrogativo: il cinema italiano non ha saputo rappresentare la democrazia perché non è mai riuscito a capirla o – al contrario – perché ha capito fin troppo bene la sua essenza, e ne è rimasto traumatizzato? Filmografia di riferimento Cabiria (Pastrone, 1914), Camicia nera (Forzano, 1933), Scipione l’Africano (Gallone, 1937), Senso (Visconti, 1954), Il gattopardo (Visconti, 1963), Le mani sulla città (Rosi, 1963), La presa del potere da parte di Luigi XIV (Rossellini, 1966), Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Petri, 1970), Il potere (Tretti, 1972), L’udienza (Ferreri, 1972), Salò o le 120 giornate di Sodoma (Pasolini, 1975), Todo modo (Petri, 1976), Forza Italia! (Faenza, 1978), Prova d’or-
506
Lessico del cinema italiano
chestra (Fellini, 1979), L’ultimo imperatore (Bertolucci, 1987), Il portaborse (Luchetti, 1991), Buongiorno, notte (Bellocchio, 2003), Il caimano (Moretti, 2006), I viceré (Faenza, 2007), Il divo (Sorrentino, 2008), Vincere (Bellocchio, 2009), Noi credevamo (Martone, 2010), Bella addormentata (Bellocchio, 2012), Viva la libertà (Andò, 2013), Belluscone. Una storia siciliana (Maresco, 2014).
INDICE DEI FILM
A memoria (D. Ciprì, F. Maresco, 1996), 274 Abbasso la miseria! (G. Righelli, 1945), 167 Abbasso la ricchezza! (G. Righelli, 1946), 167 Accattone (P.P. Pasolini, 1961), 48, 105, 184, 406-407, 421 Achtung! Banditi! (C. Lizzani, 1951), 323n Addio del passato (M. Bellocchio, 2002), 423 Addio Mimì! (C. Gallone, 1947), 380 Aida (C. Fracassi, 1953), 379 Alberi (M. Frammartino, 2013), 107 Albero degli zoccoli, L’ (E. Olmi, 1978), 169, 185, 195 Albero delle pere, L’ (F. Archibugi, 1998), 174 Alì ha gli occhi azzurri (C. Giovannesi, 2012), 204 All’armi siam fascisti! (L. Del Fra, C. Mangini, L. Miccichè, 1962), 335, 359 Allegro fantasma, L’ (A. Palermi, 1941), 243 Allonsanfàn (P. e V. Taviani, 1974), 420-421, 427, 470 Alta infedeltà (M. Monicelli, E. Petri, F. Rossi, L. Salce, 1964), 99 Amami, Alfredo! (C. Gallone, 1940), 380, 382 Amarcord (F. Fellini, 1973), 168, 184, 463 Americano a Roma, Un (Steno, 1954), 96 Amiche, Le (M. Antonioni, 1955), 93
Amici miei (M. Monicelli, 1975), 196, 419 Amici miei - Atto II (M. Monicelli, 1982), 268, 419 Amici miei – Atto III (N. Loy, 1985), 419 Amico di famiglia, L’ (P. Sorrentino, 2006), 136, 489 Amleto e il suo clown (C. Gallone, 1920), 232 Amo te sola (M. Mattoli, 1936), 162n Amor ch’a nullo amato, (E. D’Accursio, 1917), 25 Amor mio non muore!, L’ (G. Amato, 1938), 228 Amor Pedestre (M. Perez, 1914), 231 Amore a Roma, Un (D. Risi, 1960), 94, 114 Amore molesto, L’ (M. Martone, 1995), 125, 140, 194, 196 Amore si fa così, L’ (C.L. Bragaglia, 1939), 240n Amore tossico (C. Caligari, 1983), 196 Andrea Chénier (C. Fracassi, 1955), 379 Angelo bianco, L’ (R. Matarazzo, 1955), 392 Anima divisa in due, Un’ (S. Soldini, 1993), 204 Animali pazzi (C.L. Bragaglia, 1939), 240, 243, 282 Anita Garibaldi (M. Caserini, 1910), 293 Anna (A. Lattuada, 1951), 401, 404 Anna (A. Grifi, M. Sarchielli, 1975), 117n, 155-156, 197, 213
508
Anno uno (R. Rossellini, 1974), 483 Appunti per un poema sul Terzo Mondo (P.P. Pasolini, 1968), 107 Appunti per un’Orestiade africana (P.P. Pasolini, 1968-1969), 107 Aprile (N. Moretti, 1998), 135, 278, 485 Arbitro, L’ (L.F. D’Amico, 1974), 58, 68 Aristogatti, Gli (The Aristocats, W. Reitherman, 1970), 183 Armata Brancaleone, L’ (M. Monicelli, 1966), 171, 201 Arte di arrangiarsi, L’ (L. Zampa, 1954), 96, 266 Assedio dell’Alcazar, L’ (A. Genina, 1940), 314 Assedio, L’ (B. Bertolucci, 1998), 347 Assunta Spina (F. Bertini e G. Serena, 1915), 73, 160, 213, 375, 377, 427 Attenti a quei P2 (P.F. Pingitore, 1982), 495 Avanti a lui tremava tutta Roma (C. Gallone, 1946), 380-381, 383 Avatar (Id., J. Cameron, 2009), 67n Avventura di Salvator Rosa, Un’ (A. Blasetti, 1939), 229, 232n, 247n, 282 Avventura galante di un provinciale (L. Comerio, 1908), 73 Avventura, L’ (M. Antonioni, 1960), 51, 132 Baarìa (G. Tornatore, 2009), 196 Bacio di Cirano, Il (C. Gallone, 1913), 232 Ballando ballando (E. Scola, 1983), 198n Ballo a tre passi (S. Mereu, 2003), 195 Ballo in maschera, Il (U. Falena, 1911), 373 Bambola di carne, La (Die Puppe, E. Lubitsch, 1919), 233 Banchetto di Platone, Il (Le banquet, M. Ferreri, 1989), 270-271, 282
Lessico del cinema italiano
Banditi a Orgosolo (V. De Seta, 1961), 340n Bandito, Il (A. Lattuada, 1946), 11 Barbagia (C. Lizzani, 1969), 340n Barbiere di Siviglia, Il (M. Costa, 1947), 379 Basilicata Coast to Coast (R. Papaleo, 2010), 195 Basilischi, I (L. Wertmüller, 1963), 170 Battaglia di Algeri, La (G. Pontecorvo, 1966), 338 Batticuore (M. Camerini, 1939), 89 Bella addormentata (M. Bellocchio, 2012), 429, 430, 433, 506 Bella e perduta (P. Marcello, 2015), 235n Bella mugnaia, La (M. Camerini, 1955), 224 Bell’Antonio, Il (M. Bolognini, 1960), 57, 190 Bellas mariposas (S. Mereu, 2012), 135, 195 Bellissima (L. Visconti, 1952), 392 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata (L. Zampa, 1971), 204n Belluscone. Una storia siciliana (F. Maresco, 2014), 275n, 282, 503, 505-506 Benvenuti al nord (L. Miniero, 2012), 168, 210 Benvenuti al sud (L. Miniero, 2010), 168, 210 Benvenuto Presidente! (R. Milani, 2013), 459 Benvenuto reverendo! (A. Fabrizi, 1950), 11, 12, 68 Bianca (N. Moretti, 1984), 135 Biaso el luganegher (A. Roatto, 1907), 158 Big Night (Id., C. Scott, S. Tucci, 1996), 207 Bigamo, Il (L. Emmer, 1956), 268 Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza) (Birdman: Or (The Unexpected Virtue of
Indice dei film
Ignorance), A. González Iñárritu, 2014), 136n Blow-up (M. Antonioni, 1966), 86 Boccaccio ’70 (V. De Sica, F. Fellini, M. Monicelli, L. Visconti, 1962), 252n Bohème, La (L. Comencini, 1988), 419 Boom, Il (V. De Sica, 1963), 98, 263, 266, 282 Borghese piccolo piccolo, Un (M. Monicelli, 1977), 270 Boss in salotto, Un (L. Miniero, 2014), 168n Brancaleone alle crociate (M. Monicelli, 1970), 171, 201 Brigante, Il (R. Castellani, 1961), 340n Bronte: cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato (F. Vancini, 1972), 341 Brutti, sporchi e cattivi (E. Scola, 1976), 263, 268 Buongiorno papà (E. Leo, 2013), 66, 68 Buongiorno, notte (M. Bellocchio, 2003), 180, 348-349, 423-424, 493, 498, 501-503, 506 Burla di Fregoli, Una (L. Fregoli, 1899), 231 C’eravamo tanto amati (E. Scola, 1974), 202, 213, 269 Cabiria (G. Pastrone, 1914), 25 e n, 73, 140, 159, 213, 376, 445, 505 Caccia tragica (G. De Santis, 1947), 322 e n, 385 Cadaveri eccellenti (F. Rosi, 1976), 441 Cado dalle nubi (G. Nunziante, 2009), 67 Caduta di Troia, La (L.R. Borgnetto, G. Pastrone, 1911), 375 Cafè Express (N. Loy, 1980), 263 Caimano, Il (N. Moretti, 2006), 100, 135, 275-276, 278, 282, 448, 483486, 488, 503, 506
509
Callas forever (F. Zeffirelli, 2002), 422n Camicia nera (G. Forzano, 1933), 42, 109, 140, 438, 505 Cammino degli eroi, Il (C. D’Errico, 1936), 312 Cammino della speranza, Il (P. Germi, 1950), 190 Canzone dell’amore, La (G. Righelli, 1930), 38 Capitale umano, Il (P. Virzì, 2013), 65, 210 Capitan Fracassa (D. Coletti, 1940), 232n Cappello a tre punte, Il (M. Camerini, 1935), 224, 246, 282 Cappotto, Il (A. Lattuada, 1952), 17, 18 e n, 65, 68, 153n, 262 Capriccio all’italiana (M. Bolognini, M. Monicelli, P.P. Pasolini, Steno, P. Zac, F. Rossi, 1968), 282 Carabiniere a cavallo, Il (C. Lizzani, 1961), 267 Carmen (F. Rosi, 1984), 419 Carmen (G. Lo Savio, 1909), 373, 427 Carmen di Trastevere (C. Gallone, 1962), 380, 382, 427 Carnevalesca (A. Palermi, 1918), 232, 282 Caro diario (N. Moretti, 1993), 132, 135 Carosello napoletano (E. Giannini, 1954), 282 Carro armato dell’8 settembre, Il (G. Puccini, 1960), 333n Carrozza d’oro, La (Le carrosse d’or, J. Renoir, 1952), 245 e n Casa del sorriso, La (M. Ferreri, 1991), 62 Casanova di Federico Fellini, Il (F. Fellini, 1976), 55, 122, 255, 282 Caso Mattei, Il (F. Rosi, 1972), 483, 495, 504n Caso Moro, Il (G. Ferrara, 1986), 486, 494 Catene (R. Matarazzo, 1949), 93n, 170, 183-185, 213, 390-391, 394, 399, 401, 403, 405, 427
510
Caterina va in città (P. Virzì, 2003), 64-65, 68, 134 Cavalleria rusticana (U. Falena, 1916), 375 Cavalleria rusticana (C. Gallone, 1955), 379 Cavalleria rusticana (F. Zeffirelli, 1982), 419 Cena delle beffe, La (A. Blasetti, 1942), 228 C’era una volta in America (Once Upon a Time in America, S. Leone, 1984), 420 Certi bambini (A. e A. Frazzi, 2004), 174, 195 Che cosa sono le nuvole? (P.P. Pasolini, episodio di Capriccio all’italiana, 1968), 172, 241, 243, 244, 258, 282 Chi lavora è perduto (In capo al mondo) (T. Brass, 1963), 53 Christus (G. Antamoro, 1916), 491 Ciao maschio (M. Ferreri, 1978), 55 Cielo sulla palude (A. Genina, 1949), 383-385, 395, 427 Cina è vicina, La (M. Bellocchio, 1967), 408 Cirano di Bergerac (A. Genina, 1923), 232n Città ideale, La (L. Lo Cascio, 2012), 207 Colpi di fulmine (N. Parenti, 2012), 90, 164n, 210 Colpire al cuore (G. Amelio, 1982), 348, 359 Comandante, Il (P. Heusch, 1963), 267 Come due coccodrilli (G. Campiotti, 1994), 420n Come sono buoni i bianchi! (M. Ferreri, 1988), 62, 106 Come te nessuno mai (G. Muccino, 1999), 174 Come tu mi vuoi (V. De Biasi, 2007), 66, 68 Comizi d’amore (P.P. Pasolini, 1964), 197
Lessico del cinema italiano
Commedia dal mio palco, La (L. D’Ambra, 1918), 232 Commissario, Il (L. Comencini, 1962), 267 Compagni, I (M. Monicelli, 1963), 139 Compagnia della teppa, La (C. D’Errico, 1941), 163n Compleanno, Il (M. Filiberti, 2009), 422 Complessi, I (L.F. D’Amico, D. Risi, F. Rossi, 1965), 263, 264 Concorrenza sleale (E. Scola, 2001), 352 Condottieri (L. Trenker, 1937), 309n Conformista, Il (B. Bertolucci, 1970), 413, 414, 445 Conseguenze dell’amore, Le (P. Sorrentino, 2004), 136, 489 Conte Ugolino, Il (G. De Liguoro, 1908), 25 Contessa di Parma (A. Blasetti, 1938), 88, 89, 225 Corazziere, Il (C. Mastrocinque, 1960), 267 Corona di ferro, La (A. Blasetti, 1941), 377-378, 427 Corpo celeste (A. Rohrwacher, 2011), 135 Corpo del duce, Il (F. Laurenti, 2011), 436n Cose dell’altro mondo (N. Malasomma, 1939), 226 Così ridevano (G. Amelio, 1998), 420n Cretinetti al cinematografo (A. Deed, 1911), 231 Cretinetti troppo bello (A. Deed, 1909), 232 Crociata degli innocenti, La (A. Blasetti, 1917), 25 Cronaca di un amore (M. Antonioni, 1950), 400, 402 Cronaca familiare (V. Zurlini, 1962), 408 Dante e Beatrice (M. Caserini, 1913), 25
Indice dei film
Darò un milione (M. Camerini, 1935), 41, 167 Decameron, Il (P.P. Pasolini, 1971), 55, 59 Delitto di Giovanni Episcopo, Il (A. Lattuada, 1947), 11 Delitto Matteotti, Il (F. Vancini, 1973), 495 Deserto dei tartari (V. Zurlini, 1976), 408 Deserto rosso, Il (M. Antonioni, 1964), 51 Detenuto in attesa di giudizio (N. Loy, 1971), 475, 477, 480 Diavolo in corpo (M. Bellocchio, 1986), 55 Diaz - Non pulire questo sangue (Diaz - Don’t Clean Up This Blood, D. Vicari, 2012), 497 Dillinger è morto (M. Ferreri, 1969), 101, 106, 140, 272 e n Dimenticati, I (V. De Seta, 1959), 107 Divo, Il (P. Sorrentino, 2008), 100, 275, 278, 279, 282, 487-489, 496, 506 Divorzio all’italiana (P. Germi, 1961), 95, 97-99, 189, 193, 213 Dolce vita, La (F. Fellini, 1960), 51, 200, 201 e n, 213, 231, 257, 269 Don Giovanni (C. Bene, 1970), 253, 282 Don Giovanni in Sicilia (A. Lattuada, 1967), 57, 68 Donna della montagna, La (R. Castellani, 1944), 83, 140 Donna libera, Una (V. Cottafavi, 1954), 80, 400 Dora Nelson (M. Soldati, 1940), 224 Dottor Mabuse, Il (Dr. Mabuse, der Spieler - Ein Bild der Zeit, F. Lang, 1922), 455 Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) (E. Scola, 1970), 202, 269 Due colonnelli, I (Steno, 1962), 333n Due marescialli, I (S. Corbucci, 1961), 333n
511
Due nemici, I (The Best of Enemies, G. Hamilton, 1961), 333n Due soldi di speranza (R. Castellani, 1952), 91, 92, 95, 97, 189, 387 E la nave va (F. Fellini, 1983), 419, 423, 427 È l’amor che mi rovina (M. Soldati, 1951), 401 E lucean le stelle (C. Gallone, 1935), 380 È piccerella (E. Notari, 1922), 161n È primavera... (R. Castellani, 1950), 97, 387 È stato il figlio (D. Ciprì, 2012), 196n Ecce bombo (N. Moretti, 1978), 125, 134n, 172, 213 Eclisse, L’ (M. Antonioni, 1962), 132, 203n Effetti di luce (U. Falena, E.L. Morselli, 1916), 233 Elisir d’amore, L’ (M. Costa, 1947), 379 Emigrantes (A. Fabrizi, 1948), 204 Emir cavallo da circo (I. Illuminati, 1917), 232 Eravamo sette sorelle (M. Mattoli, 1939), 226 Ernani (L.J. Gasnier, 1911), 373 Eroe dei nostri tempi, Un (M. Monicelli, 1957), 263, 266 Ettore Fieramosca (A. Blasetti, 1938), 228, 229, 377, 379, 384 Europa ’51 (R. Rossellini, 1952), 132, 401 Faictz ce que vouldras (M. Ferreri, 1994), 270 Fame chimica (A. Bocola, P. Vari, 2003), 174, 180, 213 Famiglia Passaguai, La (A. Fabrizi, 1951), 14 Fantasia bianca (A. Masi, S. Pozzati, 1919), 234 Fantasma d’amore (D. Risi, 1981), 84, 140 Fantasmi a Roma (A. Pietrangeli, 1961), 85
512
Fantozzi (L. Salce, 1975), 53 Fari nella nebbia (G. Franciolini, 1942), 78 Federale, Il (L. Salce, 1961), 266, 329, 330, 463 Fellini–Satyricon (F. Fellini, 1969), 258, 282 Ferdinando I° re di Napoli (G. Franciolini, 1959), 224, 247n, 282 Ferie d’agosto (P. Virzì, 1996), 64, 68 Figaro qua, Figaro là (C.L. Bragaglia, 1950), 240 Figli di nessuno, I (R. Matarazzo, 1951), 390-392 Figli di nessuno, I (U.M. Del Colle, 1921), 73 Film d’amore e d’anarchia, ovvero “stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…” (L. Wertmüller, 1973), 171 Fine del gioco, La (G. Amelio, 1970), 180, 213 Fine pena mai (E. Colusso, 1995), 195 Finto storpio, Il (I. Pacchioni, 1896), 231 Forza del destino, La (C. Gallone, 1950), 379 Forza Italia! (R. Faenza, 1978), 335n, 448n, 465, 467, 505 Freccia nel fianco, La (A. Lattuada, 1945), 80 Fregoli dietro le quinte (L. Fregoli, 1903), 231 Fregoli, danza serpentina (L. Fregoli, 1897), 34 Fregoli dopo morto (1898), 231 Frou-Frou (A. Genina, 1955), 384 Fuga a due voci (C.L. Bragaglia, 1943), 224, 227 Fuoco, Il (G. Pastrone, 1916), 375 Gabinetto del dottor Caligari, Il (Das Cabinet des Dr. Caligari, R. Wiene, 1920), 455 Galileo (L. Cavani, 1968), 439 Gallo nel pollaio, Il (E. Guazzoni, 1916), 73 Garibaldi (M. Caserini, 1907), 293
Lessico del cinema italiano
Gattopardo, Il (L. Visconti, 1963), 397, 398 e n, 399, 417, 469, 471, 505 Generale Della Rovere, Il (R. Rossellini, 1959), 326, 359 Gente moderna (M. Monicelli, episodio di Alta infedeltà, 1964), 99 Germania anno zero (R. Rossellini, 1948), 45, 131, 185, 319, 322 Giarabub (G. Alessandrini, 1942), 314 Ginger e Fred (F. Fellini, 1986), 62 Giorni d’amore (G. De Santis, L. Savona, 1954), 93 Giorno devi andare, Un (G. Diritti, 2013), 195 Giorno di nozze (R. Matarazzo, 1942), 225 Giovane favoloso, Il (M. Martone, 2014), 179n, 426n Giovane Toscanini, Il (F. Zeffirelli, 1988), 419 Giovani mariti (M. Bolognini, 1958), 94 Giovanni Falcone (G. Ferrara, 1993), 488 Giovedì, Il (D. Risi, 1964), 267 Giudice ragazzino, Il (A. Di Robilant, 1994), 478 Giulietta degli spiriti (F. Fellini, 1965), 85 Giulietta e Romeo (Romeo and Juliet, G. Cukor, 1936), 149 Giuseppe Verdi (R. Matarazzo), 392 Giusta distanza, La (C. Mazzacurati, 2007), 63 Gloria – Apoteosi del milite ignoto (Federazione Cinematografica Italiana, 1921), 302, 303 Gomorra – La serie (2014-), 468n Gomorra (M. Garrone, 2008), 195 Grande abbuffata, La (M. Ferreri, 1973), 54, 101, 106, 271 Grande bellezza, La (P. Sorrentino, 2013), 136, 179n, 278, 279, 281, 282 Grande cocomero, Il (F. Archibugi, 1993), 136, 174, 420n Grande guerra, La (M. Monicelli,
Indice dei film
1959), 139, 140, 190, 191, 204, 213, 266, 326, 327, 359 Grande luce – Montevergine, La (C. Campogalliani, 1939), 377 Grande speranza, La (D. Coletti, 1954), 324, 359 Grandi magazzini, I (M. Camerini, 1939), 225, 226 Granduchessa si diverte, La (G. Gentilomo, 1940), 224 Grazie zia (S. Samperi, 1968), 60n Grido, Il (M. Antonioni, 1957), 51, 52, 68, 400, 402-404, 427 Gruppo di famiglia in un interno (L. Visconti, 1974), 51, 400 Guardie e ladri (Steno e M. Monicelli, 1951), 266 Guerra e il sogno di Momi, La (S. de Chomón, G. Pastrone, 1917), 297, 298, 359 Habemus Papam (N. Moretti, 2011), 7, 68, 69, 135, 137, 140, 276, 278 Histoire d’un Pierrot (B. Negroni, 1914), 234n Histoire(s) du cinéma (Id., J.-L. Godard, 1989-1998), 132, 339n, 435 Ho fatto splash (M. Nichetti, 1980), 198n Homeland (2011-), 205 Homo Eroticus (M. Vicario, 1971), 58 I love you (M. Ferreri, 1986), 106 Identificazione di una donna (M. Antonioni, 1982), 86 Il fu Mattia Pascal (M. L’Herbier, 1926), 158 Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni (F. Vicentini Orgnani, 2003), 495 Illustre attrice Cicala Formica, L’ (L. D’Ambra, 1920), 232 Immaturi (P. Genovese, 2011), 135, 174 Impiegato, L’ (G. Puccini, 1960), 263 In ginocchio da te (E.M. Fizzarotti, 1964), 50
513
In nome del Papa Re (L. Magni, 1977), 440 In nome del popolo italiano (D. Risi, 1971), 270, 475, 476, 480 In nome della legge (P. Germi, 1949), 190, 478 Incompreso – Vita col figlio (L. Comencini, 1967), 389n Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (E. Petri, 1970), 90, 99, 140, 278, 336, 479, 480, 488, 505 Inferno, L’ (F. Bertolini, G. De Liguoro, A. Padovan, 1911), 25 Innaffiatore innaffiato, L’ (L’arroseur arrosé, A. e L. Lumière, 1895), 34 Innocente, L’ (E. Bencivenga, 1911), 25 Io ballo da sola (B. Bertolucci, 1996), 84 Io la conoscevo bene (A. Pietrangeli, 1965), 111, 117, 140, 266 Io sono Li (A. Segre, 2011), 204 Italiani brava gente (G. De Santis, 1964), 191, 332, 333, 359 Italians (G. Veronesi, 2009), 204n Ivan il terribile (Ivan Groznyy, S. M. Ejzenštejn, 1945), 455 JFK - Un caso ancora aperto (JFK, O. Stone, 1991), 494 Johnny Stecchino (R. Benigni, 1991), 252 Kapò (G. Pontecorvo, 1960), 338 LaCapaGira, (A. Piva, 2000), 195 Ladri di biciclette (V. De Sica, 1948), 45, 127, 129, 132, 165, 166, 175, 198, 213 Ladro di bambini, Il (G. Amelio, 1992), 132, 140, 195, 200 Lamerica (G. Amelio, 1994), 199, 200, 213 Leggenda del santo bevitore, La (1988), 62 Lezioni di volo (F. Archibugi, 2007), 174
514
Lilli e il vagabondo (Lady and the Tramp, C. Geronimi, W. Jackson, H. Luske, 1955), 207 Lincoln (Id., S. Spielberg, 2012), 455 Lo vedi come sei... Lo vedi come sei? (M. Mattoli, 1939), 227 Lucia di Lammermoor (P. Pagliej, 1908), 375 Lucia di Lammermoor (P. Ballerini, 1946), 379 Lucky Luciano (F. Rosi, 1973), 495 Ludwig (L. Visconti, 1972), 398, 399, 421, 427 Luna, La (B. Bertolucci, 1979), 416 e n, 417, 427 Lunga notte del ’43, La (F. Vancini, 1960), 328, 333, 359 Lunga vita alla signora! (E. Olmi, 1987), 62 Ma non è una cosa seria (M. Camerini, 1936), 41 Maciste all’inferno (G. Brignone, 1926), 38 Maciste alpino (G. Pastrone, 1917), 161n, 298 Maciste atleta (V. Denizot, G. Pastrone, 1918), 38 Madama Butterfly (C. Gallone, 1954), 379 Maddalena (A. Genina, 1954), 383384 Maddalena... zero in condotta (V. De Sica, 1940), 167, 314 Made in Italy (N. Loy, 1965), 193 Maestri di musica (L. Fregoli, 1898), 34 Mafia uccide solo d’estate, La (Pif, 2013), 180, 503 Magnifica presenza (F. Ozpetek, 2012), 135 Maledetti vi amerò (M.T. Giordana, 1980), 420 Malizia (S. Samperi, 1973), 60n Malombra (M. Soldati, 1942), 81, 82, 117, 140 Mamma Roma (P.P. Pasolini, 1962), 47, 48, 68, 184
Lessico del cinema italiano
Mani sulla città, Le (F. Rosi, 1963), 179-180, 456, 505 Manon Lescaut (P. Pagliej, 1908), 375 Mantenuto, Il (U. Tognazzi, 1961), 268 Manuale d’amore (G. Veronesi, 2005), 142, 168, 213 Maraviglioso Boccaccio (P. e T. Taviani, 2015), 421 Marcia nuziale (M. Ferreri, 1965), 101-102 Marcia su Roma, La (D. Risi, 1962), 329, 330 Marcia trionfale (M. Bellocchio, 1976), 110, 140 Maria Zef (V. Cottafavi, 1981), 195 Mariti in città (L. Comencini, 1957), 401 Marito per Anna Zaccheo, Un (G. De Santis, 1953), 97, 385, 387 Marito, Il (N. Loy, F. Palacios, G. Puccini, 1958), 95, 268 Marrakech Express (G. Salvatores, 1989), 62, 134 Marsina stretta (A. Fabrizi, episodio di Questa è la vita, 1954), 262 Martiri d’Italia, I (D. Gaido, 1927), 304, 307, 359 Maschera sul cuore, La (Le capitaine Fracasse, A. Gance, 1943), 232n Matrimonio all’italiana (V. De Sica, 1964), 57 Mattatore, Il (D. Risi, 1960), 263, 266 Medea (P.P. Pasolini, 1969), 258-260, 282 Mediterraneo (G. Salvatores, 1991), 62, 134, 348, 351, 352 Meglio gioventù, La (M.T. Giordana, 2003), 422 Merlo maschio, Il (P. Festa Campanile, 1971), 56, 68 Mery per sempre (M. Risi, 1989), 194, 213 Messa è finita, La (N. Moretti, 1985), 135 Mestiere delle armi, Il (E. Olmi, 2001), 283, 290, 353, 354, 359
Indice dei film
Metello (M. Bolognini, 1970), 176 Metropolis (Id., F. Lang, 1927), 440n Mi rifaccio vivo (S. Rubini, 2013), 135 Mia madre (N. Moretti, 2015), 135, 136, 139n Mia signora, La (M. Bolognini, T. Brass, L. Comencini, 1964), 99 Mignon è partita (F. Archibugi, 1988), 174, 420n Milano ’83 (E. Olmi, 1984), 419 1860 (A. Blasetti, 1934), 162, 164, 168, 204, 213, 377, 379, 474 Mimì metallurgico ferito nell’onore (L. Wertmüller, 1972), 171 Ministro, Il – L’esercizio dello Stato (L’exercice de l’État, P. Schoeller, 2011), 454, 455 Mio cognato (A. Piva, 2003), 195 Mio fratello è figlio unico (D. Luchetti, 2007), 63 Mio miglior nemico, Il (C. Verdone, 2006), 168 Mio nome è Nessuno, Il (T. Valerii, 1973), 94 Miracolo a Sant’Anna (Miracle at St. Anna, S. Lee, 2008), 350n Miracolo, Il (E. Winspeare, 2003), 195 Miseria e nobiltà (M. Mattoli, 1954), 171 Miss Europa (A. Genina, 1930), 39, 68 Moda vuole l’ala larga, La (E. Vaser, 1912), 27 Mogli pericolose (L. Comencini, 1958), 401 Moloch (Molokh, A. Sokurov, 1999), 489 Mondo vuole così, Il (G. Bianchi, 1949), 79, 140 Monello, Il (The Kid, C. Chaplin, 1921), 491 Moralista, Il (G. Bianchi, 1959), 96, 268 Mortacci (S. Citi, 1989), 85 Morte a Venezia (L. Visconti, 1971), 399
515
Morte di un matematico napoletano (M. Martone, 1992), 426 Morte in Vaticano (M. Aliprandi, 1982), 495 Mostri oggi, I (E. Oldoini, 2009), 265 Mostri, I (D. Risi, 1963), 94, 95, 98, 101, 262, 263, 265, 267, 282, 462 Mostro, Il (R. Benigni, 1994), 252 Mr Smith va a Washington (Mr. Smith Goes to Washington, F. Capra, 1939), 455, 459 Mulino del Po, Il (A. Lattuada, 1949), 401 My Name Is Tanino (P. Virzì, 2002), 134, 204n Napoleone (Napoléon vu par Abel Gance, A. Gance, 1927), 455 Nave bianca, La (R. Rossellini, 1941), 44, 68, 320 Nave, La (E. Bencivenga, 1912), 25, 68 Nel nome del padre (M. Bellocchio, 1972), 110, 408 Nemico occulto, Il (1916), 295n Nemico, Il (G. De Liguoro, 1915), 295n Nerone (A. Blasetti, 1930), 227, 282 Nerone e Agrippina (M. Caserini, 1914), 446 Neuropatologia, La (R. Omegna, 1908), 98n ‘Nfama! (E. Notari, 1924), 161n Noi credevamo (M. Martone, 2010), 361, 362, 405, 415, 425 e n, 426, 427, 472-474, 506 Non c’è pace tra gli ulivi (G. De Santis, 1950), 385, 386, 395, 427 Non è vero... ma ci credo (S. Grieco, 1952), 252 Nostos: Il ritorno (F. Piavoli, 1990), 201 Nostra signora dei turchi (C. Bene, 1968), 410 e n, 411, 412, 427 Nostra vita, La (D. Luchetti, 2010), 63
516
Nostri anni, I (D. Gaglianone, 2000), 357 Nostri sogni, I (V. Cottafavi, 1943), 225 Notte di San Lorenzo, La (P. e V. Taviani, 1982), 349, 359, 420, 421, 427 Notte italiana (C. Mazzacurati, 1987), 63 Notte prima degli esami - Oggi (F. Brizzi, 2007), 134-135 Notte prima degli esami (F. Brizzi, 2006), 134 Notti bianche, Le (L. Visconti, 1957), 397 Notti di Cabiria, Le (F. Fellini, 1957), 129, 231 Novecento (B. Bertolucci, 1976), 344, 345, 349, 359, 405, 413, 414 e n, 415, 416, 425, 427 Nuovi mostri, I (M. Monicelli, D. Risi, E. Scola, 1977), 193, 265 Nuovo Cinema Paradiso (G. Tornatore, 1988), 62, 68 Nuovomondo (E. Crialese, 2006), 198, 199, 204 O somma luce (J.-M. Straub. 2010), 185 Occhio del nemico, L’ (E. Rodolfi, 1919), 295n Ogro (G. Pontecorvo, 1979), 338 Oh! Uomo (Y. Gianikian, A.R. Lucchi, 2004), 356 Oltre il giardino (Being There, H. Ashby, 1979), 459 Onorevole Angelina, L’ (L. Zampa, 1947), 11, 46, 68, 154, 155, 213 Opera (D. Argento, 1987), 419 Operai, contadini (D. Huillet, J.-M. Straub, 2001), 185, 350n Ora di religione, L’ (Il sorriso di mia madre) (M. Bellocchio, 2002), 280 Ore 9: lezione di chimica (M. Mattoli, 1941), 167, 314 Oro di Napoli, L’ (V. De Sica, 1954), 83, 262
Lessico del cinema italiano
Ossessione (L. Visconti, 1943), 385, 392, 400, 417 Otello (F. Zeffirelli, 1986), 419 Ottobre (Октябрь, S. M. Ejzenštejn, 1928), 491 8 ½ (F. Fellini, 1963), 51, 121, 122, 132, 168, 184, 200, 201n, 213, 419 Ovosodo (P. Virzì, 1997), 134, 195 Padre padrone (P. e V. Taviani, 1977), 195 Padrino, Il (The Godfather, F.F. Coppola, 1972), 207, 271 Pagliacci (F. Zeffirelli, 1982), 419 Pagliacci (M. Costa, 1948), 379 Pagliaccio (1900), 373n Paisà (R. Rossellini, 1946), 45, 126, 128, 132 e n, 140, 177, 204, 318, 319, 359, 501 Palombella rossa (N. Moretti, 1989), 123, 173, 213, 278 Pane, amore e fantasia (L. Comencini, 1953), 93, 170, 188 Panni sporchi (M. Monicelli, 1999), 268 Parenti serpenti (M. Monicelli, 1992), 268 Parisina (Un amore alla Corte di Ferrara nel XV secolo) (G. De Liguoro, 1909), 159n Parlami d’amore (S. Muccino, 2008), 174 Passeggiate al Campo di Marte, Le (Le promeneur du champ de Mars, R. Guédiguian, 2005), 455 Pazzo d’amore (G. Gentilomo, 1942), 240n Peccato che sia una canaglia (A. Blasetti, 1955), 91-92 Per un pugno di dollari (S. Leone, 1964), 94, 140 Pesce di nome Wanda, Un (A Fish Called Wanda, C. Crichton, 1988), 206 Petrolini disperato per eccesso di buonumore (1913), 231 Pia de’ Tolomei (G. Zannini, 1921), 25
Indice dei film
Piazza delle cinque lune (R. Martinelli, 2003), 180, 494 Piccoli maestri, I (D. Luchetti, 1998), 63 Piccolo Buddha (Little Buddha, B. Bertolucci, 1993), 417 e n, 418 Piccolo diavolo, Il (R. Benigni, 1988), 252 Pilota ritorna, Un (R. Rossellini, 1942), 44, 320 Pinocchio (G. Antamoro, 1911), 28, 68, 255, 282 Pinocchio (R. Benigni, 2002), 252 Pizzicata (E. Winspeare, 1996), 195 Polizia ha le mani legate, La (L. Ercoli, 1975), 495 Pollo ruspante, Il (U. Gregoretti, episodio di Ro.Go.Pa.G., 1963), 101, 263, 266 Porcile (P.P. Pasolini, 1969), 258, 259 Portaborse, Il (D. Luchetti, 1991), 63, 457, 506 Porte aperte (G. Amelio, 1990), 478 Portiere di notte, Il (L. Cavani, 1974), 55 Posto, Il (E. Olmi, 1961), 53 Potere, Il (A. Tretti, 1972), 448, 505 Poveri ma belli (D. Risi, 1957), 92, 156, 171, 186, 187, 196, 213 Presa del potere da parte di Luigi XIV, La (La prise de pouvoir par Louis XIV, R. Rossellini, 1966), 245, 433, 434, 441, 505 Presa di Roma, La (F. Alberini, 1905), 287, 288, 359 Prete sposato, Il (M. Vicario, 1970), 58 Prigionieri della guerra 1914-1918 (Y. Gianikian, A.R. Lucchi, 1995), 355 Prima della rivoluzione (B. Bertolucci, 1964), 50, 68, 413, 416, 417 Prima di sera (P. Tellini, 1954), 80 Prima neve, La (A. Segre, 2013), 204 Prima notte di quiete, La (V. Zurlini, 1972), 408
517
Principe di Homburg, Il (G. Lavia, 1983), 349 Private (S. Costanzo, 2004), 180n, 204 Professione: reporter (M. Antonioni, 1975), 85-87, 140 Proprietà non è più un furto, La (EPetri, 1973), 99, 101, 169 Prova d’orchestra (F. Fellini, 1979), 346, 347, 359, 447, 450, 505 Provinciale, La (M. Soldati, 1953), 401, 404 Puccini e la fanciulla (P. Benvenuti, 2008), 422n Puerto Escondido (G. Salvatores, 1992), 62 Pugni in tasca, I (M. Bellocchio, 1965), 51, 408, 423, 427 Purgatorio, Il (G. Berardi, A. Busnego, 1911), 25 4 ragazze sognano (G. Giannini, 1943), 226 Qualunquemente (G. Manfredonia, 2011), 463, 464 Quando le donne avevano la coda (P. Festa Campanile, 1970), 201 Quando le donne persero la coda (P. Festa Campanile, 1972), 201 47 morto che parla (C.L. Bragaglia, 1950), 85 Quartieri alti (M. Soldati, 1945), 88, 89, 225 Quattro giornate di Napoli, Le (N. Loy, 1962), 329 Quattro volte, Le (M. Frammartino, 2010), 107, 140 Quei due (G. Righelli, 1935), 228 Queimada (G. Pontecorvo, 1969), 338 Quel bandito sono io (M. Soldati, 1950), 252n Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (M. Laurenti, 1972), 59, 68 Questa è la vita (A. Fabrizi, G. Pastina, M. Soldati, L. Zampa, 1954), 262
518
Quo Vadis? (E. Guazzoni, 1913), 73, 376, 446 Rabbia, La (G. Guareschi, P.P. Pasolini, 1963), 335n Radiofreccia (L. Ligabue, 1998), 170 Ragazza con la valigia, La (V. Zurlini, 1961), 94, 408, 409, 427 Ragazze di Piazza di Spagna, Le (L. Emmer, 1952), 91, 92 Ragazze di San Frediano, Le (V. Zurlini, 1955), 97 Ragazzi fuori (M. Risi, 1990), 194 Rata nece biti! (La guerra non ci sarà) (D. Gaglianone, 2008), 356, 359 Ratataplan (M. Nichetti, 1979), 198n Re, le Torri e gli Alfieri, Il (I. Illuminati, 1917), 232, 233 Reality (M. Garrone, 2012), 137, 140, 262, 263, 281, 282 Regista di matrimoni, Il (M. Bellocchio, 2006), 83n, 491 Respiro (E. Crialese, 2002), 199 Resto di niente, Il (A. De Lillo, 2004), 354, 422 Retroscena (A. Blasetti, 1939), 225 Retroscena (L. Fregoli, 1898), 34 Ricotta, La (P.P. Pasolini, episodio di Ro.Go.Pa.G., 1963), 48, 406, 407, 427, 485 Rigoletto (C. Gallone, 1946), 379 Rigoletto (G. Lo Savio, 1910), 373 Riso amaro (G. De Santis, 1949), 385 Ritorno del figlio prodigo, Il (D. Huillet, J.-M. Straub, 2003), 350n Ritorno di Cagliostro, Il (D. Ciprì, F. Maresco, 2003), 215, 274, 282 Ro.Go.Pa.G. (J.-L. Godard, U. Gregoretti, P.P. Pasolini, R. Rossellini, 1963), 101, 263, 266, 406 Rocco e i suoi fratelli (L. Visconti, 1960), 49, 68, 192, 204, 393, 397399, 414, 415, 427 Roma città aperta, (R. Rossellini, 1945), 11, 44, 131, 165, 176, 213, 318, 319, 359, 382
Lessico del cinema italiano
Roma ore 11 (G. De Santis, 1952), 385, 387 Romanzo criminale (M. Placido, 2005), 180 Romanzo di una strage (M.T. Giordana, 2012), 495, 496 Romanzo popolare (M. Monicelli, 1974), 269 Rosa tatuata, La (The Rose Tattoo, D. Mann, 1955), 207 Rossini! Rossini! (M. Monicelli, 1991), 419 Rotaie (M. Camerini, 1929), 377 Sacro GRA (G. Rosi, 2013), 211 Salò o le 120 giornate di Sodoma (P.P. Pasolini, 1975), 55, 110 e n, 342344, 359, 447, 451-453, 505 Salomè (C. Bene, 1972), 410-412 Salvatore Giuliano (F. Rosi, 1962), 181, 194, 213, 340, 359 San Giovanni decollato (T. Ruggeri, 1917), 161 San Michele aveva un gallo (P. e V. Taviani, 1972), 421 Sangue del mio sangue (M. Bellocchio, 2015), 111 Sangue vivo (E. Winspeare, 2000), 195 Sbaglio di essere vivo, Lo (C.L. Bragaglia, 1945), 76, 80, 140 Sbatti il mostro in prima pagina (M. Bellocchio, 1972), 179, 337 Scapolo, Lo (A. Pietrangeli, 1955), 96, 268 Sceicco bianco, Lo (F. Fellini, 1952), 97, 201, 269 Scialla! (F. Bruni, 2011), 142, 174, 213 Scipione l’africano (C. Gallone, 1937), 309, 359, 437, 439n, 505 Sconosciuta, La (G. Tornatore, 2006), 204 Se io fossi onesto (C.L. Bragaglia, 1942), 81, 226 Sedotta e abbandonata (P. Germi, 1964), 98, 189 Seduttore, Il (F. Rossi, 1954), 96, 267
Indice dei film
Segretaria privata, La (G. Alessandrini, 1931), 89, 90, 140 Segreti di stato (P. Benvenuti, 2003), 495 Segreto per vestirsi (L. Fregoli, 1898), 34 Seme della discordia, Il (P. Corsicato, 2008), 174 Sempre nel cor la patria! (C. Gallone, 1915), 296 Senso (L. Visconti, 1954), 176, 383, 392 e n, 393 e n, 394, 395 e n, 396-401, 404, 405, 411, 414-416, 424, 427, 469, 505 Serva padrona, La (G. Mannini, 1934), 379 Siamo donne (G. Franciolini, A. Guarini, R. Rossellini, L. Visconti, L. Zampa, 1953), 93, 140 Sicilia! (D. Huillet e J.-M. Straub, 1999), 185, 350n Signor Max, Il (M. Camerini, 1937), 41-43, 68, 88, 89, 140, 164 e n, 167 Signora senza camelie, La (M. Antonioni, 1953), 400-402 Signorina Ciclone, La (A. Genina, 1916), 232 Smemorato di Collegno, Lo (S. Corbucci, 1962), 123, 124 Sogni d’oro (N. Moretti, 1981), 278 Sogni nel cassetto, I (R. Castellani, 1957), 94 Sogno della farfalla, Il (M. Bellocchio, 1994), 198 Sogno di Butterfly, Il (C. Gallone, 1939), 380, 382 Sogno di Don Chisciotte, Il (A. Palermi, 1915), 232n Sole (A. Blasetti, 1929), 161, 307, 308n, 377 Sole a catinelle (G. Nunziante, 2013), 67, 68 Sole sorge ancora, Il (A. Vergano, 1946), 317 Soliti ignoti, I (M. Monicelli, 1958), 95, 156, 190, 266, 268 Solitudine dei numeri primi, La (S. Costanzo, 2010), 134
519
Sonnambula, La (C. Barlacchi, 1952), 379 Sorelle Mai (M. Bellocchio, 2010), 423n Sorpasso, Il (D. Risi, 1962), 95, 96, 98, 99, 140, 203n, 266, 267, 382 Sotto il sole di Roma (R. Castellani, 1948), 387-389, 427 Sovversivi, I (P. e V. Taviani, 1967), 51 Squadrone bianco, Lo (A. Genina, 1936), 312, 359 Stanno tutti bene (G. Tornatore, 1990), 62 Stanza del figlio, La (N. Moretti, 2001), 135, 278 Stella che non c’è, La (G. Amelio, 2006), 200 Stendalì – Suonano Ancora (C. Mangini, 1960), 105, 140 Straniero, Lo (L. Visconti, 1967), 400 Strategia del ragno (B. Bertolucci, 1970), 413 Straziami ma di baci saziami (D. Risi, 1968), 269 Stromboli, terra di Dio (R. Rossellini, 1950), 132, 207, 208 Su tutte le vette è pace (Y. Gianikian, A.R. Lucchi, 1999), 355-356 Tè nel deserto, Il (The Sheltering Sky, B. Bertolucci, 1990), 395n, 413, 417 e n, 427 Teatro di guerra (M. Martone, 1998), 354, 359 Tempo massimo (M. Mattoli, 1934), 88 Tentazioni del dottor Antonio, Le (F. Fellini, episodio di Boccaccio ’70, 1962), 252n Teorema (P.P. Pasolini, 1968), 106 Terra trema, La (L. Visconti, 1948), 46, 165, 184, 185n, 192, 194, 195, 213, 385, 394 Terra vista dalla luna, La (P.P. Pasolini, episodio di Le streghe, 1967), 85, 244 Terraferma (E. Crialese, 2011), 182, 199, 204, 213
520
Terrazza, La (1980), 269 Terrorista, Il (G. De Bosio, 1963), 330, 331, 359 The Dreamers - I sognatori (The Dreamers, B. Bertolucci, 2003), 414, 416 The Iron Lady (Id., P. Lloyd, 2011), 455 The Queen - La regina (The Queen, S. Frears, 2006), 455 This Must Be the Place (P. Sorrentino, 2011), 136 Ti conosco, mascherina! (E. De Filippo, 1943), 228 Tigre reale (G. Pastrone, 1916), 375 Todo modo (E. Petri, 1976), 99, 275, 277, 278, 282, 461, 462, 488, 505 Toh, è morta la nonna! (M. Monicelli, 1969), 268 Tontolini è triste (Cines, 1911), 231 Tormento (R. Matarazzo, 1950), 390, 391 Torneranno i prati (E. Olmi, 2014), 353, 354 Toro, Il (C. Mazzacurati, 1994), 63 Tosca (C. Gallone, 1956), 379 Totò a colori (Steno, 1952), 171, 201, 243, 255, 455 Totò che visse due volte (D. Ciprì, F. Maresco, 1998), 274 Totò e Carolina (M. Monicelli, 1955), 266 Totò e i re di Roma (Steno e M. Monicelli, 1951), 268 Totò entusiasta della nuova moda (E. Vardannes, 1911), 27 Totò, Peppino e la… malafemmina (C. Mastrocinque, 1956), 201 Tra le nevi e i ghiacci del Tonale (L. Comerio, 1916), 299, 359 Tragedia di un uomo ridicolo, La (B. Bertolucci, 1981), 417 Traviata ’53 (V. Cottafavi, 1953), 400, 401, 402 e n, 403, 404, 427 Traviata, La (F. Zeffirelli, 1982), 419 Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto (L. Wertmüller, 1974), 169, 171
Lessico del cinema italiano
Tre aquilotti, I (M. Mattoli, 1942), 314 Tre canti su Lenin (Tri pesni o Lenine, D. Vertov, 1934), 455, 500 Tre metri sopra il cielo (L. Lucini, 2004), 174 Tre storie proibite (A. Genina, 1952), 387n Tre uomini in frak (M. Bonnard, 1933), 227 Trecento della Settima, I (M. Baffico, 1943), 313, 359 Treno crociato, Il (C. Campogalliani, 1943), 314 Trenta secondi d’amore (M. Bonnard, 1936), 91 Tristano e Isotta (U. Falena, 1911), 373 Tristi amori (C. Gallone, 1943), 78 Trovatore, Il (A. e L. Pineschi, 1908), 373 Trovatore, Il (C. Gallone, 1949), 379 Tu ridi (P. e T. Taviani, 1998), 421 Turné (G. Salvatores, 1990), 134 Tutta la vita davanti (P. Virzì, 2008), 65 Tutti a casa (L. Comencini, 1960), 329, 330 Tutti dentro (A. Sordi, 1984), 478 Tutto il mondo è teatro (P.A. Gariazzo, 1919), 233n Tutto il mondo ride (Vesyolye rebyata, G. Aleksandrov, 1934), 240n Tutto tutto niente niente (G. Manfredonia, 2012), 463 Uccellacci e uccellini (P.P. Pasolini, 1966), 241, 242, 282, 406, 407 Udienza, L’ (M. Ferreri, 1972), 444 Ultimi giorni di Pompei, Gli (A. Ambrosio, L. Maggi, 1908), 375, 376 Ultimi giorni di Pompei, Gli (M. Caserini, E. Rodolfi, 1913), 375, 376 Ultimo imperatore, L’ (B. Bertolucci, 1987), 417, 443, 506
Indice dei film
Ultimo tango a Parigi (B. Bertolucci, 1972), 55, 84, 413, 414, 417 Ultrà (R. Tognazzi, 1991), 196 Umberto D. (V. De Sica, 1952), 46, 128, 185 Umiliati (D. Huillet, J.-M. Straub, 2003), 350n Uomini contro (F. Rosi, 1970), 341 Uomini e no (V. Orsini, 1981), 352 Uomini sul fondo (F. De Robertis, 1941), 323, 324, 359 Uomini, che mascalzoni…, Gli (M. Camerini, 1932), 41, 88, 89, 167 Uomo a metà, Un (V. De Seta, 1966), 117, 121, 122, 140 Uomo che sorride, L’ (M. Mattoli, 1937), 226 Uomo che verrà, L’ (G. Diritti, 2009), 125, 195 Uomo dalla croce, L’ (R. Rossellini, 1943), 44, 320 Uomo meccanico, L’ (A. Deed, 1921), 232 Urlatori alla sbarra (L. Fulci, 1960), 50 Vaghe stelle dell’Orsa (L. Visconti, 1965), 51 Validità giorni dieci (C. Mastrocinque, 1940), 224 Vangelo secondo Matteo, Il (P.P. Pasolini, 1964), 104, 406 Vecchia guardia (A. Blasetti, 1934), 42, 291 Vedovo, Il (D. Risi, 1959), 99, 268 Vendetta di pagliaccio (L. Maggi, E.M. Pasquali, 1907), 373 24 (2001-2014), 205
521
Vento fa il suo giro, Il (G. Diritti, 2005), 195 Vergine giurata (L. Bispuri, 2015), 135 Vesna va veloce (C. Mazzacurati, 1996), 204 Viaggio in Italia (R. Rossellini, 1954), 51, 208, 240, 426n Viceré, I (R. Faenza, 2007), 468, 506 Vigile, Il (L. Zampa, 1960), 267 Villa da vendere (F. Cerio, 1941), 226 Vincere (M. Bellocchio, 2009), 110n, 275, 280, 282, 423 e n, 424, 425, 427, 490, 491, 506 Vita agra, La (C. Lizzani, 1964), 53, 68 Vita difficile, Una (D. Risi, 1961), 266 Vitelloni, I (F. Fellini, 1953), 258 Viva l’Italia (M. Bruno, 2012), 66, 68, 459, 460 Viva la libertà (R. Andò, 2013), 135, 280, 422, 459, 460, 506 Voce della luna, La (F. Fellini, 1990), 62, 201, 255, 463 Vogliamo i colonnelli (M. Monicelli, 1973), 463 Volto di un’altra, Il (P. Corsicato, 2012), 135 Ybris (G. Ledda, 1984), 201 Youth – La giovinezza (P. Sorrentino, 2015), 136 Yuppies – I giovani di successo (C. Vanzina, 1986), 172 Zabriskie Point (M. Antonioni, 1970), 55 Zio di Brooklyn, Lo (D. Ciprì, F. Maresco, 1995), 274
INDICE DEI NOMI
Abatantuono, Diego, 61, 67 Accetto, Torquato, 223 Adamo, Pietro, 49n Agamben, Giorgio, 134n, 216n, 261n, 287, 292 e n, 308 e n, 316, 344n, 350 e n, 351 e n, 352, 358 Age (pseudonimo di Agenore Incrocci), 171, 202, 475 Agosti, Silvano, 194 Alatri, Paolo, 434 e n Albanese, Antonio, 463, 464 Alberini, Filoteo, 287, 293, 359, 474 Alberoni, Francesco, 53 e n Alberti, Carmelo, 220n Aleksandrov, Grigorij Vasil’evič, 240n Alessandrini, Goffredo, 43, 90, 140, 314 Alfieri, Vittorio, 144 Alicata, Mario, 166n Alighieri, Dante, 144, 148, 171, 216, 304, 462 Aliprandi, Marcello, 495 Allasio, Marisa, 187 Allodoli, Ettore, 148, 150, 151n Alonge, Andrea Giaime, 297n, 298n Alovisio, Silvio, 25n Amato, Peppino, 228 Amelio, Gianni, 140, 180, 181, 184n, 195, 199, 200, 213, 348, 359, 420n, 478 Amendola, Ferruccio, 183 Amidei, Sergio, 475 Andò, Roberto, 280, 422, 459, 460, 506 Andreotti, Giulio, 100, 281, 483, 487, 501, 504
Angelini, Pietro, 104n Angelucci, Anna, 180n, 204n Angiolini, Ambra, 66 Anile, Alberto, 217 e n Antamoro, Giulio, 28, 68, 255, 280, 282, 491 Antonelli, Laura, 56 Antonioni, Michelangelo, 51, 52, 55, 68, 85, 86, 93-95, 103, 111, 116, 131, 132, 139, 140, 194, 203 e n, 208n, 400 e n, 401, 402 e n, 405, 427 Aprà, Adriano, 33, 253n, 254n, 308n, 319n, 388n, 402n Archibugi, Francesca, 174, 420n Arcoleo, Giorgio, 239n Arecco, Sergio, 350n Arena, Maurizio, 187 Argentieri, Mino, 320n, 483n Argento, Dario, 419 Aristarco, Guido, 176, 392n, 393n Aristofane, 271 Aristotele, 432 Arlanch, Francesco, 483n Arnheim, Rudolf, 158 e n Aron, Raymond Claude Ferdinand, 22 Artaud, Antonin, 412n Ashby, Hal, 459 Augias, Corrado, 254n Bach, Johann Sebastian, 32n, 406, 407, 421, 422 Bachtin, Michail, 217, 262, 270, 488 Badiou, Alain, 287 e n, 292, 296 e n, 344n, 345, 358n, 359 Baffico, Mario, 313, 320, 359 Baldacci, Luigi, 291n
524
Baldi, Alfredo, 320n Ballerini, Piero, 379 Banfield, Edward Christie, 24n Banti, Anna, 473n Barbareschi, Luca, 475 Bardot, Brigitte, 254n Barlacchi, Cesare, 379 Barletti, Davide, 195 Basili, Giancarlo, 486 Bassani, Giorgio, 328 Bataille, Georges, 305 e n, 313 Batchelor, David, 255n Battiato, Franco, 124 Baudelaire, Charles Pierre, 35, 254 Bauman, Zygmunt, 67 e n Bazin, André, 127 e n, 128, 130, 131n, 350 e n, 388n Bazzicalupo, Laura, 261n Bednarek, Monika, 146n Bellassai, Sandro, 54n Bellavita, Andrea, 398n Bellini, Vincenzo, 32n, 362, 369, 376, 396 Bellocchio, Marco, 51, 55, 83n, 110, 111, 140, 179, 180, 198, 275, 280282, 337, 348, 349, 407-409, 412, 423 e n, 425, 427-429, 483, 490493, 498, 499, 500- 503, 506 Belpoliti, Marco, 441 e n Benadusi, Lorenzo, 309n Bencivenga, Edoardo, 25, 295n Bene, Carmelo, 201, 248, 253, 254 e n, 255, 282, 394, 409, 410 e n, 411, 412, 426, 427 Ben-Ghiat, Ruth, 307 e n, 313n Benigni, Roberto, 61, 186, 193, 196, 217, 252, 255, 265, 268 Benjamin, Walter, 35, 75 e n, 108 e n, 226, 354, 355 e n Bentivoglio, Fabrizio, 143 Benvenuti, Paolo, 422n, 495 Berardi, Giuseppe, 25 Berg, Alban, 402 Bergman, Ingmar, 72, 121, 184 Bergman, Ingrid, 184 Bergoglio, Jorge Mario (papa Francesco), 8 Berkeley, Busby, 233
Lessico del cinema italiano
Berlinguer, Enrico, 501 Berlusconi, Silvio, 100, 270, 281, 429, 441, 448, 467, 483-486, 491, 504, 505 Bermani, Cesare, 342n Bernardi, Sandro, 245n, 248n Bernardini, Aldo, 30n, 33, 36 e n, 158n, 287n Bernhard, Ernst, 119 e n, 120n, 121, 249, 250n Bernini, Gian Lorenzo, 220, 236, 440 Berruto, Gaetano, 150n Bertetto, Paolo, 471 e n Berti, Marina, 83 Bertini, Antonio, 406 Bertini, Francesca, 73, 160, 213, 234, 375, 427 Bertolini, Francesco, 25 Bertolucci, Bernardo, 50, 55, 68, 84, 344, 345, 347, 349, 359, 390n, 393n, 394, 399, 405, 409, 412, 413 e n, 415, 416, 417 e n, 418, 427, 443, 444n, 445, 506 Bertozzi, Marco, 336n Besana, Bruno, 351n Bianchi, Giorgio, 79, 140, 268 Bianchi, Patricia, 241n Bianciardi, Luciano, 53, 56 Bisoni, Claudio, 55n, 479, 480, 482 en Bispuri, Ennio, 201n, 244n Bispuri, Laura, 135 Blair, Betsy, 52 Blasetti, Alessandro, 25, 42, 88, 92, 109 e n, 161, 162, 164, 168, 213, 225, 227, 228, 229, 246, 282, 377-379, 389, 393, 427, 474, 491 Blumer, Herbert, 64n Boarini, Vittorio, 55n Bobbio, Norberto, 430, 431n, 454, 455n Boccaccio, Giovanni, 185 Boccafurni, Anna Maria, 153n Bocola, Antonio, 174, 213 Bodei, Remo, 108n Boito, Arrigo, 395n, 470 Boldi, Massimo, 185 Bollati, Giulio, 179n
Indice dei nomi
Bolognini, Mauro, 56, 57, 94, 190 Boltanski, Luc, 63n Bolter, Jay David, 28n, Bonaiuto, Anna, 125 Bonitzer, Pascal, 231n Bonnard, Mario, 227 Bontempelli, Massimo, 233 Borelli, Lyda, 73, 233 Borgnetto, Romano Luigi, 161n, 298 Borio, GianMario, 363n Bortolotto, Mario, 363n Boschetti, Anna, 24n Bosè, Lucia, 92, 385 Bossuet, Jacques Bénigne, 255 Bouquet, Michel, 455 Bourdieu, Pierre, 9n, 19n, 22 e n, 23n, 24, 43 e n, 47n, 51, 63n Bowles, Paul, 395n, 417 Bragaglia, Anton Giulio, 234 Bragaglia, Carlo Ludovico, 76, 81, 140, 224, 226, 234, 240 e n, 282 Braghetti, Anna Laura, 499 Brancati, Vitaliano, 57, 189, 190 Brando, Marlon, 338 Brasillach, Robert, 303 e n, 305 Brecht, Bertolt, 395, 407 Brialy, Jean-Claude, 113 Brignone, Guido, 38 Brinducci, Monica, 241n Bronzini, Giovanni Battista, 258n Brooks, Louise, 39 Brooks, Peter, 369n, 370n, 374 e n, 375, 386, 387n Brownlow, Kevin, 294 e n Bruckner, Anton, 393n Brunetta, Gian Pietro, 36 e n, 37, 38n, 109n, 188n, 293 e n, 294, 295n, 297n, 306 e n, 309, 329 e n, 373 e n, 376 e n Bruni, Francesco, 64, 142, 213 Bruno, Giordano, 70 Bruno, Massimiliano, 66, 68, 459 Bubel, Claudia, 157n Büchner, Georg, 403n Buñuel, Luis, 274 Buonarroti, Michelangelo, 144 Buratti, Mariano, 460n Burruano, Luigi Maria, 207
525
Bursi, Giulio, 25n, 402n, Busnego, Arturo, 25 Buzzanca, Lando, 56-58 Calà, Jerry, 185 Calabretto, Roberto, 375n, 400n Calamai, Clara, 232n, 392, 417 Calderoli, Roberto, 448 Caldiron, Orio, 80n, 146n, 225n, 309n, 388n Caligari, Claudio, 196 Callieri, Bruno, 217n Callot, Jacques, 220, 229 Calogero, Francesco, 486 Calvino, Italo, 148 e n Camagni, Bianca Virginia, 234n Camerini, Mario, 40, 42-44, 68, 88, 89, 140, 164, 167, 224, 225, 246, 282, 377 Cameron, James, 67n Camilleri, Andrea, 129n Cammarano, Michele, 293 Campbell, Scott, 207 Campiotti, Giacomo, 420n Campogalliani, Carlo, 314, 377 Cancellieri, Franco, 254n Canetti, Elias, 473n, 487, 488 e n, 489, 490 e n Cangiullo, Francesco, 32n Canosa, Michele, 26n, 30n, 287n Canova, Gianni, 281, 388 e n Cappabianca, Alessandro, 253n, 271n Capra, Frank, 455, 459 Capuano, Antonio, 468n Caravaggio (pseudonimo di Michelangelo Merisi), 144 Cardinale, Claudia, 254n, 409 Cardona, Giorgio Raimondo, 168 e n Caronia, Antonio, 440n Carotenuto, Mario, 187 Carotenuto, Memmo, 187, 266 Carrà, Raffaella, 500 Cartier, Max, 49 Casadio, Gianfranco, 25n Casella, Paola, 207n Caserini, Mario, 25, 293, 446, 474 Casetti, Francesco, 35n, 60n
526
Cassirer, Ernst, 22 Castel, Robert, 63n Castellani, Renato, 83, 91, 94, 140, 189, 340n, 387-389, 427 Castellitto, Sergio, 65, 200, 491 Cavani, Liliana, 55, 439, 440 Cavell, Stanley, 389n Cazzullo, Aldo, 210 e n Cecchi D’Amico, Suso, 469 Čechov, Anton Pavlovič, 9 Celentano, Adriano, 61 Celli, Silvio, 309n, 312n Censi, Rinaldo, 253n, 254n Cereja, Federico, 317n Cerio, Ferruccio, 226 Cervi, Gino, 76, 79, 247n, 328 Cervini, Alessia, 125n Cesa, Claudio, 426n Ceserani, Remo, 493n Chamboredon, Jean-Claude, 63n Charrier, Jacques, 382 Chaucer, Geoffrey, 185 Chenal, Pierre, 236 Cherchi Usai, Paolo, 26n, 445 e n Chiarini, Luigi, 152n, 187n, 365 Chion, Michel, 147n, 201n Chomsky, Avram Noam, 23n Chopin, Frédéric François, 32n, 426 Cicerone, Marco, Tullio, 261, 290, 319 e n, 320 Cigoli, Emilio, 183, 184 Cilea, Francesco, 371 Ciprì, Daniele, 195, 196 e n, 197, 215, 273, 274, 282, 491 Cirillo, Giuseppe Pasquale, 221 Citti, Sergio, 268, 462 Clair, René, 39, 233 Clement, Catherine, 424 e n Cobelli, Giancarlo, 254n Cochran, Steve, 52 Cola di Rienzo (Nicola di Lorenzo Gabrini), 249 Colagrande, Luigi, 33 Colagreco, Luigi, 32 e n, 34 e n, 35 en Coletti, Duilio, 232n, 324, 359 Collodi, Carlo, 28, 235, 243, 249 Colombo, Cristoforo, 484
Lessico del cinema italiano
Colombo, Emilio, 501 Colombo, Fausto, 28 Comand, Mariapia, 193n, 203n Comencini, Luigi, 13, 166 e n, 192, 267, 329, 389n, 401, 419 Comerio, Luca, 73, 299, 359 Comolli, Jean-Louis, 343 e n Consoli, Giampiero, 257n Conte, Lorenzo, 195 Contini, Gianfranco, 144n Corbucci, Sergio, 123, 333n Cordero, Franco, 178n Corra, Bruno (pseudonimo di Bruno Ginanni Corradini), 32n Corsi, Barbara, 61n Corsi, Mario, 36 Corsicato, Pappi, 135, 174, 175 Cortelazzo, Michele A., 150n Cortellesi, Paola, 168n Cossa, Pietro, 29 Cossiga, Francesco, 501 Costa, Antonio, 37 e n, 201n, 287n, Costa, Mario, 379 Costanzo, Maurizio, 190, 504 Costanzo, Saverio, 134, 204 Cottafavi, Vittorio, 80, 195, 225, 400, 401, 402n, 403, 405, 427 Coveri, Lorenzo, 194n Crainz, Guido, 62n Craxi, Bettino, 270, 501 Crialese, Emanuele, 170, 182, 198, 200, 213 Crichton, Charles, 206 Crispino, Francesco, 348n Croce, Benedetto, 221 e n, 363, 365 e n, 366, 368 Cucchiarelli, Paolo, 496 e n Curreli, Enzo, 18 Curti, Roberto, 495n Custen, George Frederick, 483n D’Accursio, Eduardo, 25 D’Ambra, Lucio, 232, 233, 234 e n D’Amico, Luigi Filippo, 58, 68 D’Angelo, Nino, 170 D’Angelo, Paolo, 364n D’Annunzio, Gabriele, 25
Indice dei nomi
D’Annunzio, Gabriele Maria (detto Gabriellino), 25, 68, 376 D’Assunta, Rocco, 171 D’Aurevilly, Barbey, 253n D’Autilia, Gabriele, 436n D’Azeglio, Massimo, 229, 469 D’Errico, Corrado, 163n, 311, 312 D’Oriano, Pietro, 370n Da Ponte, Lorenzo, 396 D’Agostino, Patrizia, 164n Daney, Serge, 339 e n, 452, 453n Daniele, Pino, 196 Davoli, Ninetto, 241, 242, 407 Debenedetti, Giacomo, 41, 42 e n, 75n, 77n, 176 e n, 208n De Benedetti, Aldo, 91 De Bernardinis, Flavio, 335n De Berti, Raffaele, 393n, 470n De Biasi, Wolfango, 66, 68 De Blasi, Nicola, 241n De Bosio, Gianfranco, 330, 331, 359 De Capitani, Elio, 484, 485 De Cataldo, Giancarlo, 472n De Chirico, Giorgio, 233, 238 De Chomón y Ruiz, Segundo Víctor Aurelio, 37, 297, 359, 446 De Filippo, Eduardo, 85, 125n, 196, 224, 227, 228, 404 De Filippo, Peppino, 201, 224, 227, 228, 252 De Gaetano, Roberto, 8 e n, 125n, 139n, 238n, 244n, 272n, 273n, 275n, 277n, 278n, 426n, 474n, 479 e n, 480 e n De Gasperi, Alcide, 11, 12, 14, 483 De Giorgi, Elsa, 232n De Laude, Silvia, 48n, 139n, 144n, 394n, 442n, 448n De Liguoro, Giuseppe, 25, 159n, 295n De Lillo, Antonietta, 354, 422 De Luca, Lorella, 187 De Maria, Luciano, 32n De Maria, Renato, 486 De Martino Cincotti, Anna, 168n De Martino, Ernesto, 102, 103n, 104 e n, 105 e n, 168, 259 De Matteis, Stefano, 31 e n
527
De Robertis, Francesco, 323, 324, 359 De Roberto, Federico, 468 De Sanctis, Francesco, 94n, 222 e n, 239n De Santi, Pier Marco, 421n De Seta, Vittorio, 107, 117, 122, 140, 249n, 340n De Sica, Christian, 185 De Sica, Vittorio, 40, 41, 45, 46, 57, 76, 79, 81, 83, 127, 132, 164, 165, 167, 175, 185, 192, 213, 226, 262, 266, 268, 314, 326 e n, 327 De Vincenti, Giorgio, 52n, 347n De Angelis, Enrico, 418n De Santis, Giuseppe, 166n, 322, 323, 332, 359, 383, 384 e n, 385, 386, 387, 393, 395, 396, 400, 427 Debussy, Claude-Achille, 234n Deed, André (pseudonimo di Henri André Augustin Chapais), 26, 227, 231, 232 Del Balzo, Raimondo, 389n Del Fra, Lino, 103, 335, 359 Deleuze, Gilles, 70n, 82, 87, 128, 130 e n, 131, 139n, 233, 253n, 254, 286 e n, 321 e n, 410n Dell’Utri, Marcello, 504 Della Casa, Steve, 388n Delon, Alain, 49 Denizot, Vincenzo, 38 Depero, Fortunato, 245n Derrida, Jacques, 285 e n, 288 Di Gianni, Luigi, 103 Di Robilant, Alessandro, 478 Dickinson, Emily, 499 Di Venanzo, Gianni, 267 Diritti, Giorgio, 125, 195 Dominijanni, Ida, 497, 498n Donizetti, Gaetano, 392, 424 Dor, Karin, 113 Dos Passos, John Roderigo, 132n Dotti, Marco, 412n Douglas, Mary, 67 e n Doyle, Helen Claudia, 287n Durkheim, Émile, 22 Dürrenmatt, Friedrich, 92n, 100n Duvivier, Julien, 234
528
Eastwood, Clint, 94 Eco, Umberto, 289 e n Ejzenštejn, Sergej Michailovic, 240n, 286, 455, 488 e n, 491 Eliade, Mircea, 104n, 218 e n, 259 Emmer, Luciano, 91, 268 Ercoli, Luciano, 495 Escobar, Roberto, 242n Esposito, Roberto, 70n, 71n, 76n, 179n, 212 e n, 261n, 304n, 314, 315n, 320n, 331n, 340n, 358 Fabre, Marcel (pseudonimo di Marcelo Fernández Peréz), 26, 231 Fabrizi, Aldo, 11-14, 68, 202, 204, 262 Fabrizi, Elena (detta “Lella”), 202 Faccioli, Alessandro, 310n, 436n Faenza, Roberto, 335n, 448n, 465 e n, 466, 468, 469, 473, 505, 506 Falasca-Zamponi, Simonetta, 310n, 378n Faldini, Franca, 241n Falena, Ugo, 233, 375 Fanfani, Massimo, 152n Faranda, Laura, 217n Farassino, Alberto, 386n, 451 e n Farinelli, Gian Luca, 26n Farinotti, Luisella, 456 e n Faulkner, William, 132n Fellini, Federico, 51, 62, 94, 103, 121 e n, 122, 131, 132, 139, 200, 201, 213, 217, 231, 242, 246, 249n, 252n, 255 e n, 256, 257, 258, 260, 269, 279, 282, 346, 359, 408, 419, 423, 427, 447, 450, 463, 506 Ferida, Luisa, 79, 232n Ferrara, Giuseppe, 488, 494, 495 Ferreri, Marco, 54, 55, 62, 101, 106, 107, 131, 140, 217, 218, 260, 270273, 282, 444, 445, 505 Ferzetti, Gabriele, 328 Festa Campanile, Pasquale, 56, 68, 201 Fichte, Johann Gottlieb, 426 e n Filiberti, Marco, 422 Finocchiaro, Donatella, 182 Fiorello, Giuseppe (detto Beppe), 182
Lessico del cinema italiano
Fiorello, Rosario, 30n Fizzarotti, Ettore Maria, 50 Flaubert, Gustave, 43, 50 Florenskij, Pavel, 319 Focas, Spiros, 49 Fofi, Goffredo, 97n, 241n Fontana, Alessandro, 432n Ford, John, 274 Forgacs, David, 10 e n, 44n, Forlani, Arnaldo, 501, Formia, Lia, 232 Fornara, Bruno, 434 e n Fortini, Franco, 107, 223, 335, 401 e n Forzano, Giovacchino, 42, 109, 140, 438, 505 Foucault, Michel, 111, 222, 432n, 443, 452n Fracanzani, Michelangelo, 245-248 Fracassi, Clemente, 379 Frammartino, Michelangelo, 107, 140, 235n Franceschini, Fabrizio, 191n Franchi, Franco, 172, 194, 243, 264 Franciolini, Giovanni, 78, 93, 140, 224, 246, 282 Franco, Giacomo, 220 Frazer, James, 259 Frazzi, Andrea e Antonio, 174, 195, 196 Frears, Stephen, 455 Freddi, Luigi, 42 e n, 43, 44, 309n Freeman, Hugh, 468n Fregoli, Leopoldo, 24, 29, 30, 31 e n, 32 e n, 33, 34, 35 e n, 36, 37, 41, 67, 158, 231, 240, 306n Freud, Sigmund, 230, 252 Frye, Northrop, 269, 371n Fubini, Enrico, 370n, 410n Fulci, Lucio, 50 Fuller, Loïe (pseudonimo di MaryLouise Fuller), 34 Fusco, Giovanni, 400 e n, 403, 404 Fusillo, Massimo, 272n Gadda, Carlo Emilio, 45 e n, 46, 171, 176, 436 e n, 491 Gaglianone, Daniele, 356, 357, 359 Gallini, Clara, 103n
Indice dei nomi
Gallone, Carmine, 78, 232, 296, 309, 310, 359, 377, 379-384, 387, 389, 396, 403, 427, 437, 505 Gance, Abel, 232n, 233, 455 Gargiulo, Marco, 194n Gariazzo, Piero Antonio, 233n Garibaldi, Giuseppe, 399 Garrone, Matteo, 137, 138, 140, 195, 196, 262, 282, 486 Gassman, Vittorio, 96, 98, 156, 190, 202, 203n, 263, 266-268, 270, 280, 327, 475, 489 Gastaldon, Stanislao, 412 Gaudio, Domenico, 304 e n, 359 Gautier, Théophile, 232n Gelli, Licio, 270 Genina, Augusto, 39, 40, 68, 232 e n, 312-314, 320, 358, 359, 383, 384, 387n, 393, 396, 427 Genovese, Paolo, 174 Gentile, Giovanni, 70, 300 e n, 301, 302, 305n, 307, 311, 324, 363, 366, 367 e n, 368 Gentile, Maria Teresa, 251n Gentilomo, Giacomo, 224, 240n Germi, Pietro, 97, 170, 181, 189n, 190, 191, 194, 213, 478 Gerratana, Valentino, 301n, 364n Gervasoni, Marco, 61n Ghelli, Simone, 281n Giacovelli, Enrico, 227n, 270n Gianikian, Yervant, 355 Giannarelli, Ansaldo, 187n, 208n Giannini, Ettore, 282 Giannini, Gabriele, 206n Giannini, Giancarlo, 169, 197 Giannini, Guglielmo, 47, 226 Gili Fivela, Barbara, 152n Gili, Jean Antoine, 384n Gilman, Sander L., 372n Ginna, Arnaldo, 234 Ginsborg, Paul Antony, 12n Ginzburg, Natalia, 448n Giordana, Marco Tullio, 207, 409, 420, 422, 495 Giordani, Claudia, 234n Giordano, Umberto, 371 Giori, Mauro, 397 e n
529
Giovannesi, Claudio, 204 Girotti, Massimo, 387 Godard, Jean-Luc, 132, 195, 286, 339 e n, 435 Goffman, Erving, 9 e n Gogol, Nikolaj Vasilevič, 15, 18, 19 Goldoni, Carlo, 220n, 267, 280 Goodman, Paul, 49 e n Gramsci, Antonio, 43, 70, 148 e n, 150, 301 e n, 302, 307, 363, 364 e n, 367, 368, 373 Grande, Maurizio, 80n, 97n, 146n, 189n, 225n, 253, 262n, 263, 270, 271 e n, 277n, 388n, 395n, 461n Grasso, Aldo, 60n Gray, Dorian (pseudonimo di Maria Luisa Mangini), 52 Greg (pseudonimo di Claudio Gregori), 90 Greggio, Ezio, 185 Gregoretti, Ugo, 180, 263 Grieco, Sergio, 252n Griffith, David Wark, 376 Grifi, Alberto, 117n, 155, 194, 213, 335 Grillo, Giuseppe (detto Beppe), 281 Grizzaffi, Chiara, 464n Grossi, Marco, 384n Gruault, Jean, 244, 245, 248n Grusin, Richard, 28n Guareschi, Giovanni, 335n Guazzoni, Enrico, 73, 446 Guccini, Gerardo, 31n Guédiguian, Robert, 455 Gui, Vittorio, 234n Guicciardini, Francesco, 442 e n Guillaume, Ferdinand, 26, 28, 227, 231 Guitry, Sacha, 234 Gullo, Fausto, 12 Gundle, Stephen, 10 e n Guttuso, Renato, 441 Habermas, Jürgen, 21 e n Hamilton, Guy, 333n Harper, John Lamberton, 12n Hawks, Howard, 226 Haydn, Franz Joseph, 369n
530
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 325 e n, 364n, 365n, 366 e n Heilmann, Luigi, 205n Herzog, Werner, 372 Heusch, Paolo 267 Hobbes, Thomas, 431, 455 e n Hobsbawm, Eric, 292 Hoffmann, Robert, 113 Holtus, Günter, 150n Howard, Leslie, 149 Huillet, Danièle, 350n Illuminati, Ivo, 232 Impastato, Peppino, 207, 346 Iñárritu González, Alejandro, 136n Ingrassia, Francesco (detto Ciccio), 172, 194, 243, 264, 277 Jacob, Livio, 26n Jakobson, Roman, 205n Jallat, Jeannine, 219n Jameson, Frederic, 52n, 496 e n Jandelli, Cristina, 487n Jandolo, Augusto, 474 Jannacci, Enzo, 444 Jervis, Giovanni, 72n, 121n Joe, Jeongwon, 372n Joyce, James, 52 Jung, Carl Gustav, 118 e n, 119n Ka a, Franz, 241, 337, 401 Kezich, Tullio, 466 e n Klee, Paul, 350 Kluge, Alexander, 372 Koch, Karl, 379 Kozloff, Sarah, 157n Kracauer, Siegfried, 35 Kress, Gunther, 157n Kristeva, Julia, 472n Kubin, Alfred, 241 Kyenge, Cécile, 448 L’Herbier, Marcel, 158, 236 Lacan, Jacques, 216 Lacis, Asja, 354, 355n Lacoue-Labarthe, Philippe, 303n Lang, Fritz, 232, 372, 440n, 455 Langlois, Henri, 293n
Lessico del cinema italiano
Lanham, Richard A., 219n Lattuada, Alberto, 11, 17, 18, 57, 68, 80, 153n, 217, 262, 401, 404 Laura, Ernesto G., 320n Laurenti Rosa, Silvio, 304n Laurenti, Fabrizio, 436n Laurenti, Mariano, 59, 68 Lavinio, Cristina, 152n Leccardi, Carmen, 67n Ledda, Gavino, 201 Lee, Spike, 350n Leed, Eric J., 108n Lenin (Vladimir Il’ič Ul’janov), 449, 500 Leo, Edoardo, 66, 68 Leoncavallo, Ruggero, 371, 373n Leone, Giovanni, 466 Leone, Sergio, 94, 140, 338, 420 Leopardi, Giacomo, 144n, 178n, 179n, 222, 237, 255, 287, 290 e n, 291, 292, 342 e n, 358 Leutrat, Jean-Louis, 293n Lévy-Bruhl, Lucien, 259 Ligabue, Luciano, 170 Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo), 90 Lionello, Alberto, 260 Lisi, Virna, 254n Lista, Giovanni, 31n Littizzetto, Luciana, 142 Livi, Grazia, 97n Lizzani, Carlo, 53 e n, 68, 267, 323n, 340n Lloyd, Phillyda, 455 Lo Bello, Concetto, 58 Lo Cascio, Luigi, 207, 501 Lo Verso, Enrico, 199, 200 Locke, John, 123 e n, 431 Locuratolo, Massimo, 31n Lollini, Massimo, 219n, 220n, 221n, 230n Longanesi, Leo, 166n Loren, Sophia, 92, 196 Loy, Nanni, 268, 329, 419, 475, 477 Lubitsch, Ernst, 224, 226, 232, 234 Luchetti, Daniele, 63, 457, 506 Lucini, Luca, 174 Lukács, György, 395 e n
Indice dei nomi
Lumière, Auguste e Louis, 33, 37 Lussu, Emilio, 341 Luzzatto, Sergio, 435 e n, 436 e n, 437n Macario (pseudonimo di Erminio Macario), 227, 240 Maccari, Mino, 313n Maccari, Ruggero, 116n Macchia, Giovanni, 41n, 223 Machiavelli, Niccolò, 70, 287, 289 e n, 290, 291n, 292, 325, 340n, 358, 430, 447 Macis, Alessandro, 268n Manfredonia, Giulio, 463 Maggi, Luigi, 161n, 298, 373 Magnani, Anna, 46, 47, 154, 167, 176, 245n, 382, 392 Magni, Luigi, 208n, 440 Malasomma, Nunzio, 226 Malerba, Luigi, 17 Mancino, Anton Giulio, 493n, 498 e n, 502 Manfredi, Nino, 98, 113, 263, 440 Manganaro, Jean-Paul, 410n Manganelli, Giorgio, 249n Mangano, Silvana, 83, 385 Mangini, Cecilia, 103, 105, 140, 335, 359 Mann, Daniel, 207 Mann, Thomas, 401 Mannini, Giorgio, 379 Manzoli, Giacomo, 25n, 205n Manzoni, Alessandro, 144 e n, 149, 150, 191 Manzoni, Giacomo, 402n Maraldi, Antonio, 116n Marcel, Gabriel, 19 Marcello, Pietro, 235n Marcuse, Herbert, 60 Maresco, Franco, 195-197, 215, 273, 275 e n, 282, 504 e n, 505, 506 Marin, Louis, 434 e n Marinetti, Filippo Tommaso, 32 e n Marini Maio, Nicoletta, 489n Martinelli, Renzo, 180, 494 Martini, Andrea, 223n Martone, Mario, 125, 140, 179n, 194,
531
196, 354-356, 359, 361, 362, 393n, 405, 415, 423, 425 e n, 426, 427 e n, 472 e n, 473, 474, 506 Marx (fratelli), 227, 269 Marx, Karl, 488 Masaniello (Tommaso Aniello d’Amalfi), 220, 245, 246, 249 Mascagni, Pietro Antonio Stefano, 34 Masi, Alfredo, 234 Masoero, Francesca, 66n Massenzio, Marcello, 103n Mastrocinque, Camillo, 201, 224, 267 Mastroianni, Marcello, 57, 84, 92, 121, 184, 189, 190, 217, 271, 277, 280, 461 Matarazzo, Raffaello, 93n, 170, 183, 184, 213, 225, 377, 382, 387-389, 390 e n, 391-393, 396, 399, 401, 403, 427 Mattei, Enrico, 484, 493 Mattera, Paolo, 61n Mattoli, Mario, 162n, 167, 171, 226, 227, 314 Mauss, Marcell, 20 e n, 21, 66 e n Mazzacurati, Carlo, 63, 204, 486 Mazzanti, Nicola, 26n Mazzini, Giuseppe, 368 e n, 369, 370, 371, 374, 426 Medin, Gastone, 226 Melato, Mariangela, 169, 461 Meldolesi, Claudio, 171n Méliès, Georges, 36, 37, 231, 232 Menarini, Alberto, 152 e n Menarini, Roy, 380n Mendolesi, Luisa Anna, 331 Menduni, Enrico, 60n Meneghelli, Andrea, 233n Menichelli, Pina, 375 Mereu, Salvatore, 135, 195 Merker, Nicolao, 366n Metz, Christian, 147 e n Micali, Simona, 493n Micciché, Lino, 18n, 42n, 115n, 185n, 330n, 335, 344n, 359, 398, 469n Michelet, Karl Ludwig, 325n Micheli, Paola, 164n, 203n
532
Miglio, Gianfranco, 285n, 288 e n Milani, Lorenzo don, 49 Milani, Riccardo, 459 Milanini, Claudio, 45n Milano, Paolo, 148, 149 e n, 165 Milian, Thomas, 183 Mingozzi, Gianfranco, 103 Miniero, Luca, 168 Minuz, Andrea, 450n, 451 Miranda, Isa, 76 Mitterand, François, 455 Moccia, Federico, 175 Molière (pseudonimo di JeanBaptiste Poquelin), 261 Moliterni, Ivan, 429n Mondella, Diego, 481n Mondzain, Marie-José, 286 e n Monelli, Paolo, 148, 150 Moneti, Guglielmo, 322n Monicelli, Mario, 139, 156, 171, 190, 191n, 196, 213, 236, 263, 266, 268270, 326, 359, 419, 463 Montaldo, Giuliano, 486 Montesano, Enrico, 61 Monti, Vincenzo, 144 Morandi, Gianni, 381 Morandini, Morando, 284 e n Moravia, Alberto, 106, 120 e n, 187n, 267 Moretti, Mario, 501 Moretti, Nanni, 7, 61, 68, 69, 100, 123, 135, 139 e n, 140, 172, 173, 174n, 213, 218, 265, 275, 276, 277n, 278, 281, 282, 448, 457, 458, 483-488, 503, 506 Moro, Aldo, 277, 346, 424, 461, 462n, 484, 493, 494, 495, 498, 499-502 Morreale, Emiliano, 63n, 194n, 196n, 268n, 362n, 504n Morricone, Ennio, 421 Morselli, Ercole Luigi, 233 Mozart, Wolfgang Amadeus, 369n, 371, 396, 406 Muccino, Gabriele, 174 Muccino, Silvio, 174 Murgia, Tiberio, 190 Murolo, Roberto, 170 Murri, Serafino, 343n, 453n
Lessico del cinema italiano
Muscio, Giuliana, 310n, 437n, 438n Musco, Angelo, 161 Mussolini, Benito, 37, 38, 109, 246, 249, 280, 281, 305n, 306, 423 e n, 424, 435, 437, 438 e n, 439, 457, 483, 491 Mussolini, Vittorio, 150 Naitza, Sergio, 268n Nancy, Jean-Luc, 303n Napolitano, Riccardo, 189n Nazzari, Amedeo, 83, 183, 184, 387, 390 Nazzaro, Giona A., 474n Nencioni, Giovanni, 152 e n Nero, Franco, 110 Nichetti, Maurizio, 198n Nicodemi, Aldo, 183 Ninchi, Annibale, 309 Noris, Assia, 89, 226 Notari, Elvira, 161 e n Nunziante, Gennaro, 67 e n, 68 Nussbaum, Martha, 473n Nuti, Francesco, 61, 193, 196, 265 O’Leary, Alan, 494 e n, 496 e n Occhini, Ilaria, 118 Olivetti, Adriano, 249n Olmi, Ermanno, 53, 62, 169, 185, 194, 283, 290, 353, 354, 358, 359, 419 O’Rawe, Catherine, 66n Orlando, Silvio, 65, 458, 484 Orsini, Valentino, 352 Ortoleva, Peppino, 335n Orwell, George, 452n Ottoni, Filippo, 207 e n Ozpetek, Ferzan, 135, 422 Pabst, Georg Wilhelm, 39 Padovan, Adolfo, 25 Pagano, Bartolomeo, 38, 298 Pagnol, Marcel, 234 Palermi, Amleto, 232 e n, 282 Pampanini, Silvana, 387 Panaro, Alessandra, 187 Panofsky, Erwin, 21 e n, 22 Panzini, Alfredo, 148, 150 Paolella, Domenico, 36 e n
Indice dei nomi
Paolo VI, papa (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini), 444 Paolucci, Gabriella, 21n Papaleo, Rocco, 195, 210 Papini, Giovanni, 234n Parenti, Neri, 164n, 172 Parigi, Stefania, 45n, 185n, 344n Parinetto, Luciano, 370n, 396n Parini, Giuseppe, 144 Parise, Goffredo, 101n Parlangeli, Oronzo, 148n Parsons, Talcott, 49 e n Pasolini, Pier Paolo, 43, 47, 48 e n, 49n, 55, 65, 68, 104 e n, 105, 106 e n, 107, 110, 139 e n, 144 e n, 147 e n, 148 e n, 152n, 172, 183 e n, 185, 190, 191, 192 e n, 195 e n, 197n, 216, 241-244, 258, 259 e n, 260, 268, 274, 282, 335n, 339n, 342-344, 358, 359, 394 e n, 406 e n, 407n, 408, 409, 412, 422, 427, 442 e n, 446, 447, 448 e n, 451-453, 465, 485, 493, 505 Pasquino, Pasquale, 432n Passeron, Jean-Claude, 19n, 22 e n Pastrone, Giovanni (pseudonimo di Pietro Fusco), 25 e n, 38, 140, 159, 213, 297, 298, 375, 376, 445, 446, 505 Patuelli, Raffaello, 209n Pavolini, Corrado, 164n Pavone, Claudio, 315, 316 e n, 331, 353 Pavone, Rita, 381 Pellanda, Marina, 408n Perniola, Mario, 236 e n, 238n, 419n Perrin, Jacques, 117 Persico, Luca “Zulù”, 175 Pescatore, Guglielmo, 380n Petraglia, Sandro, 495 Petrarca, Francesco, 144n Petri, Elio, 56, 99, 140, 169, 180 e n, 218, 275, 277-279, 282, 335-337, 461, 479, 482, 488, 505 Petrolini, Ettore, 30n, 31 e n, 32, 227, 231, 234, 340 Petronio, Tito Nigro, 258, 260 Piavoli, Franco, 107, 201
533
Piazza, Roberta, 146n Picabia, Francis, 240 Picasso, Pablo, 245n Picchiorri, Emiliano, 174n Piccoli, Michel, 69, 272n Piccolo, Francesco, 467 e n Pietrangeli, Antonio, 94, 95, 111, 115 e n, 116n, 140, 217, 268 Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto), 180, 503, 504 Pingitore, Pier Francesco, 495 Pippo Franco (pseudonimo di Francesco Pippo), 59 Pirandello, Luigi, 41 e n, 52, 74n, 75 e n, 76 e n, 77, 87, 149, 158 e n, 234 e n, 236, 237 Pirro, Ugo, 479 Pistolesi, Elena, 152n Pitagora, 107 Piva, Alessandro, 195 Pizzorno, Alessandro, 85n, 216n Placido, Michele, 180, 199, 484 Poe, Edgar Allan, 218 Poggi Salani, Teresa, 150n Pontecorvo, Gillo, 338 Popper, Karl, 494 e n Pozzati, Severo, 234 Pozzetto, Renato, 61, 268 Prampolini, Enrico, 245n Pravadelli, Veronica, 398n, 470n Proietti, Luigi (detto Gigi), 268 Prosperi, Giorgio, 17 Proust, Marcel, 52, 401 Pucci, Piero, 165n, 176, 177 e n, 187n Puccini, Giacomo, 233, 371, 391, 421 Puccini, Gianni, 263, 268, 333n, 380 Pucillo, Filippo, 199 Pugliese, Rosa, 152n Quaresima, Leonardo, 25n Rabelais, François, 270 Radtke, Edgar, 150n Raffaelli, Sergio, 147n, 152 e n, 153 e n, 158n, 160n, 161n, 165n, 188n, 201n Ralli, Giovanna, 202, 382 Rancière, Jacques, 351n
534
Randone, Salvo, 440, 481 Rascel, Renato (pseudonimo di Renato Ranucci), 15-19, 154n, 240n, 267 Rati, Maria Silvia, 211n Ratzinger, Joseph Aloisius (papa Benedetto XVI), 8, 69n Recalcati, Massimo, 112n Redi, Riccardo, 308n Reich, Jacqueline, 38n, 57 e n Renoir, Jean, 245 e n, 400 Renzi, Renzo, 26n, 31n, Resnais, Alain, 121 Ricci Lucchi, Angela, 355 Ricci, Laura, 145n Riefenstahl, Leni, 372 Righelli, Gennaro, 38, 39, 167, 228 Ring, Sacha, 426n Risi, Dino, 84, 92, 94, 114, 140, 156, 171, 203n, 213, 254n, 262, 263, 266, 268-270, 282, 329, 382, 462, 475, 476 Risi, Marco, 194, 196, 213 Risi, Nelo, 254n Roatto, Almerico, 158 Roberti, Bruno, 125n, 426n, 474n Rodolfi, Eleuterio, 295n Rodotà, Stefano, 261n Rohrwacher, Alba, 135 Rohrwacher, Alice, 135 Romeo, Giuseppe, 198n Romitelli, Valerio, 473, 474n Roncoroni, Mario, 25, 68 Roncoroni, Stefano, 434, 435n Rosa, Salvator, 220, 222, 229, 236, 245, 246 Rosi, Francesco, 179, 181, 182, 213, 335, 340 e n, 341, 359, 419, 441, 456, 483, 495, 505 Rosi, Gianfranco, 211 Rossellini, Roberto, 44, 45, 51, 68, 126, 132, 140, 165, 185, 207, 208, 213, 240, 244, 245 e n, 246, 247, 248 e n, 270, 317, 318, 319 e n, 320322, 326, 339n, 343, 350, 351, 358, 359, 382, 401, 407, 433-437, 441443, 452, 474, 483, 501, 503, 505
Lessico del cinema italiano
Rossi, Fabio, 145n, 146n, 171n, 201n, 206n Rossi, Franco, 268 Rossini, Gioacchino, 34, 369, 371, 376, 421, 425n, 426 e n Rota, Nino, 393n, 419 Rubini, Sergio, 135 Ruffin, Valentina, 164n Ruggeri, Telemaco, 161 Rulli, Stefano, 495 Rutelli, Francesco, 464 Sabatini, Francesco, 150n, 153 e n Sacchi, Filippo, 228n Sadoul, Georges, 446 e n Sakamoto, Ryuichi, 418 Sala, Emilio, 375n Salce, Luciano, 53, 266, 329, 463 Salerno, Enrico Maria, 113 Salinari, Carlo, 176 Salotti, Marco, 309n Salvatores, Gabriele, 62, 63, 134, 348, 351, 352 Salvatori, Renato, 49, 187 Salvini, Anton Maria, 160n Samperi, Salvatore, 60n Sandrelli, Stefania, 112, 266 Sanna, Emilio, 475 Sanson, Yvonne, 16, 19, 123, 183, 184, 387, 390 Santoro, Marco, 24n Sapiro, Gisèle, 21n Saragat, Giuseppe, 444 Sarchielli, Massimo, 117n, 155, 194, 213 Sartre, Jean-Paul, 22 Sassatelli, Roberta, 24n Savinio, Alberto, 233 Scaldati, Franco, 215 Scaramuzza, Giuseppe, 370n, 371n Scarpelli, Furio, 171, 202, 475 Scarpetta, Eduardo, 30 Scarpetta, Vincenzo, 73 Scavolini, Romano, 389n Scavuzzo, Carmelo, 189n Schiera, Pierangelo, 285n Schifano, Mario, 441 Schmidt, Johann N., 371n
Indice dei nomi
Schmitt, Carl, 285 e n, 286, 287, 288 e n, 289, 290, 291 e n, 304, 306, 314 e n, 347, 358 Schneider, Romy, 84 Schoeller, Pierre, 454 Schönberg, Arnold Franz Walther, 402 e n, 413 Schopenhauer, Arthur, 372n Schroeter, Werner, 372 Schweppenhäuser, Hermann, 108n Sciascia, Leonardo, 207n Scicchitano, Filippo, 142 Scola, Ettore, 116n, 198n, 201, 203n, 213, 268, 269, 352, 408 Secci, Lia, 373n Segni, Antonio, 12 Segre, Andrea, 204 Serato, Massimo, 79 Serena, Gustavo, 213, 375, 427 Serromani, Sandra, 153n Servillo, Toni, 136, 179n, 196n, 279, 280, 487n Sesti, Mario, 194n Settimelli, Emilio, 32n Severini, Gino, 245n Sewell, William Hamilton Jr., 24n Shakespeare, William, 32n, 149, 243, 369n, 396 Shearer, Norma, 149 Simondon, Gilbert, 120 e n Simoneschi, Lidia, 183, 184 Simonetti, Michela, 418n Sinisgalli, Leonardo, 17 Siti, Walter, 48n, 104n, 139n, 144n, 394n, 442n, 448n Socrate, 270, 271 Sokurov, Alexander, 489 Soldati, Mario, 81, 88, 140, 224, 225, 252n, 401, 404 Soldini, Silvio, 204 Sommario, Giuseppe, 169n Sonego, Rodolfo, 475 Sorcinelli, Paolo, 49n, 54n Sordi, Alberto, 37, 96, 98, 169, 172, 190, 204n, 217, 258, 261, 263, 264, 266, 270, 280, 327, 477, 478 Sorlin, Pierre, 294 e n, 296n, 299 Sorrentino, Paolo, 100, 136, 179n,
535
218, 269, 275, 278, 279, 281, 282, 483, 486-490, 496, 506 Sosa, Haydée Mercedes, 10 Spadaro, Micco, 220 Spielberg, Steven, 455 Spinazzola, Vittorio, 14 e n, 56 e n, 187n, 400n Starace, Simone, 402n Steiger, Rod, 457 Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), 171, 266, 268, 333n, 455 Stewart-Steinberg, Suzanne, 20 e n, 239n, 249n, 250n, 251, 252 e n Stone, Oliver, 494 Stoppa, Paolo, 80, 81 Straub, Jean-Marie, 185, 350n Stravinskij, Igor Fëdorovič, 402 e n Stuhr, Jerzy, 485 Subini, Tomaso, 104n, 393n, 395n, 470 e n Svevo, Italo (pseudonimo di Aron Hector Schmitz), 52 Syberberg, Hans-Jürgen, 372 Tagliavini, Ferruccio, 381 Tarkovskij, Andrej, 72 Tati, Jacques, 198 Tausk, Viktor, 252 Taviani, Paolo e Vittorio, 51, 195, 349, 359, 409, 420, 427, 470 Tellini, Piero, 11, 80 Teodoro, Maria, 227n Testori, Giovanni, 397 Tiedemann, Rolf, 108n Tiepolo, Giambattista, 237 Tilgher, Adriano, 74, 76n Timi, Filippo, 280, 491 Tinazzi, Giorgio, 167n, 470 e n Tognazzi, Ricky, 196 Tognazzi, Ugo, 53, 98, 113, 169, 217, 260, 263, 266, 268, 271, 280, 417, 444, 462, 476 Tomasello, Dario, 53n, 193n Tomasi di Lampedusa, Giuseppe, 471 Tornatore, Giuseppe, 62, 68, 170, 196, 204 Toscani, Claudio, 396n
536
Toschi, Paolo, 236n Totò (pseudonimo di Antonio De Curtis), 85, 123, 171, 172, 196, 198, 201, 203, 204n, 217 e n, 240-244, 252, 254 e n, 255, 266, 268, 333n, 407, 455 Trabalza, Ciro, 148, 150 Tretti, Augusto, 447-449, 505 Trifone, Pietro, 174n Trintignant, Jean-Louis, 203n Troisi, Massimo, 61, 169, 174, 186, 193, 196, 265 Tucci, Stanley, 207 Tumiati, Domenico, 159n Turco, Enzo, 171 Turi, Gabriele, 300n, 301n Turroni, Giuseppe, 59n Uva, Christian, 61n, 489n, 493n, 495n Valenti, Osvaldo, 232n Valeri, Franca, 170 Valerii, Tonino, 94 Valli, Alida, 52, 93 Vallone, Raf, 385 Van Leeuwen, Theo, 157n Van Nort, Doug, 426n Vancini, Florestano, 328, 341, 359, 495 Vanzina, Carlo ed Enrico, 172, 185 Vardannes, Emilio (pseudonimo di Antonin Bénevént), 27 Vari, Paolo, 174, 213 Varni, Angelo, 49n Vaser, Ernesto, 27 Vecchietti, Maura, 287n Ventura, Francesco, 494n Verdi, Giuseppe, 34, 144, 361, 362, 369, 370 e n, 371, 376, 386, 392, 393 e n, 394, 396 e n, 397, 398, 403n, 405, 408, 409, 410 e n, 411, 412, 413 e n, 414 e n, 415, 416, 421424, 425 e n, 426, 427, 500 Verdone, Carlo, 61, 168, 186, 193, 265, 268 Verdone, Mario, 36, 373n Verga, Giovanni, 149, 165
Lessico del cinema italiano
Vergano, Aldo, 317 Vernant, Jean-Pierre, 218 e n Veronesi, Giovanni, 142, 168, 204n, 213 Veronesi, Sandro, 411n Vertov, Dziga, 438, 455, 500 Vicario, Mario, 58 Vicentini Orgnani, Ferdinando, 495 Vichi, Laura, 31n Vico, Giambattista, 220, 221 e n, 430, 454 Viganò, Dario E., 430n Vigo, Jean, 240n Villa, Claudio, 381 Villaggio, Paolo, 53, 186, Virno, Paolo, 120n Virzì, Paolo, 64, 65, 68, 134 e n, 195, 204n, 210, 486 Visconti, Luchino, 46, 49, 51, 56, 68, 132, 140, 165, 192, 213, 245n, 383, 384n, 385, 390n, 392 e n, 393, 395n, 396, 397, 398 e n, 399, 400, 401, 403, 404, 411-415, 417, 421, 427, 469-474, 490, 505 Vitali, Alvaro, 183 Vitti, Antonio, 332n Vitti, Monica, 202 Vittorini, Elio, 350n Viviani, Christian, 390n Volonté, Gian Maria, 99, 277, 280, 331, 338, 341, 461, 479, 480, 482, 484 Von Humboldt, Wilhelm, 238n Von Trier, Lars, 194 Wagner, Wilhelm Richard, 32n, 34, 372 e n, 391n, 398, 399, 405, 407, 410, 418 e n, 419, 421, 422 Warhol, Andy, 194 Watteau, Jean-Antoine, 232n Wayne, John, 184 Weber, Maximilian, 66, 466 e n Weil, Simone, 319 Wertmüller, Lina, 169-171, 194, 197, 201 Wiene, Robert, 455 Wilde, Oscar, 411 Winspeare, Edoardo, 195
Indice dei nomi
Zabagli, Franco, 104n Zaccagnini, Edoardo, 490n Zagarrio, Vito, 42 e n, 62n, 223n, 348n, 481n Zalone, Checco (pseudonimo di Luca Pasquale Medici), 67 e n, 210 Zambetti, Sandro, 477n Zampa, Luigi, 11, 68, 140, 154, 155, 204n, 213, 267 Zancan, Maria, 167n Zannini, Giovanni, 25
537
Zavattini, Cesare, 17, 45, 130 e n, 175, 198n, 241, 268, 395n Zecca, Federico, 64n Zeffirelli, Franco, 419 e n, 422n Zigaina, Giuseppe, 259n Zinni, Maurizio, 332n, 334n Žižek, Slavoj, 326n Zucconi, Francesco, 433, 434n, 474n, 475 Zurlini, Valerio, 94, 408, 409, 413, 421, 427
MIMESIS GROUP www.mimesis-group.com MIMESIS INTERNATIONAL www.mimesisinternational.com [email protected] MIMESIS EDIZIONI www.mimesisedizioni.it [email protected] ÉDITIONS MIMÉSIS www.editionsmimesis.fr [email protected] MIMESIS AFRICA www.mimesisafrica.com [email protected] MIMESIS COMMUNICATION www.mim-c.net MIMESIS EU www.mim-eu.com
Finito di stampare nel mese di ottobre 2015 da Digital Team - Fano (Pu)
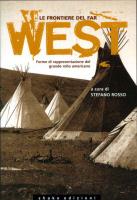





![Il Centauro. Rivista di filosofia e teoria politica. Soggetti Forme [Vol. 1]
8870420493, 9788870420494](https://dokumen.pub/img/200x200/il-centauro-rivista-di-filosofia-e-teoria-politica-soggetti-forme-vol-1-8870420493-9788870420494.jpg)

![Il romanzo. Le forme [Vol. 2]
8806152912](https://dokumen.pub/img/200x200/il-romanzo-le-forme-vol-2-8806152912.jpg)

![Lessico del cinema italiano. Forme di rappresentazione e forme di vita [Vol. 2]
8857530736, 9788857530734](https://dokumen.pub/img/200x200/lessico-del-cinema-italiano-forme-di-rappresentazione-e-forme-di-vita-vol-2-8857530736-9788857530734.jpg)