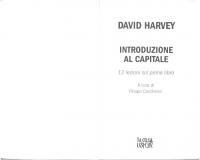Introduzione al documentario 8880333674, 9788880333678
Quando nasce il documentario? Cosa lo distingue dagli altri generi? A chi si rivolge, che aspettative genera nello spett
196 88 13MB
Italian Pages 206 [400] Year 2014
Polecaj historie
Table of contents :
Colophon
Frontespizio
INDICE
INTRODUZIONE
CAPITOLO 1 - COME SI PUÒ DEFINIRE UN DOCUMENTARIO?
Benvenuti nell’Età dell’oro
Alla ricerca di un terreno comune: la definizione di documentario
Idee confuse e cambiamenti in atto
Una struttura istituzionale
Una comunità di registi
Un corpus di testi: convenzioni, periodi, movimenti e modalità
Un gruppo di spettatori: presupposti, aspettative, prove e qualità indicativa dell’immagine
CAPITOLO 2 - PERCHÉ I PROBLEMI ETICI SONO FONDAMENTALI PER I DOCUMENTARI?
In che modo i documentari rappresentano il mondo
L’etica della rappresentazione degli altri
Lo scopo dell’etica
Registi, persone, spettatori
CAPITOLO 3 - DA DOVE PRENDONO LA VOCE I DOCUMENTARI?
Le caratteristiche della voce
Categorie di voce
Il documentario e la voce dell’oratore
CAPITOLO 4 - CHE COSA RENDE I DOCUMENTARI COINVOLGENTI E PERSUASIVI?
Il triangolo della comunicazione
Eventi concreti e concetti astratti
Temi comuni, argomenti ricorrenti
La sfida della persuasione
Il potere della metafora
CAPITOLO 5 - COM’È NATA LA FILMOGRAFIA DOCUMENTARISTICA?
L’origine mitica nel cinema primitivo
Il realismo e il desiderio di rappresentarlo: un terreno non sufficiente per il documentario
Il documentario come convergenza di diversi fattori
Gli anni Venti: il documentario trova le sue gambe
CAPITOLO 6 - COME DIFFERENZIARE I DOCUMENTARI? CATEGORIE, MODELLI, E LE MODALITÀ ESPOSITIVA E POETICA DEL DOCUMENTARIO
Il bisogno di classificazione
Il documentario e il suo rapporto con altri generi di film
Modelli e modalità del documentario
Le modalità del documentario e la voce del regista
La modalità poetica
La modalità espositiva
CAPITOLO 7 - COME SI POSSONO DEFINIRE LE MODALITÀ OSSERVATIVA, PARTECIPATIVA, RIFLESSIVA E PERFORMATIVA DEL CINEMA DOCUMENTARIO?
La modalità osservativa
La modalità partecipativa
La modalità riflessiva
La modalità performativa
CAPITOLO 8 - IN CHE MODO I DOCUMENTARI AFFRONTANO LE QUESTIONI SOCIALI E POLITICHE?
Le persone come vittime o come responsabili
Costruire un’identità nazionale
Contestare lo Stato-Nazione
Oltre il nazionalismo: nuove forme di identità
Ridefinire la politica di identità
Questioni sociali e ritratti personali
Coda
CAPITOLO 9 - COME SI PUÒ SCRIVERE EFFICACEMENTE SUL DOCUMENTARIO?
NOTA BIBLIOGRAFICA
FILMOGRAFIA
INDICE DEI NOMI E DEI FILM
RINGRAZIAMENTI
Citation preview
Bill Nichols Introduzione al documentario Traduzione della prima edizione Alessandra Litta Modignani Traduzione ed editing seconda edizione Alice Arecco © 2006, 2014 Editrice Il Castoro Srl viale Abruzzi 72, 20131 Milano www.castoro-on-line.it [email protected] Grafica di copertina di Giuseppe Reale © 2001, 2010 Bill Nichols Pubblicato per la prima volta da Indiana University Press con il titolo Introduction to Documentary. Italian language rights handled by Agenzia Letteraria Internazionale, Milan, Italy. eISBN 978-88-8033-926-7 Prima edizione digitale 2015 Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata. ebook by ePubMATIC.com
Bill Nichols
Introduzione al documentario Nuova edizione
INDICE INTRODUZIONE CAPITOLO 1 - COME SI PUÒ DEFINIRE UN DOCUMENTARIO? Benvenuti nell’Età dell’oro Alla ricerca di un terreno comune: la definizione di documentario Idee confuse e cambiamenti in atto Una struttura istituzionale Una comunità di registi Un corpus di testi: convenzioni, periodi, movimenti e modalità Un gruppo di spettatori: presupposti, aspettative, prove e qualità indicativa dell’immagine
CAPITOLO 2 - PERCHÉ I PROBLEMI ETICI SONO FONDAMENTALI PER I DOCUMENTARI? In che modo i documentari rappresentano il mondo L’etica della rappresentazione degli altri Lo scopo dell’etica Registi, persone, spettatori
CAPITOLO 3 - DA DOVE PRENDONO LA VOCE I DOCUMENTARI? Le caratteristiche della voce Categorie di voce Il documentario e la voce dell’oratore
CAPITOLO 4 - CHE COSA RENDE I DOCUMENTARI COINVOLGENTI E PERSUASIVI? Il triangolo della comunicazione Eventi concreti e concetti astratti Temi comuni, argomenti ricorrenti La sfida della persuasione Il potere della metafora
CAPITOLO 5 - COM’È NATA LA FILMOGRAFIA DOCUMENTARISTICA? L’origine mitica nel cinema primitivo Il realismo e il desiderio di rappresentarlo: un terreno non sufficiente per il documentario
Il documentario come convergenza di diversi fattori Gli anni Venti: il documentario trova le sue gambe
CAPITOLO 6 - COME DIFFERENZIARE I DOCUMENTARI? CATEGORIE, MODELLI, E LE MODALITÀ ESPOSITIVA E POETICA DEL DOCUMENTARIO Il bisogno di classificazione Il documentario e il suo rapporto con altri generi di film Modelli e modalità del documentario Le modalità del documentario e la voce del regista La modalità poetica La modalità espositiva
CAPITOLO 7 - COME SI POSSONO DEFINIRE LE MODALITÀ OSSERVATIVA, PARTECIPATIVA, RIFLESSIVA E PERFORMATIVA DEL CINEMA DOCUMENTARIO? La modalità osservativa La modalità partecipativa La modalità riflessiva La modalità performativa
CAPITOLO 8 - IN CHE MODO I DOCUMENTARI AFFRONTANO LE QUESTIONI SOCIALI E POLITICHE? Le persone come vittime o come responsabili Costruire un’identità nazionale Contestare lo Stato-Nazione Oltre il nazionalismo: nuove forme di identità Ridefinire la politica di identità Questioni sociali e ritratti personali Coda
CAPITOLO 9 - COME SI PUÒ SCRIVERE EFFICACEMENTE SUL DOCUMENTARIO? NOTA BIBLIOGRAFICA FILMOGRAFIA INDICE DEI NOMI E DEI FILM
INTRODUZIONE Strutturata in capitoli che rispondono a una serie di domande, la seconda edizione di Introduzione al documentario esamina nel dettaglio questa affascinante forma di cinema. Le domande che pone riguardano questioni come la definizione, l’etica, l’argomento, la forma, le tipologie e le politiche. Poiché i documentari affrontano il mondo in cui viviamo, e non un mondo immaginato dal regista, sono molto diversi dai vari generi di fiction (fantascienza, horror, avventura, dramma e così via). Essi sono realizzati con diversi presupposti di significato, richiedono un diverso tipo di relazione tra regista e soggetto e creano nel pubblico diversi tipi di aspettative. Queste differenze, come vedremo, non garantiscono una separazione assoluta tra fiction e documentari. Alcuni di essi fanno un grande uso di alcune pratiche o convenzioni che spesso vengono associate alla fiction, come la sceneggiatura, la messa in scena, le ricostruzioni, le prove e la recitazione. Altri utilizzano convenzioni ben note, come l’eroe che deve affrontare una sfida o imbarcarsi in un’avventura o partire alla conquista di qualcosa, creando situazioni di suspense e crescendo emozionali e offrendo soluzioni al termine di un climax. Per contro, nella fiction si ricorre spesso alle riprese in esterni, all’uso di attori non professionisti, alle camere a mano, all’improvvisazione, ai filmati d’archivio (ovvero filmati non girati dal regista), al commento fuori campo e a riprese in luce naturale, che spesso vengono associati al documentario o alla non-fiction. Il confine tra i due generi è assai fluido, ma, in molti casi, sempre percepibile. Poiché la nozione di che cosa sia distintivo di un documentario e che cosa non lo sia cambia attraverso il tempo, sono alcuni film in particolare ad alimentare il dibattito su quali siano i confini tra “fiction” e “non-fiction”. In un dato momento della storia del cinema, film come Rapacità (Greed, 1924) di Erich von Stroheim e Sciopero (Stačka, 1925) di Sergej Ejzenštejn venivano lodati per l’alto grado di realismo e verosimiglianza presenti nelle loro storie. Possedevano il fascino del documentario. In un altro momento, Roma città
aperta (1945) di Roberto Rossellini e Ombre (Shadows, 1959) di John Cassavetes hanno portato sullo schermo la realtà della vita vissuta in modi mai sperimentati prima. Sebbene tutti questi film siano sempre stati considerati fiction, si potrebbe tranquillamente discutere della potenza della loro dimensione documentaristica e della loro capacità di spingere registi, sia di documentari che di fiction, a ripensare i loro parametri. Reality show televisivi come Cops, American Idol e Survivor hanno aumentato la capacità della televisione di sfruttare contemporaneamente il senso di autenticità tipico del documentario e lo spettacolo drammatico. Inoltre, film come Forrest Gump (1994), The Truman Show (1998), The Blair Witch Project (1999) e The Road to Guantanamo (2006) hanno costruito le loro storie attorno a uno dei presupposti impliciti del documentario: noi siamo chiaramente affascinati dall’opportunità di osservare la vita di altre persone, se queste appartengono al nostro stesso mondo. In The Blair Witch Project questo nostro interesse non nasce soltanto dalla combinazione di convenzioni proprie del documentario con il crudo realismo della ripresa amatoriale per dare credibilità storica a una situazione fittizia, ma si basa anche sull’impiego particolare della pubblicità e della promozione del film stesso per prepararci alla sua visione. Tra questi modi di promozione c’è anche il sito web, con informazioni sulla strega di Blair, testimonianze degli esperti e riferimenti a fatti e persone “veri”, tutto creato in modo da vendere il film non come fiction – e neanche come un semplice documentario – ma come se si trattasse dei filmati originali di tre registi tragicamente scomparsi. Se non altro, il caso di The Blair Witch Project dovrebbe farci capire che la nostra stessa percezione di un film come documentario o come fiction può essere facilmente manipolata (la recensione di Susan Stewart di Curse of the Blair Witch, pubblicata su «TV Guide» del 10-16 luglio 1999, tratta il programma messo in onda da Sci-Fi Channel come un tentativo scadente ma autentico di documentare la storia di una vera strega, invece che come la promozione di un’ingegnosa storia fittizia). La pellicola, il video e anche le immagini digitali possono mostrare ciò che è accaduto davanti
all’obiettivo con straordinaria verosimiglianza. Il dipinto e il disegno sembrano una pallida imitazione della realtà se paragonati alle rappresentazioni nette, precise e ad alta definizione disponibili su pellicola, video o schermo del computer. Tuttavia, questa fedele restituzione della realtà asseconda i bisogni della fiction tanto quanto l’uso di radiografie, risonanze magnetiche o tac facilita il lavoro della medicina. La verosimiglianza dell’immagine può essere tanto importante per un primo piano di Tom Cruise o Catherine Deneuve quanto per la radiografia di un polmone, ma i suoi usi sono molto diversi. Possiamo dire che entrambi offrono una testimonianza del mondo in cui viviamo, ma, mentre la prima la riconosciamo come altamente filtrata dagli occhi del regista, la seconda è per noi una trascrizione quasi diretta e inalterabile di determinate caratteristiche presenti nella realtà. Noi crediamo a ciò che vediamo a nostro rischio e pericolo. Come rendono evidente i media digitali, la verosimiglianza si trova tanto nella mente di chi osserva quanto nella relazione tra una cinepresa e ciò che le sta davanti (con le immagini digitali potrebbe non esserci più né una cinepresa né ciò che le sta davanti, anche se l’immagine prodotta avesse una somiglianza straordinaria con persone, luoghi e oggetti familiari). Non si può garantire che l’immagine che vediamo sia esattamente quello che avremmo visto se fossimo stati presenti.
Palace of Delights (di Jon Else e Steve Longstreth, 1982). Una troupe di un documentario in esterni. La maggior parte dei componenti di un film di fiction è presente anche in una produzione documentaria, seppure in scala minore. La troupe può essere composta anche da un solo operatore/regista con macchina da presa. Per molti documentari, l’abilità di reagire a eventi che non avvengono esattamente come il regista spera (in quanto “reali”) è un fattore centrale nell’organizzazione della troupe e dei metodi di lavorazione. In questo caso, Jon Else utilizza una cinepresa a 16mm e Steve Longstreth cattura il suono con un registratore Nagra sincronizzato all’immagine. Stanno girando una scena sulla Momentum Machine all’Exploratorium di San Francisco. Fotografia di Nancy Roger, per gentile concessione di Jon Else.
Alcuni linguaggi e tecnologie ci incoraggiano a credere che ciò che vediamo corrisponda in modo aderente, o addirittura in modo perfetto, alla realtà; gli effetti di obiettivi, messa a fuoco, contrasto, profondità di campo, colore, alta risoluzione (pellicola con grana molto fine, schermi con molti pixel) sembrano garantirci l’autenticità. Tuttavia, ognuna di queste tecniche può essere utilizzata per dare l’impressione di veridicità a qualcosa che è stato in realtà falsificato o creato dal niente. E dopo che le immagini sono state selezionate e disposte in sequenze, in scene o in interi film, l’interpretazione e il significato di ciò a cui assistiamo si baseranno su molti più fattori che il solo domandarsi se si tratti di una rappresentazione fedele di ciò che sta davanti alla cinepresa.
La tradizione del documentario conta molto sul mostrarci un’impressione di autenticità. Si tratta di una caratteristica fondamentale, nata con l’immagine cinematica e l’apparenza del movimento: per quanto l’immagine fosse scadente e diversa dall’oggetto fotografato, l’impressione del movimento restava indistinguibile dal movimento vero e proprio (ogni fotogramma di un film è un’immagine fissa; il movimento apparente si basa sull’effetto prodotto dalla loro proiezione in rapida successione). Quando il movimento è quello prodotto da attori sociali (le persone) che non recitano davanti alla camera e non interpretano un ruolo in un film di fiction, esso sembra attestare l’autenticità del film stesso. Quando questo movimento è combinato con più specifiche convenzioni tipiche del documentario – il commento fuori campo, le riprese in esterni, l’utilizzo di attori non professionisti impegnati a vivere da persone comuni la loro vita quotidiana e la disamina di temi sociali, come il riscaldamento globale o la giustizia sociale –, la sensazione di vedere rappresentata la realtà che condividiamo può essere davvero potente. Le forme digitali di rappresentazione si aggiungono ai numerosi media che già soddisfano questi criteri. Il loro emergere è assimilabile a un processo di impollinazione incrociata con la tradizione documentaristica. Media collegati tra loro si scambiano convenzioni e si prestano tecniche l’uno con l’altro. Siti web come YouTube e Facebook, come prima di loro fece la fotografia, ben presto meriteranno una propria storia e una propria teoria. Per il momento possiamo considerare tutte queste forme di produzione, distribuzione ed esposizione come contributi significativi alla tradizione del cinema documentario, che continua ad ampliarsi. Quando crediamo che ciò che vediamo rispecchi il mondo, fondiamo su questa certezza le nostre idee e le nostre azioni all’interno del mondo. Questo è ovviamente vero nel campo della scienza, dove le immagini giocano un ruolo chiave nella diagnostica di quasi tutti i settori della medicina. Sulla base di quanto le immagini rivelano vengono prese le decisioni e si cominciano le terapie di cura. Allo stesso modo, la propaganda, così come la pubblicità, si basa sulla nostra fiducia che ci sia un legame tra quello che vediamo, come
stanno davvero le cose e il modo in cui ci comportiamo in relazione a esse. Molti documentari fanno lo stesso quando tentano di convincerci ad adottare una certa visione o punto di vista sul mondo. Le argomentazioni proposte nel libro ci porteranno a scoprire come le problematiche connesse con la rappresentazione della realtà abbiano messo alla prova le risorse e le capacità inventive dei registi di documentari. Introduzione al documentario fa riferimento anche ad alcuni elementi della storia del cinema documentario, poiché le questioni e le pratiche prese qui in esame hanno origine nella storia (sia sociale che cinematografica) e non possono essere discusse prescindendo completamente da essa. Tuttavia questo libro non pretende di essere esaustivo e paritetico nel trattare i registi, i movimenti e i caratteri nazionali che si sono dimostrati determinanti nella storia del genere documentario. Gli argomenti e i film di cui parleremo servono a illustrare specifiche domande oppure esemplificano approcci importanti nel considerare determinate questioni. Più che delle risposte definitive, forniscono delle indicazioni. Il fatto di scegliere alcuni titoli da discutere fa venire subito in mente l’idea di un canone, una lista di film che costituisce il meglio della tradizione. Ho cercato di evitare questa trappola, poiché un tale approccio implicherebbe affermare che l’andamento storico del genere sia rappresentato solo da grandi lavori e da grandi artisti. Il mio parere personale è che taluni artisti, pur avendo grande influenza, siano solo una parte di un gruppo più grande formato da idee, valori, temi, tecnologie, quadri istituzionali, garanzie e forme condivise di espressione e che tutto questo, nell’insieme, contribuisca alla storia del documentario così come di ogni altro mezzo di comunicazione. Questo libro, perciò, intende suggerire che i lavori scelti, pur essendo dei risultati straordinari dal punto di vista artistico e sociale, non possono figurare come monumenti incontestati o simbolici. La priorità in questo contesto viene data a come essi risolvano problemi e trovino soluzioni, a come rappresentino le tendenze, le regole, gli stili e le tematiche, più che al valore assoluto che possiedono. Molte delle opere alle quali si fa riferimento in Introduzione al documentario fanno già parte di un canone, ovvero sono
spesso citate in altri testi e incluse all’interno dei corsi di cinema. Per sviluppare gli strumenti di analisi proposti, è sembrato più utile prendere in considerazione opere già conosciute piuttosto che fare conto su altre meno accessibili. Quindi, se il libro rafforza in qualche modo l’idea di un canone, ogni qual volta è stato possibile ho comunque cercato di usare più di un film come esempio di un determinato argomento. In questo modo, spero di dare un’idea più ampia di come film diversi tra di loro riescano a trovare soluzioni leggermente differenti a problemi comuni, e di far capire che nessuno merita di essere considerato il migliore, sicuramente non in termini assoluti ed eterni. Questo libro dà per scontato che il legame tra le immagini in pellicola, video o digitali e ciò che rappresentano possa essere straordinariamente potente anche se completamente inventato. Le domande che ci siamo posti non ci sono utili per decidere la presenza o il grado di invenzione, in modo da determinare che cosa “veramente” sia ciò a cui ci riferiamo o che cosa sia “realmente accaduto”. Servono invece a farci riflettere sul perché siamo disposti a fidarci delle rappresentazioni generate da immagini in movimento, sulle occasioni in cui questa fiducia può essere più o meno garantita, e servono inoltre a farci pensare a quali potrebbero essere le conseguenze della nostra fiducia in relazione al mondo in cui viviamo. Introduzione al documentario si pone le seguenti domande: nel Capitolo 1, “Come si può definire un documentario?”. Questo capitolo esplora alcuni dei modi secondo i quali si può ridefinire in maniera più approfondita il termine comune di documentario. Esso prepara inoltre il terreno per le domande poste nei capitoli successivi, prendendo in esame i diversi presupposti e le diverse aspettative di registi, istituzioni che operano a sostegno dei documentari e pubblico. Nel Capitolo 2 ci si chiede “Perché i problemi etici sono fondamentali per i documentari?”. Il capitolo affronta questioni che hanno a che fare con il potere, la fiducia e la responsabilità e spiega in che modo possono differire da quelle simili presenti nelle opere di fiction.
La domanda del Capitolo 3 è “Da dove prendono la voce i documentari?”. Essa ci porta ad analizzare concetti dell’arte e della retorica per mostrare in che modo il documentario sia ancora debitore della tradizione retorica, e come il regista di un documentario assomigli spesso all’oratore dei tempi antichi nel suo modo di affrontare questioni o problemi che richiedono un’opinione generale o una soluzione. Il Capitolo 4 vuole capire “Che cosa rende i documentari convincenti e persuasivi?”. In esso vengono studiate alcune caratteristiche di quegli argomenti che di solito costituiscono il soggetto per i documentari, e in particolare il modo in cui le questioni affrontate dal documentario non possano avere spiegazioni puramente logiche o scientifiche. Esse dipendono da presupposti e valori che, in quanto variabili, si affidano a rappresentazioni (come i documentari) per persuaderci della validità di un approccio rispetto a un altro. Nel Capitolo 5 ci si chiede “Com’è nata la filmografia documentaristica?” per mettere in discussione alcuni dei principali presupposti che la vedono come sinonimo del cinema delle origini – simile per esempio a quello di Louis Lumière in L’uscita dalle officine Lumière (La sortie des usines Lumière, 1895) – o della nonfiction in generale. Questo capitolo identifica quattro diverse caratteristiche che alla fine degli anni Venti si sono fuse nella forma distintiva del genere documentario. Il Capitolo 6 si propone di rispondere alla domanda “Come differenziare i documentari?”. Inizialmente parte di un capitolo unico dedicato alle sei modalità di fare documentario, esso riserva un’attenzione particolare a come queste modalità siano differenti dai modelli sviluppati in altri media ma poi adattati al documentario, ed esamina da vicino due modalità specifiche, quella espositiva e quella poetica. Ognuna ha i suoi registi e i suoi film rappresentativi, le sue forme di sostegno istituzionale e determinate aspettative da parte del pubblico. I Capitoli 6 e 7 esplorano nel dettaglio queste tematiche. Il Capitolo 7 si chiede “Come si possono definire le modalità osservativa, partecipativa, riflessiva e performativa del cinema documentario?”. Come i Capitoli 4 e 5, anche il 6 e il 7 hanno una dimensione storica, in quanto studiano il modo in cui viene rappresentato all’interno dei documentari il tema
centrale delle relazioni interpersonali o della comunità: come i documentari rafforzano o interrompono i legami che abbiamo con il prossimo, e come sono testimoni della natura e della qualità del rapporto tra il regista e la realtà storica alla quale egli si rivolge. Le quattro modalità discusse in questo capitolo spesso mettono il regista in diretto rapporto con gli altri, cosa che la modalità espositiva e quella poetica non riescono a fare, e quindi affinano i termini della questione. Il Capitolo 8 pone la domanda “In che modo i documentari affrontano le questioni sociali e politiche?”. Esso considera gli stretti legami tra l’ascesa del genere documentario e i bisogni di uno Statonazione. Oggi sono molti i documentari che affrontano problemi di portata nazionale e, sempre più, internazionale. Da un punto di vista storico, lo fanno al posto del governo in carica o in alcuni casi in diretta opposizione a esso. Il capitolo considera le varie modalità secondo cui i documentari si occupano di temi sociali e mette a confronto il ritratto personale, che può far emergere in modo indiretto più ampie questioni sociali, con i documentari di stampo sociale che le affrontano in maniera diretta. Il Capitolo 9 si pone la domanda “Come si può scrivere efficacemente sul documentario?”. La risposta comporta l’osservazione, passo dopo passo, delle fasi principali della creazione di un saggio, usando una traccia ipotetica di scrittura e due possibili risposte. Avendo come modello due saggi che presentano considerazioni molto diverse su un documentario classico – Nanuk l’eschimese (Nanook of the North, 1922) di Robert Flaherty – il capitolo cerca di indicare in che modo la prospettiva personale dello studente possa diventare nodo centrale dell’analisi scritta di un film. Questa edizione include anche una discussione sul modo in cui si possono utilizzare le diverse fonti online e bibliotecarie per sostenere le tesi di un saggio. Dietro Introduzione al documentario c’è il presupposto che la conoscenza dei concetti fondamentali del documentario, insieme a una conoscenza di base della storia del cinema documentario, fornisca strumenti molto preziosi sia per il regista sia per il critico. La maggior parte della filmografia documentaristica del passato è stata caratterizzata da una forte
relazione tra la produzione e lo studio. La mia speranza è che questo legame resti vivo anche in futuro e che i concetti discussi in questo libro servano ad alimentare tale vitalità.
CAPITOLO 1 COME SI PUÒ DEFINIRE UN DOCUMENTARIO? Benvenuti nell’Età dell’oro Nei titoli dei capitoli di questo libro sono poste una serie di domande in merito alle modalità con cui il genere documentario affronta il mondo in cui viviamo. Tali domande rappresentano i tipici interrogativi che si sollevano quando si vogliono comprendere i film documentari. Ognuna di esse ci permette di entrare un po’ più in profondità in questo universo, e ci aiuta a comprendere come si sia formata una tradizione storica del genere e che cosa esso possa offrire al giorno d’oggi. L’Età dell’oro del documentario ha avuto inizio negli anni Ottanta del Novecento e ancora non si è conclusa. Una vasta produzione di film ha infuso nuova vita a una vecchia forma e ha spinto a chiedersi come definire questo tipo di opere. I documentari sono film che mettono alla prova i nostri pregiudizi e alterano le nostre percezioni. Guardano il mondo in modo nuovo e creativo. Spesso costruiti come storie, sono storie, ma con una differenza: parlano del mondo in cui viviamo con chiarezza e impegno. Chiunque si sia affacciato all’età adulta dopo il 1980 non ha bisogno convincesene, mentre le generazioni precedenti devono probabilmente rivedere le loro ipotesi sul potere delle opere di non-fiction in relazione alle altre. In un’epoca in cui i principali mezzi di comunicazione riciclano in continuazione le stesse storie sugli stessi argomenti, rischiando ben poco in materia di innovazione formale e restando legati a potenti finanziatori con agende politiche ben precise e richieste limitanti per la libertà di espressione, sono i documentari indipendenti ad aver rivolto uno sguardo nuovo a ciò che accade nel mondo e ad aver raccontato con verve e immaginazione storie capaci di allargare orizzonti prima ristretti e di ridestare nuove possibilità.
Il documentario è diventato la nave ammiraglia dell’impegno sociale e di una visione distintiva della realtà. L’impulso documentaristico si è propagato verso l’esterno, verso internet e verso siti come YouTube e Facebook, dove sono proliferati mock/quasi/semi/pseudo documentari e documentari veri e propri, che spesso abbracciano nuove forme e affrontano argomenti emergenti. Pur essendo una delle prime strade a essere imboccate dagli aspiranti registi nel loro percorso verso il lungometraggio d’esordio, il documentario è, in questo momento più che mai, un punto di arrivo di per sé. I canali via cavo, la produzione digitale lowcost e la facile distribuzione in Dvd, internet e i suoi costi di divulgazione prossimi allo zero: tutti questi elementi, insieme a una forma unica di entusiasmo che prolifera con il passaparola e al fatto che molte persone hanno sempre più bisogno di avere punti di vista nuovi e alternativi, garantiscono alla forma documentaria un futuro luminoso e pieno di prospettive.
The Times of Harvey Milk (di Robert Epstein e Richard Schmeichen, 1984). Il documentario tratteggia la carriera del primo politico dichiaratamente gay, influenzando in maniera significativa il film del 2008, l’applauditissimo Milk, con Sean Penn nei panni di Harvey Milk. Per gentile concessione di Rob Epstein/Telling Pictures, Inc.
Dalla metà degli anni Ottanta anche i premi Oscar riconoscono l’ascesa di un documentario capace di parlare al grande pubblico e di essere persuasivo. La Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che non ha mai brillato per le sue scelte coraggiose, spesso perlopiù orientate verso il sentimentalismo, non è stata tuttavia all’altezza quando si è trattato di riconoscere molti degli esempi più riusciti di documentari dell’Età dell’oro. Prendiamo in esame i vincitori degli Oscar e alcuni dei nominati degli anni Ottanta:
Eyes on the Prize (di Henry Hamptons, 1987). Il film si affida a filmati storici per riportare alla luce sentimenti e atmosfere del movimento per i diritti civili dei primi anni Sessanta. La capacità delle immagini di repertorio di conferire autenticità a ciò che dicono gli intervistati rende la loro testimonianza più forte che mai. Per gentile concessione di Blackside Inc./Photofest.
The Times of Harvey Milk (I tempi di Harvey Milk, 1984), ritratto del politico e attivista gay Harvey Milk Broken Rainbow (Arcobaleno spezzato, 1985), la storia dei diecimila Navajo cacciati dalle terre dei loro antenati negli anni Settanta; Las madres de la Plaza de Mayo (Le madri di Plaza de Mayo, 1985), di Lourdes Portillo e Susana Muñoz, sulle madri che protestavano contro le “sparizioni” illegali dei loro figli a opera del governo argentino è nella cinquina con il primo documentario nominato agli Oscar di Ken Burns, The Statue of Liberty (La statua della Libertà) Artie Shaw: Time is All You’ve Got (Artie Shaw, il tempo è tutto quel che hai, 1985), sul grande musicista jazz, e Down and Out in America (Squattrinati in America, 1986), sulle classi sociali più colpite dalla recessione della metà degli anni Ottanta, che vinsero la statuetta ex aequo fra i nominati ci furono anche Radio Bikini (1987), sull’esplosione della bomba atomica e sugli effetti delle radiazioni, letali per tanti, e Eyes on the Prize (Gli occhi
sul premio, 1987), epica storia del movimento per i diritti civili Hôtel Terminus (1988), sulla caccia all’infame criminale nazista Klaus Barbie, Who Killed Vincent Chin? (Chi ha ucciso Vincent Chin?, 1988), di Christine Choy e Renee Tajima-Peña, racconto dell’omicidio di un giovane cinoamericano da parte di un ex operaio di Detroit, rimasto disoccupato ed esasperato dal successo dell’industria automobilista giapponese nella competizione con quella americana Common Threads: Stories from the Quilt (Fili comuni: storie dal quilt, 1989), racconto del progetto noto come “coperta dei nomi”, in memoria dei morti di Aids American Dream (Sogno americano, 1990), di Barbara Kopple, acuto studio di una complessa e prolungata azione di sciopero sul lavoro; Berkeley in the Sixties (Berkeley negli anni Sessanta, 1990), appassionante storia dell’ascesa dei movimenti per la libertà di parola e contro la guerra in Vietnam. Saltano all’occhio, come grandi assenti in questa lista, alcuni dei titoli che registrarono i maggiori successi di pubblico tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta: lo splendido La sottile linea blu (The Thin Blu Line, 1988), di Errol Morris, su un uomo innocente che attende la sua esecuzione a Dallas, in Texas; Roger & Me (1989), di Michael Moore, che mette in scena l’eroicomico tentativo del regista di chiedere a Roger Smith, capo della General Motors, come intendesse comportarsi con tutte le persone rimaste disoccupate in seguito alla chiusura di una fabbrica a Flint, in Michigan; e Hoop Dreams (Sogni di basket, 1994), straordinario diario su quattro anni della vita di due liceali giocatori di basket la cui ambizione è quella di arrivare nella Nba. Questi titoli, così come tanti altri che il pubblico nazionale e internazionale ha potuto vedere ai festival, nei cinema, in Tv e su internet, attestano il clamoroso fascino della voce del regista. Una voce che non è semplicemente un commento fuori campo – anche se colpisce come molti documentari di recente produzione contino essenzialmente sulla vera voce del regista
che si rivolge direttamente e personalmente al pubblico parlando di ciò che ha sperimentato e imparato. È una voce che emerge dal complesso degli elementi audiovisivi di ciascun film: il modo in cui sono selezionate le riprese, sono inquadrati i soggetti, giustapposte le scene, mixati i suoni e utilizzati titoli o didascalie sono tutte tecniche attraverso le quali un regista si pone da un determinato punto di vista per guardare un dato argomento e per cercare di convincere gli spettatori ad adottare il suo punto di vista come fosse il loro. Le voci di registi come Jonathan Caouette (Tarnation, 2003), Morgan Spurlock (Super Size Me, 2004), Zana Briski (Born into Brothels, Nati nei bordelli, 2005) e, naturalmente, Michael Moore (Fahrenheit 9/11, 2004 e Sicko, 2007) ci ricordano che tutti mantengono una certa distanza dal tono autorevole dei media ufficiali, con lo scopo di parlare al potere piuttosto che essere allineati a esso. Il loro coraggio stilistico – l’urgenza che esprimono nello stare in stretta relazione con un momento storico e con le persone che lo vivono – stravolge il commento onnisciente tipico del documentario convenzionale e lo stile distaccato delle news televisive. Alla ricerca della voce giusta per trattare gli argomenti che stanno loro a cuore, i registi, proprio come i grandi oratori, devono parlare con il cuore in un modo che da un lato è adeguato all’occasione, dall’altro proprio da essa prende spunto.
Who Killed Vincent Chin? (di Renee Tajima-Peña e Christine Choy, 1988). Lungo tutto il film, le registe partono da filmati presi da televisioni locali o dal loro repertorio per indagare che cosa portò all’omicidio di Vincent Chin. Questa foto è un fermo immagine ripreso dalle registe che erano parte della troupe televisiva chiamata a coprire l’accaduto. La madre della vittima sta parlando a una manifestazione a cui partecipava anche il Reverendo Jesse Jackson. Per gentile concessione della regista.
Alla ricerca di un terreno comune: la definizione di documentario Date la vitalità di espressione, la molteplicità di voci e l’accentuata popolarità del documentario, potremmo chiederci che cosa abbiano in comune questi film, sempre che qualcosa ci sia. Questo accresciuto interesse verso il genere è frutto di un avvicinamento ai film di fiction avvenuto tramite l’utilizzo di musiche coinvolgenti, ricostruzioni e interviste messe in scena, sequenze (o interi film) in animazione, ritratti di personaggi affascinanti e storie appassionanti? O invece i documentari rimangono un tipo di racconto diverso da tutti gli altri? Vale a dire che raccontano storie che per quanto simili a quelle dei film di fiction, rimangono distinte da esse? Questo libro risponde che sì, il documentario è una forma distinta di cinema, ma forse non quanto si potrebbe pensare a un primo approccio.
Una definizione concisa e onnicomprensiva è possibile, ma non così cruciale. Finirebbe per celare qualcosa nel momento stesso in cui rivela qualcos’altro. È più importante qui capire come ogni film che consideriamo documentario contribuisca a tener vivo un dialogo continuo che attinge a caratteristiche comuni, che a loro volta accolgono nuove e diverse forme, proprio come un camaleonte che si trasforma senza sosta. Tuttavia, cominceremo a considerare alcune caratteristiche comuni del genere documentario per arrivare a definire un’idea generale del territorio all’interno del quale ci muoviamo. Sicuramente è possibile sostenere che il documentario non ha mai avuto una definizione precisa. È oggi prassi comune riprendere la definizione di documentario come “trattamento creativo della realtà” data da John Grierson negli anni Trenta. Questa definizione riconosce che i documentari sono imprese creative. Ma lascia d’altro canto irrisolta l’ovvia tensione che c’è tra i termini “trattamento creativo” e “realtà”. Il primo suggerisce le licenze di una fiction, mentre il secondo ci ricorda le responsabilità di un giornalista o di uno storico. Proprio nel fatto che nessuno dei due termini abbia il sopravvento, e che la forma documentaria si tenga in equilibrio tra visione creativa e rispetto della realtà storica, sta una delle fonti di interesse del documentario. Non essendo né un’invenzione creativa né una riproduzione di fatti, il documentario attinge e si riferisce alla realtà storica nel momento stesso in cui la rappresenta da un punto di vista originale. Le idee sul documentario basate sul senso comune sono un utile punto di partenza. Nella loro forma tipica, si rivelano al tempo stesso utili e fuorvianti. Le tre affermazioni sul documentario esaminate qui, con le dovute precisazioni, aumentano il nostro livello di comprensione del genere documentario, ma non lo esauriscono. 1. I documentari parlano della realtà. Raccontano qualcosa che è realmente accaduto
Anche se corretto, e anche se basato sull’idea di Grierson del “trattamento creativo della realtà”, è importante approfondire come i documentari parlino di “qualcosa che è
realmente accaduto”. Per esempio, dobbiamo ammettere che anche molte fiction riguardano aspetti della realtà. Fa’ la cosa giusta (Do the Right Thing, 1989) tratta del problema reale del razzismo; Schindler’s List (1993) racconta la storia vera di Oskar Schindler, un membro del partito nazista che salvò la vita a oltre un migliaio di ebrei, e JFK - Un caso ancora aperto (1991) riesamina l’assassinio del presidente John F. Kennedy utilizzando le riprese documentaristiche di Abraham Zapruder nel momento in cui il presidente veniva colpito dai proiettili. Potremmo quindi modificare la definizione di documentario dicendo: “Il documentario racconta situazioni ed eventi reali e rispetta fatti conosciuti; non ne introduce di nuovi o di non verificabili. Parla della realtà storica in modo chiaro e senza l’uso di allegorie”. Le narrazioni fittizie sono fondamentalmente allegorie e creano un mondo che sostituisce quello storico (in un’allegoria, o parabola, ogni cosa ha un significato altro: quindi il significato superficiale può costituire un commento mascherato su persone, situazioni ed eventi reali). All’interno di un mondo fittizio si sviluppa una storia. Nel momento in cui lo fa, propone visioni e produce idee sul mondo in cui viviamo. Ecco perché ci rivolgiamo alla finzione per comprendere la natura umana. I documentari, invece, fanno riferimento diretto alla realtà storica. Le immagini (e molti dei suoni) scaturiscono direttamente da essa. Anche se porremo in seguito delle restrizioni a questo presupposto, in genere le immagini documentaristiche colgono persone ed eventi che appartengono al mondo in cui viviamo, invece di presentare personaggi e azioni inventate per raccontare una storia che fa riferimento al nostro mondo in modo trasversale e allegorico. Riescono a farlo prima di tutto rispettando i fatti conosciuti e fornendo prove verificabili. In realtà fanno molto di più, ma quel che è certo è che i documentari che distorcono i fatti, alterano la realtà o fabbricano prove mettono a rischio il proprio stesso status (nel caso di alcuni mockumentary e di alcuni registi più provocatori questo è esattamente il risultato che intendono ottenere: come vedremo, Las Hurdes [1932], è uno dei primi esempi di questa possibilità).
2. I documentari parlano di persone reali
Questa affermazione, per quanto vera, necessita di alcune modifiche. Anche i film di fiction si concentrano su persone reali, a parte il fatto che queste persone reali sono solitamente attori professionisti che interpretano dei ruoli (personaggi). Gli spettatori spesso vanno a vedere film di fiction per ammirare le loro star preferite, anche se il film in sé promette di essere mediocre. Nei film di fiction le persone reali assumono dei ruoli e diventano riconosciute come personaggi che popolano un mondo fittizio. Un’affermazione più accurata potrebbe essere: “I documentari parlano di persone reali che non recitano o interpretano dei ruoli”. Al contrario, “interpretano” o mostrano se stesse. Esse attingono dalle proprie esperienze e abitudini per essere se stesse di fronte alla macchina da presa. Possono essere del tutto consapevoli della presenza della camera, alla quale, nel caso di interviste e altre situazioni di interazione, rivolgono direttamente lo sguardo (lo sguardo in macchina, quando degli individui parlano in modo diretto alla macchina da presa o al pubblico, è raro nei film di fiction in cui la camera funziona nella maggior parte dei casi come astante invisibile). La presentazione di sé di fronte alla macchina da presa nel documentario potrebbe essere denominata performance, proprio come in una fiction, ma questo termine può confondere tanto quanto chiarire le cose. Quel che accade nei documentari è diverso da quello che comunemente si interde per “peformance” in campo teatrale o cinematografico. Le persone reali, o gli attori sociali, come Erving Goffman sottolineò molti decenni fa nel suo libro The Presentation of Self in Everyday Life (1959), presentano se stesse nella vita quotidiana secondo modalità che differiscono da un ruolo consapevolmente adottato o da una performance di finzione. Una performance a teatro o sul grande schermo richiede che gli attori mettano in subordine i propri tratti individuali per rappresentare uno specifico personaggio e per fornire attraverso la loro recitazione una prova di quali cambiamenti o trasformazioni investano quel personaggio. L’attore ne rimane relativamente immune e va avanti a recitare altri ruoli, e i
personaggi che interpreta possono essere profondamente diversi. Tutto ciò richiede grande esperienza e si basa su convenzioni e tecniche ben precise. La presentazione di sé nella vita di ogni giorno ha a che fare con le modalità con cui una persona esprime la sua personalità, il suo carattere, i suoi tratti individuali, anziché come li soffoca per adottare un ruolo. Sono le modalità attraverso le quali le persone vanno incontro a un cambiamento in quanto persone, e non quelle con cui esse rappresentano i cambiamenti che avvengono in personaggi fittizi. Non c’è una formazione specifica per imparare a presentarsi che non sia l’esperienza che deriva dal diventare un membro della società. Più che un divario tra la presentazione di sé e la persona reale, la “facciata” che una persona presenta è un modo per negoziare con gli altri la natura e la qualità di una forma di interazione nel suo evolversi. La presentazione di sé permette all’individuo di rivelarsi in modo più o meno esplicito, di essere schietto o di rimanere sulla difensiva, di manifestare emozioni o di restare riservato, di essere inquisitorio o distaccato, tutto secondo le modalità attraverso cui l’interazione si sviluppa momento dopo momento. La presentazione di sé più che una maschera che si indossa è un mezzo flessibile di adattamento. Essa suggerisce che l’identità individuale si sviluppa in risposta agli altri e che non è un dato permanente e indelebile. Alcuni hanno pensato perfino che l’identità di genere (il modo in cui una persona vive la propria natura maschile o femminile) possegga una qualità fluttuante e adattabile. La presentazione di sé entra pienamente in gioco nel momento in cui le persone si presentano davanti alla macchina da presa e interagiscono con il regista. Non è come aderire a un ruolo precostituito. In altre parole, una persona non si presenta esattamente nella stessa maniera a un appuntamento con il partner, a un dottore in ospedale, ai suoi bambini a casa e a un regista durante un’intervista. E nemmeno le persone continuano a presentarsi nello stesso modo a mano a mano che l’interazione si sviluppa: tutti modifichiamo il nostro comportamento di pari passo con l’evolversi di una data situazione. Una situazione
amichevole suggerisce una presentazione informale, ma l’inserimento di una nota sarcastica può indurre a un irrigidimento. Nei documentari, ci aspettiamo che gli attori sociali si presentino in questo modo, non recitando la parte di un personaggio ideato dal regista, anche se l’atto stesso di filmare ha decisamente un’influenza sul modo in cui essi si presentano. Film di finzione quali La corazzata Potëmkin (Bronenosec Potëmkin, di SergejEjzenštejn, 1925), Ladri di biciclette (di Vittorio De Sica, 1948), Salt of the Earth (Sale della terra, di Herbert J. Biberamn, 1954) e Ombre e show televisivi come Real World o Survivor ci mostrano attori non professionisti che recitano parti così fortemente plasmate da registi o produttori che questi lavori sono considerati normalmente opere di finzione anche se il loro stile li colloca davvero vicino alla tradizione documentaristica.
Monster (di Patty Jenkins, 2003). Charlize Theron, attrice e fotomodella, alterò in maniera drammatica il suo aspetto per interpretare la squattrinata Aileen Wuornos. Della signora Theron come persona apprendiamo ben poco dalle sue capacità interpretative poiché il film è tutto centrato sul personaggio. Copyright Media 8 Entertainment. Per gentile concessione di Film Look Studios. 3. I documentari raccontano storie su quel che accade nel mondo reale
Questa nozione di senso comune fa riferimento al potere narrativo dei documentari. Essi ci raccontano che cosa porta
agli eventi o ai cambiamenti reali, che siano le esperienze di singoli individui o di un’intera comunità. I documentari ci raccontano come le cose cambiano e chi produce questi cambiamenti. Anche questa nozione necessita di precisazioni. La domanda che sta alla base è: quando i documentari raccontano una storia, di chi è questa storia? Del regista o del soggetto? La storia deriva direttamente dagli eventi e dalle persone coinvolte o è più che altro opera del regista, anche se basata sulla realtà? È necessario aggiungere alla nozione di partenza qualcosa che suona come: “Nella misura in cui un documentario racconta una storia, la storia è una plausibile rappresentazione di ciò che è accaduto piuttosto che un’interpretazione fantasiosa di ciò che potrebbe essere accaduto”. Nella maggior parte dei film di finzione la storia è essenzialmente quella del regista, anche se basata su eventi reali. «Questa è una storia vera» è spesso la frase introduttiva di un film di finzione che per la sua trama prende lo spunto da avvenimenti storici. Schindler’s List non è la storia come se fosse raccontata da Oskar Schindler stesso o dalle persone a cui salvò la vita, ma la rappresentazione immaginaria e allegorica della sua storia come viene raccontata da Steven Spielberg, anche se è basata in modo consistente su fatti storici. Monster (2003), allo stesso modo, è un racconto fittizio della vita di Aileen Wuornos, una serial killer, ma con Charlize Theron che interpreta la sua parte. Per contro, Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (1992) è un documentario realizzato da Nick Broomfield che mostra Aileen Wuornos in carne e ossa e che affronta in maniera diretta la sua vita. Il “trattamento creativo della realtà”, per tornare alla definizione di Grierson, permette al termine “trattamento” di includere la narrazione, ma una storia deve rispondere a determinate caratteristiche per essere qualificata come documentario. Analogamente, sono criteri di precisione fattuale e coerenza interpretativa a governare la storiografia. La separazione tra documentario e fiction, così come quella tra storiografia e ricostruzione finzionale, in sostanza sta nel livello in cui la storia corrisponde a situazioni, eventi e
persone reali rispetto al livello in cui essa è principalmente un’invenzione del regista. C’è sempre un po’ di tutte e due le cose. La storia che un documentario racconta ha origine dalla realtà storica ma è pur sempre raccontata dal punto di vista del regista e con la voce del regista. È questione di gradazione di intensità, non c’è una separazione netta. Un sorprendente numero di documentari, proprio come di fiction, racconta storie: quella dei contadini migranti che soffrono la più disperata povertà mentre lasciano la Florida per New York per mietere l’abbondante raccolto nazionale nel tagliente documentario televisivo di Edward R. Murrow Harvest of Shame (Il raccolto della vergogna, 1960); o quella di Philippe Petit, che nel 1974 riuscì a fare la traversata dalla cima di una delle Torri Gemelle all’altra camminando su un filo in Man on Wire (2008). In casi come questi, le storie raccontate parlano di avvenimenti reali in maniera diretta, non allegorica, e i film aderiscono a fatti storici riconosciuti. Gli attori sociali, le persone, si presentano in modo fluido, aperto, rivelatore. Non recitano parti o personaggi di invenzione di qualcun altro. Nanuk l’eschimese, esaminato in dettaglio nel Capitolo 9, dove serve da modello per comprendere come si scrive su un documentario, è un caso esemplare. Di chi è la storia? La storia è apparentemente quella di Nanuk, un intrepido capo tribù Inuit e grande cacciatore. Ma Nanuk è per gran parte un’invenzione di Robert Flaherty. Il suo nucleo familiare corrisponde alla struttura della famiglia europea o americana ben più che a quella delle famiglie allargate tipiche degli Inuit. I suoi metodi di caccia appartengono a un’epoca di trent’anni o più antecedente a quella in cui il film venne realizzato. La storia riguada un modo di vivere passato, che Nanuk incarna più come fosse una parte o una performance di un personaggio che come se dovesse presentare se stesso nella vita di ogni giorno al tempo in cui il film venne girato. Il film può essere considerato tanto una fiction quanto un documentario. Quando viene classificato come documentario di solito è perché:
Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (di Nick Broomfield, 1992). In questo documentario vediamo e sentiamo Aileen Wuornos stessa che parla della sua vita. Veniamo a conoscenza di moltissime cose dal modo in cui si presenta al regista, così come da quello che gli altri dicono di lei. Broomfield dichiara apertamente che per realizzare il film furono necessarie complesse negoziazioni (e pagamenti). Per gentile concessione di Nick Broomfield.
1. la storia che Flaherty racconta con grandissima cura corrisponde a un grado altissimo ai modi di vivere degli Inuit, anche se essi vengono fatti riemergere dal passato. 2. Allakariallak, l’uomo che interpreta Nanuk, incarna uno spirito e una sensibilità che sembrano in armonia tanto con uno specifico stile di vita Inuit quanto con la concezione che ne ha un occidentale. La storia può essere compresa sia come una rappresentazione plausibile della vita degli Inuit sia come la visione particolare che ne ha Flaherty. Se i documentari fossero una riproduzione della realtà, questi problemi si farebbero sentire in misura molto minore.
Ci troveremmo semplicemente davanti a una replica o a una copia di qualcosa che esisteva già. Ma il documentario non è una riproduzione della realtà, è una rappresentazione del mondo così come lo conosciamo. Questi film non sono documenti più di quanto non siano rappresentazioni espressive che possono essere basate su documenti. I documentari rappresentano una particolare visione del mondo, spesso una visione nella quale non ci siamo mai imbattuti prima, anche se tutti gli aspetti reali di quel mondo ci sono familiari. Noi giudichiamo una riproduzione dalla fedeltà all’originale, cioè dalla sua capacità di riprodurre caratteristiche visibili dell’originale con massima precisione e di servire a scopi che richiedono precise riproduzioni, proprio come accade nelle foto segnaletiche della polizia, nelle foto dei passaporti o nei raggi X. Giudichiamo invece una rappresentazione più per la natura di piacere che suscita, per il valore dell’idea che propone e per la qualità della prospettiva che suggerisce. Chiediamo cose diverse alle rappresentazioni e alle riproduzioni, ai documentari e ai documenti. La domanda “Di chi è la storia?” lascia un considerevole spazio all’ambiguità. Le ricostruzioni proposte dai documentari ne sono la prima prova. Il regista deve ricreare in modo fantasioso alcuni avvenimenti in modo da filmarli in ogni loro aspetto. Tutto Nanuk l’eschimese può essere definito una gigantesca ricostruzione, ma conserva significative qualità documentaristiche (John Grierson disse che il film possedeva “valore documentaristico”. Ecco come – pare – il termine documentario entrò nell’uso). Qualunque cosa la ricostruzione crei, tuttavia, essa deve corrispondere a fatti storici riconosciuti se vuole essere plausibile. Le ricostruzioni non devono essere ricreazioni di alto livello realistico, come accade di solito nei film di finzione. Alcuni documentari ricreano avvenimenti del passato in maniera chiaramente stilizzata. Per esempio, in Valzer con Bashir (Vals Im Bashir, 2008), la ricreazione di battaglie realmente avvenute nel 1982 durante l’invasione israeliana del Libano, le esperienze dei soldati traumatizzati e l’atroce massacro di musulmani libanesi vengono raccontati attraverso rappresentazioni animate e altamente stilizzate (a esclusione
della scena finale del film). Le sequenze in animazione rivelano chiaramente una qualità fortemente soggettiva, quando non espressionistica. Esse cercano di mostrare la guerra così come la vedono i soldati israeliani, disorientati e confusi. E tra essi c’è proprio il regista. I loro ricordi della guerra si svelano in una serie di interviste reali, rappresentate ancora una volta da scene in animazione. In quanto rappresentazione di uno stato mentale soggettivo, il film raggiunge un alto livello di plausibilità anche se si distacca dall’accezione comune di realismo documentaristico. L’idea che ciò che vediamo e sentiamo fornisca una prospettiva plausibile ci permette anche di riconoscere che per ogni dato avvenimento esiste più di una storia che possa rappresentarlo o interpretarlo. Enron - L’economia della truffa (Enron: the Smartest Guys in the Room, 2005), per esempio, non sostiene la storia del fallimento di Enron come viene raccontato dai suoi stessi dirigenti, che affermano esser stato il risultato di ingenui errori o della cattiva gestione di qualcun altro, e non delle loro azioni. Al contrario, il film racconta la storia scoperta dai giornalisti investigativi Peter Elkind e Bethany MacLean: il fallimento fu il risultato di una truffa deliberata e dell’avidità di quegli stessi dirigenti. Abbiamo modificato quindi le tre comuni definizioni di documentario appena esposte per arrivare a un’unica definizione che sia in qualche modo più precisa e che può suonare più o meno così: Il documentario parla di situazioni ed eventi che coinvolgono persone reali (attori sociali) che si presentano agli spettatori come se stesse in storie che comunicano una lettura o un punto di vista plausibile delle vite, delle situazioni e degli avvenimenti ritratti nel film. Il punto di vista peculiare del regista plasma queste storie facendole diventare una maniera di vedere in modo diretto la realtà storica, e non un’allegoria fittizia.
Idee confuse e cambiamenti in atto La definizione a cui siamo arrivati è un utile primo passo ma lascia considerevole spazio all’“interpretazione creativa”.
È anche difficile da ripetere. Resta la tentazione di far ricorso a definizioni più sintetiche e semplici, come “I documentari affrontano la realtà” o “I documentari parlano di persone reali che sono se stesse”. Queste definizioni hanno una loro utilità nel momento in cui teniamo presente che nella loro concisione nascondono anche una forte complessità. La definizione più elaborata ha un altro difetto significativo: non fa differenza tra le diverse tipologie di documentario (compito che assolveranno i Capitoli 6 e 7). I documentari, infatti, tendono a raggrupparsi in diverse tipologie o modalità. Non tutti affrontano la realtà storica nello stesso modo e non tutti adottano le stesse tecniche cinematografiche. Il commento fuori campo, una volta dato per scontato, venne scomunicato dal cinema osservativo degli anni Sessanta, per esempio. I registi non sono legati a definizioni e regole che governano il loro operare. Provano grande piacere nel sovvertire le convenzioni, sfidare gli spettatori, provocare il dibattito. Le definizioni di documentario si sono sempre rincorse le une con le altre, cercando di adattarsi ai cambiamenti nel considerare che cosa è documentario e perché. I documentari non utilizzano un elenco fisso di tecniche, non si dedicano sempre alle stesse questioni, non mostrano un solo insieme di stili o formule. La pratica del documentario è un’arena in cui le cose cambiano. Si tentano sempre degli approcci alternativi, che vengono poi adottati da altri o in seguito abbandonati. Avvengono contestazioni. I prototipi spiccano sugli altri lavori e vengono emulati, senza riuscire a essere mai completamente copiati o imitati. Compaiono opere sperimentali, capaci di sfidare le convenzioni che determinano i confini del documentario. Queste opere sanno forzare i limiti e a volte modificarli. Più che proclamare una definizione che fissi una volta per tutte che cosa è e cosa non è un documentario, dobbiamo guardare agli esempi e ai prototipi, alle opere sperimentali e alle innovazioni come prove dell’ampiezza dell’area in cui il documentario opera e si evolve. I prototipi sono utili per le definizioni perché in genere propongono qualità o caratteristiche esemplari senza affermare la necessità che ogni
documentario le abbia tutte quante. Nanuk l’eschimese, per esempio, è da considerarsi un prototipo, sebbene molti altri film – che usano allo stesso modo una singola avventura come tema narrativo, che hanno un protagonista esemplare e fotogenico e che intendono mostrare qualità culturali generali attraverso il comportamento di un singolo – rifiutino il romanticismo, l’enfasi su un ambiente naturale inospitale e gli occasionali elementi condiscendenti presenti nel film di Flaherty. In effetti, anche alcuni film di finzione, come Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, condividono molte qualità di Nanuk l’eschimese senza essere affatto considerati documentari. I cambiamenti nella comprensione di che cosa sia un documentario si sono verificati in modi diversi. La maggior parte di questi cambiamenti è sopraggiunta in relazione a quel che accade nei quattro seguenti ambiti: 1. le istituzioni che sostengono la produzione e la diffusione; 2. gli sforzi creativi dei registi; 3. l’influenza duratura di alcuni film; 4. le aspettative del pubblico. Di fatto, questi quattro fattori – istituzioni, registi, film e spettatori – meritano un’analisi più approfondita. Sono tutti fondamentali, sia per sostenere l’idea di che cosa un documentario sia in un dato luogo e momento storico, sia per promuovere le continue trasformazioni a cui esso va incontro nel corso del tempo e in luoghi diversi. Possiamo arrivare a una migliore comprensione del documentario se esaminiamo nel dettaglio questi quattro elementi.
Una struttura istituzionale Sembrerà ridondante, ma un modo di definire il documentario è: “I documentari sono ciò che viene realizzato dalle organizzazioni e dalle istituzioni che li producono”. È come dire che un film di Hollywood è ciò che viene realizzato dallo studio system di Hollywood. Se John Grierson definisce Night Mail (Basil Wright e Harry Watt, 1936) un
documentario o se Discovery Channel definisce un programma un documentario, allora queste opere sono etichettate come tali prima che possa esserci un intervento da parte di critica o pubblico. Questa definizione, a parte la sua forma ridondante, può essere un primo indizio che un dato lavoro possa essere definito come un documentario. Il contesto fornisce l’indizio: sarebbe sciocco ignorarlo, per quanto questo tipo di definizione sia poco esauriente. I segmenti che formano il programma della Cbs 60 Minutes, per esempio, sono normalmente considerati esempi di inchiesta giornalistica, anzitutto perché 60 Minutes è un programma giornalistico. Noi diamo per scontato che essi si riferiscano a persone e fatti reali, che sarà presente un livello standard di obiettività giornalistica, che ogni storia sarà certamente interessante e istruttiva e che le ipotesi saranno sostenute da un’esibizione di prove credibili. Mostrati in un’altra ambientazione, questi segmenti potrebbero assomigliare di più al melodramma o al docudrama, vista l’intensità emotiva e l’alto grado di affettazione degli incontri che vi avvengono; queste interpretazioni alternative svaniscono, però, quando la struttura istituzionale ci rassicura che si tratta, in effetti, di un’inchiesta giornalistica. Il classico mockumentary This Is Spinal Tap (di Rob Reiner, 1984) costruisce questo tipo di struttura istituzionale intorno al film in un modo furbo o ironico: il film si presenta infatti come un documentario, per poi rivelarsi la sua ricostruzione o simulazione. Molto dell’impatto ironico dipende dalla sua abilità di convincerci almeno in minima parte, poiché così ci viene detto, che stiamo guardando un documentario vero. (I mockumentary adottano le convenzioni del documentario ma sono organizzati, scritti e recitati per creare l’apparenza di un documentario vero e, lasciando nel contempo dietro di sé alcuni indizi che rivelano che non lo sono. Una parte del piacere che provocano sta nel modo in cui fanno entrare un pubblico ben informato nella presa in giro: possiamo goderci il film come una parodia e acquisire nuove conoscenze rispetto a consuetudini date per scontate.) Se prendiamo sul serio la descrizione che il film dà di sé, crederemo che gli Spinal Tap siano un gruppo rock realmente
esistente. Di fatto, il gruppo è stato creato apposta per il film, come la “strega di Blair” per The Blair Witch Project. I membri del gruppo sono reali nello stesso modo in cui lo sono gli attori che interpretano i personaggi di un film: sono persone vere ma recitano dei ruoli invece che presentare se stesse. Una struttura istituzionale impone anche un modo analogo di vedere e di parlare, che funziona come una serie di limiti, o di convenzioni, validi sia per il regista che per il pubblico. Affermare che è “ovvio” che un documentario debba avere un commento fuori campo, o che “tutti sanno” che deve mostrare entrambi i lati di una questione, significa riconoscere che questa è di solito la norma all’interno di una determinata struttura istituzionale. Il commento fuori campo, a volte poetico, a volte dal tono più concreto, quasi onnipresente, era un’importante convenzione nelle produzioni di film sponsorizzati dal governo capeggiate da John Grierson nell’Inghilterra degli anni Trenta; d’altra parte, l’equilibrio di cronaca, ovvero non parteggiare apertamente per nessuno mostrando tutti i possibili punti di vista, è la convenzione prevalente all’interno dei settori giornalistici nelle reti televisive odierne.
Always for Pleasure (di Les Blank, 1978). I film di Les Blank sono difficili da collocare. I libri sul documentario e sul cinema etnografico ignorano a volte il suo lavoro, sebbene film come questo, che affronta gli aspetti del Mardi Gras di New Orleans, mostrino caratteristiche importanti di entrambi i generi. Blank, come molti registi di documentari, non segue le regole codificate e non si preoccupa che i suoi film rientrino o meno in certe categorie. Il fatto che non proponga commenti fuori campo, interpretazioni politiche, problemi chiaramente identificabili e soluzioni potenziali nasce dalla scelta di riprendere con enfasi descrittiva forme di esperienza esuberanti e vitali. Per gentile concessione di Les Blank e Flower Films.
Questo carattere di “ovvietà” serve anche a considerare insindacabili le convenzioni tipiche del documentario. Per molto tempo è stato dato per scontato che i documentari potessero parlare di qualsiasi cosa al mondo tranne che di se stessi. Le strategie riflessive, che pongono in questione l’atto stesso di rappresentazione, scuotono il presupposto fondamentale del documentario, ovvero la capacità della pellicola di catturare la realtà. Rammentare agli spettatori che la realtà che guardano è stata ricostruita, o che la famosa definizione data da John Grierson del termine “documentario” è «trattare creativamente la realtà», insidia la rivendicazione di verità e autenticità su cui si basa il documentario stesso. Se
non possiamo considerare queste immagini come prove visibili della natura di una parte specifica del nostro mondo, come le dobbiamo valutare? La rassicurante struttura istituzionale, annullando questa domanda, elimina gran parte della complessità all’interno del rapporto tra rappresentazione e realtà, ma fa anche acquistare una notevole chiarezza e semplicità nel garantire che i documentari daranno un ritratto sincero e veritiero del mondo reale. Questa è una delle principali attrattive del genere, anche se è una rivendicazione che dobbiamo valutare con cura. Oltre agli enti che sponsorizzano la produzione documentaristica, esiste un circuito specifico di distributori e di spazi di programmazione che contribuisce alla circolazione di questi film. Questi enti operano affiancandosi alle principali catene di sale cinematografiche e ai videonoleggi specializzati in film di intrattenimento. A volte un’istituzione, come il National Geographic o Discovery Channel, produce, distribuisce e mostra un film documentario. Altre volte i distributori sono entità separate, come i distributori di film specializzati Women Make Movies, New Day Films, Facets, Third World Newsreel, Netflix, o siti web come YouTube, che rendono visibili documentari prodotti da altri (Netflix oggi combina il video on demand su internet con il noleggio di film in Dvd spediti via posta). Altri enti, come la Corporation for Public Broadcasting e il British Film Institute, forniscono un sostegno finanziario alla produzione di documentari. Mentre altri ancora, come la Film Arts Foundation, la Foundation for Independent Film and Video, lo European Documentary Film Institute o la International Documentary Association, forniscono sostegno professionale ai registi di documentari, come l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences fa con i registi di Hollywood. Qualunque sia il loro ruolo, queste istituzioni contribuiscono al livello di realtà di ciò che viene realizzato e al modo in cui appare. Spesso esse impongono norme e convenzioni alle opere che sostengono, e i loro scopi e criteri cambiano con il passare del tempo. Senza di esse, davvero pochi documentari raggiungerebbero gli spettatori attesi.
Una comunità di registi
Coloro che realizzano film documentari, come le istituzioni che li sostengono, partono da determinati presupposti e aspettative nei confronti di quello che fanno. Sebbene ogni struttura istituzionale imponga dei limiti e delle convenzioni, i singoli registi non sono obbligati ad accettarle del tutto. La tensione tra le aspettative prestabilite e l’innovazione individuale è spesso fonte di cambiamenti. Tutti i registi di documentari condividono la missione personale di rappresentare il mondo invece di inventarne uno nuovo con l’immaginazione. Si riuniscono in festival del cinema specializzati, come l’Hot Springs Documentary Film Festival (Usa), lo Yamagata Documentary Film Festival (Giappone) o l’Amsterdam International Documentary Film Festival (Paesi Bassi), e scrivono articoli o realizzano interviste per molte riviste dello stesso genere, come «Release Print», «Documentary» e «Dox». Affrontano temi sociali, come l’effetto dell’inquinamento e l’identità sessuale, ed esplorano problemi tecnici come l’autenticità dei filmati d’archivio e le conseguenze della tecnologia digitale. Per quanto riguarda quello che fanno, gli esperti di documentario parlano una lingua comune. Come gli altri professionisti, i registi di documentari hanno un loro vocabolario o gergo. I termini in esso contenuti possono andare dall’adattabilità di certi tipi di pellicola a diverse situazioni alle tecniche di registrazione in presa diretta, e dai risvolti etici di osservare gli altri a quelli pragmatici di trovare distributori e stipulare contratti di lavoro. I registi di documentari hanno problemi precisi e comuni tra di loro – per esempio, lo sviluppo di una stabile relazione etica con i loro soggetti o il rivolgersi a un pubblico specifico – che li distinguono dagli altri filmmaker. Queste caratteristiche comuni danno ai registi di documentari l’idea di un obiettivo condiviso, nonostante alcuni di essi possano competere per la stessa sovvenzione o per lo stesso distributore. I singoli autori sceglieranno una forma o cambieranno le tradizioni che hanno ereditato, ma lo faranno mantenendosi in costante dialogo con chi altri condivide la loro stessa missione. Questa definizione di documentario contribuisce al suo profilo sfocato ma ben
distinguibile. Dà una prova della variabilità storica del genere: la nostra percezione di che cosa sia un documentario cambia quando i registi cambiano la loro idea di che cosa stanno realizzando. Quello che è iniziato come un’apparente anomalia, come in alcuni dei primi film osservativi come Les Raquetteurs (I racchettatori, di Michel Brault e Gilles Groulx, 1958), Chronique d’un été (Cronaca di un’estate, 1960), o Primary (Primarie, 1960), può sbiadire nel tempo come una variante fallita oppure, come in questo caso, può essere ritenuto una trasformazione innovativa che a sua volta sfocerà in un nuovo standard o una nuova tecnica. Il documentario non è mai stato una cosa sola. Per il momento, possiamo usare la storia della concezione mutevole di che cosa sia un documentario come un segno della qualità dinamica, variabile e sempre aperta di questo genere. Sono gli stessi registi, attraverso il loro coinvolgimento con istituzioni, critici, soggetti e pubblico, a creare questo senso di cambiamento dinamico.
Un corpus di testi: convenzioni, periodi, movimenti e modalità La diversità dei film che costituiscono la tradizione del cinema documentario contribuisce anche alla sua fluidità. Per quanto diversissimi, Nanuk l’eschimese, L’uomo con la macchina da presa (Cělovek s kino-apparatom, 1929), Las Hurdes, Hoop Dreams, Dont Look Back (1967), Koyaanisqatsi (1983) e Roger & Me rappresentano pietre miliari della produzione documentaristica. Tutti adottano e modificano le convenzioni tipicamente associate al genere. Offrono agli spettatori modi alternativi di vedere il mondo, che sia il commento fuori campo che si rivolge in modo ambiguamente caustico alla comunità apparentemente condannata in Las Hurdes, o il rispettoso ritratto in presa diretta di un grande musicista (Bob Dylan) in Dont Look Back. Guardando a questa vasta gamma di film, possiamo considerare il documentario un genere esattamente come il western o la fantascienza. Per appartenere a un genere un film deve mostrare convenzioni condivise da altri film che appartengono allo stesso genere. Queste convenzioni ci aiutano a distinguere un genere dall’altro: l’uso di una voce fuori campo, le
interviste, l’audio in presa diretta, gli inserti per fornire immagini che illustrano o mettono in questione una tesi esposta e la scelta di affidarsi ad attori sociali, ossia la gente comune, sono alcune delle convenzioni comuni a numerosi documentari. Un’altra convenzione è la prevalenza di una logica informativa che orienta il film in relazione alla rappresentazione del mondo sociale che vuole dare. Una forma tipica di struttura è quella che porta alla risoluzione di un problema. Essa può assomigliare a una costruzione narrativa, in particolare della narrativa poliziesca. Il film inizia con il presentare un problema o una questione, dopodiché ne comunica un aspetto di fondo e lo segue esaminandone la serietà e la complessità. Questa presentazione porta a una raccomandazione o a una soluzione finale, che lo spettatore è incoraggiato ad approvare o condividere personalmente. The City (La città, di Ralph Steiner e Willard Van Dyke, 1939) fornisce un primo approccio a questa idea di logica documentaristica. Attraverso un montaggio di scene che include le riprese accelerate del ritmo frenetico della città, viene mostrato come la vita urbana sia diventata un fardello più che una gioia. La vita moderna prosciuga le persone della loro energia e del loro entusiasmo (il film ignora alcune questioni correlate, come la relazione tra stress urbano e classe sociale o razza). Qual è la soluzione? La parte finale ne fornisce una: la comunità “verde”, accuratamente pianificata, dove ognuno vive in armonia con il vicino e il luogo di lavoro si raggiunge a piedi. Il terribile frastuono delle catene di montaggio e le nuvole di fumo delle grandi industrie non devono essere a portata di vista. La povertà sembra scomparire. Tutti sono felici. Un dispositivo automatico si occuperà di fare il bucato (la versione anni Trenta della lavatrice), così che un gruppo di donne si godrà il sole caldo chiacchierando. L’appagamento che dà la tranquilla vita di una piccola città, sostenuta da fabbriche e stabilimenti rispettosi degli operai, all’improvviso è alla portata di tutti. La soluzione proposta dal film è un insieme affascinante di pianificazione idealistica,
molto diversa da quella dei quartieri periferici tutti uguali sorti nel dopoguerra, e illusorio tentativo di evadere dalla dura realtà della situazione economica. Il film non fa riferimento ai problemi razziali e non accenna in nessun modo a come il povero squattrinato di città possa raggiungere un nuovo idilliaco Shangri-la. Quello che fa è creare una visione convincente da un lato del problema, dall’altro della sua soluzione. Lascia che lo spettatore apprezzi che cosa si prova a sperimentare il gioioso appagamento di una comunità “verde” e nello stesso tempo lo stress e la miseria della città tradizionale. The City, un classico del genere documentaristico, è stato sponsorizzato dall’American Institute of City Planners. Questo gruppo aveva avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione delle città americane. Il governo federale, allo stesso modo, aveva supportato numerosi film chiave degli anni Trenta, in particolare The Plow That Broke the Plains (L’aratro che spacca le pianure, 1936) e The River (Il fiume, 1937), un film che sosteneva gli sforzi della Tennessee Valley Authority per prevenire le inondazioni e produrre elettricità, una iniziativa federale che incontrò l’opposizione dei conservatori. Una variazione dello stile logico problema/soluzione è presente in Il trionfo della volontà (Der Triumph des Willens, 1935). I leader del partito nazista nei loro discorsi fanno riferimento al disordine in cui era caduta la Germania dopo la Prima guerra mondiale, e al contempo indicano se stessi, il partito, e soprattutto Adolf Hitler, come soluzione al problema dell’umiliazione nazionale e del collasso economico. Il film sorvola sui problemi veri; preferisce dedicare la maggior parte della sua energia a esortare gli spettatori (soprattutto quelli della Germania degli anni Trenta) ad approvare gli sforzi che il partito nazista e il suo capo stanno facendo per redimere la Germania e rimetterla sul sentiero della ripresa, della prosperità e del potere. Il film dà per scontato che il pubblico del tempo fosse ben conscio della natura e della gravità dei problemi. Piuttosto che i filmati d’archivio sulla sconfitta tedesca nella Prima guerra mondiale, una spiegazione dei termini umilianti imposti dal Trattato di Versailles o le difficoltà causate dall’inflazione schizzata alle stelle, Leni Riefenstahl ha preferito mostrare un ritratto vivido e
stimolante del partito nazista e di Hitler, accuratamente coreografato. The Cove (2009) ha un approccio molto diverso e ambiguo: da un lato c’è il massacro di un enorme numero di delfini nel segreto di una grotta marina nei pressi della cittadina di Taiji, in Giappone – perché per i giapponesi i delfini sono solo fastidiosi concorrenti della loro industria ittica –, dall’altro il modo in cui il massacro viene documentato malgrado gli sforzi governativi per nasconderlo. Il film tesse un racconto coinvolgente, che oscilla tra la spiegazione dettagliata del massacro e le difficoltà affrontate per riuscire a introdursi segretamentenella baia. Il film rende esplicito che la soluzione al problema trascende i suoi ambiti: sarà necessaria un’azione congiunta di tutte le parti coinvolte per convincere i giapponesi a fermare il massacro. Ric O’Barry, un tempo trainer di delfini, adesso loro fiero difensore, è il protagonista assoluto del film, ma tutti i suoi sforzi vengono presentati più come un modello per gli altri che come azioni fini a se stesse. L’organizzazione logica di un film documentario serve ad avvalorare un argomento sotteso, un’affermazione o una dichiarazione riguardante il mondo. Con i documentari ci aspettiamo di interessarci a film che a loro volta si interessano al mondo. Questo tipo di coinvolgimento e questa logica liberano il documentario da alcune delle convenzioni utilizzate per creare un mondo immaginario. Il montaggio in continuità, per esempio, utilizzato per rendere invisibili gli stacchi tra le riprese in un film di fiction, ha un’importanza minore. Possiamo pensare che quello che si ottiene con il montaggio in continuità nella fiction si possa ottenere nel documentario con la storia: gli elementi si relazionano nel tempo e nello spazio non attraverso il montaggio, ma per mezzo dei collegamenti attuali e storici. Nel documentario, il montaggio rende palesi questi collegamenti. L’argomentazione può essere convincente o improbabile, accurata o distorta, ma agisce in relazione a situazioni ed eventi con cui abbiamo già familiarità, o su cui possiamo trovare altre fonti di informazione. Il documentario utilizza dunque molto meno, rispetto alla fiction, il montaggio in continuità per stabilire la credibilità del mondo a cui si riferisce.
Il film documentario, infatti, presenta spesso un numero di inquadrature e scene maggiore della fiction, tenute insieme non da una narrazione sviluppata intorno a un personaggio protagonista, ma da una retorica organizzata intorno a una logica o a un argomento centrale. I personaggi, o attori sociali, possono andare e venire, offrendo informazioni, dando testimonianze, fornendo prove. Luoghi e oggetti possono comparire e scomparire, o essere portati in primo piano per supportare la tesi o il punto di vista del film. Un’implicazione logica collega questi salti di persone e di luoghi. Se, per esempio, passiamo da una donna seduta a casa sua che descrive il lavoro da saldatrice durante la Seconda guerra mondiale a un’inquadratura, tratta da un cinegiornale degli anni Quaranta, di un cantiere navale, il taglio vuol fare intendere che la seconda inquadratura illustra il tipo di ambiente lavorativo descritto dalla donna nella prima. Lo stacco non ha un effetto di distrazione, nonostante non ci sia continuità di spazio o di tempo tra le due situazioni. Stacchi di questo genere avvengono spesso in The Life and Times of Rosie the Riveter (La vita e i tempi di Rosie l’operaia, 1980); non ci confondono perché seguono lo sviluppo di una storia raccontando con coerenza di argomentazione come le donne fossero state dapprima attivamente reclutate per coprire i posti lasciati dagli uomini partiti per la guerra e in seguito, quando gli uomini avevano fatto ritorno, scoraggiate dal rimanere nella forza lavoro. Le inquadrature trovano senso in relazione a ciò che le donne intervistate dalla regista Connie Field hanno da dire. Noi prestiamo attenzione a quello che dicono, e quello che vediamo serve a sostenere, amplificare, illustrare o a collegarsi alle storie narrate e alla linea di discorso che Field segue a sostegno di quello che viene detto. Invece che “in continuità”, potremmo chiamare questo tipo di montaggio documentaristico “montaggio evidenziatore”. Al posto di organizzare i pezzi di una scena in modo da presentare un insieme unificato di tempo e spazio in cui seguire le azioni dei personaggi principali, il “montaggio evidenziatore” taglia all’interno di una scena per presentare l’impressione di un solo argomento convincente sostenuto dalla logica. Piuttosto che staccare dall’inquadratura di un
personaggio che si avvicina a una porta con una seconda inquadratura dello stesso soggetto che entra nella stanza dall’altro lato della porta, il montaggio tipico di un documentario alternerebbe il primo piano di una bottiglia di champagne che viene infranta sulla prua al campo lungo di una nave, magari anche del tutto diversa, che viene varata. Le due inquadrature possono essere state girate a distanza di anni o di chilometri, ma insieme contribuiscono alla rappresentazione di un singolo avvenimento più che allo sviluppo di un singolo personaggio.
The City (Ralph Steiner e Willard Van Dyke, 1939). Immagini di grandi quantità di oggetti simili, e persone, contribuiscono a trasmettere il messaggio di The City: l’urbanistica non soddisfa più i bisogni dell’uomo. Per gentile concessione dei National Archives.
Seguendo l’esempio di The Life and Times of Rosie the Riveter, si possono delineare alcune scelte per descrivere un dato argomento, come per esempio la costruzione di una nave. Un film può: descrivere il processo di costruzione in maniera poetica o evocativa, catturandone in qualche modo il mistero e sperimentando con angolature di ripresa, montaggio e musica;
presentare una proposta o porre una domanda riguardante la costruzione della nave attraverso il commento – dicendo, per esempio, che le donne erano state chiamate a sostituire gli operai e poi dissuase dal mantenere il posto dopo la Seconda guerra mondiale; interagire con i veri operai, sia semplicemente osservandoli mentre svolgono il loro lavoro sia coinvolgendoli attivamente magari con delle interviste; spiegare come si costruisce una nave, con dettagli e informazioni su parti specifiche del processo che potrebbero essere utili a chi svolge il lavoro. Questo renderebbe il documentario più che altro un film “informativo” o quasi “manualistico”, anche se c’è sempre spazio per approcci ibridi.
The City. Immagini di individui, come questa, dissociano l’ascesa della città e l’ascesa della civilizzazione: il trionfo umano soccombe in un ambiente congestionato e frenetico. Immagini simili mostrano invece che la città tradizionale sconfigge l’umano spirito e predispongono l’arrivo della soluzione offerta dal film: quartieri suburbani pianificati e “verdi”.
In ogni caso, il montaggio ha una funzione di evidenziazione. Non solo aumenta il nostro grado di coinvolgimento nello svolgimento del film, ma sostiene anche il tipo di affermazioni o asserzioni che esso fa riguardo al
mondo. Noi tendiamo a valutare la solidità della struttura di un documentario in base alla capacità di persuaderci e convincerci delle sue rappresentazioni, e non rispetto a quanto siano plausibili e affascinanti le sue invenzioni. Nel documentario, gran parte della capacità di persuadere nasce dalla colonna sonora. Da sempre, fin dalla fine degli anni Venti, il cinema documentario ha fatto un grandissimo affidamento sul suono in tutti i suoi aspetti: commento parlato, discorsi sincronizzati, effetti acustici, musica. Le argomentazioni fanno capo a una logica che le parole sanno esprimere meglio delle immagini. Per esempio, queste ultime non hanno un tempo verbale e una forma negativa. Possiamo fare un cartello che dica “Vietato fumare”, ma solitamente comunichiamo questa richiesta attraverso le immagini, con la convenzionale barra rossa davanti al disegno di una sigaretta. Se decidessimo di non mostrare l’immagine di una sigaretta, non riusciremmo assolutamente a comunicare lo stesso significato che trasmette un cartello con la scritta «Vietato fumare». La convenzione di una barra rossa sopra un’immagine a indicarne il divieto è molto difficile da adattare al mondo cinematografico. I documentari si appoggiano notevolmente alla capacità del parlato, attraverso ciò che un commentatore ci dice riguardo all’argomento del film, o ciò che gli attori sociali ci raccontano nelle loro interviste, o ciò che sentiamo dire tra di loro agli attori sociali mentre la macchina da presa li osserva. Il parlato dà rilevanza fisica alla nostra idea del mondo. Un evento raccontato acquista profondità storica. Come gli altri generi, anche il documentario attraversa fasi e periodi. Nazioni e regioni differenti hanno diverse tradizioni documentaristiche. I registi europei e sudamericani, per esempio, preferiscono forme soggettive e chiaramente retoriche, come quelle che troviamo in Las Hurdes di Luis Buñuel o in Sans soleil (Senza Sole, 1982) di Chris Marker, mentre quelli inglesi e nordamericani pongono maggiore enfasi su forme più oggettive di osservazione, come il metodo “le due facce di ogni argomento” di molte cronache giornalistiche e l’approccio non interventista di Frederick Wiseman in film come High School (Liceo, 1968), Hospital
(Ospedale, 1970), e La danse (La danza, 2009), per citarne alcuni. Il documentario, come il film di fiction, ha avuto anche i suoi movimenti. Tra di essi potremmo includere il lavoro documentaristico di Dziga Vertov, Esther Shub, Mikhail Kalatazov, Victor Turin e altri che lavorarono in Unione Sovietica tra gli anni Venti e i primi anni Trenta. Questi autori furono pionieri nello sviluppo della forma documentaria come modo di guardare il mondo in maniera nuova e attinsero moltissimo dalle pratiche e dalle tecniche delle avanguardie storiche. Il British Documentary movement degli anni Trenta fece combaciare il cinema documentario con il bisogno di uno Stato e lanciò figure quali Basil Wright, Harry Watt, Alberto Cavalcanti, Paul Rotha e Humphrey Jennings, sotto la leadership di John Grierson. Il Free Cinema dell’Inghilterra degli anni Cinquanta portò alla luce un altro movimento, quando Lindsay Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson e altri diedero alla vita contemporanea inglese un aspetto nuovo e dimesso in film come Every Day Except Christmas (Ogni giorno tranne Natale, 1957), Momma Don’t Allow (La mamma non lo permette, 1956) e We Are the Lambeth Boys (Noi siamo i ragazzi di Lambeth, 1958). Il cinema osservativo di autori come Frederick Wiseman, i fratelli Maysles e Drew Associates (fondamentalmente Richard Drew, D.A. Pennebaker e Richard Leacock) nell’America degli anni Sessanta sposò un tono giornalistico apparentemente neutrale con uno stile fortemente osservativo.
The Life and Times of Rosie the Riveter (di Connie Field, 1980). Donne saldatrici alla fabbrica Landers, Frary e Clark, Connecticut, 1943. Rosie the Riveter è un esempio brillante di film che utilizza materiale di film storici non per confermare la verità di una situazione, ma per dimostrare in che modo essa possa essere asservita a scopi politici. In questo caso, i filmati d’archivio erano destinati prima a incoraggiare le donne a unirsi alla forza lavoro durante la Seconda guerra mondiale e poi a lasciarla al ritorno dei soldati dalla guerra. Grazie al montaggio di Field, le contorsioni logiche usate a questo scopo sono comicamente amplificate (pochi film governativi davano risalto alla presenza di donne afroamericane nella forza lavoro, il che fornisce a questa fotografia un particolare valore). Fotografia di Gordon Parks.
Un movimento cinematografico nasce quando un gruppo di individui che condividono la stessa visione o lo stesso approccio a un tema si mettono insieme, in maniera formale o informale. Questo viene spesso fatto consciamente attraverso i manifesti e altre dichiarazioni, come NOI: Variante di un
manifesto e Il cine-occhio di Dziga Vertov, che dichiarano apertamente guerra ai film sceneggiati e recitati. Questi saggi hanno definito i principi e gli scopi di cui film come L’uomo con la macchina da presa e Entuziazm: Simfoniya Donbassa (Entusiasmo: Sinfonia del Donbass, 1930) danno un esempio tangibile. Il saggio di Lindsay Anderson del 1956 sulla rivista «Sight and Sound», Stand Up! Stand Up!, auspicava un forte senso di dedizione sociale per la regia documentaristica. In esso venivano indicati i principi e gli scopi di una rappresentazione poetica ma cruda della realtà quotidiana della classe operaia che però si esimesse dalla responsabilità civile di indicare “soluzioni” che aveva fatto sembrare i lavori degli anni Trenta di John Grierson asserviti alle politiche di miglioramento sociale del governo britannico. Gli esponenti del Free Cinema cercavano un tipo di filmografia libero dalla propaganda del governo, dal borsellino degli sponsor e dalle convenzioni fisse dei generi. Il loro movimento contribuì a stimolare la rinascita del cinema inglese costruito intorno agli stessi principi, film che mostravano ritratti non abbelliti di comuni operai e un comportamento irriverente nei confronti delle convenzioni sociali e cinematografiche. La generazione dei “giovani arrabbiati” dell’Inghilterra degli anni Cinquanta ci ha dato film come Sabato sera, domenica mattina (Saturday Night and Sunday Morning, di Karel Reisz, 1960), Gioventù, amore e rabbia (The Loneliness of the Long Distance Runner, di Tony Richardson, 1962) e Io sono un campione (This Sporting Life, di Lindsay Anderson, 1963), realizzati con uno spirito che attingeva a un tipo di sensibilità simile a quello del Free Cinema del tempo. Molti di coloro che avevano iniziato con il documentario hanno in seguito girato film che venivano descritti come drammi di vita operaia, i cosiddetti kitchen sink. La storia del cinema documentario, oltre che movimenti, identifica periodi storici. Anche questo tipo di divisione contribuisce a definirlo e a differenziarlo da altri tipi di film con movimenti e periodizzazioni proprie. Il periodo degli anni Trenta, per esempio, vide gran parte del lavoro documentaristico assumere uno stile da cinegiornale (immagini tenute insieme dal commento della voce fuori
campo) come riflesso della nuova sensibilità nata nel periodo della Grande depressione, e un nuovo interesse politico su questioni economiche e sociali. Negli anni Sessanta ci fu l’introduzione di nuove cineprese leggere, a mano, che potevano essere comodamente usate con il sonoro in sincrono. I registi acquisirono così la mobilità e la reattività che permisero loro di seguire gli attori sociali nelle loro abitudini quotidiane. Si ebbe la possibilità di scegliere se osservare un comportamento privato o drammatico da una certa distanza o se partecipare in modo più diretto: negli anni Sessanta sull’uso del commento fuori campo predominava dunque l’idea di un cinema rigorosamente osservativo o fortemente partecipe. Queste modalità segnarono una netta rottura con gli stili documentaristici dominanti tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Negli anni Settanta e Ottanta, il documentario è ritornato spesso al passato attraverso l’uso di filmati d’archivio e interviste contemporanee, per dare una nuova prospettiva a eventi passati o a quelli collegati a questioni correnti (la prospettiva storica era un elemento spesso mancante nel cinema osservativo e partecipativo). Il film di Emile de Antonio In the Year of the Pig (Nell’anno del maiale, 1969) ha fatto da modello o prototipo che molti altri hanno poi emulato. De Antonio ha combinato una ricca varietà di materiale d’archivio con interviste taglienti per ri-raccontare la storia della guerra in Vietnam in un modo che contrastava radicalmente con la versione ufficiale del governo americano. With Babies and Banners: the Story of the Women’s Emergency Brigade (Con i bambini e con gli stendardi: la storia della Women’s Emergency Brigade, 1979), sullo sciopero in una fabbrica di automobili negli anni Trenta dal punto di vista delle donne, Union Maids (Donne del sindacato, 1976), sulle lotte sindacali in diverse industrie, e The Life and Times of Rosie the Riveter sul ruolo delle donne operaie durante e dopo la Seconda guerra mondiale, sono solo tre esempi di film che si sono ispirati all’opera di de Antonio e l’hanno elaborata per illustrare questioni riguardanti le donne. Come tali, hanno anche fatto parte dell’ampia tendenza, negli anni Sessanta e Settanta, a narrare la storia “dal basso”, ovvero
com’è vista e vissuta da persone comuni, invece che narrarla “dall’alto”, attraverso le azioni dei capi e i pareri degli esperti. Il documentario è caratterizzato da periodi e movimenti, ma anche da una serie di modalità di produzione che, una volta avviate, continuano a rappresentare un modello utile di sfruttamento delle risorse del cinema per realizzare documentari. Ogni modalità pone l’accento su risorse e tecniche cinematografiche diverse. Ognuna evidenzia anche notevoli variazioni di prospettiva a seconda di quanto è influenzata da singole figure autoriali, caratteristiche nazionali e tendenze particolari dettate dal periodo storico. I documentari di esposizione inizialmente si basavano sul commento onnisciente di un commentatore maschio professionista. La modalità del commento fuori campo resta in voga ancora oggi, ma le voci sono nella maggior parte dei casi femminili e appartengono agli stessi registi e registe invece che a professionisti che recitano il commento. La filmografia osservativa è nata negli anni Sessanta, ma resta una fonte di ispirazione importante, anche se viene spesso mescolata con altre modalità per realizzare forme ibride di documentario. Le sei modalità principali di regia documentaria sono: Modalità poetica: enfasi sulle associazioni visive, sulle qualità di tono o di ritmo, sui passaggi descrittivi e sull’organizzazione formale. Esempi: De Brug (Il ponte, 1928), Song of Ceylon (La canzone di Ceylon, 1934), Listen to Britain (Ascoltate la Britannia, 1941), Notte e nebbia (Nuit et brouillard, 1955), Koyaanisqatsi. Questa modalità ha una forte somiglianza con il cinema sperimentale, personale o d’avanguardia. Modalità espositiva: enfasi sul commento verbale e sulla logica argomentativa. Esempi: The Plow That Broke the Plains, Terra di Spagna (The Spanish Earth, 1937), Trance and Dance in Bali (Danza e trance a Bali, 1952), Les Maîtres fous (1955), i servizi giornalistici televisivi. Questa è la modalità che la maggior parte delle persone identifica con il documentario in generale. Modalità osservativa: enfasi su un coinvolgimento diretto con la vita quotidiana dei soggetti, osservati con
discrezione da una cinepresa. Esempi: Primary, High School, Salesman (Commesso, 1969), The War Room (La stanza della guerra, 1993) e Metallica: Some Kind of Monster (Metallica: specie di mostri, 2004). Modalità partecipativa: enfasi sull’interazione tra regista e soggetto. Le riprese sono composte da interviste o altre forme anche più dirette di coinvolgimento, spesso abbinate a filmati d’archivio per esaminare questioni storiche. Esempi: Chronique d’un été, Vlast’ Solovetskaija (La forza di Solovky, 1988), Shoah (1985), The Fog of War: La guerra secondo Robert McNamara (The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert McNamara, 2003) e Enron - L’economia della truffa. Modalità riflessiva: richiama l’attenzione sui presupposti e sulle convenzioni della regia documentaristica. Aumenta la nostra consapevolezza che la rappresentazione della realtà da parte del film è una macchinazione. Esempi: L’uomo con la macchina da presa, Las Hurdes, The Ax Fight (La battaglia delle scuri, 1975), The War Game (Il gioco della guerra, 1966) e Reassemblage (1982). Modalità performativa: enfasi sull’aspetto soggettivo o espressivo del coinvolgimento del regista col soggetto, e sulla reazione del pubblico a questo coinvolgimento. Rifiuto delle nozioni di obiettività a favore dell’evocazione della memoria e dell’affettività. Esempi: The Act of Seeing with One’s Own Eyes (Vedere coi propri occhi, 1971), History and Memory (Storia e memoria, 1991), Tongues Untied (Lingue slegate, 1989), Chile: Obstinate Memory (Cile: memoria ostinata, 1997), Valzer con Bashir, e reality show televisivi come Cops (esempio del lato squallido di questa modalità). I film di questo tipo condividono tutti alcune qualità dei film sperimentali, personali e di avanguardia, ma con una forte enfasi sull’impatto emotivo e sociale sul pubblico. Le modalità rivestono particolare importanza in determinati periodi e luoghi, ma perdurano e diventano più influenti dei movimenti. Ognuna può nascere come reazione, in parte a precise limitazioni delle modalità precedenti, in parte alle
nuove possibilità tecnologiche e a costrizioni e incentivi istituzionali, o come adattamento e risposta, in parte a esempi di film particolarmente d’effetto (e prototipici), e in parte a cambiamenti nel contesto sociale e nelle aspettative del pubblico. Tuttavia, una volta stabilite, le modalità si sovrappongono e si mescolano. I singoli film possono essere caratterizzati da quella che sembra più influente all’interno della loro struttura, ma possono anche “mischiare e abbinare” le modalità a seconda dell’occasione. Un caso esemplare di quest’ultimo fenomeno è la serie di documentari Battle 360, trasmessa su History Channel, che racconta alcune vicende della Seconda guerra mondiale da diversi punti di vista, per esempio da quello della nave portaerei Uss Enterprise. La serie fa uso in modo predominante del commento fuori campo e di materiali d’archivio (modalità espositiva), ma a essi sono affiancate interviste (modalità partecipativa) e sequenze animate delle battaglie (modalità performativa). L’animazione ha qui l’apparenza e il sapore di un videogioco: gli aeroplani bombardano e affondano le navi e le traiettorie del fuoco solcano il cielo; la camera scivola in soggettiva lungo le bombe chiuse nei loro involucri d’acciaio mentre si avvicinano all’obiettivo; i siluri sfrecciano sotto il livello del mare e penetrano nei fianchi delle navi nemiche. La maggior parte delle scene d’azione in animazione non presenta figure umane: la battaglia sembra avulsa da ogni elemento umano e dal prezzo che porta con sé. Questi elementi animati possono anche avere un effetto riflessivo su alcuni spettatori, spingendoli a mettere in dubbio il presupposto che un documentario debba sostenere la sua tesi o il suo punto di vista con l’utilizzo di materiali d’archivio storicamente autentici. Ma lo sponsor della serie ha fatto qualcosa di più. Il sito di History Channel permette agli utenti di chattare a proposito della serie e di comprare i Dvd di diverse puntate del programma. Anche se legata alla modalità espositiva, questa serie si spinge al di là non solo di tale modalità ma anche dei confini entro cui si muove la produzione documentaristica.
Un gruppo di spettatori: presupposti, aspettative, prove e qualità indicativa
dell’immagine Ci resta da considerare la fluidità del documentario in relazione al suo pubblico. Le istituzioni che sostengono i documentari possono anche sostenere film di fiction; i registi di documentari possono anche dirigere film di fiction; le stesse caratteristiche del film documentario possono essere simulate in un contesto di fiction, come dimostrato da lavori come No Lies (Niente bugie, 1973), The Blair Witch Project e Campioni di razza (2000). In altre parole, quello che abbiamo con tanta fatica identificato come il regno del documentario ha dei confini permeabili e un aspetto camaleontico. L’idea che un film sia un documentario nasce dalla mente dello spettatore tanto quanto dal contesto e dalla struttura del film. Quali presupposti e aspettative caratterizzano la nostra idea che un film sia un documentario? Come diversifichiamo la nostra esperienza di visione di un film documentario rispetto a uno di un altro genere? Sostanzialmente, partiamo da alcuni presupposti di base. I documentari: riguardano la realtà; parlano di persone reali; raccontano ciò che realmente è accaduto. Anche se nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di approfondire e di elaborare migliori definizioni di questi elementi, essi restano punti di partenza fondamentali per il pubblico. Questi presupposti spesso si rivelano fondati sulla capacità dell’immagine fotografica, e della registrazione audio, di replicare quelle che noi percepiamo come le caratteristiche proprie di ciò che hanno registrato. Che si tratti di un presupposto, incoraggiato dalle specifiche qualità della lente, delle emulsioni, dell’ottica e degli stili (come per esempio il realismo), è un fatto. Il suono che sentiamo e l’immagine che vediamo conservano una traccia tangibile di ciò che le ha prodotte. Il digitale e le tecniche di computer graphic possono essere utilizzati per ottenere un effetto simile, anche se il suono o l’immagine che apparentemente riproducono sono creati in modo fittizio.
Alcune note sull’immagine indicativa: gli strumenti di registrazione (cineprese e registratori audio) riproducono l’impressione delle cose (immagini e suoni) con grande fedeltà. Questo dà loro valore di documento, allo stesso modo in cui le impronte digitali valgono come documento. Questa accezione, difficile da spiegare, di un documento o immagine che ha in sé una corrispondenza esatta con ciò a cui si riferisce è chiamata la sua qualità indicativa. La qualità “indicativa” di un’immagine si riferisce al modo in cui il suo aspetto prende forma o viene determinato in base a ciò che registra: per esempio, la foto di un bambino con in braccio un cane rappresenta, in due dimensioni, un’esatta analogia della relazione spaziale tra il bambino e il cane a tre dimensioni; un’impronta digitale mostra esattamente lo stesso disegno di linee presenti sul dito che l’ha prodotta; una fotocopia replica precisamente il suo originale; i segni su un proiettile esploso hanno una relazione indicativa con la canna della pistola che lo ha sparato. La superficie della pallottola “registra” il suo passaggio attraverso la canna della pistola con una precisione tale da permettere ai periti forensi di utilizzarla come prova in un processo. Allo stesso modo, i suoni e le immagini cinematografici hanno un rapporto indicativo con quello che registrano. Essi colgono con precisione alcuni aspetti di ciò che sta di fronte alla macchina da presa, che in alcuni casi viene definito evento profilmico. Questa qualità è ciò che fa sì che l’immagine documentaristica appaia come fonte vitale di prove del mondo reale. Anche se è vero, è cruciale chiarire subito questo punto. Un documento e una registrazione sonora indicativa o un’immagine indicativa sono documenti: essi forniscono prove. Ma un documentario è più che una prova: è anche un particolare modo di vedere il mondo, che formula ipotesi e offre punti di vista. In questo senso, è una maniera di interpretare il mondo. E utilizza prove per farlo. Quello che dobbiamo tenere bene a mente, perciò, è la differenza tra immagine indicativa usata come prova e l’argomentazione, la prospettiva, la spiegazione o l’interpretazione che la supportano. La prova è messa lì per essere usata. Serve alla tesi che tutto il film sostiene. La stessa
prova può servire come materiale grezzo per più tesi e punti di vista, proprio come ogni processo in tribunale virtualmente dimostra. L’accusa e la difesa fanno riferimento alle stesse prove ma tracciano conclusioni opposte. Nella stessa maniera, l’immagine indicativa può sembrare la prova di una data interpretazione, ma l’interpretazione non può essere valutata solo in base alla validità delle prove che utilizza. Altre interpretazioni, che utilizzano le stesse prove, metteranno in discussione i suoi presupposti di fondo. Questo non significa, tuttavia, che tutte le interpretazioni siano valide allo stesso modo. Da una parte, si potrà fare un uso più convincente delle prove a disposizione, dall’altra si potranno volutamente mistificare o eliminare alcuni aspetti di quelle stesse prove. È evidente, in ogni caso, che l’immagine indicativa possiede un forte potere probatorio che ha grandemente contribuito al successo del genere documentario. Chi non si esalta a vedere, in Primary, il futuro presidente John F. Kennedy muoversi nel dietro le quinte del suo quartier generale, come dentro un labirinto, per poi emergere davanti al pubblico durante le primarie del 1960 in Wisconsin contro Hubert Humphrey? Chi non rabbrividisce di paura nel vedere il solitario Timothy Treadwell condividere lo schermo con minacciosi orsi grigi nei remoti e selvaggi spazi estremi dell’Alaska in Grizzly Man (2005)? Il potere indicativo di queste immagini è unico e coinvolgente. Le inquadrature delle vittime e dei sopravvissuti dei campi di concentramento nel film di Alain Resnais Notte e nebbia hanno lo stesso aspetto che avremmo visto anche noi se fossimo stati presenti, perché l’immagine cinematografica è una registrazione di come apparivano queste persone quando sono state riprese, durante e alla fine della Seconda guerra mondiale. Il punto di vista del film su questi eventi, tuttavia, è notevolmente diverso da quelli di Memorandum di Donald Brittain e John Spotton (1965), Shoah di Claude Lanzmann, The Last Days (1998) di James Moll. Anche tralasciando gli effetti speciali, le manipolazioni digitali o altre forme di alterazione che possono falsificare un’immagine fotografica, l’autenticità dell’immagine non necessariamente rende un’argomentazione o un punto di vista superiore a un altro. La
logica interna e la verifica esterna di quello che un documentario proclama come la verità devono essere rigorosamente sostenute: l’inclusione di immagini indicative come prove non può assolvere questo compito. La rilevanza che diamo alla qualità indicativa del suono e dell’immagine, il nostro presupposto che un documentario dia evidenza documentaristica a livello di inquadratura, o di frasi pronunciate, non si estende automaticamente all’intero film. Di solito capiamo o riconosciamo che il documentario non è una trascrizione fedele della realtà, ma un trattamento creativo della realtà. Le trascrizioni, o registrazioni prettamente documentaristiche, hanno un loro valore, come i filmati di sorveglianza o la registrazione di un avvenimento o una situazione specifici, per esempio il lancio di un missile, lo svolgimento di una sessione terapeutica o una particolare performance sportiva o di intrattenimento. Noi tendiamo, tuttavia, a considerare questi materiali come documenti o “filmati” e non come documentari. Questi ultimi utilizzano l’evidenza della realtà, ma la usano per fondare i loro punti di vista o le loro argomentazioni sul mondo, la loro risposta poetica o retorica a esso. Noi ci aspettiamo che questa evidenza si trasformi in qualcosa di più che la registrazione di semplici fatti, e siamo delusi se questo non accade. Tra i vari presupposti che colleghiamo al concetto di documentario, quindi, c’è quello che le singole immagini e inquadrature, forse anche le scene e le intere sequenze, avranno una relazione indicativa con gli eventi che rappresentano, ma che il film nel suo insieme si discosterà dall’essere un semplice documento o una trascrizione di questi eventi, scegliendo invece di commentarli o di proporre un punto di vista su di essi. I documentari non sono documenti nel senso testuale della parola, ma sono basati sulle qualità documentarie degli elementi che li compongono. Come pubblico, noi pretendiamo di poterci fidare del collegamento indicativo tra ciò che vediamo e ciò che è accaduto davanti alla cinepresa; pretendiamo inoltre di poter valutare la trasformazione retorica o poetica di questo collegamento all’interno di un commento o di un’interpretazione del mondo in cui viviamo. Sappiamo che ci sarà un’oscillazione tra il
riconoscere la realtà storica e il riconoscerne una rappresentazione. Tale aspettativa fa sì che il nostro coinvolgimento in un documentario sia diverso da quello che proviamo per altri generi. Questo tipo di aspettativa caratterizza inoltre, nella nostra società, quelli che potremmo definire i “discorsi impegnati”. Questo termine indica i modi con cui esprimiamo un parere su realtà sociali e storiche, come la scienza, l’economia, la medicina, la strategia militare, la politica estera e l’istruzione. Quando entriamo in un contesto istituzionale che supporta questo tipo di espressioni, acquistiamo un potere strumentale: quello che decidiamo e che diciamo può influenzare il corso degli eventi reali e avere vere conseguenze. Si tratta di modi di vedere e di parlare che sono anche modi di fare e di agire, poiché posseggono una sorta di potere. Un’aria di sobrietà pervade questi discorsi poiché non riguardano quasi mai la fantasia e i desideri o personaggi inventati e mondi immaginari (a meno che non si tratti di riproduzioni utili del mondo reale, come nel caso dei simulatori di volo o dei modelli economici). Sono veicoli di azioni e di reazioni, di potere e di conoscenza, di desiderio e di volontà, diretti al mondo in cui tutti viviamo. Come questo tipo di discorsi, il documentario vuole rivolgersi al mondo reale e avere la capacità di intervenire sul modo in cui noi lo osserviamo. Anche se il cinema documentaristico può non essere accettato come equivalente della ricerca scientifica o delle iniziative di politica estera (e questo è dovuto al fatto che, essendo un mezzo basato sulle immagini, al documentario mancano le importanti qualità del discorso scritto e parlato, come l’immediatezza e la spontaneità dei dialoghi, o la logica rigorosa del saggio scritto), questo genere possiede ancora una tradizione di impegno, che nasce dalla sua intenzione di cambiare il modo di vedere e di affrontare il mondo. Non tutti i documentari, ovviamente, sono “impegnati” e pesanti, così come non tutti i discorsi politici o le relazioni scientifiche sono noiosi. In molti casi, si tratta di mettere in campo ingegno e doti immaginifiche, retoriche e persuasive. La storia del genere documentario dimostra quanto questo sia vero con le sue
rappresentazioni convincenti, coinvolgenti e perfino poetiche della realtà storica.
Hoop Dreams (di Steve James, Frederick Marx e Peter Gilbert, 1994). William Gates è uno dei due giovani che seguiamo in Hoop Dreams. Queste foto pubblicitarie, offrono una documentazione indicativa di Gates da ragazzo annunciano un film “di formazione” in cui vediamo lui e Arthur Agee, l’altro protagonista, crescere come giocatori di basket e maturare come uomini. Il distributore del film, in effetti, montò una campagna pubblicitaria per fare candidare il film agli Oscar non come migliore documentario, ma come miglior film. La campagna non ebbe successo, ma evidenziò la natura arbitraria e spesso permeabile delle distinzioni nette tra film di fiction e documentari. Fotografie concesse da Fine Line Features.
Quando guardiamo un documentario, noi ci aspettiamo di imparare, o di commuoverci, vogliamo fare una scoperta o essere persuasi che esistono altre possibilità riguardanti il nostro mondo. I documentari usano ciò che è evidente per affermare qualcosa che suona come “Così stanno le cose”, seguito da un implicito “Non trovate?”. Questa affermazione viene comunicata attraverso la forza persuasiva o retorica della rappresentazione. San Pietro (The Battle of San Pietro, di John Huston, 1945), per esempio, vuole comunicare che “la guerra è un inferno” e ci convince di questo attraverso i primi piani di
una serie di soldati morti e non, per esempio, con un unico campo lungo alla fine di una battaglia, scelta che diminuirebbe l’orrore e forse aumenterebbe il senso di nobiltà dello scontro. Una tale serie di primi piani ha invece un impatto, o un “colpo indicativo”, che è molto diverso dalla visione di morti in film di fiction, come in La sottile linea rossa (The Thin Red Line, di Terrence Malick, 1998) o Salvate il soldato Ryan (Saving Private Ryan, di Steven Spielberg, 1998), nei quali si riflette allo stesso modo sul costo umano della guerra. Le rappresentazioni possono essere simili, ma l’impatto emotivo del vedere primi piani di persone morte o morenti cambia considerevolmente se sappiamo che non c’è stato un momento nel quale il regista ha detto «Stop!» e i morti si sono rialzati. Come molti documentari, San Pietro ha uno scopo impegnato, ma usa strumenti emotivamente persuasivi per raggiungerlo. Gli spettatori affrontano dunque i documentari con l’idea che il loro desiderio di sapere di più sul mondo in cui vivono verrà esaudito nel corso del film. I documentari evocano questo desiderio di conoscenza quando affrontano un soggetto storico e propongono la loro interpretazione personale della lezione di storia. Come si è arrivati a una data situazione (la povertà tra i contadini emigranti in Harvest of Shame; il degrado del terreno agricolo in The Plow That Broke the Plains)? Come funzionano le istituzioni (in High School o Herb Schiller Reads the New York Times [Herb Schiller legge il New York Times, 1982])? Come si comportano le persone in situazioni di stress (le reclute femminili durante il loro addestramento in Soldier Girls (Donne soldato), 1980; i soggetti sperimentali durante dei potenzialmente dannosi test di obbedienza in Obedience [Obbedienza, 1965])? Che tipo di dinamiche interpersonali avvengono in un contesto storico concreto (i membri di una famiglia che cerca di avviare una piccola pizzeria in Family Business [Impresa di famiglia, 1982]; il tentativo di far fronte alle accuse di pedofilia contro un padre e uno dei suoi figli in Una storia americana [Capturing the Friedmans, 2003])? Qual è la fonte di un dato problema e come possiamo affrontarlo (gli inadeguati alloggi degli operai in Housing Problems [Problemi di abitazione, 1935]; la storia dello sfruttamento coloniale in Argentina in L’ora dei forni [La Hora de los hornos, 1968])? Per quali
motivi combattiamo (la serie Why We Fight, sulla partecipazione degli Stati Uniti alla Seconda guerra mondiale; People’s War [La guerra della gente, 1969], sulle ragioni del Vietnam del Nord per cercare di unificare il Vietnam e opporsi all’intervento americano)? Come fanno i membri di una cultura diversa a organizzare le loro vite ed esprimere i loro valori sociali (tra i Dani negli altipiani della Nuova Guinea in Dead Birds [Uccelli morti, 1965]; tra i Turkana del Kenya in Wedding Camels [Cammelli da matrimonio, 1980])? Cosa succede quando la nostra cultura ne incontra un’altra, e in particolare quando i poteri coloniali occidentali incontrano le cosiddette “popolazioni primitive” (per la prima volta nella Nuova Guinea degli anni Trenta, come in First Contact, Primo contatto, 1984; o spesso lungo il fiume Sepik della Nuova Guinea in Cannibal Tours, I tour dei cannibali, 1988)?
American Teen (di Nanette Burstein, 2008). Il documentario utilizza molte tecniche tipiche della fiction per intensificare l’idea di che cosa voglia dire essere un liceale (montaggio in continuità, riprese in soggettiva, montaggio alternato e così via). Come mostra bene questa locandina, il film si posiziona in maniera precisa come un ritratto di cinque liceali tipici, o stereotipici, e sviluppa ogni singolo personaggio in modo da rafforzare l’idea che esso ne impersoni una data tipologia. La strategia somigliava al marketing di un film di genere e provocò un dibattito sullo status di documentario del film. Per gentile concessione di Paramount Vantage/Photofest.
I film e i video documentari stimolano nel loro pubblico la “epistefilia” (desiderio di conoscenza). Comunicano una logica informativa, una retorica persuasiva o una poetica commovente che promettono conoscenza e informazioni, intuito e consapevolezza. Il documentario propone al pubblico di occuparsi di gratificare la loro sete di conoscenza. Colui-
che-sa (questa figura ha sempre avuto connotati maschili) spartirà la sua conoscenza con coloro che desiderano sapere. Anche noi possiamo avere il ruolo di Colui-che-sa. Loro parlano di loro a noi, e noi ne riceviamo in cambio una nuova conoscenza, unita a un senso di piacere e di soddisfazione. Questa dinamica può far sorgere nuove domande, oltre che risolverle. Ci potremmo chiedere: chi siamo noi per avere il diritto di sapere una tal cosa? Che tipo di conoscenza è quella fornita dai documentari? Che uso dobbiamo fare, noi e gli altri, della conoscenza acquisita da un film? Che cosa sappiamo e come abbiamo fatto ad apprenderlo, sono questioni di rilievo sociale. La conoscenza contiene il potere e la responsabilità; l’uso che facciamo di quello che impariamo va oltre l’analisi dei film documentari, rientrando invece nel campo di come affrontiamo il mondo sociale rappresentato in tali film.
CAPITOLO 2 PERCHÉ I PROBLEMI ETICI SONO FONDAMENTALI PER I DOCUMENTARI? In che modo i documentari rappresentano il mondo Il legame tra il documentario e la realtà è intenso e profondo. I documentari arricchiscono la memoria popolare e la realtà storica di una nuova dimensione. Stabiliscono una connessione profonda con il mondo che rappresentano, e lo fanno in tre modi. Prima di tutto, il documentario ci offre una rappresentazione o raffigurazione del mondo che porta con sé una familiarità che ci appartiene. Attraverso la capacità dei dispositivi di registrazione audio e video di memorizzare situazioni ed eventi in modo molto fedele, noi vediamo nei documentari persone, luoghi e cose che potremmo vedere noi stessi fuori dalla sala cinematografica. Questa qualità già in se stessa conferisce ai documentari una base di credibilità: noi vediamo ancor prima della macchina da presa quel che c’era, che quindi deve per forza essere vero (è realmente accaduto o esistito). Sarebbe sciocco sottostimare il potere straordinario dell’immagine fotografica, anche se vanno fatte alcune puntualizzazioni, poiché: - un’immagine non può dire tutto quello che sappiamo di ciò che è successo; - le immagini possono essere alterate sia durante che dopo i fatti, tanto attraverso tecniche analogiche quanto digitali; - un’immagine autentica e verificabile non garantisce necessariamente la validità di più vaste asserzioni che si possono fare a proposito di ciò che l’immagine rappresenta o significa. Nei documentari troviamo storie o tesi, rievocazioni o descrizioni che ci fanno vedere il mondo sotto una nuova luce.
L’abilità dell’immagine fotografica di riprodurre con verosimiglianza ciò che le viene posto di fronte ci spinge a credere che quello che viene rappresentato davanti ai nostri occhi sia la realtà stessa. Possiamo essere già a conoscenza dei problemi riguardanti tagli aziendali, catene di montaggio globali e chiusure di fabbriche, ma Roger & Me di Michael Moore ci dà un visione nuova e particolare di questi problemi. Possiamo conoscere la chirurgia estetica e le critiche ai tentativi di recuperare con essa la giovinezza perduta, ma il film di Michael Rubbo Daisy: The Story of a Facelift (Daisy: la storia di un lifting facciale, 1982) aggiunge alla nostra conoscenza la visione personale del regista. In secondo luogo, i documentari mostrano o rappresentano l’interesse altrui. In una democrazia diretta ogni individuo prende parte attivamente alle decisioni politiche invece che appoggiarsi a un rappresentante. La democrazia rappresentativa, al contrario, si basa su individui scelti a rappresentare gli interessi dei loro elettori. I registi di documentari assumono spesso il ruolo di rappresentanti pubblici. Parlano nell’interesse di altri, sia a nome degli individui che rappresentano nel film sia dell’istituzione o dell’ente che finanzia la loro attività filmica. The Selling of the Pentagon (La vendita del Pentagono, 1971) – una produzione della Cbs News su come l’esercito americano vende la propria immagine in modo da assicurarsi una fetta cospicua di tasse federali – si presenta come rappresentante del popolo americano nell’investigare l’uso e l’abuso di potere politico a Washington. Rappresenta anche l’interesse della Cbs News nel dare di sé l’immagine di un’istituzione indipendente dalle pressioni governative e dedita all’autorevole tradizione dell’inchiesta giornalistica.
Daisy: The Story of a Facelift (di Michael Rubbo, National Film Board of Canada, 1982). Michael Rubbo non ci risparmia i dettagli clinici. Il suo commento fuori campo cerca di far comprendere la complessità della questione, mentre le immagini mostrano la realtà dell’intervento.
Analogamente, Nanuk l’eschimese, la grande storia della lotta per la sopravvivenza di una famiglia Inuit nell’Artico, ritrae la loro cultura in modi non ancora proponibili per gli stessi Inuit, ma rappresenta anche gli interessi dei fratelli Revillon, i finanziatori di Flaherty, per lo meno nell’intento di mostrare che la caccia agli animali da pelliccia è un’attività che giova agli Inuit oltre che ai consumatori. In terzo luogo, i documentari possono raffigurare il mondo nello stesso modo in cui un avvocato può rappresentare gli interessi del suo cliente: pongono un caso e le prove in maniera tale che ci risultino interpretabili in un determinato
senso. In questo modo i documentari non soltanto si mettono al posto di altri, rappresentandoli come essi non avrebbero altrimenti potuto fare, ma espongono attivamente un caso o un problema: affermano la natura di una questione per guadagnare consenso o influenzare l’opinione. The Selling of the Pentagon rappresenta la tesi che l’esercito degli Stati Uniti alimenti aggressivamente la percezione della propria indispensabilità e del proprio immenso, continuo e crescente bisogno di fondi. Nanuk l’eschimese rappresenta la lotta per la sopravvivenza in un clima duro e impervio, dove sono messe alla prova le forze di un uomo e della sua famiglia. Attraverso il valore e il coraggio di questo gruppo familiare, dove i ruoli sono ben definiti e le interazioni sono semplici, noi acquisiamo un’idea della dignità di un intero popolo. Daisy: The Story of a Facelift rappresenta il caso della costruzione sociale dell’immagine di un individuo in modi insoliti e inquietanti, risultato dalla combinazione degli effetti di influenze sociali, procedure mediche e regia documentaristica.
L’etica della rappresentazione degli altri I documentari, dunque, offrono ai nostri occhi e alle nostre orecchie una rappresentazione di alcune parti del mondo. Mostrano i punti di vista di individui, gruppi e istituzioni. Possono anche creare impressioni, generare dibattiti o formulare strategie persuasive in maniera indipendente, cercando di convincerci ad accettare come valide le loro opinioni. Il concetto di rappresentazione è ciò che ci spinge a formulare la domanda: “Perché i problemi etici sono fondamentali per i documentari?”. Questa domanda può anche essere posta in altri termini: “Come ci rapportiamo con le persone quando facciamo un documentario?”. Come trattiamo le persone che filmiamo, che cosa dobbiamo loro e che cosa al nostro pubblico? Dovrebbero essere ricompensati? Dovrebbero avere il diritto di escludere l’utilizzo di materiale compromettente? È giusto chiedere alle persone di ripetere azioni o conversazioni a beneficio della camera? Questo compromette l’integrità delle loro azioni e l’impegno
dichiarato del film di rappresentare una realtà che esiste indipendentemente da esso? Per i film di fiction la risposta è semplice: diciamo loro che cosa vogliamo che facciano. Le “persone” vengono trattate come attori nello svolgimento delle loro capacità professionali. Il loro ruolo sociale all’interno della creazione di un film è definito da quello tradizionale dell’attore. Gli individui stipulano dei contratti per recitare nel film e il regista ha il diritto, e l’obbligo, di ottenere una prestazione accettabile. L’attore viene valutato in base alla qualità della sua interpretazione, non della somiglianza con la sua personalità e il suo comportamento quotidiano. L’utilizzo di attori non professionisti complica la situazione. Le storie che utilizzano attori non professionisti, come molti film neorealisti italiani o alcuni dei film del nuovo cinema iraniano, occupano un territorio misto tra fiction e non-fiction. Queste opere hanno spesso influenzato sia i registi di documentari che di fiction. Per la non-fiction, o il documentario, la risposta non è sempre così semplice. Le “persone” sono trattate come attori sociali: continuano a condurre le loro vite più o meno come avrebbero fatto senza la presenza della macchina da presa. Invece che interpreti teatrali, restano attori culturali. La loro importanza per il regista non dipende da una relazione contrattuale ma da ciò che le loro vite incarnano. Il loro valore non risiede nella loro capacità di nascondere o modificare il comportamento e la personalità di tutti i giorni, ma nel modo in cui questi assecondano i bisogni del regista. Detto ciò, spesso i registi di documentari preferiscono persone il cui comportamento spontaneo davanti alla macchina da presa trasmette un senso di complessità e profondità simile a quello che ci colpisce nella performance di un attore. Questi individui possiedono carisma: attraggono la nostra attenzione, tengono vivo il nostro interesse e ci affascinano. Nanuk potrebbe benissimo essere considerato la prima star di un documentario, ma molte altre ce ne sono state in seguito, da Timothy Treadwell, il personaggio principale dello straordinario documentario di Werner Herzog Grizzly Man, a Becky Fischer, la trascinante fondamentalista cristiana capace
di guidare ragazzi e ragazze verso Gesù in Jesus Camp (di Heidi Ewing e Rachel Grady, 2006). Il diritto di un regista a un’interpretazione è un “diritto” che, se esercitato, può minare il senso di autenticità tipico dell’attore sociale. Gli attori sociali presentano se stessi così come sono, non nel modo in cui un regista plasma un ruolo. Se la direzione del regista diventa troppo invadente, la sensazione che ci resta di un’autorappresentazione autentica può vacillare. American Teen (2008), di Nanette Burstein, ricevette critiche proprio su questo punto, poiché la regista costruì in modo attivo i cinque personaggi principali, un gruppo di liceali prossimi alla maturità, ispirandosi in gran parte a stereotipi (l’atleta bellissimo, il disadattato con la passione dell’arte e così via), ma gli studenti dichiararono di essere stati rappresentati in maniera corretta. Dall’altro lato, l’autoconsapevolezza e i cambiamenti nel comportamento possono essere testimonianze del modo in cui l’atto di filmare altera la realtà che si appresta a rappresentare. Come detto nel Capitolo 1, le persone modificano il modo in cui si mostrano agli altri durante i momenti di interazione, in relazione alle reazioni che suscitano. Per esempio, la famosa serie documentaristica di dodici ore sulla famiglia Loud, An American Family (Una famiglia americana, di Craig Gilbert, 1972), trasmessa dalla Pbs, ha generato forti discussioni tra chi sosteneva che il comportamento dei Loud e le loro relazioni familiari fossero stati modificati dalla presenza delle cineprese e chi riteneva che fossero stati semplicemente “catturati” su pellicola. I genitori si separarono, il figlio si dichiarò gay; questi avvenimenti influirono pesantemente sulla drammaticità della serie. E se questi fatti erano avvenuti a causa della presenza dell’occhio vigile della cinepresa e dei registi, era possibile che fossero stati (anche inavvertitamente) incoraggiati, in quanto aumentavano l’intensità drammatica della serie?
Jesus Camp (di Heidi Ewing, Rachel Grady, 2006). Becky Fisher, inquadrata in primo piano, si rivolge a un gruppo di ragazzini. La sua personalità carismatica ha un effetto potente su di loro. Jesus Camp mostra la donna all’opera e lascia che sia lo spettatore a decidere come giudicare l’impatto delle sue visioni fondamentaliste. Per gentile concessione di Loki Film e Magnolia Pictures.
I registi dei documentari di solito si fanno rilasciare una liberatoria da chiunque essi filmino. La liberatoria garantisce al regista un potere decisionale assoluto. L’individuo perde completamente ogni controllo sull’uso della rappresentazione delle sue azioni e quindi sul risultato finale. Cionondimeno, a volte accade che colore che partecipano a documentari di successo finiscano per sentirsi usati. In quanto determinanti per il successo di un film, possono sentirsi autorizzati a chiedere un compenso commisurato a quello che riceverebbe un attore. Dopotutto, la loro “performance” ha attirato il pubblico a vedere il film. In casi diversi, sia Randal Adams, figura centrale nel potente La sottile linea blu di Errol Morris, sia Georges Lopez, protagonista dello straordinario Essere e avere (Être et avoir, 2002) di Nicolas Philibert, storia di un insegnante in una scuola a classe unica della Francia contadina, fecero causa ai registi chiedendo un’equa ripartizione dei considerevoli incassi al botteghino ottenuti dai film. I legali di entrambi i registi ribatterono che erano pronti a
offrire una forma di risarcimento, ma rifiutarono categoricamente l’idea che degli individui avessero il diritto di essere pagati per essere se stessi, anche se di fronte a una macchina da presa. Farlo avrebbe distrutto la storia del documentario, era la loro conclusione. I tribunali americani e francesi che trattarono i casi diedero ragione ai registi, anche se i due uomini in effetti ricevettero un risarcimento come parte dell’accordo. Che cosa fare con le persone? Formulata diversamente, la domanda diventa: “Che responsabilità hanno i registi verso l’influenza che la loro presenza apporta nelle vite delle persone riprese?”. La maggior parte di noi pensa che l’invito a recitare in un film sia un’opportunità desiderabile, perfino invidiabile. Ma se la richiesta non fosse di recitare in un film, ma di essere in un film, ovvero essere se stessi in un film? Che cosa penseranno gli altri di te? Come ti giudicheranno? Quali aspetti della tua vita saranno inaspettatamente rivelati? Che tipo di pressione, sottintesa o esplicita, entrerà in gioco a modificare il tuo comportamento, e con quali conseguenze? Queste domande hanno risposte varie, a seconda della situazione, ma rientrano in una categoria diversa da quella delle questioni poste dalle opere di finzione. Il regista che decide di rappresentare gli altri invece di ritrarre personaggi inventati si troverà con un diverso fardello di responsabilità. Queste domande aggiungono al documentario un livello di sensibilità etica che nel cinema di finzione ha molto meno rilievo. Consideriamo Las Hurdes di Luis Buñuel. Nell’opera, il regista rappresenta le vite dei cittadini delle Hurdes, una regione povera e sperduta della Spagna, con l’aiuto di un commento fuori campo dai toni incredibilmente presuntuosi, se non addirittura razzisti. «Voici un autre cretin» (ecco un altro cretino), dice il narratore quando un hurdano entra nell’inquadratura. In un altro momento si vede un ruscello di montagna e il narratore spiega che «durante l’estate questa è l’unica fonte d’acqua, e gli abitanti vi attingono nonostante il sudiciume disgustoso che vi galleggia». Visto dall’esterno, questo modo ingiurioso di descrivere la gente lascia senza parole. Che mancanza di rispetto, che arroganza! Così poca
considerazione per le difficoltà e i problemi di un popolo in un ambiente inospitale, che il regista non accosta nemmeno al mito del buon selvaggio, come invece faceva Robert Flaherty con Nanuk. A livello superficiale, Las Hurdes sembra un esempio della forma di cronaca più cinica, persino peggiore dei paparazzi a caccia di celebrità o delle crude rappresentazioni della gente nei “Mondo Movie”, come Mondo cane (di Gualtiero Jacopetti e Franco E. Prosperi, 1962). Invece, il film di Buñuel fa gradualmente intuire la presenza di un grado di consapevolezza e di calcolo tale da farci chiedere se il regista sia davvero lo spietato che sembra. In una scena, per esempio, ci viene detto che gli hurdanos mangiano carne di capra solo quando ne muore una accidentalmente. Quello che vediamo, però, è una capra che cade dall’orlo di un burrone non appena una nuvoletta di polvere da sparo compare in un angolo dell’inquadratura. Se si trattava di un incidente, perché hanno sparato un colpo? E come ha fatto Buñuel a spostarsi da una posizione, a una certa distanza, a un’altra, proprio sopra la capra che cade lungo il fianco della montagna? Il modo in cui Buñuel rappresenta l’incidente sembra contenere una “strizzatina d’occhio”: è come se suggerisse che non si tratta di una rappresentazione vera e propria della vita degli hurdanos, né di una presa di posizione incredibilmente offensiva, ma piuttosto di una critica o una messa a nudo delle forme di rappresentazione più comuni dei popoli legati alle tradizioni. Forse i commenti e le opinioni del film sono una caricatura del tipo di considerazioni presenti nei documentari di viaggio tipici del tempo e dei pregiudizi di molti potenziali spettatori dell’epoca. Forse Buñuel sta facendo una satira di un modo di rappresentazione che usa prove documentaristiche per rafforzare gli stereotipi preesistenti. Da questo punto di vista, Las Hurdes può essere considerato un film fortemente politico che mette in questione gli stessi presupposti etici del documentario.
In and Out of Africa (di Ilisa Barbash e Lucien Taylor, 1992). Questo film adotta un approccio radicalmente diverso da Las Hurdes. Tra regista e soggetto è presente un alto livello di collaborazione. L’interazione dà allo spettatore l’idea di essere “all’interno” o “dietro le quinte” invece che l’impressione di una possibile parodia o, forse, irriverenza. Gabai Barré, mediatore e mercante, rassicura il regista che questo pezzo di “legno”, come lo definisce, è una buona scultura. L’incremento di valore che un oggetto subisce quando passa da “legno” ad “arte” è fonte dell’entusiasmo di Barré e del senso estetico del suo cliente. Fotografie concesse da Lucien Taylor.
Visto da questa prospettiva, Buñuel diventa, nel 1932, un avvertimento precoce e importante contro la nostra stessa tendenza a prendere alla lettera tutto ciò che vediamo e sentiamo. Il nostro rischio è quello di non cogliere l’ironia di un Buñuel o la manipolazione di una Riefenstahl. In Il trionfo della volontà, Leni Riefenstahl dipinge un ritratto lusinghiero del partito nazionalsocialista e del suo capo, Adolf Hitler, durante il raduno a Norimberga del 1934, allo stesso modo con cui Buñuel ne dipinge uno negativo degli hurdanos in Las Hurdes. Noi accettiamo entrambe le rappresentazioni come “vere” a nostro rischio e pericolo. Buñuel è stato il primo regista a sollevare esplicitamente la questione etica all’interno del documentario, ma sicuramente non è l’ultimo.
Lo scopo dell’etica
L’etica serve a guidare il comportamento di un gruppo nelle questioni in cui le regole severe, o le leggi, non bastano. Dovremmo avvisare le persone che riprendiamo del fatto che potranno essere ridicolizzate o giudicate negativamente da molti? Il regista Ross McElwee avrebbe dovuto spiegare alle donne che riprendeva durante il suo viaggio nel Sud degli Stati Uniti per il film Sherman’s March (La marcia di Sherman, 1985) che molti spettatori le avrebbero giudicate delle “dame” del Sud civettuole e ossessionate dall’eterosessualità? Michael Moore avrebbe dovuto dire agli abitanti di Flint, Michigan, intervistati nel film Roger & Me, che li avrebbe fatti sembrare sciocchi per far apparire la General Motors ancora peggio? Il regista Jean Rouch avrebbe dovuto avvisare gli uomini della tribù Hausa, ripresi durante una complicata cerimonia mistica in Les Maîtres fous, che le loro azioni sarebbero potute sembrare, a chi non conosceva le loro tradizioni, bizzarre, se non addirittura barbariche, nonostante l’aiuto del commento fuori campo? Tanya Ballantyne avrebbe dovuto avvisare il marito della famiglia spiantata da lei ripresa in The Things I Cannot Change (Le cose che non posso cambiare, 1966) che la registrazione di certi suoi comportamenti poteva essere utilizzata come prova contro di lui (come per esempio quando prende parte a una scazzottata)? Queste domande indicano gli effetti imprevisti che un film documentaristico può avere sulle persone in esso rappresentate. Le considerazioni etiche cercano di minimizzare gli effetti dannosi. L’etica diventa così una misura del modo con cui la negoziazione del rapporto tra regista e soggetti filmati crea conseguenze su di essi e sugli spettatori. I registi che intendono rappresentare persone che inizialmente non conoscono, ma che hanno una particolare conoscenza di un problema o di un argomento di interesse, corrono il rischio di sfruttarle. Quelli che scelgono di osservare gli altri ma di non intervenire apertamente nelle loro faccende corrono invece il rischio di alterare il comportamento e gli avvenimenti correlati, e di mettere in dubbio la loro stessa reazione umana. I registi che scelgono di lavorare con persone con cui hanno già familiarità affrontano poi la sfida di rappresentare responsabilmente ciò che li accomuna, anche a costo di sacrificare la propria voce o punto di vista a favore degli altri.
Carolyn Strachan e Alessandro Cavadini adottano consapevolmente questo tipo di scelta collaborativa annullando la loro presenza all’interno del film Two Laws (Due leggi, 1981), in cui prendono decisioni su ogni cosa, dal soggetto all’obiettivo della cinepresa, attraverso il dialogo con il popolo aborigeno, il cui tentativo di riconquista della terra d’origine è l’argomento chiave del film.
In and Out of Africa. Wendy Engel, proprietaria di una galleria, esamina i manufatti di Gabai Barré per poi venderli nel suo negozio. Gran parte dell’interesse di questo film è incentrato sul modo in cui gli oggetti acquisiscono nuovi significati e valori quando attraversano i confini culturali. Barré ha un ruolo fondamentale, ma in quest’ambito solitamente sottinteso. Il desiderio di lasciare che i registi ricavino significati e valori originali dalla sua attività rende Barré determinante per la realizzazione del film.
Un test di verifica di questi problemi etici è il principio del “consenso informato”. Questo principio – frequentemente utilizzato in antropologia, sociologia, sperimentazione medica e in altri campi – afferma che i partecipanti a uno studio dovrebbero essere informati delle possibili conseguenze del loro coinvolgimento. Per esempio, invitare qualcuno a partecipare a un esperimento medico con un nuovo farmaco senza dirgli che la sostanza ha effetti collaterali potenzialmente pericolosi, che potrebbe non essere una cura
efficace e che potrebbe essere o non essere un placebo, è una infrazione dell’etica medica. Il soggetto potrebbe acconsentire a partecipare perché non può permettersi la medicina vera, per esempio, ma non può dare un consenso informato senza una spiegazione coscienziosa del progetto e dei rischi dell’esperimento.
Il trionfo della volontà (di Leni Riefenstahl, 1935). A differenza di The City, Il trionfo della volontà celebra il potere delle masse riunite e coreografate. Il movimento coordinato delle truppe e il ritmo della colonna sonora comunicano chiaramente che questi cittadini non provano alienazione, ma esaltazione.
Invitare qualcuno a partecipare a un film riguardante la sua famiglia, la disoccupazione e le possibilità di essere romantici nell’era nucleare (come descritto da Ross McElwee in Sherman’s March), o seguire qualcuno attraverso la procedura di un lifting facciale come Michael Rubbo con Daisy, pone un problema dai termini meno netti. Di quali conseguenze o rischi dovrebbero essere avvisati i soggetti? Fino a che punto il regista può rivelare con sincerità le sue intenzioni, o anticipare gli effetti di un film quando alcune di quelle intenzioni sono inconsce e molti di quegli effetti sono imprevedibili? Obedience, lo straordinario documentario di Stanley Milgram, rappresenta una notevole eccezione a questa prospettiva. Il film è un resoconto espositivo di esperimenti che Milgram condusse a Yale, nei quali alcuni soggetti ignari
acconsentirono a “testare” la memoria di altri soggetti. Se lo “studente” falliva, il soggetto target doveva somministrargli una scossa elettrica. Ogni errore portava a una scossa più forte, fino a includere livelli segnati con le specifiche “Scossa molto pericolosa” e “Letale”. Dopo che ciascun soggetto somministrava il livello più forte di scossa o si rifiutava di continuare prima di arrivare al punto estremo, chi conduceva gli esperimenti rivelava che le scosse non arrivavano mai a toccare lo studente e che il secondo soggetto era complice dell’inganno. Non era, in realtà, un test sulla memoria, ma sulla disponibilità delle persone a obbedire agli ordini in un dato contesto.
Two Laws (Carolyn Strachan e Alessandro Cavadini, 1981). Le riprese dall’alto e l’utilizzo di lenti a grandangolo che mostrano la relazione spaziale tra gli individui e la presenza visibile del sound recorder (uno degli attori sociali) sono tutte decisioni che rendono esplicita la collaborazione tra il regista e i suoi soggetti. Per gentile concessione di Facets Multimedia.
Milgram stesso rimase sconvolto da quante persone dimostrarono piena accondiscendenza all’ordine di continuare a dare le scosse elettriche. I risultati dei suoi test hanno suscitato un grande dibattito sul tema dell’obbedienza. Si è notato molto meno il fatto come l’esperimento richiedesse che il soggetto target non conoscesse il vero scopo dell’esperimento stesso. Il piano prevedeva che fosse negata la possibilità di un consenso veramente informato. Milgram
stesso non cercò di difendere la sua scelta nelle successive discussioni – non pensava che così tanti sarebbero andati così oltre e perciò non aveva pensato che sarebbe emerso il problema del consenso informato. L’esperimento, e di conseguenza il film, rimane un esemplare avvertimento in materia di etica. Nel 2002 Alex Gibney ripropone il lavoro di Milgram in The Human Behavior Experiments (Esperimenti sul comportamento umano, 2006), sull’esperimento carcerario di Stanford negli anni Settanta, durante il quale alcuni studenti vennero divisi fra prigionieri e guardie solo per vedere come la brutalità e il sadismo esplodessero fino a eccessi sconvolgenti, e su altri esperimenti dello stesso genere. Gibney collega le sue scoperte a eventi di storia recente, come la pratica della tortura condotta ad Abu Ghraib nel 2004 dalla polizia militare e dalla Cia, o come la spietata condotta della Enron, raccontata in Enron - L’economia della truffa, che deliberatamente alterò la fornitura di energia elettrica nello stato della California. Anche Errol Morris, in Standard Operating Procedure (2008), indagò le conseguenze dell’obbedienza all’autorità attraverso una serie di interviste con alcuni membri della polizia militare che “ammorbidivano” i prigionieri in vista degli interrogatori. Questi poliziotti, ma non i reali torturatori né i più alti ufficiali, furono inquisiti e condannati alla reclusione.
Obedience (Copyright 1968 di Stanley Milgram, rinnovato nel 1993 da Alexandra Milgram e in distribuzione presso Penn State Media Sales). Questa immagine presenta un soggetto ignaro che crede di svolgere un esperimento che prevede la trasmissione di scosse elettriche a uno “studente”. La scossa non arriva mai ma il soggetto non lo sa. Il linguaggio del corpo messo in atto da molti soggetti suggerisce estremo disagio e angoscia anche se molti di loro negano di essere stati coinvolti emotivamente da ciò che dovevano fare. Permesso di pubblicazione concesso da Alexandra Milgram.
La problematica relativa alla possibilità che il consenso informato possa essere negato ci porta a considerare il tema dell’inganno. Che cos’è una pratica ingannevole? È accettabile fingere interesse nei risultati di un’azienda per acquisire prove delle sue carenze nel campo della sicurezza? È appropriato filmare degli atti illegali (come l’uso di cocaina o il furto di auto) per fare un documentario su un uomo d’affari di successo ma sotto stress o sulle gang urbane? Quali obblighi hanno i registi di documentari nei confronti dei loro soggetti, per quello che riguarda il pubblico o la loro idea di verità? È giusto far sembrare sciocca Miss Michigan chiedendole le sue opinioni sulle condizioni economiche locali, allo scopo di mostrare l’irrilevanza dei concorsi di bellezza rispetto al danno causato dalla chiusura delle fabbriche automobilistiche di Flint, come fa Michael Moore in una scena di Roger & Me?
No Lies (di Mitchell Block, 1973). La troupe in azione. In No Lies, una persona riprende il film che noi vediamo. In questo caso possiamo chiederci se siamo stati ingannati, quando ci rendiamo conto che l’uomo che riprende non è il regista. D’altra parte, possiamo decidere che Mitchell Block ha fatto bene a scegliere attori per recitare nei ruoli del regista e della protagonista, data la natura fortemente invadente delle sue domande.
Un altro esempio concreto di questi problemi riguarda una scena di Hoop Dreams in cui i registi vanno con Arthur Agee in un campo da gioco del quartiere. Arthur è uno dei due ragazzi protagonisti del film il cui sogno è arrivare nell’Nba. Mentre Arthur si allena in primo piano, la cinepresa riprende sullo sfondo suo padre che spaccia droga. I registi avrebbero dovuto includere questa scena nel montaggio finale? Non si comprometteva l’immagine del signor Agee o non si rischiava di diffondere prove legali contro di lui? Per trovare risposta a queste domande, i registi hanno interpellato i loro avvocati, che hanno reputato il dettaglio nell’immagine insufficiente per essere accettato come prova in un tribunale. Hanno inoltre discusso la faccenda con la famiglia Agee, pronti a rimuovere la scena nel caso qualcuno di loro l’avesse voluto. Invece la famiglia, incluso il signor Agee, ha deciso di tenerla: il signor Agee è stato in seguito arrestato per spaccio di stupefacenti, un
fatto che lo ha trasformato, dopo la scarcerazione, in un padre molto più responsabile. Secondo lui, quella scena avrebbe contribuito a sottolineare drammaticamente la sua crescita nel tempo come genitore. Poiché molti registi agiscono come rappresentanti di coloro che filmano o che sponsorizzano il loro film, e non come membri della comunità, sorgono spesso tensioni tra il desiderio del regista di creare un film interessante e quello dell’individuo di mantenere intatti i propri diritti sociali e la dignità personale. Il film di Mitchell Block No Lies esprime molto chiaramente questo punto di vista. La pellicola è ambientata interamente all’interno dell’appartamento di una donna che il regista va a trovare con la sua cinepresa a mano. Il regista chiacchiera con lei con noncuranza mentre continua a filmare, come se si esercitasse con la tecnica di ripresa, finché una domanda qualsiasi rivela un evento traumatico: la ragazza è stata recentemente violentata. Cosa deve fare il regista? Fermare la ripresa e consolarla da amico? Continuare a riprendere e fare un film che può darci una migliore comprensione di questo tipo di crimine? Il regista sceglie di continuare a filmare. Le sue domande investigano sempre più nel profondo e nel personale. Egli esprime dei dubbi sul fatto che lo stupro sia addirittura avvenuto, causando notevole angoscia alla donna. Alla fine del cortometraggio, il regista sembra rendersi conto di avere osato troppo e accetta di smettere di filmare. Come reagiamo al comportamento dell’uomo? Il film di Block sembrerebbe un’opera grottesca e insensibile, se fosse davvero Mitchell il regista e se gli eventi fossero completamente veri. Ma No Lies agisce più o meno come Las Hurdes; e come lo straziante film belga C’est arrivé près de chez vous (È successo vicino a casa vostra, 1992), nel quale una troupe di documentaristi sembra divenire complice degli atti criminosi di un delinquente, la cui vita essi intendono documentare. Questi film servono a mettere in dubbio le convinzioni del pubblico riguardo alla rappresentazione documentaristica. Essi indagano cosa accade quando un’osservazione distaccata si trasforma in un profondo stato di disagio.
Block attua un inganno ben calcolato per dimostrare il suo punto di vista: dai titoli di coda capiamo infatti che i due protagonisti sono, in realtà, attori professionisti e che la loro interazione non era spontanea ma derivava da un copione. No Lies funziona da meta-commento sull’atto stesso del riprendere, poiché suggerisce che anche noi, come spettatori, siamo messi in una posizione simile a quella della donna: anche noi siamo vittime della manipolazione e degli stratagemmi del regista, e possiamo sentirci sconvolti e turbati da essi. Siamo turbati non solo dall’interrogatorio aggressivo che la donna subisce sullo schermo, ma anche dal fatto che il regista non mette in scena il film come un lavoro di fiction con attori scritturati. Il film diventa, in un certo senso, un secondo stupro, una nuova forma di abuso, se lo spettatore si sente abbindolato o usato, ma l’inganno può anche dare un notevole senso di sollievo. No Lies rappresenta un’importante dichiarazione in merito alla possibilità di commettere abusi che ha un documentario, che trasforma le persone in vittime per far sì che gli spettatori vengano a conoscenza, in maniera voyeuristica, delle loro sofferenze e miserie. Le questioni etiche nascono spesso in relazione alla domanda su come si fa a trattare le persone in modo etico, per via del grado di separazione tra il regista e coloro che riprende. Il regista controlla la macchina da presa e di conseguenza possiede un potere che gli altri non hanno. Inoltre, i registi, in modo particolare di reportage giornalistici, appartengono a organizzazioni e istituzioni con standard e tecniche propri. Persino quelli indipendenti si reputano di solito artisti professionisti in carriera e non individui dediti a rappresentare gli interessi di determinati gruppi o elettori. Heidi Ewing e Rachel Grady, coregiste di Jesus Camp, nel loro commento fuori campo incluso nell’edizione Dvd del film descrivono la figura centrale del loro documentario, la fondamentalista Becky Fischer, come «un grande soggetto documentaristico» per via del suo carisma. Il suo fascino risiede nella sua convinzione e motivazione. Il fatto che Becky professi una serie di credo fondamentalisti altamente discutibili non è qualcosa che le registe mostrano di voler attaccare o difendere. Quello che interessa loro è fare un buon
film e chiaramente hanno valutato il fatto che avere a disposizione una persona così carismatica avrebbe conferito all’opera una notevole potenza: il carisma, virtualmente, garantisce il coinvolgimento del pubblico anche se la natura propria di quel coinvolgimento può spaziare da riverenza a repulsione. Le registe lasciano decidere al pubblico come reagire agli sforzi della signora Fischer per trasformare ragazzi e ragazze in devoti fondamentalisti. Si danno infatti abbastanza da fare per non svalutare né avallare ciò che la donna dice. Tale approccio fa sì che i fondamentalisti, compresa Becky Fischer, abbiano la sensazione che il film li rappresenti accuratamente, mentre chi contesta tali visioni e pratiche religiose vi trovi considerevole materia di preoccupazione. In questo caso, le registe adottano un distacco professionale dalle questioni che affrontano. L’etica non deve prendere posizione a favore o contro i valori o le convinzioni degli altri, né agire in modo da negare il rispetto dei soggetti o minare la fiducia degli spettatori. Allo stesso modo, alcuni film come Las Hurdes e No Lies ci ricordano che questi valori possono comunque essere messi in discussione. Sviluppare un senso di rispetto etico diventa una parte fondamentale della professionalità del regista di documentari.
Registi, persone, spettatori “Come dovremmo trattare le persone che filmiamo?” è una domanda che fa anche venire in mente i vari modi con cui i registi possono scegliere di rappresentare gli altri. Come dovremmo relazionarci fra di noi e quanto la presenza della macchina da presa cambia le regole del gioco? Forme molto diverse di alleanza possono prendere vita all’interno del triangolo regista, soggetti o attori sociali, e pubblico o spettatori. Un modo semplice per immaginare questa interazione è una formulazione sintattica della relazione triangolare. Vari tipi di formulazioni ricorrono frequentemente nei documentari. La formulazione più classica è: Io parlo di loro a voi.
Io. Il regista prende una forma personale, sia direttamente sia attraverso un surrogato. Un tipico surrogato è il narratore onnisciente, la voce che sentiamo fuori campo ma non vediamo mai. Questo surrogato vocale anonimo è nato negli anni Trenta come espediente con cui descrivere una situazione o un problema, presentare una questione, proporre una soluzione e talvolta dare un tono o un’ambientazione poetici. Film come Song of Ceylon e Night Mail hanno descritto, rispettivamente, la cultura cingalese e il servizio postale britannico con dei toni poetici che hanno reso la trasmissione di informazioni secondaria rispetto alla costruzione di un ritratto lusinghiero e, in qualche modo, romanzato. La voce onnisciente e una similmente autorevole – qualcuno che vediamo e sentiamo parlare a nome del film, come i corrispondenti sul campo di Harvest of Shame, che registrano le condizioni dei lavoratori agricoli migranti, o Roger Mudd in The Selling of the Pentagon, che investiga sulle attività della macchina delle pubbliche relazioni del Pentagono, o Wynton Marsalis in Jazz (2000), che ci mostra la sua personale lettura della storia del jazz negli Stati Uniti – sono tuttora delle caratteristica principali del film documentaristico (e anche dei notiziari televisivi). Un’altra possibilità è che sia lo stesso (o la stessa) regista a parlare; o di fronte alla cinepresa, come in Sherman’s March e Roger & Me, o fuori campo e mai inquadrato, come in La sottile linea blu e Nobody’s Business (1996), il film che Alan Berliner ha realizzato sul suo irascibile ma amato padre. In questi casi, oltre che autore, il regista diventa un personaggio all’interno del suo stesso film. Il personaggio può avere uno sviluppo minimo, come nel caso di La sottile linea blu, dove si sa molto poco di Errol Morris, oppure essere riccamente sviluppato, come in Roger & Me, dove il regista Michael Moore interpreta un ficcanaso con il pallino del sociale che farà tutto il possibile per indagare a fondo su pressanti questioni sociali, un personaggio poi presente in altri suoi lavori: TV Nation (1994), Bowling a Columbine (Bowling for Columbine, 2002), Fahrenheit 9/11, Sicko e Capitalism: a Love Story (2009).
Parlare in prima persona spinge la forma documentaria verso quella del diario e del saggio, e verso aspetti di film e video d’avanguardia o sperimentali. L’enfasi può essere sul convincere il pubblico di un particolare punto di vista o approccio a un problema, ma anche sul mostrare una visione personale e chiaramente soggettiva dei fatti. Dalla persuasione, l’enfasi può essere trasposta all’espressione. Ciò che viene espresso sono il punto di vista e la visione personale del regista. Questa espressione resta tuttavia collegata a rappresentazioni del mondo sociale in cui viviamo proposte agli spettatori. Molti esempi del “nuovo giornalismo” (per esempio Slouching toward Las Vegas di Hunter Thompson) e della regia dei documentari che ne è stata influenzata (come il lavoro di Michael Rubbo e quelli di Michael Moore) hanno posto l’accento su questa combinazione di una voce personale o insolita con la descrizione di un particolare argomento. Parlo di. Il regista rappresenta gli altri. L’idea di parlare di un determinato argomento o di una persona dà all’intento un’aria di importanza civica. Parlare di qualcosa può voler dire raccontare una storia, creare un’atmosfera poetica o costruire una narrazione, come per esempio la storia del recapito della posta o di come Nanuk riesca a trovare cibo per la sua famiglia; indica però anche il desiderio di dare informazioni, basarsi su fatti e mostrare un’opinione sul mondo in cui viviamo. Paragonata a “Quale storia racconterò?”, la domanda “Di che cosa parlerò?” indirizza il nostro interesse verso la sfera pubblica e l’atto di parlare ad altre persone di un argomento di interesse comune. Non tutti i documentari adottano questa impostazione, ma si tratta comunque di una delle strutture più comuni per un film documentario. Loro. Il pronome in terza persona indica una separazione tra chi parla e il soggetto. L’io parlante è diverso da coloro di cui parla. Come pubblico, percepiamo che i soggetti del film sono mostrati per essere esaminati e identificati da noi. Possono essere ritratti come individui dalla personalità ricca e complessa, una tendenza che si nota soprattutto all’interno dei documentari osservativi (discussi nel Capitolo 7), ma in altrettanti casi ci vengono mostrati come illustrazioni o esempi, prove di una situazione o di un evento che è avvenuto
nel nostro mondo. Può sembrare riduttivo, ma può avere risultati molto efficaci. I documentari degli inizi, precedenti alla nascita delle modalità osservativa e partecipativa nei primi anni Sessanta, si fondavano quasi interamente sull’utilizzo di individui come esempi o illustrazioni. L’impossibilità di registrare l’audio in sincrono incoraggiò a trattare le riprese di persone specifiche come esempi di situazioni universali. In alcune occasioni tali individui assumono un significato simbolico, come nel caso di Rodney King, il cui pestaggio da parte della polizia di Los Angeles a uno stop stradale venne registrato da una videocamera. Il signor King non emerge come un personaggio ben definito nel filmato, che ebbe una vasta visibilità nelle news e altrove. Ma rappresenta un simbolo della brutalità della polizia e del razzismo delle istituzioni. La forza d’impatto di quel filmato nasce dalla sua crudezza e dalla presupposta autenticità, e non dalla profondità dei personaggi in esso ritratti. Persino in questi casi, “loro” rimangono a una certa distanza, e non ci vengono mostrati con la stessa complessità che potremmo trovare in una fiction. Secondo alcuni, in un documentario questo aspetto riduce il piacere della visione; per lo meno, ci suggerisce di guardare altrove se desideriamo una rappresentazione documentaria soddisfacente. A voi. Come “loro”, anche “voi” implica una separazione. Una persona parla e altre ascoltano. Un regista parla e il pubblico segue. Da questo punto di vista, il documentario appartiene a un discorso o a una struttura di tipo istituzionale. Persone con un dato tipo di abilità, i registi di documentari, si rivolgono a noi. Ci riuniscono momentaneamente nella forma di un “voi”. In quanto parte del pubblico, siamo solitamente separati sia dall’atto che dall’argomento della rappresentazione. Ci poniamo in un tempo e in uno spazio sociali diversi da entrambi; in quanto spettatori e membri del pubblico, possediamo un ruolo e un’identità propri che distinguono in partenza la nostra figura sociale: seguiamo il film da spettatori e carichiamo questo ruolo di specifiche convinzioni e attese. Anche “loro” possono essere mariti, mogli, avvocati, consulenti, studenti, atleti, professionisti e viaggiatori come noi, e le loro azioni possono rivelarsi per noi più istruttive di quelle che vediamo nelle fiction. Possiamo
fare a meno di chiederci se le reclute dell’esercito sono come Demi Moore in Soldato Jane (G.I. Jane, di Ridley Scott, 1997): ci basta vedere le vere reclute nel documentario di Joan Churchill e Nick Broomfield Soldier Girls o in quello di Fred Wiseman Basic Training (Addestramento di base, 1971). Dagli eventi drammatici in Soldato Jane possiamo trarre analogie sul comportamento umano, ma dagli eventi reali mostrati in Soldier Girls e Basic Training possiamo trarre conclusioni. “Voi” innesca la nostra reazione di pubblico quando il regista sembra rivolgersi effettivamente a noi, quando il film cerca di raggiungerci in qualche modo. Senza questo senso di partecipazione, potremmo vedere un film ma non seguirlo attivamente. I registi devono trovare un modo di farci sentire chiaramente sia coloro a cui si rivolgono (nel descrivere un fatto o una persona) sia parte di un gruppo o di una comunità, un pubblico per cui questo argomento è importante. Il modo tipico per ottenere questo effetto è l’uso di abilità retoriche (che saranno affrontate nel Capitolo 4). La retorica è la forma di discorso utilizzata per persuadere o convincere gli altri di un determinato argomento, per il quale non esiste una risposta univoca e ben definita. Nei processi giuridici, l’innocenza e la colpevolezza dipendono spesso non solo dalle prove, ma dalla capacità di rendere verosimile una loro interpretazione. Il processo di O.J. Simpson ne è stato un chiaro esempio: nonostante la notevole quantità di prove incriminanti, gli avvocati della difesa hanno sostenuto con efficacia che potevano essere state contraffatte, e quindi la loro validità era in dubbio. Il verdetto finale è fuori dalla giurisdizione di scienza, poesia e narrativa: nasce dall’arena della competizione retorica, nella quale opera anche la maggior parte dei documentari. Le sang des bêtes (Il sangue delle bestie, 1949) di Georges Franju, per esempio, usa l’ironia e le immagini surreali per dimostrare quanto sia bizzarro il macello dei bovini nella Francia degli anni Quaranta, in modo da farci apprezzare il consumo di carne. Meat (Carne, 1976) di Frederick Wiseman, invece, osserva le attività di un macello del Midwest, nell’America degli anni Settanta, per mostrarci la natura ripetitiva delle interazioni umane tra lavoratori e supervisori,
tra uomini e animali. Wiseman concentra l’attenzione sul problema della classe operaia, Franju sulla dimensione mitica e rituale. Wiseman descrive i lavoratori come tipici salariati in un contesto di gestione aziendale, Franju li dipinge come figure mitiche che compiono imprese sbalorditive. In entrambi i casi, sono state utilizzate delle precise scelte retoriche e stilistiche per attivare la reazione del pubblico in specifiche direzioni. Io parlo di loro a voi può essere la formulazione più semplice del rapporto triangolare tra regista, soggetto e pubblico, ma non è certamente l’unica. Si potrebbe fare una tabella con tutte le variazioni di pronomi all’interno di questa frase. Ogni variazione comporta una diversa serie di implicazioni per il rapporto tra regista, soggetto e pubblico. Ecco alcune delle più importanti: Esso parla di loro (o di ciò) a noi. Questa formulazione mette a nudo un senso di separazione, se non addirittura di alienazione, tra la voce narrante e il pubblico. Il film o il video sembra essere indirizzato a noi da parte di una fonte priva di individualità. Si rivolge inoltre a un soggetto che è similmente diverso da noi, pur essendoci in qualche modo vicino. Questa formulazione caratterizza quello che potremmo chiamare un “discorso istituzionale”, in cui il film, spesso attraverso un commento fuori campo, magari anche un classico commentatore onnisciente dalla voce maschile e profonda, ci informa di alcuni aspetti del mondo in modo impersonale ma autorevole. I soggetti o attori sociali rappresentati sono di solito esempi di una situazione o condizione generale. The City, per esempio, affronta il problema della povertà urbana, della decadenza e dell’alienazione come “ciò”: argomenti astratti di interesse generale. Le persone mostrate servono a illustrare il punto di vista del film: le nuove metropoli devono assumere le caratteristiche delle cittadine di provincia piuttosto che quelle delle periferie urbanizzate. Gli spettatori non arrivano a conoscerne nessuna in maniera individuale. L’effetto è convincente, non necessariamente distaccato o freddo, ma mantiene un’aura di discorso istituzionale.
The City, e anche altri film a esso similari, sembrano parlare a “noi”, ma si rivolgono a un pubblico indifferenziato. Noi dovremmo seguire il film poiché abbiamo bisogno di informarci su quel dato argomento. I film informativi e i messaggi pubblicitari, compresi i trailer dei film in uscita, hanno spesso questa struttura. The River, per esempio, non solo usa un commentatore maschile dalla voce stentorea, ma fa sempre riferimento a quello che “noi” abbiamo fatto alla terra e come “noi” possiamo cambiare le cose, nonostante le persone a cui si riferiva all’epoca della sua uscita, nel 1938, fossero molto diverse dal pubblico di oggi. Il film vuole che tutti ci prendiamo la responsabilità di occuparci dell’erosione del suolo e del controllo delle inondazioni. Film di questo genere non sembrano provenire da alcun luogo in particolare. Non sono opere di un individuo che chiameremmo regista; spesso non lo sono neanche di un’istituzione ben identificabile, come la Cnn News e i suoi rappresentanti (annunciatori, reporter, intervistati). Arrivano a noi come le parole di un “esso” che resta impersonale e non identificabile. (“Esso”, per esempio, potrebbe essere la comunità scientifica, il mondo medico, il governo o l’industria pubblicitaria.) Questo “esso” parla a un “noi” che può essere l’intera collettività o più spesso una fetta demografica. Tali lavori forniscono informazioni, assegnano valori o invitano all’azione per farci trovare un senso di comunità all’interno di una struttura che può essere sobriamente concreta o densa di emozioni, ma che raramente riesce a essere qualcosa di più di una rappresentazione statistica, generica o astratta di un “noi”. Io (o noi) parlo (parliamo) di noi a voi. Questa formulazione sposta il regista da una posizione di separazione rispetto alle persone che rappresenta a una di aggregazione con loro. Il regista e il soggetto sono simili. Nel cinema etnografico questo tipo di formulazione viene chiamata “auto-etnografia”: un riferimento ai tentativi delle popolazioni indigene di girare film e video sulla loro cultura in modo da mostrarla a “noi”, gli spettatori esterni. Gli indiani Kayapo del Rio delle Amazzoni sono stati incredibilmente attivi in questa pratica, usando i loro video per convincere i politici brasiliani
ad attuare piani di protezione della loro terra contro lo sviluppo e lo sfruttamento. Spesso, il senso di comunità si basa sulla rappresentazione della famiglia. Alan Berliner, per esempio, ha girato due film eccezionali su suo nonno e su suo padre: rispettivamente, Intimate Stranger (Intimo estraneo, 1992) e Nobody’s Business. Tarnation, di Jonathan Caouette, è un ritratto familiare intensamente personale. Il documentario confina con l’arte-terapia nel momento in cui, raccontando la storia della discesa verso la follia della madre, provocata dagli errori di genitori e parenti, rappresenta l’opportunità per il regista di riconciliarsi con lei. Marlene Booth ha fatto un film affascinante sull’esperienza di ebrei assimilati vissuta dalla sua famiglia nell’Iowa, Yidl in the Middle (Yidl nel mezzo, 1998). Dopo aver scoperto in età adulta che suo padre era ebreo, Lisa Lewenz è andata in Europa per capire come la sua famiglia ha vissuto nella Germania degli anni Trenta, come racconta nel documentario Letter Without Words (Lettera senza parole, 1999). Nel film Finding Christa (Trovare Christa, 1991), che unisce momenti inscenati e rappresentazioni documentaristiche, Camille Billops racconta che cosa è successo quando ha ritrovato la figlia, ormai cresciuta, che aveva dato in adozione. Parlando di un “noi” che comprende anche il regista, questi film possono raggiungere un notevole livello di intimità. Uno degli esempi più singolari dell’uso della voce in prima persona all’interno di un documentario si trova nello straordinario video di Marlon Riggs Tongues Untied. In quest’opera Riggs racconta che cosa significhi essere un uomo di colore gay in una sottile fusione di “parlo di noi a voi” e “parlo di me stesso a voi”, formulazioni che mettono in rilievo i collegamenti tra esperienza personale e collettiva. Davanti alla videocamera e fuori campo, Riggs e altri attori sociali parlano delle loro esperienze di omosessuali di colore. Alcuni recitano delle poesie, altri raccontano storie, altri riproducono delle scene. Non si tratta delle solite voci autorevoli: queste voci non sono state spogliate della loro identità etnica o delle loro peculiarità nel parlare per avvicinarle alla norma che richiede una voce standard e priva di accento. Al contrario,
l’inflessione e il ritmo, la cadenza e lo stile contribuiscono al potere della percezione individuale e alla forza dell’espressione personale che rendono Tongues Untied una delle pietre miliari della produzione documentaristica. Queste diverse formulazioni del rapporto tra chi parla, soggetto e pubblico servono a spiegare la posizione adottata dal regista nei confronti delle persone rappresentate nel film e di quelle a cui il film si rivolge. Si tratta di una posizione che richiede un certo grado di negoziazione e di consenso. Il risultato fornisce una qualche valutazione del rispetto concesso agli altri, anche in caso di disaccordo, e della fiducia stabilita con il pubblico. I segni di fiducia e rispetto rappresentano una prova delle considerazioni etiche che sono entrate nel progetto del film, riconoscendo che alcuni film deliberatamente sfideranno o sovvertiranno quei valori. Queste formulazioni suggeriscono il tipo di relazione che gli spettatori dovrebbero avere con il film suggerendo il tipo di relazione che dovremmo avere con il regista e i suoi soggetti. Chiederci che cosa fare con le persone in un film documentaristico vuol dire anche chiederci che cosa fare con il regista e il pubblico, oltre che con i soggetti. I presupposti sul tipo di relazione che dovrebbe esserci fra i tre sono così importanti da determinare il tipo di film o di video documentaristico risultante, la qualità della relazione con i soggetti e l’effetto che avrà sul pubblico. I presupposti, come vedremo, cambiano notevolmente, ma la domanda soggiacente “Cosa dobbiamo fare con le persone” rimane una questione fondamentale per gli aspetti etici del cinema documentaristico.
CAPITOLO 3 DA DOVE PRENDONO LA VOCE I DOCUMENTARI? Le caratteristiche della voce Si può dire che i documentari parlino degli aspetti, dei problemi, delle qualità e dei conflitti di questo mondo attraverso suoni e immagini. La questione del discorso si collega a quella della “voce”, ma cercare e avere una voce ha maggiori implicazioni rispetto all’uso di parole riportate. Quando un documentario “parla di” qualcosa, quando “noi parliamo di qualcosa a te”, per esempio, esso parla attraverso la composizione delle riprese, l’unione delle immagini nel montaggio e l’uso della musica, tra le altre cose. Tutto ciò che noi vediamo e ascoltiamo non rappresenta solo la realtà storica, ma anche il modo in cui chi ha realizzato il film vuole parlare di quella realtà. Proprio come l’oratore, che usa il suo intero corpo per dare voce a un punto di vista particolare, i documentari parlano attraverso tutti i mezzi a loro disposizione. Le questioni del “discorso” e della voce non vanno prese completamente alla lettera. La parola, ovviamente, ha un ruolo molto importante in numerosi film e video documentari: alcuni, come Portrait of Jason (Ritratto di Jason, 1967), Word Is Out (1977) o Shoah, a un primo sguardo possono sembrare costituiti essenzialmente dal parlato. Quando Jason ci racconta la sua vita in Portrait of Jason, un modo per comprendere meglio le sue parole è quello di interpretare le sue inflessioni, i suoi gesti e il suo comportamento, compreso il suo modo di interagire con la regista Shirley Clarke nei dialoghi da lei condotti. E quando i gay e le lesbiche in Word Is Out o le persone intervistate in Shoah parlano del loro passato, un aspetto molto importante per capirne la forza e la gravità è vedere gli effetti che quel passato ha sul loro modo di parlare e agire nel presente. Anche i documentari composti per lo più da “parlato” (i cosiddetti film di “teste parlanti”) esprimono dei significati, alludono a dei fatti e sanno formulare opinioni su molti più livelli che il
senso letterale di quello che viene detto. Che cosa significa, quindi, sollevare la questione della voce nel documentario? Nel Capitolo 1 abbiamo detto che i documentari rappresentano la realtà storica dando una forma ascoltabile e visibile “a una maniera di vedere la realtà in modo diretto invece che allegorico-finzionale”. In quanto tali, diventano una tra le tante voci che danno forma al nostro mondo, come gli storiografi, i leader politici o religiosi, gli urbanisti. Nel loro complesso, queste voci si ritrovano nell’arena dei dibattiti e delle contestazioni sociali, un’arena che in alcuni casi viene definita spazio pubblico. Il fatto che i documentari non sono una riproduzione della realtà dà loro una voce propria. Essi sono, al contrario, una rappresentazione del mondo. La voce del documentario ci rende consapevoli che qualcuno ci sta parlando dal suo punto di vista del mondo in cui viviamo insieme con quella persona. La voce del documentario può fare affermazioni, proporre punti di vista ed evocare sentimenti. I documentari cercano di persuaderci o convincerci attraverso la rilevanza dei loro argomenti e punti di vista e attraverso il richiamo o la forza della loro voce. La voce del documentario è il modo specifico in cui viene espresso un punto di vista o un argomento. Lo stesso argomento o punto di vista può essere espresso in modi diversi. Per esempio, “La libertà di scelta è fondamentale per le donne che devono decidere se abortire o no”: questo è un argomento, o punto di vista. Tuttavia, un documentario può adoperarsi attivamente per rappresentare che cosa provano le donne in una situazione del genere, come in Speak Body (Il corpo parla, 1987), in cui viene presentato un certo numero di voci di donne fuori campo mentre sullo schermo si vedono frammenti di corpi femminili; oppure, può basarsi su interviste di donne provenienti da Paesi diversi per sottolineare il differente impatto sociale che deriva dalla possibilità o dalla proibizione dell’aborto, come in Abortion Stories: North and South (Storie di aborti: Nord e Sud, 1984), in cui sono mostrate numerose donne, provenienti da diverse nazioni dell’America del Nord e del Sud, che raccontano alla macchina da presa le loro esperienze. Speak Body e Abortion Stories: North and South trattano lo stesso argomento, ma lo
propongono da punti di vista nettamente diversi e, quindi, con voci distintamente differenti. L’idea di una voce è anche collegata a quella della logica informativa che sovrintende la struttura di un documentario, simile alla trama intrigante che controlla la struttura di un film di fiction. Pur non essendo reciprocamente esclusive, si ha l’idea che una logica informativa, espressa da una voce distinta, abbia un ruolo dominante all’interno del documentario, allo stesso modo in cui una trama interessante, espressa da uno stile distinto, ne ha uno all’interno della fiction narrativa. La voce, quindi, esprime come la logica e il punto di vista di un film ci vengono trasmessi. La voce di un documentario è chiaramente correlata allo stile di un film: entrambi si basano sulla stessa tecnica cinematografica (montaggio, parlato, musica originale e non, fotografia e così via), ma nel documentario funzionano in maniera un po’ diversa rispetto alla fiction. Lo stile agisce in modo differente a seconda che si tratti di film documentari o di fiction. L’idea di una voce di un documentario ci suggerisce come ricavare un significato dal fatto che il film si rivolge a noi in quanto spettatori con un posizionamento preciso nella società e parla della nostra realtà condivisa. Lo stile in un film di fiction ci da invece l’idea di come un regista costruisca un mondo diverso dal nostro, nel quale entriamo senza essere direttamente interpellati. In un film di finzione non ci sentiamo chiamati in causa da una voce, al contrario, la storia si sviluppa per conto proprio: in quanto spettatori vediamo e sentiamo quello che succede dall’esterno. Mentre lo facciamo, sviluppiamo varie forme di coinvolgimento emotivo con questo mondo di finzione. La voce del documentario, d’altra parte, prende corpo dal tentativo del regista di tradurre il suo punto di vista sul mondo reale in termini audiovisivi; essa ha origine dal suo diretto coinvolgimento con il soggetto del film. La voce, in altre parole, attesta il modo in cui il regista entra in contatto con la realtà storica nel processo di realizzazione di un film. Questo porta con sé una componente etica, nelle modalità di cui abbiamo già discusso nel Capitolo 2. La voce è una misura di come il regista reagisce e parla del mondo che condivide con noi spettatori. Se lo stile della finzione ritrae
una realtà distinta e immaginaria, di creazione del regista, la voce del documentario rappresenta il modo in cui il regista entra in contatto con la realtà storica stessa. Quando Robert Flaherty filma Nanuk che morde un disco perché non capisce che cosa sia quello strano oggetto che produce suoni, la forma, la durata e il posizionamento della ripresa – elementi basilari di stile – rivelano l’intenzione da parte del regista di burlarsi di Nanuk: l’eschimese usa “per sbaglio” la bocca invece delle orecchie. La fiducia e la collaborazione tra regista e soggetto può sembrare a rischio, soprattutto se vista attraverso gli studi postcoloniali, che hanno riscontrato la permanenza di un senso di gerarchia negli incontri tra persone di diverse culture. La voce del film lascia trasparire un tipo di rapporto con il mondo da parte del regista ignoto forse anche a lui. Essa parla da, e rivela, un punto di vista differente sul mondo. In un altro esempio, Jon Silver utilizza un piano sequenza all’inizio di Watsonville on Strike (Sciopero a Watsonville, 1989), un film sullo sciopero dei lavoratori di Watsonville, città situata sulle coste della California; durante questa sequenza, lo sentiamo discutere con il capo del sindacato sul permesso di continuare le riprese all’interno della sala. Questa scelta stilistica, che predilige il piano sequenza rispetto al montaggio, testimonia anche un bisogno essenziale: Silver deve negoziare, sul momento, il suo stesso diritto a essere presente e a filmare. Tutto è messo a rischio in un preciso lasso di tempo, che non può essere rappresentato in altro modo se non in questa forma molto diretta. Il piano sequenza è una registrazione di quel momento, visto attraverso il punto di vista letterale e politico di Silver, che ci viene gradualmente ma drammaticamente rivelato. Quando il capo del sindacato minaccia di fare cacciare Silver, egli reagisce con una panoramica verso i lavoratori ispanoamericani presenti alla scena e chiede loro, in spagnolo invece che nell’inglese con cui si rivolge al capo: «Che dite? Posso filmare?». La registrazione della loro risposta entusiasta, all’interno della stessa sequenza in cui è presente il rifiuto intransigente da parte del direttore di fornire il permesso, testimonia il desiderio di Silver di porsi come un attivista
corretto e disinteressato la cui lealtà si associa spontaneamente ai lavoratori e non ai rappresentanti del sindacato. Noi lo vediamo mostrare la sua lealtà quando sposta l’interesse della cinepresa dal sindacalista ai lavoratori, scegliendo di non tagliare su un’altra discussione in un altro luogo. Non smette di riprendere fino a quando il capo non punta il dito verso di lui e dice: «Se mi fai finire in televisione, ti faccio causa».
Watsonville on Strike (di Jon Silver, 1989). Nella scena d’apertura, il capo del sindacato indica, guardandola direttamente, la cinepresa in mano a Jon Silver. Questi momenti possono causare imbarazzo in un documentario osservativo puro o in un contesto di fiction. In questo caso, il confronto diretto tra il regista e il sindacalista sottolinea il ruolo attivo e partecipativo di Silver nel dare forma agli eventi. Quello che vediamo non sarebbe accaduto se la cinepresa, e il regista, non fossero stati lì.
La voce del film rivela il desiderio di Silver di mostrare la realtà del momento, invece che dare l’illusione che la macchina da presa e il regista non siano presenti. La sua voce, rappresentata tanto nel piano sequenza e nei movimenti della cinepresa quanto in quello che dice, mostra come egli presenti il suo argomento a sostegno della causa dei lavoratori. Simile allo stile, ma con un senso di veridicità etica e politica, la voce serve a dare concretezza al modo con cui il regista affronta il mondo.
La voce del documentario dà una testimonianza del regista, come per esempio Robert Flaherty o Jon Silver, e di come egli si comporta nei confronti della realtà sociale e della propria visione creativa. Lo stile acquista una dimensione etica. La voce del documentario fornisce un’idea di quale sia il punto di vista sociale del regista e di come questo si renda manifesto durante la realizzazione del film. Questa voce dice, chiaro e tondo, “Questo è come io scelgo di agire e fare film in relazione al mondo in cui viviamo: che cosa ne capisci?”. La voce del documentario non si limita soltanto alle voci di “divinità” invisibili o di “autorità” visibili che rappresentano il punto di vista del regista (che parla per il film), o a quelle di attori sociali che rappresentano i propri punti di vista (che parlano nel film). La voce del documentario parla con ogni mezzo a disposizione del regista. Questi mezzi possono essere riassunti come la selezione e la disposizione dei suoni e delle immagini, ovvero la creazione di una struttura logica. Vanno dunque prese le seguenti decisioni: 1. quando tagliare, o come montare, e che cosa giustapporre; 2. come inquadrare o comporre una ripresa (primo piano o campo lungo, inquadratura dal basso o dall’alto, illuminazione artificiale o naturale, colore o bianco e nero, se fare una panoramica, uno zoom avanti o indietro, un carrello o mantenere fissa l’inquadratura, e così via); 3. se registrare il suono in sincrono con le immagini, e se aggiungere in seguito ulteriori suoni, come traduzioni e voce fuori campo, dialoghi doppiati, musica, effetti sonori o un commento; 4. se aderire a una cronologia accurata o se riordinare gli eventi per supportare un significato o un’atmosfera; 5. se usare filmati o fotografie d’archivio o di altri autori, o solo le immagini riprese sul posto dal regista; 6. su quale modalità di rappresentazione basarsi per strutturare il film (espositiva, poetica, osservativa, partecipativa, riflessiva o performativa).
Categorie di voce
Quando rappresentiamo il mondo da un punto di vista particolare, lo facciamo con una voce che ha le stesse qualità di altre voci. Un modo per raggruppare tali qualità è usare le convenzioni di genere. Alcune di esse non sono specifiche del cinema, ma condivise anche con altri mezzi espressivi, come saggio, diario, appunti, editoriale, elogio, esortazione, descrizione o servizio giornalistico. (Queste categorie sono anche i titoli dei capitoli nell’interessante opera di Erik Barnouw sulla storia del film documentario – Documentary: A History of the Non-Fiction Film – in cui, tra le altre, ne elenca alcune come “reporter”, “difensore”, “accusatore” e “guerrigliero”.) Le altre convenzioni, come quelle che caratterizzano le varie modalità del documentario (per esempio, documentario espositivo e osservativo), sono specifiche di questo mezzo di comunicazione. Tale aspetto sarà approfondito nei Capitoli 6 e 7. Le forme e le modalità generiche stabiliscono alcuni dei termini che identificano la voce di un documentario, ma non la determinano completamente. Ogni voce mantiene una sua unicità, che nasce dall’uso specifico di forme e modalità, di tecniche e di stili all’interno di un dato film, e dal tipo specifico di incontro che avviene tra regista e soggetto. La voce di un documentario serve a evidenziare un punto di vista, un argomento o un incontro. Riconoscere il tono particolare con cui essa si rivolge a noi è un elemento chiave per comprendere che un dato film è un documentario.
Bontoc Eulogy (di Marlon Fuentes, 1995). Trovare una voce. Alla prima visione non capiamo che la persona seduta davanti al grammofono è il regista; non sappiamo neanche che i suoni “graffiati” presenti in scena diventeranno alla fine la voce del nonno del regista. Nel corso del film, Fuentes parte per il suo viaggio personale per scoprire di più su suo nonno e sull’incontro che egli ha avuto all’inizio del secolo scorso con l’antropologia coloniale. Con un insieme di filmati d’archivio, eventi inscenati (come questo) e con il suo stesso commento fuori campo, Fuentes dà al film una voce che recupera sia la storia della sua famiglia sia quella della popolazione filippina. Fotografia concessa dal regista.
Il fatto che la voce di un documentario utilizzi tutti i mezzi possibili, non solo il discorso parlato, implica che l’argomento o punto di vista di un documentario può essere più o meno esplicito. La forma di voce più esplicita è senza dubbio quella comunicata dalle parole pronunciate o scritte. Sono parole che esprimono direttamente il punto di vista del film e che vengono solitamente definite come commento fuori campo autoritario o voce “onnisciente” (noi vediamo e sentiamo autorità che appaiono e parlano in nome del film, ma sentiamo solo voci “onniscienti”, che possono essere quelle di esperti professionisti o di altre persone la cui voce viene scelta perché si adatta particolarmente bene al film).
Il commento, o il discorso diretto, è una voce che si rivolge direttamente a noi: esprime esplicitamente i suoi punti di vista. I commenti possono essere sfacciatamente di parte, come gli intertitoli a grandi lettere nel film Sol Svanetii (Il sale della Svanezia, 1928), girato in Unione Sovietica negli anni Trenta, durante il piano quinquennale di Stalin per accelerare l’industrializzazione e la produzione agricola. Questi intertitoli proclamano l’arrivo della strada che porterà il sale, tanto necessario in questa remota regione che si annuncia un trionfo di prim’ordine. In altri casi, i commenti possono sembrare imparziali, come nello stile giornalistico della maggior parte dei servizi televisivi. In entrambi i casi, questa voce che si rivolge direttamente al pubblico difende il punto di vista che dice, in effetti, “Vedila in questo modo”. Questa voce può essere elettrizzante o rassicurante, ma il suo tono ci fornisce subito un punto di vista al quale, si spera, ci uniremo. Alcuni documentari evitano questo tipo di chiarezza. Per esempio i documentari poetici possono eliminare sia la voce dell’autorità sia quella onnisciente, o usarle per evocare, accennare, suggerire invece che dichiarare o spiegare. Song of Ceylon e Night Mail usano una voce onnisciente sia per evocare che per spiegare. La voce del film non si rivolge allo spettatore in modo così diretto. Le prove si accumulano, ma sono prove di cosa? Sia di un’atmosfera e di un tono, sia di una tesi o argomentazione. Il punto di vista di un film diventa in questo modo del tutto implicito. In questo caso, la voce del film resta presente in tutti i mezzi di rappresentazione utilizzati dal regista tranne che nel commento esplicito. In contrasto con quella del commento, questa potrebbe essere chiamata la “voce della prospettiva”. Koyaanisqatsi è un esempio classico di questo approccio, seguito poi anche da Apocalisse nel deserto (Lektionen in Finsternis, 1992). Questi due film evocano sensazioni di perdita, di rovina, in relazione, rispettivamente, al degrado ambientale e agli incendi dei pozzi petroliferi in Kuwait durante la guerra del Golfo. Tali sensazioni non emergono dalle parole del commento: il film parla attraverso le immagini selezionate e montate, e attraverso la musica che le accompagna. La “voce della prospettiva” parla attraverso le
specifiche decisioni prese dal regista riguardo la selezione e disposizione di suoni e immagini. Questa voce porta avanti un’argomentazione o avanza tesi sulla realtà in modo implicito. L’argomentazione viene espressa a livello tacito. Noi dobbiamo immaginare quale sia, in effetti, il punto di vista del regista. L’effetto non sarà “Vedila in questo modo”, ma “Vedete voi”. I documentari, dall’epoca del cinema muto, spesso parlano in questo modo, da Berlino: Sinfonia di una grande città (Berlin: die sinfonie der Großstadt, 1927), ritratto poetico per immagini di Berlino, a Pioggia (Regen, 1929), storia degli effetti di un temporale estivo per le strade di Amsterdam. Nonostante l’invito a vedere e a dedurre ciò che è accennato o non detto, quello che vediamo non è una riproduzione del mondo, ma una forma precisa di rappresentazione, con un punto di vista specifico. Il senso della prospettiva – cioè la presenza di una logica e di un’organizzazione dell’informazione – rende un documentario diverso da un puro girato o da una registrazione fotografica, in cui il senso della prospettiva è minimo (con il termine “puro girato” si intendono le riprese singole, le scene tagliate, il girato grezzo, insomma tutte le forme di materiale non assemblato o montato). Questo tipo di girato può comunque avere un accenno di prospettiva, ma in misura minima: i filmati di sorveglianza di un negozio, che riprendono in particolare le transazioni di una cassa, comunicano implicitamente qualcosa sull’importanza data a un particolare aspetto del rapporto tra cliente e personale. Una volta fornita una prospettiva, sappiamo che non vedremo delle immagini del nostro mondo prive di valore. Anche se il film sceglie una descrizione spassionata, imparziale, disinteressata e oggettiva del mondo, si tratta comunque di una prospettiva. La strategia di nonpartecipazione mostra per lo meno la consapevolezza, da parte del regista, delle sue responsabilità e il suo desiderio di fornire un ritratto quanto più accurato possibile del mondo. La sottile linea blu, per esempio, non usa alcun tipo di commento fuori campo e tuttavia riesce, attraverso la prospettiva che offre, a mostrare chiaramente il suo punto di
vista su un uomo ingiustamente condannato per omicidio. La voce del film ci parla attraverso la giustapposizione di interviste e immagini che confermano o smentiscono quanto detto, con uno spirito di ironia critica simile a The Life and Times of Rosie the Riveter, in cui questa ironia era indirizzata ai filmati ufficiali di propaganda che celebravano il lavoro operaio femminile durante la Seconda guerra mondiale. Una testimone chiave d’accusa, in La sottile linea blu, viene criticata attraverso la scelta di Errol Morris di inserire delle scene tratte da una serie di film degli anni Quaranta su Boston Blackie, un ex ladro che aiuta la polizia a catturare i criminali. Una scena di Blackie che cattura un bandito grazie all’aiuto della sua fedele assistente dà una nota comica alle dichiarazioni solenni della testimone: attraverso l’accostamento di un film di intrattenimento con quella che dovrebbe essere una testimonianza fondamentale, Morris esprime un punto di vista che, pur essendo nascosto e indiretto, passa difficilmente inosservato. I diversi modi in cui si manifesta la voce del documentario sono riassunti nella tabella 3.1. Alcune sfumature di queste distinzioni saranno approfondite nei Capitoli 6 e 7. Discorso diretto: il regista si rivolge alla macchina da presa o al pubblico. Questo crea l’idea che il film stia proponendo agli spettatori una tesi sulla natura della realtà storica (“Le cose stanno così, vero?”), o perfino sui modi in cui potrebbe essere modificata (“Le cose potrebbero stare così, vero?”). Discorso indiretto: il regista non intende rivolgersi direttamente al pubblico, come accade nei film di fiction. Nel documentario, questo crea una percezione che il film stia suggerendo un punto di vista su un aspetto o su certe caratteristiche della realtà storica. Non offre un chiaro orientamento come quando propone una tesi o un’argomentazione, ma cionondimeno chiama in causa il nostro consenso e la nostra partecipazione: “Questo è un modo di vedere il mondo: che cosa ne pensate?”. Tabella 3.1 Le forme della voce nel documentario Discorso diretto
Incarnato (si vede una persona, un attore sociale) Voce dell’autorità (anchorman, reporter) Intervista (si vede l’intervistato e magari si vede o sente chi lo intervista)
Disincarnato (non si vede chi parla) Voce onnisciente (commento fuori campo) Titoli o intertitoli (informazioni scritte o pensate per lo spettatore)
Discorso indiretto
Incarnato (comunicato da attori sociali) Osservazione (gli attori sociali vivono la loro vita)
Disincarnato (comunicato dalla tecnica del film) Forma del film (il regista comunica attraverso il montaggio, la composizione, le musiche, gli effetti e così via. Sta allo spettatore interpretare come queste scelte lo interpellino)
Il documentario e la voce dell’oratore La voce del documentario è spesso quella di un oratore, o di un regista, che si pone nella condizione di prendere una posizione o di esporre una tesi riguardo a un aspetto della realtà storica per convincerci della sua validità. La posizione o la tesi di solito riguardano quegli aspetti del mondo che non si prestano a prove scientifiche. Come le questioni di comprensione e interpretazione, di morale e di opinione sul mondo in cui viviamo, le quali richiedono un modo di parlare che è fondamentalmente diverso da quello della logica (cruciale per la scienza) o della narrazione (centrale nelle opere di fiction). La tradizione retorica fornisce una base a questo modo di parlare. Può utilizzare la ragione e la narrativa, la rievocazione e la poesia, ma lo fa per convincere l’interlocutore. Sembra ispirare fiducia o infondere sicurezza riguardo al valore di un particolare punto di vista su un tema dibattuto. Una scomoda verità (An Inconvenient Truth, 2006), per esempio, si avvicina a una disamina scientifica sui rischi del riscaldamento globale, ma in realtà pone problemi riguardo ai
quali c’è un grande dibattito: non tanto se ci sia o meno il riscaldamento globale, quanto sulle sue cause primarie e sulle possibili soluzioni. L’ex vicepresidente Al Gore, la voce dell’autorità del film, prende spunto dalla scienza e dalla logica per dare importanza alla sua battaglia, ma fa anche affidamento sul racconto, sulla narrazione e sull’evocazione poetica per conferirle una forma convincente. Egli si comporta come un oratore perorando una causa che ci fa vedere il mondo in modo diverso, più di un logico o di un filosofo che seguono un’accurata linea di ragionamento. Come si procede con la retorica? In che forme e con quali convenzioni parliamo? Il pensiero retorico classico identifica tre divisioni (discusse nel Capitolo 4) e cinque “sezioni”, ognuna delle quali si può riferire al documentario: invenzione, disposizione, stile, memoria ed esposizione. Cicerone descrive in questo modo il loro collegamento: Tutta l’energia e l’abilità dell’oratore si applicano a cinque punti. […] Per prima cosa egli deve reperire gli argomenti, quindi organizzarli e disporli non solo secondo criteri di ordine logico, ma anche in base a criteri di importanza e di opportunità; poi rivestirli con gli ornamenti dello stile, fissarli nella memoria, e infine pronunciare il suo discorso con dignità e grazia. (De oratore, I, XXXI) Possiamo ora esaminare l’utilità di ognuna di queste cinque sezioni. Invenzione
L’invenzione si riferisce alla scoperta di prove a supporto di una posizione o di un argomento. (La parola “prova” si trova nei testi classici, tuttavia dobbiamo tenere presente che la retorica, e il documentario, affrontano aspetti dell’esistenza dell’uomo dove non esistono prove scientifiche. Ciò che si intende come prova è soggetto alle regole e convenzioni sociali e non ha portata conclusiva come accade in campo scientifico.) Aristotele propone due tipi di prova, che corrispondono alla divisione tra fare appello ai fatti – prove non creative né artificiali – o ai sentimenti del pubblico – prove creative o artificiali. Questi corrispondono alle idee e alle convinzioni che un pubblico magari ha già acquisito e alle
modalità che un oratore utilizza per attivarle attraverso la sua voce. Il primo tipo sostiene un argomento con l’utilizzo di fatti dalla validità indiscutibile (sarà l’interpretazione di queste prove a essere messa poi in discussione). Per esempio i testimoni, i documenti, le confessioni, i reperti fisici e l’analisi scientifica di impronte digitali, capelli o campioni di sangue, Dna e così via. Questi tipi di prova sono fuori dalla portata creativa dell’oratore o del regista, anche se su di essi viene poi applicata l’abilità di interpretazione e di analisi. Il secondo tipo di prova risulta però più pertinente alla nostra discussione su come i documentari trovano la loro voce. Si basa su tecniche usate per dare l’impressione di efficacia e di veridicità. Queste tecniche spesso interpretano la prova in questione o la pongono all’interno di un quadro interpretativo. Sono il prodotto dell’inventiva dell’oratore o del regista, e non qualcosa reperito altrove e mantenuto intatto. Nella Retorica, Aristotele divide questo secondo tipo di prova in tre tipologie (ethos, pathos, logos). Ognuna di esse cerca di convincerci della validità di un argomento o di una prospettiva. Tutte e tre hanno rilevanza nell’ambito dei film e dei video documentari, e possono essere descritte come: – prova credibile o etica (ethos): genera nel regista, nel testimone, nelle autorità, in tutti, un’impressione di buona condotta e credibilità morale – prova convincente o emotiva (pathos): fa appello alle emozioni del pubblico per produrre in esso la disposizione desiderata; mettendo il pubblico nello stato d’animo o in un atteggiamento mentale adatto per essere d’accordo con un’opinione particolare, questa prova ha una base nei sentimenti più che nella logica – prova verosimile o dimostrativa (logos): fa ricorso a un ragionamento o a una dimostrazione reale o apparente; prova, o dà l’impressione di provare, il caso. Se il ragionamento o la logica fossero completamente soddisfacenti, il problema sarebbe di natura scientifica o matematica piuttosto che retorica. L’insieme di frammenti di
vero ragionamento, uniti a pezzi di ragionamento apparente, incompleto o erroneo, caratterizzano l’impostazione retorica. Questo può essere visto come un difetto, dal punto di vista della logica pura, o come una necessaria conseguenza dell’affrontare argomenti per i quali non esiste una sola interpretazione o una soluzione univoca. In questo caso, le decisioni si baseranno sulla morale e sull’opinione, su presupposti e su tradizioni, piuttosto che sul solo peso del ragionamento. Il ragionamento può essere impeccabile ma la premessa iniziale può essere fallace; questo è di fatto un problema comune e la sfida dello spettatore sta nel determinare quale sia la premessa sottesa. Per esempio, decidere se bloccare lo sviluppo agricolo di una regione per non danneggiarne l’ambiente, o se promuoverlo per stimolarne l’economia, ammette in parte l’uso di prove scientifiche o di fatto, ma la decisione finale si baserà soprattutto su principi morali e opinioni e sull’assunto di base che li sostiene. La retorica facilita l’espressione di questi fattori reali e fondamentali. In generale, le politiche governative sono quasi sempre soggette al dibattito. I fatti e le prove ne sono parte, ma, che sia saggia o rischiosa, una data procedura è anche una questione di interpretazione. Le prove serviranno a sostenere valori e opinioni e la retorica renderà convincente questo meccanismo di sostegno. Il dibattito è inevitabile; la sfera pubblica, per cui i documentari rappresentano un contributo, facilita l’assimilazione di quel dibattito nella vita di una società. Queste tre strategie richiedono all’oratore o al regista di seguire le tre “c” del discorso retorico: essere credibile, convincente e coinvolgente. Una tendenza importante all’interno del documentario, a partire dagli anni Settanta, è stata quella di spostare il centro dell’attenzione su queste strategie e di utilizzare punti di vista, invece che di esperti e autorità, più personali e individuali. Un film come History and Memory di Rea Tajiri, per esempio, non vuole essere una storia onnicomprensiva sull’internamento dei cittadini nippoamericani durante la Seconda guerra mondiale. Al contrario, è piuttosto un racconto personale sull’esperienza della sua famiglia. Allo stesso modo, il film Les glaneurs et la glaneuse (Gli spigolatori e la spigolatrice, 2000) di Agnès Varda non
esamina le implicazioni sociali del rovistare tra i rifiuti da una posizione autoritaria o universale. Diversamente, il film trasmette la reazione personale di Varda nei confronti di coloro che incontra nei campi e nelle città e che per vivere spigolano o rovistano tra i rifiuti. Film come questi possono essere credibili, convincenti e coinvolgenti, pur senza offrire soluzioni definitive.
History and Memory (di Rea Tajiri, 1991). L’immagine di mani femminili che stringono una borraccia sotto un getto d’acqua compare spesso nel film di Tajiri. Sotto un certo aspetto è un’immagine impossibile (per un documentario), perché, come ci dice la regista, compare nei suoi sogni come se fosse un ricordo dell’esperienza vissuta dalla madre nei campi di internamento per giapponesi durante la Seconda guerra mondiale. Nel suo commento fuori campo, Tajiri indica questa immagine come una delle sue fonti di ispirazione per affrontare una storia che era stata rimossa e che nessuno nella sua famiglia voleva ricordare quanto lei. Come poteva ricostruire da questo piccolo brandello un’esperienza che parlasse del deserto, dell’importanza dell’acqua, delle mani della madre e del senso di isolamento e frammentazione che permeava le persone? History and Memory è una risposta eloquente alla domanda.
Tra questi lavori personali, i migliori sono quelli che riescono ad associare il racconto di un’esperienza individuale con più ampie diramazioni sociali e storiche, conservando tuttavia un fulcro locale. Alcuni esempi: i film di Tajiri e Varda; i due film di Alan Berliner, Intimate Stranger e
Nobody’s Business, sulle figure spesso assenti ed enigmatiche del nonno e del padre del regista; il lavoro di Deborah Hoffmann Complaints of a Dutiful Daughter (I lamenti di una figlia rispettosa, 1994), sul rapporto dell’autrice con la madre malata di morbo di Alzheimer; Rabbit in the Moon (Il coniglio sulla luna, 1999) di Emiko Omori, sulla prigionia della sua famiglia durante la Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze; l’opera di Su Friedrich The Ties That Bind (I legami più forti, 1984), sulla sua relazione con la madre di origini tedesche e sulla storia della Germania vista attraverso gli occhi della madre; Journal inachevé (Diario incompiuto, 1982) di Marilu Mallet, sulla sua vita in Canada come esule cilena e moglie di un documentarista canadese (Michael Rubbo); il film di Ngozi Onwurah The Body Beautiful (Il corpo bellissimo, 1991), sulla relazione della regista con la madre inglese bianca e il padre africano di colore; l’opera di Marlon Riggs, Tongues Untied, sull’esperienza come uomo di colore omosessuale vissuta dal regista; Bontoc Eulogy (Eulogia di Bontoc, 1995), di Marlon Fuentes, sul rapporto del regista con il nonno e l’eredità coloniale nelle Filippine; Valzer con Bashir, sulle memorie personali di Ari Folman della guerra tra Israele e Libano del 1982; e la storia ossessiva della relazione di Jonathan Caouette con la sua tormentata madre e la sua famiglia in Tarnation. Questo tipo di unione di temi personali e sociali serve spesso a fornire credibilità e veridicità, poiché il regista parte da ciò che conosce meglio, ossia la propria esperienza familiare, e allarga da lì la sua ricerca. È questa soggettività che instaura la fiducia in ciò che si vede: invece di un senso generale di veridicità abbiamo una confessione sincera, proveniente da un punto di vista che è sì parziale, ma rilevante, specifico ma appassionato. Questi lavori diventano interessanti e coinvolgenti grazie anche all’intensità con cui il regista affronta gli aspetti della sua vita privata. La sincerità e il senso di intimità di questo approccio contrappongono un tono drammatico al senso di distaccata oggettività che caratterizzava i documentari più tradizionali. Un esempio di approccio più tradizionale allo stile retorico è la trasmissione televisiva di notizie. Il conduttore o il
corrispondente, in un ruolo opposto a quello del conduttore di talk show, stabilisce una prova etica basilare: si presenta come una persona onesta e affidabile, priva di pregiudizi personali o motivi reconditi; puoi essere sicuro che questa persona ti riferirà le notizie senza distorsioni. Nei telegiornali, le dimostrazioni emotive sono utilizzate in senso opposto rispetto al solito: il programma serve a calmare, e non a suscitare, le emozioni. Quello che è accaduto nel mondo non deve turbarci, per quanto ci possa interessare. Non dobbiamo compiere nessuna azione se non assistere al telegiornale. Il modo con cui le questioni mondiali vengono confezionate e gestite, la rassicurazione che qualsiasi tipo di evento, per quanto straordinario, possa essere incapsulato sotto forma di servizio televisivo, ci rassicura che, per quanto le cose possano cambiare, il giornalismo televisivo sarà sempre in grado di assimilarle. Se è presente uno sforzo di instillare fiducia, nasce dall’intenzione della rete televisiva di convincerci delle sue capacità di inchiesta. Possiamo sentirci sicuri e tranquilli perché i telegiornali ci sono sempre. Gli eventi accadono, le persone muoiono, i capi di Stato cambiano, le nazioni crollano, ma i telegiornali restano un punto di riferimento costante. Possiamo essere certi che in essi troveremo sempre una finestra dalla quale osservare il mondo.
Rabbit in the Moon (di Emiko Omori, 1999). Il film, molto personale, espone le riflessioni della regista Emiko Omori e della sorella, che rievocano l’esperienza vissuta da ragazzine nei campi di internamento costruiti durante la Seconda guerra mondiale, in cui furono rinchiusi i cittadini di origine giapponese sulla costa occidentale degli Stati Uniti e del Canada. Il film unisce interviste alle famiglie e il commento fuori campo della regista a filmati d’archivio per porre la storia personale in un contesto più ampio di razzismo latente e politiche governative di “sicurezza nazionale”. Fotografie concesse dalla regista.
Le trasmissioni giornalistiche televisive devono anche convincerci. Devono fornire prove dimostrative attraverso il solito miscuglio di prove reali e apparenti. Quelle reali sono fornite dall’evidenza dei fatti che viene messa davanti ai nostri occhi: informazioni statistiche sulla disoccupazione o sull’inflazione, testimonianze personali di un particolare evento, prove documentate di un dato fatto e così via. Un tipo di prova apparente, invece, nasce dal modo in cui essa può essere interpretata a sostegno di un caso particolare. I reportage televisivi americani sulla guerra del Golfo contro l’Iraq, per esempio, possono fornire delle immagini autentiche di un discorso fatto da Saddam Hussein alla televisione irachena, ma montato e posizionato in modo da rappresentarlo come un guerrafondaio antiamericano, che questo fosse stato l’argomento del suo discorso o meno.
Una fonte più ampia di prove apparenti nasce dalla struttura stessa del telegiornale. La convenzione di posizionare il conduttore all’interno di uno studio che raramente ha connotazioni geografiche serve a indicare che “le notizie” nascono da un luogo che è lontano dagli eventi che riferisce, ed è, quindi, libero da ogni coinvolgimento di parte con essi. Contemporaneamente, una seconda convenzione vuole che il conduttore dia un breve riassunto della notizia e che chiami poi il reporter per approfondire. A differenza del conduttore, che ha un tono imparziale e parla da uno spazio privo di coordinate geografiche, il reporter è sempre “sulla scena”. Questa convenzione serve a dire: “Io ti ho parlato di questo evento ma, per non farti dubitare, proverò che quello che ho detto è vero chiamando un reporter, che ti fornirà ulteriori dettagli proprio dal posto in cui il fatto è avvenuto”. Quando la linea passa al reporter, egli è sempre in primo piano, mentre lo sfondo serve a documentare o dare la prova della sua posizione: la “Zona Verde” a Baghdad, la Casa Bianca a Washington, il Vaticano a Roma e così via. In questo caso, la presenza fisica ha la funzione retorica della metonimia. Se le metafore collegano tra di loro elementi separati per suggerire una somiglianza sottostante (per esempio, l’amore è un campo di battaglia o il matrimonio è un gioco da ragazzi), le metonimie creano associazioni tra fenomeni collegati fisicamente. Usano un aspetto di un qualcosa per suggerire il tutto: il pesce fresco si associa ai ristoranti sul lungomare perché l’oceano è a portata di mano, per esempio (in effetti, il pesce può provenire da un grossista a chilometri di distanza). Similmente, i reporter presenti sulla scena di un evento sapranno la storia vera perché sono lì, fisicamente vicini all’evento stesso. La metafora e la metonimia, più che al mondo della prova logica, appartengono a quello degli strumenti retorici o figurativi. Di solito non sono vere nel senso proprio della parola. Non tutti gli amori sono per forza un campo di battaglia, e non tutto il pesce cucinato sul lungomare è fresco. Allo stesso modo, non tutti i commenti provenienti dai reporter presenti sulla scena sono veri, ma questo avrà poca influenza sulla loro capacità di convincere gli spettatori. Il
valore di figure retoriche come metafora e metonimia è proprio quello di offrire un’immagine più vivida e coinvolgente di qualcosa, che questa corrisponda o meno a un certo grado di verità. Il giornalismo televisivo è un lavoro serio. Ha la stessa aria solenne di altri discorsi seri che riguardano il mondo reale, come economia, business, medicina o politica estera. Questa serietà, insieme alle tre “c” del discorso retorico, può essere ugualmente trattata con ironia. Film come Las Hurdes, Le sang des bêtes, Cane Toads (Rospi delle canne, 1987), sulla notevole crescita della popolazione dei rospi in Australia, e Ilha das flores (L’isola dei fiori, 1989), sulla relazione fra la spazzatura e il sistema sociale brasiliano nel suo complesso, fanno un uso ironico delle prove. La credibilità del commentatore in tutti e tre i film, per esempio, sembra garantita dalla sua intonazione solenne e dallo stile oggettivo. E i tre commentatori sono maschi, il che richiama il presupposto culturale che siano gli uomini a parlare del mondo reale e che possano farlo in maniera autorevole. Ma la credibilità sussulta quando quello che dicono inizia a contraddire come lo dicono. Perché il commentatore indica «un altro cretino», o loda un lavoratore di un macello come fosse una divinità, o descrive l’aumento dei rospi come l’assalto di un esercito, o paragona le persone ai maiali? Anche la nostra convinzione viene meno quando iniziamo a capire che il tono apparentemente oggettivo e scientifico è solo una presa in giro. È serio il commentatore quando parla della minaccia dei rospi, se si vede il paesaggio australiano scorrere davanti agli occhi di un singolo rospo seduto nella carrozza di un treno merci? Quanto è genuino l’eroismo dei macellatori, se ci fanno vedere le teste delle mucche appena macellate, che ancora si muovono, impilate in un angolo? Possiamo davvero capire la vita degli hurdanos quando il commentatore associa le loro abitudini a quelle degli altri popoli “barbarici”? E possono avere un senso l’apparente armonia e l’equilibrio derivanti dal fatto che ognuno abbia la sua parte, quando i maiali che rovistano nella spazzatura hanno la precedenza sulla gente disperata?
Infine, questi film si rifiutano consciamente di instillare fiducia nella verità espressa nelle loro rappresentazioni. Gli accenni di parzialità ed esagerazione si sommano per dare l’idea che quello che vediamo non è ciò che un’attenta analisi dei fatti rivelerebbe. La peculiarità del punto di vista cattura la nostra attenzione; la sua eccentricità ci porta a credere che si tratti di una rappresentazione volutamente poco credibile. Questi quattro film mettono in dubbio la nostra consueta disponibilità a credere a opere che adottano lo stesso tipo di convenzioni, che qui vengono messe sottosopra. Ironizzare significa anche non dire quello che si vuole, o dire il contrario. Allo stesso modo con cui l’uso ironico delle convenzioni giornalistiche è un indizio del fatto che This Is Spinal Tap è un finto documentario, l’uso ironico del commento autorevole in questi film è un segno molto importante per capire che, più che persuaderci della validità del loro modo di vedere il mondo, vogliono farci sospettare delle stesse convenzioni del genere documentaristico. Las Hurdes, Le sang des bêtes, Cane Toads e Ilha das flores servono tutto sommato a ricordarci che ciò in cui crediamo nasce da valori condivisi, che a loro volta provengono dalle convenzioni. Tra queste c’è anche il modo di rappresentare il mondo all’interno del documentario (il tono sobrio del commentatore, il fornire prove con le immagini, l’occhio discreto della cinepresa che osserva, le riprese in location e così via) e anche i modi convenzionali di vedere e pensare il mondo stesso. Rovesciando le convenzioni, si ribaltano anche i valori che generano la fiducia. Disposizione
La disposizione riguarda la struttura delle parti all’interno di un discorso retorico o, nel nostro caso, di un film, pensata per ottenere il massimo effetto. Una disposizione tipica è stata già discussa con la struttura problema/soluzione. Un’analisi più completa della disposizione, come raccomandata dall’oratore classico, la mette in parallelo con la struttura a cinque atti della tragedia classica ma propone una tesi, un punto di vista, o un’argomentazione, invece di una storia: – un’introduzione che attiri l’attenzione del pubblico;
– una chiarificazione su che cosa sia ciò su cui si è d’accordo e che cosa va discusso, o un’affermazione o un’elaborazione della questione stessa; – un argomento concreto a sostegno di un particolare punto di vista; – una confutazione che risponde alle obiezioni previste da parte degli oppositori; – un riassunto del caso che convinca il pubblico e lo prepari a una determinata reazione. La disposizione può essere strutturata in vari modi. Aristotele, per esempio, ne ha sottolineati due – l’affermare un argomento e il metterlo in discussione –, mentre Quintiliano ne preferisce cinque, che elaborano lo schema di Aristotele. In qualsiasi modo venga suddiviso, il discorso retorico classico mantiene due caratteristiche. La prima è l’alternanza di argomenti pro e contro che dà alla retorica la tendenza a porre le questioni in un contesto come un aut-aut, “bianco o nero”, in cui tutto è giusto o sbagliato, vero o falso, innocente o colpevole. Ciò contribuisce particolarmente agli approcci del tipo problema/soluzione, al dibattimento giudiziario che prevede accusa e difesa, o al punto di vista giornalistico che cerca “entrambi i lati di una questione”, pur trovando all’interno di essi punti di vista giusti o sbagliati, buoni o cattivi. Questo rende la retorica particolarmente utile nelle situazioni polarizzate o indirizzate verso un’azione specifica, come la pubblicità – votata a guidare i consumatori nello scegliere particolari prodotti – e la propaganda – designata a propugnare una e una sola soluzione a un problema o a una questione. Sin dagli anni Novanta un considerevole numero di documentari ha messo in rilievo la complessità e l’ambiguità di diverse situazioni o questioni. Le prospettive a finale aperto e senza indicazione di giudizio, come la perplessità e lo stupore del film di Errol Morris Fast, Cheap and Out of Control (Veloce, a poco prezzo e senza controllo, 1997) o la complessa interazione tra la vita e l’arte di Robert Crumb nel film di Terry Zwigoff Crumb (1994), si distaccano in modo
piuttosto radicale dall’aspetto persuasivo della forma retorica tradizionale. Una storia americana ne è un altro chiaro esempio. Il film esamina le complesse e ambigue questioni che riguardano l’arresto per pedofilia di Arnold Friedman e di suo figlio Jesse. Entrambi finiscono per dichiararsi colpevoli, ma per ragioni che possono essere o non essere connesse alla loro reale colpa. Entrambi respingono le accuse, nonostante la loro ammissione di colpa, e molti testimoni (studenti liceali maschi che prendevano lezioni di computer a casa dei Friedman) dichiarano che non successe nulla. Altri studenti raccontano storie orribili e crude di molestie e abusi. E se queste storie fossero il risultato di suggerimenti della polizia? E se i Friedman fossero le vittime di un’ondata di isteria per gli abusi sessuali verso minori nelle scuole? Sono vittime o carnefici? Il film non intende condannarli o assolverli – non salva un uomo innocente come fece La sottile linea blu –, ma trasmette un vivido senso di che cosa si prova a essere immersi in una situazione di totale incertezza. Il documentario ha più in comune con un film d’autore della tradizione europea come L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960), che esplora le relazioni più che le azioni, che con un film di genere come La fiamma del peccato (Double Indemnity, 1944) di Billy Wilder. La polizia non ha trovato prove concrete di abusi sessuali da parte dei Friedman. Le accuse si basano interamente sulla testimonianza degli studenti di Friedman (in qualche modo imbeccati e addestrati). La massa impenetrabile di dubbi che né Arnold né Jesse possono dissipare dicendo semplicemente “Io sono innocente” colpisce ancor più profondamente Elaine, moglie e madre dei sospettati. Un altro figlio, David, ripete con insistenza che suo padre è vittima di una montatura, mentre la presa di coscienza di Elaine che Arnold abbia nascosto un passato da pedofilo (ancora precedente ai fatti in questione) le provoca un grande dolore. Ciò che al film interessa indagare sono proprio le ripercussioni di questa situazione complessa e dolorosa. (Interessante notare come in occasione dell’uscita del film in Dvd siano stati inclusi materiali che rafforzano la tesi dell’innocenza di Arnold e Jesse, ma che allo stesso tempo approfondiscono la
comprensione, negli spettatori, dell’ammissione della pedofilia da parte di Arnold e di come il suo passato lasci margini di dubbio.)
Vlast’ Solovetskaija (di Marina Goldovskaija, 1988). Un monastero medievale è diventato uno dei primi gulag sovietici, a 3.500 chilometri a nord di Mosca. La spiritualità dell’ex monastero si è ben adattata alla propaganda governativa, che si basava sui benefici della prigionia. Fotografie concesse dalla regista.
Ci sono altri film che non fanno emergere alcun tipo di giudizio né offrono soluzioni univoche. Per esempio L’incubo di Darwin (Darwin’s Nightmare, 2004), che racconta la complessa interdipendenza tra governi, business e mondo del lavoro che ha condotto al disastro del persico del Nilo nel lago Vittoria (i pesci persici una volta introdotti artificialmente hanno mangiato quasi tutte le altre specie di pesci che vivevano nel lago, anche se hanno aperto un mercato particolarmente proficuo verso la Tanzania). Il documentario comunica in modo potente l’impatto assoluto di una serie di azioni, nelle quali nessuno si prende la responsabilità delle conseguenze a lungo termine di decisioni immediate. Nello stesso modo, film diversi tra loro come The War Room, che racconta le strategie dietro le quinte che hanno preparato il terreno all’elezione di Clinton a presidente nel 1992, e Control Room (2004), sul lavoro della controversa televisione in lingua araba Al Jazeera, osservano e ascoltano piuttosto che accusare e asserire. Altri esempi similari sono Hell House (La casa dell’Inferno, 2001), che racconta l’impegno di una comunità ecclesiastica nella creazione di un parco di divertimenti
pensato per ricreare l’inferno che attende i peccatori, e Jesus Camp (2006), che segue Becky Fischer nell’opera di convertire a Gesù ragazzini in età preadolescenziale. Questi film lasciano allo spettatore la possibilità di trarre le proprie conclusioni. La voce propria dei registi si fa sentire in forme più sottili, ossia nel montaggio e nella messa in scena. L’ambiguità esiste; l’alternativa bianco/nero ignora i grigi e questi documentari richiamano la nostra attenzione proprio sulla zona grigia di dubbio e di complessità piuttosto che su determinate opinioni o alternative. La retorica continua a guidare gli sforzi atti a stabilire la fiducia nel regista e a convincere della complessità di ciò che viene mostrato e della potenza del suo impatto reale o virtuale, ma lo fa senza l’urgenza di arrivare a una conclusione, a un giudizio o a una soluzione. In secondo luogo, senza preoccuparsi dell’equilibrio tra certezza e ambiguità, i documentari continuano a esibire la classica alternanza tra ciò che si riferisce alle prove e al pubblico, ai fatti e alle emozioni. Dato che i tipi di argomento affrontati dalla retorica riguardano sempre, oltre che le prove dei fatti, questioni di morale e opinione, questo alternarsi ha un senso. Esso permette al discorso, o alla voce del documentario, di aggiungere sostanza ai fatti e di collocare i propri argomenti non nel dominio astratto della logica impersonale, ma in quello concreto dell’esperienza fisica e dell’avvenimento storico. L’oratoria era in origine una qualità reale e fisica: risiedeva nel modo persuasivo ed eloquente con cui una persona si rivolgeva agli altri, faccia a faccia, usando tutta la sua corporeità. Il documentario preserva il senso di un discorso incarnato e pieno di passione, attraverso una voce che parla facendo appello alle emozioni quanto ai fatti. Gran parte del potere del documentario, e molta della sua importanza per i governi e altri sponsor istituzionali, sta nella sua capacità di unire le prove e le emozioni. È più potente vedere Rodney King pestato dalla polizia, come ha reso possibile la testimonianza del video registrato, o mostrare immagini dei prigionieri torturati ad Abu Ghraib in Iraq piuttosto che leggere solo dei resoconti delle presunte torture come fa Standard Operating Procedure di Errol Morris. Tali
immagini non solo forniscono delle prove evidenti, ma hanno anche un impatto emotivo che è reso ancora più forte dall’effetto indicativo della fiducia nella veridicità di ciò che vediamo. Le immagini collocano un argomento ancora più fortemente in relazione con il nostro mondo e con il modo in cui noi lo affrontiamo.
Vlast’ Solovetskaija. La regista Marina Goldovskaija ha scoperto un film di propaganda degli anni 1927-28 che descriveva la prigione di Solovkij come un modello di vita pulita, cibo sano e redenzione attraverso il duro lavoro. Le autorità dovettero ritirare il film dalla circolazione: il loro ingannevole entusiasmo aveva costruito un ambiente che sembrava migliore di quello in cui viveva la maggior parte degli spettatori; i cittadini si sarebbero chiesti come mai i prigionieri avevano stanze più belle e cibo migliore di loro! Stile
Lo stile facilita la voce del documentario. Gli elementi di stile, come la scelta dell’inquadratura, la composizione e il montaggio, forniscono al regista gli strumenti con i quali parlare al suo pubblico, non in maniera puramente fattuale e didattica, ma attraverso una retorica espressiva che è poeticamente potente.
La familiarità con lo stile del film è una parte importante del repertorio del regista. Lo stile comprende l’uso di figure retoriche e codici grammaticali per raggiungere un tono specifico. I libri di introduzione al cinema affrontano solitamente gli elementi di stile cinematografico sotto le categorie generali, ampie ed esaurienti, di ripresa, illuminazione, montaggio, recitazione, sonoro e così via. Questi stessi elementi entrano chiaramente in gioco nei documentari, filtrati dalle forme (diario, saggio ecc.) e dai modi (espositivo, riflessivo ecc.) più tipici del genere. Poiché anche altri testi introduttivi trattano approfonditamente questi elementi, all’interno di questo libro ne verrà data una trattazione contestualizzata e meno approfondita
Vlast’ Solovetskaija. Marina Goldovskaija ricostruisce la storia della prigione attraverso le interviste con i superstiti, i diari dei prigionieri e i registri ufficiali che dimostrano le condizioni di vita estremamente dure. Qui vediamo alcune delle fotografie di famiglia e delle lettere di un prigioniero di Solovkij. Memoria
La memoria aveva importanza vitale per il discorso orale, come per esempio nei dibattiti. Si poteva imparare a memoria un discorso o disporre di “argomenti cruciali”, o sviluppare un “teatro della memoria” per ricordare ciò che andava detto. Questo metodo consisteva nel visualizzare le parti del discorso in diversi luoghi di uno spazio familiare, come la propria casa o un luogo pubblico. L’immagine mentale avrebbe facilitato il recupero dei componenti del discorso, mentre l’oratore si “muoveva” nello spazio immaginario in un ordine preciso,
recuperando gli argomenti che aveva depositato nei vari luoghi. Poiché i film non sono composti da un discorso spontaneo, la memoria viene utilizzata per lo più in due modi: prima di tutto, il film stesso si pone come un “teatro della memoria” tangibile. È una rappresentazione esterna e visibile di ciò che è stato detto e fatto. Come la scrittura, il film risolve il problema di mettere in sequenza dettagliata la memoria. Esso può diventare una fonte di “memoria popolare”, dandoci un senso vivido di come un fatto sia avvenuto in un tempo e un luogo particolari. Secondariamente, la memoria entra in gioco all’interno dei vari modi in cui gli spettatori utilizzano ciò che hanno già visto per interpretare quello che si trovano davanti. Questo atto di retrospezione, di ricordarsi che cosa è successo e creare una connessione con quello che si vede al momento, può essere cruciale per la formulazione di un discorso coerente. Sebbene non sia parte del discorso retorico in quanto tale, rientra nell’atto retorico generale. Quando Errol Morris inizia La sottile linea blu con delle riprese in esterno, di sera, di sagome astratte e impersonali dei grattacieli di Dallas, abbinate alla voce fuori campo dell’accusato che narra che Dallas era «come un inferno», esse hanno uno scopo metaforico che resta presente in tutto il film, se noi facciamo in modo di ricordarle in maniera appropriata. Similarmente, il nostro ricordo di un uomo seduto per terra che ascolta un disco su un fonografo diventa cruciale per capire in modo completo Bontoc Eulogy di Marlon Fuentes. A mano a mano che il film va avanti, comprendiamo l’identità dell’uomo e il significato di questo atto. Iniziamo gradualmente a comprendere perché il film inizia in questa maniera. Possiamo capirlo solo con il ricordo, tornando indietro alla prima scena e aggiungendovi le informazioni che abbiamo acquisito in seguito. Questa forma di “re-visione” è spesso fondamentale per una comprensione completa del significato di un film. Esposizione
Originariamente l’orazione era una questione di incontro diretto, faccia a faccia, e non una comunicazione attraverso
strumenti di mediazione come la scrittura o il film: per questo l’esposizione aveva a che fare con ciò che veniva detto, con il modo in cui veniva detto, e con l’espressività e la gestualità che accompagnavano il discorso. Questo richiama in qualche modo ciò che abbiamo evidenziato in precedenza rispetto alla distinzione tra il rivolgersi in maniera diretta e indiretta e tra le forme incarnate e disincarnate dell’espressione documentaristica. Tutte queste possibilità continuano ad avere la capacità di provocare un impatto emotivo, esattamente come le molteplici facce dell’esposizione oratoria classica. L’espressività e la gestualità hanno a che fare con una comunicazione non verbale. Sono modi di “dire qualcosa” che non ricorrono all’uso della parola. Quando si parla di individui, esse giocano un ruolo chiave in quella che consideriamo la presentazione di sé. Questo livello di comunicazione entra chiaramente in gioco durante le interviste. Molta della loro fascinazione – e uno dei motivi più importanti per cui i mezzibusti televisivi non sono necessariamente noiosi – sta nel fatto che buona parte del loro potere emozionale deriva dal modo in cui una persona utilizza il volto e il corpo in concerto con ciò che sta dicendo. Pensiamo ad Abraham Bomba, sopravvissuto all’Olocausto, che racconta con grande reticenza di quando tagliava i capelli dei prigionieri che andavano a morire in Shoah; o a Lila Lipscomb, la madre in lutto per la morte del figlio in Iraq in Fahrenheit 9/11; o a Jonathan Caouette, il regista di Tarnation, che interagisce con la madre malata; o a Timothy Treadwell, che diventa amico degli orsi grigi che vivono allo stato brado nelle remote regioni dell’Alaska (in Grizzly Man). Tutti rivelano qualcosa con i loro volti e corpi tanto quanto con le loro parole. Il carisma è un elemento fortemente correlato all’esposizione così intesa, e tutti questi personaggi ne possiedono moltissimo. Altri aspetti vitali dell’esposizione sono le idee di eloquenza e decoro. Questi termini ora hanno un sapore di antico cerimoniale, ma questo è solo il risultato di una eredità culturale che va a detrimento della loro importanza originaria. Nella retorica classica non c’era nulla di eccessivamente rifinito in nessuno dei due concetti. L’eloquenza, per esempio,
può essere considerata un indice della chiarezza di un argomento e della forza di un richiamo emotivo, mentre il decoro può essere definito come l’efficacia di una particolare strategia argomentativa, o di un discorso, applicata a un determinato contesto. L’eloquenza e il decoro misurano “che cosa funziona”, senza dare importanza a quanto sia raffinato o grezzo. Mettono in risalto la natura pragmatica, che punta all’effetto o al risultato, della retorica in generale. Non si limitano in alcun modo al discorso educato (o eccessivamente educato): possono essere applicati a qualsiasi forma di discorso o di voce che voglia colpire il pubblico in un dato contesto. I cinque settori della retorica classica forniscono una guida utile alle strategie che il documentarista contemporaneo può utilizzare. Come l’oratore dei vecchi tempi, il documentarista parla di argomenti di valore attuale, propone nuove direzioni, giudica le precedenti, misura la qualità della vita e delle culture. Queste azioni sono tipiche del discorso retorico non in quanto “retoriche” (ovvero nel senso di discutere per il gusto di discutere), ma perché affrontano quegli argomenti urgenti, riguardanti morale e opinione, per i quali i fatti e la logica non possono fornire una guida efficace su come comportarsi, che decisioni prendere e che opinioni avere. La voce del documentario è prova di un impegno con l’ordine sociale e di un punto di vista che guarda ai valori morali a esso sottesi. Si tratta di un orientamento particolare nei confronti del mondo storico e sociale che dà al documentario la sua voce.
CAPITOLO 4 CHE COSA RENDE I DOCUMENTARI COINVOLGENTI E PERSUASIVI? Il triangolo della comunicazione In ogni documentario ci sono almeno tre storie che si intrecciano: la storia del regista, quella del film e quella del pubblico. Queste trame fanno tutte parte, ognuna in modo diverso, della risposta alla domanda “Di che cosa parla un film?”. Ovvero, quando guardiamo un film ci rendiamo conto che esso proviene da un dato luogo e da una data persona. C’è una storia che riguarda come e perché è stato realizzato. Queste storie sono spesso più personali e peculiari quando riguardano i film documentari e sperimentali rispetto a quelli narrativi. La produzione del film di Leni Riefenstahl Il trionfo della volontà, per esempio, contiene la storia controversa della sua ambizione artistica di realizzare film di grande impatto emotivo e privi di intento propagandistico (secondo quanto raccontato da lei), unita alla storia del desiderio, da parte del partito nazista, di realizzare un film che generasse di esso un’immagine positiva in un momento in cui il suo potere non era ancora del tutto consolidato, e il dominio del partito non era ancora, dal punto di vista di molti storici, completamente nelle mani di Hitler. Le interpretazioni del film prendono sempre il filo dall’una o dall’altra di queste storie, lodandolo come un lavoro dalle notevoli qualità artistiche o condannandolo come un chiaro esempio di propaganda nazista. Anche il pubblico, come è ovvio, ha avuto reazioni diverse. Alla sua uscita, alcuni anni prima della Seconda guerra mondiale, il film ha vinto premi e ha ricevuto gli apprezzamenti di molti, compreso John Grierson. Dopo la guerra, con la consapevolezza del genocidio perpetrato dal partito nazista, l’ingenua approvazione dell’operato di Hitler e dei suoi seguaci ha causato molto più shock che entusiasmo. Bisogna spesso tenere conto di come un film si relaziona con i lavori precedenti e con le preoccupazioni del regista, con il modo con cui egli asserisce e presenta le sue intenzioni e le
sue motivazioni, e di come queste considerazioni si rapportino al contesto sociale generale in cui il lavoro è stato realizzato. Questo riferimento al regista e al contesto di produzione è uno dei modi di discutere su ciò di cui parla un film. La storia di sfondo non basta, tuttavia, a soddisfare la nostra curiosità ed è necessario prendere le dichiarazioni di intenti del regista con le dovute precauzioni, perché l’effetto che un lavoro ha sugli altri, e la sua interpretazione, risulta spesso diverso dalle intenzioni originali.
Il trionfo della volontà L’ingresso drammaticamente coreografato dei tre capi nazisti sottolinea l’estrema centralità dei leader, onnipotenti rispetto alle masse di soldati presenti. George Lucas ha ripreso questa coreografia alla fine di Guerre stellari (Star Wars, 1977), eliminando il contesto fascista e applicando l’adorazione degli eroi a Han Solo, Chewbecca e Luke Skywalker, cioè i “buoni”.
Si deve anche considerare la storia del testo stesso e il modo in cui noi la comprendiamo e interpretiamo. Questo è il compito tipico dell’analisi critica e il punto di interesse principale per gli studiosi di storia e critica del cinema. Ci concentriamo ora su che cosa il film rivela e su cosa, per
quanto riguarda il documentario, esso rivela rispetto al mondo in cui viviamo. È qui che si dimostra utile la conoscenza delle diverse forme, modalità e tecniche del documentario. Ci chiediamo in che modo il film rappresenti una specifica forma di impegno nei confronti del mondo e un tipo distintivo di relazione tra il regista e il suo soggetto. Infine, va considerata la storia dello spettatore. Ogni spettatore si avvicina a un film con determinati presupposti e aspettative, basati sulle sue precedenti esperienze. Il grande film di Jean-Luc Godard Il disprezzo (Le mépris, 1963) si riferisce chiaramente a questo fenomeno. Uno sceneggiatore, Paul, ha il compito di scrivere un adattamento cinematografico dell’Odissea di Omero. Nel frattempo, sua moglie lo accusa di aver rovinato la loro relazione nell’essere stato complice delle avance che il produttore del film le ha fatto. Lo scrittore diventa gradualmente sempre più geloso e diffidente. Preso dal suo stesso conflitto coniugale, arriva a dichiarare che il tema centrale dell’Odissea è l’infedeltà. Perché? Perché, secondo Paul, Penelope ha tradito Ulisse e lui, consapevole di ciò, ha ritardato apposta il rientro a casa per evitare il più possibile di affrontare le conseguenze di questo tradimento!
Il trionfo della volontà. Cambiando gli angoli d’inquadratura, Riefenstahl pone i capi al livello della massa, pur mantenendo un chiaro senso di distanza fisica e separazione gerarchica.
Paul ha rovesciato l’interpretazione normale del testo classico, in cui Penelope aspetta fedelmente il ritorno del marito, come risultato dell’aver proiettato le proprie esperienze sulla storia. Per quanto sia un’interpretazione fuorviante, questa proiezione dell’esperienza personale sulla storia di Omero raggiunge un certo livello di credibilità. Si tratta di un esempio perfetto di come lo spettatore, con le sue aspettative e il suo atteggiamento mentale, possa dare un significato diverso alla storia. In quanto membri del pubblico, troviamo sovente nel film ciò che vogliamo, o dobbiamo, trovare, spesso a discapito di ciò che ha davvero da offrire. Tipi differenti di pubblico vedranno cose diverse: la promozione del film in un modo particolare può spingere il pubblico a vederlo sotto una luce specifica piuttosto che sotto un’altra; questo viene fatto anche per evitare un tipo di interpretazione che possa portare il pubblico a proiettare esperienze personali sulla storia del film.
Le consuetudini di altre culture possono, per esempio, sembrare bizzarre o “innaturali” agli spettatori che appartengono a una cultura diversa. Guardare senza preparazione Les Maîtres fous, in cui i membri della tribù Hauka entrano in trance e si trasformano in spiriti Hauka, e hanno la schiuma alla bocca, sbavano, sacrificano un pollo vivo e mangiano la carne di un cane, o The Nuer (I Nuer, 1970), in cui a un ragazzo Nuer vengono praticati, durante un rito di passaggio dall’infanzia alla maturità, diversi tagli sulla fronte, può generare in molti spettatori occidentali sensazioni di repulsione e nausea. Queste reazioni ci rivelano molto più su ciò che il pubblico considera un comportamento appropriato, riguardo al controllo del corpo e alla vista del sangue, invece che informarci sulle abitudini di un’altra cultura. Porre questi film in una cornice etnografica che dà maggiore attenzione all’interpretazione transculturale e alle questioni di pregiudizio culturale può incoraggiare a spostare il punto di attenzione della storia su qualcosa che non è solo la nostra personale percezione dei fatti. Non è possibile eliminare completamente le nostre predisposizioni ed esperienze, né andrebbe fatto. I documentari sfruttano spesso le supposizioni e le aspettative che portiamo con noi, con lo scopo di creare un collegamento più che di generare una repulsione o una proiezione. È questa la base del fondamentale principio retorico per cui un film è coinvolgente per il pubblico. Se un’opera è capace di attivare le nostre predisposizioni personali e cogliere nel segno di reazioni emotive che già abbiamo in noi, in riferimento a determinati valori o convinzioni, allora essa accresce il suo potere emozionale. I documentari possono fare appello al nostro senso di curiosità o al nostro desiderio di cercare una spiegazione alla condotta americana nella guerra in Vietnam, a Grenada, ad Haiti o in Serbia, in Iraq o in Afghanistan, per esempio. Il nostro desiderio di sentire una storia che rafforzi le nostre precedenti convinzioni ci attira spesso verso certi tipi di documentari. Per questo liberali o progressisti spesso trovano interessanti i documentari di Michael Moore mentre Jesus Camp attrae i fondamentalisti che vogliono vedere “uno di loro” che si batte per trasformare i ragazzi in cristiani devoti e attivi. La capacità di utilizzare tecniche di retorica per creare
una descrizione credibile, convincente e coinvolgente dipende anche da quanto si conosce il proprio pubblico e da come si sanno impiegare per fini specifici il suo buonsenso e le sue esperienze precedenti. Per esempio, un film come Operation Abolition (Operazione abolizione, 1960), in cui le proteste contro una serie di udienze del Comitato per le attività antiamericane riguardanti le agitazioni comuniste nella San Francisco Bay Area nel maggio 1960 sono descritte come l’opera di pericolosi estremisti, è un film che attinge facilmente ai pregiudizi che molti membri del pubblico hanno già riguardo a un’oscura, sinistra minaccia comunista presente nella società americana. Al contrario, Operation Correction (Operazione correzione, 1961), che narra di nuovo gli stessi eventi utilizzando i medesimi filmati, ribatte che la violenza nata dalle proteste è stata per lo più istigata dalla polizia, e non dai manifestanti. Descrivendo nel dettaglio la cronologia effettiva dell’accaduto, il film dimostra che Operation Abolition ha deliberatamente invertito l’ordine degli eventi e ha contrapposto falsamente i fatti di modo da incolpare i manifestanti per ciò che è stata la polizia a istigare. Operation Correction risulta quindi più interessante per i membri del pubblico che già sospettano che la “minaccia comunista” nella società americana del secondo dopoguerra fosse un riflesso esagerato, se non paranoico, dell’idea di mire sovietiche sugli Stati Uniti. Una tecnica simile si palesa in The Revolution Will Not Be Televised (La rivoluzione non sarà trasmessa in Tv, anche noto come Chávez: Inside the Coup, 2002), brillante cronistoria dei primi momenti di Hugo Chávez alla presidenza del Venezuela. Ai registi accadde di trovarsi là durante il colpo di stato militare che rovesciò Chávez nel 2002, fino al momento in cui le stesse guardie di palazzo giocarono un ruolo fondamentale nel riportarlo al potere. Nei giorni immediatamente precedenti al colpo di stato molte proteste di strada, in cui i sostenitori di Chávez si lamentavano delle strutture del potere costituito a cui il neopresidente si opponeva, degenerarono in violenza. I notiziari della televisione locale mostrarono immagini in cui la polizia aveva dovuto far fuoco su un folla che la aveva
attaccata. Il documentario ribalta la situazione: nel tracciare l’esatta tempistica degli scontri, rivela che la polizia ha sparato per prima, provocando quella violenza di cui accusava i manifestanti. The Revolution Will Not Be Televised avrà maggiore presa su un pubblico disposto a pensare che le fazioni di destra e le unità paramilitari sono più inclini a scatenare la violenza che su coloro che credono che i manifestanti di sinistra sono pronti a usare qualunque mezzo necessario, violenza inclusa, pur di raggiungere i loro scopi.
Eventi concreti e concetti astratti I concetti e i problemi di cui parlano i documentari sono quasi sempre astratti e invisibili. Non si possono vedere la ricchezza o la povertà, per esempio, come concetti generali. Li possiamo definire a parole, ma possiamo filmare solo dei segni e dei sintomi specifici di vita agiata o degradata, alla quale viene assegnato il concetto di “ricchezza” o “povertà”. (Alcuni spettatori, a seconda dei diversi punti di vista, possono assegnare a questi segni altri concetti, come “la bella vita”, “il lusso”, oppure “i poveri pezzenti” o “vita da ghetto”.) Allo stesso modo, non possiamo filmare “la paura”, “l’obbedienza” o “il dolore”, ma possiamo filmare determinate situazioni che incarnano visibilmente questi concetti. Lo straziante documentario di Rithy Panh S21, la machine de mort Khmère rouge (S21, La macchina di morte dei Khmer rossi, 2003), per esempio, riesamina quanto accadde a S21, una famosa prigione in cui morirono migliaia di cambogiani. Sofferenza e dolore, ma anche dignità, illuminano i volti dei pochi sopravvissuti, che tornano a visitare la prigione e a confrontarsi con alcuni dei loro torturatori e delle loro guardie. Le situazioni filmate da Panh rendono testimonianza di come si manifestino e di come si facciano sentire il dolore, la sofferenza e la dignità, il tutto a livello di esperienza personale. Questo serve a spiegare che il valore documentaristico dei film di non-fiction sta nel modo in cui riescono a dare una rappresentazione visiva e udibile ad argomenti dei quali il nostro linguaggio parlato e scritto può solo fornire concetti. Le immagini fotografiche non ci presentano dei concetti, li
incarnano (per questo molti documentari utilizzano un commento parlato per guidare lo spettatore verso la “corretta” interpretazione delle immagini che illustrano quello che viene detto. Il commento, o discorso parlato, può nominare la povertà o la tortura in modo diretto). I documentari mostrano ai nostri sensi un insieme di suoni e immagini organizzato in modo tale da provocare reazioni emotive negli spettatori: attivano sentimenti ed emozioni, rivelano valori e convinzioni, e mentre lo fanno possiedono un potere espressivo equivalente o superiore a quello delle parole scritte. Il film Hospital di Frederick Wiseman, per esempio, osserva una serie di incontri tra pazienti e personale in un ospedale pubblico (il Metropolitan Hospital di New York), ma riesce a mostrare qualcosa di più che una semplice descrizione di come funziona quella struttura. Il film diventa una rappresentazione, o una prospettiva, su come tutti gli ospedali funzionano. Il film ha una sua voce e un suo punto di vista. Il modo con cui Wiseman organizza questi incontri specifici serve a dare una prospettiva a concetti basilari come “etica medica”, “burocrazia”, “differenza tra classi” e “qualità di vita”. Noi deriviamo tali concetti, che in sé sono intangibili e invisibili, dalle scene che Wiseman ci pone di fronte, allo stesso modo con cui deriviamo dal montaggio e dall’organizzazione del film l’opinione di Wiseman che questo singolo ospedale svolga bene i suoi doveri e i suoi obblighi. In un modo simile, John Huston potrebbe dire, per iscritto, “La guerra è un inferno” o “Il soldato semplice paga con la sua vita quello che i generali decidono”, ma il suo film San Pietro ci mostra com’è la guerra, così da farci arrivare da soli a queste astrazioni tematiche attraverso la visione di alcuni momenti che Huston sceglie di mostrarci. L’atto del mostrare, da parte del regista, acquista maggiore significato perché è organizzato con accorgimenti specifici di selezione e disposizione, come per esempio il commento fuori campo, con Huston stesso nel ruolo del narratore, in cui siamo invitati a notare «il trattamento interessante riservato al coro» mentre la cinepresa inquadra le rovine, distrutte dai bombardamenti, della chiesa del paese di San Pietro. Il riferimento “casuale” al massacro, espresso con i toni e il lessico dell’architettura,
serve a restituire un chiaro senso di ironia: è come se Huston stesse dicendo “La guerra è un inferno, e quando non la consideriamo tale è ancora peggio”. In un film più recente, ma egualmente critico, Why We Fight (2005), Eugene Jarecki sostiene che gli Stati Uniti nella maggior parte dei casi dichiarano guerra per alimentare l’enorme sistema industriale e militare. Questo concetto è stato affermato per la prima volta dal presidente Eisenhower alla fine degli anni Cinquanta, ma Jarecki gli conferisce uno slancio emotivo attraverso la sua scelta di specifiche immagini e suoni combinati a interviste esplicative: il risultato è un’argomentazione convincente (anche se non conclusiva) a sostegno di politiche alternative. In altri termini, i film documentari contengono di solito una tensione tra lo specifico e il generale, tra singoli momenti storici e generalizzazioni. Senza queste generalizzazioni i potenziali documentari sarebbero poco più che mere registrazioni di particolari eventi o esperienze. D’altro canto, se fossero solo generalizzazioni, i documentari sarebbero poco più che trattati astratti. È la combinazione di questi due elementi, le riprese individuali e le scene che ci collocano in un tempo e spazio particolari, unite alla loro organizzazione in un insieme più grande, che dà ai film e video documentari il loro potere e il loro fascino. La maggior parte degli argomenti ritenuti comuni nel cinema documentario – come guerra, violenza, biografia, sessualità, etnia e così via – sono astrazioni derivate da esperienze simili ma non identiche. Sono modi di legare l’esperienza in unità più ampie, o gestalt, che noi chiamiamo “concetti”. È così che riusciamo a considerarli come qualcosa di più che delle semplici registrazioni o dei filmati. I documentari sono delle sequenze organizzate di inquadrature che parlano di qualcosa di astratto o di concettuale attraverso la loro organizzazione (per esempio la struttura problema/soluzione, una storia con un inizio e una fine, la focalizzazione su una crisi, l’enfasi su un tono o un atteggiamento e così via).
Temi comuni, argomenti ricorrenti
Se un concetto non è in dubbio, come la condensazione dei liquidi quando cala la temperatura o l’evaporazione quando aumenta, c’è poco bisogno di un documentario che ne discuta. Un film educativo o istruttivo potrebbe essere d’aiuto per spiegarlo, ma la sua organizzazione sarà dedicata interamente a fornire informazioni reali e consolidare la nostra conoscenza di un concetto indiscusso, piuttosto che a dare un tono o un’inflessione alla nostra comprensione di tale concetto. Il loro interesse in quanto documentari è vicino allo zero. I documentari affrontano continuamente concetti discussi e questioni criticate.
Hospital (di Frederick Wiseman, 1970). Frederick Wiseman mostra un indomito empirismo che rimanda, per alcuni spettatori, al surrealismo e al teatro dell’assurdo. La sua attenzione alle istituzioni e alle pratiche sociali, dai licei ai grandi magazzini, si dimostra uno studio notevole sulla vita contemporanea americana. Questo collage a mosaico, composto da numerosi eventi non collegati a un singolo personaggio o una singola questione, e non uniti da un commento fuori campo, obbliga lo spettatore a reagire alla carica, spesso fortemente emotiva, delle immagini e a comprendere autonomamente il tema più generale di potere e controllo, necessità e reazione all’interno dello specifico quadro sociale ritratto nel film. Fotografia concessa da Zipporah Films, Inc., Cambridge, Massachusetts.
Che tipi specifici di concetti o problemi sono affrontati nei documentari? In generale, si affrontano quei concetti e quei problemi sui quali c’è una notevole discussione a livello sociale oppure quelle esperienze alle quali i registi possono contribuire con il loro particolare punto di vista. Possono essere i più disparati, a partire da alcuni aspetti della vita stessa del regista, come accade in Les glaneurs et la glaneuse, in cui Agnès Varda viaggia attraverso la Francia scoprendo una notevole varietà di stili di spigolatura, che hanno poi avuto una notevole influenza nella sua vita, per arrivare al potente Trouble the Water (Smuovere le acque, 2008), incisivo ritratto delle fatiche di Kim e Scott Roberts per sopravvivere all’uragano Katrina a New Orleans prima dell’arrivo di un qualunque aiuto esterno. Che si parli di spigolatura come maniera di vivere o della risposta ai disastri da parte dei nostri governi, i documentari esplorano questioni e adottano punti di vista che presentano i loro soggetti in maniera distintiva e potente. Le discussioni e le critiche circondano le istituzioni e le abitudini sociali fondamentali della nostra società. Le abitudini sociali sono ciò che il nome fa intendere: il modo convenzionale di fare le cose. Potrebbero essere diverse; per esempio, molte questioni serie di giurisprudenza vengono decise dalle giurie in America e dai giudici in Europa. Un giudice o una giuria diversi possono giungere a conclusioni difformi sulla stessa questione. I bambini possono sentirsi in debito nei confronti dei genitori una volta raggiunta l’età adulta, oppure no, a seconda delle convenzioni della loro cultura e della loro relazione individuale con essa e con i propri genitori. Una donna può ritenere di avere diritto e può essere pronta a richiedere le stesse opportunità e lo stesso trattamento di un uomo, oppure no, a seconda delle abitudini sociali correnti e del suo atteggiamento personale nei loro confronti. Nella maggior parte delle abitudini sociali in cui è possibile più di un modo di fare e in cui si può far capo a più di un gruppo di valori e di morali, si avrà uno scontro tra diversi tipi di approccio. I valori dominanti devono lottare per restare tali. Quelli alternativi devono farlo per guadagnare legittimità. Si
entra in un territorio conteso in cui i diversi ideali e valori lottano per avere la nostra alleanza. Questa competizione, più che in termini di coercizione, viene giocata in un’arena ideologica. Le pratiche sociali dominanti e alternative, invece di forzarci fisicamente a obbedire, cercano di convincerci del loro valore: la forza resta l’ultima risorsa. La persuasione, tuttavia, ha bisogno di una maniera per rappresentare un modo di agire accettabile, una linea d’azione consigliabile, una soluzione preferibile che renda questa opzione quella che saremo disposti ad accettare come nostra. La persuasione ha bisogno di comunicazione, e la comunicazione dipende da un mezzo di rappresentazione che va dalla lingua scritta al codice di abbigliamento, dalla televisione al cinema, dal video a internet. Questi sistemi di segni sono il mezzo fondamentale della rappresentazione persuasiva.
La sfida della persuasione Nella tradizione occidentale, gli usi diversi che si fanno del linguaggio parlato e scritto hanno portato a una classificazione in tre ampie categorie: - narrativa e poetica (per raccontare storie ed evocare stati d’animo); - logica (per per indagini razionali, scientifiche e filosofiche); - retorica (per generare consenso oppure ottenerlo su argomenti aperti al dibattito). Anche se queste tre grandi suddivisioni del linguaggio hanno ognuna una sfera per la quale sono maggiormente appropriate, esse non sono reciprocamente esclusive: gli elementi di narrativa (la suspense o il punto di vista) e le figure retoriche poetiche (la metafora o la similitudine) possono dare colore a discorsi scientifici e argomentativi; le tattiche persuasive a volte hanno un ruolo centrale sia nella narrativa sia nel ragionamento scientifico. (Galileo, per esempio, ha dovuto esprimere le sue argomentazioni contro l’idea generale che la Terra fosse al centro dell’universo in termini che convincessero le gerarchie della Chiesa e che non
sembrassero blasfemi; questa sfida necessitava di abilità retoriche oltre che di prove logiche.) In generale, quindi, il documentario testimonia lo specifico, spesso inusuale, punto di vista da cui i registi osservano aspetti del mondo in cui viviamo; accumula sforzi per convincerci, persuaderci o predisporci a una certa visione della verità che abbiamo in comune. Il documentario non fa appello principalmente o esclusivamente alla nostra sensibilità estetica; può intrattenerci o soddisfarci, ma lo fa in relazione a uno sforzo retorico o persuasivo rivolto al mondo sociale. Il documentario non solo attiva la nostra consapevolezza estetica (diversamente da un film strettamente informativo o educativo), ma attiva anche la nostra coscienza sociale. Questo può essere deludente per alcuni, che cercano il piacere di rifugiarsi in un mondo immaginario, ma può essere una fonte di stimolo per altri, che desiderano affrontare con passione e originalità le questioni più dibattute e i problemi attuali. Nell’antichità la retorica, o l’oratoria, era meno rispettata della logica, o della filosofia, perché sembrava dare riconoscimento a quegli aspetti umani che non erano ancora soggetti al dominio della ragione. La nostra esperienza di circa duemila anni di ulteriore storia, la nostra conoscenza di Sigmund Freud e dell’idea del subconscio, e la nostra consapevolezza del collegamento tra potere e conoscenza, fede e ideologia ci danno ragione di credere che la retorica non sia la “figlia bastarda” della logica, ma piuttosto la sua maestra. Se non altro possiamo dire che la retorica è un alleato indispensabile in quelle situazioni in cui dobbiamo parlare di argomenti per cui non esiste un’opinione generale concorde. In altre parole, se una questione non è ancora stata decisa definitivamente, o se non si riesce a trovare un accordo definitivo, il documentario è un mezzo importante per permetterci di vederla da un particolare punto di vista. La maggior parte delle abitudini sociali (dalla vita familiare al benessere sociale, dalla guerra alla pianificazione urbana) risiede in un territorio conteso. Il documentario in film e in video ci sfida proprio su di esso. La retorica, o l’oratoria, dunque, è l’uso del linguaggio che maggiormente interessa i film e i video documentari. Gli
argomenti di cui parla il documentario appartengono spesso ai tre tipi di problemi che vengono considerati appartenenti alla sfera della retorica. Questi argomenti ricadono nelle tre suddivisioni classiche della retorica, che identificano molte – anche se non tutte – le questioni che i documentari affrontano. La sfera deliberativa: che cosa fare?
Questo è il contesto in cui si incoraggia o scoraggia, si esortano o dissuadono gli altri riguardo a un certo modo pubblico di agire. Le questioni politiche di rilievo sociale, come la guerra, il benessere, la conservazione, l’aborto, la riproduzione assistita, l’identità nazionale e le relazioni internazionali ricadono in questo dominio. Le deliberazioni in questo ambito riguardano il futuro e pongono domande su che cosa vada fatto. Una struttura del tipo problema/soluzione è molto adatta alla deliberazione; ci consente o ci impedisce di esaminare con attenzione le diverse scelte. Film come Smoke Menace (La minaccia del fumo, 1937), che invita all’uso del riscaldamento a gas invece del caliginoso carbone, The City, con la sua proposta di centri periferici “verdi” come alternative ai pericoli della città, e Una scomoda verità, con il suo richiamo a fermare il riscaldamento globale, dimostrano bene l’utilizzo della retorica deliberativa nell’ambito del documentario. La sfera giudiziaria o storica: che cosa è realmente successo?
In questo contesto si valutano (accusando o difendendo, giustificando o criticando) delle azioni precedenti. Il regista guarda al passato e pone questioni del tipo “Che cosa è realmente accaduto?”. Si tratta di problematiche di verità e di interpretazione, in cui la colpa o l’innocenza dipendono dalla legge, e la verità o la menzogna dalla storia. Nella retorica giudiziaria e in quella deliberativa vengono messe alla prova questioni di composizione e interpretazione. I processi servono a porre fine al dubbio, ad arrivare a una conclusione, proprio come i resoconti storici cercano di “registrare in maniera inequivocabile”, ma lo fanno sulla base di prove e argomentazioni che, nel loro insieme, sono aperte a più di una interpretazione. Il fatto che ci serva più di un racconto degli eventi per formare il nostro giudizio personale
dimostra quanto sia difficile farsi un’opinione definitiva sul passato. Shoah, che parla di colpa e innocenza nei confronti dell’Olocausto, La sottile linea blu, che affronta un singolo caso di colpa o innocenza, La caduta della dinastia dei Romanov (Padeniye dinastii Romanovikhj, 1927), sulla storia della Russia fino alla rivoluzione del 1917, e Eyes on the Prize, sulla storia del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, sono esempi dell’ampia filmografia documentaristica nel campo storico e giudiziario. La sfera apologetica o critica: com’è davvero il soggetto?
Questo è l’ambito della retorica in cui si lodano o si incolpano gli altri, o, più spesso, entrambe le cose. Esso evoca qualità o comportamenti ben precisi delle persone e i risultati che esse hanno ottenuto. È il genere della biografia che si dedica a questo. L’autobiografia, il diario, il film saggio riescono ad avere una svolta riflessiva quando i registi esplorano le loro stesse vite e sensibilità. I caratteri individuali possono essere rappresentati – in modo sincero o falso – nelle maniere più diverse, e la giustizia e l’imparzialità non sempre sono onorate. Proprio come le prove dimostrative si appoggiano più sulla logica apparente che sulla logica vera e propria, così la retorica commemorativa o critica si appoggia più sull’impressione di giustizia e accuratezza che sulla scrupolosa aderenza ai fatti.
Far from Poland (di Jill Godmilow, 1984). Jill Godmilow esplora il problema del documentarista che non può presenziare all’evento. Il movimento di Solidarność ha cambiato la società polacca, ma Godmilow non è riuscita ad avere un visto per entrare in Polonia come regista. Come poteva dunque rappresentare il movimento e il suo dilemma personale? Ha scelto una tecnica più vecchia di Nanuk l’eschimese di Flaherty: la rappresentazione. Invece di trattare la rappresentazione come gli eventi autentici, Godmilow ci fa capire chiaramente che ciò che vediamo mostra situazioni ed eventi a cui non abbiamo potuto assistere direttamente. Godmilow recluta degli attori per i ruoli dei membri di Solidarnosc. Lei stessa recita nel ruolo di una regista che vuole fare un film sul movimento. Fotografie di Mark Magill, concesse dalla regista.
Ne è esempio lampante il film di Jay Rosenblatt Human Remains (Resti umani, 1998), nel quale cinque dittatori (Mao, Hitler, Stalin, Franco e Mussolini) ci raccontano, attraverso le loro parole, le loro abitudini quotidiane e le loro manie. Nessuno di loro fa mai riferimento ai fatti politici e ai delitti
commessi. Il commento fuori campo è interamente in prima persona, come se stessimo ascoltando la lettura dei loro diari. Rosenblatt rivelò poi di aver svolto lunghissime ricerche e di aver selezionato dettagli reali a partire da una varietà di fonti, e riscrivendoli in seguito come se fossero resoconti in prima persona. L’impressione di veridicità è solo in parte valida, poiché, proprio come accade con il montaggio delle immagini, la composizione delle parole genera nuovi significati che, in questo caso, appartengono più a Rosenblatt che ai dittatori. Per esempio, il film crea una dissonanza deliberata tra la nostra conoscenza preesistente di quegli uomini come famigerate figure pubbliche e le loro abitudini e i loro gusti, a volte un po’ bizzarri e retrò. La retorica commemorativa o critica sceglie un soggetto o una situazione e fornisce loro una coloritura morale o affettiva. Cerca di dare tonalità piacevoli o spiacevoli a persone, cose o luoghi, in modo da renderli degni di emulazione e rispetto, o di biasimo e rifiuto. Come accade per le domande precedenti, “Che cosa fare?” e “Che cosa è realmente accaduto?”, anche la vera natura degli individui rimane aperta al dibattito. Siamo di nuovo nel terreno di ciò che è discutibile e privo di giudizio certo, ed è compito della retorica farci muovere verso una decisione e un giudizio, anche se a volte essa serve a prolungare un senso di meraviglia nei confronti delle complesse contraddizioni degli individui. Molti dei film di Errol Morris, a partire dai primi film ritratto, come Vernon, Florida (1981), sugli eccentrici abitanti di una piccola cittadina, fino a Standard Operating Procedure, studio ben più elaborato sulla polizia militare che partecipò, scattando fotografie tristemente note, agli abusi ad Abu Ghraib, sottolineano le ambigue ragioni e gli impulsi irrazionali che soggiaciono alle azioni umane. Nanuk l’eschimese, con il suo ritratto di Nanuk come un abile cacciatore; N!ai: Story of a !Kung Woman (N!ai: la storia di una donna !Kung, 1980), il ritratto della vita complicata di una volenterosa donna !Kung nell’arco di venti anni; Lonely Boy (Ragazzo solitario, 1962), con Paul Anka come esempio discutibile di giovane cantante di successo; e Paris Is Burning (Parigi brucia, 1990), una descrizione piena di rispetto e
comprensione delle vite dei membri di una sottocultura gay nera e latinoamericana e dei suoi spettacoli di travestimento: questi film danno un’idea della gamma di titoli che affrontano argomenti per i quali è appropriato l’utilizzo di uno stile retorico apologetico.
Il potere della metafora Un’ultima generalizzazione sugli argomenti ricorrenti nei documentari è che essi coinvolgono concetti e questioni che devono essere descritti con le metafore. Ovvero, ci sono alcuni argomenti che si prestano a una descrizione diretta; vengono utilizzate poche espressioni e basta una narrazione prosaica e lineare. La creazione dei chip al silicone può essere un argomento del genere, così come l’uso di diversi tipi di racchetta nel tennis. L’amore, la guerra e la famiglia, d’altra parte, sono argomenti che una descrizione schietta, da dizionario, non riesce a raccontare in modo completo. Possiamo conoscere il significato letterale di questi termini (“forte affetto o attrazione reciproca”, “conflitto armato e ostile tra due stati”, “unità base della società, che ha come nucleo un genitore e un figlio”), ma continuiamo lo stesso a discutere se si tratti di cose positive o negative, belle o brutte. Possiamo discutere di questioni come l’amore, la guerra, la famiglia e altri argomenti in generale, o possiamo concentrarci su singoli esempi: la guerra potrà essere un male necessario, ma i bombardamenti americani in Vietnam hanno una giustificazione? Le famiglie possono essere considerate una forma sacra di unione, ma la famiglia Loud (protagonista del documentario televisivo in più parti An American Family) ne è un esempio? I documentari contribuiscono al dibattito con il loro potere persuasivo. Ci mostrano un modo per dire che “le famiglie sono nidi di serpi” oppure “un porto in un mare burrascoso” e lo fanno secondo la loro modalità unica e affascinante. Queste metafore arricchiscono e ravvivano la nostra percezione del mondo. Le abitudini sociali, i tasselli fondamentali dell’esperienza umana, si prestano facilmente alla metafora. Anche se sappiamo che cos’è la famiglia in termini da dizionario, possiamo volere maggiori informazioni su come è una
famiglia, in termini più metaforici. Le metafore servono a darci un modo di accostare la guerra o l’amore o la famiglia a qualcos’altro che abbia qualità e valori simili. A seconda che noi definiamo la famiglia un porto sicuro in un mare burrascoso, come in Black is, Black Ain’t (Nero è, nero non è, 1995), in cui Marlon Riggs esplora le sue radici in una famiglia allargata di New Orleans, o un campo di battaglia, come in A Married Couple (Una coppia di sposi, 1970), in cui Allan King filma il processo di separazione pieno di acrimonia di due coniugi, la nostra visione della vita familiare cambierà considerevolmente. Allo stesso modo, se la guerra è una specie di inferno e se l’inferno è un ambiente terribile e indesiderabile, allora dev’essere qualcosa da evitare, come suggerito in San Pietro. Se la guerra è un rito di passaggio o una prova di maturità, e questo tipo di prova serve a fornire un senso di identità e di gloria, allora la guerra dev’essere qualcosa da cercare, come suggerito da Terra di Spagna: dipende tutto dai valori che assegniamo alla guerra in generale o a una specifica guerra o a una fazione specifica in una guerra. Il valore che preferiamo o rifiutiamo è spesso indicato da una metafora. Le metafore ci aiutano a definire o a capire le cose in termini di aspetto e sensazione; stabiliscono una somiglianza collegata a un nostro incontro fisico o astratto con qualcosa di nostra conoscenza, invece che limitarsi a fornire una descrizione da vocabolario. Le metafore fanno appello a forme basilari di esperienza personale e di orientamento fisico (su, giù, sopra, sotto) per attribuire dei valori a dei concetti sociali. Il successo, per esempio, può essere rappresentato come una scalata verso un punto più alto della propria carriera, anche se in senso letterale non avviene nessun cambio di altitudine, ma solo uno spostamento metaforico verso una posizione sociale di maggiore prestigio. Esso attiva quello che può essere definito come il riflesso muscolare che sta nel gesto di elevarsi e alzarsi e il sentimento di realizzazione e di potere che si prova nel compiere quell’atto. Molte metafore hanno origine da un’esperienza diretta e tangibile, ma collegano quella esperienza con qualità più astratte e intangibili.
Un tipo di rappresentazione di questo genere è il cuore del cinema. L’immagine documentaristica è sempre qualcosa di concreto e specifico. Possiamo mostrare una persona che scala una montagna vera e propria come metafora del successo, o mostrare immagini di cadaveri per fare capire che la guerra è un inferno. La selezione e la disposizione di questi suoni e immagini sono concrete e reali; forniscono una forma immediata di esperienza da vedere e sentire, ma diventano anche, attraverso la loro organizzazione in un insieme più grande, una rappresentazione metaforica di come sia una cosa nel mondo reale. Come sono le negoziazioni per un matrimonio di una giovane donna nella società dei Turkana? Sono così, come in Wedding Camels, quando vediamo le negoziazioni per un matrimonio, e capiamo che il loro scopo è rappresentare le negoziazioni per ogni tipo di matrimonio in quella società. L’amore è così in A Married Couple, Sherman’s March, o Silverlake Life: the View from Here (La vita a Silverlake: la vista da qui, 1993); la guerra è così in La section Anderson (1966), o Victory at Sea (Vittoria sul mare, 1952-1953), o Gunner Palace (2004); la famiglia è così in Finding Christa, Complaints of a Beautiful Daughter o Nobody’s Business. Finiamo per avere un estremo bisogno di rappresentazioni metaforiche che ci aiutino a capire quali valori dobbiamo attribuire alle pratiche sociali. I documentari ci danno l’idea di poter capire in che modo gli altri incasellino in categorie a noi familiari le esperienze vissute (vita familiare, sanità pubblica, scelte sessuali, giustizia sociale, morte e così via). Offrono una visione delle esperienze degli altri e, per estensione, delle abitudini sociali che noi abbiamo in comune con loro. La nostra scelta di accettare o meno le opinioni e i punti di vista di un documentario dipende molto dalla forza stilistica e retorica del film, così come dal nostro orientamento precedente. L’oscillazione tra specifico e generale all’interno del documentario, tuttavia, deriva dal permettere o meno che una data rappresentazione sostenga (metaforicamente) un’opinione o un parere generale su un dato argomento. La comprensione attraverso la metafora è spesso il modo più significativo e persuasivo di convincerci del merito di
un’opinione piuttosto che di un’altra. Una definizione di “genocidio” può suonare terrificante (“la distruzione intenzionale e premeditata di un gruppo razziale, politico o culturale”), ma il suono e l’immagine di un particolare bulldozer che spinge una grande quantità di cadaveri nudi dentro una trincea in un determinato momento storico risulta terrificante in un modo più vivido e indelebile. Se il genocidio è così, come suggerisce la rappresentazione di Notte e nebbia, la metafora ci fornisce un significato e una descrizione dalla potenza straordinaria.
Valzer con Bashir (di Ari Folman, 2008). In questo film, immagini crude e spesso fantasmagoriche assalgono lo spettatore, poiché il regista rifiuta di fare uso di filmati storici e decide invece di ricorrere all’animazione, altamente soggettiva ed emotivamente potente, per trasmettere l’esperienza di un evento traumatico. Per gentile concessione di Sony Picture Classics/Photofest.
È qui che i documentari animati hanno un impatto considerevole. Le immagini animate colpiscono per l’uso di tutte le risorse dell’immaginazione creativa e, nel caso dei documentari, si legano con date situazioni ed eventi, e talvolta persino con le voci di persone reali. Valzer con Bashir ne è un esempio notevole per la maniera in cui incarna i sentimenti di Ari Folman, il regista, nell’essere complice di un massacro orrendo durante l’invasione israeliana in Libano nel 1982. L’accaduto lo perseguita per anni, e le immagini animate
forniscono una rappresentazione grafica dell’agonia, dell’isolamento, della disperazione che lui, e molti altri come lui, hanno provato negli anni successivi. Allo stesso modo, in His Mother’s Voice (La voce di sua madre, 1997), Dennis Tupicoff registra il panico e la paura che assalgono una madre quando scopre che il proprio figlio è stato colpito. La colonna sonora del film è la registrazione stessa della voce della madre che racconta quanto accaduto, mentre il montaggio delle immagini fornisce una rappresentazione animata di come ci si senta a raggiungere il luogo della sparatoria senza sapere se il proprio figlio sia vivo o morto. Anche solo con questa scelta, Tupicoff sarebbe riuscito a realizzare un film toccante e pieno di rispettosa empatia, ma nel bel mezzo del film decide di riprendere la colonna sonora, ossia la registrazione della voce, dall’inizio. In quel momento l’animazione cambia stile, e questa volta lo spettatore resta a casa della madre invece di seguirla nel percorso verso la scena della sparatoria. La macchina da presa indugia sulla stanza del figlio e sugli oggetti che si caricano di significati metaforici, come i poster, i vestiti, la chitarra. Le immagini animate ci spingono a immaginare ciò che questi oggetti rappresentano per una madre che ha perso il proprio figlio. È un pezzo di cinema straordinariamente potente.
His Mother’s Voice (di Dennis Tupicoff, 1997). Utilizzando per due volte il racconto che la madre fa della sparatoria in cui il figlio è rimasto colpito, Dennis Tupicoff riesce a offrire due visioni soggettive dell’accaduto: le sensazioni durante un viaggio che porta la donna sulla scena della sparatoria per scoprire che cosa sia successo al figlio e la sensazione che dà ascoltare il racconto mentre le immagini di suo figlio e della sua stanza riempiono la sua mente. Fotografia concessa dal regista.
L’identità personale, l’intimità sessuale e l’appartenenza a un gruppo sociale sono alcuni dei modi per definire gli argomenti di un documentario. Ciò che ci fa parlare di più in un documentario sono dunque quei temi che nella vita di ogni giorno ci appassionano e ci dividono maggiormente. Essi seguono il sentiero di ciò che desideriamo, a mano a mano che comprendiamo che cosa vuol dire cercare la propria identità, avere una relazione intima e privata con un’altra persona e fare parte anche del resto della società. Tra i sentieri delimitati dai nostri desideri in queste tre direzioni, troviamo alcuni argomenti basilari come la biografia e l’autobiografia, il sesso e la sessualità, la famiglia e le relazioni intime, il lavoro e la classe sociale, il potere e la gerarchia, la violenza e la guerra, l’economia, la nazionalità, l’etnia, la razza, la giustizia e i cambiamenti sociali, la storia e la cultura. I documentari ci forniscono delle rappresentazioni di come siano stati gli incontri con queste diverse forme di tradizione sociale, in altri luoghi e per altre persone e da un diverso punto di vista, in
modo da predisporci alla formazione di un nostro proprio punto di vista. La caduta della dinastia dei Romanov, per esempio, racconta la storia degli ultimi anni del dominio dei Romanov in Russia e i primi anni della Rivoluzione sovietica. Il documentario costruisce una serie di evidenti paralleli e contrasti tra le immagini di vita dello zar, la sua famiglia, la sua corte e le immagini di vita della maggior parte della popolazione russa. La vita sotto i Romanov diventa un mondo di chiare opposizioni: piacere o lavoro, ricchezza o povertà, eleganza o necessità. Esther Shub delinea questa prospettiva con una serie di materiali d’archivio che monta in modo da formare una dichiarazione d’accusa. Decide di accentuare il contrasto con l’uso di intertitoli, giustapposizioni e riprese individuali che mostrano, a volte in modo ironico e a volte in modo caustico, il decadimento morale di un regime che era indifferente alle condizioni dei suoi sudditi. In un’inquadratura, per esempio, un conte e sua moglie prendono il tè a un tavolo all’aperto. Dopo che si sono alzati per andarsene, compare un servitore, che porta via il servizio da tè. La relazione tra le classi viene rivelata attraverso queste azioni, ma il filmato d’archivio di Shub va anche oltre: se si guarda da vicino, è possibile vedere il servitore che resta sullo sfondo per tutta la ripresa, aspettando il suo turno per muoversi e portare via il servizio da tè. Shub ha recuperato quello che sembra uno dei primi filmati casalinghi, che questo conte ha inscenato per documentare la sua vita in campagna, allo stesso modo in cui i dipinti paesaggistici celebravano la ricchezza della nobiltà terriera; in questo contesto però il valore morale del documento è rovesciato: viene usato per biasimare quello che era nato per elogiare. L’atto stesso di mettere in scena un rituale di dominio e di servitù, che all’origine poteva passare inosservato, diventa, invece, la prova della volontà di sfruttare gli altri per mantenere i propri privilegi, principio che, secondo Shub, ha contribuito a demolire i Romanov. In un altro documentario sui cambiamenti sociali, Jill Godmilow descrive l’ascesa del movimento Solidarność in Polonia e il collasso del governo comunista. In contrasto con
Shub, Godmilow non ha la possibilità di utilizzare filmati d’archivio, né può riprendere gli eventi durante il loro svolgimento. Mentre Solidarność guadagna consensi, una serie di ostacoli costringono la regista a restare a New York. Come può allora rappresentare quello a cui non può assistere? Far from Poland (Lontano dalla Polonia, 1984) usa una strategia di riflessione più che di esposizione. Godmilow trasforma il film in un’opera che, allo stesso tempo, parla delle difficoltà della rappresentazione, della convinzione che “essere presenti” sia l’unica prova del fatto che si sta dicendo la verità, delle motivazioni che i registi hanno nel rappresentare gli altri se questo atto distorce la realtà nel rivelarla, oltre che parlare di questo specifico momento storico di trasformazione sociale. Il punto di vista della regista ci mette in guardia nei confronti del potere della rappresentazione documentaristica e allo stesso tempo esprime chiaramente la propria solidarietà con quel movimento sociale che può rappresentare solo in maniera parziale e incompleta.
La caduta della dinastia dei Romanov (di Esther Shub, 1927). Le immagini di un conte e della moglie non si basano sul consenso del protagonista, ma su una sua attiva orchestrazione: come filmato amatoriale, mostrano il rituale giornaliero, nella Russia prerivoluzionaria, di prendere il tè in giardino. La coppia esce dall’inquadratura e noi pensiamo che la ripresa sia terminata. Invece no: essa continua e una coppia di servitori fa il suo ingresso per portare via il servizio da tè. Shub trasforma il filmato amatoriale in un documento sociale sulla struttura e gerarchia di classe. In una buona edizione del film, si può anche vedere il cameriere che aspetta, dietro i cespugli sul fondo, il momento per entrare e, secondo Shub, essere immortalato per i posteri.
Far from Poland. Riprese in esterni per il film, ma con Shamokin, in Pennsylvania, a rappresentare le miniere di carbone in Polonia. Con il suo approccio “consapevole”, Godmilow aggiunge al film delle riflessioni che ci fanno capire la sostituzione di luogo. In seguito a questo, potremmo porre delle questioni sul compromesso tra la volontà di comunicare un senso di autenticità e l’effettiva verità. La tattica della regista, per lo meno, contrasta fortemente con quelle adottate dai giornalisti televisivi riguardo agli stessi eventi. Fotografia di David Dekok, concessa da Jill Godmilow.
Similmente, Dead Birds, di Robert Gardner, è un racconto etnografico sulla vita della popolazione Dani sugli altopiani della Nuova Guinea, una tribù che, ai tempi della spedizione del 1961, viveva ancora quasi del tutto separata dal resto dell’umanità. La preoccupazione centrale del film è la violenza rituale all’interno della tribù dei Dani. Con un tono poetico e meditativo, Gardner vuole fare capire che la severità e i rischi dei combattimenti rituali, in cui squadre di uomini provenienti da tribù vicine si affrontano con lance e frecce fino a che qualcuno non viene ucciso o ferito, hanno un ruolo molto importante nel definire l’identità culturale e individuale. La vita è così, dice Gardner, e queste forme disciplinate di
aggressione sociale sono le migliori per mantenere un senso di coerenza sociale. Per contrasto, il film di Mitchell Block No Lies, similmente a Far from Poland di Godmilow, assume un atteggiamento più riflessivo sulla violenza rituale. Block mostra la violenza fisica di un regista inopportuno e insensibile, che continua a farsi raccontare e a giudicare la violenza che ha subito la sua amica al fine di riflettere non solo sul problema dello stupro e della nostra reazione a esso in quanto uomini e donne, ma anche sulla violenza rituale con cui le vittime di uno stupro vengono rappresentate dai mezzi di comunicazione che prolungano la vittimizzazione dell’atto originale. Il regista abusa fisicamente del proprio soggetto, allo stesso modo con cui l’aggressore ha abusato di lei. Rappresentando questo processo di abuso come una possibile funzione della rappresentazione del documentario, Block mette in questione il fondamento etico della relazione tra regista e soggetto in maniera diretta ed esplicita. Egli si chiede se l’atto di filmare e intervistare in questo modo una donna che è stata violentata sia simile alla violenza vera e propria che ha già subito. Come esempio finale, vanno considerate due rappresentazioni di relazioni familiari. In Four Families (Quattro famiglie, 1959), Margaret Mead adotta la modalità espositiva (commento fuori campo) per paragonare e sottolineare le differenze tra la vita di quattro famiglie in quattro culture diverse: Francia, India, Giappone e Canada. La regista utilizza delle categorie sociali – come l’educazione dei figli, la disciplina, i ruoli maschili e femminili, e così via – per esprimere dei pareri sulle varie somiglianze e su alcune delle differenze tra queste culture. Le singole famiglie che vediamo servono come esempi, come accadeva nei documentari degli anni Trenta quando riprendevano singoli individui: noi non impariamo a conoscere in modo approfondito i singoli membri di ogni famiglia. Il film presenta alcuni esempi di come si comportano e di come interagiscono per illustrare caratteristiche culturali generali, più che quelle dei singoli attori sociali. Margaret Mead ci informa che la vita familiare in queste culture è così.
Questa rappresentazione della famiglia come un’entità culturale omogenea, meglio identificata se paragonata ad altre di differenti culture, è in netto contrasto con la visione che ci viene data nel film di Ngozi Onwurah The Body Beautiful. Onwurah adotta un approccio performativo verso l’argomento principale del film, ovvero la sua relazione con la madre. La regista è figlia di un matrimonio interrazziale tra il padre africano e la madre inglese. Questo mette già in discussione l’assunto di Mead che ogni cultura nazionale sia nettamente diversa: il soggetto in sé è già un’incarnazione di due culture differenti. Attraverso un commento poetico fuori campo e alcune scene di infanzia reinterpretate con la sua vera madre, la regista descrive l’ambivalenza che provava da piccola nei confronti della genitrice, una donna di umili origini e, dal suo punto di vista infantile, non attraente. Solo retrospettivamente la regista si rende conto della sofferenza che sua madre ha patito e dei sacrifici che ha fatto, a partire dalla scelta di portare a termine la gravidanza di Ngozi, anche se ciò avrebbe comportato una mastectomia, a causa di un cancro che la donna avrebbe potuto curare senza ricorrere alla chirurgia, ma mettendo a rischio il feto.
The Body Beautiful (di Ngozi Onwurah, 1991). Sian Martin posa per una sessione fotografica di moda nel film di Onwurah sul suo rapporto con la madre. Il mondo della fotografia di moda rappresenta un mezzo di fuga dall’esistenza scialba associata alla madre. Una scena di seduzione immaginaria, che Onwurah filma con sua madre come attrice, suggerisce il tentativo di portare quest’ultima fuori dalla sua esistenza comune, verso un mondo di fantasia. Il tema principale del film, tuttavia, è il processo con cui Onwurah riesce ad accettare sia la madre sia la dura realtà della sua vita. Fotografia concessa da Women Make Movies.
Onwurah mette in scena un dramma di affetto e riconciliazione altamente significativo, che enfatizza il grande investimento soggettivo, da parte della regista, sul suo soggetto, la madre, e trasmette forzatamente questo investimento sul pubblico. (A un certo punto, Onwurah allestisce una scena d’amore e di seduzione tra sua madre e un uomo di colore più giovane che trasmette una forte carica emotiva.) Da questo film non apprendiamo niente per quanto riguarda le stime statistiche dei matrimoni misti o la complessità di trovare riconoscibili differenze nella struttura familiare a livello di cultura nazionale. Invece, The Body
Beautiful si immerge in una rappresentazione che suggerisce che “una relazione ambivalente con la propria madre è così”. La metafora è ancora più potente quando è basata sulla complessa relazione con la propria madre. Il potere emotivo di questi due film è radicalmente diverso, così come lo sono le rivelazioni di cultura sociale generale che ogni film fa. Quello di Mead suggerisce che le famiglie possono essere capite attraverso un esame comparativo e transculturale di alcune categorie, a cui viene data una esemplificazione concreta attraverso i quattro nuclei familiari studiati; il film di Onwurah, invece, suggerisce che le famiglie possano essere comprese attraverso la descrizione dei conflitti e delle scelte difficili di una di esse in particolare, la propria. Come il film di Mead lascia spazio alla individualità attraverso la scelta delle quattro famiglie, ma minimizza tale aspetto, così quello di Onwurah lascia spazio alla generalizzazione di questioni di razza, classe e nazionalità, ma minimizza questi elementi in favore della specificità. Entrambi i film hanno una forma metaforica che asserisce che “La vita familiare è così”, ma lo fanno in modi molto diversi. Concentrarsi sul particolare piuttosto che sul generale è diventata la scelta prediletta di molti registi contemporanei. Le ampie categorie in cui rientrano situazioni ed eventi specifici (famiglia, amore, guerra, cultura e così via) restano in gioco, ma ancor più resta fondamentale la scelta dello spettatore di ricavare interazioni e stabilire connessioni più che accettare in maniera diretta asserzioni e argomentazioni rispetto a tali categorie. Tongues Untied e Silverlake Life adottano questo metodo nel trattare diversi aspetti della vita omosessuale; Tarnation e Una storia americana indugiano sulle complesse forme di ambivalenza presenti nelle relazioni familiari; Bus 174 (2002) e Grizzly Man investigano sulle vite di particolari individui che vivono, in maniera diversa, ai margini della società. Si possono sempre tenere in considerazione le categorie più ampie e le associazioni metaforiche, ma la loro importanza risulta attenuata se paragonata alla vorticosa intensità emotiva di certi individui e situazioni particolari. In conclusione, i film e i video documentari parlano del mondo sociale in modo tale da smuoverci o convincerci.
Tendono a rivolgersi a quegli aspetti della nostra esperienza che ricadono nelle categorie generiche di pratiche sociali e rapporti mediati dalle istituzioni: vita familiare, orientamento sessuale, conflitto sociale, guerra, nazionalità, etnia, storia e così via. Ricorrono a prove ma non sono in se stessi documenti. Possiedono una voce e un punto di vista propri, con i quali comunicano con noi. In quanto tali diventano una tra le tante voci nell’arena della discussione e del dibattito sociale. È in questa arena che noi gareggiamo per il sostegno e il favore degli altri, in nome di una data causa o un dato sistema di valori. Infine, si tratta di un’arena ideologica, che stabilisce la nostra fiducia o il nostro distacco nei confronti delle tradizioni e dei valori dominanti della nostra cultura. Le tecniche di retorica sono fondamentali all’interno di questo scenario, poiché né la logica né la forza possono facilmente prevalere. L’arena è piccola e coinvolgente in The Body Beautiful, è grande e stimolante in La caduta della dinastia dei Romanov. In entrambi i casi, i film e i video documentari ci spingono a capire e ad affrontare la realtà storica in modo significativo.
CAPITOLO 5 COM’È NATA LA FILMOGRAFIA DOCUMENTARISTICA? L’origine mitica nel cinema primitivo La nostra analisi del documentario non sarebbe completa se non dedicassimo una riflessione alla maniera in cui questo genere trova la sua forma di espressione. La voce del documentario si riferisce ai modi con cui i film e i video documentari parlano del mondo intorno a noi, ma da un punto di vista particolare. Quando un documentario pone un caso o espone un argomento, la “voce” identifica il modo in cui lo fa. In quale momento storico alcuni film hanno iniziato a parlarci attraverso questo tipo distintivo di voce? Che relazione ha con le altre forme di cinema? Come ha fatto il documentario a trovare la sua voce? C’è da notare che nessuno si è imposto di inventare tale voce o di creare dal nulla una tradizione documentaristica. Lo sforzo di costruire una storia del cinema documentario, una storia con un inizio nel passato e una conclusione nel presente o nel futuro, nasce dai fatti. Ha origine dal desiderio da parte di registi e studiosi, come me, di capire come hanno fatto le cose a diventare come sono ora. Ma per chi è venuto prima di noi, il modo in cui sarebbero andate le cose fino a oggi era questione di pura speculazione. I loro scopi erano del tutto immediati: fare film che rispondessero ai loro bisogni e alle loro intuizioni a proposito della maniera in cui rappresentare i soggetti che avevano scelto. L’interesse dei documentaristi di un tempo non era quello di fornire un sentiero semplice e chiaro per lo sviluppo di una tradizione non ancora esistente. La loro grande passione era esplorare i limiti del cinema, scoprire nuove possibilità e forme mai provate. Alcuni di questi sforzi avrebbero in seguito preso forma in ciò che ora chiamiamo “documentario”. Guardando indietro, tuttavia, l’esistenza di una tradizione documentaristica rende ancora più sfocati i confini tra fiction e non-fiction, tra narrativa e retorica, tra poesia e spettacolo, tra
l’intento di documentare la realtà e quello di sperimentare con la forma che davano energia a quei primi sforzi. Il proseguimento di questa tradizione di sperimentazione continua, ma in relazione a nuove forme e nuove tecniche, dall’animazione alla ricostruzione: è proprio questo che permette al documentario di restare un genere vivace e complesso. Un modo tipico per spiegare l’ascesa del documentario parte dalla storia dell’interesse del cinema nei confronti dell’aspetto visibile delle cose, la sua prodigiosa capacità di catturare la vita così com’è, un’abilità che è stata la caratteristica principale del cinema primitivo e del suo immenso catalogo di persone, luoghi e cose ripresi in tutto il mondo. Come la fotografia prima di esso, il cinema è stato una rivelazione. Le persone non avevano mai visto immagini che possedessero una tale, straordinaria somiglianza con il loro oggetto, e non avevano mai visto un movimento apparente che fornisse un’idea così convincente di quello vero. Come ha fatto notare il teorico del cinema Christian Metz negli anni Sessanta, duplicare l’impressione del movimento vuol dire duplicare la realtà. Il cinema ha ottenuto questo risultato a un livello che nessun altro mezzo aveva mai raggiunto. La capacità delle immagini fotografiche di ritrarre un’impressione vivida della realtà, compreso il movimento, quell’aspetto che il dipinto e la scultura erano riusciti a sfiorare ma non a duplicare, fa riferimento ad altri due miti da svelare: uno sull’immagine e uno sul regista. Entrambi necessitano di alcune correzioni.
Il realismo e il desiderio di rappresentarlo: un terreno non sufficiente per il documentario La notevole somiglianza dell’immagine fotografica con ciò che registra fornisce un determinato aspetto, quando non lo stesso status, a un documento. Offre una prova visibile di quello che ha visto la macchina. Il senso di autenticità presente nei film di Louis Lumière girati alla fine del XIX secolo, come L’uscita dalle officine Lumière, L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat (L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat), L’innaffiatore innaffiato (L’arroseur arrosé) e Il pasto
del bambino (Répas de bébé), tutti datati 1895, li fa apparire poco distanti dal film documentario vero e proprio. Nonostante siano tutti composti da una singola inquadratura e durino pochi minuti, si ha l’impressione che forniscano una finestra all’interno del mondo storico e sociale. I film di fiction ci danno spesso l’idea di guardare dentro un mondo privato o insolito dal nostro vantaggioso punto di vista all’esterno di esso, mentre i film documentaristici ci danno quella di guardare fuori, dal nostro angolo di mondo verso un’altra sua parte. Gli operai che escono dalla fabbrica in L’uscita dalle officine Lumière, per esempio, passano di fianco alla cinepresa dandoci l’impressione di essere lì, a guardare quel preciso momento storico mentre avviene. Questi film delle origini del cinema vengono solitamente indicati da molti come “origine” del documentario. Molti d’altra parte li identificano come “origine” del realismo nei film di fiction. In entrambi i casi, mantenendo viva quella “fede nell’immagine” che il critico francese André Bazin ammirava, i film dei fratelli Lumière sembrano registrare la vita di tutti i giorni così come si presentava. Girati senza abbellimento o montaggio, rivelano lo scintillante mistero degli eventi. Come se volessero rappresentarli ma non svelarne i lati oscuri. Una nota di umiltà è sempre presente nell’aria. Il cinema era uno strumento dal potere straordinario, non aveva bisogno di esagerazione o di spettacolo per conquistare la nostra ammirazione per ciò che era in grado di fare.
L’uscita dalle officine Lumière (di Louis Lumière, 1895). I primi film dei fratelli Lumière documentano in maniera esplicita e senza pretese alcune caratteristiche della vita quotidiana e nonostante ciò non è del tutto vero che non siano in parte messe in scena. Gli operai, tutti ben vestiti per l’occasione, defluiscono dall’ingresso principale della fabbrica su un piano accuratamente preparato e perpendicolare alla macchina da presa, in modo che la messa a fuoco resti nitida e la composizione d’insieme gradevole alla vista. Nessuno guarda in camera. L’impressione di realtà, comunque, rimane piuttosto forte poiché tutta l’azione si svolge in un unico piano sequenza. Per gentile concessione di Photofest.
Il secondo mito riguarda il regista. La notevole accuratezza dell’immagine come rappresentazione fotografica di ciò che la macchina ha visto affascinava coloro che facevano fotografie. Un bisogno urgente di esplorare questa fonte di interesse ha spinto i primi registi a registrare i diversi aspetti del mondo intorno a loro. Anche quando si trattava di mettere in scena l’azione o di abbellire la scena, come ha fatto Georges Méliès in Viaggio nella Luna (Le voyage dans la Lune, 1902), l’interesse nei confronti della capacità dell’immagine fotografica di registrare qualsiasi cosa le passasse davanti e presentarne il prodotto a un pubblico attraverso la striscia di pellicola, che può essere proiettata più e più volte, ha sempre avuto la precedenza su raffinatezze come la narrazione e l’approfondimento dei personaggi. Abbiamo, quindi, due miti delle origini: il regista era un eroe che viaggiava in lungo e in largo per rivelare angoli
nascosti e accadimenti notevoli che facevano parte della nostra realtà; e le immagini su pellicola (e le fotografie) avevano il potere di riprodurre la realtà tramite un processo fotomeccanico, grazie al passaggio della luce attraverso la lente e l’emulsione fotografica. Per alcuni, queste due caratteristiche costituiscono le origini mitiche del documentario. La combinazione della passione per la registrazione del reale e per lo strumento capace di una grande verosimiglianza ha generato una notevole purezza di espressione nell’atto della ripresa documentaria. Come vedremo, tuttavia, c’è un grande salto da fare per passare dalla documentazione cinematografica al film documentario. La storia delle origini del genere, per convenzione, culmina in un doppio risultato: da un lato la lucidità narrativa con cui Robert Flaherty ha portato gli Inuit sul grande schermo con Nanuk l’eschimese e dall’altro la capacità di marketing con cui John Grierson ha stabilito una base istituzionale per il cinema documentario. Grierson ha capeggiato la sponsorizzazione della produzione di documentari da parte del governo inglese negli anni Trenta, come Dziga Vertov aveva fatto negli anni Venti in Unione Sovietica e Pare Lorentz durante gli anni Trenta negli Stati Uniti. A dire il vero, Vertov ha iniziato la promozione del film documentario ben prima di Grierson, ma è rimasto più che altro un personaggio singolare all’interno dell’appena sbocciata industria cinematografica sovietica; non ha attratto un gruppo di registi con gli stessi obiettivi, né ha assunto quel solido ruolo istituzionale raggiunto da Grierson. Quest’ultimo è stato il primo a guidare il movimento documentaristico inglese e, in seguito, canadese. Nonostante il valido esempio di Dziga Vertov e del cinema sovietico in generale, è stato Grierson ad assicurare alla produzione documentaristica una nicchia stabile in cui restare. Unire la strana capacità della pellicola di documentare eventi avvenuti in precedenza con la nascita di una base istituzionale corrisponde ai quattro modi di definire il documentario discussi nel Capitolo 1. Questi sviluppi hanno fatto nascere un gruppo di registi, un quadro istituzionale, un genere di film dalle caratteristiche comuni e, presumibilmente,
un pubblico interessato a queste particolari qualità. Il fatto che siano passati oltre trent’anni tra la prima immagine capace di rendere in maniera incredibilmente accurata la realtà, movimento incluso, e il ruolo pionieristico di Grierson nel creare le basi istituzionali del genere documentario pone un problema. Perché non ci fu un Grierson nel 1895? Dove finirono quelle rappresentazioni estremamente realistiche tra il 1895 e la fine degli anni Venti? Ciò che abbiamo sono delle condizioni necessarie ma non sufficienti. Questa storia delle origini del genere ha a che vedere con un mito.
Il documentario come convergenza di diversi fattori Uno dei problemi di queste origini mitiche sta nel fatto che la capacità propria del cinema di fornire una documentazione rigorosa di ciò che passa davanti alla cinepresa porta in almeno due altre direzioni, oltre al documentario: scienza e spettacolo. La loro presenza indica che la qualità indicativa dell’immagine non conduce in maniera diretta al documentario. Entrambe le direzioni hanno inizio con il cinema delle origini (più o meno dal 1895 al 1906, quando il cinema narrativo ha iniziato ad avere il predominio). Sia la scienza che lo spettacolo contribuiscono allo sviluppo del film documentario ma non ne sono sinonimi. Possiamo in poche parole sottolinearne le differenze. In primo luogo, la capacità dell’immagine fotografica (e in seguito della colonna sonora registrata) di generare delle repliche precise di certi aspetti di un oggetto fisico è ciò su cui si basano i metodi scientifici di rappresentazione. Questi sistemi si basano fortemente sulla qualità indicativa dell’immagine fotografica. Un segno distintivo ha una relazione fisica con ciò a cui si riferisce: un’impronta digitale è una replica esatta dell’insieme di spirali sui nostri polpastrelli; la forma asimmetrica di un albero colpito dal vento rivela la sua forza e la sua direzione. Il valore di questa qualità indicativa nell’ambito delle immagini scientifiche dipende molto dalla capacità di minimizzare ogni grado con cui l’immagine, sia essa una radiografia o un’impronta digitale, mostra aspetti di
un’opinione o di un punto di vista che appartiene al suo creatore. Va applicato un severo codice di obiettività o di prospettiva istituzionale. L’immagine indicativa ha la funzione della prova fattuale o empirica. Non offre un punto di vista e non ha una voce, o se la ha è molto flebile. È la voce dell’analista o dell’interprete qualificato che porta significato all’immagine. Il documentario invece prende vita quando ottiene una voce tutta sua. Produrre dei documenti accurati o delle prove visive non aiuta a trovare questa voce; anzi, può allontanarci ancora di più da essa. Il cinema delle origini, dei fratelli Lumière o di altri autori, così come la scienza, mancava di quella voce che poi caratterizzerà il documentario. Il documentario non dipende dalla qualità indicativa dell’immagine per trovare una sua identità. Non è la scienza. In effetti, i documentari delle origini utilizzavano le ricostruzioni, che non potevano certo essere registrazioni autentiche di quanto accaduto, proprio come oggi utilizzano l’animazione. Solitamente il documentario fa uso delle immagini indicative come prove, o per creare l’impressione di prova a sostegno delle tesi o dei punti di vista che propone. Robert Flaherty, per esempio, ha creato l’impressione che la maggior parte delle scene avesse luogo dentro l’igloo di Nanuk, mentre in realtà erano state girate all’aria aperta con mezzo igloo gigante come sfondo. Questo ha permesso a Flaherty di avere abbastanza luce per girare, ma ha imposto al soggetto di recitare come se si trovasse all’interno di un vero igloo, quando in realtà non era così. Night Mail ricreava la sensazione di come ci si doveva sentire ad attraversare l’Inghilterra sull’espresso notturno che trasportava la posta fino in Scozia, ma le scene di interni in cui la corrispondenza veniva ordinata vennero girate in uno studio di registrazione e non sul treno. Per La sottile linea blu, Errol Morris ha girato una serie di ricostruzioni che rappresentano l’omicidio di un ufficiale della polizia di Dallas come descritto da numerosi personaggi del film. Non solo le ricostruzioni sono diverse l’una dall’altra, il che solleva la domanda “Che cosa è accaduto davvero?”, ma ognuna di esse è stata girata non a Dallas, ma in New Jersey. Tutte queste scelte rappresentano delle tattiche che il regista attua per generare l’effetto desiderato su un pubblico. Dal punto di vista
scientifico potrebbero valere poco, ma sono parte vitale della rappresentazione documentaria.
Mondo cane (di Gualtiero Jacopetti e Franco E. Prosperi, 1962). Una serie di “Mondo Movie” ha seguito la scia del successo di Mondo cane. Il senso di spettacolo e di sensazionalismo che richiama il cinema delle origini è stato ripreso ai nostri giorni in parecchi programmi della “Reality Tv”, da Cops a Survivor, che servono a presentare una successione di immagini e scene fantastiche come a dire: “Non è incredibile?!”.
Quando crediamo in qualcosa senza che vi sia una prova conclusiva della validità della nostra opinione, questo diventa un atto di fede, o di feticismo. I documentari ci invitano spesso ad affidarci alla fede nel credere che “quello che si vede è quello che è stato”. Questo atto di fede può derivare dalla capacità dell’immagine fotografica di rappresentare la realtà, nonostante da ciò non si possa trarre una completa giustificazione, come accade nelle ricostruzioni. Per il regista, creare la fiducia, ovvero portarci alla sospensione del dubbio o dell’incredulità attraverso il mostrarci un’impressione di realtà e, quindi, di verità, corrisponde più alle proprietà della retorica che della scienza. Un documentario non solo documenta gli avvenimenti, ma trasmette anche un distinto punto di vista o una tesi a proposito di essi. Il punto di vista, o la tesi, è uno tra molti altri. Noi accettiamo il valore di prova delle immagini
come dimostrazione della validità di un certo punto di vista, ma non senza rischi. In secondo luogo, anche lo spettacolo è diverso dal documentario. Il cinema primitivo non solo sosteneva l’uso scientifico delle immagini, ma è anche sfociato in quello che lo storico del cinema Tom Gunning ha definito il “cinema delle attrazioni”. Esso si basava sull’immagine come documento per presentare agli spettatori rappresentazioni sensazionali dell’esotismo e ritratti inusuali della realtà. Il termine “cinema delle attrazioni” si riferisce all’idea delle attrazioni da circo e del loro chiaro piacere nel mostrarci una grande quantità di fenomeni insoliti. Esse riuscivano a stimolare la curiosità e a soddisfare la passione dei primi registi e del pubblico, entrambi interessati a immagini che rappresentassero gli aspetti più strani del mondo intorno a loro. In tutto questo resta presente un forte senso di ostentazione, che differisce radicalmente sia dall’idea di osservare dall’esterno un mondo fittizio e privato sia da quella di servire da prova scientifica. Come le immagini scientifiche, le attrazioni mantengono una forma di fascino diversa da quella dei punti di vista e delle tesi proposte dal documentario. Il “cinema delle attrazioni” rilanciava il suo motivo di interesse sugli spettatori e si rallegrava del sensazionalismo generato dallo strano, dall’esotico e dal bizzarro. Esso cercava di divertire, sorprendere, solleticare e scioccare, più che di dichiarare, valutare o elogiare (una parte della sua eredità sono i numerosi reality show che hanno proliferato a partire dagli anni Novanta). Il punto di vista specifico del regista scivolava in secondo piano rispetto allo spettacolo raccontato. Louis Lumière ha mandato numerosi operatori in giro per il mondo, armati del loro brevettato cinematografo (uno strumento che non solo poteva impressionare la pellicola come una moderna cinepresa, ma serviva anche per svilupparla e proiettarla!). Noi ricordiamo il nome di pochissimi di loro: quello che hanno ripreso importava di più di come l’avevano ripreso. Alcuni aspetti di questa tradizione del “cinema delle attrazioni” sono ancora presenti oggi, così come persistono gli usi scientifici dell’immagine fotografica. Si possono chiaramente trovare in una grande quantità di film, che
sondano la parte più cruda della vita di tutti i giorni. Li troviamo, per esempio, nei “Mondo Movie”, a cominciare dalla classica serie di abitudini scandalose e costumi bizzarri di Mondo cane, con il suo elenco di donne a petto nudo, maiali al macello e cimiteri per animali provenienti da ogni parte del mondo. Troviamo una simile dimostrazione di “attrazioni” in programmi come Australia’s Funniest Home Movie Show e Monster Kid Home Movies (2005), così come nei film pornografici, in cui il tono esibizionista sembra non avere limiti. I film di safari e i diari di viaggio di ogni tipo, dal surf all’architettura, utilizzano allo stesso modo questo impulso esibizionista per stupirci con le immagini straordinarie che la macchina ha ripreso. Pur essendo un elemento tipico del documentario, questo “cabaret delle curiosità” è spesso visto più come un aspetto imbarazzante che come un fattore chiave.
Gli anni Venti: il documentario trova le sue gambe Per fornire una base adeguata al cinema documentario, non serve porre l’enfasi né sull’esibizione (come il “cinema delle attrazioni”), né sulla raccolta di prove (documentazione scientifica), anche se entrambi gli aspetti si basano sull’immagine indicativa. Non si può tracciare una linea retta tra l’arrivo del treno alla stazione di Louis Lumière a quello di Hitler a Norimberga (in Il trionfo della volontà), né tra il fascino del movimento e quello provocato dal fatto di spingere il pubblico a vedere il mondo in un modo piuttosto che in un altro. In queste prime tendenze non è ancora presente il tono oratorio del regista. Se ci fosse una linea diretta che va da queste qualità del cinema primitivo al documentario, ci aspetteremmo che il secondo si sia sviluppato in parallelo con la fiction narrativa, nel corso dei primi due decenni del XX secolo, invece di guadagnare ampio riconoscimento in seguito, negli anni Venti e Trenta. Possiamo però identificare quattro elementi chiave che formano la base per il genere documentario. È solo quando tutti e quattro convergono che una tradizione documentaria può costituirsi:
- documentazione indicativa (condivisa con le immagini scientifiche e il cinema delle attrazioni); - sperimentazione poetica; - racconto narrativo; - oratoria retorica. Il riconoscimento del documentario come una forma distinta di film diventa, più che una questione di origine o di evoluzione di questi elementi diversi, un risultato della loro combinazione in un dato momento storico. Quel momento si colloca tra gli anni Venti e i primi anni Trenta e sarà discusso più avanti nel Capitolo 8. Possiamo esaminare brevemente la natura di questi tre nuovi elementi. La sperimentazione poetica
La sperimentazione poetica nasce generalmente dall’incrocio tra il cinema e le varie avanguardie che fiorirono all’inizio del XX secolo. Questa dimensione ha un ruolo vitale per la nascita di una voce del documentario. Il potenziale poetico del cinema, tuttavia, resta per lo più assente all’interno del “cinema delle attrazioni”, dove il “mostrare” aveva la meglio sull’“essere poetici”. Ed è allo stesso modo chiaramente assente dalle pratiche dell’immagine scientifica. Esempi classici del cinema poetico sono, tra gli altri, i lavori degli artisti e critici impressionisti francesi degli anni Venti, come Jean Epstein (L’affiche [Il poster, 1925]), Abel Gance (La roue [La ruota, 1922]), Louis Delluc (Fièvre [Febbre, 1921]), Germaine Dulac (La Souriante Madame Beudet [La sorridente Madame Beudet, 1923]), René Clair (Paris qui dort [Parigi che dorme, 1924]), l’opera sperimentale del regista olandese Joris Ivens (De Brug, 1928; Pioggia, 1929), l’artista tedesco Hans Richter (Rhytmus 23, 1923; Inflation [Inflazione, 1928]), lo svedese Viking Eggeling (Symphonie diagonale [Sinfonia diagonale, 1924]), l’artista francese Marcel Duchamp (Anémic Cinéma [Cinema anemico, 1927]), il regista ucraino Aleksander Dovženko (Zvenigora [La montagna incantata, 1928]), l’americano espatriato Man Ray (Retour à la raison [Il ritorno alla ragione, 1923]) e l’accoppiata surrealista formata da Salvador Dalí e Luis Buñuel (Un chien andalou, 1929).
È stato all’interno dell’avanguardia che ha preso forma un’idea distinta di opinione e di voce del regista, che si rifiutava di subordinare la propria prospettiva allo spettacolo o ai fatti. Il lavoro delle avanguardie aveva spesso origine da immagini fotografiche della realtà di tutti i giorni, anche se alcune, come i “rayogrammi” di Man Ray, venivano realizzate senza una lente, esponendo la pellicola non sviluppata a diversi oggetti. Queste immagini di un mondo riconoscibile hanno subito virato verso altre direzioni, abbandonando la fedeltà all’oggetto e lo stile realista. Il modo con cui il regista vedeva le cose ha acquistato importanza maggiore del voler dimostrare l’abilità della cinepresa di registrare con accuratezza e fedeltà ciò che vedeva. La prova visibile serviva come veicolo dell’espressione poetica. La voce è passata in primo piano in lavori come Ménilmontant (1924) di Dimitri Kirsanov, un racconto di amore tradito, omicidio e tentato suicidio narrato dal punto di vista di una donna; il film di Alberto Cavalcanti Rien que les heures (Nient’altro che le ore, 1926), un giorno nella vita di Parigi che gira bizzarramente tra immagini di realtà e la realtà delle immagini (quelle di una donna che scende una scalinata diventano una striscia di pellicola che viene strappata e lanciata per strada, per esempio); De Brug di Joris Ivens con la sua “storia” della costruzione e la distruzione di un ponte, narrata per lo più attraverso delle inquadrature, spezzettate ma composte meravigliosamente, della struttura del ponte; infine il film di Man Ray L’étoile de mer (La stella di mare, 1928), una serie surreale di scene sulla vita di tutti i giorni di una donna parigina. L’abilità empirica del film di produrre una registrazione fotografica di quello che viene registrato è stata vista da molti di questi artisti come un handicap. Se tutto quello che si voleva era una copia perfetta, che spazio restava per il desiderio dell’artista di vedere il mondo in modo del tutto nuovo? Sarebbe bastato un tecnico della ripresa. La teoria impressionista francese degli anni Venti lodava quella che Jean Epstein definiva la fotogenia, mentre la teoria filmica sovietica difendeva il concetto di montaggio. Entrambi erano modi di superare la riproduzione meccanica della realtà in favore della
costruzione di qualcosa di nuovo che solo il cinema poteva ottenere. Un simile impulso si rivelò vitale per lo sviluppo della tradizione documentaristica. Fotogenia si riferisce a ciò che l’immagine cinematografica offriva di ulteriore o di diverso da quello che rappresentava. Una riproduzione automatica e meccanica di ciò che avveniva di fronte alla cinepresa diventava secondaria rispetto alla magia messa in atto dall’apparato cinematografico stesso. I dettagli della realtà potevano diventare meravigliosi se proiettati su uno schermo. L’immagine offriva un ritmo accattivante e una meraviglia seducente tutta sua. L’esperienza di guardare il film era diversa dall’osservare la realtà in un modo che le parole potevano solo a fatica descrivere.
Berlino: Sinfonia di una grande città (di Walter Ruttmann, 1927). Questa immagine pubblicitaria del film usa il fotomontaggio per celebrare le dinamiche e l’energia della città moderna, ma senza il taglio politico che i montaggi fotografici e cinematografici avevano acquisito nel corso degli anni Venti in Germania e in Unione Sovietica con il cinema e l’arte costruttivista. Il montaggio può sottolineare la relazione formale o le associazioni politiche. Quello di Berlino, come in questa immagine, preferisce la visione poetica più che quella politica.
La roue di Abel Gance, per esempio, usava dei flashback a passo uno e numerosi motivi di ruote, rotazione e movimenti per catturare il delirio di un ingegnere ferroviario coinvolto in un amore impossibile. Robert Flaherty, in uno spirito diverso dagli impressionisti francesi, suggerisce come possa essere questo senso di meraviglia quando inizia Lousiana Story (Storia della Lousiana, 1948) con un viaggio lento e incantato attraverso l’affluente del fiume Louisiana, visto dalla piroga di un ragazzo.
L’idea della fotogenia e del montaggio permetteva alla voce del regista di essere messa in risalto. Il film di Ruttmann Berlino: Sinfonia di una grande città, per esempio, possiede una voce poetica ma non analitica; celebra la diversità della vita di tutti i giorni di Berlino scollegata da ogni analisi sociale o politica della vita urbana. Per contrasto, il film di Dziga Vertov L’uomo con la macchina da presa adotta un tono poetico, ma anche riflessivo, per analizzare il potere di trasformazione delle masse umane mentre, come il macchinario di un cinema, continuano il loro lavoro per produrre una nuova società sovietica postrivoluzionaria. L’avanguardia è sbocciata in Europa e in Russia negli anni Venti. La sua enfasi sul vedere le cose con un occhio nuovo, attraverso lo sguardo dell’artista o del regista, aveva un immenso potenziale artistico. Rendeva il cinema libero dall’obbligo di replicare quello che passava di fronte alla cinepresa, per permettere a questa “cosa” di diventare il materiale grezzo non solo della filmografia narrativa, ma anche del cinema poetico. Questo spazio che si estendeva oltre il filone principale del cinema è diventato il terreno da cui sono sorte le voci che si rivolgono agli spettatori con un linguaggio diverso da quello dei film di fiction. Il racconto narrativo
Insieme alla nascita di una avanguardia poetica, il periodo successivo al 1906 ha visto anche lo sviluppo di un cinema narrativo ancora più dominante. Questo elemento gioca un ruolo decisivo nell’ascesa del documentario. La storia e la biografia, per esempio, di solito assumono la forma di narrazioni, ma in un modo non finzionale, a partire da The River fino ad arrivare a Born into Brothels. Nel racconto narrativo, lo stile (sia quello dei singoli registi che quello di gruppi quali gli espressionisti, i neorealisti e i surrealisti) si unisce alla costruzione di una trama (la sequenza secondo la quale gli eventi si susseguono sullo schermo) per raccontare una storia, sia essa reale o inventata. La forma della storia, attraverso la combinazione unica di stile e trama, nello stesso momento rivela la voce del regista sul al mondo che egli rappresenta direttamente nei film di non-fiction o che ricrea allegoricamente nei film di fiction.
La cosa più importante per lo sviluppo del documentario è stata il miglioramento delle tecniche narrative per il cinema, dal montaggio parallelo di D.W. Griffith all’uso di diversi obbiettivi e distanze focali per riprendere personaggi e avvenimenti. La narrazione ha altresì elaborato i molteplici modi con cui un’azione o un evento potevano essere raccontati da diversi punti di vista (da quello di un narratore onnisciente, di un osservatore esterno o di personaggi diversi, per esempio). Queste possibilità hanno promosso la ricerca di una voce attraverso la quale rappresentare la realtà storica in modi che non venivano necessariamente esplicitati con le parole, ma che invece trovavano espressione nelle diverse forme del film (il montaggio, le inquadrature, la musica, la luce e così via). La narrativa perfeziona l’idea di un finale ritornando ai problemi e i dilemmi posti all’inizio e dando loro una soluzione. Lo stile narrativo serve a risolvere i conflitti e a ristabilire l’ordine. La struttura problema/soluzione di molti documentari fa uso di tecniche narrative e della retorica per arrivare a una risoluzione. La narrativa accetta di buon grado anche l’utilizzo di forme di suspense e di dilazione dei tempi, in cui aumentano le complicazioni e cresce il senso di anticipazione. Questo può servire ad approfondire il senso di un personaggio, non solo attraverso la performance di attori professionisti, ma anche tramite le tecniche di illuminazione, la composizione dell’inquadratura, il montaggio, la ricostruzione e le interviste, tra le altre, che possono essere applicate facilmente ad attori non professionisti. La narrativa ridefinisce le tecniche del montaggio in continuità per dare una coerente fluidità spaziale e temporale ai luoghi in cui gli attori hanno recitato. Anche quando i documentari hanno deciso di utilizzare il montaggio evidenziatore e l’assemblaggio di filmati d’archivio di luoghi e tempi diversi per supportare una linea di pensiero, le tecniche collaudate del montaggio in continuità sono servite a facilitare lo scorrimento da un’immagine all’altra coordinando movimenti, azione, sguardi e scala dei piani da un’inquadratura a un’altra. Tutti questi sviluppi hanno trovato un utilizzo nel documentario. In modo più evidente, forse, all’interno di film strettamente osservativi (come Primary e Salesman), che studiavano le vite delle
persone e invitavano il pubblico a interpretare quello che vedeva come se fosse fiction. Negli anni del dopoguerra, in Francia, André Bazin ha lodato i risultati del neorealismo italiano per ragioni simili a quelle che furono usate in seguito per esaltare il documentario partecipativo e quello osservativo. I film italiani dimostravano quel che Bazin considerava un profondo rispetto per la realtà utilizzando di una “voce” narrante che fosse umile e modesta ma non silenziosa. I neorealisti evitavano di rendere il film fotogenico attraverso la stilizzazione estrema tipica degli impressionisti francesi. Evitavano anche le tecniche espressionistiche usate da registi tedeschi come Robert Wiene (Il gabinetto del dottor Caligari [Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920]), F.W. Murnau (Nosferatu, il vampiro [Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922]) e Fritz Lang (Metropolis, 1927), che modificavano l’aspetto dell’immagine per suggerire un mondo distorto e squilibrato, popolato da forze minacciose e personalità instabili. I neorealisti non utilizzavano neanche gli stili di montaggio di registi sovietici come Sergej Ejzenštejn (Ottobre [Oktiabr’, 1927]), Vsevolod Pudovkin (La fine di San Pietroburgo [Konec Sankt-Peterburga, 1927]) e Dziga Vertov (L’uomo con la macchina da presa), che giustapponevano le inquadrature per urtare lo spettatore e produrre delle nuove visioni attraverso i diversi modi con cui le accostavano. Univano la narrativa alla purezza documentaristica di Lumière per raggiungere uno stile dal valore duraturo. I neorealisti come Roberto Rossellini (Roma città aperta), Vittorio De Sica (Ladri di biciclette) e Luchino Visconti (La terra trema, 1948) sottolineavano le qualità narrative in sintonia con la potenza cinematografica dell’immagine indicativa: una visione semplice, non abbellita della vita quotidiana; una serie labirintica di azioni e di eventi, uniti dalle coincidenze; illuminazione naturale e riprese in esterni; l’utilizzo di attori non professionisti; il rifiuto dei primi piani sui volti delle star; e soprattutto l’enfasi sui problemi che riguardavano la gente comune del tempo, invece che un passato storico o un futuro immaginato. Questo è stato un
momento importante della filmografia narrativa, che ha contribuito allo sviluppo del documentario. Questo senso di realismo indicativo o fotografico, il rivelare quello che la vita ha da offrire quando viene filmata con semplicità e onestà, non è, in effetti, una verità, ma uno stile. Si tratta di un effetto ottenuto con l’utilizzo di mezzi modesti, semplici ma ben definiti, che corrisponde al significato di uno dei tre modi chiave con cui il termine “realismo” viene applicato ai documentari.
Ladri di biciclette (di Vittorio De Sica, 1948). La genialità di Vittorio De Sica sta nel ricreare delle storie che hanno il sapore di qualcosa di intimamente connesso con un senso concreto di spazio e tempo. Questo tipo di racconto riverbera attraverso tutto il neorealismo italiano, e nell’uso che fa di riprese in esterni, attori non professionisti e racconti di vita quotidiana e di sopravvivenza difficile (il titolo italiano, in accordo con l’enfasi tipica di Hollywood sull’individuo, fu inizialmente tradotto come The Bicycle Thief).
– Realismo fisico o empirico: il realismo fotografico autentica o sembra autenticare ciò che è accaduto realmente di fronte alla macchina da presa. La qualità indicativa dell’immagine può generare un senso di realismo di tempo e di spazio attraverso le riprese in esterni, le inquadrature semplici e il montaggio in continuità, che minimizzano gli utilizzi
distorti e suggestivi del montaggio amati dai registi delle avanguardie. – Realismo psicologico: vuole comunicare le condizioni interiori dei personaggi o degli attori sociali in modo plausibile e convincente. I sentimenti personali, ansia, felicità, rabbia, gioia e così via, paiono accessibili allo spettatore. Noi ci sentiamo di avere accesso alla vita intima di un personaggio. Questo richiede uno sforzo creativo da parte del regista, come per esempio prolungare un’inquadratura, scegliere un particolare angolo di ripresa, aggiungere musica evocativa, o giustapporre un’immagine o una sequenza con un’altra. Un regista di documentari con un forte senso delle qualità drammatiche di una situazione o di un avvenimento può raggiungere altissimi esempi di realismo psicologico. – Realismo emotivo: si ottiene quando si arriva a suscitare nello spettatore uno stato emotivo appropriato. Un numero musicale emozionante può esaltare il pubblico, anche in presenza di uno scarso approfondimento psicologico dei personaggi e di una ambientazione chiaramente ricostruita. Noi riconosciamo all’esperienza di esaltazione (o di altre espressioni emotive) una dimensione realistica: l’emozione stessa è familiare e sinceramente sentita. Una marcia, per esempio, spesso produce un senso di realismo emotivo in film documentari e di fiction che raccontano la guerra. Il documentario fa forte affidamento sul realismo empirico di tempo e di luogo. Esso genera il realismo psicologico trovando persone, o attori sociali, che si rivelano davanti alla cinepresa con una sincerità e una naturalezza simili a quelle che riescono a ottenere gli attori professionisti. Alla fine, il documentario raggiunge il realismo emotivo attraverso l’utilizzo di tecniche cinematografiche e della voce che gli è propria per toccare le corde di un vissuto emotivo preesistente nel suo pubblico. Il neorealismo, con altre forme di racconti narrativi, e insieme alla tradizione delle avanguardie, ha aperto la strada alle possibilità espressive del cinema documentario. Oratoria retorica
La documentazione indicativa, il racconto narrativo e la sperimentazione poetica sono tre delle quattro pietre miliari
del cinema documentario. La quarta, la tradizione retorica dell’oratoria, è condivisa con altre forme di cinema, ma è sbocciata in maniera più viva proprio nel cinema documentario. La voce classica dell’oratoria intendeva parlare del mondo storico – affrontando le domande relative a che cosa fare, che cosa è davvero accaduto, o come era fatto qualcuno o qualcosa – in modo tale da rivelare una particolare prospettiva su di esso. Cercava di persuaderci dei meriti di un dato punto di vista e di prepararci all’azione o all’adozione di sentimenti o valori morali promossi dall’oratore. Una voce di questo genere si può chiaramente sentire in Nanuk l’eschimese di Robert Flaherty e, per un pubblico minore, nel film di Edward Curtis del 1915 In the Land of the Headhunters (Nella terra dei cacciatori di teste, restaurato e ridistribuito nel 1972 con il titolo In the Land of the War Canoes, Nella terra delle canoe di guerra). Il film di Curtis, come quello di Flaherty, unisce elementi del “cinema delle attrazioni” a una narrativa coerente, all’orchestrazione poetica delle scene e a un tono oratorio che afferma il suo preciso punto di vista sul mondo dei nativi americani che sta scomparendo.
Grass: A Nation’s Battle for Life (di Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, 1925). I due registi che realizzarono questo film alcuni anni più tardi furono i produttori di King Kong e di altri film. La donna seduta tra i due uomini, Margaret Harrison, fu una giornalista in grande anticipo sui tempi, che aveva lavorato come spia americana in Europa dopo la Prima guerra mondiale e pubblicato numerosi libri. Nel film interpreta il ruolo di una reporter, e il trio di cui fa parte inizia una indagine sulla popolazione Bakhtiari nel moderno Iran. Per gentile concessione di Milestone Film and Video.
Insieme a Moana (1926) di Flaherty, che parla della cultura polinesiana, altri film come Grass: A Nation’s Battle for Life (Erba: la battaglia di una nazione per vivere, 1925) di Merian Cooper ed Ernest B. Shoedsack, sui popoli nomadi di Turchia e Persia, Turksib (1929) di Victor Turin, sulla costruzione di un nuovo, importante collegamento ferroviario tra le regioni remote dell’Unione Sovietica, e A proposito di Nizza (À propos de Nice, 1930) di Jean Vigo, uno sguardo crudele sulle differenze di classe in questa stazione balneare, affermavano la vitalità della voce del documentario. Questa voce adattava il “cinema delle attrazioni”, altrimenti detto spettacolo, la documentazione indicativa, la narrativa e l’espressività della poesia cinematografica per parlare del mondo reale in modi tali da far pensare ed emozionare il pubblico.
Negli anni Venti questi sviluppi presero una forma precisa in Unione Sovietica, dove un movimento prerivoluzionario di sperimentazione artistica noto come Costruttivismo aveva continuato a fiorire anche nei primi anni del nuovo Stato. Il cinema sovietico attinse pesantemente dal Costruttivismo e dalla sua determinazione a rifondare il mondo dalle sue basi. (La graduale imposizione di uno stile “ufficiale” di Stato per l’arte e per il cinema, il realismo sociale, eliminò quasi tutte le forme di sperimentazione entro la metà degli anni Trenta.)
Grass: A Nation’s Battle for Life. La locandina originale del film mostra come la grafica possa evocare lo spirito di avventura in una terra distante ed esotica forse meglio di quanto riuscirebbe a fare un’immagine fotografica tratta dallo stesso film. Per gentile concessione di Milestone film and Video.
In un importante saggio, il pittore, grafico e fotomontatore costruttivista Aleksandr Rodčenko ha protestato contro il “ritratto sintetico” che cercava di catturare una personalità intera in un solo dipinto. A questo, egli preferiva un assemblaggio di fotografie documentaristiche, ognuna delle quali rivelava un lato diverso di una figura complessa. Le teorie sovietiche di montaggio cinematografico facevano eco a
questa idea. In un altro saggio, Costruttivismo nel cinema (1928), l’artista russo Alexei Gan ha delineato un nuovo tipo di cinema, capace di coniugare forza poetica e dimostrativa: Non basta collegare, attraverso il montaggio, i singoli momenti degli episodi della vita, uniti da un titolo più o meno efficace [Berlino: Sinfonia di una grande città potrebbe essere stato il tipo di film che Gan aveva in mente]. Gli eventi meno attesi, le combinazioni e i casi sono sempre collegati organicamente alla radice fondamentale della realtà sociale. Mentre si percepiscono questi eventi con il guscio delle manifestazioni esterne, si dovrebbe esporre la propria essenza interiore a una serie di altre scene. Solo su una base del genere è possibile costruire un film di concreta e attiva realtà, allontanandosi gradualmente dal cinegiornale, il cui materiale è spunto per questa nuova forma cinematografica. (“Constructivism and the Cinema”, in Stephen Bann (a cura di), The Tradition of Constructivism, p. 130). Anche Dziga Vertov preferiva un approccio di ricostruzione poetica audace di ciò che la cinepresa aveva registrato. Il montaggio e l’intervallo (l’effetto della transizione tra le inquadrature) formavano il cuore dello stile di cinema di nonfiction chiamato cine-occhio: 1. Montaggio durante l’osservazione [orientare l’occhio nudo sempre e ovunque]. 2. Montaggio dopo l’osservazione [organizzare mentalmente ciò che si è visto, secondo caratteristiche tipiche]. 3. Montare durante la ripresa [orientare l’occhio meccanico della cinepresa nel posto osservato nel punto 1]. 4. Montare dopo la ripresa [organizzare approssimativamente il filmato secondo caratteristiche particolari. Cercare i frammenti di montaggio ancora mancanti]. 5. Misurazione a occhio [orientarsi all’istante, in ogni ambiente visivo, in modo da catturare le riprese di collegamento essenziali. Prestare molta attenzione. Una regola militare: valutazione a vista, velocità, attacco].
6. Montaggio finale [rivelare i temi minori e nascosti presenti accanto ai temi principali. Riorganizzare i filmati in sequenze migliori. Tirare fuori il centro del filmoggetto. Coordinare gli elementi simili e, infine, calcolare numericamente i grappoli di montaggio]. (Nikolaj Pavlovic Abramov, Dziga Vertov, p. 50). Questi saggi riguardano questioni di tecnica cinematografica, nello specifico l’assemblaggio delle inquadrature in una sequenza che sappia mostrare aspetti meno visibili del mondo, oltre che affermare la voce del regista. Questa necessità di montaggio o di assemblaggio spesso si basa su una documentazione indicativa ma va oltre l’esibizione delle “attrazioni” o le osservazioni scientifiche. Le teorie sovietiche sull’arte costruttivista e il montaggio cinematografico univano il potere dell’espressione formale al desiderio collettivo di rifare il mondo a immagine di una nuova società rivoluzionaria. Il montaggio sottolineava la disposizione degli eventi in frammenti, o inquadrature. Contrapponendo delle inquadrature che non si accostavano “naturalmente” tra di loro, il regista costruiva delle nuove impressioni e delle nuove visioni. Ejzenštejn associava il realismo fotografico tradizionale a un’ideologia imposta:
The Prince Is Back (di Marina Goldovskaija, 1999). La famiglia. Questo ritratto di gruppo della famiglia Mescherskij – del 1912, prima della rivoluzione – afferma la loro nobiltà e il loro status all’interno dell’aristocrazia russa. Il principe. Negli anni Novanta, il principe Mescherskij decide di rivendicare la sua proprietà, confiscata dal governo, e di restaurarla. Fotografie concesse dalla regista.
Il realismo assoluto non è in alcun modo la forma corretta della percezione. È semplicemente la funzione di una certa
forma di struttura sociale. A chi è suddito di una monarchia di stato viene imposta un’uniformazione statale di pensiero. (“The Cinematographic Principle and the Ideogram”, in Jay Leyda (a cura di), Film Form and the Film Sense, p. 35). Che cosa vedeva Ejzenštejn come alternativa? Plasmare e rimodellare la realtà attraverso il montaggio per crearne una nuova, radicale visione. Non è proprio questo che il cinema fa […] quando creiamo una sproporzione mostruosa tra le parti di un fatto che sta accadendo, e a un tratto smembriamo l’evento in “primi piani di mani che afferrano”, “piano americano della lotta” e “dettaglio occhi strabuzzati”, e disintegriamo l’evento attraverso il montaggio in numerosi piani? Noi rendiamo un occhio grande il doppio di un uomo! Combinando queste mostruose incongruenze, noi ricomponiamo l’evento spezzettato in un unico insieme, creato secondo noi. Secondo il trattamento della nostra personale esperienza dell’evento. (“The Cinematographic Principle and the Ideogram”, cit., p. 34; corsivo nell’originale). Il cinema sovietico era fortemente retorico. Attraverso il lavoro di molti registi, dai famosi film dello stesso Sergej Ejzenštejn (Sciopero, La corazzata Potëmkin, Ottobre, La linea generale ecc.) alle meno conosciute ma ugualmente pionieristiche raccolte documentarie di Esther Shub (The Great Road [La grande strada, 1927]; La caduta della dinastia dei Romanov; e Rossiya Nikolaya II i Lev Tolstoy [La Russia di Nicola II e Leo Tolstoj, 1928]), le tecniche di montaggio hanno delineato le fondamenta della celebrità che John Grierson ha in seguito dato al documentario nella Gran Bretagna degli anni Trenta.
The Prince Is Back. La proprietà. Questo modello mostra l’aspetto del palazzo del principe prima della rivoluzione del 1917. Il problema. Sono passati più di ottant’anni dalla rivoluzione. È possibile per un uomo e la sua famiglia restaurare ciò che resta della casa avita? Può un Paese muoversi in avanti se i suoi cittadini vogliono tornare indietro? Marina Goldovskaija solleva questioni più generali attraverso il racconto privato del sogno del principe.
La retorica, in ogni suo scopo e in ogni sua forma, serve a fornire la caratteristica decisiva e distintiva del documentario. La figura di colui che registra gli avvenimenti accaduti, quella dell’imbonitore, del cantastorie e del poeta della fotogenia si fondono in quella del regista di documentari in quanto oratore che parla con voce propria del mondo in cui viviamo. Questi elementi si sono uniti per la prima volta nell’Unione Sovietica degli anni Venti, quando la sfida di costruire una nuova società ha avuto la priorità in tutte le arti. Tale particolare insieme ha poi messo radici in altri Paesi tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, quando altri governi, grazie a sostenitori come John Grierson, hanno iniziato a capire il valore dell’utilizzo dei documentari per promuovere nei cittadini il senso di partecipazione alla comunità e per cercare il loro consenso sui problemi più difficili del momento, come l’inflazione, la povertà e la Grande depressione. Le risposte a questi problemi variavano molto dalla democratica Inghilterra alla Germania nazista e dagli Stati Uniti del New Deal alla Russia comunista ma, in ogni caso, la voce del documentarista ha contribuito significativamente a inquadrare i piani nazionali e a proporre una linea di azione.
CAPITOLO 6 COME DIFFERENZIARE I DOCUMENTARI? CATEGORIE, MODELLI, E LE MODALITÀ ESPOSITIVA E POETICA DEL DOCUMENTARIO Il bisogno di classificazione Nel Capitolo 1 abbiamo definito il documentario come una forma di cinema che ci parla di situazioni e avvenimenti reali. Esso riguarda persone reali (attori sociali) che ci presentano loro stesse in storie che comunicano una tesi o un punto di vista plausibili sulle loro vite, sulle situazioni e sugli eventi ritratti. Il punto di vista distintivo del regista plasma queste storie nell’esplicitazione di una tesi o di una prospettiva sulla realtà sociale, aderendo a fatti noti e non creando una allegoria fittizia. Sebbene questa definizione sia utile per parlare in generale dei documentari, non aiuta quasi per niente a iniziare a distinguere fra i differenti tipi di documentario. Molti di essi violano qualsiasi definizione specifica, e i mockumentary, in ogni caso, sfumano deliberatamente la zona di confine tra fiction e documentario. Non ci sono leggi e poche sono le vere regole quando si tratta di espressione creativa. In realtà ciò che si considera come documentario rimane fluido, aperto al dibattito tra istituzioni, registi, spettatori e film stessi. Istituzioni che spaziano dai canali televisivi alle fondazioni che sostengono i documentari; registi come l’estroverso Michael Moore o il mimetico D.A. Pennebaker; film come l’intensissimo Notte e nebbia e l’esilarante Super Size Me; aspettative del pubblico, che variano dal “Mostrami la verità” a “Intrattienimi” e che coesistono le une con le altre. Gli stili in auge vanno e vengono. Le istituzioni offrono opportunità e impongono limiti, le tecnologie e le ispirazioni creative si rinnovano, le aspettative del pubblico si evolvono: tutto questo cambia costantemente lo scenario di ciò che si considera come
documentario e di quel che costituisce l’orizzonte delle sue possibilità. Piuttosto che rammaricarsi per l’incapacità dei documentari di allinearsi a una sola singola definizione e lamentare la difficoltà di identificare tutti i possibili tipi di documentari con una sola definizione, è meglio accettare questa fluidità come qualcosa di molto positivo. Il documentario è fatto per essere una forma dinamica e in continua evoluzione. Confini fluidi e sfumati sono prove di crescita e vitalità. Il sorprendente vigore e la popolarità dei documentari negli ultimi venticinque anni sono una prova evidente che i labili contorni e uno spirito creativo producono una forma d’arte appassionante ed eclettica. Ciò detto, è sempre possibile dare delle definizioni. I nuovi documentari continuano ad avere forti somiglianze con i documentari di un tempo. In effetti, è possibile notare una serie di tendenze o modi che operano nel documentario, come le modalità poetica ed espositiva. Vi abbiamo già accennato nel Capitolo 1 e le esamineremo nel loro complesso qui e nel prossimo capitolo. Queste modalità identificano i modi differenti nei quali si manifesta la voce del documentario in termini cinematografici. Esse differenziano i documentari in riferimento a qualità formali e cinematografiche. Queste qualità sono state per decenni potenziali risorse, ma secondo proporzioni diverse e con diversa enfasi. La maggior parte dei film ha in sé più di una modalità, anche se alcune sono più preminenti di altre in un dato tempo o luogo. Queste modalità hanno la funzione di un’intelaiatura di base che i singoli registi arricchiscono di contenuti in base alla loro predisposizione creativa. Ma, prima di scomporre la rappresentazione documentaristica in una serie di modalità, è utile dare un veloce sguardo al documentario da un punto di vista più ampio considerandolo come una componente del cinema in generale. Il modo in cui suddividiamo in categorie un ambito di esperienza è raramente un atto puramente oggettivo nel quale seguiamo le linee guida naturali che ci vengono da una realtà preesistente. La scienza, che ha a che fare con il mondo naturale, può eseguire classificazioni in questa maniera, ma quando ciò che vogliamo classificare è il prodotto della nostra
stessa attività umana, le linee guida naturali di colpo scompaiono. Per quanto riguarda il documentario, queste categorie appartengono più a un dialogo continuativo tra istituzioni, registi, film e spettatori che al mondo naturale. Esse evolvono, cambiano, si consolidano e prendono diverse direzioni in maniera imprevedibile. I bisogni a cui vanno incontro in un dato momento possono non essere soddisfatti in un altro. I registi sono spesso i primi a notarlo quando cercano nuovi modi di raccontare storie e di comunicare il loro punto di vista. Le categorie e i concetti spesso non stanno al passo quando cercano di dare coerenza alla straordinaria varietà di opere generate dall’attività umana.
Il documentario e il suo rapporto con altri generi di film Guardandolo da una giusta distanza, potremmo vedere il cinema come suddiviso in film di fiction e film di non-fiction, rappresentati in due insiemi o cerchi che in parte si sovrappongono (tabella 6.1). La fiction vera e propria è esclusivamente nel cerchio di sinistra. Qui troviamo la maggior parte dei film di fiction, che sono facilmente identificabili come opere che richiamano un mondo originale popolato da attori che interpretano ruoli definiti (personaggi). Questi personaggi sembrano agire come se la macchina da presa che li osserva non fosse in nessun modo parte del loro mondo. Ciò che dicono e, ancora di più, ciò che fanno può essere incredibile, fantastico, verosimilmente impossibile e perciò sorprendente, eppure tutto si sviluppa come se questi avvenimenti fossero una parte plausibile della realtà nella quale i personaggi vivono. La non-fiction si trova esclusivamente nel cerchio di destra, che comprende il documentario, i film informativi, i film scientifici, i filmati di sorveglianza e così via. Qui troviamo la maggior parte dei documentari che sono identificabili da: 1. le rappresentazioni in suoni e immagini di un mondo storico preesistente; 2. il fare affidamento su attori sociali che presentano se stessi invece che assumere ruoli predeterminati;
3. la complessa relazione che può nascere dall’interazione del regista con gli attori sociali del film che coesistono chiaramente nella stessa realtà storica. Proprio da questa interazione nasce la storia del film, così come la sua tesi e il suo punto di vista. In entrambi i cerchi, annidate nella zona di sovrapposizione, ci sono forme che prendono in prestito elementi da tutte e due le tradizioni e che vengono classificate come appartenenti all’una o all’altra a seconda degli obiettivi e dei fini di chi le analizza. La maggior parte dei critici considera il cinema neorealista come fiction perché chi vi recita, anche se non si tratta di attori professionisti, interpreta ruoli predeterminati; i film possiedono una forma narrativa chiara e lo stile trattenuto e preciso dà in qualche modo la sensazione di una voce documentaria. Queste caratteristiche, tuttavia, sono presenti anche nel documentario osservativo, ma questi film sono di solito considerati documentari perché le storie che raccontano sembrano essere prima di tutto frutto dell’interpretazione di un attore sociale. Tabella 6.1. La relazione tra fiction e non-fiction
In contrasto con il neorealismo, nelle discussioni sul documentario vengono chiamati in causa le ricostruzioni, i mockumentary e i docudrama, anche se adottano molte tecniche proprie della fiction e sono in genere considerati fondamentalmente fiction. Questo capita perché le
ricostruzioni di solito sono una parte del documentario o del film informativo e prendono molto del loro significato e valore da quel più ampio contesto. I mockumentary si prefiggono esplicitamente di instaurare un dialogo provocatorio con le convenzioni del documentario e con le aspettative del pubblico, mentre i docudrama traggono da eventi reali gran parte della loro struttura narrativa e della caratterizzazione dei personaggi. Quando spostiamo la nostra attenzione sul lato non-fiction del diagramma rappresentato nella tabella 6.1 scopriamo che a sua volta ricade in due categorie sovrapposte: film documentari e non documentari, illustrate nella tabella 6.2. Tabella 6.2. La relazione tra documentari e non documentari
Nella zona di sovrapposizione ci sono quelle formule che possono essere considerate documentarie o non documentarie, a seconda degli obiettivi e dei fini dei critici. Il puro girato è materiale grezzo, spesso si tratta di un’unica ripresa come i filmati delle videocamere di sorveglianza o come la famosa ripresa in Super8 dell’assassinio del presidente John F. Kennedy realizzata da Abraham Zapruder. Il puro girato in sé manca di qualunque voce o punto di vista ma può essere convogliato sia in un’opera documentaria che in una fiction. JFK di Oliver Stone è una fiction narrativa eppure riesce a rappresentare la ripresa di Zapruder come prova scientifica di una cospirazione e della presenza di molteplici assassini.
Andando in una direzione opposta Jean Painlevé trasformò registrazioni scientifiche della vita acquatica, che erano puro girato, in un poema documentaristico emozionante in The Sea Horse (L’ippocampo, 1934). I suoi film sono spesso considerati documenti scientifici ma molti musei li includono nelle loro collezioni di documentari. I film aziendali o istituzionali spesso si rivolgono a una clientela limitata o promuovono apertamente una specifica attività o prodotto. Le pubblicità, che possono contenere alcuni elementi documentaristici, sono altamente promozionali. La loro faziosità spinge a comprare un prodotto, un fine assai più limitato di quelli della maggior parte dei documentari, anche se le due forme hanno in comune molte tecniche retoriche. Un film come Louisiana Story di Robert Flaherty, commissionato da Shell, ha in sé un messaggio meno puntuale (il film parla di un giovane cajun; per la Shell era sufficiente che passasse il messaggio che il mondo tradizionale e il mondo delle estrazioni petrolifere potevano coesistere). In questo caso la committenza è simile a quella dei governi che sovvenzionano un documentario: il film promuove un punto di vista o un modo di vedere le cose più che uno specifico atto di acquisto. I documentari non sono documenti. Possono utilizzare documenti e fatti, ma li interpretano sempre. E normalmente lo fanno in una maniera espressiva e coinvolgente. Questo conferisce conferisce loro l’idea forte di una voce che manca invece ai non documentari. Questa voce è l’elemento distintivo dei film documentari. Lo spettatore sente che c’è una voce che gli si rivolge da un particolare punto di vista riguardo ad alcuni aspetti della realtà storica. Questo punto di vista è più personale e qualche volta più appassionato di quello delle news che tutti conosciamo. Le notizie fornite dai telegiornali aderiscono a standard giornalistici che hanno un forte orientamento informativo, anche se sono ben lontane dal mancare delle caratteristiche tipiche della voce. L’orientamento, che plasma il contesto all’interno del quale presentare la notizia, le supposizioni su chi ritenere un esperto o un’autorità in materia e le scelte di determinate parole o toni possono far scivolare un reportage verso il terreno proprio del
documentario, mentre gli standard giornalistici di oggettività e accuratezza spingono nella direzione di un film informativo. I non documentari, come i film scientifici, i filmati delle videocamere di sorveglianza e i film informativi o “istruttivi”, manifestano un’idea di voce che è ridotta al minimo: funzionano più come documenti che come documentari e trasmettono informazioni in maniera diretta e spesso didattica. Essi parlano di aspetti della realtà con un alto grado di trasparenza e di indicalità. È questo che conferisce un valore di evidenza a ciò che mostrano: le riprese mantengono una relazione altamente indicativa con situazioni ed eventi preesistenti, come accade con i filmati che riprendono i comportamenti degli animali o il lancio di una navicella spaziale. La chiarezza e la semplicità sono molto richieste nei film scientifici, mentre l’espressività, lo stile e in qualche caso l’ambiguità sono caratteristiche preziose dei documentari.
Modelli e modalità del documentario Se prendiamo queste categorizzazioni generali come utile punto di partenza, ricordando che esse possono, per altri scopi, essere ridisegnate in altri modi, possiamo dunque chiederci, una volta che si è formata una tradizione di cinema documentario, quali categorie ci possono aiutare a caratterizzare i diversi tipi di film documentari. Il presente volume propone due modi principali per dividere i documentari: Secondo preesistenti modelli di non-fiction. I documentari adottano modelli quali il diario, la biografia, il saggio. Il documentario appartiene a una lunga e sfaccettata tradizione di discorso non-fiction che continua a evolvere (saggi, reportage, manifesti, blog e così via). Erik Barnouw ha utilizzato alcuni di questi modelli per categorizzare i documentari nella sua storia internazionale del cinema, Documentary: A History of the Non-fiction Film (Barnouw tratta “documentario” e “nonfiction” come sinonimi). Secondo modalità specificamente cinematografiche. I documentari adottano modalità quali quella espositiva e
osservativa. Essi selezionano e organizzano suoni e immagini in maniera particolare, usando tecniche e convenzioni squisitamente cinematografiche. Queste forme non esistevano prima del cinema. Molte di esse da allora sono state traslate alla televisione, alla produzione digitale, a internet. Così come le tecniche cinematografiche si sono evolute a partire dal cinema degli esordi, aiutando a definire i contorni del cinema narrativo, queste modalità aiutano a definire la forma e il significato del documentario. Esse, per esempio, identificano le qualità che distinguono un documentario di esposizione da uno osservativo senza che importi più di tanto se il film utilizza il diario, il reportage o la biografia come modello. Qui si sottolinea l’importanza delle modalità del documentario, ma c’è anche un altro punto che è necessario chiarire. È possibile classificare un qualunque documentario secondo ciascuno di questi due modi: quali modelli adotta da altri media; a quale modalità fa riferimento in quanto forma di cinema. Le due classificazioni non si autoescludono. Anzi, sono complementari: insieme danno un significato più completo della struttura di un qualunque documentario. La tabella 6.3 fornisce una lista di alcuni dei modelli primari di non-fiction, dai quali il documentario ha tratto elementi, e delle sei modalità cinematografiche che caratterizzano la maggior parte dei documentari (gli esempi di film inclusi nella categoria “Modelli non-fiction” compaiono anche nella colonna di destra “Modalità di documentario”, a seconda della modalità documentaristica a cui appartengono maggiormente, e viceversa). Tabella 6.3. Alcuni dei principali modelli e modalità di riferimento per il documentario. MODELLI NON-FICTION
MODALITÀ DEL DOCUMENTARIO
Investigazione/Resoconto
Espositiva
(raccoglie prove, pone questioni o offre un punto di vista)
(ci parla in modo diretto con la voce fuori campo)
Bus 174
Afrique, je te plumerai
Control Room
Chile: Obstinate Memory
Enron - L’economia della truffa
The Civil War
Gunner Palace
Dead Birds
Harvest of Shame
Grass
The Corporation
Real Sex (serie della Hbo) Grizzly Man Harvest of Shame Una scomoda verità Les Maîtres fous La marcia dei pinguini Nanuk l’eschimese Notte e nebbia Night Mail The Plow That Broke the Plains The Power of Nightmares The River Roger & Me Seven Days in September Sicko Stranger with a Camera Super Size Me
Journal inachevé Victory at Sea Why We Fight (serie) Wild Safari 3D: A South African Adventure (film Imax) Difesa/Promozione di una causa
Poetica
(l’accento è su prove ed esempi convincenti e persuasivi: spinge all’adozione di uno specifico punto di vista)
(l’accento è su ritmi e schemi visivi e sonori, e sulla forma complessiva del film)
The Corporation
De Brug
Una scomoda verità
Koyaanisqatsi
Night Mail
The Maelstrom
The Plow That Broke the Plains
Pioggia
The Power of Nightmares Sicko Storia
Osservativa
(racconta ciò che è realmente accaduto e offre su di esso un’interpretazione o un punto di vista)
(guarda gli attori sociali che si muovono nelle loro vite come se la macchina da presa non ci fosse)
The Civil War
Control Room
An Injury to One
Gunner Palace
Notte e nebbia
High School
Seven Days in September
Jesus Camp
Victory at Sea
L’ultimo valzer
Metallica: Some Kind of Monster N!ai: Story of a !Kung Woman Primary Salesman Up the Yangtze Wedding Camels Testimonianza
Partecipativa
(assembla storia orale o testimoni che raccontano la loro personale esperienza)
(il regista interagisce con il suo attore sociale e partecipa alla messa in scena di ciò che accade davanti alla macchina da presa: le interviste sono un elemento primario)
The Fog of War: La guerra secondo Robert McNamara
Bus 174
Las madres de la Plaza de Mayo Shoah The Woman’s Film Word is Out
Enron - L’economia della truffa Las madres de la Plaza de Mayo The Life and Times of Rosie the Riveter Nobody’s Business Real Sex (serie HBO) Sherman’s March Shoah The Wild Parrots of Telegraph Hill The Woman’s Film Word Is Out
Esplorazione
Riflessiva
(trasmette la singolarità e spesso il fascino di luoghi distanti, l’accento è su caratteristiche esotiche o inusuali)
(richiama l’attenzione sulle convenzioni del documentario e a tratti su metodologie tipiche quali ricerca sul campo o interviste)
Grass
L’uomo con la macchina da presa
La marcia dei pinguini Nanuk l’eschimese Up the Yangtze
(sul perché non sia nella colonna dei modelli si veda la discussione nel testo che segue)
Wild Safari 3D: A South African Adventure (film Imax) Reassemblage
Stranger with a Camera Sociologia
Performativa
(lo studio delle subculture solitamente comprende ricerca sul campo, partecipazione/osservazione dei soggetti e tanto descrizione quanto interpretazione)
(l’accento è sulla capacità del regista di esprimere il suo coinvolgimento rispetto al soggetto del film: egli si rivolge al pubblico in maniera appassionata)
High School
Chile: Obstinate Memory
Jesus Camp Primary
Complaints of a Dutiful Daughter
Salesman
Finding Christa
Stranger with a Camera
Les glaneurs et la glaneuse An Injury to One Tarnation Tongues Untied Valzer con Bashir
Antropologia visiva/Etnografia
(lo studio di altre culture: la ricerca sul campo è similare a quella della sociologia, ma solitamente con l’aggiunta dell’acquisizione di un linguaggio proprio; si fa affidamento a fonti di informazione per avere accesso alle culture oggetto di studio) Dead Birds Les Maîtres fous N!ai: Story of a !Kung Woman Reassemblage Wedding Camels Saggio in prima persona
(un racconto personale di alcuni aspetti dell’esperienza dell’autore/regista e del suo punto di vista; è similare all’autobiografia ma l’accento è posto sullo sviluppo dell’individuo) Chile: Obstinate Memory Nobody’s Business Roger & Me Super Size Me De Brug Koyaanisqatsi The Maelstrom Pioggia
Diario
(le impressioni quotidiane che possono iniziare o interrompersi in maniera arbitraria) Afrique, je te plumerai Les glaneurs et la glaneuse Sherman’s March Journal inachevé Ritratto individuale o di gruppo/Biografia
(racconta la storia della maturazione di una persona o di un gruppo e della sua singolarità) 7 Up (e i suoi seguiti: 7 Plus Seven fino a 49 Up) Grizzly Man L’ultimo valzer Metallica: Some Kind of Monster The Wild Parrots of Telegraph Hill Autobiografia
(un racconto personale dell’esperienza e della maturazione di qualcuno o uno sguardo su una vita) Complaints of a Dutiful Daughter Finding Christa
Tarnation Tongues Untied Valzer con Bashir Alcuni passaggi approfondimento.
di
questa
tabella
richiedono
un
Prima di tutto, la classificazione riflette un giudizio personale più che una precisa misurazione. Molti film possono essere classificati in relazione a molteplici modelli e modalità. Per capirci, Stranger with a Camera (Uno straniero con la macchina da presa, 1999) compare nella modalità espositiva e in quella riflessiva, e Chile: Obstinate Memory in quella espositiva e in quella performativa. Allo stesso modo, Night Mail presenta una caratterizzazione fortemente poetica nel commento fuori campo (scritto da W.H. Auden) e può essere considerato un film più legato alla poesia e alla modalità poetica che alla promozione di una causa e alla modalità espositiva. Nanuk l’eschimese presenta una corrispondenza con l’antropologia e con l’esplorazione, poiché è stato una pietra miliare per molte discussioni e dibattiti nell’ambito dell’antropologia visiva e del film etnografico. L’accento posto sul personaggio di Nanuk fa pensare anche all’autobiografia come modello di riferimento. Tutte queste sono scelte valide. Esse sottolineano caratteristiche specifiche, proprio come mettere Nanuk nella categoria della modalità osservativa sottolinea la notevole pazienza e attenzione di Flaherty nel lasciare che gli avvenimenti si sviluppassero con i propri tempi, anche se ci volle l’intervento attivo del regista per organizzare eventi quali per esempio la caccia alla foca o la costruzione dell’igloo. Spettatori diversi reagiscono in maniere più o meno forti a diversi aspetti dello stesso film e lo classificano di conseguenza. La modalità espositiva contiene di gran lunga la più vasta quantità di esempi. Questo si deve agli specifici film scelti, ma suggerisce anche che si tratta della modalità prevalente. I documentari espositivi comparirono alla
nascita della tradizione del cinema documentario e restano predominanti ancora oggi, benché alcuni dei film dell’elenco possano essere associati anche con altre modalità. Questa modalità dà priorità alla parola detta per trasmettere il punto di vista del film da una singola e univoca fonte. Questo, a seconda dei casi, facilita la comprensione. Film come Enron - L’economia della truffa e Sicko dimostrano come una modalità possa combinarsi con altre, in particolare attraverso l’utilizzo delle interviste. È possibile porre l’accento sul ruolo guida del commento che si rivolge direttamente al pubblico come in Sicko (modalità espositiva) o sulle interviste e su ciò che rivelano in Enron (modalità partecipativa). In ciascun film le interviste sono del tutto centrali. In Enron esse forniscono alcune delle informazioni cruciali e dimostrano come le dichiarazioni rilasciate pubblicamente dagli impiegati dell’azienda abbiano nascosto invece di rivelare la verità, cosa resa evidente dalle interviste rilasciate da altri. In Sicko le interviste consentono un notevole approfondimento e apportano elementi umoristici, grazie all’uso che Michael Moore fa della finta ingenuità e delle tattiche di guerilla per cogliere di sorpresa gli intervistati, cosa che non sarebbe successa utilizzando altre tecniche. Porre l’accento sul ruolo di commentatore proprio di Michael Moore presuppone che venga enfatizzata una modalità principalmente espositiva, poiché la sua voce ci guida attraverso gli aspetti complessi del sistema sanitario per comprendere come venga fornita l’assistenza. Questo commento è diventato una firma distintiva dei suoi lavori. Sia la modalità espositiva che quella partecipativa sono esplicitamente presenti in ciascun film. Quale prevalga dipende in larga parte da quali aspetti dell’opera vogliamo esplorare più approfonditamente. Nessuna delle due è giusta o sbagliata in senso assoluto. Questa pratica di mescolare le modalità è applicabile a molti film. Ciò non significa che le categorie siano inadeguate ma che i registi spesso adottano un approccio
fluido e pragmatico rispetto ai materiali a disposizione, mescolando diversi modelli e modalità per raggiungere un risultato specifico. Questo è molto diverso da un approccio del tipo “va bene tutto” in cui il regista inventa strutture e schemi sul momento, senza far ricorso a qualcosa di precedente. Come accade in altre forme d’arte, quei registi che hanno familiarità con opere precedenti e sono consapevoli delle caratteristiche base di modelli e modalità differenti di solito sono capaci di utilizzare con fluidità e grazia nella loro capacità di usare una vasta gamma di convenzioni e tecniche per creare uno stile, e una voce, che appartengono unicamente a loro. La modalità riflessiva è chiaramente la meno rappresentata. Tuttavia, questo non ci sorprende se pensiamo che molti documentari riflessivi richiamano l’attenzione sulle convenzioni formali del documentario stesso. In altre parole, essi mettono in discussione i principi che sono sottesi alle altre cinque modalità più che i diversi modelli tratti da altri media, come per esempio il mondo della carta stampata. Non c’è motivo per cui non possano essere riflessivi anche in relazione ai modelli non-fiction, attirando l’attenzione sulle convenzioni del diario, della biografia, o dell’antropologia visiva, per esempio. Stranger with a Camera, ciononostante, innesca una consapevolezza riflessiva dei presupposti antropologici e sociologici che coinvolgono la ricerca sul campo. Il film si sofferma a lungo su due individualità: il regista canadese Hugh O’Connor, che filmò gli abitanti degli Appalachi alla fine degli anni Sessanta, e Hobart Ison, un abitante locale che sparò a O’Connor uccidendolo. La regista Elizabeth Barret chiede in maniera riflessiva in che modo le profonde incomprensioni e gli stereotipi interculturali abbiano portato a quel tragico epilogo. Facendo ciò, spazza via molti dei pregiudizi che gli spettatori avrebbero potuto avere nei confronti di poveri cittadini e autorevoli registi, innescando considerazioni
più profonde sulle problematiche rappresentazione sociale.
sottese
a
una
Allo stesso modo, Reassemblage osserva alcuni aspetti della cultura dell’Africa occidentale, ma lo fa prima di tutto per mettere in discussione i presupposti tradizionali della metodologia antropologica. Un altro film riflessivo come L’uomo con la macchina da presa (non presente nella colonna dei modelli) pone l’attenzione sul processo realizzativo stesso e su come i registi attraverso il cinema costruiscano un punto di vista preciso sulla realtà storica. Il suo autore, Dziga Vertov, fu inflessibile nel non adottare modelli preesistenti. Egli cercò di forgiarne di nuovi che fossero propri unicamente del cinema. Il suo film, di conseguenza, non rientra in nessuno dei modelli elencati nella colonna di sinistra, anche se in esso ci sono tracce di sociologia, poesia, saggio in prima persona. Le modalità espositiva e poetica spesso raccolgono, isolano o compongono immagini provenienti dalla realtà con relativa indifferenza rispetto a precise situazioni o individui, immortalati con lo scopo di dare una forma a tesi o punti di vista su un argomento generale. L’idea di un vasto coinvolgimento tra il regista e il suo soggetto trova, nel migliore dei casi, un modesto riscontro. The River, per esempio, contiene numerose riprese di persone e luoghi particolari mentre racconta la storia di come la Tennessee Valley Authority controllò il corso del Mississippi e portò energia in un’ampia regione. Possiamo trovare, nel corso del film, i nomi di alcune di queste persone e luoghi, ma la loro storia personale e la relazione individuale con gli scopi del film restano appena accennati. Il classico film poetico Pioggia adotta un atteggiamento similare: vediamo tantissime persone sorprese da un acquazzone estivo ad Amsterdam, ma nessuna di esse emerge in quanto personaggio con un nome e una personalità. Il potere poetico del film sta in qualcos’altro. Immagini selezionate da altri film producono un film di montaggio che unisce insieme tali frammenti in maniera particolare. L’interazione reale tra il regista e gli
attori sociali è di solito una preoccupazione minima, visto che le immagini contribuiscono a comporre il quadro globale proposto dal film. Le immagini sono raccolte e assemblate in un insieme che è più grande delle singole parti. Questo è vero per la grande maggioranza delle riprese nella serie Why We Fight (1942-1945), poiché i film promuovono la partecipazione degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale più che raccontare la storia di singoli individui. Il rapporto del regista con coloro che compaiono davanti alla macchina da presa ha in generale meno importanza della tesi o del punto di vista globali che risultano dalla composizione delle immagini. Le modalità osservativa, partecipativa e performativa funzionano in modo diverso. Il rapporto tra il regista e la persona filmata diventa più diretto, personale e complesso. Lo spettatore ha la sensazione che l’immagine non sia solo una rappresentazione indicativa di una parte della realtà storica, ma anche una registrazione indicativa dell’incontro reale tra il regista e il soggetto. L’dea di un coinvolgimento esteso tra regista e soggetto è spesso forte. L’individualità di particolari attori sociali e persone conta moltissimo. Il regista entra nel mondo dell’attore sociale attraverso interviste, conversazioni, provocazioni o altre forme di incontro e ha il potere di alterare quel mondo. Qualcosa è messo a rischio in questi incontri. Ci rendiamo conto che il regista si colloca sullo stesso piano dell’esistenza umana del suo attore sociale invece che sul piano più distaccato del commentatore e poeta. Le discussioni relative al comportamento etico nel documentario spesso vertono sulla natura di queste interazioni (discussioni etiche che coinvolgono anche questioni di distorsione, rappresentazione fallace e inganno che si estendono a tutte le modalità).
Le modalità del documentario e la voce del regista Come ogni voce, anche quella cinematografica ha uno stile o un “timbro” particolare che funziona come una firma o un’impronta digitale; esso testimonia l’individualità del regista
o, a volte, attesta il potere dello sponsor o dell’organizzazione che controlla il documentario. I telegiornali possiedono ognuno una voce propria, così come registi quali Frederick Wiseman o Chris Marker, Esther Shub o Barbara Kopple. Le voci individuali sono utili per la teoria del cinema d’autore, mentre quelle più generali servono per l’analisi dei generi cinematografici. Solitamente raggruppiamo i film di fiction in sottocategorie note come generi quali il melodramma e l’horror, il western o la fantascienza. Gli studi sui generi prendono in considerazione le caratteristiche che contraddistinguono questi gruppi di film. In molti casi il documentario può essere trattato come un genere simile al western o al film di gangster, con le tipiche convenzioni o aspettative che lo permeano. Il Capitolo 1 ha trattato il documentario su questo livello analizzandolo in notevole profondità. Ma per arrivare al punto nodale della nostra discussione è necessario che differenziamo tra diverse tipologie di documentario. È a questo punto che entrano in gioco le nozioni di modelli e modalità. I modelli non sono specifici del cinema, mentre lo sono le modalità. Queste modalità, in effetti, meritano di essere discusse in profondità poiché formano lo scheletro concettuale della maggior parte della produzione documentaria. Queste sei modalità creano una struttura semirigida entro la quale lavorare, predispongono convenzioni che un dato film può adottare e forniscono inoltre delle precise aspettative che gli spettatori vogliono vedere mantenute. Ogni modalità ha degli esempi che si possono identificare come prototipi o modelli: essi esprimono le caratteristiche tipiche di quella modalità. Non possono essere copiati, ma possono essere emulati dagli altri registi che, con altre voci, intendano rappresentare degli aspetti del mondo usando un prototipo che riflette la loro particolare prospettiva. L’ordine in cui verranno presentate le sei modalità corrisponde grossomodo a quello cronologico con cui sono state introdotte. Questo non è completamente vero poiché le tendenze performative e riflessive erano in realtà evidenti fin dagli inizi. La grossa frattura temporale si colloca, approssimativamente, intorno al 1960. È il momento in cui la
registrazione portatile del suono sincronizzato divenne realtà e le modalità osservativa e partecipativa divennero predominanti. Esse sono sostanzialmente diverse da quelle espositiva e poetica perché la reale presenza fisica del regista in un dato momento storico assume una nuova e profonda importanza. Le diverse modalità possono apparentemente fornire una storia del cinema documentario, ma lo fanno in modo imperfetto. Non soltanto la maggior parte di esse erano presenti fin dagli inizi, ma un film che è stato identificato con una data modalità può non farne interamente parte. Un documentario di tipo riflessivo può avere sezioni che appartengono alla modalità osservativa o partecipativa; un documentario espositivo può contenere dei segmenti poetici o performativi. Le caratteristiche di una data modalità danno una struttura al film, ma non indicano né determinano ogni aspetto della sua organizzazione. Resta comunque possibile una considerevole libertà. Le modalità non costituiscono una genealogia del genere documentario ma un insieme di risorse disponibili a tutti. Un documentario performativo può condividere molte caratteristiche del documentario poetico, per esempio. Le modalità non sono una catena evolutiva in cui quelle successive dimostrano superiorità estetiche su quelle precedenti e le eliminano, anche se a tratti emerge la tentazione di fare dichiarazioni di questo tipo. Una volta determinatasi attraverso una serie di convenzioni e di film esemplari, una data modalità resta disponibile per tutti. Ogni modalità espande l’idea di ciò che è possibile in una rappresentazione documentaristica. Il documentario espositivo risale, per esempio, agli anni Venti, ma mantiene anche oggi una forte influenza. La maggior parte dei telegiornali e dei reality show televisivi dipendono molto da queste convenzioni un po’ datate, così come quasi tutti i documentari scientifici e naturalistici, le biografie di canali come A&E Biography e la maggioranza dei documentari storici in grande scala come The Civil War (La guerra civile, 1990), Eyes on the Prize, The People’s Century (Il secolo della gente, 1998) o The War (La guerra, 2007).
Per certi versi, ogni modalità di rappresentazione documentaristica nasce in parte da un senso crescente di insoddisfazione dei registi nei confronti di altre modalità. Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie spesso giocano un ruolo fondamentale. Le modalità osservativa e partecipativa divennero altamente attrattive in seguito alla disponibilità delle nuove cineprese leggere a 16mm e dei registratori portatili a nastro magnetico durante gli anni Sessanta. Allo stesso modo, l’avvento delle videocamere e dei dispositivi di registrazione digitali, dei programmi di montaggio al computer e di internet ha generato una produzione di opere documentaristiche che promettono di cambiare molti dei presupposti formali di base. Dai video registrati con i telefonini nel cuore di un momento che passa in maniera molto rapida alle parodie di icone della cultura popolare, passando per i diari in video praticamente sempre disponibili, queste nuove tecnologie espandono l’idea del possibile in maniera drammatica. A titolo di esempio, su Flickr.com esiste un photostream ufficiale della Casa Bianca, cioè un sito dedicato alla pubblicazione di immagini. Le foto sono presentate con titolo e didascalia e spesso informano sulle attività presidenziali. Nel 1963, Robert Drew organizzò uno studio osservativo della Casa Bianca durante il picco della battaglia sulla disgregazione scolastica nel Sud: Crisis: Behind a Presidential Commitment (1963). Esso fornì una visione da dietro le quinte del confronto tra il presidente Kennedy e il governatore dell’Alabama George Wallace. I critici hanno lodato la sua capacità di entrare nei corridoi del potere e di arrivare fino al cuore delle retrovie come un insider. Adesso quelle attività diventano un diario quotidiano su Flickr, realizzato dalla Casa Bianca stessa, e la storia per immagini del presidente diventa un prodotto ben confezionato opera di coloro che un tempo non avrebbero affatto permesso a degli estranei di arrivare a guardare dal di dentro le attività della Casa Bianca nei più piccoli dettagli. Questa è una seppur minima indicazione di come le nuove tecnologie e le menti creative di oggi modifichino in maniera costante il panorama documentaristico.
The Day After Trinity (di Jon Else, 1980). Le considerazioni sulla Guerra Fredda avvenute dopo gli anni Sessanta hanno portato a una revisione dei documenti del dopoguerra. Registi come Connie Field in The Life and Times of Rosie the Riveter e Jon Else in The Day After Trinity pongono i filmati storici in un nuovo contesto dando loro un nuovo significato. In questo caso, Else riesamina i dubbi e le esitazioni di Robert J. Oppenheimer sullo sviluppo della bomba atomica, mostrandoli come una flebile voce della ragione in un periodo di semi isterismo. Oppenheimer stesso fu accusato di tradimento. Fotografia concessa dal regista.
Il desiderio di scoprire nuovi modi di rappresentare il mondo contribuisce, insieme allo sviluppo di nuove circostanze, alla formazione di ogni modalità. Le nuove modalità nascono in parte in risposta a delle carenze percepite nelle precedenti, ma l’idea di questa mancanza deriva dalla consapevolezza che serve qualcosa di nuovo per rappresentare il mondo da un dato punto di vista in un certo momento. L’apparente neutralità e il tono da “questi sono i fatti”, tipici del cinema osservativo, sono nati alla fine dei calmi anni Cinquanta e nel momento di massima presenza delle forme di sociologia descrittive e basate sull’osservazione. Si sono poi
sviluppati come l’impersonificazione di una presunta “fine dell’ideologia” e come nuovo interesse nei confronti del mondo di tutti i giorni, ma non necessariamente in accostamento all’impegno sociale o alla rabbia politica di chi era ai margini della società. Similmente, l’intensità emotiva e l’espressività soggettiva del documentario performativo hanno preso una forma più compiuta durante gli anni Ottanta e Novanta. Le sue radici più profonde sono all’interno di quei gruppi il cui senso di comunità era cresciuto nel tempo, come risultato di una politica di identità. Questa forma di organizzazione politica, spesso militante, su una base diversa da quella di classe, affermò la relativa autonomia e la singolarità sociale di gruppi marginalizzati. Questi film rifiutavano tecniche come il commento fuori campo onnisciente, non perché mancassero di umiltà ma perché appartenevano a un’epistemologia, o modo di vedere e percepire il mondo, che non era più ritenuta accettabile. Stanchi di sentire altri parlare di loro, i membri di questi gruppi cominciarono a parlare per se stessi. Noi facciamo bene a prendere con la dovuta cautela ogni dichiarazione che una nuova modalità migliori l’arte del cinema e sappia catturare aspetti del mondo mai visti prima. Quello che cambia è la modalità della rappresentazione, non la sua qualità o il suo status definitivo. Una nuova prassi non è migliore, ma diversa, anche se viene spesso espressa al suo arrivo l’idea di “miglioramento”, soprattutto tra coloro che sostengono e utilizzano una nuova modalità o una nuova tecnologia. Ogni cambiamento porta una diversa serie di enfasi e di influssi. Ma ogni nuova modalità, ogni nuova maniera di realizzare e distribuire film, alla fine si rivelerà vulnerabile, a sua volta, nei confronti di critiche mosse a quei limiti che essa promette di superare. Le nuove modalità non indicano un modo migliore di rappresentare il mondo, ma un nuovo modo di organizzare un film, una nuova prospettiva per guardare alla nostra relazione con la realtà e una nuova serie di problemi e di desideri da proporre a un pubblico. Possiamo ora dire qualcosa di più su ogni singola modalità.
La modalità poetica
Come abbiamo visto nel Capitolo 5, il documentario poetico ha qualcosa in comune con l’avanguardia modernista. La modalità poetica sacrifica le convenzioni del montaggio in continuità e il conseguente senso di una collocazione specifica nel tempo e nello spazio che deriva da esso. L’interesse del regista per la forma del suo film è equivalente, se non superiore, a quello per i suoi attori sociali. Questa modalità esplora le associazioni e i motivi che riguardano i ritmi del tempo e le giustapposizioni dello spazio. Gli attori sociali non prendono mai le forme di personaggi a tutto tondo, con una mentalità complessa e una visione costante del mondo. Le persone vengono più spesso appaiate con altri oggetti nel ruolo di materiale grezzo che i registi selezionano e dispongono in associazioni e motivi di loro scelta. Nel documentario Pioggia di Joris Ivens, per esempio, non acquisiamo una conoscenza approfondita degli attori sociali che vi compaiono, ma impariamo ad apprezzare l’impressione poetica, creata dal regista, di un temporale estivo che passa sopra Amsterdam.
Pacific 231 (di Jean Mitry, 1949). La locomotiva comincia il suo viaggio in una rimessa di forma rotonda e ben presto si lancia a tutta velocità sui binari. Il film di Mitry è uno dei grandi omaggi cinematografici al treno, un veicolo, proprio come il cinema, che ci trasporta repentinamente in luoghi lontani. Per gentile concessione di Photofest.
La modalità poetica è particolarmente adatta a esplorare le possibilità di comunicare in maniera alternativa le informazioni, di proporre determinati argomenti o punti di vista, o presentare ragionevoli soluzioni a un problema. Questa modalità dà evidenza all’impressione, al tono e comunica molto più che sole informazioni o un tentativo di persuasione retorica. L’elemento retorico resta poco sviluppato, ma la qualità espressiva è vivissima. Sono l’affezione e il sentimento che ci fanno imparare dal film, nel senso che impariamo il significato di cosa voglia dire vedere e sperimentare il mondo in una maniera peculiare e poetica. Il film di László Moholy-Nagy Zeigt ein Licthspiel: Schwarz, weiß, grau (Gioco di luce: nero, bianco, grigio, 1930), per esempio, presenta numerose inquadrature di una delle sue sculture cinetiche, più per enfatizzare le qualità della luce che passa attraverso la pellicola cinematografica che per documentare la forma fisica della scultura stessa. L’effetto di questo gioco di luce sullo spettatore ha più importanza dell’oggetto a cui fa riferimento nel mondo reale. Similmente, Pacific 231 (1949) di Jean Mitry è in parte un omaggio al film di Abel Gance La roue e in parte una rievocazione poetica del potere e della velocità di una locomotiva a vapore, che guadagna lentamente velocità e inizia a correre verso la sua (ignota) destinazione. Il montaggio sottolinea il ritmo e la forma, più che descrivere il funzionamento di una locomotiva. Il potere poetico del film è ancora più eviente quando lo paragoniamo a L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat. Pacific 231 trasmette una vivida idea dei ritmi dinamici di un grande viaggio, che manca completamente nel piano sequenza dell’arrivo graduale ma drammatico del treno nel film precedente. La dimensione documentaristica della modalità di rappresentazione poetica deriva largamente dal grado con cui i film modernisti utilizzano il mondo reale come loro fonte di materiale. Alcuni film di avanguardia, come Komposition in Blau (Composizione in blu, 1935) di Oskar Fischinger, fanno uso di motivi astratti di forme o colori o figure animate, e hanno perciò una relazione minima con la tradizione documentaristica che vuole rappresentare il mondo reale e non
uno immaginato dall’artista. I documentari poetici, però, attingono dalla realtà per recuperare il loro materiale grezzo che poi trasformano in modi particolari. Il film di Francis Thompson N.Y., N.Y. (1957), per esempio, usa delle riprese di New York che mostrano l’aspetto della città negli anni Cinquanta, dando tuttavia grande importanza alla selezione e alla disposizione di queste riprese in modo da fornire un’impressione poetica della città come massa di volume, colore e movimento. Il film di Thompson continua la tradizione della sinfonia urbana e conferma il potenziale poetico del documentario per vedere il mondo con occhi nuovi. Questo tono affettivo rispetto alla realtà vissuta assume un’assoluta predominanza nei documentari animati, molti dei quali possiedono una forte qualità poetica, benché facessero riferimento a un particolare evento o tipo di esperienza. Sylvie Bringas e Orly Yadin raccontano in modo emozionante l’esperienza dell’Olocausto vissuta da Tana Ross durante la sua infanzia in Silence (Silenzio, 1998), che è ampiamente narrato attraverso l’animazione. La grande capacità dell’animazione di evocare fantasmi pone l’accento su una storia non detta e non dicibile, che la sua famiglia si portò dietro senza farne mai parola. Ci volle la metà di una vita per sentirla e viverla, in maniera indiretta, proprio nella misura in cui l’animazione evoca con potenza memorabile la realtà dei campi di sterminio e la surreale illusione di Theresienstadt, che i nazisti utilizzarono come “campo modello” per dare l’impressione che i prigionieri fossero trattati bene. Con un simile spirito, Feeling My Way (Sentire a modo mio, 1997), di Jonathan Hodgson, utilizza l’animazione per evocare un mondo altamente soggettivo immaginato dal narratore del film nei suoi viaggi di lavoro. Niente è davvero reale ma tutto porta con sé una strana somiglianza con la realtà. Il narratore, “John”, applica categorie ed etichette a ciò che vede, ma queste sembrano poter fare poco per ridurre il potere affettivo di un mondo pieno di mistero e, qualche volta, di pericolo. Quando alla fine egli arriva al lavoro è per attraversare una porta che ha il nome di “Universo Parallelo”. La domanda si pone: l’universo parallelo è quello che noi
consideriamo come la realtà o è invece una variazione ancor più folle della realtà soggettiva che abbiamo appena sperimentato? Questo film, e molti altri come questo, utilizzano l’animazione per ottenere risultati poetici mescolati con modelli e modalità autobiografiche, diaristiche e performative.
Pioggia (di Joris Ivens, 1929). Immagini come questa danno l’idea di che cosa sia un acquazzone, più che fornire informazioni sull’argomento. Si tratta di una prospettiva poetica distinta dal mondo storico. La ricerca di una visione del genere era comune a molti artisti che in seguito sarebbero stati considerati, più specificamente, autori di documentari o filmmaker sperimentali. Fotografia concessa dalla European Foundation Joris Ivens.
La modalità poetica è nata insieme al modernismo come modo di rappresentare la realtà attraverso un insieme di frammenti, impressioni soggettive, azioni incoerenti o libere associazioni. Questi aspetti sono stati spesso attribuiti alle trasformazioni generate dall’industria e in particolare alle conseguenze della Prima guerra mondiale. L’evento modernista non sembrava avere più senso in termini realistici, con metodi narrativi tradizionali. Spezzare il tempo e lo spazio in prospettive multiple, negare coerenza a personalità dall’inconscio instabile e rifiutarsi di fornire soluzioni a problemi insormontabili significava mantenere comunque un
senso di onestà, anche nel caso di opere d’arte che generavano perplessità o ambiguità. Sebbene alcuni film esplorassero delle concezioni più classiche di poetica in cerca di una fonte di equilibrio, integrità e unità, questo interesse per la frammentazione e l’ambiguità resta una caratteristica principale di molti documentari poetici. Un chien andalou e L’Âge d’or (di Luis Buñuel, 1930), per esempio, danno l’impressione di una realtà documentaria, ma la popolano di personaggi presi da desideri incontrollabili, cambi improvvisi di tempo e di spazio e più domande che risposte. Registi come Kenneth Anger hanno ripreso questi aspetti della modalità poetica in film come Scorpio Rising (La rivolta di Scorpio, 1963), una rappresentazione dei rituali dei membri di una banda di motociclisti, lo stesso ha fatto Chris Marker in Sans soleil, una meditazione complessa sul cinema, sul ricordo e sul postcolonialismo (all’epoca della loro uscita, film come quello di Anger sembravano fortemente collegati alla tradizione dei film di sperimentazione, ma in retrospettiva possiamo notare come in essi sia presente una combinazione di elementi di sperimentazione e documentaristici; il modo in cui vengono definiti dipende molto dai presupposti che adottiamo sulle categorie e sui generi, sui modelli e le modalità). Al contrario, lavori come Song of Ceylon di Basil Wright, sulla bellezza intatta dell’isola di Ceylon (Sri Lanka) nonostante le influenze del commercio e del colonialismo, Glass (Vetro, 1958) di Bert Haanstra, un tributo all’arte dei soffiatori di vetro tradizionali e alla bellezza del loro lavoro, o Always for Pleasure (Sempre per piacere, 1978) di Les Blank, una celebrazione dei festeggiamenti del Mardi Gras di New Orleans, ritornano a un senso più classico di unità e bellezza, cercandone le tracce nel mondo reale. La modalità poetica ha molte sfaccettature e tutte quante tendono a enfatizzare i modi con cui la voce del regista dà ai frammenti del mondo reale un senso di integrità formale ed estetica tipico del film. Le notevoli opere di Péter Forgács, in cui il regista elabora filmati amatoriali per creare documenti storici, preferiscono sottolineare le qualità poetiche e associative piuttosto che fornirci informazioni o convincerci di un particolare punto di vista. Az Örvény (Caduta libera, 1998), per esempio, racconta
il destino degli ebrei europei negli anni Trenta e Quaranta attraverso i filmati amatoriali di un famoso uomo d’affari ebreo (Gyorgy Peto), e Danube Exodus (L’esodo del Danubio, 1999) segue il viaggio di una nave da crociera sul Danubio mentre trasporta gli ebrei dall’Ungheria al Mar Nero fino al volo per la Palestina, e al ritorno trasporta i tedeschi provenienti dalla Bessarabia (all’epoca la regione a Nord della Romania) che, cacciati dalla Russia, vengono evacuati in Germania e stanziati in Polonia. I filmati storici, i fermo immagine, i ralenti, le immagini virate, la colorazione selettiva, i titoli per identificare tempo e luogo, le voci che leggono paragrafi di diario, insieme alla musica inquietante, servono, più che a spiegare o descrivere il corso della guerra, a creare un tono e un’ambientazione. La qualità poetica che Forgács aggiunge ai filmati familiari originali dà al film un afflato e una dimensione affettiva che sgorgano dai punti deboli e dai piaceri della vita di tutti i giorni più che dai drammi e dall’intensità degli avvenimenti che scuotono il mondo.
Yosemite: The Fate of Heaven (di Jon Else, 1988). La diatriba tra accesso pubblico e conservazione è il tema principale del film. Il commento di Robert Redford ha un tono onnipresente e onnipotente, poiché non vediamo mai il celebre attore di persona. Sapere che Redford è da molto tempo un sostenitore della causa ambientalista ci dà l’idea che egli sia un commentatore più esperto di una voce anonima, e il fatto che noi spettatori abbiamo già un’immagine di come sia Redford che ci viene dai molti film che ha interpretato dà al contempo alla voce un tono autorevole. Fotografia concessa dal regista.
La modalità espositiva Questa modalità unisce frammenti del mondo reale in una struttura più retorica o argomentativa di quella estetica o poetica. È la modalità che per prima combinò i quattro elementi base del documentario descritti nel Capitolo 5 (immagini indicative della realtà, associazioni poetiche e affettive, qualità narrative e capacità di persuasione retorica). Essa si rivolge direttamente allo spettatore, con dei titoli o delle voci che forniscono una visione o propongono un argomento di discussione. I film espositivi adottano un tipo di commento onniscente fuori campo (in cui il narratore si sente ma non si vede mai), come quelli che troviamo nelle serie Why We Fight, Victory at Sea, The City, Le sang des bêtes e Dead Birds, oppure utilizzano un commento autorevole (in cui il
narratore si sente e si vede), come quelli che troviamo nei telegiornali, nella serie America’s Most Wanted o in The Selling of the Pentagon, 16 in Webster Groves (Al 16 di Webster Grove, 1966), Ways of Seeing (Modi di vedere, 1974) di John Berger, Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, Born into Brothels di Zana Briski e Ross Kaufman.
Il trionfo della volontà (di Leni Riefenstahl, 1935). La separazione fisica e gerarchica tra i capi e i sostenitori viene chiaramente mostrata in questa scena del passaggio di Hitler per le strade di Norimberga.
Terra di Spagna (di Joris Ivens, 1937). Il sostegno di Ivens alla causa repubblicana contro la ribellione filonazista del generale Franco fa seguito al suo impegno politico per promuovere ideali democratici e socialisti. In questa inquadratura di un ufficiale e di un soldato il regista toglie ogni enfasi al rapporto gerarchico, in diretta contrapposizione con lo stile registico di Riefenstahl.
La tradizione della voce onnisciente ha portato alla nascita di un commento dalla tipica voce colta, professionale, maschile e profonda che è diventata il simbolo della modalità espositiva, nonostante alcuni dei film di maggiore impatto si
siano basati su voci meno perfette per aumentare la credibilità evitando un’eccessiva raffinatezza. Terra di Spagna, il grande film di Joris Ivens a sostegno dei difensori repubblicani della democrazia spagnola, per esempio, esiste in almeno tre versioni. Nessuna ha un commentatore professionista. Tutte e tre hanno la stessa traccia di immagine, ma la versione francese usa un commento improvvisato del famoso regista francese Jean Renoir, mentre quella inglese ha Orson Welles ed Ernest Hemingway. Ivens aveva scelto all’inizio Welles, ma la sua esposizione si è rivelata un po’ troppo elegante; dava agli eventi un sentimento di umana compassione, mentre Ivens sperava in un senso più forte di coinvolgimento viscerale. Hemingway, che aveva scritto il commento, si è dimostrato la voce più efficace: ha saputo dare un tono franco ma chiaramente impegnato a un film che voleva, più che generare compassione, stimolare solidarietà (alcune copie del film accreditano la voce fuori campo a Welles anche se chi si sente è Hemingway). I documentari espositivi utilizzano molto una logica informativa che viene comunicata attraverso la parola parlata. Le immagini hanno in questi casi un ruolo di sostegno: illustrano, illuminano, rievocano o agiscono in contrappunto con quanto viene detto. Il commento viene solitamente presentato come separato dalle immagini del mondo sociale che lo accompagnano. Serve a organizzarle e a dare loro un senso, allo stesso modo di una didascalia. Il commento, quindi, proviene da un luogo non specificato e viene associato a obiettività e onniscienza. Esso manifesta segnali di comprensione e rappresenta l’organizzazione logica del film. Il commento, insomma, indica il punto di vista del film. Noi diamo retta al commento e accettiamo le immagini come prove o dimostrazioni in base a quello che esso dice. Un telegiornale che definisce “biblica” la carestia in Etiopia, per esempio, viene comprovato da inquadrature in grandangolo di una pianura piena di persone che muoiono di fame.
Il trionfo della volontà. Il saluto dei soldati si unisce alla ripresa dal basso dell’aquila tedesca e delle svastiche naziste. Come Hitler, l’aquila è un simbolo del potere della Germania. Sorvola il mare di truppe in marcia che le sfilano sotto, trasformando il loro movimento in un saluto all’unità nazionale.
Terra di Spagna. In contrasto con le sfilate infinite e i discorsi di Riefenstahl, Ivens cattura la qualità modesta della vita di tutti i giorni nella Spagna degli anni Trenta. L’immagine del paese, Fuenteduena, vicino al fronte della battaglia, mostra che la vita della gente comune è messa a rischio, e non esaltata, dalla ribellione fascista.
All’interno della modalità espositiva, il montaggio non serve tanto a stabilire un ritmo o un motivo formale, come all’interno della modalità poetica, quanto a mantenere la continuità dell’argomento o del punto di vista di cui si parla. Esso viene definito “montaggio evidenziatore” e può sacrificare la continuità di spazio e di tempo per utilizzare immagini provenienti anche da lontano che aiutino a motivare l’argomento o a sostenere una tesi. Il regista di un film espositivo ha spesso, rispetto a uno di fiction, una libertà maggiore nella selezione e nella disposizione delle immagini. In The Plow That Broke the Plains le inquadrature delle aride
pianure provengono da tutto il Midwest, per esempio, con lo scopo di sostenere la teoria del profondo danno arrecato alla terra. Il montaggio delle riprese fatte in Kansas insieme a quelle del Texas, a partire dall’affermazione che le Grandi Pianure corrono un serio pericolo di danni permanenti, ottiene un effetto di intensità più che di appiattimento. La modalità espositiva sottolinea l’impressione di oggettività e di un’opinione sostenuta da ottimi argomenti. Il commento fuori campo sembra provenire letteralmente “dall’alto”; possiede la capacità di giudicare le azioni del mondo reale senza esserne invischiato. Il tono ufficiale del commentatore professionista, come lo stile autorevole del giornalista televisivo, cerca di comunicare un senso di credibilità confermato da qualità come il distacco, la neutralità, l’imparzialità e l’onniscienza. Queste qualità possono essere adattate a un punto di vista ironico, come nel commento del film di Charles Kuralt 16 in Webster Groves, o ribaltate del tutto, come in Las Hurdes, in cui viene implicitamente attaccata la nozione stessa di oggettività. Più recentemente, registi come Michael Moore, Su Friedrich, Jill Godmilow, Travis Wilkerson, Alan Berliner, Trinh Minh-ha e Patricio Guzmán hanno deciso di parlare con la propria voce. Questo cambiamento pone l’accento sulla prospettiva personale dell’autore e rinuncia al richiamo al potere ultimo o alla verità imparziale tipico della voce onnisciente. Esso è parte di un più ampio cambiamento che ha enfatizzato le prospettive personali rispetto all’autorità istituzionale presente in genere nel documentario così come in altre forme di discorso. La modalità espositiva può anche mantenere il grado di analisi al minimo, poiché i suoi argomenti possono essere affrontati brevemente e con poche parole. Il documentario espositivo è un modo ideale di comunicare informazioni o di mobilitare il sostegno all’interno di una struttura già esistente. In questo caso, il film aggiungerà materiale al nostro archivio di conoscenze, ma non metterà in discussione né rovescerà le categorie che organizzano e legittimano in primo luogo quelle conoscenze. Il buon senso sarà il presupposto perfetto per la
rappresentazione del mondo, poiché esso, come la retorica, è soggetto più alla morale che alla logica. Per esempio, Frank Capra ha organizzato, nella serie Why We Fight, gran parte della sua argomentazione sul perché i giovani americani si sarebbero dovuti unire come volontari alle battaglie della Seconda guerra mondiale facendo appello a un misto di patriottismo genuino, ideali americani di democrazia, descrizione delle atrocità commesse dalle forze dell’Asse e della cattiveria di Hitler, Mussolini e Hirohito. Con delle nette opposizioni tra “mondo libero” e “mondo oppresso”, chi non avrebbe scelto il primo? Il buon senso rendeva semplice la risposta, soprattutto al pubblico a maggioranza bianca già indottrinato con il calderone di credenze nei valori americani. Cinquant’anni dopo, l’appello di Capra sembra notevolmente ingenuo ed esagerato nel suo sbandierare valori patriottici e idee democratiche. Per esempio, nessuna minoranza, nessun problema di giustizia sociale, povertà o fame si insinuano nel film. I bianchi americani rappresentano tutti gli americani e tutti gli americani si oppongono al nemico fascista. Quando Ken Burns raccontò di nuovo la storia della Seconda guerra mondiale in The War, serie Tv in sette parti, prima di tutto si rese conto che non poteva invocare così facilmente una visione alla Capra di un unico calderone di valori. In un episodio ambientato a Sacramento, in California, faceva scarsi riferimenti agli sforzi messi in campo dagli americani di sangue messicano durante la guerra e immediatamente sorsero le proteste. Burns, un regista e storico fondamentalmente conservatore, sebbene molto talentuoso, fece velocemente marcia indietro e aggiunse riferimenti ai messicani americani, mantenendo comunque la sua visione d’insieme. Nonostante il carattere di retropensiero, la consapevolezza di Burns rispetto a una comunità minoritaria emarginata che aveva sofferto recriminazioni e ingiustizie rende esplicito il fatto che la modalità espositiva non serve a promuovere solo il punto di vista dominante. La Seconda guerra mondiale appare molto diversa se guardata dalla prospettiva degli ispanici di Sacramento, delle donne che affrontano il sessismo nel lavoro in fabbrica in tempo di guerra
o dei nippo-americani che subiscono il confino forzato nei campi di reinsediamento. Le tesi e i punti di vista di determinati documentari espositivi possono diventare datati molto più velocemente della modalità stessa, che persiste ed è probabilmente la più utilizzata oggi.
CAPITOLO 7 COME SI POSSONO DEFINIRE LE MODALITÀ OSSERVATIVA, PARTECIPATIVA, RIFLESSIVA E PERFORMATIVA DEL CINEMA DOCUMENTARIO? La modalità osservativa Le modalità poetica ed espositiva del documentario hanno spesso sacrificato il coinvolgimento diretto con persone specifiche in favore della costruzione di motivi formali o punti di vista persuasivi. Il regista raccoglieva il materiale grezzo necessario e da esso traeva un ragionamento, una prospettiva o un’argomentazione. E se il regista avesse semplicemente voluto osservare quello che accadeva di fronte alla cinepresa, senza intervenire? Questa forma di documentazione non sarebbe stata nuova e stimolante? Gli sviluppi tecnici in Canada, in Europa e negli Stati Uniti negli anni dopo la Seconda guerra mondiale portarono alla nascita, intorno al 1960, di numerose cineprese a 16mm come l’Arriflex e l’Auricon e di registratori come il Nagra, strumenti che potevano essere utilizzati tranquillamente da una sola persona. L’audio poteva essere sincronizzato con l’immagine, senza l’uso di equipaggiamento ingombrante o cavi che collegavano registratore e cinepresa. Il registratore video e audio poteva essere mosso liberamente intorno a una scena e catturare all’istante quello che avveniva. Molti registi in quel momento scelsero di abbandonare tutte le forme di controllo nell’ambito di messa in scena, disposizione o composizione di una ripresa rese possibili dalle modalità poetica ed espositiva. Al contrario, scelsero di osservare le esperienze vissute con spontaneità. L’intento di restare fedeli a questo spirito di osservazione anche nella postproduzione oltre che durante le riprese portò alla realizzazione di film privi di commento fuori campo, senza musica aggiunta o effetti sonori, senza intertitoli né
ricostruzioni storiche, senza ripetizioni di scene per la cinepresa e perfino senza interviste. Quello che si vede è quello che è successo, o almeno questa è l’impressione in Primary, High School, Les Raquetteurs, in cui un gruppo di cittadini di Montreal gioca nella neve, o in alcune parti di Chronique d’un été, che narra la vita di alcuni abitanti della Parigi del 1960, The Chair (La sedia, 1962), sugli ultimi giorni di un uomo condannato a morte, Gimme Shelter (1970), sul tristemente famoso concerto dei Rolling Stones ad Altamont, California, in cui l’uccisione di un uomo da parte degli Hell’s Angels venne parzialmente registrata dalle cineprese, Dont Look Back, sul tour in Inghilterra di Bob Dylan del 1965, Monterey Pop (1968), su un festival musicale a cui, tra gli altri, parteciparono Otis Redding, Janis Joplin, Jimi Hendrix e i Jefferson Airplane, o Jane (1962), che segue Jane Fonda mentre si prepara per un’opera teatrale a Broadway.
Victory at Sea (di Henry Salomon e Isaac Kleinerman, 1952-53). Come Notte e nebbia, Victory at Sea torna al passato recente per raccontare la Seconda guerra mondiale. Realizzato come serie televisiva per la Cbs, il film adotta un tono commemorativo. Vengono ricordate le battaglie e le strategie, le sconfitte e le vittorie dal punto di vista dei sopravvissuti e dei veterani. Viene celebrata la potenza navale e il suo contributo alla vittoria, prestando scarsa attenzione alla guerra sulla terraferma o alle conseguenze per i civili, temi affrontati invece in Notte e nebbia. Entrambi i film, tuttavia, utilizzano un montaggio di filmati d’archivio dell’epoca. I film di montaggio alterano immancabilmente il significato dei filmati che contengono. Entrambe le pellicole usano i filmati per riflettere sul significato del passato, piuttosto che affrontare avvenimenti contemporanei.
I risultati ricordano spesso il lavoro dei neorealisti italiani. La vita è ripresa nel modo in cui appariva realmente. Spesso i personaggi passano dei momenti problematici o di crisi, che richiedono la loro attenzione e li distraggono dalla presenza del regista. Le scene tendono, come in un film di fiction, a rivelare la personalità e gli aspetti del carattere dei protagonisti. Come pubblico, noi facciamo deduzioni e arriviamo a delle conclusioni sulla base del comportamento che osserviamo. Poiché il regista resta appartato nel suo ruolo di osservatore, allo spettatore tocca un ruolo più attivo nel determinare il significato di ciò che viene detto e fatto. La modalità osservativa pone una serie di domande a sfondo etico che riguardano l’atto di osservare gli altri mentre svolgono
i propri compiti. È da considerarsi voyeurismo? È vero che lo spettatore viene sempre posto in una posizione più scomoda rispetto a un film di fiction? In quest’ultimo, le scene vengono specificamente preparate affinché noi le vediamo e sentiamo, mentre quelle del documentario rappresentano la vita di persone vere che noi osserviamo come se fosse per caso. Questa posizione, simile allo spiare dal buco della serratura, può risultare spiacevole se si percepisce che viene data più importanza al piacere dello sguardo che alla possibilità di interagire con quanto visto. La sensazione può essere ancora più sgradevole quando si sa che la persona non è un attore che ha volontariamente scelto di essere filmato mentre interpreta un ruolo fittizio. Ad alcuni, il ritratto di Edith ed Edie Bouvier Beale realizzato dai fratelli Maysles in Grey Gardens (Giardini grigi, 1975) provocò proprio questo tipo di acuto disagio. Le due donne, imparentati con la famiglia di Jacqueline KennedyOnassis, vivono in una enorme ma cadente magione nella zona chic degli Hamptons, vicino a New York. Si trovano a loro agio davanti alla macchina da presa e sono spontanee nel modo in cui interagiscono con essa, ma sembrano non avere alcuna idea del fatto che gli altri giudicheranno il loro eccentrico, solitario e altamente codipendente stile di vita come bizzarro, se non malato. In che modo i registi possono semplicemente osservare e passare accanto a ciò che vedono se quello che vediamo noi ora diventa materiale per una diagnosi di malattia o per giudizi di disfunzionalità? Non hanno i registi l’obbligo etico di confrontarsi con questi argomenti in modo più diretto? Ovviamente queste domande rientrano nell’arena del dibattito etico che riguarda le responsabilità del regista, ma il fatto stesso di rientrare in questa arena non vale quanto riconoscere il problema e cercare di risolverlo sul momento invece che osservarlo e possibilmente sfruttarlo. L’impressione che la presenza del regista non intralci il comportamento degli altri fa sorgere anche la questione dell’invadenza implicita o indiretta. Le persone che vediamo hanno cambiato apposta il loro comportamento in modo da dare alla nostra idea di loro un connotato negativo o positivo per soddisfare un regista che non ha detto loro chiaramente che cosa voleva? È possibile che il regista abbia scelto di rappresentare
delle date persone perché possiedono delle qualità che affascineranno il pubblico nel modo sbagliato? Questa domanda sorge spesso con i film etnografici che osservano, in altre culture, dei comportamenti che potrebbero, senza una contestualizzazione adeguata, sembrare esotici o bizzarri, più adatti a un “cinema delle attrazioni” che a uno sguardo scientifico. Il regista avrà ottenuto un consenso informato dai partecipanti, attraverso una adeguata spiegazione? Come fa a spiegare chiaramente le possibili conseguenze che deriveranno dal permettere che il proprio comportamento venga osservato e mostrato ad altri? Frederick Wiseman, per esempio, richiede verbalmente il consenso quando filma, ma dà per scontato di avere il diritto di registrare quanto avviene, se riprende all’interno di edifici e istituzioni pubbliche finanziate dai contribuenti; in questo caso non permette mai ai partecipanti alcun controllo sul risultato finale. Nonostante questo, molte persone che hanno preso parte a High School hanno ritenuto che il film fosse una rappresentazione veritiera, per quanto molti critici l’abbiano invece considerato un aspro attacco al regime e alla disciplina scolastici. Un approccio radicalmente diverso avviene in Two Laws, film sui diritti alla terra degli aborigeni, in cui i registi non hanno ripreso niente senza il consenso e la collaborazione dei partecipanti. Ogni cosa, dai contenuti al tipo di obiettivo usato, è stata messa in discussione e decisa di comune accordo. Poiché il regista dei documentari osservativi adotta un modo particolare di essere presente “sulla scena”, scegliendo di apparire come invisibile ed esterno agli eventi, sorge anche la domanda su quando sia necessario un intervento da parte sua. Se succede qualcosa che mette a rischio o ferisce uno degli attori sociali? È giusto che l’operatore riprenda un monaco vietnamita che, conscio della presenza della cinepresa, si dà fuoco per protestare contro la guerra in Vietnam, o è più giusto che egli si rifiuti di riprendere o cerchi di dissuaderlo? È giusto che un regista accetti un coltello come dono durante le riprese di un processo per omicidio e poi consegni l’oggetto alla polizia quando su di esso viene trovato del sangue (come fatto da Joe Berlinger e Bruce Sinofsky nel loro film Paradise Lost: The Child Murderers at Robin Hood Hills [Il paradiso perduto: gli infanticidi di Robin Hood Hills, 1996])? Quest’ultimo esempio
ci sposta verso una forma di partecipazione inattesa o involontaria piuttosto che di mera osservazione, e fa anche sorgere la questione più ampia del rapporto tra il regista e i suoi soggetti. I film osservativi mostrano una spiccata forza nel dare un senso di durata reale agli eventi. Spezzano il ritmo drammatico dei film di fiction e l’accostamento frenetico di immagini che a volte sorregge i documentari di tipo poetico o espositivo. Per esempio, quando Frederick Wiseman osserva la realizzazione di una pubblicità televisiva di trenta secondi per i venticinque minuti della durata di Model (1980), comunica l’idea di avere osservato tutto ciò che valeva la pena di notare su quelle riprese. I suoi venticinque minuti, tuttavia, condensano ore e ore di reale girato per la pubblicità. Similmente, quando David MacDougall riprende le lunghe discussioni tra il suo protagonista Lorang e un altro uomo sul prezzo da pagare per fare sposare sua figlia in Wedding Camels, il regista sposta la nostra attenzione dall’accordo finale o dalle implicazioni narrative che ne derivano per farci percepire l’impressione e l’essenza della discussione stessa: egli vuole sottolineare il linguaggio del corpo, il gioco di sguardi, il tono e il timbro delle voci, le pause e i silenzi che danno all’incontro un senso di realtà concreta e vissuta. MacDougall stesso descrive il bello dell’esperienza vissuta come qualcosa che può essere espresso attraverso la differenza tra i giornalieri (i filmati non montati, nel formato in cui sono stati originariamente ripresi) e le sequenze montate. I giornalieri hanno una densità e una vitalità che manca al film montato. Tale caratteristica viene persa quando anche solo una struttura e un punto di vista prendono forma: Il senso di perdita identifica quei valori positivi che vengono percepiti all’interno dei filmati grezzi e ricercati dal regista nel momento della ripresa, ma che non riescono a trasparire nel film completo. È come se il vero senso del fare un film venisse contraddetto dall’atto stesso di realizzarlo. Montare un film a partire dai giornalieri significa tagliare sia la lunghezza complessiva sia accorciare la maggior parte delle riprese. Entrambi questi processi servono ad accentrare progressivamente i significati. A volte i registi si rendono conto
di ciò quando cercano di mantenere alcune delle qualità che erano presenti nei giornalieri, o cercano di reintrodurre queste qualità con altri mezzi. (“When Less Is Less”, in Trancultural Cinema, p. 215). La presenza della cinepresa “sulla scena” testimonia la sua presenza nel mondo reale. Ed esprime anche il desiderio di impegnarsi e di affrontare, nel momento in cui avviene, quello che è immediato, intimo e personale. Questo dimostra anche il desiderio di mantenere la verosimiglianza nei confronti di ciò che avviene di fronte alla cinepresa, che ci viene mostrato come ciò che è semplicemente successo quando, in realtà, si tratta di eventi costruiti in modo da avere quel preciso aspetto. Un esempio modesto è la cosiddetta “intervista mascherata”. In questo caso il regista lavora in un modo più direttamente partecipativo con i soggetti per stabilire l’argomento generale di una scena prima di filmarla in maniera imparziale. David MacDougall ha usato efficacemente questo metodo in numerosi film. Ne è un esempio la scena di Boran Herdsmen (I pastori Boran, 1974) in cui, senza guardare la cinepresa (ma in base a delle linee guida stabilite prima di riprendere), due membri di tribù del Kenya esprimono le loro opinioni sull’introduzione di misure anticoncezionali da parte del governo. Quasi tutti i registi contemporanei che fanno affidamento sulle interviste incontrano e parlano con i loro soggetti prima delle riprese, spesso facendo delle prove di ciò che verrà detto davanti alla macchina da presa per avere la certezza, almeno, che sia chiaro e coerente. Oltre a offrire una vantaggio concreto, questa pratica fornisce l’opportunità di dare forma a un punto di vista o di porre l’accento su un tono particolare in accordo con le necessità del regista più che con l’esperienza del soggetto. Un esempio più complesso è un evento preparato in modo da diventare parte di una registrazione storica. Le conferenze stampa, per esempio, possono essere filmate in modalità di chiara osservazione, ma tali eventi non esisterebbero senza la presenza della cinepresa. Si tratta dell’esatto opposto della premessa chiave, alle spalle dei film osservativi, secondo la quale quello che vediamo sarebbe avvenuto anche senza la presenza della cinepresa.
Questa inversione ha avuto dimensioni monumentali in uno dei primi documentari osservativi, Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl. Dopo un’introduzione con una serie di titoli che creano lo scenario per il raduno del partito nazionalsocialista tedesco tenutosi a Norimberga nel 1934, Riefenstahl decide di osservare gli avvenimenti senza più commentarli. Gli eventi – per lo più parate, schieramenti di truppe, riunioni di massa, immagini di Hitler e discorsi – avvengono come se la cinepresa stesse semplicemente registrando ciò che sarebbe avvenuto comunque. Con una durata di due ore, il film può dare l’impressione di avere registrato degli eventi storici fin troppo fedelmente e ingenuamente.
Roy Cohn/Jack Smith (di Jill Godmilow, 1994). Il film di Godmilow, come molti documentari sui concerti musicali, riprende una performance pubblica; in questo caso registra due monologhi di Ron Vawter. Poiché le esibizioni sono identificate sin dal principio come rappresentazioni teatrali, la regista riesce a evitare l’accusa che la presenza della cinepresa possa aver prodotto un’alterazione degli eventi. Fotografia concessa dalla regista.
Tuttavia, pochissimo di tutto questo sarebbe successo senza l’intento, da parte dei nazisti, di fare un film su questo evento.
Riefenstahl aveva avuto quantità ingenti di denaro a sua disposizione e gli eventi erano stati accuratamente pianificati per facilitare le sue riprese, compresa la scelta di ri-registrare alcuni discorsi in un altro momento e luogo quando i filmati originali si erano rivelati inutilizzabili (i pezzi sostituiti sono stati ricostruiti artificialmente in modo da fondersi con i filmati originali, nascondendo la collaborazione che aveva contribuito alla loro realizzazione).
Roy Cohn/Jack Smith. Godmilow utilizza il montaggio per creare una visione particolare dell’interpretazione di Ron Vawter del regista gay underground Jack Smith e dell’avvocato conservatore, anticomunista (e segretamente gay) Roy Cohn. Intervallando le riprese delle diverse interpretazioni, la regista sollecita l’interesse verso i modi contrastanti con cui i due uomini hanno affrontato la loro sessualità negli anni Cinquanta. Fotografia concessa dalla regista.
Il trionfo della volontà dimostra il potere dell’immagine di rappresentare il mondo storico e al contempo di partecipare alla costruzione di alcuni aspetti del mondo stesso. Questa partecipazione, specialmente nel contesto della Germania nazista, possiede un senso di ambiguità, che era l’ultima cosa
che registi come Robert Drew, D.A. Pennebaker, Richard Leacock e Frederick Wiseman volevano nei loro lavori. L’integrità del loro intento di osservazione è riuscita a evitare con successo questo rischio, per la maggior parte dei casi, e tuttavia l’atto sottinteso di essere presenti a un evento, riprendendolo però come se non lo si fosse (come se il regista fosse soltanto una “mosca sul muro”), genera l’inevitabile discussione su quanto di quello che vediamo sarebbe davvero accaduto se non ci fosse stata la cinepresa, o che cosa sarebbe cambiato se la presenza del regista fosse stata più accentuata. Questa controversia è per sua stessa natura impossibile da risolvere e continua a dare un senso di mistero e inquietudine al cinema osservativo
La modalità partecipativa La modalità partecipativa comparve intorno al 1960 con l’avvento di nuove tecnologie che permisero la registrazione sul posto del suono sincronizzato. In questo caso il regista interagisce con i suoi soggetti invece che osservarli in maniera non intrusiva. Le domande diventano interviste e conversazioni, e il coinvolgimento sfocia in uno schema di collaborazione o confronto. Ciò che accade davanti alla macchina da presa diventa indice della natura dell’interazione tra regista e soggetto. Questa modalità influenza la formulazione del “parlo di loro a te”, trasformandolo in qualcosa spesso più vicino al “parlo con loro per noi (io e te)” nel momento in cui l’interazione del regista ci apre una finestra particolare su una data porzione del nostro mondo. La modalità partecipativa è arrivata a comprendere anche la partecipazione dello spettatore. I siti web e le installazioni interattive permettono allo spettatore di farsi il proprio percorso attraverso lo spettro di possibilità messe in campo dal regista. Un caso esemplare di questo passaggio è rappresentato dal film di Péter Forgács, Danube Exodus, documentario sul trasferimento degli ebrei, durante la Seconda guerra mondiale, dall’Europa centrale al Mar Nero a bordo di una nave da crociera, e sul tragitto inverso dei tedeschi dalla Bessarabia verso la Germania. Forgács costruisce il suo film a partire dai filmati amatoriali del capitano della nave e il risultato è uno studio estremamente potente, poetico e provocatorio della
dislocazione e dell’esodo di due popoli. Più tardi, Forgács, in collaborazione con il Labyrinth Project, che ha realizzato una serie di “documentari-database” interattivi disponibili su Dvd, ha trasformato le riprese in installazioni. Un computer controlla la proiezione delle riprese su uno schermo più grande, ma il pubblico può ora interagire con il computer per scegliere come proiettare le immagini, e optare per trame o temi differenti dal girato originale. In più, altri computer ospitano le scene escluse, le interviste, e altre fonti documentarie primarie che possono essere visualizzate secondo le scelte dello spettatore. Le vite degli individui possono essere esaminate nel dettaglio e approfondite più di quanto non permettesse il film originario. Simili innovazioni suggeriscono che la modalità partecipativa è particolarmente adatta a essere sfruttata in forme basate sulla tecnologia digitale, che garantiscono molto più controllo da parte dello spettatore rispetto alle strutture inalterabili e agli standard fissati del documentario in pellicola. Poiché il regista, o il creatore del database, ha il controllo definitivo su ciò che finirà a far parte del database e sulla sua accessibilità, l’esperienza globale di visione presenterà qualità estetiche e retoriche che vanno al di là di quelle di un comune archivio, ma l’accento partecipativo si sposta dall’interazione tra regista e soggetto a quella tra spettatore e materiale assemblato. Tali documentari-database occupano un terreno molto fertile che sta tra la struttura apertissima di un archivio ordinario e quella molto più lineare di un documentario tipo. La modalità partecipativa ha i suoi antecedenti in altri media e altre discipline. La radio ha da sempre presentato una diretta interazione tra gli ospiti e gli ascoltatori di talk show, una forma che ben presto è trasmigrata verso la televisione prima di mettere radici anche nel cinema. Inoltre, le scienze sociali hanno per molto tempo promosso lo studio di gruppi sociali attraverso i mezzi dell’investigazione e dell’interazione diretta. L’antropologia, per esempio, resta fortemente legata al cosiddetto “lavoro sul campo”, dove un antropologo vive a contatto con un popolo per un lungo periodo di tempo, impara il suo linguaggio e i suoi costumi e scrive quanto ha imparato. Una ricerca del genere necessita solitamente di una certa forma di partecipazione-osservazione. Il ricercatore va sul campo, partecipa alla vita di altri, ne ricava una sensazione concreta o
intima di come sia la vita in un dato contesto, e poi riflette su questa esperienza, utilizzando gli strumenti e i metodi dell’antropologia e della sociologia. “Essere lì” richiede partecipazione; “essere qui” permette l’osservazione: ovvero, chi lavora sul campo non deve, in circostanze normali, “diventare come loro”, ma mantenere un certo grado di distacco che lo separi da coloro di cui scrive. L’antropologia, in effetti, dipende notevolmente da questo atto complesso che è insieme coinvolgimento e distacco tra due culture. Anche i registi di documentari fanno ricerche sul campo; vivono anch’essi tra culture diverse dalla loro e raccontano o rappresentano quello che hanno vissuto. La pratica della partecipazione-osservazione, tuttavia, non è un paradigma. I metodi della ricerca sociologica sono rimasti subordinati alla pratica retorica dominante di commuovere e convincere un pubblico. Il documentario osservativo toglie volutamente enfasi al risvolto persuasivo per darci un’idea di che cosa voglia dire vivere una data situazione, ma senza comunicare anche che cosa abbia provato il regista a sperimentare lo stesso evento. Il documentario partecipativo ci dà un senso di cosa voglia dire, per il regista, essere in una data situazione, e come essa subisca modifiche a causa della sua presenza. La nostra esperienza della rappresentazione di un incontro può essere molto forte in film come Nobody’s Business, che ritrae la figura sfuggente e spigolosa del padre del regista, o Tarnation, che racconta gli sforzi del regista per comprendere perché sua madre divenne una malata di mente e la sua infanzia un incubo, utilizzando come modelli il diario, la confessione o la tradizione saggistica. In effetti, la biografia, l’autobiografia, la storia, il saggio, le confessioni e i diari sono tra i modelli più popolari per i documentari partecipativi. Come la modalità performativa, che affronteremo a breve, la presenza del regista, e il suo punto di vista, spesso contribuisce in modo significativo all’impatto generale che il film produce. Quando vediamo dei documentari partecipativi ci aspettiamo di scrutare il mondo attraverso la rappresentazione che ne fa qualcuno che si confronta direttamente con gli altri, invece di osservare da lontano, esprimere in termini poetici o assemblare in maniera argomentativa ciò che gli altri dicono o fanno. Il
regista scende dal podio del commento fuori campo, si allontana dalla meditazione poetica, esce dal nascondiglio dal quale osservava la scena e diventa un attore sociale (quasi) come gli altri (il “quasi” dipende dal fatto che il regista ha il controllo della cinepresa e, con essa, anche un certo grado di ipotetico potere e controllo degli eventi).
Grizzly Man (di Werner Herzog, 2005). Werner Herzog utilizza le riprese di orsi grizzly girate da Timothy Treadwell per riflettere sulla relazione dell’uomo con la natura e su quella di Treadwell con la sanità mentale. Treadwell registra i suoi pensieri durante le riprese che fa di se stesso, realizzate senza nessun intervento di terzi e mentre si trovava nella natura selvaggia. Herzog in seguito aggiunge a quelle riprese il suo commento fuori campo e introduce inoltre interviste ad altre persone. Le riprese straordinarie di Treadwell, come questa che vedete, spesso lo ritraggono nella stessa inquadratura con gli orsi, lontano mille miglia dalla civiltà. Il potere indicativo di piani sequenza in cui tutti gli elementi sono pienamente a fuoco dà un carattere di stupefacente autenticità al suo girato. È fuori questione che lui e l’orso coesistano nella stessa inquadratura proprio come avevano coesistito nei remoti spazi selvaggi dell’Alaska. Per gentile concessione di Lions Gate Films/Photofest.
Documentari partecipativi come Chronique d’un été, Portrait of Jason o Word Is Out riguardano l’etica e la politica di un incontro. L’incontro avviene tra una persona che ha in mano una cinepresa e una che non ce l’ha. Come reagiscono a vicenda il regista e l’attore sociale? Emerge un senso di rispetto, a dispetto del disaccordo, oppure prevale una sensazione di inganno, manipolazione, distorsione? Come fanno a negoziare il
controllo e a condividere le responsabilità? Quanto può un regista insistere sulla necessità di testimoniare qualcosa che è doloroso da rappresentare? Che responsabilità ha per le conseguenze emotive che derivano dal fatto di aver messo qualcuno o qualcosa davanti alla macchina da presa? Che obiettivi uniscono il regista e il soggetto e quali bisogni li dividono? Molti spettatori ravvisano un esempio dell’esistenza di una linea di demarcazione etica nelle interviste a sorpresa realizzate dalla Cbs in 60 Minutes e poi riprese e perfezionate da Michael Moore in una struttura più complessa in tutti i suoi film. Cogliere di sorpresa qualcuno che è impreparato e talvolta indifeso nel sostenere un’intervista può essere indice di mancanza di rispetto e perfino di irriverenza. In molti casi, gli obiettivi delle imboscate di Michael Moore sembrano meritarsi quello che accade loro: Dick Clark, proprietario del ristorante dove una madre, che vive grazie ai sussidi statali, guadagna appena il necessario per coprire i costi di trasporto verso il lavoro e i bisogni quotidiani dei suoi figli, si dà precipitosamente alla fuga invece di cercare di spiegare la sua posizione a Moore in Bowling a Columbine, ma Charlton Heston non può scappare dalla sua casa dopo averlo lasciato entrare. Un crescente senso di disagio assale molti spettatori man mano che si rendono conto che molte delle risposte esitanti di Heston sono almeno in parte dovute all’Alzheimer, e fanno sembrare Moore insensibile e senza rispetto alcuno invece che determinato ad affrontarlo. Moore si comporta in modo simile in Roger & Me, quando tende una trappola a Miss Michigan per interrogarla sulle condizioni economiche di Flint. La donna è chiaramente digiuna di nozioni specifiche e non è in grado di fingere una qualche conoscenza autorevole sulla chiusura delle fabbriche e sull’economia globale, e Moore la fa apparire come una stupida. Tuttavia, per alcuni l’insensibilità di fronte alla sua individualità di persona fa sembrare il regista irrispettoso nella sua ricerca dell’irriverenza a tutti i costi. Il senso di presenza fisica, più che l’assenza, che emerge dagli scambi di battute (con il suono sincronizzato) tra regista e soggetto pone la figura del regista “sulla scena”. Noi ci aspettiamo che ciò che impariamo si basi sulla natura e sulla qualità dell’incontro tra regista e soggetto. Possiamo vedere e
sentire il regista che agisce e reagisce in diretta, nello stesso momento storico del soggetto del film. C’è quindi la possibilità che egli serva da mentore, critico, indagatore, collaboratore o provocatore. Il documentario partecipativo può sottolineare l’incontro vero e proprio e sincero tra regista e soggetto, nello spirito di L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov, Chronique d’un été di Jean Rouch ed Edgar Morin, Hard Metals Disease (Intossicazione da metalli pesanti, 1987) di Jon Alpert, Shoah di Claude Lanzmann e Sherman’s March di Ross McElwee. La presenza del regista acquista una notevole importanza, a partire dall’atto fisico di “inquadrare la ripresa”, che ha così grande rilievo in L’uomo con la macchina da presa, fino all’atto politico di unire le forze con il proprio soggetto come fa Jon Silver all’inizio di Watsonville on Strike, quando chiede ai lavoratori se può filmare nella sala della riunione sindacale sfidando l’opposizione del capo del sindacato stesso. In altri casi, la presenza del regista assume una connotazione altamente personale e talvolta pungente, come accade in Complaints of a Dutiful Daughter quando Deborah Hoffmann, la regista, lotta per affrontare il declino della madre verso la demenza, o in Finding Christa, dove la regista Camille Billops combatte con la sua stessa decisione di rintracciare la figlia che ha dato in adozione una ventina d’anni prima.
Takeover (di David e Judith MacDougall, 1981). I MacDougall hanno creato uno stile di regia di forte collaborazione con i protagonisti dei loro film etnografici. In una serie di documentari che affrontano i problemi degli aborigeni – dei quali Takeover è un esempio – i registi hanno fatto spesso da loro portavoce, testimoniando le tradizioni e le credenze sostenute dagli aborigeni nelle dispute con il governo per il diritto alla terra e altre questioni. L’interazione mostra un alto grado di partecipazione, sebbene il risultato possa sembrare, all’inizio, modesto o quasi osservativo, poiché la fase di maggior collaborazione avviene prima dell’inizio delle riprese. Fotografia concessa da David MacDougall.
Questo stile di regia è ciò che Rouch e Morin definiscono cinéma vérité, traducendo in francese il titolo ideato da Dziga Vertov per il suo cinegiornale della società sovietica, kinopravda. In quanto “cinema verità”, l’idea enfatizza il fatto che si tratti della verità su un incontro, piuttosto che di una verità assoluta o innegabile. Noi vediamo come il regista e il soggetto negoziano una relazione, come agiscono l’uno nei confronti dell’altro, che tipo di potere e di controllo entra in gioco, e quali gradi di rivelazione o di rapporto nascono da questa forma specifica di incontro. Il cinéma vérité rivela la realtà di quello che succede quando le persone interagiscono alla presenza di una macchina da presa.
Sherman’s March (di Ross McElwee, 1985). In questa foto, il regista Ross McElwee assume la posa di un soldato confederato, ma per la maggior parte del film egli semplicemente registra il suo viaggio attraverso il sud degli Stati Uniti all’ostinata ricerca dell’amore. Il film è un classico esempio di film saggio in cui il punto di vista personale del regista dà forma non solo a quello che vediamo, ma anche alla maniera con cui lo vediamo. La scena più memorabile è quella in cui interagiscono McElwee e diverse figure femminili che discutono la sua ricerca dell’amore. Per gentile concessione di First Run Features/www.firstrunfeatures.com.
Se c’è una verità in questo caso, è quella di una forma di interazione che non esisterebbe se non in funzione della cinepresa. In questo senso si tratta dell’opposto della premessa osservativa, secondo la quale ciò che vediamo è quello che avremmo visto se fossimo stati presenti. Nel documentario partecipativo, quello che vediamo è ciò che possiamo vedere solo quando una cinepresa, o un regista, è lì al nostro posto. Jean-Luc Godard ha dichiarato una volta che il cinema è la
verità espressa ventiquattro volte al secondo: il documentario partecipativo illustra bene questa dichiarazione. In Chronique d’un été, per esempio, troviamo scene che derivano dalla collaborazione tra i registi e i loro soggetti, un gruppo eclettico di persone che vivono a Parigi nell’estate del 1960. A un certo punto del film, Marcelline Loridan, una giovane donna che in seguito sposerà il regista olandese Joris Ivens, parla della sua esperienza di ebrea francese deportata in un campo di concentramento tedesco durante la Seconda guerra mondiale. La cinepresa la segue mentre cammina attraverso Place de la Concorde e poi attraverso l’ex mercato parigino di Les Halles. Lei si esprime in un monologo molto commovente in cui racconta le sue esperienze, ma solo perché Rouch e Morin avevano pianificato la scena con lei e le avevano dato un registratore portatile. Se avessero aspettato che un evento del genere avvenisse, in modo da poterlo filmare, non sarebbe mai accaduto. I due registi hanno proseguito ulteriormente questa idea di collaborazione mostrando ai partecipanti parte del film e riprendendo la discussione che ne nasceva. Anche Rouch e Morin compaiono davanti alla cinepresa, mentre affermano che il loro scopo è studiare «questa strana tribù che vive a Parigi» e raccontano, alla fine del film, quello che hanno imparato. I registi che intendono rappresentare il loro incontro diretto con il mondo che li circonda e quelli che intendono rappresentare questioni sociali più ampie e punti di vista storici attraverso interviste e filmati d’archivio formano due grandi componenti della modalità partecipativa. Essi si differenziano, per dirla in termini imprecisi, tra saggisti e storici. Come spettatori, abbiamo l’impressione di assistere a una forma di dialogo tra regista e soggetto – che si tratti di uno sciopero di lavoratori o di una persona come la madre del regista – in cui troviamo un impegno, delle interazioni negoziate in precedenza e degli incontri dal grande impatto emotivo. Queste caratteristiche forniscono alla modalità partecipativa della regia documentaristica un fascino notevole, che nasce dalla possibilità di spaziare all’interno di una grande varietà di soggetti, dal più personale al più storico. Spesso, infatti, questa modalità dimostra come l’aspetto personale e quello politico si intreccino in modo da creare una rappresentazione del mondo
da un punto di vista particolare, che è allo stesso tempo imprevisto e impegnato. Similmente, in Not a Love Story (Non una storia d’amore, 1981), Bonnie Klein, la regista, e Linda Lee Tracy, una ex spogliarellista, discutono le loro reazioni a varie forme di pornografia mentre intervistano delle persone che lavorano nell’industria del sesso. In una scena, Linda Lee posa per una fotografia di nudo, raccontando in seguito come quell’esperienza l’abbia fatta sentire. Le due donne si imbarcano in un viaggio che è in parte esplorativo, su una linea simile a quello di Rouch e Morin, e in parte di confessione/riscatto, con un senso completamente diverso. L’atto di girare il film ha un ruolo catartico, purificatorio all’interno delle loro vite; non è il mondo dei loro soggetti a cambiare, ma il loro mondo privato. Alcune volte, come in Le chagrin et la pitié di Marcel Ophüls (Il dispiacere e la pietà, 1970), sul collaborazionismo francese con la Germania durante la Seconda guerra mondiale, il regista funziona da ricercatore o reporter investigativo. In questi casi, la sua voce emerge da una partecipazione diretta e personale agli eventi che svela. Il reporter investigativo rende il suo coinvolgimento personale con la storia vitale per il suo svolgimento. Un altro esempio sono i lavori del regista canadese Michael Rubbo, come Sad Song of Yellow Skin (Storia triste di pelle gialla, 1970), in cui esplora le conseguenze della guerra del Vietnam nella popolazione civile vietnamita. Altro caso ancora è l’opera di Nick Broomfield, il quale adotta uno stile più schietto e diretto – se non addirittura arrogante – nel suo Kurt & Courtney (1998). La sua esasperazione verso l’ambiguità di Courtney Love, nonostante i sospetti della sua complicità con la morte di Kurt Cobain fossero privi di fondamento, spinge Broomfield a riprendere la sua personale denuncia, apparentemente spontanea, nei confronti della donna durante una cena ufficiale dell’American Civil Liberties Union. In altri casi, ci si allontana dall’approccio investigativo per avere una relazione più responsabile e riflessiva nei confronti di eventi che coinvolgono il regista. Quest’ultima scelta ci porta in direzione del diario e della testimonianza personale. La voce in prima persona assume un ruolo principale nella struttura
generale del film. È la partecipazione del regista agli eventi che cattura la nostra attenzione. In questo senso, è il tentativo da parte di Emiko Omori di ripercorrere la storia celata della sua famiglia durante la permanenza nei campi di internamento in cui la popolazione nippo-americana era stata confinata negli anni della Seconda guerra mondiale che dà forma a Rabbit in the Moon. Marilu Mallet presenta una chiara struttura a diario in Journal inachevé (Diario incompiuto), il ritratto della sua vita di esiliata cilena a Montreal, sposata al regista canadese Michael Rubbo; Kazuo Hara fa lo stesso per raccontare la relazione complessa e instabile che lui e la sua nuova compagna vivono per un certo periodo di tempo con la sua ex moglie in Gokushiteki erosu: Renka (Eros molto personale: canto d’amore, 1974). Il film presenta una scena impressionante in cui Hara riprende la sua ex moglie che partorisce sul pavimento del suo appartamento. Questi film rendono il regista un personaggio vivido quanto gli altri protagonisti e, in quanto testimonianze e confessioni, possiedono spesso una grande forza rivelatrice. Come notato in precedenza, non tutti i documentari di partecipazione sottolineano l’esperienza continua e aperta del regista, o l’interazione tra lui e i soggetti. Il regista può voler introdurre una prospettiva più ampia, spesso di natura storica. Come riuscirci? La risposta più comune è l’utilizzo di interviste e materiali d’archivio. Il risultato spesso assume la forma di un film di montaggio e riprende la storia dall’alto (da figure o eventi maggiori) o dal basso (dall’esperienza di persone comuni in relazione a un avvenimento storico). L’ampio archivio di materiali precedentemente filmati che ora esiste fornisce riprese storiche da accompagnare alle voci di coloro che c’erano o che sanno ciò che accadde.
Crumb (di Terry Zwigoff, 1994). Terry Zwigoff stringe un rapporto di grande partecipazione con il disegnatore di cartoon Robert Crumb. Molte delle conversazioni e delle interazioni non sarebbero avvenute se Zwigoff non fosse stato lì con la cinepresa. Crumb assume un tono riflessivo nei confronti di se stesso e uno più investigativo verso i suoi fratelli, mentre collabora con il regista per esaminare la complessità e le contraddizioni della sua vita.
L’intervista è una delle forme più comuni di incontro tra regista e soggetto all’interno del documentario partecipativo. Le interviste sono una forma distinta di incontro sociale. Sono diverse dalle normali conversazioni e dai procedimenti di interrogatorio più coercitivi a causa della cornice istituzionale in cui avvengono e per via dei protocolli e delle linee guida specifiche che le strutturano. Le interviste avvengono all’interno del lavoro sul campo in ambito antropologico o sociologico; vengono chiamate “anamnesi” nel campo della medicina e della sanità pubblica; nella psicoanalisi, prendono la forma di sessioni terapeutiche; in giurisprudenza, l’intervista è prima l’acquisizione di documenti e, durante il processo in tribunale, la testimonianza; in televisione, forma la struttura chiave dei talk show; nel giornalismo, prende la forma di intervista e di conferenza stampa; e, nell’istruzione, compare come dialogo socratico. Michel Foucault ritiene che queste forme comprendano tutte delle modalità di scambio regolate in qualche maniera, con una distribuzione sbilanciata di potere tra
cliente e istituzione, e che abbiano la loro radice nella tradizione religiosa del confessionale.
Las madres de la Plaza de Mayo (di Susana Muñoz e Lourdes Portillo, 1985). Le due registe creano una dinamica di forte partecipazione con le madri che hanno rischiato la vita nelle dimostrazioni pubbliche durante la “guerra sporca” argentina. I figli e le figlie di queste donne erano tra i desaparecidos rapiti dal governo e spesso uccisi senza alcun avviso o processo legale. Muñoz e Portillo non potevano dare forma agli eventi pubblici, ma potevano raccontare le storie personali delle madri che, spinte dal coraggio, hanno sconfitto un regime brutalmente repressivo. Fotografia concessa da Lourdes Portillo.
I registi utilizzano l’intervista per convogliare diversi racconti all’interno di una singola storia. La voce del regista emerge nel momento in cui tesse insieme in una maniera particolare il contributo delle voci con il materiale portato a sostegno di quello che dicono. Questo insieme di interviste e materiale di supporto ci ha dato numerosi esempi di film, da In the Year of the Pig, sulla guerra in Vietnam, a Eyes on the Prize, sulla storia del movimento per i diritti civili, e da Shoah, sulle conseguenze dell’Olocausto per coloro che l’hanno vissuto, fino a Jazz, sulla storia del jazz in America. I film di montaggio, come La caduta della dinastia dei Romanov di Esther Shub, che si basa interamente su filmati d’archivio trovati e ri-montati per raccontare una storia sociale, risalgono agli albori del cinema documentario. Shub ricava
giudizi e argomenti attraverso il modo in cui monta insieme le riprese, proprio come più tardi registi come Emile de Antonio trarranno una più ampia prospettiva storica dal montaggio delle interviste. Alcuni documentari, come Harlan County, U.S.A. (1977) di Barbara Kopple, sullo sciopero in una miniera del Kentucky, o Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, parlano di eventi del presente in cui il film viene realizzato e ai quali il regista partecipa, aggiungendo nel contempo dei dettagli storici. Altri, come La sottile linea blu di Errol Morris, Quando eravamo re (When We Were Kings, 1996) di Leon Gast, sul match del 1974 tra Muhammad Ali e George Foreman, o Macht der Bilder: Leni Riefenstahl (Il potere dell’immagine: Leni Riefenstahl, 1993) di Ray Müller, sulla controversa carriera della regista, si concentrano sul passato e sui racconti di chi ne è a conoscenza.
El Diablo nunca duerme (di Lourdes Portillo, 1995). La regista Lourdes Portillo interpreta un’investigatrice che sembra uscita da un romanzo giallo. Il film racconta il suo viaggio in Messico per indagare sulla morte sospetta dello zio. A tratti riflessivo e a tratti ironico, il film di Portillo lascia irrisolte le domande sulla morte dello zio, di cui potrebbe essere colpevole un membro della famiglia. Fotografie concesse dalla regista.
Le esperienze di gay e lesbiche nei giorni prima di Stonewall, per esempio, potrebbero essere raccontate come una generica storia sociale, con un commento fuori campo e immagini che illustrano ciò che viene detto. (Nel 1969, i clienti omosessuali del bar Stonewall di New York ingaggiarono una battaglia con la polizia che fece una retata nel bar: ebbe così origine il movimento in difesa dei diritti degli omosessuali). L’episodio potrebbe anche essere raccontato attraverso le parole di chi ha vissuto quelle esperienze. Word Is Out, del collettivo Mariposa, sceglie la seconda strada. I registi, come anche Connie Field per The Life and Times of Rosie the Riveter, hanno visionato un gran numero di possibili soggetti prima di scegliere
la dozzina di persone che compaiono nel film. A differenza di Field o Emile de Antonio, tuttavia, il collettivo Mariposa sceglie di utilizzare il meno possibile materiale d’archivio di supporto, e assembla la storia innanzitutto a partire dai “mezzibusti” di coloro che possono narrare con parole proprie questo capitolo di storia sociale americana. Chi parla è una massa così articolata ed emotivamente diretta da dare ai film di testimonianza come questo un carattere altamente coinvolgente. La forma è simile ma diversa da quella della storia orale, un vasto resoconto di eventi passati fatto dai partecipanti stessi. I racconti orali forniscono una fonte essenziale di materiale ma mancano di un’accurata selezione e di una disposizione delle interviste in un tutto più ampio o in una più vasta prospettiva.
El Diablo nunca duerme. La regista, nel corso di un’intervista, va in cerca di indizi e, idealmente, della confessione che risolverà il mistero. Anche se non ottiene una rivelazione, il fatto che lei potrebbe ottenerne una dà alla pellicola un’aura da film noir o da thriller.
La modalità riflessiva Se il mondo reale fornisce il luogo di incontro in cui negoziare il rapporto tra regista e soggetto nella modalità partecipativa, questo processo di negoziazione diventa il punto focale d’attenzione nella modalità riflessiva. Più che seguire il regista mentre affronta gli altri attori sociali, in quest’ambito assistiamo a come il regista affronta noi, parlando non solo dei
problemi del mondo ma anche di quelli che nascono dal rappresentarlo. Questo più intenso livello di riflessione su ciò che vuol dire rappresentare la realtà è l’elemento che distingue la modalità riflessiva dalle altre.
Cadillac Desert (di Jon Else, 1997). Cadillac Desert è un altro ottimo esempio di pellicola che associa i filmati d’archivio della tradizione del film di montaggio con interviste contemporanee per aggiungere una prospettiva nuova agli eventi storici senza l’utilizzo del commento fuori campo. Cadillac Desert ripercorre la storia dell’utilizzo dell’acqua in California e del suo impatto devastante sulle vallate dell’entroterra. Fotografia concessa dal regista.
La dichiarazione da parte di Trinh Minh-ha di voler parlare “vicino” e non “intorno” o “con” i nativi dell’Africa occidentale in Reassemblage simboleggia il cambiamento prodotto dalla riflessione: noi ora osserviamo come rappresentiamo il mondo oltre a che cosa viene rappresentato. Invece di guardare attraverso il documentario per vedere il mondo, i film riflessivi ci chiedono di guardare il documentario per ciò che è: una rappresentazione ricostruita. Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin portano questo approccio all’estremo in Letter to Jane (Lettera a Jane, 1972), una “lettera” di quarantacinque minuti in cui analizzano minuziosamente una fotografia di Jane Fonda durante la sua visita nel Vietnam del Nord. Senza tralasciare alcun dettaglio. Allo stesso modo con cui la modalità osservativa del documentario dipende dall’apparente assenza del regista e dal suo non intervento negli eventi che registra, il documentario è legato in generale alla capacità dello spettatore di dimenticare la propria situazione personale e, davanti allo schermo,
interpretare il film in base alla visione di determinati avvenimenti che gli viene fornita, come se solo tali eventi debbano essere interpretati, e non il film stesso. La modalità riflessiva del documentario mette in dubbio l’affermazione che un film sia riuscito in base a quanto il suo contenuto riesca a smuovere il pubblico. Una delle questioni portate in primo piano all’interno dei documentari riflessivi è quella che abbiamo trattato nel Capitolo 2: Che cosa fare delle persone? Alcuni film, come Reassemblage, Daughter Rite (Il rito di una figlia, 1978), Bontoc Eulogy o Far from Poland affrontano direttamente questo problema, mettendo in dubbio i modi soliti di rappresentazione: Reassemblage infrange le convenzioni realistiche dell’etnografia per criticare il modo con cui la cinepresa rappresenta, bene o male, gli altri; Daughter Rite rovescia la convenzione di affidarsi ad attori sociali attraverso l’utilizzo di due attrici, nel ruolo di due sorelle, per riflettere sulla loro relazione con la madre, utilizzando commenti tratti da una serie di interviste fatte a numerose donne ma eliminando le voci originali delle intervistate; Bontoc Eulogy racconta la storia della famiglia del nonno del regista stesso, che era stato portato via dalle Filippine per far parte di un’esibizione sulla vita dei filippini alla Fiera Mondiale di Saint Louis del 1904, attraverso una serie di ricostruzioni e ricordi immaginati che mettono in dubbio l’uso convenzionale della realtà; la regista di Far from Poland, Jill Godmilow, si rivolge a noi direttamente per riflettere sui problemi di rappresentare il movimento di Solidarność in Polonia quando si ha solo un accesso parziale agli eventi veri e propri. Questi film vogliono aumentare la nostra consapevolezza dei problemi di rappresentare gli altri, tanto quanto vogliono convincere dell’autenticità e della verità della loro rappresentazione.
Surname Viet Given Name Nam (di Trinh T. Minh-ha, 1989). Queste tre inquadrature successive – tutte di primi piani che tagliano parti del volto dell’intervistato – corrispondono agli storyboard di preproduzione disegnati dalla regista. Il fatto che violino le norme delle interviste filmate richiama la nostra attenzione sul loro aspetto formale e convenzionale, segnalando che non si tratta di una intervista “normale”. Fotografia concessa dalla regista.
I documentari riflessivi affrontano anche la questione posta dal realismo in quanto stile. Esso sembra offrire un accesso aproblematico al mondo; prende forma come realismo fisico, psicologico ed emotivo (si veda il Capitolo 5), attraverso le tecniche di montaggio evidenziatore o in continuità, sviluppo dei personaggi e struttura narrativa. I documentari riflessivi sfidano queste tecniche e queste convenzioni. Surname Viet Given Name Nam (Cognome Viet nome proprio Nam, 1989), per esempio, utilizza delle interviste con donne del Vietnam che descrivono le condizioni di oppressione che hanno dovuto affrontare dalla fine della guerra; a metà del film, tuttavia, capiamo (se ancora non l’avevamo intuito da vari dettagli stilistici) che le interviste sono state inscenate in vari modi: le donne che interpretano le vietnamite in realtà sono persone immigrate negli Stati Uniti che recitano, su un set, dei racconti trascritti e rielaborati che Trinh ha tratto da alcune interviste fatte in Vietnam da qualcun altro ad altre donne! Similmente, in L’uomo con la macchina da presa Dziga Vertov dimostra come l’impressione della realtà sia costruita, a cominciare da una scena in cui l’operatore, Mikhail Kaufman, riprende la gente in carrozza da una macchina che viaggia accanto a essa. Vertov taglia allora la scena per spostarsi all’interno di una sala di montaggio, dove il montatore, Elizaveta Svilova, sua moglie, mette insieme strisce di film che rappresentano questo evento per formare la sequenza che, probabilmente, abbiamo appena visto. Il risultato finale serve a decostruire l’impressione di avere un accesso scorrevole alla realtà, e ci invita a riflettere sul processo di montaggio che rende possibile questa impressione.
Surname Viet Given Name Nam. Trucchi e costumi sono utilizzati nell’ambito dei documentari più spesso di quanto pensiamo. Qui la regista Trinh T. Minh-ha prepara l’attrice Tran Thi Bich Yen per una scena in cui recita la parte di una donna che racconta la sua vita. L’intervista sembra ambientata in Vietnam ma è stata girata in California. Come Far From Poland, questo film affronta il problema della rappresentazione di situazioni a cui il regista non ha accesso diretto. Fotografia concessa dalla regista.
Altri film, come David Holzman’s Diary (Il diario di David Holzman, 1968), No Lies, Daughter Rite e The Blair Witch Project, si presentano come fiction non proprio vere. Si basano su attori professionisti per ottenere delle performance che ci facciano inizialmente credere di assistere a rappresentazioni veritiere di persone nella vita di tutti i giorni. Quando ci rendiamo conto della finzione, attraverso una serie di indizi posti nel film o, alla fine, leggendo dai titoli di coda che le interviste a cui abbiamo assistito erano inscenate, siamo spinti a mettere in dubbio l’autenticità del documentario in generale: quale “verità” rivela il documentario su se stesso? In che modo è diverso da una performance inscenata o prestabilita? Quali convenzioni ci spingono a credere nell’autenticità del documentario? E in che modo si possono rovesciare? La modalità riflessiva è quella che ha una maggiore consapevolezza di sé e che maggiormente mette in dubbio se stessa. Un accesso realistico al mondo, la capacità di fornire
prove convincenti, la possibilità di trovare una prova inconfutabile, il legame tra l’immagine indicativa e ciò che rappresenta: tutte queste nozioni vengono messe in dubbio. Il fatto che queste nozioni possano ispirare allo spettatore una fiducia indiscriminata nelle immagini porta il documentario riflessivo a esaminare la natura di tale fiducia, invece che a dimostrare la validità di ciò in cui si crede. Nella sua forma migliore, la modalità riflessiva spinge lo spettatore a essere maggiormente consapevole del rapporto con il documentario e con ciò che rappresenta. Vertov fa così con L’uomo con la macchina da presa, per farci vedere in che modo costruiamo la nostra percezione del mondo; Buñuel fa lo stesso in Las Hurdes, per ironizzare sui pregiudizi che accompagnano alcune percezioni; Trinh lo fa in Reassemblage, per mettere in dubbio i presupposti che stanno dietro a un certo tipo di percezione o di ricerca etnografica; così come fa Chris Marker in Sans soleil, per criticare l’idea stessa di fare film sulla vita degli altri in un mondo diviso da confini politici e razziali. Essere maggiormente consapevoli comporta un cambiamento del nostro livello di coscienza. Il documentario riflessivo cerca di modificare i pregiudizi e le aspettative del suo pubblico, e non di aggiungere nuova conoscenza ad argomenti già esistenti. Questi film sembrano dire: “Riflettiamo su come quello che vediamo e ascoltiamo ci porta a credere a una particolare visione del mondo”. Nel perseguire questo invito alla riflessione e a una più alta forma di consapevolezza, i documentari possono essere riflessivi sia dal punto di vista formale che da quello politico. Dal punto di vista formale, la riflessività attira la nostra attenzione verso i nostri stessi pregiudizi e le nostre aspettative nei confronti del documentario stesso. Trinh lo fa in maniera evidente in Surname Viet Given Name Nam nel momento in cui mette in dubbio le idee preconcette degli spettatori sulle interviste come forma privilegiata di accesso a ciò che le persone decidono di raccontare. È solo man mano che il film va avanti che ci rendiamo conto che le interviste apparentemente reali delle donne che soffrirono la dittatura comunista in Vietnam sono interamente messe in scena e che quelle donne raccontano esperienze vissute da altri. Forse si tratta di un modo
per sottolineare la natura prescrittiva, se non stereotipata, delle storie di grandi difficoltà, sofferenze e persecuzioni. Almeno la rivelazione che le interviste non sono quello che sembrano spinge lo spettatore a ripensare i suoi assunti sul valore di verità e credibilità di ciò che viene detto. Con uno spirito simile, le numerose “confessioni” di dipendenza dal sesso fatte dal regista Caveh Zahedi in I Am a Sex Addict (Sono un maniaco sessuale, 2005) coinvolgono così tante ricostruzioni chiaramente esagerate o stilizzate che alla fine la loro stessa validità è messa in dubbio. Anche se in maniera meno insistentemente riflessiva del film di Trinh, Zahedi incoraggia lo spettatore a essere sempre più scettico rispetto all’autenticità delle sue confessioni. Da un punto di vista politico, la riflessività punta più verso i nostri pregiudizi e verso le aspettative nei confronti del mondo che ci circonda che sulla forma del film. La nascita dei documentari femministi negli anni Settanta fornisce un esempio chiaro di lavori che mettono in dubbio le convenzioni sociali. Film come The Woman’s Film (Il film della donna, 1971), Joyce at 34 (Joyce a trentaquattro anni, 1972) e Growing Up Female (Crescendo da femmina, 1970) seguono la maggior parte delle convenzioni del documentario di partecipazione, ma cercano anche di dare allo spettatore una consapevolezza della discriminazione nei confronti delle donne al giorno d’oggi. Contrappongono le immagini (per lo più) stereotipate delle donne a rappresentazioni radicalmente diverse, e accostano le speranze e i desideri che vengono solitamente proposti dai mass media a quelle esperienze e quelle pretese che nascono da donne che hanno rifiutato tali atteggiamenti, scegliendone altri radicalmente diversi. Questi film sfidano le consolidate nozioni di femminilità e servono a dare un nome a ciò che prima era invisibile: l’oppressione, la svalorizzazione e la gerarchia possono ora essere chiamate sessismo. Le esperienze individuali si combinano per sostenere un nuovo modo di vedere, una prospettiva distinta sull’ordine sociale. Entrambi i punti di vista si basano su tecniche che creano contrasto, per ottenere quell’effetto che Bertolt Brecht descriveva come “straniamento”, o quello che i formalisti russi definivano ostranenie (“rendere strano”). Ciò assomiglia allo sforzo dei surrealisti di vedere il mondo di tutti i giorni in modi inattesi. Come strategia formale, rendere strano ciò che è
familiare ci ricorda che il documentario è un genere le cui affermazioni sul mondo vengono spesso ricevute senza filtri. Come strategia politica, ci ricorda di come la società funzioni in base a codici e convenzioni che spesso diamo per scontati. Il termine usato da Brecht, lo “straniamento” (un modo consapevole di distaccarsi e prendere le distanze), ci tiene lontani dai presupposti dominanti. La riflessività formale ci rende coscienti dei presupposti formali; la riflessività politica provoca consapevolezza dei presupposti che sostengono una data struttura sociale. Entrambe tendono, quindi, a scatenare un effetto “Ecco!”, in cui noi cogliamo un principio o una struttura generale che aiuta a spiegare come comprendiamo e rappresentiamo il mondo. Vi diamo un’occhiata più approfondita. La nostra nuova consapevolezza crea una separazione tra conoscenza e desiderio, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. I documentari riflessivi politici si rivolgono a noi, in quanto spettatori e attori sociali, non ai film, per colmare questa separazione tra quello che già esiste e le nuove forme che possiamo dare alla realtà.
La modalità performativa Come la modalità poetica della rappresentazione documentaristica, la modalità performativa si interroga sulla conoscenza. Che cos’è la comprensione? Quali elementi, oltre all’informazione sui fatti, formano la nostra comprensione del mondo? La conoscenza si può descrivere come una cosa astratta e separata dal corpo, basata su generalizzazioni e tipizzazioni, secondo la tradizione della filosofia occidentale? Da questo punto di vista, può essere tramandata o scambiata liberamente e coloro che effettuano il trasferimento o lo scambio sono solo dei canali, ma la conoscenza non viene alterata dal loro personale coinvolgimento con essa. O la conoscenza è meglio se descritta come una cosa concreta e corporea, basata sulle peculiarità dell’esperienza personale, secondo la tradizione poetica, letteraria e retorica? Da questa prospettiva, la conoscenza può essere dimostrata o evocata, ma chi effettua la dimostrazione o l’evocazione permea ciò che fa con una singolarità che non può essere facilmente replicata. Il documentario performativo abbraccia la seconda prospettiva. Esso si impegna a dimostrare
in che modo la conoscenza personale aiuti a capire i processi generali che reggono la società.
Wedding Camels (di David e Judith MacDougall, 1980). In questa trilogia di film sui Turkana del Kenya del Nord, David e Judith MacDougall adottano numerose strategie di riflessione per farci capire il loro attivo coinvolgimento nel dirigere le scene. A volte è una domanda posta dal regista a generare la discussione, a volte sono i titoli scritti che ci ricordano la complessità del procedimento di rappresentazione di un’altra cultura in forme comprensibili agli occidentali. Questi atti di riflessione erano rari ai tempi dei film etnografici. Molte pellicole di questo genere danno la stessa impressione di Nanuk l’eschimese: noi pensiamo di osservare i comportamenti “naturali” e non l’interazione tra regista e soggetto. Fotografia concessa da David MacDougall.
Il significato è chiaramente un fenomeno soggettivo e personale. Un’auto o una pistola, un ospedale o una storia d’amore avranno significati differenti per persone diverse. L’esperienza e il ricordo, il coinvolgimento emotivo, il contesto preciso, le questioni di morale e di opinione, di impegno e di principio – tutto fa parte del nostro modo di comprendere quegli aspetti del mondo che vengono più spesso affrontati dai documentari: la struttura istituzionale (i governi e la religione, le famiglie e il matrimonio) e i concetti sociali specifici (amore e guerra, competizione e cooperazione) che formano una società (come discusso nel Capitolo 4). Il documentario performativo
sottolinea la complessità della nostra conoscenza del mondo nell’enfatizzare la sua dimensione soggettiva e personale.
Corpus: A Home Movie for Selena (di Lourdes Portillo, 1999). Lourdes Portillo investiga le ripercussioni seguite all’omicidio della famosa cantante tex-mex Selena. Era un modello positivo, che spronava le giovani donne a incanalare la loro energia nel diventare cantanti, o piuttosto incoraggiava l’immagine stereotipata della femminilità sexy? Portillo non risponde alle domande, ma si limita a porle in modo coinvolgente. L’utilizzo delle riprese in video serve a creare un ritratto intimo di Selena e della sua eredità. Fotografia concessa dalla regista.
Lavori come Tongues Untied di Marlon Riggs, The Body Beautiful di Ngozi Onwurah, Bontoc Eulogy di Marlon Fuentes, Les glaneurs et la glaneuse di Agnès Varda, Tarnation di Jonathan Caouette e Valzer con Bashir di Ari Folman sottolineano la complessità emotiva dell’esperienza dal punto di vista personale del o della regista. In questi film è presente un tono autobiografico, simile al modello del saggio e del diario, che li accosta ai documentari partecipativi. Quelli performativi danno nuova enfasi alle qualità soggettive dell’esperienza e
della memoria. Marlon Riggs, per esempio, utilizza poesie recitate e scene ricostruite per mostrare i rischi personali dell’essere uomini di colore gay; il film di Onwurah arriva anche a mettere in scena un incontro sessuale tra sua madre e un giovane uomo attraente; Fuentes inscena la fuga immaginaria di suo padre dalla Fiera Mondiale di Saint Louis del 1904 in cui era stato messo in mostra. Agnès Varda si interroga sul passare del tempo e sulla mortalità delle cose quando intervista chi ospita gli spigolatori urbani e rurali; Caouette evoca ricordi potenti e inquietanti della sua giovinezza caotica e carica di traumi nel suo percorso di comprensione dei motivi che hanno portato sua madre a essere mentalmente instabile e Folman racconta un terribile episodio di guerra attraverso l’animazione. I fatti reali vengono amplificati da quelli immaginati. L’accostamento libero tra ciò che è vero e ciò che è immaginato è un tratto comune del documentario performativo. Quello che accomuna questi e altri film – come Looking for Langston (Alla ricerca di Langston, 1988) di Isaac Julien, sulla vita di Langston Hughes, o Frantz Fanon: Black Skin/White Mask (Frantz Fanon: pelle nera, maschera bianca, 1996), sempre di Julien, sulla vita di Frantz Fanon; Forest of Bliss (Foresta di gioia, 1985) di Robert Gardner, sulla tradizione funeraria di Benares, India; Who Killed Vincent Chin? di Christ Choy e Renee Tajima-Peña, sull’omicidio di un americano di origini cinesi da parte di due operai di un’industria automobilistica disoccupati che l’avevano preso erroneamente per un giapponese; e History and Memory di Rea Tajiri, sui suoi sforzi per apprendere la storia della sua famiglia, internata nei campi di detenzione durante la Seconda guerra mondiale – è l’allontanamento dell’interesse documentaristico dalla rappresentazione classica del mondo in favore di libertà poetiche, strutture narrative non convenzionali e forme di rappresentazione più soggettive. La qualità referenziale del documentario, che ne conferma la funzione di finestra sul mondo, si sottomette alla qualità espressiva, che afferma l’importanza di una visione del mondo molto precisa, fisica e personale da parte dei singoli soggetti, compreso il regista. Questo uso della parola “performativo” è diverso da quello ben noto che ne fece il filosofo J.L. Austin nel suo libro Come fare cose con le parole. Per Austin, il discorso normalmente si
riferisce a cose esterne a esso e non altera quella realtà. Il discorso performativo è un’eccezione. In questo caso dire qualcosa diventa una forma di azione: ne sono degli esempi i comandi o pronunciamenti espressi da chi ha l’autorità per enunciarli e le promesse fatte per essere mantenute. L’ufficiale che dice «Fuoco» a un plotone di esecuzione, il prete che dice «Vi dichiaro marito e moglie», e la persona che dice «Ti ripagherò» attraverso le parole compiono delle azioni. La natura della realtà cambia. I documentari performativi non agiscono in questo senso. La rappresentazione qui attinge in modo molto più significativo dalla tradizione attoriale per aumentare il coinvolgimento emotivo nei confronti di una situazione o di un ruolo. I documentari performativi portano in primo piano l’intensità emotiva dell’esperienza e della conoscenza personale più che cercare di fare qualcosa di tangibile. Se si predispongono a farlo, è per aiutare lo spettatore a capire come ci si senta all’interno di una data situazione o esperienza. Essi ci vogliono far sentire a livello viscerale più che comprendere a livello concettuale. I documentari performativi intensificano il desiderio retorico di essere persuasivi e lo legano più a uno scopo di affezione che di persuasione, per farci sentire o sperimentare il mondo in un modo particolare e più vivo possibile. Almeno dai tempi di Turksib o Sol Svanetii e, in senso satirico, Las Hurdes, il documentario ha mostrato molte qualità recitative o performative, ma raramente le ha applicate a un intero film. Tali caratteristiche erano presenti ma non preponderanti. Alcuni documentari di partecipazione degli anni Ottanta, come Las madres de la Plaza de Mayo e Roses in December (Rose a dicembre, 1982), presentano momenti di rappresentazione che ci mostrano delle ricostruzioni ipotetiche e soggettive di eventi drammatici del passato (rispettivamente, la “scomparsa” del figlio di una delle madri che avevano protestato contro la repressione governativa in Argentina e lo stupro di Jane Donovan e di altre tre donne da parte di soldati di El Salvador), ma l’organizzazione generale dei film ruota attorno a una storia lineare che comprende anche questi eventi. I documentari performativi si rivolgono a noi attraverso l’espressione e l’emozione piuttosto che attraverso i fatti.
Tongues Untied, per esempio, inizia con una voce fuori campo che fa risuonare da destra e sinistra, in stereo, le parole «Da fratello a fratello», «Da fratello a fratello…», e termina con una dichiarazione: «Gli uomini neri che amano gli uomini neri compiono un atto rivoluzionario». Il film, attraverso una serie di dichiarazioni, ricostruzioni, recite poetiche e rappresentazioni inscenate che illustrano le complessità delle relazioni razziali e sessuali all’interno della sottocultura gay, cerca di fare assumere anche a noi la posizione di “fratello”, se non altro per la durata del film. Noi siamo invitati a sperimentare soggettivamente la posizione sociale di un uomo di colore gay, come lo stesso regista Marlon Riggs. Come l’estetica femminista può cercare di portare gli spettatori, indipendentemente dal loro sesso e dal loro orientamento sessuale, nella posizione soggettiva del mondo visto con gli occhi di una femminista, così il documentario performativo cerca di portare il suo pubblico in una stessa situazione di affinità soggettiva con la sua particolare visione del mondo. Come lavori precedenti – per esempio Listen to Britain, sulla resistenza ai bombardamenti tedeschi da parte della popolazione inglese durante la Seconda guerra mondiale, o Tre canti su Lenin (Tri pesni o Lenine, 1934), sul lutto della popolazione sovietica per la morte di Lenin –, i documentari performativi più recenti cercano di dare una visione di una soggettività sociale che unisca il generale al particolare, l’individuale al collettivo, il personale al politico.
Paris Is Burning (di Jennie Livingston, 1991). Paris Is Burning mostra una sottocultura gay di colore, in cui giovani uomini si riuniscono in “case” che competono le une contro le altre in varie categorie di mimo e balli drag. In parte organizzato per spiegare questa sottocultura a chi non ne fa parte, il film ci immerge nelle peculiarità e nelle sensazioni di questo mondo con un’intensità differente da quella di 16 in Webster Groves o Dead Birds.
Anche qui l’animazione si è rivelata uno strumento potentissimo. His Mother’s Voice, discusso nel Capitolo 4, ci aiuta a capire come ci si senta a sapere che il proprio figlio è stato coinvolto in una sparatoria utilizzando due diversi trattamenti animati che mostrano che cosa sia passato per la testa alla donna mentre racconta quella terribile esperienza. Valzer con Bashir ci trascina in maniera fortissima dentro l’esperienza della guerra come incubo surreale che disorienta e nel quale l’autonomia e la responsabilità dell’individuo si dissolvono nel caos e nella confusione. Ryan (2004), di Chris Landreth, dà una potente forma visiva ed espressività emotiva alla maniera di vedere il mondo di uno dei più importanti artisti del National Film Board of Canada, Ryan Larkin, capace di guardare alla realtà dal suo vivido punto di vista di persona schizofrenica. Il film è tanto un omaggio alla maestria di Larkin quanto un lamento per una vita sconvolta dalla malattia mentale.
L’intensità emotiva e la soggettività sociale, protagoniste dei documentari performativi, sono spesso quelle dei gruppi più in secondo piano, come le donne o le minoranze etniche, i gay e le lesbiche. Il documentario performativo può funzionare come correttivo per quei film in cui “Noi parliamo di loro a noi”; esso afferma, invece, che “Noi parliamo di noi a voi”, o “Io parlo di me a te”. Il documentario performativo ha la stessa tendenza all’equilibro e alla correzione dei documentari autoetnografici (opere di carattere etnografico realizzate da membri delle comunità che sono solitamente oggetto di studio da parte dell’etnografia occidentale, come i numerosi lavori della popolazione Kayapo del bacino del Rio delle Amazzoni e degli aborigeni australiani). Tuttavia, non risponde agli errori con i fatti, alla disinformazione con l’informazione. Al contrario, adotta una particolare modalità di rappresentazione che afferma che acquisire conoscenza e comprensione richiede un modo completamente diverso di affrontare le cose. Come i primi documentari poetici ed espositivi – prima che l’uso della modalità osservativa desse la priorità alle riprese dirette di incontri sociali –, i documentari performativi mischiano liberamente le tecniche espressive che danno forma e densità alla fiction (inquadrature soggettive, colonna sonora musicale, espressione di stati mentali soggettivi, flashback e fermo immagine ecc.) e le tecniche di oratoria per affrontare i problemi sociali che né la scienza né la ragione possono risolvere. Il documentario performativo si avvicina al dominio poetico del cinema di sperimentazione o d’avanguardia ma vuole dare meno enfasi ai ritmi e ai toni formalmente autosufficienti del film o del video. La sua dimensione espressiva si riferisce alla realtà storica per arrivare al suo significato ultimo. Noi continuiamo a riconoscere il mondo reale attraverso la familiarità con luoghi e persone (Langston Hughes, la città di Detroit, il ponte di San Francisco Bay e così via) e la testimonianza di altri (i partecipanti di Tongues Untied che descrivono la loro esperienza di uomini di colore gay, il commento fuori campo confidenziale di Ngozi Onwurah riguardo la sua relazione con la madre in The Body Beautiful e gli strazianti filmini di famiglia di Jonathan Caouette che
ritraggono lui e sua madre mentre combattono per mantenere una dignità e sanità mentale in un mondo ostile). Il mondo mostrato dai documentari performativi diventa, però, colmo di toni evocativi e ombre espressive che ci ricordano sempre che il mondo è più grande della somma di tutte le prove che ne traiamo. Un altro dei primi, parziali esempi della modalità performativa, il film Notte e nebbia di Alain Resnais sull’Olocausto, esprime chiaramente questo aspetto. Il commento fuori campo e le immagini che lo illustrano lo rendono adatto per la modalità espositiva, ma il tono inquietante e personale del commento ci spinge verso quella performativa. Questo film non parla tanto di storia e memoria, di storia vista dall’alto – che cosa è successo, come e perché – ,quanto di storia vista dal basso, ovvero ciò che una persona proverebbe e come ci si sentirebbe a subire la stessa esperienza. Attraverso il tono ellittico ed evocativo del commento di Jean Cayrol, un sopravvissuto di Auschwitz, Notte e nebbia vuole rappresentare l’irrappresentabile: la totale inconcepibilità di atti che vanno oltre ogni ragione e ogni ordine narrativo. C’è un gran numero di prove visibili – gli oggetti personali e i corpi delle vittime e dei sopravvissuti – ma la voce di Notte e nebbia si estende oltre quello che l’evidenza conferma: va alla ricerca di una reazione emotiva da parte nostra, per farci capire che è del tutto impossibile comprendere questo evento all’interno di qualsiasi struttura di riferimento prestabilita (anche se possiamo arrivare a giudicare l’immonda mostruosità di un tale genocidio).
Notte e nebbia (di Nuit et brouillard, Alain Resnais, 1955). Molti dei filmati presentati in Notte e nebbia sono stati girati dagli ufficiali dei campi di concentramento e scoperti dopo la guerra dagli alleati. Alain Resnais li ha montati realizzando una testimonianza bruciante di orrori disumani. Il suo film offre molto di più che delle prove visive delle atrocità naziste: ci impone di ricordare, e non dimenticare mai, quello che è accaduto in questi campi, collegando il passato al presente e affidando alla memoria il compito di sostenere la coscienza morale.
Con uno spirito simile, il regista ungherese Péter Forgács ha affermato che il suo scopo non è polemizzare, spiegare, discutere o giudicare, ma evocare il senso di come sono state le esperienze passate per coloro che le hanno vissute. I suoi documentari straordinari sono composti da filmati casalinghi riorganizzati per rappresentare lo sconvolgimento sociale causato dalla Seconda guerra mondiale: Az Örvény racconta la vita di un uomo d’affari di successo degli anni Trenta, Gyorgy Peto, che avrà la peggio alla decisione, da parte della Germania, di applicare la “soluzione finale” agli ebrei ungheresi.
Az Örvény (di Péter Forgács, 1988). Péter Forgács si basa su filmati ritrovati, in questo caso riprese amatoriali degli anni Trenta e Quaranta. Questi filmati rivelano spezzoni di vita vissuta. Il regista lavora su di essi, tagliando le immagini, rallentando il movimento, aggiungendo titoli e musica per fornire un senso di prospettiva storica e impegno morale. Il risultato è molto poetico, radicalmente diverso dal tono descrittivo dei documentari classici sulla Seconda guerra mondiale, come la serie Why We Fight. Fotografie concesse dal regista.
Concentrando l’attenzione su eventi particolari, visti dalla prospettiva di chi vi ha preso parte invece che da quella di uno storico, Forgács suggerisce qualcosa, però, sul tono generale
della guerra: indica che, per alcuni di coloro che vi erano coinvolti, essa stazionava sull’orizzonte, togliendo apparentemente spazio a ogni piacere o distrazione. Noi, beneficiando del senno di poi, conosciamo meglio la situazione. Forgács mantiene alta la suspense grazie alla disparità nei livelli di conoscenza. La vita di Gyorgy Peto è destinata ad andare in pezzi. Noi lo sappiamo, lui no. Già questa è una maniera forte di invocare il potere della storia in modo performativo: lo spettatore sperimenta come ci si senta ad avere una conoscenza storica dei fatti e si rende allo stesso tempo conto che non può cambiare qualcosa che ha già avuto luogo. Forgács lascia a noi il compito di valutare e giudicare, ma vuole anche posticipare questo tipo di riflessione per farci vivere un incontro soggettivo con questi eventi storici. Pone l’affetto sopra l’effetto, l’emozione sulla ragione, non per rifiutare l’analisi e il giudizio ma per collocarli su una base diversa. Come Resnais, Vertov e Kalatozov prima di lui, e come molti dei suoi contemporanei, Forgács mette da parte i preconcetti e le categorie prefissate. Ci invita, come fanno i grandi documentaristi, a guardare il mondo con occhi nuovi e a ripensare la nostra relazione con esso. I documentari performativi intendono ridare un senso di grandezza a ciò che è locale, specifico e concreto. Vogliono dare vita all’aspetto personale in modo da farlo diventare la nostra porta d’ingresso per l’aspetto politico. Possiamo riassumere lo schema generale delle sei modalità di rappresentazione documentaristica nella tabella 7.1. Come già discusso in precedenza, le modalità non sono una genealogia e la tabella non è un albero genealogico. Essa ha il solo scopo di suggerire che ogni modalità possiede caratteristiche distintive, e che è su queste che si tratta a volte di porre l’accento più che su distinzioni ferree. Le caratteristiche di ciascuna modalità, insieme ai modelli che i registi adottano, forniscono una sorta di cassetta degli attrezzi piena di risorse, da cui formare nuovi e distintivi documentari. Tabella 7.1. Alcune caratteristiche specifiche delle modalità del documentario. Caratteristica
Espositiva
Poetica
Osservativa
In alternativa Fiction/avanguardia Fiction/esposizione Orazione a classica ed espressione poetica Limitata da
Didatticismo
Astrazioni formali che perdono contatto con la realtà storica
Ciò che accade davanti alla macchina da presa (difficile quando si rappresenta la realtà storica)
Tratta la conoscenza come
Idee, concetti o punti di vista disincarnati o astratti
Affettiva, un nuovo modo di vedere e comprendere il mondo e di guardare ciò che è familiare
Senso tacito di ciò che impariamo guardando, ascoltando, osservando e facendo congetture su quanto accade agli altri
Suono
Espressivo e cognitivo, pienamente sotto il controllo del regista; nessun collegamento indicativo con le immagine che sorregge; spesso è in forma di voce fuori campo
Espressivo, Collegato utilizzato per la all’immagine sua capacità di attraverso il fornire modelli e legame ritmi, ma con il indicativo regista che della mantiene un alto registrazione grado di controllo in sincrono. Il come accade nella regista modalità espositiva rinuncia al controllo assoluto del suono per registrare ciò
che viene detto e ascoltato in una data situazione ed evita la voce fuori campo Dimensione spaziotemporale
Discontinua. Utilizza immagini realizzate in momenti e luoghi diversi per illustrare un punto di vista o un argomento
Discontinua. Utilizza immagini che costruiscono stati d’animo e schemi senza dare troppa rilevanza alla somiglianza originaria
Continua. Forte senso di continuità che collega le parole e le azioni dei soggetti fra una ripresa e un’altra
Questioni etiche
Accuratezza e Uso di persone, verificabilità luoghi e oggetti storica; corretta reali senza rappresentazione considerare la loro degli altri, senza identità fare sì che appaiano individuale, in come vittime alcuni casi indifese; sviluppo distorcendo o di fiducia nello esagerando spettatore elementi per ottenere un particolare effetto estetico
Osservazione passiva di attività pericolose, dannose o illegali che può portare in serie difficoltà i soggetti. Gravi questioni di responsabilità nei confronti dei soggetti
Caratteristiche Orazione classica della voce alla ricerca della verità che cerca di informare e suscitare emozioni nel pubblico
Desiderio espressivo di dare forme nuove e diverse prospettive al mondo rappresentato
Pazienza, modestia e tendenza a restare nascosta. Volontà di lasciare il
pubblico libero di decidere da solo in merito a ciò che vede e sente
Caratteristica
Partecipativa
Riflessiva
Performativa
In alternativa Osservazione a passiva e orazione classica
Rappresentazione Forme di realistica che conoscenza ignora il processo empiriche o formale di astratte rappresentazione del mondo o i presupposti sociali sulla sua natura
Limitata da
Può lasciare il controllo e il punto di vista ad altri, e perdere indipendenza di giudizio
Senso rafforzato di astrazione formale e distacco, perdita di un impegno diretto rispetto ai temi sociali
Tratta la conoscenza come
Ciò che Contestuale e apprendiamo sempre dall’interazione considerata con le persone; all’interno di un ciò che le quadro di limiti persone dicono istituzionali e di e fanno nel presupposti momento in cui personali che si confrontano possono essere o sono esposti e
Il punto di vista e la visione personale possono diventare private o dissociate da percezioni più ampie della realtà sociale Rappresentata. Affettiva e collocata in maniera precisa. È ciò che apprendiamo dall’incontro diretto più che da un’esperienza di seconda mano
chiamate in causa dagli altri; ciò che può essere trasmesso dalle interviste e da altre forme di incontro
cambiati; si chiede che cosa si apprenda nel momento in cui lo si apprende
fornita da esperti o libri di testo
Suono
Pone l’accento sui discorsi tra regista e soggetto, specialmente nel caso di interviste. Si affida in massima parte al suono in sincrono ma può anche far ricorso al commento fuori campo; il regista mantiene un controllo del suono solo parzialmente creativo
Può metacomunicare sulla maniera in cui la comunicazione ha luogo. Discute dell’atto di parlare di qualcosa e il suono è tanto in sincrono quanto non in sincrono
Spesso fa affidamento sulla voce del regista per strutturare il film e pone l’accento su forme di discorso e di dialogo che sono introspettive, testimoniali e saggistiche. Mescola sincrono e non sincrono e utilizza in modo espressivo musica e suoni
Dimensione spaziotemporale
Continua. Può interconnettere una dimensione di tempo e spazio presente con una passata (tempo e spazio storici)
Contestualizzata. Varia a seconda Rivolge dei fini l’attenzione su espressivi. Può come il tempo e dare forma lo spazio possano stilizzata a essere manipolati tempo e spazio da sistemi di per enfatizzare continuità e la dimensione discontinuità affettiva
Questioni etiche
Manipola o spinge gli altri a confessioni o azioni che poi potrebbero rimpiangere; la responsabilità nel rispettare i diritti e la dignità dei soggetti è forte ed emergono questioni di manipolazione e distorsione
Caratteristiche Impegno e della voce forte investimento sugli incontri con gli altri o nella presentazione di un punto di vista sulla realtà storica
Fa uso o abuso dei soggetti per porre domande che sono nella testa del regista e non in quella dei soggetti
Gradazioni di onestà e autoesame contro auto-illusione; rappresentazione fuorviante o distorsione di tematiche più ampie, tendenza a scivolare completamente nel particolare
La voce si pone domande, mette in dubbio, anche in maniera radicale, le certezze o i dati certi della conoscenza
L’oratore dà un’impostazione fortemente personale e impegnata nel tentativo di perseguire la verità o di capire come sia sperimentare il mondo in una maniera diversa
CAPITOLO 8 IN CHE MODO I DOCUMENTARI AFFRONTANO LE QUESTIONI SOCIALI E POLITICHE? Le persone come vittime o come responsabili Quando ci siamo chiesti per la prima volta “Che cosa fare con le persone?”, nel Capitolo 2, la nostra discussione si è svolta soprattutto all’interno di argomenti etici. Quali conseguenze derivano dai diversi modi di reagire all’approccio con gli altri? Come possiamo rappresentare altre persone o parlare di loro senza ridurle a stereotipi, pedine o vittime? Quesiti simili sono emersi dalla spiegazione delle modalità osservativa e partecipativa. Queste domande non trovano una facile risposta, ma indicano anche che non si tratta di questioni esclusivamente di portata etica. Agire in maniera non etica o rappresentare gli altri nel modo sbagliato ha a che fare anche con la politica e l’ideologia. In una dura critica alla tradizione documentaristica, specialmente quella telegiornalistica, Brian Winston afferma che i registi inglesi di documentari degli anni Trenta avevano una visione romantica dei loro soggetti operai: non riuscivano a vedere l’operaio come l’autore attivo e indipendente di un cambiamento. L’operaio portava un “giogo” e gli altri, per esempio le agenzie governative, dovevano fare qualcosa per aiutarlo. Housing Problems, per esempio, ha dato agli abitanti dei quartieri disagiati l’opportunità di esprimere la loro opinione, attraverso interviste realizzate all’interno delle loro case. Le parole degli operai comparvero per la prima volta sugli schermi inglesi, una conquista notevole per un’epoca ancora lontana da televisione o reality show. Tuttavia, gli operai apparivano come se fossero arrivati, con il cappello in mano, a raccontare le loro misere condizioni di vita nella speranza che qualcuno decidesse di fare qualcosa a riguardo. (C’è da notare che Housing Problems aveva come finanziatore la Gas Light
and Coke Company, e che lo sgombero dei quartieri malfamati, la cosiddetta “soluzione” alla richiesta degli operai, avrebbe servito gli interessi della proprietà generando un notevole aumento del consumo di gas.) Non era un atto politico ma piuttosto una supplica, una sorta di caritatevole benevolenza. Come nota Winston, il desiderio di rappresentare romanticamente o poeticamente l’operaio, all’interno di un’etica di problemi sociali ed empatia caritatevole, negava di fatto al lavoratore la possibilità di porsi allo stesso livello del regista. Quest’ultimo manteneva il controllo dell’atto di rappresentazione: non c’era senso di collaborazione. Un gruppo di registi professionisti si era messo a rappresentare un altro gruppo sociale secondo le proprie disposizioni etiche e secondo il suo mandato istituzionale di propagandista assunto dal governo, come nel caso di John Grierson e dei suoi colleghi, o di giornalisti della “tradizione delle vittime” che, secondo Winston, è nata da questo esempio. Dopo alcuni anni di film del genere, «L’operaio sarebbe stato messo al centro del soggetto documentaristico, anonimo e patetico, e il regista di documentari di tradizione vittimistica sarebbe stato un “artista” tanto quanto ogni altro regista» (“The Tradition of the Victim in Griersonian Documentary”, in Alan Rosenthal, a cura di, New Challenges for Documentary, p. 274). Tra parentesi, si potrebbe notare che questa “tradizione”, se così si può chiamare una forma di pregiudizio di classe, non è stata valida ovunque e con chiunque. Come vedremo più avanti, negli anni Venti e Trenta le associazioni cinematografiche e fotografiche di molti Stati hanno scelto di mostrare, come materia delle loro opere, immagini di resistenza operaia, come scioperi e proteste, e Joris Ivens e Henri Storck hanno realizzato il loro racconto (chiaramente di parte) di uno sciopero in una miniera di carbone belga in Borinage (Misère au Borinage, 1934) come segno di solidarietà verso gli operai in difficoltà. Si tratta di un precursore del documentario vincitore dell’Oscar nel 1977, Harlan County, U.S.A., di Barbara Kopple. Life and Debt (Vita e debito, 2001), di Stephanie Black, segue le pratiche delle agenzie di prestito nei confronti delle presunte vittime: gli
stessi giamaicani, le cui esistenze sono paralizzate dalle pratiche di prestito dell’Fmi (Fondo Monetario Internazionale) e della Banca Mondiale, spiegano quali rigide regole facciano in modo che il cibo coltivato e cresciuto localmente non possa competere con prodotti qualitativamente inferiori che provengono dall’estero, devastando l’economia e creando un saldo negativo per la bilancia commerciale. Le loro spiegazioni sono tanto articolate e molto più oneste di quelle dei ricchi portavoce dell’Fmi che vedono i loro interventi solo come un beneficio che si sentirà sul lungo termine, senza nessun bisogno di porre un argine alla devastazione in atto almeno nel breve termine. È un grido distante di supplica che proviene dall’innocenza, come quello rappresentato in Housing Problems. Il soggetto dell’ira di Winston, più che i documentari indipendenti, sono quei reportage prodotti dal governo o dalle reti televisive che preferiscono rappresentare gli operai come persone docili, asservite e bisognose di aiuto. Per Winston esiste una domanda che può fare da cartina di tornasole per le politiche di rappresentazione documentaristica: «Visto che i problemi delle abitazioni restano immutati dopo cinquant’anni di documentari di denuncia, che motivo c’è per continuare a realizzare questi film?». Egli fa notare che un fallimento nell’ottenere cambiamenti sociali non era inevitabile; deriva dalla politica di rappresentazione attuata: Non c’era niente, tuttavia, in questo desiderio di propugnare una società migliore e più corretta (idea condivisa dall’intero movimento dei documentaristi) che poteva prevedere l’inevitabile trasmissione, ripetitiva e in fondo inutile, degli stessi problemi sociali sugli schermi delle televisioni occidentali. […] Furono quindi stabiliti dei punti chiave per tutti i lavori seguenti, sia al cinema sia in televisione, da applicare all’intero mondo anglofono e oltre. (Ibidem, p. 270). Possiamo fare delle eccezioni a questa netta condanna del documentario e all’affermazione che solo un approccio più radicale avrebbe potuto risolvere problemi come quello collegato alle abitazioni o che, al contrario, l’incapacità di
risolvere i problemi più urgenti sia la dimostrazione dell’impotenza di quei documentari che li rappresentano senza consapevolezza delle forze sociali e politiche in gioco in quel momento storico. Il grado di attivismo presente tra gli operai, l’equilibro di potere politico nel governo e le politiche di azione delle industrie coinvolte nei problemi di alloggio, per esempio, sono fattori che hanno tutti una notevole importanza, tanto quanto, se non di più, ne ha la forza di convinzione retorica e l’efficacia politica dei documentari. Possiamo, tuttavia, essere d’accordo sul fatto che le politiche di rappresentazione pongono il documentario all’interno di un’ampia arena di dibattiti e contestazioni sociali. Avere riguardo per i risvolti etici implica averne anche per le conseguenze politiche e ideologiche. Tutti i documentari hanno una voce propria, ma non tutte le voci del documentario affrontano direttamente problemi sociali e politici. (I documentari poetici possono distaccarsi dalle problematiche sociali; potrebbe trattarsi, sotto un certo aspetto, di una scelta politica, ma serve a spostare la nostra attenzione su altre considerazioni.) Osserveremo adesso alcuni documentari che affrontano direttamente dei problemi politici. Si tratta, per esempio, di documentari inglesi degli anni Trenta come Housing Problems, Coal Face (Faccia di carbone, 1935) e Smoke Menace; e di Sicko, Enron - L’economia della truffa e Trouble the Water, che affrontano i dibattiti in corso su valori e opinioni in ambito sociale, più che fatti assodati o visioni poetiche.
Costruire un’identità nazionale Tra i numerosi problemi specifici che i documentari hanno affrontato nel corso della loro storia, ci concentreremo sulla costruzione della nazionalità e del nazionalismo e sulla relazione tra la regia documentaria e gli interessi del governo e dei più deboli. Karl Marx una volta disse che «[la classe operaia] non può rappresentare se stessa; deve essere rappresentata», un monito ascoltato dalla gran parte dei film e video documentari realizzati da coloro che sono a loro volta stati “vittime” della tradizione documentaristica: le donne, le
minoranze etniche, i gay e le lesbiche, le popolazioni del Terzo Mondo. La costruzione di identità nazionali implica quella di un senso di comunità. “Comunità” evoca dei sentimenti di interesse condiviso e rispetto reciproco, di relazioni interne di stampo familiare e non regolate dalle obbligazioni di un contratto. Condividere valori e fedi è di vitale importanza per una comunità, mentre le relazioni contrattuali possono essere strette nonostante le differenze. Un senso di comunità sembra spesso una qualità “organica” che lega insieme persone che hanno in comune una tradizione, una cultura o un fine ultimo. In quanto tale può sembrare distante dai problemi di ideologia, dove opinioni tra di loro contrastanti lottano per vincere i nostri cuori e le nostre menti. D’altra parte, la forma più insidiosa di ideologia può essere quella che fa sembrare la comunità come qualcosa di naturale o organico. Raramente ci fermiamo a considerare con attenzione domande come: con chi scegliamo di identificarci e chi decidiamo di imitare, e perché? Chi scegliamo di seguire come membri di una comunità, e perché? Il bisogno di modelli, affetti e senso di appartenenza sociale è radicato nell’animo umano. Queste forme di indipendenza sono “naturali”, o così sembra. Eppure, all’interno di diverse società, in momenti storici differenti, gli individui sviluppano forme di relazione molto diverse. Indipendentemente dal tipo di spinta o di bisogno che le genera, queste relazioni prendono numerose forme concrete e queste sembrano, almeno al giorno d’oggi, sensibili alla manipolazione sociale. Che siano stabilite da una carta dei diritti o da un “piano quinquennale”, da un dispotismo benigno o da uno spirito di competizione, le ideologie entrano in gioco per creare storie, immagini e miti che forniscano una serie di valori. Il senso di comunità si acquista attraverso il rifiuto di certi valori e opinioni che vengono giudicati sbagliati, sovversivi o illegali. La politica della produzione documentaristica affronta i modi in cui il documentario aiuta a dare espressione tangibile ai valori e alle opinioni che formano, o criticano, dei tipi particolari di appartenenza sociale o di comunità, in un dato periodo e luogo.
Prendiamo per esempio il cinema sovietico degli anni Venti, che dopo la Rivoluzione russa del 1917 dipendeva dal sostegno dello Stato. Come il movimento d’arte sovietico conosciuto come Costruttivismo, il cinema esplorava i modi con cui i film potevano servire le aspirazioni rivoluzionarie del momento: come si poteva rappresentare l’“uomo nuovo” della società comunista, come si poteva costruire una cultura libera dalla tradizione borghese, come si potevano trascendere le vecchie divisioni di classe nelle città, le relazioni quasi-feudali nelle campagne e le lealtà parrocchiali nelle varie repubbliche per creare un senso di comunità basato sull’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e il comando del partito comunista? Le risposte erano varie ma, in generale, il cinema sovietico ha scelto di adottare dei mezzi di espressione fortemente retorici. C’era una predominanza di forme e stili persuasivi, e pochi avevano un tono tanto efficace, nella loro espressione di strategie particolari, quanto Sergej Ejzenštejn e Dziga Vertov. La teoria di Ejzenštejn sul montaggio, così come le idee di Vertov, sottolineavano la necessità da parte del regista di giustapporre immagini, o inquadrature, in modi che costringessero lo spettatore a formare delle nuove visioni. I frammenti di quello che poteva essere posto davanti alla cinepresa si combinavano insieme in una visione del nuovo, di ciò che il regista, come altri membri di una nuova società, poteva realizzare al momento. Ejzenštejn, più di Vertov, faceva affidamento su una struttura narrativa per raccontare storie di trasformazione sociale. Metteva in scena eventi storici e ne inventava di compositi o tipologici. Il suo lavoro ha ispirato molti, ma stranamente si ritiene che i suoi risultati più importanti si siano avuti nello sviluppo del film narrativo di fiction. Questo va a discapito del contributo formale che egli ha dato alle qualità espressive e poetiche del documentario, un contributo grande quanto quello di Vertov. Ejzenštejn si sarebbe stupito di sapere che sarebbe stato considerato dai critici delle generazioni successive un regista di fiction: come quelli dei primi documentaristi delle altre nazioni, i suoi film, come Sciopero, La corazzata Potëmkin, Ottobre e La linea generale, hanno cercato di dare un’espressione tangibile a un senso di comunità che andava costruendosi. Ejzenštejn celebra
le masse di persone che si uniscono per raggiungere degli scopi che non potevano essere raggiunti in nessun altro modo. È molto poco ciò che lo separa da registi considerati puri documentaristi, come Dziga Vertov. Quest’ultimo, come i registi osservativi degli anni Sessanta, rifiutava ogni forma di sceneggiatura, messa in scena, recitazione o ricostruzione. Vertov spinse all’estremo la sua differenza da Ejzenštejn poiché Ejzenštejn faceva maggiore affidamento sui principi narrativi. Vertov voleva catturare la vita in diretta e poi montarla per fornire una visione della nuova società che stava emergendo. Il suo termine per descrivere il cinema – kinopravda (cine-verità) – insisteva su una rottura radicale tra il film e ogni forma di struttura teatrale e letteraria: queste forme dipendevano da architetture narrative che bloccavano il potenziale del cinema come aiuto alla costruzione di una nuova realtà sociale. I suoi quarantatré rulli settimanali girati tra il 1918 e il 1919 sugli eventi correnti, la sua serie Kinopravda di reportage sulla vita nell’Unione Sovietica postrivoluzionaria (1923-25), il suo primo lungometraggio – Kinoglaz (Il cine-occhio, 1925) – e il suo film più famoso, L’uomo con la macchina da presa, sono tutte dimostrazioni della sua fede nella capacità del cinema di vedere un mondo invisibile all’occhio umano e di aiutarci a rendere tale mondo possibile. Il cinema e la rivoluzione vanno mano nella mano. Come detto da Vertov stesso: Io sono l’occhio cinematografico. Ho creato un uomo più perfetto di Adamo; ho creato migliaia di persone diverse in accordo con schemi e piani precedentemente redatti. Io sono l’occhio cinematografico. Prendo da uno le mani più agili, da un altro le gambe più dritte e veloci, da un terzo la testa più proporzionata e il volto più espressivo, e componendoli insieme creo un essere umano perfetto e completamente nuovo. (da Nikolaj Pavlovic Abramov, Dziga Vertov, pp. 154-155). Il cine-occhio viene inteso come “quello che l’occhio non vede”,
Come il microscopio e il telescopio del tempo. […] [come] “la vita colta alla sprovvista”, ecc., ecc. Tutte queste diverse formulazioni erano complementari l’una all’altra, poiché nel concetto di “cine-occhio” erano comprese: - tutte le tecniche di ripresa; - tutte le immagini in movimento; - tutti i metodi e i mezzi con i quali si può giungere alla scoperta della verità. - Non il cine-occhio per il proprio interesse, ma la verità con i mezzi del cineocchio: una verità in movimento. - “La macchina da presa allo stato puro”, non nel suo egoismo, ma per mostrare il popolo senza trucco alcuno, afferrarlo a ogni istante con l’occhio e arrestandolo nell’attimo in cui finge; imprigionare, al fine, i suoi pensieri. - Il cine-occhio come capacità di rendere visibile l’invisibile, chiaro lo scuro, nascondere il banale e tutto ciò che ci viene rivelato sotto i segni equivoci del travestimento: mettere l’immobile in movimento. Vertov non aveva bisogno di coniare una parola come “documentario” poiché pensava che i suoi film rappresentassero l’essenza stessa del cinema, non le caratteristiche di un genere. Per Vertov tutto il vero cinema marciava sotto lo stendardo di cine-occhio e kinopravda. Ironicamente, il termine kinopravda sarebbe stato di nuovo utilizzato attraverso l’omaggio tributato a Vertov da Jean Rouch ed Edgar Morin, i quali hanno chiamato la loro nuova forma di regia documentaristica cinéma vérité, indicando con quel termine, più che una categoria generale, una tipologia particolare di documentario. Un termine che era nato da Vertov come definizione di tutto ciò che è vero cinema viene utilizzato per indicare non solo un’area delimitata di un certo genere (il documentario), ma un’ulteriore delimitazione del sottogenere del documentario di partecipazione! Il cine-occhio ha contribuito alla costruzione di una nuova società, dimostrando che il materiale grezzo della vita di tutti i
giorni, catturato dalla cinepresa, poteva essere ri-costruito e sintetizzato in un nuovo ordine. Vertov non si rivolgeva al passato storico, poiché una tale scelta avrebbe comportato l’uso di costumi, sceneggiatura e recitazione. Preferiva i film di montaggio di Esther Shub alle ricostruzioni di eventi storici di Ejzenštejn, Dovženko, Pudovkin e altri, ma ciò che più di tutto amava era riprendere situazioni ed eventi della vita moderna per rimontarli e rivelarne poi la forma del futuro. Vertov, come molti artisti dell’inizio del XX secolo, provava una grande venerazione per la tecnologia meccanica e per la sperimentazione radicale con le forme tradizionali. Nelle sue mani, la venerazione per la perfezione del cine-occhio rese più facile la costruzione di una comunità sovietica in cui la collettività regnava sull’individualismo, il cambiamento sulla stasi, e l’unità come singolo Stato, con un solo capo (Lenin e poi Stalin). La sua dedizione all’innovazione formale, tuttavia, gli avrebbe causato, insieme ad altre figure importanti del cinema sovietico e dell’arte costruttivista, sempre più difficoltà nel corso degli anni Venti e dei primi anni Trenta, quando lo Stato iniziò a imporre uno stile di rappresentazione più accessibile e chiaramente formulato, conosciuto come “realismo sociale” (un ritorno alla narrativa lineare, a personaggi riconoscibili con profili psicologici familiari e a temi di consapevolezza per stimolare gli eroi a dedicarsi al “popolo” e allo Stato). Entro il 1939, Vertov aveva perso il sostegno dello Stato necessario per realizzare i film. Come scrisse nel suo diario di quell’anno: Mi sembra di essere completamente sul fondo. Ho davanti a me il primo gradino di una lunga, ripida scala. Il mio violino giace in cima alla scala, sul pianerottolo. Io muovo l’archetto […] nell’aria. Chiedo di poter prendere il mio violino. Salgo sul primo gradino, ma la persona che controlla i gradini mi spinge da parte e chiede: “Dove vai?”. Io indico il mio archetto e spiego che il mio violino è là in alto. “Ma cosa intendi suonare con il violino? Diccelo, descrivicelo. Ne discuteremo; lo correggeremo; faremo le nostre aggiunte; lo coordineremo con gli altri gradini; alla fine lo rifiuteremo o l’accetteremo.”
Io dico che sono un compositore. E che non scrivo parole, ma suoni. Allora mi dicono di non preoccuparmi. E mi portano via l’archetto. Forse l’archetto è stato passato a John Grierson. Grierson, insieme a Flaherty, viene spesso chiamato il “padre del documentario”, un’espressione che, si dice, è stata coniata da lui nella recensione di Moana di Flaherty; Vertov non avrebbe avuto bisogno di un termine del genere, poiché la sua teoria comprendeva tutto il cinema. Grierson convinse il governo inglese negli anni Trenta a fare con il cinema quello che il governo sovietico aveva fatto prima: utilizzare una forma artistica per comunicare un senso di identità nazionale e di comunità basati sugli scopi politici del governo. Creando una sezione cinematografica all’Empire Marketing Board dal 1930 al 1933 e in seguito al Government Post Office (Gpo), Grierson ha dato al documentario una base istituzionale, ha fondato una comunità di professionisti, ha sperimentato delle forme precise di convenzioni documentaristiche e ha stimolato un tipo particolare di aspettative da parte del pubblico. Grierson ha esportato questo esempio prima in Canada, dove è diventato il primo direttore del National Film Board of Canada nel 1939, e poi alle Nazioni Unite, dove ha lavorato come coordinatore dei mass media per l’Unesco dal 1947. Questo modello di finanziamento governativo del cinema documentario è stato accolto da molte altre nazioni, compresi gli Stati Uniti, all’inizio attraverso la semplice determinazione di Pare Lorentz, produttore di The Plow That Broke the Plains e The River per conto di diverse agenzie governative, e in seguito, grazie alla Seconda guerra mondiale, attraverso gli sforzi di registi di Hollywood come Frank Capra (la serie Why We Fight), John Ford (The Battle of Midway [La battaglia delle Midway, 1942]), Alfred Hitchcock (Bon Voyage [Buon viaggio] e Aventure Malgache [Avventura malgascia], entrambe del 1944) e John Huston (Report from the Aleutians [Cronaca dalle Aleutine, 1943] e San Pietro).
The River (di Pare Lorentz, 1937). Il potere del fiume è accostato a quello del commento fuori campo. Molto presto, ci viene detto, la violenza delle piene verrà domata dalla forza delle dighe, grazie all’aiuto della Tennessee Valley Authority. Fotografia concessa dai National Archives.
John Grierson, come Pare Lorentz, ha evitato le innovazioni formali e poetiche di Dziga Vertov o l’avanguardia europea in generale per sottolineare il ruolo del regista come oratore. Si trattava di film creati per entrare nell’arena delle politiche sociali e per indirizzare l’opinione pubblica verso una data soluzione. Dal recupero dei quartieri disagiati in Housing Problems al combattimento in Prelude to War (Preludio alla guerra, 1941) – il primo dei sette episodi della serie Why We Fight –, questi film cercavano di orientare lo spettatore verso una visione particolare del mondo, verso un consenso nazionale sui valori morali espressi dal film. Il governo dello Stato-nazione serviva un bene comune e l’uomo comune avrebbe dovuto quindi servire il governo con sollecitudine e buona volontà. Tali sforzi servirono ad affermare un senso di identità nazionale e di comunità. Gli individui partecipavano a una causa comune per difendere degli ideali preziosi, come raccontato da alcuni film: Coal Face, per esempio, girato da Alberto Cavalcanti per la Gpo di Grierson, è un omaggio
rispettoso agli operai che estraggono il carbone, fonte del potere industriale britannico; The River, girato da Pare Lorentz nel 1937 per la Farm Security Administration, promuove il lavoro della Tennessee Valley Authority come soluzione al problema delle inondazioni distruttive e al disperato bisogno di energia elettrica in ambito agricolo.
The River. “Il guadagno di un anno” è messo a rischio. Il cotone soffice, asciutto, difficile da raccogliere, contrasta con la furia del fiume. The River si sofferma sui problemi personali (mostrandoli dalla prospettiva dei poveri) piuttosto che sull’interesse delle grandi industrie nell’acquisire il controllo sulle piene. Come in The City, il “povero” non può farcela da solo e il governo deve agire per lui. Why We Fight, motivando gli uomini ad andare in guerra, ridarà quel senso di iniziativa populista che questi film, sostenendo il New Deal, cercavano di minimizzare. Fotografia concessa dai National Archives.
John Grierson ha spesso definito la sua posizione in contrasto all’idealismo romantico di Robert Flaherty. Grierson ha sempre affrontato i problemi del mondo e ha cercato di esprimere un approccio sensato al nazionalismo e alla comunità, più che promuovere una venerazione per le qualità di un mondo passato e una visione mitologica di amicizia e affinità. Il suo contribuito al documentario non è solo un approccio più pratico e duro ai problemi sociali, ma anche una
visione conservativa dell’estetica del cinema sovietico. Più che coltivare il potenziale rivoluzionario degli operai e dei contadini del mondo, Grierson ha sostenuto il potere migliorativo della democrazia parlamentare e l’intervento del governo per risolvere i problemi più urgenti e le ingiustizie più gravi all’interno di un sistema sociale che, comunque, non viene mai messo in dubbio. Questo impulso migliorativo ha contribuito sicuramente alla “tradizione della vittima” descritta da Brian Winston. John Grierson ha anche denigrato, senza mai criticarla seriamente, la predominanza economica dei lungometraggi di fiction. Egli vedeva il documentario come una forma alternativa, moralmente superiore: non divertente come la fiction, ma migliore per noi. Anche le storie preconfezionate e la sperimentazione poetica hanno un loro ruolo, ma poggiano su un gradino più basso della classifica culturale. Grierson ha accostato il concetto di documentario a quello di utilità sociale e importanza pubblica, eliminando l’affermazione di Vertov che intendeva il cine-occhio come l’elemento essenziale di tutto il vero cinema, non solo del documentario. Il potere e la grandezza della teoria filmica sovietica si sono alla fine ristretti fino a diventare una serie di direttive su un’idea piuttosto limitata di ciò che il documentario, in quanto genere di non-fiction, poteva significare o fare. La costruzione di un senso di comunità e di identità nazionale si basava sulla coordinazione di aspirazioni individuali e politiche e priorità di governo, attraverso una forma documentaristica spogliata delle sue più audaci ambizioni. John Grierson ci ha fornito la nostra visione primordiale del documentario che, trattata con la creatività e la sensibilità di Alberto Cavalcanti, Basil Wright e Humphrey Jennings, poteva essere portatrice di grande bellezza ma spesso, nelle mani del governo e dei finanziatori, è diventata noiosamente didattica.
Contestare lo Stato-nazione John Grierson ha dato alla sua visione della forma documentaristica un tono di importanza e rispettabilità, ma a un prezzo che non tutti i registi volevano pagare. Altri autori proposero un senso di comunità che si fondava sulle azioni, e
sui cambiamenti, che il governo sembrava non pronto ad accettare o a fare. I loro film presero posizioni che si opponevano alle politiche governative e industriali. Questi registi formarono l’avanguardia politica del cinema documentario. Negli Stati Uniti, un’attività del genere risale ai primi sforzi delle società cinematografiche e fotografiche operaie degli anni Venti e Trenta, che fornivano informazioni sugli scioperi e altri argomenti importanti dal punto di vista della classe operaia. Associate al partito comunista, altre società hanno preso piede in Inghilterra, Giappone, Olanda e Francia. Adottando una modalità di ripresa partecipativa, si identificavano e collaboravano notevolmente con i loro soggetti-operai, evitando in questo modo di ritrarli come vittime impotenti. Questo era un cinema di potere, che contribuiva ai movimenti sociali più radicali degli anni Trenta e cercava di costruire un senso di comunità a partire dalla base, dalle fondamenta, invece che da una prospettiva elevata e sponsorizzata dal governo. Le persone che avevano iniziato la loro carriera in queste società hanno cambiato direzione nel corso degli anni Trenta per formare delle compagnie dedicate alla produzione di film dalle ambizioni maggiori. Scrittori come Lillian Hellman e Clifford Odets e registi come Leo Hurwitz e Joris Ivens hanno partecipato a questi progetti. Frontier Films, per esempio, ha prodotto Heart of Spain (Il cuore della Spagna, 1937) per sostenere la causa repubblicana nella guerra civile spagnola, mentre il governo lottava senza successo per impedire il colpo di stato militare di estrema destra. Contemporary Historians, un gruppo più specifico di sostenitori (da John Dos Passos a Ernest Hemingway), ha sponsorizzato, per la stessa causa, la produzione del potente documentario di Joris Ivens Terra di Spagna. Joris Ivens può essere considerato uno dei tanti “padri” del documentario – insieme a Louis Lumière, Esther Shub, Dziga Vertov, John Grierson e Robert Flaherty –, ma la sua carriera, iniziata meravigliosamente con due grandi film poetici e sperimentali quali De Brug e Pioggia, è terminata quasi del tutto dopo la Seconda guerra mondiale, quando le sue
convinzioni politiche lo hanno portato dall’altra parte della cortina di ferro. Ivens ha realizzato numerosi film in Russia (Komsomolsk, 1932), Germania dell’Est (Das lied der Ströme [La canzone del fiume, 1954]), Vietnam del Nord (Le 17e parallèle: La guerre du peuple [Il diciassettesimo parallelo, 1968]) e Repubblica Popolare Cinese (Before Spring, 1958; Come Yukong spostò le montagne [Comment Yukong déplaça les montagnes, 1976]; Io e il vento [Une histoire de vent, 1988]). Questi documentari appartengono solo in minima parte alla storia documentaristica dell’Occidente, anche se molti di essi possiedono lo stesso livello di merito artistico dei suoi primi lavori. Per esempio, Ivens è una figura che gode di grande considerazione in Cina per Come Yukong spostò le montagne, la sua epica serie, ancora oggi potente, sulla Rivoluzione Culturale ora tanto criticata. È significativo come il sito dell’Internet Movie Database (Imdb), che di solito è molto esaustivo quanto alla presenza dei registi, non riporti alcuna informazione su questa serie. Come altri film di Ivens, è rimasta vittima delle politiche da guerra fredda. Per Ivens, la collaborazione si è rivelata un ingrediente essenziale della sua pratica di regista. L’utilizzo di prove, messa in scena o ricostruzione, pratiche che avrebbero sconcertato Vertov, aveva per Ivens un grande valore, purché esse contribuissero ad aumentare il senso di sforzo collettivo e di causa comune nati dal conflitto sociale. (È stato solo dopo la nascita del cinema osservativo negli anni Sessanta che queste tecniche hanno subito pesanti critiche; i documentari riflessivi e performativi hanno in seguito ridato loro importanza stilistica.) Per esempio, nel realizzare Borinage con il regista belga Henri Storck, un film su uno sciopero in una miniera di carbone nella regione belga del Borinage, Ivens si è reso conto che catturare «la vita colta nel suo darsi» non bastava: bisognava anche guardarsi dalle tecniche artistiche che potevano abbellire lo sguardo del regista e diminuire la sua voce politica. Come nota Ivens nel suo libro The Camera and I: Quando l’ombra netta delle finestre delle baracche iniziò a scendere sugli stracci sporchi e sui piatti della tavola, il suo effetto gradevole annullò l’impatto visivo dello sporco che
cercavamo, così spezzammo i bordi dell’ombra. Il nostro scopo era quello di evitare degli effetti fotografici gradevoli che distraessero il pubblico dalle verità sgradevoli che stavamo mostrando. […] Ci sono anche stati casi nella storia del documentario in cui i fotografi sono stati così affascinati dallo sporco da finire per ritrarlo come qualcosa di interessante e strano, e non qualcosa di repellente per il pubblico del cinema. Il regista dev’essere arrabbiato e indignato nei confronti del degrado e della povertà delle persone prima di trovare l’angolo e la luce giusta per illuminare lo sporco e la verità. (The Camera and I, p. 87). Questo crudo realismo trova il suo culmine nell’ultima sequenza del film, quando gli operai mettono di nuovo in scena una marcia di protesta che aveva avuto luogo prima dell’arrivo di Ivens e Storck. Non solo essi hanno collaborato nel ripetere la marcia esattamente allo stesso modo, ma hanno ritrovato anche lo stesso senso di comunità e solidarietà che avevano provato nella marcia originale! L’atto partecipativo del filmare ha contribuito a recuperare quel senso di comunità che Ivens intendeva rappresentare. È a questo senso di solidarietà collettiva che Jon Silver ha fatto calorosamente appello quando ha reclutato i lavoratori tentando di filmare dentro la sala riunioni del sindacato in Watsonville on Strike, discusso nel Capitolo 3. Ivens e Storck non hanno collaborato né con il governo né con la polizia, ma con le stesse persone la cui miseria non era stata ancora né affrontata né eliminata dalle istituzioni. Il loro coinvolgimento e la loro partecipazione sono riusciti a ricreare gli stessi aspetti che i registi intendevano documentare, non in quanto spettacolo per affascinare esteticamente e sottomettere politicamente, come in Il trionfo della volontà, ma come modo attivo per smuovere esteticamente e trasformare politicamente. Un cinema di oratoria, fatto in collaborazione con le “vittime della terra”, ha creato delle solide fondamenta che avrebbero sostenuto numerosi altri esempi di coinvolgimento politico affrontato dall’altra parte della barricata.
La costruzione del consenso nell’ambito dell’identità nazionale, sia per sostenere sia per criticare il governo corrente, ha avuto un ruolo molto importante durante i primi decenni del documentario. Molti dei primi tentativi di regia etnografica si sono basati su esperienze di questo genere, applicandole ad altre culture. Tutti quei tentativi tendevano a classificare gli individui in modi che minimizzavano la singolarità per massimizzare la tipologizzazione: riprese di singole persone valevano per illustrare caratteristiche più ampie, una tendenza incoraggiata in parte dalla difficoltà di registrare il suono in sincrono e in parte dalla preferenza accordata alla generalizzazione politica e all’espressività poetica. Nel genere etnografico, il commento della voce fuori campo e le tecniche di montaggio poetico identificavano le singole azioni come rappresentative o tipologiche, spostando quindi l’attenzione sulle caratteristiche generali della cultura. Trance and Dance in Bali (1952), Les Maîtres fous, Dead Birds e The Hunters (I cacciatori, 1957), per esempio, hanno seguito il modello di Nanuk l’eschimese nel trattare l’individuo come il rappresentante di una cultura e di una comunità unificata e omogenea. Insieme all’“identità nazionale”, anche il “carattere nazionale” diventa un’idea generalizzante e riduttiva: i documentari etnografici ne hanno subito le conseguenze tanto quanto quelli finanziati dal governo. Esiste tuttavia una concezione alternativa di individui e di comunità a cui essi appartengono, che occupa la posizione opposta rispetto alla generalizzazione e alla stereotipizzazione dell’altra. Le comunità non si allineano alla perfezione con il concetto di Stato-nazione; restano delle differenze che distinguono il singolo individuo dalla moltitudine, le sottoculture dalla cultura dominante, le minoranze dalle maggioranze. Il melting pot mantiene al suo interno delle differenze: viene data una rappresentazione anche alle comunità di discendenza (identità etniche ereditate di generazione in generazione nonostante esili e diaspore) e a quelle di scelta (identità collettive formate da una scelta attiva di adottare e difendere i comportamenti e i valori di un dato gruppo). La loro presenza serve a sottolineare la natura mitica di alcune affermazioni che vogliono tutti uguali e dei
presupposti di un nazionalismo privo di differenze di razza, classe e colore. Il lavoro di alcuni registi ha sfidato l’ideologia di un singolo carattere nazionale e di un obiettivo nazionale trascendente. Essi hanno cercato dei cambiamenti più radicali di un semplice miglioramento sociale. Dai reportage delle società cinematografiche e fotografiche operaie sulle marce della fame degli anni Trenta a Las Hurdes di Luis Buñuel, questi registi respingevano l’idea di Grierson di lavorare al servizio del governo e preferivano sfidarlo. Las Hurdes, per esempio, mostrava una regione devastata dalla miseria in un modo inaccettabile per il governo spagnolo (che per molti anni bandì il film); Strange Victory (Strana vittoria, 1948) di Leo Hurwitz ha criticato il generale senso di trionfo sul fascismo del secondo dopoguerra, sottolineando la presenza di discriminazioni razziali e conflitti di classe all’interno della società americana; Indonesia Calling (L’Indonesia chiama, 1946) di Joris Ivens sosteneva il movimento di indipendenza indonesiano contro il dominio coloniale dell’Olanda (film che gli ha alienato ogni consenso in patria per molti anni).
Borinage (di Joris Ivens e Henri Storck, 1933). In contrasto con Jill Godmilow in Far from Poland, Joris Ivens è riuscito a raggiungere il luogo dei fatti: una miniera in cui era in corso uno sciopero. Anche lui, tuttavia, ha scelto di rimettere in scena l’evento, in questo caso per riprendere la marcia dei lavoratori che era già avvenuta. Ivens non aveva però alcun desiderio di riflettere e attirare l’attenzione sui problemi della rappresentazione. Al contrario, il fatto che i lavoratori provassero di nuovo un senso di attiva partecipazione durante la messa in scena era proprio ciò a cui Ivens mirava. L’intensità dei sentimenti provati durante la scena avvicina l’evento storico a quello rappresentato, il documento alla rappresentazione, rendendo chiaro il potere formativo del documentarista. Fotografia concessa dalla European Fondation Joris Ivens.
Gli anni Sessanta e Settanta hanno dato ancora più risalto a questa tendenza a rappresentare “la storia dal basso” (ovvero dal punto di vista di chi è rimasto ai margini). L’esempio più notevole di produzione cinematografica collettiva è il gruppo americano di registi chiamato Newsreel. Con dei centri molto attivi a New York e San Francisco, e distributori in molte altre città, Newsreel ha creato e distribuito dozzine di film dal 1967 in poi, con argomenti come la guerra in Vietnam, la resistenza alla leva, gli scioperi universitari (Columbia University e San Francisco State), i movimenti di liberazione nazionale in tutto il mondo e i movimenti femministi. I film del gruppo Newsreel erano identificati dal logo, in cui la parola “Newsreel” appariva a scatti, in sincronia con il
fuoco di un mitra. Non v’era dubbio che queste pellicole fossero militanti, come i primi cinegiornali di Dziga Vertov negli anni 1918-1919. Quei film si battevano per promuovere la resistenza contro le azioni e le politiche governative. Non erano firmati individualmente. Venivano intesi come il prodotto di uno sforzo collettivo e l’idea di una visione artistica individuale era subordinata all’impegno del gruppo verso una posizione politica radicale. A San Francisco, Newsreel arrivò addirittura a creare dei turni di lavoro secondo i quali i membri avrebbero dovuto lavorare per dei periodi a rotazione e devolvere i guadagni a sostegno delle attività del gruppo. Attraverso la distribuzione dei loro film e la proiezione nei campus, nelle comunità e sui muri degli edifici, prima che fossero disponibili le videocassette, i Dvd e internet, Newsreel ha contribuito all’attivismo politico più intenso degli anni Sessanta e dei primi Settanta. Si tratta di un importante precursore di siti web come MoveOn.org, che mobilita oggi l’attivismo politico. Il film del gruppo Newsreel di San Francisco The Woman’s Film, per esempio, mostrava il punto di vista di una serie di operaie su come le loro esperienze quotidiane le rendessero consapevoli della loro situazione di oppressione. The Woman’s Film, realizzato soprattutto dai membri femminili del gruppo, spicca come uno dei primi documentari femministi del dopoguerra. Con le sue interviste, accostate a scene della vita quotidiana dei partecipanti, questo film ha dato conferma del ruolo delle donne come registe e come attiviste politiche, e non più come le “vittime” identificate da Brian Winston come preoccupante eredità del documentario inglese degli anni Trenta.
Oltre il nazionalismo: nuove forme di identità L’approccio “Noi parliamo di noi a voi” aveva preso quindi una nuova connotazione, che si allargava su una lunga serie di aspetti della vita sociale che erano stati trascurati, dall’esperienza delle donne a quella di afroamericani, latini, nativi americani, gay e lesbiche. Insieme alla nascita di una “politica d’identità” che celebrava l’orgoglio e l’integrità dei gruppi emarginati e ostracizzati, la voce del documentario ha
anche dato una forma indimenticabile a culture e storie che erano rimaste ignorate o schiacciate dai valori predominanti della società. Sostenere o opporsi alle politiche del governo diventò dunque secondario al compito, maggiormente localizzato (e a volte isolato), di recuperare queste storie e affermare quelle identità che i miti, le ideologie o l’unità nazionale avevano fino ad allora negato. Imagining Indians (Immaginare gli Indiani, 1993) e Color Adjustment (Ritocco di colore, 1991), per esempio, gettano uno sguardo critico sul modo sbagliato e stereotipato di rappresentare, rispettivamente, i nativi americani al cinema e gli afroamericani in televisione. Essi sfidavano presupposti dati per scontati da sempre, che portavano a rappresentazioni distorte e umilianti, non solo di quelle particolari minoranze, ma di tutte le minoranze in genere. Con l’eccezione dei lavori di registi afroamericani e di autori del Quarto Mondo (individui con le proprie radici nel Terzo Mondo, che vivono tuttavia nel mondo industrializzato), il processo di dare nome, forma e visibilità a un’identità prima di allora sconosciuta è stato espresso più vividamente nelle questioni di sesso e sessualità. The Woman’s Film ha dato inizio a questo processo, ma sono stati realizzati molti altri documentari a sostegno dei movimenti femministi, con opere che esploravano l’esperienza dell’oppressione, recuperavano storie perdute e delineavano correnti di cambiamento. Janie’s Janie (La Janie di Janie, 1971) di Geri Ashur e Peter Barton, come The Woman’s Film, collegava l’oppressione allo sfruttamento, il sessismo alle difficoltà economiche. Come Housing Problems aveva fatto molto tempo prima, questi due film hanno dato voce all’esperienza operaia, ma con una modalità di rappresentazione più sentita e fortemente partecipativa, che si rifiutava di trasformare gli svantaggiati in vittime che attendevano un’assistenza caritatevole. Le donne dirigevano l’attenzione della cinepresa, invece di sottomettere le loro voci a un argomento o a una visione che era solo del regista. Per contrasto, Growing Up Female, di Julia Reichert e Jim Klein, e Joyce at 34, di Joyce Chopra e Claudia Weill, toglievano enfasi al punto di vista economico per presentare la
visione borghese del sessismo come un’esperienza dai risvolti principalmente psicologici condivisa da un gran numero di donne. A Film about a Woman Who… (Un film su una donna che…, 1974), di Yvonne Rainer, e Jeanne Dielmann, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), di Chantal Ackerman, hanno spinto ancora più in là questi aspetti del femminismo. I loro lavori si accostavano alla fiction per quanto riguardava la creazione di personaggi e di situazioni, ma possedevano qualità antropologiche e saggistiche, compresi, nel caso di Rainer, una forma di rappresentazione alla Brecht e, per Ackerman, uno stile etnografico iperrealista. Il risultato in ogni caso è stata una finestra aperta su visioni femministe di amore, ambiente domestico e autodeterminazione, che mai erano state viste prima. Union Maids di Julia Reichert, Jim Klein e Miles Mogulescu e With Babies and Banners: The Story of the Women’s Emergency Brigade di Lorraine Grey, Lynn Goldfarb e Anne Bohlen adottavano un approccio partecipativo, da film di montaggio, attraverso l’uso di interviste e filmati d’archivio, per raccontare l’organizzazione operaia e gli scioperi di massa degli anni Trenta dal punto di vista delle donne. In The Life and Times of Rosie the Riveter si riprende il filo dei primi movimenti di protesta delle suffragette per svolgerlo in avanti, fornendo un importante contesto storico alla storia del film, che parla della nascita di opportunità di lavoro per le donne nei cantieri navali durante la Seconda guerra mondiale e della loro scomparsa alla fine del conflitto con il ritorno degli uomini. Questi lavori presentano argomenti e approcci che i documentari dagli anni Trenta in poi, con il loro interesse per la retorica unificatrice della costruzione della nazione o le proteste operaie rigorosamente maschili, non avevano affrontato. Edward R. Murrow, nel suo innovativo documentario televisivo Harvest of Shame, rappresentò i lavoratori agricoli migranti, una di quelle categorie di più deboli che trovarono non solo una maniera di essere conosciute, ma anche una voce in opere come The Global Assembly Line (La catena di montaggio globale, 1986) di Lorraine Gray e Maquilapolis (2006) di Vicki Funari e Sergio de La Torre. Questi ultimi non solo fanno un significativo
tentativo di rappresentare le difficoltà degli operai, prevalentemente donne, delle maquiladoras (stabilimenti controllati da multinazionali e situati lungo il confine che aggirano legalmente molti dei diritti civili basilari e le leggi sul lavoro vigenti sia in Messico che negli Stati Uniti), ma coinvolgono due operaie stesse nella costruzione del film. Carmen Duran e Lourdes Lujan diventano attiviste, spinte dalle paghe misere, dalle tutele minime, dall’inquinamento dilagante e dall’indifferenza dei manager. Maquilapolis celebra la trasformazione delle potenziali vittime in combattenti attive in una moderna arena dell’economia globale.
A Film About a Woman Who… (di Yvonne Rainer, 1974). Questo film illustra il sottile confine tra il documentario e cinema d’avanguardia: Yvonne Rainer si serve di tecniche stilistiche particolari, scene accuratamente strutturate e una precisa agenda politica per indagare l’esperienza del mondo vissuta dalle donne. Per gentile concessione di Zeitgeist Film.
I documentari dei primi movimenti femministi trovano un parallelo in quelli dei primi movimenti gay e lesbici. Anche qui si trovano lavori che esplorano l’esperienza di oppressione, recuperano storie perdute e delineano correnti di cambiamento. Il film collettivo Word Is Out si basava su una serie di interviste con un numeroso gruppo di gay e lesbiche
che raccontavano la loro scoperta della sessualità e la resistenza sociale che la circondava in un’epoca in cui il movimento per i diritti civili dei gay non aveva ancora preso forma.
Maquilapolis (di Vicki Funari e Sergio de la Torre, 2006). L’immagine illustra la collaborazione partecipativa tra registi e soggetti: alcune delle lavoratrici mostrano il frutto del loro lavoro. Attraverso una drammatica messa in scena, essa svela che cosa succede dentro una maquiladora, come quella che vediamo sullo sfondo dell’inquadratura. Per gentile concessione di California Newsreel.
Una prospettiva storica più forte sull’esperienza omosessuale domina il film di Greta Schiller e Robert Rosenberg Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community (Prima di Stonewall: la creazione di una comunità gay e lesbica, 1984). In questo film non solo le persone intervistate riferiscono la loro esperienza personale, ma adottano anche la voce di testimoni ed esperti per rendere percepibile la vita gay nascosta agli occhi pubblici. I soggetti stessi sono membri della comunità che descrivono; forniscono una prospettiva dall’interno. Before Stonewall, come molti altri film riguardanti le questioni di identità, non utilizza il commento di esperti e di autorità esterne secondo i tipici modelli della sociologia e del giornalismo, ma preferisce che
la presa di coscienza e le descrizioni provengano dai membri della comunità che formano l’oggetto del documentario. Con uno spirito simile, il ritratto del primo politico dichiaratamente gay di San Francisco, il documentario vincitore dell’Oscar The Times of Harvey Milk di Rob Epstein e Richard Schmiechen, si affida in maniera consistente a interviste e notiziari televisivi per raccontare la carriera di Milk come consigliere comunale, componendo un racconto di resistenza sprezzante agli stereotipi e di grande abilità politica. Il ritratto indimenticabile che offre di Harvey Milk gioca chiaramente un ruolo significativo nella maniera in cui Sean Penn ne ha costruita la sua personale rappresentazione in Milk (di Gus Van Sant, 2008), film di fiction dedicato a quest’uomo eccezionale. Altri film hanno trattato temi correlati a questo. Per esempio, Nitrate Kisses (1992) di Barbara Hammer recupera le storie di esperienze omosessuali doppiamente censurate di coppie lesbiche anziane e interrazziali. Si discosta anche dal formato standard delle interviste. Hammer adotta tecniche filmiche sperimentali e ricostruzioni di incontri sessuali molto forti per rappresentare la struttura e la soggettività di un’esperienza del genere, andando oltre i tratti storici. Nitrate Kisses delinea, in termini performativi ed evocativi, quali siano gli aspetti e le caratteristiche di questa comunità. Il risultato è più simile a Az Örvény di Péter Forgács che a Word Is Out del collettivo Mariposa per l’accento posto su un tono poetico ed evocativo di rimembranza. Come notato dal critico cinematografico omosessuale Thomas Waugh, il documentario gay e lesbico si è sviluppato principalmente attraverso la modalità performativa. La rappresentazione stessa è di vitale importanza per la comprensione di una identità sessuale. Articolata in modo più completo, e radicale, nel libro di Judith Butler Gender Trouble, la dimensione performativa della sessualità non indica semplicemente la scelta di dare un taglio drag o camp alla sessualità, ma sottolinea anche la costruzione di un’identità sessuale, etero o gay, come atto di rappresentazione, in cui può essere stabilita non con ciò che una persona è o dice, ma con ciò che fa. La questione della flessibilità della presentazione di
sé in un contesto sociale in cui la discriminazione ha deformato la situazione in atto rende la modalità performativa particolarmente adatta. Per i membri di una minoranza oppressa è il modo per esprimere il coinvolgimento emotivo che colora la loro esperienza personale e dà animo all’attivismo politico. Un chant d’amour (1950), di Jean Genet, film sulla passione e il desiderio tra i carcerati maschi e le loro guardie, nel 1950 scioccò gran parte del pubblico e offese i censori. Insieme a Fireworks (Fuochi d’artificio, 1947), di Kenneth Anger, ritratto degli intensissimi sogni erotici di un giovane uomo, preparò il terreno per opere successive di grande espressività. Considerati solitamente cortometraggi o film d’avanguardia, queste due opere offrono una rappresentazione vivida dell’impulso performativo e celebrano in maniera visiva il desiderio omoerotico con una florida immaginazione e un atteggiamento di sfida che si rivelò fonte di ispirazione per molti registi successivi. Per esempio, A Comedy in Six Unnatural Acts (Una commedia in sei atti innaturali, 1975), il film pionieristico di Jan Oxenberg, si affida principalmente alla modalità performativa per infrangere gli stereotipi e i miti sulle lesbiche, con lo stupore di molti degli spettatori del tempo. Film successivi, come Tongues Untied e Anthem (Inno, 1991) di Marlon Riggs, utilizzano scene recitate, ricostruzioni, poesia e commenti personali e (in Anthem) uno stile di montaggio da video musicale per affermare la natura dell’amore omosessuale e dell’identità gay di colore. Tarnation è virtualmente inimmaginabile senza gli antecedenti di Genet e Anger, con il suo fantasioso uso del montaggio e dello split screen per assemblare inquadrature che rappresentano che cosa voglia dire sperimentare sensazioni di angoscia mentale e confusione sessuale.
Nitrate Kisses (di Barbara Hammer, 1992). Nitrate Kisses usa le tecniche del cinema sperimentale per esplorare la storia della rappresentazione della cultura gay e lesbica nella cinematografia. Hammer esplora anche aspetti della sessualità spesso ignorati, come l’intimità sessuale tra persone di età avanzata. L’industria della pubblicità e dello spettacolo vorrebbe farci credere che le relazioni sessuali non avvengono quasi mai prima dei quindici e dopo i cinquant’anni.
Anthem (di Marlon Riggs, 1991). Anthem continua, dopo Stonewall, la tradizione iniziata da Word Is Out. Questo film – una celebrazione emozionante dell’orgoglio gay – è un esempio delle qualità emotive e coinvolgenti dei documentari performativi. Come in Tongues Untied, Riggs usa la poesia forte e diretta di Essex Hemphill (nella foto).
In uno spirito in qualche modo diverso, Paris Is Burning di Jennie Livingston usa un insieme di modalità di rappresentazione osservativa e partecipativa per descrivere la ricca sottocultura delle “case” in cui uomini gay latini e di colore vivono una vita che si basa sul mimare e, spesso, parodizzare la moda, i vestiti e il normale comportamento “etero”. Livingston esplora una sottocultura della comunità gay in un modo che rischia di sfociare in una rappresentazione esotica, con balli in costume e gare di moda. Resta in dubbio se la regista sia riuscita o meno a evitare questa potenziale trappola. Il senso di collaborazione partecipativa tra regista e soggetto, che caratterizza Tongues Untied e The Times of Harvey Milk, ha in Paris Is Burning un aspetto molto diverso, poiché l’orientamento sessuale della stessa Livingston resta sconosciuto e la rappresentazione serve più ad attirare l’attenzione sul soggetto che sulla relazione tra cinepresa e soggetto.
Tongues Untied (di Marlon Riggs, 1989). Né il lavoro precedente di Marlon Riggs, sulle immagini stereotipate degli afroamericani nella cultura popolare (Ethnic Notions, 1986), né il documentario successivo, sulla rappresentazione razziale in televisione (Color Adjustment, 1991), avevano preparato gli spettatori per Tongues Untied. Il video di Riggs, fortemente personale, poetico e polemico, ha infranto il mito dell’identità gay, che trascende il concetto di razza. Fortemente conscio dell’impatto dell’Aids sui gay in generale e su lui stesso in particolare, Riggs (nella foto con il poeta Essex Hemphill) ha creato una forma di testimonianza visiva paragonabile nel suo impatto a quella scritta di Rigoberta Menchú sulla sua esperienza di ragazza india del Guatemala in Mi chiamo Rigoberta Menchú.
Questi film di stile performativo sul genere e sulla sessualità si allontanano da un programma politico particolare, dalle questioni di carattere sociale o dalla costruzione di un’identità nazionale. Essi, al contrario, ampliano la nostra idea della dimensione soggettiva di vite e di amori “proibiti”. Al pari di molti altri lavori, contribuiscono alla costruzione sociale di un’identità comune tra i membri di una data comunità. Danno visibilità sociale a vicende un tempo considerate esclusivamente o principalmente a livello personale, e testimoniano la presenza di una comune esperienza e la necessità di lottare per superare gli stereotipi, la discriminazione e l’intolleranza. La voce politica di questi documentari rappresenta i punti di vista e le visioni di
comunità che condividono una storia di esclusione e il desiderio di cambiare la società.
Hoop Dreams (di Steve James, Frederick Marx e Peter Gilbert, 1994). Foto pubblicitaria delle “star” di Hoop Dreams. Pur avendo la forma di un racconto di stampo familiare, basato sulla domanda “Ce la faranno i nostri eroi?”, il film è anche un esempio straordinario di quanto i registi si siano dedicati all’approfondimento delle vite dei loro soggetti. Molti film vengono girati in alcuni mesi, ma Hoop Dreams è stato realizzato nell’arco di sei anni. Fotografia concessa da Fine Line Features.
Al loro meglio, generano un senso di tensione tra il film in quanto rappresentazione e il mondo che è alle sue spalle. Ci comunicano un senso di grandezza incommensurata: un film rappresenta il mondo, ma il non detto rimane più grande del detto, poiché resta impossibile comprendere tutto un argomento dentro il solo atto di rappresentarlo. Il mondo rimane un’entità più grande di ogni tentativo di
rappresentazione, ma una sua raffigurazione può portarci a sentire ancora più fortemente questa discrepanza. L’esperienza di una cosa non può essere interamente rinchiusa nella sua spiegazione: risulta sempre maggiore, e noi riusciamo a intuirlo. I documentari, quando si sanno mantenere aperti nei confronti di questa differenza di grandezza tra la loro rappresentazione e quello che rappresentano, permettono anche a noi di restare aperti nei confronti del processo storico reale di creazione di una società e di una cultura, con i suoi valori e la sua morale, la quale non può mai essere ridotta a un singolo stampo o a un sistema fisso.
Ridefinire la politica di identità I documentari cha affrontano il tema delle politiche d’identità si misurano anche con la questione delle alleanze e delle affinità tra i vari gruppi, sottoculture e movimenti. Questo rappresenta un altro passaggio dalle prime costruzioni di identità nazionale al riconoscimento di identità ibride o parziali che raramente ricadono in una sola categoria stabile. Queste categorie ibride, con la loro natura elusiva e mutevole, mettono in discussione anche l’idea stessa che possa esistere una comunità dall’identità fissa e immutata. Tale processo di identificazione serve a creare un’identità e un orgoglio di gruppo, ma rischia anche di produrre un falso senso di sicurezza o di permanenza. Come risultato, esiste un fattore di mescolanza e di diaspora, di esilio e di spostamento, che è in contrasto con i contorni più chiaramente definiti di una politica di identità. Anche gli uomini gay e le donne lesbiche, per esempio, vivono le loro vite in relazione a identità di classe o di razza; gli ebrei vivono la loro appartenenza etnica in relazione a identità di nazione, classe e sesso imposte. Persino il modello di una singola identità di base viene messo in discussione dalle novità e dai cambiamenti in atto nella storia moderna, che suggeriscono che tutte le identità sono provvisorie nella loro costruzione e politiche nelle loro implicazioni. Studiare l’identità principale di un ebreo o di un bosniaco, di un uomo di colore o di una donna asiatica significa darvi una dimensione contingente e politica, collegata a uno specifico
contesto storico, evitando ogni nozione di un’identità di gruppo fissa e immutabile. Il senso di confini fluidi e incerti, che non possono essere categorizzati in identità chiare, è diventato anch’esso oggetto di rappresentazione documentaristica. Questa complessità è ben illustrata da due film che raccontano i travagli di alcuni dei giovani sudanesi fuggiti dal loro Paese provato dalla guerra per giungere finalmente negli Stati Uniti: Lost Boys of Sudan (I ragazzi perduti del Sudan, 2003) e God Grew Tired of Us: The Lost Boys of Sudan (Dio si è stancato di noi: i ragazzi perduti del Sudan, 2005). Le loro identità nazionali, tribali, linguistiche e religiose sono rimosse nel momento in cui cominciano una nuova vita di “africaniamericani”, non pienamente accettati dalla comunità afroamericana e nemmeno dagli americani bianchi. Il primo, Lost Boys of Sudan, è più duro nella descrizione del senso di disorientamento, solitudine e discriminazione che i ragazzi affrontano con risoluta buona volontà e pazienza. God Grew Tired of Us adotta un tono più morbido, sollevato, esemplificato forse anche dal fatto di aver scelto la voce di Nicole Kidman per fornire un commento attento a rassicurare più che a denunciare qualcosa. Con uno stile cinematografico molto più riflessivo, Chris Marker esamina l’esperienza dello spostamento e dello straniamento nel suo complesso film Sans soleil. Una voce femminile legge delle lettere scritte da un regista itinerante, Sandor Krasna, la cui esperienza è stranamente simile a quella di Marker. Scorrono immagini tra Africa, Groenlandia e Giappone mentre “Krasna” cerca di trovare un senso nelle interrelazioni globali tra nazioni e persone e nei suoi incontri frammentati in molti anni e molti film. L’opera si rifiuta di identificare una tesi concreta e men che meno vuole “tirare le somme”. Cerca invece di comunicare le esperienze soggettive di crudeltà e innocenza, luogo e spaesamento, memoria e tempo che caratterizzano il nostro passaggio attraverso il presente. Il film di Trinh Minh-ha Surname Viet Given Name Nam adotta una tesi dello stesso tipo riguardo l’instabilità delle categorie. Con il suo insieme complicato di fatti e di finzione,
di scene reali e ricostruite, di interviste scritte e spontanee, il film ci sprona a ripensare il nostro concetto di documentario come mezzo per comunicare informazioni in modo aproblematico. La pellicola ci spinge anche a mettere in discussione la nostra consapevolezza di conoscere una persona, come in questo caso con le donne vietnamite in Vietnam e negli Stati Uniti. Trinh, come Marker, vuole farci capire che ogni affermazione di conoscenza che possediamo ci è arrivata attraverso il filtro della forma con cui l’abbiamo acquisita. Lo stile delle interviste inscenate con donne del Vietnam ci dà l’idea di una performance ben diretta attraverso l’uso di luci e composizione, della sovrimpressione della trascrizione di ciò che le donne dicono sopra le immagini, e attraverso il modo lento e preparato con cui dicono, o recitano, i loro commenti. Lo stile delle interviste fatte con le stesse donne ma nei loro ruoli “veri” di donne di San José, in California, ha invece la spontaneità di interazione trovata in documentari partecipativi classici come Chronique d’un été o Roger & Me, data dall’utilizzo di luce naturale, inquadrature meno formali e più spontanee, dalla mancanza di parole sovrapposte alle immagini e dal modo più veloce e impreparato in cui le donne parlano. Il risultato, tuttavia, non serve a dimostrare che le scene di San José sono “vere” mentre le interviste in Vietnam sono “false”, ma piuttosto a mettere in mostra due modi diversi di rappresentazione con i quali possiamo accedere al mondo reale. Le categorie e i concetti sono nostre stesse creazioni sociali, a volte utili, a volte controproducenti. Le persone, gli attori sociali, si spostano attraverso queste astrazioni (compresi i concetti di identità personale e collettiva) in modi che risultano troppo semplificati se ridotti in categorie ben definite. Non è una coincidenza che le donne in Surname Viet Given Name Nam provengano dal Vietnam ma appartengano ora a una comunità di immigrati, che è parte di una diaspora conseguente a una guerra: identità ibride, alleanze provvisorie, e una tensione tra passato e presente tolgono sicurezza a molte categorie fisse, comunicando un senso inquietante di incompletezza. Trinh cerca di farci capire questo senza dover
creare un’altra categoria per spiegarcelo. È, tuttavia, una spiegazione che guarda alla vita degli immigrati negli Stati Uniti in modo meno critico di quanto non faccia nei riguardi della vita in Vietnam: nonostante l’incombente e diffusa oppressione sociale, là non c’è ombra di razzismo; si potrebbe pensare che l’esatto opposto accada a San José – paese pieno di opportunità dove però il razzismo persiste – ma nel film questo aspetto non viene esplorato. Anche i film riflessivi possono presentare dei punti cechi in merito a ciò che danno per scontato.
Surname Viet Given Name Nam (di Trinh Minh-ha, 1989). Un altro utilizzo dei “sottotitoli”. Trinh sovrappone una trascrizione delle parole pronunciate dalla persona intervistata nello stesso momento in cui vengono dette. Questa tecnica crea una separazione nella nostra attenzione e serve anche a farci percepire ancora più distintamente l’artificiosità delle interviste: la scena sembra meno “naturale” quando la regista modifica le convenzioni a cui siamo abituati. Fotografia concessa dalla regista.
Con un tono simile ma più personale, Journal inachevé di Marilu Mallet sottolinea l’esperienza di esilio dalla sua madrepatria, il Cile, da cui è scappata dopo il crollo del governo Allende e l’inizio della dittatura del generale Pinochet. La regista deve imparare il francese e adattarsi alle usanze del Québec. Deve anche imparare l’inglese e usarlo nella sua relazione con il marito di origine australiana, il
regista canadese Michael Rubbo. Mallet prova ogni giorno sentimenti di perdita e solitudine, che l’allontanano da quel ramo del femminismo che ritiene necessaria un’identità nazionale stabile per affrontare la questione della discriminazione sessuale. C’è una separazione netta che divide Mallet da coloro che si inseriscono in altre categorie sociali. L’identità, sembra, dev’essere negoziata attraverso le categorie tanto quanto, se non di più, al loro interno. In un confronto più diretto con l’esilio e con il passato, un altro regista cileno, Patricio Guzmán, ritorna in Cile dopo la caduta della dittatura repressiva del governo Pinochet. Guzmán aveva già realizzato il potente documentario The Battle of Chile (La battaglia del Cile, 1975-1977-1979), sull’ascesa di Salvador Allende, il primo presidente socialista democraticamente eletto in Sud America. Ma, l’11 settembre 1973, Allende viene deposto e ucciso e Guzmán fugge in esilio. Chile: Obstinate Memory è la storia del suo ritorno. Il suo scopo è esaminare gli effetti degli oltre trent’anni di dittatura militare sul Paese, e in particolare sul modo in cui la storia della nazione è stata tramandata, distorta o dimenticata. Il film è un’esplorazione appassionante di questo tema, attraverso l’utilizzo di interviste a chi partecipò all’ascesa di Allende e a più giovani generazioni di cileni che non hanno nessuna conoscenza o memoria diretta di quegli avvenimenti. Guzmán ci ricorda che la memoria stessa è un’arena di lotta politica nel momento in cui diverse forze politiche si fronteggiano per scrivere la storia ufficiale di quello che è accaduto nel passato e del modo in cui esso ha dato forma al presente. Questo schema di alcuni dei modi con cui il documentario rivela una sua voce politica si è concentrato sull’idea di comunità. Ha affrontato: - la costruzione di un’identità nazionale in termini di melting pot omogeneo fino agli anni Cinquanta e primi Sessanta; - le sfide di questa costruzione associate a un confronto politico (attivismo operaio, proteste contro la guerra, rivendicazione di diritti civili) negli anni Sessanta e Settanta;
- la nascita di una politica d’identità che ha dato voce alle minoranze negli anni Settanta e Ottanta e, infine, - i rischi di queste stesse categorie e identità, in seguito a eventi catastrofici come traumi, esili o diaspore negli anni Novanta e oltre. Questo quadro è fin troppo schematizzato per poter essere usato come una storia completa della rappresentazione politica del documentario. Fa intuire come la scelta di adottare una data modalità di rappresentazione e un dato argomento per rappresentarlo dipenda non solo dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti di estetica, ma anche dalla relazione con un contesto storico più ampio. Il nazionalismo e le questioni transnazionali come il riscaldamento globale, le politiche d’identità, la diaspora, le mescolanze e l’esilio non nascono dal documentario ma più in generale dalla società. I registi di documentari cercano di trovare i mezzi per rappresentare queste questioni in modi che sappiano mantenere l’idea della loro importanza per coloro che le vivono.
Questioni sociali e ritratti personali Due elementi di interesse caratterizzano la voce politica di molti dei film discussi in questo capitolo. Si tratta di caratteristiche che presentano uno spettro di possibilità più ampio che la sola scelta tra due soluzioni e possono essere trovate in tutte le sei modalità di rappresentazione documentaristica. Possiamo chiamarle interesse per le questioni sociali e interesse per i ritratti personali. I documentari sulle questioni sociali possono essere associati alla modalità espositiva e agli esordi del documentario, mentre il ritratto personale può essere associato alla modalità osservativa e partecipativa e ai dibattiti contemporanei sulla politica d’identità. Anche se esiste una base di verità in questa generalizzazione, c’è un notevole grado di diffusione di entrambi questi interessi in tutto il campo della rappresentazione documentaristica. I documentari sulle questioni sociali affrontano problemi pubblici da un punto di vista sociale. Alcuni individui reclutati
per il film spiegano o danno la loro opinione sulla questione. Why We Fight, per esempio, si basa sulla voce fuori campo di Walter Huston per guidarci nelle complessità della Seconda guerra mondiale. Nessun individuo che compare nel film si eleva al livello di un personaggio ben sviluppato. Con un tono radicalmente differente, The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear (Il potere degli incubi: l’ascesa della politica della paura, 2004), di Adam Curtis, è un riesame sbalorditivo del concetto di Stato-nazione e delle politiche di chi ha utilizzato da un lato l’esca del fanatismo, in particolare nel Medio Oriente, e dall’altro la paura del terrorismo, principalmente in Occidente, per impostare programmi antidemocratici. Curtis si affida a uno stile di montaggio simile a quello di Why We Fight, ma utilizzando asserzioni e accostamenti ancora più forti e fatti per tenere incollati allo schermo. Gli individui che hanno giocato un ruolo fondamentale nel promuovere una politica dell’odio e della paura ottengono una notevole attenzione, ma solo a causa del ruolo politico che hanno ricoperto, non in quanto soggetti completamente delineati. Talvolta, uno o due soggetti diventano la porta d’accesso per affrontare temi sociali. In questo caso, può esserci uno sviluppo del personaggio ma è spesso minimo, poiché la sua primaria importanza sta in quello che dice a proposito dell’argomento più ampio. Per esempio, The Fog of War: La guerra secondo Robert McNamara, di Errol Morris, vincitore dell’Oscar nel 2003, racconta molto della storia della guerra del Vietnam, ma esclusivamente dal punto di vista di Robert McNamara, che guarda indietro al suo ruolo di segretario della Difesa. Lo spettatore apprende solo alcuni fatti fondamentali di McNamara come persona, e moltissimo invece di come vede ora ciò che ha fatto a quei tempi. In modo simile, Taxi to the Dark Side (2007), di Alex Gibney, che ha vinto l’Oscar nel 2007, racconta come le decisioni prese ai livelli governativi più alti rispetto all’uso della tortura, secondo la definizione della Convenzione di Ginevra, abbiano cambiato la vita di un detenuto come Dilawar, un tassista che non ha mai avuto nulla a che fare con il terrorismo. Noi spettatori sappiamo pochissimo della vita di Dilawar, ma conosciamo nei particolari tutte le azioni intraprese, dalla Casa Bianca fino ad
Abu Ghraib, che portarono alla sua morte. In entrambi i casi, il tema più ampio ha la precedenza sulle complessità delle vite individuali dei personaggi principali. I documentari di ritratto personale si concentrano invece sui soggetti più che sui temi sociali. Al loro meglio, rivelano gli uni attraverso gli altri. È un altro modo di passare dal particolare all’universale. (Alcuni ritratti personali, o biografie, assoggettano l’aspetto politico a un’idea di soggetto che è un’entità autosufficiente e autodeterminata.) I film illustrati qui dimostrano un profondo legame tra sfera personale e politica, mentre i documentari sulle questioni sociali tendono a dare per scontato che meritino la nostra attenzione per motivi propri: la sfera personale resta qualcosa di privato e proibito nel momento in cui il nostro io pubblico viene assorbito dal tema che si affronta. Film come Az Örvény di Péter Forgács, Tongues Untied di Marlon Riggs o Trouble the Water di Tia Lessin e Carl Deal occupano una zona di confine tra gli estremi di entrambi gli interessi: si dipanano chiaramente all’esterno, partendo dai personaggi e andando verso questioni più ampie, ma ritraggono anche i protagonisti con cura notevole. Nei documentari di ritratto personale, se più ampi temi sociali sono evocati implicitamente nel film essi restano sullo sfondo. Gli individui ritratti nel film testimoniano o sperimentano implicitamente la questione di fondo, senza necessariamente identificarla. Nanuk l’eschimese, per esempio, si basa sul ritratto che Flaherty costruisce di Nanuk e della sua famiglia per darci un senso di come sopravvivere alla dura realtà quotidiana della cultura eschimese. Saltando in avanti di più di ottant’anni, Kimberly e Scott Roberts vivevano nel nono distretto di New Orleans e Kimberly aveva appena comprato una videocamera quando arrivò l’uragano Katrina. Trouble the Water incorpora una gran quantità del materiale girato da lei nel racconto di come quella coppia e i loro amici sopravvissero all’uragano. Il film è meno critico verso l’amministrazione Bush di quanto lo sia When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts di Spike Lee (Quando si ruppero gli argini: un requiem in quattro atti, 2006), ma ciò che i protagonisti devono fare da soli rispetto a ciò che le
agenzie governative non riescono a fare produce una critica devastante. Eppure, il film è prima di tutto un ritratto di due persone e di come sopravvivono. In modo simile, Nobody’s Business e Intimate Stranger raccontano le complesse e affascinanti storie, rispettivamente, del padre e del nonno del regista, Alan Berliner. I membri della famiglia Berliner erano ebrei immigrati negli Stati Uniti, ma le due storie non affrontano in maniera diretta il più ampio fenomeno migratorio, anche se i valori e le azioni del padre e del nonno continuano a evocare esperienze condivise da molti altri con un simile background. Portrait of Jason di Shirley Clarke ci permette di scoprire gli strati di recitazione e di negoziazione tra la regista e il suo soggetto, Jason, un travestito di colore filmato durante un solo, lungo incontro. Le interazioni della regista con quest’ultimo e le confessioni sincere di Jason rivelano problemi di sesso e razza, e la complicità della regista con ciò che avviene davanti alla cinepresa, in modi sconosciuti a molti film osservativi. Clarke ha confermato quello che Jean Rouch ed Edgar Morin avevano mostrato in Chronique d’un été: la relazione tra regista e soggetto è una parte vitale dell’atto di rappresentazione. Il film propone un ritratto del suo soggetto e del regista e, attraverso di loro, delle problematiche legate all’intercultura e alle politiche di genere negli anni Sessanta.
Trouble the Water (di Carl Deal e Tia Lessin, 2008). Scott Roberts, una delle due persone ritratte nel film, ha disperatamente bisogno di una casa dopo l’uragano Katrina. Qui affronta un’unità della Guardia Nazionale che vieta, a lui come ad altri, di entrare in una scuola abbandonata. Non sfugge a molti spettatori l’ironia del fatto che, ai primordi del movimento per i diritti civili, il presidente Kennedy aveva ordinato alla Guardia Nazionale di assicurare a tutti i bambini afroamericani il libero accesso alle scuole pubbliche in Alabama che una volta erano aperte solo ai bianchi. Fotografia concessa da Zeitgeist Film.
Venticinque anni dopo, Silverlake Life: The View from Here offre un toccante autoritratto di Mark Massi e Tom Joslin, in quello che era nato come un film amatoriale di quest’ultimo. Allo stesso tempo, ci dà un’idea della devastazione subita da milioni di persone a causa del virus dell’Aids. Quando Joslin, il regista, muore, il progetto è completato da Mark Massi e da un amico, Peter Friedman. Il soggetto di Joslin, Mark Massi, diventa il regista, e il regista, Tom Joslin, diventa il soggetto. Questo cambiamento rivela degli aspetti di entrambi gli individui che di solito sono mascherati dalla separazione dei ruoli. Attraverso il complesso ritratto di una relazione d’amore interrotta bruscamente dall’Aids, il film solleva questioni più ampie ma solo in maniera indiretta.
Two Spirits: Sexuality, Gender and the Murder of Fred Martinez (di Lydia Nibley, 2009). Questa foto storica è una delle prove utilizzate nel film per descrivere in che modo gli individui che si identificano sia come uomini che come donne siano una categoria che gode di altissima considerazione nella cultura Navajo tradizionale. Il loro status di persone rispettabili li colloca in una posizione molto diversa da quella in cui si trovano gay, lesbiche, bisessuali e transessuali nella cultura contemporanea. Fotografia concessa dalla regista.
Non tutti i documentari si possono far rientrare in una categoria piuttosto che nell’altra. Un numero notevole di film esplora in prima istanza temi sociali più vasti, ma lo fa dal punto di vista specifico di uno o più individui. Documentari performativi come History and Memory, Tongues Untied e Who Killed Vincent Chin? affrontano rispettivamente l’esperienza dei campi di internamento per giapponesi negli Stati Uniti e le sue ripercussioni, il crocevia di identità sessuali e razziali, e la mescolanza di razzismo, sessismo e xenofobia
che portarono alla morte di un uomo. Lo fanno attraverso punti di vista fortemente personali, proprio come The Fog of War: La guerra secondo Robert McNamara rivisita la guerra del Vietnam ma solo come viene ricordata e spiegata da Robert McNamara, unico soggetto del film. Two Spirit: Sexuality, Gender and the Murder of Fred Martinez (Due-spiriti: sessualità, genere e l’omicidio di Fred Martinez, 2009) affronta lo sconosciuto fenomeno di individui che nel contesto della cultura nativa americana si vedono sia come uomini che come donne. Il film si sviluppa intorno al ritratto di Fred Martinez, un giovane Navajo che si vede anche come una ragazza. Egli venne ucciso durante un agguato omofobico quando era ancora un adolescente. Attorno alla storia della vita di Fred la regista Lydia Nibley intesse un commento che da un lato la collega a quella dei bisessuali e dei travestiti nella cultura americana e dall’altro spiega come dei soggetti che possiedono “due spiriti” fossero riveriti come sciamani e veggenti nella cultura tradizionale Navajo. Il loro status elevato di individui che venivano richiesti per specifici bisogni nel tempo passato non si può comparare con quello di soggetti che hanno un simile orientamento di genere nella cultura contemporanea, che sia nativa americana o meno. Il ritratto intimo di Fred innesca una disamina della repressione a cui spesso vanno incontro persone che non si conformano alle norme sociali. Altri film adottano una simile strategia. Born into Brothels traccia il profilo di un gruppo di bambini le cui madri fanno le prostitute in India, evidenziando gli sforzi personali della regista per aiutarli. Lo spettatore finisce per conoscere molto bene i ragazzini e la regista Zana Briski, ma tutto quello che apprende concerne la più ampia questione di come garantire una possibilità dignitosa di vita felice a dei bambini svantaggiati. Trouble the Water si concentra sul fallimento del governo, a tutti i livelli, nel rispondere in modo efficace all’allarme causato dall’uragano Katrina, ma lo fa prima di tutto descrivendo il peso che questo fallimento ha sulle vite dei due protagonisti, Kimberly e Scott Roberts. La selezione dei personaggi, che presentano una complessità psicologica ma le cui esperienze descrivono in maniera significativa anche temi
sociali più ampi, combina le tendenze di discussione sociale e di ritratto personale per arrivare a un efficace ibrido utilizzato da molti documentaristi. Le differenze tra questi due principali elementi di interesse sono rappresentate nella tabella 8.1. Compito dei film documentari è muoverci verso un’opinione o un punto di vista riguardante alcuni aspetti del mondo. Questo scopo richiede una particolare attenzione verso le tre “c” del credibile, convincente e coinvolgente. Attirare la nostra attenzione verso quei problemi che ci uniscono e dividono come popolo e mostrare degli individui che testimoniano il modo in cui questi problemi prendono forma nelle loro vite sono le due scelte più frequenti operate dai registi. I film che combinano queste due tendenze indicano che siamo di fronte a un ampio spettro di possibilità più che a una scelta in termini di netta contrapposizione. Attraverso questo spettro il film adotta una voce retorica che da un lato ci fa chiedere che cosa è accaduto e che cosa dovremmo fare e dall’altro ci fa interrogare sulla questione della forza e della debolezza degli individui. Ogni approccio pone al regista dei diversi problemi etici su come affrontare la domanda basilare “Che cosa fare con le persone?” e ognuno si misura con il dibattito politico da un angolo particolare. Insieme ci ricordano che se affrontiamo una questione dal punto di vista dell’individuo o della società nel suo insieme, o da un punto che sta da qualche parte in mezzo tra i due, è nella relazione tra individuo e società che le questioni di potere e gerarchia, di ideologia e politica si esprimono con più forza.
Strange Fruit (di Joel Katz, 2002). Billie Holliday non aveva paragoni quando cantava e Strange Fruit è la sua canzone più conosciuta e più potente. Ed è diventata anche un lamento di grande impatto per tutte le vite perse in quella orrenda pratica che era il linciaggio. Katz, in questo film memorabile, fonde con maestria il ritratto personale di Billie Holliday e di Abel Meeropol, che scrisse la canzone, con quello della realtà sociale di cui la canzone parlava. Fotografia di Charles Peterson, per gentile concessione di Don Peterson. Tabella 8.1. Due elementi di interesse nel documentario Documentari su questioni sociali
Documentari di ritratto personale
Voce autorevole del regista, più voce di testimoni ed esperti a supporto di quanto viene detto. Il regista interagisce con i soggetti in merito alla questione sociale. Può basarsi fortemente sulla retorica per coinvolgere o convincere lo spettatore
Voce degli attori sociali (persone) che parlano di se stessi invece di rappresentare una causa o un tema sociale. Il regista interagisce con i soggetti in modo più personale, anche per negoziare la relazione. Può basarsi fortemente sullo stile per coinvolgere lo spettatore
Discorso sobrio. Lo stile è subordinato al contenuto; il contenuto è ciò che conta: il mondo reale nella sua esistenza, presente o passata
Discorso poetico o soggettivo. Lo stile conta tanto quanto il contenuto; la forma è ciò che conta: vedere il mondo da una prospettiva particolare
Accento su una conoscenza non esteriore e concettuale e persistente rilevanza dei problemi sociali e degli avvenimenti storici
Accento su una conoscenza rappresentata e collocata, valore durevole di singoli momenti e di esperienze soggettive
Questioni pubbliche
Momenti privati
Il diritto a sapere o a servire un bene più grande guida la ricerca della conoscenza
Il diritto alla privacy e il confine tra personale e politico sono stati tenuti in attenta considerazione
I personaggi acquisiscono una minima profondità psicologica rispetto all’indagine di concetti o problemi di maggiore portata
I personaggi sono portatori di una considerevole profondità psicologica: problemi di più vasta portata possono emergere in maniera implicita o esplicita
Gli individui sonospesso rappresentati come stereotipi (rappresentativi di una categoria più ampia), vittime, esperti o testimoni
Gli individui sono spesso rappresentati come unici (particolari), mitici, carismatici
Massima attenzione all’argomento, al problema e al concetto, che vengono nominati in maniera esplicita: sessismo, riscaldamento globale, Aids ecc.
Attenzione alle caratteristiche e alle sfide poste da un soggetto, spesso con un riferimento indiretto o implicito al problema di fondo
L’accento sulla missione o scopo sociale del regista è più importante della padronanza dello stile o della sua personale capacità di esprimersi
L’accento sullo stile del regista o sulla sua capacità di esprimersi sono più importanti della sua missione sociale
Il regista, o il suo surrogato rappresentato dal commento fuori campo, è presente in un universo onnisciente e trascendente separato dal mondo dei soggetti o attori sociali del film. Le interviste, se ci sono, servono a soddisfare i bisogni di questo punto di vista onnisciente
Il regista è presente dentro lo stesso universo sociale e storico dei soggetti o attori sociali con cui interagisce. Queste relazioni (in particolar modo le interviste) possono essere un elemento chiave del film
Presenta solitamente la struttura problema/soluzione; spesso offre delle spiegazioni ad argomenti precisi (povertà, stato sociale, guerra, ingiustizia sociale, danni all’ambiente)
Presenta solitamente il problema, la situazione o il soggetto senza offrire una soluzione o un definitivo senso di chiusura; spesso invita al ragionamento o all’empatia (in occasioni di crisi, esperienze particolarmente intense, maturazione, crescita o cambiamento personale, effetti di un’esperienza)
Accento sul risvolto drammatico del trovare una soluzione praticabile per risolvere un problema comune
Accento sul risvolto drammatico insito nello sperimentare la realtà da un punto di vista individuale e soggettivo
Esempi: Before Stonewall, Esempi: Antonia: A Portrait Berlino: Sinfonia di una of a Woman, Bontoc Eulogy, grande città, The City, Enron - Una storia americana,
L’economia della truffa, Eyes on the Prize, Harvest of Shame, In the Year of the Pig, Una scomoda verità, An Injury to One, Ilha das flores, Las Hurdes, The Life and Times of Rosie the Riveter, L’uomo con la macchina da presa, Midnight Movies, Notte e nebbia, The Power of Nightmares, Taxi to the Dark Side, This Film is Not Yet Rated, Tribulation 99, Ways of Seeing (I-V), Why We Fight
Derrida, Dont Look Back, Fast, Cheap and Out of Control, Hôtel Terminus, Man on Wire, Metallica: Some Kind of Monster, Murderball, My Architect, Nanuk l’eschimese, Portrait of Jason, Primary, Ryan, S21, Salesman, Sherman’s March, Silverlake Life, Standard Operating Procedure, Tarnation, The Wild Parrots of Telegraph Hill
Coda Certi documentari cercano di spiegarci alcuni aspetti del mondo. Analizzano problemi e propongono soluzioni. Vogliono ottenere il nostro sostegno per una posizione o per un’altra. Altri documentari ci invitano a capire meglio alcuni aspetti del mondo. Osservano, descrivono o rievocano poeticamente delle situazioni e delle interazioni. Cercano di arricchire la nostra comprensione di alcuni aspetti della realtà storica attraverso la loro rappresentazione. Rendono meno semplice la nostra adesione a certe posizioni minando le nostre certezze con complicazioni e dubbi. Abbiamo bisogno di spiegazioni per determinare le cose. Se sappiamo la causa della povertà o degli abusi sessuali, dell’inquinamento o della guerra, possiamo prendere delle misure per affrontare il problema. Abbiamo bisogno di comprensione, empatia e osservazione per capire le implicazioni e le conseguenze di ciò che facciamo. Le azioni si basano su dei valori morali, che sono oggetto di discussione. Le vite dipendono da questo. La comprensione, come la prospettiva critica, fa lievitare le spiegazioni, le politiche e le soluzioni. Gli attori sociali non sono pedoni, ma persone. I film e i video documentari rappresentano una tradizione che affronta proprio questi aspetti, a volte in modo imperfetto,
a volte egregio. Si muove in avanti e in relazione a tutto il lavoro fatto prima, studiando i problemi, esplorando le situazioni, stimolando gli spettatori in modi che continueranno a istruirci e intrattenerci, commuoverci e smuoverci. La sua storia appartiene al futuro e agli sforzi ancora a venire. Sono questi futuri lavori che arricchiranno una tradizione già esistente e contribuiranno a formare un mondo che dobbiamo ancora creare.
CAPITOLO 9 COME SI PUÒ SCRIVERE EFFICACEMENTE SUL DOCUMENTARIO? Questo capitolo dà per scontata una certa familiarità di fondo con la scrittura di un saggio di cinema. Tutti i testi introduttivi al cinema affrontano questo aspetto ed esistono altri utili manuali di scrittura critica. Il capitolo si concentra soprattutto su un saggio che ha per oggetto il documentario, ma i principi basilari restano gli stessi per quasi ogni argomento di ricerca delle scienze umane. È possibile trovare alcuni suggerimenti per ulteriori approfondimenti, compresi i nomi di manuali introduttivi alla scrittura cinematografica, nella sezione “Bibliografia essenziale” di questo volume. Fondamentale per scrivere un buon saggio è averne chiaro lo scopo. Che può essere un voto o passare un esame, ma, a un livello più specifico, l’argomento richiede comunque un investimento in termini di curiosità, entusiasmo e impegno. Un fine specifico, come per esempio difendere una posizione, avanzare un’opinione o esplorare una problematica, è importante perché un saggio risulti interessante. Fare una semplice recensione di un film, ripetendo ciò che già altri hanno detto, o descrivendone alcune parti senza esprimere un giudizio di valore – in sostanza, non offrendo un punto di vista personale – va a detrimento del saggio stesso. Bisogna trovare un tema o un’idea che tenga vivo il proprio genuino interesse per produrre un buon saggio, e non portare semplicemente a termine un compito. Esamineremeo l’efficacia della scrittura usando un esempio concreto: un saggio su Nanuk l’eschimese. Questa ipotetica traccia invita lo studente a valutare il film e a rispondere di conseguenza: Il documentario affronta la realtà storica dando forma alla sua rappresentazione del mondo da un punto di vista o una prospettiva precisa. Identificate il punto di vista adottato da Robert Flaherty in Nanuk l’eschimese e prendete in
considerazione alcune delle implicazioni che ha per voi, basandovi su ciò che avete imparato sul genere documentario. Date dimostrazione di capacità di analisi dell’argomento, facendo uso all’interno del saggio di almeno tre citazioni. Lunghezza 850-1000 parole. Il primo passo per scrivere un saggio è la preparazione. Vedere Nanuk l’eschimese è la cosa più ovvia, ma è anche importante vederlo più di una volta. La prima volta possiamo perderci nell’esperienza della visione. Possiamo porci delle domande su ciò che vediamo, ma è solo durante la seconda che questo processo di domanda e riflessione su ciò che vediamo acquista rilievo. Per esempio possiamo chiederci: perché Flaherty inizia in questo modo? Che cosa intende fare nel resto del film? Perché termina in quella maniera? In che modo la fine si collega al principio? Che tipo di relazione esiste tra Flaherty, o la cinepresa, e Nanuk? Come sono state montate le scene? Quali scene risaltano in modo particolare e perché? In che modo una scena è collegata a un’altra? Intorno a che cosa ruota la struttura narrativa del film? In che modo Flaherty rappresenta le persone di un’altra cultura? Come le caratterizza o come mostra la loro individualità?
Nanuk l’eschimese (di Robert Flaherty, 1922). Nanuk morde un disco. Si tratta di uno scherzo per la cinepresa o è il modo in cui Flaherty dimostra l’arretratezza del suo soggetto? I due saggi che seguono prendono strade diverse nell’interpretare questo documentario classico.
Domande come queste possono essere poste in base a un’idea specifica che già abbiamo in mente, o possono essere solo delle considerazioni preliminari per svilupparla. In entrambi i casi, esse ci aiutano ad accrescere la nostra consapevolezza dell’approccio distintivo di Flaherty. Alcuni spettatori preferiscono prendere appunti durante la prima visione del film; altri ne sono distratti. È comunque importante farlo mentre si guarda un film per avere il materiale su cui basare la propria analisi critica. In generale, gli appunti possono comprendere: - l’ordine cronologico delle scene (che cosa accade prima, che cosa in seguito e così via); - i tipi di inquadratura (grandangolo, teleobiettivo, carrellata, zoom, composizione del quadro ecc.); - le tecniche di montaggio (montaggio in continuità, inquadrature in soggettiva, accostamenti insoliti o stacchi di tempo e spazio);
- il ruolo dei testi parlati (dialoghi, commento) o scritti (titoli, sottotitoli, intertitoli), della musica o degli effetti sonori in una scena; - lo sviluppo dei personaggi: come il film sceglie di potenziare la nostra sensazione di vedere dei personaggi con un’individualità e una personalità (angolazioni di ripresa, montaggio, struttura delle scene, selezione di ciò che viene detto, possibilmente qualche accenno a quel che rimane non detto o viene omesso); - le tecniche retoriche (in che modo il film si rende o non si rende credibile, convincente e coinvolgente); - modalità e modelli (in che modo il film si organizza in base a modalità di rappresentazione e modelli e in che modo essi lo modulano); - altre qualità particolari, per esempio quanto sia tangibile la presenza del regista in scena o la visione politica, se presente, che il film comunica; - risposte estetiche ed emotive a specifiche caratteristiche del film e cosa sembra innescarle in termini di tecnica o argomento. Prendere appunti è un compito selettivo. Possiamo tenere conto solo di limitati aspetti di un film. Possiamo scegliere di focalizzare la nostra attenzione sullo stile delle riprese o sul montaggio poetico, sulla presenza del regista o sullo sviluppo degli attori sociali come personaggi, ma non possiamo concentrarci contemporaneamente su ogni aspetto. Gli appunti forniscono una registrazione di alcuni dei nostri interessi. Applicati a un saggio, forniscono la fonte per i punti che vogliamo sviluppare. Ipotizziamo che due studenti, Marco e Roberta, abbiano visto Nanuk una sola volta e si siano formati un’opinione iniziale. Discutiamo del processo di creazione di un testo di critica. Marco: «Che cosa pensi di Nanuk?». Roberta: «Non mi è piaciuto». Marco: «Oh, a me è piaciuto».
Questo tipo di commento risulta a malapena un tentativo incerto di risposta sul film. È comunque un valido punto di partenza per una riflessione. Ogni spettatore ha una reazione forte che può dare una motivazione alla scrittura di un testo. Essa fornisce uno scopo: difendere un primordiale sentimento nei confronti del film. Per fare ciò, tuttavia, occorre dare alla prima reazione emotiva la forma di un’analisi critica che sia supportata dalle giuste argomentazioni per dimostrare il proprio punto di vista. A questo punto i sentieri si separano in due direzioni. Una porta a una recensione, l’altra a un saggio critico. Un modo utile per distinguere i due tipi di testo è che il recensore scrive per coloro che non hanno ancora visto il film, come una specie di guida per il consumatore. Il saggista scrive per coloro che l’hanno visto, come parte di un confronto analitico. Sebbene alcuni recensori professionisti pongano delle questioni che contribuiscono al dialogo critico tra coloro che hanno visto il film, raramente i saggi critici hanno la forma di recensioni: il professore ha già visto il film. La traccia assegnata su Nanuk fa sì che ci si aspetti un saggio che sia parte di un confronto critico tra coloro che hanno già visto il film. Una prima conseguenza è che non ci sarà bisogno di fare un riassunto della trama. Quando in un testo critico, contrariamente a quanto accade in una recensione, iniziamo a riassumere il film o a descrivere una scena, lo slancio analitico del saggio si blocca. I riassunti sono in gran parte ridondanti poiché il lettore ha già visto il film e, una volta iniziati, chiedono a chi scrive di continuare ad addentrarsi sempre più nella storia, fino a che tutta la trama è chiaramente svelata. Questo capovolge le priorità. Per la critica, è più importante sostenere un’opinione e fornire prove a supporto attraverso scene del film che riassumerne la trama e poi apporvi un commento critico complessivo. La priorità assoluta va data allo sviluppo di un’argomentazione che comunichi i vostri pensieri ponderati. Descrivete scene o tecniche a sostegno della vostra argomentazione ma evitate riassunti che non fanno progredire il vostro punto di vista. Le dichiarazioni iniziali di amore e odio di Marco e Roberta sono opinioni prive di argomentazioni (non hanno ancora
fornito nessuna prova a supporto) e non possono essere considerate come una critica. Approfondiamole un po’: Marco: «Mi è piaciuto il modo in cui Flaherty ha mostrato elementi della cultura eschimese che non avevo mai visto prima». Roberta: «Non mi è piaciuto il modo in cui Flaherty ha fatto comportare Nanuk come il classico primitivo che sa tutto sulla natura ma non capisce come si usa un grammofono». Ora si comincia a ragionare. Ogni studente ci ha spiegato perché ha apprezzato o detestato il film. Marco ha iniziato a indicare le qualità di Flaherty che egli ammira: da qui potrebbe iniziare a riflettere su che cosa Flaherty mostra e come lo mostra, e su quali aspetti della rappresentazione meritino di essere lodati. Roberta ha iniziato a collegare Flaherty a una serie di rappresentazioni di parte, in cui le culture tradizionali vengono presentate come simili alla nostra ma più arretrate o primitive: da qui potrebbe iniziare a riflettere su cosa Flaherty fa per dare questa sensazione e come il suo stile vi contribuisca. Le note di visione del film aiuteranno questo processo di riflessione. Marco e Roberta possono ora scrivere un enunciato introduttivo o tracciare delle linee guida dei loro testi e vedere di nuovo il film alla ricerca di scene e momenti che supportino la loro tesi. Possono anche condurre delle ricerche ulteriori, ma prima vediamo come possono elaborare le loro argomentazioni iniziali attraverso un enunciato e poi in che modo un lavoro di ricerca possa aiutarli a sostenere lo sviluppo delle loro idee in forma scritta. Lo scopo dell’enunciato o delle linee guida è indicare in maniera concisa quale sarà l’argomentazione o il punto principale su cui il saggio verterà. Marco: «Mi è piaciuto il fatto che Flaherty adotti il punto di vista di una sola famiglia per farci comprendere la cultura eschimese. Questa scelta è particolarmente utile perché siamo già a conoscenza dei ruoli familiari, ma non dei problemi tipici e specifici di questa famiglia. Il regista ci coinvolge principalmente con Nanuk, ma mostra anche come i suoi figli comincino a capire le usanze eschimesi e ci fa vedere come
Nyla, la moglie di Nanuk, contribuisca al benessere familiare. Flaherty mostra le scene con naturalezza, senza affrettarne la conclusione. Il Polo Nord è un ambiente molto aspro e per sopravvivere gli uomini devono essere molto determinati e abili». Roberta: «Non mi è piaciuto il modo trito in cui Flaherty ha cercato di farci amare gli eschimesi facendoci amare Nanuk. È una maniera banale di affermare che dobbiamo apprezzare le altre culture perché le persone che vi appartengono sono carine e vivaci. È il tipo di immagini che vediamo sempre nelle guide turistiche delle località esotiche. Nanuk agisce in modo impacciato quando Flaherty gli dà l’occasione di interagire con la macchina da presa, come alla stazione commerciale. Si sente più a suo agio quando caccia le foche, ma è quello l’elemento in cui noi ci aspettiamo di vederlo agire con più naturalezza. Flaherty lo tiene al suo posto e lo manovra come se lui fosse la mente e Nanuk il braccio». Già meglio. Queste dichiarazioni ovviamente non sono conclusive ma riescono a dare un’idea dei punti di vista di chi le ha espresse e a indicare quali possono essere le prove portate a sostegno. Saltano qua e là tra gli argomenti e non riflettono ancora nessun tipo di ricerca. Roberta esprime un giudizio anacronistico: giudica male Flaherty perché le ricorda le guide turistiche che ha visto in giro. Queste guide, tuttavia, sono comparse circa ottant’anni dopo il film. Un punto di analisi più corretto sarebbe stato quello di scoprire se esistessero delle guide simili anche all’epoca del film, per capire se potessero avere avuto qualche influenza sull’approccio di Flaherty o sulle strategie di comunicazione relative al film (l’immagine pubblicitaria di Grass nel Capitolo 5 suggerisce in effetti che ci sia stata una certa influenza delle guide turistiche e delle pubblicità sulla promozione dei film negli anni Venti). Entrambi hanno bisogno di un ulteriore approfondimento, ma stanno anche delineando i punti che necessitano di un supporto teorico. Marco cercherà articoli o libri in cui ritrovare il suo apprezzamento per il metodo di Flaherty, mentre Roberta si metterà alla ricerca di materiale che assume un punto di vista molto più scettico rispetto a quel metodo.
Marco e Roberta possono adesso portare avanti le ricerche sulle questioni che vogliono chiarire e approfondire, rivedere il film, o parti di esso, e preparare una stesura completa. Idealmente, la bozza finale avrà bisogno di “riposare” un giorno o due, per poi essere rivista un’ultima volta per individuare i punti deboli, le falle di argomentazione e i refusi. Difetti simili emergono con la giusta distanza che il tempo provvede a dare. Per esempio, le frasi con cui i due studenti hanno cominciato erano «mi è piaciuto» e «non mi è piaciuto». Queste scarne espressioni di apprezzamento o meno possono essere completamente omesse nel momento in cui l’accento si sposta dall’opinione alla considerazione di ciò che il film riesce o non riesce a dire. Potremmo riscrivere la frase di Marco in «Flaherty adotta il punto di vista di una sola famiglia per farci comprendere l’intera cultura eschimese». In questo modo la frase diventa un’affermazione forte riguardo al film e può anche essere usata come dichiarazione della tesi del saggio. Segna l’inizio di una visione critica, che sarà completata da una precisazione della tesi, un approfondimento, e un’organizzazione generale più forte. È qui che il lavoro di ricerca gioca il suo ruolo fondamentale. Fare un lavoro di ricerca vuol dire solitamente utilizzare due diverse fonti per il reperimento del materiale: il web e la biblioteca. Ciascuna di esse offre una ricchezza di informazioni sotto tre forme diverse: - una fonte primaria è il materiale originale, diverso da analisi o descrizioni. Il film stesso è una fonte primaria, come accade con ogni altro materiale che fornisce accesso diretto ai pensieri e alle azioni dei soggetti coinvolti nel film, quali diari, racconti orali o autobiografie. In quanto documenti, questi materiali richiedono analisi e interpretazione; - una fonte secondaria è il corpus di materiali scritti sulla fonte primaria: esso rappresenta il risultato dell’analisi e dell’interpretazione. Questo materiale assume molti diversi punti di vista, proprio come fanno Marco e Roberta. Libri, articoli, recensioni, siti web, blog e altre fonti simili su Nanuk sono tutti fonti secondarie;
- fonte terziaria sono tutte quelle informazioni ricavate dalle fonti secondarie, che sintetizzano, riassumono e divulgano quel materiale, proprio come fanno le voci enciclopediche. Essa può fornire un utile background ma raramente gioca un ruolo decisivo nella stesura concreta del saggio poiché di solito manca di un punto di vista distintivo e ricicla le informazioni prese altrove. La voce Nanuk di The International Encyclopedia of Documentary Film, per esempio, rappresenta una fonte terziaria. Un mirato senso di curiosità fa da guida all’impegno che si applica a ogni tipo di fonte: chi scrive un saggio legge quei materiali con l’idea di ottenere informazioni o conoscenze supplementari per il proprio lavoro. Questo procedimento è molto simile a quello che caratterizza l’attività di recensione di un film. Marco, per esempio, cercherà un lavoro, o parti di un lavoro, che dimostri perché Nanuk meriti rispetto e apprezzamento. Roberta invece andrà alla ricerca di materiale che metta in dubbio il valore del film e aiuti a indicare come i pregiudizi e i limiti culturali di Flaherty abbiano preso forma. Le biblioteche sono un’insostituibile fonte di informazione. Quasi tutto, all’interno di una biblioteca, è stato acquisito in modo selettivo lungo un esteso periodo di tempo. Le fonti secondarie normalmente godono di grande considerazione in quanto si tratta di opere di autori riconosciuti o pubblicazioni di editori di prestigio. Le biblioteche di solito davano accesso ai loro fondi attraverso cataloghi a schede: migliaia di schede, conservate in cassetti su più livelli, che un ricercatore poteva passare al setaccio alla ricerca di autori, titoli o soggetti di interesse. Tutto questo non esiste più. L’accesso avviene ora tramite cataloghi online che contengono le stesse informazioni. Non solo questo è enormemente più comodo, ma significa anche che la biblioteca geograficamente più vicina non è più la sola risorsa: le ricerche si possono effettuare anche in biblioteche molto più grandi e qualunque materiale utile che viene reperito può essere richiesto attraverso il prestito interbibliotecario, acquistato da chi lo vende online o talvolta consultato anche in forma digitale. I consistenti fondi dell’Università della California, per esempio, possono essere reperiti su http://melvyl.worldcat.org.
In maniera più selettiva, quelli dell’Università della California a Berkeley (Ucb) – sia libri che film – possono essere ricercati su http://lib.berkeley.edu. L’elenco include i film conservati al Pacific Film Archive insieme ad appunti di programma e altre informazioni. Allo stesso modo, le ricche risorse della biblioteca dell’Università della California a Los Angeles (Ucla) che comprendono i racconti orali e gli scritti personali di molte figure della storia del cinema, possono essere reperite sul sito della Ucla, http://www.ucla.edu, seguendo il link della biblioteca universitaria. Internet risulta essere uno strumento incredibilmente utile di ricerca. Come appena visto con i cataloghi delle biblioteche online, una vasta quantità di materiale è a portata di click. Il problema principale con internet è che la fonte definitiva di informazioni e il suo carattere permanente non sono mai certi. Un materiale può essere online un giorno e sparire o essere alterato in maniera significativa il giorno seguente. Può essere copiato da un altro sito o da un libro, può essere opera di un utente amatoriale o di un professionista capace; può coincidere con un testo che è stato anche stampato o modificarlo a un livello più o meno esteso. Per questi motivi è consigliabile ricontrollare le informazioni trovate sul web e, nel momento in cui si citano, non segnalare soltanto l’Url (l’indirizzo web dove sono state trovate) ma anche la data in cui il sito è stato visitato. Marco e Roberta potrebbero benissimo trovare lo stesso materiale nel corso della loro ricerca, ma lo useranno in maniera diversa. In generale cercheranno del materiale che dia loro nuove idee o che dia sostegno alle idee che hanno già. La ricerca, talvolta, può segnalare che l’idea iniziale era stata concepita in maniera errata e forse non è più sostenibile. Può incoraggiare un argomento o la modifica dell’argomentazione. Marco e Roberta possono citare direttamente la loro ricerca nel saggio finale o semplicemente assimilarla come informazione che gli fa da sfondo. Un modo tipico di agire è scegliere di citarne un passaggio nel caso in cui esso fornisca un’idea chiara e sintetica, espressa in maniera significativa o importante nel contesto da cui esce. Ciò che qualcuno disse nel 1922 in una recensione di Nanuk, per esempio, può essere riassunto, ma una citazione darà un esempio concreto di come
il film venne inizialmente accolto. La fonte normalmente non viene citata se comunica una conoscenza assodata e delle generalizzazioni o potrebbe essere semplicemente parafrasata nelle parole dell’autore. Possiamo illustrare come potrebbe risultare dal lavoro di ricerca di Marco e Roberta mappando alcuni esiti di ricerche effettuate sia su internet che in biblioteca. Cominciando da internet, potremmo partire con un paio di siti ampiamente consultati: Imdb e Wikipedia. Da soli, essi non sono adeguati. Entrambi sono fonti terziarie, ma possono anche essere un buon punto di partenza dal momento che forniscono informazioni di base e conducono a materiali più sostanziosi di primo e di secondo livello. Essendo un database, Imdb raccoglie informazioni pertinenti sui film, ed essendo un’enciclopedia Wikipedia è una delle fonti di terzo livello più utilizzate del web. Entrambi i siti citano Nanuk l’eschimese. Imdb fornisce alcune informazione di base sulla sua produzione e diverse possibilità di comprarne una copia. Presenta anche dei link a recensioni esterne scritte da critici cinematografici, nonché recensioni scritte dagli utenti del sito. Le recensioni esterne comprendono quella relativamente recente di Roger Ebert, che ha lodato il film, insieme ad altre diciannove recensioni di qualità variabile. Le voci di Wikipedia non sono firmate e non indicano il livello di conoscenza dei loro autori. Correzioni agli errori e revisioni possono esserci in qualunque momento, come un errore può resistere e non essere corretto per un tempo indefinito poiché non esiste una redazione interna a Wikipedia che garantisca che le singole voci siano conformi a specifici standard. Essendo per la maggior parte una fonte terziaria, le sue voci non vogliono avanzare un particolare punto di vista o generare una nuova forma di conoscenza e nemmeno riassumere quella esistente. In questo caso la voce, come ci si aspettava, tratta temi noti. Elenca inoltre numerose fonti di informazione supplementari che possono essere reperite sul web e presenta una barra laterale fornita da Wikipedia che descrive come accreditare le informazioni trovate sul sito: se si fa uso di qualcosa di ciò che è scritto a proposito del film su
Wikipedia è necessario citare l’Url e la data di accesso come segue: Nessun autore [o “collaboratori esterni di Wikipedia”], Nanuk l’eschimese, Wikipedia, l’enciclopedia libera. http://it.wikipedia.org/wiki/Nanuk_l%27eschimese (accesso: 16 giugno 2009) La voce online di Wikipedia, che rappresenta un ampio distillato di altri lavori, si rivela un utile punto di partenza non tanto per quello che dice, ma per quello a cui porta. Tra i riferimenti presenti nell’articolo su Nanuk ci sono alcuni collegamenti esterni: - Nanook of the North su YouTube - scheda su Nakuk l’eschimese dell’Internet Movie Database Ciascuno dei link è cliccabile e rimanda a qualcosa. Seguendo i link si arriva a una vasta gamma di materiali, da Imdb, già citato, a fonti primarie e secondarie. Chi si inoltra in queste ricerche deve usare una certa capacità di discernimento nel determinare il valore e la credibilità di quei materiali. Il principio generale della ricerca sul web vuole che si cominci con alcuni siti promettenti o immettendo su Google il titolo del film o il nome del regista per poi passare al vaglio ciò che emerge, prendendo appunti, copiando le citazioni selezionate e registrando dove e quando si è effettuata la ricerca in questione. Un sito web può non presentare un contenuto di particolare valore ma può rimandare attraverso dei link ad altri siti utili. Una cosa conduce a un’altra e una fortuna inattesa spesso apre tutta una serie di nuove prospettive relative all’argomento trattato. La questione se incorporare materiali specifici nel saggio si porrà più avanti. Per il momento, il punto è trovare informazioni supplementari sul film che supportino un’opinione o una tesi su di esso. La ricerca continua con la consultazione di un catalogo online di una biblioteca. “Investigator”, il catalogo della San Francisco State University, per esempio, fornisce molti titoli di libri quando si inseriscono le parole chiave Nanook of the
North nella barra del titolo e Robert Flaherty come autore o soggetto. Tra questi: - Robert e Frances Flaherty, My Eskimo Friends, “Nanook of the North” - William Rothman, Documentary Film Classics - Daniel Bernardi (a cura di), The Birth of Whiteness: Race and the Emergence of U.S. Cinema - Richard Griffith, The World of Robert Flaherty - Alexander Calder-Marshall, The Innocent Eye - Frances Flaherty, The Odyssey of a Filmmaker - Paul Rotha (a cura di Jay Ruby), Robert Flaherty: a Biography Queste informazioni sono solo una lista di titoli, non una bibliografia, poiché questo vuole essere solo una ricerca ausiliaria sull’argomento. Non tutti quei titoli saranno presi in esame. I lavori consultati saranno annotati con tutti i dettagli bibliografici e, se saranno davvero utilizzati, inclusi nel saggio. È importante prendere nota della collocazione di ciascun volume, in modo da poterlo localizzare all’interno della biblioteca. Per esempio, la collocazione del Documentary Film Classics di Rothman è PN 1995.9 D6 R69 1997. Questo libro, nella bibliografia essenziale in fondo al volume, cita Documenting the Documentary, una raccolta di saggi, a cura di Barry Grant e Jeannette Sloniowski, che prendono in esame i più importanti film documentari della storia. L’antologia include una versione leggermente aggiornata del saggio che appare anche nel volume di Rothman Documentary Film Classics. A questo stadio non è ovvio notarlo, ma si dà il caso che il libro di Daniel Bernardi, The Birth of Whiteness, compare nella ricerca perché include “Taxidermy and Romantic Ethnography: Robert Flaherty’s Nanook of the North”. È un capitolo di The Third Eye: Race, Cinema and Ethnographic Spectacle (Duke University Press, Durham, N.C., 1996) di Fatimah Tobing Rony. Il volume offre accesso allo stesso materiale citato da Bernardi: è una critica
incisiva dell’approccio di Flaherty e quasi sicuramente sarà di grande interesse per Roberta. Le biblioteche solitamente separano le ricerche di libri da quelle di riviste e articoli di giornale. Questi possono essere localizzati utilizzando dei database che contengono riferimenti, e in qualche caso il testo integrale, ad articoli che compaiono nell’elenco specifico di riviste e giornali che quel database raccoglie. Alcuni di essi riguardano le materie scientifiche e le scienze sociali; molti le materie umanistiche e altri comprendono le numerose fonti di articoli su film e registi. Per esempio, una ricerca sullo Humanities Full Text database del titolo “Nanuk l’eschimese” rivela, tra gli altri risultati, il seguente articolo: Titolo: Exploration as construction: Robert Flaherty and Nanook of the North Autore: Grace, Sherrill Nome della rivista: Essays on Canadian Writing Fonte: Essays on Canadian Writing n. 59 (autunno 1996), pp. 123-146 Anno di pubblicazione: 1996 Abstract: parte di uno studio particolare delle rappresentazioni del Nord. La saggista si interroga a proposito della realizzazione e della promozione del film Nanuk l’eschimese di Robert Flaherty, concentrandosi sulla sua ricostruzione del Canada, dell’Artico e della civiltà Inuit. Mette in questione l’utilizzo del termine “documentario”, argomentando come Flaherty abbia creato un “romanzo elegiaco” in cui ricostruire un “altro” etnografico chiamato Nanuk. Grace colloca la sua attività come esploratore/regista nel quadro della più vasta problematica sulla rappresentazione del Canada e del Nord. Soggetto/i: film/film documentari; regioni artiche; scoperte ed esplorazioni; regioni artiche nel cinema; Inuit nel cinema; Nanuk l’eschimese (film).
L’abstract riassume l’argomento alla base del saggio e l’intero saggio si può leggere online. Un passaggio utile potrebbe essere copiato e incollato direttamente nella ricerca (citando la fonte in una nota a piè di pagina). La revisione che opera su Flaherty, alla luce di una comprensione più ampia della ricerca etnografica, potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per Roberta. Un altro database di valore è quello del Fiaf, organizzato dall’International Federation of Film Archives. Una ricerca di “Nanuk l’eschimese” in quel database produce diciannove risultati. Tra questi troviamo un articolo di Richard Leacock, un regista che abbiamo già citato in altre parti di questo libro per il suo lavoro pionieristico nell’ambito del documentario osservativo. Il risultato relativo al suo saggio è: «Film Culture» Leacock, Richard. «Film Culture», n. 79 (inverno 1996), pp. 1-6. In defense of the Flaherty Traditions. Articolo; Illustrazione/i. Numero di collocazione: 48603919 Descrizione del film: LOUISIANA STORY (US, Robert Flaherty, 1948), L’UOMO DI ARAN (Uk, Robert Flaherty, 1934), MOANA (Us, Robert Flaherty, 1926), NANUK L’ESCHIMESE Il titolo suggerisce che Leacock difende Flaherty da chi ha trovato il suo metodo carente; in questo è particolarmente interessante per Marco. Dopo aver considerato in maniera selettiva alcune delle fonti, prendendo appunti e scegliendo i passaggi da citare, Marco e Roberta ritornano alle loro considerazioni primarie per completare la bozza dei loro rispettivi saggi. Marco: “Il grande rispetto e la considerazione umana di Flaherty verso gli altri” Flaherty adotta il punto di vista di una sola famiglia per farci comprendere l’intera cultura eschimese. Questa strategia è uno dei motivi dell’immensa popolarità del film. Un altro può essere il modo in cui Flaherty dà l’impressione di lasciarsi
ispirare dalle azioni di Nanuk e della sua famiglia. Tranne l’introduzione dei personaggi mentre caricano un kayak e alcune prese in giro alla stazione commerciale, Flaherty osserva con rispetto la famiglia di Nanuk che cerca di sopravvivere nel duro clima del Polo Nord. La famiglia di Nanuk ha una forte qualità rappresentativa. La moglie completa le abilità del marito con le sue, come accudire i bambini e preparare il cibo. Nanuk diventa piano piano un ottimo cacciatore. Se nelle prime scene può sembrare un po’ spaesato, questo può essere inteso come un tentativo da parte di Flaherty per farci comunque sentire superiori a questo “selvaggio”, ma non è un espediente che il regista utilizza a lungo. Nanuk può anche mordere un disco come uno sciocco, alla ricerca del suono che emette, ma, se mordere e assaggiare le cose è un’azione di grande importanza per sopravvivere in un ambiente selvaggio, chi è più sciocco, Nanuk che morde o noi che ridiamo di lui? Flaherty prosegue dimostrandoci che l’abilità di Nanuk di procurare cibo alla sua famiglia attraverso la caccia è qualcosa che merita il nostro pieno rispetto. Mordere un disco non sarà accettabile per i canoni di chi vive alla stazione commerciale o nel mondo civilizzato che la stazione rappresenta, ma è una parte normalissima di quello di Nanuk. La scena in cui lui e la moglie masticano i loro stivali di cuoio per ammorbidirli serve da prova della sua saggezza pratica. Mordere le cose può generare informazioni importanti. Flaherty include questa sequenza per mostrarci il nostro errore nell’aver giudicato troppo in fretta. Questo punto i primi spettatori del film lo avevano ben presente, come la prima recensione del «New York Times» ci rivela. L’autore non identificato nota che: Quando Nanuk, il mastro cacciatore e un vero eschimese, si confronta con il tricheco, non c’è alcuna simulazione nella lotta. La vita di Nanuk dipende dal fatto che riesca a uccidere il tricheco, e non c’è nessuna certezza che riesca a farlo. Un giorno potrebbe non farcela. E quel giorno Nanuk morirà. Quindi lo spettatore guarda Nanuk come un uomo che affronta un combattimento che è questione di vita o di morte. E come è
più eccitante questa rispetto a una “battaglia” tra due attori ben pagati che si sparano colpi a salve! (citato nella voce Nanook of the North su Wikipedia inglese: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html? res=9A00E2DB1E3EEE3ABC4A52DFB0668389639EDE; url consultato in data 15 giugno 2009) Chi ha scritto la recensione percepisce il senso di frattura radicale con la fiction che il fatto di filmare fatti reali in luoghi reali innesca. Per quanto Flaherty abbia contribuito a costruire la scena, il rischio era reale ed è proprio Nanuk che lo ha affrontato. Non solo Nanuk ci ricorda di non giudicare troppo in fretta, ma ci impone anche di avere pazienza nell’esprimere un parere su ciò che vediamo. Molte volte Flaherty presenta una scena senza spiegare completamente quello che succede. In questo modo crea una specie di suspense nello spettatore. Essa non si basa solo sulla tensione della ripresa, ma riguarda anche la vita di Nanuk e la sua capacità di sopravvivere grazie ad azioni che non riusciamo subito a capire. Per esempio, quando Nanuk costruisce un igloo, leggiamo da un titolo che c’è ancora una cosa da fare. “Cosa sarà?”, ci chiediamo. Invece di dircelo, Flaherty continua a osservare Nanuk mentre cerca un pezzo di ghiaccio trasparente e lo taglia via. Quando lo mette sul fianco del suo igloo e inizia a limarlo, riusciamo finalmente a capire cosa sta succedendo: sta facendo una finestra per il suo igloo! È questa modesta rivelazione che ha fatto riflettere Richard Leacock, che lavorò con Flaherty in Louisiana Story e in seguito realizzò molti film lui stesso. In un articolo che scrisse nel 1996, disse che «Flaherty era convinto della relativa semplicità del processo sotteso alla realizzazione di un film, che poteva portare a termine tutto da solo con l’aiuto della popolazione locale. A oggi io sono d’accordo con questa sua posizione» (Richard Leacock, In Defense of the Flaherty Traditions, «Film Culture», inverno 1996, p. 1). Questo tipo di regia è uno dei grandi contributi di Flaherty al documentario. Il regista lascia che la cinepresa segua le azioni mentre avvengono secondo il loro ritmo naturale. Noi veniamo a conoscenza del significato degli eventi attraverso la
loro osservazione, invece di avere un significato imposto da titoli, commenti o montaggio. La scena in cui Nanuk fa un buco nel ghiaccio, ci infila una lenza e aspetta è un altro grande esempio. Noi non siamo sicuri di cosa stia facendo, ma quando lo vediamo scagliare la sua lancia nel buco dopo aver visto la lenza muoversi, capiamo la sua bravura di cacciatore, anche se abbiamo impiegato un po’ di tempo a renderci conto che c’era una foca all’altro capo della lenza. Il professor Edmund Carpenter ha scritto che il metodo usato da Flaherty era adatto alla cultura eschimese. Carpenter spiega che un intagliatore eschimese non inizia a incidere l’avorio con l’idea di una statuetta di foca in mente. Esamina prima il pezzo d’avorio, lo rigira e inizia a intagliare senza scopo, cercando di trovare la forma nascosta al suo interno. «Dopodiché la cava fuori dall’avorio: la foca, nascosta all’interno, emerge. Era sempre stata lì: l’artista non l’aveva creata, ma solo aiutata a prendere forma» (Edmund Carpenter, “Notes on Eskimo Art Film”, citato in Arthur Calder Marshall, The Innocent Eye, basato su materiali di Paul Rotha e Basil Wright, Penguin Books, Baltimora, Maryland, 1970, p. 70). Flaherty ci lascia, allo stesso modo, guardare e soppesare le scene, cercando di trovare il significato di una cultura che non conosciamo. Quando, in scene come la finestra dell’igloo o la caccia alla foca, capiamo cosa Nanuk sta facendo, riusciamo di colpo a calarci nel suo mondo. Quel mondo era sempre stato lì: Flaherty l’aveva solo aiutato a prendere forma. [1010 parole] Marco ha composto un testo ben fatto. Ha presentato una tesi chiara: Flaherty ci coinvolge nella cultura eschimese attraverso le figure familiari che ha scelto, ma ci spinge poi a scoprirla da soli attraverso l’osservazione degli eventi, allo stesso modo con cui gli artisti eschimesi affrontano la loro arte. Marco fornisce anche una buona dimostrazione di questa tesi con il riferimento a delle scene specifiche. La scrittura è chiara e i paragrafi sono ben organizzati. È presente un’opinione, ma è più la motivazione di un’argomentazione critica che un parere fine a se stesso. Le citazioni danno sostanza alla posizione di Marco, dimostrando che la sua
visione ha un fondamento in quello che anche altri hanno apprezzato nell’opera di Flaherty. Un tema sviluppato in relazione a delle specifiche qualità cinematiche rende possibile un’interpretazione del film che lascia spazio sia all’aspetto tecnico che all’esperienza personale. Vediamo ora il saggio di Roberta: Roberta: “Flaherty: come vedere gli altri nella maniera in cui li si vuole vedere”. Robert Flaherty può essere considerato il primo regista a fare uso dello stile documentaristico di partecipazioneosservazione, nonché un pioniere del cinema etnografico; va tuttavia detto che, più che le virtù di Flaherty, la visione di questo film rende chiari i problemi dell’etnografia. Per esempio, in una delle prime scene Nanuk va alla stazione commerciale per scambiare le pellicce con vettovaglie. Questo è l’unico riferimento nel film alla merce occidentale. Perché Nanuk non compra i materiali che gli sono più utili, come un fucile per la caccia? Perché il film non associa la stazione commerciale con i produttori della pellicola, i fratelli Revillon? Ritraendo il commerciante come un padre benevolo che dà regalini ai bambini e dei gingilli a Nanuk, Flaherty mostra in modo implicito come i Revillon trattano i nativi eschimesi. Nanuk è facilmente distratto dai ninnoli, come i suoi figli dai biscotti e dal lardo. La scena del grammofono presenta Nanuk come un buffone. La tecnologia non è una minaccia, ma una curiosità. Nanuk e la sua famiglia se ne vanno felici. Tutti ci hanno guadagnato, o così sembra. Flaherty osserva più che partecipare, almeno quando riprende. Dietro le quinte, il regista partecipa più di quanto voglia ammettere. Come mai, se la famiglia viene riempita di prelibatezze alla stazione commerciale, a un tratto rischia di morire di fame? Flaherty è pronto a vedere morire di fame Nanuk? È probabile in realtà che si tratti di quello che nei film si chiama “aggancio”: è un modo per coinvolgere gli spettatori in un dramma attraverso l’invenzione di picchi drammatici. Riuscirà Nanuk a trovare cibo? Restate con noi e lo scoprirete. Flaherty sta lavorando attivamente, dietro la macchina da presa, per creare degli eventi drammatici. Il suo trucco è
quello di presentare il dramma come se stesse accadendo in diretta. Per esempio, nella scena in cui Nanuk e altri uomini (scelti magari dal direttore del casting) uccidono un tricheco con una lancia, Flaherty sta filmando vicino a loro. Secondo il racconto del regista stesso, gli uomini lo avevano implorato di usare il fucile per uccidere il tricheco, ma lui aveva fatto finta di non sentire. Questo atteggiamento aveva costretto gli uomini a rischiare senza motivo la loro vita, ma aveva anche permesso a Flaherty di “osservare” una caccia “autentica” come se non fosse stato presente. Flaherty stesso nel suo diario ammette: «Per molto tempo ci fu un testa a testa – e più volte la troupe mi chiese di intervenire con un fucile – ma la manovella della macchina da presa era l’unica cosa che mi interessava in quel momento e feci finta di non capire» (Robert J. Flaherty, “How I Filmed Nanook of the North.” Questa porzione del testo viene citata online all’indirizzo http://www.cinemaweb.com/silentfilm/bookshelf/23_rf1_2.ht m; url consultato in data 14 giugno 2009. Erik Barnouw cita questo passaggio nel suo libro Documentary, ma non vuole giudicarlo: il rifiuto da parte del regista può sembrare giustificato ai suoi occhi, poiché permette a Flaherty di filmare le “tradizioni” degli eschimesi nonostante i rischi e nonostante l’intervento per preparare la scena in prima istanza. Erik Barnouw, Documentary, Oxford University Press, New York, 1993, p. 37). L’approccio di Flaherty è una specie di frode. Vuole fornirci un’immagine infantile di una cultura popolata da persone innocenti. Vuole agire come se questa cultura non avesse mai avuto contatti con la nostra, anche se la presenza di Flaherty stesso e della stazione commerciale è prova del contrario. Il regista non vuole esplorare le conseguenze di queste relazioni, almeno nel film. Preferisce prendere soldi dai fratelli Revillon per fare il documentario, e trattare Nanuk come un amico, se non altro per il tempo necessario a realizzare il film. Come sottolinea senza troppi giri di parole Fatimah Tobing Rony, «quella che è stata definita “la sottile narrazione” di Flaherty in questo caso si confà perfettamente a una rappresentazione razzista degli Inuit, che colloca le
popolazioni indigene al di fuori della storia moderna» (Fatimah Tobing Rony, The Third Eye: Race, Cinema and Ethnographic Spectacle, Duke University Press, Durham, N.C., 1996, p. 103). Una simile visione li preserva in quanto immagini di un passato d’altri tempi, ma è anche capace di accendere passioni, come quella che Flaherty provò per Maggie Nujarlutuk, che interpreta Nyla nel film, e che gli diede un figlio (Melanie McGrath, The Long Exile, Alfred A. Knopf, New York, 2007, pp. 21-22; il libro è scritto in uno stile romanzesco, come i racconti di Jon Krakauer basati su storie vere – Into The Wild, Into Thin Air, Under the Banner of Heaven – e, come i suoi libri, è basato in gran parte su avvenimenti reali; comprende una bibliografia e riferimenti a un consistente corpus di interviste con la popolazione Inuit e con altre). Dato che Flaherty era sposato con Frances a quel tempo, e lei lo aveva accompagnato nel suo viaggio per realizzare il film, questa parte del mito del regista è stata cancellata. Secondo la nostra discussione in classe, questo tipo di intento fa parte del cosiddetto modello di “etnografia del recupero”, in cui gli etnografi descrivono le altre culture prima che vengano in contatto con il mondo occidentale, nel tentativo di catturarne la purezza prima che venga perduta. Ciò aveva lo scopo molto utile di disporre di una registrazione permanente di alcune culture prima che sparissero. Ma negava anche il fatto che gli etnografi, o i registi, interagissero comunque con quelle culture che descrivevano come prive di contatti con i bianchi. Dove ricadeva quindi il ruolo del regista? Egli doveva sparire, insieme alle varie negoziazioni avvenute per potere avere le informazioni. Fatimah Tobing Rony cita un film del 1988, Nanuk Revisited, che spiega le cose celate da Flaherty. Un uomo Inuit racconta che i vestiti di pelle di orso, il set dell’igloo e la caccia alla foca erano tutte distorsioni. Qualunque documentario che voglia rappresentare un periodo storico precedente deve ricostruirlo o rimetterlo in scena, ma nel momento in cui la ricostruzione viene fatta passare come il modo in cui le cose stanno veramente invece di una messa in scena, l’effetto di delusione è dietro l’angolo. Rony racconta
anche che l’uomo che aveva la “parte” di Nanuk, Allakariallak, non faceva che ridere durante le riprese perché le richieste di Flaherty gli sembravano molto buffe. Il regista ha chiaramente scelto Allakariallak e altri Inuit per aiutarlo a fare il suo film, ma come ci dimostra la risata maliziosa del protagonista, per loro il risultato è stato più una commedia che un documentario etnografico. [1070 parole] Anche Roberta ha sviluppato una tesi solida e coerente con un gran numero di materiali bibliografici a sostegno. La sua ricerca le ha fornito importanti informazioni che non potevano essere tratte dalla sola visione del film (proprio perché Flaherty intendeva nascondere quello che lei ha scoperto). È presente un tono fortemente accusatorio che non rende giustizia alla complessità del lavoro di Flaherty, né al fatto che sia stato un enorme successo nonostante i suoi difetti. Per esempio, il riferimento al “direttore del casting” è una provocazione gratuita, e la parola “frode” è un po’ troppo forte per indicare la dissimulazione e la messa in scena da parte di Flaherty, così come il riferimento alla storia di Flaherty con una delle attrici non ha a che vedere direttamente con il film in quanto tale. In altre parole, lo stile di scrittura ha un tono tagliente e indignato che potrebbe sminuire lo scopo meno giudicante e più riflessivo del lavoro. Un testo più lungo avrebbe probabilmente esaminato il motivo di questo lento ripensamento sulla reputazione e sull’abilità di Flaherty, invece che adottare un tono indignato perché nessuno aveva punito il regista per la sua truffa. Chiaramente, una sfida interessante sarebbe stata quella di vedere se è possibile accettare il film di Flaherty in un’ottica che tenga conto sia del punto di vista di Marco che di quello di Roberta. La tesi di Marco, infatti, segue l’opinione di Flaherty tipica degli anni Ottanta, mentre Roberta appartiene alla recente revisione del “mito Flaherty”. Questo non toglie validità a nessuna delle due opinioni, ma aiuta a collocarle in un contesto storico più ampio. Entrambi i saggi, tuttavia, assolvono il loro compito: si allontanano dalla semplice opinione e analizzano il film.
Identificano uno specifico punto di vista riguardante Flaherty ed esaminano con successo alcune delle sue implicazioni e conseguenze. Dimostrano anche come i semplici fatti ed eventi presenti in un film possano portare a più di un’interpretazione. L’apparente verosimiglianza dell’immagine, le riprese in esterni e le lunghe inquadrature non portano automaticamente a una sola opinione o una sola conclusione, allo stesso modo con cui le prove di un processo non portano direttamente a un verdetto di colpevolezza o di innocenza. Bisogna affrontare il film dal punto di vista dell’interpretazione e della spiegazione. Quella proposta dal regista è sicuramente una, ma, chiaramente, non è la sola. Come i saggi dimostrano, il film di Flaherty può essere letto in molti modi. Parte della sfida della storia del cinema è comprendere come le analisi cambino con il tempo e con il luogo, quando degli spettatori diversi, da punti di vista differenti, applicano le loro abilità critiche a un film. Ma entrambi questi saggi ci danno un’idea interessante di come semplici tecniche di analisi cinematografica possano essere applicate allo studio dei film documentari.
NOTA BIBLIOGRAFICA Libri sul documentario in lingua italiana Daniele Dottorini (a cura di), Per un cinema del reale. Forme e pratiche del documentario italiano contemporaneo, Forum Editrice Universitaria Udinese, Udine, 2013. Giovanni Spagnoletti (a cura di), Il reale allo specchio. Il documentario italiano contemporaneo, Marsilio, Venezia, 2012. Guy Gauthier, Storia e pratiche del documentario, Lindau, Torino, 2009. Marco Bertozzi, Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell’altro cinema, Marsilio, Venezia, 2008. Jean-Louis Comolli, Vedere e potere. Il cinema, il documentario e l’innocenza perduta, a cura di Alessandra Cottafavi e Fabrizio Grosoli, Donzelli Editore, Roma, 2006. Cecilia Pennacini, Filmare le culture: un’introduzione all’antropologia visiva, Carocci, Roma, 2006. Jean Breschand, Il documentario: l’altra faccia del cinema, Lindau, Torino, 2005. Ivelise Perniola, Oltre il neorealismo: documentari d’autore e realtà italiana del dopoguerra, Bulzoni, Roma, 2004. Marco Bertozzi (a cura di), L’idea documentaria. Altri sguardi dal cinema italiano, Lindau, Torino, 2003. Salvatore Pinna, Uomini con la macchina da presa. Introduzione al cinema documentario, Aipsa edizioni/Cinemania, Cagliari, 2002. Carlo Alberto Pinelli, L’ABC del documentario, Dino Audino Editore, Roma, 2001. G. Antonucci, B. Winston, L. Quaresima, Dal Documentario al Docudrama, Prix Italia-Cineteca nazionale, 1996. Paolo Chiozzi, Manuale di antropologia visuale, Unicopli, Milano, 1993.
Roberto Nepoti, Storia del documentario, Pàtron Editore, Bologna, 1988. Giampaolo Bernagozzi, Il cinema allo specchio. Appunti per una storia del documentario, Quaderni di documentazione cinematografica, n. 5, Pàtron Editore, Bologna, 1985. Giampaolo Bernagozzi, Il cinema corto. Il documentario nella vita italiana dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, La Casa Usher, Firenze, 1979.
Libri sul documentario in lingua inglese Bill Nichols, Engaging Cinema, Norton, New York, 2010. AA.VV., Honest Truths: Documentary Filmmakers on Ethical Challenges in Their Work, Center of Social Media, Washington, 2009. Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing about Film, 7th ed., Longman, New York, 2009. AA.VV., MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing, 3rd ed., Mla, New York, 2008. Jonathan Kahana, Intelligence Work: the Politics of American Documentary, Columbia University Press, New York, 2008. Pat Aufderheide, Documentary Film: a Very Short Introduction, Oxford University Press, New York, 2007. Joram Ten Brink (a cura di), Building Bridges: The Cinema of Jean Rouch, Wallflower Press, New York, 2007. Frances Guerin, Roger Hallas (a cura di), The Image and the Witness: Trauma, Memory and Visual Culture, Wallflower Press, Londra, 2007. Dave Saunders, Direct Cinema: Observational Documentary and the Politics of the Sixties, Wallflower Press, Londra, 2007. Kate Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations, 7th ed., University of Chicago Press, Chicago, 2007.
Stella Bruzzi, New Documentary, 2nd ed., Routledge, New York-Londra, 2006. Alexandra Juhasz, Jesse Lerner (a cura di), F is for Phony: Fake Documentary and Truth’s Undoing, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006. Ian Aitken (a cura di), The International Encyclopedia of Documentary Film, Routledge, New York, 2005. Jeffrey Skoller, Shadows Specters Shards: Making History in Avant-Garde Film, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2005. Sheila Curran Bernard, Documentary Storytelling for Film and Videomakers, Elsevier Press, Oxford, 2004. Michael Renov, The Subject of Documentary, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2004. AA.VV., The Chicago Manual of Style, 15th ed., University of Chicago Press, Chicago, 2003. Alexandra Juhasz (a cura di), Women of Vision: Histories in Feminist Film and Video, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2001. Lev Manovich, The Language of New Media, Mit Press, Cambridge, 2001. Jane Roscoe, Craig Hight, Faking It: Mock-Documentary and the Subversion of Factuality, Manchester University Press, Manchester, 2001. Phyllis R. Klotman, Janet K. Cutler (a cura di), Struggles for Representation: African American Documentary Film and Video, Indiana University Press, Bloomington, 2000. Chon A. Noriega Shot in America: Television, the State and the Rise of Chicano Cinema, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000. Thomas Waugh, The Fruit Machine: Twenty Years of Writing on Queer Cinema, Duke University Press, Durham, 2000. Patricia Zimmerman, States of Emergency: Documentaries, Wars and Democracies, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 2000. Rick Altman, Film/Genre, British Film Institute, Londra, 1999. Kees Bakker (a cura di), Joris Ivens and the Documentary Context, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1999. Trinh T. Minh-ha, Cinema Interval, Routledge, New York, 1999. Michael Renov, Jane Gaines, Collecting Visible Evidence, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999. Catherine Russell, Experimental Ethnography, Duke University Press, Durham, 1999. Dai Vaughan, For Documentary, University of California Press, Berkeley, 1999. Diane Waldman, Janet Walker (a cura di), Feminism and Documentary, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999. Michelle Citron, Home Movies and Other Necessary Fictions, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1998. AA.VV., Aleksandr Rodchenko, MoMA, New York, 1998. Stephen C. Foster (a cura di), Hans Richter: Activism, Modernism and the Avant-Garde, Mit Press, Cambridge, 1998. John Hill, Pamela Church Gibson (a cura di), The Oxford Guide to Film Studies, Oxford University Press, New York, 1998. Barry Grant, Jeannette Sloniowski (a cura di), Documenting the Documentary, Wayne State University Press, Detroit, 1998. Kevin MacDonald, Mark Cousins (a cura di), Imagining Reality, Faber and Faber, Londra, 1998. David MacDougall, Transcultural Cinema, Princeton University Press, Princeton, 1998.
Derek Paget, No Other Way to Tell It, Manchester University Press, Manchester, 1998. Ilisa Barbash, Lucien Taylor, Cross-Cultural Filmmaking, University of California Press, Berkeley, 1997. Judith Butler, Excitable Speech, Routledge, New York, 1997. Chris Holmlund, Cynthia Fuchs (a cura di), Between the Sheets, in the Streets: Queer, Lesbian and Gay Documentary, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1997. John Izod, Richard Kilborn, Confronting Reality: An Introduction to Television Documentary, Manchester University Press, Manchester, 1997. E. Ann Kaplan, Looking for the Other: Feminism, Film and the Imperial Gaze, Routledge, New York, 1997. Carl R. Plantinga, Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, Cambridge University Press, New York, 1997. John Corner, The Art of Record: Critical Introduction to the Documentary, University of Manchester Press, Manchester, 1996. William Rothman, Documentary Film Classics, Cambridge University Press, New York, 1997. Michael Renov, Erika Suderburg (a cura di), Resolution: Contemporary Video Practices, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996. Timothy Druckrey (a cura di), Electronic Culture: Technology and Visual Representation, Aperture, New York, 1996. Thomas Waugh, Hard to Imagine: Gay Male Eroticism in Photography and Film from the Beginnings to Stonewall, Columbia University Press, New York, 1996. Brian Winston, Technologies of Seeing, British Film Institute, Londra, 1996. Paul Hockings (a cura di), Principles of Visual Anthropology, 2nd ed., Mouton de Gruyter, Berlino, 1995.
Brian Winston, Claiming the Real, British Film Institute, Londra, 1995. Patricia Zimmerman, Reel Families: A Social History of Amateur Film, Indiana University Press, Bloomington, 1995. Philip Bell, Theo Van Leeuwen, The Media Interview: Confession, Contest, Conversation, University of New South Wales Press, Kensington, 1994. W.J.T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, University of Chicago Press, Chicago, 1994. Bill Nichols, Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture, Indiana University Press, Bloomington, 1994. Paula Rabinowitz, They Must Be Represented, Verso, New York, 1994. Richard Abel, French Film Theory and Criticism, 1907-1939, Princeton University Press, Princeton, 1993. Erik Barnouw, Documentary: A History of the Non-fiction Film, 2nd ed., Oxford University Press, New York, 1993. Michael Renov, Theorizing Documentary, Routledge, New York, 1993. Barry Grant, Voyages of Discovery: The Cinema of Frederick Wiseman, University of Illinois Press, Urbana, 1992. Trinh T. Minh-ha, Framer Framed, Routledge, New Yortk, 1992. John Willett (a cura di), Brecht on Theatre, Hill and Wang, New York, 1992. Benedict Anderson, Imagined Cummunities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, New York, 1991. Linda Deutschman, Triumph of the Will: The Image of the Third Reich, Longwood Press, Wakefield, 1991. Gary Evans (a cura di), In the National Interest: A Chronicle of the National Film Board of Canada from 1949 to 1989,
University of Toronto Press, Toronto, 1991. Tom Gunning, D.W. Griffith and the Origins of the American Narrative Film, University of Illinois Press, Urbana, 1991. Richard Lanham, A Handlist of Rhetorical Terms, 2nd ed., University of California Press, Berkeley, 1991. Bill Nichols, Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary, Indiana University Press, Bloomington, 1991. Peter Berger, Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality, Anchor, New York, 1990. Judith Butler, Gender Trouble, Routledge, New York, 1990. Thomas Elsaesser, Adam Barker (a cura di), Early Cinema: Space, Frame, Narrative, British Film Institute, Londra, 1990. Alan Rosenthal, Writing, Directing, and Producing Documentary Films, Southern Illinois University Press, Carbondale, 1990. John Ellis, The Documentary Idea, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1989. Ilan Avisar, Screening the Holocaust: Cinema’s Images of the Unimaginable, Indiana University Press, Bloomington, 1988. Larry Gross, John Stuart Katz, Jay Ruby (a cura di), Image Ethics, Oxford University Press, New York, 1988. Sarah Kozloff, Invisible Storytellers: Voice-Over Narration in American Fiction Film, University of California Press, Berkeley, 1988. Alan Rosenthal (a cura di), New Challenges for Documentary, University of California Press, Berkeley, 1988. Kaja Silverman, The Acoustic Mirror, Indiana University Press, Bloomington, 1988. Michael Rabiger, Directing the Documentary, Focal Press, Boston-Londra, 1987.
Hayden White, The Content of the Form, Johns Hopkins University Press, Baltimora, 1987. James Clifford, George Marcus (a cura di), Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley, 1986. W.J.T. Mitchell, Iconology: Image, Text, Ideology, University of Chicago Press, Chicago, 1986. Ien Ang, Watching Dallas, Methuen, New York, 1985. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, University of Wisconsin Press, Madison, 1985. John Belton, Elisabeth Weis (a cura di), Film Sound: Theory and Practice, Columbia University Press, New York, 1985. Jack Douglas, Creative Interviewing, Sage Publications, Beverly Hills, 1985. Annette Michelson, Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov, University of California Press, Berkeley, 1984. Thomas Waugh, “Show Us Life!”: Toward a History and Aesthetic of the Committed Documentary, Scarecrow Press, Metuchen, 1984. E. Ann Kaplan, Women and Film: Both Sides of the Camera, Metheun, New York, 1983. Robert Kolker, The Altering Eye, Oxford University Press, New York, 1983. Christian Metz, The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema, Indiana University Press, Bloomington, 1982. William Alexander, Film on the Left: American Documentary Film from 1931 to 1942, Princeton University Press, Princeton, 1981. Bill Nichols, Ideology and the Image, Indiana University Press, Bloomington, 1981. Thomas Waugh, Joris Ivens and the Evolution of the Radical Documentary, 1926-1946, Columbia University Press, Ann Arbor, 1981.
Sol Worth, Studying Visual Communication, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1981. George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago, 1980. Stephen Neale, Genre, British Film Institute, Londra, 1980. Bill Nichols, Newsreel: Documentary Filmmaking on the American Left, 1969-1974, Arno Press, New York, 1980. Mick Eaton, Anthropology, Reality, Cinema: The Films of Jean Rouch, British Film Institute, Londra, 1979. Lewis Jacobs, The Documentary Tradition, 2nd ed., Norton, New York, 1979. P. Adam Sitney, Visionary Film: the American Avant-Garde, 2nd ed., Oxford University Press, New York, 1979. David Hinton, The Films of Leni Riefenstahl, Scarecrow Press, Metuchen, 1978. P. Adam Sitney, The Avant-Garde Film: a Reader of Theory and Criticism, New York University Press, New York, 1978. Barry Grant (a cura di), Film Genre: Theory and Criticism, Scarecrow Press, Metuchen, 1977. Linda Nochlin, Realism, Penguin, Baltimora, 1976. Richard Meran Barsam, Film Guide to “Triumph of the Will”, Indiana University Press, Bloomington, 1975. J.O. Urmson, Marina Sbisa (a cura di), How To Do Things with Words, 2nd ed., Oxford University Press, New York, 1975. Stephen Bann (a cura di), The Tradition of Constructivism, Viking, New York, 1974. Stephen Mamber, Cinéma Vérité in America: Studies in Uncontrolled Documentary, Mit Press, Cambridge, 1974. Christian Metz, Film Language: a Semiotics of the Cinema, Oxford University Press, New York, 1974.
Amos Vogel, Film as a Subversive Art, Random House, New York, 1974. Richard Meran Barsam, Nonfiction Film, Dutton, New York, 1973. László Moholy-Nagy, Painting, Photography, Film, Mit Press, Cambridge, 1973. William Scott, Documentary Expression and Thirties America, Oxford University Press, New York, 1973. Sol Worth, Through Navajo Eyes: an Exploration in Film Communication and Anthropology, Indiana University Press, Bloomington, 1973. Émile Benveniste, Problems in General Lingustics, University of Miami Press, Coral Gables, 1971. Alan Rosenthal, The New Documentary in Action, University of California Press, Berkeley, 1971. Arthur Calder Marshall, The Innocent Eye, Penguin, Baltimora, 1970. Alan Rosenthal, The Documentary Conscience, University of California Press, Berkeley, 1970. Joris Ivens, The Camera and I, International Publishers, New York, 1969. Sergej Ejzenštejn, Film Form and the Film Sense, a cura di Jay Lejda, Meridian Books, New York, 1968. Erving Goffman, Interaction Ritual: Essays in Face to Face Behavior, Aldine, Chicago, 1967. A. William Bluem, Documentary in American Television, Hastings House, New York, 1965. Lee Lemon, Marion Reis (a cura di), Russian Formalist Criticism: Four Essays, University of Nebraska Press, Lincoln, 1965. Jay Leyda, Films Begets Films, Hill and Wang, New York, 1964. Alan Lovell, Anarchist Cinema, Peace Press, Londra, 1962.
Jay Leyda, Kino: A History of the Russian and Soviet Film, Macmillian, New York, 1960. Erving Goffman, Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, New York, 1959. Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler, Noonday Press, New York, 1959. Paul Rotha, Documentary Film, Norton, New York, 1939.
Libri sul documentario in lingua francese Jean-Luc Lioult, À l’enseigne du réal: penser le documentaire, Université de Provence, Aix-en-Provence, 2004. Didier Mauro, Le documentaire: cinéma et télévision, écriture, réalisation, production, diffusion, formation, Dixit, Parigi, 2003. Guy Gauthier, Le documentaire, un autre cinéma, Nathan, Parigi, 2000. François Niney, L’épreuve du réel à l’écran. Essai sur le principe de réalité documentaire, Édition De Boeck Université, Bruxelles, 2000. Marc Henri Piault, Anthropologie et cinéma: passage à l’image, passage par l’image, Nathan, Parigi, 2000. Roger Odin, L’âge d’or du documentaire: Europe, années cinquante, Tome 1-2, l’Harmattan, Parigi, 1998. Gilles Marsolais, L’aventure du cinéma direct revisitée, Les 400 coups, Laval, 1997. Gérard Althabe, Jean-Louis Comolli, Regards sur la ville, Editions du Centre Georges Pompidou, Parigi, 1994. Jean-Paul Colleyn, Le regard documentaire, Editions du Centre Georges Pompidou, Parigi, 1993. René Prédal, Le documentaire française: dossier, Cerf, Parigi, 1987. Michel Chion, Le son au cinéma, Editions de l’Etoile, Parigi, 1985.
Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, Esthétique du film, Nathan, Parigi, 1983. Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Gallimard, Parigi, 1976. André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma?, Cerf, Parigi, 19581962.
FILMOGRAFIA A proposito di Nizza (À propos de Nice), di Jean Vigo, Francia, 18 min., 1930. Abortion Stories: North and South (Storie di aborti: Nord e Sud), di Gail Singer, National Film Board of Canada, Irlanda/Giappone/Thailandia/Perù/Colombia/Canada, 55 min., 1984. Act of Seeing with One’s Own Eyes, The (Vedere coi propri occhi), di Stan Brakhage, Usa, 32 min., 1971. Âge d’or, L’, di Luis Buñuel, Francia, 60 min., 1930. Affiche, L’ (Il poster), di Jean Epstein, Francia, 73 min., 1925. Afrique, je te plumerai (Africa, io ti spennerò), di Jean-Marie Téno, Camerun/Francia, 88 min., 1993. Aileen Wuornos: the Selling of a Serial Killer (Aileen Wuornos, la vendita di un serial killer), di Nick Broomfield, Usa, 87 min., 1992. Always for Pleasure (Sempre per piacere), di Les Blank, Usa, 58 min., 1978. America’s Most Wanted (Il più ricercato d’America), di Glenn Weiss, serie Tv, Usa, 30 min. a episodio, 1988. American Dream (Sogno americano), di Barbara Kopple, Usa, 98 min., 1990. American Cinema, The (Il cinema americano), New York Center for Visual History/Public Broadcasting System (Pbs), serie Tv, Usa, 10 episodi, 60 min. a episodio, 1994. American Family, An (Una famiglia americana), di Craig Gilbert, National Educational Television (Net), serie Tv, Usa, 12 episodi, 60 min. a episodio, 1972. American Teen, di Nanette Burstein, Usa, 101 min., 2008. Anémic Cinéma (Cinema anemico), di Marcel Duchamp, Francia, 5 min., 1927. Anthem (Inno), Marlon Riggs, Usa, 9 min., 1991.
Antonia: A Portrait of a Woman (Antonia: ritratto di una donna), di Jill Godmilow e Judy Collins, Usa, 58 min., 1974. Apocalisse nel deserto (Lektionen in Finsternis), di Werner Herzog, Germania/Francia/Regno Unito, 50 min., 1992. Arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat, L’ (L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat), di August e Louis Lumière, Francia, 1 min., 1895. Artie Shaw: Time Is All You’ve Got (Artie Show, il tempo è tutto quel che hai), di Brigitte Berman, Canada, 114 min., 1985. Australia’s Funniest Home Movie Show, di Bryan Cockerill, serie Tv, Australia, 30 min. a episodio, 1990-2009. Aventure Malgache (Avventura malgascia), di Alfred Hitchcock, Ministero britannico dell’informazione, Regno Unito/Francia, 31 min., 1944. Avventura, L’, di Michelangelo Antonioni, Italia, 142 min., 1960. Ax Fight, The (La battaglia delle scuri), di Timothy Asch e Napoleon Chagnon, serie Yanomamö, Venezuela/Usa, 30 min. a episodio, 1975. Basic Training (Addestramento di base), di Frederick Wiseman, Usa, 90 min., 1971. Battle 360: Call To Duty (Battaglia 360: appello al dovere) serie Tv, History Channel, Flight 33 Production, Usa, 60 min. a episodio, 2008. Battle Of Chile, The (La battaglia del Cile), di Patricio Guzmán, Cuba/Cile/Venezuela, 3 parti di 100 min., 1975, 1977, 1979. Battle of Midway, The (La battaglia delle Midway), di John Ford, Usa, 18 min., 1942. Ballet Mécanique (Balletto meccanico), di Fernand Léger, Francia, 14 min., 1924.
Before Spring (Prima della primavera), di Joris Ivens, Cina, 38 min., 1958. Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community (Prima di Stonewall: la creazione di una comunità gay e lesbica), di Greta Schiller, John Scagliotti e Robert Rosenberg, Usa, 87 min., 1984. Berkeley in the Sixties (Berkeley negli anni Sessanta), di Mark Kitchell, Usa, 117 min., 1990. Berlino: Sinfonia di una grande città (Berlin: die sinfonie der Großstadt), di Walter Ruttmann, Germania, 53 min., 1927. Black Is, Black Ain’t: A Personal Journey through Black Identity (Nero è, nero non è: un viaggio personale attraverso l’identità nera), di Marlon Riggs, Usa, 88 min., 1995. Blair Witch Project, The, di Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, Usa, 80 min., 1999. Body Beautiful, The (Il corpo bellissimo), di Ngozi Onwurah, Usa, 20 min., 1991. Bon Voyage (Buon viaggio), di Alfred Hitchcock, Ministero britannico dell’informazione, Regno Unito/Francia, 26 min., 1944. Bontoc Eulogy (Eulogia di Bontoc), di Marlon Fuentes, Filippine/Usa, 50 min., 1995. Boran Herdsmen/Boran Women (I pastori Boran/Le donne Boran), parti I e II, di David MacDougall e James Blue, serie Faces of Change, Usa, 33 min. a episodio, 1974. Borinage (Misère au Borinage), di Joris Ivens e Henri Storck, Belgio, 36 min., 1933. Born into Brothels: Calcutta’s Red Light Kids (Nati nei bordelli: i bambini a luci rosse di Calcutta), di Ross Kaufman e Zana Briski, India/Usa, 83 min., 2004. Bowling a Columbine (Bowling for Columbine), di Michael Moore, Usa, 120 min., 2002.
Broken Rainbow (Arcobaleno spezzato), di Mario Florio e Victoria Mudd, Usa, 70 min., 1985. Brug, De (Il ponte), di Joris Ivens, Paesi Bassi, 11 min., 1928. Bus 174 (Ônibus 174), di José Padilha, Brasile, 120 min., 2002. Cadillac Desert: Water and the Transformation of Nature (Mulholland’s Dream; An American Nile; The Mercy of Nature; Last Oasis) (Nel deserto delle Cadillac: l’acqua e la trasformazione della natura [Il sogno della Mulholland; Un Nilo americano; La clemenza della natura; L’ultima oasi]), di Jon Else, Usa, 60 min. ciascuna delle 4 parti, 1997. Caduta della dinastia dei Romanov, La (Padeniye dinastii Romanovykh), di Esther Shub, Unione Sovietica, 90 min., 1927. Cane Toads: An Unnatural History (Rospi delle canne: una storia innaturale), di Mark Lewis, Australia, 46 min., 1987. Campioni di razza (Best in Show), di Christopher Guest, Usa, 90 min., 2000. Cannibal Tours (I tour dei cannibali), di Dennis O’Rourke, Papua Nuova Guinea/Australia, 70 min., 1988. Capitalism: A Love Story, di Michael Moore, Usa, 127 min., 2009. C’est arrivé près de chez vous (È successo vicino a casa vostra), di Rémy Belvaux, André Bonzel e Benoît Poelvoorde, Belgio/Francia, 95 min., 1992. Chagrin et la pitié, Le (Il dolore e la pietà), di Marcel Ophüls, Francia, 251 min., 1970. Chair, The (La sedia), di Drew Associates, Gregory Shukur, Richard Leacock, D.A. Pennebaker, Usa, 60 min., 1962. Chile: Obstinate Memory (Cile: memoria ostinata), di Patricio Guzmán, Canada/Francia, 53 min., 1997. Chien andalou, Un, di Luis Buñuel, Francia, 16 min., 1928. Chronique d’un été (Cronaca di un’estate), di Jean Rouch e Edgar Morin, Francia, 85 min., 1962.
City, The (La città), di Ralph Steiner e Willard Van Dyke, Usa, 43 min., 1939. Civil War, The (La guerra civile), di Ken Burns, Pbs, 9 parti, Usa, 680 min., 1990. Coal Face (Faccia di carbone), di Alberto Cavalcanti, Regno Unito, 10 min., 1935. Color Adjustment (Ritocco di colore), di Marlon Riggs, Usa, 88 min., 1991. Comedy in Six Unnatural Acts (Una commedia in sei atti innaturali), A, Jan Oxenberg, 41 min., 1975. Come Yukong spostò le montagne (Comment Yukong deplaça les montagnes), di Joris Ivens e Marceline Loridan, Francia/Cina, 12 segmenti di un’ora, 1976. Common Threads: Stories from the Quilt (Fili comuni: storie dal quilt), di Rob Epstein e Jeffrey Friedman, Usa, 79 min., 1989. Complaints of a Dutiful Daughter (I lamenti di una figlia rispettosa), di Deborah Hoffmann, Usa, 44 min., 1994. Control Room (Sala di controllo), di Jehane Noujaim, Usa/Qatar, 84 min., 2004. Cops (Poliziotti), di John Langely, serie Tv, Usa, 30 min. a episodio, 1989. Corporation, The (La corporazione), di Mark Achbar e Jennifer Abbott, Canada, 145 min., 2003. Corpus: A Home Movie For Selena (Corpus: un film amatoriale per Serena), di Lourdes Portillo, Usa, 56 min., 1999. Cove - La baia dove muoiono i delfini, The (The Cove), di Louis Psihoyos, Usa, 92 min., 2009. Crisis: Behind a Presidential Commitment (Crisi: dietro un impegno presidenziale), di Robert Drew, Usa, 53 min., 1963. Corazzata Potëmkin, La (Bronenosec Potëmkin), di Sergej M. Ejzenštejn, Unione Sovietica, 75 min., 1925.
Crumb, di Terry Zwigoff, Usa, 119 min., 1994. Daisy: The Story of a Facelift (Daisy: la storia di un lifting facciale), di Michael Rubbo, National Film Board of Canada, Canada, 57 min., 1982. Danube Exodus (L’esodo del Danubio), di Péter Forgács, Ungheria, 60 min., 1999. Daughter Rite (Il rito di una figlia), di Michelle Citron, Usa, 55 min., 1978. David Holzman’s Diary (Il diario di David Holzman), di Jim McBride e L.M. Kit Carson, Usa, 71 min., 1968. Day after Trinity: J. Robert Oppenheimer and Atomic Bomb, The (Il giorno dopo la Trinità: J. Robert Oppenheimer e la bomba atomica), di Jon Else, Usa, 88 min., 1980. Dead Birds (Uccelli morti), di Robert Gardner, Nuova Guinea Occidentale/Usa, 83 min., 1965. Derrida, di Kirby Dick e Amy Ziering Kofman, Usa/Francia, 84 min., 2002. 17° parallèle: la guerre du peuple, Le (Il diciassettesimo parallelo: la guerra del popolo), di Joris Ivens, Vietnam/Francia, 113 min., 1968. Disprezzo, Il (Le mépris), di Jean-Luc Godard, Italia/Francia, 105 min., 1963. Dont Look Back (Non guardarti indietro), di D.A. Pennebaker, Regno Unito/Usa, 96 min., 1967. Down and Out in America (Squattrinati in America), di Lee Grant, Usa, 57 min., 1986. Due o tre cose che so di lei (Deux ou trois choses que je sais d’elle), di Jean-Luc Godard, Francia, 90 min., 1967. Enron - L’economia della truffa (Enron: The Smartest Guys in the Room), di Alex Gibney, Usa, 110 min., 2005. Entuziazm: Simfoniya Donbassa (Entusiasmo: sinfonia del Donbass), di Dziga Vertov, Unione Sovietica, 69 min., 1930.
Essere e avere (Être et avoir), di Nicolas Philibert, Francia, 100 min., 2002. Ethnic Notions (Nozioni etniche), di Marlon Riggs, 57 min., 1986. Every Day Except Christmas (Ogni giorno tranne Natale), di Lindsay Anderson, Regno Unito, 41 min., 1957. Eyes on the Prize (Gli occhi sul premio), di Henry Hampton, Pbs, Usa, 14 episodi, prima serie: 1987, seconda serie: 1990. Fahrenheit 9/11, di Michael Moore, Usa, 122 min., 2004. Fa’ la cosa giusta (Do the Right Thing), di Spike Lee, Usa, 120 min., 1989. Family Business (Impresa di famiglia), di Tom Cohen, Middleton Series, Pbs, Peter Davis (prod.), Usa, 90 min., 1982. Far from Poland (Lontano dalla Polonia), di Jill Godmilow, Usa, 106 min., 1984. Fast, Cheap and Out of Control (Veloce, a poco prezzo e senza controllo), di Errol Morris, Usa, 80 min., 1997. Feeling My Way (Sentire a modo mio), di Jonathan Hodgson, Regno Unito, 5 min., 1997. Fiamma del peccato, La (Double Indemnity), di Billy Wilder, Usa, 107 min., 1944. Fièvre (Febbre), Louis Delluc, Francia, 30 min., 1921. Film about a Woman Who…, A (Un film su una donna che…), di Yvonne Rainer, Usa, 105 min., 1974. Finding Christa (Trovare Christa), di Camille Billops e James Hatch, Usa, 55 min., 1991. Fine di San Pietroburgo, La (Konec Sankt-Peterburga), di Vsevolod Pudovkin, Unione Sovietica, 69 min., 1927. Fireworks (Fuochi d’artificio), di Kenneth Anger, Regno Unito, 20 min., 1947.
First Contact (Primo contatto), di Robin Anderson e Bob Connelly, Papua Nuova Guinea/Austcralia, 54 min., 1984. Fog of War: La guerra secondo Robert McNamara, The (Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert McNamara, The), di Errol Morris, Usa, 107 min., 2003. Forest of Bliss (Foresta di gioia), di Robert Gardner, India/Usa, 91 min., 1985. Forrest Gump, di Robert Zemeckis, Usa, 142 min., 1994. Four Families (Quattro famiglie), di Margaret Mead, Fali Bilimoria, John Buss, Richard Gilbert e William Novik, National Film Board of Canada, Canada, 58 min., 1959. 49 Up, di Michael Apted, Regno Unito/Usa, 135 min., 2005. Frantz Fanon: Black Skin/White Mask (Frantz Fanon: pelle nera, maschera bianca), di Isaac Julien, Francia/Martinica/Regno Unito, 70 min., 1996. Gabinetto del dottor Caligari, Il (Das Cabinet des Dr. Caligari), di Robert Wiene, Germania, 52 min., 1920. Gioventù, amore e rabbia (The Loneliness of the Long Distance Runner), di Tony Richardson, Regno Unito, 104 min., 1962. Gimme Shelter (Proteggimi), di David Maysles, Albert Maysles e Charlotte Zwerin, Usa, 91 min., 1970. Glas (Bicchiere), di Bert Haanstra, Paesi Bassi, 11 min., 1958. Glaneurs et la glaneuse, Les (Gli spigolatori e la spigolatrice), di Agnès Varda, Francia, 82 min., 2000. Global Assembly Line, The (La catena di montaggio globale), di Lorraine Gray, Usa, 58 min., 1986. God Grew Tired of Us: The Lost Boys of Sudan (Dio si è stancato di noi: i ragazzi perduti del Sudan), di Cristopher Quinn, Usa, 86 min., 2005. Gokushiteki erosu: Renka (Eros molto personale: canto d’amore), di Kazuo Hara, Giappone, 92 min., 1974.
Grass: A Nation’s Battle for Life (Erba: la lotta per la vita di una nazione), di Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack, Usa, 70 min., 1925. Great Road, The (La grande strada), di Esther Shub, Unione Sovietica, 1927. Grey Gardens (Giardini grigi), di Albert e David Maysles, Usa, 95 min., 1975. Grizzly Man, di Werner Herzog, Canada/Usa, 104 min., 2005. Growing Up Female: As Six Become One (Crescendo da femmina: sei diventano una), di Julia Reichert e Jim Klein, Usa, 60 min., 1970. Guerre stellari: Episodio IV - Una nuova speranza (Star Wars Episode IV: A New Hope), di George Lucas, Usa, 122 min., 1977. Gunner Palace, di Michael Tucker e Petra Epperlein, Usa, 85 min., 2004. Hard Metals Disease (Intossicazione da metalli pesanti), di Jon Alpert, Usa, 57 min., 1987. Harlan County, U.S.A. (Contea di Harlan, U.S.A.), di Barbara Kopple, Usa, 103 min., 1977. Harvest of Shame (Il raccolto della vergogna), di Edward R. Murrow, Cbs News, Usa, 60 min., 1960. Heart of Spain (Il cuore della Spagna), di Herbert Kline e Geza Karpathi, Frontier Films, Spagna/Usa, 30 min., 1937. Hell House (La casa dell’Inferno), di George Ratliff, Usa, 85 min., 2001. High School (Liceo), di Frederick Wiseman, Usa, 75 min., 1968. His Mother’s Voice (La voce di sua madre), di Dennis Tupicoff, Australia, 52 min., 1997. History and Memory (Storia e memoria), di Rea Tajiri, Usa, 33 min., 1991.
Hoop Dreams (Sogni di basket), di Steve James, Frederick Marx e Peter Gilbert, Usa, 170 min., 1994. Hospital (Ospedale), di Frederick Wiseman, Usa, 84 min., 1970. Hôtel Terminus, di Marcel Ophüls, Francia/Usa, 267 min., 1988. Housing Problems (Problemi di abitazione), di Edgar Anstey e Arthur Elton, Regno Unito, 30 min., 1935. Human Behavior Experiments, The (Esperimenti sul comportamento umano), di Alex Gibney, Usa, 58 min., 2006. Human Remains (Resti umani), di Jay Rosenblatt, Usa, 30 min., 1998. Hunters, The (I cacciatori), di John Marshall e Robert Gardner, Usa, 72 min., 1957. Hurdes, Las, di Luis Buñuel, Spagna, 27 min., 1932. I Am A Sex Addict (Sono un maniaco sessuale), di Caveh Zahedi, Usa, 99 min., 2005. Ilha das Flores (L’isola dei fiori), di Jorge Furtado, Brasile, 13 min., 1989. I’m British but… (Sono inglese, ma…), di Gurinder Chadha, Regno Unito, 30 min., 1989. Imagining Indians (Immaginare gli indiani), di Victor Masayesva Jr., Usa, 90 min., 1993. Incubo di Darwin, L’ (Darwin’s Nightmare), di Hubert Sauper, Australia/Belgio/Francia, 107 min., 2004. Innaffiatore innaffiato, L’ (L’arroseur arrosé), di Louis Lumière, Francia, 1 min., 1895. In and Out of Africa (Dentro e fuori l’Africa), di Ilisa Barbash e Lucien Taylor, Francia/Usa, 59 min., 1992. In the Land of the Headhunters (Nella terra dei cacciatori di teste) (restaurato, rititolato e pubblicato come In the Land
of The War Canoes, 1972), di Edward S. Curtis, Usa, 47 min., 1914. In the Year of the Pig (Nell’anno del maiale), di Emile de Antonio, Usa, 101 min., 1969. Indonesia Calling (L’Indonesia chiama), di Joris Ivens, Australia, 15 min., 1946. Inflation (Inflazione), di Hans Richter, Germania, 8 min., 1928. Injury to One, An (Una ferita a una persona), di Travis Wilkerson, Usa, 53 min., 2002. Intimate Stranger (Intimo estraneo), di Alan Berliner, Usa, 60 min., 1992. Io e il vento (Une histoire de vent), di Joris Ivens, Francia, 80 min., 1988. Io sono un campione (This Sporting Life), di Lindsay Anderson, Regno Unito, 134 min., 1963. It’s Elementary: Talking about Gay Issues in School (È elementare: parlare di questioni gay a scuola), di Debra Chasnoff e Helen Cohen, Usa, 77 min., 1996. Jane, di D.A. Pennebaker, di Richard Leacock e Drew Associates, Usa, 54 min., 1962. Janie’s Janie (La Janie di Janie), di Geri Ashur e Peter Barton, Usa, 25 min., 1971. Jazz: The Story of America’s Music (Jazz: la storia della musica americana), di Ken Burns, serie Tv, 10 episodi, Usa, durata totale 1.114 min., 2000. Jeanne Dielmann, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, di Chantal Ackerman, Belgio/Francia, 201 min., 1975. Jesus Camp, di Heidi Ewing e Rachel Grady, Usa, 84 min., 2006. JFK - Un caso ancora aperto (JFK), di Oliver Stone, Francia/Usa, 189 min., 1991.
Journal inachevé (Diario incompiuto), di Marilu Mallet, Canada, 55 min, 1983. Joyce at 34 (Joyce a trentaquattro anni), di Joyce Chopra e Claudia Weill, Usa, 28 min., 1972. Jupiter’s Wife (La moglie di Giove), di Michel Negroponte, Usa, 87 min., 1995. Khush, di Pratibha Parmar, Regno Unito, 24 min., 1991. Kinoglaz (Cine-occhio), di Dziga Vertov, Unione Sovietica, 74 min., 1924. Kinopravda, di Dziga Vertov, Unione Sovietica, 81 min., 1925. Komposition in Blau (Composizione in blu), di Oskar Fischinger, Germania, 4 min., 1935. Komsomolsk, di Joris Ivens, Unione Sovietica, 50 min., 1932. Koyaanisqatsi, di Godfrey Reggio, Usa, 87 min., 1983. Kurt & Courtney, di Nick Broomfield, Usa, 95 min., 1998. Ladri di biciclette, di Vittorio De Sica, Italia, 93 min., 1948. Last Days, The (Gli ultimi giorni), di James Moll, Ungheria/Usa, 87 min., 1998. Letter to Jane (Lettera a Jane), di Jean-Luc Godard e JeanPierre Gorin, Francia, 45 min., 1972. Letter Without Words (Lettera senza parole), di Lisa Lewenz, Usa, 62 min., 1999. Lied der Ströme, Das (La canzone del fiume), di Joris Ivens e Joop Huisken, Germania Est, 100 min., 1954. Life and Debt (Vita e debito), di Stephanie Black, Usa, 80 min., 2001. Life and Times of Rosie the Riveter, The (La vita e i tempi di Rosie l’operaia), di Connie Field, Usa, 65 min., 1980. Linea generale, La, poi Il vecchio e il nuovo (Staroye i novoye), di Sergej M. Ejzenštejn, Unione Sovietica, 70 min., 1929.
Listen to Britain (Ascoltate la Britannia), di Humphrey Jennings e Stewart McAllister, Regno Unito, 21 min., 1941. Lonely Boy (Ragazzo solitario), di Roman Kroiter e Wolf Koenig, National Film Board of Canada, Canada, 27 min., 1962. Looking for Langston (Alla ricerca di Langston), di Isaac Julien, Regno Unito, 55 min., 1988. Lost Boys of Sudan (I ragazzi perduti del Sudan), di Megan Mylan e Jon Shenk, Usa, 87 min., 2003. Lousiana Story (Storia della Lousiana), di Robert Flaherty, Usa, 75 min., 1948. Macht der Bilder: Leni Riefenstahl, Die (Il potere dell’immagine: Leni Riefenstahl), di Ray Müller, Germania, 180 min., 1993. Madres de la Plaza de Mayo, Las (Le madri di Plaza de Mayo), di Susana Muñoz e Lourdes Portillo, Argentina/Usa, 64 min., 1985. Maelstrom: A Family Chronicle, The, di Péter Forgács, Paesi Bassi, 60 min., 1997. Maîtres fous, Les (I maestri folli), di Jean Rouch, Francia, 30 min., 1955. Man on Wire - Un uomo tra le Torri (Man on Wire), di James Marsh, Regno Unito/Usa, 94 min., 2008. Maquilapolis: City of Factories (Maquilapolis: città di fabbriche), di Vicki Funari e Sergio de la Torre, Messico/Usa, 68 min., 2006. Marcia dei pinguini, La (La Marche de l’empereur), di Luc Jaquet, Francia, 80 min., 2005. Married Couple, A (Una coppia di sposi), di Allan King, Canada, 90 min., 1970. Meat (Carne), Frederick Wiseman, Usa, 112 min., 1976. Memorandum, di Donald Brittain e John Spotton, National Film Board of Canada, Canada, 58 min., 1965.
Ménilmontant, di Dimitri Kirsanoff, Francia, 38 min., 1924. Metallica: Some Kind of Monster (Metallica, specie di mostri), di Joe Berlinger e Bruce Sinofsky, 134 min., 2004. Metropolis, di Fritz Lang, Germania, 115 min., 1927. Midnight Movies: From the Margin to the Mainstream (Film di mezzanotte: dai margini al mainstream), di Stuart Samuels, Canada/Usa, 86 min., 2005. Milk, di Gus Van Sant, Usa, 127 min., 2008. Moana, di Robert J. Flaherty, Samoa/Usa, 26 min., 1926. Model (Modella), di Frederick Wiseman, Usa, 129 min., 1980. Momma Don’t Allow (La mamma non lo permette), di Karel Reis e Tony Richardson, Regno Unito, 22 min., 1956. Mondo cane, di Gualtiero Jacopetti e Franco E. Prosperi, Italia, 105 min., 1963. Monster (Mostro), di Patty Jenkins, Usa/Germania, 109 min., 2003. Monster Kid Home Movies (Film amatoriale di mostri fatti da bambini), di Robert Tinnell, Usa, 120 min., 2005. Monterey Pop, di D. A. Pennebaker, Usa, 82 min., 1968. Murderball, di Henry Alex Rubin e Dana Adam Shapiro, Usa, 88 min., 2005. My Architect: A Son’s Journey (Il mio architetto: il viaggio di un figlio), di Nathaniel Khan, Usa, 116 min., 2003. N!ai: Story of a !Kung Woman (N!ai: la storia di una donna !Kung), di John Marshall, Odyssey Series/Pbs, Deserto del Kalahari (Namibia, Angola)/Usa, 58 min., 1980. Nanuk l’eschimese (Nanook of the North), di Robert Flaherty, Canada/Usa, 55 min., 1922. Netsilik Eskimo, di Asen Balikci e Guy Mary-Rousseliere, Education Development Corporation e National Film Board of Canada, Canada, 18 episodi, durata totale circa 10 ore, 1967-68.
Night Mail (La posta notturna), di Harry Watt e Basil Wright, Usa, 30 min., 1936. Nitrate Kisses (Baci al nitrato), di Barbara Hammer, Usa, 67 min., 1992. Nobody’s Business (Gli affari di nessuno), di Alan Berliner, Usa, 60 min., 1996. No Lies (Niente bugie), di Mitchell Block, Usa, 16 min., 1973. Nosferatu il vampiro (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens), di F.W. Murnau, Germania, 63 min., 1922. Not a Love Story: A Film about Pornography (Non una storia d’amore: un film sulla pornografia), di Bonnie Klein, National Film Board of Canada, Canada, 68 min., 1981. Notte e nebbia (Nuit et brouillard), di Alain Resnais, Polonia/Francia, 31 min., 1955. Nuer, The (I Nuer), di Hilary Harris, George Breidenbach e Robert Gardner, Etiopia/Usa, 75 min., 1970. N.Y., N.Y., di Francis Thompson, Usa, 15 min., 1957. Obedience (Obbedienza), di Stanley Milgram, Usa, 45 min., 1965. Ombre (Shadows), di John Cassavetes, Usa, 87 min., 1959. Operation Abolition (Operazione abolizione), House UnAmerican Activities Committee e Washington Video Production, Usa, 45 min., 1960. Operation Correction (Operazione correzione), American Civil Liberties Union, Usa, 47 min., 1961. Ora dei forni, L’ (La Hora de los hornos), di Octavio Getino e Fernando E. Solanas, Argentina, 260 min., 1968. Örvény, Az (Caduta libera), di Péter Forgács, Ungheria, 75 min., 1998. Ottobre - I dieci giorni che sconvolsero il mondo (Oktiabr’), di Sergej M. Ejzenštejn, Unione Sovietica, 104 min., 1927. Pacific 231, di Jean Mitry, Usa, 10 min., 1949.
Palace of Delights, di Jon Else, Usa, 50 min, 1982 (episodio 18 della stagione 9 di Nova, serie Tv di informazione della Pbs) Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills (Il paradiso perduto: gli infanticidi di Robin Hood Hills), di Joe Berlinger e Bruce Sinofsky, Usa, 150 min., 1996. Paris Is Burning (Parigi brucia), di Jennie Livingston, Usa, 71 min., 1990. Paris qui dort (Parigi che dorme), di René Clair, Francia, 36 min., 1924. Pasto del bambino, Il (Répas de bébé), di Louis Lumière, Francia, 1 min., 1895. People’s Century, The (Il secolo della gente), WgbhBoston/Pbs, Usa, 26 episodi, 60 min. a episodio, 1998. People’s War (La guerra della gente), N.Y. Newsreel, Usa, 40 min., 1969. Pets or Meat: The Return to Flint (Cuccioli o carne: il ritorno a Flint), di Michael Moore, Usa, 23 min., 1992. Pioggia (Regen), di Joris Ivens, Paesi Bassi, 14 min., 1929. Plow That Broke the Plains, The (L’aratro che spezzò le pianure), di Pare Lorentz, U.S. Resettlement Administration, Usa, 25 min., 1936. Portrait of Jason (Ritratto di Jason), di Shirley Clarke, Usa, 105 min., 1967. Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear, The (Il potere degli incubi: l’ascesa della politica della paura), di Adam Curtis, Regno Unito, 180 min., 2004. Prelude to War (Preludio alla guerra), di Frank Capra, primo dei sette film Why We Fight, U.S. War Department, Usa, 54 min., 1941. Primary (Primarie), di Drew Associates, D.A. Pennebaker e Richard Leacock, con Terence Macartney e Albert Maysles, Usa, 60 min., 1960.
Prince Is Back, The (Il principe è tornato), di Marina Goldovskaija, Russia, 59 min., 1999. Quando eravamo re (When We Were Kings), di Leon Gast, Usa, 87 min., 1996. Rabbit in the Moon (Il coniglio sulla luna), di Emiko Omori, Usa, 85 min., 1999. Radio Bikini, di Robert Stone, Usa, 56 min., 1987. Rapacità (Greed), di Eric Von Stroheim, Usa, 140 min., 1925. Raquetteurs, Les (I racchettatori), di Michel Brault e Gilles Groulx, National Film Board of Canada, Canada, 15 min., 1958. Real Sex (Sesso Vero), di Patti Kaplan, serie Tv, Home Box Office (Hbo), Usa, 27 episodi, 50 min. a episodio, 19922001. Reassemblage (Riassemblaggio), di Trinh Minh-ha, Senegal/Usa, 40 min., 1982. Rennsymphonie (Sinfonia della corsa), di Hans Richter, Germania, 7 min., 1929. Report from the Aleutians (Cronaca dalle Aleutine), di John Huston, U.S. Army Signal Corps, Usa, 47 min., 1943. Retour à la raison, Le (Il ritorno alla ragione), di Man Ray, Francia, 3 min., 1923. Revolution Will Not Be Televised, The, (alias Chávez: Inside the Coup, La rivoluzione non sarà trasmessa in tv), di Kim Bartley e Donnacha O’Briain, Irlanda/Paesi Bassi/Usa, 74 min., 2002. Rhytmus 21, di Hans Richter, Germania, 15 min., 1921. Rhytmus 23, di Hans Richter, Germania, 4 min., 1923. Rien que les heures (Nient’altro che le ore), di Alberto Cavalcanti, Francia, 45 min., 1926. River, The (Il fiume), di Pare Lorentz, Farm Security Administration, Usa, 31 min., 1937.
Road to Guantanamo, The, di Mat Whitecross e Michael Winterbottom, Regno Unito, 95 min., 2006. Roger & Me, di Michael Moore, Usa, 87 min., 1989. Roma città aperta, di Roberto Rossellini, Italia, 100 min., 1945. Roses in December (Rose a dicembre), di Ana Carrigan e Bernard Stone, El Salvador/Usa, 56 min., 1982. Roue, La (La ruota), di Abel Gance, Francia, 130 min., 1922. Roy Cohn/Jack Smith, di Jill Godmilow, Usa, 90 min., 1994. Rossiya Nikolaya II i Lev Tolstoy (La Russia di Nicola II e Leo Tolstoj), di Esther Shub, Unione Sovietica, 60 min., 1928. Ryan, di Chris Landreth, Canada, 14 min., 2004. S21: La machine de mort Khmère rouge (S21, La macchina di morte dei Khmer rossi), di Rithy Panh, Cambogia/Francia, 101 min., 2003. Sabato sera, domenica mattina (Saturday Night and Sunday Morning), di Karel Reisz, Regno Unito, 89 min., 1960. Sad Song of Yellow Skin (Storia triste di pelle gialla), di Michael Rubbo, National Film Board of Canada, Vietnam del Sud/Canada, 58 min., 1970. Salesman (Commesso), di Albert Maysles, David Maysles e Charlotte Zwerin, Usa, 90 min., 1969. Salt of the Earth (Sale della terra), di Herbert J. Biberman, Usa, 94 min., 1954. Salvate il soldato Ryan (Saving Private Ryan), di Steven Spielberg, 170 min., 1998. Sang des bêtes, Le (Il sangue delle bestie), di Georges Franju, Francia, 22 min., 1949. San Pietro (The Battle of San Pietro), di John Huston, Usa, 33 min., 1945. Sans soleil (Senza sole), di Chris Marker, Francia, 100 min., 1982. Schindler’s List, di Steven Spielberg, Usa, 196 min., 1993.
Sciopero (Stačka), di Sergej M. Ejzenštejn, Unione Sovietica, 82 min., 1925. Scomoda verità, Una (An Inconvenient Truth), di Davis Guggenheim, Usa, 96 min., 2006. Scorpio Rising (La rivolta di Scorpio), di Kenneth Anger, Usa, 30 min., 1963. Sea Horse, The (L’ippocampo), di Jean Painlevé, Francia, 14 min., 1934. Section Anderson, La (La sezione Anderson), di Pierre Schoendorffer, Televisione francese, Vietnam/Francia, 65 min., 1967. Selling of the Pentagon, The (La vendita del Pentagono), di Peter Davis, Cbs News, Usa, 52 min., 1971. Seven Days in September (Sette giorni a settembre), di Steven Rosenbaum, Usa, 94 min., 2002. 7 Plus Seven, di Michael Apted, Regno Unito, 53 min., 1970. 7 Up, di Paul Almond, Regno Unito, 30 min., 1964. Sherman’s March (La marcia di Sherman), Ross McElwee, Usa, 155 min., 1985. Shoah, di Claude Lanzmann, Polonia/Francia, parte I: 273 min., parte II: 290 min., 1985. Shock of the New, The (Lo shock delle novità), di Robert Hughes, Bbc-TV e Time-Life Television, Usa, 7 episodi, 60 min. a episodio, 1980. Sicko, di Michael Moore, Usa, 123 min., 2007. Silence (Silenzio), di Orly Yadin e Sylvie Bringas, Regno Unito, 10 min., 1998. Silverlake Life: The View from Here (La vita a Silverlake: la vista da qui), di Tom Joslin, Mark Massi e Peter Friedman, Usa, 99 min., 1993. 16 in Webster Groves, di Arthur Barron, Speciale Cbs, 46 min., 1966.
60 Minutes, serie Tv di informazione della Cbs, Usa, 60 min. ogni episodio, 1968. Smoke Menace (La minaccia del fumo), di John Taylor, Regno Unito, 14 min., 1937. Soldato Jane (G.I. Jane), di Ridley Scott, Usa, 125 min., 1997. Soldier Girls (Donne soldato), di Joan Churchill e Nick Broomfield, Usa, 87 min., 1980. Sol Svanetii (Il sale della Svanezia), di Mikhail Kalatozov, Unione Sovietica, 53 min., 1930. Song of Ceylon (Canto di Ceylon), di Basil Wright, Ceylon/Regno Unito, 40 min., 1934. Sottile linea blu, La (The Thin Blue Line), di Errol Morris, American Playhouse/Pbs, Usa, 115 min., 1987. Sottile linea rossa, La (The Thin Red Line), di Terrence Malick, Usa, 170 min., 1998. Sotto i tetti di Parigi (Sous le toits de Paris), di René Clair, Francia, 96 min., 1930. Speak Body (Il corpo parla), di Kay Armatage, Canada, 20 min., 1987. Souriante Madame Beudet, La (La sorridente signora Beudet), di Germaine Dulac, Francia, 54 min., 1922. Standard Operating Procedure, di Errol Morris, Usa, 116 min., 2008. Statue of Liberty, The (La statua della Libertà), di Ken Burns, Paramount Home Entertainment, Usa, 60 min., 1985. Storia americana, Una (Capturing the Friedmans), di Andrew Jarecki, Usa, 108 min., 2003. Strange Fruit (Un frutto strano), di Joel Katz, Usa, 57 min., 2002. Strange Victory (Strana vittoria), di Leo Hurwitz, Usa, 80 min., 1948. Stranger with a Camera (Uno straniero con la macchina da presa), di Elizabeth Barret, Usa, 58 min., 1999.
Super Size Me, di Morgan Spurlock, Usa, 100 min., 2004. Surname Viet Given Name Nam (Cognome Viet nome proprio Nam), di Trinh Minh-ha, Usa, 108 min., 1989. Survivor, di Charlie Parsons, serie Tv, Usa, 60 min. a episodio, 2000-2009. Symphonie diagonale (Sinfonia diagonale), di Viking Eggeling, Germania, 5 min., 1924. Takeover (Controllo), di David e Judith MacDougall, Australia, 90 min., 1981. Tarnation, di Jonathan Caouette, Usa, 88 min., 2003. Taxi to the Dark Side, di Alex Gibney, Usa/Iran, 106 min., 2007. Terra di Spagna (The Spanish Earth), di Joris Ivens, Usa, 52 min., 1937. Terra trema, La, di Luchino Visconti, Italia, 162 min., 1948. Things I Cannot Change, The (Le cose che non posso cambiare), di Tanya Ballantyne, National Film Board of Canada, Canada, 58 min., 1966. This Film is Not Yet Rated (Il film non è ancora classificato), di Kirby Dick, Usa, 97 min., 2005. This Is Spinal Tap, di Rob Reiner, Usa, 82 min., 1984. Ties That Bind, The (I legami più forti), di Su Friedrich, Usa, 55 min., 1984. Times of Harvey Milk, The (Ai tempi di Harvey Milk), di Robert Epstein e Richard Schmiechen, Usa, 87 min., 1986. Tongues Untied (Lingue slegate), di Marlon Riggs, Usa, 45 min., 1989. Trance and Dance in Bali (Danza e trance a Bali), di Gregory Bateson e Margaret Mead, serie Character Formation in Different Culture, Bali/Usa, 20 min., basato su studi sul campo compiuti negli anni 1936-1938, distribuito nel 1952. Tre canti su Lenin (Tri pesni o Lenine), di Dziga Vertov, Unione Sovietica, 62 min., 1934.
Tribulation 99: Alien Anomalies Under America, (Tribolazione 99: anomalie aliene in America), di Craig Baldwin, Usa, 48 min., 1991. Trionfo della volontà, Il (Der Triumph des Willens), di Leni Riefenstahl, Germania, 107 min., 1935. Trouble the Water (Smuovere le acque), di Carl Deal e Tia Lessin, Usa, 94 min., 2008. Truman Show, The, di Peter Weir, Usa, 103 min., 1998. Turksib, di Victor A. Turin, Unione Sovietica, 57 min., 1929. TV Nation, di Michael Moore, serie Tv, Usa, 1994. Two Laws (Due leggi), di Carolyn Strachan e Alessandro Cavadini con la comunità Borrolola, Usa, 130 min., 1981. Two Spirits: Sexuality, Gender and the Murder of Fred Martinez (Due-spiriti: sessualità, genere e l’omicidio di Fred Martinez), di Lydia Nibley, Usa, 65 min., 2009. Ultimo valzer, L’ (The Last Waltz), di Martin Scorsese, Usa, 117 min., 1978. Un chant d’amour (Un canto d’amore), di Jean Genet, Francia, 77 min., 1950. Union Maids (Donne del sindacato), di Jim Klein, Miles Mogulescu e Julia Reichert, Usa, 51 min., 1976. Uomo con la macchina da presa, L’ (Cělovek s kinoapparatom), di Dziga Vertov, Unione Sovietica, 103 min., 1929. Up the Yangtze (Su per lo Yangtze), di Yung Chang, Canada, 93 min., 2007. Uscita dalle officine Lumière, L’ (La sortie des usines Lumière), di Louis Lumière, Francia, 1 min., 1895. Valzer con Bashir (Vals Im Bashir), di Ari Folman, Israele/Germania/Francia/Usa/Finlandia/Svizzera/Belgio/A ustralia, 87 min., 2008. Vento dell’est (Vent d’est), di Jean-Luc Godard, Francia, 95 min., 1969.
Vernon, Florida (Vernon, Florida), di Errol Morris, Usa, 56 min., 1981. Viaggio nella Luna (Le voyage dans la Lune), di Georges Méliès, Francia, 14 min., 1902. Victory at Sea (Vittoria sul mare), di Henry Salomon e Isaac Kleinerman, Nbc Television, Usa, 26 episodi, 30 min. a episodio, 1952-53. Vlast’ Solovetskaija (La forza di Solovky), di Marina Goldovskaija, Unione Sovietica, 90 min., 1988. War, The (La Guerra), di Ken Burns e Lynn Novick, serie Tv in sette parti, Pbs, Usa, durata totale 840 min., 2007. War Comes to America (La guerra arriva in America), di Frank Capra e Anatole Litvak, U.S. War Department, ultimo dei sette film della serie Why We Fight, Usa, 70 min., 1945. War Game, The (Il gioco della guerra), di Peter Watkins, Regno Unito, 45 min., 1966. War Room, The (La stanza della guerra), di Chris Hegedus e D.A. Pennebaker, Pennebaker Associates, Usa, 96 min., 1993. Watsonville on Strike (Sciopero a Watsonville), di Jon Silver, Usa, 70 min., 1989. Ways of Seeing (Modi di vedere), con John Berger, Bbc, Regno Unito, 4 episodi, 30 min. a episodio, 1974. We Are the Lambeth Boys (Noi siamo i ragazzi di Lambeth), di Karel Reisz, Regno Unito, 52 min., 1958. Wedding Camels (Cammelli da matrimonio), di David e Judith MacDougall, Turkana Conversations Trilogy, Kenya/Australia, 108 min., 1980. When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts (Quando si ruppero gli argini: un requiem in quattro atti), di Spike Lee, Usa, 240 min., 2006. Who Killed Vincent Chin? (Chi ha ucciso Vincent Chin?), di Renee Tajima-Peña e Christine Choy, Usa, 87 min., 1988.
Why Vietnam? (Perché il Vietnam?), U.S. Department of Defense, Vietnam/Usa, 32 min., 1965. Why We Fight (Perché combattiamo), di Eugene Jarecki, Usa/Francia/Regno Unito/Canada/Danimarca, 99 min., 2005. Why We Fight (Perché combattiamo), serie, di Frank Capra e Anatole Litvak, U.S. War Department, Usa, sette film di varia lunghezza, 1942-45. Wild Parrots of Telegraph Hill, The (I pappagalli liberi di Telegraph Hill), di Judy Irving, Usa, 83 min., 2004. Wild Safari 3D: A South African Adventure (Wild Safari 3D: un’avventura sudafricana), di Ben Stassen, Image Maximum (Imax) film, Belgio, 45 min., 2005. With Babies and Banners: The Story of the Women’s Emergency Brigade (Con i bambini e con gli stendardi: la storia della Women’s Emergency Brigade), di Lorrain Gray, Anne Bohlen e Lynn Goldfarb, Usa, 45 min., 1979. Woman’s Film, The (Il film della donna), S.F. Newsreel Women’s Caucus, Usa, 40 min., 1971. Wonder Ring, The (Il cerchio delle meraviglie), di Stan Brakhage, Usa, 6 min., 1955. Word Is Out (Si dice in giro), di Collettivo Mariposa, Nancy Adair, Peter Adair, Andrew Brown, Robert Epstein, Lucy Massie Phenix, Veronica Silver, Usa, 130 min., 1977. Yanomamö, serie: vedi The Ax Fight. Yidl in the Middle: Growing Up Jewish in Iowa (Yidl nel mezzo: crescere ebrei in Iowa), di Marlene Booth, Usa, 58 min., 1998. Yosemite: The Fate of Heaven (Yosemite: il destino degli dei), di Jon Else, Usa, 58 min., 1988. Yuki yukite shingun (L’esercito nudo dell’imperatore è in marcia), di Kazuo Hara, Giappone, 123 min., 1987. Zeigt ein Licthspiel: Schwarz, weiß, grau (Gioco di luce: nero, bianco, grigio), di László Moholy-Nagy, Usa, 6 min., 1930.
Zvenigora (La montagna incantata), di Aleksandr Dovženko, Unione Sovietica, 90 min., 1928.
INDICE DEI NOMI E DEI FILM Le pagine evidenziate illustrazioni
in
grassetto
corrispondono
Abortion Stories: North and South, 71 Ackerman, Chantal, 215 Act of Seeing with One’s Own Eyes, The, 40 Affiche, L’, 124 Agee, Arthur, 45, 61, 62 Âge d’or, L’, 157 Aileen Wuornos: the Selling of a Serial Killer, 21-23 Al Jazeera, 88 Allakariallak, 24, 250 Allende, Salvador, 225, 226 Alpert, Jon, 174 Always for Pleasure, 28, 158 American Dream, 16 American Family, An, 52, 106 American Teen, 47, 52 America’s most wanted, 159 Anderson, Lindsay, 36, 38 Anémic Cinéma, 125 Anger, Kenneth, 157, 218 Anka, Paul, 105 Anthem, 220 Apocalisse nel deserto, A proposito di Nizza, 131 Aristotele, 79, 86
a
Arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat, L’, 118, 155 Ashur, Geri, 215 Auden, W.H., 148 Austin, J.L., 191 Australia’s Funniest Home Movie Show, 123 Avventura, L’, 87 Ax Fight, The, 40 Barbie, Klaus, 15 Ballantyne, Tanya, 56 Barbash, Ilisa, 55 Barnouw, Erik, 74, 141, 249 Barton, Peter, 215 Barré, Gabai, 55, 57 Battle of Midway, The, 207 Bazin, André, 118, 128 Before Spring, 210 Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community, 217, 234 Berger, John, 159 Berkeley in the Sixties, 16 Berliner, Alan, 64, 81, 84, 162, 228 Berlinger, Joe, 167 Berlino: Sinfonia di una grande città, 76, 126, 132, 234 Bernardi, Daniel, 244, 245 Billops, Camille, 68, 175 Black is, Black Ain’t, 106 Blair Witch Project, The, 6, 27, 41, 186 Blank, Les, 28, 158
Block, Mitchell, 61, 62, 113 Body Beautiful, The, 82, 114-116, 190, 194 Bohlen, Anne, 215 Bomba, Abraham, 92 Bontoc Eulogy, 75, 82, 91, 184, 190 Bon Voyage, 207 Booth, Marlene, 68 Boran Herdsmen, 168 Borinage, 201, 211, 213 Born into Brothels, 16, 127, 159, 231 Bowling a Columbine, 64, 174 Brecht, Bertolt, 188, 215 Bringas, Sylvie, 156 Briski, Zana, 16, 159, 231 Brittain, Donald, 43 Broken Rainbow, 15 Broomfield, Nick, 22, 23, 66, 178 Brug, De, 39, 124, 125, 143, 146, 210 Buñuel, Luis, 36, 54-56, 125, 157, 187, 212 Burns, Ken, 15, 162, 163 Burstein, Nanette, 47, 52 Bus 174, 115, 142, 144 Butler, Judith, 218 Cadillac Desert, 183 Caduta della dinastia dei Romanov, La, 103, 110, 111, 116, 134, 180 Campioni di razza, 41 Cane Toads: An Unnatural History, 84, 85
Cannibal Tours, 48 Caouette, Jonathan, 68, 82, 92, 190, 191, 194 Capra, Frank, 162, 207 Capitalism: a Love Story, 64 Carpenter, Edmund, 248 Cassavetes, John, 5 Cavadini, Alessandro, 57, 59 Cavalcanti, Alberto, 36, 125, 208, 209 Cayrol, Jean, 194 C’est arrivé près de chez vous, 62 Chagrin et la pitié, Le, 178 Chair, The, 164 Chant d’amour, Un, 218 Chien andalou, Un, 125, 157 Chile: Obstinate memory, 40, 142, 145-147, 226 Chin, Vincent, 17 Chopra, Joyce, 215 Choy, Christine, 15, 17, 191 Chronique d’un été, 30, 40, 164, 173, 174, 177, 224, 228 Churchill, Joan, 66 Cicerone, 79 City, The, 31, 32, 34, 35, 58, 67, 103, 159, 208, 234 Civil War, The, 142, 143, 152 Clair, René, 124 Clark, Dick, 174 Clarke, Shirley, 70, 228 Clinton, Bill, 88 Coal Face, 202, 208
Cohn, Roy, 169, 170 Color Adjustment, 214, 221 Comedy in Six Unnatural Acts, A, 218 Come Yukong spostò le montagne, 210 Common Threads: Stories from the Quilt, 16 Complaints of a Dutiful Daughter, 81, 145, 147, 175 Control Room, 88, 142, 143 Cooper, Merian, 131 Cops, 6, 40, 122 Corazzata Potëmkin, La, 20, 134, 204 Corpus: A Home Movie for Selena, 190 Cove, The, 32 Crisis: Behind a Presidential Commitment, 152 Crumb, 86, 179 Curse of the Blair Witch, 6 Curtis, Adam, 227 Curtis, Edward, 130 Daisy: The Story of a Facelift, 49, 50, 51 Dalí, Salvador, 125 Danube Exodus, 158, 171 Daughter Rite, 184, 186 David Holzman’s Diary, 186 Day After Trinity, The, 153 Dead Birds, 46, 112, 142, 145, 159, 193, 212 Deal, Carl, 228, 229 De Antonio, Emile, 39, 180, 182 De La Torre, Sergio, 216, 217 Delluc, Louis, 124
De Sica, Vittorio, 21, 26, 128, 129 Diablo nunca duerme, El, 181, 182 Disprezzo, Il, 94 17e parallèle. La guerre du peuple, Le, 210 Donovan, Jane, 192 Dont Look Back, 31, 164, 234 Dos Passos, John, 210 Dovženko, Aleksandr, 125, 206 Down and Out in America, 15 Drew, Richard, 36 Drew, Robert, 152, 170 Duchamp, Marcel, 125 Dulac, Germaine, 124 Duran, Carmen, 216 Dylan, Bob, 31, 164 Eggeling, Viking, 125 Ejzenštejn, Sergej, 5, 20, 128, 133, 134, 203, 204 Else, Jon, 7, 153, 159, 183 Engel, Wendy, 57 Enron - L’economia della truffa, 25, 40, 60, 142, 144, 148, 202, 234 Entuziazm: Simfoniya Donbassa, 38 Epstein, Jean, 124 Epstein, Rob, 14, 218 Essere e avere, 54 Ethnic Notions, 221 Étoile de mer, L’, 125 Every Day Except Christmas, 36
Eyes on the Prize, 15, 103, 152, 180, 234 Fa’ la cosa giusta, 18 Family Business, 46 Far from Poland, 104, 110, 112, 184, 186, 213 Fahrenheit 9/11, 16, 64, 92, 159, 181 Fast, Cheap and Out of Control, 86, 234 Feeling My Way, 156 Fiamma del peccato, La, 87 Field, Connie, 33, 37, 181 Fièvre, 124 Film about a Woman Who…, A, 215, 216 Finding Christa, 68, 107, 145, 147, 175 Fine di San Pietroburgo, La, 128 Fireworks, 218 First Contact, 48 Fischer, Becky, 52, 63, 88 Fischinger, Oskar, 156 Flaherty, Robert, 11, 22, 24, 26, 51, 54, 72, 73, 104, 120, 121, 126, 130, 131, 148, 206, 209, 210, 228, 236, 237, 239-242, 244-251 Fog of War: la guerra secondo Robert McNamara, The, 40, 144, 227, 231 Folman, Ari, 82, 108, 109, 190, 191 Forest of Bliss, 191 Forgács, Péter, 158, 171, 195, 196, 197, 218, 228 Forrest Gump, 6 Foucault, Michel, 179 Four Families, 113 Franco, Francisco, 104, 160
Franju, Georges, 66, 67 Frantz Fanon: Black Skin/White Mask, 191 Freud, Sigmund, 102 Friedman, Arnold, 86, 87 Friedman, David, 87 Friedman, Elaine, 87 Friedman, Jess, 86, 87 Friedman, Peter, 229 Friedrich, Su, 82, 162 Fuentes, Marlon, 75, 82, 91, 190, 191 Funari, Vicky, 216, 217 Gabinetto del dottor Caligari, Il, 128 Gan, Alexei, 132, 133 Gardner, Robert, 112, 113, 191 Gast, Leon, 181 Gates, William, 45 Gender Trouble (Judith Butler), 218 Genet, Jean, 218, 220 Gilbert, Craig, 53 Gilbert, Peter, 45, 222 Gimme Shelter, 164 Gioventù, amore e rabbia, 38 Glass, 158 Glaneurs et la glaneuse, Les, 80, 100, 145, 146, 190 Global Assembly Line, The, 216 God Grew Tired of Us: The Lost Boys of Sudan, 223 Godard, Jean-Luc, 94, 177, 184 Godmilow, Jill, 104, 110, 112, 113, 162, 169, 170, 184, 213
Gokushiteki erosu: Renka, 178 Goffman, Erving, 20 Goldfarb, Lynn, 215 Goldovskaija, Marina, 87, 89, 90, 134, 135 Gore, Al, 78 Gorin, Jean-Pierre, 184 Grady, Rachel, 52, 53, 63 Grass: A Nation’s Battle for Life, 131, 132, 142, 145, 240 Great Road, The, 134 Grey Gardens, 166 Grierson, John, 18, 22, 24, 27-29, 36, 38, 93, 120, 135, 201, 206, 207-210, 212 Griffith, D.W., 127 Grizzly Man, 43, 52, 92, 115, 142, 147, 173 Groulx, Gilles, 30 Growing Up Female: As Six Become One, 188, 215 Guerre stellari: Episodio IV - Una nuova speranza, 94 Gunner Palace, 107, 142, 143 Gunning, Tom, 123 Guzmán, Patricio, 162, 225 Haanstra, Bert, 158 Hammer, Barbara, 218, 219 Hara, Kazuo, 178 Hard Metals Disease, 174 Harlan County, U.S.A., 181, 201 Harvest of Shame, The, 22, 46, 64, 142, 216, 234 Heart of Spain, 210 Hell House, 88
Hellman, Lillian, 210 Hemingway, Ernest, 160, 210 Hemphill, Essex, 220, 221 Herb Schiller Reads the New York Times, 46 Herzog, Werner, 52, 173 High School, 36, 40, 46, 143, 145, 164, 167 His Mother’s Voice, 108, 109, 193 History and Memory, 40, 80, 81, 191, 231 Hitchcock, Alfred, 207 Hitler, Adolf, 32, 56, 93, 104, 124, 160-162, 169 Hoffmann, Deborah, 81, 175 Holliday, Billie, 232 Hoop Dreams, 16, 31, 45, 61, 222 Hospital, 36, 98, 100 Hôtel Terminus, 15, 234 Housing Problems, 46, 200-202, 208, 215 Hughes, Langston, 191, 194 Human Behavior Experiments, The, 60 Human Remains, 104 Humphrey, Hubert, 43 Hunters, The, 212 Hurdes, Las, 19, 30, 31, 36, 40, 54-56, 62, 63, 84, 85, 162, 187, 192, 212, 234 Hurwitz, Leo, 210, 212 Huston, John, 46, 98, 99, 207 Huston, Walter, 227 I am a Sex Addict, 187 Ilha das flores, 84, 85, 234
Imagining Indians, 214 In and Out of Africa, 55, 57 Incubo di Darwin, L’, 87 Indonesia Calling, 213 Inflation, 125 Innaffiatore innaffiato, L’, 118 In the Land of Headhunters, 130 In the Land of the War Canoes, 130 In the Year of the Pig, 39, 180, 234 Intimate Stranger, 68, 81, 228 Io e il vento, 210 Io sono un campione, 38 Ivens, Joris, 124, 125, 154, 157, 160, 161, 177, 201, 210, 211, 213 Jacopetti, Gualtiero, 54, 122 James, Steve, 45, 222 Jane, 165 Janie’s Janie, 215 Jarecki, Eugene, 99 Jazz, 64, 180 Jeanne Dielmann, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, 215 Jennings, Humphrey, 36, 209 Jesus Camp, 52, 53, 63, 88, 96, 143, 145 JFK - Un caso ancora aperto, 18, 139 Joslin, Tom, 229 Journal inachevé, 82, 143, 146, 178, 225 Joyce at 34, 188, 215 Julien, Isaac, 191
Kalatozov, Mikhail, 197 Kaufman, Ross, 159 Kennedy, John F., 18, 43, 139, 152, 229 King, Allan, 106 King, Rodney, 65, 88 King Kong, 131 Kinoglaz, 204 Kirsanov, Dimitri, 125 Klein, Bonnie, 177 Klein, Jim, 215 Kleinerman, Isaac, 165 Komposition in Blau, 156 Komsomolsk, 210 Kopple, Barbara, 16, 151, 181, 201 Koyaanisqatsi, 31, 40, 76, 143, 146 Kurt & Courtney, 178 Ladri di biciclette, 21, 26, 128, 129 Landreth, Chris, 193 Lang, Fritz, 128 Lanzmann, Claude, 43, 174 Last Days, The, 43 Leacock, Richard, 36, 170, 246, 247 Lessin, Tia, 228, 229 Letter to Jane, 184 Letter Without Words, 68 Lied der Ströme, Das, 210 Life and Debt, 201
Life and Times of Rosie the Riveter, The, 33, 34, 37, 39, 77, 144, 153, 182, 215, 234 Linea generale, La, 134, 204 Listen to Britain, 39, 192 Livingston, Jennie, 193, 220, 221 Lonely Boy, 105 Longstreth, Steve, 7 Looking for Langston, 191 Lorentz, Pare, 120, 207-209 Loridan, Marcelline, 177 Lost Boys of Sudan, 223 Louisiana Story, 126 Lumière, Louis, 10, 118, 119, 121, 123, 124, 128, 210 MacDougall, David, 167, 168, 175, 189 MacDougall, Judith, 175, 189 Macht der Bilder: Leni Riefenstahl, Die, 181 Madres de la Plaza de Mayo, Las, 15, 144, 180, 192 Magill, Mark, 104 Maîtres fous, Les, 40, 56, 96, 142, 145, 212 Mallet, Marilu, 82, 178, 225 Man on Wire, 22, 234, Maquilapolis: City of factories, 216, 217 Marker, Chris, 36, 151, 158, 187, 223, 224 Married Couple, A, 106, 107 Marsalis, Wynton, 64 Martin, Sian, 114 Martinez, Fred, 231 Marx, Karl, 202
Massi, Mark, 229 Maysles, Albert, 36, 166 Maysles, David, 36, 166 McElwee, Ross, 56, 58, 174, 176 McNamara, Robert, 227, 231 Mead, Margaret, 113, 115 Meat, 67 Meeropol, Abel, 232 Méliès, Georges, 119 Memorandum, 43 Menchú, Rigoberta, 221 Ménilmontant, 125 Mescherskij, famiglia, 134 Metallica: Some kind of Monster, 40, 143, 147, 234 Metropolis, 128 Metz, Christian, 118 Milgram, Stanley, 58-60 Milk, Harvey, 14, 15, 218 Milk, 14, 218 Minh-ha, Trinh T., 162, 184-186, 224, 225 Mitry, Jean, 155 Moana, 131, 206, 246 Model, 167 Moholy-Nagy, László, 155 Moll, James, 43 Momma Don’t Allow, 36 Mondo cane, 54, 122, 123 Monster, 21, 22
Monster Kid Home Movies, 123 Monterey Pop, 164 Moore, Michael, 16, 49, 56, 61, 64, 65, 96, 136, 148, 159, 162, 174, 181 Morin, Edgard, 174, 175, 177, 178, 205, 228 Morris, Errol, 16, 53, 60, 64, 77, 86, 88, 91, 105, 121, 181, 227 Müller, Ray, 181 Muñoz, Susana, 15, 180 Murrow, Edward R., 22, 216 Mussolini, Benito, 104, 162 N!ai: Story of a !Kung Woman, 105, 144, 146 Nanuk, 22-24, 52, 54, 65, 72, 105, 121, 148, 228, 237, 239, 240, 245-250 Nanuk l’eschimese, 11, 22, 24, 26, 30, 50, 51, 104, 105, 130, 142, 145, 148, 189, 212, 228, 234, 236-239, 241-247 Nanuk Revisited, 250 Night Mail, 27, 64, 76, 121, 142, 143, 147 Nitrate Kisses, 218, 219 Nobody’s Business, 64, 68, 81, 107, 144, 146, 172, 228 No Lies, 41, 61-63, 113, 186 Nosferatu, il vampiro, 128 Not a Love Story: A Film about Pornography, 177 Notte e nebbia, 39, 43, 108, 136, 142, 143, 165, 194, 195, 234 Nuer, The, 96 N.Y., N.Y., 156 Obedience, 46, 58, 60 Odets, Clifford, 210 Ombre, 5, 21
Omori, Emiko, 82, 83, 178 Onwurah, Ngozi, 82, 113-115, 190, 191, 194 Operation Abolition, 97 Operation Correction, 97 Ophüls, Marcel, 178 Oppenheimer, Robert J., 153 Ora dei forni, L’, 46 Örvény, Az, 158, 195, 196, 218, 228 Ottobre - I dieci giorni che sconvolsero il mondo, 128, 134, 204 Oxenberg, Jan, 220 Pacific 231, 155 Painlevé, Jean, 140 Palace of Delights, 7 Panh, Rithy, 98 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, 167 Paris Is Burning, 105, 193, 220, 221 Paris qui dort, 124 Pasto del bambino, Il, 118 Pennebaker, D.A., 36, 136, 170 People’s Century, The, 152 People’s War, 46 Petit, Philippe, 22 Peto, Gyorgy, 158, 197 Philibert, Nicolas, 54 Pioggia, 76, 124, 143, 146, 150, 154, 157, 210 Plow That Broke the Plains, The, 32, 40, 46, 142, 143, 161, 207 Portillo, Lourdes, 15, 180, 181, 190
Portrait of Jason, 70, 173, 228, 234 Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear, The, 142, 143, 227, 234 Prelude to War, 208 Presentation of Self in Everyday Life, 20 Primary, 30, 40, 43, 128, 144, 145, 164, 234 Prince Is Back, The, 134, 135 Prosperi, Franco E., 54, 122 Pudovkin, Vsevolod, 128, 206 Quando eravamo re, 181 Quintiliano, 86 Rabbit in the Moon, 82, 83, 178 Radio Bikini, 15 Rainer, Yvonne, 215, 216 Rapacità, 5 Raquetteurs, Les, 30, 164 Ray, Man, 125 Reassemblage, 40, 145, 146, 149, 184, 187 Redford, Robert, 159 Richter, Hans, 125 Reichert, Julia, 215 Reiner, Rob, 27 Reisz, Karel, 36, 38 Report from the Aleutians, 207 Resnais, Alain, 43, 194, 195, 197 Retour à la raison, Le, 125 Revillon, fratelli, 51, 249, 250 Revolution Will Not Be Televised, The, 97
Rhytmus 23, 125 Riefenstahl, Leni, 32, 56, 58, 93, 95, 160, 161, 168, 169 Rien que les heures, 125 Riggs, Marlon, 69, 82, 106, 190-192, 220, 221, 228 River, The, 32, 67, 127, 142, 149, 207-209 Road to Guantanamo, The, 6 Roberts, Scott, 101, 228, 229, 231 Rodčenko, Aleksandr, 132 Roger & Me, 16, 31, 49, 56, 61, 64, 142, 146, 174, 224 Roma città aperta, 5, 128 Rony, Fatimah Tobing, 245, 250 Rosenblatt, Jay, 104, 105 Rosenberg, Robert, 217 Roses in December, 192 Rossellini, Roberto, 5, 128 Rossiya Nikolaya II i Lev Tolstoy, 134 Rotha, Paul, 36, 244, 248 Rouch, Jean, 56, 174, 175, 177, 178, 205, 228 Roue, La, 124, 126, 155 Roy Cohn/Jack Smith, 169, 170 Rubbo, Michael, 49, 50, 58, 65, 82, 178, 225 Ruttmann, Walter, 126 Ryan, 193, 234 S21, la machine de mort Khmère rouge, 98, 234 Sabato sera, Domenica mattina, 38 Sad Song of Yellow Skin, 178 Salesman, 40, 128, 144, 145, 234 Salvate il soldato Ryan, 46
Salt of the Earth, 21 Sang des bêtes, Le, 66, 84, 85, 159 San Pietro, 46, 98, 106, 207 Sans soleil, 36, 158, 187, 223 Schiller, Greta, 217 Schindler’s List, 18, 22 Schindler, Oskar, 18, 22 Schoedsack, Ernest B., 131 Sciopero, 5, 134, 204 Scomoda verità, Una, 78, 103, 142, 143, 234 Scorpio Rising, 157 Sea Horse, The, 140 Section Anderson, La, 107 Selling of the Pentagon, The, 50, 51, 64, 159 Sherman’s March, 56, 58, 64, 107, 144, 146, 174, 176, 234 Shoah, 40, 43, 70, 92, 103, 144, 174, 180 Shub, Esther, 36, 110, 111, 134, 151, 180, 206, 210 Sicko, 16, 64, 142, 143, 148, 202 Silence, 156 Silver, Jon, 72, 73, 174, 211 Silverlake Life: The View from Here, 107, 115, 229, 234 Simpson, O.J., 66 Sinofsky, Bruce, 167 16 in Webster Groves, 159, 162, 193 60 Minutes, 27, 174 Smoke Menace, 103, 202 Soldato Jane, 66 Soldier Girls, 46, 66
Sol Svanetii, 76, 192 Song of Ceylon, 39, 64, 76, 158 Sottile linea blu, La, 16, 53, 64, 77, 86, 91, 103, 121, 181 Sottile linea rossa, La, 46 Souriante Madame Beudet, La, 124 Speak Body, 71 Spielberg, Steven, 22, 46 Spurlock, Morgan, 16 Standard Operating Procedure, 60, 88, 105, 234 Statue of Liberty, The, 15 Steiner, Ralph, 31, 34 Stone, Oliver, 139 Storck, Henri, 201, 211, 213 Storia americana, Una, 46, 86, 115, 234 Strachan, Carolyn, 57, 59 Strange Fruit, 232 Strange Victory, 212 Stranger with a Camera, 143, 145, 147, 149 Super Size Me, 16, 136, 143, 146 Surname Viet Given Name Nam, 185-187, 224, 225 Svilova, Elizaveta, 185 Symphonie diagonale, 125 Tajima-Peña, Renee, 15, 17, 191 Tajiri, Rea, 80, 81, 191 Takeover, 175 Tarnation, 16, 68, 82, 92, 115, 145, 147, 172, 190, 220, 234 Taxi to the Dark Side, 227, 234 Taylor, Lucien, 55
Terra di Spagna, 40, 106, 160, 161, 210 Terra trema, La, 128 Things I Cannot Change, The, 56 This Is Spinal Tap, 27, 85 Thompson, Francis, 156 Thompson, Hunter, 65 Ties That Bind, The, 82 Times of Harvey Milk, The, 14, 15, 218, 221 Tongues Untied, 40, 69, 82, 115, 145, 147, 190, 192, 194, 220, 221, 228, 231 “Tradition of the Victim Griersonian Documentary, The” (Brian Winston), 201 Trance and Dance in Bali, 40, 212 Treadwell, Timothy, 43, 52, 92, 173 Trionfo della volontà, Il, 32, 56, 58, 93-95, 124, 160, 161, 168, 170, 211 Tre canti su Lenin, 192 Trouble the Water, 100, 202, 228, 229, 231 Truman Show, The, 6 Tupicoff, Dennis, 108, 109 Turin, Victor A., 36, 131 Turksib, 131, 192 TV Nation, 64 Two Laws, 57, 59, 167 Two Spirits: Sexuality, Gender and the Murder of Fred Martinez, 230 Union Maids, 39, 215 Uomo con la macchina da presa, L’, 30, 38, 40, 126, 128, 145, 149, 174, 185, 187, 204, 234 Uscita dalle officine Lumière, L’, 10, 118, 119
Van Dyke, Willard, 31, 34 Varda, Agnès, 81, 100, 190, 191 Vawter, Ron, 169, 170 Vernon, Florida, 105 Vertov, Dziga, 36, 38, 120, 126, 128, 133, 149, 174, 175, 185, 187, 197, 203-206, 208-211, 214 Viaggio nella Luna, 119 Victory at Sea, 107, 143, 159, 165 Vigo, Jean, 131 Visconti, Luchino, 128 Vlast’ Solovetskaija, 40, 87, 89, 90 War, The, 152 War, The (serie), 162 War Game, The, 40 War Room, The, 40, 88 Watsonville on Strike, 72, 73, 174, 211 Watt, Harry, 27, 36 Waugh, Thomas, 218 Ways of Seeing, 159, 234 We Are the Lambeth Boys, 36 Wedding Camels, 48, 107, 144, 146, 167, 189 Weill, Claudia, 215 When the Levees Broke: A Requiem in four Acts, 228 Who Killed Vincent Chin?, 15, 17, 191, 231 Why We Fight, 99, 234 Why We Fight (serie), 46, 143, 150, 159, 162, 196, 207, 208, 227 Wilkerson, Travis, 162 Winston, Brian, 200, 201, 209, 214
Wiseman, Frederick, 36, 66, 67, 98, 100, 151, 166, 167, 170 With Babies and Banners: The Story of the Women’s Emergency Brigade, 39, 215 Woman’s Film, The, 144, 188, 214, 215 Word Is Out, 70, 144, 173, 181, 217, 218, 220 Wright, Basil, 27, 36, 158, 209, 248 Wuornos, Aileen, 21, 22, 23 Yadin, Orly, 156 Yidl in the Middle: Growing Up Jewish in Iowa, 68 Yosemite: The Fate of Heaven, 159 Zahedi, Caveh, 187 Zapruder, Abraham, 18, 139 Zeigt ein Licthspiel: Schwarz, weiß, grau, 155 Zvenigora, 125 Zwigoff, Terry, 86, 179
RINGRAZIAMENTI Il mio più grande debito di gratitudine è per gli studenti che hanno studiato con me il documentario nel corso degli anni. La loro curiosità e le loro domande costituiscono la ragione di questo libro. Sono altresì grato a tutti coloro che hanno partecipato alle conferenze di Visibile Evidente, sin dal 1993, al fine di scambiare opinioni e dibattere sulla questione del documentario. Queste conferenze, inaugurate da Jane Gaines e Michael Renov, hanno costituito un’insostituibile occasione di scambio relativa al documentario nei più ampi termini possibili. Senza il contributo dei registi che mi hanno fornito le immagini dei loro film questo libro sarebbe stato molto più povero. Li ringrazio per la loro sollecitudine nell’inviarmi magnifiche immagini. Michael Wilson ha cominciato e Victoria Gamburg ha proseguito i contatti con le case di distribuzione. La loro assistenza è stata puntuale e indispensabile al completamento della prima edizione. David Gray si è assunto il compito di ricavare i fotogrammi di cui avevo bisogno, portandolo a termine superbamente. Sono molto in debito con David per il suo aiuto inestimabile. Jane Behnken è stata il mio editore di riferimento all’Indiana University Press per la preparazione della seconda edizione. Il suo sostegno ed entusiasmo all’idea di una seconda edizione si è dimostrato insostituibile.