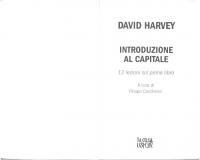Introduzione al teatro greco 8888242090, 9788888242095
Milano: Mondadori Università, 2003. — 91 p. — ISBN 88-882-4209-0.Il teatro greco, prima e fondamentale radice del teatro
487 134 1MB
Italian Pages 160 [91] Year 2004
Polecaj historie
Citation preview
Giulio Guidorizzi insegna Teatro e Drammaturgia dell'Antichità presso l'Università di Torino. Tra le sue opere più recente oltre a numerosi saggi sulla letteratura greca e sull'antropologia del mondo antico, si possono citare le edizioni delle Baccanti di Euripide (Venezia, 1989), della Biblioteca di Apollodoro (Milano, 1995) e delle Nuvole di Aristofane (Milano, 2002), le traduzioni dello Ione di Euripide (Milano, 2000) e dei Miti di Igino (Milano, 2000). È autore anche di una Letteratura greca (Milano, 2002). Il teatro greco, prima e fondamentale radice del teatro occidentale, è un fenomeno assolutamente particolare per lo straordinario intreccio di elementi poetici, rituali, sociali e politici che in esso si realizza. Il poeta è chiamato a comporre un'opera che ha nel pubblico cittadino il committente e il primo destinatario. Sulle gradinate del teatro di Dioniso, nell'Atene del V secolo a.C., sedeva tutta la popolazione per assistere non a un semplice spettacolo ma a un rituale cittadino in cui ogni anno la polis rinnovava la propria identità collettiva. Senza comprendere questa dimensione sociale e antropologica, è impossibile avvicinarsi alla meraviglia del dramma antico, alle sue trame così lontane da quelle del teatro occidentale successivo, al suo valore quasi religioso, alla forza dei suoi testi che rispecchiano la cultura dell'epoca d'oro della Grecia. La raccolta di saggi che qui si presenta, a cura di Giulio Guidorizzi, guida il lettore attraverso le nozioni teoriche fondanti del teatro classico ateniese, le sue realizzazioni sceniche (costumi, maschere, danza e musica), nonché la drammaturgia di tragedia e commedia. SOMMARIO (1. Caratteri generali del teatro greco) (2. Lo spettacolo teatrale) (3. La tr igedia) (4. La commedia) isbn 88-882-4209-0 Prezzo al pubblico Euro 10,30
azimut sezione umanistica diretta da eva cantarella e giulio guidorizzi
simone beta giulio guidorizzi silvia romani roberta sevieri introduzione al teatro greco a cura di giulio guidorizzi
© 2003 Mondadori Università Edumond Le Monnier S.p.A. Tutti i diritti riservati Prima edizione: marzo 2003 Edizioni 1 2 3 4 5 6 7 8 2003 2004 2005 2006 Stampato in Italia - Printed in Italy Stampa Grafica Dieci. Città di Castello (PG) Copertina di Luisa Conte
1. Caratteri generali del teatro greco di Giulio Guidorizzi
1.1 II teatro, un rituale cittadino Il teatro greco ha una data di nascita: nell'anno 535 a.C. il tiranno Lisistrato riorganizzò le feste pubbliche in Atene e diede spazio a una forma di poesia ancora assolutamente sperimentale, la tragedia, per cui istituì appositi concorsi destinando a questo scopo il recinto sacro di Dioniso Eleutereo ("Liberatore") ai piedi dell'Acropoli. Secondo la notizia dei cronachisti antichi (come il redattore del Marmor Parium), il primo vincitore ai concorsi fu Tespi del demo attico d'Icaria, che durante la sessantunesima Olimpiade (536-533
a.C.) «per primo recitò e mise in scena in città un dramma: il premio era un capro». Tespi è un personaggio semileggendario a cui gli antichi attribuivano varie innovazioni, tutte fantasiose: si diceva che avesse inventato il trucco tingendosi la faccia con biacca e poi avesse introdotto la maschera e anche che vagasse con la sua compagnia di attori di villaggio in villaggio sopra un carro (il "carro di Tespi" di Orazio, Ars poetica, 276). Il carro di Tespi di cui favoleggiavano gli antichi è forse il ricordo di pratiche rituali: era usanza portare le statue processionali di Dioniso sopra carri o barche semoventi montate su ruote e restano anche confuse memorie di elementari performance mimetiche con sfilate di carri durante le feste dell'anno agricolo (gli «scherzi dal carro» di cui parla il bizantino Lessico Suda). Di Tespi si conservano i titoli di quattro tragedie e una manciata di frammenti, ma il tutto è probabilmente un falso di epoca posteriore; è noto che il peripetetico Eraclide Pontico, nel secolo iv a.C., compose drammi e li fece circolare attribuendoli a Tespi. Che cosa fosse la tragedia in quei primissimi anni della sua storia non possiamo saperlo con precisione. Gli eruditi antichi amavano immaginare una sorta di antropologia teatrale primitiva: un rustico ambiente contadino, semplici compensi in natura per gli artisti, attori che si truccano il viso con biacca o mosto d'uva, un carro che vaga col suo carico di rudimentali costumi di scena, ossia lo spaccato di una comunità autosufficiente la cui vocazione è vendere illusioni a persone semplici, come la compagnia di attori girovaghi raffigurata da Ingmar Bergman ne Il settimo sigillo. La realtà fu ben diversa: il teatro greco non è il prodotto di un marginale ambiente contadino, ma un fenomeno centrale nella vita della città ed è solo apparentemente paradossale il fatto che gli spettacoli drammatici, patrocinati in origine da un tiranno, siano poi diventati l'espressione più significativa della civiltà democratica ateniese del secolo v a.C., l'epoca più alta e creativa della cultura greca. Il dramma greco non nasce nell'ambito degli attori che lo improvvisano; nasce dall'opera consapevole di un poeta che compone per un pubblico cittadino, il quale è, in un certo senso, il vero padrone del testo, in quanto suo committente e destinatario. Il teatro greco fu un fenomeno politico, vale a dire una manifestazione collettiva della polis, la città intesa come comunità di individui con pari facoltà di parola (isegoría) e pari diritti davanti alle leggi (isonomía): non un giocattolo di lusso per l'aristocrazia, come il teatro di corte europeo, e neppure un evento cultural-mondano come il teatro borghese, ma un rituale collettivo che coinvolgeva migliaia di spettatori, in sostanza tutti i cittadini maschi di Atene (è discusso se e in che misura vi partecipassero anche donne, bambini, schiavi). Una delle caratteristiche fondamentali del teatro greco è appunto di mettere al suo centro la città; per usare una bella formulazione di J.-P. Vernant, in Grecia è la città stessa che si fa teatro ponendosi sulla scena davanti ai cittadini, e di questa operazione il poeta, tragico o comico, è chiamato a fare da mediatore. Questo è evidente per la commedia, che tratta di eventi e personaggi di attualità, ma è altrettanto vero per la tragedia, nella quale il mito tradizionale viene tradotto in termini familiari alla cultura del pubblico di Atene e diventa materia di teatro solo in quanto perde il suo arcaico carattere tribale per diventare qualcosa di completamente nuovo. Dovunque la scena di una tragedia sia ambientata, a Tebe come a Troia, dietro il tessuto del dramma s'intravede Atene col suo universo cittadino, dove le vicende degli eroi mitici vengono reinterpretate. La vicenda tragica non si può comprendere davvero se non all'interno delle dinamiche profonde della vita cittadina: il potere, le leggi, le istituzioni sociali, il conflitto tra individuo e società o, ancora, la vendetta all'interno del clan, la crisi dei rapporti familiari, la ribellione della donna all'autorità della famiglia. Quella dell'eroe sulla scena non è mai - salvo forse in alcuni drammi di Euripide, l'autore in cui Nietzsche identificò 1'"assassino" della tragedia - una storia privata, così come manca nella tragedia greca il dramma d'amore che diverrà così centrale nella tragedia europea moderna: inevitabilmente la vicenda si dilata sulla società, il solo ambito, nella prospettiva dei greci, che dia un senso all'esistenza di quello che Aristotele definiva r«animale politico», l'uomo. La dimensione sociale del teatro greco è perfettamente espressa da un elemento caratteristico della sua drammaturgia: l'azione si svolge all'esterno, in uno spazio pubblico, sotto gli occhi di tutti e in presenza di un coro che assiste alle vicende e ai conflitti dei personaggi; le scene d'interno sono escluse nel dramma greco dove anche ciò che è intimo e privato deve diventare pubblico e collettivo. L'interno - lo spazio in cui sovente avvengono le azioni decisive di un dramma, come l'accecamento di Edipo o l'assassinio di Agamennone - per gli spettatori greci è un esterno, vale a dire uno spazio dove lo sguardo non può penetrare: lì l'azione scenica,
il dràma, non arriva e le cose che vi accadono possono essere soltanto riferite. In Atene il teatro era un servizio pubblico (liturgia) la cui organizzazione veniva diretta e controllata dallo stato. L'autore era quindi esentato dalla necessità di andarsi a cercare un pubblico e i mezzi economici per sostenere lo spettacolo: a questo e a ogni altro aspetto organizzativo provvedeva infatti la polis, che d'altra parte si preoccupava di consentire a ogni cittadino di assistere agli eventi teatrali elargendo un contributo (theorikón) ai meno abbienti perché potessero pagarsi il biglietto. Il poeta deve quindi rispondere al pubblico della città nel suo complesso, non a un'élite, e deve farlo procurandogli il dolceamaro piacere di emozioni forti, «pietà e terrore» (come scriveva Aristotele); deve appassionarlo e commuoverlo, talvolta provocarlo e ammonirlo; deve celebrare la grandezza di Atene e della sua democrazia riproponendone sulla scena i valori; in definitiva, deve tradurre in termini teatrali il sistema culturale degli spettatori e il loro immaginario collettivo. Il teatro greco era il momento culminante di un rituale cittadino in cui, all'inizio della primavera, si celebrava il dio Dioniso e con esso l'anno nuovo che riprende a fiorire. Il rapporto di Dioniso col teatro è ambiguo e complesso. Dioniso era un dio della natura vegetale e in particolare della vite e della vinificazione; presiedeva inoltre a culti orgiastici praticati soprattutto da donne, che comprendevano musica e manifestazioni di trance ed erano effettivamente praticati in alcune zone della Grecia anche in epoca storica. Di questi riti le Baccanti di Euripide offrono una descrizione affascinante e terribile. Non è del tutto chiaro il motivo storico per cui Dioniso divenne il patrono degli spettacoli teatrali in Atene; una delle ragioni fu probabilmente la connessione delle manifestazioni teatrali primitive con feste agricole della vegetazione, durante le quali si praticavano forme mimetiche con finalità rituali. L'ipotesi ritualistica sull'origine del teatro greco, per quanto non dimostrabile con certezza, conserva la sua forza; del resto il più antico rappresentante di questa teoria fu Aristotele, che collegava la nascita della commedia a feste contadine della fecondità (le «falloforie»). Peraltro Dioniso, appunto in quanto patrono di manifestazioni psicologiche estreme come l'ebbrezza e la follia, nel pantheon greco era il più adatto a rappresentare l'illusione teatrale, che è fondata su una sospensione della nozione di identità e sulla volontà del pubblico di accettare il gioco scenico e farsi coinvolgere nella finzione drammatica. La prima definizione dell'implicito patto che si stabilisce tra scena e pubblico, senza il quale non è nemmeno pensabile il teatro, risale al sofista Gorgia, che negli ultimi decenni del secolo v, parlando della tragedia, scrisse che «in essa il più saggio è colui che più si lascia ingannare», ossia coinvolgere nell'illusione che gli attori sulla scena costruiscono alla fantasia degli spettatori. La presenza di un aspetto visionario e della volontà di illudere e di autoilludersi è tanto più rilevante in quanto il teatro greco non fu naturalistico, ma fortemente convenzionale: più che le azioni, erano le parole degli attori a generare nella fantasia degli spettatori non solo le emozioni ma anche gli spazi e i tempi dell'azione, mediante quella che si definisce scenografia verbale. Dal punto di vista della psicologia della comunicazione, l'atteggiamento del pubblico ateniese era condizionato da un'abitudine secolare all'ascolto collettivo. La letteratura greca infatti fu sin dalle origini orale, concepita quindi per essere recitata da un esecutore in una pubblica performance e non fruita nell'isolamento della lettura. La rappresentazione teatrale non fa altro che amplificare il modello comunicativo praticato dai rapsodi che si esibivano declamando episodi di Omero. Il pubblico ateniese trasferì sul teatro la sua abitudine all'ascolto e alla visualizzazione del testo; e per questo motivo il dramma greco non ha bisogno di tanti strumenti per funzionare: a visualizzare la suggestione di un paesaggio, la violenza di un gesto, persino l'atteggiamento di un viso che piange o ride (che agli spettatori resta invisibile, coperto com'è dalla maschera) bastano le parole dell'attore. Il dio della follia e dell'ebbrezza, quel Dioniso grazie al quale i contorni della personalità si dilatano, è lo stesso che presiede all'illusione che si delinea quando ci si abbandona al fascino della finzione scenica; nel teatro greco quest'ambigua nozione di identità era ancor più esaltata dall'uso della maschera. La maschera è lo strumento che consente a una persona di alienarsi da sé per assumere provvisoriamente una differente personalità attraverso il cambiamento del primo e fondamentale elemento di riconoscimento, vale a dire il volto; è un mezzo nello stesso tempo profilattico (perché protegge la persona che la indossa dall'assalto di forze maligne) e magico (perché favorisce l'ingresso in un'altra personalità), e infatti la maschera è universalmente impiegata con questo scopo nei rituali e nelle danze di ogni popolazione. L'uso della maschera ha inoltre importanti conseguenze sul piano dell'estetica teatrale: neutralizzando il viso, essa crea un diaframma nel processo d'identificazione tra spettatore e attore ed esalta altri aspetti della rappresentazione
(in particolare la voce e la gestualità). L'impiego della maschera nel teatro si collega a un sottofondo magicorituale: in Grecia il suo uso è testimoniato nel culto di varie divinità (come Artemide Ortia a Sparta), come elemento di compene-it 11/ione tra il dio e il fedele. Anche Dioniso era venerato talvolta in l'orma ili maschera appesa a un albero e nelle processioni dionisiache il mascheramento era di rigore.
1.2 La tragedia La natura e la storia della tragedia pongono una serie di problemi attorno ai quali la critica non ha cessato di interrogarsi, a partire dalla Poetica di Aristotele che rappresenta il primo capitolo di un dibattito più che millenario. Aristotele aveva una concezione evolutiva della letteratura, perciò, n suo parere, la tragedia era il punto terminale di un processo iniziato con la forma di poesia più antica, l'epica: l'arte poetica fu dapprincipio narrazione, poi l'èpos divenne dràma, azione, e nacque il teatro. Per certi aspetti, Aristotele aveva ragione. Quasi tutti gli strumenti utilizzati nel dramma si trovano già nella poesia precedente: la danza, il coro, la musica, il canto, la metrica, le trame. La tragedia riorganizza tutto questo in forme che le sono proprie per elaborare un linguaggio che è nello stesso tempo nuovo e tradizionale, lavorando con lo stesso materiale della poesia epica, vale a dire il mito. Il poeta non ha bisogno di ideare trame e personaggi poiché li trova già presenti nella memoria collettiva; il suo compito non è inventare nuovi racconti, ma fare qualcosa di nuovo con quelli che già esistono, passando dal mito-racconto al mito-dramma. Il caso di trame inventate è eccezionale: abbiamo vaghe notizie di una tragedia del poeta Agatone, l'Anteo, in cui tutti i personaggi erano fittizi. Solo un po' meno eccezionali erano i casi in cui il poeta metteva in scena eventi storici; lo si fece soprattutto ai primordi del genere tragico, come nel caso di Frinico, autore di una Presa di Mileto e di Fenicie che trattavano le vicende della guerra dei greci contro i persiani. Questi drammi sono andati perduti, mentre si sono conservati i Persiani di Eschilo che parlano dello stesso argomento e sono anzi il più antico testo del teatro mondiale (472 a.C.). L'interesse per vicende storiche sembra essersi riaffacciato nella tragedia postclassica del secolo iv a.C.; si ha notizia di un Mausolo (il re di Caria) del tragico Teodette, di un Temistocle di Moschione e del dramma satiresco Agen di Pitone di Catania, che derideva il potente tesoriere di Alessandro Magno, Arpalo, e fu rappresentato alla presenza dello stesso re macedone. Nella tragedia greca la libertà ideativa del poeta è dunque limitata dalla tradizione, dato che il dramma altro non fa che trattare e ritrattare le vicende degli stessi eroi di cui parlavano le saghe di Omero e degli altri poeti epici, a cui i tragediografi erano vincolati: «non è possibile disfare i racconti tramandati (scrive Aristotele in Poetica 1553b), per esempio quello secondo cui Oreste uccide Clitemnestra e Alcmeone Enfile, ma il poeta deve trovare modo di usare bene la tradizione». Questo non significa che le trame delle tragedie siano ripetitive. È caratteristica congenita del mito quella di essere un racconto fluido, capace di assumere forme diverse ogni volta che viene rinarrato; tale caratteristica è tanto più esaltata dal teatro, nel quale una delle scommesse dell'autore è di misurarsi con i testi dei predecessori, facendo emergere dal racconto tradizionale aspetti sempre nuovi attraverso la dialettica dei personaggi. Entro certi limiti il poeta è anzi tenuto a presentare al pubblico una faccia nuova del mito, pur mantenendo immutato il quadro di fondo. L'Antigone di Sofocle, in cui la protagonista si sacrifica nobilmente per riaffermare i valori fondamentali della legge familiare, era ben diversa dall'omonima (e perduta) tragedia di Euripide, scritta vari anni più tardi, che presentava un intreccio pieno di colpi di scena nel quale Antigone sposava il fidanzato Emone e dava alla luce un figlio; la cupa Elettra di Eschilo è profondamente diversa da quella di Sofocle, animata da un tenace e violento odio verso la madre, e ancora di più da quella di Euripide, che s'inventa l'idea di un matrimonio tra l'infelice principessa e un oscuro contadino e fa comparire Elettra sulla scena come una donnetta del popolo, mentre si avvia con una brocca sulla testa ad attingere acqua a una sorgente. La tragedia greca non vive della novità delle trame, ma del potere del mito di essere uno e molteplice e della sua capacità di raggiungere strati profondi dell'esperienza umana. Rispetto al mito narrato dall'epica la tragedia apporta però una straordinaria innovazione: i personaggi si staccano dal racconto per agire autonomamente sulla scena e non sono descritti da un narratore esterno, ma compaiono davanti agli occhi del pubblico come individualità distinte, ciascuna provvista di una propria vita psicologica. L'epica è una narrazione (èpos, «parola»), il teatro è un'azione (dràma, «dramma», da drào, «agire»). Sotto certi punti di vista il teatro sembra perdere alcune possibilità espressive rispetto all'epica: il passaggio dal
racconto all'azione impedisce, infatti, l'incalzante serie di eventi che rendono a tratti travolgente il racconto di Omero, nel quale i tempi della narrazione possono essere condensati o allentati. La tragedia è obbligata invece a selezionare un solo momento del racconto e a collocarlo in un tempo e in uno spazio rappresentabili sulla scena, con le oggettive restrizioni che questo comporta. I limiti della rappresentazione rispetto alla narrazione sono però compensati da un fatto veramente rivoluzionario, vale a dire la possibilità di scavare nei personaggi, nella loro psicologia, nelle loro motivazioni, in sostanza di dare profondità alle figure del mito. Nel momento in cui un personaggio (Achille, Aiace o Agamennone) esce dal racconto per essere impersonato da un attore che agisce sulla scena davanti al pubblico, avviene un altro passaggio decisivo: questo personaggio assume un'autonomia psicologica e artistica del tutto impensabile rispetto ai mezzi espressivi della poesia recitata. Gli eroi tragici mostrano ciascuno un proprio volto al pubblico, acquistano spessore, discutono, lottano, si amano, si odiano, avviluppali da una trama di emozioni, idee, passioni che riducono immensamente lo spazio tra il mondo lontano del mito e l'attualità degli spettatori. La tragedia, quindi, traduce il mito in termini assai vicini all'esperienza degli spettatori e nello stesso tempo lo trasforma profondamente, fino a renderlo molto più complesso e profondo rispetto a quello che era slato nella cultura tradizionale. La psicologia degli eroi mitici si amplia e si approfondisce via via, col raffinarsi del linguaggio tragico, passando dai rigidi personaggi di Eschilo a quelli decisamente moderni di Euripide: nel teatro trova espressione la scoperta della profondità della mente e delle emozioni, senza le quali nessuna forma di rappresentazione è pensabile. L'azione tragica non mostra quindi soltanto personaggi che agiscono, ma ne mostra il carattere - éthos, come diceva Aristotele che emerge e si plasma attraverso l'azione e la relazione con altri personaggi. Dal punto di vista della comunicazione, dunque, la tragedia sviluppa mezzi espressivi completamente nuovi. È uno spettacolo (théatron, da theàomai, «guardare») assai complesso: c'è un coro che canta, e attori che recitano e declamano, ma talvolta accade che il coro reciti e l'attore canti in monodie o in alternanza al coro; in altri momenti il coro danza, mentre un flautista e altri musici accompagnano i momenti della rappresentazione. Il cuore della tragedia è il testo, ma un testo di tipo particolare, che si fa intreccio e azione; quello greco fu infatti (come abbiamo detto) un teatro della parola, e questo per noi è tanto più vero in quanto gli altri elementi dell'esecuzione (musica, danza, canto) non ci sono più accessibili e possono essere restaurati solo in via ipotetica. Anche Aristotele del resto, distinguendo nella tragedia sei elementi (intreccio, caratteri dei personaggi, stile, ideazione, musica, spettacolo), attribuì al mythos o intreccio il ruolo fondamentale, più ancora che alla caratterizzazione dei personaggi: «il fine della tragedia sono i fatti e l'azione: senza azione non può esserci tragedia, senza caratteri sì» (Poetica 1450a). La centralità del testo rispetto agli altri aspetti della rappresentazione emerge anche dalla grande elaborazione stilistica del linguaggio tragico, un linguaggio «alto» (lo stile tragico è per eccellenza elevato e sublime, mentre lo stile della commedia è più vicino alla lingua d'uso) che nei canti corali diviene fastoso e solenne. La solennità dello stile e dello spettacolo è il dato formale più caratteristico che la tragedia greca trasmette alla teoria letteraria successiva, per arrivare allo stile tragico del classicismo europeo. Gli spettatori antichi percepivano questo stile come intrinsecamente connaturato allo spettacolo tragico: quando nelle Rane Aristofane mette in scena la decadenza della tragedia, il punto su cui batte in particolare è la contrapposizione tra il linguaggio elevato del padre del dramma, Eschilo, e quello del grande provocatore Euripide, nelle cui opere lo stile tende ad assumere forme meno solenni: «io - dice l'Euripide di Aristofane (vv. 940 sgg.) - ho ricevuto da Eschilo un'arte gonfia di pomposità e paroloni e l'ho assottigliata togliendole peso con parolette e ideuzze». Sarà però Eschilo, alla fine di questa gara, a riportare la vittoria su un rivale accusato di aver depauperato la tragedia semplificandone il linguaggio. I teorici antichi parlavano della tragedia come di un perfetto esempio di mimesi o imitazione della realtà; questa mimesi avviene all'interno di un sistema di codici e di convenzioni, patti non scritti ma rispettati tra scena e pubblico. La struttura drammaturgica tipica della tragedia è la forma chiusa. Una forma chiusa tende alla concentrazione, con un intreccio semplice e l'emergere di poche figure-chiave attorno a cui ruota un'azione unitaria; la forma aperta al contrario dilata l'azione, aumenta il numero dei personaggi e contemporaneamente diminuisce il loro approfondimento psicologico e il loro peso sul corso degli eventi, complicando per converso gli intrecci. La tragedia greca adotta generalmente il primo schema, ma mostra verso la fine della sua evoluzione (specialmente col tardo Euripide) una certa tendenza verso il secondo. Tragedie come Medea o Edipo Re, focalizzate su un solo personaggio, sono esempi di forma chiusa; Fenicie e Oreste di forma aperta.
La necessità di rendere organica la trama della tragedia è generalmente nota come «unità d'azione», un concetto reso canonico ancora una volta dalla Poetica di Aristotele, che dal Rinascimento in poi divenne il punto di riferimento fondamentale per la drammaturgia tragica: «come nelle altre arti mimetiche la mimesi è una se uno solo è il suo oggetto, cosi occorre che anche la trama [della tragedia], che è mimesi di un'azione, lo sia di un'azione unica e completa e che le parti di una storia si compongano in modo tale che se una parte viene eliminata, cambi e si disgreghi il tutto» (Poetica, 1451a). Le altre due unità su cui si fondava l'estetica teatrale del classicismo europeo, vale a dire quelle di tempo e di azione, non sono enunciate da Aristotele - la loro prima formulazione risale al commentario alla Poetica di Ludovico Castelvetro, del 1570 - ma appaiono generalmente rispettate nelle tragedie che ci sono rimaste, nelle quali l'azione tende a concentrarsi in uno stesso luogo e ad essere circoscritta nell'arco di un solo giorno, sebbene con varie eccezioni, come le Eumenidi di Eschilo, che iniziano a Delfi e terminano ad Atene. Quanto al tempo, l'Agamennone dello stesso poeta inizia nella notte della presa di Troia ma prosegue di giorno, e anzi presuppone una certa estensione temporale, dato che sulla scena compare lo stesso Agamennone con le spoglie della città da lui conquistata. Il problema del tempo scenico viene risolto empiricamente: quando l'azione dei personaggi è sospesa (per esempio, da un canto del coro) si presuppone che la divaricazione tra il tempo reale e il tempo interno dell'azione teatrale sia variabile, e il tempo scorra più o meno velocemente a seconda delle esigenze della vicenda. Il teatro tragico greco presenta un aspetto difficile da tradurre in termini performativi agli occhi di un pubblico moderno, vale a dire la presenza di un coro. Per il pubblico ateniese invece la presenza del coro sulla scena non era un impaccio ma un elemento ovvio: la tragedia, anzi, ebbe origine dal canto corale. La danza e il canto (giacché queste sono le funzioni specifiche del coro) rendevano la tragedia qualcosa di simile all'opera in musica moderna, la quale del resto fu inventata a tavolino in epoca rinascimentale proprio assumendo come modello la tragedia greca; la fastosità del canto e la suggestione delle danze corali esaltavano l'azione drammatica. Musica e danza in Grecia erano linguaggi evoluti, frutto di una lunga abitudine che risaliva alle origini della letteratura greca, ed erano le basi stesse dell'educazione; la tragedia consentiva di vedere il loro effetto moltiplicato sulla scena dall'intreccio col testo recitato. Peraltro, il coro tragico non è un semplice «spettatore ideale» (la definizione è di Schlegel), come suggeriva l'estetica romantica, che gli attribuiva la sola funzione di commentare l'azione, ma tende a essere uno spettatore-attore che talvolta agisce, talvolta si limita a commentare o compiangere. Da un certo punto di vista, può essere vero che il coro è la proiezione del pubblico sulla scena: ne rappresenta infatti il punto di vista, se non altro perché si fa portavoce di un sistema di valori condiviso dall'uditorio. Tuttavia il coro può anche agire come un vero e proprio personaggio, il che appare evidente nella fase più arcaica della tragedia, anche se successivamente il suo ruolo tende a ridursi vistosamente. «Il coro - osservava Aristotele (Poetica, 1556a) - deve assumere la parte dell'attore e partecipare all'azione come fa in Sofocle, e non come in Euripide». Le fonti antiche parlano di una forte compenetrazione emotiva tra pubblico e attori, e del resto anche Aristotele riteneva che il fine della tragedia fosse quello di produrre nella mente dello spettatore una fortissima emozione psicologica: «la tragedia attraverso la pietà e il terrore produce la purificazione (katharsis, "catarsi") da simili emozioni» (Poetica I449b). Il fine della tragedia non è dunque solo spettacolare; sostanzialmente, il pubblico deve uscire da teatro diverso da come ne era entrato, e il teatro diviene l'occasione per una specie di psicodramma collettivo in cui tutta la città è coinvolta. Sul significato del concetto di «catarsi» è stato versato molto inchiostro e non si può dire che il significato di questa famosa formulazione aristotelica sia stato perfettamente chiarito; nel termine katharsis confluiscono un valore magicorituale (purificazione da una contaminazione), uno psicologico (la liberazione da un surplus di emotività) e uno medico (guarigione, eliminando gli umori che inquinano un corpo). Poiché Aristotele pensava che i comportamenti irrazionali allontanassero un uomo dalla sua vera natura, è possibile che accentuasse il valore catartico della tragedia, intendendola come un mezzo capace di ricondurre gli spettatori alla loro piena razionalità, e quindi umanità: in sostanza, si trattava di una sorta di medicina collettiva che aprendo l'accesso a stati d'animo marginali ne facilitava il superamento, nel corso di uno spettacolo-rito vissuto con possente partecipazione emotiva.
1.3 L'origine della tragedia L'origine della tragedia costituisce uno dei problemi tradizionali della letteratura greca, su cui è stato versato molto - forse troppo - inchiostro: in definitiva (per usare le parole di P. Vidal Naquet) «la tragedia greca non ha altra origine che se stessa». Tuttavia, indagare sulla sua preistoria significa anche prendere coscienza degli aspetti sia formali sia antropologici, che operano in profondità nell'elaborazione e nello sviluppo del genere
tragico. Ogni possibile interpretazione parte dalla Poetica di Aristotele, il primo che abbia formulato una teoria complessiva sul genere tragico, raccogliendo una documentazione - a noi inaccessibile - sulle fasi più antiche del dramma. «La tragedia - scrive Aristotele (Poetica, 1449a) - nasce da origini improvvisate» ed esattamente «da coloro che intonano il ditirambo (apó tón exarchónton tón dithyrambon)», vale a dire il canto in onore di Dioniso. Poco dopo, il filosofo aggiunge che le prime manifestazioni tragiche erano brevi e in linguaggio semiserio, perché contenevano un «elemento satiresco» (satyrikón) e la poesia era condizionata dalla danza; successivamente il linguaggio assunse un tono elevato (aposemnythe, «divenne serio»), il metro fu modificato (dal tetrametro trocaico al trimetro giambico) e la tragedia raggiunse la sua forma definitiva. Il nucleo dell'azione tragica sarebbe da individuare nel corifeo (ovvero capocoro), che a un certo punto si stacca dal gruppo dei coreuti e inizia a dialogare con loro, sinché diventa un vero e proprio personaggio e non soltanto un narratore. Un indizio di questo sviluppo sembra suggerito da una delle più antiche tragedie di Eschilo, le Supplici, in cui il protagonista collettivo è appunto il coro, formato da un gruppo di ragazze che fugge ad Argo e chiede asilo al re di quella città per evitare le nozze indesiderate con i cugini, gli egizi, che le stanno inseguendo. Qui troviamo tre scene (vv. 348 sgg., 734 sgg., 882 sgg.) nelle quali sezioni declamate da un attore seguono un canto del coro (secondo uno schema denominato epírrema): questo potrebbe essere un esempio di tragedia legata a modelli arcaici, dove il dramma è costituito da uno scambio di battute tra coro e attore. La teoria della derivazione dal ditirambo giustificherebbe il fatto che ad Atene gli spettacoli tragici avvenivano durante feste in onore di Dioniso e il largo spazio occupato dal coro nella fase più antica del dramma (specialmente in Eschilo), spazio che in seguito va progressivamente riducendosi. Restano però vari punti oscuri: come avvenne che il canto in onore di Dioniso iniziò a celebrare le imprese di altri eroi? In effetti la tragedia poco in comune ha con Dioniso, per quanto riguarda il contenuto, dato che tratta i miti degli eroi e non la storia sacra del dio: al punto che l'espressione «non ha nulla a che vedere con Dioniso» (che secondo la tradizione il pubblico ateniese gridò una volta, dopo avere constatato che le tragedie trattavano tutt' altro argomento) divenne un proverbio usato per definire situazioni incongrue. A un certo punto della storia del ditirambo si dovette verificare un ampliamento dei temi trattati e un intreccio tra il culto di Dioniso e quello degli eroi. Una fase di questo sviluppo si può forse intravedere da un passo di Erodoto (5,67), dal quale apprendiamo che il tiranno distene di Sicione, nella seconda metà del secolo vi a.C., impose una vera e propria censura sulle pubbliche feste della sua città, vietando di onorare Adrasto perché era l'eroe della città nemica di Argo; prosegue Erodoto: «gli abitanti di Sicione gli attribuivano molti onori e celebravano in cori tragici (tragikóisi choróisi) le sue tristi vicende... ebbene, distene restituì a Dioniso i cori tragici». Sembra quindi di dedurre che in questi «cori tragici» di Sicione si narrassero le vicende mitiche di eroi locali e che questa festa fosse stata poi riassorbita nell'ambito del culto di Dioniso. È difficile identificare esattamente che cosa fossero i cori tragici di cui parla Erodoto e a che cosa si riferisse Aristotele quando parlava di «elemento satiresco» come caratteristica della tragedia primitiva: non certo al dramma satiresco che nacque dopo la tragedia seguendone il modello. Possiamo ipotizzare che si trattasse di una forma serio-comica di dramma, a carattere rituale, forse affidata a un coro di demoni animaleschi della fertilità (i satiri), che facevano parte del corteo dionisiaco, e che queste danze avessero stretti legami con cerimonie della vegetazione. D'altra parte, il rapporto tra tragedia e ditirambo risulta anch'esso oscuro, in considerazione del fatto che niente o quasi degli antichi ditirambi si è conservato; per intero ne possediamo due soltanto, entrambi di Bacchilide, attivo quando già la tragedia aveva assunto la sua forma e che quindi dalla tragedia poteva essere stato influenzato. Essi trattano non un mito dionisiaco ma quello di Teseo, il grande eroe ateniese; uno dei due (il ditirambo intitolato Teseo) è dialogato e comporta uno scambio di battute tra due semicori (oppure tra un messaggero e il coro), secondo un modello che può essere accostato a quello della tragedia primitiva. Forse in epoca arcaica si sviluppò un ditirambo non limitato al culto dionisiaco. Un personaggio significativo, in questo campo, fu Arione di Lesbo, un famoso poeta del secolo vi a.C. a cui Erodoto fa riferimento (1,23) come all'inventore del ditirambo: ne fu invece uno degli innovatori, e sembra (se dobbiamo dare credito al bizantino Lessico Suda) che in questi ditirambi avesse introdotto cori di satiri. Oscura è anche l'etimologia di «tragedia»; si distinguono chiaramente le radici di «canto» (ode) e «capro» (tràgos), quindi la parola significherebbe «canto del capro». Gli antichi stessi ignoravano il valore
dell'espressione e fantasticavano che volesse dire «il canto del capro», ossia dei satiri camuffati da demoni caprini (ma i satiri appaiono nelle raffigurazioni antiche come mezzi uomini e mezzi cavalli!) oppure «il canto per il capro» che sarebbe il premio attribuito al vincitore in quanto animale sacrificale a Dioniso. È probabile, dopo tutto questo, che si possa giungere a una conclusione: la tragedia non ha una sola origine, ma nasce dal confluire di suggestioni e forme diverse. Ogni traccia, comunque, porta a uno spettacolo a sfondo rituale che mantiene connessioni con l'antica civiltà agraria.
1.4 Eroi ed eroine Non tutto il mito era argomento di tragedia: generalmente dal teatro resta esclusa la storia sacra degli dei (con l'eccezione del Prometeo di Eschilo). Va peraltro considerato che la civiltà greca non ebbe libri sacri o una teologia ufficiale elaborata da una casta sacerdotale; se è vero che la tragedia fu un rituale collettivo della città, è però tutt'altro che una sacra rappresentazione. Al centro della tragedia sta un eroe. Questa è una categoria non solo letteraria ma soprattutto culturale: con la parola «eroe» (héros) i greci designavano personaggi semidivini le cui vicende erano conservate nella memoria collettiva, i quali ricevevano onori di culto ed erano considerati gli antenati mitici delle famiglie aristocratiche. Ciò che distingue un eroe da un dio è l'origine (gli eroi discendono, in via diretta o indiretta, da una divinità e da un essere mortale) e il fatto di essere soggetto al destino di morte che accomuna tutti gli uomini; da un lato gli eroi sono vicini agli dei poiché come loro vivono nel venerabile tempo-senza tempo delle origini, ma dall'altro sono vicini all'umanità del pubblico per le loro vicende e le loro sofferenze. Le figure eroiche furono di enorme importanza, oltre che per la religione, anche per la letteratura greca: attorno a loro infatti si sviluppò, da epoca antichissima, un sistema di miti confluiti poi nei poemi epici e nella poesia successiva. Il mito eroico fu un serbatoio di racconti capace di offrire alla tradizione letteraria dei greci inesauribile materia di poesia. Ma vi è un altro aspetto di queste figure che occorre sottolineare, poiché influenza in modo decisivo la loro trattazione nella tragedia: l'eroe greco non solo possiede una doppia natura, divina e mortale, ma è caratterizzato da una profonda ambivalenza morale e anzi lo si potrebbe definire premorale, proprio perché riflette gli schemi di comportamento della società tribale e arcaica in cui il mito eroico si formò. Un eroe dunque può presentare caratteri riprovevoli (la violenza sanguinaria, la doppiezza) e comunque non è giusto e nobile nel senso etico della parola, e tanto meno può essere considerato il campione del bene che si batte contro il male. Benché i poeti tragici, elaborando il mito, si preoccupino di dare un carattere più alto e complesso ai loro personaggi, la materia della tragedia rimane ancorata a quella primigenia e selvaggia del mito tribale; non troveremo dunque nella tragedia greca un netto confine tra bene e male, né uno scontro tra la virtù e il vizio. Il bene e il male, l'impurità e la virtù, il trionfo e la sconfitta, sono così intimamente mescolati negli eroi tragici da impedire una chiara distinzione tra personaggi positivi e negativi. Aristotele parla di una hamartia, «colpa» (Poetica, 1452b), che l'eroe commette e che è la causa delle sue sofferenze. Talvolta questa colpa sembra evidente: è il caso di Clitemnestra che assassina in modo efferato il marito. Ma qual è la colpa di Edipo che inconsapevolmente commette atti orribili rendendo veri gli imperscrutabili responsi di un oracolo, o di Fedra resa folle d'amore senza sua colpa, o di Filottete relegato su un'isola deserta e consumato per dieci anni da una putrida piaga che lo ha trasformato in un miserabile più vicino a un animale che a un uomo? Hamartia, la colpa dell'eroe tragico, non significa necessariamente colpa morale, vale a dire consapevole volontà di operare il male (tra l'altro, la parola assume questo valore nella lingua greca solo tardi, a partire dal Nuovo Testamento). Talvolta l'impulso che conduce l'eroe a comportamenti aberranti può sembrare piuttosto una colpa intellettuale, un errore di valutazione o l'emergere di un lato oscuro del suo carattere (il cosiddetto tragic flaw, «difetto tragico»): è il caso della gelosia parossistica di Medea nella tragedia di Euripide e di Deianira nelle Trachinie di Sofocle, o della rigidezza altezzosa di Aiace e di Prometeo negli omonimi drammi. La tragedia offre un vasto campionario di «colpe»: violazione di leggi divine, infrazioni a comportamenti sociali, maledizioni ereditarie trasmesse come una lue da padre in figlio (è questa una visione tipica del teatro di Eschilo), atti sconsiderati e sanguinari commessi per impulso o desiderio di vendetta; del resto, anche la
fisionomia dell'eroe tragico muta radicalmente, dai personaggi inflessibili di Eschilo a quelli tormentati di Euripide (per alcuni dei quali si sarebbe decisamente tentati di utilizzare la definizione di «antieroi»). Talvolta la colpa si stempera nella follia, un elemento tradizionale nel dramma, anche per le grandi possibilità artistiche che la raffigurazione di una mente alterata offre al poeta (dalla follia di Oreste perseguitato dalle Erinni nelle Eumenidi di Eschilo, a quella di Agave che massacra il figlio nelle Baccanti di Euripide); fu appunto Euripide a sfruttare più di tutti le potenzialità drammatiche di simili situazioni («Euripide - scrive un antico critico letterario, l'anonimo del Sublime - fu grande nel descrivere l'amore e la follia»). In generale, si può comunque dire che l'eroe tragico ha per sua natura un piede se non nella follia quanto meno nell'irrazionalità, per l'eccesso e la dismisura dei suoi comportamenti che lo trascinano in situazioni senza ritorno. Sarebbe sbagliato cercare nella tragedia un nesso automatico tra colpa e punizione, poiché non necessariamente l'una segue l'altra. Anche se il tema della giustizia divina che si abbatte sui colpevoli non è estraneo al dramma (a diversi livelli, però: in Eschilo si presenta come una grande riflessione teologica, in Euripide diventa uno stantio cliché), la tragedia greca non poggia su una visione trascendente del destino umano né intende spiegare la sofferenza degli eroi per giustificare un piano divino. Certo, talvolta sembra di scorgere una morale, ma è una morale comunque misteriosa, ambigua, che si limita a registrare la sofferenza come un dato fatale e necessario, ben espresso dalle parole che chiudono l'Edipo Re di Sofocle: «cittadini della mia patria Tebe, guardate Edipo che risolse il famoso enigma e fu invidiato da tutti, in quale abisso di sciagura è precipitato. Perciò non chiamate felice alcun essere mortale che attende di vedere il suo ultimo giorno prima di sapere se abbia oltrepassato i confini della vita senza avere patito dolori». Il concetto che forse meglio si può applicare a un eroe tragico è quello di hybris, un'idea tipica della mentalità arcaica di cui rappresenta uno schema di pensiero fondamentale. La parola hybris significa in origine «violenza», «oltraggio», con valore sociale: non è un concetto astratto, ma un comportamento concreto che reca offesa agli altri. Quando i pretendenti invadono la casa di Odisseo e ne saccheggiano i beni commettono hybris, quando Agamennone umilia pubblicamente Achille e gli strappa la schiava commette hybris. Nel corso del tardo arcaismo (secoli vi-v a.C.) hybris cominciò ad assumere un valore diverso e divenne una sorta di malattia morale, che tuttavia non va identificata con il moderno concetto di colpa ma piuttosto con quello di «dismisura». Infatti chi commette hybris non ha necessariamente consapevolezza di compiere un atto ingiusto, è colpevole, certo, ma non moralmente aberrante. È appunto con questo valore che hybris diviene fondamentale nell'elaborazione del linguaggio tragico; l'eroe tragico del dramma attico è tendenzialmente un hybri-stés, un uomo eccessivo, poiché viene spinto dalla sua indole o dal destino a valicare i limiti davanti ai quali l'umanità comune si arresta. Secondo questa nozione, tipica della morale greca, l'uomo deve muoversi all'interno di una fascia che ne delimita il comportamento: al di sopra stanno gli dei, al di sotto gli animali. Chi non riconosce questi limiti e osa porre il piede oltre la linea che gli dei o il destino hanno fissato per il suo agire commette hybris, che in tal senso si può considerare una specie di accecamento mentale che impedisce a un uomo di distinguere chiaramente le conseguenze delle sue azioni. Secondo questa linea di pensiero, ogni uomo eccellente e fortunato rischia di violare un limite: «I fulmini scrive Erodoto - amano colpire le querce non gli arbusti». Personaggi erodotei come Creso (straordinariamente ricco) o Serse (straordinariamente potente) rappresentano un'infrazione vivente alla norma che impone all'uomo di ridursi dentro i propri limiti; la loro apparente fortuna genera un impulso ad andare oltre, accumulando ancora ricchezze e potere, sino al mutamento improvviso che li precipita dal colmo della felicità al colmo della sventura. Riconoscere i propri limiti e mantenersi al loro interno è segno di saggezza, oltrepassarli è violenza, hybris, ma un eroe tragico è tale appunto in quanto il suo destino lo porta al di là della morale comune. Abbiamo parlato di eroi, ma esiste anche un modello eroico al femminile. È un dato di fatto che molti personaggi femminili - da Antigone a Clitemnestra a Medea - emergono tra le creazioni più alte del teatro greco, il che non manca di far riflettere, se si considera lo stato di minorità da cui le donne ateniesi erano condizionate nella vita reale. Il teatro, come le altre manifestazioni pubbliche ateniesi, era un fenomeno maschile al punto che persino tutti gli attori erano maschi: le donne della tragedia sono dunque la proiezione sulla scena di un immaginario maschile, sono donne pensate da uomini, in sostanza una riflessione maschile sulla natura femminile.
Anche le eroine tragiche appaiono (come il loro corrispettivo maschile) figure eccessive, sofferenti, grandi - si potrebbe dire grandi anche nella loro apparente fragilità (basta pensare all'indomabile Antigone o all'Ecuba delle Troiane): ma è una grandezza che assume toni differenti rispetto a quella degli eroi. Anche per loro può valere il concetto di hybris, che però tende ad applicarsi a un ambito diverso: il limite infranto è quello che la società impone alla donna, collocandola all'interno della famiglia e della città e sottomettendola alla supremazia maschile. Non di rado queste eroine si ribellano, non contro il destino, ma contro la tirannia delle convenzioni sociali, e infrangono ogni legge trascinate dal loro impulso di autoaffermazione. Il prototipo di questi personaggi è la Clitemnestra assassina dell'Agamennone di Eschilo, una donna in cui alberga «un cuore dai voleri maschili» e che imbraccia spade, escogita tranelli, uccide, dominando sulla scena la sbiadita figura del suo amante Egisto e del troppo ingenuo marito Agamennone. Una donna che si comporta come un uomo era senza dubbio, per il pubblico ateniese, un modello inquietante, il segno del rovesciamento di un ordine sociale o persino di un limite imposto dalla natura; ma anche l'Antigone di Sofocle, col suo inflessibile disegno di dedicarsi alla sepoltura del fratello in omaggio alle leggi della pietà familiare, sfidando le leggi della città e il potere del re, esce dal suo limite sociale. Altre eroine sono presentate come ribelli, se non anche come portatrici di valori alternativi rispetto a quelli proposti dalla società, e appunto da questo nasce il conflitto tragico: Medea uccide i figli per gelosia e vendetta, Fedra porta alla rovina un'intera famiglia, spinta dalla sua folle passione, le Danaidi giungono all'assassinio pur di respingere il matrimonio a cui i cugini tentano di sottometterle. Le donne muoiono, sulla scena tragica, ma non nello stesso modo degli uomini: talora sono oggetto di violenza, altre volte si autodistruggono schiacciate dal peso della vergogna che gli eventi gettano sul loro onore (è il caso di Fedra o Giocasta, suicide per avere, sia pure involontariamente, violato norme di carattere sessuale). Il suicidio dell'eroina è un dato caratteristico della tragedia: questo però non avviene alla luce del sole come quello di Aiace e di altri eroi, estremo atto di affermazione di se stessi, bensì nel segreto della casa, la sfera tipica dell'azione femminile. Come scrive Nicole Loraux, il dramma greco presenta un ampio campionario dei modi «per uccidere tragicamente una donna ».
1.5 II significato culturale della tragedia Se si passa dal piano delle forme letterarie a quello del significato culturale della tragedia, si può ben dire che questo modello poetico investe l'interpretazione del destino umano nel suo complesso. Il fatto che sul suo significato uomini di varie epoche (da Aristotele a Nietzsche e oltre) non abbiano cessato d'interrogarsi - al punto da creare una categoria autonoma di pensiero che si suole definire «il tragico» o «la visione tragica della vita» - prova la perenne attualità dei problemi che la tragedia pone. In sintesi, sono forse tre gli elementi fondamentali dal cui intreccio deriva la tragedia greca. Il primo è il dolore: la tragedia mette sulla scena il pathos («sofferenza») di un eroe che dalla vicenda esce sconfitto, poiché passa «dalla fortuna alla sciagura» (per usare le parole di Aristotele in Poetica 1452b). In questo modo, la tragedia riafferma l'ineluttabilità della sofferenza: l'eroe tragico rappresenta il destino dell'umanità nel suo complesso. Si è detto - non senza ragione - che solo il mondo greco, così intimamente laico, poteva «inventare» la tragedia. Secondo George Steiner, la tragedia greca risulta estranea alla tradizione ebraicocristiana perché a differenza di questa la cultura greca non conosce redenzione e non proietta un sistema di premi e di castighi oltre l'esistenza fisica dell'individuo; il mondo greco non è governato dalla fede in una giustizia divina che dia alla sofferenza una superiore motivazione. Eschilo parla talvolta di pàthei màthos, «apprendimento che si ricava dal dolore», tuttavia sul perché all'uomo siano riservati il dolore, la morte e la sventura la tragedia non offre una risposta: presenta però, in una grande varietà di sfumature, la sofferenza come un dato oggettivo dell'esistenza umana. Questa sofferenza può derivare da un errore, da una colpa o da un oscuro progetto divino; talvolta (soprattutto in Euripide) appare invece totalmente assurda, crudele e ingiusta. Un secondo elemento è la scelta. Senza la decisione di operare in una o in un'altra direzione, sia pure aberrante e crudele (come il matricidio di Oreste o l'uccisione dei propri figli da parte di Medea), un personaggio tragico non è tale: in questo modo la tragedia propone nello stesso tempo il tema della libertà dell'uomo e della sua limitatezza. È tipico della tragedia mostrare l'eroe a un bivio, davanti a due possibilità, entrambe dolorose: la decisione, qualunque sia, non lo porta alla salvezza, bensì a nuove sofferenze. Questo
dissidio non si sviluppa tuttavia a livello psicologico, nell'angoscia e nel malessere interiore di un individuo che si sente prigioniero di una situazione senza uscita; anzi, l'eroe greco è tale appunto perché agisce e non si ritrae dalla vita ma la affronta, ben consapevole di andare incontro alla morte, alla sciagura e all'infelicità. È in questa sfida senza illusioni che i personaggi tragici assumono la loro esemplare grandezza. Il terzo elemento è il destino. I personaggi del mito tragico sono sovradeterminati. Se da un lato appaiono liberi di scegliere e di agire, dall'altro vedono fortemente limitata la propria libertà da elementi estranei: la morte prima di tutto, ma anche gli dei, il fato o la comunità con le sue leggi e i suoi vincoli. O più ancora (specialmente in Euripide) sono determinanti quelle forze oscure che si agitano dentro l'anima di un essere umano e lo portano a distruggersi anche contro la sua volontà: «io so il male che sto per compiere - dice la Medea di Euripide, in procinto di assassinare i suoi stessi figli - ma il mio impulso è più forte della mia volontà». La dinamica dell'eroe tragico si muove dunque tra libertà e costrizione: in nessun momento egli è completamente libero di operare come se fosse padrone di se stesso, poiché il suo mondo è popolato da forze visibili e invisibili che ostacolano di continuo la sua autoaffermazione. Dalla constatazione di ciò non scaturisce però un cupo pessimismo, anzi, si potrebbe affermare che il pessimismo tragico è limpido, non cupamente disperato.
1.6 Antropologia tragica Il teatro è per sua natura soggetto privilegiato per un'indagine di antropologia letteraria, se non altro perché è fatto di uomini che rappresentano altri uomini e devono quindi modellare nell'immaginazione degli spettatori un universo fittizio, un mondo «altro» che è di per se stesso un'interpretazione di quello reale. Nel caso del teatro greco questo aspetto è ancora più esaltato dal fatto che la tragedia, in quanto spettacolo-rito, mette in scena il mito, collettore di forme di pensiero che affondano le loro radici in strati antichissimi di civiltà. La tragedia delinea dunque una serie di universi culturali che si compongono e si scontrano sulla scena. Ci sono dei centri e delle periferie: la polis è il centro, e il centro del centro è quello spazio che si apre sulla skené e verso il quale confluiscono le azioni del dramma. Vi è però uno spazio alternativo, che circonda e assedia questo centro; a volte tale spazio estraneo alla città e alla cultura è il vero antagonista, come accade nel caso delle Baccanti di Euripide dove il conflitto tragico avviene tra il sistema di valori della polis, incarnata dal re di Tebe Penteo, e quello rappresentato dal gruppo delle baccanti invasate che si sono insediate sul monte da dove il loro mondo selvaggio minaccia la civiltà e finisce in effetti per sconvolgerla. È il caso dei Sette a Tebe di Eschilo, la cui azione si svolge dentro le mura di una città assediata: qui lo spazio della pace e dell'ordine è minacciato da quello della guerra, della violenza e del caos, che preme subito fuori dalla fragile difesa delle mura. A ben guardare l'alterità è uno dei motori fondamentali della tragedia. Il mito è di per se stesso un mondo «altro» rispetto a quello dell'esperienza reale del pubblico: un mondo circoscritto in un lontanissimo passato, percorso da forze ed energie che pur facendo parte di un immaginario collettivo si estendono molto oltre gli orizzonti comuni. Sulla scena tragica, questa alterità assume talvolta l'aspetto di un altrove geografico, in cui si misurano differenti culture e visioni della vita. La prima tragedia del teatro greco, i Persiani, è un esempio di quest'antitesi, che prende le forme, contemporaneamente, di una riflessione sulla relatività delle culture: da un lato sta la civiltà della polis, dall'altro il mondo asiatico della monarchia assoluta. L'antitesi tra greci e barbari, tra i loro diversi costumi (nómoi) e la loro diversa concezione della vita, era un grande tema della cultura ateniese contemporanea (la si trova quasi a ogni pagina di Erodoto); dal confronto col mondo asiatico, che certo nessuno poteva considerare selvaggio ma che indubbiamente si fondava su una cultura radicalmente diversa da quella greca, emergono con incontestabile evidenza i valori profondi della civiltà della polis, ossia individualismo, libertà, democrazia contro assolutismo dispotico. Questo grande tema culturale ricompare spesso nella tragedia. Riflettere sull'altro significa, per un pubblico che compie un rituale di ricompattamento collettivo attraverso il teatro, riflettere sulla propria cultura e sui propri valori, in un contrasto che esalta ancora di più l'hic et nunc degli spettatori e della loro città, i cui valori escono ingigantiti dalla sfida con un'antitesi culturale: perciò trame e personaggi stranieri non rappresentano affatto una concessione al gusto dell'esotico, ma costituiscono uno spunto notevole di riflessione antropologica. È il caso delle Supplici di Eschilo, dove un gruppo di fanciulle egiziane perseguitate dai cugini cerca rifugio in Grecia, o di tragedie come l'Ifigenia in Tauride o l'Elena di Euripide in cui, attraverso un gioco
d'intrecci, emerge il confronto tra la civiltà e la marginalità, che ricompare in forme ancora più devastanti nelle Baccanti euripidee. L'«altro» non è soltanto il barbaro o lo straniero, ma anche l'oscuro mondo della follia che apre uno squarcio nella realtà lasciando intravedere profondità lontanissime, forze oscure e incontrollabili che si annidano da qualche parte nella mente dell'uomo; la follia di Oreste in Eschilo, di Aiace in Sofocle, di Eracle in Euripide, o anche il delirio erotico di Fedra nell'Ippolito sono l'indagine di come un essere umano possa improvvisamente alienarsi talmente da se stesso da non potersi riconoscere, una volta tornato in senno, nella persona che è stata capace di compiere azioni così lontane dalla propria natura. Il tema della follia, tanto diffuso nella tragedia, è un viaggio nell'alterità della mente, nei meandri che conducono una persona a comprendere di essere una e molteplice nello stesso tempo. L'immaginario tragico nel suo complesso traccia una strada maestra verso il sostrato culturale profondo della civiltà greca, quel nucleo primario di idee e istituzioni sociali senza il quale non si può comprendere appieno il messaggio del dramma. I valori e i codici che costituiscono la tragedia sono gli stessi che percorrono come fiumi sotterranei la società greca, in un precario equilibrio tra le sue grandi conquiste culturali e un antico nucleo selvaggio che sempre si affaccia dalle pieghe delle trame tragiche. Un esempio è il concetto di «contaminazione» (miasma), che a sua volta è connesso con l'idea di maledizione e di colpa collettiva; queste nozioni primitive operano ancora nella tragedia, specialmente nel teatro di Eschilo che fra i tre grandi è quello più legato a un sistema di credenze arcaico. La contaminazione è diversa dalla colpa: è una macchia invisibile, prodotta da un tabù infranto, che proietta sull'individuo e su chi gli sta attorno un alone infausto, come se fosse una sorta di contagio magico. Edipo non è propriamente colpevole, ma su di lui si allunga l'ombra di una maledizione che lo rende impuro e abominevole; questa macchia si trasmette ai suoi stessi figli che, maledetti dal loro padre, si annientano a vicenda. Quando, nei Sette a Tebe di Eschilo, Eteocle si avvia verso un duello nel quale morirà uccidendo a sua volta il fratello, motiva il suo impulso all'autodistruzione dicendo che «la maledizione odiosa, nera, di mio padre Edipo si avvicina a me con occhi secchi da lacrime e mi dice che è meglio morire subito, non dopo»; quando il coro gli oppone l'argomento, del tutto ragionevole, che la sorte può comunque sempre cambiare e volgere al meglio, Eteocle scarta bruscamente l'obiezione dicendo che sono le maledizioni di Edipo ad avere scatenato questa rabbia e nulla potrà arrestarla. Sono idee arcaiche che scavalcano persino il concetto di libera scelta, così centrale nell'elaborazione del linguaggio tragico - oscure concezioni che vengono da lontano e parlano della forza magica e irresistibile delle maledizioni e portano con sé una sciagura senza speranza. Idee come hybris ("violenza") e àte ("accecamento"), vale a dire un complesso di forze esterne alla volontà del personaggio, che però lo trascinano alla rovina, operano fortemente nell'immaginario della tragedia arcaica, come pure la presenza di forze demoniache che accompagnano l'operare dei personaggi. Una delle idee più importanti nel campo dell'antropologia tragica è quella di marginalità. La marginalità è, in termini antropologici, uno spazio particolare sospeso tra cultura e natura: non così lontano dalla civiltà da imporre un viaggio senza ritorno, non però inclusa nella sfera della vita civile, che è per eccellenza quella della polis. Filottete, nella tragedia di Sofocle, è appunto un eroe dei margini: recluso su un'isola deserta, con una piaga al piede, regredito a uno stadio semiferino, accoglie in questo suo spazio gli altri personaggi della vicenda, in particolare Neottolemo, il giovane che vivrà in questo modo un vero e proprio rito di passaggio verso la condizione di adulto (lo spazio dei margini è per eccellenza quello in cui avviene l'iniziazione dei giovinetti). Il margine, dove finisce la civiltà organizzata dagli uomini e si affaccia un inquietante mondo altro, opera come struttura profonda dell'immaginario tragico e serve altresì ad esaltare l'isolamento e la grandezza del personaggio che lo occupa: è il caso di Prometeo incatenato alla rupe tra i monti del Caucaso, o di Edipo nell'Edipo a Colono di Sofocle, il maledetto condannato a vagare lontano dalla città, o del paesaggio barbarico dell' Ifigenia in Tauride di Euripide. L'eroe tragico peraltro è anch'egli un marginale, isolato dagli altri dal destino o dalla sua stessa natura; la sua stessa vicenda ne fa un essere circoscritto nella sua dimensione sovrumana ed esemplare, tanto eccezionale da non potere essere commisurato col normale metro di valutazione.
1.7 La periodizzazione La nostra conoscenza della tragedia greca è limitata a un solo, anche se memorabile, momento della sua storia:
pochi decenni del secolo v a.C., tra il 472 a.C., data di rappresentazione della più antica tragedia conservata, i Persiani di Eschilo, e il 401 a.C., anno in cui fu messo in scena Edipo a Colono, postumo, di Sofocle. Delle centinaia di drammi che furono scritti ne restano poco più di trenta, oltre a numerosi frammenti trasmessi da citazioni antiche o recuperati su brandelli di papiro. Il 406 a.C., anno della morte quasi contemporanea di Sofocle ed Euripide, rappresenta uno spartiacque oltre il quale non è possibile andare, con la sola eccezione di un dramma di qualità scadente, il Reso, falsamente attribuito a Euripide, che va collocato nel secolo successivo. È questo l'anno della vera e propria morte della tragedia (immediatamente avvertita dai contemporanei, a partire da Aristofane sulla scena delle sue Rane): al di là dei tre grandi infatti abbiamo solo nomi di personaggi minori, i più significativi dei quali furono Ione di Chio e Agatone (quest'ultimo noto come sperimentatore: eliminò i cori e li sostituì con intermezzi musicali). Nell'arco di un secolo, dunque, tutto si compì. Le prime figure di tragici che escono dalle nebbie della leggenda sono Frinico e Pratina, di poco più anziani di Eschilo. L'opera più nota di Frinico era una tragedia storica, La presa di Mileto (attorno al 493 a.C.). in cui si metteva in scena la distruzione di quella città per mano dei persiani; Erodoto (6,21 ) riferisce che il dramma, in quegli anni che preludevano alla guerra nazionale contro la Persia, suscitò una tale emozione che tutto il teatro scoppiò in lacrime e il poeta fu punito con una multa di 1000 dracme per avere messo in scena una pubblica sciagura. L'altro autore di cui si possa seguire in qualche misura l'attività è Pratina, che passa alla storia del teatro come inventore del dramma satiresco. Quest'ultimo assume la forma della tragedia e se ne distacca solo per l'inserimento di un elemento fantasticoburlesco, vale a dire un coro di satiri che intervengono con un pretesto qualsiasi nell'azione, guidati dal loro cialtronesco padre Sileno. L'evoluzione del genere tragico è affidata dunque alla triade canonica: Eschilo, Sofocle, Euripide. Secondo la tradizione antica, furono soprattutto i primi due a contribuire allo sviluppo tecnico del linguaggio tragico. Eschilo introdusse il secondo attore (il che non vuol dire ovviamente un secondo personaggio): fu questo il passo decisivo grazie al quale uno spettacolo ancora arcaico e rigido divenne teatro vero e proprio. Se in origine la tragedia era davvero costituita dal dialogo tra un coro e un personaggio, solo quando al primo attore si aggiunse il secondo divenne possibile la dialettica tra i personaggi. La presenza del coro con funzioni attive nella trama, quasi come un attore collettivo, è ancora ben visibile in Eschilo dove sono frequenti i casi in cui il dialogo si svolge tra attore e coro, in assenza di altri personaggi sulla scena (come in Persiani e Supplici). Quasi tutti i drammi di Eschilo sono rappresentabili con due soli attori; il terzo attore fu stabilmente introdotto da Sofocle ed Eschilo lo adottò nell'opera più recente che di lui si è conservata, la trilogia Orestea. L'uso di un quarto attore nella tragedia è escluso; ma (come avverte il tardo grammatico Polluce, Onomasticon, 4,109), in caso di bisogno, era concesso eccezionalmente a un quarto personaggio di pronunciare qualche battuta marginale; questa situazione era definita paracoréghema e sembra che fosse stata applicata anche da Eschilo nella perduta tragedia Meninone. Ancora a Eschilo risalgono innovazioni nella danza corale; fonti antiche riferiscono che egli fu il coreografo dei suoi drammi e inventò varie figure (schémata) di danza. Si trattava di una danza fortemente espressiva, per certi aspetti più vicina al mimo che alla danza vera e propria: si diceva che nella coreografia dei Sette a Tebe Eschilo fosse riuscito a «rendere chiara l'azione attraverso i movimenti di danza» (Ateneo, l,22a). All'epoca di Eschilo, vale a dire la prima metà del secolo v, risale lo sviluppo di un professionismo teatrale. Eschilo fu attore dei suoi drammi (questo valeva anche per gli altri poeti della tragedia primitiva, come testimonia Aristotele, Retorica 1403b) e risulta che in gioventù anche Sofocle abbia calcato la scena; relativamente presto però la figura del poeta si separò da quella dell'attore, cosicché per rappresentare i drammi vennero ingaggiati dei professionisti. Il professionismo teatrale e il divismo dell'attore (fenomeni universali nella storia dello spettacolo) si fecero più evidenti nel corso dei decenni successivi, com'è testimoniato dalla introduzione nelle feste teatrali dei premi per gli attori. Tra poeta e attore poteva stabilirsi una collaborazione duratura nella realizzazione degli spettacoli; Eschilo per esempio si valse dell'attore Cleandro e come deuteragonista gli accostò Minnisco di Calcide. Un attore rinomato, nel secolo v a.C., fu Tlepolemo, l'interprete preferito da Sofocle che a quanto pare ( Vita di Sofocle, 6) costruiva la drammaturgia delle sue tragedie tenendo conto delle caratteristiche del cast di attori che aveva a disposizione di volta in volta, proprio come un capocomico moderno. Il peso degli attori e la loro invadenza sulla scena andarono crescendo mentre parallelamente si indebolivano
quelli del poeta; dopo la scomparsa dei tre grandi poeti tragici, le loro opere vennero riprese regolarmente nei concorsi dionisiaci del iv secolo a.C. ed entrarono nel repertorio delle compagnie teatrali, cosicché (come avviene sempre nella storia del teatro) gli attori si sentirono autorizzati a manipolare i testi in rapporto alle esigenze del pubblico, in alcuni casi aggiungendo persino intere scene. Anche Sofocle contribuì notevolmente all'elaborazione del linguaggio tragico: i suoi interessi teorici sono documentati da un'opera tecnica (perduta) sulla coreografia (il trattato Sul coro). È comunemente ammesso, come si è detto sopra, che egli abbia introdotto nella tragedia un terzo attore e che abbia aumentato il numero di coreuti, portandolo da dodici a quindici. Di altre innovazioni relative alla messinscena (scenografia, macchine, pannelli) siamo solo vagamente informati. Tra i tre grandi della tragedia Euripide fu quello meno interessato allo sviluppo di nuovi mezzi tecnici ma molto più coinvolto nella sperimentazione di un tipo di tragedia che si spingeva, per trattazione dei personaggi e costruzione dei drammi, molto oltre i suoi predecessori; in effetti Euripide portò la tragedia a un punto di non ritorno, oltre il quale smette di essere tragedia nel senso greco del termine per diven-lare dramma in quello moderno. Le novità euripidee sono tutte interne al dramma: il taglio dei personaggi, l'approfondimento psicologico, l'impiego originale di forme tradizionali (come la monodia dell'attore), l'uso di moduli musicali nuovi, molto criticati dai contemporanei, che allontanavano la musica tragica dalla severità originaria. In generale, Euripide parte da un tipo di tragedia centrato sul personaggio per approdare a un dramma costruito sull'intreccio e il colpo di scena, in opere come Ione o Elena che sembrano a metà strada tra la tragedia e la commedia di costume; questo sarà di fatto il modello fondamentale per il teatro di epoca successiva. Che cosa sia diventata la tragedia dopo Euripide non è dato di sapere; certamente i concorsi tragici proseguirono ancora per molto tempo, anche se perdendo smalto. Da quanto possiamo inferire da notizie antiche, iscrizioni e papiri, sembra che una forma di spettacolo tragico che andò diffondendosi fosse il recital di attori che si esibivano in pezzi di bravura, antologizzando opere classiche. La tragedia ebbe un estremo periodo di fioritura in Alessandria, quando la dinastia dei Tolomei tentò, nel secolo ih a.C., di resuscitare spettacoli e concorsi tragici nella nuova metropoli fondata da Alessandro Magno alle foci del Nilo: si ricordano i nomi di sette poeti tragici (la cosiddetta Pleiade), di cui non resta nulla se non una singolare paratragedia, l'Alessandra di Licofrone, concepita però per la lettura (consiste in un unico ed erudito monologo). Si può tuttavia misurare la fortuna della tragedia greca da un'opera scritta attorno allo stesso periodo, che testimonia come la tragedia, nata in un preciso ambiente storico, avesse ormai assunto un aspetto universale: un poeta ebreo di nome Ezechiele compose in greco una tragedia (di cui restano frammenti), mettendo in scena un episodio della storia sacra del suo popolo, ossia la fuga di Mosè dall'Egitto alla ricerca della terra promessa. Il seguito della storia della tragedia dovremo trovarlo a Roma, dove sin da epoca repubblicana i tragediografi locali modellarono integralmente i loro testi su esemplari greci, in forma e contenuto, per arrivare sino alle tragedie di Seneca.
1.8 La commedia La commedia fu, non meno della tragedia, un'espressione della civiltà democratica di Atene, che vide il suo primo periodo di fioritura nella seconda metà del secolo v a.C. Sebbene non mancassero in altre zone della Grecia forme di rappresentazioni di natura burlesca, fu solo nell'ambito dei festival dionisiaci ateniesi che la commedia ricevette la sua definitiva strutturazione letteraria; i primi concorsi comici risalgono al 486 a.C. (il vincitore fu Chionide). Al di fuori di Atene si hanno notizie di spettacoli popolareschi come la farsa megarese, che gli autori ateniesi additavano come modello di comicità buffonesca: questa era costituita da danze sguaiate, eseguite da personaggi volgari che si scambiavano lazzi e miravano a suscitare un'elementare corrente di allegria. Una tradizione teatrale autonoma si sviluppò anche nelle colonie della Sicilia e della Magna Grecia, ma la perdita di questi testi ci impedisce di comprendere quali e quanti fossero i reciproci influssi. Secondo Aristotele (Poetica, 1449b5), la commedia siciliana precedette quella attica: il filosofo attribuisce a due autori siciliani, Formide ed
Epicarmo, il merito di avere per primi ideato trame comiche. Formide è per noi solo un nome, mentre Epicarmo era considerato uno dei grandi poeti comici dell'antichità; nato in Sicilia (forse a Me-gara Iblea) nella seconda metà del secolo vi a.C., fu attivo a Siracusa sino all'epoca del tiranno Ierone (tra il 478 e il 466 a.C.) alla cui corte entrò in contatto con Eschilo. Di lui gli antichi conservavano dieci libri di un particolare genere di commedia, il «mimo», di cui si conservano circa duecentocinquanta frammenti, tutti poco significativi. Se la commedia siciliana resta per noi enigmatica, di quella attica possiamo seguire abbastanza bene l'evoluzione. Le primitive manifestazioni comiche vanno inquadrate nell'orizzonte dei rituali agrari della fertilità; secondo Aristotele (Poetica, 1449a), la commedia si sviluppò dalle «falloforie» (phallikà), vale a dire le feste connesse al ciclo annuale della vegetazione. Il filosofo di Stagira fa derivare la parola «commedia» da kómos, corteo festivo, o in alternativa da kóme, villaggio: dunque il «canto della festa» oppure il «canto del villaggio». L'etimologia esatta è la prima, ma anche la seconda torna utile per spiegare un versante della commedia, poiché rende evidente il legame tra le primitive manifestazioni comiche e l'ambiente rurale in cui effettivamente si svilupparono. La commedia ha profonde radici contadine, mentre la tragedia col suo linguaggio elevato e i suoi miti aristocratici è legata all'ambiente evoluto della città. La commedia greca delle origini si muove nell'ottica del tempo ciclico, tipico dell'anno agricolo. È un rituale di rinnovamento e di sovvertimento durante il quale, a ogni nuova primavera, la rinascita della vita vegetale si collega alla necessità sociale di ritrovare l'identità del gruppo in un clima di baldoria, caratterizzato dalla sospensione dei normali comportamenti e da eccessi alimentari: un clima dunque che non è fuori luogo definire carnevalesco, poiché si realizza in un momento di evasione collettiva dai vincoli della realtà quotidiana. Travestimenti e manifestazioni mimiche di questa natura sono documentati sia nelle antiche culture agrarie sia a livello folklorico nell'Europa medievale, sino alle soglie dell'età contemporanea; il cosiddetto «riso rituale» riveste infatti la funzione magica di scacciare influssi nefasti e nello stesso tempo di alimentare la forza rigeneratrice della natura. Di questa particolare atmosfera la primitiva commedia greca conserva impronte evidenti: in particolare, la libertà della fantasia e l'insistenza sulle sfere sessuale e alimentare, entrambe connesse al clima della festa agricola che celebra il trionfo delle energie naturali. Elementi tipici della commedia greca, come la licenza sessuale, il linguaggio sboccato, l'ebbrezza, trovano un preciso riscontro nei comportamenti carnevaleschi, e in questa luce vanno viste anche le gozzoviglie a cui gli eroi comici si abbandonano sulla scena e i lunghi elenchi di cibi e manicaretti tipici dello stile comico. Nata da questo nucleo rituale, la commedia venne formalizzata sul modello della tragedia per l'organizzazione drammaturgica, e del giambo per il tono di aggressione virulenta, che connota tanti momenti della commedia greca arcaica: nella lirica greca, infatti, questo era il genere letterario destinato al biasimo e alla derisione di avversari politici e nemici personali, elementi che riaffiorano puntualmente nei drammi della commedia attica.
1.9 Caratteri della commedia Se da un lato la commedia subì l'influenza della tragedia strutturandosi sul suo modello, dall'altro contiene forme più antiche di quelle della tragedia. I temi della commedia si riallacciano a sistemi di credenze e modi di pensare arcaici, radicati nell'immaginario collettivo dell'uditorio: basta pensare al motivo del «mondo alla rovescia» (donne che prendono il posto degli uomini, come nelle Donne in assemblea di Aristofane) o ai cori animaleschi (uccelli, vespe e rane, nelle omonime commedie dello stesso poeta). La commedia, molto più della tragedia, mutò forma nel corso della sua storia, perdendo progressivamente il contatto con il sostrato rituale da cui derivavano le sue origini per diventare un dramma di costume. La differenza appariva evidente anche agli antichi, che distinsero tre fasi nello sviluppo della commedia: archàia, «antica» (sino alla fine del secolo v), mése, «di mezzo» (secolo iv), néa, «nuova» (a partire dalla fine del secolo iv). La commedia «antica» è per noi rappresentata da Aristofane (degli altri due principali poeti di questo periodo, Crati-no ed Eupoli, restano solo frammenti). La sua è una commedia politica nel senso più ampio del termine, che non solo sviluppa argomenti vicini alla vita quotidiana - temi di attualità come la guerra o la lotta politica, la derisione di personaggi pubblici attaccati secondo il principio dell'onomastì komodéin (deridere una persona con il suo nome) -ma tocca aspetti di fondo della convivenza civile, quali il rapporto tra le
generazioni, la dialettica dei sessi, la vita sociale e religiosa, sebbene tutto venga comicamente deformato sino al paradosso. La commedia antica non può essere considerata teatro nel senso moderno del termine. È qualcosa di più: l'espressione dell'immagina-rio collettivo di una civiltà contadina e del suo sistema di cultura ancestrale. Pur rimanendo legata a questo versante arcaico e rurale, la commedia si proietta però sullo scenario attuale della polis ateniese nell'epoca del suo pieno sviluppo. È esemplare, a questo proposito, il contrasto tra i protagonisti di una delle più geniali commedie di Aristofane, le Nuvole: da un lato il torpido contadino Strepsiade, prodotto di un mondo tenacemente abbarbicato a idee conservatrici, dall'altro Socrate, campione del pensiero laico e perfetto esponente dei tempi nuovi. I due personaggi esprimono due modi di pensare immensamente distanti tra loro, poiché rappresentano la contrapposizione, sociale e culturale, tra l'universo della campagna e quello della città, luoghi vicini nello spazio ma lontani nel tempo: uno ancorato alle forme tradizionali di un mondo antichissimo, l'altro fucina di nuove idee proiettate al futuro. Questi due lati della stessa medaglia contribuiscono a dare forma all'intreccio dei drammi di Aristofane, che sono uno specchio, comicamente deformato, della società ateniese contemporanea. In linea di massima, la commedia di Aristofane risponde a uno schema fondamentale che in vari modi si ripropone in quasi tutte le opere: il protagonista si ribella allo stato di degradazione in cui versa la vita cittadina ed escogita un'idea paradossale per rinnovare la polis, oppure per evaderne alla ricerca di un luogo migliore. A questo punto si verifica il passaggio dal grigiore della realtà quotidiana all'utopia del mondo surreale in cui i personaggi s'immergono. È come se penetrassero dall'altra parte dello specchio; spesso il passaggio è scandito dall'atto simbolico di attraversare una porta che si spalanca su un mondo diverso, precluso all'esperienza quotidiana, come la porta dell'Ade nelle Rane, quella dell'Olimpo nella Pace, oppure anche quella di case dove si annidano personaggi strani e inquietanti (la casa di Socrate nelle Nuvole o di Euripide negli Acarnesi). Si tratta in sostanza della traduzione teatrale di un rito di passaggio, grazie al quale diviene possibile l'ingresso in una diversa condizione di vita. D'un tratto tutto diventa accessibile: le leggi della realtà vengono sospese e l'eroe assurge a uno stato di surreale onnipotenza, come può accadere solo in un sogno o in una fantasia infantile. Accade così che il protagonista si liberi completamente da ogni vincolo con la realtà: può persino volare in cielo a cavalcioni di uno scarabeo alato (Pace) o discendere nell'Ade per riportare alla vita dei morti (Rane). In gioco però non è mai solo il destino privato dell'eroe comico; il processo di rinnovamento, di cui il protagonista è il promotore, coinvolge tutta la società. È questa idea comica fondamentale, presentata all'inizio del dramma, a determinare l'atmosfera, irripetibile, della commedia antica, che oscilla tra il realismo della raffigurazione quotidiana di fatti e personaggi, con scherzi e beffe diretti a uomini noti al pubblico, e l'universo fantastico che si spalanca, come in una fiaba, davanti agli occhi del pubblico. Per trasformare l'utopia in realtà il protagonista deve però debellare uno o più avversari che cercano di rendere vano il suo progetto, in un conflitto che echeggia, in forme paradossali, lo scontro tragico. Questi oppositori sono connotati grottescamente; in apparenza spaventosi e temibili, in realtà sono solo spauracchi, individui abietti che appartengono alla categoria degli alazónes («cialtroni») o dei ponerói («furfanti») e che cercano di inquinare con la loro malizia la realtà creata dall'eroe ma finiscono per essere debellati, secondo un modello simbolico ben familiare al pubblico. La cacciata del furfante corrisponde infatti nell'immaginario collettivo alla cacciata rituale del capro espiatorio (pharmakós), che sulla scena comica è rappresentato da un personaggio canagliesco, bersagliato come la causa di tutti i mali cittadini e infine espulso dalla vita civile (il Cleone dei Cavalieri o il Socrate delle Nuvole). Così la commedia si conclude con la vittoria dell'eroe e con il trionfo carnevalesco della sessualità e del cibo; generalmente, le commedie di Aristofane (Acarnesi, Vespe, Pace, Uccelli) terminano con un gran banchetto e con nozze o baldorie sessuali che richiamano il clima di ritrovata armonia e di rinnovamento delle energie tipico della festa agricola.
1.10 La commedia: un rituale di sovvertimento e di rinascita La commedia antica propone dunque un rituale di rinnovamento. Per quanto assurda e paradossale, anzi proprio perché assurda e paradossale, l'azione che si sviluppa sulla scena determina infatti una palingenesi
della vita civile, che alla fine dell'opera viene restaurata nella sua originaria purezza: la guerra finisce e la pace ritorna (Acarnesi, Pace, Lisistrata), i cattivi governanti vengono cacciati e sostituiti dai buoni (Cavalieri), i corruttori della gioventù vengono smascherati (Nuvole), le leggi cittadine vengono rinnovate (Donne in Assemblea, Uccelli), la poesia viene restaurata nel suo antico splendore (Rane). Sulla scena si delinea dunque un processo di morte e di rinascita, in cui l'autore comico prende a bersaglio della propria derisione un male cittadino. Al pari della tragedia, anche la commedia si conclude sempre con una sconfitta: tuttavia, mentre nella tragedia è l'eroe a subire la sconfitta e la sofferenza, nella commedia questo destino tocca al suo antagonista, che alla fine viene pubblicamente degradato e vinto. Un elemento tipico è altresì costituito dal costante passaggio tra realtà e finzione scenica che si attua nel corso della commedia. A differenza della tragedia, che si svolge integralmente tra personaggi dialoganti sulla scena, il personaggio comico realizza normalmente quella che si definisce la «rottura della quarta parete» che separa il pubblico dalla scena: può dialogare con gli spettatori, insolentirli e schernirli. Tale meccanismo comico trova la sua massima espressione nella para-basi, in cui vari studiosi hanno identificato il nucleo originario della commedia attica. Questa consiste in una perorazione che il poeta rivolge in prima persona al pubblico per bocca del corifeo, quando gli attori sono momentaneamente usciti di scena e il coro dimentica, se pure in via provvisoria, la sua natura di personaggio; si tratta dunque di una completa rottura della finzione scenica, che le regole teatrali consentono all'autore comico. La parabasi, tipica della fase più arcaica della commedia, si andò tuttavia indebolendo progressivamente, tanto che già le ultime commedie di Aristofane ne sono prive: segno, questo, dell'evoluzione della commedia attica da spettacolo politico a teatro di costume, evoluzione che si completò nel corso del secolo iv a.C. per giungere sino alla commedia cosiddetta "nuova" di Menandro.
1.11 L'eroe comico Anche la commedia ha al suo centro un eroe, ma di natura sostanzialmente antitetica rispetto a quello tragico: l'eroe comico è caratterizzato dalla capacità di sovvertire la realtà senza alcun vincolo di verosimiglianza. Se la colpa tipica dell'eroe tragico è per eccellenza la hybris, la tendenza a scavalcare i limiti dell'umanità, nell'eroe comico invece la hybris è connaturata, dato che deve necessariamente infrangere vincoli e sottrarsi alla norma che condiziona il resto dell'umanità. Mentre la tragedia pone sotto gli occhi, attraverso le sofferenze dell'eroe, la necessità di osservare un limite e l'obbligo di non valicarlo, la commedia delinea invece il processo inverso e impone lo scavalcamento di questo limite. L'eroe della commedia «antica» è veramente una figura particolare, unica nella storia del teatro. Il suo tratto più evidente è la beffarda amoralità: i protagonisti delle opere di Aristofane non sono figure psicologicamente autonome, con un carattere definito e una personalità individuabile, bensì personaggi dall'identità proteiforme, capaci di mascherarsi, spregiudicati, a volte persino furfanteschi (come il Salsicciaio nei Cavalieri), che facendo ricorso all'astuzia e a una intraprendente spregiudicatezza riescono nell'impresa di plasmare attorno a sé una realtà nuova, rinnovando le forme della convivenza sociale. In questo senso, l'eroe comico si riconnette a una figura tipica della mitologia, nota come trickster o "briccone divino". Il trickster è una creatura sprovvista di qualità morali ma non per questo negativa; anzi, proprio grazie ai suoi imbrogli possono realizzarsi fatti di fondamentale importanza cosmologica, che consentono all'umanità un decisivo progresso e contribuiscono a rendere stabile l'ordine dell'universo (si pensi a Prometeo, l'astuto ladro del fuoco il cui furto diede inizio alla civiltà umana). L'ambiguità morale del trickster scaturisce dal fatto di non appartenere né al mondo degli uomini né a quello degli dei, ma di operare ai margini dell'uno e dell'altro, risultando pertanto estraneo alle norme che regolano ciascuno di questi due mondi. Grazie alla sua natura duplice, il trickster è capace di mettere in contatto tra loro ambiti altrimenti destinati a rimanere eternamente divisi (il cielo e la terra; il mondo dei morti e quello dei vivi, ecc.) e per questo è, tipicamente, un fondatore, dato che il suo agire determina la nascita di un'istituzione prima inesistente. Lo stesso meccanismo fantastico appare operante nella commedia di Aristofane, il cui eroe è in un certo senso un fondatore poiché grazie a lui si realizza, sia pure burlescamente, un rinnovamento della società.
1.12 Commedia e politica Il reazionario autore della Costituzione degli ateniesi (un opuscolo di propaganda politica composto negli ultimi decenni del secolo v a.C.) scriveva che «il popolo di Atene non consente che si porti sulla scena comica il popolo o lo si denigri [...] ma chiede che lo si faccia contro privati cittadini, se uno vuole attaccarli personalmente, ben sapendo che chi viene deriso sulla scena non è uno del popolo, uno qualsiasi, ma un ricco o un nobile o un cittadino influente». Con ciò, l'autore sembra implicare che la commedia abbia una fondamentale funzione di controllo sociale, in quanto rivolta a denigrare cittadini influenti e ostili al ceto popolare, che era custode e garante della democrazia in Atene. Questa interpretazione sembra contraddire quanto emerge dai testi di Aristofane, che in buona parte deridono leader democratici come Cleone e beffano la linea politica perseguita dal popolo. Neppure le istituzioni politiche che formavano la base del regime democratico, come il tribunale popolare, escono immuni dagli scherzi comici (nelle Vespe, in particolare). Da ciò deriva la facile ma arbitraria posizione di una parte della critica, che ha fatto di Aristofane un reazionario o quanto meno un esponente della maggioranza perbenista e moderata degli Ateniesi. In realtà, la logica della satira non è la stessa della prassi politica e non sfugge a contraddizioni che sarebbe difficile risolvere solo sulla base di un'interpretazione ideologica. La satira era fondata sulla massima libertà di calunniare, di attaccare direttamente e ferocemente persone pubbliche, secondo il principio de 11'onomasti komodéin ("deridere una persona con il suo nome"), che a sua volta si basa su uno dei meccanismi fondamentali promossi dal regime democratico, vale a dire la completa libertà di parola iparres(à). Da questo punto di vista, dunque, aveva ragione l'anonimo della Costituzione degli ateniesi: la satira comica scaturisce dall'uso, per così dire, assembleare del biasimo, proiettato su singoli personaggi derisi davanti a una platea riunita. Il prendere a bersaglio sulla scena un personaggio non presuppone di per sé un'opposizione politica dell'autore e tanto meno prova l'ideologia antidemocratica della vittima colpita dal pungolo della satira; d'altra parte, il pubblico sapeva dare il giusto valore agli scherzi dei comici sulla scena. Non si potrebbe spiegare altrimenti, per esempio, il fatto che l'uditorio che acclamò vittorioso Aristofane nei Cavalieri. dove si demolisce la figura di Cleone, poche settimane più tardi abbia eletto lo stesso Cleone stratego. Accade anche che personaggi derisi sulla scena vengano pochi anni dopo riproposti dagli stessi poeti comici come modelli di virtù civica (è il caso di Lamaco, prima ferocemente deriso e poi lodato da Aristofane). Del resto, non risulta che i poeti comici fossero direttamente impegnati nel perseguire una coerente linea politica o ascritti al servizio di interessi di parte; il committente delle opere era il popolo, sia pure attraverso le figure dei coreghi, e al popolo l'autore doveva dare la possibilità di sbeffeggiare, come in uno specchio deformante, le figure eminenti che di lì a poco sarebbero state applaudite in assemblea.
1.13 Dalla commedia antica a quella nuova Le ultime opere di Aristofane (Ecclesiazuse, Pluto) mostrano un indebolimento dei meccanismi caratteristici della commedia antica: in primo luogo, la riduzione della presenza del coro nell'azione scenica e la rinuncia alla parabasi, in cui si esprimeva la stretta relazione tra poeta, pubblico e vita cittadina. Anche il linguaggio dell'ultimo Aristofane allenta la continua, feroce tensione espressiva per adeguarsi a un tono più pacato, così come si smorza la libertà fantastica, quasi visionaria, della trama. Nei decenni successivi, la commedia si evolve sviluppando forme sempre più lontane da quelle delle sue origini, sinché quando torna a rendersi visibile al nostro sguardo - con II bisbetico di Menandro, che risale al 317 a.C., settant'anni dopo il Pluto di Aristofane (388 a.C.) - è ormai diventata tutt'altra cosa e ha già assunto la struttura che senza sostanziali variazioni si trasmetterà al teatro latino, fungendo quindi da primo e fondamentale modello per quello moderno. Si tratta di una commedia che risponde a schemi familiari alle nostre consuetudini. Il dramma è suddiviso in veri e propri atti, divisi tra loro da intermezzi in cui il coro danza e canta per intrattenere gli spettatori: questi erano brani senza legame con la trama, interscambiabili tra opera e opera, che non venivano neppure inclusi nei copioni. La commedia menandrea comporta invariabilmente una vicenda d'amore, sviluppata attraverso varie peripezie sino all'immancabile lieto fine, e ha un carattere realistico, nel senso che abbandona
completamente le straordinarie invenzioni fantastiche del teatro di Aristofane. Con la commedia nuova l'orizzonte si restringe; a questo corrisponde un elemento drammaturgico che denota la distanza tra le due forme di spettacolo, ossia la chiusura della "quarta parete" che divide gli spettatori dalla scena. Ciò vuol dire che, a differenza di quanto accadeva sistematicamente in Aristofane, i personaggi cessano di dialogare col pubblico e di coinvolgerlo nella rappresentazione, sbeffeggiando o aggredendo verbalmente qualche individuo. Quello di Menandro è ormai "spettacolo" nel senso proprio del termine: i personaggi vivono la loro vicenda circoscritta nello spazio scenico, mentre gli spettatori assistono, si divertono, si commuovono, ma restano comunque al di là del palcoscenico. Queste trame comiche sono nello stesso tempo illusorie c realistiche: illusorie perché l'attualità della vita cittadina con i suoi eventi risulta ormai esclusa completamente per fare spazio a figure fitti zie, e realistiche perché le vicende portate in scena evitano le clamorose infrazioni spazio-temporali della commedia antica per delineare in forma approfondita i caratteri dei personaggi, che operano sulla scena come figure dotate ciascuna di una propria inconfondibile autonomia psicologica. Varie ragioni concorsero a determinare questa evoluzione. Fondamentale fu la fine di un'irripetibile stagione politica - quella della democrazia radicale - che costituiva il referente dell'opera comica del secolo v. L'Atene del secolo iv, anche dopo la restaurazione del sistema democratico, ha deposto le sue pretese egemoniche e si avvia verso una decadenza dorata ma fatale, sancita, poco prima che Menandro iniziasse a scrivere, dalla completa sottomissione al regno macedone di Alessandro Magno. La violenza della lotta politica si attenua, e benché le istituzioni siano le stesse, la politica è ora nelle mani di una classe dirigente moderata, che potremmo definire "borghese": sono in sostanza gli stessi uomini che compaiono sulla scena di Menandro (giovani della buona società, proprietari terrieri, militari con il loro seguito di etere, servitori, cuochi, parassiti). Questo tipo di commedia si adattava bene ai gusti di un certo pubblico, fatto di piccoli proprietari terrieri e di cittadini benestanti, più interessati a tematiche private che a commedie in cui fosse messa in discussione la struttura sociale; anche l'abolizione, per ragioni di bilancio, del contributo statale (theorikón) destinato ai cittadini poveri perché assistessero alle rappresentazioni contribuì a incrementare un teatro d'impianto meno popolare. Il pubblico teatrale non può più essere identificato con la cittadinanza della polis nel suo complesso, com'era avvenuto nel secolo precedente; il teatro, pur continuando a essere un servizio pubblico, ora esprime i gusti di una classe dirigente colta, educata a un linguaggio misurato, dotata di una sensibilità sottile. La commedia diviene uno spettacolo di evasione, poiché consente agli spettatori un distacco psicologico dalla realtà quotidiana e li conduce in uno spazio fittizio, in cui i conflitti risultano attutiti. È vero che anche il teatro di Aristofane era stato di evasione - né altrimenti potrebbe essere qualsiasi teatro comico ma in modo del tutto diverso, giacché si fondava su un processo di smantellamento fantastico e di trasfigurazione della realtà cittadina. Lo spirito carnevalesco con la sua carica di sovvertimento, la ricerca del paradossale e l'invenzione di un mondo alla rovescia risultano invece assenti dalla commedia nuova, in cui l'evasione è affidata al rassicurante lieto fine che ricompone vicende private. A questo mutamento contribuì in misura rilevante anche l'evoluzione della tecnica teatrale di attori e poeti. Aristofane rappresenta un'estetica teatrale sostanzialmente indifferente a problemi quali l'unità dell'azione, la verosimiglianza o la caratterizzazione psicologica dei personaggi; nelle sue opere la trama comica inglobava ancora aspetti collegati alle origini rituali della commedia (la danza, i corali, l'uso osceno del linguaggio). Il teatro dei suoi successori, e di Menandro in particolare, mette al bando tutto questo; musica e danza vengono escluse dalla trama e l'attore recita, adottando un tono realistico, cercando di ottenere un effetto di suggestione attraverso il gesto e la voce. La recitazione è ancora in versi (trimetri giambici), ma sono versi di timbro e di linguaggio medio, che tendono a riprodurre le forme del parlato; il costume comico è modificato e le maschere tendono a diventare tipi fissi e a differenziarsi in un ampio campionario di volti (l'Onomasticón di Polluce ne enumera quarantaquattro). Così, la commedia nuova diventa uno spettacolo intermedio tra commedia e tragedia e in ciò consiste la sua rinnovata vitalità. In questo la lezione di Euripide - divenuto l'autore prediletto del pubblico -opera profondamente, specialmente l'ultimo Euripide, che costruiva le sue tragedie su complesse peripezie, su colpi di scena e riconoscimenti, come nell' Oreste o nello Ione. Lo sviluppo di questo nuovo tipo di teatro non sfuggì, naturalmente, ad Aristotele, che nella Poetica rimarcava la distanza tra la commedia antica e quella a lui contemporanea. Anche dopo Menandro la commedia attica continuò a produrre opere originali: i concorsi drammatici ad
Atene sono attestati con certezza da fonte epigrafica almeno sino al 120 a.C. Né bisogna dimenticare che i testi di Menandro e di altri autori della commedia nuova continuarono a essere rappresentati fino alla tarda antichità.
2. Lo spettacolo teatrale di Simone Beta
2.1 Le feste: le grandi Dionisie, le Lenee, le Dionisie rurali, le Antesterie I greci non andavano a teatro tutti i giorni. Gli spettacoli teatrali si tenevano in determinati periodi dell'anno, all'interno di celebrazioni religiose dedicate a Dioniso: nel secolo v a.C., il periodo che vide Atene diventare il faro politico e culturale della Grecia, la più importante di queste feste erano le grandi Dionisie (o Dionisie urbane), che venivano celebrate nel capoluogo dell'Attica all'inizio della primavera. Seconde in ordine d'importanza erano le Lenee, che si tenevano invece nel cuore della stagione invernale, sempre ad Atene. Alcuni spettacoli teatrali potevano essere allestiti occasionalmente all'interno di altre celebrazioni meno importanti come le Dionisie rurali, che si tenevano in periodi diversi per tutto il territorio dell'Attica: infine, anche le Antesterie, le feste dedicate al vino, possedevano un tenue legame col teatro. All'interno del calendario ateniese quella delle grandi Dionisie era la celebrazione conclusiva, il culmine delle feste cittadine: se abbiamo scelto di cominciare con questa non è soltanto perché era la più importante, ma soprattutto perché si tratta della festa che conosciamo meglio. Le grandi Dionisie o Dionisie urbane (Dionysia) si tenevano nel mese di Elafebolione, che corrispondeva ai nostri marzo/aprile; la loro durata era di cinque giorni. Vi partecipavano non solo i cittadini ateniesi e gli abitanti dell'Attica, ma anche molti stranieri (ambasciatori, mercanti, visitatori): con l'inizio della stagione primaverile i mari si placavano e tornavano a essere navigabili, liberando quindi Atene dall'isolamento che aveva contrassegnato i mesi invernali. Le Dionisie urbane erano un'eccellente occasione pubblicitaria per la grandezza di Atene, che in quei giorni mostrava ai suoi alleati e a tutti i greci il suo potere, la sua ricchezza e la sua supremazia culturale. Per meglio sottolinearne il clima festivo, durante i giorni della festa venivano interrotte tutte le attività lavorative, si sospendevano i procedimenti legali, si aprivano addirittura le prigioni per fare in modo che anche i carcerati potessero assistere agli spettacoli. La festa era stata istituita in onore di Dioniso Eleutereo al tempo del trasferimento della sua immagine sacra dalla città di Eleutere, posta al confine tra l'Attica e la Beozia, ad Atene, dove era stata collocata nel tempio del dio che si trovava vicino all'area sacra del teatro, nei pressi dell'Acropoli. Il trasferimento di questa statua lignea è legato a una figura misteriosa, un certo Pegaso, forse vissuto ai tempi di Anfi-zione, uno dei leggendari sovrani ateniesi; le uniche notizie certe collegano tuttavia la crescente popolarità della festa al secolo vi a.C., agli anni della tirannia di Pisistrato (561-556 e 546-528). Ogni anno, nei giorni precedenti la festa vera e propria, il trasferimento dell'immagine sacra veniva ricordato attraverso una cerimonia che consisteva nel condurre la statua in un piccolo tempio che si trovava proprio sulla strada per Eleutere, non lontano dall'Accademia; dopo la celebrazione di un sacrificio presso l'altare del tempietto, la statua veniva riportata in processione dagli efebi fino al teatro alla luce delle fiaccole e collocata al centro dell'orchestra. Il controllo della festa spettava a una delle maggiori autorità ateniesi, l'arconte eponimo, così chiamato perché toccava a lui dare il proprio nome all'anno: sotto la diretta responsabilità dell'arconte, coadiuvato da due assistenti (i pàredroi), erano la processione che segnava l'inizio della festa, le competizioni drammatiche (tragedia, commedia e dramma satiresco) e quelle ditirambiche. La cerimonia preliminare (il viaggio rituale della statua) avveniva l'8 o il 9 di Elafebolione. In uno di questi giorni (non sappiamo se prima o dopo il trasferimento della statua del dio) aveva luogo un altro evento di fondamentale importanza per quanto riguarda gli spettacoli teatrali: il cosiddetto proagone (proagón). Questa "cerimonia preliminare che preludeva alle gare" era una sorta di sintetica "prova generale", un'anticipazione degli argomenti dei drammi che sarebbero stati rappresentati di lì a qualche giorno: i poeti venivano chiamati da un araldo, salivano su una piattaforma e presentavano schematicamente al pubblico la trama delle loro
opere; insieme a loro partecipavano anche gli attori, che erano a volto scoperto e non indossavano i costumi, ma avevano il capo incoronato da una ghirlanda. Non sono molte le testimonianze che parlano di questo evento: sappiamo che nel 422 Aristofane scrisse una commedia intitolata Proagone, dove Euripide compariva fra i protagonisti; i pochissimi frammenti che ci sono pervenuti non ci permettono tuttavia di ricostruirne la trama. Nel 406, alla veneranda età di novant'anni, Sofocle si presentò al proagone vestito a lutto per la recente scomparsa di Euripide, suscitando il pianto dei presenti. Ignoriamo in quale luogo si tenesse il proagone in occasione delle gare più antiche; a partire dal 444, questa cerimonia fu trasferita in una nuova sede, l'Odeon fatto costruire da Pericle. Al mattino del giorno seguente (il 10 di Elafebolione) si teneva la processione (pompe) che dava ufficialmente inizio alla festa, organizzata dall'arconte eponimo con la collaborazione di dieci curatori (gli epimeletài), inizialmente eletti dall'assemblea e successivamente estratti a sorte uno per ognuna delle dieci tribù nelle quali era diviso il territorio dell'Attica. Questa cerimonia consisteva in una processione religiosa preparatoria ai sacrifici che venivano celebrati nel tempio di Dioniso. Il momento principale del sacrificio era l'uccisione di un toro (uno degli animali ai quali il dio veniva assimilato); tra le altre offerte a Dioniso c'erano le primizie, che venivano portate da alcune fanciulle (le canefore) all'interno di canestri d'oro, e le focacce chiamate obell'ai', l'aspetto più singolare di questa processione era senz'altro la sfilata dei giganteschi falli in onore del dio. Alla processione non partecipavano soltanto gli Ateniesi: tra il pubblico era possibile notare le vesti rosse dei meteci (gli stranieri che risiedevano ad Atene) e quelle purpuree dei coreghi (i cittadini abbienti che contribuivano al finanziamento degli spettacoli). Non si conosce il percorso preciso della processione; sappiamo soltanto che attraversava l'agorà, dove un coro danzava e cantava davanti alle statue dei dodici dei. Alla sera di questa stessa giornata si svolgeva con tutta probabilità un altro momento fondamentale della festa, il kómos, una processione particolarmente festosa e vivace, che terminava con un banchetto nel quale i convitati bevevano grandi quantità di vino, tributando così il giusto onore al dio di cui si celebrava la festa. Nei giorni seguenti, nel teatro di Dioniso si svolgevano le competizioni drammatiche. Sul calendario preciso degli spettacoli teatrali rimangono ancora alcuni lati oscuri: il punto sul quale verte la discussione sta nell'eventualità o meno che, durante le fasi cruciali della guerra del Peloponneso, il programma abbia subito una riduzione per limitare le spese in un momento drammatico per la storia ateniese. Secondo l'ipotesi che va per la maggiore, i giorni dedicati agli agoni teatrali sarebbero stati quattro (11, 12, 13 e 14 Elafebolione): in ciascuno dei primi tre giorni sarebbero state rappresentate tre tragedie e un dramma satiresco, tutti composti dal medesimo autore; nel quarto giorno sarebbero state messe in scena cinque commedie di cinque poeti diversi. Le tre tragedie potevano essere o tre momenti successivi della stessa vicenda (come la trilogia dell'Orestea, rappresentata nel 458 e composta dall' Agamennone, dalle Coefore e dalle Eumenidi) oppure tre storie prive di qualsiasi collegamento. Secondo alcuni studiosi, durante gli anni critici della guerra con Sparta (dal 431 al 405, o forse solamente dal 423 al 414), i giorni delle rappresentazioni sarebbero stati ridotti a tre e dedicati ciascuno a tre tragedie, un dramma satiresco e una commedia. Era il sorteggio a stabilire l'ordine con il quale si succedevano le tre tetralogie e le cinque commedie. Nulla era lasciato al caso: nessun poeta amava aprire la gara, nel timore che la giuria si lasciasse influenzare dalla tragedia o dalla commedia che aveva visto per ultima e si dimenticasse di quella che aveva visto per prima. L'origine di queste competizioni era molto lontana nel tempo. La rappresentazione di tragedie in gara tra loro risale agli ultimi anni della tirannia di Pisistrato: secondo la tradizione, il primo autore di tragedie sarebbe stato Tespi, un personaggio dai contorni leggendari di cui non possediamo nemmeno un verso (conosciamo solo i titoli di quattro tragedie: Le gare per Pelia, I sacerdoti, I giovinetti, Penteo); secondo Aristotele, fu Tespi l'organizzatore del primo concorso drammatico, negli anni della sessantunesima Olimpiade (536-533 a.C.). La registrazione epigrafica delle tragedie risale agli ultimi anni del secolo vi (intorno al 501); Eschilo ottenne la sua prima vittoria nel 484; Sofocle esordì nel 468, sconfiggendo Eschilo; la prima apparizione di Euripide è datata 455 (e gli fruttò solamente il terzo posto). Per quanto riguarda le commedie, bisogna invece scendere a
tempi più recenti: le prime furono messe in scena a spese degli stessi attori; il primo concorso ricordato dalle fonti risale al 486 e fu vinto da una commedia di Chionide. Il primo successo di Cratino è più o meno contemporaneo al debutto di Euripide; l'esordio vittorioso di Eupoli risale al 429 a.C., due anni prima del primo trionfo di Aristofane. Fino agli inizi del secolo iv i drammi rappresentati alle grandi Dionisie furono sempre composizioni originali; solo in un secondo tempo prese piede la consuetudine di mettere in scena, accanto a testi nuovi, le repliche di tragedie o commedie composte nel secolo precedente. Da un'iscrizione sulla quale ritorneremo più avanti (i cosiddetti "Fasti"), risulta che nel 386 vi fu la rappresentazione straordinaria di una tragedia antica e che nel 339 avvenne la stessa cosa per una commedia. Un'altra iscrizione (le cosiddette "Didascalie") ci informa che, a partire dal 341 (con la rappresentazione dell'Ifigenia di Euripide, recitata dall'attore Neottolemo), l'inserimento di una antica tragedia nel programma della festa era divenuto una consuetudine; per la commedia, invece, possediamo una data più recente, il 311, l'anno nel quale fu messa in scena la replica del Tesoro di Anassandride. La responsabilità di scegliere quali tragedie e quali commedie rappresentare ogni anno toccava all'arconte eponimo: i poeti si recavano da lui qualche mese prima dell'inizio della festa, leggevano alcuni passi dei loro drammi e gli "chiedevano un coro". Questa frase ("chiedere un coro") era l'espressione tecnica che indicava la richiesta formale rivolta all'arconte di fornire una persona (il corego) che si accollasse i costi dell'allestimento scenico. Inizialmente la nomina dei coreghi tragici e comici spettava all'arconte; in un secondo tempo, a partire forse dal secolo iv, la scelta dei coreghi delle commedie fu trasferita alle tribù. La scelta degli attori fu riservata, almeno nel periodo iniziale, ai poeti; spesso erano i poeti stessi a recitare nei propri drammi, come risulta testimoniato per i tragici Eschilo e Sofocle (che dovette abbandonare la carriera parallela d'attore a causa della debolezza della sua voce) e per il comico Cratino. Tra i nomi degli attori possiamo ricordare Cleandro e Minnisco, che erano molto apprezzati da Eschilo, mentre Tlepolemo era l'attore preferito di Sofocle. In una fase successiva, la nomina degli attori divenne una prerogativa dello Stato; gli attori scelti dall'arconte venivano poi assegnati ai singoli poeti attraverso un sorteggio. È probabile che questo cambiamento sia stato determinato dalla scelta di istituire una competizione tra gli attori, che si affiancò a quella già esistente tra i poeti. Il primo concorso tra attori alle grandi Dionisie risale al 449 a.C. Le rappresentazioni cominciavano all'alba e terminavano al tramonto. La prima tragedia era preceduta dai consueti sacrifici agli dei e dalle libagioni davanti alla statua di Dioniso. Poi gli araldi gridavano il nome dei cittadini che avevano acquistato benemerenze nei confronti dello Stato; questi venivano premiati con una corona e ricevevano l'applauso del pubblico. Durante il periodo di maggior splendore della democrazia ateniese, prima dell'inizio delle gare veniva solennemente esposto a teatro il tributo versato dagli alleati ateniesi. Sempre negli stessi anni si teneva a teatro un'altra toccante cerimonia: i figli dei soldati ateniesi caduti in battaglia (e che erano stati fino a quel momento allevati a spese dello Stato), raggiunta la maggiore età, facevano il loro ingresso a teatro armati di tutto punto e venivano ufficialmente proclamati cittadini ateniesi adulti, ricevendo la benedizione del popolo. Gli spettatori trascorrevano a teatro l'intera giornata. Per sfamarsi, avevano due possibilità: o tornare a casa durante gli intervalli tra un dramma e l'altro (ma questo sarebbe stato impossibile per tutti coloro - ed erano di gran lunga la maggioranza - che abitavano lontano dall'Acropoli, nei demi più periferici) oppure comperare qualcosa dai venditori ambulanti (vino, frutta secca e dolci, che all'occorrenza potevano essere usati per bersagliare gli attori incapaci). La lunga durata degli spettacoli - non inferiore a sei ore - consigliava di munirsi di cuscini per attenuare la scomodità dei sedili di legno o di pietra. Accanto agli agoni teatrali bisogna poi ricordare un altro genere di competizione: le gare ditirambiche. Il ditirambo era un canto corale in onore di Dioniso, la cui esistenza è testimoniata per la prima volta nel secolo vii a.C. in un frammento di Archiloco (fr. 120 West); fu Arione di Metimna, vissuto tra i secoli vii e vi, a dare dignità letteraria a questo genere poetico. La sua introduzione ad Atene viene attribuita a La-h i in i k< >1 >1 l/ic )ni. al teatro greco so di Ermione, che al tempo dei Pisistratidi ne modificò l'aspetto musicale organizzando il primo agone ditirambico; le fonti epigrafiche datano l'istituzione delle prime competizioni ditirambiche al 508 a.C.
Le gare venivano organizzate in questo modo: ciascuna delle dieci tribù sceglieva due coreghi, che avevano a loro volta il compito di provvedere all'organizzazione dei cori selezionando gli elementi destinati a farvi parte e pagandoli. Per ogni tribù partecipavano due cori, quello degli adulti e quello dei ragazzi, che dovevano essere per forza cittadini ateniesi; ogni coro era formato da cinquanta elementi. Di conseguenza, i cori erano venti (due per ogni tribù); le persone coinvolte erano mille (più i venti coreghi). Ogni corega doveva inoltre scegliere il poeta (l'autore del testo e della musica del ditirambo) e l'auleta (il musicista che avrebbe eseguito la musica su uno strumento simile al nostro flauto diritto); siccome il valore dei poeti e degli auleti non era omogeneo, i coreghi tiravano a sorte per decidere chi sarebbe stato il primo ad avere il diritto di scegliere tra gli artisti disponibili. I coreghi dei ditirambi dovevano avere notevoli disponibilità finanziarie, perché il numero dei coreuti ditirambici era molto superiore a quello dei cori tragici e comici. Tra i compiti del corego c'era anche quello di trovare il luogo per le prove (nel caso dei cori giovanili, questo poteva essere addirittura la casa del corego) e di cercare un maestro che fosse in grado di istruire i coreuti (il chorodidàskalos, "istruttore del coro"); nei primi tempi, è probabile che quest'ultimo compito delicato spettasse al poeta stesso. Anche le competizioni ditirambiche si tenevano nel teatro di Dioniso; il giorno riservato all'esecuzione dei componimenti era probabilmente il 10 di Elafebolione, nel pomeriggio successivo alla processione inaugurale. Dopo essersi disposto in circolo intorno all'altare collocato al centro dell'orchestra (ed è questo il motivo per cui i cori ditirambici erano chiamati anche col nome di "cori ciclici"), il coro eseguiva la propria performance cantando e danzando a volto scoperto. In un primo periodo, il valore dei testi era superiore a quello delle musiche (tra gli autori si ricordano poeti come Simonide, Bacchilide e Pindaro); in un secondo tempo, però, a partire dalla metà del secolo v, con autori come Melanippide, Frinide, Cinesia, Timoteo e Filosseno, la musica cominciò a farsi sempre più elaborata finendo per prevalere sul testo, che divenne un semplice supporto per le note musicali. Le gare ditirambiche si tennero senz'altro fino al 328 a.C.; alcune testimonianze epigrafiche ne attestano l'esistenza fino all'età romana (intorno al 200 d.C.). Al termine degli spettacoli venivano pronunciati i verdetti sulle diverse competizioni. La scelta dei giurati chiamati a dare il loro parere sugli spettacoli avveniva molto probabilmente in questo modo: prima della festa veniva preparato un elenco di nomi scelti da ciascuna delle dieci tribù; i nominativi di ogni tribù venivano collocati in dieci urne (una per tribù); le urne venivano sigillate e custodite nell'Acropoli. All'inizio di ogni gara, l'arconte estraeva un nome da ogni urna; la giuria sorteggiata (che era quindi formata da dieci membri, uno per ogni tribù) era tenuta a giurare di comportarsi in modo imparziale. Ogni giurato scriveva su una tavoletta la sua graduatoria; le dieci tavolette erano messe in un'altra urna dalla quale l'arconte ne estraeva cinque; la media di queste cinque tavolette costituiva la classifica definitiva. Un araldo annunciava il nome del poeta vincitore, che riceveva dall'arconte una corona d'edera. Non sappiamo se le competenze di questa giuria valessero per tutti i concorsi di ogni festa (tragedie, commedie, drammi satireschi e ditirambi) o se per ogni gara venisse sorteggiata una giuria diversa. È inoltre probabile che non fosse molto diversa la procedura per incoronare il vincitore nella competizione tra gli attori. Dal momento che ogni cittadino ateniese dotato di diritti politici poteva essere scelto come giudice, indipendentemente dalle sue competenze letterarie, non ci si deve stupire del fatto che alcuni giudizi paiano poco equilibrati. La tragedia più celebre del teatro greco, la più apprezzata da un sicuro esperto come Aristotele, l'Edipo re di Sofocle, arrivò soltanto seconda, battuta da un dramma di Fi lode, un poeta tragico di non eccezionale valore, spesso preso in giro dai comici che ne deridono le asprezze stilistiche. Alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che dietro simili giudizi apparentemente incomprensibili potessero esserci tentativi riusciti di favorire un poeta a scapito di un altro (Filocle era parente di Eschilo - per la precisione, era figlio di una sua sorella); può anche darsi però che tra le motivazioni della giuria ci fossero anche altri fattori quali la bellezza dei costumi, la bontà o meno dell'esecuzione, la bravura o l'incapacità degli attori e del coro. Anche Aristofane fu vittima di giudizi abbastanza sorprendenti: nel 423 le Nuvole furono sconfitte non soltanto dalla Damigiana di Cretino, ma anche dal Conno del non eccelso Amipsia; nel 414 gli Uccelli finirono al secondo posto dietro ai Cornasti dello stesso autore. È per questo motivo che nelle commedie non sono inconsueti gli appelli all'onestà dei giudici: nelle Donne in assemblea, lo stesso Aristofane chiede alla giuria di non
tradire il giuramento e di valutare le opere con onestà (vv. 1154-5); alcuni anni prima, Ferecrate aveva invitato i giudici a non essere spergiuri e a non pronunciare un verdetto disonesto (fr. 102 Kassel-Austin). La conclusione definitiva delle grandi Dionisie era segnata da una speciale assemblea pubblica convocata dai pritani nel giorno successivo a un'altra festa (le Pandie, dedicate a Zeus), probabilmente il 16 di Elafebolione. Nel corso di questa assemblea si esaminava attentamente l'operato dell'arconte e quello dei suoi collaboratori, e si dava un giudizio sull'organizzazione e sullo svolgimento della festa. Se durante i giorni delle celebrazioni si erano verificati episodi spiacevoli (irregolarità nello svolgimento delle prove oppure tafferugli fra il pubblico) e qualcuno sporgeva querela, venivano istituiti regolari processi; se invece tutto si era svolto regolarmente, l'arconte riceveva un pubblico elogio e veniva incoronato al termine dell'assemblea. Esisteva un'altra festività religiosa dedicata a Dioniso che permetteva agli ateniesi di assistere ad alcuni spettacoli teatrali: le feste Lenee (Lénaia). Queste si tenevano due mesi prima delle Dionisie urbane, in pieno inverno, e per la precisione a gennaio/febbraio, nel mese attico di Gamelione, alla presenza di un pubblico esclusivamente ateniese. Il significato del nome "Lenee" è sempre stato oggetto di controversie. Per molto tempo lo si è messo in relazione con il sostantivo lenós ("pressa per il vino"); poi si è pensato che fosse imparentato col nome lénai, che indicava le Baccanti o le Menadi, le donne che veneravano Dioniso. Anche le origini della festa sono poco note; è possibile che sia arrivata ad Atene dalle regioni settentrionali della Macedonia o della Tracia, passando attraverso la Beozia e Tebe. A differenza delle Dionisie, che erano sotto la giurisdizione dell'arconte eponimo, le Lenee erano organizzate dall'arconte re, il funzionario che esercitava la sua competenza sulle questioni religiose e si occupava dei reati più gravi (omicidio ed empietà). Era lui a guidare la processione solenne che costituiva un momento nodale della festa ed era accompagnata da un sacrificio. La festa si teneva in un luogo chiamato "Leneo" sulla cui ubicazione le notizie in nostro possesso sono scarse e problematiche: secondo alcune fonti il Leneo si trovava in campagna, al di fuori delle mura cittadine; secondo altre, invece, era collocato in città, nel luogo della festa del mercato, a nord-ovest dell'Acropoli. Altre fonti meno attendibili sembrano collegare la festa con il santuario di Dioniso "nelle paludi" (en Limnais, "a Limnai"), dove venivano celebrate le Antesterie, un'altra celebrazione connessa col culto di Dioniso "dio del vino", che aveva luogo nel mese di Antesterione (verso la fine di febbraio). Gli spettacoli teatrali si tennero inizialmente nel recinto del Leneo e furono poi trasferiti nel teatro di Dioniso; l'ipotesi che i drammi presentati alle Lenee fossero messi in scena in un altro teatro costruito appositamente, formulata da Carlo Anti e sostenuta da Carlo Ferdinando Russo, non sembra trovare oggi molto credito. Le fonti in nostro possesso sono alquanto lacunose per quanto concerne i vari momenti della festa. A proposito della processione (che non raggiungeva certo la magnificenza di quella che apriva le grandi Dionisie), le fonti ricordano un altro elemento curioso: i partecipanti accompagnavano la processione levando canti beffardi e derisori, co ine accadeva anche alle feste eleusine. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, che costituivano il momento culminante della festa, è sicuro che, a differenza delle Dionisie (dove erano le tragedie i drammi più attesi), nelle Lenee le commedie erano lo spettacolo più importante. In effetti, per tutto il secolo v, alle Lenee parteciparono solo due poeti tragici (invece di tre), che presentavano solamente due tragedie ciascuno (una in meno che alle Dionisie, e senza il dramma satiresco); se è certo che Sofocle partecipò agli agoni lenaici, sembra che Euripide non vi abbia mai presentato nessuna tragedia; il poeta tragico Agatone conquistò una vittoria alle Lenee del 416 a.C. Per i poeti comici, invece, le Lenee erano un'ottima occasione per mettersi in mostra: se le Dionisie rappresentavano senz'altro una vetrina più prestigiosa, soprattutto in considerazione della presenza di personalità straniere tra il pubblico, è vero che un successo alle Lenee non era affatto disprezzabile. Dal momento che il pubblico era composto quasi esclusivamente da cittadini ateniesi, gli argomenti di queste commedie erano molto legati alle vicende politiche, culturali e sociali della polis. Ogni edizione della festa vedeva la rappresentazione di cinque commedie; è probabile che anche per le Lenee
sia stato previsto un ridimensionamento del numero degli spettacoli durante gli anni cruciali della guerra contro Sparta (tre sole commedie invece di cinque). L'esordio di Aristofane avvenne proprio alle Lenee: nel 427 il poeta fece rappresentare i suoi Banchettanti con la collaborazione di Callistrato, conquistando il secondo posto. Tra le commedie di Aristofane che ci sono pervenute integralmente, tre ottennero il primo premio ai concorsi lenaici (Acarnesi, Cavalieri, Rane); tra le altre sue commedie che trionfarono alle Lenee, ricordiamo il perduto Proagone. I primi concorsi tra i poeti tragici risalgono agli anni che vanno dal 440 al 430 a.C.; le prime gare tra i comici sono invece di poco più antiche (la prima di cui abbiamo testimonianza risale al 442). Agli stessi anni risalgono le prime competizioni tra gli attori tragici e comici, ricordate dall'iscrizione LG. ir 2325, che riporta l'elenco dei vincitori in tutte le competizioni (alle Dionisie e alle Lenee, tra i poeti e gli attori). Non abbiamo testimonianze che ricordino riprese di drammi antichi alle Lenee; l'unica menzione di un agone ditirambico è molto tarda (inizi del secolo iii a.C.). La nostra rassegna delle festività religiose connesse col teatro non sarebbe completa se non si facesse un rapido accenno alle Dionisie rurali (ta kat' agroús Dionýsia, le "Dionisie [che si celebravano] nei campi"). Queste feste non si celebravano in città, ma in campagna, e per la precisione nei demi, i distretti territoriali nei quali era suddivisa la superfìcie dell'Attica. Anche queste feste si svolgevano in inverno, a dicembre, nel mese di Poseidone; i giorni precisi tuttavia variavano da demo a demo, rendendo così possibile a chi lo desiderasse il passare da una festa all'altra. L'elemento più singolare di queste feste era la falloforia, la processione durante la quale veniva portato in giro un enorme fallo eretto, simbolo di fertilità. Negli Acarnesi, rappresentati nel 425, Aristofane mette in scena una versione domestica di questa cerimonia: Di-ceopoli, il protagonista della commedia, guida un ridotto corteo composto dalla figlia nel ruolo di "canefora" (la fanciulla che portava un canestro contenente l'offerta di un dolce o di una focaccia) e da due schiavi fallofori (che avevano il compito di reggere e trasportare il fallo); durante la processione, Diceopoli canta un inno a Fales (una divinità legata a Dioniso, simboleggiante la fertilità). Sappiamo da altre fonti che del corteo facevano parte anche schiavi che portavano ceste di fichi secchi e anfore piene di vino. È probabile che la festa avesse origini molto antiche, addirittura anteriori all'introduzione del culto di Dioniso in Attica; il rito venne legato al dio del vino solo in un secondo tempo. Il responsabile dell'organizzazione della festa era il demarco, cui spettava il consueto compito di nominare i coreghi. Altre testimonianze su questo momento della festa - che comprendeva, oltre alla processione, il sacrificio di un caprone - ci vengono da alcuni demi. Particolarmente famose erano le Dionisie rurali che si celebravano al Pireo: Eliano racconta che Socrate aveva l'abitudine di scendere fino al porto quando Euripide metteva in scena le sue tragedie (Storie varie, 2.13). La legge di Evegoro (citata in un'orazione di Demostene e risalente al secolo iv a.C.) dice inoltre che nelle Dionisie del Pireo si tenevano agoni tragici e comici. Da un'epigrafe risalente alla metà del secolo iv (I.G. II2 1186) si ricava la notizia che alle Dionisie di Eleusi le competizioni riguardavano, oltre alle tragedie, anche i ditirambi (sono menzionati due cori, uno di bambini e uno di adulti, dedicati alle due divinità eleusine, Demetra e Core - oltre che, naturalmente, a Dioniso); da un'altra (I.G. II 2 3090), di difficile interpretazione, sembra di capire che nella città sacra ai misteri di Demetra siano state messe in scena anche tragedie di Sofocle e commedie di Aristofane. È probabile che, come nel caso delle tragedie euripidee citate da Eliano, si trattasse di repliche di drammi già messi in scena precedentemente durante le feste più importanti. Abbiamo sicure testimonianze epigrafiche che riguardano anche il demo di Icario, una località che gli antichi racconti mitici collegano all'arrivo di Dioniso nell'Attica: secondo una vicenda testimoniata da Apollodoro (e presente, con qualche variazione, nel romanzo Le avventure di Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio), Dioniso avrebbe fatto conoscere il vino al pastore Icario, ordinandogli di diffondere l'uso della bevanda tra i suoi compatrioti; i vicini di Icario, avendo bevuto troppo vino ed essendosi ubriacati, credettero di essere stati avvelenati e se la presero col povero Icario, uccidendolo; venuti a conoscenza del loro tragico errore, lo seppellirono solennemente. Tra gli altri demi che ospitavano, all'interno delle celebrazioni delle Dionisie rurali, spettacoli teatrali, possiamo inoltre ricordare Acarne, Aissone, Ana-girunte, Collito, Egilia, Mirrinunte, Ramnunte e Salamina.
Le Dionisie rurali erano una versione ridotta e locale delle Dionisie più grandi: tuttavia, benché le compagnie teatrali fossero meno prestigiose e gli spettacoli risultassero inevitabilmente di livello inferiore, queste feste popolari ebbero il merito di diffondere anche tra gli strati più bassi della gente la conoscenza del teatro e la dimestichezza con gli autori più celebri. Il collegamento tra le competizioni teatrali e le Antesterie è molto sottile. Questa festa (che, tra tutte le celebrazioni ateniesi in onore di Dioniso, era la più antica) si teneva alla fine del mese di febbraio, nei giorni 11, 12 e 13 di Antesterione: nel primo giorno della festa, chiamato Pithoigía ("l'apertura degli orci"), si aprivano gli orci contenenti il vino che era stato vendemmiato l'autunno precedente (e che veniva bevuto da tutti i partecipanti alla festa, schiavi compresi); la seconda giornata, chiamata Chóes ("i boccali"), era caratterizzata da una serie ininterrotta di bevute di vino e da una gara fra bevitori arbitrata dall'arconte (al termine della quale il vincitore riceveva in premio, ovviamente, un otre pieno di vino); il terzo giorno, che veniva chiamato Chytroi ("le pentole", dal nome dei contenitori nei quali veniva cotta una minestra offerta a Hermes), rappresentava un radicale cambiamento di tono rispetto alle giornate precedenti, perché era dedicato al culto dei morti. Non sembra che durante le Antesterie ci fossero rappresentazioni teatrali; da un passo proveniente da un'opera attribuita a Plutarco (Vite dei dieci oratori, 841 f) pare però di poter dedurre che nel corso della festa si tenesse una competizione tra attori comici (le "gare delle pentole") che permetteva al vincitore di acquisire il diritto di recitare in una delle commedie che sarebbero state rappresentate alle grandi Dionisie del marzo successivo.
2.2 La struttura e le caratteristiche dei teatri greci. Il teatro di Dioniso ad Atene Nell'età classica i teatri greci avevano tutti la medesima struttura: il pubblico si disponeva seduto nella "cavea" (théatron); gli attori recitavano sulla "scena" (skené); i coreuti danzavano nella cosiddetta "orchestra" (orchestra). La cavea era di solito appoggiata a un pendio naturale (nel caso del teatro di Dioniso i sedili poggiavano sulle pendici meridionali dell'Acropoli). era tagliata verticalmente da una serie di scalette che la dividevano in settori a forma di cuneo (kerkides); orizzontalmente, invece, era attraversata da uno o più corridoi (diazómata, letteralmente "cinture") che permettevano agli spettatori di muoversi da un'estremità all'altra del teatro alla ricerca di un posto a sedere. La scena era un palco di legno più alto rispetto al piano dell'orchestra, sul quale si muovevano gli attori. Sulla sua superfìcie potevano trovarsi alcune strutture provvisorie necessarie per la trama di alcuni drammi: nei Persiani di Eschilo, un tumulo indicava la tomba di Dario; nelle Vespe di Aristofane, davanti alla casa del giudice Filocleone era collocato l'altare dell'eroe attico Lieo. Tra la cavea e la scena si trovava l'orchestra, uno spiazzo semicircolare in terra battuta, al centro del quale era collocato l'altare di Dioniso. L'orchestra (dal verbo orchéomai, che significa "danzare") era il luogo riservato alle evoluzioni del coro. Non esisteva una scenografia vera e propria nel senso nel quale intendiamo il termine oggi. Nella Poetica (1449al8-9), Aristotele si limita a dire che a Sofocle si deve l'introduzione della "scenografia" (letteralmente, "decorazione della scena"); secondo Vitruvio, l'autore di un trattato latino Sull'architettura, scritto nel secolo I a.C. e ricco di informazioni sugli edifici teatrali greci e romani, sarebbe stato invece il pittore Agatarco di Samo a progettare le prime pitture di scena per i drammi di Eschilo (7, praef. 11 ); la Suda (un'enciclopedia bizantina) ricorda infine il nome di un drammaturgo siracusano, un certo Formo, che tra i secoli vi e v a.C. avrebbe usato per primo una tenda fatta di pelli conciate e colorate in rosso. È probabile che il termine usato da Aristotele si riferisse, molto semplicemente, all'adozione di un rudimentale fondale dipinto che aveva il compito di separare la parte anteriore della scena (sulla quale si muovevano gli attori) da quella posteriore (che conteneva gli spogliatoi degli attori). Del resto, il termine greco skené (dal quale sono derivati sia il latino scaena che il nostro "scena") significa propriamente "tenda"; solo in un secondo tempo finì per indicare sia il fondale sia il palcoscenico.
Aristotele si dimostra sempre molto attento all'aspetto scenico del teatro: nella Poetica (1450a8 sgg.), tra i sei elementi costitutivi della tragedia, accanto a musica, parole, caratteri, pensiero e trama, egli sottolinea l'importanza della "vista" (ópsis), di ciò che gli spettatori vedevano. Il valore di questo aspetto visivo è evidenziato dalla parola stessa che designava (e designa ancora) il teatro: il sostantivo greco théatron ("il luogo nel quale si vede") deriva dal verbo theaomai ("vedere"); théatron indicava il luogo nel quale era seduto il pubblico (cioè la cavea). Secondo il filosofo, l'aspetto scenografico è "affascinante" (psychagogikón, "capace di trascinare con sé l'animo degli spettatori"), ma non ha nulla a che vedere con la tecnica poetica; se ci si limita alla dimensione spettacolare del teatro, l'abilità di chi prepara le scene e disegna i costumi (due compiti definiti con un'unica parola, skeno-poiós, "colui che crea gli attrezzi e gli strumenti") è più importante del lavoro degli stessi poeti ( 1450bl8 sgg.). Nel fondale si aprivano una o più aperture, attraverso le quali entravano e uscivano gli attori. Questo fondale poteva di volta in volta rappresentare ambienti differenti: un palazzo reale (come nell'Agamennone di Eschilo), un tempio (nello Ione di Euripide, ambientato a Delfi), un'abitazione privata (nelle Vespe di Aristofane), una grotta (nel Filottete di Sofocle). Ben presto quella che era originariamente una semplice tenda di stoffa divenne una struttura lignea; al suo fianco vennero collocati due avancorpi laterali (i paraskénia); tra questi avancorpi (che costituivano le due estremità della scena) e i sedili più laterali della cavea c'erano due passaggi (chiamati éisodoi o pàrodoi), che venivano utilizzati dal coro al momento del suo ingresso nell'orchestra. Sopra la scena era inoltre collocato il cosiddetto theologéion, una piattaforma capace di reggere il peso di un paio di attori, che vi accedevano salendo per i gradini di una scala appoggiata sul retro della scena stessa. Il theologéion era generalmente riservato alle apparizioni delle divinità; il suo nome significa "il luogo riservato ai discorsi degli dei". Tuttavia, in altre circostanze, vi potevano montare anche i mortali: nel prologo dell'Agamennone, Eschilo fa pronunciare le prime battute della tragedia a una sentinella che, nella finzione scenica, aveva il compito di montare la guardia sul tetto del palazzo regale di Micene. Più avanti, a partire dal secolo iv, la scena (il fondale) diviene sempre più elaborata: se prima, da semplice tenda che distingueva lo spazio destinato alla recitazione da quello riservato ai camerini degli attori, era diventata una struttura in legno dipinto, adesso assume un aspetto ancora più stabile e viene costruita in pietra. Alle tre porte che si aprono nella scena (i thyrómata) vengono fissati alcuni pannelli dipinti per dare il senso della prospettiva. Gli avancorpi laterali diventano più imponenti; i passaggi per il coro vengono decorati da architravi e colonne. Con la costruzione di una scena in pietra, si ha un'altra novità: viene edificato un proscenio sopraelevato, a circa due metri dalla facciata della scena, sorretto da alte colonne. La scena diventa il luogo verso il quale si dirige ormai l'attenzione degli spettatori; lo spazio dell'orchestra finisce per rimanere sempre più isolato e meno visibile. Determinati effetti erano resi possibili dall'uso delle macchine sceniche. Nel suo Onomasticon, Giulio Polluce (un erudito egiziano vissuto nel secolo il d.C.) ne ricorda diciannove. Tra queste, la più famosa era la "macchina" per eccellenza, la mechané (l'antecedente greco del nostro "macchina"), un'apparecchiatura formata da un gancio o da una carrucola usata per far scendere o salire alcuni personaggi. La sua frequente utilizzazione nel teatro euripideo ha dato origine all'espressione theós apó mechanès (più nota nella versione latina deus ex machina, che significa "il dio (che scende] dalla macchina"); essa indicava in origine l'apparizione di una divinità che, calata dall'alto attraverso la mechané, portava a conclusione la vicenda tragica - e finì poi per designare la persona che, intervenendo alla fine, risolve una situazione particolarmente intricata. In una tragedia perduta di Euripide, il Bellerofonte, l'eroe era comparso sulla scena a cavallo del suo mitico destriero alato. Pegaso; l'apparizione era stata resa possibile dall'uso della macchina. Nel prologo della Pace, Aristofane si serve della stessa macchina per far volare uno scarabeo gigante; il protagonista della commedia, il vignaiolo Trigeo, a cavallo sull'insetto, si rivolge direttamente al manovratore e prende in giro Euripide alludendo proprio al suo Bellerofonte. Un'altra macchina scenica di uso molto comune era l' enkyklema ("enciclema"), una piattaforma che permetteva di far uscire da una delle porte e di mostrare agli spettatori qualcosa che si trovava all'interno di una casa (o di un tempio, o di una grotta). Non esistono prove certe dell'esistenza di questo espediente scenico nei drammi rappresentati nel secolo v; se l'enciclema era usato anche in quegli anni, allora è grazie a questa macchina che, nell'Agamennone, Eschilo aveva potuto mostrare al pubblico i cadaveri del re acheo e di Cassandra che erano stati uccisi da Clitemnestra ed Egisto all'interno del palazzo di Micene, ed è sempre
grazie all'enciclema che, negli Acarnesi, Aristofane ha potuto far vedere al pubblico il poeta Euripide intento alla composizione delle sue tragedie all'interno della sua abitazione. Non c'è accordo tra gli studiosi sulla forma precisa di questa macchina: secondo alcuni si trattava di una piattaforma rettangolare che si muoveva dall'interno verso l'esterno scorrendo su piccole ruote; secondo altri, invece, era una sorta di piattaforma circolare che ruotava di centottanta gradi. Gli "scalini di Caronte" non erano una macchina vera e propria: si trattava di una scala nascosta collocata sotto il palcoscenico, che permetteva la comparsa di personaggi che venivano dall'Oltretomba. Se questo espediente era già in voga nel secolo v, allora era su questi scalini che era salito lo spettro di Dario nei Persiani di Eschilo e si erano arrampicate le anime dei quattro grandi Ateniesi del passato (Solone, Milziade, Aristide e Pericle) evocate nei Demi, la commedia più famosa di Eupoli, un contemporaneo di Aristofane. Altre macchine erano poi il keraunoskopéion ("ciò che fa vedere i fulmini"), una sorta di prisma a tre facce colorate di nero e decorate con il disegno di un lampo che veniva girato rapidamente simulando l'esplosione di una saetta, e il brontéion ("la macchina del tuono"), un orcio pieno di pietre che venivano rovesciate in un recipiente metallico per riprodurre un suono simile al rumore di un tuono. A partire dal secolo iv a.C. furono introdotte le periaktoi ("macchine girevoli"): si trattava di prismi girevoli a tre facce che venivano collocati o nelle due porte esterne oppure alle due estremità della scena; su ogni faccia era dipinta una scena particolare. Facendo girare il prisma, era possibile realizzare continui cambiamenti di scena e mostrare al pubblico dove si trovavano di volta in volta i personaggi; in genere, nel prisma di destra era visibile un paesaggio cittadino (l'agorà o il porto), mentre quello di sinistra raffigurava la campagna. Non esiste alcuna testimonianza che alluda con certezza all'utilizzo di un sipario nelle rappresentazioni del periodo classico; è quindi probabile che nel secolo di Eschilo e di Aristofane i Greci non ne facessero uso. Questa era la struttura tipica di un teatro greco di età classica con le sue modifiche successive. Ma com'erano i teatri più antichi, le vecchie strutture che furono poi sostituite da quelle che possiamo ammirare in molte località del mondo antico - dalla Grecia stessa alla Magna Grecia, dall'odierna Turchia all'Africa settentrionale - e che sono spesso il risultato di numerosi rifacimenti d'età ellenistica o addirittura romana? Ad Atene le prime rappresentazioni si tennero probabilmente nell'agorà, vicino al luogo che ospitava i momenti più importanti delle feste in onore di Dioniso Leneo. Il fulcro di questi spettacoli era costituito dall'orchestra, uno spazio circolare (o, forse, trapezoidale) destinato alla danza; il coro vi eseguiva le sue evoluzioni e gli spettatori assistevano stando seduti attorno all'orchestra. Quando la figura del corifeo (il personaggio che, pur facendo parte del coro, si era distinto dai suoi compagni e dialogava con loro) acquistò un ruolo predominante, anche l'aspetto fisico del teatro dovette modificarsi: fu allora che venne creata una piattaforma sulla quale il corifeo saliva per dialogare con i suoi compagni. Nello stesso tempo, per consentire al pubblico di assistere più comodamente agli spettacoli, si modificò anche la disposizione dello spazio riservato agli spettatori: questi si disposero lungo i due terzi della circonferenza dell'orchestra e si accomodarono su provvisorie tribune di legno (gli ìkria). In seguito, con l'introduzione (attribuita tradizionalmente a Tespi) di un singolo attore nettamente distinto dal coro e destinato a ricoprire più ruoli differenti, fu necessario riservargli uno spazio nascosto agli occhi del pubblico dove l'attore potesse cambiarsi; nella parte posteriore della piattaforma sulla quale l'attore si esibiva fu perciò montata una tenda che fungeva da spogliatoio. Ecco quindi presenti i tre elementi costitutivi del teatro greco: l'orchestra, la scena (la tenda - ossia lo sfondo - e la piattaforma) e la cavea. Il passo successivo fu la costruzione di un teatro stabile in pietra. Una fonte tarda (la Suda) ci riferisce un episodio che potrebbe spiegare l'origine di una simile decisione: pare che, all'inizio del secolo v, durante un agone tragico che vedeva concorrere Pratina (l'inventore del dramma satiresco), Cherilo (uno dei primi poeti tragici) ed Eschilo, le tribune di legno siano crollate causando molte vittime; questa tragedia avrebbe spinto gli Ateniesi a costruire un teatro più solido. Sulla scelta del luogo (le pendici meridionali dell'Acropoli) influirono due motivi, uno di ordine religioso e l'altro pratico: proprio alle pendici dell'Acropoli si trovava il recinto sacro dedicato a Dioniso Eleute-reo; inoltre, con un simile pendio naturale non si sarebbe corso il rischio di un nuovo crollo. Inizialmente il pubblico aveva assistito alle rappresentazioni seduto sulla nuda terra; è probabile che in seguito
si sia deciso di scavare una serie di gradoni naturali successivamente ricoperti forse da panche di legno. I sedili collocati vicino all'orchestra erano destinati alle personalità; gli altri erano invece riservati agli spettatori comuni. Nel corso del tempo, il teatro originario subì numerose modifiche. Al tempo di Pericle, il teatro fu ampliato e reso ancora più sicuro con la costruzione di muri di contenimento per la cavea; i resti che si possono ammirare ancor oggi risalgono in gran parte al rimaneggiamento effettuato un secolo dopo, fra il 338 e il 330 a.C., al tempo dell'oratore Licurgo (amico di Demostene e curatore della prima edizione ufficiale delle tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide) e alle successive modifiche di età romana. Il lavoro degli archeologi (a cominciare dagli scavi effettuati da Wilhelm Dörpfeld alla fine dell'Ottocento) ha permesso di individuare i segni delle varie stratificazioni; tuttavia, nonostante le ripetute campagne di scavi, non è stato ancora possibile raggiungere conclusioni sicure sull'aspetto del teatro che ha visto i successi di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Gli attuali gradini della cavea sono una testimonianza del restauro del secolo iv. Le settantotto file dei posti sono suddivise in tre ordini orizzontali (separati da due passaggi); le quattordici scale dividono le file in tredici cunei. È probabile che le file degli ordini superiori fossero divise da altre scale aggiuntive; oggi i sedili di queste ultime file sono quasi del tutto scomparsi, poiché il marmo è stato asportato nel Medioevo ed è stato usato altrove come materiale da costruzione. Dei sedili di marmo della prima fila riservati alle personalità ne sono rimasti sessanta, tutti d'età adrianea; fra tutti spicca il sedile centrale, adorno di bassorilievi, che era riservato al sacerdote di Dioniso. L'orchestra originaria era una grande area circolare dal diametro di circa venticinque metri; l'ipotesi che inizialmente l'orchestra avesse una forma trapezoidale (come risulta testimoniato da alcuni piccoli teatri antichi quali per esempio quello del demo attico di Torico, risalente al secolo vi a.C.) non sembra godere più di molto credito. Tra il limite della sua circonferenza e la prima fila di posti c'era uno spazio vuoto largo alcuni metri, nel quale era stato scavato un canale di scolo destinato a raccogliere l'acqua piovana che scendeva dalle pendici dell'Acropoli. Della scena originaria restano alcune fondazioni antiche; vi sono ancora visibili i buchi nei quali venivano infissi i pali destinati a sostenere la tenda contro la quale recitavano gli attori. La scena era lunga una ventina di metri, era leggermente rialzata ed era collegata con l'orchestra da una scala di gradini bassi che permetteva al coro di interagire con gli attori. Col restauro del secolo iv la scena mutò il suo aspetto originario e diventò una costruzione di pietra provvista di tre grandi porte; successivamente venne costruito un proscenio sopraelevato, sorretto da colonne che erano collocate a circa due metri dalla facciata della scena. Questa accresciuta magnificenza della scena è legata alla crescente importanza degli attori e alla conseguente riduzione del ruolo del coro. Se il teatro greco era nato dall'orchestra, e cioè dalle evoluzioni del coro, e solo in un secondo tempo un protagonista si era distanziato dal coro per dialogare con i suoi componenti, col secolo iv a.C. la situazione è totalmente cambiata: il coro è un semplice spettatore degli eventi che vengono rappresentati sulla scena, divenuta a sua volta il fulcro dell'azione e del teatro stesso, il punto sul quale si concentra oramai l'attenzione degli spettatori.
2.3 I protagonisti: i poeti, i coreghi, gli attori, i coreuti, i costumi e le maschere, la danza e la musica, il pubblico. Come abbiamo visto nel capitolo dedicato alle feste, l'organizzazione degli spettacoli teatrali era particolarmente complessa: numerosissime erano le persone coinvolte, pesanti le responsabilità, alta la posta in palio. La prima parte di questo capitolo sarà dedicata agli individui che rendevano possibile la realizzazione degli eventi; le sezioni successive affronteranno un'altra serie di aspetti pratici legati agli spettacoli. Cominciamo dai personaggi che rappresentavano, direttamente o indirettamente, la polis. Del compito dei primi (l'arconte eponimo per le grandi Dionisie, l'arconte re per le Lenee, il demarco per le Dionisie rurali) abbiamo già parlato; per quanto riguarda i secondi (i coreghi nominati dagli arconti), è giunto adesso il momento di raccontare chi fossero e in che cosa consistesse il loro incarico. Dal momento che la messa in scena di uno spettacolo teatrale e l'allestimento di un coro per l'esecuzione di
un ditirambo erano operazioni molto costose, bisognava assolutamente trovare qualcuno che facesse fronte a tutta una serie di spese che andavano dal reclutamento dei coreuti alla scelta del loro istruttore, dall'acquisto dei costumi e delle maschere dei coreuti stessi all'affitto della sala dove si facevano le prove, dall'allestimento della scenografia all'arruolamento di eventuali comparse e, forse, anche all'onorario per l'auleta, il musicista che avrebbe eseguito l'accompagnamento musicale suonando il suo aulo. Il corego era una figura simile a quella del nostro sponsor:; la coregia era una delle forme di tassazione indiretta (le cosiddette "liturgie") alle quali erano sottoposti gli ateniesi più ricchi. Per poter coprire alcune spese rilevanti che avrebbero creato qualche problema al bilancio dello Stato (come l'allestimento di una trireme o la preparazione di un banchetto pubblico), la polis costringeva i cittadini più abbienti ad accollarsi simili prestazioni; si trattava di un obbligo al quale non ci si poteva sottrarre, a meno di riuscire a dimostrare che esisteva qualcuno che aveva maggiori disponibilità finanziarie (mettendo in moto un complesso meccanismo chiamato antídosis ["scambio reciproco"], che consisteva nel dichiararsi disponibile a scambiare la propria ricchezza con quella di quest'altra persona). Per quanto onerosa, però, questa spesa aveva anche i suoi risvolti positivi: i cittadini ambiziosi potevano infatti sfruttare simili occasioni per guadagnarsi la simpatia e la benevolenza del popolo e, nello stesso tempo, farsi un po' di pubblicità. Nelle epigrafi ufficiali che registravano a perpetua memoria le generalità dei vincitori, il nome del corego figurava infatti sia nelle liste dei vincitori dei ditirambi (dove non comparivano nemmeno i nomi dei poeti che avevano composto il testo) sia in quelle dei vincitori degli agoni teatrali veri e propri (dove il nome del corego precedeva quello dei poeti stessi). Spesso il corego vincitore faceva addirittura costruire un monumento per celebrare il proprio successo: a oriente del tempio di Dioniso, là dove si trovava anticamente la Via dei Tripodi, è ancora visibile, ottimamente conservato, il monumento a forma di torre cilindrica che ricorda la vittoria ottenuta da Lisicrate, corego del coro di fanciulli che trionfò agli agoni ditirambici del 334 a.C.; sulla sommità del monumento, alto una decina di metri, è collocata una cupola a sua volta sormontata da un fregio a foglie di acanto su cui posava il tripode di bronzo dorato che era stato donato allo stesso Lisicrate dalla tribù vittoriosa. Alla coregia era tenuto ogni cittadino ateniese il cui patrimonio non fosse inferiore a tre talenti; negli anni conclusivi della guerra contro Sparta, le pessime condizioni finanziarie di Atene costrinsero l'arconte a suddividere il peso di ogni coregia tra due sincoreghi. Anche Pericle fu corego (nel 472 finanziò la rappresentazione della tetralogia di Eschilo comprendente i Persiani); Nicia esercitò la coregia in numerose occasioni, riportando sempre la vittoria (Plutarco, Vita di Nicia, 3.3). L'istituto della eoregia fu soppresso alla fine del secolo iv a.C m torno al 316 sotto il regno di Demetrio Falereo; i coreghi furono sostituiti da alcuni funzionari eletti ogni anno, gli agonoteti, che si occupa vano della gestione finanziaria degli spettacoli attingendo a un fondo pubblico istituito per l'occasione. Con il declino politico ed economico di Atene, terminata ormai l'esperienza eccitante della democrazia, la scarsa partecipazione dei cittadini alla vita della polis si rifletteva anche in questo diminuito interesse nei confronti di una festa religiosa, di una competizione artistica e di un'occasione culturale che appena cento anni prima era capace di suscitare una partecipazione entusiastica. Lasciamo per un attimo da parte il compito dei coreghi e passiamo ai veri protagonisti, agli autori dei testi teatrali. È presumibile che i poeti tragici e comici cominciassero a lavorare alle trame dei loro drammi non appena terminate le Dionisie urbane, verso la fine della primavera, in modo da avere materiale sufficiente da sottoporre agli arconti per ottenere il coro; l'insediamento degli arconti aveva luogo infatti in piena estate, alla fine di luglio, e pare che uno dei loro primi doveri consistesse proprio nella scelta dei coreghi. Questo significa che ogni poeta aveva a disposizione - se l'arconte accoglieva la sua richiesta - circa sei mesi (nel caso delle Lenee) oppure otto (nel caso delle grandi Dionisie) per completare la stesura del dramma. Se è vero che la composizione del testo della tragedia o della commedia costituiva il compito principale del poeta, non era certo questa l'unica sua fatica: dal momento che un dramma greco era uno spettacolo composto dall'unione di parole, di musica e di danza, al poeta spettava anche l'onere di comporre le musiche e di disegnare le coreografie (Eschilo aveva la fama di essere un eccellente coreografo). E non solo: nel teatro antico i compiti che, ai giorni nostri, vengono svolti dal "regista", toccavano al poeta stesso. Dal momento che si trattava di una fatica non indifferente, poteva succedere che il poeta preferisse
non occuparsi di questi aspetti pratici. In questo caso, il suo compito veniva assolto da un altro personaggio, il chorodidàskalos ("istruttore del coro"), che poteva essere scelto dal corego oppure designato dal poeta stesso. Dopo la nomina dei coreghi venivano scelti gli altri protagonisti dello spettacolo: gli attori e i coreuti. Per quanto riguarda la tragedia, grazie alla preziosa testimonianza di Aristotele sappiamo che «Eschilo fu il primo a portare da uno a due il numero degli attori, riducendo il ruolo del coro; Sofocle lo elevò a tre e creò la scenografia» (Poetica, 1449a16-9). Dal momento che i personaggi delle tragedie erano quasi sempre superiori a tre, ne consegue inevitabilmente che i tre attori ricoprivano più ruoli all'interno di ogni spettacolo; nelle scene che richiedevano la presenza di più di tre personaggi, alcuni ruoli erano interpretati da comparse mute. Il valore degli attori non era omogeneo: il più bravo era chiamato protagonistés ("protagonista" o "primattore"); gli altri due erano chiamati deuteragonistés ("deuteragonista" o "secondo attore") e tritagonistés ("tritagonista" o "terzo attore"). Solo il protagonista concorreva al premio riservato al miglior attore. Per quanto riguarda la commedia la situazione era probabilmente diversa, perché ci sono alcune commedie di Aristofane dove è inevitabile presupporre un quarto e addirittura un quinto attore per ricoprire ruoli di minore importanza. Tra le comparse mute, spiccano in Aristofane alcuni personaggi femminili che impersonificavano entità astratte (Opóra ["Abbondanza"] e Theoria ["Festa"] nella Pace, Basi'leia ["Sovranità"] negli Uccelli). Questa limitazione nel numero degli attori aveva conseguenze molto rilevanti: non solo lo stesso attore interpretava spesso due o più ruoli diversi, ma talvolta lo stesso personaggio poteva essere interpretato da due attori differenti. A ciò deve essere aggiunto il fatto che solo ai maschi era consentito esercitare la professione di attori: i ruoli femminili erano sempre interpretati da uomini. Queste consuetudini possono sembrare incomprensibili ai nostri occhi, abituati al teatro naturalistico; eppure non procuravano alcun fastidio ai greci, che le ritenevano del tutto naturali. Del resto, la presenza sul palcoscenico di uomini nei panni di una donna non è una prerogativa del teatro greco (né tantomeno una caratteristica del teatro comico in generale): in Inghilterra, a cavallo tra Cinquecento e Seicento, alle donne la recitazione era proibita e toccava agli uomini calcare il palcoscenico (William Shakespeare dovette vedere la sua Giulietta, la sfortunata fanciulla veronese innamorata di Romeo, interpretata da un uomo); viceversa, nell'opera lirica del Settecento e dei primi dell'Ottocento accadeva di frequente che un mezzosoprano indossasse i panni di un personaggio maschile (il ruolo di Romeo, l'innamorato di Giulietta ne I Caputeti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, rappresentati per la prima volta nel 1830 alla Fenice di Venezia, è scritto per essere cantato dalla voce di una donna). Due erano gli elementi che permettevano all'attore di celare la propria identità e di impersonare in modo credibile un ruolo femminile: il costume e la maschera. Per una ricostruzione attendibile dell'aspetto degli attori che recitavano nelle tragedie, nelle commedie e nei drammi satireschi del secolo v a.C. bisogna servirsi di due tipi di fonti, quelle letterarie e quelle iconografiche: le prime sono in gran parte molto posteriori a quel periodo, mentre le seconde non sono sempre facili da interpretare. Nel secolo n d.C. l'erudito Polluce dedicò alcuni capitoli del suo Onomasticon ai costumi e alle maschere degli attori. Le fonti usate da Polluce risalgono probabilmente all'età ellenistica (secolo iii a.C.) e si può supporre quindi che descrivessero consuetudini teatrali non molto diverse da quelle dell'età classica; tuttavia le notizie che se ne ricavano devono essere usate con cautela. Più utili (perché molto più vicine agli anni di Eschilo, Sofocle ed Euripide) sono le testimonianze iconografi che, che consistono principalmente nei disegni che decorano la ceramica attica del secolo v a.C. In un cratere a volute ritrovato a Ruvo e conservato al Museo Archeologico di Napoli, opera del cosiddetto Pittore di Pronomo, databile agli anni a cavallo tra la fine del secolo v a.C. e l'inizio del iv, sono raffigurati venti personaggi connessi con la rappresentazione di un dramma satiresco. Tra queste figure si distinguono chiaramente, oltre al dio Dioniso seduto su un divano insieme ad Arianna, l'autore del dramma (Demetrio), un suonatore di cetra (Carino) e uno di flauto (Pronomo); quest'ultimo è stato identificato con l'auleta Pronomo di Tebe, il maestro di musica di Alcibiade, al quale è attribuita la pratica di suonare tutti i diversi tipi di armonia sullo stesso aulo. Gli altri personaggi sono con certezza attori e coreuti, tutti contrassegnati da un tipico nome ateniese; sono perfettamente visibili le maschere (fornite di barba e capelli posticci). I costumi sono diversi: i coreuti indossano soltanto un paio di pantaloncini ricoperti di pelo, hanno una piccola coda di cavallo e portano, attaccato sul ventre, un fallo eretto; gli attori indossano un chitone riccamente decorato dalle maniche lunghe, un mantello e un paio di calzari forniti di lacci.
Alcuni di questi elementi si ritrovano anche in altri vasi e trovano riscontro nelle testimonianze letterarie. Polluce elenca, oltre al chitone (che era l'abito consueto dei greci, indossato ugualmente da uomini e donne, lungo fino alle caviglie e fornito di maniche lunghe), anche altri tipi di vesti, tra le quali possiamo ricordare la xistide (una sopravveste), la batrachide (una veste colorata di verde), la clamide (una corta mantella di lana leggera che veniva fissata sulla spalla da una fibbia), la fenicide (un mantello colorato di porpora); in determinate circostanze, gli attori indossavano anche lo himation, una sorta di mantello pesante (caratteristico degli uomini), oppure il peplo, una tunica di lana variopinta (caratteristica delle donne). Per quanto riguarda il costume degli attori comici, possediamo altre interessanti raffigurazioni vascolari: si tratta dei vasi cosiddetti "fliacici" provenienti dall'Italia meridionale e databili al secolo iv a.C. Le scene dipinte su questi vasi riproducono scene comiche di vario tipo che hanno molte affinità con le trame delle commedie dei secoli v e iv a.C. Accanto a questi vasi possiamo anche ricordare una serie di statuette di terracotta, databili al secolo iv a.C., che ci permettono di integrare le testimonianze fornite dai testi letterari. Il costume dei comici consisteva generalmente in una sorta di calzamaglia aderente; per accrescere l'effetto comico, gli attori erano provvisti di un'imbottitura che li rendeva molto grassi. L'altro elemento caratteristico del costume comico era la presenza di un fallo di cuoio allacciato sul ventre, un simbolo strettamente connesso col culto di Dioniso che veniva visto come un segno di fertilità. Sull'esistenza di questo attributo non c'è accordo fra gli studiosi; molti sono tuttavia gli elementi, contenuti nelle commedie di Aristofane, che sembrano rendere necessaria la sua presenza per poter comprendere alcune battute che altrimenti sarebbero prive di significato. Alcuni vasi raffigurano personaggi che indossavano un chitone più corto rispetto a quello utilizzato dagli attori tragici, così da far vedere il fallo. Gli schiavi indossavano l'esomide, una tunica che lasciava scoperti il braccio e la spalla destra. Parte integrante del costume era spesso un attributo che caratterizzava alcune figure particolari: Eracle era chiaramente riconoscibile grazie alla pelle di leone e, soprattutto, alla clava; Atena portava sul petto come segno distintivo l'egida, uno scudo di pelle di capra. I re brandivano uno scettro, i sacerdoti e gli indovini avevano il capo fasciato da bende, i vecchi si appoggiavano a un bastone, i supplici tenevano in mano un rametto coronato di fiocchi di lana (il klàdos). I personaggi stranieri potevano essere vestiti in modo inconsueto ed essere per questo facilmente riconoscibili. Le calzature degli attori raffigurati sui vasi sono principalmente di tre tipi: un calzare ampio e morbido, privo di decorazioni, a punta (caratteristico dei cori femminili); un calzare allacciato per mezzo di lunghe stringhe; un calzare dotato di risvolto, con la parte superiore ripiegata all'esterno. Nel periodo postclassico, la calzatura tipica degli attori tragici era una scarpa dalla suola rialzata che aumentava l'altezza dell'attore, rendendo peraltro meno agili i movimenti. Durante l'età classica, questi stivaletti avevano invece una suola bassa: il termine usato per designare le calzature degli attori tragici era kóthornos, che nel secolo v indicava però un calzare largo e morbido che aveva la prerogativa di poter essere calzato da entrambi i piedi; più avanti, "coturno" finì per indicare la scarpa a suola alta, il cothurnus destinato a diventare la calzatura tipica degli attori tragici latini. Gli attori comici recitavano spesso a piedi scalzi. Ma l'elemento che permetteva all'attore di "cambiare faccia" era la maschera, che in greco veniva designata col termine prósopon ("volto", letteralmente "ciò che si presenta davanti ai nostri occhi"). Tespi, il primo (mitico) interprete di tragedie, avrebbe cominciato a recitare con il volto coperto da uno strato di biacca bianca; solo in un secondo tempo avrebbe utilizzato una sottile maschera di lino colorata con feccia di vino. La tradizione attribuisce a Frinico l'invenzione di due tipi distinti di maschere per gli uomini (scure) e le donne (chiare); Eschilo sarebbe invece responsabile dell'introduzione di maschere colorate che probabilmente riproducevano - in parte distorcendoli ed esagerandoli - i tratti del volto umano. Gli artigiani che erano incaricati di costruirle insistevano sugli aspetti più caratteristici del volto come i capelli (acconciatura e colore), la barba, le sopracciglia, il naso, la bocca, le rughe; il colore delle parrucche, che andava dal biondo chiaro al nero al grigio al bianco, permetteva di capire subito l'età del personaggio. Oltre al lino, è possibile che altri materiali usati per fabbricare le maschera fossero il cuoio, il legno, il sughero o la cartapesta; il lino stesso poteva essere reso rigido dall'uso dello stucco. Polluce elenca e descrive una lunga serie di maschere tragiche: uomini (divise per età, maschere di vecchi e di giovani), donne (senza nessuna divisione), schiavi. Accanto a queste, ci sono maschere particolari: quella di Fineo (che era cieco) e quella di Argo (che aveva tantissimi occhi), quella di un Titano e quella di un Fiume,
quella della personificazione dell'inganno e quella della morte (che compariva nel prologo dell'Alcesti di Euripide). Alcuni personaggi potevano indossare due maschere diverse nel corso della stessa tragedia: è il caso di Edipo, che nelle battute finali del capolavoro di Sofocle si presentava in scena con un'altra maschera che dava particolare risalto alle sue occhiaie vuote. Per quanto riguarda la commedia antica, che vedeva spesso recitare sulla scena attori che impersonavano personaggi storici e ben conosciuti al pubblico (Socrate nelle Nuvole, Eschilo ed Euripide nelle Rane), sappiamo con certezza che queste maschere erano disegnate in modo da riprodurre le loro caratteristiche fisiche. Eliano racconta che, durante la prima (e contrastata) rappresentazione delle Nuvole alle grandi Dionisie del 423, dal momento che gli stranieri presenti a teatro non sapevano chi fosse quel Socrate che veniva preso in giro nella commedia, il filosofo (che era seduto nel settore migliore) si alzò e rimase in piedi, ben visibile a tutti, per l'intero spettacolo (Storie varie 2.13). Talvolta questa somiglianza poteva essere fonte di seri problemi: nei Cavalieri dello stesso Aristofane, messi in scena l'anno prima, il protagonista era il potente uomo politico Cleone, che veniva portato in scena nei panni di uno schiavo della Paflagonia; dal momento che nessun artigiano se l'era sentita di costruire una maschera somigliante al politico, Aristofane era stato costretto a tingersi il volto di ocra e a recitare lui stesso nella propria commedia. Questa notizia - per quanto priva di fondamento - costituisce una prova sicura della consuetudine di preparare maschere il più possibile somiglianti. Per quanto riguarda la commedia nuova, oltre alle curiose descrizioni di Polluce (che cita più di quaranta maschere), possediamo molte statuette di terracotta; alcune di queste, conservate nel Museo Archeologico di Lipari, risalgono agli anni che vanno dalla prima metà del iv secolo a.C. alla seconda metà del iii e corrispondono in parte alle descrizioni di Polluce. La presenza della maschera aveva essenzialmente la funzione pratica di permettere agli spettatori di identificare i diversi personaggi. Sembra invece da escludere che, almeno per quanto riguarda il teatro greco, la maschera potesse avere il compito di amplificare la voce: l'acustica dei teatri greci che si sono conservati sufficientemente integri sembra tale da non rendere necessario un simile espediente; appare inoltre diffìcile credere che le prime sottili maschere di lino potessero riuscire a fungere da megafoni. Maschere e costumi erano indossati anche dai coreuti. Il loro numero variava a seconda del tipo di dramma. Per quanto riguarda il coro tragico, sembra che Eschilo adoperasse un coro composto da dodici danzatori, poi diventati quindici nelle tragedie di Sofocle e di Euripide. Non abbiamo notizie certe sul numero dei coreuti che interpretavano i! ruolo dei satiri nel dramma satiresco; sappiamo invece con certezza che il normale coro comico era composto da ventiquattro membri. Il ruolo del coro nei drammi del secolo v consisteva principalmente nel canto e nella danza. L'aspetto legato alla recitazione era molto limitato; quando il coro interagiva con gli attori, a parlare non era tutto il coro ma soltanto il corifeo (il "capo del coro"), colui che aveva anche il compito di dare l'attacco nei brani cantati. Nelle tragedie, i momenti riservati al coro erano la parodo (il momento successivo al prologo recitato, che vedeva l'ingresso dei coreuti nell'orchestra attraverso gli éisodoi posti ai due lati della scena), gli stasimi (i canti corali che erano intercalati agli episodi recitati e che venivano cantati quando il coro aveva preso la sua posizione "stabile" nell'orchestra), i commi (le parti della tragedia che vedevano il coro unirsi agli attori in un dialogo lirico che aveva l'aspetto della lamentazione) e l'esodo (la conclusione del dramma); nelle commedie, il coro aveva il suo momento di gloria nella parabasi, quando i suoi membri "si facevano avanti", si spogliavano dei costumi e si rivolgevano agli spettatori parlando a nome del poeta. La foggia del costume dei coreuti dipendeva dalla nazionalità dei personaggi che componevano il coro: nelle Supplici di Eschilo, ambientate in Egitto, le donne indossavano probabilmente una veste di lusso stretta alla vita da una fascia (le allusioni nel testo parlano di fasce, di cinture, di un chitone, di veli di finissimo lino fenicio e di pepli variopinti). I coreuti del dramma satiresco indossavano un perizoma di pelle di capra dotato di fallo e di una piccola coda di cavallo; il dio Sileno, il padre dei Satiri che era un protagonista fisso di questo genere di spettacolo teatrale, aveva il corpo ricoperto da un costume peloso (nel vaso del Pittore di Pronomo, il costume era aderente, color marrone, ricco di ciuffi bianchi a testimoniare la sua età avanzata). I coreuti della commedia potevano indossare i costumi più svariati: nelle commedie che prendevano il titolo da animali (le Vespe, gli Uccelli), il costume richiamava sicuramente alcune loro caratteristiche (il pungiglione, le ali, il becco); in altre commedie, come per esempio le Nuvole, la particolare natura del coro doveva senz'altro
stimolare la fantasia dei costumisti; in altre ancora, come le Città o i Demi di Eupoli, è probabile che i coreuti fossero vestiti in modo diverso così da essere facilmente identificabili o con una particolare città o con uno dei distretti territoriali attici; nelle commedie con un coro doppio (come quello della Lisistrata, formato da un semicoro maschile e da uno femminile), i costumi dei due semicori dovevano essere per forza differenti. I cori drammatici si disponevano in formazione rettangolare, a differenza di quelli ditirambici che erano invece "ciclici" (collocati in circolo intorno all'altare di Dioniso, nell'orchestra). I cori tragici presentavano cinque file composte da tre coreuti ciascuna; le righe dei cori comici erano invece sei, ed erano composte ognuna da quattro coreuti. Ogni genere drammatico era caratterizzato da una danza sua propria. Nelle tragedie vigeva un tipo di danza solenne e piena di dignità, la cosiddetta emméleia. La danza del dramma satiresco si chiamava "sicinnide" ed era presumibilmente molto vivace (secondo alcune etimologie antiche il nome deriverebbe dai verbi séiesthai, "agitarsi" e kinéisthai, "muoversi"); la commedia era infine contrassegnata dal "cordace", una danza che era formata da movimenti particolarmente volgari. Grazie all'opera di Polluce (e alle notizie fornite da Luciano nell'opuscolo Sulla danza, che tuttavia si riferiscono soprattutto al genere teatrale della "pantomima", particolarmente in voga a Roma in età imperiale), conosciamo i nomi di alcuni dei passi di danza compiuti dal coro. Tra questi possiamo citare il kalathìskos ("canestro"), che consisteva probabilmente nel muoversi tenendo le mani alte sopra la testa, lo xiphismós (la "danza della spada") e la thermaustris (la "danza della tenaglia"), che era contrassegnata da salti verso l'alto e dal l'intrecciare le gambe prima di ricadere a terra. Esistevano anche le danze guerriere; tra queste, la più famosa era la "pirrica". Particolarmente importanti nella danza erano i gesti: nella Poetica, Aristotele scrive che i danzatori «imitano i caratteri, i sentimenti e le azioni grazie ai ritmi accompagnati dai gesti» (1447a27). Per i greci la gestualità delle mani era già una forma di danza; il termine che indicava i loro movimenti è cheironomìa ("movimento regolare e cadenzato delle mani"). Dopo aver parlato dei protagonisti del dramma, torniamo adesso ai compiti del corego, che comprendevano, oltre alla preparazione dei costumi, anche l'arruolamento (é l'onorario) dell'auleta che aveva l'incarico di eseguire le musiche di scena. Questo musicista era parte integrante dello spettacolo: era lui che, suonando l'aulo a volto scoper-lo (l'unica parte del suo volto invisibile agli spettatori era la bocca, sulla quale era applicata la phorbeià, una sorta di museruola che gli permetteva di controllare meglio il suo strumento), guidava il coro al momento del suo ingresso nell'orchestra; a lui era affidata la responsabilità della corretta esecuzione delle musiche per quanto riguardava sia la melodia che il ritmo; dalla sua abilità dipendeva l'ordinato svolgimento delle danze. A differenza del teatro cui noi siamo abituati, che vede prevalere l'aspetto della recitazione, gli spettacoli greci avevano una struttura più complessa, che li rendeva più simili alla nostra opera lirica. Gli attori pronunciavano le loro battute in tre modi: recitavano il testo senza alcun accompagnamento musicale, lo recitavano accompagnati dal suono di uno strumento musicale, cantavano accompagnati da uno strumento musicale. Il primo modo era adoperato per le parti del dramma composte in trimetri giambici (il metro che Aristotele considerava più vicino al discorso parlato perché possedeva lo stesso ritmo della conversazione corrente); il secondo era adoperato per la recitazione dei tetrametri e dei giambi collocati all'interno delle sezioni liriche; il terzo era adoperato per i metri lirici. Lo strumento musicale che veniva usato per accompagnare le parti cantate era l'aulo, uno strumento ad ancia corrispondente al nostro flauto diritto; gli esecutori potevano usare tre tipi diversi di aulo (uno per le melodie di genere enarmonico, un altro per quelle di genere cromatico, un altro ancora per quelle di genere diatonico). L'effetto di una simile esecuzione doveva assomigliare grosso modo a quello dei recitativi accompagnati dell'opera lirica, una via di mezzo tra parlato e cantato. L'aulo era preferito alla lira perché il suo suono costituiva un accompagnamento migliore per la voce umana (secondo l'autore dei Problemi attribuiti ad Aristotele l'eccellente interazione tra aulo e voce era dovuta soprattutto al fatto che entrambi erano strumenti ad aria). Esistono alcune testimonianze che accennano all'uso della cetra da parte di Sofocle ed Euripide per l'esecuzione di alcune sezioni liriche, ma si tratta di circostanze eccezionali; altrettanto raro era l'utilizzo della lira (che fu suonata da Sofocle quando, in una sua tragedia perduta, egli sostenne la parte del mitico cantore
Tamiri) e di altri strumenti come la zampogna, la tromba, i timpani, i cembali e le nacchere. Nel periodo classico, la musica era sicuramente subordinata al testo: la cosa essenziale era poter comprendere il significato delle parole. Verso la fine del secolo v, alcuni autori di ditirambi (Timoteo, Melanippide, Frinide, Cinesia, Filosseno) diedero vita ad alcune innovazioni che tendevano ad aumentare l'importanza della musica; Agatone ed Euripide introdussero queste novità nei canti corali delle loro tragedie, provocando reazioni non molto positive. Tra i compiti del corego era infine compresa la scelta dell'istruttore del coro. Inizialmente, nella gran parte dei casi, era il poeta stesso (l'autore del dramma o del ditirambo) ad assumersi l'incarico di istruire il coro; in alcune circostanze poteva tuttavia verificarsi che il poeta affidasse il compito a qualcuno più esperto di lui. Si trattava di un caso abbastanza frequente soprattutto nella commedia: se i poeti tragici non sembravano avere difficoltà a fare i "registi" e mettere in scena i loro drammi (il verbo usato per indicare tale azione era didàskein, "istruire"), i comici mostravano una certa cautela nell'assumersi il compito della "regia". Sappiamo per esempio che Aristofane non amava mettere in scena personalmente le proprie commedie: i suoi primi drammi (Banchettanti, Babilonesi, Acarnesi) furono messi in scena dal più anziano Calli-strato; più avanti, nel corso della sua carriera, Aristofane affidò alcune commedie (Vespe, Rane, il perduto Anfiarao) all'altro suo collaboratore Filonide. I motivi di un simile comportamento sono stati oggetto di discussione (e lo sono tuttora). È probabile che ci fosse più d'una ragione dietro queste scelte di Aristofane: il desiderio di affidarsi alle mani di persone più esperte di lui evitando rischi eccessivi per un debuttante; il desiderio di concentrarsi esclusivamente sul testo lasciando ad altri i problemi tecnici connessi con l'allestimento dello spettacolo. Tutte le altre spese gravavano sullo Stato: i poeti tragici e comici ricevevano il loro compenso direttamente dalla polis (che aveva inoltre il compito di offrire il premio ai due poeti che erano risultati vincitori nel concorso); spettava inoltre allo Stato saldare l'onorario degli attori (e, con tutta probabilità, provvedere ai loro costumi). La composizione della giuria e le sue prerogative sono state già trattate in precedenza. Per quanto riguarda la competizione tra i poeti e gli attori, ci rimane ancora da dire qualcosa sulle testimonianze antiche che permettono di ricostruire almeno parzialmente le vicende teatrali di Atene. Le fonti a nostra disposizione sono, come sempre, duplici: archeologiche e letterarie. Le testimonianze epigrafiche, ossia i frammenti di iscrizioni che sono stati rinvenuti nei pressi dell'Acropoli, ci consentono di ripercorrere a grandi linee la storia del teatro ateniese, dalle sue origini (inizi del secolo vi a.C.) al suo declino (secolo n a.C.). Purtroppo il loro stato frammentario lascia spazio a seri problemi interpretativi, solo parzialmente risolvibili attraverso congetture. Un'epigrafe (nota col nome di "Fasti") contiene le registrazioni ufficiali dei nomi dei vincitori ai concorsi tragici, comici e ditirambici alle grandi Dionisie, senza indicazione del titolo dei drammi (I.G. II 2 2318). Delle diciotto colonne che facevano parte dell'iscrizione, ritrovata alle pendici settentrionali dell'Acropoli, ne sono rimaste soltanto tredici; la prima colonna superstite (che era forse la terza o la quarta dell'iscrizione originaria) comincia con l'anno 473-2 a.C.; l'ultima colonna rimasta arriva fino al 329-8 (ed è probabile che l'iscrizione si fermasse al 316, l'anno in cui gli agonoteti sostituirono i coreghi e ricevettero l'incarico di organizzare le feste). Per ogni anno l'iscrizione riportava il nome dell'arconte eponimo (un particolare che ci permette di datare l'anno con sicurezza), il nome della tribù che aveva vinto la gara del ditirambo dei ragazzi e quello del suo corego, il nome della tribù che avevano vinto la gara del ditirambo degli adulti e quello del suo corego, il nome del corego e del poeta che aveva vinto la gara comica, il nome del corego e del poeta che aveva vinto la gara tragica. A partire dal 450-449, compare sulla stele anche la menzione del nome dell'attore tragico che era risultato vincitore nella sua competizione. Esiste poi un'altra serie di epigrafi (le «Didascalie») altrettanto frammentarie che provengono tutte da un'unica iscrizione collocata all'interno di un edificio posto sulle pendici meridionali dell'Acropoli (I.G. II 2 2319-23). Questa iscrizione riportava, nell'ordine, le liste dei poeti vincitori ai concorsi tragici e comici delle grandi Dionisie e delle Lenee insieme al titolo dei drammi (LG. II2 2319-23 e 2325): nomi e titoli erano preceduti dal nome dell'arconte (che permette di fissare l'anno) e seguiti da quelli degli interpreti.
Alcuni frammenti provenienti dall'architrave di questo stesso edificio riportano inoltre i nomi dei poeti e degli attori con il numero delle vittorie da loro riportate negli agoni dionisiaci e lenaici (LG. II 2 2325). Grazie a questa iscrizione è possibile sapere che, alle Dionisie, Eschilo ottenne tredici vittorie e Sofocle diciotto; per quanto riguarda invece i poeti comici, conosciamo per esempio il numero delle vittorie ottenute da Cratino (sei alle Dionisie, tre alle Lenee). Altre notizie interessanti le ricaviamo da un'altra epigrafe, il Marmor Parium, una stele di marmo databile al 260 a.C. che riporta un lungo elenco di avvenimenti della storia greca a partire probabilmente dal regno di Cecrope, il primo mitico re di Atene; secondo questa iscrizione, il primo concorso tragico risalirebbe agli anni della sessantunesima Olimpiade (536-533 a.C.) e sarebbe stato vinto da Tespi. Accanto alle epigrafi possediamo per fortuna altre notizie contenute nelle cosiddette "ipotesi": questi dati, integrati con quelli ricavati dalle iscrizioni, ci consentono di illuminare ancora di più le nostre conoscenze sulla cronologia del teatro antico. Le "ipotesi" (conosciute anche col nome latino di argumenta) sono le introduzioni ai singoli drammi composte dai filologi alessandrini e giunte fino a noi insieme ai drammi stessi; alcune di queste prefazioni contengono una serie di dettagli interessanti che riguardano le particolari modalità della rappresentazione. Nella "ipotesi" dei Sette a Tebe di Eschilo si legge che la tragedia è ambientata a Tebe e che il coro è composto da fanciulle tebane; dopo un rapido riassunto della vicenda, compaiono l'indicazione dell'arconte (Teagene) e quella del numero dell'Olimpiade (la 78esima), due notizie che ci consentono di conoscere l'anno della rappresentazione del dramma (467 a.C.); infine, si apprende che nello stesso giorno Eschilo fece rappresentare anche il Laio, l'Edipo e la Sfinge (un dramma satiresco), ottenendo il primo posto, che Aristia arrivò secondo (col Perseo, col Tantalo e con il dramma satiresco I lottatori, composto da suo padre Pratina) e Polifrasmone fu solamente terzo (con una tetralogia dedicata al re tracio Licurgo, che secondo il mito aveva scacciato Dioniso dalla sua terra ed era stato per questo colpito da improvvisa pazzia). Analoga era l'articolazione delle "ipotesi" comiche: in quella degli Uccelli di Aristofane, si legge che la commedia fu rappresentata durante l'arcontato di Cabria (ossia nel 414 a.C.) "in città" (ossia "alle grandi Dionisie") per opera di Callistrato (il "regista"); che Aristofane arrivò solo secondo, preceduto da Amipsia (con i Cornasti) e seguito da Frinico (con il Misantropo). Tutte le notizie presenti nelle iscrizioni e nei manoscritti hanno un padre: Aristotele. Fu il celebre filosofo a rivolgere, a partire dal 334 a.C., la sua attenzione alle notizie contenute nelle antiche iscrizioni ufficiali; fu lui a scrivere le Didascalie, una delle opere (tutte purtroppo perdute) nelle quali Aristotele metteva ordine nella complicata cronologia del teatro ateniese. A questo lavoro fondamentale si ispirarono tutti gli studiosi successivi (Eratostene, Licofrone, lo stesso Callimaco); le informazioni apprese da Aristotele finirono poi nei manoscritti medievali e sono pervenute fino a noi. Per completare questo panorama sugli aspetti pratici del teatro ateniese bisogna adesso affrontare brevemente il problema del pubblico. Non sappiamo con assoluta certezza quanti spettatori potesse accogliere il teatro di Dioniso, né al tempo di Pericle (seconda metà del secolo v a.C.) né dopo la ristrutturazione voluta da Licurgo (seconda metà del secolo iv a.C.). Secondo Platone, alle Lenee del 416 avrebbero assistito alla prima vittoria di Agatone trentamila persone (Simposio 175e): si tratta di una cifra che è ritenuta poco realistica, anche considerando la presenza di spettatori in piedi: già ventimila sembra essere un numero eccessivo. Dopo la ristrutturazione (e quindi nella forma testimoniata dalle rovine attuali), è probabile che il teatro contenesse da quattordicimila a diciassettemila spettatori. Analoga incertezza riguarda la composizione del pubblico: oltre ai maschi adulti, a teatro erano presenti anche i ragazzi e le donne? Per quanto riguarda i ragazzi, è molto probabile che potessero assistere; pare invece che la presenza delle donne a teatro non fosse prevista. Al riguardo, le fonti sembrano estremamente contraddittorie: accanto ad aneddoti che sembrano suggerire la presenza di un pubblico femminile (secondo l'anonima Vita di Eschilo, l'apparizione delle Erinni nell'ultima tragedia dell'Orestea avrebbe a tal punto spaventato le donne presenti a teatro da provocare una serie di aborti), esistono passi che hanno tutta l'aria di negare questa possibilità (l'invito finale ad applaudire rivolto da Menandro - nel suo Misantropo - a un pubblico formato esclusivamente da «fanciulli, ragazzi e uomini»).
Contrariamente all'opinione generale, ad Atene l'ingresso a teatro non era gratuito: il biglietto costava due oboli. Esisteva però un contributo statale (il cosiddetto theorikón) che dava ai cittadini non abbienti la facoltà di acquistare il biglietto; secondo Plutarco, la costituzione di un fondo statale destinato a permettere la partecipazione agli spettacoli teatrali a spese della polis sarebbe stata uno dei tanti espedienti di Pericle per accattivarsi il favore popolare (Vita di Pericle 9.2-3); altre fonti attribuiscono invece questa innovazione ad altri uomini politici come Agirrio o Cleofonte. Prima della festa, gli aventi diritto si recavano dai funzionari del demo al quale appartenevano e ricevevano il corrispondente in denaro. L'incasso finiva nelle tasche dell'impresario che aveva stipulato con la città il contratto per la manutenzione del teatro. Non sappiamo se fossero a suo carico (o gravassero invece sul bilancio della polis) i biglietti omaggio riservati alle personalità. A questi personaggi (gli arconti, gli ambasciatori delle città straniere, gli orfani dei soldati caduti in battaglia) era di solito riservata la prima fila, la cosiddetta proedria; il posto centrale di questa era riservato al sacerdote di Dioniso. Altri posti privilegiati erano quelli riservati a diverse categorie di funzionari statali come gli strateghi, i tesorieri, i tassiarchi, i membri della Bulé; poi venivano i cittadini ateniesi (maschi adulti ed efebi), i meteci (gli stranieri residenti ad Atene) e gli stranieri che avevano acquistato meriti particolari nei confronti della città; i posti peggiori erano occupati dagli altri stranieri, dagli schiavi (che accompagnavano i loro padroni) e dalle donne (sempre che queste assistessero davvero agli spettacoli). Ad Atene sono stati ritrovati alcuni gettoni di piombo che recano, su una delle facce, incisioni che riproducono maschere tragiche e comiche; alcuni studiosi hanno pensato che fossero antichi biglietti teatrali, ma si tratta soltanto di un'ipotesi. Il pubblico non assisteva passivamente agli spettacoli: le sue reazioni erano sempre molto rumorose, sia se il dramma era di suo gradimento che in caso contrario. Gli spettatori potevano fischiare, sibilare, schiamazzare, battere i piedi (in segno di disapprovazione) o le mani (per applaudire); se non avevano apprezzato la recitazione degli attori, potevano lanciare oggetti di ogni genere (fichi, chicchi d'uva, olive). Gli aneddoti al riguardo sono molto numerosi: la carriera dell'attore tragico Egeloco ricevette un duro colpo quando, nel pronunciare un verso di Euripide, sbagliò la lunghezza di una vocale dicendo «vedo la donnola» invece di «vedo la bonaccia» e suscitando l'ilarità del pubblico (un episodio che viene ricordato beffardamente dai poeti comici); quando il celebre attore Polo interpretò il ruolo di Elettra nell'omonima tragedia di Sofocle e fece il suo ingresso sulla scena portando l'urna che conteneva le ceneri di suo figlio (e che, nella finzione teatrale, avrebbe dovuto contenere le ceneri di Oreste, fratello di Elettra), la sua recitazione appassionata e sofferta commosse il pubblico presente. Spesso scoppiavano tafferugli tra i sostenitori di due poeti o di due attori; in questi casi, era necessario l'intervento di alcuni sorveglianti dotati di bastoni (i "rabduchi") che avevano il compito di mantenere l'ordine. Anche in questo caso siamo a conoscenza di molti episodi interessanti: in un'orazione attribuita ad Andocide viene descritta la lite che vide protagonisti Alcibiade e Taurea, coreghi di due cori ditirambici. Alcibiade ebbe la meglio due volte sul rivale: prima perché lo costrinse ad abbandonare il teatro e poi perché i giudici, spaventati dalla sua prepotenza, gli diedero la vittoria benché il pubblico fosse dalla parte di Taurea. Poiché l'autore dell'orazione è ostile ad Alcibiade, è probabile che l'aneddoto sia tendenzioso e poco veritiero; esso tuttavia testimonia come le competizioni fossero sentite da tutti, dai protagonisti e dal pubblico, e quanto fosse alta la posta in palio.
3. La tragedia di Roberta Sevicri
3.1 Materiali per una drammaturgia tragica Le aspettative del pubblico che affollava le gradinate del teatro di Dioniso ad Atene, in occasione delle rappresentazioni drammatiche, avevano un oggetto preciso, caratterizzato da una regolarità di struttura e, almeno per la tragedia, da un contenuto che faceva riferimento a un patrimonio culturale conosciuto e
condiviso da tutti. Proprio in questo aspetto consiste l'apporto decisivo della cultura ateniese del secolo v a.C. alla definizione del genere teatrale nelle categorie a noi note: da un lato nella fissazione di una struttura, capace di dare a uno spettacolo originariamente legato all'improvvisazione un'identità specifica e riconoscibile, e dall'altro nella definizione di un contenuto, se non in termini assoluti almeno come indicazione di massima. Entrambi questi elementi, ma soprattutto il primo, sono legati alla sfera della drammaturgia, ossia al teatro in quanto realizzazione scenica di un testo strutturato, e in particolare alla sua natura di attività civica, inserita in una dimensione istituzionale e agonale: i concorsi drammatici ateniesi. Proprio qui, all'interno di coordinate spazio-temporali precise e sorprendentemente limitate, si attua la progressiva differenziazione con reciproca definizione tematica prima, e l'assimilazione strutturale poi, fra tragedia, dramma satiresco e commedia. Sempre qui si sviluppa la specializzazione dei ruoli fra autore ed esecutore del testo: qui in sostanza il teatro assume quell'identità che ancora in larga misura lo distingue. Quest'identità è basata su alcune opposizioni, anch'esse legate in prima istanza ai caratteri dell'istituzione teatrale antica, ma tuttora valide: quella fra unicità (pratica) e ripetibilità (teorica) della rappresentazione, e quella fra oralità e scrittura, attraverso le quali si concretizza l'opposizione di base fra prevedibilità di forma e contenuto e originalità di realizzazione. Nata dall'interazione fra queste antinomie, ogni rappresentazione teatrale genera un "mondo possibile", una realtà virtuale creata per una singola, irripetibile occasione eppure teoricamente riproducibile a piacere, a partire da materiale tematico tradizionale e da convenzioni espressive ed elementi oggettivi (le condizioni pratiche del teatro) sostanzialmente costanti. Ciascuno di questi infiniti mondi possibili è concepito per il breve spazio di un'unica rappresentazione, per quell'attimo magico e irreversibile in cui una certa sequenza di eventi immaginari assume per il pubblico statuto di realtà, al di fuori del tempo e dello spazio immediati. Esso nasce come testo scritto, e come tale può essere conservato, diffuso e tramandato, ma in una forma parziale e limitata, poiché trova la propria compiuta realizzazione in quella modalità di fruizione visiva, aurale e collettiva che solo la scena può dare. L'esistenza di un testo che può essere assunto quale punto di riferimento sembrerebbe garantire allo spettacolo una ripetibilità infinita, tanto che ad Atene, specie dopo che invalse l'uso di riproporre alle grandi Dionisie un pezzo "classico", si avvertì l'esigenza di stabilire e conservare una copia ufficiale dei testi dei tragici che ancora oggi costituiscono la triade immortale Eschilo-Sofocle-Euripide. La misura fu presa per impedire le frequenti interpolazioni da parte degli attori, che cercavano in questo modo non solo maggiore gloria per se stessi, ma tentavano anche di venire incontro ai gusti di un pubblico sempre più incline ad apprezzare quegli "effetti speciali" di cui la tragedia antica sembra singolarmente avara. Tuttavia, anche a prescindere dalla possibilità di vere e proprie alterazioni del testo in quanto tale, o dall'arbitrario inserimento di elementi spettacolari posticci, questa riproducibilità tecnica dell'evento teatrale (del resto ampiamente sfruttata anche in precedenza, dato che riprese di rappresentazioni tragiche erano comuni nelle Dionisie rurali) è più apparente che reale, poiché è chiaro che nulla come il teatro vive nella dimensione dell'unicità: per quanto fedelmente ripetuta, nessuna rappresentazione potrà mai essere uguale a un'altra. All'illusorietà della dimensione scritta del testo teatrale, solo sussidiario rispetto alla sua reale destinazione orale-aurale, fa quindi riscontro la sua altrettanto illusoria ripetibilità. Non meno inconsistente si rivela l'opposizione fra tradizione e innovazione: la struttura, se non rigidamente fissa, almeno ragionevolmente costante, e il riferimento a un patrimonio tematico noto non sono che i codici espressivi di un discorso la cui essenza muta liberamente secondo le intenzioni dell'autore; essi servono a poeta e pubblico per intendersi e riconoscersi, sono come una lingua comune, compresa e parlata da entrambi, che consente l'espressione e la ricezione di qualunque contenuto. La competenza drammaturgica dell'autore e del pubblico è proprio il tassello essenziale di questa interazione fra patrimonio tradizionale e creazione originale, dalla quale scaturisce l'opera teatrale antica. Essa consente al poeta di utilizzare elementi convenzionali in maniera innovativa, strutturando in modo nuovo un testo il cui contenuto è sostanzialmente noto, perché basato su racconti e personaggi del mito, e al pubblico di goderne a sua volta come di una novità, ma senza provare smarrimento come di fronte a un'incognita assoluta: il piacere del riconoscimento e della ripetizione, dell'attesa e della sua soddisfazione, si fonde perfettamente con quello della curiosità e della sorpresa. Già gli antichi tragici erano consapevoli di questo aspetto della propria arte, se è vero che Eschilo definiva le proprie opere «porzioni dei grandi banchetti di Omero»; la definizione eschilea, mentre chiarisce la sfera tematica di riferimento del genere tragico, ne indica anche statuto e collocazione letteraria: all'interno della fondamentale struttura binaria che oppone nella cultura greca la poesia "alta", ossia quella che, con tono sublime e con intenzione laudatoria, ha come oggetto dei ed eroi, o comunque
personaggi di levatura superiore alla media, a quella "bassa" o comica, che si occupa con tono dimesso e intenzione denigratoria degli uomini, specie nei loro aspetti meno elevati e più quotidiani, la tragedia afferisce chiaramente al primo tipo. Ciò che permette al tragediografo di trasformare una di queste "porzioni" omeriche in un'opera d'arte compiuta e originale è proprio la sceneggiatura, l'invenzione di un'azione scenica che consenta di passare dalla narrazione alla mimesi drammatica, attraverso la quale si esprima non solo e non tanto un certo racconto tradizionale, ma soprattutto l'interpretazione che di quel particolare racconto il poeta ha voluto quella volta far rivivere, se così si può dire, in prima persona al suo pubblico. Si tratta di un pubblico attento ed esperto, capace di notare i riferimenti e di apprezzare le variazioni proposte dall'autore, e di confrontarle con quanto, sullo stesso tema, era già stato fatto da altri prima di lui, eppure pienamente disposto a lasciarsi coinvolgere e sorprendere, a collaborare attivamente con il poeta in questo lavoro di continua riscrittura e riattualizzazione di un patrimonio culturale condiviso da tutti. Ogni volta che un nuovo pezzo drammatico va in scena, il pubblico, pur conoscendo gli elementi fondamentali della storia, è quindi preparato ad accogliere, di quella stessa storia, solo ciò che il drammaturgo ha deciso di portare in luce e rappresentare, trascurando ciò che ha voluto omettere o lasciare nell'ombra. Ma questa specie di gioco fra tradizione e innovazione, in cui gli spettatori sono pronti a svolgere la loro parte, è spesso condotto dall'autore a carte truccate, nel senso che egli sovente sembra indirizzare il pubblico in un senso, per poi frustrarne le attese e mostrargli che lo aveva impercettibilmente spinto in un altro. In fondo, a mutare il significato di una vicenda può bastare anche molto poco: spostare l'ingresso o l'uscita di un personaggio, invertire la successione di due eventi, modificare la struttura espositiva di un discorso, ritardare o anticipare uno svolgimento atteso. Si tratta di una forma di rielaborazione del patrimonio mitologico e di emulazione del passato letterario, condotta con perfetta consapevolezza dei propri strumenti (i meccanismi compositivi della tragedia e la loro funzione), e lucidamente esposta alla comprensione e all'apprezzamento da parte del pubblico, a sua volta partecipe di quel codice espressivo e quindi in grado di valutarne impiego e varianti. Dunque, anche ciò che viene omesso e trascurato svolge il suo ruolo; partendo da coordinate note (la storia tradizionale, magari già trattata da altri tragici), è sufficiente uno spostamento anche minimo dei termini per ottenere il massimo del risultato: ecco perché la tragedia greca appare così singolarmente sobria in termini di azione scenica, concentrando tutto il peso della rappresentazione sulle parole, più che sui fatti, sul commento più che sull'evento in sé. Altrettanto sorprendente è in fondo la constatazione che gli elementi strutturali di cui l'autore si vale per creare questo complesso organismo scenico sono abbastanza fìssi e ripetitivi da poter essere descritti con un'accettabile dose di approssimazione, come appunto si cercherà di fare nelle pagine che seguiranno. Quali erano dunque le aspettative del pubblico ateniese (ciò che viene definito "orizzonte di attesa") nel momento in cui lo spettacolo stava per avere inizio? Chi nei giorni precedenti aveva avuto modo di assistere al proagone sapeva non solo chi fossero i tragediografi ai quali era stato "concesso il coro" (il termine tecnico per indicare l'ammissione in gara - perché di una gara ovviamente si trattava, con un vincitore e dei vinti, secondo il più puro spirito agonistico greco), ma anche quale sarebbe stato l'argomento delle tragedie in concorso: storie che tutti conoscevano fin da bambini, almeno nei loro lineamenti essenziali, e un singolo nome era sufficiente a evocare un complesso di avvenimenti. Supponiamo per esempio che si trattasse di Edipo: nessuno ignorava il suo vittorioso duello verbale con la Sfinge né il suo malaugurato scontro con l'ignaro e sconosciuto padre Laio, né l'altrettanto scellerato e inconsapevole matrimonio con la madre Giocasta e l'infausta nascita di figli destinati a reciproco fratricidio, per citare solo gli elementi fondamentali della vicenda. Nessuno andava a teatro per vedere se per caso alla fine si scopriva che non era stato Edipo a uccidere il padre e a sposare la madre, perché questi erano i punti fermi del mito, presenti già nel "banchetto" omerico, e il poeta tragico normalmente non si spingeva fino ad alterare i connotati basilari delle storie tradizionali. Quello che veramente interessava al pubblico era vedere come l'autore avrebbe portato il suo Edipo a fare ciò che non poteva evitare di fare, ossia appunto uccidere il padre e sposare la madre: anzitutto, quale sequenza di avvenimenti avrebbe effettivamente fatto rappresentare sulla scena e quali invece avrebbe preferito lasciare alla competenza del pubblico, alludendovi nelle rievocazioni degli antefatti o nelle anticipazioni di successivi sviluppi; poi, come avrebbe presentato i personaggi, quale carattere avrebbe loro attribuito, quali motivazioni avrebbe dato alle loro azioni, quali parole avrebbe fatto loro pronunciare, quali canti avrebbe assegnato al coro - in una parola, come era stata sceneggiata la vicenda. Chi aveva assistito a precedenti versioni della medesima storia, o chi era riuscito a procurarsene una copia scritta (benché non ancora capillare, fra i secoli v e iv la diffusione del libro cominciava ad assumere proporzioni considerevoli) si preparava a fare confronti, a valutare come il poeta tragico avesse saputo sfruttare la flessibilità del patrimonio
mitologico greco, suscettibile fin dalle epoche più remote di infinite varianti, per creare una versione nuova di una storia vecchia, rendendola capace di affrontare tematiche attuali e coinvolgenti, non tanto nel senso di concreti argomenti di attualità politica (quelli riguardano piuttosto l'ambito della commedia), quanto in quello di problematiche etiche e culturali, in un processo di costante discussione e adattamento dell'identità collettiva di una società e dei suoi valori. Non si tratta in fondo di un meccanismo molto differente da quello che spinge i moderni ad assistere all'ennesima versione dell 'Amleto, per la curiosità di vedere come il regista abbia saputo adattare un testo già trattato un'infinità di volte (e in questo caso non solo la trama, ma l'opera in quanto tale è nota), o a un dramma di argomento storico, che coinvolga personaggi i cui destini sono fissati in partenza. Anche lo spettatore moderno d'altra parte, nel momento in cui prende posto in teatro, ha un'idea abbastanza precisa di ciò che lo aspetta (a prescindere da opere di dichiarata intenzione sperimentale): una struttura sostanzialmente costante, fondata su unità fisse (atti), suddivise a loro volta in diverse scene (determinate dall'ingresso e dall'uscita dei personaggi) e intervallate da brevi momenti in cui la scena è vuota. Qualcosa di relativamente simile è anche ciò che si aspettava il pubblico nel teatro di Dioniso ad Atene, con una differenza fondamentale: nell'intervallo fra gli "atti" la scena non rimaneva vuota, perché restava a occuparla il coro, la cui presenza costante per tutto lo svolgimento della tragedia conferiva all'opera unità e compattezza formali, che controbilanciavano la suddivisione in parti contraddistinte da una diversa modalità espositiva: recitazione e canto. Siamo così arrivati a porre in luce il principio compositivo fondamentale della tragedia greca, lo schema di base sul quale si innestano, per tutto il secolo v a.C., le possibili sperimentazioni e variazioni degli autori: una struttura costituita dall'alternanza fra parti recitate dagli attori e parti cantate dal coro, che scandisce lo svolgersi degli eventi e il loro progressivo precipitare verso una conclusione tanto nota quanto inevitabile. Così come i connotati fondamentali della storia cui si apprestava ad assistere (per esempio, si è detto, quella di Edipo), anche la fisionomia strutturale della tragedia era dunque in linea di principio familiare al pubblico, e non solo per quanto riguarda le macro-componenti dello spettacolo, ma anche per le tipologie dei suoi elementi costitutivi: le diverse modalità di canto, danza e recitazione possibili, il tipo di scenari e costumi, un certo repertorio di situazioni ricorrenti (il lamento, il riconoscimento, la vendetta...), e, a un livello più generale, il rapporto fra la vera e propria azione scenica e la sua espressione verbale, con l'assoluta preminenza di quest'ultima. Nessuno si aspettava di vedere rappresentato sulla scena il momento fatale in cui Edipo incontrò e uccise il padre al crocevia di Delfi, né quello in cui decise di togliere la vista ai propri occhi, tanto a lungo ciechi di fronte alla verità: orrore e sangue erano presenti sulla scena greca solo per il tramite della parola. Non si trattava soltanto di un possibile tabù religioso, ma anche di una felice intuizione drammaturgica, poiché, come ogni buon regista sa, nulla tocca e sconvolge il pubblico tanto quanto ciò che è solo evocato e suggerito, rispetto a ciò che è effettivamente mostrato e visto; anche l'effettiva realizzazione scenica di sconvolgenti fenomeni naturali (terremoti, incendi, tempeste) o di grandiosi eventi bellici (battaglie terrestri e navali) era fuori discussione: tutto questo, e altro ancora, veniva felicemente lasciato all'immaginazione di un pubblico collaborativo e consenziente, abituato a trarre tutto il profitto possibile da un teatro largamente anti-naturalistico e convenzionale, ossia basato su un ampio numero di convenzioni concordemente accettate e non sul tentativo di realizzare a tutti i costi un'illusione scenica di tipo realistico. La presenza costante del coro e il suo periodico e spesso scenicamente immotivato effondersi in commenti o rievocazioni liriche nei momenti di pausa dell'azione non è che la prima e la più vistosa di una lunga serie di convenzioni, che il pubblico antico accettava tanto prontamente quanto quello moderno le proprie: assistere a una rappresentazione nel buio di una sala, con un sipario che cala e si alza a scandire sezioni di testo, con personaggi che agiscono in un ambiente dichiaratamente chiuso (una stanza, una casa...), eppure davanti ai nostri occhi, sarebbe parso ai greci tanto innaturale quanto per noi seguire all'aria aperta, a partire dalle prime ore del mattino, un'intera trilogia tragica più un dramma satiresco, con personaggi che trattano questioni molto delicate all'aperto, magari davanti a un tempio o a un palazzo, ma mai dentro, e per di più di fronte a un gruppo di anziani o di giovani donne, sempre pronti a interloquire o a dispensare consigli e commenti, salvo che talvolta non siano i protagonisti stessi a lanciarsi in appassionati lamenti lirici o in dettagliate descrizioni di ciò che hanno compiuto o di quanto si apprestano a compiere. È chiaro che non si tratta di altro se non di elementi di una lingua comune, che consentono ad autore e pubblico di dialogare fra loro, forti di una condivisa competenza contenutistica e formale, basata proprio sulle ricorrenze e sulle variazioni di uno schema. Anche per quanto riguarda la struttura vale infatti il discorso fatto a proposito del contenuto, per cui se pure è noto il "cosa" (l'alternanza di base coro-attori), rimane libero e soggetto ad artistiche variazioni il "come", ossia quella scelta drammaturgica che conferisce alla famosa
"porzione" omerica unità e coerenza, consentendo agli spettatori di partecipare "in tempo reale" al dramma di Edipo, soffrendo e vivendo con lui una vicenda che, lui non lo sa, ma loro sì, ha una fine obbligata. Che cosa vedeva il pubblico quando la rappresentazione aveva inizio? Ben pochi e semplici erano gli accessori scenici: niente sipario, come si diceva, anche perché il teatro era aperto; la luce naturale dei vari momenti della giornata; una scenografia ridotta al minimo, focalizzata intorno alla facciata dell'edificio che ospitava i cambi di costume degli attori e alcuni strumenti scenici, detto skené. Esso poteva rappresentare qualunque cosa il drammaturgo suggerisse con le parole: un palazzo, un tempio, un'umile dimora, una caverna, oppure, se nessuna indicazione in proposito era fornita, essere semplicemente ignorato. In questo contesto, l'inizio vero e proprio del dramma era rappresentato dall'ingresso in scena dell'attore al quale era affidato il prologo. Questo ingresso poteva avvenire da una delle due vie d'accesso laterali (dette éisodoi) che conducevano dal limitare della cavea all'orchestra, oppure direttamente dalla porta della skené sul palcoscenico antistante (ammesso che ci fosse - in ogni caso, non doveva essere niente di più che una bassa piattaforma, tale da non impedire la comunicazione e il contatto fra coro e attori). Poiché ogni indicazione era affidata alle parole, era indispensabile che il nuovo arrivato si presentasse, fornendo nel contempo ragguagli al pubblico sull'ambientazione della vicenda: la funzione essenziale del prologo, ossia di quella parte della tragedia che precede l'ingresso del coro, è infatti quella di informare sui dettagli pratici, anche molto concreti, quali il luogo, il tempo, l'ora. Il prologo deve inoltre presentare i personaggi coinvolti, ed eventualmente accennare agli antefatti, in modo da consentire al pubblico di individuare con precisione quale segmento della fabula mitica il poeta ha assunto come base per l'intreccio della sua tragedia e aiutarlo a integrare con l'immaginazione la sinteticità dei mezzi scenici. Il carattere convenzionale del teatro greco si manifesta anche nel tipo di costumi e nell'uso delle maschere, funzionali a fornire indicazioni sull'identità e lo status dei personaggi: uomini e donne, re e schiavi, araldi e sacerdoti, dei e supplici, tutti sono individuati dal modo in cui si presentano sulla scena, dall'abbigliamento e dalle insegne che portano e dal tipo di maschera che indossano, oltre che dalle proprie parole o da quelle di altri personaggi che ne annunciano l'entrata. Anche il tipo di recitazione, più stilizzata che naturalistica, assolve d'altra parte la funzione di rendere immediatamente e facilmente riconoscibili movimenti e situazioni: in un teatro delle dimensioni di quello di Dioniso ad Atene, o di quello di Siracusa o di Epidauro, benché l'acustica fosse eccellente, lo stesso non si poteva dire delle condizioni di visibilità, che da un lato rendevano necessario il ricorso a maschere e a costumi fissi per consentire al pubblico una rapida identificazione dei personaggi (e agli attori di ricoprire vari ruoli: in questo caso decisamente l'abito fa il personaggio), dall'altro imponevano movimenti scenici di una certa ampiezza e solennità, confacenti peraltro alla dignità del genere tragico. Di azione scenica vera e propria nella tragedia se ne trova invece piuttosto poca, e nella maggior parte dei casi si tratta di atti e comportamenti "normali" e quotidiani: arrivare, partire, porgere e ricevere oggetti, abbracciarsi, fare offerte agli dei, indicare cose o persone... Essa è normalmente anticipata o commentata nelle parole, destinate a preparare l'evento (nel teatro greco la categoria dell'attesa prevale decisamente su quella della sorpresa) e a fornirne un'interpretazione. Anche tutto ciò che o non poteva essere percepito dal pubblico (per esempio, le espressioni del volto) o non veniva realisticamente rappresentato (fenomeni atmosferici, cataclismi, movimenti di massa) era trasmesso attraverso le parole: mai come in questo caso la parola è azione e crea la realtà che intende rappresentare.
3.2 Gli elementi costitutivi 3.2.1 Il prologo Il prologo è dunque la prima delle sezioni costitutive della tragedia (anche se era l'unica a non essere obbligatoria: manca infatti nei Persiani e nelle Supplici di Eschilo, oltre che nel Reso pseudo-euripideo) e, nella fondamentale alternanza fra recitazione e canto, appartiene al dominio della prima. Con il prologo entra infatti l'attore sulla scena ancora vuota e recita un pezzo in trimetri giambici (un metro ritenuto il più vicino al ritmo del parlato) e con il suo discorso fornisce agli spettatori le fondamentali coordinate spaziali, temporali e tematiche dell'azione che sta per svolgersi sotto i loro occhi. Raramente tuttavia le cose sono così semplici come in questo schematico abbozzo, poiché le varianti possibili di questa struttura di base sono molte. Per
cominciare dall'inizio, bisogna osservare che non sempre il concreto ingresso dell'attore sulla scena coincide con l'entrata del personaggio: alcune tragedie si aprono con un quadro che bisogna presupporre statico, in cui il personaggio deve in realtà essere immaginato come già presente da tempo nel luogo e nella posizione in cui si mostra al pubblico. Saranno quindi ancora una volta le sue parole a indicare se il movimento scenico d'ingresso deve essere considerato parte integrante dell'azione drammatica, o se deve essere convenzionalmente "cancellato" dalla consapevolezza degli spettatori, come se non fosse mai avvenuto. Per esempio, il prologo dell' Agamennone di Eschilo è recitato dalla sentinella che la regina di Argo, Clitemnestra, ha collocato sul tetto della reggia per spiare l'arrivo di un segnale di fuoco che deve comunicarle l'avvenuta presa di Troia e quindi il prossimo ritorno del marito, il re Agamennone (vv. 1-11): Prego gli dei che giunga la liberazione da questi tormenti, da questa veglia lunga un anno, in cui, accucciato come un cane presso la reggia degli Atridi, ho imparato a conoscere i raduni notturni degli astri, e le stelle che agli uomini portano l'inverno e l'estate, e splendono padrone del cielo, con le loro albe e i loro tramonti. Così ora attendo il segno della fiaccola, il raggio di fuoco che viene da Troia a portare una voce, l'annuncio di vittoria: in tal modo infatti governa, pieno d'attese, un cuore di donna dal maschio pensiero. È chiaro che la situazione presupposta è quella di chi da lungo tempo sta appostato, immobile in attesa del segnale; è però altrettanto evidente che l'attore avrà invece dovuto a un dato momento comparire sulla scena e prendere posto, né si può pensare che l'avesse fatto prima che il primo spettatore entrasse nel teatro. In mancanza di un sipario, che possa nascondere il quadro iniziale, l'unica soluzione accettabile è che il pubblico, abituato a obbedire fedelmente alle indicazioni del drammaturgo, fosse pronto a "dimenticare" automaticamente il movimento scenico iniziale, come estraneo all'azione della tragedia. Il teatro di convenzione consente al poeta e al pubblico di supplire con l'immaginazione all'economia espressiva imposta dalle circostanze. Queste poche parole permettono anche di illustrare alcune caratteristiche presenti in molti prologhi: il personaggio che le pronuncia non comparirà più nel resto della tragedia, la sua funzione si esaurisce nella scena iniziale, che culmina nella comparsa dell'atteso segnale e nella conseguente uscita di scena della sentinella, che deve recare l'annuncio alla padrona. Come lui, molti altri personaggi fanno la loro comparsa nelle tragedie solo nel prologo, per introdurre un'azione alla quale non prenderanno poi parte. Una variante di questo tipo di prologo è caratteristica di molte tragedie di Euripide, in cui il personaggio in questione è una divinità, che compare non solo a introdurre la vicenda, ma anche ad anticipare i tratti essenziali dello svolgimento e della conclusione, consentendo così al pubblico di seguire più facilmente l'evoluzione degli eventi, specie quando questa si distacca in maniera significativa dalla versione più nota. È chiaro che in questo modo veniva a cadere un elemento che nello spettacolo moderno è comunemente reputato essenziale, ossia la sorpresa, che però, come si è già detto, nel teatro greco afferiva più alla sfera del «come» che a quella del «cosa»: sollecitata dall'annuncio iniziale, che instaura un rapporto di complicità fra poeta e pubblico, l'attenzione degli spettatori si sarebbe concentrata sul modo in cui l'autore avrebbe saputo realizzare quanto aveva promesso, pronta a valutarne pregi e difetti. Si è già notato del resto che nella tragedia l'azione visibile sulla scena è poca e normalmente poco spettacolare: assai più emozionante che assistere all'atto in sé sarà dunque seguire la preparazione dell'evento, quindi il resoconto e poi la sua discussione; poiché il dato di fatto è noto, il margine maggiore di libertà per il drammaturgo consiste nell'interpretazione. Per esempio, nel prologo dell'Ippolito di Euripide la dea Afrodite afferma (vv. 1-23): Dea potente e celebrata fra i mortali e in cielo, io sono chiamata Cipride; di quanti abitano fra il Ponto e i confini d'Atlante e vedono la luce del sole, rispetto quelli che onorano il mio potere, ma abbatto chi è superbo nei miei confronti. ... Dimostrerò subito la verità di queste parole: il figlio di Teseo e dell'Amazzone, Ippolito, allevato dal nobile Pitteo, unico fra gli abitanti di questa terra di Trezene afferma che io sono la divinità peggiore per natura, rifiuta l'amore e spregia le nozze; onora invece Artemide, figlia di Zeus, sorella di Febo, e la ritiene la più grande fra gli dei. ... Delle sue colpe verso di me, io punirò oggi Ippolito: da tempo ho preparato ogni cosa, non mi occorrerà grande fatica. Essa prosegue poi esponendo antefatti e conclusioni del dramma: Fedra, moglie di Teseo, si è perdutamente innamorata del figliastro Ippolito per volontà della stessa Afrodite e la cosa è destinata a essere svelata a Teseo, il quale, infuriato, provocherà la morte del figlio invocando contro di lui l'intervento del proprio padre
Posidone. Anche il suicidio di Fedra, che a questa passione tenta invano di opporsi, è anticipato dalla dea, le cui parole offrono anche una sintetica motivazione del proprio intervento, insieme con la caratterizzazione di uno dei due personaggi principali, Ippolito appunto, la cui maniacale dedizione ad Artemide ben presto gli spettatori vedranno in azione. Un raffronto con i pochi versi citati sopra dal prologo eschileo mostra chiaramente somiglianze e differenze: anche nelle parole della sentinella non mancava un rapido accenno alla figura principale della tragedia, con l'inquietante riferimento al carattere virile della regina Clitemnestra (una donna dotata di senno e volontà «come un uomo» è, per la cultura greca, una pericolosa anomalia, certamente foriera di guai), nonché un'oscura quanto sintetica allusione a sventure passate e future (Agamennone, vv. 34-39): Possa io dunque la mano amata del signore della casa tenere nella mia al suo ritorno. Del resto, taccio: un grosso bue mi sta sopra la lingua; la casa stessa, se prendesse voce, lo direbbe nel modo più chiaro, e io allora volentieri parlo a chi intende, ma con chi non intende, volentieri dimentico. Si tratta tuttavia di accenni e non di narrazioni diffuse, benché per un pubblico che conosca la vicenda non sia difficile cogliere l'allusione all'agguato mortale che Clitemnestra, d'accordo con l'amante Egisto, sta preparando contro il marito. Mancano invece più espliciti riferimenti agli avvenimenti che di questa situazione costituiscono l'antefatto e, nello stesso tempo, la spiegazione: in primo luogo la sanguinosa guerra, giusta ed empia come tutte le guerre, scatenata per volere di Zeus contro Troia da Agamennone e dal fratello Menelao per punire Paride, reo di aver rapito la sposa di Menelao, Elena. Questa guerra, pagata a caro prezzo dallo stesso Agamennone, costretto da un prodigio divino a sacrificare la figlia Ifigenia per poter far salpare quella flotta di cui era a capo, sarà rievocata successivamente in un ampio canto corale, che di quelle vicende conterrà anche elementi di valutazione e interpretazione, accennando alle loro possibili implicazioni attuali. Il collegamento fra passato e presente è di norma invece più esplicito nei prologhi di Euripide, dove non mancano dettagliate genealogie dei personaggi e precise ricostruzioni degli antefatti in ordine cronologico, come per esempio in questi versi iniziali della Medea (vv. 1-19): Ah, se mai la nave Argo avesse varcato le fosche Simplegadi, verso la Colchide! Mai fosse caduto nei boschi del Pelio quel pino, né mai avesse fornito di remi le mani degli eroi che andarono in cerca del vello d'oro per Pelia! Mai allora la mia signora Medea avrebbe navigato alla volta delle mura di Iolco, piagata nel cuore dall'amore per Giasone, né, dopo aver persuaso le figlie di Pelia ad uccidere il padre, abiterebbe ora questa terra di Corinto, ben gradita ai cittadini del paese in cui è giunta nel suo esilio e disposta a compiacere in ogni cosa Giasone. ... Ma ora tutto è ostile e l'amore è distrutto, poiché Giasone, traditi i suoi figli e la mia signora, ha scelto nozze regali, sposando la figlia di Creonte, sovrano di questa terra. Parla qui la nutrice della protagonista, secondo un'abitudine anch'essa ricorrente in Euripide, ossia quella di affidare il prologo a un personaggio affettivamente legato a quello principale, ma non coinvolto in prima persona negli eventi, e quindi capace sia di rievocare lucidamente i fatti che di presentare efficacemente l'eroe o l'eroina della tragedia al pubblico. La concatenazione dei fatti è esposta in modo diretto e preciso, anche se emotivamente partecipe: Medea, figlia del re della Colchide, ha abbandonato casa e famiglia, macchiandosi anche di gravi crimini, per seguire in Grecia Giasone, capo della spedizione degli Argonauti, che l'ha poi tradita per una nuova moglie, figlia del re di Corinto. Lo svolgimento successivo degli avvenimenti invece è anche qui solo accennato, prima in maniera più vaga (vv. 39 ss.): Io la conosco, temo che si configga un'acuta spada nel ventre ... o che uccida il tiranno e il marito e si attiri una sventura ancora più grande. poi in modo più chiaro (vv. 90 ss.): Tienili [i bambini] il più possibile in disparte e non farli avvicinare alla madre disperata: l'ho vista che li fissava con occhi torvi, come se volesse fare qualche cosa. Quest'ultima allusione alla sorte che Medea, per vendicarsi dello sposo infedele, riserverà ai suoi figli è contenuta all'interno di un dialogo che, sempre nel corso del prologo, si svolge fra la nutrice e un secondo personaggio, il pedagogo dei figli di Giasone e Medea, ehi- nel frattempo ha raggiunto la nutrice sulla scena. Da questo dialogo la nutrice, e con lei il pubblico, apprende i più recenti sviluppi della situazione, dai quali la
vicenda scenica prenderà concretamente l'avvio: il sovrano di Corinto, nuovo suocero di Giasone, ha decretato l'esilio contro Medea e i bambini. Il pedagogo e la sua conversazione con la nutrice introducono un'altra tipologia di prologo, più complessa di quella vista finora e caratterizzata dal dialogo: dopo l'ingresso e la prima esposizione da parte di un personaggio possono infatti susseguirsi ancora una o due scene, definite dall'ingresso e dall'uscita di un secondo ed eventualmente di un terzo personaggio; evidentemente almeno una di queste scene, quando non entrambe, è di tipo dialogico. L'ingresso di due personaggi insieme già dalla prima scena e il dialogo fra loro è meno comune, e sembra essere una caratteristica soprattutto di Sofocle, che nei prologhi delle sue tragedie privilegia l'esposizione del carattere dei personaggi rispetto a quella degli antefatti, e preferisce affidarla al dialogo che all'esposizione diretta. Un esempio è offerto dal prologo dell'Antigone, che consiste interamente di un dialogo fra le due sorelle Antigone e Ismene, figlie di Edipo, attraverso il quale emerge gradatamente la situazione, con qualche breve cenno agli antefatti immediati: dopo la morte di Edipo si è scatenata tra i suoi figli maschi, Eteocle e Polinice, una guerra per la spartizione del potere, nella quale i due fratelli hanno finito per uccidersi a vicenda. Poiché l'uno è morto in difesa della patria (Eteocle) e l'altro invece nel tentativo di conquistarla alla testa di un esercito straniero, il nuovo sovrano di Tebe, Creonte, ha decretato per il primo solenni onori funebri e per il secondo ha proibito, pena la morte, la sepoltura. Il tentativo di Antigone di dare anche al fratello Polinice il sepolcro che gli viene negato, e le sue funeste conseguenze, saranno quindi l'argomento della tragedia, come risulta chiaro dalle battute finali del dialogo, che suggellano anche la presentazione del carattere risoluto di Antigone e il suo isolamento, reso più evidente dal contrasto con la sorella, che la esorta alla ragionevolezza (vv. 83-99): Antigone: Tu avanza pure questi pretesti: io vado ad innalzare un tumulo al fratello amatissimo. Ismene: Ahimè, infelice, quanto temo per te! Antigone: No, non temere per me: metti al sicuro la tua sorte. Ismene: Almeno, non svelare a nessuno quest'impresa, tienila nascosta, e lo stesso farò io. Antigone: No, devi gridarlo forte: sarai molto più odiosa se non lo proclamerai a tutti. Ismene: Tu hai un cuore caldo per cose che raggelano. Antigone: Ma so di essere gradita a chi più d'ogni altro devo. Ismene: Se ci riuscirai: ma desideri una cosa impossibile. Antigone: Va bene, quando non avrò più forze, smetterò. Ismene: Dal principio non bisogna cercare l'impossibile. Antigone: Se parli così, verrai in odio a me e giustamente sarai odiosa al morto. Lascia pure che io e la mia follia subiamo questa terribile sorte: non mi capiterà nulla di così grave da non poter morire nobilmente. Ismene: Vai pure, se credi: sappi che sei folle davvero, ma giustamente cara ai tuoi cari. In questo caso la scena è unica, ma frequentemente il prologo ne può presentare due, come nel caso della Medea, in cui, come si è visto, al monologo della nutrice fa seguito il dialogo con il pedagogo, oppure anche tre, come nell' Edipo a Colono di Sofocle, che riporta al segmento di storia immediatamente precedente a quello trattato nell'Antigone: Edipo, vecchio e cieco, esule da Tebe, giunge guidato dalla figlia Antigone nei pressi di Atene, nel demo di Colono, dove lo raggiungerà la morte. Padre e figlia entrano naturalmente insieme, e la prima scena consiste in un dialogo fra loro, nel quale i personaggi si presentano brevemente (la loro stessa apparizione era peraltro sufficiente a identificarli: un padre cieco guidato dalla figlia non può che essere Edipo con Antigone) e soprattutto forniscono al pubblico le coordinate sceniche: ci troviamo poco lontano da Atene, al limitare di un boschetto sacro (e l'ambientazione, in questa tragedia, è particolarmente importante,
poiché in quel boschetto, consacrato alle Eumenidi, Edipo troverà la pace di un sepolcro eroico). Sopraggiunge a un certo punto uno degli abitanti del luogo, con il quale Edipo dialoga per convincerlo ad accordargli asilo (in questa seconda scena Antigone rimane silenziosa: anche quando sono tre i personaggi presenti, normalmente solo due per volta parlano fra loro); dopo che costui si allontana per andare a conferire con i suoi concittadini, fra padre e figlia si svolge ancora un breve dialogo. Da questi pochi esempi appare comunque evidente la funzione introduttiva del prologo, costante al di là delle differenti tipologie: esso deve fornire agli spettatori gli elementi per orientarsi, identificando chiaramente luoghi, tempi e personaggi; ciò che si trova sulla scena deve essere spiegato e individuato, e il pubblico deve essere aiutato a immaginare ciò che non è fisicamente presente. Un'altra funzione del prologo è quella di stabilire una relazione con lo spazio extra-scenico: alla fine del suo discorso, la sentinella dell' Agamennone corre a palazzo a informare la regina, così come Antigone si avvia a porre in atto il suo proposito (Antigone) e l'abitante di Colono si premura di avvisare i concittadini dell'arrivo di uno straniero sospetto (Edipo a Colono). A queste informazioni e azioni che procedono dalla scena verso il fuori scena, preparando conflitti e mettendo in moto il meccanismo drammaturgico, corrisponde un movimento uguale e contrario nel pròlogo della Medea, dove l'arrivo del pedagogo apporta, da fuori scena, un'informazione essenziale allo sviluppo dell'azione. Sempre in questo prologo però, particolarmente complesso, lo spazio extra-scenico irrompe sulla scena anche in un altro modo e da un'altra direzione, poiché il dialogo fra la nutrice e il pedagogo è interrotto dalle grida di dolore di Medea che, ancora chiusa in casa, e quindi non visibile al pubblico, fa echeggiare il proprio lamento dall'interno della skené. Prima ancora di essere vista, la protagonista è quindi udita, identificata dalla dismisura del suo dolore; i lamenti alterni di Medea e della nutrice continueranno a echeggiare anche per tutta la parodo, che ha in questa tragedia la forma di un dialogo lirico degli attori con il coro, consentendo quindi un passaggio particolarmente morbido fra le due sezioni - tanto morbido che anche noi, quasi inavvertitamente, siamo giunti a parlare appunto del canto d'ingresso del coro sulla scena.
3.2.2 La parodo Il termine pàrodos indica convenzionalmente la prima sezione della tragedia cantata dal coro (nel caso delle tragedie prive di prologo essa è dunque anche l'apertura vera e propria del dramma). La sua funzione drammaturgica non si discosta significativamente da quella del prologo: anche il canto d'ingresso del coro è destinato a fornire al pubblico alcune coordinate essenziali alla comprensione degli eventi, anzitutto in quanto introduce il gruppo corale, la cui presenza sulla scena sarà d'ora in poi costante. Nella parodo possono inoltre trovare posto rievocazioni di antefatti, che ripetono o integrano le informazioni fornite nel prologo; oppure il coro, in quanto nuovo arrivato sulla scena, può interrogarsi circa fatti che nel prologo sono stati in realtà già chiariti, creando così un'atmosfera d'attesa che verrà sciolta solo nel primo episodio, e sottolineando mediante la ripetizione le tematiche portanti della tragedia. Strutturalmente invece la linea di demarcazione fra prologo e parodo è, almeno fino a un certo punto nell'evoluzione del genere tragico, piuttosto netta e corrisponde all'essenziale alternanza di parti recitate e cantate: nel prologo entrano uno o più attori sulla scena e recitano in trimetri giambici; nella parodo entra il coro nell'orchestra e canta un pezzo in metri lirici. Di norma l'entrata avveniva da uno degli ingressi laterali ed era in origine accompagnata da un brano composto in un particolare ritmo di marcia (anapesti), eseguito in forma di recitativo o dal coro stesso o dal suo corifeo (colui che lo guidava e che poteva anche dialogare con gli attori nel corso degli episodi, a nome di tutto il coro). Seguiva quindi un vero e proprio canto, composto in metri lirici ed eseguito con l'accompagnamento della musica del flauto e della danza. In mancanza del preludio anapestico la sfilata d'ingresso poteva essere scandita da un pezzo di sola musica, mentre il canto aveva di norma luogo quando i coreuti avevano raggiunto lo spazio circolare dell'orchestra, adatto a ospitare le evoluzioni della danza. Caratteristica di questo come dei successivi interventi corali è la responsione: il canto è composto in strofe che si corrispondono metricamente a due a due; ogni coppia (costituita dalla proposizione del tema metrico-musi-cale, strofe appunto, e dalla sua ripresa, detta antistrofe, alle quali risponde il ripetersi dei movimenti di danza) costituisce un'unità ritmicamente autonoma, e il poeta può giocare con questa struttura compositiva decidendo di far corrispondere a ogni unità metrico-ritmica anche un'unità di senso, scandendo così lo sviluppo del pensiero per stadi successivi e chiaramente articolati, oppure creare una tensione tra forma e contenuto evitando di far coincidere le pause ritmiche con quelle di senso. L'intera struttura può essere seguita da un'unità singola, diversa dalle altre, a guisa di congedo (epodo); è
possibile anche l'inserimento di un elemento di mezzo (mesodo) fra strofe e antistrofe; se si tratta di un ritornello in cui si ripetono le medesime parole si parla di efimnio (in contesti a forte connotazione patetica o rituale). Qualche volta il coro poteva fare la propria comparsa anche in modo diverso e più spettacolare: così accade nella parodo delle Eumenidi di Eschilo (l'ultimo atto della vicenda narrata nell'Orestea), in cui il coro è costituito dalle Erinni, divinità degli inferi che perseguitano chi abbia versato il sangue dei parenti. Esse stanno dando la caccia a Oreste, il figlio di Clitemnestra, che ha dovuto uccidere la madre per vendicare l'omicidio del padre Agamennone. Il coro entra in scena dalla porta della skené, che in questa prima parte della tragedia rappresenta il tempio di Apollo a Delfi, dove il supplice Oreste ha cercato rifugio; questo ingresso avveniva presumibilmente in ordine sparso, con alcuni gruppi di versi che dovevano accompagnare l'apparizione dei gruppi di coreuti e quindi la loro discesa nell'orchestra, dove veniva infine cantata da tutti insieme l'ultima coppia strofica. Le singolarità di questa tragedia non si esauriscono qui, perché eccezionalmente, nel corso del successivo primo episodio, il coro lascerà la scena per inseguire la preda fuggita, rendendo così necessario un secondo canto d'ingresso, detto epiparodo, realizzato questa volta come di norma da un'entrata laterale, ma ancora in formazione sparsa e in atteggiamento di caccia. È chiaro che questi ingressi "irregolari" acquistano tanto maggiore rilievo proprio in relazione alla "norma" che viene violata: il pubblico si aspetta un'entrata ordinata e composta, come di consueto, e invece si trova di fronte a una realtà ben diversa. In questo caso l'effetto-sorpresa è giocato appunto sulla competenza drammaturgica del pubblico, di cui il poeta frustra abilmente le attese. L'estensione della parodo, come quella degli altri canti corali, può variare anche molto: quella appena citata delle Eumenidi consta di tre brevi coppie strofiche per un totale di trentaquattro versi, quella dell'Agamennone si estende per sei ampie coppie strofiche, precedute da una lunga sezione in anapesti, e copre più di duecento versi. In questo caso la differenza è agevolmente spiegabile in termini di funzione, se consideriamo che la parodo della prima tragedia della trilogia (alia quale fa da contrappeso un prologo singolarmente breve e lineare) deve introdurre le premesse di un ampio sviluppo, destinato a compiersi solo con la terza opera del ciclo, mentre la parodo di quest'ultima si limita a presentare il coro di questa tragedia e le sue funzioni immediate. Se torniamo ora alla parodo della Medea dalla quale abbiamo preso le mosse, notiamo che essa si presenta sostanzialmente diversa dallo schema che abbiamo delineato: invece di un semplice canto corale troviamo un dialogo lirico, al quale prendono parte il coro di donne corinzie, giunte a informarsi della sorte di Medea e a portarle la propria solidarietà, la nutrice e, dall'interno della casa, Medea stessa. La particolarità di questa innovazione risulta ancora più notevole se si tiene conto del fatto che lo scambio di battute in versi lirici fra Medea e la nutrice era iniziato già prima dell'ingresso del coro, nella parte conclusiva del prologo (vv. 96-147): Medea (dall'interno): Ahimè sventurata, infelice per tante sciagure, ahimè, io voglio morire! Nutrice (rivolta ai figli di Medea): Ecco, bambini cari, vostra madre ha il cuore sconvolto dall'ira! Entrate presto in casa, ma state lontani dai suoi occhi, non vi avvicinate, guardatevi dal suo animo selvaggio e dalla crudele natura della sua mente sfrenata. (...) Medea (dall'interno): Ahimè, misera, soffro, io soffro pene degne di pianto e lamento! Ahi, figli maledetti di una madre ripudiata, possiate morire, voi e vostro padre, e tutta la casa! Nutrice: Ahimè, ahimè sventurata, che c'entrano i figli con le colpe del padre? Perché tu li odii? (...) Coro (facendo il suo ingresso): Ho udito la voce, ho udito il grido dell'infelice donna di Colchide, non è mite per nulla. Ma tu spiegami, vecchia, poiché io dalla porta ho udito i lamenti da dentro la casa, e non mi rallegro, o donna, per i dolori di questa dimora che ho cara. Nutrice: Non c'è più, la casa: tutto è finito. Lui è preso da un letto regale, lei invece nella sua stanza si strugge, la mia signora, e nessun amico le scalda il cuore con qualche parola. Medea (dall'interno): Ahimè, mi trafigga il capo la fiamma del cielo: perché dovrei vivere ancora? Ahi ahi, vorrei mettere fine morendo a questa vita odiosa.
Se la differenza strutturale fra prologo e parodo è data dalla modalità espositiva (parlato da una parte, canto dall'altra), occorrerà riconoscere che questo tipo di parodo tende a travalicare la distinzione fra le parti, tanto più che al canto partecipano anche gli attori. Nella tipologia più lineare di parodo, invece, il coro canta a scena vuota, oppure, se uno dei personaggi è presente, normalmente rimane muto sullo sfondo, anche nei casi in cui il coro gli si rivolga nel corso del canto, sollecitando una risposta o una reazione. In effetti a partire dalla data di rappresentazione della Medea (431 a.C.) si fa sempre più frequente il ricorso a dialoghi lirici fra coro e attori, magari preceduti da monodie liriche dell'attore nel prologo (rimane isolato l'esperimento del dialogo lirico fra due attori). Questa monodia inizia spesso in ritmo anapestico, quasi a voler sostituire il preludio del corifeo nella parodo, della quale costituisce in effetti una vera e propria introduzione, poiché normalmente fornisce al coro lo spunto per il suo ingresso: richiamato dai lamenti dell'attore, esso si inserisce in maniera drammaturgicamente coerente nell'azione. In questa linea evolutiva si colloca una progressiva riduzione della parte svolta dal coro a vantaggio di quella dell'attore, che spesso conclude anche la parodo con un proprio pezzo monodico. Il confine effettivo fra prologo e parodo sembra dunque da individuarsi, più che semplicemente nell'ingresso materiale del coro, nel mutamento di ritmo con il passaggio dal verso recitato a quello cantato, che può anche, come si è visto, non coincidere con l'inizio del canto corale, ma essere anticipato dall'attore. Analogamente, bisognerà riconoscere che il passaggio dalla parodo al primo episodio è indicato dal ritorno al verso recitato: un nuovo personaggio entra in scena e inizia a dialogare o con il coro o con l'altro attore oppure, se il personaggio o i personaggi erano già presenti, essi passano dai versi lirici ai trimetri.
3.2.3 Episodi e stasimi Già con la successione prologo-parodo si è infatti instaurato il fondamentale ritmo di alternanza fra parti recitate e cantate che continua per tutta la tragedia; dopo il prologo, le sezioni in cui predomina la recitazione degli attori (qualche volta si tratta invece di un recitativo in tetrametri trocaici o in anapesti) prendono il nome di episodi, mentre le parti affidate al canto strofico del coro sono dette stasimi. Gli episodi (in numero variabile da tre a cinque) risultano così definibili come le sezioni di una tragedia comprese fra due canti corali, e si può dire con un accettabile grado di approssimazione che esse corrispondono agli atti del teatro moderno. Tale è del resto l'origine di questi ultimi, poiché la progressiva riduzione delle parti corali e infine la loro eliminazione dal tessuto drammaturgico conduce sostanzialmente alla struttura canonica del teatro europeo, teorizzata nell'Ars poetica da Orazio. La differenza fondamentale consiste proprio nella presenza continua del coro, che conferisce alla tragedia una forte omogeneità tematica e formale, nonostante l'eterogeneità delle sue componenti. Da un lato infatti occorre osservare che l'intervento del coro nell'azione drammatica non si limita alle parti dichiaratamente corali, ma si estende a quelle dialogate, in cui esso può interloquire con gli attori per bocca del corifeo (mentre analogamente gli attori possono dialogare liricamente con il coro); dall'altro bisogna sottolineare che le sezioni corali, pur rappresentando momenti di pausa dell'azione, non ne rimangono escluse in termini di pertinenza tematica, bensì forniscono spunti di valutazione e riflessione, sollecitando e orientando le reazioni degli spettatori. Mediatore fra scena e cavea, il coro, normalmente costituito da un gruppo omogeneo di persone legate al protagonista da vincoli di consuetudine e d'affetto (ancelle, compagni d'armi, concittadini) o da esponenti più o meno autorevoli della comunità che è teatro dell'azione (notabili, anziani, semplici cittadini), si trova nella duplice posizione di attore e spettatore della vicenda e può identificarsi ora con l'uno ora con l'altro dei due punti di vista. Esso di norma non interviene nello svolgersi dell'azione scenica, se non in funzione di supporto e consiglio, o talvolta di opposizione, ai progetti e alle intenzioni dei personaggi; il suo compito è quello di trascinare emotivamente gli spettatori all'interno dell'azione drammatica, offrendo loro lo specchio di una voce collettiva con cui confrontarsi. Questa funzione è tanto più importante in quanto nella tragedia non è consentita la rottura dell'illusione scenica, consueta invece nella commedia, e nessuno degli attori può rivolgersi direttamente al pubblico uscendo dal personaggio; ciascuno di essi rappresenta un punto di vista individuale e parziale, mentre la voce pubblica del coro, pur simpatizzando a volte con l'uno o con l'altro, è portatrice di valori istituzionali e fornisce un commentario immediato e continuo allo svolgersi dei fatti. Normalmente non è data ai
componenti del coro la possibilità di affrancarsi dall'identità collettiva per far sentire la propria voce individuale: un caso eccezionale in questo senso è il dialogo che si svolge fra i dodici coreuti dell'Agamennone, che si consultano perplessi sul da farsi dopo aver udito le grida del re colpito a morte dall'interno del palazzo (vv. 1348-1372: due versi a testa): - Io per parte mia vi dico il mio parere: far chiamare in aiuto qui a palazzo i cittadini dall'araldo. - A me sembra che si debba irrompere al più presto e sorprendere il fatto con la spada ancora sanguinante. - Anch'io mi associo a questa proposta e voto che si faccia qualche cosa: non è il momento d'indugiare. - È chiaro: questo è il preludio di chi, con le sue azioni, prepara alla città indizi di tirannide. - Noi perdiamo tempo, quelli invece, calpestando la gloria dell'indugio, non tengono le mani inoperose. - Non so quale consiglio io possa dire colpendo nel segno: ma chi agisce deve anche deliberare. - Anch'io la penso in questo modo, poiché non sono in grado con le parole di risuscitare il morto. - E noi, trascinando la nostra vita, ci piegheremo così al potere di chi disonora la casa? - No, non è sopportabile, è meglio morire: è una sorte più dolce della tirannide. - E dunque, traendo indizio dai lamenti, davvero dovremo divinare che egli è morto? - Bisogna avere piena conoscenza per parlare di queste cose, e congetturare è diverso da sapere con chiarezza. - Questo in ogni caso trovo da approvare, che si debba sapere con certezza cosa ne è stato dell'Atride. Scenicamente le parti corali costituiscono comunque una cesura nell'azione, tanto è vero che la loro estensione tende a ridursi verso la fine della tragedia, quando il ritmo si fa più sostenuto in vista della conclusione; esse articolano lo svolgimento del dramma in fasi successive, coprendo convenzionalmente il passaggio del tempo extra-scenico, e tecnicamente servono anche a consentire i cambi di costume fra gli attori, poiché coincidono normalmente con cambi di scena. L'episodio si può infatti più precisamente definire come la sezione dialogata di una tragedia compresa fra due canti corali, che si apre con l'ingresso di un personaggio e si chiude con un'uscita; all'interno dell'episodio possono comunque succedersi diverse "scene", analogamente segnate dall'arrivo e dalla partenza di uno o più personaggi. Questi movimenti sono normalmente segnalati dalle parole di altri personaggi o del coro, che li accompagnano e commentano, fornendo spesso dettagli sull'abbigliamento o sull'atteggiamento dei nuovi arrivati; ecco come, all'inizio del secondo episodio dei Sette a Tebe di Eschilo, il coro di donne tebane, suddividendosi momentaneamente in due semicori, segnala il contemporaneo arrivo da opposte direzioni del re Eteocle e dell'esploratore da lui inviato al campo dei nemici che, sotto la guida dell'altro figlio di Edipo, Polinice, assediano la città (vv. 369374): i semicoro Ecco l'esploratore, mi pare, che dall'esercito ci porta, amiche, qualche novità, assecondando in gran fretta il rapido volgere dei piedi. ii semicoro Ed ecco qui il signore, il figlio di Edipo in persona, che viene al momento giusto per apprendere il racconto del messaggero: di fretta anche lui e con passo vorticoso. Lo scopo di questo genere di annunci è duplice: da un lato essi servono a coprire il tempo necessario all'attore per entrare nel campo visivo del pubblico e quindi nel mondo della rappresentazione; date le dimensioni del teatro, entrate e uscite erano azioni sceniche di una certa durata. D'altra parte essi anticipano il significato dell'evento, integrando quanto visivamente non rappresentabile (qui per esempio è improbabile che i due personaggi entrassero veramente in scena correndo all'impazzata: sarebbe stato inadatto al decoro tragico). Per questo stesso motivo ogni azione scenica è di norma accompagnata e commentata dalle parole, che ne
rendono immediatamente comprensibile il significato per il pubblico oppure ne scandiscono lo svolgimento in precisi segmenti, così da favorire una corretta esecuzione da parte di attori e coreuti, come vere e proprie indicazioni di regia. Così ad esempio Fedra, alla sua prima apparizione nell' Ippolito, esorta le ancelle a sorreggere il suo corpo sofferente (vv. 198-202): Sollevate il mio corpo, reggetemi il capo: le giunture delle membra non mi sostengono più. Prendetemi per le braccia, o ancelle. Mi pesa questa acconciatura sul capo: (rivolta alla nutrice) toglimela, lasciami i capelli sciolti sulle spalle. Solo a questa sorta di didascalie intratestuali è del resto affidata la nostra capacità di ricostruire movimenti, azioni e aspetto dei personaggi: poiché il drammaturgo era di norma anche regista, scenografo, costumista e coreografo della rappresentazione, il testo che egli produceva non possedeva alcun tipo di notazione autonoma di carattere scenico. Analogamente, alla forza evocativa delle parole erano affidati i cambi di ambientazione, che talvolta potevano essere anche clamorosi: per riprendere l'esempio di una tragedia per molti versi singolare, le Eumenidi, il suo primo episodio vede non solo uno dei rarissimi casi di uscita del coro dalla scena, con conseguente secondo ingresso, ma anche una totale rifocalizzazione spaziale e temporale: quando il perseguitato Oreste riappare (v. 235), seguito a pochi versi di distanza dal coro delle Erinni, la scena non è più, come era fino al v. 234, a Delfi, ma ad Atene, dove egli spera di trovare accoglienza e giustizia presso la dea della città. Nessun cambio di scenografia è ovviamente possibile, né richiesto; le parole di Oreste sono sufficienti a chiarire la nuova situazione (vv. 235-243): Atena sovrana, per ordine di Lossia sono giunto: accogli benevola il supplice, non più contaminato né con mani impure, ma con la macchia ormai stinta e consunta dal contatto con case altrui e dalle peregrinazioni fra gli uomini. Traversando terra e mare, osservando gli ordini profetici di Lossia, io giungo alla tua casa e tenendomi stretto al tuo simulacro, dea, attendo qui l'esito del giudizio. In questo caso tra l'altro è il personaggio stesso che commenta il proprio aspetto, sottolineando la sua condizione di supplice, che doveva visivamente essere tradotta in un tipo specifico di insegna (un ramoscello cinto di bende) e di atteggiamento. Che cosa, dunque, in concreto si vedeva accadere sulla scena? Di effettiva azione, si è detto, abbastanza poco e, proprio per questo, quel poco era di norma altamente significativo: la condensazione del senso di una vicenda in una breve sequenza di semplici eventi è una delle caratteristiche più spiccate della tragedia greca, almeno fino alla produzione degli ultimi anni di Euripide, che con la sua sperimentazione di intrecci più complessi e movimentati imprime una svolta decisiva in direzione di una più marcata spettacolarità. Sulla scena predomina la parola, mentre l'azione è normalmente confinata fuori scena, sia a livello spaziale che temporale: una tensione o un conflitto fra spazio (e tempo) scenico e spazio (e tempo) extra-scenico è infatti alla base della maggior parte delle tragedie. Ecco perché ingressi e uscite dei personaggi sono tanto importanti e necessitano di anticipazioni e spiegazioni: mentre il coro rimane dove si trova, gli attori vanno e vengono, e così facendo istituiscono rapporti con lo spazio extra-scenico, quello in cui si svolgono i fatti, che poi sulla scena vengono raccontati e commentati. Eppure, proprio questo dimostra che il centro dell'attenzione è e deve rimanere quanto accade sulla scena: ogni azione, per quanto importante, che avvenga al di fuori dello spazio e del tempo scenici, ha importanza solo in quanto sulla scena viene riportata e quindi riferita a ciò che lì accade. Perciò nessun riassunto può esaurire il significato di una tragedia greca, proprio come conoscere preventivamente situazioni e personaggi non poteva sostituire per gli spettatori ateniesi il significato di ciò a cui assistevano. Quando il re Agamennone, nell'omonima tragedia di Eschilo, torna in patria dopo aver conquistato Troia, il suo destino è da tempo segnato: egli dovrà cadere sotto i colpi della moglie Clitemnestra e dell'amante di lei (e cugino di lui) Egisto; nessuno, fra il pubblico, dubita che ciò effettivamente accadrà, già nell'Odissea il suo triste ritorno è più volte narrato, come paradigma dei rischi che attendono i reduci dalla decennale impresa. E così naturalmente accade, ma ciò che il pubblico realmente vede è solo un re che torna in patria sul carro del
trionfo (quando ormai la tragedia è già a metà del suo svolgimento: l'intera prima parte è solo preparazione, in un crescendo ossessivo di premonizioni) e che esce abbastanza rapidamente di scena, dopo un diverbio con la consorte, camminando su tappeti di porpora. Il particolare non è solo scenografico; per chiunque abbia assistito a una rappresentazione dell'Agamennone è evidente che ciò che il re sta calpestando non è altro che una scia di sangue, il sangue che egli stesso ha versato: quello della figlia sacrificata ad Aulide, quello dell'intera città di Troia, quello che anche prima di lui era stato sparso nella sua famiglia (una delle più inclini, nel pur cruento panorama della mitologia eroica greca, alla violenza su consanguinei). Agamennone non ha scampo, e il momento in cui egli varca la soglia del palazzo che da dieci anni attende il suo ritorno coincide perfettamente, per il pubblico, con quello della sua morte: non c'è alcun bisogno di vedere realmente l'assassinio sulla scena, poiché nessuno si aspetta ormai più di rivederlo vivo, quel sangue che cola dalla casa colpita a morte è evidentemente anche il suo. Come questo ci sono altri casi di oggetti che convogliano su di sé un forte valore simbolico o che rappresentano un decisivo snodo drammaturgico: l'urna che l'Elettra sofoclea abbraccia piangendo, convinta che contenga le ceneri del fratello Oreste (il quale sta in realtà vivo e vegeto davanti a lei); i doni fatali (peplo e corona intrisi di veleno) che Medea affida ai figli, perché li consegnino alla nuova sposa di Giasone; l'arco di Filottete (ancora Sofocle), dal quale è destino che Troia debba essere conquistata, che Odisseo e Neottolemo cercano di carpire all'eroe, abbandonato per lunghi anni in solitudine sull'isola di Lemno a causa di una ripugnante ferita, e molti altri ancora. In complesso il numero e la lunghezza degli episodi tende progressivamente ad aumentare, dal primo Eschilo all'ultimo Euripide; la loro successione e funzione corrisponde a una precisa intenzione drammaturgica: si va da tragedie "a forma chiusa", con uno sviluppo sostanzialmente lineare, organizzate intorno a una grandiosa scena centrale oppure a due o tre punti nodali, con altri episodi in funzione di transizione (una struttura più frequente in Eschilo), ad altre in cui un conflitto centrale viene risolto in una catena di situazioni conflittuali in progressiva accentuazione, fino a un punto di svolta, dal quale inizia un movimento opposto, verso lo scioglimento finale (una tipologia ricorrente specie in Sofocle, e che può anch'essa essere organizzata in due o tre stadi successivi), fino a casi in cui i singoli episodi sembrano acquisire vita autonoma, come avviene in alcune tragedie di Euripide («forma aperta»). La ricerca di simmetria nella costruzione della tragedia porta spesso alla formazione di ampie strutture, in cui diversi episodi o scene si corrispondono per analogia o per contrasto, contribuendo anche per questa via alla creazione del senso. In Eschilo questo fenomeno si riscontra anche su più ampia scala, ossia nell'organizzazione dell'intera trilogia, di norma legata da una vicenda unitaria: nell'Orestea alcune situazioni sceniche si ripetono identiche, ma con diversi personaggi, dall' Agamennone alle Coefore (il secondo dramma), a segnare il procedere della storia dall'assassinio del re per mano della moglie alla sua vendetta ad opera del figlio. Analoghe considerazioni spiegano la notevole diversità di ritmo e il diverso peso relativo di parti corali ed episodi fra le tragedie di questo autore: solo l'Orestea è una trilogia completa, e mostra chiaramente come al passo più lento e meditativo della prima tragedia corrisponda un ritmo via via più sostenuto nelle altre, a mano a mano che lo scioglimento finale si avvicina: le altre tragedie superstiti di Eschilo sono solo frammenti di organismi più complessi, la cui tessitura globale per forza di cose in buona parte ci sfugge. Negli altri due tragici ogni opera è invece a sé, e una valutazione strutturale risulta quindi più facile; sempre per questo motivo probabilmente si può osservare che la lunghezza degli episodi tende, in Sofocle ed Euripide, a una maggiore uniformità, rispetto a quanto accade nelle tragedie di Eschilo. Anche il numero di scene per episodio (in media da una a tre) tende ad aumentare con l'evoluzione del genere tragico; per quanto riguarda Eschilo bisogna poi osservare che l'impiego del terzo attore, introdotto secondo la tradizione da Sofocle (e da lui largamente usato, anche più che da Euripide), rimane confinato all'Orestea, e anche qui i tre attori contemporaneamente sulla scena si trovano solo nel finale delle Eumenidi (non si tratta peraltro di un vero e proprio dialogo fra i tre: si è già detto che questo è un fenomeno assai raro e limitato). Quando l'episodio si conclude gli attori escono (non sempre tutti, per la verità: abbastanza spesso almeno uno rimane sulla scena) e, sulle note dell'aulós, i coreuti si apprestano a cantare e danzare. Questo canto corale, regolarmente collocato fra due episodi e di norma preceduto dall'uscita di un attore e seguito dall'ingresso di un altro, si chiama stasimo; il nome significa propriamente "canto statico", nel senso che non prevede spostamento, in quanto contrapposto alla parodo o "canto d'entrata". Si tratta di un canto, normalmente costruito in responsione strofica, che il coro esegue, come la parodo, nell'orchestra, e sempre accompagnandolo con movimenti di danza (di una danza chiamata emméleia, che dobbiamo immaginare molto
composta e stilizzata, per nulla mimetica e vivace come quella che caratterizzava il dramma satiresco, detta síkinnis). È possibile che esso venga eseguito a scena vuota, ma non necessariamente e anzi talvolta anche l'attore presente può prendervi parte, nella forma di un dialogo lirico (come si era visto per la parodo). Dialoghi lirici (amebei) o parzialmente lirici (epirrematici, ossia inframmezzati da versi recitati) fra coro e attori si possono trovare anche al di fuori degli stasimi, mentre, come si è detto, il coro può svolgere funzioni di personaggio all'interno dell'azione scenica dialogando in trimetri con gli attori durante gli episodi tramite il corifeo. Lo stasimo invece non è un vero e proprio evento scenico, in quanto non è di norma inserito mimeticamente nel tessuto drammaturgico, ma ne costituisce un commento o un riflesso, dove l'"io" del coro non è da intendersi in senso soggettivo-autobiografico, ossia come il discorso di uno dei personaggi dell'azione drammatica, bensì proprio come un "io lirico", una voce pubblica in cui ciascuno degli spettatori può riconoscersi. Solo molto raramente l'effusione lirica del coro viene motivata con il ricorso a pratiche rituali (come la preghiera o il lamento funebre) che richiedano l'esecuzione di un canto corale; lo stasimo è piuttosto una sorta di sospensione del tempo scenico e dell'azione drammatica. Il suo contenuto è infatti narrativo o riflessivo, e tende a ripercorrere la stessa materia svolta nell'azione scenica, ma su un altro piano, quello dell'interpretazione e della meditazione. In alcuni casi la sua funzione nella vicenda rappresentata può essere anche più profonda, quando esso non si limita a fornire o a sollecitare una valutazione degli eventi agiti o narrati, ma li integra, completandoli con informazioni, spiegazioni, motivazioni, che concorrono a definire un quadro emerso solo parzialmente dai discorsi dei personaggi. In generale si può dire che il canto del coro, oltre a riempire pause tecniche o drammaturgiche, ha normalmente il compito di preparare o concludere uno sviluppo drammatico, riallacciandosi alle scene precedenti o anticipando quelle successive; in questo senso, le riflessioni del coro costituiscono parte integrante del tessuto tematico e drammaturgico della tragedia. Un'integrazione del canto corale si ha più facilmente in brevi forme di canto astrofico ricorrenti all'interno degli episodi, in cui il coro manifesta la propria reazione immediata (emozione, disperazione, paura, gioia) a un evento scenico, oppure quando si verifica una forma di dialogo (lirica o recitata) fra i due semicori o, come si è visto, del coro con gli attori. Molto più stretta risulta naturalmente l'integrazione del coro e dei suoi canti nell'azione quando il coro stesso è protagonista della tragedia, come nelle Supplici di Eschilo e in quelle di Euripide (ma si tratta di due vicende diverse, a dispetto dei titoli: nel primo caso sono le cinquanta figlie del re egiziano Danao che cercano rifugio nella città di Argo, per sfuggire le aborrite nozze con i cugini; nel secondo si tratta delle madri dei guerrieri argivi caduti nella guerra dei Sette contro Tebe che implorano aiuto dal re ateniese Teseo per ottenere la restituzione dei cadaveri dei figli). Alcune volte il canto corale, di ridotta estensione, non è che un semplice riflesso lirico dell'azione scenica, o perché commenta quella appena avvenuta, o perché anticipa quella immediatamente prossima, coprendo il tempo necessario allo svolgimento dello sviluppo extrascenico o addirittura sostituendolo. Per esempio, nel secondo stasimo dell'Edipo a Colono di Sofocle, il coro immagina, e così facendo descrive, la battaglia che il valoroso re di Atene, Teseo, sta conducendo contro l'esercito tebano per ricondurre al padre Edipo, che egli ha deciso di accogliere in città, le due figlie Antigone e Ismene, sottrattegli con la forza dal nuovo re di Tebe, il cognato Creonte (vv. 1044-1095). Non sempre peraltro è necessario ricorrere a simili sistemi, poiché lo scorrimento del tempo extra-scenico può tranquillamente essere ignorato, oppure contratto o allungato a piacere. Un caso particolare di integrazione fra canto e azione si ha spesso ancora in Sofocle, che gioca volentieri sull'ambivalenza di certe affermazioni, lasciando al pubblico il compito di scoprire, alla fine della vicenda, i reali referenti del discorso poetico, o crea veri e propri effetti di ironia tragica, facendo sì che il coro esulti all'apparente approssimarsi di una soluzione positiva, solo per far precipitare con più violenza l'inevitabile catastrofe. Così nel quinto stasimo dell' Antigone (vv. 1115-1152) il coro ripercorre le molte glorie mitologiche della città di Tebe in un'atmosfera di esultanza, fiducioso nel buon esito del ravvedimento del sovrano Creonte, appena uscito di scena per andare a liberare Antigone dalla caverna dove aveva ordinato che fosse sepolta viva. Ma la conclusione sarà ben diversa: non appena il canto si è chiuso, un messaggero entra ad annunziare la morte di Antigone stessa, suicida per impiccagione, e del suo promesso sposo, Emone, figlio di Creonte, trafittosi con la spada alla scoperta del cadavere della ragazza. Seguirà di lì a poco il suicidio anche di Euridice, la moglie di Creonte, al quale non rimarrà che piangere le proprie sventure. Al polo opposto si collocano quegli stasimi, più frequenti nelle opere tarde di Euripide, che perdono qualsiasi collegamento con lo svolgimento dell'azione, salvo un tenuissimo legame magari di tipo narrativo-mitologico,
per acquisire un'evidente funzione di intrattenimento autonomo. Per esempio, nel secondo stasimo dell' Elena di Euripide, il coro si effonde in un'ampia rievocazione lirica delle vicende della dea Demetra e della figlia Persefone, rapita dal dio degli Inferi. Ade, e affannosamente cercata dalla madre per mari e monti, che non appare in alcun modo collegata alle vicende dell'eroina spartana, se non per un'esortazione finale a non trascurare il culto di questa potente divinità. A questo fenomeno, destinato a progredire decisamente già dalla generazione immediatamente successiva (per esempio con Agatone, i cui canti erano detti embólima, ossia appunto "intermezzi") e ad affermarsi in maniera irreversibile poi nella Commedia Nuova, è legato spesso un ampliamento dell'estensione delle parti corali (che da Eschilo in poi era invece andata via via riducendosi, per fissarsi nella forma canonica della doppia coppia strofica) e all'introduzione di sperimentazioni in campo musicale, con una progressiva tendenza verso quei fenomeni di mimetismo che erano in origine considerati estranei alla gravità dell'éthos tragico. In questo quadro, che investe peraltro non solo la tragedia, ma l'evoluzione della lirica in genere, è la musica che tende a prendere il sopravvento sulla parola: e poiché il teatro è, per eccellenza, il dominio della parola, la progressiva espulsione di questi canti dal corpo della tragedia in quanto sostanzialmente estranei all'organismo scenico non è affatto sorprendente.
3.2.4 L'esodo La parte conclusiva della tragedia è detta esodo; essa è definibile come quella sezione «alla quale non segue alcun canto del coro». Già questa identificazione "in negativo" lascia intendere come sia difficile individuare una fisionomia univoca per l'esodo, tanto più che il nome stesso è in qualche misura ambiguo, poiché può tecnicamente indicare anche il vero e proprio "canto di uscita" del coro, specularmente contrapposto alla parodo, o meglio al suo preludio, con il quale normalmente condivide l'impiego dei ritmi di marcia (anapesti). Questo canto di uscita è di regola assai breve, e non è che una delle componenti di quello che potremmo più genericamente definire l'atto conclusivo della tragedia, formalmente assai vario e ricco di sorprese. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che si tratta dell'ultimo episodio, nel senso che si apre, come di norma, con un ingresso e prevede la presenza di personaggi recitanti secondo le modalità consuete, mentre alla sua conclusione tutti gli attori, e dopo di loro il coro, lasceranno, questa volta definitivamente, la scena. D'altra parte le sue differenze rispetto agli altri episodi sono evidenti, intanto nel ritmo, che tende a farsi più rapido e concitato: entrate e uscite dei personaggi si susseguono a una velocità inconsueta, e aumenta così il numero delle scene. La sua stessa estensione è generalmente più ampia della media degli episodi (l'esodo dell' Agamennone, per esempio, si stende per trecento versi, mentre la lunghezza media degli episodi di questa tragedia è di 177 versi). Non è infrequente anche, in maniera speculare a quanto avviene spesso nel prologo, la comparsa di personaggi nuovi, magari precedentemente citati ma non ancora apparsi sulla scena, come Egisto, l'amante di Clitemnestra e suo complice nell'assassinio di Agamennone, che arriva a cose fatte a rivendicare la propria parte nell'impresa (Agamennone), oppure anonimi, come il messaggero che riporta la morte di Antigone ed Emone (Antigone), o anche totalmente inaspettati, come le divinità che spesso giungono a concludere le tragedie di Euripide. Nell'Ippolito, per esempio, al prologo di Afrodite fa da contrappunto l'esodo in cui appare l'altra dea chiamata in causa, Artemide, che rivela a Teseo l'innocenza del figlio, ingiustamente accusato di violenza da Fedra prima di morire e ormai morente a sua volta, travolto con i suoi cavalli dal mostro marino suscitato da Poseidone in risposta all'invocazione dello stesso Teseo. Queste apparizioni divine sono spesso considerate una sorta di "marchio di fabbrica" di Euripide, data la frequenza con cui giungono a concludere le sue tragedie, specie quando queste abbiano raggiunto un grado di complicazione nell'intreccio difficilmente risolvibile per altra via; si indicano di norma con l'espressione deus ex machina, con riferimento all'impiego della mechané, una specie di gru usata per simulare il volo e quindi adatta a rappresentare l'arrivo di entità soprannaturali. anche se non è del tutto certo che, almeno nelle tragedie che ancora possiamo leggere, essa sia stata sempre effettivamente utilizzata (è possibile che si tratti di un uso posteriore, magari poi reintrodotto nelle riprese postume). Il suo impiego tra l'altro doveva risultare alquanto complesso e lento, mentre molte di queste epifanie divine sono apparizioni improvvise, destinate a sventare situazioni rischiose proprio all'ultimo momento: in alcuni casi si può anche pensare che avvenissero piuttosto dal tetto della skené, che si prestava a fornire una rapida via d'accesso, ed era in generale destinato proprio alla comparsa di esseri soprannaturali (era detto, per questo motivo, theologéion). L'arrivo del deus ex machina, in ogni caso, porta alle estreme conseguenze quella che è comunque la funzione drammaturgica dell'esodo, ossia condurre a conclusione la vicenda, risolvendo tutte le situazioni in sospeso, sciogliendo tutti i nodi, proponendo magari anticipazioni su futuri sviluppi, specie se legati in qualche modo all'attualità. Molti di questi dei infatti ordinano la fondazione di culti e santuari effettivamente esistenti, gettando così un ponte
fra il «mondo possibile» della rappresentazione e quello reale del pubblico; del resto già Atena, nel finale delle Eumenidi di Eschilo, creava il tribunale ateniese dell'Areopago, una delle principali istituzioni giuridiche cittadine. L'aspetto inquietante, e tipicamente euripideo, di questo genere di finale consiste nella sua sostanziale estraneità, per non dire palese contraddizione, rispetto al modo in cui la vicenda era stata precedentemente condotta: gli eroi di Euripide agiscono in un mondo che pare ormai quasi senza dei, o che comunque sembra averli messi fortemente in discussione, e la loro comparsa, si potrebbe dire, in carne e ossa sulla scena, per riportare la conclusione della vicenda all'interno dei connotati tradizionali del mito, dai quali gli avventati comportamenti dei personaggi minacciavano di farla uscire, propone sicuramente uno spunto anche provocatorio di riflessione al pubblico. Anche questa peraltro è una delle funzioni connaturate all'esodo, ossia quella di fornire un momento di valutazione di quanto sulla scena è avvenuto: questo è il punto in cui le fila del destino convergono, chi ha agito deve rendere conto del proprio operato e, di norma, subirne le conseguenze. In questo senso è caratteristico l'esodo Antigone, ricordato poco sopra: l'entrata di un messaggero, che riferisce gli esiti, di norma disastrosi, verificatisi fuori scena, dà il via a una complessa scena di lamentazione, in cui si alternano le reazioni del coro, spesso in metri lirici, e quelle degli attori, che possono anch'essi effondersi in monodie liriche o dialogare liricamente con il coro, oppure ripercorrere in metri recitati moventi e risultati delle proprie azioni. Gli effetti pratici delle vicende occorse possono essere portati alla vista del pubblico, con l'esposizione dei cadaveri dei defunti, e il conseguente lamento funebre; se si tratta di un'uccisione che si è verificata in uno spazio chiuso, quello scenicamente rappresentato dalla skené, è possibile il ricorso all'enkyklema, una sorta di piattaforma su ruote che veniva fatta uscire, simulando convenzionalmente la visione di uno spazio interno. Così si concludono per esempio tanto l'Agamennone quanto le Coefore, mostrando una volta il cadavere di Agamennone, colpito a morte nel bagno con la concubina Cassandra, appena portata come preda di guerra da Troia, dalla moglie Clitemnestra, l'altra invece Clitemnestra stessa, uccisa con l'amante Egisto dal figlio Oreste, vendicatore del padre. In questi casi il carattere convenzionale della drammaturgia greca risulta evidente: una volta che il quadro iniziale è stato recepito dal pubblico in tutta la sua suggestione visiva, l'ambientazione della scena torna a farsi convenientemente sfumata, tanto da consentire agevolmente la partecipazione continua del coro e l'arrivo di altri personaggi, senza dover necessariamente supporre che il tutto dovesse immaginarsi trasferito nel suo complesso all'interno. In queste forme di esodo prevale la dimostrazione visiva degli effetti e la riflessione verbale sui significati dell'azione; esiste però anche un'altra tipologia di esodo, in cui l'azione in quanto tale continua a svolgersi, ricevendo nuovi impulsi fino all'ultima scena, e solo una breve sezione finale affidata al coro serve in qualche modo a tirare le somme della vicenda. Mentre nel primo caso predomina la tonalità del lamento, nel secondo il ritmo si mantiene sostenuto fino in fondo: ciò accade specialmente o nelle tragedie eschilee che occupavano il primo e il secondo posto in una trilogia legata, che evidentemente sono destinate a preparare il prosieguo dell'azione, rimandandone lo scioglimento alla tragedia conclusiva, oppure in quelle caratterizzate da un più complesso intreccio e dal ricorso all'intrigo o a colpi di scena, come il riconoscimento fra personaggi intimamente legati fra loro, ma per qualche motivo da lungo tempo separati. Ma con questo si è giunti a parlare di componenti tematiche, un argomento che si cercherà ora di approfondire più dettagliatamente.
3.3 Temi, motivi e tipologie compositive 3.3.1 Temi e motivi: la vendetta Molte delle più significative e ricorrenti componenti tematiche della tragedia attica sono in realtà già state anticipate, quando si è accennato alle vicende trattate in alcune opere. È questo il caso della vendetta, uno dei nodi concettuali più importanti nel teatro greco, movente delle azioni di Medea, che per vendicarsi dell'abbandono del marito Giasone decide di privarlo di ciò che di più prezioso un uomo greco possedesse, ossia la propria discendenza - e questo nonostante che i figli fossero ovviamente anche suoi (Medea di Euripide). Ancora per vendetta Clitemnestra uccide il marito Agamennone, che dieci anni prima le aveva strappato la figlia Ifigenia, immolata sull'altare di Artemide ad Aulide per permettere la partenza della spedizione verso Troia (Agamennone di Eschilo); sarà quindi il turno di Oreste vendicare la morte del padre
uccidendo la madre (Coefore), con tutte le conseguenze del caso (persecuzione delle Erinni, esilio, processo: Eumenidi). Come si noterà, si tratta di una violenza che si esercita soprattutto nella sfera dei rapporti familiari: questo è tipico della tragedia, che tende, come una lente d'ingrandimento, a presentare i suoi personaggi in situazioni estreme, esasperando tensioni e conflitti ad un livello impensabile per esseri umani "normali" (ma si è già detto che la tragedia ha come oggetto fatti e personaggi di dimensioni eroiche, ossia superiori alla norma). La vendetta in quanto tale peraltro apparteneva al codice morale e giuridico greco, e dunque il pubblico, quando i personaggi tragici parlavano di necessità di lavare il sangue con il sangue o di vendicare un'offesa, non li guardava come bizzarri relitti del tempo che fu, ma ne comprendeva le motivazioni di fondo, benché l'applicazione contingente potesse apparire, come si diceva, volutamente esasperata. Anche in questo senso si può dunque dire che la tragedia si muove lungo binari prestabiliti: non solo la sua struttura risulta regolare almeno nelle linee di base, ma anche i comportamenti dei personaggi obbediscono ad un codice culturale riconosciuto (e vincolante, data la natura tradizionale, ossia fortemente conservativa, della società). Non sarà dunque sorprendente scoprire che anche la loro possibilità di dare voce ai propri conflitti risponde a precisi canoni strutturali. Il modo in cui attori e coro intervengono sulla scena non è infatti esente da vincoli formali: anche qui si possono rintracciare tipologie drammaturgiche costanti.
3.3.2 Tipologie compositive: la rhésis Una delle forme espressive più tipiche è la rhésis, ossia "discorso" (il sostantivo indica l'azione del dire, dalla radice rhe-): in senso lato, si tratta di ogni intervento recitato da un personaggio, di lunghezza variabile da un minimo di 7 versi (meno di così è difficile che si tratti di un discorso autonomo, sarà piuttosto da considerarsi inserito all'interno di una struttura più complessa in cui si alternano interventi di vari personaggi) a un massimo di 110 (i più lunghi delle tragedie superstiti). In questo senso la rhésis si contrappone da un lato al canto, perché si tratta di un pezzo recitato, dall'altro al dialogo, perché è un "pezzo a solo", e non richiede necessariamente interlocutori; per esempio, Medea, prima di risolversi a mettere in atto la vendetta, effonde ansie ed esitazioni in un lungo discorso, non rivolto ad altri che a se stessa (vv. 1021-1080). Quello del monologo è un caso particolare, all'interno di una delle tipologie di rhésis più frequenti, ossia quella destinata alla riflessione, che può a sua volta vertere sulla decisione riguardo a un'azione da intraprendere o sull'argomentazione di un tema anche teorico: la stessa Medea dedica un'altra ampia rhésis a esporre una serie di considerazioni sulla sorte delle donne (vv. 214-266) e due discorsi a progettare ed esporre il proprio piano d'azione (vv. 364-409; 764-810). Normalmente il destinatario del discorso è però diverso dal suo autore (per esempio, in questa stessa tragedia, la contesa fra Medea e Giasone trova espressione nel secondo episodio in discorsi contrapposti rivolti dall'uno all'altra), ma la sintassi drammaturgica prevede comunque che egli ascolti senza interloquire e solo in un secondo momento, eventualmente, intervenga a sua volta. Se esortazione e riflessione costituiscono spesso argomento e funzione delle rhéseis, la destinazione più frequente è quella informativa: un personaggio entra in scena e rende edotti gli spettatori degli antefatti (come avviene normalmente nel prologo: ricordiamo per esempio la nutrice di Medea, o la sentinella presso il palazzo degli Atridi nel-1*Agamennone), oppure comunica agli altri personaggi un importante sviluppo drammatico avvenuto fuori scena; è questo il caso più tipico in assoluto, l'arrivo di un messaggero che reca notizie, a volte attese, altre volte inaspettate, quasi sempre catastrofiche. Grazie alla rhésis informativa anche lo spazio e il tempo extra-scenici entrano a far parte del mondo della rappresentazione: ciò che avviene fuori scena, in un altro luogo e in un altro tempo, è integrato tramite il racconto nell'esperienza scenica del pubblico. Per rimanere nell'ambito del tema della vendetta, quando Medea avrà portato a compimento la prima parte del proprio piano, sarà appunto un messo che, in un lungo ed elaborato discorso, riferirà con dovizia di particolari l'orribile morte che essa ha destinato alla nuova sposa di Giasone, consumata dalle inestinguibili fiamme della pozione magica di cui Medea ha intriso il peplo inviato alla rivale come ingannevole omaggio (vv. 1136-1230). Abbiamo qui anche un esempio dello schema di collocazione rispettiva più frequente delle principali tipologie di rhésis nella tragedia: il discorso informativo all'inizio, nel prologo (la nutrice), il discorso argomentativo o esortativo al centro (Medea), e quello narrativo alla fine, a esporre la catastrofe lungamente preparata e temuta (il messaggero). Poiché lo spargimento di sangue non è normalmente rappresentato sulla scena greca, questo dalla Medea non è che uno dei numerosissimi esempi che si potrebbero addurre: in maniera del tutto analoga è riferito l'incidente mortale di Ippolito, nell'omonima tragedia, vittima della vendetta postuma di Fedra, portata ad
effetto dalle maledizioni di Teseo. Almeno un altro tuttavia se ne potrebbe aggiungere, per mostrare come ad ogni schema consolidato corrispondano infinite possibilità di variazione, giocate sulla rottura dello schema stesso: altra sposa tradita, altra vendetta, ora è Clitemnestra che fa giustizia del marito Agamennone e della sua concubina Cassandra, giunta con lui da Troia appena conquistata. Non è un messaggero questa volta chi reca la notizia, anzi, per meglio dire, chi espone la descrizione dettagliata e compiaciuta dell'assassinio (le grida del re colpito a morte sono state appena intese da coreuti e pubblico, dunque il fatto in quanto tale è noto), ma la regina in persona, che compare ancora sporca del sangue delle sue vittime, con la spada in pugno, trionfante sui cadaveri dei suoi nemici. Nella stessa tragedia anche l'annuncio della conquista di Troia e la descrizione dei primi momenti della città caduta erano stati dati da Clitemnestra che, avvertita dal consorte tramite un ingegnoso sistema di "telegrafo luminoso" (segnali di fuoco trasmessi da una cima all'altra dei monti), aveva anticipato grazie alla sua fervida fantasia il racconto che, più normalmente, sarebbe dovuto spettare ad un messaggero; quando questi nel secondo episodio farà effettivamente la sua comparsa, altri saranno infatti i temi delle sue rhéseis (ringraziamento agli dei, rievocazione delle sofferenze patite nei dieci anni di guerra, descrizione della tempesta abbattutasi sulla flotta nella via del ritorno). Varie sono dunque le funzioni che una rhésis può svolgere, come vario può essere il suo contenuto; essa si presenta in ogni caso come un brano retoricamente strutturato, dotato di un'introduzione, uno svolgimento e una conclusione, e consente pertanto una certa espansione del pensiero e spesso anche un'esposizione del carattere del personaggio. A seconda del contenuto e della funzione, lo svolgimento può essere articolato in una serie di punti successivi (se si tratta di una narrazione) o in una progressione retoricamente graduata, culminante nella conclusione (climax), oppure logicamente argomentato per analogia o per antitesi, strutturato a cornice o in forme più complesse come l'anello (Ringkomposition) o la spirale. Talvolta, specie in Sofocle, discorsi diversi di uno stesso personaggio sono strutturati nello stesso modo; altre volte, specie in Euripide, quando due personaggi si confrontano in una disputa (agone), i loro discorsi contrapposti a sostegno di contrastanti punti di vista presentano rispondenze strutturali, verbali e argomentative. In base al suo grado di integrazione nell'azione, la forma della rhésis può essere più o meno chiusa: quanto più organicamente inserito nello sviluppo drammatico, tanto più il singolo discorso tende a collegarsi concettualmente e formalmente con ciò che precede o che segue, fino al punto di perdere la parte introduttiva o quella conclusiva, inglobate in una sezione dialogica, o di accogliere direttamente al proprio interno uno sviluppo drammaturgico, come accade per esempio nel prologo dell'Agamennone, quando la sentinella percepisce l'atteso segnale di fuoco e muta improvvisamente contenuto e scopo del suo discorso, dalle sofferenze passate alla gioia presente e all'anticipazione di quella futura. Non si tratta di un caso isolato: qualcosa di simile accade nelle Coefore a Elettra, figlia di Clitemnestra e Agamennone, la quale, mentre s'interroga sul significato della ciocca di capelli rinvenuta sul tumulo del padre, che sembra indicare un possibile ritorno del fratello Oreste, allontanato da casa fin dal tempo della morte del re, scopre all'improvviso anche delle impronte, che si riveleranno ben presto essere proprio quelle dell'atteso Oreste (vv. 205 sgg.). La nuova direzione presa dal discorso di Elettra trova naturale e immediata continuazione, nel momento in cui il fratello effettivamente le si presenta, in un dialogo denso e serrato fra l'incredulità della sorella, che non sa convincersi di avere davanti chi da tempo attendeva, e l'impazienza del fratello, teso alla missione da portare a compimento (vv. 212-224): Oreste: Prega che la sorte ti sia propizia anche in futuro, e proclama agli dei che i tuoi voti si sono compiuti, (fa per avvicinarsi alla sorella, che invece si ritrae) Elettra: Perché, che cosa ho ottenuto io. ora. dagli dei? Oreste: Hai davanti agli occhi chi invocavi poco fa. Elettra: E chi sai, tu, che io invocavo? Oreste: Oreste, lo so, e con grande affetto. Elettra: E in qual modo sarebbero state esaudite, le mie preghiere?
Oreste: Sono io: non cercare chi ti sia più caro. Elettra: Straniero, una rete d'inganno tu mi tessi intorno? Oreste: Contro me stesso tramerei l'insidia. Elettra: Certo tu vuoi ridere delle mie sventure? Oreste: Riderei anche delle mie, allora. Elettra: Sei Oreste... con questo nome ti debbo chiamare?
3.3.3 Tipologie compositive: la sticomitia La momentanea opposizione fra i due, destinata ben presto a risolversi in una totale comunanza d'intenti, è espressa attraverso una peculiare forma di scambio dialogico, onnipresente nella tragedia greca e del tutto rispondente ai canoni di elevata formalizzazione e di ricercata armonia che la caratterizzano: la sticomitia, ossia uno scambio di battute di un verso ciascuna (in senso stretto; in senso lato si chiama sticomitia anche l'alternanza di battute di due versi, o quella di mezzo verso a testa, detta propriamente antilabé), che qui si limita a pochi versi, ma che può dilatarsi fino a comprendere intere scene o interi episodi. Regolarità di ritmo e concentrazione espressiva sono le caratteristiche degli scambi sticomitici, che creano strutture lucidamente simmetriche e di forte intensità drammatica, la cui estensione e portata drammaturgica vanno ampliandosi progressivamente, dalla serie di sette domande che la regina Atossa rivolge al coro di dignitari nei Persiani di Eschilo, ricevendone informazioni su Atene (vv. 231 -244; 472 a.C., la prima tragedia superstite), alle lunghe sezioni centrali delle Baccanti, l'ultima opera composta da Euripide prima di morire (406 a.C. ca.). La crescita d'importanza e d'estensione della sticomitia nelle sue varie forme (ossia del dialogo, poiché nella tragedia non esiste scambio dialogico che non sia sorretto da una struttura formalizzata), a spese della rhésis, non dipende però esclusivamente da una tendenza evolutiva del genere tragico in quanto tale, ma anche dalle tematiche e dalle tipologie di ogni singola tragedia: la sticomitia prevale laddove prevale l'azione e l'interazione fra esseri umani, della quale essa si mostra adeguato strumento, mentre predomina la rhésis dove predominano il racconto o il pathos, o dove l'eroe appare del tutto isolato, o concentrato sui suoi rapporti con il mondo divino più che con quello umano (come avviene soprattutto nelle tragedie di Eschilo anteriori all'Orestea), o dove lo scontro fra gli uomini incarna in realtà uno scontro fra idee. Questo accade in alcuni drammi di Euripide, caratterizzati da un'impostazione che si potrebbe definire "a tesi", in cui si assiste spesso a un agone, in cui ciascuno dei contendenti rappresenta un'istanza di carattere politico o sociale, come per esempio il confronto tra democrazia e tirannide, impersonato dai due fratelli Polinice ed Eteocle, figli di Edipo, nelle Fenicie (con significativa inversione delle relative posizioni, rispetto alle versioni eschilea e sofoclea, in cui Polinice era l'aggressore ed Eteocle il difensore della patria). Analoga situazione si riscontra nelle Supplici, nel contrasto fra Teseo e l'araldo di Tebe, che si oppone alla restituzione alle madri argive dei cadaveri dei caduti nella guerra dei Sette. Per contro, quando i rapporti umani sono al centro dell'attenzione, la sticomitia sembra imporsi come strumento privilegiato di relazioni interpersonali; parallelamente si assiste al suo progressivo affrancarsi dalla subordinazione drammaturgica rispetto alla rhésis o alle sezioni liriche e al suo svilupparsi in forme meno chiuse e meno rigide. Il passaggio dalla sezione precedente, qualunque essa sia, alla sticomitia, e da questa a quella successiva risulta generalmente mediato da gruppi di due, tre o quattro versi (detti rispettivamente "base" e "clausola"), destinati a introdurla o concluderla integrandola con più naturalezza nello sviluppo dell'azione; la rigida regolarità dello scambio di battute risulta spesso interrotta dall'inserimento di distici o tristici (battute di due o tre versi) o dell'antilabé (questa non in Eschilo). Ciò avviene nei momenti di maggiore pathos o dove si verifichi un'inversione di ruoli fra chi domanda e chi risponde o quando si manifesti una svolta tematica o drammatica. Queste ultime vengono appunto progressivamente a fare la loro comparsa anche nelle sezioni sticomitiche, mentre in un primo momento ne rimanevano tendenzialmente escluse: nei drammi più antichi di Eschilo infatti la sticomitia, tematicamente e funzionalmente unitaria, appare più come un'appendice statica, un complemento dimostrativo o una ripetizione di quanto già emerso in forma diversa per altra via. Tutt'al più essa si presenta come preparatoria di uno sviluppo destinato a compiersi
definitivamente solo con una successiva rhésis, come nella scena di riconoscimento fra Oreste ed Elettra citata poco fa: sarà solo con un discorso continuo, successivo allo scambio dialogico, che al fratello riuscirà di superare definitivamente le resistenze della sorella e indurla a riabbracciarlo. Proprio questa scena consente di affrontare un'altra delle più diffuse componenti tematiche della tragedia, una che trova nella sticomitia il proprio veicolo espressivo privilegiato, ossia appunto il riconoscimento.
3.3.4 Temi e motivi: il riconoscimento La situazione di base, sottoposta poi a infinite variazioni, specie in molte delle tragedie più tarde di Euripide (definite spesso per questo motivo "drammi ad intreccio"), è in sostanza quella presupposta dalle Coefore: due persone, legate da uno strettissimo rapporto di parentela (fratello e sorella, marito e moglie, madre e figlio) e separate per lungo tempo dai capricci della sorte o dalla crudeltà degli uomini, si scoprono infine felicemente riunite, non prima di avere però dovuto superare difficili prove, in primo luogo quella del vero e proprio riconoscimento, impegnativo specie quando entrambi risultino all'oscuro delle reciproche identità. La coppia così ricostituita deve normalmente a questo punto dare prova della propria ritrovata coesione sviluppando un piano d'azione contro un nemico comune: al riconoscimento segue quindi spesso la progettazione e l'attuazione di un intrigo, destinato per lo più a risolversi felicemente. Tutti questi stadi sono presenti già nella tragedia di Eschilo, in cui i due fratelli riuniti coalizzano le proprie forze contro gli assassini del padre per compiere la sospirata vendetta; essi furono poi in un certo senso canonizzati da Euripide, che ne fece uno schema ricorrente sul quale intessere molteplici variazioni. Poiché, come si è accennato parlando delle diverse tipologie di prologo, in queste tragedie euripidee il pubblico è stato preventivamente informato del risultato della vicenda, il suo interesse principale consiste proprio nel vedere non se, ma come i personaggi riescono a ricostruire le proprie identità, smarrite nell'imperversare del caso, attraverso i frammenti di verità che possiedono e che, spesso casualmente e inavvertitamente, si scambiano, e come poi a loro volta fanno uso dell'ambiguità del reale e delle possibili ambivalenze del linguaggio per ingannare gli avversari. Si tratta di un sofisticato divertimento intellettuale, offerto al godimento dello spettatore onnisciente alle spalle dei personaggi che conoscono solo una verità parziale; una sorta di gioco, fondato sulla complicità fra poeta e pubblico, che condividono lo stesso livello di informazione, nel quale parte essenziale del piacere consiste nella possibilità di seguire il formarsi e lo svilupparsi dei pensieri dei personaggi, offerta appunto dalla sti-comitia, che non si limita qui ad accompagnare il progredire dell'azione, ma lo promuove. Il faticoso emergere della verità o, viceversa, la concezione e l'attuazione dell'inganno sono seguiti passo passo nel loro nascere, attraverso il continuo ribattere di affermazioni e reazioni, di proposte e obiezioni, in un percorso emozionante lungo i processi mentali dei protagonisti. Non pare privo di interesse in questo senso sottolineare che nella tragedia di Eschilo, capostipite del genere ma parte di un organismo più ampio in cui il riconoscimento e l'intrigo sono mezzi e non fini, solo la breve sezione citata è in forma sticomitica, tutto il resto si svolge in forma di rhésis, sia il convincimento definitivo di Elettra, sia l'esposizione delle motivazioni e del piano di Oreste, sia, più avanti nella tragedia, il nucleo centrale dell'inganno ai danni della madre. Solo nel momento dello scontro decisivo, a carte ormai scoperte, fra vittima e carnefice, tornerà l'uso della sticomitia, in un confronto serrato destinato da un lato a ritardare, dall'altro a porre in evidenza il momento cruciale del matricidio. Comune ai tre tragediografi è poi la funzione primaria del dialogo sticomitico, ossia quella informativa: richieste o scambi di informazioni di qualunque tipo (compresi veri e propri interrogatori, come nella scena del processo contro Oreste nelle Eumenidi o nel corso dell'inchiesta condotta da Edipo sulla morte di Laio nell' Edipo re) sono il contenuto più frequente della sticomitia, fino al punto in cui essa viene a sostituire in questa funzione la stessa rhésis del messaggero, che espone le proprie notizie non con un discorso continuo ma in risposta alle domande di un interlocutore (come accade nell' Edipo re, all'arrivo del messo da Corinto che riferisce della morte del re Polibo, rivelando nel contempo a Edipo il fatto cruciale di essere un trovatello). Altre volte essa più semplicemente introduce il racconto del messo, anticipandone sinteticamente il contenuto, o lo riassume a favore di nuovi arrivati sulla scena, evitando così noiose ripetizioni. Molti altri contenuti sono naturalmente possibili, in primo luogo l'espressione di contrasti e dispute e i tentativi di persuasione, e in generale tutti i casi centrati sull'interazione fra due personaggi (lamento,
preghiera, saluto, consulto...), che viene segnalata anche a livello sintattico, oltre che strutturale: è normale nella sticomitia che i versi risultino connessi da riprese sia verbali che tematiche, dall'uso di particelle e congiunzioni, o addirittura che si trovino l'uno in dipendenza sintattica dall'altro per effetto di ellissi grammaticali che segnalano anche un'accelera?ione del ritmo, mentre una frase interrotta a fine verso può essere continuata dall'interlocutore o semplicemente ripresa e completata dal parlante dopo l'interruzione. In generale si può dire che la tendenza è da forme più rigide in Eschilo a una maggiore flessibilità in Sofocle, sia strutturale che tematica, con la creazione di un dialogo mosso e vario, in cui possono mutare argomenti e situazioni e dal quale emergono non solo i fatti, ma anche i caratteri dei personaggi, in forme dinamiche e liberamente orientate secondo le esigenze drammaturgiche, fino a veri e propri esempi di conversazioni a tre (Edipo re, vv. 639-648; Filottete, vv. 1288-1313; Edipo a Colono, vv. 820-832: con il corifeo, qui i parlanti sono addirittura quattro). Nelle tragedie di Euripide si assiste invece a un ritorno verso forme più rigorose ma di notevole estensione, talvolta in tetrametri trocaici anziché in trimetri giambici, con ampio uso deWantilabé, anche senza una precisa motivazione drammatica (ad esempio, l'espressione di intenso pathos, di emozione, di incapacità comunicativa, come di solito accade invece in Sofocle).
3.3.5 Temi e motivi: la supplica Una delle situazioni che meglio si prestano al ricorso alla sticomitia è quella della cosiddetta hikesía, ossia della supplica: si è già accennato all'esistenza di due tragedie intitolate appunto Supplici e, nonostante la differenza di argomento, non è difficile notare l'esistenza di uno schema comune, ricorrente peraltro anche in molte altre tragedie pur non esplicitamente intitolate in questo modo. La struttura è semplice, e può riguardare l'intero svolgimento della tragedia o anche una singola scena: in una situazione di grave pericolo, uno o più personaggi cercano rifugio presso un altare dove, grazie allo status di inviolabilità riconosciuto ai supplici, ottengono aiuto e protezione contro i propri persecutori. Corollario quasi inevitabile è quindi lo scontro fra il salvatore dei supplici e i loro persecutori, normalmente culminante nella sconfitta o nella ritirata di questi ultimi. Scenicamente si tratta di una situazione di notevole efficacia, che si può tradurre in un quadro altamente dinamico (i perseguitati si sottraggono con la fuga ad una minacciata violenza, cercando rifugio presso l'altare) o in una composizione statica, magari visibile ad apertura di dramma (e quindi da immaginare preesistente), come negli Eraclidi di Euripide (i discendenti di Eracle, che cercano protezione contro il malvagio re Euristeo), con il gruppo dei supplici già disposto presso l'altare. Un caso particolare di supplice, soprattutto per quanto riguarda le figure dei persecutori e del salvatore, nonché per le circostanze della messa in scena, è Oreste, il vendicatore delle Coefore che, al termine di quella tragedia, esce di scena in veste di esule, perseguitato dalle Erinni della madre uccisa. Egli ricompare nelle Eumenidi come supplice, prima in attesa di purificazione al santuario delfico, poi, dopo l'eccezionale rifocalizzazione scenica, in attesa di processo sull'acropoli di Atene, presso la statua della dea poliade.
3.3.6 Tipologie compositive: l'amebeo Molte delle situazioni ricorrenti nei drammi impostati sulla supplica (la preghiera dei supplici al salvatore, il tentativo di violenza da parte dei persecutori, lo scontro fra salvatore e persecutori) impongono quasi di necessità il ricorso allo scambio di battute, spesso teso e serrato come appunto si conviene alla sticomitia; altrettanto bene però si prestano all'impiego di un altro tipo di dialogo, detto amebeo, in cui gli interventi successivi degli interlocutori sono lirici e non recitati (se versi lirici e recitati si alternano si parla di amebeo epirrematico). Una definizione generale dell'amebeo potrebbe dunque essere quella di "sezione dialogata di una tragedia che consiste, in tutto o in parte, di versi lirici": si tratta di uno strumento di dialo-gizzazione dell'elemento lirico, e in quanto tale il suo contenuto può essere estremamente vario. Spesso inoltre non è semplice individuarne correttamente i confini, poiché la tendenza all'integrazione drammaturgica fa sì che esso sia introdotto e concluso da "proemi" e "clausole" appositamente designati allo scopo di provvedere un passaggio graduale e non traumatico. La parte lirica può essere strutturata in responsione strofica; in questo caso ogni strofe può essere unitaria, oppure può venire suddivisa fra i diversi interlocutori. Questi possono alternarsi in modo regolare (ad A
risponde sempre A, a B risponde B e così via, rispettando la responsione strofica) oppure sfalsato (ad A risponde B, a B risponde A); Lo schema può anche variare a ogni coppia strofica. Esistono anche costruzioni astrofiche, ossia senza responsione, ma anche qui ci sono principi di ordinamento strutturale precisi: essi risultano più evidenti nelle forme epirrematiche, poiché la presenza degli inserti recitati (la cui estensione può a sua volta essere sempre uguale oppure variare) aiuta a suddividere le sezioni, delineando simmetrie e corrispondenze. Euripide in particolare sfrutta a fondo questa possibilità, fino a dare vita ad un tipo particolare di amebeo epirrematico, detto appunto "euripideo", caratterizzato da regolarità dell'elemento recitato ed estrema libertà di quello lirico. Sofocle invece usa il cosiddetto "epirrema interno", ossia l'inserimento di una breve sezione recitata all'interno delle strofe liriche. Già da queste osservazioni emerge la varietà di forme in cui l'amebeo si può presentare, alla quale corrisponde la varietà dei contenuti possibili: si tratta di un elemento duttile, che può piegarsi a molteplici funzioni, anche perché diversi possono essere i personaggi coinvolti e le modalità della loro partecipazione. Un amebeo solo lirico coinvolge normalmente uno o più attori e il coro (solo Euripide ha amebei lirici fra attori senza partecipazione del coro); un amebeo epirrematico può coinvolgere due o anche tre attori (ma la voce lirica è comunque una sola), oppure uno o due attori e il coro: in questo caso occorre distinguere fra i casi in cui è il coro a proporre gli interventi recitati e quelli in cui invece la recitazione spetta all'attore. Per quanto legato alla tonalità lirica, l'amebeo può essere anche inserito nell'azione: sono per esempio tipiche le scene di uccisione in cui i lamenti del morente risuonano da dentro la skené, mentre un altro personaggio o il coro (o entrambi) rispondono dalla scena; così accade nella Medea, nel momento in cui l'eroina uccide i figli, o nell' Elettra di Sofocle e anche in quella di Euripide, quando Clitemnestra viene colpita a morte dalla vendetta di Oreste. Più in generale si trovano spesso, soprattutto in Sofocle, amebei decisamente improntati all'azione, anche concitata, di norma con il coro che ricopre la parte lirica e l'attore (o gli attori) quella recitata, come nell'Edipo a Colono, nel momento in cui Creonte tenta di sottrarre Antigone al vecchio Edipo il coro cerca di opporsi alla violenza. In alcuni casi la funzione può essere invece informativa, in sostituzione di una rhésis o di una sticomitia; oppure ancora l'amebeo può servire a concludere con una manifestazione di inaspettata gioia la tensione di una scena di riconoscimento. Comunque la presenza dell'elemento lirico comporta di norma una forte componente patetica, che risulta predominante in alcuni casi di amebeo solo lirico ad esplicito contenuto trenodico, ossia di lamentazione funebre. Così sono per esempio strutturati gli esodi dei Sette contro Tebe e dei Persiani di Eschilo, rispettivamente destinati a piangere la morte dei figli fratricidi di Edipo, Eteocle e Polinice, e la disfatta dell'esercito persiano a Sala-mina. In un caso le due sorelle dei defunti, Antigone e Ismene, nell'altro il re Serse in persona entrano in scena, facendo la loro prima e unica comparsa nella tragedia appositamente per questa scena finale, e guidano il coro nell'esecuzione di un lamento, detto commo (kommós). Esso comprende numerosi elementi di natura propriamente rituale, legati alle cerimonie di compianto funebre: la presenza di elementi brevi, succedentisi a un ritmo incalzante di botta e risposta, destinati a evocare il susseguirsi delle percosse che i dolenti si infliggevano nello svolgimento del rito, l'abbondanza di ripetizioni e di altre figure retoriche (antitesi, chiasmi, riprese concettuali, assonanze e allitterazioni), le esortazioni a piangere e a lamentarsi, come mostra un esempio dai Sette (vv. 961 sgg.): - Colpito colpisti. / Uccidesti e moristi. - Di lancia feristi. / Di lancia peristi. - Dolore procurasti. / Dolore patisti. - Giaci nella morte. / Hai dato la morte. - Scorra il lamento. / Scorra il compianto. -Ahimè! / Ahimè! - Delira la mente nel pianto. / Geme il cuore nel fondo.
- Ahi, ahi, tu degno d'ogni lamento. / E tu d'ogni compianto. - Dal fratello ucciso. / Il fratello uccidesti. - Male duplice a dirsi. / Male doppio a vedersi. - Dolori congiunti a dolori. / Dolori a dolori fratelli.
3.3.7 Temi e motivi: il lamento Questo del lamento è un altro dei più tipici elementi tematici della tragedia, sia specificamente legato al vero e proprio compianto funebre, sia genericamente destinato a esporre e compiangere una situazione infelice. Ancora in Eschilo un caso veramente eccezionale di commo è quello che occupa la parte centrale della tragedia centrale dell'Orestea, le Coefore: qui, in una struttura epirrematica di ampiezza e complessità senza pari, il coro di ancelle, Oreste ed Elettra si alternano in un compianto del defunto Agamennone nel quale al lamento per la morte del re e per l'infelice situazione dei suoi figli si mescolano la rievocazione della sua uccisione per mano della moglie infedele, l'invocazione dell'aiuto delle potenze infernali e dello spirito del defunto stesso e l'esortazione alla vendetta. In questo caso la voce recitante (più che di vera recitazione, bisognerà parlare di una forma di recitativo) appartiene alla corifea, altre volte è il coro a cantare mentre l'attore risponde recitando, oppure il coro reagisce liricamente a notizie o esortazioni espresse dall'attore. Si tratta in ogni caso di un confronto tra l'elemento patetico e quello logico-razionale, che ben si presta a scene di dialogo o di contrasto; non sempre si raggiunge in quest'ultimo caso fra i rappresentanti delle due diverse modalità espressive una convergenza, spesso ciò non è possibile finché entrambi non scendono sul terreno del verso recitato. Scopo di tali scene peraltro non è tanto quello di giungere a un risultato concreto, quanto quello di esplorare ed esporre tutte le diverse implicazioni e motivazioni di un'azione, rendendo in qualche modo evidenti gli stessi processi mentali o le reazioni emotive dei protagonisti. Esse sono frequentemente introdotte o concluse da rhéseis o sticomitie in cui le posizioni contrapposte vengono presentate o riassunte. Un confronto impossibile è spesso anche il contenuto dell'epirrema in cui attore e coro si fronteggiano a ruoli invertiti: di fronte all'effondersi in versi lirici della sofferenza dell'eroe, il coro incarna la voce sobria e razionale del mondo esterno, fino al caso estremo della straordinaria scena di possessione divina in cui nell'Agamennone la sacerdotessa Cassandra si abbandona al delirio profetico di cui Apollo la pervade, vaticinando (e anticipando così per il pubblico nella lucidità assoluta della sua visionaria follia) le morti ormai prossime di Agamennone e di lei stessa, mentre il coro ostinatamente rifiuta di accogliere nelle forme ordinate del proprio discorso in trimetri il devastante orrore della verità che Cassandra liricamente prospetta.
3.3.8 Temi e motivi: la follia Casi di follia e possessione divina non sono tra l'altro argomento infrequente sulla scena tragica: oltre alla stessa Cassandra, che ancora nelle Troiane di Euripide profetizza le prossime sciagure che attendono i conquistatori greci al loro ritorno in patria (primo fra tutti il suo nuovo signore, Agamennone), possiamo ricordare Aiace che, nell'omonima tragedia di Sofocle, viene indotto dall'ostile Atena a sterminare pecore innocenti, credendole greci sui quali vendicare l'affronto di non aver ricevuto in dono, quale guerriero più forte del campo, le armi del defunto Achille, o l'Eracle di Euripide, che la follia mandata dalla gelosa Era spinge a trucidare moglie e figli appena salvati da un mortale pericolo (Eracle), o l'Oreste dell'omonimo dramma euripideo, con la mente devastata dal rimorso per il matricidio, o ancora Penteo, il re di Tebe ostile a Dioniso, che il dio medesimo, nelle Baccanti di Euripide, spinge a mascherarsi da menade, solo per essere letteralmente fatto a pezzi dalle baccanti invasate, guidate dalla sua stessa madre Agave.
3.3.9 Tipologie compositive: la monodia Le strutture amebeiche in Sofocle ed Euripide finiscono spesso con una vera e propria monodia dell'attore, ossia un canto a solo, lo strumento espressivo più adeguato a dare voce alla tonalità del pathos in tutte le sue forme. La monodia si presenta in un certo senso come il corrispettivo lirico della rhésis: dotata di una discreta estensione e autonomia strutturale, essa consente al personaggio ampia espansione espressiva, quasi
esclusivamente destinata all'effusione del lamento e alla manifestazione dei sentimenti; drammaturgicamente essa funge da elemento ritardante e statico, di reazione a una certa situazione o di presentazione di un personaggio. Anche se non mancano casi di più stretta integrazione, magari ottenuti con l'inserimento di elementi narrativi o descrittivi del luogo o dell'azione che si viene svolgendo, la monodia di norma non contribuisce attivamente allo sviluppo drammatico, ma può tutt'al più rivelare i prodromi psicologici di una certa decisione o di un evento scenico, poi maturato e compiutamente espresso sul piano logico-razionale del verso recitato.
3.3.10 Temi e motivi: il sacrificio volontario Un caso significativo, anche perché consente di accennare a un elemento tematico ricorrente nel teatro euripideo, è in questo senso quello di Ifigenia, la giovane figlia di Agamennone e Clitemnestra, attirata con l'inganno al campo acheo ad Aulide per essere sacrificata sull'altare di Artemide, nell'Ifigenia in Aulide. Passata una comprensibile disperazione iniziale, con i relativi tentativi di ottenere dal padre una grazia, è l'eroina stessa, dopo una toccante monodia, a dichiarare in una lucida rhésis di sacrificarsi volontariamente per il bene dell'intera Grecia, offrendo la propria vita alla dea in cambio della partenza della spedizione verso Troia e della gloria immortale per sé. Non è l'unico esempio di sacrificio spontaneo in Euripide: come lei, si votano alla morte Alcesti, al posto del marito Admeto (Alcesti), la giovane Macaria, per garantire la vittoria ateniese contro i persecutori argivi dei supplici figli di Eracle (Eraclidi), il giovane Meneceo, per salvare Tebe dall'assalto dei Sette (Fenicie), l'infelice e orgogliosa Polissena, figlia di Priamo, che i greci vincitori vogliono offrire in espiazione alla tomba di Achille, al quale era stata un tempo promessa in sposa (Ecuba). Spesso introdotta da un recitativo, la monodia è ancora strettamente legata, in Sofocle, all'amebeo (di cui può costituire introduzione o conclusione), che ne facilita l'integrazione drammaturgica, mentre nelle tragedie di Euripide tende ad assumere autonomia e importanza sempre maggiori, coerentemente con la progressiva riduzione del ruolo corale. Formalmente essa ha tutte le caratteristiche della lingua lirica, nel metro, nella struttura, che può essere strofica o astrofica (specie in quelle introdotte da recitativo), nell'impiego del vocalismo dorico, nel ricorso a figure retoriche, ripetizioni, apostrofi, interiezioni che valorizzano la componente patetica. Raramente essa si trova a diretto contatto con una sezione recitata e quasi mai costituisce da sola una scena: la necessità di integrazione drammaturgica fa sì che la sua comparsa sia in qualche modo mediata, e sempre per questo motivo nessuna tragedia inizia o finisce direttamente con una monodia. Le forme più tipiche prevedono o che il cantore faccia il suo ingresso con la monodia (soprattutto nel prologo, dove essa ha evidente funzione di presentazione del personaggio), o che immediatamente prima del canto un altro personaggio esca di scena (il cantore, lasciato così solo, può dare libero sfogo al proprio dolore). La conclusione della monodia è normalmente segnata dall'ingresso del coro o di un altro personaggio che, convogliando su di sé l'attenzione, motivano a livello drammatico l'interruzione del canto e agevolano drammaturgicamente il passaggio alla sezione successiva. L'effusione lirica della monodia, tranne pochi casi, è destinata solo ai personaggi principali, normalmente donne: sono famose le arie delle eroine euripidee, spesso legate ad effetti scenici e mimetici di forte impatto emotivo, ricche di elementi patetici e di riflessioni personali, tanto più quando si tratta della vera e propria presentazione della protagonista del dramma o in quei pochi casi in cui l'intera vita scenica del personaggio si esaurisce in quella singola monodia, come Evadne, moglie del caduto Capaneo (uno dei sette condottieri della spedizione argiva contro Tebe), che per amore e per disperazione si getta sulla pira funebre del marito, nel finale delle Supplici euripidee (vv. 9901008): Che luce splendeva quel giorno / attraverso il carro del sole, / e la luna correva nel cielo / con rapidi bagliori nell'ombra, / quando la città di Argo / celebrava con canti le mie nozze / e chiamava felice il mio sposo, / Capaneo armato di bronzo! / Dalla mia casa di corsa a te, / come una menade folle, / io vengo cercando la pira, / cercando lo stesso sepolcro, / per sciogliere nell'Ade la pena / di una vita che è solo dolore: / perché la cosa più dolce è la morte / per chi muore insieme ai suoi cari, / se un dio a questo consente. / Un caso assolutamente eccezionale, infine, è quello offerto dallo schiavo frigio che, nell' Oreste di Euripide, giunge a riferire il fallito attentato alla vita di Elena, mezzo estremo escogitato dai figli di Agamennone per ottenere salvezza dall'adirato Tindaro, padre di Clitemnestra (che essi hanno appena ucciso) e di Elena: in luogo della tradizionale rhésis di un messaggero, una concitata scena lirica ricca di effetti mimetici (miranti a evocare la buffa parlata barbarica del servo) che accoglie in pieno le nuove tendenze musicali della fine del
secolo v. Il patetico si stempera nel burlesco, la forma tende a prendere il sopravvento sul contenuto, la ricerca di effetti scenici assume l'aspetto di un inserimento di pezzi virtuosistici, mentre nella progressiva dissoluzione delle forme tradizionali l'attore si avvia a diventare una star: la tragedia sta perdendo la sua fisionomia, altre realtà si affacciano alla vita teatrale.
3.4 II dramma satiresco Un'intera giornata di rappresentazioni tragiche era, per il pubblico, una prova impegnativa; dopo aver assistito per diverse ore al dipanarsi dei destini degli eroi, averli seguiti nel loro impari scontro con le imperscrutabili leggi della necessità divina o con gli imprevedibili capricci della sorte, aver temuto e sofferto con loro, partecipato dei loro dilemmi e patito le loro angosce, gli spettatori meritavano certamente un poco di ristoro, qualcosa che alleggerisse l'animo dai turbamenti della giornata: questo era appunto il ruolo del dramma satiresco. Che a un "pezzo" serio e impegnativo ne segua uno giocoso non è un fatto inconsueto nella prassi teatrale anche di epoche posteriori; un aspetto singolare del teatro greco (e di quello classico europeo, che da quello greco direttamente deriva) è piuttosto il fatto che le due realtà esistano l'una a fianco dell'altra, anziché risultare in qualche modo mescolate. La tragedia attica esclude dal proprio ambito ogni concessione al registro comico, nessun abbassamento di livello drammatico è consentito, nessun allentamento della tensione patetica. Eppure non doveva essere così all'inizio: secondo la testimonianza di Aristotele nella Poetica, la tragedia sarebbe stata anzi in origine qualcosa di molto diverso da ciò che siamo venuti delineando nelle pagine precedenti, qualcosa di più simile ad una pièce brillante, che egli definisce «satiresca e alquanto orientata alla danza». Che cosa esattamente ciò significhi non è chiaro, ma a quanto pare questo elemento brioso e "satiresco", una volta eliminato definitivamente dalla tragedia nel momento in cui questa assunse la forma che anche noi conosciamo, fu in qualche modo recuperato con l'introduzione nel concorso del dramma satiresco. Secondo la tradizione fu Pratina l'autore di questa "invenzione", collocata sul finire del secolo vi a.C., e che avrebbe dovuto rispondere anche all'esigenza di reintrodurre nella festa dedicata a Dioniso proprio quell'elemento dionisiaco che la tragedia stessa era invece andata via via perdendo, parallelamente alla sua progressiva trasformazione in un "pezzo" rigorosamente serio. Pur con tutte le cautele necessarie alla corretta valutazione di quanto viene riferito dalle fonti antiche, alcuni elementi appaiono certi: è proprio nella realtà degli agoni drammatici che si possono cogliere due aspetti fondamentali e complementari che aiutano a definire un genere sfuggente come il dramma satiresco, del quale non rimane che un'opera completa (il Ciclope di Euripide), un certo numero di frammenti di qualche altra (i Cercatori di tracce di Sofocle, i Pescatori con la rete di Eschilo), numerosi titoli e poco di più. Anzitutto, il fatto stesso che il dramma satiresco fosse rappresentato nell'ambito della giornata tragica, e che fosse composto dal medesimo autore della trilogia che concludeva, sottolinea con chiarezza che esso si pone in rapporto diretto con la tragedia: un rapporto che è evidentemente di opposizione (e questo è l'altro punto essenziale), anzi per essere precisi proprio di rovesciamento, ma che risulta innegabile, tanto più se lo si confronta con la commedia. Il dramma satiresco utilizza infatti le medesime strutture formali e, in larga misura, i medesimi personaggi e temi della tragedia, mentre la commedia si caratterizza per elementi drammaturgici propri e fortemente connotati, oltre che per la presenza di personaggi appartenenti al mondo "reale" anziché a quello eroico, per il frequente riferimento a fatti contemporanei e per l'uso di trame originali. Il dramma satiresco ha dunque come referente esplicito la tragedia, rispetto alla quale si definisce in un rapporto di progressiva differenziazione da un lato e assimilazione dall'altro: se la tragedia conquista la propria "vera natura", come dice Aristotele, staccandosi dall'originario elemento "satiresco", quest'ultimo torna a vivere negli agoni come contraltare della tragedia stessa, della quale assume personaggi e struttura. Dunque, nel dramma satiresco agivano ancora gli stessi eroi tragici che animavano la tragedia e le trame attingevano allo stesso repertorio mitologico; anzi, non mancavano casi di vere e proprie tetralogie legate: a conclusione della trilogia di Eschilo costituita da Laio, Edipo, Sette a Tebe era posto il dramma satiresco Sfinge, in cui evidentemente tornavano temi e personaggi della medesima vicenda mitica. Qual era dunque la differenza? Il coro di satiri, ovviamente. L'effetto di «tragedia giocosa» (la definizione è ancora di un autore antico, Demetrio) che il dramma satiresco doveva sortire, a ristoro e refrigerio degli animi degli spettatori, messi a dura prova dall'intensa partecipazione emotiva ai travagli della scena tragica, era ottenuto appunto
dall'incongruo inserimento all'interno del tessuto eroico di questo elemento straniarne, che determinava di per sé un effetto di aggressione comica al mondo della tragedia. Di fronte all'eroe tragico, che della sua provenienza mantiene dignità e dizione, è posto una specie di specchio deformante, un coro di creature semiferine e grottesche, caratterizzate dall'entusiastica adesione a tutti i più primordiali e meno onorevoli istinti: ingordi di cibo, vino e sesso, codardi e servili con i forti e arroganti e maneschi con i deboli, fanfaroni e mentitori, i satiri e il loro padre Sileno, che funge da corifeo, si intrufolano nel mondo tragico con risultati dirompenti, anche dal punto di vista strettamente drammaturgico. Formalmente infatti il dramma satiresco impiega i medesimi elementi strutturali della tragedia, ma distorcendoli in funzione comica: dal linguaggio (quello dei satiri), che appare nettamente più colloquiale, ricco di vistosi doppi sensi e di riferimenti alla sfera del quotidiano, anche nei suoi aspetti più bassi, alla struttura metrica, che si concede libertà inaccettabili in ambito tragico e appare assai semplificata nelle parti corali (normalmente non strofiche), per continuare con la stessa presenza scenica dei satiri, non solo caratterizzata dal bizzarro costume con orecchie e coda di cavallo e smisurato fallo, ma anche da danza, posture e movenze del tutto in contrasto con la dignità tragica (per esempio, nei Cercatori di tracce di Sofocle essi apparivano in atteggiamento di segugi, chini al suolo a cercare le tracce dell'armento di Apollo trafugato da Ermes bambino). Ma nemmeno le strutture più profonde della tragedia restano immuni dal giocoso dilagare della sdrammatizzazione satiresca: tutti gli elementi costitutivi sono infatti presenti (prologo, parodo, stasimi e così via), anche se quasi irriconoscibili per una notevole accelerazione del ritmo (il dramma satiresco è di norma assai più breve della tragedia) e una significativa disubbidienza a quel complesso di regolarità strutturali che abbiamo cercato di tracciare nelle pagine precedenti. Insomma, le diverse componenti della tragedia sono più accennate che compiutamente sviluppate, e inoltre risultano mescolate con elementi di generi diversi, anch'essi appena allusi in una sorta di parodico pastiche evidentemente destinato al godimento di spettatori competenti, capaci di riconoscere e di apprezzare la mescolanza, proprio in contrasto con le forme rigorose della tragedia. Così, per fare solo qualche esempio, si mantengono nel dramma satiresco tutte le componenti della struttura tragica, come rhésis, sticomitia, amebeo, ma spesso direttamente accostate l'una all'altra senza il ricorso a quegli elementi di transizione e preparazione che caratterizzano l'armoniosa tessitura tragica, o collocati laddove in una tragedia normalmente non si trovano; il contrasto e l'opposizione sembrano anzi tratti connotativi del genere, che del resto vive sull'effetto reciprocamente straniarne sortito dall'accostamento di due mondi fra loro incongrui come l'eroico e il satiresco. Non è inoltre infrequente nei corali il ricorso a ripetizioni, ritornelli e in generale elementi propri di altri generi lirici (inno, epitalamio, canto simposiale) o addirittura riconducibili alla tradizione popolare (veri e propri canti di lavoro). La forte presenza di componenti che si potrebbero definire folklori-che è d'altronde uno degli aspetti più tipici del dramma satiresco, anche a livello di contenuti: a parte l'obbligatorio lieto fine, esso è popolato da creature mostruose di chiara impronta fiabesca (a partire dai satiri stessi), specialmente da orchi o mostri di varia natura (primo fra tutti appunto il Ciclope), che normalmente fungono da "cattivi". Contro di essi lotta l'eroe, per lo più caratterizzato da tratti di bricconeria o furbizia che sarebbero poco apprezzati in ambiente tragico (e spesso infatti si trovano come protagonisti personaggi del calibro di Odisseo, Sisifo, Autolieo, Ermes, Edipo, noti per la loro intelligenza ma anche per i loro modi, se così si può dire, disinvolti), ma che qui sono necessari per ordire la beffa destinata a sconfiggere il cattivo. Quest'ultimo spesso si connota in quanto tale per una violazione delle leggi dell'ospitalità, e normalmente tiene prigionieri i poveri satiri, la cui liberazione corona il finale: essi potranno così tornare all'agognato servizio presso il loro signore "naturale", Dioniso. Così accade per esempio nel Ciclope di Euripide, dove i satiri sono appunto schiavi del mostruoso Polifemo, dal quale potranno fuggire grazie all'intervento di Odisseo che. come da copione, lo acceca dopo averlo fatto ubriacare. Qualche volta invece sono loro a volersi allontanare da Dioniso, come negli Spettatori ai giochi Istmici di Eschilo, dove essi decidono di recarsi a gareggiare alle Istmie, salvo poi desiderare di tornare da lui al più presto; altre volte fuggono essi stessi da "cattivi" della situazione, insidiando magari la virtù di qualche malcapitata eroina, come nei Pescatori con la rete, dove Sileno tenta di sedurre Danae, ripescata dal mare insieme al figlioletto Perseo solo per incorrere in questo nuovo pericolo. Accanto a personaggi ed elementi di carattere magico e fiabesco, non mancano infatti tratti di un gusto più materiale: ghiottoneria, scurrilità, infingardaggine si sprecano, specie da parte dei satiri - ma sono peccatucci veniali, all'interno di un ordine cosmico che resta saldo e non problematico: i buoni sono buoni e i cattivi cattivi, non ci sono dilemmi morali qui, solo un sano desiderio d'evasione (messa letteralmente in atto nella finale e liberatoria fuga dei satiri dall'orco) al quale normalmente risponde l'ambientazione campestre o esotica, ma comunque remota dal mondo cittadino, protagonista quasi assoluto tanto della tragedia quatto della commedia. Si tratta in sostanza di un mondo a metà fra il fiabesco e il romanzesco, dominato da una visione ottimistica e
semplificata della vita, con un tono medio in cui forse gli spettatori potevano più facilmente riconoscersi che non nelle sublimità della tragedia, senza peraltro smentirne il messaggio: nonostante tutto, i satiri (specie il vecchio Sileno) possedevano, nella tradizione, anche un'impronta sapienziale e pedagogica, accanto a quella furfantesca e oscena. Il dramma satiresco non è dunque una derisione della tragedia dall'esterno: è la tragedia stessa che si prende gioco di sé, senza sconfessarsi, ma solo per riposarsi un po'. Era tanto legato a questa sua funzione postcatartica, il dramma satiresco, che non sopravvisse al mutare dell'atteggiamento emotivo del pubblico nei confronti della scena tragica: con la progressiva evoluzione della tragedia in senso spettacolare e divistico, a spese di quella "pietà e terrore" che. secondo Aristotele, essa doveva Suscitare negli spettatori per purificarli, la necessità della "boccata d'aria" finale dovette essere sempre meno avvertita, finché l'occasione concreta della sua scomparsa non fu forse offerta, all'epoca della guerra del Peloponneso, dalla riduzione delle giornate del concorso drammatico da cinque a tre, con la rappresentazione di una commedia al termine di ogni trilogia tragica. Già dal 438 a.C. almeno il dramma satiresco aveva dovuto subire la concorrenza della tragedia stessa: in quella data fu infatti rappresentata, come quarto dramma di una tetralogia, la tragedia Alcesti di Euripide, ricca di per sé di elementi contenutistici non lontani da quelli tipici del dramma satiresco (Eracle, un Eracle dai tratti goderecci e buffoneschi, lotta con il demone della morte, Thanatos, per riportare in vita Alcesti, moglie del suo ospite Admeto, che aveva accettato di morire al posto del marito). Difficile dire in questo caso se sia stata la tragedia a subire l'influsso del dramma satiresco del quale qui detiene il posto, adottandone le tematiche, o il dramma stesso a subire l'influsso della tragedia al punto di perdere il suo elemento più tipico, ossia appunto il coro di satiri; a ogni modo, le ultime notizie conosciute del dramma satiresco riguardano un'epoca decisamente posteriore, quando, dopo la metà del secolo iv, esso sembra ormai del tutto svincolato dalla tragedia e anzi assimilato piuttosto alla commedia, in quanto contenitore di satira d'attualità. Ecco che dal "dramma satiresco" si è passati alla "satira": il tempo dei satiri è ormai tramontato.
4. La commedia di Silvia Romani
4.1 Una riflessione preliminare Nella storia del teatro, antico e moderno, non vi è nulla che possa essere equiparato - sul piano della drammaturgia - all'esperienza artistica della commedia antica, in particolare di chi ne fu, per noi, il principale portavoce, Aristofane. Non si tratta di assegnare ad Aristofane la palma dell'eccellenza artistica, quanto piuttosto di mettere in luce la consapevolezza straordinaria con cui l'artista guardò ai meccanismi e alle strategie comunicative che presiedono alla realizzazione dell'opera drammatica. Nonostante l'assoluta genialità della sua vena poetica, le liste degli agoni drammatici ci raccontano che Aristofane non fu sempre primo nei concorsi e anzi, come egli stesso sottolinea (per esempio nella pa-rabasi delle Nuvole), gli vennero spesso preferiti altri colleghi degni, a quanto ci è dato di sapere, di plauso ed elogi per la grandezza della loro opera. Ma nulla di tutto quanto circondava Aristofane, opere e artisti, ci è giunto se non per scarni frammenti, sui quali è impossibile lavorare per ricostruire un percorso artistico e una drammaturgia precisa. La commedia antica è dunque sostanzialmente perduta, così come la sezione a essa dedicata della Poetica aristotelica, il cui contenuto avrebbe certo potuto illuminare le ombre che si allungano intorno alla solitaria figura di Aristofane. Non è tuttavia un vuoto disperante, poiché la ricchezza dell'opera aristofanea è tale da permetterci di ricostruire, con discreta precisione, la drammaturgia della commedia antica e di osservare, sempre attraverso la lettura dei testi di Aristofane, il passaggio dalla commedia antica a quella di mezzo, nonché i prodromi della nascita della commedia nuova (che sopravvive grazie al salvataggio, seppur parziale, delle opere di Menandro). Questo accade perché Aristofane non fu semplicemente un poeta comico, ma un innovatore geniale e un teorico delle strutture che presiedono alla realizzazione dell'opera drammatica: sperimentò sempre nuovi linguaggi, nuove forme espressive e, soprattutto, riuscì a portare sulla scena opere che spesso non furono semplicemente l'esecuzione di un'idea comica, ma una riflessione sui meccanismi che permettono a tale idea
di divenire intreccio e di divenire teatro. Da questo punto di vista, la commedia antica di Aristofane si discosta totalmente dall'esperienza della tragedia del secolo v, poiché si offre al pubblico non soltanto come evento artistico, ma anche come filtro che ci consente di decifrare e comprendere il processo attraverso cui l'invenzione dell'artista si concretizza nell'opera teatrale. È cioè lo stesso poeta a fornirci le chiavi interpretative per comprendere la sua drammaturgia, come dimostra, per esempio, in modo assolutamente chiaro, il prologo delle Rane, una delle ultime commedie messe in scena da Aristofane. Rappresentate nel gennaio del 405 a.C., alle feste Lenee, le Rane sono un caso assolutamente unico, per la complessità e la raffinatezza delle idee comiche che in esse si realizzano. Il primo elemento inconsueto è costituito dalla scelta del protagonista, identificato in Dioniso, dio dell'ebbrezza, ma soprattutto del teatro. Un dato significativo è anche il movente principale dell'azione: la nostalgia per l'epoca d'oro della tragedia, appena conclusasi con la morte di Sofocle, l'ultimo ad andarsene, del trittico rappresentato da Eschilo, Sofocle ed Euripide. Proprio spinto dalla mancanza di quell'epoca ormai perduta, Dioniso decide di scendere nel mondo degli Inferi (parodiando viaggi compiuti da celebri eroi) per cercare di riportare in vita Euripide e, con lui, l'arte drammatica. Per compiere questo percorso insidioso si presenta, in compagnia del proprio servo Xantia, issato in bilico sulla groppa di un asino, alla porta della casa di Eracle, al quale vuole strappare la "mappa" del mondo infernale e qualche consiglio utile per uscire incolume dalle innumerevoli insidie del regno delle Ombre. La chiave per comprendere il carattere esemplare di questa commedia si trova nella scena iniziale, orchestrata dal poeta per provocare nel suo pubblico riso e nel contempo un vago senso di disorientamento. Di fronte agli occhi stupiti degli spettatori ateniesi si presentò, infatti, una figura dai vaghi contorni imprecisi che indossava i coturni, i calzari tipici della tragedia, e una veste color zafferano, di quelle che indossavano gli attori tragici. Su questi abiti, che richiamano il mondo "alto" della tragedia, lo strano personaggio portava di sghimbescio una pelle di leone e brandiva un'enorme clava: elementi che alludevano alle "insegne" di Eracle e al suo trionfo contro i mostri sconfitti nelle dodici imprese. Il risultato finale è tuttavia un'accozzaglia magmatica di elementi diversi, in cui a stento si può riconoscere la fisionomia di un unico personaggio e di un unico ruolo. L'effetto straniarne si doveva accentuare quando Dioniso bussava con forza (siamo alle prime battute del dramma) alla porta di Eracle e ad aprigli giungeva proprio l'eroe, colui al quale il dio tentava di assomigliare, per poter penetrare senza pericoli nel mondo minaccioso degli Inferi. A questo punto, due personaggi si fronteggiavano e fronteggiavano il pubblico: l'uno l'immagine distorta e sbavata dell'altro. Ed è proprio a quest'ultimo, a Eracle appunto, che spettava il compito di esprimere le sensazioni che anche il pubblico nel teatro doveva provare, riso e sconcerto: Come faccio a non ridere se vedo una pelle di leone, buttata sopra la veste zafferano? Che ti passa per la testa? Cosa significano il coturno e la clava portati a braccetto? Dove te ne vai? (vv. 45-48) In questa scena, lo spettatore moderno, nonché, a maggior ragione, quello antico trovano già alcuni fili fondamentali che formavano la trama comica antica: in particolare, il rapporto tutto speciale con il pubblico e con l'illusione drammatica, l'interesse per il teatro in quanto oggetto che nelle Rane diviene, di fatto, uno dei protagonisti dell'azione. Quest'attenzione per la costruzione della macchina drammatica è presente anche nelle prime battute con cui il servo Xantia entra in scena: «Devo dire una delle solite battute, padrone, di quelle che fanno ridere il pubblico?». Da queste parole, gli spettatori riuniti nel teatro venivano a sapere che i due stralunati personaggi (simili probabilmente nella coreografia della loro immagine a Sancho Panza e Don Chisciotte) erano un servo e un padrone, ma anche che uno dei due stava parlando proprio del pubblico e si interrogava su quale fosse la battuta migliore con cui fare l'ingresso in scena. In questo modo, Aristofane forniva i primi indizi per comprendere la trama che si andava delineando, ma usciva nel contempo fuori dal tessuto della commedia per alludere a individui (gli spettatori), che di tale tessuto non facevano parte e dal quale dovevano per forza di cose rimanere estranei. L'esordio delle Rane rappresenta perciò sia il prologo di un dramma comico sia il prologo di una riflessione generale sul comico (e sul teatro, come avremo modo di scoprire): su ciò che fa ridere e su quanto un autore, o un attore, deve fare per riuscire a carpire il plauso del pubblico. Nelle Rane si ragiona cioè fin da subito di
drammaturgia, non soltanto attraverso l'ingresso di Xantia, ma anche attraverso la complessa simbologia che definisce Dioniso, il personaggio principale del dramma. Questi non interpreta un semplice carattere drammatico (su tale nozione torneremo), ma è egli stesso simbolo del teatro, in quanto suo nume tutelare. Di fronte alle gradinate su cui sedeva il pubblico, fra l'altro, e di fronte alla scena in cui si muovevano gli attori, c'era uno scranno sul quale sedeva, tradizionalmente, proprio il sacerdote di Dioniso, in funzione di rappresentante mortale del dio. A un certo punto delle Rane (v. 297), il personaggio Dioniso si rivolge addirittura al proprio sacerdote, invocandone la protezione nel momento del pericolo. Questa super-identità di Dioniso (un attore che impersona un personaggio comico che è proprio il dio del teatro) si arricchiva ulteriormente di un altro "strato": quello rappresentato dall'abbigliamento tradizionale di Eracle, gettato un po' a casaccio sopra la tunica zafferano. Gli spettatori dunque sapevano che chi entrava in scena era un attore vestito da Dioniso, che a sua volta si era vestito da qualcun altro. L'effetto doveva essere disorientante, ma serviva a riportare direttamente il pubblico alle radici dell'invenzione drammaturgica. Doveva cioè ricordare il carattere fittizio su cui si basava - e si basa naturalmente - ogni testo teatrale: ciò che accade di fronte agli spettatori è una finzione, l'attore indossa una maschera che non corrisponde alla sua identità reale e che a essa mai allude. Il compito di chi stava seduto sulle gradinate polverose di un teatro ateniese nel mese di gennaio era dunque quello di accondiscendere a tale finzione e di crederla, anche se per poco, vera. Queste osservazioni fanno emergere un elemento importante che permette fin da subito di stabilire una profonda differenza fra la drammaturgia comica e quella tragica: la tragedia portava di fronte agli occhi del pubblico una trama che sostanzialmente riproponeva racconti del mito assai noti a chi partecipava agli spettacoli teatrali. L'accento veniva posto non certo sulle novità dell'intreccio, ma sulla modalità con cui una serie di eventi, conosciuti agli spettatori, venivano portati in scena. Per fare soltanto un piccolo esempio, il pubblico dell'Aiace di Sofocle conosceva la biografia mitica dell'eroe protagonista e intuiva come si sarebbero evolute le vicende del dramma: Aiace diviene folle per opera di Atena, fa strage di buoi e pecore, credendo di uccidere guerrieri greci; tornato in sé, si suicida in preda alla vergogna. Al contrario, chi presenziava alle rappresentazioni comiche non poteva conoscere anzitempo i protagonisti degli Acarnesi, dei Cavalieri, degli Uccelli di Aristofane o della Samia di Menandro. E anche quando tutti gli attori fossero stati presenti in scena e avessero dichiarato la loro identità drammatica, lo spettatore non sarebbe stato in grado di prevedere cosa avrebbero fatto e quali sarebbero stati gli esiti delle loro azioni. Per tali ragioni, il pubblico delle Rane entrava in teatro impreparato: non sapeva chi vi avrebbe trovato e cosa avrebbe fatto; non aveva cioè un codice preesistente utile a comprendere cosa ci facesse un attore vestito da dio, travestito da eroe di fronte alla porta di un altro eroe, Eracle. Quest'assoluta novità e originalità della trama comica deve sempre essere tenuta presente quando si legga o si assista alla rappresentazione di una commedia antica, soprattutto nel caso delle opere di Aristofane, poiché per la commedia nuova (sopravvissuta nelle creazioni di Menandro) si assiste a una progressiva "normalizzazione" della trama e all'uso di canovacci narrativi ben più codificati e ripetitivi di quelli aristofanei.
4.2 II tessuto formale La commedia antica basa la sua struttura, così come accade nella tragedia, su un'alternanza fra sezioni recitate e sezioni cantate. A questa scansione strutturale ne corrisponde una analoga sul piano del contenuto: a certe porzioni del dramma, e ai metri in cui queste vengono presentate sulla scena, corrispondono determinati tipi di contenuto. Nonostante questa regolarità di fondo, non è tuttavia possibile presentare per la commedia greca una griglia generale alla quale sia possibile assoggettare tutte le commedie in nostro possesso. Le prime commedie di Aristofane non hanno, infatti, la medesima struttura delle sue ultime né, tantomeno, Menandro compose commedie che seguivano la partizione dell'opera del suo predecessore. Inoltre, anche qualora si decida di isolare soltanto un periodo, per esempio la commedia antica, sarà difficile rintracciare una struttura fissa e invariabile a cui Aristofane abbia piegato tutte le sue creazioni poetiche. Quando parliamo di "forma" di una commedia antica e analizziamo le sue componenti, siamo costretti perciò a descrivere uno schema sottoposto a numerosissime eccezioni e a variazioni sul tema. Si deve dunque ribadire - per la commedia antica - il medesimo concetto già espresso per quanto riguarda il suo contenuto: contrariamente a quanto accade nella tragedia, la cifra caratterizzante della commedia di Aristofane era l'imprevedibilità, anche a livello formale. Ciò non significa, naturalmente, trovarsi nell'impossibilità di presentare alcune indicazioni di carattere
generale: anzi le opere della commedia antica presentano analogie strutturali molto evidenti. Si tratta di opere scandite da una partizione in tre singole unità: la parodo, il momento in cui propriamente il coro fa il suo ingresso sulla scena; l'agone, il luogo per eccellenza in cui i due antagonisti della trama comica si oppongono e lottano per prevalere; e la parabasi, il cui valore e il cui significato sono impossibili da definire in poche righe, ma che certamente rappresenta un unicum nella drammaturgia antica. È l'occasione in cui il coro cessa di agire all'interno della vicenda comica e si presenta agli spettatori senza la maschera, al di fuori del suo ruolo. Accanto a queste tre grandi divisioni, che possono comparire nella commedia nell'ordine in cui le abbiamo proposte o possono essere parzialmente invertite o sostituite, vi sono altre singole unità drammatiche che talvolta servono da introduzione o corollario alle scene principali, o rappresentano pezzi di raccordo fra una sezione e un'altra. Dei singoli aspetti di ogni porzione della commedia parleremo fra poco, per ora è importante segnalare che parodo, agone e parabasi subirono nel tempo una serie di cambiamenti, il più importante dei quali riguarda la parabasi che, negli ultimi drammi di Aristofane (Ecclesia-zuse e Pluto), venne eliminata e mai più riproposta nella commedia di mezzo o in quella nuova.
4.2.1 Le sezioni iniziali: prologo e parodo Dal punto di vista tematico, il prologo della commedia antica manifesta fin da subito la natura utopica del progetto dell'eroe: viaggi verso il cielo, nuovi regni, paci miracolosamente guadagnate, espedienti bizzarri e grotteschi. Questo sipario alzato sulla fantasia sembra essere stato un elemento caratteristico non soltanto delle commedie di Aristofane, ma anche di quelle a esse contemporanee di cui sopravvivono soltanto titoli e frammenti: basti pensare a opere come i Pluti e il Dionisalessandro di Cratino, o ai Demi di Eupoli. Questa porzione di dramma rappresenta una sezione a sé stante, distinta dai blocchi successivi di parodo, agone e parabasi anche dal punto di vista metrico. Composto di trimetri giambici, un metro considerato assai vicino alla lingua parlata, il prologo aristofaneo accoglie abitualmente l'esposizione dell'idea comica, che diverrà il perno su cui ruoterà la vicenda. Arricchiscono la scansione della scena battute di ogni genere, talvolta anche slegate dal tessuto della trama, attraverso cui l'autore, per bocca dei suoi personaggi, tenta di ingraziarsi la benevolenza del pubblico o semplicemente di provocare il suo riso. Un esempio classico di prologo è rappresentato dalla Pace, in cui due attori, che interpretano il ruolo di personaggi secondari, entrano in scena per raccontare al pubblico quanto è già accaduto e quanto sta per accadere. Si tratta di un esordio in medias res: il prologo del dramma non coincide cioè con l'inizio della vicenda, bensì si colloca a un certo livello dell'intreccio e chiarisce quanto agli spettatori non è dato di conoscere, perché avvenuto in uno spazio e in un tempo estranei alla scena. Messa in scena alle grandi Dionisie del 421 a.C., la Pace è, fra l'altro, una delle commedie superstiti in cui più evidente è il ricorso alla cifra del fantastico e al linguaggio dell'utopia. La Grecia era allora, come negli anni delle Rane, profondamente segnata dal conflitto fra Atene e Sparta, nel quale erano morti, l'anno precedente alla rappresentazione, due generali di grande valore: Cleone, sul fronte ateniese, e Brasida, su quello spartano; Atene aspirava alla pace e proprio di quest'istanza si fa interprete Trigeo, l'eroe della commedia. Dal prologo tuttavia Trigeo è assente, mentre dominano la scena due servi, che si presentano agli occhi del pubblico con un enorme mastello di letame: uno dei due sta preparando focacce, impastate nientemeno che con lo sterco, mentre l'altro sta disperatamente tentando di calmare il ventre vorace di un enorme scarabeo, al quale getta in continuazione le puzzolenti palle che il suo collega prepara. I due parlano fra loro e inframmezzano questo dialogo con frequenti appelli al pubblico, perché giunga in aiuto e li sollevi da un incarico tanto gravoso: dalle parole dei poveretti emergono gli elementi fondamentali per comprendere l'antefatto della scena che si sta svolgendo, ma anche gli indizi per decifrare gli eventi successivi. Il loro padrone, Trigeo, è impazzito e da giorni non fa altro che progettare un viaggio in cielo, dove vorrebbe chiedere a Zeus la ragione per cui ha abbandonato i greci a una guerra tanto crudele e inutile. Un primo tentativo, quello di costruire una scala con migliaia di pioli per raggiungere le "alte sfere", è miseramente fallito, e ora una nuova idea si è affacciata alla mente dell'eccentrico viticultare ateniese: quella di utilizzare un enorme scarafaggio per volare sull'Olimpo e presentare il suo esposto al signore degli dei. I due servi considerano il progetto una follia, ma nel frattempo sono obbligati a nutrire l'odioso animale. A nulla poi valgono i tentativi di fermare Trigeo, portati innanzi dalle figlie e dai servi stessi: l'eroe parte per l'Olimpo in groppa al suo scarafaggio, come se si trattasse di Pegaso, il cavallo alato di Bellerofonte, e ondeggia nello spazio di cielo sopra la scena, portato in alto
dall'artificio della mechané, finché non dichiara di essere giunto proprio alla dimora degli dei. Sulla porta gli si fa incontro effettivamente un dio, Hermes, il quale prima lo rimprovera per essere salito fin lì, e poi gli racconta che Pace, a cui il vignaiolo sembra tanto tenere, viene tenuta in ostaggio da Guerra in un antro profondo. L'intera scena, che si dilata per circa 300 versi, fino all'ingresso del coro festante, presenta tutti gli elementi tradizionali del prologo comico e ha il compito fondamentale, com'è evidente dalla descrizione del suo svolgimento, di informare gli spettatori sullo status quaestionis: su chi hanno di fronte e su chi entrerà in scena, su cosa potrà accadere nei versi successivi. La Pace rappresenta tuttavia soltanto una delle modalità di presentazione del prologo aristofaneo. Spesso è proprio il protagonista della commedia a entrare in scena e a raccontare, attraverso un soliloquio o un dialogo con un altro personaggio, alcuni elementi fondamentali della narrazione. In quest'ultima categoria si situa il prologo delle Rane, in cui Dioniso, l'eroe della commedia, presenta se stesso e il servo Xantia fin dai primi versi. Ottimi esempi del tipo di prologo in cui il o i protagonisti compaiono fin dall'inizio sulla scena sono anche le Nuvole e gli Acarnesi, la prima delle commedie di Aristofane a noi giunte. Rappresentata nel 425 a.C., sotto il nome di Callistrato, forse perché Aristofane era troppo giovane per partecipare alla competizione, vinse il primo premio al festival delle Lenee: in essa, il poeta descrive la realizzazione di un progetto utopico molto simile a quello presentato alcuni anni dopo nella Pace. Il contesto storico, da cui l'invenzione di Aristofane prende spunto, è sempre la guerra con Sparta, per la quale molto avevano già sofferto gli ateniesi, e - nella finzione comica -gli abitanti del demo di Acarne, che formano il coro e danno il nome alla commedia. Come nel caso di Trigeo, inoltre, Diceopoli, eroe degli Acarnesi, aspira alla pace, anche se ambisce a una tregua ben più intima e personale di quella cittadina auspicata dal "Bellerofonte" della Pace, che dovrà essere stipulata attraverso un contratto privato fra lui e Sparta. La commedia si apre con la scena deserta verso la quale avanza Diceopoli, che entra da una delle pàrodoi laterali e procede attraverso l'orchestra. In un dialogo "a solo", egli si lamenta, nei primi versi, della tristezza della sua condizione e descrive se stesso mentre attende, annoiato, l'inizio dell'assemblea in cui si dovrà discutere della pace con Sparta: Città, città! Io arrivo sempre per primo all'assemblea e mi siedo, ma visto che sono solo, mi lamento, sbadiglio, mi agito, scoreggio, non so cosa fare, scrivo, mi tiro i capelli, faccio di conto, e guardo alla campagna, sospirando la pace. Odio la città e amo invece il mio demo, dove nessuno mi ha mai detto di comprarmi il carbone, (vv. 27-34) A poco a poco, lo sfondo si popola: entrano i pritani, i magistrati, e via via gli ambasciatori dei paesi stranieri. Ad un certo punto, l'azione prende un ritmo serrato: Diceopoli riesce allora, almeno parzialmente, a realizzare il suo progetto, fornendo del denaro a un certo Anfiteo, affinché negozi la pace privata fra lui e Sparta. Il prologo si interrompe con l'irruzione degli abitanti del demo di Acarne, gli "acarnesi" appunto, che entrano vociando alla ricerca di chi si è impadronito della tregua. Il prologo interpretato da Diceopoli e da quanti, dopo di lui, arrivano ad affollare la scena, presenta evidentemente una diversa opzione strutturale e narrativa, rispetto a quella individuata nella Pace, ma anche un caso in cui l'azione iniziale (che comprende il soliloquio di Diceopoli), la teoria degli ambasciatori, la contrattazione per la pace e la conquista della tregua privata trascorrono naturalmente nella parodo, nell'ingresso del coro. Ciò manifesta la singolare abilità del poeta nel fondere, qualora l'argomento e la costruzione drammaturgica lo permettano, gli elementi che appartengono alle diverse parti della commedia. La tendenza a saldare armonicamente le singole porzioni della trama è, fra l'altro, ben visibile in tutta l'opera di Aristofane, soprattutto nei continui esperimenti strutturali che percorrono la sua produzione. A una maggiore unità all'interno delle commedie si orienta del resto anche la graduale evoluzione del prologo che rinuncia a poco a poco a tutti gli elementi non necessari all'esposizione della trama per concentrarsi sulla pura definizione del plot narrativo: da questo punto di vista un buon esempio è costituito dal prologo di commedie più tarde come le Tesmoforiazuse, le Rane o la Lìsistrata. La commedia nuova di Menandro conserva solo in parte l'idea dell'antico prologo aristofaneo, poiché la divisione in cinque atti, inframmezzati da intermezzi corali, caratteristica delle sue opere, stravolge completamente il segmento iniziale di narrazione destinato a precedere nella commedia antica l'ingresso del coro. Il coro di Menandro, di cui poco si sa se non che aveva la semplice funzione di intrattenimento, non rendeva necessaria l'invenzione di porzioni del dramma pensate appositamente perché si saldassero con il suo ingresso. Nonostante il quasi totale naufragio dell'opera menandrea, possiamo però dire che il poeta fece spesso ricorso al cosiddetto "prologo espositivo", mutuato dalla tragedia, in particolare al prologo divino,
presente in quei drammi euripidei, Ippolito, Baccanti e Ione, in cui la volontà del dio si palesa fin da subito come uno dei motori fondamentali dell'azione. In questo schema rientrano gli atti primi, anche se parzialmente lacunosi, dello Scudo, della Donna tosata e del Misantropo. In realtà, la funzione e il ruolo di queste figure divine non è il medesimo nelle tre opere. In due casi, quelli dello Scudo e della Donna tosata, il dio che compare in scena è sostanzialmente una figura allegorica, il cui compito è chiarire le pieghe oscure degli eventi, illustrando agli spettatori ciò che essi non possono apprendere dagli altri personaggi del dramma. Parliamo per questo tipo di esordio di "prologhi ritardati", poiché le sezioni dedicate al theós prologizon ("dio che recita il prologo") sono precedute da veri e propri dialoghi espositivi, in cui solo un segmento della trama viene mostrato al pubblico. Lo Scudo, per esempio, si apre con il servo fedele Davo che riferisce al vecchio e crudele Smicri-ne della morte di suo nipote Cleostrato sul campo di battaglia, mentre combatteva in Asia come mercenario. Subito Smicrine, avido e senza scrupoli, progetta di sposare la sorella del giovane caduto (sua nipote), divenuta improvvisamente erede unica (epìklera) dei beni di Cleostrato. All'uscita dei due personaggi, ecco entrare in scena una donna maestosa (v. 97), che definisce se stessa come colei che «arbitra e amministra tutte queste vicende, la Fortuna», alla quale spetta il compito di raccontare la realtà dei fatti e di narrare gli eventi futuri: Cleostrato non è morto, è solo stato fatto prigioniero; presto tornerà a casa e impedirà a Smicrine di realizzare il suo piano immorale... Fortuna (tyche in greco) non si propone come un personaggio scenico a tutti gli effetti; la sua funzione è eminentemente simbolica e si sostanzia in quella sentenza: "arbitra e amministra tutte queste vicende", che serve da chiusa per il suo pezzo drammatico (v. 148). Al medesimo schema corrisponde il prologo divino della Donna tosata: anche in questo caso, esisteva probabilmente una prima scena con funzione introduttiva, per noi perduta, in cui i protagonisti umani degli eventi chiarivano al pubblico gli elementi basilari della trama. Il frammento di commedia superstite porta tuttavia direttamente in scena la dea Agnoia, l'Ignoranza, la quale non si limita a chiarire alcuni punti nodali della storia, ma confessa di essere intervenuta direttamente sugli eventi, provocando la smodata gelosia del soldato Pole-mone perché l'ira di questi potesse divenire il motore fondamentale dell'azione e portare alla soluzione positiva dell'intreccio comico. Si tratta ancora una volta di una figura allegorica, alla quale appartiene un livello di conoscenza della vicenda che è precluso ai suoi protagonisti. Contemporaneamente, Agnoia rappresenta e simboleggia il fulcro della vicenda comica da cui si sviluppano tutti gli eventi successivi: è infatti proprio l'ignoranza del legame di parentela fra Moschione e Glicera a costituire l'antefatto e la causa di tutto quanto avviene nella commedia. Un'opzione strutturale differente è quella presentata dal Misantropo, dove compare, proprio all'inizio, il dio Pan, con il classico ruolo "espositivo". In questo caso, tuttavia, l'ingresso di Pan non è preceduto da alcun prologo affidato a mortali: il pubblico apprende, per la prima volta e per bocca di una divinità, alcuni frammenti dell'intreccio che si andrà componendo in scena. Siamo ancora una volta di fronte a un prologo divino, ma per il Misantropo possiamo parlare di prologo "incipitario", poiché l'attore che impersonava il dio è di fatto il primo personaggio a fare il suo ingresso in scena. Si noterà, a questo proposito, come Pan sia l'unica divinità in senso stretto a occupare lo spazio del palcoscenico: nello Scudo e nella Donna tosata infatti il ruolo del dio era incarnato da figure allegoriche, che nulla avevano a che fare con il pantheon tradizionale. A causa delle caratteristiche peculiari del suo ingresso in teatro, la funzione di Pan si riduce a quella che, nella tragedia, è incarnata - parzialmente - dal personaggio del messo o dell'indovino, ai quali spetta il compito di chiarire agli spettatori le pieghe invisibili dello sviluppo dell'azione, ma non quello di intervenire su di essa in modo attivo. Il suo pezzo, infatti, risulta molto più didascalico di quello affidato all'Ignoranza e alla Fortuna, come dimostrano già i primi versi della commedia: Dovete sapere che questo posto è File, nell'Attica, e il ninfeo da cui sono uscito è l'illustre santuario dei Filasii, capaci di coltivare anche le pietre. Il campo sulla destra è quello di Cnemone, un uomo che non ama gli uomini, iroso con tutti, ostile alla gente, (vv. 1-6). Nella commedia di Menandro, come abbiamo già detto, il prologo non assolve ad alcuna funzione prolusiva per l'ingresso del coro, poiché quest'ultimo non occupa una posizione rilevante all'interno della costruzione della trama. Nella commedia aristofanea, e antica in genere, l'entrata dei coreuti in scena gioca invece un ruolo importante e si salda, in modo più o meno fluido, con il prologo. Per descrivere questa porzione del dramma i critici moderni abitualmente utilizzano la parola "parodo", a cui però non corrisponde una struttura fissa e omogenea, diversamente da quanto accade nella tragedia, per la
quale Aristotele (Poetica 1452 b) impiegò proprio questo termine. Gli autori antichi, infatti, non parlarono mai di parodo in riferimento alla commedia: questo probabilmente perché da un lato l'ingresso del coro all'interno dell'azione è sempre saldato con le scene successive del dramma, sia che si tratti di scene di raccordo sia che, per esempio, si tratti della sezione che precede l'agone (proagone), dall'altro perché il ruolo del coro, la sua funzione e persino il metro in cui si esprime si differenziano molto da commedia a commedia (anche se sembrano prevalere i tetrametri sugli altri metri). Nella parodo, per la prima volta, il coro si schierava di fronte al pubblico e dava inizio all'interpretazione. Si trattava certamente di un segmento della commedia costruito per provocare un forte impatto emotivo negli spettatori, non tanto, o non soltanto, per i versi che il coro pronunciava, ma per la perfetta coreografia dell'insieme, formata nel contempo dai costumi e dalle maschere indossate dai coreuti e dalla danza che spesso interpretavano. Nel teatro attico, sia per quanto riguarda la tragedia che per la commedia, il coro rappresentava del resto una sorta di cassa di risonanza dell'azione drammatica e dei sentimenti dei singoli protagonisti, ma era anche un veicolo attraverso cui i personaggi della commedia e il pubblico potevano comunicare tra loro. La sua entrata aveva dunque un'importanza cruciale nella commedia antica in generale, in particolare in quella aristofanea del primo periodo. Data l'estrema variabilità di questo segmento di commedia, è difficile mettere a punto un modello generale entro cui far rientrare le parodo delle singole opere; possiamo però dire che esse si definiscono essenzialmente dal contesto in cui agiscono i protagonisti del dramma e dalle loro azioni iniziali, nonché dal luogo in cui è diretto il coro al suo ingresso, dalle sue intenzioni, dal modo in cui entra e da quali sono le parole che pronuncia. Prologo e parodo sono dunque profondamente legate: la prima giustifica e definisce la seconda. In base a questo criterio, è possibile individuare alcune tipologie diverse, che presentano tuttavia molte affinità. Vi sono commedie in cui il coro entra in teatro a scena vuota, dopo che gli attori hanno in qualche modo anticipato il suo arrivo: i coreuti fanno il loro ingresso a passo di marcia per raggiungere il luogo finale a cui sono diretti. Mentre entrano e si dispongono nell'orchestra, si incoraggiano fra loro, chiamandosi talvolta per nome. È il caso di commedie anche distanti cronologicamente, come gli Acarnesi, le Vespe, la Lisistrata e le Ecclesiazuse. Nella prima, per esempio, è proprio Diceopoli a preparare l'arrivo degli acarnesi, gli abitanti del demo di Acarne, i quali irrompono in teatro, alla rabbiosa ricerca di Anfiteo, responsabile di aver sottratto e nascosto la tregua con Sparta. Si tratta di una parodo che doveva articolarsi come una marcia guerresca all'inseguimento del nemico e che si evolve, come spesso accade, in una scena di battaglia violenta e grottesca ("scena di battaglia") fra Diceopoli e gli acarnesi. La parodo ha qui il compito di chiudere la sezione che aveva avuto inizio con il prologo e di fornire l'antefatto per la sezione agonale, di cui protagonista sarà proprio Diceopoli: Tutti da questa parte: inseguite quell'uomo e interrogate tutti i passanti: è interesse dello stato prenderlo. Ma voi (rivolgendosi agli spettatori) ditemi se sapete in quale angolo di terra si è cacciato chi portava la tregua, (vv. 204-207) Nelle Vespe, l'ingresso del coro è ampiamente introdotto dall'azione del prologo, in cui due servi, in compagnia del loro padrone, Bdeli-cleone, cercano in tutti i modi di impedire al padre di questi, Filocleo-ne, di scappare da casa per raggiungere il tribunale, dove il vecchio vuole a ogni costo recarsi per esercitare il proprio impegno di giudice. La passione smodata per i tribunali di Filocleone e l'opposizione del figlio a tale eccesso sono il motore principale di tutta l'azione comica e il prologo assolve ampiamente alla sua funzione didascalico-esplica-tiva, dilatandosi in una serie di piccole scene esilaranti in cui famiglia e servi tentano di trattenere il vecchio giudice a casa. A un certo punto, è proprio Filocleone a invocare il coro (v. 197), rappresentato dai suoi vecchi amici, che come lui hanno consuetudine con i processi e, come lui, si alzano a notte fonda per recarsi al tribunale. Pochi versi più oltre (vv. 218-227) è Bdelicleone a ritornare sull'argomento - in un dialogo con il servo - per informare il pubblico del prossimo arrivo del coro: Nel mezzo della notte di solito lo vengono a chiamare e, portando le lucerne, cantano vecchie e dolci melodie di Frinico, che servono da segnale. (...) Già, ma la genia dei vecchi, se la pungoli, è come un nido di vespe: hanno sotto i lombi un pungiglione acutissimo e con quello, urlando, colpiscono, saltano, e ti si gettano
addosso come faville. Al termine del breve scambio di battute, il giovane, in compagnia del servo, rientra in casa e se ne torna a dormire, abbandonando la scena, mentre in teatro fa il suo ingresso il coro dei vecchi, con il costume da vespa, accompagnato dai giovani che reggono le lucerne. Bdelicleone ha adempiuto quindi egregiamente al suo compito, rivelando agli spettatori l'identità del coro prima ancora che questo sia entrato e, contemporaneamente, esplicitando la ragione di un costume "animale" tanto bizzarro. Il tratto che differenzia il coro degli Accintesi da quello delle Vespe è la modalità con cui i membri del coro fanno il loro ingresso: di corsa il primo, a passi cauti, alla luce delle lanterne il secondo. Un altro tipo di parodo è rappresentato da quelle commedie in cui il coro entra impetuosamente in scena, tutto preso da un compito da assolvere che costituisce anche il fulcro dell'azione comica. Il suo arrivo è non solo segnalato, ma anche invocato da uno dei protagonisti del prologo, che ne sollecita con calore l'intervento. Cavalieri e Pace rientrano in quest'ultima categoria: nel primo caso i cavalieri del coro arrivano nell'orchestra, invitati da uno dei due servi che, nel prologo, hanno esposto al pubblico il loro piano di spodestare Paflagone, colpevole a loro dire di aver turlupinato Demo, il Popolo di Atene, e di tenerlo in sua balia. Lo scopo dei due è quello di scatenare l'ira dei cavalieri, così da spingerli a ingaggiare una battaglia contro Paflagone: Dagli, dagli addosso al disgraziato, uno che sconvolge le schiere dei Cavalieri (taraxippóstraton), al gabelliere, a questo abisso a questa Carid-di di rapina, al disgraziato e di nuovo disgraziato; e non farò che ripeterlo, dal momento che fa il furfante più volte al giorno. E dai: inseguilo, scuotilo, sconvolgilo e odialo - lo odiamo anche noi! - stagli addosso, strilla forte e bada che non ti sfugga! (vv. 247-253) A questa entrata impetuosa, segue un fitto dialogo fra Paflagone e il coro, che - ancora una volta - ha tutte le caratteristiche di uno scontro violento. I medesimi elementi strutturali si ritrovano anche nella parodo della Pace, dove però il coro non si presenta in teatro per ingaggiare una lotta con uno dei protagonisti del dramma, ma per aiutare l'eroe. Tri-geo, che ne ha richiesto l'intervento: Avanti, contadini, mercanti, artigiani, operai, meteci, stranieri, isolani, venite tutti, il più velocemente possibile con badili e leve e funi. (vv. 296-297) Subito, un gran numero di coreuti fa il suo ingresso nell'orchestra e aderisce entusiasticamente alla richiesta di Trigeo di prestare il proprio aiuto all'impresa a cui quest'ultimo si sta volgendo. È importante notare, a proposito del coro della Pace, come la sua composizione sia tutt'altro che omogenea e ben definita: non si sa cioè quale fosse esattamente l'identità scenica di quanti ne facevano parte, denominati da Trigeo in sostanza come coloro che avevano a cuore la Pace per la città e la volevano liberare dall'antro oscuro in cui l'aveva rinchiusa la Guerra. La sostanziale diversità di questo tipo di parodo, rispetto a quelle delle prime commedie che abbiamo analizzato, risiede nello stretto legame esistente fra il coro e i protagonisti del dramma, che rimangono in scena, anche se non tutti, per tutta la durata della sezione. Ciò consente indubbiamente di legare la natura e la funzione del coro, in quanto "attore" al pari degli altri, ai personaggi e alla struttura della vicenda comica vera e propria. Una terza tipologia è quella presente nelle Nuvole e negli Uccelli: in questo caso, il coro entra sulla scena, aderendo a un invito rivoltogli da un personaggio con cui ha un legame particolare. Prima di entrare, intona un canto (formato da una strofe e da un'antistrofe) fuori scena e poi sfila lungo l'orchestra danzando, ma non cantando, fino a collocarsi nello spazio che occuperà per buona parte del dramma. È soltanto a questo punto, dopo un ingresso di grande impatto coreografico, che, rivolgendosi al personaggio con cui intrattiene una relazione particolare, chiede la ragione per cui è stato invitato. Da questo punto di vista, l'esempio più importante è indubbiamente rappresentato dagli Uccelli (anche se l'intera sezione presenta problemi interpretativi), il cui coro entra in scena, invocato dall'Upupa, che vuole metterlo al corrente del piano concepito da Pisetero ed Evelpide per creare un nuovo regno in cielo, dominato dalle creature alate e non dagli dei. Il carattere straordinario di questa parodo è costituito dal fatto che, mentre il coro fa il suo ingresso
in silenzio, i protagonisti del prologo non si limitano a dichiararne l'arrivo, ma descrivono e identificano uno a uno gli uccelli che ne fanno parte: «La gazza, la tortora, l'allodola, l'elea, l'ipotimide, la colomba, il nerto, lo sparviero, il palombo, il cuculo, il capirosso, il piedirosso, il porfirione, il gheppio, lo smergo, l'ampelide, l'aquila marina, il picchio» (oltre a quelli che sono già stati elencati in precedenza). Ciò che va disponendosi di fronte agli spettatori è dunque, con ogni probabilità, una teoria di danzatori abbigliati in modo molto simile con ali e becchi d'uccello - ma con alcune caratteristiche peculiari che ne identificano la specie. Pur trattandosi di una performance teatrale che venne realizzata per la prima volta migliaia di anni fa, è dunque facile intuire quale impatto potesse avere sul pubblico l'ingresso in teatro di ventiquattro danzatori abbigliati con costumi dai colori più vari. E, infatti, quella degli Uccelli fu certamente una delle parodo più immaginifiche e più coinvolgenti del teatro attico, destinata a creare, inventandola dal nulla, l'impressione di un regno animale fantastico, collocato negli spazi celesti. Anche nelle Nuvole del resto, il coro formato da figure che incarnavano proprio gli agenti atmosferici era pensato per provocare una grande reazione sugli spettatori, soprattutto per il canto che, da fuori scena, si levava ancor prima che le Nuvole si fossero rese visibili e invadeva lo spazio del teatro: Nuvole eterne, splendenti di rugiada lucente, leviamoci dal padre Oceano mugghiarne, dalle cime degli alti monti, coperti di boschi; per vedere le cime lontane, le messi e la terra sacra irrigata, i fiumi divini che mormorano, il mare dal cupo rimbombo. L'occhio dell'Etere risplende instancabile negli astri sfolgoranti. Noi scuotiamo la nebbia piovosa dal volto immortale, e con occhio che vede lontano guardiamo la terra... (vv. 275-290) Questo tipo di parodo, così come quello che abbiamo descritto in precedenza, presuppone un forte legame fra i protagonisti del prologo e le azioni del coro, ma anche un uso raffinato e sapiente delle grandi possibilità che un coro comico poteva offrire a livello coreografico: canto, danza, costumi si intrecciavano per produrre una performance di alto valore immaginifico. Un analogo accento sull'importanza coreografica della parodo viene posto in quelle commedie, come Tesmoforiazuse e Rane, in cui il coro entra in scena per ragioni che nulla hanno a che fare con l'azione principale del dramma o con qualcuno dei personaggi che già hanno occupato e che al momento occupano il palcoscenico. Il suo canto assume, in questo caso, la forma di un inno religioso e si dilata nell'orchestra incurante del pubblico e dei protagonisti del dramma. Particolare a questo proposito è la struttura delle Rane, che presenta non uno ma due cori distinti: il primo è composto dalle rane che gracidano nel lago, su cui Dioniso deve navigare, in bilico sulla barca di Caronte, per raggiungere il regno infernale (secondo la maggior parte degli interpreti, questo coro non entra mai nell'orchestra). Il loro verso stridente è il contraltare sonoro all'ingresso di Dioniso nell'Ade e, pur possedendo in parte le caratteristiche di un inno religioso (invocazione alla divinità, tono solenne), in realtà si sfilaccia in una serie di versi ostinati e ripetitivi (Brechechex, coax, coax) con i quali le rane tediosamente sfidano il bislacco Dioniso del dramma. Quando Dioniso mette finalmente piede sulla terraferma, questa pletora gracidante di coreuti tace, per far posto al vero coro della commedia, gli "iniziati", i seguaci dei misteri di Eleusi, che fanno il loro ingresso, preceduti dal canto solenne della processione: O lacco, tu che abiti in queste sedi molto venerate, lacco, o lacco, vieni a danzare su questo prato, dai tuoi pii devoti, scuotendo intorno al capo una corona carica di mirti, rigogliosa di frutti e con il piede battendo un ritmo ardito alla festa sfrenata che ama la gioia, che tanto partecipa della grazia, della pura sacra danza dei pii iniziati (vv. 324-336). Il loro inno si dilata per molti versi, in un fiorire barocco di aggettivazione e di epiteti, tutti tesi a celebrare la santità di lacco, il quale non è altro che uno dei nomi di Dioniso stesso: le parole si accumulano e si riversano sul pubblico così come sui personaggi presenti in scena, i quali non riescono in alcun modo ad attirare l'attenzione dei coreuti, fino al termine della processione iniziatica che coinciderà con l'arrivo del coro alla sua destinazione finale. Soltanto allora (vv. 431-433) Dioniso potrà interagire con gli iniziati e chiedere loro l'unica notizia per lui di qualche interesse: dove sia ubicata la porta che permette l'accesso agli Inferi. L'assoluta mancanza di relazione fra l'eroe, i suoi compagni e il coro risulta ancor più bizzarra se si pensa che, di fatto, i seguaci dei misteri non fanno che invocare per molti versi Dioniso (seppur con il nome di lacco), senza rivolgergli neppure un breve cenno di riconoscimento.
Questo breve quadro dei diversi modi in cui la commedia di Aristofane declinò l'ingresso in teatro del coro rende evidente da un lato il carattere eterogeneo della parodo, dall'altro il sapiente uso delle diverse possibilità drammaturgiche da parte del poeta. Va segnalato anche come non esista - per la parodo della commedia antica - alcuna evoluzione, in senso cronologico, da una tipologia a un'altra: Acarnesi ed Ecclesiazuse hanno per esempio una struttura simile, anche se appartengono a fasi della produzione aristofanea molto diverse. Si può affermare con sicurezza, comunque, che la natura della parodo non influenza in alcun modo la scansione degli eventi successivi e che un importante tratto unificante di tutte le commedie analizzate risiede nel fatto che il coro, dopo essere entrato in scena per la prima volta, non esce mai dall'orchestra prima della fine della parabasi: l'azione della commedia si sviluppa nei modi più vari, sui quali torneremo fra poco, ma il coro non lascia il teatro, anche se non è mai solo sulla scena. Se è possibile tracciare uno schizzo generale della struttura della parodo aristofanea, lo stesso discorso ovviamente non può valere per la commedia di mezzo (di cui poco o nulla sappiamo) o per quella nuova che, come abbiamo detto, modifica in modo sostanziale il ruolo del coro: esso scompare gradualmente dal teatro in quanto personaggio dotato di precisa identità drammatica e finisce per giocare il ruolo di semplice intermezzo. Nella commedia di Menandro, infatti, il coro entra in scena per separare un atto dall'altro e, nella parodo, la sua funzione è quella di segnalare la chiusura del primo quadro. Ciò non significa che un poeta della qualità espressiva di Menandro abbia ridotto, fino a farla scomparire, l'importanza del coro nelle sue opere: vi sono casi in cui probabilmente esso assumeva un'identità specifica, legata cioè al singolo intreccio comico. Per esempio, con ogni probabilità, il coro del Misantropo era formato da un gruppo di seguaci di Pan, il dio a cui è affidata la recitazione del prologo. Questa caratterizzazione doveva, peraltro, essere peculiare di quelle commedie in cui la presenza di un dio nella sezione prologica permetteva di mettere in scena un intermezzo corale legato alla natura della divinità. Nonostante questa possibilità di dotare il coro di qualcosa di più di un'identità vaga, il suo ingresso in scena è sempre segnalato in modo piuttosto convenzionale e generico, con espressioni simili nelle diverse commedie, e il suo ruolo, sempre per quanto ci è dato di sapere dal momento che gli intermezzi corali non sono conservati, non comprende mai la possibilità di un intervento diretto sullo sviluppo degli eventi. Ai coreuti della commedia nuova è tuttavia affidata la funzione di spezzare il ritmo instaurato nella prima parte del dramma e di variarne in qualche modo il tono, accentuando per esempio il carattere ludico e gioioso della rappresentazione comica: in questo modo, il drammaturgo sfruttava la possibilità di marcare il passaggio da un momento della commedia a un altro e di distinguere un atto dal successivo.
4.2.2 L'agone L'agone rappresenta, all'interno della commedia antica, la sezione centrale del dramma: si tratta di uno dei momenti fondamentali della performance comica, non soltanto per questioni strutturali e formali, ma anche e soprattutto per ragioni di contenuto. Nell'agone trova, infatti, piena realizzazione uno dei valori principali dell'azione comica: il conflitto fra l'eroe e la sua utopia, sempre percepita come innovatrice, anche qualora si prefigga il compito di restaurare un ordine ormai scomparso, e l'antagonista che gli si oppone, sia esso il vero "nemico" o un semplice contendente. Proprio la natura conflittuale dell'agone ne fa un elemento profondamente radicato nella realtà politica, sociale e culturale in cui la commedia antica venne prodotta: il dibattito politico acceso, la possibilità di attaccare direttamente personaggi in vista del tempo, la persuasione viva nella produzione aristofanea - di poter realmente influire sugli avvenimenti contingenti sono il perno su cui si gioca il confronto agonale. Al contrario, l'età ellenistica segna, com'è noto, un profondo mutamento nei rapporti del cittadino con lo Stato, ma anche, più in generale, con l'universo relazionale con cui il primo si rapporta. Lo scontro nei tribunali, il conflitto in piazza non occupano più nell'epoca di Menandro la centralità di un secolo prima. Per questa ragione, l'intreccio menandreo e la struttura a cinque atti della sua commedia non prevedono l'esistenza di momenti di duro confronto fra i protagonisti del dramma: l'agone scompare dunque dalla realtà più intima della commedia nuova in cui nulla ha la forza eroica e definitiva dell'epoca precedente. La sezione agonale appartiene perciò esclusivamente al mondo della commedia antica e, per noi, è visibile solo attraverso l'opera di Aristofane: in essa è situata abitualmente nella prima parte del dramma, anche se si verificano numerose eccezioni a tale modello. La collocazione è direttamente legata al suo valore di conflitto risolutorio: dall'agone, infatti, emergono vincitori e vinti e il protagonista della trama, attraverso lo scontro
verbale, riesce ad avere ragione del nemico, contrariamente a quanto accade nell'agone tragico, dal quale nessuno esce vincente. Sembra che, in una prima fase di sviluppo della commedia, l'agone precedesse sempre la parabasi e che a quest'ultima fosse affidato il compito di "tirare le fila" degli eventi, scrivendo la parola "fine": in questo quadro, lo scontro agonale serviva a proclamare la vittoria dell'eroe comico, mentre nella parabasi il coro ne celebrava il trionfo. A livello formale, l'agone ha una scansione generalmente "responsiva": è cioè formato da alcune parti fisse a cui si contrappongono altre parti che presentano esattamente la medesima struttura. Tecnicamente, questo modulo espressivo viene chiamato sizigia epirrematica (da epirrema: "ciò che viene detto dopo") e consta di una mescolanza di sezioni recitate e sezioni cantate; non è tipico soltanto dell'agone, ma anche della parodo e della parabasi. Rispetto a queste ultime due porzioni del dramma, di cui il coro è il solo protagonista, la sezione recitata dell'agone (epirrema e antepirrema) è però interpretata essenzialmente dal primo attore e dal suo antagonista. Per chiarire meglio quale sia l'esatta scansione della sizigia agonale, analizziamo nel dettaglio l'agone di una delle poche commedie in cui questo si presenta in versione completa: gli Uccelli, che ci forniscono un ottimo esempio dal punto di vista strutturale, anche se non contenutistico, dal momento che l'intero agone, entro cui si dispiega l'utopia di Pisetero, non è "dotato" di un vero e proprio antagonista, di un vero nemico, e perde dunque un po' il suo significato di scontro conflittuale. L'agone serve, infatti, all'eroe per illustrare al compagno Evelpide, al coro e agli spettatori, la grandiosità della sua idea: la costruzione di un regno celeste in cui gli uccelli la facciano da padrone e soprattutto riescano a mettere in ombra il potere, fino a quel momento esclusivo, degli dei. A poco a poco, l'immagine di questa città ideale e potente, dominata dalla stirpe superiore dei volatili, riesce a incantare gli uccelli del coro ed Evelpide, cosicché tutti, alla fine, vengono convinti dell'opportunità di realizzare quanto Pisetero propone. In tutto l'agone, né le voci degli uccelli né quella di Evelpide si levano mai come controcanto: forniscono al contrario la base argomentativa sulla quale poggia il fiume barocco di parole, necessario a Pisetero per costruire il quadro di un nuovo Olimpo ornitologico. La sezione si apre con un'ode del coro, che invita genericamente Pisetero a esporre il suo progetto, a cui segue il cosiddetto katakeleusmós, l'invito vero e proprio, sempre affidato alla voce del coro, che questa volta però non canta, ma recita, due versi in tetrametri anapestici. Sempre in anapesti è recitata la parte seguente, l'epìrrema, in cui l'attore ha la possibilità di articolare nel dettaglio il suo punto di vista (in questo caso descrive il regno degli uccelli). A questa parte segue una nuova ode (antode) del coro, che sembra convincersi della proposta di Pisetero, e un nuovo katakeleusmós (antikatakeleusmós). In perfetta corrispondenza con l'epìrrema arriva poi l' antepìrrema, recitato esattamente con lo stesso metro utilizzato nella prima sezione e nello stesso numero di versi: in esso Pisetero, supportato da Evelpide, dimostra in modo definitivo l'efficacia della sua idea. Chiude l'intero agone un "sigillo" (sphragìs), pronunciato dal coro (in tetrametri anapestici e in trimetri giambici), al quale spesso viene lasciato il compito di celebrare il vincitore del confronto e la qualità del duello oratorio. Nel caso degli Uccelli, l'argomento di questa chiusa finale è naturalmente la lode per l'abilità retorica di Pisetero: Vecchio mio, ti sei trasformato nel mio preferito, da detestato che eri. Non succederà mai che di mia volontà io mi distacchi da quanto tu vuoi. Confido nelle tue parole, minaccio e giuro: se ci accordiamo per un patto condiviso e tu, giusto, leale e pio muovi contro gli dei, in armonia con quanto noi sentiamo, non per molto tempo ancora gli dei logoreranno il mio scettro. E quando ci sarà bisogno di forza per agire, ci penseremo noi. Quando invece ci sarà bisogno di cervello per decidere, ti occuperai tu di tutto, (vv. 627-638) Pur mancando alla struttura degli Uccelli quella cascata ininterrotta di versi (pnìgos), pronunciati tutti d'un fiato, che segue talvolta l'epìrrema e ne rappresenta la naturale conclusione (si veda a tal proposito l'agone delle Vespe), in generale questa commedia offre un'ottima descrizione della struttura agonale tradizionale che potremmo schematizzare nel modo seguente: l'agone è spesso preceduto da quello che, convenzionalmente, viene chiamato "pro-agone" (abitualmente una "scena di battaglia", di scontro: negli Uccelli ai vv. 352-434); un'ode pronunciata dal coro apre poi la sezione agonale e a essa segue un invito esplicito a dare avvio al confronto (katakeleusmós). Ha inizio poi l'epirrema (abitualmente in anapesti) che talvolta si chiude con una pnígos pronunciata tutto d'un fiato. La fase responsiva si articola - a questo punto - in antode, antikatakeleusmós, antepirrema e, talvolta, antipnigos. Chiude il tutto un sigillo, la sphragis. Si tratta, come si può vedere, di uno schema fisso, soggetto però -nell'opera aristofanea-a numerose eccezioni.
Innanzitutto, sono davvero poche le commedie che presentano l'agone nella sua forma regolare, posizionato nella prima parte del dramma (Cavalieri, Vespe, Uccelli e Lisistrata). I Cavalieri per esempio hanno un altro agone completo anche nella seconda parte della commedia; le Nuvole presentano ben due agoni nella sezione che segue la parabasi. La Pace non ha un agone vero e proprio, forse a causa del suo contenuto, così connesso a temi politici "caldi" come il rapporto fra guerra e pace, particolarmente sentiti nel pieno della guerra del Peloponneso. Acarnesi ed Ecclesiazuse hanno una sezione che, nella sostanza, può essere accostata all'agone, ma a livello formale gli è del tutto estranea: si tratta in entrambi i casi di parodie delle orazioni giudiziarie (Acarnesi) o assembleari (Ecclesiazuse) che simulano, nella loro scansione metrica, proprio il tipo di versi utilizzato in quei contesti: il trimetro giambico. Gli agoni sono dunque in questo caso duelli oratori, che non fanno ricorso né al metro consueto dell'agone (l'anapesto) né allasizigia epirrematica. Possiamo dunque avere commedie che rispettano la formula tradizionale (sizigia epirrematica collocata nella prima parte del dramma), commedie che presentano un vero e proprio agone che però può essere posizionato dopo la parabasi o avere un contenuto non precisamente agonale, commedie infine che, pur avendo una sezione dedicata esplicitamente al confronto fra le opinioni di due o più contendenti, non rispettano in alcun modo la struttura formale dell'agone. Mentre il protagonista e il suo avversario si contendono la scena e lottano per ottenere la palma del vincitore, il coro abitualmente si dispone all'ascolto e rinuncia alla danza. Questo accade perché i coreuti nell'agone assolvono alla funzione di giudici e sorvegliano la regolarità dello scontro: è infatti il coro a elogiare nella sphragis non soltanto il progetto utopico del vincitore, ma il buon funzionamento del meccanismo agonale. Fa eccezione a questo schema soltanto la Lisistrata in cui le protagoniste del coro femminile (le compagne di Lisistrata appunto) si esortano l'un l'altra e dichiarano esplicitamente di non voler mai smettere di ballare: No, non sarò mai sazia di ballare, è sicuro, né le ginocchia mi si piegheranno per la fatica, (vv. 541-542). L'anomalia di questo agone è, con ogni probabilità, dovuta alla composizione originale del coro della Lisistrata: si tratta infatti di due semicori, uno maschile e uno femminile, che si oppongono in continuazione nel corso del dramma poiché rappresentano le due opposte fazioni in lotta, a sostegno della causa di Lisistrata o, al contrario, di quella degli uomini. Sono cioè un coro partigiano e, in quanto direttamente interessati all'esito dello scontro agonale, non possono che assumere, al suo interno, la funzione attiva di sostenitori degli interessi di una o dell'altra parte. Per questa ragione, è loro precluso il ruolo imparziale di giudice e di "guardiano" della lealtà del conflitto.
4.2.3 La parabasi Sappiamo che Aristofane ottenne spesso uno straordinario successo di pubblico e dunque non è arbitrario utilizzarlo, come noi facciamo, quale strumento principale, se non unico, per indagare le strutture drammaturgiche della commedia antica. Ciononostante - lo abbiamo già accennato - non ottenne sempre il primo premio nei concorsi e anzi venne di frequente superato dai suoi rivali: nel 423 per esempio, la sua commedia, le Nuvole, subì una clamorosa sconfitta, così cocente da spingere il poeta a riscriverla una seconda volta. È questa seconda versione a essere giunta fino a noi, un'opera dal destino strano poiché di fatto non venne mai rappresentata e perché manifesta, in alcune sue parti, tracce di una revisione non ancora completa. Si tratta ugualmente di un dramma di straordinario valore poetico; un'impresa in cui si intrecciano tematiche quotidiane: il peso dei debiti, l'educazione dei figli, con argomenti filosofici, e in cui un contadino, Strepsiade, il protagonista della commedia, si confronta con il filosofo per eccellenza, Socrate. Tuttavia, il suo interesse specifico, al di là dell'intrinseca qualità artistica, è dovuto proprio al fatto che si tratta di un'opera seconda e che in essa si fa un riferimento esplicito a quella prima rappresentazione destinata alla sconfitta. Ciò accade in particolare nella parabasi, che trova posto, eccezionalmente, nella prima sezione della commedia, prima dell'agone, quando ormai l'argomento della composizione è stato esposto nel prologo e il coro delle Nuvole ha fatto il suo ingresso nell'orchestra (una seconda parabasi, mutila di gran parte delle parti, è presente ai vv. 1114-1130). Il coro in essa si toglie la maschera, "si sveste", seppur parzialmente, della sua identità scenica e parla al pubblico esponendo il pensiero del poeta: Va' dunque, fidando nel tuo valore. Buona fortuna all'uomo che pur essendo giunto al limite dell'età, tinge di nuove imprese la sua natura e coltiva la sapienza. O spettatori, a voi dirò liberamente la verità, nel nome di
Dioniso, che mi ha allevato. Possa io vincere ed essere considerato in gamba dal momento che, ritenendovi un pubblico competente e credendo questa la migliore delle mie commedie, ho pensato di darla a voi per primi da gustare, poiché mi è costata tanta fatica. Allora sono stato sconfìtto da gente volgare e non lo meritavo. Di questo rimprovero voi, che pure siete uomini intelligenti e per i quali mi sono tanto impegnato. Ma non sceglierò mai di tradire quanti di voi hanno gusto. [...] Questa commedia è venuta come quell'Elettra a cercare, se riesce a trovarli, spettatori di buon gusto. [...] Guardate com'è pudica di natura; prima di tutto non si è cucita davanti quel lungo affare di cuoio, rosso in cima e grosso che fa ridere i bambini. Non prende in giro i calvi, non balla il cordace, non c'è un vecchio che mentre pronuncia le sue battute picchia col bastone l'interlocutore, per celare la povertà dei suoi scherzi, (vv. 510-542) La perorazione prosegue per molti versi, in un ricco elenco di ragioni per cui gli spettatori avrebbero dovuto consegnare la palma della vittoria a una commedia tanto raffinata. Al termine di questa sezione, il coro inizia a cantare e non è più la pura voce del poeta; torna a essere l'incarnazione delle sfuggenti divinità atmosferiche che danno nome alla commedia, le Nuvole: Eccelso Zeus, signore degli dei, te per primo chiamo a questo coro. E il forte dio del tridente, che scuote selvaggio la terra e il salso mare; e nostro padre dal grande nome, l'Etere sacro che nutre tutte le cose. Poi l'auriga che avvolge la terra di raggi fulgenti, grande dio tra gli immortali e i mortali. O spettatori saggissimi, fate attenzione: voi avete offeso e noi a nostra volta vi biasimiamo. Più di tutti gli dei siamo utili alla città, ma a noi, sole fra tutte le divinità, non fate sacrifici né libagioni: e siamo noi che vi proteggiamo! (vv. 263-269) In questo secondo segmento di versi, che si dilata ancora a lungo fino a comprendere tutta una serie di ulteriori invocazioni alle divinità, l'interlocutore privilegiato del coro è ancora il pubblico, ma sono le Nuvole a parlare, le Nuvole a lamentarsi per la scarsa considerazione di cui godono nel pantheon adorato dai comuni mortali. Nella parabasi, dunque, il coro può essere ora la cassa di risonanza del pensiero del poeta, ora la voce interlocutoria dei sentimenti dei protagonisti della commedia, ora un "personaggio" scenico che, al pari degli altri, si rivolge al suo pubblico, in cerca di appoggio e aiuto. Siamo di fronte - dal punto di vista strutturale - al fulcro portante della commedia attica antica, alla sezione del dramma comico che meglio individua le caratteristiche salienti della produzione più antica: la centralità della riflessione drammaturgica, l'importanza del rapporto fra il poeta e il suo pubblico, fra i diversi personaggi del dramma e gli spettatori, il ruolo del coro, quale strumento cardine attraverso cui mettere in scena ed esprimere la concezione poetica del singolo artista. Le Nuvole rappresentano al meglio questi singoli elementi, poiché esplicitamente fanno riferimento a una querelle sul valore dell'opera comica, sulle sue caratteristiche: nella parabasi il poeta rimprovera il pubblico di "scarso gusto", lo stimola, anche se in modo paradossale, a evolversi, a comprendere la raffinatezza della sua invenzione, la qualità superiore della sua arte in confronto a quanti lo hanno preceduto e quanti competono con lui in quel momento. La valorizzazione della propria opera a spese della produzione altrui - come vedremo - è un tratto peculiare delle sezioni parabatiche, ma qui viene espressa al massimo livello, poiché inserita all'interno di una commedia che, sconfitta in prima battuta, ha subito una revisione, non sappiamo quanto profonda e quanto capillare, per meglio andare incontro ai gusti del pubblico che l'aveva bocciata. Come emerge chiaramente dalla parabasi delle Nuvole, una cifra caratteristica di questa sezione delle commedie antiche è la celebre "rottura" dell'illusione scenica: il coro cessa di essere il coro delle Nuvole per rivolgersi esplicitamente al pubblico seduto sulle gradinate del teatro. Eppure tale elemento, per il quale la parabasi viene di frequente considerata un unicum nella storia del teatro antico e moderno, non si concentra unicamente in questa porzione del dramma: gli stessi attori di frequente si rivolgono al pubblico nel corso dell'azione drammatica. Chiedono il suo aiuto, illustrano e spiegano eventi specifici, irridono questo o quel personaggio politico presente nel teatro. Soprattutto nel prologo, i protagonisti della commedia spesso sostengono il valore dell'opera inscenata e invocano la benevolenza di quanti siedono in teatro: un caso piuttosto esemplare, da questo punto di vista, è costituito dalle Rane, che mettono in scena, fin dal primo verso, una discussione fra il servo Xantia e il padrone Dioniso su quale possa essere la battuta migliore per far ridere il pubblico. Resta allora da stabilire con esattezza quale sia la definizione più esatta di "illusione scenica" all'interno di un testo antico: se è vero, infatti, che ogni performance teatrale si fonda su un tacito accordo stabilito fra artista e
pubblico, in base al quale il secondo è disponibile a credere alla realtà della vicenda messa in scena dal primo, per lo spazio della rappresentazione, è vero anche che questo tipo di adesione assoluta, di svuotamento della dimensione reale a favore di quella immaginifica del dramma non corrispondeva certo alla natura della commedia greca antica. Il pubblico di un teatro antico poteva provare uno sconvolgimento totale per le vicende messe in scena in teatro, ma questo livello di straniamento era peculiare della tragedia, il cui coro non aveva il compito di attirare l'attenzione dello spettatore sul carattere illusorio degli eventi inscenati, quanto piuttosto di fornire una cassa di risonanza dell'azione e celarne l'aspetto artificiale. Al contrario i coreuti della commedia, in particolar modo nella parabasi, segnalano il lato fittizio di ogni illusione scenica e rendono del tutto particolare l'esperienza della performance comica nell'Atene classica. Se, infatti, la parabasi non è certo l'unico spazio all'interno della commedia in cui gli attori, il poeta e il pubblico si trovano di fronte senza il filtro dell'identità drammatica, indubbiamente essa, attraverso un meccanismo raffinato di riappropriazione della realtà storica e contingente, spinge gli spettatori a una riflessione generale sui meccanismi che stanno alla base e permettono la rappresentazione teatrale. Il pubblico, cioè, per quanto avvinto dal procedere degli eventi scenici, è costretto, attraverso la parabasi, a fermarsi e a riflettere sull'identità drammatica del coro, sulle scelte drammaturgiche del poeta, sui trucchi che questi coscientemente decide di adottare per vincere il concorso, su tutti i variegati elementi che compongono il tessuto di una commedia. In questo modo, la parabasi rappresenta spesso il "luogo" della drammaturgia dove ci è possibile, così come lo era per gli spettatori del secolo v a.C., osservare le strutture nodali dell'artificio teatrale senza la barriera dell'identità fittizia della trama: Aristofane apre in questo modo uno squarcio sulla sua officina di artista e ci mostra nella parabasi, anche se non solo in questa, come lavora e attraverso quali scelte di drammaturgia procede alla costruzione dell'opera comica. Come abbiamo già accennato, la parabasi occupava anticamente la sezione finale del dramma, serviva a chiudere l'azione comica e, infatti, soltanto in questa sede il poeta parla esplicitamente attraverso il coro e lo fa in uno spazio costruito a tale scopo. Del resto, lo stesso significato del termine "parabasi" (dal verbo greco parabàinó) ha un duplice valore: "avanzare di fronte agli spettatori" e "dire qualcosa in favore del poeta o della sua opera". Indica cioè contemporaneamente il movimento compiuto dal coro, nel momento in cui rinuncia alla sua "maschera" e si fa incontro agli spettatori, e lo scopo del coro medesimo: quello di sostenere le ragioni del poeta. Questo è quanto possiamo desumere dalle testimonianze degli antichi commentatori: Polluce, per esempio, retore erudito del secolo li d.C., che fu maestro dell'imperatore Commodo, si riferiva alla para-basi come a «una delle parti corali della commedia, cioè quando il coro avanza e dice ciò che il poeta vuole esprimere in teatro». Ma da quali segmenti era composta esattamente la parabasi? Come era possibile riconoscerla e isolarla dalle altre sezioni del dramma? Un criterio selettivo preferenziale è rappresentato dalla struttura metrica di questa porzione di commedia: la parabasi, infatti, si compone di sette sezioni distinte, alcune delle quali venivano cantate, dal coro o dal capocoro, e altre venivano recitate, ognuna con il suo metro o i suoi metri specifici. La peculiarità metrica della parabasi è, fra l'altro, una delle risorse migliori a disposizione dei filologi per collocare i frammenti comici superstiti nella sezione del dramma di cui facevano parte, in mancanza di qualsiasi notizia che aiuti a ricostruire con esattezza la struttura di una commedia perduta. All'inizio della parabasi, vi era di frequente una sezione introduttiva, chiamata kommàtion, spesso cantata, che costituiva il trait d'union fra la scena precedente e la parabasi vera e propria: in essa il coro talvolta salutava gli attori, che lasciavano la scena, prima che la sezione parabatica avesse inizio, "svestiva" i panni scenici e si rivolgeva al pubblico per richiedere la sua attenzione. Per esempio negli Acarnesi, una delle poche commedie che presentano la parabasi nella sua forma completa, il coro nel kommàtion recita: Quest'uomo l'ha avuta vinta con il suo discorso. E ci ha fatto cambiare idea riguardo alla tregua. Togliamo allora i costumi e diamo inizio agli anapesti, (vv. 626-627) In pochi versi sono contenute tutte le funzioni fondamentali di questa sezione iniziale: il coro chiude con la scena precedente e, nel contempo, dichiara in modo esplicito di volersi togliere gli abiti scenici, quelli degli abitanti del demo di Acarne. L'allusione agli anapesti serve poi a introdurre la parabasi vera e propria, il cui metro predominante era appunto il tetrametro anapestico. Il kommàtion non era comunque una sezione isolata, ma andava a formare un tutt'unico con la parte successiva, quella che gli antichi commentatori chiamavano propriamente parabasi, nonché con la chiusa finale, pronunciata spesso tutta d'un fiato (denominata, come nel
caso dell'agone, pnìgos). Situata abitualmente al termine del kommàtion, almeno nei casi in cui la porzione del dramma dedicata alla parabasi era completa e comprendeva cioè tutte e sette le sezioni che andremo ad analizzare (Acarnesi, Cavalieri, Vespe e Uccelli), la parabasi vera e propria era, di fatto, la parte più importante fra tutte, e anche la più originale. Recitata e non cantata, rappresentava la zona della commedia deputata a esprimere le istanze del poeta e i suoi appelli al pubblico. In essa, il commediografo spiegava spesso - attraverso la voce del coro - la ragione per cui prima di allora non si era mai fatto avanti (parabàinein) per difendere il suo operato; faceva allusione alle sue virtù personali, fra cui la modestia, e all'originalità delle sue creazioni. Attraverso la parabasi, il poeta poteva anche attaccare con violenza i suoi rivali, parlare con nostalgia dei tempi andati, sottolineare il grande valore civile dei suoi drammi e, infine, sollecitare la benevolenza del pubblico, dei giudici, talvolta attraverso il ricorso al biasimo contro chi lo aveva in precedenza privato della vittoria. Esemplificativa a questo proposito è la parabasi dei Cavalieri, poiché è fra le poche complete sopravvissute fino a noi e perché contiene molti degli elementi appena elencati: Va', dunque, ti saluto: che possa tu riuscire secondo la mia intenzione, e ti protegga Zeus Agoraio. Che tu possa, vincitore, tornare di nuovo da noi, incoronato di molte corone. E voi prestate attenzione a questi anapesti, voi che avete già gustato ogni specie di poesia, (ha qui termine il kommàtion) Se qualcuno degli istruttori di cori, di quelli antichi, ci avesse voluto costringere ad avanzare in teatro (tó théatron parabénai, da parabàino) di fronte al pubblico per recitare dei versi, non ci sarebbe riuscito con molta facilità. Questa volta però il poeta ne è degno, perché odia gli stessi che odiamo noi e ha il coraggio di dire il giusto e avanza nobilmente contro Tifone e l'uragano devastatore. E per quanto meravigli molti di voi che, andando da lui, gli domandavano per qual motivo, ormai da tanto, egli non chiedesse il coro a suo nome, egli stesso ci ha chiesto a spiegar-vene le ragioni. Dice dunque che non era per incapacità che aveva deciso di rimandare così, ma perché pensava che il mestiere di comporre commedie sia quello più difficile fra tutti e che, fra tanti che ci hanno provato, solo pochi ci siano riusciti. E poi perché si è accorto da tempo come voi cambiate umore ogni anno, e abbandonate gli antichi poeti non appena invecchiano. [...] Proprio perché temeva quest'eventualità il poeta indugiava; e inoltre era solito dire che bisogna fare il rematore, prima di diventare nocchiero, e poi diventare copilota, e osservare i venti, e, infine, fare il capitano per proprio conto. Per tutte queste ragioni dunque, e perché, uomo saggio qual è, non si è lanciato come uno stolto in teatro per raccontare frottole, levate, in suo onore, molti applausi, accompagnatelo con undici colpi di remo e con quel clamore di buon augurio proprio delle Lenee, affinché il poeta se ne vada contento per aver visto realizzarsi il suo voto, splendente e radioso nel volto, (vv. 498-550) Messi in scena alle Lenee del 424 a.C., i Cavalieri sono la prima commedia che Aristofane allestì a proprio nome, con un bersaglio politico di alto livello, il demagogo Cleone, rappresentato nei panni dell'odioso Paflagone. Nella parabasi è possibile ritrovare gli elementi caratteristici di questa sezione: le ragioni per cui il poeta non si è presentato prima di fronte al suo pubblico, le caratteristiche "meditate" della sua arte (non frutto di improvvisazione ma di duro lavoro), il timore per la volubilità di gusto degli spettatori, il richiamo alle commedie di chi lo ha preceduto e che, dopo un periodo di gloria, è entrato nella zona d'ombra del fallimento; la sollecitazione del favore del pubblico e la speranza della vittoria. Alla parabasi vera e propria segue la sizigia epirrematica, un blocco compatto di versi la cui struttura è già nota dall'agone: probabilmente all'interno della parabasi a metà del coro era assegnato il canto dell'ode, all'altra metà quello dell'antode, mentre la recitazione di epìrrema e antepirrema era affidata rispettivamente ai capocoro delle due metà del coro. Nella sizigia, il coro poteva cantare sia nelle vesti di coro comico, sia in quello di personaggio del dramma: poteva cioè parlare come avrebbe potuto fare qualsiasi coro, senza un'identità drammatica precisa, oppure assumere il ruolo di "personaggio del dramma": le Nuvole, i Cavalieri, le Rane... Una componente fondamentale del suo canto era l'invocazione alla divinità, sia che si trattasse di divinità del pantheon tradizionale, sia che si trattasse, per esempio, delle Muse. Gli esempi sono molti: anche la sizigia dei Cavalieri, di cui abbiamo appena fornito uno stralcio della parabasi, ha inizio proprio con l'inno agli dei: O Poseidon, ippio signore, cui piace il nitrito dei cavalli e il loro galoppo sonoro come il bronzo, e le veloci triremi dal rostro scuro, e le gare dei giovani superbi sul carro, anche se destinati a un destino crudele, vieni nel nostro coro! (vv. 551-559) La sizigia poteva anche contenere attacchi, più o meno duri, a cittadini in vista, noti al pubblico che sedeva nel
teatro: basti pensare al pesante assalto contro Cleone contenuto nella sizigia delle Nuvole: Quando volevate eleggere stratego il cuoiaio, Paflagone, odioso agli dei, aggrottammo le ciglia, e impazzammo con tuoni e fulmini. La luna abbandonò il suo corso, il sole ritirò la sua lanterna e minacciò di non illuminarvi più se fosse stato stratego Cleone. (vv. 581-586) In questo caso, il coro lancia i suoi strali contro Cleone e lo fa indossando i panni del suo personaggio scenico: le Nuvole. Oggetto della satira poteva anche non essere un individuo preciso, ma un gruppo di persone: quando il coro delle Vespe descrive se stesso agli spettatori, istituendo una precisa equivalenza fra i tratti peculiari del suo carattere e il comportamento delle vespe, il suo biasimo si appunta violento sui parassiti che si godono i frutti di chi si dà da fare e lavora con impegno: Ci guadagniamo la vita pungendo qui e là. Ma anche fra di noi ci sono parassiti che non hanno pungiglione, che se ne stanno lì senza far niente e succhiano il frutto della nostra fatica, senza far fatica. Questo è per noi il dolore più grande: che un "disertore" si mangi il nostro stipendio, uno che per la nostra terra non ha mai toccato remo, né lancia, e non ha neanche calli sulle mani. (vv. 1113-1119) Si tratta di un segmento estratto dal quadro di un discorso generale sui "bei tempi antichi": un'epoca in cui gli attici autoctoni (i giudici del coro) vincevano in guerra il barbaro straniero e ricevevano plauso e onori. Anche l'elogio del tempo che fu rientra del resto fra i temi preferiti della sizigia, così come la tendenza a glorificare il coro, nella sua dramatis persona. Gli appelli al pubblico sono altrettanto frequenti e lo sono anche gli appelli ai giudici, affinché concedano benevoli la vittoria nell'agone, nonché le minacce loro rivolte, qualora dichiarino vincitore un avversario del poeta. Negli Uccelli, per esempio, che contengono non una ma due para-basi, a stretta distanza una dall'altra, la seconda sizigia accoglie un articolato appello ai giudici del concorso (l'appello ai giudici, ove presente, è sempre confinato alla seconda parabasi): Vogliamo dire ai giudici una parola a proposito della vittoria: se ce la concederanno, daremo a tutti tanti doni quanti non ne ha avuti neppure Alessandro. Per prima cosa, ciò che ognuno dei giudici desidera di più: le civette del Laurio che non vi abbandoneranno mai. Verranno anzi a vivere nelle vostre case, faranno il nido nelle vostre borse e dalle uova faranno saltare fuori gli spiccioli. Poi le vostre dimore diventeranno templi, perché avranno aquile come frontoni. Se avete ottenuto in sorte un incarico pubblico, e volete rosicchiare qualcosa per voi, vi metteremo tra le mani un piccolo, ma rapace sparviero. Se sarete invitati a pranzo, vi daremo il gozzo. Ma se invece non ci fate vincere, pensate a fabbricarvi dei dischi di ferro come quelli delle statue. Chi di voi non ce l'ha e porta una veste bianca ce la pagherà doppiamente: tutti gli uccelli gliela molleranno addosso, (vv. 1102-1117) Nel suo genere, questo piccolo frammento di parabasi è un vero capolavoro: il coro promette ai giudici soltanto ciò che un "volatile" potrebbe fornire e, contemporaneamente, utilizza il classico motivo dell'aiscrologia (linguaggio osceno e offensivo) per minacciarlo. Come dimostrano gli esempi, nella sizigia epirrematica si mescolano molti temi, alcuni dei quali già presenti, seppur parzialmente, nella parabasi vera e propria. Tuttavia non si deve immaginare la struttura della sizigia soltanto come una successione di parti ordinate, ognuna con una precisa corrispondenza metrica e di contenuto. Può capitare, per esempio, che alcuni argomenti, riservati abitualmente alla sezione recitata (l'epìrrema), come l'autocelebrazione del coro nel suo ruolo drammatico, gli appelli agli spettatori, compaiano nell'ode o nell'antode che, anche se sono introdotte di solito dall'inno alla divinità, e hanno dunque un carattere più solenne, possono all'occasione contenere riferimenti del coro alla sua natura e alla sua funzione. Ciò accade fra l'altro nella Pace, dove l'epìrrema vero e proprio è assente: le tematiche che tradizionalmente vi avrebbero trovato posto, vengono spostate allora nella sezione cantata della sizigia.
Tale eterogeneità, per quanto riguarda gli argomenti trattati, è fra l'altro tipica della parabasi, una porzione del dramma esposta più di altre all'evoluzione, dal momento che protagonista ne era il coro, destinato a vedere fortemente ridotto il suo ruolo con il passare degli anni. Così, per esempio, sembra che già intorno al 430 a.C. (come dimostrano i frammenti superstiti di Cratino, il più antico fra i grandi comici ateniesi del secolo v a.C.) nella struttura di base della parabasi fosse stato operato qualche cambiamento: i temi peculiari della sizigia erano penetrati nella parabasi vera e propria a discapito dell'elogio del poeta, a cui questa sezione era originariamente dedicata. Questo mutamento "tematico" inizia a comparire nell'opera di Aristofane fra la Pace (421) e gli Uccelli (414): prova ne sono per esempio le Tesmoforiazuse (411), in cui la parabasi, mutila di molte delle sue sezioni, si concretizza in una lunga tirata del coro, nella sua veste di personaggio scenico (le donne del Tesmoforio), a favore delle donne, del loro ruolo e della loro onestà, contro gli uomini, identificati parzialmente con il pubblico, che pur essendo per la gran parte malfattori e sicofanti, non rinunciano ad accusare le loro compagne delle peggiori nefandezze. Sparisce, da qui in poi, qualsiasi tentativo di lodare il poeta e la sua arte e di perorarne la sorte, anche se il coro aveva la possibilità di rivolgersi ugualmente agli spettatori e invocare la vittoria, in una parabasi secondaria, che seguiva la prima, come accade per gli Uccelli. Del resto, anche quando la parabasi cessò di occupare alcun ruolo all'interno della commedia, come accade nelle ultime opere di Aristofane, Ecclesiazuse (392) e Pluto (382), il coro poteva ancora cercare di sensibilizzare pubblico e giudici per ottenere la palma della vittoria, utilizzando uno stile che richiamava direttamente l'antica parabasi. Negli ultimi versi delle Ecclesiazuse, infatti, il coro così si esprime: Voglio dare un piccolo consiglio ai giudici. I saggi siano memori delle mie sagge parole, e mi votino. Quelli che ridono volentieri, per le risate che hanno fatto votino me. E dunque dico quasi a tutti di votare per me. Non mi danneggiate con il sorteggio, solo perché mi è toccato in sorte di uscire per primo. Ricordatevi di tutto ciò, e non mancate al giuramento: si devono giudicare i cori secondo il merito, e non fare al modo delle puttane da poco, che ogni volta si ricordano soltanto dell'ultimo! Su, su, è ora, mie care compagne, se vogliamo realizzare appieno il nostro progetto, di muovere danzando verso il banchetto, (vv. 1154-1165)
4.2.4 La seconda parte del dramma Quando la parabasi si chiude, ha inizio una serie di scene in metri giambici che possono emulare nella struttura responsiva quella della sizigia epirrematica (si parla allora di sizigia giambica) oppure possono assumere la forma di scene episodiche, inframmezzate da sezioni liriche autonome. A volte queste scene si susseguono senza alcuna interruzione, a catena, e può capitare che siano posizionate nella prima parte della commedia, anziché, come di consueto, verso la fine: qualora trovino posto all'inizio del dramma, sostituiscono altre porzioni dell'opera. Per esempio, negli Acarnesi, l'agone propriamente detto viene rimpiazzato da due sizigie giambiche: lo scopo è quello di presentare la difesa di Diceopoli come una parodia delle orazioni pronunciate in tribunale, il cui metro privilegiato era appunto il trimetro giambico (vv. 366-384). Dal punto di vista del contenuto, questi segmenti isolati sono talvolta la prosecuzione dell'azione principale della commedia e rappresentano perciò la realizzazione del progetto utopico dell'eroe: nei Cavalieri, nelle Rane e nelle Tesmoforiazuse la seconda parte del dramma è ancora dedicata alla concretizzazione dell'idea comica elaborata nella prima parte. In genere, tuttavia, le scene episodiche situate nella seconda parte dell'opera sono destinate alla rappresentazione di azioni e situazioni "minori", o alla descrizione di quanto è stato già realizzato nella porzione iniziale della commedia; per esempio negli Uccelli è questa la sede in cui viene descritto il regno fra le nuvole, adombrato nel progetto immaginifico di Pisetero. Questo vale tanto per le commedie (Acarnesi, Vespe, Pace, Uccelli e Lisistrata) in cui è presente la parabasi, tanto per le ultime opere, Ecclesiazuse e Pluto, che non hanno la parabasi e rinunciano esplicitamente a conferire un'importanza così centrale al ruolo del coro. Particolarmente sfruttata è poi - nei drammi più antichi - l'idea di presentare sulla scena un personaggio farsesco, ridicolo e abborracciato (il cosiddetto bomolóchos) che irrompe in teatro tentando di mettere in crisi la realizzazione del progetto eroico. I suoi sforzi non hanno naturalmente esito alcuno, se non quello di farlo cacciar via in malo modo: la maggior parte delle scene giambiche di Acarnesi, Pace e Uccelli corrispondono a tale modello, ma anche alcune di quelle presenti nelle Nuvole o nelle Vespe. La sezione dell'esodo chiudeva definitivamente la commedia antica, così come accade nella tragedia: essa non presenta un contenuto fisso e stereotipato, anche se alcuni temi ricorrono con frequenza. Sulla scorta del modello tragico, per esempio, un personaggio in funzione di messo può fare la sua comparsa sulla scena a illustrare agli spettatori gli eventi: eventi futuri o fatti avvenuti fuori scena. Negli Acarnesi infatti spetta a un
servo di Lamaco, l'antagonista di Diceopoli, aprire l'esodo: O servi della casa di Lamaco, scaldate subito una pentola d'acqua, preparate fasce e cerotti, lane e bende per la caviglia. Saltando un fosso, l'eroe si è ferito contro un palo; si è slogato la caviglia, e cadendo ha sbattuto anche la testa: la Gorgone dello scudo si è praticamente svegliata. E, come la piuma di quello spavaldo cadeva per terra, levò un canto terribile: "Splendido occhio del sole, per l'ultima volta ora ti vedo; lascio la luce, ormai non sono più". Dopo aver detto ciò, cade in un rigagnolo, (vv. 1174-1186) Un servo con funzione di nunzio compare anche nelle Vespe e un vero e proprio araldo è presente nell'ultima parte degli Uccelli: Voi ricolmi di ogni bene, più di quanto si possa dire, tre volte beati, stirpe degli uccelli, accogliete il re nel ricco palazzo. Si avanza fulgido come mai si vide un astro rifulgere nel suo cammino dorato di luce, più del baleno del sole, i cui raggi arrivano lontani. E insieme a lui si avanza una donna di una bellezza indicibile. In mano ha la folgore, la freccia alata di Zeus. Un profumo arcano si diffonde nel profondo del cielo: meraviglioso spettacolo a vedersi. Brezze leggere sollevano in volute il fumo d'incenso. Eccolo, ora s'intoni il sacro canto delle Muse, (vv. 1706-1719) Al di là di questi richiami, spesso ironici, al mondo alto della tragedia, l'esodo della commedia ha tratti ricorrenti, come l'accentuazione della licenziosità di fondo tipica del carattere ludico di questo tipo di opera: nell'esodo si celebrava di frequente non solo il trionfo dell'eroe, ma anche la speranza di ottenere la vittoria nel concorso drammatico. Al canto trionfale per l'esito della vicenda comica si intrecciavano anche scene di festini, descrizioni boccaccesche di unioni sessuali e canti di imeneo (nuziali): negli Acarnesi, l'ultimo quadro offerto allo sguardo degli spettatori rappresenta Diceopoli vincitore contrapposto allo sconfitto Lamaco e lo raffigura mentre celebra la realizzazione della sua utopia in un tripudio di gioie sessuali. Nelle Rane, commedia non solo decisamente più tarda (405), ma anche più cupa degli Acarnesi, il re degli Inferi offre un banchetto finale ai suoi ospiti e così si congeda dagli spettatori. Al coro spettava il compito di accompagnare con il canto e la danza il carattere festivo dell'occasione, anche se vi sono casi, come quello degli Acarnesi e delle Nuvole, in cui i coreuti lasciavano il teatro a passo di marcia, senza danzare. Le Nuvole rappresentano un'eccezione parziale anche alla regola in base a cui una commedia si doveva chiudere con un'esplosione di gioia: nella scena finale di questo dramma trova infatti posto un evento tutt'altro che felice, l'incendio del pensatoio socratico. Ma le Nuvole, quelle in nostro possesso, non vennero mai rappresentate e non possiamo dunque sapere con certezza quale sarebbe stato il destino scenico di questa commedia. Il naufragio pressoché totale della commedia di mezzo non ci permette di valutare quale significato e quale ruolo avesse l'esodo in queste opere per noi perdute, ma anche la commedia di Menandro da questo punto di vista ci fornisce ben pochi elementi di raffronto con quella aristofanea più antica. I drammi di Menandro sopravvissuti purtroppo sono spesso mutili della parte finale e non ci consentono di delineare un modello generale di esodo. Con ogni probabilità, dal momento che gli intrecci menandrei sono sempre storie di vicende familiari, complicate da equivoci e fraintendimenti, le commedie si chiudevano spesso con la risoluzione delle intricate questioni domestiche e con uno o più matrimoni: con un'unione nuziale ha termine infatti la Samia e con un doppio matrimonio, accompagnato da un banchetto liberatorio, trova risoluzione il conflitto del Misantropo.
4.3 Gli ingredienti del dramma Negli Acarnesi si narrano le vicende di Diceopoli, personaggio con un nome parlante (dike, la "giustizia" e pòlis, la "città": "colui che conosce la giustizia per la città", il "portatore di giustizia"), il quale, afflitto dalla miseria che imperversa ad Atene, ma soprattutto nelle campagne che la circondano, concepisce un progetto grandioso: una pace privata fra lui e Sparta. Per raggiungere il suo obiettivo, deve superare numerosi pericoli e scontrarsi con il coro, finché riesce a raggiungere lo scopo e, dopo essersi liberato di individui molesti che vogliono rubargli la tregua, ha ragione dei suoi nemici e celebra il trionfo nel banchetto finale. Quest'arido riassunto tenta di schematizzare la costruzione dell'intreccio degli Acarnesi e si presenta né più né meno sullo
stesso piano dei tentativi di fornire un modello formale per elementi centrali della commedia antica, quali l'agone e la parabasi. Anche dal punto di vista del contenuto, infatti, si può proporre una griglia generale che gli Acarnesi, ridotti così a scarne relazioni fra eventi, sembrano esprimere alla perfezione: c'è un eroe, spesso vecchio e spesso contadino, che concepisce un'impresa, il cui contenuto è segnato dalla cifra dell'utopia o del grottesco; si impegna per realizzare quanto vuole fortemente e lo fa con toni e modi che richiamano, parodiandole, le imprese eroiche del mito greco. Trova chi gli si oppone: si tratti del nemico o del coro, quest'ultimo ricondotto a più miti consigli dopo la vittoria agonale dell'eroe. Nella seconda parte del dramma, interviene una serie di figure minori, che vogliono sfruttare o mettere in crisi il nuovo mondo del protagonista, ma questi nemici vengono alla fine espulsi e sconfitti. Un banchetto, nella maggior parte dei casi una festa nuziale, costituisce il sigillo trionfale alla vicenda. Tuttavia, la ricostruzione di questo racconto semplifica eccessivamente l'invenzione dell'autore; in realtà, se è sempre difficile "disciplinare" la creatività e le scelte drammaturgiche di un artista a una serie di affermazioni di carattere generale, nel caso di Aristofane tutto ciò è reso ancor più difficile dalla complessità della produzione artistica, dal carattere spesso inafferrabile dello spirito che pervade le sue commedie. Qualora si vogliano indagare le sue scelte drammaturgiche, si deve dunque procedere per filoni, per piste, e analizzare, di volta in volta, le ragioni delle strategie compositive che soggiacciono ai suoi drammi, per individuare alcuni nuclei tematici da cui hanno origine gli intrecci e lo sviluppo delle singole trame. Un tratto fondamentale della drammaturgia aristofanea è costituito indubbiamente dalla creazione del suo "eroe", del protagonista delle sue trame illusorie. Accusato spesso di sfornare "tipi" (il vecchio contadino, il filosofo, il poeta, il servo...), Aristofane in realtà è ben lontano dalla tipizzazione compiuta dalla commedia nuova, che inventa di fatto i ruoli e fa dei protagonisti della trama espressioni di altrettante categorie sociali e culturali: l'avaro, il misantropo, la mezzana, il soldato... Ogni eroe di Aristofane è invece una figura originale, anche se condivide con i protagonisti delle altre commedie alcune caratteristiche generali e una certa tendenza ad agire, di fronte a problemi simili, in modo simile. Diceopoli, che è il primo protagonista di Aristofane a essere giunto fino a noi, assomma gran parte di questi ingredienti comuni a molti degli eroi del poeta: è un contadino, è tradizionalista, sente di appartenere profondamente ad Atene, ma viene da un demo campagnolo. Ha di se stesso un'alta opinione dal punto di vista "sociale", ma è tutto preso dalla realizzazione di un'utopia strettamente personale ed egoistica. È uno che si arrangia, un po' ignorante, ma che sa perfettamente come la strada vincente passi attraverso l'utilizzo e l'abuso di tutte le armi "della cultura" su cui potrà mettere le mani. Per questa ragione, si reca a casa del tragediografo Euripide (sul rapporto fra Euripide e Aristofane torneremo fra poco), per rubargli qualche straccio tratto dalle sue tragedie. Il piano è quello di sfruttare i "panni tragici" che giacciono nell'officina creativa di Euripide, per interpretare un ruolo tragico: Telefo di Misia, protagonista dell'omonimo dramma euripideo (di cui non sopravvivono che frammenti). Il fine è di presentarsi davanti agli acarnesi con un costume mutato e una nuova personalità: quella di un eroe "pezzente", ma in possesso di eccezionali qualità oratorie, com'era Telefo. Sono queste le armi con cui Diceopoli intende vincere la resistenza del coro e scampare al linciaggio. L'idea comica che soggiace a questa realizzazione scenica è, di fatto, uno dei fulcri della poetica aristofanea e una delle spie rivelatrici delle sue scelte drammaturgiche. Il teatro comico di Aristofane è ricerca sul modo di fare teatro, sui trucchi del mestiere, sulle potenzialità del costume e sull'effetto che quest'ultimo ha sul pubblico. Se la para-basi o le frequenti rotture dell'illusione scenica dimostrano quanto il teatro comico sapesse riflettere su se stesso e sulle proprie convenzioni, l'idea di un eroe che veste i panni di un altro eroe questa volta tragico - e lo fa sulla scena, di fronte allo sguardo degli spettatori, apre un ulteriore squarcio sul laboratorio della creazione poetica. E lo fa prima di tutto spingendo lo spettatore a una profonda presa di coscienza del ruolo che il costume assumeva nella finzione drammatica, sia comica che tragica. Diceopoli non è, infatti, naturalmente, un individuo reale, ma un attore che impersona il ruolo di quest'originale contadino, al quale non sembra bastare la parte carismatica di eroe della situazione; al contrario egli va alla ricerca di un nuovo costume, tratto dai drammi di Euripide, per avere la meglio sui propri nemici. Il costume è dunque un'arma: serve a ingannare gli interlocutori (o gli spettatori), a creare una realtà fittizia in luogo di quella
originale, a convincere, a persuadere, a produrre un'illusione. Quest'esperimento, il tentativo cioè di travalicare i limiti della finzione drammatica per proporre una riflessione sul modo in cui si faceva teatro, non rimane del resto un caso isolato nella produzione di Aristofane: Diceopoli è soltanto il primo degli eroi a cui viene in mente di rubare un nuovo "costume" per utilizzarlo come strumento per realizzare i propri piani. Dopo Diceopoli, viene lo stesso Euripide il quale, nelle Tesmoforiazuse, interpreta brani delle proprie tragedie per produrre finzioni sceniche in grado di disorientare i carcerieri del suo parente, Mnesiloco, fino a spingerli a liberarlo. Ma quest'idea innovativa, che ha come suo antenato il Diceopoli degli Acarnesi, celebra il suo trionfo nelle Rane, le quali si aprono, come abbiamo più volte avuto occasione di ricordare, con il dio del teatro che indossa i grotteschi panni di Eracle per entrare nel mondo degli Inferi. Il movente di questa scelta bizzarra, che in ogni caso conduce alla creazione di un personaggio ibrido - nel quale si assommano costumi appartenenti a identità diverse -, è anche nelle Rane quello di utilizzare il nuovo ruolo come uno strumento per realizzare la propria, personale utopia. Acarnesi, Tesmoforiazuse e Rane non hanno, tuttavia, in comune soltanto l'impiego di nuovi costumi, di nuove identità, ma anche il profondo legame con la tragedia, in particolare quella euripidea: è alla porta di Euripide, infatti, che Diceopoli bussa per avere il suo abito di scena; è Euripide uno dei protagonisti delle Tesmoforiazuse che indossa proprio i panni dei suoi eroi e che, in apertura del dramma, si reca a casa del poeta tragico Agatone, per chiedergli aiuto nella realizzazione dei suoi piani. Le Rane infine celebrano il legame, strettissimo, che la commedia aristofanea intrattiene con la tragedia, portando sulla scena il dio del teatro che scende nel mondo delle Ombre spinto dalla nostalgia e dal rimpianto per la tragedia dell'epoca. Quando le Rane vengono rappresentate (405), sono ormai morti sia Eschilo, sia Sofocle, sia Euripide, e il pavido Dioniso decide di affrontare le insidie degli Inferi, pur di ritrovare Euripide, del quale soffre irrimediabilmente la mancanza. Giunto nel regno di Ade, dio dei morti, si troverà ad assolvere al ruolo di giudice di un agone poetico di altissimo livello: quello fra Eschilo ed Euripide. Gli esiti di questo scontro non ci interessano direttamente, ma è importante ricordare il ruolo che, ancora una volta, la tragedia assolve nella costruzione della trama aristofanea. E non si tratta soltanto di un pretesto per creare un plot narrativo: l'antico poeta Cratino, contemporaneo di Aristofane, inventò a tal proposito un bellissimo verbo: Euripidaristofanizein, per indicare lo speciale legame che Aristofane intrattenne con il suo rivale di sempre, Euripide. A quest'ultimo, infatti, il poeta guardò costantemente nella costruzione dei suoi drammi e ne sezionò verso per verso le tragedie, alla ricerca delle straordinarie scelte poetiche (linguistiche, stilistiche e contenutistiche) che in esse si disvelavano. Euripide è così presente nell'opera comica di Aristofane da divenire spesso un personaggio del dramma: dileggiato per la sua passione per gli eroi cenciosi, ma padrone dell'officina in cui, negli Acarnesi, viene inventato il teatro, protagonista delle Tesmoforiazuse, interprete dell'agone centrale delle Rane. Proprio questo legame fecondo e conflittuale con Euripide rivela la profondità dell'interesse che Aristofane sempre manifestò per gli elementi drammaturgici che compongono la rappresentazione, e la consapevolezza con cui ne fece uso nelle sue opere. Il cenno al protagonista delle Rane, Dioniso, ci riporta al tema da cui siamo partiti: la definizione dell'eroe comico di Aristofane e delle sue caratteristiche. Se Diceopoli, infatti, rappresenta al meglio un certo "tipo eroico" a cui Aristofane fece spesso ricorso (basti pensare al Trigeo della Pace o, parzialmente, allo Strepsiade delle Nuvole), non si può utilizzare il modello esemplificato dal contadino di Acarne per definire tutti i protagonisti della trama aristofanea. Dioniso, per esempio, non è né un mortale né, tanto meno, un contadino: è un dio, il dio del teatro fra l'altro, e il suo personaggio somiglia solo parzialmente a quello di Diceopoli. In comune i due hanno certamente la pervicacia con cui perseguono i propri fini ma, mentre Diceopoli appare fin da subito dotato di quella furbizia, di quella capacità di sopravvivere e di arrangiarsi che sono le sue armi fondamentali, Dioniso è sprovveduto, del tutto impreparato ad affrontare le insidie del mondo infernale, anche se il suo status "divino" lo eleva poi, nella seconda parte del dramma, al rango privilegiato di giudice e lo sottrae alle peripezie che toccano a Diceopoli e a quanti gli somigliano. Ancor più distanti dal modello del vecchio contadino sono le donne: Lisistrata (protagonista della commedia omonima) e Prassagora (eroina delle Ecclesiazuse). In questo caso, il primo elemento che le distanzia dal modello generale elaborato è la loro appartenenza al sesso femminile, ma non si tratta soltanto di una differenza di genere. Lisistrata e Prassagora sono, infatti, profondamente diverse, sia da un eroe come Diceopoli che da uno come Dioniso. La loro diversità è, prima di tutto, una diversità fisica: il loro corpo comico (gli attori come sappiamo erano tutti uomini) è costruito in modo antitetico rispetto a quello dei colleghi maschi. Al posto dei "pieni", rappresentati dall'enorme fallo di cuoio, a cui anche Aristofane - pur negandolo - faceva ricorso, ci sono i "vuoti", e al posto dei "vuoti" i "pieni": seni barocchi e natiche generose. Quest'estraneità anatomica, rispetto al rustico contadino di tante commedie, influenza la definizione del personaggio e determina l'andamento del
dramma. Sia nella Lisistrata che nelle Ecclesiazuse, infatti, l'utopia femminile passa per il dominio sul corpo, che si trasforma in un'arma per acquisire il potere. Nella Lisistrata, messa in scena nel 411, la protagonista del dramma decide di prendere il potere e di occupare l'acropoli, imponendo agli uomini il cessate-il-fuoco con Sparta, proprio utilizzando il suo corpo e quello delle compagne, o meglio sottraendolo al desiderio dei mariti. Rappresentata, significativamente, proprio nell'anno in cui Mnesiloco nelle Tesmoforiazuse si travestiva da donna e si sottoponeva a ogni serie di vessazioni per far somigliare il proprio aspetto a quello femminile (depilazione...), la Lisistrata ha per protagoniste donne che fanno ricorso all'astinenza forzata per realizzare la loro utopia: la pace con Sparta. Sessualità e potere si intrecciano anche nelle Ecclesiazuse che, pur essendo molto più tarde della Lisistrata (di circa una ventina d'anni), mettono in scena lo stesso binomio pericoloso e descrivono un gruppo di donne, capitanate da Prassagora, impegnate a trasformare il proprio corpo al punto da potersi introdurre in un'assemblea di soli uomini e strappare loro il controllo della città. Diceopoli, Dioniso e Lisistrata sono naturalmente soltanto esempi: esempi della decisione di Aristofane di inventare un eroe che va a caccia della sua utopia, senza declinarlo in modo identico in ogni commedia. Proprio la poliedricità, l'ambiguità, anche la contraddizione di queste figure rappresentano del resto il marchio del poeta sulla sua opera e differenziano in modo sostanziale le scelte compiute nella commedia antica da quelle menandree della commedia nuova. La diversità fra i due mondi è ben visibile fin dall'origine in una scelta diversa per quanto riguarda il costume e il corpo dell'eroe che si presenta sulla scena: la commedia nuova rinuncia, infatti, totalmente al costume, quale elemento rivelatore di un'identità originale, e si affida alle maschere che servono a tipizzare un ruolo, a fare, per intenderci, di ogni vecchio in ogni commedia lo stesso vecchio. È la creazione del "tipo": del servo, della mezzana, dell'innamorato, del vecchio... che costituirà il segno distintivo di questo genere di commedia, destinato a divenire oggetto di imitazione nella commedia latina di Plauto e Terenzio. In Menandro non ci sono eroi, e neppure protagonisti: è difficile rintracciare all'interno delle commedie superstiti una figura centrale, intorno alla quale tutte le altre ruotino. In parte Smicrine, il detestabile vecchio dello Scudo, assolve a questa funzione, ma non possiamo sapere se la parte del dramma per noi perduta avrebbe confermato la sua centralità. Abitualmente, i personaggi che si muovono sulla scena del secolo iv non assumono mai una dimensione assoluta e, proprio per questo, non sono segnati dalla strabordante individualità degli eroi aristofanei. Il protagonista della commedia antica, lo abbiamo visto, giganteggia nella trama, coinvolge e travolge tutti gli eventi e tutti i personaggi sotto la forza della sua utopia, mentre il personaggio della commedia nuova interagisce con gli altri interpreti del dramma e difficilmente assume una statura di primo piano: nella Donna tosata, per esempio, protagonista dovrebbe essere Polemone il quale, tuttavia, non ha che un ruolo marginale nella vicenda centrale dell'opera (il riconoscimento); lo stesso vale per Demea che, nella Samia, rimane di fatto estraneo al nucleo della commedia, la storia di Moschione. Forse solo Cnemone, protagonista del Misantropo, assurge con la sua ingombrante misoginia, la sua pazzia, il suo odio per il mondo, a individualità originale. In questo ricorda la personalità di Filocleone, il vecchio pazzo per i processi delle Vespe di Aristofane, ma, mentre l'eroe di Aristofane utilizza la follia come puntello per realizzare il suo progetto utopico, Cnemone è imploso, isolato, non ha nulla della forza titanica dei suoi colleghi più antichi: solo la figlia può entrare nel suo mondo di solitudine e spezzarne le rigide leggi. Questa "normalizzazione", la tendenza a fare di ogni personaggio un tipo, più che un individuo, da un lato fa sì che sia difficile stabilire un rapporto "gerarchico", di maggiore o minore importanza, fra uno e l'altro dei protagonisti della scena, dall'altro sbilancia l'interesse drammaturgico di Menandro verso il plot narrativo, l'intreccio. Se i personaggi sono, infatti, un po' appiattiti su un modello generico, le sue storie compensano questa normalità di ruoli con un barocco affollarsi di colpi di scena: figli nati da relazioni clandestine, amori contrastati, fratelli separati, personaggi creduti morti, conflitti fra generazioni... si affollano nelle commedie e costituiscono la ragione per cui gli antichi decretarono con tanto entusiasmo il successo di questa tipologia di dramma. Essa si distacca completamente dalla costruzione drammatica della commedia antica, per la quale centrale era il rapporto dinamico fra l'eroe e la sua impresa, fra il primo attore e il coro e non i particolari novellistici delle vicende. La rinuncia ad approfondire le caratteristiche dei singoli personaggi si contrappone anche alla ricerca originale che Aristofane compì per delineare la fisionomia dei personaggi minori: quelli che si oppongono all'eroe comico o che, al contrario, ne sostengono la causa, ma anche quelli che compaiono in teatro per una sola scena. Fra gli antagonisti, un posto d'onore è occupato da Lamaco, il capitano sconfitto degli Acarnesi, il quale in una scena esilarante contrappone la sua concezione del mondo, fatta di onore e di scontro in battaglia, a quella di Diceopoli, pronto a una tregua ottenuta con trucchi di scena. Lamaco è destinato a essere sconfitto, perché è esattamente l'opposto di Diceopoli: perché il suo ego non invade il palcoscenico e non lo permea, perché non sa arrangiarsi e conquistarsi la sua tranquillità personale, anche a spese di quella collettiva. Mentre Diceopoli celebra il suo trionfo, abbracciato a due fanciulle compiacenti, Lamaco viene portato via, ferito e
sconfitto. Attraverso il personaggio di Lamaco, Aristofane esplora un altro nucleo centrale della sua drammaturgia: l'attacco contro un personaggio reale, a lui contemporaneo. Lamaco, infatti, era un valoroso generale, protagonista di molti atti eroici nel corso della guerra del Peloponneso e compagno di Alcibiade e Nicia nella spedizione in Sicilia. Morto nell'assedio a Siracusa nel 414, era ancora vivo quando Aristofane decise di farne l'oggetto del suo dileggio negli Acarnesi. Specchio deformato della fama di cui godeva nell'opinione pubblica sono le parole con cui il coro lo accoglie sulla scena, mentre fa il suo ingresso, avvolto in alta e sgargiante uniforme: «Oh Lamaco, sguardo sfolgorante, cimiero di Gorgone, vieni in aiuto, oh Lamaco!» (vv. 566-568). Ma ai toni rutilanti di questa entrée fanno da contraltare le parole con cui il poeta atterra, verso per verso, il suo personaggio e lo condanna alla sconfitta. Lamaco è il capostipite di tutta una serie di figure colpite dal dileggio spietato di Aristofane: di una sorta di persecuzione fu oggetto Cleone, il generale ateniese, figlio di un conciatore di pelli. Aristofane odiava Cleone, così come lo disprezzava lo storico Tucidide, e affonda l'arma della sua ironia più in profondità che in altri casi, facendone l'odioso protagonista dei Cavalieri, sotto le mentite spoglie del volgare e tracotante Paflagone, e insultandolo pesantemente anche nella parabasi delle Nuvole. Per Cleone, Aristofane inventa un'immagine proteiforme, al confine fra umanità e bestialità: Cleone è una cagna, una foca, un cammello, un vampiro. Il suo odio contro il demagogo non rimane nei limiti della leggera ironia, ma si scatena con una pesantezza che non ha uguali, né nella produzione del poeta né in quella dei suoi contemporanei. Persino Cratino, celebre per la fierezza dei suoi versi, non toccò mai il picco raggiunto da Aristofane nel delineare la figura di Cleone: forse non è un caso (come sostiene Cedric Whitman) se i Cavalieri sono la prima opera rappresentata da Aristofane a proprio nome. Probabilmente, Callistrato - che fino ad allora era stato il prestanome dei drammi aristofanei - non ebbe il coraggio di sostenere una commedia in cui così duro e diretto era l'attacco contro un personaggio politico del tempo. Accanto a figure politiche ci sono grandi esponenti del mondo della cultura: Agatone (il poeta tragico deriso nella prima parte delle Tesmoforiazuse), Euripide, ma anche il filosofo Socrate (le Nuvole). Secondo Platone (Apologia) proprio l'attacco dei poeti comici, e di Aristofane in particolare, a Socrate può essere annoverato fra le cause maggiori della sua impopolarità e fra le ragioni, anche se indirette, che portarono alla sua condanna a morte. Nelle Nuvole, infatti, Socrate viene messo in scena mentre ondeggia, grottesco e svanito, in una cesta appesa a mezz'aria. Il suo pensatoio, che va in fiamme nella scena finale della commedia, è la rappresentazione distorta di una scuola filosofica, dove, di fatto, si insegnano i principi in voga negli ambienti sofistici, legati sostanzialmente alla capacità di vincere il nemico in un agone retorico. Eppure, così come accade per Euripide, la durezza dell'attacco contro Socrate non è sufficiente a nascondere il profondo interesse con il quale Aristofane guardava alle correnti filosofiche del suo tempo. Da questo punto di vista, l'ironia dalla quale è investito il celebre pensatore si muta in un tributo: nel riconoscimento della potenzialità dirompente delle nuove idee e della loro declinazione nel mondo reale. Naturalmente, la satira rivolta contro personaggi "in carne e ossa" è del tutto assente dalla commedia nuova: la rinuncia all'ironia feroce, a ogni accenno alla realtà del tempo non ammette la presenza di individui veri, anche se distorti dallo specchio deformante del verso comico. L'unico tratto di somiglianza - sul piano della definizione dei personaggi secondari - fra la commedia antica e quella nuova si ritrova forse nella figura del servo il quale, anche in Aristofane, assume caratteristiche "standard" che lo fanno somigliare al tipo del servo menandreo. Il servo per eccellenza nella commedia di Aristofane è certamente Xantia, lo straordinario compagno del viaggio di Dioniso agli Inferi: Xantia è furbo, persino geniale nella sua astuzia; riesce a sfruttare l'ingenuità del suo padrone per usurparne, seppur temporaneamente, il ruolo. Assume, nella prima parte del dramma, il ruolo di comprimario, che gli viene sottratto soltanto quando la commedia cambia tono e si incentra sul conflitto agonale fra Eschilo ed Euripide. Forti personalità sono anche i servi della Pace, i quali intrattengono gli spettatori per tutto il prologo, nella descrizione esilarante dell'accudimento dello scarafaggio gigante che deve portare Tri geo sull'Olimpo. Un ruolo determinante è affidato ai servi dei Cavalieri, a cui viene attribuita l'idea geniale di inventare dal nulla un nuovo demagogo, un rozzo venditore di salsicce che serva a contrastare la schiacciante individualità di Paflagone. Analogamente, grande importanza nella trama assume il celebre Davo, pedagogo di Cleostrato nello Scudo menandreo, nonché i molti servi del Misantropo. A Onesimo, poi, (l'Arbitrato) viene riservato il compito, cruciale, di riconoscere l'anello del suo padrone fra gli abiti del bambino abbandonato e di indirizzare in senso positivo il flusso degli eventi. Il servo della commedia è dunque, spesso, una figura determinante, in grado di imprimere una svolta alla trama o di illustrarla al pubblico; è furbo e duttile, abitualmente più di quanto lo siano i suoi padroni e può rappresentare - anche se unicamente nella commedia antica - una sorta di filtro fra il protagonista del dramma e gli spettatori, attraverso l'espediente della rottura dell'illusione scenica. Al di là della figura del servo (o dei personaggi che assumono analoga importanza all'interno della trama),
tuttavia, Menandro non sembra minimamente interessato alla cesellatura dei personaggi di contorno: quelli per intenderci che compaiono una sola volta in scena. Al contrario, Aristofane dispiega tutta la sua arte nella definizione di tali ruoli, anche e soprattutto con il ricorso alle armi del lessico e della lingua. Fra tutti spicca per esempio il celebre ambasciatore persiano degli Acarnesi, che compare sulla scena all'inizio del dramma ondeggiante come una nave sulle onde, con un enorme occhio grottesco posto al centro della fronte e viene così apostrofato da Diceopoli: Per Eracle, per tutti gli dei! Hai uno sguardo che sembra una nave da guerra e mira alla darsena, curvando intorno al promontorio. E sotto l'occhio, pare che tu abbia un fodero per remi. (vv. 94-97) Lo scopo è quello di rappresentare l'"occhio del re", una sorta di ispettore, di spia del re presso le città straniere, un altissimo dignitario della corte persiana, del quale parlano anche Erodoto (Storie 1, 114) e Senofonte (Ciropedia 8, 2). Questa creatura abnorme si esprime in una lingua proteiforme, in cui affiorano fonemi linguistici greci, privi però di ogni nesso sintattico che li colleghi: «Artamane Serse Ioni satra... Oro niente soldi, ioni rottinculi» (vv. 100-104). La distorsione linguistica è anche lo strumento con cui viene caratterizzata la figura dell'arciere scita: il carceriere di Mnesiloco (il parente di Euripide) nelle Tesmoforiazuse, nella cui parlata emergono distorsioni linguistiche di ogni genere (soprattutto l'uso eccessivo delle aspirate). La commedia aristofanea abbonda del resto di nuove parole, di ambiziose invenzioni grazie alle quali un fonema diventa il frutto di un assurdo accumulo di singoli termini: il richiamo che Lisistrata lancia alle compagne perché l'aiutino suona così «O spermagoraio-lekitholachanopolides, o skorodopandokeutriartopolides» (Lisistrata vv. 457-458). Bdelicleone, per esprimere il suo desiderio che il padre rinunci ad alzarsi al mattino presto per recarsi in tribunale, utilizza la seguente espressione: orthrofoitosykofantodikotalàiporon, una cascata di sillabe impronunciabili. La sperimentazione linguistica del poeta non si limita fra l'altro alla creazione di nuove parole, stralunate e incomprensibili, ma mira all'invenzione di un intero vocabolario, la cui cifra caratterizzante sia la sorpresa, l'assurdo, l'inaspettato. Poche parole vanno dette anche a proposito di un altro protagonista fondamentale della trama aristofanea: il coro. Il coro della commedia antica irrompe potentemente in scena nella parodo, organizza un filtro musicale e immaginifico fra gli attori e gli spettatori nel teatro; svela i trucchi della macchina scenica nella parabasi e sostiene le istanze del poeta così da fargli ottenere la vittoria; assiste, abitualmente come spettatore silenzioso, al conflitto agonale e concede all'eroe e alla sua utopia la propria benevolenza. Lascia infine la scena sfilando nell'orchestra davanti agli spettatori e scrive la parola fine del dramma. Ma il coro è anche, lo abbiamo già detto, un personaggio: è le Nuvole, le Rane, gli Acarnesi, le Tesmoforiazuse. Ha, cioè, un suo ruolo in quanto attore e influenza l'esito degli eventi. La sua importanza nella commedia aristofanea è tale che proprio dalla sua composizione viene tratto abitualmente il titolo dell'opera. Il coro può essere formato da compagni dell'eroe, come accade negli Acarnesi, nelle Ecclesiazuse, nelle Tesmoforiazuse, nella Lisistrata, ma i cori più straordinari e immaginifici sono probabilmente quelli in cui i coreuti sono animali (vespe, rane, uccelli) o creature fantastiche (nuvole). È a queste creature sovra-mortali che il poeta riserva le sue coreografie più importanti e le invenzioni "pittoriche" più raffinate: chissà quale aspetto doveva avere il coro caleidoscopico degli Uccelli, o la solenne entrata in scena delle nuvole, nell'omonima commedia? Questa sezione non può che chiudersi con una breve riflessione sull'architettura generale della trama. Parlando di Aristofane, abbiamo spesso utilizzato il termine "utopia": il progetto dell'eroe è sempre utopico; è la tensione verso un pensiero apparentemente impossibile e illusorio di trasformazione della realtà. Nella descrizione e nella realizzazione del proprio disegno, l'eroe aristofaneo dispiega tutto il proprio ego strabordante, fino a soffocare e a determinare gli altri personaggi e gli eventi. Per quanto personale, e limitata alla sfera pratica, l'utopia presuppone sempre l'impiego di un'energia illimitata e una radicale trasformazione della quotidianità. Vi sono utopie segnate in modo evidente dal distacco dalla realtà: idee che presuppongono l'ingresso in un altro mondo o, addirittura, la sua creazione. A questo modello corrispondono per esempio le Rane, in cui il viaggio agli Inferi sembra essere l'unico modo per riportare ad Atene i fasti e la bellezza del teatro. Il cielo è invece lo spazio in cui si dispiega il progetto utopico di Pace e Uccelli: scritte in un periodo molto diverso della guerra del Peloponneso (rispettivamente 421 e 414 a.C.), queste due commedie rispecchiano un grado differente di pessimismo, a cui corrisponde un allontanamento progressivo dalla realtà politica e storica di Atene. Nella Pace, infatti, Trigeo vola sull'Olimpo a bordo di uno scarafaggio, ma lo fa per conquistare una pace estremamente terrena, per riportare l'armonia nel suo mondo reale. Al contrario, gli
Uccelli manifestano una rinuncia: la città celeste che Pisetero vuole costruire è definitivamente spostata nello spazio aereo e abitata da esseri dotati di ali, che non hanno nulla di umano, per lo meno dal punto di vista anatomico. Le utopie di Aristofane non sono però sempre viaggi fantastici nell'altro mondo: la realtà può irrompere in modo potente nel tessuto della trama e scandire l'andamento del dramma. I Cavalieri sono, per esempio, profondamente radicati alla terra: protagonista è, fra gli altri, il popolo di Atene ("Demo"); la lotta fra Paflagone e il venditore di salsicce è un confronto in cui il linguaggio sanguinolento, gestito attraverso un continuo richiamo al cibo e ai suoi odori, è specchio del realismo generale dell'opera. Nei Cavalieri, Aristofane mette in scena uno scontro per il potere che è interamente gestito fra le mura cittadine, come accade, per esempio, anche nelle commedie "femminili", Lisistrata ed Ecclesiazuse, in cui le donne sottraggono ai loro uomini il controllo della città e lo fanno - non a caso - spostando i termini del confronto dal regno della politica a quello del desiderio sessuale: sesso, umori, corporeità sono la filigrana attraverso cui si osservano Lisistrata, Prassagora e l'universo maschile che sta loro di fronte. Dalla commedia nuova sparisce invece - lo abbiamo già accennato - l'idea stessa dell'utopia e ciò avviene, chiaramente, perché non esiste più il motore del progetto utopico: l'ego ipertrofico dell'eroe aristofaneo. Si possono naturalmente addurre motivazioni storiche per tale evidente cambiamento: il distacco dal mondo della politica cittadina, caratteristico dell'età ellenistica; la rinuncia a influire con la propria individualità sui macrofenomeni del tempo; la focalizzazione dell'interesse sulla famiglia e le sue dinamiche interne; lo sviluppo di una diversa idea di individuo, che si definisce attraverso i legami che riesce a stabilire nel suo piccolo mondo e non attraverso il confronto con gli estranei o le istituzioni cittadine. Si tratta di elementi che hanno influito in modo massiccio sulla creazione di una nuova forma di commedia (lontanissima se non antitetica all'esperienza del dramma arcaico) e che certo sono alla base di molte scelte drammaturgiche di Menandro, ma se ci concentriamo sulla pura e semplice definizione del plot narrativo, è evidente come anche in questo caso il destino dell'eroe comico sia indissolubilmente connesso alle vicende in cui quest'ultimo rimane coinvolto. Come dunque l'eroe di Aristofane, descritto quasi sempre in preda a una sorta di follia solipsistica, si definisce attraverso la sua utopia e anzi la giustifica, poiché certi accenti visionari si collegano strettamente alle caratteristiche eccessive del protagonista, così i diversi comprimari che occupano il palcoscenico di Menandro non si lanciano in un progetto "centrifugo" che coinvolga un mutamento sostanziale della realtà: sia essa la famiglia o, ancor più, la città. Sono piuttosto pedine di intrecci romanzeschi in cui la sorte, più che la volontà individuale di qualcuno, sembra dettare il tempo: i personaggi della commedia nuova rimangono spesso vittime di equivoci, non conoscono, se non parzialmente, la realtà in cui si trovano ad agire e, quand'anche la conoscessero, non inventerebbero certo pericolose rivoluzioni per riportare il destino su una strada a loro più favorevole. Alla fine — per lo meno per i drammi di cui ci è dato conoscere l'esito - la soluzione arriva sempre, spesso sotto forma di "verità": le famiglie si ricompongono, i conflitti si risolvono, ma tutto avviene in un tono pacato e conciliante che non ammette né i sentimenti né i colori forti della commedia aristofanea.
Guida bibliografica La bibliografia sul teatro greco è imponente; quella che segue si propone di essere soltanto una breve guida ragionata, utile al lettore per un primo approfondimento. Una bibliografia aggiornata anno per anno si trova nei volumi dell'Année Philologique (disponibile anche online all'indirizzo www.annee-philologique.com) sotto le voci dei singoli autori. I testi dei principali poeti tragici e comici (Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Menandro) sono reperibili nelle collane internazionali di cui si servono gli specialisti: Oxford ClassicaI Texts (solo testo greco); Bibliotheca Teubneriana (solo testo greco); Les Belles Lettres (testo greco con traduzione francese a fronte); Loeb Classical Library (testo greco con traduzione inglese). La collana Lorenzo Valla-Mondadori (testo greco, traduzione italiana e commento) per ora offre solo alcune commedie di Aristofane, ma sta iniziando la pubblicazione di Sofocle. I frammenti tragici delle opere perdute (solo testo greco) sono reperibili nei volumi dei Tragicorum Graecorum Fragmenta (a cura di B. Snell - R. Kannicht - S. Radt; manca ancora Euripide); per Euripide è in completamento l'edizione Les Belles Lettres (a cura di F. Jouan -H. Van Looy, con traduzione francese). I frammenti dei comici sono raccolti in R. Kassel - C. Austin, Poetae Comici Graeci, De Gruyter, Berlin-New
York 1983-2001. Numerose e assai facili da reperire sono le traduzioni italiane, che coprono, con ampia possibilità di scelta, tutta la produzione teatrale antica; le traduzioni moderne più complete, generalmente con testo greco a fronte, sono quelle degli editori BUR, Oscar Mondadori, UTET, Marsilio.
1 Caratteri generali del teatro greco La Poetica di Aristotele è disponibile in varie edizioni italiane, tra cui le più recenti sono a cura di D. Lanza (BUR, Milano 1987) e di C. Gallavotti (Lorenzo Valla, Milano 1974). Un quadro complessivo sulle varie forme di spettacolarità è B. Gentili, Lo spettacolo nel mondo antico, Laterza, Roma-Bari 1977. Per la moderna riflessione sul teatro greco e sul concetto di tragico un punto di partenza fondamentale è F. Nietzsche La nascita della tragedia (in traduzione italiana insieme agli interventi di Rohde, Wilamowitz, Wagner in La polemica sull'arte tragica, a cura di F. Serpa, Sansoni, Firenze 1972). Sulle origini della tragedia in chiave antropologica, un testo classico è quello di W. Rid-geway, The Origin of Tragedy with special Reference to the greek Religion, Cambridge University Press, Cambridge 1910. Un'introduzione agile sia ai caratteri pratici che alle valenze culturali e sceniche degli spettacoli teatrali nella Grecia antica è H.C. Baldry, The Greek Tragic Theatre, London 1971 (trad. it. I Greci a teatro, Laterza, Roma-Bari 2001l4). Sul concetto di colpa tragica un saggio complessivo è quello di S. Said, La faute tragique, Maspero, Paris 1978; sulla follia dell'eroe, R. Padel, In and out of Mind. Greek Images of tragic Self, Princeton University Press, Princeton 1992.
2 Lo spettacolo teatrale I testi di riferimento per l'organizzazione degli spettacoli teatrali ateniesi sono i due libri di A. W. PickardCambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, 2. Ed. rev. by T.B.L. Webster, Oxford 1962 e The Dramatic Fe-stivals of Athens, 2. Ed. rev. by J. Gould - D. M. Lewis, Oxford 1968 (trad. it. Le feste drammatiche di Atene, Firenze 1996, con Aggiunta bibliografica a cura di A. Blasina e N. Narsi). Un altro saggio complessivo che abbraccia i vari aspetti dello spettacolo è H. Kindermann, Das Theaterpublikum der Antike, Otto Miiller, Salzburg 1979 (trad. it. Il teatro greco e il suo pubblico, a cura di A. Andrisano, La casa Usher, Firenze 1990). Sull'archeologia e l'architettura dei teatri greci M. Bieber. The history of Greek and Roman Theatre, Princeton 1971. Sugli attori: P. Ghiron-Bistagne, Recherches sur les acteurs en Grece antique, Paris 1976. Sulle convenzioni sceniche: P. Arnott, Greek scenic conventions in Fifth Century B.C., Oxford 1962. leggere O. Taplin, Greek Tragedy in Action, Methuen, London 1978 e D. Wiles, Tragedy in Athens. Performance Space and Theatrical Meaning, Cambridge University Press, Cambridge 1999. Esplorano aspetti di carattere antropologico legati al mito e alla sua interpretazione tragica i libri di J. P. Vernant - P. Vidal Naquet, Mythe et tragèdie en Grece ancienne, Maspero, Paris 1972 (trad. it. Mito e tragedia nell'antica Grecia, Einaudi, Torino 1976); id. Mythe et tragèdie deux, Paris 1986 (trad. it. Mito e tragedia due, Einaudi, Torino 1991); N. Loraux, Come uccidere tragicamente una donna, Laterza, Roma-Bari 1988.
4 La commedia Opere introduttive su Aristofane in generale: G. Mastromarco, Introduzione ad Aristofane, Laterza, Roma-Bari 1994; S. Silk, Aristopha-nes and the definition of comedy, Oxford University Press, Oxford 2000. Meno recente ma di alto livello interpretativo è il libro di G. Murray, Aristophanes. A Study, Oxford 1933 a cui si può aggiungere (in traduzione italiana) il testo di J. G. Droysen, Aristofane, Selle-rio, Palermo 1998. Sui rapporti tra Aristofane e la vita politica ateniese contemporanea, rimane utile V. Ehrenberg, L'Atene di Aristofane, La Nuova Italia, Firenze 1988. Sulle componenti antropologiche della commedia il testo di riferimento è F. M. Cornford, The origin of Attic comedy, Cambridge 1934 (rist. University of Michigan Press, Michigan 1993). Contributi più recenti nella stessa direzione sono W. Roe-sler-B. Zimmermann, Carnevale e utopia nella Grecia antica, trad. it., Levante, Bari 1991 e M. Bowie, Aristophanes: Myth, Ritual and Comedy, Cambridge University Press, Cambridge 1993. Sull'eroe comico, C. H. Whitman, Aristophanes and the Comic Hero, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1964. Sulla parabasi ci si può riferire a G. M. Sifakis, Parabasis and animai choruses. A contribution to the history ofAttic comedy, The Athlone Press, London 1971. Sugli aspetti spettacolari e drammaturgici della
commedia attica, tra i molti titoli di riferimento: C. F. Russo, Aristofane autore di teatro, Sansoni, Firenze 1962; W. Dearden, The Stage of Aristophanes, The Athlone Press, London 1976. Sui rapporti tra commedia antica e nuova, F. Perusino, Dalla commedia antica alla commedia di mezzo, Quattroventi, Urbino 1986. Studi generali sulla commedia nuova e su Menandro, anche in rapporto ai legami con il teatro latino: A. Barigazzi, La formazione spirituale di Menandro, Bottega d'Erasmo, Torino 1965; T. B. L. Webster, An introduction to Menander, Manchester University Press and Barnes and Noble, Manchester-New York 1974; S. M. Goldberg, The Making of Menander's Comedy, The Athlone Press, London 1980; R. L. Hunter, The New Comedy of Greece and Rome, Cambridge University Press, Cambridge 1985; O. Taplin, Comic Ange Is, Oxford University Press, Oxford 1993.
Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte, è da considerar copia di saggio fuori commercio non soggetto a IVA (D.P.R 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni art. 2 sub. D) e com tale non può essere messo in vendita. Giulio Guidorizzi insegna Teatro e Drammaturgia dell'Antichità presso l'Università di Torino. Tra le sue opere più recenti, oltre a numerosi saggi sulla letteratura greca e sull'antropologia del mondo antico, si possono citare le edizioni delle Baccanti di Euripide (Venezia, 1989), della Biblioteca di Apollodoro (Milano, 1995) e delle Nuvole di Aristofane (Milano, 2002), le traduzioni dello Ione di Euripide (Milano, 2000) e dei Miti di Igino (Milano, 2000). È autore anche di una Letteratura greca (Milano, 2002). Il teatro greco, prima e fondamentale radice del teatro occidentale, è un fenomeno assolutamente particolare per lo straordinario intreccio di elementi poetici, rituali, sociali e politici che in esso si realizza. Il poeta è chiamato a comporre un'opera che ha nel pubblico cittadino il committente e il primo destinatario. Sulle gradinate del teatro di Dioniso. nell'Atene del V secolo a.C., sedeva tutta la popolazione per assistere non a un semplice spettacolo ma a un rituale cittadino in cui ogni anno la polis rinnovava la propria identità collettiva. Senza comprendere questa dimensione sociale e antropologica, è impossibile avvicinarsi ali. meraviglia del dramma antico, alle sue trame così lontane da quelle de teatro occidentale successivo, al suo valore quasi religioso, alla forza dei suoi testi che rispecchiano la cultura dell'epoca d'oro della Grecia La raccolta di saggi che qui si presenta, a cura di Giulio Guidorizzi, guida il lettore attraverso le nozioni teoriche fondanti del teatro classico ateniese, le sue realizzazioni sceniche (costumi, maschere, danza e musica), nonché la drammaturgia di tragedia e commedia. SOMMARIO (1. Caratteri generali del teatro greco) (2. Lo spettacolo teatrale) (3. La tragedia (4. La commedia) isbn 88-882-4209-0 Prezzo al pubblico Euro 10,30 788888 2420951
![Athenaze : introduzione al greco antico. [2, Seconda edizione.]
9788895611501, 8895611500](https://dokumen.pub/img/200x200/athenaze-introduzione-al-greco-antico-2-seconda-edizione-9788895611501-8895611500.jpg)




![Atti diversi, incanti di corpi. Introduzione al teatro di Pasolini [Vol. 1]
9791254510759, 1254510753](https://dokumen.pub/img/200x200/atti-diversi-incanti-di-corpi-introduzione-al-teatro-di-pasolini-vol-1-9791254510759-1254510753.jpg)