Dizionario della favola antica 9788858639207
La grande e complessa tradizione della favola greca e latina, le cui antichissime origini si perdono nei primordi della
1,283 252 3MB
Italian Pages 900 Year 2012
Polecaj historie
Table of contents :
Indice......Page 897
Frontespizio......Page 4
Il Libro......Page 2
L'autore......Page 3
Introduzione......Page 6
Personaggi......Page 9
La narrazione: strutture e tipologie......Page 11
La morale......Page 13
Ideologia della società esopica......Page 15
La terminologia della favola......Page 19
Favola e proverbio......Page 21
Storia della favola antica......Page 23
La favola nella letteratura greca......Page 24
La favola nella letteratura latina......Page 29
La favola nella letteratura cristiana antica......Page 35
La favola nelle altre tradizioni culturali......Page 37
Tradizione mesopotamica......Page 38
Tradizione indiana......Page 41
Tradizione egizia......Page 43
La favola nella Bibbia......Page 44
La fortuna della favola......Page 46
Nota al testo e criteri di impostazione dell’opera......Page 50
Edizioni di riferimento......Page 52
Bibliografia generale......Page 57
A......Page 90
Abete......Page 91
Afrodite......Page 93
Agnello......Page 97
Airone......Page 101
Alcione......Page 103
Allodola - (terragnola)......Page 106
Alloro......Page 111
Amaranto......Page 115
Anguilla......Page 116
Ape......Page 118
Apicoltore......Page 121
Apollo......Page 123
Aquila......Page 129
Arabo......Page 139
Arciere......Page 141
Artigiano......Page 143
Asinaio......Page 145
Asino......Page 147
Aspide......Page 167
Astronomo......Page 169
Atena - (Minerva)......Page 171
Atleta......Page 173
Augusto......Page 176
Avvoltoio......Page 180
B......Page 182
Balena......Page 183
Biscia d’acqua......Page 186
Borea......Page 189
Bovaro......Page 191
Bue......Page 193
C......Page 201
Cacciatore......Page 202
Calzolaio......Page 207
Cammello......Page 209
Cane......Page 214
Canna......Page 228
Capra......Page 231
Capraio......Page 237
Caprone......Page 240
Castoro......Page 243
Cavallo......Page 246
Cedro del Libano......Page 255
Cervo......Page 256
Chiocciola......Page 266
Cicala......Page 268
Ciclope......Page 273
Cicogna......Page 275
Cigno......Page 277
Cinghiale......Page 281
Citaredo......Page 286
Civetta - (gufo)......Page 288
Coccodrillo......Page 292
Conchiglia......Page 295
Conciapelli......Page 296
Contadino......Page 298
Cornacchia......Page 307
Corvo......Page 313
Cuculo......Page 321
D......Page 322
Danaidi......Page 323
Delfino......Page 324
Demade......Page 328
Demetra......Page 330
Demetrio......Page 331
Demostene......Page 333
Dessicreonte......Page 335
Diogene......Page 337
Dioniso - (Bacco)......Page 340
Dioscuri......Page 343
Donna......Page 344
Donnola......Page 355
Drago......Page 363
E......Page 366
Elefante......Page 367
Era - (Giunone)......Page 371
Eracle......Page 373
Eros......Page 378
Esopo......Page 381
Etiope......Page 391
F......Page 393
Fabbro......Page 394
Farfalla......Page 396
Fico......Page 398
Fiume......Page 400
Formica......Page 402
Fortuna......Page 407
Frassino......Page 410
Fuco......Page 411
G......Page 412
Gabbiano......Page 413
Gallina......Page 415
Gallo......Page 419
Gambero......Page 424
Gatto......Page 425
Gelso......Page 429
Ghiozzo......Page 431
Giardiniere......Page 433
Gracchio......Page 437
Granchio......Page 442
Gru......Page 446
Guerra......Page 448
H......Page 449
Hermes - (Mercurio)......Page 450
Horkos - (Giuramento)......Page 459
I......Page 461
Iena......Page 462
Indovino......Page 464
Inganno......Page 467
Iride......Page 468
Issione......Page 469
L......Page 471
Leone......Page 472
Leopardo......Page 486
Lepre......Page 488
Lucertola......Page 495
Luna......Page 498
Lupo......Page 500
M......Page 512
Macellaio......Page 513
Maga......Page 516
Maiale - (scrofa)......Page 519
Mani......Page 524
Mare......Page 525
Maschera......Page 528
Medico......Page 531
Melo......Page 536
Melograno......Page 537
Menagirti - (Galli)......Page 539
Menandro......Page 541
Menzogna......Page 542
Mirto......Page 543
Momo......Page 545
Montone - (ariete)......Page 547
Morte - (Thanatos)......Page 551
Mosca......Page 553
Mulo......Page 557
Muse......Page 561
N......Page 564
Naufrago......Page 565
Navigante......Page 567
Nibbio......Page 571
Noce......Page 575
O......Page 577
Oca......Page 578
Oggetti......Page 581
Olivo......Page 587
Onagro......Page 590
Orfeo......Page 593
Orso......Page 595
Ostrica......Page 600
P......Page 601
Pantera......Page 602
Pappagallo......Page 604
Passero......Page 605
Pastore......Page 607
Pavone......Page 614
Pecora......Page 618
Penia - (Povertà)......Page 625
Pernice......Page 626
Pescatore......Page 629
Pesce......Page 634
Piccione - (colombo)......Page 639
Pidocchio......Page 644
Pino......Page 646
Pioppo......Page 648
Pipistrello......Page 649
Platano......Page 651
Pluto......Page 653
Polpo......Page 654
Pompeo......Page 655
Poros - (Espediente)......Page 658
Poseidone......Page 659
Principe - (flautista)......Page 660
Prometeo......Page 663
Pudore......Page 669
Pulce......Page 670
Q......Page 673
Quercia......Page 674
R......Page 678
Ragno......Page 679
Ramno......Page 681
Rana - (rospo)......Page 682
Religione......Page 690
Riccio......Page 692
Rondine......Page 695
Rosa......Page 700
Rovo......Page 702
S......Page 705
Sacerdote......Page 706
Sardella......Page 708
Satiro......Page 709
Scarabeo......Page 711
Schiavo......Page 714
Scimmia......Page 719
Scorpione......Page 730
Serpente......Page 732
Simonide......Page 740
Sisifo......Page 745
Smaride......Page 746
Socrate......Page 748
Soldato......Page 753
Sole - (Helios)......Page 757
Sparviero - (falco)......Page 759
Spugna......Page 762
Stagioni......Page 764
Struzzo......Page 766
T......Page 767
Talpa......Page 768
Tantalo......Page 770
Tartaruga......Page 771
Tempo - (Kairos/ Occasione/Giorno)......Page 776
Terra - (Gea)......Page 778
Tiberio......Page 781
Tigre......Page 785
Tiresia......Page 787
Tizio......Page 790
Tonno......Page 791
Topo......Page 793
Tordo......Page 802
Toro......Page 804
U......Page 808
Uomo......Page 809
Usignolo......Page 828
V......Page 831
Vacca......Page 832
Vasaio......Page 833
Verità......Page 835
Verme......Page 838
Vespa......Page 839
Violenza......Page 841
Vipera......Page 842
Vitello - (giovenco)......Page 845
Vite - (vino, uva)......Page 849
Volpe......Page 853
Z......Page 866
Zanzara......Page 867
Zeus - (Giove)......Page 870
AUTORI E FONTI......Page 877
Citation preview
La grande e complessa tradizione della favola greca e latina, le cui antichissime origini si perdono nei primordi della civiltà, si estende su più secoli, con una sorprendente coerenza di temi e figure: per la prima volta in Italia questo dizionario la cataloga, da Esopo a Fedro fino alle raccolte tardoantiche e medievali, senza trascurare influssi ed echi biblici, mesopotamici, indiani. Volpi astute, scimmie sciocche, lupi spietati, piante vanitose, pastori beffati: il variegato universo della favola è popolato di personaggi umili, e i suoi protagonisti, animali, piante o esseri umani che siano, mettono in scena i motivi del conflitto e dei rapporti di forza, della rinuncia e dell’immutabilità del destino individuale, in un’esortazione continua al pragmatismo e alla scoperta della verità nascosta sotto le apparenze. A ciascuno di essi è dedicata una voce di presentazione e una ricca scelta di favole – oltre cinquecento – e di proverbi; se gli indici e gli ampi apparati sono preziosi per una consultazione puntuale, il repertorio favolistico e proverbiale offre il piacere della lettura – e della rilettura.
Christian Stocchi, dottore di ricerca in Filologia latina e docente di Patrologia all’Istituto Superiore di Scienze religiose di Parma, scrive per la “Gazzetta di Parma”. Tra le sue pubblicazioni, Orazio, Numicio e la morale del possibile (2004).
Proprietà letteraria riservata © 2012 RCS Libri S.p.A., Milano eISBN 978-88-58-63920-7 Prima edizione digitale 2012 da edizione BUR novembre 2012
In copertina: da Le favole di Bidpai (Il Pañcatantra), Animali in posa umana, 1480, Museo Condé, Chantilly, Francia © 2012 White Images / Foto Scala, Firenze Progetto collana di Mucca Design Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore. È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
Introduzione «La favola – spiegava Elio Teone, un retore del I-II secolo d.C. – è una storia fittizia che rappresenta una verità». Questa definizione – la più nota e la migliore possibile, secondo Perry (1959, 22), uno dei maggiori studiosi moderni della tradizione esopica – suggerisce la difficoltà di inquadrare con precisione un genere che si colloca al confine con il proverbio, il mito, la fiaba, la novella e altri tipi di narrazione. La favola, peraltro, ha sempre oscillato tra la sua originaria dimensione retorica e una dignità letteraria raggiunta a fatica. Essa si presenta generalmente come un breve e semplice racconto, che ha l’obiettivo di affermare una morale, per lo più esplicita. Le sue caratteristiche appaiono non rigorosamente definite, soggette a mutamenti nel corso della storia, sulla base del contesto nel quale, di volta in volta, è stata calata. I personaggi sono privi di una psicologia individuale e di una puntuale caratterizzazione, in quanto assumono quella tipica della categoria a cui appartengono, mentre l’ambientazione e la dimensione cronologica restano generiche e imprecisate. Anche la capacità di dilettare il pubblico rappresenta un elemento distintivo del genere esopico, al punto che esso giunge a essere concepito come un modo efficace per impartire insegnamenti filosofici piacevoli e divertenti: così, ad esempio, si esprimerà, nel II secolo d.C., Aulo Gellio (2,29) a proposito di Esopo. Nella Grecia antica, di là dell’inserimento di favole fin dall’VIII-VII secolo a.C. in contesti poetici di varia natura, la dimensione più comune della narrativa esopica pare quella popolare della prosa e dell’oralità. D’altra parte, in origine la favola è concepita soprattutto come genus dicendi, ossia come strumento retorico, e solo in un secondo momento si afferma come genere letterario autonomo. In particolare, 1
2
3
nella classificazione di Aristotele (Retorica 1393a-1494b) relativa ai processi argomentativi, vengono distinti l’esempio e l’entimema. L’esempio può riferirsi a fatti reali o inventati: a quest’ultima categoria appartengono la parabola e la favola, di cui il filosofo non fornisce una definizione, ma soltanto due modelli: uno tratto dal poeta Stesicoro (il cavallo, il cervo e l’uomo: fr. 104a P.), l’altro centrato sulla figura di Esopo nella sua qualità di narratore (la volpe e il riccio). Sulla base di una tradizione scolastica probabilmente ellenistica, i retori greci di età imperiale discutono sull’origine delle favole, classificandole, secondo la provenienza, sibaritiche, ciprie, libiche, egizie, cilicie, carie, frigie. Ma – si chiedono – dove sta la differenza? Le risposte, del tutto congetturali, sono le più diverse e dipendono dal contenuto, dal tipo di personaggi o dall’inventore del genere. Spuntano così nomi esotici, che servono solo a giustificare una situazione piuttosto caotica e priva di certezze; ecco, dunque, Conni il Cilicio, Turo il Sibarita, Cibisso il Libico. In ambito latino, Isidoro di Siviglia (Etimologie 1,40) riconduce la favolistica a Esopo, che eccelse in Frigia in questo tipo di narrazione, ma considera inventore del genere Alcmeone di Crotone; inoltre, tenta una singolare classificazione, sostenendo che la favola esopica presenta animali o esseri inanimati che parlano, e la favola libica animali e uomini. Tuttavia, questa, come altre classificazioni, appare imprecisa, perché nella favola esopica a noi pervenuta può intervenire anche l’uomo. Non mancano interrogativi circa la figura di Esopo come inventore del genere: fu il primo o il più bravo tra i narratori di favole in Grecia? Del resto, favole si ritrovano in autori precedenti alla sua supposta esistenza e si registrano attribuzioni di paternità del genere a poeti come Esiodo e addirittura Omero, che però nei suoi poemi presenta soltanto similitudini, strutturalmente assai diverse dalle favole. Giuliano (Orazioni 7,266) riterrà addirittura infondata l’intera questione: sarebbe sensato chiedersi chi ha starnutito per primo? 4
5
Nel tempo, la favola si impone sempre più nell’ambito della scuola, che finirà per diventarne una sorta di prigione: rinchiusa dietro le sbarre delle necessità pedagogiche, la narrativa esopica è spesso costretta a rinunciare all’aspirazione letteraria. Nel I secolo d.C., il professore di retorica Quintiliano consiglia di far esercitare i ragazzi a narrare in uno stile corretto, misurato, le favole di Esopo, immediatamente dopo le favole delle nutrici. L’esercizio consiste nel mantenere lo stesso livello stilistico, nello sciogliere i versi, nel trovare sinonimi e parafrasare il testo, con la possibilità di abbreviare e di ornare, nel rispetto però del pensiero del poeta. Anche Quintiliano considera la favola un exemplum, che ha un efficace influsso sulle persone rozze e ignoranti, grazie al diletto che facilita la persuasione. Così la favola si consolida quale utile strumento per bambini o per adulti poco istruiti, come aveva spiegato già Livio, narrando l’apologo del corpo e delle membra, con cui nel 495 a.C. Menenio Agrippa convinse i plebei a rinunciare alla secessione (v. LA FAVOLA LATINA). Peraltro, anche nei secoli successivi, la favola ha larga fortuna in ambito scolastico, come testimoniano gli esercizi di traduzione dello Pseudo-Dositeo (v.) e i cosiddetti πρoγυμνάσματα (esercizi preparatori alla composizione) dei retori greci. Retrospettivamente, Isidoro (Etimologie 1,40-44), sulla base della sua cultura enciclopedica, tira le somme: «I poeti – osserva – ricavarono il nome di favole da fari [parlare], poiché non narrano cose accadute, ma solo immaginate e dette». Lo scopo è quello di offrire un’immagine della vita degli uomini attraverso le vicende inventate degli animali. La classificazione di Isidoro distingue tra historiae, vere e accadute; argumenta, racconti di fatti possibili, anche se non accaduti; fabulae, narrazioni di cose non accadute e impossibili, in quanto contrarie alla natura. Sintetizzando le definizioni degli antichi, Van Dijk (1997, 72 ss.) riconosce il carattere fittizio, metaforico e narrativo delle favole. Per il resto, come si è notato, il dibattito non riesce a tracciare confini certi. 6
7
Personaggi Se normalmente la favola esopica presenta come protagonisti gli animali – e per questo è soprattutto nota nella sua dimensione popolare – non mancano tuttavia personaggi di altra natura: piante, oggetti, uomini, dei, personificazioni di concetti astratti. Tutti questi personaggi sono dotati di parola e hanno una psicologia tipicamente umana, che non è elaborata sulla base di una caratterizzazione individuale, ma tende a mantenere, uniformandoli, gli attributi simbolici originari del gruppo di appartenenza. Allo stesso modo sono descritti i loro comportamenti, peraltro noti sulla base delle leggi naturali e cristallizzati nell’immaginario popolare, come l’aggressività del lupo (cfr. Fedro 1,1) o la proverbiale stoltezza dell’asino, che spesso si mette nei guai, come quando, testardo, finisce nel dirupo nonostante lo sforzo dell’asinaio di salvarlo (Esopo 277 Ch.). D’altra parte, la caratterizzazione di ogni personaggio è oscillante e la favolistica presenta anche immagini contraddittorie. Così possiamo trovare il leone descritto come sovrano saggio, che porta la giustizia nel mondo degli animali (Esopo 195 Ch.) o come infido ingannatore dei suoi sudditi (Esopo 196 Ch.). Allo stesso modo, la volpe, notoriamente simbolo di astuzia, può essere essa stessa beffata, come quando s’infila nella cesta per cibarsi e poi non riesce più a uscirne (Esopo 30 Ch.), o come quando non riesce a impossessarsi dell’uva e si consola dicendo che non è ancora matura (Esopo 32 Ch.). In questo e in altri casi (v. in particolare LUPO), agiscono anche specifici modelli culturali, come quello del trickster, che tende a presentare un personaggio dal duplice volto, capace di coniugare crudeltà e astuzia con una stolta credulità. Se le favole che presentano come personaggi piante e, in genere, vegetali hanno spesso un’origine orientale, come esplicitamente dichiara Callimaco a proposito della contesa tra l’alloro e l’olivo (fr. 194 Pf.), più rari sono gli oggetti 8
parlanti, che comunque appaiono fortemente caratterizzati dalla loro funzionalità: il serpente si dimostra sciocco a mordere la lima, abituata addirittura a mordere il ferro (Fedro 4,8; cfr. anche Esopo 77; 166 Ch.); il chiodo non può che trafiggere il muro innocente e si giustifica incolpando chi lo spinge da dietro (Esopo 337 Ch.). Gli uomini appaiono per lo più descritti in relazione alla loro attività (ricorrenti sono il contadino, il pastore, l’artigiano), talora in relazione a una specifica azione (il viandante) o all’età (il giovane, la vecchia), senza però nomi o caratterizzazioni particolari; perciò il loro ruolo è fortemente prevedibile nell’economia della narrazione (v. UOMO). Sono rarissimi principi e regine, personaggi tipici delle fiabe; allo stesso modo, i maghi o gli indovini, quando appaiono, vengono criticati e derisi (cfr. Esopo 233 Ch.). In genere, i protagonisti umani della favolistica sono espressione di un contesto sociale umile. I personaggi noti, invece, acquisiscono un valore paradigmatico e vengono svuotati della loro dimensione storica. Così possiamo trovare aneddoti che presentano lo stesso Esopo come protagonista di una favola o personaggi equivalenti come Socrate o Diogene Cinico. Gli dei sono calati per lo più in favole eziologiche (ossia quelle che spiegano le origini di un fatto o di un fenomeno), secondo schemi ricorrenti, come quello degli animali che scioccamente chiedono un beneficio a Zeus. Il cammello vorrebbe le corna del toro, ma il dio, sdegnato, non gli concede alcun dono, anzi gli toglie addirittura una parte delle orecchie (Esopo 146 Ch.). Gli asini inviano un’ambasceria al re degli dei per essere sgravati dei carichi che sono costretti a portare, ma Zeus risponde che finiranno di soffrire soltanto quando riusciranno a formare un fiume con la loro orina; così si spiega perché questi animali aggiungono la loro orina dove vedono quella di un loro simile (Esopo 262 Ch.). Sono più rare le favole dove sono presenti solo dei e uomini, spesso collegabili a proverbi, come quello di Zeus giudice (Esopo 126 Ch.).
Le personificazioni in genere assumono un ruolo nelle favole sulla base del contrasto che suggeriscono, secondo uno schema concettuale caro alla narrativa esopica: così, ad esempio, il conflitto dialettico tra Inverno e Primavera, impegnati a rivendicare i loro meriti (Esopo 346 Ch.).
La narrazione: strutture e tipologie In genere la favola è narrata al passato ed è concentrata in un’unica scena. Allo stato iniziale segue un tentativo di modificazione o di mantenimento della situazione e una soluzione finale, che vede riuscire o fallire il proposito del protagonista. Caratteristiche ricorrenti sono l’ambiguità del valore, il rovesciamento della situazione e la bivalenza dell’azione. Alla gallina che le dona un uovo al giorno, una vedova aumenta il grano, ritenendo che così possa offrirgliene due; ma l’animale ingrassa e non produce più nulla (Esopo 90 Ch.). Un corvo affamato ghermisce un serpente, che si rivolta e lo morde: così, invece di nutrirsi, finisce per morire (Esopo 167 Ch.): il corvo, come spesso accade a chi si mette imprudentemente nei guai, conclude la favola con un’esclamazione di autocommiserazione. La tipica struttura della narrativa esopica è il conflitto tra due personaggi, che può anche essere allargato a un terzo soggetto, in grado di risolvere, con il suo intervento, la situazione. Così troviamo, ad esempio, la volpe che si avventa su un agnellino, ma il cane è pronto a sventare la minaccia (Esopo 36 Ch.); un serpente e una donnola si battono accanitamente, ma quando vedono i topi, cessano la lotta per gettarsi su di loro (Esopo 289 Ch.). I personaggi possono anche essere più numerosi, ma sono per lo più accorpati in due gruppi contrapposti. Fedro (1,5), facendo probabilmente evolvere il più antico ed elementare motivo del leone e dell’asino selvatico che vanno a caccia insieme (Esopo 207 Ch.), raddoppia i personaggi, che restano tuttavia divisi in due gruppi contrapposti: da un lato il re 9
degli animali, che si appropria dell’intero bottino di caccia, dall’altro i subalterni (la vacca, la capretta e la pecora). Talora si registra l’arrivo del cosiddetto survenant, un personaggio che commenta la vicenda senza intervenire direttamente, dandone un’interpretazione che coincide con quella del narratore. Spesso è la volpe a rivestire questo ruolo. Così in Sintipa 19: i cani lacerano la pelle di un leone morto. La volpe commenta che l’esito sarebbe ben diverso se il re degli animali fosse vivo. Una gallina cova le uova di un serpente: la rondine le chiede conto della sua dissennatezza (Esopo 286 Ch.). L’opposizione tra i personaggi può essere giocata sulla forza, che spesso rinuncia anche al travestimento verbale (come nel caso del gatto che, esauriti i pretesti, mangia il gallo: Esopo 12 Ch.) o soltanto sullo scontro dialettico: la volpe si contende la palma della bellezza con la pantera e alla fine prevale, sottolineando che le sue qualità risiedono nella mente e non nel corpo (Esopo 37 Ch.). Si rilevano schemi narrativi assai antichi, come quello dell’arbitrato, di origine mesopotamica: il lupo e la volpe si presentano al tribunale della scimmia (Fedro 1,10). Ma si hanno anche variazioni nella stessa struttura, che non è necessariamente centrata sul conflitto. In Fedro (3,12), il gallo trova la perla nel letamaio, ma non può trarne vantaggio perché non sa che farsene e preferisce di gran lunga il cibo. Difficile vedere qui un conflitto. Talora la favola presenta un solo personaggio o un solo gruppo di personaggi: i cani bevono l’acqua del fiume per raggiungere la pelle che vi è immersa (Esopo 177 Ch.). Qui il conflitto non è tra due personaggi, ma si gioca nella situazione o, meglio, all’interno del personaggio che compie una scelta. Tra i tipi di favole più ricorrenti, si rilevano le narrazioni eziologiche. In alcuni casi, sono semplicemente descritte situazioni che derivano da credenze zoologiche, come quella secondo cui il castoro si recide i genitali quando viene inseguito e non vede vie d’uscita (Esopo 153 Ch.). Alcune narrazioni appaiono piuttosto come aneddoti costruiti 10
11
intorno a detti celebri, che possono essere pronunciati indifferentemente da diversi personaggi storici. Così Fedro (3,3) presenta Esopo intento a risolvere il mistero delle greggi che partoriscono agnelli con le teste umane, mentre lo stesso motivo è attribuito a Talete da Plutarco (Il convito dei sette sapienti 149ce). Proprio Fedro pare sperimentare narrazioni innovative e apre il genere esopico a nuove soluzioni: racconta fatti contemporanei, in una chiave satirica, come la vera fabella (un ossimoro, ovviamente) dell’imperatore Tiberio e dello schiavo atriense (2,5); propone novelle come quella della vedova e del soldato (App. 13 [15]), nota anche da altre fonti (v. SOLDATO). Il favolista latino sconfina anche nella pura allegoria: una descrizione del tutto statica presenta, attraverso una sorta di indovinello che si risolve nell’ultima parola del componimento, l’immagine del Tempo, inteso come occasione, attimo propizio (5,8).
La morale La favola si compone generalmente di due parti: una narrazione e una spiegazione morale, che prende il nome di promitio (se posta all’inizio del testo) o di epimitio (se posta alla fine). Promitio ed epimitio non sono necessariamente alternativi: nelle sue narrazioni Aftonio inserisce sia l’uno sia l’altro. In un noto articolo di Perry (1940, 391 ss.) viene respinta l’origine scolastica dell’epimitio, ipotizzabile soltanto in una tarda fase della tradizione. Così l’epimitio delle collezioni esopiche, debitore delle conclusioni delle più antiche favole, trarrebbe origine dal promitio, che, invece di essere inteso come una spiegazione delle favole, appare come una sorta di titolo, ossia un riferimento per l’indice della collezione, come sembra suggerire anche l’analisi di una delle più interessanti fonti esopiche: il Papiro Rylands (v.). Insomma, sembrerebbe funzionale a un prontuario la costruzione dei promiti che vede, all’inizio della frase, la
categoria di persone a cui la favola è destinata e alla fine il soggetto e il verbo (sulla base del modello: «A coloro che… la favola si rivolge»). Altri studiosi, come Nøjgaard (1964, 493 ss.), rigettano l’idea della nascita dell’epimitio in epoca postalessandrina, spostandola indietro di alcuni secoli. Le differenti interpretazioni dipendono anche dalla valutazione di due fattori, che, secondo Perry, contribuirebbero alla nascita dell’epimitio: l’applicazione pratica data alla favola antica e le repliche finali gnomiche, frequenti nella favola attica del periodo classico. Appare comunque acquisito che l’epimitio non è artificiosamente aggiunto dalla tarda manipolazione dei retori, ma ha un’altra origine. Secondo una nota classificazione, la morale può essere di tre tipi: 12
a. paradigmatica, secondo il modello «La favola dimostra che quanto a ciascuno è assegnato dal destino è senza possibilità di cambiamento» (Esopo 262 Ch.): stabilisce un principio generale, è la più diffusa nelle collezioni anonime; b. parenetica, secondo il modello «Anche noi dunque dobbiamo farci bastare quello di cui disponiamo…» (Esopo 163 Ch.): partendo dalla narrazione, il favolista esorta il destinatario ad assumere un certo comportamento; originariamente legata all’enunciazione orale, è poi funzionale anche all’uso scolastico; c. sarcastica, secondo il modello «La favola è adatta agli uomini avidi che, per cupidigia, ingannano persino gli dei» (Esopo 260 Ch.): si rivolge a una determinata categoria di persone e sembra uno sviluppo della replica finale. 13
Della parte morale può essere fatto un uso differente: ad esempio, Esopo astrae per generalizzare, mentre in genere Fedro astrae per dare una specificazione e per entrare in polemica col tessuto sociopolitico di riferimento. Talora una stessa favola può presentare differenti morali, a 14
testimonianza dell’estrema adattabilità del materiale esopico a contesti e culture differenti. Non mancano nemmeno morali cristiane, come quella di Esopo 20 Ch., la favola dei due galli in lotta tra di loro e dell’aquila che ghermisce il borioso vincitore: «La favola dimostra che il Signore si oppone ai superbi, ma dona la sua grazia agli umili».
Ideologia della società esopica La favola esprime quasi sempre una valutazione morale, che prevale sul piacere della narrazione; peraltro, la tensione etica appare figlia di una coerente, per quanto non sempre organica, visione del mondo. Si tratta di un mondo antieroico, con un sistema di valori agli antipodi di quello dell’epica, segnato da inevitabili rapporti gerarchici e da rigide separazioni, dove il cambiamento è ritenuto sconveniente e in cui è necessario che ognuno accetti la sua condizione. Significativo è, ad esempio, il commento della volpe quando sottolinea la stoltezza di un lupo di enormi dimensioni che ambisce a vivere con i più nobili leoni (Babrio 101). Nell’ambito di un ricorrente schema narrativo, che vuole gli animali alla ricerca di un re, la scimmia, animale di umile livello sociale, viene eletta come sovrano, ma presto la volpe fa emergere la sua indegnità (Esopo 38 Ch.). Animali di terra, di acqua e di aria vivono dimensioni separate, che non possono intrecciarsi. Il nibbio osserva che giustamente il gabbiano è stato punito con la morte per avere voluto mangiare un pesce: un animale d’aria non deve cercare cibo sul mare (Esopo 193 Ch.). Ma che cosa muove il microcosmo esopico? Soprattutto la forza e l’astuzia, che troveranno i loro naturali simboli, anche al di fuori della favolistica, nel «lione» e nella «golpe» del Principe di Machiavelli. La forza si trasforma spesso in violenza, l’astuzia in frode: il lupo, che non riesce a giustificare le presunte colpe dell’innocente agnello, ricorre infine all’aggressione (Fedro 1,1); la volpe trae in inganno
l’ingenuo cervo, portandolo nelle grinfie del leone per ben due volte (Esopo 196 Ch.). Più in generale, è la capacità di leggere la situazione in modo corretto e pragmatico a determinare il successo. Il leone, l’asino e la volpe vanno a caccia, ma, quando è il momento di spartire il bottino, il leone sbrana l’asino che ha osato fare tre parti uguali: allora la volpe comprende la situazione e si adatta subito, ammassando tutto in un unico mucchio e tenendo per sé solo qualche avanzo (Esopo 209 Ch.). Il pipistrello si spaccia ora per uccello ora per topo, adattandosi di volta in volta alla situazione (Esopo 251 Ch.). La favola ha un obiettivo fondamentale: svelare la verità nascosta dietro le apparenze; mettere a nudo la vanagloria, l’ipocrisia, l’avidità, l’egoismo, la frode, la violenza mascherata attraverso il diritto. Il lupo s’inorgoglisce vedendo le dimensioni della propria ombra, ma viene presto divorato dal leone (Esopo 219 Ch.). Il cavallo smaschera l’ipocrisia del lupo, che si finge generoso nei suoi confronti (Esopo 225 Ch.). L’interpretazione della realtà si mantiene abbastanza costante attraverso i secoli, tanto che si è parlato di «fissità» della favola esopica antica, che, per certi aspetti, può essere considerata un tipo di letteratura primitiva e popolare, in grado di esprimere sentimenti collettivi, senza concedere un eccessivo rilievo alla personalità dell’autore. I testi sono facilmente modificabili anche da anonimi compilatori e appaiono spesso influenzati dalla tradizione orale: in questa prospettiva, la favolistica segna un distacco piuttosto significativo dalla cultura religiosa e va ad elaborare una cultura laica, segnata dalla necessità di comprendere la realtà sociale. Perciò gli dei appaiono calati in situazioni comiche, spesso in relazione agli animali, mentre maghe e indovini finiscono inevitabilmente per essere oggetto di scherno (Esopo 91; 233 Ch.). Nel suo pragmatismo intuitivo e razionale, la favola condanna qualità non immediatamente utili come la bellezza, che si rivelano ora superflue ora persino dannose: è meglio 15
vivere a lungo, senza troppe pretese, come fa l’amaranto, che avere un’esistenza effimera come la splendida rosa (Esopo 323 Ch.). L’utile prevale sempre sull’aspetto esteriore, le qualità intellettuali su quelle fisiche: la volpe, astuta, può vantare perciò doti superiori rispetto alla pantera, che si segnala per la sua eleganza (cfr. Esopo 37 Ch.). La favola condanna anche l’ambizione. Gli animali che si rivolgono a Zeus per avere un miglioramento della loro condizione vengono spesso puniti: così accade ai cani che reclamano un diverso trattamento da parte degli uomini (Fedro 4,18 [19]); al cammello, invidioso del toro (Esopo 146 Ch.); alle rane, che desiderano un re (Esopo 66 Ch.). L’immutabilità della natura individuale è alla base di numerose narrazioni: il serpente, ingrato, non potrà che mordere persino il suo benefattore (Esopo 82 Ch.); la donnola non perde l’antico vizio e rincorre il topo anche dopo che Afrodite l’ha trasformata in una bella fanciulla (Esopo 76 Ch.). L’accettazione della dura realtà pare essere il presupposto per la sopravvivenza. Per il debole sono rare le occasioni di rivincita. Vengono attivati anche meccanismi consolatori: il pesce piccolo vive un’esistenza più tranquilla del pesce grosso, che invece finisce nella rete (Esopo 25 Ch.). L’amicizia è rara, l’odio conduce persino all’autodistruzione: il serpente è disposto a morire, pur di uccidere la vespa che lo punge (Esopo 331 Ch.). L’invidia è motore di diverse narrazioni: è soprattutto la volpe a coltivare questo sentimento, ad esempio di fronte alla ricchezza del lupo: entrambi finiscono così in rovina (Romulus 56). Questo mondo cupo, dove la pietà non trova spazio e il particulare prevale sull’interesse generale, dove non c’è speranza e tutto appare desolatamente legato a un elementare principio utilitaristico, è molto lontano dal luogo comune che vuole la favola come letteratura dell’infanzia, anche se, nel corso della sua parabola nell’antichità, essa ha finito per piegarsi spesso alle esigenze della scuola. Al di là
di una generale coerenza d’impostazione, si riscontrano di frequente insegnamenti empiricamente adattati a singoli episodi, con alcuni casi anche contraddittori. Ad esempio, forze imponderabili come la Fortuna sono valutate in modo differente, secondo le narrazioni: la sorte è determinante nella condizione dell’eunuco (Fedro 3,11), ma il contadino che trova il tesoro ringrazia la Terra, non la Fortuna, che subito se ne lamenta (Esopo 84 Ch.). Molto frequente, soprattutto nel primo libro di Fedro, la dialettica sociale tra umili e potenti, che si fonda su un principio di immutabilità della struttura della società, corollario dell’immutabilità della natura individuale. Perciò è meglio rassegnarsi a una vita dura piuttosto che anelare a cambiamenti impossibili: allo schiavo che intende fuggire Esopo spiega che se, non avendo fatto nulla di male, viene maltrattato, chissà quale punizione dovrà subire una volta che si sarà macchiato di una colpa (Fedro, App. 18 [20]). Lo stesso Fedro, nel prologo al terzo libro (vv. 33 ss.), offre una significativa interpretazione della funzione della favola come strumento sfruttato dagli schiavi, che, non osando esprimersi liberamente, trasposero in questi racconti i loro sentimenti, per evitare false accuse. In questo arido contesto, non c’è dunque speranza di redenzione o di rivoluzione: tutto si gioca qui e ora, in una spietata lotta per la sopravvivenza. Quanto incisero le filosofie antiche sulla favolistica? «Nella morale del contentarsi di poco, nell’elogio della vita povera, – spiega La Penna (1961, 516) – senza ambizioni, ma senza pericoli la favola esopica si incontra con larghe correnti della filosofia antica, sia aulica che popolare». Tra gli influssi più significativi va segnalato certamente quello del cinismo: al di là delle convergenze filosofiche e tematiche, riscontrabili puntualmente nelle singole favole, troviamo anche narrazioni che presentano come protagonista una figura simbolica come quella di Diogene Cinico (Esopo 97; 98 Ch.), mentre, inversamente, i Cinici hanno rielaborato la figura di Esopo, fino a farne un equivalente dello stesso Diogene. Ad esempio, Fedro
rappresenta Esopo che si aggira con una lucerna in pieno giorno e, a chi gliene chiede il motivo, risponde: «Cerco un uomo»; altre fonti (Diogene Laerzio 6,41) attribuiscono la stessa battuta a Diogene Cinico. Peraltro, la favola, intesa come strumento degli indotti, si presta perfettamente alla predicazione di questa corrente filosofica e la diatriba ha avuto un ruolo fondamentale nella tradizione esopica. Del resto, va anche notato che, prima del cinismo, la favola esopica, affermando il distacco, oltre che dalla religione, anche dallo Stato, impone una sua visione cosmopolita. Resta poi una differenza fondamentale con le correnti filosofiche antiche: se nell’affermare l’opzione di un’esistenza povera e tranquilla le filosofie ellenistiche sottolineano il primato dell’autarchia, dell’autosufficienza dell’uomo, nella favola, al netto di ogni tentativo di costruire un sistema etico, si ha solo un semplice, immediato calcolo utilitaristico.
La terminologia della favola La terminologia chiarisce bene la funzione e l’uso della favola antica nel corso della storia. In Grecia è un termine epico, ionico e poetico, aînos, a prevalere nella letteratura arcaica: sembra fortemente legato all’idea (e all’etimologia) di «enigma», a qualcosa cioè che necessita di una interpretazione: un’allusione che può essere spiegata con l’acume di chi sa interpretarla. Il significato del termine è variabile e spesso incerto. La parola è riferita, nell’ambito dei suoi numerosi significati, soltanto alla favola arcaica preesopica, a partire dalla narrazione dello sparviero e dell’usignolo di Esiodo (Le opere e i giorni 202 ss.), mentre successivamente la favola è sempre definita altrimenti non solo nelle citazioni degli autori, ma anche nelle collezioni. Nell’uso, il termine sembra orientato più alla poesia che alla prosa. Quindi, si impone il termine lógos, che occupa un’ampia area semantica. In Erodoto, per la prima volta, si
trova il significato di «favola» (1,141), riferito alla vicenda del pescatore flautista; e, ancora per la prima volta, la qualifica a Esopo di logopoiós (2,134), ossia di «favolista». Preziosa la distinzione introdotta da Platone (Repubblica 2,376e): lógos, che di per sé ha un valore essenzialmente neutro, può inclinare alla verità o alla fantasia. Il termine è il più antico modo di designare non solo la favola esopica in generale, ma anche, nello specifico, quella delle collezioni; più appropriato per le opere in prosa che per quelle in poesia, senza aggettivi che lo qualificano ha un valore neutro; tuttavia in genere esprime dati e concetti reali piuttosto che idee e rappresentazioni fantastiche. Invece, mŷthos, già impiegato nei poemi omerici al plurale con il significato di «parola» e al singolare con quello di «racconto», «notizia» o «consiglio», indica la «favola» (libica) per la prima volta in Eschilo (fr. 139 R.). Platone usa spesso il termine, per lo più con un significato variabile tra «mito» e «favola» (per quest’ultimo valore cfr. ad esempio Fedone 60c); e in generale mŷthos in questo senso entra nell’uso presto ma con minore diffusione rispetto a lógos, finendo quindi per imporsi in età imperiale. Questo termine sembra più orientato alla poesia che alla prosa: il suo campo semantico abbraccia tendenzialmente l’idea del fantastico e del fittizio, in opposizione a quella del reale e del razionale. Si rileva insomma un duplice connotato fondamentale che accomuna i tre termini: il significato generico, la possibilità di applicazione a diversi generi di narrazione, ma anche la difficoltà a specializzarsi in una direzione precisa. Allora, per evitare ambiguità, la gran parte degli autori decide di aggiungere al termine che designa la favola una qualifica che lo determina senza lasciare dubbi. Esistono due possibilità: o indicare la favola su un piano geografico (ad esempio «libica» già in Eschilo, fr. 139 R.), oppure facendo riferimento all’auctor Esopo. Nella letteratura latina, si ritrova un lessico ancora più ampio, a testimonianza dell’adattabilità del genere a diversi contesti: così Fedro utilizza anche nomi che non hanno il
significato proprio di «favola», ma mettono in rilievo un certo aspetto della narrazione e sono per lo più collocati nel promitio e nell’epimitio. Questi termini possono essere ricondotti ad alcune grandi aree di significato. Emerge così il fatto che la favola serve non solo a narrare (fabula, fabella, narratio), ma anche a dimostrare e a insegnare qualcosa (argumentum, exemplum, documentum, termine tecnico, quest’ultimo, del lessico giudiziario), ad ammonire (praeceptum), a divertire (argutiae, iocus, neniae). Si rilevano poi altre espressioni più generiche, relative alla forma (versus) o al contenuto (res), oppure termini onnicomprensivi, come dictum e scriptum. Ma, al di là di Fedro, la testimonianza della difficoltà di circoscrivere esattamente questo genere narrativo dai confini così indefiniti si comprende anche dall’uso occasionale di altri termini, come logos (Seneca, Consolazione a Polibio 8,3), calco del corrispondente termine greco, o apologatio (Quintiliano 5,11,20). Orazio, invece, sembra prediligere il termine imago (immagine), che usa in riferimento alla favola della volpe dal ventre gonfio (Epistole 1,7,34) e della rana e del bue (Satire 2,3,320). Il significato è riconducibile all’idea di «similitudine», «paragone», e si può collegare alla celebre definizione di Elio Teone (ripresa anche, in ambito latino, dal grammatico Prisciano): la favola rappresenta la realtà attraverso il filtro dell’immagine fittizia.
Favola e proverbio Nota Quintiliano (5,11,21) che il proverbio si trova al confine della favola. Anzi, è come «una favola più breve». Ha, infatti, in comune «il valore assertivo, la capacità allegorica, la possibilità di applicazione referenziale» e la sua formulazione (asserzione, interrogazione retorica, ipotesi o esortazione) coincide con quella della battuta finale della favola. Va inoltre ricordato che le più antiche narrazioni 16
favolistiche sono espresse attraverso proverbi (v. LA TRADIZIONE MESOPOTAMICA) e ancora oggi sono in uso detti che rimandano a favole assai note. Ad esempio, ognuno riconosce dietro l’espressione «La volpe e l’uva» la favola e il significato morale sottesi, che rimandano a un comportamento autoconsolatorio di fronte a un obiettivo irraggiungibile. Per tutta l’antichità greco-romana, la favola ha così trovato nel proverbio un suo naturale veicolo di diffusione e si è talora discussa la priorità dell’uno o dell’altra, oltre che l’eventuale rapporto genetico. In alcuni casi, l’analisi può suggerire un processo di semplificazione da una struttura più complessa, quella della favola, a una più semplice, quella del proverbio. In altri, invece, si può ipotizzare il meccanismo contrario. In realtà, la spiegazione appare generalmente più articolata: proverbio e favola derivano da uno stesso nucleo di elaborazione concettuale e vivono una spiccata dimensione orale: lo dimostrano l’uso che ne fanno alcuni generi popolari, come la commedia plautina. Si possono così distinguere tre livelli di contatto tra favola esopica e proverbio: a. il proverbio mette in rilievo una caratteristica di un personaggio (per lo più un animale) che trova una simile connotazione nella favola, senza però lasciare supporre un collegamento stretto; così, ad esempio, Parvola … magni formica laboris («La minuscola formica dotata di grande laboriosità»): può ricordare la favola della cicala e della formica (Esopo 336 Ch.); b. il proverbio lascia chiaramente intravedere la favola sottesa; ad esempio, ῞Eνα... ἀλλὰ λέoντα, «Uno... ma leone»: l’espressione rimanda puntualmente a una favola esopica 194 Ch.: la leonessa, orgogliosa, così replica alla volpe che la deride per la sua limitata prolificità; ma il riferimento non è necessariamente letterale: l’espressione Lupo agnum eripere postulant – «Vogliono strappare
l’agnello al lupo» (Plauto, Poenulus 776) – rimanda concettualmente, ma non letteralmente, a una favola molto nota, quella del leone che rapisce una pecora al lupo, rapitore per eccellenza (Esopo 227 Ch.); c. alcuni promiti ed epimiti assumono autonomamente valore di proverbio. Così l’epimitio Dominum videre plurimum in rebus suis («Il padrone vede particolarmente bene nei suoi affari») è tratto dalla favola del cervo e dei buoi (Fedro 2,8,28); spesso, come nel caso segnalato, il motivo concettuale, che trova un’originale elaborazione nella favola, non è esclusivamente proprio di essa, ma può trovare riscontri, in varie forme, anche in altri contesti letterari. Esistono, inoltre, situazioni più complesse, come il celebre Lupus in fabula: in questo caso, favola e proverbio sembrano, già nelle ipotesi degli antichi, avere un puntuale riscontro, anche se il detto implica una più articolata spiegazione culturale (v. LUPO). La favola ha, dunque, inciso profondamente nella cultura popolare, ma anche in alcuni ambiti specialistici: ad esempio, nel lessico giuridico, il cosiddetto «patto leonino» deriva dall’espressione Societas leonina, che ha origine da una favola di Fedro (1,5). Non a caso, dunque, le favole sono alla fine approdate anche nelle raccolte dei paremiografi per spiegare la genesi e il senso dei proverbi antichi.
Storia della favola antica La favola esopica nell’antichità vive un’evoluzione che si costruisce in tre fasi: 17
– Nel periodo dall’VIII al IV secolo a.C., al di là di ipotetiche raccolte (v. ESOPO), la favola non gode di una sua autonomia artistica, ma viene usata come exemplum in altri contesti letterari, attraverso brevi
narrazioni o semplici allusioni di carattere proverbiale. Diffuso è l’impiego come «racconto tradizionale» in ambito orale. – Nella seconda fase, a partire dalla fine del IV secolo a.C., le favole trovano sistemazione autonoma nelle collezioni: la prima, peraltro non superstite, sembra essere quella di Demetrio Falereo, filosofo peripatetico, discepolo di Teofrasto (cfr. Diogene Laerzio 5,80). Duplice è l’interesse per la narrativa esopica: come oggetto di studio e come strumento utile per retori e pedagoghi. – Nella terza fase, a partire dal I secolo d.C., comincia il tentativo di conferire una dignità pienamente letteraria alla favola, messa in versi prima da Fedro, poi da Babrio e da Aviano. Continua, anche in questa fase, la dimensione prosastica della narrativa esopica e nel tempo si consolida la funzione che essa riveste nella scuola. Ecco, nello specifico, le principali linee di sviluppo nell’ambito della letteratura greca e latina e nella letteratura cristiana antica.
La favola nella letteratura greca Sono attestate favole in Grecia prima di Esopo, a cui sono poi attribuite numerose narrazioni precedenti e successive alla sua supposta esistenza. Il primo autore che fa uso di favole è infatti Esiodo (VIII-VII secolo a.C.), che, nel poema didascalico Le opere e i giorni 202 ss., racconta la vicenda dello sparviero e dell’usignolo. La narrazione è semplice e si fonda sulla struttura più ricorrente della favolistica, ossia quella del conflitto tra due personaggi, basato sulla forza, secondo uno degli schemi narrativi probabilmente più antichi, ma in seguito meno frequenti nelle collezioni esopiche. Lo sparviero ghermisce l’usignolo e gli dice con arroganza che può disporre di lui a suo piacimento. Alla fine
del discorso, rivolto all’inerme uccello, sottolinea la morale: «Stolto è chi si vuole opporre a chi è più forte: non ottiene vittoria e aggiunge sofferenza alla vergogna». Dopo Esiodo, anche Archiloco, poeta lirico del VII secolo a.C., ricorre alla favola. Nei frammenti superstiti della sua opera riconosciamo, tra l’altro, una vicenda di larga fortuna nell’antichità: quella dell’aquila e della volpe (frr. 174-180 W. ) . L’aquila rapisce i piccoli della volpe, ma alla fine viene punita per la sua empietà. La favola, una delle più celebri della tradizione esopica, sembra di origine orientale (v. sotto). Inoltre, costruito sulla base del meccanismo demistificante che caratterizza la tradizione esopica, troviamo anche il motivo della volpe pronta a sbugiardare la scimmia, che si ritiene nobile, anche se le sue natiche indecorose costituiscono un insuperabile motivo di vergogna (frr. 185 ss. W. ). Ma, oltre a questi celebri riferimenti, la favola appare largamente diffusa in gran parte della poesia del VII e VI secolo a.C.: troviamo, ad esempio, accenni, non sempre di facile interpretazione per la natura frammentaria dei testi, in Solone (fr. 11 W. ), Semonide (frr. 8-9 W. ; 13 W. ), Teognide (347 s.; 602). Nel V secolo a.C., lo storico Erodoto (1,141) presenta una narrazione favolistica, quella del pescatore auleta (cfr. Esopo 24 Ch.), significativamente attribuita al re persiano Ciro, che si rivolge, in un discorso impostato su uno schema tipico della diplomazia orientale (v. LA FAVOLA NELLA BIBBIA), agli ambasciatori di Eoli e Ioni. Anche questa testimonianza sembra rafforzare l’idea di una originaria elaborazione e di una tecnica orientale della favola, che pare avere un profondo influsso sulla cultura greca. Dopo la supposta esistenza di Esopo (v.), la favola penetra anche nella cultura attica, al punto che lo stesso Fedro collocherà la figura di Esopo nell’Atene di Pisistrato (intorno alla metà del VI secolo a.C.). Ad ospitare spunti favolistici, esposti sulla base di differenti modalità narrative, è la commedia più che la 2
2
2
2
2
tragedia. Tuttavia, l’aquila ferita dalla freccia prodotta da una sua penna è un motivo che ritroviamo in un frammento dei Mirmidoni di Eschilo (139 R.); nello stesso autore si rileva anche la narrazione del giovane leone (Agamennone 717 ss.), che lascia intravedere generici riscontri con la tradizione esopica. Invece, in Aristofane si hanno numerosi spunti favolistici, per lo più brevi e talora riferibili esplicitamente a Esopo: si è supposta anche l’esistenza di un libro dedicato alle sue favole, sulla base di un passo degli Uccelli (vv. 471 ss.), che appare tuttavia di interpretazione controversa. Il commediografo, tra l’altro, riprende narrazioni archilochee (l’aquila e la volpe: Uccelli 652 ss.; la volpe e la scimmia: Acarnesi 120 ss.) e mette in scena Esopo nelle vesti di protagonista di aneddoti, come quello che narra la risposta del favolista a una cagna sfrontata e ubriaca (Vespe 1401 ss.). Esopo pare piuttosto popolare, dunque, nell’Atene del V secolo. Le sue favole si diffondono presto in diversi contesti letterari, tanto che, a parte l’epica eroica, tutti i generi sembrano conservarne evidenti tracce. In Platone (Fedone 60c-61b), Socrate, mentre si trova in carcere, riflette sul rapporto tra dolore e piacere, sottolineando che Esopo ne avrebbe potuto trarre una favola: Piacere e Dolore, in perenne conflitto tra di loro, furono puniti dalla divinità che legò le loro teste insieme, cosicché chi si avvicina all’uno, si avvicina allo stesso tempo all’altro. La narrazione esopica diventa dunque un modo per interpretare e spiegare la realtà, e la figura di Esopo assume un valore simbolico simile a quella di Socrate (v.). Dall’uso socratico di mettere in versi favole esopiche ricaviamo indirettamente l’informazione che doveva essere la prosa la dimensione propria della narrativa esopica. Anche in Aristotele troviamo esempi di favole esopiche (tra questi, Meteorologica 356b, una sorta di cosmogonia acquatica narrata da Esopo; Politica 1284a: le lepri e i leoni), al di là della trattazione teorica della favola intesa come strumento retorico (Retorica 1393b-1394a). Il passaggio che segna una prima svolta per la tradizione 18
19
esopica è attestato in Diogene Laerzio (5,80). Avviene con Demetrio Falereo, che, alla fine del IV secolo a.C., pubblica la prima raccolta di favole a noi nota. Quindi, in questa fase, la favola sembra finalmente emanciparsi dall’uso strumentale e contestuale che ne fanno gli altri generi letterari, per imporsi invece con una sua autonomia, anche se non sembra assumere ancora una piena dignità letteraria e pare piuttosto legata alla retorica. Peraltro, negli autori del periodo alessandrino, si rileva un minore uso della favolistica: in Callimaco, comunque, troviamo sia il riferimento a una favola di origine orientale che presenta la contesa tra l’alloro e l’olivo (fr. 194 Pf.), sia un riferimento a Esopo, in relazione a un’altra narrazione (fr. 192 Pf.). Spunti favolistici si rilevano anche nell’epigramma ellenistico dell’Antologia Palatina, grazie ad autori come Leonida di Taranto (9,99) o Alceo di Messene (6,218). A partire all’incirca dal I secolo a.C., le favole tornano ad avere una larga diffusione e, come dimostra il Papiro Rylands (databile al I secolo d.C.), continuano a circolare repertori che presentano favole concepite come exempla, a cui i retori possono attingere. In questo periodo sembra consolidarsi, inoltre, la funzione scolastica della favola, come segnalano trattazioni teoriche e raccolte didattiche. I testi di cui disponiamo chiariscono bene questa funzione: datano dal I al V secolo d.C. e sono opera di retori quali Teone (I-II secolo), Ermogene (II-III secolo), Aftonio (IV secolo), Nicolao di Mira (V secolo). Si vengono inoltre a costituire le raccolte esopiche anonime: secondo l’ipotesi di alcuni studiosi, l’Augustana, la collezione più antica (v. APPENDICE), sarebbe databile al I-II secolo d.C. Oltre a significativi riferimenti favolistici presenti in autori di diversa epoca ed estrazione, come Dione Crisostomo, Dione di Prusa, Massimo di Tiro, la più ricca miniera di racconti esopici si trova certamente in Plutarco, sia nelle Vite parallele (ad esempio, nella Vita di Temistocle 21,7 è riportata la favola della volpe senza coda, nella Vita di Lisandro 22,3 quella, già aristotelica, delle lepri e dei leoni),
sia nei cosiddetti Moralia, che in alcuni casi presentano narrazioni riferite esplicitamente a Esopo, peraltro prive di riscontro nelle collezioni. Una di queste – l’ombra dell’asino (Vite dei dieci oratori 848a) – spiega bene il modo in cui è concepita la favola nell’antichità: l’oratore Demostene, a cui fu impedito dagli Ateniesi di tenere un discorso, cominciò a esporre una narrazione di tipo esopico incentrata sull’ombra di un asino, ma a un certo punto si interruppe. Gli Ateniesi lo pregarono di finire la storia. «E dunque – replicò Demostene – voi volete sapere tutto sull’ombra di un asino, ma vi rifiutate di stare attenti a chi parla riguardo ad argomenti seri?» Nel II secolo d.C., è soprattutto Luciano a segnalarsi per le brevi allusioni, da cui possiamo riconoscere narrazioni attestate già negli autori dei secoli precedenti: tra le più note, la scimmia che si distingue nella danza (Il pescatore 36), Filemone e l’asinello (I longevi 25), il notissimo motivo dell’asino e della lira, che compare, con riferimenti di diversa natura, in varie opere di questo autore. Come si vede, dunque, la favola del periodo imperiale trova un certo spazio nella diatriba, il genere filosofico che oscilla tra la conversazione e la predica, coltivando una finalità divulgativa. Nel II secolo d.C., si impongono i coliambi di Babrio (v. APPENDICE), che si segnalano come un ulteriore passo in avanti nella storia della favola, ormai collocata in una dimensione consapevole di genere letterario autonomo e non semplicemente di strumento retorico funzionale ad altri contesti. Il poeta afferma, nel prologo del secondo libro, che la favola è un’invenzione degli antichi Siri del tempo di Nino e di Belo: si riferisce, insomma, agli antichi Assiri e Babilonesi. Sul piano stilistico, Babrio, che si segnala per la cura formale, ha come obiettivo una elegante brevità, mentre sul piano dei contenuti tende a concentrare il significato della narrazione in una efficace battuta finale (così, alcune di queste narrazioni sono solo di quattro versi: cfr. Babrio 8 e 17). «Furono forse il garbo, la misura, la colta 20
urbanitas a procurare alle favole di Babrio un immediato e largo successo», anche se il poeta sembra mancare di vis mimica e di vis comica. La fortuna di Babrio non è solo scolastica (Tavolette di Assendelft; Pseudo-Dositeo), ma arriva a incidere anche sulla letteratura latina, visto che da lui deriva buona parte delle narrazioni in distici elegiaci del poeta latino Aviano. In età bizantina la favola trova largo spazio: proprio in questo periodo vengono articolandosi le raccolte anonime riferite a Esopo (v.). Rielaborazioni in prosa e versi di Babrio si aggiungono a collezioni come quelle di Sintipa e a favole di retori come Niceforo Basilace, talora molto più lunghe e strutturalmente differenti, secondo il gusto del periodo, rispetto a quelle della tradizione esopica classica. 21
La favola nella letteratura latina La più antica favola attestata a Roma risale al 495 a.C. ed è ricordata, alcuni secoli dopo, dallo storico Tito Livio (2,32,8-12). Si tratta dell’apologo che narra, «nel primitivo e rozzo modo di parlare di quel tempo», la ribellione delle membra contro lo stomaco. Con questa favola, Menenio Agrippa risultò tanto persuasivo che risolse la secessione della plebe, ritiratasi sul Monte Sacro. La narrazione ha origine egizia, e, sia pure con qualche variazione, ha fortuna anche nella tradizione esopica (cfr. Esopo 159 Ch.). Dionigi di Alicarnasso, nelle Antichità romane (6,48-49), sottolinea proprio che fu raccontata da Menenio Agrippa «alla maniera di Esopo». Al di là di questo episodio, la favola a Roma trova spazio soprattutto in due generi letterari: la commedia e la satira. I riferimenti sono spesso molto brevi (in forma di proverbio) e dimostrano una conoscenza diffusa del patrimonio esopico in tutti gli strati sociali. In Plauto, si segnala soprattutto la favola del bue e dell’asino (Aulularia 226 ss.), sintetizzabile nel proverbio «Passare dagli asini ai buoi», ossia da una
classe sociale umile a una elevata, con tutti i rischi del caso (v. BUE). D’altra parte, al di là di alcune allusioni alla sfera mitologica (come in Rudens 13 ss.: il motivo proverbiale e quindi anche favolistico di Giove giudice), i riferimenti più ricorrenti sono quelli che riguardano il lupo: tende insidie al gregge custodito dal cane (Trinummus 169 ss.), viene lasciato paradossalmente a custodia delle pecore (Pseudolus 139 ss.), viene rapinato (lui, predone per eccellenza) dal leone (Poenulus 776). Queste immagini servono per lo più a descrivere il comportamento dei personaggi della commedia, al punto che «Lupo» diventa un nome parlante di un personaggio (il lenone Lycus nel Poenulus). Anche in Terenzio e nei frammenti di altri comici si ritrovano possibili riferimenti alla favolistica, come nell’Eunuco (832), dove la schiava Pitia ha imprudentemente consegnato la povera Panfila nelle grinfie del finto eunuco Cherea: Taide la rimprovera dicendole che ha affidato «una pecora a un lupo» (motivo esopico: v. PECORA; LUPO). Tra gli altri riferimenti possibili, il noto proverbio Lupus in fabula (I fratelli 537), di cui non si esclude la derivazione da un motivo esopico (Esopo 223 Ch.), e, come già Donato e poi alcuni studiosi hanno ipotizzato, il vecchio e la vecchia della commedia La suocera 619 ss. potrebbero alludere all’inizio di una favola. In un frammento di Titinio (34 R. ), inoltre, si fa riferimento all’uomo di campagna molto simile alla formica; ciò ha indotto alcuni studiosi a proporre un parallelo con la narrazione esopica in cui la formica era in origine un contadino che viveva del lavoro dei campi (Esopo 240 Ch.). La favola trova un suo naturale veicolo nella tradizione diatribica. Di qui i numerosi spunti esopici nella satira latina, che condivide con la favolistica tensione morale e semplicità formale. In questo caso possiamo notare una linea di sviluppo che va da una funzionalità etica della favola in Ennio e Lucilio fino a un’originale rielaborazione artistica in Orazio. Nei frammenti enniani troviamo riferimenti alla contesa tra la Morte e la Vita (fr. 20 V. ), secondo uno schema assimilabile a quello esopico; un verso (fr. 69 V. ) 22
3
2
2
può essere ricondotto alla favola del pescatore auleta (cfr. Erodoto 1,141); da segnalare, soprattutto, la favola dell’allodola che nidifica in mezzo alle messi: la fonte è Gellio (2,29), che premette alla favola un elogio di Esopo, capace di impartire un insegnamento filosofico con apologhi divertenti. Anche in Lucilio troviamo tracce di favole: la più significativa è quella della volpe che non cade nel tranello del leone (frr. 980-989 Marx): riprende Esopo 196 Ch. Inoltre si hanno tracce della favola della formica e dello scarabeo (Esopo 241 Ch.), in un passo del XIX libro (frr. 561 s. Marx), che rimanda al tema dell’avarizia. Ma è in Orazio (I secolo a.C.) che la favola latina compie un vero e proprio salto di qualità. I riferimenti favolistici sono concentrati nelle Satire e nelle Epistole, opere caratterizzate da una lingua colloquiale e dall’esametro. Si possono distinguere tre livelli di rielaborazione. Innanzitutto i riferimenti e le allusioni che si esprimono attraverso immagini proverbiali (Satire 1,1,32 ss.; 1,9,20 s.). Ma ci sono anche riferimenti a motivi assai noti come quello delle due bisacce (Satire 2,3,298 s.; cfr. Esopo 303 Ch.), che compare in altri contesti della letteratura latina (in particolare, in Catullo 22). Il secondo livello di rielaborazione è quello che si potrebbe definire dell’Esopo oraziano: favole narrate in modo esteso, che rimandano alla tradizione esopica, di cui assimilano anche alcune caratteristiche. Ecco, dunque, la favola della rana e del bue (Satire 2,3,314 ss.; cfr. Fedro 1,24), quella della volpe che si insinua attraverso la fessura di una cesta per mangiare il grano ma poi, gonfiandosi, non riesce più a uscirne (Epistole 1,7,28 ss.; cfr. Esopo 30 Ch.), quella del cavallo sconfitto dal cervo, che cerca l’aiuto dell’uomo e ne rimane schiavo (Epistole 1,10,34 ss.; cfr. Aristotele, Retorica 1393b). Il terzo livello è quello che si potrebbe definire dell’Orazio esopico: in un’originale creazione, il poeta riprende la favola dei due topi e costruisce una lunga narrazione, che esce dallo schema tipico della favolistica (Satire 2,6,77 ss.). La 23
favola segue una riflessione del poeta, che spiega la sua predilezione per la campagna (vv. 65-76). L’esperimento è originale per l’articolazione del racconto, il gusto del particolare, le sfumature psicologiche dei due topi, rese con garbata ironia. Sarà inutile, dunque, cercare un riscontro nella tradizione esopica; sarà semmai più fruttuoso indagarne la fortuna fino a La Fontaine (1,9) e oltre. Tra gli autori che fanno uso di favole, va segnalato anche il poeta Ovidio, che ricorre alla materia esopica soprattutto nei Fasti, dove fa riferimento, ad esempio, alla storia del caprone che si nutre dei pampini della vite (Esopo 339 Ch.) o al contadino che lega una fiaccola alla volpe per vendicarsi (ma poi l’animale finisce per incendiare i suoi campi: 4,681 ss.; cfr. Esopo 58 Ch.). Insomma, per lo più «Ovidio trova nella favola non solo l’occasione di soddisfare la sua voglia di raccontare, ma anche nuovo materiale narrativo al quale attribuire carattere eziologico». La vera svolta per la favola latina si ha, come è noto, con Fedro (v. scheda in appendice): sua è la prima raccolta favolistica in versi (senari giambici) del mondo classico, contemporanea a quella, in prosa, del Papiro Rylands (v.). «Il posto di Fedro – è il noto giudizio di Concetto Marchesi – è tra i piccoli poeti: ma è un posto cospicuo.» Discusso è il rapporto con il «padre» della favolistica Esopo, che compare anche in diverse narrazioni nel ruolo di schiavo sapiente. Il poeta, nel primo libro, chiarisce fin dai primi versi (Prologo, vv. 1 ss.) i suoi obiettivi letterari: dare dignità poetica, attraverso una elaborazione artistica in versi senari, alla materia esopica. Duplice è l’obiettivo: divertire e offrire utili consigli di vita. Questo primo libro, che si apre con la violenza del lupo sull’agnello, presenta di frequente lo schema narrativo fondato sul conflitto tra due personaggi e offre spesso traccia di una forte dialettica socioeconomica, che si esprime bene nelle parti morali, contrapponendo, in un mondo rigorosamente gerarchizzato, umili e potenti. Così la favola 24
25
26
di Fedro appare cupa, caratterizzata da un’irriducibile negatività, da leggere spesso in chiave autobiografica; al poeta, infatti, sono riconducibili numerose immagini nell’ambito dell’opera: tra le altre, l’anfora vuota che ancora profuma (3,1), la perla nel letamaio (3,12), il vecchio cane bistrattato (5,10). L’estrema brevità appare come la cifra stilistica della narrazione. Se nel primo libro il poeta sembra rimanere fedele al suo programma, già nel secondo pare riscontrabile un parziale mutamento di prospettiva: nel prologo (vv. 8 ss.) Fedro dichiara di osservare «scrupolosamente» il modo di narrare del «vecchio», ma dichiara l’intenzione di inserire qualcosa di nuovo, in modo che la varietà aumenti il diletto. E, in effetti, troviamo una narrazione, quella di Tiberio e dello schiavo atriense (2,5), un episodio ambientato nella corte imperiale. Si aprono così le porte a nuovi esperimenti. Le otto favole superstiti di questo libro, tuttavia, lasciano pensare che molte ne manchino. Nel prologo del terzo libro, il poeta, rivolgendosi a Eutico, conferma la fedeltà al modello esopico, ma, nonostante il livore dei detrattori, ricorda la sua originalità (vv. 38 s.), avendo ideato più storie di quante ne abbia elaborate Esopo. Qui diverse narrazioni tendono alla composizione aneddotica o novellistica: 3,1 (la vecchia e l’anfora), 3,8 (la sorella e il fratello), 3,10 (l’uomo e la moglie). L’ambientazione sembra meglio definita in un contesto locale (ad esempio, in 3,1 si fa riferimento al Falerno, un vino campano). Anche nel prologo del quarto libro, l’auctor viene ricordato, ma viene ribadita la rivendicazione della sua autonomia artistica (vv. 10 ss.). Dopo l’intento di rielaborazione affermato nel primo libro, a partire dal secondo la carica innovativa si estende ai contenuti (le res), sia sul piano quantitativo, sia sul piano qualitativo: così c’è spazio anche per inserzioni novellistiche. In questo quarto libro circa la metà delle favole trova un riscontro esopico: forse si tratta di un nuovo inizio, considerato che nell’epilogo del terzo libro Fedro aveva dichiarato l’intenzione di porre termine alla sua opera.
Nemmeno nel prologo del quinto libro manca il riferimento a Esopo, anche se il poeta ritiene di avere saldato il proprio debito. Si tratta di un omaggio che però non impedisce a Fedro di ribadire la propria originalità, peraltro dimostrata, anche nelle poche favole superstiti di questo libro (alcune piuttosto lunghe, ben oltre i trenta versi), visto che in 5,7 (il flautista sfrontato), si narrano personaggi realmente esistiti (Principe e Batillo) e un fatto veramente accaduto, a cui forse Fedro ha personalmente assistito (v. 6). Siamo approdati addirittura all’«antifavola», alla historia, insomma. Anche nell’Appendix Perottina troviamo narrazioni che sembrano porsi al di fuori dalla tradizione favolistica, per approdare invece a un’altra dimensione: in particolare, il racconto della matrona di Efeso (App. 13 [15]), riportato anche nel Satyricon di Petronio (111-112), ci riconduce alla novellistica, così come la vicenda dei due fidanzati (App. 14 [16]). Dopo Fedro, che ha dunque consapevolmente introdotto innovazioni nel genere esopico, la favola sembra ignorata per alcuni secoli, a parte brevi incursioni di Frontone, Gellio, Apuleio e Ausonio. La sua naturale destinazione pare ormai quella della scuola: non solo disponiamo delle favole dello Pseudo-Dositeo (v.), ma abbiamo anche notizia di una raccolta di narrazioni a cura di Giulio Tiziano, maestro a Besançon e a Lione, autore di una fortunata versione in prosa di Aesopia trimetra, che visse nel IV secolo (ma alcuni studiosi propongono una diversa identificazione, spostando la collocazione cronologica al II-III secolo). Alla fine, tuttavia, sarà Aviano (v. APPENDICE), vissuto tra il IV e il V secolo, a rispolverare la favola, nell’ambito di un’operazione artistica che insiste consapevolmente sul terreno della poesia. Questo poeta, di cui molto poco è noto, scrive, infatti, in distici elegiaci. Nella lettera prefatoria a Teodosio, l’autore indica come guida Esopo, non dimentica di citare Socrate e Orazio, ma rende omaggio anche ai suoi due precedessori, che si
impegnarono a garantire dignità artistica alla favola: Babrio e Fedro. Qual è l’obiettivo? Dilettare, esercitare l’ingegno, attenuare le preoccupazioni e interpretare la vita. Il Romulus e le parafrasi di Fedro, di cui le opere sono note, mentre il nome viene ignorato, aprono le porte alla fortuna del genere esopico, apprezzato nel Medioevo specialmente per la sua tensione morale.
La favola nella letteratura cristiana antica La favola ha una notevole diffusione anche nella letteratura cristiana dei primi secoli, in ambito sia greco sia latino. Si rilevano riferimenti a Esopo, citazioni, spesso nella modalità del proverbio, e anche una riflessione sul genere favolistico svolta da Agostino e Isidoro di Siviglia. Duplice è lo scopo dei Padri della Chiesa nell’uso della favola: ironizzare su comportamenti o concezioni ritenute scorrette e illustrare con chiarezza ed efficacia un determinato assunto. Già nel II secolo d.C., Taziano (Contro i Greci 34,2) cita, in chiave polemica, il «narratore di frottole» Esopo e il mimografo Sofrone. Così facendo, d’altra parte, ne attesta la fama, anche sulla base dell’arte del bronzo e della scultura, ricordando, in particolare, la statua dedicata al favolista da Aristodemo (IV secolo a.C.). Il contesto è importante per comprendere la natura polemica del riferimento: siamo nell’ambito dell’apologetica, in un’epoca di forte scontro tra cultura cristiana e cultura pagana. Di lì a poco, Tertulliano fa riferimento alle favole esopiche, soprattutto per mettere in ridicolo opinioni altrui che ritiene errate. Nell’ambito della polemica Contro i Valentiniani (12,4; 13,1) troviamo citata la favola del gracchio superbo e del pavone (Fedro 1,3; cfr. anche Esopo 162 Ch.). Si tratta di un riferimento appena accennato, che lascia pertanto supporre una diffusa conoscenza delle favole di Esopo. Peraltro questo motivo, che si adatta bene a differenti contesti argomentativi, pare 27
di larga fortuna nell’ambito della letteratura cristiana, tanto che viene impiegato anche in altri autori, talora con la variante della cornacchia al posto del gracchio (v.). Diverso è l’uso che della favola fa Clemente Alessandrino, il quale ricorre ai riferimenti esopici per lo più per illustrare le sue teorie: si serve in particolare della favola dell’asino che si accosta alla lira, ma non la sa suonare (Fedro, App. 12 [14]). Anche in questo caso, l’autore allude alla forma proverbiale («L’asino che ode la lira»), che nel mondo antico doveva avere una certa fortuna (v. ASINO). L’intento è quello di dimostrare che la vera conoscenza non è per tutti (Stromateis 1,2,2); in un altro passo della stessa opera (6,112,1) allude alla favola per affermare che chi non ha le conoscenze per svolgere un’attività, non deve praticarla. Ma, al di là dei riferimenti alle favole che si riscontrano in vari autori, troviamo persino una ripresa puntuale di Fedro in Prudenzio. Nel Cathemerinon (7,115), infatti, l’autore cristiano racconta l’episodio in cui Giona viene inghiottito dalla balena e cita Fedro (4,6,10): «sprofondò nella tartarea spelonca del suo ventre capiente» (il favolista latino qui sta narrando la favola dei topi che combattono con le donnole). Reminiscenza scolastica? Allusione consapevole con una finalità letteraria? Diverse le spiegazioni ipotizzabili. La trattazione più consapevole riguardo alla favola è, d’altra parte, quella di Agostino (Contra mendacium 13,28): confutando la teoria secondo cui alcuni passi biblici legittimerebbero la menzogna, il santo, a proposito della parabola del figliol prodigo, parla di una narrazione fittizia che permette di conoscere una verità. Cita, inoltre, come esempi simili, due narrazioni esopiche: lo scopo è quello di «inculcare in modo più incisivo l’oggetto dell’insegnamento». Il riferimento è relativo alle favole oraziane dei due topi (Satire 2,6,77 ss.) e della donnola che consiglia alla volpe di ritornare magra per uscire dalla cesta dove si era infilata per cibarsi (Epistole 1,7,29 ss.). Agostino aggiunge anche un riferimento a Esopo e alla favola biblica degli alberi che cercano un re (Giudici 9,8-15). Il linguaggio immaginario,
insomma, risponde a una verità. Anche Isidoro di Siviglia, che svolge un ampio discorso teorico sulla favola (Etimologie 1,40), arriva a citare queste narrazioni, ribadendo la linea interpretativa di Agostino (1,40,6).
La favola nelle altre tradizioni culturali La favola esopica non è un genere esclusivamente greco, ma appare piuttosto come il risultato di numerosi contatti e interferenze tra popoli asiatici ed europei in costante comunicazione. Peraltro narrazioni che presentano animali come protagonisti e hanno una struttura narrativa e una finalità morale abbastanza simili si ritrovano anche in Africa e in altre parti del mondo. Tuttavia, già nell’antichità, ad esempio in Babrio (v. LA FAVOLA NELLA LETTERATURA GRECA), si segnala la consapevolezza di un’origine orientale della favola. Non mancano menzioni, anche presso i retori, di favole libiche, carie o di altra provenienza. Lo stesso Esopo (v.) viene rappresentato di origine tracia, frigia o lidia. Si è a lungo discusso, soprattutto nell’Ottocento, della possibile derivazione della favola greca da quella indiana e viceversa; si sono analizzati singoli motivi, per stabilirne derivazione e propagazione. Il dibattito si è poi, recentemente, spostato sui rapporti tra la letteratura dell’area mesopotamica, ritenuta da alcuni studiosi la culla della favolistica antica, e quella greca. D’altra parte, al di là di alcuni specifici casi di scambi di motivi favolistici, al di là di qualche inevitabile interferenza, in generale pare preferibile optare per una possibile poligenesi di alcuni motivi favolistici, piuttosto che per una monogenesi o, addirittura, per la derivazione di un’intera tradizione dall’una all’altra tradizione culturale. Ecco, nello specifico, quali sono le tradizioni che presentano punti di contatto con la cultura greca e latina.
Tradizione mesopotamica La tradizione mesopotamica – in particolare sumerica, babilonese e assira – presenta, in fasi successive, numerosi testi accostabili alle favole esopiche. Si tratta di testi di natura eterogenea e non è possibile parlare di un vero e proprio genere favolistico. Il contesto, come suggerisce il titolo di uno studio di Lambert, è quello della «saggezza orientale». La conoscenza di questa letteratura si è accresciuta notevolmente nel secolo scorso, quando sono stati scoperti testi fondamentali che risalgono al III millennio a.C. Infatti, già nelle cosiddette Istruzioni di Šuruppak (2500 a.C. circa), dove troviamo i consigli di questo saggio al figlio Ziusudra, si rilevano tracce vagamente accostabili alla favolistica. Testi successivi presentano importanti paralleli con la tradizione esopica. Gli studiosi si sono a lungo soffermati sul Poema di Etana, conservato in una redazione accadica e risalente al XVIII secolo a.C. È dedicato al mito del tredicesimo re della prima dinastia di Kish, secondo la lista reale sumerica. Il sovrano sale in cielo sul dorso di un’aquila per ottenere dagli dei l’erba della generazione: così potrà avere un erede. Nell’ambito di questo testo, troviamo anticipato il motivo esopico (presente già in Archiloco frr. 174-180 W. : v. AQUILA) dell’aquila e della volpe, qui sostituita dal serpente. I due animali, legati da un patto di amicizia, pongono la loro abitazione l’uno sopra, l’altro alla base di un albero e vi si stabiliscono insieme ai loro piccoli. L’aquila, però, tradisce l’amicizia, rapendo proditoriamente i piccoli del serpente con l’intenzione di divorarli. Ne consegue, grazie all’intervento della divinità invocata, l’inevitabile vendetta. Pubblicata già da Ebeling nella prima edizione dei proverbi del 1927, la favola dell’elefante e della mosca è riportata in una collezione assira copiata nel 716 a.C., ma risalente a un originale più antico. Questa la vicenda: la mosca si posa sull’elefante e, quando decide di andarsene, 2
gli chiede se lo ha affaticato con il suo peso. L’elefante risponde di non essersene neppure accorto. Lo stesso motivo è riscontrabile nella tradizione esopica (Esopo 189 Ch.; Babrio 84): qui si trovano di fronte la zanzara e il toro; la morale si rivolge agli uomini di nessun valore, la cui presenza (o assenza) è del tutto indifferente. Al di là di questi testi piuttosto noti, nella tradizione mesopotamica ne troviamo altri di varia impostazione formale: lamentazioni, dialoghi e tenzoni. Note, in particolare, sono le dispute (alcune in lingua sumerica, altre in accadico, altre bilingui) che vedono protagonisti, proprio come nella favolistica esopica, piante, animali o personificazioni: l’estate e l’inverno, il bestiame e il grano, l’uccello e il pesce, l’albero e la canna, l’argento e il rame, il tamarindo e la palma, il bue e il cavallo. D’altra parte, sono i «proverbi» – tale definizione non rende, tuttavia, la specificità di questi testi – le fonti su cui si è più concentrata l’attenzione degli studiosi. Le tavolette in caratteri cuneiformi studiate da Gordon ci riportano alla prima metà del II millennio a.C. La quinta collezione, pubblicata dal sumerologo nel 1958, è, in particolare, quella più ricca di spunti interessanti per gli studiosi della favolistica: presenta 125 brevissimi testi, ricostruiti sulla base di 29 tavolette, in parte danneggiate. Protagonisti sono gli animali: 38 di questi testi si avvicinano alla favola esopica. Sono caratterizzati per lo più da una breve parte narrativa, seguita da una battuta finale. Ma ci sono anche dialoghi e proverbi animali. Così, ad esempio, all’elefante che si vanta e sostiene che non esiste nessuno come lui, il minuscolo scricciolo risponde a tono, ridimensionandone la superbia (5,1). Un cane sta attaccato all’asino che nuota dentro un fiume e gli chiede quando ne uscirà, così da poterlo mangiare: il tema è quello dell’ingratitudine del cane, che deve la sua salvezza all’asino, ma è impaziente di divorarlo (5,38). Il testo che più si avvicina alla favolistica è forse quello dedicato al leone che cattura una capra (5,55), ma viene persuaso a liberare la preda in cambio di una
pingue pecora. La capra dimostra la sua astuzia, e alla fine lo beffa. Qui riscontriamo già uno schema narrativo che pare certamente esopico (v. CAPRA). Una segnalazione a parte merita poi il cosiddetto Romanzo di Ahiqar, ripreso in seguito nell’ambito del Romanzo di Esopo (v. APPENDICE). Si tratta di un racconto di origine assiro-babilonese che presenta come protagonista un alto funzionario del re di Babilionia (nel Romanzo troviamo il nome greco di Licurgo): questo personaggio è definito «consigliere di tutta l’Assiria» e «guardasigilli del re d’Assiria», nella cosiddetta versione di Elefantina, la più antica di cui disponiamo. Alcuni studiosi hanno proposto di riconoscere una realtà storica a questa figura, in quanto il nome è attestato in relazione a un ummanu, ossia un alto consigliere dei re assiri Sennacherib (705-681) ed Esarhaddon (680-669), suo figlio. Ahiqar venne calunniato presso il sovrano dal nipote Nadan, in precedenza adottato come figlio, e perciò venne condannato a morte: ma l’incaricato dell’esecuzione, riconoscente per i benefici che Ahiqar gli aveva concesso, lo nascose e uccise al suo posto un eunuco. In seguito, il sapiente si rifece vivo in occasione di una sfida enigmistica, consistente in un indovinello, che vedeva contrapposto il re di Babilonia al faraone egiziano. Alla fine, Ahiqar, pienamente riabilitato e trionfante, punì il nipote fino a farlo morire. Il racconto serve da cornice a due prediche che contengono anche favole assimilabili a quelle di tipo esopico. Esistono di questa vicenda varie redazioni. Quella più antica si conserva nel papiro aramaico di Elefantina, peraltro mutilo e frammentario, databile al V secolo a.C.: presuppone un modello babilonese anteriore e forse uno intermedio persiano; seguono, in fasi differenti, varie versioni: oltre a quella greca del Romanzo di Esopo, da cui dipende quella latina, ne vanno ricordate molte altre, di elaborazione siriaca, araba, armena, turca, georgiana, demotica, rumena, serba, russa, etiopica; si riscontrano anche punti di contatto con la letteratura biblica (la figura di Ahiqar compare nel libro di Tobia: cfr. in particolare il 28
contributo di Toloni 141 ss. in Contini-Grottanelli). La favolistica dell’Asia Minore resta tuttora un terreno di esplorazione aperto. Nel 1983 e nel 1985 sono stati scoperti nuovi testi in caratteri cuneiformi, pubblicati da Erich Neu nel 1988, che sembrano accostabili, per la semplicità della struttura narrativa e per l’intento di proporre una morale, alla successiva favolistica esopica. Si tratta di testi bilingui in hurrita e ittita, scoperti a Boğazköy (l’antica Hattusa, in Anatolia). Alcuni esempi ci fanno comprendere lo schema più ricorrente. Un metallo prezioso lamenta di essere battuto dal fabbro, che gli ricorda come solo così potrà aumentare il suo valore. Si tratta di un insegnamento ai figli ribelli nei confronti dei genitori. Una capra selvaggia maledice una montagna, che risponde allo stesso modo: l’immagine va a rappresentare l’uomo esiliato e la sua città che lo ha allontanato. Anche in questo caso, troviamo, dunque, significative affinità con la tradizione esopica. 29
Tradizione indiana La tradizione indiana è molto ricca nell’ambito della favolistica e della novellistica. Qualche traccia di favole che presentano come protagonisti gli animali si riscontra già nell’antico Rigveda (10,28). D’altra parte, è il Pañcatantra l’opera a cui più spesso è stata accostata la favola esopica greca: entrambe sono generalmente prese come riferimento per delineare la tipologia di narrazione che ha per lo più come protagonisti gli animali ed è finalizzata a un insegnamento morale. Nell’Ottocento gli studiosi si esercitano in accostamenti di tipo genetico. L’entusiasmo per la «scoperta» del sanscrito in Occidente permette un’equazione di questo genere: come al sanscrito vanno ricondotti il greco e il latino, così alla favola indiana quella esopica. Si studiano così le singole favole per stabilirne la relazione genetica: un metodo criticato poi da Hausrath e superato da più solidi 30
presupposti scientifici. Nella sua edizione del Pañcatantra (1859), già Benfey chiarisce che non c’è derivazione diretta, i temi comuni sono pochi e le interferenze potrebbero essere tarde. La datazione di quest’opera, non anteriore al III secolo d.C., rende difficile approdare a certezze; resta d’altra parte acquisito che l’India non è stata il centro propulsore della favolistica europea, anche se è possibile il passaggio di singoli motivi tra la cultura greca e quella indiana, in entrambe le direzioni. Appartenente alla tradizione hinduista, il Pañcatantra (Cinque libri) è un’opera che racchiude diverse favole inserite in una serie di racconti a cornice, che mescolano azione e narrazione, essi stessi calati nell’ambito di un racconto più ampio, che unifica tutta l’opera. Il narratore è il brāhmana Visnuśarman. Nel tempo il testo viene rielaborato e ampliato. L’intento è didattico, lo stile semplice ma elegante: i destinatari primi sono tre principi a cui si insegna la scienza politica. Le cinque parti trattano: a) la separazione degli amici; b) l’acquisizione di amici; c) la pace e la guerra; d) la perdita delle cose acquistate; e) l’agire sconsiderato. Sono cinque le versioni principali: a. la versione pehlevi (perduta, risalente al VI secolo d.C.); b. la versione nord-occidentale (perduta), ma inserita in altre opere; c. il Tantrākhyāyika, la versione più antica che risale al IV-VI secolo d.C., scoperta in alcuni manoscritti del Kashmir e derivata da una fonte comune perduta; d. la versione meridionale; e. l’estratto di strofe nepalese, fonte dell’Hitopadeśa; Più recenti il textus simplicior, anonimo, e il textus ornatior (1199), che unisce materiali riconducibili al Tantrākhyāyika e al textus simplicior. Alcune
favole
sono
conservate
soltanto
in
queste
collezioni più recenti, anche se non è detto che non possano avere un’origine più antica. Le caratteristiche principali di questa tradizione narrativa sono la mescolanza di prosa e di versi (strofe sentenziose memorizzabili a scopo didattico), la presenza di massime e illustrazioni tratte dalle letteratura precedente. Gli Arabi lo tradussero nell’VIII secolo dalla versione pehlevi (Kalīla e Dimna realizzata in Persia da ‘Abdallah Ibn ‘il Muqaffa) e Giovanni da Capua ne offrì una versione in latino nel 1265 con il titolo Directorium humanae vitae. Nel 1548 Agnolo Fiorenzuola lo tradusse in italiano sotto il titolo Prima veste de’ discorsi degli animali. Altre traduzioni, a testimonianza della larga fortuna ottenuta in Occidente, furono realizzate, ad esempio, in spagnolo, tedesco, inglese, paleoslavo. Diversi motivi favolistici presentano analogie con narrazioni della tradizione greca, al di là della sostituzione di alcuni personaggi, che evidentemente assumono un diverso valore simbolico nelle due culture di riferimento. Tra i paralleli più significativi, il leone tratto in inganno dalla sua stessa immagine riflessa nell’acqua (primo tantra, racconto sesto), accostabile al cane che si specchia nel fiume (Esopo 185 Ch.); l’asino rivestito con la pelle di una pantera (secondo alcune versioni, di una tigre), che finisce per andare incontro a un destino infausto (terzo tantra, primo racconto), simile all’asino nella pelle del leone (cfr. Esopo 267; 279 Ch.); la topina resa fanciulla (primo tantra, nono racconto), accostabile alla donnola e Afrodite (Esopo 76 Ch.). 31
Tradizione egizia Alcuni animali, come la scimmia, sembrano entrare molto presto nella tradizione favolistica greca. Ad esempio, già in Archiloco (frr. 185 ss. W. ) si rileva una narrazione che presenta una scimmia come protagonista. Si è supposta una derivazione egizia (Adrados 1999, 328), anche se questo animale era noto a Creta e a Tera nella prima metà del 2
secondo millennio a.C. Invece, per altri animali, come il coccodrillo, l’ingresso nella favolistica greca è certamente più tardo, databile all’età ellenistica. La favola egizia è meno nota e decifrabile di quella mesopotamica e indiana. I reperti archeologici lasciano pensare a favole esistenti già alla fine del IV millennio a.C., ma non consentono conclusioni precise. In questo senso, nell’ambito della tradizione figurativa, disponiamo di reperti rinvenuti a Deir el-Medina databili tra il XIV e il XII secolo a.C. Abbiamo tuttavia due favole superstiti. Di origine scolastica, risalente forse alla XII dinastia (1991-1786 a.C.), pare la disputa tra il corpo e la testa, ritenuta modello di Livio 2,32,9-11 (lo stomaco e le membra), con varianti che si ritrovano nella tradizione esopica e in Babrio. Alla XVIII dinastia (è stato rinvenuto su un reperto del XIV secolo a.C.) pare invece risalire la narrazione del sicomoro e della palma. Nel papiro di Leida (I 384) del II secolo d.C., si trova una narrazione di età ellenistica, relativa al mito della dea gatta Tefnut che si ritira in Etiopia ed è fatta ritornare dal messaggero divino, la scimmia Thoth; si tratta del mito del ritorno del sole: come accade nel Romanzo di Esopo e nel Pañcatantra, vi sono introdotte favole, forse derivate dalla tradizione greca (come quella conservata, su un testo demotico, della rondine che intende prosciugare il mare perché non ha protetto i suoi piccoli: cfr. Adrados 1999, 330). Dalla tradizione iconografica possiamo dedurre la presenza di altri motivi favolistici, come la battaglia tra gatti e topi. Questa tradizione favolistica, pur di difficile ricostruzione, sembra molto connotata in senso religioso e riflette immagini della vita egizia, come quella degli animali musicisti (immagine del coro reale) e delle scimmie danzatrici. 32
La favola nella Bibbia
Anche la Bibbia presenta qualche spunto favolistico. Il caso più noto, peraltro segnalato anche da sant’Agostino (Contra mendacium 13,8), è quello che si ritrova nel libro dei Giudici (9,8-15): le piante che cercano un re (il dialogo tra le piante è, come si è notato sopra, uno schema narrativo tipicamente orientale). Gli abitanti di Sichem si erano scelti come capo un uomo ambizioso e crudele, Abimelech. Allora Iotam, suo fratello, li mise in guardia raccontando l’apologo delle piante che, cercando un sovrano, interpellano l’olivo, il fico, la vite: tutte rifiutano. Il rovo, invece, molto meno nobile delle altre piante, accetta. Si tratta di una critica alla selezione della classe dirigente, che finisce per privilegiare chi è meno degno del ruolo. Gli abitanti di Sichem finirono per ribellarsi ad Abimelech e per liberarsi di lui. Nella tradizione greca (Esopo 252 Ch.) troviamo una favola del tutto simile: manca soltanto la vite e non c’è una morale espressa. Ma esiste un altro passo accostabile alla tradizione narrativa esopica, che vede ancora protagonisti i vegetali. Si tratta di un messaggio che Ieohash (2 Re 14,9), re di Israele, inviò ad Amasia, re di Giuda, usando l’immagine del cardo del Libano che chiede al cedro del Libano di dare in moglie la figlia a suo figlio. Una bestia selvatica del Libano passa e calpesta il cardo. Perché provocare una calamità? Amasia rischierebbe di precipitare insieme a Giuda. Lo stesso modulo retorico si ritrova in Aristotele (Retorica 1393b-1394a), a proposito della favola del riccio e della volpe, narrata da Esopo in un discorso pubblico ai cittadini di Samo. «Questa forma di retorica ufficiale imperniata sulla densità gnomica di uno stile asciutto esclusivamente narrativo e fortemente metaforico era uso non greco, ben attestato nei moduli espressivi delle diplomazie del Vicino Oriente». Tale passo è accostabile a un’altra favola greca (Esopo 24 Ch.), resa nel suo contesto da Erodoto 2,141: il re persiano Ciro risponde a Ioni ed Eoli con la favola dell’auleta che suona senza che i pesci vengano a riva; allora prende una rete e li cattura: vedendoli guizzare tardivamente, dice 33
34
loro di smettere di ballare, visto che non lo avevano fatto quando egli suonava. Va inoltre sottolineato che, pur se in modo meno articolato e puntuale, altre immagini presenti nella tradizione esopica sembrano trovare qualche affinità nella Bibbia: il lupo che indossa la pelle di pecora (Niceforo Basilace, Esercizi preparatori 1,4) ricorda i profeti simili a lupi travestiti da pecore (Vangelo di Matteo 7,15); il superamento dell’eterna inimicizia tra lupo e agnello (Isaia 11,6-9) trova riscontro nella favola del regno del leone (Esopo 195 Ch.). Nei Proverbi di Salomone emergono immagini piuttosto incisive, che trovano paralleli nella favolistica, come ad esempio la fortunata immagine della formica, che, nella sua saggezza, prepara il cibo durante l’estate (6,6).
La fortuna della favola La favola è un genere universale, che trova ospitalità in età e presso popoli lontanissimi. In Occidente, la tradizione medievale segna la fortuna della narrativa esopica, al punto che troviamo una vasta produzione sia in prosa sia in versi. Tale successo si deve essenzialmente allo scopo morale che la caratterizza. In ambito bizantino si rilevano non solo la diffusione delle collezioni anonime riferite a Esopo (v. APPENDICE), ma anche parafrasi in prosa e rifacimenti poetici di Babrio (i cosiddetti dodecasillabi), autore molto noto e popolare, soprattutto a livello scolastico. Tra gli scrittori bizantini che fanno un vario uso della favola, vanno ricordati almeno Niceforo Basilace, Tzetze e Fozio, ma soprattutto la raccolta attribuita a Sintipa e le testimonianze contenute nella Suda. Nell’Occidente latino, invece, sotto il nome di Esopo circola, per tutto il Medioevo, materiale di Fedro (v. Romulus), il cui nome è però a lungo ignorato. Maggiore è certamente, in questa fase, la fama di Aviano: oltre alle 35
parafrasi, vengono composti rifacimenti più elaborati, come le Parabolae realizzate dopo il 1225 dal predicatore inglese Odone di Cheriton. Riguardo alle raccolte poetiche, va ricordato Egberto di Liegi (Fecunda ratis, in cui sono comprese favole di diversa provenienza: XI secolo), ma soprattutto l’Aesopus di Gualtiero Anglico, conosciuto anche come Anonymus Neveleti. Notevole anche il Novus Aesopus di Alessandro di Neckam, anch’esso, come l’opera di Gualtiero Anglico, in distici elegiaci, in gran parte debitore del Romulus. Tradotte in volgare, le raccolte medievali danno origine ai cosiddetti Ysopets (il più noto è quello di Maria di Francia) e Avionnets, che rivestono un’importante funzione nelle scuole. Il Novus Avianus del cosiddetto poeta Astensis (1100 circa) si presenta come un elaborato rifacimento poetico, in distici leonini, di Aviano (altre opere dallo stesso titolo si ritrovano alla fine del XII secolo, uno di questi sotto il nome di Alessandro Neckam), mentre il Novus Aesopus del poeta Baldone (siamo ancora nel XII secolo) segna un passaggio importante nella fortuna delle favole indiane del Pañcatantra in Occidente. La favola gode di notevole attenzione anche nella letteratura rinascimentale. In questo periodo, sono particolarmente diffusi i volgarizzamenti dei testi latini, sia in prosa sia in versi, di autori come Francesco del Tuppo, Accio Zucco, Fazio Caffarello. Si entra così in una nuova prospettiva, che allarga la fruizione dei testi anche al ceto dei mercanti. Rinuccio Aretino traduce la Vita Aesopi e 101 favole esopiche (1474); anche il suo illustre allievo Lorenzo Valla, uno dei più autorevoli rappresentanti della cultura rinascimentale, concependo la favola come un elegante motivo di diletto, traduce in latino 33 favole di Esopo. Oltre a originali elaborazioni, come gli apologhi composti intorno al 1440 da Leon Battista Alberti, che inserisce favole in latino anche in un’opera originale come le Intercoenales, in quest’epoca si registra la riscoperta di Fedro, come
testimonia l’Appendice di Niccolò Perotti (1470) e la prima edizione del favolista latino del Pithou (1596). Seguendo il consolidato modello satirico latino, soprattutto di Orazio, Ludovico Ariosto inserisce alcune favole nelle sue Satire (composte tra il 1517 e il 1525, ma stampate in prima edizione soltanto nel 1534). Alcuni autori, come Agnolo Fiorenzuola nel 1548 (La prima veste de’ discorsi degli animali) e Anton Francesco Doni nel 1552 (Moral filosofia), si interessano alla tradizione del Pañcatantra, traducendo non l’originale ma versioni già filtrate attraverso lo spagnolo e il latino. La favola è utilizzata anche dai polemisti protestanti e apprezzata da Martin Lutero. D’altra parte, la svolta verso la narrativa esopica moderna è certamente segnata da Jean de La Fontaine (1621-1695), che, attingendo, tra l’altro, nella Mythologia Aesopica, la ricca antologia di Nevelet (1610), con le sue Favole (1668-1695) rinnova il genere, ancorandolo alla realtà sociale contemporanea, e si pone come modello per gli autori successivi. La favola trova, quindi, il suo più significativo apprezzamento in età illuministica. Numerosi gli autori di favole in tutta Europa: in Italia, Aurelio de’ Giorgi Bertola, Giambattista Roberti e soprattutto il toscano Lorenzo Pignotti (1739-1812), la cui raccolta Favole e novelle esce nel 1782, sulla base di una prospettiva razionalistica non disgiunta da una pungente ironia; in Francia, sulla linea di La Fontaine, Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) con le sue Favole (1792) rinnova il genere, segnalandosi per la prospettiva illuminista e per la cura formale; in Inghilterra, importante è l’opera di John Gay (due le raccolte, pubblicate nel 1727 e nel 1738); in Spagna quella di Félix María Samaniego (Fábulas en verso castellano: 1781-1784). In Germania Gotthold Ephraim Lessing si dedica sia all’approfondimento teorico della favola sia alla produzione di novanta favole suddivise in tre libri (1759): a partire per lo più dalle fonti tradizionali, elabora nuovi componimenti. Nell’Ottocento la favola conosce meno fortuna, poiché il
Romanticismo valorizza soprattutto la fiaba, più vicina alla tradizione popolare e alla cultura originaria e fantastica dei popoli. In questo periodo, Lev Tolstoj (1828-1910) scrive numerose favole che inserisce nei Quattro libri di lettura (1873). Spesso il genere esopico passa attraverso significativi adattamenti e assume anche un valore satirico in chiave politica: in questa direzione, ad esempio, opera Ambrose Bierce negli Stati Uniti. Nel XX secolo, la favola torna a essere valorizzata e imbocca vie assai diverse, secondo il periodo storico e il contesto sociale in cui è calata: in Italia Pietro Pancrazi firma L’Esopo moderno (1930); Trilussa scrive favole in romanesco. Anche Carlo Emilio Gadda si cimenta nella favolistica e fa esordire la sua raccolta con il nome di Fedro (Il primo libro delle favole, 1952). Altri importanti autori del Novecento sono lo statunitense James Thurber, attento nella sua produzione alle incongruenze della società americana, i tedeschi Wolfdietrich Schnurre e Helmut Arntzen, dallo stile secco e incisivo, il francese Jean Anouilh, dall’approccio intimista; da ricordare anche il guatemalteco Augusto Monterroso, che riprende temi della cultura occidentale, ponendosi contro ogni dogmatismo. «L’apologo moderno, come già quello fedriano, – spiega Solimano 54 – non è sorridente, amabile, cantilenante; non è rivolto a un pubblico di bambini; prende le distanze dal moralismo didascalico, che soprattutto la scuola e la predicazione religiosa hanno aggiunto alla favola». Al di là della tradizione favolistica in senso stretto, si potrebbe allargare il discorso a quei generi e a quegli autori che usano gli animali come elemento narrativo fondamentale, dal medievale Roman de Renard fino a George Orwell, con la sua Fattoria degli animali. Ma questa è un’altra storia. E un’altra storia, sia pure parallela, è anche quella della notevole fortuna della narrativa esopica nella tradizione iconografica. 36
Nota al testo e criteri di impostazione dell’opera Il Dizionario si compone di voci proposte in ordine alfabetico, che presentano i personaggi sotto un duplice profilo. Innanzitutto, per introdurre il lettore al contesto culturale proprio della letteratura antica, si offre un inquadramento generale (credenze, miti, valori simbolici e religiosi; profilo storico per i personaggi umani); segue, quindi, un’analisi specifica della loro ricezione nella tradizione favolistica, di cui si evidenziano specificità o rapporti di continuità con gli altri testi. Inoltre, si esamina come i personaggi siano delineati dai favolisti, tenendo conto delle diverse versioni delle narrazioni e dei temi più ricorrenti nella tradizione esopica. Vengono talora tracciati alcuni paralleli, ad esempio riguardo a singoli motivi favolistici, con le tradizioni orientali, in particolare quella mesopotamica e quella indiana. Dopo la descrizione introduttiva, seguono le favole in cui si ritrova il personaggio analizzato. Poiché ogni narrazione presenta generalmente più di un personaggio, sotto ciascuna voce viene riportata solo una parte delle favole relative alla figura in esame (l’elenco completo è proposto negli indici). Di ogni favola è scelta e tradotta una versione: si privilegiano normalmente Esopo e Fedro, senza però escludere favolisti meno noti o autori estranei alla tradizione esopica, per brevi riferimenti, specialmente quando non ci siano riscontri nelle collezioni, o per narrazioni di particolare interesse, inserite in altri contesti letterari (ad esempio, quella dei due topi nelle Satire di Orazio). Si è adottato un criterio estensivo nella scelta delle narrazioni, comprendendo anche testi la cui natura favolistica appare discussa dagli stessi studiosi, considerati gli incerti confini del genere esopico (non esiste un elenco condiviso delle favole antiche).
Si è generalizzata una traduzione in forma prosastica, visto lo scopo dell’opera: le favole sono attinte dalla letteratura antica, ma non mancano incursioni nella letteratura successiva. Secondo criteri affini a quelli usati anche da altri studiosi, da Perry ad Adrados, si sono aggiunte, infatti, per la favola latina, le traduzioni delle parafrasi in prosa tardoantiche e medievali di Fedro, in particolare quelle relative a narrazioni non altrove attestate nella letteratura precedente; per la tradizione greca, narrazioni di età bizantina, che, per le loro specificità, sembrano connesse con la complessa tradizione delle collezioni anonime (v. APPENDICE). Non si è allargato ulteriormente il campo alla restante tradizione medievale latina, che si rifà per lo più ad Aviano e presenta un legame meno stringente con la favolistica antica. Le note segnalano lezioni alternative rispetto a quelle presenti nelle edizioni di riferimento, particolari scelte nella traduzione o elementi culturali importanti per la comprensione dei testi, non illustrati sotto la voce corrispondente. Nei riferimenti che accompagnano la favola (la fonte principale sono i repertori di Van Dijk-Adrados, ampliati quando possibile, soprattutto per i proverbi collegabili alle narrazioni), si dà inoltre conto degli altri autori che riprendono lo stesso motivo e delle varianti tematiche o strutturali più significative. Per tendere a una maggiore precisione nel delineare e circoscrivere il profilo dei personaggi, si separa l’analisi di figure affini (ad esempio, per i bovini si è distinto tra bue, toro, vacca e vitello) e si aggiungono i proverbi che presentano un’attinenza, letterale o solo concettuale, con le favole: in questo caso, l’obiettivo è semplicemente quello di sottolineare il nesso che lega favola e proverbio, talora nell’ambito di una tradizione lunga diversi secoli e ancora attiva nella cultura contemporanea (per un approfondimento specifico, si rimanda in genere a Renzo Tosi e al suo Dizionario delle sentenze latine e greche: v. Tosi 1991).
La bibliografia, suddivisa in tre sezioni, è costruita anche sulla base di una finalità orientativa. Oltre ad alcune bibliografie di riferimento sulla favola e alle più importanti edizioni, si segnalano, insieme alle opere citate, ulteriori contributi relativi a vari aspetti della favolistica antica e ad altre questioni affrontate nel libro, senza dimenticare commenti, lessici, traduzioni e studi testuali significativi, in modo da offrire al lettore un ampio panorama per eventuali approfondimenti.
Edizioni di riferimento a) Esopo (collezioni anonime, Romanzo di Esopo) e collezioni d’autore ESOPO E ROMANZO DI ESOPO: non esiste un’edizione canonica delle favole esopiche, a testimonianza delle peculiarità di questo genere e della complessità della tradizione manoscritta. Tuttavia, nel secolo scorso si sono imposte tre edizioni di riferimento, che presentano un numero di favole e criteri di impostazione differenti. Qui si traduce da É. Chambry, Ésope. Fables, Paris 1927 (editio minor, con la scelta di una sola redazione per ogni favola, rispetto a É. Chambry, Aesopi fabulae, I-II, Paris 1925-1926). Per le favole mancanti in Chambry si traduce da A. Hausrath e H. Hunger, Corpus fabularum Aesopicarum, Lipsiae, f. I 1957 W , f. II (a cura di H. Hunger) 1959 W . Ogni favola di Esopo è accompagnata dall’abbreviazione Ch. (favole tratte dall’edizione Chambry) o H.-H. (favole tratte dall’edizione Hausrath-Hunger). Quest’ultima edizione presenta anche favole di retori e di altra provenienza (v. sotto). Tra le altre edizioni di Esopo, particolare attenzione merita quella di B.E. Perry, Aesopica, Urbana 1952: a differenza degli altri due maggiori editori moderni, Perry opera su base tematica e alle favole di Augustana ne aggiunge altre tratte dalle raccolte anonime e pseudonime, oltre a narrazioni riprese da 2
2
diversi autori. Nella sua opera trovano spazio anche testimonianze su Esopo, oltre a detti sentenziosi e proverbi attribuiti al padre della favolistica antica. Per quanto riguarda le edizioni precedenti a quelle segnalate, merita una menzione quella di C. Halm, Fabulae Aesopicae collectae, Lipsiae 1852, a lungo punto di riferimento per gli studiosi della tradizione esopica; tale edizione appare oggi superata: sebbene utile per lo sforzo di completezza, non distingue fonti e recensioni dei testi editi. Al volume di Perry si fa riferimento, inoltre, per la Vita Aesopi (si traduce dalla redazione G). A proposito di quest’opera, va ricordata anche l’edizione (relativa alla redazione G) di M. Papathomopoulos (Ioannina 1990). V. inoltre il testo approntato da Franco Ferrari, su cui si basa l’edizione Bur del Romanzo di Esopo (Milano 1997). FEDRO: si traduce dall’edizione di L. Müller, Phaedri Fabularum Aesopiarum Libri quinque, Lipsiae 1878: esperto metricologo, l’editore presenta una numerazione delle favole del quarto libro e dell’Appendix Perottina leggermente differente dalla maggior parte delle altre, per cui nei riferimenti relativi a queste favole si presenteranno accostate entrambe le numerazioni; particolare attenzione meritano inoltre le edizioni di A. Guaglianone, Phaedri Augusti liberti liber fabularum, Augustae Taurinorum, 1969 (v. anche dello stesso studioso, I favolisti latini, Napoli 2000, 45-250). Da segnalare inoltre le edizioni a cura di L. Havet, Phaedri Augusti liberti fabulae Aesopiae, Paris 1895 (utile non solo per il testo critico e perciò ricordato anche in bibliografia generale); D. Bassi, Phaedri fabulae ad fidem codicis Neapolitani denuo excussi, Augustae Taurinorum 1918; J.P. Postgate, Phaedri Fabulae Aesopiae cum Nicolai Perotti prologo et decem novis fabulis, Oxonii 1919; A. Brenot, Phèdre. Fables, Paris 1924. Da ricordare, infine, tra le numerose edizioni fedriane dei secoli scorsi, almeno l’editio princeps del Pithou, Phaedri Augusti liberti Fabularum Aesopiarum libri quinque, Augustobonae
Tricassium 1596 (segnalata inoltre in bibliografia generale l’edizione commentata di Burman). BABRIO: si traduce dall’edizione di B.E. Perry, Babrius and Phaedrus, London 1965. Particolare attenzione anche a Babrii Mythiambi Aesopei, a cura di A. La Penna e M. J. Luzzatto, Leipzig 1986. Va ricordato che è stata a lungo punto di riferimento per gli studiosi l’edizione teubneriana di Crusius del 1897 (Babrii Fabulae Aesopeae. Recognovit prolegomenis et indicibus instruxit Otto Crusius; accedunt fabularum dactylicarum et iambicarum reliquiae. Ignatii et aliorum tetrasticha iambica recensita a Carolo Friderico Mueller). AVIANO: si traduce dal testo di F. Gaide, Avianus. Fables, Paris 1980. Tra le edizioni del secolo scorso, da ricordare anche quella di A. Guaglianone, Aviani Fabulae, Augustae Taurinorum 1958 (cf., dello stesso studioso, I favolisti latini, Napoli 2000, 273 ss.) e quella di L. Herrmann, Avianus. Oeuvres, Bruxelles 1968. b) Altre fonti PAPIRO RYLANDS 493: per il Papiro Rylands 493 del I secolo d.C., forse derivante da una fonte comune all’Augustana e a Fedro, si fa riferimento all’edizione Hausrath-Hunger (v. sopra, Esopo); il papiro è pubblicato prima da C.H. Roberts, Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, III, Manchester 1938). Per le favole contenute in altri papiri, da segnalare almeno R. Cavenaile, Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden 1958). PSEUDO-DOSITEO: si tiene conto del testo proposto da A. Guaglianone, I favolisti latini, Napoli 2000,553 ss.; da ricordare che il testo greco è presente nell’edizione Hausrath-Hunger (vedi sopra, Esopo). V. inoltre G. Goetz,
Corpus glossariorum latinorum, III, Lipsiae 1892 (pp. 39 ss.). TAVOLETTE DI ASSENDELFT: sono comprese nell’edizione Hausrath-Hunger (v. sopra, Esopo). Da ricordare anche l’edizione di Crusius (v. sopra, Babrio); cfr. inoltre Hesseling 1892-93. AFTONIO: si fa riferimento all’edizione e al commento F. Sbordone, Recensioni retoriche delle favole esopiane, «Rivista indo-greco-italica» 16, fasc. 3-4, 1932, 45-66. Le favole di Aftonio sono pubblicate anche nell’edizione Hausrath-Hunger (v. sopra, Esopo). CODICE BRANCACCIANO: si traduce dal testo proposto da Sbordone (v. sopra, Aftonio). ROMULUS E PARAFRASI IN PROSA DI FEDRO: l’editore di riferimento è G. Thiele, Der Lateinische Äsop des Romulus und die Prosa-Fassungen des Phädrus, Heidelberg 1910. Si traducono le seguenti favole in una delle diverse versioni in cui sono tramandate: 23, 56 e 94 (r. v.); 7, 9, 18, 25, 26, 34, 55, 64, 80 (r. g.); per quanto riguarda le favole 36, 70 (r. W.) e 53, 54, 78, 82 (da Ademaro), si tiene conto delle correzioni proposte a uso divulgativo da La Penna 1968. Sulla tradizione favolistica medievale latina, da segnalare inoltre, per lo sforzo di completezza, L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d’Auguste jusq’à la fine du moyen âge, 5 voll., Paris 1884-99 (rist. Hildesheim 1970). Su Ademaro, v. l’edizione critica di F. Bertini e P. Gatti (Favolisti latini medievali, III, Genova 1988). TETRASTICI: l’edizione di riferimento dei Tetrastici giambici di Ignazio Diacono e dei suoi imitatori è quella di Müller in Crusius (v. sopra, Babrio). FAVOLE DATTILICHE: l’edizione di riferimento è quella di Crusius (v. sopra, Babrio).
PARAFRASI BODLEIANA E DODECASILLABI: si fa riferimento all’editio maior di Chambry: v. sopra, Esopo. Da ricordare anche l’edizione di P. Knoell, Fabularum Babrianarum Paraphrasis Bodleiana, Vindoboniae 1877. SINTIPA: si fa riferimento al testo di Perry (v. sopra, Esopo), senza dimenticare l’edizione Hausrath-Hunger (v. sopra, Esopo). Per le favole siriache, v. anche l’edizione di B. Lefèvre (cfr. APPENDICE). Altre edizioni di autori sono esplicitate nei riferimento all’interno del volume. 1
Bibliografia Bibliografie Beschorner A. e Holzberg N., A Bibliography of the Aesop Romance, in N. Holzberg (a cura di), Der AsopRoman: Motivgeschichte und Erzählstruktur, Tübingen 1992, 33-75. Carnes P., Fable Scholarship. An Annotated Bibliography, New York-London 1985. Lamb R.W., Annales Phaedriani, 1596-1996. A Bibliography of Phaedrus, Lowestoft 1998. Tortora L., Recenti studi su Fedro (1967-1974), Bollettino di Studi Latini 5, 1975, 266-273. Oltre alle bibliografie contenute negli studi segnalati sotto, va ricordata quella presente in www.niklasholzberg.com.
Edizioni dei principali favolisti V. Nota al testo.
Bibliografia generale Adrados F.R. 1952: El papyro Rylands 493 y la tradición fabulística antigua, «Emerita» 20, 337-388. 1964: El tema del águila, de la épica acadia a Esquilo, «Emerita» 32, 267-282. 1965: El tema del léon en el Agamenon de Esquilo (717749), «Emerita» 33, 1-5. 1969-70: La tradición fabulística griega y sus modelos
métricos, «Emerita» 37, 235-315; 38, 1-52. 1979: The «Life of Aesop» and the Origins of Novel in Antiquity, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica» 30, n.s. 1, 93-112. 1984: Las ranas pidiendo rey: origen y evolución de una fábula política, «Emerita» 52, 25-32. 1993: Mito y fábula, «Emerita» 61, 1-14. 1994: La fábula en Horacio y su poesía, «Myrtia» 9, 131-151. 1997: Favola, in Enciclopedia Oraziana, II, 57-59, Roma. 1999: History of the Graeco-Latin Fable, I, Introduction and from the Origins to the Hellenistic Age, trad. di L.A. Ray (ed. rivista e aggiornata dall’autore e da G.-J. van Dijk), Leiden-Boston-Köln (ed. or. Madrid 1979). 1999a: Nuevos testimonios papiráceos de fábulas esópicas, «Emerita» 67, 1-11. 2000: History of the Graeco-Latin Fable, II, The Fable during the Roman Empire and in the Middle Age, trad. di L.A. Ray (ed. rivista e aggiornata dall’autore e da G.-J. van Dijk), Leiden-Boston-Köln (ed. or. Madrid 1985). 2003: History of the Graeco-Latin Fable, III, Inventory and Documentation of the Graeco-Latin Fable, trad. di L.A. Ray e F. Rojas Del Canto, accresciuta e rivista dall’autore e da G.-J. van Dijk, indici di G.-J. van Dijk, Leiden-BostonKöln (ed. or. Madrid 1987). Adrados F.R. e Reverdin O. 1984 (a cura di): La fable. Huit exposés suivis de discussions, Entretiens sur l’Antiquité Classique 30, Vandœuvres-Genève, 22-27 août 1983, Genève. Alfonsi L. 1964: Parva moralia in Fedro, «Latomus» 23, 21-29. Alster B. 1974: The Instructions of Suruppak, Copenhagen. 1975: Studies in Sumerian Proverbs, Copenhagen.
1978: Sumerian Proverbs Collection Seven, «Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale», 72, 97-112. Andorlini I. e Marcone A. 2004: Medicina, medico e società nel mondo antico, Bagno a Ripoli. Archibald H.T. 1902: The Fable in Archilochus, Herodotus, Livy and Horace, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 33, LXXXVIII-XL. 1910: The Fable in Horace, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 41, XIV-XIX. Ayán Calvo J.J. 2002: La fábula en la primera literatura cristiana, in A. Peréz Jiménez e G. Cruz Andreotti (a cura di), «Y así dijo la zorra». La Tradición Fabulística en los Pueblos del Mediterráneo, Madrid-Málaga, 119-139. Bajoni M.G. 1997: Un esempio di autoapologia in Phaedrus, III, 1?, «L’Antiquité Classique» 66, 289-291. 1999: II tempo dello schiavo: alcune osservazioni a Phaedr. 5,8, «Philologus», 143, 247-258. 2000: Una nota a «Phaedr.» 3,13, «Acta classica Univ. Scient. Debreceniensis» 36, 93-98. Battaglia S. 1956: Lupus in fabula, «Filologia romanza» 2, 292-295. Bechis G. 1983 (a cura di): Pañcatantra. Il libro dei racconti, prefazione di G. Cusatelli, Milano. Bellonzi F.
1973: Fedro e i diritti della fantasia, «Studi Romani» 21, 61-63. Benfey Th. 1959: Pantschatantra. Fünf Bücher indischer Fabel, Märchen und Erzählungen, trad. dal sanscrito con introd. e note di Th. Benfey, I-II, Leipzig (rist. Hildesheim 1966). Bernardi Perini G. 1992: «Cui reddidi iampridem quicquid debui»: il debito di Fedro con Esopo secondo Fedro, in AA. VV., La storia, la letteratura e l’arte a Roma da Tiberio a Domiziano. Atti del convegno (Mantova, Teatro Accademico, 4-5-6-7 ottobre 1990), Mantova, 43-59. Bertini F. 1975: Il monaco Ademaro e la sua raccolta di favole fedriane, Genova. 1981: Fortuna medievale e umanistica della favola dell’asino e del cinghiale (Phaedr. I 29), in AA. VV., Letterature comparate. Problemi e metodo. Studi in onore di Ettore Paratore, Bologna, 1063 -1073. 1998: Interpreti medievali di Fedro, Napoli. Bertschinger J. 1921: Volkstümliche Elemente in der Sprache des Phädrus (Diss.), Bern. Bettini M. 1998: Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi, Torino. 2000: Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche, Torino. 2008: Voci. Antropologia sonora del mondo antico, Torino. Bieber D.
1906: Studien zur Geschichte der Fabel in den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit (Diss.), München. Bisanti A. 2010: Le favole di Aviano e la loro fortuna nel Medioevo, Firenze. Blänsdorf J. 2000: Lecture pédagogique-morale-politique? Problèmes herméneutiques des fables de Phèdre, «Revue des Études Latines» 78, 118-138. Bodson L. 1977: Le Mouton dans la Méditerranée antique: de la civilisation créto-mycénienne au monde gallo-romain, «Ethnozootechnie» 21, 107-121. 1986: Observations sur le vocabulaire de la zoologie antique: les noms de serpents en grec et en latin, «Documents pour l’histoire du vocabulaire scientifique» 8, 65-119. 1989: Évolution du statut culturel du serpent en Europe de l’Antiquité à nos jours, in A. Couret e F. Oge (a cura di), Actes du congrès international «Animal et Histoire», Toulouse, 14-19 mai 1987, Toulouse, 525-548. Bodson L. e Marcolungo D. 1994: Aspects de l’histoire ancienne de l’oie domestique («Anser anser» f. domestica), in J.-P. Lensen (a cura di), L’oie de bon aloi, Visé, 41-59. Boldrini S. 1988: Fedro e Perotti. Ricerche di storia della tradizione, Urbino. 1990: Il codice fedriano modello di Ademaro, in AA.VV., Memores tui. Studi di Letteratura classica ed umanistica in onore di M. Vitaletti, Sassoferrato, 11-19. 1991: Fedro in Ademaro, «Maia» 43, 47-49.
1994: Gualtiero Anglico, Uomini e bestie. Le favole dell’«Aesopus latinus», testo latino con una traduzionerifacimento del ’300 a cura di S. Boldrini, Lecce. Bowra C.M. 1940: The Fox and the Hedgehog, «The Classical Quarterly» 34, 26-29. Brenner J. 2008: Die Fabel von Aesop bis Arntzen, München. Brind’Amour P. 1976: Des ânes et des boeufs dans l’Aululaire, «Maia» 28, 25-27. Brosse J. 1989: Storie e leggende degli alberi, trad. it. di A. Zanetello, Pordenone. Bugnyar T. e Heinrich B. 2005: Food-storing Ravens Differentiate between Knowledgeable and Ignorant Competitors, «Proceedings Royal Society London», Series B, 272, 1641-1646. Burman P. 1745: Phaedri Augusti liberti Fabularum Aesopiarum libri V, cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii et exceprtis aliorum, curante P. Burmanno, Lugduni Batavorum (3 ed.). a
Burzachechi M. 1962: Oggetti parlanti «Epigraphica» 24, 3-54.
nelle
epigrafi
greche,
Camastra P. 1986: Quid refert mea cui serviam? Nota a Fedro I, 15,
«Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari» 29, 63-72. Cameron A. 1967: Macrobius, Avienus and Avianus, «The Classical Quarterly», n. s. 17, 385-399. Campanile E. 1979: Ennio ed Esopo, in AA. VV., Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia, 63-68. Caporali R. 2009: La schiavitù nel mondo antico, in T. Casadei e S. Mattarelli (a cura di), Il senso della Repubblica. Schiavitù, Milano. Capponi F. 1979: Ornithologia latina, Genova. Carnes P. 1988 (a cura di): Proverbia in fabula. Essays on the Relationship of the Proverb and the Fable, Bern-Frankfurt am Main-New York-Paris. Carratello U. 1964: Marziale, Canio Rufo e Fedro, «Giornale Italiano di Filologia» 17, 122-148. Cascajero J. 1991: Lucha de clases e ideologia: introducción al estudio de la fábula esopica como fuente historica, «Gerión» 9, 11-58. 1992: Lucha de clases e ideologia. Aproximación temática a las fábulas no contenidas en las collecciones anónimas, «Gerión» 10, 23-63. Castelli R.
1987: La favola d’Orazio e la favola di Fedro, Padova. Castrucci V. 1996: Elementi orientali nella letteratura ellenistica: per una lettura di Callimaco, fr. 194 Pfeiffer, «Quaderni di Storia» 22 (43), 279-293. Cattabiani A. 1994: Erbario. Dialoghi sulle piante e i fiori simbolici, Milano. 2000: Volario. Simboli, miti e misteri degli esseri alati: uccelli, insetti, creature fantastiche, Milano. 2002: Acquario. Simboli, miti, credenze e curiosità sugli esseri delle acque: dalle conchiglie alle sirene, dai delfini ai coccodrilli, dagli dei agli animali fantastici, Milano. Causeret C. 1886: De Phaedri sermone grammaticae observationes, Parisiis. Cavarzere A. 1973-74: La trama allusiva di Fedro IV 7, «Atti e memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti», 86, 99-119. Chambry É. 1927: Notice sur Ésope e les fables ésopiques, in Id., Ésope. Fables, Paris, IX-LIV. Chaparro Gómez C. 1986: Aportación a la estética de la fabula greco-latina; análisis y valoración de la breuitas fedriana, «Emerita» 54, 123-150. Chevalier J. e Gheerbrandt A. 1986: Dizionario dei simboli, trad. it. di M.G. Margheri Pieroni, I. Sordi, Milano.
Christes J. 1979: Reflexe erlebter Unfreiheit in den Sentenzen des Publilius Syrus und den Fabeln des Phaedrus. Zur Problematik ihrer Verifizierung, «Hermes» 107, 199-220. Cinquini A. 1905: Index Phaedrianus, Milano (rist. Hildesheim 1964). Clement P.A. 1945: Moralia 614E, «American Journal of Philology» 66, 192-196. Clemente G. 1990: Guida alla storia romana, Milano. Cocchiara G. 1981: Il mondo alla rovescia (con presentazione di P. Camporesi), Torino. Colson F.H. 1919: Phaedrus and Quintilian I. 9. 2. A Replay to Professor Postgate, «Classical Review» 33, 59-61. Colton R.E. 1984: La Fontaine and Horace. Fable 1.9 and Sermones 2.6.79-117, «Classical Bulletin» 60, 15-17. Contini R. e Grottanelli C. 2005 (a cura di): Il saggio Ahiqar, Brescia. Cooper J.C. 1997: Dizionario degli animali mitologici e simbolici, trad. it. L. Perria, Padova. Corvino D.
2004: Nuove proposte letterarie latine e civiltà romana, Napoli. Cozzoli A.T. 1995: Poesia satirica latina e favola esopica: Ennio, Lucilio e Orazio, «Rivista di Cultura Classica e Medievale» 37, 187-204. Craven T.C. 1973: Studies in the Style McMaster University, Hamilton.
of
Phaedrus
(Diss.),
Cremona C.A. 1980: Lexicon Phaedrianum, Hildësheim-New York. Criniti N. 1997 (a cura di): Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale, Brescia. Crusius O. 1894: Fabeln des Babrios auf Wachstafeln aus Palmyra, «Philologus» 53, 228-252. 1896: Avianus, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, II, Stuttgart, 23742378. 1896a: Babrius, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, II, Stuttgart, 26552667. 1913: Aus der Geschichte der Fabel, in C.H. Kleukens (a cura di), Das Buch der Fabeln, Leipzig, I-LXI. Cupaiolo F. 1973: Itinerario dell’Impero, Napoli. Curletto S.
della
poesia
latina
nel
I
secolo
1984: Il lupo e la gru da Esopo a La Fontaine, in AA. VV., Favolisti latini medievali, I, Genova, 11-24. 1989-1990: Temi e trasformazioni nella favola del leone malato e del lupo scorticato, «Sandalion» 12-13, 115-138. Currie H. MacL. 1984: Phaedrus the Fabulist, in AA. VV., Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 32.1, 497-513. Dadone M. 1954: Appunti sulla fortuna di Fedro, I. Fedro e Seneca, «Rivista di Studi Classici» 2, 3-12. 1954a: Appunti sulla fortuna di Fedro, II. Fedro e Persio, III. Fedro e Marziale, «Rivista di Studi Classici» 2, 79-86. Daly L. 1961: Hesiod’s Fable, «Transactions of the American Philological Association» 92, 45-51. Davies M. 1981: Aeschylus and the Fable, «Hermes» 109, 248251. D’Elia S. 1980: Fedro, un liberto fallito, «Riscontri» 2, 33-39. De Lorenzi A. 1955: Fedro, Firenze. Della Corte F. 1939: Phaedriana, «Rivista di Filologia e Istruzione Classica» 17, 136-144 (= Opuscula IV, Genova 1973, 107 ss.). 1945: Moralità della favola, Genova, 1-14 (= Opuscula IV, Genova 1973, 93-106). 1958: Favolisti latini. Corso di letteratura latina tenuto
dal prof. Francesco Della Corte nell’Anno Accademico 1958-1959, Genova. 1966: Tre papiri favolistici latini, in AA. VV., Atti dell’XI Congresso Internazionale di Papirologia, Milano, 542-550 (= Opuscula IV, Genova 1973, 147-155). 1971-72: Punti di vista sulla favola esopica, «Annali della Facoltà di Magistero dell’Università di Palermo» 4, 130, (= Opuscula IV, Genova 1973, 117-145). 1986: Orazio favolista, «Cultura e Scuola» 25, 87-93 (= Opuscula XI, Genova, 1988, 35-41). Del Vecchio L. e Fiore A.M. 1998: «Fabula in satura». Osservazioni su alcuni frammenti delle Satire di Ennio, «Invigilata Lucernis» 20, 59-72. Demandt A. 1991: Politik in den Fabeln Äsops, «Gymnasium» 98, 397-419. De Maria L. 1987: La «femina» in Fedro. Emarginazione e privilegio, Lecce. Desclos M.L. 1997: «Le Renard dit au lion…» (Alcibiade Majeur, 123a) ou Socrate à la manière d’Ésope, in B. Cassin e J.L. Labarrière (a cura di), L’animal dans l’antiquité, Paris, 395-422. Diels H. 1910: Orientalische Fabeln in griechischem Gewande, «Internationale Wochenschrift für Wissenschaft Kunst und Technik» 4, 993-1002. Dijk (Van) G.J. 1994: The Lion and the He-Goat. A New Fable in
Procopius, «Hermes» 122, 376-379. 1997: AΙNOΙ, ΛOΓOΙ, MYΘOΙ. Fables in Archaic, Classical and Hellenistic Greek Literature, Leiden-New York-Köln. 1999: Esopo, Plutarco, Platon y Aristóteles. La función de la fábula y el arte de la alusión, in AA. VV., Actas del V Congreso Internacional de la I.P.S. (Madrid-Cuenca, 4-7 de mayo de 1999), Madrid. Dillery J. 1999: Dillery, Aesop, Isis, and the Heliconian Muses, «Classical Philology» 94, 268-280. Donati A. 1997: Un mare di pesci, in A. Donati-P. Pasini (a cura di), Pesca e pescatori nell’antichità, Milano, 7-44. Dorjahn A.P. 1936: On Phaedrus I, 10, «Classical Journal» 32, 560562. Dyson G.W. 1929: ΛEONTA TEKEΙN, «Classical Quarterly» 23, 186195. Ebeling E. 1927: Die babylonische Fabel und ihre Bedeutung für die Literaturgeschichte, Leipzig. Eliade M. 1954: Trattato di storia delle religioni, trad. it. di V. Vacca, Torino. Fabre J.-H. 1975: I devastatori, trad. it. di E. Somaré, Milano, 5053.
Fansa M. 2009 (a cura di): Tierisch moralisch. Die Welt der Fabel in Orient und Okzident. Begleitschrift zur Sonderausstellung des Landesmuseums Natur und Mensch Oldenburg vom 22. Februar bis zum 01. Juni 2009, Oldenburg. Fansa M. e Grunewald E. 2008 (a cura di): Von listigen Schakalen und törichten Kamelen. Die Fabel in Orient und Okzident. Wissenschaftliches Kolloquium im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg zur Vorbereitung der Ausstellung «Tierisch moralisch. Die Welt der Fabel in Orient und Okzident» am 22. und 23. November 2007, Wiesbaden. Favole 1981: AA. VV., Favole africane, Roma. Fedeli P. 1993: La favola oraziana del topo di città e del topo di campagna. Una proposta di lettura, «Cultura e Scuola» 32, 42-52. Ferrari F. 1995: Per il testo della recensione G della «Vita Aesopi», «Studi Classici e Orientali» 45, 249-259. 1995(a): P. Oxy. 3331 e Vita Aesopi 18, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 107, 296. 1997: Romanzo di Esopo, introd. e testo critico a cura di F. Ferrari, trad. e note di G. Bonelli e G. Sandolini, Milano. Festa N. 1924: Su la favola di Fedro, «Rendiconti della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia dei Lincei», 39-54. Fisher B.F. 1987: A History of the Use of Aesop’s Fables as a
School Text from the Classical Era through the Nineteenth Century (Diss.), Indiana University. Fisichella R. 1976: Appunti per un saggio su Fedro, «Orpheus» 23, 331. Fontaine J. 1959: Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne Wisigothique, I, Paris. Fraenkel E. 1924: Zur Form der αἶνoι, Rheinisches Museum 73, 366-370 (= Id., Kleine Beiträge zur Klassischen Philologie, I, 235-239, Roma 1964). Franco C. 2007: Callimaco e la voce del cane, in A.M. Andrisano (a cura di), Animali, animali fantastici, ibridi e mostri, «Annali online dell’Università di Ferrara Lettere», num. spec. 1, 45-68. Früchtel L. 1950: Zur Äsopfabel des Kallimachos, «Gymnasium» 57, 123-124. Gaide F. 1991: Avianus, ses ambitions, ses résultats, in G. Catanzaro e F. Cantucci (a cura di), La favolistica latina in distici elegiaci. Atti del Convegno Internazionale, Assisi, 26-28 ottobre 1990, Assisi, 45-61. Galli R. 1983: Fedro e Orazio, «Paideia» 38, 195-199. Garbugino G. 1984: La favola del leone ammalato e della volpe nel
mondo classico e medioevale, in AA. VV., Favolisti latini medioevali, I, Genova, 35-56. García Gual C. 1976: La fábula esópica: estructura e ideología de un género popular, in AA. VV., Estudios ofrecidos a Emilio Alaros Llorach, I, Oviedo, 309-322. 1978: Historia y ética de la fábula esópica, in AA. VV., Actas del V congreso español de estudios clasicos (Madrid, 20-25 de abril de 1976), Madrid, 179-208. García F.M. e A.R. Lopez 1990: Index mythiamborum Babrii, Hildesheim-ZürichNew York. 1991: Index Aesopi fabularum. Hildesheim-Zürich-New York. Gärtner U. 2007: «Consulto inuoluit ueritatem antiquitas.» Zu den Werten bei Phaedrus, «Gymnasium» 114, 405-434. 2007a: «Levi calamo ludimus». Zum poetologischen Spiel bei Phaedrus, «Hermes» 135, 429-459. Gatti P. 1979: Le favole del Monaco Ademaro e la tradizione manoscritta del corpus fedriano, «Sandalion» 2, 247-256. Gibbs L. 2002: Aesop’s Fables, trad., introd. e note di L. Gibbs, Oxford. 2009: Aesop’s Fables in Latin: Ancient Wit and Wisdom from the Animal Kingdom, Mundelein. s.d.: www.aesopica.net. Gislon M. e Palazzi R. 1997: Dizionario di mitologia e dell’antichità classica, Bologna.
Goetz G. 1905: Dositheus magister, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, V 2, Stuttgart, 1606-1607. Gordon E.I. 1958: The Sumerian Animal Proverbs and Fables: «Collection five», «Journal of Cuneiform Studies» 12, 1-21; 43-75. Graf F. 1995: La magia nel mondo antico, trad. it. di G. Ferrara degli Uberti, Roma-Bari. Gragg G. 1963: The Fable of the Heron and the Turtle, «Archiv für Orientforschung» 24, pp. 51-72. Grilli A. 1906: La favola latina prima di Fedro, Imola. Grimal P. 1990: I giardini di Roma antica, trad. it. di V. Abrate, Milano. Grottanelli V.L. 1965: Ethnologica. L’Uomo e la civiltà, III, Milano. Guaglianone A. 1968: Fedro e il suo senario, «Rivista di Studi Classici» 16, 91-104. 1970-71: Commento alla favola IV 5 (poeta) e alle altre favole giudiziarie di Fedro, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Macerata», 3-4, 437-452. 2000: Favolisti latini, Napoli.
Guarino A. 1972: La società col leone, «Labeo» 18, 72-77. Guénon R. 1975: Simboli della scienza sacra, trad. it. F. Zambon, Milano. Hamblenne P. 1981: Le choucas chez les paons (Phaedr. 1,3). Phèdre, Séjan ou Pallas?, «Les Études Classiques» 49, 125 -133. Hanlet C. 1944: Phèdre, le fabuliste Classiques» 12, 317-324.
latin,
«Les
Études
Hausrath A. 1898: Das Problem der äsopischen Fabel, «Neue Jahrbücher für das classische Altertum» 1, 305-322. 1909: Fabel, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, VI 2, Stuttgart, 17041736. 1932: Syntipas, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, IV 2, 1464-71. 1936: Zur Arbeitsweise des Phaedrus, «Hermes» 71, 70-1031938: Phaedrus, in Paulys Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, XIX 2, 1475-1505. Havet L. 1895: Phaedri Augusti liberti fabulae aesopiae, Paris. Henderson J. 1999: «Phaedrus» Fables. The Original Corpus, «Mnemosyne» 52, 308-329. 2001: Telling Tales on Caesar: Roman Stories from Phaedrus, Oxford. Hesseling D.C.
1892-1893: On Waxen Tablets with Fables of Babrius (Tabulae ceratae Assendelftianae), «The Journal of Hellenic Studies» 13, 293-314. Hillgruber M. 1996: Die Erzählung des Menenius Agrippa. Eine griechische Fabel in der römischen Geschichtsschreibung, «Antike und Abendland» 42, 42-56. Holzberg N. 1991: Die Fabel von Stadtmaus und Landmaus bei Phaedrus und Horaz, «Würzburger Jahrbücher für die Altertumswissenschaft», 17, 229-239. 1999: The Fabulist, the Scholars, and the Discourse: Aesop Studies Today, «International Journal of the Classical Tradition» 6, 236-242. 2001: Die antike Fabel. Eine Einfürung, Darmstadt, 2 ed. [The Ancient Fable: An Introduction, trad. di Ch. Jackson-Holzberg, Bloomington 2002, da cui si cita]. 2005: Fabel, in H.H. Schmitt ed E. Vogt (a cura di), Lexikon des Hellenismus, Wiesbaden, 323-325. a
Hubbard T.K. 1995: Hesiod’s Fable of the Hawk and the Nightingale Reconsidered, «Greek, Roman and Byzantine Studies» 36, 161-171. Immisch O. 1930: Babriana, «Rheinisches Museum» 79, 153-169. Jacob O. 1935: Le rat de la ville et le rat des champs, «Les Études Classiques» 4, 130-154. Jedrkiewicz S. 1987: La favola esopica nel processo di argomentazione orale fino al IV sec. a.C., «Quaderni Urbinati di Cultura
Classica» 56, 35-63. 1989: Sapere e paradosso nell’antichità: Esopo e la favola, Roma. 1990: Fedro e la verità, «Quaderni Urbinati di Cultura Classica» 63, 121 ss. 1997: Il convitato sullo sgabello. Plutarco, Esopo ed i Setti Savi. Pisa-Roma. 2009: Aesop and the Gods: Divine Characters in the Aesop Romance, «Métis» n.s. 7, 171-201. Josifović S. 1974: Aisopos und die Aisopische Fabel, in Paulys RealEncyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, Suppl. 14, München, 15-40. Karadagli T. 1981: Fabel und Ainos. Studien zur griechischen Fabel, Königstein im Taunus. Keller O. 1909: Die Antike Tierwelt, I, Leipzig (rist. Hilesheim 1963). 1913: Die antike Tierwelt, II, Leipzig (rist. Hildesheim 1963). Kilpatrick R.S. 1973: Fact and Fable in Horace Epistle 1.7, «Classical Philology» 67, 47-53. Kleist J.A. 1950: Aesop and Phaedrus, «Classical Bulletin» 27, 7-8. Knox B.M.W. 1952: The Lion in the House (Agamemnon 717-736 [Murray]), «Classical Philology» 47, 17-25. Korzeniewski D.
1970: Zur Verstechnik des Phaedrus, «Hermes» 98, 430-458. Kostantakos I.M. 2006: Aesop Adulterer and Trickster: A Study of «Vita Aesopi» ch. 75-76, «Athenaeum» 94, 563-600. Kramer N.S. 1978: La historia empieza en Sumer, Barcelona (4 ed.). a
Küppers J. 1977: Die Fabeln Avians. Studien zu Darstellung und Erzälweise spätantiker Fabeldichtung, Bonn. Kurke L. 2011: Aesopic Conversations: Popular Tradition, Cultural Dialogue, and the Invention of Greek Prose, Princeton. Lambert W.G. 1960: Babylonian Wisdom Literature, Oxford. Lamberti G. 1980: La poetica del «lusus» in Fedro, «Rendiconti dell’Istituto Lombardo» 114, 95-115. Lana I. 1989: Il I libro delle «epistole» di Orazio, Torino. La Penna A. 1961: La morale della favola esopica come morale delle classi subalterne nell’antichità, «Società» 17, 459-537. 1962: Il romanzo di Esopo, «Athenaeum» n.s. 40, 264314. 1964: Letteratura esopica e letteratura assirobabilonese, «Rivista di Filologia e Istruzione Classica» 92, 24-39.
1968: Fedro, Favole, introd. di A. La Penna, versione di A. Richelmy, Torino. 1991: Un’altra favola esopica di origine babilonese, «Maia» 43, 163-165. 1996: Esopo, Favole, introd. di A. La Penna, a cura di C. Benedetti, Milano. 1997: Una favola esopica e l’interpretazione di Catullo 96, «Studi Italiani di Filologia Classica» 15, 246-249. Leclerc M.-C. 1992: L’épervier et le rossignol d’Hésiode. Une fable à double sens, «Revue des Études Grecques» 105, 37-44. Livrea E. 1970: Livrea, L’αἶνoς esiodeo, «Giornale Italiano di Filologia» 22, 1-20. Lonsdale S.H. 1989: Hesiod’s Hawk and Nightingale (Op. 202-12): Fable or Omen?, «Hermes» 117, 403-412. Luria S. 1934: L’asino nella pelle del leone, «Rivista di Filologia e Istruzione Classica» 13, 447-473. Luzzatto M.J. 1975: La cultura letteraria di Babrio, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» 5, 17-97. 1976: Fedro. Un poeta tra favola e realtà, Torino. 1984: Note su Aviano e sulle raccolte esopiche grecolatine, «Prometheus» 10, 75-94. 1992: Grecia e vicino oriente: tracce della «Storia di Ahiqar» nella cultura greca tra VI e V secolo a. C., «Quaderni di Storia» 36, 5-84. 1994: Ancora sulla «Storia di Ahiqar», «Quaderni di Storia» 39, 253-277. 1996: Esopo, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia
Cultura Arte Società, II 1, Torino, 1307-1324 Maciá L.M. 2008: The Fable of «the Middle-Aged Man with Two Wives». From the Aesopian Motif to the Babylonian Talmud Version in b. B. Qam. 60b, «Journal for the Study of Judaism» 39, 267-281. Mader L. 1973: Antike Fabeln, München. Maiuri A. 1956: Fedro a Miseno, «La Parola del Passato» 11, 3237. Mañas Núñez M. 1998: Fedro-Aviano. Fábulas, di M. Mañas Núñez, Madrid. Mancini D. 1819: Archeologia greca, Napoli. Mandruzzato E. 1979: Fedro. Favole, introd., trad. e note di E. Mandruzzato, Milano. Marchesi C. 1923: Fedro e la favola Latina, Firenze. 1951: Uomini e bestie nella favola antica, in Id., Divagazioni, Venezia, 9-20. Marchianò M. 1900: L’origine della favola greca e i suoi rapporti con le favole orientali, Trani. Marenghi G. 1954: I mitiambi di Babrio e la tradizione esopiana,
«Giornale Italiano di Filologia» 7, 341-348. 1955: Babrio e la favola romana, «Athaeneum» 33, 233246. 1987: Favolisti greci, in F. Della Corte (a cura di), Dizionario degli scrittori greci e latini, II, Milano, 961-969. Marsh D. 2003: Aesop and the Humanist Apologue, «Renaissance Studies» 17, 9-26. Martínez Pastor M. 1978: Fábula, epigramma y sátira, «Estudios Clásicos» 22, 299-322. Martínez Vázquez R. 1984: Una cosmogonía acuática en una fábula de Esopo, «Habis» 15, 35-40. Masoin F. 1924: La morale dans les fables de Phèdre, «Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge» 28, 6971. Maspero F. 1997: Bestiario antico. Gli animali-simbolo e il loro significato nell’immaginario dei popoli antichi, Casale Monferrato. Massaro M. 1977: Aniles fabellae, «Studi Italiani di Filologia Classica» 49, 104-135. 1979: «Variatio» e «sinonimia» in Fedro, «Invigilata Lucernis» I, 89-142. 1981: Una caratteristica dello stile di Fedro: la «variatio sermonis», «Quaderni dell’Associazione di cultura classica della deleg. di Foggia» 1, 49-61.
Mattiacci S. 2011: Da Kairos a Occasio: un percorso tra letteratura e iconografia, in L. Cristantev e S. Ravalico (a cura di), Il Calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità. IV (Atti del IV incontro internazione, Trieste, Biblioteca Statale 28-30 aprile 2010), Trieste, 127154. Mazzoli G. 1968: Due note Anneane, «Athenaeum» 46, 355-368. Melella O. 1945-46: Esopo y la fábula esópica, «Anales del Instituto de Literaturas Clásicas» (Buenos Aires) 3, 291339. Menna F. 1983: La ricerca dell’adiuvante: sulla favoletta esopica dell’allodola (Enn. «Sat.» 21-58 Vahl. W ; Babr. 88; Avian. 21), «Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi classici» 10-11, 105-132. 2
Mercatante A.S. 2001: Dizionario universale dei miti e delle leggende, trad. it. di R. Gatti e L. Rodinò, Roma. Merlo V. 2003: Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico, Milano. Meuli K. 1950: Herkunft und Wesen der Fabel, «Schweizerisches Archiv für Volkskunde» 50, 65-88. Migotto L. 1994: Argonautiche orfiche, Pordenone.
Moretti G. 1982: Lessico giuridico e modello giudiziario nella favola fedriana, «Maia» 34, 227-240. Moroncini G. 1895: Sull’autenticità delle favole di Fedro, «Rivista di Filologia e Istruzione Classica» 23, 1895, 23-92. Müller C.V. 1976: Ennius und Aesop, «Museum Helveticum» 33, 193-218. Nappa C. 1994: Agamemnon 717-36: The Parable of the Lion Cub, «Mnemosyne» 47, 82-87. Narkiss D. 1995: Beginning Again: On Aristotle’s Use of a Fable in the Meteorologica, «Scripta Classica Israelitica» 14, 42-51. Neu E. 1988: Das Hurritische. Eine altorientalische Sprache in neuem Licht, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz, Geistes und sozialwissenschaftliche Klasse, n. 3, Mainz. Nøjgaard M. 1963: Le cerf, le cheval, et l’homme. Étude sur la transmission des fables antiques, «Classica et Mediaevalia» 24, 1-19. 1964: La fable antique, I, La fable grecques avant Phèdre, København. 1967: La fable antique, II, Les grands fabulistes, København. Oberg E. 1996:
Römische
Rechtspflege
bei
Phaedrus,
«Rheinisches Museum» 139, 146-65. 2000: Phaedrus-Kommentar, Stuttgart. Oldaker W.H. 1934: Greek Fables and Babrius, «Greece & Rome» 3, 85-93. Önnerfors A. 1987: Textkritisches und Sprachliches zu Phaedrus, «Hermes» 115, 429-52. Opelt I. 1982: Krokodile als Gymnasiarchen. Zur Datierung aesopischer Fabeln, «Rheinisches Museum» 125, 241-51. Otto A. 1890: Die Sprichwörter Redensarten der Römer, Leipzig.
und
Sprichwörtlichen
Pahlen K. 1981: Storia della musica, trad. it. di G. Bianchetti, Firenze. Palazzi F. 1990: Mythos. Dizionario mitologico e di antichità classiche, riveduto e arricchito da E. Barelli, Milano. Pannwitz R. 1967: Pannwitz, Aesop, «Antaios» 8, 47-65. Papademtriou I.-Th.A. 1997: Aesop as an Archetypal Hero, Athens. Pepe L. 1991: La novella dei romani, Napoli. Peréz Jiménez A. e Cruz Andreotti G.
2002 (a cura di): «Y así dijo la zorra». La tradición fabulística en los pueblos del Mediterráneo, MadridMálaga. Perry B.E. 1933: The Text Tradition of the Greek Life of Aesop, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 64, 198-244. 1940: The Origin of the Epimythion, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 71, 391-419. 1952: Aesopica, Urbana. 1957: Babriana, «Classical Philology» 52, 16-23. 1959: Fable, «Studium Generale» 12, 17-37. 1961: Two Fables Recovered, «Byzantinische Zeitschrift» 54, 4-14. 1962: Demetrius of Phalerum and the Aesopic Fables, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 93, 287-346. 1965 (a cura di): Babrius and Phaedrus, LondonCambridge (Mass.). Peters W.A.M. 1946: Phaedrus: een studie over persoon, werk en taal van den romeinschen fabeldichter, Nijmegen. Pighi G.B. 1954: De Phaedri senariis, «Latinitas» 2, 107-114. Pizzigalli J.A.M. 1933: «Mons parturiens». Un parallelo indiano della favola IV, 23 di Fedro, «Rendiconti del Reale Instituto Lombardo di Scienze e Lettere» 66, 1086-1090. Polara G. 2000: Appunti per una ricerca sul Perotti studioso di Fedro, «Studi Umanistici Piceni» 20, 3-19.
Postgate P. 1919: Phaedrus and Seneca, «Classical Riview» 33, 1924. Pugliarello M. 1973: Le origini della favolistica classica, Brescia. 1981-82: Appunti di sintassi fedriana I-II, «Studi e ricerche dell’Istituto di Latino, Facoltà di Magistero, Genova», 4, 109-121; 5, 101-117. Puppini P. 1991: Esopo a simposio, «Sileno» 17, 185-206. Ramorino F. 1897: Mitologia classica illustrata, Milano (si cita dalla 16 ed., Milano 1998). a
Rank L. 1910: Observatiunculae ad Phaedrum, «Mnemosyne» 38, 261-277. Ribezzo R. 1901: Nuovi studi sull’origine e la propagazione delle favole indoelleniche, Napoli. Rinaldi G. 1968: Le letterature antiche del Vicino Oriente, Firenze. Rodella C. 2007: Prossimità tra uomini e orsi nella tradizione classica, in A. Valvo e R. Gazich (a cura di), Analecta Brixiana, II, Milano, 325-350. Roncalli Amici R. 2004: La storia della pulce nell’arte e nella letteratura, Parassitologia 46, 15-18.
Rothwell K.S. (jr) 1995: Aristophanes’ «Wasps» and the Sociopolitics of Aesop’s Fables, «The Classical Journal» 90, 233-254. Ruiz-Montero C.M. e Sánchez Alacid D. 2005: La estructura de la «Vida de Esopo»: análisis funcional, «Habis» 36, 243-252. Sarkady J. 1968: Aisopos der Samier. Ein Beitrag zur archaischen Geschichte Samos, «Acta Classica Universitatis Scient. Debrecen.» 4, 7-12. Schirru S. 2009: La favola in Aristofane, Berlin. Sassen (von) H. 1911: De Phaedri sermone, Marpurgi ad Lanum. Sbordone F. 1932: Recensioni retoriche delle favole esopiane, «Rivista Indo-Greca-Italica di Filologia» 16, 35-68. Scanzo R. 2001: Aviano. I suoi modelli, le sue fonti, «Maia» 53, 5161. 2002: Arguzia e «lusus» nelle «fabulae» di Aviano: una nuova proposta di interpretazione, «Maia» 54, 71-80. Schibli H.S. 1983: Fragments of a Weasel and Mouse War, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 53, 1-25. Sirtori I. 2001: Fedro misogino, «Maia» 53, 387-398.
Solimano G. 2005 (a cura di): Favole di Fedro e Aviano, Torino. Solinas F. 1992 (a cura di): Fedro, Favole, Milano 1992. Stinton T.C.W. 1979: Phaedrus and Folklore: an old Problem Restated, «Classical Quarterly» 29, 432-435. Stocchi C. 2003: Fedro, le rane e i bovini: decostruzione e ricostruzione di un paradigma esopico?, «Paideia» 58, 345354. 2004: Publilio Siro nella struttura e nel lessico del promitio e dell’epimitio di Fedro, «Bollettino di Studi Latini» 34, 410-421. 2005: La dialettica socioeconomica nei promiti di Fedro (Phaedr. 1,24,1; 1,27,1 s.; 1,28,1 s.; 1,30), «Lexis» 23, 295303. 2009: Tracce esopiche nella commedia plautina, «Bollettino di Studi Latini» 39, 75-90. Svelo A. 1978: La novella in Peloritana» 54, 379-399.
Fedro,
«Atti
dell’Accademia
Swoboda M. 1962: De Phaedro Aesopi aemulatore, «Eos» 52, 323336. Tartuferi P. 1984: Phaedr. 1,5. Nota su Fedro e la tradizione esopica, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Macerata» 17, 321-333. Thiel (Van) H.
1971: Sprichwörter in Fabeln, «Antike und Abendland» 17, 105-118. Thiele G. 1906: Phaedrus-Studien, I, «Hermes» 41, 562-592. 1908: Phaedrus-Studien, II, «Hermes» 43, 337-400. 1911: Martial III,20, «Philologus» 70, 539-548. 1911a: Phaedrus-Studien, III, «Hermes» 46, 376-392. Thompson D’Arcy W. 1895: A Glossary of Greek Birds, Oxford. Thompson S. 1967: La fiaba nella tradizione popolare, trad. di Q. Maffi, Milano. Tosi R. 1991: Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano (nuova ed. francese: Dictionnaire des sentences latines et grecques, Grenoble 2010). 2006: La musica nei proverbi greci, in D. Restani (a cura di), Etnomusicologia storica del mondo antico, Ravenna, 83-101. 2008: Gli «Adagia» di Erasmo e la presenza di TOΠOΙ classici nella letteratura europea, in E. Pasini e P.B. Rossi (a cura di), Erasmo da Rotterdam e la cultura europea. Atti dell’Incontro di Studi nel V centenario della laurea di Erasmo all’Università di Torino (Torino, 8-9 settembre 2006), Firenze, 43-59. 2010: Introduzione, in E. Lelli (a cura di), ΠAPOΙMΙAKΩΣ. Il proverbio in Grecia e a Roma, Pisa, 1329. 2011: Precedenti classici di proverbi italiani, in T. Franceschi (a cura di), Ragionamenti intorno al proverbio, Alessandria, 179-194. Tournier H.
2006: Fables grecques et latines. Babrius et Phèdre, trad. e pres. da H. Tournier, pref. di J.-P. ChausserieLaprée, Aix-en- Provence. Travis A.H. 1940: Travis, Improbi iocos Phaedri, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 71, 579-586. Vaio J. 2001: The Mythiambi of Babrius. Constitution of the Text, Hildesheim.
Notes
on
the
Valenti Pagnini R. 1981: «Lupus in fabula». Trasformazioni narrative di un mito, «Bollettino di Studi Latini» 11, 3-22. Walter Ph. 2005: Artù. L’orso e il re, trad. di M. Faccia, Roma. West D. 1974: Of Mice Men: Horace Satires II 6, 77-117, in T. Woodman e D. West (a cura di), Quality Pleasure in Latin Poetry, Cambridge, 67-80. Zafiropoulos C.A. 2001: Ethics in Aesop’s Collection, Leiden-Boston-Köln.
Fables:
the
Augustana
Zander C. 1921: Phaedrus solutus vel Phaedri fabulae novae XXX, Lund. Zoia A. s.d.: Il tema dell’ulivo, in www.antiqvitas.it.
A
Abete Presso diverse culture antiche, dalla tradizione greca a quelle celtiche e germaniche, l’abete è associato alla natività. In particolare, in Grecia è sacro ad Artemide, protettrice delle nascite, e a Elate (in greco ἐλάτη è, non a caso, il nome dell’albero), dea della luna nuova, simbolo di rinnovamento. Questa diffusa elaborazione culturale favorirà l’introduzione, non immediata, dell’abete come albero di Natale nella tradizione cristiana. Gli antichi lo apprezzano e lo usano per vari scopi, dalla costruzione delle case a quella delle navi. Un abete di grandi dimensioni viene impiegato come albero della nave su cui l’imperatore Caligola fa portare un enorme obelisco dall’Egitto a Roma (cfr. Plinio, Naturalis historia 16,201). L’unica favola in cui si trova l’abete come protagonista (Esopo 101 Ch.) presenta l’albero come pianta nobile e superba, impegnata a vantare le proprie qualità: le dimensioni, ma anche la bellezza e l’utilità per le costruzioni e per le navi (Aviano, nella sua versione della favola, si sofferma lungamente sull’impiego dell’abete come albero maestoso delle imbarcazioni). Tuttavia, il rovo ricorda la fine violenta che inesorabilmente tocca all’illustre pianta. La morale è quella, assai diffusa nella tradizione favolistica, secondo cui chi sta in basso nella scala sociale vive con maggiore tranquillità (cfr., ad esempio, Fedro 4,6). Questa narrazione sembra contaminare due motivi favolistici: quello del dibattito tra piante, di origine orientale (cfr. Callimaco, fr. 194 Pf.), e quello della scure che si abbatte sugli alberi e spesso (Esopo 100 Ch.; Romulus 64) è realizzata proprio con il materiale fornito dalle piante stesse, che così decretano la loro rovina (cfr. Adrados 2003, 329). L’abete e il rovo Esopo 101 Ch.
Un abete e un rovo litigavano tra di loro. L’abete, lodando se stesso, diceva: «Sono bello e grande e alto e utile per i tetti dei templi e per le navi; come osi confrontarti con me?». Ma il rovo replicò: «Se tu avessi memoria delle scuri e delle seghe che ti spezzano, anche tu preferiresti essere un rovo». Nella vita non bisogna montare in superbia per la propria fama; infatti l’esistenza della gente comune è senza pericoli. RIFERIMENTI: Babrio 64; Aviano 19; F. dattiliche 4 e 17; Parafrasi 102. Cfr. anche Callimaco, fr. 194 Pf.
Afrodite Nata dalla spuma del mare fecondata dai genitali di Urano, Afrodite (a Roma, Venere) è dea della bellezza e dell’amore, inteso anche nella sua accezione primigenia di forza vitale della fecondazione. Un altro mito la vuole, invece, figlia di Zeus e di Dione. Spesso la dea ha al suo fianco il figlio Eros e assoggetta al proprio culto chi è recalcitrante. Si distinguono Afrodite Urania, simbolo celeste dell’amore spirituale, e Afrodite Pandemia, simbolo invece dell’amore terreno. La dea viene concessa in sposa da Zeus al fabbro Efesto, ma ha una relazione con Ares ed è protagonista di diverse altre vicende amorose, fra cui quella con il bellissimo Adone. Le sono sacre le isole di Cipro e di Citera, a cui si ricollegano le sue origini. È venerata anche a Corinto, Cnido ed Erice. Secondo i Romani, Venere e il troiano Anchise generano Enea. Alla dea sono sacri, in particolare, il mirto, la rosa, la colomba, il passero, il cigno. Proprio il legame tra Venere e il mirto è sottolineato nella favola fedriana che presenta gli alberi sotto la protezione degli dei (3,17). D’altra parte, la dea, che spicca per la perfezione della sua bellezza (Aristide, Orazioni 28,136) e prende sdegnata le distanze da chi non possiede questa qualità (Esopo 18 Ch.), è protagonista di narrazioni originali, che rimandano anche alla sfera del folclore. Così, ad esempio, la favola esopica 14 Ch., da cui probabilmente deriva anche un proverbio (vd. DONNOLA): Afrodite, dopo avere trasformato una donnola in una bella ragazza per consentirle di sposare il giovane che ama, la fa ritornare, per punizione, alla sua condizione precedente, constatando che, anche da donna, non riesce a trattenersi dal dare la caccia ai topi (nella tradizione indiana del Pañcatantra troviamo una favola simile, ma la protagonista è una fanciullatopina: tantra terzo, racconto nono). La dea interviene nelle vicende degli uomini. In un’originale racconto di impronta
novellistica (cfr. Pepe 175 s.; De Maria 120 ss.), Venere favorisce un giovane nobile e povero, che ambisce a sposare una bella fanciulla contesa anche da un ricco pretendente (Fedro, App. 12 [16]). La dea ama scherzare e le favole di cui è protagonista si segnalano spesso per gli accenti comici, come quella, non priva di tratti misogini, che allude alla libido delle donne (Fedro, App. 9 [11]). Alcuni racconti relativi ad Afrodite, così come ad altri dei, appaiono a metà tra mito e favola: così la narrazione eziologica sull’origine del culto di Afrodite a Samo (Plutarco, Questioni greche 303c) e il racconto platonico sulla nascita di Eros (Platone, Simposio 203a ss.). Quanto al culto di Afrodite, si rileva anche una favola, quella della scrofa e della cagna, costruita sul divieto di ingresso nei templi della dea imposto a chi si ciba di carni suine, considerate impure (Esopo 329 Ch.). La schiava brutta e Afrodite Esopo 18 Ch. Una schiava brutta e malvagia era amata dal suo padrone. La donna, che riceveva da lui del denaro, si abbigliava meravigliosamente e litigava con la sua padrona. Faceva senza sosta sacrifici ad Afrodite e la pregava, convinta che fosse lei a renderla attraente. Afrodite, tuttavia, apparsa in sogno alla schiava, le disse che non doveva esserle grata, come se fosse lei a renderla bella; anzi: «Io – disse la dea - sono molto irritata e sdegnata nei confronti di quell’uomo a cui tu sembri attraente». Quelli che diventano ricchi con mezzi turpi non devono inorgoglirsi, specialmente se sono di umili origini e di pessimo aspetto. RIFERIMENTI: Babrio 10; Parafrasi 18; Suda η 447 Adler.
Tetrastici
1,10;
I due giovani pretendenti: il ricco e il povero
Fedro, App. 14 [16] A volte la fortuna favorisce gli uomini oltre ogni speranza e attesa Due giovani ambivano alla stessa ragazza. Il ricco ebbe la meglio sulla nobiltà e sulla bellezza del povero. Giunto il giorno fissato per le nozze, l’innamorato, poiché non aveva potuto sopportare il dolore, si ritirò afflitto nel suo piccolo podere, che si trovava lì vicino. Un po’ oltre, si trovava la splendida villa del ricco, che era pronto ad accogliere la ragazza dalle braccia della madre; infatti, la casa in città era sembrata poco spaziosa. Si snoda il corteo, accorre la folla in gran numero e Imeneo offre la fiaccola nuziale. Intanto un asinello, che era solito portare il carico dei proventi del povero, si trovava sulla soglia della porta della città. Per caso noleggiano per la fanciulla proprio quella bestia, affinché la fatica del cammino non danneggi i suoi teneri piedini. Per l’intervento misericordioso di Venere, all’improvviso, è sconvolto dai venti il cielo, dove rimbomba il fragore del tuono e si prepara una notte fitta di dense nubi. La luce è sottratta agli occhi e, allo stesso tempo, la violenza della grandine si diffonde e disperde qua e là l’impaurito corteo, costringendo ognuno a fuggire e a cercare riparo. L’asinello s’infila sotto il tetto più vicino, a lui ben noto, e fa segno, con forti ragli, di essere giunto. Accorrono i servi, vedono la bella fanciulla e ne restano ammirati: poi vanno a riferire la notizia al signore. Egli, che sedeva insieme a pochi amici, cercava di scacciare gli effetti della delusione amorosa a forza di bere. Quando gli fu riferita la notizia, si rianimò per la gioia e, grazie all’incoraggiamento di Bacco e di Venere, portò a compimento le dolci nozze tra gli applausi dei
coetanei. I genitori cercano la figlia attraverso un banditore; il novello sposo, persa la compagna, si rattrista. Dopo che fu comunicato alla gente che cosa era successo, tutti non esitarono ad approvare il favore dei celesti.
Agnello Se gli ovini (cfr. PECORA) sono animali sacrificali per eccellenza, l’agnello rappresenta, in particolare, l’innocenza e la purezza. Il termine «agnello» va infatti posto in relazione con il sanscrito agnis (fuoco purificatore) e con parole di significato affine sia greche sia latine (cfr. Maspero 233). Importante nella tradizione ebraica, l’animale, in ambito cristiano, diventa immagine di Gesù, che toglie i peccati del mondo (Vangelo di Giovanni 1,29). Più prosaicamente, l’agnello è molto apprezzato in ambito gastronomico, come attesta il ricettario di Apicio, opera dedicata all’arte culinaria romana di età imperiale. Questo animale nella favolistica si caratterizza per avere due amici che lo proteggono (il pastore nel mondo degli uomini e il cane, che fa la guardia al gregge, nel mondo degli animali) e due nemici giurati (il macellaio, nel mondo umano; il lupo, nel mondo animale). Significativa è una favola che presenta l’agnello intento a biasimare il macellaio e a elogiare il pastore (Massimo di Tiro 19,2). Quanto al rapporto con il lupo, è paradigmatica la favola che vede l’agnello contrapposto al feroce animale: la versione più celebre è quella che apre, dopo il prologo, il primo libro delle favole di Fedro; in questa narrazione «la violenza si organizza come diritto» (La Penna 1968, XXXIX). Qui l’animale va a rappresentare gli innocenti, secondo una elaborazione culturale propria, come si è visto, anche di altre tradizioni. In un’altra favola, l’agnellino, in Babrio e Aviano sostituito dalla pecora o dal capretto, preferisce farsi ammazzare dal sacerdote piuttosto che dal malvagio lupo (Esopo 222 Ch.). Nella favola del cane e dell’agnello (Fedro 3,15), impostata secondo la tecnica della diatriba cinica (Hausrath 1936, 93 s.), si è anche ipotizzata una trasposizione autobiografica: l’agnello, calato anche qui nella parte di vittima di un destino avverso, interpreta
efficacemente la sofferta sensibilità del poeta e afferma il primato della madre acquisita, capace di amare, rispetto a quella naturale, che genera e poi non si cura della prole (v. il proverbio sotto). Questo animale, così nettamente caratterizzato nel suo profilo, è naturalmente al centro di numerosi proverbi, talora riconducibili a favole: in particolare, l’espressione Lupo agnum eripere postulant (Plauto, Poenulus 776), ossia «Vogliono strappare l’agnello al lupo» (v. sotto). Il lupo e l’agnellino rifugiato nel tempio Esopo 222 Ch. Un lupo inseguiva un agnellino, che si rifugiò in un tempio. Poiché il lupo lo chiamava e gli diceva che il sacerdote, se lo avesse sorpreso, lo avrebbe sacrificato alla divinità, l’agnellino rispose: «Per me è meglio essere sacrificato a un dio, piuttosto che venire ucciso da te». La favola dimostra che per coloro su cui incombe la morte, è meglio morire con onore. RIFERIMENTI: Babrio 132; Aviano 42. Il lupo e l’agnello Fedro 1,1 Allo stesso ruscello, spinti dalla sete, erano giunti un lupo e un agnello. Sopra stava il lupo, molto più in basso l’agnello. A un certo punto il predone, spinto dalla sua malvagia gola, accampò un pretesto per litigare. «Perché – disse – mi hai sporcato l’acqua, mentre ero intento a bere?». Il lanuto, di rimando, con timore: «Come posso, di grazia, lupo, fare ciò di
cui ti lamenti? Da te la corrente scende verso il luogo in cui io sto bevendo». Respinto dalla forza della verità, il lupo disse: «Sei mesi fa parlasti male di me». Rispose l’agnello: «Ma veramente non ero ancora nato». «Tuo padre, per Ercole – disse quello – parlò male di me». E così lo fa suo e lo dilania, uccidendolo ingiustamente. Questa favola è stata scritta per quegli uomini che, con pretesti infondati, opprimono gli innocenti. RIFERIMENTI: Esopo 221 Ch.; Babrio 89; Romulus 3; Parafrasi 222; Dodecasillabi 222; Basilio, Epistole 189,2. Cfr. anche Gregorio di Nissa, Ad Eustazio, p. 4 Müller; Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 90, ed. Boissonade) . Il cane e l’agnello Fedro 3,15 A un agnello che si aggirava tra le capre, un cane disse: «Sciocco, ti sbagli: non è qui tua madre»; e fece cenno in direzione delle pecore che si trovavano lontano, staccate dal gregge. «Io non cerco quella che, sotto l’impulso del piacere, concepisce e poi porta un peso estraneo per un certo numero di mesi, per sgravarsi infine del fardello e sbarazzarsene; ma colei che mi nutre, dopo avermi offerto le sue poppe, e priva del latte i suoi piccoli, perché a me non ne manchi». «Ma ha più importanza chi ti ha generato». «Non è così. Come faceva a sapere se sarei nato nero o bianco? Su, dunque, rifletti: se avesse voluto generare una femmina, che successo avrebbe avuto, dal momento che sono nato maschio? Proprio un grande beneficio offrì al mio giorno natale: quello di attendere il macellaio da un’ora all’altra. Una il cui
potere nel generarmi fu nullo perché dovrebbe essere preferibile rispetto a questa, che ebbe pietà di me, abbandonato, e mi offre spontaneamente la sua affettuosa benevolenza? L’amore, non il vincolo di sangue, rende genitori». Con questi versi l’autore ha inteso dimostrare che gli uomini resistono alle leggi, mentre sono conquistati da chi fa loro del bene. RIFERIMENTI: Romulus 32. PROVERBI Lupo agnum eripere postulant Vogliono strappare l’agnello al lupo Il verso (Plauto, Poenulus 776) appare iperbolico e non privo di una connotazione proverbiale (cfr. Otto 198). Viene suggerita una morale paradossale, che pare perciò impossibile: il lupo, predatore per eccellenza, può essere predato? La favola a cui sembra riconducibile il passo plautino dà una riposta affermativa. Si tratta della narrazione del leone che sottrae al lupo una pecora (Esopo 227 Ch.; un porcellino in Sintipa 52). Πατὴρ oὐχ ὁ γεννήσας, ἀλλ᾽ ὁ θρέψας σε Padre non è chi ti ha generò ma chi ti ha allevato La sentenza, proposta tra i monostici di Menandro (452 J.), viene ripresa anche nei proverbi esopici (19 Perry). Anche se in questi casi si fa riferimento al padre e non alla madre, è evidente che il nucleo concettuale è il presupposto della favola del cane e dell’agnello (Fedro 3,15), forse di carattere autobiografico.
Airone L’airone, classificato in tre specie (cinerino, bianco e stellato), è ritenuto un animale battagliero, pronto a muovere guerra contro chi lo danneggia: in particolare aquile, volpi e allodole (cfr. Aristotele, Historia animalium 609b). Considerato simbolo di sapienza, è spesso associato ad Atena (cfr. Omero, Iliade 10,274 ss.). L’uccello non è particolarmente caratterizzato nella tradizione favolistica, dove è anche poco presente. Nell’unica narrazione che lo vede protagonista (Esopo 224 Ch.), pecca di ingenuità. Chiede, infatti, la ricompensa pattuita al lupo, senza considerare che, come spiega la morale, quando si ha a che fare con i malvagi l’importante è non subire danni. Il presupposto filosofico di questa favola è naturalmente quello, tipicamente esopico, dell’immutabilità della natura individuale. Come accade per la cicogna, l’airone può essere sostituito dalla gru (in Fedro 1,8 e in altre versioni della narrazione che ha fortuna anche in età medievale: cfr. Curletto 11 ss.). Un frammento di Semonide (fr. 9 W. ) suggerisce l’inizio di una favola, ma leggiamo solo che l’uccello strappa un’anguilla a uno sparviero e non abbiamo indizi per immaginare il resto della vicenda. Va segnalato che l’airone entra nella tradizione favolistica orientale a partire da una narrazione mesopotamica che, sia pure con significative varianti, nelle sue linee generali è stata accostata a quella, assai nota, della volpe e dell’aquila (Esopo 3 Ch.): in questo caso, troviamo un airone che ha a che fare con una tartaruga (cfr. Gragg). 2
Il lupo e l’airone Esopo 224 Ch. Un lupo, dopo aver ingoiato un osso, andava in
giro alla ricerca di chi potesse curarlo; si imbatté allora in un airone e prese a pregarlo di togliergli l’osso dietro ricompensa. L’airone, infilata la sua testa nella gola del lupo, estrasse l’osso e reclamò il compenso concordato. Allora l’altro gli diede questa risposta: «Caro, non sei contento di aver tirato fuori indenne dalla bocca del lupo la tua testa, vuoi anche una ricompensa?». La favola dimostra che la più grande ricompensa per un servizio, quando si ha a che fare con i malvagi, consiste nel non subire ingiustizie da parte loro. RIFERIMENTI: nella maggior parte delle versioni di questa favola si trova una gru anziché un airone. Cfr. Fedro 1,8; Babrio 94; Aftonio 25; Codice Brancacciano 7; Parafrasi 225; Dodecasillabi 225; Tetrastici 1,30; Romulus 11; da segnalare anche il proverbio a cui la favola è riconducibile (v. sotto). PROVERBI ᾽Eκ λύκoυ στóματoς Dalla bocca di un lupo L’espressione rimanda all’immagine paradossale dell’airone che estrae un osso dalla bocca del lupo (Esopo 224 Ch.) e indica coloro che inaspettatamente riescono a cogliere qualcosa da dove sembrerebbe impossibile. Si ritrova, in forma simile, in vari paremiografi: cfr. Zenobio 3,48; Gregorio Ciprio (L) 2,8; Diogeniano 4,42; Apostolio 6,99.
Alcione Con questo nome viene indicato un uccello che oggi si tende a identificare con il martin pescatore. Sulla questione, tuttavia, esiste una discussione aperta. Infatti, in base alle descrizioni che si trovano nelle fonti antiche, si è tentato di identificare l’alcione anche con altri volatili, come il gabbiano; inoltre, alcune caratteristiche del presunto alcione, dal sapore fantastico o comunque in contrasto con quelle ben note del martin pescatore, quali emergono da una descrizione di Aristotele (Historia Animalium 616a), hanno fatto addirittura pensare che si tratti di un animale leggendario. Pare che deponga le uova verso il solstizio d’inverno: in particolare, i sette giorni prima servono per fare il nido e i sette giorni dopo per deporre le uova; i «giorni dell’alcione» sono inoltre caratterizzati da bel tempo (si vedano Aristotele, Historia Animalium 542b; Plinio, Naturalis historia 10,47). La caratteristica che ha garantito a questo uccello una certa fortuna, specialmente presso i poeti, sembra essere il canto particolarmente malinconico, attestato già in Omero. In un celebre frammento del poeta Alcmane (26 Dav.), ripreso poi anche da Giosuè Carducci (Cèrilo, Odi barbare), leggiamo: «Fanciulle dal canto di miele, dalla sacra voce, non più le membra possono portarmi. Magari, magari fossi un cerilo, che vola sul fiore dell’onda insieme alle alcioni con animo privo di paura, sacro uccello cangiante come il mare». Quindi le alcioni simboleggiano le fanciulle, ossia la giovinezza. Secondo il mito, Alcione, figlia di Eolo e moglie di Ceice, apprese in sogno che il marito era morto in un naufragio. Allora, disperata, si gettò in mare: gli dei, mossi a compassione, trasformarono lei e Ceice in uccelli marini. Numerose fonti attestano anche che le alcioni, in genere visibili agli uomini piuttosto raramente, compaiono di frequente proprio durante il solstizio d’inverno: secondo Thompson 1895, 28
ss., all’origine del mito starebbe un fenomeno atmosferico, cioè la culminazione della costellazione delle Pleiadi, di cui Alcione è la stella principale. Nel corpus esopico, troviamo una sola favola dedicata (interamente, senza nemmeno l’intervento di altri personaggi) all’alcione. Ne emerge un profilo in linea con la tradizione, in cui spicca l’amore dell’animale per la solitudine, anche se non si rileva l’elemento simbolico della giovinezza. Il riferimento alla nidificazione indica gli scogli della costa come luogo privilegiato: altrove si suggerisce che avvenga addirittura sull’acqua (v., tra gli altri, Gellio 3,10,5). Nella favola l’uccello, solitario, viene descritto mentre si lamenta per la perdita di suoi piccoli inghiottiti dal mare. Il tema del volatile a cui il mare (o l’oceano) sottrae i nati è presente anche nella tradizione favolistica egizia (Adrados 2003, 38), dove tuttavia troviamo anche il tentativo di prosciugare le enormi distese d’acqua per recuperare la prole. In una favola indiana del Pañcatantra (primo tantra, racconto decimo) una coppia di uccelli discute sull’opportunità che i propri nati siano deposti sull’insidiosa spiaggia dell’Oceano, troppo più forte di loro. L’alcione Esopo 28 Ch. L’alcione è un uccello marino che ama la solitudine e trascorre la vita sul mare. Si dice che, per sfuggire alla caccia degli uomini, faccia il suo nido sugli scogli della costa. Ora, un giorno, un femmina di alcione, che era uscita per andare a deporre le uova, giunse su un promontorio, vide una roccia a strapiombo sul mare e qui decise di fare il nido. Tuttavia una volta che uscì in cerca di cibo, capitò che il mare, sconvolto da una burrasca, s’alzò fino al nido, lo coprì d’acqua e annegò i piccoli. E quando l’alcione al suo ritorno si rese conto
dell’accaduto, urlò: «Ahimè infelice! Io, per evitare i pericoli della terra, mi sono rifugiata in questo mare, che è stato per me ben più infido!». Allo stesso modo, anche alcuni tra gli uomini, cercando di sfuggire ai nemici, si imbattono in amici molto più pericolosi dei nemici.
Allodola (terragnola) Uccello solare, considerato una sorta di messaggero tra il cielo e la terra, l’allodola colpisce gli antichi, che elaborano questo simbolismo per la sua tendenza, all’inizio della primavera, a innalzarsi in cielo per poi discendere in picchiata verso terra cantando. Tale comportamento suggerisce invece, nella tradizione cristiana, l’accostamento a Cristo e all’Ascensione. Il nome «allodola» deriva da un prestito celtico (alauda). Nelle antiche mitologie nordiche, l’allodola è una delle incarnazioni dello spirito del grano, perché ha l’abitudine di fare il nido nei campi di frumento ancora in erba (cfr. Cattabiani 2000, 285). Eliano (De natura animalium 1,35) afferma che l’allodola usa la gramigna come amuleto per difendersi dal malocchio delle fattucchiere. Il legame con la terra e con il grano emerge spesso anche nella favolistica, tanto che nella narrazione di Aviano (21) riconosciamo l’allodola sotto le vesti di un anonimo uccello (ma negli altri contesti favolistici in cui viene riportato questo motivo la sua identità è resa esplicita). Stessa rappresentazione in un’altra favola di Fedro (App. 30), in cui l’allodola è definita terragnola, secondo un uso tipico dell’Italia meridionale. A tale proposito va precisato che «il nome terraneola è stato dato certamente agli Alaudidi a causa dell’abitudine di camminare o correre sul terreno, di nidificarvi e dei colori proiettivi, simili all’ambiente in cui vivono» (Capponi 482). In questa narrazione troviamo una struttura tipica della favola: il confronto dialettico tra esseri che vivono diverse dimensioni (la volpe è animale di terra, l’allodola d’aria). Spesso l’allodola è vittima (ingenua) di trappole: è ovviamente l’amore per il grano che la tradisce (Esopo 169 Ch.); altrove, quando un cacciatore di uccelli la
inganna (Esopo 283 Ch.), essa, catturata, dimostra comunque una certa ironia. Si è supposto che l’inizio di questa favola abbia una genesi comune con una narrazione inserita nelle cosiddette favole siriache (74), in cui un’allodola ingannata da una trappola si finge benevola, sostenendo, tra l’altro, di avere nella sua bocca pane per i poveri: questa narrazione potrebbe derivare dalla tradizione orientale di Ahiqar (cfr. Adrados 2003, 529 s.). In generale, l’allodola nella favola è un normalissimo uccello, del tutto desacralizzato; tuttavia, in Aristofane (Uccelli 471 ss.), si riporta una narrazione di Esopo, secondo cui un’allodola seppellisce nel suo cranio il padre (v. sotto): sembrerebbe qui richiamata una dimensione sacrale. Peraltro, Eliano (De natura animalium 16,5) accosta questa narrazione a un racconto simile di tradizione indiana: si dice che un tempo un giovane principe avesse alcuni fratelli più grandi di lui. Rivelando presto la loro malvagità, questi indussero il giovane e i genitori, che non sopportavano più quella situazione, a prendere la via dell’esilio. Ma, sopraffatti dalla fatica, il padre e la madre morirono. Allora il ragazzo si decapitò per seppellire all’interno di sé i genitori. Il Sole, commosso per la devozione filiale del giovane, decise di trasformarlo in un magnifico uccello: l’upupa indiana, volatile amato dai re di quelle terre, come il cavallo è amato dai sovrani greci, nella prospettiva omerica. L’allodola Esopo 169 Ch. Un’allodola, presa al laccio, si lamentava dicendo: «Ahimè! Sono proprio un uccello misero e sfortunato! Non ho commesso alcun furto di oro e di argento o di qualcos’altro di valore; ma un solo piccolo chicco di grano mi ha portato alla morte». La favola è adatta per quelli che affrontano grandi pericoli in cambio di magre ricompense.
RIFERIMENTI: Dodecasillabi 170; Apostolio 9,97 (si riporta la morale della favola esopica). La terragnola e la volpe Fedro, App. 30 [32] Non si deve prestar fede ai malvagi Il volatile che gli agricoltori chiamano terragnola, perché fa proprio per terra il suo nido, per caso si imbatté in un’infida volpacchiotta. Vistala, si alzò verso l’alto con un colpo d’ala. «Salve! – disse la volpe – Perché, scusami, sei scappata da me, come se non avessi cibo in abbondanza nel prato, una grande quantità di grilli, scarabei? Non hai nulla da temere: io ti apprezzo molto per i tuoi costumi tranquilli e per la tua vita retta». L’allodola, allora, rispose: «Tu predichi veramente bene: per terra non sono al tuo livello, ma in aria sì. Anzi, vienimi dietro: ti affido la mia salvezza». Il cacciatore di uccelli e l’allodola Esopo 283 Ch. Un cacciatore stava disponendo trappole per gli uccelli. Un’allodola, che lo vide da lontano, gli chiese che cosa stesse facendo. Egli le disse che fondava una città, ma poi si allontanò a buona distanza e si nascose. L’allodola prestò fede alle parole dell’uomo e giunse vicino alle reti, rimanendone intrappolata. Allora disse all’uccellatore, che era accorso: «Carissimo, se fondi una città di questo genere non troverai molti abitanti». La favola dimostra che case e città si svuotano specialmente quando coloro che le
governano si comportano con crudeltà. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 284 (secondo Adrados 2003, 268 è forse individuabile un parallelo tematico anche con Romanzo di Esopo 105). Il contadino e l’uccello Aviano 21 Un uccellino aveva affidato i suoi piccoli alla terra, dove la bionda messe si ergeva sulla zolla verde. A un agricoltore, che desiderava strapparla dal fragile stelo, capitò di chiedere aiuto ai vicini, pregandoli di venire. Questi discorsi, d’altra parte, turbarono gli uccellini implumi, creduloni: si erano persuasi a lasciare la casa. La mamma, più assennata, tornando, proibì loro di andarsene e disse: «Che cosa mai potranno portare a termine persone che vengono da fuori?». Egli, per la seconda volta, affidò l’incarico a cari amici, ma la mamma, ancora piuttosto tranquilla, rimase lì. Ma dopo che si rese conto che il padrone prendeva le curve falci e capì che davvero la mano si stava avvicinando al grano, disse: «Ora, o infelici, lasciate i diletti campi, visto che egli affida alle sue forze la realizzazione dei suoi propositi». RIFERIMENTI: Babrio 88; Ennio frr. 21-58 V. (la fonte è Gellio 2,29 che premette alla favola un elogio a Esopo). 2
L’allodola che seppellì il padre Aristofane, Uccelli 471 ss.
Sei davvero un ignorante privo di curiosità e non hai mai studiato Esopo, che indicava l’allodola come il più antico tra tutti gli uccelli, nato prima della terra. Poi il padre morì a causa di una malattia. Siccome la terra non c’era ancora, rimase insepolto per cinque giorni. Allora, in difficoltà e a corto di soluzioni, l’allodola prese il padre e lo seppellì nella sua testa. RIFERIMENTI: Eliano, Historia animalium 16,5. Cfr. anche Galeno (Dei temperamenti e delle facoltà dei medicamenti semplici 11,37), che cita Teocrito a proposito di questa storia. Il riferimento è presente nei paremiografi (cfr., ad esempio, Apostolio 7,74, che si rifà a Eliano). La Suda, invece, allude ad Aristofane (α 1470; π 783 Adler). Cfr. anche Erasmo, Adagia 3,3,67; 2,6,27). V. anche Schirru 2009, 103 ss.
Alloro L’alloro è pianta legata al sole e, quindi, al culto di Apollo. Il mito, che presenta diverse varianti, narra che la ninfa Dafne, vergine figlia del fiume Peneo, ottenne di essere trasformata in alloro per sfuggire alle brame del dio, che la amava (δάϕνη in greco significa appunto «alloro»). Nell’antichità, la pianta è al centro delle Dafneforie, celebrazioni che si tengono in varie città greche, in onore di Apollo Dafneforo (portatore di lauro). L’alloro è ritenuto profetico proprio per il legame con il dio; le sue foglie sono masticate dalla Pizia, la sacerdotessa dell’oracolo di Delfi, e favoriscono la divinazione. Simbolo di vittoria, la corona di alloro viene data come premio in occasione dei Giochi Pitici. Anche a Roma viene recepita questa simbologia. Collegata ai trionfi, la pianta è anche simbolo di pace e viene posta davanti alle case (cfr. Plinio, Naturalis historia 15,27; 33). Raffigurazioni e peristili ricostruiti di Pompei confermano la diffusione della pianta nei giardini. I generali vittoriosi ne ornano i fasci e si fanno precedere da messaggeri che portano alloro in Campidoglio a Giove Ottimo Massimo; successivamente l’alloro è riservato agli imperatori. La pianta, apprezzata pure in campo medico, va a rappresentare (anche nella tradizione cristiana) gloria, clemenza, compassione, libertà. Importante è inoltre la simbologia legata alla poesia, poiché Apollo è guida delle Muse: in particolare, Melpomene, Calliope e Clio sono rappresentate con una foglia di alloro in mano. Naturalmente l’alloro diventa riconoscimento distintivo per i poeti: già tra l’VIII e il VII secolo a.C., Esiodo (Teogonia 30) dice di averne ricevuto un ramoscello dalle Muse. Tale tradizione ha lunga fortuna, ben oltre l’antichità: nella letteratura italiana, Petrarca diventerà il simbolo per eccellenza del «poeta laureato» che sarà messo in discussione nel Novecento (si ricordi Montale: I limoni).
Nella favola di Fedro che presenta gli alberi posti sotto la protezione degli dei (3,17), viene ribadita la tradizione secondo cui l’alloro è sacro a Febo. In questo caso, la pianta, insieme ad altre meritevoli di gloria in quanto premiate dalla predilezione divina, è contrapposta all’olivo, sacro a Minerva. Questo albero è ritenuto di maggiore utilità e quindi valorizzato nella pragmatica prospettiva esopica, che si pone agli antipodi della poesia più raffinata e non può amare quanto non giova agli uomini. La stessa contrapposizione con l’olivo caratterizza l’altra narrazione che presenta l’alloro come protagonista (quarto giambo di Callimaco, fr. 194 Pf.). Qui il poeta racconta una favola che intende rappresentare una contesa con un rivale, nella quale a un certo punto si intromise un tal Simo, persona di nessun valore (simboleggiato dal rovo della favola). Il fatto che lo stesso Callimaco precisi la derivazione dalla Lidia di questa narrazione conferma un dato ricorrente: l’origine orientale del motivo del dibattito tra gli alberi (cfr. anche OLIVO). La favola, peraltro, presenta l’alloro descritto secondo le più rilevanti caratteristiche attestate nell’antichità. La superbia che dimostra sembra in linea con la fama di cui gode. Quindi ecco che cosa può vantare la pianta: è presente presso la soglia di ogni dimora, è associata da sempre all’arte divinatoria; premio per i Giochi Pitici, viene condotta a Delfi da Tempe (il rituale delfico del Septerion consiste in riti evocatori dell’uccisione del serpente Pitone da parte di Apollo e quindi in una processione di alcuni giovani, che nella valle di Tempe colgono l’alloro da usare come premio per i Giochi Pitici). Nonostante le indiscusse qualità, il fatto che non dia frutti commestibili è uno degli elementi decisivi per cui, proprio come nella favola di Fedro, l’alloro, che comunque sembra nel complesso poter vantare meno meriti del rivale, soccombe di fronte al più utile olivo. L’alloro e l’olivo Callimaco, fr. 194 Pf.
L’inizio del giambo, frammentario, presenta i versi forse più noti (6-8): Ascolta, dunque, questa favola: una volta, sul monte Tmolo – così affermano gli antichi Lidi – un alloro e un olivo vennero a contesa […] Quindi, l’alloro descrive in modo sprezzante la foglia dell’olivo e passa a esaltare se stesso: è presente presso la soglia di ogni dimora e associato da sempre alla mantica; premio per i Giochi Pitici a Delfi, viene condotto a Delfi da Tempe per la cerimonia del Septerion. È pianta sacra e pura, non associata alla morte come l’olivo, le cui corone sono usate nei riti funebri. L’olivo replica che come l’alloro è associato ad Apollo, lui è associato ad Ares (accompagna i valorosi morti in guerra). Premio nelle gare di Olimpia, ritenuti più importanti di quelle di Delfi, la pianta riporta un dialogo di uccelli tra le sue fronde. Questi confrontano l’alloro e l’olivo immaginando a ogni «scontro» tra le piante la «caduta» del perdente come in una gara di pugilato: l’alloro è stato prodotto dalla terra, l’olivo da Pallade nella contesa con Poseidone (cade l’alloro); Apollo onora l’alloro, Pallade ha inventato l’olivo (parità); l’alloro non dà frutti commestibili, l’olivo dà frutto e unguento (cade l’alloro); i supplici protendono fronde di olivo, non di alloro (cade ancora quest’ultimo); i Delii proteggono il tronco d’olivo che diede sollievo a Leto, non l’alloro, che risulta, a questo punto, il perdente. Quindi, dopo un passaggio frammentario, la favola (vv. 93 ss.) si conclude così: Così disse. Il suo cuore soffriva per queste parole e fu spinto più di prima alla sfida. Finché {…} un rovo, quanto di aspro si trova sui muri {…} (non era infatti distante dagli alberi) disse: «Smettiamola, disgraziati, perché non diventiamo zimbello dei nemici e non offendiamoci più spudoratamente l’un
l’altro. Ma queste {…} Allora l’alloro guardò verso di lui, con occhio torvo, come un toro, e disse: «O essere brutto e vile, sei uno di noi anche tu? Zeus me lo risparmi! Certo soffochi i vicini {…} no, per Febo, no per la veneranda Cibele, per la quale risuonano i cimbali, no per il Pattòlo {…} RIFERIMENTI: la favola è assente dalle collezioni esopiche e ignorata dai maggiori favolisti, anche se nel finale ricorda Esopo 324 Ch. Questi celebri versi di Callimaco, in particolare i vv. 6-8, sono ampiamente citati da paremiografi, lessicografi, scoliasti e grammatici (cfr. Adrados 2003, 427) e allusioni si ritrovano anche in autori cristiani (cfr. Clemente Alessandrino, Stromateis 5,8,48).
Amaranto Di origine tropicale, l’amaranto, pianta dal tipico colore rosso scarlatto tendente al cremisi, si diffonde presto in Europa. I Greci sono molto colpiti dalla sua longevità, al punto che il fiore diventa simbolo di immortalità. Anche nel nome (α privativo e radice del verbo μαραίνω: «appassisco») è evidenziata questa caratteristica. Nel mondo antico la pianta va a rappresentare anche l’amicizia. La favola recepisce la caratteristica dell’immortalità. L’amaranto, di cui si sottolinea in particolare l’eterna giovinezza, è contrapposto alla rosa, fiore di rara bellezza ma dalla vita brevissima (Esopo 323 Ch.). Lo schema della favola è una originale variazione di quello che in genere mette a confronto due personaggi intenti a vantare i propri meriti (qui invece l’uno evidenzia le qualità dell’altro).
Anguilla Simbolo del misantropo solitario secondo i Geroglifici di Orapollo (2,103), l’anguilla diventa proverbiale, nell’antichità, a causa della sua inafferrabilità. L’espressione plautina Anguillast: elabitur (Pseudolus 747: «È un’anguilla: scivola via») trova numerose affinità con proverbi simili nelle letterature antiche e nelle lingue moderne: può indicare un furfante imprendibile o una persona che sfugge alle domande (Tosi 1991, 109). Anche sul piano scientifico, l’anguilla, a cui è associata in varie culture l’idea di fertilità, genera curiosità: secondo Aristotele, la cui osservazione ha lunga fortuna, non è ovipara né vivipara, ma nasce spontaneamente dal fango (Historia animalium 570a). Sia alla luce di questa credenza sia per la sue sembianze molto simili a quelle del serpente, l’anguilla è ricondotta al simbolismo dei rettili, anche in considerazione del fatto che vive in acqua; perciò è considerata emblema della vita nascente (cfr. Cattabiani 2002, 308). Registriamo questa equivalenza simbolica e narrativa con il serpente nella favola delle rane che chiedono un re a Zeus (66 Ch.). Infatti, in una versione secondaria di questa narrazione, troviamo un’anguilla, al posto della biscia d’acqua, nelle vesti del sovrano sterminatore delle rane. La rara capacità di sopravvivere fuori dall’acqua sembra alla base di un’altra favola in cui troviamo l’anguilla per strada insieme alla dea Demetra e alla rondine (Esopo 96 Ch.; v. DEMADE). L’airone, lo sparviero e l’anguilla Semonide, fr. 9 W
2
Un airone s’imbatté in uno sparviero che stava divorando un’anguilla del fiume Meandro e gliela strappò.
RIFERIMENTI: la favola è evidentemente incompleta: si tratta di un frammento citato da Ateneo (7, 54, 299c) in un discorso relativo a questioni grammaticali.
Ape Le api, spesso presenti nel mito a partire dalla vicenda di Aristeo (v. APICOLTORE), sembrano godere di ottima considerazione nel mondo antico, tanto che Plinio (Naturalis historia 11,4) sottolinea il primato e la «speciale ammirazione» che meritano questi insetti, gli unici a essere generati appositamente per l’uomo: oltre al miele, hanno il merito di fabbricare i favi e la cera, sempre nella prospettiva del bene comune. Simbolo dunque di saggia operosità e di obbedienza, le api rappresentano anche l’anima (già nell’antico Egitto) e sono talora considerate ministre delle Muse, in quanto sensibili alla musica (Varrone, De re rustica 3,6). Rappresentano, inoltre, la concordia, la purezza, il coraggio e persino la temperanza, al punto che respingono chi si profuma e chi è incline ai piaceri del sesso (cfr. Eliano, De natura animalium 5,11). Diventano poi simbolo del Cristo (Cattabiani 2000, 56). Secondo una singolare credenza, peraltro molto radicata e ripresa anche da Virgilio (Georgiche 4,281 ss.), le api nascerebbero dalle carogne dei bovini. Questa strana convinzione potrebbe scaturire dal fatto che gli antichi confondono l’ape con un altro insetto: l’eristalo (cfr. Fabre 50 ss.). Accanto alle qualità riconosciute alle api, non vanno dimenticati i difetti. Così le api si trasformano in crudeli «vipere» e possono persino non avere pietà di un bambino indifeso (Bianore, Antologia Palatina 9,548). Esopo tace i pregi e tende ad amplificare i difetti delle api, che finiscono puntualmente per simboleggiare i malvagi. In particolare, si segnala una narrazione di tipo eziologico, che riprende lo schema narrativo degli animali in missione da Zeus e spiega perché, perso il pungiglione, questi insetti muoiano (Esopo 234 Ch.): è la punizione per la loro malvagità. Se il miele è tanto attraente, la presenza delle api, aggressive e pericolose, finisce tuttavia per allontanare
l’uomo (Aftonio 27). La struttura, giocata sull’opposizione tra il bene desiderato e il pericolo imminente, si presta a essere la base concettuale per un proverbio: «Né miele né api» (v. sotto). Tra i difetti, emerge anche l’ingratitudine nei confronti dell’uomo che si prende cura di loro: il simbolo del male è, nella favola 235 Ch., ancora una volta il pungiglione, secondo una prospettiva che sarà anche cristiana. In una delle favole siriache, l’ape uccide uno scarabeo che vorrebbe fare il miele senza però esserne capace: si tratta di una narrazione con tutta probabilità di origine antica, che ribadisce la necessità di rimanere nell’ambito della natura individuale (cfr. Adrados 2003, 465). La figura di questi insetti è, dunque, prevalentemente negativa, a parte il caso di Fedro 3,13. Qui le api, operose, sono contrapposte agli oziosi e inetti fuchi: questo accostamento è assai diffuso nell’antichità e si riscontra già in Esiodo (v. FUCO). Le api e Zeus Esopo 234 Ch. Le api, che si erano rifiutate di offrire il loro miele agli uomini, andarono da Zeus e lo pregarono di concedere loro la forza di uccidere con i pungiglioni coloro che si avvicinassero ai favi. Allora Zeus, indignato con le api per la loro malvagità, dispose che quelle, colpendo qualcuno, perdessero il pungiglione e poi morissero. Questa favola potrebbe essere riferita agli uomini maligni che sopportano di essere essi stessi vittime dei danni che procurano. RIFERIMENTI: Parafrasi 235; Dodecasillabi 235; cfr. anche Nicandro, Rimedi contro i veleni degli animali 806 ss. Le api e il pastore
Aftonio 27 Favola delle api e del pastore, che esorta a non darsi a cattivi guadagni. Delle api facevano il miele nel cavo di una quercia, quando un pastore, scoperto il loro lavoro, tentò di portare via il miele. Le api, allora, volando intorno all’uomo ora da una parte ora dall’altra, lo scacciarono con il loro pungiglione. Alla fine il pastore esclamò: «Mi arrendo! Non ho bisogno del miele, se devo avere a che fare con le api». Guai attendono coloro che perseguono disonesti guadagni. RIFERIMENTI: v. proverbio sotto. PROVERBI Mηδὲ μέλι μηδὲ μελίσσας Né miele né api Il proverbio è attestato in diversi paremiografi (cfr. Diogeniano 6,58; Gregorio Ciprio 3,4; Apostolio 12,96) ed è riferito a coloro che rifiutano di accedere a un bene a causa dei pericoli che esso comporta. Come si vede, il collegamento con la favola 27 di Aftonio è molto chiaro.
Apicoltore Fonti iconografiche attestano l’antichità dell’apicoltura, che sembra molto diffusa nell’antico Egitto. Nel mondo greco-romano, questa pratica si fa risalire al mito di Aristeo, che insegnò agli uomini anche la vita pastorale e l’arte di fare l’olio. Abbiamo notizia di numerosi poemi didattici sull’apicoltura, andati perduti, soprattutto di età ellenistica e poi ripresi dagli autori latini. Plinio (Naturalis historia 11,19) ricorda gli scritti di Filisco di Taso e Aristomaco di Soli. L’apicoltore, assimilabile nel suo profilo generale alla figura del contadino o del pastore, è il protagonista di una sola favola, costruita sul tema dell’ingratitudine (Esopo 235 Ch.). Le api da lui allevate si dimostrano paradossalmente irriconoscenti nei suoi confronti. Si tratta di un tema non raro nella favolistica: si pensi al cane che morde il giardiniere impegnato a salvarlo (Esopo 155 Ch.) o al pastore a cui le pecore mangiano il mantello caduto a terra (Esopo 316 Ch.). L’apicoltore Esopo 235 Ch. Un tale si introdusse nella casa di un apicoltore, mentre l’uomo era fuori, e lo derubò del miele e dei favi. Tornato il padrone di casa, quando vide le arnie vuote, si fermò a esaminarle. Le api, tuttavia, rientrate dalla raccolta del polline, lo sorpresero là e lo assalirono, riducendolo in pessime condizioni. L’uomo, allora, rivolto a loro, esclamò: «Brutte bestie, voi avete lasciato andare via senza punizione chi ha rubato i vostri favi, invece colpite senza pietà me che ho cura di voi». Così alcuni fra gli uomini, per ignoranza, non stanno in guardia dai nemici, ma
respingono gli amici come se volessero tendere loro insidie.
Apollo Figlio di Zeus e di Leto (Latona per i Romani), nato ai piedi del monte Cinto (nell’isola di Delo), Apollo è fratello gemello della dea della caccia Artemide. Il suo culto è piuttosto articolato: non solo il dio vigila sui campi, sull’agricoltura, sulle arti, ma a lui si rivolgono i giovani, i cacciatori e gli sportivi. Venerato soprattutto a Creta e nel Peloponneso, protegge le fondazioni di nuove città. Poiché purifica dai mali fisici e morali, viene considerato, in una fase molto antica, dio della medicina; poi è sostituito dal figlio Asclepio. Ma, al di là di questi aspetti, è venerato soprattutto come dio della luce e del sole, forse per influssi cultuali di provenienza asiatica; come dio della bellezza e della musica, patrono della poesia e maestro delle Muse. La popolarità si deve anche alla capacità profetica, per cui la sua figura è legata alla divinazione e agli oracoli: il più noto è quello di Delfi, che Apollo controlla dopo avere lottato contro il drago Pitone: la vittoria sul mostro gli consente di ottenere l’attributo di «Pizio»; d’altra parte, tra i suoi epiteti quello più diffuso è Febo («splendente»). In suo onore si celebrano varie feste, tra cui le Targelie e i Giochi Pitici. Gli sono consacrati, tra gli animali, il cigno, la cicala, il corvo, il serpente e il lupo; tra le piante, la palma, l’olivo, ma soprattutto l’alloro, in cui era stata trasformata la sua amante Dafne. L’arco e la cetra sono suoi attributi. Consolidati elementi culturali e cultuali compaiono, intrecciandosi, nella tradizione favolistica, dove viene confermato lo stretto legame del dio con il corvo (Esopo 166 Ch.) e con l’alloro (Fedro 3,17; Callimaco, fr. 194 Pf.). Nel Romanzo di Esopo (126), una narrazione eziologica si sofferma sugli antenati degli abitanti di Delfi e sull’antica usanza greca di offrire un decimo del bottino di guerra al dio. Anche altre narrazioni vengono costruite intorno al culto di Apollo: in un’anomala favola fedriana (App. 6 [8]), viene
descritta la Pizia, la sacerdotessa impegnata nei sacri riti, mentre raccomanda di coltivare la virtù (tra i modelli, forse anche Virgilio, Eneide 3,90 ss.). Il dio compare a volte anche insieme a Zeus e talora lo sostituisce (cfr. le varianti di Esopo 291 Ch.: il serpente calpestato si lamenta con la divinità). Il re degli dei lo manda sulla terra per verificare fino a che punto arrivi l’ambiguità degli uomini: Apollo, indicato da Aviano con gli appellativi di «Febo» e «Titano» (venendo così assimilato a Helios: v.), sorride, arrivando a constatare che l’uomo invidioso, pur di generare danno agli altri, è disposto a subire patimenti (Aviano 22). Il rapporto con Zeus è sbilanciato in una necessaria subordinazione del figlio rispetto al padre: pur essendo assai abile, Apollo deve soccombere nel tiro con l’arco (Esopo 121 Ch.). Nel Romanzo di Esopo (33), si trova una favola che spiega l’origine della capacità del dio di prevedere il futuro. Si crea subito un attrito tra Apollo e Zeus, il quale si irrita quando vede che questa dote fa conseguire al figlio una eccessiva popolarità. Perciò vengono introdotti i sogni che svelano all’uomo ciò che accadrà; ma subito dopo Apollo si riconcilia con il padre: vengono creati anche i sogni fallaci e così il dio mantiene il primato nella previsione del futuro. Ancora nell’ambito del Romanzo, Esopo è stato interpretato come figura anti-apollinea, in quanto seguace delle Muse e simbolo di una cultura popolare, in opposizione al dio che di esse è guida (v. ESOPO). Alcune narrazioni relative agli dei sembrano porsi al di fuori del genere esopico: tra queste, il racconto mitologico dedicato ad Apollo, le Muse e le Driadi (Ermesianatte in Pseudo-Plutarco, I fiumi 2,3; Imerio, Orazioni 66). L’avido e l’invidioso Aviano 22 Dalle altezze celesti Giove mandò in terra Febo, per conoscere gli animi ambigui degli uomini.
C’erano allora due persone che avanzavano richieste opposte agli dei; infatti, uno era avido, mentre l’altro era invidioso. Così, cercando di conoscere i pensieri di entrambi, Titano andò in mezzo a loro e, perché gli fossero rivolte preghiere, disse: «Sono disponibile a concedere favori; infatti quello che uno avrà chiesto, l’altro lo otterrà subito raddoppiato». Tuttavia, colui al quale la straordinaria avidità non riuscirebbe a saziare il cuore, decise con enorme danno di rinviare la preghiera, poiché confidava di aumentare i benefici sperati, grazie alla richiesta dell’altro e riteneva di ottenere lui solo due doni. L’altro, rendendosi conto che il compagno cercava di ottenere il suo premio, affermò trionfante di desiderare il supplizio del proprio corpo; chiese infatti di vivere privo di un occhio affinché il rivale, a causa della concessione raddoppiata, trascorresse la sua esistenza completamente cieco. Allora Apollo, resosi conto dell’umana condizione, rise e così egli stesso descrisse a Giove il male dell’invidia, che mentre gode delle disavventure altrui, desidera addirittura il suo danno, più felice nella disgrazia. NOTA: al v. 7 si legge Praestandi facilis: nam...: con Küppers, Solimano e altri, si mantiene la lezione dei codici e non sono recepite la congettura nunc e la punteggiatura di Gaide. L’Autore Fedro, App. 6 [8] L’oracolo di Apollo «Che cosa sia più utile a noi, dillo, Febo, ti scongiuro, tu che a Delfi e sul magnifico Parnaso hai dimora, che accade?» Le chiome della sacra
profetessa si rizzano, i tripodi si spostano, risuona nei recessi del tempio la voce della Religione, fremono gli allori e la stessa luce del giorno impallidisce. Scioglie la sua voce la Pizia colpita dal Nume: «Udite, o genti, i moniti del dio di Delo: coltivate la pietà; rendete quanto avete promesso agli dei; difendete con le armi la patria, i genitori, i figli, le caste coniugi, scacciate col ferro il nemico; portate conforto agli amici, abbiate indulgenza nei confronti degli infelici, siate ben disposti nei confronti dei buoni e opponetevi a coloro che tendono insidie; vendicate i delitti, castigate gli empi, punite coloro che violano i letti nuziali con la vergogna dell’adulterio; state in guardia dai malvagi, non concedete troppa fiducia a nessuno». Pronunciate queste parole, cadde nel sonno la vergine delirante: delirante, certo, infatti quanto disse lo gettò al vento. I sogni veri e i sogni falsi Romanzo di Esopo 33 Non tutti i sogni sono veri. Zeus, infatti, donò ad Apollo, il patrono delle Muse, che lo desiderava, il dono dell’arte profetica, in modo da essere il migliore degli oracoli. Apollo, dunque, avendo suscitato devota ammirazione nell’intera umanità, si riteneva superiore a tutti gli altri dei e li trattava con ancora più arroganza di prima. Perciò Zeus, che a lui era superiore, si irritò e non volendo che egli avesse tanto potere presso gli uomini, ideò i sogni veri, in grado di annunciare il futuro, durante il sonno. Il patrono delle Muse, avendo capito che nessuno aveva più bisogno di lui per le sue profezie, chiese a Zeus di riconciliarsi con lui e di non togliergli il
potere profetico. Zeus allora si riappacificò con Apollo e così creò gli altri sogni per gli uomini, perché mostrassero a loro nel sonno false previsioni, in modo che essi, sbagliando l’interpretazione, ricorressero di nuovo all’arte divinatoria delle origini. RIFERIMENTI: Euripide, Ifigenia in Tauride 1259 ss. Gli antenati degli abitanti di Delfi Romanzo di Esopo 126 Gli abitanti di Delfi chiesero a Esopo: «Chi erano i nostri antenati?». Esopo, allora, rispose: «Schiavi. Se lo ignorate, è il momento di saperlo. C’era un’antica usanza presso i Greci, che, una volta conquistata una città, offrivano la decima parte del bottino ad Apollo: di cento buoi, dieci; di capre lo stesso e così anche per quanto riguarda gli altri beni: soldi, uomini, donne. Voi, generati da loro, siete stati privati della libertà, come schiavi in catene: dal momento che quella è la vostra origine, siete così diventati schiavi di tutti i Greci». Zeus e Apollo Esopo 121 Ch. Zeus e Apollo discutevano a proposito della loro abilità nel tiro con l’arco. Apollo tese l’arco e scoccò una freccia; Zeus attraversò, con un passo, uno spazio ampio quanto quello percorso dalla freccia di Apollo. Così coloro che gareggiano con i più forti, oltre a non raggiungere il loro livello, vengono derisi.
RIFERIMENTI: Babrio 68; Tetrastici 1,46.
Aquila Uccello legato alle potenze solari, venerato presso diversi popoli nel mondo antico, l’aquila è simbolo delle forze celesti, spesso in contrapposizione con il serpente, associato invece agli Inferi. Dotato degli attributi di regalità e di vittoria e posto in relazione con le divinità della guerra già nella cultura assiro-babilonese, il volatile è assunto come insegna militare persiana, quindi viene adottato anche da Alessandro Magno; finisce per diventare il simbolo delle legioni romane. Nella Bibbia esprime rinnovamento, ma anche rapidità e forza. I numerosi significati culturali che le sono attribuiti vengono puntualmente assimilati dalla tradizione favolistica, che presenta vari punti di contatto con numerose fonti letterarie. L’aquila occupa infatti un posto di particolare rilievo nella società esopica. Come il leone comanda sulla terra e il delfino è il sovrano dei mari, così, nella tradizione favolistica, l’aquila regna nei cieli. Esopo, che spesso nelle parti morali delle sue favole associa l’uccello ai potenti (a volte in opposizione ad altri, ritenuti inferiori, come il gracchio in 5 Ch.), esplicita il riferimento alla regalità nella favola 6 Ch. Qui troviamo un animale sofferente, a cui sono tagliate le ali: per il dolore si rifiuta di mangiare ed è descritto come «un re in catene» (anche se non ha immediata relazione con la favola, il proverbio Mihi pinnas inciderant, «Mi avevano tarpato le ali», è motivo proverbiale, attestato, fra gli altri, da Cicerone, Epistulae ad Atticum 4,2,5, per indicare un boicottaggio: cfr. Tosi 1991, 130). Anche in Fedro (1,28) l’aquila è associata ai sublimes, ossia a coloro che stanno in alto nella scala sociale, ma non per questo devono sottovalutare la vendetta degli humiles. Il suo primato nella società esopica emerge in modo molto chiaro da una favola di Babrio (99), in cui l’aquila vorrebbe stipulare un patto di alleanza con il leone, per conseguire un dominio
incontrastato nel mondo degli animali, ma alla fine non ottiene il suo scopo. La tradizione medievale tenderà a confermare la dignità regale del volatile, e così anche la favola moderna (è, ad esempio, definita «principessa degli uccelli» in La Fontaine 2,8,9). Coerente con questo profilo appare il ruolo nel mito: l’aquila è legata a Zeus, come attesta Omero (Iliade 24,293; 311); ancora, in epoca moderna, La Fontaine (nella favola 2,15,1) la definirà «uccello di Giove». All’aquila sono dedicate alcune delle più antiche favole della tradizione greco-romana, a partire dal VII secolo a.C. Il poeta lirico Archiloco (frr. 174-180 W. ) fa riferimento a una vicenda ripresa poi da vari favolisti: l’aquila rapisce i piccoli della volpe, ma alla fine viene punita per la sua empietà grazie all’intervento divino. La favola, una delle più celebri della tradizione esopica, è presente anche in altre letterature antiche, a testimonianza non solo dell’ampia diffusione di motivi simili presso popolazioni lontane, ma soprattutto della persistente presenza dell’aquila in differenti contesti favolistici (e letterari: Adrados 1964). Va peraltro sottolineato come nel Poema di Etana (v. Introduzione) la vicenda ricalchi quella esopica, ma la volpe sia sostituita dal serpente, secondo uno schema oppositivo aquila-serpente che è proprio anche della letteratura greca (Omero, Iliade 12,200 ss.) e sarà assimilato dalla cultura cristiana, dove l’uccello che afferra il rettile indica la vittoria sul peccato. D’altra parte, questi antichi avversari, che peraltro troviamo in lotta anche in una favola (Aftonio 28), «se raffigurati insieme, possono simboleggiare l’unità cosmica, la totalità, l’unione fra spirito e materia, intelletto e istinto, potere spirituale e potere temporale» (Cooper 37). La società esopica è tendenzialmente laica, e i rapporti tra i suoi membri prescindono dall’intervento della divinità: così nelle versioni successive della favola dell’aquila e della volpe l’intervento di Zeus si riduce e addirittura si annulla in Fedro (1,28), dove la volpe si vendica grazie soltanto al proprio ingegno. 2
Se Aristotele propone un’articolata classificazione dei vari generi di aquila, la tradizione favolistica, come spesso accade, preferisce concentrarsi su una versione uniformata, priva di particolari dal punto di vista esteriore: qui l’aquila pare vicina, in particolare, alla specie dell’aquila nera (Aristotele, Historia animalium 618b); certamente di bell’aspetto (Esopo 79 Ch.), non è tuttavia priva di elementi controversi sul piano morale. Il suo profilo emerge, infatti, attraverso caratteristiche di segno opposto: traditrice in 3 Ch., sprezzante e superba col piccolo scarabeo in 4 Ch., spietata giustiziera di un gallo superbo in 20 Ch.; talora persino poco scaltra, come in Fedro 2,6, favola in cui l’uccello, rappresentativo come sempre dei potenti, cattura una tartaruga, che si rinchiude nel suo guscio: solo l’astuzia della cornacchia le indicherà il modo più efficace per espugnarla. L’aquila, d’altra parte, appare anche coraggiosa, forte e abile predatrice, ad esempio quando ghermisce un agnello (5 Ch.). Nell’ambito di una società fondata sull’agricoltura e sulla pastorizia, non può che rappresentare un’insidia per l’uomo; si manifesta perciò un rapporto ambivalente, in cui il timore si unisce all’ammirazione. Ma spesso l’aquila si dimostra grata all’uomo o comunque gli reca benefici (come è attestato anche al di là della tradizione favolistica: Eliano, nel De natura animalium, 13,1, ricorda che un’aquila si recò da Gordio, mentre arava, preannunciandogli che il figlio Mida sarebbe diventato re della Frigia). Nella favola esopica, l’uomo può fare violenza all’aquila, magari mozzandole le ali, ma può anche curarla (come in Esopo 6 Ch.). L’animale – regale, venerato, sacro a Zeus – non è comunque mai profanato «fino alle estreme conseguenze», nel mondo laico e a volte rovesciato della favola esopica, probabilmente perché miti e credenze religiose sono ancora vitali in epoca storica (Pugliarello 1973, 110). L’aquila e la volpe
Esopo 3 Ch. Dopo essere diventate amiche, un’aquila e una volpe decisero di abitare l’una vicino all’altra, così da consolidare la loro amicizia. Perciò l’aquila salì su un alto albero e vi pose il nido; la volpe si introdusse in un cespuglio sottostante e partorì alcuni cuccioli. Un giorno la volpe uscì per cercare cibo e l’aquila, priva di nutrimento, piombò sul cespuglio, rapì i piccoli dell’amica e se ne cibò, offrendone anche alla sua prole. Una volta tornata, la volpe, compreso l’accaduto, non si disperò tanto per la morte dei suoi piccoli, quanto per l’impossibilità della vendetta: essendo un animale terrestre, non poteva dar la caccia a un volatile. S’arrestò lontano e – solo questo resta agli impotenti e ai deboli – maledisse la nemica. D’altra parte, accadde che l’aquila non tardò a subire la punizione per il suo crimine contro l’amicizia: mentre in campagna si svolgeva il sacrificio di una capra, l’aquila scese in picchiata e sottrasse dall’altare viscere infuocate, portandole al nido. Ma si levò un forte vento che appiccò a sterpi vecchi e sottili una grande fiammata: i piccoli dell’aquila, non ancora in grado di volare, finirono a terra ustionati. La volpe, accorsa immediatamente, li divorò tutti sotto gli occhi dell’aquila. La favola mostra che quanti tradiscono l’amicizia, anche se sfuggono alla vendetta delle vittime a causa della loro impotenza, non possono certo evitare il castigo divino. RIFERIMENTI: Archiloco, frr. 174-180 W ; Aristofane, Uccelli 651 ss.; Fedro 1,28; Romulus 16; Sintipa 24; Parafrasi 3. Per altri possibili paralleli, per lo più riprese da Archiloco, cfr. Adrados 2003, 3 ss. 2
L’aquila e lo scarabeo Esopo 4 Ch. Un’aquila inseguiva una lepre: questa, non potendo contare su alcun aiuto, appena vide uno scarabeo, l’unico animale che la sorte gli facesse incontrare, lo scongiurò di soccorrerla. Lo scarabeo la rassicurò e, quando vide l’aquila avvicinarsi, la pregò di non portare via la sua supplice. Tuttavia l’aquila, disprezzando la sua piccolezza, divorò la lepre sotto gli occhi dello scarabeo. Da allora lo scarabeo, memore dell’offesa, continuava a sorvegliare senza sosta i nidi dell’aquila, e, quando questa deponeva le uova, si librava in aria, faceva rotolare le uova e le rompeva, finché l’aquila, perseguitata ovunque, si rifugiò da Zeus (è infatti uccello a lui sacro) e lo pregò di trovarle un luogo dove poter covare in assoluta sicurezza. Zeus le consentì di deporre le uova nel suo grembo, ma lo scarabeo, scoperto l’accordo, fece una palla di sterco e, quando, volando, fu sopra il grembo di Zeus, la lasciò cadere. Zeus allora volle scuotersi di dosso lo sterco: come si levò, senza accorgersene lasciò rotolare via le uova. Si dice che, da allora, durante la stagione in cui ci sono gli scarabei, le aquile non covano. La favola insegna a non avere disprezzo per nessuno, perché non c’è essere così debole che un giorno non sia in grado di vendicare un affronto. RIFERIMENTI: Romanzo di Esopo 135-139; Semonide, fr. 13 W. ; Aristofane, Vespe 1448, Pace 123-130; Luciano, Icaromenippo 10 (v. proverbio sotto per ulteriori riferimenti e cfr. anche Adrados 2003, 6 ss.). 2
L’aquila, il gracchio e il pastore Esopo 5 Ch. Un’aquila, piombata giù da un’alta rupe, ghermì un agnello. Un gracchio vide la scena e per l’invidia volle imitarlo. Allora si precipitò in picchiata con grande rumore e si abbatté su un montone, ma i suoi artigli si impigliarono nel vello: batteva le ali senza potersi liberare, finché il pastore, resosi conto dell’accaduto, accorse e lo prese, quindi gli tagliò la punta delle ali e, quando scese la sera, lo portò ai suoi figli. Poiché questi gli chiesero che genere di uccello fosse, egli rispose: «Per quanto ne so, è un gracchio, ma lui pretende di essere un’aquila». Così gareggiare con chi è superiore, oltre a non portare vantaggi, suscita il riso per le disgrazie che ci capitano. RIFERIMENTI: Aftonio 19; Babrio 137; Tavolette Assend. 2; Codice Brancacciano 2; Sintipa 9; Parafrasi 5; Tetrastici 1,55. L’aquila dalle ali mozzate e la volpe Esopo 6 Ch. Un giorno un’aquila venne catturata da un uomo, che le tarpò le ali e la pose in casa a vivere con le galline. Quella si sentiva assai umiliata e per il dolore non mangiava nulla: era come un re in catene. Un altro uomo, tuttavia, la comprò e le tolse i mozziconi delle penne, poi, cospargendola di unguento, le fece ricrescere. Allora l’aquila si levò in volo, ghermì con gli artigli una lepre e la portò in dono all’uomo. Una volpe vide e disse: «Non darla a
costui, ma al primo uomo, perché questo è buono per natura: fatti amico piuttosto quello, perché, nel caso ti catturi nuovamente, non ti levi le ali». Dobbiamo contraccambiare generosamente i benefattori, ma anche tenerci prudentemente in guardia dai malvagi. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 6; Parafrasi 6. L’aquila ferita da una freccia Esopo 7 Ch. Un’aquila si era appollaiata su una roccia e faceva la posta alle lepri. Ma un uomo la ferì con una freccia, che penetrò in profondità nelle sue carni, mentre la cocca con le piume si arrestò all’altezza dei suoi occhi. Vedendola, l’aquila disse: «Questo per me è un ulteriore dolore: morire a opera delle mie penne». L’aculeo della sofferenza è più pungente quando siamo esposti al pericolo per causa dei nostri familiari. RIFERIMENTI: Parafrasi 7; Aftonio 32; Tetrastici 1,25; Eschilo fr. 139 R.; Antologia Palatina 9,223. Si rilevano numerose allusioni, anche in ambito cristiano: v. Adrados 2003, 340. Per il collegamento con il proverbio «Cacciare via costui con le sue stesse armi» v. Tosi 1991, 125 ss. Il contadino e l’aquila Esopo 79 Ch. Un contadino trovò un’aquila presa al laccio, ammirò la sua bellezza e la lasciò libera. L’aquila non si mostrò ingrata nei confronti del suo benefattore,
ma, una volta che lo vide seduto sotto un muro vacillante, volò verso di lui e gli levò con gli artigli la benda appoggiata sulla sua fronte. L’uomo si alzò e si mise a seguirla: l’aquila lasciò allora cadere la benda. Dopo aver ripreso la benda ed essere tornato indietro, il contadino trovò crollato il muro sotto cui sedeva e si meravigliò del favore contraccambiato. Bisogna ricambiare i benefici ricevuti. RIFERIMENTI: Parafrasi 79. I due galli e l’aquila Esopo 20 Ch. Due galli combattevano per le galline: uno riuscì a scacciare l’altro. Lo sconfitto andò a nascondersi in un luogo all’ombra. Il vincitore, invece, si levò in aria, e, fermatosi su un alto muro, cominciò a cantare a gran voce. Subito un’aquila, piombata su di lui, lo ghermì. Da allora, il gallo che si era nascosto nell’ombra si accoppiava con le galline in piena tranquillità. La favola dimostra che il Signore si oppone ai superbi, ma dona la sua grazia agli umili. RIFERIMENTI: Babrio 5, Aftonio 12, Sintipa 7, Parafrasi 20; Dodecasillabi 20; Tetrastici 2,19. Cfr. anche Suda τ 69; 105 Adler. La tartaruga e l’aquila Esopo 351 Ch. La tartaruga supplicava l’aquila di insegnarle a volare; ma per quanto questa la ammonisse che non era fatta per il volo, quella diventava più insistente
nella sua richiesta. Un giorno allora l’aquila prese la tartaruga con gli artigli, la sollevò per lungo tratto e poi la lasciò cadere. La tartaruga cadde sulle rocce e si sfracellò. La favola dimostra che molti, facendo a gara con altri senza ascoltare i più saggi, si rovinano. RIFERIMENTI: Fedro 2,6; Babrio 115; Aviano 2; Romulus 17; F. dattiliche 11; Tetrastici 1,40. Cfr. inoltre Eliano, De natura animalium 7, 16 e Valerio Massimo 9, 12. L’aquila, la gatta e la scrofa selvatica Fedro 2,4 L’aquila aveva costruito il suo nido sul punto più alto di una quercia. La gatta, trovata una cavità nel mezzo del tronco, aveva partorito; la scrofa selvatica aveva deposto in basso la sua prole. Allora la gatta, con inganno e scellerata malizia, sconvolse così la fortuita coabitazione: salì sul nido dell’uccello e gli disse: «Una strage si prepara per te e forse anche per me infelice; vedi la femmina del cinghiale che ogni giorno scava la terra: ecco, il motivo è che vuole sradicare la quercia, per uccidere con facilità a terra la nostra prole». Sparso il terrore e sconvolta l’aquila, scese strisciando fino al nido dell’irsuta scrofa. «In grande pericolo – disse – sono i tuoi figli; infatti, non appena uscirai a mangiare con i tuoi teneri cuccioli, l’aquila è pronta a rapirli.» Dopo avere riempito anche questo luogo di timore, la perfida gatta si ritirò nella sua tana sicura. Uscita di là di notte in punta di piedi, dopo avere rimpinzato di cibo sé e la sua prole, sta all’erta tutto il giorno, fingendo di avere paura. Temendo il crollo, l’aquila rimane sui rami. La cignala, volendo evitare la
cattura, non esce. Perché tante parole? Morirono di fame con i loro figli e la gatta offrì ai suoi un abbondante pasto. Gli sciocchi creduloni possono trovare qui un insegnamento di quanto male un uomo dalla lingua biforcuta sappia combinare. L’aquila e il leone Babrio 99 Un’aquila volò da un leone e gli chiese di diventare suo alleato. «Perché no?» replicò il leone. «Ma prima tu devi darmi le tue penne come garanzia che manterrai la promessa. Come potrò considerarti un’amica se tu non stai qui con me?» PROVERBI ᾽Aετὸν κάνθαρoς μαιεύεται Lo scarabeo fa da levatrice all’aquila Il proverbio si trova non solo nella tradizione paremiografica (cfr. Zenobio 1,20), implicando certamente il riferimento alla favola, ma è presente in Aristofane: oltre che nei passi sopra citati (v. riferimenti a Esopo 4 Ch.), è anche in Lisistrata 695 («ti assisterò come fece lo scarabeo con l’aquila che partorì i suoi piccoli»). Il senso è chiaro: indica che anche chi sembra inoffensivo può essere pericoloso.
Arabo Erodoto è tra i primi autori greci a soffermarsi sugli Arabi, soprattutto nel terzo libro delle Storie: sono considerati come uno tra i popoli più rispettosi dei patti; venerano solamente Urania e Dioniso e sostengono di portare i capelli tagliati esattamente come quest’ultimo. Erodoto puntualizza inoltre che l’Arabia è, verso sud, l’estrema regione abitata, unico paese al mondo produttore di incenso, mirra, cassia, cinnamomo e ledano. Gli antichi suddividono l’Arabia, di cui hanno generalmente un’idea piuttosto approssimativa, in tre parti: Arabia Deserta, Arabia Felix (all’incirca l’attuale Yemen: territorio noto per la fertilità), Arabia Petraea (la zona che prende il nome dalla città di Petra). Scrutati spesso con curiosità, gli Arabi «lontani» divengono, specialmente in età augustea, proverbiali come popolo dotato di grandi ricchezze, a volte in associazione con altri popoli orientali come gli Indiani (Orazio, Epistole 1, 6, 5; Odi 3,24,1 s.). Questo «orientalismo» di maniera, sempre piuttosto indefinito, sembra alla base anche delle uniche due favole in cui compaiono gli Arabi. Entrambe non a caso trovano origine in Babrio, favolista romano ma di lingua greca, immerso in una cultura orientale (v. Introduzione e Appendice). Nella prima narrazione, di tipo eziologico (Esopo 112 Ch. ripresa da Babrio 57), si spiegano le origini della tendenza a mentire e a ingannare tipica degli Arabi. Un (pre)giudizio che avrà lunga fortuna, sopravvivendo anche dopo la fine dell’antichità. Sono evidentemente trascorsi diversi secoli dalla valutazione, più benevola, di Erodoto. Appare interessante notare come il modello del proverbio secondo cui la divinità rompe in un certo luogo il carro (o il sacco) in cui sono contenuti difetti o caratteristiche negative è presente nella tradizionale locale italiana ed è talora usato per denigrare gli abitanti delle città vicine (a Parma, ad
esempio, è detto in riferimento a Piacenza). Nell’altra favola, di soli quattro versi, tipicamente babriana (8), si coglie un elemento ampiamente attestato nella letteratura precedente: il collegamento tra gli Arabi e il cammello, animale esotico agli occhi dei Greci e dei Romani. L’ambientazione è indefinita: la favola si concentra sull’arguzia espressa dalla battuta del cammello. Il carro di Hermes e gli Arabi Esopo 112 Ch. Una volta Hermes conduceva per tutta la terra un carro pieno di falsità, cattiveria e inganni, distribuendo in ogni regione una piccola quantità del suo carico. Ma come giunse nel Paese degli Arabi, si dice che il carro si ruppe improvvisamente. Quelli, preso il contenuto del carro come se si trattasse di un carico prezioso, non lasciarono che Hermes proseguisse verso altri popoli. Gli Arabi sono menzogneri e ingannatori sopra ogni altro popolo; non c’è verità infatti nella loro lingua. RIFERIMENTI: Babrio 57; Parafrasi 113. L’Arabo e il cammello Babrio 8 Un Arabo, dopo avere caricato il suo cammello, gli chiese se preferisse prendere la strada in salita o quella in discesa. Quello, non senza arguzia, risposte: «Perché, il sentiero pianeggiante è forse bloccato? ».
Arciere L’arco nell’antichità è strumento di guerra e di caccia. Già nel mito la stessa dea della caccia Artemide (Diana a Roma) è rappresentata con arco e faretra. Paradigmatica è la bravura con l’arco anche del dio Apollo (cfr. Esopo 121 Ch.) e di Eracle. La figura dell’arciere, nel mondo esopico, compare eccezionalmente nell’ambito di una delle numerose situazioni di caccia che vengono descritte (v. CACCIATORE). La favola 338 Ch. narra il terrore degli animali nei suoi confronti: soltanto il loro re accetta la sfida, anche se poi, una volta colpito da una freccia, si dà alla fuga. Si è supposta un’origine orientale di questa narrazione (Adrados 2003, 347 s.). Peraltro, la caccia (con l’arco) al leone è ampiamente attestata nell’antico Egitto, e, in generale, va rilevato che la sfida al leone assume significati simbolici di grande rilievo nel mondo antico. Si tratta di un tema di tradizione appunto orientale: può rappresentare una sorta di prova di iniziazione. Anche Alessandro Magno è descritto come un abile cacciatore, che non teme di sfidare il sovrano degli animali (Plutarco, Alessandro 40,4), affermando così la sua dignità regale. L’arciere e il leone Esopo 338 Ch. Un abile arciere salì in montagna per cacciare. Tutti gli animali se la diedero a gambe; solamente il leone era pronto a sfidarlo in battaglia. L’uomo scoccò una freccia e, colpendo il leone, gli disse: «Vedi qual è il mio ambasciatore: dopo di lui arriverò da te anch’io». Il leone, ferito, affrettò la fuga. Allora a una volpe che lo invitava a essere coraggioso e a
non fuggire, l’animale rispose: «Non riuscirai a ingannarmi: dal momento che il suo ambasciatore è tanto amaro, qualora venga egli stesso, io che cosa potrò fare?». Dall’inizio è necessario prevedere la fine e, da subito, ci si deve mettere al sicuro per il futuro. RIFERIMENTI: Babrio 1; Parafrasi 338; Aviano 17 (qui troviamo una tigre anziché un leone); Dodecasillabi 338; Tetrastici 1.20.
Artigiano Gli artigiani non godono di alta considerazione nel mondo greco-romano. Tra l’VIII e il VII secolo a.C., Esiodo mette sullo stesso piano il mendico e l’artigiano professionale, che hanno bisogno degli altri per vivere (cfr. soprattutto Le opere e i giorni, vv. 21 ss.; 493 ss.). Il primato va decisamente al lavoro agricolo, che, da solo, sa soddisfare tutti i bisogni dell’uomo: l’artigianato non è tuttavia disprezzato come attività manuale, tanto che è ammesso a livello familiare, per produrre gli strumenti agricoli (cfr. Merlo 24). Nella città ideale di Platone sono sufficienti i frutti della terra (Leggi 842c): l’artigianato si giustifica solo in funzione dell’agricoltura. Peraltro, le attività artigianali implicano sedentarietà e infiacchiscono il corpo e lo spirito, poiché sono esercitate nel chiuso della bottega: questo le rende meno nobili dell’agricoltura, che si svolge all’aria aperta ed esercita gli agricoltori, legati alla terra e pronti a combattere in caso di invasione (cfr. Senofonte, Economico 4,3; 6,6-7). Anche in ambito romano troviamo una valutazione riduttiva delle attività artigianali, spesso contrapposte alle arti liberali proprie dei ceti dominanti: così Cicerone le giudica volgari (De officiis 1,42,150). Va comunque segnalato che tale punto di vista, proprio dei ceti dominanti, è parziale; dalle testimonianze epigrafiche e dai reperti archeologici desumiamo, infatti, un certo orgoglio degli artigiani per il loro lavoro, tanto che spesso ritroviamo rappresentati gli strumenti del mestiere sui monumenti sepolcrali. La diffidenza nei confronti degli artigiani, figure peraltro meno presenti e significative rispetto ad agricoltori e pastori, si riscontra anche nella tradizione esopica. In particolare, una favola (Esopo 111 Ch.) spiega il motivo per cui gli artigiani sono uomini falsi: protagonista è Hermes, che sparge il veleno della menzogna sugli artigiani e in
particolare sui calzolai. Uno schema narrativo simile si ritrova anche per altri personaggi (cfr. ARABO). La tradizione esopica offre narrazioni relative a vari mestieri, come calzolai, conciapelli, fabbri, vasai (v. le singole voci). In genere, questi lavoratori sono rappresentati nello svolgimento della loro professione, senza una particolare caratterizzazione: prevale un profilo neutro, quando non esplicitamente negativo. Spesso tali figure sono poste in rapporto con gli animali, anche se in alcuni casi (in particolare per quanto riguarda il conciapelli e il macellaio) tale relazione, come si può immaginare, non è particolarmente felice. Hermes e gli artigiani Esopo 111 Ch. Zeus incaricò Hermes di versare a tutti gli artigiani il veleno della menzogna. Il dio, tritandolo, ne fece parti uguali per ciascuno e lo versò loro. Una volta rimasto soltanto il calzolaio, poiché era avanzato molto veleno, Hermes lo prese tutto e lo versò su di lui. Di qui deriva il fatto che tutti gli artigiani, senza alcuna eccezione, sono falsi, ma i calzolai sono i più falsi di tutti. La favola può essere riferita agli uomini falsi.
Asinaio La cura e l’allevamento degli asini sono attestati nelle trattazioni specialistiche relative all’agricoltura, dove si rileva come l’animale sia utile, paziente e facile da tenere anche per un allevatore ignorante e negligente (cfr. Columella 7,1). L’associazione tra l’asinaio e l’asino, d’altra parte, è spesso impiegata con significati augurali o simbolici. Ad esempio, si racconta che, presso Azio, mentre andava in battaglia, Augusto incontrò un asino e un asinaio e, dopo la vittoria, fece erigere un tempio con le loro statue nel luogo dove si trovava l’accampamento (Svetonio, Augusto 96,5; Plutarco, Antonio 65). Asinaio e asino si ritrovano anche nella vicenda di Amore e Psiche, nell’ambito della discesa della ragazza nel regno di Dite (Apuleio, Metamorfosi 6,20). La tradizione favolistica suggerisce un legame meno intenso tra asino e asinaio, rispetto a quello dell’uomo nei confronti delle pecore o di altri animali. Di fronte a un asino testardo, sul punto di precipitare, l’asinaio si arrende e lo abbandona al suo destino (Esopo 277 Ch.) oppure ride quando il corvo becca la ferita della bestia, causando molto dolore (274 Ch.). L’asinaio inoltre carica l’asino di pesi, gli dà meno da mangiare che al mulo (272 Ch.) e lo fa bastonare (275 Ch.). L’animale può avere diversi proprietari, che lo trattano senza troppi scrupoli (ad esempio, il giardiniere, il vasaio e il conciapelli in Esopo 273 Ch.). All’asino, in fondo, non importa di cambiare padrone: la sua vita non diventerà certo più dura (Fedro 1,15). Anche al di fuori della tradizione esopica, si riscontra il fatto che, a differenza del pastore, l’asinaio è ben disposto a sacrificare l’asino nei momenti di pericolo: Valerio Massimo (7,3 ext. 1) narra che un giorno ad Alessandro Magno era stato suggerito da un oracolo di far uccidere chi avesse incontrato per primo; il caso volle che fosse un asinaio con il suo asino, ma l’asinaio salvò se stesso, dicendo che l’asino veniva prima di lui: così venne sacrificato
l’animale. L’asino e l’asinaio Esopo 277 Ch. Un asino, guidato da un asinaio, dopo avere percorso un po’ di strada, lasciò la via pianeggiante e cominciò ad avanzare sui dirupi. Poiché stava per precipitare, l’asinaio lo prese per la coda, cercando di farlo tornare indietro. Ma visto che l’asino continuava a tirare con forza in direzione opposta, l’asinaio lo lasciò e gli disse: «Te la do vinta: ma ottieni davvero una brutta vittoria». La favola è adatta a chi ama litigare. RIFERIMENTI: Parafrasi 278; Appendix proverbiorum 4,8. Cfr. Orazio, Epistole 1,20,14 ss. PROVERBI Nικᾷ τὸν ὀνήλατην Ha la meglio sull’asinaio Il proverbio (Appendix proverbiorum 4,8) è usato per criticare chi non presta attenzione a consigli che tendono a metterlo in guardia e finisce così nei guai. Il collegamento con la favola è molto probabile (cfr. Adrados 2003, 257).
Asino L’asino è considerato generalmente simbolo di ignoranza e di stoltezza, al punto che, come accade ancora oggi, l’epiteto «asino» è impiegato come insulto (cfr., ad esempio, Cicerone, Contro Pisone 73). Importante anche sul piano religiososacrale, l’animale è in particolare connesso al culto del dio Dioniso (v.) come emblema di fertilità sessuale. Nell’ambito del servizio che offre all’uomo, l’asino è tanto utile quanto poco considerato e già nell’Iliade (11,558 ss.) è presentata l’immagine, che poi si consolida, dell’animale preso a bastonate. La pazienza e la resistenza, d’altra parte, ne fanno un costante punto di riferimento in campo agricolo (come spiega, tra gli altri, Columella 7,1). La sua domesticazione pare risalire al III millennio a.C.; si discute sul fatto se sia indigeno della Grecia o se vi sia giunto dall’Africa in epoca neolitica (cfr. Pugliarello 1973, 135). Nelle Metamorfosi di Apuleio, l’asino emerge quale simbolo di lussuria, come spesso accade nella letteratura classica (cfr. Senofonte, Anabasi 5,8,3), e la sua figura va letta in connessione con il culto di Iside: in questa ottica l’asino si identificherebbe con Seth, divinità demoniaca della morte e della distruzione. In ambito cristiano, oltre al tenace simbolismo legato all’ignoranza (cfr. Basilio di Cesarea, Omelie sull’Esamerone 9,3), emerge quello relativo all’umiltà e alla pazienza. L’asino è uno degli animali più presenti nella tradizione favolistica, che ne rielabora in modo piuttosto articolato le caratteristiche assorbite dalla cultura antica; d’altra parte, le narrazioni risalgono a una fase in cui gli elementi religiosi sembrano in gran parte superati. Come nota Marchesi 1923, 59, «l’asino è un tipo variabile». Si segnala infatti per la vanagloria, quando chiede riscontro del suo presunto valore, ma viene riportato subito dal leone all’umile dimensione che gli appartiene (Esopo 208 Ch.; cfr. anche Fedro 1,11).
Appare, invece, piuttosto stolto quando cerca di imitare il cane (Esopo 275 Ch.) o la scimmia (Babrio 125) senza averne le caratteristiche: così la sua goffaggine lo porta a un’inevitabile punizione. Una sorte ingloriosa gli tocca anche quando, carico di sale, cade in un fiume: il sale si scioglie e lui si rialza leggero; allora prova a comportarsi allo stesso modo quando si ritrova a trasportare spugne, ma l’esito è ovviamente opposto (Esopo 265 Ch.). Queste narrazioni si basano su un semplice schema concettuale, per cui «tipico dello stolto è non cogliere le differenze da situazione a situazione, applicare meccanicamente il risultato di un’esperienza» (La Penna 1961, 500). L’animale diventa, quindi, provocatorio e volgare quando insulta il cinghiale, paragonando il proprio enorme membro al grugno dell’interlocutore, che preferisce trascurarlo, considerandolo un imbelle (Fedro 1,29); appare inoltre simbolo di ignoranza (anche se la favola sembra dirigere in altra direzione la morale) nella narrazione che lo vede accostarsi a un lira: lui non ha la capacità di usarla (Fedro, App. 12 [14]). Questa narrazione, che si ricollega all’idea pitagorica secondo cui l’asino non ha orecchio musicale e non sente il suono della lira (Eliano, De natura animalium 10,28), è riconducibile, come altre, a un proverbio (v. sotto), a testimonianza della forte caratterizzazione nell’immaginario collettivo della figura dell’asino. L’animale è considerato ignobile ed è disprezzato dalle altre bestie, al punto che il leone lo definisce «vergogna della natura» (Fedro 1,21,11). Del resto, il leone, re degli animali, rappresenta una figura che si pone agli antipodi dell’asino. Sulla base di questa opposizione tra il primo e l’ultimo del gruppo sociale degli animali, va certamente letta la favola di Esopo 267 Ch., che riprende lo schema narrativo, comune anche ad altre favole (v. SCIMMIA), del membro più umile della comunità che assume, attraverso un travestimento, le sembianze del capo, ma viene smascherato e torna alla sua iniziale situazione (v. LEONE per il parallelo con la tradizione del Pañcatantra). Anche i cavalli (o i buoi nel mondo romano) sono animali
considerati agli antipodi dell’asino, al punto da diventare proverbiale l’espressione «Passare dagli asini ai cavalli (buoi)» o viceversa (v. BUE), che si applica per lo più per esprimere un’ascesa sociale da una classe umile a una privilegiata (cfr. Esopo 142 Ch. e Babrio 76). Lo stesso cavallo sembra trattare con sufficienza il povero asino, negandogli ogni solidarietà e sostegno (Esopo 141 Ch.; Romulus 53; 82). La figura dell’animale oscilla dunque da una caratterizzazione comica (come in Esopo 274 Ch.) a una rappresentazione tragica: la sua rassegnazione si manifesta efficacemente in Fedro 1,15: che importa se cambia il padrone? Il carico rimarrà sempre lo stesso. Assenza di speranza ed esercizio di una sopportazione senza fine sono gli elementi di questa favola, che sembrano caratterizzare assai efficacemente il punto di vista delle classi subalterne dell’antichità (La Penna 1961, 19). Insomma, l’asino è sfruttato da vivo e può essere persino percosso e umiliato da morto quando, come nell’agghiacciante favola 236 Ch., finisce per diventare parte di un tamburo (v. SACERDOTE). Occorre, dunque, accontentarsi: chi si lamenta, rischia di peggiorare la propria condizione, come accade all’asino della favola 273 Ch. di Esopo, che prega Zeus di cambiare la sua situazione, ma finisce dal giardiniere al ben più temibile conciapelli. L’impossibilità di un cambiamento della condizione di vita – prospettiva tipica della società esopica – si esprime bene anche nell’estremo appello degli asini alla divinità, presentato secondo il consueto motivo narrativo degli animali che inviano un’ambasceria agli dei. Ma Zeus risponde che le loro fatiche cesseranno solo quando, con l’orina, riusciranno a formare un fiume (Esopo 262 Ch.). Anche il rapporto con l’uomo non è semplice: l’asinaio (v.) non esita a percuotere l’animale ed è sordo alle sue esigenze. Come accade anche per altri animali, sulla base di uno schema narrativo tipicamente esopico, la condizione dell’asino domestico viene paragonata a quella dell’asino selvatico: nonostante l’abbondanza di cibo, la condizione di schiavitù del primo sembra da compiangere (Esopo 264 Ch.),
tuttavia garantisce, secondo una morale decisamente consolatoria, un riparo di fronte alle aggressioni delle bestie feroci che condannano inevitabilmente alla morte l’altro (Sintipa 30). Ritenuto inferiore anche al mulo (v.), raramente l’asino si prende qualche rivincita, come quando con un’astuzia riesce a sferrare il suo formidabile calcio sul malcapitato lupo (Esopo 281 Ch.). L’asino e il cane in viaggio insieme Esopo 276 Ch. Un asino e un cane procedevano insieme per la stessa strada. Trovando per terra una lettera sigillata, l’asino la prese, ruppe il sigillo, la aprì e la lesse, in modo da essere udito dal cane. Lo scritto era relativo a nutrimenti quali fieno, orzo e paglia. Tuttavia, mentre l’asino leggeva questa lettera, il cane si annoiava; perciò gli disse: «Scendi di qualche riga, carissimo, così, scorrendola, potrai trovare qualcosa riguardo alla carne e agli ossi». L’asino, tuttavia, passò in rassegna tutta la lettera, senza riuscire a trovare nulla di quanto il cane cercava. Allora quest’ultimo aggiunse: «Getta via, mio caro, questa lettera, perché è del tutto insignificante». L’asino e il cagnolino ovvero il cane e il suo padrone Esopo 275 Ch. Un uomo, che aveva un cane maltese e un asino, giocava sempre con il cane; se una volta andava a mangiare fuori casa, gli portava qualche bocconcino e glielo gettava, quando l’animale gli si avvicinava scodinzolando. Allora, accadde che l’asino, poiché
era geloso, corse incontro al padrone e saltellando finì per dargli un calcio. L’uomo, indignato, ordinò di portarlo via a bastonate e di legarlo alla greppia. La favola dimostra che non tutti sono per natura adatti alle stesse cose. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 276; Romulus 21; Pseudo-Luciano, L’asino 40,1; cfr. anche Apuleio, Metamorfosi 9,1; Galeno, Contro Giuliano 8. Una versione bizantina è stata scoperta da Perry 1961, 7 ss. Per il proverbio, v. sotto. L’asino, la volpe e il leone Esopo 270 Ch. Un asino e una volpe strinsero un’alleanza e andarono a caccia. Incontrarono un leone: la volpe, rendendosi conto del pericolo incombente, si avvicinò al leone e gli promise di dargli l’asino, se avesse garantito di risparmiarla. Il leone promise di lasciarla andare; allora la volpe condusse l’asino presso una trappola e fece in modo che vi cadesse dentro. Il leone, vedendo che quello non poteva fuggire, innanzitutto catturò la volpe, quindi si volse nello stesso modo all’asino. Così, spesso quelli che tramano contro i loro compagni senza accorgersene mandano in rovina anche se stessi. Gli asini che si rivolsero a Zeus Esopo 262 Ch. Una volta gli asini, stanchi di portare continuamente pesi e di patire sofferenze, mandarono ambasciatori da Zeus e chiesero di
essere liberati dalle fatiche. Ma Zeus, volendo dimostrare loro che ciò non era possibile, disse che avrebbero cessato di faticare, quando, orinando, avessero formato un fiume. Gli asini credettero che il dio parlasse seriamente, e da allora, dove vedono l’orina di altri asini, si mettono anch’essi a orinare. La favola dimostra che quanto a ciascuno è assegnato dal destino è senza possibilità di cambiamento. L’asino e il lupo Pseudo-Dositeo 13 Mentre visitava un asino ammalato, un lupo prese a toccarne il corpo e a chiedergli quali parti gli facessero più male. L’asino rispose: «Quelle che tocchi tu». Così i malvagi, se anche hanno l’aria di essere utili, causano maggiori danni. RIFERIMENTI: Romulus 89. L’asino e l’uomo Babrio 125 Un asino salì sul tetto di una casa e, mentre si stava trastullando, ruppe alcune tegole. Un uomo arrivò di corsa, trascinò l’asino a terra e lo colpì con un bastone. Allora, l’asino, che aveva un forte dolore alla schiena, disse all’uomo: «Ma proprio ieri e il giorno prima eravate così divertiti, quando una scimmia si è comportata in questo modo». RIFERIMENTI: Petronio 63 (v. proverbio).
Filemone e l’asinello Valerio Massimo 9,12 ext. 6 La violenza di un riso smodato uccise Filemone. Mentre un asinello mangiava fichi apparecchiati e posti davanti all’uomo, egli chiamò uno schiavo, perché allontanasse l’animale. «Poiché – disse – sei stato tanto lento, dà ora da bere del vino all’asinello». E, immediatamente, fece seguire alla facezia frequenti e affannose risate: a causa della sua avanzata età, il respiro gli si bloccò in gola, facendolo soffocare. RIFERIMENTI: Diogene Laerzio 7,185; Luciano, I longevi 25. L’asino e l’anziano pastore Fedro 1,15 Molto spesso, nel cambio di un governo, i poveri non cambiano nulla oltre al nome del padrone. Questa breve favoletta mostra che tale considerazione è vera. Un vecchio pauroso faceva pascolare in un prato un asinello. Atterrito dall’improvviso fragore dei nemici, cercava di persuadere la bestia a fuggire con lui, perché non fossero catturati. Ma quello, placido, rispose: «Di grazia, pensi forse che il vincitore porrà su di me due basti?». Il vecchio disse di no. «Dunque, che mi importa chi devo servire, purché porti solo il mio carico?» L’asino che mangiava foglie di marruca e la volpe
Esopo 280 Ch. Un asino mangiava foglie spinose di marruca. Una volpe lo notò e gli disse, deridendolo: «Con una lingua così molle e delicata, come puoi rendere morbido e gustare un cibo così duro?». La favola si rivolge a coloro la cui lingua pronuncia discorsi duri e pericolosi. RIFERIMENTI: Babrio 133; resta discusso l’accostamento tra la favola e il proverbio «Le labbra stringono la lattuga, come quando l’asino si ciba del cardo» (v. Tosi 1991, 227): il collegamento è ravvisabile soltanto a un livello superficiale, secondo Luzzatto 1975, 56. L’asino e la lira Fedro, App. 12 [14] Un asino notò una lira abbandonata su un prato. Si avvicinò e toccò le corde con lo zoccolo; al primo contatto, risuonarono. «Un oggetto bello, per Ercole – disse – ma finito male, poiché non sono esperto di quest’arte. Se l’avesse trovata uno più abile, avrebbe rallegrato le orecchie con celesti melodie». Così spesso le doti naturali vanno perse a causa di circostante sfavorevoli. RIFERIMENTI: Diogene Laerzio 7,33; Menandro, Misoumenos 295; fr. 460 K.-T.; Macone 140 G.; Aristeneto, Epistole 1,17; Girolamo, Epistole 27,1; 61,4; Clemente Alessandrino, Stromateis 1,2; Rufino 2,20; Luciano, Contro un bibliomane ignorante 4; Su coloro che vengono assunti per mercede 25; Dialoghi
delle meretrici 14,4; Macario 6,39; Marziano Capella 8,807; Boezio, Consolazione della filosofia 1,8; Eustazio, Commento a Omero, Odissea 1601,45; inoltre l’espressione «L’asino che ode la lira», oltre che negli scoli di Areta a Platone, Teeteto 146a, è titolo di una delle Satire menippee di Varrone (cfr. anche fr. 349 B.). Variante è «L’asino che ode la lira, il maiale che ode la tromba»: cfr. Macario 6,38; Arsenio 12,91a. Altri riferimenti in Adrados 2003, 407 s.; v. anche proverbio sotto. L’asino che portava la statua di un dio Esopo 266 Ch. Un uomo, dopo avere caricato la statua di un dio su un asino, la conduceva in città. Coloro che li incontravano si inchinavano di fronte alla statua; allora l’asino, pensando che rendessero omaggio a lui, eccitato ragliava e non voleva più procedere. Così l’asinaio, dopo essersi accorto dell’accaduto, lo colpì col bastone, dicendogli: «Stolto, ci mancava anche questo, che un asino fosse venerato dagli uomini!». La favola dimostra che quanti si vantano dei beni altrui diventano oggetto di scherno presso coloro che li conoscono. RIFERIMENTI: Parafrasi 267; Tetrastici 1,36; Pseudo-Luciano, L’asino 37; Suda κ 2260 Adler. L’asino che si fingeva zoppo e il lupo Esopo 281 Ch. Un asino, che stava brucando in un prato, vide un lupo che avanzava verso di lui: così finse di zoppicare. Poiché il lupo gli si avvicinò e gli chiese il
motivo per cui zoppicava, l’asino rispose che nell’oltrepassare una siepe aveva pestato una spina; pertanto, lo esortò a estrargliela prima di divorarlo, perché non si pungesse mentre lo mangiava. Il lupo si convinse e, sollevata la zampa dell’asino, aveva tutta l’attenzione rivolta a essa: a quel punto, l’asino gli sferrò un calcio sulla bocca e gli ruppe i denti. Allora quello, sofferente, disse: «Mi sta bene; perché mai mi sono occupato di medicina, quando mio padre mi insegnò il mestiere di macellaio?». Così, anche tra gli uomini, giustamente finiscono male quelli che provano a fare ciò che non si addice loro per nulla. RIFERIMENTI: Babrio 122; Aftonio 9; F. dattiliche 12; Parafrasi 282; Dodecasillabi 282; Tetrastici 1,21; Romulus 52. Cfr. anche Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 67, ed. Boissonade). L’uomo che voleva comprare un asino Esopo 263 Ch. Un uomo, che aveva intenzione di comprare un asino, lo prese in prova: lo condusse in mezzo ai suoi e lo sistemò presso la greppia. L’asino, distaccatosi dagli altri, si mise vicino al più pigro e goloso. Così, poiché la bestia non faceva nulla, dopo averla legata, l’uomo la portò dal suo padrone e gliela restituì. Il padrone gli chiese se lo avesse sottoposto a una prova valida e lui rispose: «Non ho bisogno di nessuna prova; so infatti che è tale quale il compagno che si è scelto tra tutti». La favola dimostra che ognuno è giudicato allo stesso modo dei compagni che ama frequentare. L’asino vestito della pelle del leone e la volpe
Esopo 267 Ch. Un asino girava con indosso la pelle di un leone, spaventando gli animali. Allora vide una volpe e cercava di far paura anche a lei. Quella però (per caso aveva infatti sentito in precedenza la sua voce) disse all’asino: «Stai sicuro che anche io avrei avuto paura, se non ti avessi sentito ragliare». Così alcune persone incolte, che sembrano importanti per la loro evidente affettazione, vengono smascherate dalla smania di parlare. RIFERIMENTI: Babrio 139 (Tavolette Assend. 11); Aftonio 10; Aviano 5; Parafrasi 280; Tetrastici 1,19; 2,23; Platone, Cratilo 411a; Simposio 216d; Luciano, I fuggitivi 13; 33; Il pescatore 32; Lo pseudologista 3; L’amante della menzogna 5; Temistio, Orazioni 21,245b; Libanio, Orazioni 18,19; 55,24; Nicolao, Esercizi preparatori 1,2; Sopatro retore presso Giovanni di Sardi, Commento ad Aftonio (p. 7 Rabe); Dossopatre, Commento ad Aftonio, pp. 161-162 Walz; Tzetze, Chiliadi 932-936 (qui, come in Luciano e in Apostolio, si indica il cosiddetto leone di Cuma; per il proverbio e tutti i riferimenti, v. sotto). Ulteriori riprese in ambito medievale. L’asino che fece capolino Zenobio 5,39 Si racconta che un vasaio allevava molte galline nella sua officina. Arrivò un asino, seguito distrattamente dall’asinaio: fece capolino attraverso la porta e mise in agitazione le galline, che ruppero gli oggetti che si trovavano nell’officina. Allora il
padrone dell’officina trascinò in giudizio l’asinaio. Quando gli fu chiesto dai presenti di che cosa fosse accusato, l’asinaio rispose: «Di un asino che fece capolino». RIFERIMENTI: Suda o 398 Adler; Fozio, Lessico, s.v. ὄνoυ; Apostolio 12,87 (Arsenio 39,66): da segnalare la variante del telaio al posto dei vasi rotti. Molto diffuso il proverbio (v. sotto). L’ombra dell’asino Plutarco, Vite dei dieci oratori 848a Una volta, durante un’assemblea, a Demostene fu impedito dagli Ateniesi di tenere un discorso, così l’oratore chiese di poter dire loro solo poche parole. Una volta che i presenti furono in silenzio, Demostene disse: «Era estate e un giovane aveva noleggiato un asino per andare da Atene a Megara. A mezzogiorno, quando il sole era rovente, il giovane e il conducente dell’asino volevano entrambi porsi all’ombra dell’animale. Si allontanavano a vicenda: l’asinaio sosteneva che l’uomo aveva affittato l’asino, ma non la sua ombra, mentre l’altro replicava che ne aveva pagato tutti i diritti». Dopo avere raccontato questa storia, Demostene fece per andarsene. Gli Ateniesi allora cercarono di fermarlo e lo pregarono di finire la storia. «E dunque – replicò Demostene – voi volete sapere tutto sull’ombra di un asino, ma vi rifiutate di ascoltare con attenzione chi parla riguardo ad argomenti seri?» RIFERIMENTI: Zenobio 6,28. Il proverbio e la relativa favola sono ripresi negli scoli a Luciano, Ermogene 71 e a Platone, Fedro 260c; cfr. inoltre
Fozio, Biblioteca 265, 495a 15-44; Lessico s.v. ὄνoυ σκιά; Suda o 400; υ 327 Adler. Apostolio 17,69 (Arsenio 51,54). Demostene, fr. 15 B.-S. L’asino ritenuto un leone Esopo 279 Ch. Un asino aveva indossato la pelle di un leone e tutti lo scambiavano davvero per il re degli animali. Allora ecco fuggire gli uomini, ecco fuggire le bestie. Ma dopo che un soffio di vento gli strappò la pelliccia e l’asino si ritrovò nudo, allora tutti presero ad aggredirlo, colpendolo con mazze e bastoni. Chi è un povero e semplice privato, non imiti le azioni dei ricchi, in modo da non venire mai deriso e non correre rischi; infatti, quanto è estraneo alla nostra natura è per noi inadatto. RIFERIMENTI: V. Esopo 263 Ch. Il lupo e l’asino Esopo 228 Ch. Un lupo diventò capo del branco e stabilì leggi valide per tutti, secondo cui ogni preda di caccia doveva essere messa in comune e divisa in parti uguali per ciascuno, perché i lupi rimasti senza cibo non si divorassero l’uno con l’altro. Si presentò un asino e, scuotendo la criniera, disse: «Bella idea, questa, concepita dalla mente di un lupo! Ma come si spiega il fatto che tu hai nascosto nella tua tana quanto hai catturato ieri? Forza, mettilo in comune e spartiscilo». Il lupo, posto sotto accusa, abolì la sua legge. Coloro che danno l’impressione di stabilire
leggi giuste sono gli stessi che poi non osservano le disposizioni da loro fissate e decretate. RIFERIMENTI: Parafrasi 229; Dodecasillabi 229. Il leone e l’asino a caccia insieme Esopo 208 Ch. Un leone e un asino, che si erano messi in società, partirono per andare a caccia. Giunsero a una grotta, dove si trovavano delle capre selvatiche; il leone si fermò davanti all’ingresso della caverna, per controllare quando uscissero, mentre l’asino penetrò all’interno, si lanciò tra di loro e si mise a ragliare, con l’intento di spaventarle. Quando il leone ne ebbe catturata la maggior parte, l’asino, uscito dalla grotta, chiese se si fosse battuto valorosamente nel costringere a uscire le capre. Il leone rispose: «Sappi che persino io avrei avuto paura di te, se non fossi stato a conoscenza del fatto che sei un asino». Così coloro che si vantano di fronte ai conoscenti si attirano giustamente il loro scherno. RIFERIMENTI: Romulus 83.
Fedro
1,11;
Tetrastici
2,1;
Il leone, l’asino e la volpe Esopo 209 Ch. Un leone, un asino società e andarono a catturato molte prede, dividerle. L’asino fece
e una volpe si misero in caccia. Dopo che ebbero il leone ordinò all’asino di tre parti uguali e invitò il
leone a sceglierne una, ma il leone, sdegnato, aggredì l’asino e lo divorò. Poi ordinò alla volpe di dividere le parti e lei riunì tutto in un unico mucchio, mettendo via per sé pochi resti. Allora il leone le chiese chi le avesse insegnato a dividere a quel modo e lei rispose: «La sventura dell’asino». La favola dimostra che le disgrazie del prossimo rappresentano per gli uomini un ammonimento. RIFERIMENTI: Fedro 1,5; Babrio 67; F. dattiliche 5; 21; Parafrasi 208; Dodecasillabi 208; Tetrastici 1,41; 1,48; Romulus 8; Ulpiano 17,2,29,2 (cfr. inoltre Aristone e Cassiano in Ulpiano, passo citato). Il contadino e gli asini Romanzo di Esopo 140 Un contadino, invecchiato in campagna senza essere mai stato in città, chiese ai suoi figli di andare a vederla, prima di morire; essi, allora, gli aggiogarono gli asini al carro e gli dissero: «Devi soltanto farli partire e ti condurranno in città». A metà del percorso, però, calò l’oscurità e scoppiò una tempesta, così gli asini presero a correre fuori strada, finendo in un dirupo. Accorgendosi del pericolo incombente, il vecchio esclamò: «O Zeus, che oltraggio ho compiuto nei tuoi confronti, da dover morire in questo modo, per opera non di cavalli ma di spregevoli asini?». RIFERIMENTI: Esopo 303 H.-H. L’asino e il lupo Retore anonimo, Anon. Prog. I, pp. 597 ss. Walz
Un lupo, cammin facendo, incontrò un asino. Tenendolo chiaramente nelle sue reti, fu sul punto di divorarlo; non era comunque soddisfatto del suo pasto e della disgrazia dell’asino; perciò aggiunse un’ulteriore prepotenza con i suoi discorsi e si prese gioco dell’infelice, dicendogli: «Non avere paura, io non sono così crudele da infliggerti un male, qualora io abbia constatato che la tua vita è senza macchia. Confesseremo, allora, gli errori commessi nella nostra esistenza l’uno all’altro e se le mie azioni saranno peggiori delle tue, sarai lasciato libero da me, che tu ora guardi con sospetto, come se fossi un pericolo; e potrai pure correre via senza paura verso i tuoi pascoli. Se invece ti rivelerai colpevole, superandomi nelle azioni ingiuste, proprio tu sarai giudice della disputa, valutando se, per la tua iniquità, meriti di essere condannato da me a scontare la pena». Dopo avere parlato in questo modo, gli elencò le sue colpe. Erano le seguenti: l’uccisione delle pecore e delle capre, i rapimenti di migliaia di capretti e di agnelli; i buoi strozzati e i loro guardiani morsi o addirittura eliminati. Il lupo minimizzava la descrizione e raccontava in qualche modo, attraverso eufemismi, questi e altri fatti, così che tali azioni non sembrassero colpe, come lui stesso pensava. Anche l’asino fu esortato a raccontare le sue malefatte: passando in rassegna le proprie azioni, l’animale non trovava niente che fosse degno di biasimo; infatti, non pensava di aver mai fatto niente di male. Così alla fine, incerto, dichiarò questo, come se fosse davvero un’azione sbagliata: «Una volta portavo il carico del mio padrone – si trattava di verdure – e mentre camminavo, una mosca mi dava noia. Poiché non la sopportavo, piegai il collo per soffiarla via con le narici, così masticai e ingerii una foglia di quegli
ortaggi, che stava sospesa e mi si era conficcata nei denti. Ma subito scontai anche questa colpa, poiché fui incalzato ripetutamente dal padrone con il bastone che portava con sé; fui colpito con forza sulla schiena, così che feci uscire di nuovo la foglia, vomitandola all’istante». La confessione non era ancora giunta alla fine per il poveretto e il lupo prese a urlare a gran voce, come se avesse rapito un agnello: «Che azione ingiusta! Che colpa smisurata, magari la terra ti avesse respinto fino ad ora! Scellerato, quale abominio, quale empietà, quale impurità! Oh, disgraziato, che insensibilità verso il tuo padrone! Te ne spiegherò la ragione: egli seminò gli ortaggi con fatica, innaffiandoli continuamente, ripulendoli, cogliendoli, sopportando chissà quante altre fatiche per tali verdure, in cui soltanto riponeva le speranze di sostentamento. All’improvviso, per colpa tua, è andato perso il guadagno che se ne poteva ricavare; infatti le sue percosse, che, come dicevi, si sono abbattute violentemente su di te, dimostrano la terribile ferita della sua anima, che fu colpita a morte, quando tu mangiasti gli ortaggi. Ma, poiché la giustizia non ritenne sufficiente tale punizione riguardo a quanto avvenuto, tenne in serbo il resto dell’espiazione; infatti, questa stessa situazione dimostra con tutta evidenza che tu non sei affatto stato cacciato come una preda da me, che ora ti sto interrogando». Dopo aver detto queste parole, il lupo assalì e sbranò l’asino, facendo dell’infelice il suo pasto. Così agì prima che l’altro completasse la sua confessione, anche se, fingendo un sincero senso di giustizia, stabilì non sconveniente divorare subito l’asino: del resto, infliggeva questo stesso trattamento agli uomini più malvagi, che, quando portano via i beni del prossimo, giustificano le loro azioni, tentando di far passare con parole molto inique l’ingiustizia per giustizia.
Il leone vecchio, il cinghiale, il toro e l’asino Fedro 1,21 Chi ha perso l’antico prestigio è irriso, nella sua rovinosa caduta, anche dai vili. Sfinito dagli anni e abbandonato dalle forze, un leone, giacendo a terra, esalava l’ultimo respiro. Un cinghiale si precipitò su di lui con i suoi fulminei denti e vendicò con un colpo un vecchio oltraggio. Subito un toro trafisse con le corna ostili il corpo del nemico. Un asino, come notò che la feroce belva era oltraggiata impunemente, gli spaccò il cranio a forza di calci. Allora, spirando, il leone disse: «Che i forti mi offendessero non l’ho tollerato di buon grado, ma il fatto che io sia costretto a sopportare te, vergogna della natura, mi dà l’impressione davvero di morire due volte». RIFERIMENTI: Romulus 20. PROVERBI ῎Oνoς λύρας L’asino (che ode) la lira In origine, il proverbio, diffuso in ambito greco a partire da Cratino, fr. 247 K.-A., con una larga fortuna presso i paremiografi (cfr., oltre ai passi riportati sopra, anche Diogeniano 7,33; Gregorio Ciprio 3,29; M. 4,66; Apostolio 12,82-83 e Arsenio 39,59-60) suggerisce l’incontro paradossale tra un essere rozzo e un oggetto raffinato: l’asino si allontana, non riuscendo a capire il valore della musica. Tale accostamento è icasticamente suggerito già in Mesopotamia, nel III millennio a.C.: qui si trovano rilievi che presentano orchestre in cui l’asino suona la lira (Cocchiara 38 s.). Come osserva Tosi 1991, 225 s., la tradizione di questo proverbio è articolata e vi si inseriscono diverse varianti oltre a elementi orfico-pitagorici (l’asino è animale
contrapposto ad Apollo). Nella favola fedriana si rileva un significato differente rispetto alla gran parte della tradizione del proverbio: l’ignoranza dell’asino, che peraltro dimostra consapevolezza, è elemento secondario della narrazione, mentre l’ineluttabilità della sorte pare il tema centrale e la lira – così si è supposto – potrebbe indicare lo stesso poeta. Il proverbio ha fortuna anche nella tradizione francese, tedesca e italiana (cfr. Ariosto, Orlando Furioso 34,19,7 s.). ῎Oνoυ παρακύψεως Di un asino che fece capolino Il proverbio viene collegato alla favola direttamente dai paremiografi: Zenobio (5,39) spiega che viene usato per le denunce ridicole; più in generale indica la futilità di certe azioni. Si ritrovano diversi riferimenti sia in ambito greco sia in ambito latino: cfr. Menandro, La sacerdotessa fr. 211 K.-T; Pseudo-Luciano, L’asino 45; Apuleio, Metamorfosi 9,42; Macario 6,36 (v. inoltre sopra, i riferimenti della favola). ῾Yπὲρ ὄνoυ σκιᾶς Per l’ombra di un asino Il proverbio viene sempre citato in relazione alla favola riportata da Plutarco (Vite dei dieci oratori 848a) e va a rappresentare coloro che ambiscono a cose di nessun valore, come spiegano, tra gli altri, Suda υ 327 Adler e Apostolio 17,69 (cfr. sopra tutti i riferimenti). Ha lunga fortuna e si ritrova anche negli Adagia di Erasmo (1,3,52), che ricorda come, in alcune versioni della favola, la meta non sia Megara ma Delfi. Asinus in tegulis L’asino sul tetto L’espressione si trova in Petronio (63,1) e «indica una apparizione magica e inaspettata, tale da provocare perfino spavento» (Tosi 1991, 224): in questo senso ritorna anche nelle lingue moderne (in tedesco Der Esel auf dem Dache), con diverse variazioni (in italiano, L’asino che vola). L’immagine, piuttosto caratterizzata, richiama una favola di Babrio (125), che forse di qui prende spunto, proponendo
però un significato differente: un asino sale sul tetto, imitando la scimmia, ma, invece del premio riservato in genere a essa finisce per essere bastonato, perché danneggia le tegole. Detrahere pellem Togliere la pelle Questa espressione è usata da Orazio (Satire 2,1,64) in relazione all’arte satirica di Lucilio e trova ampia fortuna in questo genere letterario (cfr. Persio 4,14, ma anche Orazio, Epistole 1,16,45). Può essere ricollegata alla favola dell’asino vestito della pelle del leone (Esopo 267 Ch.), che viene ripresa anche da Luciano con il riferimento proverbiale all’asino di Cuma (cfr. anche Apostolio 11,90a; 12,84; 16,19a), il quale, vestito da leone, pensò di essere diventato Icone, e, ragliando metteva paura agli ignari abitanti del luogo, fino a che uno straniero, che distingueva bene gli asini e i leoni, lo scoprì e lo cacciò a bastonate (Il pescatore 32; ancora in Luciano, cfr. Pseudologista 3). In generale, il tema del travestimento svelato ha lunga fortuna nella letteratura classica (cfr. Tosi 1991, 105 per le numerose varianti). ῎Oνoς τὰ Mελιταῖα L’asino (che imita) i cagnolini maltesi Il proverbio, attestato nell’Appendix proverbiorum (6,25), si ricollega chiaramente alla favola dell’asino punito dopo avere cercato goffamente di imitare un cagnolino maltese (Esopo 275 Ch.). Il senso è chiaro: si riferisce a quelle persone che per vana gelosia tentano, con comportamenti fuori luogo, di imitare altri, ottenendo però risultati negativi. Questa massima è simile a un’altra, riportata da Macario (6,32): «L’asino che imita il cavallo» (v. MULO).
Aspide Con aspide (greco: ἀσπίς; latino: aspis) si indica un tipo di serpenti velenosi, di cui gli antichi individuano numerose specie. Si tratta, ad esempio, del serpente che dà la morte a Cleopatra. Il nome, piuttosto che al prestito da una lingua straniera, si fa risalire al termine che indica lo «scudo» (Bodson 1986, 69) per la forma che questo tipo di serpente assume quando deve difendersi o attaccare (si pensi al movimento tipico dei cobra). In Egitto era immagine del potere solare; nel mondo greco-romano esiste una certa attenzione alla classificazione delle diverse specie; si tratta di un rettile assai temuto: secondo Plinio (Naturalis historia 8,85-86), non va in giro da solo ma in coppia e, se il compagno è ucciso, lo vendica in modo spietato (cfr. SERPENTE). Nella tradizione cristiana l’aspide sarà designato in modo piuttosto negativo, spesso come «portatore di morte» (ad esempio, in Palladio, Storia Lausiaca 18,10). L’aspide compare in una sola favola (Esopo 137 Ch.) e si presenta come serpente velenoso e malvagio, il cui morso ha effetti mortali. Va precisato che, come in generale accade per i serpenti, anche in questa favola non troviamo un’attenzione specifica rispetto alle caratteristiche dell’animale, che emerge con un profilo decisamente generico. L’impressione è che la sua immagine tenda a sfumare in quella della vipera. Il cacciatore di uccelli e l’aspide Esopo 137 Ch. Un cacciatore di uccelli prese vischio e canne e andò a caccia. Dopo avere visto un tordo posato sulla cima di un albero, si mise in testa di prenderlo. E
così unì le canne tra di loro e osservava l’uccello intensamente, fissando la sua attenzione verso l’alto. Con la testa all’insù a questo modo, senz’accorgersene mise il piede su un aspide addormentato, che si girò e lo morse. Sentendosi venire meno, l’uomo disse all’animale: «Oh me infelice! Volendo catturare una preda, non mi sono accorto che sono divenuto io stesso preda della morte». Così, proprio quelli che ordiscono inganni a danno degli altri incorrono in qualche sventura. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 138.
Astronomo Si ritiene che lo studio degli astri abbia origine, per quanto in forma assai rudimentale, già nella preistoria. Si affina, quindi, nell’antichità presso diversi popoli: in particolare, presso i Babilonesi, i Caldei, gli Egizi, gli Indiani e i Cinesi. L’osservazione del cielo non è solo finalizzata a conoscere la posizione dei corpi celesti, studiare fenomeni (come le eclissi) e definire con precisione la misurazione del tempo, ma serve anche per indagare l’influsso che gli astri hanno sulla vita degli uomini (la cosiddetta astrologia). I primi astronomi greci si ritrovano, a partire dal VII secolo a.C., tra i filosofi naturalisti presocratici (Talete, Anassimandro, Pitagora); successivamente la disciplina suscita interesse anche in Platone e Aristotele. Proprio Talete di Mileto (VII-VI secolo) è il protagonista, secondo Platone, di un gustoso aneddoto (Teeteto 174a): mentre è impegnato a scrutare gli astri, finisce nel pozzo (il filosofo è noto, tra l’altro, per avere previsto, tra lo stupore dei suoi contemporanei, l’eclissi solare del 585 a.C.). Questo motivo ha lunga fortuna nell’antichità (v. sotto): l’idea della paradossale situazione di chi si occupa di quanto è lontano o invisibile e non vede quanto gli sta davanti diventa persino proverbiale. La favola assimila il motivo, che appare perfettamente funzionale alla visione del mondo propria dei subalterni (in Platone, è, non a caso, una schiava tracia a canzonare Talete). In Esopo, tuttavia, si trova un anonimo astronomo che scruta le stelle (65 Ch.). L’astronomo Esopo 65 Ch. Un astronomo era solito uscire tutte le sere per osservare attentamente gli astri. Una volta,
aggirandosi nei pressi della città, con la mente tutta rivolta al cielo, senza accorgersene cadde in un pozzo. Si mise a gemere e a gridare e così un passante, come udì i lamenti, si avvicinò e si informò su quanto era accaduto; poi disse all’astronomo: «Carissimo, tu ti sforzi di guardare il cielo e non vedi quello che c’è sulla terra?». Si potrebbe narrare questa favola per quegli uomini che non fanno altro che vantarsi delle loro mirabolanti imprese, senza essere in grado, tuttavia, di compiere le azioni più comuni. RIFERIMENTI: cfr. soprattutto Tetrastici 1,52; Platone, Teeteto 174a (forse aneddoto originale); Pseudo-Callistene 1,14; Diogene Laerzio 1,34; Ennio, fr. 244 V. (da Cicerone, De republica 1,30); Cicerone, De divinatione 2,13,30; Antologia Palatina 7,172,7 (Antipatro Sidonio). Ulteriori paralleli, anche di ambito cristiano, in Adrados 2003, 57 s. e Tosi 1991, 196 s. 2
PROVERBI pedes nemo
Quod est ante spectat, caeli scrutantur plagas Nessuno fa attenzione a quanto ha davanti ai suoi piedi, mentre stanno a contemplare le regioni del cielo Questo verso enniano (fr. 244 V. ) riassume efficacemente il senso della favola. L’espressione, divenuta proverbiale, si inserisce in una lunga tradizione, sia greca sia romana, che tende a ridicolizzare la figura del filosofo immerso in pensieri alti, ma incapace di badare alle questioni di tutti i giorni. Molte le riprese in differenti contesti letterari (cfr. RIFERIMENTI). 2
Atena (Minerva) Generata dal cervello di Zeus, Atena (a Roma Minerva) è dea della scienza e delle arti, simbolo di intelligenza e di saggezza. In origine, forse in età minoica, o ancora prima, è venerata come dea della casa e dei vincoli familiari: una caratteristica che conserva, sia pure marginalmente, anche in età successive; a questa figura originaria, si sovrappone quindi la valorosa dea Pallade, vergine guerriera. Atena diventa, dunque, dea guerriera, che in vari miti combatte con Ares contro dei ed eroi. Protettrice della città di Atene, viene rappresentata con una lancia ed è impegnata anche a curare l’amministrazione della giustizia. Insegna agli uomini a filare, a tessere e a tingere; tra le sue invenzioni c’è anche l’aratro. Nell’antica Grecia, le Panatenee sono le principali feste che si tengono in suo onore; a lei gli Ateniesi dedicano il Partenone. Tra le piante, le è sacro l’olivo, di cui fa dono alla comunità ateniese; tra gli animali, le sono cari la civetta e il gallo. Al centro di diversi miti, Atena è avversaria di Poseidone, su cui prevale per la signoria dell’Attica, ed è figura centrale nella guerra di Troia, in cui si schiera con i Greci. La figura di Atena non ricorre di frequente nella favolistica, ma si segnala per un profilo del tutto coerente con la tradizione. In una narrazione che vede protagonista Eracle, la dea, che naturalmente spicca per la saggezza, gli consiglia di lasciare stare la mela, simbolo di discordia: se la si contrasta, si ingrandisce (Esopo 129 Ch.). In un’altra narrazione (Esopo 124 Ch.), Atena, come dea della scienza e della tecnica, realizza una casa, criticata dall’implacabile Momo, che è giudice riguardo alle creazioni della dea, di Zeus (il toro) e Prometeo (l’uomo). In Fedro, che cita
Minerva occasionalmente anche con il nome di Pallade (come nelle favole 3,16 e 4,7), la dea viene definita «saggia» dal padre Giove, perché avanza un’obiezione rispetto alla scelta delle altre divinità di associarsi piante sterili, mentre a lei è caro l’utile olivo (3,17).
Atleta La figura dell’atleta trova uno spazio significativo nella letteratura antica. Poeti come Simonide (anche Fedro 4,25 [26] ricorda un inno di lode, composto dal poeta per un pugile vittorioso), Bacchilide e soprattutto Pindaro (Istmiche, Pitiche, Olimpiche e Nemee, secondo i Giochi Panellenici e la divinità che veniva onorata in quell’occasione) ne celebrano le gesta. Al di là della dimensione strettamente sportiva, questi componimenti, detti epinici, esaltano la vittoria, intesa come segno della presenza divina nelle questioni umane; infatti, dimostrando le estreme potenzialità umane, l’atleta viene assimilato agli eroi del mito, eletti dalla divinità. Nell’antichità le manifestazioni sportive sono dunque feste di natura religiosa: le più importanti, i Giochi Olimpici, si svolgono in onore di Zeus e vengono celebrate per oltre mille anni (dal 776 a.C. al 393 d.C.). I giochi sportivi diventano presto appuntamenti molto attesi anche a Roma, dove l’aspetto religioso lascia progressivamente spazio all’intrattenimento popolare; peraltro, le varie discipline implicano un duro allenamento preparatorio. Persino l’imperatore Nerone nel 67 si reca in Grecia e partecipa ai Giochi Panellenici. Nella tradizione esopica, la figura dell’atleta appare in riferimento al pentathlon (costituito da cinque discipline: il salto, la corsa, il lancio del giavellotto, il lancio del disco, la lotta) o con una caratterizzazione più generica. L’ottica è comunque sempre negativa, probabilmente sulla base di una prospettiva cinica, generalmente ostile alla forza fisica e alle grandi dimensioni del corpo, intesi come indice di bestialità: così (cfr. Adrados 1999, 626) nella favola in cui Esopo stronca la vanagloria e la millanteria di un atleta (Fedro, App. 11 [13]). In generale, l’atleta appare come un fanfarone, non degno di credito, rispetto a cui i fatti non corrispondono alle parole (Esopo 51 Ch.): si tratta di un
tema che, in altro ambito, si ritrova anche nel mondo animale, come nella favola della volpe e della scimmia (Esopo 39 Ch.). Addirittura, in una narrazione dai connotati comici, una pulce morde uno sportivo e riesce a fuggire, mentre l’uomo si lamenta dell’accaduto con Eracle (Esopo 356 Ch.). Questa favola ne ricorda una indiana: nel Pañcatantra (settimo racconto del primo tantra), una pulce morde un re ma poi riesce a nascondersi, mettendosi in salvo, mentre un pidocchio finisce per essere ucciso dai servi del sovrano. Il fanfarone Esopo 51 Ch. Un atleta di pentathlon, che veniva sempre biasimato dai concittadini per la sua mancanza di vigore, una volta se ne andò lontano. Tornato dopo un po’ di tempo, si vantava di aver compiuto molte imprese valorose in altre città: a Rodi aveva fatto un salto tanto alto che nessuno degli atleti dei Giochi Olimpici poteva eguagliarlo. Diceva che gli spettatori avrebbero potuto offrirne testimonianza, se mai un giorno fossero giunti da quelle parti. Uno dei presenti gli rispose: «Caro mio, se questa è la verità, non hai bisogno di nessun testimone; ecco dunque qua Rodi: salta». La favola dimostra che è inutile ogni discorso relativo a ciò che facilmente viene provato attraverso i fatti. RIFERIMENTI: Apostolio 8,100 (epimitio). Per il proverbio, v. sotto. PROVERBI Hic Rodus, hic salta Qui è Rodi, qui salta Il proverbio, molto noto in questa forma medievale
(Walther 10908), trova equivalenti e significativi paralleli anche in ambito greco (Gregorio Ciprio 1,90, Macario 2,63, Apostolio 4,41) e ha fortuna nelle letterature moderne, ad esempio in Goethe. Come spiega Tosi 1991, 776, «bolla le insulse vanterie». Cfr. Esopo 51 Ch.
Augusto Nato a Roma nel 63 a.C., pronipote di Giulio Cesare, viene da lui nominato figlio adottivo ed erede, assumendo il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano. Dopo che Cesare viene assassinato, si pone contro Antonio e lo sconfigge a Modena nel 43, facendosi quindi eleggere console. Poi instaura il secondo triumvirato con Antonio e Lepido. Vengono così sconfitti, nel 42, i cesaricidi Bruto e Cassio a Filippi. Nell’ambito del triumvirato, gestisce il potere sulla parte occidentale dello Stato romano. Sconfigge quindi, nel 31, ad Azio, Antonio, che ha assunto atteggiamenti da monarca ellenistico. Fino al 27 riordina lo Stato, poi nel gennaio di quell’anno riceve dal Senato il titolo di Augusto, dopo avere già ottenuto l’anno precedente il titolo di princeps senatus. Dietro la facciata repubblicana, si impone una nuova forma di governo: il principato. Augusto acquisisce infatti poteri civili (nel 23, la potestà tribunizia), militari (ancora, nel 23, lasciato il consolato, ha l’imperium proconsolare, per il governo delle province), religiosi (pontefice massimo, nel 12, dopo la morte di Lepido). Governa Roma con abilità, sostituendo le mansioni delle magistrature elettive, il cui valore era ormai onorifico, con un’articolata schiera di funzionari. Fin dagli anni Trenta, imposta anche una persuasiva opera di propaganda, grazie alla collaborazione del ricco amico Mecenate e di illustri poeti. Dopo la morte, avvenuta a Nola nel 14 d.C., gli succede Tiberio. Augusto compare in una narrazione di Fedro (3,10), che assomiglia piuttosto a un aneddoto o a una lunga novella: ben sessanta sono i versi, in contrasto con la generale tendenza alla brevitas proclamata dall’autore e tipica della favolistica. Lo stesso poeta afferma di avere personale memoria del fatto (v. 8), anche se alcuni studiosi tendono a ritenere che si tratti di un artificio tipico della novellistica,
simile a quello impiegato nel Satyricon di Petronio (110,8). La narrazione si sviluppa in due parti: nella prima, un liberto inganna un uomo, suggerendogli una tresca della moglie con un amante. Nella seconda parte, si ha l’omicidio inconsapevole del figlio e il conseguente suicidio dell’uomo disperato, a cui segue il processo ingiustamente intentato alla donna. Se nella prima fase si ha l’adattamento della narrazione al tipico conflitto esopico tra due personaggi (il marito credulone e il liberto ingannatore), nella seconda troviamo l’antico schema dell’arbitrato, risolto dalla superiore figura di Augusto, che appare come una figura non umana, in grado di illuminare le menti dei giudici. Risolvendo l’enigma, sembra quasi sostituire, nobilitandola, la tipica figura di Esopo, sempre in grado di dare soluzione, con la sua penetrante intelligenza, a situazioni complesse (ad esempio, in Fedro 4,5, dove si presenta un’altra questione relativa a un’eredità). Augusto aveva formalmente evitato in Occidente il culto alla sua persona, associandolo a quello di Roma, ma esso venne ampiamente praticato in Oriente (cfr. Clemente 227). D’altra parte, alcune pratiche sono volte in quella direzione e lo stesso titolo di Augusto rappresenta un attributo connesso con la sfera religiosa, già usato in riferimento a Giove. Dopo la sua morte, come accadde per Cesare, si ha l’apoteosi (con l’attribuzione del titolo di divus). Il poeta Fedro 3,10 È pericoloso credere, ma anche non credere; esporrò in breve un esempio di entrambe le situazioni. Ippolito morì, perché la sua matrigna fu creduta; Ilio andò in rovina, poiché non fu creduta Cassandra. Pertanto la verità va indagata a fondo, prima che uno sciocco giudizio induca a valutazioni sbagliate. Ma perché le mie argomentazioni non
siano sminuite da episodi che si perdono in un’antichità dalle sfumature mitiche, ti narrerò un fatto di cui io stesso ho memoria. Un uomo, che amava la moglie, stava già preparando la toga virile al figlio, quando venne tratto in disparte da un suo liberto, che coltivava la speranza di subentrare come erede diretto. Dopo avere molto mentito sul conto del ragazzo, e ancora di più su presunti comportamenti scandalosi dell’onestissima moglie, aggiunse un’informazione che – ne aveva consapevolezza – avrebbe causato un’acuta sofferenza in un uomo innamorato: ossia che un amante frequentava la casa e ne insozzava l’onore con una scandalosa tresca. L’uomo, infiammato dal crimine falsamente imputato alla moglie, finse di andarsene in campagna, mentre rimase nascosto in città. Quindi, di notte, all’improvviso entrò in casa, puntando direttamente alla camera della consorte, dove la madre aveva ordinato al figlio di dormire, avendo il proposito di controllarlo con maggiore attenzione, in considerazione della sua età ormai adulta. Mentre la servitù cerca un lume, mentre tutti accorrono, non riuscendo a sostenere l’impeto della sua furia e della sua ira, si precipita verso il letto e nel buio tocca una testa. Come si accorge che è tosata, trafigge il petto con una spada, senza prestare attenzione a nulla, pur di vendicare la dolorosa offesa. Portata una lucerna, l’uomo vide, allo stesso tempo, il figlio e la moglie, che dormiva nella camera e non si era accorta di nulla, assopita nel primo sonno. Allora eseguì contro di sé la pena del misfatto e si lasciò cadere sulla spada, che la credulità lo aveva indotto a impugnare. Alcuni accusatori denunciarono la donna e la condussero a Roma di fronte ai centumviri. Maligni sospetti si addensano sull’innocente, perché è la
titolare dell’eredità. Si battono con forza gli avvocati che difendono la causa della donna, priva di colpe. Allora si rivolsero i giudici al Divo Augusto, perché concedesse loro aiuto nell’essere fedeli al giuramento, dal momento che li aveva disorientati la complessità dei fatti oggetto di imputazione. Egli, dopo avere allontanato le tenebre della calunnia e individuato la fonte certa della verità, sentenziò: «Sconti la pena il liberto, che è causa della sventura. Infatti, credo che la vedova, privata insieme del figlio e del marito, sia da commiserare piuttosto che da condannare. Se il capofamiglia avesse analizzato con attenzione i crimini che gli erano stati denunciati, se avesse compiuto un esame approfondito della menzogna, non avrebbe sconvolto dalle fondamenta la sua casa con un funesto delitto». Le orecchie non sottovalutino nulla e tuttavia non prestino immediatamente fede. Poiché accade anche che siano colpevoli coloro di cui non sospetteresti e che gli innocenti siano aggrediti dalla calunnia. Questa narrazione può anche ammonire le persone semplici a non valutare quanto accade sulla base dell’opinione altrui. Gli uomini sono mossi, infatti, da differenti impulsi: ora si lasciano trascinare dalla benevolenza, ora dall’odio. Infatti, una persona ti sarà nota una volta che tu l’abbia conosciuta a fondo. Ho narrato questo aneddoto un po’ più estesamente, a causa del fastidio provocato ad alcuni dall’eccessiva brevità. NOTA: i giovani romani fino a 16 anni indossavano una toga orlata da una striscia di porpora (toga praetexta); in seguito, la toga virile, bianca, segno del raggiungimento dell’età adulta.
Avvoltoio Simbolo della Grande Madre, sacro in Egitto alla dea Mut, posto in relazione anche con le dee Atena ed Era, l’avvoltoio per lo più non gode di buona fama, perché, a differenza di altri rapaci, si nutre di uomini e di animali morti. Secondo Eliano (De natura animalium 2,46) spia gli uomini che stanno per morire e individua subito gli eserciti che entrano in un Paese straniero, sapendo che le battaglie producono cadaveri. Emerge, quindi, come simbolo di voracità, ma, come nota ancora Eliano (10,22), presso alcuni popoli è ritenuto sacro e gli si offrono i cadaveri dei morti in battaglia. Nella tradizione cristiana è un simbolo per lo più negativo e va a rappresentare il demonio; ma la diffusa credenza del concepimento dell’avvoltoio, che avverrebbe attraverso il vento, lo fa diventare simbolo della verginità di Maria. Questo uccello compare in alcuni miti, anche come esecutore del castigo divino: Omero ricorda i due avvoltoi che rodevano il fegato di Tizio, figlio della Terra (cfr. Odissea 11,576 ss.); sacro ad Apollo, perché dal suo volo si possono trarre presagi, l’avvoltoio è determinante, nel mito della fondazione, per stabilire i confini di Roma. L’avvoltoio è presente in poche favole, dove perde ogni connotato riferibile alla sfera religiosa: si è ipotizzato che questo dipenda dal fatto che l’uccello ha subito la concorrenza dell’aquila, uccello dotato di una più solida tradizione mitica (Pugliarello 1973, 138). La più significativa di queste narrazioni è quella del cane che muore custodendo un tesoro (Fedro 1,27): alla fine l’avvoltoio, che svolge la funzione, tipicamente esopica, del survenant, giunge a rimproverare l’animale morto per la sua avidità. Questa narrazione non trova riscontri nelle raccolte esopiche; d’altra parte, ricorda il nibbio che rimprovera il gabbiano con la gola squarciata per avere ingoiato un pesce (Esopo 193 Ch.). Alla base di questa vicenda, che peraltro presenta
temi propri del cinismo, si è ipotizzata una narrazione di origine mediorientale (Havet 164) o egizia (Luzzatto 1976, 205 s.). Nella favola che narra la lite fra il leone e il cinghiale (Esopo 203 Ch.), troviamo invece l’avvoltoio nella sua tipica posizione di attesa, pronto ad approfittare del pasto costituito dallo sconfitto. In una variante della favola di Esopo 292 Ch., in cui troviamo un ragazzo che pensa di vomitare le sue viscere mentre ha semplicemente mangiato troppa carne, sono protagonisti due avvoltoi (cfr. Plutarco, Sull’evitare di prendere denaro a prestito 831c). Il cane, il tesoro e l’avvoltoio Fedro 1,27 Questa narrazione può essere riferita agli avidi e a coloro che, nati poveri, desiderano essere detti ricchi. Un cane, dissotterrando ossa umane, trovò un tesoro, e, poiché aveva profanato gli dei Mani, gli fu infusa la brama di ricchezza, in modo da pagare la pena alla Santa Religione. E così, custodendo l’oro, si dimenticò del cibo e fu consumato dalla fame. Si tramanda che un avvoltoio, incombendo su di lui, dicesse: «Cane, giustamente giaci morto tu che hai desiderato all’improvviso ricchezze degne di un re, mentre sei stato concepito in un trivio e sei cresciuto nello sterco». RIFERIMENTI: Romulus 38.
B
Balena La balena è, fin dall’antichità, collegata al potere delle acque. Essere inghiottiti dal suo ventre, per poi uscirne, è simbolo di oscuramento e di conseguente rigenerazione (cfr. Cooper 53), come una sorta di passaggio tra due stati o modi di essere (cfr. Guénon 141 ss.). In varie culture la balena è animale cosmoforo (ossia portatore del mondo). Nel mito greco, Andromeda si salva, grazie a Perseo, da un mostro marino che suggerisce il profilo di una balena. Il grande pesce (in ebraico tannîm: designa tutti i cetacei e anche il Leviatano) che, nella Bibbia, inghiottisce Giona per lasciarlo uscire intatto, dopo tre giorni e tre notti, dal suo ventre è assimilabile alla balena (Giona 2). Peraltro, questa vicenda trova significativi paralleli non solo nella letteratura greca (Luciano, Storia vera 1,30 ss. racconta di una gigantesca balena che ingoia una nave, senza produrre danni a chi è a bordo), ma anche nelle letterature moderne (si pensi ai capp. 34-35 di Pinocchio, in cui Geppetto finisce nel ventre di un pescecane). Nella tradizione cristiana la balena diventa simbolo degli eretici e del demonio, che attrae i piccoli pesci con il suo alito profumato e poi li inghiottisce. In origine questo cetaceo è poco conosciuto e sembra temuto soprattutto in considerazione delle sue notevoli dimensioni (si pensi che le balenottere raggiungono i trentacinque metri di lunghezza). Gli antichi sono piuttosto imprecisi nella classificazione: conoscono soprattutto la balenottera e il capodoglio, presenti nel mar Mediterraneo. Perciò «la balena, l’animale più grande della terra […] ha disputato al delfino la sovranità del mare», come è attestato anche nelle letterature europee moderne (cfr. Cattabiani 2002, 149, che ricorda Charles Lamb). Forse proprio questa considerazione spiega l’inevitabile conflitto con i delfini che sembra alla base dell’unica favola in cui la troviamo protagonista (Esopo 95 Ch.), impegnata in una dura lotta
contro i rivali (certo non casualmente, la morale riporta il discorso sul piano politico). Peraltro questo conflitto è testimoniato anche dalle fonti antiche e pare proverbiale (v. sotto). D’altra parte, la scarsa familiarità dell’uomo con l’animale rende marginale la sua presenza nella tradizione favolistica e carente la sua caratterizzazione nell’unico racconto che la vede protagonista. I delfini, le balene e il ghiozzo Esopo 95 Ch. Delfini e balene combattevano tra di loro. Poiché la lotta si protraeva, facendosi aspra, emerse dal mare un ghiozzo (questo è un piccolo pesce), che cercò di riconciliare gli avversari. Uno dei delfini, d’altra parte, gli disse: «Per noi è più onorevole morire combattendo gli uni contro gli altri, invece che essere riconciliati da te». Così alcuni tra gli uomini, che non hanno nessuna importanza, credono di essere qualcuno, quando sono coinvolti in rivolgimenti politici. RIFERIMENTI: Babrio 39: qui troviamo un granchio, invece di un ghiozzo. Cfr. sotto per il motivo proverbiale. PROVERBI Δελϕὶς ϕαλλαίνη διάϕoρoς Il delfino non va d’accordo con la balena Eliano (De natura animalium 5,48) osserva che una persona istruita e attenta deve conoscere l’inimicizia tra questi due animali, così come non deve essere all’oscuro di altre proverbiali ostilità, ad esempio quella tra squalo e triglia. Come si vede, la favola anche in questo caso si costruisce intorno a un motivo culturale condiviso. Ancora
oggi l’accostamento di due animali nemici è comunemente usato come espressione proverbiale (ad esempio, «cane e gatto»).
Biscia d’acqua La connessione con le acque spiega gli arcani poteri che gli antichi tendono ad attribuire al serpente (Pugliarello 1973, 114), anche perché le acque «possiedono infusa la forza sacra dell’abisso […] e regolano […] la fecondità del mondo» attraverso piogge, umidità e fiumi, come nota Eliade 215. Rispetto agli altri serpenti, la biscia d’acqua riveste un ruolo piuttosto marginale nella favolistica antica, dove, come accade a molti altri animali, ha perso la carica simbolicoreligiosa che si riscontra nel mito. Lì, in particolare, troviamo la figura fantastica dell’idra della palude di Lerna: un mostro dalle numerose teste che Eracle uccide dopo un duro combattimento. Servio, nel suo commento all’Eneide di Virgilio (6,287), razionalizzando spiega che questo mostro era in realtà un luogo da dove usciva tanta acqua da distruggere la città vicina (ma l’eroe riuscì a fermarla). L’immagine del serpente custode delle fonti, peraltro, non è infrequente nel mito (così, ad esempio, il drago che divora il bambino narrato dal mitografo Igino [74]). Riguardo invece all’immagine del serpente in lotta, va precisato che non coinvolge solo la biscia d’acqua ma è ricorrente nel mito, dove si trovano combattimenti serrati tra dei e mostri dalle sembianze e dalla natura di serpenti (peraltro, i serpentidemoni sembrano precedere le divinità olimpiche, come suggerisce, tra gli altri, il caso di Pitone, custode dell’oracolo di Delfi: è ucciso da Apollo che s’impossessa dell’oracolo e prende il soprannome di Pizio). La lotta e lo stretto legame con le fonti d’acqua, elementi che caratterizzano così fortemente i serpenti nel mito, lasciano qualche traccia nella favola 117 Ch.: qui la biscia d’acqua (da notare anche il nome che la designa: hydrus in latino, ὕδρoς in greco) e la vipera si battono per conquistare una fonte, abitata in origine dalla biscia. Questo tipo di biscia non fa eccezione rispetto ai tratti generali del profilo
del serpente: nella favola 1,2 di Fedro (e così nella favola esopica 66 Ch.) è spietata e divora le rane che si sono rivolte a Giove per avere un re. In questo caso, si è anche supposto un riferimento a Seiano, il prefetto del pretorio dell’imperatore Tiberio, calato nei panni di Giove (Mandruzzato 22). Seiano è spietato accusatore del favolista latino che, come spiega nel prologo al suo terzo libro, subì un ingiusto processo, destinato a segnarlo per tutta la vita. Un personaggio di rara malvagità, dunque, come ci attestano anche altre fonti antiche. Da notare che in una favola indiana del Pañcatantra (terzo tantra, 10), troviamo il vecchio serpente Mandavisa che raggiunge il lago, si finge amico delle rane e si offre come loro cavalcatura, ma poi le divora. La vipera e la biscia d’acqua Esopo 117 Ch. Una vipera era solita andare a bere a una fonte. La biscia d’acqua, che abitava lì, glielo voleva impedire, per l’indignazione dovuta al fatto che quella non si accontentava del suo territorio, ma sconfinava. Poiché l’ostilità aumentava sempre di più, decisero di fare una battaglia e la vincitrice avrebbe ottenuto sia l’acqua sia la terra. Stabilito il giorno, le rane, che odiavano la biscia, andarono dalla vipera e la incoraggiarono, promettendole che avrebbero combattuto con lei. Cominciò la battaglia: la vipera e la biscia combattevano, mentre le rane, non potendo fare di più, emisero forti grida. E così la vipera, dopo la vittoria, le rimproverò perché, dopo la promessa di battersi insieme con lei, durante la lotta non solo non l’avevano aiutata, ma avevano cantato. Quelle allora le risposero: «Amica, sappi che la nostra alleanza non sta nelle braccia ma nella sola voce». La favola dimostra che il soccorso portato con le parole non serve a niente dove c’è bisogno di
braccia.
Borea Figlio di Eos e di Astreo, fratello di Zefiro e Noto, Borea è venerato come la divinità del vento del Nord, che segna la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno. Corrisponde al dio romano Aquilone. Viene rappresentato prima come un cavallo impetuoso e poi come uomo alato, barbuto e dotato di lunghe chiome. Lo onorano, in particolare, gli Ateniesi, che ritengono di essere stati da lui sostenuti nella guerra contro la flotta persiana di Serse. Borea compare in una sola favola di carattere mitologico (Esopo 73 Ch.), che lo vede soccombere nell’ambito di una contesa in cui gareggia con il Sole: alla fine, il potere della persuasione supera la forza della violenza, rappresentata dal vento. Nella versione di Aviano (4), si contrappone esplicitamente dal primo verso l’«impetuoso» Borea al «placido» Febo. La favola, fondata non sul confronto dialettico ma sui fenomeni naturali, sembra antica, come suggerisce un frammento di Sofocle, tramandato da Geronimo di Rodi e citato da Ateneo (13,82, 604f). Del resto, se l’opposizione violenza-persuasione, su cui si basa la favola, sembra un tema assai ricorrente nel V secolo a.C., nello specifico «Sofocle con l’epigramma si difenderebbe contro Euripide (che lo sbeffeggiava per essersi ritrovato con vesti non sue dopo un incontro erotico) rinfacciandogli il bacio avuto non dalla ragazza corteggiata, ma da Borea» (cfr. Jedrkiewicz 1989, 359). Insomma, il sole e il vento, che inducono a spogliarsi o a coprirsi, sono qui impiegati per suggerire due differenti situazioni amorose. Borea e il Sole Esopo 73 Ch. Borea e il Sole discutevano a proposito di chi
fosse il più forte. Decisero di assegnare la vittoria a chi di loro avrebbe spogliato un viandante. Allora Borea cominciò a soffiare con violenza; mentre l’uomo stringeva a sé il vestito, lo incalzava con maggiore forza. Sempre più tormentato dal freddo, il viandante si mise un vestito in più, finché Borea, esausto, passò l’uomo al Sole. Quest’ultimo, all’inizio, comincio a splendere in modo non eccessivo; quando però l’uomo si tolse il mantello supplementare che aveva indossato, rese più intensa la vampa, finché l’uomo, non riuscendo a resistere al calore, si svestì e andò a fare il bagno nel fiume che scorreva lì vicino. La favola dimostra che spesso è più efficace la persuasione della violenza. RIFERIMENTI: al di là del frammento di Sofocle citato da Ateneo (13,82,604f), cfr. Babrio 18; Aviano 4; Sintipa 55; Parafrasi 73; Dodecasillabi 73; Tetrastici 1,47; Plutarco, Precetti coniugali 139d; Temistio, Orazioni 16,208a; Agatia, Antologia Palatina 16,332; Demetrio Falereo, fr. 120 Wehrli.
Bovaro Nell’ambito dell’allevamento degli animali e del lavoro agricolo, la figura del bovaro sembra richiedere particolari caratteristiche. Secondo Columella (1,9), non basta essere svelti d’ingegno, ma sono anche necessari una voce forte e un aspetto imponente, tali da incutere timore negli animali. Del resto, chi ha a che fare con i bovini può correre rischi maggiori rispetto ad altre figure di allevatori, come i pastori: Eliano paragona il bue a un prigioniero sotto il giogo, che, quando si libera, spesso aggredisce il padrone (De natura animalium 4,35). Figure tipiche delle classi subalterne, i bovari, insieme agli altri personaggi legati all’agricoltura e all’allevamento, non mancano all’interno della tradizione favolistica. Spesso appaiono piuttosto semplici, non privi di sfumature comiche, e sono posti in relazione con la divinità, a cui puntualmente si rivolgono per recuperare beni o animali (cfr. Esopo 72 e 74 Ch.). In altre narrazioni li troviamo come personaggi secondari, nell’ambito di normali descrizioni di vita quotidiana (Fedro 2,8); talora la figura del bovaro sfuma in quella, più generica, dell’agricoltore (Fedro, App. 26 [28]). Il bovaro e il leone Esopo 74 Ch. Un bovaro, che conduceva al pascolo una mandria di tori, perse un vitello. Pur cercandolo in giro, non lo rintracciò, così promise a Zeus di sacrificargli un capretto, qualora avesse trovato il ladro. Dopo essere entrato in un bosco, l’uomo vide un leone che divorava il vitello: allora, colto da autentico terrore, levò le mani al cielo e gridò: «Signore Zeus, ti ho promesso il sacrificio di un capretto, nel caso avessi
trovato il ladro; ora, invece, sono pronto a sacrificarti un toro, se riesco a fuggire dalle grinfie del ladro». Questa favola potrebbe essere narrata per gli uomini sventurati, che, quando si trovano in difficoltà, pregano di trovare un rimedio, ma, una volta che l’hanno trovato, cercano di evitarlo. RIFERIMENTI: in alcune versioni cambia l’animale smarrito (toro o pecora). Cfr. Babrio 23; Sintipa 12; Parafrasi 74.
Bue Il bue, insieme con il toro, assume numerosi significati simbolici presso i popoli del Mediterraneo, soprattutto in relazione al lavoro dei campi. «Animale polivalente, ma usato soprattutto come lavoratore, il bue viene raffigurato mentre ara, miete, trebbia, trasporta carichi, tira carri» (Cooper 62); è simbolo, dunque, di forza e di fatica, di pazienza e di sacrificio. Esistono diverse attestazioni dello stretto rapporto tra l’uomo e l’animale, che è presente anche nelle liturgie rituali: l’ecatombe, ricordata anche nella favola esopica 55 Ch., è il sacrificio di cento buoi agli dei. Questo animale è al centro anche di ricorrenze consolidate: ogni anno ad Atene, nell’ambito delle feste Dipolie, in onore di Zeus Polieo, si tenevano le Bufonie, una cerimonia in cui alcuni buoi venivano condotti presso un altare e il primo che si avvicinava veniva sacrificato con una scure. I bovini, la cui figura è fondamentale anche nei miti di fondazione, sono, tra l’altro, associati alle divinità, in Egitto (culto di Api) come in Grecia. In Omero, ad esempio, a Era è attribuito l’epiteto «dagli occhi di bue», per indicarne l’intensità dello sguardo. Coerente con la cultura greca e romana il valore simbolico del bue secondo i cristiani: è emblema dell’evangelista Luca e, in generale, rappresenta non solo forza, ma anche mitezza, sacrificio (di qui il collegamento al sacrificio di Cristo). Nelle favole il bue è certamente un personaggio secondario: appare per lo più aggiogato, intento al lavoro dei campi o al trasporto. Così, ad esempio, nella favola 70 Ch.: i buoi, impegnati a tirare un carro, litigano con l’asse delle ruote, che stride perché tutta la fatica del trasporto ricade in realtà su di loro, che non si lamentano. Troviamo immagini simili anche nelle raffigurazioni del mito: a Pompei Bacco e Arianna vengono rappresentati sul carro trionfale condotto da buoi. Peraltro, la figura dell’animale emerge già nella letteratura mesopotamica, dove troviamo una tenzone con il
cavallo che rimprovera al bue la sua schiavitù (v. Introduzione). In generale, nella cultura greca «bue» è metaforicamente detto delle persone stolte (Thesaurus Linguae Grecae, 1833, vol. II, col. 375). Anche in Esopo l’animale non spicca mai per particolare valore: nella favola 71 Ch. si vede il leone sbranare tre buoi. A volte, però, il bue si segnala per l’imponenza della mole e per la forza. In una favola eziologica, la 139 Ch., si spiega che gli animali un tempo cedettero parte dei propri anni all’uomo; l’uomo così riuscì ad allungare la sua vita, in origine assai breve. Nell’età adulta, che corrisponde agli anni sottratti al bue, gli uomini sono «atti a comandare». La favola 358 Ch., invece, presenta la vicenda della pulce e del bue. La pulce sottolinea la grandezza e la forza del bue (di qui forse si può anche spiegare meglio il parallelo con l’uomo in età adulta) ma ne evidenzia, allo stesso tempo, il suo vivere in schiavitù. In effetti, l’idea del bue come animale asservito all’uomo è ricorrente nella tradizione greca, ma viene completamente ribaltata nella favolistica romana. Nella letteratura latina il bue va a simboleggiare la ricchezza e il potere: ne troviamo traccia già nelle commedie plautine (Brind’Amour 1976, 25 ss.): ad esempio in Poenulus 597 s. In Plauto è anche presente un ampio motivo favolistico (Aulularia 226 ss.), riassumibile nell’espressione, divenuta proverbiale, «Passare dagli asini ai buoi» (v. sotto). Il poeta comico, sintetizzando efficacemente il percorso di avanzamento sociale da un ceto umile a uno elevato, evoca l’immagine di un asino che si unisce al bue, ma non riesce a sostenere un uguale peso: allora rischia di finire nel fango e di essere disprezzato. Sembra chiaro un collegamento con le favole 142 Ch. e, specialmente, 141 Ch.: in entrambe le narrazioni l’asino è simbolo del povero e il cavallo del ricco e potente. Appare allora evidente la sostituzione, in favole del tutto simili, del cavallo (in ambito greco) con il bue (in ambito romano). Va rilevato che asino e bue appaiono insieme nella favola 55 di Babrio, ma non se ne trae una morale simile a quelle di Plauto. Ancora in prospettiva favolistica, si ha un’ulteriore
prova della tendenza anche nella nota favola della rana che si gonfia per imitare il bue (motivo assente nelle collezioni anonime ma presente in Orazio, Fedro e Babrio). In particolare, Orazio (Satire 2,3,314 ss.) associa il vitello (una scelta finalizzata certamente a ingentilire il riferimento: cfr. Della Corte 1986, 91) nientemeno che a Mecenate, suo protettore, oltre che amico di Augusto: una figura esemplare di persona potente. Lo stesso fa Fedro nella favola 1,24, dove la rana rappresenta il povero e il bue il potente. Anche questo motivo favolistico conferma, dunque, il rovesciamento dei codici culturali: fatto molto raro nella tradizione esopica greco-romana. I buoi e l’asse Esopo 70 Ch. Dei buoi trainavano un carro. Poiché l’asse delle ruote strideva, si girarono e gli dissero: «Ehi, caro, mentre noi sosteniamo tutto il peso, tu ti lamenti?». Così anche alcuni degli uomini cercano di dare l’impressione di essere esausti, mentre sono altri ad affaticarsi. RIFERIMENTI: cfr. Babrio 52; Parafrasi 70; Dodecasillabi 70; Tetrastici 2,10; Ierocle, Facezie 48. I tre buoi e il leone Esopo 71 Ch. Tre buoi pascolavano sempre insieme. Un leone, che voleva mangiarli, non riusciva nel suo scopo a causa della loro concordia. Ma, seminando zizzania con discorsi perfidi, riuscì a separarli l’uno dall’altro: allora, trovandoli isolati, li divorò uno alla volta. Se
vuoi vivere del tutto senza pericoli, non prestare fede ai nemici, ma dai ascolto agli amici e conservali. RIFERIMENTI: si rileva anche la variante dei tori al posto dei buoi. Cfr. Babrio 44, Aftonio 16, Aviano 18, Parafrasi 71, Tetrastici 1,11, Sintipa 13, Temistio, Orazioni 22,278c-279a. La pulce e il bue Esopo 358 Ch. Un giorno la pulce chiese al bue: «Perché, grande e forte come sei, servi ogni giorno gli uomini, mentre io pungo impietosamente le loro carni e bevo in abbondanza il loro sangue?». Il bue rispose: «Non sono ingrato nei confronti della stirpe degli uomini: essi mi amano e mi trattano con affetto: spesso mi grattano anche la fronte e le spalle». La pulce allora disse: «Per me, disgraziata, questo sfregamento che ti procura tanto piacere è una sciagura terribile, quando mi capita per caso di finire nelle loro mani». I fanfaroni sono confutati anche da una persona semplice. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 359. La rana e il bue Fedro 1,24 Il povero, quando vuole imitare il potente, va in rovina. In un prato una rana vide un bue e, colta da invidia per una così grande stazza, gonfiò la sua rugosa pelle: allora chiese ai suoi piccoli se fosse più grande del bue. Loro dissero di no. Tese nuovamente
la pelle e allo stesso modo chiese chi fosse più grande. Loro dissero: «Il bue». Alla fine, furiosa, volendo gonfiarsi con ancor più energia, finì per scoppiare. RIFERIMENTI: la favola è assente nelle collezioni anonime, ma è presente in Orazio (Satire 2,3,314 ss.), che associa il vitello a Mecenate, e in Babrio 28. Le due versioni più note, quella di Orazio e di Fedro, presentano una differenza significativa: nel primo caso la rana vuole uguagliare il bue, nell’altro persino superarlo (una caduta di gusto di Fedro, secondo i critici). Nella favola fedriana, che parte nel promitio da una sentenza di Publilio Siro, la drammatica conclusione rende chiaro come sia primario per l’autore sottolineare con forza la prospettiva morale. Il motivo è presente anche in Tetrastici 1,42, Pseudo-Plutarco, Pro nobilitate 21 (VII p. 278 Bern.), Romulus 50. Esistono inoltre allusioni di natura proverbiale in ambito romano (vedi sotto): Petronio 74,13; Marziale 10,79,9. Il bue e l’asino Plauto, Aulularia 228-235 Ora, se ti dessi in sposa mia figlia, mi viene in mente che tu saresti il bue, mentre io sarei l’asinello: una volta che sia diventato tuo parente, nel momento in cui non potessi sopportare come te il peso, io, l’asino, mi ritroverei nel fango; tu, il bue, non mi degneresti di uno sguardo, come se non esistessi, e mi troverei inferiore nei tuoi confronti e i miei pari mi deriderebbero. Nel caso poi di una separazione, non troverei da nessuna parte un rifugio sicuro: gli asini mi farebbero a pezzi con i loro morsi, i buoi mi prenderebbero a cornate: è davvero un grande
pericolo passare dagli asini ai buoi. RIFERIMENTI: Esopo 141 Ch.; 142 Ch. (vedi sopra per le differenze); Babrio 55; Romulus 41; Parafrasi 143. I buoi e i macellai Babrio 21 Una volta i buoi decisero di uccidere i macellai, poiché esercitano un mestiere molto ostile a loro. Si riunirono e affilarono le loro corna per l’imminente battaglia. Tra di loro c’era un bue anziano, che aveva arato una grande quantità di terra nella sua vita. Questo bue disse agli altri: «I macellai ci tagliano con mani esperte e ci uccidono senza tormento inutile; invece, caduti nelle mani di uomini inesperti, moriremo due volte. Certo ci sarà sempre qualcuno in grado di macellarci, anche se ci liberiamo dei macellai!». [Chi è desideroso di fuggire un pericolo imminente, deve fare attenzione a non finire in una situazione peggiore]. Il vitello e il bue Aviano 36 Un bel vitello, non ancora sfiorato nel collo dal giogo, saltellando in giro, aveva visto un bue che dissodava continuamente i campi. «Oh, non ti fa vergogna – disse il vitello – portare un laccio intorno al vecchio collo e non poter conoscere riposo, dopo esserti tolto il giogo, mentre a me è possibile circolare a mio piacere sulle distese d’erba e, di nuovo, mi è permesso andare in cerca dell’ombra dei
boschi?». L’anziano bue, tuttavia, che non si era adirato per quelle parole, pur affaticato, continuava a rivoltare la terra col vomere, finché gli fosse permesso di deporre l’aratro e adagiarsi mollemente sul letto erboso. Subito vede il vitello, legato e condotto verso l’altare sacrificale, avvicinarsi al coltello del sacerdote. «Ti dà questa morte – osserva il bue – la funesta indulgenza che ti ha risparmiato il nostro giogo: sarà meglio dunque sopportare fatiche, per quanto pesanti esse siano, che godere in giovane età di un riposo destinato presto a finire.» Questa è la sorte degli uomini: a coloro che vivono felici è data una morte prematura, mentre una lunga vita impera sugli infelici. RIFERIMENTI: la versione di Aviano è ampliata rispetto alle precedenti. Si vedano anche Esopo 92 Ch., Babrio 37, Parafrasi 92, Dodecasillabi 92. In ambito cristiano, interessante la versione, peraltro molto diversa, di Gregorio Nazianzeno Carmina dogmatica, MPG 37,436. PROVERBI Ab asinis ad boves transcendere Passare dagli asini ai buoi L’espressione plautina (Aulularia, v. 235: vedi sopra) è di natura proverbiale e ha a che fare con la prospettiva della scalata sociale dovuta a un matrimonio. Si riscontra in diversi paremiografi greci, dove si nota, sia pure con sfumature differenti, quasi sempre lo stesso significato, nonostante la sostituzione del bue con il cavallo. Questo si deve al codice culturale romano, che assegna all’animale una dignità simile a quella del cavallo nella cultura greca. Nella favola 76 di Babrio (da cui Esopo 142 Ch.) si trova un cavallo che, dopo la guerra, è costretto ai più umili e pesanti lavori e
non è più idoneo al combattimento; allora chiede al suo padrone: «Tu, dopo avermi fatto passare da cavallo ad asino, come mi riporterai da asino a cavallo?». Il proverbio si presenta sostanzialmente in due forme. La prima, la più diffusa, sottolinea il passaggio dalla ricchezza alla povertà (cavallo-asino): così, ad esempio, in Zenobio 2,33; Diogeniano 1,96; l’altra propone il percorso contrario (asinocavallo) e significativamente viene ripresa dagli stessi paremiografi (Zenobio 2,5; Diogeniano 1,94 e altri). Tosi 1991, 357 rileva come il proverbio, anche se con alcune significative variazioni, abbia seguito e fortuna nelle letterature moderne.
C
Cacciatore La caccia affonda le sue origini nel mito: il centauro Chirone la apprende da Artemide (Diana a Roma, casta dea della caccia) e Apollo (Mercurio), insegnandola poi, tra gli altri, anche a Eracle. In Omero troviamo diverse modalità di caccia: da quella al cinghiale, effettuata con i cani, a quella agli uccelli (Odissea 19,428 ss.; 12,330 ss.). Se in origine la caccia e la raccolta sono le più diffuse forme di sussistenza, questa pratica diventa progressivamente un elemento complementare alle attività agricolo-pastorali. Tra gli altri, Senofonte osserva questa utile complementarietà (Economico 5,5). Ma, come testimonia lo stesso Senofonte in un’opera dedicata alla caccia (Cinegetico), l’arte venatoria è uno strumento molto utile nell’educazione dei cittadini (questo vale in particolare per l’aristocrazia e si verifica anche presso altri popoli: nella Ciropedia il re dei Persiani Ciro comincia a dimostrare, da giovane, il suo coraggio proprio nella caccia). Platone critica la caccia dei volatili e tecniche come l’uso delle reti e delle trappole, mentre elogia la caccia a cavallo e con i cani: il cacciatore non deve mirare al guadagno (Leggi 823b). Aristotele conferma una valutazione positiva della caccia, tra le attività naturali, come l’agricoltura e la pastorizia (Politica 1258). Presso i Romani, la caccia si afferma come pratica sportiva, utile al corpo e allo spirito: Cicerone, che distingue la caccia dall’uccellagione, la considera un possibile svago anche nella vecchiaia (De senectute 16,56). Non mancano tuttavia valutazioni di segno diverso, che ridimensionano la dignità della caccia (è mansione da schiavi per Sallustio, La congiura di Catilina 4,1). La caccia, nel mondo esopico, «non è l’unico mezzo di sostentamento, bensì un’attività collaterale rispetto all’agricoltura e alla pastorizia» e sembra avere insomma «la funzione di sport, come oggi» (Pugliarello 1973, 147). La
figura del cacciatore, sia di uccelli sia di animali di terra, è spesso presente e può trovarsi accostata a figure affini, come quella del pescatore (Babrio 61). L’uomo pare avere a disposizione diversi strumenti di caccia, come l’arco (v. ARCIERE), le reti (cfr. Esopo 284 Ch.), il vischio e le canne (Esopo 137 Ch.); può anche prendere al laccio gli uccelli (Esopo 169 Ch.). Al fianco del cacciatore troviamo alcuni animali, che possono essere usati nella funzione di esche, come le colombe domestiche e le pernici. Ma è soprattutto importante la collaborazione dei cavalli (Esopo 328 Ch.) e dei cani, che aiutano l’uomo a catturare la preda (Fedro 5,10). Nell’uso e nella trattatistica antica esiste una precisa classificazione dei cani, sulla base del loro impiego (i venatici, ossia quelli destinati alla caccia, sono allevati diversamente da quelli dei pastori o da quelli da guardia impiegati nelle fattorie). Quanto alle prede, oltre ovviamente alla lepre, al cervo, al cinghiale e a numerosi tipi di volatili (tordi, pernici, gru, cicogne, allodole), si segnala anche la caccia al leone, che sembrerebbe rimandare a un’epoca anteriore, caratterizzata da un’economia venatoria: in realtà è coesistente all’attività agricola. A questo proposito, nella tradizione favolistica troviamo due comportamenti antitetici: l’uomo pauroso finge di cacciare il leone, quando in realtà ne ha una enorme paura (Esopo 93 Ch.); l’arciere infallibile incute in tutti gli animali un senso di timore, eccetto che nel leone; la belva tuttavia deve soccombere. Una volta catturato, il re degli animali può essere umiliato e finire legato a un albero con una fune, come una sorta di trofeo (cfr. Esopo 206 Ch.). Lo stesso leone, oltre che vittima, è naturalmente il principale attore della caccia che si realizza nel microcosmo degli animali, spesso in associazione con bestie meno nobili (cfr. Esopo 208 Ch.). Il cacciatore pauroso e il taglialegna Esopo 93 Ch.
Un cacciatore era sulle tracce di un leone; allora chiese a un taglialegna se avesse visto il percorso dell’animale e dove avesse la tana. «Ti mostrerò – disse l’altro – addirittura il leone stesso». Impallidito per la paura, battendo i denti, il cacciatore disse: «Ma io cerco solo la pista, non il leone». La favola punta l’indice contro quelli che sono coraggiosi e vigliacchi, ossia quelli che mostrano audacia a parole ma non nei fatti. RIFERIMENTI: Babrio 92; Parafrasi 93; Tetrastici 1,26. Il cacciatore e l’uomo a cavallo Sintipa 49 Un cacciatore catturò una lepre e se la stava portando via: tornò, dunque, sulla sua strada, quando incontrò un uomo a cavallo che gli chiese l’animale, fingendo di volerlo comprare. Ma, presa la lepre dal cacciatore, subito il cavaliere tagliò la corda, fuggendo al galoppo. Il cacciatore, andandogli dietro di corsa, credeva proprio di riuscire a raggiungerlo. Tuttavia, dopo che il cavaliere riuscì a distanziarlo di molto, il cacciatore, contro la sua reale volontà, gli urlò: «Vai pure: la lepre è un mio dono». La favola dimostra che molti, quando si vedono sottrarre i beni contro le loro intenzioni, fingono che si tratti proprio di doni volontari. RIFERIMENTI: Tetrastici 1,24. Il cane vecchio e il cacciatore Fedro 5,10
Un cane pieno di vigore, che aveva sempre soddisfatto il suo padrone contro tutti i veloci animali selvatici, cominciò a indebolirsi sotto il peso degli anni. Una volta, spinto a combattere contro un irsuto cinghiale, gli azzannò un orecchio, ma a causa dei denti cariati dovette lasciare la preda. Allora, il cacciatore, contrariato, rimproverò il suo cane. Il vecchio cane gli rispose, latrando: «Non ti ha abbandonato il mio coraggio, ma le mie forze. Devi elogiare ciò che sono stato, se ora critichi ciò che sono». Capisci bene, o Fileto, perché ho scritto questa favola. NOTA: Si legge latrans contra senex anziché senex contra Lacon (v. 7). RIFERIMENTI: Romulus 32. Il cacciatore di uccelli e la pernice Esopo 285 Ch. Un cacciatore di uccelli, non avendo nulla da offrire a un ospite che gli fece visita a tarda sera, andò a prendere la sua pernice domestica, con l’idea di sacrificarla. La pernice prese ad accusarlo di essere un ingrato, dal momento che egli aveva spesso ricevuto molto aiuto da lei, che richiamava gli uccelli della sua stirpe e glieli consegnava, mentre ora lui la stava per uccidere; allora il cacciatore rispose: «Un motivo in più per ucciderti, se tu non risparmi nemmeno i tuoi simili». La favola dimostra che i traditori dei parenti non solo sono odiati da coloro che subiscono violenza, ma anche da coloro a cui consegnano le vittime.
RIFERIMENTI: Babrio 138; Tavolette Assend. 5; Sintipa 26; Parafrasi 301; Dodecasillabi 301; Tetrastici 2,30 (a-b). Cfr. anche Eschilo, Supplici 226.
Calzolaio Il calzolaio, come le altre figure di artigiani, generalmente non assume una caratterizzazione positiva nel mondo grecoromano (v. ARTIGIANO). In coerenza con questa prospettiva, la favolistica lo indica come il più falso tra gli artigiani, a causa del veleno portato da Hermes (Esopo 111 Ch.). Anche Fedro, nell’ambito di una narrazione di origine probabilmente ellenistica, lo descrive come abile negli inganni: si trasforma in un falso medico e fa fortuna, contando sulla stoltezza del popolo, ma poi viene smascherato (1,14). Questa narrazione può avere qualche attinenza con un proverbio secondo cui il calzolaio non deve giudicare qualcosa al di sopra della calzatura (cfr. Tosi 1991, 257). Esistono, a questo proposito, aneddoti di varia provenienza: il pittore Apelle rimprovera, riportandolo alle sue limitate competenze, un calzolaio che prima lo critica con ragione per la rappresentazione di una scarpa, ma poi, inopportunamente, estende le sue osservazioni al resto del dipinto (Plinio, Naturalis historia 35,85; Valerio Massimo 8,12 ext. 3). Una storia simile vede protagonista il citarista Stratonico e il calzolaio Minnaco, che si permette di fare obiezioni di carattere musicale (Ateneo 8,351a). Insomma, non è bene che il calzolaio esca dalle sue competenze. Da calzolaio a medico Fedro 1,14 Un calzolaio incapace, finito in miseria, aveva cominciato a esercitare l’arte medica in una località dove non era conosciuto e andava vendendo un antidoto spacciato con un falso nome; così divenne famoso grazie alle sue astute chiacchiere. Allora il sovrano della città, costretto a letto e logorato da
una grave malattia, per metterlo alla prova, chiese una coppa; quindi, versata dell’acqua, simulando di mescolare una dose di veleno insieme al suo antidoto, gli ordinò di berlo tutto, con la promessa di un premio. A quel punto, temendo la morte, il calzolaio confessò di avere conquistato la fama di medico non per una qualche conoscenza di quest’arte, quanto piuttosto per la stoltezza del popolo. Il sovrano convocò il popolo in assemblea e così parlò: «Ma quanto siete sciocchi? Ne avete consapevolezza voi, che non avete incertezza nell’affidare le vostre teste a uno a cui nessuno ha dato i propri piedi da calzare?». Direi che questa narrazione riguarda appunto coloro la cui stoltezza costituisce un guadagno per gli impudenti.
Cammello Il cammello, animale addomesticato a partire dalla metà del III millennio a.C., presenta due specie, entrambe di provenienza orientale: quella a una gobba (ossia il dromedario, tipico dell’Arabia e dell’Africa mediterraneosahariana) e quella a due gobbe, ossia il cammello di Battriana (all’incirca l’attuale Afghanistan), tipico di una fascia che va dall’Armenia e dall’Iraq fino all’Estremo Oriente. Si tratta di un animale importante per l’uomo: fornisce cibo, pelle, latte; i suoi peli sono impiegati nella produzione di vestiti. In molte culture diventa simbolo di obbedienza. Estraneo al mito classico, non è però sconosciuto in Grecia: il re di Sparta Agesilao ne importa diversi esemplari all’inizio del IV secolo a.C. I cammelli sono impiegati sia come animali da soma sia in guerra: il re persiano Ciro li usa contro i Lidi, perché la loro vista e il loro odore atterriscono i cavalli (Erodoto 1,80). L’etimologia del nome «dromedario» si riferisce all’estrema velocità della corsa (dromos), che impressiona gli antichi (Curzio Rufo 5,2,5). Eliano riferisce una serie di singolari notizie riguardo a questo animale: è pudico, perché si apparta quando si accoppia (De natura animalium 6,60); rifiuta decisamente l’incesto: a questo proposito, si racconta la storia di un cammello che uccise un cammelliere perché lo aveva costretto a unirsi a sua madre, quindi l’animale si suicidò, gettandosi in un burrone (3,47). Anche in altre culture la sua figura è oscillante: animale impuro, nell’Antico Testamento (Levitico 11,4; Deuteronomio 14,7), il cammello è citato nei Vangeli e nei Padri della Chiesa: qui diventa simbolo positivo, di pazienza e di mitezza; addirittura di Cristo, definito, con un’immagine ardita, il «grande cammello» (cfr. Agostino, Esposizioni sui Salmi 51,15; Questioni sui Vangeli 2,47). Ma non manca nemmeno (v. proverbio sotto) una tradizione differente, meno benevola, che si traduce ad
esempio nell’immagine, propria anche della favolistica, di animale goffo e ridicolo. Il cammello, in effetti, non si distingue per particolare valore nelle favole esopiche: dalle numerose narrazioni di cui è protagonista scaturisce il profilo di un animale eccessivamente mite, piuttosto sgraziato e non molto intelligente. Nella favola 145 Ch. è ritenuto inadatto a regnare sugli animali perché «non sa adirarsi contro gli iniqui». Gli antichi percepiscono il paradosso, riscontrato anche per l’elefante, che deriva dallo scarso coraggio contrapposto alle enormi dimensioni. Quando fu visto per la prima volta – racconta Esopo (148 Ch.) – il cammello terrorizzò l’uomo; ma, dopo che lo conobbero, lo affidarono alla guida dei bambini. L’imponente mole, peraltro, è funzionale alla struttura di altre favole: in una narrazione medievale derivata da Fedro (Romulus 92) l’animale, la cui figura è rielaborata in chiave positiva, è contrapposto alla pulce, simbolo invece di ciò che è irrilevante (v. PULCE). Pur con uno scopo e in un contesto differente, la narrazione si basa sullo stesso contrasto simbolico (grande-piccolo) che ispira il detto evangelico del cammello che passa per la cruna dell’ago (cfr. Matteo 19,24, anche se il passo è suscettibile di diverse interpretazioni). Un’altra caratteristica è l’invidia, del tutto puerile, nei confronti ora del toro (146 Ch.), per le sue belle corna, ora della scimmia (306 Ch.), per l’abilità nella danza. In tutte le situazioni, tuttavia, il cammello si mette nei guai e viene inesorabilmente punito. In particolare, nella prima narrazione che trova ampia fortuna nella letteratura classica, con numerose allusioni anche al di fuori della tradizione favolistica, è punito da Zeus. La scarsa grazia ne fa una figura comica, al punto che l’immagine del cammello che balla diventa proverbiale per indicare un’azione assurda e grottesca (v. proverbio sotto). In una breve favola di Babrio (8), lo troviamo associato all’Arabo. Nel caso specifico, verrebbe pertanto da pensare al dromedario. L’associazione simbolica del cammello con l’Oriente si riscontra, del resto,
anche nella tradizione cristiana: nell’iconografia, ad esempio, i Magi vengono spesso raffigurati insieme all’animale. Il cammello che ballava Esopo 147 Ch. Un cammello, costretto dal suo padrone a ballare, disse: «Figurarsi! Non sono solo sgraziato a ballare, ma anche a camminare». La favola è raccontata riguardo a tutte le azioni sconvenienti. RIFERIMENTI: Babrio 80; Dodecasillabi 148. Cfr. anche Adrados 2003,185 che sostiene una derivazione archilochea. Il cammello visto per la prima volta Esopo 148 Ch. Quando il cammello fu visto per la prima volta, gli uomini, presi da paura, anzi da terrore, per la sua mole, si diedero alla fuga. Ma quando, tempo dopo, si resero conto che era un animale mite, presero coraggio fino al punto che gli si avvicinarono. Quando, poco alla volta, si resero conto che questo animale non riesce a adirarsi, arrivarono a un tale disprezzo che, mettendogli intorno al collo delle briglie, lo diedero da condurre ai bambini. La favola dimostra che l’abitudine ridimensiona quanto ci incute timore. Il cammello che fece i suoi bisogni in un fiume Esopo 144 Ch.
Un cammello attraversava un fiume dalla rapida corrente. Dopo aver fatto i propri bisogni, notò davanti ai suoi occhi gli escrementi, subito trasportati dalla velocità del flusso delle acque; perciò disse: «Che è questo? Vedo ora passare davanti a me quanto era dietro di me». La favola è adatta a uno Stato nel quale detengono il potere gli ultimi e gli stolti invece che i primi e i saggi. RIFERIMENTI: Babrio 40; Parafrasi 145. Il cammello e Zeus Esopo 146 Ch. Un cammello, dopo aver visto un toro orgoglioso delle sue corna, essendo pieno di invidia, desiderò anch’egli averne di simili. Perciò andò da Zeus e lo supplicò di fornirgli le corna. D’altra parte, Zeus, sdegnato nei suoi confronti perché non era soddisfatto per la grandezza del corpo e per la forza, ma era desideroso di avere ancora di più, non solo non gli diede le corna, ma gli tolse anche una parte delle orecchie. Così molti che invidiano gli altri a causa della loro avidità senza accorgersene perdono le proprie qualità. RIFERIMENTI: Aftonio 15; Aviano 8; Sintipa 59; Parafrasi 147; Dodecasillabi 147; Tetrastici 1,13. Favola assai nota: lo deduciamo dalle numerose allusioni. Cfr. Teone, Esercizi preparatori 3; Libanio, Declamazioni 31,43; Luciano, Icaromenippo 10. La scimmia e il cammello Esopo 306 Ch.
Durante un’assemblea degli animali, una scimmia si alzò e si mise a ballare. Poiché riscosse molto successo e suscitò l’attenzione di tutti gli animali, un cammello, invidioso, volle ottenere lo stesso consenso. Perciò si alzò e provò anche lui a ballare. Tuttavia, poiché assunse molti strani atteggiamenti, gli animali, irritati, lo cacciarono a bastonate. La favola è adatta a coloro che per l’invidia vogliono competere con chi è più dotato di loro. RIFERIMENTI: cfr. Archiloco, frr. 185-187 W. , accostabile anche alla favola 38 Ch. 2
PROVERBI Camelum vidimus saltitantem Abbiamo visto un cammello ballare Come nella favola, l’immagine è paradigmatica di una situazione assurda e grottesca, perché il cammello è considerato un animale assai goffo nei movimenti. Questo modo di dire si ritrova in Girolamo (Adversum Helvidium 18,226). Come nota Tosi 1991, 54, presenta paralleli curiosi: ad esempio, tra le «maschere del carnevale tedesco si ha il cammello sui trampoli».
Cane Il rapporto tra l’uomo e il cane è antichissimo (si registrano attestazioni fin dal mesolitico) e la sua domesticazione precede quella degli altri animali. Impiegato nella caccia e nella pastorizia, ma anche come guardiano e persino in guerra (Plinio, Naturalis historia 8,61), questo animale tende, infatti, al commensalismo con l’uomo e ne diventa presto il più fedele alleato. La letteratura offre significativi esempi, a partire da Argo, che muore dopo avere finalmente rivisto il suo padrone (Odissea 17,326 ss.); sono numerosi i racconti di cani che preferiscono rinunciare alla vita, per il dolore dovuto alla morte del padrone (cfr. Plinio, Naturalis historia 8,142 s.). Questo rapporto, costituito insieme di affetto e di subalternità nei confronti dell’uomo, non esclude elementi negativi; già nell’Iliade l’animale viene giudicato sullo stesso piano di lupi e sciacalli: si ciba dei cadaveri dei nemici e l’accostamento a esso ha il valore di un insulto (1,4; 1,225), secondo una consolidata tradizione letteraria (cfr. Otto 68 ss.). Il cane è anche l’animale simbolo del cinismo, movimento filosofico che ha un notevole influsso sulla tradizione favolistica: secondo la tradizione, Diogene (v.) definisce se stesso «il cane» perché scodinzola con chi gli offre qualcosa, abbaia a chi non gli dà nulla e morde i ribaldi. Interessante appare l’elaborazione della figura di questo animale nella sfera religiosa e mitologica. Le diverse tradizioni che si sviluppano nell’antichità lo vedono ora gradito agli dei (come testimonia Eliano, De natura animalium, custodiva il tempio di vari dei, fra cui Asclepio – 7,13 – e Atena – 11,5; lo stesso accadeva a Roma, presso il tempio di Iuppiter custos sul Campidoglio: Gellio 6,1,6), ora legato a cerimonie agricole, ora considerato animale impuro (non poteva entrare nel tempio di Apollo a Delo; Plutarco, Questioni romane 290a testimonia la proibizione a Roma per un sacerdote, il flamine di Giove, di toccare un cane o
pronunciarne il nome), ora implicato in sacrifici e riti catartici, visto il suo rapporto con il regno dei morti. Del resto, «il cane è psicopompo cioè conduce le anime attraverso la notte della morte: presso gli Egizi era Anubi e Thot, presso i Greci e i Romani poteva essere Ecate o Hermes (Mercurio) oppure Cerbero», il cane custode dell’Ade (Maspero 64). Probabilmente, occorre risalire a epoche remote per inquadrare nella dimensione corretta il contrasto tra amicizia e repulsione che caratterizza il rapporto tra uomo e cane: già da quei tempi «dovette instaurarsi un mitico rapporto tra l’uomo e il cane, poiché questi sentimenti dalla realtà si trasferirono nelle pratiche religiose, estrinsecandosi in diverse credenze e cerimonie»: di qui l’ambiguità che si riflette di conseguenza anche nella tradizione favolistica (Pugliarello 1973, 81). La figura del cane è infatti oscillante. Spesso è descritto come fedele amico dell’uomo, abile a prevenire le insidie del ladro (Fedro 1,23); la sua condizione domestica di schiavitù diventa anche un motivo di rimprovero da parte del lupo, che è simbolo invece dell’amore per la libertà (Esopo 226 Ch.): la favolistica gioca, tra l’altro, sulla comune origine tra lupi e cani, che si assomigliano «in tutto», eppure sono su fronti opposti (Esopo 216 Ch). Il servizio più frequente del cane è quello svolto a difesa del gregge (v. PECORA), con lo scopo di prevenire le aggressioni del lupo (cfr., tra le tante favole sul tema, Esopo 217 Ch.). Ma l’animale fedele si muta in malvagio calunniatore, quando, in Fedro 1,17, si accorda con il lupo, facendo condannare con una falsa accusa chi dovrebbe difendere, cioè la pecora; le menzogne e gli inganni si rivolgono persino contro i suoi stessi simili: una cagna raggira un’altra cagna, peraltro benefattrice nei suoi confronti (Fedro 1,19). Tra i vizi del cane, emergono l’avidità, nell’ambito di una favola probabilmente di origine orientale (Fedro 1,27; v. AVVOLTOIO), la pigrizia e la tendenza a una vita da parassita (Esopo 345 Ch.), l’ingordigia, che lo spinge non solo a mangiare una
conchiglia, per poi soffrire atrocemente (Esopo 181 Ch.), ma anche a tentare di bere l’acqua di un fiume per raggiungere alcune pelli (Esopo 176 Ch.) o a tuffarsi, vedendo riflessa la propria immagine e pensando di poter raggiungere quello che in realtà non esiste (Esopo 185 Ch.). Curiosamente, questa narrazione appartiene anche ad altre tradizioni culturali: in Africa, nel repertorio favolistico dei Bangwa, troviamo un cane che perde il suo osso, secondo una stessa, esplicita, morale che condanna i golosi. Nemmeno nella tradizione indiana del Pañcatantra manca il motivo narrativo dell’inganno causato da un’immagine riflessa nell’acqua (il contesto, però, è differente; in questo caso, è il leone il protagonista: primo tantra, racconto sesto). Un altro elemento accolto in modo negativo dalla favolistica è l’abbaiare del cane, «percepito come un suono poco armonioso, nemico delle Muse» (Franco 2007, 51): forse su questo presupposto si basa la favola dei cani musicisti (Dione Crisostomo 32,66). Del resto, lo stesso Esopo rivolge parole salaci a una cagna che abbaia in modo insolente (Aristofane, Vespe 1401 ss.: nella commedia, la storiella serve a offendere indirettamente una fornaia). Vista l’oscillazione della sua immagine presso gli antichi, non può mancare l’ambiguità tra le caratteristiche del cane. La lepre, catturata, viene mordicchiata e leccata, al punto che non capisce se le intenzioni del cane sono benevole o ostili (Esopo 182 Ch.). Ma il cane si segnala anche per qualità rilevanti, come l’accortezza, che lo aiuta a prevenire le insidie del coccodrillo (Fedro 1,25), e il coraggio: il cacciatore si dimostra ingeneroso, quando, pur vecchio e abbandonato dalle forze, l’animale non rinuncia a adempiere al suo dovere contro il temibile cinghiale (Fedro 5,10; ma se la dà a gambe al solo ruggito del più forte leone: Esopo 187 Ch.). Oltre a fare la guardia e proteggere il gregge, il cane gioca un ruolo importante nella caccia, anche se il rapporto con l’uomo non è sempre facile (v. CACCIATORE), mentre la sua relazione con gli dei è descritta secondo l’abituale schema narrativo degli animali che mandano un’ambasceria
a Giove. L’obiettivo è reclamare un migliore trattamento da parte degli uomini (Fedro 4,18 [19]), ma, poiché defecano di fronte allo stesso re degli dei, i cani vanno incontro a un’inevitabile punizione. Questa immagine, collocata in una favola dagli accentuati connotati comici, forse di impronta cinica, si ricollega all’idea, come si è notato assai diffusa, dell’impurità di questo animale. Del resto, la contiguità con gli escrementi è attestata anche in Fedro 1,27, dove il cane è definito «concepito in un trivio e cresciuto nello sterco». Particolare rilievo ha il ruolo della cagna, in perenne lite con la scrofa, che discute con lei circa la fecondità di entrambe (Esopo 342 Ch.) e la accusa di essere puzzolente da viva e da morta (Esopo 329 Ch.). Il cane fedele Fedro 1,23 Chi all’improvviso diventa generoso, è gradito agli sciocchi, ma tende inganni vani agli assennati. Di notte un ladro aveva gettato un pezzo di pane a un cane, per vedere se mai potesse adescarlo, mettendogli davanti del cibo. «Ehi tu – disse – vuoi chiudermi la bocca, perché io non abbai a difesa del patrimonio del mio padrone? Ti sbagli davvero. Infatti, questa improvvisa benevolenza mi spinge a stare attento che tu non tragga profitto per mia colpa». RIFERIMENTI: Romulus 29; Sintipa 21. I cani che laceravano la pelle di un leone Sintipa 19 Alcuni cani, trovata la pelle di un leone, la
laceravano. Una volpe li vide e disse loro: «Se questo leone fosse ancora tra i vivi, vi rendereste conto che i suoi artigli sono più forti dei vostri denti». Questa favola indica coloro che disprezzano un uomo importante, una volta caduto dalla sua posizione di potere e di fama. Il cane che inseguiva un lupo Sintipa 38 Mentre inseguiva un lupo, un cane era orgoglioso della sua velocità nella corsa e della sua forza. Immaginava, infatti, che il lupo fuggisse davvero a causa della propria debolezza. Ma poi il lupo si voltò e disse al cane: «Io non temo te, ma l’inseguimento del tuo padrone». La favola mostra che non si deve essere orgogliosi delle nobili qualità che in realtà appartengono ad altri. Il cane che portava un pezzo di carne Esopo 185 Ch. Un cane stava attraversando un fiume con un pezzo di carne in bocca. Quando vide la sua immagine riflessa nell’acqua, credette che si trattasse di un’altra cagna, che aveva in bocca un pezzo di carne più grosso. Perciò lasciò andare il suo e si lanciò nel tentativo di prendere quello dell’altra. D’altra parte, accadde che perse entrambi i pezzi: uno perché non poteva raggiungerlo, dal momento che non esisteva; l’altro, invece, perché venne portato via dalla corrente. Questa favola può essere applicata agli uomini avidi.
RIFERIMENTI: Fedro 1,4; Babrio 79; PseudoDositeo 11; Aftonio 35; Codice Brancacciano 4; Sintipa 28; Parafrasi 186; Tetrastici 1,9; Romulus 6; Teognide 347 s.; Luciano, Ermotimo 79; Teone, Esercizi preparatori 3; Ireneo di Lione, Contro le eresie 2,11; Epifanio di Costanza, Panarion 41,1; Dossopatre II 188,31 Walz; Democrito 68 B 224 D.K.; Papiro Michigan 6 recto 6-8; Girolamo, Epistole 29,7; Sopatro retore presso Giovanni di Sardi, Commento ad Aftonio (p. 7 Rabe); Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 17, ed. Boissonade). Il cane addormentato e il lupo Esopo 184 Ch. Un cane dormiva davanti a una fattoria, quando un lupo lo aggredì con l’intenzione di mangiarlo. Allora il cane si mise a pregarlo che non gli togliesse subito la vita. «Ora infatti – disse – sono magro e debole, ma attendi per un breve periodo; i miei padroni stanno per celebrare un matrimonio e, in quella occasione, io potrò mangiare cibi abbondanti, ingrasserò e diverrò per te un pasto più succulento.» Allora il lupo, persuaso, se ne andò. Tornò dopo alcuni giorni e trovò il cane che dormiva nella parte alta della casa: prese a chiamarlo dal basso, ricordandogli i patti stabiliti; allora il cane replicò: «O lupo, se dovessi vedermi in futuro dormire davanti alla fattoria, non attendere più alcun matrimonio». La favola dimostra che gli uomini assennati, quando si salvano da qualche situazione pericolosa, ne stanno in guardia per tutta la loro esistenza. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 185.
Il cane che portava un campanello Esopo 186 Ch. Un cane mordeva a tradimento. Il suo padrone allora gli mise al collo un campanello, in modo che l’animale fosse segnalato a tutti. Il cane, scuotendo il campanello, se ne vantava in piazza. Una vecchia cagna gli disse: «Che motivo hai di vantarti? Non porti questo campanello per il tuo valore, bensì come segno della tua intima malvagità». I modi vanagloriosi dei fanfaroni mostrano chiaramente la loro segreta malvagità. RIFERIMENTI: Babrio 104; Aviano 7; Parafrasi 187. Esopo e la cagna Aristofane, Vespe 1401 ss. Mentre una sera Esopo tornava a casa da un banchetto, una cagna insolente e ubriaca gli abbaiava contro. Allora lui disse: «Cagna, cagna, per Zeus, se tu, in cambio di questa cattiva lingua, comprassi un po’ di grano, mi sembreresti decisamente più saggia». RIFERIMENTI: Pseudo-Erodiano, Filetero 2. I cani affamati Esopo 176 Ch.
Alcuni cani affamati, come videro delle pelli immerse in un fiume, non potendo raggiungerle, si accordarono per bere prima l’acqua, così da avvicinarsi poi ad esse. Accadde, però, che, a forza di bere, i cani scoppiarono prima di raggiungere le pelli. Così alcune persone intraprendono azioni pericolosamente faticose, sperando in un guadagno, ma si rovinano prima di ottenere quanto desiderano. RIFERIMENTI: Fedro 1,20; Sintipa 61; Romulus 2; Plutarco, Sulle nozioni comuni contro gli Stoici 1067f. L’uomo morso da un cane Esopo 177 Ch. Un uomo, morso da un cane, andava in giro alla ricerca di qualcuno che lo curasse. Un tale gli disse che doveva gettare al cane un pezzo di pane, dopo avere assorbito con esso il sangue. Il ferito gli rispose: «Se lo farò, è inevitabile che mi vengano a mordere tutti i cani della città!». Così la malvagità umana, se lusingata, spinge ad agire con ancora maggiore iniquità. RIFERIMENTI: Fedro 2,3; Sintipa 56. Il cane e il suo padrone Babrio 110 Un uomo, sul punto di partire per un viaggio, disse al suo cane, che se ne stava accanto a lui: «Perché sei lì con la bocca spalancata? Prepara
tutto, perché partirai con me». L’animale, che, scodinzolando, faceva festa al suo padrone, disse: «Io ho tutto pronto, tu stai ritardando». La cagna partoriente Fedro 1,19 Le lusinghe di un uomo malvagio sono insidiose: i versi che seguono ci esortano a evitarle. Una cagna sul punto di partorire chiese a un’altra la possibilità di deporre la prole nella sua cuccia: ebbe il permesso senza difficoltà. Quindi, quando l’altra pretese di riavere il suo posto, la cagna, supplicandola, chiese e ottenne ancora un po’ di tempo, fino a che potesse condurre via i suoi piccoli, una volta divenuti più robusti. Trascorso anche questo lasso di tempo, la padrona di casa cominciò a reclamare con maggiore insistenza la sua cuccia. «Se sarai in grado di competere con me e con la mia squadra – disse l’altra – me ne andrò di qui». RIFERIMENTI: Giustino 43,4,4 (Pompeo Trogo presso Giustino: passo citato); Papiro di Colonia 2,64; Romulus 12. La casa del cane Plutarco, Il convito dei sette sapienti 157b In inverno un cane, poiché giaceva stretto e ripiegato su se stesso a causa del freddo, progettava di edificare una casa. Ma quando arrivò l’estate, mentre di nuovo disteso si riposava, l’animale, impressionato dalla sua grandezza, ritenne opera non necessaria, né lavoro di poco conto, erigere
intorno a sé un’abitazione tanto grande da andare bene per le sue dimensioni. NOTA: Plutarco riferisce esplicitamente a Esopo. RIFERIMENTI: F. dattiliche 16.
questa
favola
Il cacciatore e il lupo Sintipa 6 Un cacciatore, dopo avere visto un lupo intento ad attaccare un gregge e a dilaniare il maggior numero di pecore possibile, bracca sapientemente la belva e scaglia i cani contro di essa, urlandole: «Bestiaccia terribile, dove è la forza che avevi prima, visto che non riesci affatto a opporti ai cani?». Questa favola dimostra che ogni uomo si costruisce la sua reputazione nell’arte che gli riesce meglio. I due cani Esopo 175 Ch. Un uomo aveva due cani. A uno insegnò a cacciare, mentre fece dell’altro un cane da guardia. Così quando il primo, uscendo a caccia, catturava una preda, il padrone ne gettava una parte anche all’altro. Il cane da caccia, sdegnato, insultava il compagno: mentre lui andava sempre fuori a faticare, l’altro, senza far nulla, godeva dei frutti delle sue fatiche. Il cane da guardia allora gli disse: «Non biasimare me, ma il padrone che non mi ha insegnato a faticare, bensì a nutrirmi delle fatiche altrui». Così anche i bambini indolenti non devono essere biasimati quando i loro genitori li hanno resi
tali. RIFERIMENTI: Cfr. Archiloco, fr. 237 W. ; Aristofane, Vespe 894 ss.; Nicolao di Damasco, FGH 90F56. 2
I lupi che si riconciliarono con i cani Esopo 216 Ch. I lupi si rivolsero così ai cani: «Perché, anche se ci assomigliate in tutto, non andate d’accordo con noi come fratelli? Infatti non c’è tra noi alcuna differenza, se non il modo di pensare. Noi viviamo in libertà, mentre voi siete sottomessi agli uomini e loro schiavi, sopportate le loro percosse, avete catene al collo, fate la guardia alle loro greggi. Quando mangiano, vi gettano solo gli ossi. Ma lasciatevi convincere e consegnateci ogni membro del gregge: metteremo tutto in comune, mangiando fino a essere sazi». I cani, dunque, diedero ascolto a queste parole. I lupi, entrati nella stalla, uccisero innanzitutto i cani. Coloro che tradiscono la loro patria ricavano tale ricompensa. RIFERIMENTI: Fedro 3,7; Babrio 100; Tetrastici 1,3; Romulus 65; Aviano 37. Cfr. inoltre Archiloco, fr. 237 W. ; Aristofane, Vespe 894 ss.; Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 90, ed. Boissonade). 2
La volpe e il cane Esopo 36 Ch. Una volpe, che si era insinuata in un gregge di
pecore, sollevò un agnellino lattante, facendo finta di baciarlo. Un cane le chiese che cosa combinasse e lei rispose: «Lo coccolo e gioco con lui». Allora il cane le disse: «Se ora non lasci andare l’agnellino, ti farò provare il modo di coccolare dei cani!». La favola è adatta a uomini senza scrupoli e sciocchi ladri. Il lupo e il cane Esopo 226 Ch. Un lupo notò un cane enorme, legato a una catena, e gli chiese: «Chi ti ha legato e poi ti ha fatto crescere così?». Il cane gli rispose: «Un cacciatore». «Voglia il cielo – disse l’altro – che un lupo mio amico non debba sopportare questa sventura. Infatti, la fame equivale al peso di un collare». La favola dimostra che nelle disgrazie non conta nulla riempirsi la pancia. RIFERIMENTI: Fedro 3,7; Babrio 100; Tetrastici 1,3; Romulus 65; Aviano 37. Cfr. inoltre Archiloco, fr. 237 W. ; Aristofane, Vespe 894 ss.; Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 90, ed. Boissonade). Il passo archilocheo è riportato da Eroziano, Lessico σ 25, in relazione al significato di σκύτα. 2
Il cane invitato a pranzo ovvero l’uomo e il cane Esopo 178 Ch. Un uomo preparava la cena con l’intenzione di invitare un caro amico. Il suo cane chiamò un altro cane: «Mio caro, – disse – vieni qui a cena da me!». Una volta arrivato, l’animale, fermatosi a guardare
contento l’imponente banchetto, esclamava in cuor suo: «Oh! Che gioia inaspettata mi è ora apparsa all’improvviso! Mangerò e mi rimpinzerò a sazietà, così da non avere nemmeno un po’ di fame domani». Il cane rifletteva così tra sé e nello stesso tempo scodinzolava, poiché aveva fiducia nell’amico. Il cuoco, come vide la coda della bestiola muoversi di qua e di là, afferrò il cane per le zampe e lo gettò subito fuori dalla finestra. Allora, facendo ritorno a casa, l’animale si allontanava abbaiando energicamente. Lungo la strada incontrò altri cani; uno di questi gli chiese: «Come hai cenato, caro?». Quello gli rispose: «Così, ubriaco come sono per tutto quello che ho bevuto, non so neppure da che parte sono uscito». La favola dimostra che non si deve riporre fiducia in coloro che promettono di farci del bene a spese altrui. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 179.
Babrio
42;
Parafrasi
179;
PROVERBI Ut canis a corio numquam absterrebitur uncto Come il cane non si staccherà mai dal cuoio unto di grasso L’espressione, chiaramente proverbiale, è presente in Orazio (Satire 2,5,83) ed esprime tenace attaccamento e avidità, come quella dei cani affamati, che, per raggiungere le pelli, cercano di bere l’acqua del fiume (cfr. Esopo 176 Ch.; cfr. Fedro 1,20, che usa lo stesso termine di Orazio: corium). Il collegamento tra favola e proverbio è rilevato da diversi studiosi: Pisi 61 segnala alcuni paralleli di ambito greco (Luciano, Contro un bibliomane ignorante 25; Alcifrone 3,47). Mare interbibere Bersi il mare
L’espressione, attestata in Nevio (55 R. ), pare di valore proverbiale e, come nota Tosi 1991, 202, «indica un’operazione completamente assurda e impossibile da realizzare, ed è in particolare impiegata in iperboli e paragoni con disperati tentativi destinati al fallimento» (cfr., ad esempio, Properzio 2,32,49). Appare chiara la convergenza con la favola 176 Ch. di Esopo: i cani, bevendo, provano a prosciugare il fiume, per raggiungere le pelli (v. sopra per gli altri paralleli). Melior canis vivus leone mortuo Meglio un cane vivo che un leone morto Il proverbio è attestato dalla versione della Vulgata dell’Ecclesiaste (9,4). Pare collegabile con la favola in cui i cani si accaniscono su un leone morto, mentre una volpe osserva che, se fosse vivo, l’esito del conflitto sarebbe ben diverso (Sintipa 19). Tosi 1991,480 s., che ricorda anche varianti moderne come «Meglio un asino vivo che un dottore morto», osserva come questa immagine sia accostabile al proverbio «Strappare la barba al leone morto» (cfr. anche Fedro 1,21: persino l’asino umilia il leone morente). 3
Canna Nel mondo antico la canna è considerata simbolo di loquacità, in relazione al vento che la scuote. Nel mito, il re frigio Mida, punito con orecchie da asino per avere preferito il dio silvestre Pan in una gara musicale contro Apollo, non riesce a tenere segreta questa vergognosa condizione: il suo barbiere lo sorprende e rivela il segreto a una fossa; proprio in quel luogo nasce una canna, che, in presenza del vento, rivela puntualmente a tutti l’imbarazzante situazione del sovrano. Ma la pianta è anche valorizzata come elemento naturale che produce musica. La naiade Siringa, insidiata da Pan, chiede al padre Ladone, dio-fiume arcadico, di essere trasformata in una canna. Allora Pan si costruisce un flauto per consolarsi (fra le narrazioni del mito, che presentano alcune differenze, cfr. Ovidio, Metamorfosi 1,690 ss.; Achille Tazio 8,6). La pianta (κάλαμoς in greco, calamus in latino) diventa anche strumento di scrittura. Tra i più diffusi significati simbolici che presenta la canna, non si può certo dimenticare il servilismo, per l’attitudine della pianta a piegarsi; tuttavia, questa condizione può essere anche interpretata in termini positivi come flessibilità. Proprio questo aspetto positivo emerge bene nella tradizione esopica, dove la pianta è contrapposta all’olivo, o, in altre versioni, alla quercia (v. sotto). La favola 143 Ch. riporta una morale utilitaristica, costruita sul punto di vista dei ceti subalterni: è meglio non opporsi a chi è più forte e potente. Il tema narrativo offre spunti significativi anche in altri autori: Aviano (16), sottolineando anche il «dolce sussurro» della pianta (v. 11), evoca implicitamente il rumore prodotto dal vento e riprende così il simbolismo della loquacità. Questa favola, inoltre, sviluppa un altro tema caro alla tradizione esopica: quello della maggiore sicurezza di chi si trova in modeste condizioni (cfr. anche Fedro 2,7,13). Questa narrazione, che sembra trovare un precedente
significativo, peraltro senza diretto riferimento alla canna, in alcuni versi dell’Antigone di Sofocle (712 ss.), ha forse una derivazione orientale e suggerisce elementi di contatto con le tradizioni indiana, assiro-babilonese e persino sumerica (cfr. Adrados 2003, 97). La canna che si piega ma non si spezza è valorizzata nella favolistica moderna (La Fontaine 1,22), ma anche in altri contesti (Guido Cavalcanti, nella canzone Il moto, il corso, e l’opra di fortuna, la contrappone proprio alla quercia, riprendendo fedelmente lo schema della favola). L’immagine, sia pure con qualche variazione, ha larga fortuna. Nel Purgatorio (1,103 ss.), Dante, in riferimento ai giunchi simbolo dell’umiltà necessaria all’espiazione, osserva: «Null’altra pianta che facesse fronda, / o indurasse, vi puote aver vita, / però ch’alle percosse non seconda». Al di là dell’immagine su cui si costruisce la favola, la canna diventa simbolo dell’uomo anche in altri contesti letterari e con diversi valori: Pascal afferma che l’uomo è simile a una canna per la sua fragilità (Pensieri 264). La canna e l’olivo Esopo 143 Ch. Una canna e un olivo discutevano sulla loro resistenza, sulla forza e sulla sicurezza della loro vita. Quando la canna fu accusata dall’olivo di essere priva di forza e di lasciarsi piegare con facilità da tutti i venti, essa restò zitta e non diede alcuna risposta. Poco tempo dopo, quando si levò un forte vento, la canna, scossa e piegata dall’aria, si salvò senza difficoltà; l’olivo, invece, facendo resistenza al vento, fu spezzato dalla violenza delle raffiche. La favola dimostra che quelli che non si oppongono alle circostanze e a chi ha maggiore forza prevalgono su quelli che sfidano i potenti.
RIFERIMENTI: in alcune versioni si trova la quercia anziché l’olivo (ma si riscontra anche l’indicazione generica di alberi). Cfr. Sofocle, Antigone 712 ss.; Babrio 36; Aviano 16; Parafrasi 101; Tetrastici 1,45; F. dattiliche 2; Antologia Palatina 10,122,5 s. (Lucillio).
Capra Le capre sono, in diverse culture, simbolo di energia vitale e di fecondità (cfr. Cooper 77). Fin da tempi antichissimi, trovano ampio spazio nella vita quotidiana: probabilmente sono tra i primi animali, dopo il cane, a essere addomesticati. Sono pertanto spesso presenti nella letteratura delle popolazioni europee e del Vicino Oriente; considerate animali sacrificali, vengono impiegate anche in ambito rituale (così, ad esempio, presso gli Ebrei, i Greci e i Romani). Alla luce dell’antica consuetudine con l’uomo, troviamo diverse leggende che ci presentano bambini allevati da capre: Dafni, nel romanzo Dafni e Cloe di Longo Sofista o Egisto, l’assassino di Agamennone. La stessa capra della ninfa Amaltea è la nutrice di Zeus a Creta. Tra l’altro, la capra è animale sacro a Era e a Dioniso. Nella letteratura antica, questi animali si segnalano sia per l’utilità nell’ambito dell’economia agraria e persino nella cucina (diverse le ricette di Apicio dedicate alla carne dei capretti), sia come fonte di ispirazione per la poesia (si pensi solo alle Bucoliche virgiliane e all’amore del pastore Melibeo per le sue caprette). Chi alleva capre, secondo Columella, deve avere specifici requisiti (v. CAPRAIO). A differenza degli ovini, ritenuti piuttosto stupidi, i caprini sono considerati animali dotati di una certa intelligenza, come attesta anche Plinio (Naturalis historia 8,76). Peraltro, caprini e ovini sembrano legati da una particolare simpatia reciproca (Eliano, De natura animalium 4,48). La tradizione favolistica concede ampio spazio alle capre, anche perché si tratta di animali familiari all’uomo, e le considera non prive di una certa astuzia. Già in una collezione retorica risalente alla prima metà del II millennio a.C., troviamo una favola sumerica (componimento 55, collezione quinta di Gordon) che narra le vicende di un leone che cattura una capra, ma viene persuaso a liberare la preda
in cambio di una pingue pecora. La capra raggira, non senza un’astuta ironia, il leone, che alla fine si vede beffato, ritrovandosi senza la preda già in suo possesso e senza la pecora promessa. Lo stolto leone finisce così per essere irriso. Secondo La Penna 1996, IX, questa narrazione assomiglia, persino nella morale, alla favola di Esopo 184 Ch., che tuttavia presenta come protagonisti il lupo aggressore e il cane nella parte dell’astuta preda. Un’altra favola, di cui è stata ipotizzata un’origine non greca, forse egizia (cfr. Adrados 2003, 127), è quella del capretto che, con un’astuzia, beffa il lupo impegnato a suonare l’aulòs (Esopo 107 Ch.). Di fronte dunque ai più temibili predatori, la capra non si lascia raggirare: la favola esopica 120 Ch. presenta un lupo (nella preziosa rielaborazione di Aviano 26 è scelto, più letterariamente, un leone) da cui non si lascia trarre in inganno. Addirittura, in una favola di matrice cinica centrata sull’importanza delle circostanze (Esopo 106 Ch., per certi versi accostabile con 332 Ch., il toro maltrattato dalle capre selvatiche), il capretto che si trova su un tetto (in altre versioni su una torre o su un muro) arriva al punto di irridere il lupo, confortato dal fatto che esso non può raggiungerlo: si è notato come questa favola presenti significative affinità con un noto proverbio (v. sotto). Da rilevare che nemmeno l’uomo riesce a raggirare e a fare sue le capre selvatiche (v. CAPRAIO). La tendenza, generalmente positiva, della rappresentazione delle capre trova alcune eccezioni, lasciando spazio anche a favole di segno diverso, in cui le capre appaiono invidiose (Esopo 16 Ch.) o vanagloriose (Fedro 4,16 [17]). La capra e l’asino Esopo 16 Ch. Un tale allevava una capra e un asino. La capra, invidiosa dell’asino perché a lui davano una maggiore quantità di cibo, gli diceva: «Tu subisci
continui tormenti, ora girando la macina, ora portando enormi pesi». Così gli suggeriva di fingersi epilettico e di cadere in un fosso, in modo da trovare un po’ di riposo. L’asino allora seguì i suoi consigli e, cadendo, si spezzò le ossa. Il padrone chiamò il veterinario e gli chiese di curarlo. L’uomo allora suggerì di praticare un’infusione di polmone di capra all’asino, per restituirgli la salute. Così curarono l’asino attraverso il sacrificio della capra. Chi trama inganni nei confronti degli altri, è il primo responsabile delle proprie disavventure. RIFERIMENTI: Parafrasi 16; Dodecasillabi 16. Il capretto sul tetto della stalla e il lupo Esopo 106 Ch. Un capretto che si trovava su un tetto, vedendo un lupo aggirarsi nei paraggi, prese a oltraggiarlo e a irriderlo. Allora il lupo gli disse: «Mio caro, non mi insulti tu, ma il luogo in cui ti trovi». La favola dimostra che spesso il luogo e la circostanza infondono coraggio anche davanti a chi è più forte. RIFERIMENTI: in altre versioni il capretto si trova su una torre o su un muro. Cfr. F. dattiliche 14; Babrio 96; Codice Brancacciano 10; Sintipa 17; Parafrasi 107; Dodecasillabi 107; Tetrastici 1,31; Diogeniano 3,24; la favola sembra avere larga fortuna: cfr. anche Suda π 2298 τ 966 Adler (altri riferimenti in Adrados 2003, 129); v. sotto per il proverbio. Il capretto e il lupo che suonava l’aulòs Esopo 107 Ch.
Un capretto, attardatosi dietro al suo gregge, era inseguito da un lupo; la bestiola allora, dopo essersi girata, disse al lupo: «So bene, lupo, che sono destinato al tuo pasto, ma perché io non muoia ingloriosamente, suona l’aulòs in modo che io possa danzare». Mentre il lupo si mise a suonare e il capretto a danzare, i cani sentirono e balzarono fuori all’inseguimento del lupo. Allora il lupo, giratosi, disse al capretto: «Mi sta proprio bene, poiché io, che sono un macellaio, non dovevo fare l’auleta». Così, coloro che agiscono senza considerare le circostanze si vedono sottrarre anche quanto è nelle loro mani. RIFERIMENTI: Codice Brancacciano 11. Il toro e le capre selvatiche Esopo 332 Ch. Un toro, inseguito da un leone, fuggì in una grotta, dove c’erano delle capre selvatiche. Assalito da esse e preso a cornate, esclamò: «Non per paura di voi sopporto, ma di colui che si trova all’ingresso della grotta». Così molti, per paura dei più potenti, si rassegnano a tollerare anche le azioni tracotanti dei più deboli. RIFERIMENTI: Babrio 91; Tavolette Assend. 7; Pseudo-Dositeo 14; Aviano 13; Sintipa 40; Parafrasi 332; Tetrastici 1,32; Romulus 90. La capretta e il leone Aviano 26
Un leone, in preda alla fame, aggirandosi nelle vicinanze, aveva notato una capretta che si pasceva su un’alta rupe. E subito disse: «Ehi, lascia il pendio con le sue rocce scoscese e non cercare il tuo pascolo tra i gioghi spinosi, ma vieni nei verdi prati alla ricerca del giallo fiore del citiso, dei salici dal colore grigio e azzurro, del piacevole timo». La capretta, sospirando, replicò: «Cessa, ti prego, di far finta ingannevolmente, con sottili astuzie, che io sia sicura. Per quanto veri siano i tuoi ammonimenti, nonostante tu cerchi di allontanare da me pericoli più grandi, tuttavia fai in modo che io non presti fede alle tue parole. Infatti, quantunque il tuo consiglio si fondi su giuste osservazioni, è il feroce consigliere che lo fa diventare sospetto». RIFERIMENTI: questa rielaborazione di Aviano è particolarmente interessante, perché prende spunto da una similitudine di Virgilio sul leone affamato (Eneide 10,723 ss.; cfr. Küppers 138 ss.) e tutta la narrazione si costruisce su citazioni virgiliane e oraziane. Qui si trova il leone anziché il più comune lupo presente invece in Esopo. Cfr. Esopo 220 Ch.; Sintipa 44; Tetrastici 2,8; Appendix proverbiorum 1,18; 3,73. PROVERBI ’Aϕ’ὑψηλoῦ μoυ καταγελᾷς Mi sbeffeggi dall’alto Il proverbio, attestato in opere paremiografiche e lessicografiche (Apostolio 4,62; Macario 2,66; Gregorio Ciprio L 1,59; Suda α 4666 Adler), si riferisce a chi, trovandosi in un luogo o in una situazione privilegiata, si comporta in un modo differente da come agirebbe in una condizione normale. Sembra probabile, dunque, come è stato
notato da Van Dijk e Adrados (2003, 129), il collegamento con Esopo 106 Ch., la favola del capretto insolente che offende il lupo, perché si trova in una posizione più alta, dove l’altro non può raggiungerlo
Capraio In un mondo profondamente fondato su agricoltura e pastorizia, si segnala una distinzione, nel lessico e nelle caratteristiche, tra il pastore di pecore e quello di capre, due specializzazioni differenti (cfr. comunque PASTORE per gli aspetti generali). Nelle trattazioni specialistiche emerge perciò uno specifico profilo del capraio ideale, che deve essere dotato di forza e di resistenza, di agilità negli spostamenti, spesso complessi, e non deve nemmeno essere privo di audacia (cfr. Columella 7,6). Anche nella favolistica emerge questa distinzione, per cui il capraio, pur risultando un subalterno, timoroso del padrone (Esopo 15 Ch.), e dunque affine socialmente al pastore, ha a che fare con animali che sono più intelligenti delle pecore, secondo una convinzione radicata nel mondo antico (cfr. CAPRA). Così le capre selvatiche non cadono nel tranello teso dall’uomo (Esopo 17 Ch.). Da notare l’indicazione dell’ambiente montano, piuttosto raro nella favolistica, che sembra giustificare le attitudini specifiche generalmente richieste al capraio. La capra e il capraio Esopo 15 Ch. Un capraio richiamava le sue capre nella stalla. Una di loro tuttavia si attardò, perché stava mangiando qualcosa di gustoso. Allora il pastore le gettò una pietra e le colpì un corno, spezzandolo. L’uomo implorò la capra di non raccontarlo al padrone. L’animale replicò: «Anche se io non parlerò, come potrò tenere nascosto quanto è successo? Risulta infatti evidente a tutti che il mio corno è stato rotto». Nel momento in cui la colpa è
evidente, non si può tenerla nascosta. RIFERIMENTI: Fedro, App. 22 [24]; Babrio 3; Aftonio 5; Tetrastici 1,35-2,26; Parafrasi 15; Dodecasillabi 15. Il capraio e le capre selvatiche Esopo 17 Ch. Un capraio aveva condotto a pascolare le sue capre; come vide che si erano mescolate con altre, selvatiche, sul far della sera le fece entrare tutte insieme nella sua grotta. L’indomani, poiché c’era una forte tempesta, il capraio non poteva condurre il gregge a pascolare come al solito e così accudì le sue capre dentro la grotta, dando loro una quantità di foraggio appena sufficiente a sfamarle; a quelle selvatiche, invece, garantì molto più nutrimento, per fare in modo che diventassero sue. Una volta terminato il maltempo, quando le portò tutte al pascolo, le capre selvatiche fuggirono, arrampicandosi sui monti. Il pastore allora le accusò di ingratitudine, visto che lo abbandonavano, pur essendo state trattate con grande cura. Esse si volsero e gli risposero: «Anche per questo stiamo più in guardia: se infatti tu hai trattato meglio delle tue vecchie capre noi che siamo giunte da te soltanto ieri, è evidente che se altre si aggiungeranno presso di te, tu le prediligerai rispetto a noi». La favola dimostra che non dobbiamo essere felici per l’amicizia di quelli che, appena conosciuti, ci tengono in maggiore considerazione rispetto ai vecchi amici; si deve infatti ritenere che, se faranno amicizia con altri, li terranno in maggiore considerazione, nel momento in cui noi avremo maturato una conoscenza di vecchia data.
RIFERIMENTI: Babrio 45; Dodecasillabi 17; Tetrastici 2,14.
Parafrasi
17;
Caprone Il caprone è generalmente considerato lussurioso (libidinosus, nell’efficace definizione di Orazio, Epodi 10,23) e non particolarmente intelligente (cfr. Petronio 57,11). D’altra parte, riveste una certa importanza sul piano culturale, nel mondo mediterraneo e in Oriente (in India è identificato con il dio del fuoco). Dal termine greco che lo designa, τράγoς, sembra derivare la parola «tragedia». Tale genere letterario è sorto, infatti, nell’ambito del culto di Dioniso (cfr. Aristotele, Poetica 1449a). Nel mito troviamo il dio trasformato in capro da Zeus, che vuole sottrarlo alle persecuzioni di Era. Il caprone è simbolo dei dannati e di Satana nella tradizione cristiana (nel Vangelo di Matteo 25,31 ss. i capri sono in contrapposizione alle pecore nell’ambito del Giudizio universale). Il legame di questo animale con Dioniso emerge anche nella favolistica: in Esopo 339 Ch. il caprone è protagonista insieme alla vite, in una narrazione che forse deriva dal Romanzo di Ahiqar e fa riferimento all’ambito rituale, mentre la tradizione favolistica presenta per lo più i personaggi in una chiave desacralizzata (v. comunque VITE per l’interpretazione della favola). Qui l’animale va a rappresentare gli ingrati. Se in Fedro 4,16 [17], narrazione costruita secondo l’usuale schema dell’arbitrato, il caprone viene descritto come dotato di una certa dignità, la sua scarsa intelligenza emerge in Esopo 40 Ch.: la volpe lo raggira senza troppa fatica. La proverbiale puzza del caprone (cfr. Catullo 69,6) si rileva anche nella favolistica: in Aviano (13), che presenta una versione della favola 332 Ch. ricca di differenze (a partire dalla sostituzione dei personaggi), il toro, in fuga dal leone, apostrofa il caprone con gli epiteti «fetido» e «maleodorante», ritenendolo, tra l’altro, «stoltissimo», in linea con una consolidata convinzione propria dei popoli antichi.
Le capre barbute Fedro 4,16 [17] Poiché le capre avevano ottenuto da Giove la barba, i caproni cominciarono a sdegnarsi, lamentandosi per il fatto che le femmine avevano avuto una dignità pari alla loro. «Lasciate – disse Giove – che quelle godano di una vana gloria e si approprino dell’ornamento del vostro grado, purché non dispongano di una forza dello stesso livello della vostra». Questa storia invita a sopportare chi ti è simile in aspetto ma non in valore. Il caprone e la volpe Esopo 40 Ch. Una volpe precipitò in un pozzo, rimanendo bloccata lì contro la sua volontà. Raggiunse quel pozzo un caprone oppresso dalla sete. Scorgendo la volpe, le chiese se l’acqua era buona e quella, contenta della circostanza favorevole, tesseva le lodi di quell’acqua: sosteneva che era buona e insisteva perché il caprone si calasse nel pozzo. Quello, senza pensarci, spinto dal desiderio, scese. Mentre si dissetava, cercava di capire con la volpe come risalire, ma la volpe gli rispose: «Se solo vuoi che ci salviamo entrambi, so io come fare. Appoggia, per favore, le zampe anteriori contro il muro, alza le corna; a quel punto, io correrò su e ti solleverò». Il caprone diede subito ascolto al suo consiglio. La volpe, risalendo attraverso le sue zampe, le spalle e le corna, si trovò presso l’apertura del pozzo; e, una volta che si fu tirata fuori del tutto, era pronta a svignarsela. Poiché il caprone la biasimava per aver
tradito gli accordi, la volpe si voltò e gli disse: «Caro mio, se avessi tanta saggezza quanti peli hai sulla barba, non saresti sceso prima di aver escogitato la modalità per risalire». Così bisogna che anche gli uomini saggi prima osservino le conseguenze delle loro azioni e poi agiscano. RIFERIMENTI: Fedro 4,9; Sintipa 10; Parafrasi 40; Dodecasillabi 40; Tetrastici 2,15; 2,31a-b.
Castoro Il castoro, simbolo nella cultura europea di operosità, vigilanza e mansuetudine, è al centro di curiose credenze. Plinio (Naturalis historia 8,109) lo descrive come animale «dal terribile morso», capace di tagliare come con una scure le piante nei pressi dei fiumi; lo scienziato romano, inoltre, riferendosi ai castori del Ponto, spiega che essi si tagliano i genitali quando sono inseguiti, poiché sanno che gli uomini danno loro la caccia per impossessarsene. La stessa credenza, peraltro generalizzata a tutti i castori, è riferita da Eliano (De natura animalium 6,34), che paragona questi animali a uomini inseguiti dai briganti e li promuove a simbolo di saggezza e di astuzia, perché prevengono il pericolo e inoltre, quando si sono già recisi i testicoli, si alzano in piedi e mostrano ai cacciatori di esserne privi. Addirittura talvolta riescono a nasconderli alla vista degli uomini con un certo ingegno, sfuggendo così alla morsa degli inseguitori. La credenza dell’autocastrazione, peraltro presente in varie tradizioni culturali, assume nel mondo antico un carattere proverbiale, al punto che nasce la falsa etimologia che associa il nome castoro (fiber è il termine proprio latino, castor, invece, quello di derivazione greca) con l’atto del castrare (così, ad esempio, in Servio e poi in Isidoro di Siviglia). Nella cultura cristiana simboleggerà il tentativo di separarsi dalle opere della carne per lasciarle al diavolo, che è in cerca dell’anima (Cooper 83). Plinio riporta l’opinione di Sestio, esperto di farmaci, che ritiene tale comportamento impossibile, perché provocherebbe la morte dell’animale (Naturalis historia 32,26). Come è noto, il castoreo è un liquido secreto dalle ghiandole prepuziali dell’animale e ha avuto largo impiego in passato come sedativo nella medicina e oggi come fissativo in profumeria. Credenze di storia naturale e caratterizzazione favolistica convergono nella figura di questo singolare anfibio, al punto
che Esopo (153 Ch.), nella sua narrazione, non fa altro che spiegare la caratteristica più nota dell’animale, di cui sente persino la necessità di puntualizzare la natura di quadrupede. Nella narrazione non sono nemmeno menzionati altri animali. Secondo Adrados 2003,155, questo tema favolistico, centrato essenzialmente sull’idea del primato della vita su tutto il resto, è di derivazione cinica. In Fedro si trova una versione della favola molto simile, con l’aggiunta però dei cani, che appaiono come i naturali inseguitori, insieme ai cacciatori. Inoltre, il favolista latino, riflettendo sul nome dell’animale, osserva polemicamente che i Greci, pur avendo un ricco vocabolario, lo hanno chiamato «castoro» attribuendogli il nome di un dio (Castore, figlio di Leda e fratello di Polluce). Allusioni alla favola (o al motivo proverbiale: i confini, come si vede, sfumano) si hanno nella Satire di Giovenale (12,34 ss.) e nelle Metamorfosi di Apuleio (1,9,2), dove, in riferimento a una maga che vuole punire il tradimento di un amante, si racconta la trasformazione dell’uomo in castoro; lo scopo del sortilegio è facilmente immaginabile. Il castoro Esopo 153 Ch. Il castoro è un quadrupede che vive negli stagni. Si dice che i suoi testicoli servano per alcune terapie. Se mai qualcuno lo vede e lo insegue con l’intenzione di toglierglieli, lui, ben sapendo il motivo dell’inseguimento, per un po’ fugge, sfruttando la velocità delle sue zampe, per conservarsi intatto; ma quando si vede in trappola, si taglia i genitali, li getta via e in questo modo ottiene la salvezza. Così anche tra gli uomini sono saggi coloro che, insidiati per le loro ricchezze, le sacrificano per non mettere a rischio la vita.
RIFERIMENTI: Fedro, App. 28 (30), Dodecasillabi 154, Eliano, De natura animalium 6,34, Giovenale 12,34 ss.; Apuleio, Metamorfosi 1,9,2, Plinio, Naturalis historia 8,109.
Cavallo Sebbene sia un animale di più recente domesticazione rispetto ad altri, in quanto difficile da domare, il cavallo comincia a vivere con l’uomo fin da tempi antichissimi, già prima della metà del II millennio a.C. Si dimostra sempre molto utile: offre cibo, serve per il trasporto, nei lavori agricoli, nelle gare; viene impiegato in guerra. Plinio sostiene – pare con qualche fondamento scientifico (cfr. Pugliarello 1973, 32) – che i cavalli sono stati importati in Grecia, perché non si trovano in letteratura riferimenti a cavalli selvaggi (Naturalis historia 27,45). Dotato della capacità di percepire il futuro (Tacito, Germania 10), venerato presso vari popoli (ad esempio in Persia: cfr. Erodoto 3,84 s.; 7,40), stimato per la grande intelligenza (ancora Plinio: 8,159), sacro a Poseidone, che l’ha creato (Virgilio, Georgiche 1,10), questo animale è posto in relazione, nell’ambito di alcune cerimonie a Roma, anche con Marte e con Conso, antica divinità latina, probabilmente legata alla vegetazione (cfr. Maspero 82). È animale sacrificale (presso vari popoli asiatici, indoeuropei e mediterranei i cavalli venivano immolati ai padroni defunti; Achille sacrifica sulla pira di Patroclo quattro cavalli: cfr. Iliade 23,171 s.). Possedere un cavallo nell’antichità è sinonimo di ricchezza; peraltro, il ruolo strategico nella guerra fa in modo che la sua immagine sia associata a nobili, eroi e re (si pensi al rapporto di Ettore con i suoi quattro cavalli: cfr. Iliade 8,184 ss.; o a Enea che parla dei suoi nobili destrieri: cfr. Eneide 20,219 ss.). Da Cesare al folle Caligola, è noto lo stretto rapporto di affetto che lega alcuni dei più noti personaggi della storia romana con i loro cavalli. In generale, il simbolismo dell’animale è solare e lunare insieme (cfr. Cooper 85). Nel mito, oltre al ligneo cavallo di Troia, emblema per antonomasia dell’inganno, troviamo i cavalli impegnati a guidare il cocchio del Sole; il cavallo
(alato) più noto è forse Pegaso, che venne catturato da Bellerofonte, a cui la dea Atena mostrò come domarlo per uccidere la Chimera. In genere, il cavallo pare orgoglioso della propria bellezza e va quindi a simboleggiare la moglie e l’amante (Artemidoro, Sull’interpretazione dei sogni 1,56). Curiosamente, il primo esempio animale parlante nella letteratura occidentale, è quello di Xanto, il cavallo che fa una profezia al suo padrone Achille (Iliade 19,392 ss.). Poiché la favolistica è un genere letterario umile, agli antipodi dell’epica, il cavallo compare in un numero relativamente limitato di favole, pur essendo, come si è rilevato, uno degli animali con cui l’uomo ha una più consolidata consuetudine. La domesticazione non è considerata in modo positivo: la sua alleanza con l’uomo contro il cinghiale diventa sinonimo di schiavitù (Esopo 349 Ch.). È naturale che nel mondo esopico l’animale, non sempre connotato da un’immagine positiva e raramente in grado di riscuotere simpatia, conservi il suo legame con la guerra (Esopo 242 e 268 Ch.) e la sua nobiltà come ad esempio viene sottolineato in Fedro (App. 19 [21]), che presenta un cavallo da corsa venduto a un mulino. Si tratta di una variante di una fortunata favola: Esopo parla semplicemente di un cavallo anziano (138 Ch.) e centra la riflessione morale non sulla nobiltà, ma sugli affanni della vecchiaia. Spesso, nella favolistica, il cavallo è protagonista di mutamenti di situazione (povertà-ricchezza, privilegioperdita del privilegio) ed è messo a confronto con l’asino, ritenuto invece simbolo di umiltà per eccellenza. A proposito di questa caratterizzazione, esistono anche significativi proverbi: «Passare da cavalli ad asini» (o viceversa) significa mutare in peggio (o, nel caso contrario, in meglio) la propria condizione. Nelle favole 142 Ch. (cfr. Babrio 76) e 141 Ch., l’asino è indicato nella morale come simbolo del povero e il cavallo del ricco e potente. In ambito romano il valore simbolico del cavallo è stato trasferito al bue (v. BUE, anche per il proverbio). Il cavallo si segnala spesso per la superbia e per l’orgoglio, come nella narrazione del Romulus (53) in
cui alla fine paga il disprezzo nei confronti dell’asino. Nella favola che spiega come l’uomo abbia ricevuto parte degli anni della sua vita da alcuni animali (Esopo 139 Ch.), si spiega che nella fase dell’esistenza ricevuta dal cavallo, che coincide con la giovinezza, è vanitoso e superbo. In coerenza con questo profilo, il cavallo è anche rappresentato quale simbolo delle passioni, come emerge in una favola riportata da Luciano (Il cinico 18). Per questo è anche difficile dominarlo, se non si è esperti (Aristofane, Vespe 1427 ss.). In controtendenza con tale caratterizzazione è un’osservazione di Fedro (App. 2 [3], v. 7), che sottolinea come la Fortuna abbia attribuito al «rapido» cavallo una mansueta docilità. Il cavallo vecchio Esopo 138 Ch. Un cavallo ormai vecchio fu venduto per girare la macina. Quando si vide legato al mulino, gemendo, esclamò: «Dalle corse di un tempo a questi giri: come mi sono ridotto!». Non bisogna lasciarsi prendere eccessivamente dall’orgoglio per la forza dovuta alla giovinezza o alla fama. Molti infatti consumano la vecchiaia tra gli affanni. RIFERIMENTI: Babrio 29; Fedro, App. 19 [21]: qui si rilevano significative differenze, a partire dal fatto che il cavallo da corsa (secondo altri da guerra) non è descritto come anziano; Aftonio 13: qui interviene anche il mugnaio che riflette sulla questione della fortuna; Parafrasi 139; Dodecasillabi 139; Pseudo-Luciano, L’asino 42. Cfr. anche Nicolao, Esercizi preparatori 1,3; Apuleio, Metamorfosi 9,11; commenti relativi ad Aftonio in Giovanni Sardiano (pp. 8 e 9 Rabe) e Dossopatre (II 173,11-12 Walz).
Il cavallo e lo staffiere Esopo 140 Ch. Uno staffiere rubava l’orzo di un cavallo e lo vendeva. Per tutto il giorno, d’altra parte, strofinava e strigliava il cavallo. L’animale gli disse: «Se vuoi veramente che io abbia un bell’aspetto, non vendere l’orzo di cui mi nutro». Gli avidi, adescando i poveri con discorsi persuasivi e con lusinghe, li privano anche di ciò di cui hanno bisogno. RIFERIMENTI: Babrio 83; Parafrasi 141. Il cavallo e il soldato Esopo 142 Ch. Durante la guerra, un soldato dava abbondanti dosi di orzo al suo cavallo, con cui condivideva ogni pericolo. Quando la guerra cessò, tuttavia, il cavallo era costretto a umili mansioni e portava pesanti carichi, nutrito di sola paglia. Come nuovamente fu annunciata la guerra e le trombe risuonarono, il padrone mise le briglie al cavallo, si armò egli stesso e salì sull’animale. Il cavallo, tuttavia, senza più forze, continuava a cadere; disse allora al padrone: «Vattene con i fanti! Tu infatti mi hai mutato da cavallo in asino: come dunque pretendi di avere nuovamente da un asino un cavallo?». Nelle circostanze in cui c’è sicurezza e quiete, non si devono dimenticare i momenti di sventura. RIFERIMENTI: Babrio 76; Parafrasi 143. Il cavallo e l’asino
Esopo 141 Ch. Un uomo aveva un cavallo e un asino. Durante un viaggio, lungo la via, l’asino disse al cavallo: «Prendi una parte del mio carico, se vuoi che io non muoia». L’altro non gli diede retta e l’asino cadde a terra vinto dalla fatica, perdendo la vita. Allora il padrone caricò dell’intero peso il cavallo, compresa la stessa pelle dell’asino. Lamentandosi, allora, il cavallo esclamò: «Ahimè sventurato! Che cosa mi è accaduto, povero me! Ho rifiutato un piccolo peso ed ecco che adesso sono caricato di tutto, anche della pelle». La favola dimostra che se i grandi si alleano con i piccoli, entrambi potranno trovare la salvezza. RIFERIMENTI: Babrio 7; Parafrasi 142; 273; Sintipa 26; Dodecasillabi 142. Cfr. anche la variante dell’asino e del mulo (Esopo 192 H.-H.) e quella del bue e del cammello (Plutarco, Precetti igienici 137d). Il cavallo, il bue, il cane e l’uomo Esopo 139 Ch. Quando Zeus creò l’uomo, gli assegnò un’esistenza di breve durata. Grazie al suo ingegno, quando giunse l’inverno, egli si costruì una casa dove abitare. Un giorno, a causa del freddo pungente e della pioggia, un cavallo, che non riusciva più a resistere, giunse di corsa dall’uomo e lo supplicò di dargli riparo. Allora egli gli disse che l’avrebbe fatto solo in cambio del dono di una parte dei suoi anni. Il cavallo glielo concesse di buon grado. Dopo non molto tempo, giunse anche il bue: nemmeno lui riusciva a tollerare il maltempo. Ugualmente l’uomo
gli disse che non l’avrebbe accolto se non gli avesse offerto un certo numero dei suoi anni; il bue gliene donò una parte e fu accolto in casa. Infine, giunse il cane, tormentato dal freddo: cedendo una parte dei suoi anni, ottenne riparo. Di conseguenza, gli uomini, quando vivono nel tempo assegnato loro da Zeus, sono integri e buoni; quando sono negli anni del cavallo, risultano vanitosi e superbi; giunti agli anni del bue, sono adatti a comandare; quando, alla fine, arrivano agli anni del cane, sono irritabili e abbaiano. Si potrebbe riferire questa favola a un anziano irascibile e burbero. RIFERIMENTI: Babrio 74; Parafrasi 170. L’asino che riteneva felice il cavallo Esopo 268 Ch. Un asino riteneva felice un cavallo poiché veniva nutrito abbondantemente e con tutte le cure, mentre lui non disponeva nemmeno di paglia a sufficienza e doveva subire moltissime tribolazioni. Quando giunse il tempo della guerra, il soldato montò in armi sul cavallo, lo spinse di qua e di là e anche in mezzo ai nemici. Così il cavallo, colpito, finì per rovinare a terra. Dopo che vide questo, l’asino cambiò idea e compianse il cavallo. La favola dimostra che non bisogna nutrire invidia nei confronti di coloro che sono potenti e ricchi, ma, tenendo presenti l’ostilità e il pericolo a cui sono esposti, occorre apprezzare la povertà. RIFERIMENTI: Sintipa 29; Dodecasillabi 269; Romulus 53.
Parafrasi
269;
Il cavallo pazzo Luciano, Il cinico 18 Riflettendo sulla forza delle passioni che trascinano gli uomini, Luciano narra una storia relativa a «Un uomoche montava un cavallo pazzo […] Il cavallo, dopo averlo rapito, lo portava in giro. L’uomo non riusciva più a scendere, perché lo comandava il cavallo. Allora, un tale, che lo incontrò, gli chiese dove andasse. L’uomo rispose, indicando il cavallo: “Dove vuole lui”». Il lupo e il cavallo Esopo 225 Ch. Un lupo, passando per un campo, trovò dell’orzo: non potendo cibarsene, lo lasciò lì e andò via. Imbattutosi in un cavallo, lo condusse nel campo e gli disse che, avendo trovato dell’orzo, non l’aveva mangiato, ma l’aveva conservato per lui, poiché ascoltava volentieri il rumore dei suoi denti. Allora il cavallo rispose: «Caro mio, se i lupi potessero cibarsi di orzo, tu non avresti mai preferito le orecchie al ventre». La favola dimostra che quelli che sono malvagi per natura, anche se ostentano una buona disposizione d’animo, non sono creduti. Il cavallo superbo Romulus 53 Un cavallo, superbo per i suoi ornamenti, s’imbatté in un asino, che, affaticato dai suoi mali, fu
piuttosto lento a fargli strada. «A stento – disse – mi trattengo dal colpirti a calci». L’asino tacque e gemendo invocò gli dei a testimoni. Il cavallo, correndo, si fece male e poco tempo dopo fu inviato nella fattoria; come l’asino lo vide carico di letame, lo irrise con queste parole: «E dunque, che è capitato? Non ti vantavi dei tuoi ornamenti? Ora ti sei ridotto alla miseria di cui avevi disprezzo». Coloro che si trovano in condizioni felici e guardano con disprezzo qualcuno devono ricordare, nell’incertezza, che ignorano il loro futuro. Il cavallo avaro Romulus 82 Un asino chiedeva al cavallo di concedergli un po’ di orzo. «Volentieri – rispose l’altro – se potessi; e te ne offrirei anche quantità generose, come si conviene alla nostra dignità; ma, una volta tornati nella stalla questa sera, ti donerò un sacchetto colmo di farro». E l’asinello: «Visto che rifiuti di soddisfare una così modesta richiesta, che cosa dovrei pensare che farai riguardo a una più consistente?». Coloro che promettono grandi cose rifiutano le piccole. Chi è avaro nel dare è facile alle promesse. Il Sibarita Aristofane, Vespe 1427 ss. Un Sibarita cadde dal cocchio e si ruppe la testa con un gran colpo, inesperto com’era nel condurre i cavalli. Arrivò dunque un tale, suo amico: «Ognuno – affermò – si occupi del mestiere che sa fare».
RIFERIMENTI: la parafrasi di Pseudo-Diogeniano (Praefatio, p. 179 Von Leutsch-Schneidewin) esemplifica il tipo di favola sibaritica. Per i riferimenti relativi al proverbio, v. sotto. Il puledro Sintipa 45 Un uomo era trasportato da una cavalla gravida, quando, lungo il percorso, essa generò un puledro. La bestiola si mise subito al seguito della madre e perse presto la stabilità; così disse al passeggero della madre: «Ecco, vedi che io sono molto piccolo e non ho sufficiente forza per viaggiare. Sappi che, se mi lasci qui, non tarderò a morire. Ma se mi porti via da qui, mi conduci a casa e mi nutri, in futuro, una volta cresciuto, io mi lascerò guidare da te». Questa favola dimostra che bisogna trattare bene coloro dai quali si spera anche di essere ricompensati per le buone azioni. PROVERBI ῎Eρδoι τις ἣν ἕκαστoς εἰδείη τέχνην Ognuno si occupi del mestiere che sa fare Il proverbio, tratto dal v. 1431 delle Vespe di Aristofane, è illustrato dal poeta con un gustoso quanto esplicito quadretto, che ne spiega immediatamente il senso. Numerose sono le riprese, in contesti letterari differenti (per cui si rimanda a Tosi 1991, 258 e a Adrados 2003, 392). Tra le altre, si segnala la citazione e la traduzione di Cicerone (Epistulae ad Atticum 5,10,13; Tusculanae disputationes 1,18,41). Interessante, poi, in quanto calato nel mondo animale, il riferimento che ne fa Orazio (Epistole 1,14,43), relativo al cavallo desideroso di arare e al bue che, viceversa, reclama la sella.
Cedro del Libano Albero imponente, dalla lunga vita, apprezzato nell’antichità anche per la qualità del legno, il cedro del Libano è simbolo di immortalità e nel Vicino Oriente va a rappresentare la dignità regale. Nella Bibbia compare spesso come simbolo di potenza e di grandezza, qualità che rischiano di fare esaltare oltre la giusta misura chi le possiede (Ezechiele 31,1-18). Nel libro dei Giudici (9,8-15), l’albero entra anche in una narrazione dai connotati favolistici: le piante che cercano un re. La favola viene ripresa nella tradizione greca (Esopo 252 Ch). Sia qui sia nel passo biblico, il ramno (rovo) accetta con arroganza, pur senza esserne degno, di diventare re delle piante e minaccia un fuoco tale da divorare il cedro del Libano, evidentemente simbolo, anche in questo caso, di un albero dalle notevoli qualità, agli antipodi dell’indegno candidato (cfr. ROVO, OLIVO, FICO). Nella Bibbia troviamo la pianta calata anche in un’altra narrazione di tipo favolistico, che non ha paralleli nella tradizione greca e romana (2 Re 14,8-13). Gioas, re di Israele, risponde non senza disprezzo, con un apologo, ad Amasia, re di Giuda, che lo invita a misurarsi faccia a faccia: il cardo manda a dire al cedro del Libano di dare in moglie la figlia a suo figlio; tuttavia, le bestie selvatiche del Libano calpestano il cardo. Gioas aggiunge che Amasia, dopo avere sconfitto gli Edomiti, è divenuto altero e lo invita a non provocare una calamità. Inevitabile, arriva, dunque, la guerra: Amasia perde e viene fatto prigioniero.
Cervo Nel mito, Atteone viene trasformato in cervo e poi sbranato dai cani per avere spiato la dea Artemide nuda. La dea, peraltro, in quanto protettrice della caccia, viene messa in relazione al cervo (associato per lo più alle divinità lunari) ed è spesso rappresentata nell’atto di trafiggere con una freccia questo animale, che nell’antichità è preda molto ambita nella caccia. A proposito di questo animale, sono, tra l’altro, riportate diverse credenze curiose: ad esempio, si pensa che abbia un udito eccezionale quando alza le orecchie, ma che diventi sordo nel momento in cui le abbassa (Aristotele, Historia animalium 611b). In generale, il cervo è simbolo di timidezza, vigliaccheria e longevità. È attestata in Omero (Iliade 1,225) l’espressione spregiativa «cuore di cervo», impiegata per indicare una persona vile (in questo caso, è usata da Achille nei confronti di Agamennone). Si attribuisce inoltre al cervo una lunghissima vecchiaia, perché vivrebbe per un periodo pari a trentasei volte l’esistenza degli uomini (cfr. Tosi 1991, 314), per cui è assai diffusa l’espressione Cervus vivax, ossia «Cervo longevo» (cfr., ad esempio, Virgilio, Bucoliche 7,30), anche se Aristotele non accoglie questa credenza (Historia animalium 578b). Viene inoltre considerato animale veloce e agile per antonomasia (cfr. Otto 81), anche nella tradizione giudaico-cristiana, che rappresenta l’animale con caratteristiche positive (cfr. Isaia 35,6). In Plauto (Poenulus 529 s.) troviamo un certo Agorastocle, il quale afferma che se i suoi interlocutori fossero invitati a pranzo, vincerebbero «nella corsa un cervo e nel camminare una persona che va sui trampoli». In questo caso, secondo Della Corte 1958, 43, l’autore comico si riferirebbe a una favola sul modello di Fedro (1,12) o di Esopo 102 Ch., narrazioni in cui il cervo è delineato nella sua tipica rapidità di corsa. Costretto a soccombere di
fronte ai più forti, questo animale è vittima designata e rientra in quella categoria di personaggi esopici la cui funzione pare quella «di subire le varie situazioni per permettere agli avversari di mostrare il loro carattere e le loro tendenze» (Pugliarello 1973, 127). I nemici più ricorrenti e insidiosi sono, da un lato, il leone e, dall’altro, i cacciatori, talora accompagnati dai fedelissimi cani: così accade che l’animale fugga dagli uni per finire nelle grinfie dell’altro (Esopo 104 Ch.). Questi avversari del cervo sono considerati in modo equivalente, tanto che possono alternarsi come protagonisti di uno stesso motivo narrativo: ad esempio, la citata favola 102 Ch., che corrisponde alla 1,12 di Fedro. In questa narrazione il paradosso, colto dai favolisti antichi, risiede nella differente utilità di corna possenti, che alla fine si rivelano decisive per la cattura del cervo, e di zampe sottili, gli unici mezzi in grado di procurare la salvezza all’animale. Un altro paradosso che caratterizza la figura del cervo nella favolistica è costituito, come accade anche ad altri animali, dall’apparente incoerenza tra dimensioni e coraggio. La favola 247 Ch. di Esopo presenta la curiosa domanda di un cerbiatto, che chiede al padre il motivo della sua paura nei confronti dei cani, considerate le sue dimensioni e le corna possenti di cui dispone: è l’istinto a sovrastare la ragione. Peraltro, il cervo non si dimostra nemmeno dotato di grande intelligenza e viene raggirato per due volte dalle lusinghe della volpe (Esopo 199 Ch.); oppure, spinto in fuga dalla consueta «cieca paura», finisce per nascondersi in una stalla, dove il padrone, attento ai suoi beni, lo riconosce e lo fa uccidere (Fedro 2,8; v. sotto per il proverbio). Anche in altre narrazioni (Sintipa 20; Esopo 105 Ch.), il cervo si conferma perfettamente calato nel ruolo di vittima, per quanto possano cambiare il contesto e le ragioni per cui soccombe. Il leone furioso e il cervo Esopo 212 Ch.
Un leone era furibondo. Un cervo lo vide dalla foresta ed esclamò: «Poveri noi, infelici! Che cosa non farà infatti costui, infuriato com’è, visto che anche quando non era ancora fuori di sé risultava a noi insopportabile». Tutti stiano lontani dagli uomini violenti e inclini alla malvagità, quando conquistano il potere e lo esercitano. RIFERIMENTI: cfr. Babrio 90; Parafrasi 213; Tetrastici 1,38; Dodecasillabi 183. Il cervo e il leone in una grotta Esopo 104 Ch. Un cervo, in fuga dai cacciatori, giunse davanti a una grotta in cui si trovava un leone e lì entrò con l’intenzione di nascondersi. Tuttavia, venne catturato dal leone; mentre veniva divorato, disse: «Povero me! Mentre fuggivo dagli uomini, mi sono infilato tra le grinfie di una belva». Così alcuni uomini, per paura di un pericolo minore, si gettano in uno più grande. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,17. Il cerbiatto e il cervo Esopo 247 Ch. Una volta un cerbiatto disse al cervo: «Papà, tu sei per natura più grande e più veloce dei cani e hai corna straordinarie per difenderti. Perché mai, dunque, ti fanno così paura?». Il cervo allora gli
rispose, non senza sorridere: «Figlio mio, quanto dici è vero; d’altra parte, io so solo questo, che quando mi capita di sentire il latrato di un cane, subito ho l’istinto di darmi, non so come, alla fuga». La favola dimostra che nessuna rassicurazione infonde coraggio a quanti sono paurosi per natura. RIFERIMENTI: Aftonio 17; Parafrasi 238; Dodecasillabi 238; Nicolao, Esercizi preparatori 1,4 (testo uguale a quello di Aftonio). Il cervo ammalato Sintipa 20 Un cervo si ammalò e si distese su un prato, in pianura. Alcuni degli animali che vennero a fargli visita, tuttavia, divorarono l’erba del pascolo su cui si trovava. Quindi, superata la malattia, la bestiola cominciò a debilitarsi terribilmente a causa della mancanza di cibo e, oltre al pascolo, finì così per perdere anche la vita. Questa favola dimostra che coloro che hanno un gran numero di amici sciocchi, invece di guadagnarci, da loro ricevono piuttosto un danno. RIFERIMENTI: Babrio 46. Il cervo alla fonte e il leone Esopo 102 Ch. Un cervo, oppresso dalla sete, arrivò a una fonte; dopo aver bevuto, come si vide riflesso nell’acqua, osservò la grandezza e la forma articolata delle sue
corna e se ne sentì fiero; era invece davvero preoccupato per le zampe, poiché erano sottili e deboli. Mentre ancora era immerso in questi pensieri, comparve un leone e si mise a inseguirlo. Il cervo prese a fuggire e stava davanti al leone con un notevole distacco (la forza dei cervi, infatti, risiede nelle zampe, quella del leone nel cuore). Fino al punto in cui la pianura era priva di alberi, il cervo era salvo, mantenendo il leone a distanza. Quando però giunse in un bosco, accadde che le sue corna si impigliarono nei rami e, poiché non riusciva a correre, fu catturato. Ormai sul punto di morire, disse tra sé: «Povero me! Mi stavano salvando le zampe, che avrebbero dovuto tradirmi; vado in rovina, invece, a causa delle corna, di cui avevo piena fiducia». Così spesso, nelle situazioni pericolose, gli amici che guardiamo con diffidenza diventano nostri salvatori, quelli in cui riponiamo tutta la nostra fiducia la tradiscono. RIFERIMENTI: Fedro 1,12; Babrio 43; Tavolette Assend. 12; Pseudo-Dositeo 1; Aftonio 18; F. dattiliche 3; Sintipa 15; Parafrasi 103; Tetrastici 1,14; 2,11; Romulus 57 (Van Dijk in Adrados 2003, 104 suggerisce anche un’allusione in un’epistola di Libanio: 1395,4). Il cervo e i buoi Fedro 2,8 Un cervo, stanato dalle fronde tra cui si nascondeva, si diresse, spinto da cieca paura, verso la fattoria più vicina, per sfuggire alle insidie mortali dei cacciatori, e si nascose nella stalla dei buoi,
opportunamente trovata. Qui a lui, che se ne stava ben acquattato, disse un bue: «Che idea ti è venuta, sciagurato? Sei corso spontaneamente verso la morte e hai affidato la tua vita alla casa degli uomini?». Ma il cervo, implorando, rispose: «Almeno voi risparmiatemi. Alla prima occasione che si presenterà, balzerò nuovamente fuori». Allo spazio del giorno segue il corso della notte. Il bovaro porta il foraggio, senza tuttavia accorgersi di nulla. Vanno più volte e tornano i contadini: nessuno nota nulla. Passa anche il fattore e nemmeno lui coglie nulla. Allora, con grande gioia, la bestia selvatica prese a ringraziare i placidi buoi per l’ospitalità resa in un frangente difficile. Uno dei buoi gli rispose: «Desideriamo davvero che tu possa salvarti; tuttavia, se verrà colui che ha cento occhi, la tua vita correrà un grande pericolo». Ma in quel momento, ecco proprio il padrone, reduce dalla cena; notati, poco prima, i buoi in disordine, s’avvicina alla mangiatoia: «Per quale motivo c’è poco foraggio e manca lo strame? Costa molta fatica togliere queste ragnatele?». Mentre osserva con attenzione ogni singola cosa, nota anche le alte corna del cervo; chiama i servi, dà disposizione che sia ucciso e s’impossessa della preda. Questo è il significato della favola: il padrone vede particolarmente bene nei suoi affari. RIFERIMENTI: Romulus 69. Il cervo cieco da un occhio Esopo 105 Ch. Un cervo, che era rimasto privo di un occhio, giunse sulla riva del mare e lì pascolava: volgeva
l’occhio sano verso terra, in modo da stare in guardia rispetto al possibile arrivo dei cacciatori, mentre teneva l’occhio cieco in direzione del mare, da dove immaginava che non incombesse alcun pericolo. Tuttavia, alcuni uomini, che navigavano da quelle parti, lo videro e lo abbatterono. Allora il cervo, esanime, disse tra sé: «Sono davvero disgraziato! Rivolgevo la mia attenzione alla terra, che ritenevo insidiosa, mentre si è rivelato molto più pericoloso il mare, presso cui pensavo di trovare rifugio». Così, spesso, contro la nostra aspettativa, le situazioni che ci sembrano difficili si rivelano vantaggiose, quelle che invece riteniamo utili alla nostra salvezza si dimostrano pericolose. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,12. Cfr. anche Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 67, ed. Boissonade). Il leone, la volpe e il cervo Esopo 199 Ch. Un leone giaceva ammalato in una caverna. Disse allora a una volpe, con cui era amico e aveva una certa familiarità: «Se vuoi che io guarisca e viva, inganna e conduci qui, tra le mie grinfie, con le tue suadenti parole, quel grande cervo che abita nella foresta; ho brama infatti delle sue viscere e del suo cuore». Allora la volpe andò a scovare il cervo, che scorrazzava nei boschi; gli si accostò con un modo di fare gentile, lo salutò e disse: «Sono venuta a darti buone notizie: sai che il nostro re, il leone, è mio vicino; ora, tuttavia, è ammalato e prossimo alla morte, perciò ragionava su chi potesse essere il suo successore. Ha detto, d’altra parte, che il cinghiale è
stolto, l’orso ottuso, la pantera collerica, la tigre vanagloriosa. Il cervo è pertanto il più degno del trono, poiché è di aspetto imponente, vive per molti anni e le sue corna sono temibili per i serpenti. Ma perché farla tanto lunga? Sei stato scelto per regnare. Che cosa avrò, allora, io in cambio, per avertelo annunciato per prima? Forza, ti prego, dimmelo, perché ho fretta e temo che il leone mi cerchi di nuovo; infatti, in tutto ha necessità dei miei consigli. Anzi, se vuoi dare ascolto a me, che sono anziana, vieni anche tu – questo è il mio consiglio – e rimani accanto a lui in queste ultime ore della sua vita». In questo modo parlò la volpe. Allora il cervo si inorgoglì per quel discorso e così andò nella grotta, senza immaginare che cosa stesse per capitare. Il leone piombò su di lui in modo fulmineo, ma riuscì solamente a lacerargli le orecchie con gli artigli. Il cervo allora fuggì rapidamente nel bosco. La volpe, da parte sua, batté le zampe, poiché si era affaticata invano. Il leone, invece, prese a gemere con forti ruggiti. Era, infatti, affamato e sofferente. Si mise dunque a supplicare la volpe di fare un secondo tentativo e di condurre nuovamente, con l’inganno, il cervo da lui. La volpe allora rispose: «Mi affidi un incarico difficile e spiacevole, tuttavia ti renderò questo servizio». E andava alla ricerca del cervo come un segugio, tramando inganni. Chiese ai pastori se avessero notato un cervo sanguinante. Quelli la indirizzarono verso il bosco. Lo trovò, dunque, mentre era intento a rinfrescarsi e gli si parò davanti con sfacciataggine. Il cervo, adirato e con il pelo rizzato, disse: «Sporca bestiaccia, non mi prenderai più: prova ad avvicinarti e sarai finita. Vai a imbrogliare con i tuoi trucchi da volpe altri che non sanno chi sei, incorona altri e fai loro montare la testa». La volpe allora rispose: «A tal punto sei vigliacco e pauroso? A tal punto nutri sospetti verso
di noi, che siamo tuoi amici? Il leone, poiché stava morendo, ti aveva preso le orecchie e stava per darti consigli e indicazioni riguardo al tuo importante ruolo di sovrano. Ma tu nemmeno il graffio della zampa di un malato sei riuscito a sopportare. Ora è ancora più in collera con te e vuole fare re il lupo: ahimè, un malvagio signore! Ma su, vieni e non farti prendere dalla paura e sii docile come una pecora. Ti giuro infatti, per tutte le foglie e le fonti, che tu non subirai niente di male dal leone. Io voglio essere al servizio soltanto tuo». Avendo così ingannato il disgraziato animale, lo persuase ad andare una seconda volta dal leone. Appena entrò nella caverna, il leone ebbe il suo pasto e poté succhiare tutte le ossa, le midolla e le viscere del cervo. La volpe se ne stava a guardarlo. Di nascosto arraffò il cuore, caduto, per mangiarselo come ricompensa del suo sforzo. Il leone, passati in rassegna tutti i pezzi, era alla ricerca del cuore. La volpe allora, standosene a distanza, gli disse: «Questo animale non aveva davvero un cuore. Smettila di cercarlo. Che cuore poteva avere chi si è cacciato per due volte nella tana e tra gli artigli del leone?». La brama di onore offusca la mente dell’uomo e non permette di individuare le situazioni di pericolo. NOTA: il cuore dell’intelligenza.
era
ritenuto
la
sede
RIFERIMENTI: Babrio 95; Parafrasi 200; F. dattiliche 9 (altre allusioni sono ipotizzate da Adrados 2003, 438 s.: la più suggestiva e discussa è quella relativa alla ricostruzione di un epodo archilocheo; pare preferibile, tuttavia, assecondare la prudenza di Van Dijk 1997, 637; 649; 676). La pecora, il cervo e il lupo
Fedro 1,16 Un imbroglione, quando si affida alla malleveria delle persone disoneste, non intende regolare la questione, ma compiere un’azione malvagia. Un cervo chiedeva in prestito a una pecora un moggio di frumento: ne sarebbe stato garante il lupo. Ma quella, che sospettava un tranello, disse: «Rapinare e andarsene è sempre stata una caratteristica del lupo. Tua abitudine è invece fuggire dalla vista a grande velocità. Dove vi troverò, una volta arrivato il giorno della scadenza?». RIFERIMENTI: Romulus 40. PROVERBI Dominum videre plurimum in rebus suis Il padrone vede particolarmente bene nei suoi affari Questa massima, tratta da un verso della favola del cervo e dei buoi (Fedro 2,8,28), trova riscontro in diverse espressioni affini e talora più specificamente caratterizzate (secondo il modello «Niente ingrassa tanto il cavallo come l’occhio del re»: cfr. i numerosi riferimenti elencati da Tosi 1991,472 s.). Si tratta, peraltro, di proverbi di larga diffusione fino ai nostri giorni: tendono, in sostanza, a sottolineare l’efficacia della vigilanza del padrone sui propri beni, come appunto dimostra la favola.
Chiocciola Aristotele classifica la chiocciola tra i testacei (Historia animalium 527b), segnalandone anche la natura «ermafrodita». Marginale nel mito (è al centro di una prova superata da Dedalo in fuga da Creta), questa singolare creatura colpisce gli antichi soprattutto per una caratteristica: porta con sé la propria casa. Pertanto, è definita, con una significativa parola composta, ϕέρoικoς («portatrice della casa») già da Esiodo, che aggiunge un’interessante osservazione: quando la lumaca da terra sale sugli alberi, è giunto il tempo della mietitura (Le opere e i giorni, vv. 571 ss.). Allo stesso modo, con un termine che ricalca la parola greca, è detta domiporta in Cicerone (De divinatione 2,133), dove è anche descritta come «figlia della terra», «dal passo lento» e «priva di sangue». Alla luce dell’ermafroditismo e della casa che porta sempre con sé, diventa emblema della terra, intesa nelle implicazioni divine di magna mater; il guscio e la sua particolare forma la legano, inoltre, alla simbologia del parto e del ventre della donna. In diverse culture è associata alla luna. Le poche favole che vedono protagonista la chiocciola valorizzano caratteristiche ampiamente attestate nell’immaginario del mondo antico: in una narrazione (Esopo 172 Ch.), troviamo un uomo che arrostisce le chiocciole e le rimprovera perché cantano mentre bruciano le loro case. Questa situazione conferma quanto colpisca gli antichi lo stretto rapporto con la casa; inoltre, segnala indirettamente quanto le lumache siano apprezzate sul piano gastronomico: fatto testimoniato da diverse fonti; ad esempio, Plinio (Naturalis historia 9,173) spiega che un certo Fulvio Lippino aveva addirittura dei vivai di lumache, dove erano separate secondo le differenti specie. Una favola del Romulus (9) mette, invece, in prosa una narrazione fedriana che non ci è pervenuta: qui si segnala il tema della bava della chiocciola
come elemento di impurità in contrasto con lo splendore dello specchio. Di qui la morale rivolta alle donne che si uniscono a uomini indegni. Anche al di fuori della cultura greco-romana troviamo il riferimento, in chiave negativa, alla viscida traccia prodotta dalla bava della chiocciola. Da rilevare che nella Bibbia (Salmi 58,9), riguardo ai giudici iniqui, si legge: «Passino come bava di lumaca». Le chiocciole Esopo 172 Ch. Il figlio di un agricoltore arrostiva delle chiocciole. Poiché le sentiva come risuonare, disse: «Bestiacce, mentre bruciano le vostre case, voi cantate!». La favola dimostra che tutto quello che si compie fuori tempo è degno di essere criticato. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,18. La chiocciola e lo specchio Romulus 9 Una chiocciola s’imbatté in uno specchio. Colpita dalla sua straordinaria lucentezza, se ne innamorò e subito, salendo sopra il disco, incominciò a leccarlo. Ma a lei non sembrò di aver ricavato alcun piacere se non quello di imbrattarne lo splendore con la saliva e con le sue impurità. Una scimmia lo trovò così sporco e disse: «Coloro che si lasciano calpestare da simili individui meritano di soffrire tali conseguenze». Per le donne che si uniscono a uomini stolti e senza qualità.
Cicala Il canto è il principale elemento di caratterizzazione della cicala, che sembra consacrare a esso tutta la sua vita. Proverbiale è l’espressione «Dalla voce più melodiosa di una cicala» (v. sotto). Narra Platone (Fedro 259bc) che un tempo le cicale erano uomini, i quali, dopo la nascita delle Muse, furono travolti dal piacere del canto e, dimenticando di bere e di mangiare, vennero trasformati nella stirpe delle cicale. Esse cantano così fino alla morte per poi giungere nel cielo, tra le Muse, a riferire chi in terra le onori. Sono due le caratteristiche del canto secondo gli antichi: la melodiosità e la continuità. Ancora in ambito cristiano, san Girolamo raccomanda a Eustochio di essere «la cicala della notte», invitandolo a una preghiera senza soste (Epistole 22,48). Ma queste caratteristiche possono essere lette in modo differente: la melodiosità diventa «stridulo canto» (Virgilio, Bucoliche 2,12-13); la continuità assume anche una valenza negativa (cfr. Ovidio, L’arte di amare 1,271). La cicala è legata alla stagione estiva e perciò diventa naturale attributo del dio Apollo: secondo Eliano (De natura animalium 3,38; ma cfr. anche Aristotele, Historia animalium 682a), canta solo quando è riscaldata dal sole, poiché è fredda per costituzione. Sulla base di questi presupposti, la cicala non può godere di una fama positiva nell’utilitaristico mondo esopico. Una delle favole più celebri (la cicala e le formiche: Esopo 336 Ch.) la segnala come simbolo delle persone superficiali, agli antipodi della laboriosa formica, e diventa tanto celebre da essere ripresa nel capolavoro che apre la raccolta di La Fontaine (1,1). Questa fortunata narrazione, in alcune delle sue numerose versioni (Aviano 34; Aftonio 1), diventa un’esortazione ai giovani, perché si impegnino e non restino inerti, evitando così i guai che ne deriverebbero nella vecchiaia. La tradizione favolistica (cfr. Esopo 278 Ch.) riprende anche la credenza secondo cui le cicale si nutrono
di rugiada (leccandola con un organo posto al centro del petto, visto che sono sprovviste di bocca, secondo Plinio, Naturalis historia 11,93-94). A colpire gli antichi è anche la sproporzione tra l’intensità del canto e le modeste dimensioni (Aftonio 4): la cicala suggerisce così l’immagine di chi non vale nulla, pur dandosi arie di persona importante. Come spesso accade nel mondo esopico, tuttavia, proprio il suo essere insignificante diventa l’àncora di salvezza nei momenti difficili: non essendo utile, la cicala ha salva la vita (così sembra suggerire Sintipa 62: la salvezza è peraltro resa esplicita nella versione esopica 298 H.-H.). Fedro (3,16) riprende il motivo dell’insistenza molesta del canto della cicala, che finisce, a causa della sua scortesia, per essere vittima della civetta. In questo caso, la cicala è stata interpretata come il simbolo del poeta che perseguita gli altri, continuando a declamare i suoi componimenti (cfr. Mandruzzato 341). Insomma, il profilo della cicala è tendenzialmente negativo nell’ambito della tradizione favolistica, anche se eccezionalmente la cicala può emergere per la saggezza (Esopo 335 Ch.) o compiere un’azione giusta, quando supplica il contadino di non abbattere un albero infruttuoso, che poi si rivela pieno di miele (Esopo 85 Ch.). Il cacciatore di uccelli e la cicala Aftonio 4 Favola del cacciatore di uccelli e della cicala, che esorta a prestare attenzione non alle parole ma alle azioni. Un cacciatore, sentendo una cicala, era convinto di dare la caccia a qualcosa di enorme, poiché stimava le dimensioni della preda di caccia sulla base del volume del canto. Tuttavia, come si affrettò e la catturò, non ottenne niente di più di un canto e allora se la prese con l’apparenza che conduce
spesso a giudizi sbagliati. Allo stesso modo, persone di nessun valore possono apparire molto più di quello che sono. RIFERIMENTI: Plutarco, Apoftegmi spartani 233a; non mancano allusioni in alcuni retori e altri possibili paralleli nell’Antologia Palatina (epigrammi 9,264; 9,273: gli uccellatori sono puniti per avere dato la caccia alla cicala) rilevati da Van Dijk (cfr. Adrados 2003, 459-460). L’uomo e la cicala Sintipa 62 Una cicala vide un uomo che stava cercando di catturarla. Così gli disse: «Vai a caccia di quegli uccelli da cui puoi trarre davvero una qualche utilità! Non hai proprio nulla da guadagnare, infatti, catturando me». Questa favola dimostra che non dobbiamo inseguire quanto è inutile e poco redditizio. RIFERIMENTI: la favola non è presente nella collezione esopica di Chambry; cfr. tuttavia 298 H.H.; Romanzo di Esopo 99 (qui si ha una cavalletta al posto della cicala). L’asino e le cicale Esopo 278 Ch. Un asino sentì delle cicale cantare e fu preso da invidia per la loro bella voce; allora domandò che cosa mangiassero per emettere una tale melodia. Le cicale risposero: «Rugiada!». L’asino, aspettando la
rugiada, morì consumato dalla fame. Così, anche coloro che coltivano desideri contro natura non conseguono l’obiettivo e vanno incontro alle peggiori sventure. RIFERIMENTI: Sintipa 1. La cicala e le formiche Esopo 336 Ch. Nella stagione invernale le formiche facevano asciugare il grano umido. Una cicala, che aveva fame, chiese loro un po’ di cibo; allora le formiche le domandarono: «Perché non hai raccolto anche tu il nutrimento durante l’estate?». La cicala rispose: «Non avevo tempo perché cantavo melodiosamente». Allora le formiche, ridendo, dissero: «Se d’estate hai suonato, d’inverno danza!». La favola dimostra che non bisogna comportarsi superficialmente per non ritrovarsi a patire sofferenze o a correre pericoli. RIFERIMENTI: Babrio 140; Pseudo-Dositeo 17; Parafrasi 336; Dodecasillabi 336; Aftonio 1; Aviano 34; Codice Brancacciano 14; Sintipa 43; Tetrastici 1,6; 2,25; Romulus 93; Luciano, Lettere Saturnali 402; Teofilatto Simocatta, Epist. 61 Boiss.; Dossopatre 2,177-190 Walz. La cicala e la volpe Esopo 335 Ch. Una cicala cantava su un alto albero. Una volpe, che voleva mangiarla, architettò uno stratagemma di questo genere. Si pose di fronte a lei, ammirò il suo
bel canto e la invitò a scendere, sostenendo che desiderava vedere le dimensioni di un animale dotato di una voce tanto potente. Quella, che aveva intuito l’inganno, strappò una foglia e la lasciò cadere. La volpe accorse, credendo che si trattasse della cicala, e quest’ultima disse: «Ti sei sbagliata, carissima, se credevi che sarei scesa: io, in effetti, sto in guardia dalle volpi dal giorno in cui ho visto negli escrementi di una volpe le ali di una cicala». Le sventure del prossimo rendono accorti gli uomini saggi. PROVERBI Tέττιγoς εὐϕωνότερoς Dalla voce più melodiosa di una cicala Il proverbio, riportato da Apostolio (16,37) in relazione a «coloro che si danno al canto», sancisce una caratteristica della cicala largamente rilevata dagli autori antichi (v. sopra), per quanto ambigua nella sua percezione. L’aggettivo in greco ha un doppio valore e può significare «dalla bella voce» o «dalla forte voce». Il proverbio ha fortuna anche nell’espressione latina cicada vocalior, presente negli Adagia di Erasmo (1,9,100). Cfr. Tosi 2006, 88 ss.
Ciclope Figli di Urano e di Gea, i ciclopi sono, secondo il mito, giganti che fabbricano i fulmini per Zeus. Sono dotati di un solo occhio. La tradizione presenta altri tipi di ciclopi, attribuendo loro le funzioni di fabbri e di costruttori. Omero, invece, li descrive come un popolo di giganti sgraziati, mostruosi, asociali, impegnati nella pastorizia, che non si curano della divinità e mangiano gli uomini (il più noto è Polifemo). Rappresentano, agli occhi dei Greci, il simbolo di quanto si oppone alla civiltà. Generalmente estranei alla favolistica, si ritrovano in una versione della vicenda relativa all’uomo giusto che perde i suoi beni (Sintipa 48). In quest’ottica il ciclope, come chiarisce anche l’epimitio, rappresenta l’individuo malvagio, a cui giustamente toccano la sventura e la morte. Il riferimento al tema del tesoro del ciclope non sembra trovare precedenti puntualmente ricollegabili. Il ciclope e il suo tesoro Sintipa 48 Un uomo irreprensibile, forse anche esemplare nella sua condotta, godette per un bel pezzo di una esistenza agiata insieme con i suoi figli, ma poi cadde in una condizione di estrema povertà. Il suo animo, com’è naturale in questi casi, era afflitto e l’uomo si lasciava andare alle bestemmie, sentendosi costretto al suicidio. Così prese la spada e cercò un luogo deserto, preferendo morire piuttosto che vivere miseramente. Sulla sua strada, s’imbatté in una fossa profonda, in cui si trovava un consistente gruzzolo d’oro, nascosto da un gigante chiamato ciclope. Vedendo l’oro, quest’uomo onesto è
sopraffatto subito dal timore e dalla gioia. Depone così la spada, porta via di lì l’oro e torna a casa dai figli, tutto felice. Successivamente, il ciclope giunse alla fossa, non trovò l’oro e vide al suo posto una spada: subito la afferrò e si ammazzò. La favola dimostra che le disgrazie colpiscono naturalmente le persone cattive, mentre gli eventi belli sono dispensati alle persone oneste e prudenti. RIFERIMENTI: Antologia Palatina 9,44-45; Ausonio, Epigrammi 14, p. 316 Pei. (23 Green); Diogene Laerzio 3,33; Epigrammata Bobiensia 28. In questi casi il ciclope non è menzionato.
Cicogna La cicogna nell’antichità è considerata simbolo di pietas e, in particolare, rappresenta le persone che si prendono cura dei genitori (cfr. Aristofane, Uccelli 1355 ss.), secondo una tradizione che ha lunga fortuna anche nei bestiari medievali. Il senso della lealtà e della famiglia è così sviluppato in loro che le cicogne non tollerano i tradimenti coniugali: si narra che una cicogna accecò la bella Alcinoe, moglie infedele di un uomo della Tessaglia (Eliano, De natura animalium 8,20). Spesso cicogne e gru vengono menzionate insieme (anche nel mito; cfr. Ovidio, Metamorfosi 6,90 ss.: Antigone viene trasformata in cicogna da Giunone) e sono loro attribuite caratteristiche comuni, compresa la leggenda secondo cui esiste un’ostilità nei confronti dei Pigmei (cfr. Omero, Iliade 3,3 ss.; v. anche GRU). Le cicogne sono sacre a Era (Giunone), di buon auspicio per la famiglia e vengono considerate manifestazioni della Grande Madre come generatrici di vita. Non è, d’altra parte, chiara l’origine (forse nordica) della credenza secondo cui sarebbero portatrici dei neonati (cfr. Cattabiani 2000, 163 s.). Gru e cicogne compaiono insieme anche in una favola di Esopo (284 Ch.), in cui la cicogna viene catturata insieme alla gru: pur simboleggiando, in linea con la tradizione positiva associata a questo volatile, le persone giuste, viene punita perché, come spiega la morale, frequenta cattive compagnie (ossia le gru); in questa favola, inoltre, la cicogna rivendica la sua utilità per l’uomo, per il fatto che cattura e divora i rettili. Si tratta di un motivo di merito che viene riconosciuto all’uccello anche da altri autori (cfr. Seneca, Epistulae ad Lucilium 104; Giovenale 14,74). Inoltre, sempre a proposito della frequente associazione di gru e di cicogne, va segnalato che i due animali tendono a sovrapporre la loro immagine nella tradizione favolistica. Così, la nota
narrazione della cicogna e della volpe (Fedro 1,26) si ritrova anche nella versione che prevede la sostituzione della cicogna da parte della gru (v. sotto). Il motivo favolistico è molto celebre, al punto che esistono diverse rappresentazioni iconografiche (tra le più antiche, una pittura vascolare forse del III secolo a.C. e una stele funeraria del I secolo d.C., rinvenuta a Villa Dianella, vicino a Empoli). L’immagine di questo uccello non è sempre positiva. In una delle favole in prosa di derivazione fedriana (Romulus 80), troviamo una cicogna che si professa coraggiosa e vuole difendere un’oca, ma quando giunge l’inesorabile sparviero, il destino dell’oca è ovviamente segnato. La volpe e la cicogna Fedro 1,26 Non si deve arrecare danno a nessuno; d’altra parte, le eventuali offese dovranno essere ripagate con la stessa moneta: questo è l’ammonimento della favola. Si dice che una volpe avesse invitato per prima a cena una cicogna e le avesse offerto su un piatto del brodo, che in nessun modo la cicogna, affamata, poté gustare. A sua volta questa invitò la volpe e le servì una bottiglia piena di cibo tritato. Inserendo il becco, la cicogna mangia a sazietà, invece la commensale si ritorce per la fame. Mentre quella leccava vanamente il collo della bottiglia, sappiamo che l’uccello migratore si espresse in questo modo: «Bisogna che ognuno subisca di buon grado le conseguenze dell’esempio che ha dato». RIFERIMENTI: Romulus 43; Plutarco, Questioni conviviali 614e-f (la gru compare in alternativa alla cicogna).
Cigno Il cigno è associato al canto già a partire dal nome. Infatti, i termini che in greco (κύκνoς) e in latino (cygnus) designano l’uccello sembrano derivare dalla stessa radice indoeuropea propria anche del verbo «cantare». Non a caso l’animale diventa simbolo delle Muse e «cigno» è, soprattutto nella poesia e nella musica, qualifica onorifica, non solo nell’antichità (si pensi a Shakespeare, il cigno dell’Avon, o a Verdi, il cigno di Busseto). Proprio il canto, oltre al fatto che l’uccello trainerebbe, secondo una certa tradizione, il cocchio di Afrodite, collega il cigno alla sfera divina: riguardo al cosiddetto canto del cigno, espressione divenuta proverbiale, Platone (Fedone 84e-85b) fa dire a Socrate che questi uccelli, sacri ad Apollo, quando sentono vicina la morte, levano più alto e più bello il loro canto, felici di tornare presso gli dei, mentre gli uomini, per la loro paura della morte, erroneamente dicono che essi si lamentano. Il filosofo aggiunge una nota sulle doti profetiche dei cigni che prevedono le delizie dell’Ade. Il tema è presente anche nella letteratura latina: Cicerone (Tusculanae disputationes 1,30,73) riprende Platone proprio a questo proposito. La mitologia non trascura i cigni. Zeus, trasformatosi in cigno, amò Leda, che depose due uova: in uno di essi c’erano i Dioscuri. Cicno, figlio di Stenelo, fu mutato da Apollo in cigno e trasportato tra le costellazioni (esistono varie versioni del mito: fra le più note, quella di Ovidio, Metamorfosi 2,367 ss.). Spesso concepito come simbolo di saggezza, di coraggio e di purezza, in diverse culture antiche il cigno è associato alla divinità, in relazione ai temi ultimi della morte, come si è visto nella cultura greca e romana, e della vita. Nella cultura indiana, ad esempio, «l’uovo cosmico contenuto nelle acque primordiali viene covato dal cigno mitico (hamsa). Esso costituisce la forma primitiva di Brahma» (Walter 101 n. 25); qui inoltre il cigno è
cavalcatura di dei. La favola, pur non concedendo ampio spazio all’uccello, recepisce pienamente la tradizione relativa al proverbiale canto. Nella favola 173 Ch., il cigno, scambiato per un’oca, riesce a salvarsi dalla morte proprio grazie al suo canto: la morale suggerisce l’idea del canto del cigno come simbolo del potere salvifico della musica. Questo dato è rilevato anche nell’ambito dell’interpretazione dei sogni: secondo Artemidoro (Sull’interpretazione dei sogni 2,20), il cigno può corrispondere a un uomo che si dedica alla musica o addirittura «alla musica stessa». Viceversa, in un’altra favola (174 Ch.) sembra proprio il canto, che non arriva se non nell’imminenza della fine, a condannare l’uccello, indisponibile ad allietare il suo padrone durante la vita. Oltre al canto, è apprezzato il colore bianco delle sue piume (gli antichi non conoscono il cigno nero australiano, anzi l’idea che il cigno abbia quel colore rientra tra i fatti ritenuti impossibili: cfr., ad esempio, Lucrezio 2,824). In una favola, il corvo ne è invidioso e muore cercando invano di sbiancarsi (Aftonio 40). Il cigno è spesso presente nelle tradizioni favolistiche orientali. Da segnalare, in particolare, che l’aquila di una favola greca sembra sostituita dal cigno in una simile favola indiana del Pañcatantra (primo tantra, 11). La favola greca è la 351 Ch.: un’aquila solleva una tartaruga desiderosa di volare e poi la lascia cadere a terra. Il tema è molto simile, ma si rilevano importanti differenze in quella indiana, dove troviamo una tartaruga amica di due cigni. «Nell’indiana son due cigni, che innalzano per l’aria una testuggine, mentre nella greca è un’aquila, e dove nell’indiana la testuggine si appende con la bocca a un pezzo di legno sollevato dai cigni, nella greca essa è adunghiata dall’aquila. Inoltre, nell’indiana, mentre la testuggine rovina per la sua vanità, nella greca ella è lasciata cascar giù per la perversità dell’aquila»; al di là degli ulteriori elementi di diversità che si riscontrano in altre redazioni, comunque «queste differenze non vietano affatto che l’una favola sia derivata dall’altra» (Marchianò 89). Va precisato che il
termine hamsa, interpretato qui con cigno, è comune anche all’oca e non indica esattamente un cigno, ma un essere simile a esso, dai connotati fantastici. Il cigno preso per un’oca Esopo 173 Ch. Un uomo ricco allevava insieme un’oca e un cigno, naturalmente non per gli stessi motivi: il cigno per il canto, l’oca per la tavola. Quando arrivò il momento in cui l’oca doveva affrontare il suo destino, era notte e la circostanza impedì di distinguere l’una dall’altro. Il cigno, allora, preso al posto dell’oca, intonò un armonioso canto, preludio della morte; così grazie a quella melodia si salvò. La favola mostra che la musica spesso consente di differire la morte. RIFERIMENTI: Aftonio 2. Il cigno e il suo padrone Esopo 174 Ch. Dicono che i cigni cantino nell’imminenza della morte. Un uomo, imbattendosi in un cigno messo in vendita, poiché aveva sentito dire che è un animale dotato di canto melodioso, lo comprò. E un giorno, visto che aveva ospiti a pranzo, andò a pregarlo di cantare durante il banchetto. Ma l’animale allora rimase in silenzio; in seguito, però, si mise a intonare un canto funebre su se stesso, quando comprese che stava per morire; così il padrone, udendolo, gli disse: «Se tu non ti metti a cantare che quando muori, ero stolto io che allora ti chiedevo di esibirti, senza
sacrificarti». Così alcuni tra gli uomini compiono a forza quelle azioni che non vogliono concedere di loro spontanea volontà. Il corvo e il cigno Aftonio 40 Favola del corvo: esorta a obbedire alla natura. Il corvo, avendo visto il cigno, lo invidiava per il colore delle sue piume. Pensando che fosse dovuto all’acqua in cui il cigno faceva il bagno, il corvo lasciò gli altari dove trovava il cibo e si tuffò nelle paludi e nei fiumi. Ma, pur lavandosi, non mutò l’aspetto e morì di fame. Una diversa abitudine non può mutare la natura. PROVERBI Kύκνειoν ᾆσμα Il canto del cigno Il proverbio, che sembra trovare la sua prima attestazione letteraria nell’Agamennone di Eschilo (1444 s.), tende a indicare «un ultimo disperato tentativo, specie se effettuato tramite un discorso», come quello attestato da Polibio (30,4,7), che vede protagonisti gli ambasciatori di Rodi a Roma (cfr. Tosi 1991, 294 s.). Su questo proverbio si basano chiaramente due favole di Esopo (173 e 174 Ch.), una delle quali addirittura comincia riportando la credenza popolare che caratterizza poi lo svolgimento della narrazione. Questo modo di dire ha lunga fortuna nella letteratura antica ed è ancora in uso in diverse lingue europee.
Cinghiale Alla luce della condizione selvatica, il cinghiale è generalmente simbolo di coraggio e di forza, anche se la sua immagine è ambivalente: ora ha natura divina, ora viene considerato animale malvagio e impuro (Cooper 103). Insidioso, preda ambita dai cacciatori, questo animale è al centro di miti simili anche presso popolazioni lontane: nella tradizione sumero-semitica, un cinghiale uccide Tamnuz (proprio come accade a Adone nella mitologia greca) mentre va a caccia. Sacro ad Ares (Marte), è anche attributo di Demetra e di Atalanta. La rappresentazione del cinghiale come simbolo di forza, sempre nell’ambito della caccia, è attestata spesso nella letteratura antica, a partire dalle similitudini omeriche, in cui emerge come nemico di uomini e cani, con le setole rizzate, gli occhi luminosi, i denti aguzzi (Iliade 13,470 ss.). A tale proposito, Eliano (De natura animalium 6,1) spiega che, quando è pronto a combattere, il cinghiale affila le zanne sulle pietre levigate. Viene accostato all’orso da Artemidoro (Sull’interpretazione dei sogni 4,56) come simbolo degli uomini violenti e solitari. Nella favolistica, il cinghiale si segnala puntualmente per la sua selvatica fierezza e spesso appare in conflitto con il leone. Litiga con il re degli animali, disputandosi una piccola fonte (Esopo 203 Ch.); si vendica di un vecchio oltraggio quando la temibile belva è anziana e abbandonata dalle forze (Fedro 1,21). Del resto, anche nei proverbi sumerici, che per diversi aspetti richiamano le favole esopiche, si trova il leone predatore dei cinghiali (5,57 nella collezione di Gordon), senza contare che la disputa è presente anche in altri contesti letterari (v. LEONE), rappresentando probabilmente, a livello simbolico, il conflitto tra il bene (il leone) e il male (il cinghiale). Anche il rapporto con l’uomo appare abbastanza conflittuale e la sfrontata audacia del cinghiale finisce inevitabilmente per essere punita (Aviano
30). In una narrazione che tende a razionalizzarne il comportamento, si trova un cinghiale che affila le zanne, la sua temibile arma di offesa e di difesa: lo fa per tenersi pronto in caso di bisogno (Esopo 327 Ch.). La figura di questo animale si caratterizza per lo più per la tendenza a adirarsi: provocato dall’asino, bestia agli antipodi del cinghiale per dignità e forza, contiene il suo «tipico impeto» (Fedro 1,29); nella sfida con il cavallo, ha la peggio soltanto quando quest’ultimo chiede il soccorso dell’uomo, che però lo riduce in schiavitù (Esopo 328 Ch.). Secondo Pugliarello 1973, 131, la sporadica presenza del cinghiale nella tradizione favolistica lascia pensare che la sua parte di animale feroce non sia di grande stimolo per la fantasia degli antichi. Il leone e il cinghiale Esopo 203 Ch. In estate, quando il caldo stimola la sete, un leone e un cinghiale andarono a bere a una piccola fonte. Litigavano su chi per primo di loro dovesse bere; ne derivò una contesa all’ultimo sangue. All’improvviso entrambi si voltarono per riprendere fiato e videro degli avvoltoi in attesa che uno di loro cadesse per divorarlo. Perciò posero fine alla contesa e dissero: «È meglio che noi diventiamo amici piuttosto che finire in pasto a corvi e avvoltoi». È opportuno mettere fine alle scellerate discordie e ai conflitti, poiché conducono comunque a una fine pericolosa. RIFERIMENTI: Parafrasi 204; Tetrastici 1,5. L’uomo e il cinghiale Aviano 30
Dopo avergli tagliato un orecchio, un contadino aveva lasciato libero un cinghiale che devastava le messi e irrompeva nei fertili campi, affinché l’animale, portando i segni del dolore patito, ne facesse memoria e risparmiasse in seguito i teneri prodotti della terra. Sorpreso di nuovo sul fatto, mentre perpetrava la scellerata azione di saccheggiare il campo, il malvagio perse il peso dell’orecchio che non gli era stato in precedenza reciso. Senza concedere tregua, riportò il suo irsuto capo nel solito terreno, ma la doppia pena che gli era stata già inflitta gli precluse ogni possibilità di clemenza. Allora l’uomo lo catturò e lo offrì alla fastosa tavola del padrone, tagliandolo in diversi pezzettini, in funzione delle varie portate del banchetto. Il padrone, tuttavia, dopo avere terminato di gustare il cinghiale, prese a cercarne il cuore, che – si dice – venne rubato dal cuoco, incapace di trattenersi; il contadino placò allora la giusta ira del signore con queste parole, spiegando che lo sciocco animale non aveva mai posseduto un cuore: «Altrimenti, perché mai, folle, sarebbe tornato a danno delle sue membra, con la concreta possibilità di essere catturato tante volte da uno stesso nemico?». Questa favola ammonisce coloro che troppo spesso agiscono con sconsiderata audacia e non tengono mai lontane le mani dai guai. NOTA: l’orecchio era considerato sede della memoria, il cuore sede dell’intelligenza. L’asino che derideva il cinghiale Fedro 1,29
Il più delle volte gli sciocchi, cercando di suscitare facili risate, infliggono pesanti insulti agli altri e attirano su di sé un grande pericolo. Un asinello, incontrato un cinghiale, disse: «Salve, fratello». Quello, indignato, respinge la cortesia e chiede perché l’asino voglia mentire a quel modo. L’asino, con il membro penzoloni: «Se dici che io non sono simile a te, senza dubbio questo è simile al tuo grugno». Il cinghiale, pur volendolo aggredire con il suo tipico impeto, scacciò l’ira e disse: «Sarebbe una vendetta semplice per me, ma non voglio sporcarmi con il sangue di un imbelle». RIFERIMENTI: Romulus 14. Il cinghiale e la volpe Esopo 327 Ch. Un cinghiale stava vicino a un albero e vi affilava contro le zanne. A una volpe che gli chiedeva il motivo per cui lo faceva, dal momento che non c’era nessun cacciatore e non incombeva alcun pericolo, rispose: «Non mi comporto così certo senza ragione. Se infatti mi capiterà una situazione pericolosa, non sarò impegnato ad affilarmi le zanne, ma, poiché saranno pronte all’uso, potrò servirmene». La favola insegna che bisogna tenersi pronti prima che i pericoli incombano. Il cinghiale, il cavallo e il cacciatore Esopo 328 Ch. Un cavallo e un cinghiale condividevano lo stesso pascolo. Poiché il cinghiale distruggeva
continuamente l’erba e sporcava l’acqua, il cavallo chiamò in aiuto un cacciatore per vendicarsi. L’uomo gli disse però che non avrebbe potuto aiutarlo se non si fosse sottoposto al morso e non lo avesse preso in groppa. Il cavallo acconsentì a tutte le condizioni. Allora il cacciatore, in groppa all’alleato, sconfisse il cinghiale, condusse via il cavallo e lo legò alla greppia. Così molti, con l’intenzione di vendicarsi dei nemici, si assoggettano agli altri a causa di una cieca ira. RIFERIMENTI: Papiro Rylands 1; Fedro 4,4; Parafrasi 144; Tetrastici 1,53; Romulus 79; Aristotele, Retorica 1393b; Stesicoro, fr. 104a P.; Orazio, Epistole 1,10,34 ss.; Conone, Narrazioni 42; Plutarco, Arato 38,9; Teone, Esercizi preparatori 2 (cita lo storiografo Filisto, FGrHist 556F6). Cfr. lo studio specifico di Nøjgaard 1963, 1 ss.
Citaredo Nell’antica Grecia i citaredi sono cantori che si esibiscono con l’accompagnamento della cetra (o citara), un tipo di strumento a corda dotato di una cassa di risonanza in legno generalmente trapezoidale, e di due bracci laterali, collegati con un giogo (utile a tendere le corde). Il citaredo pizzica le corde dello strumento con le dita oppure con un plettro. Orfeo, che ammansisce le belve con il suo canto accompagnato dalla cetra, è considerato precursore mitologico del citaredo (Ramorino 388). Questo strumento è caro ad Apollo, che ne sarebbe l’inventore. Disponiamo di attestazioni molto antiche sulla cetra, ampiamente rappresentata sia nelle fonti iconografiche che in quelle scritte. Tra i paradigmi più antichi e significativi della figura del citaredo, vanno ricordati Terpandro di Lesbo (VII secolo a.C.), a cui è stata per lungo tempo attribuita l’invenzione della cetra a sette corde (ora da molti studiosi contestata) in sostituzione di quella, più rudimentale, a quattro corde, e Arione di Metimna, di poco successivo a Terpandro: il suo profilo storico sfuma in alcune leggendarie vicende (v. DELFINO). Nella favola esopica 156 Ch. troviamo la parodia del citaredo vanitoso. Sembra qui presente una sorta di dissacrazione del valore della musica e della poesia, secondo una tendenza che è propria della favola. La narrazione, dai caratteri decisamente comici, è riportata dall’epimitio a uno degli ambiti propri della favola, quello della scuola, e sembra quasi precorrere un proverbio moderno secondo cui «chi sa, fa; chi non sa, insegna» (massima attribuita, tra gli altri, a George Bernard Shaw). Dione Crisostomo (32,66) narra una favola che illustra l’origine canina dei Citaredi (v. ORFEO). Il citaredo
Esopo 156 Ch. Un citaredo senza talento cantava in continuazione in una stanza imbiancata e, a causa dell’eco prodotta dai muri, pensò di avere una voce straordinaria. Allora, inorgoglito da questo fatto, pensò di doversi esibire anche a teatro. Ma giunto sulla scena cantò malissimo e gli tirarono pietre per cacciarlo. Così anche alcuni degli oratori nelle scuole pensano di essere qualcuno, ma quando si cimentano nella carriera politica dimostrano di non valere nulla.
Civetta (gufo) La civetta è sacra alla dea Atena, che, tra l’altro, è definita «glaucopide» proprio in relazione allo sguardo scintillante di questi rapaci notturni. Secondo il mito, la civetta era in origine una fanciulla, Nittimene, figlia del re di Lesbo (o del re d’Etiopia, secondo altre versioni), che, dopo avere intrattenuto una relazione incestuosa con il padre ed essere poi fuggita nei boschi per la vergogna, venne trasformata da Atena, impietosita, in civetta. Da allora, a causa di questa vicenda, vive di notte e si nasconde di giorno (cfr. Ovidio, Metamorfosi 2,590 ss.). Esistono anche tradizioni di segno diverso, che ci restituiscono un’immagine decisamente negativa dell’animale. Eliano paragona la civetta alle fattucchiere (De natura animalium 1,29) e spiega che, in Omero, Atena manda come segno augurale a Diomede e a Odisseo un airone (Iliade 10,274) e non una civetta, animale infausto, anche se gradito alla dea. Insieme al gufo e a altri uccelli notturni (noctua, da nox, notte, è il nome della civetta in latino) condivide una simbologia negativa: questi sono considerati uccelli di malaugurio e possono corrispondere ad adulteri e ladri (Apollodoro, Sull’interpretazione dei sogni 4,56). La civetta è un uccello marginale nell’ambito della tradizione esopica. In Fedro (3,16), che caratterizza il rapace sulla base delle sue abitudini notturne, l’uccello appare un implacabile giustiziere di chi, come la cicala, non ha rispetto per gli altri. In una delle numerose varianti delle favole 9 e 349 Ch. (Esopo 39ab nell’edizione Hausrath-Hunger: cfr. Adrados 2003, 54 s.), troviamo la civetta che mette in guardia gli altri uccelli sui pericoli del vischio, del lino e del tiro con l’arco, ma quelli la ignorano per poi pentirsene
amaramente: a quel punto però la civetta non è disposta a dare ulteriori consigli (Dione Crisostomo 12,7-9; cfr. anche 72,12-15). Questa narrazione, che pare mettere in rilievo la saggezza della civetta, si ricollega probabilmente alla tradizione che associa l’uccello ad Atena, dea della sapienza. In ambito cristiano, Gregorio Nazianzeno (Carmina moralia, MPG 37,873-874) fa riferimento a un uomo che accusa la civetta di avere numerosi difetti (ma rileva anche che nessun uccello possiede, insieme, tutte le qualità). Caratterizzazione meno benevola si riscontra invece nella tradizione del Romulus (25), in cui il gatto e la civetta subiscono la maledizione del topo. La tradizione favolistica riprende, inoltre, il noto motivo dell’inimicizia tra la specie dei corvidi e quella delle civette (attestata anche in Eliano, De natura animalium 3,9; 5,48), che sembra trovare conferma in alcune versioni della favola del gracchio che si impossessa delle penne di altri volatili (cfr. Libanio 3; Teofilatto Simocatta 1 H.-H.). In questo caso, d’altra parte, potrebbe esserci uno scambio tra gufo e civetta, poiché, come è noto, il gufo è avido della carne dei corvidi e loro nemico. Insomma, «spesso gli studiosi di simbolismo confondono il gufo [...] con la civetta, specie quando traducono da lingue straniere, come per esempio dall’inglese o dal sanscrito, dove uno stesso termine può indicare entrambi» (Cattabiani 2000, 479). Questo pare il caso della tradizione indiana del Pañcatantra, che, nel terzo tantra, ha come tema dominante la guerra tra gufi e corvi. Tale opposizione è piuttosto radicata nella cultura indiana e sembra avere un profondo significato simbolico, a partire dalla considerazione che i due uccelli sono legati rispettivamente alla notte e al sole, e dunque alle tenebre e alla luce. La cicala e la civetta Fedro 3,16
Chi non si adegua agli usi del rispetto e della convivenza, il più delle volte sconta la pena della sua arroganza. La cicala faceva un grande rumore che risultava fastidioso alla civetta, abituata a cercare il cibo di notte e a riposare di giorno nel cavo di un albero. Fu pregata quindi di stare zitta, ma prese a strillare con molta più forza. Ripetuta nuovamente la preghiera, la cicala si accese ancor di più. La civetta, come vide che nulla le era di aiuto e le sue parole non erano considerate, affrontò la strillona con questa astuzia: «Poiché non riesco a dormire a causa del tuo canto, che sembra quasi provenire dalla cetra di Apollo, ho in animo di bere il nettare che poco fa mi ha donato Pallade; vieni, se non ti dispiace, beviamolo insieme!». La cicala, che ardeva per la sete, non appena sentì che veniva elogiata la sua voce, si avvicinò in volo piena di desiderio. La civetta, uscita dal suo cavo, aggredì la cicala tremante e la uccise. Così, da morta, concesse ciò che, da viva, aveva negato. La civetta Gregorio Nazianzeno, Carmina moralia, MPG 37,873-874 Un tale insultava una civetta, ma l’uccello rispose con efficacia a ogni provocazione. «Che testa enorme!» «Quanto è più grande quella di Zeus!» «Che colore cilestro!». «Questo è il colore della glaucopide Atena!». «Hai una voce stridula.» «La gazza anche di più.» «Ma quanto sono sottili le tue zampe?» «Che cosa ti pare di quelle dello storno?» Dopo avere facilmente evitato tutti i rilievi, in un punto tuttavia si vede sconfitta, nonostante la sua intelligenza. «Ma, mia saggia, ognuno ha in sé uno di
questi difetti, mentre a te appartengono tutti e anche in grande misura: hai occhi cerulei, voce stridula, zampe sottili, testa enorme.» Confuso per queste parole, l’amabilissimo volatile se ne andò.
Coccodrillo Il coccodrillo è un animale esotico e singolare agli occhi dei Greci e dei Romani: Cicerone sottolinea la meraviglia che suscita (De natura deorum 2,124); Giovenale, in una satira (15,1 ss.), fa riferimento al folle costume egiziano di venerare mostri come questo. Nelle ampie descrizioni a esso dedicate, a partire da Erodoto (2,68 ss.), è associato normalmente al fiume Nilo. L’animale riveste un ruolo importante nella mitologia dell’antico Egitto, dove è temuto e onorato perché considerato un essere demoniaco e benefico (Mercatante 182); talora, visto il suo legame con le acque, diventa simbolo di fertilità; è posto in relazione non solo al dio Sobek (raffigurato come coccodrillo, uomo dalla testa di coccodrillo o vestito delle pelli dell’animale), ma anche a Seth e alle forze infere. Nella favolistica esopica il coccodrillo compare solo tre volte: le narrazioni, che si prestano a letture umoristiche, prendono spunto da caratteristiche e comportamenti singolari, che colpiscono fortemente l’immaginario occidentale. Nella favola 35 Ch., il coccodrillo si vanta di essere di nobili origini, addirittura discendente di ginnasiarchi (cittadini illustri, che pagavano le spese di feste pubbliche). Giocando sull’equivoco, poiché il termine indica, allo stesso tempo, i soprintendenti delle palestre, la volpe ironizza sulla pelle dell’animale, che dimostra un certo esercizio ginnico (con allusione probabilmente ai colpi subiti dagli schiavi). Va sottolineato che questa parte del corpo è descritta con curiosità da vari autori greci: Diodoro Siculo (1,35) rileva come la natura abbia straordinariamente protetto il coccodrillo, anche grazie alla pelle dura e provvista di scaglie. Lo stesso autore nota anche che divora la carne degli uomini e di tutti gli animali che si avvicinano alla riva del Nilo. Proprio questa situazione, che deve avere colpito fortemente Greci e Romani ed è attestata in vari autori, dà spunto a una favola
di Fedro (1,25), in cui il cane non si fida della benevolenza del coccodrillo e beve dal Nilo mentre continua a correre. L’immagine si diffonderebbe come motivo proverbiale grazie ai legionari di Cesare, a seguito del Bellum Alexandrinum (48-47 a.C.); dopo l’assedio di Modena del 43 a.C., viene usata in riferimento ad Antonio costretto a fuggire (cfr. Solimano 171; Della Corte 1973,145s.). Qui, come altrove nella favola esopica, il coccodrillo sembra essere simbolo di ambiguità e di ipocrisia, forse anche perché è creatura, insieme, di terra e di acqua, abituato dunque a vivere una doppia natura. Peraltro, non troviamo motivi favolistici che valorizzino le proverbiali «lacrime di coccodrillo», comunque già note nell’antichità (ad esempio, l’espressione trova spazio nella raccolta di Apostolio [10,17]). In un’altra favola (Esopo 45 Ch.), dalle sfumature tragiche e comiche ad un tempo, d’impronta probabilmente stoica, un empio assassino è perseguitato dagli animali che si fanno strumento della vendetta divina: il coccodrillo, che vive nel Nilo, è il giustiziere implacabile. La volpe e il coccodrillo Esopo 35 Ch. Una volpe e un coccodrillo discutevano sulla nobiltà delle loro origini. Poiché il coccodrillo si soffermò a lungo sulla gloria dei suoi antenati e alla fine dichiarò che i suoi progenitori erano ginnasiarchi, la volpe replicò: «Ma anche se tu non lo dicessi, dalla tua pelle sarebbe evidente che da molto tempo sei allenato negli esercizi ginnici». Allo stesso modo anche i fatti sbugiardano gli uomini falsi. Il cane e il coccodrillo Fedro 1,25
Chi dà malvagi consigli a uomini saggi, si sforza invano e si espone a una vergognosa derisione. Si tramanda che i cani bevano correndo, sul fiume Nilo, per non essere preda dei coccodrilli. A un cane che aveva dunque cominciato a dissetarsi in questo modo, un coccodrillo così parlò: «Bevi tranquillamente tutta l’acqua che vuoi, non temere». Ma quello: «Lo farei, per Ercole, se non conoscessi il desiderio che hai della mia carne». RIFERIMENTI: Romulus 28. L’assassino Esopo 45 Ch. Un uomo, dopo avere commesso un omicidio, era inseguito dai familiari della vittima; giunse presso il fiume Nilo e si imbatté in un lupo. Impaurito, salì su un albero che si trovava vicino al fiume, dove si nascose. Poiché, però, vide lì un serpente che si rizzava contro di lui, si lasciò cadere nel Nilo: tuttavia, qui un coccodrillo lo divorò. La favola dimostra che per gli uomini maledetti dagli dei nessun elemento naturale è sicuro: né la terra, né l’aria, né l’acqua. RIFERIMENTI: in parte della tradizione manoscritta troviamo il leone invece del lupo. Cfr. inoltre Antologia Palatina 11,348; Papiro Grenfell 2,84 (altri paralleli sono suggeriti da Adrados 2003, 47).
Conchiglia In varie culture la conchiglia è associata alla luna. Plinio afferma che, a causa della luna, aumenta e diminuisce di dimensione (Naturalis historia 2,109). Nel mito, troviamo una conchiglia che trasporta Afrodite, nata dalla schiuma del mare, fino a Cipro. Perciò è legata al simbolismo della fecondità (Cattabiani 2002, 315): v. anche OSTRICA. Nell’unica favola esopica in cui compare (181 Ch.), viene scambiata per un uovo e causa grande sofferenza al cane, che, ingurgitandola, si segnala per la sua stupidità. La forma a uovo sembra forse suggerire qui il tipo di conchiglia univalve, la cosiddetta ciprea (dal nome dell’isola di Cipro). Il cane e la conchiglia Esopo 181 Ch. Un cane, che era solito ingoiare uova, vide una conchiglia, spalancò la bocca, richiudendola poi bruscamente, e la ingoiò scambiandola per un uovo. Il suo stomaco si appesantì e il cane, afflitto da grande dolore, disse: «Soffro giustamente, perché ho scambiato tutte le cose rotonde per uova». La favola ci insegna che coloro che si comportano in modo impulsivo finiscono senza accorgersene in situazioni singolari.
Conciapelli Come tutti gli artigiani, il conciapelli si colloca nella parte inferiore della scala sociale e non gode di buona fama (v. ARTIGIANO). Nel Simposio di Platone (221e) si dice che, a una prima impressione, Socrate sembra trattare argomenti ridicoli, perché parla di asini, fabbri, calzolai, conciapelli, ma poi i suoi discorsi si rivelano filosoficamente importanti. Del resto, dall’Asia all’Africa, questa figura professionale nell’antichità sconta puntualmente il pregiudizio relativo allo spiacevole contatto dell’uomo con corpi morti e sostanze impure. Addirittura Eliano (De natura animalium 1,38) riporta una diceria secondo cui i conciapelli, che trascorrono tutta la vita respirando un’aria malsana, provano nausea per i profumi. Questa condanna sociale, con lo stato di emarginazione che ne deriva, prosegue in età medievale. La favola fa propria tale scarsa considerazione: un conciapelli è posto a confronto con un uomo ricco (una figura, appunto, antitetica socialmente), che lo invita a cambiare casa a causa del fetore che proviene dalla sua bottega (Esopo 309 Ch.). Il conciapelli, peraltro, appare anche come una delle figure più temute dagli animali: lo testimonia l’asino della favola 273 Ch., che si pente amaramente di avere chiesto a Zeus di cambiare i precedenti padroni. Il ricco e il conciapelli Esopo 309 Ch. Un uomo ricco prese casa vicino a un conciapelli. Non riuscendo a sopportare il cattivo odore, continuava ogni volta a sollecitare l’artigiano a trasferirsi. Ma il conciapelli rimandava sempre, dicendo che nel volgere di poco tempo se ne sarebbe andato. Dopo che si era trascinata a lungo questa
polemica, accadde che, passato un po’ di tempo, l’uomo si abituò all’odore e cessò di importunare il conciapelli. La favola dimostra che l’abitudine addolcisce le situazioni spiacevoli. RIFERIMENTI: Parafrasi 310; Dodecasillabi 310.
Contadino Nel mondo antico, il rapporto dell’uomo con la terra ha origini sacrali e religiose, prima ancora che economiche. Il culto della terra madre e nutrice è diffuso presso diversi popoli. L’agricoltura è quindi un’attività tenuta in grande considerazione e probabilmente praticata, in un primo momento, per motivi rituali, a fianco della caccia e della raccolta. Nel suo «manuale» poetico dedicato al lavoro dei campi, Le opere e i giorni, che presenta anche la favola più antica delle letteratura greco-romana (vv. 202 ss.: v. USIGNOLO; SPARVIERO), Esiodo non dimentica il rapporto con la divinità e sostiene che, se nell’età dell’oro la terra produceva spontaneamente i suoi frutti, nell’età in cui egli vive è necessario un duro lavoro per la sopravvivenza. Viene elaborato così un codice etico proprio del contadino, molto differente da quello aristocratico, che caratterizza invece gli eroi omerici. Senofonte, vissuto tra il V e il IV secolo a.C., nell’Economico dà spazio a Iscomaco, un ricco proprietario terriero, che tesse gli elogi dell’agricoltura, ritenuta attività utile, piacevole, gradita agli dei e agli uomini (15,4); nella stessa opera anche Socrate, il grande filosofo, sottolinea il fatto che è attività degna di un uomo libero (5,1). Gradualmente si fa strada l’idea che l’agricoltura possa servire non solo al sostentamento, ma anche per il commercio. D’altra parte, i filosofi, pur avendo generalmente una visione positiva della coltivazione della terra, non la considerano in funzione del guadagno che essa può produrre. Per Platone, filosofi e militari devono costituire la classe dirigente della città ideale, mentre gli agricoltori, che pure hanno titolo per farne parte, rappresentano, a un livello inferiore, la classe produttiva. Aristotele sembra porre l’attenzione su una distinzione tra i cittadini, che hanno proprietà terriere, e coloro che lavorano concretamente la terra e si collocano perciò a un livello inferiore (Politica
1328b-1329a). I Romani, in origine dediti soprattutto alla pastorizia, ritengono l’agricoltura un progresso rispetto all’allevamento (cfr. PASTORE), e la privilegiano tra le attività economiche, anche per motivi sociali e politici: la proprietà agraria dà prestigio e stabilità. Simbolo del romano fedele alla terra è Lucio Quinzio Cincinnato: dittatore designato dal Senato per combattere gli Equi, quando gli viene comunicata la scelta sta lavorando nel suo campo, intento alla semina: vinta la battaglia, ritorna al lavoro dei campi senza chiedere nulla. Anche a Roma si passa dall’agricoltura a scopo di sussistenza all’agricoltura commerciale. Esiste un’ampia trattatistica dedicata all’agricoltura: da Catone a Varrone, fino a Columella. Secondo una nota definizione di Catone, che unisce sfera morale e abilità pratica, il contadino è vir bonus colendi peritus… («uomo onesto esperto nel coltivare […]», fr. 6 Jordan). Sono delineati diversi modelli di sviluppo agrario, in una chiave certamente utilitaristica. D’altra parte, in età augustea troviamo l’idealizzazione del lavoro agricolo nelle Georgiche virgiliane, poema epico-didascalico. La campagna è posta in relazione all’otium già in Cicerone, che, sulla linea di una lunga tradizione, indica l’agricoltura come l’occupazione più nobile e più degna di un uomo libero (De officiis 1,42,151): tuttavia, delega la pratica concreta della cura dei suoi possedimenti al fattore, che dirige il lavoro degli schiavi. Tre, dunque, sono sostanzialmente gli obiettivi dell’agricoltura nel mondo antico: «fornire i prodotti per l’autoconsumo familiare, consentire guadagni monetari con la vendita del raccolto, assicurare stabilità economicosociale» (cfr. Merlo 218 s.). Nella favola esopica, specchio di un contesto sociale che si colloca agli antipodi del mondo aristocratico, il contadino non ha un profilo ben definito, tuttavia l’agricoltura appare come la pratica prevalente, insieme alla pastorizia, dei personaggi umani. In linea con la prospettiva largamente positiva che la cultura antica attribuisce a questa occupazione, si sottolinea, anche in modo esplicito, una
chiara prospettiva etica fondata sul lavoro: così, ad esempio, nella favola 83 Ch. lo sforzo del contadino nell’insegnare ai suoi figli a zappare la terra viene efficacemente sintetizzato dalla morale, secondo cui «la fatica del lavoro è per gli uomini un tesoro». Il buon senso dell’agricoltore si esprime anche nella favola 86 Ch., contaminazione dei motivi delle narrazioni 83 e 159 Ch. (lo stomaco e i piedi): il contadino, che si segnala per la sua saggezza, invita i figli alla concordia. Da notare che in Plutarco lo stesso aneddoto è riferito a un personaggio di altro livello sociale: un re della Scizia (De garrulitate 511c). Il rapporto con il mondo vegetale e animale non è sempre semplice: in una narrazione (Esopo 85 Ch.), il contadino vuole tagliare una pianta infruttuosa, senza ascoltare le preghiere degli animali che vi trovano riparo, ma si ferma, ritenendola sacra, quando scopre un alveare. Spesso nell’uomo il senso dell’utilità prevale su quello della giustizia. Si è supposta l’origine orientale di questa favola (Adrados 2003, 420): va anche ricordato che il tema dell’albero infruttuoso, ritenuto perciò da tagliare, è alla base anche di una nota parabola evangelica (Luca 13,6-9). Generalmente, è con gli animali feroci che più spesso si rileva un rapporto problematico: la pantera (Fedro 3,2), ma soprattutto il leone, che, rinchiuso nella fattoria, fa una strage (197 Ch.). Viene qui confermato il difficile rapporto tra uomo e leone, già presente a partire dai poemi omerici (in un passo dell’Iliade, 22,262, ripreso anche da Babrio 98, si sostiene che uomo e leone non possono essere amici). In un’altra favola troviamo invece un motivo popolare di larga diffusione (v. sotto), relativo a un leone che si innamora di una bella fanciulla. Il modulo narrativo dell’animale che ama un essere umano è di origine mitico-religiosa ed è presente anche nella favola della donnola e Afrodite (Esopo 76 Ch.) e in altri contesti narrativi (Eliano, De natura animalium, 6,17 racconta l’amore di un enorme serpente e di una fanciulla). Ma, in questa favola, l’amore del leone sembra richiamare il tema della follia dall’innamoramento ed è forse
condizionato dal filtro della filosofia cinica. Peraltro, il contadino dimostra un’astuzia che gli consente di cavarsela sul re degli animali. Esistono avversioni irriducibili e amicizie altrettanto forti, che rispecchiano probabilmente antiche credenze: se il serpente si rivela perfido e uccide il contadino che lo ha salvato dal gelo (Esopo 82 Ch.) e, in un’altra narrazione, il figlio dell’agricoltore (Esopo 81 Ch.), l’aquila, invece, beneficata dall’uomo, dimostra tutta la sua gratitudine, salvandogli la vita (Aftonio 28; Esopo 79 Ch.). Il contadino e la pianta Esopo 85 Ch. Nel terreno di un contadino c’era una pianta che non portava frutto, ma costituiva soltanto un riparo per i passeri e per le cicale che cantavano a gran voce. Un giorno il contadino decise di tagliare quell’albero poiché era infruttuoso. Prese così la scure e vibrò un colpo. Le cicale e i passeri lo pregavano allora di non distruggere il loro rifugio, ma di lasciarlo, in modo che potessero esibirsi sulla pianta nel loro canto e allietare così l’agricoltore. Tuttavia l’uomo non le ascoltò e vibrò altri due colpi. Poiché produsse un buco nell’albero, trovò un alveare e del miele. Dopo che ne ebbe assaggiato, l’agricoltore gettò via la scure, rendendo onore alla pianta, come se fosse sacra; e se ne prese una gran cura. Gli uomini, per natura, non amano e non rispettano tanto ciò che è giusto, quanto perseguono ciò che è utile. RIFERIMENTI: Parafrasi 85; Dodecasillabi 85. I figli del contadino che litigavano Esopo 86 Ch.
I figli di un contadino litigavano continuamente tra di loro. Allora l’uomo, poiché, pur esortandoli con grande sforzo, non riusciva a persuaderli con le parole a cambiare comportamento, ritenne di dover conseguire questo obiettivo attraverso un’azione concreta; così li invitò a portargli un fascio di verghe. Quelli fecero quanto fu loro ordinato; dapprima l’agricoltore diede loro le verghe riunite insieme e ordinò di spezzarle. Essi, pur con tutta la loro forza, non ci riuscirono; così, in un secondo momento, sciolse un fascio e diede loro le verghe separatamente, al punto che le ruppero facilmente. Allora egli disse: «Anche voi, figli, se andrete d’accordo, sarete invincibili per i vostri nemici, se invece litigherete ne sarete facile preda». La favola dimostra che la concordia è tanto superiore in forza, quanto la discordia è facile da vincere. RIFERIMENTI: Babrio 47; Parafrasi 86; Plutarco, De garrulitate 511c (si riferisce a un re della Scizia e ai suoi figli). Il leone innamorato e il contadino Esopo 198 Ch. Un leone si innamorò della figlia di un contadino e andò a chiederne la mano. L’uomo da un lato non tollerava l’idea di dare la propria fanciulla a una belva, ma dall’altro temeva di rifiutare; allora meditò questo piano: poiché il leone continuava a insistere, gli disse che come marito lo riteneva degno della figlia; d’altra parte, gliela avrebbe potuta concedere
in sposa a patto che si togliesse i denti e si tagliasse gli artigli, dal momento che la ragazza ne aveva paura. Per amore il leone accolse senza opporre resistenza entrambe le richieste, ma il contadino, quando l’animale tornò da lui, lo trattò con disprezzo e lo cacciò a bastonate. La favola dimostra che quelli che si fidano facilmente degli altri, quando si privano dei loro vantaggi, diventano facili prede di quelli che prima avevano paura. RIFERIMENTI: Babrio 98; Aftonio 7; Parafrasi 199; Dodecasillabi 199; Diodoro Siculo 19,25. Tema ripreso ampiamente in opere scolastiche tarde e in ambito medievale: Adrados 2003, 191. Il leone imprigionato e il contadino Esopo 197 Ch. Un leone entrò nella fattoria di un agricoltore. Quest’ultimo voleva catturarlo e così chiuse la porta del cortile. Allora l’animale, non potendo più andarsene, in un primo momento annientò il gregge, poi si volse ai buoi. L’agricoltore, dunque, temendo per se stesso, spalancò la porta. Quando il leone se ne fu andato, la moglie del contadino, di fronte ai lamenti del marito, disse: «Hai avuto quello che ti sei meritato; perché hai voluto rinchiudere questo animale da cui avresti dovuto fuggire, anche solo vedendolo da lontano?». Allo stesso modo, coloro che provocano quanti sono più forti di loro giustamente sopportano le conseguenze dei loro sbagli. RIFERIMENTI: il lupo si può trovare al posto del leone. Cfr. Babrio 113; Dodecasillabi 318; Aristofane, Rane 1431 s.
Il contadino e i cani Esopo 80 Ch. Un contadino, bloccato a causa del maltempo a casa sua, dal momento che non poteva uscire a prendersi del cibo, mangiò dapprima le pecore del suo gregge. Quindi, poiché continuava il cattivo tempo, mangiò anche le capre. Alla fine, visto che non si registrava nessun miglioramento, fu la volta dei buoi necessari ad arare. I cani allora, avendo visto quanto era successo, dissero tra di loro: «Dobbiamo andarcene di qui perché il padrone, se non ha risparmiato i buoi che lavorano con lui, come potrebbe risparmiare noi?». La favola dimostra che bisogna stare in guardia soprattutto da coloro che non si astengono dal commettere atti malvagi nemmeno nei confronti dei loro famigliari. RIFERIMENTI: numerose le traduzioni latine, medievali e umanistiche; troviamo anche il contadino sostituito dal pastore (Dati 35). Il contadino e i suoi figli Esopo 83 Ch. Un contadino, vicino alla morte, poiché voleva che i suoi figli cercassero di diventare abili nel lavoro agricolo, li chiamò e disse loro: «Figli miei, io ormai sto per morire, voi cercate nella vigna e scoprirete tutto quanto vi è nascosto». I figli allora pensarono che là, in qualche posto, fosse sepolto un tesoro e scavarono sistematicamente per tutto il vigneto, dopo che il padre morì. Non trovarono nessun tesoro,
ma la vigna ben zappata produsse un frutto assai più copioso. La favola mostra che la fatica del lavoro è per gli uomini un tesoro. Il contadino e la Fortuna Esopo 84 Ch. Zappando, un contadino trovò per caso dell’oro. Allora ogni giorno offriva corone alla Terra come se fosse stato beneficato da essa. Ma la Fortuna gli apparve e lo ammonì: «O mio caro, perché attribuisci alla Terra i miei doni, che io ti ho procurato per arricchirti? Se infatti la situazione mutasse e questo tuo oro finisse in altre mani, ho la certezza che rimprovereresti me, la Fortuna, di questo». La favola dimostra che bisogna riconoscere chi ci fa del bene e avere gratitudine nei suoi confronti. RIFERIMENTI: Aviano 12. Le vespe, le pernici e il contadino Esopo 330 Ch. Delle vespe e delle pernici, spinte dalla sete, giunsero da un contadino per chiedergli da bere, promettendo che in cambio dell’acqua gli avrebbero reso questo servizio: le pernici avrebbero zappato le sue vigne, le vespe, invece, girando intorno, avrebbero respinto con i loro pungiglioni i ladri. Allora il contadino disse: «Io ho già due buoi, che, senza alcuna promessa, compiono tutti questi lavori; pertanto è certamente meglio dare l’acqua a loro piuttosto che a voi». La favola è rivolta agli uomini corrotti che promettono di essere utili, ma che, in
realtà, fanno grandi danni. RIFERIMENTI: Cfr. Archiloco, frr. 35, 37,126 W. (ma il parallelo è discusso).
2
PROVERBI Oὐ χρὴ λέoντoς σκύμνoν ἐν πόλει τρέϕειν Non bisogna allevare in città un cucciolo di leone Il proverbio (attestato nella raccolta di Macario: 6,71) deriva direttamente dalle Rane di Aristofane (1431a) e sembra accostabile alla favola di Esopo 197 Ch. (v. sopra, cfr. anche 313, 314 e 315 Ch.). Il riferimento ha larga fortuna nell’antichità e si ritrova, spesso insieme ai versi successivi 1431b e 1432, in Plutarco (Alcibiade 16,3), nell’Antologia Palatina (10,110), in Valerio Massimo (7,2 ext. 2) e ancora in Erasmo (Adagia 2,3,77). Il significato, esplicitato già nella commedia di Aristofane, è che se si nutre un piccolo leone, poi, una volta cresciuto, imporrà i suoi (selvaggi) costumi. Cfr. anche Eschilo, Agamennone 717 ss.
Cornacchia Secondo il mito, Coronide (dal termine greco che indica la cornacchia), figlia di Coroneo re della Focide, era tanto bella che venne concupita da Poseidone: allora Atena la salvò trasformandola in una cornacchia. Perse il rapporto privilegiato con la dea per l’eccessiva e ingenua loquacità, nonostante la devozione manifestata sempre dal volatile nei suoi confronti (cfr. Ovidio, Metamorfosi 2,551 ss.). Questo elemento mitologico è comune al corvo, sacro invece ad Apollo (v. CORVO), con cui peraltro la cornacchia condivide numerose caratteristiche simboliche (a partire dal suo impiego nella divinazione). Anche le cornacchie sembrano impiegate nell’interpretazione dei presagi: se giunge da sinistra (nel caso del corvo, da destra) è negativo (cfr. Cicerone, De divinatione 1,85). Caratteristica distintiva della cornacchia è invece quella della fedeltà coniugale (cfr. Eliano, De natura animalium 3,9), secondo una tradizione che continua anche in ambito cristiano. La cornacchia riesce a rappresentare bene la mentalità del mondo esopico e gli espedienti necessari per la sopravvivenza. Talvolta spicca per la sua intelligenza: così, ad esempio, nella favola che la vede alle prese con una brocca d’acqua difficile da «espugnare» (cfr. Aviano 27; Pseudo-Dositeo 8). In una favola di Fedro (App. 24 [26]), la cornacchia, che non riscuote molta simpatia (è definita «odiosa»), afferma che la sua proverbiale longevità dipende dalla capacità di opprimere i deboli e di piegarsi di fronte ai potenti. A questo proposito, l’uccello compare come malvagio consigliere dell’aquila contro la povera tartaruga, che va incontro a un tragico destino (Fedro 2,6). La tradizione favolistica, in linea con una consolidata elaborazione culturale, associa spesso questo volatile al corvo, che pare tuttavia dotato di una dignità superiore, anche perché, contrariamente a quanto testimoniato da altre
fonti, alla cornacchia talora non sembrano riconosciute capacità profetiche (Esopo 170 Ch.; ma cfr. anche la favola 110 Ch., segnata certamente da un finale ironico, in cui la cornacchia, con il movimento del capo, suggerisce a Tiresia la soluzione di un furto compiuto dal dio Hermes). La spiegazione di questo atteggiamento di sfiducia trova fondamento nel mito, come spiega la favola 171 Ch., perché Atena le ha tolto le facoltà divinatorie di cui in origine era dotata. La cornacchia a volte si sovrappone al gracchio, ad esempio in un noto proverbio, sintetizzato nell’espressione «La cornacchia di Esopo» (v. GRACCHIO), che ha larga fortuna soprattutto in ambito cristiano. La cornacchia e la pecora Fedro, App. 24 [26] Molti attaccano i deboli e si piegano di fronte ai forti Un’odiosa cornacchia si era sistemata su una pecora, che, avendola portata controvoglia e per un bel pezzo, disse: «Se tu avessi fatto questo al cane ben dotato di denti, avresti già scontato la pena che meriti». L’uccello, perfido, rispose: «Ho disprezzo per i deboli e cedo ai forti; so chi aggredire e chi blandire con ingannevoli astuzie. Per questo riesco a prolungare la mia vecchiaia fino a mille anni». RIFERIMENTI: Romulus 95. La cornacchia e il corvo Esopo 170 Ch. Una cornacchia invidiava il corvo perché quest’uccello offre presagi agli uomini, annuncia il futuro e perciò è invocato da essi come testimone.
Allora desiderò arrogarsi le stesse prerogative. Così, quando vide alcuni viandanti di passaggio, volò su un albero. Si fermò e cominciò a gracchiare a gran voce. Gli uomini si volsero verso quel suono e ne furono spaventati; uno di loro parlò in questo modo: «Andiamocene, amici, si tratta infatti di una cornacchia, il cui verso non suggerisce alcun presagio». Così, anche tra gli uomini quelli che competono con chi è più forte, oltre a non riuscire a essere alla pari, vengono per lo più derisi. La cornacchia e la brocca Aviano 27 Una cornacchia assetata aveva notato una enorme brocca, che conteneva nel fondo una quantità d’acqua assai esigua. Per un bel pezzo, si sforzò di versarla su una superficie piana, evidentemente per scacciare così la sua straordinaria sete. Dopo che nessun tentativo basato sulla forza garantì un buon esito, l’uccello, indispettito, mise in atto con notevole astuzia ogni genere di stratagemma. Immersi dei sassolini, la poca acqua si innalzò naturalmente e offrì una facile opportunità di bere. Questa narrazione ha insegnato quanto più efficace della forza sia l’accortezza con cui il volatile realizzò l’opera intrapresa. RIFERIMENTI: Pseudo-Dositeo 8; Romulus 87; Biante, Antologia Palatina 9,272; Plinio, Naturalis historia 10,125; Eliano, De natura animalium 2,48; Plutarco, L’intelligenza degli animali 967a. Nella maggior parte dei casi segnalati, l’espediente è riferito non alla cornacchia, ma al corvo.
La cornacchia e il cane Esopo 171 Ch. Una cornacchia, che offriva sacrifici ad Atena, invitò un cane al convito. Allora il cane le disse: «Perché sprechi i tuoi beni in sacrifici inutili? La dea infatti ti disprezza al punto che ha sottratto ogni credibilità ai tuoi presagi». Allora la cornacchia rispose: «Proprio per questo sacrifico alla dea: so che lei mi è ostile e voglio che si riconcili con me». Così, per paura, molti non si trattengono dal beneficare i loro nemici. La gru e la cornacchia Romulus 18 Una gru e una cornacchia strinsero un patto e saldarono la loro alleanza: la gru avrebbe difeso la cornacchia dagli altri volatili e la cornacchia avrebbe previsto il futuro e lo avrebbe riferito all’altro uccello. Le due amiche molto spesso andavano al campo di un uomo e strappavano dalle radici il grano che era stato in precedenza seminato. Il padrone, vedendole, si preoccupò per il campo e disse a uno schiavo: «Dammi un pietra». Ammonì la gru e allora si comportarono con cautela. Un’altra volta la cornacchia sentì che chiedeva la pietra e ammonì la gru a non farsi male. Quell’uomo valutò la situazione, poiché la cornacchia prevedeva il futuro. Disse allora allo schiavo: «Quando ti dirò: “Dammi la focaccia!”, allungami una pietra». Allora, mentre arrivava, disse allo schiavo di dargli la focaccia, ma lui gli porse la pietra, che colpì la gru e le spezzò le zampe. La gru, ferita, chiese alla cornacchia: «Dove sono i tuoi divini
auspici? Perché non mi hai avvertito? così avrei potuto uscirne indenne». Rispose: «Questa mia facoltà profetica non ha colpa, ma sono ingannevoli i consigli di tutti i malvagi che dicono una cosa e ne fanno un’altra». Per coloro che ingannano gli innocenti con promesse, ma poi non smettono di danneggiarli. Il contadino e gli uccelli Babrio 33 Era il tramonto delle Pleiadi, quando è tempo di seminare le colture; e così un contadino gettava nella terra fresca i semi del grano, standovi a guardia: giunse una innumerevole schiera oscura di cornacchie dalla voce aspra e degli storni, rovina dei campi seminati. Seguiva l’uomo uno schiavo con una fionda ricurva. Gli storni sentivano in genere se mai il contadino chiedesse la fionda e, prima che li colpisse, fuggivano. Il contadino ideò un altro stratagemma e lo illustrò al ragazzo, dicendogli: «Ragazzo, dobbiamo ingannare questa furba razza di uccelli; una volta giunti, – disse – ti chiederò del pane e tu mi darai non il pane, ma la fionda». Gli storni giunsero e aspettavano il momento. Il contadino chiese il pane, secondo quanto stabilito; gli uccelli, allora, non fuggirono. Lo schiavo gli diede la fionda con tante pietre; il vecchio ferì la testa di uno degli uccelli; di uno colpì la gamba, di un altro la spalla. Gli storni allora fuggirono dalla zona. Giunsero delle gru e si informarono sull’accaduto. E una delle cornacchie disse: «Fuggite dalla crudele razza umana: imparano a dirsi delle cose, ma ne fanno altre».
RIFERIMENTI: Cfr. Suda ν 204 Adler. PROVERBI Cornicis aevum La longevità della cornacchia La credenza della longevità della cornacchia è proverbiale: viene sintetizzata dallo stesso Fedro, App. 2 [3], v. 6, in una favola in cui elenca le doti concesse agli animali e precluse all’uomo. L’idea è ripresa in forme diverse in molti altri autori, come ad esempio Orazio (Odi 3,17,13), che fa riferimento alla cornacchia «carica di anni» (cfr. anche 4,13,25) e Ovidio, secondo cui l’uccello a fatica muore dopo nove generazioni (Amori 2,636; cfr. anche Metamorfosi 2,74). Questa credenza è alla base della favola di Fedro (App. 24 [26]) in cui la longevità dell’animale si spiega con la sua capacità di adattarsi alle spietate regole sociali. Questa convinzione trova ampie attestazioni anche in ambito greco (si rimanda, a questo proposito, a Tosi 1991, 313 s.).
Corvo Uccello oracolare, il corvo è sacro ad Apollo, patrono della divinazione: dal suo volo vengono tratti presagi. Eliano nota che, quando gracchia e agita le ali, annuncia temporali (De natura animalium 7,7). Lo stesso autore (1,47) spiega, inoltre, il motivo per cui in estate il corvo gracchia, afflitto dalla sete: un giorno Apollo, di cui l’uccello era servitore, lo inviò a prendere un po’ d’acqua, ma il corvo si fermò in un campo ad attendere che le biade maturassero. Allora il dio lo punì con la sete per la negligenza dimostrata. Il volatile è, dunque, simbolo di pigrizia: secondo Agostino (Esposizioni sui Salmi 102,16) coloro che rimandano la conversione ripetono quasi il verso del corvo: cras, cras («domani», in latino); il santo ricorda anche che l’uccello, uscito dall’arca, non vi fece ritorno. Inoltre questo volatile, spesso addomesticato, è simbolo di loquacità, perché impara a riprodurre le parole degli uomini (cfr., ad esempio, Macrobio, Saturnalia 2,4). Una tradizione vuole che Apollo gli cambiò colore (da bianco a nero) proprio a causa della sua loquacità (cfr. Ovidio, Metamorfosi 2,540 ss.). La favolistica riprende diversi motivi culturali presenti nella tradizione antica. Innanzitutto, il legame del corvo con la divinazione e con i presagi (Fedro 3,18,12), che però, come si verifica anche per altri personaggi (animali e uomini: v. CORNACCHIA; INDOVINO; MAGA), sono spesso motivo di scherno nell’utilitaristico e disincantato mondo esopico. In Esopo 255 Ch. un corvo, privo di un occhio, è deriso da alcuni viandanti perché non è stato in grado di prevedere la sua mutilazione. Forse si riprende qui il proverbio «Trafiggere gli occhi dei corvi» (cfr., ad esempio, Cicerone, Pro Murena 11,25), ossia ingannare chi è particolarmente attento, come appunto è questo uccello, dotato di un’acuta vista (cfr. Tosi 1991, 606). Invece, come la favola del ragazzo e del leone dipinto (Esopo 295 Ch.), anche
quella del ragazzo e del corvo (Esopo 294 Ch.) ha un’impostazione diversa. Non si tratta comunque di un atto di fede nella profezia, poiché sembrano prevalere l’ambiguità e l’aspetto ironico della vicenda. Per lo più, il corvo emerge in una prospettiva negativa, come bestia perfida e ingrata nei confronti di Apollo, per cui un altro dio, Hermes, non può fidarsi di lui (Esopo 166 Ch.); inoltre, è solito mangiare il cibo degli dei, pertanto alla sua morte non troverà pietà alcuna (168 Ch.). Il povero gracchio che si avventura tra i corvi finisce miseramente: questa favola è stata ritenuta una possibile fonte del proverbio «(Finire) ai corvi», che corrisponde all’incirca alla nostra espressione «Alla malora» (tale modo di dire è spesso presente in Aristofane: cfr. Nuvole 123,133; 789; Vespe 51; v. proverbio sotto). Peraltro, il proverbio è collegabile anche all’idea secondo cui il corvo è un uccello di malaugurio. Pur essendo un animale di notevole intelligenza, capace anche di tessere sofisticati inganni, tipici dell’uomo, come peraltro ha ribadito l’etologia anche di recente (cfr. Bugnyar-Heinrich 2005), il corvo non sembra emergere per queste qualità nella tradizione esopica; anzi, affamato, si getta in modo avventato su un serpente, che poi lo uccide (Esopo 167 Ch.); nella celebre favola che lo vede contrapposto alla volpe si segnala per la superbia e per l’ingenuità con cui si lascia raggirare (cfr. Esopo 165 Ch. e Fedro 1,13). Questa favola, piuttosto antica (per lo meno di età classica, come deduciamo da una rappresentazione realizzata su un vaso corinzio), ha trovato lunga fortuna in età umanistica: si suppone, tra l’altro, una ripresa in un racconto della tradizione albanese (cfr. Adrados 2003, 164). Non si tratta dell’unica narrazione a segnalarsi per una certa comicità: in Esopo 274 Ch. il corvo becca la ferita di un asino, che per il dolore comincia a saltellare e a ragliare, suscitando il riso dell’asinaio. Il caratteristico colore nero del corvo (da cui il proverbio antico «Nero come un corvo»: cfr. Petronio 43,7) è alla base di una favola in cui l’uccello, invidioso del cigno, cerca di lavarsi le penne, ma non ha successo e così finisce per
morire di fame (Aftonio 40). Lo schema narrativo ricorda la favola in cui il padrone cerca invano di sbiancare l’Etiope, che alla fine si ammala (Esopo 11 Ch.). I corvi si ritrovano come protagonisti anche nella tradizione favolistica indiana del Pañcatantra (primo tantra, racconti 4 e 5): una coppia di corvi abitava su un albero; un serpente venne e divorò la prole; allora l’uccello, volendo vendicarsi, chiese consiglio a uno sciacallo che gli suggerì di prendere una catena d’oro e di collocarla nella sua abitazione. Il corvo, giunto alla corte del re, rubò la catena d’oro e, volando lentamente per farsi inseguire dalle guardie, fece ritorno al nido. Intanto il serpente si era addormentato. Così quando, le guardie arrivarono al nido, una di loro salì sull’albero, prese la catena e uccise il serpente. La morale è semplice: l’astuzia può sostituire il valore. Ancora nella tradizione del Pañcatantra, va segnalata l’inimicizia con i gufi (cfr. CIVETTA), che porta a una inevitabile guerra. Il ragazzo e il corvo Esopo 294 Ch. Una donna consultò l’oracolo per conoscere la sorte di suo figlio, che era ancora molto giovane; gli indovini profetizzarono che avrebbe trovato la morte a causa di un corvo. Perciò, impaurita, la donna fece preparare un’enorme cassa e vi rinchiuse il bambino, cercando con grande attenzione di evitare che un corvo lo uccidesse. Così, quotidianamente, a ore prestabilite, continuava ad aprire la cassa e a dare al figlio il nutrimento di cui necessitava. Ma un giorno che la donna aveva aperto la cassa e la stava richiudendo, il figlio imprudentemente mise fuori la testa. Così il gancio della cassa, abbattendosi sulla sua testa, lo uccise. NOTA: La traduzione italiana non può rendere il
gioco di parole che in greco rivela il senso della favola. Il termine κόραξ è impiegato sia per «corvo» sia per «gancio» (della cassa). L’uomo pauroso e i corvi Esopo 47 Ch. Un uomo pauroso stava andando in guerra. Avendo sentito i corvi gracchiare, depose le armi e si fermò; poi le riprese e di nuovo si mise in viaggio. I corvi, d’altra parte, fecero sentire di nuovo il loro verso, così l’uomo s’arrestò e alla fine disse: «Voi gracchiate pure quanto più potete, comunque non gusterete la mia carne». La favola è per gli uomini molto codardi. RIFERIMENTI: Plutarco, Focione 9. Il corvo ammalato Esopo 168 Ch. Un corvo ammalato disse alla madre: «Mamma, prega gli dei e non piangere». La madre gli rispose così: «Ma chi fra gli dei, figlio mio, potrà avere pietà di te? A chi infatti non hai rubato la carne?». La favola dimostra che coloro che si procurano, durante la loro vita, molti nemici, non potranno trovare alcun amico nel momento in cui ne avranno bisogno. RIFERIMENTI: Babrio 78; Tavolette Assend. 3; Parafrasi 169; Dodecasillabi 169; Romulus 23. Il corvo e la volpe
Esopo 165 Ch. Un corvo, rubato un pezzo di carne, si posò su un albero. Una volpe, allora, lo vide e voleva impossessarsi della carne: fermandosi ai piedi dell’albero, cominciò a elogiarlo per le sue enormi dimensioni e per la sua bellezza; aggiunse anche che nessuno era più meritevole di regnare sugli uccelli e sicuramente sarebbe accaduto questo se avesse avuto la voce. Allora il corvo, volendo dimostrarle che possedeva anche la voce, lasciò cadere il pezzo di carne e cominciò a gracchiare a gola spiegata. La volpe si affrettò ad afferrare la carne e gli disse: «Corvo, se tu avessi anche il cervello, non ti mancherebbe davvero nulla per regnare su tutti». La favola è adatta per gli stolti. RIFERIMENTI: Fedro1,13; Babrio 77; PseudoDositeo 9 a-b; Aftonio 29; Codice Brancacciano 8; Tetrastici 1,15; Romulus 19; Orazio, Satire 2,5,55 ss.; Tzetze, Chiliadi 10,756 ss.; Apuleio, Il demone di Socrate, prologo 4; Nicolao, Esercizi preparatori 1,8; Porfirione (commento a Orazio, Epistole 1,17,50; Satire, 2,5,56) e Pseudo-Acrone (commento a Satire 2,5,56; Arte poetica 437). Il corvo e il serpente Esopo 167 Ch. Un corvo, a corto di cibo, come vide un serpente che dormiva in un luogo assolato, scese su di lui e lo afferrò. Il serpente, tuttavia, si rivoltò e lo morse; allora il corvo, sul punto di morire, esclamò: «Ahimè sventurato, ho fatto proprio una felice scoperta, per
cui vado addirittura in rovina!». Questa favola potrebbe essere narrata riguardo a coloro che, a causa della scoperta di un tesoro, mettono addirittura a rischio la loro vita. RIFERIMENTI: cfr. Omero, Iliade 12,200 ss. L’asino, il corvo e il lupo Esopo 274 Ch. Un asino, ferito sul dorso, si nutriva in un prato. Un corvo si appoggiò su di lui e prese a beccare la piaga, sicché l’asino, a causa del dolore, ragliava e saltava. L’asinaio, da lontano, scoppiò a ridere, mentre un lupo, che s’aggirava da quelle parti, vide la scena e disse tra sé e sé: «Ahinoi disgraziati! Quando soltanto ci vedono, ci danno la caccia; a questi, invece, dispensano sorrisi, anche quando li aggrediscono». La favola dimostra che gli uomini scellerati si rivelano tali dall’aspetto esteriore e a prima vista. I viandanti e il corvo Esopo 255 Ch. Alcune persone, in viaggio per i loro affari, si imbatterono in un corvo che aveva perso un occhio. Si volsero a guardarlo e uno degli uomini esortò a ritornare indietro, poiché, a suo giudizio, questo era il significato del presagio. Un altro, tuttavia, replicò: «Ma come può questo uccello profetizzare a noi il futuro, quando non ha saputo prevedere nemmeno la sua mutilazione, in modo da evitarla?». Allo stesso modo, anche tra gli uomini coloro che non sono
previdenti nei loro stessi interessi sono qualificati a offrire suggerimenti al prossimo.
poco
Il viandante e il corvo Fedro, App. 21 [23] Un tale, percorrendo attraverso la campagna una strada fuori mano, «Salve» udì, e, dopo avere indugiato per un po’, come constatò che non c’era nessuno, riprese il cammino. Una seconda volta, da un luogo imprecisabile, lo salutò la medesima voce. Rinfrancato dal tono gentile, si fermò per rendere la cortesia, chiunque fosse. Dopo che, guardando in giro, era rimasto a lungo smarrito e aveva perso il tempo corrispondente al percorso di alcune miglia, un corvo si fece avanti e, passando sopra di lui in volo, continuò a ripetere: «Salve». Allora, l’uomo comprese di essere stato vittima di uno scherzo e prese a esclamare: «Maledizione a te, spregevole volatile! Hai bloccato così il cammino di un uomo che andava di fretta». PROVERBI ’Eς κόρακας (Finire) ai corvi L’espressione, che potrebbe essere tradotta con il nostro «Andare alla malora», ha una lunga fortuna a partire da Archiloco (fr. 196a,31 W. ), soprattutto nella commedia attica e naturalmente nella tradizione dei paremiografi. Il riferimento alla favola di Esopo 161 Ch., che presenta un gracchio trattato piuttosto male dai corvi, è suggerito da alcuni testimoni: Suda ε 3154 A.; Fozio, Lessico, s.v. ἐς κόρακας; Eustazio, Commento all’Odissea (12,408). Va precisato che, oltre a questa possibile origine del proverbio, 2
si aggiungono altre spiegazioni. Ma, come spiega Tosi (1991, 534), il senso della locuzione è molto semplice da comprendere, «visto che condizione particolarmente miserevole era reputata il rimanere insepolti, pasto per fiere e rapaci»; del resto, anche Orazio (Epistole 1,16,48) suggerisce che chi muore in croce diventa pasto per i corvi.
Cuculo Emblema di Era, sedotta da Zeus trasformato nelle vesti di questo volatile, il cuculo è simbolo di gelosia, pigrizia e parassitismo, perché depone le sue uova nel nido di altri uccelli. Descrivendone il profilo, Eliano (De natura animalium 3,30) ne segnala le abitudini e, d’altra parte, ne sottolinea l’intelligenza e l’abilità a risolvere le difficoltà. Il cuculo non compare nelle raccolte esopiche, ma è protagonista di una brevissima narrazione che Plutarco (Arato 30) attribuisce allo stesso padre della favolistica. Gli uccellini non si fidano del cuculo, destinato a diventare uno sparviero: come nota Adrados (2003, 466) la favola si costruisce intorno a un errore di storia naturale (la diceria è riportata in Aristotele, Historia animalium 563b), dovuto al fatto che i due uccelli non compaiono nella stessa stagione, e insiste sul tema, ricorrente nella favolistica, che la vera natura alla fine si rivela sempre (così, ad esempio, nel caso dei lupi di Esopo 315 Ch.). La narrazione riportata da Plutarco vuole rappresentare lo stratega Lidiade, un tempo tiranno, incapace di liberarsi dal sospetto che minava la credibilità del suo comportamento. Il cuculo Plutarco, Arato 30 Esopo narra come al cuculo, che domandò agli uccellini perché scappassero da lui, essi risposero: «Perché un giorno sarai sparviero».
D
Danaidi Simbolo di insaziabile ricerca del piacere (già in Platone, Gorgia 493 b-c), le Danaidi sono le cinquanta figlie del re di Argo Danao. Tranne una, Ipermnestra, si macchiano tutte dell’assassinio dei loro cugini e mariti, figli di Egitto, durante la prima notte di nozze. Sono perciò condannate, nell’Ade, ad attingere acqua in vasi senza fondo o a riempire, con le loro brocche, botti forate. Compaiono in una sola favola di Fedro (App. 5 [7]) e sono accostate agli altri grandi dannati del mito: Issione, Sisifo, Tantalo, Tizio (v.). Il favolista interpreta, in una prospettiva morale, il loro sforzo, sostenendo che «ciò che avrai concesso al piacere scivolerà via». Insomma, il mito viene riportato in un’ottica strettamente etica, come in genere accade nella favola.
Delfino Intelligente, amante della musica, amico dell’uomo, riconoscente: nell’antichità il delfino è descritto così, con caratteristiche decisamente positive. Esiste un racconto di larga fortuna, testimoniato innanzitutto da Erodoto (1,24), utile a inquadrare bene il profilo di questo simpatico mammifero acquatico: il poeta Arione, diretto a Corinto, viene depredato e gettato in mare dai marinai. Tuttavia, un delfino lo salva dalla morte: lo prende sul dorso e lo conduce al Tanaro; i malfattori, increduli per l’accaduto, sono puniti. I cristiani rielaborano questa narrazione per simboleggiare la salvezza dei convertiti grazie alle acque del battesimo. Plinio (Naturalis historia 9,25 ss.) racconta l’amicizia di un bambino con un delfino finito nel lago Lucrino: il piccolo gli offre da mangiare e trova la riconoscente benevolenza del mammifero, che per anni lo trasporta a scuola a Pozzuoli attraverso il lago; un giorno però il bambino muore per una malattia e così anche il delfino si lascia spegnere dal dolore. Ancora Plinio (9,24) testimonia l’amore del delfino per la musica, la sua tendenza a giocare e a saltare, avvicinandosi alle imbarcazioni senza paura. Questa descrizione appare del tutto coerente con l’esperienza che abbiamo ancora oggi, rispetto ad esempio agli spettacoli che vedono il delfino protagonista. L’animale è inoltre sacro ad Apollo e associato all’oracolo di Delfi a partire dall’affinità del nome. Tra l’altro, secondo la tradizione, Delfi è fondata da Delfo, figlio di Poseidone, re del mare, che si era unito a Melanto con le sembianze di un delfino (l’animale è considerato sacro a questo dio). Anche in altre tradizioni è associato alla divinità: in Egitto, dove il delfino dimostra il suo coraggio scontrandosi con i coccodrilli alla foce del Nilo (Seneca, Naturales quaestiones 4,2,13-14), l’animale è attributo di Iside. Secondo il mito greco, inoltre, Dioniso fece impazzire alcuni pirati malvagi, che si gettarono in mare e si
trasformarono in delfini: da quel momento diventarono benefattori dei naviganti per riscattarsi delle loro colpe (Ovidio, Metamorfosi 3,670 ss. ne descrive la trasformazione). Queste caratteristiche rendono naturalmente il delfino degno del primato fra gli animali acquatici: ed è innanzitutto nella veste di re dei mari che lo troviamo nella favola esopica 202 Ch., nella quale, non a caso, è suggerita una possibile alleanza con il leone, sovrano sulla terra, anche se poi si constata che si tratta di un’amicizia assai difficile da concretizzare. Forse questa narrazione riprende un motivo proverbiale secondo cui «Il bue e il delfino non hanno nulla di comune» (nel senso che appartengono a dimensioni troppo dissimili) e di conseguenza non può sussistere un buon rapporto tra un pescatore e un aratro (come rileva Eliano, De natura animalium 14,25). Per altri motivi, l’accostamento tra leone e delfino si ritrova anche fuori dalla tradizione favolistica: ancora Eliano (15,17) rileva l’affinità e la parentela misteriosa tra i due animali, non solo per il fatto che regnano rispettivamente sulla terra e sull’acqua, ma anche perché, quando invecchiano, prendono una scimmia (il delfino una «scimmia marina») come rimedio alla loro senilità. Il primato sugli esseri del mare sembra insidiato solamente dalla balena, che troviamo in conflitto con il delfino sia nella favola che in altre tradizioni letterarie (v. BALENA). Meno consolidata nell’immaginario collettivo, invece, l’inimicizia del delfino e del tonno, che nella favola esopica 132 Ch. sembrano condividere, piuttosto, la caratteristica dell’estrema rapidità dello slancio, che finisce per penalizzare entrambi. D’altra parte, questa appare una delle caratteristiche salienti del delfino, anche al di fuori della tradizione favolistica, dove il mammifero è descritto come dotato di una rapidità superiore addirittura a quella delle imbarcazioni che viaggiano a vele spiegate (cfr. ancora Plinio il Vecchio 10,24). In un’altra favola emerge una ripresa della leggenda di Arione, in chiave parodica: non viene salvato un uomo, ma una scimmia, che però per la sua
stupidità viene scoperta e fatta annegare. Qui il delfino appare generoso e certamente più intelligente della scimmia: quando intuisce l’inganno, è però implacabile nella vendetta. Una curiosità: nessuna delle morali valorizza come simbolo positivo il delfino, che pure nelle narrazioni compare secondo caratteristiche consolidate. Il leone e il delfino Esopo 202 Ch. Un leone che gironzolava su una spiaggia, come vide un delfino spuntare dal mare, gli propose un’alleanza, poiché sarebbe stato molto vantaggioso diventare amici e soci; infatti, il delfino regna sugli animali marini, il leone su quelli della terra. Il delfino accettò volentieri e il leone, che era da molto tempo in guerra con un toro selvaggio, chiamò il delfino in suo aiuto. Sebbene il delfino volesse andare in suo soccorso, non poteva uscire dal mare; così il leone lo accusò di tradimento. Il delfino allora gli rispose: «Non criticare me, ma la natura, che mi ha fatto animale marino e non mi permette di muovermi sulla terra». Allo stesso modo bisogna che anche noi, quando stringiamo un’amicizia, scegliamo compagni che possano essere al nostro fianco nei pericoli. RIFERIMENTI: cfr. sopra (Eliano, De natura animalium 15,17). Il tonno e il delfino Esopo 132 Ch. Un tonno, inseguito da un delfino, fuggiva con grande rumore. Sul punto di essere catturato, senza
accorgersene, si trovò catapultato sulla spiaggia dalla forza del suo slancio. Trascinato dallo stesso impeto, il delfino si ritrovò accanto a lui. Il tonno, voltandosi a guardare l’altro, ormai in punto di morte, disse: «La morte non è per me più motivo di dolore; infatti, vedo perire con me anche chi è causa della mia fine». La favola dimostra che gli uomini sopportano più facilmente le disgrazie quando vedono che chi ne è causa condivide la stessa sorte. La scimmia e il delfino Esopo 305 Ch. Coloro che navigano hanno l’abitudine di portare con sé cani maltesi e scimmie per svagarsi nel corso del viaggio; così un tale, che viaggiava sul mare, aveva con sé una scimmia. Mentre si trovavano presso il Sunio, promontorio dell’Attica, scoppiò una grande tempesta. Poiché la nave si rovesciò e tutti cercarono a nuoto la salvezza, lo stesso fece anche la scimmia. Un delfino la vide e, scambiandola per un uomo, le andò sotto e la sollevò dirigendosi verso la terraferma. Come giunse al Pireo, il porto di Atene, domandò alla scimmia se fosse ateniese. Quella, confermando, precisò anche che proveniva da una nobile famiglia del posto. Il delfino le chiese se conosceva anche il Pireo. La scimmia, credendo che parlasse di un uomo, disse che era addirittura un carissimo e intimo amico. Così il delfino, colto dall’indignazione a causa di tale menzogna, immergendola sott’acqua la fece annegare. La favola è rivolta a quegli uomini che, non conoscendo la verità, pensano di riuscire a ordire inganni. RIFERIMENTI: Tzetze, Chiliadi 4,944-952.
Demade Demade, oratore greco del IV secolo a.C., partecipa alla vita politica di Atene. Di posizione filomacedone, si fa mediatore tra le due parti, in modo non sempre lineare e disinteressato. La svolta della sua carriera avviene quando è fatto prigioniero da Filippo II di Macedonia, durante la battaglia di Cheronea, nel 338 a.C.: esiste un aneddoto secondo cui conquista il sovrano grazie alla sua arguzia. A Filippo che gira tra i prigionieri con superbia, Demade suggerisce di non recitare la parte di Tersite, vile e codardo, quando il destino gli ha assegnato quella del valoroso Agamennone (Diodoro Siculo 16,87,1-2). Suo rivale è il famoso oratore Demostene, la cui dote migliore è la preparazione tecnica, mentre Demade eccelle per il talento. Pare che il suo valore come oratore sia notevole: secondo Aristone di Chio, Teofrasto (in linea con il giudizio degli ambienti peripatetici) ritiene Demostene «degno della sua patria», Demade «al di sopra della sua patria» (Plutarco, Demostene 10,1-2). Demade viene condannato a morte, nell’ambito delle lotte dei successori di Alessandro Magno, nel 319 a.C. Non entra nel canone degli oratori, perché, già secondo gli antichi, non mette niente per iscritto. Ci resta una collezione di motti arguti, i Demadeia, peraltro non tutti autentici. Non pare del tutto impossibile che Demade abbia davvero raccontato la favola 96 Ch., vista la sua abilità a governare l’uditorio e la sua tendenza all’uso di immagini efficaci (cfr. Adrados 2003, 89). Tuttavia, Demade entra nella favola non tanto come personaggio storico, quanto piuttosto come simbolo dell’uomo d’ingegno, capace di arguzie accattivanti (come Socrate, Diogene e lo stesso Esopo). Del resto l’arguzia emerge di frequente come elemento caratterizzante della favola, non solo in Esopo: Fedro, riflettendo sulla sua opera, osserva che «le arguzie, moderate, sono soavi» (v. 3
dell’epilogo del quarto libro). La favola, insomma, appare come una forma narrativa piacevole, curiosamente collocata agli antipodi del (noioso, sembrerebbe di capire) discorso politico, che induce il pubblico alla distrazione. Questa narrazione, la cui origine ovviamente non è attribuibile a Esopo, dimostra inoltre l’uso, attestato e teorizzato nell’antichità (v. Introduzione), della favola come exemplum di grande efficacia, funzionale alla tecnica retorica. Peraltro, non abbiamo paralleli di una vicenda che offra insieme Demetra, la rondine e l’anguilla. La favola ha fortuna in età umanistica: la riprende Leonardo Dati (40). L’oratore Demade Esopo 96 Ch. Una volta l’oratore Demade, parlando agli Ateniesi riuniti in assemblea, si rese conto che l’uditorio non gli prestava molta attenzione e chiese dunque se i presenti gli consentissero di raccontare una favola di Esopo. Con il loro consenso, cominciò allora a dire: «Demetra, una rondine e un’anguilla percorrevano la stessa strada. Giunte a un fiume, la rondine si levò in volo, mentre l’anguilla s’immerse nell’acqua». E a queste parole Demade smise di parlare. «E Demetra – gli chiesero – che cosa fece?» Allora lui rispose: «Si è adirata con voi, che non prestate attenzione agli affari della città, e seguite invece le favole di Esopo». Così anche tra gli uomini sono stolti quelli che sottovalutano quanto è necessario e invece preferiscono ciò che dà piacere. RIFERIMENTI: Demade fr. 22 De Falco (ripresa del testo esopico).
Demetra Demetra (Cerere a Roma), dea del grano e della terra coltivata, è protettrice, oltre che della fertilità del suolo, anche della fecondità femminile. Le è dedicato uno degli Inni omerici. Figlia di Crono e di Rea, genera Pluto, il dio della ricchezza, e Persefone, poi rapita da Ade. Eleusi era la sede del suo culto. La dea compare in una sola favola (Esopo 96 Ch.), senza un particolare ruolo e senza specifici attributi. L’oratore Demade cita una narrazione esopica che vede protagonisti Demetra, la rondine e l’anguilla, ma non la conclude: si tratta soltanto di una tecnica per rimproverare la distratta assemblea degli Ateniesi, più interessata a futili favole che a importanti questioni pubbliche (v. DEMADE).
Demetrio Demetrio, detto Falereo in quanto nato nella zona del porto di Falero presso Atene, è allievo di Teofrasto, alla cui scuola conosce probabilmente Menandro; abile oratore, filomacedone della prima ora, dal 317 al 307 a.C. regge la città con poteri dittatoriali come fiduciario di Cassandro, figlio di Antigono, uno dei generali di Alessandro Magno. Si ha certezza del fatto che abbia raccolto in un volume le favole esopiche (secondo alcune ipotesi, in numero contenuto: non più di cento): una sorta di prototipo delle collezioni successive. La sua raccolta, «prodotto dell’erudizione peripatetica, può essere considerata sia come una collezione di materiale folklorico, sia come un repertorio di paradigmi retorici» (Jedrkiewicz 1989, 26). Demetrio si cimenta anche nella critica letteraria e nella storia politica: delle sue opere restano solo frammenti. Il personaggio compare in una sola favola ed è descritto come una figura dispotica, pronto a cambiare rapidamente il suo giudizio su Menandro (Fedro 5,1). Si è supposta una contaminazione della sua figura con quella di Demetrio Poliorcete, che nel 307 occupa Atene, salutato dalla città come un liberatore (cfr. Plutarco, Demetrio 33-34); quindi, perseguita gli amici del Falereo, compreso Menandro (v. MENANDRO). La favola è costruita sulla base della struttura del conflitto; significativamente, alla fine il tiranno riconosce la superiorità del poeta (cfr. Mañas Núñez 138 s.; Solimano 279 s.). Il re Demetrio e il poeta Menandro Fedro 5,1 Demetrio, detto Falereo, occupò Atene imponendo alla città il suo tirannico potere. Come succede di
solito, la folla accorre da ogni parte e a gara grida: «Evviva!». Gli stessi cittadini più illustri baciano quella mano dalla quale sono oppressi, lamentando in silenzio quel triste cambiamento della loro sorte. Anzi, anche coloro che vivono nella tranquillità della loro vita privata si trascinano per ultimi perché l’assenza non procuri loro danno: tra di loro c’era Menandro, noto per le sue commedie, che Demetrio aveva letto pur senza conoscere di persona l’autore, di cui aveva ammirato l’ingegno. Il poeta veniva avanti con un passo leggiadro ed effeminato, tutto cosparso di profumo e vestito con abiti fluenti. Quando il tiranno lo vide in fondo alla fila, chiese: «Chi è quell’effeminato che ha il coraggio di presentarsi al mio cospetto?». I più vicini replicarono: «È lo scrittore Menandro». Subito Demetrio cambiò il suo atteggiamento e disse: «Non può esserci uomo più bello».
Demostene Nato ad Atene nel 384 a.C. da una famiglia benestante, Demostene si cimenta presto nell’eloquenza giudiziaria; dopo la guerra sociale (357-355), debutta in ambito politico. Tra le orazioni più importanti, si segnalano le Filippiche contro il re Filippo II di Macedonia, che Demostene, democratico convinto, ritiene un rischio per la libertà di Atene. Nel 348 la città avvia trattative con Filippo: dell’ambasceria fa parte anche l’oratore, che però nel 344, con la Seconda Filippica, attacca il suo avversario politico Eschine, corrotto e ingannato, a suo giudizio, dal sovrano macedone. Nel 340 e nel 339 gli viene assegnata dagli Ateniesi la corona aurea di benemerito della città. Demostene continua la sua azione antimacedone, ma la lega greca che muove guerra a Filippo viene sconfitta nel 338, nel disastro di Cheronea. Quando nel 336 Ctesifonte propone di assegnare ancora a Demostene la corona aurea, Eschine ne sostiene l’illegalità. Nel processo che si svolge poi nel 330, Demostene pronuncia il suo più noto discorso (Per la corona), in cui sottolinea come la libertà costituisca il destino e la gloria di Atene, mentre Eschine elabora il discorso Contro Ctesifonte. Demostene ha la meglio. Dopo un oscuro caso di corruzione in cui si trova coinvolto e dopo alterne vicende, l’oratore si suicida nel 322, quando la fazione filomacedone ha preso il potere nella città ellenica. Secondo Plutarco (Vite dei dieci oratori 848a), Demostene compare come narratore di una favola in un’occasione pubblica. La sua figura va così a sovrapporsi (se non nella favola narrata, almeno nella situazione che ne fa da cornice) a quella di un altro oratore, suo rivale: Demade (v.). Se infatti Demade racconta agli Ateniesi la favola di Demetra, della rondine e dell’anquilla (Esopo 96 Ch.), Demostene narra ai concittadini la vicenda dell’ombra dell’asino, che va a rappresentare, anche nella tradizione dei proverbi, coloro
che ambiscono a qualcosa di nessun valore (v. ASINO). Come spesso accade nella tradizione esopica, la figura dei due personaggi storici assume la stessa funzione, quella di richiamare attraverso una favola l’attenzione del pubblico, nell’ambito di un’assemblea che affronta temi di ben altro rilievo. La favola si impone, dunque, come forma narrativa piacevole, in grado di catturare l’uditorio, in opposizione al discorso politico, più importante e solenne, ma certamente meno accattivante.
Dessicreonte Dessicreonte è un personaggio i cui contorni sfumano nella leggenda; a lui si riferiscono infatti due storie alternative, che Plutarco (Questioni greche 303c) riporta nel tentativo di spiegare un particolare culto di Afrodite a Samo, legato a questo nome. Nella prima leggenda, Dessicreonte è descritto come una sorta di mago che, attraverso un rito di purificazione, libera le donne di Samo dalla libidine e dalla dissolutezza. L’altra spiegazione è fornita di seguito da Plutarco attraverso un racconto che presenta caratteristiche proprie della tecnica narrativa esopica. Dessicreonte, grazie al suggerimento della dea, compie un’azione che sembra insensata ma poi si rivela salvifica per molti e motivo di arricchimento per lui stesso. Ritorna, come accade puntualmente nella tradizione favolistica, la tipica associazione che lega commercio e navigazione, attività che è sempre descritta insieme con i rischi che comporta (v. NAVIGANTE). Afrodite e il mercante Plutarco, Questioni greche 303c Dessicreonte, che era un armatore, salpò alla volta di Cipro per un viaggio commerciale, e, quando stava per caricare la sua imbarcazione, Afrodite gli disse di mettere a bordo acqua e nient’altro e di navigare il più velocemente possibile. Egli obbedì e, caricata molta acqua a bordo della nave, si mise in mare; quindi, quando il vento cessò e si fece bonaccia in mare aperto, egli guadagnò un bel gruzzolo, vendendo acqua agli altri mercanti e armatori. Perciò modellò una statua della dea, a cui
attribuì il suo nome. Se questo è vero, sembra che la dea abbia voluto non arricchire una sola persona, ma, attraverso un uomo, salvarne molti.
Diogene Diogene di Sinope, detto il Cane per il suo provocatorio stile di vita, è il più noto dei filosofi cinici, in perenne polemica contro le istituzioni e la società (la scuola cinica, fondata dall’ateniese Antistene, suo maestro, proclama l’autosufficienza dal mondo, l’esaltazione dello stato di natura e il disprezzo delle passioni). Vissuto dal 412 al 323 a.C., Diogene si comporta in modo singolare, rifiutando ogni pudore e convenzione sociale (la fonte principale sulla sua vita è Diogene Laerzio, nel sesto libro delle Vite dei filosofi). Secondo una consolidata tradizione, vive in una botte, espleta i suoi bisogni in pubblico e possiede soltanto una scodella, a cui peraltro rinuncia, ritenendola superflua, quando vede un giovane che raccoglie l’acqua col cavo della mano. Interpreta il cinismo, insomma, come un pragmatico modo di vivere. Si tramandano vari aneddoti sul suo conto. Tra gli altri, il più noto è forse quello che lo vede aggirarsi in pieno giorno con una lucerna: a chi gliene chiede la ragione, il filosofo risponde che sta cercando un uomo (Diogene Laerzio 6,41). Proprio questo aneddoto costituisce il primo collegamento, per quanto indiretto, di Diogene con la tradizione esopica. Infatti, Fedro (3,19) adatta la storia a Esopo, che replica così a un chiacchierone. Viceversa, nelle collezioni favolistiche troviamo il filosofo cinico calato nei panni tipici del padre della favolistica, protagonista di alcuni di quegli aneddoti che presentano figure facilmente interscambiabili: in particolare, Esopo e Socrate. Del resto, questi tre personaggi sono accostati anche da altri autori: Dione Crisostomo (Orazioni 79,13) sostiene che i detti di Socrate e di Diogene (nell’antichità curiosamente definito il «Socrate impazzito» per le sue stranezze) vengono posti sullo stesso piano di quelli di Esopo. Inoltre, le gesta del favolista rimandano a una visione del mondo tipica del cinismo, la cui filosofia si delinea nella concreta predicazione
di vita piuttosto che nell’astratto insegnamento scolastico. Entrambi i personaggi, che conoscono la schiavitù, testimoniano il primato del valore intellettuale su quello sociale. Al di là dell’affinità «ideologica» e dei paralleli ricavabili delle loro biografie, Esopo e Diogene «appartengono al medesimo tipo narrativo: sono sempre dotati […] della capacità di trarsi d’impaccio emettendo una battuta che tronca la discussione o risolve la situazione in loro favore, spesso coprendo l’interlocutore o l’antagonista di ironia o dileggio» (Jedrkiewicz 1989, 120). Così troviamo Diogene che insulta un calvo insolente (Esopo 97 Ch.) con una battuta fulminante; oppure (98 Ch.) lo vediamo rimproverare un traghettatore generoso, ma incapace di distinguere le persone degne da quelle indegne del suo aiuto. Diogene e il calvo Esopo 97 Ch. Il filosofo cinico Diogene, oltraggiato da un uomo calvo, disse: «Io certo non ti insulto, non sia mai! Lodo i tuoi capelli perché si sono allontanati da una testa così malvagia». RIFERIMENTI: Parafrasi 97. Diogene in viaggio Esopo 98 Ch. Diogene il cinico, detto il Cane, mentre era in viaggio, giunse presso un fiume in piena e si arrestò sull’argine, disorientato. Un tale, che era solito fare il traghettatore, lo vide in difficoltà e si avvicinò, lo caricò e lo trasportò sull’altra riva con cortesia.
Allora Diogene si fermò, rimproverandosi per la sua povertà che non gli permetteva di offrire una giusta ricompensa al suo benefattore. Mentre ragionava ancora così tra sé, il benefattore vide un altro viaggiatore che non riusciva ad attraversare il fiume. Allora si fece subito avanti per trasportare anche lui. Quindi Diogene si avvicinò all’uomo e gli disse: «A questo punto io non ti sono più grato per quanto successo: noto, in effetti, che non con giudizio agisci in questo modo, ma come spinto da una sorta di mania». La favola dimostra che coloro che aiutano sia le persone degne sia le persone indegne non meritano la fama di benefattore, quanto piuttosto quella di uomo poco saggio. RIFERIMENTI: Seneca, De beneficiis 4,18,1 (aneddoto attribuito a Platone), Gnomologio Vaticano 223 S.
Dioniso (Bacco) Nato da Zeus e da Semele, Dioniso (a Roma noto specialmente come Bacco o Libero) è il dio del vino, dell’energia vitale e del delirio mistico; viene nascosto dal padre per evitare l’ira di Era. Persa la madre, è allevato a Orcomeno dalla zia Ino e da suo marito Atamante. Quindi, Zeus trasporta il giovane a Nisa e lo affida, sotto forma di capro, alle ninfe locali. Una volta diventato adulto, Dioniso scopre l’uso dell’uva, ma Era lo fa impazzire. Dopo avere errato per vari territori (il culto del dio ha punti di contatto in diverse religioni e culture), dall’Egitto alla Siria, giunge in Frigia, dove la dea Cibele lo purifica e lo inizia ai suoi riti. Nei suoi viaggi, quindi, Dioniso raggiunge anche la Beozia, terra natale della madre, e qui introduce i Baccanali, feste orgiastiche caratterizzate da danze frenetiche, cembali e timbali risuonanti, e grida rituali («Evoè»). Alle feste dedicate a Dioniso pare connessa l’origine della tragedia (v. CAPRO). Il culto originario ha un seguito nelle feste Dionisie (rurali e urbane) e nelle Antesterie, penetrando presto anche a Roma (Baccanali, Liberali), ma, come sappiamo da uno dei più antichi documenti della lingua latina, nel 186 a.C. viene proibito, per essere poi reintrodotto da Cesare e ottenere successivamente un largo seguito in età imperiale. Secondo una tradizione, Dioniso è l’ultimo degli dei a prendere posto nell’Olimpo. Il dio non compare di frequente nella tradizione favolistica e non è presente nelle collezioni esopiche, se non indirettamente. La vite, posta a confronto con il caprone in una narrazione forse di derivazione orientale (Esopo 339 Ch.), rimanda insolitamente a una sfera rituale, che può suggerire una sopravvivenza del culto di Dioniso, anche
presso gli strati più umili della società, soprattutto in ambito rurale (v. VITE). Il rapporto del dio con il vino emerge anche nella favola che spiega le conseguenze del vino sull’uomo (Romanzo di Esopo 68): il motivo, molto antico, probabilmente deriva dalla lirica corale (cfr. Adrados 2003, 430). In generale, al di là delle numerose varianti, si crede che i primi due crateri diano un influsso benefico, il terzo porti all’ubriachezza molesta (un frammento di Paniassi, 13 D., riconduce alle Grazie, alle Ore e a Dioniso la prima coppa di vino; a Dioniso e ad Afrodite la seconda; a Hybris, la tracotanza, e Ate, la dissennatezza, la terza). Il rapporto di Dioniso con il vino è al centro dell’unica favola di Fedro (4,15 [16]) che presenta come protagonista il dio: in questo caso Libero invita a cena Prometeo, che poi, ubriaco, inverte le parti sessuali negli esseri umani, mentre è impegnato a plasmarle. Si tratta di una narrazione eziologica, che, attraverso il mito, spiega la genesi dell’omosessualità. Infine, una narrazione presenta un artigiano che è incerto se vendere una statua del dio per un sepolcro o per un tempio: Bacco appare all’uomo, ricordandogli l’importanza della scelta, da cui dipende il suo destino, che sarà o tra i morti o tra gli dei (Aviano 23): lo stesso motivo narrativo si trova in Babrio (30); qui, tuttavia, è Hermes (v.) il dio al centro della vicenda. Dioniso e il vino Romanzo di Esopo 68 Dioniso inventò il vino e, mescolate tre coppe, mostrò agli uomini come bisogna servirsi delle bevute nel simposio. La prima coppa è quella del piacere, la seconda è quella dell’allegria, mentre la terza è quella del torpore. RIFERIMENTI: Paniassi, Eraclea fr. 13 D.; Eubulo, presso Ateneo 2,3, 36d; Apuleio, Florida 20;
Stobeo 3,18-25; Fulgenzio, Mitologie 2,12; Fozio, Epistole 16; Massimo Confessore, MPG 91,885; Antonio Melissa 1,41; Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 41, ed. Boissonade).
Dioscuri I gemelli Castore e Polluce, nati dal re degli dei (letteralmente Dioscuri significa appunto «figli di Zeus») e da Leda (moglie del re spartano Tindaro), fratelli di Elena e di Clitemnestra, secondo il mito vengono alla luce ad Amicle. Castore è un abile domatore di cavalli, Polluce eccelle nel pugilato. Dopo la morte di Castore, ucciso nella lotta contro i cugini Afaridi, Polluce ottiene dal padre Zeus che entrambi, condividendo la stessa sorte, vivano alternando un giorno sull’Olimpo e un giorno nell’Ade. Sono, quindi, trasformati nella costellazione dei Gemelli. Vengono considerati protettori del commercio, degli atleti, dei viaggi e dell’ospitalità; in loro onore ad Atene e a Sparta si celebrano le feste Dioscurie; anche i Romani li onorano, in ricordo dell’apparizione del lago Regillo, dove sarebbero scesi in battaglia al loro fianco. I Dioscuri hanno un ruolo determinante in una narrazione di Fedro (4,25 [26]), che «riproduce la struttura delle favole dell’arbitrato» (Solimano 275), per cui, grazie a loro, il virtuoso è premiato e il malvagio è invece punito. Il poeta Simonide cita Castore e Polluce in un componimento in onore di un pugile vittorioso, ma questi non lo ripaga adeguatamente. Invitato a banchetto, il poeta evita, grazie all’intervento dei Dioscuri, la morte, che invece non risparmia gli altri commensali, dopo un crollo dell’edificio (v. SIMONIDE). L’episodio viene adattato allo schema favolistico, ma – va ricordato – ha larga fortuna in vari generi della letteratura greca e latina (cfr., in particolare, Cicerone, De oratore 2,26; Quintiliano 11,2,11; Valerio Massimo, 1,8 ext. 7; anche negli Aitia di Callimaco, fr. 64 Pf., si rileva un accenno).
Donna La donna è spesso oggetto del feroce sarcasmo dei favolisti. In effetti, la misoginia è piuttosto accentuata nella tradizione esopica: Cascajero (1992, 47) ha calcolato che questo tema compare nel 7,1% delle favole delle collezioni anonime contenute nell’edizione Hausrath e nel 15,4% delle favole presenti nel resto della tradizione favolistica. Gli studiosi hanno individuato diverse ragioni sia di carattere generale sia specifiche, in riferimento a singoli autori. La spiegazione è stata innanzitutto ricondotta al fatto che questo è uno dei motivi topici della letteratura antica. Già in Omero, come è noto, la causa della guerra di Troia viene attribuita a una donna: Elena. Esiodo (Le opere e i giorni 373 ss.) esorta a non lasciarsi trarre in inganno dalle donne, che mirano ai beni dell’uomo, perché «chi presta fede a una donna, presta fede a ladri». Nel mito di Pandora, sviluppato dallo stesso poeta anche nella Teogonia (570 ss.), la donna è considerata come un dono irresistibile ma dannoso offerto da Zeus agli uomini per la loro rovina. Noti, poi, sono i versi satirici del poeta Semonide (VII secolo a.C.), tradotti anche da Giacomo Leopardi: passano in rassegna dieci specie di donne, ritenendole derivate da un animale o da un elemento: troviamo, tra l’altro, quella disordinata e sordida che trova il suo modello nella scrofa, quella perfida che assomiglia alla volpe, quella pigra, che è come l’asina; l’unica che si salva per la sua laboriosità è la donna ape, ma questo non impedisce al poeta, alla fine, di considerare la donna come «il male più grande» (fr. 7 W. ). Anche nella letteratura latina si confermano alcuni di questi motivi topici. Tra i testi più celebri, la satira sesta contro le donne di Giovenale, che presenta una galleria di figure femminili ritratte in una irriducibile negatività: oltre alla lussuria, numerosi sono i vizi che rendono insopportabili le mogli ai mariti, dalla superbia all’autoritarismo, dalle manie sportive 2
fino alle tendenze delittuose, con l’uso di filtri e veleni. Al di là di motivi topici e considerazioni di carattere generale legate alla cultura antica, alcuni studiosi, come Adrados (1999, 639 ss.), hanno in particolare sottolineato l’influsso cinico che, a partire dal III secolo a.C., incide profondamente sul genere favolistico. In altri casi, come quello di Fedro, dove questa tendenza appare particolarmente accentuata, si è fatto riferimento al contesto sociale romano o addirittura a motivi di natura autobiografica. In genere, in Fedro le donne spiccano per la grettezza (come in App. 3 [4]), per l’impudicizia (la loro lingua è stata plasmata da Prometeo a imitazione del membro maschile: 4,14 [15]), per la notevole propensione a mentire e a tradire (come la cortigiana bugiarda di App. 27 [29]). Come sostiene anche Giovenale, il vizio peggiore delle donne è la mancanza di castità (App. 9 [11]): lo suggerisce già, sia pure in modo scherzoso, la giocosa sfida tra Giunone, dea protettrice degli amori legittimi, ossia dei matrimoni, e Venere, dea degli amori nella loro accezione più ampia. Ma quando la libidine e la volubilità della donna, come accade nella novella della vedova e del soldato (App. 13 [15]), infrangono l’ordine sociale, la critica di Fedro si fa più severa. Infatti, il favolista esorta a punire chi viola il letto nuziale (App. 6 [8],14). L’idea che la donna non possa disporre di bellezza e castità insieme, come notano altri autori, da Giovenale (10,297 s.) a Ovidio (Amori 3,4,41 s.), pare confermata in Fedro 4,5. Il favolista latino presenta Esopo come l’unico in grado di risolvere un caso di eredità che vede coinvolte tre sorelle: «una bella e sempre a caccia di uomini con i suoi occhi; la seconda, invece, donna di campagna, frugale, dedita a filare la lana; la terza amante del vino e assai brutta». In questa narrazione, l’unica donna apprezzabile riprende il modello di laboriosità semonideo e l’ideale romano, che Fedro sembra condividere nella sua critica al mondo femminile. Tale ideale, legato ovviamente a esigenze
di ordine sociale, è riassumibile in quattro caratteristiche: la donna libera e appartenente alle classi sociali elevate deve essere di onorevoli costumi (casta), trascorrere la sua vita in casa (domiseda), dedicarsi a filare la lana (lanifica) e appartenere rigorosamente a un solo uomo (univira). La moglie fedele e sventurata descritta in un’altra favola (3,10) rappresenta l’eccezione che non smentisce la regola. Il Romanzo di Esopo attribuisce esplicitamente una tendenza alla misoginia al padre della favolistica, secondo cui le donne vanno picchiate o terrorizzate perché siano ammansite. La moglie del suo padrone, Xanto, appare libidinosa e sleale ed Esopo commenta le sue abitudini con versi euripidei, considerando la donna un’enorme disgrazia. Nell’ambito degli apoftegmi attribuiti allo stesso Esopo, ne troviamo alcuni che hanno riscontro anche al di fuori della favolistica. Uno di questi (2 Perry) sostiene che la donna è uno dei «tre mali», insieme al mare e al fuoco, come spiega anche un monostico di Menandro (823 J.). Un altro presenta l’immagine della donna impiccata a un albero come «un bel frutto» (20 Perry); viene riportato anche da Diogene Laerzio, anche se con una diversa attribuzione (6,52). Nelle favole, in linea con la tradizione culturale che si è considerata, la donna viene descritta come avida (Esopo 90 Ch.), ingannatrice (ad esempio la maga di Esopo 91 Ch.), insopportabile per il marito, che per verificarne l’indole la manda presso la famiglia di suo padre (Esopo 49 Ch.). La donna giovane non brilla per intelligenza (Romanzo di Esopo 131). Anche la vecchia che minaccia il bambino, promettendo di darlo in pasto al lupo se non smette di piangere, diventa nell’epimitio l’esempio di chi non fa corrispondere le parole ai fatti (Esopo 223 Ch.). Come recita un proverbio molto noto nel mondo antico, «Abili sono le donne a ideare stratagemmi» (Euripide, Ifigenia in Tauride 1032). Così l’adultera concorda con l’amante un raffinato piano per i loro incontri clandestini (Esopo 300 H.-H.). In Esopo, tuttavia, si rileva qualche raro caso di rielaborazione positiva della figura della donna, la quale, ad
esempio, escogita uno stratagemma per aiutare il marito ubriacone a vincere il vizio, che tuttavia si rivela, alla fine, troppo radicato (Esopo 88 Ch.). In una favola cristiana si spiega l’origine del rossore, segnalando come questa manifestazione di pudore appartenga soprattutto alle donne (Gregorio Nazianzeno, Carmina moralia, MPG 37,898). In generale, la tendenza alla misoginia coinvolge anche altri autori, non solo attraverso le narrazioni ma anche mediante affermazioni che esplicitano il punto di vista. Babrio, nella favola dell’uomo reso calvo dalle due amanti, sentenzia: «Infelice colui che si imbatte nelle donne» (22,14). Anche le narrazioni presenti in altri contesti letterari (come in Aristofane) fanno emergere il complicato rapporto tra uomo e donna, anche se in una prospettiva meno univoca (così le storie di Melanione e Timone). Il padre e la figlia Esopo 304 H.-H. Un uomo, innamorato della figlia e in preda alla lussuria, mandò in campagna la moglie. Prese quindi la figlia con la forza, e la ragazza disse: «Padre, commetti un’azione diabolica: avrei preferito concedermi a cento uomini piuttosto che a te». RIFERIMENTI: Romanzo di Esopo 141. L’amante e la donna Esopo 300 H.-H. Un uomo andava di nascosto, durante la notte, da una donna e s’intratteneva con lei. Le aveva dato un segnale perché si accorgesse di lui: quando, giunto fuori dalla porta, abbaiava come un cagnolino, lei gli
apriva. Si comportava in questo modo ogni giorno. Un altro uomo lo vide mentre camminava di sera per quella strada e, intuendo la sua disonestà, una notte lo seguì da una certa distanza, di nascosto. L’amante, senza sospettare nulla, giunse alla porta e si comportò come d’abitudine. L’uomo che lo seguiva vide tutto e tornò verso casa sua. La notte successiva, egli partì e giunse per primo dall’adultera e, poiché abbaiava come un cagnolino, la donna, confidando che fosse il suo amante, spense la lampada, perché nessuno lo vedesse e aprì la porta. L’uomo entrò e si unì a lei. Dopo poco tempo, giunse anche il primo amante, abbaiando da fuori come un cagnolino, così come era abituato. Dopo che l’uomo all’interno della casa si accorse di quello che abbaiava dall’esterno come un cagnolino, egli stesso prese ad abbaiare con forza, come un cane di grandissime dimensioni. Allora l’amante che se ne stava fuori pensò che l’altro fosse più grande di lui e se la diede a gambe. La figlia sciocca e la madre Romanzo di Esopo 131 Una donna aveva una figlia sciocca; allora pregava tutti gli dei di mettere un po’ di senno nella ragazza. La figlia spesso sentiva la madre, mentre pregava. Una volta andarono nella villa di campagna e, lasciata la madre, la ragazza vide fuori dalla fattoria un’asina che subiva violenza da parte di un uomo. Allora chiese all’uomo: «Che cosa fai?». Ed egli rispose: «Ficco un po’ di senno dentro di lei». Memore della preghiera della madre, la giovane disse: «Metti anche dentro di me un po’ di senno». L’uomo oppose un deciso rifiuto, dicendo: «Non c’è
nulla di più ingrato di una donna». E lei esclamò: «Non preoccuparti, signore, mia madre ti sarà grata e ti pagherà la ricompensa che vuoi, poiché fa preghiere perché io abbia senno». Allora l’uomo la deflorò. La giovane, tutta felice, corse dalla madre e le disse: «Ho senno, madre». E lei: «Come hai ottenuto il senno, figlia?». La sciocca spiegò: «Un uomo infilò dentro di me una cosa grande, rossa e muscolosa, che correva dentro e fuori». Dopo avere ascoltato il racconto della ragazza, la madre le disse: «Figlia, hai perso anche quel po’ di senno che avevi prima». NOTA: alcuni studiosi si sono interrogati sulla battuta dell’uomo («Ficco un po’ di senno dentro di lei») impegnato a fare violenza all’asina. In sé non alluderebbe letteralmente a un ambito sessuale, ma è stato anche supposto un gioco di parole più esplicito (ὄνoν-νόoν, i termini che indicano rispettivamente «asino» e «senno») nella versione originaria della favola. RIFERIMENTI: Esopo 305 H.-H. Il ragazzo ladro e sua madre Esopo 296 Ch. Un ragazzino rubò da scuola la tavoletta di un suo compagno e la portò alla madre. La donna non solo non lo punì, ma addirittura lo lodò. La seconda volta il ragazzino rubò un mantello e lo portò alla madre, che lo lodò ancora di più. Con il passare del tempo, divenuto un giovanotto, provava ormai a rubare anche beni di maggiore valore. Una volta venne colto
in flagrante e, con le mani legate dietro alla schiena, fu condotto a morte. La madre lo seguiva e si batteva il petto. Lui disse di volerle dire qualcosa all’orecchio; ma appena gli si accostò, egli le afferrò l’orecchio e lo morse. La donna lo rimproverò per la sua empietà: non pago dei delitti compiuti, aveva anche fatto del male alla madre! Il ragazzo le rispose: «Se tu mi avessi picchiato quando per la prima volta rubai la tavoletta e te la portai, non mi sarei spinto fino al punto di essere condotto a morte». La favola dimostra che quanto non è frenato dall’inizio cresce a dismisura. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 297. La moglie e il marito ubriacone Esopo 88 Ch. Una donna aveva un marito ubriacone; allora architettò uno stratagemma con l’intenzione di togliergli il vizio. Lo osservò, attendendo che fosse inebetito per la sbornia e diventasse insensibile come un morto; quindi, lo caricò sulle spalle, lo portò al cimitero, lo depose e se ne andò. Quando pensò che fosse ormai tornato in sé, giunse e bussò alla porta del cimitero. Il marito disse: «Chi bussa alla porta?». La donna rispose: «Sono io, colui che porta il cibo ai morti». E lui: «No, carissimo, a me porta piuttosto da bere, non da mangiare: mi fai stare male a ricordarmi il cibo e non il vino». La donna, battendosi il petto, disse: «Povera me, lo stratagemma non mi è dunque per nulla servito; tu, marito mio, non solo non sei migliorato, ma sei diventato anche peggio di prima, poiché il tuo vizio è divenuto una condizione naturale». La favola
dimostra che non bisogna perseverare nelle cattive abitudini. Infatti, arriva il momento in cui quel comportamento si impone all’uomo anche contro la sua volontà. La padrona e le schiave Esopo 89 Ch. Una vedova, tutta dedita al lavoro, aveva delle schiave, che svegliava abitualmente di notte, al canto del gallo, perché lavorassero. Quelle, sopraffatte senza sosta della fatica, ritennero che fosse necessario sopprimere il gallo di casa. Pensavano, infatti, che fosse la causa della loro sofferenza, poiché svegliava di notte la loro padrona. Alle schiave che portarono a termine questo piano accadde però di incorrere in sciagure peggiori. Infatti, la padrona, non venendo più a sapere l’ora tramite il gallo, le faceva alzare ancora prima, nella notte, per metterle al lavoro. Così per molti uomini sono causa di sventura le loro decisioni. Melanione Aristofane, Lisistrata 781 ss. Voglio narrarti una storia che io stesso ho sentito quando ero bambino. C’era una volta un giovane, Melanione, che, volendo fuggire le nozze, era andato a vivere da solo sui monti. E così dava la caccia alle lepri, intrecciava reti e possedeva un cane. Non tornò più a casa per l’odio che provava; a tal punto giungeva il suo disprezzo per le donne. E noi, che siamo assennati, non saremo certamente inferiori a Melanione.
Timone Aristofane, Lisistrata 805 ss. Anch’io desidero narrarti una storia, che risponda al racconto di Melanione. C’era un tempo Timone, errabondo, che aveva il viso coperto da fitti pruni, discendenza delle Erinni. Questo Timone certamente se ne andò per odio, molto maledicendo gli uomini scellerati. Così quello ricambiava sempre il vostro odio, uomini scellerati, ma provava enorme amore per le donne. La donna partoriente Fedro 1,18 Nessuno ritorna di buon grado nel luogo che gli portò afflizione. Compiuti i mesi, una donna, nell’imminenza del parto, era sdraiata a terra ed emetteva lamenti che suscitavano pietà. Il marito la esortò ad appoggiare il corpo sul letto, per meglio deporre il fardello della natura. «Non ho affatto fiducia – disse – che il mio male finisca nel luogo dove in origine fu concepito.» RIFERIMENTI: Plutarco, Precetti coniugali 143e. La meretrice e il giovane Fedro, App. 27 [29] Ci piacciono molte cose, che tuttavia recano disagio Una meretrice bugiarda blandiva un giovane
e tuttavia egli, spesso offeso da molti tradimenti, era accondiscendente nei confronti della donna; così lei, abile a tessere inganni, disse: «Per quanto tutti mi contendano, facendomi regali, tu mi piaci molto di più». Il giovane, ricordando quante volte era stato ingannato, rispose: «Volentieri, mia luce, ascolto questa tua voce, non perché sia credibile, ma per il fatto che mi dà buon umore». La Sibarita Aristofane, Vespe 1435 ss. FILOCLEONE Ascolta, non fuggire. A Sibari una volta una donna frantumò un vaso. […] Il vaso, dunque, si prese un testimone. Allora la Sibarita disse: «Se, per Core, tu avessi lasciato da parte la testimonianza e avessi acquistato rapidamente una benda, saresti stato più intelligente». L’origine del rossore Gregorio Nazianzeno, Carmina moralia, MPG 37,898 Un tempo la stirpe degli uomini non faceva differenza tra chi era migliore e chi era peggiore, come afferma una venerabile leggenda. Molti, pur essendo eccellenti, erano considerati pessime persone, molti, invece, che erano onesti, erano al contrario ritenuti dissennati. Gloria così toccava a chi non era degno di onore e disonore a chi era senza macchia, poiché questi riconoscimenti si alternavano senza giustizia. Ma la malizia sovrana non sfuggiva all’attenzione del Signore Dio, che, lento all’ira,
tenne un simile discorso: «Non è giusto che buoni e cattivi godano della stessa reputazione. Così aumenterebbe la malvagità. Perciò io conferirò agli uomini un segno onesto, affinché si possa riconoscere chi è malvagio e chi è buono». Dopo avere parlato così, fece arrossire le guance degli uomini, riversando il sangue sotto la pelle, una volta suscitata la vergogna. E specialmente alle donne, poiché sono esili nel fisico e delicate nel cuore, conferì il rossore in maggiore quantità. Rese invece rigidi i malvagi e li fece duri al loro interno, perciò nemmeno un po’ di vergogna li coglie.
Donnola La donnola è un animale complesso e singolare, dalla connotazione simbolica ambivalente: viene rappresentata come dissoluta, perversa, malefica ma anche astuta, talora pronta a soccorrere le donne. Se in Grecia ha una fama sinistra, a Roma sembra forse godere di una migliore reputazione (cfr. Bettini 1998). Nel mito giunge in aiuto di Alcmena, il cui parto è ostacolato da Era, quando la gestante dà alla luce Eracle: in alcune narrazioni si parla di una ragazza che si trasforma in donnola (così, ad esempio, in Ovidio, Metamorfosi 9,281 ss.), in altre (Eliano, De natura animalium 12,5) direttamente di una donnola. In ogni caso, qui come altrove, appare stretto il legame con l’universo femminile. Peraltro, la corsa della donnola pare avere un valore simbolico, per cui basta il solo passaggio, secondo alcune versioni, per sbloccare il parto di Alcmena: forse, una «magia di tipo omeopatico» (Bettini 1998,150). Il legame con il parto delle donne è attestato anche da scienziati come Plinio il Vecchio. Sul piano religioso, la dea Ecate, a cui la donnola è associata, è posta in relazione con il parto. Il valore simbolico dell’animale si riscontra in termini simili presso diverse culture antiche: il corrispondente della donnola in Egitto, l’icneumone, pare avere caratteristiche affini anche nel rapporto con la sfera divina. Nell’antichità si pensa che la donnola, considerata madre premurosa, concepisca attraverso le orecchie e generi attraverso la bocca. Secondo Plutarco (Iside e Osiride, 381a), molti ravvisano in questa credenza un riferimento simbolico alle origini del linguaggio, poiché si ascolta (ossia si riceve) dalle orecchie e si parla (ossia si emette) dalla bocca. Poiché la tradizione giudaica rappresenta la donnola come essere impuro (Levitico 11,49-51), la letteratura cristiana ribalta la credenza pagana: la donnola genera attraverso la bocca e partorisce tramite le orecchie (così nel Fisiologo). Il
ribaltamento è necessario affinché la donnola, animale impuro, diventi simbolo del rifiuto della Parola di Dio, al contrario di quanto fa Maria, che concepisce Gesù accogliendola. Nel mondo antico circola anche la leggenda secondo cui in origine la donnola era una strega, trasformata, poi, da Ecate in un malvagio animale (Eliano, De natura animalium 15,11): il suo verso è incluso tra i suoni sinistri; vedersi attraversare la strada da una donnola è presso i Greci un segno negativo (oggi è il gatto ad avere assunto queste caratteristiche). Ma le credenze su questo animale così ricco di significati non finiscono qui: da ricordare il suo potere di far ammutolire (da cui il proverbio «Ha inghiottito una donnola») e la leggenda del vampirismo, che si deve, fra l’altro, al tipo di morso e al fatto che l’animale lecca il sangue delle ferite. Nella favola antica troviamo amplificati tratti culturali di diversa provenienza, a partire dalla convivenza di questo animale con l’uomo. Tra gli altri, Ovidio (Metamorfosi 9,323) evoca un’immagine domestica della donnola. Proprio questa immagine caratterizza anche la favola 355 Ch., in cui la donnola si vanta di fronte al pappagallo, ultimo arrivato, di essere un animale «nato in casa». D’altra parte, qui, come spesso, la figura della donnola emerge per la sua malignità. La convivenza con l’uomo e la natura ambigua si rilevano anche nella favola in cui l’animale, sperando di non essere ucciso dall’uomo, cerca di vantare come merito la caccia ai topi, in realtà svolta per fini del tutto personali (Fedro 1,22). Alcuni motivi favolistici orientali sembrano avere relazioni con la tradizione greca, dove la donnola si trova a volte al posto di altri animali. In una narrazione di età bizantina, che sembra richiamare motivi favolistici egizi e indiani (Adrados 2003, 415), troviamo la donnola che si colora per sbaglio di nero e così s’impossessa facilmente del topo che le si avvicina ingenuamente, non riconoscendola (Niceforo Gregora, Historia Byzantina 7,1). Questo animale tende a confondersi col gatto (v.) nella terminologia degli antichi (le stesse traduzioni degli interpreti moderni sono oscillanti) e
nelle situazioni più ricorrenti: ad esempio, la guerra con i topi (Fedro 4,2; Esopo 13 Ch.). L’animale è anche pronto a catturare i pipistrelli (Esopo 251 Ch.) e a sfidare i serpenti (Esopo 289 Ch.). A questo proposito, Plinio (Naturalis historia 8,78) nota che la donnola s’insinua nelle cavità e sfida persino il temibile e leggendario basilisco, serpente velenosissimo. In alcuni dialetti, tra l’altro, il nome della donnola si confonde con quello del serpente, probabilmente proprio alla luce della stessa abilità nello scivolare con agilità dentro i buchi (Bettini 1998,158). Proprio questa caratteristica sembra in relazione con una favola riportata da molti, tra cui Orazio (Epistole 1,7,28 ss.): una donnola consiglia a una piccola volpe, incastrata in una cesta, di rinunciare a quanto ha mangiato per poter dimagrire e così liberarsi. Anche nella tradizione favolistica, infine, emerge lo stretto legame con la donna. Se nel folclore è spesso simbolo di grazia e di vanità femminile, e ancora oggi in varie lingue europee è designata con nomi che rimandano all’idea di bellezza (mono in spagnolo, belette in francese), l’animale è anche fortemente legato all’esperienza del matrimonio (nel greco moderno e in altre lingue la donnola è chiamata «sposina» o «sposa»). Peraltro, già nella tradizione antica appare piuttosto come una sposa mancata. La favola esopica 14 Ch., da cui probabilmente deriva anche il proverbio «Alla donnola non si addice l’abito da sposa», appare assai eloquente in questo senso: Afrodite, dopo avere trasformato una donnola in una bella ragazza per consentirle di sposare il giovane che ama, la fa ritornare, per punizione, alla sua condizione precedente, constatando che, anche da donna, non riesce a trattenersi dal dare la caccia ai topi. La donnola conserverà il rancore per la perdita della nuova identità (nella tradizione indiana del Pañcatantra si ha una favola simile, ma la protagonista è una fanciulla-topina, che non trova il pretendente giusto e così opta per un topo: tantra terzo, racconto nono). Così si spiega meglio l’ostilità, attestata nel folclore greco, della donnola nei confronti delle spose; perciò si mettevano miele e profumi in un piatto nella
stanza in cui era conservato il corredo e si invitava l’animale ad accettare il dono e a non sottrarre nulla alla sposa. Questa storia della donnola come sposa mancata (o zitella gelosa) è assai diffusa e si ritrova nelle tradizioni regionali italiane e addirittura in Germania (Bettini 1998, 323 ss.). Comunque sia, l’immagine dell’animale nella tradizione greca sembrerebbe contraddittoria: da un favorisce il parto, dall’altro è ostile alle spose. Ma occorre ricordare che il ruolo della levatrice è spesso assegnato, come è attestato fin da Platone (Teeteto 149b), a donne infeconde; e alla stessa Artemide, dea vergine e levatrice, le partorienti si appellavano per placarne il disappunto dovuto al cambio di condizione da vergini a madri. La donnola e l’uomo Fedro 1,22 Una donnola, catturata da un uomo, volendo evitare la morte che incombeva disse: «Ti supplico, risparmiami, visto che libero la tua casa dal fastidio dei topi». L’uomo rispose: «Se ti comportassi così per fare un favore a me, sarebbe un gesto gradito e risparmierei te, che mi supplichi. Ora, poiché ti dai da fare per godere degli avanzi destinati a essere rosicchiati dai topi, e insieme divori gli stessi sorci, non mettermi in conto un favore che non esiste». E, con queste parole, uccise l’impudente. Devono riconoscere come rivolta a loro questa favola coloro che ricavano vantaggio dai propri servizi e rinfacciano agli ingenui un merito inconsistente. NOTA: si legge inprudentibus per inprudentius (v. 12). RIFERIMENTI: Romulus 49.
La donnola e Afrodite Esopo 76 Ch. Una donnola s’innamorò di un bel ragazzo e pregò Afrodite di trasformarla in donna. La dea, impietosita per la sua passione, la trasformò in una graziosa fanciulla, e così il giovane, dopo averla vista ed essersene innamorato, la portò a casa sua. Giacendo nella camera nuziale, Afrodite, che voleva sapere se la donnola, con il mutamento del corpo, avesse mutato anche il carattere, pose un topo in mezzo alla stanza. La ragazza si dimenticò della sua condizione presente e, alzatasi di scatto dal letto, si mise a inseguire il topo con l’intenzione di mangiarlo. Allora la dea, adirata con lei, la restituì alla sua precedente condizione. Così anche gli uomini malvagi per natura, anche se mutano nell’aspetto, non cambiano di certo il carattere. RIFERIMENTI: Babrio 32; Parafrasi 76; Dodecasillabi 76; 1,39; Giuliano, Epistulae 82; Gregorio Nazianzeno, Carmina de se ipso, MPG 37, 1217; Tzetze, Chiliadi 4,938-943; Michele Coniate, Epistulae 116. Il pipistrello e le donnole Esopo 251 Ch. Un pipistrello, caduto per terra, venne afferrato da una donnola e, poiché stava per essere ucciso, supplicava di essere risparmiato. Quella affermò che non poteva liberarlo, essendo per natura nemica di tutti gli uccelli. Il pipistrello replicò che non era un uccello ma un topo, e così fu lasciato andare. In
seguito, caduto di nuovo e preso da un’altra donnola, la supplicava di non essere divorato. La donnola gli disse che odiava tutti i topi, così quello rispose che non era un topo ma un pipistrello; e se la cavò di nuovo. E così accadde che si salvò per avere cambiato il nome due volte. La favola dimostra che anche noi non dobbiamo persistere sempre negli stessi comportamenti, tenendo presente che coloro che si sanno adattare alle circostanze spesso evitano i pericoli. RIFERIMENTI: Varrone, Satire menippee fr. 13 B. Il pappagallo e la donnola Esopo 355 Ch. Un uomo comprò un pappagallo al mercato e lo portò a casa dove lo lasciò vivere libero. Il pappagallo, addomesticato, balzò sul focolare e vi si appollaiò; e di lì emetteva versi piacevoli. Una donnola, vedendolo, gli chiese chi fosse e da dove venisse. Il pappagallo le rispose: «Il padrone mi ha da poco comprato». «Gridi in questo modo, pur essendo appena arrivato, tu che sei il più sfrontato degli animali, – disse la donnola – quando a me, che sono nata in casa, i padroni non lo consentono, ma, se mai provo a farlo, mi cacciano irritati». Il pappagallo le rispose: «Oh, signora di casa, vattene via, lontano da qui; i padroni, infatti, non si irritano nello stesso modo per la mia voce, come succede per la tua». La favola è adatta ai malvagi, che sono sempre pronti a criticare gli altri. RIFERIMENTI: Babrio 135; Dodecasillabi 356. La battaglia dei topi e delle donnole
Fedro 4,6 I topi, vinti dall’esercito delle donnole (la loro storia è dipinta anche nelle osterie), fuggendo e correndo confusamente intorno agli stretti ingressi delle tane, pur con difficoltà nella ritirata, evitarono la strage. I loro capi, che avevano legato alla testa delle corna, per avere durante il combattimento un’insegna chiaramente visibile che i soldati potessero seguire, rimasero bloccati all’entrata delle tane e furono presi dai nemici. Il vincitore, con avidi denti, immerse questi, immolati, nella spelonca tartarea del suo ampio ventre. Se il popolo è oppresso da un triste evento, la grandezza dei cittadini più eminenti corre pericoli; il popolino riesce a nascondersi, trovando facilmente riparo. RIFERIMENTI: Babrio 31; Pseudo-Dositeo 3; Sintipa 51; Parafrasi 239; Dodecasillabi 239; Aristofane, Vespe 1182. La donnola nera Niceforo Gregora, Historia byzantina 7,1 C’era un calzolaio che possedeva una donnola bianca, la quale ogni giorno dava la caccia a uno dei topi che albergavano nella casa. Un giorno la donnola si gettò in un recipiente nel quale il calzolaio teneva un liquido che rendeva nere le pelli; a fatica uscì di lì, colorata di nero. Allora, i topi pensarono che quella con atteggiamento coerente non avrebbe più voluto mangiare carne, poiché aveva assunto l’aspetto di un monaco. E così essi, senza timore, si sparpagliarono in tutto quel luogo, seguendo con il
fiuto su e giù il cibo di cui si sarebbero nutriti. Dopo essersi accostata a un tale teatro di caccia, la donnola avrebbe davvero voluto catturare i topi tutti insieme, ma era impossibile. Così, avendone presi due, li divorò. Allora tutti gli altri si misero in fuga, domandandosi con meraviglia come mai il gatto fosse diventato ancora più selvaggio, dopo avere assunto l’aspetto di un monaco. PROVERBI Oὐ πρέπει γαλῇ κρoκωτόν Alla donnola non si addice l’abito da sposa La favola esopica (76 Ch.) costituisce evidentemente «la spiegazione e l’equivalente perfetto» del proverbio, molto noto (Bettini 1998, 324; 342 n. 16 e n. 18; cfr., tra gli altri, Zenobio 2,93). Il folclore e la tradizione favolistica si saldano dunque per mettere in risalto la concezione che l’uomo ha elaborato sull’animale (v. sopra). Il significato è molto chiaro: non è possibile cambiare la propria natura. Decipit / frons prima multos L’esteriorità inganna molti Prima di narrare la favola della donnola e dei topi, Fedro, con questa affermazione (4,2,6 s.) che si inserisce nella tradizione delle sentenze più celebri, «parla […] di sé e della propria poesia, la quale, attraverso storie di animali, vuole impartire insegnamenti agli uomini» (Tosi 1991,101, a cui si rimanda per i numerosi possibili paralleli). V. anche MASCHERA (in particolare, il proverbio tratto dalla favola di Fedro 1,7).
Drago Nell’ambito dell’ampia serie di nomi con cui è designato il serpente nelle lingue classiche, troviamo un termine (draco in latino, δράκων in greco) il cui significato è in relazione con il verbo δέρκoμαι, che indica l’atto del guardare intensamente (in effetti, lo sguardo e i poteri a esso connessi sono spesso elementi caratterizzanti del rettile nella cultura antica). Generalmente, in questo modo si indica un serpente di grosse dimensioni, talora legato all’uomo da rapporti di vicinato, non velenoso, anche se non necessariamente inoffensivo (ad esempio, nella favola di Esopo 347 Ch. lo vediamo arrampicarsi su un albero e divorare senza pietà i piccoli della rondine). D’altra parte, il termine può indicare anche il drago delle leggende, l’essere fantastico in grado di assumere forme diverse, al centro (dalla Cina alla Mesopotamia) di numerose narrazioni di forte impatto nell’immaginario collettivo. A questo proposito, va sottolineato che «nel ricordo collettivo dell’umanità i mostri preistorici vengono rappresentati dai serpenti» e il drago delle leggende non è altro che «un serpente mostruoso più o meno somigliante a quello in natura» (Maspero 311). Se è vero che, in generale, draco, oltre a essere un termine poco ricorrente, «nella favolistica antica non corrisponde al drago protagonista delle fiabe, ma designa un serpente» (Pugliarello 1973, 112), occorre, comunque, evidenziare che in una favola di Fedro (4,20[21]) la maggior parte degli interpreti traduce proprio con «drago» (qualcuno lo pone in relazione con il serpente ctonio). Questa narrazione presenta una volpe che, scavando, s’imbatte nell’animale, custode inamovibile, tenacemente legato a un tesoro; simbolo dunque di avidità. In effetti, l’immagine si collega alla tradizione che vede questo serpente fantastico nel ruolo di guardiano o custode di tesori o luoghi straordinari. In questa veste lo troviamo spesso nel mito: è
un drago a fare la guardia nel giardino delle Esperidi, dove sono conservate le mele d’oro che Eracle deve portare a Euristeo; ancora, è un drago a custodire la fonte che l’eroe tebano Cadmo deve avvicinare per compiere un sacrificio in onore di Atena (il drago è ucciso con una lancia: il tema viene poi ripreso anche nel racconto medievale di san Giorgio). Nel caso di questa favola fedriana, certamente anomala e senza paralleli nel patrimonio esopico antico, il drago potrebbe assumere un valore soprattutto di tipo morale e allegorico, per indicare l’accumulo sterile di ricchezza (Nøjgaard 1964, 249). La volpe e il drago Fedro 4,20 [21] Una volpe, impegnata a scavarsi la tana, mentre gettava fuori la terra e realizzava cunicoli in profondità, giunse nella parte più interna della grotta di un drago, che custodiva tesori nascosti. Appena lo vide, disse: «Ti prego di perdonare prima di tutto questa avventatezza; poi, se ben comprendi quanto l’oro non convenga al mio stile di vita, rispondimi, sii cortese. Quale frutto ricavi da questa fatica o quale premio è così grande da toglierti il sonno e da farti vivere nelle tenebre?». «Nessuno – disse il drago – ma questo compito mi è stato affidato dal sommo Giove.» «Dunque non prendi nulla per te e non dai niente a nessuno?» «Così vuole il fato.» «Non adirarti se parlerò liberamente: chi è simile a te, è nato sotto dei incolleriti. Destinato ad andare là dove finirono i tuoi antenati, perché, con mente cieca, tormenti il tuo infelice animo?» Dico a te, avaro, gioia del tuo erede, a te che frodi gli dei dell’incenso e te stesso del cibo, che triste ascolti l’armonioso suono della cetra, che la letizia dei flauti affligge; a te, a cui i prezzi dei cibi strappano un
gemito; a te che, pur di aggiungere spiccioli al patrimonio, affatichi il cielo con ignobile spergiuro, a te che tagli ogni spesa per il tuo funerale, perché Libitina non guadagni dal tuo patrimonio. NOTA: Libitina è la dea romana dei funerali.
E
Elefante Le enormi dimensioni e il comportamento fanno dell’elefante un simbolo di forza, giustizia, saggezza e fedeltà. Aristotele (Historia animalium 630b) ne sottolinea anche l’intelligenza superiore agli altri animali, introducendo una convinzione che ha lunga fortuna nel mondo antico. Come è noto, l’elefante è animale esotico agli occhi dei Greci e dei Romani. La testa di elefante è, tra l’altro, usata come simbolo dell’Africa e dell’India. Animale da soma, addomesticato dapprima da Indiani e Cartaginesi, è conosciuto in guerra, sul fronte nemico, dai Greci solo nel 326 a.C. (battaglia dell’Idaspe), nell’ambito della campagna indiana di Alessandro Magno; dai Romani, che lo useranno poi anche nei giochi del circo, nel 280 a.C. (guerra contro Pirro). Vista l’origine, raramente è associato alla divinità: tuttavia, ad esempio, a Pompei Venere è ritratta insieme agli elefanti. La vicinanza con la sensibilità dell’uomo è affermata anche da Plinio (Naturalis historia 8,1), che descrive l’animale come un essere docile, dotato di memoria, giusto e onesto, e appare confermata nell’immaginario moderno (si pensi alla dolcezza che connota la figura di Dumbo, così amato dai bambini). Simbolo di castità presso i cristiani, l’elefante, peraltro affascinato dalle belle donne, sembra non tollerare l’adulterio, come già curiosamente testimonia Eliano, che spiega come un elefante uccise la moglie del suo domatore e l’amante, colti in una situazione inequivocabile (Natura animalium 11,15). Fedro, spiegando quali virtù siano state benevolmente attribuite dalla Fortuna agli animali, indica la forza come la caratteristica principale dell’elefante (App. 2,5). A fronte della sua mole, tuttavia, l’animale appare, paradossalmente, assai pauroso nei confronti di creature più piccole: è il caso, in particolare, del porcellino, del topo, del montone e della zanzara. Secondo Eliano, la vittoria dei Romani contro Pirro
si deve proprio a queste paure (De natura animalium 1,38). Ed è proprio tale curiosa fragilità a caratterizzare l’elefante nella raccolta esopica. In una narrazione (Esopo 145 Ch.), che riprende il fortunato motivo degli animali riuniti in assemblea (riscontrabile, sia pure con diversi protagonisti, anche nelle favole 38 e 306 Ch.), l’elefante è ritenuto inadatto a regnare a causa proprio della paura nei confronti del porcellino. Da notare però che il cammello appare inadatto perché invece manca della capacità di adirarsi contro gli iniqui: una dote che il rivale possiede (almeno, così si può dedurre implicitamente) e richiama il valore morale e simbolico dell’elefante attestato nell’antichità (v. sopra). La favola comunque testimonia il fatto che l’elefante è preso in considerazione per un’alta carica, degna generalmente del leone. E proprio il leone è l’animale a cui, forse non casualmente, è accostato nella favola 210 Ch. (per il motivo mitologico che ne è alla base, v. PROMETEO). Tuttavia, ancora una volta, il terrore per un essere molto più piccolo non gli consente di raggiungere la dignità del leone. In questo caso è la zanzara a minacciarlo. Per certi aspetti, questa caratterizzazione, tutt’altro che eroica, sembra essere più vicina a un’altra tradizione, meno positiva, nei riguardi all’animale; nelle collezioni dei proverbi troviamo l’espressione «Non differisci in nulla da un elefante»: indica una persona grossa che si segnala soprattutto per la goffaggine (cfr. Tosi 1991, 324). Se la presenza dell’elefante appare come un’eccezione nella favolistica occidentale, l’animale sembra più a suo agio nella tradizione indiana (dove rappresenta anche il dio Ganesha) e africana. Nel Pañcatantra (tantra terzo, racconto terzo) leggiamo che gli elefanti un tempo furono costretti a emigrare a causa della siccità; trovarono un lago, ma, con la loro mole, uccisero numerose lepri che abitavano sul posto. Allora, con un’astuzia, il messo delle lepri si finse una divinità, li spaventò e li indusse ad andarsene. Nella tradizione dei Bangwa (Camerun), troviamo invece l’elefante che si vanta sempre della sua forza e delle sue abilità. La tartaruga gli
propone allora una sorta di tiro alla fune; presa la corda, entra però nella foresta e consegna l’altra estremità al forte ippopotamo, con cui ha stretto accordi simili. La gara finisce in parità e la tartaruga, che inganna così entrambi gli animali, da quel giorno viene temuta dai ben più imponenti rivali. Pur con tutte le differenze di ambientazione e di stile, anche in questo caso, così lontano dalla nostra tradizione favolistica, la morale segnala il timore dell’elefante per un animale tanto piccolo. Il cammello, l’elefante e la scimmia Esopo 145 Ch. Gli animali si erano riuniti per eleggere un re; il cammello e l’elefante si candidarono sperando di prevalere su tutti gli altri per la grandezza del corpo e per la forza. La scimmia allora disse che entrambi erano inadeguati: «Il cammello perché non sa adirarsi contro gli iniqui, l’elefante invece per il rischio che il porcellino, da cui lui è terrorizzato, ci attacchi». La favola dimostra che molti sono frenati anche dal compiere azioni importanti a causa di futili motivi. RIFERIMENTI: non è attestata altrove. Cfr. comunque Archiloco, frr. 185-187 W. (in relazione forse con le favole esopiche 38 e 306 Ch.). 2
Il leone, Prometeo e l’elefante Esopo 210 Ch. Il leone se la prendeva spesso con Prometeo perché lo plasmò grande e bello, armò la sua mascella di denti, rese forti le zampe con gli artigli e
lo fece più potente degli altri animali. «Ma, pur essendo così, – diceva – ho timore del gallo.» E di rimando Prometeo: «Perché mi accusi senza motivo? Da me infatti hai avuto tutte le qualità che ho potuto offrirti: il tuo coraggio ha soltanto questo piccolo neo». Il leone dunque compiangeva se stesso e si accusava di vigliaccheria e, alla fine, prese a desiderare di morire. Mentre meditava in questo modo, incontrò l’elefante e, dopo averlo salutato, si fermò a parlare con lui. Dal momento che lo vedeva muovere le orecchie senza sosta, gli chiese: «Che hai? Perché le tue orecchie non si fermano nemmeno per un momento?». L’elefante, allora, poiché una zanzara si trovava a volargli intorno, disse: «Vedi questa piccolina che continua a ronzare? Se entra nel condotto del mio orecchio, sono morto». E il leone replicò: «Perché, dunque, dovrei morire visto che sono così forte e più fortunato dell’elefante quanto il gallo è più potente della zanzara?». Vedi quanta forza ha una zanzara, da far paura anche a un elefante. RIFERIMENTI: Achille Tazio 2,21.
Era (Giunone) Figlia di Crono e di Rea, la dea Era (a Roma Giunone) è sorella e poi sposa di Zeus, quindi regina degli dei. Viene inghiottita da Crono e riportata alla luce dallo stesso Zeus, che sposa, dopo essere stata allevata da Oceano e da Teti (o dalle Ore) e ne è la terza moglie in giuste nozze (esistono, tuttavia, altre credenze sulla questione). Dall’unione con il re degli dei nascono due figli maschi – Efesto e Ares – e due femmine, di particolare valore simbolico: Ilizia (dea protettrice dei parti) ed Ebe (la giovinezza). Viene considerata protettrice delle spose e delle partorienti, ed è simbolo di fedeltà coniugale. Violenza e gelosia sono i suoi caratteri distintivi e si rivolgono non solo verso le vittime degli appetiti del marito (v. ERACLE), ma anche nei confronti dello stesso infedele Zeus, che arriva a punirla, sospendendola all’Olimpo e attaccando ai suoi piedi due incudini. Nella guerra di Troia si schiera dalla parte dei Greci e protegge, in particolare, due eroi: Achille e Menelao. Nell’antica Roma, dove in suo onore si celebrano le Feste Matronali il 1° marzo e quelle Caprotine il 7 luglio, viene identificata con la dea Giunone, che da tempi remoti rappresenta il ciclo lunare. Le è sacro il melograno; il pavone e la vacca sono considerati suoi simboli; anche la cornacchia e il cuculo sono animali a lei consacrati. Nella tradizione favolistica, Era appare molto più defilata rispetto a Zeus, anche se il suo rilievo nel mondo esopico non sembra meno significativo di quello del re degli dei, anzi curiosamente la sua statua costa più di quella del consorte e di Hermes (Esopo 108 Ch.). Maggiore spazio trova la figura di Giunone in Fedro, che la pone al centro di due curiose narrazioni. Nella prima, il pavone si lamenta con la dea
perché non ha la stessa voce dell’usignolo, ma Giunone ricorda che gli è stata concessa una straordinaria bellezza (Fedro 3,18). La favola riprende un consolidato schema narrativo: quello della lamentela degli animali presso gli dei. Significativo (non solo qui: cfr. anche Aviano 15,1) appare il ruolo del pavone come «uccello di Giunone» per antonomasia: la dea pose nelle sue penne gli occhi di Argo, quali gemme preziose simili alle stelle (cfr. Ovidio, Metamorfosi 1,722 s.). In un’altra narrazione di Fedro (App. 9 [11]), dai caratteri comici e misogini, Giunone si vanta per la sua continenza; allora Venere le racconta una storia sulla libido delle donne.
Eracle Eracle (nella mitologia romana Ercole) è figlio di una donna, Alcmena, e di Zeus. Nato a Tebe, è fin da bambino dotato di grande forza: nella culla uccide due serpenti inviati da Era, a lui ostile. Nell’infanzia riceve un’eccellente educazione, soprattutto nel guidare il cocchio, nel tirare con l’arco, nel cantare e nel suonare la lira. Gli viene data Megara come sposa dal re di Tebe Creonte; Era, quindi, lo fa impazzire e, nella follia, l’eroe uccide i figli. Per espiare la colpa, è indotto dall’oracolo di Delfi a obbedire a Euristeo, re di Tirinto, e ad affrontare così una serie di imprese, le famose dodici fatiche (altre versioni del mito pongono questi episodi prima dell’uccisione dei figli). Si tratta della lotta contro il leone Nemeo, dell’uccisione dell’Idra di Lerna, mostro con nove teste; della cattura del cinghiale di Erimanto che devastava l’Arcadia, della cerva di Cerinea sacra ad Artemide; della cacciata degli uccelli del lago Stinfalo; della presa della cintura che apparteneva alla regina delle Amazzoni; della pulizia delle stalle di Augia; della cattura del toro di Creta, delle cavalle di Diomede, dei buoi di Gerione; della raccolta delle mele d’oro delle Esperidi e infine della cattura di Cerbero negli Inferi. Dopo le dodici fatiche, che sono state poste in relazione ai dodici segni dello zodiaco, Eracle torna a Tebe, lascia la moglie Megara a Iolao, e, volendo sposare Iole, figlia di Eurito, partecipa a una gara di tiro con l’arco, vincendola, ma il padre della giovane gli nega il matrimonio. Allora l’eroe si vendica uccidendone il figlio Ifito, ma poi deve espiare filando la lana come schiavo di Onfale, regina di Lidia. Fra le numerose altre imprese di Eracle, vanno ricordate anche la lotta contro i Giganti a fianco del padre Zeus e la partecipazione alla spedizione degli Argonauti; nell’ultima parte della sua vita da uomo, sposa a Calidone Deianira, poi, costretto all’esilio, si stabilisce a Trachis e uccide Eurito insieme con tutti i suoi
figli, portando in schiavitù Iole. Inoltre, uccide Nesso, un centauro che insidia la moglie Deianira. Morendo, tuttavia, il centauro consiglia a Deianira, gelosa di Iole, di mettere a Eracle la sua camicia, per assicurarsi l’amore del marito. Ma il sangue del centauro, di cui la camicia è intrisa, agisce da veleno, portando alla morte l’eroe. Allora Zeus, commosso, assume il figlio in cielo assieme agli altri dei: qui sposa Ebe, dea della giovinezza. Simbolo di forza, di coraggio e di generosità anche presso i Romani, Eracle è considerato vendicatore degli empi, protettore degli atleti e custode delle palestre; gli uomini spesso giurano in suo nome (mentre in genere le donne giurano per Castore). È venerato a Sicione, Tebe, Coo e in numerosi altri centri della Grecia; in suo onore si celebrano le feste Eraclee. Già a partire dall’Iliade, il mito di Eracle dà spunto a numerose riprese nei più diversi generi letterari. In caso di disgrazie, gli antichi lo invocano come Hercules Defensor o Salutaris. Proprio in questa veste di protettore lo troviamo nella favola antica: confidando in lui, un bovaro non muove dito dopo che il carro gli è finito in un burrone (Esopo 72 Ch.), ma Eracle, che peraltro non nega il suo sostegno, lo invita a darsi prima da fare. Si tratta di un motivo di lunga fortuna, la cui prima versione sembra di Babrio; ne esiste una variante (Esopo 53 Ch.) con altri personaggi (un naufrago chiede aiuto ad Atena). Il tema diventa proverbiale e ancora oggi è presente in diverse culture (in italiano, «Aiutati, che il ciel ti aiuta», o «Aiutati, che Dio ti aiuta»: modo di dire attestato anche nel sesto capitolo dei Promessi Sposi). Un aneddoto originale di carattere filosofico è la favola 130 Ch.: Eracle evita Pluto, dio della ricchezza; i due sembrano rappresentare due elementi antitetici: la virtù e il vizio. Insomma, in questa, come in altre narrazioni, Eracle si impone come divinità popolare, paradigma positivo che, in chiave spesso satirica, rappresenta bene i valori della filosofia cinica. Un’altra favola, che si gioca nella sfera mitico-religiosa e rimanda a tematiche cinico-stoiche, è la 129 Ch., in cui Eracle compare con la clava, uno degli
oggetti che caratterizzano la sua immagine nel mondo antico. Tra gli elementi tipici della sua raffigurazione, uno, in particolare, trova spazio in alcuni motivi favolistici, pur senza un diretto riferimento a Eracle: si tratta della pelle del leone indossata dall’asino (Esopo 267 Ch.), che viene presto scoperto; invece, l’eroe nel mito indossa la pelle del leone Nemeo, a seguito di una delle sue dodici fatiche. Anche qui, come spesso accade, la favola sembra dissacrare un tema così caro al mito. A questi motivi, Adrados 2003, 455, nel suo repertorio, aggiunge una narrazione d’impronta mitologica, tratta da alcuni frammenti di Archiloco (286-288 W. ): l’episodio di Eracle e Deianira, impegnati ad attraversare il fiume Eveno, mentre il centauro Nesso insidia la moglie dell’eroe. Ma non si tratta di una favola in senso proprio. 2
Il bovaro ed Eracle Esopo 72 Ch. Un bovaro conduceva un carro verso un villaggio. Visto che il veicolo precipitò in un profondo burrone, il bovaro, pur essendo necessario il suo intervento, rimaneva inerte e invocava il solo Eracle tra tutti gli dei, poiché gli era molto devoto. Allora Eracle gli apparve e disse: «Metti mano alle ruote e pungola i buoi: prega gli dei quando anche tu avrai cominciato a fare qualcosa o pregherai invano». RIFERIMENTI: Babrio 20; Dodecasillabi Aviano 32. Cfr. anche Adrados 2003, 413.
72;
Eracle e Atena Esopo 129 Ch. Eracle percorreva una strada stretta. Vedendo per
terra qualcosa di simile a una mela, cercava di schiacciarla. Come vide raddoppiare le dimensioni di quella cosa, si mise a calpestarla ancora di più e a colpirla con la clava. L’oggetto, aumentando in grandezza, ostruì la strada. Eracle, dopo avere gettato via la clava, si fermò stupito. Allora Atena, apparendogli, disse: «Smettila, fratello, questa mela rappresenta rivalità e discordia; se la si lascia in pace, non muta; se la si contrasta, si gonfia fino a tal punto». A tutti appare evidente che la lotta e le contese sono motivo di danni enormi. RIFERIMENTI: Parafrasi 130. Eracle e Pluto Esopo 130 Ch. Eracle, divinizzato e ospite alla tavola di Zeus, salutava gli dei uno a uno, con grande cortesia. Tuttavia, abbassati gli occhi a terra, evitò Pluto, che era arrivato per ultimo. Meravigliato per l’accaduto, Zeus chiese a Eracle il motivo per cui, avendo parlato volentieri a tutti gli dei, guardasse male soltanto Pluto; quello rispose: «Io mi comporto in questo modo, perché quando ero tra gli uomini, lo vedevo stare per lo più con i malvagi». La favola può essere raccontata per chi è ricco per quanto riguarda la sorte, ma povero per quanto riguarda la natura. RIFERIMENTI: Papiro Rylands 3; Fedro 4,12; si veda il modello di Prodico citato in Senofonte, Memorabilia 2,1,21-34. PROVERBI
’Aλλ´ὅταν σπηύδῃ τις αὐτóς, χὠ θεὸς συνάπτεται Quando uno si dà da fare, anche la divinità collabora Il v. 742 dei Persiani di Eschilo diventa proverbiale, come nota Tosi 1991, 428, fornendo un ricco elenco di passi simili. La sentenza, espressa in diverse forme, è presente nei paremiografi (tra cui Diogeniano 8,11 e Apostolio 15,92) e in Plutarco (Instituta Laconica 239a). Probabile, dunque, la derivazione dalla favola.
Eros Eros (a Roma noto come Cupido o Amore) è il dio dell’amore. Esiodo, nella Teogonia (vv. 116 ss.), lo presenta come uno degli dèi più antichi, contemporaneo al Caos, alla Terra, al Tartaro, definendolo «il più bello degli immortali», in grado di sciogliere le membra e di domare mente e saggezza di dei e uomini. Esprime la forza generatrice della natura. Altre tradizioni suggeriscono una differente origine (la più accreditata lo vorrebbe figlio di Afrodite e di Ares), considerandolo il più giovane dei numi. In lui trova riferimento una lunga tradizione poetica. Inoltre, Amore è al centro di un noto racconto delle Metamorfosi di Apuleio (4,28-6,24) che lo vede protagonista insieme a Psiche (l’anima). Questa narrazione ha una lunga fortuna. Fulgenzio (IV-V secolo d.C.) interpreterà la vicenda come conflitto tra Anima e Desiderio. Spesso Eros è raffigurato come un fanciullo alato, dotato di arco, frecce e faretra; un altro tipico attributo sono le fiaccole. Non compaiono racconti dedicati a Eros nelle raccolte favolistiche anonime e neppure nei principali autori di narrazioni esopiche. Tuttavia, gli studiosi dibattono su alcuni racconti in chiave mitologica assimilabili alle favole. Il racconto forse più vicino al genere esopico (così pensano Perry e Adrados, di parere differente Van Dijk) è quello relativo alla nascita di Eros, narrata da Platone (Simposio 203b-204a): una storia eziologica, riferita da Socrate, il quale dice di averla appresa da Diotima. Così si spiega la natura di questo «demone» (il demonico è il livello che sta tra la dimensione divina e quella mortale), diviso tra le caratteristiche ereditate dalla madre (Penia, ossia l’indigenza) e quelle ereditate dal padre Poros (ossia, l’espediente). Secondo Jedrkiewicz 1989, 373, «il tema del racconto, la fondamentale ambiguità di Eros, è esopico fra tutti»; egli è una sorta di «allegoria personificante un valore
ben noto come movente dell’azione umana»; la sua ambiguità tra l’umano e il divino si costruisce su tre coppie di antinomie: mortale/immortale, povero/ricco, ignorante/sapiente. Lo qualificano anche la continua ricerca che non trova mai piena soddisfazione e la perenne tensione che lo porta dallo squallore verso la bellezza. Altre narrazioni, di cui si dibatte la natura favolistica, sono quella, sempre riportata da Platone nel Simposio, secondo cui in origine gli uomini erano sferici con due sessi e poi furono divisi in due parti, così da essere sempre alla ricerca della loro metà (189c-191d), e quella di Imerio (Orazioni 10,6, riportata da Fozio, Biblioteca 165), in cui si spiega che Zeus inviò Eros tra gli uomini, preoccupato per il rischio della loro estinzione: gli Amori volgari furono mandati nelle anime degli uomini comuni, mentre egli trovò dimora nelle persone dotate di un’anima celeste, ponendo in loro la follia erotica. Questa narrazione deriva da quella di Platone (Simposio 180c-e) sui due Amori, figli di Afrodite volgare e celeste. La nascita di Eros Platone, Simposio 203b-204a Quando nacque Afrodite, gli dei erano radunati a banchetto e, fra gli altri, c’era anche Poros, figlio di Metis. Dopo che ebbero mangiato, arrivò per mendicare, poiché c’era lì naturalmente gran festa, Penia, e se ne stava vicino alle porte. Ora, Poros, ubriaco di nettare (il vino, infatti, non esisteva ancora), entrò nel giardino di Zeus e, appesantito, si assopì. Allora Penia, tramando nella sua indigenza di avere un figlio da Poros, gli si distese accanto e concepì Eros. Ed è per questo che Eros è seguace e ministro di Afrodite, in quanto fu concepito nella festa della sua nascita e, allo stesso tempo, è per natura amante del bello, poiché anche Afrodite è
bella. Perciò, in quanto figlio di Poros e di Penia, Amore è venuto a trovarsi in questa condizione: innanzitutto, è sempre povero e tutt’altro che tenero e bello, come invece pensano i più, anzi è aspro, squallido, scalzo e senza casa, abituato a gettarsi sempre a terra e senza un giaciglio, dormendo all’aperto davanti alle porte e in mezzo alle strade, secondo la natura di sua madre, sempre accompagnato dal bisogno. Invece, per parte di padre, insidia i belli e i virtuosi, in quanto è coraggioso e ardito e tenace e bravo cacciatore, sempre pronto a tramare certi inganni, assetato di sapienza, ricco di espedienti, e per tutta la vita amante del sapere, temibile incantatore e stregone e sofista; e non è nato né immortale né mortale, ma talora nello stesso giorno fiorisce e vive, se la fortuna gli è favorevole, talora invece muore, ma poi rinasce, grazie alla natura del padre, e quel che acquista gli si sfila via sempre di mano, al punto che Amore non è mai né povero né ricco, e d’altra parte si trova in mezzo tra la sapienza e l’ignoranza. RIFERIMENTI: Plotino 3,5.
Esopo Esopo, oltre che padre della favolistica, ne è personaggio e spesso narratore interno. Al di là, infatti, della ricostruzione biografica (v. APPENDICE), si registra la sua presenza già nella letteratura greca del V secolo. Aristofane fa riferimento a spunti favolistici e li riconduce esplicitamente a Esopo: si è supposta anche l’esistenza di un libro dedicato alle sue favole, sulla base di un passo degli Uccelli (vv. 471 ss.). Esopo entra in scena anche come protagonista di aneddoti, ad esempio, la battuta rivolta a una cagna ubriaca (Vespe 1401 ss.). In Platone (Fedone 60c61b), Socrate, mentre si trova in carcere, riflette sul rapporto tra dolore e piacere, sottolineando che Esopo ne avrebbe potuto trarre una favola. Anche Aristotele descrive Esopo impegnato a narrare una favola (la volpe e il riccio) ai cittadini di Samo (Retorica 1393b-1394a). Questo personaggio rimane, anche nei secoli successivi, una figura costantemente presente nella letteratura extrafavolistica e spesso viene accostato ai Sette Savi, come in Plutarco, che comunque lo rappresenta in una condizione di inferiorità rispetto a essi, seduto su un modesto sgabello (lo stesso Plutarco inserisce Esopo come narratore di favole in varie opere dei Moralia). Rispetto alle fonti più antiche, che sembrano attestare la sua realtà storica, progressivamente gli sono attribuite caratteristiche inverosimili. La sua figura viene prima assimilata a quella di Socrate, poi, in età ellenistica, passa attraverso il filtro della filosofia cinica ed è così rivalutata per gli aspetti negativi (bruttezza, schiavitù); quindi, in età imperiale, «si affermano gli elementi […] capaci di collegare Esopo alla figura del «filosofo», nell’ambito di una saggezza concepita da un punto di vista esterno o, se si vuole, «popolare»» (Jedrkiewicz 1989, 161). Così nel Romanzo di Esopo (v.), grande collettore di
diverse tradizioni, troviamo il favolista descritto come schiavo. Venduto a un mercante di schiavi, finisce a Samo, acquistato dal filosofo Xanto. La sua figura ha una carica paradossale: egli, privo di cultura, supera intellettualmente il colto e borioso padrone. Esopo, abile nel risolvere enigmi, viene così affrancato e affronta varie peripezie (addirittura la sua figura si sovrappone a quella del protagonista di una narrazione orientale: il Romanzo di Ahiqar: v.). Il favolista – schiavo, straniero, brutto d’aspetto ma ingegnoso – viene descritto in modo caricaturale, secondo una tradizione iconografica attestata già da una coppa attica del V secolo a.C., in cui è rappresentato con testa enorme e membra disarmoniche. Tale aspetto fisico pare coerente con la sua condizione sociale subalterna. Ma l’ingegno riscatta l’uomo, secondo una connotazione tipicamente paradossale, che segna la figura esopica sotto vari punti di vista. All’interno della tradizione favolistica, troviamo spesso presente la figura di Esopo come personaggio o narratore interno. Questo avviene soprattutto nell’opera di Fedro, anche se il fenomeno si registra persino nelle collezioni anonime. Così il favolista assume i connotati dell’uomo acuto, che sa mettere in ridicolo chi cerca di farsi beffe di lui, come accade nell’episodio che lo descrive in un cantiere navale (Esopo 19 Ch.). L’ingegno rende Esopo più abile di un’intera moltitudine nel risolvere un caso di eredità (Fedro 4,5) e più efficace addirittura degli indovini (Fedro 3,3), contro cui peraltro si abbatte di frequente l’attacco satirico del razionalismo empirico esopico. Il favolista, talora sfrontato nei suoi modi, non esita ad affermare la verità (Fedro, App. 15 [17]); per questo viene punito, ma alla fine consegue il suo riscatto, secondo la logica ambigua del paradosso, tipica della favolistica, che rovescia l’apparenza. Così il saggio, secondo uno schema tipico di molte narrazioni, prima viene provocato e quindi risulta «vittorioso» (Fedro 3,14) contro chiunque cerchi di ridicolizzare il suo, spesso anticonformista, modo di pensare e di comportarsi.
Nella sua evoluzione, Esopo si caratterizza per alcuni elementi biografici consolidati (come il suo legame conflittuale con Delfi: Romanzo di Esopo 126; 127-129), ma spesso perde la dimensione storica originaria. Fedro (1,2) lo immagina ad Atene, al tempo del tiranno Pisistrato (intorno alla metà del VI secolo a.C.); inoltre, lo segnala come emblema del merito che sa imporsi e ribaltare anche le umili origini di schiavo, al punto che, come sottolinea lo stesso Fedro nell’epilogo del secondo libro, gli Ateniesi gli eressero una statua. Peraltro la sua figura diventa intercambiabile con quelle in cui compaiono altri filosofi, come Socrate, Talete e soprattutto Diogene il Cinico (v.): l’aneddoto di Esopo che si aggira con una lampada in pieno giorno e afferma di cercare «un uomo» (Fedro 3,19) è attribuito a Diogene da altre fonti (v. sotto); anche nella favola del lupo e della volpe giudicati dalla scimmia, di cui si immagina narratore proprio Esopo (Fedro 1,10), si ritrova una sentenza attribuita al filosofo cinico (cfr. Diogene Laerzio 6,54). Al di là della sovrapponibilità della figura di Esopo con Diogene, elementi spiccatamente cinici, frutto del «filtro» operato da questa scuola filosofica sulla favola in età ellenistica, si ritrovano in varie narrazioni: ad esempio, la polemica contro gli sportivi è presente, tra l’altro, nella favola in cui Esopo ridicolizza l’atleta presuntuoso (Fedro, App. 11 [13]). Significativo della mentalità esopica è soprattutto l’aneddoto dello schiavo fuggitivo, che il saggio favolista distoglie dal suo proposito, prospettandogli tremende conseguenze (Fedro, App. 18 [20]). L’esortazione ad accettare con rassegnazione la situazione presente, per quanto amara, è tipica della mentalità esopica, perché ogni desiderio di cambiamento, come dimostrano anche le favole ambientate nel mondo animale (ad esempio, le rane che cercano un re: Esopo 66 Ch.), comporta un rischio fatale. Esopo e il vincitore di una gara sportiva Fedro, App. 11 [13]
Come, una buona volta, si possa frenare la presunzione Una volta il saggio frigio aveva visto un uomo che aveva vinto una gara sportiva e si vantava smodatamente. Gli domandò così se il suo avversario avesse maggiore forza di lui. E quello: «Non fare un’affermazione di questo genere! Ero di gran lunga più forte io». «Ma allora, stolto, – disse – che gloria hai meritato, se tu, che sei più forte, hai superato uno di minor vigore? Saresti sopportabile se affermassi di avere superato casualmente uno più vigoroso di te.» Esopo e la padrona Fedro, App. 15 [17] Quanto spesso provochi danno affermare la verità Esopo era schiavo di una donna assai brutta, che trascorreva tutta la giornata truccandosi e adornandosi di vesti, gioielli, oro e argento, ma non trovava un uomo che la toccasse con un dito. «Posso dire una parola?» chiese. «Parla pure.» «Penso che, mettendo da parte questi ornamenti, tu possa ottenere quello che vuoi.» «Davvero ti sembra che io sia un po’ più affascinante al naturale?» «Tutto il contrario: se non pagherai, il tuo letto rimarrà a riposo.» «Ma non rimarrà a riposo la tua schiena» rispose, e diede ordine che lo schiavo loquace fosse castigato. Dopo poco, un ladro rubò un braccialetto d’argento. Riferito alla donna che il braccialetto non si trovava, lei, furiosa, chiama tutti gli schiavi e minaccia pesanti percosse, se non diranno la verità. «Minaccia pure gli altri – disse Esopo – ma non farai
finire in trappola me, padrona; sono stato massacrato a frustate, perché poco fa ho detto il vero.» Esopo e lo scrittore Fedro, App. 7 [9] Un tale aveva letto a Esopo le sue opere di infimo livello, in cui, stoltamente, si era dato molte arie. Desiderando dunque sapere quale opinione ne avesse il vecchio, disse: «Ti sono sembrato forse un po’ troppo presuntuoso? Non è infondata la fiducia nel mio ingegno». E lui, spossato dal pessimo libro, rispose: «Io approvo pienamente che tu dia lode a te stesso; infatti, non succederà mai che un altro ti elogi». Il poeta Fedro 4,5 Esporrò ai posteri, con una breve narrazione, come spesso ci sia più senno in un solo uomo che in una moltitudine di persone. Un tale, morendo, lasciò tre figlie: una bella e sempre a caccia di uomini con gli occhi; la seconda, invece, donna di campagna, semplice e dedita a filare la lana; la terza amante del vino e assai brutta. Ora, il vecchio aveva nominato come erede la loro madre, con la clausola che distribuisse in tre parti uguali tutto il patrimonio, ma in modo che nessuna avesse la proprietà e neppure fruisse di quanto le fosse stato assegnato; e poi, appena fosse cessata la proprietà dei beni ricevuti, ciascuna delle tre donne versasse centomila sesterzi alla madre.
Ad Atene tutti ne parlano. La madre, sollecita, chiede consiglio a esperti di diritto. Nessuno riesce a spiegare come le figlie possano non avere il possesso dei beni a loro assegnati e neppure usufruirne; e inoltre in quale modo possano versare una somma di denaro, non avendo ricevuto nulla. Trascorso un lungo periodo, senza che si riuscisse a cogliere il senso del testamento, la madre, lasciate da parte le questioni relative al diritto, interpellò la sua coscienza. Alla cacciatrice di uomini assegna i vestiti, gli oggetti per la bellezza femminile, la vasca da bagno in argento, gli eunuchi, gli schiavi depilati; alla filatrice di lana i terreni, le greggi, la fattoria, i braccianti, i buoi, gli animali da soma e gli attrezzi agricoli; all’ubriacona la cantina ricca di orci di vino invecchiato, la casa raffinata e i giardini deliziosi. La donna voleva dare a ognuna i beni così assegnati, con l’approvazione del popolo, che le conosceva; ma, a un tratto, Esopo si fece avanti tra la folla e disse: «Oh, se il padre ormai sepolto fosse ancora in grado di sentire, come mal sopporterebbe il fatto che gli Ateniesi non siano riusciti a interpretare la sua volontà!». Dopo che gli fu richiesto, dunque, risolse l’errore comune. «Date la casa, gli ornamenti, insieme ai deliziosi giardini, e i vini invecchiati alla donna dedita alla campagna e a filare la lana. Assegnate vesti, gioielli, servi e tutto il resto di questa parte di patrimonio a colei che si dà ai bagordi. Consegnate all’adescatrice terre, stalla con i buoi, armenti e pastori. Nessuna di loro potrà tollerare di tenersi beni tanto difformi dai suoi costumi. La figlia bruttissima venderà gli ornamenti per procurarsi il vino; la cacciatrice di uomini sarà pronta a disfarsi delle terre per acquistare oggetti per la sua bellezza; colei, invece, che è contenta del bestiame ed è dedita alla lana venderà, per qualsiasi cifra, la sua casa così ricca di lusso. In tal modo,
nessuna di loro possiederà quello che avrà ricevuto. E consegneranno alla madre la somma stabilita, traendola dal ricavato dei beni venduti da ognuna». Così l’intelligenza di un solo uomo scoprì quanto era sfuggito a una moltitudine priva di discernimento. Il gioco e la serietà Fedro 3,14 Dopo avere notato Esopo intento a giocare alle noci in mezzo alla moltitudine dei ragazzi, un Ateniese si fermò e lo schernì, come se fosse un demente. Appena se ne rese conto, il vecchio, più adatto a deridere che a essere deriso, pose un arco allentato in mezzo alla via. «Ehi, tu, sapientone, – disse – spiegami per quale motivo l’ho fatto.» Accorre la folla. L’uomo si contorce a lungo, senza riuscire a comprendere il perché della questione. Alla fine, si arrende. Allora il saggio, vittorioso, dice: «Rapidamente spezzerai l’arco, se lo terrai sempre in tensione. Ma se lo terrai allentato, ti sarà utile, quando lo vorrai. Così, talvolta, si deve concedere svago alla mente, perché torni a te più brillante nel momento in cui occorre riflettere». RIFERIMENTI: cfr. l’aneddoto riportato Erodoto 2,73; per il proverbio, v. sotto.
da
Esopo e i Corinzi Diogene Laerzio 2,5,42 Una volta Esopo esortò i Corinzi a non valutare la virtù secondo la saggezza del giudizio popolare.
NOTA: della favola, abbiamo solo l’inizio.
raccontata
da
Socrate,
Esopo a un pettegolo Fedro 3,19 Fu ordinato a Esopo, che da solo costituiva la servitù del suo padrone, di preparare la cena in anticipo. Passò in rassegna alcune case cercando fuoco, e alla fine trovò un luogo dove accendere la sua lampada. Quindi, fece più in fretta quel percorso che aveva allungato mentre andava in giro; e così ritornò direttamente attraverso la piazza. Allora un pettegolo, tra la folla, disse: «Esopo, che cosa fai con una lampada, in pieno giorno?». Rispose Esopo: «Cerco un uomo»; e si affrettò a tornare a casa. Se quel seccatore ha ragionato su questo fatto, ha capito certamente di non essere apparso come un uomo al vecchio, lui che aveva scherzato in modo inopportuno con Esopo indaffarato. RIFERIMENTI: Diogene Laerzio 6,41; Plutarco, Detti di re e generali 189c. In questi casi, l’attribuzione è a Diogene il Cinico. Esopo e l’insolente Fedro 3,5 Il successo conduce molti alla rovina. Un uomo insolente aveva lanciato contro Esopo una pietra. «Ma bravo!» disse. Poi gli diede una moneta e aggiunse: «Per Ercole, di più non ho, ma ti farò vedere come tu possa guadagnare. Ecco qua in
arrivo un uomo ricco e potente: lancia allo stesso modo una pietra a lui e riceverai una ricompensa adeguata». L’altro si convinse e fece quello che gli fu consigliato. Tuttavia, la speranza ingannò la sua insolente sfacciataggine; infatti, fu arrestato e scontò la pena sulla croce. Piacere e dolore Platone, Fedone 60b «E a me pare – disse [Socrate] – che se Esopo avesse riflettuto su questi concetti [piacere e dolore], avrebbe composto una favola, narrando che la divinità, con l’obiettivo di riconciliare questi due principi in guerra tra loro, dal momento che non riusciva nel suo scopo, legò insieme le loro teste, e così a chi si presenta uno dei due, immediatamente dopo arriva di seguito anche l’altro. Come appunto sembra accaduto anche a me: dopo il dolore sopportato nella gamba a causa della catena, mi pare giunto di seguito il piacere.» Esopo a Delfi Aristofane, Vespe 1446 ss. FILOCLEONE Una volta gli abitanti di Delfi Esopo... BDELICLEONE Me ne importa ben poco! FILOCLEONE …accusavano d’aver sottratto un calice del dio. E lui narrò come una volta lo scarabeo... RIFERIMENTI:
Romanzo
di
Esopo
127-129;
Pseudo-Luciano, L’asino 41. Cfr. anche Apuleio, Metamorfosi 9,9-10. PROVERBI Cito rumpes arcum, semper si tensum habueris Rapidamente spezzerai l’arco, se lo terrai sempre in tensione La sentenza è attribuita a Esopo da Fedro, nella narrazione in cui il padre della favolistica spiega il valore dello svago in rapporto alla serietà richiesta dagli impegni quotidiani (3,14). Il detto trova significativi paralleli in generi letterari differenti (cfr., ad esempio, Orazio, Satire 2,7,19 s.; Odi 2,10,18 ss.; Ovidio, Heroides 4,91), e l’immagine dell’arco che, teso oltre misura, è destinato a spezzarsi ha lunga fortuna anche in ambito medievale e nelle lingue moderne (cfr. Tosi 1991, 774 s.).
Etiope Nell’antichità gli Etiopi sono considerati una popolazione leggendaria, lontana, che vive in una terra dai confini imprecisati, nelle zone più meridionali del mondo, dove Helios, il dio del sole, ha dimora presso l’Oceano; perciò questa è la regione più assolata della terra. Così si spiega il colore della pelle, che crea tanto stupore in Grecia e a Roma. Già l’etimologia del nome indica una persona dal volto «bruciato». Più realisticamente, in senso stretto, si parla dell’Etiopia come della regione a sud dell’Egitto. Nel mito troviamo Memnone, figlio di Eos e di Titone, re degli Etiopi, che è al fianco di Priamo nell’ambito della guerra di Troia. Agli Etiopi, spesso studiati con curiosità, sono associate singolari leggende: Erodoto si sofferma sulla «cosiddetta tavola del sole» (3,23), riferendo che secondo gli indigeni c’è un campo che produce spontaneamente carni cotte di ogni specie. Anche presso i Romani si raccontano fatti straordinari riguardo a queste terre: Plinio nella Naturalis historia (8,72) spiega che in Etiopia nascono cavalli alati e armati di corna, insieme a molti altri animali mostruosi. Con «Etiope», dunque, si tende spesso a indicare non tanto una persona che fa parte di un’etnia ben determinata, quanto invece, più semplicemente, un uomo dalla pelle scura (esiste anche una variante minoritaria che presenta un Indiano come protagonista delle favole). Proprio questo è l’uso che ne fa Esopo (11 Ch.): un padrone compra uno schiavo etiope e vuole «normalizzarlo»: cerca di sbiancarlo ma finisce per farlo ammalare. La morale è tipicamente esopica: nessuno può cambiare la natura di un uomo. Nella narrazione, dalle sfumature decisamente razziste, sembra implicata una valutazione etica, oltre che estetica, che si gioca sull’opposizione tra bianco e nero, peraltro presente anche in altri autori (cfr., ad esempio, Giovenale 2,23). Va anche sottolineato che il tentativo di sbiancamento come
esempio di impresa impossibile e sciocca strettamente la favola e il proverbio (v. sotto).
unisce
L’Etiope Esopo 11 Ch. Un tale comprò un Etiope e credette che il colore della pelle fosse dovuto alla negligenza del precedente padrone. Così, portandolo a casa, provò su di lui ogni genere di sapone, e cercava di sbiancarlo con ogni tipo di lavaggio. Non riusciva tuttavia a cambiare il suo colore, anzi, a causa di quegli sforzi, lo fece ammalare. La favola dimostra che le caratteristiche naturali persistono come appaiono in principio. RIFERIMENTI: Aftonio 6; Sintipa 41; Temistio, Orazioni 32,359bc (altri passi nella spiegazione del proverbio). PROVERBI Aἰθίoπα σµήχεις Lavi un Etiope Il proverbio è molto diffuso nelle raccolte dei paremiografi (tra gli altri, Diogeniano 1,45; Macario 1,62) e trova ampio spazio anche nella tradizione cristiana (cfr. soprattutto Girolamo, Adversus Pelagianos 2,26; Epistula adversus Rufinum 23; Epistulae 97,2). Si tratta di un esempio di azione illogica e insensata, visto che, come appare in modo evidente anche nella favola, l’atto di «lavare» si gioca sull’idea dello «sbiancare» (v. l’approfondimento e i numerosi passi segnalati da Adrados 2003, 341 s. e da Tosi 1991, 205 s., che segnala anche espressioni affini nelle lingue moderne).
F
Fabbro L’arte del fabbro è, insieme con quella del vasaio, una delle più antiche, e affonda le sue origini nel mito: il dio del fuoco Efesto (Vulcano nel mondo romano) è descritto come una sorta di fabbro degli dei; tuttavia, è rappresentato come storpio e brutto d’aspetto. Nel mondo greco-romano il fabbro sconta, del resto, il pregiudizio relativo ai lavori artigianali, che infiacchiscono il corpo e sono meno nobili dell’agricoltura (v. ARTIGIANO): già Esiodo non nasconde una scarsa considerazione dei fabbri e invita i contadini a evitare la loro bottega in inverno per svolgere invece attività più proficue (cfr. Le opere e i giorni 493 ss.). Questo mestiere è tuttavia fondamentale nell’economia antica, non solo greco-romana; lo stesso Platone pone l’arte del fabbro tra quelle necessarie (cfr. Epinomide 974e-975c: l’attribuzione dell’opera è contestata). Esopo ci descrive un fabbro al lavoro, alle prese con incudine e martello, affiancato da un cagnolino (345 Ch.). L’artigiano, coerente con le numerose figure di subalterni presenti nella favolistica, appare operoso, a differenza dell’animale, che anche la morale indica come una sorta di parassita, felice di vivere alle spalle del padrone. In un’altra narrazione i fabbri deridono un topo che porta via il cadavere di un compagno morto di fame (Tetrastici 1,8). Gli stessi attrezzi del fabbro possono diventare personaggi che parlano (la lima: cfr. Esopo 77; 116 Ch.). Il fabbro e il cagnolino Esopo 345 Ch. Un fabbro aveva un cagnolino, che dormiva quando l’uomo lavorava, ma, quando egli mangiava, si poneva al suo fianco. Il fabbro allora gli gettò un
osso e gli disse: «Disgraziato dormiglione, quando batto l’incudine, sonnecchi, ma quando muovo i denti, subito ti svegli!». La favola rimprovera i dormiglioni, gli inoperosi e quelli che vivono grazie al lavoro degli altri. RIFERIMENTI: Parafrasi 346; Dodecasillabi 346; Sintipa 16.
Farfalla La simbologia della farfalla nel mondo antico è legata a quella dell’anima, che esce in volo dal corpo dopo la morte (ψυχή in greco è termine che significa sia anima sia farfalla). Pur senza riferimento all’insetto, l’anima in Platone è descritta come dotata di ali (cfr. Fedro 251b-252b): «probabilmente nel filosofo greco riecheggiava una tradizione che doveva essere antichissima se già nelle tombe regali di Micene si sono trovati grandi dischi d’oro dove sono incise farfalle, a simboleggiare l’immortalità dell’anima del defunto» (Cattabiani 2000, 64). Successivamente, la vicenda di Amore e Psiche (celebre la narrazione nelle Metamorfosi di Apuleio: 4,28-6,24) presenta, nella tradizione iconografica, la giovane Psiche, simbolo dell’anima, rappresentata con ali di farfalla. Quanto al simbolismo del bruco e della crisalide, ha lunga fortuna e arriva persino a rappresentare il Cristo nella tarda antichità. Sul piano scientifico, il fenomeno colpisce gli antichi ed è già descritto con attenzione da Aristotele (Historia animalium 551a). L’unica favola in cui troviamo la farfalla è attestata in Fedro (App. 29 [31]) ed è basata sul tema della trasformazione dell’insetto, non a caso accostato alla vespa, altro essere che si crede nascere dalla carcassa di un animale morto (cfr. VESPA). «Sia che Fedro alluda alla metempsicosi, sia alla teoria sulla nascita degli insetti dalla decomposizione dei cadaveri […] si tratta sempre di metamorfosi naturale» (Solimano 336). La farfalla appare qui come una sorta di nobile decaduta, che rimpiange il suo illustre passato. Morale (pragmaticamente esopica): bisogna badare al presente, non al passato. La farfalla e la vespa Fedro, App. 29 [31]
Non si deve badare alla sorte passata ma a quella presente Passando in volo, una farfalla aveva visto una vespa. «O sorte iniqua! Finché vivevano i corpi dai cui resti abbiamo ricevuto la vita, io fui eloquente nella pace, forte in guerra, in ogni arte prima tra i miei simili. Ecco tutto ciò che sono! Languida leggerezza e cenere che vola! Tu che fosti un mulo da soma, ora offendi chi vuoi, trafiggendolo con il tuo pungiglione.» E la vespa parlò così, secondo il suo stile: «Guarda non chi siamo stati, ma chi siamo ora».
Fico Il fico presenta una simbologia complessa: genera inquietudine ed è per lo più legato ai temi della sessualità e della fecondità (peraltro, come accade ancora oggi, è elemento del simbolismo genitale). In Grecia, la pianta, il cui frutto è molto apprezzato come alimento, è associata al dio Dioniso (il fallo rituale usato nella processione delle Falloforie è fatto in legno di fico ed esprime l’energia vitale della natura) e a Priapo, dio della fecondità, figlio di Dioniso e di Afrodite. A Roma è anche associato a Marte. Qui la pianta è considerata sacra e importante nel mito delle origini: secondo la leggenda, Romolo e Remo vengono allattati dalla lupa sotto un fico selvatico (caprifico, chiamato anche ficus ruminalis da ruma, «mammella»). Si ricorda anche un rituale tutto femminile, dedicato a Giunone Caprotina, celebrato il 9 luglio sotto un fico selvatico. Pianta cosmica, in alcune culture è legata al tema della conoscenza: potrebbe essere l’albero dell’Eden, visto che Adamo ed Eva intrecciano foglie di fico e se ne fanno cinture (Genesi 3,7). A differenza di altre piante, come ad esempio la quercia, posta in relazione con Zeus, il fico compare nella tradizione favolistica svuotato dei suoi complessi significati simbolici e religiosi. Si tratta semplicemente di una pianta che produce frutti apprezzabili. In una favola di lunga fortuna, che ha una morale antimonarchica e trova origine addirittura nella Bibbia (Giudici 9,8-15), il fico rifiuta di diventare re delle piante proprio per non lasciare i suoi frutti dolci e buoni (v. OLIVO; ROVO). In questa narrazione, che presenta lo schema tipicamente orientale del dibattito tra gli alberi, la pianta costituisce la seconda scelta, dopo l’olivo, come candidato ideale per regnare sugli alberi (v. OLIVO): qui sembra quasi suggerita una graduatoria coerente con la percezione degli antichi, visto che il fico è certamente meno pregiato dell’olivo. In un’altra favola, che non si ritrova nelle
collezioni esopiche, il fico è invece contrapposto proprio all’olivo, che vanta una maggiore nobiltà. L’umiltà della sua condizione mette al riparo il fico dalla disgrazia che invece colpisce il superbo olivo (la vanagloria come fonte di guai caratterizza molte altre favole esopiche: cfr., ad esempio, Esopo 237 Ch.). Il fico e l’olivo Sintipa 31 Un fico, dopo avere perso le foglie nella stagione invernale, era deriso per la sua nudità da un vicino olivo, che affermava: «Io, sia in inverno sia in estate, mi ritrovo meravigliosamente ornato di foglie e sono sempre verde; tu, invece, hai una bellezza limitata alla sola estate». Mentre l’olivo si vantava, all’improvviso un fulmine, per volere divino, scese dal cielo e lo incendiò. Il fico restò completamente indenne. Coloro che si vantano per la ricchezza e per la sorte possono incappare in una grande sventura. RIFERIMENTI: Aftonio 22.
Fiume Nella Teogonia Esiodo inserisce i fiumi, distinguendoli dal mare, tra le più antiche divinità (v. 109): figli di Oceano e di Teti (vv. 337 ss.), nutrono gli uomini e sono complessivamente tremila. Nell’iconografia i corsi d’acqua più importanti sono spesso rappresentati come vegliardi con barbe e capelli lunghi. L’opposizione fiumi-mare si rileva in diversi ambiti: nella pesca il primato appartiene al mare (v. PESCATORE). Questa netta distinzione si avverte anche nella favolistica esopica, dove il fiume, che ha perso ogni attributo divino, è per lo più un elemento secondario della narrazione e appare di dignità inferiore al mare. Se in una favola l’anonimo pesce d’acqua dolce è descritto di qualità minore rispetto al pesce di mare (Aviano 38), in un’altra narrazione i fiumi si lamentano con il mare, quando invece – osserva la morale – ne ricevono beneficio (Sintipa 4). Il fiume può rappresentare un ostacolo arduo da superare, soprattutto quando è in piena (Esopo 98 Ch.) ed è anche temuto per la sua corrente, in grado piegare una superba pelle di bue che afferma di chiamarsi Dura (Esopo 320 Ch.). Il motivo dell’inganno indotto dal riflesso dell’acqua (in Esopo 185 Ch. troviamo una cagna che si specchia in un fiume) è tema tipico anche di altri contesti narrativi (si pensi al mito di Narciso, dove, d’altra parte, si fa spesso riferimento a una fonte o a uno stagno). Il fiume e la pelle Esopo 320 Ch. Un fiume vide una pelle di bue trasportata dalla sua corrente e le chiese: «Qual è il tuo nome?». Essa rispose: «Mi chiamo Dura». Allora il fiume,
travolgendola, disse: «Prova un po’ a cambiare nome; infatti, ormai ti sto per rendere morbida io». Spesso le sventure che accadono nella vita piegano a terra un uomo audace e superbo. RIFERIMENTI: Parafrasi 321; Aviano 41
Formica Nel mito, i Mirmidoni, popolo su cui regna Achille, devono il loro nome al sovrano Mirmidone (dal termine greco µύρµηξ che significa appunto «formica»), figlio di Zeus e di Eurimedusa, che il re degli dei sedusse sotto le sembianze di una formica. Si racconta, inoltre, che i Mirmidoni discendevano dalle formiche, mutate in uomini da Zeus per preghiera di Eaco, con lo scopo di dare nuovi abitanti all’isola di Egina a seguito di una pestilenza. La formica, sacra alla dea Cerere, è simbolo di operosità, costanza, accortezza e concordia in diverse culture (anche nell’Antico Testamento è indicata come esempio di saggezza: Proverbi 6,6); viene apprezzata sia dagli autori pagani (Eliano la elogia per la grande disciplina familiare e anche per la capacità di calcolare il tempo: De natura animalium 1,22; 4,3) sia dagli autori cristiani, che nel lavoro estivo, finalizzato ad accumulare il cibo per l’inverno, vedono, tra l’altro, una diligente preparazione della vita celeste (cfr. Basilio, Omelia sull’Esamerone 9,3). Insieme a questa percezione, generalmente positiva, ne esiste una di segno differente, dovuta alla minaccia che questi animali portano agli agricoltori (cfr. Columella 2,19). La favola di Esopo 240 Ch., di tipo eziologico, spiega che in origine la formica era un agricoltore, punito da Zeus per la sua avidità e per la tendenza ad appropriarsi del lavoro dei vicini: così si spiega perché ancora oggi essa raccolga il frutto delle altrui fatiche. In un frammento dell’autore comico Titinio (34 R. ) troviamo una similitudine che sembra rimandare proprio a questa narrazione: «Il contadino è certo assai simile alla formica». Il parallelo si fonda sul meccanismo inverso rispetto alla favola, che rappresenta una realtà altra per spiegare quella umana, mentre in questo caso la similitudine esplicita immediatamente le relazioni tra mondo umano e mondo animale, senza offrire una narrazione, ma costruendo il 2
personaggio che ne è presupposto. Se in questo nucleo narrativo la formica si segnala per la sua malvagità e in altre favole emergono comportamenti molesti per l’uomo (in Esopo 48 Ch. si ha il tema della critica ai disegni divini: cfr. Eschilo, Sette contro Tebe 597 ss.), più spesso prevale invece un profilo positivo. In particolare, si segnala l’elogio della laboriosità (motivo topico: v. proverbio sotto; ma anche Otto 141) e della generosità. Così, ad esempio, nella celebre narrazione della cicala e della formica (Esopo 336 Ch.: v. CICALA); inoltre, Fedro (4,24 [25]) mette a confronto la mosca e la formica: se (solo in apparenza) la prima sembra vivere una vita più spensierata e felice, in realtà la seconda, con il suo duro lavoro, si costruisce un’esistenza più sicura. Lo stesso schema narrativo di queste due favole, fondato sul contrasto tra apparenza e realtà, tra capacità di previsione del futuro e cieco appiattimento sul presente, si ritrova anche nella favola della formica e dello scarabeo (Esopo 241 Ch.). Un’altra importante dote riconosciuta alla formica è la riconoscenza. Ne dà prova quando morde un uomo, liberando così una colomba che le aveva salvato la vita (Esopo 242 Ch.). La rappresentazione della formica è decisamente oscillante tra valori positivi e valori negativi: in una delle cosiddette favole siriache, di impronta chiaramente cristiana, troviamo una formica invidiosa di una pernice: espone le proprie lamentele a Dio per essere così piccola, ma poi se la prende con se stessa quando vede un cacciatore che cattura l’uccello (cfr. Adrados 2003, 508 s.). La formica Esopo 240 Ch. Quella che ora è la formica, un tempo era un uomo: dedicandosi all’agricoltura, non si accontentava del frutto del proprio lavoro, ma guardava con invidia a quello degli altri e continuava a rubare quanto era coltivato dai vicini. Zeus,
indignato per la sua avidità, lo trasformò nell’animale che viene chiamato formica. Nonostante avesse cambiato aspetto, egli non mutò la sua indole; infatti, fino a oggi, girando per i campi, la formica raccoglie il frumento e l’orzo degli altri, accumulandolo per sé. La favola dimostra che coloro che sono malvagi per natura, anche se subiscono la più grande delle punizioni, non mutano il loro carattere. La formica e la mosca Fedro 4,24 [25] [La favoletta invita a non fare nulla che non sia utile.] Era in corso un’aspra contesa tra la formica e la mosca su chi valesse di più. Cominciò così per prima la mosca: «Puoi tu mettere a confronto i miei meriti con i tuoi? Mi fermo tra gli altari, vado in giro per tutti i templi dove si svolgono sacrifici, per prima assaggio le viscere offerte agli dei. Sto seduta sulla testa del re quando voglio e colgo i casti baci delle matrone. Non m’affatico per nulla e godo di grandissimi privilegi. Che cosa di simile a ciò tocca in sorte a te, zoticona?». «È certamente motivo di gloria partecipare al banchetto degli dei, ma per quelli che sono invitati, non per quelli che sono invisi. Frequenti gli altari, certo, ma, appena giungi, vieni cacciata. Ricordi i re e i baci delle matrone, ostenti persino quello che il pudore dovrebbe coprire. Non ti affatichi per nulla: per questo motivo, quando hai necessità, non hai nulla. Io, quando, con grande premura, accumulo il grano in inverno, vedo te mentre ti pasci di escrementi lungo i muri. Mi provochi durante l’estate; quando è inverno, stai zitta. Il freddo ti costringe a morire rattrappita; me,
invece, incolume accoglie una ricca dimora. Ho certamente rintuzzato la tua tracotanza». Questa favoletta distingue le caratteristiche degli uomini: quelli che si ornano di lodi infondate e quelli il cui valore mostra un solido motivo di gloria. RIFERIMENTI: Romulus 46. Cfr. inoltre Luciano, Elogio della mosca 8. L’uomo morsicato da una formica e Hermes Esopo 48 Ch. Una volta, un uomo, dopo aver visto una nave che affondava con il suo equipaggio, andava affermando che gli dei sono iniqui nel giudicare; per l’empietà di una sola persona, infatti, erano andati in rovina anche degli innocenti. Mentre parlava in questo modo, poiché nel luogo dove si trovava c’erano molte formiche, accadde che venne morso da una di esse. Allora egli, per quanto fosse stata solo una delle formiche ad arrecargli danno, le calpestò tutte. A quel punto, gli apparve Hermes, che, colpendolo con il caduceo, gli disse: «Quindi, tu non tolleri che gli dei siano giudici degli uomini come tu sei giudice delle formiche?». Nessuno oltraggi la divinità quando capita una sventura, ma piuttosto esamini le proprie colpe. RIFERIMENTI: Babrio 117; Tavolette Assend. 6; Parafrasi 48. PROVERBI Parvola … magni formica laboris La minuscola formica dotata di grande laboriosità
La caratteristica, proverbiale, della laboriosità della formica, così espressa da Orazio (Satire 1,1,33), è un dato comunemente condiviso (cfr. ad esempio, oltre ai passi citati sopra, anche Virgilio, Georgiche 185 s.; Giovenale 6,359 ss.; Teocrito 17,106 s.) ed è naturalmente alla base di una delle più note favole esopiche: quella della cicala e della formica (Esopo 336 Ch.). In questo caso, la favola si gioca su due modelli etici antitetici, di grande impatto simbolico.
Fortuna Figlia di Oceano e di Teti, Tyche è venerata come dea del caso e presiede alla prosperità degli Stati: a lei sono dedicati templi e statue. Il suo rilievo cresce in età ellenistica. Nell’antica Roma è chiamata Fortuna e viene festeggiata il 24 giugno. La cornucopia, la spiga, il timone, la corona turrita sono i suoi attributi. Nella tradizione esopica, la Fortuna compare come personaggio in tre narrazioni. Se Fedro (App. 2 [3]) rileva come abbia generosamente attribuito agli animali specifiche doti, Esopo la presenta mentre salva un uomo che rischia di cadere in un pozzo (Esopo 261 Ch.): la morale ricorda come molti uomini, caduti in disgrazia, incolpino gli dei. In un’altra narrazione (Esopo 84 Ch.), viene ripreso il tema dell’irriconoscenza dell’uomo: un contadino trova un tesoro e ringrazia la Terra, ma è la Fortuna ad averlo favorito. Nel caso in cui perdesse l’oro, l’uomo sarebbe pronto a incolparla. Al di là dei casi in cui viene personificata, la sorte ha un ruolo spesso decisivo nella tradizione favolistica. Fedro ne sottolinea la volubilità (App. 5 [7]). A volte, essa determina un esito altrimenti impossibile, come nella favola in cui i pescatori non riescono a catturare nulla, finché un tonno finisce da sé sulla barca: il caso a volte dà quello che l’arte non riesce a garantire (Esopo 22 Ch.). La mutabilità della sorte è ben rappresentata dal mare: nella vana fatica dei pescatori (Esopo 23 Ch.) così come nella rischiosa esistenza dei naviganti (Esopo 307 Ch.). Una sorte fatale, secondo una prospettiva forse già stoica, è quella del figlio della scimmia che viene amato e strangolato dagli abbracci, mentre l’altro, abbandonato, ha salva la vita (Esopo 306 Ch.). Analizzando la parte più antica della tradizione esopica (Augustana), Nøjgaard (1964, 540) descrive la Fortuna come una sorta di «dea immanente», ossia «l’espressione astratta dell’inesistenza di forze trascendentali […]», secondo un
carattere profondamente collezione.
antireligioso,
proprio
della
L’autore Fedro, App. 2 [3] Non si deve chiedere più del giusto Se la natura avesse creato la stirpe dei mortali a mio arbitrio, saremmo di gran lunga più dotati; infatti, avrebbe attribuito a noi tutti i vantaggi che la Fortuna ha generosamente concesso ai singoli animali: la forza dell’elefante e l’impeto del leone, la longevità della cornacchia, la fierezza del truce toro, la placida mitezza del rapido cavallo, restando all’uomo comunque la sua tipica ingegnosità. Certamente Giove, in cielo, ride tra sé, lui che negò, con grande saggezza, queste qualità agli uomini, affinché la nostra audacia non gli levasse lo scettro del mondo. Pertanto, appagati dal dono dell’invitto Giove, trascorriamo gli anni che il destino ci ha assegnato e non tentiamo più di quanto la nostra natura mortale ci permetta. RIFERIMENTI: cfr. Esopo 57 Ch.; Parafrasi 57; Platone, Protagora 320c-322d; Seneca, De beneficiis 4,18; Plutarco, La fortuna 98d; Imerio, Orazioni 68,10-11. Il viandante e la Fortuna Esopo 261 Ch. Un viandante, dopo aver percorso un lungo tratto di strada, sfinito per la fatica, si sdraiò accanto a un pozzo e si mise a dormire. Mentre stava quasi per
cadere dentro, gli apparve la Fortuna, lo svegliò e gli disse: «Mio caro, se fossi precipitato veramente, non avresti dato la colpa alla tua imprudenza, ma a me». Così molti uomini, caduti in disgrazia per causa loro, incolpano gli dei. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 262.
Babrio
49;
Parafrasi
262;
Frassino Il frassino è albero di Poseidone, dio dei sismi, che scuote la terra. Nella prospettiva degli antichi, attira «il fuoco celeste e le piogge fecondatrici» (Brosse 95). Ritenuto pianta mediatrice tra cielo e terra, è inoltre considerato albero cosmico presso le popolazioni germaniche. Il frassino compare in una sola favola (Romulus 64), derivata probabilmente da una narrazione di Fedro andata persa. Gli alberi danno all’uomo il legno che serve a costruire la scure destinata ad abbatterli (v. QUERCIA). Qui il frassino è un personaggio secondario, privo di particolari caratterizzazioni.
Fuco Il fuco, maschio dell’ape, non gode di molta considerazione presso gli antichi. Aristotele è perplesso rispetto al comportamento e al genere di questo insetto (La generazione degli animali 759b): ne rivela l’inoperosità e la lentezza. Si tratta, non a caso, delle caratteristiche che segnalano i fuchi anche nell’unica favola in cui compaiono (Fedro 3,13): inetti, soccombono di fronte al giudizio della vespa. Fedro sembra usare i fuchi per rappresentare i plagiari (v. VESPA), in un accorato sforzo di difesa della sua opera. Qui si sviluppa il motivo relativo all’opposizione fuchi-api, presente in diversi autori: così, ad esempio, in Esiodo (Teogonia 594 ss.; Le opere e i giorni 303 ss.), che sottolinea la nota pigrizia dei fuchi.
G
Gabbiano Gli antichi non sembrano considerare i gabbiani in modo positivo: ad esempio, secondo Artemidoro essi conducono i naviganti in pericolo (Sull’interpretazione dei sogni 2,17). Il loro simbolismo è connesso con l’acqua. Proprio questa caratteristica li fa diventare personaggi da guardare con sospetto nella tradizione favolistica, che generalmente giudica in modo negativo chi vuole vivere una condizione ambigua (ad esempio, il granchio della favola 150 Ch.). Così, il gabbiano che ingoia un pesce finisce per morire giustamente, perché, pur essendo un animale d’aria, ha cercato da vivere sul mare (Esopo 193 Ch). Il fatto che mangi i pesci colpisce gli antichi: Eliano sottolinea che i gabbiani divorano il pesce pilota (De natura animalium 15,23). Lo stesso Eliano (3,20) ricorda una caratteristica dei gabbiani che trova paralleli in altri uccelli della tradizione esopica: portano in alto le conchiglie e le rompono sugli scogli (stessa immagine dell’aquila che vuole espugnare il guscio della tartaruga: cfr. Fedro 2,6). La favola più curiosa, d’altra parte, è quella in cui il gabbiano si dà al commercio, in società con il rovo e con il pipistrello, ma la navigazione finisce in un naufragio (Esopo 250 Ch.). Questo spiega perché il gabbiano vive sempre sulle coste: vuole vedere se il mare restituisce il rame che l’uccello intendeva vendere. Il gabbiano e il nibbio Esopo 193 Ch. Dopo aver ingoiato un pesce, un gabbiano giaceva morto sulla riva del mare, con la gola squarciata. Un nibbio lo vide ed esclamò: «Hai avuto la giusta punizione, perché sei nato uccello e conducevi la tua vita sul mare». Così coloro che dimenticano i loro
abituali costumi e ne assumono altri, per loro del tutto sconvenienti, sono giustamente vittime di disgrazie. RIFERIMENTI: Tetrastici 1,6.
Gallina Simbolo della fecondità, la gallina, secondo Plinio (Naturalis historia 10,146), arriva a deporre sessanta uova al giorno. La chioccia è inoltre madre premurosa per antonomasia e viene, in questo senso, impiegata in chiave simbolica (così anche nei Vangeli e nella successiva tradizione cristiana: cfr. Matteo 23,37). Le galline, molto apprezzate in ambito gastronomico (oltre al ricettario di Apicio, cfr. Orazio, Satire 2,4,17 ss.), sono impiegate anche nella divinazione: il modo in cui si accostano al mangime è oggetto di interpretazione (cfr. Livio 10,40). Quando si agitano e strillano, le galline, come i galli, indicano l’arrivo del temporale (Eliano, De natura animalium 7,7). In linea con il valore simbolico dell’animale, alcune narrazioni esopiche sono costruite sul tema della fecondità, declinata in una chiave utilitaristica: questo aspetto si rivela funzionale a condannare l’avidità dell’uomo. Così nella favola della donna che ingrassa eccessivamente il volatile sperando che produca più uova (Esopo 90 Ch.), e anche nella celeberrima favola della gallina dalle uova d’oro (Esopo 287 Ch.), che viene sventrata dall’avido proprietario (v. anche OCA per la variante, meno nota, della vicenda). In un’originale narrazione di Fedro, che manifesta così la sua misoginia, la gallina diventa anche simbolo della libido delle donne (Fedro, App. 9 [11]). Nella spietata dinamica di prevaricazione tipica della società esopica, la gallina appare ora prudente ora ingenua; tuttavia, a parte rari casi, come la favola 286 Ch., dove la troviamo impegnata stoltamente a covare le uova di serpente, non sembra raffigurata con gli attributi fortemente negativi che ha assunto in seguito. In genere, è insidiata dai felini (Pseudo-Dositeo 5, Esopo 14 Ch.) o dal lupo (Tetrastici 2,28). Poiché si trova in casa ed è soggetta all’uomo, si colloca agli antipodi dell’aquila, re degli uccelli, che, come accade nella favola 6 Ch., soffre
quando le sono tagliate le ali e si ritrova a vivere, come un sovrano in catene, tra le galline. La donna e la gallina Esopo 90 Ch. Una vedova aveva una gallina che le produceva un uovo al giorno. Le venne in mente che, se le avesse dato una più consistente dose di grano, essa avrebbe prodotto almeno due uova al giorno. Allora così fece. La gallina tuttavia divenne tanto grassa che non poté più nemmeno produrre un solo uovo al giorno. La favola dimostra che coloro che, a causa dell’avidità, desiderano avere di più si lasciano sfuggire anche le cose che possiedono. RIFERIMENTI: Sintipa 42. La gallina dalle uova d’oro Esopo 287 Ch. Un uomo aveva una bella gallina che faceva delle uova d’oro. Poiché era convinto che dentro di essa ci fosse una grande quantità di oro, la sventrò, ma scoprì che era simile a tutte le altre galline. Pertanto, spinto dalla speranza di trovare un grande tesoro, fu privato anche della sua piccola rendita. Bisogna accontentarsi di quello che si possiede ed evitare un’eccessiva avidità. RIFERIMENTI: Babrio 123; Tavolette Assend. 13; Parafrasi 288; Aviano 33; Codice Brancacciano 9; Sintipa 27; Dodecasillabi 288; Tetrastici 1,37 (si trova anche l’oca al posto della gallina: v. OCA).
Giunone, Venere e la gallina Fedro, App. 9 [11] Sul desiderio delle donne Poiché Giunone lodava la propria continenza, Venere non rinunciò all’occasione di scherzare e, per rendere chiaro che nessuna era come lei, si dice che abbia interrogato così una gallina: «Per favore, dimmi quanto cibo ti occorre perché tu possa essere saziata». Quella rispose: «Qualunque razione mi darai, mi basterà, purché le mie zampe possano raspare». «Ma affinché tu non raspi – disse la dea – ti è sufficiente un moggio di frumento?» «Sicuro, anzi è persino eccessivo, ma consentimi di raspare.» «Insomma, per non raspare che cosa vuoi?» Allora, alla fine, la gallina confessò il vizio proprio della sua natura: «Per quanto mi si spalanchi un granaio, io, tuttavia, continuerò a raspare». Si racconta che Giunone abbia riso per lo scherzo di Venere, poiché, attraverso la gallina, parlava delle donne. RIFERIMENTI: Romulus 58. La gatta Pseudo-Dositeo 5 Una gatta finse di fare festa per il suo compleanno: dopo avere invitato a cena le galline, imprigionò quelle che erano entrate; chiuse, quindi, la porta e iniziò a divorarle una dopo l’altra. Questa favola è applicabile a chi, partito con una fiduciosa speranza, finisce per subire il contrario di quanto ha auspicato.
RIFERIMENTI: Romulus 85. Il lupo e la gallina Tetrastici 2,28 Un lupo, impegnato a studiare i versi di Licofrone, si avvicina a una gallina per esporglieli. D’altra parte, quando il pennuto vede lo studioso con la bocca spalancata, agitando le ali, in fretta si mette in fuga. NOTA: Licofrone di Calcide è un poeta di età ellenistica, che si segnala per il linguaggio oscuro ed enigmatico.
Gallo Sacro ad Apollo, a Leto (Latona) e anche al dio della medicina Asclepio, il gallo è il più importante degli uccelli di terra e, presso vari popoli, viene associato al sole (è infatti annunciatore del giorno), ma anche alla luna. Secondo il mito, in origine era un compagno del dio Ares, che, per punizione, lo trasformò nell’animale perché si era addormentato invece di vigilare mentre egli trascorreva una clandestina notte d’amore con Afrodite, moglie di Efesto: da quel giorno il gallo annuncia il sole. Così diventa naturalmente emblema di vigilanza (valore simbolico che lo rende caro anche ad Atena, insieme alla civetta), ma anche di coraggio per la sua combattività: in Grecia, come presso Assiri, Indiani e altri popoli, viene consacrato al dio della guerra (Ares); Temistocle, prima di combattere contro i Persiani, incita i soldati e indica l’esempio dei galli: «in ricordo di quell’avvenimento s’istituì ad Atene una festa annuale dove li si faceva combattere tra loro» (Cattabiani 2000, 215). Plinio (Naturalis historia 10,46-47) li definisce «sentinelle della notte», create dalla natura per richiamare l’uomo al lavoro, mettendo fine al sonno; osserva inoltre che si contendono il potere con una lotta serrata tra di loro: chi vince canta e si proclama sovrano, chi perde si nasconde silenzioso, subendo le conseguenze della sconfitta; infine nota che il leone, l’animale dotato di maggiore coraggio, ne è terrorizzato. Che il leone sia terrorizzato dal gallo è sostenuto anche da altre fonti (cfr., ad esempio, Lucrezio 4,710 ss.; Eliano, De natura animalium 3,31). Negli Uccelli di Aristofane (vv. 488 ss.), Peisetero parla del canto del gallo, in relazione anche a un’origine regale dell’animale. La favolistica riprende alcune radicate credenze, a partire da quella secondo cui il canto del gallo spaventa il leone (cfr. Esopo 269 Ch.). Questa situazione, che per la sua carica paradossale (il piccolo ha la meglio sul grande) funziona
perfettamente nello schema narrativo esopico, viene anche accostata alla paura che un animale enorme come l’elefante ha nei confronti della zanzara (Esopo 210 Ch.). Un’altra immagine che molto colpisce l’immaginario collettivo ed entra a pieno diritto nella tradizione favolistica è la lotta tra i due galli per prevalere nel pollaio (Esopo 20 e 21 Ch.; Romulus 7): se il riferimento è per lo più generico, in Babrio (5) i protagonisti sono due galli di Tanagra, molto noti per la loro gagliardia, come spiega, tra gli altri, anche Plinio, mettendoli sullo stesso piano dei galli di Rodi (Naturalis historia 10,48). Questo motivo favolistico riprende la radicata tradizione testimoniata da Plinio (v. sopra). Il gallo è definito poeticamente ὡρóµαντις, «nunzio delle ore», in una favola di Babrio (124,15). Suoi nemici irriducibili sono la volpe (Esopo 180 Ch.) e il gatto (o la donnola), ostile al gallo come alle galline (Esopo 12 e 14 Ch.; Fedro, App. 16[18]). Talvolta l’animale riesce a non soccombere, come quando trova un valido protettore nel cane. In questa favola (180 Ch.) troviamo un’originale contaminazione di diversi motivi narrativi (Esopo 3, 165, 335 Ch.). Si tratta dello schema tipico dell’animale che si trova su un albero ed è insidiato con l’inganno o con la violenza. L’asino, il gallo e il leone Esopo 269 Ch. Una volta un gallo stava mangiando insieme a un asino, quando un leone balzò addosso a quest’ultimo e il gallo prese a strillare. Il leone allora – si dice infatti che è terrorizzato dal verso del gallo – scappò. L’asino, d’altra parte, ritenendo che la belva fosse fuggita a causa sua, si mise immediatamente a inseguirla. Tuttavia, dopo che l’inseguimento li ebbe condotti fino a un luogo lontano, dove non arrivava lo strillare del gallo, il leone si voltò e divorò l’asino. Morendo, la bestia esclamò: «Ahimè infelice e stolto!
Perché, pur non essendo nato da genitori guerrieri, sono partito per andare in guerra?». La favola dimostra che molti uomini aggrediscono nemici che si fanno passare per deboli ad arte; e così vanno in rovina a causa loro. Il gallo portato in lettiga dai gatti Fedro, App. 16 [18] L’eccesso di sicurezza spesso conduce gli uomini in pericolo Un gallo aveva dei gatti che gli facevano da lettighieri. Una volpe lo vide mentre lo trasportavano, tutto pieno di boria; allora, così gli parlò: «Ti suggerisco di stare attento agli inganni; infatti, se considerassi bene i volti di costoro, riterresti che essi stiano portando una preda e non un carico». Dopo che quella combriccola feroce cominciò ad avere fame, dilaniò il padrone e si spartì il frutto del misfatto. Il cane, il gallo e la volpe Esopo 180 Ch. Un cane e un gallo, diventati amici, si misero in viaggio. Scesa la sera, il gallo salì su una pianta a dormire, mentre il cane si mise ai piedi dell’albero, che aveva una cavità. Come era sua abitudine, il gallo, alla fine della notte, prese a cantare; una volpe lo udì e corse verso di lui: si fermò sotto l’albero e lo invitò a scendere da lei, perché desiderava abbracciare un animale che aveva una voce così bella. Il gallo allora le disse di svegliare prima il
portinaio che riposava ai piedi della pianta, perché sarebbe sceso solo quando quello le avesse aperto. Ma quando la volpe cercò di chiamarlo, il cane subito saltò in piedi e la dilaniò. La favola dimostra che gli uomini saggi sanno condurre con l’inganno i nemici che li aggrediscono contro coloro che sono più forti. I ladri e il gallo Esopo 158 Ch. Dei ladri entrarono in una casa, ma non trovarono nient’altro se non un gallo e, dopo averlo preso, si allontanarono. Sul punto di essere ucciso da loro, il gallo li pregava di lasciarlo andare, affermando di essere utile agli uomini per il fatto che li svegliava di notte per le loro incombenze. I ladri gli risposero: «Abbiamo allora un motivo in più per sacrificarti: infatti se svegli loro, non consenti a noi di rubare». La favola dimostra che i malvagi sono soprattutto contrariati da quelle cose che sono utili alle persone oneste. Il galletto e la perla Fedro 3,12 Un galletto che cercava da mangiare in un letamaio trovò una perla. «Preziosa come sei, – disse – ti ritrovi in un luogo tanto indegno; se ti avesse visto qualcuno avido del tuo valore, saresti già tornata all’antico splendore da un bel pezzo. Ti ho ritrovata io, che preferisco di gran lunga il cibo, e questo non può essere di alcuna utilità né a te, né a me.» Narro questa vicenda per coloro che non mi comprendono.
RIFERIMENTI: Romulus 1 (qui la narrazione è attribuita a Esopo).
Gambero Il gambero per i Greci è simbolo di fertilità: è proibito mangiarlo in occasione delle festività di Aloè dedicate alle donne (Cooper 168). Nell’iconografia cristiana, alla luce della sua corazza, sembra talora raffigurare il Cristo invulnerabile e vittorioso sulle forze maligne (Cattabiani 2002, 348). Condivide alcune caratteristiche con il granchio, compreso il collegamento con il solstizio d’estate e il segno zodiacale del cancro. Poiché dunque la distinzione tra granchio e gambero è molto sottile agli occhi degli antichi e talora la figura dei due si sovrappone (i vocaboli καρκίνoς, in greco, e cancer, in latino, sono riferibili a entrambi), nella favola 150 Ch. troviamo una madre che dice al figlio di non camminare di traverso (senza peraltro dare lei stessa il buon esempio): questi personaggi sono stati interpretati ora come gamberi (Chambry e altri) ora come granchi (Adrados e altri). V. GRANCHIO.
Gatto Il gatto è molto venerato nell’antico Egitto, come attesta anche Erodoto (2,63): la dea della guerra e della fecondità Bastet, identificata con Artemide in Grecia, ha il corpo di una donna e la testa di una gatta. In Grecia e a Roma la sua immagine viene elaborata in modo differente, anche perché la sua domesticazione pare piuttosto tarda. Se si riscontra un apprezzamento per l’agilità e l’accortezza del felino, anche per come è solito nascondere le sue feci (Plinio, Naturalis historia 10,202), in genere l’animale viene tuttavia rappresentato come lussurioso (Eliano, De natura animalium 6,27), astuto e perfido, talora più attento alle pernici che ai topi (cfr. Democaride, Antologia Palatina 7,206); un animale, insomma, di cui diffidare. Questa caratterizzazione negativa è presente nella favolistica oltre i confini del mondo greco-romano (nel Pañcatantra, terzo tantra, quarto racconto, si trova un gatto che uccide con l’inganno un francolino e un leprotto) e i limiti dell’epoca antica, quando il gatto è da tempo pienamente integrato nella vita domestica (La Fontaine 12,2). Come nota Marchesi 1923, 73, il gatto è marginale nella favola latina, anche perché «venuto dall’Africa, esso non era presso i romani né bene né generalmente conosciuto e tanto meno addomesticato: e nelle rare rappresentazioni apparisce nello stato selvatico, in atto di predatore di uccelli». In Fedro la gatta selvatica (2,4), abile a ingannare con scellerata malizia, tesse insidie all’aquila e alla scrofa selvatica, e nell’epimitio viene paragonata a un uomo dalla lingua biforcuta. Anche nella tradizione del Romulus (25) il gatto appare allo stato selvatico, pronto a ingannare, insieme alla civetta, il suo più noto nemico: il topo. Il gallo portato in lettiga dai gatti finisce in realtà per essere vittima del loro inganno, come ammonisce, inascoltata, la volpe (Fedro, App. 16 [18]); attraverso l’inganno, anche le galline
finiscono per essere vittime del felino (Pseudo-Dositeo 5). Al di là dell’incertezza terminologica (gatto e donnola vengono spesso confusi, anche sul piano lessicale, per cui risulta difficile l’identificazione: v. DONNOLA), anche nella raccolta esopica si ritrovano queste situazioni tipiche: la guerra del gatto con i topi (Esopo 13 Ch.) e le insidie portate al gallo (Esopo 12 Ch.) e alle galline (Esopo 14 Ch.). La tradizione favolistica tende insomma a fotografare situazioni quotidiane e reali, senza riferimenti alla sfera mitologico-religiosa, come invece accade per altri animali (v. ad esempio AQUILA). Il gatto, la civetta e il topo Romulus 25 Una civetta chiese a un gatto di salire sopra di lei e di andare insieme a cercare qualcuno con cui parlare. Il gatto portò la civetta a casa di un topo. La civetta chiese al gatto di annunciarla e lui così fece. Quando il topo sentì la voce del gatto, venne alla porta della sua casa e disse: «Che cosa volete da me? Che cosa avete da dirmi?». «Vogliamo parlarti» dissero la civetta e il gatto. Il topo comprese che i due avevano ideato un complotto malvagio contro di lui; così rispose: «Sii maledetto, mio signor gatto, e maledetto sia anche colei che stai portando. E una maledizione si abbatta sulla casa, sui figli e sulle figlie, e su tutti i vostri parenti! Male avete fatto a venire qui, e male venga a voi sulla via del ritorno da qui!». Per coloro che non sanno parlare in modo adeguato ai loro nemici, si creano così ostilità e si mettono nei guai. Il gatto e le galline Esopo 14 Ch.
Un gatto, avendo sentito che in una fattoria c’erano galline ammalate, si travestì da medico e, presi i ferri del mestiere, vi andò. Una volta che si trovò davanti alla fattoria, chiese loro come stavano. Le galline risposero: «Bene, purché tu te ne stia lontano da qui». Così anche tra gli uomini i malvagi non ingannano i saggi, anche se fingono le migliori intenzioni. RIFERIMENTI: Babrio 121; Tavolette Assend. 14; Codice Brancacciano 1; Parafrasi 14; Dodecasillabi 14; Tetrastici 1,16; 2,24; Plutarco, L’amore fraterno 490c (allusione). Il gatto e i topi Esopo 13 Ch. In una casa c’erano molti topi. Un gatto, venuto a saperlo, andò lì e, prendendoli uno dopo l’altro, li divorò. I topi, sistematicamente catturati, si nascondevano nelle loro tane. Poiché non poteva più raggiungerli, il gatto capì che occorreva attirarli fuori con l’inganno. Perciò salì su un palo e, stando lì sospeso, si finse morto. Ma uno dei topi affacciandosi dalla sua tana, come lo vide, gli disse: «Mio caro, non m’avvicinerò a te neppure se diventerai un sacco». La favola dimostra che gli uomini saggi, quando sperimentano la malvagità di certe persone, non si lasciano più irretire dai loro inganni. RIFERIMENTI: Fedro 4,2; Babrio 17; Romulus 72. Il gatto e il gallo Esopo 12 Ch.
Un gatto, dopo avere catturato un gallo, cercò un pretesto plausibile per divorarlo. Di conseguenza lo accusò di essere molesto agli uomini poiché cantava di notte e impediva loro di dormire. Il gallo si difese dicendo che lo faceva per essere utile agli uomini, poiché li svegliava per i loro consueti lavori. Il gatto di nuovo lo accusava dicendo che violava le leggi di natura, accoppiandosi alla madre e alle sorelle. Il gallo diceva di comportarsi in questo modo nell’interesse dei padroni, perché così venivano prodotte numerose uova. Il gatto allora rispose: «Se tu riesci a trovare tante magnifiche giustificazioni, io certo non resterò a bocca asciutta», e lo mangiò. La favola dimostra che la natura malvagia, decisa a compiere il male, se non può agire con una scusa ragionevole opera in modo scoperto.
Gelso Il gelso nero è molto noto e apprezzato nell’antichità. Plinio ne segnala le numerose proprietà benefiche per l’uomo (Naturalis historia 23,136-140) e lo definisce, con un’espressione significativa sul piano simbolico, «il più saggio tra gli alberi», poiché la sua germinazione è tardiva ma rapida e avviene quando il periodo freddo è alle spalle (16,102). Noto è un mito, riportato in modo suggestivo da Ovidio (Metamorfosi 4,55 ss.), che ne suggerisce un’origine asiatica, probabilmente alla luce della provenienza dell’albero. A Babilonia, Piramo e Tisbe, amanti contrastati dalle famiglie, sono costretti a incontrarsi in segreto, e così si danno appuntamento sotto un gelso bianco. Tisbe, arrivata sul luogo dell’incontro, vede un leone e, impaurita, scappa, lasciando sul posto un velo che l’animale sporca del sangue della preda appena uccisa. Quando giunge, Piramo pensa che la sua amata sia stata uccisa e si trafigge così il cuore, sporcando di sangue l’albero. Tisbe ritorna quando è troppo tardi: si rende conto dell’accaduto e si uccide dopo avere maledetto l’albero, che da allora porta frutti scuri per ricordare il tragico fatto. La saggezza della pianta e il suo legame evocativo con il sangue sono proprio gli elementi alla base dell’unica favola esopica in cui compare il gelso (Esopo 214 Ch.). L’assassino, che addebita all’albero il fatto di avere le mani sporche di sangue, finisce appeso alla stessa pianta, che nella morale va a rappresentare gli uomini «buoni per natura». Il tema è quello, tipicamente esopico, della malvagità punita e ricorda la narrazione dell’assassino perseguitato, dopo il suo atto scellerato, in aria, in terra e in acqua, dove, infine, trova la morte a causa di un coccodrillo (Esopo 45 Ch.). Il termine greco usato per indicare la pianta, συκάµινoς, lascia aperta qualche incertezza riguardo all’identificazione: alcuni, come nei Vangeli, interpretano «sicomoro» (Luca 19, 1-10:
Zaccheo, basso di statura, per vedere Gesù sale su tale albero). Del resto, già gli antichi tendono a confondere le due piante e lo stesso nome del sicomoro rimanda sia al fico sia al moro. La maggiore diffusione del gelso, più comune in Occidente, fa comunque ritenere come più probabile questa identificazione, peraltro non decisiva nell’economia della narrazione. Va rilevato che il sicomoro, albero cosmico, è ritenuto nutrimento dei morti e degli dei presso gli antichi egizi; è anche chiamato, proprio in considerazione delle sue origini, «fico egizio» (cfr., ad esempio, Plinio, Naturalis historia 13,56) ed è apprezzato per le virtù medicinali. Poiché il frutto ha il colore del sangue (e del suo umore rimane aspersa la pianta), l’albero diventa simbolo della croce e del sangue di Cristo, che produce il frutto dei martiri. I briganti e il gelso Esopo 214 Ch. Un brigante uccise un uomo lungo la strada e, dopo averlo lasciato insanguinato, se la dava a gambe, inseguito dai presenti. Alcuni viandanti, provenienti dalla direzione opposta, gli chiesero di che cosa fossero sporche le sue mani; allora egli rispose che era da poco sceso da un gelso. Ma, mentre parlava in questo modo, gli inseguitori lo raggiunsero e lo catturarono; quindi lo impiccarono proprio al gelso. L’albero gli disse: «Non mi rincresce affatto di essere servito alla tua morte; infatti tu hai asciugato su di me questo sangue, derivato dall’omicidio che tu stesso hai compiuto». Così, spesso anche coloro che sono buoni per natura, quando alcuni li accusano di essere malvagi, non esitano a comportarsi impietosamente nei loro confronti.
Ghiozzo I ghiozzi sono pesci della famiglia dei gobidi, dotati di buona capacità di adattamento a diversi ambienti. Se ne conoscono diverse specie: sono abbastanza diffusi nei nostri mari soprattutto il ghiozzo comune, il ghiozzo testone e il ghiozzo paganello. Nell’antichità vanno spesso a simboleggiare qualcosa di scarso valore. Tra l’altro, in senso figurato, per la grandezza della testa del pesce, ancora oggi in italiano «ghiozzo» indica un uomo di poca intelligenza. In una satira (11,37), Giovenale li indica come pesci acquistabili a poco prezzo, a differenza della triglia, molto più cara. Nelle Vite dei Filosofi (2,67), Diogene Laerzio racconta un aneddoto riferito ad Aristippo, fondatore della scuola cirenaica, che visse alla corte del tiranno Dionisio I di Siracusa. Poiché un tale era sdegnato per lui a causa del fatto che Dionisio gli aveva sputato addosso, il filosofo, senza prendersela per l’oltraggio, rispose che se i pescatori, per prendere un ghiozzo, si lasciano bagnare dal mare, egli, per prendere una balena, poteva ben sopportare uno sputo. La stessa opposizione ghiozzo-balena si ritrova nell’unica favola di Esopo in cui compare il pesce, che svolge senza successo il ruolo di mediatore: anche qui, come suggerisce la morale, se la balena, come il delfino, va a simboleggiare i potenti, il ghiozzo, di cui si sottolineano le esigue dimensioni, è invece immagine di uomini di scarsa importanza, che si immischiano poco opportunamente in questioni rilevanti. Il phoecis della favola 38 di Aviano è interpretato dalla maggior parte degli studiosi come «ghiozzo», anche se l’identificazione non è del tutto convincente; infatti, il ghiozzo afferma, di fronte a un anonimo e vanaglorioso pesciolino di fiume che accede al mare, di essere un pesce pregiato. Va anche segnalato, tuttavia, che in uno dei suoi epigrammi (13,88), Marziale segnala come questo pesce apra i fastosi banchetti dei
Veneti. Nella favola di Aviano, comunque, l’opposizione si gioca soprattutto sul diverso valore dei pesci d’acqua dolce e dei pesci di mare, generalmente considerati di maggior pregio. Il tema della disputa sulla nobiltà è caro alla tradizione esopica e pare di origine cinica (v., ad esempio, COCCODRILLO: Esopo 35 Ch.). Il pesce che va in mare Aviano 38 Trascinato fuori dai dolci stagni dalla forza della corrente di un fiume, un pesce precipitava a capofitto verso le acque del mare. Lì, guardando in modo altezzoso una schiera di pesci coperti di squame, l’arrogante sosteneva di essere assai nobile. Il ghiozzo non sopportò l’ospite catapultato lì dagli stagni, e si rivolse a lui in modo assai aspro e provocatorio: «Evita di dire inutili menzogne con frasi ricercate che si possono facilmente confutare portando proprio te come testimone. Infatti dimostrerò, alla presenza di tutti, chi tra noi due sia di maggiore valore qualora le umide reti ci catturino e ci traggano fuori. Allora un acquirente molto importante mi comprerà a caro prezzo, mentre i poveracci ti acquisteranno per due soldi».
Giardiniere Già Omero descrive frutteti e giardini fecondi, come quelli dei Feaci (Odissea 7,112 ss.), segnalando così un aspetto che pare assai rilevante nella cultura di vari popoli. Dai «paradisi» orientali (come il parco di Ciro a Sardi) fino ai giardini sacri della polis, si riscontra un utilizzo diversificato di questi spazi. I primi giardini ornamentali sono realizzati dai tiranni della Magna Grecia. Sulla cura dei giardini vengono quindi elaborati diversi trattati (andati persi) che in Grecia vengono chiamati Cepurica e suggeriscono le funzioni e le tecniche del giardiniere: dalle poche testimonianze sulla questione, si deduce che dovevano approfondire aspetti di carattere agricolo piuttosto che estetico. A Roma, dove in origine prevale una funzione pratica dei giardini (comunque non priva di risvolti religiosi), a partire dalla fine del II secolo a.C. viene importata la tecnica greca: così si assiste a una progressiva specializzazione di schiavi-giardinieri. Significativo, in particolare, il termine topiarius, la cui radice è greca: indica l’addetto alla cura del giardino decorativo. Questa specifica tecnica, confusa dai Greci con quella dei giardini in genere, a Roma finisce così per assumere una sua autonomia (Grimal 95). Nella tradizione favolistica, come accade anche per gli altri personaggi umani, il giardiniere emerge senza una precisa fisionomia. L’unica narrazione esopica in cui lo troviamo impegnato nel suo lavoro è la 154 Ch., dove è impegnato a innaffiare i suoi ortaggi: a un interlocutore curioso, con una saggia battuta spiega la differenza tra i floridi frutti naturali e i più deboli frutti coltivati. La contrapposizione naturaleartificiale sembra di derivazione cinica e si può giocare su diversi piani (la morale distingue tra madre e matrigna). In un aneddoto di Fedro (2,5), troviamo uno schiavo (atriense) pronto a occuparsi del giardino, mentre cerca invano di guadagnarsi un premio
dall’imperatore Tiberio. Ma il giardiniere può diventare anche una figura tanto generica da non essere nemmeno caratterizzata dal lavoro che svolge: così è nella favola in cui cerca di recuperare il cane che cade nel pozzo (Esopo 155 Ch.) o in quella del Romulus (26) in cui irride un calvo, che poi gli taglia la testa. Comunque, in generale, non appare come il più crudele degli uomini nei confronti degli animali: lo conferma un asino, che prima si lamenta di averlo come padrone, ma poi finisce nelle mani di un conciapelli, che, come si può intuire, gli riserva un trattamento decisamente meno benevolo (Esopo 273 Ch.). Il giardiniere che innaffiava gli ortaggi Esopo 154 Ch. Un uomo si fermò presso un giardiniere che stava innaffiando i suoi ortaggi e gli chiese per quale motivo quelli selvatici erano floridi e robusti, mentre quelli coltivati fragili e indeboliti. Allora il giardiniere gli rispose: «La terra è madre degli uni e matrigna degli altri». Così anche fra i ragazzi, non sono allevati allo stesso modo quelli educati dalle matrigne e quelli che hanno le loro madri. RIFERIMENTI: Sintipa 32; Romanzo di Esopo 3537. Il giardiniere e il cane Esopo 155 Ch. Il cane di un giardiniere cadde in un pozzo. Allora il giardiniere, volendo farlo uscire di lì, scese anch’egli nel pozzo. Poiché il cane pensò che l’uomo venisse a spingerlo ancor più giù, si rivoltò e lo
morse. Il giardiniere, ritornando indietro sofferente, disse: «Mi sta proprio bene: perché mai infatti mi sono impegnato per salvare chi si fa del male da sé?». La favola è rivolta agli ingiusti e agli ingrati. RIFERIMENTI: Sintipa misantropo 633 s. (allusione).
34;
Menandro,
Il
Il calvo e il giardiniere Romulus 26 Un uomo calvo chiese a un vicino giardiniere di dargli dei meloni. L’altro, deridendolo, rispose: «Vattene, calvo, vattene via, non voglio darti dei meloni perché sei un rozzo plebeo. D’inverno e d’estate sia maledetta la tua testa: ti vengano mosche e tafani sulla fronte, ti mordano e succhino il sangue dal capo e poi facciano i loro bisogni!». Il calvo, irritato, sfoderò la spada e lo prese per i capelli con l’intenzione di ucciderlo. Ma il giardiniere, afferrato un melone, colpì il calvo in fronte. Costui, molto più forte, gli tagliò la testa. Per coloro che non offrono i loro beni a chi ne fa richiesta e non usano nemmeno parole e risposte adeguate. RIFERIMENTI: Alcuni interpreti intendono «zucca» («pumpkin»: Perry e Gibbs) per la relazione con il motto proverbiale «Più pelato di una zucca» (Apuleio, Metamorfosi 5,9), dove però è usato il termine specifico cucurbita e non melo, che invece indica per lo più il melone. Peraltro, zucca e melone possono essere assimilabili nell’aspetto esteriore. PROVERBI
Ἐν ϕρέατι κυσὶ µάχεσθαι Battersi con i cani nel pozzo Come segnala Zenobio (3,45), si tratta di un proverbio che può essere riferito a chi combatte con difficoltà contro qualcuno senza avere vie di fuga. L’immagine, chiaramente connessa con la favola (il senso però è leggermente differente), si ritrova, sia pure in forme diverse, anche in Platone (Teeteto 165b e in Menandro, che sembra alludere alla favola: cfr. RIFERIMENTI).
Gracchio Il verso dei gracchi, proverbiale, suggerisce un suono stridulo e poco piacevole (cfr. Ammiano Marcellino 22,6,2). La simbologia del gracchio tende a confondersi con quella della cornacchia (v. CORNACCHIA). Se un corvo, una cornacchia o un gracchio strepitano quando cala la sera, annunciano che è in arrivo il maltempo (Eliano, De natura animalium 7,7); i gracchi danneggiano i campi coltivati, così i Veneti fanno con loro un patto di non belligeranza, inviando pagnotte d’orzo e focacce (17,16). Nella tradizione esopica, il gracchio, insieme alla cornacchia e al corvo, sembra costituire «quasi un ciclo favolistico» (Pugliarello 1973,140). Spesso è rappresentato in una chiave comica. In Esopo 162 Ch., favola di lunga fortuna confluita in un proverbio (v. sotto), il gracchio cerca di sopperire alla sua bruttezza impossessandosi delle penne degli altri volatili, ma finisce male, proprio come nella narrazione in cui, superbo, si adorna delle penne di pavone e abbandona i suoi simili (Fedro 1,3): scoperto dai pavoni, a cui si è unito, viene cacciato. La stessa sorte gli tocca quando vuole unirsi ai corvi, ma questi lo trattano assai male e l’uccello non trova nemmeno più accoglienza presso i suoi simili (Esopo 161 Ch.): la favola è stata posta in relazione al proverbio «Finire ai corvi» (v. CORVO). In generale, il gracchio appare protagonista di disavventure che lo vedono per lo più soccombere (costruita sullo schema delle narrazioni precedenti, anche quella del gracchio e dei colombi, Esopo 163 Ch., dove viene ribadita la morale tipica della favola secondo cui è bene accontentarsi). Come si conferma anche nella favola del gracchio fuggitivo (Esopo 164 Ch.), questo uccello è molto abile a mettersi nei guai. Del resto, nel mondo esopico chi vuole mutare la propria situazione rischia di peggiorarla: così, ad esempio, suggerisce Fedro (App. 18 [20]) quando presenta Esopo
impegnato ad ammonire uno schiavo fuggitivo. L’ingenuità del gracchio emerge anche nella favola 160 Ch.: la volpe gli consiglia di non aggrapparsi alla speranza che i fichi maturino (la narrazione ricorda per alcuni aspetti Esopo 32 Ch.: la vicenda della volpe e dell’uva). Il gracchio e gli uccelli Esopo 162 Ch. Volendo eleggere un re degli uccelli, Zeus stabilì un giorno nel quale tutti dovevano presentarsi al suo cospetto, perché egli potesse scegliere come loro sovrano il più bello. Essi, allora, si recarono presso un fiume per lavarsi per bene. Un gracchio, tuttavia, che si rendeva conto della sua bruttezza, andò a raccogliere le piume cadute agli altri uccelli. Se le mise intorno al corpo e le attaccò. Riuscì così a diventare, grazie a questa astuzia, più bello di tutti gli altri. Giunse allora il giorno stabilito e tutti gli uccelli si recarono al cospetto di Zeus. Si presentò anche il gracchio con le sue penne variopinte. Tuttavia, mentre Zeus stava per incoronarlo per la sua bellezza, gli uccelli si indignarono e gli levarono ciascuno la propria penna. Così l’uccello, denudato, finì per diventare di nuovo un gracchio. Allo stesso modo anche tra gli uomini, coloro che hanno debiti, finché vivono grazie ai soldi degli altri, sembrano essere qualcuno, ma quando li restituiscono, appaiono come erano all’inizio. RIFERIMENTI: Decine le riprese, di vario genere. Queste le principali: Fedro 1,3; Babrio 72; Aftonio 31; Parafrasi 125; Tetrastici 1,29; Romulus 45; Orazio, Epistole 1,3,18 ss.; Diogene Laerzio 6,80 (per gli altri riferimenti, cfr. l’elenco di Adrados 2003, 133 ss., che comprende anche varie possibili
allusioni). Il gracchio fuggitivo Esopo 164 Ch. Un uomo prese un gracchio, gli legò la zampa con una corda di lino e lo diede a suo figlio. L’uccello tuttavia, non sopportando la vita con gli uomini, appena ebbe un momento di libertà fuggì per ritornare al suo nido. La corda però si impigliò nei rami di una pianta ed egli non poteva levarsi in volo; ormai sul punto di morire, disse a se stesso: «Che sventurato sono! Non ho sopportato di essere schiavo presso gli uomini e così, senza rendermene conto, ho perso anche la vita». Questa favola potrebbe essere applicata a coloro che, volendo evitare pericoli modesti, finiscono, senza accorgersene, in disgrazie ben peggiori. Il gracchio e la volpe Esopo 160 Ch. Un gracchio affamato si fermò su un fico. Poiché trovò dei frutti ancora acerbi, si mise ad aspettare che maturassero. Una volpe lo vide fermo lassù e si informò del motivo del suo comportamento. Quindi disse: «Commetti un errore, caro, ad aggrapparti alla speranza, che, come un pastore, conduce al pascolo ma non offre nutrimento». [Favola dedicata a chi è bramoso di successo]. Il gracchio e i corvi
Esopo 161 Ch. Un gracchio, che si segnalava per grandezza rispetto agli altri, disprezzando i suoi simili, si unì ai corvi, pretendendo di vivere con loro. Questi, tuttavia, non conoscendo il suo aspetto e la sua voce, lo picchiarono e lo mandarono via. E allora il gracchio, respinto dai corvi, tornò nuovamente dai suoi simili. Essi, tuttavia, sdegnati per la sua tracotanza, non lo vollero più tra di loro. In questo modo finì per essere privato della possibilità di vivere con l’una e con l’altra specie. Così, anche tra gli uomini, coloro che lasciano la loro patria e preferiscono altre regioni, non hanno buona fama in quelle, per il fatto che sono stranieri, e sono sopportati a fatica dai concittadini per il disprezzo che hanno dimostrato nei loro confronti. RIFERIMENTI: nessun favolista riprende il motivo. Cfr., tuttavia, Suda ε 3154 Adler; Fozio, Lessico, s.v. ἐς κóρακας; Eustazio, Commento all’Odissea (v. 408). Il gracchio e i colombi Esopo 163 Ch. Un gracchio vide alcuni colombi ben nutriti in una piccionaia e rese bianche le sue penne per condividere la loro vita. I piccioni, finché se ne stette zitto, lo accolsero, ritenendo che fosse uno di loro; ma una volta, in un momento di distrazione, il volatile gracchiò. Allora i piccioni, riconoscendone il verso, lo mandarono via. Quello, non essendo riuscito a ottenere cibo lì, di nuovo ritornò dai gracchi, ma
essi, non riconoscendolo a causa del colore, lo allontanarono dalla loro comunità. Così, dopo aver coltivato due desideri, non ne realizzò nemmeno uno. Anche noi dunque, dobbiamo farci bastare quello di cui disponiamo, consapevoli che l’avidità, oltre a non portare alcuno giovamento, spesso ci fa perdere anche quello che possediamo. PROVERBI Alienis me coloribus adornare Adornarmi con colori di altri Come nota Tosi 1991, 776, in genere «la locuzione indica chi per smodata vanità e desiderio di primeggiare non esita ad arrogarsi i meriti altrui». Il proverbio, che può adattarsi a contesti differenti ed è attestato in san Girolamo (Prologo al trattato di Didimo sullo Spirito Santo 106), ha larga fortuna in ambito cristiano, dove si trovano, tra l’altro, espliciti riferimenti alla favola esopica, tramite le espressioni Graculus Aesopi, ossia «Il gracchio di Esopo» (Braulio, Epistole 11; Tertulliano, Contro i Valentiniani 12,4) e Cornix Aesopi, ossia «La cornacchia di Esopo» (cfr., ad esempio, ancora Girolamo, Epistole 108,15), usate per indicare le persone superbe. Il riferimento è naturalmente a Esopo 162 Ch., a Fedro 1,3 e alle numerose riprese di queste narrazioni: cfr., tra l’altro, Orazio, Epistole 1,3,18 ss. (il riferimento qui è a una cornacchia). La Fontaine trasformerà il gracchio in una gazza (4,19).
Granchio Nel mondo classico il granchio è considerato simbolo di ambiguità, talora di slealtà, a causa della sua andatura obliqua; la sua immagine non migliora presso i cristiani, che lo eleggono a emblema negativo (così, ad esempio, Ambrogio, Exameron 5,23) anche se una certa tradizione lo vorrebbe, in quanto crostaceo dotato di corazza, immagine del Cristo vittorioso (ma v. GAMBERO). Nel mito troviamo un granchio che ostacola Eracle impegnato a lottare contro l’Idra di Lerna. Schiacciato dall’eroe, per volere di Era, che è ostile a Eracle, il crostaceo trova posto fra le costellazioni dello zodiaco (il segno del cancro deriva dal termine latino cancer, che indica appunto il granchio). Al solstizio estivo, infatti, il sole comincia a retrocedere, con movimento obliquo. Gli antichi tendono a non distinguere esattamente il granchio dal gambero, in questa come in altre credenze. In molte tradizioni culturali, si rileva l’associazione del granchio con le acque (in Grecia è anche ritenuto sacro a Poseidone) e con la luna (cfr. Cattabiani 2002, 346). Artemidoro ne traccia un profilo singolare: il granchio, come gli altri crostacei, per la sua tendenza a mutare veste sarebbe beneaugurate per i malati, i carcerati, i poveri; inoltre preannuncia percosse, perché picchia se stesso (Sull’interpretazione dei sogni, 2,14). L’andatura del granchio dà spunto a una favola di Esopo, la 151 Ch., da cui deriva forse un proverbio (v. sotto): la madre pretende che il figlio proceda diritto, ma non dà per prima l’esempio (il modo di camminare del granchio simboleggia la mancanza di rettitudine morale). Per ironia della sorte, il granchio, descritto in un’altra favola (Esopo 290 Ch.) come schietto e benevolo nei confronti del serpente, si vendica dell’ambiguità e della perfidia del rettile, uccidendolo mentre l’altro dorme. Questa favola trova fondamento in tradizioni di varia origine: ad esempio,
Eliano (De natura animalium 16,38) riporta una diceria secondo cui presso un lago nelle vicinanze di Efeso ci sono granchi che uccidono i grossi e terribili serpenti che, usciti dal lago, approdano sulla terraferma. Perciò questi serpenti hanno profondo terrore dei granchi (cfr. anche Marchianò 78 per un parallelo della favola del serpente e del granchio con una narrazione della tradizione indiana). La vita condotta tra l’acqua e la terra rappresenta probabilmente un ulteriore elemento che connota il granchio come essere ambiguo, allo stesso modo di altri animali, come il coccodrillo (tra l’altro il granchio è accostato al coccodrillo anche per altri motivi: entrambi hanno l’abitudine di portare le loro uova nei fondali del Nilo, come attesta Eliano, De natura animalium 5,52). Ma quando approda sulla spiaggia, come nella favola esopica 150 Ch., trova l’implacabile punizione: la volpe è pronta a catturarlo. E la stessa vittima sembra rimproverarsi la sua doppia natura. Il granchio, peraltro, assume un ruolo importante anche in altre favole orientali: nel Pañcatantra (primo tantra, racconto quinto), un airone, ormai anziano, inganna i pesci prospettando un pericolo imminente nel loro lago; dichiarandosi disponibile a portarli via, li prende ma poi li divora; mentre sta facendo lo stesso con un granchio, il crostaceo capisce l’inganno e taglia la testa all’airone, quindi ritorna nel suo laghetto. Il granchio e la volpe Esopo 150 Ch. Un granchio, risalito dal mare, stava solo su una spiaggia. Una volpe affamata, come lo vide, poiché era senza cibo, gli saltò addosso e lo catturò. Allora il granchio, sul punto di essere mangiato, disse: «È quello che merito, perché io, che sono un animale del mare, ho voluto diventare terrestre». Così anche tra gli uomini, quelli che lasciano i loro costumi abituali per assumere quelli che a loro non si addicono
vengono giustamente travolti dalla sventura. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,24. Il granchio e sua madre Esopo 151 Ch. «Non camminare di traverso – diceva la madre al granchio – e non sfregare i fianchi contro la roccia umida.» Allora il piccolo rispose: «Mamma, tu che mi insegni, procedi diritta e, guardandoti, io ti imiterò». È giusto che coloro che criticano vivano e procedano sulla retta via: allora potranno essere maestri coerenti. RIFERIMENTI: se si segue l’interpretazione di Adrados 2003, 273 (ma restano molti dubbi), questa favola è una versione breve di quella del serpente e del granchio. Cfr. Babrio 109; Aftonio 11; Aviano 3; Parafrasi 152; Tetrastici 1,34; Carmina Convivalia 892 (il modello, secondo Adrados). V. ANCHE GHIOZZO: in Babrio 39 il granchio sostituisce il ghiozzo come mediatore tra le balene e i delfini. PROVERBI Oὔπoτε πoιήσεις τὸν καρκίνoν ὀρθὰ βαδίζειν Non farai mai camminare diritto un granchio Come spiega Tosi 1991, 172, questo verso di Aristofane (Pace 1083) assume valore proverbiale e sembra tratto direttamente dalla favola del granchio e di sua madre (151 Ch.): una narrazione di lunga fortuna che entrerà anche nell’opera di La Fontaine (12,10). L’impossibilità di insegnare a camminare diritto a un granchio è ripresa anche nella raccolta di sentenze di Apostolio (9,50). Per quanto riguarda il gambero, nelle lingue moderne è attestato come
esempio di chi va all’indietro.
Gru Uccello migratore, si segnala per l’eleganza ed è associato ad Apollo e a Hermes (Mercurio), dio dei viaggiatori. Diventa simbolo della vigilanza: secondo una fantasiosa convinzione, che dura fino al Medioevo, le gru incaricate di svolgere di notte la funzione di sentinelle terrebbero una pietra nella zampa, perché se si addormentassero, ne verrebbe provata la negligenza. La gru rappresenta la previdenza, la prudenza e la protezione divina, in Oriente e in Occidente (cfr. Cattabiani 2000, 170 ss.). Le grida e il suo volo nell’alto del cielo colpiscono gli antichi: secondo Plinio (Naturalis historia 10,58-59) servono per mantenere unito lo stormo durante gli spostamenti. La connessione con la sfera celeste e il caratteristico verso della gru sono qualità apprezzate nella società esopica: la fama di questo uccello si contrappone così, come simbolo positivo, alla ricchezza dell’anonimo pavone (Esopo 333 Ch.). Qui, come nella favola 353 Ch., dove le gru appaiono più leggere delle oche e riescono perciò a salvarsi, l’uccello va a simboleggiare i poveri, sempre in una prospettiva positiva. Quando la gru approfitta dei campi seminati a frumento, viene minacciata dal contadino (Babrio 26), che prima la spaventa e poi passa ai fatti, secondo uno schema narrativo non inusuale (v. ALLODOLA). In questa favola c’è un riferimento al rapporto che curiosamente lega la gru ai Pigmei. Eliano (De natura animalium 15,29) allude al motivo mitologico della guerra tra l’uccello e questo popolo: morto il re, i Pigmei vollero essere guidati dalla regina Gerana; le tributarono onori divini e la fecero così diventare pazza, al punto che, ritenendosi più bella delle dee, fu tramutata da Era in gru, il più brutto degli uccelli. Perciò ancora oggi la gru continua a combattere contro i Pigmei (cfr. anche Plinio, Naturalis historia 7,26); un racconto simile esiste nella tradizione indiana, che narra l’inimicizia dell’uccello garuda
e dei nani Kirata (Cooper 181). Da sottolineare, infine, un elemento caratteristico della cultura antica: i trampolieri (gru, cicogna, airone) hanno una simbologia affine. La condivisione dello stesso valore simbolico rende pertanto la gru equivalente alla cicogna anche nella tradizione favolistica: in alcune varianti della favola 1,26 di Fedro si trova infatti proprio questo uccello al posto della cicogna. Il contadino e le gru Babrio 26 Alcune gru vennero a becchettare in un campo che un contadino aveva da poco seminato a frumento. Per un bel pezzo l’uomo, che agitava una fionda senza sassi, riuscì a cacciarle, spaventandole. D’altra parte quelle, come videro che il contadino muoveva la fionda al vento, presero a disprezzarlo sicché non fuggivano più, fino a che l’uomo, non comportandosi più come prima, prese a tirare sassi e ferì gran parte delle gru. Allora le gru se ne andarono dal campo, urlando tra loro: «Fuggiamo verso la terra dei Pigmei: quest’uomo, a quanto pare, non si accontenta più di minacciarci; ormai è passato ai fatti». RIFERIMENTI: cfr. Suda π 3221 Adler (forse un’allusione). V. anche Adrados 2003, 419.
Guerra Gli scarsi riferimenti letterari inducono a pensare alla Guerra (in greco, Πóλεµoς), come a un demone secondario, padre di Alala (il grido di battaglia), che fa parte del gruppo delle divinità belliche; in altri casi pare piuttosto un attributo del dio Ares. In ambito filosofico, è noto il frammento di Eraclito, che, individuando il principio oppositivo che regola la diversità, afferma: «Polemos è padre di tutte le cose, sovrano di tutte le cose, rivela la divinità e l’umanità, rende gli uni liberi e gli altri schiavi» (fr. 53 D.-K.). Nella Pace di Aristofane troviamo la personificazione della Guerra, che ha rinchiuso Eirene (la pace) in una caverna e vuole mettere le città greche in un mortaio per ridurle in poltiglia; ma Eirene viene liberata. A questo riferimento letterario pare ispirarsi l’unico caso in cui emerge la Guerra in ambito favolistico: sembra non presentare alcun punto di contatto con il sistema mitologico, mentre può essere ricondotta alla personificazione di un principio. In quest’ottica, nella favola di Esopo 319 Ch., Polemos viene accostato alla Violenza (v.). La narrazione spiega così le origini del loro temibile matrimonio. In generale, il tema della guerra come origine di mali si trova spesso nelle favole di impronta cinica (cfr., ad esempio, Esopo 268 Ch.: qui il cavallo trova la morte).
H
Hermes (Mercurio) Nato da Zeus e da Maia (una delle Pleiadi, figlie di Atlante), il dio Hermes (a Roma Mercurio) viene alla luce in Arcadia, in una caverna del monte Cillene, il quarto giorno del mese, che gli viene poi consacrato. Lo stesso giorno sottrae cinquanta giovenche al fratellastro Apollo e inventa la lira. Dopo avere fatto pace con Apollo, gli dà il flauto (una sua invenzione) in cambio di una verga d’oro. In genere, si distingue per scaltrezza e senso pratico, oltre che per capacità di inganno e abilità nell’usare le parole (cfr. Platone, Cratilo 407e-408d): agisce sempre su mandato di Zeus e degli altri dei, di cui diviene araldo. Inventa, tra l’altro, le lettere, le cifre, i riti religiosi; perciò è considerato dio delle invenzioni. Nell’antico repertorio iconografico, viene rappresentato con un semplice motivo simbolico che varia dal fallo (emblema di fecondità) fino a un semplice pilastro posto all’incrocio di più strade. Nella rappresentazione antropomorfica appare come un giovane con la barba, dotato del petaso (cappello con larga tesa e piccole ali), calzari forniti di piccole ali e caduceo. Viene considerato «psicopompo», ossia accompagnatore delle anime dei morti nell’Ade; è ritenuto protettore dei mercanti, dei viandanti, dei retori e dei ladri. Viene anche considerato dio dei sogni, a cui dedicare libagioni prima di andare a dormire. Nella tradizione esopica, la figura di Hermes si conferma per il ruolo di mediatore tra Zeus e gli animali (o gli uomini). Tale funzione si trova, ad esempio, in Fedro 4,18 [19], narrazione che presenta i cani impegnati a mandare ambasciatori al re degli dei, secondo uno schema di larga fortuna, impiegato con diversi animali (ad esempio, lo stesso
fanno gli asini di Esopo 262 Ch.); ma Zeus assegna molti altri incarichi a Hermes: quello di instillare l’intelligenza degli uomini (Esopo 120 Ch.), di condurli sulla terra per insegnare loro come procurarsi il cibo (Esopo 109 Ch.) o di somministrare agli artigiani (v.) il veleno della menzogna (Esopo 111 Ch.). A un guasto del carro del dio (Esopo 112 Ch.), che trasporta in giro per il mondo malizia e inganni, si deve la falsità degli Arabi (v.). In generale, Hermes, che conferma nelle favole esopiche arguzia e scaltrezza, è spesso protagonista di vicende dagli accentuati caratteri comici. Così risponde con ironia al cane che vuole onorarne la statua ungendola (Babrio 48) o ripaga beffardamente due donne che, ospitandolo, non lo trattano in modo decoroso (Fedro, App. 3 [4]): in questa narrazione, che non ha un corrispondente nelle collezioni esopiche ma rientra nel diffuso schema della richiesta alla divinità, si registrano i tipici meccanismi dell’ambiguità del valore e del rovesciamento della situazione. La qualifica di «ladro» viene esplicitamente attribuita a Hermes nell’epimitio di una favola in cui il dio sottrae buoi a Tiresia per mettere alla prova l’arte divinatoria (Esopo 110 Ch.). La sua dimensione è tipicamente umana e il dio può addirittura venire raggirato da un viandante, che fa una promessa abilmente manipolata (Esopo 260 Ch.). Nella gerarchia divina Hermes, raffigurato anche con il tradizionale caduceo (Esopo 48 Ch.), appare naturalmente dietro a Zeus e a Era: la sua statua vale molto meno delle altre e nessuno la compra (Esopo 108; 2 Ch.); perciò la sua vanità viene frustrata. Una considerazione a parte merita, per l’originalità dei contenuti e della struttura, la favola del taglialegna e di Hermes (Esopo 253 Ch.), da cui deriva anche un fortunato proverbio (v. sotto): forse è di origine mesopotamica e trova paralleli anche nella tradizione circassa (cfr. Adrados 2003, 242 s.). La rassicurante morale sottolinea che la divinità aiuta i giusti e penalizza i disonesti. L’uomo che raccoglieva legna e Hermes Esopo 253 Ch.
Un uomo, impegnato a raccogliere legna, perse la sua accetta in un fiume. Non sapendo allora che cosa fare, si sedette presso la riva e si mise a piangere. Hermes, venuto a conoscenza del motivo della sua tristezza, avendone compassione, scese nel fiume, ripescò un’accetta d’oro e gli chiese se era quella che aveva perso. Visto che l’uomo disse di no, scese di nuovo e ne portò su una d’argento. Poiché il taglialegna disse che non era quella la sua scure, sceso per la terza volta, gli portò su la sua. L’uomo disse che quella era veramente l’accetta che aveva perso e Hermes, approvando la sua onestà, gli regalò tutte e tre le accette. Il boscaiolo, una volta che fu tra i compagni, raccontò loro l’accaduto. Uno di essi decise di fare in modo di ottenere lo stesso e giunto al fiume, dopo aver gettato apposta la sua scure in acqua, si sedette a piangere. Hermes comparve dunque anche a lui e, dopo aver appreso il motivo del suo lamento, nello stesso modo si tuffò, gli riportò su una scure d’oro e gli chiese se aveva perso quella. Il taglialegna rispose felice: «Sì, è veramente quella». Il dio, disprezzando profondamente tale sfrontatezza, non solo tenne l’accetta d’oro, ma non gli ridiede nemmeno la sua. La favola dimostra che la divinità aiuta i giusti tanto quanto è avversa ai disonesti. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 254; Macario 6,68 (v. proverbio sotto). Mercurio e le due donne Fedro, App. 3 [4] Un’altra favola sullo stesso argomento
Una volta due donne avevano dato ospitalità in modo indecoroso e sordido a Mercurio: una di loro teneva un figlio piccolo nella culla, l’altra si guadagnava da vivere facendo la prostituta. Pertanto, per ricambiarle con favori uguali ai servizi resi, mentre era in procinto di andarsene e stava già varcando la soglia il dio disse: «Voi avete di fronte ai vostri occhi un dio; vi concederò subito ciò che ognuna di voi vorrà». La madre, supplicandolo, gli chiede di vedere quanto prima suo figlio con la barba; la prostituta gli chiede che la segua qualunque cosa lei toccherà. Mercurio spicca il volo e le donne tornano in casa. Ed ecco vagire il bambino barbuto. Poiché la meretrice rideva smodatamente, accadde che le sue narici si riempirono di muco, come avviene di solito. Volendosi dunque soffiare il naso, lo prese con le dita e lo tirò lungo lungo fino a terra: deridendo l’altra, divenne lei stessa bersaglio di riso. Gli ambasciatori dei cani da Giove Fedro 4,18 [19] Una volta i cani mandarono ambasciatori a Giove per pregarlo di concedere loro una condizione di vita migliore e per essere sottratti ai cattivi comportamenti degli uomini, che davano loro del pane cosparso di crusca e così placavano la loro grandissima fame con delle turpi schifezze. Gli ambasciatori partirono con passo lento, fiutando il cibo nello sterco con le narici. Convocati in udienza, non rispondono. A fatica finalmente li trova Mercurio e se li trascina dietro di sé tutti turbati. Allora quando vedono il grande volto di Giove, per la paura defecano per tutta la reggia. Cacciati a bastonate,
escono fuori, ma il grande Giove vieta che essi siano congedati. I cani si meravigliano per il fatto che i loro ambasciatori non tornano; credono che abbiano commesso qualche azione vergognosa e dopo un po’ di tempo dispongono che ne siano nominati altri. Le dicerie tradiscono i primi ambasciatori. Temendo dunque che accada di nuovo qualcosa di simile, riempiono di abbondante aroma il sedere dei cani. Danno disposizioni, gli ambasciatori sono inviati e subito se ne vanno. Chiedono udienza e immediatamente la ottengono. Si accomoda sul trono allora il grandissimo genitore degli dei e scuote il fulmine, così tutto comincia a tremare. I cani, turbati dall’improvviso fragore, subito cacano profumo misto a sterco. Tutti gli dei gridano: «Bisogna vendicare l’offesa». In questo modo allora parlò Giove, prima di infliggere la pena: «Non è degno di un re non lasciare andare gli ambasciatori e non è difficile attribuire una pena alla colpa; ma voi avrete questa ricompensa secondo la seguente sentenza: non impedisco che siano congedati, ma la fame li tormenti, perché possano trattenere il loro ventre. Riguardo a quanti mandarono voi, che siete così incontinenti, non saranno mai esenti dalle offese dell’uomo». [Così i loro discendenti aspettano ancora gli ambasciatori, e chi vede arrivare un cane non conosciuto gli annusa il sedere]. NOTA: al v. 26 si legge Di clamant invece di reclamant. L’uomo che spaccò una statua Esopo 61 Ch. Un uomo povero, che possedeva la statua in legno
di un dio, la pregava di portargli qualche beneficio. Poiché si comportava così e sprofondava sempre più nella miseria, preso dalla collera, sollevò la statua per una gamba e la gettò contro il muro. La testa del dio subito si spaccò e ne uscì dell’oro, che l’uomo corse a prendere, gridando: «A quanto pare, sei proprio strano e ingrato, poiché quando ti veneravo non mi procuravi alcun vantaggio, adesso che ti ho trattato male mi dai in cambio un enorme beneficio!». La favola dimostra che non otterrai nulla onorando un uomo malvagio, ma ne avrai un maggior vantaggio trattandolo male. RIFERIMENTI: Babrio 119 (qui Hermes è citato come il dio a cui è dedicata la statua); Codice Brancacciano 12; Dodecasillabi 61; Parafrasi 61; Antologia Palatina 16,187; Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 67, ed. Boissonade). Il venditore di statue Esopo 2 Ch. Un uomo che aveva realizzato una statua di Hermes in legno la portò in piazza e la mise in vendita. Poiché non si faceva avanti nessuna persona intenzionata a comprarla, volendo attirare qualcuno, prese a urlare che stava vendendo un dio generoso e portatore di guadagni. Uno dei presenti gli si rivolse allora in questo modo: «Carissimo, se è così perché lo vendi e non trai profitto invece dai vantaggi che può arrecare?». L’uomo rispose: «Io ho bisogno di guadagnare rapidamente, mentre lui è abituato a concedere i suoi favori con calma». La favola è adatta a quegli uomini che hanno turpi interessi e non si prendono alcuna cura degli dei.
Hermes e lo scultore Esopo 108 Ch. Hermes, volendo sapere quale fosse la considerazione degli uomini nei suoi confronti, assunse vesti mortali e andò nel laboratorio di uno scultore. Così, vista una statua di Zeus, chiese quanto costasse. L’uomo gli disse che costava una dracma; sorridendo, Hermes gli chiese il prezzo della statua di Era. Lo scultore gli rispose che era ancora più cara. Allora Hermes vide che c’era anche la sua statua ed era convinto che gli uomini avessero molta stima di lui, poiché era messaggero degli dei e dio del guadagno. Gli chiese quindi il prezzo. Lo scultore allora gli rispose: «Se compri le altre due statue, questa te la darò in aggiunta». La favola è adatta agli uomini vanitosi che non sono affatto considerati dagli altri. Lo scultore e Hermes Babrio 30 Un tale, scolpita una statua di Hermes in marmo bianco, la mise in vendita. Si fecero avanti due acquirenti: uno la desiderava per una lapide (un figlio, infatti, gli era morto di recente), l’altro, un artigiano, voleva la statua per consacrarla al suo dio. Si stava facendo tardi e lo scultore non aveva ancora venduto la statua, così si accordò per mostrare nuovamente l’opera ai due uomini, che sarebbero ritornati il mattino dopo. Lo scultore, tuttavia, durante il sonno, vide Hermes in persona presso la porta dei sogni. Il dio gli disse: «Ecco, la mia sorte adesso è nelle tue mani: farai di me un morto o un
dio?». RIFERIMENTI: Aviano 23 (qui Hermes è sostituito da Bacco). Il corvo e Hermes Esopo 166 Ch. Un corvo, preso al laccio, promise ad Apollo di offrirgli incenso. Tuttavia, salvato dal pericolo, dimenticò la sua promessa. Di nuovo fu preso a un altro laccio e, rinunciando a rivolgersi ad Apollo, promise un sacrificio a Hermes. Ma il dio gli rispose: «Malvagio, come potrò crederti, visto che tu hai rinnegato e oltraggiato il tuo primo padrone?». Coloro che si dimostrano ingrati verso i benefattori non potranno contare su alcun aiuto, una volta che si ritrovino in difficoltà. RIFERIMENTI: Parafrasi 167. Il viandante e Hermes Esopo 260 Ch. Un viandante che aveva un lungo cammino da affrontare fece voto che, se avesse trovato qualcosa, ne avrebbe consacrato la metà a Hermes. A un certo punto, si imbatté in una bisaccia nella quale c’erano mandorle e datteri; la raccolse, pensando che ci fosse dentro del denaro. Dopo averla scossa, appena scoprì quale fosse in realtà il contenuto, mangiò i frutti e, presi i gusci delle mandorle e i noccioli dei datteri, li pose su un altare e disse: «Io, Hermes, ho
adempiuto al mio voto, poiché ho diviso con te l’interno e l’esterno di ciò che ho trovato». La favola è adatta agli uomini avidi che, per cupidigia, ingannano persino gli dei. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 261. PROVERBI Oὐκ ἀεὶ πoταµὸς ἀξίνας ϕέρει Non sempre il fiume porta le scuri Il proverbio si trova in Macario (6,68) e viene ripreso con un esteso riferimento alla favola di Esopo 253 Ch. (Arsenio 41,36; Apostolio 13,67a), dove due taglialegna che perdono la loro scure si comportano diversamente con il dio Hermes: l’uomo onesto viene premiato, quello mendace punito. Il proverbio, come spiega l’interpretazione di Macario, si riferisce a coloro che non sempre fanno gli stessi doni.
Horkos (Giuramento) Horkos, inteso quale personificazione del Giuramento, viene descritto da Esiodo (Teogonia 231 s.) come figlio di Eris, la Contesa, che genera anche Fatica, Dimenticanza, Fame, Dolori, Lotte, Battaglie, Assassinii, Stragi, Liti, Menzogne, Dispute, Sregolatezza, Sventura. Il Giuramento, puntualizza il poeta, «soprattutto perseguita gli uomini sulla Terra, quando volontariamente qualcuno spergiura». Proprio questa è la veste in cui viene calato Horkos nell’unica favola esopica che lo vede protagonista (Esopo 298 Ch.), forse derivata da Erodoto (6,86). Viene raffigurato come un uomo zoppo, secondo una consolidata tradizione iconografica, per la lentezza dei suoi castighi. Rappresenta, come spiega l’epimitio, l’imprevedibilità della vendetta divina nei confronti degli uomini scellerati. Questa convinzione appare anche in altre favole, come Fedro 1,17: il lupo, che rende una falsa testimonianza in tribunale, dopo qualche giorno viene trovato morto in una fossa per volere degli dei. L’uomo che aveva ricevuto un deposito e Horkos Esopo 298 Ch. Un uomo, che aveva ricevuto il denaro di un amico in deposito, pensava di non restituirlo. L’amico lo chiamò a prestare giuramento, ma lui, prudentemente, partì per la campagna. Mentre si trovava presso le porte, come vide un uomo zoppo che usciva dalla città, gli chiese chi fosse e dove andasse. Quello gli rispose che era Horkos e che
andava contro gli uomini empi. Di nuovo l’altro gli chiese dopo quanto tempo fosse solito ritornare. Horkos gli disse: «Quarant’anni, a volte trenta». Il giorno successivo l’uomo, senza più indugiare, giurò di non aver ricevuto alcun deposito. Si imbatté però in Horkos, da cui fu trascinato in un precipizio; allora lo rimproverò di avergli detto che sarebbe giunto dopo trent’anni e di non avergli concesso neppure un solo giorno di impunità. Horkos gli rispose: «Sappi che se uno sta per farmi del male, sono solito tornare anche lo stesso giorno». La favola dimostra che è impossibile prevedere quando la punizione del dio colpisce gli empi. RIFERIMENTI: Erodoto 6,86.
I
Iena La iena è simbolo di ambiguità, di vizio e di perversione. Nell’antichità esiste la convinzione, non unanime ma diffusa, che l’animale abbia la tendenza a cambiare sesso: Aristotele (Historia animalium 759b) la nega, Eliano (De natura animalium 1,25) e Plinio (Historia naturalis 8,105) la riportano. Lo stesso Plinio (8,106) riassume le curiose credenze relative all’animale: tra le mirabolanti qualità che gli vengono attribuite, c’è anche quella di sapere imitare la voce umana. Si dice che, aggirandosi tra le capanne dei pastori, ne chiamerebbe uno per nome, traendolo a sé con l’inganno, e poi lo strazierebbe. Lo stesso farebbe con i cani, dopo averli attirati con l’imitazione del vomito umano (avrebbe anche il potere di ammutolirli). Nel linguaggio del sogno la iena indica la donna-strega (Artemidoro, Sull’interpretazione dei sogni 2,12). La cultura cristiana ne fa un simbolo del vizio: la Lettera di Barnaba (10,6-8) mette in guardia dalla carne della iena, perché chi ne mangia può assumere le sue perversioni sessuali. Nella tradizione favolistica la iena emerge come animale ambiguo e inaffidabile. La favola di Esopo 340 Ch. ruota intorno alla proposta di un atto sessuale contro natura: un tema abbastanza raro nelle raccolte di favole. Se in generale «la bisessualità sembra implicare un eccesso di libido» (Bettini 1998, 267), nello specifico, la favola sembra porsi contro l’omosessualità, secondo una certa tradizione cinica (Adrados 2003, 303). Tuttavia, il senso della narrazione è trasposto, nell’epimitio, su un piano etico differente: la morale pagana non coincide con quella cristiana, che, come si è notato sopra, si concentra invece sull’atto sessuale. Allo stesso modo, nell’altra favola dedicata alla iena (Esopo 341 Ch.) l’ambiguità sessuale viene generalizzata su un piano simbolico più ampio, come sinonimo di inaffidabilità nei rapporti interpersonali. La iena appare comunque sempre
come simbolo negativo. Le iene Esopo 340 Ch. Dicono che le iene mutino natura tutti gli anni e diventino ora maschi ora femmine. Un giorno una iena maschio propose a una iena femmina un rapporto contro natura. Quella rispose: «Carissimo, comportati pure così, ma sappi che presto subirai lo stesso». Questa favola potrebbe essere narrata giustamente per colui che sta per sostituire un magistrato, nel caso in cui sia vittima di un oltraggio da parte dell’altro. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 340. Qui si rileva una piccola variante: alla fine la femmina dice che vorrebbe diventare maschio. La iena e la volpe Esopo 341 Ch. Si dice che le iene, poiché ogni anno mutano natura, diventino ora maschi ora femmine. Una iena vide una volpe e la rimproverò di non accettarla, pur volendo lei diventare sua amica. Quella allora rispose: «Non irritarti con me, ma con la tua natura: a causa di questa, infatti, non so se trattarti come un amico o come un’amica». La favola riguarda gli uomini ambigui.
Indovino L’arte divinatoria è molto diffusa nell’antichità e, nella favola come in altri contesti letterari, emergono celebri figure di indovini, come Cassandra o Tiresia. In generale, il dono di quest’arte si trasmette per via ereditaria. Sono attestate diverse tecniche: esterne, come l’osservazione del cielo (aeromanzia), del volo di uccelli (ornitomanzia), del fuoco (empiromanzia), dei visceri delle vittime dei sacrifici (ieroscopia); interne, quando la volontà divina viene comunicata direttamente all’uomo, tramite sogni (oniromanzia) o attraverso le ombre dei morti (necromanzia). La figura dell’indovino talora sfuma in quella del mago. Di qui una confusione terminologica e concettuale, spesso declinata in chiave sarcastica, presente in varie fonti. Così ad esempio, Tiresia, il celebre indovino protagonista anche della favola 110 Ch. (v. TIRESIA), nell’Edipo re di Sofocle (vv. 387 ss.) è definito polemicamente da Edipo stregone (µάγoς), ciarlatano (ἀγύρτης: il termine usato per indicare i sacerdoti mendicanti) e appunto indovino (µάντις). Si tratta esattamente dei termini impiegati nelle favole della maga e dell’indovino (Esopo 233 Ch.), a cui si aggiunge quello che designa le figure, spesso screditate, dei sacerdoti mendicanti (v. MENAGIRTI). Se nella favola 110 Ch. Tiresia è impegnato nell’ornitomanzia, nella favola 233 Ch. non emerge chiaramente la tecnica utilizzata dall’indovino, che comunque non sa badare a se stesso. In un mondo disincantato, che vive un cupo pragmatismo, indovino non può che essere, in ultima analisi, sinonimo di ciarlatano. E la sua condanna o il suo fallimento sono una conferma rassicurante per l’equilibrio sociale. Il discredito per la figura degli indovini (anche il termine usato, hariolus, ha spesso una connotazione dispregiativa) si ritrova in Fedro (3,3), dove il disaccordo nell’interpretazione di un fatto straordinario induce alla morale secondo cui chi ha
esperienza interpreta con maggiore prontezza i fatti rispetto agli indovini. L’indovino Esopo 233 Ch. Un indovino si mise in piazza ottenendo enormi guadagni. All’improvviso venne da lui un tale e gli comunicò che le porte della sua abitazione erano state aperte e tutto quanto c’era all’interno era stato sottratto: allora, sconvolto, l’indovino si alzò e gridando corse ad accertarsi dell’accaduto. Uno dei presenti, vedendolo, disse: «Carissimo, proprio tu, che ti vanti di prevedere i fatti degli altri, non sei riuscito a indovinare i tuoi?». Si potrebbe riferire questa favola a quegli uomini che regolano la propria vita in modo sciocco e si danno pensiero di quanto non compete loro. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 234. Si è supposta una trasposizione favolistica di un frammentario aneddoto archilocheo, relativo all’indovino Batusiade (cfr. Adrados 2003, 227: quinto epodo). Cfr. inoltre le possibili allusioni di Senofonte, Simposio 4,5 e Aristide, Orazioni 3,611. Esopo e il paesano Fedro 3,3 Chi è esperto, è più rapido nel capire di un indovino. Lo dicono tutti senza spiegarne il motivo, che ora sarà reso noto, per la prima volta, dalla mia favoletta. A un tale che possedeva delle greggi, le pecore generarono agnelli dalla testa umana.
Atterrito da questo prodigioso evento, l’uomo si precipita sgomento a consultare gli indovini. Uno risponde che il fatto riguarda la testa del padrone e occorre allontanare il pericolo con un sacrificio. Un altro invece afferma che la moglie è un’adultera e che l’evento significa che i figli sono di altri, ma è possibile un’espiazione con una vittima più grande. Perché aggiungere altro? Danno pareri discordanti e accrescono la preoccupazione dell’uomo con una preoccupazione ancora maggiore. Era presente lì Esopo, vecchio dal fiuto eccellente, che la natura non riuscì mai a ingannare; e sentenziò: «Paesano, – disse – se vuoi scongiurare il fatto prodigioso, dai moglie ai tuoi pastori». RIFERIMENTI: cfr. Plutarco, Il convito dei sette sapienti 149c-e (protagonista qui è il filosofo Talete e al posto delle pecore si trovano i cavalli). PROVERBI Usu peritus hariolo velocior Chi è esperto, è più rapido nel capire di un indovino Già Fedro (3,3,1) segnala questa frase come proverbiale. La sentenza ha una lunga fortuna e sopravvive anche in età medievale (cfr. Tosi 1991, 180, che tuttavia legge veracior, «più fededegno», anziché velocior, «più rapido», come invece fanno Müller e altri editori e come è attestato anche in ambito medievale).
Inganno Dolus (l’inganno) è figlio di Etere e della Terra, da cui, secondo una certa tradizione attestata nei Miti di Igino (Prologo), nacquero anche la Menzogna, la Vendetta, il Lutto e altri demoni che portano il male all’uomo. In una favola di Fedro (Fedro, App. 4 [5]), Inganno è preso a bottega da Prometeo: cerca di imitare la statua della Verità, ma finisce per produrre la Menzogna (v. Verità).
Iride Figlia di Taumante e di Elettra, ha la funzione di messaggera degli dei. Viene rappresentata come personificazione dell’arcobaleno. Proprio nelle sue consuete vesti di messaggera, Iride (definita «scintillante») compare in una delle versioni della favola che vede protagonista il gracchio alle prese con una gara di bellezza dall’infelice esito: Babrio (72), impreziosendo la narrazione, introduce la messaggera degli dei all’inizio della favola.
Issione Figlio del re dei Lapiti Flegia, padre di Piritoo, Issione sposa Dia, ma getta in una fornace il suocero Deioneo quando questi gli chiede i ricchi doni nuziali che gli aveva promesso. Riscattato da Zeus, che lo invita anche alla mensa degli dei, viene tuttavia castigato perché dimostra assai poca gratitudine e cerca perfino di violentare Era. Viene così legato a una ruota infuocata destinata a girare in eterno. Proprio questa immagine si trova in apertura di una anomala narrazione di Fedro (App. 5 [7]), in cui il favolista specifica che la vicenda di Issione insegna quanto sia volubile la fortuna. Segue la descrizione dei celebri dannati del mito, che caratterizzano una favola dai risvolti etici (cfr. TANTALO), interpretati in chiave allegorica. L’autore Fedro, App. 5 [7] Bisogna valutare il significato, non le parole La narrazione secondo cui Issione è fatto girare su una ruota ci insegna che la Fortuna è volubile e muta. Sisifo, che spinge sugli alti monti la pietra con un grande sforzo e poi dalla vetta volge giù, vanificando sempre il suo sudore, mostra che la miseria degli uomini è senza fine. La storia secondo cui Tantalo, stando in mezzo al fiume, ha sete, raffigurerà gli avari, intorno a cui scorrono i beni da godere senza che loro possano toccare nulla. Le scellerate Danaidi portano nelle anfore acqua, senza poter riempire le botti forate; insomma, ciò che avrai concesso al piacere scivolerà via. Disteso per nove iugeri, Tizio offre a una pena logorante il fegato che ogni volta si rinnova; questa vicenda mostra che
quanto maggiore è l’estensione della terra che si possiede, tanto più gravi sono gli affanni da cui si è colpiti. Ben a proposito la verità fu velata dagli antichi, affinché il saggio la capisse, l’ignorante andasse fuori strada. NOTA: lo iugero è un’unità di superficie agraria romana che equivale a 0,252 ettari.
L
Leone Nel mondo antico, il leone è simbolo di coraggio, forza, nobiltà e regalità. La sua presenza in Europa, se è attestata in epoca preistorica, rimane incerta in epoca storica. A partire da Erodoto (7,25), disponiamo di numerose fonti che ne suggeriscono l’esistenza nel territorio greco, in particolare in Macedonia, Tracia e Tessaglia, ma, oltre ai dubbi sulla fondatezza di tali segnalazioni, resta il fatto che nessun autore dichiara di avere fatto esperienza diretta di questo animale. Il diffuso motivo del leone nell’arte greca e cretese potrebbe, in realtà, essere di influsso orientale, anche se non è escluso che se ne conservi memoria da tempi remoti (cfr. Pugliarello 1973, 89 ss.). A Roma l’importazione di questi animali, assenti in Italia in epoca preistorica, è attestata già nel II secolo a.C., soprattutto in relazione ai giochi del circo (cfr. Plinio, Naturalis historia 8,53 s.). L’immagine del leone è ampiamente utilizzata nei poemi omerici: in particolare, nell’Iliade la superiorità dell’animale va a rappresentare eroi quali Aiace, Odisseo e Agamennone. Siamo ancora lontani dal diffuso simbolismo legato alla clemenza, secondo cui il leone è magnanimo e risparmia gli animali stesi al suolo (cfr., tra gli altri, Plinio, Naturalis historia 8,48). In gran parte del mondo antico, il leone è contiguo alla divinità o ne è immagine (cfr. Maspero 190). In India, Indra, il sovrano degli dei, è rappresentato anche sotto forma di leone; il fabbro celeste Tvashttar (equivalente a Efesto-Vulcano, nella nostra tradizione) è raffigurato come un leone verso cui sono rivolti il cielo e la terra. In Egitto, inoltre, il leone è considerato animale solare e rappresenta Ra (la testa da leonessa è propria delle dee Bastet e Sekhmet). Proprio in relazione alla simbologia solare del rinnovamento, nella tradizione cristiana l’animale diventa simbolo della resurrezione di Cristo, sebbene gli siano attribuiti anche significati meno positivi. In Grecia, il leone è
sacro ad Apollo; l’animale compare anche insieme a Dioniso (Bacco), raffigurato alla guida di un cocchio di leoni o con al fianco un leone o in groppa alla belva; e al fianco di Eros (cfr. Luciano, Dialoghi degli dei 12). In tutto il bacino del Mediterraneo, l’animale appare inoltre «strettamente connesso con la dea madre» (Pugliarello 1973, 93). In Oriente e in Grecia il leone è simbolo di re ed eroi e la sua immagine è motivo ornamentale dei troni dei sovrani (come quello di ramesse II nell’antico Egitto). Isidoro di Siviglia (Etimologie 12, 2, 3) esplicita questo legame, sostenendo che in greco e in latino «leone» significa re, dal momento che è il primo tra tutti gli animali. Prerogativa dei sovrani è la caccia al leone (la pratica anche Alessandro Magno nella regione di Bazaira, insieme ai suoi ufficiali: cfr. Curzio Rufo 8,1). La prima fatica di Eracle vede l’eroe sconfiggere il leone Nemeo (cfr. Teocrito 25) e ricoprirsi della sua pelle, secondo un uso di forte significato simbolico. Forse la vicenda dell’eroe va posta in relazione con il motivo orientale della sfida tra divinità e belve (cfr. Keller 1909, 36 ss.). Altri miti simili si inseriscono in un’ottica sacrale: Cadmo, fratello di Europa, combatte rivestito dalla pelle di un leone (Ovidio, Metamorfosi 3, 52-53; 81). Il tema del rivestirsi con la pelle del leone penetra, con accenti comici, anche nella favolistica (v. ASINO e proverbi sotto), dove è narrato il tentativo di primeggiare dell’ultimo di una comunità, che tuttavia alla fine viene smascherato. La favola, insomma, «ha operato la dissacrazione di un motivo che nel mito conserva la sua validità» (cfr. Pugliarello 1973, 93). In generale, al leone sembra applicabile anche in altri casi il meccanismo, evidenziato dalla stessa studiosa, secondo cui il «re degli animali» decade al rango di buffone, come accade al coyote nelle narrazioni della tradizione degli indigeni dell’America settentrionale: questa trasformazione dipende dai mutamenti del contesto economico e sociale, in cui l’animale perde il suo antico ruolo. Così, ad esempio, troviamo il leone beffato anche nella narrazione, dai caratteri fiabeschi, del leone innamorato della figlia di un
contadino: il padre è disposto a concedergliela solo dopo che l’animale si sia strappato denti e artigli; ma il leone, dopo che si ritrova volontariamente disarmato, viene cacciato a bastonate (Esopo 198 Ch.). L’animale è inoltre beffato dalla minuscola zanzara (Esopo 188 Ch.), teme il piccolo gallo (Esopo 210; 269 Ch.: v. GALLO), vergognandosene, e appare goffo e incapace di tendere un inganno al toro (Esopo 211 Ch.). In generale, tuttavia, l’animale (molto più presente in Esopo che in Fedro, in cui sono solo cinque le favole che lo vedono protagonista, e amato da Aviano, che talora lo sostituisce al lupo) conferma le sue note caratteristiche, peraltro non sempre positive. Innanzitutto si segnala per il coraggio ed è l’unico animale pronto a sfidare l’uomo (Esopo 338 Ch.), che spesso ne ha terrore, come il bovaro di Esopo 74 Ch.; il leone appare prepotente (Esopo 209 Ch.), feroce e spietato e, tra le sue vittime designate, ci sono soprattutto gli inermi cervi (199 Ch.), i buoi (71 Ch.), le lepri (204 Ch.), le pecore (227 Ch.: in questo caso ne strappa una al temibile lupo, affermando così la sua inequivocabile superiorità), ma non mancano altri animali, meno ricorrenti nella favolistica, come l’onagro di Sintipa 30. La sua regalità è esplicitamente sottolineata in diverse narrazioni: viene descritto come un sovrano mite e giusto (Esopo 195 Ch.), anche se non sempre riesce a tenere fede ai suoi propositi, lasciando alla fine riemergere la sua natura spietata (Romulus 70). Il suo mondo è quello terrestre, nettamente separato dagli altri, con cui i contatti sono solo occasionali: il leone vuole stringere un patto con il delfino, sovrano dei mari (Esopo 202 Ch.), e riceve una proposta di alleanza da parte dell’aquila, regina dei cieli (Babrio 99). La sua corte vede spesso la presenza della volpe in qualità di consigliera o di primo ministro, anche se talvolta essa non gli dimostra piena fedeltà (Esopo 199 Ch.). Se il leone rappresenta la forza, la volpe è simbolo dell’astuzia, le principali forze che regolano la società esopica, ora integrandosi ora contrapponendosi. Talvolta il leone emerge per le sue qualità intellettuali: grazie alla sua capacità dialettica, divide le vittime e le
divora (Esopo 71 Ch.), risponde argutamente a un uomo (Esopo 59 Ch.) o ad altri animali: la leonessa ammette di generare un solo figlio, «ma leone» (Esopo 194 Ch.). Questa e altre narrazioni favolistiche trovano significativi riscontri con spunti presenti in generi letterari diversi. Erodoto (3,108) riprende la leggenda secondo cui la leonessa genera un solo figlio perché, nel parto, espellerebbe anche l’utero. Ma Aristotele rifiuta la credenza, ritenendola infondata (Historia animalium 579b). Lo stesso Aristotele (611a) spiega che i torelli, se si allontano dalla mandria, diventano vittima delle bestie feroci: in Esopo 71 Ch. (ma cfr. soprattutto Aviano 18, dove si parla di giovenchi) troviamo descritta questa situazione, in cui i buoi sono preda del leone, sulla base della morale del divide et impera. Anche la celebre narrazione del leone vecchio e morente, che ritroviamo in due varianti principali (Fedro 1,21; Esopo 196 Ch.), sembra fondarsi sulla constatazione che il leone vive a lungo, ma da vecchio perde i denti (Aristotele, Historia animalium 629b) e quindi non può più azzannare le prede. Persino in un genere antitetico come quello epico si ritrova una situazione simile a quella di una favola (Esopo 203 Ch.); nell’Iliade (16,821 ss.), infatti, un leone e un cinghiale arrivano a una sorgente ed entrano in competizione. Questo tema del conflitto tra i due animali, rappresentato anche da artisti già in epoca arcaica, a livello simbolico può raffigurare l’opposizione tra luce e tenebre, tra bene e male (lo stesso accade per la lotta tra leone e serpente). Un altro racconto che trova spunto fuori dal contesto strettamente esopico è quello narrato da Eschilo (Agamennone 717 ss.): il cucciolo di leone allevato in casa dapprima appare innocuo, ma, quando cresce, rivela la sua natura spietata. Tale vicenda potrebbe essere alla base di Esopo 133 Ch. (narrazione simile, ma qui i protagonisti sono alcuni lupacchiotti) e 197 Ch. (per il proverbio collegato, v. CONTADINO). Questi dati testimoniano la forte caratterizzazione delle immagini che vedono il leone protagonista; per lo stesso motivo, numerose favole trovano
significativi riscontri in proverbi concettualmente affini (v. sotto). Il rapporto con l’uomo non è necessariamente fondato sul conflitto: il leone, confermando la diffusa convinzione circa la sua mitezza quando non è affamato (Aristotele, Historia animalium 488b), si dimostra generoso con l’innocuo viandante (Fedro 2,1) e mostra la sua gratitudine nei confronti di chi gli reca benefici (come nella vicenda di Androclo narrata da Eliano, De natura animalium 7,48, che ha ispirato anche George Bernard Shaw). Come si può notare da questa breve rassegna, lo schema narrativo più diffuso nelle favole dedicate al leone è quello fondato sull’opposizione di due personaggi, da cui deriva il sarcasmo del vincitore o il lamento dello sconfitto. Spesso, sulla base di questo schema narrativo, il leone spicca tra i principali protagonisti di altre tradizioni favolistiche antiche. Nell’ambito dei proverbi sumerici, il componimento 55 della V collezione secondo Gordon è quello strutturalmente più vicino alla favola greca: si basa sul dialogo, sul conflitto «morale» e sulla replica finale: una capra riesce astutamente a ingannare un leone (v. CAPRA). La favola ricorda Esopo 184 Ch. La quinta collezione di proverbi sumerici (cfr. Gordon 1958, 48 ss.) presenta diversi testi dedicati al leone (dal 56 al 65): questo gruppo di componimenti è preceduto dall’appellativo «somma belva» o «enorme belva» e mostra l’animale nella duplice veste di predatore, di ingannatore, ma anche di vittima di inganni. Anche nella tradizione indiana del Pañcatantra si riscontrano diverse favole che vedono il leone protagonista. Nel racconto sesto del primo tantra, viene descritto come «re delle fiere»: per placare il suo istinto distruttore, i sudditi propongono di offrirgli in pasto un animale ogni giorno, a patto che plachi la sua furia. Ma, quando arriva il turno della lepre, il piccolo e astuto animale dice al leone che esiste nella foresta un suo simile e lo conduce a una cisterna d’acqua, dove il sovrano annega scagliandosi contro la sua immagine riflessa nell’acqua. Nel Pañcatantra non mancano inoltre motivi simili a quelli greci. Ricorrente il tema del leone malato, circondato dalla sua
corte, che con l’astuzia gli procura una vittima (primo tantra, racconto nono). Ma la narrazione che ricorda più da vicino Esopo 199 Ch., dove una volpe raggira per due volte un cervo, portandolo in pasto al suo signore, è il secondo racconto del quarto tantra: uno sciacallo porta con l’inganno un asino dal leone malato, che però in un primo tempo non riesce a farlo suo; allora lo sciacallo lo riconduce una seconda volta e la missione va a buon fine, ma l’assistente del leone con un’astuzia sottrae sia il cuore sia le orecchie. Come accade in altre narrazioni del Pañcatantra, un animale può essere sostituito da altri di valore simbolico equivalente, anche se lo schema narrativo rimane simile a quello della favola greca: l’asino, rivestito da un lavandaio con la pelle non di un leone ma di una pantera (secondo alcune versioni, di una tigre), finisce per andare incontro a un destino infausto (terzo tantra, primo racconto; cfr. Esopo 267; 279 Ch.; v. anche ASINO). Il sacerdote di Cibele e il leone Simonide, Antologia Palatina 6,217 Un sacerdote di Cibele si rifugiò all’interno di una grotta deserta, in cerca di riparo da una nevosa tempesta invernale. Appena l’uomo asciugò l’acqua dai capelli, un leone vorace, che seguiva le sue tracce, irruppe all’ingresso della grotta. Il sacerdote, però, aveva un grande timpano: lo percosse con il palmo della mano e la caverna risuonò rumorosamente. Il selvaggio animale non riuscì a sopportare il sacro fragore della dea Cibele, per cui corse rapidamente sulle montagne boscose, terrorizzato da questo ministro effeminato della dea, che perciò appese come offerta a Rea i vestiti e le bionde ciocche di capelli. RIFERIMENTI: cfr. altri componimenti del libro
sesto dell’Antologia Palatina: 218 (Alceo di Messene), 219 (Antipatro di Sidone), 220 (Dioscoride), 237 (Antistio). La volpe e il leone a caccia Aftonio 20 Favola della volpe che esorta a non puntare troppo in alto Una volpe viveva insieme a un leone, comportandosi come se fosse al suo servizio. La volpe scovava la preda, mentre il leone sferrava l’attacco e la catturava; quindi, a ognuno, secondo i meriti, era assegnata una parte. La volpe, tuttavia, invidiosa perché al leone spettava una ben più consistente porzione di cibo, decise di andare a caccia da sola anziché indicare le prede al leone. Mentre tentava di arraffare qualcosa da un gregge, finì però prima per essere preda dei cacciatori. È preferibile servire in sicurezza che comandare tra i pericoli. Il leone e il pastore Eliano, De natura animalium 7,48 Uno schiavo chiamato Androclo (non so dire quale ne era la colpa né l’età) fuggì di nascosto dal suo padrone, che era un membro del Senato romano. Raggiunse la Libia: evitava le città e, come dice il proverbio, «segnava i loro luoghi solo con le stelle»; così proseguì fino al deserto. Quindi, afflitto dai forti e ardenti raggi solari, trovò gradito riparo nell’antro di una roccia e qui si riposava. Ma quel luogo era in realtà la tana di un leone. La belva ritornò allora
dalla caccia trafitta in una zampa da una terribile spina ed era sofferente: quando s’imbatté nel giovane, gli offrì uno sguardo amichevole e cominciò a dimenare la coda; inoltre, gli allungò la zampa, supplicandolo in tutti i modi possibili di tirargli via la spina. In un primo momento, l’uomo fu colto dallo spavento. Poi, quando vide che la belva aveva un atteggiamento amichevole e si rese conto che aveva dolore a una zampa, estrasse la spina, liberandola dalla sofferenza. Soddisfatto per il rimedio, il leone ospitò Androclo, considerandolo ospite e amico e mettendo in comune le prede di caccia. Il leone, secondo il costume della sua specie, mangiava carne cruda, mentre l’uomo la cuoceva. Godevano, insomma, di una tavola comune, ciascuno secondo la sua natura. Androclo visse in questo modo per tre anni. Quindi, cresciuta enormemente la chioma, afflitto da un forte prurito, lasciò il leone e si diede all’avventura, seguendo il suo destino. Lo arrestarono mentre errava in giro e lo sottoposero a un interrogatorio per sapere di dove fosse originario; quindi, lo rimandarono in catene a Roma dal suo padrone. Questi, ritenendosi danneggiato, accusò lo schiavo, che venne condannato a essere dato in pasto alle fiere. Per caso anche quel leone libico venne catturato dai cacciatori e quindi condotto nell’arena, come quel giovane condannato a morte, che era stato suo amico e commensale. L’uomo non riconobbe l’animale, ma il leone identificò immediatamente Androclo, gli fece festa muovendo la coda e, piegandosi, si gettò ai suoi piedi. Allora, sia pure in ritardo, anche Androclo riconobbe il suo ospite e lo abbracciò salutandolo con trasporto, come si fa con un amico di ritorno da un viaggio in terre lontane. Poiché l’uomo diede l’impressione di essere un mago, entrò nell’arena anche un leopardo, che si scagliò contro di lui, ma il leone, ricordandosi della
condivisione della mensa con Androclo, difese colui che un tempo lo aveva guarito e fece a pezzi il leopardo. Ovviamente il pubblico viene colto di sorpresa dall’accaduto; l’impresario del circo chiama Androclo e apprende tutta la vicenda. La voce si diffonde attraverso la folla e il popolo, venuto a sapere la verità, chiede a gran voce che ad Androclo e al leone sia accordata la libertà. RIFERIMENTI: Romulus 51; Gellio 5,14. Cfr. Seneca, De beneficiis 2,19,1. La volpe, il lupo e il leone Babrio 101 Un lupo era diventato così grosso rispetto ai suoi simili che cominciarono a chiamarlo «leone». Lo sciocco non fu appagato dalla fama, così lasciò i lupi, cominciando a frequentare i leoni. Una volpe si prese gioco di lui e disse: «Che io non mi inorgoglisca mai tanto quanto tu ora sei superbo, poiché puoi apparire davvero come un leone tra i lupi, ma, confrontato con i leoni, torni a essere un lupo». L’uomo e il leone compagni di viaggio Esopo 59 Ch. Una volta un leone stava affrontando un viaggio con un uomo. Ciascuno dei due faceva discorsi per vantarsi. Lungo il percorso apparve una stele di pietra che presentava un uomo mentre strangolava un leone. Allora l’uomo la mostrò all’animale e gli disse: «Vedi come noi siamo più forti di voi?». Il
leone, accennando a un sorriso, rispose: «Se i leoni sapessero realizzare sculture, vedresti molti uomini sopraffatti da un leone». Molti si gloriano a parole di essere valorosi e pieni di coraggio, mentre, messi alla prova, vengono smentiti e smascherati. RIFERIMENTI: Pseudo-Dositeo 15 (l’unico caso in cui viene stabilita la vittoria finale dell’uomo: qui il narratore interno è lo stesso Esopo); Aftonio 34; Aviano 24; Parafrasi 59; Dodecasillabi 59; Tetrastici 1,1; Romulus 91. Cfr. anche gli scoli a Euripide, Medea 424. In Senofane (21 B 15 D.-K.) si trova un riferimento accostabile alla favola: «Ma se buoi, cavalli e leoni avessero mani e fossero in grado di disegnare…»: il senso però va in direzione differente (gli animali rappresenterebbero gli dei simili a se stessi). Il regno del leone Esopo 195 Ch. Un leone non collerico, né malvagio, né violento, ma mite e giusto come un uomo, divenne re. Sotto il suo regno si tenne un’assemblea di tutti gli animali, perché dessero e ricevessero giustizia reciprocamente: il lupo con la pecora, la pantera con la capra selvatica, la tigre con il cervo, il cane con la lepre. La timida lepre allora disse: «Io mi sono vivamente augurata di vedere questo giorno, in cui i deboli potessero apparire temibili per i potenti». Quando c’è giustizia in uno Stato e tutti i giudizi sono equi, anche gli umili vivono in tranquillità. RIFERIMENTI: Babrio 102; Parafrasi 196.
Il leone invecchiato e la volpe Esopo 196 Ch. Un leone, che era ormai diventato vecchio e non riusciva più a procurarsi il cibo con la forza, comprese che avrebbe dovuto agire con l’astuzia. Allora entrò in una grotta e qui si sdraiò, facendo finta di essere malato; e così catturava e mangiava tutti gli animali che giungevano da lui a fargli visita. Dopo che molte bestie vennero così divorate, una volpe, che aveva capito la sua malizia, si recò da lui e, stando lontano dalla grotta, gli chiese come stava. Il leone rispose: «Male». E quando le domandò per quale motivo non entrasse, la volpe disse: «Sarei entrata, se non avessi visto le impronte di molti che entrano, di nessuno che esce». Così gli uomini saggi riescono a capire prima da qualche segnale i pericoli e li evitano. RIFERIMENTI: Babrio 103; Pseudo-Dositeo 6; Tavolette Assend. 8; Aftonio 8; Sintipa 37; Parafrasi 197; Dodecasillabi 197; Tetrastici 2,2; Romulus 86; Temistio, Orazioni 13,174c; Lucilio, frr. 980 ss. Marx; Filostrato, Vita di Apollonio 7,30; tra le numerose allusioni, le più note sono quelle di Platone, Alcibiade I 1,123a, Orazio, Epistole 1,1,70 ss. (ripreso da Quintiliano 5,11,20), Seneca, La vita contemplativa 1,3, Plutarco, Il progresso nella virtù 79a, Teognide 293 s. (quest’ultima più controversa). Per ulteriori riferimenti, cfr. Adrados 2003, 194 ss., che suggerisce anche paralleli con la tradizione orientale. PROVERBI Ὄπoυ γὰρ ἡ λεoντῆ µὴ ἐϕικνεῖται, πρoσραπτέoν
ἐκεῖ τὴν ἀλωπεκῆν Quando la pelle del leone non è sufficiente, è tempo di cucirsi addosso quella della volpe Plutarco attribuisce questa espressione di natura proverbiale al generale Lisandro (Lisandro 7,6; Apoftegmi di re e generali 190e; Apoftegmi spartani 229b): si può combattere con la forza, come il leone o con l’astuzia, come la volpe. Le due qualità caratterizzano le dinamiche del mondo esopico, ma hanno anche una lunga fortuna al di fuori di esso. Il proverbio, puntualmente registrato dai paremiografi (cfr. Tosi 1991, 118 per questi e altri riferimenti sul tema) si ritrova anche nella didascalia di una favola di Fedro (App. 23 [25]: Ubi leonis pellis deficit, vulpinam induendam esse) e può essere riferito al motivo della pelle del leone (Esopo 267; 279 Ch.). Larga fortuna anche nelle epoche successive per questa simbologia che si ritrova nell’ambito del Principe (18) di Machiavelli. In propria non pelle quiessem (v. RANA: Inflat tamquam rana). Ἔνα... ἀλλὰ λέoντα Uno... ma leone! L’espressione, che appare chiaramente di natura proverbiale, si ricollega alla favola esopica 194 Ch.: la leonessa, orgogliosa, così replica alla volpe che la deride per la sua limitata prolificità. Tosi 1991, 558 s. ricorda detti affini anche di epoca recente, come Meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora, che si fonda sul concetto affine dello straordinario valore del leone. Γῆρας λέoντoς κρεῖσσoν ἀκµαίων νεβρῶν Il leone anziano è più forte dei cerbiatti giovani Come spiega Tosi 1991, 309, il proverbio, di incerta attribuzione (potrebbe essere un frammento dell’enigmatico autore tragico Ippotoonte: 5 Snell), riportato anche dal paremiografo Apostolio (5,41), suggerisce l’idea che i forti, anche da vecchi, risultino superiori agli imbelli nel pieno del
vigore. Potrebbe ricollegarsi – anche se manca la dialettica giovinezza-vecchiaia – alla favola esopica 199 Ch., in cui il leone, ammalato, riesce, grazie all’astuto contributo della volpe, a uccidere un grande cervo. Barbam vellere mortuo leoni Strappare la barba al leone morto Quando un potente cade, spesso viene sbeffeggiato. Questa espressione di Marziale (10,90,10), che ne riprende altre affini (come il più sintetico detto «Strappare la barba»: cfr. Orazio, Satire 1,3,133), indica tale mancanza di rispetto. Il contrasto tra la grande potenza dell’animale vivo e la sua totale vulnerabilità dopo la morte è ben rappresentata nella favola 19 di Sintipa, in cui i cani lacerano la pelle del leone morto, mentre – nota la volpe – se fosse vivo, l’esito sarebbe differente; nella morale si fa riferimento a «coloro che disprezzano un uomo importante, una volta caduto dalla sua posizione di potere e di fama». Esistono altre espressioni proverbiali che presentano una certa affinità concettuale, come «Calpestare chi è a terra» (Ovidio, Ibis 29). Come nota Otto 190, il proverbio trae probabilmente origine dalla tradizione favolistica. Va sottolineata, oltre alla citata narrazione di Sintipa, anche la favola 1,21 di Fedro: tutti gli animali, anche l’asino, aggrediscono il leone vecchio e senza forze. Societas leonina La società col leone L’origine di questa espressione proverbiale, propria dell’ambito giuridico romano, va probabilmente ricercata in una favola di Fedro (1,5), che si apre con il promitio: «Non ci si può mai fidare dell’alleanza con un potente» (cfr. anche Esopo 207; 209 Ch.). Il leone va a caccia con altri animali, ma, quando giunge il momento di spartire il bottino, con prepotenza tiene tutto per sé. L’origine della locuzione è spiegata da Guarino (72 ss.): con Societas leonina «viene denominata usualmente, da secoli, quella specie di società in cui uno dei soci ha diritto a prendersi tutto il guadagno, mentre il consocio o i consoci si caricano di tutte le perdite.
Non v’è alcun costrutto a mettere su una società di questo tipo, e appunto perciò la società leonina è invalida». L’espressione, che non sembra di larga diffusione tra i giureconsulti romani, è riportata da Ulpiano (17,2,29,2), che la riferisce a Cassio Longino. Vestigia terrent Mi atterriscono le orme L’espressione oraziana (Epistole 1,1,70 ss.) è chiaramente proverbiale e si riferisce alla favola di Esopo 196 Ch.: il leone si finge malato per poter divorare gli altri animali; ma la volpe, astuta, non entra nella caverna, perché vede solo orme in entrata. Orazio qui si identifica con la volpe, che non accoglie le lusinghe del temibile leone (il popolo). Si tratta di un invito alla cautela e di un’esortazione a valutare tempestivamente i possibili rischi di un’azione. Lo stesso motivo si ritrova anche in Platone, Alcibiade I 123a e Lucilio, frr. 980 ss. Marx. Esurienti leoni ex ore exculpere praedam Strappare la preda dalla bocca del leone affamato Secondo Otto 189, questa immagine di paternità luciliana (fr. 286 Marx: il testimone è Nonio), potrebbe derivare dalle favole. Il senso è chiaro: viene suggerita l’idea di un’azione rischiosa, che richiede molto coraggio. Anche se è difficile l’identificazione con una delle narrazioni superstiti, alcune immagini, come quella del leone affamato, sono caratteristiche della tradizione esopica. Secondo Della Corte 1986, 88, qui non si potrebbe supporre il riferimento a una favola, perché sembra piuttosto presupposto il proverbio plautino (v. AGNELLO) «Vogliono strappare l’agnello a un lupo» (Poenulus 776).
Leopardo Leopardo e pantera tendono a confondersi nella terminologia degli antichi (v. PANTERA). Questo animale viene accostato a orsi, lupi, leoni per i poderosi artigli e per le zanne affilate (Eliano, De natura animalium 1,31). Inoltre, il leopardo è spesso associato a Dioniso e si distingue per l’aggressività, oltre che per l’astuzia nel trarre in inganno gli altri animali, anche attraverso il suo profumo (5,40; 54). D’altra parte, l’aspetto che emerge nella favolistica, nell’ambito dell’unica narrazione dedicata a questo animale, è il variegato pelame (Esopo 37 Ch.), peraltro descritto, con particolare ammirazione anche da altri autori (cfr. Plinio, Naturalis historia 18,62-63, che, riferendosi genericamente alle pantere, parla di macchie di piccole dimensioni, dalla forma di occhi, su sfondo bianco). In questo caso, la vanità della belva soccombe rispetto al primato intellettuale della volpe. Si tratta di una favola di impronta cinica. Interessante la rielaborazione di Aviano (40), dove compare anche il leone come termine di paragone del leopardo. L’animale è descritto qui come privo di capacità critica e conferma il conflitto tra apparire ed essere su cui si fonda il motivo favolistico. Nella favola esopica 199 Ch. il leopardo (o pantera: la terminologia, come detto, è generica, e in questo caso lascia aperte entrambe le interpretazioni) è descritto come «irascibile» e perciò indegno di succedere al leone quale re degli animali. La sua vittima designata sembra la capra selvatica (cfr. Esopo 195 Ch.), come peraltro si riscontra anche in altre tradizioni culturali (cfr. Isaia 11,6-9). La volpe e il leopardo Esopo 37 Ch. Una
volpe
e
un
leopardo
discutevano
animatamente su chi fosse più bello. Dal momento che il leopardo continuava a vantare la varietà del suo pelame, la volpe replicò: «Quanto sono più bella io di te che non ho vario il corpo, ma la mente!». La favola dimostra che le qualità intellettuali superano la bellezza del corpo. RIFERIMENTI: Aviano 40; Parafrasi 37; Tetrastici 2,16; Plutarco, Se siano peggiori le affezioni del corpo o dell’anima 500c-d; Il convito dei sette sapienti 155b-c. (cfr. anche Diogene, Pordalis).
Lepre In diverse culture le lepri, legate alle divinità lunari, sono considerate simbolo di fertilità, timidezza, agilità, ingegnosità (cfr. Cooper 203). Nella cultura greco-romana vanno a essere attributo di Afrodite (Venere) e di Eros. Già a partire da Omero (Iliade 10,360 ss.), la lepre è segnalata come una delle prede di caccia privilegiate dall’uomo, che si avvale della collaborazione dei cani. Questo animale è tanto apprezzato sul piano gastronomico che a Roma viene allevato in un luogo ad hoc: il leporarium. La condizione di preda, che generalmente segna la vita della lepre, si gioca anche su piani differenti: talora il termine «lepre» è impiegato per designare una persona fatta oggetto di desiderio sessuale (così, ad esempio, il soldato Trasone si rivolge a un giovane nell’Eunuco di Terenzio, v. 426). In considerazione della sua difficile esistenza, in perenne fuga, la lepre va a designare gli uomini vili (cfr. Demostene, Per la corona 263). Tra le curiose osservazioni sulla lepre, da segnalare anche la convinzione che sia l’animale più peloso in assoluto (Plinio, Naturalis historia 11,230); l’attributo del pelo torna, tra l’altro, in alcune favole. La lepre ha un ruolo importante nell’arte divinatoria: le due aquile che uccidono la lepre pregna consentono all’indovino Calcante di profetizzare la presa di Troia, ma anche i pericoli e la collera di Artemide, pietosa nei confronti della bestiola (cfr. Eschilo, Agamennone 109 ss.: questo passo è stato anche incluso da Adrados nel suo repertorio di favole, ma non pare assimilabile alla tecnica esopica). In linea con la consolidata elaborazione culturale che si è descritta, le lepri appartengono ai subalterni nella società esopica e il loro destino è quello di vittime designate: ora costituiscono il pasto della volpe (Esopo 192 Ch.), come spesso è attestato anche da altre fonti (cfr. Eliano, De natura animalium 13,11), ora sono prede del cane (Babrio 69; Esopo
182 Ch.) o del leone (Esopo 204 Ch.), che però ambisce a una preda più ghiotta, ora sono ghermite dall’aquila (Fedro 1,9). Le volpi, opportuniste, rifiutano di allearsi con loro, quando esse sono impegnate nella guerra contro le aquile (Esopo 190 Ch.). Le lepri giungono dunque a tal punto di disperazione, che – fatto inusuale nel mondo animale e nella tradizione esopica, tesa a una disperata sopravvivenza – decidono di suicidarsi, ma quando si rendono conto che esistono animali ancora più vili di loro (le rane, che si tuffano nello stagno al loro arrivo), desistono: la morale mette in evidenza le sfortune degli altri come motivo di consolazione (Esopo 191 Ch.). La vita di questi animali è sempre difficile: solo il regno di un giusto leone può garantire la fine delle prepotenze (Esopo 195 Ch.). L’animale non riesce a spiccare nemmeno in virtù delle sue doti naturali: la velocità della lepre soccombe, in effetti, di fronte all’impegno della lentissima tartaruga, in una favola arricchita anche da un noto proverbio (v. TARTARUGA). Nella favola della lepre e del bifolco (Fedro, App. 26 [28]), l’animale rischia di essere vittima della malafede dell’uomo, che «ha la parola del salvatore e il gesto del carnefice» (Marchesi 1923, 54). In questo caso, il ragionamento conclusivo della lepre, che separa la benevola lingua dai perfidi occhi del bifolco, sembra richiamare una tendenza della favolistica, secondo cui ogni parte del corpo gode di una sua autonomia (cfr., ad esempio, la favola dello stomaco e dei piedi dell’uomo: Esopo 159 Ch.). Da questa favola, tra l’altro, deriva forse un racconto della tradizione della Circassia (cfr. Adrados 2003, 33). In altre tradizioni favolistiche, come quella africana e quella indiana, la lepre pare emergere con un profilo meno negativo, nonostante la sua innegabile debolezza, anzi spesso si distingue per l’astuzia, come nella favola del Pañcatantra che la vede contrapposta all’elefante (v. ELEFANTE). D’altra parte, il suo ruolo di vittima viene confermato quando si rivolge al gatto per dirimere una lite circa l’abitazione sottratta al francolino. Il felino, dotato di sottile ipocrisia, conquista la fiducia dei due, riuscendo alla
fine a divorare entrambi gli animali (terzo tantra, racconto quarto). La lepre e la volpe Esopo 192 Ch. La lepre chiese alla volpe: «Fai realmente molti profitti? Oppure sai spiegarmi perché sei definita abile a profittare?». La volpe rispose: «Se non ci credi, vieni qui. Ti invito a mangiare a casa mia». La lepre la seguì e, una volta entrata nella sua abitazione, vide che la volpe non aveva altro che la lepre da mettere sotto i denti. La lepre disse: «Ho imparato sulla mia pelle da dove deriva il tuo nome: non da “guadagnare”, ma da “ingannare”». Spesso ai curiosi che usano male la loro curiosità capita una grandissima sventura. NOTA: la favola si gioca sul del termine κερδώ, dal doppio valore: «astuto» e «profittatore». RIFERIMENTI: Parafrasi 193. Le lepri e le volpi Esopo 190 Ch. Una volta le lepri, in guerra contro le aquile, esortarono le volpi a diventare loro alleate. Quelle, tuttavia, risposero: «Vi aiuteremmo se non sapessimo chi siete e con chi combattete». La favola mostra che chi si vuole misurare con chi è più forte non si preoccupa della propria salvezza. RIFERIMENTI: Sintipa 22.
Il cane, la lepre e il capraio Babrio 69 Un cane inesperto nella caccia, dopo avere stanato da sotto un cespuglio una lepre dalle zampe pelose, la inseguiva, ma fu superato nella corsa. Allora un capraio, vedendolo, disse: «Un animale più piccolo si è rivelato più veloce di te». Quello rispose: «Correre per catturare qualcuno è una cosa. Per mettersi in salvo, un’altra». RIFERIMENTI: un riferimento si trova in uno scolio a Tucidide (4,92,2). Il cane e la lepre Esopo 182 Ch. Un cane da caccia catturò una lepre e ora la mordicchiava, ora le leccava le labbra. Esasperata, la lepre gli disse: «Mio caro, cessa di mordermi o di baciarmi, perché sappia se tu sei un nemico o un amico». La favola si adatta alle persone ambigue. RIFERIMENTI: Babrio 87; Sintipa 50; Parafrasi 183; Sofocle, fr. 885 R.; Aristofane, Cavalieri 1068 ss.; Demetrio, Sull’elocuzione 261; Luciano, Due volte accusato 33; Zenobio, 4,90. Altri riferimenti in scoli e commenti (v. sotto, proverbio). Il leone e la lepre Esopo 204 Ch.
Un leone, imbattutosi in una lepre addormentata, stava per divorarla. Frattanto vide un cervo che passava da quelle parti, lasciò stare la lepre e si mise a inseguirlo. Allora la lepre a causa del rumore si alzò e fuggì. Il leone, per un bel pezzo, inseguì il cervo e dal momento che non riusciva a prenderlo, tornò indietro dalla lepre, ma trovò che anch’essa era fuggita. «Mi sta proprio bene – disse – visto che ho lasciato la preda che avevo a disposizione e ho preferito inseguire la speranza di una preda più consistente.» Così alcuni tra gli uomini, non accontentandosi di esigui guadagni, inseguono speranze maggiori, senza rendersi conto di perdere quanto hanno tra le mani. La lepre e il bifolco Fedro, App. 26 [28] Molti sono cortesi a parole e sleali nel cuore Una lepre dal rapido piede scappava da un cacciatore e, notata da un bifolco mentre si infilava sotto un cespuglio, disse: «Per gli dei e per tutte le tue speranze, ti scongiuro di non tradirmi, bifolco; non ho mai danneggiato questo tuo campo». Ma il contadino: «Non temere, rimani nascosta, stai tranquilla». Ed ecco che ormai era arrivato il cacciatore che la inseguiva: «Di grazia, bifolco, è forse giunta qui una lepre?». «È arrivata, ma se n’è andata di qua verso sinistra.» E indica la destra con un cenno. Il cacciatore, a causa della fretta, non capì e sparì dallo sguardo. Allora così disse il bifolco: «Non mi sei grata per il fatto che ti ho nascosto?». «Non nego assolutamente la gratitudine nei
confronti della tua lingua e la ringrazio moltissimo, ma vorrei che tu fossi privato dei tuoi perfidi occhi.» RIFERIMENTI: la versione fedriana appare non priva di innovazioni, a partire da un più ampio uso del discorso diretto che vivacizza la narrazione, rispetto a quella esopica, in cui sono protagonisti una volpe e un taglialegna. Cfr. Esopo 34 Ch.; Babrio 50; Romulus 73; Ovidio, Metamorfosi 2,690-706; Massimo di Tiro 32,1 (in questo caso i protagonisti sono un cervo, un leone e un pastore). Le lepri e i leoni Aristotele, Politica 1284a-Antistene fr. 100 Caizzi Aristotele, riflettendo sul fatto che sarebbe ridicolo e non corretto fare leggi per persone di eccezionale levatura, simili a dei fra gli uomini, poiché le leggi valgono solamente tra uguali, osserva che gli uomini superiori «risponderebbero molto probabilmente come fecero i leoni, secondo Antistene, quando le lepri parlarono all’assemblea degli animali, proponendo uguaglianza per tutti». RIFERIMENTI: la risposta dei leoni non è nota, vista l’allusività del riferimento. Ci sono stati tentativi (Camerarius) di integrazione. Cfr. inoltre Plutarco, Lisandro 22,3; Come distinguere l’adulatore dall’amico 71e; Apoftegmi di re e generali 190f; Apoftegmi spartani 212e; 229c. PROVERBI Λήθαργoς κύων Cane sornione
Come spiega Zenobio (4,90), il proverbio si applica alla contemporanea azione di scodinzolare e di mordere di nascosto. Sottolinea, dunque, l’incoerenza del comportamento dell’animale e si ricollega naturalmente a Esopo 182 Ch.: il cane che lecca e morde insieme la lepre (oltre ai passi citati a proposito della favola, v. anche Suda λ 178; σ 171 Adler, e cfr. Van Dijk 1997, 678).
Lucertola Le lucertole colpiscono gli antichi per la vitalità delle loro membra: Eliano (De natura animalium 2,23) osserva che, se si taglia in due parti questo animale, ciascuna di esse continua a vivere e a muoversi separatamente, per poi eventualmente tornare a formare un unico corpo. Sulle lucertole si raccontano aneddoti fantasiosi: addirittura Plinio sostiene che in India ne esistano di lunghe ventiquattro piedi (Naturalis historia 8,141). Poco amato dagli apicoltori, perché insidia gli alveari, questo animale ha una simbologia articolata: da un lato, è emblema di persone di scarso valore ma capaci di fare il male (Artemidoro, Sull’interpretazione dei sogni 4,56); dall’altro, «la lucertola come animale simbolico appare su pietre tombali romane, immagine del sonno della morte e del futuro risveglio (la lucertola che in inverno va sotto terra e in primavera riappare in superficie)»: simbologia ripresa nell’arte cristiana (Maspero 205). Talora sostuisce i serpenti (a cui peraltro è spesso accostata, per alcune caratteristiche come la vitalità della coda: cfr. Aristotele, Historia animalium 508b) nella funzione di custode o genio della casa (Cooper 213). Nella tradizione esopica, la lucertola si confronta proprio con il serpente, risultando inevitabilmente sconfitta, perché, nel tentativo di allungarsi, finisce per spezzarsi (Babrio 41). Si tratta di una favola che ha molte differenti versioni e presenta, in alternativa alla lucertola babriana, anche il verme o la volpe, nelle redazioni esopiche (v. sotto). Si tratta della morale, tipicamente esopica, secondo cui non bisogna imitare chi è di gran lunga superiore, presente anche in altre narrazioni come la nota favola della rana e del bue (cfr. la versione di Fedro 1,24). In un frammento babriano, riportato dalla Suda, si trova poi la favola della lucertola e del ragno, ma abbiamo soltanto la parte iniziale: una lucertola che entra nella tela del ragno. Secondo una congettura del
Crusius, la favola (204) probabilmente narrava la vendetta del ragno, secondo uno schema esopico consolidato. Lo stesso editore, sulla scorta di alcune testimonianze, ricorda la differente considerazione dei due animali presso gli antichi: stolta la lucertola, accorto il ragno (v. anche RAGNO). Peraltro, la narrazione sembra trarre origine dall’osservazione della natura: Plinio (Naturalis historia 11,84) descrive come i ragni abbiano l’abitudine di tendere insidie ai piccoli delle lucertole: ne avvolgono la testa nella tela e ne mordono le labbra. Tale spettacolo è curiosamente accostato a quello dell’anfiteatro. La lucertola è certamente animale secondario nella favolistica: compare anche in un’altra favola (Fedro, App. 23 [25]), in cui si segnala per l’intelligenza, in controtendenza con un’opinione non sempre positiva circa l’ingegno dell’animale. Significativamente, l’umanista Perotti suggerisce l’accostamento della lucertola alla volpe e afferma che quando manca la pelle del leone, bisogna indossare quella della volpe (cfr. il proverbio commentato da Tosi 1991, 118 e le favole di Esopo 267 e 279 Ch.). La lucertola e il serpente Babrio 41 Dicono che una lucertola si spezzò in due, a metà del dorso, mentre cercava di eguagliare in lunghezza un serpente. Farai del male a te stesso e non concluderai nulla, se imiterai chi è di gran lunga superiore a te. RIFERIMENTI: Esopo 33 Ch. (in questo caso protagonisti sono una volpe e un serpente); ma cfr. anche Esopo 237 H.H. (presenta un verme e un serpente). Il ragno e la lucertola
Suda κ 2245 Adler [Babrio, 204 Cr.; fr. 13 Luzzatto-La Penna] Una lucertola trovò la tela di un saggio ragno e vi entrò, tagliata la sottile trama del muro. NOTA: il frammento è breve e non si conosce lo sviluppo della favola. Perry (286) traduce ἐνέδυ con «entered», Herrman «s’y enfonça», mentre Adrados 2003, 397 precisa che la lucertola si fece un abito con la tela.
Luna La Luna è venerata da tutti i popoli antichi: il suo culto si ritrova, ad esempio, presso le popolazioni italiche, gli Etruschi, i Greci, i Romani (la tradizione narra che già il re Servio Tullio le eresse un tempio). Figlia di Iperione e di Teia, sorella del Sole e dell’Aurora, nella mitologia la dea della luna Selene appartiene alla stirpe dei Titani. Percorre il cielo con un carro trainato da quattro buoi bianchi per portare la sua luce agli uomini. Viene, quindi, posta in relazione con il culto di Artemide ed Ecate. Va anche segnalato che la luna è oggetto dello studio e dell’osservazione di autori che hanno interessi scientifici, come Plinio il Vecchio (v. CONCHIGLIA). La Luna è assente dal corpus favolistico esopico, ma è protagonista di una narrazione considerata di tipo esopico dagli studiosi, che viene riportata da Plutarco (Il convito dei sette sapienti 157a). La favola, che si avvicina piuttosto al genere dell’enigma, viene attribuita, nell’ambito di un ragionamento sulle differenze tra l’uomo saggio e lo stolto, a Cleobulo, uno dei sette savi, che dice di averla appresa dalla figlia. Giocando sul variabile aspetto della luna, la favola riprende il tema dell’ambiguità, piuttosto ricorrente nella tradizione esopica (ad esempio, nella favola 251 Ch., il pipistrello e le donnole, o nella 340 Ch., che vede protagoniste le iene). La Luna e sua madre Plutarco, Il convito dei sette sapienti 157a La Luna pregò sua madre di tesserle una tunica su misura. Ma lei rispose: «E come potrei prepararti un vestito su misura? Vedo, infatti, che ora sei piena, poi calante, quindi crescente». Così, caro Chersia,
anche per l’uomo sciocco e di nessun valore non c’è alcuna misura nel possesso di beni. RIFERIMENTI: cfr. Eustazio, Opuscula 14,48 (p. 110 Tafel).
Lupo Il lupo è simbolo di ferocia, di avidità e di malvagità. Le sue vittime designate, come osserva Aristotele (Historia animalium 594a; 596b; 612b), sono gli ovini, mentre nemici per eccellenza sono tori, asini e volpi (609b); la sua aggressività si rivolge persino verso l’uomo (594a). La figura del lupo è talmente caratterizzata che entra con una certa frequenza anche nella tradizione dei proverbi, connessi per lo più con situazioni di estremo pericolo, come «Tengo il lupo per le orecchie» (non riuscendo a tenerlo fermo né a respingerlo), «Di qua i lupi, di là i cani» (Plauto, Casina 971 usa l’«antico detto» che indica la situazione di chi è stretto tra due rischi), oppure, trasferendo le dinamiche proprie dell’animale al mondo degli uomini, «L’uomo è un lupo per l’uomo» (Homo homini lupus), espressione di origine plautina (Asinaria 495), resa celebre soprattutto da Thomas Hobbes. Non solo: «Lupo» diventa anche un nome «parlante», che qualifica le caratteristiche di un personaggio, come avviene per il lenone Lycus nella commedia Poenulus di Plauto. Piuttosto diffusa nell’antichità è la credenza relativa alla licantropia, che entra in numerosi racconti fantastici (ad esempio, nel Satyricon di Petronio: 62). Pur contestando questa convinzione, Plinio (Naturalis historia 8,81) riferisce incredulo una vicenda significativa: in Arcadia, terra ricca di simili leggende, durante un sacrificio a Giove Liceo un certo Demeneto di Parrasia mangiò la carne di un ragazzo immolato e si mutò in lupo: dopo nove anni, riacquisì un aspetto umano e vinse nel pugilato a Olimpia. Secondo Pausania (8,2,6), l’origine sarebbe da ricercare nel mito del re Lykaon, trasformato da Zeus in lupo, con i suoi figli, dopo un banchetto cannibalesco offerto al re degli dei. Come spiega Pugliarello (1973, 56 ss.), sulla scorta di alcuni studi scientifici, la licantropia sarebbe in realtà una malattia mentale presente nell’antichità e oggi
rara che appartiene alla categoria della demenza precoce, definibile secondo il contesto culturale (presso altri popoli, il lupo viene sostituito, ad esempio, dalla tigre o da un altro animale), riscontrata per lo più in ambito arcaico. In sostanza, chi ne è affetto crede di trasformarsi nell’animale e ne imita i comportamenti. Va richiamato, a questo proposito, il caso del troiano Dolone, che, nell’Iliade (10,334 s.), prima di combattere, si pone sulle spalle la pelle di un lupo grigio e, come «in un procedimento di magia imitativa», assume le caratteristiche dell’animale. Probabilmente dunque la licantropia deve collegarsi «a queste arcaiche concezioni, nelle quali l’assunzione della natura animale era un privilegio che metteva in contatto con le forze della natura». Sacro ad Apollo in Grecia, il lupo è messaggero e servitore di Marte nella tradizione italica; a Roma, in febbraio, si festeggiavano i Lupercalia, realizzati sulla base di un articolato complesso rituale e connessi con il dio Fauno (Luperco), protettore del bestiame dagli attacchi dei lupi. Nota, inoltre, è la leggenda della lupa che nutre Romolo e Remo, alle origini di Roma. Le narrazioni esopiche che vedono il lupo protagonista rimandano al contesto di una società pastorale: come nota Pugliarello 1973, 63 ss., pur non avendo un diretto collegamento con le leggende mitiche, queste vicende riprendono alcune caratteristiche del dio Fauno e presentano l’animale nelle vesti del trickster (v. VOLPE): personaggio malvagio e astuto ma anche ingenuo e spesso beffato. Così, ad esempio, è beffato dall’asino che gli sferra un potente calcio (Esopo 281 Ch.), ma soprattutto dalla volpe, che riesce ad avere la meglio (Esopo 205 Ch.) oppure finge amicizia con il lupo, inducendolo ad attivare, suo malgrado, il meccanismo di una trappola (Babrio 130). Ma, al di là di questi episodi dai connotati «comici», il lupo viene per lo più descritto nella tipica immagine di animale affamato e in cerca di cibo (Esopo 64; 223 Ch.). Inoltre – soprattutto nel primo libro di Fedro, quello caratterizzato da più forte tensione sociale – è rappresentato come malvagio
oppressore degli innocenti (Fedro 1,1: la celebre favola del lupo e dell’agnello), testimone mendace (Fedro 1,17), avido e capace di subdoli inganni, che possono andare a buon fine (cfr., tra le altre, Esopo 229 Ch.) o essere sventati dalla prudenza della possibile vittima, come il capretto ben ammaestrato dalla madre del Romulus (36). Il lupo viene spesso inserito in un ben caratterizzato sistema di relazioni, che lo vede affiancato per lo più al leone, alla volpe e al cane. Il rapporto con il leone è segnato da una chiara inferiorità del lupo, come testimonia la favola di Esopo 227 Ch., in cui il re degli animali strappa una pecora alla belva, che l’aveva appena rapita e perciò vanamente si lamenta. Quando il lupo s’insuperbisce, tratto in inganno dalla sua ombra, finisce per essere vittima del leone (Esopo 219 Ch.). Un lupo di imponenti dimensioni desidera addirittura andare a vivere con i leoni, come se ciò rappresentasse una sorta di ascesa sociale, ma la volpe interviene per sottolineare la sua stoltezza (Babrio 101). In questo caso, come in altri, il rapporto con la volpe si fonda sull’opposizione dei ruoli e si gioca spesso sui temi dell’invidia e della gelosia. Quando la volpe è assente, il lupo non esita a metterla in cattiva luce agli occhi del leone, ma l’astuzia dell’antagonista è fatale per il nemico (cfr. la citata favola di Esopo 205 Ch.); l’invidia della volpe per la ricchezza del lupo porta entrambi in rovina (Romulus 56). Capita anche che il lupo e la volpe si presentino insieme al tribunale della scimmia, in una favola che riprende l’antico tema dell’arbitrato di origine mesopotamica: la loro fama è screditata, l’esito della contesa negativo per entrambi gli animali (Fedro 1,10). Anche in altre narrazioni il lupo appare animale dalla reputazione compromessa, e la sua apparente generosità viene sempre smascherata: ad esempio, il cavallo della favola 225 Ch. coglie subito l’ipocrisia della belva, che si finge benevola nei suoi confronti. Più problematico è, invece, il rapporto con il cane. I due animali condividono una comune origine, ma sono separati da una condizione inconciliabile: l’uno vive in libertà, l’altro è schiavo dell’uomo (Esopo 226 Ch.). Inoltre,
militano su fronti opposti (Esopo 216 Ch); quando scendono in battaglia, l’eterogeneità dei cani, diversi per razza e caratteristiche, rappresenta uno svantaggio rispetto alla compattezza dei lupi. Una delle situazioni più ricorrenti della favolistica è quella che vede protagonisti il lupo, da un lato, e il gregge difeso dal pastore, insieme al cane, dall’altro. Questo schema prevede la variante del lupo accolto dall’uomo (cfr. 313; 314; 315 Ch.): l’animale è irriconoscente e malvagio, simbolo dell’immutabilità della natura individuale, tema assai caro alla pessimistica visione esopica del mondo. Il lupo non teme il cane bensì il suo padrone (Sintipa 38), anche se l’animale sa sopperire alle distrazioni dell’uomo, quando la belva entra nella stalla, avvertendolo (Esopo 317 Ch.): la narrazione sembra trovare un vago riscontro nell’immagine plautina dei «cani che spingono con astuzia il lupo in trappola» (Poenulus 648 s.) e si può forse porre in relazione con il proverbio «Il lupo in trappola» (Tosi 1991, 128). Tale immagine delle pecore e dei lupi è ricorrente nella Bibbia, dove si possono trovare alcune situazioni che presentano affinità con la favolistica: il lupo che indossa la pelle di pecora (Niceforo Basilace, Esercizi preparatori 1,4) ricorda i profeti che sono come lupi travestiti da pecore (Vangelo di Matteo 7,15). Il superamento dell’eterna inimicizia tra lupo e agnello (cfr. Isaia 11,6-9) si ritrova nella favola utopistica del regno del leone, che presenta il raggiungimento della giustizia reciproca tra lupi e pecore (Esopo 195 Ch.). Alcuni proverbi, come il celebre Lupus in fabula (v. sotto), sembrano collegabili con narrazioni esopiche (in questo caso, il lupo e la vecchia: Esopo 223 Ch.), a testimonianza dell’incisività, nell’immaginario popolare, delle diverse situazioni che riguardano questo animale. Nella tradizione favolistica non manca nemmeno un divertente riferimento al tema della licantropia (Esopo 301 H.-H.). Il lupo e i pastori Plutarco, Il convito dei sette sapienti 156a
Esopo raccontò questa favola: «Un lupo vide alcuni pastori mangiare un agnello nella loro tenda; allora si avvicinò e disse: “Che gran trambusto ci sarebbe da parte vostra, se io mi comportassi così”». RIFERIMENTI: cfr. Ermia d’Alessandria, Commento a Platone, Fedro 272c (da segnalare anche scoli relativi allo stesso passo); Gregorio Ciprio L 2,66; Macario 3,48; Fozio, Lessico s. v. τὸ τoῦ λύκoυ, Suda κ 1209 Adler. Per il proverbio, v. sotto. Il lupo che indossava una pelle di pecora Niceforo Basilace, Esercizi preparatori 1,4, p. 427 Walz I Il travestimento è pericoloso per chi lo indossa Una volta un lupo decise di mutare la sua natura e di cambiare aspetto, per ottenere una grande quantità di cibo. Indossata una pelle di pecora, se ne andava con il gregge al pascolo. Ingannò così il pastore grazie al travestimento. Scesa la notte, anche la belva venne rinchiusa insieme alle pecore. La via d’uscita venne bloccata tramite la recinzione, così che l’ovile era perfettamente chiuso. Ma quando il pastore ebbe voglia di mangiare una pecora, uccise con il coltello il lupo. Così, dunque, chi si traveste perde spesso la vita e scopre che la sua finzione produce enormi guai. RIFERIMENTI: Vangelo di Matteo 7,15; Nonno di Panopoli, Parafrasi del Vangelo di Giovanni B 112.
Il capretto e il lupo Romulus 36 È sempre lodevole che i figli prestino ascolto agli insegnamenti dei genitori. Una capra, che aveva da poco partorito, volendo andare a pascolare nel bosco, ammonì l’inesperto capretto esortandolo a non aprire la porta ad altri. L’aveva chiusa perché molte belve si avvicinavano alla stalla del gregge. Così la madre avvertì il capretto, mentre partiva per il bosco. Dopo breve tempo giunse un lupo, che, simulando la voce della madre, disse: «Aprimi, ti prego, apri alle mammelle che sono rigonfie per te». Tuttavia, il capretto lo scorse attraverso una fessura ed esclamò: «Sento la voce della madre, ma non ne vedo l’immagine: malvagio, cerchi di fare tuo, il nostro sangue. Ma mi ha avvertito chi ti conosce e, per il timore nei tuoi confronti, non voleva nemmeno lasciarmi solo». Il lupo e la vecchia Esopo 223 Ch. Un lupo affamato se ne andava in giro cercando cibo. Arrivato in un certo luogo, udì un bambino che piangeva e una vecchia che gli diceva: «Smetti di piangere, altrimenti ti do immediatamente al lupo». Il lupo pensò che la vecchia dicesse la verità; pertanto rimase in attesa a lungo. Ma, a sera, sente di nuovo la vecchia coccolare il bambino e dirgli: «Se viene il lupo qui, figliolo, lo ammazzeremo». Udite queste parole, il lupo se ne andò, osservando: «In questa casa dicono una cosa e ne fanno un’altra». La favola è rivolta a quegli uomini che non fanno
seguire fatti conformi alle parole. RIFERIMENTI: Babrio 16; Aftonio 39; Aviano 1; F. dattiliche 1; Parafrasi 224; Dodecasillabi 224; Papiro Amherst 2,26 (n. 40 Cavenaile). Per i proverbi, v. sotto. Il lupi e i cani in guerra tra loro Esopo 215 Ch. Una volta c’era una contesa tra lupi e cani. Questi ultimi scelsero come capo un cane greco, che cercava di ritardare la battaglia, mentre i lupi lo minacciavano ferocemente. Il cane disse: «Sapete perché temporeggio? Conviene sempre pensare bene prima di agire. Infatti, di voi tutti sono unici la razza e il colore del pelo; i nostri hanno invece costumi diversi e vanno fieri dei luoghi di provenienza. Anche il colore non è unico e identico per tutti, ma ci sono quelli neri, quelli fulvi, quelli bianchi e quelli color cenere. E come potrei io condurre in guerra dei militari che non sono in sintonia e che sono dissimili in tutto?». In tutti gli eserciti è l’unità della volontà e del pensiero che assicura la vittoria sui nemici. RIFERIMENTI: Babrio 85; Parafrasi 216; Suda δ 725 Adler. Il leone, il lupo e la volpe Esopo 205 Ch. Il leone, ormai vecchio, giaceva ammalato in una grotta. Tutti gli animali, eccetto la volpe, fecero visita al loro sovrano. Allora il lupo colse l’occasione
propizia per accusare la volpe di fronte al leone, dal momento che non teneva in alcun conto il re di tutti gli animali e perciò non gli aveva nemmeno fatto visita. Proprio in quel frangente arrivò la volpe e riuscì a intendere le ultime parole del lupo. Così il leone prese a ruggire contro di lei, ma la volpe chiese l’opportunità di potersi giustificare. «Chi – disse – tra quanti sono qui riuniti, ti ha reso un servizio tanto grande quanto il mio? Io sono andata in giro ovunque, cercando presso i medici una cura che potesse fare al caso tuo, e l’ho ottenuta.» Subito il leone ordinò di rivelare quale fosse la terapia. La volpe allora spiegò: «Dopo avere scuoiato vivo un lupo, indossa la sua pelle ancora calda». In un istante il lupo giacque morto e la volpe, sogghignando, così parlò: «Non si deve incitare il padrone a cattivi istinti, ma alla benevolenza». La favola dimostra che le macchinazioni nei confronti degli altri si rivolgono contro chi le ha congegnate. Il lupo orgoglioso della sua ombra e il leone Esopo 219 Ch. Una volta un lupo, che errava per luoghi deserti, al calar del sole, notò che la sua ombra si allungava e così disse: «Io temo il leone, anche se sono così grosso? Poiché la mia lunghezza è di un pletro, non diventerò agevolmente il signore di tutti gli animali?». Ma un forte leone ghermì il lupo, che si era fatto prendere dalla superbia, e si mise a divorarlo. Il lupo, cambiando opinione, esclamò: «La presunzione è per noi causa di sventure!». NOTA: Un pletro equivale a trenta metri.
RIFERIMENTI: Dodecasillabi 220. Il pastore e le pecore Esopo 229 Ch. Un lupo seguiva un gregge di pecore senza fare nulla di male. Il pastore all’inizio stava sulla difensiva, ritenendolo un nemico, e, impaurito, lo teneva d’occhio. Poiché il lupo continuava a seguirli senza mettere in atto un minimo tentativo di rapina, il contadino ebbe l’impressione che fosse un guardiano piuttosto che un animale insidioso. Così, avendo bisogno di andare in città, gli lasciò le pecore e partì. Poiché ritenne di avere una buona occasione, il lupo assalì la maggior parte del gregge, facendo una strage. Al suo ritorno, il pastore vide il gregge fatto a pezzi e disse: «Mi sta proprio bene; infatti, perché ho affidato un gregge a un lupo?». Così, anche tra gli uomini, coloro che affidano un deposito alle persone avide finiscono giustamente per perderlo. RIFERIMENTI: Plauto, Pseudolus 139 ss. (v. PECORA: proverbio); cfr. inoltre Erodoto 4,149; Terenzio, Eunuco 832; Cicerone, Filippiche 3,11,27; Ovidio, L’arte di amare 3,7 s.; 2,363 s. Il contadino e il lupo Esopo 64 Ch. Un contadino impegnato ad arare sciolse i buoi dal giogo per condurli a bere. Un lupo affamato, in cerca di cibo, si imbatté nell’aratro e prese a leccare la parte del giogo dove mettono la testa i buoi.
Quindi, poco alla volta, senza accorgersene, abbassò il collo e, poiché non riusciva a tirarlo fuori, trascinava l’aratro per il campo. Il contadino ritornò, lo vide e gli disse: «Magari, disgraziato, smettessi di rubare e di comportarti in modo malvagio per dedicarti al lavoro agricolo!». Così gli uomini malvagi, anche se fanno professione di virtù, a causa del loro carattere non riscuotono fiducia. PROVERBI Λύκoυ ῥήµατα Le parole del lupo Come nota Adrados (2003, 500), il proverbio può essere riferito alla favola esopica riportata da Plutarco (Il convito dei sette sapienti 156a). Si riferisce a coloro che si comportano iniquamente con parole e opere, come spiega lo scolio a Platone (Fedro 272c). Il proverbio, oltre che nel passo del Fedro, viene ripreso anche dai paremiografi (Macario 5,73; Appendix proverbiorum 3,77: qui viene ripresa la spiegazione dello scolio). Lo stesso Macario (ma anche altri: v. sopra) si ricollega alla favola anche in un altro passo (3,48), attraverso un’espressione esplicitamente riferita alla narrazione esopica: «Se io mi comportassi così, quanto rumore ci sarebbe». Λύκoς ἔχανεν Il lupo se ne sta a bocca aperta L’immagine, probabilmente assai diffusa a livello popolare, è molto incisiva e si ritrova soprattutto negli autori comici, a partire da Aristofane (cfr. Lisistrata 629; fr. 350 K.A.), ma anche in contesti diversi (cfr., ad esempio, Luciano, Il gallo 11; Aristeneto, Epistole 2,20; Diogeniano 6,20). Come spiega Tosi 1991, 411, a cui si rimanda per ulteriori riprese proverbiali, «l’espressione indica una persona che confida in vacue aspettative e vuote speranze, e sembra quindi un lupo affamato che aspetta la preda con la bocca spalancata e che alla fine rimane deluso». Nell’uso dell’italiano di oggi si
tende a usare l’espressione, per certi versi affine, «Andarsene a bocca asciutta». L’immagine richiama naturalmente la favola della vecchia che illude il lupo e poi lo lascia insoddisfatto (Esopo 223 Ch.; in Babrio 16 si riscontra una ripresa puntuale del proverbio). Lupus in fabula Il lupo nel discorso L’espressione, attestata in vari autori (cfr. Terenzio, I fratelli 577; Cicerone, Epistulae ad Atticum 13,33,4), indica, ancora oggi, la comparsa una persona di cui si sta parlando. Un passo plautino (Stico 577) suggerisce l’equivalenza di fabula con sermo: quindi, non è possibile tradurre «Il lupo nella favola», per quanto il riferimento a una narrazione esopica sia supposto dalla maggior parte dei commentatori. Gli antichi propongono una doppia interpretazione del proverbio, basata forse sull’interferenza di due distinte credenze. Nel suo commento al passo di Terenzio, Donato rileva che Lupus in fabula si collega alla credenza popolare (di origine rurale) che chi è guardato dal lupo perde all’improvviso la voce; inoltre, segnala il possibile riferimento alla favola esopica 223 Ch., in cui un’anziana donna minaccia un bambino in lacrime di darlo in pasto al lupo proprio mentre l’animale si aggira da quelle parti. Anche secondo Servio (commento a Virgilio, Bucoliche 9,53 s.), il proverbio si collega al fatto che chi è guardato dal lupo, perde subito la voce; lo stesso fa Plinio (Naturalis historia 8,80): si ricordi anche il proverbio, di ambito greco, «Avere visto il lupo», che suggerisce l’azione di ammutolire (cfr. Platone, Repubblica 336). L’alternativa compare esplicitamente nel commento all’Ars di Donato compilato da Pompeo (311 Keil) ed è relativa all’ipotesi di un discorso evocatore, che potrebbe invece dipendere, come nota Tosi 1991, 433 (a cui si rimanda per altri paralleli medievali e moderni) dalla credenza secondo cui il lupo è animale totemico e nominarlo significa evocarlo; in ambito greco, un proverbio affine è attestato in Diogeniano 4,64, Apostolio 6,50 e nella Suda ει 67 Adler: «Se solo menzioni il lupo».
Ancora oggi si rilevano significativi paralleli (come in francese, Quand on parle du loup, on en voit la queue). Insomma, «Il lupo nel discorso» si riferisce a un discorso interrotto o a un discorso evocatore. D’altra parte, come spiega Bettini 2000, 20 ss., il senso «pieno» del proverbio potrebbe sintetizzare le due interpretazioni: «se parli del lupo, il lupo compare e ti toglie la voce»; inoltre, questa espressione sembra comprendere (come nota anche Donato) una intimazione di silenzio, per cui «alla sua normale funzione descrittiva ne aggiunge una di carattere performativo», ossia un’esortazione a tacere, rivolta all’interlocutore, nel momento in cui la «persona parlata» arriva.
M
Macellaio Il termine greco µάγειρoς, usato anche nella favola esopica per designare il macellaio, ha un significato originario di «macellaio sacrale, sacrificatore», quindi va a designare non solo il macellaio, ma anche il cuoco (discorso simile per il termine latino lanius, che indica sia il macellaio sia il sacrificatore). Questo dato suggerisce una certa complessità del profilo del macellaio, che, in una prospettiva non religiosa, assume normalmente una duplice funzione, in relazione sia alla lavorazione sia alla vendita della carne. Dal punto di vista sociale, la sua dignità professionale non è dissimile a quella di chi svolge attività artigianali (v. ARTIGIANO): mestiere tipico dei ceti subalterni, quello del macellaio è considerato un impiego poco onorevole dai ceti dominanti. Non a caso è figura ricorrente nella letteratura popolare, ad esempio nella commedia plautina. Cicerone (De officiis 1,42,150) ne dà una valutazione negativa, inserendo questo tra i mestieri che hanno lo scopo di soddisfare i bisogni e i piaceri della plebe. Nell’ambito della favola esopica, emergono entrambi gli aspetti di questo mestiere, sia la macellazione, sia la vendita della carne. I macellai, all’opposto dei pastori (Massimo di Tiro 19,2), sono certamente tra le figure più temute dagli animali, tanto che i buoi progettano di ucciderli; tuttavia un anziano bue ne riconosce l’abilità nel tagliare e immagina conseguenze ben peggiori se fossero mani inesperte a macellare (Babrio 21). I macellai non esitano ad approfittare della scarsa solidarietà tra gli animali per ucciderli a uno a uno (Romulus 76). Troviamo poi scene di vita quotidiana: al macellaio viene sottratto qualcosa da due ragazzi (Esopo 246 Ch.) o da un cane (Esopo 183 Ch.). In questi casi l’uomo si dimostra capace di risposte pronte e dotato di una certa saggezza. Una battuta di spirito efficace è anche quella che il macellaio pronuncia riguardo alla scimmia appesa nella
sua bottega, il cui sapore sarebbe uguale alla sua testa (Fedro 3,4). I ragazzi e il macellaio Esopo 246 Ch. Due giovani compravano carne nella stessa bottega. Approfittando di un momento di distrazione del macellaio, uno dei due rubò alcuni pezzi e li nascose addosso all’altro. Voltatosi, l’uomo si mise a cercare quei pezzi di carne e prese ad accusare i ragazzi: quello che li aveva sottratti giurava di non averli, quello che li teneva addosso giurava invece di non averli sottratti. Il macellaio allora comprese la loro astuta tecnica e disse: «Anche se con il vostro falso giuramento potete ingannare me, certamente non sfuggirete agli dei». La favola dimostra che l’empietà di un falso giuramento rimane tale, anche se si trova qualche astuto accorgimento. Il macellaio e la scimmia Fedro 3,4 Un tale vide una scimmia appesa nella bottega di un macellaio, tra altre merci e generi alimentari; chiese di che cosa sapesse. Allora, scherzando, il macellaio rispose: «Quale è la testa, tale il sapore». Penso che queste parole siano più spiritose che vere, dal momento che spesso ho trovato pessime persone di notevole bellezza, mentre ho avuto esperienza di molte persone brutte d’aspetto che in realtà erano eccellenti. Il cane e il macellaio
Esopo 183 Ch. Un cane si introdusse con un balzo in una macelleria e, approfittando del fatto che il macellaio era occupato, afferrò un cuore e fuggì. Allora il macellaio si girò e, come vide l’animale fuggire, esclamò: «Ehi tu, sappi che, ovunque tu vada, io ti terrò sott’occhio: tu non mi hai preso un cuore, in realtà mi hai dato un cuore». La favola insegna che spesso le sventure sono insegnamenti per gli uomini. NOTA: il cuore era inteso come sede dell’intelligenza e della ragione. RIFERIMENTI: Sintipa 33; Dodecasillabi 184; Pseudo-Luciano, L’asino 39,4. Il pastore e il macellaio Massimo di Tiro 19,2 Un pastore e un macellaio camminavano insieme lungo la stessa strada, quando videro un agnellino ben pasciuto che vagava lontano dal gregge, dimenticato dai suoi compagni. Sia il pastore sia il macellaio piombarono sull’animale. Era l’epoca in cui gli animali parlavano lo stesso linguaggio degli uomini: così l’agnello chiede ai due uomini a che titolo l’uno e l’altro vogliano prenderlo e portarlo via. Venuto a conoscenza del mestiere di entrambi, l’animale si volge verso il pastore, offrendosi a lui. «Tu sei un carnefice – dice al macellaio – e le tue mani assassine sono sporche del sangue del gregge. Quest’uomo invece gioisce se viviamo in salute.»
Maga Plinio (Naturalis historia 30,1 ss.) delinea una breve storia della magia nel mondo antico, indicandola significativamente come «la più fraudolenta delle arti». In coerenza con quanto affermato anche da altre fonti, sostiene che essa è nata dalla combinazione di medicina, religione e astrologia (quest’ultimo ambito in relazione alla funzione divinatoria della magia). L’origine dello stesso termine «mago» ci fa risalire alla Persia di Zoroastro; quindi, pratiche magiche sono diffuse presso numerosi popoli: la magia si ritrova in Grecia, presso i Carii di Telmesso, gli Ebrei, i Ciprioti, i popoli italici fino a Galli e Britanni. Come emerge anche da questo passo di Plinio, a Roma le pratiche della stregoneria sono sempre state combattute dalle autorità civili (Graf 34), a partire dalle Leggi delle Dodici Tavole (451-450 a.C.), che condannano gli autori di incantesimi e maledizioni. D’altra parte, la magia nel mondo antico è oggetto di interpretazioni differenti rispetto alla sua funzione e ai suoi ambiti di applicazione. Platone, nella Repubblica (364b), fa riferimento a ciarlatani e indovini che bussano alle porte dei ricchi e, vantando i loro poteri, prospettano la possibilità di feste e riti che rimediano a ingiustizie (qui si rimanda ai riti misterici di ambito orfico e dionisiaco), pronti anche a trovare il modo di fare del male ai nemici (l’allusione è alla magia nera). La protagonista della favola 91 Ch. è una maga che fa ottimi affari. La scelta di una figura femminile da parte del favolista non è casuale. A partire dalla figura di Medea, la maga figlia del re della Colchide innamorata dell’eroe Giasone nella saga degli Argonauti, l’identità femminile dei maghi è piuttosto ricorrente. Lo stesso Plinio, nella sua breve storia della magia, ricorda in particolare la maga Circe, le sirene omeriche, ma anche le streghe tessaliche. Così fanno anche altri autori, come Teocrito (secondo idillio),
Virgilio (ottava egloga), Orazio, che descrive, tra l’altro, streghe pronte ad agire col favore delle tenebre (Satire 1,8,17 ss.). In questa favola di Esopo, la maga finisce per essere messa sotto accusa, pagando evidentemente l’invidia per il successo, non coerente con la marginalità della donna nella società. Non a caso, l’accusa che le viene rivolta è quella di sovvertire, con nuovi culti, l’ordine costituito. Alcuni episodi storici spiegano bene questo fenomeno, che si verifica anche con personaggi maschili costretti a pagare il prezzo della loro marginalità. Nel II secolo a.C., Gaio Furio Cresimo, schiavo liberato di origine orientale, ottiene grandi raccolti da un piccolo campo, molto superiori a quelli dei vicini più ricchi: messo sotto processo con l’accusa di avere fatto incantesimi, viene poi assolto. Intorno al 160 d.C. si ha poi un altro celebre processo: quello allo scrittore Apuleio. In questi casi, pur con significative differenze emerge il profilo del presunto mago come di una persona che vive in una condizione di marginalità e giunge da lontano. Questi elementi si attagliano perfettamente al contesto esopico, che rappresenta il mondo dei subalterni con spietato realismo. La figura della donna, ossia della strega messa sotto processo, rientra dunque, in questo genere di stereotipo. La maga Esopo 91 Ch. Una maga si vantava di compiere magie e incantesimi in grado di frenare l’ira divina e viveva grazie a molte di queste pratiche, ottenendo consistenti guadagni. Alcuni la denunciarono per queste sue magie, sostenendo che introduceva nuove pratiche religiose, la citarono in giudizio e, accusandola, riuscirono a farla condannare a morte. Un tale la vide mentre la portavano via dal tribunale e le disse: «Donna, tu che sostenevi di saper allontanare l’ira divina, come mai non sei riuscita
nemmeno a convincere gli uomini?». Si potrebbe riferire questa favola a una donna ingannatrice, che promette risultati straordinari e poi non si rivela in grado di ottenere risultati normali.
Maiale (scrofa) Animale di antichissima domesticazione (attestata fin dal Neolitico), il maiale è simbolo di prosperità, lussuria, passione, impurità; in particolare, la scrofa (sacra a Zeus Ditteo, che proprio da una scrofa venne allattato), è emblema di fertilità ed è associata al culto della Grande Madre (cfr. Cooper 320). Animale sacrificale per eccellenza, il maiale viene offerto a varie divinità, in particolare in Grecia a Demetra e a Roma a Marte, Cerere e Tellus (quest’ultima associata a Cerere). La consuetudine dell’uomo con il maiale è attestata nei testi letterari più antichi (si pensi al porcaro Eumeo nell’ Odissea). Apprezzato sul piano culinario, largamente allevato (si vedano le accurate istruzioni in proposito di Columella 7), il maiale non è considerato animale molto intelligente e nei proverbi diventa sinonimo di «ignorante», contrapposto alla dea della sapienza Atena (cfr. Plutarco, Demostene 11), Minerva a Roma («Il maiale insegna a Minerva», scrive ad esempio, in forma proverbiale, Cicerone, De oratore 2,233). Fondamentale, nella cultura romana, appare la scrofa, con i suoi nati, connessa con la fondazione di Alba Longa e di Lavinio, dove le sarebbe stato edificato un monumento (Varrone, De re rustica 2,14). Il maiale conferma, nella favolistica, il suo caratteristico valore simbolico connesso per lo più con la fertilità e l’impurità. Prevale nettamente, per frequenza, la femmina rispetto al maschio, spesso in relazione ai temi della fecondità e della procreazione (Fedro, App. 17 [19]; Esopo 342 Ch.: si veda anche il proverbio sotto). La favola di Fedro riprende il motivo dell’animale che si finge medico, ma viene smascherato e respinto (qui si ha il lupo, che si spaccia per
ostetrico, e la scrofa; in Esopo 14 Ch., il gatto, finto medico, e le galline). La scrofa si segnala per la sua accesa inimicizia nei confronti della cagna: nella favola 329 Ch. i due animali si offendono a vicenda. Mentre la cagna ironizza sul fatto che Afrodite non accetta nei suoi templi chi si ciba di carne suina, ritenuta impura, la scrofa ribalta a suo vantaggio il tabù, peraltro presente in varie religioni orientali: sostiene che la dea la ama perché respinge chi le fa del male. Come rileva Pugliarello 1973, 131, «il maiale, che pure diede origine ad una notevole quantità di credenze e tradizioni come animale da sacrificio, non gode di eccessiva diffusione nelle favole». In due favole si segnala anche la figura del porcellino, considerato animale da sacrificio (Fedro 5,4) e apprezzato per la sua carne (Esopo 94 Ch.: favola con significative varianti): per questo diventa il simbolo di chi rischia la vita e non solo la ricchezza, come invece succede alle pecore, private della lana e del latte. La scrofa partoriente e il lupo Fedro, App. 17 [19] Bisogna mettere alla prova una persona, prima di fidarsi di lei Sul punto di partorire, una scrofa, giacendo a terra, gemeva; accorse il lupo e, mentre le prometteva aiuto, le disse che poteva farle da ostetrico. Comprendendo tuttavia l’inganno che si tesseva nel cuore infido del farabutto, la scrofa rifiutò il sospetto aiuto del malvagio: «Mi basta – disse – che tu te ne stia alla larga». Se si fosse affidata al perfido lupo, con pari dolore avrebbe pianto il suo destino. NOTA: al verso 8 si legge (come, tra gli altri, fa Bassi, che, per quanto riguarda l’Appendix Perottina, ha operato un riesame critico del codice N) pari
dolore fata deflesset sua anziché, come Müller, partus dolore fata complesset sua. RIFERIMENTI: Romulus 30. La scrofa e la cagna che si insultavano a vicenda Esopo 329 Ch. Una scrofa e una cagna si offendevano vicendevolmente. La scrofa giurava in nome di Afrodite che avrebbe dilaniato la cagna. La cagna perciò disse sarcastica: «Fai bene a giurarmelo su Afrodite; è evidente, infatti, che sei amata moltissimo da lei, che non accetta in nessun modo, nel suo tempio, chi si ciba delle tue carni impure». La scrofa rispose: «Proprio per questo – è evidente – la dea mi ama; infatti, respinge con ogni sua forza chi mi uccide o mi fa altrimenti del male; tu certo sei maleodorante da viva e da morta». La favola dimostra che i bravi oratori mutano con abilità gli insulti dei nemici in elogi. La scrofa e la cagna che disputavano sulla loro fecondità Esopo 342 Ch. Una scrofa e una cagna litigavano riguardo alla loro fecondità. La cagna affermò di essere l’unica dei quadrupedi ad avere una rapida gestazione; la scrofa le rispose: «Cara mia, quando dici questo, devi riconoscere anche che generi cuccioli ciechi!». La favola dimostra che le cose vanno valutate non per la loro velocità, ma per la loro perfezione.
RIFERIMENTI: cfr. il proverbio riportato Archiloco (fr. 196a, 26 s. W. ). V. sotto.
in
2
L’asino e il porcello Fedro 5,4 Un uomo aveva immolato un verro al divino Ercole, a cui era debitore di un voto perché l’aveva salvato. Quindi dispose che l’orzo rimasto fosse dato all’asinello; la bestiola, tuttavia, lo rifiutò, parlando in questo modo: «Davvero volentieri m’accosterei a questo cibo, se chi ne ha mangiato non fosse stato sgozzato». Dissuaso dalla considerazione di questa favola, ho sempre evitato i guadagni che comportano pericoli. Ma tu dici: «Chi ha rapinato ricchezze, adesso se le tiene». Forza, facciamo l’elenco di coloro che, colti in fallo, sono andati in rovina. Vedrai che è più consistente il numero delle persone che sono state punite. La temerità è un bene per pochi, per molti un male. Il porcellino e le pecore Esopo 94 Ch. Un porcellino si era aggregato a un gregge di pecore e andava a pascolare. Una volta, però, il pastore lo afferrò ed ecco che quello strillava e faceva resistenza. Le pecore lo rimproveravano per le grida e gli dicevano: «Noi veniamo prese continuamente e tuttavia non strilliamo». Il porcellino rispose: «Il pastore non prende me per lo stesso motivo per cui prende voi; infatti, prende voi
per la lana o per il latte, invece acchiappa me per la carne». La favola dimostra che si lamentano giustamente quelli che rischiano non le ricchezze, bensì la vita. RIFERIMENTI: Romanzo di Esopo 48; Eliano, Varia historia 10,5; Platone comico in Clemente Alessandrino, Stromateis 7,6,33; Massimo di Tiro 19,2; Ierocle, Facezie 103; 129. Cfr. Esopo 189 H.H., favola simile a questa: qui i personaggi che affiancano il porcellino sono una pecora e una capra; inoltre, interviene anche una volpe. Cfr. anche Aftonio 30; Nicolao, Esercizi preparatori 1,9. PROVERBI Kύων σπεύδoυσα τυϕλὰ τικτεί La cagna frettolosa genera cuccioli ciechi Questo proverbio, che ha larga fortuna ancora oggi, «ammonisce a non agire in fretta, ma con la necessaria prudenza e ponderazione ed è di origine orientale» (cfr. Tosi 1991, 706, anche per la bibliografia). In ambito greco si trova un’attestazione in Archiloco (fr. 196a, 26 s. W.1 ), quindi anche in Macario 5,32 (al di là della variante della cardellina al posto della cagna, cfr. anche Aristofane, Pace 1078). Molto evidente il legame con la favola di Esopo 342 Ch., che presenta una morale sul primato della compiutezza delle cose rispetto alla velocità con cui vengono realizzate. 2
Mani I Mani sono, presso i Romani, le anime dei morti, venerati come numi tutelari della famiglia. La festa dedicata a loro è quella dei Parentalia, celebrata a febbraio. Il culto privato prevede invece l’offerta di latte, vino e fiori il nono giorno dopo la morte. I Mani compaiono in una favola di Fedro (1,27), dove vengono profanati da un cane avido, che, dissotterrate le ossa dei morti, trova un tesoro. Il riferimento a questi numi tutelari ha probabilmente la funzione di romanizzare una favola di derivazione egizia (cfr. Luzzatto 1976, 205 ss.).
Mare Il mare è un elemento centrale nella vita dei popoli mediterranei, che lo considerano sotto un duplice profilo, venerandolo (Poseidone-Nettuno ne è il dio presso Greci e Romani) e temendolo allo stesso tempo. La letteratura antica esprime questa consuetudine e questa ambivalenza già a partire da Omero, che lo indica, tra l’altro, con l’epiteto di «divino», ma ne descrive allo stesso tempo la vastità e le insidie: Odisseo, il naufrago più illustre dell’antichità, accosta i pericoli delle onde a quelli della guerra (Odissea 5,224 s.). In contesti differenti, viene anche indicato come infedele (in quanto mutevole e pericoloso: Pittaco in Diogene Laerzio 1,11) e ingiusto o infido (Properzio 1,15,11 s.; Ovidio, Amori 2,11,1 s.). Il mare compare di frequente in relazione alla navigazione e ai venti che lo condizionano, mettendo a rischio la vita del mercante (v. NAVIGANTE). Esiste, tra l’altro, una tradizione proverbiale che include il mare tra i mali che toccano all’uomo, insieme al fuoco e alla donna (cfr. Tosi 1991, 623 s.). Nella tradizione esopica si rileva una certa diffidenza rispetto al mare, che compare come un elemento della narrazione, generalmente in riferimento a pesci, pescatori o naufraghi, molto più spesso che come personaggio. I repentini mutamenti del suo stato ingannano gli uomini: questa situazione si verifica puntualmente in relazione ai personaggio del navigante o del naufrago. Non stupisce, dunque, che, allettato dai possibili guadagni del commercio e pronto a prendere incautamente il largo, il pastore finisca per perdere il suo carico a causa di una tempesta: qui il mare, curiosamente, pare avido di datteri (Esopo 311 Ch.); ma non lascia scampo nemmeno agli animali che si danno al commercio (Esopo 250 Ch.). Va ricordato che nel mondo esopico cielo, terra e mare sono realtà nettamente distinte: il gabbiano che cerca cibo in acqua finisce per morire (Esopo
193 Ch.), l’alcione perde il suo nido travolto dalle onde (28 Ch.); ma vale anche il contrario: il granchio, pur essendo un animale marino, va sulla terra ed è pertanto vittima designata della volpe (Esopo 150 Ch.). Il mare è protagonista di due sole favole: in una si contrappone ai fiumi che lo accusano di alterare le loro acque (Sintipa 4); nell’altra (Esopo 245 Ch.) addossa ai venti la responsabilità del suo comportamento ambiguo, ora tranquillo ora in tempesta (la fonte potrebbe essere un distico di Solone, fr. 12 W , in cui il mare, che si agita solo a causa dei venti, è descritto come «il più giusto tra tutti gli elementi naturali»). Questa narrazione presenta un’anomalia rispetto al codice narrativo della favola, poiché il mare si trasforma in una donna (la metamorfosi è tipica piuttosto di altri generi, come il mito o la fiaba). Probabilmente in questo processo narrativo gioca un ruolo rilevante la memoria della figura delle Nereidi, le cinquanta figlie del dio marino Nereo e di Doride, ninfe protettrici del mar Mediterraneo, pronte a salire in superficie per assistere i naviganti. 2
Il naufrago e il mare Esopo 245 Ch. Un naufrago, finito sulla spiaggia, s’assopì a causa della stanchezza: rialzatosi dopo poco, come vide il mare, prese a rimproverarlo perché attira gli uomini con il suo aspetto tranquillo, ma quando li ha accolti in acqua, infuria selvaggiamente e li uccide. Allora il mare, dopo aver assunto un aspetto di donna, gli si rivolse dicendo: «Carissimo, non rimproverarmi, ma prenditela con i venti: io per natura infatti sono come anche ora mi vedi; quelli invece piombano su di me all’improvviso, mi agitano e mi rendono selvaggio». Ecco, dunque, che anche noi non dobbiamo incolpare per le ingiustizie coloro che le commettono, quando costoro dipendono da
altri, ma dobbiamo prendercela con i loro mandanti. RIFERIMENTI: Solone, fr. 12 W ; Babrio 71; Parafrasi 247; Dodecasillabi 247; Pseudo-Callistene 3,8 (di derivazione soloniana). 2
I fiumi e il mare Sintipa 4 I fiumi si riunirono per lamentarsi nei confronti del mare. «Perché – gli chiesero – ci rendi salati e imbevibili, mentre noi veniamo a te con acque dolci e potabili?» Di fronte a quelle critiche, il mare rispose loro: «Non venite e non diventerete salati». La favola è indirizzata a chi critica qualcuno a sproposito, mentre ne riceve piuttosto giovamento.
Maschera La maschera è una componente fondamentale del teatro greco e poi (in termini parzialmente differenti) anche di quello romano. Nell’antichità il suo uso, collegato con tutta probabilità ai riti magico-mimetici tipici della preistoria del teatro, ha una duplice funzione, acustica e scenica: non soltanto amplifica la voce, ma consente anche agli uomini di interpretare ruoli femminili e, in generale, a tutti gli attori di sostenere diverse parti. La maschera, inoltre, facilita il riconoscimento del personaggio da parte dello spettatore. Per quanto riguarda nello specifico le maschere della tragedia, Giulio Polluce (Onomastico 4,133-142), nel II secolo d.C., attingendo con ogni probabilità a una fonte ellenistica, ne individua ventotto tipologie. Va detto che le maschere mutano nel tempo, nella direzione di una sempre maggiore esasperazione dei tratti: questo accade specialmente in ambito romano. Il tema della maschera (in latino designata dal termine persona) entra anche nella riflessione filosofica (ad esempio, in Seneca, De tranquillitate animi 17) e si presta a diventare elemento costitutivo di motivi proverbiali (v. sotto). Esopo e Fedro, la cui brevitas conferisce alla narrazione l’incisività tipica della sentenza, mettono una volpe di fronte a una maschera («da tragedia», puntualizza il poeta latino). L’animale, attratto dalla bellezza dell’aspetto esteriore, si rende tuttavia conto dell’inconsistenza di quello che resta semplicemente un oggetto privo di cervello. Viene qui sviluppato, dunque, un tema caro alla tradizione favolistica: quello del contrasto tra l’essere e l’apparire. Il motivo sembra di ascendenza cinica. Se la favola di Esopo è rivolta agli «uomini bellissimi nel fisico, ma limitati nell’intelligenza», quella di Fedro invece è dedicata «a coloro a cui la fortuna ha concesso onore e gloria, ma ha privato di buon senso». Questo è l’esito inevitabile di un
processo di svelamento morale, prima che fisico, assai ricorrente nelle favole esopiche. La volpe e la maschera da tragedia Fedro 1,7 Per caso una volpe aveva visto una maschera da tragedia. «Oh, – esclamò – che straordinario aspetto! Ma non ha cervello.» Queste parole sono rivolte a coloro a cui la Fortuna ha concesso onore e gloria, ma ha privato del buon senso. RIFERIMENTI: Apostolio 18,60.
Esopo
43
Ch.;
Romulus
44;
PROVERBI O quanta species! Cerebrum non habet Oh che straordinario aspetto! Ma non ha cervello Il proverbio è tratto direttamente dalla favola fedriana(1,7). Come spiega Tosi, 1991, 193, «è questa una esclamazione tuttora nota e usata a indicare una persona bella, ma stupida». Viene ripresa anche da La Fontaine (4,14), anche se il riferimento non è a una maschera, ma al busto di un’eroe. Secondo lo stesso Tosi, questa sentenza si collega ad altri motivi proverbiali: decipit / frons prima multos (Fedro 4,2,6 s.), ossia «l’aspetto esteriore inganna molti» (v. DONNOLA), e rara est … concordia formae / atque pudicitiae (Giovenale 10, 297 s.), ossia «rara è la coesistenza di bellezza e pudicizia»: il tema è ovviamente quello del conflitto tra l’apparire e l’essere, declinato in diverse forme. Personam capiti detrahet illa tuo Lei ti leverà la maschera dal viso Questa espressione di Marziale (3,43,4) – riferita al comportamento di Proserpina nei confronti di una tale che vuole dissimulare l’età – è riconducibile alla favola dell’asino
vestito con la pelle del leone (Esopo 267 Ch.). V. ASINO (anche per un proverbio concettualmente affine).
Medico Le origini mitiche della medicina si fanno risalire al centauro Chirone, che insegnò l’arte della guarigione ad Asclepio (Esculapio nella tradizione romana), figlio di Apollo. Già nei poemi omerici troviamo, tuttavia, una doppia interpretazione della medicina: da un lato quella miticoreligiosa, dall’altro quella più laica e scientifica (cfr. Andorlini-Marcone 2). Spesso si guarda all’Egitto come terra di medici esperti (Omero, Odissea 4,219 ss.), dotati di specializzazione (Erodoto 2,84). In Grecia, il passaggio decisivo per l’identificazione della medicina come scienza, fondata sopra un metodo razionale, è quello dalla medicina ippocratica (da Ippocrate, vissuto nel V secolo a.C.). Questa scienza raggiunge, quindi, il suo effettivo sviluppo in età ellenistica, ad Alessandria d’Egitto, con la creazione delle prime scuole mediche. Quanto alla figura sociale del medico nel mondo greco, nella tradizione preippocratica troviamo personaggi che vivono del loro guadagno, spesso considerati uomini avidi di ricchezza (attributo anche di Asclepio, secondo Pindaro, Pitiche 3,54 ss.). Nel mondo greco, la figura più prestigiosa è quella del «medico pubblico». In età ellenistica assumono una posizione importante anche i «medici di corte». A Roma, invece, i medici sono per lo più stranieri, spesso schiavi o liberti. Ricevono progressivamente diversi privilegi in età imperiale, godendo, tuttavia, di uno status sociale non elevato, soprattutto in Occidente (cfr. Andorlini-Marcone 172). Dalle opere di Vettio Valente e Firmico Materno si rileva come il medico sia accostato ora ad astrologi, sacerdoti e maghi, ora a oratori e insegnanti, ora ad artigiani, in relazione alle sue specifiche competenze (scaltrezza mentale, scienza o capacità tecniche e operative). Nonostante il crescente prestigio (Cicerone, De officiis 150151 pone la medicina tra le professioni intellettuali onorevoli; ad Antonio Musa, che guarisce Augusto, è
dedicata una statua sul Palatino), a Roma resiste una certa diffidenza verso i medici, in particolare quelli greci: quest’arte, del resto, appare sempre dalle regole e dai confini piuttosto incerti. L’avidità e l’istrionismo dei medici sono oggetto di critica, e sembra quasi che l’unica qualità che decreta il successo sia l’abilità nel parlare (cfr. Plinio, Naturalis historia 29,5), per tacere delle medicine sperimentate da loro, ignoranti e pronti a improvvisare, a spese dei malati (35,108). In Petronio (42,5) troviamo una valutazione riduttiva del medico, «utile soltanto a sollevare il morale», secondo un’idea che si fa proverbio nell’antichità (Tosi 1991, 351). La tradizione favolistica accoglie l’immagine deteriore del medico inetto, rappresentato spesso come ignorante (Esopo 133 Ch.), ladro (Esopo 87 Ch.), imbroglione. Significativa è la favola del calzolaio incapace (Fedro 1,14), che, ridotto in miseria, produce un antidoto e, grazie alla sua abilità nel parlare, fa fortuna a spese dell’ottusità del popolo. In questo caso sembra prevalere il profilo pratico dell’arte medica e il luogo comune dell’abilità del medico nel raggirare il prossimo. Questa figura professionale sembra insomma assimilabile ad altre poco onorevoli, come quella dell’indovino o della maga (v.). D’altra parte, anche quando il medico non è esplicitamente descritto in modo negativo (come in Esopo 134 e 249 Ch.), le sue cure sono puntualmente intempestive o inefficaci. Curiosamente, quando gli animali si camuffano da medici, come nella favola di Esopo 14 Ch., si deve supporre immediatamente un inganno. In quel caso è il gatto, che, munito degli strumenti della professione, è disponibile a curare le galline. La rana medico, che proclama di conoscere tutti i rimedi (Esopo 69 Ch.), è ridicolizzata dalla volpe, perché è zoppa e non sa curare se stessa (qui emerge un luogo comune che si volge spesso anche contro indovini e maghi non in grado di prevedere il proprio futuro). Molto più rara la figura del veterinario, invece, che comunque non spicca per una particolare caratterizzazione (cfr. Esopo 16 Ch.), quando
deve curare l’asino e la capra. Il medico ignorante Esopo 133 Ch. C’era un medico ignorante che curava un malato; mentre tutti gli altri dottori dicevano che non correva pericolo, anche se sarebbe stato a lungo malato, egli solo gli consigliò di mettere ordine in tutti i suoi affari: «Non arriverai, infatti, a dopodomani». Dopo aver parlato in questo modo, se ne andò. In seguito il malato si rialzò e uscì di casa: era pallido e camminava a fatica. Il medico si imbatté in lui e gli chiese: «Salve, come se la passano gli abitanti degli Inferi?». L’uomo allora rispose: «Sono quieti, perché hanno bevuto l’acqua del Lete. Di recente, tuttavia, Morte e Ade hanno cominciato a minacciare terribilmente tutti i medici, perché non consentono ai malati di morire; e si sono messi ad annotare ogni nome. Erano sul punto di segnare anche te, ma io mi sono gettato di fronte a loro e li ho implorati, giurando che non è vero che tu sei un medico e sei stato incriminato senza motivo». Questa favola condanna i medici ignoranti e impreparati, il cui talento risiede solo nelle belle parole. NOTA: Il Lete è il fiume infernale dove si immergevano le anime dei morti per cancellare la memoria della vita passata. RIFERIMENTI: Babrio 75; Pseudo-Dositeo 7; F. dattiliche 6; Parafrasi 134; 15; cfr., inoltre, Ausonio, Epigrammi 4. Esopo e il malato
Esopo 134 Ch. Un medico curava un malato. Quando il paziente morì, il dottore disse a coloro che lo accompagnavano al cimitero: «Quest’uomo non sarebbe certo morto se si fosse astenuto dal vino e avesse fatto dei clisteri». Uno dei presenti gli rispose così: «Carissimo, non avresti dovuto dire queste parole ora che sono del tutto inutili, ma formulare i tuoi suggerimenti quando l’uomo ancora poteva servirsene». La favola dimostra che bisogna offrire sostegno agli amici quando ne hanno necessità e non sentenziare nelle situazioni che non hanno rimedio. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 135. L’ammalato e il medico Esopo 249 Ch. A un tale, che era ammalato, il medico chiese come si sentisse ed egli rispose che aveva sudato più del normale. Allora il medico osservò: «Questo è positivo». Interrogato poi per la seconda volta sulle sue condizioni di salute, l’ammalato spiegò di essere stato assalito da brividi che l’avevano profondamente scosso. Allora il medico rispose: «Anche questo è bene». La terza volta, come giunse e gli chiese conto della sua salute, l’uomo rispose di avere sofferto di dissenteria. Allora l’altro disse: «Va bene anche questo» e poi se ne andò via. Quando poi andò a fargli visita un parente e gli chiese come si sentisse, l’ammalato gli rispose: «Sono ormai morto a forza di stare bene». Così, molti fra gli uomini sono ritenuti felici dal prossimo sulla base di una valutazione
superficiale, per gli stessi motivi per cui sono interiormente assai afflitti. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 250. La vecchia e il medico Esopo 87 Ch. Una vecchia, che soffriva di una malattia agli occhi, mandò a chiamare, dietro compenso, un medico. Quando veniva a visitarla, a ogni unzione che le praticava, l’uomo le rubava, uno dopo l’altro, gli oggetti di casa, mentre lei teneva gli occhi chiusi. Nel momento in cui ebbe completato la cura, dopo avere sottratto tutto, il medico reclamò il compenso concordato. La vecchia, tuttavia, si rifiutò di pagare e allora lui la condusse di fronte ai magistrati. Lei ammise di avergli promesso del denaro in caso di guarigione. «Ma la mia condizione dopo le cure – aggiunse – è peggiore di prima, perché io allora vedevo tutti gli oggetti di casa mia; ora, al contrario, non sono in grado di vedere più nulla.» Così i malvagi, a causa della loro avidità, non si accorgono di offrire prove contro se stessi.
Melo Albero diffuso nelle regioni temperate, il melo, nella prospettiva culturale di vari popoli, da quelli celtici fino ai Romani, si segnala per il suo valore simbolico connesso alla conoscenza salvifica e all’immortalità. Nel mito greco, la Madre Terra dona a Era un melo dai frutti d’oro: nella sua undicesima fatica, Eracle deve riuscire a coglierli nel giardino delle Esperidi, nonostante la custodia di un drago. Ancora nel mito, nell’ambito di una gara di bellezza causata dalla dea della discordia, Paride, scelto come arbitro, assegna la mela d’oro ad Afrodite, che prevale così su Era e Atena. L’odio delle sconfitte porterà alla rovina di Troia. L’albero e il suo frutto diventano, dunque, attributo di Afrodite e simbolo di amore e di fertilità. Sono, inoltre, sacri a Nemesi, ad Artemide e ad Apollo. La tradizione cristiana, recuperando le antiche credenze della cultura europea, individua il melo come albero della conoscenza, da cui Eva coglie il frutto proibito: nella Bibbia, tuttavia, non si fa esplicito riferimento al melo, ma a un generico «albero della conoscenza» (Genesi 2,17). La tradizione favolistica, nell’unica narrazione in cui presenta il melo, sembra suggerire un riferimento al valore simbolico della fecondità (Esopo 324 Ch.). Tuttavia, come spesso accade nel mondo esopico, il riferimento pare del tutto svuotato di valori sacrali. Si tratta, insomma, semplicemente di un albero che produce molti frutti e discute con altre piante ugualmente prolifiche. La morale, comunque, sembra offrire un’interpretazione decisamente positiva del melo, che, insieme al melograno e all’olivo, va a rappresentare gli uomini migliori, in opposizione al rovo, simbolo delle persone da nulla. Il motivo favolistico costruito sul dibattito tra alberi pare di origine orientale (v. MELOGRANO).
Melograno In diverse culture antiche il melograno è simbolo di fecondità (per i numerosi grani del frutto) e di morte: sono state rinvenute melegrane d’argilla sulle tombe greche dell’Italia meridionale (cfr. Cattabiani 1996, 328). In relazione al mito di Kore-Persefone, costretta a tornare periodicamente nell’Ade per avere mangiato semi di melograno, la pianta (o meglio: il frutto) va a rappresentare il ciclo di rinnovamento del cosmo. Lo stesso simbolismo è assimilato da vari popoli mediterranei. Inoltre, il melograno, sacro a Era, è associato anche a eroine femminili, che portano i nomi greci riferiti alla pianta: Rhoió, figlia di Dioniso, dal cui sangue il melograno avrebbe trovato origine, e Síde. In latino, la pianta è definita malus punica, per la provenienza fenicia. Nella tradizione favolistica, troviamo soltanto in una occasione il melograno, impegnato a discutere con il melo e l’olivo: non si segnala per particolari caratteristiche, a parte la fecondità, così radicata nella percezione degli antichi (Esopo 324 Ch.). La narrazione appartiene al genere del dibattito tra gli alberi, di derivazione probabilmente orientale, ma presente anche nei Giambi di Callimaco (fr. 194 Pf.). Lo schema narrativo è quello della lite con l’intervento di un mediatore (così anche la favola esopica 95 Ch., che presenta la lite tra balene e delfini; in quel caso, tuttavia, il ghiozzo interviene in modo infruttuoso). Nella tradizione orientale di Ahiqar, troviamo un’altra tenzone con il melograno: «Il rovo mandò un messaggio al melograno: “Il rovo al melograno: a che serve l’abbondanza delle tue spine per chi tocca i tuoi frutti?”. Rispose il melograno al rovo: “Tu non sei altro che spine per chi ti tocca!”» (traduzione di Riccardo Contini dal testo aramaico di Elefantina, col. VII, 101-102).
Il melograno, il melo, l’olivo, il rovo Esopo 324 Ch. Un melograno, un melo e un olivo litigavano riguardo all’abbondanza dei loro frutti. La disputa si fece molto animata: allora un rovo, che dalla vicina siepe aveva udito, disse: «Carissimi, cessiamo di essere in lotta tra di noi una buona volta». Così, di fronte alle discordie dei migliori, anche coloro che non valgono nulla cercano di sembrare qualcuno. RIFERIMENTI: Callimaco, fr. 194 Pf.
Menagirti (Galli) Sacerdoti della dea Cibele, eunuchi, devono il loro nome ai viaggi compiuti ogni mese per questuare (la loro dea, il cui culto è di origine orientale, è detta anche magna mater: è forza primigenia, procreatrice di tutto). Spesso sono visti come vagabondi, fanatici, dissoluti (Mancini 293); si vestono da donna, suonano cembali e tamburi, cantano, predicono il futuro: il loro culto si estende anche a Roma, dove vengono chiamati Galli (dal fiume frigio Gallo, la cui acqua aveva fama di causare un furioso «entusiasmo»). In generale non sembrano proprio godere di alta considerazione (v. anche la voce SACERDOTE per i caratteri generali di tale figura). I Menagirti compaiono nella favola 236 Ch.: una delle più efficaci nella rappresentazione della spietata mentalità esopica. L’asino è sfruttato da vivo, percosso e umiliato da morto, secondo la prospettiva cieca e senza speranza che caratterizza gli schiavi nell’antichità. Da notare, sul piano simbolico, che l’asino, come emblema di fertilità sessuale, in ambito religioso è in stretta connessione proprio con Dioniso e Cibele. Il timpano, strumento usato dai sacerdoti, è un tamburo introdotto dall’oriente proprio con il culto di queste due divinità: è suonato dai Menagirti in occasione delle feste. Se in Esopo i sacerdoti non presentano particolari connotazioni negative, a parte la loro indole impietosa, nella versione di Fedro (4,1) sono oggetto di un’ironica allusione circa i loro comportamenti sessuali. Qui pare essere suggerita una situazione simile a quella presentata nelle rocambolesche avventure descritte nelle Metamorfosi di Apuleio (8,24-26), dove il protagonista, trasformato in asino, viene acquistato da un strano gruppo di viziosi sacerdoti (cfr. Solimano 236 s.).
I Menagirti Esopo 236 Ch. Alcuni Menagirti erano soliti viaggiare caricando i bagagli sul loro asino. Tuttavia un giorno l’asino morì a causa della fatica e quelli, scuoiatolo, con la sua pelle realizzarono dei timpani, che poi erano soliti usare per i loro scopi. Incontrandoli, altri Menagirti chiesero loro dove fosse l’asino. Allora essi risposero che era morto ma che prendeva tante botte quante neppure da vivo aveva mai sopportato. Così anche alcuni fra gli schiavi, per quanto si affranchino, non si liberano dalle loro origini servili. RIFERIMENTI: Fedro 4,1; Babrio 141; Romulus 68. Cfr. Apuleio, Metamorfosi 8,24-26 (v. anche Pseudo-Luciano, L’asino 35).
Menandro Commediografo, nato nel demo ateniese di Cefisia nel 342/1 a.C. da una famiglia di nobili origini, si dedica per tutta la vita al teatro e non sembra partecipare alla vita pubblica (morirà nel 291). Apre un’epoca nuova per la commedia: esprime sentimenti e dinamiche familiari in linea con il disorientamento e la mutata sensibilità maturati in seno alla società in epoca ellenistica. Il lieto fine delle sue opere, indirizzato spesso dal decisivo ruolo della sorte, è preceduto da sofferenze, equivoci e complessi percorsi conoscitivi. Gli antichi conoscono più di cento sue opere, che vanno però perse nel Medioevo: nel secolo scorso, cospicui ritrovamenti papiracei hanno restituito sezioni di varia estensione di una ventina di testi. Tra le commedie superstiti, Il bisbetico (l’unica completa), L’arbitrato e La donna di Samo (conservati per tre quarti). Nella favola 5,1, Fedro ripropone il tema della superiorità della poesia (v. SIMONIDE) e sembra sottolineare la bellezza della ricca interiorità di Menandro in contrapposizione con il suo atteggiamento esteriore (cfr. Mañas Núñez 138 s.; Solimano 279 s.). Questo aneddoto storico, di cui non conosciamo la fonte, lascia qualche perplessità sull’identità e sulla descrizione del Demetrio descritto dal favolista (una contaminazione con Demetrio Poliorcete?), poiché Menandro in gioventù è discepolo del filosofo peripatetico Teofrasto e diventa così ottimo amico del Falereo, che regge il governo di Atene dal 317 al 307 (v. DEMETRIO).
Menzogna La Menzogna (Mendacium) è figlia di Etere e della Terra, secondo la tradizione riportata nei Miti di Igino (Prologo). Da essi sarebbero nati anche Inganno, Lutto e altri demoni. In una favola di Fedro (Fedro, App. 4 [5]), Inganno (v.) realizza una statua a imitazione della Verità (v.), ma gli viene a mancare l’argilla per modellare i piedi. Così alla fine, mentre la santa Verità procede con il suo passo misurato, l’altra statua rimane bloccata. Allora la falsa immagine, frutto di un lavoro furtivo, viene chiamata Menzogna. La favola sembra riconducibile al proverbio «La menzogna non ha i piedi».
Mirto Il mirto è considerato simbolo di femminilità, di bellezza e di fecondità: è sacro alla dea dell’amore Afrodite, che, uscendo dal mare nuda, nell’isola di Citera, si nasconde dietro a un ramo di mirto. Anche le Grazie al seguito della dea e la Musa della poesia amorosa Erato sono rappresentate insieme a questa pianta. Del resto, in diverse culture il mirto è associato a divinità femminili: dalla mesopotamica Ishtar fino all’etrusca Turan. La pianta è usata anche per i matrimoni: gli sposi si cingono di corone di mirto beneaugurante, tanto che Plinio (Naturalis historia 15,122) lo definisce significativamente myrtus coniugalis. Proprio nell’antica Roma il mirto gode di una notevole considerazione nella sfera pubblica ed è, tra l’altro, usato nella celebrazione dei trionfi. Pare, inoltre, posto in relazione con l’idea di pace attraverso Venere, che, con un ramoscello di questa pianta, è ritratta insieme alla Concordia su alcune monete del periodo repubblicano; in generale, «il simbolismo […] in Roma testimonia non tanto un influsso greco quanto l’eredità delle arcaiche culture mediterranee legate al culto della Grande Madre» (Cattabiani 1996, 350). Nella tradizione favolistica, troviamo il mirto tra gli alberi posti sotto la protezione degli dei (Fedro 3,17): qui viene descritto secondo la consolidata tradizione di pianta sacra a Venere, contrapposta, insieme ad altre, all’olivo, di cui viene affermato, nella morale, il primato in funzione della maggiore utilità. La gloria, invece, è l’elemento distintivo del mirto. Non si trovano altre narrazioni che presentano il mirto come personaggio, mentre altrove, in una prospettiva del tutto desacralizzata, tipica della narrativa esopica, la pianta è apprezzata per la dolcezza del frutto. Particolarmente noto è il suo legame con il tordo nelle credenze popolari così come nell’arte culinaria: nella favola di Esopo 157 Ch., il tordo si gioca la vita proprio a causa del
suo smodato amore per il mirto (cfr. TORDO). Anche se qui il mirto diventa di fatto causa di morte, il contesto non sembra rimandare ad alcuni significati simbolici attestati a partire dal mito. Infatti, un altro valore simbolico di larga diffusione è quello che associa la pianta proprio alla morte: Dioniso, quando liberò la madre Semele dall’Ade, lasciò in cambio una pianta di mirto. Di qui il suo legame con i rituali funebri. Nel mito, il mirto è spesso associato a personaggi sacrificati e non manca nella descrizione dell’aldilà (cfr. Virgilio, Eneide 6,443 s., che descrive i Campi del Pianto, dove si trovano Didone, Fedra e altre tragiche figure segnate fatalmente dall’amore).
Momo Figlio della Notte e di Ipno, il dio del sonno, rappresenta il biasimo e la maldicenza. Viene descritto come ipercritico ed eternamente scontento, sempre pronto al sarcasmo. Secondo una leggenda, Zeus lo caccia dall’Olimpo per una critica inopportuna. La sua figura ha lunga fortuna: in età umanistica Leon Battista Alberti gli dedica l’opera Momo o del principe, in cui, attraverso il filtro dell’ironia, l’autore impartisce insegnamenti politici in chiave allegorica. Nella tradizione favolistica, Momo si conferma implacabile critico degli dei. In una narrazione che ha lo scopo di dimostrare come nulla sia perfetto, sono mossi impietosi rilievi a Zeus, che ha creato un toro, a Prometeo, che ha plasmato un uomo, ad Atena, che ha realizzato una casa: ma di fronte alle critiche, Zeus, sdegnato, caccia Momo dall’Olimpo (Esopo 124 Ch.). In un’altra narrazione, definita «antica» dal retore Aristide (Orazioni 28,136), questo curioso personaggio viene descritto quasi disarmato di fronte alla bellezza della dea Afrodite: allora se ne va, non senza criticare i calzari della dea, anche se poi non viene udito. Zeus, Prometeo, Atena e Momo Esopo 124 Ch. Zeus, Prometeo e Atena plasmarono l’uno un toro, l’altro un uomo e la terza una casa. Quindi scelsero Momo come giudice. Egli, invidioso per quello che avevano realizzato, prese a osservare che Zeus aveva commesso un errore nel non porre gli occhi del toro sulle corna, perché potesse vedere dove andava a sbattere. Prometeo, invece, aveva sbagliato nel non collocare il cuore dell’uomo all’esterno, perché così
non si sarebbero nascosti i malvagi e sarebbe stato evidente il pensiero di ognuno. In terzo luogo, diceva che sarebbe stato necessario che Atena avesse messo delle ruote sotto la casa; così qualora un malvagio avesse preso dimora nelle vicinanze, si sarebbe potuto spostarla facilmente. Allora Zeus si sdegnò per la sua invidia e lo cacciò dall’Olimpo. La favola dimostra che nulla è così perfetto da non essere immune da qualche critica. RIFERIMENTI: Babrio 59; Parafrasi 125; Platone, Protagora 320d; Luciano, Ermotimo 20, Nigrino 32, Storia Vera 2,3. Sono state ravvisate molte altre possibili allusioni: cfr. Adrados 2003,132. Momo e Afrodite Aristide, Orazioni 28,136 Dicono che Afrodite se ne stava magnificamente adornata, mentre Momo traboccava di disappunto, non avendo nulla da poter criticare. Alla fine, si allontanò da lei, prendendo tuttavia di mira i sandali della dea, sicché entrambi finirono per ritrovarsi soddisfatti: Afrodite non aveva sentito alcuna malignità, Momo non aveva speso parole di elogio. RIFERIMENTI: cfr. Adrados 2003,513 per alcune possibili allusioni.
Montone (ariete) Il montone (figura sovrapponibile all’ariete, specialmente nel mito) è molto apprezzato nel mondo antico; procura infatti all’uomo latte, carne, pelle e soprattutto lana. L’importanza del montone per l’uomo, soprattutto in alcune regioni europee, è ben spiegata da un aneddoto secondo cui il filosofo cinico Diogene, vedendo nella zona di Megara i montoni coperti da pelli, mentre i bambini andavano nudi, esclamò: «Meglio essere il montone di un megarese che uno dei suoi figli». In generale, «l’ariete è simbolo naturale di virilità maschile e forza generatrice» e viene spesso associato alla divinità: al dio fenicio Baal/Hamon, al dio babilonese degli abissi e del destino Ea, al dio solare egizio Amon-Ra (Cooper 44 s.). In Grecia è sacro a Zeus/Sabazio e a Dioniso, in relazione al tema della fertilità; a Roma è sacrificato nei riti di purificazione. Per quanto riguarda il mito, l’ariete è presente in pochi racconti. Noto è l’episodio della fuga di Odisseo, nascosto sotto il vello del montone, dall’antro del ciclope Polifemo (Odissea 9,170 ss.): è interessante rilevare come nel racconto folclorico usualmente l’eroe si travesta indossando una pelle di pecora e si mescoli al gregge che esce dalla grotta al pascolo. Proprio questo episodio sembra suggerire un collegamento tra mito e favola. «Il rivestimento con la pelle sembra poter essere – nel mito originario – una forma di rito iniziatico, non più compreso ai tempi di Omero, che finì col razionalizzarlo, cambiando la versione originale e facendo fuggire Odisseo nascosto sotto il vello del montone. A questo proposito, è interessante notare che in molte raffigurazioni che ritraggono la fuga di Odisseo l’eroe sembra proprio ricoperto dalla pelle di una pecora, con solamente il volto
visibile, rivolto a terra» (Zoia). In effetti, il rivestimento con la pelle di un altro animale è spesso presente anche nella tradizione favolistica e assume significati simbolici forti: ad esempio, in Esopo 267 Ch. si ha un’inversione, presto smascherata, tra l’asino e il leone, tra l’ultimo e il primo degli animali. La favola opera, insomma, la dissacrazione del motivo mitico. D’altra parte, non si trova niente di simile per il montone, che invece compare in ruoli marginali, comunque mai come protagonista di una favola: il fatto può sorprendere, visto che la favola è ambientata in un mondo rurale popolato da pecore e pastori, ma bisogna tenere conto dello svuotamento della dimesione simbolico-religiosa degli animali nel mondo esopico. Comunque, dalle rare apparizioni pare emergere una certa saggezza del montone, soprattutto in confronto all’ottusità delle pecore (Esopo 218 Ch.). Questa favola sembrerebbe in contraddizione con Romulus 76: castroni e montoni sembrano sciocchi perché, non sapendosi organizzare, vengono sterminati dal macellaio. In realtà, qui, piuttosto che un’immagine negativa del montone, sembra emergere il disprezzo per le folle stolte (Marchesi 1923, 72), spesso presente nella favola, anche in riferimento ad altri animali. Da notare, infine, che lo spessore della lana, una delle qualità del montone più apprezzate dagli antichi, compare come elemento di svolta di una favola in cui comunque il montone assume un ruolo del tutto marginale (Esopo 5 Ch.). Oltre a questi motivi favolistici, in un Papiro di Colonia (2,64) ci rimane un frammento simile all’inizio di una favola, dove troviamo un montone selvatico e una scimmia, che sembrano richiamare il consolidato modello dell’amicizia tradita tra due animali (cfr. Adrados 2003, 470). I lupi e le pecore Esopo 218 Ch. I lupi mandarono un’ambasceria alle pecore per
stipulare con esse una pace perpetua, a patto che prendessero i cani e li uccidessero. Le pecore, stolte, decisero di acconsentire. Un vecchio montone, tuttavia, disse: «Come potrò credervi e vivere con voi, quando, anche con la protezione dei cani, non posso pascolare in sicurezza?». Non dobbiamo privarci della nostra sicurezza, ponendo fiducia nei nostri peggiori nemici. RIFERIMENTI: la favola è soggetta a significative variazione nella struttura e nei personaggi (in alcune versioni non compare il montone): Babrio 93; Aftonio 21; Parafrasi 219; Romulus 63; Romanzo di Esopo 97. Il motivo è ripreso, in ambito scolastico, negli Esercizi preparatori di Libanio (VIII 24 edizione Foerster) e di Nicolao (1,5). La favola è messa in bocca a Demostene sia in Plutarco (Demostene 23,5: si rifà ad Aristobulo) sia in Isidoro di Siviglia (Etimologie 1,40). I montoni e il macellaio Romulus 76 Parenti e amici che non sono concordi vanno in rovina malamente: ce lo racconta la seguente favola. Trovandosi i castrati tutti insieme con i montoni, entrò il macellaio tra di loro e questi, pur riconoscendolo, fecero finta di non vederlo. Quando si resero conto che uno di loro veniva afferrato dalla mano assassina del macellaio, tratto fuori e quindi sgozzato, nemmeno allora furono presi dalla paura, ma fra di loro, ciechi, dicevano: «A me non tocca, a te non tocca: lasciamo che sia trascinato via quello che egli sceglie». Alla fine ne restò uno soltanto. Quando vide che allo stesso modo era trascinato via,
si dice che così abbia parlato al macellaio: «Giustamente siamo stati uccisi uno dopo l’altro da una sola persona, noi che non provvedemmo a noi stessi! Poiché, quando eravamo insieme, vedendoti in mezzo al nostro branco, non ti uccidemmo squassandoti e fracassandoti a testate». Questa favola dimostra che chi in vita non ha saputo essere prudente, viene eliminato da chi è malvagio.
Morte (Thanatos) Figlio dell’Erebo e della Notte, fratello gemello di Ipno (il sonno), Thanatos è insensibile a ogni genere di pietà e di commozione. Viene incatenato da Sisifo, ma è liberato da Zeus. Compare anche nell’Alcesti di Euripide. La personificazione della morte si trova in una sola favola (Esopo 78 Ch.), all’insegna del primum vivere, tema caro ai cinici. Un vecchio la invoca per l’insopportabile peso della legna che sta portando: quando Thanatos compare, l’uomo dice che l’invocazione dipendeva dall’esigenza di essere aiutato a trasportare il carico. Secondo Adrados 2003, 82, si tratta di una resa favolistica di un passo di Euripide (Alcesti, 669 ss.), in cui si sottolinea che gli anziani fingono quando invocano la morte, in quanto nessun uomo vuole morire, quando è vicina la fine, e nemmeno la vecchiaia pare più un fardello. Oltre a questa favola, va sottolineato che, secondo quanto riferisce Quintiliano nell’Institutio oratoria (9,2,36), Ennio nelle sue satire avrebbe presentato una contesa tra la Vita e la Morte (fr. 20 V. ), secondo uno schema simile a quello di altre favole (cfr., ad esempio, Esopo 1 Ch.: il conflitto tra i Beni e i Mali). In generale, invece, il tema della morte è assai ricorrente nella tradizione esopica, soprattutto come inevitabile esito del conflitto tra potenti e umili (si pensi solo alla celebre narrazione del lupo e dell’agnello, che apre il primo libro delle favole fedriane). 2
Il vecchio e la Morte Esopo 78 Ch. Un giorno un vecchio tagliò della legna e,
caricatala sulle spalle, cominciò un lungo cammino. Il viaggio però era faticoso e così l’uomo depose il suo carico a terra, invocando la Morte. Quando questa gli apparve e gli domandò per quale motivo la chiamasse, il vecchio rispose: «Perché mi sollevi questo carico di legna!». La favola dimostra che tutti gli uomini, anche nella disgrazia, sono attaccati alla vita. RIFERIMENTI: Sintipa 2; Tetrastici 2,21; Euripide, Alcesti 669 ss.; Van Dijk in Adrados 2003, 83 segnala altre possibili allusioni e riprese, fra cui quella, estesa e dotata sia di promitio sia di epimitio, di Niceforo Crisoberge, Esercizi preparatori 1.
Mosca Mentre oggi abbiamo una considerazione negativa della mosca, che valutiamo esclusivamente come un insetto molesto e odioso, gli antichi sembrano avere un atteggiamento più articolato, non privo di qualche espressione di benevolenza (cfr. Maspero 217 ss.). Luciano di Samosata (II secolo d.C.) scrive addirittura un divertente e scherzoso Elogio della mosca, in cui ne loda, tra l’altro, il coraggio, riprendendo il paragone che Omero fa tra l’insetto e il valente Menelao (Iliade 17,567 ss.): in quest’ottica la sua insistenza molesta diventa ardimento e perseveranza negli assalti. Ancora, Luciano ne ricorda la storia dell’origine, per cui una donna bella e chiacchierona di nome Mosca era innamorata di un ragazzo, Endimione, e continuava a svegliarlo; così la rivale, Selene, la trasformò nella sua condizione attuale, nella quale tuttavia non ha perso l’antico vizio di essere molesta nei confronti di chi dorme. Del resto, chi è importuno, merita decisamente il nome dell’insetto (cfr. Plauto, Mercator 361; Pseudolus 690). Anche Eliano (De natura animalium 7,19) definisce le mosche, allo stesso modo dei cani, decisamente sfrontate, difficili da allontanare. Nella favolistica la mosca conferma la sua tendenza a essere molesta: ad esempio, quando pizzica il capo spelacchiato di un uomo (Fedro 5,3). Nella morale, diventa simbolo di chi fa il male di proposito (l’idea della mosca come essere votato al male è peraltro presente presso vari popoli, dai Persiani agli Egizi). Anche nella tradizione favolistica, d’altra parte, l’insetto assume un significato più articolato, diventando simbolo di alcuni aspetti del cinismo (cfr. Adrados 2003, 236): su questa linea è la favola 238 Ch., in cui, dopo avere soddisfatto i bisogni primari, la mosca accetta serenamente la morte. Ma l’insetto può eccedere nei piaceri della gola e allora trova meritatamente la morte (Esopo 239 Ch.), secondo una morale e una struttura
narrativa che riguardano anche altri animali, come il tordo della favola 157 Ch., che paga con la vita il suo smodato amore per il mirto. In genere la mosca non è descritta come un animale forte, che incute paura: in un riferimento che si avvicina allo schema esopico, troviamo una miriade di mosche che vengono cacciate da una prateria da alcune vespe con il solo ronzio, a testimonianza che chi è più forte trionfa per quanto sia numericamente inferiore (PseudoCallistene 3,6). Questa vicenda riprende l’uso, quasi proverbiale, di indicare nella mosca un simbolo di debolezza (cfr., ad esempio, Eroda, Mimiambi 1,15), agli antipodi di elefanti o di altri animali di ben diversa dimensione. Si tratta di una tendenza presente anche nella favola 3,6 di Fedro, dove la mosca è rappresentata come una nullità che si crede invece molto importante (sul modello di altre favole, come quella della zanzara e del toro: Esopo 189 Ch.). Sembra quasi agli antipodi della formica nella favola 4,25 di Fedro: l’una, nella morale, diventa simbolo di chi si attribuisce falsi meriti, mentre l’altra, più laboriosa, è simbolo degli uomini di valore. La mosca Esopo 238 Ch. Una mosca, caduta in una pentola di carne, dal momento che stava per affogare nel brodo, disse a se stessa: «Ho mangiato, ho bevuto e ho fatto il bagno; anche se mi tocca di morire, non mi importa nulla!». La favola dimostra che gli uomini sopportano facilmente la morte quando giunge senza sofferenza. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 240. Le mosche Esopo, 239 Ch.
Alcune mosche volarono sopra un po’ di miele che si era rovesciato in una dispensa, con l’obiettivo di mangiarlo. Tuttavia poi, a causa della dolcezza del miele, non riuscirono a staccarsene. Le loro zampette rimasero appiccicate e, poiché non riuscivano più a volare via, le mosche affogarono, esclamando: «Quanto siamo infelici! Andiamo in rovina per un piacere che dura così poco!». Così per molti la golosità è causa di numerosi guai. La mosca e la mula Fedro 3,6 Una mosca andò a posarsi sul timone di un carro e rimproverò la mula con queste parole: «Come sei lenta, non vuoi andare avanti più rapidamente? Bada che non ti punzecchi il collo con lo stiletto». La mula rispose: «Le tue parole mi lasciano indifferente, mentre temo quest’uomo che, seduto a cassetta, tenendomi sotto il giogo, mi guida con la sua frusta flessibile e frena la mia bocca con il morso coperto di schiuma. Perciò falla finita con la tua sciocca insolenza: so perfettamente quando devo indugiare e quando devo affrettarmi». Con questa favola può essere giustamente deriso chi si avventura in vane minacce, senza valere niente. RIFERIMENTI: Romulus 47. Il calvo e la mosca Fedro 5,3
Una mosca pizzicò il capo spelacchiato di un calvo, che, cercando di schiacciarla, si diede un forte colpo in testa. Allora la mosca, deridendolo, disse: «Tu hai voluto vendicare con la morte la puntura di un piccolo insetto; che cosa farai a te stesso, dopo avere aggiunto al danno la beffa?». «Con me faccio pace facilmente – rispose – perché sono consapevole di non aver avuto l’intenzione di farmi del male. Ma te, brutta bestiaccia di razza spregevole, che ami bere il sangue dell’uomo, vorrei ucciderti, anche a costo di arrecarmi un danno maggiore.» Questa narrazione insegna che merita perdono chi sbaglia involontariamente. D’altra parte, giudico essere degno di ogni genere di castigo chi fa del male di proposito. RIFERIMENTI: Romulus 42.
Mulo Animale usato per il trasporto e per il lavoro dei campi, il mulo simboleggia per lo più testardaggine e perseveranza, talora anche docilità (cfr. Cooper 231) e vigore. Viene molto apprezzato nell’ambito dell’economia agraria e se ne raccomanda l’allevamento (cfr. Columella 6,36). Riguardo all’anomalia di questo animale, che deriva da un incrocio tra un cavallo e un asino, Eliano (De natura animalium 12,16) osserva, non senza toni critici, che non è una creatura della natura, ma una bestia frutto dell’intelligenza degli uomini, i quali, secondo Democrito, hanno appreso la modalità di procreazione dopo la prima violenza di un asino su una cavalla. Il termine «mulo» viene spesso usato come sinonimo di «asino», in termini spregiativi, generalmente con il significato di «sciocco» o di «stupido» (cfr. Catullo 83,3). La favola di Esopo più significativa per comprendere l’ambivalente natura dell’animale è certamente la 128 Ch.: la mula crede che suo padre sia un cavallo, mentre invece, non senza delusione, constata che è un asino. Di qui anche un fortunato proverbio: «L’asino che imita il cavallo» (v. sotto). Peraltro, il mulo, sempre a metà tra la natura di asino e quella equina, è al centro di una curiosa variante del proverbio «Da cavalli ad asini», affine ad alcuni motivi favolistici (v. BUE, «Passare dagli asini ai buoi») e in grado di indicare efficacemente un processo di peggioramento, per lo più di carattere economico-sociale: Cicerone afferma: «Puoi giungere a Roma con questo mulo, dato che ti sei mangiato il ronzino» (Epistulae ad familiares 9,18,4). Il mulo, tipico animale da soma, rappresenta bene un tema caro alla tradizione esopica: chi è meno importante, vive in modo più sicuro. Così accade che l’animale impegnato a trasportare oggetti preziosi venga ammazzato in un agguato di briganti, mentre il suo compagno, più umile, che porta un carico di scarso valore, ha salva la vita (Fedro 2,7). Una
narrazione, simile a una favola esopica (265 Ch.), che però vede protagonista un asino, è quella presentata da Eliano (De natura animalium 7,42) a proposito di un’astuzia di Talete, che punì un mulo malvagio. L’animale, mentre portava un carico di sale, attraversando un fiume, scivolò e perse il sale, che a contatto con l’acqua si sciolse. Visto che il carico così si alleggerì, il mulo ripeteva volontariamente questo comportamento, ogni volta che il mulattiere, nel percorrere la sua strada, era costretto ad attraversare il fiume. Talete allora consigliò all’uomo di sostituire il sale con spugne e lana. Il mulo, scivolando come al solito, inzuppò tuttavia d’acqua il carico, questa volta appesantendolo, e finalmente comprese che non doveva comportarsi così. In genere, al mulo si riserva un migliore trattamento rispetto a quello concesso all’asino, che se ne lamenta, secondo un motivo – quello dell’animale a cui è riservato un cibo migliore rispetto a un altro – proprio anche di altri autori, non solo in ambito favolistico (Senofonte, Memorabili 2,7,13; Babrio 128). Ma la favola esopica (272 Ch.) sembra giustificare la differenza, alla luce del diverso valore dei due animali. La mula Esopo 128 Ch. Una mula ben nutrita d’orzo prese a saltare per la gioia, gridando a se stessa: «Mio padre è un cavallo rapido nella corsa e io sono del tutto simile a lui». Un giorno, tuttavia, la mula si trovò costretta, per necessità, a correre. Come ebbe terminato la corsa, si ricordò immediatamente che suo padre era un asino e divenne triste. La favola dimostra che, anche se le circostanze conducono alla fama, non ci si deve dimenticare della propria origine; infatti questa vita è instabile.
RIFERIMENTI: Babrio 62; Parafrasi 129; Plutarco, Il convito dei sette sapienti 150 a-b; cfr. anche Simonide, fr. 10 P. Per i proverbi collegati, v. sotto. L’asino e il mulo che portavano lo stesso carico Esopo 272 Ch. Un asino e un mulo percorrevano insieme la stessa strada. L’asino, vedendo che il suo carico era uguale a quello del compagno, sdegnato, si lamentava perché il mulo era ritenuto degno di una doppia quantità di cibo e non portava un peso maggiore. Dopo aver percorso un breve tratto di strada, l’asinaio notò che l’asino non aveva più resistenza e gli tolse una parte del suo peso, per caricarla sul mulo. Dopo aver percorso un altro pezzo di strada, vedendo l’asino ancora più affaticato, di nuovo spostò una parte del suo carico fino a che prese tutta la soma; la tolse all’asino per trasferirla sul mulo. Allora, volgendo gli occhi verso l’asino, il mulo disse: «Mio caro, non ti sembra dunque giusto che io sia ritenuto meritevole di una doppia razione di cibo?». È opportuno pertanto che anche noi formuliamo la nostra opinione sulla condizione di ciascuno non all’inizio, ma alla fine. I due muli e i ladroni Fedro 2,7 Due muli se ne andavano gravati dei loro carichi: uno portava cesti pieni di denaro, l’altro sacchi gonfi di un’ingente quantità di orzo. Quello che porta il prezioso carico avanza a testa alta e scuote il
campanello tintinnante con il collo, mentre il compagno gli tiene dietro con passo placido e tranquillo. All’improvviso piombano loro addosso dei briganti, tendendo un agguato, e, nella cruenta mischia, trafiggono il mulo con la spada, sottraggono il denaro e trascurano il vile orzo. Mentre il mulo depredato, dunque, piangeva il suo destino, l’altro disse: «Sono proprio felice di essere stato disprezzato, infatti non ho perso nulla e non ho subito alcuna ferita». Questa storia è la prova che la povertà degli uomini garantisce la sicurezza; i grandi beni sono esposti al pericolo. PROVERBI ῎Oνoς ἵππoν µιµoύµενoς L’asino che imita il cavallo Il proverbio, riportato da Macario (6,32), indica chi cerca scioccamente di emulare qualcuno: sembra ovviamente collegabile con la favola della mula che pensava di avere un padre cavallo, mentre invece era un asino (Esopo 128 Ch.). Riguardo al legame di questa favola con la tradizione dei proverbi, cfr. inoltre Esichio, π 1134 Schmidt (Archiloco, fr. 232 Adrados/fr. 95 Lasserre: la paternità del frammento è tuttavia incerta).
Muse Figlie di Zeus e di Mnemosine (la memoria), dee del canto, della poesia e delle arti, le Muse sono in tutto nove (ma, secondo un’altra tradizione, in origine sarebbero state soltanto tre). Clio è la Musa della storia, Euterpe della poesia lirica, Talia della commedia, Melpomene della tragedia, Tersicore della danza, Erato della poesia erotica, Polinnia degli inni, Urania dell’astronomia, Calliope dell’epica, la più illustre. La loro guida è Apollo. Abitano sul monte Elicona, ma sono attribuite loro anche altre dimore, presso monti o fonti. Vengono identificate dai Romani con le Camene. Le Muse sono personaggi tipici del mito e quindi sostanzialmente estranee alle narrazioni favolistiche. D’altra parte, nel Romanzo di Esopo, il favolista viene descritto come devoto a esse. Egli è esponente di una cultura popolare e trascura il culto del dio Apollo, che è guida delle più umili Muse e «ipostasi di una sapienza sacerdotale e aristocratica»: il dio è incollerito nei confronti di Esopo, pur senza esserne stato sfidato, come accade invece nel caso del satiro frigio Marsia (Jedrkiewicz 1989, 91 ss.). Ancora nel Romanzo, a Babilonia il re Licurgo fa erigere una statua d’oro a Esopo tra quella delle Muse per sancire pubblicamente la saggezza del favolista. Peraltro, le Muse compaiono soltanto nella favola che spiega l’origine delle cicale, narrata da Platone (Fedro 259bd): un tempo uomini amanti del canto, le cicale ottengono dalle Muse il dono di cantare per tutta la vita, senza la necessità di nutrirsi. Il passaggio da uomo ad animale si ritrova anche altrove (cfr., ad esempio, quella dell’agricoltore mutato in formica: Esopo 240 Ch.). Un altro riferimento alle Muse si registra in Fedro, che, nel prologo al suo terzo libro (vv. 17 ss.), rivela di essere stato partorito sulle giogaie del monte Piero, dove Mnemosine, secondo una
tradizione che risale a Esiodo (Teogonia 53 ss.; 915 ss.), si unì nove volte con Giove in Pieria, generando le nove dee. Di qui si è ipotizzata la provenienza macedone di Fedro, che, però, probabilmente è originario della Tracia: in realtà il riferimento pare puramente letterario ed è finalizzato a nobilitare l’arte del poeta. Le cicale Platone, Fedro 259b-d Si dice che un tempo queste creature [le cicale] erano uomini, di quelli vissuti in un’epoca precedente a quella in cui nacquero le Muse; quando successivamente ebbero origine le Muse e comparve il canto, alcuni di loro furono tanto colpiti dal piacere che cantando non si curarono più di mangiare e di bere. Così, senza rendersene conto, perirono. Da loro poi derivò la stirpe delle cicale, che ebbe dalle Muse questo dono, di non avere necessità di nutrirsi fin dalla nascita, ma di iniziare immediatamente a cantare senza mangiare né bere fino alla morte, e, dopo questa vita, di andare dalle Muse a riferire chi tra gli uomini di quaggiù le onora, e a quale di esse in particolare reca omaggio. Segnalano, dunque, a Tersicore coloro che la hanno onorata nei cori, rendendoli più graditi alla Musa. A Erato chi le ha reso omaggio nei riti d’amore, e così fanno con le altre, secondo lo specifico culto attribuito a ciascuna. A Calliope, la più anziana, e a Urania, che le viene appresso, indicano coloro che trascorrono l’esistenza nella filosofia e rendono onore alla loro musica; esse, infatti, emettono tra tutte le Muse la voce più bella, occupandosi del cielo e delle storie divine e umane. RIFERIMENTI: cfr. soprattutto Imerio, Orazioni 10,6; si rilevano diverse altre riprese e allusioni, non
solo in commenti e scoli. Cfr. Adrados 2003, 561.
N
Naufrago A partire da Omero, che introduce Odisseo nell’immaginario collettivo come paradigma del naufrago illustre, il timore del naufragio è una costante che si ritrova spesso nella letteratura antica sia greca sia romana (in contesti e generi assai diversi: da Archiloco fino a Virgilio e a Petronio). Esiste, infatti, una diffusa percezione dei rischi che comporta il mare (v.). La tradizione favolistica associa puntualmente il tema della navigazione alla conseguenza del naufragio (v. NAVIGANTE): e la sorte può toccare sia agli uomini (cfr. Esopo 53 Ch.; 311 Ch.) sia agli animali (250; 350 Ch.). Per chi vive nel mondo esopico, profondamente legato alla terra, sfidare il regno del mare significa mettere a rischio le proprie fortune e la stessa vita. Curioso appare il dialogo tra il naufrago e il mare, che è pronto a difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte e dà la colpa ai venti (245 Ch.). Fedro presenta un naufragio illustre: quello del poeta Simonide (4,22 [23]). Il naufrago Esopo 53 Ch. Un ricco ateniese stava facendo un viaggio in nave insieme ad altri passeggeri. A un certo punto si scatenò una grande tempesta e la nave venne rovesciata: allora tutti si misero a nuotare, mentre l’ateniese continuava a invocare Atena, promettendole molte offerte se si fosse salvato. Uno dei naufraghi, che nuotava lì vicino, gli disse: «Insieme ad Atena, anche tu aiutati muovendo le braccia». Ebbene, anche noi, insieme alle preghiere rivolte agli dei, dobbiamo pensare a impegnarci in
prima persona per conseguire i nostri scopi. È desiderabile ottenere la benevolenza degli dei anche impegnandosi direttamente, piuttosto che non curarsi di se stessi e affidare alla divinità la propria salvezza. Coloro a cui capitano sventure devono anche attivarsi personalmente per se stessi e solo a questo punto chiedere il sostegno divino. RIFERIMENTI: sembra riscontrabile una variante concettuale di Esopo 72 Ch. (v. ERACLE e il proverbio collegato alla favola). La vicenda è comunque diversa.
Navigante I Greci, insieme ai Fenici, sono abili navigatori fin da tempi antichissimi. La navigazione, in origine praticata per lo più di giorno e vicino alla costa, è spesso considerata in relazione al rischio che comporta (v. NAUFRAGO). In Esiodo troviamo espresso un punto di vista che associa la navigazione al commercio, come pratica aggiuntiva rispetto all’agricoltura (ma i giusti, secondo il poeta, ricavano dalla terra beni sufficienti per non dover navigare); Esiodo, inoltre, la considera rischiosa e consiglia di affrontarla nei tempi opportuni, per evitare i pericoli che derivano dai venti e dalle tempeste (Le opere e i giorni 236 s.; 618 ss.). L’immagine del mercante che solca il mare con una nave sempre in balia dei venti ha lunga fortuna e approda anche nella letteratura latina (cfr., ad esempio, Orazio, Odi 1,1,15 s.; Satire 1,1,6: qui il commercio per mare è contrapposto ad altri modelli di vita). Questa associazione tra navigazione, naufragio e commercio ritorna anche nella tradizione favolistica. Il mondo esopico è un mondo di terra, non di acqua: il pastore che lascia il suo tranquillo mestiere per mettersi in mare e commerciare datteri perde inevitabilmente il suo carico (Esopo 311 Ch.). Anche quando la navigazione non è associata al commercio, comporta spesso la conseguenza del naufragio: il poeta Simonide s’imbarca su una nave che si sfascia in mare aperto per un’orribile tempesta e perché ormai inadatta a causa degli anni: poi arrivano anche i pirati (Fedro 4,22 [23]); un ricco ateniese finisce in mare, ma non nuota confidando nell’aiuto divino (Esopo 53 Ch.). Quando una nave viene assalita dalla tempesta, le persone che sono a bordo si disperano per poi gioire senza misura quando il tempo torna sereno (Esopo 308). La morale di questa narrazione, che in Fedro viene raccontata dallo stesso Esopo (4,17 [18]), è che bisogna rallegrarsi e disperarsi con
moderazione, perché le sorti dell’uomo sono incostanti. Si tratta di un tema già presente in Archiloco (fr. 128 W. ), che ha lunga fortuna. Del resto la navigazione può diventare metafora della vita e di alcuni suoi aspetti: ad esempio, a partire da Alceo (fr. 208a V.) l’immagine della nave in tempesta è impiegata per rappresentare le sorti dello Stato. 2
I naviganti Esopo 308 Ch. Alcuni uomini, saliti su una nave, navigavano. Quando furono al largo, si scatenò una violenta tempesta, e per poco la nave non affondò. Uno dei naviganti si strappò le vesti e si mise a invocare gli dei della sua patria con gemiti e lamenti, promettendo che avrebbe offerto sacrifici di ringraziamento se i naviganti si fossero salvati. Una volta che la tempesta ebbe termine e di nuovo si fece bonaccia, i naviganti apparecchiarono un banchetto solenne e si misero a danzare e a saltare, come chi è appena sfuggito a un pericolo improvviso. Allora il nocchiero, uomo inflessibile, disse loro: «Cari miei, dobbiamo gioire pensando che la tempesta potrebbe eventualmente scatenarsi di nuovo». La favola insegna che non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo per le circostanze favorevoli, ma pensare che la sorte cambia facilmente. RIFERIMENTI: Fedro 4,17 [18]. Il padre di famiglia Pseudo-Dositeo 4 Un padre di famiglia, un tale, non so chi,
navigando in mare, era in affanno per una tempesta, a causa della quale i marinai governavano la nave in modo piuttosto inefficace. A loro l’uomo disse: «Se non conducete più rapidamente questa nave, vi getterò contro gli scogli». Allora uno dei marinai rispose: «Magari fossimo in un punto dove si potessero raccogliere pietre». Così, in simili frangenti, dobbiamo rendere le nostre anime più tolleranti, mentre cerchiamo di evitare sventure più grandi. Il marinaio e il figlio Esopo 306 H.-H. Un marinaio – si dice – aveva un figlio e volle fargli imparare la grammatica, per cui lo mandò a lezione, dove gli fece praticare la disciplina per un tempo sufficiente ad arrivare a conoscerla molto bene. Quindi il figlio disse al padre: «Papà, ecco che sono arrivato a conoscere in modo preciso tutta la grammatica; ma ora voglio studiare a fondo anche la retorica». Il padre ne fu contento e di nuovo lo mandò a lezione: divenne molto bravo nella retorica. Trascorsi alcuni giorni, mentre mangiava in casa con la madre e il padre, il giovane raccontava loro di essere ormai esperto di grammatica e di retorica. Il padre dice al figlio: «Ho sentito, riguardo alla retorica, che essa è la più preziosa tra tutte le arti e anche che chi ne è ricco si esprime con sicurezza. Da’ dunque anche tu prova di tale abilità». Il ragazzo rispose: «Distribuendo questa gallina in base a come richiede quest’arte, vi mostrerò che in realtà essa è migliore delle altre arti». Mentre faceva le parti, il giovane disse: «A te papà darò la testa, perché sei la “testa” della casa e comandi tutti noi. A te, invece,
mamma, darò queste zampe, perché, correndo tutto il giorno per la casa, riesci a compiere molte cose: senza le gambe, non potresti farcela. A me, dunque, resta questo corpo morto: niente nella vita può risultarmi agevole, a meno che non ricavi qualcosa di utile dai molti insegnamenti che ho ricevuto». E, così dicendo, cominciò a mangiare la gallina. Il padre, irritato, gliela prese e, dopo averne fatto due parti, disse: «All’inizio non volevo tagliare questa gallina, ma adesso voglio farlo, per mangiarne una parte, mentre tua madre mangerà l’altra. Tu gusta, invece, ciò che hai prodotto con la tua retorica». Così accade a coloro che nella vita vanno avanti a forza di inganni e discorsi astuti.
Nibbio Il nibbio, che si distingue dallo sparviero per le dimensioni quasi doppie, è simbolo delle persone avide. Provocatoriamente, nel Satyricon di Petronio (42) la donna viene accostata alla razza del nibbio. D’altra parte, secondo Plinio (Naturalis historia 10,28) questo uccello è rapacissimo ma ha anche una sensibilità religiosa, perché non ruba cibo dalle offerte funebri, dall’altare di Olimpia e dalle mani di chi porta offerte sacrificali; se lo fa, si tratta di un funesto presagio. Proverbiale è non solo la rapacità degli artigli del nibbio, ma anche l’acutezza della sua vista, caratteristica comune all’aquila (l’espressione Milvinos oculos, ossia «Occhi di nibbio», si trova in Apuleio, Metamorfosi 6,27). Al nibbio viene attribuito un verso singolare (iugilare o iubilare, verbo usato anche per indicare il modo di gridare dei contadini), probabilmente onomatopeico; addirittura Isidoro di Siviglia (Etimologie 12,7,9) sostiene che il nome dell’uccello in latino (milvus) deriva dal suo verso, ma forse si tratta semplicemente di un suono simile. Proprio sul verso del nibbio si costruisce una delle favole esopiche forse più curiose: la 136 Ch. Qui troviamo un nibbio che perde la sua voce senza riuscire a imitare quella del cavallo: così si ritrova con una voce peggiore (secondo alcune versioni della favola «più volgare»). Ecco dunque svelato, a partire dalla voce, il singolare profilo di questo «uccello contadino»; si può pertanto giungere alla conclusione che «il carattere “rustico” della voce romana del nibbio corrisponde perfettamente a quanto ne dicevano i Greci, che la consideravano “volgare”» (cfr. Bettini 2008, 94 ss.). Nelle altre favole il nibbio, in linea con una consolidata tradizione, simboleggia gli uomini iniqui e malvagi (cfr. Fedro 1,31; Esopo 135 Ch.). L’uccello, contrariamente alla tendenza descritta da Plinio, sembra passare la propria vita deturpando i luoghi sacri (Romulus 23).
Il nibbio che nitriva Esopo 136 Ch. Il nibbio aveva in origine un’altra voce, acuta. Poiché sentì un cavallo che nitriva magnificamente, prese a imitarlo di continuo e tuttavia non riuscì ad apprendere bene il suo verso; così perse la propria voce, non riuscendo né ad acquisire quella del cavallo né a mantenere quella precedente. Gli inetti che, per invidia, imitano quanto è contrario alla loro natura, perdono anche le doti che derivano dalla loro indole. RIFERIMENTI: Babrio 73; Aftonio 3; Parafrasi 137; Dodecasillabi 137; Giuliano, Misopogone 366a. Il nibbio e le colombe Fedro 1,31 Chi si fa proteggere da un uomo iniquo, mentre cerca aiuto, trova la sua rovina. Dal momento che le colombe spesso erano sfuggite al nibbio e grazie alla rapidità delle ali erano scampate alla morte, il rapace ricorse all’inganno e raggirò quella specie inerme con un’astuzia di questo tipo: «Perché trascorrete tutta la vita in ansia, invece di eleggere me come re, stipulando un patto, in modo che possa rendervi sicure da ogni oltraggio?». Quelle, dandogli retta, si consegnarono al nibbio, che, conquistato il potere, cominciò a divorarle una dopo l’altra e a esercitare il suo dominio con gli spietati artigli. Allora una delle superstiti disse: «Subiamo la giusta punizione».
RIFERIMENTI: Romulus 28. Il serpente e il nibbio Esopo 135 Ch. Un nibbio, dopo avere ghermito un serpente, volò in cielo. Ma il rettile si volse e lo morse, così entrambi precipitarono dall’alto e il nibbio morì. Allora gli disse il serpente: «Perché sei stato tanto folle da volere attaccare chi non ti faceva nulla di male? Così hai ricevuto la giusta pena per il rapimento». Un uomo che cede all’arroganza e fa del male ai più deboli, trovandosi davanti uno più forte di lui, pagherà, quando meno se lo aspetta, anche il male commesso in precedenza. RIFERIMENTI: Parafrasi 136; Dodecasillabi 136. Il nibbio ammalato Romulus 23 Vanamente chiede perdono per i suoi misfatti chi indugia nella malvagità. Colto da una malattia, un nibbio, che giaceva da molti mesi e ormai non aveva speranza di vita, pregò in lacrime sua madre di visitare i luoghi sacri e di fare grandi voti per la sua salvezza. «Figlio, – disse lei – farò quello che vuoi; ma ho molta paura e temo, mio caro, di non conseguire lo scopo. Dal momento che hai devastato tutti i templi e hai profanato tutti gli altari, senza risparmiare nemmeno i sacrifici, ora che preghiere vuoi che faccia?». Ascoltino queste parole coloro che, commesso un crimine, persistono nella loro
malvagità e, segnati dalle loro macchie, osano andare in giro per luoghi sacri. Devono darsi da fare e faticare affinché i loro mali siano cancellati. RIFERIMENTI: cfr. Esopo 168 Ch. (qui c’è il corvo).
Noce Simbolo di abbondanza e di ricchezza nascosta, il frutto, custodito all’interno del guscio, fin dall’antichità è naturalmente associato al rituale delle nozze (Brosse 151), come attesta, tra gli altri, Plinio (Naturalis historia 15,86). Il termine greco καρύα rimanda al mito di Caria, figlia di Dione, re della Laconia: morì di dispiacere per la perdita delle sorelle; allora Dioniso, che l’aveva amata, commosso la trasformò in un noce ricco di frutti. In relazione a questo mito, Artemide, che racconta ai Laconi l’accaduto, viene onorata con un tempio e riceve l’appellativo di Cariatide (in realtà, secondo alcune interpretazioni, il mito deriverebbe da uno più antico relativo a una divinità pelasgica che dà il nome alla Caria, regione dell’Asia Minore). Il frutto è molto apprezzato nell’antichità: se ne trae un olio, è usato nella farmacopea. A Roma è consacrata a Giove: il nome iuglans è interpretato come «ghianda di Giove». La favola valorizza la percezione positiva della pianta, ma in un contesto paradossale. In Esopo 152 Ch., infatti, si rappresenta il noce come un benefattore degli uomini che viene ricompensato dai passanti con il lancio di pietre. La narrazione, tuttavia, è molto breve e omette di spiegare estesamente quanto invece è chiarito da altre fonti: le pietre sono lanciate per far cadere gli ottimi frutti, di cui i passanti sono ghiotti. La favola potrebbe avere origine orientale; nella tradizione di Ahiqar, un albero lungo la strada è depredato dagli uomini e danneggiato dagli animali: è paragonato a un uomo privo di fratelli, moglie e figli (cfr. Contini-Grottanelli 202). Al centro della narrazione esopica è il tema dell’ingratitudine, sviluppato in diverse altre favole, come nella 82 Ch., in cui il serpente morde l’uomo che l’ha salvato dal gelo. Il noce
Esopo 152 Ch. Un noce che si trovava lungo una strada ed era continuamente colpito dalle pietre gettate dai passanti, gemendo per la sua condizione, disse: «Ahimè infelice, ogni anno procuro a me stesso insulti e dolori!». La favola è rivolta a coloro che soffrono per i loro stessi beni. RIFERIMENTI: Parafrasi 153; Dodecasillabi 153; Antologia Palatina 9,3 (Antipatro di Tessalonica, ripreso in Epigrammata Bobiensia 44); PseudoOvidio, Nux 1-2.
O
Oca Fin da tempi remoti, l’oca assume importanti significati simbolico-religiosi presso i popoli eurasiatici e africani, sia nella veste originaria di animale selvatico, sia in quella, già largamente attestata presso i Sumeri e gli Egizi, di animale domestico (cfr. anche CIGNO). In Mesopotamia è considerata uccello sacro alla dea Baba; in Egitto rientra spesso tra le offerte rese a dei e sovrani; in Grecia rientra nel numero degli animali che possono essere offerti in sacrificio (v. Bodson-Marcolungo 49). Inoltre, l’oca selvatica è associata ad Afrodite; ammirata per la bellezza (Artemidoro, Sull’interpretazione dei sogni 4,83), è accolta presso gli uomini anche come animale da compagnia. Nel mondo antico l’uccello, spesso ingrassato, è particolarmente apprezzato come prodotto alimentare (in particolare, il foie gras risulta noto ai Greci a partire dal IV secolo a.C.); ma l’oca è ritenuta anche un ottimo animale da guardia, attento nel vigilare (come rileva Aristotele, Historia animalium 488b), in grado di lanciare l’allarme con tempestività: in questo servizio addirittura migliore del cane (Columella 88,13,1-2). Noto, in questo senso, l’episodio delle oche del santuario di Giunone che, secondo la tradizione, nel 390 a.C., salvarono il Campidoglio dai Galli. Nella letteratura, l’animale è spesso presente già a partire da Omero: ma se l’Iliade ci presenta soltanto oche selvatiche (in 2,460 si rileva l’accostamento di oche e gru che ritorna nella favola), l’Odissea, che fa riferimento a una società successiva, segnala in vari passi la presenza di oche domestiche. Anche nella tradizione favolistica, in cui l’uccello compare raramente, ritroviamo la distinta rappresentazione di oche selvatiche e domestiche. Sono selvatiche, simbolo di ricchezza e di opulenza, quelle della favola 353 Ch.: frenate dal peso, sono preda dei cacciatori, mentre le agili gru, nella morale simbolo dei poveri, riescono a volare via. Il tema del
radicamento a terra dell’oca ha larga fortuna anche nella tradizione favolistica successiva. In età umanistica, ad esempio, troviamo, in un apologo di Leon Battista Alberti (52), il racconto relativo a un’oca meravigliata per la sproporzione tra la testa, piccola, e i piedi, enormi. Questi ultimi allora ricordano all’uccello che è meglio avere piedi ben piantati per chi ha una testa leggera. Si parla, invece, di un’oca domestica nella favola 173 Ch., dove ricorre il motivo dell’allevamento a scopi alimentari: l’uccello, ingrassato, avrà una sorte differente dal cigno, la cui principale qualità è l’eccellente canto. In una versione secondaria di una favola di larga fortuna, La gallina dalle uova d’oro (287 Ch.), si trova come protagonista un’oca che finisce per essere sventrata dal suo avido proprietario. Ma, grazie anche a La Fontaine (5,13), la gallina ha avuto gioco facile a imporsi sulla rivale nella letteratura europea, nella tradizione dei proverbi e nell’immaginario dei lettori. Le oche e le gru Esopo 353 Ch. Oche e gru becchettavano su uno stesso prato. Quando comparvero di fronte a loro dei cacciatori, le gru, leggere, volarono via; invece le oche, bloccate a terra a causa del peso dei corpi, furono catturate. Così anche fra gli uomini, quando scoppia una guerra in una città, i poveri, che si spostano con facilità, si salvano agevolmente passando da una città all’altra; invece i ricchi, trattenuti dalla grande quantità dei loro beni, diventano schiavi. RIFERIMENTI: anziché gru).
Sintipa
60
(si
L’oca e la cicogna
trovano
cigni
Romulus 80 Quando la cicogna giunse al solito stagno, trovò l’oca che si tuffava di frequente in acqua. Le chiese perché lo facesse. Rispose l’altra: «Siamo abituate così; infatti troviamo cibo nel limo e così sfuggiamo l’impeto dello sparviero che piomba su di noi». Di rimando la cicogna: «Sono più forte dello sparviero. Stringi amicizia con me e farò sì che sia tu ad avventarti su di lui». L’oca le credette e chiese di lì a poco il suo soccorso. Mentre quella usciva nei campi con la cicogna, subito arrivò lo sparviero, afferrò l’oca con gli artigli e la divorò […] A lei l’oca in risposta: «Chi si unisce a un difensore tanto debole, necessariamente trova peggiore morte». Per coloro che desiderano essere difesi da chi non può offrire protezione alcuna.
Oggetti Nel mondo antico esiste una lunga tradizione di «oggetti parlanti», attestati innanzitutto a livello epigrafico, sia in ambito greco (cfr. Burzachechi 3 ss.), dove troviamo la celebre Coppa di Nestore (VIII secolo a.C.), sia in ambito romano, dove abbiamo, tra i più antichi documenti della lingua latina, il vaso di Dueno (databile intorno al 600 a.C.) e la (discussa) Fibula prenestina, una spilla in oro, di poco precedente, che reca questa frase: «Manio mi fece per Numerio». Quanto alla sfera più strettamente letteraria, la tendenza alla personificazione di oggetti inanimati appartiene specialmente alla tradizione epigrammatica: oltre alla consolidata immagine del libro parlante (cfr., ad esempio, Marziale 10,1), uno dei casi più ricorrenti è quello delle statue di dei a cui i poeti danno voce (in Antologia Palatina 12,143, si rileva, ad esempio, il dialogo tra un uomo e una statua di Hermes, che si rifà forse a Callimaco, fr. 199 Pf.). Nelle Satire di Orazio (1,8) troviamo la vicenda di un tronco di fico che racconta la sua vita: di fronte alle possibili prospettive di diventare o uno scanno o un dio, finisce, grazie all’opera di un falegname, per diventare la statua di Priapo, il dio della fertilità (un Priapo che parla al poeta si trova inoltre in Tibullo 1,4). Più vicina alla rappresentazione esopica, è certamente la torre parlante che si trova nella vicenda di Amore e Psiche (Apuleio, Metamorfosi 6,17), una narrazione che presenta caratteri fiabeschi più che favolistici. La favola trasferisce le sue tipiche strutture e i motivi narrativi al mondo degli oggetti, a cui viene occasionalmente attribuita la parola. Il tema dell’immutabilità della natura caratterizza la nota vicenda del serpente che vuole avere qualcosa dalla lima, abituata tuttavia a prendere e non a dare (Esopo 116 Ch.; come dichiara anche nel promitio, Fedro 4,8 sembra invece centrare il racconto sullo scontro
tra due personaggi, uno più forte dell’altro). Basata invece sullo schema del conflitto tra due personaggi è la narrazione che presenta la pentola di terracotta e quella di bronzo nelle vesti l’una del povero e l’altra del ricco (Esopo 354 Ch.). Questo scontro diviene un naturale spunto per la tradizione dei proverbi, fino alle letterature moderne (v. sotto). Aviano (11) offre una versione ampliata dell’originaria narrazione babriana, ricostruibile attraverso la Parafrasi Bodleiana. Un altro motivo narrativo tipicamente esopico è quello dell’orgoglio punito di chi vuole essere superiore alla sua natura (v., ad esempio, CALZOLAIO): la lampada si vanta per la sua luce, ma viene riportata alla realtà da un anonimo interlocutore che propone un confronto impietoso con la luminosità degli astri (Esopo 232 Ch.). Nella favolistica ritorna la situazione, come si è visto assai diffusa nella letteratura classica, della statua parlante: in una narrazione dai caratteri decisamente comici (Babrio 48), Hermes promette gratitudine a un cane a lui devoto se eviterà di ungere, pur con le migliori intenzioni, la sua statua. In altri casi, non è l’oggetto stesso a prendere direttamente la parola, ma il dio rappresentato dalla statua appare successivamente in sogno (Babrio 30; Esopo 131 Ch.: qui la statua è quella di un eroe). Narrazione dalle sfumature comiche è quella del muro trafitto dall’incolpevole chiodo (Esopo 337 Ch.): intende probabilmente rappresentare l’interdipendenza delle azioni umane e la necessità di ricercare la vera responsabilità quando si subisce un torto. Nel Romulus (94), troviamo un uomo impegnato in un singolare dialogo con una spada, simbolo dei malvagi. Già in una commedia di Plauto, Il soldato fanfarone (5 ss.), il miles Pirgopolinice parla della sua spada, quasi personificandola. Le pentole Esopo 354 Ch. Una pentola di terracotta e una di bronzo erano
trascinate dalla corrente di un fiume. La pentola di terracotta disse a quella di bronzo: «Stai lontana e non avvicinarti; infatti, se mi urti, vado in pezzi, anche se non è mia intenzione toccarti». Un povero che sta vicino a un ricco avido non ha una vita tranquilla. RIFERIMENTI: Aviano 11; Parafrasi 355. La lampada Esopo 232 Ch. Una lampada ebbra d’olio, che produceva una luce splendente, si vantava di essere più brillante del sole, ma ci fu un soffio di vento e subito si spense. Un tale la riaccese di nuovo e le si rivolse in questo modo: «Splendi, lampada, e taci: la luminosità degli astri non si spegne mai». Non bisogna gonfiarsi d’orgoglio nei momenti di fama e di gloria; infatti tutto quello che si acquisisce ci è estraneo. RIFERIMENTI: Babrio 114; Parafrasi 233. Cfr. anche Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 90, ed. Boissonade). L’eroe Esopo 131 Ch. Un uomo offriva generosi sacrifici a un eroe di cui teneva in casa la statua. Poiché per quei sacrifici spendeva in continuazione e consumava molto denaro, l’eroe gli apparve una notte e gli disse: «Caro mio, smettila di dilapidare le tue sostanze;
infatti, una volta consumato tutto, diventerai povero e darai la colpa a me!». Così molti, infelici a causa della loro sconsideratezza, danno la colpa agli dei. RIFERIMENTI: Babrio 63. Cfr. inoltre Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 31, ed. Boissonade). La statua di Hermes e il cane Babrio 48 In una strada era collocata una statua quadrangolare di Hermes, con un mucchio di pietre accatastate alla base. Un cane si avvicinò alla statua e le si rivolse in questo modo: «Innanzitutto, Hermes, ti saluto; poi voglio ungerti, per non passare accanto a un dio senza ungerlo, e per di più un dio degli atleti». Hermes gli rispose: «Se tu non vieni a leccare l’olio su di me, né a orinare, ti sarò grato. Non devi attribuirmi maggiori onori!». Il muro e i chiodi Esopo 337 Ch. Un muro, trafitto con violenza da un chiodo, urlava: «Perché mi trafiggi? Non ti ho fatto niente di male». E l’altro rispose: «Non è colpa mia, ma di colui che mi spinge con forza da dietro». Il soldato e la tromba Aviano 39
Un giorno un soldato, provato dalle battaglie, aveva fatto voto di dare fuoco a tutte le armi, sia quelle che la moltitudine dei militari avversari aveva consegnato morendo a lui vincitore, sia quelle che aveva potuto ottenere dal nemico in fuga. Nel frattempo, la fortuna gli fu benigna e il soldato, ricordandosi del voto, aveva cominciato a portare le armi, una a una, sul rogo acceso. Allora la tromba, con roco suono, respinge la colpa e gli spiega innanzitutto che non merita le fiamme. «Nessuna freccia – gli dice – che tu possa affermare spinta dalla mia forza, ferì le tue braccia. Ma io ho soltanto radunato le armi con soffi d’aria e con suoni, e per di più (chiamo gli astri a testimoni) con questo segnale sommesso.» L’uomo, aggiungendo alle fiamme crepitanti la tromba riluttante, disse: «Ora ti rapiscono una pena e una sofferenza più grandi. Infatti, per quanto tu stessa non possa né osi compiere nulla, risulti più crudele per questa ragione, che rendi gli altri malvagi». RIFERIMENTI: Esopo 325 Ch.; Dodecasillabi 326 (in queste versioni, il trombettiere ha il ruolo che in Aviano assume il suo strumento). La spada Romulus 94 Chi manda in rovina gli altri, andrà una buona volta in rovina. Un viandante, camminando, trovò una spada che giaceva a terra sulla strada. Le domandò: «Chi ti ha perduto?». A lui l’arma rispose: «Uno solo ha perduto me, io invece ho perduto molti». Questa favola narra che un malvagio può
perire, ma prima può nuocere a molti. NOTA: La favola si gioca sul doppio senso del verbo «perdere» (inteso come «smarrire» e come «uccidere»). PROVERBI Χύτρα και πέτρα oὐ συμϕωρεῖ La pentola di terracotta e la pietra non vanno d’accordo Questa espressione proverbiale, riportata nelle Discussioni di Epitteto (Arriano 3,12,12), va certamente letta, come nota Tosi 1991, 709, alla luce della favola delle due pentole (Esopo 354 Ch.). L’immagine ha lunga fortuna e si ritrova nelle letterature successive: non solo in ambito favolistico (La Fontaine 5,2), ma anche nei Promessi Sposi (25), dove si spiega così la difficile condizione di don Abbondio, che deve fare i conti con i potenti.
Olivo L’olivo, originario probabilmente dell’Asia Minore, è, secondo il mito, introdotto in Grecia da Atena, che, per giudizio del re Cecrope, supera Poseidone in una gara in cui le due divinità si sfidano per portare il dono più utile all’Attica. Anche in ambito romano il legame tra Minerva e l’olivo è noto: Virgilio, ad esempio, riprende l’idea secondo cui la dea ne è la scopritrice (Georgiche 1,18). Esistono, comunque, altre leggende secondo cui sarebbe stato Hermes a insegnarne la coltivazione all’uomo; o Eracle a portare in Grecia l’olivo silvestre. Proprio l’eroe, peraltro, istituisce i Giochi Olimpici, svolti ogni quattro anni in onore di suo padre Zeus. La corona di oleastro diventa poi il premio per i vincitori. L’olio, assai apprezzato, è invece premio nei Giochi Panatenaici in onore di Atena. Ma anche altre divinità, come Zeus e Apollo, sono onorate con questa pianta. Il valore simbolico dell’olivo è decisamente complesso. Emblema di castità, per la relazione con la vergine Atena, la pianta, come ricaviamo anche da monete e altre fonti archeologiche, va a rappresentare, tra l’altro, la clemenza, l’equità, la pietà, la misericordia e la luce (ancora nell’Alcyone di D’Annunzio, la poesia L’ulivo celebra il legame con Atena e la luce). Molto noto, presso vari popoli del Mediterraneo, è soprattutto il simbolismo della vita, della rigenerazione, della prosperità e della pace, attestato anche nell’Antico Testamento (Genesi 8,11: in relazione con la colomba). I re e i sacerdoti nella Bibbia sono unti con olio (1 Samuele 16,12-13). Nella lunga favola riportata da Callimaco (fr. 194 Pf.), di origine orientale, come attesta lo stesso poeta, attribuendone la paternità ai Lidi, si ritrovano numerosi elementi di larga diffusione nella cultura greca: l’uso dell’olivo in ambito funebre (a Sparta Licurgo impone di seppellire i defunti con foglie di olivo: cfr. Plutarco, Licurgo 27; è usato anche dai Pitagorici insieme a foglie di pioppo
nero e rami di mirto: cfr. Plinio, Naturalis historia 35,160); il noto impiego come premio alle gare di Olimpia; il legame con Atena; i frutti e l’unguento prodotti dalla pianta; il fatto che, in linea con il simbolismo illustrato sopra, i supplici protendano rami di olivo (v. anche ALLORO). D’altra parte, l’elemento che alla fine decreta il successo dell’olivo è il fatto che i Delii proteggono il tronco che diede sollievo a Leto (cfr. anche Callimaco, Inno a Delo 262; 321 ss.; Giambo XIII, fr. 203 Pf., v. 62): il riferimento qui è al parto di Apollo. Se l’utilità della pianta è una delle virtù lodate nella contesa con l’alloro, su questa stessa qualità è impostata anche una favola di Fedro (3,17), nella quale Minerva chiede a Giove perché gli dei tendano a porre sotto la propria protezione piante infeconde, mentre la dea sostiene che l’olivo è «più caro proprio per il frutto». La contrapposizione è tra la gloria e l’utilità, che la morale esorta a ricercare. D’altra parte, all’olivo non sono riferiti solo significati positivi: diventa simbolo di orgoglio punito nella favola di Esopo 143 Ch. che lo vede contrapposto alla canna: non piegandosi, si spezza per la forza del vento (la superbia è punita anche nella favola 31 di Sintipa, dove l’olivo si vanta con un fico). A proposito di questa narrazione, va rilevato un dato interessante: in alcune versioni della favola si trova la quercia anziché l’olivo, quasi a testimoniare la nobiltà equivalente di due alberi tenuti in grande considerazione dagli antichi (cfr. CANNA; QUERCIA). Un’altra favola presenta elementi di notevole interesse: quella degli alberi che cercano un sovrano. Come molte altre relative agli alberi, si segnala per la sua origine orientale. La narrazione di impronta antimonarchica trova origine nella Bibbia (Giudici 9,8-15) e viene recepita con poche varianti nelle collezioni esopiche (v. anche FICO). Qui l’olivo appare come pianta nobile, degna di regnare sugli alberi, ma non disponibile a farlo per non lasciare l’olio così apprezzato da uomini e dei: la relazione con la dignità regale sembra, peraltro, chiara a partire dalla pratica dell’unzione dei sovrani e dei sacerdoti (v. sopra).
Gli alberi e l’olivo Esopo 252 Ch. Un giorno gli alberi sentirono il bisogno di eleggersi un re e dissero all’olivo: «Regna su di noi». L’olivo disse loro: «Dovrei andare a governare gli alberi e lasciare il grasso olio che in me apprezzano gli dei e gli uomini?». Allora gli alberi dissero al fico: «Vieni qui a governare su di noi». Ma il fico replicò: «Dovrei andare a governare gli alberi e lasciare i miei frutti dolci e buoni?». Allora gli alberi dissero al ramno: «Vieni qui a regnare su di noi!». E il ramno rispose loro: «Se veramente mi ungete come vostro re, mettetevi al riparo sotto di me; altrimenti esca il fuoco dal ramno e divori i cedri del Libano». RIFERIMENTI: oltre al parallelo con la Bibbia, vanno ricordati: Giuseppe Flavio, Antichità Giudaiche 5,236-238; Agostino, Contra mendacium 13,28; Isidoro, Etimologie 1,40,6.
Onagro L’onagro, ossia l’asino selvatico, presenta tratti comuni ma anche significative differenze rispetto a quello domestico (v. ASINO). Più consistenti sono le dimensioni, differente anche l’uso, visto che viene impiegato per trainare i pesanti carri dei Sumeri o i carri da guerra nell’antico Egitto (qui fa parte anche della simbologia astronomica); inoltre, «l’asino selvatico del deserto simboleggiava desolazione, diffidenza, rapidità e solitudine» (Cooper 47 s.). Tra le notizie curiose circa questo animale, spesso localizzato in terre orientali e aspre, Eliano (De natura animalium 17,26) riferisce che in India vengono cacciati, insieme ad altri animali, da leoni addomesticati; mentre nel selvaggio territorio degli Armeni gli onagri vengono eliminati attraverso pesci triturati e infarinati, che risultano loro fatali. Nella favolistica la figura dell’onagro si definisce spesso attraverso la contrapposizione con l’asino domestico, secondo uno schema proprio anche di altri animali, fondato per lo più sul rapporto dialettico tra una vita libera ma dura e un’esistenza agiata ma trascorsa nella schiavitù. Così, ad esempio, il lupo compiange l’asservimento del cane, attratto dal cibo che gli offre l’uomo (Esopo 226 Ch.). La contrapposizione animale selvatico-animale domestico si declina in vari modi ma quasi sempre sottolinea le conseguenze negative della domesticazione: addirittura le colombe selvatiche vengono catturate a causa di quelle domestiche, più fedeli al padrone che ai loro simili (Esopo 282 Ch.). In linea con questa prospettiva, in una narrazione di Esopo (264 Ch.) l’onagro prima invidia l’asino per la vita agiata che conduce, ma poi si ricrede quando vede i carichi e le bastonate a cui è sottoposto; invece, in una favola di Sintipa (30) la morale pare rovesciata: l’onagro compiange l’asino domestico, ma poi viene aggredito dal leone, mentre la vicinanza del padrone garantisce la salvezza all’asino. In
una narrazione che presenta poche differenze con quella dell’asino e del lupo (Esopo 281 Ch.), da cui peraltro deriva, un onagro zoppicante con un calcio uccide (non semplicemente ferisce) un lupo (Esopo 257 H.-H.) e dimostra maggiore aggressività del suo simile che vive con l’uomo. Anche un’altra narrazione (Esopo 207 Ch.), che ha una lunga fortuna e presenta diverse varianti nella struttura e nei personaggi (v. sotto), sottolinea la subordinazione dell’onagro al più potente leone: la favola rimanda al proverbiale patto leonino (v. LEONE). Il leone e l’onagro Esopo 207 Ch. Un leone e un onagro andavano a caccia di bestie selvatiche, il primo facendo affidamento sulla forza, il secondo sulla velocità delle zampe. Dopo che ebbero catturato alcuni animali, il leone divideva il bottino e ne faceva tre parti: «Una – disse – la prenderò io, perché sono il più importante, infatti sono il re; la seconda la prenderò in qualità di socio alla pari; questa terza parte ti procurerà un grosso danno se non fuggirai.» In ogni circostanza è bene valutare la propria condizione sulla base della forza che si possiede e non legarsi né associarsi con i più potenti. RIFERIMENTI: cfr. anche Esopo 209 Ch., favola in cui troviamo il leone a caccia con l’asino e la volpe: alla fine, sbranato l’asino e intimidita la volpe, tutte e tre le parti sono sue. Cfr. inoltre Fedro 1,5; Babrio 67; Romulus 8; F. dattiliche 5 e 21; Parafrasi 208; Dodecasillabi 208 e 210; Tetrastici 1,41 e 1,48. L’onagro e l’asino
Sintipa 30 Un onagro notò un asino che trasportava un pesante carico; commiserando la sua schiavitù, affermò: «Io sono veramente fortunato, perché vivo libero e non sono costretto a svolgere faticosi lavori quotidiani: ho anche a disposizione il nutrimento sui monti, mentre tu dipendi da un altro per il cibo e devi continuamente sottostare alla schiavitù e alle percosse». Proprio in quel momento comparve un leone: non aggredì l’asino, poiché era insieme all’asinaio, mentre balzò con violenza contro l’onagro, che era solo, e lo sbranò. Questa favola dimostra che le persone insubordinate e ostinate fanno una brutta fine, perché si lasciano trascinare dalla loro testardaggine, senza chiedere aiuto ad altri. L’asino selvatico e l’asino domestico Esopo 264 Ch. Un asino selvatico vide un asino domestico in un luogo soleggiato e gli si avvicinò. Lo considerava fortunato per il suo corpo in ottime condizioni e per la notevole disponibilità di cibo. In seguito, tuttavia, vedendo che portava dei carichi e che l’asinaio lo seguiva e lo colpiva con un bastone, gli disse: «Non ti considero più felice: vedo infatti che vivi in un’abbondanza non priva di grandi sofferenze». Così non sono invidiabili quei vantaggi che comportano pericoli e disgrazie.
Orfeo Mitico poeta originario della Tracia, è ritenuto figlio di Eagro e di Calliope o, secondo altre tradizioni, di Apollo e di Clio. Le sue gesta vengono narrate da numerosi poeti, tra cui Apollonio Rodio, Ovidio, Virgilio. Il suo canto è tanto efficace da commuovere le pietre e ammansire le belve. Molto noto è l’episodio della sua discesa nell’Ade, per riportare alla vita la moglie, la ninfa Euridice, morsa mortalmente da un serpente mentre fuggiva dal pastore Aristeo. La dea Persefone, in omaggio al meraviglioso canto, lo autorizza a portare a termine la sua impresa, a patto che non si volti mai a guardarla, nel corso del suo viaggio. Orfeo non riesce a resistere e così la moglie tragicamente scompare. Orfeo va anche con gli Argonauti nell’ambito dell’impresa del vello d’oro. Dalla sua figura trae origine l’orfismo, una religione misterica piuttosto diffusa nel mondo antico. Rappresentato, secondo la tradizione, in relazione alla meravigliosa armonia della sua musica, Orfeo compare in una sola favola, narrata da Dione Crisostomo (32,66), che spiega l’origine dei citaredi (v.). La dimensione mitologica della storia lascia spazio all’aspetto comico, secondo una tecnica narrativa che è spesso presente nelle favole degli animali. Così, ad esempio, nella favola di Fedro (4,18 [19]), che vede i cani, sfrontati, mandare un’ambasceria a Zeus. Qui i cani vogliono mettersi allo stesso livello di un inarrivabile eroe del mito. La trasformazione da animale a uomo si trova anche in altre narrazioni, come in quella di Prometeo che plasma uomini e animali, trasformando alcuni di questi ultimi in esseri umani, destinati però a conservare un’anima da bestie (Esopo 322 Ch.). Più frequente è la metamorfosi inversa, da uomo ad animale, come nella vicenda dell’agricoltore trasformato in formica da Zeus (Esopo 240 Ch.) o degli uomini mutati in cicale (Platone, Fedro 259b-d).
I cani musicisti Dione Crisostomo 32,66 Gli animali vivevano in compagnia di Orfeo: godevano della sua musica, avendone ammirazione, senza tentare di imitarlo. Tuttavia, alcuni cani senza vergogna e impiccioni si diedero alla musica; subito se ne andarono via ad esercitare quest’arte per loro conto; quindi, si mutarono in forma umana e proseguirono la loro pratica. Questa, dunque, è proprio la stirpe dei citaredi e perciò ancora oggi costoro non riescono a vincere completamente la loro natura innata: conservano l’insegnamento di Orfeo, ma in esigua misura; per il resto, a loro rimane molto della musica dei cani.
Orso Nell’antichità la presenza dell’orso è più diffusa di quanto non sia oggi e si riscontra anche in territori dove ora esso è scomparso. La troviamo attestata in Armenia e presso il corso del Tigri (Oppiano, Cynegetica 4,355), ma anche sui monti della Sicilia (Teocrito 1,115) e nell’Italia meridionale (a Venosa, secondo Orazio, Odi 3,4,18). Non è noto al mondo greco e romano l’orso polare, mentre è diffusa la specie dell’ursus arctos, ossia l’orso bruno. L’uomo coglie nell’orso un animale non ostile, addirittura «filantropo» per il rispetto che ha dei cadaveri, ma allo stesso tempo ne teme la crudeltà e l’ira: ha ampia circolazione, nel mondo antico, e ancora in diverse forme nel Medioevo, il proverbio «In presenza di un’orsa non cercarne le tracce», che suggerisce di evitare guai facilmente prevedibili. Addirittura, in latino il verbo che indica il verso dell’orso è saevire, ossia «incrudelire», per cui «la designazione intende fornire più un’immagine del comportamento tipico dell’animale, che non una registrazione del suono» (Bettini 2008, 82). Il mito riserva un certo spazio agli orsi, in particolare alle femmine, soprattutto in relazione al tema della maternità: spesso l’orsa diventa protettrice degli infanti. Così si rileva nella vicenda di Atalanta, figlia di Giasone: abbandonata dal padre sul monte Pelio, viene accudita da un’orsa inviata da Artemide; l’animale se ne prende cura allattandola. Sorte simile anche per un altro noto eroe del mito: Paride. Non manca nemmeno il tema dell’unione tra uomo e orsa: Cefalo, seguendo l’ordine dell’oracolo di Delfi, si accoppia con un’orsa che si trasforma poi in una donna e procrea Arceisio (o Arcesio), presente, nelle genealogie, come il nonno di Ulisse (il mito di Polifonte narra invece il matrimonio tra una donna e un orso). Dalla tradizione mitologica deriva anche il nome della costellazione dell’Orsa Maggiore. Se nel mito l’orso trova spazi significativi, nella tradizione
favolistica non accade altrettanto. Si rilevano comunque elementi culturali ampiamente diffusi, che tendono a segnalare la prossimità tra uomo e orso. In questo senso, va rilevato innanzitutto il tema della «filantropia» e del rispetto dei cadaveri: in Esopo 254 Ch. un uomo si salva la vita fingendosi morto di fronte a un orso (fatti del genere sono attestati anche da recenti notizie di cronaca). In questo caso, l’orso rappresenta una minaccia che genera forte paura, anche se poi si lascia raggirare con una certa facilità. In Esopo 63 Ch., invece, l’atteggiamento dell’orso verso i cadaveri non suscita affatto un giudizio positivo, anzi qui l’animale va a simboleggiare gli arroganti e gli ipocriti, visto che, come sostiene la volpe, sarebbe meglio lasciare stare i vivi e fare a pezzi i morti. Altrove alcune caratteristiche, ad esempio l’uso delle zampe, riconducono l’orso all’uomo. Rodella 332 nota, in questo senso, «una bella immagine di una zampa ursina impegnata in un gesto umano» in una favola di Fedro (App. 20): un orso, affamato, si sposta dalle foreste al mare in cerca di cibo, ma prima di immergere la zampa pelosa nella speranza che vi restino impigliati i granchi, si aggrappa una sporgenza rocciosa, proprio «come vi si assicurerebbe un paziente pescatore». In generale, al di là di questi dati, appare difficile tracciare un profilo organico e coerente dell’orso nel mondo esopico, proprio perché l’animale compare in un modesto numero di favole. Per quanto riguarda il rapporto con gli altri animali, è comunque significativo il fatto che Esopo accolga una tradizione attestata anche in altri autori, circa la rivalità e l’inimicizia tra orsi e leoni: in Esopo 200 Ch. l’orso combatte con il leone contendendo un cerbiatto. Il tema è presente anche in Eliano (De natura animalium, 3,21), che riferisce di una gratuita uccisione di cuccioli di leone da parte di un’orsa, destinata poi a subire la giusta vendetta. Probabilmente si tratta di una lotta per la supremazia nel mondo degli animali. I viandanti e l’orso Esopo 254 Ch.
Due amici percorrevano la stessa strada. Presentandosi di fronte a loro un orso, uno lo prevenne con rapidità: salì su un albero e qui si nascose; l’altro, sul punto di cadere nelle sue grinfie, scivolò a terra, fingendosi morto. L’orso, accostando il muso all’uomo, lo fiutava ma egli tratteneva il respiro (dicono, infatti, che l’animale non tocchi i cadaveri). Dopo che l’orso se ne fu andato, l’uomo sull’albero scese e domandò che cosa gli avesse detto l’orso nell’orecchio; l’altro rispose: «Di non viaggiare, in futuro, con amici di tal genere, che non ti rimangono vicini nelle difficoltà». La favola dimostra che le avversità mettono alla prova la sincerità degli amici. RIFERIMENTI: Aviano 9; si veda anche Eliano, De natura animalium 5,49. L’orso e la volpe Esopo 63 Ch. L’orso si vantava in lungo e in largo di essere amico degli uomini, per il fatto di astenersi dal divorare i loro cadaveri. Lo provocò, allora, la volpe con queste parole: «Magari tu facessi a pezzi i morti, ma non i vivi». Questa favola accusa gli arroganti che vivono nell’ipocrisia e nella superbia. RIFERIMENTI: Parafrasi 63.
Babrio
14,
Dodecasillabi
L’orso affamato
63,
Fedro, App. 20 [22] Quando nella foresta vengono a mancare all’orso le provviste, l’animale corre verso una riva irta di scogli, e, aggrappandosi a una sporgenza rocciosa, affonda a poco a poco nel basso fondale le zampe pelose. Appena i granchi restano impigliati fra i peli, trascina a terra e scuote la preda marina, e poi si gusta il cibo raccolto qua e là: astuto! La fame aguzza l’ingegno anche agli sciocchi. Il leone, l’orso e la volpe Esopo 200 Ch. Un leone e un orso, trovato un cerbiatto, se lo contendevano. Scontrandosi violentemente, si ritrovarono a giacere tramortiti, dopo che la vista si era annebbiata. Giunta da quelle parti una volpe, quando vide i due nemici sfiniti e il cerbiatto giacere in mezzo, lo catturò e se la svignò passando tra di loro. Quelli, che non riuscivano ad alzarsi, allora dissero: «Ahinoi! Ci siamo affannati per una volpe». La favola dimostra che giustamente si rattristano coloro che vedono i primi venuti godersi i frutti delle loro fatiche. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 201; Tetrastici 2,13. L’orso, la volpe e il leone a caccia Tetrastici 2,7 L’orso, il leone e la volpe andarono a caccia
insieme. Mentre il leone e l’orso catturavano le prede grazie alle loro fatiche, la volpe trovò un cammello legato a un palo; allora andò dai suoi compagni e indicò loro questo cammello come preda.
Ostrica Il simbolismo dell’ostrica, anche per la somiglianza con la vulva, si ricollega all’idea della fecondità. A essa (così come alle perle che vi sono contenute e spesso sono emblema della forza generatrice) viene attribuita anche una proprietà magico-religiosa. Nell’antichità è radicata la convinzione dell’influsso delle fasi lunari sulle ostriche (cfr., tra gli altri, Gellio 20,8). V. anche CONCHIGLIA. In una curiosa favola del poeta Antifilo (Antologia Palatina 9,86), l’ostrica si richiude quando viene morsa dal topo, che si ritrova così imprigionato in una sorta di tomba, senza via d’uscita. Quanto alla perla, è al centro della favola 3,12 di Fedro, in opposizione al letamaio in cui viene a trovarsi. Questa narrazione, che aprirà anche la raccolta del Romulus e avrà lunga fortuna in età moderna (La Fontane 1,20; Lessing 2,9), si segnala, non a caso, per l’accentuato autobiografismo.
P
Pantera Gli antichi, nella loro terminologia, tendono a confondere pantera e leopardo (cfr. Maspero 235). Le informazioni vere si confondono con quelle fantastiche: ad esempio, tutti i quadrupedi verrebbero inesorabilmente attratti dall’odore delle pantere ma sarebbero atterriti, allo stesso tempo, dall’aspetto del loro capo (Plinio, Naturalis historia 18,6263). Come accade anche per altri animali nella commedia plautina, la pantera suggerisce il nome di un personaggio: Pardalisca, una sfrontata ancella della Casina. A Roma le pantere vengono importate per i cruenti giochi del circo. La pantera compare in una sola favola (Fedro 3,2) e la sua caratterizzazione appare pienamente in linea con la ferocia che le è normalmente attribuita. D’altra parte, l’animale si dimostra anche giusto: la narrazione valorizza la gratitudine, come la favola di Esopo 206 Ch. (il topo riconoscente nei confronti del leone) o Aftonio 28 (il serpente e l’aquila grata verso il contadino). Talora può confondersi con il leopardo (v.). Nel Pañcatantra (primo tantra, racconto nono), si trova una pantera al seguito di un leone debilitato: insieme a un corvo e a uno sciacallo raggirano un cammello, che diventa un pasto per il loro sovrano (la narrazione ricorda quella di Esopo 199 Ch., dove una volpe raggira un cervo, conducendolo per due volte nelle grinfie del leone malato). Inoltre, la pelle di pantera (terzo tantra, racconto primo) svolge la funzione della pelle del leone in una favola che ricorda il noto motivo esopico dell’asino nella pelle del leone (v. ASINO). La pantera e i pastori Fedro 3,2 In genere chi è disprezzato ripaga allo stesso
modo. Una volta una pantera finì incautamente in una fossa. La notarono i contadini: alcuni la prendono a bastonate, altri la bersagliano di sassi; certe persone, al contrario, prese da compassione perché l’animale stava per morire anche se nessuno avesse infierito ulteriormente, le gettarono del pane perché sopravvivesse. Calò la notte. Senza più curarsene se ne vanno a casa convinti che il giorno successivo l’avrebbero trovata morta. Ma la belva, recuperate le sue forze vacillanti, con un agile balzo si libera dalla fossa e si affretta con rapido passo alla sua tana. Pochi giorni dopo irrompe fulminea, trucida il gregge, uccide gli stessi pastori e, devastando tutto, infuria in un impeto d’ira. Allora, temendo per sé, coloro che avevano risparmiato la belva non intendono evitare il danno, ma soltanto supplicano di avere salva la vita. Ecco, tuttavia, la risposta della fiera: «Ricordo chi mi ha gettato i sassi e chi mi ha offerto il pane; voi cessate di avere paura; ritorno nemica nei confronti di coloro che mi hanno colpito». RIFERIMENTI: Romulus 75.
Pappagallo Animale tipicamente esotico, e perciò estraneo al mito, è identificato già da Aristotele (Historia animalium 597b) come uccello dell’India: colpisce per la voce che ricorda quella umana e per il fatto che può persino diventare insolente quando beve il vino. Eliano (De natura animalium 13,8) riferisce che, proprio per la sua capacità di imitare la voce degli uomini, è animale sacro agli Indiani e sta intorno al re: impara a parlare proprio come i fanciulli (16,2). Il pappagallo compare nella favola di Esopo 355 Ch. come animale domestico, comprato da un uomo proprio alla luce della sua piacevole voce. La dimensione domestica (e di corte) dell’uccello è tipica non solo del mondo greco-romano, ma anche dell’India, come si è rilevato sopra, per cui il pappagallo è generalmente ritenuto animale intelligente e bello, anche se talvolta (cfr. Callimaco 192 Pf.) presenta valori simbolici non positivi.
Passero Al di là del celebre passero di Lesbia cantato da Catullo (3), questo piccolo uccello, certamente molto noto, non sembra riscuotere molta simpatia presso gli autori greci e romani, e trova poco spazio anche nella letteratura medievale (cfr. Maspero 240). Come spiega Eliano (De natura animalium 17,41), questi volatili rovinano i campi seminati dai contadini. Ritenuti timidi, i passeri tirano la carrozza di Afrodite in una poesia di Saffo (fr. 1 V.). L’uccello è naturalmente simbolo dei subalterni nella favolistica, dove trova uno spazio molto limitato, peraltro in una chiave non positiva. Non a caso è posto in contrapposizione con lo sparviero che ne decreta la morte (Fedro 1,9), mentre rimprovera sconsideratamente la lepre ghermita dall’aquila. Questa narrazione, che non è presente nelle raccolte esopiche, ha lunga fortuna e sarà rielaborata anche da La Fontaine (5,17). La favola riprende, tuttavia, temi assai diffusi nella tradizione esopica: il rimprovero inopportuno a chi è in pericolo di morte (Esopo 297 Ch.) e la consolazione che si ha quando si è vicini alla fine, di fronte alla morte del nemico (Esopo 132 Ch.). I passeri si segnalano inoltre per il canto nella favola che li vede accostati alle cicale, mentre supplicano il contadino di non abbattere un albero infruttuoso (Esopo 85 Ch.). Il passero consigliere della lepre Fedro 1,9 Dimostreremo in pochi versi che è sciocco non badare a se stessi e dare consigli agli altri. Ghermita dall’aquila, una lepre piangeva a dirotto; un passero la rimproverava: «Dov’è – disse – quella tua famosa rapidità? Che fine hanno fatto le tue zampe?».
Mentre parla, lo sparviero lo afferra all’improvviso e lo uccide tra il pianto e le grida del passero. La lepre, in fin di vita, esclamò: «La morte arriva con una consolazione. Tu che poco fa, senza avere preoccupazioni, irridevi la mia sventura, ora con lamenti simili piangi il tuo destino». RIFERIMENTI: Romulus 81.
Pastore Forse non è un caso che il primo poeta greco che inserisce una favola nei suoi versi (L’usignolo e lo sparviero, nel poema Le opere e i giorni, vv. 202 ss.) sia Esiodo, pastore e agricoltore della Beozia, vissuto probabilmente tra l’VIII e il VII secolo a.C.: mentre porta a pascolare le sue pecore, riceve la visita delle Muse, che gli insegnano un bel canto (Teogonia, vv. 22 ss.). Lo stesso Esiodo sottolinea spesso il primato dell’etica del duro lavoro legato alla terra (v. CONTADINO). Successivamente, il tema della pastorizia, e più in generale dell’allevamento, spesso connesso a quello più ampio dell’agricoltura, ritorna, con una connotazione puntualmente positiva, in diversi contesti letterari, come nella filosofia: Platone pone la pastorizia tra le attività che costituiscono la base economica della città ideale, alle quali il legislatore deve porre mano (Leggi 842c); lo stesso Aristotele inserisce l’allevamento nella crematistica naturale, ossia quella serie di attività che soddisfano i bisogni primari, secondo natura (Politica 1258a). Ma la figura del pastore nel mondo antico incide anche sulla sensibilità dei poeti. In età ellenistica, Teocrito, che sarà ripreso da Virgilio nelle Bucoliche, tende a un processo di idealizzazione della figura del pastore, che nei suoi Idilli appare impegnato anche nel canto poetico. Nel mondo romano, il passaggio dalla primitiva economia pastorale all’economia agricola è ritenuto «un progresso economico e civile» (Merlo 137 n. 23). Del resto, le due attività vanno a integrarsi reciprocamente. Così, se da un lato si tende a privilegiare l’agricoltura rispetto alla pastorizia nell’ottica del massimo profitto, dall’altro lato non si negano la dignità e la nobiltà della pastorizia come fonte di reddito per i ceti possidenti (cfr. Varrone, De re rustica 3,1,8). Va sottolineato che, nella trattatistica antica, esiste una chiara distinzione tra pastore di pecore e pastore di capre (cfr. CAPRAIO).
Nel mondo esopico, la pastorizia sembra essere attività prevalente, o comunque complementare all’agricoltura, mentre le altre occupazioni (compresa la caccia) appaiono residuali. La favolistica, infatti, introduce a un mondo antieroico, che rovescia il sistema di valori aristocratici, tipici dell’epica, e presenta personaggi di ceti sociali umili, spesso inevitabilmente legati alla terra. Questo profilo emerge bene in una favola in cui il pastore vende il suo gregge e si mette per mare, ma il naufragio gli fa perdere il carico (Esopo 311 Ch.): così l’uomo imparerà dai suoi errori e non proverà più l’azzardo di un rischioso viaggio in mare, secondo una morale che è già presente in Esiodo (cfr. NAVIGANTE). Peraltro, il pastore, sempre anonimo, come accade per gli altri uomini presenti nella favola esopica, non si distingue per una particolare caratterizzazione psicologica (talvolta, la terminologia è generica e la sua figura sfuma in altre affini, come quella dell’agricoltore: cfr. Fedro 3,2). La sua unica preoccupazione è il gregge, che deve allevare e proteggere con cura: questo nesso, inscindibile e positivo, è presente in diverse culture antiche e diventa metafora di grande efficacia (si pensi solo all’immagine del Signore come buon pastore nella Bibbia, Salmi 23). In una favola di Massimo di Tiro (19,2) l’agnello posto di fronte alla scelta tra il pastore e il macellaio non ha dubbi: il pastore lo tratterà bene (cfr. MACELLAIO). L’altro animale con cui il pastore è in costante relazione è il cane, fedele, irrinunciabile alleato, di cui la trattatistica antica arriva a delineare persino un profilo ideale in relazione all’uso che se ne deve fare: l’animale deve essere bianco, per non essere confuso al buio con le altre bestie; deve essere robusto, forte e pronto a dare battaglia ai possibili nemici (Columella 7,12). Il nemico irriducibile è ovviamente il lupo, con cui esiste uno strano rapporto ambivalente, per cui spesso succede che l’uomo è disponibile a fidarsi (Esopo 229 Ch.) e ad accogliere l’animale (Esopo 313, 314, 315 Ch.), salvo pentirsene amaramente. Questo motivo narrativo presenta una dinamica affine a quello del contadino che accoglie una
serpe in seno per salvarle la vita e viene poi morso mortalmente (Esopo 82 Ch.). Nelle favole indicate sopra, d’altra parte, pare sviluppato un tema che deriva da una tragedia di Eschilo, dove però si trova il leone al posto del lupo (Agamennone 717 ss.): nella tradizione indiana, invece, il motivo è presente in una delle versioni del Pañcatantra (4,5: pp. 401-404 Ryder), dove tuttavia compare uno sciacallo. L’insegnamento morale, che il pastore recepisce troppo tardi, è ricorrente nella tradizione favolistica e riguarda l’immutabilità della natura individuale, ossia l’impossibilità per un malvagio di cambiare indole. Le pecore suggeriscono, invece, il tema dell’ingratitudine, quando, nella loro ottusità, mangiano per sbaglio il mantello del loro padrone, che le nutre amorevolmente, mentre donano agli altri, senza ricevere niente in cambio, la loro lana (316 Ch.): questa narrazione gioca esplicitamente sul rapporto d’affetto che lega pastore e pecore. Come si può notare, nelle raccolte esopiche, a parte qualche rara eccezione, troviamo il pastore sempre insieme al lupo, al cane e alle pecore, nell’ambito di schemi narrativi piuttosto rigidi; in altri autori questo tema è meno ricorrente. Il pastore e il mare Esopo 311 Ch. Un pastore, facendo pascolare il gregge in una zona costiera, vide il mare tranquillo e fu colto dal desiderio di prendere il largo per dedicarsi al commercio. Vendette dunque le pecore e, dopo avere acquistato dei datteri, si imbarcò. Sopraggiunse una terribile tempesta e la nave rischiò di essere sommersa. Il pastore, dopo aver gettato in mare tutto il carico, si salvò a fatica, con la nave svuotata. Dopo diversi giorni, poiché sentì un uomo che si meravigliava della tranquillità del mare, che era calmo, il pastore disse: «Mio caro, sembra tranquillo,
a quanto pare, perché desidera ancora datteri». La favola insegna che le disgrazie portano insegnamento agli uomini. Il pastore e il cane che faceva festa alle pecore Esopo 312 Ch. Un pastore, che aveva un cane di grandi dimensioni, era solito gettargli i feti delle pecore e le pecore morte. Una volta, tornato ormai il gregge nella stalla, il pastore vide il cane che si avvicinava alle pecore e le accoglieva con gioia, scodinzolando; allora il pastore disse: «Carissimo, quello che desideri per loro ricada sul tuo capo». La favola è adatta agli uomini che sono soliti adulare gli altri. RIFERIMENTI: Parafrasi 313. Il pastore e i lupacchiotti Esopo 313 Ch. Un pastore trovò dei lupacchiotti e prese ad allevarli con molta cura, nella convinzione che, quando fossero cresciuti, non solo avrebbero fatto da guardia alle sue pecore, ma gli avrebbero anche portato altre pecore rubate. Quelli tuttavia, come diventarono grandi, senza più timore, per prima cosa cominciarono a uccidere le sue pecore. Allora il pastore, quando si rese conto di quanto avveniva, si lamentò dicendo: «Ho subito la giusta punizione: perché mai ho salvato queste bestie quando erano piccole, mentre sarebbe giusto ucciderle anche da adulte?». Così, quelli che salvano le persone empie non si accorgono che queste rivolgeranno la loro
violenza innanzitutto contro di loro. RIFERIMENTI: cfr. Eschilo, Agamennone 717 ss. (qui si trova il leone al posto del lupo). V. inoltre CONTADINO per il proverbio «Non bisogna allevare in città un cucciolo di leone». Il pastore e il lupo allevato con i cani Esopo 314 Ch. Un pastore trovò un cucciolo di lupo appena nato, lo prese e lo allevò insieme ai cani. Quando il cucciolo fu cresciuto, se mai un lupo rapiva una pecora, anche lui lo inseguiva insieme ai cani. Talora i cani non erano in grado di raggiungere il lupo e perciò ritornavano indietro, invece quello lo inseguiva, finché non era riuscito a prenderlo e, come lupo, riceveva parte della preda; quindi tornava indietro. Se invece nessun lupo da fuori veniva a rapire una pecora, quello, sgozzandola di nascosto, se ne mangiava una insieme con i cani. A un certo punto, però, il padrone si fece sospettoso e intuì quello che succedeva: allora lo appese a un albero e lo uccise. La favola dimostra che una natura malvagia non produce un comportamento onesto. RIFERIMENTI: cfr. Eschilo, Agamennone 717 ss. (si trova il leone al posto del lupo). V. inoltre CONTADINO per il proverbio «Non bisogna allevare in città un cucciolo di leone». Il pastore e il cucciolo di lupo Esopo 315 Ch.
Un pastore che aveva trovato un piccolo lupo lo allevò e poi, una volta che l’animale fu cresciuto, gli insegnò a rapire le pecore dalle greggi dei pastori che abitavano nelle vicinanze. Una volta ammaestrato, il lupo disse: «Tu, che mi hai abituato a rubare, guarda di non essere poi costretto a cercare molte delle tue pecore». Coloro che hanno una natura malvagia, se imparano a rubare e a commettere angherie, spesso causano danno ai loro maestri. RIFERIMENTI: Parafrasi 316. Il pastore e le pecore Esopo 316 Ch. Un pastore condusse le pecore in un bosco di querce; come vide un albero di grandi dimensioni pieno di ghiande, stese sotto il suo mantello e si arrampicò sulla pianta per scuoterla e fare cadere i frutti. Tuttavia le pecore non si resero conto che, mangiando le ghiande, divoravano insieme il mantello. Una volta sceso, il pastore, come si accorse dell’accaduto, esclamò: «Bestiacce, voi offrite agli altri la vostra lana per i vestiti; a me, che vi nutro, sottraete anche il mantello». Così molti tra gli uomini, senza averne consapevolezza, fanno del male ai familiari, mentre arrecano benefici a quelli che non hanno nessun legame con loro. RIFERIMENTI: Papiro Rylands 2. Il pastore che fece entrare un lupo nella stalla e il cane
Esopo 317 Ch. Un pastore, mentre conduceva dentro la stalla le pecore, era sul punto di chiudere insieme a queste anche un lupo, se un cane, vedendolo, non gli avesse detto: «Come pretendi di conservare sano e salvo il tuo gregge, se fai entrare insieme anche questo lupo?». La compagnia dei malvagi può procurare un grandissimo danno e addirittura la morte. RIFERIMENTI: cfr. Babrio 113; Parafrasi 118; Tetrastici 2,27. Il pastore che scherzava Esopo 318 Ch. Un pastore, che conduceva il suo gregge al pascolo assai lontano dal paese, era solito fare questo scherzo: chiamava a gran voce in aiuto gli abitanti del villaggio, urlando che i lupi assalivano le pecore. Per due o tre volte gli abitanti si spaventarono e accorsero dal villaggio; quindi, tornarono beffati. Ma, alla fine, accadde che i lupi arrivarono veramente. Assalirono il gregge e allora il pastore chiamò in aiuto gli abitanti del villaggio, che non gli prestarono nessuna attenzione, pensando che, come sempre, scherzasse. In questo modo il pastore perse le sue pecore. La favola insegna che i bugiardi riescono a non essere creduti nemmeno quando sono sinceri. RIFERIMENTI: in una parte della tradizione esopica, si ritrova un ragazzo nel ruolo del pastore. Parafrasi 319; Dodecasillabi 319.
Pavone Il pavone, sacro alla dea Era (Giunone a Roma), è simbolo di grazia e di bellezza. Nel mito, Argo, essere mostruoso dotato di numerosi occhi, sorveglia Io, amante di Zeus, ma Hermes lo uccide per ordine del re degli dei. Allora Era, impietosita, trasporta gli occhi di Argo nelle penne del pavone. Anche presso altri popoli il pavone, simbolo tra l’altro del firmamento e delle stelle, assume un notevole rilievo: è associato alle divinità (accompagna Iside in Egitto, rappresenta, tra gli altri, Indra, re degli dei, in India) e simboleggia la regalità (in Persia). La bellezza straordinaria del pavone ritorna in numerosi autori antichi. Secondo Eliano (De natura animalium 5,21), il pavone ha consapevolezza del suo aspetto estetico e ne trae motivo di vanto, al punto che riesce a cogliere le lodi che gli si rivolgono: in quel caso, per farne sfoggio, alza le sue penne una dopo l’altra. Le penne, inoltre, possono costituire un riparo dall’ombra e aiutano l’uccello a spaventare gli estranei. Eliano ricorda anche che Alessandro Magno, colpito dalla bellezza del pavone, ne vietò l’uccisione, minacciando sanzioni molto pesanti. L’allevamento dei pavoni è previsto, con una chiara valorizzazione dei pregi estetici di questo uccello, anche nella trattatistica romana dedicata all’agricoltura, peraltro segnata generalmente da forte utilitarismo (cfr. Columella 8,11). Ai numerosi valori simbolici che gli sono attribuiti si aggiunge anche quello dell’immortalità, perché si ritiene che le sue carni siano incorruttibili (per questo motivo, oltre che per il rinnovamento del piumaggio, nel mondo cristiano il pavone è considerato simbolo di risurrezione). La tradizione esopica, che pure riprende diversi motivi culturali assai diffusi, non offre un’immagine particolarmente favorevole di quest’uccello. In una favola di Fedro (3,18) viene posto in evidenza il legame tra il pavone e
Giunone: l’uccello eccelle ovviamente in bellezza, ma è deriso per la sua voce. La narrazione è anomala rispetto a quelle di simile struttura, che vedono in genere un animale lamentarsi presso un dio; infatti, la favola non spiega l’origine di una caratteristica dell’animale e non si riscontra nemmeno una punizione per il tentativo di cambiare natura (cfr. lo schema tipico presentato, ad esempio, dal cammello di Esopo 146 Ch.). La bellezza dell’uccello è certamente un valore secondario nel mondo esopico, segnato da una tendenza forte al pragmatismo: quando il pavone è candidato a essere il re degli animali, la scarsa forza lo condanna al fallimento (cfr. Esopo 334 Ch.). Le penne di oro e di porpora diventano, inoltre, sinonimo di ricchezza, mentre, nella prospettiva esopica, è preferibile la fama che alla gru viene garantita dal bel canto (334 Ch.). La bellezza del pavone diventa motivo d’invidia per altri uccelli: il gracchio, che se ne orna, diventa motivo di scherno da parte degli altri animali, in una narrazione (Fedro 1,3) che per il suo contenuto morale sembra avere una larga fortuna negli autori cristiani (cfr. Ayán Calvo 123 ss.). Questa favola sembra tanto nota che è sufficiente l’espressione «Il gracchio di Esopo» per identificarla (v. GRACCHIO); allo stesso modo, noi oggi comprendiamo immediatamente l’espressione «La volpe e l’uva», senza la necessità di narrare l’intera favola da cui deriva. Il pavone da Giunone per la propria voce Fedro 3,18 Il pavone si presentò da Giunone, mal sopportando il fatto che non gli fosse stato concesso il canto dell’usignolo: quello riscuoteva l’ammirazione di tutti gli uccelli, lui era deriso non appena emetteva un suono. Allora la dea, per rincuorarlo, disse: «Ma lo superi in bellezza, lo superi in grandezza; lo splendore dello smeraldo
rifulge sul tuo collo e dispieghi la coda di gemme con piume di vari colori». «Che me ne faccio – osservò il pavone – di una muta bellezza se sono vinto nella voce?» «Dall’arbitrio dei fati sono attribuite a voi le parti: a te la bellezza, la forza all’aquila, il dolce canto all’usignolo, il dono della profezia al corvo, alla cornacchia che viene da sinistra i presagi favorevoli e tutti sono contenti delle proprie doti.» Non aspirare a ciò che non ti è stato concesso, perché la speranza delusa non diventi lamento. RIFERIMENTI: Romulus 74. Il pavone e la gru Esopo 333 Ch. Un pavone derideva una gru, canzonandola per il suo colore: «Io mi rivesto di oro e di porpora, – diceva – tu invece non hai niente di bello nelle tue ali». La gru allora rispose: «Io però ho un canto che arriva a sfiorare le stelle e volo fino ai punti più alti del cielo. Tu invece, come un gallo, cammini a terra insieme alle galline». È preferibile essere ammirato in povere vesti che vivere senza fama ostentando la propria ricchezza. RIFERIMENTI: Babrio 65; Aviano 15; Parafrasi 333; Dodecasillabi 333. Il pavone e il gracchio Esopo 334 Ch. Gli uccelli si riunirono per eleggere un re; allora il
pavone pretendeva il trono in virtù della sua bellezza. Mentre gli uccelli stavano convergendo su questa scelta, il gracchio disse: «Ma una volta diventato re, se l’aquila ci inseguirà, come ci proteggerai?». La favola dimostra che non devono essere criticati coloro che, in previsione dei possibili pericoli, prima di affrontarli si mettono in guardia. RIFERIMENTI: Sintipa 53. Il gracchio superbo e il pavone Fedro 1,3 Esopo ci lasciò questo esempio affinché nessuno voglia gloriarsi dei beni di altri, ma piuttosto vivere secondo la sua condizione. Un gracchio, gonfio di vuota superbia, raccolse le penne che erano cadute a un pavone e se ne adornò. Quindi, disprezzando i suoi simili, si mescolò alla splendida schiera dei pavoni. I pavoni strappano via le penne all’impudente uccello e lo cacciano beccandolo. Ridotto male e afflitto il gracchio provò a ritornare presso la propria stirpe, da cui fu respinto e severamente biasimato. Allora uno dei gracchi, che lui prima aveva disprezzato, gli disse: «Se ti fossi accontentato dei nostri nidi e avessi voluto accettare la tua natura, non avresti patito quell’offesa e, disgraziato, non soffriresti ora questo rifiuto». RIFERIMENTI: Romulus 45; cfr. Orazio, Epistole 1,3,18 ss. (il riferimento qui è a una cornacchia). V. GRACCHIO per il proverbio collegato.
Pecora Animale sacrificale per eccellenza, la pecora ha una simbologia ambivalente e rappresenta da un lato la mansuetudine, la passività e la timidezza, dall’altro la stupidità, in contrasto con l’intelligenza generalmente apprezzata nelle capre. Sempre fedelmente al seguito della loro guida (cfr. PASTORE), in ambito agricolo questi animali sono molto utili, perché consentono di disporre di indumenti e di cibo (cfr. Columella 7,2). Nella prospettiva cristiana, le pecore rappresentano il gregge di Dio e i beati nel Giudizio Universale (Vangelo di Matteo 25,31 ss.). Nella religione pagana, l’animale è talora al centro di curiosi culti: Eliano (De natura animalium 12,40) riferisce che a Samo venne venerata una pecora, dedicata alla dea Era, che aveva ritrovato una certa quantità d’oro rubato. La placidità delle pecore è proverbiale (Terenzio, I fratelli 534: cfr. Otto 261). Inoltre, la stupidità di questi animali suggerisce immagini iperboliche, ad esempio nella commedia plautina (Persa 172 s.), dove peraltro si ritrovano proverbi che sembrano rimandare, sia pure solo a livello tematico, alla tradizione favolistica. A una narrazione esopica, ad esempio, si rifà il proverbio, presente in Pseudolus 139 ss. (ma cfr. anche Terenzio, L’eunuco 832), «Lasciare i lupi presso le pecore» (v. proverbio sotto). Nella tradizione favolistica, il gregge è spesso definito in una prospettiva generalizzante. Come le rane e altri animali che appartengono ai ceti subalterni del mondo esopico, le pecore diventano anonima folla, per cui si tende a citare indeterminatamente il gregge, non solo nelle favole (ad esempio, in Esopo 311, 317 e 318 Ch.), ma anche nei riferimenti a narrazioni esopiche che si rinvengono in altri generi letterari (Trinummus 169 ss.). Nella favolistica, le pecore sono esplicitamente descritte come animali «sciocchi» (Esopo 218 Ch.), secondo una radicata
convinzione diffusa nella cultura antica. Il loro comportamento giustifica tale qualifica. Così, ad esempio, nella favola 217 Ch., forse derivata da Senofonte (Memorabili 2,7,13 s.), si lasciano raggirare dai lupi, consegnano loro i cani e alla fine vengono divorate. Proprio il cane, riferimento positivo, e il lupo, nemico giurato, sono i personaggi insieme ai quali più di frequente compare la pecora: talora il sistema naturale di relazioni viene sovvertito e così accade che il cane e il lupo si mettano in società per danneggiare la pecora (Fedro 1,17). La pecora può essere contesa al lupo dal leone (Esopo 227 Ch.), ma si cala invariabilmente nella parte di preda. L’animale è vittima designata anche in altre tradizioni culturali: nei proverbi sumerici, per certi versi affini alla tradizione favolistica, compare in relazione al leone predatore (nella quinta collezione di Gordon). La pecora è spesso descritta insieme all’uomo che se ne prende cura (v. PASTORE), però può accadere che si lamenti per il pasto, molto più magro rispetto a quello del cane (Babrio 128), secondo un modulo narrativo impiegato anche per altre bestie (v. MULO). In una favola dedicata al tema dell’ambiguità (Esopo 321 Ch.), simile nell’impostazione a quella del cane e della lepre (182 Ch.), la pecora viene tosata in modo maldestro e pertanto si lamenta, dicendo all’uomo di decidere che cosa vuole: la lana o la carne. La pecora tosata Esopo 321 Ch. Una pecora, che veniva tosata malamente, disse al suo tosatore: «Se cerchi lana, taglia più in alto; ma se desideri carne, uccidimi una volta per tutte e smettila di torturarmi a poco a poco». La favola è adatta a coloro che svolgono male il loro mestiere. RIFERIMENTI:
Babrio
51;
Parafrasi
322;
Dodecasillabi 322. Il lupo sazio e la pecora Esopo 230 Ch. Un lupo, sazio di cibo, quando vide una pecora accasciata al suolo, accortosi che era caduta per la paura nei suoi confronti, le si avvicinò e la confortò, dicendole che se avesse fatto tre affermazioni sincere l’avrebbe lasciata andare. La pecora cominciò a dire innanzitutto che non avrebbe voluto incontrarlo; in secondo luogo, gli disse che se poi questo fosse accaduto, avrebbe voluto incontrarlo cieco; ed ecco la terza affermazione: «Possiate perire miseramente voi tutti, malvagi lupi, perché ci fate guerra senza aver ricevuto da noi alcuna offesa». Dopo avere apprezzato la sua sincerità, il lupo la lasciò andare. La favola dimostra che spesso la verità dispiega la sua forza anche sui nemici. RIFERIMENTI: Babrio 53; Parafrasi 231; Dodecasillabi 231; Tetrastici 2,5; Plauto, Trinummus 169 ss. (dubbi su questo parallelo, suggerito da Adrados 2003, 221 s., a cui si rimanda per altre possibili allusioni). La pecora, il cane e il lupo Fedro 1,17 Di solito i bugiardi scontano le cattive azioni che hanno compiuto. Un cane, con una falsa accusa, chiedeva a una pecora una pagnotta che sosteneva di averle affidato. Un lupo, citato come testimone, affermò che il debito non consisteva in una sola
pagnotta, ma in dieci. La pecora, condannata sulla base della falsa testimonianza, pagò ciò di cui non era debitrice. Dopo pochi giorni, il povero animale vide il lupo che giaceva in una fossa: «Questa – disse – è la ricompensa che viene data dagli dei alla frode». RIFERIMENTI: Romulus 5. Il lupo ferito e la pecora Esopo 231 Ch. Un lupo, morso da alcuni cani e ridotto male, si era sdraiato a terra e non riusciva a procurarsi da mangiare; allora vide una pecora e le chiese di prendergli dell’acqua dal fiume che scorreva lì accanto: «Se infatti mi procuri l’acqua, io mi troverò da solo il cibo». La pecora gli rispose: «Se ti darò da bere, tu mi userai anche per mangiare». La favola è adatta a un uomo malvagio, abile a fingere mentre tende insidie. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,3. I lupi e le pecore Esopo 217 Ch. Dei lupi tramavano contro un gregge di pecore. Poiché non riuscivano a impadronirsene a causa dei cani che stavano a guardia, capirono che, per conseguire il loro scopo, era necessario ricorrere all’inganno. Così mandarono ambasciatori a chiedere alle pecore di consegnare loro i cani, dicendo che
erano essi la causa della loro inimicizia: se avessero agito in questo modo, allora avrebbe regnato la pace tra pecore e lupi. Le pecore, non sospettando ciò che stava per accadere, consegnarono i cani e così i lupi se ne impadronirono e, senza alcuna difficoltà, fecero strage anche del gregge, rimasto senza guardia. Così anche gli Stati che consegnano senza farsi scrupoli i loro capi vengono essi pure, senza rendersene conto, sottomessi in breve tempo dai nemici. RIFERIMENTI: Romanzo di Esopo 97; Babrio 93; Libanio 1 H-H.; Aftonio 21; Parafrasi 219; Romulus 63; Plutarco, Demostene 23,5; Nicolao, Esercizi preparatori 1,5; Isidoro, Etimologie 1,40. Il lupo e il leone Esopo 227 Ch. Una volta un lupo, sottratta una pecora a un gregge, la stava portando nella sua tana, quando s’imbatté in un leone, che, a sua volta, gliela rubò. Il lupo, che se ne stava a debita distanza, gli disse: «Porti via ingiustamente quanto mi appartiene». Il leone si mise a ridere; quindi, gli rispose: «Perché ti è stata data, nel rispetto della giustizia, da un amico?». La favola accusa i ladri e gli avidi furfanti, che, quando si trovano nelle sventure, si incolpano a vicenda. RIFERIMENTI: Babrio 105; Dodecasillabi 228; Sintipa 52.
Parafrasi
La pecora, il pastore e il cane
228;
Babrio 128 Una pecora così parlò al pastore: «Tu ci tosi e tieni la nostra lana, ti piace mungere il latte e trasformarlo in formaggio, grazie ai nostri figli le tue greggi prosperano. Eppure non c’è profitto per noi in queste cose. Tutto ciò che mangiamo viene dalla terra. E che vegetazione rigogliosa nasce sui fianchi delle montagne? L’erba è scarsa e coperta di rugiada. Ma nutri bene questo cane del gregge e gli dai da mangiare in abbondanza lo stesso tuo cibo». Quando il cane udì ciò, disse: «Se non facessi la guardia, stando in mezzo a voi, non potreste nemmeno avere la vostra razione d’erba! Muovendomi, infatti, qui intorno, io impedisco allo scaltro ladro e al lupo insidioso di avvicinarsi». RIFERIMENTI: Senofonte, Memorabili 2,7,13 s. PROVERBI Lupos apud oves … linquere Lasciare i lupi presso le pecore Il proverbio è attestato in Plauto (Pseudolus 139 ss.): il lenone Ballione è critico nei confronti degli schiavi lasciati a custodire la casa; a loro viene applicato il proverbio relativo agli effetti della vicinanza tra pecore e lupi. Numerose le narrazioni fondate su tale nucleo concettuale; va sottolineata, in particolare, la favola di Esopo 229 Ch.: un lupo segue il gregge, mostrandosi tranquillo e inoffensivo; il pastore gli affida così le pecore, ma al suo ritorno le trova tutte sterminate. Anche in questo caso si segnala la funzione paradossale di «custode» esercitata dal lupo, e la morale insiste sul tema dell’avidità. Ma anche altre favole riprendono questo motivo (Esopo 313; 315 Ch.), che, come rileva Tosi 1991, 713, dall’antichità a oggi trova fortuna in vari contesti letterari: cfr. Terenzio, Eunuco 832; Cicerone,
Filippiche 3,11,27.
Penia (Povertà) Nel mito, Penia è la divinità che rappresenta l’indigenza. La sua presenza nella letteratura greca non è frequente: in riferimento all’isola degli Andri, Erodoto (8,111) spiega come essa, abitando qui insieme all’Impotenza, sia considerata una divinità inutile. In Platone (Simposio 203b-204a), si unisce a Poros (l’espediente) e concepisce Eros (v.), che conserva, nella sua natura demonica, le caratteristiche di entrambi i genitori. La narrazione è di tipo eziologico, a metà tra favola e mito, ma presenta spiccati connotati esopici nella struttura.
Pernice Simbolo di lascivia, la pernice, sacra ad Afrodite in quanto dea della fertilità, è guardata con curiosità dagli antichi: secondo Plinio (Naturalis historia 10,101-102), nessun animale ha una così accesa sensualità. Le pernici, infatti, sono preda di una tale follia amorosa che talvolta, mentre volano, si fermano sulla testa dei cacciatori. Artemidoro (Sull’interpretazione dei sogni 4,56) associa la pernice ai pavoni e ai pappagalli, animali dotati di una certa grazia e bellezza: sostiene che corrispondono a persone amanti del bello. Lo stesso Artemidoro (2,46), tuttavia, la accosta anche a donne empie e sacrileghe. La caratterizzazione negativa di questo uccello nella cultura cristiana, in cui è associata al diavolo, deriva da una credenza ebraica, per cui la pernice sottrae e cova le uova di altri volatili e perciò ricorda chi accumula ricchezze ingiustamente (come si sottolinea in un passo biblico: Geremia 17,11). Eliano attesta che esistono diverse vocalità delle pernici secondo le località ed è come se, nelle diverse zone, parlassero la stessa lingua; inoltre, questi volatili compensano gli allevatori richiamando, con il loro verso, i loro simili che vivono allo stato selvatico (De natura animalium 3,35; 4,13; 16). Questo uso delle pernici (uccelli peraltro molto apprezzati sul piano gastronomico) come esche è tanto frequente da diventare uno dei motivi caratterizzanti di diverse favole a esse dedicate (cfr. Esopo 285; 300 Ch.; Babrio 124) e talora rappresenta paradossalmente il motivo della loro condanna, perché, a livello simbolico, le fa diventare immagine negativa dei traditori dei parenti. Se nella favolistica pare assente il tema della lascivia, ritorna (ancora in Babrio 124) il motivo del bel canto che allieta l’uomo ed è paragonabile alla poesia (il poeta Alcmane fa derivare la sua arte dal canto delle pernici: cfr. Bettini 2008, 43 ss.; 118 ss.). Questi uccelli, d’altra parte, possono diventare simbolo, ancora negativo, di
chi promette di essere utile, ma combina soltanto guai, quando si offrono per zappare i vigneti del contadino in cambio di un po’ d’acqua (Esopo 330 Ch.). Nell’oscillante elaborazione della loro figura, le pernici vanno a rappresentare anche gli uomini saggi quando hanno a che fare con il gallo (Esopo 21 Ch.), animale con cui non sembrano legate da un buon rapporto. La pernice e l’uomo Esopo 300 Ch. Un uomo, catturata una pernice, stava per ucciderla. L’uccello, implorandolo, disse: «Lasciami vivere e io, in cambio, ti farò catturare molte pernici». L’uomo rispose: «È un motivo in più per ucciderti, poiché vuoi tendere un agguato a familiari e amici». Chi trama inganni e macchinazioni contro i suoi amici, finirà anch’egli nelle insidie e nei pericoli. RIFERIMENTI: CACCIATORE.
simile
a
Esopo
285
Ch.:
v.
I galli e la pernice Esopo 21 Ch. Un tale, che aveva dei galli nel suo pollaio, quando trovò in vendita una pernice domestica la acquistò e la portò a casa per nutrirla con i polli. Ma poiché questi presero a beccarla e la cacciarono via, la pernice era afflitta, ritenendo che la disprezzassero perché era di una razza diversa. Ma, poco tempo dopo, vide che i galli lottavano tra di loro e non si separavano mai fino a che non arrivavano al sangue; allora disse a se stessa: «Io davvero non devo lamentarmi più di essere colpita da costoro,
poiché vedo che neppure tra di loro essi si risparmiano». La favola dimostra che le persone sagge sopportano facilmente gli oltraggi del prossimo, quando vedono che costui non risparmia nemmeno i suoi familiari. RIFERIMENTI: Eschilo, Supplici 226. Il cacciatore di uccelli, la pernice e il gallo Babrio 124 Un cacciatore di uccelli, che stava per consumare un povero pasto di santoreggia e sedano, ricevette la visita imprevista di un amico. La gabbia era vuota: il cacciatore non aveva catturato nulla. Così decise di uccidere una pernice dalle piume screziate, addomesticata, che egli usava come esca; ma l’uccello supplicava di non essere sacrificato: «In futuro, mio caro, che cosa farai con la tua rete, quando caccerai? Chi ti riunirà il gregge di uccelli dal bell’aspetto, che sono uniti da reciproco affetto? Chi ti farà addormentare con un canto melodioso?». Lasciata la pernice, l’uomo decise di sacrificare un galletto barbuto. Il gallo, dalla sua postazione, strillando, disse: «Da dove apprenderai quanto manca all’aurora, una volta ucciso me che ti annuncio le ore? E quando se ne va a dormire Orione dall’arco d’oro? Chi ti ricorderà le occupazioni del mattino, nell’ora in cui la rugiada bagna le ali degli uccelli?». L’uomo rispose: «Tu conosci i momenti utili della giornata, tuttavia è necessario dare da mangiare all’amico». NOTA: Orione, figlio di Poseidone, fu trasformato in una costellazione tra le più belle del cielo.
Pescatore Già le più antiche civiltà mediterranee praticano la pesca con tecniche abbastanza avanzate: nel II millennio a.C., la civiltà micenea, ad esempio, esercita la pesca con la lenza, anche in mare aperto, ma allo stesso tempo conosce la pesca a strascico, con le nasse e non ignora nemmeno le tonnare. Per i popoli antichi riesce difficile una distinzione netta fra caccia e pesca: «gli etnologi ritengono, ad esempio, che la cattura dei grandi cetacei acquatici vada definita caccia e che si debba parlare di raccolta quando ci si riferisce ai molluschi e ai frutti di mare» (Donati 11). Del resto, il mondo marino, guardato spesso con diffidenza in quanto poco conosciuto, riproduce nella terminologia la fauna terrestre (v. PESCE). Stando alle testimonianze degli autori (fra gli altri, Eliano, Oppiano, Ovidio) che si occupano del tema, i pescatori usano soprattutto quattro tecniche nell’antichità: lenza, rete, nassa e fiocina. Se in Omero la pesca appare come un’attività residuale, svolta in condizioni eccezionali (cfr. Odissea 12,330 ss.), anche dalle testimonianze successive si rileva come questa pratica non raggiunga mai la dignità dell’agricoltura, che nel mondo antico mantiene un indiscusso primato. Mentre nella polis reale la popolazione trae sostentamento sia dalla terra sia dal mare, nella città ideale di Platone la pesca è invece vietata (Leggi 842c). Il pescatore appartiene alle classi subalterne e la sua vita è descritta spesso come dura e difficile. Nell’Idillio 21 di Teocrito (spurio) si descrivono le umili condizioni di vita dei pescatori. Il pescatore entra, quindi, nelle commedie plautine (Rudens, Captivi) sia come schiavo sia come uomo libero ma di bassa condizione sociale. La sua vita è dura, perché scende in mare ogni giorno, anche quando c’è tempesta, per procurarsi da vivere, mentre appesta di cattivo odore il mercato del pesce (è spesso anche pescivendolo) e perciò diventa facile bersaglio.
Nell’epistolario di Alcifrone (II secolo d.C.) emergono ancora i motivi della miseria e dell’incertezza di una vita difficile: per i pescatori «terra» vuol dire «morte» come per i pesci (1,4). Questa caratterizzazione è tipica del pescatore anche nella favola esopica, che non può non accogliere tale figura, perfettamente coerente con l’intento di rappresentare il mondo dei subalterni. L’uomo, che ha a che fare con gli esiti incerti delle sue fatiche, teme spesso di morire di fame. Così in una favola, che pare attestata già in Simonide (fr. 9 P.) ed è ripresa da vari autori, troviamo il pescatore di fronte al dilemma: immergersi e morire di freddo o non immergersi e morire di fame? Va precisato che, pur essendo realistico, questo aneddoto è tipicamente esopico, perché «ogni possibile scelta è bivalente e implica un risultato opposto al fine prefisso» (Jedrkiewicz 1989, 330). Lo stesso timore di morire di fame riappare anche in un’altra favola (Esopo 27 Ch.). In generale, il rapporto con il mare va a simboleggiare le alterne vicende della vita, che è mutevole e dispensa gioie e dolori, come accade ai pescatori che prendono pietre (cfr. Esopo 23 Ch.; si ricordi il forte valore simbolico della pesca anche in altri contesti letterari, come il Vangelo: dalla pesca miracolosa agli apostoli «pescatori di uomini»). Piuttosto frequente in Esopo, di fatto assente in Fedro, la figura del pescatore è in stretta connessione con i pesci, ragione ed elemento essenziale della sua vita. Così ecco persino il tentativo di catturarli dopo averli incantati con la musica (Esopo 24 Ch.: la vicenda è narrata anche in Erodoto 1,141). Come si è notato sopra, esiste una contiguità tra pescatore e cacciatore: questa somiglianza viene valorizzata in una favola di Babrio (61), in cui i due si scambiano felicemente le prede per diversi giorni, anche se sembrano destinati a tornare alle vecchie abitudini. La tecnica di pesca più ricorrente nella favolistica è quella che prevede l’uso della rete: e proprio l’immagine del pescatore che getta le reti, insieme alla scena del pescatore in barca, è la più diffusa riguardo a questa figura. Talora si distingue tra la pesca di
mare e quella di fiume, comunque esercitata con la rete (Esopo 27 Ch.): come appare anche in Aviano 38 esiste una notevole differenza di valore tra i due tipi di pesce (nell’editto dei prezzi di Diocleziano del 301 d.C., il pesce di mare ha un valore doppio del pesce di fiume di pari qualità). Il cacciatore e il pescatore Babrio 61 Un cacciatore ritornava dai monti dopo la caccia, mentre un pescatore ritornava con la cesta piena di pesci. Per caso si incontrarono e il cacciatore preferì i pesci del mare, mentre il pescatore desiderò la selvaggina: così scambiarono i loro beni. Quindi, presero quotidianamente a barattare le rispettive prede, godendo di pasti migliori, finché un tale un giorno li avvertì: «Attenzione: con l’abitudine rovinerete anche il piacere di questi pasti. Così, di nuovo, ognuno cercherà quello che aveva un tempo». Il pescatore che batteva l’acqua Esopo 27 Ch. Un pescatore pescava in un fiume. Stese le reti e sbarrata la corrente da una riva all’altra, attaccò un sasso a una corda di lino e prese a battere l’acqua, per fare in modo che i pesci fuggissero e, non avendo scampo, cadessero nelle maglie della rete. Un tale che viveva nei dintorni vide il pescatore all’opera e lo rimproverò perché insozzava il fiume, impedendo alla gente del posto di bere acqua pura. «Ma – rispose il pescatore – se non agito così l’acqua del fiume, dovrò morire di fame.» Così anche i demagoghi delle città hanno più forza quando
conducono la loro patria nella discordia. RIFERIMENTI: cfr. Simonide, fr. 9 P.; Timocreonte, fr. 8 P.; Aristofane, Cavalieri 864 ss. I pescatori che presero delle pietre Esopo 23 Ch. Dei pescatori tiravano a terra una grossa rete: poiché era pesante, si rallegravano e ballavano per la felicità, ritenendo di avere fatto un’abbondante pesca. Tuttavia, come la trassero a riva, trovarono pochi pesci; infatti, la rete era piena di pietre e di altro materiale. Allora si rattristarono molto, non tanto per la delusione dovuta allo scarso risultato, quanto piuttosto perché avevano immaginato il contrario. Uno di loro, un vecchio, allora disse: «Smettiamola, amici: la gioia, a quanto sembra, ha come sorella la sofferenza e noi, che abbiamo pregustato tanto piacere, dovevamo andare incontro anche a un po’ di dolore». Pertanto anche noi, vedendo quanto la vita è mutevole, non dobbiamo sempre rallegrarci, confidando nella stabilità degli eventi: consideriamo che inevitabilmente arriva la bufera, dopo che c’è stato a lungo bel tempo. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,9; Luciano, Ermotimo 65, Timone 22; cfr. anche Platone, Fedone 60b. Il pescatore e il polpo Pseudo-Diogeniano, Praef., p. 179 L.-S. A un pescatore capitò di vedere un polpo in
inverno. Allora disse: «Se mi svesto e mi tuffo in acqua per prenderlo, mi congelerò! Ma se non catturo questo polpo, farò morire mio figlio di fame». RIFERIMENTI: esempio di favola caria secondo Pseudo-Diogeniano. Cfr. Simonide, fr. 9 P.; Timocreonte, fr. 8 P.; Codice Parigino suppl. gr. 676 (p. 79 Cohn); Ateneo 7,107; Macario 5,9.
Pesce In varie culture antiche il pesce è associato alla divinità e assume il valore di salvatore del mondo, secondo una tradizione che influirà, tra l’altro, sul simbolismo cristiano. Nella tradizione induista, Visnù s’incarna in un pesce e salva il mondo dal diluvio universale, apparendo a Manu, legislatore dell’attuale ciclo; dei dalla forma di pesci adoravano anche i Babilonesi (Ea), i Fenici e i Filistei (Dagon). Nel mito classico il pesce è sacro non solo ad Afrodite, che assume proprio queste sembianze per sfuggire a Tifone, ma anche a Poseidone. Nelle feste dedicate al dio Vulcano (Volcanalia) il 23 agosto, gli antichi Romani sacrificano pesciolini sul fuoco, ritenendo così di risparmiare vite umane, poiché i pesci vanno a sostituire simbolicamente le vite degli uomini (Maspero 261). Dall’acqua in cui è immerso, il pesce trae anche il valore simbolico della fecondità e presso alcuni popoli rappresenta l’emblema dell’organo sessuale maschile, come ancora accade in alcune zone dell’Africa (Cattabiani 2002, 41 ss.). Sulla scia di una lunga tradizione, i cristiani lo rendono simbolo di Gesù; le lettere del termine ἰχθύς («pesce» in greco) diventano le iniziali di «Gesù Cristo figlio di Dio salvatore». I Padri della Chiesa, secondo una consolidata metafora evangelica, considerano gli apostoli «pescatori di uomini» (Matteo 4,19), mentre i fedeli sono «piccoli pesci» che seguono il «Pesce» per eccellenza: Cristo (cfr. Ambrogio, Sui Sacramenti 2,2). La classificazione dei pesci è ispirata spesso alle analogie d’aspetto o di comportamento con gli animali terreni, più familiari all’uomo: così troviamo, come in un mondo metaforico che funge da specchio di quello emerso, il pescecane, il pesce-tordo, il pesce-ragno, persino il pesce-donnola. Al di là degli aspetti legati al mito o al simbolismo, i pesci costituiscono un alimento molto apprezzato nell’antichità: i Romani li allevano anche nei vivaria. Ai pesci e alla pesca
sono dedicate opere specifiche (tra queste, il poemetto Halieutica di Ovidio e un’opera dallo stesso titolo di Oppiano di Anazarbo). La società degli animali esopici, calata in un mondo pastorale, è ovviamente una società di terra piuttosto che di acqua. Tuttavia, gli esseri marini compaiono in diverse favole: va puntualizzato che gli antichi sono piuttosto imprecisi nella classificazione e non distinguono tra pesci, cetacei e altri animali acquatici. Quanto ai crostacei, per la loro ambiguità sono guardati con sospetto (lo stesso accade per i coccodrilli), perché vivere una doppia natura, sulla terra e in acqua, significa, nella semplice mentalità esopica, essere poco affidabili (v. GRANCHIO); inoltre, il mondo del mare appare qualcosa di «altro» e misterioso, secondo una mentalità ampiamente radicata nel mondo antico. Nelle favole i pesci, quando sono definiti in modo generico, appaiono sempre in rapporto dialettico non tra di loro (a eccezione della favola 38 di Aviano: v. GHIOZZO) ma con il pescatore, figura che li collega a una dimensione meno indefinita: peraltro, questo dualismo è rappresentato di frequente a partire da Omero (v. PESCATORE). Nella favola esopica 25 Ch., i «pesci piccoli» si salvano nel momento del pericolo, mentre i «pesci grossi» non trovano via d’uscita: l’immagine – e in particolare la stessa espressione – sopravvive ancora oggi nell’immaginario collettivo. La morale è consolatoria per le classi subalterne e perciò appare tipicamente esopica. Del resto, nell’antichità esiste anche il motivo proverbiale, di segno opposto, secondo cui «Spesso il pesce grande mangia i pesci piccoli»: è attestato nelle Satire Menippee di Varrone (289,2 Bücheler). In un’altra favola, la 24 Ch., i movimenti dei pesci che si dimenano dopo la cattura, molto simili a una singolare danza, diventano motivo per una vicenda che ha larga fortuna nella letteratura antica ed è attestata già in Erodoto (1,141): poiché gli Eoli e gli Ioni non hanno accettato le condizioni dei suoi ambasciatori prima di essere costretti dagli eventi, Ciro, re persiano, li paragona ai pesci che si
decidono a danzare quando finiscono nella rete. Appare qui evidente il processo di dissacrazione tipico della favola: i pesci sono soltanto un cibo ambito e diventano persino motivo di scherno. Infatti, paradossalmente non danzano sentendo l’aulòs, strumento originario dell’Asia, caro a Dioniso, «dal suono eccitante e sensuale» (accostabile all’oboe a canna doppia: cfr. Pahlen 44; altri studiosi riscontrano somiglianze anche con flauti – il termine più usato nelle traduzioni – e clarinetti), ma solo dopo la cattura. Questa tecnica di pesca è attestata da Eliano (De natura animalium 1,39) per la cattura delle pastinache (osservazione simile anche in 17,18). In altre favole, il profilo dei pesci, o degli esseri a loro assimilati, emerge con maggiore precisione, anche se prevale, per lo più, un generico significato simbolico (v. BALENA, DELFINO, GHIOZZO, SARDELLA, SMARIDE, TONNO). Anche nel Pañcatantra (tantra primo, racconto dodicesimo), troviamo il conflitto pescatori-pesci, in una narrazione dai chiari significati simbolici. Tre grandi pesci che vivono in un lago reagiscono diversamente quando si rendono conto che stanno per arrivare i pescatori con le loro reti: uno (dal nome significativo: «Organizzatore-del-futuro») se ne va, gli altri due restano. Quando arriva il momento della pesca, uno di questi («Pronto-di-spirito») con l’astuzia si salva, fingendosi già morto, mentre l’altro («Ciò-che-avverrà») non trova scampo e paga così la sua superficialità. Il pescatore, i pesci grandi e i pesci piccoli Esopo 25 Ch. Un pescatore, dopo aver tirato su dal mare la rete, catturò pesci di grandi dimensioni e li depose a terra. Invece i pesci più piccoli attraverso le maglie della rete scivolarono nel mare. Per chi si trova in condizioni modeste la salvezza è agevole, mentre raramente si può vedere sfuggire ai pericoli chi ha
fama di essere una persona importante. RIFERIMENTI: Babrio 4; Parafrasi 25. Il pescatore che suonava l’aulòs Esopo 24 Ch. Un pescatore, abile auleta, avendo preso con sé il suo aulòs e le reti, si sistemò sul mare e, stando su uno scoglio sporgente, in un primo momento suonava, ritenendo che i pesci volontariamente, per la dolcezza della melodia, sarebbero balzati fuori dall’acqua per venire da lui. Tuttavia, visto che i suoi lunghi sforzi non producevano alcun risultato, mise da parte l’aulòs e prese la rete. Così, dopo averla calata in acqua, catturò molti pesci. Li gettò dalla rete sulla spiaggia e, come vide che si dimenavano, disse: «Maledette bestie, quando suonavo, voi non danzavate; lo fate invece ora che ho smesso». La favola si addice a coloro che agiscono al momento sbagliato. RIFERIMENTI: Babrio 9; Aftonio 33; Erodoto 1,141; Eliano, De natura animalium 1,39; 17,18. Cfr. anche Ennio, fr. 65 V. ; Teone, Esercizi preparatori 2; Filostrato, Vita di Apollonio 1,23. 2
PROVERBI Pur non essendoci un collegamento esatto, la favola 24 Ch. è stata accostata a due proverbi: ῎Aλλως ᾄδεις («Canti invano»): il proverbio è impiegato per indicare coloro che si affaticano inutilmente e si ritrova ampiamente attestato nella tradizione paremiografica: cfr.,
tra gli altri, Zenobio 1,72, Diogeniano 2,19, Macario 1,92; Aristeneto, Epistole 1,27. Hὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ oὐκ ὠρχήσασθε («Vi abbiamo suonato il flauto [il verbo greco indica propriamente l’aulòs] e non avete danzato»): il proverbio di matrice evangelica (Matteo 11,17; Luca 7,32) è sulla bocca di Gesù che condanna l’incredulità di chi diffida di Giovanni Battista.
Piccione (colombo) A partire dalla narrazione biblica del diluvio universale (Genesi 8), la colomba, che reca una foglia d’ulivo, assume una connotazione positiva, arrivando a rappresentare, nella tradizione cristiana, l’immagine dello Spirito Santo o del Cristo che porta pace e redenzione. Legato in varie culture alla Grande Madre, principio universale di vita, nel mondo greco-romano il colombo (o piccione), sacro ad Afrodite (Venere), è simbolo di purezza, fedeltà coniugale, armonia dell’anima (nell’orfismo), oltre che naturalmente di pace. Anche qui l’uccello è considerato messaggero fidato degli uomini, nella vita quotidiana (cfr. Marziale 10,32) come in guerra, addirittura in episodi importanti della storia romana come l’assedio di Modena (43 a.C.). Ma, oltre a questi aspetti decisamente positivi, ne troviamo altri più prosaici, che rivelano un diverso approccio dell’uomo: i colombi nell’antichità sono molto apprezzati sul piano gastronomico; perciò vengono allevati anche in modi crudeli: Columella (8,8) suggerisce di strappare alcune penne e di spezzare loro le zampette in modo che non possano muoversi più. L’allevamento e la schiavitù che ne consegue caratterizzano diverse favole: le colombe domestiche sono contrapposte alle colombe selvatiche nella favola 282 Ch.; secondo una morale tipicamente esopica, nessun biasimo merita chi è fedele al padrone e lo aiuta a catturare i suoi consanguinei (ma talora vale anche il ragionamento contrario: v. PERNICE). Questa narrazione sembra trovare riscontro anche nella saga orientale di Ahiqar, in cui si parla di «un uccello da richiamo, che non salva se stesso dalla morte e con la sua voce ammazza i suoi compagni» (ContiniGrottanelli 2005, 221; traduzione dal testo siriaco di
Pennacchietti). Ma la schiavitù non può che essere una condizione infelice; perciò la cornacchia compiange la colomba orgogliosa della sua prolificità: qualità, questa, che a dispetto della sua valenza positiva cambia di segno se il destino dei figli non prevede la libertà (Esopo 302 Ch.). Come spiega in una prospettiva simmetrica la favola 194 Ch., non è il numero dei figli a fare la differenza: la leonessa partorisce un solo cucciolo, ma è un leone! La colomba si presta perfettamente a rappresentare i subalterni, nella dialettica sociale della favola esopica: tale condizione spinge addirittura Fedro (1,31) a rappresentare questi uccelli inermi come vittime del nibbio, in una narrazione che sembra essere parzialmente in controtendenza con una convinzione secondo la quale tra colombi e uccelli rapaci vige un patto di non aggressione a parte alcune eccezioni (cfr. Eliano, De natura animalium 3,45): ritorna, in questo caso, il frequente tema del patto tradito, a cui segue spesso una strage degli animali più deboli (cfr. Esopo 216, 217, 218 Ch.). La colomba conserva i suoi connotati positivi quando si trova a confronto con la formica, in una favola in cui il sostegno reciproco dei due animali porta al lieto fine (Esopo 242 Ch.): qui si ha anche la ripresa del motivo della riconoscenza dei piccoli animali (cfr. Esopo 206 Ch.). La colomba diventa anche simbolo degli sconsiderati che la passione conduce in rovina (Esopo 301 Ch.), secondo uno schema e una morale applicati anche al tordo della favola 157 Ch. Si è supposto infine che un riferimento del poeta Orazio, in cui si parla dell’intensa amicizia con Fusco, amante della città mentre lui è amante della campagna (Epistole 1,10,4 ss.), possa rimandare a una favola (Esopo 282 Ch.?): forse si tratta semplicemente di un richiamo scherzoso a una consolidata convinzione degli antichi, testimoniata anche da Eliano (4,2). La colomba assetata Esopo 301 Ch.
Una colomba, afflitta dalla sete, come vide dipinta su una tavola una coppa d’acqua pensò che fosse vera. Perciò si lanciò con grande strepito su quell’immagine e, senza rendersene conto, andò a sbattere contro la tavola. Allora, caduta a terra con le ali spezzate, venne presa da un tale che si trovava sul posto. Così alcuni uomini, trascinati dalla violenza delle loro passioni, si impegnano in imprese sconsiderate e finiscono, senza rendersene conto, in rovina. RIFERIMENTI: Sintipa 8. La colomba e la cornacchia Esopo 302 Ch. Una colomba, allevata in una colombaia, si vantava per la sua prolificità. Ma una cornacchia che aveva sentito i suoi discorsi disse: «Cara, smetti di darti delle arie per questo motivo, perché quanti più figli possiederai, tanti più schiavi sarai costretta a piangere». Così anche tra i servi, i più infelici sono quanti mettono al mondo figli in schiavitù. Il cacciatore d’uccelli, le colombe selvatiche e le colombe domestiche Esopo 282 Ch. Un cacciatore di uccelli tese le sue reti e vi legò delle colombe domestiche; quindi, allontanatosi, osservava a distanza quello che stava per accadere. Dopo che alcune colombe si avvicinarono a quelle
domestiche e rimasero imprigionate nelle maglie delle reti, l’uomo, accorso, cercava di prenderle. Allora le colombe selvatiche accusarono quelle domestiche per il fatto che, pur essendo della stessa razza, non le avevano avvertite della trappola; quelle, allora, risposero: «Ma per noi è meglio avere riguardo per il padrone che compiacere i nostri simili». Così anche tra gli schiavi non devono essere biasimati quanti, per amore dei loro padroni, non rispettano l’amicizia per i propri consanguinei. RIFERIMENTI: cfr. Eschilo, Supplici 226. La formica e la colomba Esopo 242 Ch. Una formica assalita dalla sete scese a una fonte, ma, portata via dalla corrente, stava annegando. Una colomba vide la scena e staccò un rametto da un albero, gettandolo nella fonte: la formica vi salì sopra e si mise in salvo. Successivamente un cacciatore di uccelli, preparate le canne, avanzava per catturare la colomba. La formica allora vide la scena e morse il piede del cacciatore. In questo modo, l’uomo, dolorante, gettò via le canne e così fece subito fuggire la colomba. La favola dimostra che bisogna contraccambiare chi ci fa del bene. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 244. I due colombi Orazio, Epistole 1,10,4 ss.
Siamo quasi gemelli [...] vecchi colombi che si conoscono a fondo. Tu custodisci il nido, io lodo i ruscelli della bella campagna, le rocce coperte dal muschio e il bosco.
Pidocchio Nel mondo antico, i pidocchi sono considerati importuni e noiosi, al pari di altri esseri senza importanza quali le pulci, le mosche, le zanzare o le cimici: accostamenti, sviluppati in questo senso, compaiono, ad esempio, nella commedia plautina (così in Curculio 499 ss.). Secondo una leggenda molto nota, furono i pidocchi a causare indirettamente la morte di Omero. Il poeta, infatti, vide dei ragazzi di ritorno dalla pesca e li interrogò sull’esito della loro fatica; essi risposero: «Quanto prendemmo, lasciammo; quanto non prendemmo, portiamo»: si riferivano alla «pesca» dei pidocchi, non a quella dei pesci. Omero non comprese l’enigma e morì per il dolore. Nelle raccolte esopiche i pidocchi sono assenti, tuttavia compaiono in una narrazione dello storico Appiano (Le guerre civili 1,101): qui emergono nella loro dimensione abituale di esseri molesti. La favola (narrata da Silla in un contesto pubblico come monito che intimorisse coloro che non assecondavano i suoi disegni) sembra suggerire una morale secondo cui è meglio estirpare il male alla radice, quando esso è tenace; forse può essere ricondotta all’insegnamento cinico che invita a non inciampare due volte nella stessa pietra (cfr. Adrados 2003, 569 s.). Il Pañcatantra presenta una narrazione (primo tantra, settimo racconto) che vede protagonisti una pulce e un pidocchio, anche in questo caso, come accade in altri contesti letterari, accostati. Sono tuttavia destinati a una diversa fortuna (v. PULCE). I pidocchi e il contadino Appiano, Le guerre civili 1,101 Dei pidocchi mordevano un contadino impegnato
ad arare. L’uomo, per due volte, lasciò l’aratro e ripulì il vestito. Poiché tuttavia venne di nuovo morsicato, per non interrompere spesso il suo lavoro bruciò il vestito.
Pino Nelle tradizioni mediorientali il pino è collegato al culto della Grande Madre (Cibele) e ad Attis, dio che le è associato, il cui mito simboleggia il ciclo della primavera per la sua morte e risurrezione. Nell’antichità Cibele e Attis sono onorati, in Frigia come a Roma, con feste solenni nel mese di marzo. In relazione al mito di Attis, questo albero è impiegato nel simbolismo funebre, ma è anche emblema di fecondità: le fiaccole usate nelle nozze sono fatte con il suo legno. Questo valore dipende dalla percezione che gli antichi hanno delle sue caratteristiche: Plinio (Naturalis historia 16,107) ne sottolinea la notevole generosità nel portare frutto. Nella mitologia greca, il pino è posto in relazione anche a Dioniso. I Corinzi ricevono dall’oracolo delfico l’invito a venerare quest’albero come un dio. Nei Giochi Istmici, celebrati ogni quattro anni a Corinto, con il pino si incoronavano i vincitori. Quanto alle origini della pianta, si narra, tra l’altro, che la ninfa Pitys chiese di essere trasformata in un pino per sfuggire alle brame di Pan (di qui l’associazione del pino con il tema della verginità; ma esistono altre versioni sulla metamorfosi). Il pino è usato per costruire le navi, come si segnala già in contesti mitologici (cfr. Ovidio, Metamorfosi 1,94 s.; Seneca, Medea 336: anche in contesto favolistico, Fedro 4,7,6 s. fa riferimento al pino in relazione alla nave degli Argonauti). Fedro (3,17) accenna al pino come pianta sacra a Cibele: insieme ad altri alberi, definiti sterili, lo contrappone all’olivo, considerato più generoso di frutti. La considerazione pare in controtendenza con la tradizione che attribuisce all’albero il valore opposto; tuttavia, qui il riferimento sembra spiegabile semplicemente con il fatto che non produce frutti destinati a essere mangiati dall’uomo. Nell’unica favola di Esopo in cui il pino, peraltro spogliato di qualsiasi relazione con la sfera divina, è presente (100 Ch.;
ma in altre versioni è sostituito dalla quercia), si propone un tema di larga diffusione, forse di origine orientale: quello della disgrazia procurata da se stessi o, come spiegato nella morale, dai familiari. Il dolore per la morte è dovuto al paradosso che sono i cunei ricavati dalla pianta a decretarne la rovina. Lo stesso motivo si ritrova, ad esempio, nella favola dell’aquila trafitta da una freccia, la cui cocca è realizzata con le sue penne (Esopo 7 Ch.). Molto simile l’epimitio: «L’aculeo della sofferenza è più pungente quando siamo esposti al pericolo per causa dei nostri familiari». I boscaioli e il pino Esopo 100 Ch. Dei boscaioli tagliavano un pino. E lo tagliavano facilmente proprio grazie ai cunei ricavati dallo stesso legno. Allora il pino si lamentò: «Non me la prendo tanto con la scure che mi spezza, quanto piuttosto con i cunei che da me hanno origine». Non è tanto terribile essere oltraggiati dagli estranei come esserlo dai propri familiari. RIFERIMENTI: in alcune versione si trova una quercia anziché un pino. Cfr. Babrio 38; F. dattiliche 13; Parafrasi 100; Dodecasillabi 100. Cfr. anche Suda ε 1145 Adler. Motivo non dissimile in Romulus 64.
Pioppo Il pioppo nero presenta un simbolismo legato alla morte e all’Aldilà: è dedicato alle Eliadi, figlie del dio del Sole, che furono trasformate in quest’albero dagli dei, impietositi dal pianto causato dalla morte del loro fratello Fetonte. Il pioppo bianco, invece, ha foglie di due colori differenti: da un lato sono scure, dall’altro argentee; perciò questa pianta è simbolo del passaggio verso una nuova vita (nella tradizione cristiana è posto naturalmente in relazione con la resurrezione). In particolare, diventa «l’albero ombroso di cui si corona Ercole» (Virgilio, Georgiche 2,66). L’eroe, infatti, è ornato dell’argenteo ramoscello del pioppo quando torna dall’Acheronte, a compimento della dodicesima delle sue celebri fatiche (v. ERACLE). Un lato delle foglie rimane scuro, l’altro lato diventa bianco-argenteo per il sudore dell’eroe, come a simboleggiare la duplice natura (terrestre e oltretombale) della fatica d’Ercole: i commenti di Servio alle Bucoliche (7,61) e all’Eneide (8,276) di Virgilio danno ampiamente conto del mito. Nella tradizione favolistica, il pioppo compare tra gli alberi posti sotto la protezione degli dei (Fedro 3,17). Il riferimento è certamente al pioppo bianco, perché viene segnalato per il suo stretto legame con Ercole. L’albero, che spicca per l’imponente altezza, viene contrapposto, insieme ad altre piante, all’olivo, di cui viene affermato, nella morale, il primato in funzione della maggiore utilità. La gloria, invece, è l’elemento distintivo del pioppo, come del mirto, della quercia e del pino.
Pipistrello Gli antichi sono molto colpiti dai pipistrelli, per la loro paradossale condizione di mammiferi volanti. Nel mito, le figlie di Minia, re beota di Orcomeno, sono trasformate in pipistrelli per essersi rifiutate di partecipare a una festa in onore del dio Dioniso (cfr. Ovidio, Metamorfosi 4,401 ss.). Esiste un diffuso atteggiamento di sospetto nei confronti dell’animale, che è collegato anche a una dimensione magica. Eliano (De natura animalium 1,37) afferma che il pipistrello, al solo contatto, rende sterili le uova della cicogna, che si protegge da esso con una foglia di platano in grado di narcotizzarlo. Plinio (Naturalis Historia 29,83) riferisce l’uso di inchiodare questi mammiferi vivi, a testa in giù, sulle case, dopo averli condotti a fare tre volte il giro dell’abitazione: a quel punto, il pipistrello fungerebbe da amuleto. Nella tradizione cristiana, l’animale va generalmente a simboleggiare il demonio (già nella tradizione dell’Antico Testamento, peraltro, è considerato animale impuro). La natura ibrida di volatile e di topo, che tanto colpisce gli antichi, fa del pipistrello un simbolo di ambiguità ed è ripresa dalla tradizione esopica, anche con connotazioni positive. Nella favola 251 Ch., il mammifero rappresenta chi si sa adeguare con intelligenza alle diverse situazioni, ora spacciandosi per topo, ora spacciandosi per uccello (v. DONNOLA). Un’altra caratteristica, che segna questo animale a partire dal nome (vespertilio, con riferimento alla sera, in latino; νυκτερίς, con riferimento alla notte, in greco), è il suo legame con l’oscurità, che viene spiegato in diversi modi nella tradizione favolistica. Così una delle favole in prosa che derivano da Fedro (Romulus 54), unendo questo motivo con quello della doppia natura, spiega che il pipistrello si nasconde nelle tenebre notturne per la vergogna dovuta al fatto che, quando gli uccelli erano in
guerra con i quadrupedi, si univa in modo opportunistico a chi sembrava prevalere. Ma Esopo motiva in modo differente questa caratteristica: dopo essersi dato al commercio con altri animali, il pipistrello perse il carico, e da quel giorno vive di notte per sfuggire ai creditori (250 Ch.). Inoltre, anche quando la sua funzione nell’economia narrativa è marginale, il pipistrello appare come un efficace personaggio secondario di vicende che si svolgono nelle ore notturne (Esopo 75 Ch.). Il pipistrello Romulus 54 I volatili facevano guerra ai quadrupedi: ora vincevano, ora erano vinti. Per timore dell’incertezza degli eventi, il pipistrello si gettava dalla parte di chi aveva visto prima prevalere. Ritornata l’antica pace, volatili e quadrupedi si resero conto dell’inganno. Il pipistrello, condannato dunque per quel misfatto così vergognoso, si nascose nelle fosche tenebre della notte. Chiunque desideri essere accolto da due parti, risulta vergognosamente sgradito a entrambe.
Platano Pianta di origine asiatica, sacra in Lidia, secondo una certa tradizione giunge in Grecia per la prima volta per adornare la tomba dell’eroe acheo Diomede, protagonista a Troia. D’altra parte, già nell’Iliade (2,308 ss.) troviamo quest’albero, in un contesto oracolare: un serpente divora otto piccoli passeri e la loro madre su un platano; i Greci, che si trovano in Aulide, di lì dedussero le sorti della guerra di Troia. La somiglianza delle foglie della pianta con il palmo della mano rende il platano sacro alla Grande Madre, divinità che a Creta è rappresentata con le cinque dita: è possibile che dall’isola sia giunto in Grecia, dove è consacrato a Elena, figlia di Zeus e di Leda; quindi, viene dedicato ad Apollo (cfr. Cattabiani 1996, 369 s.). L’etimologia di «platano» rimanda all’aggettivo greco πλατύς (largo, ampio) e suggerisce la notevole estensione dei rami e le dimensioni delle foglie di questo albero, che è un naturale riparo per gli uomini. Proprio con questa funzione il platano compare nella tradizione favolistica (Esopo 256 Ch.), a cui si riferiscono anche autori estranei a essa (v. riferimenti sotto). La morale lo segnala come benefattore dell’uomo, che però non contraccambia con la dovuta gratitudine (ma nell’antichità la venerazione per il platano è notevole, al punto che la pianta viene talora innaffiata non con l’acqua, ma con il vino). Questa funzione di riparo è ampiamente attestata: è noto il viale dei platani, vicino all’Accademia di Atene, dove i filosofi si fermavano a discutere; anche Socrate non disdegnava di discutere sotto i platani (come racconta Platone, Fedro 279b-c). Questa percezione positiva del platano diventa quasi proverbiale: si attribuisce a Temistocle l’espressione «Facciamo con lui come si fa con i platani». Si vuole così indicare la possibilità di trarre vantaggio da una persona come si fa con i platani, che offrono riparo in caso di particolari condizioni
meteorologiche: maltempo o calura estrema. I viandanti e il platano Esopo 256 Ch. D’estate alcuni viandanti, intorno a mezzogiorno, sfiniti dal caldo, videro un platano, andarono sotto le sue fronde e, dopo essersi sdraiati all’ombra, si riposavano. Guardarono quindi il platano e tra di loro dicevano che questa pianta infruttuosa era inutile per gli uomini. Ma l’albero esclamò: «Ingrati, ancora state sfruttando la mia benefica ombra e avete il coraggio di definirmi inutile e sterile». Così anche tra gli uomini alcuni sono sfortunati, poiché, anche se fanno del bene al prossimo, non vedono riconosciuta la loro generosità. RIFERIMENTI: cfr. Eliano, Varia Historia 9,18; Plutarco, Temistocle 18. Si tratta di allusioni.
Pluto Figlio di Demetra e di Giasone, dio della ricchezza, Pluto, raffigurato come zoppo e cieco, nasce a Creta. Secondo una leggenda, dopo che Zeus lo ha accecato distribuisce le ricchezze a caso. In una commedia di Aristofane che prende il nome da lui, Pluto viene condotto nel tempio di Asclepio e guarisce le sue infermità, così che la ricchezza viene concessa agli onesti e tolta ai malvagi. Il dio compare soltanto in una favola, in cui Eracle lo evita a causa della frequentazione degli individui malvagi a cui Pluto si dedica sulla terra (Esopo 130 Ch.). L’epimitio ribadisce l’accostamento di malvagità e ricchezza. La narrazione forse trova il suo modello nel noto racconto di Prodico su Eracle e la virtù, citato in Senofonte, Memorabili 2,1,21-34 (v. ERACLE).
Polpo Il polpo è ritenuto un animale pigro, ma anche astuto, perché, aderendo agli scogli, evita le reti dei pescatori (cfr. Ovidio, Halieuticon 31 ss.). Secondo una tradizione che risale a Esiodo (Le opere e i giorni 524 s.), in inverno non percorre le acque del mare, ma sta nelle sue dimore e rosicchia i propri tentacoli. Il polpo compare, senza particolari caratterizzazioni, in una curiosa narrazione di origine simonidea, che lo Pseudo-Diogeniano (Praef. p. 179 L.-S.) indica come esempio di favola caria. Senza dubbio questo mollusco rappresenta un’ottima preda, ma, visto che è inverno, il pescatore è bloccato dal dilemma: se si tuffa, congelerà; se rinuncia alla cattura, suo figlio morirà di fame.
Pompeo Generale e uomo politico, Pompeo (106-48 a.C.) vive da protagonista la travagliata fase conclusiva della Repubblica romana. Eredita, dopo la morte del padre, i latifondi del Piceno. Con un esercito personale, sostiene Silla, che, divenuto dittatore, gli riconosce il trionfo, il titolo di Imperator e l’appellativo di Magnus, per le vittorie riportate in Sicilia e in Africa contro i partigiani di Mario (82-81). Successivamente, dopo la morte di Silla (78), Pompeo consegue altri importanti successi: in particolare la guerra condotta come proconsole contro Sertorio in Spagna (76-71). Tornato in Italia, affianca Crasso nel portare a termine vittoriosamente la guerra contro gli schiavi guidati da Spartaco. Nel 67, con la legge Gabinia, viene nominato comandante unico nella guerra contro i pirati, nella quale riporta l’ennesimo successo. Ha la meglio, quindi, sull’ostico Mitridate, re del Ponto, facendo di quella regione una provincia romana; conquista anche la Siria e occupa Gerusalemme: nel 61 ottiene il terzo trionfo. Stringe poi alleanza con Crasso e Cesare, costituendo così il primo triumvirato (60). Dopo la morte di Crasso (53), Pompeo si avvicina sempre di più al Senato; inevitabile è poi il conflitto con Cesare, a cui viene negata la proroga del comando in Gallia. Ha inizio la guerra civile: sconfitto a Farsalo (48), Pompeo fugge a Mitilene di Lesbo e in Egitto. È ucciso dai sicari di Tolomeo XIV, che vuole ingraziarsi Cesare: Plutarco riferisce che gli troncano il capo e gettano il corpo nudo fuori dalla barca su cui all’arrivo era stato accolto (Pompeo 79-80). Pompeo è calato in uno degli aneddoti storici di Fedro. Questo aneddoto, di ambientazione indefinita se non per il riferimento al personaggio storico, è «forse il capolavoro narrativo di Fedro» (La Penna 1968, LI) e si gioca sul contrasto tra apparire ed essere, oltre che sul mutamento
del tono, che oscilla dal livello alto, quasi epico, del primo verso (una sorta di singolare promitio) alla comicità che caratterizza i versi successivi. Protagonista è un soldato dall’aspetto femmineo, che, secondo la tradizionale tecnica del rovesciamento della situazione, si rivela per quello che non sembra: un militare di valore. Pompeo, descritto come uomo «di animo schietto», appare come figura saggia, degna della sua fama. Alla fine si dimostra anche arguto nell’indovinare la vera natura del soldato: «è proprio questa pronta battuta comica, accompagnata dal colorito gesto del giuramento, a porre in una dimensione più umana […] il personaggio di Pompeo che, perso ogni effettivo legame storico, si sviluppa secondo le tendenze e le finalità artistiche di Fedro in carattere individuale, perdendo ciò che di statico e di convenzionale conserva spesso il personaggio storico nell’aneddoto fedriano» (Svelo 388). Pompeo Magno e il suo soldato Fedro, App. 8 [10] Quanto è difficile conoscere gli uomini! Un soldato di Pompeo Magno, dal corpo enorme, a causa della voce stridula e dell’andatura femminea, si era guadagnato una indubitabile fama di invertito. Una notte costui tese un’insidia ai giumenti del suo comandante e sottrasse i muli con vestiti, oro e grandi quantità d’argento. Si comincia a diffondere la voce sull’accaduto; il soldato è posto sotto accusa e viene condotto nella tenda del comandante. Allora Pompeo chiede: «Che dici? Tu dunque, mio commilitone, hai osato depredare me?». Egli subito si sputa nella mano sinistra e sparge la saliva con le dita: «Generale, così i miei occhi si sciolgano in gocce se ho visto o toccato i tuoi beni». Allora Pompeo, uomo di animo schietto, ordina che quella vergogna dell’accampamento sia scacciata e non
crede che quell’uomo abbia tanta audacia. Dopo poco tempo un barbaro di grande forza nelle braccia sfida a duello uno fra i Romani. Ciascuno teme per sé: per primi bisbigliano timorosi gli ufficiali. Alla fine quell’uomo, invertito all’apparenza, ma un Marte per forza, si avvicina al comandante seduto sul palco, dove era solito prendere le decisioni, e con femminea voce dice: «Mi è permesso?». Naturalmente Pompeo Magno è colto da sdegno e, vista la gravità della situazione, ordina che l’uomo sia cacciato. Allora un anziano amico del capo dice: «Penso che sarebbe preferibile offrire alla Fortuna costui, per il quale non sopporteremmo un grave danno, piuttosto che un uomo forte, che, una volta vinto, ti rimproveri l’imprudenza». Condivise il parere Pompeo Magno e diede al soldato il permesso di combattere. Egli, con meraviglia dell’esercito, tagliò la testa del nemico più rapidamente di quanto non si possa dire e tornò vincitore. Allora, riguardo a questi fatti, Pompeo disse: «Soldato, volentieri ti offro la corona, perché hai garantito l’onore dell’autorità di Roma, ma si sciolgano in gocce i miei occhi – disse imitando il turpe giuramento del militare – se non sei stato tu a sottrarmi poco tempo fa i miei bagagli».
Poros (Espediente) Figlio di Metis, Poros, ossia l’espediente, compare già nella cosmogonia di Alcmane (fr. 5 Dav.), dove tuttavia rappresenta la «via» all’interno del vuoto primordiale. Secondo Platone (Simposio 203b-204a), si unisce a Penia (l’indigenza), che concepisce Eros. Si tratta di una narrazione eziologica, che spiega la natura di questo «demone» che presiede all’amore (v. EROS).
Poseidone Figlio di Crono e di Rea, fratello di Zeus, Poseidone (Nettuno a Roma) è dio del mare, nelle cui profondità si trova il suo palazzo. Sposa Anfitrite, da cui ha un figlio: Tritone. Il suo culto, diffuso in tutta la Grecia, era concentrato soprattutto nel Peloponneso. Gli erano sacri il cavallo, il toro, il delfino e il pino. I Romani festeggiavano le feste in suo onore (Neptunalia) il 23 luglio. Spesso è rappresentato con il tridente, che costituisce sia un’arma sia una sorta di scettro. Il dio del mare compare nella variante alla linea principale della favola di Zeus, Prometeo, Atena e Momo (Esopo 124 Ch.). Questa seconda linea della tradizione, che si ritrova ad esempio in Babrio (59), presenta Zeus, Poseidone e Atena impegnati a creare rispettivamente l’uomo, il toro e la casa. Momo, in qualità di giudice, trova un difetto a ognuna di queste opere. Oltre al mutamento dei personaggi, in questa variante della favola manca la punizione del giudice ipercritico.
Principe (flautista) Lucio Cassio Principe era un flautista, la cui esistenza è attestata anche da un’iscrizione (CIL XI 4424). Si esibiva con Batillo, pantomimo, liberto di Mecenate, originario di Alessandria d’Egitto. Fedro (5,7) lo presenta, raccontando un aneddoto che mette in ridicolo la sua vanagloria. Sentendo un gioco di parole che allude al princeps senatus, ossia all’imperatore, pensa che ci si riferisca a lui. La sua sciocca boria genera le risate del pubblico. Uno schema narrativo simile si ritrova applicato al più stolto degli animali, l’asino, che in Esopo (266 Ch.) viene descritto mentre porta la statua di un dio e pensa ingenuamente che gli onori tributati a essa siano invece rivolti a lui. Il flautista Principe Fedro 5,7 Quando un animo vanaglorioso, colto dall’aura frivola della fama, si è attribuito un’insolente presunzione, la sua sciocca leggerezza finisce facilmente per essere derisa. Principe era un flautista assai noto, che di solito accompagnava in scena Batillo. Per caso, in occasione di uno spettacolo (non ricordo quale), mentre una macchina teatrale veniva alzata frettolosamente senza che lui se lo aspettasse, egli cadde con un pesante impatto. Si fratturò così la tibia sinistra, mentre avrebbe preferito la lesione delle due tibie di destra. Sollevato a braccia, mentre geme con grande
strepito, viene riportato a casa. Trascorsi alcuni mesi, le cure gli restituiscono la forma fisica. Come è costume degli spettatori, si cominciò a sentire l’assenza di quell’artista, con il suo piacevole genere di esibizione, che, attraverso il suono del flauto, era solito stimolare l’energia del ballerino. Un importante signore aveva l’intenzione di organizzare uno spettacolo. Dal momento che Principe aveva ricominciato a camminare, lo indusse, con preghiere e con soldi, a presentarsi nel giorno stesso dello spettacolo. Appena arriva il giorno, le chiacchiere sul flautista attraversano il teatro. Alcuni dicono che è morto, alcuni che è pronto a ripresentarsi, senza ulteriore indugio, di fronte al pubblico. Calato il sipario, scatenati i tuoni, gli dei parlarono secondo l’uso imposto dalla tradizione. Allora il coro fece risuonare un canto ignoto a lui, che aveva appena fatto ritorno in teatro. Queste erano le parole: «Sii felice, Roma, incolume, poiché sano e salvo è il tuo principe!». Subito gli spettatori si levarono in piedi per applaudire. Principe getta baci intorno, convinto che gli ammiratori si congratulino con lui. Il ceto equestre comprende lo sciocco errore e, ridendo di gusto, richiede il bis. Il canto viene così ripetuto. Il nostro uomo, sul palcoscenico, è tutto impegnato a fare inchini. I cavalieri, deridendolo, lo applaudono. Il popolo crede che chieda la corona. Ma, come la situazione divenne manifesta in ogni settore del teatro, Principe, con la gambe avvolte da una fascia nivea, con una tunica nivea, anche con le scarpe color della neve, orgoglioso per gli onori attribuiti invece alla divina casa imperiale, venne cacciato fuori da tutti con la testa in avanti. NOTA: l’autore gioca sull’ambiguità del termine tibia, che in latino significa sia tibia sia flauto, strumento realizzato secondo quattro tipologie, sulla
base di lunghezza e suono delle canne: tibiae pares, impares, dextrae, sinistrae. Al contrario di oggi, il sipario era lasciato cadere e arrotolato a terra per scoprire la scena e segnare l’inizio dell’esibizione. Alla fine dello spettacolo veniva rialzato. La corona era un riconoscimento concesso all’attore per premiare la sua abilità. Cfr. Solimano 288 ss. per altri particolari.
Prometeo Figlio del titano Giapeto e dell’oceanina Climene, fratello di Atlante, Menezio ed Epimeteo, Prometeo (l’etimologia del nome suggerisce il significato di «previdente») è dotato di notevole intelligenza ed è ritenuto un benefattore dell’umanità per avere donato agli uomini il fuoco, le scienze e le arti. Inoltre, secondo il mito, Prometeo plasma con il fango (o la creta) il primo uomo e lo anima con il fuoco sottratto a Zeus. Il re degli dei punisce gli uomini, creando la prima donna, Pandora, e regalandole un vaso in cui sono racchiusi tutti i mali. Prometeo viene incatenato su una rupe del Caucaso, dove un avvoltoio gli rode continuamente il fegato, che poi torna a ricrescere. Viene poi liberato da Eracle o, secondo altre leggende, dallo stesso Zeus. La tradizione favolistica sembra naturalmente destinata ad accogliere la figura di Prometeo, simbolo di astuzia e di previdenza, valori fondamentali nel mondo esopico. In effetti, il personaggio compare in numerose narrazioni, tuttavia l’interesse prevalente riguarda l’atto della creazione (Esopo 124 Ch.), che va a spiegare alcune caratteristiche dell’uomo. Nello specifico, si spiega, ad esempio, l’origine degli uomini più rozzi (Esopo 322 Ch.), che rivelano la loro precedente condizione di animali. Nella narrazione delle due bisacce, che ha goduto di lunga fortuna ed è entrata anche nell’uso dei proverbi, si spiega invece perché gli uomini vedono i vizi degli altri ma non i propri, che sono collocati dietro alle loro spalle (Esopo 303 Ch.: Fedro 4,10 sostituisce Prometeo con Giove). In una favola frammentaria di Fedro (4,14 [15]) troviamo invece la spiegazione dell’origine della fellatio. Nella narrazione successiva (4,15 [16]), che sembra legata a questa come in un dittico (Oberg 2000, 187), Prometeo, descritto come compagno di banchetto del dio del vino Libero (Dioniso), per un errore dovuto alla scarsa lucidità, dà origine all’omosessualità. Ma l’atto creativo
riguarda anche entità personificate come la Verità (Fedro, App. 4 [5]: qui Prometeo ha la meglio su Inganno, in una favola insolitamente fiduciosa, ma forse ironica: cfr. Nøjgaard 1967, 185) e gli animali, che, come tendono a fare anche con Zeus, si lamentano per le qualità che a loro mancano. In una narrazione troviamo addirittura il leone che rimprovera Prometeo di averlo reso timoroso nei confronti del gallo (Esopo 210 Ch.). Una storia, che qualcuno non considera di carattere strettamente favolistico (cfr. Van Dijk 1997, 673), ma che è alla base di alcune narrazioni esopiche, è quella delle due vie: la virtù e il vizio (v. in particolare Esiodo, Le opere e i giorni 287 ss.; Prodico 84B D.-K. in Senofonte, Memorabili 2,1,21 ss.); in particolare, nel Romanzo di Esopo (94) è Prometeo a stabilire le due vie: quella della libertà e quella della schiavitù. Prometeo Fedro 4,14 [15] A imitazione del membro virile, Prometeo formò la lingua della donna. Di qui trasse affinità un certo tipo di rapporto sessuale. Lo stesso Fedro 4,15 [16] Un altro chiese con quale criterio fossero stati creati le lesbiche e i maschi effeminati. Il vecchio spiegò: «Fu lo stesso Prometeo a formarci con l’argilla in modo che, non appena ci scontriamo con la sorte, finiamo in cocci; egli, avendo lavorato separatamente per un’intera giornata le parti della natura che il pudore nasconde con i vestiti, così da adattarle poi ai loro corpi, fu invitato
inaspettatamente a cena da Libero. Dopo avere inondato di abbondante nettare le vene, fece ritorno a casa tardi, barcollando. Allora, a metà tra la veglia e il sonno, a causa di un errore dovuto all’ubriachezza, applicò le parti sessuali femminili al genere maschile e i membri maschili alle femmine. Ora, pertanto, il piacere si gratifica in un godimento distorto». NOTA: «il vecchio» è un modo per indicare Esopo. Prometeo e le lacrime Temistio, Orazioni 32, 359d Anche questo sostiene Esopo: l’argilla che Prometeo usò quando plasmò l’uomo fu impastata non con l’acqua ma con le lacrime. Pertanto non si deve tentare di fare del tutto a meno delle lacrime: è impossibile. RIFERIMENTI: Svetonio, Tiberio 57; Stobeo 3,1,122; Niceforo Gregora, Historia Byzantina 16,4,3. Prometeo e gli uomini Esopo 322 Ch. Per ordine di Zeus, Prometeo plasmò gli uomini e gli animali. Dopo aver visto che gli animali erano molto più numerosi delle persone, Zeus ordinò a Prometeo di eliminarne una parte e di trasformarli in esseri umani. Una volta eseguito il comando divino, ne conseguì che quelli che non erano stati plasmati
come uomini ebbero forma umana, ma un’anima da bestia. La favola è adatta per gli uomini rozzi e animaleschi. RIFERIMENTI: Platone, Protagora 320d; Orazio, Odi 1,16,13. Le due bisacce Esopo 303 Ch. Una volta Prometeo, dopo aver plasmato gli uomini, appese al loro collo due bisacce: l’una piena dei vizi degli altri, l’altra invece piena dei propri e sistemò davanti la prima, ponendo invece l’altra dietro. Per questo motivo gli uomini scorgono da lontano i vizi degli altri, mentre non riescono ad accorgersi dei propri. Ci si potrebbe servire di questa favola a proposito di un uomo invadente, che, incapace di vedere le proprie azioni, si dà pensiero di quelle che non lo riguardano. RIFERIMENTI: Fedro 4,10; Babrio 66; Parafrasi 304; Catullo 22,21; Orazio, Satire 2,3,298 s.; Seneca, L’ira 2,28,8; Persio 4,24; Plutarco, Crasso 32; Esopo, Sentenze 23 P.; Girolamo, Epistole 102,2; Tzetze, Chiliadi 9,943-948. Una variante della favola prevede che l’uomo non porti davanti a sé alcuna bisaccia, ma veda quella di chi lo precede. Altre possibili allusioni sono suggerite da Van Dijk in Adrados 2003, 291. Le due vie Romanzo di Esopo 94
Zeus una volta ordinò a Prometeo di mostrare agli uomini le due vie: quella della libertà e quella della schiavitù. Egli allora rese la via della libertà all’inizio aspra e difficile da superare, ardua, senz’acqua, piena di rovi ed esposta ai pericoli da ogni parte. Alla fine invece essa è una pianura uniforme, dotata intorno di sentieri, con un bosco pieno di alberi da frutto e corsi d’acqua, affinché l’angoscia approdi infine a una pausa [per coloro che respirano l’aria della libertà]. Lo stesso Prometeo rese invece la via della schiavitù all’inizio una pianura uniforme, con un aspetto dolce, impreziosita da bei fiori e molto raffinata, ma alla fine impraticabile, da ogni parte scoscesa e insormontabile. RIFERIMENTI: Esiodo, Le opere e i giorni 287 ss.; Prodico 84B D.-K. in Senofonte, Memorabili 2,1,21 ss. Decine le riprese e le citazioni, fra cui Stobeo 3,1,205; Cicerone, De officiis 1,32,118; Massimo di Tiro 14,1-2; Filostrato, Epistole 73, Vita di Apollonio 6,10; Ateneo 12,2 510C; Suda π 2366 Adler (altri riferimenti sono proposti da Van Dijk in Adrados 2003, 434 s.). L’asino e il serpente Eliano, De natura animalium 6,51 Si racconta che Prometeo rubò il fuoco. Secondo la leggenda, Zeus si adirò e donò a coloro che avevano denunciato il furto un filtro come rimedio contro la vecchiaia. Ho quindi saputo che costoro, ricevuto il rimedio, lo posero su un asino. La bestia procedeva portando il peso. Era estate e la necessità di bere spinse l’asino a dirigersi verso una sorgente. Allora il serpente che la custodiva lo fermò e lo
rimandò indietro; e così l’asino, torturato dalla sete, gli offrì come ricompensa e coppa dell’amicizia il filtro che stava trasportando. Ecco, dunque, lo scambio: uno beve, l’altro elimina la vecchiaia, ricevendo in cambio, come si racconta, la sete dell’asino. RIFERIMENTI: Eliano riferisce che la favola è narrata dai poeti Sofocle, Ibico, Dinocolo, Aristia e Apollofane. Cfr. inoltre Ibico 32 P. (Crisippo, fr. 180,14 SVF); Nicandro, Rimedi contro i veleni animali 343 ss. PROVERBI Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt Teniamo i vizi degli altri davanti ai nostri occhi, mentre quelli degli altri sono alle spalle Il proverbio, efficacemente sintetizzato da Seneca (L’ira 2,28,8), riprende senza dubbio la favola delle due bisacce, che Prometeo (o Giove) in origine ha posto sugli uomini: davanti quella dei vizi altrui, dietro quella dei propri (Esopo 303 Ch.; Fedro 4,10; Babrio 66). Si tratta di una narrazione di larga fortuna (v. riferimenti sopra), rielaborata in età moderna anche da La Fontaine (1,7), che spiega l’innata tendenza dell’uomo a giudicare gli altri e a non vedere i propri errori (per certi versi appare simile all’immagine della pagliuzza e della trave: cfr. Vangelo di Matteo 7,5). V. sopra per gli altri riferimenti.
Pudore Il Pudore, inteso come personificazione del senso di vergogna, è una divinità (o meglio, un demone) venerata sia in Grecia sia a Roma, dove si ha notizia di due santuari a essa dedicati. Generato da Prometeo, il Pudore è generalmente inteso come un sentimento positivo, dal momento che distoglie gli uomini dal commettere azioni non oneste. Talora si accompagna a Nemesi. In una favola di tipo eziologico, che spiega l’incompatibilità del Pudore con Eros, Esopo (118 Ch.) spiega che esso fu introdotto in ritardo nell’uomo da Zeus e trovò il sedere come via di ingresso. Va rilevato il ruolo del padre degli dei, che, in questo caso, è al posto di Prometeo, generalmente indicato come colui che in origine dà forma all’uomo. Zeus e il Pudore Esopo 118 Ch. Quando Zeus plasmò gli uomini, mise dentro di loro le altre disposizioni dell’animo: si dimenticò di inserire solo il Pudore. Perciò, non avendo modo di farlo entrare, gli ordinò di passare attraverso il sedere. Quello all’inizio, sdegnato, si rifiutò. Poiché Zeus era molto insistente, disse: «Io entro, ma solo a questa condizione: che non entri mai Eros; se vi entrerà, io davvero subito ne uscirò». Di qui derivò che tutti i depravati sono senza pudore. La favola dimostra che coloro che si lasciano dominare dall’amore perdono il pudore.
Pulce In diverse culture, la pulce è simbolo di quanto è insignificante, spesso anche nocivo e fastidioso. Così già nella Bibbia, ad esempio nel primo libro di Samuele (24,14), si trova il riferimento all’insignificanza, mentre su un papiro egizio, nell’ambito di «un inno dedicato al dio Ammone, si riportava che gli insetti – come le pulci – sebbene nocivi sono creature protette da Dio» (cfr. Roncalli Amici 15 ss.). Nel mondo greco-romano la pulce emerge per entrambe le caratteristiche, che si prestano perfettamente alla commedia: se in Aristofane Socrate e i suoi allievi sono impegnati in operazioni senza importanza come misurare il salto di una pulce (Nuvole 143 ss.), in Plauto questo insetto è considerato negativamente come simbolo di un essere molesto (Curculio 499 ss.). Proprio la tendenza a comportarsi in modo fastidioso caratterizza l’insetto nella favolistica, dove esso viene spesso messo in contrapposizione con esseri di enormi dimensioni: si tratti di animali, come il bue di Esopo 358 Ch. o il cammello di Romulus 92 (molto simile alla favola del toro che ritiene del tutto indifferente la presenza della zanzara: v. TORO), o di uomini. In particolare, in due favole strutturalmente piuttosto simili si trova la pulce impegnata a infastidire l’uomo (Esopo 356 e 357 Ch.): se nella prima narrazione, l’attenzione è concentrata sull’atleta intento a reclamare l’intervento di Eracle, nell’altra si trova il tipico schema dell’animale che, una volta catturato, supplica di essere lasciato libero (come nel più antico esempio di favola greca, quella dello sparviero e dell’usignolo: Esiodo, Le opere e i giorni 202 ss.). La pulce finisce così per diventare il simbolo dei malvagi o di chi è insignificante, secondo una prospettiva che, come si è notato, è abbastanza consolidata nella cultura antica. Nel Pañcatantra (primo tantra, settimo racconto) si trova una narrazione che presenta alcune
affinità con le favole greche. Una pulce, sospinta dal vento, finisce sopra il letto di un re, dove vive un pidocchio, che la invita a mordere il sovrano dopo che egli è caduto nel sonno profondo. La pulce tuttavia non se ne cura e va all’assalto dell’uomo prima del tempo: arrivano i custodi del letto e scovano il pidocchio, che viene ucciso, mentre la pulce si nasconde in una fessura. La morale è che non bisogna concedere asilo a coloro di cui si ignora il carattere. La pulce e l’atleta Esopo 356 Ch. Una giorno una pulce, con un balzo, andò a finire sul dito del piede di un atleta ammalato e, saltando, gli diede un morso. L’atleta, irritato, si preparò a schiacciare la pulce con le unghie, ma quella, preso lo slancio e spiccato uno dei suoi soliti salti, si allontanò ed evitò così di morire. Allora l’atleta prese a lamentarsi: «Eracle – disse – se mi offri questo sostegno contro una pulce, come mi aiuterai contro i miei avversari?». La favola insegna dunque che anche noi non dobbiamo invocare subito gli dei nelle situazioni meno importanti e prive di rischi, ma per le necessità più pressanti. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 358 (cfr. Esopo 357 Ch.). La pulce e l’uomo Esopo 357 Ch. Una volta una pulce dava un gran fastidio a un uomo, che, dopo averla catturata, le urlò: «Chi sei tu che sei andata in giro a cibarti per tutto il mio corpo,
pizzicandomi alla cieca e facendomi torto?». Quella, a sua volta, gli rispose, urlando: «Questo è il nostro modo di vivere, non uccidermi; non posso, infatti, procurarti un gran male». L’uomo rise e le parlò in questo modo: «Adesso ti ucciderò con le mie stesse mani; infatti, bisogna assolutamente fare in modo che non si produca alcun genere di male: né grande né piccolo». La favola dimostra che non conviene avere pietà di chi è malvagio, piccolo o grande che sia. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 358.
Q
Quercia La quercia è simbolo di vita, di forza e di valore. Sacra a Zeus, è perciò anche emblema di sovranità: il proverbio, che ha lunga fortuna nell’antichità e nel medioevo, «Quando un albero è abbattuto, tutti vi fanno legna» è spesso riferito al primato della quercia (significa che, come accade per il leone nel mondo animale, quando un potente va in rovina, viene sbeffeggiato da chi prima lo temeva). Secondo il mito Dodona, in Epiro, è il luogo dove si trova l’alta quercia sacra a Zeus, antichissimo oracolo greco, in grado di offrire responsi attraverso il fruscio delle foglie (ma è attestata anche una divinazione attraverso paioli appesi ai rami). Anche Ulisse lo va a consultare (Odissea 14,327 s.; 19,296 s.). Il legame con Zeus si deve non solo alla sua mole robusta e maestosa (la farnia, quercus robur, può superare ampiamente i trenta metri di altezza; altre specie sono ancora più imponenti), ma anche alla credenza secondo cui la pianta attrae i fulmini, altro attributo del padre degli dei (questa associazione tra l’albero e la sfera divina si diffonde presso numerosi popoli del Mediterraneo). Come attesta Plinio, i Romani la usano per creare la cosiddetta corona civica, onorificenza di notevole prestigio attribuita a chi abbia salvato la vita a un cittadino romano, ucciso il nemico e tenuto la posizione in battaglia (Naturalis historia 16,3 ss.; cfr. anche Gellio 5,6). Ma la quercia, che, secondo una certa tradizione, ha prodotto il primo alimento degli uomini, la ghianda, non è sacra soltanto a Zeus: è usata per inghirlandare anche Eracle, Ecate, Cibele e Sileno. Se nella Bibbia collega cielo e terra, nella tradizione cristiana è subito considerata con ostilità, come avviene per molti altri alberi venerati dai pagani, fino a che, una volta superato il conflitto col paganesimo, va a simboleggiare l’immortalità. La tradizione favolistica recepisce molte delle caratteristiche della quercia, a partire dal suo stretto legame
con Zeus. Nella narrazione 99 Ch. di Esopo, infatti, emerge immediatamente il legame con il padre degli dei. Ma, come spesso avviene nella favola, non c’è nulla di solenne nella loro vicenda, che, giocando sul paradosso, spiega come proprio l’utilità dell’albero e il suo legno siano causa della disgrazia. Questa narrazione mette insieme due temi narrativi tipici della favola: quello della sventura dovuta a se stessi e quello della delegazione che si rivolge alla divinità. In particolare, riguardo al primo tema, va ricordata anche una narrazione in cui si trovano alternativamente la quercia e il pino (Esopo 100 Ch.; v. PINO): le piante vengono tagliate, producendo esse stesse il materiale per la loro esecuzione. Il motivo ha una certa fortuna e si ritrova anche nella tradizione tardo-antica e medievale: nel Romulus (64), un uomo chiede un manico di legno agli alberi, che ingenuamente gliela concedono. Tuttavia, con quel legno produce un’ascia che si abbatte contro di loro; allora la quercia sottolinea che si tratta di una meritata punizione. Un altro motivo di eccellenza, ossia la mole robusta, diventa paradossalmente causa di sventura per la quercia, nella narrazione che la vede contrapposta alla canna: chi non si piega, si spezza; chi si piega, si salva (v. CANNA: si trova anche l’olivo al posto della quercia). La morale è evidentemente costruita sul punto di vista dei ceti subalterni. Anche nella tradizione romana si ribadisce chiaramente il legame della quercia con Giove (Fedro 3,17): in questo caso, la pianta viene opposta, insieme ad altre, all’olivo, sacro ad Atena. Qui è messo in risalto il tema della fecondità, che secondo il padre degli dei potrebbe oscurare la gloria. Le querce e Zeus Esopo 99 Ch. Le querce rimproveravano Zeus, sostenendo che erano state create vanamente. «Più di tutte le altre
piante, infatti, siamo sottoposte alla violenza dell’ascia». E Zeus rispose: «Voi stesse siete causa delle vostre sventure! Se voi non produceste i manici e non foste utili al lavoro edile e agricolo, l’ascia certo non vi taglierebbe». Alcuni che sono causa dei loro mali attribuiscono stoltamente la responsabilità alla divinità. RIFERIMENTI: Babrio 142; Parafrasi 99. Gli alberi sotto la protezione degli dei Fedro 3,17 Un tempo gli dei scelsero gli alberi che intendevano porre sotto la loro protezione. A Giove piacque la quercia e a Venere il mirto, a Febo l’alloro, il pino a Cibele, l’alto pioppo a Ercole. Minerva, meravigliata, chiese perché si associassero quelle piante infeconde. Giove le illustrò la ragione: «Perché non sembri che scambiamo l’onore con il frutto». «Per Ercole, si dica quel che si vuole, ma l’olivo ci è più caro proprio per il frutto.» Allora il padre degli dei e seminatore degli uomini così parlò: «O figlia, giustamente sei detta sapiente da tutti. Se ciò che facciamo è inutile, la gloria è senza senso». La favoletta invita a non fare nulla che non sia utile. La scure e gli alberi Romulus 64 Dare aiuto al nemico significa andare in rovina, come dimostra la seguente narrazione. Dopo aver costruito una scure, un uomo chiese
agli alberi di dargli un manico di legno solido. Gli altri alberi invitarono l’oleastro a soddisfare la richiesta: l’uomo così prese il manico. Adattata la scure, l’uomo senza indugi cominciò a tagliare rami, tronchi e tutto quello che volesse. Pertanto la quercia disse al frassino: «Scontiamo la giusta e degna punizione, dal momento che abbiamo fornito, come ciechi, il manico al nemico che ce ne ha fatto richiesta». Pertanto si mediti bene: non si facciano regali al nemico.
R
Ragno Gli antichi guardano con meraviglia all’abilità dei ragni nel realizzare la ragnatela e alla prontezza nell’accorrere quando cade in trappola una vittima (cfr. Plinio, Naturalis historia 11,79). Noto è il mito di Aracne, una giovane della Lidia abile a tessere e a ricamare, che sfidò Atena in una gara; la dea, però, distrusse lo splendido lavoro della ragazza, che, disperata, voleva impiccarsi, ma venne trasformata in un ragno (cfr. la descrizione che Ovidio ne fa nel sesto libro delle Metamorfosi: vv. 139 ss.). Il ragno non è universalmente emblema di perfidia, come oggi, anzi in varie culture antiche rappresenta la Grande Madre ed è simbolo della potenza creatrice (nell’antico Egitto, ad esempio, è simbolo di Neith, tessitrice del mondo). In generale, si ha una percezione positiva dei ragni, di cui, a partire da Aristotele (Historia animalium 622b-623a), si elogia l’intelligenza. Questa opinione, così diffusa, trova puntuale conferma nelle sentenze attribuite a Esopo (12 Perry), in cui si sottolinea la straordinaria saggezza del ragno, confermata peraltro dalla stessa aggettivazione presente nella favola che lo vede contrapposto alla lucertola (Suda κ 2245 Adler). Si tratta di una narrazione basata sull’osservazione della natura; il finale è andato perso (v. LUCERTOLA). Il ragno, personaggio marginale nella società esopica, compare anche in un’altra favola: quella della zanzara e del leone (Esopo 188 Ch.). Qui punisce l’insolenza della zanzara, che provoca il leone, ma poi finisce in trappola nella ragnatela: lei, che non teme il più potente tra gli animali, finisce paradossalmente per essere vittima di un giustiziere «di nessun valore». La favola, di cui si è rilevata l’anomalia strutturale e stilistica, è simile ad altre che presentano il tema della superbia punita (ad esempio, Esopo 20 Ch., in cui però è la potente aquila a punire il gallo, che gioisce senza
misura).
Ramno La pianta è tipica delle regioni temperate e presenta circa centocinquanta specie differenti: si tratta di piccoli arbusti o alberelli spinosi. Il ramno, cheha dato il nome alla località di Ramnunte in Attica, famosa per il santuario di Nemesis, è utilizzato normalmente nei rituali magici (cfr. Migotto 137). Eliano (De natura animalium 1,35) segnala che viene impiegato come amuleto dal nibbio contro il malocchio di fattucchiere e stregoni. Nella favolistica non troviamo riferimenti a rituali magici connessi con la pianta: qui il ramno diventa semplicemente un albero di poco valore, simbolo dell’uomo inetto e arrogante. Infatti, è protagonista di una narrazione che trova origine nella Bibbia (Giudici 9,8-15) e descrive gli alberi alla ricerca di un sovrano (cfr. OLIVO): la versione greca della favola sostituisce l’indegno rovo appunto con il ramno (cfr. ROVO), che sembra dunque assumerne le caratteristiche tutt’altro che positive, soprattutto in confronto alle più nobili piante che invece rifiutano la carica (Esopo 252 Ch.).
Rana (rospo) Sacra nell’antico Egitto, la rana è poco presente nel mito greco-romano. Nota, tra gli altri, è la vicenda di Lato (Latona): trasformò in rane i pastori che per dispetto cercarono di impedirle di dissetarsi presso una sorgente della Licia (Ovidio, Metamorfosi 6,313 ss.). Questo animale è impiegato come emblema di Afrodite (Venere a Roma) e, a livello simbolico, va a rappresentare la sensualità e la licenziosità (cfr. Cooper 281). In generale, le rane non sembrano riscuotere una grande considerazione e non sono apprezzate nemmeno sul piano gastronomico (cfr. Sinesio, Lettere 148). L’interesse degli antichi sembra piuttosto concentrato sul gracidare, come emerge anche dalla commedia a loro dedicata da Aristofane (cfr. vv. 209 ss.). Alle rane è attribuita la capacità di cogliere l’arrivo della pioggia (Eliano, De natura animalium 9,13), come del resto si rileva anche in un inno indiano del Rig-Veda. Secondo Artemidoro, le rane preannunciano impostori (Sull’interpretazione dei sogni 2,15). La favola esopica 244 Ch. riprende temi presenti nella Batracomiomachia (ossia la battaglia tra le rane e i topi, una sorta di parodia dell’epica: v. TOPO) fino alle Rane di Aristofane, commedia con cui ha in comune la riproduzione onomatopeica del verso della rana («brekekekèx»). D’altra parte, le rane, concepite per lo più in una dimensione collettiva, come folla indistinta, nella tradizione favolistica rappresentano i poveri e i subalterni. Questa tendenza è particolarmente significativa nel primo libro di Fedro, dove è molto forte la tensione socioeconomica, su cui si costruiscono, sulla base dello schema del contrasto, le favole della rana e del bue (1,24) e quella delle rane e dei tori (1,30): qui gli umili non hanno alcun
ruolo attivo, si limitano a essere vittime dei conflitti degli altri. In questa narrazione, che non trova un riferimento nelle collezioni esopiche, sembra emergere una certa «psicosi per il ritorno alla guerra civile», che si coglie nell’epoca di Tiberio (Mandruzzato 23). Il valore simbolico della rana come subalterno è confermata anche da altre fonti, in cui il termine «rana» è usato per indicare il diseredato (cfr., ad esempio, Petronio 77). Le lepri addirittura si consolano vedendo le rane che si trovano in una condizione peggiore della loro (Esopo 191 Ch.). Così, di fronte all’asino che cade nel pantano e si lamenta della spiacevole situazione in cui si è venuto a trovare, le rane fanno presente che quella è la loro condizione abituale (Esopo 271 Ch.). Ma le rane non si segnalano nemmeno per l’ingegno: alle loro richieste, Zeus dapprima concede come sovrano un pezzo di legno e quindi, di fronte alle loro insistenze, un serpente d’acqua che le divora (Esopo 66 Ch.). Questa narrazione, che presenta alcune varianti significative nelle diverse versioni (in Fedro 1,2 è Esopo il narratore interno, ad Atene, al tempo di Pisistrato), sembra di provenienza cinica e riprende diversi temi orientali o riferibili ad autori come Stesicoro e Solone (cfr. Adrados 1984, 25 ss.). Da sottolineare, nella tradizione indiana del Pañcatantra, la favola del vecchio serpente che si offre come cavalcatura delle rane e poi le divora (terzo tantra, decimo racconto). Talora le rane, a causa del loro verso, rappresentano chi parla senza concludere nulla (Esopo 117 Ch.). La scarsa considerazione nei confronti di questo animale emerge anche nel fatto che viene calato nei panni del medico, figura generalmente screditata nella tradizione esopica (Esopo 69 Ch.). Per le rane allontanarsi dallo stagno è pericoloso (Esopo 68 Ch.), e può causare addirittura la morte (67 Ch.). Marginale è la figura del rospo nella favolistica: si ritrova eccezionalmente in sostituzione della rana e ne assume le caratteristiche in Babrio 28, che rielabora il motivo del bue e della rana, con alcune limitate varianti.
Le rane che chiedevano un re Esopo 66 Ch. Le rane, che soffrivano per l’anarchia in cui si trovavano, inviarono ambasciatori da Zeus e lo pregarono di concedere loro un sovrano. Il dio, conoscendo la loro semplicità, gettò nello stagno un pezzo di legno. Dapprima le rane furono spaventate dal rumore e si immersero nelle profondità dello stagno. Successivamente, tuttavia, poiché il legno non si muoveva, tornarono in superficie e lo disprezzarono a tal punto che salivano su di esso e ci si accomodavano sopra. Contrariate di avere un simile re, andarono per la seconda volta da Zeus e lo pregarono di concedere loro in sostituzione un altro sovrano, poiché il primo era troppo pigro. E Zeus, spazientito, inviò loro un serpente d’acqua, da cui furono catturate e mangiate. La favola dimostra che è meglio avere sovrani pigri ma non malvagi che dinamici ma cattivi. RIFERIMENTI: Fedro 1,2; Romanzo di Esopo 125; Romulus 27; Parafrasi 66; Dodecasillabi 66; Dione Crisostomo 8,36 (allusione). Cfr. anche Servio, Commento a Virgilio, Georgiche 1,378. Le rane che vivevano vicine Esopo 67 Ch. Due rane vivevano vicine l’una all’altra. Abitavano l’una in uno stagno profondo e distante dalla strada, l’altra in una ristretta pozza sulla strada. Allora quella che viveva nello stagno invitava l’altra a trasferirsi da lei, perché potesse condividere una vita
più agiata e più sicura. Quella non si lasciava persuadere, sostenendo che era complicato per lei allontanarsi dai suoi luoghi abituali. Finché accadde che un carro che passava da quelle parti la investì. Così, anche tra gli uomini, quelli che continuano a comportarsi stoltamente vanno in rovina prima di volgersi a migliori abitudini. Le rane nello stagno Esopo 68 Ch. Due rane abitavano in uno stagno. Ma dopo che il calore estivo lo essiccò, lo abbandonarono per andare alla ricerca di un altro stagno. Capitarono allora presso un pozzo profondo; quando lo videro, una rana disse all’altra: «Caliamoci insieme, cara, in questo pozzo». L’altra replicò con queste parole: «Se però anche l’acqua che si trova qui venisse meno, come potremmo risalire?». La favola dimostra che non bisogna procedere nelle situazioni senza la dovuta riflessione. RIFERIMENTI: Tetrastici 2,20. La rana medico e la volpe Esopo 69 Ch. Una volta c’era in uno stagno una rana che si mise a gridare a tutti gli animali: «Io sono un medico e ho conoscenza dei farmaci». Una volpe la sentì e le chiese: «Come guarirai gli altri tu che sei zoppa e non riesci nemmeno a curare te stessa?». Chi non è istruito, come potrà insegnare agli altri? Questo
dimostra la favola. RIFERIMENTI: Babrio 120; Aftonio 24; Aviano 6; Parafrasi 69; Dodecasillabi 69; Tetrastici 2,29 a-b; cfr. anche Temistio, Sulla virtù p. 43 Mach. Adrados 2003, 353 ipotizza la resa favolistica di un passo soloniano. Le rane che temevano le contese dei tori Fedro 1,30 Gli umili patiscono quando i potenti si scontrano. Una rana che si trovava in una palude vide un combattimento di tori ed esclamò: «Ahimè! Che disgrazia ci sovrasta!». Poiché un’altra le chiese perché parlasse in questo modo, in considerazione del fatto che i tori si sfidavano per la supremazia sulla mandria e vivevano molto lontano da loro, replicò: «Stanno in luoghi separati e sono di diversa razza; tuttavia, chi sarà espulso dal regno del bosco verrà nei recessi appartati della palude e, calpestandoci, ci schiaccerà con il suo duro piede. Pertanto il loro furore riguarda la nostra testa». Il leone e la rana Esopo 201 Ch. Un leone, che aveva sentito una rana gracidare, si volse in direzione di quel rumore, pensando che ci fosse un grosso animale. Aspettò un po’. Come vide che la rana usciva dallo stagno, avvicinandosi a essa la schiacciò e le disse: «Ma guarda un po’! Sei così piccola e gridi così forte?». La favola è adatta per chi
è loquace e non sa fare altro che parlare. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 202. L’asino e le rane Esopo 271 Ch. Un asino, portando un carico di legna, passava attraverso un pantano; come scivolò e cadde, non riuscendo ad alzarsi, si mise a lagnarsi. Le rane che vivevano nel pantano lo udirono gemere e dissero: «Caro, che cosa avresti fatto tu, se avessi trascorso tanto tempo qui come noi, quando, caduto per un attimo, così ti lamenti?». Uno che da parte sua sopporta facilmente maggiori sofferenze potrebbe riferire questa favola a coloro che, indolenti, si lamentano per patimenti lievi. Il cagnolino e le rane Esopo 307 H.-H. Un cagnolino, al seguito di un viandante, sfinito dal continuo cammino e dal caldo estivo, si sdraiò presso uno stagno, in un fresco prato, e si addormentò. Ed ecco che, una volta colto dal sonno, le rane che stavano lì vicino, secondo la loro abitudine, presero a gracidare tutte insieme. Allora il cucciolo, svegliatosi, andò su tutte le furie e pensò che se si fosse avvicinato allo stagno e avesse abbaiato contro le rane, le avrebbe fatte smettere di gridare e avrebbe potuto dormire liberamente lì vicino. Poiché, nonostante avesse così agito con una certa insistenza, non ne cavò fuori nulla, se ne andò
via irritato, dicendo: «Sarei davvero più stupido di voi, se cercassi di correggere voi, che siete chiacchierone e moleste per natura, per rendervi educate e gentili». La favola insegna che, allo stesso modo, pure gli uomini insolenti, anche se vengono esortati infinite volte, non tengono certo in nessuna considerazione il prossimo. Le lepri e le rane Esopo 191 Ch. Una volta le lepri si radunarono e presero a compiangere vicendevolmente la loro vita, dal momento che è incerta e abbonda di paure. Infatti, sono braccate dagli uomini, dai cani, dalle aquile e da molti altri animali. Pertanto, ritenevano che fosse meglio morire una buona volta, piuttosto che vivere sempre terrorizzate. Avendo così deciso, si precipitarono insieme verso lo stagno, per gettarsi in esso e porre termine alla loro esistenza. Le rane che si trovavano intorno allo stagno, come percepirono il rumore della corsa, subito si immersero in acqua; così una delle lepri, che sembrava più accorta delle altre, esclamò: «Arrestatevi, compagne, non fate nulla di male contro voi stesse, poiché, come vedete, esistono altri animali che sono più paurosi di noi». La favola dimostra che gli infelici trovano consolazione nell’osservare coloro che si trovano in condizioni peggiori di loro. RIFERIMENTI: Babrio 25; Aftonio 23; Parafrasi 192; Dodecasillabi 192; Tetrastici 1,44; Romulus 35; Nicolao, Esercizi preparatori 1,10. PROVERBI
Inflat se tamquam ranam Si gonfia come una rana Il detto, proverbiale, si trova in Petronio (74) e rimanda naturalmente alla favola della rana e del bue, sulla linea di numerose altre espressioni affini, come In propria non pelle quiessem, ossia «Non me ne starei nella mia pelle» (Orazio, Satire 1,6,22, commentato anche da Porfirione), riferibile forse (cfr. Otto 272) anche alla favola dell’asino che si riveste della pelle del leone (Esopo 267; 279 Ch.). Il riferimento è all’aspirare a cariche superiori alla propria condizione (cfr. Tosi 1991, 256 per altri paralleli).
Religione Accanto agli dei tradizionali, i Romani venerano anche alcune entità astratte, come Salus (la dea della salute), Libertas (la dea della libertà) o Spes (la dea della speranza). In questa specifica sfera cultuale rientra anche la Religio (la Religione). Tale genere di culto affonda le sue origini nei primi tempi della civiltà romana (cfr. Corvino 262). In tre favole (1,27; App. 6 [8],4, ma soprattutto in 4,11), Fedro presenta la Religione come una sorta di personificazione del sentimento del sacro: spesso è accompagnata dall’aggettivo «santa», come accade anche per altre entità, quali la Verità (App. 4 [5],18). In generale, al contrario di quanto si riscontra per gli altri favolisti antichi, questo e altri elementi sembrano segnalare una certa religiosità di Fedro, che, peraltro, come fa anche Esopo, non prende i miti davvero sul serio (cfr. Nøjgaard 1967, 171). In una narrazione eziologica (4,11), il ladro sacrilego viene ammonito dalla Religione. La forte tensione etica di questa narrazione viene esplicitata dalla presenza di ben tre morali (è ripresa qui l’idea, proverbiale, che la punizione dei malvagi non arriva subito, ma al tempo stabilito dal fato: v. ZEUS). Il ladro e la lucerna Fedro 4,11 Un ladro sottrasse dall’altare di Giove la fiamma per la sua lucerna e saccheggiò il tempio fruendo della sua luce. Mentre egli si allontanava sotto il peso del sacrilegio, la santa Religione, all’improvviso, pronunciò queste parole: «Sebbene questi doni fossero di persone scellerate, a me invise, tanto che non sono offesa per il fatto che mi
vengono sottratti, tuttavia tu, malvagio, pagherai la colpa con la vita, quando giungerà il giorno stabilito per la pena. Ma perché il nostro fuoco, attraverso cui la pietà onora i venerabili dei, non faccia luce a quest’atto iniquo, dispongo che non si faccia uso comune della stessa luce». Pertanto oggi non è lecito accendere né la lucerna dalla fiamma degli dei, né il fuoco sacro dalla lucerna. Quanti utili insegnamenti contenga questa storia, non potrà spiegarlo nessun altro, se non chi l’ha inventata. Significa, in primo luogo, che spesso scopri a te assai ostili coloro che tu hai allevato. In secondo luogo mostra che le scelleratezze non sono punite dall’ira degli dei, ma nel momento stabilito dal fato; infine, proibisce che l’uomo retto metta in comune con il malvagio l’uso di qualsiasi cosa.
Riccio Il riccio è descritto da Plinio (Naturalis historia 8,133) come un animale astuto, perché accumula riserve per l’inverno, infilando sulle proprie spine i frutti che non riesce a portare alla bocca. Il suo atteggiamento è semplice ma efficace, perché per difendersi è solito serrarsi in se stesso con tutti gli aculei puntati. Eliano (De natura animalium 6,24) pone in evidenza il rapporto con la subdola volpe, che, ingannandoli, cattura i ricci. Proprio alla differenza tra il riccio e la volpe si riferisce un proverbio («La volpe sa molte cose, il riccio una sola, grande»: Pseudo-Omero, Margite fr. 5 W. ; Archiloco, fr. 201 W. ), che forse presuppone una favola, come sembra suggerire un motivo esopico della tradizione medievale (v. sotto, Proverbi). Questo differente atteggiamento nei confronti della vita emerge anche nell’unica favola antica superstite dedicata al riccio, che, anche in questo caso, compare insieme alla volpe. Nella sua semplicità, il riccio vuole togliere le zecche alla volpe per alleviare le sue sofferenze, ma lei, più astuta, prevede le conseguenze: tolte le prime, verranno altre zecche che prosciugheranno tutto il suo sangue. Si riscontrano il meccanismo del rovesciamento e l’ambiguità del valore, elementi tipici della narrativa esopica: il male apparente si rivela un bene relativo davanti alla disgrazia che viene ipotizzata. La favola, che ha come narratore interno Esopo, è riportata da Aristotele (Retorica 1393b1394a): la sua applicazione riporta al tema politico della rassegnazione di fronte al potere, trattato anche in Esopo 66 Ch. (le rane che chiedono un sovrano). 2
2
La volpe e il riccio Aristotele, Retorica 1393b-1394a
Esopo, difendendo un demagogo di Samo che in un processo rischiava la condanna a morte, disse: «Una volpe stava attraversando un fiume, ma venne trascinata dalla corrente in un precipizio. Incapace di uscirne, se ne stette a lungo in una condizione assai fastidiosa, assalita da molte zecche. Allora un riccio, che vagava da quelle parti, come la vide, ne ebbe pietà e le chiese se dovesse rimuovere le zecche, ma lei rifiutò. Quando il riccio gliene chiese il motivo, la volpe rispose: “Queste zecche sono già sazie e mi hanno succhiato poco sangue; ma se le allontanate, ne verranno altre, affamate, che prosciugheranno tutto il sangue rimasto!”. Anche per voi, quindi, cittadini di Samo, vale tale discorso: quest’uomo non vi farà alcun danno (infatti, è già ricco), ma se lo giustiziate, ne verranno altri senza quattrini, che, derubandovi del resto, vi manderanno in rovina». RIFERIMENTI: oltre a scoliasti e commentatori di Aristotele (cfr. Van Dijk 1997, 540 ss.), cfr. Plutarco, Se un vecchio debba occuparsi di politica 790 c-d. PROVERBI Πόλλ’oἷδ’ἀλώπηξ, ἀλλ’ἐχῖνoς ἓν μέγα La volpe sa molte cose, il riccio invece una sola, grande Il proverbio ha larga fortuna e compare innanzitutto nel Margite pseudo-omerico fr. 5 W. . e in Archiloco fr. 201 W. : il sapere della volpe è spregiudicato e ricco di risorse, mentre quello del riccio caparbio, sistematico e difensivo. Non è ricostruibile la favola che potrebbe esserne alla base, né è chiaro il contesto, ma si tratta forse di una critica alle molteplici abilità, quando nella vita è sufficiente conoscere una sola cosa, ma decisiva (cfr. Adrados 2003, 390). Il tema non viene sviluppato nelle collezioni esopiche, ma si ritrova nella favolistica medievale (605 Perry), dove un gatto, che 2
2
conosce una sola tecnica per mettersi in salvo dai cacciatori (salire su un albero), riesce nell’intento, mentre la volpe, pur dotata di numerose astuzie, va incontro a una ingloriosa fine. Molte le riprese successive, che si rifanno al Margite e ad Archiloco (cfr., tra le altre, riportate da Van Dijk 1997, 126 n. 18, Plutarco, L’intelligenza degli animali 971ef; Zenobio 5, 68; Diogeniano 7,83; Macario 7,22). Partendo dal frammento archilocheo, Isaiah Berlin nel 1953 scrisse Il riccio e la volpe, opera in cui segnala due differenti approcci mentali: quello riferibile al riccio tende a centralizzare, riportando tutto a una chiave di interpretazione universale, mentre quello della volpe tende alla molteplicità delle esperienze e all’osservazione delle differenze.
Rondine La rondine, la cui origine è spiegata dal mito di Procne e Filomela (v. USIGNOLO), è da sempre ritenuta amica degli uomini (Eliano, De natura animalium 1,52), che la considerano con benevolenza. Annuncia la primavera e in vari centri dell’antica Grecia viene accolta con simpatiche canzoni cantate dai giovani (cfr. Ateneo 8,360c). L’uccello è sacro ad Afrodite, ma sembra legato anche ad altre divinità, come Atena, che appare a Odisseo proprio sotto forma di rondine (Odissea 21,411). La sua voce è considerata in modi differenti: ad esempio, Artemidoro (Sull’interpretazione deisogni 4,56) pone l’uccello tra quelli dotati di un bel canto, mentre altri autori considerano il suo verso in modo negativo (cfr. Eschilo, Agamennone 1050). Virgilio (Georgiche 4,307) la considera «garrula», ossia chiacchierona, secondo una prospettiva che peraltro avrà fortuna anche nelle epoche successive. La cultura cristiana dà generalmente una valutazione positiva della rondine, che arriva a essere simbolo di speranza e di ascetismo, oltre che emblema dello stesso Cristo. Nella favolistica l’uccello è spesso presente. La consolidata amicizia con l’uomo si esprime innanzitutto nel fatto che la rondine fa il suo nido sui tetti e non teme le persone: il volatile, lodato per la sua intelligenza, si presenta come supplice all’uomo, che, da quel momento, gli concede spazio presso la sua abitazione (Esopo 349 Ch.). Il legame tra case e rondini ha peraltro larga fortuna, al di là della tradizione esopica: a tale proposito, Eliano (10,34) ricorda che la rondine è sacra agli dei protettori della casa, sottolineando inoltre le capacità profetiche dell’uccello, che ricorrono anche in questa favola ma in una chiave del tutto desacralizzata: è la saggezza che consente di prevedere il futuro. Non a caso, nella favola 286 Ch. la rondine, per la sua intelligenza, si ritrova agli antipodi della gallina, simbolo
di stoltezza, che cova le uova di serpente (qui prevale, tuttavia, il tema dell’indole malvagia, che non muta nonostante i benefici ricevuti: cfr. Esopo 82 Ch.). Alcune narrazioni esopiche (9 e 350 Ch.) si ricollegano al mito di Procne e Filomela, presentando, tra l’altro, la rondine come uccello vanaglorioso e chiacchierone, secondo la tradizione che sembra fatta propria, tra gli altri, da Virgilio. Tra le qualità della rondine c’è anche la bellezza: sempre legata alla primavera, non può che essere una qualità effimera nel concreto mondo esopico, dove in un’ottica di dura lotta per la sopravvivenza è più apprezzata la resistenza della cornacchia (Esopo 348 Ch.). Un’altra favola (Esopo 248 Ch.) si ricollega al proverbio, diffuso ancora oggi, secondo cui «Una rondine non fa primavera»: la morale richiama alla necessità di agire nei tempi opportuni. La rondine vanagloriosa e la cornacchia Esopo 350 Ch. Disse la rondine alla cornacchia: «Io sono una fanciulla ateniese: sono una principessa, figlia del re di Atene» e raccontò di Tereo, della violenza subita e del taglio della lingua. Le chiese allora la cornacchia: «Che cosa faresti dunque, se tu avessi la lingua, dal momento che, nonostante ti sia stata tagliata, chiacchieri tanto?». A forza di mentire, chi è vanaglorioso è causa di vergogna per se stesso. RIFERIMENTI: Sintipa 3; Parafrasi 351. La rondine e gli uccelli Esopo 349 Ch. Nel momento in cui spuntò il vischio, la rondine
comprese il pericolo che incombeva sui volatili; così, avendo radunato tutti gli uccelli, consigliò loro innanzitutto di tirarlo via dalle querce su cui si trovava. Nel caso in cui non riuscissero a fare ciò, li invitò a rifugiarsi dagli uomini e a pregarli che non sfruttassero le qualità del vischio per catturarli. Gli uccelli però la deridevano, come se parlasse invano; allora la rondine si presentò come supplice dagli uomini, che la accolsero in considerazione della sua intelligenza e le diedero ospitalità nelle loro abitazioni. Così gli altri uccelli sono cacciati dagli uomini, mentre soltanto la rondine, che ha chiesto loro protezione, fa il nido senza alcun timore persino nelle loro case. La favola dimostra che quelli che prevedono il futuro sfuggono naturalmente ai pericoli. RIFERIMENTI: la favola presenta numerose varianti (v. Esopo 39ab nell’edizione HausrathHunger; cfr. i passi segnalati da Adrados 2003, 54 s.). La gallina e la rondine Esopo 286 Ch. Una gallina, che aveva trovato delle uova di serpente, le covava con grande attenzione e, dopo averle covate, le fece dischiudere. Una rondine la vide e le disse: «Sei folle! Per quale motivo allevi costoro che, una volta cresciuti, cominceranno a commettere su di te innanzittutto le loro turpi azioni?». Così la malvagità non si lascia addomesticare per quanto sia abbondantemente beneficata.
RIFERIMENTI: Sintipa 57. La rondine e la cornacchia che litigavano a proposito della loro bellezza Esopo 348 Ch. Una rondine e una cornacchia discutevano animatamente riguardo alla loro bellezza. Replicando alle ragioni della rondine, la cornacchia disse: «La tua bellezza fiorisce durante la primavera, mentre il mio corpo resiste anche d’inverno». La favola dimostra che la durata della vita è preferibile alla bellezza. RIFERIMENTI: Sintipa 3; Parafrasi 351. Il giovane scialacquatore e la rondine Esopo 248 Ch. A un giovane scialacquatore, che aveva divorato il suo patrimonio, rimase soltanto il mantello. Come vide una rondine che era arrivata fuori stagione, credendo che fosse già estate, ritenne di non avere più bisogno del mantello e andò a vendere anche questo. Ma poi, sopraggiunto il cattivo tempo, ci fu molto freddo e il ragazzo, andando in giro, vide la rondine morta per il freddo e le disse: «Disgraziata, hai portato in rovina, insieme, me e te». La favola dimostra che tutto quello che non è compiuto nel momento opportuno è rischioso. RIFERIMENTI: Babrio 131; Dodecasillabi 249; Tetrastici 2,4. Per il proverbio, cfr. sotto. PROVERBI
Mία χελιδὼν ἔαρ oὐ πoιεῖ Una rondine non fa primavera Il proverbio, presente in Zenobio (5,12) e in altri paremiografi (cfr. Gregorio Ciprio 3,11; Apostolio 13,14) e diffuso ancora oggi, sembra trovare origine già in Aristotele (Etica Nicomachea 1098a; cfr. inoltre Aristofane, Uccelli 1417). Come spiega anche Erasmo (Adagia 1,7,94), il concetto può essere generalizzato, per cui, ad esempio, una azione buona non è sufficiente per giudicare in modo conseguente una persona.
Rosa Gli antichi sono colpiti dalla bellezza e dalla vita effimera della rosa. Queste due caratteristiche sono rilevate da diversi poeti: ad esempio, Orazio si riferisce alle rose in relazione al vino e ai profumi, descrivendole come bei fiori dalla vita breve (Odi 2,3,13 s.); il contesto è quello del convito, dove si suole cospargere di ghirlande e petali di fiori (tra cui le rose) il triclinio, secondo un uso rituale. In coerenza con la celebrata bellezza di questo fiore, nel mito la rosa è attributo di Afrodite e la tradizione iconografica evidenzia il legame con la dea dell’amore (si pensi alla Nascita di Venere di Botticelli). La rosa, che secondo una certa tradizione diventa anche emblema di segreto e di riserbo, assume una funzione simbolica importante in diversi ambiti religiosi. Come emerge nelle Metamorfosi di Apuleio, infatti, è impiegata nell’iniziazione al culto di Iside. Nella tradizione cristiana, invece, ha una funzione rilevante in riferimento alla simbologia di Maria e di Cristo. Del resto, nella mitologia e nel folclore di diversi Paesi, è associata alla morte e alla resurrezione (Mercatante 542). La favolistica, perfettamente in linea con l’immagine elaborata dalla cultura antica, sottolinea, nell’unica narrazione in cui compare questo fiore, il contrasto tra la bellezza e la brevità della vita (Esopo 323 Ch.): è più felice l’amaranto, che gode di eterna giovinezza. Si tratta di un motivo ricorrente nella tradizione esopica, che, nella sua semplice prospettiva sapienziale, tende a evidenziare l’inutilità dell’aspetto esteriore fine a se stesso. Nella morale, tipicamente utilitaristica, la bellezza non può che diventare simbolo del lusso inutile. Forse questa narrazione è di derivazione cinica. La rosa e l’amaranto Esopo 323 Ch.
Un amaranto, cresciuto a fianco di una rosa, le disse: «Che bellissimo fiore sei, desiderato sia dagli dei sia dagli uomini! Beato te, per la tua bellezza e per il tuo profumo». La rosa gli rispose: «O amaranto, io vivo per breve tempo e anche se nessuno mi recide, appassisco. Tu invece fiorisci e vivi rimanendo sempre così giovane». È preferibile vivere a lungo accontentandosi di poco che vivere deliziosamente per breve tempo, ottenendo in sorte rovesci di fortuna o addirittura la morte. RIFERIMENTI: Parafrasi 324.
Rovo Il rovo, nelle sue numerose articolazioni (gli antichi ne classificano oltre un centinaio di specie), è pianta umile, che non viene valorizzata dal mito; non assume particolari valori simbolici, se non quello della rusticità. Ne vengono, però, apprezzate le more. La pianta e il suo frutto sono anche impiegati dai Romani come medicinali per diversi scopi. Il rovo è, d’altra parte, elemento largamente presente nella cultura ebraica, anche in contesti teologicamente rilevanti: sono noti nella Bibbia gli episodi di Abramo (nel rovo si impiglia l’ariete; si tratta della vicenda del sacrificio di Isacco: Genesi 22,12-13) e di Mosè (il roveto arde ma non si consuma: Esodo 3,1-2). Appare, a questo proposito, significativo che la più antica narrazione dai connotati favolistici compaia proprio nella Bibbia (Giudici 9,8-15): si tratta degli alberi che cercano un sovrano e alla fine si rivolgono all’arrogante rovo, che li invita a ripararsi sotto la sua ombra. La favola viene ripresa, con poche varianti, nelle collezioni esopiche, ma qui il rovo è sostituito dal ramno (v. anche OLIVO; FICO). Questa storia, di impostazione antimonarchica, è relativa all’episodio di Abimelech, che cercò invano di unire, con la forza e i massacri, le tribù di Israele: emerge un certo pessimismo riguardo ai «meccanismi della selezione politica, che spesso vede la conquista del potere da parte di colui che non ha altro da offrire alla società se non la propria arroganza, quando non la violenza, poiché si sa che l’ombra del rovo è quasi inesistente» (Cattabiani 1996, 679). Nella tradizione favolistica greca, il rovo compare spesso, forse per il fatto che, essendo pianta di scarso pregio, s’inserisce perfettamente nella dialettica subalterni-potenti propria del mondo esopico. In particolare, si trova nella funzione di mediatore disprezzato per la sua indegnità nella favola delle piante che discutono sulla ricchezza dei loro frutti: la morale
ne fa il simbolo delle persone da nulla (Esopo 324 Ch.). Lo stesso accade nella contesa, descritta nel quarto giambo di Callimaco, dell’alloro e dell’olivo (fr. 194 Pf.): anche qui il rovo si intromette ma viene rifiutato e offeso (v. ALLORO; OLIVO). La connotazione del rovo appare sempre negativa e abbastanza coerente in tutta la tradizione favolistica. Addirittura, nella favola 31 Ch., di impronta cinica, la volpe, che stranamente in questo caso si segnala per ingenuità e viene ferita dal rovo, subisce una lezione ben spiegata dalla morale: è inutile chiedere aiuto a chi è malvagio per natura. Qui il rimando è al tema, caro alla tradizione favolistica, dell’impossibilità di cambiare la natura degli individui. Le modeste qualità della pianta, simboleggiate da una serie di attributi che vanno dallo scarso valore fino alla malvagità, possono, comunque, diventare paradossalmente una risorsa nel gioco di rovesciamento tipico della società esopica. L’abete, albero nobile, disprezza il rovo, che gli ricorda tuttavia quanto in fondo sia meglio essere rovi, per evitare scuri e seghe degli uomini (Esopo 101). In questo caso, dunque, come esplicita anche l’epimitio, il rovo va a rappresentare gli uomini comuni, senza particolari qualità, e perciò più tranquilli dei potenti. Va inoltre segnalata una favola abbastanza divertente nella quale il rovo si mette in società con il pipistrello e il gabbiano: partono per un viaggio e naufragano (Esopo 250 Ch.). Da allora il rovo si aggrappa alle vesti della gente, per vedere se possa recuperare la stoffa che voleva commerciare e che il naufragio gli fece perdere. Il rovo, sempre disprezzato, compare anche nella tradizione orientale di Ahiqar (v. MELOGRANO). La volpe e il rovo Esopo 31 Ch. Saltando una siepe, una volpe scivolò e stava per cadere: allora cercò di aggrapparsi a un rovo.
Tuttavia, si ferì le zampe, a causa delle spine della pianta, e sofferente le disse: «Ahimè! Ho cercato sostegno in te e tu mi hai maltrattato». «Ma carissima, sei tu che hai commesso un errore – rispose il rovo – nel volerti aggrappare a me, che sono solito aggrapparmi a tutti.» La favola dimostra che così anche tra gli uomini sono sciocchi coloro che, per avere aiuto, si rivolgono a coloro che sono, piuttosto, portati naturalmente a fare il male. RIFERIMENTI: Parafrasi 31; Tetrametri 1,49
S
Sacerdote Nel mondo antico, il sacerdote si colloca in una posizione privilegiata nella gerarchia sociale e ha una funzione di mediazione tra la sfera umana e quella divina. Spesso la carica sacerdotale si intreccia con quella politica: ad esempio, i monarchi dell’epoca omerica hanno attribuzioni religiose. Nell’antica Grecia le funzioni del sacerdote erano di carattere liturgico (consacrava la vittima sacrificale e pronunciava la preghiera) e amministrativo (gestiva i beni del dio); naturalmente, coadiuvato spesso da altre figure di supporto, il sacerdote si occupava anche della manutenzione della statua del dio e del santuario. Gli erano attribuiti onori e vantaggi materiali, spesso consistenti in offerte e rendite legate ai beni immobili appartenenti al tempio. Il contatto con il mondo divino consentiva la profezia: particolarmente nota, nel mondo greco, la Pizia, la sacerdotessa che pronunciava gli oracoli in nome di Apollo nel Santuario di Delfi. Proprio la Pizia è protagonista di una favola di Fedro (App. 6 [8]), che la descrive secondo la tradizionale rappresentazione legata ai responsi; è chiaro lo scetticismo del poeta e alla fine di questi versi emerge che la sacerdotessa «è davvero pazza, come lo sono tutti quelli che predicano la virtù. Fedro si sottrae a questa follia, perché le sue favole non esortano a compiere il bene, ma a sopravvivere in un mondo di malvagi» (Solimano 307, n. ai vv. 16-17). In generale, la figura del sacerdote, a cui possono essere richiesti sacrifici in vista del conseguimento di un preciso obiettivo (cfr. Esopo 113 Ch.), nel mondo esopico appare piuttosto screditata (v. MENAGIRTI), così come le figure contigue di indovini e maghe (v.), in linea con l’ideologia laica e razionalistica che contraddistingue la tradizione favolistica. Ma in età medievale si ritrovano in alcune narrazioni anche figure di sacerdoti non pagani. Nelle
favole siriache, ad esempio, i sacerdoti si segnalano comunque per comportamenti controversi: in un caso, un sacerdote mente a un’anziana e ne sconta le conseguenze; in un altro, tre sacerdoti si odiano e il loro superiore li riprende, conducendoli al pentimento, secondo i precetti evangelici (cfr. Adrados 2003, 537; 563).
Sardella La sardella è un piccolo pesce poco pregiato, cibo dei poveri. Entra anche, come divertente insulto, nelle commedie di Plauto, in particolare nell’espressione deglupta maena, ossia «sardella spellata» (Poenulus 1312). Simbolo, dunque, di qualcosa di scarso valore, si trova in alternativa alla smaride in una favola in cui il pescatore non rinuncia alla sua preda, che, essendo piccola, lo prega di liberarla per catturarla di nuovo quando sarà cresciuta. La narrazione è attestata da una parte della tradizione manoscritta delle favole anonime (v. SMARIDE). Tra l’altro, smaride e sardella sono talvolta accostate nei Deipnosofisti Ateneo riferisce (7,313a) che, secondo il filosofo Speusippo, sono simili alla sardella il boaga e la stessa smaride.
Satiro I satiri sono figure mitologiche dotate di orecchie aguzze, corna ritorte, coda, gambe e piedi caprini; considerati semidei, talora rappresentati con un vistoso fallo in erezione, nel tempo tendono ad attenuare la loro caratterizzazione animalesca. Secondo alcune leggende, sono ritenuti originari dell’Arcadia e del Peloponneso. Lascivi e burloni, insidiano le ninfe, vivono sui monti e nelle foreste cantando, suonando e giocando. Vengono associati al culto di Dioniso: insiemecon le menadi e i sileni, fanno parte del suo corteo. Nella favolistica, i satiri trovano scarso spazio e appaiono caratterizzati in modo piuttosto generico nella loro ingenua semplicità. Nella favola di Esopo 60 Ch., un satiro diventa amico di un uomo, da cui prende le distanze per la sua presunta ambiguità, quando lo vede soffiare sia per scaldare le mani sia per raffreddare le pietanze. La narrazione esopica trae spunto da un’osservazione contenuta nei Problemi pseudoaristotelici (964a), ma anche in un frammento di Anassimene (13B1 D.-K.) e in Plutarco (Il principio del freddo 947f). La semplicità genuina di questi personaggi emerge bene nella versione della favola elaborata da Aviano (29), che descrive la generosa semplicità dei satiri e il loro atteggiamento premuroso, in contrapposizione alla doppiezza dell’uomo civilizzato, da cui pare il caso di guardarsi. Da segnalare anche il riferimento di Plutarco (Come trarre vantaggio dai nemici 86e-f) a un passo di Eschilo (fr. 207 R.): l’ingenuo satiro intenzionato a baciare e ad abbracciare il fuoco viene ammonito da Prometeo, che lo invita a desistere (cfr. tuttavia Van Dijk 1997, 633, che, a differenza di altri studiosi, non ritiene questo riferimento di natura favolistica). L’uomo e il satiro Esopo 60 Ch.
Si racconta che una volta un uomo avesse stretto amicizia con un satiro. Sopraggiunto l’inverno, poiché c’era freddo, l’uomo si portava le mani alla bocca e vi soffiava sopra. Il satiro gli chiese per quale motivo facesse ciò e l’uomo rispose che così scaldava le mani afflitte dal gelo. In seguito, ritrovandosi insieme intorno a una tavola imbandita per loro, poiché il cibo era molto caldo, l’uomo ne prendeva in piccole quantità per volta, lo portava alla bocca e vi soffiava sopra. Il satiro gli chiese di nuovo perché si comportasse in quel modo; l’uomo disse che raffreddava il cibo, dal momento che era troppo caldo. Allora il satiro gli rispose: «Caro mio, dico addio alla tua amicizia, poiché fai uscire dalla stessa bocca sia il caldo sia il freddo». Bisogna quindi che anche noi evitiamo l’amicizia di quelli che si comportano in modo ambiguo. RIFERIMENTI: Aviano 29; Sesto Empirico, Contro i matematici 8,103. Il satiro e il fuoco Plutarco, Come trarre vantaggio dai nemici 86e-f Visto il fuoco per la prima volta, un satiro voleva baciarlo e abbracciarlo, ma Prometeo lo ammonì: «Tu, capro, piangerai la perdita della barba». E infatti esso brucia chi lo tocca, ma fornisce luce e calore ed è strumento di ogni arte per chi ne ha appreso l’uso. RIFERIMENTI: la frase pronunciata da Prometeo è una citazione da Eschilo, fr. 207 R. (v. sopra).
Scarabeo Venerato in Egitto, lo scarabeo gode di una fama meno favorevole nel mondo greco-romano, dove è turpe immagine del vizio (cfr. Maspero 298) e pare di buon auspicio solo per chi svolge mestieri sudici, almeno secondo Artemidoro (Sull’interpretazione dei sogni 2,22); Eliano (De natura animalium 1,38) lo descrive come insetto puzzolente che muore a contatto con i profumi. Plinio (Naturalis historia 11,98) riferisce che gli scarabei pongono, come in un nido, la loro prole in grosse palle di sterco. Proprio la contiguità con lo sterco, di cui si ciba, è il filo conduttore che unisce le diverse favole dedicate nella tradizione esopica allo scarabeo, animale simbolo dei Cinici. Oltre alla favola 149 Ch., in cui sono protagonisti due scarabei che si cibano dello sterco di un toro, e alla 241 Ch., che riprende lo schema della cicala e della formica, spicca una narrazione fondata sull’antica inimicizia con l’aquila (Esopo 4 Ch.), peraltro segnalata pure da un fortunato proverbio (v. AQUILA). In questa narrazione, che spiega perché nella stagione in cui spuntano gli scarabei le aquile non covano, lo scarabeo dimostra che nessuno è tanto piccolo da non potersi vendicare: una morale tipicamente esopica. Nelle favole siriache troviamo uno scarabeo punito perché vuole produrre il miele senza esserne capace (v. anche APE). I due scarabei Esopo 149 Ch. In una piccola isola viveva un toro. Dei suoi escrementi si cibavano due scarabei. Allora, nel principio della stagione invernale, uno disse che desiderava andare sul continente per lasciare
all’altro, una volta rimasto solo, un sufficiente nutrimento, mentre lui, dopo essere andato là, vi avrebbe trascorso l’inverno. Diceva inoltre che, qualora avesse trovato una grande quantità di cibo, ne avrebbe portato anche a lui. Approdato sulla terraferma e trovata una grande quantità di letame, benché molle, decise di fermarsi e di nutrirsi lì. Trascorso l’inverno, volò di nuovo sull’isola. L’altro lo vide florido e in ottime condizioni; allora lo rimproverò perché non gli aveva portato niente, nonostante tutte le promesse. Lo scarabeo rispose: «Non rimproverare me, ma la natura del luogo: là infatti è possibile nutrirsi, ma non è possibile portar via nulla». Questa favola potrebbe essere adeguata per coloro che concedono la loro amicizia soltanto fino a pranzo e non offrono agli amici niente di più. La formica e lo scarabeo Esopo 241 Ch. Durante la stagione estiva, una formica andava in giro per la campagna e raccoglieva chicchi di frumento e di orzo, mettendoli da parte per sé come nutrimento per l’inverno. Uno scarabeo la vide e si meravigliò del fatto che si dava tanto da fare, affannandosi nello stesso periodo in cui gli altri animali, liberati dalle loro fatiche, si riposano. La formica non rispose, ma, successivamente, sopraggiunto l’inverno, lo sterco fu sciolto dalla pioggia. Allora lo scarabeo, assalito dalla fame, andò da lei, pregandola di darle un po’ di nutrimento. La formica gli rispose: «Scarabeo, se tu ti fossi dato da fare allora, quando io mi affaticavo e tu mi schernivi, non ti troveresti ora senza cibo». Così coloro che quando c’è abbondanza non si preoccupano del
futuro scivolano in una grande miseria, nel momento in cui cambiano le circostanze. RIFERIMENTI: vicenda e struttura narrativa molto simili alla favola della cicala e della formica (v. CICALA).
Schiavo Il mondo antico conosce la schiavitù fin da tempi remoti: il fenomeno riguarda, sia pure con modalità differenti, tutti i popoli indoeuropei. Già il porcaro Eumeo nell’ Odissea appare in una condizione servile, dai tratti però originali: è schiavo di Ulisse ma a sua volta è «proprietario» di una casa oltre che di uno schiavo. Le origini della schiavitù vanno cercate nella guerra, nella pirateria e anche nell’indebitamento. Il filosofo Eraclito (VI-V secolo a.C.) scrive che Polemos è «padre di tutte le cose» e rende gli uomini liberi o schiavi, in quello che è stato considerato il primo tentativo di un’interpretazione della schiavitù (fr. 53 D.-K.). Aristotele cerca di offrire il più articolato tentativo di giustificazione della schiavitù, intesa come condizione naturale di inferiorità rispetto all’uomo libero. In Grecia troviamo «due modelli di schiavitù» (Caporali 95): il più antico, ossia quello dorico, è «l’assoggettamento stanziale e di massa delle popolazioni sconfitte», una sorta di servitù della gleba (ad esempio, questo è il modello degli iloti a Sparta). Opposto al modello dorico-spartano c’è il modello attico, che si fonda sullo «schiavo-merce», catturato, sradicato dalla sua terra d’origine, comprato e venduto individualmente. La politica espansionistica di Roma, soprattutto dopo le guerre puniche, fa aumentare notevolmente il numero degli schiavi, per cui si crea anche un mercato con prezzi oscillanti: dai 1000 sesterzi per uno schiavo comune fino a 700.000 per un grammatico. Gli schiavi di città (familia urbana) sono trattati meno duramente di quelli di campagna, dediti al lavoro agricolo (familia rustica). Lo schiavo è ritenuto una cosa, un instrumentum vocale, uno strumento di lavoro dotato di voce, che i grandi latifondisti valutano in termini di resa economica, al punto che Catone considera gli schiavi vecchi e malati come eccedenza di cui disfarsi (L’agricoltura 2,7).
La rivolta di schiavi più nota a Roma è quella di Spartaco (73 a.C.), ma questo genere di fenomeno non implica la richiesta di abolizione della schiavitù, pratica profondamente radicata nel mondo antico, ma è espressione di un malcontento generale. Seneca, nell’epistola 47, invita a trattare bene gli schiavi ed esorta a considerare che «costui, da te chiamato schiavo, è nato dallo stesso seme, gode dello stesso cielo, respira, vive, muore come te! Tu puoi vederlo libero, come lui può vederti schiavo». I liberti, ossia gli schiavi affrancati, acquisiscono sempre maggiore rilievo in età imperiale, come si ricava anche dal Satyricon di Petronio. Soltanto in tarda età imperiale, con la diffusione del cristianesimo, la schiavitù comincia a declinare. La favola presta particolare attenzione alla figura dello schiavo, sulla linea di altri generi letterari popolari, come la commedia, che spesso (ad esempio, in Plauto) ne valorizza l’astuzia. Del resto, come attesta il Romanzo di Esopo sulla scorta di una lunga tradizione, l’inventore del genere favolistico è uno schiavo di grandi capacità intellettuali, paradossalmente superiore al suo padrone Xanto (v. ESOPO). Fedro, che ha conosciuto la schiavitù ed essendo un liberto vive comunque una condizione subalterna, nel prologo del terzo libro addirittura afferma che la favola è un genere inventato dagli schiavi, soggetti al potere, per esprimere i propri sentimenti senza essere incriminati (vv. 33 ss.). Il favolista latino in alcune narrazioni presenta Esopo, descritto ora come unico schiavo di un padrone (3,19), ora come schiavo di una donna assai brutta (Fedro, App. 15 [17]). Esopo non è disposto a rinunciare alla verità, nonostante l’inevitabile punizione. Alla fine, il saggio favolista, secondo uno schema tipico di queste genere, risulta sempre vittorioso, almeno su un piano dialettico, al di là delle iniziali apparenze. In altre favole troviamo impegnati anonimi schiavi, in situazione tipiche della società romana. Così emerge il tema dello schiavo fuggitivo (Fedro, App. 18 [20]), che Esopo distoglie dal suo proposito: è irreprensibile e viene trattato duramente; che cosa potrebbe succedere, se
si macchiasse di una colpa? Questa favola descrive bene l’infelice condizione degli schiavi, che, oltre a ricevere percosse e scarso cibo, erano soggetti, come attestano anche altre fonti (in particolare, Seneca nella citata epistola a Lucilio), ad altre umiliazioni: mentre il padrone mangiava, dovevano stare in piedi, in silenzio, pronti a obbedire a ogni cenno; in caso di cene fuori casa, dovevano accompagnarlo e attenderlo sulla strada. Del resto, come dimostra anche un’altra favola riportata da Plutarco (Precetti coniugali 144a), le punizioni erano severe: lo schiavo fuggitivo finisce proprio al mulino, dove espierà la sua colpa, girando la macina con le bestie da soma (cfr. anche Plauto, Persa 22). Se questa era la norma, altri castighi erano gratuitamente crudeli: si ha notizia, ad esempio, di un certo Vennio Pollione che si divertiva a dare in pasto i suoi schiavi alle murene. In una narrazione anomala, di ambientazione romana (Fedro 2,5), lo schiavo atriense cerca di ottenere la libertà attraverso lo zelo dimostrato all’imperatore Tiberio, che gli rivolge alla fine una battuta: «Non hai fatto molto e questa fatica è vana: presso di me gli schiaffi si vendono a prezzo ben maggiore». Il riferimento qui è al rituale dell’affrancamento, che avviene attraverso uno schiaffo o con la verga posata sul capo, come simboli dell’emancipazione. In generale, nella favola esopica la schiavitù è senza speranza e spesso, non solo in riferimento alla figura di Esopo, è associata alla bruttezza. Le schiave che cercano con un’astuzia di migliorare le loro condizioni alla fine si ritrovano inevitabilmente in una situazione peggiore (Esopo 89 Ch.); l’asino che, desiderando cambiare padrone, finisce in guai peggiori simboleggia quegli schiavi che, quando mutano proprietario, rimpiangono il precedente (Esopo 273 Ch.); la schiava brutta che si adorna magnificamente è disprezzata da Afrodite, dea della bellezza (Esopo 18 Ch.). La morale che emerge, esplicitamente o implicitamente, da queste favole è quella di una rassegnata accettazione di una condizione senza speranza di miglioramento.
Esopo e lo schiavo fuggitivo Fedro, App. 18 [20] Non si deve aggiungere male a male Uno schiavo in fuga da un duro padrone incontrò Esopo, che lo conosceva perché erano vicini. «Per quale motivo sei agitato?». «Te lo svelerò senza riserve, padre: e davvero tu sei degno di essere chiamato con questo nome, perché con te ci si può sfogare senza rischi. Ricevo percosse in soprannumero, mi manca il cibo; spesso sono inviato alla fattoria senza provviste per il viaggio. Se il padrone cena a casa, me ne sto in piedi per tutta la notte; se è invitato a casa di altri, rimango sdraiato sul marciapiede fino all’alba. Mi sono meritato la libertà, ma continuo a servire anche ora che ho i capelli bianchi. Se avessi consapevolezza di qualche colpa, sopporterei rassegnato; non mi sono mai saziato e oltretutto io, misero, devo subire un padrone crudele. Per questi motivi e per altri che sarebbe lungo elencare, ho deciso di andarmene dove mi condurranno i piedi.» «Ebbene, – disse Esopo – stai a sentire: non avendo fatto nulla di male, ti sono toccate, come racconti, queste pene; che cosa ti succederà se commetterai qualcosa di sbagliato? Quali pene pensi che dovrai subire?» Con tale ammonimento lo schiavo fu distolto dalla fuga. NOTA: al v. 13 si legge dominum invece di dominium. Lo schiavo fuggitivo Plutarco, Precetti coniugali 144a
Un uomo vide, dopo un po’ di tempo, il suo schiavo fuggitivo e cominciò a inseguirlo. Poiché lo schiavo nella fuga lo precedette al mulino, gli disse: «Dove vorrei trovarti piuttosto che qui?».
Scimmia La simbologia della scimmia, di cui è attestata una consuetudine domestica sia presso i Greci sia presso i Romani, è spesso connessa con la sfera umana, non solo in relazione all’aspetto esteriore, ma anche riguardo al profilo morale. Secondo il mito, un giorno due crudeli briganti, i Cercopi, furono per punizione trasformati in scimmie da Zeus, in modo che potessero apparire bestialmente deformati e sembrare allo stesso tempo simili e dissimili agli uomini (Ovidio, Metamorfosi 14,91 ss.). In effetti, come nota Plinio (Naturalis historia, 11,246), questo animale presenta numerose affinità, anche fisiche, con l’uomo e un’evidente tendenza all’imitazione. L’epiteto di scimmia, inteso in senso deteriore come «imitatore», si ritrova in vari autori, anche con riferimenti all’imitazione letteraria (cfr., ad esempio, Orazio, Satire 1,18,10; Sidonio Apollinare, Epistole 1,1,2); gli scoli a Pindaro (Pitiche 2,72) parlano della scimmia come di un animale ridicolo, amato dai bambini, che la osservano divertiti. Spesso prevalgono gli aspetti negativi. Semonide, in alcuni noti versi satirici fortemente misogini (fr. 7 W. ) , accosta le donne a vari tipi di animali: quella simile alla scimmia è brutta, scaltra e maligna. Esistono diverse narrazioni, anche fantasiose, riguardo alla scimmia e alle sue diverse specie: ad esempio, il gorilla appare collerico, non sopporta la schiavitù e, in questo caso, si lascia morire, come attesta anche Pitagora (Eliano, De natura animalium 17,9). Per i vari elementi che ne caratterizzano il profilo, la scimmia è riferimento efficace nell’ambito della commedia, anche per tratteggiare le qualità dei personaggi (cfr. Plauto, Il soldato fanfarone 285; 505). Rappresenta inoltre gli imbroglioni (Artemidoro, Sull’interpretazione dei sogni 4,56). Adorato in Egitto, in ambito cristiano, invece, questo animale assume una connotazione negativa e va a rappresentare il diavolo stesso e anche l’eresia, imitazione 2
deformata della vera fede. La scimmia nella favolistica si presenta sotto una veste ambivalente: è simile all’uomo e addirittura può svolgerne funzioni tipiche, anche nobili, come quella di giudice (Fedro 1,10); cerca di imitarlo, organizzando la società dei suoi simili sul modello umano (Romulus 78), ma in fondo «questa prossimità all’uomo ne informa pure il carattere morale: essa è crudele, vanitosa, adulatrice: e dinanzi ai potenti cortigiana fino all’impudenza» (Marchesi 1923, 68). In questo suo sforzo di emulazione, risulta spesso goffa e inadeguata, come quando cerca di imitare i pescatori e finisce imbrigliata nella rete (Esopo 304 Ch.); tuttavia eccelle nella danza (Esopo 306 Ch.) e per questo viene scelta addirittura per regnare sugli animali, ma poi la volpe ne smaschera l’indegnità. Questa favola, che sembra assai antica (cfr. Archiloco, frr. 185 ss. W. ), richiama lo schema narrativo dell’ultimo individuo di una comunità che ne diventa capo e poi viene smascherato, fisicamente o intellettualmente. L’esempio più noto è quello dell’asino rivestito della pelle del leone (v. ASINO). Del resto, secondo Luria (450 s.) «la poesia popolare attribuiva alla scimmia quasi i medesimi tratti caratteristici dell’asino – la si riteneva brutta, ridicola, sfacciata», come attesta anche il proverbio «Asino tra le scimmie» (cfr. Appendix proverbiorum 4,24). Sulla base di una credenza assai diffusa (cfr. Oppiano, Cynegetica 2,605 ss.; Plinio il Vecchio 8,216), si ritiene che uccida i figli: di qui la narrazione dei nati della scimmia (Esopo 307 Ch.), secondo cui quello più amato viene strangolato dagli abbracci, mentre quello trascurato riesce a sopravvivere. Sarebbe dunque l’eccesso d’amore a determinare un’apparente crudeltà, che viene comunque smentita dalla favola in cui la scimmia ritiene che il suo piccolo sia il più bello fra tutti i nati degli animali (cfr. Babrio 56; Aviano 14); in realtà, viene descritto come orribile d’aspetto, in linea con la tradizionale rappresentazione della bruttezza di tale bestia (cfr. anche Fedro 3,4, che nell’epimitio smentisce il luogo comune secondo cui alla 2
bruttezza corrisponde un pessimo profilo morale). La stupidità che le attribuiscono gli antichi emerge bene nella favola di Esopo 305 Ch.: dopo un naufragio, il delfino la carica su di sé, credendola un uomo, ma, di fronte a una sciocca menzogna dovuta all’ignoranza, sdegnato la fa annegare. L’invito a mentire le viene rivolto anche dalla volpe, in una favola che vede la scimmia afflitta per le umili origini dei suoi antenati: ma – osserva la volpe – nessuno potrà alzarsi dai sepolcri e contraddirla, se non dirà la verità (Esopo 39 Ch.). In questo caso, si può forse ravvisare un collegamento con la credenza secondo cui questo animale non sopporta la schiavitù. La scimmia è presente anche nella tradizione favolistica indiana. Nel Pañcatantra viene descritta nell’ambito del branco e rappresentata come sconsiderata (primo racconto del primo tantra) e poco intelligente, in una favola (primo tantra, racconto quattordicesimo) in cui una scimmia, pur consigliata da un uccello di non farlo, continua a soffiare su una lucciola, ritenendola fatta di fuoco. I figli della scimmia Esopo 307 Ch. Dicono che le scimmie partoriscano due figli: uno è amato e allevato con cura, l’altro odiato e trascurato. Accade, tuttavia, che, per volere del fato, quello accudito con amore e stretto con energia dagli abbracci finisce per essere soffocato dalla madre, mentre quello trascurato riesce a diventare adulto. La favola dimostra che la sorte è più potente di ogni nostra previdente attenzione. RIFERIMENTI: Babrio 35; Aviano 35; Parafrasi 308; Oppiano, Cynegetica 2,605 ss.; cfr. anche Plinio, Naturalis historia 8,216.
La volpe e la scimmia eletta re Esopo 38 Ch. Dopo che nell’assemblea degli animali la scimmia si era fatta onore danzando, venne da loro eletta re. La volpe, che era invidiosa di lei, come vide un pezzo di carne che si trovava dentro una trappola vi condusse la scimmia e le disse che, pur avendo trovato un tesoro, non voleva farne uso, ma lo aveva conservato come omaggio alla sua regalità, e la invitava a prenderlo. La scimmia accorse senza prestare attenzione e, dopo essere stata incastrata dalla trappola, si mise ad accusare la volpe di averle teso un tranello. La volpe replicò: «Scimmia, tu, così sciocca, regni sugli animali?». Allo stesso modo, coloro che, nelle loro azioni, operano sconsideratamente, oltre a patire disgrazie finiscono anche per essere derisi. RIFERIMENTI: si rilevano molte allusioni e riferimenti relativi soprattutto a frammenti di Archiloco (frr. 185 ss. W. ), che sembrano riferibili a questa favola (Epodo VI, nella ricostruzione di Adrados). Cfr. Van Dijk 1997, 463 ss. Tra i passi riconducibili a questa narrazione, cfr. inoltre Luciano, Il pescatore 36; Tzetze, Chiliadi 4,953-958. 2
La scimmia e i pescatori Esopo 304 Ch. Una scimmia, che stava sulla sommità di un albero, notò dei pescatori che gettavano le reti in un fiume e prese a osservare come operavano. Dopo che essi abbandonarono le reti e si allontanarono a breve
distanza per mangiare, la scimmia scese dalla pianta e provò a imitarli (dicono, infatti, che questo animale abbia la tendenza a imitare). Toccate le reti, tuttavia, si ritrovò imbrigliata, correndo il pericolo di affogare. «Me lo merito proprio: – disse a se stessa – perché ho provato a pescare senza avere prima appreso come si deve fare?» La favola dimostra che mettere mano a quanto ci è estraneo non solo non è utile, ma è anche dannoso. RIFERIMENTI: Sintipa 46; Parafrasi 305. La volpe e la scimmia che discutevano sulla loro nobiltà Esopo 39 Ch. Una volpe e una scimmia, in viaggio insieme, discutevano sulla loro nobiltà. Ognuna delle due elencava molti titoli, ma, a un certo punto del percorso, dopo avere gettato uno sguardo intorno, la scimmia scoppiò a piangere. La volpe gliene chiese il motivo e lei le indicò alcuni monumenti funebri, dicendo: «Non dovrei piangere, vedendo le stele funerarie dei miei antenati liberti e schiavi?». La volpe, allora, le disse: «Tu menti quanto vuoi, perché nessuno di loro si alzerà per sconfessarti». Così, anche fra gli uomini, i bugiardi si vantano specialmente quando non c’è nessuno che li possa smentire. RIFERIMENTI: Babrio 81; Sintipa 14; Suda π 1579 Adler (derivazione archilochea? Cfr. Adrados 2003, 23). Il leone, la volpe e la scimmia
Babrio 106 C’era un leone che voleva imitare il migliore modello di vita presente presso la società degli uomini. Fece la sua tana dentro una grotta spaziosa e cercò di dimostrare la sua genuina generosità nei confronti di tutte le più nobili bestie della montagna. La sua tana spesso ospitava una grande moltitudine di diversi animali, riuniti in un clima di notevole cortesia. Il leone li accoglieva e si prendeva cura di loro secondo le regole dell’ospitalità, offrendo a tutti cibo gradito in abbondanza. Il leone accolse come amica e commensale una volpe, con cui spesso si intratteneva amabilmente. C’era, inoltre, una vecchia scimmia, che aveva l’incarico di tagliare e distribuire le porzioni di carne ai convitati del leone. Ogni volta che si presentava un nuovo ospite, la scimmia offriva la stessa porzione fornita al suo padrone, cioè le prede che il leone aveva cacciato nell’ultima spedizione di caccia. La volpe allora riceveva avanzi del giorno precedente in una quantità inferiore a quella consueta. Ma accadde che un giorno la volpe se ne stette ostentatamente in silenzio e si astenne dalla carne servita al banchetto. Il leone le chiese quale fosse il motivo. «Saggia volpe, – disse il leone – parla con me come al solito! Sorridi con volto lieto, mangia, mia cara.» Ma la volpe disse: «O leone, che sei il più illustre tra tutte le stirpi degli animali, il mio cuore è tormentato da molte preoccupazioni. Non solo il presente mi affligge, ma anche il futuro che prevedo mi induce alla tristezza, perché se ogni giorno continuano a presentarsi nuovi ospiti, e se questa diventa un’abitudine, io non avrò più nemmeno i resti della carne da mangiare». Queste parole divertirono il leone, che, sorridendo con un sorriso da leone, rispose: «Rimprovera di questo la
scimmia, non me». RIFERIMENTI: cfr. anche Georgide, Gnomologio (Anecdota Graeca, vol. 1, p. 9, ed. Boissonade). Lo scimmiotto e la volpe Fedro, App. 1 L’avaro non concede volentieri nemmeno quello che gli avanza Uno scimmiotto chiedeva alla volpe una parte della coda per potersi coprire, in modo conveniente, le natiche nude; la maligna gli rispose così: «Anche se diventasse più lunga, la trascinerei attraverso il fango e i rovi, piuttosto che dividerne con te una parte, benché piccola». RIFERIMENTI: Romulus 67. Il sovrano delle scimmie Romulus 78 Due uomini – l’uno bugiardo, l’altro sincero – facevano un viaggio insieme e, camminando, giunsero al paese delle scimmie. Come li vide uno del popolo delle scimmie che si era imposto alla guida della sua nazione, ordinò che i due uomini fossero fermati; quindi, si mise a interrogarli, chiedendo loro che opinione gli uomini avessero espresso su di lui. E ordinò che tutti i suoi simili gli si schierassero di fronte, in una lunga fila a destra e a sinistra, e gli fosse allestito un trono. Come aveva visto fare una volta a un imperatore, le fece disporre
davanti a sé. Il capo delle scimmie chiese: «Chi sono io?». L’uomo bugiardo rispose: «Tu sei l’imperatore». Lo interroga di nuovo: «E costoro che sono disposti di fronte a me?». «Questi – rispose il bugiardo – sono il tuo seguito.» E, poiché attraverso una menzogna venne lodato insieme al suo popolo, il capo ordinò di ricompensarlo. L’uomo sincero, invece, tra sé e sé pensava: «Se costui che dice il falso viene premiato, io, se dirò la verità, avrò una ricompensa ancora più grande». Allora il capo delle scimmie disse: «Dimmi anche tu chi sono io e chi sono questi che stanno di fronte a me». Ma l’uomo, che amava ed era solito dire la verità, rispose: «Tu sei davvero una scimmia e tutti questi tuoi simili sono sempre scimmie». Viene subito impartito l’ordine che l’uomo sia dilaniato con i denti e con le unghie, perché aveva detto la verità. Così di solito gli uomini scellerati fanno in modo che l’inganno e la malvagità siano amate, l’onestà e la verità siano fatte a pezzi. RIFERIMENTI: Fedro 4,13 (versione incompleta). La scimmia Aviano 14 Una volta Giove aveva chiesto, in ogni parte del mondo, chi gli donasse il figlio più bello. Accorrono a gara dal re tutte le stirpi delle bestie selvatiche e sono spinti ad andare anche gli animali domestici. Ma non mancano alla sfida neppure i pesci squamosi e tutti gli uccelli che la pura aria conduce. Tra questi, le madri emozionate portavano i loro piccoli, che dovevano essere sottoposti al giudizio di un dio così importante. Allora, una scimmietta, trascinando il figlio, orribile alla vista, indusse lo stesso Giove a
mettersi a ridere. Tuttavia, la bruttissima scimmia disse, anticipando gli altri, queste parole, mentre desiderava che fosse così eliminata la colpa della sua stirpe: «Giove sa chi merita la vittoria; a mio parere, questo mio piccolo supera tutti gli altri». Le scimmie che volevano fondare una città Ermogene, Esercizi preparatori 1 Le scimmie si riunirono per discutere riguardo alla necessità di fondare una città. Così, quando ebbero preso la decisione, erano sul punto di procedere all’opera, ma una vecchia scimmia fermò i suoi compagni, dicendo: «Più facilmente saremo conquistati, una volta bloccati dentro le mura di una città». RIFERIMENTI: favola singolare, forse di origine orientale. La morale non è del tutto chiara. Cfr. anche Prisciano, Esercizi preparatori 3. Per altri riferimenti, v. le osservazioni di Adrados 2003, 532 s. Il leone regnante Romulus 70 Parlare può portare a una pena, ma anche tacere può causare disavventure. Il leone, dotato di straordinario valore, si era imposto come re degli animali e, secondo il costume dei sovrani, voleva conseguire fama di giustizia; rinunciò ai precedenti comportamenti, cambiando il suo consueto modo di agire, giurò di non aggredire più alcun animale, contento di procurarsi cibo senza sangue e di
mantenere santa e integra la sua fede. Dopo che cominciò a pentirsi di questa promessa, non riuscendo a mutare natura, prese ad attirare gli animali in disparte uno a uno, per tendere loro una trappola, affermando che il suo alito puzzava; così dilaniava l’animale, sia che fosse sincero sia che fosse bugiardo, per appagare il suo appetito. Dopo avere agito così nei confronti di molte bestie, chiese alla scimmia se il suo alito avesse un cattivo odore; ma lei rispose che profumava di cinnamomo ed era simile all’altare degli dei. Allora il leone ebbe vergogna di aggredire la scimmia, che aveva formulato tale elogio. Cercando di tessere un altro inganno, si finse malato. Subito i medici cercano […]. Gli tastarono le vene: aveva un battito indicibile. Viene persuaso a nutrirsi con qualche cibo che lo calmi e gli tolga la nausea, poiché ai re tutto è consentito. «Non conosco – disse – la carne di scimmia: la vorrei. Ignoro quale sia il suo sapore.» Dopo che ebbe pronunciato queste parole, subito la scimmia, abile a parole, venne presa e offerta al re, secondo quanto ordinato, e immediatamente fu dilaniata dal leone. RIFERIMENTI: incompleta.
Fedro
4,13
[14]:
versione
Il lupo e il volpe, giudice la scimmia Fedro 1,10 Chi si è fatto conoscere una volta per un turpe inganno, anche se dice la verità, non trova credito. Lo illustra una breve favola di Esopo. Il lupo accusava la volpe di un furto, mentre quella sosteneva di non essere nemmeno lontanamente
colpevole. Così sedette tra loro, in qualità di giudice, la scimmia. Dopo che entrambi ebbero perorato la loro causa, la scimmia – si dice – emise questa sentenza: «A mio parere, tu non hai perso quanto reclami; credo, invece, che tu abbia sottratto quello che bellamente neghi di avere preso». RIFERIMENTI: Romulus 48. Cfr. Diogene Laerzio 6,54; Gnomologio Vaticano 190 S.
Scorpione Nell’antichità, lo scorpione è simbolo del male, della morte, dell’odio e del tradimento. Il fatto che si nasconda in anfratti e tenda a evitare la luce contribuisce, insieme con il suo terribile pungiglione, a definirne questo profilo, che è proprio non solo della cultura europea ma anche di quella egizia (lo scorpione è attributo del dio Seth) e di altre tradizioni orientali. Nel Vangelo, Gesù dà agli apostoli il potere di avere la meglio sugli scorpioni, simbolo di ciò che si oppone a Dio (Luca 10,19). Curiose le leggende relative alla sua genesi. Secondo Eliano (De natura animalium 2,35) dalle carogne dei coccodrilli nascerebbero scorpioni dai pungiglioni pieni di veleno; secondo Ovidio (Metamorfosi 15,369 ss.) da un granchio sotterrato, a cui siano levate le chele, spunterebbe questo sinistro essere. Nel mito lo scorpione, per vendicare Artemide, punge il piede di Orione ed è trasformato dalla dea in una costellazione. In una favola troviamo uno scorpione pronto a fare del male a un ragazzo che sta raccogliendo cavallette (Esopo 293 Ch.). Per quanto marginale, visto che compare soltanto in questa narrazione, la figura dello scorpione si connota in modo negativo e, come risulta dall’epimitio, l’animale diventa simbolo dei malvagi. Il pungiglione è lo strumento che lo rappresenta: è folle pertanto ignorare la natura dell’animale (si tratta di un tema cinico: cfr. Adrados 2003, 276 s.). Sebbene sia di origine medievale, il proverbio In cauda venenum, ossia «Il veleno nella coda», ha senza dubbio a che fare con l’immagine dello scorpione (e del suo colpo di coda) così diffusa nel mondo antico (altri proverbi sullo scorpione in Tosi 2011, 183). Il fanciullo a caccia di cavallette e lo scorpione Esopo 293 Ch.
Un fanciullo era a caccia di cavallette davanti alle mura della città. Ne aveva già prese molte, quando vide uno scorpione: pensando che fosse una cavalletta, aprì il cavo della mano come per deporvelo. E quello, alzando l’aculeo, gli disse: «Magari l’avessi fatto veramente; avresti perso anche le cavallette già catturate». Questa favola insegna che non bisogna trattare tutti, buoni e cattivi, allo stesso modo. RIFERIMENTI: Parafrasi 294; Pseudo-Dositeo 10; Sintipa 39; Dodecasillabi 294; Tetrastici 1,18; Romulus 88.
Serpente Da sempre il serpente genera inquietudine nell’uomo, che, già nell’antichità, coltiva nei suoi confronti un sentimento ambivalente di timore e, insieme, di venerazione. L’animale, diffuso prima in Asia e nell’Africa mediterranea che in Europa, è spesso posto in relazione con i corsi d’acqua, presso cui è solito vivere (specialmente negli ambienti tropicali), e con la terra. Peraltro, il suo legame con la terra, su cui striscia e da cui ha origine, suggerisce rapporti stretti con l’aldilà; perciò il serpente diviene presto simbolo delle divinità infere. Inoltre, grazie al cambio di pelle rappresenta l’eterna giovinezza. In Egitto è animale domestico fin da tempi remoti. Nella Bibbia compare spesso in chiave negativa, come tentatore dell’uomo (Genesi 3,115). D’altra parte, l’Antico Testamento ci presenta anche episodi di altro segno: il serpente può assumere funzioni salvifiche o, più semplicemente, si fa strumento funzionale al rapporto tra Dio e l’uomo, ad esempio quando il bastone di Mosè prende le sembianze del rettile (Esodo 4,2-5). Legato in varie culture alla sfera del sacro, il serpente è considerato essere primordiale, animale totemico. Oggetto di venerazione sia nella civiltà cretese-micenea sia in quella italica antica, anche nel mondo classico assume un ruolo di rilievo. Tuttavia il suo profilo appare fluttuante e varia nel tempo: assume dapprima, nel mondo greco, un valore oscillante ed è spesso presente nella letteratura, da quella scientifica a quella mitologica, oltre che nella religione, che lo considera animale oracolare e lo impiega nella divinazione. Quindi, nel mondo romano, si assiste a un’accentuazione degli aspetti negativi. La tradizione giudaico-cristiana li sottolinea e li esaspera poi nel Medioevo; perciò questi aspetti finiscono per prevalere, nella tradizione occidentale, dove esiste tuttora una diffusa ostilità verso l’animale, identificato come simbolo del male (cfr.
Bodson 1989, 525 ss.). Già Aristotele, comunque, ne parla come di un essere vile e insidioso (Historia animalium 488b). Vista la sua natura falliforme, il serpente è, tra l’altro, simbolo della sessualità. Eliano (De natura animalium, 6,17) racconta l’amore di un enorme serpente e di una bella fanciulla, riferendo un episodio che sarebbe avvenuto in Palestina. Dall’Idra di Lerna a Cecrope, il mito è ricco di figure di serpenti, spesso rappresentati con connotati mostruosi e fantastici (v. anche DRAGO). Importante, nella cultura antica, anche il suo legame con la medicina: il bastone di Asclepio (Esculapio nel mondo romano), dio della salute, è un antico simbolo dell’arte medica. In questa prospettiva, l’animale è simbolo di rinascita e di fertilità. Il processo di dissacrazione, tipico della favola, degrada il serpente da essere straordinario, connesso alla sfera divina, a semplice animale, emblema dell’uomo e delle sue peggiori inclinazioni. Nella tradizione favolistica è presente in un numero piuttosto ridotto di narrazioni, se si considera viceversa la sua notevole importanza nella cultura antica. Secondo Pugliarello 1973, 124, questo dato si deve «al perdurare nel mondo mitico e nella coscienza religiosa degli antichi delle rappresentazioni del rettile quale divinità teriomorfa ctonia»: insomma, miti e tradizioni sono ancora parzialmente vitali in epoca storica, perciò esistono riserve nell’accoglierlo nella favola. Va precisato che il serpente viene indicato con termini differenti in greco e in latino; tuttavia la favola non ha un interesse specifico per la caratterizzazione delle singole specie. Accanto ai termini più generici (ὄϕις in greco e serpens in latino), che sono anche i più diffusi nelle narrazioni esopiche, se ne trovano altri, che vanno a individuare la biscia d’acqua, il drago, l’aspide e la vipera (questi ultimi tra loro assai simili: v. gli approfondimenti relativi alle singole voci). In generale, nella favolistica antica il serpente appare infido, vorace, crudele, ingrato. Talvolta è disposto a morire, pur di riuscire a uccidere il suo nemico (Esopo 331 Ch.). Lo stesso Zeus ammette di non fidarsi del serpente e quindi non accetta il
suo dono (Esopo 122 Ch.). L’animale, simbolo di perfidia, come esplicita anche la morale della favola, dimostra di essere un ingrato, una sorta di traditore dei benefattori in Esopo 82 Ch. Qui troviamo un contadino che viene morso e ucciso dal serpente (Babrio, con maggiore sforzo di precisione, parla di una vipera) che ha riscaldato e salvato poco prima da probabile morte. La favola 81 Ch. presenta, invece, il tentativo di riconciliazione del contadino con il serpente, dopo che quest’ultimo ha ucciso il figlio dell’uomo. Questa narrazione potrebbe presupporre un motivo abbastanza radicato nella cultura antica, quello del serpente inteso come genius loci, custode e protettore della casa, che tuttavia pare assente nella tradizione favolistica antica, ma rispunta nelle parafrasi medievali: tra l’altro, in linea con una lunga tradizione, il poeta satirico Persio (1,113 s.), nel I secolo d.C., ricorda che dipingere serpenti in un locale significa rendere sacro l’ambiente. Peraltro, il legame tra uomo e rettile è attestato anche da altre fonti letterarie (come Plinio, Naturalis historia 8,61). Insomma, secondo Pugliarello 1973, 123, il mitico rapporto di dipendenza dell’uomo nei confronti dell’animale sembrerebbe il presupposto di questa favola di Esopo (Nøjgaard 1967, 407 s. pensa che, in generale, il tema sia di derivazione orientale). Il processo di degradazione porta il serpente a diventare persino simbolo di stoltezza, come in Esopo 116 Ch., favola in cui la vipera morde vanamente la lima, dimostrando davvero poco acume. L’animale è ampiamente presente nelle tradizioni favolistiche orientali: è interessante notare come, ad esempio, l’antica favola babilonese del serpente e dell’aquila venga assimilata nella tradizione greco-romana, presentando tuttavia la sostituzione del serpente orientale con la volpe (v. la voce AQUILA). Anche la tradizione favolistica indiana offre ampio spazio al serpente e pare riprendere diversi motivi propri della tradizione greca, sia pure con alcune differenze: ad esempio, la favola del serpente che si offre come cavalcatura delle ranocchie e poi impietoso le divora (v. l’elenco e l’analisi di Marchianò
77 ss.). Il serpente calpestato e Zeus Esopo 291 Ch. Un serpente, calpestato da molti uomini, si lamentò di questo con Zeus, ma il dio gli disse: «Se tu avessi morso il primo che ti ha pestato, nessun altro avrebbe provato a farlo». La favola dimostra che quelli che oppongono resistenza ai primi che li aggrediscono diventano temibili per gli altri. RIFERIMENTI: Sintipa 18. Zeus e il serpente Esopo 122 Ch. Alle nozze di Zeus tutti gli animali portarono doni, ciascuno secondo le sue possibilità. Un serpente, strisciando, salì fino a lui con una rosa in bocca. Zeus, scorgendolo, disse: «Io accetto i doni di tutti gli altri, ma dalla tua bocca non accetto assolutamente nulla». La favola dimostra che bisogna temere le cortesie dei malvagi. RIFERIMENTI: probabilmente si tratta di un tema derivato dall’apoteosi di Eracle, presente in altre favole (cfr. Adrados 2003,311). Il serpente e il granchio Esopo 290 Ch. Un serpente e un granchio trascorrevano la loro
vita nello stesso luogo. Mentre il granchio trattava il compagno con semplicità e benevolenza, il serpente era sempre ambiguo e perfido. Benché il granchio continuamente lo invitasse ad agire con schiettezza verso di lui e a imitare il suo comportamento, il serpente non gli dava ascolto. Perciò, il granchio, colto dall’indignazione, fece attenzione a quando il rettile andava a dormire e, dopo averlo preso per la gola, lo uccise; quindi, vedendolo lungo stecchito, disse: «Mio caro, bisognava che tu fossi diritto non adesso che sei morto, ma quando ti esortavo a esserlo; così non saresti stato ucciso». Questa favola potrebbe essere narrata giustamente per quegli uomini che durante la loro vita si comportano da malvagi con gli amici e fanno loro del bene dopo la morte. RIFERIMENTI: Babrio 109; Aftonio 11; Aviano 3; Parafrasi 152; Tetrastici 1,34; Carmina Convivalia 892. Il serpente e l’aquila Aftonio 28 Favola dell’aquila e del serpente che ci invita a essere i primi a concedere un favore. Un’aquila e un serpente stavano lottando corpo a corpo; il serpente stringeva la sua presa sull’aquila, quando un contadino, vedendoli, sciolse il nodo del rettile e liberò l’aquila. Il serpente, allora, adirato per quanto successo, andò ad avvelenare l’acqua potabile del liberatore. Poiché l’agricoltore, inconsapevole, era in procinto di bere, l’aquila volò giù dal cielo per strappare la coppa dalle mani dell’uomo. La gratitudine resta nei confronti di
coloro che fanno del bene. RIFERIMENTI: Eliano (De natura animalium 17,37) riporta la favola, riferendo che Cratete di Pergamo la attribuisce a Stesicoro, poeta lirico di Imera vissuto nel VII-VI secolo a.C.: il motivo, perciò, sembrerebbe piuttosto antico. Il serpente, la donnola e i topi Esopo 289 Ch. Un serpente e una donnola lottavano in una casa. I topi che erano lì e venivano sempre divorati da entrambi, come li videro combattere, uscirono a passeggio. Appena notarono i topi, i due sospesero subito la lotta e si volsero contro di loro. Così anche negli Stati, quelli che s’immischiano nelle dispute dei demagoghi diventano senza rendersene conto le vittime di ciascuna delle due parti. La coda e le membra del serpente Esopo 288 Ch. Una volta la coda di un serpente voleva precedere e condurre le membra. Il resto del corpo reclamava: «In che modo ci guiderai tu, senza occhi e senza naso, come gli altri animali?». Ma le membra non riuscivano a convincerla, fino a che il buon senso fu sconfitto. La coda allora guidava e comandava, trascinandolo alla cieca, tutto il corpo, finché il serpente non finì in un burrone roccioso, dove si ferì al dorso e dappertutto. Così la coda, agitandosi per blandirla, supplicava la testa dicendo: «Salvaci, per piacere, padrona: ho sperimentato che litigare con te
ha effetti negativi». La favola si rivolge agli uomini ingannevoli e malvagi che sono ribelli nei confronti dei loro padroni. RIFERIMENTI: Parafrasi 289; Plutarco, Agide 2. La rondine e il serpente Esopo 347 Ch. Una rondine, dopo avere fatto il nido in un tribunale, spiccò il volo e si allontanò. Un serpente si arrampicò e divorò i suoi piccoli. La rondine, di ritorno, trovò il nido e cominciò a gemere per il dolore. Poiché un’altra rondine cercava di consolarla e le diceva che non solo a lei era capitato di perdere i figli, lei rispose: «Ma io non piango tanto per i miei piccoli, quanto perché proprio in questo luogo in cui le vittime ottengono soddisfazione, ho subito un’ingiustizia». La favola insegna che spesso le disgrazie sono più terribili da sopportare quando si ricevono da coloro da cui meno le si aspetta. RIFERIMENTI: Tetrastici 1,56.
Babrio
118;
Parafrasi
348;
La vespa e il serpente Esopo 331 Ch. Una vespa si appoggiò sulla testa di un serpente e lo tormentava, colpendolo senza sosta con il pungiglione; il rettile, colto da intenso dolore e incapace di vendicarsi dell’aggressore, infilò la testa sotto la ruota di un carro. E così morì insieme con la
vespa. La favola dimostra che alcuni scelgono di morire con i nemici. Il serpente e la lucertola Fedro, App. 23 [25] Quando manca la pelle del leone bisogna indossare quella della volpe, cioè se vengono meno le forze, occorre usare l’astuzia Un serpente aveva preso una lucertola per caso dalla coda; poiché voleva divorarla a gola spalancata, la lucertola afferrò un rametto che giaceva a terra, e, tenendolo di traverso con morso tenace, bloccò con l’astuto ostacolo le fauci bramose di cibo. Il serpente lasciò andare dalla bocca l’inutile preda. NOTA: al v. 1 si legge aversam invece di adversam.
Simonide Nato nel 556 a.C. a Ceo, isola delle Cicladi, il poeta Simonide incarna perfettamente la figura dell’artista a contatto con una committenza molto varia (città democratiche, tiranni, famiglie aristocratiche), tanto da guadagnarsi, secondo una certa tradizione, la fama di poeta avido di denaro, perché pronto a vendere la propria arte al miglior offerente. Ospite del tiranno ateniese Ipparco, una volta che il governo di quest’ultimo viene abbattuto, si reca in Tessaglia presso gli Scopadi. In seguito torna ad Atene, dove mantiene buoni rapporti con il nuovo regime democratico al tempo delle guerre persiane (490-480 a.C.). In questo frangente scrive alcuni carmi celebrando i caduti in battaglia (a Maratona e alle Termopili) e le più importanti vittorie ateniesi (Artemisio, Salamina, Platea). Trascorre l’ultimo periodo della sua vita a Siracusa, alla corte del tiranno Ierone, e in Sicilia muore nel 468 a.C. Famoso per la raffinatezza dello stile, Simonide si segnala per un’ampia produzione poetica. Oltre ai citati componimenti celebrativi in occasione delle guerre persiane, restano lamenti funebri, peani, ditirambi, elegie, epigrammi ed epinici, dei quali passa alla storia come il vero inventore. L’unico favolista che presenta narrazioni su Simonide è Fedro, che, traendo spunto da una ricca tradizione aneddotica dedicata al poeta, ne fa l’emblema dell’alta considerazione di cui gode la poesia presso gli uomini e gli dei (non a caso, Fedro scrive in versi, cercando di nobilitare la favola, che trova nella prosa la sua dimensione prevalente). Nella favola 4,22 [23], Simonide, che non bada ai beni materiali e alla fine è premiato per la sua arte, viene rappresentato come esempio dell’autosufficienza propria del saggio, secondo l’elaborazione della sua figura proposta dalla tradizione cinica. All’occasione dell’encomio scritto per Scopas (fr. 542 P.), un compianto funebre per i membri della
famiglia morti a causa del crollo della stanza in cui si svolgeva un banchetto, è invece ricollegabile la leggenda secondo cui anche lo stesso poeta sarebbe stato presente al banchetto, ma si sarebbe salvato grazie all’intervento dei Dioscuri: questo è il tema della favola 4,25 [26]. Adattando l’aneddoto allo schema tipico della favola esopica, Fedro qui presenta un conflitto con tre personaggi protagonisti, di cui uno sconfitto; mentre nel caso della favola precedente l’azione è semplificata e l’errore, dovuto ai presupposti sbagliati dell’opinione comune, viene svelato durante l’azione (cfr. La Penna 1968, LIV s.). Da segnalare anche un altro aneddoto, peraltro estraneo alle raccolte favolistiche, che coinvolge Simonide insieme a Laso di Ermione, compositore, citaredo, istruttore di cori: insomma, un rivale del poeta, che lo sconfigge in un concorso ditirambico. Il riferimento è di Aristofane, che, nelle sue commedie, sembra fare di Laso l’emblema delle nuove idee musicali, più amate dai giovani, contro quelle più tradizionali di Simonide; tra l’altro, racconta (Vespe, 1409 ss.) che un giorno i due si trovarono a gareggiare: Laso allora esclamò: «Me ne infischio davvero!» (Adrados 2003, 489 inserisce questi versi nel suo repertorio delle favole antiche). Simonide Fedro 4,22 [23] L’uomo di cultura ha sempre un tesoro dentro di sé. Simonide, che scrisse poesie straordinarie per sostenere con più facilità le sue povere condizioni di vita, cominciò ad andare in giro per le prestigiose città dell’Asia, cantando le lodi degli atleti vincitori in cambio di ricompensa. Dopo che divenne ricco in questo modo, volle tornare in patria attraversando il mare; era nato infatti, come dicono, nell’isola di Ceo: s’imbarcò su una nave che si sfasciò in mare aperto per un’orribile tempesta e perché ormai inadatta a
causa degli anni. Questi raccolgono le cinture, quelli gli oggetti preziosi come mezzi di sussistenza. Un uomo, spinto da una certa curiosità, chiede: «Simonide, tu non prendi nulla dei tuoi beni?». «Con me – risponde – ho tutte le mie cose.» Allora pochi si salvano nuotando, perché i più erano periti per la pesantezza del carico. Ed ecco i predoni che si danno alla rapina di tutto quanto ciascuno aveva portato con sé, e li lasciano spogliati. Per caso era vicina Clazomene, antica città, dove si diressero i naufraghi. Qui un amante della letteratura, che aveva letto spesso i versi di Simonide ed era un grandissimo ammiratore del lontano poeta, lo riconobbe da come si esprimeva e con grande calore lo accolse presso di sé. Lo rifornì di vestiti, denaro e servi. Gli altri portavano il loro quadretto votivo chiedendo cibo. Simonide per caso li incontrò; quando li vide, disse: «Vi ho detto che avevo con me tutto; ciò che avete portato via voi, è andato perso». RIFERIMENTI: v. sotto per il proverbio Homo doctus in se semper divitias habet. Il poeta Fedro 4,25 [26] Già ho detto sopra quale grande rilievo avesse la letteratura tra gli uomini: tramanderò adesso alla memoria quale straordinario onore sia stato tributato a essa dai celesti. Quello stesso famoso Simonide di cui ho già parlato si ritirò in un luogo appartato per scrivere, dietro ricompensa, una poesia in lode di un pugile vittorioso. Poiché la modestia dell’argomento era di freno alla sua vena creativa, si avvalse della licenza che è propria del poeta e inserì come
esempio i figli gemelli di Leda, facendo riferimento al prestigio di una simile gloria. L’opera riuscì, ma egli ricevette un terzo del compenso. Poiché Simonide chiedeva il resto, «te lo daranno – disse il pugile – quelli che hanno avuto due terzi dell’epinicio. Tuttavia, affinché tu non pensi di essere stato congedato in malo modo, promettimi di venire a cena; io oggi voglio invitare i miei parenti, fra i quali considero anche te». Per quanto raggirato e rattristato dal torto subito, accettò, pur dissimulando a fatica, per non rompere il buon rapporto. Tornò all’orario concordato e si sedette a tavola. Risplendeva di coppe festoso il convivio, risuonava la casa allegra con grande sfarzo: all’improvviso due giovani cosparsi di polvere e madidi di sudore, i corpi dalle fattezze sovrumane, incaricano uno schiavetto di chiamare alla loro presenza Simonide: era nel suo interesse non tardare. Quello, turbato, induce Simonide a uscire. Aveva appena fatto un passo fuori dalla sala, quando il crollo della volta immediatamente travolse gli altri e non fu trovato nessuno dei due giovani alla porta. Come si seppe in giro l’ordine dei fatti secondo la narrazione, tutti ebbero consapevolezza che la presenza dei numi aveva concesso la vita al poeta in luogo della ricompensa. RIFERIMENTI: nessun altro favolista riprende la vicenda. Ricordano invece l’episodio, in diverso modo, Callimaco, fr. 64 Pf.; Cicerone, De oratore 2,86; Quintiliano 11,2,11; Valerio Massimo 1,8 ext. 7. PROVERBI Homo doctus in se sempre divitias habet L’uomo dotto ha sempre un tesoro dentro di sé La frase assume valore proverbiale per indicare l’autosufficienza del saggio che ha ogni ricchezza dentro di
sé. Esistono altri proverbi simili: in particolare omnia mea mecum porto, «Porto con me tutti i miei beni» (cfr. Tosi 1991, 819; ma anche 169 per l’idea della cultura come tesoro) che peraltro è molto simile all’espressione del v. 14 di Fedro 4,22 [23] («con me […] ho tutte le mie cose»). Il concetto, adattabile a contesti differenti, è riferito per lo più a filosofi: cfr. Cicerone, Paradoxa Stoicorum 1,8; Seneca, De constantia sapientis 5,6-7; Epistulae 9,19. Da segnalare anche una sentenza di Publilio Siro (P 7 Meyer) che ha qualche affinità con il verso fedriano: Patientia animi occultas divitias habet («La pazienza dell’animo ha un tesoro celato in sé»).
Sisifo Figlio di Eolo e di Enareta, marito di Merope, una delle Pleiadi, Sisifo è fondatore e re di Corinto. Ritenuto il più scaltro e inaffidabile tra gli uomini, rivela ad Asopo che è stato Zeus a rapirgli la figlia Egina. Condannato a morte, incatena Thanatos (la morte) e così non perisce più nessuno. Ma Zeus manda Ares a liberare Thanatos. La pena riservata a Sisifo, dopo che è precipitato nel Tartaro, è quella di spingere in cima a un alto monte un enorme masso, che, raggiunta la vetta, precipita subito a valle: il dannato riprende così da capo l’eterna e vana fatica. Sisifo rientra nella galleria dei grandi dannati (sul tema, cfr. anche Lucrezio 3,978 ss.) proposta da Fedro (App. 5 [7]). Nell’ambito della visione pessimistica che caratterizza il favolista, questo illustre esempio, tratto dal mito, spiega come le miserie dell’uomo siano senza fine. La verità coperta dal mito può essere compresa dal saggio, ma non dallo stolto, come spiega l’epimitio di Fedro.
Smaride La smaride è un pesce di mare che compare raramente nella letteratura antica e in genere non si segnala per particolare rilievo. Aristotele (Historia animalium 607b) lo elenca tra i pesci che hanno la caratteristica di mutare colore secondo le stagioni. Nella letteratura latina compare raramente e in contesti specifici (cfr. Ovidio, Halieutica 120 e Plinio, Naturalis historia 32,145). Nella tradizione favolistica è impiegata una sola volta come simbolo di qualcosa di scarso valore (in una versione della favola, attestata da una parte della tradizione manoscritta esopica, la smaride, σμαρίς in greco, lascia spazio alla sardella, μαινίς). La favola di Esopo 26 Ch. ha un’affinità tematica con quella del cane addormentato e del lupo (184 Ch.), anche se il finale è differente. Il pescatore e la smaride Esopo 26 Ch. Un pescatore, dopo avere gettato le reti in mare, tirò su una smaride. Siccome era piccola, questa lo supplicava di lasciarla andare, in considerazione delle sue modeste dimensioni. «Ma quando, una volta cresciuta, sarò diventata un grosso pesce – disse – potrai prendermi, dal momento che diventerò per te molto più utile.» Il pescatore le rispose: «Sarei proprio sciocco se rinunciassi al guadagno che ho tra le mani, anche se è piccolo, e sperassi in quello a venire, per quanto grande». La favola dimostra che sarebbe irragionevole chi rinunciasse a quanto ha tra le mani, sebbene di modesto valore, nella speranza di qualcosa di più grande.
RIFERIMENTI: Babrio 6; Aviano 20.
Socrate Nato nel 470/469 a.C. da uno scultore e da un’ostetrica, Socrate, uno dei più grandi filosofi dell’antichità, non lascia nulla di scritto, ritenendo il suo messaggio comunicabile soltanto per via orale, attraverso il metodo dialettico. Sposato con la bisbetica Santippe, padre di tre figli, vive ad Atene con estrema semplicità, compiendo il proprio dovere di cittadino; nell’ambito della sua attività pubblica di filosofo, esercita il suo forte carisma. Assume una posizione polemica nei confronti della sofistica, di cui non accetta il relativismo rispetto alla verità. L’oracolo di Delfi lo indica come il più sapiente dei mortali (sapiente, nella prospettiva socratica, è colui che sa di non sapere). Fedele ai propri principi, si trova in contrasto sia con il regime oligarchico dei Trenta Tiranni sia con quello democratico. L’ostilità che genera la sua anticonformistica figura, soprattutto da parte delle frange conservatrici di Atene, porta al processo (a cui sono dedicate le Apologie di Platone e di Senofonte) e alla condanna a morte. Nel 399, infatti, viene presentato un atto di accusa secondo cui il filosofo sarebbe colpevole di non riconoscere gli dei della città, di introdurne altri e di corrompere i giovani. Socrate non prende mai in considerazione l’ipotesi dell’esilio, poiché ritiene che le leggi vadano rispettate (si deve lottare per cambiarle, ma non è accettabile infrangerle); accetta, quindi, la condanna a morte eseguita in carcere mediante la somministrazione della cicuta. Le fonti principali sulla sua vita, per motivi differenti non sempre concordi e attendibili, sono Platone, Senofonte, Aristofane e Aristotele. La sua riflessione pone al centro l’anima, intesa come essenza dell’uomo, e cerca di definire il bene nelle sue varie forme. In quest’ottica, sapienza e virtù coincidono: chi conosce il bene non può che metterlo in pratica (intellettualismo). Il metodo dialettico, caratterizzato da un’ironia funzionale a smascherare l’ignoranza, si fonda su
due fasi: la confutazione e la maieutica, nella quale il discepolo partorisce la verità di cui è gravido grazie al maestro, proprio come la puerpera dà alla luce un bambino con l’aiuto dell’ostetrica. Il carisma e l’autorevolezza fanno di Socrate un protagonista naturale dell’aneddotica presente nella favola. La sua figura è equivalente a quella di Esopo e di altri personaggisimbolo della favola, sempre svuotati della loro dimensione storica. Comunque, per alcuni aspetti il suo approccio all’etica sembra accostabile a quello tipico della tradizione esopica, anche perché il suo pensiero rinuncia alla sistematicità; l’aneddotica, che fiorisce soprattutto in età imperiale, rende Socrate figura adattabile a diversi contesti filosofici. Va sottolineato che, nell’immaginario degli antichi, Socrate ed Esopo sono uniti da una serie di analogie indirette e dirette. Si riportano aneddoti in cui sia l’uno sia l’altro dichiarano di non sapere e poi finiscono per prevalere su coloro che, vanagloriosi, credono di sapere; entrambi sono definiti sapienti dall’oracolo di Delfi; secondo una certa tradizione, anche l’umiltà delle origini li accomuna, così come l’estrema bruttezza, posta in rapporto paradossale con l’estrema sapienza. Libanio, nel IV secolo d.C., traccerà persino un parallelo rispetto alla morte (Apologia di Socrate 181). Ma, al di là delle somiglianze «indirette», l’analogia tra i due personaggi «si sviluppa partendo da un’affinità affermata in modo esplicito fin dal IV sec. a.C. […] è Socrate stesso a dichiararsi esopico, secondo Platone» (Jedrkiewicz 1989,114). Così scopriamo che il filosofo mette in versi favole esopiche: nel Fedone (60c-61b) Socrate, in carcere, riflette sul rapporto tra dolore e piacere, sottolineando che Esopo ne avrebbe potuto trarre una favola. In questo modo, «il favoleggiare esopico può dunque essere una forma alternativa del filosofare, del discorrere mirando al vero: letteralmente, un’allegoria» (Jedrkiewicz 1989, 369). Nello specifico, Socrate narra che Piacere e Dolore, in perenne conflitto tra di loro, furono puniti dalla divinità, che, volendo riconciliarli ma non riuscendovi, legò le loro teste insieme,
sicché chi si avvicina all’uno si avvicina allo stesso tempo all’altro. Altri riferimenti a favole collegate al filosofo si riscontrano in Platone (cfr. Simposio 203b-e: la nascita di Eros narrata da Diotima a Socrate; Fedro 259bc; Alcibiade I 123a, dove è nuovamente menzionato Esopo, con riferimento alla narrazione 196 Ch.). Anche Senofonte suggerisce il fatto che il filosofo fa uso di favole (Memorabili 2,7,13). Altre testimonianze antiche vanno in questa direzione. L’uso della tecnica dell’exemplum avvicina, per certi aspetti, Socrate ed Esopo nella classificazione di Aristotele (Retorica 1393a1394a). Dione Crisostomo afferma inoltre che i detti di Socrate e di Diogene il Cinico sono accostabili a quelli di Esopo (Orazioni 79,13). Tutti questi elementi spiegano come e perché il filosofo entra nella favola nelle vesti di saggio, sempre brillante nel confrontarsi dialetticamente con gli altri. In particolare, lo troviamo protagonista in Fedro: si distingue per l’arguzia (3,9) e per la capacità di smascherare la vuota arroganza dei suoi interlocutori (App. 25 [27]). La punizione di un comportamento biasimevole è tipica della tradizione stoico-cinica, che propone aneddoti di questo genere (Adrados 2003, 558). Il gioco di parole con cui, nella seconda favola, Socrate smaschera lo schiavo malvagio si attaglia perfettamente al gusto dell’ironia e del paradosso con cui il filosofo ci viene restituito dalle fonti antiche. In un’altra favola (3,8), Fedro attribuisce a un anonimo padre una battuta che la tradizione riferisce a Socrate: è il segno del valore paradigmatico, non storico, delle situazioni che lo riguardano. Altre narrazioni di carattere satirico, come quella di Socrate che evoca le anime dei morti (Aristofane, Uccelli 1553-1564), non sembrano rientrare nella prospettiva della favolistica, anche se ci segnalano quanto efficace sia, per la sua originale carica ironica, la figura di questo straordinario filosofo. Socrate e gli amici Fedro 3,9
Diffuso è il nome di amico, ma rara è la fedeltà. Mentre Socrate (la cui morte non eviterei se ne conseguissi la fama e accetterei la malevolenza pur di essere assolto, una volta diventato cenere) si stava costruendo una piccola casa mentre un popolano, non so chi, gli chiese, come suole avvenire: «Scusa, tu che sei un uomo così grande, ti fai una casa così piccola?». Rispose: «Magari potessi riempirla di nuovi amici!». Lo schiavo e il padrone Fedro, App. 25 [27] Nessun insulto è più pesante del rimorso Uno schiavo malvagio, che aveva corrotto la moglie del suo padrone, offendeva Socrate; ed egli, poiché sapeva che quel fatto era noto a chi stava lì intorno, disse: «Ti compiaci perché piaci a chi non devi, ma non la passerai liscia poiché non piaci a chi devi piacere». Il fratello e la sorella Fedro 3,8 Ammonito da questo insegnamento, esamina spesso te stesso. Un uomo aveva una figlia bruttissima e un figlio di notevole bellezza. Questi, giocando come fanno i bambini, per caso guardarono dentro a uno specchio, appena posato sulla poltrona della madre. L’uno si vanta per la propria bellezza, l’altra si irrita e non sopporta le provocazioni del fratello vanitoso, prendendo tutto (e perché no?) come un’offesa. Pertanto corre dal padre, decisa a
offendere a sua volta il fratello, e, con grande ostilità, accusa lui, maschio, di avere toccato un oggetto da femmine. Allora l’uomo, abbracciando entrambi e ricevendo baci, distribuì il suo dolce affetto a entrambi. «Ogni giorno – dice – voglio che usiate lo specchio: tu lo userai per non corrompere con i segni della cattiveria la tua bellezza; tu per vincere questo tuo volto con un buon comportamento.» RIFERIMENTI: l’aneddoto è riportato da varie fonti, fuori dalla tradizione favolistica. Generalmente, la battuta del padre è messa in bocca a Socrate (ma anche a Biante). Cfr., in particolare, Diogene Laerzio 2,33; Plutarco, Precetti coniugali 141e; Apuleio, De magia 15; Stobeo 2,31,98.
Soldato Nel mondo antico, la figura del soldato varia profondamente, in relazione ai popoli e alle epoche. In Grecia si assiste a una sua progressiva democratizzazione: si passa dal modello eroico e aristocratico descritto nell’Iliade, fino all’imporsi di una organizzazione differente, basata sulla falange oplitica, costituita da artigiani e mercanti, che non possiedono la terra e sono in grado di armarsi con una spesa minore dei cavalieri. L’organizzazione, dunque, prevale sull’eroismo individuale: dopo il modello dell’epica omerica, il soldato viene pertanto presto smitizzato: salvare la vita è una priorità, anche a costo di commettere il disonorevole gesto di abbandonare lo scudo (Archiloco, fr. 5 W. ). Il paradigma del soldato per eccellenza è naturalmente quello spartano. Infine, in particolare a partire dalla guerra del Peloponneso, le città greche fanno anche ricorso ai servizi dei mercenari. A Roma resta valido, sia in età repubblicana sia in età imperiale, il principio dell’obbligatorietà del servizio militare, ma ha un valore effettivo soltanto sino alla riforma di Mario (107 a.C.), secondo cui non è più necessario, per arruolarsi, avere ricchezze. A quel punto, il soldato cambia il suo profilo, divenendo di fatto proletario e volontario. Il soldato è figura comica per eccellenza, in particolare nella commedia di mezzo in Grecia (prima parte del IV secolo a.C.); in ambito romano, va ricordato Il soldato fanfarone protagonista dell’omonima commedia di Plauto. Secondo Orazio (Satire 1,1), il soldato valuta la propria vita come faticosa e logorante e invidia il mercante, mentre, dal punto di vista del mercante, è una fortuna sapere la propria sorte in breve (vittoria o morte). Nella favolistica, la figura del soldato compare raramente e non trova una particolare e specifica caratterizzazione, come del resto non la trovano nemmeno gli altri personaggi umani. In genere, coerentemente con l’approccio ideologico 2
della tradizione esopica, il soldato è comunque spogliato della dimensione eroica propria dell’epica e arriva perfino ad assumere connotati comici. In Fedro (5,2), troviamo un soldato pauroso che abbandona il compagno nel momento del pericolo, per poi ripresentarsi gagliardo una volta che l’altro ha ucciso il brigante in cui si sono imbattuti. Nella narrazione della matrona di Efeso (Fedro, App. 13 [15]), una novella di larga fortuna, ripresa anche da Petronio nel Satyricon (v. sotto), troviamo un soldato che si innamora di una vedova e non adempie ai suoi doveri. Solo un’astuzia della donna salverà l’uomo dall’inevitabile punizione. Una figura paradossale è invece quella del soldato di Pompeo (Fedro, App. 8 [10]), dalla grande corporatura e dal grande valore, nonostante la voce acuta e i modi femminei. Nelle raccolte esopiche anonime, la figura del soldato appare decisamente meno caratterizzata: nella favola 142 Ch. viene descritto il rapporto tra l’uomo e il suo cavallo, ben nutrito in tempo di guerra, trattato con molto minore riguardo in tempo di pace. La vedova e il soldato Fedro, App. 13 [15] Quanto sono grandi la volubilità e la lussuria delle donne Dopo alcuni anni, una donna perse l’amato marito e pose il suo corpo in un sarcofago. Nessuno riusciva a staccarla dal sepolcro, dove trascorreva l’esistenza piangendo. Ottenne così una splendida fama di casta vedova. Frattanto alcuni ladri, che avevano saccheggiato il tempio di Giove, scontarono la loro pena con la crocifissione per la colpa commessa contro la divinità. Perché nessuno ne trafugasse le spoglie, vennero posti dei soldati come sentinelle dei loro corpi, proprio accanto al sepolcro dove si era rinchiusa la donna. Una volta, in piena notte, una
delle guardie, poiché aveva sete, chiese dell’acqua alla servetta della donna: essa si trovava in quel momento ad assistere la sua padrona, che era in procinto di andare a dormire; infatti aveva lavorato, vegliando fino a tarda ora. Il soldato sbircia dalla porta socchiusa e vede una donna sofferente e molto bella nell’aspetto. Il suo cuore, rapito, resta folgorato e, a poco a poco, l’uomo, innamorato, arde di passione. Trova, allora, astutamente mille motivi per poter vedere la vedova più spesso. Condizionata dalla quotidiana frequentazione, lei, poco alla volta, diventò più disponibile con l’ospite. Presto il contatto sempre più stretto vinse ogni resistenza del suo animo. Mentre la sentinella, premurosa, trascorre lì le notti, viene a mancare un corpo su una delle croci. Il soldato, sconvolto, espone alla donna l’accaduto. Ma quella santa donna dice: «Non devi aver paura» e gli consegna il corpo del marito da appendere alla croce, perché egli non venga punito per la sua negligenza. Così l’infamia prese il posto della lode. RIFERIMENTI: Petronio 111-112; Romulus 59. Cfr. anche Esopo 300 H.-H.; Romanzo di Esopo 129: una versione «esopica», secondo alcuni studiosi, non priva però di significative differenze. I viandanti e il brigante Fedro 5,2 Due soldati avevano incontrato un brigante: uno fuggì, l’altro invece resistette, difendendosi con la forza del suo braccio. Ucciso il brigante, il compagno pauroso accorre, brandendo la spada; quindi, dopo essersi tolto il mantello, dice: «A lui penso io! Farò subito in modo che si accorga di chi ha attaccato».
Allora il soldato che aveva combattuto disse: «Vorrei che tu mi avessi aiutato poco fa, almeno con queste parole; sarei stato più forte, sapendo che erano sincere. Ora rimetti via la spada e anche la lingua, ugualmente futile! Sebbene tu possa ingannare gli altri, che non ti conoscono, io, che ho sperimentato con quale velocità scappi, so che non si deve dare credito al tuo valore». Questo racconto si addice a colui che è coraggioso nella buona sorte, ma scappa di fronte al pericolo. NOTA: rispetto al testo di Müller, si cambia la punteggiatura, come fanno anche altri editori: si pone un punto anziché una virgola prima di ut (v. 11) e una virgola anziché un punto dopo fallere, alla fine dello stesso verso.
Sole (Helios) Figlio dei titani Iperione e Teia, fratello di Selene (luna) ed Eos (aurora), Helios è il dio del sole, padre di numerosi figli, fra cui Circe e Fetonte. Dopo essersi alzato al mattino da Oceano, attraversa la volta celeste, trasportando il sole tirato da cavalli che spirano fuoco dalle narici; e alla sera torna a tuffarsi nell’Oceano. Divinità minore della mitologia greca, dotata di straordinaria bellezza, nel tempo tende a confondersi con Apollo. Il suo culto è molto radicato ad Argo, in Elide e a Rodi. Gli sono sacri, fra gli animali, il bue e specialmente il gallo, incaricato di annunciare il giorno. Il Sole compare in due sole favole esopiche e viene puntualmente associato alla luce e al calore che promana. Le rane, sciocche, gioiscono alla notizia delle sue nozze, che si celebrano naturalmente in estate: non considerano tuttavia i patimenti che potrebbero derivare da un figlio simile a lui (Esopo 127 Ch.). In una sfida con il vento del Nord, Borea, finalizzata a indurre un uomo a denudarsi, il Sole ha la meglio: il progressivo calore che induce l’uomo a spogliarsi diventa nell’epimitio sinonimo di efficace persuasione, mentre la violenza del vento induce il malcapitato a stringersi nelle vesti, producendo così l’effetto opposto a quello desiderato, secondo il principio, tipicamente esopico, dell’ambivalenza dell’azione (Esopo 73 Ch.). Il Sole e le rane Esopo 127 Ch. Durante l’estate, si tenevano le nozze del Sole: tutti gli animali si rallegravano per l’avvenimento e
ne gioivano anche le rane. Una di loro disse: «Perché gioite, sciocche? Infatti, dal momento che da solo il Sole secca ogni pantano, se dopo le nozze genererà un figlio simile a sé, quali mali dovremo mai patire?». Molti, fra coloro che hanno poco cervello, gioiscono a causa di fatti che non presentano alcun motivo per rallegrarsi. RIFERIMENTI: Babrio 24; Fedro 1,6; Parafrasi 128; Tetrastici 1,12; Romulus 10.
Sparviero (falco) Uccello sacro al Sole, venerato soprattutto in Egitto, lo sparviero si confonde con il nibbio e con il falco (su cui esiste una ricca serie di racconti mitologici: cfr. Cattabiani 2000, 454 ss.), sia nel lessico e nell’identificazione, sia sul piano simbolico. Appare interessante la distinzione di Apollodoro (Sull’interpretazione dei sogni 2,20), secondo cui il falco corrisponde a una donna bella, assennata e di condizione regale, mentre lo sparviero e il nibbio corrispondono invece a briganti e a pirati; nello specifico, lo sparviero suggerisce coloro che assaltano all’aperto. In effetti, l’uccello colpisce l’immaginazione degli antichi per la sua rapacità e il suo volo perpendicolare dall’alto del cielo verso terra; come tutti i falconidi, inoltre, si ritiene che la sua vista sostenga la luce del sole. Tra le curiose credenze che lo riguardano, va segnalata quella secondo cui, poiché è simbolo dell’anima, beve sangue e non acqua, stando alla convinzione degli Egizi (Orapollo, Geroglifici 1,7). Eliano (De natura animalium 12,2) lo indica come il favorito del dio Hermes, ma, ancora secondo quanto afferma Orapollo a proposito degli Egizi, la coppia di sparvieri – maschio e femmina – rappresenta Afrodite e Ares per le modalità dell’accoppiamento, che vedono la femmina totalmente sottomessa al maschio. Nella tradizione favolistica, la figura dello sparviero sembra intercambiabile, sul piano narrativo e simbolico, con quella del nibbio (i due uccelli sono, peraltro, accostati in vari contesti letterari: cfr. Terenzio, Formione 330 ss.): addirittura lo sostituisce nella tradizione in prosa della favola di Fedro 1,31. Rispetto al nibbio, lo sparviero si segnala per le minori dimensioni. Generalmente, va a rappresentare l’arroganza dei potenti nei confronti dei
subalterni, raffigurati per lo più tramite volatili inermi (ma lo sparviero può rapire anche un’anguilla: Semonide, fr. 9 W ). Per questo motivo è presente soprattutto in Fedro e nella tradizione delle favole in prosa che derivano dal poeta latino, sempre molto attento alle violente dinamiche socioeconomiche che caratterizzano la società del suo tempo. Nelle vesti di potente senza pietà lo troviamo protagonista di due favole in cui si trova di fronte all’usignolo, che può opprimere senza alcun motivo o magari con qualche pretesto, non rispettando i patti (Esiodo, Le opere e i giorni 202 ss.; Romulus 55). Altre vittime designate sono l’oca (Romulus 80) e l’indifeso passero (Fedro 1,9). La sua malvagità, che talvolta (come appunto in Romulus 55) può essere punita, si manifesta anche nei confronti del gallo, che vorrebbe la protezione del rapace ma ne diventa vittima (Romulus 7): questa favola, che deriva da Fedro, sembra trovare il suo modello nella vicenda dei due galli che combattono tra di loro, prima che il vincitore, superbo, sia ghermito dall’aquila (Esopo 20 Ch.). Lo sparviero sembra, insomma, un perfetto protagonista delle crudeli dinamiche che caratterizzano il mondo esopico. 2
I galli e lo sparviero Romulus 7 Un gallo, molto spesso in lotta con un altro gallo, chiese protezione allo sparviero. Sperava, infatti, che il rapace, quando entrambi fossero giunti di fronte a lui, avrebbe divorato il gallo che egli conduceva con sé. Giunti davanti al giudice per esporre la loro causa, lo sparviero ghermì quello che per primo si era rivolto al suo giudizio. Allora il gallo esclamava: « Non sono io, ma quello che fugge!». A lui rispose lo sparviero: «Non pensare di liberarti adesso dai miei artigli, poiché è giusto che tu subisca la macchinazione che volevi realizzare contro l’altro».
Per quelli che tramano la morte degli altri e ignorano che cosa si prepara contro loro stessi. L’usignolo e lo sparviero Romulus 55 Chi tende insidie ad altri, deve temere di essere preceduto dalla sua malizia, come dimostra questa favola. Lo sparviero, appollaiato sul nido dell’usignolo per fare la posta a una lepre, trovò lì i piccoli dell’uccello. Tornato in fretta, l’usignolo lo supplicava di risparmiare i suoi nati. «Farò quanto chiedi – disse lo sparviero – se ti esibirai per me in un bel canto.» L’usignolo, per quanto fosse scoraggiato, tuttavia, spaventato, costretto dalla paura e pieno di dolore, cantò. Lo sparviero sfrontato, trovata una preda, non intendeva lasciarla andare: «Non hai cantato bene» disse; e ghermì uno dei suoi piccoli, cominciando a divorarlo. Dalla parte opposta, arrivò un cacciatore, e, alzata in silenzio la canna, fece precipitare a terra lo sparviero, invischiato. Chi prepara macchinazioni contro gli altri deve temere di esserne vittima.
Spugna Le spugne sono apprezzate dagli antichi, che se ne servono per diversi usi, ma, come emerge già dai poemi omerici, soprattutto per operazioni di pulizia (cfr., ad esempio, la pulizia di mense e seggi descritta in Odissea 22,438 ss.). La loro appartenenza al regno animale è presto compresa e approfondita. Aristotele si sofferma a lungo sulla loro descrizione e classificazione (Historia animalium 487b; 548a-b). Molto noti, nell’antichità, sono anche i pericoli che corrono i pescatori di spugne. Nella favolistica la spugna compare una sola volta, nella comica narrazione dell’asino che, caduto in acqua con un carico di sale, si rialza ovviamente più leggero, ma, quando volontariamente (e stoltamente) ripete la stessa azione con un carico di spugne si appesantisce e annega (Esopo 265). La spugna, dunque, è uno strumento che assolve a una funzione tipica della favola: smascherare l’ottusità di un personaggio che non sa leggere dietro le apparenze. L’asino carico di sale Esopo 265 Ch. Un asino che portava del sale, attraversando un fiume, scivolò e cadde nell’acqua. Allora il sale si sciolse e l’asino si alzò più leggero. Felice per quanto era accaduto, quando poi un’altra volta, carico di spugne, arrivò presso un fiume, pensò che, se fosse caduto di nuovo, si sarebbe alzato più leggero. E così scivolò apposta. Accadde che, a causa delle spugne imbevute d’acqua, non riuscì più ad alzarsi e lì affogò. Così anche alcuni fra gli uomini non si rendono conto di precipitare nella sventura, a causa dei loro pensieri.
RIFERIMENTI: Babrio 111; Parafrasi 266; Dodecasillabi 266; Tetrastici 1,57; Eliano, De natura animalium 7,42; Plutarco, L’intelligenza degli animali 971b; Pseudo-Luciano, L’asino 31,4; Apuleio, Metamorfosi 7,20.
Stagioni La divinizzazione e la personificazione delle stagioni appartiene, in varia forma, a tutte le culture antiche. Nella mitologia greca, le Ore, figlie di Zeus e di Temi, presiedono ai periodi dell’anno e ai relativi cicli vitali: Tallo rappresenta la primavera; Auso, invece, l’estate, mentre Carpo va a raffigurare l’autunno. Esistono vari culti di differente origine, che evolvono o si sovrappongono. Ad esempio, in origine Marte, noto come dio della guerra, è considerato dio della primavera in lotta contro l’inverno (Ramorino 69). Inoltre, importante nella tradizione italica è Flora, dea della primavera e dei fiori, di origine sabina, il cui culto viene introdotto a Roma da Tito Tazio: è celebrata, nell’ambito delle feste dette Floralia, alla fine di aprile. La contesa tra le stagioni affonda le sue radici addirittura nella letteratura mesopotamica. Nell’ambito del mito dei due fratelli Emesh (dio dell’estate) ed Enten (dio dell’inverno), già si trova un dibattito che vede a confronto le due stagioni: prevale l’inverno (cfr. Kramer 195 ss.). Questo schema tipicamente orientale della contesa viene ripreso nella raccolta di Esopo (346 Ch.), per quanto la favola appaia chiaramente differente dal precedente mesopotamico: di fronte alla provocazione dell’inverno, la primavera replica ricordando la gioia provocata dal suo arrivo. Secondo Adrados 2003, 363, un’eco sarebbe rinvenibile nelle Satire di Ennio (II p. 207 dell’edizione di Vahlen). L’Inverno e la Primavera Esopo 346 Ch. L’Inverno si prese gioco della Primavera, rinfacciandole il fatto che, appena lei compare, nessuno sta più tranquillo, ma uno va nei prati, uno
nei boschi, a questo poi piace cogliere fiori e gigli o intrecciare intorno agli occhi una rosa e adornarsene la chioma; un altro si imbarca e, attraversando il mare, se la sorte lo assiste, giunge subito presso genti straniere; e nessuno si preoccupa più dei venti o delle piogge copiose. «Io – disse l’Inverno – sembro un dominatore o un sovrano assoluto, e ordino di guardare non verso il cielo, ma giù sulla terra e costringo le persone ad avere paura e a tremare, rassegnandosi a trascorrere talvolta le giornate in casa.» La Primavera gli rispose: «Per questo gli uomini farebbero volentieri senza di te; trovano invece bello anche il mio nome, certo il più bello di tutti i nomi, per Zeus, così che quando me ne vado, mi ricordano, e quando compaio, si rallegrano».
Struzzo Aristotele descrive lo struzzo come un animale che presenta caratteristiche proprie di un uccello, pur non riuscendo a volare, e altre tipiche di un quadrupede, pur essendo un bipede come gli uccelli (Le parti degli animali 697b). Plinio (Naturalis historia 10,1) ne sottolinea le dimensioni, ma anche la stupidità. Secondo Oppiano di Apamea (Cynegetica 3,482 ss.), questa creatura, ibrida, unisce le caratteristiche del cammello e quelle del passero. Questa ambiguità si ritrova nell’unica favola dedicata allo struzzo (Tetrastici 1,22), che, comportandosi come il pipistrello di Romulus 54, conferma – nella morale – quanto poco apprezzato sia il tentativo di appartenere a due mondi contrapposti, in una società, come quella esopica, rigidamente articolata in realtà separate. In genere, tuttavia, tale tentativo viene castigato: così, ad esempio, nella favola di Esopo 193 Ch., in cui il gabbiano, che cerca cibo sul mare, viene (giustamente, secondo la morale) punito con la morte. Lo struzzo Tetrastici 1,22 Ci fu una battaglia tra tutte le bestie di terra e gli uccelli. Una volta catturato, lo struzzo ingannò entrambi gli schieramenti, facendosi passare ora come un uccello, ora come un animale di terra: mostrò ai volatili la sua testa e alle bestie i suoi piedi. [Non è possibile fidarsi di un’ambigua alleanza.]
T
Talpa Nella cultura occidentale la talpa è simbolo di cecità, ottusità e misantropia (cfr. Cooper 324). A partire da Aristotele (Metafisica 1022b; Historia animalium 491b; 533a), si insiste sul fatto che l’animale non possiede la vista. D’altra parte, questa mancanza sarebbe compensata dall’ottimo udito: secondo alcune credenze, la talpa sente assai bene i discorsi degli uomini, ma se qualcuno parla di lei è veloce a fuggire (cfr. Plinio, Naturalis historia 10,191). Nella cultura ebraica è considerata un animale impuro (Levitico 11,30); in quella cristiana diventa simbolo di avarizia. Nel mito, la troviamo solo nella vicenda di Fineo, re della Tracia, trasformato da Fetonte in una talpa. Poiché vive sotto la superficie terrestre, è posta in relazione con l’aldilà e con le forze della terra. In Grecia e in India è associata a divinità guaritrici (Asclepio e Rudra). La tradizione favolistica sembra in linea con l’elaborazione che la cultura antica fa della figura di questo animale, anche se la talpa compare in una sola narrazione (Esopo 326 Ch.), dal tono decisamente umoristico, e si presenta come simbolo di vanagloria. Viene immediatamente puntualizzata la caratteristica della cecità: e il piccolo della talpa sembrerebbe anche confermare la non spiccata intelligenza attribuibile all’animale. La talpa e sua madre Esopo 326 Ch. Una talpa (è un animale cieco) disse a sua madre che ci vedeva. Quella allora mise alla prova il figlio e gli diede un grano d’incenso, chiedendogli che cosa fosse. Il piccolo rispose che si trattava di una pietra; allora la madre disse: «Figliolo, non solo sei cieco,
ma non hai più neanche l’olfatto». Così alcuni tra gli uomini vanagloriosi promettono imprese impossibili e sono sbugiardati in questioni di poco conto. RIFERIMENTI: Dodecasillabi 327; Parafrasi 327. PROVERBI Tυϕλóτερoς ἀσπάλακoς Più cieco di una talpa La credenza, che dà lo spunto anche alla favola di Esopo, è testimoniata dai paremiografi (ad esempio, Apostolio 17,35; Diogeniano 8,25) e ha ampia fortuna in vari contesti: è ripresa anche dai cristiani (Girolamo, Epistulae 84,7: «Avete gli occhi di una talpa»). Ancora oggi è presente in diverse tradizioni culturali europee (cfr. Tosi, 1991, 334).
Tantalo Figlio di Zeus (secondo alcune versioni, di Tmolo) e di Pluto (secondo altre fonti, di Taigeta), ricco re della Lidia (o della Frigia), Tantalo, secondo una leggenda non priva di significative varianti, avrebbe dato in pasto agli dei il figlio Pelope o avrebbe rivelato i segreti degli dei, di cui era commensale, e avrebbe anche sottratto ambrosia e nettare dal loro banchetto. La sua condanna nell’Ade consiste nell’essere immerso dentro l’acqua fino al mento, mentre su di lui si protendono rami di alberi da frutta: quando prova a bere o a mangiare, acqua e cibo si allontanano da lui. Tantalo compare in una sola favola di Fedro (App. 5 [7]), in cui, attraverso una lettura allegorica di impronta stoicocinica, si passano in rassegna i grandi dannati del mito. Si tratta di una narrazione certamente anomala, che «di esopico ha tuttavia il motivo dell’ambiguità delle cose narrate, del “rovesciamento” che fa apparire sotto una luce ben diversa quanto generalmente si afferma» (Solimano 303). Il mito è, in quest’ottica, la rappresentazione di una verità morale: l’accostamento dell’avaro a Tantalo è tipico della letteratura diatribica (cfr. Orazio, Satire 1,1,68 s.).
Tartaruga Le tartarughe, sacre ad Afrodite (Venere) e Hermes (Mercurio), sono poste in relazione al potere delle acque e spesso vanno a rappresentare la perseveranza e la tenacia (cfr. Cooper 328 s.). Gli antichi descrivono con curiosità i loro costumi: i maschi sono considerati lussuriosi, le femmine frigide. Plinio (Naturalis historia 32,32) ne cataloga quattro specie: terrestri, marine, fangose e d’acqua dolce. Il loro lentissimo incedere assume connotati proverbiali ed è presente in vari contesti letterari: ad esempio, nella commedia plautina, dove si trova l’espressione proverbiale Testudineus gradus (Aulularia 48 s.), ossia «Passo da tartaruga», che sembra presupporre un racconto: a tale proposito, Della Corte 1958, 41 ha proposto un riferimento alla narrazione di Achille e della tartaruga; nell’antichità è assai noto il paradosso di Zenone di Elea (filosofo nato intorno al 500 a.C.), relativo all’eroe, piè veloce, e al lentissimo animale, che si sfidano in una corsa. Per rendere la gara più equilibrata, Achille concede un vantaggio alla tartaruga. Ma, secondo Zenone, l’eroe non raggiungerà mai la tartaruga perché dovrebbe prima arrivare dove si trovava l’animale, che, intanto, avrà raggiunto una nuova posizione di vantaggio: così di seguito per gli ulteriori spostamenti, in un processo all’infinito in cui la distanza tra i due non arriverà mai a essere pari a zero. L’intento di Zenone è quello di dimostrare che i sensi sono fallaci e che il movimento è impossibile. Proprio la proverbiale lentezza della tartaruga (cfr. Otto 346) è al centro anche di una nota favola, che presenta qualche affinità con il paradosso del filosofo. Si tratta di Esopo 352 Ch. dove vengono messi a confronto due personaggi agli antipodi: la tartaruga e la lepre, che soccombe di fronte alla meno dotata avversaria. La narrazione è di lunga fortuna: si riscontrano riprese e
allusioni in vari autori. Nel dramma satiresco Onfale di Acheo, fr. 34 N. , leggiamo: «Il veloce talora dai deboli è preso e l’aquila dalla tartaruga, in un batter d’occhio». Tale frammento, che secondo Diogene Laerzio (2,17) il filosofo Menedemo di Eretria era solito citare contro gli avversari politici, è forse riconducibile a questa favola, nonostante la diversità dei personaggi (cfr. Van Dijk 1997, 184). La favola esopica 125 Ch. narra invece l’origine mitica della tartaruga e sottolinea l’abitudine di portare sempre la propria abitazione con sé. A proposito di tale vicenda, Servio (commento a Virgilio, Eneide 1,105) spiega il mito relativo alla ninfa Chelona (in greco χελώνη), che, rifiutando scortesemente di partecipare alle nozze di Zeus e di Era, nonostante l’invito di Hermes, venne trasformata in una tartaruga. La casa, che la ninfa non voleva abbandonare neppure temporaneamente per andare al matrimonio, divenne così una parte del suo corpo. Il legame tra la tartaruga e la sua abitazione diventa proverbiale (v. sotto) e il concetto viene ripreso in vari contesti letterari (Plutarco, Tito Flaminino 17,12; Livio 36,32,6). Tartaruga e aquila sono al centro anche di un’altra favola di larga diffusione (Esopo 351 Ch.), da cui deriva forse un proverbio (v. sotto): la tartaruga, che desidera volare, finisce per essere gettata a terra dall’aquila (in Fedro 2,6 troviamo anche un terzo personaggio, la cornacchia, nel ruolo di malvagio consigliere della sovrana degli uccelli). Va sottolineato che l’immagine della tartaruga lanciata dall’aquila è abbastanza diffusa, anche al di là della tradizione favolistica. Eliano (De natura animalium 7,16) narra un’altra nota storiella, secondo cui il poeta tragico Eschilo venne ucciso da una tartaruga che un’aquila fece cadere dal cielo, scambiando la testa senza capelli dell’uomo per una roccia. Nella tradizione indiana del Pañcatantra, troviamo la tartaruga trasportata da due hamsa, uccelli mitici che le sono amici, da una zona colpita da siccità verso un lago, ma, nel corso del viaggio attraverso l’aria, la tartaruga reagisce ai commenti della gente e lascia andare il 2
bastone che la sostiene, finendo per precipitare al suolo (primo tantra, racconto dodicesimo). La tartaruga e la lepre Esopo 352 Ch. Una tartaruga e una lepre discutevano animatamente a proposito di chi fosse più veloce. Dopo aver fissato un giorno e un luogo, partirono. La lepre non si preoccupò della corsa, dato che era velocissima per natura e, adagiatasi lungo la strada, prese a dormire. La tartaruga, invece, che ben sapeva di essere lentissima, continuò a correre e così, superando la lepre addormentata, arrivò ad ottenere il premio della vittoria. La favola mostra che frequentemente la fatica prevale su doti naturali trascurate. RIFERIMENTI: Parafrasi 353; Codice Brancacciano 3; Dodecasillabi 353; Libanio 2 H.-H. La favola è di lunga fortuna: cfr., in particolare, Acheo, Onfale fr. 34 N. , frammento che il filosofo Menedemo di Eretria era solito citare contro gli avversari politici, secondo Diogene Laerzio 2,17; cfr. inoltre Plutarco, Sulle nozioni comuni contro gli Stoici 1082e. Per le altre possibili allusioni, molte delle quali ancora di Libanio, v. Adrados 2003, 319. 2
Zeus e la tartaruga Esopo 125 Ch. Il giorno del suo matrimonio Zeus invitò tutti gli animali al banchetto nuziale. Soltanto la tartaruga risultò assente: il dio, che faticava a capirne la
ragione, l’indomani le chiese per quale motivo non fosse venuta al banchetto. Allora la tartaruga rispose: «Casa propria, eccellente casa». Zeus si sdegnò nei suoi confronti e la costrinse a caricarsi la sua abitazione sulle spalle e a condurla in giro con sé. Allo stesso modo, molti uomini preferiscono abitare senza lussi a casa propria piuttosto che vivere negli agi presso altri. RIFERIMENTI: cfr. Stobeo 4,16,7 cita un passo dei Meliambi di Cercida (fr. 7 Lomiento); Appendix Proverbiorum 4,15; Apostolio 12,39; Suda ει 291 Adler. Cfr. anche il commento di Servio a Virgilio, Eneide 1,105. PROVERBI Πρóτερoν χελώνη παραδραμεîται δασύπoδα Prima la tartaruga supererà in velocità la lepre Il proverbio, fondato sulla nota lentezza della tartaruga in opposizione a un animale assai più veloce come la lepre, indica chiaramente, come chiosano i paremiografi, un’azione impossibile e perciò diventa proverbiale (Diogeniano 7,57; Diogeniano Vind. 3,63; Apostolio 5,82; 14,88; Suda π 2875 Adler; Libanio, Epistole 74). Appare chiaro il collegamento con la favola di Esopo 352 Ch., peraltro orientata verso un positivo intento morale, visto che sottolinea il valore della fatica. Testudo volat La tartaruga vola Questa azione, ritenuta impossibile, assume un valore proverbiale (Claudiano, Contro Eutropio 1,352) e trova espressioni equivalenti anche in ambito greco, persino nella stessa favolistica (cfr. Luciano, Antologia Palatina 11,436; Babrio 115). Appare evidente il collegamento con la favola di Esopo 351 Ch., che presenta una tartaruga desiderosa di volare: l’aquila la accontenta ma poi la fa precipitare a terra.
In altre versioni, in particolare in Aviano (2), emerge esplicitamente la necessità morale, tipicamente esopica, di non bramare quanto non appartiene alla nostra natura. Oἶκoς ϕίλoς, oἶκoς ἄριστoς Casa propria, eccellente casa Il proverbio, attestato non solo nella tradizione paremiografica (v. i passi citati a proposito della favola 125 Ch.), ma anche in Cicerone (Epistulae ad Atticum 4,8,1; 15,16a), ha diverse riprese nella tradizione medievale (cfr. Tosi 1991, 485). La tartaruga, nella favola, diventa la perfetta testimonianza del proverbio: del resto, negli stessi paremiografi si ritrova esplicito riferimento all’animale. Va ricordato che ancora oggi sono molto diffuse le espressioni proverbiali riconducibili concettualmente alla favola e all’antico detto (ad esempio: «Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia»).
Tempo (Kairos/ Occasione/Giorno) Il tempo è considerato dagli antichi sotto vari punti di vista: nella sua sequenzialità (χρóνoς in greco e tempus in latino), nella sua durata eterna (αἰών in greco ed aevum in latino) o come attimo fuggente, opportunità (καιρóς in greco e occasio in latino). Nel sistema mitologico, Kairos è nipote di Crono e figlio di Zeus. Aion è figlio di Crono. Il Giorno è figlio di Erebo e della Notte (o, secondo un’altra tradizione, deriva da Caos e Caligine). In Fedro (5,8) si ritrova una narrazione di carattere allegorico, che si rifà probabilmente a una scultura di Lisippo. Il tempo corre con un piede sul filo del rasoio, che rappresenta l’attimo fuggente, l’occasione. Condannando ogni indugio dovuto alla pigrizia, il favolista «radica nel principio di azione tutta la vita, e stabilisce un’antitesi fondamentale tra la moralità dell’azione e l’immoralità dell’infingardaggine» (Solimano 293). Intorno al tema dell’occasione sono costruite numerose narrazioni esopiche: ad esempio, quella del medico che elenca le cure necessarie quando il paziente è già morto (Esopo 134 Ch.) o quella del capretto che sbeffeggia il lupo, quando le circostanze glielo consentono (Esopo 107 Ch.). Da segnalare anche un’altra favola, che vede protagonisti il Giorno di Festa e il Giorno Dopo (Plutarco, Temistocle 18): la loro personificazione è funzionale, come è tipico della tecnica esopica, a esprimere un conflitto concettuale dagli esiti paradossali. Non hanno nulla a che vedere con la sfera mitologica. Il Tempo Fedro 5,8
Con una corsa alata, sospeso sul filo del rasoio, un calvo, con un ciuffo in fronte (se sei riuscito a prenderlo, tienilo stretto; una volta sfuggito, neppure lo stesso Giove potrebbe riprenderlo), suggerisce che l’occasione è fugace. Perché il lento indugio non ostacolasse la realizzazione dei nostri progetti, gli antichi elaborarono questa rappresentazione del Tempo. RIFERIMENTI: il testo è anomalo e non presenta paralleli in senso stretto; tuttavia, esistono varie descrizioni della statua di Lisippo. Cfr. Van Dijk 1997, 6 n. 20. V. anche Mattiacci 2011. Il Giorno di Festa e il Giorno Dopo Plutarco, Temistocle 18 Il Giorno Dopo ebbe una disputa con il Giorno di Festa. Affermava che quello era pieno di occupazioni e di noie, mentre con lui tutti godevano in ozio dei preparativi portati a termine in precedenza. «Vero – rispose a questa osservazione il Giorno di Festa – ma se non ci fossi stato io, tu non ci saresti.»
Terra (Gea) Personificazione della Terra, madre della natura, Gea (Tellus per i Romani, che la identificano con Cerere) trae origine dal Caos (cfr. Esiodo, Teogonia 116 ss.) e genera Urano (il cielo). Dall’unione tra la Terra e il figlio Urano nascono i Titani, i Ciclopi, i tre mostruosi Centimani; quindi, fecondata dal sangue di Urano evirato da Crono su suggerimento di Gea (mito spiegato, sul piano antropologico, con l’esigenza di separare la terra dal cielo, che in origine si temeva potesse precipitare), nascono anche i Giganti, le Erinni e le Melie. Dall’unione con il figlio Ponto (il mare), vedono la luce Nereo, Taumante, Forco, Ceto ed Euribia. Divinità di antichissimo culto, la Terra continua comunque a essere venerata anche dopo che si sono imposti gli dei olimpici. Viene poi confusa con Cibele e Demetra. L’antichità del culto della Terra sembra confermata anche nella favola in cui, in origine, dopo che Zeus ha plasmato l’uomo e la donna, invia Hermes a insegnare loro come procurarsi da mangiare: chi scava la terra per cibarsi è destinato a offrire l’estremo, doloroso tributo a essa nel momento della fine della vita (Esopo 109 Ch.). Al centro della narrazione, di impronta cinica, si trova, dunque, il tema dell’ineluttabilità della morte, mentre l’epimitio sposta l’interpretazione morale sulla sofferenza dovuta alla restituzione del prestito. La Terra compare poi in una narrazione di carattere eziologico (Esopo 19 Ch.), in cui, non senza ironia, il favolista, che è anche narratore interno, illustra una sorta di «cosmogonia acquatica» (Martínez Vázquez 35 ss.). In un’altra favola, un contadino, zappando, trova un tesoro e così comincia a onorare con ghirlande la dea Terra, attribuendole il merito della scoperta, ma si fa
avanti la Fortuna a rivendicare per sé quegli onori (Esopo 84 Ch.). Hermes e la Terra Esopo 109 Ch. Zeus plasmò l’uomo e la donna; poi ordinò a Hermes di portarli sulla Terra e di indicare loro dove, scavando, si potevano procurare del cibo. Hermes eseguì il comando, ma all’inizio la Terra gli si opponeva. Poiché Hermes la costringeva a fare quello che – diceva – Zeus aveva ordinato, la Terra disse: «Scavino pure quanto vogliono, infatti mi ripagheranno con pianti e lamenti». La favola è adatta a coloro che facilmente prendono in prestito, ma restituiscono con sofferenza. Esopo in un cantiere navale Esopo 19 Ch. Esopo, il favolista, un giorno in cui non aveva niente da fare entrò in un cantiere navale. Gli operai lo deridevano e lo provocavano perché egli replicasse; allora Esopo prese a raccontare che anticamente c’erano il caos e l’acqua, ma Zeus volle far nascere un altro elemento, la Terra, e consigliò a quest’ultima di inghiottire il mare in tre riprese. Allora la Terra cominciò ad assorbire l’acqua: con il primo sforzo fece comparire i monti; con la seconda sorsata, scoprì anche le pianure. «Se decide di bere per la terza volta – disse – la vostra arte diventerà inutile.» La favola dimostra che quanti sbeffeggiano coloro che sono migliori di loro, si procurano da questi, senza avvedersene, fastidi più grandi.
RIFERIMENTI: Aristotele, Meteorologica 356b.
Tiberio Imperatore romano appartenente alla dinastia giulioclaudia, Tiberio (42 a.C.-37 d.C.) è figlio di Tiberio Claudio Nerone e di Livia Drusilla, che sposa in terze nozze Augusto. Si distingue fin da giovane per le doti militari, ma è messo da parte dal patrigno, che gli preferisce l’altro figliastro, Druso. Decide così di allontanarsi da Roma volontariamente, andando a vivere per otto anni a Rodi. Tuttavia, dopo la morte di Druso e dei nipoti Gaio e Lucio Cesare, Augusto si decide a designarlo per la successione, costringendolo però a adottare il nipote Germanico. Nel 14 d.C., Augusto muore e Tiberio gli succede: di posizione conservatrice, cerca da subito la collaborazione del Senato senza cedimenti alla tentazione del dispotismo: il suo intento è quello di riaffermare e consolidare la politica e l’architettura istituzionale augustea. Tuttavia Germanico, che gode di grande popolarità, muore ad Antiochia, nell’ambito di una spedizione in Oriente (19). Si comincia a creare un clima di sospetto intorno a Tiberio, che favorisce anche l’ascesa della sinistra figura del prefetto del pretorio Seiano, mentre egli nel 27 decide di ritirarsi a Capri. Seiano, con il terrore e con le delazioni, accresce enormemente il suo potere, tramando contro i possibili successori dell’imperatore: dopo avere goduto di notevole favore, viene però condannato a morte nel 31. Gli ultimi anni della vita di Tiberio, che resta sempre lontano da Roma, sono segnati da un clima di incertezza e di paura; dopo la sua morte, nel 37 gli succederà Caligola. La storiografia romana di orientamento repubblicano offre un ritratto ostile all’imperatore: Tacito, negli Annali (1-6), ne descrive una graduale trasformazione in tiranno, che svela la sua vera natura, crudele e spietata, con una notevole abilità nella simulazione. Anche Svetonio, nel De vita Caesarum, sottolinea come a Capri l’imperatore faccia emergere «i vizi mal dissimulati per molto tempo», segnalandosi per la
notevole malvagità, ancora più marcata dopo la morte di Seiano (cfr. soprattutto Tiberio 42; 61-62). Gli studiosi tendono oggi a offrirne un ritratto più equilibrato, che evidenzia anche diversi aspetti positivi, come il profilo di buon amministratore nell’attività di governo. La figura di Tiberio rappresenta un’anomalia nella tradizione favolistica. L’imperatore non assume il valore puramente simbolico dei grandi personaggi, come Socrate e lo stesso Esopo, ma è calato pienamente nella sua dimensione storica, nell’amata villa di Miseno (proprio a Miseno troverà la morte, come ci attestano varie fonti). Tiberio è contemporaneo del liberto Fedro (si è anche supposta la presenza del favolista a Miseno) e diviene perciò protagonista di una vera fabella: ossimoro che indica un aneddoto storico, dall’ambientazione abbastanza circostanziata, grazie ai numerosi dettagli di carattere geografico. Al momento della composizione, questa narrazione doveva apparire come un curioso fatto di cronaca di corte, forse già noto per via orale a qualche lettore. Restano, tuttavia, alcuni elementi tipici della favola: la struttura a due personaggi, il rovesciamento della situazione, la bivalenza dell’azione e l’ambiguità del valore attribuito a essa. Lo schiavo atriense (un portinaio addetto all’atrium, la grande sala delle case romane posta dopo il vestibolo) cerca di cogliere l’occasione per mettersi in luce di fronte a Tiberio, ma il suo zelo è oggetto di riso e diventa l’esempio negativo di una certa categoria di persone stolte. Su di loro Fedro esercita la sua vena satirica. Il comportamento del portinaio assume da subito connotati comici, e la battuta finale dell’imperatore fa riferimento al buffetto che viene dato dal padrone al momento dell’affrancamento dello schiavo. Il personaggio di Tiberio è molto lontano dalla descrizioni di Tacito e di Svetonio e più vicino al profilo elogiativo tracciato da altri autori, come Velleio Patercolo, che lo indica come una persona onesta e restia al potere, desideroso di essere un cittadino come gli altri (2,124,2). In questa narrazione l’imperatore appare in
una chiave positiva, come un saggio non incline ad assecondare il servilismo. Lo stesso Tacito, d’altra parte, ne suggerisce il profilo di un uomo insofferente nei confronti degli uomini servili (Annali 3,65). L’imperatore potrebbe essere stato protagonista anche di altre narrazioni fedriane poi andate perse, perché una parte della tradizione manoscritta nel titolo riporta un’espressione interpretata come item (ma Havet pensa a un fraintendimento: si indicherebbe invece il nome, abbreviato, di Tiberio). Cesare e lo schiavo atriense Fedro 2,5 C’è un popolo di faccendoni a Roma che continua a correre frettolosamente di qua e di là, impegnato pur senza avere autentiche occupazioni, affannato senza un motivo, che fa molte cose senza farne alcuna, fastidioso per se stesso, insopportabile agli altri. Vorrei correggere questa genia, se fosse possibile, con un aneddoto tratto dalla realtà: vale la pena di prestare attenzione. Cesare Tiberio, mentre si dirigeva a Napoli, era giunto alla sua villa di Miseno, che, realizzata per iniziativa di Lucullo sulla sommità del promontorio, si volge verso il mare di Sicilia e guarda, dietro, il mar Tirreno. Uno degli schiavi atriensi dalla veste succinta, a cui una tunica di lino di Pelusio scendeva giù dalle spalle con una serie di frange che pendevano, mentre il signore camminava tra le verdeggianti aiuole, cominciò a innaffiare la terra cocente con un secchiello di legno, ostentando il proprio impegno generoso. Ma viene deriso. Poi, per scorciatoie a lui note, corre avanti in un altro viale e tiene la polvere al suolo. Cesare lo riconosce e comprende la situazione. Mentre quello riteneva che ci fosse per lui qualche ricompensa, il signore lo chiamò: «Senti, tu»; lo schiavo allora fece
un salto eccitato per la gioia di un dono ormai certo. Allora così scherzò quell’imperatore di così grande maestà: «Non hai fatto molto e questa fatica è vana: presso di me gli schiaffi si vendono a prezzo ben maggiore».
Tigre Animale esotico agli occhi dei Greci e dei Romani (in Oriente le è attribuita la supremazia sugli animali, che normalmente in Occidente è assegnata al leone), la tigre non è tuttavia ignota alla letteratura classica. Nel mito è collegata al dio Dioniso, che si trasformò in tigre per sedurre la ninfa Anfesibea. Nella poesia latina viene citata spesso la tigre dell’Ircania (cfr. Virgilio, Eneide 4,365 ss.). Augusto presentò a Roma per la prima volta una tigre addomesticata, in occasione dell’inaugurazione del teatro di Marcello (Plinio, Naturalis historia 18,65). La scarsa conoscenza suggerisce la diffusione di credenze curiose: da alcuni testi indiani si apprende che le tigri si accoppierebbero con cagne di razza lasciate libere dai cacciatori (Eliano, De natura animalium 8,1). La favolistica accoglie in poche narrazioni le tigri e sempre in modo marginale. Nella favola esopica 199 Ch. (cfr. anche Babrio 95), la tigre è descritta come «vanagloriosa» e perciò indegna di succedere al leone quale re degli animali. La sua vittima designata, con cui un giorno è costretta a riconciliarsi grazie a un giusto leone, è il cervo (Esopo 195 Ch.). Assente in Fedro, la tigre compare in una favola di Aviano (17), versione secondaria della narrazione dell’arciere e del leone (Esopo 338 Ch.): qui l’animale emerge sia per la rapidità sia per l’audacia e la volontà (abbastanza singolare, in considerazione della sua tipica ferocia) di proteggere le altre bestie. Probabilmente tale caratterizzazione si spiega con il fatto che, come si è notato, in questo specifico caso, sostituisce il re degli animali. Molto più rilevante ovviamente è la presenza della tigre in altre tradizioni favolistiche. Ad esempio, nelle raccolte favolistiche africane dei Bangwa la tigre non emerge per spiccata intelligenza: una narrazione spiega che teme il caprone da quando notò che possedeva una pelle di tigre; pensò così che
fosse tanto forte da ucciderne una, mentre in realtà si trattava del dono degli uomini con cui aveva convissuto. In un’altra favola, due tigri stupide attraversano insieme un ponte dalle due parti opposte, ma può passare un animale per volta, così litigano e finiscono per diventare il pasto di un coccodrillo. Continuano poi a discutere nello stomaco del coccodrillo, ne vengono espulse e alla fine si ammazzano.
Tiresia Figlio di Evereo e di Cariclo, il tebano Tiresia costituisce, insieme a Calcante, il paradigma dell’indovino nell’antichità (anche sua figlia Manto è un’indovina). Secondo il mito diventa cieco per avere dato ragione a Zeus in una discussione con Era. Il re degli dei ritiene che in amore la donna provi più piacere dell’uomo; la moglie sostiene il contrario. Tiresia, giudice attendibile per essere stato prima uomo, poi donna per sette anni, poi di nuovo uomo, viene comunque ricompensato da Zeus, che, tra l’altro, gli attribuisce la capacità di prevedere il futuro (cecità e preveggenza sono strettamente connesse nella cultura antica). Esistono, tuttavia, altre versioni del mito, secondo cui sarebbe stato punito con la cecità per avere visto Atena nuda, intenta a bagnarsi alla fonte Ippocrene. Della sua singolare figura si occupa diffusamente Ovidio nelle Metamorfosi (3,316 ss.). Tiresia è anche personaggio significativo della tragedia greca (lo troviamo, ad esempio, nell’Antigone e nell’Edipo re di Sofocle). Le sue doti divinatorie restano intatte nell’Aldilà: nell’Odissea (XI libro), Ulisse, su consiglio di Circe, va nell’Ade e consulta la sua ombra per conoscere il futuro. Dante lo collocherà nell’Inferno (nella bolgia degli indovini: XX canto, vv. 40 ss.). La favola esopica sembra (sor)ridere dell’arte divinatoria, togliendole così quell’aura di sacralità che sembra invece caratterizzarla in altri contesti letterari (v. INDOVINO). Le figure che la rappresentano non sembrano godere di notevole considerazione sociale; infatti, indovini (Esopo 233 Ch.) e maghe (91 Ch.) sono spesso bersaglio di ironie. Nello specifico, Tiresia compare nella favola 110 Ch., una narrazione dalle sfumature comiche che prende di mira non tanto la figura dell’indovino in sé, quanto piuttosto le furbizie di Hermes e la pratica della divinazione attraverso gli uccelli. Tiresia non assume una particolare
caratterizzazione: si parla anche genericamente di una città senza menzionare Tebe; sembra pertanto calarsi nelle vesti, simboliche, del profeta per antonomasia. Se l’aquila non risolve l’enigma al centro della favola, il corvo risulta invece decisivo: in un gustoso quadretto, Esopo suggerisce come elemento risolutore il movimento della testa dell’uccello (il suo rapporto con gli dei è esplicitato nella favola 170 Ch.). I temi che emergono nella narrazione dedicata a Tiresia sono probabilmente di ambito cinico, anche se lo spunto per questa favola sembra ravvisabile negli Uccelli di Aristofane (vv. 49 ss.; vv. 582 ss.), dove, a partire dal tema del corvo e della divinazione, emergono alcuni elementi che suggeriscono un parallelo. Hermes e Tiresia Esopo 110 Ch. Hermes, volendo verificare se l’arte divinatoria di Tiresia fosse autentica, rubò dalla campagna i suoi buoi e, assunte sembianze umane, si presentò in città, facendosi ospitare da lui. Quando fu annunciata a Tiresia la scomparsa della sua coppia di buoi, prese Hermes con sé e andò alle porte della città nel tentativo di ottenere, riguardo al furto, qualche auspicio osservando gli uccelli; allora lo invitò a dire quale uccello avvistasse. In un primo momento Hermes, vista un’aquila che volava da sinistra verso destra, gliela segnalò, ma Tiresia disse che quella non faceva al caso loro. Quindi Hermes vide e gli indicò una cornacchia appollaiata su un albero, che ora guardava verso l’alto, ora si chinava verso terra. Allora l’indovino disse: «Questa cornacchia giura per il cielo e per la terra che, se lo vuoi, potrò riprendermi i miei buoi». Questa favola potrebbe essere riferita a un ladro.
RIFERIMENTI: cfr. Aristofane, Uccelli 49 ss.; 582 ss.
Tizio Omero (Odissea 11,576) descrive il gigante Tizio come «il figlio glorioso di Gea» (secondo altre versioni, sarebbe invece figlio di Zeus ed Elara). Cerca di violentare Leto (Latona), viene fulminato da Zeus (o trafitto da Apollo e Artemide); il suo corpo resta attaccato al suolo e si distende a terra per nove iugeri (lo iugero è pari a 0,252 ettari); il suo fegato viene dilaniato dagli avvoltoi e continuamente ricresce. Fedro (App. 5 [7]) riporta la descrizione di Tizio, presentando, in una narrazione non priva di anomalie, il destino dei grandi dannati (cfr. la descrizione simile di Virgilio, Eneide 6,595 ss.). La morale sottesa al mito di Tizio è che «quanto più estesa è la terra che si possiede, tanto più gravi sono gli affanni da cui si è colpiti». Si tratta di una visione consolatoria, propria della tradizione favolistica.
Tonno Anche se non è valorizzato dal mito, il tonno è molto noto nell’antichità. Apprezzato dal punto di vista gastronomico, a partire dai Fenici questo pesce è vittima delle famigerate mattanze, che prevedono la cattura attraverso alcune trappole collocate nei punti di passaggio obbligato. Il periodo in cui avviene la pesca è la primavera, che coincide con la fase della riproduzione. Così i tonni, che non possono trovare scampo, finiscono per essere uccisi in modo piuttosto violento. Questa pratica suscita curiosità: Eliano (De natura animalium 15,5) descrive con notevole precisione come avviene la mattanza nel Ponto Eusino. Al tonno sono poi attribuite particolari caratteristiche: Plinio (Naturalis historia 9,50) riferisce che, per quanto miopi, questi pesci vedono meglio con l’occhio destro (e ciò condizionerebbe i loro percorsi marini). «Lungo fino a tre metri, il tonno è un grande e instancabile nuotatore, sicché lo si potrebbe eleggere a emblema del viaggiatore ma anche del maratoneta perché può compiere lunghi percorsi alla velocità media di 50 chilometri all’ora» (Cattabiani 2002, 256). Proprio l’immagine del pesce in movimento caratterizza le uniche due favole di Esopo in cui compare il tonno, che è sempre descritto (peraltro con le stesse parole) nell’atto di fuggire. In entrambe le narrazioni trova una sorte infelice, a cui sembra inesorabilmente destinato, come del resto pare suggerire l’immaginario collettivo degli antichi. Nella favola 22 Ch. lo slancio con cui scappa lo fa finire sulla barca dei pescatori. Si tratta di una narrazione di impronta cinica dedicata al tema della fortuna. Nell’altra favola (132 Ch.), il tonno è inseguito dal delfino. Anche qui la sua sorte sarà tragica. Queste immagini non sembrano lontane dalla caratterizzazione diffusa che tende a dipingerlo come uno stolto, perché finisce sempre nelle reti dei pescatori; tra
l’altro, è attestata l’espressione «sciocco come un tonno» (Orazio, Satire 2,5,44), anche se si riscontrano punti di vista differenti: Eliano lo descrive come un pesce capace, con abili tecniche, di evitare la cattura da parte dei pescatori (De natura animalium 1,40). I pescatori e il tonno Esopo 22 Ch. Alcuni pescatori uscirono al lavoro e, pur dandosi da fare a lungo, non presero niente. Seduti nella loro barca, si abbandonarono allo sconforto. Proprio in quel momento un tonno, inseguito, fuggiva con grande rumore e, senza accorgersene, saltò nella barca. I pescatori, dopo averlo catturato, lo portarono in città e lo vendettero. Così, spesso ciò che l’arte ci nega ci viene donato dalla sorte.
Topo Nel mondo greco-romano, e in generale nella cultura mediterranea, il topo è considerato in modo ambivalente. Insieme alla venerazione di Apollo Sminteo («sterminatore di topi»), specialmente nella Misia, si riscontra anche un culto del topo, attributo di Zeus/Sabazio e di Apollo (in particolare, nella Troade). Le sue abitudini sotterranee lo rendono creatura ctonia, vicina alle potenze infere (Cooper 334). Questa bestiola è guardata, dunque, ora con simpatia ora con timore e con sospetto, per i danni che arreca e per le capacità profetiche che le sono attribuite, spesso in relazione a eventi negativi (cfr. Plinio, Naturalis historia 8,221 s.; Cicerone, De divinatione 1,44). Va sottolineato che «gli antichi, quando parlano di topi, si riferiscono per lo più al topolino domestico [...] non conoscevano il ratto comune o ratto nero [...] che giunse in Europa dall’Asia, probabilmente intorno al XII secolo e neppure il surmolotto o ratto delle chiaviche» (Maspero 332 s.). Questo animale è considerato considerato molto lussurioso (Eliano, De natura animalium 12,5). Nella commedia plautina, spesso diventa immagine del parassita, sempre alla ricerca del cibo di altri (Captivi 77; Persa 57 ss.) e viene considerato animale piccolo e saggio (Truculentus 868 s.). Nella Batracomiomachia, un poemetto attribuito a Omero ma di epoca più recente, attraverso la parodia dell’epica viene descritta la guerra tra topi e rane. Il conflitto scoppia a seguito della morte del topo Rubabriciole, che il re delle rane Gonfiaguancia, impegnato a portare il sorcio sulle proprie spalle, fa annegare, dopo essersi immerso nello stagno per paura di un serpente. Proprio lo spunto iniziale di questo poema pare essere alla base di una curiosa favola che vede la rana uccidere il topo nello stagno, per poi essere a sua volta vittima di un nibbio (Esopo 244 Ch.). D’altra parte, nella tradizione favolistica, troviamo per lo più topi impegnati a combattere
contro gatti, donnole e serpenti (Esopo 13; 237; 289 Ch.: motivi spesso ripresi da Fedro e Babrio); la battaglia dei topi e delle donnole potrebbe trovare spunto in una narrazione simile alla Batracomiomachia (cfr. Solimano 244; Schibli 1 ss.); il topo sa anche prevenire i rischi, come quando non cade nella trappola della civetta e del gatto (Romulus 25). Si tratta, del resto, di un’ostilità che viene significativamente sottolineata anche da altri generi letterari, come la commedia (cfr. Plauto, Stico 460 s.). In alternativa, troviamo di frequente i topi intenti a risolvere difficoltà attraverso l’astuzia: in alcuni casi, «il topo è affiancato ad animali che, per mole e forza, contrastano con la piccolezza della bestiola», rivelando in questa opposizione prontezza, ingegno e coraggio (cfr. Pugliarello 1973, 176 s.). Così il piccolo animale, riconoscente, salva la vita addirittura al leone (Esopo 206 Ch.) e riesce anche a spaventarlo, passando sul suo corpo di corsa (Esopo 213 Ch.). Questa favola trova elementi di somiglianza con narrazioni di diverse tradizioni asiatiche e africane. Curiosamente, anche nella tradizione favolistica africana dei Bangwa si narra che il leone è terrorizzato dal topo a partire dal giorno in cui il piccolo animale gli fece credere con un’astuzia di riuscire a spezzare un sasso con la bocca. Il topo non teme nemmeno il toro (di Babrio 112 o il bue di Aviano 31), così come altri animali di enormi dimensioni: secondo alcune fonti, riesce a spaventare persino l’elefante (Plinio, Naturalis historia 8,29). Anche la favolistica insomma recepisce la figura del topo come immagine del saggio (ciò emerge anche dalla morale della favola 13 Ch.). La favola più significativa è certamente quella del topo di campagna e del topo di città, resa celebre soprattutto dal capolavoro oraziano (Satire 2,6,79 ss.): qui, il poeta chiarisce perché la campagna per lui rappresenti un approdo alla felicità, fatto di piccole soddisfazioni e di filosofia spicciola. Il topo di campagna viene descritto come votato al risparmio, ma non ignaro del dovere di ospitalità; il topo di città appare invece raffinato e schizzinoso, ma alla fine esposto a maggiori pericoli e preoccupazioni, che non
possono in nessun modo giustificare una vita comunque più agiata. Da notare che, anche in questo caso, la narrazione relativa al topo si presta a qualche parodica ripresa dell’epica (vv. 97; 100 s.). La morale è quella che sostanzialmente prevale nella tradizione esopica (cfr. 243 Ch.). Nella tradizione indiana del Pañcatantra, troviamo la celebre favola della topina trasformata in fanciulla (terzo tantra, racconto nono), accostabile a una favola greca che presenta però una diversa protagonista (v. DONNOLA). Un’altra favola, che si fonda sul timore delle notevoli capacità di questi roditori, molto diffuso nell’antichità (cfr. Erodoto 2,141: si parla di un esercito le cui armi furono rose dai topi), prende spunto da una grande bilancia che pare rosa dai sorci. Ma si tratta solo di una menzogna che sarà smascherata con un’astuzia (primo tantra, 17). Si è riscontrata una generica somiglianza tematica con la favola che contrappone fabbri e topi (Tetrastici 1,8), per la discussa tendenza di questi animali a non mangiare il ferro, se non nell’aldilà (cfr. Erodoto 3,76). Da segnalare, infine, un componimento del poeta Antifilo (Antologia Palatina 9,86), nel quale un topo ghiotto di un’ostrica finisce imprigionato nel guscio. Il topo e la rana Esopo 244 Ch. Un topo di terra, per sua sventura, aveva stretto amicizia con una rana. La rana, che aveva cattive intenzioni nei suoi confronti, legò una zampa del topo a una sua zampa. Allora, in un primo momento, la coppia andò in giro sulla terra alla ricerca di grano da mangiare; successivamente, avvicinatisi alla riva dello stagno, la rana trascinò il topo sott’acqua, in profondità, dibattendosi nell’acqua ed emettendo un forte «brekekekèx». Il disgraziato topo, gonfio d’acqua, annegò e venne a galla, legato alla zampa
della rana. Un nibbio lo vide e lo ghermì con gli artigli: la rana, incatenata al topo, gli stava dietro e divenne anch’essa pasto per l’uccello. Anche se uno è morto, ha la forza per la vendetta. La giustizia divina, che vigila su tutto, mette in equilibrio ogni azione e contraccambia in eguale misura. RIFERIMENTI: Romanzo di Esopo 133; PseudoDositeo 12; Parafrasi 246; Dodecasillabi 246; Romulus 4. I due topi Orazio, Satire 2,6,79 ss. Si racconta che una volta un topo di campagna avesse accolto nella sua povera tana un topo di città, da tempo amico e ospite. Era rozzo e attaccato alle cose che possedeva, ma non così tanto da non essere generoso con gli ospiti. In breve: non risparmiò ceci e chicchi d’avena e portando alla bocca un acino secco e un avanzo di lardo, li offrì invano all’amico, nell’intento di vincere con quella cena così varia il disagio dell’altro topo, che toccava appena ogni cibo con dente superbo. Intanto, il padrone di casa, disteso su paglia fresca, mangiava loglio e farro, lasciando i cibi migliori al suo ospite. Alla fine il topo di città disse all’altro: «Che gusto ci provi, amico mio, a sopportare di vivere su un pendio scosceso? Non preferiresti la città e la gente a questi boschi selvaggi? Poiché gli esseri della terra hanno avuto in sorte anime mortali e non è possibile né ai grandi, né ai piccoli sfuggire alla morte, dammi ascolto, vieni via con me, amico, e dove ti porterò, vivi felice, mio caro, tra le cose piacevoli, finché ti è concesso, memore di quanto sia breve la tua vita». Queste
parole colpirono il topo di campagna, che saltò fuori veloce dalla sua tana. Allora entrambi percorrono il cammino che si sono proposti, con l’intenzione di strisciare furtivamente di notte dentro le mura della città. E già la notte aveva raggiunto la metà del suo corso, quando entrambi entrarono in un ricco palazzo, dove un drappo rosso splendeva su divani d’avorio ed erano rimasti in un angolo molti avanzi di una cena sontuosa del giorno prima, posti in cesti ricolmi. Fatto dunque stendere su un drappo purpureo il topo di campagna, l’ospite corre avanti e indietro con le vesti sollevate e gli serve continuamente vivande come uno schiavetto, assaggiando prima tutto ciò che porta. Quello, sdraiato, si gode la sua nuova condizione e si comporta, in quella festa, da convitato felice. Allora, improvvisamente, un fracasso di porte fa balzare i due topi giù dai divani. Ed eccoli correre spaventati per tutta la stanza e più ancora tremare senza fiato, come l’immenso palazzo risuona del latrato di cani molossi. Così il topo di campagna dice: «Questa vita non fa per me, stammi bene. Mi consoleranno i miei poveri legumi, il bosco e la tana sicura di fronte ai pericoli». RIFERIMENTI: Esopo 243 Ch.; Aftonio 26; Babrio 108; Pseudo-Dositeo 16; F. dattiliche 10; Parafrasi 245; Dodecasillabi 245; Romulus 15. Cfr. inoltre Agostino, Contra mendacium 13,28; Isidoro, Etimologie 1,40,6. Altre allusioni sono elencate in Adrados 2003, 510. Il leone e il topo riconoscente Esopo 206 Ch.
Un topo passò correndo sopra il corpo di un leone che dormiva. Quando la fiera si alzò, lo catturò ed era pronta a mangiarlo. Il topo la pregò allora di lasciarlo andare e disse che, in cambio della salvezza, gli avrebbe reso un favore. Il leone scoppiò a ridere e lo fece andare via. Accadde che, non molto tempo dopo, il leone fu salvato dalla gratitudine del topo. Quando infatti venne catturato da alcuni cacciatori e fu legato con una corda a una pianta, il topo sentì i suoi gemiti e si precipitò a rodere la corda e a dare la libertà alla belva. Allora il topo gli disse: «Tu, che mi deridesti, non ritenendo possibile il contraccambio da parte mia, ora tieni ben presente che la riconoscenza vige anche presso i topi». La favola dimostra che, mutando le situazioni, anche le persone molto potenti hanno bisogno dei più deboli. RIFERIMENTI: Babrio 107; Pseudo-Dositeo 2; Tavolette Assend. 9; Codice Brancacciano 6; Parafrasi 207; Romulus 22; Libanio, Epistole 47,16; Temistio, Epistole 9, p. 750 Hercher (cfr. anche Giuliano, Epistole 8, p. 377 D.); Mario Vittorino, Retorica 1,17. Il leone spaventato da un topo e la volpe Esopo 213 Ch. Un topo correva sul corpo di un leone addormentato. Questi, alzatosi, si girava da ogni parte, cercando colui che lo aveva assalito. Una volpe, vedendolo, lo derideva, dicendo che, anche se era un leone, si era messo in guardia di fronte a un topo. E l’altro rispose: «Non ho avuto paura del topo, ma mi sono meravigliato che qualcuno avesse osato correre sul corpo di un leone addormentato». La favola insegna
che gli uomini dotati di saggezza non trascurano neppure le piccole cose. RIFERIMENTI: Parafrasi 214; Babrio 82; F. dattiliche 7; Tetrastici 1,4; Tzetze, Chiliadi 13,492496. Cfr. anche Suda ε 449; π 46; ϕ 644; 718 Adler; allusione in Niceta Coniate, Orazioni 11. Il topo e il toro Babrio 112 Un topo morse un toro. L’animale, colto da grande dolore, inseguiva allora il topo. Ma quello fu lesto nell’andarsi a nascondere in fondo alla tana. Il toro scavava il muro con continui colpi assestati con le corna, fino a che, spossato, cadde sulle ginocchia e si addormentò vicino al buco. Il topo, messo fuori il musetto, scivola verso di lui e fugge, dopo averlo nuovamente morso. L’altro, levatosi, non sapendo più che cosa fare, era in difficoltà. Rivolto a lui, il topo mormorò: «Chi è grande, non sempre è forte; in alcuni casi, piuttosto, il piccolo e l’umile sono dotati di forza». RIFERIMENTI: Aviano 31. Il topo e i fabbri Tetrastici 1,8 Un topo portava via il cadavere di un altro topo, che era morto di fame. Vedendo la scena, alcuni fabbri si misero a ridere. Il topo ancora vivo affermò: «Dovreste piangere, poiché non siete nemmeno in grado di nutrire un solo topo». [Non deridere la
sventura del prossimo] La montagna partoriente Fedro 4,23 [24] Nelle doglie del parto, una montagna emetteva fortissime grida e sulla terra c’era una enorme attesa. Ma essa partorì un topolino. Questo è scritto per te, che, mentre prometti con baldanza grandi cose, non ne cavi fuori un bel nulla. RIFERIMENTI: Orazio, Arte poetica 139; Romulus 31. V. sotto, in aggiunta, i riferimenti al proverbio. Il topo e l’ostrica Antifilo, Antologia Palatina 9,86 Un topo vorace e goloso che strisciava per la casa, avendo visto un’ostrica con il guscio aperto, morse l’umida barba, scambiandola per carne. Subito la conchiglia, per il dolore, si chiuse rumorosamente. Il topo, stretto in una morsa serrata, si procurò una tomba con le proprie mani. PROVERBI Parturient montes, nascetur ridiculus mus Partoriranno le montagne, nascerà un ridicolo topolino Il verso oraziano, calibrato su una polemica letteraria (sulla stessa scia forse anche Fedro) e chiosato da Porfirione (commento al verso 139 dell’Arte poetica), condensa un tema che ha avuto lunga fortuna sia come favola sia come
proverbio, non solo in ambito romano, ma anche in ambito greco. Oltre che nei paremiografi (cfr., ad esempio, Diogeniano 8,75; Macario 8,94), troviamo riferimenti in altri autori, cristiani e pagani (cfr. Girolamo, Contro Gioviniano 1,238; Luciano, Come si deve scrivere la storia 23). Chiarisce bene il significato dell’espressione Plutarco (Agesilao 36,9): gli Egiziani, delusi dall’aspetto fisico di Agesilao, non imponente ma piuttosto dimesso, se ne escono con tale constatazione. Espressioni come questa, insomma, vengono impiegate per chi promette molto, ma in realtà offre risultati di modesta consistenza. Larga fino a oggi la fortuna del proverbio, di cui qualcuno ipotizza la precedenza rispetto alla favola (cfr. Perry 1965, LXXXVIII s.), anche se, come è inevitabile, si tratta di interpretazioni necessariamente aleatorie.
Tordo Nell’antichità, il tordo è molto apprezzato in ambito gastronomico, soprattutto nella Roma imperiale. Lo ricordano, con riferimenti positivi, non solo il ricettario di Apicio, ma anche poeti come Marziale e Orazio, che suggerisce, per bocca di un singolare edonista, come niente sia meglio di un pingue tordo (Epistole 1,10,40). Plinio narra che Agrippina, moglie dell’imperatore Claudio, aveva un tordo che imitava le parole degli uomini (Naturalis historia 10,120). Ma il tordo non sembra avere le abilità del pappagallo; questa curiosa diceria, dunque, pare quasi introdurre alla dimensione tipica degli animali parlanti della favola. Il tordo compare solo due volte nella favolistica esopica, nelle vesti di una tipica e pregiata preda di caccia. In una favola (Esopo 137 Ch.) troviamo un cacciatore impegnato a prendere un tordo su un albero, ma l’aspide lo morde. In un’altra narrazione (157 Ch.), che pare di impronta cinica, il volatile, goloso, viene catturato da un cacciatore con il vischio: una tecnica ampiamente attestata (la segnala anche Orazio, Epodi 2,34 per indicare la cattura dei «tordi ghiottoni»); a tradire l’uccello, il suo amore per i mirti, che peraltro emerge non solo nella favolistica. Eliano, infatti, osserva che alcuni animali sanno difendersi dal malocchio di fattucchiere e stregoni: il tordo usa come speciale amuleto un rametto di mirto (De natura animalium 1,35). Da segnalare una curiosità sull’allevamento di questi prelibati uccelli, che conferma la nota golosità dei tordi per i mirti: il ghiotto impasto di bacche di mirto e fichi secchi, dapprima ridotti in poltiglia e poi mescolati con la farina, ingrassa i tordi e li rende perfetti per i banchetti dei Romani. Tordo e mirto formano, anche oggi, come nell’antichità, un binomio felice sul piano gastronomico: i tordi al mirto sono un piatto ancora apprezzato, ad esempio nella cucina sarda.
Il tordo Esopo 157 Ch. Un tordo era solito nutrirsi in un bosco di mirti e non se ne allontanava, stregato dalla dolcezza del frutto. Un cacciatore di uccelli, accortosi che il tordo si tratteneva volentieri lì, lo catturò con il vischio. E, mentre stava per essere ucciso, il tordo disse: «Ohimè infelice! Vado in rovina per il dolce gusto del cibo». La favola è adatta agli uomini dissoluti che vanno in rovina a causa dei piaceri. RIFERIMENTI: Sintipa 58.
Toro Tra i bovini (v. BUE, VACCA, VITELLO), il toro si distingue come simbolo di coraggio, di virilità (intesa anche come capacità maschile di procreare) e di forza. Il culto del toro è attestato già nelle antiche religioni sumero-semitiche; in Egitto l’animale viene onorato e diventa attributo del faraone; a Creta, dove abbiamo antiche attestazioni di tauromachie così come in altre zone della Grecia, è ambientato il noto mito del Minotauro: dall’unione di un toro inviato da Poseidone e della moglie del re Minosse, Pasifae, nacque un mostro mezzo uomo e mezzo toro; per lui, che si nutriva di carne umana, Dedalo costruì il noto labirinto di Cnosso: il mostro venne poi ucciso da Teseo. Lo stesso Zeus prende le sembianze del toro per amare Europa (cfr. Luciano, Dialoghi marini 15). Negli autori antichi, il toro diventa un termine di paragone lusinghiero anche per gli eroi del mito: così Omero riguardo ad Agamennone (Iliade 2,480 ss.). La furia e il muggito del toro non possono lasciare indifferenti (cfr. Esiodo, Teogonia 829 ss.). La natura bellicosa di questo animale viene bene rappresentata dalle maestose corna: Eliano le descrive «rigide e dritte», rilevando che il toro si appassiona a esse, come gli uomini alle loro armi (De natura animalium 2,20). Nella tradizione favolistica il toro si distingue per il coraggio e per la forza. Con le corna – il suo principale punto di forza – può uccidere il leone, per lo meno quando il temibile avversario è addormentato (Sintipa 11) o anziano (Fedro 1,21); comunque gli mette paura, al punto che il re degli animali cerca, con esiti non sempre felici, di superarlo in astuzia (Niceforo Basilace, Esercizi preparatori 1,1; Esopo 211 Ch.) e non affronta tori in gruppo, ma cerca di dividerli (in una variante di Esopo 71 Ch., dove invece protagonisti sono tre buoi). Ma le corna non sono sempre una risorsa, anzi talora possono essere d’impaccio (Fedro 5,9). In linea
con il valore simbolico assegnato ai bovini dalla cultura romana (v. BUE), il toro in Fedro riveste un ruolo importante, in quanto è emblema dei potenti, non a caso contrapposto alle rane, che rappresentano viceversa i ceti subalterni (1,30). Quanto alle sue caratteristiche più significative, il favolista, in una narrazione in cui segnala le qualità assegnate dalla Fortuna agli animali, delinea l’immagine del toro come animale torvo e fiero (App. 2 [3]). Ma, pur essendo forte e temuto, il toro deve soccombere di fronte alle capre selvatiche (in altre versioni, come in Pseudo-Dositeo 14, si hanno i caproni), quando viene inseguito dal leone (Esopo 332 Ch.): l’insegnamento è che le circostanze possono ribaltare i rapporti di forza. Il leone e il toro Esopo 211 Ch. Un leone, tramando contro un toro di straordinarie dimensioni, decise di avere la meglio su di lui con l’inganno. Perciò, dopo avergli spiegato che aveva sacrificato una pecora, lo invitò a mangiare da lui, con l’obiettivo di ucciderlo, una volta che si fosse accomodato a tavola. Il toro arrivò e vide molti bracieri e grandi spiedi, ma nessuna pecora; allora, si allontanò senza dire nulla. Il leone lo rimproverò e gli chiese perché, pur non subendo alcun oltraggio, se ne andava senza proferire parola; il toro rispose: «Non mi comporto così senza motivo; vedo infatti un allestimento più idoneo a una pecora che a un toro». La favola dimostra che gli inganni dei malvagi non sfuggono alle persone assennate. RIFERIMENTI: Babrio 97; Tavolette Assend. 4; Dodecasillabi 212. Il leone e il toro
Niceforo Basilace, Esercizi preparatori 1,1, pp. 423 ss. Walz I Una giorno un leone vede un toro: è bramoso di cibo, ma è spaventato dalle lunghe corna. Quindi, pur trovato il rimedio, rinuncia a curare la sua dolorosa condizione; la fame, tuttavia, ha il sopravvento e lo induce a vedersela con il toro, ma la grandezza delle corna lo dissuade. Alla fine, tuttavia, dà ascolto alla fame, e, finta amicizia nei confronti del toro, si prepara a ingannarlo (quando il rischio è incombente, anche il coraggio vacilla e se si accorge che l’attacco è pericoloso, ecco che trama segreti inganni). «Io – dice il leone – lodo la tua forza e ammiro la tua bellezza; che testa, che bell’aspetto! Che piedi maestosi e che zoccoli! Ma quale pesante fardello sei costretto a portare sulla testa! Leva dunque questo inutile aggeggio: la tua testa sarà più bella, ti libererai dal peso e il cambiamento ti migliorerà. A che ti servono le corna, se c’è pace con il leone?» Il toro dà retta a queste parole, ma, appena si è levato l’armatura, ecco che da quel momento diventa una facile preda e un pasto senza rischi per il leone. Così credere ai nemici porta con l’inganno anche il pericolo. Il toro, la leonessa e il cinghiale Sintipa 11 Un toro trovò un leone che dormiva e lo uccise a cornate. Sopraggiunta, la madre del leone piangeva amaramente il figlio. Quando un cinghiale vide la leonessa gemere, rimanendo a debita distanza, le
disse: «Oh, quanti uomini si trovano costretti a versare lacrime, perché i loro figli sono stati uccisi da voi leoni!». Questa favola dimostra che quello che uno fa, sarà fatto a lui, secondo la stessa misura.
U
Uomo L’uomo esopico è anonimo e scarsamente caratterizzato; è inserito in schemi convenzionali che ne rendono fortemente prevedibili i comportamenti; non è dotato di una particolare psicologia, anche se dalle sue azioni emergono sentimenti e istinti che ne determinano la condotta. In genere, l’uomo si segnala per il mestiere che svolge e dunque per le azioni che, prevedibilmente, dovrà compiere. Ad esempio, la sola presenza del pescatore suggerisce invariabilmente l’azione di calare (o tirare a secco) le reti (23, 24, 25, 26 e 27 Ch.); l’indicazione del pastore presuppone una narrazione che coinvolge direttamente anche il suo gregge; il navigante finisce per fare i conti con i pericoli del mare. L’uomo esopico appartiene per lo più ai ceti umili: il mondo di riferimento è quello di contadini, pastori, cacciatori e artigiani; marginale, quantitativamente, è il mondo dei pescatori, così come le favole ambientate in mare sono molto meno ricorrenti di quelle ambientate in terra. Secondo le analisi statistiche di uno studioso spagnolo (Cascajero 1992, 23 ss.), i lavoratori legati alla terra corrispondono infatti al 59,4% nell’edizione di Hausrath, mentre i lavoratori legati al mare sono il 12,3%; gli artigiani l’11,3% (intellettuali, religiosi e altre figure sono residuali). Nell’ambito dei lavoratori di terra, prevalgono pastori (34,9%), cacciatori (27%), agricoltori (22,2%). Percentuali abbastanza simili si riscontrano nel resto della tradizione favolistica, dove però gli agricoltori (32%), la cui presenza è pari a quella dei pastori, sono più ricorrenti dei cacciatori (24%). Questi personaggi sono naturalmente coerenti con la prospettiva esopica, che ribalta il punto di vista dell’epica e della letteratura elevata. Anche quando appare la figura di un eroe (Esopo 131 Ch.), il contesto, dai connotati quasi
comici, rovescia la solennità del riferimento. Lo stesso accade per la figura del soldato, che, nelle sue rare apparizioni, spicca per il profilo paradossale, anche quando se ne segnala eccezionalmente il valore (Fedro, App. 8 [10]). La presenza di figure tipiche di altri generi letterari, come re e imperatori, appare dunque del tutto eccezionale: Fedro li cala in narrazioni aneddotiche abbastanza anomale, episodi di ambientazione romana (come quello di Tiberio e dello schiavo atriense in Fedro 2,5) e vengono persino ad assumere una connotazione quasi divina, come Augusto, in grado di risolvere un complesso caso di omicidio e di eredità (3,10). Questo sistema dei personaggi fa emergere una significativa differenza rispetto ad altre tradizioni favolistiche, come quella indiana del Pañcatantra, che, pur presentando narrazioni simili a quelle esopiche, si cala in un contesto aristocratico e presenta figure di un certo rilievo sociale: nel racconto che funge da cornice, si fa riferimento a un re e ai suoi consiglieri, a tre principi e a un brahmana. Se rara è la rappresentazione del rapporto tra uomo e pianta (ad esempio, i boscaioli e il pino: Esopo 100 Ch.) o uomo e oggetto (il viandante e la spada: Romulus 94), le favole presentano spesso uomini in relazione con gli animali, proprio mentre svolgono il loro mestiere, che talora prende il nome dalla bestia affidata alle loro cure (v. ASINAIO; BOVARO CAPRAIO), stabilendo così un legame che incide sull’identità stessa del personaggio; peraltro, non mancano narrazioni anomale dai caratteri fiabeschi, come quella del leone innamorato della bella fanciulla (Esopo 198 Ch.). In una favola eziologica (Esopo 139 Ch., che, come la 120, indica Zeus come l’artefice degli uomini), alcuni animali (cavallo, bue, cane) offrono all’uomo una parte dei loro anni, conferendogli anche le loro caratteristiche. Un’altra favola fa riferimento a Prometeo che plasma gli uomini e gli animali, conferendo poi a una parte di questi ultimi, troppo numerosi, sembianze umane, mentre essi conservano la loro indole bestiale (Esopo 322 Ch.). Ma, secondo alcune leggende, può
avvenire anche il contrario, ossia che da un uomo che si è macchiato di un comportamento sbagliato sia derivato un animale (come la formica di Esopo 240 Ch. o l’aquila di Aristotele, Historia animalium 619a). Come nei casi segnalati sopra, gli uomini sono talvolta rappresentati in relazione agli dei, ma, significativamente, queste favole trovano ambientazione per lo più in terra, non presso le dimore divine (così la 112 Ch., quella del carro di Hermes e degli Arabi o la 108 Ch., quella di Hermes e dello scultore). Nel mondo degli uomini, a differenza di quello degli animali, l’empietà è spesso sanzionata: la stessa Religione interviene in una narrazione che descrive le gesta di un ladro sacrilego (Fedro 4,11). Anche dove non c’è un intervento divino, peraltro, troviamo il ladro o il brigante soccombere, soprattutto in Fedro (1,23; 2,1; 5,2; ma cfr. anche Aviano 25). Si rilevano anche vicende di altro tipo (favole o aneddoti o novelle) che si svolgono in un microcosmo esclusivamente umano, senza infrazioni alla logica naturale dei comportamenti e senza riferimenti alla sfera del divino. Si va così da una tipica favola esopica presente nelle collezioni anonime, come quella dell’ubriacone e della moglie (88 Ch.), fino alla celebre novella della vedova e del soldato (Fedro App. 13 [15]), passando attraverso episodi paradigmatici, come quello dell’oratore Demade (Esopo 96 Ch.). Il razionalismo empirico e demistificante della favola relega ai margini le figure di sacerdoti o indovini (v.) e spesso ne dà una rappresentazione negativa. Anche altre figure che hanno grande rilievo nel mondo antico vengono descritte in termini critici: ad esempio, gli atleti sono considerati millantatori, forse sulla base di una polemica introdotta nella favolistica dalla filosofia cinica. Quando, raramente, ci troviamo di fronte a personaggi storicamente identificabili, segnalati in via eccezionale anche dal nome proprio, si tratta in realtà di figure simboliche e intercambiabili, che hanno valore non per la loro individualità, ma per l’autorevolezza e per le frasi che
vengono loro attribuite. Così a Esopo si riconduce la paternità di una battuta che altre fonti fanno risalire a Diogene Cinico: il saggio schiavo si aggira con una lampada in pieno giorno e afferma di cercare «un uomo» (Fedro 3,19); ma può anche succedere che a un anonimo padre sia riferita una battuta che la tradizione riconduce addirittura a Socrate o a Biante (Fedro 3,8). Talora l’uomo non si caratterizza per un mestiere o una particolare qualifica, ma semplicemente per l’azione che svolge. Così, ad esempio, accade per il viandante, che si ritrova in numerose narrazioni. Come nota Nøjgaard 1964, 311, questa figura non rientra tra le tipologie tradizionali, né si riferisce a una certa sfera sociale, ma indica soltanto un’azione esteriore, non collegata a pensieri e a comportamenti; il viaggio non è dunque un motivo centrale, poiché rappresenta soltanto una situazione in grado di legare i personaggi: così accade che i viandanti, camminando, trovino una scure (Esopo 256 Ch.), o sentano la necessità di fermarsi a riposare sotto un platano (257 Ch.); o che, durante il percorso, ci sia un incontro, come quello con la Verità (Esopo 259 Ch.). Ma l’uomo può anche affrontare il suo viaggio con un leone (Esopo 59 Ch.). Perciò, lo studioso, convinto che l’indicazione del personaggio sia una sorta di nome proprio, afferma che in questo caso essa è vuota di contenuto se non per un valore spaziale, ed «è qui che l’autore ha potuto realizzare pienamente la sua concezione dell’indicazione del personaggio» (i nomi animali, infatti, comportano l’obbligo di rispettare almeno certe condizioni materiali). A volte gli uomini possono essere classificati sulla base di una certa caratteristica fisica, che diventa l’elemento costitutivo dell’identità del personaggio. Così, accade per l’eunuco (Fedro 3,11; Esopo 113 Ch.) o per il calvo (Esopo 343 Ch.; Fedro 5,3; Romulus 26), che risponde a un canone comico presente anche al di fuori della tradizione favolistica (cfr. Seneca, De constantia sapientis 16,4). La classificazione dei personaggi umani può avvenire anche sulla base del sesso (v. DONNA) o dell’età. Così il
giovane è prevedibilmente e puntualmente caratterizzato dall’inesperienza, oltre che dall’incapacità di gestire i propri comportamenti: dissipa le sostanze di famiglia (Esopo 248 Ch.), non riesce a tenere a freno l’ardore e la violenza (Fedro, App. 10 [12]), si abitua a rubare e, non punito adeguatamente dalla madre, aumenta l’entità dei furti (Esopo 296 Ch.), rischia di annegare in un fiume a causa della sua imprudenza (Esopo 297 Ch.). Queste caratteristiche trovano riscontro anche nella società degli animali, che talvolta, come nella citata favola di Fedro, servono come esempio esplicito proprio per interpretare meglio la realtà umana. L’attributo di senex («anziano») è usato spesso da Fedro come termine onorifico, in relazione a Esopo (3,14; 3,19; App. 7 [9]) e alla sua saggezza; e la vecchiaia, tuttavia, non è necessariamente sinonimo di virtù. L’anziano pastore, pronto a fuggire quando arrivano i nemici, viene descritto come pauroso (Fedro 1,15). In alcune situazioni, alla luce della forte prevedibilità della caratterizzazione, l’anziano è spesso messo in relazione con la morte e con la malattia, in linea con la convinzione che si esprime in un proverbio molto diffuso nel mondo antico: «La vecchiaia è di per sé una malattia». In Esopo 78 Ch., un uomo anziano invoca la Morte, ma poi se ne pente subito. In 87 Ch., una donna, afflitta da una malattia agli occhi, viene raggirata da un medico truffatore. Protagonisti delle favole possono essere addirittura le membra dell’uomo, come accade anche per quelle degli animali: così troviamo la favola dedicata alle membra e alla coda del serpente (Esopo 288 Ch.), ma anche il racconto dello stomaco e delle membra, che Livio (2,32,8-12) attribuisce a Menenio Agrippa, nell’ambito di quella che pare la più antica narrazione esopica romana. Peraltro, anche nella letteratura egizia abbiamo una vicenda di questo genere (v. INTRODUZIONE). Al di fuori della tradizione favolistica, come accade per gli animali, si trovano possibili riferimenti a narrazioni esopiche con protagonisti umani: così, ad esempio, nel dibattuto passo terenziano (La suocera
619 ss.), che presenta un vecchio e una vecchia, un inizio di favola già secondo i commentatori antichi. A differenza dei riferimenti agli animali, spesso piuttosto caratterizzati, in questi casi risulta però difficile individuare la favola sottesa. L’eunuco e lo screanzato Fedro 3,11 Un eunuco litigava con uno screanzato, che, oltre a rivolgergli parole volgari e offese provocatorie, lo insultò riguardo alla menomazione del corpo. «Certo, – rispose – è proprio per questo unico aspetto che mi cruccio di più: mi mancano i testimoni della mia integrità. Ma perché, sciocco, mi addossi una colpa che dipende dalla sorte? L’uomo deve vergognarsi soltanto di quello che ha meritato di soffrire.» NOTA: va rilevato il gioco di parole di testis (v. 5), che indica sia «testicolo» sia «testimone». Cfr. anche Plauto, Curculio 30 s.; 621 ss. Il buffone e il contadino Fedro 5,5 I mortali sono soliti cadere in errore per il favore concesso stoltamente e, mentre perseverano nel loro giudizio sbagliato, sono spinti a pentirsene dall’evidenza dei fatti. Un uomo ricco, assai noto, intenzionato a organizzare uno spettacolo pubblico, mise in palio un premio e invitò tutti a mostrare una nuova esibizione, secondo le possibilità del repertorio di ciascuno. Si fecero avanti diversi artisti per gareggiare e farsi onore. Fra questi c’era un buffone conosciuto per la sua garbata arguzia: disse
di avere un genere di spettacolo che non era mai stato presentato in teatro. Si diffonde la voce, sale l’eccitazione dei cittadini. I posti, poco prima vuoti, non sono sufficienti per il numeroso pubblico. Quindi, dopo che sulla scena se ne stette fermo, da solo, senza strumenti, senza aiutanti, l’attesa stessa fece calare il silenzio. L’uomo infilò all’improvviso il capo tra le pieghe del mantello e imitò così bene, con la sua voce, il verso del porcellino, che il pubblico sostenne che ne tenesse uno sotto il mantello e lo invitò a scuoterlo. Così fu fatto, senza che nulla fosse trovato. Allora lo riempiono di molti doni e lo applaudono con grande convinzione fino all’uscita di scena. Un contadino vide questa scena e disse: «Per Ercole, costui non mi supererà!». E subito dichiarò che il giorno successivo avrebbe proposto la stessa esibizione in modo ancora più efficace. La folla diventa ancora più consistente. Ormai la faziosità ha preso possesso delle menti e gli spettatori siedono con il proposito di deridere, non di guardare. Entrambi si presentano sulla scena. Il buffone grugnisce per primo: è applaudito ed è acclamato. Allora il contadino, simulando di tenere nascosto un porcellino sotto i vestiti (e lo faceva veramente, ma evitava i sospetti, perché non si era trovato nulla nell’esibizione precedente), tirò energicamente un orecchio all’animale in carne e ossa, che teneva celato, e, insieme al dolore, gli cavò fuori il verso naturale. La folla acclama il buffone, sostenendo che la sua imitazione è molto più fedele, mentre fa in modo che il contadino sia mandato via. Ma l’uomo tira fuori dal mantello proprio il porcellino e, dimostrando il loro scandaloso abbaglio con una prova manifesta, esclama: «Ecco, questo chiarisce che razza di giudici siete!». L’aquila e il forestiero
Aristotele, Historia animalium 619a Alle aquile, mentre invecchiano, cresce la parte superiore del becco, curvandosi sempre più verso il basso, e alla fine esse muoiono di fame. Si racconta anche una storia secondo cui questo capita per il fatto che un tempo l’aquila era un uomo che si comportò in modo iniquo nei confronti di un forestiero. L’aquila mette così in serbo le eccedenze di cibo per i piccoli; infatti, poiché non è facile ogni giorno procurarsi il cibo, talora non riesce a reperirlo dall’esterno. RIFERIMENTI: Demetrio, Sull’elocuzione 157. Cfr. anche Zenobio 2,38: il proverbio «Vecchiaia d’aquila, giovinezza d’allodola», pur presentando, nella spiegazione del paremiografo, il richiamo alla curvatura del becco in tarda età, non è posto in collegamento con alcuna favola. Cfr. anche Apostolio 1,46 (Arsenio 1,66). Il calvo e un tale spelacchiato Fedro 5,6 Un uomo calvo trovò casualmente un pettine in un trivio. Gli si avvicinò un altro, anche lui senza capelli, e disse: «Ehi! Dividiamo a metà, qualunque sia il guadagno». Quello gli fece vedere il bottino e, al tempo stesso, aggiunse: «Il volere degli dèi è dalla nostra parte, ma, come si dice, per un destino avverso abbiamo trovato carbone, invece di un tesoro». Chi ha sperato invano è d’accordo con questa lagnanza.
L’uomo disonesto Esopo 50 Ch. Un uomo disonesto aveva scommesso con un tale di poter dimostrare che l’oracolo di Delfi diceva il falso. Nel giorno stabilito, prese in mano un passerotto e, dopo averlo coperto con il mantello, andò al santuario, si mise di fronte all’oracolo e gli chiese se ciò che aveva in mano respirava o era senza vita, con l’intenzione, qualora l’oracolo avesse affermato quest’ultima ipotesi, di mostrargli il passero vivo. Se invece gli avesse detto che respirava, intendeva strozzarlo prima di tirarlo fuori. Allora il dio, che aveva capito il suo malvagio proposito, disse: «Smettila, uomo, infatti dipende da te che quanto hai in mano sia vivo o morto». La favola dimostra che non ci si può mettere contro la divinità. L’uomo che prometteva l’impossibile Esopo 46 Ch. Un uomo povero si era ammalato ed era sofferente. Poiché secondo i medici era senza speranza, pregava gli dei, promettendo che avrebbe offerto un’ecatombe e avrebbe consacrato offerte votive, qualora fosse guarito. Così la moglie, che si trovava accanto a lui, gli chiese: «Da dove prenderai queste offerte?». Ed egli rispose: «Pensi dunque che guarirò, perché gli dei possano richiedermele?». La favola insegna che gli uomini promettono con facilità quanto non credono di poter concretamente mantenere.
Il debitore ateniese Esopo 10 Ch. Ad Atene, a un uomo che aveva contratto un debito venne richiesta dal creditore la somma dovuta. All’inizio il debitore chiedeva che gli fosse concessa una dilazione, dicendo che non aveva quattrini. Poiché però non riusciva a convincerlo, gli portò l’unica scrofa che aveva e davanti a lui la mise in vendita. Giunse un acquirente e gli chiese se fosse una scrofa prolifica. Il debitore rispose che non solo lo era, ma aveva anche una qualità eccezionale, poiché generava femmine durante i Misteri, maschi durante le Panatenee. Mentre l’acquirente fu impressionato da queste parole, il creditore disse: «Suvvia, non stupirti. Essa, infatti, genererà per te anche capretti, in occasione delle Dionisiache». La favola dimostra che molti, per il loro personale tornaconto, non esitano neppure a mentire, facendo affermazioni del tutto irrealistiche. NOTA: i Misteri eleusini erano feste rituali legate al culto di Demetra; le Panatenee erano invece celebrate in onore di Atena e le Dionisiache in onore di Dioniso. Efudione Aristofane, Vespe 1381 ss. In occasione delle Olimpiadi, al tempo in cui io fui teoro, Efudione, per quanto fosse ormai anziano, si batté con successo contro Asconda: un pugno e il vecchio mandò al tappeto il giovane.
Oreste Aristofane, Uccelli 1482 ss. C’è poi una regione, laggiù verso le tenebre, nel deserto di luci, dove gli uomini fanno banchetti e vivono insieme agli eroi, eccetto al crepuscolo. Allora non è più sicuro incontrarli in quel luogo: se di notte un mortale si imbattesse nell’eroe Oreste, si ritroverebbe denudato, da lui percosso in tutte le parti nobili del corpo. Il ladro e l’albergatore Esopo 301 H.-H. Un ladro sostò in una locanda e là soggiornò per alcuni giorni nella speranza di rubare qualcosa. Poiché non riuscì nel suo intento, un giorno vide l’albergatore vestito con un chitone nuovo e bello – era infatti festa – seduto davanti alla sua porta, mentre nessun altro si trovava là. Allora il ladro lo raggiunse, si sedette accanto e cominciò a conversare con lui; durante il colloquio che si protraeva lungamente, il ladro prese a sbadigliare, ululando, allo stesso tempo, come un lupo. Allora l’albergatore gli chiese perché facesse così e il ladro rispose: «Te lo dirò, ma ti prego di custodire il mio mantello, perché io lo lascerò qui. Io, signore, non so da dove mi viene questo sbadigliare, non conosco per quale colpa o altra causa accada; ma quando sbadiglio per la terza volta, divento un lupo e mangio gli uomini». E, dopo avere detto queste parole, sbadigliò per la seconda volta, ululando nuovamente. All’udire questo discorso, l’albergatore, credendo al
ladro, fu preso dalla paura e si alzò, con l’intenzione di fuggire. Il ladro lo afferrò per il chitone e lo pregò, dicendo: «Attendi, signore, e prendi il mio mantello, perché io non lo faccia a pezzi». E, mentre lo pregava, aprì la bocca e cominciò a sbadigliare per la terza volta. L’albergatore, preso dal timore che lo mangiasse, lasciò il suo chitone e rientrò di corsa nella locanda, chiudendosi all’interno. Il ladro, allora, prese il chitone e se ne andò. Così succede a coloro che credono a quanto non è vero. Il ventre e i piedi Esopo 159 Ch. Il ventre e i piedi discutevano su chi di loro fosse più forte. I piedi affermavano continuamente di essere tanto superiori in quanto a forza, da trasportare anche lo stesso ventre. Quest’ultimo rispose: «Cari miei, se non vi fornisco il cibo io, voi non potrete certamente portarmi». Così anche in un esercito, se gli strateghi non sono molto intelligenti, il numero non ha nessun valore. RIFERIMENTI: Sintipa 35; Romulus 66; Dionigi di Alicarnasso 6,86,1-3; Livio 2,32,9-12; Plutarco, Coriolano 6,3; Massimo di Tiro 15,5. Il ragazzino che mangiava la trippa Esopo 292 Ch. Alcuni pastori, che sacrificavano una capra in campagna, chiamarono i vicini. Con loro c’era anche una donna povera e, insieme a lei, c’era pure suo figlio. Il banchetto andava avanti e il ragazzino, con
la pancia piena di carne, stava male e diceva: «Mamma, vomito le viscere!». Sua madre gli fece notare: «Non vomiti le tue, figlio, ma quelle che hai mangiato!». Questa favola è adatta a un debitore, che è pronto a prendere le sostanze degli altri, ma quando gli viene richiesta la restituzione, soffre come se le dovesse concedere di tasca sua. RIFERIMENTI: Babrio 34; Tetrastici 1,28; Plutarco, Sull’evitare di prendere denaro a prestito 831c; Suda oι 105 A. Il ragazzo e il leone dipinto Esopo 295 Ch. Un vecchio pauroso, che aveva un solo figlio, coraggioso e amante della caccia, vide in sogno il giovane ucciso da un leone. Temendo che la visione si concretizzasse e il sogno fosse veritiero, fece realizzare un appartamento bellissimo, sopraelevato, e lì sorvegliava il figlio. Fece anche dipingere la stanza per il suo diletto con ogni sorta di immagine di animali, tra i quali fu rappresentato anche un leone. Il figlio, tuttavia, più osservava quelle immagini e più soffriva. Allora, una volta, stando davanti al leone, disse: «Bestiaccia, a causa tua e del sogno falso di mio padre, fui rinchiuso sotto sorveglianza come una femminuccia: che cosa, dunque, ti farò?». E, dopo avere parlato in questo modo, tirò un pugno contro il muro, come per accecare il leone. Una scheggia, però, gli penetrò sotto un’unghia e gli procurò un dolore acuto e un’infiammazione e, quindi, un ascesso; si aggiunse a ciò la febbre, che presto condusse il ragazzo alla morte. Così, il leone, sebbene fosse dipinto, uccise il
giovane, e la trovata del padre non fu per niente utile. Si deve affrontare coraggiosamente, senza cercare astuzie, quanto è destinato a succedere; infatti, non si potrà sfuggire. RIFERIMENTI: Babrio 136; Tavolette Assend. 1; Parafrasi 296; Dodecasillabi 296; Psello, Orazioni 52,54-55 Littlewood; Suda β 420 Adler; Scoli ad Aristofane, La pace 153; Etymologium Magnum s.v. πεπρωμένoν. Il calvo a cavallo Esopo 343 Ch. Un uomo calvo, che portava in testa una parrucca, andava a cavallo. Prese a soffiare il vento e gliela portò via; così i presenti ridevano di gusto. Allora l’uomo disse, smettendo di correre: «Che c’è di strano se i capelli che hanno lasciato il loro proprietario e non sono naturalmente miei mi abbandonano?». Nessuno deve soffrire per il sopraggiungere di una disgrazia; infatti, non ci resta a lungo ciò che per natura non ci è assegnato fin dalla nascita, poiché siamo venuti al mondo nudi e nudi ce ne andremo. RIFERIMENTI: Parafrasi 344; Aviano 10; Marziale 2,41,10 (possibile allusione). Il carbonaio e il lavandaio Esopo 56 Ch. Un carbonaio vide che un lavandaio era venuto ad abitare vicino all’edificio dove egli lavorava. Allora si
recò dal nuovo vicino e lo invitò a trasferirsi da lui, spiegandogli che sarebbero diventati più amici e avrebbero ricavato un maggiore guadagno, abitando in un’unica casa. Allora il lavandaio lo interruppe e gli disse: «Non posso farlo assolutamente; infatti, tu sporcherai di fuliggine ciò che io sbiancherò». La favola dimostra che non è possibile mettere insieme tutto ciò che è diverso. I due nemici Esopo 114 Ch. Due uomini, che si odiavano reciprocamente, viaggiavano sulla stessa nave. Uno di loro stava a poppa, l’altro a prua. Sopraggiunse una tempesta e la nave era ormai sul punto di affondare. Allora l’uomo che stava a poppa chiedeva al timoniere quale parte della nave sarebbe finita sott’acqua per prima. Il nocchiero gli rispose che sarebbe stata la prua e lui disse: «La morte per me non è un dolore, se sto per vedere il mio nemico che perisce prima di me». La favola dimostra che molti uomini non si preoccupano del loro danno, se solo vedono che prima di loro vengono danneggiati i nemici. Il fanciullo e il ladro Aviano 25 Un bambino in lacrime si sedette sull’estremità di un pozzo pieno di acqua. La smorfia del suo volto era ingannevole, la bocca completamente spalancata. Dopo averlo visto sconvolto dal pianto, uno scaltro ladro gli domanda subito quale sia la causa della sua tristezza. E lui fa finta che si sia spezzata la corda e
si lamenta che gli è precipitato giù un orcio d’oro. Senza ritardo, la mano briccona leva l’impaccio della veste: nudo, il ladro si spinge subito fino in fondo al pozzo. Si racconta che il fanciullo, ponendo il mantello intorno al suo piccolo collo, si nascose nella macchia e scomparve. Invece, il ladro, dopo i pericoli affrontati a causa di un desiderio fallace, assai afflitto per la perdita della veste, sedette a terra. Si narra che quell’uomo astuto prese a lamentarsi in questo modo e, piangendo, invocasse i sommi dei: «D’ora in avanti, creda di avere ben meritato di perdere il mantello chiunque pensi che un orcio nuoti nella limpida acqua». Il pazzo e il setaccio Galeno, Il metodo terapeutico 1,9 Kühn Questa definizione è tanto piena di falle, che mi fa venire in mente la storia di quel pazzo che, riguardo a un setaccio, disse che non trovava quali parti di esso ostruivano e quali non ostruivano. L’uomo che trovò un leone d’oro Esopo 62 Ch. Un uomo pauroso, dopo avere trovato un leone d’oro, diceva: «Non so in che modo mi comporterò in questa circostanza; sono fuori di me e non so che cosa fare: sono diviso tra l’avidità e la mia innata paura. Quale sorte o quale divinità produsse infatti un leone d’oro? A causa di questa situazione, la mia anima è combattuta: desidera l’oro, ma ha paura di ciò che è stato realizzato con l’oro. Il desiderio mi
spinge a toccarlo, la natura mi spinge a starne alla larga. O sorte che dai e non permetti che si prenda! O tesoro che non reca piacere! O grazia divina che diventa disgrazia! Che fare, dunque? Come posso servirmene? A quale stratagemma posso ricorrere? Me ne vado per portare qui i miei schiavi, che, attaccando con una squadra numerosa, dovranno prenderlo, mentre io resterò a guardare da lontano». La favola è adatta per un ricco che non osa toccare né usare la sua ricchezza. RIFERIMENTI: Antologia Palatina 9,431; Cfr. inoltre Adrados 2003, 97 s. e Zafiroupolos 2001, 51. L’uomo che defecò il senno Romanzo di Esopo 67 Xanto disse a Esopo: «Puoi dirmi perché spesso guardiamo i nostri escrementi quando andiamo in bagno?». Esopo rispose: «Molto tempo fa c’era il figlio di un re, che, concedendosi lussi e sfarzosi banchetti, finiva per stare per un bel pezzo in bagno. E trascorse così tanto tempo seduto lì che finì per dimenticarsi di ciò che stava facendo e defecò anche il senno. Da allora, gli uomini, quando vanno in bagno, si chinano, preoccupati di ritrovarsi nella stessa situazione. Ma non affliggerti per questo, non espellerai il senno, dal momento che non ce l’hai». L’agricoltore e la sua zappa Babrio 2 Un contadino perse la sua zappa mentre scavava nel vigneto. Allora controllò se qualcuno dei
braccianti presenti l’avesse presa, ma ognuno di loro negò. Non sapendo come comportarsi, portò tutti in città, per costringerli a fare un giuramento solenne (c’è la convinzione, infatti, che solo gli dei più semplici vivano in campagna, mentre si crede che i veri numi risiedano all’interno delle mura della città, osservando tutto quanto accade). Entrarono attraverso le porte della città, presero a lavarsi i piedi presso una fontana e posarono le bisacce; intanto, un araldo annunciava, con alte grida, la ricompensa di mille dracme a chi fornisse informazioni sul bottino sottratto al dio. Quando l’agricoltore udì queste parole, disse: «Come sono stato sciocco a venire! Come potrebbe, infatti, il dio individuare altri ladri, quando non sa nulla nemmeno di quelli che rubano la sua roba, ma deve offrire una ricompensa per scoprire se un uomo sa che cosa è successo!». PROVERBI Φαλακρὸς κτένα Un calvo (trova) un pettine Questa sentenza, che si trova nell’Appendix Proverbiorum (5,12), mette insieme due elementi evidentemente inconciliabili: lo stesso accade per altri casi paradossali accostati a questo, come il cieco e lo specchio oppure il nocchiero di una nave e l’aratro. Il tema del calvo che trova un pettine è sviluppato in una favola di Fedro (5,6), centrata sul tema cinico della fortuna, beffarda proprio nel momento in cui sembra favorevole. La stessa situazione è umoristicamente descritta da Marziale (14,25). Carbonem … pro thensauro invenimus Abbiamo trovato carbone invece di un tesoro L’espressione è citata da Fedro (5,6,6), con l’indicazione esplicita («come dicono») che si tratta di un proverbio. Detti affini si ritrovano anche nella tradizione greca, in Luciano
(ad esempio, Philopseudes 32) e nei paremiografi (Zenobio 2,1; Gregorio Ciprio 1,64; Diogeniano 1,90 e altri). Tosi 1991, 410 ipotizza una favola non pervenuta, sottolineando che il carbone, nella tradizione folclorica, è simbolo di disillusione, come accade nella favola fedriana dei due calvi che trovano un pettine a loro del tutto inutile.
Usignolo Uccello dotato di un canto melodioso, l’usignolo colpisce profondamente l’immaginario degli antichi per questa caratteristica, tanto che diventa simbolo della poesia e dei poeti (ad esempio, il poeta lirico Simonide è anche noto come l’Usignolo di Ceo). Secondo una leggenda, l’anima del mitico poeta trace Tamiri, accecato dalle Muse per essersi messo in competizione con loro, volle reincarnarsi in un usignolo (Platone, Repubblica 620a). Plinio (Naturalis historia 10,81) osserva che gli usignoli cantano senza sosta per quindici giorni e quindici notti e sembra sorpreso dal fatto che un corpo così piccolo possa avere una tanto considerevole riserva di fiato; impressionanti, ancora secondo Plinio, sono le notevoli variazioni melodiche. L’usignolo, catturato e commerciato anche per scopi gastronomici (cfr. Orazio, Satire 2,3,243 ss.), è descritto come un uccello che ama profondamente la libertà e si rifiuta di cantare, una volta messo in gabbia (Eliano, De natura animalium 3,40). Il motivo del canto ritorna anche nella favolistica esopica: passando in rassegna le maggiori qualità dei più noti volatili, Fedro (3,18,11) segnala la dolcezza canora di cui il fato ha dotato l’usignolo. Sul canto si fonda la narrazione in cui l’uccellino in gabbia canta solo di notte, pensando così di essere diventato prudente, da quando è stato catturato mentre si esibiva in pieno giorno (Esopo 75 Ch.). L’usignolo appare, invece, come simbolo delle persone indifese nella favola più antica della letteratura greca, attestata in Esiodo (Le opere e i giorni 202 ss.) e poi anche nella tradizione esopica: qui l’uccello è vittima dello sparviero, rapace crudele simbolo dei potenti, che operano a loro arbitrio. La struttura narrativa è quella tipicamente esopica del contrasto che si esprime nel dialogo; come chiarisce il contesto, la constatazione della violenza «non è accettazione,
anzi è protesta contro la violenza portatrice d’iniquità» (La Penna 1996, XI): la legge del più forte, presente nel mondo animale, deve lasciare spazio alla giustizia tra gli uomini. Nella narrazione esopica, la morale è identica a quella della favola 26 Ch. (il pescatore e il pesce): lo sparviero non si lascia sfuggire la preda, per quanto di esigue dimensioni. Questa favola trova anche una versione alternativa (Romulus 55), in cui lo sparviero aggredisce i figli dell’usignolo, ma poi viene catturato dall’uomo. La narrazione dell’usignolo che non vuole convivere con la rondine, memore delle disgrazie di un tempo (Esopo 9 Ch.), rimanda, invece, al mito di Procne e Filomela: ne esistono diverse varianti (tra le versioni più celebri quella di Ovidio, Metamorfosi 6,426 ss.). Procne, figlia del re di Atene Pandione, era andata in sposa al re della Tracia Tereo; tuttavia, Tereo violentò Filomela, sorella di Procne, e le tagliò la lingua per costringerla al silenzio. Informata attraverso un ricamo, Procne punì il marito, uccidendo il figlio avuto da lui e servendoglielo in pasto. Tereo, resosi conto dell’accaduto, inseguì le donne, ma gli dei, impietositi, mutarono Procne in rondine, Filomela in usignolo, Tereo in upupa (secondo altre versioni Procne in usignolo e Filomela in rondine). Lo sparviero e l’usignolo Esiodo, Le opere e i giorni, 202 ss. Ora narrerò una favola ai re, per quanto saggi essi siano. Così parlò lo sparviero all’usignolo dal variopinto collo, portandolo tra le alte nubi, dopo averlo fatto suo con gli artigli: l’usignolo, straziato dagli artigli ricurvi, si lamentava, mentre l’altro gli disse brutali parole: «Sventurato, perché gemi? Ti ha in suo potere uno molto più forte di te: per quanto abile nel canto, tu sei destinato ad andare proprio dove io intendo condurti; se lo desidero, farò di te il mio pasto oppure ti lascerò andare. Stolto è chi si
vuole opporre a chi è più forte: non ottiene vittoria e aggiunge sofferenza alla vergogna». Così parlò il rapido sparviero, l’uccello dalle ampie ali. RIFERIMENTI: Esopo 8 Ch.; questa narrazione esiodea viene ripresa da decine di commentatori, scoliasti, retori e altri autori: cfr. Adrados 2003, 10. Si veda anche SPARVIERO per la versione b (Romulus 55). L’usignolo e la rondine Esopo 9 Ch. Una rondine suggeriva a un usignolo di realizzare il nido e di vivere sotto lo stesso tetto degli uomini, come lei. Allora l’usignolo rispose: «Non voglio rinnovare il dolore delle antiche sventure e perciò trascorro la vita in luoghi solitari». Chi ha sofferto per qualche evento sfavorevole, desidera fuggire persino il luogo in cui è accaduto quel triste episodio. RIFERIMENTI: Babrio 12; Parafrasi 9; cfr., con significative varianti, anche Papiro Rylands 4; Parafrasi 350; Dodecasillabi 9; Romulus 24 e 77. Un’altra versione, comunque abbastanza dissimile, è accostata a questa da Adrados 2003, 54 s.
V
Vacca «Come rappresentazione tanto delle dee lunari, munite di corna, quanto della Madre Terra che assicura il nutrimento, la vacca ha insieme un carattere celeste e ctonio»: la sua simbologia è legata per lo più alla nutrizione e alla procreazione, oltre al ciclo della vita, della morte e della rinascita (Cooper 355). Venerata in India, identificata in Egitto con la Grande Madre Hathor, è associata alla dea Era (Giunone), che prende le sembianze di una vacca; Zeus ama la bella sacerdotessa Io e la trasforma in una giovenca bianca, per evitare che la moglie lo scopra. Le vacche del Sole Iperione sono empiamente uccise dai compagni di Odisseo: ne consegue un’inesorabile vendetta (Odissea, libro XII). La vacca compare, senza una particolare caratterizzazione ma accostata a figure non troppo dissimili come la capra e la pecora, in una sola favola di Fedro (1,5): una variante della fortunata storia del leone che va a caccia con gli altri animali (cfr. Esopo 207 e 209 Ch.). Come il vitello e il giovenco, anche la giovenca viene messa a confronto con il ben più saggio bue (v. VITELLO); in Esopo 92 Ch. è simbolo degli oziosi.
Vasaio L’arte del vasaio è tra le più antiche e più diffuse nell’antichità. Nel mondo greco-romano sconta tuttavia la valutazione riduttiva relativa alle attività artigianali (v. ARTIGIANO). Sono tre le operazioni in cui lo descrivono impegnato le fonti antiche: la scelta e l’impasto dell’argilla, la modellazione, la cottura dei manufatti. Con il tempo si affina anche la strumentazione tecnica: dalla ruota usata già dai popoli mesopotamici si passa al tornio. Una caratterizzazione piuttosto generica, com’è tipico della tradizione favolistica, di questa figura, connessa esplicitamente con l’argilla e i manufatti che ne derivano, si trova nella favola 273 Ch. Per il povero asino, simbolo dei subalterni sfruttati, il vasaio rappresenta un padrone peggiore del giardiniere, ma decisamente migliore, com’è intuibile, del conciapelli. L’asino e il giardiniere Esopo 273 Ch. Un asino lavorava al servizio di un giardiniere: poiché mangiava poco e sopportava enormi fatiche, pregò Zeus che gli concedesse di liberarsi del giardiniere e di essere venduto a un altro padrone. Zeus esaudì la sua richiesta e ne dispose la vendita a un vasaio; ma l’asino era di nuovo infelice, perché veniva caricato di pesi maggiori rispetto a prima, dovendo trasportare sia l’argilla sia i vasi. Pertanto, implorava ancora di cambiare padrone e venne venduto a un conciapelli. Finì così a un padrone ben peggiore dei precedenti: vedendo quanto faceva il nuovo proprietario, l’asino osservò tra le lacrime: «Ahimè disgraziato! Sarebbe stato meglio rimanere
con i precedenti padroni; infatti, costui, da quanto vedo, concerà anche la mia pelle». La favola dimostra che i servi rimpiangono i primi padroni soprattutto quando hanno fatto esperienza dei successivi. RIFERIMENTI: F. dattiliche 15; Dodecasillabi 274. Cfr. anche Pseudo-Luciano, L’asino 43,1.
Verità Sia in ambito greco sia in ambito romano, la verità viene spesso divinizzata e personificata. Differente il concetto che ne sta alla base: il termine ἀλήθεια suggerisce un processo di svelamento, indicando etimologicamente quello che non resta nascosto, mentre il concetto di veritas (dal sanscrito var, termine che rimanda alla sfera sacrale) a Roma è legato all’ambito del diritto. Spesso descritta insieme alla Giustizia (appaiono in sogno a Epimenide, fr. 3B1 D.-K.), la verità riveste un ruolo fondamentale nel poema del filosofo Parmenide Sulla natura, dove viene identificata con la «Grande Dea». Viene indicata come figlia di Zeus da Pindaro (Olimpiche 10,1 ss.), mentre, in ambito romano, Veritas è una dea di antico culto. Orazio la descrive come nuda Veritas (Odi 1,24,7), accanto ad altre personificazioni, come appunto la Giustizia. Nella favolistica, la Verità si trova puntualmente in conflitto con la Menzogna, secondo una struttura dualistica tipica della narrativa esopica. Una favola di tipo allegorico (Esopo 259 Ch.) descrive la Verità come una donna che si è ritirata nel deserto, alla luce del prevalere della menzogna (che qui non pare personificata) presso gli uomini. Questa narrazione, senza dubbio anomala, forse di origine babriana, sembra ispirarsi al mito dell’età dell’oro, a cui seguono epoche sempre peggiori (cfr. Esiodo, Le opere e i giorni 106 ss.). Un’altra favola, forse derivata dal tema dell’origine degli esseri viventi (Esopo 57 Ch.), si trova solo in Fedro (App. 4 [5]): Prometeo, che, in linea con i presupposti culturali romani, plasma la Verità in funzione della giustizia, ha la meglio su Inganno, che prova a plasmare una statua simile, la Menzogna, ma priva dei piedi (v. PROMETEO). In Fedro, che designa la Verità (v. 18) con l’attributo di «santa», come fa anche per la personificazione della Religione (v.), il tema del contrasto tra questi due principi appare particolarmente incisivo, alla luce del fatto
che «proprio nello scambio e scontro tra verità e menzogna sta l’antitesi fondamentale del mondo fedriano» (Solimano 2003, XIX). Il viandante e la verità Esopo 259 Ch. Un viandante, incontrata in una zona deserta una donna che stava sola, con gli occhi abbassati, le domandò: «Chi sei?». Lei rispose: «La Verità». «Per quale motivo hai lasciato la città per vivere in un luogo deserto?» La donna disse: «Perché anticamente la menzogna era di pochi; ora invece appartiene a tutti gli uomini, qualunque cosa si dica o si ascolti». La vita è per gli uomini terribile e dolorosa, quando si antepone la menzogna alla verità. RIFERIMENTI: Babrio 126; Parafrasi 260. Prometeo e Inganno Fedro, App. 4 [5] Verità e menzogna Una volta Prometeo, che plasmò con l’argilla una nuova generazione, aveva realizzato con attenzione e accuratezza la Verità, perché potesse rendere giustizia tra gli uomini. All’improvviso venne chiamato dal messaggero del grande Giove e così affidò la sua officina all’Inganno fallace, che egli aveva, da poco tempo, preso a bottega. Questi, infiammato dal desiderio di imitarlo, realizzò finché ebbe tempo, con abile mano, una statua di pari splendore, di uguale statura e simile in tutte le
membra. Nel momento in cui quasi tutta l’opera era ormai meravigliosamente realizzata, gli venne a mancare l’argilla per modellare i piedi. Torna il suo maestro; perciò, affrettandosi, Inganno, turbato dalla paura, riprende il suo posto. Prometeo, notando con meraviglia una così grande somiglianza, volle che fosse posta in evidenza l’eccellenza della sua arte. Così mise nella fornace le due statue insieme; una volta terminata la cottura e infuso il soffio vitale, la santa Verità procedette con passo misurato, mentre la figura mutila rimase bloccata sul posto. Allora la falsa immagine, prodotto di un lavoro furtivo, fu chiamata Menzogna; e io senza fatica condivido il punto di vista di chi sostiene che non abbia i piedi. A volte i vizi, simulati, giovano agli uomini, ma il tempo fa emergere la Verità. PROVERBI Mendacium … [non] habere pedes La menzogna non ha i piedi Alla fine di una favola di Fedro (App. 4 [5]), il favolista dichiara di essere d’accordo con chi sostiene che la menzogna non abbia i piedi. Appare, dunque, chiaro il riferimento a un proverbio che sembra godere di una larga diffusione popolare. Come rileva Tosi 1991, 137 s. (n. 296 e n. 298), esistono numerose varianti del concetto, espresse da diversi proverbi: un modello concettualmente vicino è forse «Nessun bugiardo la fa franca per molto tempo» (Menandro, Monostici 841 J.). Va rilevato, come fa lo stesso Tosi, che ancora oggi esistono proverbi simili, per cui si ritiene che le bugie abbiano le gambe corte.
Verme In diverse culture il verme presenta una simbologia negativa ed evoca «la terra, la morte, la dissoluzione, l’umiliazione, la codardia e l’infelicità» (Cooper 357). Già a partire da Omero è frequente il riferimento al verme in relazione ai cadaveri (cfr., ad esempio, Iliade 19,25 ss.). In generale, nel mondo greco-romano si conferma una percezione non positiva: una commedia di Plauto prende il nome dal parassita curculio, Gorgoglione (verme roditore del grano). Seneca (De beneficiis 3,31,4) accosta i vermi e le mosche in quanto simboli di una vita priva di ragione, lontana da quella a cui deve tendere l’uomo. Il verme è figura marginale e poco apprezzata anche nella società esopica. La favola di Esopo 237 H.-H. presenta un verme e un serpente: nel tentativo di allungarsi, il primo finisce per spezzarsi. In altre versioni si trovano la lucertola e la volpe invece del verme, ma la struttura narrativa è simile (v. LUCERTOLA). Al centro di questo motivo favolistico è il tema, tipicamente esopico, della vanità che conduce alla rovina. Interessante, sul piano simbolico, la favola esopica (69 Ch.) della rana che si presenta come medico ma non trova credito e viene esortata a curare se stessa perché è zoppa (in alcune varianti, si indica come motivo della presunta infermità il suo colore verde giallastro): come protagonista, in alternativa alla rana, si trova un verme (Esopo 287 H.-H.). In entrambi i casi, dunque, per costruire una favola dal sapore paradossale, vengono scelti animali che appaiono agli antipodi del paradigma della salute.
Vespa La vespa ha sempre ispirato «simboli opposti all’ape perché non produce né miele né cera e la sua arnia, tranne quella della cartonia, è costruita sotto terra, in quelle tenebre che simbolicamente evocano il disordine, la confusione, il male» (Cattabiani 2000, 62). Nel mondo classico, tendenzialmente prevale questa simbologia negativa: ad esempio, Artemidoro (Sull’interpretazione dei sogni 2,22) sostiene che preannuncia uomini crudeli; Eliano, riprendendo un motivo diffuso che riguarda anche le api, spiega che le vespe nascono dalle carcasse dei cavalli (De natura animalium 1,28); inoltre, imbevono di veleno il loro pungiglione, gettandosi sulle vipere morte (5,16). Presso i cristiani il vespaio, nell’antichità come ora simbolo negativo, va a rappresentare le sette degli eretici. C’è un’altra funzione a cui le vespe sono simbolicamente accostate: quella di giudice. Nella commedia di Aristofane intitolata appunto Vespe, i vecchi giudici popolari ateniesi sono paragonati a questi insetti, per l’illusione che hanno di «pungere» gli imputati: la connotazione evidentemente non è positiva. In tutt’altro contesto, Fedro (3,13) riprende l’idea della vespa come giudice (su cui, cfr. Bajoni 93 ss.), indirizzandola verso una prospettiva migliore: l’insetto qui è un giudice che dirime la contesa tra api e fuchi (v. anche APE e FUCO). La favola sembra autobiografica: forse il riferimento ai fuchi rimanda a un’accusa di plagio che il poeta rivolge contro qualcuno (cfr. anche 4 prol. 16). Si tratta di una narrazione di tipo giudiziario, presente soprattutto nel primo libro di Fedro (1,10; 1,16; 1,17). Per il resto, la connotazione della vespa è tendenzialmente negativa e spesso appare in relazione con il suo pungiglione: la vespa che vuole pungere il serpente trova una morte infelice (Esopo 331 Ch.); quando si presenta all’uomo per tenere lontani i ladri, non trova considerazione da parte del
contadino (Esopo 330 Ch.): nella morale la vespa è emblema di chi promette di essere utile, ma procura solo danni. Le api e i fuchi giudicati dalla vespa Fedro 3,13 Le api avevano realizzato i favi su un’alta quercia: i fuchi, inetti, sostenevano che erano i loro. La contesa finì in tribunale e venne giudicata dalla vespa. Essa, conoscendo molto bene la razza di entrambi, propose questa soluzione alle due parti: «Il vostro corpo non si differenzia di molto e uguale è il colore, sicché ben a ragione è molto incerta questa questione. Ma perché il mio scrupolo non finisca per sbagliare a causa dell’imprudenza, prendete le arnie e versate l’esito della vostra fatica nelle cellette, in modo che dal sapore del miele e dalla forma del favo emerga l’autore di ciò di cui si sta trattando ora». I fuchi rifiutano, mentre le api accettano di buon grado la proposta. Allora la vespa emise una sentenza di questo genere: «Evidente è chi non può realizzarli e chi li ha realizzati. Perciò restituisco alle api quanto hanno prodotto». Avrei taciuto questa favola se i fuchi non avessero rifiutato di osservare i patti.
Violenza In greco, il termine ὕβρις oscilla tra il significato di «tracotanza» (come, ad esempio, nella tragedia, dove è elemento centrale dell’universo concettuale) e quello di «violenza» (in Esiodo, Le opere e i giorni 213, è contrapposta alla Giustizia). La Violenza viene personificata da Erodoto (8,77), che la descrive come madre di Sazietà, mentre Solone la presenta, inversamente, come generata da essa (fr. 6 W ). Nella tradizione esopica si ritrova una favola eziologica, di origine babriana, che presenta le nozze e lo stretto legame tra Guerra (v.) e Violenza (Esopo 319 Ch.). Non pare esserci riferimento alla sfera mitologica, quanto piuttosto, secondo il tipico schema esopico, a una sfera concettuale astratta. Secondo Teone (Esercizi preparatori 2), questa favola è già presente nello storico Teopompo. 2
Guerra e Violenza Esopo 319 Ch. Tutti gli dei si sposarono e ognuno di loro trasse a sorte la propria moglie. Il dio della Guerra, a cui toccò l’ultimo sorteggio, non trovò che Violenza. Si innamorò alla follia di lei e la sposò. Ecco perché la segue ovunque lei vada. Presso le città o i popoli dove giunge violenza, guerra e conflitti immediatamente le tengono dietro. RIFERIMENTI: Babrio 70; Teone, preparatori 2 (Teopompo FHG 115F27).
Esercizi
Vipera La vipera è il serpente velenoso per eccellenza; fin da tempi antichissimi è presente, sia in Grecia sia nella penisola italica, dove troviamo tre specie principali: la vipera aspis, onnipresente, la vipera berus nel Nord e sulle Alpi, e la vipera ursinii, nel centro (Bodson 1986, 75). La malvagità, in linea con il profilo generale tracciato per il serpente, è il tratto più ricorrente ed emerge in alcune credenze, come quella segnalata da Plinio (Naturalis historia 10,170) che la descrive come «il solo animale terrestre che genera le uova dentro di sé»; impazienti e malvagi, i piccoli della vipera escono dalla madre sfondandone i fianchi. Inoltre, già secondo Erodoto (3,109), appena vedono la luce i nati della vipera divorano la madre. Queste immagini saranno riprese nella cultura cristiana, visto che «anche all’Anticristo, che si credeva generato per parto cesareo, si attribuiva una nascita “per sfondamento” dal ventre materno simile a quello della vipera» (Bettini 1998, 40 n. 87). Del resto, già nella Bibbia (Salmi 57,5-6) la vipera e l’uomo scellerato sono associati in chiave negativa. Nella tradizione favolistica sono confermate tutte le caratteristiche della vipera, che comunque non sembra designata con una particolare precisione, ma è semplicemente sinonimo di serpente velenoso (si veda anche SERPENTE). Le morali le attribuiscono puntualmente valori simbolici negativi: è malvagia (115 Ch.), sempre pronta a mordere ma stolta (116 Ch.). Nella favola 116 Ch. si dimostra anche ingrata nei confronti delle rane che l’hanno aiutata, sostenendola col canto, nel corso della sua lotta con la biscia d’acqua. L’elaborazione simbolica operata dalla favola, insomma, appare abbastanza coerente con l’immagine diffusa nel mondo antico. Va segnalata anche la favola di Esopo 82 Ch. (cfr. anche Fedro 4,19 [20]), che, per quanto indichi un serpente in termini generici, fa
decisamente pensare a una vipera, non solo perché morde ed è velenosa, ma soprattutto per il fatto che la sua natura perfida di traditrice dei benefattori ricorda le credenze zoologiche secondo cui è spietata traditrice dei parenti. Il timore sembra il tratto prevalente del rapporto che l’uomo ha con esssa. La vipera e la lima Esopo 116 Ch. Una vipera, entrando nella bottega di un fabbro, chiese agli utensili di fare una colletta. Dopo avere ricevuto contributi dagli altri, giunse dalla lima e le chiese di darle qualcosa. Quella le rispose: «Sei sciocca se pensi di prendere qualcosa da me, che sono abituata non a dare ma a ricevere da tutti». La favola dimostra che sono stolti coloro che credono di avere qualche guadagno da chi è avido. RIFERIMENTI: dattiliche 9.
Fedro
4,8;
Romulus
62;
F.
La vipera e la volpe Esopo 115 Ch. Una vipera era trasportata dalla corrente di un fiume sopra un fascio di rovi. Una volpe che passava di lì, come la vide, disse: «Il nocchiero è degno della nave». La favola è dedicata a un uomo malvagio che si volge a cattive azioni. RIFERIMENTI: Parafrasi 116; Dodecasillabi 116; Tetrastici 2,32.
PROVERBI Tu viperam sub ala nutricas Ti nutri una serpe in seno L’espressione (Petronio 77,2) si attaglia perfettamente alla favola di Fedro 4,20 e a Esopo 82 Ch. (v. SERPENTE). Il proverbio, di larga fortuna, conferma che la vipera si consolida, nell’immaginario collettivo, come paradigma di ingratitudine e perfidia. La prima attestazione è in ambito greco (Teognide 602).
Vitello (giovenco) Simbolo di sacrificio, il vitello appare spesso legato alla madre. In genere, rispetto agli altri bovini (v. BUE, TORO, VACCA), si distingue per l’ingenuità e l’inesperienza, che lo portano alla rovina. Il giovenco è il bue giovane, più grande del vitello. In latino la parola iuvencus va a indicare anche il ragazzo (Orazio, Odi 2,8,21); lo stesso, peraltro, accade in italiano e in altre lingue moderne. Vitello e giovenco sono figure sovrapponibili nella favolistica. Appaiono generalmente ingenui (Fedro 5,9) e irruenti (Aviano 28; Fedro, App. 10 [12]). Per questo devono essere tenuti a freno dagli allevatori. Il giovenco, cocciuto, è efficace simbolo dell’immutabilità della natura, tema esopico di larga diffusione, come emerge bene dalla favola avianea. Curiosamente, come nella favola si rileva una descrizione minuziosa dei tentativi del contadino di placare l’animale, così sono teorizzate nella trattatistica tecnica (Columella 6,2) le modalità per domare i torelli. Appare differente, invece, l’impostazione della favola fedriana in cui Esopo consiglia a un padre di domare con la dolcezza l’impetuoso ragazzo-giovenco (App. 10 [12]): secondo un’originale interpretazione, questa figura rappresenterebbe Caligola, preso dall’imperatore Tiberio sotto la sua tutela (cfr. Mandruzzato 24). In ogni caso, l’animale appare cristallizzato in un’immagine coerente e ben delineata. Il toro e il vitello Fedro 5,9 Un toro si affannava con le corna in un angusto
passaggio, dal momento che solo a fatica poteva entrare nella stalla; un vitello gli indicava come dovesse piegarsi. Gli disse il toro: «Stai zitto! Ho imparato come si fa prima che tu nascessi». Chi corregge uno che è più sapiente, consideri che questa favola è adatta a lui. RIFERIMENTI: Romulus 98. Il padre di famiglia ed Esopo Fedro, App. 10 [12] Come si debba tenere a freno l’irruenza giovanile Un padre di famiglia aveva un figlio crudele, che, quando riusciva a sottrarsi alla sua vigilanza, riempiva di percosse gli schiavi, dando sfogo all’ardore della sua giovinezza. Allora Esopo narra in breve all’anziano genitore questo racconto: «Un tale aggiogava insieme un giovenco e un vecchio bue; quello, distogliendo dal giogo il suo collo inadatto a portarlo, si giustificava sostenendo che le sue forze erano divenute precarie a causa dell’età. “Non hai nulla da temere: – gli disse l’agricoltore – non lo faccio perché tu ti affatichi, ma perché domi costui, che, a forza di calci e di cornate, sfianca molti”. Anche tu, se non tieni sempre con te questo giovane e se non freni con la dolcezza la sua indole piena di irruenza, stai attento che non aumentino le lamentele nella tua casa». La mitezza è il rimedio contro la violenza. RIFERIMENTI: Romulus 61. Il contadino e il giovenco Aviano 28
A un giovenco che rifiutava i lacci e non voleva sottoporre il collo ribelle al doloroso giogo, un contadino tagliò le corna con un falcetto ricurvo e pensò che la folle bestia si fosse così tranquillizzata; prudentemente, gli legò anche il collo a un enorme aratro (infatti l’animale era assai pronto di corno, come di zampa), affinché il lungo timone non gli consentisse di colpire e i duri zoccoli non sferrassero facili calci. Tuttavia, dopo che l’animale cerca di allontanare dal collo indomito le corde e di rivoltare il suolo innocente con le zampe libere, immediatamente sparge con gli zoccoli la terra smossa, gettandola con violenza sul viso del padrone, che lo segue. Allora il contadino, scuotendo i capelli sporcati dalla sudicia polvere, sconfitto, dal profondo del cuore dice: «Davvero mi mancava l’esempio di una natura scellerata, per cui si possa diventare dannosi con deliberato proposito». Il giovenco, il leone e il predone Fedro 2,1 Sopra un giovenco abbattuto se ne stava un leone. Un predone arrivò e ne reclamò una parte: «Te la darei – disse – se tu non avessi l’abitudine di prendertela da solo». E mandò via il prepotente. Per caso, un innocuo viandante passò in quel luogo e tornò indietro alla vista della belva. A lui il leone, con mitezza, disse: «Non hai niente da temere e quella parte che è dovuta alla tua discrezione, prendila, coraggio». Allora, divisa la preda, si avviò verso la foresta, per garantire il passaggio all’uomo. È davvero un esempio straordinario e lodevole; tuttavia
gli avidi sono ricchi e i timidi sono poveri.
Vite (vino, uva) La vite è onorata presso i popoli antichi soprattutto come generatrice del vino. I Sumeri la venerano come dea madre, simbolo della vita; nella saga di Gilgamesh, l’eroe, giunto nel giardino del Sole, si rivolge a Siduri, donna del vino, che sta presso una vite, per conseguire l’immortalità. Culti simili sono riscontrabili anche presso altri popoli dell’Asia Minore: il dio del vino è onorato dagli Arabi, secondo le testimonianze di Erodoto (v. ARABO). Si ritiene che l’idea di una divinità del vino, in stretta relazione con l’immagine della donna e del toro, sia sorta a Creta dall’arcaica figura della Grande Madre, nel secondo millennio a.C. (cfr. Cattabiani 1996, 93 ss.): si tratta del culto di Dioniso, che così giunge in Grecia come simbolo di forza e come impulso vitale (Bacco, chiamato anche Lieo o Libero o in altri modi nella tradizione romana). Secondo il mito, il dio, figlio di Zeus e di Semele, fu ucciso quando era bambino da due Titani, per volere della gelosa Era; poi rinacque come vite. Secondo un altro mito, Icario fu il primo uomo a produrre il vino, istruito proprio da Dioniso, sbarcato in Attica. Va notato che Ikarion, il cui nome deriva da Ikaria, isola che si trova presso la Caria ed è individuata come uno dei luoghi di nascita del dio, è un centro sui monti dell’Attica da dove probabilmente si irradia il culto di Dioniso. Il ciclo della vendemmia va a simboleggiare vita, morte e risurrezione della divinità. La letteratura greca e latina nobilita il vino in ambito poetico, interpretandolo come fonte di ispirazione (Archiloco, fr. 120 W. ) e come mezzo per raggiungere la verità (cfr. Alceo, fr. 366 V.; Orazio, Satire 1,4,89: in seguito, si ha il proverbiale in vino veritas). Nella Bibbia, la vite assume una connotazione generalmente positiva: nell’Antico 2
Testamento è simbolo della sapienza divina (Ecclesiastico [Siracide] 24,17); nei Vangeli lo stesso Gesù si paragona alla vite (Giovanni 15,1-8). Pianta cosmica, la vite è, tra l’altro, considerata anche albero della conoscenza nella tradizione ebraica. Non è un caso che questa pianta compaia nella narrazione biblica relativa agli alberi alla ricerca di un re (Giudici 9,8-15), accanto a vegetali nobili come l’olivo e il fico, anch’esso ritenuto albero della conoscenza (Genesi 3,7). In questo passo si sottolinea in particolare il pregio del vino. Proprio la vite, d’altra parte, è l’elemento che viene eliminato nella versione esopica di questa favola biblica (Esopo 252 Ch.). Va precisato, a questo proposito, che al vino nella tradizione favolistica sono estranei alcuni attributi nobilitanti assai diffusi nella cultura antica, come il fatto che ispiri la poesia: o è considerato come bevanda di pregio (addirittura Fedro, con una precisione che non è propria di Esopo, si riferisce a uno specifico vino campano, il Falerno, nella favola 3,1: la vecchia e l’anfora) o si trova persino come sinonimo di vizio, in contesti dai connotati comici (una donna gioca un inutile scherzo per ammonire il marito ubriacone: Esopo 88 Ch.). Significativamente, in controtendenza con il suo rilievo culturale testimoniato in vari contesti letterari, troviamo la vite come protagonista di una sola favola esopica (339 Ch.), forse proprio perché si tratta di una pianta che resta dotata a lungo di un forte valore religioso e perciò appare meno adatta di altre, più umili ed estranee al mito e a liturgie rituali (ad esempio, il rovo), a diventare personaggio centrale nel mondo esopico. In effetti, qui è a confronto con il caprone, in una narrazione forse di derivazione orientale (cfr. Adrados 2003, 562), che rimanda insolitamente a una sfera rituale, mentre in genere le piante, come gli animali, sono presenti nella tradizione favolistica in una chiave desacralizzata (spiega Servio che i caproni sono sacrificati a Bacco per una sorta di «contrappasso», perché fanno danno alla vite: v. sotto). Questo si spiega probabilmente con la lunga sopravvivenza del culto di Dioniso, anche presso gli
strati più umili della società, soprattutto in ambito rurale. Il fenomeno si estende oltre i confini del mondo antico, tanto che, in ambito cristiano, se ne occupa con preoccupazione il secondo Concilio di Costantinopoli (691 d.C.), che proibisce di invocare il dio durante la vendemmia. La connessione del caprone con il dio, su cui implicitamente si basa la favola, è motivata da diversi racconti. Secondo un’antica tradizione, gli abitanti di Ikarion uccisero uno straniero, senza riconoscere che si trattava di Dioniso. Dal cadavere spuntò la prima pianta di vite: da quel momento fu realizzato un rito che rievocava l’episodio, con un caprone che veniva sacrificato come simbolo del dio. Di qui deriverebbe la tragedia. Da notare anche che, nell’ambito delle numerose feste dedicate alla divinità, nel mese di marzo si tenevano le Grandi Dionisie: alle viti veniva dato da bere il sangue del caprone, che era solito distruggerle: «quel caprone era l’epifania animale del dio che informava la vite» (Cattabiani 1996, 102). Nelle morali delle favole la vite pare un simbolo positivo: nella favola 339 Ch. rappresenta gli amici, mentre nella favola 103 Ch. i benefattori verso cui alcuni (in questo caso il cervo, che, dimostrandosi avido e perciò giustamente punito, ne mangia le foglie) non coltivano la doverosa gratitudine (tema cinico). La vite non è apprezzata soltanto per il vino, ma anche per l’uva: nella celebre favola 32 Ch., la volpe cerca di raggiungere un ghiotto grappolo, ma non ci riesce (v. VOLPE). Il caprone e la vite Esopo 339 Ch. Un caprone mangiava i germogli di una vite che stavano sbocciando. Allora la vite si rivolse a lui dicendo: «Perché mi procuri danno? Non c’è forse l’erba? D’altra parte, quando tu sarai sacrificato, io offrirò tutto il vino che sarà necessario». La favola punta l’indice contro gli ingrati e coloro che vogliono
trattare male gli amici. RIFERIMENTI: Aftonio 37; Dodecasillabi 339; Tetrastici 1,7; Antologia Palatina 9,75 (Eveno); 9,99 (Leonida); Svetonio, Domiziano 14; Ovidio, Fasti 1,359-362; Metamorfosi 15,114-126; Marziale 3,24; 13,39. Riscontri interessanti anche in epigrafi (CIL 4,3704,6) scoli e commenti (cfr. Servio sulle Georgiche virgiliane: 2,380). Il cervo e la vigna Esopo 103 Ch. Un cervo, che cercava di sfuggire ai cacciatori, si nascose in una vigna. Dopo che gli uomini furono di poco passati oltre, il cervo, pensando di essere ormai del tutto al riparo, incominciò a mangiare le foglie della vite. All’agitarsi delle fronde, i cacciatori si girarono e ritenendo (era appunto così) che tra le fronde si nascondesse un animale, colpirono il cervo con le loro frecce e lo uccisero. L’animale, ormai sul punto di morire, parlò in questo modo: «Mi sta bene, perché non avrei dovuto oltraggiare chi mi ha garantito la salvezza». La favola dimostra che coloro che fanno del male ai benefattori subiscono il castigo divino. RIFERIMENTI: Tetrastici 1,51.
Volpe Nella cultura occidentale la volpe è simbolo di astuzia, di scaltrezza e spesso anche di malvagità. Ne sono testimonianza non solo alcune osservazioni di carattere scientifico di Aristotele (Historia animalium 488b), ma soprattutto diversi proverbi popolari di larga diffusione, come «Comportarsi da volpe con un’altra volpe» (in Zenobio 1,70 e altri paremiografi) o «La volpe non si lascia prendere in trappola due volte» (cfr. Diogeniano 2,15). Del resto, il modo di fare della volpe è tanto caratterizzato che entra persino nel lessico greco e latino per connotare anche il comportamento degli uomini: ad esempio, il verbo latino vulpinor, usato da autori quali Varrone e Apuleio, significa «comportarsi da volpe», mentre il sostantivo vulpio corrisponde all’incirca al termine italiano «volpone». Plutarco pone la volpe tra gli animali più intelligenti, insieme al lupo e all’ape, contrapposti alla pecora e all’asino (Gli animali usano la ragione 992d). Si riscontrano curiosi aneddoti che confermano queste convinzioni: la volpe viene osservata in inverno dai Traci per comprendere se c’è il rischio che il manto gelato di un fiume si spezzi (Plinio, Naturalis historia 8,103). Non è considerata un animale sacrificale e compare raramente nei miti. La leggenda della volpe di Teumesso, che si fonda probabilmente su una triste consuetudine con cui gli agricoltori dovevano fare i conti, presenta l’animale nelle vesti di astuto beffatore, che reca danni ai campi e al bestiame (cfr. Ovidio, Metamorfosi 7,763 ss.). Artemidoro (Sull’interpretazione dei sogni 2,12) spiega che chi sogna una volpe deve attendersi insidie occulte, specialmente da parte di donne. Anche nella cultura ebraica e cristiana la volpe gode di pessima fama: nei Vangeli, Erode viene paragonato a una volpe (Luca 13,32). La volpe è uno degli animali più ricorrenti nella favolistica, dove assume spesso ruoli da protagonista o
comunque le sono in genere affidate argute battute risolutrici: invita un uomo che conta le onde a guardare al futuro, non al passato (Luciano, Ermotimo 84); commenta l’atteggiamento dei cani che fanno a pezzi la pelle di un leone (Sintipa 19). Addirittura Zeus, ammirandone l’intelligenza e la versatilità, la designa come sovrana degli animali, anche se poi, constatandone la meschinità immutata, la riconduce alla sua antica condizione (Esopo 119 Ch.). Questo animale rappresenta soprattutto l’astuzia, una delle due forze fondamentali che regolano le relazioni del mondo esopico; e, non a caso, si ritrova spesso nel ruolo di primo ministro o di consigliere del leone (cfr. Babrio 106), che è simbolo invece della forza. Queste caratteristiche, complementari, sono sintetizzate in un proverbio di larga fortuna: «Quando la pelle del leone non è sufficiente, è tempo di cucirsi addosso quella della volpe» (v. LEONE). Mentre è al servizio del leone, la volpe riesce così a trarre in inganno per ben due volte il cervo, portandolo direttamente nelle grinfie del re degli animali ammalato: tuttavia, non dimostra piena fedeltà al sovrano e non esita ad approfittare delle situazioni propizie (Esopo 199 Ch.). Non si fa scrupoli nemmeno ad approfittare del litigio tra l’orso e il re degli animali (Esopo 200 Ch.). Dunque, il rapporto con il leone, nei confronti del quale la volpe ha generalmente un senso di sudditanza, quando non addirittura di autentico terrore (Esopo 42 Ch.), non è sempre solidale: grazie alla sua avvedutezza, la volpe non cade in trappola, quando, invitata dal leone ormai invecchiato nella caverna, vede le orme dirette soltanto verso l’interno (Esopo 196 Ch.). Fingendo amicizia, conduce in errore anche il temibile lupo, che si fida ingenuamente di lei (Babrio 130). Per lo più, insomma, la volpe appare come un animale astuto, ingannatore e malvagio, ma spesso abile adulatore (ad esempio con il corvo che lascia cadere il formaggio in Esopo 165 Ch., o con la pernice di Romulus 34) e invidioso nei confronti di chi si trova in condizioni migliori (come il lupo che ha accumulato abbondanti scorte di cibo: Romulus 56). Ma viene talora
descritta in modo più positivo e definita anche «saggia» (Babrio 103). Si rilevano tuttavia favole di segno decisamente differente, che rappresentano stranamente la volpe come vittima di beffe o comunque come animale poco accorto. La volpe si fa goffamente male, quando si aggrappa a un rovo (Esopo 31 Ch.). Non sempre riesce a portare a termine i suoi inganni attraverso le lusinghe: il gallo non cade in trappola e la invita a rivolgersi al temibile cane (Esopo 180 Ch.), mentre la cicala mette saggiamente alla prova la sua (apparente) buona fede (cfr. Esopo 335 Ch.). Celebre la narrazione della volpe e dell’uva (Esopo 32 Ch.), in cui l’ingannatrice per eccellenza finisce per consolarsi ingannando se stessa, poiché non riesce a raggiungere l’obiettivo: questo tema favolistico appare piuttosto antico, tanto che già un vaso del V secolo a.C. sembra riferirsi al tema, assai simile, di una favola sumerica (protagonista un cane che non riesce a mangiare datteri: 5,90 Gordon). Alla volpe capita anche di essere derisa da antagonisti (come la cicogna di Fedro 1,26) che alla fine si dimostrano più furbi di lei. Questo filone narrativo potrebbe rientrare, come nota Pugliarello 1973, 39 ss., nel «carattere proprio di quella figura che in linguaggio di etnologia religiosa viene definita trickster, cioè “imbroglione”»: un personaggio «bifronte», che coniuga «crudeltà ed astuzia» e «sciocca credulità e ciarlataneria», rappresentando forse «la totalità dell’esistenza, nella quale rientra tutto ciò che è disordine, contrario alla norma»: tali figure sono incarnate, ad esempio, dalla lepre nei miti della cultura africana sudorientale (Bantu) o dal ragno presso gli Akasu del Sudan. Tale spiegazione potrebbe risolvere anche le obiezioni razionalistiche circa l’impossibile ingenuità dell’animale, mosse da alcuni studiosi in relazione alla nota favola della volpe dal ventre gonfio (Esopo 30 Ch.), impiegata in vari contesti, anche da Orazio (Epistole 1,7,28 s.), che, per rivendicare la sua libertà nei confronti dell’amico-patrono Mecenate, afferma di essere pronto a sgravarsi di quanto ha ingerito (ossia, le ricchezze che gli sono state donate).
Tra le altre narrazioni, la favola di Esopo 58 Ch. presenta un uomo che serba rancore nei confronti dell’animale: lo cattura e gli dà fuoco, ma la volpe finisce per giungere nei suoi campi e il raccolto va in fumo. Questa narrazione trova significativi riscontri anche nella tradizione romana. Secondo Ovidio (Fasti 4,681 s.), nell’ambito della festa dei Cerialia (in aprile) si legavano fiaccole ai fianchi di alcune volpi e le si facevano correre furiosamente. Lo stesso poeta individua l’origine del rito, che pare avere l’obiettivo di eliminare un animale nocivo (ma più probabilmente si tratta di un rito apotropaico per proteggere i cereali, visto che la volpe pare incarnare lo spirito del grano), in un episodio molto simile a quello della favola: protagonista un giovane di Carseoli. Anche nella Bibbia (Giudici 15,4), troviamo una vicenda simile: Sansone invia nei campi dei Filistei volpi legate a due a due per la coda, con una torcia accesa. La notevole diffusione della volpe in Europa è testimoniata anche dalla sostituzione con essa di altri animali, in motivi narrativi di provenienza orientale. Il più noto è certamente quello relativo alla favola dell’aquila e della volpe (Esopo 3 Ch.): nella tradizione babilonese, abbiamo il serpente che si oppone al re dei volatili (v. AQUILA). Questa equivalenza culturale tra serpente e volpe si giustifica anche sulla base di esplicite osservazioni, come quella di Aristotele, che nota come esista una certa amicizia tra volpi e serpenti, alla luce della comune ostilità nei confronti delle aquile (fr. 354 Rose; cfr. anche Plutarco, L’intelligenza degli animali 981b). Altri motivi simili ricorrono in tradizioni favolistiche lontane: ad esempio, nella tradizione africana dei Bangwa si riscontra il motivo della coda danneggiata di un animale – la lepre – che, in tale ambito culturale, assume significati simbolici affini a quelli della volpe in Occidente. Nella favola greca, d’altra parte, l’assenza della coda diventa un pretesto per un esercizio di vana ipocrisia, che ricorda vagamente il proverbio citato sopra («Comportarsi da volpe con un’altra volpe»). La caratteristica astuzia della volpe è peraltro conservata anche
nel Pañcatantra (III, 90), dove con uno stratagemma si salva dalle insidie dello sciacallo. La volpe, nella sua acuta saggezza, pronuncia anche frasi dal sapore quasi proverbiale, come quando ammonisce il gracchio, in vana attesa che maturino i frutti di un fico, suggerendo l’immagine della speranza come pastore che conduce al pascolo, ma non può riempire lo stomaco (Esopo 160 Ch.). Questo tema è tipico di numerosi proverbi di senso affine (cfr. Tosi 1991, 410), anche se qui il concetto della fallacità delle speranze, presente in diversi contesti letterari, non permette di rilevare un collegamento significativo tra favola e detto sentenzioso. L’uomo che contava le onde Luciano, Ermotimo 84 [Esopo] narrò che un uomo se ne stava seduto sulla spiaggia a contare le onde che si abbattevano sulla riva: una volta perso il conto, si sentiva triste e afflitto, fino a che una volpe gli si avvicinò e gli disse: «Perché, buon uomo, rattristarsi per le onde che sono già passate? Bisogna, invece, che tu riprenda a contare da qui e tralasci il resto». La volpe e il lupo Babrio 130 Una volpe se ne stava non lontana da una trappola, meditando le possibili strategie da mettere in atto. Un lupo, che si trovava nei paraggi, notò la volpe e le si avvicinò, chiedendole se poteva prendere la carne. La volpe rispose: «Vieni avanti e serviti a tuo piacere! Sei infatti uno dei miei amici più stretti». Il lupo si precipitò senza un attimo di
esitazione e, nel protendersi in avanti, azionò la leva: una volta scattata l’asta, venne colpito sulla fronte e sul muso. «Se questo è il genere di regali che fai agli amici, – disse il lupo – come potrà qualcuno stringere amicizia con te?» La volpe dal ventre gonfio Esopo 30 Ch. Una volpe affamata, come vide nella cavità di una quercia un po’ di pane e di carne lasciati da alcuni pastori, si insinuò dentro e li divorò. Ma il ventre le si gonfiò e, poiché non poteva uscire da lì, prese a lamentarsi e a piangere. Un’altra volpe, che passava di lì, appena sentì i suoi gemiti si avvicinò e le chiese la ragione. Dopo aver appreso l’accaduto, le disse: «Resta lì, fino a che ridiventi come quando sei entrata; così potrai uscire facilmente». La favola dimostra che il tempo risolve le difficoltà. RIFERIMENTI: Babrio 86; Parafrasi 30; Tetrastici 1,27; Orazio, Epistole 1,7,29 ss. (cfr. anche il commento di Porfirione al passo); F. dattiliche 22; Girolamo, Epistole 79,3; Agostino, Contra mendacium 28; Isidoro, Etimologie 1,40. Cfr. Suda ε 1884 Adler (per la ricca tradizione medievale, v. anche Adrados 2003, 35 ss.). L’uomo e la volpe Esopo 58 Ch. Un uomo serbava rancore nei confronti di una volpe che gli procurava danni. Allora, dopo averla catturata, volle prendersi una grande vendetta: le
legò alla coda stoppa intrisa d’olio e accese il fuoco. Un dio la guidò però nei campi di colui che l’aveva gettata tra le fiamme. Era il periodo della mietitura e l’uomo le andava dietro gemendo, perché non aveva raccolto nulla. Bisogna essere miti e non arrabbiarsi smodatamente; agli uomini collerici, infatti, l’ira procura spesso un grave danno. RIFERIMENTI: Babrio 11; Aftonio 38; Ovidio, Fasti 4,701; Pseudo-Luciano, L’asino 31,3; Parafrasi 58. Cfr. anche Bibbia, Giudici 15,4-5. La volpe e l’uva Esopo 32 Ch. Una volpe affamata, vedendo dei grappoli d’uva che pendevano da una vite, fu presa dal desiderio di raggiungerli, ma non ci riuscì. Allora, andandosene, disse tra sé: «Sono acerbi». Così anche tra gli uomini, alcuni, quando non riescono a raggiungere per la loro incapacità un obiettivo, danno la colpa alle circostanze. RIFERIMENTI: Fedro 4,3; Babrio 19; Parafrasi 32; Dodecasillabi 32; Tetrastici 1,23; Romulus 71. Cfr. anche Teocrito 1,48 ss. La volpe e il taglialegna Esopo 34 Ch. Una volpe, in fuga dai cacciatori, vide un taglialegna e lo supplicò di nasconderla. L’uomo le consigliò di entrare nella sua capanna e di nascondersi lì. Dopo non molto tempo si avvicinarono i cacciatori e chiesero al taglialegna se avesse visto
una volpe passare di lì. Il taglialegna negò a parole di averla vista, ma con un cenno della mano indicò loro dove era nascosta. I cacciatori non fecero caso al suo cenno, ma prestarono fede alle sue parole. La volpe vide i cacciatori che se ne andavano e, una volta uscita, si allontanava senza dire nulla. Il taglialegna la biasimava, poiché dopo essersi salvata grazie a lui, non aveva espresso nemmeno una parola di riconoscenza. «Io – disse la volpe – ti avrei ringraziato, se il cenno della tua mano e il tuo atteggiamento fossero stati conformi alle tue parole.» Questa favola potrebbe essere applicata a quegli uomini che affermano apertamente buoni propositi, ma si comportano male. RIFERIMENTI: cambiano i protagonisti, ma la struttura è molto simile a Fedro, App. 26 [28]: v. LEPRE per i riferimenti. Le volpi sul Meandro Esopo 29 Ch. Una volta alcune volpi si riunirono lungo il fiume Meandro, con l’intenzione di bere dalle sue acque. Poiché la corrente era impetuosa, esse, anche se si sollecitavano reciprocamente, non avevano il coraggio di affrontarla. Una di loro, tuttavia, si fece avanti per umiliare le altre e derise la loro vigliaccheria; ritenendosi più audace, si avventurò nell’acqua con spavalderia. Poiché però la corrente la trascinò in mezzo al fiume, le altre, ferme sulla riva, le urlarono: «Non lasciarci, ma torna indietro e mostraci la via attraverso cui potremo bere senza correre rischi». Quella, trasportata via dalla corrente, diceva: «Ho un messaggio per Mileto e
voglio portarlo là: quando ritornerò, vi mostrerò il passaggio». Per coloro che finiscono nei guai a causa della loro vanagloria. La volpe senza coda Esopo 41 Ch. A una volpe era stata mozzata la coda da una trappola. Poiché riteneva che la vergogna le avrebbe reso la vita insostenibile, capì che era necessario ridurre anche le altre volpi nella stessa condizione, perché il suo particolare difetto sparisse nella disgrazia comune. Pertanto, dopo averle riunite tutte, le esortò a tagliarsi la coda, affermando che non solo essa era sconveniente, ma era anche un peso inutile, che pendeva dal loro corpo. Tuttavia, una delle volpi prese la parola e disse: «Mia cara, se ciò non giovasse a te, certamente non ci avresti dato questo consiglio». Questa favola è adatta a coloro che regalano consigli al prossimo non per benevolenza, ma per il proprio tornaconto. RIFERIMENTI: Timocreonte, fr. 3 P.; Plutarco, Temistocle 21,7; Zenobio, Codice Monacense 525 (I 166 Bühler); Apostolio 7,28 (Arsenio 23,62). La volpe invidiosa Romulus 56 Chi è malizioso, spesso nella sua astuzia finisce ingannato. Un lupo aveva accumulato nella tana molte provviste, in un lungo periodo, per avere di che abbuffarsi piacevolmente per parecchi mesi; una volpe, come venne a sapere ciò, giunse presso la sua
tana con il proposito di tessere un inganno e, invidiosa nei suoi confronti, gli si avvicinò chiedendogli: «Come mai non ti sei fatto vedere? Sono stata triste per giorni per te, dal momento che non ti ho potuto fare visita». Il lupo si rese conto dell’invidia e replicò: «Non sei venuta preoccupandoti di me, ma per avere qualcosa: so che cerchi di ingannarmi». Assai irritata per queste parole, la volpe andò dal pastore del gregge e gli disse: «Mi sarai grato se ti consegnerò il nemico del gregge oggi?». Il pastore rispose: «Ti offrirò il mio servizio e ti concederò una ricompensa, se vorrai qualcosa». Allora la volpe mostrò dove era la tana in cui si trovava il lupo e il pastore lo trafisse con una lancia; e così la volpe invidiosa si saziò con il cibo altrui. Non molto tempo dopo, anche la volpe venne catturata dai cacciatori e dai cani; allora disse: «Io, che ho commesso del male, ora finisco disgraziatamente in rovina, poiché ho arrecato danno a un altro». Pertanto, ha di che temere chi di nascosto macchina disegni crudeli contro il prossimo. La volpe e la pernice Romulus 34 Mentre una pernice se ne stava in un luogo elevato, una volpe giunse e le disse: «Quanto è bello il tuo aspetto! Le tue gambe, il becco, la bocca sono come un corallo. Se dunque tu dormissi, saresti ancora più bella!». Credendole, la pernice chiuse gli occhi e la volpe subito la rapì. Allora la pernice, singhiozzando, disse: «In nome delle tue abili astuzie, ti prego di pronunciare il mio nome, prima di divorarmi». Quando la volpe fece per dire:
«Pernice», aprì la bocca, e il volatile scappò. Dolendosene, la volpe esclamò: «Oh, che bisogno c’era di parlare!». Rispose il volatile: «Ehi, che necessità c’era che io dormissi, visto che non avevo sonno?». Per coloro che quando non è necessario, parlano, e, quando occorre vigilare, dormono. La volpe che non aveva mai visto un leone Esopo 42 Ch. Una volpe non aveva mai visto un leone. Quando le capitò di incontrarne uno per la prima volta, restò così sconvolta che stava quasi per morire. La seconda volta che le capitò di imbattersi in un leone, ne ebbe paura, ma non come nella prima occasione. La terza volta che lo vide, ebbe tanto coraggio che addirittura gli si accostò per parlargli. La favola dimostra che l’abitudine ridimensiona anche quanto ci fa paura. RIFERIMENTI: Codice Brancacciano 5. La volpe e l’agricoltore Codice Brancacciano 13 Una volta una volpe fissò la sua dimora nella vigna di un anziano agricoltore. Mentre di notte mangiava i chicchi d’uva, di giorno restava in una fossa, timorosa e nascosta. Ma l’uomo la prese in trappola, per poi batterla, ferirla e scuoterla, maltrattandola. «Io – protestava l’infelice – non venni per rovinare l’uva, ma perché desistesse dall’avvicinarsi qui ogni genere di bestia feroce.» Tuttavia il vecchio continuò
a colpire la sventurata oltre sopportazione, fino a farla morire.
ogni
possibile
PROVERBI Oὐκ ἐγὼ μóνα κóλoυρις Non sono io l’unica volpe senza coda L’immagine proposta da Timocreonte (fr. 3 P.) viene accolta da Plutarco (Temistocle 21,7) e dai paremiografi: Zenobio, Codice Monacense 525 (I 166 Bühler), Apostolio 7,28 (Arsenio 23,62). L’espressione di Timocreonte è preceduta e seguita dal riferimento alle altre volpi e alla loro malvagità. Come sintetizza Jedrkiewicz 1989, 331, «esiliato a Ialiso come filopersiano, irritato contro Temistocle, già suo amico, che non aveva voluto spendere la sua influenza per consentirgli di rientrare, Timocreonte esulta alla notizia che anche sull’Ateniese grava l’accusa infamante di medismo. Lo scherno contro Temistocle, ridotto ora alla stessa vergogna di colui che egli aveva sdegnato, si esprime assimilandolo a quella “volpe scodata” di cui Timocreonte adesso non è più l’unico esemplare». Appare evidente l’accostamento alla favola di Esopo 41 Ch., una favola basata su un umanissimo senso di conformismo sociale applicato al mondo degli animali, per cui una volpe senza coda vuole convincere le altre a ridursi nel suo stato, perché la comune caratteristica farebbe venire meno la sua vergognosa condizione. Ἀλωπεκίζειν πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα Fare la volpe con un’altra volpe Il proverbio, che gioca sulla forte caratterizzazione della volpe, concepita nell’immaginario collettivo come sinonimo di persona scaltra, è ampiamente riportato dai paremiografi greci (da Zenobio 1,70 fino ad Macario 1,91 e Apostolio 2,30), viene ripreso nella tradizione latina medievale (Walther 34227e) ed è anche adattato da Erasmo (Adagia 1,2,28). Nello specifico, come spiega Tosi 1991, 126, «il proverbio indica il tentativo fatto da un furbacchione di ingannare un altro furbacchione».
Tale motivo sembra perfettamente in linea con quello della volpe senza coda (Esopo 41 Ch.), che con parole ingannevoli cerca di convincere le altre volpi a togliersi la coda, ma non riesce nel suo intento. Nondum matura est Non è ancora matura Queste parole autoconsolatorie, pronunciate dalla volpe che non riesce a raggiungere l’uva (Fedro 4,3,4; cfr. anche Esopo 32 Ch.), diventano proverbiali. Sembrano inoltre presenti variazioni sul tema di questa favola, con la pera al posto dell’uva (in Plauto, Mostellaria 559; cfr. Della Corte 1958, 41 ss.). Come rileva Tosi 1991, 755, la notevole fortuna di tale proverbio si riflette in espressioni ancora presenti nelle lingue moderne, come il modo di dire italiano «Fare come la volpe e l’uva»: questa espressione ha tale fortuna che non ci si accorge più della favola da cui deriva. Favola, peraltro, rielaborata in età moderna e adattata anche da La Fontaine (3,11) in modo originale.
Z
Zanzara Le zanzare non godono di buona fama nel mondo antico e sono considerate insetti molesti, che spesso, come ricorda Orazio, impediscono il sonno (Satire 1,5,14 s.). L’insolenza delle zanzare, descritte come mostri pronti a succhiare il sangue delle persone, viene ripresa anche dal poeta Meleagro in un epigramma erotico dell’Antologia Palatina (5,151): l’uomo si offre come vittima perché sia lasciata in pace la sua amata. Le sue dimensioni, inoltre, la rendono emblema di ciò che è piccolo e insignificante: nei Vangeli è simbolo opposto al cammello (Matteo 23,24). Non sorprende, dunque, la tendenza ad associarla ai malvagi (Artemidoro, Sull’interpretazione dei sogni 3,8). Ma va segnalato anche un noto poemetto, il Culex, attribuito da una lunga tradizione a Virgilio, in cui l’insetto, benevolo, salva un pastore da un serpente, ma poi, a causa della puntura, viene schiacciato dall’uomo. La tradizione favolistica accoglie la simbologia relativa ai comportamenti molesti della zanzara, ma ne fa, allo stesso tempo, l’emblema di chi, pur di condizioni insignificanti, riesce a essere molto pericoloso: si tratta di una rappresentazione ambivalente, propria anche di altri animali. Nella favola 210 Ch., Esopo segnala la situazione paradossale di chi, come l’elefante, teme l’insetto, che, se si introduce nelle sue orecchie, risulta letale. Allo stesso modo, in due favole (Esopo 188; 189 Ch.) la zanzara è messa a confronto con altri animali di grande forza e dimensioni: il leone e il toro. Nel primo caso, l’insetto, descritto insolitamente come un soldato in guerra, piuttosto spavaldo, offende il leone, ma finisce per perire a causa della tela di un insignificante ragno (il tema della superbia dell’animale vittorioso ricorda la narrazione dei due galli e dell’aquila: Esopo 20 Ch.). La seconda vicenda presenta il toro che tratta la zanzara come una vanagloriosa senza valore; il tema è
probabilmente di derivazione orientale: si tratterebbe di una variante della favola dell’elefante e del cammello trasmessa da Mesomede (cfr. Adrados 2003, 182), da cui trarrebbe origine il proverbio «L’elefante non si cura della mosca» (v. MOSCA). Questa favola è simile alla narrazione della mosca presuntuosa, di cui la mula non si cura (Fedro 3,6) e a quella della pulce che pensa di essere di peso al cammello (Romulus 92), il quale però non la considera affatto. La zanzara e il leone Esopo 188 Ch. Una zanzara andò da un leone e gli disse: «Non ti temo e non sei nemmeno più forte di me; se sei convinto del contrario, dimmi, qual è la tua forza? Che graffi con gli artigli e mordi con i denti? Ma così si comporta anche una donna che litiga con il marito. Io invece sono molto più forte di te. Se vuoi, ti sfido anche a combattere». E, suonata la tromba, la zanzara aggredì il leone, pungendolo sul muso intorno alle narici, dove è senza peli. Il leone, con i suoi artigli, continuava a farsi del male fino a che si arrese. Allora la zanzara, vittoriosa sul leone, suonò la tromba e cantò un epinicio, per poi alzarsi in volo, ma si ritrovò imprigionata nella tela di un ragno. Sentendosi divorare, si lamentava del fatto che lei, che faceva guerra contro i più potenti, periva a causa del ragno, un insetto di nessun valore. RIFERIMENTI: Achille Tazio 2,22. La zanzara e il toro Esopo 189 Ch.
Una zanzara si posò sul corno di un toro e vi si fermò per molto tempo. Quando stava per allontanarsi, domandò al toro se desiderava che ormai se ne andasse; allora il toro rispose: «Quando sei venuta, non mi sono accorto di nulla; se te ne andrai, ugualmente non mi accorgerò di nulla». Si potrebbe applicare questa favola a un uomo di nessun conto, che non produce danno o utilità né se c’è né se manca. RIFERIMENTI: Babrio 84; Sintipa 47; Parafrasi 190; Tetrastici 1,50; Romulus 92; Mesomede, fr. 11 Heitsch.
Zeus (Giove) Suprema divinità in Grecia e a Roma (con il nome di Giove), Zeus, re e signore del mondo, è figlio di Crono, che viene da lui detronizzato, e di Rea; è fratello di Poseidone, Hestia, Ades, Demetra ed Era, che diventa sua moglie. Viene considerato «padre degli dei e degli uomini» e gli sono consacrate le vette del Pelio, dell’Eta, del Parnete, dell’Ida (a Creta) e naturalmente dell’Olimpo. In suo onore venivano realizzati i Giochi Olimpici; Zeus aveva inoltre un culto speciale a Dodona. Secondo una nota leggenda, sarebbe nato a Creta e la madre l’avrebbe nascosto al padre, intenzionato a divorarlo perché gli era stato predetto che sarebbe stato spodestato da uno dei suoi figli. Custodito dai Cureti, venne allattato dalla capra Amaltea, la cui ricompensa fu poi quella di essere posta tra le stelle. Una volta cresciuto, tolse il potere a Crono e lo obbligò a ridare vita ai figli ingoiati. Molto noti gli amori di Zeus: da quello con Alcmena nasce Eracle (v.), da Leto (Latona) hanno origine Apollo (v.) e Artemide, da Mnemosine le Muse (v.), da Semele Dioniso (v.), da Maia Hermes (v.). Celebre è anche l’amore per Europa, figlia di Agenore e Telefassa: Zeus la avvicina prendendo le sembianze di un toro e la porta a Creta. Il dio assume sembianze differenti per avvicinare le figure femminili che sono oggetto del suo amore: per Leda assume forma di cigno, per Danae di pioggia dorata. Tra i suoi attributi, si segnalano lo scettro, l’aquila (v.), la quercia (v.), l’olivo (v.), il fulmine. Queste caratteristiche ritornano anche nelle narrazioni esopiche, dove viene esplicitamente sancito il legame che unisce l’aquila (Esopo 4 Ch.) e la quercia (Fedro 3,17,2) con il dio. Nella tradizione favolistica, Zeus è indubbiamente la
divinità più rilevante (nemmeno Apollo può sperare di competere con lui: Esopo 121 Ch.) e più presente, sia in relazione agli animali sia in relazione agli uomini. Lo schema narrativo più frequente presenta gli animali che inviano un’ambasceria al re degli dei per lamentarsi di un difetto e quindi per ottenere un vantaggio. Così, nell’ambito di narrazioni per lo più di carattere eziologico, si trovano gli asini che chiedono a Zeus di essere sollevati dalle loro fatiche quotidiane (Esopo 262 Ch.); i cani che reclamano un migliore trattamento da parte degli uomini (Fedro 4,18 [19]); il cammello, invidioso del toro, che chiede di avere corna simili (Esopo 146 Ch.); le rane, che desiderano un re (Esopo 66 Ch.); ma troviamo anche le querce, sacre a Zeus, che si lamentano perché sono esposte all’ascia più di tutti gli altri alberi (Esopo 99 Ch.). In genere i reclami non sortiscono effetto e questi personaggi spesso vengono puniti e peggiorano così la loro condizione. Lo stesso meccanismo narrativo viene applicato anche all’uomo che si lamenta, vedendo gli altri animali dotati di specifiche qualità. Ma il re degli dei risponde che gli esseri umani hanno ricevuto il dono più grande: la ragione (Esopo 57 Ch.). Si costruisce sullo stesso schema anche una favola narrata da Callimaco nel secondo giambo (fr. 192 Pf.). Dall’argomento conservato dalla tradizione manoscritta si può ricavare la vicenda, che il testo presenta in modo frammentario: in origine gli animali parlavano come gli uomini, fino a quando il cigno guidò un’ambasceria per chiedere la liberazione dalla vecchiaia e la volpe insinuò che Zeus non agisse secondo giustizia: allora il dio trasferì agli uomini la voce degli animali. La citazione finale suggerisce che Esopo sia nativo di Sardi, mentre la tradizione lo indica, piuttosto, originario di Samo, della Tracia o della Frigia. Questa originale narrazione riprende il motivo topico, proprio della favolistica (cfr. Babrio, Prologo 6 ss.), dell’antica comunanza linguistica degli animali. Uno schema narrativo ricorrente è anche quello delle nozze di Zeus: i doni del serpente vengono respinti (Esopo 122 Ch.), mentre la tartaruga declina l’invito e preferisce rimanere
nella sua ottima casa, dentro cui la divinità, sdegnata, la costringe a vivere (125 Ch.). Alcune favole che vedono Zeus protagonista spiegano l’origine di alcune situazioni, come l’origine del pudore negli uomini (Esopo 118 Ch.). Il mito del vaso di Pandora (Esiodo, Le opere e i giorni 90 ss.) dà lo spunto (insieme a Omero, Iliade 24,527 ss.) per una favola che spiega perché i beni sono fuggiti dagli uomini per giungere presso gli dei (123 Ch.). Dalle stesse fonti, secondo Adrados 2003, 452, deriverebbe anche la favola di Zeus giudice (Esopo 126 Ch.), impostata sul motivo proverbiale (v. sotto) della (talora) lenta, ma inesorabile giustizia divina. I beni sono protagonisti di un’altra narrazione (Esopo 1 Ch.), che, secondo la struttura del conflitto tra due personaggi, soccombono di fronte ai mali, in grado invece di aggredire gli uomini con maggiore continuità ed efficacia. Tra i motivi narrativi di origine mitologica, emergono quelli che accostano Zeus a Prometeo, in relazione alla creazione degli uomini (v. PROMETEO). Zeus e l’orcio dei beni Esopo 123 Ch. Zeus chiuse tutti i beni in un orcio e lo consegnò a un uomo. L’uomo, però, curioso, volle sapere che cosa si trovava in esso e rimosse il coperchio: tutti i beni così volarono dagli dei. Agli uomini rimane solo la speranza, che promette di dare loro i beni fuggiti via. RIFERIMENTI: Babrio 58; Parafrasi 124. Probabile è la derivazione da Esiodo, Le opere e i giorni 90 ss. (il vaso di Pandora). La favola viene contaminata con Omero, Iliade 24,527 ss. Zeus e la volpe
Esopo 119 Ch. Zeus ammirava l’intelligenza e la versatilità della volpe; così le affidò la sovranità sugli animali. Voleva tuttavia sapere se, una volta mutata la sua condizione, l’animale avesse perso anche la sua meschinità; perciò, mentre la volpe si faceva trasportare su una lettiga, lanciò davanti ai suoi occhi uno scarabeo. Quella, non riuscendo a trattenersi, poiché lo scarabeo volava intorno alla lettiga, balzò su, cercando di catturarlo, senza alcun decoro. Allora Zeus fu colto da sdegno nei suoi confronti e di nuovo la fece tornare alla precedente condizione. La favola dimostra che gli uomini meschini, anche se assumono le più nobili apparenze, non mutano certo la loro natura. RIFERIMENTI: Romulus 97 (Nøjgaard 1967, 428 nota un legame anche con Esopo 76 Ch.). Zeus giudice Esopo 126 Ch. Zeus decretò che Hermes scrivesse le colpe degli uomini su una serie di cocci e li ponesse in un’urna vicino a lui, affinché egli infliggesse a ciascuno le pene adeguate. I cocci, però, si mescolarono tra loro: l’uno finì nelle mani di Zeus più velocemente, l’altro più lentamente, perché fosse adottato il giusto castigo. Non bisogna stupirsi del fatto che gli ingiusti e i malvagi non ricevano più velocemente un castigo per le loro colpe. RIFERIMENTI: Babrio 127; Parafrasi 127; Plauto,
Rudens 13 ss. Zeus e gli uomini Esopo 120 Ch. Quando Zeus plasmò gli uomini, ordinò a Hermes di riversare in loro l’intelligenza. E quello, dopo averla divisa in uguale quantità, la instillava in ciascuno. Accadde che chi era piccolo, una volta riempitosi di quella quantità, diventò saggio, invece chi era grosso, poiché il liquido non giunse in tutto il corpo, ebbe minore intelligenza. La favola è adatta a un uomo grande nel corpo, ma di limitato ingegno. Gli uomini e Zeus Esopo 57 Ch. Dicono che in origine furono creati gli animali e vennero fatti loro dei doni dalla divinità: a uno la forza, a un altro la velocità, a un altro le ali; e l’uomo, che era nudo, disse: «Lasci soltanto me privo di doni!». Zeus gli rispose: «Non ti rendi conto del dono, certo grandissimo, che ti è toccato in sorte; infatti, hai ricevuto la ragione, che ha forza presso gli dei e presso gli uomini, più potente dei potenti e più veloce dei più veloci». Allora, compreso il suo dono, l’uomo se ne andò, dopo essersi prostrato e avere ringraziato il dio. Tutti sono gratificati dal dio con la ragione, alcuni però sono insensibili a tale onore e invidiano gli animali, privi di sentimento e di razionalità. RIFERIMENTI: Parafrasi 57; Fedro, App. 2 [3]; Platone, Protagora 320c-322d; Seneca, De beneficiis
4,18; Plutarco, La fortuna 98d; Imerio, Orazioni 68,10-11. La loquacità degli uomini Callimaco, fr. 192 Pf. Era il tempo in cui la razza degli uccelli, quella degli animali marini, quella dei quadrupedi parlavano come il fango di Prometeo […] al tempo di Crono e anche prima di […] il giusto Zeus, governando non secondo giustizia, tolse la voce agli animali e la razza […] – come se noi non avessimo forza sufficiente da offrirne anche ad altri – […] in quella degli uomini; Eudemo ha la voce del cane, Filtone dell’asino, del pappagallo […] i tragici hanno la voce di quelli che abitano il mare; e tutti gli uomini sono da allora loquaci e ciarlieri, o Andronico. Narrò queste vicende Esopo di Sardi, colui che i Delfi non accolsero bene quando cantò la storia. NOTA: Prometeo fece l’uomo con il fango. RIFERIMENTI: Filone, La mescolanza delle lingue 6-8; Apollonio, Lessico omerico s.v. ἄειδε, Clemente Alessandrino, Stromateis 5,14,100; Eusebio, Preparazione Evangelica 13,13,23; Diegesis 6,22-32. I beni e i mali Esopo 1 Ch. Poiché erano deboli, i beni furono messi in fuga dai mali; così salirono in cielo e chiesero a Zeus come fare per poter stare con gli uomini. Il dio
rispose invitandoli ad andare dagli uomini uno per volta, non tutti insieme. Per questo i mali attaccano gli uomini continuamente, perché sono vicini a loro, i beni invece giungono con una certa lentezza, dal momento che devono venire giù dal cielo. Nessuno ottiene i beni velocemente, ma tutti sono colpiti dai mali ogni giorno. RIFERIMENTI: Parafrasi 1. PROVERBI Eorum referimus nomina exscripta ad Iovem Riportiamo i loro nomi scritti a Giove Questa allusione proverbiale è presente in Plauto (Rudens 13 ss.), dove Arturo sostiene di essere stato inviato per esaminare le azioni degli uomini, scrivere i nomi e consegnarli a Zeus. Pare evidente il riferimento alla favola di Zeus giudice (Esopo 126 Ch.), in cui Hermes scrive sui cocci i nomi degli uomini e le loro colpe (cfr. Grilli 44 s.); poiché i pezzi poi si mescolano, il re degli dei provvede con ineguale velocità all’adeguato castigo. Un altro proverbio affine di ambito greco è quello secondo cui «Zeus guarda dopo molto tempo nelle pergamene» (cfr. Tosi 1991, 676, per quanto riguarda le diverse riprese nei paremiografi e, più in generale, il motivo della lenta ma inesorabile giustizia divina).
Appendice AUTORI E FONTI Esopo La figura di Esopo tende a sfumare nella leggenda. Anche se alcuni riscontri sembrano attestarne la realtà storica, nel tempo gli sono state attribuite vicende e caratteristiche infondate o addirittura inverosimili, che lo hanno sostanzialmente reso un simbolo non più esattamente collegabile con il favolista di cui ci parlano le fonti più antiche. In analogia e in contrapposizione a Omero, emblema della poesia epica, Giambattista Vico interpretava la sua figura come il simbolo della saggezza plebea: non «un particolar uomo in natura, ma un genere fantastico». La testimonianza più antica è quella dello storico Erodoto (2,134), che lo indica come compagno di schiavitù di Rodopi, amante del fratello di Saffo: entrambi appartenevano a tale Idmone e vissero nel VI secolo a Samo. Aristotele, nella Costituzione dei Sami (fr. 573 Rose), aggiunge che Esopo in precedenza era stato schiavo di Xanto, un altro cittadino di Samo. Alcune fonti (tra queste, Euagon, storico di Samo del V secolo, Aristotele, Eraclide Pontico) ne suggeriscono un’origine tracia, altre ne indicano un’origine frigia (fra questi, Fedro, Dione Crisostomo, Luciano, Aulo Gellio), ma non mancano ulteriori ipotesi (l’origine lidia è suggerita da Callimaco). Anche la morte è avvolta nel mistero: sarebbe avvenuta a Delfi, dove Esopo sarebbe stato precipitato dalla rupe Iampea. Ancora Erodoto spiega che i Delfi, in conseguenza di un oracolo, avevano invitato a presentarsi nella loro città chi volesse riscuotere l’ammenda pecuniaria per l’uccisione di 1
Esopo: si presentò Idmone, figlio dell’omonimo padrone del favolista. Da alcune fonti (la cronaca di Eusebio e il Chronicon Romanum) si tende a individuare nel 564/663 la data dell’uccisione. Non è chiaro il motivo: forse si sarebbe rifiutato di consegnare ai cittadini di Delfi l’oro affidatogli da Creso, considerandoli parassiti che vivevano alle spalle del dio Apollo; e, quindi, sarebbe stato falsamente accusato di furto sacrilego. Da questo episodio, sarebbe scaturita l’ira del dio nei confronti dei cittadini, che avevano ucciso un innocente (Aristotele, fr. 487 Rose). Successivamente, fu realizzato, ai piedi della rupe dove fu ucciso Esopo, un piccolo memoriale con un altare, dove gli veniva tributato omaggio. Ma perché Esopo andò a Delfi? Confrontando alcune fonti, si può ipotizzare questa ricostruzione: Esopo riesce a liberare Samo dalle minacce del re Creso grazie alla sua sapienza; affrancato, lascia Samo e va a Sardi dal sovrano lidio, che lo invia in missione a Delfi. Non manca nemmeno una sosta alla corte di Periandro, tiranno di Corinto, che intrattiene stretti rapporti con i sacerdoti di Delfi. Dopo la morte, Esopo diventa presto un personaggio autorevole, dai contorni leggendari; forse le sue favole sono messe per iscritto da subito, tanto che, come ricaviamo da Aristofane e da Platone, pare citato e apprezzato ad Atene. Si è molto discusso anche circa l’esistenza di un Volksbuch, che sarebbe circolato ad Atene nel V secolo a.C., con il personaggio Esopo nella duplice veste di protagonista di peripezie e di narratore di favole. Aristotele cita Esopo nella Retorica (1393b), ricordandone un discorso fatto ai cittadini di Samo, che si risolve in una favola dotata di una breve spiegazione. Questa tecnica narrativa lo rende famoso e ne delinea l’assoluta originalità. Tale forma retorica, peraltro, sembra propria delle diplomazie del Vicino Oriente (cfr. Introd., La favola nella Bibbia). La tradizione aggiunge numerose caratteristiche alla figura del padre della favolistica greca. Tali caratteristiche confluiscono nel Romanzo di Esopo (v.), senza 2
tuttavia fondarsi su solide basi storiografiche. La figura di Esopo entra progressivamente nella leggenda e chi lo citerà in seguito non sarà più costretto a fare i conti con il problema della sua storicità: nel I secolo d.C., Plutarco lo descrive nel Convito dei sette sapienti insieme ad altre figure di saggi quali Solone e Talete, anche se in una posizione di inferiorità rispetto a essi. Quanto alla tradizione delle favole esopiche, si ha notizia di una raccolta di Demetrio Falereo, allievo di Teofrasto, alla fine del IV secolo a.C. ma non ce ne rimane traccia (v. Introd., La favola nella letteratura greca). Le raccolte esopiche superstiti risalgono invece all’età imperiale e medievale. Ne sono state individuate tre redazioni: 3
a. Augustana, dal nome del codice Augustanus Monacensis 564, nota anche come classe P e recensio I: presenta 231 favole, alcune comuni alle altre collezioni; a questa si può accostare anche una recensione affine Ia, che conserva 143 favole (alcune presentano motivi differenti). L’Augustana pare la redazione più antica, anche se gli studiosi non concordano nella datazione, per cui abbiamo una serie di proposte che vanno per lo più dal I-II al V secolo d.C., ma non manca chi sposterebbe in avanti, fino al X secolo, la collocazione cronologica; b. Vindobonense, dal nome di uno dei codici (Codex Vindobonensis gr. hist. 130), detta anche classe C o recensio II: presenta 130 favole: 40 di queste narrazioni derivano dalle parafrasi babriane in prosa e vengono riscritte qui in forma metrica (dodecasillabi bizantini); anche in questo caso la datazione è oscillante: si ipotizza dal IV al IX secolo d.C.; c. ) Accursiana, dal nome dell’umanista Buono Accorsio, che la pubblicò nel 1479; detta anche classe L o recensio III, è chiamata Planudea, in quanto pare essere stata compilata dal bizantino Massimo Planude nel Trecento: presenta quattro
sottorecensioni (127 le favole, in gran parte trasportate dalle altre collezioni); la datazione ipotizzata va per lo più dal III al IX secolo d.C. Non mancano trasposizioni di una favola da una collezione a un’altra, ma per lo più sembrano realizzate per via indiretta; secondo alcuni studiosi, in queste redazioni si riscontrano anche tracce di raccolte ellenistiche in versi. Come nota La Penna (1996, XX), la tradizione manoscritta delle favole è aperta e presenta chiare peculiarità rispetto ad altri testi, poiché «passa per copisti che si ritengono liberi di modificare il testo, di abbreviarlo, di ampliarlo, di ornarlo (chiamiamoli copisti-redattori o, addirittura, nuovi autori): in parte la tradizione delle favole esopiche è quella dei racconti popolari o dei commenti o di certi manuali: si tratta, cioè, di testi in continua trasformazione». Da ricordare anche il corpus dei circa duecento proverbi che sono attribuiti al favolista. Romanzo di Esopo Il Romanzo di Esopo (Vita Aesopi) è una biografia fittizia del favolista, risalente all’età imperiale, elaborata in Oriente, probabilmente in Egitto (Perry 1952) o in Siria (La Penna 1962). Mette insieme fonti e motivi narrativi di diversa epoca e provenienza: Esopo è presentato come schiavo frigio del filosofo Xanto. Il testo, la cui struttura in genere viene tripartita nell’interpretazione degli studiosi (vicende di Samo, nel Vicino Oriente, a Delfi), presenta subito Esopo, schiavo muto (o balbuziente, secondo le versioni), che ottiene da Iside (o dalla Tyche, la Fortuna) il dono della facondia. Venduto a un mercante di schiavi, finisce a Samo, dove è acquistato dal filosofo Xanto: a questo punto della storia vengono narrati vari episodi, che vedono lo schiavo privo di cultura superare intellettualmente il colto e borioso padrone. Esopo, abile nel risolvere enigmi, viene così affrancato e tiene un discorso ai
cittadini di Samo, in cui li invita a resistere al re lidio Creso, da cui poi si reca come ambasciatore. A questa parte segue l’interpolazione con il Romanzo di Ahiqar (v. Introd., La tradizione mesopotamica): divenuto consigliere del re Licurgo e scampato alla condanna a morte per una calunnia del figlio adottivo, Esopo va a Menfi e, con la sua sapienza, ha la meglio sul faraone Nectanebo. Alla fine il favolista approda a Delfi, dove, incolpato ingiustamente di un furto sacrilego, viene giustiziato, non prima di avere invocato sui suoi assassini una punizione divina, che puntualmente li colpisce. Alcune favole sono inserite lungo la narrazione, spesso in modo forzato, tanto che si sono ipotizzati innesti su un racconto già formato e preesistente. L’aspetto fisico del favolista – schiavo, straniero, brutto d’aspetto ma ingegnoso – si delinea in modo caricaturale, secondo una tradizione iconografica attestata anche da una coppa attica del V secolo a.C., in cui Esopo è rappresentato con testa enorme e membra disarmoniche. Tale aspetto fisico pare coerente con la sua condizione sociale di schiavo. Ma l’ingegno riscatta l’uomo, secondo una connotazione tipicamente paradossale, che segna la figura esopica sotto vari punti di vista. La Vita Aesopi ci è pervenuta in due versioni principali, note come Vita G (forse versione orientale con la presenza di Iside come protettrice di Esopo) e Vita W (versione occidentale, con la Tyche come protettrice di Esopo), che appare in gran parte come una rielaborazione dotta di G, derivando talora da un archetipo comune del I secolo d.C. Non mancano frammenti papiracei e si ha traccia di una terza versione, denominata da Perry π, assai diversa. A ciò si aggiungono frammenti papiracei (pubblicati da Zeitz) e versioni medievali di grande fortuna (in latino la Vita Lolliana, in greco la versione attribui-ta a Massimo Planude). Fedro La fonte per ricostruire la vita di questo poeta è quasi
esclusivamente la sua stessa opera, peraltro in diversi passaggi non semplice da interpretare. Si ipotizza che sia nato in Tracia (qualcuno, interpretando letteralmente il prologo al III libro, suggerisce invece la Macedonia come terra d’origine) intorno al 20 a.C. e che, dopo una rivolta repressa da Lucio Calpurnio Pisone Frugi, sia stato portato a Roma come prigioniero. Ricevette una buona educazione: come si rileva nell’epilogo del III libro (vv. 33 ss.), da ragazzo studiò Ennio. Inserito fra gli schiavi al servizio di Augusto, ottenne poi la libertà, probabilmente per meriti culturali. La condizione di liberto non gli garantì una vita tranquilla, tanto che subì, al tempo di Tiberio, un processo con un’accusa infamante, forse relativa a un reato comune, che Fedro non rivela mai nella sua opera, mentre si lamenta dei metodi iniqui usati in questa circostanza da Seiano, onnipotente ministro di Tiberio, che si era probabilmente ritenuto il bersaglio di favole irridenti del I e del II libro. Questa calamitas finisce per condizionare negativamente tutta l’esistenza di Fedro. Dopo che nel 31 d.C. Seiano fu giustiziato, il poeta compose il III libro delle sue favole. Cercò a lungo un protettore, soprattutto tra quei liberti che avevano assunto una posizione di potere: Eutico, il dedicatario del III libro; Particolone, uomo di cultura a cui viene rivolto il IV libro; Fileto, forse, considerato il tono più confidenziale, non un protettore ma un amico, identificabile, secondo alcuni studiosi, con un omonimo liberto di Claudio. Emerge così il profilo di un poeta emarginato, il quale, invecchiando, sembra cercare un riconoscimento che tarda ad arrivare e oltretutto si trova spesso a fare i conti con la malignità di alcuni detrattori. Ci sono diverse ipotesi circa la data della sua morte, ma non è dimostrato che egli sia vissuto fino al periodo di Nerone o addirittura di Vespasiano. La fortuna di Fedro non pare immediata e sulla sua figura cala un generale silenzio, tanto che, intorno al 43 d.C., Seneca (Consolazione a Polibio 8,27) sottolinea come la favola esopica non sia ancora stata sperimentata «dagli ingegni romani». Anche Quintiliano (1,9,2), pur
soffermandosi sulle favole esopiche, lo ignora. D’altra parte, Fedro viene nominato da Marziale, in un passo tuttavia abbastanza controverso (3,20,5) e, alcuni secoli dopo, da Aviano che nella prefazione delle sue favole ne ricorda l’opera in cinque libri. Ma l’oblio cala ancora sulla sua figura, segnando tutta l’età medievale, anche se sappiamo che in alcune biblioteche era presente la sua opera, come si apprende ad esempio da un elenco stilato dall’abate Iskar di Murbach intorno all’850 d.C.; ma solo nel 1596 con l’editio princeps, la prima edizione a stampa, di Pierre Pithou la sua fama comincia a imporsi. Per quanto riguarda la tradizione manoscritta, si segnalano innanzitutto due codici del IX secolo, copiati a Reims e apparentati: il Pithoeanus (P), pubblicato da Pierre Pithou, quindi proprietà del marchese Le Peletier de Rosanbo e ora posseduto dalla Pierpont Morgan Library di New York; il Remensis (R), distrutto nell’incendio avvenuto nel 1774 all’abbazia di Saint-Remi di Reims, ma di cui sono conservate le varianti grazie a un’opera di collazione svolta in precedenza da alcuni studiosi (Rigault, Gude, Roche, Vincent). Forse appartenente alla stessa famiglia di manoscritti, la vetus Danieli chartula (D) presenta otto favole del primo libro: risale al IX secolo e la compilazione avvenne nel monastero di Fleury (Saint-Benoît-sur-Loire). Nel 1470 secolo l’umanista Niccolò Perotti, vescovo di Siponto, trascrisse 64 favole di Fedro, metà delle quali coincidenti con quelle tramandate dalla restante tradizione manoscritta, metà invece del tutto nuove (la cosiddetta Appendix Perottina, che, nelle edizioni fedriane, viene normalmente aggiunta ai cinque libri). Il manoscritto di Perotti subì diverse vicissitudini (oggi abbiamo conservate anche le Schedae Dorvillianae, frutto dell’opera di collazione effettuata nell’Ottocento da Jacques-Philippe Dorville) e venne infine pubblicato da Cataldo Iannelli: si tratta del codice Nea-politanus IV F 58 (N), oggi danneggiato e illeggibile, ma ricopiato prima del 1517 nel codice Vaticanus Urbinas Latinus 368 (V), in gran parte trascritto nel codice
di Bologna, Bibl. Univ. 2948 (XVIII secolo). Per ulteriori dettagli, vedi Solimano 133 s. Babrio Autore della prima raccolta in versi (coliambi) di tradizione greca a noi nota, Babrio era probabilmente un discendente di una di quelle famiglie che si trasferirono dall’Italia in Oriente a partire dalla fase conclusiva della Repubblica romana. Visse nel II secolo d.C. (ma alcuni studiosi ritengono che sia vissuto nel I secolo d.C., e non mancano altre ipotesi), in Siria o in zone vicine (forse in Cilicia). Come per gli altri favolisti antichi, sappiamo poco della sua vita: dal secondo prologo (9 ss.) ricaviamo l’informazione che la sua opera ebbe un soddisfacente successo; altre fonti lo segnalano come un autore ben presto studiato nella scuola. Il fatto che per due volte dedichi le sue favole a un certo Branco, figlio del re Alessandro, ha fatto ritenere che potesse essere un pedagogo. Per tradizione diretta, abbiamo 144 favole (123 presenti nel Codice Athos, proveniente dalla biblioteca del monte Athos e ora conservato in quella del British Museum di Londra): fanno parte di una più ampia collezione antica, ordinata alfabeticamente; altre sono ricavabili dalle parafrasi in prosa e dai dodecasillabi bizantini. Aviano Di questo poeta, vissuto probabilmente tra il IV e il V secolo d.C., autore di 42 favole in distici elegiaci, è incerto tutto, persino il nome, che oscilla tra Aviano e Avieno anche nella tradizione manoscritta più antica. La maggior parte degli studiosi moderni propende per la prima opzione, in quanto Avianus appare lectio dificilior, probabilmente banalizzata in Avienus, nome più comunemente diffuso. Il dedicatario dell’opera è Teodosio, che si tende a identificare con Ambrogio Macrobio Teodosio, autore dei Saturnalia,
opera in cui troviamo la figura del giovane e nobile Avieno; pertanto, alcuni studiosi, identificandolo, senza tuttavia prove certe, con il favolista, sostengono l’ipotesi del nome Avieno anziché Aviano. Le favole di questo poeta sembrano ispirarsi soprattutto a Babrio. Tra i modelli meglio riconoscibili nei suoi versi, si rilevano Virgilio e Ovidio. Nel Medioevo Aviano è molto considerato: studiata nelle scuole, la sua opera è anche oggetto di parafrasi e di rifacimenti in versi (v. Introd., La fortuna della favola). Oltre 130 i codici superstiti. 4
Papiro Rylands 493 e altri papiri Si tratta di un frammento papiraceo che risale alla prima metà del I secolo d.C.; contiene 14 favole, di cui soltanto quattro abbastanza leggibili. Si è ipotizzata una fonte comune con la tradizione dell’Augustana. L’ipotesi che il papiro conservi una parte della collezione di Demetrio Falereo non è suffragata da prove sufficienti. Oltre a questo papiro, non ne vanno dimenticati altri che conservano singole favole o piccoli gruppi di favole: tra questi, particolarmente rilevanti sono i nn. 38, 39 e 40 Cavenaile, il Papiro Grenfell 2,84, l’Amherst 2,26, il Michigan 457. Pseudo-Dositeo La tradizione manoscritta attribuisce indebitamente a Dositeo, grammatico di origine greca del IV secolo d.C., un’opera incompleta (dodici libri di esercitazioni), intitolata Hermeneumata (Interpretazioni). L’autentico autore dell’opera, un professore celato dietro l’identità di Dositeo e perciò chiamato Pseudo-Dositeo, elabora un corpus di 18 favole in prosa a scopo didattico; due le redazioni, a cui si aggiunge ora il papiro PSI VII 848 per la favola 15 (cfr. Adrados 1999a): quella Leidense (Codex Vossianus graecus Q. 7 [L]) offre la traduzione dal greco in latino e quella Parigina (Codex Parisinus Latinus 6503 [P]) dal latino in
greco. Da elementi interni alle favole, che appaiono essenzialmente come esercizi di traduzione, è stata ipotizzata una datazione all’inizio del III secolo d.C. Due di queste narrazioni sono traduzioni di Babrio. Tavolette di Assendelft Si tratta di sette tavolette di cera ritrovate a seguito di scavi che prendono il nome dall’ufficiale olandese Van Assendelft de Coningh, che le acquistò nel 1881. Conservano gli esercizi di uno scolaro di Palmira, centro ai confini tra Siria e Mesopotamia, del III secolo d.C. Il testo è corrotto: una parte di queste 14 favole è riconducibile a Babrio, che evidentemente fu un autore piuttosto studiato nelle scuole già nel periodo immediatamente successivo alla sua morte. Due favole sembrano vicine a quelle dello Pseudo-Dositeo. Aftonio Retore del IV secolo d.C., scrive 40 favole in greco, dotate sia di promitio sia di epimitio: l’intento è didattico, lo stile semplice e immediato. Molte di queste favole derivano da Babrio o sono affini ad alcune riportate dai suoi parafrasti. Discepolo di Libanio, Aftonio, «caposcuola di tutta la tradizione bizantina» (Sbordone 1932, 46) è riferimento per retori come Nicolao di Mira e Dossopatre, che ripropongono le sue favole. Codice Brancacciano Contiene 14 favole, appare di difficile datazione (si è pensato al V secolo d.C., sulle base delle caratteristiche stilistiche). Le narrazioni, che sembrano inquadrabili in un contesto didattico, trovano per lo più corrispondenze nell’ambito della tradizione antica: fa eccezione la favola 13. I testi di questo codice, che si caratterizzano per lo stile talora pomposo e ricercato, sono stati pubblicati da
Sbordone nel 1932. Raccolte latine tardoantiche e medievali in prosa Fedro fu sostanzialmente ignoto per tutto il Medioevo, ma le sue favole, rielaborate, ebbero un’ampia circolazione in quest’epoca. La favolistica tardoantica e medievale latina presenta, infatti, sia parafrasi in prosa sia raccolte di narrazioni in versi, frutto del lavoro di numerosi compilatori. Con il nome di Esopo latino si indicano le parafrasi in prosa che risalgono per lo più a Fedro, ma talora anche ad altre fonti. Intorno al V-VI secolo d.C., si forma una raccolta di favole in prosa riconducibile sia a Fedro sia a parafrasi di Fedro: il cosiddetto Aesopus ad Rufum. Da questa collezione perduta deriva il codice Wissemburgensis della fine del IX secolo (definito anche Guelferbytanus Gudianus Latinus 148), che presenta una lettera di Esopo a Rufo (in latino il nome Rufo, ossia «fulvo», equivale al significato di Xanto in greco: nome del filosofo di Samo che secondo la tradizione del Romanzo di Esopo fu padrone del favolista) e contiene 57 favole suddivise in 5 libri. Un’altra raccolta, derivata dall’Aesopus ad Rufum attraverso l’intermediazione di una silloge perduta, è quella chiamata Romulus, perché i codici iniziano con la lettera di un certo Romolo al figlio Tiberino, dove si afferma che le favole sono tradotte dal greco al latino. Entrambe le ramificazioni di questa famiglia di manoscritti (Gallicana e vetus), che riportano un numero variabile di favole, presentano, dopo la lettera di Romolo al figlio, anche quella di Esopo a Rufo. Oltre a queste due redazioni, va segnalata una terza silloge di parafrasi in prosa: quella che risale al codice Vossianus Latinus 8° 15 della Biblioteca dell’Università di Leida, frutto dell’opera del monaco Ademaro di Chabannes (la redazione risale circa al 1025). Si tratta di 67 parafrasi di favole fedriane o del Romulus, talora contaminate: l’opera è 5
a uso didattico. Thiele, il maggiore editore moderno del Romulus, ha pubblicato con una numerazione continua queste favole, accostando le versioni delle differenti tradizioni manoscritte. La ricostruzione del Romulus appare, dunque, un’operazione delicata, perché «si potrebbe parlare di un processo di poligenesi complessa e contemporaneamente limitata, in complicati intrecci che di comune hanno, spesso, soltanto la lontana origine»: meglio riferirsi, dunque, ai Romuli piuttosto che a un Romulus (Boldrini 1994, 8). Grazie agli studi degli ultimi secoli, oggi si riesce a ricostruire meglio l’impronta fedriana dietro i testi tardoantichi e medievali. Uno dei maggiori esperti della questione, lo svedese Carlo Zander, ha cercato di ricostruire i testi in senari di Fedro. Molte altre riprese favolistiche segnano il Medioevo, ma non hanno diretta attinenza con Fedro e con la favola antica (v. Introd., La fortuna della favola). 6
Tetrastici giambici di Ignazio Diacono e dei suoi imitatori Si tratta di favole di quattro versi (con alcune, limitate eccezioni), in trimetri giambici, opera di Ignazio Diacono, autore bizantino del IX secolo, e dei suoi imitatori. Pubblicate da Müller nell’edizione babriana di Crusius, sono suddivise in due libri: il primo presenta 57 favole, il secondo, meno regolare sul piano metrico, 32. Sulla base della tradizione manoscritta, tendono a essere riferite a Babrio, ma non mancano altre significative affinità, ad esempio con il Codice Brancacciano. Favole dattiliche Dai frammenti in nostro possesso, siamo in grado di supporre l’esistenza di una serie di favole in distici elegiaci. Conservati in gran parte nella Suda, ma anche in altre fonti,
pubblicati da Crusius, questi frammenti sono per lo più considerati imitazioni babriane. Questa collezione (o forse ce n’era più di una) segue la tradizione, che va da Solone e Teognide fino all’Antologia Palatina, di favole in distici elegiaci. Parafrasi Bodleiana e Dodecasillabi I testi della Parafrasi Bodleriana (versioni in prosa con resti di versi coliambici) sono così chiamati dal nome del manoscritto Ba di Oxford (Bodleianus Auct. F 4.7), che insieme ad altri (denominati Bb, Bc e Bd) ci conserva questa tradizione (oltre a manoscritti delle collezioni anonime, con versioni babriane delle favole): Chambry, non ritenendo che tutte le 148 favole di Ba avessero connessione con Babrio, ma solo 92 di esse, peraltro in diversa misura, pubblicò le parafrasi con le favole anonime. La datazione è dibattuta e oscilla dal IV al VII secolo d.C. Nell’ambito della tradizione babriana, vanno segnalate anche le favole scritte in dodecasillabi politici (ossia versi «comuni», «volgari», tipici della poesia bizantina e neoellenica). Sintipa Sotto lo pseudonimo di questo personaggio di origine orientale, conosciuto sotto diversi nomi (Syntipas in greco), alla cui leggendaria biografia sono legati vari aneddoti nelle letterature medievali, conserviamo un corpus di 62 favole tradotte in greco nell’XI secolo da un testo siriaco, che derivava, a sua volta, dalla tradizione greca. La traduzione venne eseguita da Michele Andreopoulos, autore anche di una versione greca dal siriaco del Libro di Sindbad (novelle persiane medievali). Alcune delle favole provengono dalla tradizione anonima, altre da Babrio; «undici di esse risultano senza riscontro e si è pensato a una derivazione da tradizioni siriache, ebraiche o arabe» (Jedrkiewicz 1989, 33). Da ricordare anche le favole siriache di Esopo pubblicate da
Bruno Lefèvre nel 1941 (Une version syriaque des fables d’Esope). La favola nei retori In età imperiale le favole sono largamente impiegate nelle scuola. Molti retori ne teorizzano l’uso nell’insegnamento, per esercitare gli allievi nella produzione scritta, senza dimenticare l’insegnamento morale, nei Progymnasmata (Esercizi preparatori): fra questi, Ermogene, Aftonio (v.), Teone, Pseudo-Dositeo (v.) e Nicolao (II-V secolo d.C.). Di qui, come teorizzato anche da Quintiliano, la favola si impone come un genere di ampia diffusione nella scuola, come del resto è ancora oggi.
1 Esercizi preparatori 1, p. 57 Spengel II [=1, p. 1 Patillon]; 3, p. 72 Spengel II [=4, p. 30 Patillon]; esistono comunque differenti interpretazioni: invece di «verità», alcuni traducono «realtà». Cf. Van Dijk 1997, 48 n. 59. 2 Senza contare altri generi di confine o sfumature interne a questi generi: ad esempio, Tosi 2010, 13 ricorda la contiguità, rispetto al proverbio, dell’adagio, dell’apoftegma, della sentenza, della massima e dell’aforisma. I confini restano tuttavia incerti e oscillanti. 3 Si è supposta l’esistenza di un libro esopico: v. ESOPO; si sa anche che Socrate si divertiva a mettere le favole in versi: cfr. Platone, Fedone 60c. 4 Si è supposto, pertanto, che Isidoro abbia male interpretato uno scolio del retore Aftonio, in cui si riferisce che nella favola sibaritica intervengono solo animali razionali, mentre in quella esopica razionali e irrazionali, in quella libica e frigia soltanto quelli razionali (cfr. Fontaine 177). 5 Cfr. Jedrkiewicz 1989, 48 s. 6 Cfr. Mandruzzato 6 s. 7 Nell’Institutio oratoria si sofferma sul tema in due riprese: 1,9,2; 5,11,19. 8 Cfr. Pugliarello 1973, 39 ss. 9 Cfr. Jedrkiewicz 1989, 194 ss. 10 Così nota La Penna 1968, XXXIX, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti circa le strutture narrative in Fedro.
11 Cfr. Nøjgaard 1964, 148. 12 Cfr. Nøjgaard 1964, 361 ss. 13 Cfr. anche la variante presente, ad esempio, in Esopo 217 Ch. 14 Cfr. Pisi 65. 15 Si traggono diversi spunti dall’articolata analisi di La Penna 1961, 464 ss., a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 16 Cfr. Jedrkiewicz 1989, 262. Per il rapporto tra favola e proverbio, v. Van Thiel 105 ss. 17 Cfr. Jedrkiewicz, 1989 297 ss. Sulla favola nella letteratura greca e latina, v. anche l’analisi e gli elenchi di Holzberg 2002, 10 ss. 18 Sulla favola in Aristofane, v. Schirru. 19 Cfr. Van Dijk 1997, 124 ss. 20 Contro un bibliomane ignorante 4; Su coloro che vengono assunti per mercede 25; Dialoghi delle meretrici 14,4. 21 La Penna 1996, XXIV. 22 In generale, in Plauto ricorrono le caratteristiche animali dei personaggi, spesso convergenti con quelle esopiche; così, ad esempio, il topo risulta piccolo ma saggio (Truculentus 868 s.), il cervo rapidissimo nella corsa (Poenulus 529 s.), il cane sempre pronto a mordere (Bacchides 1146). 23 Il padrone del campo chiama amici e parenti, ma, come
prevede l’uccello, questi non vengono a mietere; quando, invece, il padrone dichiara di voler svolgere il lavoro personalmente con il figlio, allora l’allodola dice ai suoi piccoli che è davvero giunto il tempo di andare; significativa appare la morale, riportata in versi settenari trocaici (metro di sapore popolare, non a caso usato anche nella commedia), che invita a non aspettarsi da altri quello che si può fare di persona (frr. 21-58 V. ). 24 In generale, la favola oraziana si distingue per il frequente effetto di pointe finale, la presenza di termini propri della tradizione favolistica (forte, per caso; olim, un tempo) e di espressioni assimilabili all’epimitio. Appare, inoltre, costante l’adattamento del motivo esopico al contesto poetico e alla biografia del poeta. 25 Cfr. Solimano 32. 26 Marchesi 1923, 79. 27 Cfr. Ayán Calvo 119 ss. 28 Per un quadro completo, cfr. Contini-Grottanelli 40 s. 29 Cfr. La Penna 1996, VII ss. 30 Cfr. Thompson 1967, 27. 31 Si rimanda a Bechis 11 ss., da cui si traggono le notizie qui sintetizzate, per ulteriori informazioni su questo e altri aspetti del Pañcatantra. 32 Cfr. Adrados 1999, 328 ss. 33 Chambry, nella sua edizione di Esopo (Notizia su Esopo, XXVIII), liquidava in poche parole l’ipotesi di una derivazione della favola esopica da quella ebraica, sostenuta da 2
Landsberg e Goldberger. Tuttavia, esistevano punti di contatto in epoca tarda: alcuni motivi della tradizione esopica furono ripresi nella letteratura rabbinica. Cfr. Maciá 267 ss. 34 Luzzatto 1996, 1312. 35 Sulla fortuna delle favole di Aviano nel Medioevo, v. Bisanti 2010. 36 Per una rassegna di illustrazioni del XV al XX secolo, v. il sito web www.aesopica.net.
1 Per quanto riguarda i paremiografi, se non diversamente indicato, si fa riferimento al Corpus Paroemiographorum Graecorum, I-II (Gottingae 1839-1851) a cura di E. Leutsch e F.G. Schneidewin: qui è presentata la cosiddetta versione «vulgata» (I, 1-175), più lontana dall’originale rispetto alla versione «atoa»; sulla questione, v. W. Bühler, Zenobii Athoi Proverbia, I, Gottingae 1987 (si farà esplicita segnalazione quando non si citerà Zenobio dal CPG). Riguardo alla Suda, si fa riferimento ad A. Adler, Suidae Lexicon, I-V, Lipsiae 1928-1938. Per quanto riguarda, invece, il Pañcatantra, in assenza di diverse indicazioni, si segue Bechis, citato in bibliografia anche per l’introduzione (presenta la versione del Tantrākhyāyika).
1 Cfr. La Penna 1996, XIV. Per un approfondimento, v. Luzzatto 1996, 1307 ss. 2 Cfr. Perry 1952, Test. 9-10. 3 Cfr. la puntuale sintesi di Jedrkiewicz 1989, 19 ss. sulla scorta degli studi precedenti. 4 Cfr. Solimano 123 ss. per una sintesi sulla tradizione manoscritta. 5 Cfr. la sintesi di Bertini 1998, 8 ss. 6 Zander 1921.
.
Frontespizio Il Libro L'autore Dizionario della favola antica Introduzione
Personaggi La narrazione: strutture e tipologie La morale Ideologia della società esopica La terminologia della favola Favola e proverbio Storia della favola antica La favola nella letteratura greca La favola nella letteratura latina La favola nella letteratura cristiana antica La favola nelle altre tradizioni culturali Tradizione mesopotamica Tradizione indiana Tradizione egizia La favola nella Bibbia La fortuna della favola
4 2 3 6 6
9 11 13 15 19 21 23 24 29 35 37 38 41 43 44 46
Nota al testo e criteri di impostazione dell’opera
50
Bibliografia
57
A
90
Edizioni di riferimento
B
C
Bibliografie Edizioni dei principali favolisti Bibliografia generale Abete Afrodite Agnello Airone Alcione Allodola - (terragnola) Alloro Amaranto Anguilla Ape Apicoltore Apollo Aquila Arabo Arciere Artigiano Asinaio Asino Aspide Astronomo Atena - (Minerva) Atleta Augusto Avvoltoio Balena Biscia d’acqua Borea Bovaro Bue Cacciatore Calzolaio Cammello Cane Canna Capra Capraio Caprone Castoro Cavallo Cedro del Libano Cervo Chiocciola Cicala Ciclope Cicogna Cigno
52
57 57 57
91 93 97 101 103 106 111 115 116 118 121 123 129 139 141 143 145 147 167 169 171 173 176 180
182 183 186 189 191 193
201 202 207 209 214 228 231 237 240 243 246 255 256 266 268 273 275 277
D
E
F
G
H I
L
M
Cinghiale Citaredo Civetta - (gufo) Coccodrillo Conchiglia Conciapelli Contadino Cornacchia Corvo Cuculo Danaidi Delfino Demade Demetra Demetrio Demostene Dessicreonte Diogene Dioniso - (Bacco) Dioscuri Donna Donnola Drago Elefante Era - (Giunone) Eracle Eros Esopo Etiope Fabbro Farfalla Fico Fiume Formica Fortuna Frassino Fuco Gabbiano Gallina Gallo Gambero Gatto Gelso Ghiozzo Giardiniere Gracchio Granchio Gru Guerra Hermes - (Mercurio) Horkos - (Giuramento) Iena Indovino Inganno Iride Issione
281 286 288 292 295 296 298 307 313 321
322 323 324 328 330 331 333 335 337 340 343 344 355 363
366 367 371 373 378 381 391
393 394 396 398 400 402 407 410 411
412 413 415 419 424 425 429 431 433 437 442 446 448
449 450 459
461 462 464 467 468 469
471
Leone Leopardo Lepre Lucertola Luna Lupo
472 486 488 495 498 500
Macellaio Maga Maiale - (scrofa) Mani Mare Maschera Medico
513 516 519 524 525 528 531
512
N
O
P
Q R
S
Melo Melograno Menagirti - (Galli) Menandro Menzogna Mirto Momo Montone - (ariete) Morte - (Thanatos) Mosca Mulo Muse Naufrago Navigante Nibbio Noce
536 537 539 541 542 543 545 547 551 553 557 561
564 565 567 571 575
577
Oca Oggetti Olivo Onagro Orfeo Orso Ostrica
578 581 587 590 593 595 600
Pantera Pappagallo Passero Pastore Pavone Pecora Penia - (Povertà) Pernice Pescatore Pesce Piccione - (colombo) Pidocchio Pino Pioppo Pipistrello Platano Pluto Polpo Pompeo Poros - (Espediente) Poseidone Principe - (flautista) Prometeo Pudore Pulce
602 604 605 607 614 618 625 626 629 634 639 644 646 648 649 651 653 654 655 658 659 660 663 669 670
Quercia Ragno Ramno Rana - (rospo) Religione Riccio Rondine Rosa Rovo Sacerdote Sardella Satiro Scarabeo Schiavo Scimmia Scorpione Serpente Simonide Sisifo Smaride Socrate Soldato Sole - (Helios)
601
673 674
678 679 681 682 690 692 695 700 702
705 706 708 709 711 714 719 730 732 740 745 746 748 753 757
T
U V
Z
Sparviero - (falco) Spugna Stagioni Struzzo Talpa Tantalo Tartaruga Tempo - (Kairos/ Occasione/Giorno) Terra - (Gea) Tiberio Tigre Tiresia Tizio Tonno Topo Tordo Toro Uomo Usignolo Vacca Vasaio Verità Verme Vespa Violenza Vipera Vitello - (giovenco) Vite - (vino, uva) Volpe Zanzara Zeus - (Giove)
Appendice AUTORI E FONTI
759 762 764 766
767
768 770 771 776 778 781 785 787 790 791 793 802 804
808 809 828
831 832 833 835 838 839 841 842 845 849 853
866 867 870
877 877

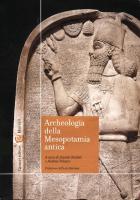






![Archeologia della Mesopotamia antica [1a edizione.]
9788843077830, 884307783X](https://dokumen.pub/img/200x200/archeologia-della-mesopotamia-antica-1a-edizione-9788843077830-884307783x.jpg)

