Atlante della Bibbia 9788839923950
In breve con 115 pagine di illustrazioni a colori Questo Atlante della Bibbia intende facilitare ad un vasto pubblico l
1,062 101 38MB
Italian Pages 256 Year 2006
Polecaj historie
Citation preview
ANNEMARIE OHLER
ATLANTE DELLA BIBBIA con 115 pagine di illustrazioni a colori
Organizzazione grafica delle illustrazioni Tom Menzel con la collaborazione di Jan-Martin Lohndorf
QUERINIANA
Titolo originale: Annemarie Ohler, dtv-Atlas Bibel
© 2004, 2006' by Deutscher Taschenbuch Verlag © 2006
GmbH & Co. KG, Miinchen, Germany by Editrice Queriniana , Brescia via Ferri, 75 - 25123 Brescia {Italia/ UE) te!. 030 2306925 - fax 030 2306932 internet: www.queriniana.it e-mail: [email protected]
Tutti i diritti sono riservati.
È pertanto vietata la riprodu zione, l'archiviazione o la trasmissione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo , comprese la fotocopia e la digitalizzazione, senza l'autorizzazione scritta dell'Editrice Queriniana. ISBN 88-399-2395-0 Traduzione dal tedesco di ANNAPAOLA LALDI Stampato dalla Tipolitografia Queriniana, Brescia
Prefazione
In questo 'Atlante della Bibbia' sono entrate molte cose che ho potuto collaudare in corsi, seminari e conferenze tenuti nell'arco di qualche decennio. All'idea di presentare la Bibbia sono però arrivata soltanto otto anni fa. A ciò fui spinta dal fatto che mi ero resa conto che tanto all'Università quanto nelle serate di formazione organizzate dalle parrocchie, risultava sempre meno possibile costruire sulla conoscenza dei fatti; anche per i cristiani la Bibbia è diventata estranea. Già l'uso linguistico è indicativo: 'Bibbia' viene chiamato un libro, le cui enunciazioni devono essere considerate indiscusse. Eppure l'Antico e il Nuovo Testamento non sono affatto una raccolta di dottrine che prescrivono ai credenti che cosa devono credere. La Bibbia è il libro che, nel nostro ambiente culturale, ha dato un'impronta persistente al modo di parlare e di pensare, alla vita pubblica e privata, all'arte figurativa, alla letteratura, alla musica, alla filosofia . Per poter descrivere adeguatamente la peculiarità di questo libro unico nel suo genere per l'umanità bisognava raccogliere un complesso di conoscenze disparatissime. Infatti la Bibbia è lo specchio di una storia più che millenaria dell'Antico Israele, del popolo ebraico e delle prime comunità cristiane. Spazi ancora più vasti di epoche e civiltà si rivelano grazie ai pensieri e alle immagini, alle forme linguistiche e di vita, che gli autori biblici hanno ripreso dal mondo dell'Antico Oriente e da quello greco-romano, trasformandole e trasmettendole a loro volta. Inoltre la Bibbia prese forma in una lw1ga storia di interpretazioni sempre nuove di ciò che era stato tramandato, interpretazioni che non sostituivano gli strati anteriori, ma li ampliavano. Così divenne testimonianza di una molteplicità di interpretazioni che invita alla discussione. Con la Bibbia è possibile studiare come questo fondamento spirituale abbia reso possibile a persone appartenenti a un popolo piccolo, al quale arrise un breve successo politico (e alla fine, anche a persone di altri popoli, che da loro impararono) , di rapportarsi in modo intelligente con realtà storiche e interpretazioni del mondo mutevoli. Per rendere visibili, anche con citazioni della Bibbia, le tracce di questa awincente storia della sua formazione, piuttosto che servirmi delle traduzioni correnti, ho preferito, all'occasione, tenermi vicina al testo ebraico e greco. Horben, primavera 2004
Annemarie Ohler
6
1. La Bibbia/Introduzione
LJ
1500 a.e.
I testi sorgono
o
sono raccolti
1000 a.e.
diventano il centro di una religione
500 a.e.
vengo no canonizzati
o
sono importanti nella loro letteralità
"'
'O E
"'e ()
~
vengono parafrasati, tradotti
500 d.e.
~
Qi
"C Q)
Lsono model lo per nuove scritture sacre
e ·;; 'O
~ ·~
:g
Q) Q)
"C
"' ~
o. o o. Q)
ti s
o
~
o
e
"C "C
~
CD ·e
Cl
li
.o
o
o
:.:J
fino ad o
1000 d.e.
g
A Storia delle Scritture sacre
... per Israele
... nella legge
... nella storia
.. . per Israele e i popoli
... con i profeti
... con Cristo
lette e ascoltate nel servizio divino presso gli Ebrei
presso i cristiani come parola di Dio
B La Bibbia: Scrittura sacra e testimon ianza di eventi storici
1.1 Sacre Scritture
Segni distintivi delle Sacre Scritture In religioni fra loro distanti si sono formate idee simili sulle scritture sacre. Lo rivela in modo chiaro un confronto tra i Veda e la Bibbia. Sono ricevute, non inventate I Veda sono i testi originari delle religioni dell 'India, le cui parti più antiche risalgono al II millennio a.C. Sono venerati come 'scienza eterna' (sanscrito: veda), scoperta da veggenti in tempi remoti e custodita da sacerdoti. A ciò si può paragonare l' idea della Bibbia come 'parola di Dio'. Ma secondo quanto dice la Bibbia, gli esseri Lll11ani hanno ricevuto questa parola nel corso di una lunga storia. Per questo, nella Bibbia non ha importanza solo ciò che è 'eterno' ; le esperienze legate al tempo mantengono negli scritti biblici il proprio peso. Sono vive nella parola ascoltata In realtà, i Veda ancora oggi devono essere solo ascoltati, imparati a mente e conservati nella memoria da bramani a tale scopo istruiti. Il modo giusto di incontrare la Bibbia è invece considerato il servizio divino (la liturgia) , in cui si legge a voce alta dalla Sacra Scrittura affinché la 'parola di Dio' venga udita e sia di nuovo attuale. Vengono tramandate con rigore testuale Ancora prima dei Veda furono stabilite le regole che dovevano assicurarli contro ogni modifica; si fissarono sia le regole metriche e declamatorie sia quelle grammaticali , fonetiche ed etimologiche della lingua sanscrita (dal V sec. a.C.). Nella storia delle religioni bibliche il richiamo al 'testo originario' della Bibbia, da rispettare rigorosamente, divenne un fattore di stabilità, ma spesso anche di riforma . Vengono separate nettamente da altri testi Alcune enunciazioni dei Veda furono parafrasate in forma poetica in inni o epopee divine, ma anche contestate. Dal V sec. a.C. i Veda sono distinti da questi testi; mentre i Veda sono considerati 'uditi ', cioè non fatti dall'uomo, altri testi sacri sono ' ricordati', cioè hanno l'impronta del pensiero umano, e possono essere modificati e citati nella vita quotidiana. Neppure il testo della Bibbia può essere cambiato. Dal II sec. d.C. ci si preoccupò di stabilire w1 testo unitario e si definirono i confini del 'canone' dei libri biblici rispetto ad altri scritti religiosi. Ma diversamente dai Veda, la Bibbia deve essere accessibile a tutti; per questo è tramandata in forma scritta e, fin dall'antichità, anche in traduzioni.
Caratteristiche della Bibbia Una letteratura nazionale diventa Sacra Scrittura Gli eventi decisivi sono due: 1. Dopo la caduta del loro stato, nel 587 a.C ., gli Ebrei deportati poterono ancorare la loro identità soltanto alle tradizioni scritte e orali. Raccolte con cura e rielaborate per la nuova situazione, esse divennero il segno principale di appartenenza per le c01mmità ebraiche disperse. 2. Con la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., gli Ebrei persero per la seconda volta il luogo venera to come centro del loro popolo. D'ora in poi, centro e torah ('insegnamento') della vita ebraica furono unicamente, e in sempre nuove interpretazioni, le Sacre Scritture.
È una rivelazione costituita da più parti L'idea della Bibbia come parola di Dio si fonda su due linee-guida della Sacra Scrittura d'Israele: 1. I profeti parlano in nome di Dio; 2. Le norme che regolano la vita d'Israele sono considerate la legge annunciata da Dio al Sinai. Per questo, nel NT la Sacra Scrittura d'Israele è chiamata spesso
il
le leggi
per costruire il santuario
'Libro del Patto'
ISRAELE
un santuario
approva A Annuncio dell'alleanza (Es 20)
B Conclusione dell'alleanza (Es 21-24)
C Violazione dell 'alleanza (Es 25-32)
te tribù d'ISRAELE circondano il santuario
I' ISRAELE convertito costruisce il santuario D Nuova alleanza (Es 33-40)
E Consolidamento dell'alleanza
(Lv)
F Alleanza santa (Nm 1-10)
3.11 Israele al Sinai (Es 19-Nm 1O) • 45
Il racconto della sosta d'Israele ai piedi del Sinai è la pericope più lw1ga della Bibbia; qui furono collocate tutte le leggi che nelle varie epoche d'Israele dovettero dare ordine alla vita sociale e religiosa. Questa cornice dà alle leggi un 'importanza straordinaria. Le altre leggi dell'An tico Oriente sono leggi dello stato, proclamate dal re. Le leggi d'Israele sono dono di Dio al suo popolo. Nel mito b abilonese l'essere umano viene forma to dalla potenza sconfitta del caos; lo stato deve assicurare l'ordine del mondo contro l'umanità caotica. Nel1'AT, invece, al di sopra di stato, tempio, ordine sacerdotale, sta la volontà di Dio che ha liberato Israele affinché anche Israele renda giustizia agli oppress1. Dalla critica di Paolo alla legge dell'AT (Rom 3) i teologi cristiani fanno derivare una contrasto tra legge e vangelo (gr. 'buona notizia'); ciò è immotivato alla luce del!' AT. La prim a parte della peri cop e del Sin ai (20-24) è composta di testi che sottolineano il fatt o ch e I sra ele, istruito da Dio, deve prowedere direttamente alla giustizia. Solo nel Decalogo (20) , che è premesso alle leggi come modello, Dio si rivolge direttamente a Israele. Tutte le altre leggi, Dio le dà al popolo, perché è così che egli vuole, con la mediazione di Mosè. Dopo questa premessa, il cosiddetto Libro del Patto (21-23 ) appare come giurisp ru denza divina. Stato e sacerdoti non compaiono in questa raccolta di leggi; l'Israele maggiorenne può regolare da sé le sue questioni giuridiche. La composizione che segue (24) narra di tre azioni simboliche che indicano la legislazione del Sinai qu ale fondamento dell'alleanza di Dio con Israele: • Come nel caso di un trattato, Mosè legge un 'docw11eoto del patto' e Israele approva. • Come in una fratellanza di sangue, Mosè asperge altare e popolo col 'sangue del patto'. • Un pasto, che Mosè e i 70 anziani hanno il permesso di tenere al cospetto di Dio, suggella l'unione con Dio. Nella seconda parte (25-40) si tratta del significato del santuario. Nell'immagine di una tenda addobbata troppo riccamente per Lll1 santuario mobile per il deserto, il testo parla del santuario dell'Israele postesilico, il tempio di Gerusalemme. Israele dovrà onorarlo come il luogo in cui dimora Dio, inteso come maestro delle gi uste norme di vita, perché Dio, nel!' entrare nel suo santuario , si è presentato nella nuvola come accadde al Sinai (40,34). In Dt 10,5s. incontriamo W1'altra idea: Israele deve portare da sé la legge divina; l'immagine di ciò è l'arca in quanto custodia delle tavole della legge. L'idea dell'arca è più antica del tra-
no, su cui Dio prende posto in mezzo a Israele e da cui si alza per camminare con Israele (Nm 10,35s.). Tra le istruzioni per la costru zione del santuario (25-31) e la loro esecuzione (35-40) sono inseriti dei testi che pongono la questione se Israele sia degno della presenza divina. Il racconto del cosiddetto vitello d'oro (32) risponde di no. Mentre Dio istruisce Mosè sul san tuario , il sacerdote Aronne dichiara segno della presenza divina l'immagine di un vitello. Israele, dunque, già al Sinai viola il tra ttato secondo cui non cercherà Dio in W1'immagine fat ta con le proprie mani (20,4). Dietro a ciò stanno delle esperienze dell'VIII sec. , quando in Israele, per paura dell'Assiria, ci si volle assicurare la vicinanza divina con w1 esagitato culto delle immagini. Cfr. Os 13 ,2: IV. Una generazione nuova (26-37) prima di morire Mosè le dà istruzioni per vivere nel paese
50
100 km
A Indicazioni geografiche nel libro dei Numeri
31
teoria bellica presentata in modo narrativo
33
Tappe del cammino
B Struttura del libro dei Numeri
3.13 Israele in cammino per il suo paese (Nm) • 49
I racconti del deserto parlano di un Israele che è liberato dalla schiavitù solo esteriormente e che è incapace di essere responsabile. Le immagini che descrivono Israele come un bambino, che Dio deve imboccare, portare in braccio, guidare, ritraggono questa situazione (Nm 11 ,12 ; Dt 1,31 ). La promessa di «latte e miele» (secondo Is 7,15 un nutrimento da lattanti) dovrebbe rendergli 'appetitoso' il paese, in cui bisognerà che si procacci il nutrimento col proprio lavoro.
Prima dell'evento del Sinai Dio era pronto ad aiutare Israele senza riserve (Es 14-17) . Nelle angosce di morte davanti all'esercito egizio, alle acque amare, alla fame, alla sete, Israele si ribella a Mosè e vuole tornare in schiavitù . Mosè invoca aiuto; Dio lo ascolta e salva Israele.
Dopo la rivelazione del Sinai Israele è maggiorenne. Che ora le cose vadano giudicate diversamente, lo rivelano delle variazioni di racconti presinaitici: Israele marcia come in una spedizione militare, preceduto dall'arca, il segno della presenza divina tra le schiere d'Israele (10,11-36). Il popolo adesso deve sopportare da solo le conseguenze di un cattivo comportamento. Quando si ribella perché non gli piace più la manna, Dio gli dà più carne del necessario; Israele ci si butta sopra con ingordigia e parecchi muoiono (11). Le immagini di morte presentano il tempo del deserto come un passaggio critico. Altri autori delineano immagini ideali del periodo del deserto (Os 2,17; Ger 2,2s.). Il racconto degli esploratori (13s .) segna il pW1to più basso. Israele considera w1a catastrofe politica l'impresa che deve aiutarlo a raggiungere l'indipendenza nel suo paese; preferisce morire nel deserto. Di nuovo, Dio gli dà ciò che pretende; in una peregrinazione di 40 anni nel dese rto muore tutta una generazione. Ma con un 'ulteriore variazione di un motivo presinaitico, un racconto spiega che Dio è il giudice che pw1isce solo per gli individui ostinati: in Es 15 ,22ss. Dio era il medico per tutto Israele; ora viene guarito solo chi guarda il serpente di rame mostrato da Mosè (21 ). Dalla rott ura dell'alleanza del Sinai Mosè non è solo la guida per Israele, ma anche l'intercessore; egli muove Dio a perdonare Israele (Es 32,llss.; Nm 14,20). Israele deve la sua esistenza alla fedeltà con cui Mosè difende presso Dio W1 Israele che ha meritato la morte, e all'amicizia tra Dio e Mosè, che perm ette a Mosè di far cambiare idea a Dio. Q uesto elemento dell'immagine di Mosè aiu terà a interpretare l'agire di Gesù.
Dopo il Sinai le rivolte contro Mosè sono punite come resistenza a Dio, in modo particolarmente duro nei sacerdoti (16). Tuttavia Mosè stesso si umilia; se dipendesse da lui sarebbero tutti ripieni di spirito divino e il suo ufficio sarebbe superfluo (11,29; 12,3; 14,5; 16,4). Ma la crisi d'Israele coglie anche Mosè (20). Ciò è illustrato in una variazione del racconto presinaitico del dono dell'acqua. Invece di rendere onore a Dio, Mosè fa ricorso al miracolo come segno della propria autorità; di conseguenza anche lui morirà nel deserto. - Poi comin cia una nuova sezione narrativa: Israele si avvicina senza deviazioni al suo paese. La storia della formazione di Nm può essere iniziata con dei racconti in cui, nel sec. XIII, si cercava di rispondere alla domanda come mai solo W1a piccola schiera avesse portato nel paese la fede dell'esodo. Ma certo le immagini della crisi nel deserto rispecchiano esperienze del!' epoca in cui mancò poco ch e Israele scomparisse (VIII-VI a.C.) . Un 'immagine di speranza si trova alla fin e (26) : è morta la generazione che un tempo (1 ) è stata contata; ne è sorta una nuova altrettanto numerosa. La presentazione degli eventi dopo la rivelazione del Sinai contiene contraddizioni particolarmente numerose. Accanto a giudizi duri sui sacerdoti si trovano testi che narrano del dmo intervento dei sacerdoti contro usanze pagane (Es 32,26-28) . Il vertice è Nm 25: il sacerdote Pincas uccide il resto della generazione dell'esodo. Questo strato sarà stato aggiunto nel V sec. a.C., quando i sacerdoti assw1sero la guida d'Israele. In quest'epoca la piccola schiera degli Ebrei rimpatriati temeva di perdere l'identità adattandosi ai non-ebrei. Con i racconti della guerra madianita e dell' uccisione della coppia mista (25 ; 31), dovevano essere compensati i ricordi del matrimonio madianita di Mosè, di cui però non furono del tutto estù1te delle ù11magini positive: Dio lo protegge dalla calwmia (12) ; non è solo la nube di Dio a guidare Israele attraverso il deserto, ma anche il suocero madianita di Mosè (10) . Alcune incoerenze spesso ù1dicano che era stata conservata la tradizione antica. Un documento extrabiblico offre un argomento a favore del fatto che ciò vale anche per l'episodio isolato ù1 22-24: quando Israele si accampa in Transgiordania, il veggente pagano Balaam, figlio di Bear, deve maledirlo; ma, obbedendo al Dio d'israele, lo benedi ce. Nel 1967 degli archeologi trovarono a Deir Alla (Transgiordania) Lm 'iscrizione aramaica del IXVIII sec. a.C. con frammenti della visione di sventure di un certo Balaam , figlio di Bear. Evidentemente i narratori biblici si sono fatt i ispirare da un racconto profetico non israelitico.
50 • 3. Il Pentateuco
Modelli del Deuteronomio ... ... dai grandi regni dell' AO
... da Israele
Trattati di vassallaggio Codici di leggi Richiesta di lealtà Raccolte di singole leggi di un Re dei re con forza legale
XVIII sec. ~==========~ codice di Hammurabi XIVsec. Trattati ittiti dopo il 1000 Codice del Libro del Patto (Es 21-23)
VII sec. Trattati assiri dalla pomposa retorica
VIII-VII sec. predicazione dei profeti
di reciproco dovere di fedeltà fra Dio e Israele A Forme linguistiche di varia provenienza nel Deuteronomio
5u
Ninive Capitale dell'Assiria)
26 Sais (Egitto)
• Città
e paese B Giuda, uno dei molti stati vassalli dell 'Assiria nel VII sec. a.e.
3.1411 Deuteronomio (Dt) • 51
Il Deuteronomio si svolge in un solo giorno e in un solo luogo; il giorno della morte di Mosè Israele ne riceve le ultime volontà. Il Dt si presenta come il libro dei discorsi di commiato di Mosè.
Il primo discorso, una predica sulla legge (1-4) fo rnisce uno sguardo retrospettivo al camm ino d'Israele dall"Horeb' sino al confine del paese e introduce nel tema prùKipe del Dt: la vita nel proprio paese deve rendere Israele capace di mantenere l'alleanza con Dio in quanto popolo libero. Nel Dt il Sinai si chiama 'Horeb', 'terra deserta', forse per evitare l'assonanza con 'Sin ' (divinità 1LU1are assira) Il secondo discorso contiene la legge deuteronomica (D). Esso narra gli eventi accaduti allo Horeb (5-11) e interpreta D (12-28) come parola di Dio, che Mosè conosce da allora e adesso affida a Israele (5,27ss.). Nella successiva cerimonia del patto (29-3 1) Mosè vincola tutto Israele a questa legge, menzionando esplicitamente anche bambini, vecchi, donne, stranieri, nonché l'Israele a venire. Un cantico di Mosè (32) , che, con immagini altrimenti estranee ali' AT, canta il dramma della storia di Dio con Israele, era in origine la conclusione del Deuteronomio. Conclusione del Pentateuco è 33s. I redattori , che inserirono il Dt nel Pentateuco, misero alla fine la benedizione di Mosè per le 12 tribù (33 ) e la notizia della morte di Mosè, che si collega a Nm 27 . La storia della formazione del Dt è fissabile storicamente in w1 punto preciso. Con la sua sfarzosa prosa artistica, inusuale nell 'AT, prende a modello dei testi di trattati neoassiri del VII sec. a.C., a volte concordandovi alla lettera. Inoltre utilizza elementi dei formulari dei trattati, di cu i si servivano i 're dei re' orientali per esigere la fedeltà dei piccoli stati divenuti loro vassalli.
Elementi del trattato di vassallaggio: Preambolo: autopresentazione del 're dei re'; cfr. l'autopresentazione di Dio in 5,6 Prologo storico: storia dei partner del trattato; cfr. retrospettiva del Deuteronomio sul periodo passato nel deserto e previsioni circa la vita nel paese Dichiarazione di principio: ordine di lealtà; amare un solo Signore; cfr. 6,4 Clausole particolari: cfr. D {12- 26) Lista dei testimoni divini del trattato: nel Dt manca; cfr. però l'invocazione di cielo e terra in 32,1 Benedizione e maledizione: cfr. 28. Nel XIV sec. gli Ittiti usavano un formulario del genere; nel VII sec. gli Assiri lo perfezionarono,
facendone il trattato ufficiale per gli stati sottomessi. Vassallo assiro fu Manasse di Giuda (699643 ). Il nipote Giosia (641-609) visse la decadenza dell'Assiria e la sfruttò per una riforma sociale e religiosa (2 Re 22s.) . I suoi funzionari, istruiti nella retorica assira, avranno rielaborato la legge deuteronomica (D) e il Dt primitivo. Già il Libro del Patto (Es 21-23) si collega alla struttura tradizionale dei codici giuridici dell'Antico Oriente; il Dt potenzia elementi che danno a un codice la funzione giuridica. La legge diventa valida in virtù della proclamazione pubblica (5,1), accessibile in ogni momento e assicurata dai cambiamenti con la sua trascrizione sulla pietra (5 ,22 ). Il Dt nacque all'epoca di un rinascimento della letteratura dell'Antico Oriente; poco prima Assurbanipal (669-627) aveva creato la sua famosa biblioteca. Gli autori del Dt avranno saputo della stele di Hammurabi (À'VIII sec.) con i suoi 282 articoli. Proprio per questo sottolineano che Dio, nel decalogo, ba dato al suo popolo Lll1 riassunto della legge, facile da ricordare. Essi ne fanno il filo conduttore della legge deuteronomica; le singole leggi di D sono la spiegazione concreta delle dieci parole. Anche il Libro del Patto (B) era loro noto; infatti adattano alla propria società urbana delle leggi di B, che sono valide in wrn società agricola, e ne rafforzano i tratti w11anitari. Gli insegnan1enti del Deuteronomio corrispondono alle speranze dello slancio nazionale di Giosia. Un unico Dio e il suo popolo: scopo della politica assira era sottomettere i popoli e i loro dèi unicamente al dio Assur. Manasse lo aveva accettato per la sopravvivenza di Giuda. Il Dt insegna che Israele e .JHWH sono vincolati tra di loro in modo esclusivo (6,4) e reciproco (26,16ss. ). Un popolo solidale e il suo paese: l'impero assiro aveva una rigida organizzazione dal vertice alla base; il progetto costituzionale deuteronomico (16ss.) distribuisce l'esercizio pubblico della giustizia fra tribunali locali, sacerdoti, re, profeti. Israele deve esercitare la solidarietà perché è a tutto il popolo che Dio ha dato in eredità il paese come fonte di benessere e di libertà. Un solo santuario e una sola legge: Israele deve godere il proprio benessere nelle solennità religiose come una sola parentela in un solo luogo sacro. La legge deuteronomica relativa al santuario (12) è rivoluzionaria; si rivolge contro molti luoghi, in cui vivevano memorie delle esperienze divine fatte dagli antenati d'Israele. Che Giosia abbia profanato luoghi sacri (2 Re 23) è documentato dall' archeologia. L'Lll1ico santuario d'Israele doveva essere il luogo in cui i sacerdoti custodivano e insegnavano la legge.
52 • 4. L'opera storica deuteronomistica
Articolazione deuteronomistica della storia d ' Israele
La legge di Dio: Mosè l'ha proclamata (Dt) Gs
articolazione moderna
secondo i temi
secondo i libri
Presenza di Dio:
L'arca ne è il segno Mosè l'ha occupato (Nm 10,35) a est del Giordano (Nm 21 ; 32)
è il criterio per giudicare: l'epoca di Giosuè
Il dono di Dio, il paese:
entra nel paese (Gs 4)
D
epoca prestatale
Giosuè a ovest del Giordano.
dal Xlii sec. a.e .
~s1 e23
Gdc
Viene salvato dalla minaccia nemica dai 'giudici',
l'epoca dei Giudici Gdc2
1 Sam l'epoca dei re
Israele la perde (1Sam1-6)
1 Sam 12
intorno al 1000 dal re Saul, dal giovane Davide.
un unico regno
2 Sam
prima del 930 arriva a Gerusalemme (2 Sam 6)
Trova pace con i re Davide
e Salomone. il regno di Salomone
1 Re
1Re2
-------'
Dio è presente nel tempio (1 Re 6-9)
2 Re
È messo in pericolo dalla divisione in due stati.
la fine d 'Israele
L
due reg ni Israele e Giuda
722
2Re17 solo Giuda sopravvive
la riforma di Giuda
L
A Babilonia viene liberato il re Joachin
2 Re 23
la libertà politica
è
~erduta
il tempio è distrutto
il paese appartiene ai nemici
Epoche della storia d 'Israele dal punto di vista biblico e moderno
587 anche Giuda è caduto
4.1 Sua struttura • 53
I sei libri Gs-2 Re, al di là dei rispettivi confini, narrano senza interruzione la storia d'Israele dall'ingresso nel paese fino alla deportazione e all'esilio. Alla base di questo insieme sta un a teoria storiografica unitaria. I tes ti di riflessione, che evidenziano i confini delle varie epoche storiche, adottano sempre lo stesso criterio per ciascuna di esse: il popolo e i re hanno obbedito alla legge di Dio? Hanno servito solo JHWH o anche altri dèi? Al contempo viene esaminata limportanza del paese per Israele: • A che scopo Dio ha dato il paese a Israele al tempo di Giosuè (Gs 1 e 23 )? • A che scopo, al tempo dei giudici , ha chiamato dei salvatori a difendere il paese (Gdc 2)? • Quali nuove opportunità ba dischiuso l'epoca dei re (1Sam12; 2 Sam 7; lRe 2) ? • Perché Israele ha perso il suo paese (2 Re 17)? I giudizi stereotipati di questi testi sono vicini al Dt sul piano concettuale e stilistico; per questo, nell'esegesi moderna, Gs-2 Re si indicano di solito come l'opera storica deuteronomistica (dtr). L'ordine dei libri nella Bibbia ebraica insegna a leggere i libri Gs-2 Re (senza Rut) quali 'profeti anteriori ', insieme con i 'profeti posteriori' (Is, Ger, Ez e il libro dei Dodici profeti), come interpretazione profetica della storia d'Israele. Nell'AT il libro di Rut interrompe l'esposizione deuteronomistica. L'opera deuteronomistica e il Pentateuco hanno molteplici collegamenti. AlcW1i esempi: • Quella libertà degli oppressi, che l esodo doveva portare, continua a essere assen te (Gdc 6,13; 19,30); • L'arca, che entra nel tempio come segno della presenza di Dio, ba accompagnato Israele dal Sinai in poi (Nm 10,35s.); • Mosè ha conquistato e distribuito il paese a est del Giordano (Nm 21,32 ) e Giosuè fa lo stesso a ovest (Gs) . Il confine temporale fra le du e opere è costituito dalla morte di Mosè e dal p assaggio del comando a Giosuè, il confine spaziale dall 'attraversamento del Giordano da parte d'Israele. Q ui sono rappresentati circa 700 anni di storia; un terzo dell 'op era è dedicato agli appena 100 anni dall'inizio del regno al tempo di Saul, David e Salomone. Una data zione precisa degli eventi è possibile solo dal momento in cui Israele, nel IX sec., è menzionato in docW11enti scritti cieli' Assina.
Il fulcro tematico è la critica alla monarchia - una novità nel quadro della storiografia dell'Antico Oriente: • I testi storici della Mesopotamia (dal III mili. )
esaltano sempre le ges ta dei re, compiute su oggetti del loro potere. • Più criticamente parlano i testi ittiti (.XIII sec.); essi danno anche agli awersari dei re un proprio profilo e trattano i conflitti in cui cade il sovrano. Una novità è rappresentata dall'esposizione deuteronomistica di lunghi processi storici, di complessi destini della dinastia e del regno. Nuova è soprattutto la prospettiva; agli autori interessa il destino del loro popolo; chiedono a che scopo Israele abbia bisogno dei re, e se, rispetto ad essi, abbia conservato la propria peculiarità. Dei racconti originariamente indipendenti sono collocati nell'opera in modo tale che ogni epoca riceve una propria connotazione. Più volte gli autori indicano le fonti: evidentemente potevano ricorrere a ricche scorte. Ma diversamente dai primi storici greci non stanno a esaminare quali informazioni delle loro fonti siano vere; le contraddizioni possono trovarsi vicinissime. Un esempio: secondo Gdc 1,18 la tribù di Giuda ba conquistato Gerusalemme; secondo Gdc 1,21 essa è «fino a oggi» w1a città dei Gebusei. Lo scopo dell'opera non si può stabilire con chiarezza . La fine è aperta; dopo la caduta di Giuda, da LÙtimo, ricorda che il re J oiachin fu liberato dalla prigione (562 a.C.) e godette a Babilonia per tutta la vita di w1 trattamento degno del suo rango. Quest'opera deve din1ostrare che Israele ha perso giustam ente il paese? Deplorarne la perdita? Un'altra interpretazione la suggerisce 2 Re 23. Poco prima del suo fosco epilogo, la narrazione raggiunge un vertice. Più di tutti gli altri re viene celebrato Giosia; come lui, nessLmo avrebbe seguito la legge divina. Secondo la presentazione deuteronomistica la riforma di Giosia corrisponde ampiamente alle richieste del codice della legge di Dt 12ss. Nei capitoli finali che seguono non si trova più nessLmo dei giudizi deuteronomistici; diversamente dalla caduta d'Israele (2 Re 17), la fine di Giuda non viene commentata.
Il resoconto della riforma di Giosia dovrà indicare che Israele, quando vive secondo la legge di Dio, resta un popolo indipendente, e che la perdita del paese non cambia niente a questo proposito? Forse per gli autori deuteronomistici la liberazione del figlio di Giosia, J oiachin, era considerata il segno che anche nell'esilio Israele conserva la possibilità di vivere. L'opera sarà stata conclusa subito dopo quell'evento perché non contiene alcw1 cenno alla svolta dell'epoca persiana (dal 53 8).
54 • 4. L'opera storica deuteronomistica
Le
i di uerra in Dt 7 e 20 16ss.
Gs 1
Designazione di Giosuè
2-9
dal Giordano a Gabaon
@] Acsaf
Illustrazione delle leggi belliche in racconti ed enumerazioni esemplari
D simron 0 Jokneam 10
Vittoria su 5 re e 6 città nel sud
11
Vittoria sulla coalizione dei re del nord
12
Elenco dei 31 re sconfitti
13-22
La distribuzione della terra alle tribù d'Israele
o
Dor
@] Megiddo • Taanach
@J Tirza
!ZISichem @] Afek Betel @J ,....,,.,~~1 :. Ai Gs 2-9
Lista di luoghi e descrizioni dei confini
!ZI Gezer
!ZI Gabaon
:. Gerco passaggio ciano
m·
Gerusalemme!ZI Gs 1O
Jarmut @] e Makkeda :. Libna @J Lakish
o Adullam • Hebron @] Eglon @J Debir
da 19,49 a 22,34
Osservazioni finali
23
Discorso di congedo di Giosuè
o
24, 1-28
Conclusione del patto di Sichem
D città della tarda età del bronzo
24, 29-33
Morte e sepoltura di Giosuè .__ __
Gdc 1
Ciò che non era stato conquistato
Gdc 2,6-9
Ripetizione: morte e sepoltura di Giosu ·
: . Hormah :. Araci
A Struttura del libro di Giosuè
30
60 km
• in tarda età del bronzo solo piccolo insediamento :. in tarda età del bronzo solo rovine !ZI città della tarda età del bronzo e della prima età del ferro @] insediamento prima età del ferro su rovine di città del tardo bronzo insediamento età del ferro B Città regie secondo Gs 2-11
4.2 Il libro di Giosuè (Gs) • 55
Gs ha una struttura chiara: Giosuè riceve l'incarico di guida proprio di Mosè (1), conquista il paese (2-12) e lo divide fra le tribù (13-19); il libro si chiude con la sua morte e sepoltura. In 2-12, da testi diversi, sorge un'immagine della presa di possesso della terra da parte d'Israele: • Storie esemplari narrano il passaggio del Giordano e la caduta di Gerico alla stregua di funzioni religiose (3s.; 6), la distruzione prodigiosa di Ai (8,18-26), l'inganno degli abitanti di Gabaon (9). • Delle liste informano della vittoria sui cinque re e le sei città meridionali (10) e delle sconfitte dei re settentrionali (11). Alla fine vi è una lista di 31 nomi di re sconfitti (12). La 1·ipartizione del paese avviene - incredibiL11ente a ~vello storico - solo dopo la fine della conqLÙsta. E presentata con liste di luoghi, che docw11entano con inspiegabile precisione i diritti delle tribù, quali possono essersi sviluppati solo in w1a storia più lunga. Per esempio, si viene a sapere che una tribù aveva proprietà sparse (16,9), w1a seconda disboscava un terreno vergine (17,18), altre due erano separate da w1 confine descritto con precisione (18,15ss.). Alla fine stanno i discorsi di congedo di Giosuè, una predica sulla legge e una retrospettiva storica che incita le tribù riunite a Sichem a stipulare il patto. La tradizione ivi elaborata di un 'patto di Sichem' risalirà all'adesione che gli abitanti del paese dettero all'alleanza con JHWH conclusa dalla gente di Mosè (24,14s.) . Con la sua struttura sistematica Gs rappresenta più una spiegazione del possesso della terra che la descrizione di un insediamento. Con oltre 300 toponimi, Gs passa in rassegna lo spazio in cui si svolgerà la storia d'Israele; con racconti e prediche esorta Israele a curare 'in tran quilLtà' il suo paese (21,44). Il paese è considerato dono di Dio. Dio dà w1a vittoria dopo l'altra: Giosuè e Israele sono semplici organi esecutori. Israele vive Lma sconfitta solo quando un Israelita, contro l'ordine di Dio, s'impadronisce del bottino (7) . Al momento della ripartizione del paese Dio parla attraverso la sorte. Anche lo sterminio dei precedenti abitanti del paese avviene per ordine di Dio. Molte cose fanno pensare che lannientamento di tutti gli abitanti del paese sia una finzione: • I nomi dei sette popoli preisraeliti (Gs 3 ,10 e altrove) sono un semplice bagaglio culturale: i Gebusei vivevano ancora a Gerusalemme quando David prese la città (2 Sam 5); i Cananei corrispondono alla descrizione della zona della Giordania occidentale antistante all'Egitto; gli Amorrei al nome babilonese della Palestina, Amurru. Quattro nomi non sono interpretabili.
• Una lista negativa di proprietà (Gdc 1,18-21) enumera luoghi che Israele non poté conquistare a causa dei loro 'carri di ferro'. • Dei racconti spiegano che i Cananei vivevano a buon diritto in mezzo a Israele: a Gerico ha diritto di abitare il clan di Rahab perché la prostituta Rahab aveva creduto con più forza dell'incostante Israele che il Signore avrebbe dato il paese al suo popolo (2). Gabaon aveva ottenuto un trattato con l'astuzia, ma Israele vi era vincolato (9). Neppure le conoscenze archeologiche offrono testimonianze di una conquista organizzata in grande stile. Gerico era disabitata già dal XIV sec., Ai (ebr. 'la rovina'), dalla prima età del bronzo. La decadenza delle città-stato cananee all'inizio dell'età del ferro, accertabile grazie all'archeologia, va ricondotta al fatto che la potenza protettrice dell'Egitto, per sue difficoltà, aveva abbandonato i piccoli re ai conflitti interni a Canaan. La maggioranza dei nuovi villaggi dell'età del ferro si trova in un territorio fino a quel momento disabitato, e non è fortificata, come non sono fortificati neppure i piccoli insediamenti edificati sulle rovine di antiche città. Chi fa costruzioni simili non è certo penetrato con la violenza del conquistatore. Gs rispecchia esperienze della successiva epoca monarchica. La distruzione di intere etnie divenne realtà storica nell'VIII sec., quando gli Assiri, nel nome del loro Dio, sradicarono i popoli deportandoli sistematicamente. Di fronte a questo pericolo i maestri della legge hanno steso delle leggi di guerra, che dovevano rafforzare il legame d'Israele con il suo paese. Dio voleva che il suo paese fosse la patria del suo popolo; per questo allora aveva ordinato lo sterminio di quei sette popoli - già da tempo scomparsi (Dt 20,16ss.) . Gs illustra queste leggi con dei racconti. Quei maestri della legge parlano in modo diverso dei popoli che Israele conosceva come vicini; anche per Moab, Edom, Amman e i Filistei Dio aveva cacciato popoli più antichi (Dt 2,19ss.). P er tenere davanti agli occhi d'Israele, al tempo dell'aggressione assira, la preziosità della sua patria, gli autori di Gs hanno trasferito su JHWH w1 elemento dell'ideologia guerresca assira: un tempo Dio, per amore d'Israele, aveva ordinato di 'purificare' il paese da tutti i popoli stranieri. Ma gli autori mettono anche in guardia. Il possesso del paese, pur essendo la condizione p erché Israele diventi maggiorenne e provveda a se stesso (5 ,12), lo tenta però anche a non essere che un popolo fra i tanti. Se si dimentica di essere, prima di tutto, in obbligo con chi gli ha donato il paese, il suo Dio, esso stesso ne sarà cacciato (23,13).
56 • 4. L'opera storica deuteronomistica
Gdc 1, 1-3,11
Introduzione
in che cosa si distinguono l'epoca dei Giudici e l'epoca di Giosuè
oltre 400 m da O a 400 m da Oa-392 m
I Tri bù d'Israele 3-16
Epoca dei giudici
3-8
il potere carismatico assicura la vita a Israele
( Nemici d'Israele)
Aser
3 4-5
lssacar
I
6-8
Manasse Gedeone
9 il potere monarchico rispetta meno la vita
10-16
10-1 2
il pot ere carismatico si svia
= = = =
I=Jefte I una lista nomina altri cinque giudici
Beniamino
Eud
Sansone Dan
Filistei 13-1 6
lsansonel
17- 21
Anarchia
17-18
conquista pervertita
lsimeonel
nomadi madianiti
19-21
unità pervertita
A Struttura del libro
9.___..___,1,.s___._ 3_0_,, km
B Azioni dei giudici
4.3 Il libro dei Giudici (Gdc) • 57
Gdc delinea tm quadro del primo Israele tutto diverso da Gs. Secondo Gs, tutto Israele ha conquistato, per ordine divino, tutto il paese «in w1a sola volta» (10,43 ); invece, secondo Gdc, Israele non ha fatto che dimenticarsi di Dio e viene oppresso dai nemici (2,lOs.). Inoltre si vede che l'immagine del popolo d'Israele costituito dalle dodici tribù che agiscono insieme è W1a finzione applicata in modo instabile su tradizioni più antiche: la parte principale del libro è formata dalle saghe dei salvatori , in cui gli eroi liberano solo la propria tribù dal dominio dei vicini ostili (3-16). • Eud di Beniamino risolve con tm assassinio politico una rivolta contro il popolo vicino di Moab (3). • Barak di Ne/tali guida W1a schiera cli contadini contro w1 esercito cli carri da guerra delle città confinanti cli Canaan (4s.). • Gedeone di Manasse caccia dalla sua patria i nomadi madianiti coi loro cammelli (6-8). • ]e/te di Galaad penetra nel confinante paese cli Amman (lls.). • Sansone di Dan gioca brutti tiri ai Filistei delle vicine città costiere (13-16). Il cosiddetto Cantico di Debora (5), il più antico testo lungo dell' AT, pur celebrando lllla vittoria di 'Israele', nomina come combattenti soltanto Zabulon e Neftali. Altre 4 tribù si dice che erano pronte alla battaglia, mentre vengono derise ulteriori quattro tribù che sono rimaste lontane; Giuda, Simeone e Levi non sono neppure citate. Molteplici narrazioni , in origine indipendenti, sono riW1ite in Gdc a dare l'immagine cli w1 Israele assediato dai nemici. Israele sprofonda sempre più nella spirale del male: Dio, adirato, abbandona ai nemici il popolo infe dele; dato che la miseria d 'Israele lo muove a compassione, egli suscita dei salvatori; ma dopo 20, 40 o 80 anni, Israele torna a sbagliare e Dio lo abbandona cli nuovo. Il tema principale del libro è la questione relativa al modo corretto cli esercitare il potere. I redattori danno agli eroi delle tribù w1 titolo attribuito anticamente ai re, quello di 'giudici'; in loro vedono dei capi carismatici che assumon o il comando del popolo solo finché dura la necessità. In netto contrasto con ciò, vi è la fosca in1magine del dominio di un re (9). Abimelech assassina i fratelli , si assicura la dignità regale a Sichem e procura infine alla città e a se stesso W1a brutta fine. Inserito nel racconto vi è l'apologo del pruno, re degli alberi, W1a satira insolitamente mordace della forma cli governo a quei tempi comune.
I capitoli successivi dipingono immagini fosche anche dei 'giudici' ripieni di Spirito: • La vittoria di ]e/te su Amman diventa l'occasione cli una guerra spietata fra le tribù d'Israele (12). Una lista divisa in due parti, che incornicia l'episodio cli Jefte, cita altri cinque 'giudici', celebrandone però solo l'agiatezza. • Sansone spreca le sue doti in storie cli donne e solo nell'ora della morte diventa dawero il salvatore d'Israele (13-16). I capitoli finali criticano ancora più fortemente l'ordine egualitario, in cui a prendere le decisioni sono degli uomini dotati di uguali diritti: • 17s. narra di un insediamento che offende il Dio d'Israele. La tribù di Dan trafuga un'im magine di culto fabbricata con una refurtiva, distrugge una pacifica città e costruisce W1 santuario per quell'immagine. • 19-21 illustra quanto possa essere perversa l'unità: «Come un sol uomo» le tribù vogliono vendicare l'onore virile e non si accorgono che l'accusatore ha fatto violenza alla propria moglie. A seguito cli ciò Dio precipita Israele in una guerra fratricida che mostra a pieno la corruzione del popolo; gli uomini si appropriano delle donne con la violenza. In ciascwrn delle tre parti del libro assume un ruolo speciale la tribù di Giuda: • 1,1-21: Dio incarica Giuda di proseguire le guerre cli Giosuè contro i Cananei; • 3,7-11: il primo 'giudice' viene da Giuda. Il racconto è costruito come modello del corso degli eventi, valido per tutta la composizione: caduta, pietà, salvezza, nuova caduta. • 20,18: nel racconto finale Dio manda per primo Giuda nella guerra fratricida contro la vicina tribù cli Beniamino. I redattori deuteronomistici volevano chiaramente anticipare il ruolo speciale della tribù di Giuda nella storia d'Israele. In 1 Sam e 2 Sam illustreranno come il giudeo David, in conflitto con la casa regnante del beniarninita Saul, fondi una dinastia che, mentre dà sicurezza a Israele verso l'esterno, provoca al suo interno guerre fratricide. Mentre Gs circoscrive lo spazio in cui si svolgerà la storia d'Israele, Gdc si occupa a fondo degli ordinamenti politici d'Israele. Non c'è ordinamento che possa dare pace duratura a Israele. Gclc delinea immagini di un Israele debole che resiste ai nemici solo con l'astuzia, la sorpresa, armi di fortW1a come w1 vomere (3,31) e un martello (5,26). Ma i pericoli peggiori vengono dallo stesso Israele.
58 • 4. L'opera storica deuteronomistica
Città della tarda età del bronzo
Villaggi della prima età del ferro
Densità degli insediamenti nella zona montuosa ro cisgiordanica
Hazor, 80 ha da 200 m'
•
L
Lakish (o: Lakis), 20 ha
o
C\I
l[)
o
----
. Al banchetto vengono gli stranieri.
g g g
Incitamenti Esortazioni
~
!Regole di vita per i discepoli nel tempo della fine.I
51.53-56.58s .
13,18s. e 20s. 25.28s. e 34s . 14,16-2 1 e23 27.34s.; 16,1 6-18; 17,1-4.6, 33
4. La fine arriva all'improvviso.
Il giorno del Figlio dell'uomo viene come un lampo. È imprevedibile chi colpisce. Si pretende il rendiconto dei beni affidati.
17,23s., 26s., 30 34s. 19,12s., 15-24 e 26
Ammonimenti
-
La ricostruzione del la fonte dei detti , come composizione del le parole di «Colui che viene"
13.1 La fonte dei detti (Q) • 171
Matteo e Luca ebbero davanti la cosiddetta fonte dei detti, un'opera redatta in greco, ma qualche detto diventa più comprensibile se lo si retrotraduce nella lingua materna di Gesù, l'aramaico. Per esempio in 11,34 l'occhio è detto «lucerna del corpo»; in aramaico si diceva così dello sguardo che irradia ciò che è celato nell'intimo della persona. Il peculiare messaggio di Gesù è conten uto soprattutto nei detti Q che, come nella sapienza veterotestamentaria, danno buoni consigli per la riuscita della vita. I detti veterotestamentari sono per l'uomo capace, i detti Q, invece, per i poveri che non riescono a procacciarsi il necessario. La miseria nella Galilea rurale è interpretata come crisi escatologica e i poveri sono guidati a impegnarsi in modo consapevole e nonviolento perché la salvezza d'Israele inizia con loro. Q li esorta a essere generosi verso quelli ancora più poveri (6,30s.); li mette in guardia dall'ansia deprimente (12,22ss.); rafforza la loro fiducia nella bontà di Dio ricordando loro la propria personale bontà (11 ,lOs.). Ci si rallegra per i successi di tali insegnamenti con i poveri (6,20s.): viene lodato Dio che preferisce i «semplici» ai «sapienti» (10,21). Da «figli» di Dio essi devono manifestare, come il «Padre», la loro bontà anche alle persone cattive (6,35); a ciò incoraggia la preghiera rivolta al «Padre» (11 ,2ss.). Un conflitto sul messaggio di Gesù sorge a causa dei miracoli (7 ,22s.; 11, 14s.); vengono minacciati di distruzione i luoghi della Galilea in cui Gesù ha operato (10,13ss.). Q sottolinea la particolare posizione di Gesù; egli conosce solo discepoli o nemici (11 ,23 ), volta le spalle a «questa generazione» (7,3 lss.), chiama i farisei «sepolcri non riconoscibili» (11,44). In Galilea questo insulto aveva un significato concreto: Erode aveva coperto dei sepolcri a Tiberiade; gli Ebrei evitavano la città perché chi calpesta ignaro un sepolcro non sa di essere 'impuro' e di doversi purificare per non offendere Dio. Ma con uguale durezza anche i discepoli sono ammoniti se si mettono a giudicare gli altri (6,3 7) o vedono il piccolo errore del 'fratello ' (cioè degli altri Ebrei), ma non il proprio più grave (6,41). Q è una scrittura ebraico-cristiana più volte ampliata: Durante la vita di Gesù i discepoli possono aver annotato i suoi detti per usarli quando Gesù li mandava a insegnare (Mc 6,7ss.) . Due anni dopo la morte di Gesù gli ebreo-cristia-
ni ellenistici dovettero fuggire da Gerusalemme, e potrebbero aver usato per wrn prima redazione di Q quegli appunti in aramaico, che si erano portati via per ricordo. L'esperienza di questa persecuzione può aver fatto sì che i conflitti, che avevano portato alla morte di Gesù, s'inasprissero in Q e che quell'inermità, che Gesù aveva prediletto, fosse intesa più radicalmente (10,3s.). Il distacco dal popolo ebraico inizia in Q al modo ebraico. In Gesù vi è 'più' sapienza che in Salomone; il Battista è 'più' che Lm profeta (7 ,26; 11 ,31). Questo 'più' intende il messaggio del giudizio finale, in cui non interesserà l'elezione d'Israele, ma l'operato di ciasCLmo (3,8). La durezza delle parole tradisce il, male che fa la separazione dal proprio popolo. E come se uno non potesse neppure seppellire il padre defunto (9,60) . Gli stranieri siedono a tavola coi patriarchi d'Israele e Israele è «gettato fuori»; là sarà «pianto e stridor di denti» (13,28). Prima della guerra giudaica (dal 44 d.C.) i discorsi sulla fine del mondo saranno stati ancora più aspri. I partiti ebraici si combattevano accanita mente e destavano false speranze: • i profeti annunciavano che Israele doveva andare nel deserto per ritrovare il pane ('ma1ma'); • i sacerdoti, che Dio avrebbe salvato il tempio; • gli zeloti, che il popolo aveva bisogno del potere politico. Col racconto delle tentazioni (4,lss.) Q interpreta queste speranze come offerte di Satana; Gesù le respinge con parole tratte dalle Scritture sacre degli Ebrei. Lo stesso inasprimento dell'ammonimento escatologico vale però anche per le comunità di Gesù . Non basta dire «Signore!» (13 ,25); lo schiavo che batte un compagno, il «Signore», quando verrà, lo «farà a pezzi» (12 ,46). Q rispecchia l'attesa prossima dei primi cristiani, ma fa anche capire che essi sopportavano il fatto che la fine del mondo non arrivasse. Il messaggio di «Colui che viene» incornicia Q. All'inizio il Battista annuncia colui che viene, il quale separerà la pLÙa dal grano (3 ,17); verso la fine Q ammonisce la gente di non contare più sLùla «venuta del Figlio dell'Uomo» (17 ,23 ). Ma il 'Figlio dell'Uomo', che parla in Q, è già 'venuto', deriso e senza dimora (7,34; 9,58). «Un discepolo non è superiore al maestro» (6,40). Con questo atteggiamen to i cristiani poterono proseguire la discussione sLùl'inizio del tempo della fine in epoche più tranquille. Come ciò accadesse, ce lo mostra il nuovo contesto in cui Q è stato inserito in Mt e Le.
172 • 13. I vangeli sinottici
Gesù solidarizza con i peccatori
I suoi discepoli - ----"'---------' li chiama a testimoni delle sue opere I demoni lo 1,16ss. chiamano
«FiQliO di Dio»!
Essi devono ammutolire Appare loro nel la forza divina 4,39; 6,48
Vie di Gesù dal battesimo di Giovanni 1,16-8,26 attraverso i villaggi della Galilea
oltre il lago
li invia contro i demoni 6,7
... viene awolto dalle nubi
Non riconoscono chi egli è 6,52; 8,17
fino alla regione circostante
Appare loro in luce divina
8,27-10,52 attraverso la Gal ilea
... conferma: «il mio figlio prediletto!" e esorta: «Ascoltatelo!" Restano pieni di timore 4,41 ; 6,49; 10,32
a Gerusalemme 11-1 6
Nella sua angoscia Gesù invoca il «Padre"
dall' ingresso in Gerusalemme
I discepoli non lo ascoltano 14,32ss.
Il tempio si squarcia, il centurione grida: «Questi era il Figlio di Dio!"
solo delle discepole sono testimoni oculari
... invia il suo angelo alla tomba, che conferma - - - - la promessa di Gesù ma le donne fuggono piene di paura Gesù precederà di nuovo i suoi discepoli Il vangelo di Marco come racconto del mistero di Gesù
fin al la tomba
13.211 vangelo di Marco (Mc) • 173
Probabilmente Mc è sorto a Roma, dove molto presto si ebbero comunità cristiane con nw11erosi collegamenti con tutto ]'impero romano. Le tradizioni su Gesù, che entrano in Mc, potevano essere confluite qui. Marco ha disposto una accanto al1' altra delle piccole raccolte: a sette storie dell'inizio dell 'azione di Gesù (1,16-39) seguono delle discussioni collegate con i racconti di come sorge la 'famiglia ' di Gesù (fino a 3,35); poi delle parabole (fino a 4,34) ecc. L'introduzione (1,1-13) narra la preparazione, nel deserto, dell'azione di Gesù; poi Mc tratteggia in tre sezioni i viaggi di Gesù per la Palestina. 1. Gesù gira per la Palestina e arriva nella regione pagana (1,14-8,26). 2. Da lì attraversa la Galilea e, passando da Gerico, arriva a Gerusalemme (8,27-10,52). 3. Entra nella città, si presenta nel tempio e muore sul Golgota (11-15). La conclusione (16) è misteriosa: spaventate, le donne fuggono e non dicono a nessw10 del messaggio di risurrezione dell'angelo. Nell'antichità una conclusione aperta era così inconsueta che più tardi Mc fu integrato con storie della risurrezione prese da Mt e Le (16,9-20). Con catene di motivi, che attraversano il vangelo, Marco guida a mettere in relazione reciproca dei testi solo giustapposti. 1. Gesù gira per la Galilea e opera miracoli. Marco integra le storie di miracoli con due motivi misteriosi: • Gesù impone il silenzio sia a coloro che ha guarito pubblicamente sia ai demoni che lo riconosco.no 'figlio di Dio', e persi.no ai discepoli, che e~li ha portato con sé apposta a una risurrez10.ne. • I discepoli non capiscono chi è Gesù. In sei miracoli (4,35-6,5 6) Gesù si mostra loro ripieno di forza divin a; ma essi restano 'induriti '. Rafforza il mistero la tradizione della missione dei discepoli inserita in questo ciclo. 2. Gesù va a Gernsalemme e per strada istruisce i discepoli. All'inizio Marco pone due storie di Pietro: quando Pietro riconosce che Gesù è «il Cristo», Gesù gli ordina i] silenzio; quando vuole trattenere Gesù dalla passione, Gesù gli dà del «Satana». Questi racconti spiegano il significato dell'ordine di tacere: può testimoniare pubblicamente la dignità di Gesù solo chi si riconosce anche nella sua passione. Ma l'incomprensione dei discepoli diventa ancora più misteriosa. Gesù appare loro in u.na luce divina; Dio stesso li esorta ad ascoltare il suo «figlio diletto». Tuttavia essi non fanno che spaventarsi
senza capire. Le esperienze della vicinanza a Dio di Gesù (4,41; 6,5ls.; 9,6) potrebbero incoraggiarli ad andare con lui verso la passione; ma essi lo seguono sulla via di Gerusalemme pieni di angoscia (10,32) . 3. Nella storia della passione l'angoscia afferra anche Gesù . Ma egli lotta sul monte degli Lilivi pregando il «Padre» per accettare ]a sua passione. Egli vuole coinvolgervi almeno i tre discepoli principali (14,32ss.), ma questi dormono e non sentono la sua preghiera, benché fossero proprio quelli che Dio aveva esortato ad ascoltare suo «fi glio». La più importante catena di motivi , con cui Marco spiega il suo vangelo, è la parola 'Figlio di Dio'. Nei tre punti di svolta del racconto Gesù viene chiamato così - da Dio, da] suo avversario, da w1 romano: 1. Al momento della chiamata: insieme con i peccatori Gesù riceve il battesimo di Giovanni; allora il cielo si apre e Dio lo chiama suo «figlio diletto» (1,9-11). 2. Al momento della condanna a morte: Gesù provoca Ja sentenza rispondendo di sì alla domanda se lui è il «figlio dell'Altissimo» (14,62) . 3. Al momento della morte: quando Gesù muore, il Santo dei santi (il velo) nel tempio si apre, e il centurione di guardia alla croce grida: «Questi è davvero il Figlio di Dio! » (15,38s.) . 'Figlio di Dio' non è un concetto separabile da queste scene. Mc non conia concetti; egli narra del mistero che la missione di Gesù ha due lati veramente inconciliabili: Gesù diventa uno degli uomini lontani da Dio, e proprio così l'accesso a Dio s1apre. Lo scopo narrativo di Mc sta al di là del testo. Le donne han.no sia visto la morte e la sepoltura di Gesù sia udito che Dio, per mezzo dell'angelo, ha riconfermato la dignità di Gesù. Esse conoscono perciò ambo i lati della missione di Gesù, e restano tuttavia incapaci di capire. La speranza che la morte di Gesù non sia ]a fine deriva solo dalla promessa di Gesù che l'angelo ricorda: dopo la morte, Gesù li precederà in Galilea (14 ,28; 16,7). Il cerchio delle vie di Gesù si chiude; il Risorto comincerà di nuovo (nelle comunità cristiane), dalla Galilea, ad aprire ]'accesso a Dio agli esseri umani che ne sono lontani. Al tempo di Marco questa tradizione era superata; infatti per i cristiani la Galilea era inaccessibile dallo scoppio della guerra giudaica. Ma Marco ha preso nota delle tradizioni gesuane affinché un inizio, in cui il Risorto precede i suoi discepoli, diventi possibile ovunque uno mediti sulle vie di Gesù.
174 • 13. I vangeli sinottici
Il Regno di Dio: nel passato
12
Materiale particolare I ~
3-4 per mezzo di Abramo per molte genti,
affidato a Israele per mezzo di Mosè con la torah ,
f--
57,29 per mezzo, di Davide, il Salvatore del popolo;
[karo dala
rrmlag1al
89,34 f--
9,3511, 1
figlio di Davide
figlio di Abramo, maestro che porta a compimento la torah
11,2 12 In Israele Gesù non ha avuto successo.
13,153
Nel presente
13,5417,27
è affidato alla Chiesa che, come popolo formato dalle genti,
Discorso della missione! f--
18,135
-
Discorso comunitario
f--
perché presso di essa resta porta frutti ,
ha stabilità
~
19, 123 ,39
Sequenza narrativa da Mc
24 ,125,46
Discorso escatologico!
-
che giudica in modo giusto gli uomini, che invita tutti i giusti nel
26,128,8 Regno di Dio,
che fin dall 'inizio del mondo è preparato per tutti gli uomini che si impegnano per chi ha bisogno d'aiuto
A Il vangelo di Matteo come interpretazione della storia del mondo
J
-
finché , alla fine del tempo,
che convoca tutte le genti,
Discorso in parabole
28,9-20
Materiale particolare!
B La struttura di Matteo
I
I
13.3 Il vangelo di Matteo (Mt) • 175
Il canone neotestamentario comincia con Mt, un segno del suo rango nella chiesa primitiva. Solo in Mt Gesù parla della sua ekklesia, 'chiesa' (in Grecia, assem blea dei cittadini 'chiamati' a consiglio): Gesù costruirà la sua chiesa sulla 'roccia' di Pietro; a lui e alla chiesa nel suo insieme egli dà il «diritto di legare e sciogliere» (16,18; 18,17 ). Nell'AT greco ekklesia è l'Israele 'chiamato', in Mt la comwutà di Gesù separata dal popolo ebraico. Second o Mt 27 ,25 «tutto il popolo» degli Ebrei, con il giuramento imprecatorio, ha preso su di sé la colpa della morte di G esù. Per Matteo ciò fu una profezia avverata nella guerra giudaica. I 'guai!' con tro i farisei (23 ,13ss.) sono rivolti all'ebraismo postbellico, nel quale non vi era più posto per i seguaci di Gesù. Il vangelo di Ma tteo è improntato a esperienze di ebreo-cristian i, per i quali il proprio popolo era diventato estraneo. Matteo tiene presente che Gesù era stato «inviato solo alle pecore perdute della casa d ' I sraele» (10,5; 15 ,24) e sottolinea altrettanto chiaramente che ciò fa parte del passato. Come più tardi succederà ai discepoli (10,25), Gesù è naufragato sull o scoglio del suo popolo; da Risorto, ha inviato i discepoli a «tutte le gen ti» (28 ,19). Matteo ha rielaborato Mc e Q per mostrare che il messaggio di Gesù resta valido in queste condizioni. Dal materiale dei modelli ha composto cinque discorsi, che associa a delle situazioni nella vita di Gesù: 1. Il discorso della montagna (5,1-7 ,29) è per così dire lo statuto di Gesù. 2. Il discorso della missione (10) segue a dieci miracoli; Gesù prima ha incoraggiato i discepoli e poi li ha inviati. 3. Il discorso in parabole (13 ,1-53), messo subito dopo alcuni testi che narrano del Gesù umile nel pericolo e nel conflitto, illustrano come il regno di Dio si affermi già nel nascondi.mento. 4. Nel discorso comunitario (18), prima di lasciare la sua patria, la Galilea, vincola la sua ekklesia alla 'fraternità'. 5. Al discorso escatologico (24s .) segue la storia della passione. Matteo collega l'insegnamento cristiano alla storia della vita di Gesù e perciò anche alla legge veterotestamentaria, con cui Gesù ha vissuto. In Mt parla l'ebreo Gesù che «porta a compimento la legge». Solo che egli esige 'più' che fedeltà alla legge ebraica. Le opere dei suoi discepoli devono muovere «gli esseri umani» (cioè tutte le genti) a lodare Dio, il «Padre» di Gesù Cristo (5, 16). Matteo attualizza così una speranza dell' AT: i cristiani, che sono sfuggiti alla guerra giudaica, devono intendersi come quei 'superstiti', che Is 66,19 esorta ad annunciare la grandezza di Dio alle genti.
I destinatari di Mt sono quei cristiani che volevano restare ebrei, ma erano costretti a cercare la patria nella loro propria ekklesia . L'immagine della trasmissione della sovranità, con cui Matteo traccia un netto confine tra ebrei e cristiani , proviene dal!' apocalittica giudaica: «Il regno» sarà dato a un altro popolo, un popolo fedel e (D n 7 , 14; Mt 21,43). Il vangelo di Matteo è un 'opera di esegesi storica ebreo-cristiana. Matteo vede l'opera di Gesù davanti all'orizzonte della storia Lll1iversale: • il passato è la storia d'Israele e l'opera di Gesù per Israele; • il presente è la chiesa delle genti; •il futuro è il giudizio universale. Nell'opera di Gesù si incontrano tutti e tre questi piani temporali. Le cosiddette citazioni dell'adempimento rappresentano questa coincidenza con giochi di parole degne degli scribi; le speranze veterotestamen tarie trovano il loro punto d'arrivo nella vita di Gesù, e la missione alle genti annLUlciata nell' AT è ivi preparata. Per esempio, Mt 12,17ss. dà Llll senso nuovo all'ordine di tacere, che è ripreso da Mc, citando Is 42 ,lss.: Gesù agisce nel silenzio come «il servo di Dio, nel quale sperano le genti». Il prologo (ls. ) interpreta la venuta di Gesù come scopo della storia d'Israele: • La genealogia porta fino a Giuseppe, l' uomo della stirpe di Davide, che ha legittimato Gesù come proprio figlio , così che Gesù, secondo la legge um ana, è «figlio di Davide». • Racconti inventati, costruiti partendo da proposizioni veterotestamentarie, aimunciano che Gesù, che è partorito come «salvatore d'Israele» (1,21), avrà contro di sé «tutta Gerusalemme», mentre gli stranieri gli renderanno omaggio (2 ,2). L'epilogo, che Mt aggiw1ge al materiale di Mc, indirizza lo sguardo sul tempo in cui da tutte le genti sorgerà Lilla nu ova comunità di discepoli, in cui Gesù sarà presente (28,20). All'interno della storia di Gesù Mt rivolge più volte lo sguardo anche oltre questo tempo:
Nel tempo escatologico si rivelerà che il ' regno' di Dio è più gran de della chiesa. Nella parabola del gi udizio Lmiversale (25,31ss .) Matteo spiega che, in ultin1 a analisi, ciò che in1porta è che gli esseri umani siano stati prossimo agli altri. Egli insegna ad attendere Gesù come il 'Figlio dell'uomo', che invita anche le persone che non lo conoscono nel 'regno' che «è preparato per loro fin dal principio».
176 • 13. I vangeli sinottici
Ricordi della città santa
Storia delle origini della chiesa
nella
nel racconto di Luca della
1
origine di Gesù (Le 1-3)
Essa
inizia
a Gerusalemme,
Impegno di Gesù per il popolo (Le 4-23)
la
città di Dio,
e conduce Le origini della chiesa (Le 24 -At 2)
I discepoli nel tempio lodano Dio che ha innalzato Gesù (Le 24,53; At 2,46s.)
capitale del grande presso impero
Ebrei , Missione di Pietro (At 3-12)
l
La comunità di Gesù si estende da Gerusalemme in tutta la Palestina
Missione - - -di Paolo (At 13-28)
Samaritani , pagani.
Paolo apostolo dei pagani ,
--
I
arrestato nel tempio, da prigioniero porta il mess ggio di Gesù a Roma (At 21,33ss.) (At 28,31)
La duplice opera di Luca come racconto del cammino della fede da Gerusalemme a Roma
13.4 La duplice opera di Luca • 177
Mt, Mc, Le offrono in gran parte lo stesso materiale narrativo e stilistico nella stessa sequenza, ma con obiettivi differenti: • Quando la patria di Gesù sprofondò nella guerra giudaica, Marco constatò come il mistero di Gesù si fosse manifestato sulle vie da lui percorse attraverso questa regione. • Quando il giudaismo farisaico era diventato estraneo agli ebreo-cristiani, Matteo illustrò come il 'regno di Dio' pervenga alla 'chiesa' formata dalle genti. • Luca intende la sua duplice opera come un 'resoconto' storico (Le l ,l ss.; At 1,1). Egli conta su lettori di cultura ellenistica che vogliono inquadrare storicamente le origini della propria fede. Mentre Matteo, incurante degli anacronismi, riporta idee sulla natura della chiesa nel racconto della vita terrena di Gesù, Luca illustra separatamente negli At come il messaggio di Gesù arrivi alle nazioni. Egli cita date della storia contemporanea (Le 1,5; 3,1; At 11 ,28) e narra come l'imperatore romano (Le 2,1; At 18,2) , i re ebrei (Le 23; At 12 ; 25), i fw12 ionari romani (Quirinio, Pilato, Felice, Pesto, Gallione) intervenissero nella storia di Gesù e nella diffusione del suo insegnamento. Un mutamento sociale nelle comunità cristiane si può dedurre dal contributo originale di Luca; sono diventate cristiane anche delle persone benestanti e in vista. Nei discorsi di Gesù esse vengono ammonite a usare correttamente la ricchezza; At loda i cristiani che mettono le case a disposizione della comunità e condividono coi poveri i loro averi. Le donne hanno Lm proprio patrin1onio e lo usano a favore di Gesù o della comunità (Le 8,3; 10,38; At 12 ,12; 16,14). Da Q Luca prende la richiesta che i messaggeri di Gesù debbano vivere senza possedere beni (Le 9,3; Mt 10,9); ma è lui a narrare di Zaccheo che vuol dare «la metà dei suoi beni» ai poveri e che per questo è lodato da Gesù (Le 19,9). Il giudizio su Roma è equilibrato (analogamente a quello dello storico ebreo Flavio Giuseppe, contemporaneo di Luca); Luca sa che i fw12ionari romani non sempre servono la giustizia, ma sa anche che lo stato romano è Lmo spazio in cui il messaggio di Gesù può essere annunciato liberamente. Senza la pressione degli Ebrei, Pilato avrebbe liberato Gesù, e Felice avrebbe liberato Paolo (Le 23 ,20; At 24 ,27). Luca sapeva della morte di Paolo (At 20,25) , ma tace il fatto che egli morì martire a Roma. La sua opera si chiude con la notizia che Paolo, sia pure prigioniero, annuncia a Roma il messaggio di Gesù (At 28).
I suoi giudizi sugli Ebrei sono altrettanto differenziati. Della morte di Gesù Luca dà più la colpa alla élite giudaica che a Pilato; in At narra con quale furore gli Ebrei agissero contro i cristiani, ma egli loda il membro del sinedrio Giuseppe d 'Arimatea e narra anche con quanta intelligenza il fariseo Gamaliele difendesse la libertà dell'insegnamento religioso degli apostoli (Le 23 ,50; At 5,34ss.). Alla speranza in wrn fine della separazione tra Ebrei e cristiani si allude in At 7,60 là dove Luca narra della preghiera d'intercessione del perseguitato innocente per i suoi nemici ebrei. Secondo Gb 42,7ss. wrn tale preghiera muove Dio a riconciliare i nemici. Luca sottolinea il fa tto che la stori a della fede cristiana è iniziata nell'ebraismo. I primi a credere in Gesù furono degli ebrei; a 'migliaia' lo circondavano, a 'migliaia' si convertivano (Le 12,1 ; At 4,4). La città di Gemsalemme ha per Luca uno statuto particolare. Luca inizia con w1a scena nel tempio e termina con i discepoli che, pieni di gioia per l'ascensione di Gesù, stavano 'sempre' nel tempio. In At Gerusalemme è il paese d'origine dei cristiani, con cui restano in collegamento i missionari tra le genti. Della dissoluzione della comw1ità di Gerusalemme (64 d.C.) e della fuga dei cristiani a Pella (66 d.C.) , Luca ha certamente sentito dire, ma non ne fa parola. Il contributo originale di Le è la scena in cui Gesù , piangendo, annuncia la distruzione di Gerusalemme (70 d.C.) (19,41ss.). In Le 21 , come anche in Mc 13 , le immagini della caduta di Gerusalemme sono associate alla fine del mondo, ma la distruzione della città santa non è più considerata w1 evento escatologico. Gerusalemme sarà «calpestata fino a che i tempi dei pagani siano compiuti» (Le 21 ,24). Luca non rinuncia alla speranza per Gerusalemme; ma i 'tempi' dei pagani li chiama kair6i, cioè tempi che offrono delle opportunità. Luca intende l'attesa del tempo finale come un a fo rza don ata ai cristiani, che mette in movimento qualcosa di inatteso nella storia ancora incompiuta. Di ciò egli parla con parole e immagini dell'AT. Lo 'spirito di Dio', che Gesù ha ricevuto col battesimo (Le 3,22), si è riversato sui discepoli (At 2) e dà loro il coraggio di vedere le persecuzioni come un'opportunità (Le 21 ,17s.; At 20,23). Frutto di questo pensiero è la duplice opera Le e At, in cui Luca presenta lo sviluppo che procede da Israele alla chiesa delle genti passando attraverso Gesù.
178 • 13. I vangeli sinottici
Le 1e2
Il bambino Gesù
è salutato da pii Ebrei che aspettano la salvezza d'Israele; Simeone si augura gloria per Israele, luce per le genti; profetizza la contraddizione di Israele (2,32s.). Le 4-21
Il maestro Gesù
Tutti lo lodano (4, 15). 4-8 in tutta la Giudea Il popolo lo ascolta (6,18).
Insegna la salvezza delle genti, 4,23-30 odiato dai suoi.
Molti lo accompagnano (14,25). 9,51ss. andando a Gerusalemme I suoi avversari sono svergognati, il popolo gioisce (13, 17).
Tutto il popolo lo ascolta fin dal mattino 21 ,38 . 19, 28ss. nel tempio di Gerusalemme,/'----'~~~----~ I capi d'Israele temono il popolo (22,2).
l
Le 22 e 23
La passione di Gesù
I capi e il popolo esigono: 23,21 davanti a Pilato
~L
Crocifiggi lo!
)~
I capi lo deridono.
Il popolo sta a guardare.
23,35 presso la croce
23,48 dopo la morte di Gesù Il popolo si pente e si allontana.
Luca termina la prima parte della sua duplice opera con delle domande.
Che ne è delle speranze d'Israele?
? Il popolo d'Israele destinatario dell'opera di Gesù nel vangelo di Luca
13.511 vangelo di Luca {Le) • 179
Luca riferisce lopera di Gesù come uno storico dell'antichità e insieme come Lm maestro che vuole convincere della perenne importanza di Ges ù. Dove egli non è vincolato a delle fonti, parla in modo così incisivo che molti motivi sono noti ancora oggi: • la sequenza delle solennità di Pasqua - Ascensione - Pentecoste (Lc24;At 1,3.9; 2, 1-3); • le immagini: il bambino nella mangiatoia, l' angelo del Natale (Le 2); • le parole: il samaritano compassionevole, il figlio perduto, il povero Lazzaro, i farisei come definizione della persona piena di sé. Come nell'opera storica veterotestamentaria Gs-2 Re alcune predizioni richiamano l'attenzione SLÙ fatto che Dio guida invisibilmente gli eventi. Le storie dell'infanzia (l s.) narrano di promesse di nascite e del loro compimento, di angeli e di ebrei fedeli alla legge che annunciano che Gesù salverà un giorno Israele. Nei detti del vecchio Simeone risuona il tema di At. Egli ricorda le promesse dell ' AT: Dio vuole aprire alle genti l'accesso alla salvezza d'Israele (2,3 2; Is 42 ,6); ma Israele vi si oppone (2,34; Is 8,14). Il tempo dell'opera di Gesù (4-23) Luca lo indica nella prima predicazione programmatica di Gesù con w1a citazione veterotestamentaria come «l'anno di grazia», ma poi narra come si a\l\lera la parola della 'opposizione': quando Gesù soggiunge che la salvezza non è riservata a Israele, l'ammirazione si muta in odio (4,28s.). Egli riprende il motivo del cambiamento di umore nella storia della passione (cfr. 21,28 con 23 ,13ss.). Lo storico Luca pres ta attenzione al cambiamento dei tempi. Come storico sa quanto sia facile per le persone soggiacere allo spirito del tempo; come maestro di fede narra che il «tempo di Satana» può irrompere nel «tempo della grazia» . Ciò vale anche per Gesù . Intorno a Giovanni Battista si raduna «il popolo» (3,7), come se il tempo della grazia fosse già qui; ma per Gesù è solo dopo il battesimo, il ricevimento dello Spirito e la tentazione che inizia il tempo in cui «Satana si allontanò da lui», ma «solo per ritornare al tempo favorevole» (4,13 ). Luca narra di Gesù come del «profeta» (24, 19) che «caccia i demoni» (4,1.14; 5,17). Convinto che il regno di Dio sia già qui, Gesù vuole raccogliere Israele, ma sa in anticipo che per questo soffrirà a Gerusalemme e a ciò va incontro consapevolmente (13 ,33). SLÙ monte degli ulivi comincia il tempo 'favorevole' a 'Satana'. Nonostante la sua preghiera, Gesù vive in anticipo una tale angoscia che «suda sangue». Pietro cede alla tentazione (22,53ss.). SLùla croce, invece, comincia già il tempo nuovo che è determinato dall 'azione dello Spirito. Morendo, Gesù affida il suo spirito a Dio (23,46). Prima dell'ascensione promette ai discepoli il dono di
Dio (24,49) . A Pentecoste essi sperimentano che cosa aveva inteso Gesù; ricevono lo Spirito che li incoraggia a essere testimoni di Gesù (At 2). Così comin cia il tempo degli apostoli, in cui a guidare i discepoli a portare il messaggio di Gesù è sulla terra lo Spirito, e dal cielo lo stesso Gesù. Nella parte principale (Le 3-23) parlano prevalentemente le fonti di Luca, Mc e Q. Pur sintetizzando Mc, Luca si attiene alla sua sequenza narrativa. Per i discorsi di Q , Luca inventa delle scene adatte e le inserisce a blocchi, insieme con dei testi del suo materiale particolare, in due punti rimarchevoli della sua opera: • Nella 'piccola aggiW1ta' (6,20- 8,3) Gesù dà ai discepoli il loro statuto. (In Mt 5-7 questi discorsi sono costruiti a fo rmare il 'discorso della montagna ', che Gesù, circondato dai discepoli, tiene davanti alla folla). • La 'grande aggiunta' (9,5 1-18,14) fa seguito alla decisione di andare a Gerusalemme, dove lo attendono la morte e l'innalzamento. Al materiale particolare di Le appartengono le storie esemplari. Negli altri vangeli manca questa forma narrativa; Luca se ne serve con intenti catechetici: I cristiani possono imparare persino dall'anrnu nistratore disonesto (16). Il comand amento principale dell"amore del prossimo' Io osserva chi è capace di 'amare' coloro che harn10 bisogno di ai uto (10,36). Di fronte alla morte, la ricchezza non serve a 1uente (12,16-21). La serie delle parabole di Q della pecora perduta e della dracma smarrita , Luca la integra con la parabola del padre misericordioso e del suo figliolo perdu to. Le tradizimu particolari, che Luca tratteggia, sono storicamente attendibil.i: • Ai farisei Gesù è più vicino di quanto sia stato narrato di solito in reazione agli sviluppi successivi al 70 . Gesù è ospite di far isei (7,36; 11,37); i Farisei lo mettono in guardia da Erode (13 ,31) . • Alcune donne sono con Gesù nel suo andare per il paese e fin dall'inizio sono sue discepole (8,2s.; 24 ,6). Delle donne «che facevano lamento» dimostrano contro la crocifissione di Gesù (23,27). Come Matteo, anche Luca amplia la sequenza narrativa di Mc con un prologo e un epilogo. Le sue storie dell'infanzia, però, in comw1e con Mt hanno solo singoli motivi (testimonianza dello 'Spirito'; nascita a Betlemme), e nelle storie della risurrezione Luca tralascia la tradizione marcian a delle appari zioni in Galilea, mentre Mt la sviluppa. Per Luca l'esperienza della risurrezione deve stare a Gerusalemme, il centro del popolo ebraico.
180 • 14. Gli Atti degli Apostoli
1,2-2,13 Preparazione
o
150
300 km
Missione riuscita agli Ebrei !Antiochia! 1
~-~1 23
fino a 6,7
X:XI
@ l ustra
lconio
I
I 90
SalaO
Missione di Pietro in Palestina
Pafo 1 Inizio della missione al le genti
(x
Successi della missione agli Ebrei
Q
Successi della missione ai non Ebrei
2 secondo At 16 e 17
@
Passaggio dagli Ebrei ai pagani
3 secondo At 19
I Antiochia I I Filippi I Derbe
secondo At 13 e 14
Ostilità da parte degli Ebrei Ostilità da parte dei pagani nessuna notizia relativa
fi no a 15,5 15 Concilio degli apostoli
B Successi della missione e comunità fondate da Paolo secondo At
13- 20 Vi aggi di Paolo li bero
20,8-12: Paolo risuscita un morto
Missione di Paolo nell 'ambito del Mediterraneo
20,17-38: Discorso di congedo di Paolo agli anziani di Efeso
21-28 Missione di Paolo prigioniero
o
150
300 km
o (\
A Struttura di At
C Elenco delle soste e storie di Paolo in At 20 ,5-21, 1
14.1 Gli Atti degli
Gli At sono sorti intorno all 'anno 80 e narrano cli ciò che è accaduto tra il 30 e il 60. Il piano dell'opera è inclicato in Le 24,47: il Risorto incarica i discepoli cli essere suoi messaggeri «fra tutte le genti , cominciando da Gerusalemme». At descrive l'avverarsi cli questa parola; prima a Gerusalemme e poi, seppur non proprio «fra tutte le genti», fino a Roma, il centro del mondo mediterraneo. Gli At sono un'opera unica senza modello e imitazioni. In realtà il titolo 'Atti degli apostoli', che ricorda racconti dell'antichità, è docw11entabile dal 180 d.C., ma stando a quanto narrato in At i discepoli cli Gesù non procedono volontariamente sulla via inclicata da Gesù in Le 24,47, ma solo sotto W1a spinta esterna o sulla base di clirettive tÙtraterrene.
At narra come il messaggio di Gesù arrivi alle genti partendo da Gerusalemme. A Gerusalemme (2,1- 6,7) l'incarico di Gesù sembra trovare pronto adempimento. Ebrei cli molte lingue ascoltano il discorso di Pietro ; sono loro «tutte le genti»? Sorge tma c01mmità in cui le tensioni sono rapidamente ricomposte e la disputa dei gruppi linguistici trova una buona soluzione. Nel popolo la comunità è benvoluta; 'Gerusalemme' è già guadagnata? Ma degli attacchi ebraici (6,9ss.) portano alla cacciata di molti discepoli, ed è solo ora che essi iniziano ad adempiere quella parte dell'incarico che li invia alle genti. Filippo va in missione dai Samaritani (8); una visione converte Pietro allontanandolo dall'avversione per i 'pagani' (non-ebrei) , e battezza un romano (10); ad An tiochia entrano nella comW1ità alcuni greci (ll,19ss.); Paolo e Barnaba vedono nel loro viaggio missionario la conversione cli persone appartenenti a popoli pagani (13s.). Nel 'Concilio degli apostoli' (15) si arriva a una svolta decisiva. Si riesce a trovare W1a regolamentazione che rende possibile la celebrazione comune della cena a ebreo-cristiani e pagano-cristiani. Mangiare alla stessa tavola con dei non-ebrei con trastava con i comandamenti di purità ebraica. Giacomo trova la via d'uscita: basta che i pagani osservino il comandamento che Dio dette a Noè, di evitare cli mangiare il sangue (Gen 9,4). Tuttavia Luca pone sulle labbra cli Giacomo una seconda citazione: Dio ricostruirà Israele affinché le genti comincino a cercare il Dio d'Israele (Am 9,llss.). Con ciò Luca richiama l'attenzione su un problema che resta aperto sino alla fine cli At: la missione alle genti deve aspettare che Israele sia rinnovato?
Apostoli (At) • 181
Luca si dedica a questo problema narrando dei viaggi di Paolo. Nei capitoli iniziali in primo piano c'è ancora Pietro che ha ratificato ogni nuovo svilupp o, da ultimo nel 'Concilio degli apostoli ' (15,7ss.). Pietro rappresenta il passato positivo prima della disputa sulla missione alle genti. Ma per Luca rientra già nel passato anche una missione come quella che Paolo conduce in At. La parte principale di At (13-28) narra cli Paolo come cli w1 missionario ebreo impedito che, solo dopo alcW1i insuccessi, annW1cia il messaggio di Gesù anche ai non-ebrei. Quando sorse At, la separazione tra cristiani ed Ebrei era inevitabile. In At Luca prende congedo da w1 passato trasfigurato , in cui i discepoli di Gesù appartenevano al popolo ebraico. Già Paolo sperimenta cli persona che per lui è meglio essere prigioniero dei Romani che essere consegnato al suo popolo (2 1,3lss.; 23 ,12ss.). Con l'Lùtimo discorso cli Paolo in At (28,25ss .) Luca interpreta questa situazione alla lu ce della citazione di Is 6,9s.: Dio ha 'indurito' Israele. Solo ora Paolo è certo della missione ai pagani: «q uesta salvezza viene ora rivolta ai pagani», e conclude il discorso con wrn promessa che anche per Luca resta non esaudita: i pagani «l'ascolteranno». Luca non può immaginarsi che possa esservi una via della salvezza ebraica indipendente dalla fede in Cristo (cfr. 4,12) . Come altri storici dell'antichità anche Luca interpreta l'accaduto con discorsi ideati da lui: prendono la parola Ebrei, cristiani e pagani. I 26 cliscorsi costituiscono un terzo del testo; 8 cli essi li tiene Pietro, 9 Paolo. Molti discorsi comprovano, col racconto cli testi veterotestamentari, che gli Ebrei sono 'padri e fratelli' dei discepoli di Gesù. Altri lodano la devozione dei pagani ovvero lamentano clivisioni nella cristianità. In 16,10-28,16 le storie di Paolo interrompono l'elenco delle soste in un viaggio pe~· mare, che Luca fa in prima persona plurale. E W1a testimonianza diretta cli Luca o solo uno strumento stilistico? Alcuni dati si contraddicono. Così le tre cronache della conversione di Paolo (9; 22; 26): ricevette la missione alle genti subito dopo la conversione o più tardi nel tempio ? Molte cose saranno storicamente corrette. Una iscrizione trovata a Delfi conferma che Gallio, come narra At 18,12 , era proconsole in Acaia. L'iscrizione permette di datare quell'episodio al 52, fornendo così un ptmto fisso alla cronologia neotestamentaria.
182 • 15. Gli scritti giovannei
I i
Pesah (Pasqua) 14-21 Nisan (marzo-aprile) Festa della dedicazione del tempio 25 Kislew (nov./dic.)
/ canae
:Ì
GALILEA ------;..' / ---------·---.,,\ /~:_ ,__
Festa delle settimane (Pentecoste) 6 Sivan (maggio/giugno)
\
;
SAMAR IA
Festa delle capanne 15-21 Tishri (sett./ott.)
Sicar
e
\\
i
GIUDEA Gerusalemme
Efraim
•
eJ
etania
PEREA \ Luoghi [--I del battesimo
\
Cana (2) Miracolo del vino Cafarnao (2 , 12) Cana-Cafarnao (4) Guarigione a distanza Secondo Pesah (6) discorso del pane a CafarnaolC:================::-.,
r
Si ritira a Efraim Betania: risuscitazione lc=:::::I di Lazzaro (11)
Pesah della morte (12-19) Dedicazione del tempio (10,22-39):
Si vuole lapidare Gesù
~======:::::-.
Gesù a Gerusalemme Insegnamento pubblico di Gesù '===~> ! Capa nn e (7): un uomo guarito
è scacciato dagli Ebrei
Si ritira nei luog del battesimo
Primo Pesah (2 ,13-3,21) Purificazione del tempio
Tempi e luoghi della vita pubblica di Gesù nel vangelo di Giovanni
15.1 11 vangelo di Giovanni (Gv) • 183
Nm1ostante il medesimo piano globale, Gv si distmgue nettamente dai sinottici (Mc, Mt e Le). Da un lato il Gesù storico non è praticamente ri~onos_cibile: più importante della sua patria, la Galilea, e Gerusal~mme . .Al posto dei detti e delle parabole, 111 cut nsuona il linguaggio invitante di Gesù, subentrano discorsi maestosi, in cui Gesù annuncia da dove viene e a che cosa è inviato. Nello stesso stile solenne di Gesù parlano il Battista e il narratore. DaJl' altro lato, solo in Gv sono menzionati dei particolari concreti che più non esistevano poco dopo. l'epoca di Gesù: Betania e Ermon, luoghi in cm s1 battezzava (1,28; 3,23), Sicar, luogo dei sam.anta111 (4,5). Solo in Gv si parla di Gabbata, il tnb~nale.romano a Gerusalemme (19,13) , dei pellegnnagg1 per la festa di Pasqua e delle Capanne (2,23; 7,2s.), della festa di dedicazione del tempi.o (10,22). Un discorso dell'ultimo giorno della fes ta delle Capanne allude a m1 rito che ha a che fa re con l'acqua proprio in questa giornata (7,37). Alcune cose si accordano solo con difficoltà con Mc, Mt o Le. Gesù ha battezzato come Giovanni (3,22ss.)? Ha cercato, diversamente da come fa pensare Mt (10,5s.; 15,24), le «pecore perdute d'Isrnele» anche in Samaria (4,12), così che gli Ebrei lo msult~vano chiamandolo 'samaritano' (8,48)? È attend1~ile che, diversamente da quanto presentato nei s111ott1c1, du rante la vita pubblica di Gesù sta caduta più di una sola festa di Pasqua (2 13 · 11,55). ' '
Gv è sorto in commùtà che coltivavano particolari tradizioni gesuane.
Gv è redatt.o in m1 linguaggio particolare quale si usa 111 ambienti che possiedono una terminologia comune. Le proposizioni sono costruite in modo semplice, il greco è corretto, il vocabolario limitato e insieme lontano dal quotidiano. Formulazioni iperboliche riguardano la vita, la verità, la via, il mondo, la luce, le tenebre, il conoscere e non-conoscere. L' a_utore sottoline~ che solo _in. Lm secondo tempo si e compreso c10 che Gesu mtendeva davvero. Anzi, i contemporanei di Gesù non potevano sapere che la 'rinascita' alludeva al battesimo cristiano (3,4), o come mai la carne di Gesù poteva essere '~ibo' (6,52). Neppure i discepoli capiscono Gesu, nemmeno quando egli si rivela solo a loro nei lunghi discorsi di congedo dell'ultima sera (13,28; 14,9). Persino i loro stessi pensieri li hanno cap1t1 solo allorché era passato il tempo in cui avevano conosciuto il Gesù terreno (2,17.22).
Gv presenta coerentemente l'attività di Gesù dal punto di vista della fede che con Ge-
sù si è manifestata nel tempo la verità divina sovratemporale. Ma Gv non è un manuale di teolocria: esso racconta dei conflitti. Alcune affermazi~ni contrastanti sui 'Giudei' richiamano l'attenzione sul conflitto principale. L'ambiente giudaico di Gesù è così familiare all'autore che certamente anche lui doveva ess~re un ebreo. Tuttavia, degli Ebrei dà un giud1z10 generalizzato, come se fosse uno esterno. 5,18; 10,31: gli Ebrei sono adirati per i discorsi di Gesù e lo vogliono uccidere. Secondo Gv, Gesù respinge in modo durissimo proprio gli Ebrei che credevano in lui: «Voi avete il diavolo per padre» (8,44). Dall'altro lato solidarizza con gli Ebrei nei confronti dei San~aritani: «Noi preghiamo ciò che noi conosciamo· anzi la salve~z~ vi~ne dai Giudei» (4,22). L'imm~gine dei f~nse1 e chiara? 1:1a anacronistica. Al tempo di Gesu, solo la nobilta sacerdotale aveva il diritto di sovranità; ma in Gv i fa risei compaiono come m1'autorità; .essi pos,sono sottoporre a interrogatorio i seguaci di ~esu e «Cacciarli dalla sinagoga» (9,34; 12,42) , ncevere le den unce e preten de rle (11,46.57), inviare servi per procedere a Lll1 arresto (7 ,32; 18,3 ). Solo alla fine del I sec. vi era motivo di parlare così dei farisei. Dopo che i Romani avevano distrutto Gerusalemme, la responsabilità dell'ebr~ismo, c~1e minacciava d.i scomparire, fu dei fa nse1. Con 1 approvaz10ne d1 Roma essi si impegnarono perche il loro popolo, invece che intorno al tempio, si ritmisse intorno alla torali e così capisse in modo nuovo che cosa signific~sse essere 'ebreo'. In Gv, a volte i fa risei vencrono chiamati «i Giudei» (1,19/24; 3,1; 9,13/ l S). Nei dissidenti, che prima erano considerati membri del popolo ebraico, essi videro dei nemici dell'unità ebraica. I cristiani giovannei dovevano esserlo per loro tre volte: con la loro professione di fede messianica (politicamente fraintendibile), la lorn apertura per i non-ebrei, il loro linguaggio particolare.
In Gv un ebreo-cristiano risponde alla crisi in cui le comunità giovannee erano cadute a causa dell'unificazione dell'ebraismo. Le sinagoghe erano istituzioni riconosciute da Roma; le comunità cristiane, no. Gli ebreo-cristiani in yista temevano perciò di essere espulsi. Ci si rifensce a loro, quando Gv narra di Ebrei in vista, che n conosc.evano Gesù solo segretamente «per paura dei Gmde1» (3,ls.; 19,38). Ma ai cristiani, che volevano staccarsi dalle radici ebraiche Gv tiene davanti l'immagine di un Gesù che vive' con il calendario delle feste ebraiche e chiama il tempio «la casa di mio Padre» (2,16).
184 • 15. Gli scritti giovannei
L'attività pubblica di Gesù
I secondo i vangeli sinottici
secondo il vangelo di Giovanni
n
Gesù attraversa i villaggi della j lilea,
Discepoli della Galilea
f
Per tre anni Gesù insegna in Galilea
si mette in cammino accompagnano per Gerusalemme, Gesù,
Samaria Gerusalemme
là mu6ri in croce
fuggono al momento del l'arresto
u
30 d.C.
t
«discepolo prediletto»
Pietro rinnova il gruppo dei discepo)l
32
presso la croce sta il
1
Separazione dall'ebraismo che inizia con la cacciata degli ellenisti ebreo-cristiani da Gerusalemme
64
Persecuzione dei cristiani a Roma - Esecuzione di Paolo e Pietro
66
guerra giudaica
fin~ ~ Vangelo di Marco
a dimora nelle sinagoghe degli Ebrei di cu lt ura el lenistica
I
;.,.. }
70
~ Vangelo di Luca
} 1. Cris i
90
Espulsione dei cristiani dalle sinagoghe
~
Vangelo di Giovanni
Gv 21 Il gruppo giovanneo cerca di unirsi al le comu nità petrine
(Chiamata di Pietro) è agg iunta a Gv
IOO
2. Crisi Scissione del gruppo giovanneo
•
Rafforzamento del resto fedele in 1-3 Gv
I lperaccentuazione della elevata cristologia giovannea
La storia della formazione dei vangeli sinottici e degli scritti giovannei
15.2 Il vangelo di Giovanni e le lettere di Giovanni (1-3 Gv) • 185
1-3 Gv sono scritte nello stesso stile di Gv; evidentemente sono sorte nella stessa comunità, il cosiddetto gruppo giovanneo. La storia di questo gruppo si può dedurre da Gv e 1-3 Gv. Nei sinottici il primo fra i discepoli è Pietro. In Gv, invece, vicino a Gesù più di Pietro vi è un «discepolo prediletto». Questo discepolo , mai chiamato per nome, s'incontra solo in Gv e anche qui solo da 13 ,23: • A lui Gesù dice chi è il traditore. • Come conoscente del sommo sacerdote può in trodurre Pietro nel suo cortile e diventa testimone del rinnegamento (18,15ss.). • Dopo la fuga degli altri discepoli è con le donne presso la croce (19,26). • Prima di Pietro arriva a credere nella risurrezione di Gesù (20,8).
Il «discepolo prediletto» sarà stato il fondatore del gruppo giovanneo.
Il particolare linguaggio giovanneo si potrebbe spiegare col fatto che questo discepolo, che era di casa nei distinti ambienti di nùtura greca di Gernsalemme, abbia portato le forme del pensiero e del discorso del suo ceto nell'anmmcio cristiano. Una cosa è certa: i cristiani giovannei harn10 coltivato a lungo proprie tradizioni dell'attività di Gesù indipendenti da quelle sinottiche. Due crisi, che scossero questa comunità, hanno portato a fa r mettere per iscritto le loro tradizioni e a interpretarle a partire da nuove esperienze. La prima si ebbe alla fine del I sec., quando gli ebreo-cristiani non furono più riconosciuti come ebrei. Essa si rispecchia nei conflitti con gli Ebrei , di cui narra Gv. Alla seconda si arrivò quando, per sfuggire all'isolamento, il gruppo giovanneo cercò subito dopo di collegarsi con le comw1ità in cui viveva la tradizione sinottica del primato di Pietro. Su questo richiama l'attenzione Gv 21.
In Gv 21 si delinea una nuova interpretazione di Gv. 20,30s. è già Lma conclusione. Ma poi vi viene aggiunto il racconto di un'apparizione (21) , in cui Gesù conferisce il primato a Pietro, che egli, secondo i vangeli sinottici, aveva già ricevuto molto prima. La frase finale sostiene però il valore della tradizione giovannea: il discepolo prediletto avrebbe «scritto tutto» in guanto testimone veritiero. Tuttavia wia parte dei cristiani giovannei non approvò l'unione con le comunità petrine e si separò. Questo evento si riflette in 1-3 Gv. I conflitti con gli Ebrei , quali risultano evidenti in Gv, mancano totahnente; vi si legge invece di cristiani che sono «andati via», e di w1 capo della comu-
nità, che «perseguita» e «scaccia» quelli che sono malvisti.
1-3 Gv rispondono a una crisi interna del gruppo g10vanneo.
2 e 3 Gv sono lettere brevi di w1 maestro della fede riconosciuto in diverse comunità, che chiama se stesso solo !"Anziano'. In 2 Gv egli incoraggia w1a co1mmità a cui si rivolge chiamandola «signora»; in 3 Gv annuncia che, nella comw1ità, il cui capo «perseguita», egli andrà a vedere come stanno le cose. Gv è una dissertazione che fa un'ampia esposi zione dei temi contestati, che nelle lettere erano stati solo sfiorati. L'autore anche qui sarà
... offende Paolo
6° lettera
.-----------~. , Debolezza
55 primavera
autunno
2, 14-7,4
Tito
~--------~·
... chiede perdono
dell'apostolo, segno ' della forza di Dio
10-13
~,._J Paolo va incontro a nto
~------------~,-vi
~---------~
7° lettera
1,1-2, 13
.-----------~. , Consolazione
Tito Inverno 55/56: Paolo resta tre mesi a Corinto Scambio di notizie e lettere tra la comunità di Corinto e Paolo
del sofferente da parte di Dio
7 ,5-16
9- - - -
17.2 Ai Corinzi (1Cor;2 Cor) • 201
Corinto - distrutta nel 146 a.C., rifondata come colonia romana nel 45 a.C., e dal 27 a.C. capitale della Provincia dell'Acaia - era, al tempo di Paolo, wrn città cosmopolita con porti sull'Egeo e sull'Adriatico. Alla comunità, che Paolo vi aveva acquisito, appartenevano persone di tutti i ceti, soprattutto non-ebrei. Vi era una varietà di doti carismatiche. Si litigava e nei confronti di Paolo si sostenevano le proprie opinioni. Alcuni dubitavano persino delle sue capacità e della sua missione. La sua lotta per l'unità in seno alla comunità e per il riconoscimento del suo messaggio la si può seguire nel corso di tre anni, poiché Paolo dovette tenere con Corinto un rapporto epistolare, essendo stato trattenuto a Efeso più del previsto (1 Cor 4,19; 16,8; 2 Cor 1,8). Il vivace commercio tra le due città favoriva lo scambio di notizie. In 1 e 2 Cor sono riunite sei o sette lettere. Ne sono indizio alcuni accenni a missive precedenti, a latori delle lettere, al cambiamento di piani di viaggio, e un modo diverso di trattare gli stessi temi. Si tratta sempre di controversie su questioni di attualità. Ai temi principali della missione Paolo si richiama in 1 Cor 11e15. Poiché ha sentito in che modo egoistico si comportino i Corinzi nella celebrazione della Cena , egli narra l'ultima cena di Gesù. Poiché molti dubitano della risurrezione del corpo e mettono in discussione la sua stessa chiamata, egli ripete la formula di fede della morte e risurrezione di Cristo, fa i nomi dei testimoni della risurrezione e di se stesso, come l'ultimo e il più piccolo. A voce, Paolo ha certo raccontato di Gesù più di quanto faccia nelle lettere, già per spiegare che questo crocifisso non era stato né uno schiavo né un sovversivo. L'attesa escatologica tentava molti Corinzi a estrinsecare il disprezzo per il mondo col libertinismo o con l'ascesi. Paolo ammonisce i due gruppi che la vicinanza del giudizio finale rende tanto più urgente la responsabilità della situazione attuale della comunità. Dà dei giudizi duri, ma sa anche cedere. Due volte esige invano di escludere gli egoisti. Alla fine gli basta il cambiamento della 'maggioranza' per riconciliarsi con tutti e pretendere da tutti la stessa cosa affinché 'Satana' non si mascheri da giusto; cfr. sull 'argomento 1 Cor 5,2ss.9ss.; 2Cor 12,21; 11,15; 2,6ss. A maggior ragione inculca il duplice metro della condotta di vita cristiana: • Ogni cristiano è w1 'tempio' della presenza di Dio perché lo Spirito divino del tempo escato-
logico agisce già in lui. Perciò a nessuno è lecito di ferire la propria dignità. • Ogni cristiano, nella sequela di Gesù , deve dare la propria vita per gli altri. Anche i carismi, di cui Dio ha fatto dono ai Corinzi, Paolo li misura sul fatto se siano utili agli altri. Carisma (gr. 'dimostrazione di fa vore') riceve da lui il significato di 'irradiamento'. Gli avversari principali di Paolo sono i cristiani giudaizzanti che contestano che per mezzo di Cristo siano riconciliati con Dio anche i non ebrei. Quando Paolo sente della loro comparsa, manda Timoteo a vedere come stanno le cose. Questi non ha successo, così che Paolo spiega per scritto la differenza tra il 'vecchio' e il 'nuovo' patto (2 Cor 2,14 fino a 7,4). IntenzionaL11ente, come messaggero, manda il suo collaboratore non ebreo Tito. Tito deve, al contempo, promuovere una colletta per Gerusalemme (2 Cor 8) , forse anche per rendere concilianti i giudaizzanti. Tito viene respinto. Paolo va di persona, ma viene offeso e torna subito indietro. Questa seconda visita di Paolo si può dedurre da 2Cor12 ,14; 13 ,1. È con una lettera scritta «fra molte lacrime» (2 Cor 2,4), affidata cli nuovo a Tito, che egli vuole riguadagnare la comunità. Lo fa , «vru1tandosi come un pazzo» dei travagli e dei dolori patiti nella sua carriera di apostolo (2 Cor 11). Egli pone se stesso ad esempio a favore di quell 'insegnamento disprezzato nella Corinto vogliosa di vivere, insegnamento che egli tanto più spesso sottolinea in 1 e 2 Cor: Dio dimostra la sua forza attraverso ciò che tra gli esseri un1ani è considerato debole. Con «la lettera delle lacrime» Paolo ha avuto successo con la 'maggioranza'. Pieno d'inquietudine è andato incontro al messaggero Tito in Macedonia e sente del «desiderio, indignazione, affetto, scuse, timore» della comunità (2 Cor 7,7.11). Una lettera deve suggellare la riconciliazione. Essa è avvenuta perché i Corinzi possono essere certi dell'aiuto di Dio. Essi hanno anzi ricevuto il battesimo come 'sigillo' apposto sul contratto con Dio e come 'caparra' già lo Spirito che agisce in loro (2 Cor l ,18ss.). Nonostante tutta la severità del suo giudizio (cfr. 1 Cor 6,11 ; 10,13 ; 2 Cor 13,lls.) , Paolo è certo che i battezzati sono già salvati. La lettera post-neotestamentaria di Clemente (96 d.C.) rivela che il successo di Paolo non durò a lungo. La composizione di 1 e 2 Cor restò però importante.
202 • 17. Le lettere di Paolo
relazioni amichevoli con Roma
-
- - lli)-.q'
Misia Regione via commerciale vie di Paolo secondo Al 16,6
t o
secondo At 18,23t
100
200 km
A La duplice visita di Paolo nel «paese dei Celti (gr. Galati)»
Dio --~~~~~-
promette la benedizione a tutte le tribù della terra
-~~-
.....
-~~~~~~~~~~~~
schiavizzano
/r~~:~~tti i popo~ li ~~ promessa. Essa ...
La sua benedizione
si realizza per mezzo di
Cristo
I Celti che credono in Cristo sono figli di Abramo
B Adempimento della promessa ad Abramo e della legge del Sinai secondo la lettera ai Galati
17.3 Ai Filippesi (Fin; ai Galati (Gan • 203
Paolo scrisse la lettera ai Filippesi in prigione a Efeso (55 d.C. ). I Filippesi gli avevano chiesto aiuto tramite Epafrodito; Paolo lo rimandò con una lettera straordinariamente cordiale. Anche i Filippesi sono travagliati e Paolo li incoraggia; anche lui ha sperimentato di persona che persino le difficoltà servono al Vangelo. In prigione ha guadagnato a Cristo gente della «casa di Cesare» (schiavi?) , e il suo esempio ha rafforzato altri ad annunciare il Vangelo. Alcuni lo fanno, in realtà, per amore della propria gloria, ma Paolo lo accetta. «Se essi annunciano Cristo, io me ne rallegro». 'Gioia' è la parola chiave della lettera. Improvvisamente il tono cambia. Paolo insulta i 'circoncisi', spiega che, per lui , che pure è un ebreo irreprensibile, tutto ciò è solo 'spazzatura'. Per l'inspiegabile durezza, che appare mettendo 4,4 dopo 3,1, questa polemica (3,2-4,3) è certo interpolata da un'altra lettera. Un analogo cambiamento colpisce in 1 e 2 Cor. In 1 Cor 15 ,8 Paolo accetta un 'offesa fatta a lui e chiama se stesso un «aborto»; in 2Cor 11 ,13 , invece, attacca i «falsi apostoli» che annunciano un «altro Gesù». Analoghe invettive si trovano in Gal. La lettera ai Galati è uno scritto battagliero, brusco e polarizzante, che ancor oggi rende difficile il dialogo ebraico-cristiano. Lutero la lesse come appello alla libertà cristiana contro il primato di Pietro. In Gal gli avversari restano anonimi; ma alcune concordanze con Fil 3 e 2 Cor 11 tradiscono chi è che Paolo combatte. Paolo polemizza contro gli ebreo-cristiani che dubitano della sua integrità e annunciano il Vangelo in modo diverso da come lo ha fatto lui. I destinatari sono i Celti (gr. Galati) che vivevano in Asia minore (At 18,33). Essi avevano curato Paolo quando, in viaggio, si era ammalato, ed erano diventati cristiani (4,13s.). Dopo aver fatto loro visita per la seconda volta, Paolo seppe che avevano accolto un «altro vangelo» (1,6). Egli avrebbe preferito andare di persona (4,20); poiché forse non aveva alcun messaggero fidato (cfr. Fil 2,20), egli difese se stesso e la sua missione con una lettera didascalica, in cui illustra nei particolari due argomenti: 1. Il Vangelo che annuncia non l'ha ricevuto da esseri w11ani (l s.)
A prova di ciò narra di aver fatto visita agli apostoli originari solo molto dopo la sua chiamata e per poco tempo. Ma allo stesso modo sottolinea che loro lo hanno riconosciuto. Quale autorità a-
vesse Cefa per lui, lo tradisce la veemenza con cui egli lo accusa: solo per 'paura' degli ebreo-cristiani aveva smesso di prendere cibo coi pagano-cristiani. Che i cristiani «mangino insieme» è per Paolo il segno irrinunciabile della loro unità. 2. Il vangelo che anmmcia è conforme alla Scrittura (3-6). Lo dimostra con un'ardita reinterpretazione di alcuni essenziali segni di riconoscimento degli Ebrei: La circoncisione era certo celebrata dagli avversari di Paolo come il segno del patto di Abramo (Gen 17). Paolo spiega, invece, che soddisfa quel patto solo chi, come Abramo, crede alla promessa (Gen 15,6) . «Figli di Abramo» sono i Galati solo finch é davanti a Dio non hanno da esibire che la loro fede in Cristo; allora però la linea Abramo Isacco continua senza interruzioni anche presso i Celti. La legge veterotestamentaria aveva fatto impressione ai Galati soprattutto a causa del suo ordinamento del sabato e delle feste. Forse gli avversari di Paolo appartenevano a gruppi ebraici che davano importanza centrale alle questioni di calendario . Paolo esorta i Galati: chi si aspetta la salvezza dal!'osservanza dei tempi sacri, pratica l'idolatria. Il tempo è Lma delle 'forze elementari' che rendono schiavi gli esseri umani. Per mezzo di Cristo, Dio ha spodestato queste forze venerate dai pagani come dèi. Da allora anche la torah ha w1 nuovo significato; una volta essa ha 'custodito ' Israele (3,24), ma non ha portato la benedizione, che essa promette ai giusti. 'Custodire' ha per Paolo significato positivo; anche la «pace di Dio custodisce» gli esseri umani (Fil 4,7). Poiché nessuno è libero dall'ingiustizia, si realizza solo la maledizione, con cui la torah minaccia tutti quelli che operano l'ingiustizia (D1 28). Per questo Dio è intervenuto e ha donato la benedizione per mezzo di Cristo. Neppure secondo l'insegnamento veterotestamentario-ebraico il retto agire è condizione preliminare della benedizione, bensì la devota risposta alla bontà di Dio. La novità dell 'insegnamento paolino è solo che a salvare è la fede in Cristo. Incompatibile con le idee veterotestamentarie è comw1que l'immagine della torah come 'pedagogo' (gr. 'guida del fanciullo') . Nel mondo greco il 'pedagogo' era uno schiavo anziano che accompagnava il fanci ullo a scuola. La torah veterotestamentaria è, invece, insegnamento rivolto all'Israele maggiorenne che regola da sé la propria vita e deve diventare così Lm popolo che risponde nella libertà all'amore del suo Dio.
204 • 17. Le lettere di Paolo
Dio La giustizia conduce alla vita
nella storia del mondo
L'ingiustizia conduce alla morte
rive la
Poiché ovunque regna l'ingiustizia
egli consegna tutti alla morte:
egli sveg lia
c uore e rag ione del l'essere umano
eg li dà
eg li inseg na
a Israele la torah
eg li ri vela
nel tempo escatologico, che è già iniziato
la SUA giustizia per mezzo del Cristo morto a causa dell ' ingiustizia d i tutti gli umani , risuscitato, affinché Dio possa rendere tutti giusti
alla fine del mondo
La sua ira distrugge tutti gli ingiusti
Spiegazione del mondo nella lettera ai Romani
17.4 Ai Romani (Rom) 1• 205
Paolo ha scritto le sue lettere spinto da una forte preoccupazione per le co1mmità da lui fondate: • 1 Ts deve eliminare le paure; • 1 Cor deve sanare le divisioni; • Fil incoraggia la comunità perseguitata; • 2 Core Gal combattono i giudaizzanti. Solo in Rom Paolo si rivolge a comunità a lui sconosciute. Dei motivi contingenti Paolo li ha anche per Roma. Egli scrive la lettera nel 56 d.C. da Corinto. Il suo lavoro in Oriente è finito (15,23ss.); vuole solo portare la colletta delle sue comunità a Gerusalemme e poi - prima della fine del mondo (13,11) - andare in missione in Spagna. A Roma spera di trovare aiuto per questo intento, e così la sua lettera deve convincere i cristiani romani della sua causa. Dalle esortazioni (12 ,1-15,13) risulta che Paolo conosce la situazione romana. Ricorda i diritti dello stato forse perché sa che i cristiani avevano provocato 'tLmrnlti', ragion per cui l'imperatore Claudio, nel 49, aveva cacciato gli Ebrei da Roma (Svetonio, Claudio 25,4). Paolo aveva incontrato in Oriente alcuni profughi, che saluta in 16; evidentemente erano tornati a Roma dopo la morte di Claudio (54 d.C.). Quei twmùti erano sorti forse per la disputa sulle norme alimentari; per Paolo questo è un motivo per richiamare le com unità alla tolleranza su questi problemi. Nella parte didascalica principale (1 ,18-11,36) Paolo rende conto della sua fede con la massima accuratezza. Lo fa nello stile di un discorso parlato, inscena per esempio delle arringhe contro l 'uomo , l'Ebreo o addirittura un soliloquio di Adamo (7,14-24). Per il tema, Rom è affine a Gal; ma mentre Gal mette in guardia i non-ebrei dal!' assumere la torah, Rom insegna che ebreo-cristiani e pagano-cristiani sono un a unica collettività. Paolo sa che a molti pagano-cristiani romani è cara la legge ebraica (1,6; 7,1) , e che il suo insegnamento li irrita. Egli si occupa a fondo di questo argomento: dovrebbe Dio aver eletto e istruito Israele con la torah per pretendere poi, però, solo la fede in Cristo? Rom è l'w1ico scritto neotestamentario che si chiede che senso ha che il popolo ebraico continui a esistere. Il problema delle intenzioni di Dio è al centro di Rom. Paolo non lo risolve, ma spiega ai suoi destinatari la realtà in cui vivono. Che cosa è successo loro quando sono diventati cristiani? Che cosa è cambiato nel mondo con la morte e risurrezione di Cristo? Egli svolge la logica interna di questo even-
to; collegando concetti filosofici e biblici, sviluppa allo scopo un linguaggio elaborato. Così la promessa che Dio sanerà l'infedeltà d'Israele, «scrivendo la sua legge nel loro cuore» (Ger 31 ,33), gli serve per provare che torah e coscienza hanno lo stesso valore (2,15). Nel loro intimo anche i pagani sanno che cosa è giusto e che cosa ingiusto. SLùl'importanza universale di Cristo Paolo richiama già nell 'intestazione sostituendo la formula cli fede che Gesù è 'risuscitato' con il t6pos apocalittico della 'risurrezione dai morti'. L'opera cli Cristo è utile a tutti quelli che devono morire. Il significato di questa affermazione Paolo lo espone in modo particolareggiato, prima in negativo, poi in positivo. Innanzitutto (1,18-3 ,20) spiega che il mondo è giustamente in balìa della morte. L''ira' cli Dio lo rivelerà definitivamente alla fine del mondo, ma la cosa è già verificabile. Infatti tutte le genti disprezzano le forze con cui potrebbero favorire la giustizia e proteggere la vita, i pagani la ragione, gli Ebrei, inoltre, anche la torah. Nel secondo passaggio (3,21-5,21) Paolo spiega che Dio esercita la giustizia in modo tale che essa salvi l'umanità. L'AT ebraico parla della giustizia di Dio come di una forza che sana l'ingiustizia. Paolo fissa questo significato al greco clikaiosJine, parlando delle intenzioni di Dio anche come riconciliazione che Dio accord a ai suoi nemici (5,10), o come 'liberazione' dell'individuo anche dall 'irretimento nel peccato e nella morte (7,23s .). Che Dio sopporti ogni ingiustizia è incomprensibile; ma a che scopo egli eserciti la pazienza e la fine del mondo non arrivi, Paolo lo può dire. Tutti devono avere l'opportunità con cui già vivono i cristiani. Paolo lo chiarisce con una variazione della formula cristiana della fede: Cristo «consegnato a causa dei nostri peccati, è stato risuscitato per la nostra giustificazione» (4,25). Dio «agisce con giustizia» , facendo partecipare alla vita del Risorto. Perché faccia così, Paolo non lo spiega; anche il Dio misericordioso è incomprensibile. In Rom Paolo espone cos'è che lo spinge a portare
il messaggio di Cristo alle genti. Nella capitale del mondo avrà sperato di trovare dei cristiani che avevano imparato a ignorare le barriere tra Ebrei e pagani. Probabilmente, nonostante la prospettiva di un processo corretto in Palestina (At 26,32), è stato questo il pensiero che lo ha spinto a fare quel ricorso all'imperatore, che lo portò a Roma. Non poteva sapere che a quel tempo un cristiano a Roma non otteneva Lma sentenza equa (Svetonio, Nerone 16).
206 • 11. Le lettere di Paolo
il diritto d ivino d 'Israele comunicato per mezzo d i Mosè
Norma della prassi cristiana è " la legge",
~ Il comandamento principale dell'am ore del prossimo rende liberi di subordinare tutto iI resto Idolatria e desideri rendono schiavi!
la Sacra Scrittura d ' Israele Profeti Mosè
hanno il loro com imento
Salmi A La vali d ità della 'legge' per i cristi ani seco ndo l'inseg namento di Paolo
Nel tempo prima di Cristo Dio ha dato al suo popolo legge e promessa affinché vivesse Chi è figlio d 'Israele solo secondo la carne, confida nelle opere della legge e non trova la vita
Chi, come fig lio d'Israele, confida nelle promesse, riceve il dono della vita
Le genti che non conoscono Dio disprezzano la ragione e la coscienza e muoiono
Nel presente tempo della fine I figli secondo la carne fanno affidamento sulle opere della legge e non trovano la vita
d ' Israele .-.. 1figl i della promessa
Le genti,
il santo
chiamate alla
resto
sono i credenti a cui è fatto il dono della vita
vive Al compimento del mondo ,------------~,,----------~ La totalità delle genti
Tutto Israele liberati dal potere della morte per la misericordia di Dio
B Israele e le gent i nella storia universale secondo l'insegnamento di Paol o
fede
17.5 Ai Romani (Rom) Il B 207
Secondo l'insegnamento paolin o, Dio ha aperto con Cristo la via della salvezza a tutte le genti. In Rom Paolo esamin a a fo ndo tale idea: davanti a Dio può mai l'essere umano essere salvo - secondo il linguaggio paolino, 'giusto'? Da Lutero in poi il problema di come faccia l'essere umano a diventare 'giusto' davanti a Dio, divide la cristianità. A maggior ragione è importante leggere Rom come una lettera che si rivolge a dei destin atari ai qu ali tale domand a suonava in modo di ve rso . I cristiani romani erano amici dell 'ebraismo; essi si chiedevano se l'insegnamento di Paolo non contestasse il prim ato del popolo ebraico eletto da Dio.
Nell'esposizione del suo insegnamento (1-5) Paolo ha mostrato che gli Ebrei sono altrettanto poco 'giusti' dei pagani, e ha già ammesso che ci si debba allora interrogare sul primato degli Ebrei (3, 18). Nella discussione analizza i seguenti problemi: 1. Quale significato ha la torah se l'obbedienza alla legge non porta salvezza (6-8)? 2. L'elezione d'Israele è priva di valore se Dio salva chiunqu e crede in Cristo (9ss.)? Come autorità, Paolo interroga la Sacra Scrittura; più che mai pres uppone che i suoi destinatari la conoscano e capiscano le allusioni. Come altri Ebrei del suo tempo, è convinto che il suo pieno significato sarà svelato nel tempo escatologico, che per Paolo è iniziato con Cristo. 1. La legge è per Paolo il segno sacro dell'elezione d'Israele; ma egli è convinto che essa non possa salvare gli esseri W11ani prigionieri del peccato. Paolo chiama 'Legge' (gr. n6mos, per l'ebr. torah) sia la legge del Sinai sia la Sacra Scrittu ra, speciaL11ente i primi cinque libri, in cui Dio istruisce Israele su ciò che è la sua volontà per tutto il mondo (Gen 1- 11), per i padri d'Israele (Gen 12-50) e per Israele stesso (Es- Dt). Paolo accwm1la argomenti SLÙ perché la torah sia buona, ma anche impotente: • storici: la legge del Sinai venne solo dopo che Dio aveva abbandonato il mondo alla morte a causa del peccato di Adamo; • cognitivi: fa vedere alla persona quanto sia divisa interiormente a causa delle sue cattive azioni, che pure condanna; • psicologici: i divieti mostrano alla persona domin ata dai desideri ciò che potrebbe ancora desiderare; • dalla sua personale esperienza (cfr. p. 191): lo zelo per la legge di Dio può indurre al peccato.
Adempiere la legge è diventa to possibile solo per mezzo di Cristo. Infa tti chi sa di non dover ottenere la salvezza da sé, ha il coraggio di obbedire allo spirito della torah invece di attaccarsi con angoscia alla lettera. 2. SLùla elezione d'Israele Paolo ha già richiamato l'attenzione in 1,16 con le parole «l'Ebreo prim a». In 9ss. chiede che significato abbia che il «Vangelo», che è stato annunciato prima agli Ebrei, sia stato rifiutato dalla maggioranza di essi. Anche questo problema Io affronta da molti lati: • Dal no d'Israele nasce del bene; infatti così si avvera la promessa della Scrittura: il messaggio di salvezza esce verso le genti (15,9ss.). • I pagano-cristiani non hanno però alcun motivo per innalzarsi al di sopra d'Israele. Essi somigliano ai rami di un olivo selvatico che, innestati sul nobile olivo d'Israele, vivono delle sue radici (11 ,17ss.) . • Paolo sottolinea con fo rza che Israele non è affa tto ripudiato. I rami nobili dell'olivo sono sì tagliati, ma potranno essere reinnestati più faciL11ente dei germogli selvatici. • Due segni della ininterrotta fedeltà di Dio per il suo popolo esistono già: alcuni Ebrei sono diventati cristiani , così che le promesse del 'piccolo resto' sono già realizzate (11 ,5). Soprattutto Cristo stesso è stato il «servo dei circoncisi» (15,8). Paolo ha contestato il valore salvifico della circoncisione (Fil 3,2); qui sottolinea che i cristiani, per amore di Gesù, devono rispettare lo stile di vita ebraico. • Riprendendo un 'immagine veterotestamentaria (Is 65, l s.) Paolo vede la missione alle genti come un nuovo tipo di propaganda di Dio per il suo popolo; Israele deve diventare «geloso» (10, 19; 11 ,11). Con la stessa parola Paolo pa rla del suo compito a favore delle genti come di un servizio reso al suo popolo (11 ,14). • In un discorso profetico annuncia «un mistero: tutto Israele sarà salvato» (11 ,25) . Come accadrà non Io dice; ma sa come può contribuirvi: quando saranno guadagnate «tutte le genti», Dio avrà misericordia d'Israele. Anche Roma, con cui voleva preparare la missione in Spagna, Paolo la intendeva dw1que come parte del suo servizio al popolo ebraico. Sapeva quanto potesse diventare pericolosa per lui la 'gelosia' del suo popolo. Egli programmò Llll viaggio a Gerusalemme intuendo che gli poteva capitare qualcosa di male a ca usa degli «infedeli dell a Giud ea» (15,3 1). Una visita nel tempio gli doveva costare la libertà (At 21ss.) e infine la vita.
208
18. Effetti delle lettere di Paolo
Cronologia
Fonti nel NT
50-56 d.C.
Paolo in Asia Minore e Grecia
57-60 d.C.
Prigioniero a Cesarea e a Roma
lettere contemporanee di Paolo -30 anni dopo narrato in At 21-27
dopo 60 d.C. scomparso a Roma
62? 64? d.C.
orse giustiziato sotto Nerone
70-100 d.C.
i discepoli di Paolo nascondono l'assenza del maestro
L'operato di Paolo
50
53
2 Ts
Modi di trasmissione
e Gerapoli
Epafra, compagno di prigionia di Paolo
imitata in ==> ~L_2_i:_ s ~~
Gerapoli
Colossi
Lettera dalla Fm prigionia in Efeso all'amico che lo ha ospitato in Licaonia
1 e 2 Tm, Tt
una lettera di «Paolo prigioniero» a
•
55
Ef
Gli allievi proseguono la sua opera
due lettere a Tessalonica unite in una lettera didascalica con l'incarico di gc~==;-;====:>> 1Ts una missione autonoma Viaggi di Paolo dai Galati a Efeso via Licaonia
Col
e
Lao d.icea• •Colossi
Archippo, figlio dell'ospite
Col
I Fm2 I è successore diEpafra
rielaborate in scritto didascalico t--ic:=:=============; ~-----------~ di «Paolo prigioniero» Ricordo di Paolo Ef come martire
Raccolta delle lettere paoline 49
57
Timoteo e Tito collaboratori di Paolo
e inoltre Percorsi della tradizione paolina
At
18.1 La seconda lettera ai Tessalonicesi (2 Ts), inizio della ricezione di Paolo
2 Ts è lo scritto di un allievo di Paolo che imita 1 Ts. 2 Ts somiglia a 1 Ts nel ragionamento e in parte persino nel testo. Il vero Paolo scriveva in modo diverso; in ogni lettera affrontava i problemi contingenti con un approccio nuovo. In 2 Ts è nuovo solo il 30% del testo, che, del tempo prima della fine del mondo, delinea un quadro che è Lmico nel
NT: • 1,5-10: la salvezza dei cristiani e la «rovina eterna» di coloro che «non obbediscono al Vangelo», sono messe Lma di fronte all'altra. • 2,2-10: dapprima deve essere eliminato «colui che si oppone», poi
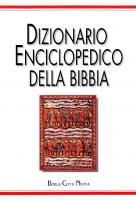


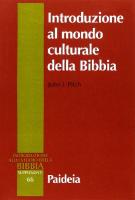


![Non capite ancora? Pagine difficili della Bibbia [Prima edizione]
9788851422834](https://dokumen.pub/img/200x200/non-capite-ancora-pagine-difficili-della-bibbia-prima-edizione-9788851422834.jpg)



