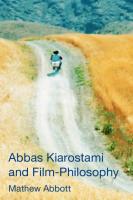Abbas Kiarostami. L'evidenza del film 8879898531, 9788879898539
Un filosofo legge l'opera di un regista. Ossia pensa a partire dall'immagine filmica e dal complesso statuto d
128 16 12MB
Italian Pages 143 Year 2004
Polecaj historie
Citation preview
Jean-Luc Nancy
ABBAS KIAROSTAMI L’evidenza del film
Con una conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy trascritta da Mojdeh Famiii e Teresa Faucon e una serie di immagini scelte da Teresa Faucon
Edizione italiana a cura di Alfonso Cariolato
DONZELLI EDITORE
Titolo originale: VÉvidence du film. Abbas Kiarostami © 2001 Yves Gevaert Éditcur, Bruxelles
Crediti fotografici: Où est la maison de mon ami * © Farabi Cinema Foundation/Abbas Kiarostami 1987. Coll. Les Grands Films Classiques; Close-up © Farabi Cinema Foundation/Abbas Kiarostami 1990. Coll. Celluloid Dreams (planche vi), Coll. Ma mad Haghighat (planche X); Er la vie continue © Farabi Cinema Foundation/Abbas Kiarostami 1992. Coll. Les Grands Films Classiques; >4 travers les oliviers © Farabi Cinema Foundation/Abbas Kiarostami-TF1 Ciby DA 1994. Coll. Farabi Cinema Foundation (planches il e XI, photos de plateau); Le Coiit de la cerise © Marin Karmitz/Abbas Kiarostami 1997. Coll. MK2; Le Vent nous emportera © Marin Karmitz/Abbas Kiarostami 1999. Coll. mk2.
Questo volume e stato pubblicato con il contributo del Premio Filmcritica-Umberto Barbaro.
La giuria del Premio c composta da Edoardo Bruno, Alessandro Cappabianca, Carmine Donzelli, Emilio Garroni, Enrico Ghezzi, Luigi Malerba, Walter Pcdullà, che ne è il Presidente. La serie «Premio Filmcritica-Umberto Barbaro» è curata da Gabriele Pedullà.
© 2004 Donzelli editore, Roma Via Mentana 2b INTERNET WWW.donzclli.it e-mail [email protected] ISBN 88-7989-853-1
ABBAS KIAROSTAMI_________________________
Indice
p.
IX
Premio Filmcritica Umberto Barbaro 2003 Nota di Edoardo Bruno
XI
Intensi sguardi Prefazione di Alfonso Cariolato
L’evidenza del film. Abbas Kiarostami 3 5 9
li 13 15 18 20
25 28 31 34
Storia 1 Storia 2 Sguardo Reale Pregnanza Arte sovrannumeraria Cosa che rotola Sguardo / immagine Rispetto Evidenza Film Traspone
39
E la vita continua
55
Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy Trascritta da Mojdeh Famiii e Teresa Faucon
75
Nota introduttiva alle tavole Immagini scelte da Teresa Faucon
v
________________________ Nancy, Abbas Kiarostami
Appendici 99
l. Conversazione con Jean-Luc Nancy
117
II. Del brillante e del falso. Conversazione con Abbas Kiarostami A cura di Daniele Dottorini, con la partecipazione di Gaetano Saccoccio
VI
Abbas Kiarostami L’evidenza del film
ABBAS KIAROSTAMI
Premio Fimcritica Umberto Barbaro 2003
Aprire gli occhi Nota di Edoardo Bruno
È un breviario di estetica filmica, un saggio che entra nelle pieghe di un’opera, £ la vita continua di Kiarostami, c ne di spiega il tracciato, l’ordito, il senso; e ne svela il pensiero, perché le immagini sono il pensiero, l’evidenza di questo «parlare» e «pensare» del film. In questa dialettica lo sguardo dello spetta tore si innesta materialisticamente nello sguardo del regista di cui diviene complice e coglie le volute del suo ragionamento, in una disposizione riguardo alle cose del mondo, che gli permet tono di «aprire» gli occhi per meglio guardare, divenendo, come dice lo stesso Kiarostami, «lui stesso» l’autore: «ciascuno co struisce il suo proprio film, lo difende o si oppone». Nella pittura, dice Nancy (Tre saggi sull'immagine), l’imma gine è «una metamorfosi dinamica», una forza che «trascina le forme, in uno slancio, in un getto, che tende a distruggerle o a eccederle»; nel cinema, c un’energia che trasforma e «ragiona», una forma di rappresentazione altra, uno «sguardo, che rende possibile e domanda un mondo che non rinvia che a se stesso e al proprio reale» con la forza dell’evidenza. Un’evidenza che ri mette in gioco l’ego sum di Cartesio, costituendosi come una nuova configurazione dell’esperienza. Sotto questo aspetto, Nancy vede il cinema di Kiarostami come una meditazione me tafisica, non un cinema che tratti temi metafisici, ma proprio di metafisica cinematografica, luogo di pensiero, di messa in di scussione e di rapporto con il senso del mondo.
tx
________________________ ABBAS KIAROSTAMI__________________________
Intensi sguardi Prefazione di Alfonso Cariolato
Il pensiero del film, il pensiero del cinema. Di questo si trat ta nel saggio di Nancy su Kiarostami. Vale a dire innanzitutto del fatto che nel cinema, con il cinema, un pensiero, dei pensieri sono all’opera e non come «significati» esterni, allegorie o senso delle storie che vi vengono raccontate, ma come la fragilità stes sa, la sensibilità delicata di quella «pelle» che c la pellicola (attra versata dalla più mobile e rapida delle velocità: la luce che esce dal proiettore), tesa fra una sorta di coazione all’annuncio della verità e l’apertura del mondo a nient’altro che alla sua presenza. Nessuna «filosofia del cinema», dunque, è qui in questione. Piuttosto un incontro, un contatto, un incrocio di sguardi e un trasporto. Dell’essere, infatti, il pensiero è l’immediato rapporto con un mondo; Và-méme, Van sicb, non si dà se non come pen siero, e questo in sé è tutt’altro che definito, ma costituisce anzi il continuo differimento, la dilazione, l’espropriazione di ogni dato e identità prevedibili, ri-conosciuti, individualizzabili. Se vi è qualcosa come un’ontologia che emerge quasi in filigrana tra queste pagine, è il cinema stesso di Kiarostami - e in particolare È la vita continua - a suggerirla. L’essere persevera, non si fer ma, va oltre. Non è qualcosa, quanto piuttosto un conatus, un’ulteriorità che tracima sempre in una continuità discontinua che avviene non sopra, ma attraverso le singolarità e gli eventi, e che non costituisce che questo continuare discontinuando o di scontinuare continuando. Quando comincia un film dì Kiarostami? Quando finisce? Vi c un momento in cui dovrebbe finire? Le immagini si susseguoxi
----------------------------------------- Alfonso Cariolato___ ________________________
no, si incontrano, si aprono c si chiudono senza sottostare, se non in misura minima e in fondo ininfluente, al diktat del rac conto, del «messaggio». Continuità e discontinuità assolute, senza alcun fine - come l’essere, come la vita. Il che non signifi ca che il cinema sia la vita ma, ben di più, che il cinema vive, si presenta, è, sta nel mondo come sguardo di sé a se, che compor ta sempre (almeno come tensione) un riguardo, un rispetto, una distanza e un’attenzione per ciò che ha luogo qui, nel mondo ap punto (si pensi all’insistenza di Nancy sulla vicinanza tra regard e égard). Sguardo finito, come ogni sguardo di/su questo mon do, e non più occhio di Dio o del Senso, che è sempre un occhio senza palpebra c dunque senza battiti e zone d’ombra. Il cinema palpita, smuove e si muove: c’è. C’è del cinema, vi sono le im magini i segni gli sguardi, e tutto questo è in movimento. Que sta è la presenza del cinema. Il cinema è il «movimento del rea le»; e ciò - l’essere «sguardo in movimento» - lo distingue dalla pittura e dalla fotografia; in esso è questione di «educare» lo sguardo, di farlo «uscire», di metterlo in moto, di contro a una certa priorità dell’interiorità, verso il mondo di cui è sguardo c dove gli alberi, le strade, le macchine, noi, ogni cosa e lo stesso cinema hanno il loro luogo. Il susseguirsi delle immagini, il montaggio, la realizzazione del film è in realtà un’esposizione, una presentazione ulteriore, un’arte che - come ogni arte, anche se in maniera diversa - afferma, pone un mondo nella sua assen za di rimandi, fini e giustificazioni. Un’intensità, dunque, da intendersi anche nel senso delcuziano, vale a dire come il dinamismo dei processi differenziali che costituiscono l’essere in quanto differenza pura; tale dinamismo è connesso in maniera essenziale al sensibile, ma si spinge fino al pensiero, se è vero che non vi è filosofia senza intensità del con cetto'. Nel cinema allora, scrive Nancy, si tratta dell’intensità dello sguardo, il che comporta una riconsiderazione del pensie ro e dei sensi (e non solo della vista, naturalmente) a partire da 1 Cfr. G. Deleuze, Differenza e ripetizione, trad. it. di G. Guglielmi, Cortina, Milano 1997, pp. 288 sgg. XII
___________________________ ___ Prefazione______________
_____________
uno sguardo che percepisce e spinge a pensare l’aprirsi del mon do così com’è. L’arte e, in particolare, il cinema pongono la que stione dei sensi e del pensiero mondani, in tutti i significati di questa espressione, vale a dire sensi e pensiero spogliati di ogni rinvio che li significhi e li riveli a se stessi da un altrove che fun ga da sostanza o da fondamento. Tutto questo avviene con il cinema di Kiarostami. O meglio: per Nancy, Kiarostami è un nome emblematico per qualcosa che riguarda anche altri registi e tocca profondamente l’essenza stes sa del cinema. Dopo cent’anni, il cinema ricomincia con qualco sa che si impone in maniera esplicita: al di fuori dell’immagine non c’è più nulla. Che cosa significa un’affermazione di questo tipo? Innanzitutto che non disponiamo più di visioni, storie e miti che possano spiegare il mondo e inoltre che le immagini non hanno più un dietro, un oltre, un al di là da cui dipendere. Non sono più nemmeno un tramite, un passaggio, un accesso verso qualcosa che, arrivate al dunque, sarebbero nell’impossi bilità di rappresentare. Con esse, non ci si può più comportare come con una scala, che permette soltanto di pervenire a un luo go posto più in alto e non presenta altro senso che questo. Le immagini si accavallano e si incrociano a ritmo vertiginoso sen za più giungere ^//’immagine che tutte le riassume predisponen dole a un senso altro rispetto al loro esserci. Tutto il cinema di Kiarostami ha a che fare con l’evidenza (evidence che Nancy collega a évider, svuotare), per cui le im magini vengono svuotate da qualsiasi senso esterno e colte da uno sguardo attraverso il quale è il mondo stesso a muoversi su se stesso in direzione del suo continuare semplicemente (ma si tratta della semplicità più complicata) ad essere. Che cosa resta dell’immagine una volta venuto meno il rimando a ciò che la si gnifica? Resta la sua nudità, la sua superficie quanto mai profon da, la sua pelle12, ciò per cui ciascuna immagine diventa singolare 1 Cfr. E Ferrari - J.-L. Nancy, La pelle delle immagini, Bollati Borinehieri, To rino 2003.
xin
Alfonso Cariolaco
e attira su di sc uno sguardo, e dunque un desiderio, una repul sione, un predisporsi o meno all’analisi, un assenso, un diniego, una ferita, una gioia. E questo l’avvento stesso proprio del mondo moderno, così come lo definisce Heidegger in Die Zeit des Weltbildes, caratte rizzato dal fatto di sfuggire alla «rappresentazione»3. Il venir meno di ogni pregnanza c capacità di incidere il presente da parte di concetti come Vorstellung e Weltanschauung, secondo Heidegger (che qui non è lontano da Benjamin c, almeno in parte, da Lukàcs, e nemmeno da Guy Debord con tutte le dif ficoltà insite in un avvicinamento di questo tipo) apre senz’al tro - come scrive, tra l’altro, Lacouc-Labarthc - al divenire im magine del mondo. Per Nancy, tuttavia, tutto questo non è interpretabile soltan to come «spettacolarizzazione», intendendo con essa (più o me no surrettiziamente) una valutazione negativa dello stato del mondo a partire da un luogo (il pensiero, la critica, la filosofia) considerato più autentico. Perché non c’è luogo fuori dal mon do. E dunque è a partire da qui che si apre ogni rapporto con le immagini. Questa evidenza è allora immediatamente legata all’e sistenza, alle esistenze, all’Azc et nuc di un mondo senza nessun legame che lo tenga unito, e per questo abbandonato alla sua as senza di senso costitutiva dalla quale soltanto può venire (può crearsi) qualcosa come un senso, dei sensi. Tutto ciò ha comin ciato ad avvenire con Spinoza, con Leibniz, ma anche con Gior dano Bruno, i quali in termini differenti hanno fatto appunto del rapporto Dio-mondo un vero e proprio nesso, una ragione es senziale al loro stesso darsi, rispettivamente, in quanto Dio e in quanto mondo4. Con Kiarostami il cinema si afferma e diviene l’affermazione delle immagini rilasciate al loro avvenire e succedersi nell’zn co mune del mondo. Ma questo vuol dire anche che non c’è più pro* M. Heidegger, L'epoca dell’immagine del mondo, in Id., Sentieri interrotti, a cura di P. Chiodi, La Nuova Italia, Firenze 1999, pp. 101 sgg. e passim. ‘ Cfr. J.-L. Nancy, La creazione del mondo o la mondializzazione, trad. it. di D. Tarizzo e M. Bruzzese, Einaudi, Torino 2003, p. 23.
XIV
_______________ Prefazione_______________________________________________
priamente un soggetto che guarda, non c’è più un’autorità ester na, un giudice (un critico) che emetta la sua sentenza, ma un ve nire ad essere di sguardi più o meno anonimi appesi al darsi ulte riore delle immagini - l’attesa, il trattenere il fiato, la sorpresa ver so il continuare ad esserci di ciò che è. Certo, le differenze, le va lutazioni, le nuove «distribuzioni differenziali degli affetti» (se condo l’espressione di Deleuze) a partire dalle immagini riman gono, e tuttavia non assumono autorevolezza e tanto meno au torità da sedicenti posizioni e istituzioni depositarie di un senso dato al di là o oltre le immagini stesse. Piuttosto, è a livello dello sguardo, e del riguardo che porta necessariamente con sé, che si ridefinisce non solo il ruolo del regista, ma ogni rapporto di frui zione e, in generale, quello che potremmo chiamare lo «statuto» quanto mai bisognoso di nuove riflessioni dello spettatore. Così il cinema è interamente un dispositivo di sguardo. La stessa sala in cui si danno le proiezioni non è che una scatola per guardare {botte à regarder) e nello stesso tempo un luogo (del mondo) in cui è possibile penetrare nel (il) mondo. E, guardan do, lo spettatore s’innesta in uno sguardo. Per questo il cinema di Kiarostami è un’ingiunzione affinché finalmente gli occhi si aprano. In sala, si è trascinati e tuttavia non si è né passivi né schiavi. Veramente qui sta tutta la forza «didascalica» di questo cinema, in quanto il trasporto non ha altro fine se non quello di permetterci di guardare. Attraverso una sorta di costrizione - vi è infatti violenza in ciascuna immagine che è lo stesso imporsi dell’immagine nella sua verità’ - si impone dunque qualcosa che si può accettare o meno (in ciò consiste la differenza fra la vio lenza dell’immagine e la violenza reale), e nondimeno aprendo si al confronto con il film si può arrivare a un’esperienza, che è appunto quella dello sguardo, nella quale attività c passività, soggetto e oggetto, vedente e veduto si danno in una sorta di re ciproca inclusione. Questa esperienza, naturalmente, è (ancora) quella dell’espo sizione. Lo sguardo c esposto; come ricorda Nancy, l’etimologia 5 Cfr. J.-L. Nancy, Immagine e violenza, in Id., Tre saggi sulTimmagine, trad, it. di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2C02.
XV
-_____________ Alfonso Canoino
fa derivare il termine «sguardo» dal germanico wardon che si gnifica insieme «osservare» e «stare in guardia». Non si tratta di placida contemplazione, come quella che contraddistingue gli dèi secondo Aristotele, ma il vedere circospetto e apprensivo di un essere nel mondo. Da qui l’affinità con «riguardo» e «rispet to»: uno sguardo finito, esposto, non può che comportare una custodia e una considerazione che portano con sé un prendere le misure della realtà, un ponderare, che costituisce la natura stes sa della giustizia. Non solo, dunque, £ la vita continua è attra versato in maniera diretta dalla questione della giustizia ma, si potrebbe aggiungere, in ciascun film, e probabilmente in ciascu na immagine (cinematografica, televisiva, pittorica ecc.), ne va sempre della giustizia (e dell’ingiustizia), o meglio del rendere giustizia, vale a dire del lasciare che gli enti si distribuiscano, si rilascino, si liberino da qualunque assegnazione. E tutto questo non va senza pensiero (e questo è il pensiero in opera nel cine ma, nella televisione, nella pittura ecc.), perche il pensiero fa spa zio, toglie alle cose la perentorietà di una sistemazione definiti va, le apre al loro avvenire imprevisto e imprevedibile mai dato una volta per tutte, e le fa essere semplicemente come sono. La distribuzione, e dunque il nomos, la legge, e la giustizia si accompagnano sempre all’esposizione e dunque alla comparizio ne delle singolarità. Da questo punto di vista si comprende me glio perche per Nancy il cinema di Kiarostami sia una sottrazio ne continua del ruolo pcrvasivo dell’interiorità: in essa, infatti, si tenta di revocare l’esposizione in una specie di punto inesteso da cui guardare al mondo come fosse il ricettacolo di una deriva on tologica, perdendo così la possibilità stessa del rendere giustizia che si dà soltanto nella giusta distanza, nel rispetto e nell’atten zione nei confronti delle singolarità che costituiscono, ognuna, un’origine del mondo. Lo sguardo, allora, lo «sguardo in movi mento» proprio del cinema è l’evidenza, il vuoto intorno alle co se, che presuppone un altro vuoto, quello di chi guarda, per esse re colto o semplicemente per essere vissuto, sentito, assaporato. Il regista ha dunque a che fare con il «dispositivo» comples so di questo sguardo che, nonostante tutto, perdura e ricomi nXVI
---------------
------------------------- Prefazione
eia sempre. E l’arte, anche la settima arte, presenta un movimen to quasi impercettibile nel suo farsi, eppure assolutamente pre sente; un movimento che riguarda l’immagine, ogni immagine, in quanto caratterizzata dal «distinto», ossia dal sacro che è il «separato», il «messo a distanza»6. Ciascuna immagine si stacca dal fondo, ma nel contempo permette al fondo di distinguersi: l’immagine, infatti, si protegge dal fondo e insieme è aperta ver so di esso7. Anche nel cinema «il fondo sale fino a noi nell’im magine» e lo sguardo fa fronte alla duplice possibilità del nau fragare nell’indistinto e del vagare nel cielo luminoso. Così ci tocca nell’intimo l’immagine; essa significa e contem poraneamente si distacca continuamente dai significati. Nell’a pice del senso vi è un’assenza incolmabile. La pittura, la foto grafia, il cinema (e non solo: Nancy parla anche di immagini musicali, ad esempio) lasciano operante quest’ambivalenza in quietante dell’immagine aperta, da una parte, sulla codificazio ne e dunque sull’imbalsamazione della bellezza e del significa to acquisito e, dall’altra, su di una sorta di autoiconoclastia che travolge l’immagine in quanto tale. Da qui, bisognerebbe ri considerare ogni discorso sul vedere, sulla visione, sul punto cieco che permette di vedere, sulla forma e sul vedere forme. La visione, il vedere e il veduto, infatti, correlativamente all’immagine, non si danno se non nel punto stesso dove il distinto na sce dall’indistinto. Prima e con ogni immagine, visione e forma vi è qualcosa come una promessa (o una minaccia) di caos, che non va mai disgiunta dall’ordine vero o presunto di ciascuna immagine, visione e forma. Il movimento del cinema, il suo giocare con l’inganno non di menticando mai la verità, riguarda esattamente questo difficile equilibrio che ormai non ha più protezione o strutture di salva taggio. Se davvero lo schermo in cui si proietta il film - una pa rete della «scatola per guardare» - è un’apertura nel mondo che dà sul mondo stesso, allora lo sguardo che si posa su queste im* J.-L. Nancy, L’immagine - Il distinto, in ld., Tre saggi sull’immagine cit., p. 31. ’ Ibid., p. 48.
XVII
------------------------------------------ Alfonso Cviolato_
magini in movimento è uno sguardo inquieto, arrischiato, nel quale ragione e affetti si provano continuamente in un esercizio fine a se stesso, ossia slegato da ogni telos. Fare un film e guar darlo significa così nient’altro che esercitarsi a fare e a guardare ogni volta un nuovo film. Non si finisce mai con lo sguardo, e ogni sguardo ne convoca altri in un andare che ricorda da lonta no quello della forza mediante la quale per Spinoza ciascuna co sa persevera nel suo essere: «[...] poiché, se non è distrutta da nessuna causa esterna, la cosa continuerà ad esistere sempre con la stessa potenza con la quale attualmente esiste, questo conatus implica, dunque, un tempo indefinito»8. II cinema con Kiarosta mi libera il tempo indefinito dello sguardo che nessuna storia, nessun pretesto narrativo, nessun significato imposto allo scor rere delle immagini potrà mai nascondere, poiché si tratta del movimento stesso del reale.
Ma quanto accade al cinema, l’imporsi stesso dei film di Kia rostami, il loro affermarsi come forma di presentazione tra le al tre, oggi tuttavia «libera per se stessa», investe radicalmente an che la scrittura, lo scrivere di cinema, l’«occuparsene». Far fron te a questa vitalità insospettata, al di là c oltre la morte del cine ma (sono forse queste le prime avvisaglie che ci dicono come si stia per entrare in un tempo post-godardiano?) vuol dire far fra nare in un certo senso la prassi stessa dello scrivere sui film. Se la storia del cinema (come ogni storia) è incessantemente scossa dall’impossibilità di rendere le opere delle icone e dalla conseguente irriducibile alterità di ciò che, storico, si sottrae in definitamente alla storia come discorso ordinato e chiuso in sé, è sul versante della critica che qualcosa s’inceppa. Da un certo punto di vista, questa è la posta in gioco presente nella scrittura di Nancy nel momento in cui rifiuta di appiattirsi sulla logica del commento o, peggio, della spiegazione. Lo sguardo all’opera nei * B. Spinoza, Etica, a cura di E. Giancotti, Editori Riuniti, Roma 19973, p. ni, prop, vili, dim. p. 179.
XVIII
______________________________ Prefazione________________________________
film di Kiarostami inaugura una scrittura nella quale chi scrive di cinema non domina più niente, perché non è più possibile al cun «oggetto» filmico. In più, nessuna autorità «preventiva» sui film viene riconosciuta - lo sguardo è sempre sguardo del mon do e nel mondo. Certo, ci sono sguardi e scritture diversi ma prioritario è il contatto, l’esperienza, l’eventuarsi di quella pre senza sempre singolare e complessa che chiamiamo «cinema». Qui la scrittura, come lo sguardo, è aperta su un’ulteriorità che impedisce il cristallizzarsi del senso, e questo comporta quasi una sua declinazione sensibile, sensitiva e sensuale, senza che ta le esperienza venga immediatamente sublimata in un’algida astrattezza. Corpus di scrittura, dunque; presenza singolare e plurale che fa senso. Che cosa avviene, infatti, nella sala di proiezione? Cosa dire sul rapporto sguardo/immagini? Che cosa ci lega all’opera che scorre sullo schermo? Qualcosa su cui può essere fatta luce, sug gerisce Nancy, a partire dal rapporto che lega anima e corpo. Come nella corrispondenza fra Cartesio ed Elisabetta, dove si pone la questione del modo in cui corpo e anima, che sono due cose distinte, possano dare luogo ad un’unione sostanziale, sul la quale peraltro «sarebbe dannoso occupare troppo a lungo il nostro intelletto»’ in quanto, risponde Cartesio, «c [...] con la sola consuetudine della vita e delle conversazioni ordinarie, aste nendoci dalla meditazione e dallo studio delle cose che esercita no l’immaginazione, che si impara a concepire» tale unione10. È quest’astensione, questo rilascio, questo se relàcher che permette il darsi di un potere passivo di essere affetto, segnato, ’ R. Cartesio, Lettere sulla morale (Lettera ad Elisabetta del 28 giugno 1643), in Id., Opere filosofiche, voi. 4, a cura di E. Garin, trad. it. di E. e M. Garin, Later za, Roma-Bari 19943, p. 133. Per l’interpretazione nancyana, aui appena accenna ta, di questa lettera si rimanda a J.-L. Nancy, L’extension de rame, in «Po&sic», 2002, 99, e inoltre all’intervista a Nancy di S. Eligcrt, preceduta da un saggio in troduttivo di quest’ultima, da) titolo L’àme-à-corps, in corso di pubblicazione. Si riveda anche, per tutta una serie di motivi che qui e nel prosieguo di queste pagi ne vengono richiamati, J.-L. Nancy, La naissance des seins, Ecole Regionale des Beaux-Arts, Valence 1996. ,s Cartesio, Lettere sulla morale (Lettera ad Elisabetta del 28 giugno 1643) cit., p. 131. X!X
___________________________ Alfonso Cariolato
impregnato, intriso dall’altro da sé (nel caso dell’anima e del cor po: da ciò che appare assolutamente eterogeneo, res cogìtans e res extensa). Così come lasciando le meditazioni si esperisce l’u nione sostanziale, allo stesso modo nel rapporto, in questo caso, con il film (e, soprattutto, nella scrittura di cinema) si può acce dere a un contatto per cui l’altro non viene fagocitato e assimi lato a sé attraverso una sorta di cattura (non viene com-preso e fatto sparire nell’atto enunciativo che ne dice il senso dall’ester no), ma nel quale al contrario è la scrittura stessa ad esporsi, ad escriversi in ciò di cui è questione. Si tratta dell’abbandono dei significati e dei sensi riconosciuti: solo così un cinema come quello di Kiarostami può dare luogo a una scrittura che dipenda dallo stesso sguardo dal quale nasce un film (ma, forse, a ben ve dere, non c’è film al di là o al di qua di Kiarostami che non pre senti, almeno in parte, in modalità magari oscure, delle vie di fu ga tali da permettere una fruizione di questo tipo). Leggere (e scrivere su) un film, un’opera d’arte, un libro di poesia, di letteratura o di filosofia vuol dire leggere (e scrivere) contro il senso determinato: «La vraie lecture avance sans savoir, elle ouvre toujours un livre comme une coupe injustifiable dans le continuum suppose du sens. Il faut qu’clle s’égare sur cette brèche»", scrive Nancy in un testo decisivo su Bataillc. L’avan zare senza sapere è l’incedere stesso della scrittura rimessa a sé, senza che si dia mai qualcosa come un «sé» della scrittura. Que sto rilascio non è affatto uno spontaneismo fine a se stesso, un non senso, un misticismo o men che meno una qualche forma di automatismo scritturale. Anzi è questo il luogo in cui qualcosa come la responsabilità dello scrivere può assumere un significa to, in quanto è nel momento in cui la scrittura si libera delle giu stificazioni e delle istanze dalle quali assume autorevolezza e considerazione che la scrittura scrive davvero, cessando così di essere mero veicolo per la comunicazione. Per questo il taglio dello scrivere, del leggere, è sempre ingiustificabile di fronte alla supposizione, convincente anche contro la stessa evidenza, di un " J.-L. Nancy, L'excrit, in Id., Une pensée finte, Galilee, Paris 1990, p. 60.
XX
Prefazione_______________________________
senso continuo mai revocato né revocabile per principio. E lì, su questa «breccia», la lettura e la scrittura non possono da un cer to punto di vista che smarrirsi, perdersi. Ma d’altronde è proprio qui che si situa l’esigenza di una nuova estetica, non solo cinematografica (e Nancy non è l’unico a muoversi in questa direzione: si pensi, tra gli altri, ai lavori di Derrida)12. Estetica, naturalmente, intesa indissolubilmente nei due sensi ricordati anche da Hegel13, che pongono nel loro darsi insieme la questione sia della sensibilità sia della sfera dei signi ficati, oltre a quella del loro rapporto. Come toccare, sentire, esperire i corpi dell’arte, i corpi delle immagini, del cinema, del la pittura, della musica ecc.? Vale a dire, come entrare in contat to, e leggere, scrivere, de-scrivcre, vedere, ascoltare, e via via fi no ad annusare, gustare, ciò che costantemente si sottrae in quanto significante?14 Come sfuggire, da un lato, al mero dato e, dall’altro, alla pervasività del senso dispiegato e continuo? L’e stetica è tutt’altro che un sapere concluso; non se ne sta quieta a rimuginare sui propri fondamenti, ma è costantemente protesa verso l’accadere di qualcosa, l’arte, l’opera, che costituisce e pro voca innanzitutto un’esperienza di interruzione di senso (da qui lo Stofi, l’urto, che altro non è - secondo Heidegger - se non il puro «[...] “che” (Dafì) dell’esser fatta (des Geschaffenseins) * dell’opera)15. Soltanto questo le permette di sfiorare i corpi e fa re esperienza delle presenze del mondo. Niente, allora, è più ek-statico dell’estetica - per questo essa non è, non è mai stata, qualcosa di accessorio, in quanto non può darsi che con l’esistere. Non c’è estetica che non sia estetica dei u Si rimanda, almeno, a J. Derrida, La verità in pittura, trad, it di G. e D. Poz zi, Newton Compton, Roma, 1981 e a Memorie di cieco, a cura di E Ferrari, trad, it. di A. Cartolato e E Ferrari, Abscondita, Milano 2003. 15 «“Senso” in effetti c quella mirabile parola che si usa in due significati oppo sti. Una volta indica gli organi dell’apprensione immediata; un’altra volta chiamia mo senso il significato, il pensiero, l’universale della cosa», G. W. F. Hegel, Esteti ca, ed. il. a cura di N. Merkcr, trad. it. di N. Merker e N. Vaccaro, Einaudi, Tori no 1997, i. 1, p. 148. J.-L. Nancy, Corpus, a cura di A. Moscati, Cronopio, Napoli 1995, pp. 59 e passim. 1M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte, in Id., Sentieri interrotti cit., p. 49.
xxi
___________________________ Alfonso Cartolato____________________________
corpi, della vita e della morte, dell’essere finito. Infatti è nell’esistere che vita e morte sono in un continuo rapporto «di pre gnanza o di impregnazione reciproca». Tutto il cinema di Kia rostami non fa che ribadirlo, con un tono estremamente misura to e quasi di sfuggita, mai soffermandosi veramente, come se l’e quilibrio raggiunto nel mostrarlo dipendesse dal movimento e dalla continuazione ulteriore. E in fondo è questa la natura del cinema: che non si può fermare. Come sulla motocicletta del dottore ne II vento ci porterà via'. l’«ingcgncrc» Behzad, seduto dietro, sobbalza e parla, mentre intorno vi sono tante spighe do rate di orzo e frumento che sembrano quasi accogliere nel loro grembo i rumori e le figure degli uomini. Stanno andando a vi sitare Malek Khanum, la vecchia inferma, per assistere alla mor te della quale Behzad è venuto appositamente con i suoi «ragaz zi» da molto lontano. Arrivato alla casa di Malek, il dottore en tra a visitarla, Behzad va a cercare i suoi compagni e ritorna su bito dopo. I due risalgono in moto, Behzad si è offerto di anda re a comprare le medicine per l’ammalata. «Ma di che cosa sof fre, dottore? Di vecchiaia?», «Di vecchiaia sì, ma c’c qualcosa di peggiore della vecchiaia: la morte. Sì, la morte c la cosa peggio re. [...] Si chiudono per sempre gli occhi su questo mondo, su questa natura così bella...», e continua citando dei versi di Omar Khayyàm, mentre Behzad si unisce a lui. Soltanto adesso la mo tocicletta scompare nel paesaggio circostante - non è la fine, non è una risposta. È un puro esistere o anche, se si preferisce, l’af fermarsi di un’estetica. A. C.
XXI!
L’evidenza del film. Abbas Kiarostami
ABBAS KIAROSTAMI
Storia 1
La storia di questo saggio è sinuosa, incompiuta e probabil mente impossibile da compiere, ad immagine delle storie che i film di Kiarostami raccontano soltanto per condurle e perderle fuori dall’universo delle storie. Ma trattare il mio oggetto per mimetismo non è l’effetto di un desiderio. Si tratta piuttosto del risultato di coincidenze successive e di cambiamenti di pro gramma a cui tuttavia non sono affatto estranei lo stile e la natu ra del lavoro di Kiarostami. Nel 1994, per il centenario del cinema, i «Cahiers du cinema» intendevano realizzare un libro in cui cento autori scrivessero su cento film tratti dalla storia di questo secolo cinematografico. A questa proposta risposi scegliendo E la vita continua., film del 1992 con il quale per la prima volta Kiarostami andava oltre il ri conoscimento puramente informale. Anche per me si trattava del primo film di questo autore, e rimase l’unico anche quando scrissi il testo destinato al volume collettivo. La mia scelta era determinata da almeno due motivi: l’evi denza con la quale il film mi si era imposto e la determinazione a scegliere un film quanto più possibile recente. Non volevo an dare a pescare nella storia del cinema; da una parte la conosce vo troppo poco e, dall’altra, gli sguardi retrospettivi sul cinema mi sembravano troppo spesso contrassegnati sotto sotto da una nostalgia compiacente (che arrivava fino a porre il cinema come cosa del passato). Questi due motivi rimandavano l’uno all’al tro: l’evidenza del film era quella di un cinema risolutamente contemporaneo per il suo oggetto (il terremoto avvenuto in 3
Nancy, Abbas Kiarostami
Iran qualche mese prima delle riprese), per la sua provenienza (l’Iran, nuovo arrivato alla ribalta del cinema, e già l’Iran dopo Khomeini, scomparso nel 1989: il film al quale si ricollega la storia di E la vita continua., Dov'è la casa del mio amico?, è del 1987) e per il suo genere impossibile da circoscrivere attraverso il racconto, il documento o la riflessione allegorica. In maniera più serrata, più profonda, in questo film s’impo neva l’attualità di un’istanza portata di proposito sul presente, né occupata dal passato in quanto tale, per quanto fosse recente, né intemporale: una forza singolare imponeva la sicurezza della sua pressione sullo sguardo. Film ostinato su di un unico proposito (ma impossibile a riassumersi) c nel contempo interminabile (senza risoluzione finale), insistente soprattutto nel non chiude re, nel proseguire il film al di là di esso (proprio come era co minciato al di qua, aprendosi con un’inquadratura come una la ma che taglia lo sguardo, con il finestrino di una vettura a un ca sello autostradale, in un baccano di motori e di radio da cui emerge un appello della Mezzaluna Rossa), facendo scorrere un susseguirsi di domande allo stesso tempo monocordc c poli morfo, ripetitivo e mobile lungo tutto il film (dove sono? per dove passare? che cosa fate? perché questo terremoto?...). Era un film imperioso, severo (seducente nella sua severità), messo in tensione dal suo stesso corso (lo spostarsi di una vet tura, dell’obiettivo in essa e fuori di essa: un film il cui soggetto scorre come la sua pellicola) così come nell’autorità della sua in giunzione. Esso faceva intendere: guardate, io non lascerò di strarre la vostra attenzione; anziché attendervi delle peripezie e uno scioglimento, guardate, abbiate riguardo di tutte le imma gini per se stesse così come del loro modo di succedersi, di le garsi e slegarsi...
4
ABBAS KIAROSTAMI
Storia 2
Il libro dei cento film non si fece per ragioni finanziarie, così ci venne detto. Alcuni testi già consegnati furono propo sti altrove. Il mio fu accolto nella rivista «Cinematheque» da Teresa Faucon. S’intitolava Dell’evidenza. Quattro anni più tardi, Teresa Faucon venne a trovarmi con Yves Gevaert, edi tore di Bruxelles. Mi chiesero di pensare a un libro che partis se da questo testo e lo ampliasse. Accettai con uno slancio che ben presto mi si ritorse contro, in quanto non riuscivo a ve dere come passare dal commento di un solo film ad altra cosa che non fosse una serie pesante di altri commenti specifici. Inoltre i film di Kiarostami si erano succeduti senza che io li avessi visti, innanzitutto perché ero stato ammalato. Sotto gli ulivi e II sapore della ciliegia erano già usciti e II vento ci por terà via stava per uscire. Ero sconcertato: troppa materia ciascun film richiedeva la sua glossa - e non abbastanza forma o schema per dominarla. Senza dubbio, tutti questi film erano assai vicini - ma dall’uno all’altro si cambiava di registro, for se di versante. Si prendevano probabilmente delle curve stret te come quelle dei sentieri sulle colline di Dov’è la casa del mio amico?, di E la vita continua e de II sapore della ciliegia, e ben presto anche de II vento ci porterà via. Questo procede re a zig zag diventava una firma di Kiarostami, affermava la sua identità, e allo stesso tempo disorientava chi avesse volu to una visione dall’alto, un punto di vista da dove fermare una prospettiva su questa identità. Poi Francesca Isidori, produt trice radiofonica, mi chiese un’intervista su Kiarostami. Fu 5
_______________ .________ Nancy, Abbas Kiarostami_
l’occasione per un distacco e un respiro: mi sembrò di capire che bisognava cercare di cogliere non tanto un genere, uno sti le, una personalità o un’originalità di cinema, ma piuttosto un’affermazione del cinema - e in un certo senso un’afferma zione del cinema per se stesso, che ci poneva altrove rispetto alla condivisione di certi stili e alle scelte cinematografiche, al trove anche rispetto a un rapporto pensoso con la storia del ci nema e con il suo avvenire, in una sorta di inaugurazione che pure era sovraccaricata da tutti i cento anni della settima arte. Una maniera per dire che il cinema ricomincia, che la sua con tinuità è il suo ricominciamento. Kiarostami non è soltanto un nuovo autore, un autore in più. Egli funge anche da testimone privilegiato del fatto che il cinema si rinnova. Vale a dire: egli si approssima di nuovo a ciò che è, ma che non cessa di rimettere in gioco. Con lui è un mondo, una cultura del mondo, ciò che precedentemente si chiamava una «civiltà», a cambiare d’aspetto. Non è vero che essa sia soltanto la «civiltà dcll’immagine» descritta dal plato nismo volgare e reattivo. Ma un altro mondo si dà altre forme e tenta di appropriarsi in esse. Kiarostami non è il solo: vi so no molti stili e sguardi diversi. Ma tutti hanno a che fare con un’insistenza del cinema che è quella della sua evidenza: que sto termine si imponeva di nuovo, benché fosse lontano da ri solvere alcunché. Il cinema (e con esso la televisione, il video e la fotografia, che non si trovano per caso nei film di Kiaro stami) mette in evidenza una forma del mondo, una forma o un senso. Un’evidenza comporta sempre il punto cieco di ciò che la fa evidente: è per questo che essa poggia sull’occhio. Il «punto cieco» non produce una privazione di vista: al contrario, esso costituisce l’apertura di uno sguardo che spinge (presse) a guar dare. Ho cercato di annotare, senza unificarli, i momenti, i frammenti di questa pressione (pression) che il cinema di Kia rostami sembra avere la funzione di esercitare - e che spinge (presse) o che esprime attraverso di esso qualcosa dell’essenza del cinema e della nostra esistenza con esso, oggi, poiché noi 6
------------------------------------- L'evidenza del film
non siamo più senza di esso, senza il cinema, ed è anche que sto che il cinema dice1. (Una sola parola ancora: scrivo nel gennaio 2000, e va da sé che il mio sguardo sull’opera di Kiarostami non può andare più lontano. In più nella mia videoteca ci sono certo i suoi film, ma ad eccezione dell’ultimo, Il vento ci porterà via, che ho potuto ve dere una volta al cinema).
1 Dopo la serie di frammenti che inizia qui si troverà il testo dedicato nel 1994 a E la vita continua. Ringrazio, nominandoli ancora una volta, Teresa Faucon, Yves Gevaert e Francesca Isidori: è alla loro amichevole convinzione che si deve l'esistenza di questo libro. Quanto alla bibliografia, per la quale sono ancora loro debitore, rinvio (nel momento in cui scrivo, dicembre 1999) da una pane al libro collettivo Abbas Kiarostami apparso nel 1997 nella Piccola biblioteca dei «Cahiers du cinema» (Éditions de l’Étoile, Paris) e che riprende tra gli altri alcuni elementi di un numero speciale dei «Cahiers» del 1995; dall’altra, agn anicoli apparsi a par tire almeno dal 1992 in «Positif» soprattutto, o in «Trafic», così come a diversi testi in inglese o in francese pubblicati su alcuni siti Internet dedicati a Kiarostami o al cinema (in panicolare la biblioteca del server degli studi cinematografici e audio visivi - imaginet.fr/secavf} - che del resto non pretendo di aver potuto leggere tutti. Infine, il libro fotografico: A. Kiarostami, Photographies, Hazan, Paris 1999, che si apre con una conversazione con Michel Cimcnt. 7
________________________ ABBAS KIAROSTAMI_________________________
Sguardo
Ecco un cinema che enuncia, con potenza e ritegno, con gra zia e severità, una necessità di sguardo e di utilizzo dello sguar do. Non una nuova problematica della rappresentazione che verrebbe ad aggiungersi a quelle che hanno scandito, a giusto ti tolo, la storia del cinema, ma piuttosto un’assiomatica dello sguardo: l’evidenza e la certezza di uno sguardo cinematografi co come riguardo per il mondo e per la sua verità. Questo cine ma (per il quale il nome di Kiarostami mi serve da esempio e da emblema, ma che non è limitato a questo nome) afferma che questa assiomatica sorge qui e ora, in questa svolta di secolo, aprendo una via nuova al già assai vecchio, secolare cinema. Kiarostami dichiara fermamente, con una dolcezza tenace: voi avete già cent’anni di cinema negli occhi, ne\Vhabitus o ethos. È piantato nella vostra cultura - voglio dire, nei vostri modi di vi vere - tanto quanto l’ulivo di cui non si conosce nemmeno lo sta to selvatico o quanto gli altri alberi che mi piace filmare o guar dare. Non è più tempo per voi di scoprire c di stupirvi come bambini davanti alla lanterna magica. Avete già composto e poi scomposto un’abbondanza di generi e dì miti del cinema. Avete modulato in moltissimi modi il suo rapporto con il reale e con l’illusione, con la storia, con il sogno e con la leggenda, le sue tec niche di immagine, di realizzazione del film, di ripresa e di mon taggio. Con l’uso e il tempo, avete percorso tutte le sue possibi lità di ra'ppresentazione. Ma così a poco a poco avete sviluppato una possibilità di sguardo che non è più esattamente uno sguar do sulla rappresentazione né uno sguardo rappresentativo. Nella misura in curii cinema c divenuto una delle nostre for me di cultura e di vita, si è elaborato uno sguardo che decisa 9
------------------------------------- Nancy, Abbas Kiarostami
mente non è più lo sguardo sulla rappresentazione (pittura o fo to, teatro o spettacolo in generale), e la cui differenza dovrebbe essere caratterizzata innanzitutto dalla differenza della sua po stura: al cinema non è questione di far variare l’angolo o la di stanza dello sguardo, né di guardare continuando a percepire un contesto della cosa guardata. Colui che guarda è fisso in un po sto nell’oscurità di una sala di cui non si può dire che l’immagi ne filmica vi si trovi (come potrebbe trovarsi un’altra immagine), poiché essa costituisce in verità tutta una parte di questa sala. Così è la sala stessa a diventare luogo o dispositivo di sguardo, scatola per guardare {botte à regarder) - ó piuttosto: scatola che è o che fa sguardo come si dice, in francese, «uno sguardo {un re gard)» per designare un’apertura destinata a permettere un’os servazione o un’ispezione (in una conduttura, in una macchina). Qui lo sguardo c un fare ingresso in uno spazio, è una penetra zione prima di essere una considerazione o una contemplazione. Spesso Kiarostami pone subito lo schermo, e certo il film con esso, come un’apertura su uno spazio o su un mondo: così la porta socchiusa in primo piano all’inizio di Dov'è la casa del mio amico? (porta il cui motivo percorre in seguito tutto il film, dal la porta della classe alle porte delle case) o i finestrini di auto mobile di E la vita continua e de II sapore della ciliegia che apro no (o collegano) il film per non cessare quasi più di farne, di dar ne e di misurarne l’apertura (lo sguardo). Nella scatola-sguardo {boite-regard) del cinema, lo sguardo innanzitutto non fa più fronte a una rappresentazione né a uno spettacolo, ma prima di tutto (e senza pertanto sopprimere lo spettacolo) s’innesta {s’emboite') in uno sguardo: lo sguardo del regista. E così che, all’apertura di Sotto gli ulivi, l’attore che reci ta la parte del regista si presenta e dichiara il proprio nome guar dandoci in faccia. Il nostro sguardo s’innesta nel suo, così come si segue qualcuno mettendo i piedi sulle sue orme {comme on em bolie lepas de quelqu'un)-. all’apertura di Close-up, il brutale pas saggio di un camion in primo piano verso sinistra ci rivela dal l’altra parte della strada due militari che seguono il passo agile {qui emboitent le pas vif) di un uomo che marcia verso destra, e 10
------------------------------- --------- L’evidenza del film____________
questo doppio movimento porta già con sé il nostro sguardo, o lo «trascina» come si dice oggigiorno di qualcuno che «trascina» un gruppo, che gli dà il suo movimento. Non si tratta di passività, c meno ancora di cattività (captivite), si tratta di accordarsi a uno sguardo al fine di guardare a nostra volta. Il nostro sguardo non c prigioniero (captif), e se è avvinto (captive) è perché c reclutato, mobilitato. Ciò comporta inevitabilmente una certa pressione che obbliga: la cattura di immagine è chiaramente un ethos, una disposizione e una condotta nei riguardi del mondo. Kiarostami mobilita Io sguardo: lo chiama c lo anima, lo ren de vigile. Questo cinema è qui, innanzitutto e fondamentalmen te, per aprire gli occhi. È ciò a cui provvedono le aperture (ouvertures) di ciascun film ed è ciò a cui ritornano, in ciascun film, un certo numero di piani che fungono come da scansione di questa apertura: inquadratura di un finestrino di automobile, scena che mostra lo scatto di fotografie, campo in un retroviso re o ancora, ne ZZ vento ci porterà via, il piano prolungato sul «regista» («ingegnere», etnologo, fotografo in ogni caso) mentre si rade e come filmato dall’interno del suo specchio, piano-im possibile su di uno sguardo su di sé, esso stesso impossibile o in finito. Nessuna riflessività in questo piano, poiché siamo noi, e non «lui stesso», che dobbiamo guardare tale sguardo occupato dalla rasatura, mentre siamo preoccupati di ciò che lo occupa se gretamente nella sua ricerca di immagini, lui che viene ad immi schiarsi in qualcosa che non lo riguarda nel tentativo di cogliere l’immagine di un lutto di cui non si potrà appropriare. Ma è co sì che noi avremo, con lui o suo malgrado, uno sguardo giusto, ossia uno sguardo per questo lutto, per le donne che lo portano e per il loro immemorabile rito.
Reale Non si tratta della fascinazione dell’immagine: si tratta dell’immaginc in quanto apre sul reale e in quanto essa soltanto apre il
_ Nancy, Abbas Kiarostami_______________________________________________
sul reale. La realtà dell’immagine è l’accesso al reale stesso: a quel lo che ha la consistenza e la resistenza, per esempio, della morte o, per esempio, della vita. Dunque, davanti allo sguardo del ci neasta in cui si tratta di innestarsi, non è questione di una rifles sività o di una speculazione sullo sguardo e sull’immagine. Non è questione né di formalismo (diciamo, se si vuole, «simbolico») né di narcisismo (diciamo, «immaginario») della visione. Non si tratta della visione - veggente o guardona, fantasticante o alluci nata, ideativa o intuitiva -, ma unicamente dello sguardo: dell’a pertura di un vedere a un reale davanti al quale esso si porta e che si lascia in questo modo anche portare fino ad esso. È di un tale «portare» e «portarsi» che si tratta, e della sua portata: portare uno sguardo all’intensità di un’evidenza e di un’esattezza. Senza dubbio non l’evidenza di ciò che è semplicemente dato (piatta mente o empiricamente, se mai qualcosa di questo tipo è possibi le), ma l’evidenza di ciò che viene a mostrarsi per quanto poco lo si guardi. Il cinema, qui, si prospetta molto lontano da una visio ne che «visiona» soltanto (che guarda «per vedere»), quest’ultima si impone come la messa in potenza di uno sguardo. Se questo sguardo si prende cura di ciò che guarda, esso si sarà preso cura del reale: di ciò che appunto resiste all’assorbimento nelle visioni («visioni del mondo», rappresentazioni, immaginazioni). Il cinema era stato un’arte dell’immaginario (o del mito), ed era stato una semiologia (una combinatoria di segni, un «lin guaggio» come si diceva). A partire da queste due qualifiche, es so non poteva affatto rendere fattivo il proprio distinguersi ri spetto alla pittura e alla foto da una parte, e al teatro e al circo dall’altra. Senza cessare di rispondere o di corrispondere a que sti diversi registri e di essere anche tirato, teso tra essi, il cinema diventa qui e ora un’altra forma di presentazione, come certa mente lo era fin dall’inizio, ma che oggi esso libera per se stessa. Più precisamente, il cinema diventa l’arte dello sguardo che ren de possibile e domanda un mondo non rinviante che a se stesso e al proprio reale: è per questo che E la vita continua occupa un posto decisivo, a tutt’oggi, nell’opera di Kiarostami. Si tratta del la vita tale quale (si) passa {(se) passe) in quanto non passa (ne 12
____ L’evidenza del film
passe)' verso nient’altro se non in una morte che fa stranamente, dolorosamente parte di essa tanto quanto la nascita, l’amore, lo spettacolo di una coppa del mondo o le riprese di un film. La morte fa parte della vita anziché rendere la vita parte di al tra cosa che se stessa. La morte non è né il contrario della vita né il passaggio a un’altra vita: è essa stessa il punto cieco che apre lo sguardo, ed è un tale sguardo che filma la vita (come appare alla fine de II sapore della ciliegia); sguardo attraverso il quale biso gna guardare, ma che non è da vedere esso stesso, che non è di quest’ordine (come viene mostrato ne II vento ci porterà via). Per questa ragione la morte c sempre anche vicina alla nascita: in E la vita continua un bambino piange in un’amaca nel mezzo di albe ri fitti che stanno attorno a lui come a guardia della sua vita, e ne // vento ci porterà via una nascita sopraggiunge a seguito di una gravidanza. Forse si tratta sempre della nascita di uno sguardo, in ciascun istante, in ciascun piano, che questo sguardo si arresti su di un’immagine, su di un viso, su di un paesaggio o sullo scher mo azzurro di un cielo attraversato molto in alto dalla scia di un aereo (ne II sapore della ciliegia). Il cinema presenta - ossia condivide (comunica) - un’inten sità dello sguardo su di un mondo di cui esso stesso fa parte in tegrante (come cinema propriamente detto e come video, come televisione, ma anche come foto e come musica: riprenderemo più avanti questi motivi). Esso ne fa parte precisamente nel senso che ha contribuito a strutturarlo così com’è: come un mondo in cui lo sguardo sul reale si è risolutamente sostituito alle visioni di ogni specie, alle previsioni e alle veggenze.
Pregnanza In questo modo si è costituita una nuova configurazione del l’esperienza. Ben più che l’invenzione di un’arte sovrannumera1 Nancy gioca con il verbo passer, «passare» c la relativa forma impersonale se patter che significa tra l’altro «svolgersi», «accadere» [n.d.t.].
13
_ ______________________ Nancy, Abbas Kiarostami__ ______________________
ria, ci viene arrecato ciò che si potrebbe chiamare una nuova pre gnanza, se si vuole ben intendere con questo termine, recepen dolo fedelmente, una forma e una forza che precede e che fa ma turare una messa al mondo, la spinta di uno schema dell’esperienza mentre assume i suoi contorni. Forse non è impossibile pensare, per fornire un’analogia, che la stampa dev’essere stata una pregnanza di quest’ordine nel mo dellamento di un’esperienza trasformata da nuove condizioni di lettura e di scrittura, di trasmissione, di sapere e di potere, di rap presentazione. O ancora, la pregnanza della musica e di tutto l’universo sonoro da quando è integralmente (ri)producibile. Molte altre analogie si potrebbero presentare. Ogni volta, si trat ta di una riconfigurazione dell’esperienza e, dunque, del mondo. Così, il cinema si rivela ormai (beninteso, con la fotografia e a partire da essa: Kiarostami lo ricorda sempre, e bisognerà ri tornarci) come ben altra cosa rispetto a un supporto relativa mente nuovo per modalità di esperienza tramandate (il raccon to o il sentimento, il mito o il sogno ecc.). Ben al di là del sup porto che comunque è, esso forma un elemento: l’elemento di uno sguardo e di un reale in quanto guardato. Al tempo stesso, il cinema è presente dappertutto, può filmare tutto, da un capo all’altro della terra (mostrando così da lontano le figure minu scole alla fine di Sotto gli ulivi}, e può mostrare dappertutto le sue immagini (come quelle della coppa del mondo in E la vita continua), ma esso è anche presente nell’esperienza di tutti: così in quella del personaggio di Close-up che usurpa l’identità di un regista conosciuto al fine di toccare attraverso questo simulacro ciò che egli considera come la realtà di un’espressione della vita nella sua sofferenza. Quella che in questo film avrebbe potuto essere la storia di una dolce follia o una denuncia dell’illusione cinematografica termina al contrario con l’arrivo del vero regista - addirittura dei due veri registi: quello di cui si erano simulate le sembianze e Kiarostami stesso - contemporaneamente al ritorno al reale che segna una sorta di dissipazione progressiva del film, il cui suono diventa intermittente, mentre le immagini prese di mira si per 14
___ L’evidenza del film
dono anch’esse e si confondono nell’intensità del traffico e nei rinvii del parabrezza a mo’ di retrovisore (incrinato o saturo di riflessi), mentre si sente: «Ora capisco tutto!» e un mazzo di fio ri rossi, il cui colore è stato oggetto di una scelta esplicita, si sta glia sull’immagine azzurro-grigia della strada rumorosa; mazzo simile all’indizio del cinema stesso: lo schiudersi di uno sguardo nel mezzo dell’ordinaria turbolenza. La macchina da presa, in questo finale, si comporta a prima vista in maniera poliziesca, investigatrice e curiosa, alla ricerca di una veduta da cogliere, di una visione in più sul simulatore che ha scontato la sua condanna. In realtà, essa non spia né capta nulla - anche perché è il regista che realizza i tagli e i disturbi -, bensì riapre sul reale tutto il cinema che si sarebbe potuto cre dere invischiato nel proprio artificio.
Arte sovrannumeraria Quando è stata inventata l’espressione «la settima arte», si fa ceva riferimento a un «sistema delle belle arti» rimasto più o me no stabile da molto tempo e si praticava una doppia operazione: aprire questo sistema a una pluralità accresciuta ed elevare il ci nema a una dignità che in un primo tempo appariva fuori porta ta per uno spettacolo divertente di questo tipo. Ma, in realtà, questa operazione precedeva e forse inaugurava uno sconvolgi mento molto più profondo: l’«arte» era entrata essa stessa in una fase di mutazione. Da allora è diventato impossibile enumerare le arti supplementari, video, performance, body art, installazio ni ccc.: non perché le specie sarebbero troppo numerose, ma perché il conteggio non ha senso se è l’arte in quanto tale a di venire essenzialmente multipla e anche numerosa. Detto altri menti: questa non è soltanto la molteplicità di diverse arti di stinte le une dalle altre, ma è anche la molteplicità interna di al cune di esse - e forse potenzialmente di tutte. Ora, si dà il caso che il cinema sia fatto precisamente di una molteplicità interna, 15
____ Nancy, Abbas Kiarostami
se non addirittura di varie molteplicità: quella delle immagini, quella dell’immagine, della musica e della parola, quella infine del movimento; Kiarostami sottolinea volentieri queste molte plicità, attraverso il suo modo di trattare la musica, mai continua in lui, attraverso il suo ricorrere alla foto (scene di fotografia © foto presenti su un muro), attraverso lo sdoppiamento dei per sonaggi del regista. Ma per di più l’insieme della sua postura o della sua condotta - e più particolarmente la maniera in cui met te in scena il o i registi - segna uno scarto deciso in rapporto al la postura classica di un «artista» di fronte a un’«opera». A que sta polarità che appartiene anch’essa al «sistema delle belle arti» si sostituisce qui una messa in movimento simultanea del regista e della realizzazione; il primo non smette, in un certo qual mo do, di muoversi nel film o uscendo dal film per rientrarvi di nuo vo. Attraverso questo movimento incessante, che si rivolge an che a un’agitazione mostrata come un dato costitutivo del cine ma (in Sotto gli ulivi e ne II vento ci porterà via), a una sorta di stato febbrile e di impazienza che percorre insomma tutti i film e che forma un singolare contrappunto con la lentezza che con fina con l’immobilità di una grande quantità di piani (il tragitto a zig zag di una persona o di un’automobile sul fondo di un pae saggio immutabile attraversa come una sola traiettoria cinque film a partire da Dov’è la casa del mio amico? e diventa una sor ta di riassunto emblematico di questo cinema), quella che viene ostinatamente indicata è un’intenzione in cui ^«estetica» si su bordina ad altra cosa che si chiamerà innanzitutto, almeno a ti tolo di prova, il «didattico» e l’«euristico». È visibile e palpabile come questo regista si preoccupi innanzitutto di insegnarci qual cosa, così come il fatto che moltiplichi le brevi scene in cui vie ne data una lezione - il più delle volte da un adulto a uno più giovane, mentre l’adulto stesso si preoccupa di trovare qualcosa -, come anche il fatto che moltiplichi le scene di domande, si po trebbe dire talvolta di interrogatori, in cui un personaggio chie de a un altro che cosa fa, da dove viene ecc. Sicuramente è lungi dall’essere indifferente il fatto che Kiaro stami abbia lavorato per molto tempo in un’istituzione educati 16
----------------- --------------------- -L’evidenza del film
va e che, a più riprese, dia a vedere la realtà del suo paese come quella di uno dei paesi in cui un’educazione, anche elementare, è una delle condizioni urgenti per un accesso al mondo attuale. Ma il suo cinema è tutt’altro che un cinema didattico così come lo si trova in molte concezioni del «documentario», sebbene qualche aspetto dei film di Kiarostami assomigli in maniera mol lo calcolata a un documentario o a un reportage. Si tratta di uno spostamento della postura e della posta in gioco dell’«arte»: alla contemplazione di un’opera si sostituisce il movimento di un in teresse a cui viene dato l’impulso e di un "educazione nel senso preciso del termine, che significa «fare uscire da...»: educazione dello sguardo a guardare il mondo, a guardare questo mondo nel quale vive il cinema; sguardo preso per mano e portato in un viaggio che non è iniziatico, che non conduce a qualche segreto, ma che ritorna innanzitutto a far muovere lo sguardo, a spostar lo, addirittura a scuoterlo, a farlo portare più lontano, più vici no, più esatto. Molto distante, conseguentemente, da ciò che aveva potuto formare l’idea di un’arte sovrannumeraria, viene qui messa in movimento l’arte tutt’intera, cì si trova in una cine matica che rimette in gioco tutto un rapporto con il mondo: per ché questo mondo sta uscendo dai cardini e il «cinema», ben più di una registrazione di forme del movimento, c da più di un se colo uno degli animatori e degli agitatori di questo spostamen to. E questo è anche ciò che significa la sostituzione della paro la cinema alla parola cinematografo^ di cui la prima c molto lon tano dall’essere semplicemente l’abbreviazione. Il cinema diventa movimento del reale, ben più che rappre sentazione. Occorrerà molto tempo perché l’illusione della realtà, alla quale innanzitutto erano state legate le ambigue ma gie del cinema - come se si fosse soltanto portata alla sua estre mità la vecchia pulsione mimetica dell’Occidente -, finisca per sparire, almeno tendenzialmente, dalla nostra coscienza del ci nema - o dalla sua coscienza di sé - e perché vi si sostituisca la mobilitazione dello sguardo. Senza dubbio il tema illusionista, con tutti i paradossi della rappresentazione, non è assente: ma non ha più la o le funzioni 17
Nancy, Abbas Kiarostami___
che ebbe nei «film sui film» (Effetto notte di Truffaut, per esem pio). Contrariamente a ciò che sembrano avere in un primo tem po percepito alcuni commentatori, questo tema non è mai l’in tenzione di Kiarostami. Egli non si interessa al film sul film ne nel film, egli non gira attorno alla mise en abyme. In lui, il tema della menzogna non porta che alla verità e quello delle apparen ze non interviene che per sottolineare la maniera in cui lo sguar do e il reale sono mobilitati insieme. È così per tutta la fiaba di Close-up, e lo stesso per quella di Sotto gli ulivi, dove vengono svelati un certo numero di artifici e di menzogne che furono ne cessari nella realizzazione di E la vita continua, ma in modo ta le che questo svelamento introduca in una nuova storia, né più né meno effettiva della prima, altro aspetto di un reale che ne conta sempre parecchi.
Cosa che rotola Come la ripresa di un tema cinematico fondamentale (nel senso di una «nota fondamentale»), l’ultimo film realizzato, Il vento ci porterà via, ripropone una scena di Close-up'. qui una scatola metallica cilindrica, come là una mela, rotola per terra, assai a lungo, e la macchina da presa segue la sua corsa erratica e senza scopo nel film, come un movimento che uscisse dal film stesso (dalla sua sceneggiatura, dal suo intento), ma con centrando su di lui la proprietà cinematica o cinetica allo stato puro: un po’ di movimento allo stato puro, non tanto per «raf figurare» il cinema, quanto piuttosto per rotolare o srotolare in esso un impulso interminabile. Esso gira e girando non arriva a nient’altro che a un’immobilizzazione, a un arresto (quasi «un fermo immagine») che pone la verità del movimento come il movimento costituiva tutta la verità della cosa la cui forma la portava a rotolare. L’automobile che rotola attraverso i film come attraverso gli ulivi è dunque anche una verità due volte 18
_____
___ L’evidenza del film
cinematica: in quanto scatola degli sguardi e in quanto movi mento incessante. Ma che cos’è il movimento che in tal modo è l’essere del ci nema (non il suo oggetto, né ciò che esso rappresenterebbe o re stituirebbe, come si crede allorquando si pensa il cinema tutto intero solo come un «disegno animato»)? Il movimento è ciò che «si fa soltanto se il tutto non è né dato né può essere dato»2. Il movimento non è lo spostamento o la traslazione, che posso no aver luogo tra posti dati in una totalità essa stessa data. Esso è al contrario ciò che ha luogo quando un corpo è nella situa zione c nello stato di dover trovare il suo posto, e pertanto di non averne o di non averne più. Io mi sposto (materialmente o mentalmente) quando non sono - ontologicamente - là dove so no - localmente. Il movimento mi porta altrove, ma l’«altrove» non è dato preliminarmente: è la mia venuta che ne farà il «lag giù» dove sarò giunto da «qui». Tutti i film di Kiarostami di cui parlo si concludono in maniera perfettamente concertata su di un’indicazione di altrove: nuovo luogo, nuova lontananza che diventa vicina, nuova appropriazione per l’apertura di un altro «là». Per non rievocarle tutte, mi accontento di quella di Dov’è la casa del mio amico? La mano del maestro scorre il quaderno dei compiti: quest’ultimo c diventato il luogo nuovo dell’amici zia e nel contempo quello dell’illusione del maestro e di una cer ta verità sull’educazione. E questo luogo è quello in cui si iscri ve il movimento della scrittura, di questa scrittura che il maestro prende per un’altra, ma che è anche la registrazione - la cinema tografia - dei tragitti incessanti e affannosi per riportare questo quaderno che hanno occupato tutto il film. Il movimento non è l’opposto dell’immobilità, oppure, se si preferisce, l’immobilità non è statica - questa immobilità che è, in tutti i film, talvolta quella di un paesaggio talvolta quella di un personaggio fisso sul volante della sua automobile e talvolta quella della macchina da presa tenuta su dei lunghi piani fissi, nei 1 G. Deleuze, Cinema 1. L’immagine-movimento, trad, di J.-P. Manganar», llbulibri, Milano 1997, p. 19.
19
----------------------------------- Nancy, Abbas Kiarostami________
quali talora molto poco o anche niente si muove sull’immagine. Il movimento è l’apertura dell’immobile, la presenza in quanto è davvero presente, ossia che viene incontro a, che si presenta, of ferta, disponibile, luogo d’attesa e di pensiero, presenza che è es-: sa stessa un passaggio verso o all’interno della presenza. Così, in una delle sequenze conclusive de II sapore della ciliegia, l’uomo che attende di conoscere la morte si siede al tramonto su di un’altura da dove domina un paesaggio urbano contrassegnato da edifici innalzati in costruzione c da alte gru, una delle quali si mette a girare, unico e lento movimento sul fondo del crepusco lo. Ci si mette allora a riflettere sul mezzo utilizzato per ottener re quest’immagine: comunicazione con la gru attraverso un te lefono, oppure attesa di un momento propizio? E questa rifles sione distanziata non esce tuttavia dal film: fa parte dello sguar do che il regista suscita e provoca con il braccio della gru. Essa mette questo sguardo in movimento verso e nel film stesso: si potrebbe dire che ne fa uno sguardo che filma - ed è come se Kiarostami non cessasse di formare il suo spettatore al film, os sia non di istruirlo a una tecnica, ma di aprirgli gli occhi sul mo vimento che è lo sguardo.
Sguardo / immagine Alle immagini c ai segni, Kiarostami sostituisce ovunque lo sguardo. O più esattamente, egli non «sostituisce» nel senso di far sparire le immagini e i segni, ma mobilita questi ultimi verso lo sguardo, e lo sguardo verso il reale. Lo sguardo: la precisione di un’inquadratura, quella di una sensibilità di pellicola, quella di un’illuminazione - stagione, momento del giorno, la cattura at traverso l’obiettivo che diventa un’automobile - in breve, nient’altro che il cinema... ma, se così si può dire, il cinema in tensificato, spinto dall’interno verso un’essenza che lo stacca ampiamente dalla rappresentazione per volgerlo verso la presen za (che sarebbe anche come cogliere l’autentica molla della sud 20
__________________
___ L’evidenza del film____________________________
detta «rappresentazione»). E la presenza non è affare di una vi sione: essa si dà a un incontro e a un’inquietudine o a una preoc cupazione. E per questo che lo sguardo è certamente fatto anche di domande che ritornano in questi film: da dove vieni? Di do ve sei? Che cosa fai? Che cosa pensi di...? - domande molto spesso staccate da ciò che più o meno si presume costituisca Nazione» del film (per esempio in modo sorprendente in Close-up, dove questa ridda di domande ha luogo tra personaggi che attendono in un’automobile mentre Nazione principale» si svolge nella casa...): poiché queste domande non hanno affatto la natura di un interrogatorio, esse hanno la qualità e la finalità di un riguardo per l’altro, c lo sguardo c riguardo. Le immagini e i segni non spariscono: al contrario, essi ven gono affermati più che mai. Al centro dì E la vita continua c’è un’immagine fissata al muro, che il regista guarda e che soprav vive al terremoto: essa è divisa, con il muro, da una lunga fessu ra. Ne II vento riporterà via, allo stesso modo, le immagini stan no sui muri e talvolta nelle stanze in cui la macchina da presa non entra, lasciandole soltanto indovinare. In quest’ultimo film, la foto è l’oggetto di un’interdizione (una donna vieta l’uso della macchina fotografica) - che non può non evocare la grande interdizione monoteista: il mono teismo è prima di tutto ritrarsi del divino al fondo di una pre senza assente {deus absconditus). L’interdizione, sulla quale la donna insiste, questo rifiuto, questo rigetto fa consonanza con il rispetto della morte e del lutto di cui il fotografo cerca al con trario di catturare l’immagine (due sguardi si affrontano, due maniere di aver riguardo). Ma questo divieto è esso stesso gio cato come in margine al monoteismo e nell’incontro con (il che non vuol dire contro) l’immagine del film stesso, data in una fotografia più sontuosa di quella dei film precedenti, una foto grafia meno arida, tutta occupata dal biancore di un villaggio e dalle messi scosse dal vento: come se la forza dei colori e dei volumi, la loro profusione e la loro pregnanza, compensasse e debordasse il divieto, ossia il ritrarsi del segreto della morte al fondo della vita. 21
Nancy, Abbas Kiarostami_______________ _____ —
Per finire, ci sarà mostrato il fotografo (etnologo del suo pae se, dei suoi riti ancestrali) al quale una donna del villaggio aveva vietato l’uso della macchina fotografica, filmato di prospetto co me lo era stato dal fondo del suo specchio, mentre sta fotogra fando, nella notte che volge al termine, le donne che si affretta no verso la casa di colei che è morta - morta troppo tardi per i termini dell’équipe etnologica venuta per registrare i riti del lut to. Foto presa al volo (prise au voi) nei due sensi della parola1, istantanea rubata come lo sono probabilmente tutte le foto, tut te le immagini di un film: un certo furto (voi) è la condizione del dono di sguardo? Bisogna sottrarre il reale per realizzarlo? Un fotografo deve essere un ladro? Così la foto rubata (volée)y sottratta al suo «soggetto» (che dunque diventa oggetto, preso in un obiettivo), sarebbe anche la foto appropriata a tale soggetto, il suo vero essere, la sua pre senza, ossia la sua comunicazione. Allo stesso modo, in Sotto gli ulivi, bisogna in qualche modo sottrarre a Tahereh, la ragazza scelta per il ruolo, ciò che permette di metterla in scena: bisogna vietarle un abito, obbligarla a levarselo, sottometterla a tutte le esigenze delle riprese; allo stesso modo, ella viene mostrata, nel la finzione del film che si gira nel film, come sottomessa alle do mande del suo giovane sposo mentre è, nella finzione del film che noi vediamo, sottomessa all’aspettativa d’amore del suo partner. Questo innesto (emboitement) di finzioni non ha esso stesso altra funzione se non quella di stimolare la nostra aspetta tiva, di tendere il nostro sguardo verso il reale che è: la verità di Tahereh - non la verità su di lei, ma la verità che può e che deve uscire da lei, questa verità che farà scintillare molto lontano, nel l’ultima immagine, la figura minuscola della ragazza, per un istante confusa con quella del ragazzo che la raggiunge corren do e poi ritorna verso di noi, verso la macchina da presa, mentre lontano, in fondo allo schermo che scompare come alla fine di ogni film, il segreto prende tutta la sua consistenza di reale, sen> Dunque anche nel senso di «rubata * (cornee noto in francese voi significa sia «volo» che» appunto, «furto») fn.dxj. 22
L’evidenza del film___
za scomparire né trasparire. L’immagine sarebbe il furto (voi) che sottrae al reale la sua realtà per dargliela confermata, appu rata, sigillata nella sua forza (nella forza dell’immagine si trova il rifugio contro i tradimenti dell’immagine). (Prima della fine del film Tahereh viene congedata dal regista: ella si sottrae troppo a ciò che le si chiede. Ma questo vuol dire che, fallendo nel simu lare, ella riesce nel reale. Qui le storie di simulazione non sono storie di illusione: tutto al contrario). Probabilmente in questo modo l’immagine di Kiarostami è tesa fra i due poli della tradizione del suo paese (della tradizione alla quale II vento ci porterà via fa maggior riferimento attraver so i riti del lutto): il polo più propriamente persiano di un’arte figurativa maggiore, uno dei più antichi c dei più pregnanti nel la storia dell’arte del Mediterraneo, e il polo islamico in cui l’a stensione dalla figurazione viene portata al culmine dalla sua tra dizione monoteista. Questa doppia polarità, avvenendo al cine ma (nel mondo occidentale), ne incrocia un’altra, giudaico-grcca, che fornisce un altro schema dell’ambivalenza intorno al l’immagine: si organizza così una configurazione complessa dei rapporti tra presenza e assenza da una parte, apparenza e realtà dall’altra. Questa configurazione - di cui il cinema è contempo raneamente un prodotto e un elemento ormai costitutivo - defi nisce un mondo che si distingue prima di tutto dai mondi per i quali la presenza (l’essere, la cosa, il reale c la comunicazione di un senso) è innanzitutto dato (come lo è nei simboli e nei riti di un lutto tradizionale). Nel mondo che è il nostro, il dato è in nanzitutto ritirato: esso è opaco, o è ritirato (si pensi ancora una volta alle aperture dei film: porta o camion che sbarrano lo schermo, passaggio in una galleria...). L’immagine allora definisce un mondo in cui il dato deve es sere ridato: esso deve essere ricevuto e ricreato per essere ciò che c. (Ne segue che l’ossessione del monoteismo è quella dell’im magine, in quanto la sua esecuzione riprodurrebbe il gesto di Dio creatore: non rifare il gesto del vasaio divino, tale è in parti colare la motivazione della tradizione islamica. Inoltre, la tradi zione sciita è forse particolarmente più sensibile a una dimen23
Nancy, Abbas Kiarostami
sionc di assenza divina o di segreto). Ma ridare il reale per rea lizzarlo significa propriamente guardarlo. Nelle storie delle riprese e della fotografia - come in quella del simulatore e in quella dell’uomo che cerca con gli occhi aper ti una morte possibile (se si può riassumere così II sapore della ciliegia) - si annoda e si gioca un triplo rapporto attorno a que sto sguardo realizzante: 1) rapporto dell’uomo (cineasta, fotografo) con la donna (quella che sorveglia la foto, le riprese - la signora Shiva in Sot to gli ulivi, - quella che veglia e protegge - la madre in Close-up -, quella che custodisce - la vecchia con il tappeto in E la vita con tinua -, e quella che interpreta il ruolo della donna segreta Tahereh; vi si possono aggiungere gli studenti del Musco di sto ria naturale, ne II sapore della ciliegia, che non si vedono, ma si sente il professore che insegna loro la preparazione di un uccel lo morto per la tassidermia: custodia della morte in una simula zione di vita); 2) rapporto della morte con la vita, che non è fatto né di op posizione né di dialettica, ma di pregnanza o di impregnazione reciproca, essendo ciascuna per l’altra e nell’altra, la vita che continua e che è «nient’altro che la vita», che segue il suo diffi cile cammino, a tornanti e in salita e discesa senza fine, che non va da nessuna parte e dappertutto, e sempre passando attraver so la morte, la quale resta segreta, incomprensibile e inappro priabile - è così per l’osso uscito dal cimitero, che l’etnologo fi nisce per gettare nel ruscello alla fine de 7/ vento ci porterà via, ma che forma anche il luogo o l’istanza di uno sguardo voltato verso la luce stessa: la luna tra le nuvole lacerate e i lampi di temporale guardati dall’uomo disteso nella sua fossa, Io sguar do del quale diventerà, attraversando il nero, quello di una vi deocamera in un sole mattutino (Il sapore della ciliegia)’, 3) rapporto dell’Iran antico con l’Iran moderno, come rap porto tra una tradizione talvolta inappropriabile (riti di lutto, in cui le donne si lacerano il volto con le unghie), talvolta confuta bile (discorsi dei vecchi sull’educazione), e sempre sospesa in un equilibrio incerto, come l’immagine al muro spaccato da una 24
---------------------------------------- L’evidenza del film
fenditura; e un mondo moderno difficile ma necessario (esso può fornire case più resistenti alle scosse sismiche, può dare istruzione), duro e caotico come un cantiere, potente e affasci nante come le sue gru e i suoi bulldozer - rapporto di ulivi e di frumento con il cemento e l’esercito.
Rispetto In questo triplo rapporto accuratamente composto e intrec ciato - in modo tale per cui i tre rapporti sono omologhi senza pertanto essere semplicemente paralleli, poiché essi si innestano anche gli uni negli altri - ciò che si gioca è sempre qualcosa del l’ordine della tensione che corre tra l’immagine e il senza-immagine, senza che sia in alcun modo possibile fermare la distinzio ne dei poli, sistemando per esempio dal lato dell’immagine l’uo mo, la vita e l’Iran moderno, come si potrebbe di primo acchito essere tentati di fare. Di fatto non ci sono poli stabili e semplicemente distinti: c’c il movimento dell’uno verso l’altro e l’energia di questo movimen to, energia di cui il film è la cattura (in tal senso questa forza gli è anche sottratta per ridarla e per realizzarla). Questa energia è quella dello sguardo mobilitato, attivato o animato: ossia la forza di un riguardo per ciò che si presenta allo sguardo. Riguardo e sguardo sono pressappoco la stessa parola: il ri-guardo (re-gard) indica l’arretramento propizio all’intensificazione della custodia (garde), della presa in custodia (prise en garde) (cfr. un radicale germanico wardon/warteri). Per custodire (garder) si veglia e si sorveglia, si osserva, si è attenti e in attesa. Ci si prende cura di ciò che si trova qui davanti e della maniera in cui si presenta: lo si la scia presentarsi - gli si lascia dunque anche il campo di un ritrar si dove la presenza è nel riserbo, in cui custodisce essa stessa il suo riserbo, come tutte queste ragazze dietro il loro velo nero, massa scura da dove avanzano dei volti chiari che il regista osser va per scegliere una di esse (e questa sarà Tahereh). 25
Nancy, Abbas Kiarostami
Lo sguardo (regard) è un riguardo (égard), e conseguente mente un rispetto (respect). La parola rispetto proviene anch’cssa da sguardo (respiceré)'. è uno sguardo voltato verso..., guida to da un’attenzione, da un’osservanza o da una considerazione. Il giusto sguardo è un rispetto per il reale guardatò, ossia un’at tenzione c un’apertura alla forza propria di questo reale c alla sua esteriorità assoluta: lo sguardo non intercetterà questa forza, lascerà che essa gli si comunichi, o comunicherà con essa. Guar dare non è in fin dei conti nient’altro che pensare il reale, met tersi alla prova di un senso che non si domina più. La cattura d’immagine nel film - che è oggetto dell’immagi ne instancabile dell’automobile, delle sue finestre, parabrezza e retrovisore come tanti rivelatori di vedute - non è una cattura se non per essere un rilascio. L’inquadratura, la luce, la durata del piano, il movimento della macchina .da presa liberano un movi mento che è quello di una presenza nel suo farsi. Il «regista» non realizza nient’altro che una realizzazione del reale: di questo rea le che rende possibile uno sguardo rispettoso. Ma non bisogna intendere nulla di sostenuto né di ossequio so nell’idea di rispetto. Nessuna autorità sovrasta quella del re gista; egli stesso si sottomette alle istanze dello sguardo, che deb ba regolare una luce o un suono, oppure che debba scegliere una ragazza fra venti altre tra le quali più di una potrebbe essere scel ta; o ancora che debba organizzare uno scenario conforme al suo pensiero, facendo portare per esempio dei vasi di fiori su un bal cone (da E la vita continua a II vento ci porterà via passando per Sotto gli ulivi, senza dimenticare quello che dà a Close-up 1^ sua coda di colore vivo). Ben lontano dall’inchinarsi dinanzi a una superiorità, il rispetto si mette all’altezza di ciò che rispetta: alla stessa altezza nell’alterità. L’alterità è quella di un altro sguardo. Close-up è un film di sguardi che poggiano gli uni sugli altri, quelli degli spettatori al cinema, quelli degli ammiratori dei regi sti, dei registi sui loro spettatori, dei giudici su dei simulatori, dei registi su dei giudici, dei registi tra loro. Una volta di più, là do ve si crederebbe di poter inferire un circolo chiuso, quella specie di autismo che capita al cinema di produrre quando si restringe 26
L’evidenza del film
su di sé, si tratta di tutt’altra cosa: di un’attenzione per il mondo nel quale il cinema impregna gli sguardi, ossia i rapporti con il reale e con il senso. In questo senso Kiarostami pensa - filma - un rispetto reci proco degli esseri che egli confronta, di cui scambia o incrocia gli sguardi: uomo e donna, bambino e adulto, cittadino e paesano, credente e miscredente, professioni, situazioni, in un certo mo do ogni film è una variazione continua, di cui uno spostamento fornisce il pretesto e il movimento, all’interno di una tale po lifonia. Il doppio registro fondamentale è forse quello di un mondo tradizionale e di un mondo attuale, nella misura in cui il primo sarebbe il mondo del senso dato, disponibile (senso della nascita, della sofferenza della morte, dell’amore e della fatica), mentre il secondo sarebbe il mondo in cui il senso deve essere ri creato, che non significa riappropriato (come un senso antico che si andrebbe a ricercare), ma al contrario riaperto all’infinità che è propriamente quella del senso o della verità. Di questa ri creazione, il cinema si fa allo stesso tempo metafora c realizza zione, l’una tessuta nell’altra come capita tanto nella storia del simulatore che vuole esprimere la sofferenza della sua esistenza quanto nella storia dell’etnologo che deve rinunciare a cogliere la morte e il dolore. Da un mondo all’altro, l’immagine crea continuità e discon tinuità, cos^come il film crea movimento e interruzioni (poiché non c’è un film di Kiarostami che non comporti cesure e iati, sincope o ignoto: vi è sempre almeno qualcosa o qualcuno che non si vede, che non si trova). L’immagine in E la vita continua non è soltanto attraversata da una fenditura: è essa stessa allo stesso tempo fenditura o irferinatura e continuità tra un passato (l’uomo che essa rappresenta, con la sua pipa all’antica) e un pre sente (lo sguardo del personaggio, che c il regista). L’immagine apre l’uno sull’altro due sguardi: il suo e quello che la guarda. Questa apertura crea spazio, distanza necessaria e rispettosa, nello stesso tempo in cui crea rapporto. Il film non è una rap presentazione, è un’attrazione dello sguardo, una trazione lun go il suo movimento, nello stesso tempo in cui definisce una par 27
Nancy, Abbas Kiarostami
te dello spazio - la parte della scatola sulla quale il film è proiet tato, l’immagine intercettata e presentata - come parte dello sguardo, della sua cornice e della sua portata, del suo aggiusta mento. Lo schermo di Kiarostami assomiglia molto meno a un teatro in cui si svolge una favola oppure a una dimostrazione che a un’apertura nella quale si fanno scorrere delle immagini, un passe-partout come si dice nell’inquadramento, o un passavedute (passe-vues) come si è detto un tempo per indicare gli appa recchi di proiezione per immagini fisse.
Evidenza L’evidenza nel suo senso forte non è ciò che cade sotto i sen si, ma ciò che colpisce e il cui colpo apre una possibilità per il senso. E una verità, non in quanto corrispondenza con un cri terio dato, ma in quanto coglimento. Non è nemmeno uno svelamento, perché l’evidenza mantiene sempre un segreto o una riserva essenziale: la riserva della sua stessa luce e del luo go da cui proviene. Evidentia: il carattere di ciò che si vede da lontano (attraver so un rovesciamento passivo del senso attivo di video, «io ve do»). La distanza dell’evidenza dà nello stesso tempo la misura del suo allontanamento e della sua potenza. Ciò si distingue da lontano perché si staglia, si separa - come le due macchie © la macchia doppia di Tahereh e del suo innamorato. Ciò colpisce per la sua distinzione: un’immagine è anche, sempre, ciò'che si taglia fuori da un contesto e che si staglia su di uno sfondo. È sempre un taglio, un’inquadratura. Il taglio taglia lo sguardo, affila i suoi bordi e la sua punta, ri schiara la sua acutezza. Quando inquadra spazi di cose - collina, strada, cumuli di pietre, riflessi di foglie, fiancata di camion, ma cerie, calcestruzzo, tubi, lontananze brumose o polverose, mes si pesanti e calde -, il regista coglie l’indistinto, l’ampio e il con fuso, il composito per renderlo distinto, restringerlo, indurirlo, 28
L’evidenza del film _
_______________________
levigarlo, farlo reale allo sguardo. Si tratta del fatto che l’occhio abbia a che fare con un muro screpolato in un modo tale che la crepa lo attraversi, con la polvere sollevata sugli sterrati in una maniera tale da colpire la visione. Evidentia fu scelto in latino per tradurre il greco enargeia, che parla del biancore potente e istantaneo del lampo: argos, insieme lampo e velocità. Colpisce in un istante e non si lascia cogliere. Va custodito in quanto istante, nel suo passaggio: nel contempo sospensione e successione, come per le migliaia di immagini che sfilano davanti alla lampada in ragione di ventiquattro al secondo. Ciascuna è un’istantanea e la loro totalità fa simultaneamente una grande istantanea del continuo - un film - e una molteplicità indefinita di pause, simili a questi nu merosi arresti dello sguardo (della macchina da presa) che rit mano i film di Kiarostami. Così, steso nella fossa che ha preparato per tentare di morir vi, il personaggio de II sapore della ciliegia vede la luna bianca tra le nuvole e poi i lampi di un temporale. Alla visione dei lampi succede quella della notte nera o della morte: è ciò che a noi ri marrà sottratto - e a questo momento immerso nel nero (che non è affatto una «dissolvenza in nero», ma un’immagine nera o un’immagine del nero) succede un levarsi della luce che c il gior no coltd da una videocamera, sullo stesso luogo, vicino all’albe ro che serve a localizzare la fossa, ma senza che quest’ultima ci sia mostrata, e senza che ci sia permesso di distinguere veramen te se uno dei personaggi preso nel campo visivo della videoca mera sia o non sia quello che si era steso per morire. Ma sia quel che sia questo personaggio è lì che accende una sigaretta per ten derla a un altro, nella vita che continua e la ripresa del film che volge al termine. La forza dell’evidenza impone e travolge ciò che è più di una verità: un’esistenza. È ciò in cui consiste l’evidenza più celebre della filosofia occidentale, quella di Cartesio, che consiste in un ego sum con il quale non è data, come talvolta si dice, una «co scienza di sé» (in ogni caso non psicologica né introspettiva), ma un’esistenza. Che questa esistenza si identifichi come pensiero 29
Nancy, Abbas Kiarostami------------------------------------
(cogito, sum) significa che questa esistenza è in rapporto con un mondo: che essa si pone e si prova, si riceve come un punto sin golare di passaggio in una circolazione di senso. L’evidenza del cinema è quella dell’esistenza di uno sguardo attraverso il quale un mondo in movimento su se”stesso, senza cielo o senza involucro, senza luogo fisso di ancoraggio o di so spensione, un mondo scosso da terremoti e attraversato da venti, può ridarsi il proprio reale e la verità del suo enigma (che certo non è la sua soluzione). In questo il cinema di Kiarostami è una meditazione metafisica (per rimettere in gioco il titolo di Carte sio). Il che non significa un cinema che tratti temi metafisici (nel senso in cui lo fa, per esempio, il Bergman de II settimo sigillo); significa piuttosto una metafisica cinematografica, il cinema co me luogo della meditazione, come il suo corpo e il suo campo, come l’aver luogo di un rapporto con il senso del mondo. Probabilmente, da che gli uomini del paleolitico disposero nelle loro grotte degli ordinamenti simbolici di figure vi fu sem pre né più né meno una simile meditazione nella proiezione di immagini su una parete. Ma una cosa è il carattere perenne della meditazione - del pensiero —, un’altra è il movimento delle sue mutazioni. Fino a noi la parete di immagini era consistente e te stimoniava per un fuori o per un intimo del mondo (almeno al la maniera in cui noi abbiamo creduto fin qui di poter interpre tare il passato dell’umanità). Con il cinema, la parete diventa un’apertura praticata nel mondo su questo mondo stesso. È. per questo che la comparazione, che fu fatta a più riprese, del cine ma con la caverna di Platone non è pertinente: il fondo della ca verna testimonia precisamente per un fuori del mondo, ma in negativo, c installa per ciò stesso il ben noto discredito delle im magini, o l’esigenza di considerare delle immagini più alte e più pure, chiamate «idee». Il cinema opera all’inverso: esso non ri flette un fuori, ma apre il dentro su se stesso. L’immagine sullo schermo è essa stessa l’idea. (Ma per questo, e per un’altra differenza con film a tema o a tesi «metafisica», la realtà sociale c politica, pratica e quotidiana dell’Iran non è mai dissociabile dalla meditazione di cui parlo. 30
------------------------------- -------- L’evidenza del film
Al contrario, essa non cessa di essere presente in tante maniere da sfidare talvolta anche la semplice comprensione di uno spet tatore troppo poco informato come lo sono io. È sufficiente pensare, per accontentarsi di un esempio per me assai chiaro, al giovane soldato ne 11 sapore della ciliegia, del quale si apprende che è un contadino del Kurdistan, che parla di lavoro non paga to ecc. - senza dimenticare che un gruppo di soldati occuperà le ultime immagini del film, soldati in stato di inattività, felici di ri lassarsi, che fumano, che colgono fiori come segni deputati ad invertire quelli della realtà militare).
Film La nuova pregnanza ha il suo elemento: il film. Ma il film inte so innanzitutto nella sua accezione più letterale, tecnica e materia le: la pellicola. Film e pellicola hanno innanzitutto lo stesso senso attraverso la stessa origine -pellis, pelle. È una piccola pelle, una pelle sottile; l’inglese film aveva innanzitutto il senso di «mem brana». Nel latino tardo, attraverso il quale la parola c passata in francese, pellicula designava la pelle staccata, la pelure (buccia) di un frutto; la. parola ha potuto anche designare il prepuzio. La pel le staccata non vale più come involucro: essa non è più che tenuità. Tale tenuità definisce un supporto che c di natura diversa ri spetto a quello della pittura e del disegno: non è una materia su scettibile di ricevere un altro materiale (impasto, mina, vernice), e una materia sensibile a quella singolare materia che è la luce, e questa sensibilità è fatta di sostanze fini, diafane («emulsione» o «sospensione» in una gelatina di grane fotosensibili). La pellico la è come parente della luce e, di più, essa non è la sola a costi tuire il supporto del cinema. Bisogna, infatti, che sia attraversa ta da un fascio luminoso nel quale l’immagine venga trascinata fino a che uno schermo non l’intercetti; schermo che deve esso stesso offrire un altro tipo di parentela con la luce per restituire, senza assorbirla né rinviarla, quella che ha appena tagliato. Il 31
Nancy, Abbas Kiarostami-------------------------------------
supporto del cinema è contemporaneamente una sorta di rap porto della luce con se stessa, il tenere in sospeso un delicato equilibrio (sensibilità, potenza di illuminazione, velocità, regola rità e distanza di proiezione) e lo spazio intero nel quale questo equilibrio deve essere tenuto. Il supporto non può essere isola to in quanto tale (alla maniera di un foglio o di una tela), e non e nemmeno esteso in tutte le direzioni come l’aria in cui si diffondono i suoni. Per certi versi, il cinema è esso stesso in equilibrio tra il disegno, la scrittura e la musica (ma bisognereb be forse spingere l’analisi fino a considerare anche ciò che rien tra nel campo della danza, della scultura, addirittura dell’archi tettura: non che il cinema abbia un privilegio di totalizzazione, ma ogni «arte» c una totalità aperta sulle altre e configurata con esse, fino a toccarle). Se finora Kiarostami non ha mostrato (a mia conoscenza) una sala cinematografica nei suoi film (ma ha mostrato almeno un cartellone cinematografico, e in Close-up l’azione di «andare al cinema» gioca un ruolo evidente), si può pensare che sia perché non si tratta per lui della retorica dello «spettacolo nello spettacolo». È in maniera molto più intima, nella tessitura stessa, se così si può dire, delle immagini e delle opere che l’elemento «filmico» è presente. (Il verbo «filmare» dovrebbe anche essere inteso come se si parlasse non di registra re un’immagine, ma di fluidificare, di gelificare o di cristallizza re ciò che «prende» l’obiettivo) . * Dall’obiettivo allo schermo, dalla cinepresa alla proiezione, c’è una continuità di questa materialità luminosa, sospensiva, diafana e dissipativa che mi piacerebbe chiamare eterea pensan do a quell’etere che fino alla fine del secolo scorso si credeva co4 Bisognerebbe qui rinviare al breve film dedicalo, nel 1998, proprio alla pelli cola da Ycrvant Gianikian e Angela Ricci-Lucchi, Trasparenze. Per 7 minuti esso filma soltanto diversi aspetti di una pellicola d’archivio in parte rovinata, lacerata o degradata, rendendo così sensibile la fragile trasparenza del sottile gel incaricato di tracciare forme e colori che ha ricevuto per portarli sullo schermo (come si dice in francese per parlare di un adattamento cinematografico di un’opera letteraria) per portarli sulla materia impalpabile di un fascio luminoso che attraversa la tra sparenza. In generale, il lavoro ai questa coppia di autori a partire da film di archi vio rielaborati è anch’csso un lavoro sull’immagine come venuta, come montata o come soffio assai più che come rappresentazione. 32
------------------ :-------------- ------ L’evidenza del film
stituisse l’ambiente o l’elemento portatore di luce. L’elemento etereo del cinema è subito quadridimensionale: allo spazio in se no al quale si gioca l’equilibrio della luce appartiene anche il tempo di questo equilibrio. La durata è inerente alla natura del la proiezione, anche se è un’immagine mobile ad essere proietta ta e quale che sia la durata della proiezione: a differenza di una fotografia, un’inquadratura immobile non è deposta sulla fissità di un sostrato. Esso vibra la durata della sua proiezione. Se è ve ro che Kiarostami palesa un gusto particolare per la fotografia, e se sceglie spesso l’immobilità della macchina da presa, all’occorrenza davanti a un’immagine inerte (blocchi di pietra, macchine ferme, colline senza vento), è per richiamare a un’immobilità più essenziale, dell’ordine della vibrazione che attraversa lo spazio come nel caso dell’antenna televisiva di E la vita continua o in quello del telefono portatile che esige, per funzionare, delle ascensioni ripetute sull’altura (ne // vento ci porterà via', il vento stesso meriterebbe l’analisi della sua materialità dinamica, que sto vento che agita i panni in Dov’è la casa del mio amico?, gli alberi in Sotto gli ulivi, le nuvole ne 11 sapore della ciliegia e le messi nel film a cui il vento dà il titolo - il vento, animazione del l’aria o dell’etere, soffio che trascina via l’immagine di un altro trascinare rispetto a quello dello scorrimento della pellicola). La luce, l’aria, il soffio appartengono all’elemento del film in quanto ambiente di passaggio, di attraversamento e di rifrazione attraverso il quale l’immagine si realizza. Contemporaneamente nastro (come le strade percorse), gel, finestrino e acqua, si tratta di una specie di fluido di cattura che coglie il vivo e che lo irrigi disce in ventiquattro imn^igini distinte al secondo, ma per flui dificare istantaneamente il loro seguito in uno sguardo continuo. La lunghezza della strada che si stende, le aperture delle auto che servono da rivelatori di immagini. Queste ultime sono etere in quadrato. L’immersione nell’elemento etereo si fa attraverso un ta glio - come l’apertura nel muro, bagnata da una grande luce, attra verso la quale il personaggio di E la vita continua guarda il pae saggio attentamente, prima di scoprire, girandosi, l’immagine sul muro fessurato. L’elemento etereo è quello di una penetrazione o 33
Nancy, Abbas Kiarostami________________________
di un’impregnazione: l’immagine resta a distanza, ma si entra nel suo elemento, si è se stessi, spettatori, presi nel fascio di luce che di viene quello del nostro sguardo. L’immobilità in cui ci tiene la sala è la condizione di questo coinvolgimento, di questo trasporto.
Trasporto Ciò su cui apre lo sguardo è un trasporto (emportement) - un addestramento (entrainement), un rapimento (enlevement)', una mobilità del mondo. Tutto è situato, ma niente sta fermo (reste en place). Vi sono dei villaggi, dei luoghi, degli indirizzi (in Close-np), ma non si trovano oppure si trovano con difficoltà, si possono confondere. Quando si incontra qualcuno, questi viene da qualche parte e va da qualche parte. Ma questi luoghi, questi «laggiù», restano fuori portata, sempre dall’altra parte di una nuova collina, di un nuovo tornante della strada. Non per questo sono «fuori campo»: nessun cinema è meno portato verso il fuori campo di questo. Esso riunisce tutto nel campo in maniera precisa: un’inquadratura serrata, addirittura stretta, in cui si concentra un’attenzione, oppure un’inquadratu ra ampia, ma su lontananze che la riempiono c che sono suffi cientemente lontane e frontali nella loro lontananza da non do versene discostare. Il taglio viene realizzato nella misura esatta di ciò che va guardato, come la fossa viene scavata a misura del cor po che deve accogliere (ne II sapore della ciliegia), mentre la bu ca che frana (ne II vento ci porterà via) è un accidente, una di sgrazia come il terremoto c come quest’ultimo la minaccia di un altro trasporto, di un inghiottimento. (Si può aggiungere che nemmeno il controcampo viene vera mente utilizzato: quando due personaggi si intrattengono, ogni ripresa di uno dei due viene resa completamente autonoma dal l’inquadratura e presuppone appena, in qualche modo, la sua controparte, oppure al contrario quest’ultima è integralmente presente attraverso la propria voce. Ora, questo corrisponde al 34
___________ :______ _______ L'evidenza del film
la realtà delle riprese, in cui Kiarostami (lo spiega lui stesso) prende spesso il posto di colui che interroga al fine di ottenere dall’altro la disposizione c l’espressione che desidera). In un modo o nell’altro, nel cinema veniamo trascinati: sia mo nel trasporto, esso è la nostra esistenza, ed è così che lo sguardo cinematografico diventa una condizione molto più che una rappresentazione. È la condizione di una trasformazione permanente o di una variazione indefinita e continua. Ciò che varia o ciò che suppor ta la variazione è sicuramente, in un certo senso, un invariante. Ma nello stesso modo in cui il supporto materiale è una mem brana diafana e impregnabile, così l’invariante è l’unità della va riazione, la forma della trasformazione. Ogni volta questa forma ha almeno un volto preciso: il bambino di Dov'è la casa del mio amico?, il simulatore di Close-up (ma anche la madre della fami glia), il regista di £ la vita continua (ma anche suo figlio, e l’au tomobile), Tahereh in Sotto gli ulivi (ma anche la signora Shiva) ecc. È la forma di un certo sguardo: questi personaggi molto spesso guardano davanti a sé, in lontananza, e talvolta si rivol gono a colui che è seduto al loro fianco, nell’automobile, senza guardarlo, come capita che si debba fare guidando. La guida del l’automobile ha una grande importanza: girare il volante su que ste strade a zig zag, cambiare velocità, frenare. Si produce un in nesto del film su tale meccanica cinetica che richiede l’attenzio ne del conducente. Non soltanto la mobilità, ma anche la motricità viene messa in gioco. L’invariante è così esso stesso motore di variazione, la forma è metamorfica o anamorfica. Allo stesso modo l’immobilità fotogràfica è il vero motore del cinema5. 5 Del fatto che una tale affermazione sia presente, al di là dello stesso Kiarostami, in molti registi contemporanci, penso che si possa trovare più di un indizio in film recenti anche diversi tra loro e da quelli di Kiarostami come, per esempio, Beau travail di Claire Denis o Yi Yi di Edward Yang. Si tratta ogni volta di un cinema che apre per certi versi la propria immagine su un reale - o su un senso - che soltanto l’immagine può anelare a prendere, e che prende a partire da una mira al di là di ogni «punto di vista», a partire da uno sguardo sprovvisto di soggettività, da un obiettivo che mirerebbe alla vita, dal segreto della morte come segreto di un’evidenza. 35
-------------------------------- _ Nancy, Abbas Kiarostami
_____ .
Il supporto, o la sostanza, o il soggetto, non porta ma c osso stesso nel trasporto, spinto o lanciato piuttosto che condotto da una forza o da un movente che non si esaurirà né nelle sue ra gioni né nei suoi effetti: perché e per che cosa, di preciso, avran no agito come hanno fatto i protagonisti di ciascun film? È ciò che non verrà dichiarato, perché non lo si deve fare. Il loro esse re si confonde con questo movimento, ma questo movimento non è un’agitazione, è una perseveranza di essere: li caratterizza una notevole ostinazione, che non è sforzata ma che ha qualco sa di testardo e di paziente a un tempo e, soprattutto, dell’auto rità. Questa non si esercita tanto sugli altri, ma a tutta prima sul movimento stesso che essa intrattiene. È un trasporto che si au torizza da sé: non un racconto che rivelerebbe una genesi o una maturazione, una rivelazione, uno scioglimento, ma tutt’al più una cronaca degli incidenti di un percorso che non è propria mente né essere né divenire, c che si potrebbe anche caratteriz zare come una lenta distensione dell’immobile: alla fine, ci si ri trova sempre in qualche modo all’inizio. Ma non c’è nulla di circolare: è la possibilità stessa dell’ini zio che sarà dispiegata, e che lo sarà come la possibilità di uno sguardo. Così come il nostro primissimo sguardo sul casello autostradale in un giorno di soccorso alle vittime del sisma, o lo sguardo dei passanti interrogati sulla foto del bambino che si ricerca. Così come lo sguardo del regista sui postulanti alle riprese. Così come lo sguardo su quelli che incontra di colui che cerca un aiutante per il proprio suicidio (sguardo innanzi tutto equivoco, sul quale aleggia deliberatamente un dubbio sessuale e di cui non si saprà, per finire, se resta nel nero o se si riapre in macchina da presa). Il senso non è né narrativo né teleologico; non è nemmeno ri petitivo. Forse non è affatto un «senso», o non trattiene del «senso» se non il significato direzionale: si segue un cammino o lo si cerca. In un certo modo, il cammino è esso stesso la verità, secondo la lezione di tanta saggezza d’Oriente e d’Occidente, di cui la parola metodo (che vuol dire cammino di ricerca) è il com pendio filosofico. Il carattere dei protagonisti è metodico: pro36
Uevidcnza del film
babilmente questa c la parola, meno psicologica di tutte le altre, che rende meglio conto della loro condotta. Non è tuttavia che qui si debba recuperare la saggezza o il sa pere dell’«assoluto in quanto cammino» (per dirlo alla maniera hegeliana), come se abbisognasse alla fine di un risultato, fosse pure il divenire stesso; propriamente non c’è neppure divenire, e non c’è risultato. Ciò che i film non ci lasciano mai dimenticare, ciò che riprendono metodicamente, è la costanza dei paesaggi che stanno «sullo sfondo» dell’immagine soltanto per essere messi in vista, per alternanze ritmiche, in piani larghi a volte im mobili a volte fuggenti alla velocità dell’automobile, masse e massicci, fianchi di colline, cumuli di terra o di pietre, rami e fo gliame, materiali, case, campi di colture, ma anche figure indi stinte, sfuggenti. Lungi dall’essere soltanto l’accompagnamento di un’azione, o ancora meno il suo scenario, queste ampie pre senze vengono allo sguardo, sono disposte per esso nell’elemen to del film che le dipana come la sua stessa evidenza. Queste presenze sono impronte della gravità e della grazia di un mondo incerto sul quale, a momenti, uno sguardo preoccu pato può posarsi; istante di un reale venuto alla presenza per me todo e per fortuna. Il cinema - la sua tela, la sua membrana sensibile - è teso e so speso tra un mondo in cui la rappresentazione si incaricherebbe dei segni di una verità, dell’annuncio di un senso o delle garan zie di una presenza a venire, e un altro mondo che si apre sulla propria presenza attraverso uno svuotamento (évidement} in cui si realizza la sua evidenza pensosa. t
37
ABBAS KIAROSTAMI
E la vita continua'1'
Et la vie continue (E la vita continua): è» nella sua traduzione francese (ci ritornerò), il titolo del film girato nel 1992 da Abbas Kiarostami. Tra le espressioni correnti, tra i modi di dire che hanno corso, ossia che hanno un valore immediatamente riconoscibile, che si scambiano senza difficoltà (che si scambiano in cambio di nulla, in cambio della propria eco, che dunque non valgono nulla...), questa espressione - dicevo - parla di quel corso costante e for zato della vita che segue il suo corso e che continua malgrado tutto, malgrado il lutto c la catastrofe. Il film lo fa intendere fin dall’inizio, attraverso la voce alla radio: «L’entità del disastro è immensa» (si tratta del terremoto del 1990 in Iran). L’espressione dice che bisogna certo che tutto questo conti nui, e dice che è bene che ciò continui, che comunque, o in fin dei conti, la vita c anche questo: che questo continui. L’espressione non dice nulla della «vita» né del suo scopo né del suo senso né della sua qualità; non dice che c la vita della specie o quella del l’universo che passerebbe al di sopra di quella degli individui (senza dubbio al centro del film, si vedrà una giovane coppia spo sarsi dopo la catastrofe, ma non si vedranno nascere bambini); non dice un’indifferenza nei confronti della morte né nei con fronti di alcuna forma di compimento e di realizzazione. In un * Ecco adesso, conformemente a quanto annunciato, il testo dell’articolo apparso sotto il titolo De l’évidence [Dell'evidenza] nella rivista «Cinematheque», autunno 1995, 8. Di proposito non l’ho riletto prima di scrivere, cinque anni più tardi, le pagine che precedono. Vi sarà dunque qualche elemento di ripetizione, ma probabilmente anche qualche dissonanza.
39
Nancy, Abbas Kiarostami,_____
certo senso, al contrario, il film stesso è il compimento, esso rea lizza, mostra questo: la catastrofe, la continuità, e altra cosa anco ra, quest’immagine che è il film stesso c che esso nel contempo designa - un’immagine che non c né la «vita» pura e semplice né un immaginario. Nessuno di questi due fantasmi, «realista» o «fittizio», ma la vita nella sua evidenza presentata o offerta.
(Probabilmente dico troppo in una volta e troppo velocemen te. Ma è così che funziona con un film. E la simultaneità di una successione: il paradosso del continuo).
L’espressione (o il titolo) dice che oltre alle realizzazioni, oltre alle produzioni o alle rivelazioni discontinue, oltre o attra verso di esse, e nel loro centro o nel loro cuore come loro verità, vi è il continuo, il fatto che ciò continua. Oltre a ciò che produ ce senso, talvolta, o non senso, vi è ciò che produce soltanto cammino: ossia, senso in un altro senso, il senso della vita come un «continuare» che non è nemmeno una direzione (nel film, non si cessa di cercare la direzione), che non è veramente un cammino, non veramente un percorso, bensì una traversata senza sponde assegnabili, dunque senza riferimenti discontinui, una traversata che non fa che continuare (questo si chiama espe rienza), un passare che non fa che continuare, un passato che passa in effetti (questo si chiama lutto), un passaggio che conti nua e non porta che al proprio presente che passa, o ancora al suo non presente (questo si potrebbe chiamare eternità) - e anche ciò che resta inafferrabile se non passando, ciò stesso è la vita, il suo senso e il suo sale, la sua verità che non obbedisce ad alcuna ingiunzione, ad alcuna destinazione.
E la vita continua dice una perseveranza dell’essere, nell’es sere, che fa inevitabilmente pensare a Spinoza. Ma non c’è biso gno di fermarsi a Spinoza. Bisogna piuttosto aggiungere che questa perseveranza, questa continuazione - che non è sempli cemente una continuità - non è altra cosa rispetto all’essere stes 40
EL la vita continua-------------------
so. L’essere non è qualcosa: è che ciò continua. È che ciò conti nua non al di là o al di qua dei momenti, degli eventi, delle sin golarità e degli individui che sono discontinui, ma in maniera più strana: nella discontinuità stessa, e senza fonderla in un conti nuum. Questo continua a discontinuare, questo discontinua continuamente. Come le immagini del film. (A questa stregua, non importa tanto che l’originale persiano del titolo dica una cosa leggermente diversa: qualcosa come «la vita, e nient’altro», «nient’altro che la vita» e dunque «io non voglio (mostrare) altro che la vita, semplicemente la vita». Perché questo vuol dire: ecco, il film non fa nulla se non conti nuare, esso filma una continuazione, quella di una storia (prima, c’è stato un altro film, e si cerca uno dei giovani attori, non si sa se sia sopravvissuto), quella di un percorso (la ricerca), quella della vita della gente dopo il terremoto, quella della vita nel film, e come film. Esso filma la continuazione di molte continuazioni incatenate, innestate o intrecciate le une nelle altre). Il cinema qui si raccoglie, si concentra sulla sua continuità e sulla sua continuazione. Esso si mostra, assai deliberatamente, ostensibilmente, semplicemente, come il movimento ininterrotto delle sue riprese e dei suoi tagli, nemmeno propriamente inter rotto al suo inizio e alla sua fine, continuante o sconfinante su un fuori campo, su un fuori film che è più di questo, o che non è più di tutto questo, poiché è ancora un film che lo precede e che lo seguirà (quest’ultimo, sotto forma di una trasmissione televisiva che il bambino guarderà). Ma il film fuori del film, il film del film, conseguentemente, o l’immagine del cinema stesso, non è proiet tato in una consistenza immaginaria, non è affidato a un’evoca zione dubbiosa: la sua continuazione è assicurata solamente dalla maniera stessa in cui il film si interrompe all’inizio e alla fine. Prima, dopo il film, c’è la vita, certo. Ma la vita continua nella continuazione del cinema, nell’immagine e nel suo movimento. Essa non continua come una proiezione immaginaria, come un sostituto a una mancanza di vita: al contrario, l’immagine è la continuazione senza la quale la vita non vivrebbe. 41
----------- ------------------------- Nancy, Abbas Kiarostami_________________________
L’immagine, qui, non è una copia o un riflesso, né una proie zione. Essa non partecipa di questa realtà seconda, indebolita, dubbiosa e pericolosa che una pesante tradizione le conferisce. Essa non è nemmeno ciò attraverso cui la vita si continuerebbe: essa è, in maniera molto più profonda (ma questa profondità è la superficie stessa dell’immagine), questo, che la vita continua con l’immagine, ossia che essa si regge da se al di là di sé, in avanti, davanti, incontro a ciò che la chiama e a ciò che le resiste a un tempo, invincibilmente, continuamente, ed evidentemente. Al centro del film c’è un’immagine, un’immagine di immagi ne c della sola immagine nel senso più semplice della parola (ve n’è un’altra, ma appena intravista, è la foto del giovane attore di cui si è alla ricerca, su una locandina del film in cui recitava): una sorta di vecchia oleografia fissata al muro di una casa in parte distrutta. Una crepa nel muro attraversa l’immagine, la lacera senza disfarla. E un quadro tradizionale, di un uomo seduto, con una pipa, vicino a una tavola con un bicchiere e una brocca. Io non so che cosa rappresenti di preciso quest’immagine per una memoria iraniana e non cerco di saperlo (voglio restare lo spet tatore straniero che sono, quale il film mi lascia essere, non spie gandomi questa immagine). L’immagine viene guardata' dal cineasta che è il personaggio principale del film (se così si può dire: egli è lo sguardo che percorre il film, lo sguardo che fa que sto film nel duplice senso per cui ne è l’oggetto c il soggetto). Non c’è, nel film, un commento a quest’immagine nel film, che è pertanto come l’emblema di tutto il film. L’assenza di com mento è riempita soltanto dallo sguardo del cineasta (attore) che guarda quest’immagine. Il commento è semplice: come ripren dere il filo delle immagini rotto dalla catastrofe.
Ed è certo a proposito dell’immagine, e più precisamente, questa volta, della televisione, che il titolo del film è enunciato all’interno del film stesso, assai avanti nel suo svolgimento (verso il 75° minuto, mentre il film ne conta 91). Qualche gior no, dunque, dopo il terremoto del 1990, un uomo installa un’an tenna perché un gruppo di rifugiati, sotto delle tende, possa 42
E la vita continua___________________
seguire alla televisione la coppa del mondo di calcio. Il cineasta (personaggio) gli domanda: «Ritiene sia conveniente guardare la televisione in giorni come questi?». L’uomo risponde: «In verità, anch’io sono in lutto. Ho perduto mia sorella e tre nipoti. Ma che cosa si può fare? La coppa si gioca ogni quattro anni. Non possiamo perderla. La vita continua». La coppa di calcio è per lui, per loro, immagine pura: scher mi televisivi, così come iconografia del calcio per tutti coloro che colpiscono dei palloni malfatti su terreni di fortuna, sognando vagamente glorie alla Maradona. Kiarostami non intraprende affatto la riabilitazione di tutta questa iconografia tanto denigra ta. Egli nort vi si sottomette neppure (del resto, non mostrerà una sola immagine della coppa alla televisione). Ma non arriva neppure a urlare con gli spiriti tristi e altezzosi che non hanno niente di più urgente da fare che denunciare lo «spettacolo» come se ci fosse una pura verità al riparo in un ’interiorità «auten tica». Egli mostra che la vita continua prima di tutto nell’este riorità, girata verso il fuori del mondo, girata verso questi scher mi che non funzionano innanzitutto come illusioni, ma ben piuttosto come occhi aperti sul fuori. L’antenna perlustra il cielo, cerca le onde portatrici di queste immagini che fanno parlare, scommettere, vibrare (dei bambini scommettono, durante il film, sull’esito della coppa), di queste immagini che sono tessu te nel rapporto sociale quanto, se non di più, nel sogno (si apprende che la sera della catastrofe molti si erano spostati per andare a vedere la televisione presso parenti, amici, e che alcuni vi hanno trovato la morte, altri la salvezza; laggiù, per vedere la televisione o il cinema bisogna spesso spostarsi). Ogni film si iscrive così in un’elusione dell’interiorità. Non si sa nulla di ciò che pensa questo cineasta alla ricerca dei suoi giovani attori forse scomparsi. Non si sa nulla di ciò che signi fica il suo sguardo (si potrebbe prendere per troppo saggio, troppo «interiore», appunto, se fosse manifestato da qualche discorso: ma non lo è mai). L’interiorità viene elusa (évitée), ed e svuotata (évidée)'. il luogo dello sguardo non è una soggetti vità, è il luogo della macchina da presa come una camera oscu43
------------------- -------------
Nancy, Abbas Kiarostami
ra che non è, questa volta, un apparecchio di riproduzione, ma un luogo senza un vero dentro (il casello autostradale all’inizio e, in seguito, l’interno dell’automobile, con i margini dei fine strini o del parabrezza che danno l’inquadratura dell’immagine - oppure, all’inverso, la stessa automobile filmata da fuori, da molto vicino o da molto lontano). L’immagine, allora, non è la proiezione di un soggetto, essa non c né la sua «rappresenta zione» né il suo «fantasma», ma è questo fuori dal mondo in cui lo sguardo si va a perdere per trovarsi come sguardo, ossia prima di tutto come riguardo per ciò che è qui, per ciò che ha luogo e che continua ad aver luogo. Per una volta, la veduta non è una captazione del soggetto, è al contrario la sua liberazione, il suo invio davanti a sé, a volte più vicino, gettato contro i blocchi di pietra, gli ammassi di rovi ne, le fiancate di camion, a volte più lontano, lanciato verso accampamenti arrischiati, colline sassose e, sempre, verso la pre senza della strada, del suo nastro srotolato e interrotto da frat ture, delle sue banchine incerte, delle sue curve e delle sue .salite il cui superamento non è assicurato. Qui il cinema si gioca simultaneamente, indissociabilmente, su due registri (ma forse non vi è cinema degno di questo nome che non giochi su questi due registri). Il primo, registro della continuazione ininterrotta, del movimento (dopo tutto, è ciò che significa cinema’, movimen to continuo, non rappresentazione dotata di mobilità, ma mobilità come essenza della presenza e presenza come venuta, venuta e passaggio), dello spostamento, della continuazione, della perseveranza, della prosecuzione più o meno incerta o errante (Vauto che è l’oggetto centrale e il soggetto del film, il suo personaggio e la sua scatola oscura, il suo riferimento e il suo motore; l’auto restituisce un pieno valore al nome auto mobile’. èssa va da sé, dell’avanti fuori di sé essa porta ciò che si presenta, tazza di WC o stufa, passeggeri occasionali, ed essa fa da staffetta fra tutti questi pedoni che vanno per le strade disa gevoli e interrotte, tutti automobili, tutti restituiti a una singo 44
__________________________ E la vita continua____________________________
lare dignità che fa di essi de$li esseri che camminano più anco ra che degli esseri parlanti). E un registro di solcatura (frayage) permanente: bisogna incessantemente trovare, aprire la strada, bisogna tornare indietro e fermarsi, bisogna costeggiare, iner picarsi, riprendere slancio; bisogna chiedere la strada ma, poi ché le strade sono state interrotte, lo stesso chiedere non ha senso; bisogna valutare delle distanze che si sono modificate, o che si sono perdute; villaggi vicinissimi sono separati da faglie. E questo * non avrà fine. L’auto porta a spasso lo schermo, o l’o biettivo, lo schermo-obiettivo del suo parabrezza sempre più lontano, e questo schermo non è appunto uno schermo - nc un ostacolo né una parete di proiezione -, ma è uno scritto, è una traccia sinuosa, scoscesa, polverosa. L’altro registro è quello del passaggio attraverso l’immagine, o dal passaggio all’immagine: il cinema stesso, la televisione, lo spettacolo del calcio, l’immagine appesa al muro, lo sguardo in generale: non lo sguardo in quanto punto di vista (poco o nulla del «punto di vista», l’immagine è sempre più avvicinata o allon tanata da tutto ciò che potrebbe fissare un «punto di vista» - e non è dunque possibile per lo spettatore del film lasciarsi iden tificare con un tale punto di vista: è un modello di ciò che Brecht indicava con distanziazione e che non indica altro se non l’es senza dello spettacolo in quanto lo spettacolo non ha niente di «spettacolare»), ma lo sguardo in quanto slancio in avanti, oblio di sé, o piuttosto: (di)mostrazione che non ci sarà mai stato un sé istallato in posizione di spettatore, poiché un soggetto non è mai altro che la punta acuta, sottile, di un’avanzata che si prece de indefinitamente. Egli non ha progetto, non conduce ciò che si chiama una ricerca (non vi è qualcosa come il Graal qui, non perché non ci sarebbe nulla da sperare, ma perché la speranza è ben altra cosa che la cambiale emessa su di un avvenire atteso, e dunque imma ginato: essa è al contrario la fiducia nell’immagine come in ciò che precede, c che precede sempre). È per questo, del resto, che questo «soggetto» non è ben indicato. Non c’è soggetto, sup porto di un’intenzione, ci sono soltanto la tensione e l’attenzio45
_ Nancy, Abbas Kiarostami
ne estreme di qualcuno - di numerosi qualcuno - nella conti nuazione di questo: che ciò continui. Questa continuazione non ha nulla di meccanico ne di scon volgente. Non è neanche la forza bruta immanente della specie che sopravvive. È ognuno - ogni uno - che va a capo dell’uno. Certo, l’immagine non è la vita. Essa è anche, all’occorrenza, sfacciatamente ingannevole: si apprende che per il film girato prima del terremoto sono stati usati dei trucchi. A uno si era applicata una falsa gobba, all’altro si era attribuita una falsa casa. Allo stesso modo, i giovani sposi che si sono sposati all’indoma ni della catastrofe sono forse un’illusione esattamente come i bei colori di cui brillano ancora le loro case, e i loro fiori e i panni che vi si vedono. E la televisione resta la televisione. Allo stesso modo in cui questo film resta un film, e non lo lascia mai dimenticare precisamente attraverso i contrasti e l’insistenza delle sue inqua drature - sempre l’auto, i suoi finestrini, le sue portiere, i cigli delle strade al limite dell’evanescente; ma anche la sistemazione paziente di tutto, le scene troppo nitide, troppo precise per esse re prese «dal vivo»: tutto ha l’aria di un reportage, ma tutto indi ca con evidenza che è la finzione di un documentario (Kiarostami infatti ha girato molti mesi dopo il terremoto) e che si tratta piut tosto di un documento sulla «finzione»: non nel senso dell’im maginazione dell’irreale, ma nel senso preciso della.tecnica o del l’arte di costruire delle immagini. Perché l’immagine per la quale, ogni volta, ognuno apre un mondo c vi si precede, quest’imma gine non è data bell’è fatta (come lo sono quelle dei sogni, dei fan tasmi, dei brutti film): essa è da fare, da tagliare e da montare. È dunque Y evidenza nel senso in cui, se mi capita di guardare un mattino la mia via che percorro dieci volte al giorno, costruisco per un istante un evidenza * nuova della mia via. Il film è il movimento continuo e mescolato dei suoi due regi stri insieme, registri paralleli e che passano dall’uno all’altro. È la loro continuazione simultanea e la continuazione di ognuno nell’altro: la strada, l’automobile, l’immagine, lo sguardo; la ricerca che va, l’immagine che si presenta; il movimento ininter 46
____ -______________________ E la vita continua___
rotto, il ritmo della visione; la distesa permanente del paese e del popolo, l’interruzione delle vite e dei contatti. Il film registra il terremoto: non, appunto, nel suo immagina rio terrificante - che non potrebbe essere se non l’una di queste due cose: o una ricostituzione da film-catastrofe (fantasma), o una macchina da presa realmente presente e oscillante anch’essa nella rovina c nel laceramento di tutte le immagini, e della vita. Il terremoto è invece qui presente come il limite delle imma gini, come il reale assoluto che è anche il taglio nel nero da cui il film sorge con la sua prima immagine e che prolunga, un po’ più tardi, l’attraversamento di un tunnel durante il quale i titoli di testo vengono ad iscriversi: il film emerge lentamente, esso trova o ritrova poco a poco la possibilità dell’immagine, che sarà innanzitutto, all’uscita dal tunnel, fatta di primi piani di rovine, di camion, di oggetti abbandonati, di spalatrici, di polvere e di blocchi di rocce caduti sulla strada. Bisogna allo stesso tempo uscire dalla catastrofe, trovare la strada verso i villaggi distrutti, e uscire dal nero, trovare l’immagine e la sua giusta distanza. Prima dei titoli di testa, per dieci minuti, ci sarà stupore, rife rimento a ciò che non è il terremoto: la solidità delle costruzio ni in cemento opposte alle costruzioni in fango c mattoni cotti al sole che sono state devastate, oppure l’emigrazione, evocata a proposito di una cavalletta; il ragazzo vorrà fermarsi per fare pipì e sarà sul punto di provocare un incidente mettendo la cavalletta davanti agli occhi di suo padre. La strada dell’immagi ne non è ancora imboccata, sebbene la vettura sia già posta come inquadratura dell’immagine: il bambino che fa pipì in lontanan za filmato dall’interno. Anche «pisciare» sarà nel film un motivo della vita che con tinua, della sua evidenza. Il padre si fermerà a sua volta per pisciare e lì vicino troverà un bambino in un’amaca, la madre del quale sta raccogliendo della legna. Più tardi, essi incontreranno un uomo che porta una pietra da bagno (che noi chiamiamo «alla turca»), essi prendono a bordo l’uomo e la pietra sul portabaga gli. Ci sarà un’inquadratura della mano dell’uomo che fuoriesce dal finestrino per mantenere salda la pietra nelle curve. Il padre 47
Nancy, Abbas Kiarostami
dirà: «L’hai comprata in un giorno come questo?» c l’altro risponderà: «Chi è morto è morto. Chi è vivo avrà bisogno di questa preziosa pietra». (Ripresa dall’alto del tetto della vettura che corre con il gabinetto). L’immagine non è data, bisogna avvicinarla: l’evidenza non è ciò che cade in qualunque modo sotto i sensi, come si dice. L’evidenza c ciò che si presenta alla giusta distanza, oppure ciò di fronte a cui si trova la giusta distanza, la prossimità che lascia aver luogo il rapporto, e che impegna alla continuità. Allo stesso modo, bisogna attendere il momento giusto per ché una musica sia possibile: più di una mezz’ora di film prima di sentire il Concerto per due comi di Vivaldi, mentre una ripre sa dall’alto nella pianura, accompagnata da uno sguardo del padre, mostra da lontano delle persone impegnate in funerali. Fino a qui, non ci sono stati che Ì rumori pesanti delle automo bili, dei camion, delle macchine e degli elicotteri. Fino alla fine ci saranno questi rumori e, sempre più isolato e fragile, quello del motore dell’auto che arranca sulle strade di montagna («Con questa automobile non ci arriverete. Ci sono delle curve perico lose») -, ma si sentirà anche un flauto iraniano, sulle immagini di una casa dipinta di azzurro vivo, con dei fiori (anche il colore viene poco a poco, per tocchi discreti, qualche fiore, un tappeto, l’oleografia sul muro e un gallo in ceramica rossa, gialla, azzur ra, raccolta dal bambino, e questi tocchi resteranno rari, isolati in larghi motivi dominanti di ocra, bruno, grigio, sabbia, verde c azzurro pallido). E il concerto riprenderà, ricomincerà per due volte, il movimento lento, trattenuto, soggiogante per finire sullo scatto di una portiera, prima che il movimento vivace accompagni l’ultima salita dell’automobile che si perde sulle ripide alture. Il tripudio di questa musica finale non è tuttavia una risoluzione della tensione: la musica resta nello stesso tempo a distanza dall’immagine e dal rumore del motore, allo stesso modo in cui la macchina da presa resta a distanza dall’auto che si allontana, e il film a distanza da questa vita che esso continua e che continua incontro ad esso. 48
__ E la vita continua____________________________
La giusta distanza dell’immagine non è una questione di media: il primissimo piano conviene tanto quanto il campo lun ghissimo, o l’inquadratura stretta, bordata (i finestrini dell’auto) tanto quanto l’inquadratura senza bordi dello schermo intero, e il piano fisso tanto quanto il movimento rapido alla velocità del l’auto. La giusta distanza è esattamente una questione di giusti zia. Se la vita non continua in un modo qualsiasi, attraverso uno stralunato sonnambulismo, ma esponendosi all’evidenza delle immagini, è perché rende giustizia al mondo, a se stessa. La questione della giustizia accompagna tutto il film. Ci si chiede se è giusto che le case degli uni resistano e quelle degli altri no, se è giusto che un paese soffra più di un altro di cata strofi naturali, se è giusto che queste catastrofi si verifichino, se sono la volontà di Dio, oppure la sua punizione («Veramente non so quale crimine abbia commesso questo popolo per essere così severamente punito da Dio», dice un uomo), se è giusto che gli uni siano morti c gli altri no (coloro che erano andati a vede re la partita, oppure gli altri, un bambino di una famiglia e non le sue sorelle o i suoi fratelli). Quando il bambino domanda a suo padre se può prendere una bottiglia di cola da un esposito re abbandonato, il padre risponde: «Sì, ma lascia il denaro vici no». La cola è troppo calda, il bambino la getterà via, lo chiama no da un’altra automobile: «Non gettarla via, dammela per il bimbo». (Si sente il bimbo piangere). La giustizia è innanzitutto prendere la misura del reale. Il bambino dice a una donna, a cui e morta una figlia: «Dio non ama uccidere i suoi bambini». La donna: «Allora chi è che ucci de?» - e il bambino: «Il terremoto». E il bambino racconterà la storia di Abramo e Isacco, storia emblematica per tutte le tra dizioni del Libro, della giustizia che sorge e che risalta in piena ingiustizia. Dire «il terremoto» è dire il reale nudo. È dire anche che forse non c’è Dio che ama e protegge i suoi bambini, oppure che que sto Dio non ha niente a che fare con il reale. È prendere la giu sta distanza con la credenza in Dio. L’immagine della vita mette l’immaginario a distanza. 49
------------------------------------ Nancy, Abbas Kiarostami
Non si tratta di rendere giustizia all’ingiustizia, ossia di sottomettervisi. Si può costruire in maniera da ridurre gli effetti dei terremoti. Si può opporre la ragione alle credenze fataliste. Bisogna, innanzitutto, parlare correttamente: un ragazzino dice: «Mio padre dice che è la volata di Dio»; il padre: «Che cosa di Dio?», «La volata di Dio», «Non si dice la volata, ma la volontà». Si tratta invece di rendere giustizia a ciò che interrompe il senso, a ciò che taglia la strada, a ciò che separa le genti le une dalle altre e ciascuno da se stesso. Si tratta di rendere giustizia alla vita nel momento in cui si viene a conoscenza della morte. Venire a conoscenza della morte significa venire a conoscenza del fatto che vi è un arresto assoluto, di cui non vi è nulla da conoscere. Ma venire a conoscenza di questo significa rendere giustizia all’evidenza della vita. L’uomo che si era applicato una gobba sulle spalle nel film precedente dice: «Quei signori mi avevano messo questa gobba per sembrare più vecchio. Ho obbedito, ma non mi è piaciuto. Ho trovato che fosse ingiusto. Che razza di arte è mostrare la gente più vecchia c più brutta di quanto sia in realtà? Arte è mostrare l’uomo più giovane. Il contrario non è arte». Il padre (il cineasta) gli risponde: «Grazie a Dio tu sci sopravvissuto e sembri più giovane». L’altro: «Nessuno può apprezzare la giovi nezza fintantoché non è vecchio. Nessuno può apprezzare la vita fintantoché non ha visto la morte. Se si potesse morire é resuscitare, si vivrebbe meglio». Non c’è resurrezione: non c’è che una vita e nient’altro che la vita, e il fatto che essa continua e discontinua continuamente. La vecchiaia è la continuazione per la quale la giovinezza è ciò che è, una giovinezza. La morte è la continuità sospesa per la quale la vita è ciò che è: una vita che continua fino alla fine. L’arte alte ra la realtà immediata, ma per far vedere l’evidenza - o più esat tamente (poiché il film non è la vita), per fare vedere che c’è que sta evidenza e questa giustizia. La vita va fino alla fine - è la sua giusta misura, ed è così che va sempre al di là di se stessa. Diciamo: è così che è un’esistenza 50
------------------------------------------ E la vita continua
e non soltanto una vita naturale, che attraverserebbe, indifferen te, le catastrofi dallo stesso nome. L’esistenza resiste all’indiffe renza della vita-delia morte, essa vive al di là della «vita» mecca nica, è sempre il proprio lutto e la propria gioia. Essa prende figura, immagine; non si aliena nelle immagini, ma vi si presen ta, le immagini sono l’evidenza della sua esistenza, l’oggettività della sua attestazione. Questo pensiero - che è, per me, il pensiero di questo film è un pensiero difficile, il più difficile forse. È un pensiero lento, sempre sulla strada, che si apre una strada perché la strada stes sa sia il pensiero. Che apre delle immagini perché le immagini siano questo pensiero, perché siano l’evidenza di questo pensie ro - e non perché lo «rappresentino». Il cinema può voler rappresentare, può anche andare verso il fantasma, oppure verso l’iconografia, può volersi «visiona rio» oppure formalmente «visuale», ma così come nessuna di queste direzioni sussiste mai allo stato puro e semplice (oppu re è uno scacco, un cinema maniacale), allo stesso modo pro babilmente esso vi mescola sempre anche qualcosa di questa dimensione dell’evidenza, che questo film lavora per se stessa. La certezza, non semplicemente della giustezza di un’immagi ne (che può appartenere all’immagine immobile, pittura o foto), ma della giustezza e della giustizia di un movimento d’approccio all’immagine, di un movimento che dipende con temporaneamente dallo scoprimento, dalla rivelazione, dalla venuta e dalla tenuta a distanza: veder venire e passare qualco sa di vero, non un’immagine veridica, ma la verità della vita che porge delle immagini a se stessa.
{Ancora una parola: potrebbe essere che Abbas Kiarostami, in un omaggio discreto alla cultura del suo popolo, e dalla distanza di un non credente, abbia pensato alle sure 98 e 99, che si intito lano rispettivamente L’evidenza e II terremoto? L'ultima comin cia così: «Quando la terra avrà provato un violento terremoto / E avrà rigettato i fardelli dal suo seno, / L'uomo dirà: quale spet tacolo! / In questo giorno, la terra racconterà ciò che sa»). 51
--------------------------- ------- Nancy, Abbas Kiarostami
Post scriptum Leggo nei «Cahiers du cinema» un’intervista a Kiarostami, il quale sta girando un nuovo film, un seguito di E la vita con tinua, del quale prosegue la storia, ma di cui vengono anche svelati certi artifici (per esempio, il matrimonio qualche giorno dopo la catastrofe era una finzione). Il cinema dunque conti nua, Kiarostami continua a portarlo alla luce in quanto cinema. Il cinema passa da una sequenza all’altra (enchaine), su se stes so, indefinitamente, come uno scoprimento di sé virtualmente infinito: da una parte, ogni nuovo scoprimento può racchiude re un nuovo artificio, e lo racchiude necessariamente, e d’altra parte ciò che vi è da scoprire non è niente «in sé». Ciò che spet ta propriamente al cinema, oltre alla narrazione e all’immagine, oltre al montaggio e alla ripresa cinematografica, oltre alla sce neggiatura, agli attori, ai dialoghi - tutti clementi che possono riferirsi ad approcci quasi letterari, quasi pittorici, addirittura quasi musicali -, ciò che spetterebbe dunque propriamente al cinema sarebbe questa singolare maniera di non essere altro che il passare da una sequenza all’altra (enchaìnement), dell’e videnza. Le altre arti possono presentare l’evidenza di una verità, di una presenza, in breve di una «cosa in sé» - un’evi denza che chiamerei piuttosto, per differenziarla, una patema (pensando alla verità secondo Spinoza, che se ipsam patefacit, che si manifesta essa stessa et nullo egeat signo, e non ha biso gno di alcun segno). Il cinema riprende anche questo gesto, questa presentazione. Ma ciò che vi aggiunge di proprio, la proprietà più propriamente distintiva del cinema, e forse anche la meno possibile da distinguere, la proprietà indistinguibile di tutto l’enorme flusso di film nel mondo, è il concatenamento, lo scorrimento indefinito della presentazione lungo se stessa. Verso dove scorre così? In un certo qual modo verso l’insignificanza (là dove le altre arti richiamano piuttosto a un eccesso di significanza). Verso l’insignificanza della vita che porge le sue immagini, sempre in movimento, per non andare verso 52
______________________
__ E la vita continua__ __________________________
alcun mistero, alcuna rivelazione, nient’altro che questo scor rimento su se stessa per il quale essa si porta da immagine ad immagine (esemplari, sublimi, banali, grottesche, ingenue, adulterate, abbozzate, sovraccariche). Una vita che si fa il suo cinema. Che strana storia quella di una civiltà che si è data que sto, che a questo si è concatenata... Uno stordimento estremo, è vero, uno stato febbrile di scoprimento e di effetti speciali innestati l’uno nell’altro a perdita d'occhio^ è vero; un sovrac carico di effetti, di parvenza, c vero. Il cinema è marcato dai segni più pesanti, più ambigui - il mito, la massa, il potere, il denaro, la volgarità, i giochi del circo, l’esibizione e il voyeuri smo. Ma tutto questo trasportato a tal punto in uno scorri mento senza fine che l’evidenza è quella del passaggio, piutto sto che qualsiasi epifania di senso e di presenza. Il cinema c certo l’arte - la tecnica, in ogni caso - di un mondo che sospen de i miti. Anche se si è messo esso stesso al servizio dei miti, finisce, al limite, per trasportarli e trascina nell’evidenza del movimento tutte le epifanie di sensi e di presenze immobili. Un mondo che concatena, che va da un film all’altro, e che insegna così, molto lentamente, un altro modo di fare senso.
53
Conversazione tra Abbas Kiarostami c Jean-Luc Nancy Trascritta da Mojdeh Famili e Teresa Faucon
ABBAS KIAROSTAMI
[Jean-Luc Nancy apre la conversazione parlando della minia turapersiana...]
AK: Una studentessa in tesi mi ha mostrato una serie di im magini in cui ho notato una somiglianza sorprendente tra certe riprese dei miei film e alcuni dettagli delle miniature: la presen za di alberi e di sentieri sinuosi. Eppure io non mi sono mai sen tito veramente vicino alla miniatura persiana. Per me è stata una strana scopèrta vedere che c’era un possibile accostamento. For se siamo giunti a uno stesso pensiero intorno all’albero o ai sen tieri a zig zag perché viviamo, i miniaturisti e io, nella stessa na tura e nello stesso paese? Non si tratta di copie volute, ma di ve re somiglianze probabilmente.
JLN: Ma Lei non si è mai sentito vicino alla miniatura?
AK: Alle Bèlle Arti di Teheran avevamo un corso sulla minia tura persiana che non mi interessava particolarmente. Per questa ragione, anche se vi sono delle somiglianze, non si tratta co munque di un’influenza. Queste somiglianze attingono alla na tura in cui noi tutti abbiamo vissuto e che ci ha tutti nutriti. In Iran ci sono ancora dei luoghi remoti che non sono stati trasfor mati dalla vita moderna. Si possono vedere sentieri, alberi, ci pressi simili a quelli delle miniature. Se li fotografo, posso dire che essi ricordano le miniature. Nel corso dei secoli, questo tipo di paesaggio o di composizione è emerso dal cuore di questa na tura e ha trovato un senso. 57
_ Nancy, Abbas Kiarostami.
JLN: Comprendo questa comunità di pensiero e, anche se non conosco l’Iran, posso immaginare questo tipo di paesaggio in cui l’albero si staglia solitario. Per la miniatura, è altra cosa. Si tratta dell’immagine. Vi è una cultura iraniana dell’immagine al di fuo ri della miniatura? D’altra parte, si dice «miniatura» in persiano? Sento infatti che lei dice «miniatura», ed è una parola latina si curamente presa a prestito recentemente. Come si dice nella tra dizione persiana?
AK: Come per molte cose create in Iran, c possibile in effetti che la parola sia venuta dall’occidente. Noi abbiamo dipinto, ma il nome è stato dato da altri ed è questo nome che si è affer mato. Talvolta abbiamo trovato dei sinonimi in persiano, ma non penso per la miniatura. Mi è difficile dire l’epoca dell’entra ta in uso di questo termine nella lingua persiana. Dev’essere molto recente, nel XIX secolo forse, poiché noi non abbiamo sempre cercato di trovare un sinonimo. È successo lo stesso per il quadro che rappresenta il volto: si utilizza il termine portrait' [ritratto]. Certo è da molto tem po che dipingiamo il volto, ma solo più tardi lo si è chiamato portrait.
JLN: E per il paesaggio?
AK: Per il paesaggio, abbiamo l’equivalente in persiano: manzarehy anche se si utilizza pure la parola paysage [paesag gio]. Così per tabiat-e bidjàn si impiega anche nature morte1 [natura morta]. JLN: Allora come si dice questo? [Mostra il ritratto di una donna a mezzobusto}. Nfc. Un «ritratto badasi»', un ritratto che rappresenta anche le mani. : Kiarostami pronuncia questo termine in francese. ? Kiarostami pronuncia questo termine in francese. 58
__________ Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy_________
JLN: Ritorno alla questione dell’immagine. Al centro di quel lo che in persiano si chiama Soltanto la vita / La vita e nienfaltro (E la vita continua) c’è comunque questa immagine sul mu ro: un ritratto, quasi un ritratto con una mano, con una pipa. È una foto o la foto di una pittura?
AK: Non si tratta di una foto, ma di una pittura di stile popo lare da cui si è ricavato un manifesto molto diffuso in tutti i vil laggi dell’Iran da dieci o dodici anni a questa parte.
JLN: Chi o che cosa rappresenta? AK: È un’immagine emblematica del contadino felice. Con la sua tazza di tè, un pezzo di pane, un po’ di carne, la sua pipa o più precisamente la sua chopoq\ Nell’immaginario della gente è l’im magine ideale del contadino nel momento più felice della sua vita. JLN: Nel film quest’immagine è attraversata da una crepa.
AK: L’ho fatta io stesso quella crepa, per una ragione simboli ca. Come si vede nel film, il contadino è separato da tutto ciò a cui teneva:, il suo pane, la sua tazza di tè, la sua carne. I suoi mez zi di sussistenza si sono trovati ad essere minacciati. Il sisma ha creato un abisso tra lui c i suoi beni. Ma il suo stato d’animo è rimasto lo stesso. È per questo che in Iran questa immagine è stata il manifesto del film E la vita continua, sulla quale avevo aggiunto: «la terra ha tremato, ma noi non abbiamo tremato». JLN: Si percepisce agevolmente il messaggio anche se non si sa nulla di questo pittore e della particolarità dell’immagine in questione; la messa in scena, infatti, dà molta forza a questo momento: il regista guarda fuori, vede le rovine, si gira e vede l’immagine. 1 La chopoq è una pipa tradizionale a rubo lungo utilizzata soprattutto dai contadini.
59
________________________Nancy, Abbas Kiarostami
Vi c anche tutto un rapporto del film con l’immagine, non soltanto nel contenuto. L’Iran resta, la tradizione resta - noi non abbiamo tremato -, ma questo avviene anche in rapporto a due specie di immagini: l’immagine del pittore c l’immagine del film. Ha veramente visto da qualche parte quest’immagine lacera ta o ha approntato tutto lei? AK: Questa lacerata dalla spaccatura e un’immagine impossi bile. Un manifesto appiccicato al muro sarebbe caduto al mo mento del terremoto. Solo una pittura murale avrebbe potuto creparsi in questo modo. Ho dunque trovato un muro spaccato, ho applicato l’immagine contro la spaccatura, disposto una luce dietro per poter tracciare precisamente questo movimento a zig zag sull’immagine e poi l’ho lacerata.
JLN: Mi sono sempre domandato com’era possibile che un’immagine incollata al muro fosse stata lacerata da una crepa, ma avevo finito per crederlo. AK: L’ho acquistata in una sala da tè qualunque presso un vil laggio e l’ho portata sul luogo delle riprese. Per me, si tratta di qualcosa di molto vicino al senso del film. In seguito al terre moto questo contadino ha perduto tutto, la sua chopoq gli è ca duta dalle mani. D’altra parte lei gli attribuisce una pipa! Gio cando con le parole, dirci che quest’immagine non rappresenta soltanto la realtà, essa possiede anche una verità. Questa verità è che la sua chopoq è diventata una pipa perché la sua sorte è di ventata migliore4. Penso che se un evento non causa la nostra morte ci rende più forti, può migliorare la nostra vita. JLN: Quale importanza riconosce al fatto che questa sia un’immagine? La stessa cosa, infatti, avrebbe potuto essere mo strata con un vecchio in carne e ossa, così come si vedono altri * La chopoq potrebbe simbolizzare la vita contadina, mentre la pipa testimo nia una maggiore agiatezza materiale.
60
Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy
personaggi che sono sopravvissuti al terremoto. Ma, qui, ap punto, si tratta di un’immagine.
ÀK: Non credo di essere capace di poter inventare tutto. Io la voro come lavorano altri. E talvolta penso che possiamo soltan to scegliere ciò che altri hanno già realizzato. All’epoca mi ponevo questa domanda: perché questo manife sto è così popolare e perché lo si ritrova in tutte le case? Se arri viamo a trovare la risposta comprenderemo che scegliere ha tan ta importanza quanto pensare. Penso che quest’immagine, come un libro sociologico o psicologico sulla vita contadina, possa ap portare del senso o delle risposte a numerose domande. Perché si tratta di un’immagine emblematica che rappresenta il culmine dei sogni di un contadino iraniano.
JLN: Ecco perché è così diffusa. AK: Sì, ma nessuno probabilmente ne conosce la ragione. Quest’immagine rappresenta i sogni e le speranze dei contadini. Al tempo stesso, essa costituisce uno specchio nel quale ricono scersi. Che cosa può essere la vita di un contadino?... la sua car ne, il suo pezzo di pane, il suo tè e il suo tabacco. Se questo di spositivo è qui, la vita è qui, la felicità è qui. È quello che si ve deva durante il terremoto, come ricorda la scena nella quale una donna anziana non cerca suo marito sotto le macerie, ma il suo bollitore per fare il tè. Si dice che per lavorare in un villaggio si debba conoscere la sociologia degli ambienti rurali. Quest’immagine mi ha aiutato. Quando l’ho trovata, ho capito che mi sarebbe servita. Per esempio, in tutte le sale da tè sul limitare del deserto si trova l’immagine di una montagna nevosa con una prateria da una parte e dall’altra un ponte su di un piccolo fiume dove nuo tano alcune anatre. Questo tipo di rappresentazione è assai ap prezzata in queste regioni dove le popolazioni non hanno mai visto nature verdeggianti e ne sono prive. Se un giorno filmassi in un deserto quest’immagine sarebbe inevitabile. 61
________________________ Nancy, Abbas Kiarostami
JLN: Anche ne II vento ci porterà via ci sono delle immagini in una casa, di cui non ricordo con esattezza il soggetto. Le si ve dono meno distintamente (non in primo piano). Ma all’interno delle stanze si vede che ci sono delle immagini.
AK: In tutte le case la gente ha delle foto che le appartengono oppure delle foto proprie. Ma se la macchina da presa non entra, queste foto non verranno mai mostrate. JLN: Mi sono domandato come si giocasse il rapporto tra im magini o foto suggerite c il fatto che tutto questo film sia una sto ria di foto da non fare e di foto alla fine rubate dall’etnologo - fo to o film, del resto, poiché egli doveva filmare le donne in lutto e alla fine farà invece delle foto. All’inizio, d’altra parte, una donna gli vieta di servirsi della sua macchina fotografica.
AK: La macchina da presa non mostra alcuna immagine per ché io non ne avevo l’intenzione. Ma il fatto che la donna non permetta all’uomo di fotografarla deriva da ragioni culturali, dal la tradizione. Assai spesso nei villaggi - come in Africa, in cui ho girato recentemente - quando la gente, uomini o donne, impara no a conoscere la macchina fotografica, non permettono, non amano che li si fotografi. La sua interpretazione dell’immagine e della fotografia c ap passionante. Mi capita di pensare che una foto, un’immagine, abbia più valore di un film. Il mistero di un’immagine resta si gillato perché non ha suono, non vi e niente attorno . * In occasione di un dibattito in Dordogna sul paesaggio (set tembre 2000) ho presentato due foto di uno stesso paesaggio con qualche albero. Non erano accompagnate da nessun commento. Quindici anni separano queste due foto e, quando le guardo, so no spaventato. Sono appunto due immagini prese esattamente nello stesso luogo e con la stessa angolazione, e rappresentano lo ' Questa idea di «attorno» potrebbe essere compresa come la nozione occi dentale di fuori campo, si veda JLN più avanti (pp. 63-4).
62
Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy
stesso paesaggio. Ma nel frattempo qualche albero è scomparso e neirimmagine più recente si vede la loro assenza. In momenti come questi, mi sento più fotografo che cineasta. Mi capita di pensare: come fare un film in cui non dire nulla? Questo mi è apparso evidente dopo la lettura del suo testo. Se delle immagini possono dare una tale forza all’altro per inter pretarle e trarre un senso che non sospettavo, allora è meglio non dire niente e lasciare immaginare tutto allo spettatore. Quando si racconta una storia, non si racconta che una storia e ogni spettatore, con la sua capacità di immaginazione, intende una storia. Ma quando non si dice niente è come se si dicesse una moltitudine di cose. Il potere passa allo spettatore. André Gide diceva che l’importanza sta nello sguardo, e non nel soggetto. E Godard dice che ciò che è sullo schermo c già morto: è lo sguar do dello spettatore ad insufflargli la vita. Ho letto parecchie volte il suo testo, e ho pensato che la re sponsabilità di essere cineasta è così grande che preferirei non realizzare dei film.
JLN: È un po’ tardi per questo! AK: Non è ancora troppo tardi! JLN: Vorrei dire che comprendo molto bene questo desiderio di voler arrivare a un’immagine, soltanto un’immagine. Ma ciò che lei dice in generale del film in rapporto alla fotografia non è completamente vero, se così posso dire. Perché non è necessario che vi sia il sonoro. Il cinema è stato per molto tempo muto e lei stesso spesso introduce la musica molto avanti nei suoi film anche se ci sono le parole. Dunque per quanto riguarda il suono è discutibile. Si può anche criticare questa nozione di assenza di attorno, assenza di fuori campo, poiché, in ogni istante, ciò che è sullo schermo è una foto. Il cinema in fondo non è altro che ventiquattro foto al secondo. Infine, la storia. Lei fa di tutto per ridurre la storia quasi al grado zero. È appena un abbozzo di storia, non è mai veramente una storia. Il suo cinema sta già an 63
Nancy, Abbas Kiarostami
dando verso ciò che Lei vuole. Aggiungerei che se si pensa alla conclusione de II vento ci porterà via, alla fotografia e all’ultima inquadratura di Dov’è la casa del mio amico? - anche se non si tratta di una foto, ma di un quaderno - c’è sempre un’immagi ne. Bisognerebbe forse considerare tutti i finali. Anche quello de Il sapore della ciliegia ha nuovi sviluppi sul cinema, si tratta co munque di quest’immagine che viene non si sa da dove, da un occhio che si trova nella fossa o che non si trova nella fossa. In generale, i finali dei film portano a una sorta di immagine, qual cosa dell’ordine dell’immagine fissa. AK: Sono sempre più persuaso del potere di richiamo di que st’immagine, della possibilità che essa dà allo spettatore di entra re profondamente in essa e di farne la propria interpretazione. Ora, nella ripresa dove c’è del movimento - dove un elemento entra in un determinato momento ed esce in un altro - la con centrazione è ridotta, l’attenzione dello spettatore non può re stare mobilitata. Come quando si parte per un viaggio. Attra versando l’atrio di una stazione incrocio centinaia di persone. Ma la sola persona di cui mi ricorderò è il passeggero che si siedcrà davanti a me e che avrò il tempo di fissare. Forse l’avrò già incrociato prima, ma senza aver avuto il tempo di concentrare la mia attenzione su di lui. Ora la sua immobilità mi permette di fissarlo come un’immagine. Allora la mia facoltà di interpreta zione si attiva. I dettagli del suo volto, i dettagli di altri visi che quel viso evoca, cominciano a prendere forma nella mia mente. Infatti, esattamente nel momento in cui mi sistemo come una macchina da presa, lui si dispone come un soggetto e si fissa co me un’immagine. Il che mi fa pensare alla macchina da presa di Bresson che non permette questo tempo dà fixation [fissazione]4. E come una finestra immobile che si apre su di un paesaggio: il tempo di una malinconia, si fissa attraverso di essa un solo al bero che si trova di fronte. Quest’albero fa la stessa cosa di una persona. E tu pensi che non lo cambieresti per tutti gli alberi del * Kiarostami pronuncia questo termine in francese. 64
Conversazione era Abbas Kiarostami e Jcan-Luc Nancy---------------
mondo. Quest'albero ti promette qualcosa di costante. Tu hai un appuntamento con lui. Tu ci vai e lui c'è. Mi sembra che queste cose fìsse abbiano la capacità di solle citare i nostri affetti.
JLN: Questo mi fa pensare a due cose. In quanto occidentale, molto occidentale (io non so come lei si consideri tra i due, orientale e occidentale), sono completamente preso dalle que stioni dell’immagine come rappresentazione, ossia come copia, come imitazione esteriore della realtà. Ora, nelle sue parole vi è per me qualcosa che appare risolutamente orientale: l’immagi ne come presenza, come forza. Il che si allaccia alla pittura ci nese con l’importanza del tratto del pennello dimostrata in ma niera esemplare nel trattato: L'unico tratto di pennello. C’è una dimensione Oriente/Occidente e una dimensione storica nel ci nema che mi hanno molto colpito nei suoi film. È vero che Bresson c vicino a tutto ciò e che nel cinema questo c’è sempre stato. Ma mi sembra che per molto tempo il cinema si sia piut tosto voluto esso stesso come narratore di storie (con tutto un materiale mitologico, come il romanzo poliziesco, le gradi sto rie d’amore, il cinema storico) e come un’arte che ha la potenza di restituire il movimento. Adesso si entra in un’altra epoca in cui appunto si tratta molto meno di raccontare delle storie o di essere fedele al movimento e a una riproduzione della totalità animata, sonora ecc. Il cinema si mette di fronte alla realtà at tuale ed è meno legato al movimento e correlativamente meno legato al fuori campo, alla storia, perché non accade più nulla al di fuori dell’immagine. AK: Finora non ho potuto trovare una definizione di cinema. Se si ritiene che il cinema abbia il dovere di raccontare delle sto rie, mi sembra che il romanzo lo faccia assai meglio. I pezzi ra diofonici, gli sceneggiati televisivi assolvono anch’cssi a questo compito. Penso a un altro cinema che mi rende più esigente e che viene definito come la settima arte. In questo cinema c’è della musica, della storia, della fantasticheria, della poesia. Ma pur in 65
—--------------------------------Nancy, Abbas Kiarostami-------------------------------------
eludendo tutto questo penso che resti un’arte minore. Io mi do mando, per esempio, perché la lettura di una poesia ecciti la no stra immaginazione e ci inviti a partecipare al suo compimento. Le poesie sono probabilmente create per raggiungere un’unità malgrado la loro incompiutezza. Quando vi si méscola l’imma ginazione, la poesia diventa mia. La poesia non racconta mai una storia, essa dà un insieme di immagini. Se io ho una rappresen tazione di queste immagini nella mia memoria, se ne possiedo i codici, posso accedere al suo mistero. Per la stessa ragione, posso affezionarmi oggi a una poesia della quale non ho capito nulla dieci anni fa. Penso alle poesie mistiche di Maulama Rumi7 che mio padre leggeva quand’ero bambino e che tolleravamo perché si trattava di nostro padre. Le ho rilette dieci anni fa, le rileggo oggi c vi trovo un altro senso che mi era sfuggito. Ho visto raramente qualcuno dire a proposito di una poesia: non capisco. Ma al cinema appena non si è colto un rapporto, un legame, è frequente dire che non si e capito il film. Ora, l’incomprensione fa parte dell’essenza del la poesia. La si accetta come tale. Lo stesso per la musica. Il ci nema c differente. Affrontiamo una poesia con i sentimenti c il cinema con il pensiero, con l’intelletto. Non si presume di po ter raccontare una buona poesia, mentre si ritiene di poterlo fa re per un buon film quando si è al telefono con un amico. Pen so che se il cinema dev’essere considerato come un’arte mag giore gli si debba accordare questa possibilità di non essere ca pito. In diversi momenti della vita un film può suscitarci di verse impressioni. Ora, il cinema è diventato sempre più un oggetto, uno stru mento di divertimento che bisognerebbe vedere, comprendere e giudicare. Se lo si considera veramente come un’arte, la sua am biguità, il suo mistero sono indispensabili. Una foto, un’imma gine può avere un mistero, perché essa dà poco, non descrive molto. Lei dice che un’immagine non rappresenta nulla, non si ' Grande poeta mistico di lingua persiana e della civiltà irano-isiamica del XIII secolo. 66
Conversazione ira Abbas Kiarostami c Jean-Luc Nancy
dà come rappresentazione ma annuncia la sua presenza, invita lo spettatore a scoprirla.
JLN: Quello che mi colpisce è questo giudizio sul cinema co me se procedesse da un rapporto interiore del cinema con se stesso. Vorrei dire due cose. Innanzitutto, fin dall’inizio c’è nel cinema il potere di cogliere una totalità con il movimento, di rac contare delle storie con l’immagine e il suono. È anche essenzia le che ciò abbia corrisposto a un momento della storia in cui vi era l’idea d’opera d’arte totale. È un’espressione di Wagner, c si potrebbe dire che è un cinema wagneriano. Evidentemente, si tratta anche di un incredibile strumento per mostrare, deittico se vuole e, quasi dall’inizio, Dziga Vertov o Eisenstein in un altro modo e qualsiasi grande cineasta (Hawks, Dreyer, ma anche Rossellini, Bresson...) hanno fatto delle immagini in questo sen so anche se attingevano da materiali di storie mitologiche (il we stern, la guerra). È come se riprendessero ciò che in un certo modo è sempre stato qui nel cinema. Tuttavia ciò che c’è qui non è soltanto foto, oppure per scoprire che cosa fosse la foto forse occorreva il cinema; perché la foto venisse, perché non fosse sol tanto qui in questo modo. AK: Io non sopporto il cinema narrativo. Esco dalla sala. Più racconta una storia e quanto meglio lo fa, più grande diventa la mia resistenza. Il solo mezzo per progettare un nuovo cinema è quello di considerare di più il ruolo dello spettatore. Bisogna progettare un cinema incompiuto e incompleto affinché lo spet tatore possa intervenire e riempire i vuoti, le mancanze. Invece di fare un film con una struttura solida e impeccabile, bisogna indebolirla - pur essendo consapevoli che non si deve far fuggi re lo spettatore! Forse la soluzione è quella di incitare appunto lo spettatore ad avere una presenza attiva e costruttiva. Credo di più a un’arte che cerca di creare la differenza, la divergenza tra le persone piuttosto che la convergenza dove tutti sarebbero d’ac cordo. In questa maniera c’è una diversità di pensiero e di rea zione. Ciascuno costruisce il suo proprio film, che aderisce al 67
___ Nancy, Abbas Kiarostami
mio film, lo difende o vi si oppone. Gli spettatori aggiungono delle cose per poter difendere il loro punto di vista e questo at to fa parte dell’evidenza del film. E con una certa debolezza, con una mancanza, che bisogna andare alla guerra contro le potenze. jl.N: A proposito di vuoti: mi ricordo di un’inquadratura completamente grigia in Hiroshima, mon amour. Avevo di ciannove anni ed ero già un po’ pratico - non so come d’altra parte -, ma compresi che si trattava di un’immagine. Nello stesso momento nella sala accanto a me una vecchia signora gridò: «Ah! C’è un guasto». Ci sono due sguardi: uno com prende che c’è un buco nel film, l’altro no. AK: Sono questi buchi, questi momenti di «avaria» che co struiscono. Questo è il mio sogno. Non mi aspetto che le cose cambino. Conosco il potere delle abitudini.
JLN: Eppure c’c un segno che le cose stanno cambiando: sem plicemente il successo dei suoi film. So bene che non è lo stesso pubblico che va a vedere E la vita continua c un qualunque film catastrofico come Indipendence Day. Ma i suoi film sono fre quentati e questo successo prova qualcosa, perché questo pub blico diceva da vent’anni che il cinema era finito a partire dalla fine del neorealismo. Godard ha parlato molto di questa morte del cinema, anche troppo. Da allora, altre cinematografie, cine se, taiwanese, coreana hanno fatto altre cose.
[La conversazione cambia argomento, l’attenzione viene atti rata da una foto del XIX secolo nella quale un personaggio di spalle guarda verso l’infinito di un paesaggio]. AK: Credo che l’interesse di questa immagine stia nel fatto che essa ci obbliga ad indovinare il soggetto di spalle, ci priva dal guardarlo di fronte. Il volto è invisibile, lo sguardo anche. Dobbiamo dunque indovinare chi sia, quale sia la sua origine sociale con l’aiuto di altri elementi - i suoi vestiti, la sua accon68
Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy
datura, la spilla che porta nei capelli. Questi segni hanno un forte potere di evocazione e, nello stesso tempo, non ci costrin gono a ricordare un volto particolare. Poiché niente è definito, tutto c in divenire costante. JLN: Questa immagine, come qualche altra in fotografia o in pittura, mostra di spalle un volto che guarda altrove. Il mondo di Christina di Wyeth, dipinto molto conosciuto in America, rappresenta una donna allungata in una prateria di cui non si ve dono che le.spalle. Uno sguardo visto da dietro, ogni volta, in vita il nostro sguardo a entrare in quello. Il mio sguardo diven ta quello di questa donna.
AK: Mi ricordo di un dipinto in cui tre personaggi guardano fuori dal quadro. Questa immagine mi sembrava avere due fun zioni. Noi guardiamo questi personaggi e costoro invitano il no stro sguardo verso un punto sconosciuto. Il quadro rappresenta tre donne e mi sembra che ciascuna evochi un’emozione, un sen timento differente. Vi sono due giovani donne e una donna più vecchia che potrebbe essere la loro madre. Immagino che guar dino un uomo. Noi abbiamo dunque tre sguardi differenti su di un uomo. Le giovani donne lo guardano con fascino o attratti va. La donna più anziana ha uno sguardo critico e sembra non apprezzare lo sguardo delle più giovani. Il valore di quest’im magine sta nel fatto che noi guardiamo i personaggi e che i per sonaggi ci dicono di guardare altrove. In quanto cineasti o fotografi, si rende servizio alla gente e nello stesso tempo la si tradisce. Noi siamo quasi al posto di Dio: si scelgono alcune cose che non si danno a vedere e non gli si di ce di che cosa li si priva. Il cinema per quanto dia a vedere limi ta lo sguardo. Perché esso limita egoisticamente il mondo a una faccia del cubo e ci priva delle altre cinque. Questo non perché la macchina da presa non si muove. Infatti non si vede di più se essa si sposta, in quanto mano a mano che si ha accesso a una faccia, si perde l’altra. I film che, come questo quadro, rinviano a un altrove sono più creativi o più onesti. 69
Nancy, Abbas Kiarostami
JLN: Ho un’interpretazione quasi inversa a partire da un altro cubo. Lei parla del cubo della visione. Ma anche nella realtà non si vedono mai se non due o tre facce del cubo, ce ne sono sem pre altre che restano nascoste ed è a partire da qui che tuttavia si vede la totalità. Vorrei parlare del cubo della sala cinematografi ca. Qui vi sono 3, 4, 5 facce completamente oscure e una lumi nosa: lo schermo. Su questa superficie, il cineasta esercita il suo potere. Ma lo schermo è nello stesso tempo la faccia dell’altro cubo di cui esso fa vedere anche la totalità. Il reale della sala nel la quale sono è in qualche modo sospeso. E qui vado in un’altra realtà, nella realtà o nella verità come lei diceva poco fa.
AK: Penso che noi limitiamo lo spettatore. È vero che nella realtà non si può vedere più di una faccia, ma noi possiamo de cidere di girare la testa e di guardare altrove, verso il rumore che viene dall’esterno. In una sala cinematografica noi cineasti fissia mo fermamente lo spettatore e il suo sguardo.
JLN: Sì, ma non si vede niente nella realtà. Salvo forse se si c cineasta.
AK: Penso che uno spettatore ordinario non abbia meno me rito di un cineasta. Questo stesso spettatore, in un ristorante, può essere migliore spettatore che al cinema. In casa sua egli può indovinare anche attraverso un doppio sipario ciò che suc cede dai vicini. Indovina se sono sposati, se la figlia si preoccu pa per suo padre. E per questo non ha a sua disposizione che un sipario grigio. In queste situazioni ordinarie si è affatto capaci di guardare la gente da lontano e di ben vedere proprio per la ragione che si trova nel suo testo. Perché queste persone non si trovano in una rappresentazione, esse hanno una presenza. JLN: Sì, ma direi che quando si guarda in questo modo si pos siede già uno sguardo da cineasta, da pittore, da fotografo o da romanziere... Il mio sguardo è istruito dai cineasti, attraverso i 70
Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy
film o le foto che ho visto. Se faccio così [gira la testa], si pro duce una specie di inquadratura, una specie di atteggiamento da riprese cinematografiche. AK: Penso che ciascuno sia curioso e che questa curiosità umana non sia specifica del creatore. Chiunque dia prova di questa curiosità è un buono spettatore.
JLN: Bisogna avere attenzione per la gente e per le cose. AK: Ciò mi fa pensare a un aneddoto su Balzac che ad una mostra si attarda davanti a un quadro che rappresenta un casci nale con un caminetto fumante in un paesaggio nevoso. Egli domanda al pittore quante persone vivano in questa casa. Il pit tore risponde che non lo sa. Balzac ribatte: «com’è possibile? Se sei tu che hai dipinto questo quadro, devi sapere quante perso ne vi abitano, quale età hanno i bambini, se il loro raccolto è sta to buono quest’anno e se essi hanno denaro a sufficienza per dare una dote alla loro figlia. Se non sai tutto sulle persone che abitano questa casa, non hai il diritto di far uscire questo fumo dal loro caminetto». Questo sguardo molto umano è quello di un buono spettato re che non è indifferente a questa casa, a ciò che vi succede. Si dà il caso che questo spettatore non sia altri che Balzac. Eppure, co stui non era là in quanto scrittore, ma come semplice spettatore. In ogni creazione, c’è una parte della realtà che non si mostra. Ma bisogna farla sentire. Un pittore deve conoscere ciò che egli non mostra. Su questo piccolo quadro che gli appartiené deve sapere tutto. Io provo una ben più grande responsabilità quando so che uno spettatore come lei vede i miei film. Mi fa paura! JLN: Questo mi fa pensare, nei suoi film, al ruolo dell’auto mobile come scatola degli sguardi. Il finestrino dell’automobile duplica lo schermo. C’è anche lo sguardo del conducente che, guidando (il che è normale, poiché deve fare attenzione), guarda 71
Nancy, Abbas Kiarostami
molto spesso la strada, dritto davanti a sé. E la sua videocamera mostra che quest’uomo parla al suo vicino guardando davanti a sé in una direzione nella quale noi non vediamo nulla. Vorrei ri vedere i suoi film per sapere se la gente si guarda spesso o se, per la maggior parte del tempo, guarda davanti a sé (come i condu centi). Anche se i passeggeri guardano il conducente, vi sono po chi sguardi scambiati, pochi campi-controcampi. AK: È un modo, per me, di fare appello allo spettatore. Due personaggi recitano, che ne è del nostro sguardo? Vi è uno scam bio di sguardi tra essi, poi tocca allo spettatore guardare e trova re il suo posto in questo scambio. Ne consegue anche il dimen ticare che essi non si guardano più perché egli li ha visti guar darsi. Adesso è il suo sguardo a metterli in relazione. Tuttavia, c’è un certo limite a tutto questo. Nel momento in cui il taglio interviene, l’attenzione deve essere concentrata sul la reazione dell’altro. Il cambiamento di inquadratura non c ar bitrario, non si tratta di un semplice avvicendamento. Capita che i tagli siano imposti da un problema sopraggiunto al mo mento delle riprese e accomodato durante il montaggio. Ma più spesso si sceglie il momento in cui è attesa una reazione, rea zione dell’uno al discorso dell’altro. Senza questo terzo sguar do, gli altri due sguardi non esistono. Come dire: nessun crea tore senza creatore! Ora ho una domanda da porle:
[Abbas Kiarostami recita un passaggio del Corano in arabo, la sura del Terremoto; Quando la terra avrà provato un violento terremoto E avrà rigettato i fardelli dal suo seno, L'uomo dirà: quale spettacolo! In questo giorno, la terra racconterà ciò che sa. Perché Dio glielo comanderà. Gli uomini avanzeranno a torme Per rendere conto delle loro opere. 72
Conversazione tra Abbas Kiarostami e Jean-Luc Nancy---------------
Colui che avrà fatto il bene Della pesantezza di un atomo lo vedrà. Colui che avrà fatto il male Della pesantezza di un atomo lo vedràf. Chi l’ha condotta a citare questa sura, dove l’ha trovata? Per me, è uno dei passi più belli del Corano. Non so che cosa nc pen si lei. Una ventina d’anni fa pensavo a questa sura per fare un film. Leggerla nel suo testo mi ha sbalordito. JLN:
Lei conosce tutto il Corano a memoria?
AK: No, ma conosco questa sura a memoria. Mi sembra che essa abbia una dimensione molto mistica, molto moderna, che contenga la negazione di tutto il sapere del Corano. Una bella immagine dell’apocalisse, della fine del mondo. JLN: Io non conosco bene il Corano e l’insieme della tradi zione islamica, e tuttavia qualcosa conosco. Così quando vidi E la vita continua mi ricordai che vi era una sura intitolata II terremoto.
AK: In che modo è venuto a conoscenza di questa sura? Nutro un grande interesse per la questione del mono teismo in generale. Ora vorrei lavorare a tale questione e in particolare a quella della vicinanza del monoteismo e della fi losofia in tutte le origini dell’Occidente. In questo contesto, ho tentato di conoscere un po’ meglio il Corano. I lo citato questo passo pensando che fosse per lei l’esergo silenzioso del film, soprattutto quando penso a questo versetto: quando tutto è diJLN:
’ Le Koran, sura XCIX, trad, frane, di Savary, Classiques Garnier, Paris I960. Qui c in precedenza si è tradotta la versione francese per essere più aderenti al testo. Si rimanda tuttavia alla traduzione italiana di A. Bausani, lì Corano, San soni, Firenze 1989, p. 483 (per la sura XCIX, «Del terremoto») c p. 482 (per la su ra xcvni, «L’evidenza» che Nancy cita precedentemente) [n.d.t.J.
73
__
Nancy, Abbas Kiarostami
strutto, la terra sì mette a parlare e racconta una storia. Per me il film è questo.
AK: Per me è una delle più belle sure del Corano. Possiede un forte linguaggio visuale. Ma quando ho fatto il film non vi ho pensato. L’allusione che lei fa nel testo me l’ha ricordata e mi so no reso conto che la conoscevo a memoria e che avevo avuto il desiderio di farne un film.
JLN: Forse è l’inconscio. Ho pensato al Corano perché lei è iraniano e non al testo di Voltaire sul terremoto di Lisbona che è il riferimento occidentale. AK: Non ha alcuna importanza essere religiosi o atei, amare o meno la miniatura. La cosa più importante è che noi abbiamo vissuto su questa terra, alla quale siamo legati.
[Questa conversazione ha avuto luogo a Parigi il 25 settembre 2000. [[interprete, che aveva preparato questa conversazione con Jean-Luc Nancy e Abbas Kiarostami, era Mojdeh Famiii. La trascrizione francese è un lavoro in comune di Mojdeh Famiii e Térésa Faucon].
74
Nota introduttiva alle tavole Immagini scelte da Teresa Faucon
In questo libro, il rapporto tra il discorso e le immagini deve restare libero: né commento né illustrazione. È per questo che testo e fotogram mi (o foto di riprese) non sono disposti mutualmente di fronte. Spetta al lettore inventare il gioco del proprio sguardo. Nel disporre le immagini, bisognava inoltre evitare di subordinarle all’unità narrativa di ciascun film (di cui il testo non parla), così come di chiuderle in comici tematiche trop po esplicite. Esse sono dunque raggruppate, per tavole di due pagine, secondo motivi tratti dal testo, ma che non hanno una relazione univoca né esclusiva con una tavola o una mezza-tavola, e che non sono dunque citati in titoli. Questi motivi si potrebbero così enunciare: sguardo impe dito, sguardo innestato, scatola degli sguardi, posto d'osservazione, aprire gli occhi, margine tagliato a misura di ciò che va guardato, penetrazione dello spazio, colpire la visione, ridare il reale, dissipazione del film, volo dello sguardo, energia cinetica... Al lettore, ancora, il compito di seguire le loro suggestioni o di formularne altre, o semplicemente di lasciare che le immagini conducano la sua memoria al proprio indice di visione.
i» Dov'c la casa del mio amico? (1987)
ISSI Close-up (1990)
E la vita continua (1992)
.w Sotto gli ulivi (1994)
Il sapore della ciliegia (1997)
Il vento ci porterà via (1999)
Tavola I
I
I
6 6
Tavola il
6
6
5
6 4
Tavola in
3
3
3
3
Tiivola iv
5
3
6
Tavola v
3
5
s
I
5
5
5
Tavola vi 3
rr
I
Invola Vil
3
3
3
3
6
6
6
6
Tavola vili
5
5
5
5
5
5
5
5
Tavola ix
Tavola x
j
6
6
'l’avola XI
6 6
4
ABBAS KIAROSTAMI_________________________
Appendici
I. Conversazione con Jean-Luc Nancy *
Edoardo Bruno. Mi sembra opportuno, con questi venti di guerra, far partire questa conversazione con te proprio dal rapporto tra im magine e violenza, cui, tra l’altro, dedichi ampio spazio nel tuo libro appena pubblicato da Cronopio, Tre saggi sull’immagine. Non so se anche voi siete d’accordo... Daniela Turco. Sì, anche perché oggi non è un giorno come un al tro: stiamo contando a ritroso le ore di un ultimatum imposto all’Iraq dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, in primo luogo, e poi perché abbia mo il privilegio di ospitare qui la parola filosofica di Jean-Luc Nancy, che forse ci può aiutare a fare un po’ di luce nel buio. Oggi è un gior no diverso, quindi, e riflettere sulla violenza e sulle immagini è senza dubbio importante...
Jean-Luc Nancy. Parlerò in francese, se credete, mentre voi potre te fare i vostri interventi in italiano...
Edoardo Bruno. Essayez de parler lentement...
Jean-Luc Nancy. Oui. Lentement. Sans violence (sorridendo). Il te ma della violenza dell’immagine va trattato cominciando con il dire che l’immagine è per se stessa violenta. Per esempio in Francia esiste una ri vista molto conosciuta che si chiama «Paris-Match», caratterizzata dal le foto shock che esibisce: in queste immagini vi è qualche cosa che ha una forza e dunque, in qualche modo, una violenza; riguardo alle criti che fatte a queste immagini della violenza, e ce ne sono state molte, da parecchio tempo a questa parte, immagini della guerra, immagini di de* Conversazione registrata nella redazione della rivista «Filmcritica», che l’ha pubbli cata nel numero 535, maggio 2003.
99
---------------------------------Nancy, Abbas Kiarostami __ ____________
_
litri, film dell’orrore ecc., dei quali si dice che sono pericolosi per que sto e per quest’altro, insomma, le conosciamo queste cose... Ma quan do si criticano le immagini violente noi ci dimentichiamo del fatto che esiste una violenza dell’immagine, che può esistere anche in un’imma gine estremamente dolce, inoffensiva, come l’immagine di un bacio in un film d’amore; un primissimo piano, per esempio, io credo sia sem pre violento, come pure una certa modalità del montaggio, può essere, a sua volta, violenta. Penso a un montaggio senza raccordi, senza tagli, c quando si passa brutalmente da una coppia che si abbraccia a una mi tragliatrice che sta per fare fuoco, per esempio... Nel mio scritto, di cui parlavi prima, ho scelto di esaminare in co sa l’immagine è violenta di per sé, o potrebbe essere violenta di per sé. Io credo che l’immagine sia violenta di per sé perché si impone subito con la sua sola presenza, in tutta la sua verità. Perché la violenza è sem pre questo: la violenza è sempre una verità che non si dimostra, che non si argomenta, ma che si impone in un colpo solo. Ciò forse vuol dire che la violenza dell’immagine è uguale alla violenza di un colpo, di un colpo che appunto impone così la sua verità. Credo che sia pro prio questo che si dimentica quando si fa la critica delle immagini di violenza, perché la violenza delle immagini, se si vuole, è una violenza che aspetta una proposta, come per esempio questa immagine (quella della copertina del libro di Edoardo Bruno, Del gusto, tratta da un film di Straub-Huillet) che è violenta c nello stesso tempo è un’immagine di violenza; anche la stessa lama che forza la terra è allo stesso modo un gesto di violenza. Se qualcuno facesse questo gesto davanti a me, vorrebbe dire che mi sta provocando. Il significato sarebbe chiaro: pri ma faccio questo - il gesto di affondare una lama nel terreno - e l’i stante dopo, ti uccido... Se mi si mostra questa immagine, va detto che c’è una violenza immediata perché nulla è spiegato, niente è detto, è la forza dell’immagine che comunica. Ma, nello stesso tempo, è ciò che io chiamo una proposta, sì, una proposta, vale a dire io resto davanti all’immagine e sta a me poi ri prendere questa violenza e analizzarla, perché per esempio, la violen za dell’immagine non c per niente la stessa cosa dell’immagine della violenza, perché qui l’immagine della violenza e soltanto la violenza di un colpo, mentre la violenza dell’immagine è invece l’inquadratura, il modo con cui è inquadrata, il braccio tagliato, l’aspetto del terreno, tutto questo fa parte della violenza dell’immagine. lo credo che la differenza tra la violenza reale e la violenza del l’immagine sia che la violenza reale non è una proposta, ma un’im 100
Conversazione con Jean-Luc Nancy
posizione, ossia: se ricevo un colpo, lo ricevo e basta, non lo posso analizzare, mentre la violenza dell’immagine, proprio perché si trat ta di un’immagine, mi «rinvia» immediatamente, e il rinvio è esso stesso violento, perche io sono rinviato a dare un mio parere su que sta immagine e a riceverne l’effetto e a rispondere a tale effetto; so no collocato nella situazione di rispondere, e si possono porre mol te domande, e si può scegliere di analizzare come le immagini eser citino la loro violenza, sia che, come ho appena detto, lo facciano at traverso l’inquadratura o il montaggio, o in molti altri modi; la scel ta della pellicola, la scelta di una certa esposizione, tutto contribui sce a costituire una certa violenza dell’immagine. Ma d’altra parte, c per il momento credo di voler rispondere soltanto questo, ci si può domandare come analizzare le immagini della violenza e come dire che ci sono delle immagini buone o brutte della violenza; io mi sen tirei tentato di dire che le immagini della violenza non possono es sere assolutamente condannate, così, in linea generale, perché altri menti nessun tipo di cinema, o di fotografia, o finanche di pittura, di delitti, o di crimini sarebbe possibile. In compenso, quando un’immagine di violenza non si propone come immagine ma, in qualche modo, come realtà, cioè quando esiste una sorta di comuni cazione diretta, immediata del godimento della violenza, essa si an nulla anche come immagine. Ad esempio Seven, che sono andato a vedere perche a mio figlio era piaciuto... A me è sembrato che sia molto poco un film di im magini e che sia piuttosto un film di idee; perché in Seven c’è l’idea dei sette peccati capitali c c’è anche un’idea di meccanismo... Tutto il film si inscrive molto più in un discorso che nelle immagini, e dal punto di vista delle immagini non l’ho trovato nemmeno molto inte ressante, perché è estremamente violento, ma non ci sono molte ana lisi da fare. Mentre, ad esempio, un film che potrebbe sembrare si mile a questo, perché presenta delle immagini estremamente violen te, Il silenzio degli innocenti di Jonathan Dcmme, in realtà è molto differente perché è tutto costruito sull’immagine della violenza e sul la violenza dell’immagine. C’è infatti una precisa ricerca sull’imma gine. Anche il modo in cui viene filmato il personaggio di Hannibal lo trasforma in un’immagine. Vorrei aggiungere, sempre riguardo a questa questione della vio lenza e dell’immagine, che la verità è sempre violenta. Evidentemen te non sto parlando della verità dimostrativa; la verità matematica non è violenta, almeno quella verità matematica che noi conosciamo; 101
Nancy, Abbas Kiarostami
.
forse la verità matematica per il matematico che la inventa esprime la sua violenza nel momento dell’invenzione, ma la verità che non è il risultato di un’analisi, di una dimostrazione, o di una constatazione, la verità che non è secondo la definizione, se voi permettete, scola stica, è adequatio rei et intellectus, l’adeguazione cioè della cosa e dell’intelletto. Questo tipo di verità non è mai violenta, perché con siste nel costruire il sistema dell’adeguazione, ma la verità come rive lazione, la verità che corrisponde piuttosto a ciò che Spinoza chiama la conoscenza di terzo genere, che non è intellettuale, ma c intuitiva c si accompagna necessariamente a qualcosa che viene chiamato «gioia», quindi (si può anche dire joui$$ancey godimento, là dove go dimento forse può essere inteso come terrore), i greci la chiamano aleth eia. Lo stesso concetto si ritrova in altri testi: anche la verità kantiana della legge morale che impone un rispetto assoluto alla stes sa ragione, tutte queste verità hanno un contenuto di violenza nella misura in cui la rivelazione è violenta, è un po’ come dire che nella vita la verità dell’amore e dell’odio è violenta. Esistono molte storie sull’amore, sul «coup de foudre» dell’amore, come si dice in italiano, colpo di fulmine, ecco, che è un’espressione di violenza, e propria mente tutte le storie sul «coup de foudre» sono storie di questa vio lenza, di una rivelazione che può essere estesa a tutte le forme di ve rità affettiva; ciò che voglio dire e che la verità affettiva non sarebbe una categoria separata o inferiore di verità, ma che tutte le verità ve ritiere come rivelazione sono anche affettive. E d’altronde, siccome stiamo parlando di filosofia, io credo che tut te le grandi filosofie della tradizione comportino, a un certo punto, un momento di rivelazione ultima e violenta della verità, e che sia una ve rità non dimostrabile, analizzabile, non discorsiva, come in Platone, quando il filosofo muove verso la luce della verità, verso il sole, e guar dando la luce stessa, ne è accecato: questa c violenza, c non può più parlare. In Cartesio l’evidenza del cogito, o più precisamente l’eviden za dell’ego sum, è una sorta di violenza esercitata sull’esercizio stesso del pensiero, perché non si può dire nient’altro se non «ego sum», e questa verità è vera nel momento in cui la dico o la penso o la enuncio, e non la si può dimostrare, c se credete, si può continuare ancora, con Kant, con Spinoza, con Leibniz ccc., c in tutti si può sempre trovare quel momento che è sia un momento di violenza, sia, in un certo sen so, un momento di immagine, perché si tratta di un momento di ab bagliamento; non si tratta ancora dell’immagine posta sullo schermo, ma si tratta del proiettore che invia l’immagine. Buca gli occhi. 102
__
Conversazione con Jean-Luc Nancy
Daniele Dottarmi. Questo discorso mi sembra molto stimolante, soprattutto perché c’è un legame evidente tra la violenza dell’immagi ne e la verità come violenza, anche con un gioco di parole che si può fare in italiano, come «violazione», anche di un ordine. Mi sembra tra l’altro che moltissimi concetti che lei ha trattato nei suoi testi abbiano una sorta di suggestione visiva, ottica; penso all’idea di «esposizione», esposizione del mondo, esposizione del soggetto, oppure al concetto di comparizione, che viene espresso ne La comunità inoperosa, com parizione inteso appunto come «apparire insieme». L’ultimo suo libro, /.’evidence du film', evidence è ancora un termine visivo, è un punto d’arrivo che tocca il cinema, come Le regard du portrait aveva toccato la pittura, in maniera non casuale, ma in modo legato a un percorso che a me sembra ossessionato da un problema di esposizione, anche vio lenta, di apertura di uno spazio di visione della verità e che cerca di evi tare l’idea di verità come processo dimostrativo, quindi il cinema in questo senso è un nuovo territorio di sperimentazione concettuale. O dire qualcosa del genere è forzato? Jean-Luc Nancy. Non direi di sperimentazione, perché non sono io a sperimentare con il cinema, ma è piuttosto il cinema che fa una specie di sperimentazione su di me, venendomi incontro; sovente si pensa ai filosofi come persone che devono sperimentare delle cose, prendere certi oggetti... ma no... piuttosto i filosofi percepiscono del le domande, degli appelli, delle violenze. Poco fa, nel pomeriggio, un iraniano mi ha intervistato per telefono, in merito al mio testo su Kia rostami, e la sua prima domanda è stata: «Perché un filosofo si occu pa di cinema?». E io gli ho risposto che la filosofia si può occupare di tutto perché non ha un oggetto particolare di ricerca e poi gli ho an cora detto che è piuttosto il cinema che si occupa di filosofia, ponen do le domande... E dunque, per tornare alle questioni che lei sollevava, potrei dire due cose: la prima riguarda l’ossessione visiva. £ vero, c’è tutta una storia moderna che risale a Heidegger, vale a dire che c Heidegger il primo ad aver mostrato il paradigma visivo della filosofia: a partire da Platone, La dottrina della verità in Platone, mostra che Platone ha co struito il modello filosofico come modello di una visione corretta, ap propriata, messa a fuoco, e che si pone di fronte all’oggetto, e l’og getto di questa visione è l’idea, che è infatti eidos, che significa, d’al tronde, forma. In Francia, da alcuni anni, i nuovi traduttori di Plato ne traducono idea con forma, e... questo è molto disturbante per i vecchi filosofi [lo dice, sorridendo, in italiano]. Dico Heidegger anche 103
Nancy, Abbas Kiarostami---------------------------------- --
per parlare della tradizione contemporanea, come ad esempio Mer leau-Ponty o Derrida, o Deleuze, o Lacan con lo stadio dello spec chio. C’è stata non una critica, ma una decostruzione di tutto quel pa radigma visivo, e in qualche modo tutto questo è già alle nostre spal le, è già stato fatto, e direi che ciò che mi interessa (lei dice, che mi os sessiona), è che dietro la visione, dietro l’orto-testo della visione, vale a dire Porto-visione, o l’orto-teoria, esiste ancora uno spazio tempo rale o un punto ancora più raccolto, che è il punto in cui non c’è più dirittura, non c’è più forma, e che è il punto dietro l’idea, il punto al la fine dell’accecamento, il punto di sorgenza della possibilità stessa della visione. Allora il punto è, in effetti, per riprendere le sue parole, dell’esposizione, e quando si dice esposizione, mi viene anche una pa rola di Heidegger, da scegliere nel lessico, aus (in tedesco), hors de (in francese), un essere fuori che ha a che fare con l’ex, il fuori dell’esi stenza; ciò che mi interessa, dunque, è questo punto nella visione in terna alla visione della forma, il cercare di pensare in che cosa questo punto invisibile nella visione appartiene alla verità e anche riflettere su come mai tutte le arti che hanno a che fare con il visibile si sono con frontate con questo problema, che ha coinvolto infatti i pittori più classici, interessati non alla forma, non al rendere al meglio la forma dell’oggetto, ma a far sorgere un’altra forma, un altro colore. Si tratta cioè di qualcosa che sta al fondo: come dico in un altro testo, in una immagine l’importante è il fondo, e non la forma. Da ciò si può passare a Kiarostami e al cinema; Kiarostami comin cia E la vita continua dal nero, dal passaggio sotto un tunnel, e termina con questi due piccoli puntini bianchi, i due personaggi, che si trovano in campo lungo molto lontani; o ancora conclude II sapore della cilie gia con questa visione «indecidibilc» che forse è la visione di un morto, o forse di un non morto, che si vede in video. Io sapevo che si trattava di un caso che il film terminasse con delle immagini video, ma in realtà non si tratta mai di un fatto casuale! E poi video, video significa: Io ve do, ecco! Non so se Kiarostami ha pensato a questo ma intanto Io fa ve dere. 11 film è un film normale, in 35 mm, ma nel corso di questo film, alla fine, mi vengono mostrate delle immagini video granulose, per cui l’oggetto deH’immagine che mi viene data è un’immagine di visione. Questo per quanto riguarda Kiarostami, ma per L’evidenza del film., lei aveva ragione nel ricordarmelo, perché per me è un fatto mol to importante; evidence è sempre stata una parola che mi ha intrigato, è la grande parola di Cartesio, ma anche Cartesio non è così «cartesia no» come si crede, così razionale, l’evidenza può anche non essere af 104
Conversazione con Jean-Luc Nancy
fatto razionale, può anche appartenere a un’altra categoria. Con Levi dence du film ho voluto dire che quando ho visto E la vita continua il primo film di Kiarostami che ho visto - ho avuto di colpo la sensa zione che nel cinema si fosse cambiati d’epoca. Mi sentivo anche un po’ stanco di Godard che va ripetendo in continuazione che il cinema è morto (capisco naturalmente il senso in cui dice una cosa del genere, ma trovo che abbia un po’ esagerato); e poi, non mi ha convinto del tutto il suo ultimo film. Tutti dicevano che il cinema è morto, c in effetti spesso avevo la sensazione che al cinema non ci fosse più nulla da vedere; mi an noiava perché si trattava sempre di storie, ormai non è più tempo per le storie, non è più l’epoca in cui si va a vedere Ivan il Terribile o L’i sola di corallo. Ho chiamato in causa dei racconti che appartengono a un’epoca in cui si entrava all’interno delle storie, un po’ come av veniva con i pittori del Rinascimento, che si muovevano nel cristia nesimo, nella mitologia, e quindi raccontavano le loro storie, e pren devano spunto da qualsiasi fatto, una crocifissione, un’annunciazio ne, una visitazione dell’angelo, poco importa. Lo so bene perché io che dipingo, mi rendo conto che Raffaello può dipingere venticinque madonne, ed è sempre la stessa cosa, possono cambiare i dettagli, la Madonna non è poi così importante per Raffaello, ciò che c impor tante è che ogni volta si tratta di un altro colore, ed è l’immagine che conta. Ma io credo che nella grande epoca del cinema ciò che ha con tato è stato come venivano fatti i film, con un abbondante materiale, fatto di storie, di miti e di generi, l’amore, il western, il poliziesco ecc., e che poi, non so perché, si è perduto in qualcosa d’altro, forse nello spettacolare. In tutto questo il film di Kiarostami mi diede l’impressione che all’improvviso qualcuno dicesse: «Ricomincio il cinema». Lo rico mincio perché è a zero, e quindi: niente storie, niente genere, se non la Grande Storia, anche la storia naturale con le grandi catastrofi, e allo stesso tempo la vita quotidiana delle persone. Non le piccole sto rie - a parte il pretesto di cercare l’attore bambino del film prece dente -, ma tutta questa «piccola narrazione del film» è fatta per mo strare che questa non e importante, dato che alla fine noi non sap piamo se il bambino è stato trovato o meno, mentre invece tutto il film dice: «Fermi, ricominciamo, che cos’è il cinema? Ecco, il cinema è un certo sguardo in movimento». Ad esempio, un’automobile, e la macchina ha un finestrino che inquadra, ed è questo che io ho chia mato \* evidenza, cioè a dire una parola che gioca sulla parola, in fran105
Nancy, Abbas Kiarostami.___________ _____________
cese esiste il verbo évidert scavare, svuotare, un termine che si usa an che in cucina: quando si vogliono fare delle mele al forno, in france se si dice «évider Ics pommes», svuotarle per riempirle con la can nella. Quindi, in francese si può dire che Vevidence ha a che fare con il vuoto, e qualcosa quindi che svuota, lo spettatore di.jutte le mito logie, di tutte storie e ricomincia, e non ha più né i re, né l’amore, né la guerra, né i crimini, né tutto questo: e allora che cosa c’è? C’è il terremoto, ci sono le persone, e ancora più di questo, ci sono i bloc chi di cemento armato ai lati della strada, le macchine, la polvere, e io mi muovo con la mia vettura... Vorrei raccontare ora una piccola storia sull’edizione francese del libro che è interessante. C’è il testo francese, quello inglese c quello persiano, che ovviamente si legge al contrario come l’arabo. L’imma gine di copertina l’avevo scelta insieme all’editore perché è veramen te un’immagine di apertura. So che anche Kiarostami è poi passato dall’editore e ha detto: «Ah, no, questa immagine va messa alla fine del libro», perché lui legge il libro, ovviamente, alla rovescia. Questo per dire che ha reagito esattamente come me, e questo significa che anche per lui si tratta di un’immagine di apertura, di inizio. Per me è importante perché ero contento che Kiarostami avesse operato la mia stessa scelta. Per me, in più, si tratta di un’immagine sia di evidenza che di svuotamento. Tutto ciò mi porta a dire che nell’evidenza e, parlando molto in ge nerale, nell’evidenza di Cartesio, in tutte le forme di evidenza, c’è sempre un punto di sostenimento (o sospensione) della visione, ed è a partire da quel punto che «si vede». Penso a molte scene, in tutta la storia del cinema, in cui si può individuare questo momento: un per sonaggio guarda e, all’improvviso, comprende. I la capito che qualcun altro lo guarda, lo ama, che qualcuno lo spia, o lo sta per uccidere e così via, si può immaginare tutto un montaggio di questi sguardi, e ci sono anche molti momenti che sono costruiti perché lo spettatore ab bia un’evidenza. Si potrebbe anche dire, forse, che fare un film sia ina nellare delle evidenze. Se si fa un primissimo piano, per fare risaltare i dettagli, questo diventa una forma di evidenza, ma anche una suc cessione di piani contigui, costituisce a sua volta un’altra forma di evi denza, cioè a dire che lo sguardo non è mai fermo e non si arresta. Bruno Roberti. Questo mi fa pensare al fatto che se l’evidenza è anche lo svuotamento, se in quello che è evidente c’è anche qualco sa che si svuota, c quindi che si apre, lì la visione tocca un punto cie co, direi, in cui il visibile, il vedere, in qualche modo è solidale con 106
Conversazione con Jean-Luc Nancy_
il suo invisibile. Qual è il lato dell’immagine? La cosa che lei ha rac contato, mi fa pensare anche al fatto che il lato deH’immagine per l’arabo è uno, per l’occidentale, invece, l’altro. È come se ci fossero due lati dell’immagine, come se l’immagine contenesse in sé il pro prio punto cieco, il proprio invisibile. Quando lei parla di questa di mostrazione della verità, una verità che non viene dimostrata ma viene, appunto, mostrata * in modo violento perché è lo stesso movi mento del mostrare che è violento, ciò sembra avere a che fare con la luce, con l’uscita dalla caverna e con il fascio del proiettore che si muove; mi veniva da pensare se all’interno di questo movimento, che è un movimento che non si dà come processuale, ma come im mediato, l’interessante non sia, poi, l’ombra, non sia la non verità, ma, che so, quello che in francese potrei chiamare la «ruse», e che in italiano non c tanto la finzione quanto l’inganno. La bugia, forse, anche; io non direi il contrario della verità, ma ciò che nella verità così come ciò che nella luce è ombra e ciò che nella visione è invisi bile - è non verità, cioè il suo punto cieco. Lì, forse, il cinema, che è sempre vero e non vero nello stesso tempo, è un falso vero, è il fal so che c’è nella verità. E questo verrebbe a dare la violenza come apertura, come un movimento di apertura e non semplicemente co me un movimento di presentificazione. Insomma, per concretizza re, mi interesserebbe sapere come l’ombra e il falso entrano, e se en trano, in un ulteriore movimento di pensiero rispetto al rapporto tra immagine e violenza.
Jean-Luc Nancy. Sì, forse preferirei non dire l’ombra, nel senso dell’ombra che si contrappone alla luce, perché tutto questo si pone in uno scenario di presentificazione, ma un’altra ombra, un’altra oscurità, che esiste al fondo della luce stessa, che è forse allo stesso tempo quel l’ombra che ha fatto sì che si cominciasse a dipingere. Conoscete la storia che racconta Plutarco, la storia della figlia del vasaio, c del suo amante o fidanzato, che doveva partire per la guerra e che prende un pezzo di carboncino e velocemente traccia il contor no della sua ombra. E poi il padre ne fa una scultura, prendendo il cal co di quel contorno tracciato. Insomma, si tratta allo stesso tempo di scultura e di pittura, ma ciò che è interessante e va messo in rilievo, è il fatto che l’ombra rimane e il ragazzo intanto è partito, c l’ombra re sta tutta sola. Il cuore deH’immagine è quest’ombra, che non ha più lu ce, e non si tratta più di un’ombra relativa alla luce, ma si tratta di un’ombra assoluta che è comunque il fuoco dell’immagine. Quindi, la verità sulla verità è che la verità non può mai essere vera senza anche 107
—_____________________ Nancy, Abbas Kiarostami
ritirarsi in se stessa; anche la verità dei fatti, la cultura, è verità dei fat ti; un fatto è quando dico: adesso sono le sette e otto minuti, è un fat to, ma che cos’è questa verità? Questa verità rimanda a una serie di co se infinite, perché sette ore e otto minuti significa una certa misura zione del tempo, una certa cronologia, che è legata anche a una certa tecnologia moderna che ecc. ecc., e non si finirà mai, perche con la ve rità non si finisce mai. h così per la sua oscurità, ma è la stessa cosa con l’amore, o con l’odio, o non so, la verità di Dio, o la verità dell’esi stenza, o la verità del cinema. Poco fa, venendo qui Edoardo mi diceva: «per me un film è anche tutte le interpretazioni che se ne possono dare», ed è proprio così, è ve ro, un film, un grande film, come tutte le grandi opere d’arte ha una sua verità che è interminabile. Mentre nel caso di un brutto film, dopo un po’, si sa dove si va a parare, non c’è bisogno di rivederlo finito. Ma vorrei dire qualcosa, ancora, a proposito di mostrare e di dimostrare, perché mostrare, viene dal latino, da monstrum, il mostro, e monstrum in latino indica un segno prodigioso; quindi una «mostrazione» è sem pre, in un certo senso, mostruosa e comporta una certa violenza, ed è mostruosa perché annuncia qualcosa di prodigioso, che è in effetti l’a spetto interminabile della verità. Recentemente, ho pensato a un’altra immagine, in rapporto alla «mostrazione» e all’immagine, e cioè al Minotauro. Il Minotauro è un mostro, è metà uomo e metà bestia. In un certo senso è un’immagine per eccellenza che colpisce, è metà uomo, metà animale, fa paura. Il Minotauro non lo si vede, lo si sente urlare con tutta la sua forza mo struosa. Fuori, c’è Ariannà che, al contrario, rappresenta la luce, ciò che è chiaro; più tardi Arianna riceverà da Dioniso la corona boreale, dunque Arianna è la luminosa e tiene in mano il filo, quindi è tutto un montaggio. Freud ha interpretato il filo di Arianna come un cordone ombelicale, dando luogo a un altro fantasma, che è il fantasma di una nascita anale, per cui il labirinto si troverebbe a rappresentare l’intesti no... Lascio da parte il lato anale che non mi interessa particolarmen te. Sarei volentieri tentato di dire che tutta l’immagine, la questione dell’immagine, la verità dell’immagine, passa tra Arianna e il Minotau ro, c Arianna e il Minotauro che sono per metà fratelli. Hanno la stes sa madre che è Pasifae, quando dico Arianna fuori con il filo, intendo che mantiene un legame con la mostruosità che non è visibile ma che si sente perché grida così forte che le grida passano attraverso le pare ti del labirinto. Quindi, da un lato vorrei dire che tra tutte le immagi ni esiste una risonanza, e c’è sempre del sonoro nell’immagine, non ne 108
----------------------------- Conversazione con Jean-Luc Nancy
cessariamente qualcosa di musicale, ma di sonoro; volevo però ripren dere per un momento il discorso sul cordone ombelicale, per dire che sempre in Freud il cordone porta all’ombelico e Freud parla dell’om belico del sogno, vale a dire che in ogni sogno c’è un punto in cui tut te le interpretazioni si perdono.
Bruno Roberti. Il punto cicco di cui si parlava prima...
Jean-Luc Nancy. Sì, perché l’ombelico è ciò che resta del taglio del cordone ombelicale. Viene tagliato il filo di Arianna, Arianna ri mane tutta sola, abbandonata, poi arriva Dioniso ecc. Ma direi vo lentieri che c’è forse sempre nell’immagine un punto del genere, ombelicale, in cui tutte le interpretazioni si perdono c nello stesso tempo fa sì che comunichi con la risonanza più profonda dell’im magine e con questa sorta di mostruosità, di mostrazione possibile che sta al fondo del labirinto e che si può sempre andare a cercare. E questo mi fa ripensare ora, che ciò che dico può essere applicato a tutte le immagini... e mi sentirei portato a dire che ci sono anche del le immagini musicali, delle modalità in cui si ascolta una melodia, una sinfonia compone una certa forma, e questo ha a che fare con l’immagine, ma dietro questo mio modo di sentire c’è anche un’al tra risonanza e all’improvviso mi mette in una risonanza assolutamente visiva. Tutto questo è piuttosto complicato, ma avviene per tutte le arti; nel cinema è il movimento che comunque definisce il ci nema, il movimento che si sviluppa come un movimento orizzonta le, laterale; ma in realtà questo movimento laterale ci rende sensibi li a un movimento, come dire, perpendicolare. Il vero movimento del cinema avviene sempre così, sale dal fondo dell’immagine. Quin di direi che il cinema è sensibile a un movimento che dal fondo risa le verso la forma delle immagini, ma tutto questo ritorna in effetti a ciò che abbiamo chiamato la «ruse», l’inganno. In francese esiste l’e spressione «la ruse de la raison», voglio dire che la ragione fa tutti i suoi affari alle nostre spalle. Bruno Roberti. La «ruse» ha anche a che fare con l’altro lato, con ciò che c’è dietro. Al fondo della verità c’è sempre un dietro. Il fon do della verità arretra sempre, e in questo senso è sempre in fuga, ed è questo ciò che costituisce, come diceva Edoardo, il senso in più che
è in fuga...
Jean-Luc Nancy. Ma in modo tale che non si tratta di una fuga di sperata, per cui non si arriverà mai... Ma è la fuga che è, in quanto ta 109
_
__ Nancy, Abbas Kiarostami------- -----------------------------
le, la verità. Nel cinema, direi, è la fine famosa di Tempi moderni, in cui Chariot e Paulette Goddard si allontanano; ci sono molte fini di film del genere, con qualcosa che si allontana... Bruno Roberti. Penso, per esempio, alla fine di Professione repor ter, dove c’è un piano sequenza che parte da una stanza d’albergo, con un cadavere, e la macchina da presa esce da una finestra senza interru zione, e ritorna a guardare lo stesso campo. Si tratta di un cadavere senza nome, di un’identità perduta, qualcosa che non si sa, non solo un movimento interminabile, quindi, ma anche un’identità indecidibile. Certo, anche la strada di Tempi moderni...
Edoardo Bruno. O di Monsieur Verdoux... Jean-Luc Nancy. Vorrei dire che la verità è questo movimento, dunque la verità del cinema è il movimento, ma non il movimento che si fa spingendo un carrello; c’è anche cinema quando la macchi na da presa è immobile, quando non c’è nessun personaggio, niente che si muova sullo schermo, e comunque si muova a causa della du rata, e tale durata non è quella di una fotografia. Anche se la foto grafia contiene una certa durata. Kiarostami rispetto a questo fatto è estremamente complicato, c un po’ contorto, perverso... Ama molto dire, e me lo ha ripetuto varie volte durante il nostro incon tro per questo libro, che ciò che lui effettivamente ama profonda mente è la fotografia, il cinema non è altrettanto importante; lo ha proprio sottolineato, che, certo, il cinema lo interessa, ma è la foto grafia che importa. Io non amo così follemente le sue fotografie, hanno un aspetto... un po’ estetizzante, ma effettivamente si vede che ha cercato di rappresentare nelle fotografie questo qualcosa che è presente anche nei suoi film; molto spesso, la forma canonica è da ta da un albero su una collina, perché Kiarostami adora l’albero. Credo che ciò che lui cerca, c ha ragione, perché è proprio ciò che rientra nella sua visione della fotografia, sia l’idea dell’immobilità dell’immagine cinematografica come potenza di movimento, cioè a dire un’immagine che continua ad avvenire senza fine, in un certo senso. Insieme a Philippe Sollers, Jean-Daniel Pollet aveva realizza to un film, Mediterranée, che ho visto molto tempo fa: non era im mobile ma estremamente lento, senza parole. Bruno Roberti. Ma sempre in Pollet è presente questo elemento della durata, e anche la fotografia, visto che nei suoi film spesso c’è la presenza delle foto dei suoi film precedenti. 110
----------------------------- Conversazione con Jean-Luc Nancy -- -------------------------
Jean-Luc Nancy. Tutto ciò mi riporta evidentemente all’importan za in parecchi film di altrettanti registi del movimento, e di tutte le questioni del movimento. Kiarostami non ha inventato l’uso dell’automobilc nel cinema, l’ha spiazzato, l’ha usato in un certo modo... Il treno, ad esempio, quante scene si svolgono su un treno... Penso a que sto per via del piccolo film che Claire Denis ha girato con me, Vers Nancy, che è di fatto una citazione di Godard, tratto da La Chinoise, ed è così perché alla fine, il film è dedicato alla cinese. E mi ricordo che quello che l’interessava quando ha fatto questo film, era esattamente il movimento del paesaggio che scorreva dietro il finestrino. È a questo punto che mi sono reso più che mai conto che il film è movimento. Durante le riprese non vedevo il paesaggio, non potevo vedere il mo vimento, perché è stato molto difficile girare il film, perché ogni mo mento ci fermavamo, perché si trattava di un film in 35 mm e si dove va cambiare chassis ogni tanti minuti. Ma dopo, quando ho visto il film, ho realizzato che la cosa più importante era il paesaggio, perché la cosa più importante era il rapporto tra la parola e, dietro le case, gli alberi, e questo mi ha reso più sensibile che mai a tutto questo movi mento che è nel cinema, che può essere anche il movimento del treno o quello della macchina da presa sui binari, sia quando essa è piazzata sulle spalle o ancora sul treppiedi. Lorenzo Esposito. Rispetto a questa differenza tra Kiarostami foto grafo e Kiarostami cineasta e possibile che il concetto di evidence, di evidenza, sia inteso come svuotamento e come improvvisa sospensio ne da cui può ricominciare tutto; il cinema, l’interpretazione, l’imma gine, e così via, è possibile che nel momento in cui costruisce la foto Kiarostami costruisca 1’evidence, mentre nel momento del cinema, in cui c’è il movimento del reale, come lei stesso scrive, a un certo punto, definendo il cinema come capacità di cogliere il movimento del reale un concetto che piacerebbe molto a Rossellini, per esempio - è possi bile che, invece, Vevidence * riesca raggiungere non la verità ma certo una sua improvvisa rivelazione. C’è cioè una minore costruzione, ma appunto, una rivelazione...
Jean-Luc Nancy. Ah sì, ma perché non la verità [lo dice in italia no]? Ma forse non c’è una, una sola verità. Forse la verità è necessaria mente una, ogni volta che c’è. Ma come è avvenuto che Kiarostami giungesse a questo? Credo che non sia il solo, penso ad alcuni cineasti taiwanesi e cinesi che partecipano di qualcosa di simile, e in un modo molto diverso Claire Denis, che ho conosciuto dopo Beau travail. Ill
Nancy, Abbas Kiarostami
Avevo visto Beau travail ed ero rimasto molto colpito per quella for ma di verità... Ci siamo conosciuti perché avevo scritto un piccolo te sto su Beau travail, senza conoscerla, e poi... Nel caso di Kiarostami, ho l’impressione che lui all’inizio, come tutti, come anche Godard (perché Godard è un po’ l’antenato della sua banda), hanno constatato che un certo materiale del cinema si era esaurito, i grandi materiali, le mitologie ecc., e che d’altra parte il grande cinema hollywoodiano si era appropriato di tutto, il mercato, le sale, tutte le storie possibili, c aveva divorato anche l’immagine, perché direi che Hollywood fa la stessa cosa che fa la verità ma al l’inverso, nel senso che costruisce un’immagine dopo l’altra, in un processo infinito. E una potenza prodigiosa che colpisce. Non è una cosa che appartiene soltanto al cinema hollywoodiano; ma in grande misura nel cinema americano, ciò che colpisce è questa capacità uni ca di mostrare la realtà americana come un’immagine che il cinema mostra e il cinema si mostra nell’atto di mostrare questa immagine, e con una sorta di realismo integrale si mostra la gente comune per strada, come osserva Resnais (mi sembra che sia stato lui a dire que sto), in un film americano una cassiera in un supermercato è una cas siera in un supermercato, in un film francese una cassiera in un su permercato assomiglia immediatamente a Gathering Deneuve. Nel cinema americano è in un certo senso affascinante questa attitudine inarrestabile a divorare se stesso. Ho visto per esempio Harry Potter, perché ho accompagnato una mia nipote, e sono rimasto stupefatto per il fatto che tutte le storie di Harry Potter siano costituite da una serie di topoi del cinema molto conosciuti, a partire dalla prima ap parizione della bambina, a tutte le storie del collegio, ero stupito per ché mi dicevo: «non capisco come questa mitologia del collegio in glese, o anglo-americano, possa parlare a un bambino o bambina francese che non sa nulla di questo. Passa attraverso il fantastico, sia mo d’accordo però»... Edoardo Bruno. Tornando alla questione del mostrare e dimostra re, tutta l’estetica di Rossellini è volta al mostrare e non al dimostrare, proprio perché rifiuta l’imposizione. «La dimostrazione, diceva Ros sellini, è sempre un qualche cosa che impone». È d’accordo sulla vio lenza della dimostrazione?
Jean-Luc Nancy. Sono molto d’accordo con questo, ma vorrei di re ancora una cosa sul tema della violenza, perché si è parlato prima di violazione, di violazione di un ordine, e allora vorrei dire che 112
Conversazione con Jean-Luc Nancy_________—
quando si parla di violenza e di violazione, si ha in mente lo stupro, e infatti spesso si dice che le immagini di violenza sono degli stupri dello spettatore, dei giovani spettatori; ciò che mi interessa chiarire è la differenza tra lo stupro e, diciamo, la violenza erotica. Nell’eroti smo c’è della violenza, ed è a causa di questa violenza che nell’eroti smo si muovono più cose, anche i fantasmi erotici; la differenza è molto semplice, ma non sempre è semplice determinarla nella realtà filmica, mentre è molto semplice nella realtà vissuta. Nello stupro, non c’è alcuna apertura dello stupratore verso la persona che sta vio lando. È un’imposizione che non vuole neppure comunicare qualco sa agli altri, mentre la violenza erotica, o la verità della violenza ero tica, è che questa verità non si impone; perché ha necessità di comu nicare qualcosa, di essere un’apertura. Nello stupro l’apertura si fa propriamente chiusura. Ma mentre è facile sapere perché un uomo ha stuprato una donna, non e sempre facile sapere se un film commette uno stupro o no sullo spettatore. Daniela Turco. Nel suo testo c’è un rapporto molto interessante tra i termini «regard», sguardo, e «égard», riguardo, rispetto. Rispet to dell’immagine a cui si avvicina, che nel suo testo viene particolar mente sottolineato, insieme a questa sorta di cammino intrecciato tra regard e égard, che è molto importante. Si parla, e questa è una cosa che mi ha colpito molto, di «giusta distanza», per guardare un’im magine. Questo viene detto a proposito del cinema di Kiarostami in cui è molto evidente il riguardo, il rispetto per ciò che viene filmato. Noi siamo abituati a un cinema che amiamo anche molto, dove inve ce lo sguardo è spesso legato alla colpa, penso per esempio a Hitch cock, e allora mi interessava in modo particolare continuare a parla re, se possibile, di questo rapporto tra sguardo e rispetto, che credo sia importante proprio nei termini della distanza, della «giusta» di stanza da un’immagine.
Jean-Luc Nancy. Sì è vero, ma la distanza giusta non può avere una sorta di giustezza offerta da altrove, da una norma, come dire che mi devo porre a cinquanta centimetri, e allora va bene, mentre a venticinque centimetri è troppo vicina... Si può dire che l’égard, il ri spetto, deve essere un rispetto per Io sguardo, un égard pour le re gard, cioè un rispetto per ciò che si guarda ma anche sempre una cu ra, un rispetto per lo sguardo, come dire, ciò che permette allo sguar do di guardare. Ho pensato, ora di nuovo, all’esempio dello stupro. Penso che uno stupratore non guardi chi sta stuprando. Che non 113
Nancy, Abbas Kiarostami
guardi, e anche che non voglia guardare... ci sono degli stupratori che nascondono la figura di chi è stato stuprato. È molto significativo questo. Nell’amore, nell’erotismo si guarda, lo sguardo di per sé è erotico. Come tenere, come custodire, allora, questo rispetto. Penso ancora una volta a un film di Claire Denis, Trouble evgryday. L’ave te visto? Sì, bene, ecco voi dite, che nel film c’è un fantasma di can nibalismo. Sì, ma si possono anche dire altre cose, perché lì c’è una prossimità pressoché infinita dello sguardo, dal momento che la macchina da presa si immerge nella carne sanguinante e lo schermo è macchiato di sangue, il luogo è completamente macchiato di sangue, ma anche l’occhio dello spettatore, come se la macchina da presa vo lesse entrare dentro lo spettatore. Sì, forse si tratta di cannibalismo, ma questo cannibalismo stesso è - in partenza bisognerebbe sapere che cos’è il cannibalismo, perché equivarrebbe richiamare adesso tutta un’altra mitologia -, ma il film fornisce molto chiaramente la chiave dello sguardo: la chiave è offer ta dalla piccola ferita che la ragazza ha sulla spalla, e questa marcatu ra la si vede molto presto durante il film, e lì comprendiamo che suo marito mentre la baciava, nel corso di quello che diveniva un rap porto erotico, l’ha un po’ morsa. Io credo che tutto il film sia una metafora enorme sullo sguardo di quel piccolo morso, vale a dire che è una metafora di ciò che c’è nel bacio, perché noi non ci pensiamo mai, ma il bacio è qualcosa di straordinario, perché quando baciamo c’è il soffio. Si dice che il soffio è l’anima, i suoi ripieghi, ma è più di questo, perché ci sono i denti, c’è la bocca, e c’è il morso, ed è vero che la piccola morsicatura erotica, questa ellissi, il film mostra sulla spalla della ragazza come il segno della verità dell’erotfsmo, di una verità che il film racconta allora come una storia di follia, di malattia, una malattia che non arriveremo mai a scoprire cos’è, eppure la vio lenza incredibile dell’immagine davanti a una scena insopportabile, io stesso vedendolo stavo molto male, mia moglie non ha voluto ve derlo, io riconosco che è estremamente al limite, gioca su un essere estremo, ma nel film, il film nel suo insieme, la piccola morsicatura sulla spalla fornisce la giustezza dello sguardo, che è sempre questo sprofondare nel sangue... Daniela Turco. Forse è qualcosa che ha a che fare con quello che di ce Godard, e cioè che non abbiamo ancora imparato a guardare; ab biamo in qualche modo a scuola imparato a leggere e a scrivere, ma non abbiamo imparato a guardare... 114
Conversazione con Jean-Luc Nancy-----------------------------
Jean-Luc Nancy. Sì certo. Ma io direi che non abbiamo neppure imparato a scrivere. Forse scrivere, per me, almeno, è sempre impa rare a scrivere c per Godard fare del cinema è sempre imparare a guardare. (Qualche volta mi chiedo come ho potuto scrivere quando avevo trent’anni. È folle, non va bene, e non mi rendevo conto, non ero cosciente all’inizio, e non si è imparato... E anche ora, non dico di aver imparato...).
Francesco Salina. Vorrei fare un piccolo intervento sull’Afe et nuncy cioè sulla circolarità non del dire ma del pensare, che è questa, la circolarità e la «gruppalità» in cui il pensiero si anima. Quello che mi interessa di Jean-Luc Nancy è questa capacità di immettere nella circolarità dei parlanti, non ancora dei pensanti, di immettere dei pensieri e ricordandomi di Bion, grande psicoanalista freudiano e kleiniano indiano, divenuto poi londinese, che diceva che ci sono dei pensieri in cerca del loro pensatore. Questo ribaltamento fondamen tale nella procedura del mentale e del pensiero a mio parere c quella del cinema. Tanto è vero che cento anni di cinema veggente e cento anni di cecità spettatoriale, questo è il rovesciamento straordinario. Dunque sono cento anni che'il cinema pensa e sono cento anni che . lo spettatore inibisce questa violenza. Strano, perché non è un’arte il cinema, è di più, è conoscenza in assoluto. L’arte è già una categoria che lo stringe e lo soffoca, e le avanguardie lo hanno detto. È strano che cominci con un nome, tradito nel suo significante, Lumière, ec co. Tutto qua.
Jean-Luc Nancy. Non so se ho compreso tutto, ma amo molto la .frase: «ci sono dei pensieri che cercano i loro pensatori», c questo mi ricorda che prima avevo perduto il filo, ma ora mi viene in mente che cosa volevo dire. Perché Kiarostami ha fatto questa cosa. Dapprima, ho pensato che forse era perché c’è una certa potenza del cinema, ma d’altra pane l’Iran come paese presenta delle differenze nella storia del cinema che non è né americano né europeo, e nemmeno asiatico, né russo, né egiziano, né indiano... Una situazione di sospensione straor dinaria perché non è la democrazia, e nemmeno semplicemente la dit tatura come noi la conosciamo bene. Una cosa molto curiosa, e d’al tronde Kiarostami nei suoi film è estremamente sottile con la questio ne. C’è la questione dell’educazione, della didattica. E per farla breve, direi che è come se tutto questo avesse prodotto una sorta di pensiero che è andato in cerca di qualcuno e ha trovato Kiarostami. E questo pensiero nello stesso tempo è in rapporto con l’Iran, per lui, con tutta 115
Nancy, Abbas Kiarostami
la tradizione iraniana, perché in E la vita continua, c’è un’immagine nel mezzo che ha in mezzo una fessura, è strappata, e questo è com pletamente un artifizio, voluto da Kiarostami, perché gliel’ho chiesto, e gli ho domandato: «Ma come è possibile?» e lui mi ha spiegato di averlo fatto appositamente, e questa immagine è un’immagine popola re che si vede in moltissimi locali, o caffè iraniani, e quindi nel bel mez zo della modernità si trova veramente l’Iran, e d’altra parte mi ha spie gato che nello stesso film, c’è una presenza di Omar Kayan che piace molto a Kiarostami e Omar Kayan, il poco che conosco di lui, è qual cuno che rappresenta questa vena molto particolare dell’islam che ha a che fare con il sufi, molto prossima al sufismo, che quindi è più vici na all’islam sciita, ed è molto vicino quindi a certo ateismo.
116
_________________________ ABBAS KIAROSTAMI
IL Del brillante e del falso. Conversazione con Abbas Kiarostami * A cura di Daniele Dottorini, con la partecipazione di Gaetano Saccoccio
Ten, dieci. Semplicemente un numero, sequenza di incontri appa rentemente casuali che costituiscono l’ossatura dell’ultimo film di Kia rostami, sorta di riflessione-limite (un limite, però, che può ancora spostarsi in avanti) sul ruolo della regia, sulla possibilità che il cinema diventi meccanismo automatico di disvelamento del vero. Incontriamo Kiarostami a Perugia, durante la manifestazione Batìk, il giorno dopo la presentazione di Ten al festival.
Iniziamo col dirle che il film ci è piaciuto molto c ci è sembrato un film importante all’interno della sua filmografia, soprattutto per quel che riguar da l’uso del digitale e l’idea stessa di regia che ne deriva. A noi sembra che a partire da II sapore della ciliegia - in cui l’uso del digitale nella sequenza fi nale sappiamo che era dovuto a ragioni contingenti -, passando per ABC Afri* ca, in cui il digitale è usato coscientemente e in cui il regista si mette in sce na nel film, in Ten il digitale è legato alla scelta di un’assenza dichiarata del la regia, che, però, non significa assenza di uno sguardo, ma, al contrario, una intenzionale moltiplicazione degli sguardi.
Hai fatto bene a partire da II sapore della ciliegia perché in quel caso il digitale entrò a forza nel film, non era una scelta cosciente, ma ero stato obbligato ad utilizzare quella ripresa. Io avevo girato la se quenza finale in pellicola, solo che il materiale si era rovinato in la boratorio e, poiché da noi il periodo primaverile dura molto poco, non ero più in grado di ottenere le stesse immagini, la stessa atmo sfera e i colori di quel periodo, tutto era cambiato. Così mi misi a ve dere quello che avevano girato i miei collaboratori sul set con la vi deocamera, inizialmente per verificare quanto avevamo perso dell’at mosfera iniziale del paesaggio. Mi sono accorto di quanto tutti gli at tori, i soldati che compaiono nella sequenza, fossero molto più tran9 Traduzione di Babak Karimi. Da «Filmcritica», gennaio-febbraio 2003, 531-32.
117
Nancy, Abbas Kiarostami
quilli, più a loro agio davanti a una videocamera rispetto alla ripresa in 35 mm. Quindi quel materiale era molto più bello e più vivo del materiale che avevo girato io in pellicola, anche se aveva delle righe perché era girato in Hi8. Alla fine ho deciso di metterlo. Rivedendo il film mi sono accorto che qualcosa era successo, perché quella se quenza è un «documento di realtà viva», mentre il resto del film, che doveva, voleva essere reale era in realtà pura finzione. Con il passare del tempo però me ne dimenticai. Anche in ABC Africa l’uso del digitale è stato determinato da una circostanza casuale: noi eravamo partiti con delle piccole videocamere per filmare i luoghi, per prendere appunti, in un certo senso. Materia le che ci sarebbe poi servito per scrivere la sceneggiatura del film, per mettere in piedi la produzione e, infine, per realizzare il documentario in pellicola. E di nuovo si è innescato lo stesso meccanismo: il video si è di nuovo «proposto», come se dicesse: «guardami». Quindi alla fine abbiamo montato i videoappunti che abbiamo preso ed è diventato ABC Africa. Un grande regista dei nostri tempi, che adesso non vo glio nominare, mi disse che ABC Africa era un film veramente molto strano, perché Ovunque si girasse la telecamera c’era sempre vita, mentre nei suoi film - diceva - se la macchina da presa si fosse spo stata leggermente, se avesse variato il suo punto di vista anche di po co, avremmo visto il cavalletto, i cavi, le luci, il set, e tutto sarebbe di ventato finto. E questa secondo me è una verità. Per me questa tec nologia è un regalo di libertà oltre che per il regista anche per l’atto re e lo spettatore. Quindi in Ten ho usato questa tecnica in maniera consapevole, men tre la mia presenza in ABC Africa è stata inevitabile; inizialmente, vi di cevo, erano degli appunti che non avrei pensato sarebbero poi entrati nel film, per cui spesso io o il mio collega siamo ripresi, in campo. In Ten ovviamente io non ci sono, però c’era una mia assenza ulte riore, un’assenza ancora più interessante. Parlo della mia presenza co me regista che vuole controllare tutto: questo non c’era più. Durante le riprese io ho, per così dire, «sfumato» la mia presenza come regista. Gli attori non erano di fronte a me, come avviene di solito, ma * io ero seduto sul sedile posteriore della macchina, non controllavo le loro facce. Lo sguardo del regista è forse lo sguardo più pesante, lo sguar do più imbarazzante che un attore può avere addosso, lo non ho mai usato la parola «Stop». Loro erano diventati se stessi. Ed e allora che si sono verificati degli eventi, sono scaturite delle scintille che sono fuo 118
_ Conversazione con Abbas Kiarostami
ri dal controllo di qualunque regista, di qualunque attore, fuori del controllo del cinema stesso. Ieri ho incontrato qui a Perugia Carlo Rambaldi, che ha fatto film come King Kong, E.T., c il bambino del mio film sembrava in un cer to senso E.T. Questo lo ha detto Rambaldi o lo pensa lei?
No, lo dico io. Una volta avevo fatto una citazione riferendomi alla persona che l’aveva detto, e questa persona rispose di non aver mai det to questa cosa, quindi o evito di fare nomi o mi assumo la paternità di ciò che dico. Tornando al film, volevo dire che ogni tanto in Ten capita no dei momenti, di pura vita, fresca. Momenti, sì, ma se avessimo i mez zi per poter creare di nuovo quei momenti faremmo un nuovo cinema. Emerge allora l’importanza del mezzo, della tecnologia...
I mezzi sono importanti. Quando uno su per essere registrato, in un certo senso «dona» una parte del suo essere, del suo pensiero al mezzo che lo sta registrando. Se qui non ci fosse suto il registratore forse avrei detto cose più interessanti, probabilmente se ci fosse stau una telecamera avrei detto un decimo di quanto vi ho racconuto, e se ci fosse stata una cinepresa in 35 mm sarei divenuto muto! Più questi mezzi si riducono, sino a sparire, meno siamo sotto lo sguardo inda gatore del regista, del fonico, dei tecnici che stanno intorno, più siamo tranquilli. Questo è il senso dell’uso del digitale che sto sperimentan do nel mio lavoro. L’idea di libertà data al cinema dalle nuove tecnologie è interessante, ma c’è anche un sottofondo di inquietudine, dato dalla sparizione della sicurezza del controllo registico, dell’inqqadratura costruita c strutturata internamente. È una libertà che lo spettatore deve prendersi come responsabilità di sguardo. Ed è una responsabilità forte per lo spettatore che si trova di fronte a degli spazi vuoti, a delle assenze, a dei silenzi, a quello che rimane fuori dal finestrino del l’auto che è ciò che sfugge, che scorre senza sosta.
Molte cose si possono ottenere indubbiamente anche con il 35mm, per esempio usando un grandangolo; rimane il fatto però che lo sguardo dello spettatore è una cosa fondamentale per la completezza del film. Finito il film, due spettatori escono dalla sala, al primo il film è piaciuto moltissimo, l’altro lo ha detestato. È sempre lo sguardo del lo spettatore più l’opera. Il gusto, le pretese, le attese dello spettatore fanno il film. 119
Nancy, Abbas Kiarostami
Si potrebbe dire che il disgregarsi della figura del regista corrisponde a un moltiplicarsi delle «regie» spcttatoriali?
L’annullamento della regia aiuta a lasciar essere la verità dell’emo zione, la mette in chiaro. TI regista si fa da parte ed emerge con chia rezza l’emozione del film. C’è un filosofo iraniano di cinquecento an ni fa, Hakim Mezami, che dice una cosa molto importante a proposi to della poesia, che quando la poesia raggiunge il massimo, e quindi ot tiene un potere, in quel momento inizia la sua menzogna. Il verso di ce: «Non lasciatevi affascinare troppo dalla costruzione della poesia, perché quando arriverai al massimo della costruzione, sarà già iniziata la sua menzogna». C’è da dire che la parola poesia in persiano signifi ca anche «costruzione». Una cosa che ci sembra molto importante in questo film, tuttavia, e che è legata profondamente al suo cinema, è che è un film potenzialmente infinito. Ci ha ricordato Compiti a casa, che come questo consiste in un accumularsi, un dispiegarsi di conversazioni. Pur essendo due film diversi hanno in comu ne questo elemento di potenziale infinità, in cui la fine è solo arbitraria e in realtà il flusso di parole e di volti potrebbe continuare all’infinito.
Tutte le storie sono infinite. Finché la terra gira, le storie vanno avanti. Noi possiamo raccontarne una porzione, ma è ovvio che dopo il film, l’esistenza di quei personaggi va avanti. Addirittura chi crede nell’aldilà dice che anche dopo la morte si proseguirà la propria storia. Si va oltre una porta chiusa, noi non vediamo, ma sappiamo che la vi ta continua... Leggendo la bellissima conversazione tra lei e il filosofo francese Jean-Luc Nancy, emerge alla fine non una definizione di cinema stabilità una volta per tutte, piuttosto una curiosità, un desiderio di sperimentazione continua, nel ci nema come nel pensiero, che si ripropone di film in film e che c’è anche in Ten.
Il cinema è uno dei mèzzi per parlare di filosofia, perché è la filo sofia in fondo ad essere infinita e sono i mezzi a creare delle limitazio ni, a dare dei confini. Anche per questo bisogna limitare il più possi bile i mezzi tecnici, perché quando i mezzi iniziano a diventare^préponderanti, raggiungono la loro massima potenza, lì inizia la menzo gna. Ogni cosa contiene già all’interno di sé la propria essenza filoso fica, non è l’interpretazione che noi ne diamo, più la lasciamo integra più è possibile che essa esprima la sua verità. La filosofia esiste al di là di noi, fuori di noi, a prescindere da noi. Quando noi arriviamo ad una «descrizione» bella, perfettamente articolata, in realtà stiamo co struendo. Di alcuni film si dice: «è stato fatto benissimo!»; nella nostra 120
Conversazione con Abbas Kiarostami
cultura, dire che è stato realizzato bene, nasconde un significato di menzogna, di bugia: è falso, l’opera è contro se stessa. Alla fine questa frase («è ben costruito») suona come una provocazione. Per indicare un diamante finto, noi diciamo «è fatto molto bene!», ma è un brillan te falso. Un brillante vero è un brillante puro, non è costruito. Ci fa venire in mente le riflessioni di Heidegger sulla tecnica come perdita del senso, quindi come forma della menzogna. Inoltre c’è un altro aspetto che ci sembra importante che è legato al rapporto tra l’abitare e il passare, tra io sradicamento e l'identità, pensiamo al divorzio in Ten come perdita dell'unità e dell’identità familiare, al terremoto come sradicamento in E la vita continua e Sotto gli ulivi.
Non amo parlare in termini simbolici degli elementi dei miei film. Facciamo finta che la macchina sia una location’, il movimento è ovvia mente il passaggio dalla vita alla morte, il movimento è tempo, e il tem po ha un significato filosofico. Questi orologi ci indicano che ci stia mo avvicinando alla nostra meta. Quando sei in macchina stai andan do verso una destinazione. Anche una macchina che gira e non smet te di girare sta andando comunque verso una destinazione finale. Per ché comunque e un tempo che sta passando, stanno arrivando a un luogo-tempo. Anche se il personaggio non arriva da nessuna parte, porta noi da qualche parte. Con il tempo. C’è un haiku giapponese che dice: «Il conto alla rovescia della mia morte / è iniziato al momento della mia nascita». La macchina ci sta portando verso questo finale, è la sua destinazione. Rispetto zEla vita continua cali sapore della ci liegia, la macchina va più veloce, ma non si ferma mai. E purtroppo voi ieri sera, vedendo il film Ten, vi siete avvicinati di novantaquattro mi nuti alla vostra mone.
4
121