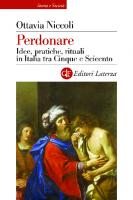Sciamanismo - Guaritori, Spiriti, Rituali 88-339-13 I7-l
287 23 4MB
Italian Pages 122 Year 2001
Polecaj historie
Table of contents :
Untitled01_2R......Page 1
Untitled02_1L......Page 2
Untitled02_2R......Page 3
Untitled03_1L......Page 4
Untitled03_2R......Page 5
Untitled04_1L......Page 6
Untitled04_2R......Page 7
Untitled05_1L......Page 8
Untitled05_2R......Page 9
Untitled06_1L......Page 10
Untitled06_2R......Page 11
Untitled07_1L......Page 12
Untitled07_2R......Page 13
Untitled08_1L......Page 14
Untitled08_2R......Page 15
Untitled09_1L......Page 16
Untitled09_2R......Page 17
Untitled10_1L......Page 18
Untitled10_2R......Page 19
Untitled11_1L......Page 20
Untitled11_2R......Page 21
Untitled12_1L......Page 22
Untitled12_2R......Page 23
Untitled13_1L......Page 24
Untitled13_2R......Page 25
Untitled14_1L......Page 26
Untitled14_2R......Page 27
Untitled15_1L......Page 28
Untitled15_2R......Page 29
Untitled16_1L......Page 30
Untitled16_2R......Page 31
Untitled17_1L......Page 32
Untitled17_2R......Page 33
Untitled18_1L......Page 34
Untitled18_2R......Page 35
Untitled19_1L......Page 36
Untitled19_2R......Page 37
Untitled20_1L......Page 38
Untitled20_2R......Page 39
Untitled21_1L......Page 40
Untitled21_2R......Page 41
Untitled22_1L......Page 42
Untitled22_2R......Page 43
Untitled23_1L......Page 44
Untitled23_2R......Page 45
Untitled24_1L......Page 46
Untitled24_2R......Page 47
Untitled25_1L......Page 48
Untitled25_2R......Page 49
Untitled26_1L......Page 50
Untitled26_2R......Page 51
Untitled27_1L......Page 52
Untitled27_2R......Page 53
Untitled28_1L......Page 54
Untitled28_2R......Page 55
Untitled29_1L......Page 56
Untitled29_2R......Page 57
Untitled30_1L......Page 58
Untitled30_2R......Page 59
Untitled31_1L......Page 60
Untitled31_2R......Page 61
Untitled32_1L......Page 62
Untitled32_2R......Page 63
Untitled33_1L......Page 64
Untitled33_2R......Page 65
Untitled34_1L......Page 66
Untitled34_2R......Page 67
Untitled35_1L......Page 68
Untitled35_2R......Page 69
Untitled36_1L......Page 70
Untitled36_2R......Page 71
Untitled37_1L......Page 72
Untitled37_2R......Page 73
Untitled38_1L......Page 74
Untitled38_2R......Page 75
Untitled39_1L......Page 76
Untitled39_2R......Page 77
Untitled40_1L......Page 78
Untitled40_2R......Page 79
Untitled41_1L......Page 80
Untitled41_2R......Page 81
Untitled42_1L......Page 82
Untitled42_2R......Page 83
Untitled43_1L......Page 84
Untitled43_2R......Page 85
Untitled44_1L......Page 86
Untitled44_2R......Page 87
Untitled45_1L......Page 88
Untitled45_2R......Page 89
Untitled46_1L......Page 90
Untitled46_2R......Page 91
Untitled47_1L......Page 92
Untitled47_2R......Page 93
Untitled48_1L......Page 94
Untitled48_2R......Page 95
Untitled49_1L......Page 96
Untitled49_2R......Page 97
Untitled50_1L......Page 98
Untitled50_2R......Page 99
Untitled51_1L......Page 100
Untitled51_2R......Page 101
Untitled52_1L......Page 102
Untitled52_2R......Page 103
Untitled53_1L......Page 104
Untitled53_2R......Page 105
Untitled54_1L......Page 106
Untitled54_2R......Page 107
Untitled55_1L......Page 108
Untitled55_2R......Page 109
Untitled56_1L......Page 110
Untitled56_2R......Page 111
Untitled57_1L......Page 112
Untitled57_2R......Page 113
Untitled58_1L......Page 114
Untitled58_2R......Page 115
Untitled59_1L......Page 116
Untitled59_2R......Page 117
Untitled60_1L......Page 118
Untitled60_2R......Page 119
Untitled61_1L......Page 120
Untitled61_2R......Page 121
Untitled62_2R......Page 122
Citation preview
Klaus E. Miiller
Sciamanismo Guaritori
Spiriti
Rituali
Bollati Boringhieri
Prima edizione marzo 2 oo r
© 2001 Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino, corso Vittorio Emanuele II, 86 I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati Stampato in Italia dalla Stampatre di Torino ISBN 88-339-13 I7-l Titolo originale, Schamanismus. Heiler, Geister, Rituale
© C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Mlinchen 1997 Traduzione di Andrea Michler Schema grafico della copertina di Pierluigi Cerri Stampato su carta Palatina delle Cartiere Miliani Fabriano
Indice
Prologo
7
rr
1.
La problematica r. La salute, II 2. La riproduzione, 14 3. La sussistenza, 16 4. Gli sciamani, r9
28
2.
Presenza del fenomeno 1. La diffusione, 28 2. La tipologia, 30 3. La terminologia, 34
3. Cosmologia La struttura del mondo, 38 Gli spiriti, 40 3. La topografia dell'aldilà, 46 1.
2.
4. La formazione La chiamata, 50 La metamorfosi, 54 3. L'investitura, 61 1.
2.
64
5. La pratica La scena, 64 Il costume, 67 3. Il corredo, 71 4. La seduta, 77 1.
2.
INDICE
6 90
6. Vita da sciamano La La 3. La 4. La 1.
2.
IOO
quotidianità, 90 funzione, 92 personalità, 94 morte, 98
7. Modelli esplicativi 1. 2.
Tesi psicologiche, 100 Tesi etnologiche, 107
II8
Epilogo
123
Bibliografia sommaria
125
Indice dei nomi
127
Indice analitico
Prologo
Migliaia di anni fa, quando l'Europa giaceva sotto la gelida coltre dell'ultimo periodo glaciale, la Glaciazione wiirmiana (circa 40 000-10 ooo a. C.), fecero la loro comparsa i primi rappresentanti del tipo umano attuale, l'Homo sapiens sapiens, votati a un'esistenza tutt'altro che facile. Questi uomini vivevano generalmente in piccoli gruppi, all'aperto, in tende o capanne di frasche, oppure al riparo cli sporgenze rocciose, in caverne o, più raramente (come in Europa orientale), in lunghi cunicoli scavati nel terreno, sorta di abitazioni semisotterranee, e traevano la loro sussistenza dallo sfruttamento diretto della natura, cioè da attività di caccia e raccolta. Dal momento che, a causa delle condizioni climatiche, i prodotti commestibili di natura vegetale - radici, erbe selvatiche, bacche - erano piuttosto scarsi, la principale fonte di sostentamento era rappresentata dalla caccia. Principali prede erano la renna, il bisonte, l'uro, il cavallo selvaggio, il mammut e il rinoceronte lanoso, cui si aggiungevano piccole quantità cli cervidi e cli selvaggina minuta. Esistevano inoltre gruppi specializzati esclusivamente nella caccia di alcune specie animali, per esempio la renna e il mammut. In Europa, durante il Paleolitico superiore, coincidente con l'ultimo periodo glaciale, esistevano dunque vere e proprie culture di cacciatori, il che presupponeva che i pochi maschi adulti appartenenti a una comunità non solo fossero dotati dell'abilità, del coraggio e dell'esperienza necessari alla caccia, ma si mantenessero sempre, per quanto possibile, in buona salute e conservassero le forze e il vigore sufficienti per affrontare le immani fatiche e i grandi pericoli connessi alla caccia grossa. Da quanto
8
PROLOGO
detto si evince che gli uomini non solo si erano formati un'idea su che cosa andasse fatto o evitato per conservare la propria efficienza fisica, ma riflettevano anche sulla natura, sulle caratter:stiche e sul comportamento degli animali, e sul loro rapporto con l'uomo, al fine di non commettere errori durante la caccia; è! soprattutto sul modo di rapportarsi alle principali prede, dal memento che l' «ostilità» di queste ultime avrebbe potuto compremettere il successo della battuta seguente, se non addirittura quello di tutte le battute future. Di questo particolare modo spirituale di rapportarsi ai prcpri problemi esistenziali e al proprio ambiente da parte dell'ucmo primitivo esistono testimonianze estremamente suggestive: il Paleolitico superiore è stato un periodo di fioritura dell'art·~ figurativa, di cui ci sono pervenute molte opere. Esemplari a questo riguardo sono le cosiddette statuette di Venere, piccol~ figure femminili di fattura ora schiettamente naturalistica ora stilizzata, dal voluminoso corpo di pietra, di osso o di avorio, con basso ventre poderoso, pesanti seni pendenti e netta evidenziazione della vulva. Se, da un lato, in esse si sono volut,~ scorgere le cosiddette «Madri animali», spiriti responsabili della riproduzione e della salvaguardia della selvaggina, dall'altro,~ indubbio che abbiano avuto anche un significato magico connesso alla fertilità, contribuendo a potenziare la capacità riprcduttiva delle donne. A favore di quest'ultima interpretazion,~ gioca tra l'altro il fatto che queste statuette sono state rinvenute dappertutto presso gli insediamenti abitativi. Va poi ricordato che esse erano portate come talismani. Altrettanto celebri sono le pitture scoperte sulle pareti di numerose caverne nel Sud della Francia e in Spagna. Oltre che segni pittografici 1! motivi geometrici, esse raffigurano soprattutto grandi animali (mammut, uro, bisonte ecc.), affiancati da figure ibride, per metà uomo e per metà animale, e talora anche da scene di caccia o pantomime venatorie, per esempio danzatori con maschere animali. Un aspetto caratteristico è il fatto che queste pitture si trovano di solito in fondo alle caverne, in zone spesso di difficile accesso; disposte in genere disordinatamente l'una sopra l'altra, avevano indubbiamente una funzione cultuale. La religione sembra aver avuto una parte importante nella
PROLOGO
9
vita degli uomini, come provano, tra l'altro, i sacrifici cli animali, documentati con certezza per quanto riguarda il Paleolitico superiore, e determinati da una duplice preoccupazione: garantire la propria fertilità e assicurarsi il successo nella c:1ccia, un presupposto del quale era rappresentato dalla salvaguardia del capitale di selvaggina. Dal momento che spettava agli spiriti dell'aldilà esaudire queste due richieste, bisognava cercare di instaurare con loro buoni rapporti. Il dualismo cosmobgico costituiva, come in tutte le religioni, il necessario fondamento dell'universo delle credenze, ragion per cui era necessario poter entrare in contatto con gli spiriti ultraterreni. A questo riguardo, il concetto chiave era quello della credenza delle anime, legato in particolare all'idea dell'esistenza di un'anima spirituale indipendente dal corpo, della stessa natura degli spiriti e pertanto in grado di entrare in contatto con loro. Che una tale credenza esistesse è fuori discussione, tanto più che essa è documentata con certezza per quanto riguarda l'uomo di Neandertal (Homo sapiens primigenius) del Paleolitico medio (circa 200 000-40 ooo a. C.). Già in quel periodo, e sicuramente a partire dal 70 ooo a. C., era invalso l'uso di s,::ppellire i morti, che presuppone necessariamente la credenza in una vita ultraterrena. La pratica della sepoltura si conservò pressoché immutata nel Paleolitico superiore; l'unica differenza risiedeva nella maggiore ricchezza e varietà di oggetti e doni im:mati insieme al defunto. Esisteva dunque, a grandi linee, un anello di congiunzione tra uomini e spiriti; tuttavia, per potersene avvalere allo scopo di comunicare con gli spiriti, bisognava disporre di un appropriato «meccanismo di guida», o meglio ancora, di un esperto che avesse il dono (e la competenza) di servirsi a tal fine della propria anima ogni volta che fosse necessario. Tra le pitture rupestri del Paleolitico superiore si trovano talvolta raffigurate scene in cui il ruolo più importante spetta a uomini travestiti da animali. Nella grotta di Lascaux, in Dordogna, è stato rinvenuto un dipinto raffigurante un uomo con il volto coperto da una maschera a forma di testa di uccello che giace come morto sul suolo, in una postura curiosamente contratta; non distante da lui è dipinto un bastone sovra,,tato da
IO
PROLOGO
un uccello. Si tratta di un motivo noto a partire dallo sciamanismo siberiano, dove l'uccello rappresenta uno spirito adiutorio dello sciamano oppure la sua anima, tramutata in uccello con l'aiuto del costume, in viaggio verso l'aldilà, mentre il corpo dello sciamano, privo di sensi, rimane nell'aldiqua. La pittura rupestre della grotta di Lascaux raffigura senz'altro una seduta sciamanica: le maschere di uccello, unitamente a quelle di cervidi, rappresentano, ancora nel recente sciamanismo nordasiatico, i principali modi di travestimento rituale degli sciamani.
I.
La problematica
1.
La salute
Le società tradizionali 1 si trovavano ad affrontare sostanzialmente gli stessi problemi dei loro antenati vissuti in età preistorica e, per riuscire a sopravvivere, necessitavano di sufficienti fonti di sussistenza, il cui sfruttamento presupponeva che gli uomini fossero in buona salute e disponessero delle necessarie conoscenze e tecniche. Queste erano trasmesse ai giovani dagli anziani, i quali, quando le forze li abbandonavano, dipendevano dal sostegno fornito loro dalla generazione successiva. Ai fini della conservazione nel tempo del gruppo e della sua cultura, risultava dunque altrettanto importante garantire la successione delle generazioni, il loro riprodursi senza soluzione di continuità. Secondo la concezione tradizionale, il corpo umano si componeva della parte fisica, mortale per natura, dell'anima vitale, meno caduca del corpo fisico, e dell'anima libera, quest'ultima immortale e staccata dal corpo. L'anima vitale manteneva in vita le funzioni organiche, conferendo al corpo la/orza vitale, connotata fra l'altro dalla facoltà di movimento, dallo sviluppo di calore e dalla densità. Si pensava che la forza vitale fosse particolarmente concentrata nel sangue e in tutti gli organi forte1 Il concetto sta a indicare, qui di seguito, le comunità di villaggio o gli accampamenti di tende dei gruppi di cacciatori e raccoglitrici, di orticoltori e di pastori nomadi, che al momento del loro ritrovamento non erano ancora entrati in contatto con le moderne civiltà industriali, o avevano avuto rapporti solo marginali con esse. La vita di queste comunità era modellata rigorosamente dalle tradizioni ancestrali (di qui il termine «società tradizionali»), consacrate dall'esempio degli antenati (avi) e sanzionate dalla creazione, e pertanto ritenute inviolabili.
I2
CAPITOLO PRIMO
mente irrorati da quest'ultimo (cuore, fegato e reni); nelle parti calde del corpo (cavità orale, ascelle, articolazione del ginocchio e sfera genitale), e in quelle dure, meno caduche (ossa e denti); nella maggior parte delle escrezioni - eccetto che in quelle « im pure» come feci, urina e sangue mestruale - che erano la conseguenza di un movimento o di una crescita fisica o emotiva (sperma, saliva prodotta dalla masticazione o dalla vista di cibo, sudore, latte materno, lacrime); e infine nello sguardo, nelle unghie e nei capelli. Poiché da questo tipo di anima dipendevano l'efficienza e la fertilità, esisteva un interesse vitale a fare di tutto per rafforzarla e preservarla attraverso esercizi corroboranti e pause ricostituenti di durata appropriata; ancora più indicato, però, era il consumo mirato di sostanze minerali, vegetali e animali particolarmente energetiche (terre e radici, cereali, frutti, succhi, resine, uova, cuori, fegati, farina d'ossa e simili) e di prodotti magici rafforzanti l'energia vitale. Tuttavia solo l'anima libera conferiva all'uomo la vita in senso proprio, in quanto sua causa ultima; essa gli veniva trasmessa dall'esterno, dal padre, durante un rapporto sessuale, o da uno spirito, quando il bambino si trovava ancora nel ventre materno, nei primi mesi dopo il concepimento. Si credeva comunemente che l'anima libera fosse localizzata nella testa, proprio sotto la volta cranica, che fosse sede della coscienza, centro di formazione del pensiero e delle idee, che conferisse all'uomo memoria e immaginazione, facoltà di conoscere, potere di concentrazione e forza di volontà, e che fosse decisiva ai fini della convivenza sociale. Mentre corpo e anima vitale formavano un intimo e indissolubile nesso funzionale, al punto che, separati l'uno dall'altra, non sarebbero stati in grado di sopravvivere, per quanto riguardava il legame tra anima libera e corpo ciò valeva solo in misura limitata. In condizioni di disattivazione o di debolezza organiche, l'anima libera poteva staccarsi dal corpo in qualsiasi momento. Abbandonava, per esempio, il corpo tutte le notti durante il sonno e si aggirava nell'ambiente circostante del dormiente, ma poteva anche allontanarsi notevolmente, spingendosi fino all'aldilà. Ciò che essa vedeva ed esperiva in questi viaggi formava il contenuto della visione onirica. L'esistenza di
LA PROBLEMATICA
13
una certa debolezza di legame rappresentava pertanto sempre un pericolo particolare. L'uomo era del tutto sano solo quando i tre principali elementi costitutivi - corpo, anima vitale e anima libera - formavano un'unità funzionale ben chiusa, quando cioè una parte teneva le altre saldamente unite mediante un legame di mutua interazione. Ciò rafforzava sensibilmente l'individuo conferendogli un'efficienza ottimale, premessa del suo farsi strada nella vita e del suo successo. Tuttavia, come insegnava l'esperienza, ciò non avveniva sempre o avveniva solo limitatamente. Stando alla concezione tradizionale, la salute si poteva pregiudicare in tre modi, conformemente alla «dottrina dei tre elementi»: attraverso lesioni del corpo fisico, dell'anima vitale o dell'anima libera. Nel primo e nel secondo caso, i disturbi, in ragione dell'intimo nesso funzionale esistente, colpivano reciprocamente le due entità: una ferita comportava una perdita di sangue, un dispendio eccessivo di energie indeboliva il corpo. I mali fisici traevano origine da contatti violenti con corpi estranei che producevano ferite: ci si tagliava sul lavoro, si cadeva dall'albero o si ven:iva colpiti dall'arma di un nemico. Si pensava che il venir meno della/orza vitale, che si manifestava per esempio con fiacchezza, assenza di stimoli e, non da ultimo, perdita della fertilità, fosse dovuto a sentimenti altrui ostili, concentrati e trasmessi dire:tamente, per esempio attraverso il malocchio; oppure a «contaminazione», in quanto si veniva a contatto con sostanze corruttibili e putrescibili, emanate da altre anime vitali in stato di decomposizione; ma soprattutto a sortilegi lanciati da malintenzionati. L'anima libera, infine, si trovava in pericolo quando l'individuo era colto all'improvviso da uno spavento «paralizz~.nte», cosicché i legami fisici cedevano, per cosl dire, per un breve lasso di tempo, e l'anima, disorientata, riusciva a evadere; oppure quando gli uomini si facevano coinvolgere in una lite violenta e perdevano la bussola, andando «fuori di sé»; o ancora quando uno spirito malintenzionato si impossessava dell'anima penetrando nel corpo o la catturava durante i suoi viaggi onirici e la torturava, oppure le faceva prendere una falsa pista in modo che non ritrovasse più la strada del ritorno. Quest'ult:ima situa-
CAPITOLO PRIMO
14
zione portava a svenimenti e, nei casi estremi, alla morte della vittima, mentre la prima induceva stati di possessione con delirio passeggero, allucinazioni, e talvolta anche uno stato di forte psicosi permanente. La causa ultima di ogni ferita, di ogni incidente e di ogni malattia risiedeva tuttavia in una colpa propria o in una colpa commessa da congiunti stretti. Si trattava allora di segnali di avvertimento o di punizioni inflitte agli uomini dagli antenati e dagli dèi perché essi non avevano tributato la dovuta attenzione agli spiriti dell'aldilà, perché non avevano offerto sacrifici o perché avevano fatto discorsi empi, infranto tabù, trasgredito regole, violando così le tradizioni ancestrali e, da ultimo, il sacro ordine della creazione. A tal fine gli spiriti che vigilavano sull'aldilà potevano servirsi sia di un albero marcio sia di un uomo malintenzionato o di uno spirito del male.
2.
La riproduzione
Chi non procreava o, peggio ancora, restava celibe veniva bandito dalla comunità perché non contribuiva alla conservazione del gruppo. L'assenza di figli era considerata una malattia, in alcune società anche una punizione; il celibato invece era giudicato espressione di asocialità, dal momento che ci si univa anzitutto per generare. Secondo le idee correnti sulla procreazione, lo sperma del padre e il sangue mestruale della madre costituivano le sostanze basilari in vista della formazione del feto, Il ripetuto rapporto sessuale causava, per così dire, la «coagÙlazione» del sangue mestruale; e infatti dopo il concepimento il mestruo cessava. Dal sangue traevano origine le parti liquide e molli del corpo, cioè quelle più caduche, mentre dallo sperma, formato, come a lungo si è creduto, a partire dalla colonna vertebrale, derivavano le parti più solide e resistenti, come ossa e denti. Ma il bambino cominciava a vivere solo in seguito all'animazione, che avveniva necessariamente in due modi. La forza vitale gli veniva trasmessa direttamente attraverso lo sperma (che ne era un vero e proprio concentrato); l'anima libera, invece, in maniera
LA PROBLEMATICA
mediata e, come già detto, dall'esterno in uno stadio ulteriore del suo processo di formazione, generalmente dal padre, ma a volte anche da uno spirito. La trasmissione dell'anima libera poteva avvenire in diversi modi. Si supponeva, per esempio, che le anime dei bambini destinate a entrare il) un corpo soggiornassero per lo più in luoghi di passaggio nell'aldilà, da dove, per reincarnarsi, venivano in certo qual modo «sospinte in alto». I possibili luoghi di passaggio erano le fonti, i bacini d'acqua, le pozzanghere, gli stagni dei villaggi, i fiumi e i laghi, oppure gli «assi di comunicazione» tra i mondi, come imponenti massi rocciosi isolati, montagne e certi alberi, i cosiddetti «Alberi dei bambini», documentati anche nelle credenze popolari europee. Quando una donna gravida passava, volutamente o inavvertitamente, abbastanza vicino a uno di questi luoghi o addirittura lo toccava, poteva accadere che un'anima balzasse sulla terra, e cosi la donna concepiva la vita. Va detto però che questo accadeva per lo più (sovente anche in sogno) al padre, il quale poi trasfondeva lo «spirito bambino» nella moglie durante il successivo rapporto sessuale. La funzione di trasmissione poteva inoltre essere svolta da certi animali che, in ragione della loro «duplice natura», avevano accesso all'aldilà, per esempio da uccelli notturni capaci di muoversi nell'oscurità, nell' «ora degli spiriti», e per di più, al pari delle anime, in grado di volare, di innalzarsi nei cieli e di oltrepassare il limite della terra. Secondo altre concezioni, diffuse soprattutto in Siberia ma anche in alcune parti dell'Indonesia e in altre zone del mondo, le anime risiedevano soltanto nell'aldilà. U, protette da una dea o dal dio celeste, vivevano le anime dei bambini, per esempio sotto le sembianze di piccoli uccelli che avevano eletto a loro dimora la chioma dell'Albero del Mondo. Quando giungeva la loro ora esse, per ordine della divinità, «volavano» sulla terra nel grembo delle loro madri, simili a uccelli. Nelle società contrassegnate da uno spiccato culto degli antenati, infine, spesso erano i morti che si occupavano del trasferimento delle anime. Ma tutto questo non sempre riusciva senza complicazioni. Alcune donne non concepivano affatto o non concepivano più, altre abortivano o mettevano al mondo esseri deformi, oppure i
CAPITOLO PRIMO
r6
loro figli nascevano morti. Le ragioni di tutto questo erano generalmente conosciute: la madre aveva infranto un tabù durante la gravidanza, forse aveva addirittura commesso un adulterio. Gli spiriti dell'aldilà le negavano pertanto un'anima, oppure questa «non riusciva», per cosi dire, a «resistere» nel suo corpo. Di natura analoga erano gli argomenti invocati per spiegare la mortalità infantile. Si supponeva che, in un primo tempo, il legame tra anima e corpo fosse alquanto debole, al punto che l'anima abbandonava a più riprese il corpo - generalmente passando dalla fontanella compresa tra l'osso frontale e le ossa parietali, che si richiude solo tra il nono e il sedicesimo mese di vita - per andare a trovare le altre anime nel regno dei morti. Questo spiegava perché i neonati dormissero tanto. Poteva però accadere che, durante i loro viaggi, le anime dei bambini venissero catturate da uno spirito malvagio, oppure che non fossero più disposte a fare ritorno nel corpo perché, in quella fase critica, i genitori del bambino si erano macchiati di una grave colpa. Tutto dipendeva dunque dal fatto di trattare i neonati con particolare amore, circondandoli di attenzioni e adoperandosi a che intorno a loro regnassero armonia e pace, per facilitare all'anima il compito di abituarsi al corpo.
3. La sussistenza
Tutto questo era tanto più possibile, quanto meno gli uomini erano assillati da preoccupazioni di altra natura. Un'importanza decisiva rivestiva, in questo contesto, l'acquisizione dell,! risorse alimentari. La garanzia dei mezzi di sussistenza presupponeva che ci fosse sempre cibo sufficiente da raccogliere - insetti che si nutrivano di foglie e piante (come larve, coleotteri, cavallette e simili, i quali svolgevano una funzione importante nell'apporto proteico), lumache, granchi, rane e altri piccoli animali, la cui raccolta rientrava nei compiti delle donne-, eh! la selvaggina non scarseggiasse e che le battute di caccia degli uomini fossero coronate da successo; e infine, presso i gruppi ::1 economia agricola, che i raccolti fossero abbondanti. Ma su tutto questo non si poteva contare con assoluta cer-
LA PROBLEMATICA
17
tezza. Spesso ci si trovava di fronte a situazioni di terrificante penuria, in un ambito come nell'altro, riconducibili probabilmente a sconvolgimenti climatici, siccità o inverni particolarmente rigidi, sebbene la causa ultima di questo stato di cose andasse ricercata altrove: anche le perturbazioni dell'equilibrio naturale erano ascrivibili a colpe commesse dall'uomo. Il mancatorispetto delle leggi di caccia induceva le grosse prede animali che vivevano in branchi a spostarsi in un altro territorio, mentre l'infrazione di pesanti tabù, come l'incesto, scatenava tempeste di grandine o terremoti. Ciò accadeva perché gli uomini - come spiegarono a Knud Rasmussen gli Eschimesi deU' Artico avevano trascurato «di attenersi rigorosamente alle ~;agge regole di vita tramandate loro dagli antenati», dal momento che tutto dipendeva dal «conservare il giusto equilibrio ·:ra uomini e resto del mondo». Particolarmente delicato era, sotto questo punto di vista, il rapporto tra uomini e prede animali. Un gran numero di miti raccontano della comune origine di uomini e animali, del fatto cioè che, in fondo, essi sono parenti. In età mitologica,, per esempio, gli esseri viventi potevano mutare a piacere il proprio aspetto, assumendo ora sembianze umane ora sembianze animali, finché, in un momento successivo, verso la fine della fase della creazione, venne fissato una volta per tutte l'ordine attuale. Le anime, comunque, rimasero in linea di principio intercambiabili, la qual cosa imponeva a uomini e animali di attenersi a comportamenti invalsi fra parenti: bisognava trattarsi con rispetto e, in caso di bisogno, soccorrersi vicendevolmente. Le fiabe di tutto il mondo contengono innumerevoli esempi di animali che prestano aiuto a uomini in pericolo e di punizioni inflitte a chi non mostra la dovuta gratitudine. Un altro argomento di cui si parla spesso è quello delle vicendevoli metamorfosi. Tra parenti, però, è vietato uccidersi, e tale divieto rappresentava il problema centrale delle società di cacciatori, un problema che veniva affrontato in vario modo e le cui fatali conseguenze si cercava quanto meno di mitigare, dal momento che la propria sussistenza presupponeva l'uccisione di animali. In molte parti del mondo, per esempio, era invalso l'uso di scusarsi, nelle debite forme, dinanzi alla preda abbattuta, addirittura
r8
CAPITOLO PRIMO
di compiere veri e propri