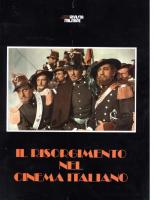Quando c'eravamo noi. Nostalgia e crisi della sinistra nel cinema italiano da Berlinguer a Checco Zalone 9788849842487, 8849842481
Per la prima volta nella sua storia, il più grande partito della sinistra erede del Pci ha un leader che non ha avuto un
167 31 4MB
Italian Pages 50 [51] Year 2014
Polecaj historie
Table of contents :
QUANDO C’ERAVAMO NOI
Indice
Quando c’eravamo noi
«Una diffusa e prevalente inclinazione alla nostalgia»
L’estasi della politica
C’era una volta il cinema, c’era una volta la sinistra
Virzì e l’Italia Giusta
Un melodramma intergenerazionale
Checco Zalone e noi (epilogo)
Citation preview
ANDREA MINUZ
QUANDO C’ERAVAMO NOI Nostalgia e crisi della sinistra nel cinema italiano da Berlinguer a Checco Zalone
Rubbettino
Indice Quando c’eravamo noi «Una diffusa e prevalente inclinazione alla nostalgia» L’estasi della politica C’era una volta il cinema, c’era una volta la sinistra Virzì e l’Italia Giusta Un melodramma intergenerazionale Checco Zalone e noi (epilogo)
«Io presumo di capire più di cinema che di politica» [Pietro Ingrao, 2013] «Non mi sono reso conto che alcuni miei comportamenti potessero essere scambiati per commistione con un ceto somigliante a una Casta», ha spiegato l’ex segretario di Rifondazione Comunista parlando della frequentazione delle serate mondane della Capitale, a cui partecipava fianco a fianco con la moglie Lella. «Pensavo che la mia vita, la mia giovinezza, la mia storia famigliare, il mio lavoro di operaio, le lotte a cui ho partecipato potessero immunizzarmi» [Fausto Bertinotti, luglio 2014] «A pensarci bene», argomenta Silvio Orlando, «Ferie d’agosto è un film sull’impossibilità di andare in vacanza, soprattutto per noi gente di sinistra» [«L’Unità», 30 settembre 1995] «Che cosa avete contro la nostalgia, eh? È l’unico svago che resta per chi è diffidente verso il futuro. L’unico» [La grande bellezza, P. Sorrentino, Italia, 2013]
Quando c’eravamo noi «Uomini, donne, bambini… tutti in lacrime… migliaia di pugni chiusi… ma che fine hanno fatto politicamente quelle persone oggi secondo voi?!». È quel che si chiede un utente in un commento lasciato sotto il link al documentario di Walter Veltroni, Quando c’era Berlinguer, in un sito di streaming e download. È quel che continuano a chiedersi in molti, nonostante il recente, storico successo del Partito Democratico alle elezioni europee. Il breve saggio che state per leggere non si avventura in una risposta a questa domanda. Prova invece a discutere i modi in cui l’interrogativo circola in alcuni film italiani degli ultimi anni (anche se l’elenco comincia con C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, uscito nel 1975, e arriva al recente documentario di Veltroni, non necessariamente seguendo quest’ordine)1. Legittimato come forma d’arte e d’impegno civile, legato ai finanziamenti statali e a lungo impugnato dagli intellettuali contro le insidie morali della televisione commerciale, il cinema è un ottimo campo di osservazione per comprendere smarrimenti, paure e struggimenti della sinistra italiana. Sulla scorta di quella sovrapposizione e condivisione di intenti tra «cultura» e «sinistra», che da noi ha assunto forme più rilevanti e opprimenti che in altri paesi, il cinema italiano non si è limitato a raccontare la crisi di un mondo travolto dalla fine del comunismo. È diventato il luogo di un rimpianto intergenerazionale, lo spazio di una compensazione utopica, mentre le cose si ostinavano ad andare in altre direzioni. La disfatta ideologica del Pci, il crollo del comunismo e la crisi d’identità della sinistra si sono trasformati attraverso il cinema in un serbatoio di motivi e figure del rimpianto. Un’epica nazionale a vocazione minoritaria costruita sui modi del melodramma e le forme della nostalgia. Per lo più abitata da personaggi maschili che, ribaltando lo stereotipo di genere associato al melodramma, occupano lo spazio della vittima vessata dal destino e dalle ingiustizie. Il richiamo al melodramma non è casuale. Basti pensare alla catarsi collettiva innescata dalle lacrime di Achille Occhetto al congresso del 1990, segno drammatico del passaggio storico del crollo del comunismo, immortalato dai telegiornali e reiterato da Blob, come in un loop, nei giorni a seguire.
Meno celebre, ma altrettanto significativa è un’altra immagine di quei giorni. È l’ultima inquadratura di La cosa, il documentario realizzato da Nanni Moretti subito dopo la proposta di Occhetto di dar vita a un nuovo soggetto politico. Moretti va a filmare le assemblee e i confronti serrati in sezione. Alla fine, mentre i militanti parlano animatamente, l’immagine vira in rosso e iniziano a scorrere i titoli di coda. Però continuiamo a sentire la voce della base. Il documentario è finito, il dibattito no. Il dibattito non finirà mai. Le lacrime di Occhetto fissavano il drammatico congedo da una storia lunga un secolo. La chiusura del documentario di Moretti è il simbolo di un’estenuante interrogazione. Una richiesta di senso che trascende il trauma del 1989 e si riflette nel cinema italiano con la forza di un melodramma collettivo.
Cosa ha significato essere di sinistra nel Paese con il più forte partito comunista dell’Occidente? Cosa si intende oggi per «sinistra»? Siamo come gli altri? Siamo diversi? Siamo chi? Domande ontologiche, analisi interminabili, scissioni, lamentazioni, rifondazioni, dubbi iperbolici che alimentano ancora una grande narrazione, appendice inesauribile del grand-récit dell’ideologia di cui Lyotard annunciò la fine nel 1979 e Vendola il rilancio nel 2010. È il racconto di uno smarrimento che lega a sé generazioni diverse. Un’elaborazione del lutto che immortala nel canone della «crisi» immaginari collettivi e storie personali. Perché parlare di sinistra e di crisi-della-sinistra significa parlare della stessa cosa. «La crisi si attaglia magnificamente alle convinzioni di sinistra, anzi, in genere la sinistra è crisi»2, scriveva Berselli in
Sinistrati. Storia sentimentale di una catastrofe politica. Con uno sguardo malinconico e impietoso, Berselli raccontava le vicende recenti della sinistra italiana inserendosi dentro una vasta tendenza editoriale che pare non avere mai fine e che proprio verso la fine degli anni zero riceveva un nuovo impulso. Sia a causa della celeberrima sconfitta del centro-sinistra alle elezioni politiche del 2008, sia per la distanza storica dal 1989 che adesso permetteva di mettere meglio a fuoco la faccenda. Una saggistica divulgativa. Tra ricostruzione storica, ricordi, abiure, elegie, «come eravamo» e un po’ di ricette per il futuro. Qualche titolo a caso da un infinito scaffale di una Feltrinelli del centro: Compagni di scuola. Ascesa e declino dei postcomunisti di Andrea Romano (2007); Qualcuno era comunista di Luca Telese (2009); Aspettando la rivoluzione. Cento anni di sinistra italiana di Antonio Ghirelli (2007) Comunisti immaginari di Francesco Cundari (2009); Perché siamo antipatici. La sinistra e il complesso dei migliori prima e dopo le elezioni del 2008 di Luca Ricolfi (2008); La sinistra è di destra di Piero Sansonetti (2012); Pensare la sinistra di Pietro Reichlin e Aldo Rustichini (2012); e poi ancora la memorialistica ufficiale: Alla ricerca di un altro comunismo di Lucio Magri (2012), Le occasioni mancate di Fausto Bertinotti (con Dario Danti) del 2012; Se noi domani. L’Italia e la sinistra che vorrei di Walter Veltroni (2013). I già classici Volevo la luna di Pietro Ingrao (2006), La ragazza del secolo scorso di Rossana Rossanda (2007) e molti altri ancora. Una scia inarrestabile di libri cui si è aggiunto da poco La gioiosa macchina da guerra, il racconto di Achille Occhetto, protagonista di quel delicato passaggio e copywriter della celebre formula che definisce il lessico della sconfitta di sinistra. E poi c’è il romanzo di Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, che racconta in prima persona il peso di una formazione nel segno della diversità morale della sinistra. Sono punti di vista spesso diversi tra loro. Ma che pure ruotano attorno a un comune motivo di fondo: occasioni perdute, ricerche di senso, nostalgie, malinconie, ripensamenti. La fine di una passione, di un «paradigma». La fine di un secolo, la difficoltà di pensarsi dentro il secolo successivo, che poi sarebbe il presente. Gran parte di queste nostalgie, smarrimenti e ripensamenti è stata raccolta dal cinema italiano, e non poteva essere diversamente. Così converrà partire dal trentennale della morte di Berlinguer, celebrato al cinema dai documentari di Mario Sesti e Walter Veltroni, per poi inseguire nostalgie e percorsi della «questione morale» lungo traiettorie impervie. Da
Maria De Filippi a Toni Servillo, da Nanni Moretti a Ettore Scola e Virzì. Fino a Checco Zalone. 1
Una prima versione di questo saggio è stata pubblicata su «Rivista di politica» (Schermi politici. Storia, identità e ideologia del cinema italiano, a cura di C. Uva, n. 1, 2014). 2
E. Berselli, Sinistrati. Storia sentimentale di una catastrofe politica (2010), in Id., Quel gran pezzo dell’Italia. Tutte le opere, 1995-2010, Mondadori, Milano 2011, p. 1032.
«Una diffusa e prevalente inclinazione alla nostalgia» «Spero fortemente di essere un autore pop. È la mia storia. Mi piacciono i centri commerciali, le multisale, Sanremo» «Se Maria De Filippi chiamasse lei, intellettuale di sinistra, a fare da autore a un suo programma ci andrebbe?» «…Ma io faccio Sanremo» [Francesco Piccolo, giugno 2014] Per la prima volta nella sua storia, il più grande partito della sinistra italiana erede del Pci ha un leader che non ha avuto una formazione comunista. Per la prima volta, quel partito raccoglie oltre il 40 per cento di preferenze. È un risultato che ha ragioni politicamente complesse, contingenti, non riducibili alla sola presenza di Renzi. Però non serve scomodare un raffinato analista per comprendere che non ci stiamo lasciando alle spalle solo le anomalie di vent’anni di Berlusconi. C’era anche l’anomalia di una sinistra non ancora socialdemocratica, incapace agli occhi degli elettori di abbandonare definitivamente la costellazione mitica del comunismo. Non che improvvisamente sia tutto cambiato. Ma dal punto di vista simbolico, è come se le conseguenze del 1989 arrivino solo ora, con quel tipico delay nazionale che fa del nostro Paese una differita permanente, non omologabile alle temporalità occidentali. Ammettiamolo, non era affatto facile. Tanto più che nella storia della sinistra italiana è andata sempre così. Più il peso schiacciante della tradizione comunista diventava politicamente impraticabile, più questa si ritraeva nel mito e aumentava la sua influenza culturale. Così, la parabola umana e politica di Enrico Berlinguer è ancora oggi una tentazione irresistibile per gli esercizi spirituali della nostalgia, della compensazione utopica, delle rivendicazioni indentitarie in salsa vintage. Della contrapposizione tra «folle oceaniche» e individualismo digitale. Tra l’«Italia vera», in canottiera con «L’Unità» sotto il braccio, e l’indifferenza tatuata dei post-italiani di oggi. È anche un melodramma perfetto, come era chiaro già dalla fine degli anni
Settanta. Più Berlinguer si avvitava su se stesso e si indeboliva sul piano politico, più aumentava il suo carisma. Poi la morte. Come ricorda Claudia Mancina in un bel libro su Berlinguer uscito da poco per Laterza, «quella drammatica morte sul palco di un comizio, lo salvò da un più triste declino, e lo consegnò al mito». «Credo che il giorno dei funerali», prosegue, «sapessimo tutti che stavamo celebrando non solo la morte di Berlinguer, ma la fine del Pci. Che infatti arrivò solo cinque anni dopo»3. Morto Berlinguer, Moretti si fa prete. C’è un’immagine de La messa è finita che mi è sempre parsa una formidabile sintesi degli ultimi trent’anni di sinistra italiana, del suo atteggiamento nei confronti del passato, delle sue ansie verso la modernità. Una sintesi della sua stasi post-traumatica. Moretti/Don Giulio seduto di fronte a sua madre distesa sul letto. La veglia funebre, la madre, l’origine, la perdita. L’abito talare e la diversità morale. Chiusi tra quattro mura, in penombra, dentro una stanza arredata come quelle di tutte le nostre nonne. Lo smarrimento di un interminabile pomeriggio dopo pranzo. È il 1985. La messa non è affatto finita. La messa, semmai, era appena iniziata e sarebbe durata trent’anni.
Dimenticare Berlinguer, suggeriva sin dal titolo del suo libro 1996 Miriam Mafai, quando nel 1996 invitava tutti a lasciarsi alle spalle un mito così ingombrante. A riconoscere che quella lettura della società, con in testa la funzione salvifica dei comunisti, era sbagliata. Mafai però era troppo in anticipo. Dimenticava che dalla costruzione dell’autostrada del Sole, osteggiata quale incitamento all’individualismo borghese dell’automobile, all’ostracismo verso la Tv a colori, i tempi di elaborazione della sinistra
seguono percorsi complicati. Nel 2014, attorno alla presa di distanza dal cosiddetto «secondo Berlinguer», quello della questione morale, Francesco Piccolo costruisce il suo desiderio di essere come tutti, vince lo Strega e diventa il portavoce di una sinistra che ora, con l’arrivo di Renzi, si scopre fatalmente insofferente alla propria presunta diversità: Una diversità morale, culturale, di stili di vita che ha prodotto un immediato allontanamento della sinistra dal resto del Paese. Come se ci fosse un’Italia all’interno dell’Italia. L’Italia dei migliori, dei seri, di quelli che lo salverebbero questo Paese se solo non dovessero averci a che fare. [Francesco Piccolo, giugno 2014] Tra i gesti più importanti di Renzi, non c’è il «jobs act» o lo smembramento del Senato. La questione morale non finisce quando si rifiuta di utilizzarla per lo scandalo «Mose», preferendo ai temi etici della purezza della sinistra i problemi strutturali del sistema degli appalti e della burocrazia italiana. La questione morale finisce il 6 aprile del 2013, quando Renzi va da Maria De Filippi, ospite della prima puntata del «serale» di Amici. Dice: ma dov’è la novità? I politici vanno sempre in tv. Insomma. Ci fu il risotto del 1997 cucinato da Massimo D’Alema in maniche di camicia e grembiule per le telecamere di Bruno Vespa. Ci fu Fassino, ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te. Ci commosse tutti ritrovando Elsa, la tata di famiglia – anzi «la signora che stava in casa con noi», come disse lui. Era impacciato ma molto motivato: «Trovo che sia un tratto di normalità partecipare a queste trasmissioni, anzi direi di civiltà». Così disse. Non la pensarono così tutti quegli elettori di sinistra inorriditi dalla partecipazione di Matteo Renzi ad Amici. «Se vuole governare, vada da Napolitano invece che dalla De Filippi», gli rinfacciava persino Enrico Mentana. Dov’è lo scandalo? Noi sappiamo dov’è, ma se dovessimo spiegarlo a chi non sa nulla di cose italiane non sarebbe affatto facile. Forse è il giubbotto di pelle, quello da Fonzie. Quello che ha innescato una serie di rimandi profetici con la battuta di Moretti su Happy Days nel film Aprile («Io me li ricordo alla Fgci, sono cresciuti vedendo Happy Days»). Il grembiule di D’Alema alle prese col risotto era un accessorio d’obbligo. Fassino era vestito come a un matrimonio o a un funerale. Entrambi avevano pur sempre l’aria di passare lì per caso, di concedersi dall’alto. Renzi, vestito così, sembra proprio uno di loro. E poi la De Filippi di Fassino era quella della nostalgia e del passato che ritorna, tutta roba che a sinistra è stata
ampiamente sdoganata da Fazio, ovviamente con il culto degli anni Settanta. Amici, invece, è un cumulo di disvalori. Era profetico Berlinguer denunciando lo strapotere della partitocrazia italiana che aveva occupato ogni spazio del Paese. Ancora più profetico era il timore di Natta che, commentando la celebre intervista di Scalfari a Berlinguer sulla questione morale, diceva: «C’è il rischio che la condanna appaia generale e sommaria, che il metro di giudizio risulti quello morale e non quello politico… che la contrapposizione tra gli altri e noi diventi così profonda da non lasciare margine a nessuna politica, da isolarci, da alimentare una intransigenza morale, una denuncia radicale ma sterile». La questione morale inizia con Scalfari e finisce con Maria De Filippi. Almeno quella che celebrava la diversità strutturale, etica e morale della sinistra comunista. Quella che non sarebbe mai andata ad Amici. L’intervista di Scalfari si intitolava, com’è noto, I partiti sono diventati macchine di potere. Si parlava di costruzione «seria» del socialismo tra analisi implacabili e varie lungimiranze. Si denunciava con grande lucidità il male strutturale dello Stato italiano (un Paese con istituzioni deboli schiacciate dal primato della politica e occupate dai partiti). Ma quando Scalfari chiedeva le cause – «me ne dica una, almeno una» – Berlinguer rispondeva «dico quella che, secondo me, è la causa prima e decisiva: la discriminazione contro di noi». Ce l’aveva con la «democrazia amputata», con l’esclusione del Pci dal governo nella logica della guerra fredda, certo. Ma di tutto il lungo ragionamento restarono due concetti soli e inseparabili: «questione morale» e «diversità». Siamo diversi, cioè ci fossimo stati noi, caro Scalfari, non staremmo qui a raccontare questo sfascio. E siccome non ci siamo stati, non avremo mai neanche la controprova. Berlinguer ovviamente era cauto. Diceva cose come: «Per-una-rispostachiara-alla-sua-domanda-elencherò-per-punti-molto-semplici-in-che-consisteil-nostro-essere-diversi-così-spero-non-ci-sarà-più-margine-all’equivoco». Ma l’equivoco restò eccome. Si espanse come un buco nero nell’universo della sinistra. Tanto che mentre scrivo, a Venezia stanno facendo i flash-mob per la questione morale come rito propiziatorio per scacciare le tangenti.
Nel 1981 nasceva una nuova prospettiva di alterità dentro un immaginario
politico da sempre disponibile alla dimensione messianica. Via il mito della Rivoluzione e della lotta di classe, dentro la questione morale come religione civile. Non avremo mai la maggioranza degli elettori, ma siamo il popolo eletto. Sull’analisi storica, concreta (e ampiamente discutibile) di Berlinguer, calava lo Spirito Santo di una diversità etica e morale che irradiava tutto il «popolo della sinistra». Si gettarono le basi di un «razzismo etico», scriverà (esagerando un po’) tanti anni dopo Luca Ricolfi. Ecco perché la questione morale è finita in prime-time, su Canale 5, il 6 aprile del 2013. Il vero Aprile l’ha fatto Renzi, non Moretti. Per carità, si era già detto varie volte, Renzi in testa, «la diversità etica della sinistra non esiste. Ci sono buoni e cattivi politici». Un’affermazione banale in qualsiasi Paese a forma di democrazia. Da noi, quasi una provocazione. Certo, lo aveva detto anche Bersani. Però un conto è sedersi sul divano di Fazio e dire che non esiste più, altro è mettersi un giubbotto di pelle e andare ad Amici. Il monologo di Renzi da Maria De Filippi ruotava attorno a una serie di ovvietà sulla speranza e i giovani. Ma non è il messaggio. È il medium che conta. Si dirà: per provare a prendere un po’ di voti dei giovani soprattutto del Sud ci voleva tutto questo baraccone? Forse sì, forse no. In ogni caso c’è anche dell’altro. In un film di Moretti degli anni Settanta o in una riunione della Fgci avremmo detto: «Per stabilire un legame con le masse dobbiamo agire in conformità con l’ammissione dell’esistenza di un’altra metà del Paese». Che poi sarebbe quella che abbiamo sempre schifato.
Francesco Piccolo, per dire, ha il desiderio di essere come tutti ma da Maria De Filippi non ci andrebbe. Si ferma a Sanremo. Lo Stato non si abbatte, si canta. Nelle interviste a ridosso del Premio Strega lo scrittore ci spiega che «la ricerca del compromesso in politica è il fondamento stesso dell’idea del progresso». Nel paese di Machiavelli non dovrebbe suonare insolito, mentre a sinistra diventa una «provocazione». Piccolo allora si ritaglia il ruolo di colui che ha vinto il Premio Strega con un «libro scomodo» («Il mio libro infastidisce chi ha un’idea pura della sinistra»). Nel frattempo, la sinistra pura riempie i cinema di falci e martello. Nei documentari di Walter Veltroni e Mario Sesti (in collaborazione con Theo Teardo), Berlinguer se la passa benissimo. Un’operazione vintage in grande stile. Sesti racconta la «grana» della voce di Berlinguer, alla Roland Barthes. La voce come reliquia laica. Veltroni lo spiega ai più giovani. Anzi, fa «il selfie di una generazione» (Denise Pardo, «L’Espresso», 21 marzo 2014). La voce di Berlinguer ricompone l’Italia in un montaggio tra gli ultimi discorsi del leader del Pci, quelli a tinte più messianiche, e le immagini di repertorio del LUCE. Non solo le assemblee di partito ma anche segmenti sparsi del Paese, film di famiglia, reportage, Pasolini e Bertolucci. Un’Italia «vera», «autentica». La gente vera, la piazza piena, le lucciole. L’affinità elettiva tra cultura italiana e modi del rimpianto, che sia per la «vera politica» o il pane fatto in casa, trova nel culto di Berlinguer una sua forma pura: La voce di Berlinguer, la sua parola, e i volti antichi, attenti, appassionati delle folle oceaniche degli anni ’70 ci precipitano in un mondo autentico, vitale, corporeo, ancora carico di speranza, forse di illusioni, appena prima che la cosiddetta modernità, e quelli che il segretario del Pci definiva i suoi alfieri, cancellassero una politica destinata a trasformarsi e smaterializzarsi nei tweet. [Massimo Sebastiani, ANSA] La sua voce echeggia sopra le folle di militanti, sui primi piani dei volti […] Uomini e donne, corpi, persone reali, quando ancora la politica non aveva conosciuto la smaterializzazione della Rete. [Gabriella Gallozzi, «L’Unità»] Il documentario sottolinea la sobrietà di Berlinguer in contrasto con la smania di protagonismo dei nostri giorni. [Gloria Satta, «Il Messaggero»] «Quanto c’è di lei in questo docufilm?» «Ci sono i miei due grandi amori,
la politica, in particolare Enrico Berlinguer, e il cinema: a 18 anni era quello il mio progetto. La vita mi ha portato a vivere altro, giornate meravigliose» [Walter Veltroni, 2014]
Quando c’era Berlinguer è invece una di quelle mirabili forme del compromesso storico, o del ma anche veltroniano, che Berlinguer non ha potuto vedere. Patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali (ma anche) prodotto da Sky. Proiettato in una fastosa anteprima all’Auditorium di Roma, che è anche «uno dei simboli del ritorno della grande architettura a Roma», come diceva il regista del film, ma anche ex sindaco della città e promotore dell’opera. Giustamente, Umberto Pizzi da Zagarolo, fotografo di Cafonal, non si è lasciato sfuggire l’occasione del red carpet parastatale, con l’abbraccio affettuoso tra cinema, Stato, e politica italiana. Giorgio Napolitano che si commuove. La grandezza di Pietro Ingrao. La voce di Toni Servillo. Il Pci in bianco e nero. E soprattutto le parole e la fascinazione di Enrico Berlinguer, l’ultimo grande della sinistra italiana, come disse Sandro Pertini, forse il suo unico vero mito. Quando c’era Berlinguer è il docufilm di Walter Veltroni sul segretario più amato del Pci con il ritmo delle testimonianze e il peso dei ricordi, persino un tramonto su una spiaggia sarda con la bandiera rossa, e le onde contro il gozzo celeste di Berlinguer. Nel trentennale della scomparsa, Veltroni non risparmia nulla, tantomeno i sentimenti. E alla fine viene fuori anche il “selfie” impietoso di una generazione, il pugno alzato di Giuliano Ferrara, i baffi di Nando Adornato dietro a una falce e martello, e di quella parte del Paese, (nel ’76 un italiano su tre) che non è riuscita a diventare quello che sperava. [«L’Espresso», 21 marzo 2014]
Quella parte del Paese che non è riuscita a diventare quello che sperava. Ma cosa sarebbe dovuta diventare? Qui certo potrebbe partire un lungo elenco di carenze, inadempienze, arretratezze strutturali del Paese che ci risparmieremo. Ma persino assecondando il mantra delle conquiste della modernità che interessavano solo un italiano giusto su tre, l’impressione è che la posta in gioco in fondo fosse un’altra. Il rimpianto non è quello di aver mancato la possibilità di fare le riforme giuste. Qui non bisognava cambiare solo le regole del gioco, bisognava cambiare i cuori e le menti delle persone, come in ogni melodramma che si rispetti. Per questo – ce lo ricorda Alberto Crespi nella sua recensione su «L’Unità» – «Quando c’era Berlinguer è un documentario forte e struggente di fronte al quale piangerete tutte le vostre lacrime». Tutte. […] finora certi giudizi negativi sull’ultimo Berlinguer sembrano non aver mai incrinato, a sinistra, una diffusa e prevalente inclinazione alla nostalgia. E questo ha avuto e ha conseguenze politicamente non irrilevanti. Nasce anche dal mito berlingueriano della diversità comunista, infatti, l’idea che vi sia una parte del Paese strutturalmente, qualcuno ha scritto antropologicamente, superiore all’altra. Nasce da lì, dall’incapacità di dimenticare Berlinguer, o meglio dall’incapacità di consegnarlo definitivamente alla storia, quel «complesso dei migliori» che Luca Ricolfi ha segnalato come una delle cause profonde della crisi del Pd. [Giovanni Belardelli, «Corriere della sera», 29 giugno 2009] «Matteo, credi in noi!» [video-appello del quotidiano «L’Unità», campagna per salvare il giornale dalla chiusura, luglio 2014]
3
C. Mancina, Berlinguer in questione, Laterza, Bari 2014, pp. 4-5.
L’estasi della politica La crisi della sinistra è al centro del recente, acclamato film di Roberto Andò, Viva la libertà (2013), tratto dal libro di Roberto Andò, Il trono vuoto, primo romanzo di Roberto Andò. Enrico Oliveri (Toni Servillo) è un politico navigato del centro sinistra. I sondaggi lo danno perdente alle prossime elezioni. I suoi vorrebbero farlo fuori. Preso dall’angoscia, Olivieri scappa. Si rifugia in incognito a Parigi da Danielle (Valeria Bruni Tedeschi), fiamma di gioventù ora sposata con un famoso regista orientale di nome Mung. Il giovane braccio destro di Olivieri, Andrea Bottini (Valerio Mastandrea), è l’unico che sa della fuga, ma tiene nascosta la cosa per non gettare nel panico il partito. Per prendere tempo, diffonde la notizia di una presunta malattia di Olivieri. Intanto, ecco l’idea. Sostituire Olivieri con suo fratello gemello (Toni Servillo II), scrittorefilosofo che si fa chiamare Giovanni Ernani e riposa in una clinica psichiatrica. Gioco degli equivoci a seguire. Il finto Olivieri è imprevedibile, sopra le righe. Coi suoi discorsi così lontani dai tatticismi della politica ridà speranza alla sinistra. Il partito risale nei sondaggi. Fino a che il vero Oliveri non decide di tornare. Grossomodo, la critica è concorde sulla seguente lettura del film: Andò viaggia tra Shakespeare e Pirandello. I due Servillo mettono in scena il conflitto tra l’utopia e la politica. Il desiderio di riscatto del Paese. L’Italia chiamò, Roberto Andò. Ma sono anche le due anime della sinistra. Due a tenersi stretti, ma insomma ci siamo capiti. Il cuore o il realismo. La vocazione maggioritaria o la follia. Siamo-comegli-altri oppure siamo diversi. Con la follia l’opposizione ritrova lo slancio perduto. Basta che alla domanda sul gioco delle alleanze Olivieri II risponda: «L’unica alleanza possibile oggi è con la coscienza della gente» e giù uno sdilinquimento generale. Su Twitter, Vendola ha scritto: «Viva la libertà è un film emozionante. Consiglio al centrosinistra di andare a vederlo». Per «Micromega», Olivieri II è «il new deal della speranza, una riscossa della decenza, l’evidenza del giusto». Secondo «Il Fatto Quotidiano», «il bellissimo film di Roberto Andò è l’estasi della politica e di quello che desiderano certamente oggi gli italiani, risvegliatisi (non tutti ma buona parte) da decenni di coma profondo». Non tutti, ma certamente buona parte (o la
parte buona). Qualcuno però, timidamente, evoca lo spettro di Grillo. Viva la libertà esce nei cinema poco prima delle elezioni del 2013 (24-25 febbraio) e nel giro di qualche giorno diventa un film profetico. D’accordo l’irruzione della follia. Va bene togliere la maschera a un apparato che non fa più sognare da vent’anni. Ma allora l’Olivieri folle è Grillo. Di sicuro non è Renzi. Qui non si tratta del nuovo. Non vogliamo il nuovo. Vogliamo qualcosa di completamente diverso che riprenda il discorso interrotto nel 1984 (anche nel film di Andò non manca l’icona di Berlinguer). Per affermare la propria diversità la sinistra di Viva la libertà ha due strade. Una porta a Parigi. A dimenticare tutto nell’oblio del cinema d’autore, della musica colta, tra donne eteree e raffinate che però te la danno. È a Parigi che si celebra il matrimonio tra «diversité culturelle» e questione morale. A Parigi con Mung, che interrogato dal vero Olivieri sul film cui sta lavorando tuona: «Non mi interessano i film di cui si possono raccontare le storie!». L’altra strada è restare in Italia e rilanciare il sogno ma a vocazione maggioritaria. Ritrovare l’utopia dentro la follia di Olivieri. Però, lo si capisce, è sempre un modo per riaffermare la propria sinistra alterità rispetto al Paese. Siamo diversi. Lo siamo o perché più raffinati e in grado di apprezzare i film senza trama di Mung, o perché più folli, poetici e visionari. E però vogliamo pure vincere. Come se ne esce? E qui succede una cosa che la critica non nota. Forse non la nota nemmeno Andò. C’è una scena chiave del film. Olivieri II ha appuntamento con una pseudo-Angela Merkel che nel film è vestita come Jessica Fletcher. Si chiudono in stanza per parlare della grave situazione europea. Andrea Bottini/Mastandrea è preoccupato. Sa che l’Olivieri folle è capace di qualsiasi cosa. Allora sbircia dal buco della serratura. E cosa vede? Li vede ballare. Olivieri e la pseudo Merkel stanno ballando il tango. Col caschè. Negli occhi di Bottini si accende la fascinazione. È rapito, sedotto. Ecco la frase che Bottini rivolge a Olivieri II dopo la scena del tango: «Solo a pensarci mi vengono i brividi ma io uno come lei lo voterei». L’Olivieri di prima era noioso, prevedibile, depresso. Suo fratello canta e balla. Inventa ritornelli, gioca e scommette sul vuoto. Piace. Seduce le donne. Balla il tango con la Merkel. Bottini scopre con orrore che la cosa non gli dispiace. Che quasi lo preferisce al grigio segretario del suo Partito. Ecco il rimosso ancestrale, l’oscena verità, l’incesto inconfessabile. Ecco l’ultimo tabù: un PD con un leader vitale. Un PD che restituisce l’Imu. Un PD con la follia seducente di Berlusconi. L’estasi della politica.
È il dramma della sinistra colta, riflessiva e conformista di questi trent’anni, che voleva governare un Paese che non conosce. Quella che ogni giorno dopo le elezioni, si guarda in faccia e si domanda: “ma-dov’è-la-genteche-vota-Berlusconi?”. Quella che “basta-lascio-il-Paese”, ma poi resta qui. Che immaginava un Paese pronto ad adeguarsi ai suoi tic, ai suoi libri, ai suoi film. Amare Brecht e il cinema di Mung. Ma il Paese non capisce e non si adegua. Peggio per lui. Raramente, l’avvitamento nel vuoto della sinistra e del cinema italiano sono stati messi così allo specchio. La crisi ideologica di una diventa la crisi di idee dell’altro. Ma nel film di Roberto Andò c’è spazio anche per Fellini. Un Fellini di repertorio. Sono le immagini di un telegiornale dove vediamo il «Maestro» impegnato nella dura battaglia legale contro le interruzioni pubblicitarie dei film trasmessi in televisione. È Mung regista a mostrare all’autoesiliatosi segretario del PD il video con Fellini. Ma incorniciandolo dentro una lapidaria sentenza che, complici gli occhiali scuri (e questo nome che rimanda più a Flash Gordon che al cinema orientale) sembra uscita da Matrix: «Quando le televisioni sono andate a spiare la sua morte [di Fellini] la loro vera missione era annunciare la fine di un mondo e la nascita di un nuovo ciclo, la politica come invenzione costante della realtà, come impostura». Un nuovo ciclo in cui non c’è più spazio per le utopie del cinema né per quelle del comunismo. Piuttosto discutibilmente, se non altro sotto il profilo politico, Viva la libertà riposiziona quindi Fellini accanto a citazioni di Brecht e all’icona di Enrico Berlinguer, patroni di un’Italia tradita e scomparsa. Fellini come variante artistica della «questione morale». Fellini travolto dall’imbarbarimento televisivo della società italiana cui ha provato a opporsi con gli ultimi aneliti del cinema4. Poi tutto è svanito per sempre, come ammonisce l’apocalisse di Mung.
La simbiosi tra cinema (d’autore) del passato e (vera) sinistra è insomma uno dei motivi ricorrenti di questo melodramma collettivo. Proviamo a ricostruirne un possibile percorso. 4
Su questi temi, e sulla ricostruzione del confronto tra Fellini e Berlusconi attorno alla legge per le interruzioni pubblicitarie dei film trasmessi in televisione, mi permetto di rinviare il lettore a A. Minuz, Viaggio al termine dell’Italia. Fellini politico, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012.
C’era una volta la sinistra, c’era una volta il cinema Non mi avete convinto. Pietro Ingrao, un eretico è un recente documentario dedicato al 98enne protagonista del Pci. Una sorta di appendice visiva del suo libro di memorie, Volevo la luna, costruita in un immaginario dialogo a distanza tra Ingrao e uno studente degli anni Settanta, chino sui libri dentro una stanza che sembra uscita dal set di Anima Mia, con il «Subbuteo», i poster dei Nomadi, Che Guevara, e via dicendo. Un passaggio del testimone tra il «vecchio» e il «nuovo», tra l’anziano leader politico e la giovane generazione che però abita un oscuro futuro imprigionato negli anni Settanta. Ingrao rievoca la sua storia e la propria passione politica come «strumento per cambiare un mondo che non mi piaceva». Ma nella prima parte del documentario parla soprattutto dell’importanza che nella sua vita ha avuto il cinema. Nel cinema si plasmano tutti i suoi ricordi. Così, ad esempio, prende forma uno dei suoi primi comizi subito dopo l’8 settembre: «Mentre parlavo alla folla sono arrivati i soldati, ma una donna si è staccata e si è arrampicata su un carro armato, e i soldati sono andati via, tutto era come un film di Ejzenstejn e Pudovkin». Poi l’ammirazione per Chaplin, poi la scoperta del neorealismo e del cinema italiano come strumento di lotta e di denuncia delle ingiustizie sociali. Sono molti i riferimenti citati da Ingrao, e nota è d’altronde la sua passione cinematografica. Qui però ci interessa la piena sovrapposizione tra l’immaginario del cinema e la storia della sinistra che si fa strada nel suo discorso, non solo nelle forme della nostalgia. Ci interessa cioè la costruzione di un gioco di specchi tra «crisi della sinistra» e «crisi del cinema», in cui una diventa metafora dell’altra. C’era una volta il cinema, c’era una volta la sinistra. Le evocazioni cinematografiche di Ingrao culminano con un’epifania. La sua stessa apparizione nel film di Ettore Scola, Dramma della gelosia. Tutti i particolari in cronaca (1970). La scena in cui Mastroianni, operaio comunista, si reca al comizio del Pci in piazza San Giovanni. Racconta Scola in proposito: «Quando per Dramma della gelosia dovevo girare la scena del comizio, ricordo che era un periodo di elezioni e c’erano quindi in giro diversi comizi. Io ho preferito aspettare quello del partito comunista, e proprio quello di Pietro Ingrao in Piazza San Giovanni a Roma, non solo perché ho
sempre percepito nel partito comunista una vicinanza ideale, ma perché ho sempre pensato a Pietro Ingrao, in primo luogo, come al politico più vicino ai drammi della povera gente»5. Proprio in questa scena citata da Scola, con Mastroianni in pieno dubbio esistenziale che non sa se sia più giusto pensare ai problemi del partito o alle sue pene d’amore, si trova uno dei motivi di fondo del suo cinema. Vittorio Spinazzola lo sintetizzava in modo assai efficace, riprendendo il dramma del deputato intellettuale che ne La terrazza (1980) sogna a occhi aperti di esporre dalla tribuna del congresso il quesito che lo assilla: «Come conciliare la ricerca della felicità individuale con la consapevolezza degli obblighi di solidarietà fattiva che legano l’io agli altri, e che possono o debbono indurre al sacrificio di sé»?6 È uno dei quesiti chiave che scandiscono il racconto di C’eravamo tanto amati, uno dei migliori film di Scola e di tutta la commedia all’italiana, ma anche un’opera decisiva per pensare al rapporto tra la sinistra e il cinema italiano dall’interno di questo motivo strutturale, cioè l’omologia simbolica del loro arco di trasformazione. Com’è noto, il film è una lunga cavalcata che va dai giorni della lotta partigiana al 1975 passando per gli anni della ricostruzione, il boom e le lotte degli anni Settanta. Si dipana lungo il triplice punto di vista di Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) e Nicola (Stefano Satta Flores) e dei loro rispettivi rapporti con Luciana (Stefania Sandrelli), giunta a Roma col sogno di diventare attrice. È il percorso di una progressiva disfatta degli ideali inseguiti in gioventù, ben sintetizzati dalla parabola del personaggio di Gianni che da eroe partigiano si ritrova infine ricco palazzinaro corrotto e corruttore. Con consueto cinismo, gli sceneggiatori Age e Scarpelli siglano attorno a lui la frase simbolo del film: «Sono i Gianni Perego che cambieranno questa società», dice Antonio, ignaro dell’evoluzione in nemico di classe del suo excompagno di lotte. Una parabola tristemente esemplare, dunque, per un discorso che il film esibisce sin dal titolo (non a caso il progetto iniziale prevedeva un racconto costruito attorno al solo personaggio di Gianni). In questo discorso però, chi ci interessa di più è Nicola. Insegnante con velleità intellettuali, responsabile del cineclub di Nocera Inferiore, dove proietta Ladri di Biciclette nell’indifferenza generale, il professore Nicola Palumbo si lancia all’inseguimento di una carriera da critico cinematografico
senza fortuna. I suoi sforzi trovano invero un picco di visibilità nella partecipazione alla trasmissione «Lascia o Raddoppia», dove si presenta come esperto del cinema di De Sica. Uscirà sconfitto anche da lì. In una delle ultime scene, quasi un’epifania che sintetizza tutto il senso del film, Nicola incontra finalmente Vittorio De Sica. Dopo averlo idealmente inseguito per tutta la vita, anziché rivolgergli la parola si lascia andare a un’amara considerazione, alla malinconia del tempo perduto: «E adesso cosa dovrei dirgli […] dovrei parlargli di illusioni, speranze, delusioni… credevamo di cambiare il mondo, invece il mondo ha cambiato noi… cose tristi, ammoscianti… per me e forse anche per lui». Uno struggimento amplificato dai primi piani di De Sica che Scola interpone alle parole di Palumbo. Un De Sica ormai anziano, stanco, ritratto poco prima della morte. La crisi degli ideali politici di Nicola è insomma tutt’uno con la fine di una gloriosa stagione del cinema italiano. È un malinconico «come eravamo» che trova il suo zenit negli omaggi ad Antonioni e Fellini (con quest’ultimo che entra in persona nel film, in un remake delle riprese de La dolce vita a Fontana di Trevi con Marcello Mastroianni), e una formidabile parodia cinefila di Ejzenstejn virata dalla scalinata di Odessa a quella di Piazza di Spagna, con Palumbo che ripercorre tutta la celebre sequenza della Corazzata Potëmkin.
La traiettoria di Palumbo è un segmento decisivo all’interno di una più profonda disfatta degli ideali della sinistra e di una trasformazione della società puntellata dal cinema italiano fino all’arrivo della televisione. Alcuni recensori del film mettevano in gioco un parallelo tra il personaggio di Satta Flores e lo stesso regista: «[…] è la storia agrodolce di un fallimento generazionale, una cavalcata dal ’45 ad oggi attraverso eventi, aneddoti, personaggi che hanno caratterizzato il melanconico cammino verso la morte di tutte le illusioni. E implicito vi è il mea culpa dello stesso Scola il quale ci sembra abbia inteso identificarsi in Nicola». [«Epoca», 11 gennaio 1975] È certo questa dimensione protoromantica, il motivo dell’illusione perduta e del destino umano che non va nella direzione sperata, ad aver trasformato C’eravamo tanto amati in un epitaffio del cinema italiano che fu.
Tuttavia, la strategia messa a punto qui da Scola – raccontare il Paese e le sue illusioni con particolare riferimento a quelle della sinistra in un gioco di
specchi col cinema, costruendo cioè un simbolico parallelo tra la perdita di un «noi» collettivo e il tramonto di un’era ormai travolta dalla televisione – si offre come una soluzione assai duttile, se non del tutto serializzabile: «[…] il film è l’amara confessione di una delusione, di una generazione che è stata tradita dalle forze ideologiche, che non ha mantenuto la fiducia riposta e che ha svuotato i contenuti che avevano alimentato tante e nuove speranze, non sa che pesci pigliare […] Il protagonista non sa più da che parte stare e come venirne fuori. Rimane un incerto, un immaturo. E credo sia questo il motivo per cui nel film vengono inseriti spezzoni del Dottor Zivago: vedi passare Lara, dopo averla tanto cercata e non riesci ad afferrarla: insegui la verità, le sei vicino, ma non riesci a fermarla dentro di te, e resti deluso e confuso e quasi morto dentro, in piena confusione tra presente e passato» [Film discussi insieme – 19907] Sono passaggi tratti da alcune recensioni di Palombella rossa di Nanni Moretti (1989). Passaggi intercambiabili con le letture di C’eravamo tanto amati. Basta sostituire Lara del Dottor Živago con Vittorio De Sica. Naturalmente, la critica più raffinata ci ricorda quanto sia riduttivo leggere Palombella rossa dentro il solo orizzonte della crisi della sinistra (ma lo stesso dicasi per il film di Scola)8. Però è indubbio che il film si presenti anzitutto come la variazione poetica dell’interrogativo che il documentario La cosa avvicinava in forma di inchiesta, ovvero: «Cosa vuol dire [oggi] essere comunisti?»9. Attraverso l’espediente narrativo della perdita di memoria dell’alter-ego di Moretti, Michele Apicella qui funzionario del Pci, e sfruttando l’insolita ambientazione di una partita di pallanuoto, Palombella rossa mette in gioco molteplici allegorie. Si arrovella in un flusso di coscienza che gravita sopra i motivi dell’infanzia perduta, l’afasia del linguaggio, l’infelicità, la crisi dei rapporti umani. «Siamo diversi ma uguali, la gente è infelice, è troppo infelice e aspetta noi, e noi sappiamo dove andare». Dove? Michele si schianta con la sua auto in un fosso. Però si salva e riesce a vedere il Sole dell’Avvenire di cartone che illumina il Circo Massimo, come la brutta scenografia di un concertone con Venditti e Fiorella Mannoia, o le celebrazioni di uno scudetto della Roma. Una metafora struggente che magari oggi non tutti sanno cogliere. Tanto che il primo commento che compare sotto il video della scena su YouTube ne riassume lo spirito con una constatazione lapidaria: «La Uno è di una solidità impressionante». La perdita di confini tra passato e presente, la pallanuoto e l’anonimia del
luogo dell’azione (la piscina) costruiscono un film postmoderno che avanza per salti, ellissi e allusioni. Moretti intreccia nel segno della «crisi» i diversi piani del racconto: crisi dell’ideologia, crisi del protagonista, crisi del linguaggio, crisi del racconto, crisi del cinema, crisi della sinistra, crisi di nervi. Ma il riferimento a Živago è più che un vezzo cinefilo. Le quattro scene in cui vediamo inserti dal film di David Lean del 1965, trasmesso alla televisione del bar della piscina, scandiscono l’arco narrativo di Palombella rossa in un percorso parallelo che culmina nel momento decisivo del rigore. La scena è celebre. Improvvisamente, poco prima di tirare, Michele esce dall’acqua come ipnotizzato. Va verso il bar seguito dal pubblico sugli spalti, tutti presi da un inspiegabile incantamento. La piccola folla si raduna quindi davanti al televisore dove si consuma il dramma di Živago che crolla a terra, ucciso da un infarto mentre invano cercava di raggiungere Lara, intravista per le strade di Mosca. Seguono mani nei capelli, urla e boato di stizza di una folla affranta. Qui Moretti mette in scena un meccanismo esemplare del melodramma. Alla base della costruzione del pathos melodrammatico sta sempre uno scarto tra ciò che noi sappiamo già e ciò che invece il personaggio deve scoprire. Il senso di impotenza dello spettatore è innescato dal fatto che non può mostrare al personaggio ciò che andrebbe fatto. Deve solo attendere e sperare. E l’impatto emotivo sarà tanto più forte quanto lungo sarà stato l’arco di tempo necessario alla consapevolezza di dover cambiare gli eventi, fino al caso limite del finale tragico in cui non c’è più tempo, e può aprirsi solo lo spazio del rimpianto. La distanza dall’oggetto-perduto, la separazione, l’incompiutezza, il destino avverso e gli altri tòpoi del melodramma di Živago e di ogni melodramma, sono lo sfondo in cui Moretti cala il proprio smarrimento esistenziale. Il suo rapporto col presente e con il passato. E l’unico momento del film in cui Moretti si concede di alzare il pugno chiuso è davanti ai paesaggi russi di Živago alla tv.
Al di là dell’ironia, c’è un richiamo a quel gioco di specchi che C’eravamo tanto amati illustra in chiave popolare e che Palombella rossa si incarica invece di elaborare in un orizzonte più intellettuale: quello del tramonto del secolo del cinema e del comunismo, cioè dei due dispositivi collettivi che più hanno forgiato sogni, illusioni, bisogni, utopie del Novecento. Il film è presentato al Festival di Venezia del 1989. Siamo ai primi di settembre. A novembre cadrà il muro di Berlino. «Mi è piaciuto l’applauso scoppiato in sala quando il protagonista, Michele, dice: “Io sono comunista”. Perché esiste un problema di identità, ma esiste anche una storia, un passato, una funzione da difendere. Mi spieghi per quale motivo il Pci deve seguire il giornalismo italiano se quello pone all’improvviso il problema del nome? È davvero una cosa senza senso. Come ho trovato fuori luogo, sui manifesti elettorali, quell’insistenza sull’aggettivo nuovo. Un partito non è una merce, un’azienda che cambia gestione. Magari divago, però è giunto il momento di ridimensionare l’importanza della pubblicità è delle trappole propagandistiche»
[Nanni Moretti, «L’Unità», 17 settembre 1989] D’altro canto, il film di Moretti usciva alla fine di un decennio segnato dal sorpasso definitivo dell’immaginario televisivo su quello cinematografico. Palombella rossa, pur nella sua specifica cifra poetico-morettiana, era insomma parte di un più vasto mainstream nostalgico del periodo. Si pensi, solo per restare al cinema italiano a La voce della luna, ultimo film di Federico Fellini, segnato dall’amara incomprensibilità di un mondo postcinematografico; o a Nuovo Cinema Paradiso (G. Tornatore), tra i maggiori incassi della stagione, di cui i giornali scrivevano: «è un melodramma, ma rivisitato con l’ottica nostalgica che celebra elegiacamente la morte del cinema»10; oppure «apologia-rendiconto dove divampa ora sotterranea, ora tutta irruenta, una prodiga memoria degli affetti, di irripetibili stagioni di un tempo ormai mitico»11. Salta agli occhi, sostituendo al discorso sul cinema quello sul comunismo il debito verso le strategie del melodramma di tre film pur assai diversi come C’eravamo tanto amati, Palombella rossa e Nuovo cinema Paradiso.
La tensione degli ideali del passato e l’«amore per il cinema» si fondono in
una comune dialettica dell’identità perduta, in un medesimo processo di rivendicazione affettiva. Poi, come ci ricordava Mung nel film di Roberto Andò, è arrivata la televisione. «Non mi piace la Tv perché involgarisce tutto», dice Moretti nelle interviste che accompagnano l’uscita di Palombella rossa. E anche l’antagonismo tra cinema e televisione commerciale si forgia nel cinema italiano con il tratto decisivo dei conflitti a tinte fosche del melodramma. Lo spiegano bene anche alla recente mostra dell’«Istituto Luce» nel complesso del Vittoriano a Roma. Quando il visitatore sta per lasciare la stanza che racconta l’Italia degli anni Settanta, un cartello lo avverte: «Presto anche le fiammate giovanili si esauriranno e la neotelevisione imporrà i suoi linguaggi totalitari». Si veda a titolo riepilogativo il documentario, Di me cosa ne sai? (V. Jalongo, 2008), una ricostruzione della crisi economica del cinema italiano con una tesi assai discutibile (è stato ucciso da Berlusconi) e una narrazione lacrimevole, del tutto esemplare di questa retrospezione rosea del passato, dell’inseguimento di un’epoca mitica segnata dalle passioni (di sinistra) e dal cinema (d’autore).
È solamente nel passato che si ritrova la modalità dominante
dell’autenticità politica e artistica. La nostalgia per un cinema «vero» non ancora vampirizzato dalla televisione commerciale e la nostalgia del comunismo – non di quello «reale», ma di quel sogno collettivo che mobilitava un «noi» identitario – viaggiano assieme. Un «noi» che Palombella rossa ricompone in un unico slancio affettivo soltanto davanti al finale del Dottor Živago trasmesso alla tv. Che ne è dunque di questo «noi» nel mondo privato del sogno del comunismo?
5
G. Berardi, Ettore scola: il racconto dell’identità nazionale. Intervista consultabile all’indirizzo www.taxidrivers.it/23152/rubriche/ETTORE-scola-il-racconto-cinematografico-dellidentitanazionale.html. 6
V. Spinazzola, Cinema e pubblico. Lo spettacolo filmico in Italia, 1945-1965, Bulzoni, Roma 1985, p. 360. 7
Recensioni degli spettatori del film, raccolte e pubblicate dal Centro Culturale San Fedele in Film discussi insieme 1990, Vol. 30, Milano 1990, p. 274. 8
Sul cinema di Moretti si vedano V. Zagarrio (a cura di), Lo sguardo morale, Marsilio, Venezia 2012; R. De Gaetano, Nanni Moretti: Lo smarrimento del presente, Pellegrini, Cosenza 2011. 9
Cfr. M.C. Zizolfi, Che cosa significa essere comunisti?A postmodern portrait of the Italian communist party in Nanni Moretti’s Palombella Rossa and La Cosa / tesi di laurea; supervisor: prof. John Foot; correlatore prof. Salvatore Veca [2008] - 1 CD-ROM (62 p.); 12 cm. (Tesi discussa presso MA Film Studies, University College London, 15 September 2009). 10
M. Morandini, recensione in «Il Giorno», 11 marzo 1989.
11
S. Borrelli, «L’Unità», 20 novembre 1988.
Virzì e l’Italia Giusta Ventotene, esterno notte. Estate. Il giornalista Sandro Molino e il negoziante Ruggero Mazzalupi discutono animatamente di fronte a una piccola folla di curiosi. Sorvoliamo sull’antefatto che innesca il diverbio e passiamo al serrato botta e risposta che ben presto trascende in politica. «Io non voglio avere niente a che fare con lei», dice Molino. «Ma scusi ma cosa le ho fatto io?»: - Che cosa mi ha fatto?… Che cosa stanno facendo quelli come voi a questo Paese… - Ma quelli come “voi” chi?… - Quelli che buttano l’immondizia in mare, quelli che vanno in giro armati, quelli che se ne fregano delle regole, che non hanno rispetto per le persone e per le cose, quelli che guardano solo la televisione, che disprezzano la cultura, che hanno votato per tutta la vita i partiti di governo […] - Ma che ne sa lei di quello che ho votato io? Io poi i partiti li ho votati tutti… Ma mi consenta un attimino perché… voglio dirle… voi intellettuali vi atteggiate tanto, parlate così sofistici, state sempre a analizza’, a critica’, a giudica’ ma lo sa qual è la verità?… La verità è che non ce state a capì più un cazzo… ma da mo’! Parliamo ovviamente di Ferie d’agosto, film del 1996 diretto da Paolo Virzì, che con brillante stereotipia metteva a confronto due gruppi sociali opposti che si ritrovano in vacanza uno di fianco all’altro. Un confronto che, proprio in questa scena ricca di spunti per il nostro discorso, trovava una sua sintesi efficace. Chiunque rivede il film oggi potrà constatare che, Renzi e Grillo a parte, poco o nulla è cambiato in questi vent’anni. Memore della lezione della commedia all’italiana, del filone vacanziero e del cinema dei Fratelli Vanzina in particolare, Ferie d’agosto sembra tenersi alla larga da un giudizio morale per posare semmai uno sguardo affettuoso su uno spaccato della società italiana a metà degli anni Novanta. È un racconto di frustrazioni e malinconie intercambiabili tra un ceto e l’altro, tra la piccola borghesia dei Mazzalupi e quella pseudo-colta e progressista dei Molino. La cornice politica in cui fa muovere i suoi tipi umani è naturalmente più che una vaga allusione (come già un anno prima in Selvaggi, di Carlo Vanzina, precoce variazione parodica di Lost e dell’Isola dei famosi, in cui
l’impiegato delle poste romano-comunista, Antonello Fassari, litigava senza sosta col chirurgo-milanese, Ezio Greggio).
Ferie d’agosto mette insomma in scena un confronto «antropologico» costruito sin da subito attorno a opposizioni nette. All’inizio del film, vediamo Mazzalupi in cima al tetto della casa di villeggiatura manovrare l’antenna del televisore per accertarsi che si prendano tutti i canali, anche «ItaliaUno e Retequattro». Di là i suoi vicini progressisti, che in casa non vogliono neanche la luce elettrica, osservano con sdegno l’arrivo dei barbari. Profili umani. Profili elettorali. Anche se scritto e girato nel 1995, Ferie d’agosto usciva a ridosso delle elezioni anticipate del 21 aprile 1996. Così lo presentava il quotidiano «La Repubblica»: «Molino, intellettuale progressista, contro Mazzalupi, bottegaio di scarsa cultura: guidano i due opposti, focosi schieramenti – neanche troppo velatamente rappresentativi di opposte tendenze politiche – che si fronteggiano al sole di Ventotene in Ferie d’agosto, il film di Paolo Virzì in uscita a fine settimana, in piena campagna elettorale. “Ma è una coincidenza, le elezioni le hanno indette che il film era già finito”, dice il regista. Del resto “non è una storia che viene dal 21 aprile, se mai da quello che è successo dal 27 marzo in poi, con l’ Italia che si è divisa in tribù. Quella è stata la spinta […] l’esigenza di guardare dentro il mondo dei Mazzalupi, dentro il loro consumismo, i debiti, i razzismi, il famiglismo [sic], le ossessioni sessuali. Quando irrompe a sprazzi dal televisore, ci incuriosisce e ci inquieta, ma è stato un errore non tentare di conoscerlo e parlo di noi, quelli della sinistra. Abbiamo voluto cercare di
avvicinarci a quell’italiano medio, che, con tutto il suo qualunquismo, è comunque uscito dalla Liberazione”»12. Non sfuggano i termini usati da «Repubblica»: bottegaio (non negoziante o commerciante) di scarsa cultura opposto a un ben più meritevole intellettuale progressista. Non sfugga poi il modo in cui Virzì, per legittimare la critica del «sinistrismo», debba ricordare al lettore del giornale la propria appartenenza («noi di sinistra»)13. Non sfugga, infine, l’appello a provare a guardare il nemico come «uno di noi». Uno «comunque uscito dalla Liberazione». Non sarà superfluo ricordare anche la vicinanza del film con la cosiddetta «svolta di Fiuggi», nel gennaio del 1995, e il conseguente scioglimento del Movimento Sociale Italiano che segnava la fine se non altro simbolica del post-fascismo. Ma cosa tentava di dire Ferie d’agosto sugli italiani del 1996? Tanto per cominciare, il film si rivolgeva a «quelli di sinistra». Raccontava tic e luoghi comuni di chi si sente dalla parte giusta delle cose. Suggeriva con ironia di togliersi gli occhiali con cui la sinistra dei Molino guarda a una società italiana che nel frattempo si è fatta più complessa. Ci sono nuovi soggetti, comportamenti, stili di vita che dovremmo provare a capire o avvicinare con curiosità, pare dire Virzì a se stesso e al suo pubblico. Altrimenti, perderemo per sempre le elezioni. Ma le figure chiave del film sono i due relativi adolescenti. Quello del gruppo di sinistra, che qui ci interessa di più, avverte tutta l’obsolescenza dei pregiudizi dei suoi. È un personaggio che agli occhi di Virzì e Francesco Bruni, sceneggiatore del film, incarna un’ipotetica «terza via» italiana, tutta da creare, visto che i due gli assegnano il ruolo di una specie di Anthony Giddens che parla come Max Pezzali: «Siete delle iene… non siete nemmeno capaci di entrare in relazione con l’uomo della porta accanto… siete aridi… siete elitari»; «Ma con chi ce l’hai?», gli ribatte Molino; «Con voi di sinistra»; «Perché sei diventato di destra adesso?»; «Ma no… è finita anche la destra… bisogna essere dentro e fuori… sopra e sotto». E non ci attarderemo qui sulle ulteriori connotazioni metaforiche della mancanza del padre del ragazzo, che il film si premura di sottolineare. Per lui, il nemico non c’è più. Per Molino invece sì. Però non sa più chi è. Decisivo allora quel passaggio di dialogo da cui abbiamo preso avvio. In quella battuta di Mazzalupi, «ma voi chi? Io i partiti li ho votati tutti» (che l’articolo di «Repubblica» definisce «spaventosa»), c’è il disvelamento di un nemico
politicamente immaginario ma che pure svolge una cruciale funzione tattica. Non c’è bisogno di scomodare la contrapposizione «amico/nemico» di Carl Schmitt, né il Bourdieu di La distinction. Basta semmai il Moretti di Caro Diario, quello che «non credo nella maggioranza delle persone, starò sempre a mio agio con una minoranza…» per ricordare un fatto elementare. Ovvero, quel che compatta il gruppo di sinistra, che modella il loro gusto, per dirla col sociologo francese, è in primo luogo il disgusto nei confronti del gusto degli altri. La consapevolezza di essere migliori dei propri vicini è la cifra identitaria profonda e l’unica rimasta a unire personaggi ideologicamente orfani; ognuno probabilmente con la sua idea di sinistra immaginaria ben incarnata nei tipi umani tratteggiati da Bruni e Virzì (il viaggiatore fancazzista che spende la sua vita tra l’Africa e il Sudamerica, la coppia lesbica che riproduce i tic del matrimonio borghese, l’attore che campa di piccole parti in pubblicità, la conformista frustrata, e così via). La crisi dell’identità politica di Molino ha come effetto la necessità di rappresentarsi un nemico politicamente compatto, omogeneo. E va da sé «fascista» e «burino». Una rappresentazione che però si infrange contro la battuta di Mazzalupi, frequentatore dell’intero arco parlamentare e forse futuro elettore del Movimento Cinque Stelle (anche se qui le cose si complicano ulteriormente perché nel film Molino accenna a un biglietto per andare a vedere uno spettacolo di Beppe Grillo). E poi c’è Ventotene. Spazio d’esilio del regime assunto a simbolo dell’antifascismo, viene qui voltato di segno ed eletto a metafora di una sinistra che si autoesilia, che sceglie e pratica l’isolamento, sia come allegoria di una manifesta superiorità morale, sia come oscura nostalgia di tempi mitici dove rivivere appieno la condizione di vittima della Storia. Non a caso, nel diverbio con Mazzalupi, Molino snocciola richiami al fascismo, alle leggi razziali, alle deportazioni, alla lotta partigiana, alle elezioni del 1948, alla Costituente, in un vertiginoso crescendo di lotte e sofferenze che annebbiano i motivi della discussione. Non si può non citare qui, come esempio supremo di questa attitudine sinistra, la biografia che la scrittrice Lidia Ravera, neo assessore alla cultura della regione Lazio, ci regala sul suo blog nel sito del «Fatto Quotidiano», e che si chiude con un richiamo al proprio confino (l’isola è un’altra, ma il concetto è lo stesso): «[…] il suo ultimo libro è A Stromboli ed è dedicato all’isola in cui si è relegata da sola, per molti mesi l’anno, dato che l’attuale regime ha abolito il confino politico per i suoi fieri oppositori, sostituendolo con più sottili forme di discriminazione».
Giochi di specchi con le vittime della Storia. Proiezioni autoreferenziali. Non è certo un caso che anche nel cinema di Virzì i personaggi «di destra» siano affidati ad icone della sinistra. Come Claudio Amendola, politico postfascista in Caterina va in città (2003). Come lo stesso Ennio Fantastichini che interpreta Mazzalupi, e che a proposito del suo ruolo diceva: «Quando, durante la discussione con Molino devo dire battute come “voi siete responsabili di 40 anni di malgoverno e di consociativismo” ho avuto quasi uno choc anafilattico»14. Uno squarcio nella coscienza, insomma. Un nemico di cui è difficile indossare i panni, pur nella finzione del personaggio. Altro che larghe intese. Nell’intervista a «Repubblica», Virzì ricordava giustamente che la spinta del film veniva da quanto successo in Italia con le elezioni del 1994. Ma Ferie d’agosto non guardava tanto agli italiani sedotti da Berlusconi quanto alla radicalizzazione dello scontro che l’ingresso in politica del Cavaliere si portava appresso. Negli stessi anni in cui la sinistra stava mandando in soffitta il proprio bagaglio culturale, l’arrivo di Berlusconi innescava un inevitabile ritorno in trincea, la riemersione di vocaboli, idee e pratiche ormai dismesse o quasi in un gruppo sociale peraltro già predisposto alla nostalgia e al recupero del passato. L’opzione resistenziale, però, faceva anzitutto leva su un tormentato nodo antropologico, come qui ci ricorda Berselli: «Se non fosse stato per Berlusconi, chissà. Qualcun altro fra noi, infatti, non era neppure di sinistra, altro che comunista […] Ma Silvio annuncia che lui vuole portare il Belpaese verso “un nuovo, un grande, uno straordinario miracolo italiano”. E mentre finisce questo rap lento del miracolo, parte sul maxischermo il video con l’inno di Forza Italia, “per essere liberi e siamo tantissimi”, con le parole in stampatello che si accendono alla base proprio come nei karaoke. Sicché uno dice: ma neanche morto. Magari aveva avuto qualche dubbio prima, ma di fronte al karaoke, come si fa? E allora adesso dobbiamo dire la verità. Cioè che se siamo diventati di sinistra, o se ci siamo confermati e rafforzati in un’idea di sinistra, quasi tutto dipende dal fatto che a un certo punto, cucù, è arrivato lui, Silvio Berlusconi. Perché è verità storica che moltissimi di noi presentano, come sintomo primario della loro malattia, un’incompatibilità essenziale con l’Uomo di Arcore»15. Un’incompatibilità essenziale che funziona come un feticcio per poter rivivere un «noi» ideologicamente compatto. Le rappresentazioni stereotipate degli italiani di destra e di sinistra proposte dal cinema di Virzì giocano così attorno a una lettura schematica
della società italiana che rivela in modo scoperto anche il bisogno di contrapposizione morale della sinistra. Alimentano la ricostruzione di un’identità sviluppata come una teologia negativa («se non sappiamo più chi siamo, sappiamo che non siamo come quelli lì»). Destra e sinistra coprono cioè gli spazi di un più profondo processo di selezione della società, di un darwinismo all’italiana. Come in Caterina va in città, dove la protagonista giunta nella capitale dalla provincia si rivela straordinariamente inadatta ai meccanismi di esclusione e accettazione messi in atto tanto delle sue compagne «parioline» che dalle cosiddette «zecche». Lo schema funziona evidentemente come cumulo di stereotipi «alla Gaber», ma anche come nutrimento di una contrapposizione netta. Modella meccanismi di integrazione o rifiuto nei vari gruppi sociali di riferimento secondo stereotipi che si rivelano preziosi per i meccanismi della commedia, ma disastrosi quando tradotti sul piano di una lettura politica della società italiana. La tendenza ai grandi conflitti morali, tipica del melodramma, viene pertanto rielaborata come scontro tra forze antitetiche che si danno battaglia sul territorio del gusto e dei consumi. Si veda il recente Passione sinistra (M. Ponti, 2013), giocato sul contrasto tra la ragazza impegnata e il manager impegnato a far soldi che il film si premurerà di unire dopo scontri ideologici post-gaberiani, in cui il «kebab che è di sinistra» si contrappone al «sushi che invece è di destra».
Queste commedie legittimano da un lato la condizione di superiorità
morale e il vittimismo dei personaggi di sinistra ma dall’altro mettono in moto un meccanismo di svelamento del «nemico» come illusione, proiezione fantasmatica. Un punto, anche questo, chiarito con la consueta efficacia da Berselli: […] sarà bene abbandonare l’idea che ci sia una differenza sostanziale tra «noi» e «loro», cioè fra noi di sinistra e loro di destra. Anzitutto, è già molto dubbio che esista un «noi»: la dissoluzione delle entità collettive ha investito tutta la società, e noi siamo pulviscolo sociale come tutti gli altri, atomi impazziti che si agitano dentro campi di forze ignoti. In secondo luogo, non si vede in base a quali criteri la sinistra dovrebbe essere migliore della destra […] Vero che Prodi disse un paio di volte che gli elettori di Forza Italia sono quelli che mettono la macchina in doppia fila; ma [alla fine, anche questa] è una semplificazione. Anzi, un vero atto di fiducia nella società italiana: se tutto il male familistico, clientelare e abbuffino stesse da una parte sola, i giochi sarebbero più semplici e ci sarebbe da riscattare solo il cinquanta per cento della comunità nazionale. Un’inezia16. «La verità è che se Berlusconi non fosse esistito, se non fosse entrato in politica nel 1994, la sinistra italiana se lo sarebbe dovuto inventare. Da quindici anni Berlusconi, con la sua presenza, aiuta la sinistra a non fare i conti con se stessa, con il vuoto in cui è precipitata dopo il crollo del muro di Berlino». [Angelo Panebianco, «Corriere della Sera», 30 giugno 2009] 12
M.P. Fusco, Destra e sinistra? S’incontrano in vacanza, in «la Repubblica», 4 aprile 1996.
13
È interessante notare come Virzì debba ricollocarsi più a sinistra del suo film, in questa e altre dichiarazioni dell’epoca, specificando soprattutto che nel film se la prende con la sinistra da salotto – sfumature di cui ovviamente non è chiamato a dar conto nel caso della rappresentazione di quelli di destra. Vedi ad esempio l’intervista rilasciata a Goffredo Fofi: «A me della sinistra non piacciono certamente i guardiani del “politically correct”, non mi piacciono i rivoluzionari da salotto» in G. Fofi (a cura di), La tribù di sinistra e di destra, in ferie, ad agosto, «La Terra vista dalla Luna», n. 15, maggio 1996, p. 61. 14
M.P. Fusco, Destra e sinistra? S’incontrano in vacanza, cit.
15
E. Berselli, Sinistrati, cit., pp. 1065-66.
16
Ivi, pp. 1142-43.
Un melodramma intergenerazionale A lungo, per la critica cinematografica come per il senso comune, «melodrammatico» è stato un termine sospetto quando non archiviato come peggiorativo (strappalacrime, stucchevole, improbabile) e fortemente connotato in chiave di genere (film per un pubblico femminile). Gli studi sul cinema più avanzati hanno invece mostrato da tempo come, lungi dal definire uno spazio astorico e disimpegnato, le strutture del melodramma siano alla base della riscrittura in termini affettivi dei conflitti ideologici del presente e tanto più del passato. La correttezza politica che fa della condizione di vittima e della sofferenza i parametri di lettura della società e di comprensione della storia ha riportato il discorso sul melodramma al centro della sfera pubblica. La scrittura e la retorica melodrammatica si rivelano ad esempio decisive per elaborare i traumi della Storia dentro una logica emozionale, non solo nel campo della finzione cinematografica. Il trauma diventa il momento fondativo di un’epica negativa attorno a cui si raccolgono specifiche memorie sociali più o meno universalizzabili, come nel caso emblematico dei genocidi. Il termine melodramma quindi si amplia. Esce dal perimetro dei canoni narrativi e intercetta una generica predisposizione emotiva della società contemporanea, una «visione del mondo». Thomas Elsaesser, tra gli studiosi di cinema più attivi nel ripensamento del melodramma, lo sottolinea con efficacia, trasferendo le sue iniziali considerazioni in uno spazio più vasto: «Come indicazione di una posizione morale, o di una modalità dell’esperienza, il melodramma suggerisce che il mondo è osservato e agito a partire da una reazione affettiva che genera un’emozione moralizzante, ad esempio un senso di giustizia […] I protagonisti si vedono (e sono visti dallo spettatore) come vittime che generalmente non imparano dalle proprie sventure, anche se potrebbero. Essi sono sofferenti seriali e modelli di virtù e, visto il pregiudizio di genere sessuale che domina la nostra cultura, si tratta per lo più di personaggi femminili. Di conseguenza, nel melodramma le storie sono raccontate dal punto di vista della vittima, il che implica un tipo particolare di pathos che scaturisce proprio dalla valorizzazione positiva della vittima come essere indifeso. Oltre alle donne, spesso il ruolo di protagonista è affidato a bambini, ai
quali sono associate naturalmente le categorie dell’innocenza e dell’impotenza»17. Ovvero: «Nella sua universalizzazione della condizione di vittima e nella designazione di quest’ultima come persona onesta che rivendica dei diritti, prima ancora di dover dimostrare la propria virtù e la propria virtuosità, [il melodramma] è diventato parte di un discorso politico e morale»18 Calate nel contesto della crisi degli ideali della sinistra racconta dal cinema italiano, tali considerazioni mi sembrano efficaci per inquadrare in uno sfondo comune i film che abbiamo discusso. Il gioco di specchi tra la fine di un’era mitica del cinema e la crisi della sinistra (entrambi femminilizzati come vittime della storia); o ancora l’invenzione del nemico per mantenere una anacronistica visione del mondo manichea, senza sfumature (visione di cui le commedie di Virzì mostrano al contempo la necessità e l’inconsistenza). Entrambe queste strategie sostengono una più vasta composizione melodrammatica innescata dal trauma identitario della fine del comunismo. Un trauma da cui si sviluppa una memoria sociale specifica della sinistra ma culturalmente dominante all’interno della memoria nazionale; con la conseguente possibilità di innescare un gioco di equivalenze. Specie tra un Paese e una sinistra più immaginari che reali. Il trauma si apre con le lacrime di Occhetto cui fanno da ideale pendant quelle più recenti di Bersani dopo il pastrocchio dell’elezione presidenziale. Il cinema lo intercetta in una chiave più ampia. Lo racconta con le gesta di personaggi come Nicola Palumbo, Michele Apicella, Silvio Molino e tanti altri di cui abbiamo per forza di cose taciuto (tra i quali un prototipo come Silvio Magnozzi, il personaggio di Alberto Sordi in Una vita difficile, di Dino Risi). Personaggi che si rivelano straordinariamente adatti ad incarnare sia una sofferta appartenenza politica, sia lo stereotipo di una mascolinità italiana femminilizzata, emotiva, infantile. Dunque già predisposta a ribaltare lo spazio di genere del melodramma. Ovviamente, è la specifica storia del Pci scandita attorno alla conventio ad excludendum a permettere l’innesco di questa rivendicazione di purezza, di un’identità di sinistra vissuta come lo spazio della vittima. Rivolta verso un immaginario oggetto perduto, tale spinta si compatta come possibilità di esperire se stessi in quanto innocenti o comunque più puri, proprio perché mai messi alla prova di governo, secondo la ben nota logica della Guerra fredda. Ci si compatta insomma attorno a una virtù che non deve essere dimostrata
perché è lì immortalata nell’intrinseca diversità morale ufficializzata a suo tempo da Berlinguer. Una virtù di purezza che si presta al passaggio di consegne tra una generazione e l’altra. O forse si prestava. Bisognerà vedere gli effetti di Renzi e quelli del libro di Piccolo. Ma la forza del melodramma sta, come sempre, nel fornire una sedia vuota a disposizione di qualsiasi vittima voglia occuparla. E sin qui, il cinema italiano ha offerto alla crisi identitaria della sinistra un variegato spazio di identificazione intergenerazionale. Nel rifiuto del presente in nome di un passato mitico del cinema e della «vera» politica, come nella visione manichea delle ingiustizie del mondo, trovano posto tanto l’anziano militante deluso che l’entusiasta studente del Dams. «La maturità esistenziale delle persone di sinistra coincide con il tempo della sconfitta politica, oppure con opache vittorie gestite da altri, il che praticamente è lo stesso» [Edmondo Berselli, Post-italiani, 2004] Certo, il discorso chiamerebbe in causa molti altri film. Al lettore ne saranno venuti in mente diversi. Quelli che ripercorrono la storia italiana facendo leva su una fascinazione vintage per i feticci della sinistra. Da Il cosmonauta [S. Nicchiarelli, 2009] al grande affresco kitsch di La meglio gioventù [M.T. Giordana, 2003], passando per un vasto paesaggio di rivendicazioni nostalgiche, incluso Toto Cutugno accompagnato dal coro dell’Armata Rossa al Festival di Sanremo 2013, utopia scritta e pensata da Piccolo, Serra & Co. Nel melodramma della sinistra italiana la cifra specifica della nostalgia politica e quella pur diversa della passione vintage si fondono in un unico spazio di ripiegamento. Un comune bisogno di asincronia del presente. Per continuare a coltivare la retrospezione idealistica del passato, l’utopia di un’identità collettiva19. C’è qualcosa di ironico nel fatto che la nostalgia di un’epoca autentica, non ancora contaminata dalla tv e dallo spettacolo, sia alimentata da meccanismi della memoria collettiva che appartengono proprio alla società dello spettacolo e alla cultura televisiva, non così diversi da quelli che ispirano i remake affettuosi dei vecchi film, la poetica del revival, i canali tematici che ritrasmettono programmi di trent’anni fa. [Guido Vitiello, In principio era Berlinguer, «Il Foglio», 10 dicembre 2013] 17
T. Elsaesser, Modalità del sentire o visione del mondo? Una rivisitazione del melodramma familiare e dell’immaginazione melodrammatica, in E. Dagrada (a cura di), Il melodramma, Bulzoni, Roma 2007, pp. 48-49. Sul melodramma, in riferimento al cinema italiano, si veda E. Morreale, Così
piangevano. Il cinema melò nell’Italia degli anni Cinquanta, Donzelli, Roma 2011; L. Cardone, Il melodramma, Il Castoro, Milano 2013. 18 19
T. Elsaesser, Modalità del sentire o visione del mondo?, op. cit., p. 68.
Sul tema della nostalgia e sul complesso rapporto presente/passato nella cultura italiana è ovviamente impossibile dar conto dei riferimenti dovuti. Si rinvia a un classico come G. Bollati, L’italiano, Einaudi, Torino 2012 (nuova edizione che include il saggio Sul modo di vedere italiano, decisivo ai fini del nostro discorso, dove si discute la forza e l’irrisolutezza del rapporto col passato dell’identità italiana). In riferimento al cinema italiano si veda E. Morreale, L’invenzione della nostalgia. Il vintage nel cinema italiano e dintorni, Donzelli, Roma 2013; vedi anche il recente D. Panosetti, M.P. Pozzato, Passione vintage. Il gusto per il passato nei consumi, nei film e nelle serie televisive, Carocci, Roma 2013.
Checco Zalone e noi (epilogo) «Dei nuovi comici le piace qualcuno?» «Checco Zalone è un genio. E per sensibilità, tic e maschera è l’Alberto Sordi di oggi. Mi sono stancato dei comici che vogliono propinarmi un messaggio. Una risata è fine e messaggio insieme. Adoro Zalone perché ha il coraggio di sembrare stupido» [Giorgio Faletti, 2014] Nel suo libro Le Catene della sinistra, Claudio Cerasa20 la chiama «sindrome Checco Zalone». Più o meno la paura di uscire dalla vocazione minoritaria, di lasciarsi alle spalle diversità morettiana. Non per piacere a o essere come tutti, ma per provare a governare il Paese. Cerasa riporta anche la tesi di Giovanni Orsina, autore di un volume formidabile, Il berlusconismo nella storia d’Italia21 La tesi di Orsina è semplice, eppure decisiva: «La sinistra si è caricata sulle spalle un numero così elevato di pezzi dell’apparato statale da essere diventata sinonimo della parola “Stato”. E così, anche se non governa, l’elettore la percepisce come una forza non d’opposizione. E, rappresentando in tutto e per tutto lo Stato, è come se si trovasse sempre al governo». Si può aggiungere che, come sinonimo di Stato, la sinistra è (era?) vista come una forza di conservazione, un freno. E per di più un freno vecchio. Una cultura politica con lo sguardo rivolto all’indietro, come molti dei film che abbiamo discusso sin qui. Il cinema italiano degli ultimi trent’anni, un cinema imparentato da cima a fondo con lo Stato, ha svolto un ruolo non indifferente nella costruzione di questa percezione. La sinistra è cultura. La cultura in Italia è lo Stato. La Sinistra è lo Stato. E poi c’è Checco Zalone. Emarginato dall’«interesse culturale», categoria grazie alla quale si accede al finanziamento statale dei film, ma legittimato dagli incassi. Da quella cosa
terribile chiamata «mercato» e «gusto del pubblico». Ora, a quelli che «Zalone è-un-abisso-di-stupidità» basterebbe già indicare la locandina del film. I padri seduti sulle spalle dei figli come sintesi visiva di una storia che a suo modo parla della «crisi» del nostro Paese. Basterebbe dire che il sofferente regista italiano col turbante in testa che gira Eutanasia mon amour e rifà il ciak perché nella scena «sente puzza di borghesia» un bel po’ se lo meritano. Bisognerebbe dirgli che obiettare a un film con dentro «Equitalia», lo Yoga, l’eutanasia, la «Cgil», «Eva Hegel», le magliette della marca «Che Guevara», il Molise, «Love Boat», la cassintegrazione, Portofino, la massoneria, il terzomondismo con l’aragosta e gli aspirapolvere della «Folletto» esposte come l’orinatoio di Duchamp da qualche parte nel Chiantishire, che obiettare – dicevo – a un film così di reggersi solo sulle gag o imputargli «una sceneggiatura che si perde per strada» («Il Giornale») è come dire che La Grande Bellezza è un film troppo incentrato su Roma. Si potrebbe anche ricordare che Zalone e il regista Gennaro Nunziante dirigono i bambini meglio di parecchi registi italiani da Festival. Ma siccome tutto questo non si può fare, perché poi si finisce da un luogo comune all’altro e Sole a catinelle rischia di diventare un capolavoro anti-intellettualistico, liberatorio, reazionario, post-ideologico di quelli preda dello «stracultismo» che piacciono a Slavoj Žižek e invece grazie al cielo non è così, allora bisogna fermarsi alle constatazioni. Dire che i suoi quasi venti milioni al primo week-end (per intenderci, meglio di Avatar) sono una pesca a strascico a raccogliere la pancia del Paese per alcuni, e una manna per tutto il cinema italiano per altri. Ora, a parte che a quelli che dicono “pancia del Paese” ci pensa già Zalone a sbeffeggiarli nel film, il discorso della boccata d’ossigeno per il cinema italiano non vale solo per gli esercenti, che pure dovrebbero fargli un monumento. Negli anni Sessanta, quando avevamo qualcosa di simile a un’industria del cinema italiano non ancora vampirizzata dalla politica e dallo Stato, potevamo produrre i film di Antonioni – quelli che incantavano i critici francesi ma al cinema li vedevano in quattro – grazie agli incassi di Totò. Dire invece che «Zalone è sintomatico del Paese in cui viviamo» significa – forse non sempre ma qualche volta sì – avere bisogno del pubblico di Zalone per sentirsi più intelligenti. Alan O’Leary22, che ha studiato il caso dei nostri cinepanettoni, ha mostrato quanto il loro successo funzioni anche in modo catartico, cioè come
capro espiatorio di una delusione politica. E il nesso cinema d’evasione/condizioni politiche del Paese è talmente radicato che la deludente resa al botteghino del cinepanettone del 2011 portò Curzio Maltese a scrivere cose come: «Il crollo del cinepanettone è forse il più clamoroso segno della fine dell’epoca berlusconiana. Il cinepanettone sta al ventennio berlusconiano così come i telefoni bianchi stanno al ventennio fascista». Si arriva così al paradosso. Più si rimproverano questi film di superficialità e grettezza più si finisce con dargli importanza maggiore di quella che hanno. Perché «per i loro detrattori diventano simboli discorsivi da utilizzare nella disputa per l’autodefinizione dell’Italia e degli italiani», che da noi va avanti dai tempi di Massimo D’Azeglio. E come dimostra Curzio Maltese, i cinepanettoni funzionano meglio per questo che per le previsioni elettorali. Italiani giusti e italiani irrecuperabili. Però, quando andai al cinema a vedere Sole a catinelle, in una sala insolitamente piena per il lunedì, età media sui cinquant’anni con punte di ottantatenni che temevo ci restassero secchi per le convulsioni, non avrei saputo distinguere i primi dai secondi. Ma la novità, rispetto al cinepanettone, è che Pietro Valsecchi, produttore di Zalone e di tre quarti della fiction italiana, ha optato per le larghe intese. Dice che questo è «un successo di tutti e per tutti gli operatori di cinema che vogliono fare bene». Zalone l’ha preso in parola: «Non andate a vedere il mio film. Andate a vedere Battiston, quel veneto bravissimo. Ho visto il trailer (di Zoran), deve essere proprio un gran bel prodotto». Una battuta intelligente, un endorsement. Anche se il miracolo di una intercambiabilità tra i due spettatori, quello di Zalone e di Zoran, è forse un miraggio. Come un miraggio per il cinema italiano, e non solo per il cinema, resta quella che è la dichiarazione più bella di Zalone. Così insolita dalle nostre parti che speriamo di sentirla più spesso: «Spero che il mio film faccia un sacco di soldi».
20
C. Cerasa, Le catene della sinistra. Non solo Renzi. Lobby, interessi, azionisti occulti di un potere immobile, Rizzoli, Milano 2014. 21
G. Orsina, Il berlusconismo nella storia d’Italia, Marsilio, Venezia 2013.
22
Cfr. A. O’Leary, Fenonemenologia del cinepanettone, Rubbettino, Soveria-Mannelli 2013.
ELENCO DEI FILM CITATI Aprile (N. Moretti, 1998) Bronenosec Potëmkin (La corazzata Potëmkin, S.M. Ejezenstejn, 1935) Caterina va in città (P. Virzì, 2003) C’eravamo tanto amati (E. Scola, 1975) Di me cosa ne sai? (V. Jalongo, 2008) Doctor Zhivago (Il dottor Zivago, D. Lean, 1965) Dramma della gelosia – tutti i particolari in cronaca (E. Scola, 1970) Ferie d’agosto (P. Virzì, 1996) Il cosmonauta (S. Nicchiarelli, 2009) La cosa (N. Moretti, 1990) La dolce vita (F. Fellini, 1960) La meglio gioventù (M.T. Giordana, 2003) La messa è finita (N. Moretti, 1985) La terrazza (E. Scola, 1980) La voce della luna (F. Fellini, 1990) La voce di Berlinguer (M. Sesti, T. Theardo, 2013) Non mi avete convinto (F. Vendemmiati, 2012) Nuovo cinema paradiso (G. Tornatore, 1988) Palombella rossa (N. Moretti, 1989) Passione sinistra (M. Ponti, 2013) Quando c’era Berlinguer (W. Veltroni, 2013) Selvaggi (C. Vanzina, 1995) Sole a catinelle (G. Nunziante, 2013) Una vita difficile (D. Risi, 1961) Viva la libertà (R. Andò, 2013) Zoran, il mio nipote scemo (M. Oleotto, 2013)