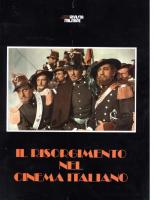Eretici e libertini nel Cinquecento italiano
1,020 117 1MB
Italian Pages 240 Year 2010
Polecaj historie
Citation preview
Quadrante Laterza 162
Luca Addante
Eretici e libertini nel Cinquecento italiano
Editori Laterza
© 2010, Gius. Laterza & Figli Prima edizione 2010 www.laterza.it Questo libro è stampato su carta amica delle foreste, certificata dal Forest Stewardship Council
Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari Finito di stampare nel giugno 2010 SEDIT - Bari (Italy) per conto della Gius. Laterza & Figli Spa ISBN 978-88-420-9380-0
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. Per la legge italiana la fotocopia è lecita solo per uso personale purché non danneggi l’autore. Quindi ogni fotocopia che eviti l’acquisto di un libro è illecita e minaccia la sopravvivenza di un modo di trasmettere la conoscenza. Chi fotocopia un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.
a Stefania, al più bel dono che la vita mi abbia dato
Introduzione
Eresia radicale, valdesianesimo, «libertinage»
Quest’indagine è dedicata ad alcune delle manifestazioni più radicali del dissenso religioso nell’Italia del Cinquecento, e in particolare a un movimento clandestino sorto a Napoli – tra discepoli ed epigoni dell’esule spagnolo Juan de Valdés – e da lì irradiatosi in altre realtà della penisola. Tra i valdesiani ci fu chi dubitò della divinità di Cristo e della verginità di Maria, dell’autenticità dei vangeli e dell’immortalità dell’anima, fino a esiti di vera e propria incredulità. Tali sviluppi sconcertanti impongono di non ignorare o sottovalutare le implicazioni radicali del valdesianesimo, spesso presentato come prigioniero di un moderatismo elitario e teologicamente ambiguo, quasi a rappresentare una sorta di terza via tra Roma e Wittenberg (o Ginevra). «Cifra della nostra ignoranza», lo definirono acutamente nel 1975 Carlo Ginzburg e Adriano Prosperi1, mentre la storiografia più recente2 ha dimostrato come quegli sconfinamenti nel radicalismo non fossero arbitrarie deviazioni dalla lezione di Valdés, quanto piuttosto esiti conseguenti (seppur estremi) degli insegnamenti di un maestro di libere coscienze, formatosi nella Spagna del primo Cinquecento, tra gli studi ad Alcalá de Henares, letture di Erasmo e di Lutero e il diretto rapporto con Pedro Ruiz de Alcaraz. Era questi il più autorevole esponente del movimento alumbrado, un’«eresia spagnola» precedente la Riforma e da essa indipendente, verso la quale il giovane Juan fu forse attratto anche in virtù dell’origine conversa della sua famiglia3. Furono tali esperienze molteplici a far maturare in Valdés un’originale ed eclettica interpretazione dei VII
grandi temi della fede che egli iniziò a diffondere fin dalla sua prima opera, il Diálogo de doctrina cristiana (1529). Il testo fu condannato dall’Inquisizione spagnola, alla quale Valdés riuscì a sottrarsi rifugiandosi in Italia, anche grazie alle potenti protezioni di cui godeva alla corte dell’imperatore Carlo V. Di questi era infatti segretario suo fratello Alfonso de Valdés. Lo stesso Juan, inoltre, fu per alcuni anni un autorevole agente segreto al servizio dell’imperatore4, dapprima nella Roma di Clemente VII e successivamente a Napoli, dove visse fino al 1541, raccogliendo intorno a sé un numero crescente di discepoli sui quali lasciò tracce indelebili. «Dove andremo noi poi che ’l signor Valdés è morto?», scrisse il letterato Iacopo Bonfadio, evocando quel «compiuto uomo [che] reggeva con una particella dell’anima il corpo suo debole e magro; con la maggior parte poi e col puro intelletto, quasi come fuor del corpo, stava sempre sollevato alla contemplazione della verità e delle cose divine»5. Come «splendido cavaliere di Cesare, ma viepiù onorato e splendido cavaliere di Cristo» lo ricordò nel 1550 l’esule piemontese Celio Secondo Curione, a giudizio del quale «chi meglio, più saldamente e più divinamente abbi scritto [delle cose cristiane] che Giovanni Valdesso, dopo gl’apostoli del Signore ed evangelisti, sarebbe forse difficile a ritrovare»6. In effetti, come avrebbero rivelato alcuni suoi discepoli, più che offrire insegnamenti dottrinali, egli stimolava in loro il desiderio di intraprendere percorsi segnati da illimitati spazi di libertà individuale, suggeriti dalle stesse cautele nicodemitiche e dal gradualismo pedagogico del suo magistero, che lasciava intravedere sempre nuove frontiere nella conoscenza dei «secretos de Dios», lungo un percorso iniziatico via via più radicale, ma al contempo segnato dall’esteriore fedeltà alla Chiesa di Roma e dall’avversione per ogni frattura della cristianità. In questa prospettiva Valdés spiegava non tanto i contenuti della parola di Dio quanto il modo in cui ascoltarla, esortava all’«experientia» e non alla «scientia» del «negotio christiano», insegnava il significato religioso del cristianesimo e non i suoi contenuti teologici, lo presentava come una «forma de doctrina» e non come un codice normativo di articoli di fede. Nel suo Alfabeto cristiano Valdés delineò la «grammatica» con cui avviarsi a un «camino secreto» che si sarebbe illuminato «poco a poco», senza forzature, attraverso una pedagogia maieutica tesa a fornire gli strumenti per forgiare autonomamente la propria fede senza cessare mai di VIII
metterla in discussione, di aprirsi a nuove verità più profonde. Un estremo soggettivismo – irriducibile a qualsiasi Chiesa o setta – in virtù del quale era possibile arrestarsi alle soglie dell’eterodossia, ma che facilmente portava ad approdi che scompaginavano ogni forma di religiosità ortodossa. La possibilità di approcci diversificati alla fede, il segreto nicodemitico che copriva la diffusione di quelle opinioni, il rifuggire ogni logica di scontro (pur coltivando la diversità delle idee), contribuiscono a spiegare lo straordinario successo che arrise in Italia al valdesianesimo, capace di attrarre nella sua orbita vescovi e cardinali, celebri predicatori, letterati di fama, esponenti di grandi casate aristocratiche, pittori famosi ma anche tante persone comuni, sia uomini sia donne. L’alto rango di molti aderenti al valdesianesimo ha indotto diversi studiosi a confinare il movimento in una dimensione elitaria, priva di incisivi sviluppi sulla storia italiana. In realtà, già quegli stessi autorevoli personaggi, ecclesiastici e laici, rappresentarono a metà Cinquecento una forza storica non trascurabile, come dimostra ad esempio la mancata elezione papale di Reginald Pole nel conclave del 1549 per un solo voto. Il clamoroso successo di quel manifesto del movimento che fu il Beneficio di Cristo, diffuso in decine di migliaia di copie, rivela poi come la circolazione delle idee valdesiane permeasse ampi strati della società. Ne offrono conferma i sospetti del Sant’Ufficio che le dottrine valdesiane avessero «infectato [...] tutta Italia de heresia»7 e lo sforzo dispiegato dall’Inquisizione nel perseguirne i molti seguaci. Nelle pagine che seguono si vedranno emergere vicende e opinioni di avvocati e di medici, ma anche di frati sfratati, merciai al minuto, umili preti, maestri di scuola, artigiani, tintori, panettieri, barbieri, garzoni di bottega, musici, servitori, tagliapietre, donne del popolo: il che dimostra la capacità del movimento di intercettare e interpretare le inquietudini che agitavano la società italiana, scossa dalla faglia aperta da Lutero ma anche dai movimenti più radicali che percorsero l’Europa, dalla guerra dei contadini all’anabattismo, dall’antitrinitarismo al libertinismo. L’individualismo degli alumbrados rimeditato da Valdés ne portava i più inquieti discepoli a porsi in modo spregiudicato di fronte a ogni dottrina e alla stessa Bibbia; non c’è da sorprendersi, quindi, se tra i valdesiani ci fu chi mise in discussione la divinità di Cristo, l’autenticità dei vangeli, l’immortalità dell’anima, la stessa religione. Certo, è necessario «distinguere attentamente tra Valdés e il valdeIX
sianesimo nelle sue pur diverse accezioni»8; ma se è vano cercare nello spagnolo esplicite ammissioni di radicalismo dottrinale, occorre precisare che il suo spiritualismo, la natura esoterica della sua lezione, il tentativo di restringere a pochi elementi essenziali i fondamenti della fede (il cosiddetto adiaforismo), l’invito ad attendere sempre ulteriori illuminazioni dallo spirito di Dio e a fondarsi sulla propria esperienza individuale «consentissero simili sviluppi, alla ricerca di un cristianesimo depurato dalle contaminazioni storiche, [...] dalle distorsioni [...] che lo avevano via via corrotto e deviato rispetto alle sue origini evangeliche»9. L’interrogativo che muove questa ricerca sul radicalismo di matrice valdesiana si incentra dunque sulla possibilità di identificare l’emersione di nuove concezioni e forme di libertà (di religione ma anche di pensiero, di ricerca e di critica, di espressione e di comportamento) nelle più eversive eresie cinquecentesche. A una domanda così generale non potrà che darsi una risposta parziale, con l’attenzione rivolta a un frammento di un movimento ben più ampio, destinato a decisivi sviluppi nella storia europea. Nondimeno, la ricostruzione minuziosa di questo frammento ha anche l’ambizione di porsi come contributo alla riflessione su problemi di storia generale. Si tratta, infatti, di capire da quali contesti e discussioni potesse scaturire quella cosciente rivendicazione di libertà implicita nell’espressione «ogniun diceva quel che li pareva», usata nel 1553 dal valdesiano Giovanni Laureto, per evocare davanti agli inquisitori la stagione in cui aveva sperimentato, con altri compagni, gli esiti più radicali del suo percorso tra le religioni. Una libertà che fu poi reclamata espressamente da alcuni di quegli eretici costretti a fuggire dall’Italia e a vagare per l’Europa o sulle rive del Mediterraneo, alimentando un conflitto che costò persecuzioni e condanne ma dando nutrimento al maturare di nuove rivendicazioni, non limitate ai soli problemi religiosi. Insomma, nel ricostruire le trame italiane di gruppi e movimenti radicali, si è cercato di cogliere qualche traccia di una discontinuità storica, dalla quale emergessero inediti atteggiamenti e idee, comportamenti e opinioni, discorsi e pratiche tese alla cosciente rivendicazione di concrete libertà individuali: alimento essenziale (seppure non unico) di quelli che saranno i linguaggi e le teorie dei diritti sei-settecenteschi. Il tentativo, pertanto, è anche quello di contribuire a una storia politica della religione, nel quadro di una genealogia storica dei diritti umani. X
La ricerca penetrerà empiricamente all’interno di mondi sin qui poco noti, sicché il tentativo che la sottende – quello di mostrare tendenze di lungo periodo che si snodano tra il Cinquecento e il Settecento, tra persistenze e mutamenti, conflitti e resistenze – è da considerarsi sceverato solamente in parte, presupponendo altri sviluppi e legandosi a precedenti studi sulle culture di opposizione, dal dissenso religioso a quello politico. Proprio per questo, è apparso utile il ricorso a una categoria come quella di libertinismo, o meglio di libertinage: termine che evoca non tanto compiuti sistemi filosofici quanto più fluide opinioni e comportamenti, che consentono connessioni tra fenomeni in apparenza slegati come l’eresia, la rivoluzione scientifica e il dissenso politico. Si tratta però di una categoria controversa, soprattutto per il Cinquecento, e alcuni chiarimenti sono necessari. È noto infatti che sulla scia di René Pintard10 gli studiosi hanno concentrato l’attenzione sui libertini francesi del Seicento, senza ignorare l’influenza del Rinascimento italiano, ma relegando questo filone di pensiero all’età barocca, con una conseguente esclusione dell’eresia cinquecentesca dagli sviluppi del deismo e di una miscredenza che Lucien Febvre giudicò inconcepibile nel Cinquecento11. In realtà, studi successivi hanno dimostrato sia la fallacia della tesi del co-fondatore delle «Annales» sia l’esistenza di istanze e movimenti libertini diffusi già dal Cinquecento, in ambiti geografici e tematici diversi, dai costumi alla politica alla religione12. Diversi sono gli usi del termine attestati nel XVI secolo: proprio negli anni in cui il valdesiano Giulio Basalù fu condotto al di là del bene e del male da un discepolo di Valdés come Juan de Villafranca (nel 1544-45), Calvino sferrò il suo attacco contro quelli che definì, per l’appunto, i libertins13. Alcuni studiosi li hanno identificati con una setta eretica originaria dei Paesi Bassi francofoni, poi diffusasi nella bassa Germania e in alcune zone della Francia14. Altri invece hanno allargato l’ambito al quale i libertins di Calvino andrebbero ricollegati, dal punto di vista sia geografico sia concettuale, sino a definirli «as a chaotic melting pot of ideas» in cui è impossibile identificare un gruppo specifico, ma suggerendo al contempo uno stretto collegamento con l’antitrinitarismo di Miguel Servet e lo spiritualismo radicale di altri eretici come David Joris, Otto Brunfels e Sebastian Franck15. Benché l’accordo sul significato del termine libertinage sia dunque lontano dall’essere raggiunto16, molte crepe si sono aperte nel paradigma delineato da René Pintard, che aveva distinto libertinage XI
d’esprit e libertinage de mœurs e visto nei libertini gli esponenti di una cultura perdente, presto sepolta dagli sviluppi sei-settecenteschi del pensiero occidentale. In questo quadro interpretativo in movimento qualche punto fermo è stato posto da Jean-Pierre Cavaillé che, riferendosi all’uso del termine «libertino» fatto dai contemporanei, ha dimostrato come «si può tranquillamente asserire che il libertinismo non è e non può essere [...] una categoria intellettuale o filosofica» e che esso rimanda «talvolta a dei fenomeni settari (religiosi o meno), talaltra a delle forme d’empietà [...], spesso un po’ a tutte queste cose allo stesso tempo»17. Proprio considerando la natura cangiante dei fenomeni accomunati dall’uso del termine, Cavaillé ha proposto di utilizzarlo al plurale, mostrando al contempo come si possano identificare nelle rivendicazioni libertine dei tratti unificanti: «Mi sembra del tutto evidente che tali rivendicazioni facciano luce su quel che è in gioco fin dall’inizio nei fenomeni di libertinage – bisognerebbe essere ciechi per non vederlo – vale a dire la questione della ‘libertà’»18. La definizione di libertino come partigiano di un’estrema libertà soggettiva – nel che emerge l’interesse di tale nozione per la presente indagine – è autorizzata dalle fonti cinquecentesche, nelle quali il vocabolo era utilizzato in senso offensivo, per designare chi sulle libertà non accettava limiti. Era questo il significato che dava all’epiteto anche Calvino19, nel suo sforzo di «tappare le falle che quell’eversivo principio della libertà del cristiano, al quale egli stesso come Lutero si era ispirato, non cessava di aprire nel mondo riformato»20. In questo contesto assunse un ruolo importante proprio l’ala radicale del movimento valdesiano. Già l’esule spagnolo richiamandosi alla libertà del cristiano l’aveva delineata con contorni simili a quelli del primo Lutero21, ma nutrendola dello spiritualismo radicale del movimento alumbrado. Tale incoercibile libertà soggettiva si legava anche in Valdés a un’esplicita perorazione della tolleranza, analoga a quella che dapprima aveva reclamato lo stesso Lutero22. Idee che si diffusero tra i valdesiani, che fondarono la loro socialità sul rispetto delle opinioni altrui – nella consapevolezza della possibile divergenza dalle proprie – e sulla possibilità di una discussione franca e pacifica, al riparo da orecchie indiscrete. Non a caso, già prima del rogo di Miguel Servet (1553) e del De haereticis an sint persequendi (1554), cui usualmente si fanno risalire le concezioni moderne sulla tolleranza, tra i valdesiani radicali era diffusa l’opinione XII
«che l’heretici non deveno esser abruciati, ma che vivant et convertantur»23. I valdesiani più eversivi non esitarono a trarre ispirazione da altre religioni come l’ebraismo e l’islamismo, con un atteggiamento che svela una prospettiva irenica ma soprattutto un’ansia di ricerca libera e spregiudicata, maturata nella reazione alla repressione inquisitoriale ma anche nell’evolvere di autonome esperienze e riflessioni. La circolazione europea di tali orientamenti fu assicurata dagli eretici italiani in fuga oltralpe, tra i quali ebbero un ruolo decisivo esuli legati direttamente o indirettamente al movimento valdesiano come Bernardino Ochino, Lelio Sozzini e Valentino Gentile24. Nei suoi Dialogi XXX Ochino approdò a un concetto di tolleranza che riprendeva e sviluppava le primitive matrici valdesiane, evocando gli stessi principi di libertà e di intangibile autonomia della coscienza. Sin dal suo primo soggiorno ginevrino (1542-45) egli affermò che «la verità quanto più è discussa tanto più resplende»25, e ancora nell’ultimo suo inedito Dialogo (1563) sostenne «la piena liceità di una libera e pubblica discussione in merito a ogni questione dottrinale, coinvolgendo anche i ‘semplici, idiotti et illetterati’: ‘Sì come l’olio quanto più è dimenato tanto più luce e viene a galla, così la verità quanto più è agitata e discussa tanto più risplende e si discopre illustre e gloriosa’», un elogio della franca discussione fatto coscientemente in nome del diritto di parlare «liberamente ed apertamente»26. L’indagine sull’ala radicale del valdesianesimo e sui possibili nessi con il libertinage, insomma, sembra offrire quella traccia cui si accennava in precedenza, uno dei molteplici frammenti della storia politica e culturale europea dai quali emersero nuovi modi di intendere e praticare libertà individuali, non più intese secondo logiche cetuali e corporative di matrice medievale. Chiarite queste premesse, non resta dunque che passare dall’impostazione del problema alla sua investigazione storica, partendo dal momento e dal luogo in cui il movimento valdesiano iniziò a diffondersi in Italia: dalla Napoli degli anni Trenta del Cinquecento.
XIII
Ringraziamenti Profonda gratitudine devo a Rosario Villari, che segue con affettuosa partecipazione i miei studi e mi ha dato il primo suggerimento sul tema del libro, e così anche a Massimo Firpo, che mi ha generosamente messo a disposizione le sue competenze e la sua biblioteca. Ringrazio inoltre Pietro Adamo, Eleonora Belligni, Marina Formica, Enzo Marzo, Giuseppe Ricuperati, Giovanni Romeo e Danilo Siragusa. Decisivi sono stati i lunghi soggiorni all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi (dal 2003): ricordo almeno Jérémie Barthas, Alain Guery, Christian Jouhaud, Sylvain Piron e, soprattutto, Jean-Pierre Cavaillé, che mi ha anche dato l’opportunità di presentare risultati delle mie ricerche sia al seminario da lui diretto all’EHESS sia all’IUE di Firenze, nel seminario diretto da lui stesso e da Anthony Molho. Ringrazio inoltre il personale di archivi e biblioteche dove ho svolto l’indagine: l’archivio della Congregazione per la dottrina della fede, l’Archivio di Stato di Venezia (ricordo Michela Dal Borgo e Giovanni Caniato), la Biblioteca Nazionale di Napoli, la Fondazione Firpo e l’Accademia delle scienze di Torino, oltre a varie biblioteche romane e parigine: la Biblioteca del Senato della Repubblica, la Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, la Biblioteca Giustino Fortunato, la Biblioteca Nazionale; la Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque Mazarine e la Bibliothèque della Maison des sciences de l’homme. Riconoscenza devo infine ai miei genitori e alle persone care che hanno seguito il mio lavoro: ricordo Selene Broccolo Tommasi, Ivan Commodaro e Umberto Nigro. Spero che la dedica compensi almeno in parte la mia compagna Stefania De Cola per la pazienza che ha avuto in questi anni di enormi sacrifici.
Eretici e libertini nel Cinquecento italiano
AVVERTENZA Nella citazione dei documenti si sono sciolte le abbreviazioni e si è ammodernato l’uso delle maiuscole e della punteggiatura.
Capitolo I
«Di consequentia in consequentia». Approdi radicali del valdesianesimo
1. La diffusione dell’eresia nel Regno di Napoli L’aurora degli anni Trenta proiettava nuova luce sul Regno di Napoli: i sudditi potevano aspettarsi almeno più stabilità. A partire dall’invasione del re di Francia Carlo VIII (1495), in meno d’un decennio cinque re di tre diverse dinastie s’erano assisi sul trono del Regno. La conquista spagnola (1503) aveva poi sancito la fine dell’autonomia di uno Stato declassato a viceregno e inserito nell’orbita «composita»1 dei domini hispani. Neanche ciò era bastato però a garantire agli spagnoli una tranquilla gestione del proprio dominio, aleggiando il rischio di un rovesciamento da parte delle forze francesi. Ne era conseguita un’iniziale debolezza della corona verso le forze politiche locali, in particolare la nobiltà feudale, tanto che l’edificio statale innalzato lungo il Quattrocento dagli aragonesi non aveva subito, in un primo momento, modificazioni di grande rilievo2. L’ascesa al trono di Spagna e poi al titolo imperiale di Carlo d’Asburgo, e lo snodarsi di iniziative diplomatiche e guerresche lungo tutti gli anni Venti, avevano via via ridimensionato le velleità francesi. L’ultimo sussulto s’era avuto con l’effimera invasione condotta dal visconte di Lautrec (1528); ma col trattato di Cambrai dell’anno dopo l’imperatore era riuscito a garantirsi saldamente il Regno di Napoli. Eventuali rischi sul dominio spagnolo in Italia gravavano ormai sul solo Ducato di Milano. Dal punto di vista dei napoletani, invece, il 1530 – l’incoronazione papale di Carlo V a Bologna – sancì la fine 3
dell’instabilità dinastica. Il segno più tangibile di questo mutamento fu la nomina a viceré di don Pedro Álvarez de Toledo, che avrebbe retto lo Stato napoletano per oltre un ventennio, dal 1532 al 15533. Il tramonto del pericolo francese non rasserenò l’orizzonte internazionale. Sul fronte del Mediterraneo incombeva la pressione ottomana e l’esser componente di un impero implicava per il viceregno il condividerne i destini: le guerre spagnole erano ben lungi dall’essere concluse. Toledo dovette poi affrontare i problemi interni di uno Stato sul quale, per diversi aspetti, era necessario intervenire sin dalle fondamenta; e a questa trama ingarbugliata ben presto s’intrecciò la penetrazione dell’eterodossia e del dissenso religiosi. Quanto le propaggini napoletane delle eresie che percorrevano l’Europa iniziassero ad angustiare la corte degli Asburgo emerge dalle istruzioni impartite al viceré il 22 marzo 1536 dall’imperatore, nelle more della sua partenza da Napoli, dove era stato accolto nel novembre dell’anno trascorso: Por que somos informados que muchas personas que sienten de mal de nuestra fe christiana que han sydo inquiridos de eretica pravidad en los otros nuestros reynos y otras con temor que se inquiriesse contra ellos, para evitar la pena condigna a tanto se han [nell’interlineo: traydo] y salido de los dichos reynos y venido a este en donde biven seguros con sus herrores, pertinacias y malas costumbres so syn sospecha que podrian contaminar a los otros en mucho deservicio de Dios nuestro señor y perdición de las animas, en lo qual conviene proveer y poner subito remedio por que el mal no passe adelante, os mandamos y encargamos muy expresamente os informeyes de lo que a esto toca con mucho cuydado come de cosa que toca a la honrra y reverencia de nuestro señor y salvación de las animas y proveays que los que fueren hallados erejes y que sienten mal de la fe sean castigados conforme a justicia y a lo que las leyes civiles y canonicas disponen con toda severitad y rigor según la qualidad del caso lo requiere4.
È ignoto se Carlo V si riferisse nello specifico a qualcuno, come il testo pare suggerire, mentre è certo che a quell’anno risalgono notizie sull’arresto «di alcune persone» operato dalla «corte dell’arcivescovato per suspetto di qualche opinione luterana»5. Se anche a Napoli erano circolati libri eterodossi sin dai primi bagliori della Riforma, fino ad allora – secondo la documentazione nota – non c’e4
rano stati fuochi tali da impensierire i detentori del potere6. Proprio in concomitanza col soggiorno dell’imperatore a Napoli, invece, le fonti concordano nel segnalare un autentico tornante. Un cronista testimone degli eventi, il notaio Antonino Castaldo, datò a quella fase i primi segnali della diffusione di dottrine ereticali. Scrivendo sulla rivolta napoletana del 1547 contro l’Inquisizione, Castaldo legò le origini della ribellione alla circolazione di idee eretiche che aveva visto propagarsi da quel fatidico 1536, con la predicazione di Bernardino Ochino, le lezioni di Pier Martire Vermigli e la propaganda di Marcantonio Flaminio; ma soprattutto in virtù del magistero di quel «perfido eretico luterano» di Juan de Valdés, che con la attività del suo conversare, oltre di aver sovvertito molti della più bassa plebe [...], sovvertì ancora molti de’ più letterati tra quali maestro Pietro Vermiglio fiorentino, fra Bernardino Ochino da Siena e Marcantonio Flaminio da Imola [...]. Or, costoro per lo spazio di alcuni anni coll’occulto veleno dell’eresia che andavano disseminando fecero del gran danno non solo in Napoli e nel Regno ma nell’Italia ancora7.
Secondo questa ricostruzione, a Valdés andava ricondotto in primo luogo l’«occulto veleno» che con la sua conversazione e la divulgazione dei suoi allievi aveva finito col disseminarsi finanche nell’«infima plebe». La diffusione delle idee valdesiane aveva innescato meccanismi inusitati di aperta discussione, di libero scambio di opinioni su argomenti fino ad allora riservati a «teologi grandi», divenuti tema di dibattito negli ambienti più diversi: non solo tra laici e donne ma persino fra i conciatori di pelle; non esclusivamente in palazzi nobiliari ma addirittura nel quartiere più popolare della capitale. Un’inedita circolazione di nuove idee, una vera e propria «frenesia»8, che avrebbe segnato la storia del viceregno napoletano (e non soltanto). Analogo scenario, con al centro Valdés, avrebbero offerto anche più tarde opere dedicate a protagonisti del tempo come il campione dell’Inquisizione Paolo IV9, il viceré Toledo10, il teologo riformato Pier Martire Vermigli11, il nobile Galeazzo Caracciolo esule a Ginevra12. Opere concordi nel segnalare l’importanza del magistero valdesiano, pur da posizioni differenti quando non del tutto opposte. Un’immagine radiosa del ruolo decisivo esercitato da Valdés offrì Celio Curione, che nel pubblicarne a Basilea le Cento e dieci divine considerazioni (1550), rivelò come l’autore avesse dato 5
«lume ad alcuni de’ più famosi predicatori d’Italia»13; e dall’ultimo processo per eresia celebrato contro il protonotario Pietro Carnesecchi, sarebbe emerso quanto gli insegnamenti dell’esule spagnolo avessero lasciato una traccia profonda su tutta una generazione di chierici e laici di grande rilievo, a cominciare da Bernardino Ochino. Secondo la testimonianza del protonotario fiorentino, infatti, in uno dei soggiorni napoletani del predicatore senese Valdés gli inviava prima di salire sul pulpito una «carticella», in cui gli suggeriva il tema da sviluppare nelle sue omelie14. Se nel corso del suo esilio pare che Valdés fosse riuscito a mascherare il suo proselitismo, negli anni seguiti alla sua morte (1541) esso venne emergendo nella consapevolezza dei custodi dell’ortodossia – sia cattolica sia riformata15 –, ai quali apparve sempre più chiaramente quale peso avesse avuto nello sviluppo dell’eterodossia nella penisola italiana. Interrogato dall’Inquisizione durante l’ultimo processo celebrato contro il valdesiano Mario Galeota (1566), il sacerdote Ranieri Gualano – già valdesiano anch’egli e prodigo d’informazioni – avrebbe affermato: «Have infectato detto Valdessio tutta Italia de heresia»16. Grazie a varie testimonianze raccolte dal Sant’Ufficio, negli anni Cinquanta si comprese appieno quanto pericoloso fosse stato il messaggio religioso dell’esule spagnolo, all’apparenza alieno da ogni polemica teologica e da ogni contrapposizione istituzionale: tanto più pericoloso poiché la strategia repressiva aveva rivelato anche esiti sconvolgenti per ogni ortodossia, e non solo cristiana. Fondamentali notizie, pur se insufficienti a far emergere l’ombra sfuggente di Juan de Valdés, vennero in mano all’Inquisizione dai costituti dell’ex sacerdote anconetano don Pietro Manelfi, ministro anabattista pentitosi nel 1551, quando (il 17 ottobre) si presentò agli inquisitori di Bologna per fornire un quadro dettagliato, anche se talora impreciso, del radicalismo religioso diffuso per l’Italia. Sebbene le notizie più specifiche riguardassero il Centro-Nord, non mancavano riferimenti al Mezzogiorno. Interrogato circa la presenza nella città partenopea di «haereticos lutheranos et anabaptistas», Manelfi rispose dichiarando di avere «inteso da messer Benitto neapolitano, qual adesso studia in Padoa di medicina», che in Napoli è una nova se[t]ta d’heretici in gran moltitudine, et de primi de Napoli, li quali tra le altre heresie loro tengono Christo non esse6
re Dio ma gran propheta et non essere venuto come messia ma come propheta, et essere morto per la verità, et che non è anchora risuscitato ma che ha da risuscitare et venire come messia, et doppo esso resuscitarano li eletti per ordine l’uno doppo l’altro per spacio di tempo, negando il detto del apostolo «erit in momento», anzi negano tutto il Testamento novo et dicono essere inventione di Greci et gentili, et che Paolo non ha inteso niente delle Scritture vechie, maxime circa la giustificatione et resurrecione, perché dice la giustificatione essere per il sangue et meriti di Christo, et la Scrittura dice la giustificatione essere per misericordia de Dio17.
Si trattava di affermazioni gravissime, secondo le quali intorno al 1551 non pochi meridionali sarebbero giunti a negare la divinità di Cristo, la sua resurrezione e il suo ruolo di messia, nonché a rigettare il Nuovo Testamento come testo apocrifo. Eppure tali elementi avrebbero trovato conferma e maggiori specificazioni grazie ad altre delazioni di eretici pentiti (o apparentemente tali), alcuni dei quali protagonisti di quella nuova setta di cui Manelfi aveva rivelato l’esistenza, senza peraltro comprenderne origini e sviluppi. Quella «nova setta», infatti, non era nuova come voleva il delatore. In effetti, tra le pieghe di quella notizia sconcertante si nascondevano indizi decisivi, che misero gli inquisitori nelle condizioni di ricomporre, in meno di un lustro, la fitta e nascosta ragnatela di un radicalismo religioso dietro il quale emerse, sempre più nettamente, il profilo umbratile di Juan de Valdés. 2. Giovanni Laureto Giusto due anni dopo le denunce di Manelfi, il 2 ottobre del 1553, si presentò agli inquisitori veneziani un «giovane» trentacinquenne «di honesta statura, cum barba negra che tende al castegnazzo»18: era tal Giovanni Laureto, ex chierico pesantemente compromesso nelle indagini. Anche il suo nome compariva tra quelli rivelati dal delatore marchigiano e altre testimonianze lo avevano inchiodato19; sin dal dicembre 1551, pertanto, pendeva sul suo capo un mandato di cattura20. Nonostante ciò, Laureto affermò di presentarsi «spontaneamente», senza dubbio indotto dalla speranza di accedere ai benefici offerti da due brevi emanati da papa Giulio III per il giubileo del 155021. Il doppio editto di grazia assicurava agli eretici e ai pos7
sessori di libri proibiti che confessassero «spontaneamente» (facendo al contempo i nomi dei propri complici), la possibilità di sottrarsi a un processo formale con una confessione segreta e un’abiura privata (pur registrate da un notaio). Nato a Cava de’ Tirreni intorno al 1518, tra i diciassette e i diciott’anni Laureto aveva vestito l’abito benedettino dei monaci napoletani di Monte Oliveto. Dopo circa otto anni di permanenza nel monastero aveva avuto una sbandata, allontanandosene senza «licentia alcuna» e gettando il saio alle ortiche: «Buttai l’habito regulare – rivelerà – et me vestì d’habito laical, et andai vagando un pezzo»22. Tornato a Napoli, evidentemente insoddisfatto dai suoi vagabondaggi, Giovanni aveva indossato di nuovo vesti clericali, ma presentandosi ora con «habito da prete seculare». Dopo più o meno un anno in cui aveva ministrato messa tuttavia, fra il 1545 e il 1546, il suo già accidentato percorso di fede ebbe una svolta. Il chierico cavese strinse infatti «amicitia» con «uno spagnol, lì in Napoli, il qual si chiamava il signor Francesco Proda, servitor del [...] viceré di Napoli et official suo»23, il quale non tardò ad agitargli inquietanti dubbi, insinuandosi fra le sue incertezze dottrinali: in capo a poco, rivelerà Laureto, «me instrusse nella doctrina lutherana, maximamente circa l’articulo della iustificatione, del purgatorio et delli altri articuli comuni»24. Dopo averlo convertito, Proda passò ad avanzare propositi di fuga, cercando di coinvolgerlo: «Mi invitò ad andar secco in Germania. Et così si partimo, et andamo a Genoa». Svestito nel frattempo l’abito talare, Laureto non poté proseguire il viaggio – secondo il suo racconto – a causa di una malattia, sicché i due si separarono «et lui se partì per Allemagna». A questo punto, nell’estate del 1548, Giovanni ebbe occasione di essere assunto da Isabella Breseña, «che andava [da Napoli] a Piacenza», e presso la quale poté vivere per circa un biennio «da lutherano, adherendo alle opinione de lutherani»25. Non è noto se egli avesse già conosciuto la nobildonna a Napoli né se fosse entrato in contatto col mondo valdesiano cui la Breseña apparteneva; ma è difficile pensare a una scelta casuale, soprattutto ove si osservi che la protezione della donna non si limitò all’ospitalità, ma comportò anche un incarico nella corte di suo marito don García Manrique, governatore di Piacenza26. Quel che è certo è che la nuova sistemazione si rivelò foriera di sviluppi imprevedibili. A Piacenza, infatti, «vene uno abbate Bussale, napolitano, chiamato dalla detta signora go8
vernatrice, et serviva al loco di secretario»27. In capo a poco Laureto entrò in confidenza col nuovo arrivato, scoprendo che «dubitava della divinità di Christo». Lungi dal ritrarsi di fronte a tale eresia Giovanni ne fu invece attratto, disposto quantomeno a discuterne su basi rigorose: «Ragionando cum mecco di questo, comenzamo a lezer et rivoltar le Scritture per chiarir questo puncto». Ebbe così inizio un percorso che lo avrebbe condotto assai lontano, molto più di quanto potesse immaginare all’inizio di quei ragionamenti. In fondo, fino a quel momento Giovanni era restato nell’alveo già cristallizzato della Riforma luterana: dapprincipio egli non negò la divinità di Gesù, accogliendo semplicemente l’invito a sceverare criticamente il problema posto dall’inquieto interlocutore. Il metodo seguito nella prima fase dell’indagine poteva apparire ancora, agli occhi di Laureto, come un avanzamento sulla strada indicata da Lutero, che tra l’altro era stato promotore della lettura diretta della Bibbia. L’impegno esegetico dei due era però radicalizzato dal metodo critico-filologico di Lorenzo Valla e di Erasmo da Rotterdam. Inoltre, era il problema in sé a essere scabroso: neanche in terra riformata se ne sarebbe potuto discutere in piena libertà. Ma questo Giovanni non poteva saperlo28, e in un primo momento non dovette comprendere neanche la radicalità eversiva di quel contatto diretto con la Bibbia. Busale, però, ben presto gli pose il problema della corruzione che il testo sacro aveva potuto subire nelle trasposizioni dall’ebraico al greco al latino: «Lui era molto dotto nella lingua hebrea et greca – rivelerà il cavese –, et esortò anche me ad imparar le ditte lingue, perché diceva che erano necessarie per haver la verità, perché lui dubitava anche che li evangeli fossero stati alterati et coroti»29. Il dubbio di matrice filologico-umanistica iniziava a svelare un retroterra radicale a contatto con la dogmatica teologica, e Busale instillava nella mente dell’adepto incertezze sconvolgenti, che di luterano non avevano più nulla. Colto il proprio pesce nella rete, all’inizio del 1550 l’abate partì per Padova per approfondire gli studi di filosofia, secondo la testimonianza di Laureto; ma lo spostamento era mosso più probabilmente da ben altri fini, essendo Padova una delle centrali dell’anabattismo, che iniziava a diffondersi tra le popolazioni del Nord-Est d’Italia. Giovanni in un primo momento restò a Piacenza, a macerarsi tra i suoi dubbi; ma fu presto costretto ad abbandonarla, temendo di essere arrestato a causa di un incidente occorsogli poco tempo dopo. 9
Venne in città, infatti, «un certo homo che vestiva da prete, che io no[n] scio il suo nome», e che s’era rivolto a lui in virtù dell’ufficio che esercitava a Piacenza, poiché «alhora havea questo carico, che quelli che venivano nella cità si venissero a consignar cum mecco». Ora, credendo di essere autorizzato a «parlare alla libera», «costui subito venuto fece due prediche lutheranissime» e fu tosto arrestato per esser successivamente «impicato». Laureto non aspettò di vederlo pencolare dalla forca, giacché – ammetterà – s’era diffusa la voce che questi «l’era stato a manzar meco, et [...] io l’havesse fatto predicare, maximamente perché già si sapea che io viveva da lutherano»30. Così, fu costretto alla fuga e ad accogliere i pressanti inviti di Busale a raggiungerlo a Padova, «dove [...] era stato invitato et chiamato per lettere dal ditto abbate»31. Nella città veneta Giovanni si dedicò in un primo momento allo studio della lingua ebraica; ma ben presto i due meridionali entrarono in contatto con due veneti, Benedetto dal Borgo e Nicola d’Alessandria, che si rivelarono loro come anabattisti: «Ci scoprirno la loro doctrina anabatistica, et fecero sì che ci persuasero a ribaptizarsi, havendone insegnato che il baptesmo del papa non valea. Et così il ditto Benedeto rebaptizò me, et quel Nicola rebaptizò l’abbate». I quattro, insieme con altri «compagni», iniziarono a vedersi assiduamente, «per far riduti et congregationi»: «Havendo pigliata una casa a Santa Catherina [...], ci reducevamo tuti in ditta casa, et qui ragionavamo di questa doctrina anabattistica, et ogniun diceva quel che li pareva»32. Un’atmosfera di estrema libertà si respirava in quell’appartamento: ciascuno diceva la sua su materie scottanti in un clima di franca discussione, che doveva portare gli astanti anche a scontrarsi. Ma al di là del fatto che quegli sperimentatori di nuove libertà dovettero bruciarsi a contatto col fluire aperto dei discorsi, ciò che conta davvero è che quella discussione potesse avvenire. Forse ognuno avvolgeva le sue proposte col manto della «verità», considerando che si trattava pur sempre di scambi di idee aventi la fede per oggetto; e si vedrà come quelle discussioni implicassero collisioni nonché autentiche fratture. Lo stesso Laureto ricorderà che «tra nui erano di molti dispareri», dal momento che l’accordo di massima, a quanto pare, verteva solo sulla «doctrina lutherana», nella quale «tutti eravamo d’accordo insieme». Vale la pena di anticipare che le indagini inquisitoriali avevano già dimostrato come Laureto fosse reticente nel parlare di quelle «congregationi», strettamente legate al10
la vicenda dei collegia vicentina e del cosiddetto concilio anabattista e antitrinitario di Venezia (1550), riunioni, incontri e assemblee che videro spaccarsi l’anabattismo italiano in due tendenze. Ma al di là dello scontro tra opinioni (e dei silenzi dell’inquisito sul contesto di quei dibattiti), nessun principio d’autorità era più capace di imporsi su quell’«ogniun diceva quel che li pareva», sostenuto da un atteggiamento di dubbio critico, di apertura al confronto, che sembra rimandare al nucleo essenziale del valdesianesimo, al suo radicale individualismo: nessuna ortodossia, nessun dogma e nessuna autorità a vincolar la discussione, nella consapevolezza che – almeno al riparo di quei muri – ognuno fosse libero di dire la propria, senza paura di essere arrestato o condotto al rogo. Ma è opportuno, per il momento, continuare a seguire Laureto nelle sue ardite evoluzioni. Intanto, «partito el ditto Benedeto, l’abbate fu electo vescovo; et perché lui era persona molto letterata et havea la lingua hebrea, esso havea il carico de leggere et de interpretare la Scrittura». L’esito di quelle conversazioni e di quegli scontri tra opinioni era stato dunque lusinghiero per Girolamo Busale, che riuscì a imporre la propria personalità sul mondo anabattistico italiano. Lusinghiero, però, forse anche troppo, dal momento che a Padova si diffusero voci allarmanti sul suo conto sicché, il 17 febbraio del 1551, «dubitando delli casi suoi, si levò de lì et andò a Napoli»33. Le reti della repressione diventavano più fitte e, legato a doppio filo ormai all’abate, Giovanni lo seguì nella sua fuga. Il percorso che li riportava a sud non mancò di far emergere posizioni divergenti, in cui affioravano le tensioni di quei giorni e, non è da escludere, antiche e non risolte ruggini tra i due. «Andando per strada – racconterà Laureto –, io mi accorsi che lui incommenciava ad uscir di sé, perché egli volleva applicar che Amos propheta prophetizasse delle ruine che haveano a venire a questi tempi, et diceva che questi Stati di Milano, di questo Dominio [veneto], di Napoli et di tuta Italia persequiteriano questi anabatisti, et che haveriano da patir, ma che poi Dio castegaria questi persecutori». Busale era a tal punto entrato nella parte da assumere atteggiamenti da profeta. Dalla libertà delle conversazioni ristrette era pronto a passare al momento della propaganda, della libertà di esprimersi coram populo e senza alcun filtro: voleva urlare le sue verità Girolamo, anche le più estreme, lasciandole affiorare dai recessi dell’interiorità e dai riservati conciliaboli, cosciente che ciò l’avrebbe condotto alla rovina. Busale confidò 11
a Laureto, infatti, «che lui dovea esser brusato in Napoli et che la casa, over pallazo, dove stava la madre cum li fratelli saria destruta et ruinata per conto di lui». Di fronte a tali argomentazioni deliranti, innanzi alla volontà di rendere pubbliche a costo della morte le sue visioni anticristiane, Giovanni protestò dando a Girolamo del pazzo e questi, il cui carattere non era aduso alle contraddizioni, reagì con vigore. Laureto avrebbe poi precisato che «perché io li contradiceva, esso mi pregò che quando fusse a Napoli non gli volesse contradir, dicendo che lui prophetizava et che io contradiceva allo spirito santo che parlava per la sua bocha»34. Forse nella reazione di Busale emergeva anche la convinzione di essere un profeta (e futuro martire); e del resto egli non sbagliava nel profetizzare «delle ruine che haveano a venire a questi tempi», e sulle persecuzioni in cui sarebbero incorsi «questi anabatisti [...] che haveriano da patir». Ma a parte il ruolo profetico che s’approntava a recitare in pubblico, occorre vedere nel comportamento di Girolamo una strategia di dissimulazione: non gli importava di parare le obiezioni di un allievo ormai sin troppo indipendente, quanto di chiedergli di non contraddirlo a Napoli, quando avrebbe rivestito quel ruolo da profeta su di un vasto proscenio. Con quest’animo inquieto i due giunsero nella capitale partenopea, gettando lo scompiglio in casa Busale. Come preannunciato, non solo il neo-profeta iniziò a «insegnar questa doctrina in casa sua»35, ma si mostrò «risoluto di voler anche predicar questa doctrina publicamente». Ad angustiare Laureto non era il fatto che l’abate si mettesse a profetare, ma che fosse deciso a divulgare in pubblico le idee radicali di cui era fautore, viatico certo per la sua morte e per la rovina dei suoi familiari. Non a caso, continuerà Giovanni, i congiunti di Girolamo, evidentemente atterriti dai suoi propositi, «pregorno me che io cerchasse di persuaderlo di levarse di Napoli et di andar verso Levante, in Alexandria, dove tenevano parentelle. Et così il cerchai di persuaderlo. Et lo persuasi a far quello che era di compiacimento alla madre et alli fratelli». A questo punto, l’ex olivetano si trovò in una posizione imbarazzante, perché «la detta madre et fratello vollevano che io andasse cum lui», ma Busale «non volse consentir, dicendo che non voleva condur seco un spirito di contraditione; et questo egli diceva perché io lo contradiceva in molte cose»36. Partito Busale e persene completamente le tracce, Giovanni de12
cise in un primo momento di stabilirsi a Napoli, entrando al servizio di Giulia Gonzaga: ancora una volta egli trovava asilo sotto l’ala protettiva di una delle grandi dame del movimento valdesiano, anzi della discepola prediletta di Juan de Valdés. Il destino imprevedibile, però, doveva sorprenderlo di nuovo. A distanza di circa un mese, infatti, l’arresto del valdesiano Apollonio Merenda lo mise in allarme, suggerendogli di fuggire alla volta di Roma e poi di far ritorno nei domini veneti, dove si stabilì «in compagnia» di uno dei fratelli di Girolamo Busale, Bruno, e di «don Lorenzo [Tizzano], il quale alhora si faceva chiamar Benedeto di Flori, et attendeva a studiar la lingua hebrea»37. Dopo più o meno quattro mesi, tuttavia, «essendo sotto il Natale del 1551 se ben mi ricordo», Bruno Busale fu tratto in arresto e condotto dinanzi agli inquisitori, il che provocò l’ennesima fuga di Laureto che si diresse con Tizzano a Ferrara, forse alla ricerca d’aiuto nella cerchia di Renata di Francia. Dopo una breve sosta, i due presero strade diverse: Lorenzo si diresse a Genova, mentre Giovanni passò per Piacenza – evidentemente cercando consiglio e sostegno materiale da Breseña – e dopo quattro giorni partì «per Levante, et andai a Salonich – affermerà – dove trovai el sopradetto messer Nicola [d’Alessandria] cum molti altri che io non cognosceva»38. Con i vecchi compagni anabattisti, però, riaffiorarono gli antichi attriti: Laureto riferirà che già a Padova era stato scomunicato. Non essendosi (a quanto pare) diffusa la notizia della delazione di Manelfi, inoltre, i veneti sospettavano di soffiate venute dai napoletani: di poco precedente era l’arresto di Bruno Busale e non mancarono diffidenze nei confronti dello stesso Girolamo. Così, dirà Laureto, «non conversai più cum el ditto Nicola», mentre le sue decisioni successive confermano (ove fosse necessario) con quale estremo individualismo, aperto a ogni esperienza, si ponesse ormai nelle questioni della fede. Riprendendo il suggerimento di Busale, Giovanni si dedicò allo studio dell’ebraico. Così, svelerà, «mi diedi a praticar lì in Salonich cum quelli ebrei et rabbini. Et stando in questa pratica, mi vene spirito di farmi ebreo, et così mi feci in effecto, lassandomi da loro circumcider». Era il logico approdo di un modo di guardare alle Scritture pervaso dalla cultura conversa sottesa alle proposte di Girolamo Busale. Dunque Laureto si convertì per l’ennesima volta e i suoi nuovi compagni di fede lo accolsero amorevolmente, dandogli «modo et provisione di viver». Gli domandarono pure se volesse 13
«fare exercitio alcuno», e Giovanni non chiese di meglio che di «studiar la Scrittura». All’uopo gli fu assegnata una camera, dove «studiava assiduamente et cum diligentia»; ma ancora una volta il contatto con la Bibbia doveva rivelarsi foriero di esiti imprevisti: «Quanto più io studiava, tanto più io mi veniva accorgendo delli loro molti errori et superstitioni». Ciò lo portò a chiudere la convulsa traiettoria dei suoi vagabondaggi religiosi, con un ritorno al punto di partenza, a quella «fede christiana» nella quale la conoscenza diretta del mondo giudaico lo «veniva a confirmare»39. Non erano trascorsi cinque mesi, ed ecco nuovamente sopraggiungere la dissociazione tra fede e pratica, ecco di nuovo farsi stringente la necessità di simulare. Gli ebrei cercarono infatti di persuadere Giovanni a prendere in moglie una di loro, per dare prova dell’autenticità della sua conversione; ma egli riuscì chissà come a svincolarsi, sempre più cosciente di avere seguito fino a quel momento nient’altro che «baie, superstitioni et ciance, et non solamente quelle de ditti hebrei, ma anche tute le altre sette che io havea seguitato fino alhora». Cosicché, «ravedutomi delli mei errori et delle mie impietà, andava pensando tuta via come io potessi uscir de là, cum animo de voler ritornar al gremio della santa Chiesa romana et riconciliarmi cum lei»40. Aveva vagato da un tiepido cattolicesimo a un generico luteranesimo a un antitrinitarismo con tinte anabattistiche e marrane, spingendosi fino ad accogliere il credo giudaico; ma in nessuna di quelle fedi aveva trovato una risposta definitiva alla sua irrequietezza, alla sua pur velleitaria ansia di conoscenza e di verità. Alla fine Giovanni giunse a quello che gli sembrava l’ultimo approdo della sua coscienza, il ritorno nel grembo romano, dove la stessa simulazione sarebbe stata più agevole (o così poté pensare). Certo non era affatto facile, compromesso com’era con la comunità giudaica che lo aveva così bene accolto. Giuntagli notizia dell’arrivo di alcune galee di Ferrante Sanseverino al porto di Costantinopoli, però, imbastendo una scusa riuscì a convincere gli ebrei della sua intenzione di recarvisi, per approfondire lo studio dell’ebraico presso una donna convertita al giudaismo di cui non rivelava il nome. I suoi ben disposti ospiti non fiutarono l’inganno, tanto che a Costantinopoli Giovanni giunse con «le loro caravane», sostandovi circa un mese, «sustentato perhò dalli ditti rabbini». Da qui riuscì a imbarcarsi nel gennaio del 1553 con un ulteriore stratagemma, raggiungendo Chio41, dove «trovato un navilio candioto» 14
ripartì diretto a Candia, donde prese vela finalmente per Venezia. Lì ebbe modo di incontrare vecchi compagni come Giulio Basalù, che gli consigliò di presentarsi spontaneamente al Sant’Ufficio42. Il che fece prontamente, chiedendo perdono e «absoluzione et reconciliatione cum la santa madre Chiesa»43. Neanche a quel punto, tuttavia, fu scritta la parola fine sulle sue vicende. Gli inquisitori disponevano di vari elementi grazie ai quali comprendere quanto la sua testimonianza – pur essenziale ai fini della ricostruzione generale – fosse stata in molti punti reticente: in relazione alle circostanze raccontate, nell’elencazione di complici e sodali e nella stessa confessione delle sue eresie; non ancora tale da rivelare quel pentimento necessario ad accedere al premio promesso dagli editti di grazia di papa Giulio III. Così Laureto fu arrestato e gli fu intimato di «specificare minutamente» i suoi «errori et tute le opinione et articuli [...] tenuti, creduti et forsi insegnati ad altri». Dalla prigione, però, riuscì a evadere in circostanze oscure, riaprendo con una via di fuga il suo percorso ellittico tra le religioni. Da allora se ne persero completamente le tracce44. A parte i silenzi sulle vicende dell’incontro tra veneti e napoletani, dalla testimonianza del cavese non emerse il nome di Juan de Valdés. Nondimeno, il tormentato itinerario religioso di Laureto – così individuale, critico e sperimentale – suggerisce di vedere in lui un epigono del valdesianesimo più radicale, così come testimoniano i suoi rapporti con vari esponenti del movimento ispirato al magistero dell’esule spagnolo: Isabella Breseña, in primo luogo, che lo accolse dandogli asilo e lavoro e all’ombra della quale maturò la svolta antitrinitaria; poi Giulia Gonzaga, che aveva offerto anch’ella riparo e sostegno a Laureto dopo l’ennesima fuga cui era stato costretto; ma soprattutto Girolamo Busale, che proprio a contatto col movimento valdesiano era passato da un generico luteranesimo a posizioni estremamente radicali. Tendenze e rapporti che a quel mondo, dunque, riconducono in linea diretta, come del resto avrebbero meglio compreso gli inquisitori grazie alle contemporanee delazioni di un altro chierico pentito, il già evocato Lorenzo Tizzano, denunciato da Manelfi sotto il nome di Benedetto Florio e di cui Laureto aveva rivelato la doppia identità.
15
3. Lorenzo Tizzano «alias» Benedetto Florio Tizzano si consegnò all’autorità ecclesiastica dapprima a Padova, per essere poi indirizzato agli inquisitori veneziani di fronte ai quali si presentò, nel 1553, negli stessi giorni di Laureto45: una convergenza di date difficilmente frutto di combinazione. Anche Tizzano, del resto, cercava di accedere ai benefici garantiti dagli editti di grazia giubilari, affettando spontaneità nel presentarsi mentre il suo nome era emerso da più testimonianze, e in primis dai costituti di Pietro Manelfi; anch’egli, di conseguenza, era ricercato dal dicembre 155146. «Domino Laurentio» invece si dichiarava «non citato, non chiamato, non querelato, ma sponte et voluntarie pentito de li soi peccati gravissimi, errori et diverse heresie»47. Così, affermando d’essersi presentato «voluntariamente et spontaneamente» per «chieder perdono delli [...] infiniti errori et diaboliche eresie», pregava gli inquisitori «che vogliano fare differentia da quelli che voluntariamente ricorreno alle braccia della santa madre Chiesia, sì come ho fatto io, da quelli che non vengono si non per forza et tirati con la corda alle carcere»48. Tizzano non fu avaro di dettagli, e fu senza dubbio per il travalicare il contesto locale delle sue rivelazioni che a Venezia decisero di inviarlo a Roma. Grazie alle sue confessioni, infatti, gli inquisitori avrebbero potuto dare ordine a molte delle notizie accumulate fino a quel momento. Elementi decisivi erano già emersi, tra il 1552 e il 1553, da processi e comparizioni spontanee di valdesiani che avevano preceduto Laureto e Tizzano davanti al Sant’Ufficio, offrendo conferme, ulteriori dettagli e anche smentite rispetto alle denunce di Pietro Manelfi: Marcantonio Villamarina, Antonio d’Alessio, Ambrogio da Pozzo, Girolamo Capece, Matteo Busale e Biagio Marese avevano rivelato agli inquisitori nomi, circostanze, idee relative al mondo ereticale meridionale di tendenze radicali49. I numerosi anabattisti del Nord-Est coinvolti dal delatore marchigiano nelle sue rivelazioni, poi, avevano ulteriormente precisato i contorni delle trame dipanatesi dal Sud al Nord d’Italia. Ma fu l’incrocio tra le precedenti deposizioni e quelle di Laureto e di Tizzano che consentì al Sant’Ufficio di avere un’idea più chiara di quelle eversive dottrine religiose e della trama di relazioni e di complicità che ne avevano consentito l’ampia diffusione. Le rivelazioni di Laureto, pur reticenti, riempirono di16
versi vuoti e fu grazie a Tizzano che si scorse, per la prima volta con relativa nettezza, il profilo di Juan de Valdés dietro le trame dell’eresia radicale sviluppatasi clandestinamente da un capo all’altro dell’Italia. Non a caso, sebbene Lorenzo chiudesse i conti con l’Inquisizione il 16 gennaio 1554, il Sant’Ufficio si sarebbe avvalso in altre occasioni dei suoi utili servigi50. Dopo aver chiarito il motivo («la paura») che l’aveva indotto a celarsi dietro il falso nome di Benedetto Florio quando s’era trasferito da Napoli nei domini veneti, e dopo aver fornito spiegazioni sulle circostanze che avevano preceduto il suo incontro con gli inquisitori, anche Tizzano rivangò il suo percorso religioso, partendo dagli anni nei quali era stato a Napoli «frate del ordine di Monte Oliveto», vale a dire nello stesso convento benedettino in cui aveva preso i voti Giovanni Laureto. Nato intorno al 151351, Lorenzo era vissuto nel monastero per circa sei anni, durante i quali era stato ammesso all’ordine e abilitato a celebrare messa, anche se ben presto aveva cominciato a manifestare insofferenza per la vita conventuale, giacché – spiegherà – «io non me ce era fatto di mia propria voluntà ma per satisfare a mia madre, la quale poi che morse io non volsi starvi più et procurai havere una bulla da la Penetentiaria». Dopo un lungo e complicato iter era riuscito a ottenere il permesso di abbandonare il monastero e di «vivere liberamente come preite seculare, administrar sacramenti et tenere beneficii»52. In seguito don Lorenzo aveva vagato senza entusiasmo da una cappellania all’altra, fino a quando era entrato a servizio di Caterina Sanseverino, sorella del potente principe di Bisignano Pietrantonio, presso la quale aveva esercitato l’ufficio di cappellano per quasi un decennio. Fu in quegli anni che venne maturando il suo distacco dall’ortodossia romana: un distacco anche nel suo caso (come per Laureto) stimolato dall’incontro con uno spagnolo. Stavolta, però, non si trattava di uno spagnolo qualsiasi, ma di Juan de Valdés in persona. Essendo in Napoli uno spagnolo ditto il signor Valdés il quale facea professione – secondo lui dicea – di christiano, et vedendo io che la signora donna Iulia di Gonzaga, il signor Mario Galeota, misser Antonio Imperato et altri ne faceano grande stima et diceano che era tanto grande homo et che componea molte cose belle, mi venne in animo di parlarli, et così li parlai non so che volte et lo trovava molto gentile, benché con me non se allargasse molto, et così lo pregai me volesse far legere al17
cune delle sue cose et così mi disse che lo faria; poi io vedendo che teneva molta reputatione non ce andai più53.
Secondo la ricostruzione di Tizzano, quindi, l’inizio del suo itinerario ereticale andava ricondotto in modo diretto al magistero di Valdés, che il chierico aveva voluto incontrare dopo averne sentito parlare da ragguardevoli personalità, forse incontrate al seguito di donna Caterina. Nondimeno, pur ricevendolo col suo garbo abituale, quel raffinato maestro non s’era granché esposto con l’aspirante adepto che, dopo qualche incontro, non osò più disturbarlo, ma non senza avergli chiesto di leggere qualcuna delle sue «molte cose belle». Fu in tal modo che Lorenzo entrò in confidenza con uno dei discepoli di Valdés a lui più vicini, un misterioso spagnolo di nome Juan de Villafranca: Uno nominato Villafranca, un altro spagnolo suo più amico di me, [...] mi prestò poi molti delli scritti soi, da donde io più largamente intesi le sue opinioni, perché da sua bocca solum intesi non so che de primatu pontificis, et sempre dicendo che bisogna star sopra di noi perché questa Chiesa romana ci ha ingannato, et altre cose mi dicea le quali ho ditto nel mio costituto di Padua54.
Fu dunque Villafranca a guidare i primi passi di Tizzano nei percorsi dell’eterodossia, passandogli gli scritti di Valdés e agitando i dubbi che quelle letture suscitavano in ogni neofita. A questo punto della sua confessione, Tizzano/Florio fornì un quadro tripartito delle eresie professate da lui e da diversi suoi compagni, una vera e propria classificazione basata su tre gradi l’uno all’altro successivi, che merita leggere in dettaglio svelando il carattere esoterico dell’insegnamento valdesiano: In primis come il romano pontefice non è vero et legittimo capo de la santa Chiesia et che la authorità che ha se l’ha usurpata, et non l’è stata donata da Dio et che quando nostro signor Iesu Christo donò le chiavi a Pietro non le donò a lui solo ma commonemente a tutti li apostoli. Item, che non si trova purgatorio, et che lo vero purgatorio è stato lo sangue di nostro signor Iesu Christo il quale ci ha purgato: et che questo purgatorio è stato trovato da li romani pontefici per loro utile et lucro, et che nelle Scritture sante non si fa mentione di purgatorio altramente. 18
Item, che non semo obligati a digiunare del modo che comanda la santa madre Chiesia romana, ma che lo vero digiuno si è abstinerse dal peccato, et poi è lecito mangiare omne cosa senza fare differentia di cibi. Item, che non è bene invocare li santi perché li santi dormeno in sinu Abrahae, et non intendono le nostre preghiere, et che solo Christo vive et prega per li nostri peccati. Item, che non è bene invocare la nostra advocata Maria vergine perché neanco ella pò pregar per noi, ma che solo nostro signor Iesu prega per noi. Item, che non havemo libero arbitrio al far bene, ma al male sì, et quando facimo opere bone son per gratia di Dio, quando facimo male son opere nostre naturale. Item, che li nostri peccati non bisogna confessarli ad homini ma basta confessarli a solo Dio perché lui solo è quello che perdona il peccato, et questa confessione non esser necessaria. Item, che semo predestinati tutti necessariamente ab eterno, et che da noi non possemo far niente si non tanto quanto la predestinatione ce violenta ad fare55.
Tizzano definiva queste idee, che rappresentavano il primo stadio della sua conversione, «lutherane opinioni», sebbene in realtà rivelassero tracce della personale interpretazione data ad esse da Juan de Valdés. È pur vero, infatti, che la negazione del primato pontificio, l’inesistenza del purgatorio, il rigetto del digiuno, delle preghiere ai santi e alla Madonna, così come il rifiuto della confessione, erano capisaldi dell’insegnamento luterano; ma da quegli articoli di fede emergono anche elementi di chiara divergenza da esso. La critica al primato papale, pur nella sua nettezza, si asteneva dall’aspra denuncia dell’Anticristo romano tipica del riformatore sassone; e in merito al libero arbitrio, gli si riconosceva un ruolo che mai Lutero avrebbe condiviso, mentre la stessa insistenza sul beneficio di Cristo era senz’altro riconducibile più al messaggio di Juan de Valdés che non a quello di Martin Lutero. Non a caso, Lorenzo specificherà come quelle «opinioni et heresie» fossero sorte «al tempo del dicto Valdés»: «Parte hebbero origine in me dal dicto Valdes parte da li soi scritti, quali me facea legere il dicto Villafranca, et parte da quello chel ditto Villafranca mi predicava et da libri lutherani diversi quali lui me prestava et donava, perché me donò assai libri de li quali sempre mi son servito legendoli per lo tempo che son stato in Napoli». 19
Letture, discussioni, dubbi, tutto convergeva al fine di innalzare l’adepto dalle «superstizioni papistiche» a una religiosità più perfetta e spirituale, quale l’immaginavano Valdés e i suoi seguaci, tra i quali va annoverato lo stesso Tizzano, che ben presto passò all’insegnamento di quelle dottrine, «intendendo per insegnare il trovarmi in compagnia, dire la opinione mia, et alcune volte volerla difensare»56, avrebbe confessato, sminuendo il proprio ruolo ma lasciando emergere altri squarci di quell’inedita libertà di discussione che si respirava nel movimento. Del resto, i complici che Lorenzo nominava, quelli con cui aveva discusso (condividendole) le cosiddette «lutherane opinioni», erano tutti riconducibili al nucleo più stretto dei valdesiani meridionali. Valdés stesso, naturalmente, e poi Villafranca e Busale; ma anche «misser Antonio Imperato»57, il «signor Galeazzo Caracciolo»58, «la signora donna Iulia [Gonzaga]», «la signora Lucrezia Poggiola creata della detta signora Iulia», «la signora domina Isabella [Breseña] Mandriches, moglie dell’illustrissimo signor governatore di Piacenza»59, «l’abate Villamari[na]»60 e altri ancora che sempre agli ambienti valdesiani facevano capo, come «misser Pietro Cirillo»61 e «misser Simone [Fiorillo], tutti dui di Caserta et creati del signor barone de Bernaldo»62, benché questi ultimi si fossero spinti oltre il primo livello eterodosso, considerando l’eucaristia come un simbolo: con il che non poteva più parlarsi di quelle che Tizzano aveva definito le «lutherane opinioni». E più oltre si erano spinti anche altri, noti e meno noti, tra cui diverse suore come «suor Bernardina, monaca [...] di San Francesco di Napoli» (dove alloggiava donna Giulia), con cui Lorenzo aveva ragionato più volte «del sacramento dell’altare, tenendo che fosse solamente un segno, et della divinità di Christo negative, et dell’altre opinioni lutherane, le quali la ditta monaca havea già intese dal Valdesio, et ne era assai bene instrutta»63. Alla matrice valdesiana possono ricondursi anche gli approdi successivi cui giunse don Tizzano, al termine di un percorso esoterico e graduale che appunto alla lezione di Valdés (e del suo allievo Villafranca) era ispirato in modo evidente. In capo a qualche tempo egli si spinse ben oltre le «lutherane opinioni», muovendo verso quelle che definirà «opinioni anabattistiche», le quali – rivelerà – «hanno avuto principio in me al tempo di Villafranca spagnolo, dapoi la morte del ditto Valdés»64. Il primo a parlargliene, però, così come a Laureto, era stato «l’abbate Busale». I caratteri essenziali di queste idee, impropriamente definite anabattistiche, erano: 20
In primis, come il nostro signor Iesu Christo non è Dio figliol di Dio ab eterno, ma che è figliol di Dio adoptivo primogenito de li figlioli di Dio adoptivi. Item, chel nostro signor Iesu Christo non è nato de verginità ma che è nato di Maria et di Ioseph come nascono li altri homini interveniente il coito. Item, che Maria vergine habia havuto deli altri figliuoli similmente nati da matrimonio contracto tra lei et Ioseph suo sposo. Item, che nel santissimo sacramento dell’altare non c’è il vero corpo del nostro signor Iesu Christo et che è solo un signo dela morte di nostro signore. Item, che lo sacramento sanctissimo del altare non si deve adorare, et che adorandosi si commette idolatria, perché non è si non signo sacramentale. Item, che le messe son profane, et che son idolatria et chi ce va fa idolatria.
Va sottolineato quanto la definizione di anabattismo fosse suscettibile di equivoci. In effetti, non si trattava tanto di anabattismo quanto, nel solco delle posizioni di Juan de Villafranca, di una forma ancora immatura eppure molto radicale di antitrinitarismo, che si innestava su una posizione sacramentaria che riduceva l’ostia a simbolo della passione di Cristo. Gesù non «Dio figliol di Dio ab eterno» ma «figliol di Dio adoptivo», nato «interveniente il coito» tra Giuseppe e Maria, che avrebbero avuto anche altri figli: si è distanti dalle raffinate evoluzioni dell’antitrinitarismo elaborate nei decenni successivi da esuli come Lelio e Fausto Sozzini, Valentino Gentile e Bernardino Ochino. Eppure quei successivi sviluppi europei – nei quali tanta parte ebbero anche le riflessioni di Miguel Servet – sarebbero incomprensibili senza considerare queste premesse napoletane maturate tra discepoli ed epigoni di Juan de Valdés, coi quali lo stesso Lelio Sozzini era entrato in contatto precocemente, condividendone la critica alla divinità di Cristo65. Peraltro, messe a confronto con le decisioni scaturite dal sinodo (o concilio) di Venezia del 1550 rese note agli inquisitori da Manelfi, le opinioni anabattistiche di Tizzano svelavano sorprendenti analogie e sovrapposizioni. In particolare, i primi due dei dieci punti sanciti dal concilio (i più importanti) prevedevano: 1. Christo non essere Dio, ma huomo concetto del seme di Ioseph et di Maria, ma ripieno di tutte le virtù di Dio. 21
2. Maria havere havuto altri figliuoli et figliuole dopo Cristo, provando per più lochi della Scrittura Cristo havere havuto fratelli et sorelle66.
Evidenti appaiono le consonanze con i punti più radicali delle cosiddette opinioni anabattistiche denunciate da Tizzano: In primis, come il nostro signor Iesu Christo non è Dio figliol di Dio ab eterno, ma che è figliol di Dio adoptivo primogenito de li figlioli di Dio adoptivi. Item, chel nostro signor Iesu Christo non è nato de verginità ma che è nato di Maria et di Ioseph come nascono li altri homini interveniente il coito. Item, che Maria vergine habia havuto deli altri figliuoli similmente nati da matrimonio contracto tra lei et Ioseph suo sposo.
Del resto, che la virata antitrinitaria degli anabattisti del Nord-Est fosse stata indotta dal gruppo napoletano di Busale – cui era legato anche Tizzano – era ormai chiaro agli inquirenti. La definizione di queste posizioni come anabattistiche, pertanto, fu probabilmente suggerita a Lorenzo dagli stessi inquisitori, che avevano potuto cogliere come egli parlasse delle stesse eresie descritte da Manelfi e da altri come caratteristiche degli anabattisti del Nord-Est. Ed è probabile che anche la definizione dell’ultimo stadio del suo percorso corrosivo del cristianesimo fosse frutto di suggerimento degli inquisitori: don Lorenzo le definirà «diaboliche opinioni», ricalcando (forse senza saperlo) la classificazione proposta l’anno precedente al Sant’Ufficio veneziano da un battilana vicentino, Matteo dalle Maddalene, che aveva parlato di opinioni «anabattistiche» e opinioni «diaboliche»67. Al terzo livello descritto da Tizzano si giungeva a ritenere: In primis, come il nostro signor Iesu Christo non è il vero messia promesso nella lege et nelli profeti, et che il messia ha da venir et che non è venuto. Item, come il nostro signor Iesu Christo è stato tantum profeta come li altri profeti, è ben vero che have havuto maggior spirito et maggior dono di Dio de li altri profeti. Item, come morto il corpo more ancora l’anima, ma che Dio benedetto resusciterà li suoi electi li quali son morti con la speranza della resurrettione et son stati homini da bene et son morti nella unione dei fedeli. [...] 22
Che le Scripture sancte et evangeliche siano false perché si ritrova alcuna contradditione in esse non tamen vere ma certo modo apparente68.
Insomma: partito da un luteranesimo rivisitato da Valdés e passato a un generico antitrinitarismo sulle orme di Juan de Villafranca, Tizzano era approdato a esiti nei quali parevano confluire un giudaismo non alieno da echi islamici, un predestinazionismo radicale irrorato da materialismo, un umanesimo filologico complicato da una sorta di ansia distruttiva di ogni ortodossia. Anche nel suo caso, allora, si profilava un percorso di liberazione da ogni dogmatica profondamente segnato dalle premesse spiritualistiche del valdesianesimo. Anzi, dalle sue confessioni ciò emergeva con nettezza maggiore rispetto alle ricostruzioni di Laureto, sul quale Lorenzo diede peraltro più precise specificazioni, accomunandolo a sé e ad altri compagni nella credenza delle «diaboliche opinioni». Grazie alle sue rivelazioni, pertanto, era chiaro che vicende quale quella di Laureto non erano il frutto di chissà quali stravaganze, ma i coerenti snodi delle trame di un pericoloso movimento, nel quale gli inquisitori potevano vedere riflesse le fattezze inquietanti della nuova setta rivelata da Manelfi. Era sufficiente porre a confronto le due versioni: Manelfi
Tizzano
Tra le altre heresie loro tengono Christo non essere Dio ma gran propheta et non essere venuto come messia ma come propheta, et essere morto per la verità, et che non è anchora risuscitato ma che ha da risuscitare et venire come messia, et doppo esso resuscitarano li eletti per ordine l’uno doppo l’altro per spacio di tempo, negando il detto del apostolo «erit in momento», anzi negano tutto il Testamento novo, et dicono essere inventione di Greci et gentili, et che Paolo non ha inteso niente delle Scritture vechie, maxime circa la giustificatione et resurrecione, perché dice la giustificatione essere per misericordia de Dio.
In primis, come il nostro signor Iesu Christo non è il vero messia promesso nella lege et nelli profeti, et che il messia ha da venir et che non è venuto. Item, come il nostro signor Iesu Christo è stato tantum profeta come li altri profeti, è ben vero che have havuto maggior spirito et maggior dono di Dio de li altri profeti. Item, come morto il corpo more ancora l’anima, ma che Dio benedetto resusciterà li suoi electi li quali son morti con la speranza della resurrettione et son stati homini da bene et son morti nella unione dei fedeli. [...] Che le Scripture sancte et evangeliche siano false perché si ritrova alcuna contradditione in esse non tamen vere ma certo modo apparente.
23
Risulta evidente come si trattasse delle stesse dottrine. Eppure, se sul piano delle idee gli inquisitori trovavano conferme, emergevano al contempo alcune incongruenze. Secondo Manelfi, infatti, la cosiddetta nuova setta avrebbe assunto la sua specifica configurazione dopo il concilio di Venezia del 1550, in cui gli anabattisti del NordEst erano approdati a posizioni antitrinitarie, una svolta indotta da Busale e da suoi compagni come Laureto e lo stesso Tizzano. Apparentemente, quindi, in un primo momento (almeno fino all’autunnoinverno del 1550) i napoletani guidati da Busale non s’erano spinti oltre quelle posizioni antitrinitarie che nei costituti di Tizzano erano definite impropriamente anabattistiche, posizioni originate da Busale stesso oltre che da Juan de Villafranca che, come si è visto, potevano sovrapporsi ai principali esiti dottrinali del concilio veneziano. Nella ricostruzione di Manelfi, quindi, la stessa posizione di Busale appariva come superata da più avanzate rivendicazioni promosse successivamente (forse dopo il suo esilio in terra ottomana) dai compagni della sua stretta cerchia. In realtà, Tizzano chiarì come fosse stato proprio Busale (con un certo Francesco Renato) a indurlo verso le «diaboliche opinioni», e che a quelle i napoletani erano giunti già un lustro prima della celebrazione del sinodo veneziano del 1550. Ne conseguiva che in un primo momento Busale e i suoi non avevano ritenuto opportuno divulgare nei domini veneti le punte più estreme del loro itinerario di distacco dal cristianesimo, preferendo un approccio gradualistico che rivelava il metodo appreso alla scuola valdesiana. Dopo le delucidazioni di Lorenzo, dunque, gli inquisitori furono in grado di dare un ordine più coerente a prove e indizi raccolti in precedenza, potendo del pari contare su un nutrito elenco di nomi con precise conferme e nuovi riferimenti. Inoltre, gli inquirenti ebbero la possibilità di porre alcuni punti fermi (pur ancora insufficienti) rispetto alla notizia della cosiddetta nuova setta napoletana: un movimento e non una setta, capace di collegarsi ad altre realtà e di plasmarle con raffinate modalità di propaganda e di proselitismo, basate su un uso spregiudicato di simulazione e dissimulazione e su un messaggio esoterico e graduale, fondato su una libertà individuale che man mano si rivelava esente da ogni limite dogmatico o istituzionale. Un movimento del quale si profilavano sempre meglio gli esiti dottrinali e i ruoli da protagonista, a cominciare da Busale, 24
da Villafranca e da altri ancora dietro i quali, sempre più netta, si delineava l’immagine di Juan de Valdés. 4. Giulio Basalù Fu con uno degli ultimi tra processi e riti abbreviati celebrati dal Sant’Ufficio contro i radicali, nel 1555, che gli inquisitori si chiarirono le idee sulle evoluzioni del radicalismo valdesiano, riuscendo a scorgere trame e orditi della fitta rete che s’era intessuta tra il Sud e il Nord Italia negli anni a ridosso della metà del secolo. Ancora una volta, in quel tardo inverno veneziano del 1555, gli inquisitori si trovarono di fronte a una supposta comparizione spontanea, che cercava d’appigliarsi agli editti di grazia di Giulio III. A presentarsi era un legista napoletano che viveva da tempo nei domini veneti, cugino del famigerato latitante Girolamo Busale, benché il suo cognome fosse un po’ diverso: si chiamava Giulio Basalù (o Besalù) e si presentò agli inquisitori di Venezia il 2 marzo 1555. Il flusso di notizie fornite nel suo primo costituto fu talmente ricco che al Sant’Ufficio non si lasciarono sfuggire l’occasione, sicché fu celebrato a suo carico un processo, chiuso nel luglio del 1555, grazie al quale gli inquirenti sistemarono le ultime tessere del puzzle. Anche Basalù sosteneva dunque d’essersi presentato «per manifestar spontaneamente et voluntariamente tutte quelle oppinion cattive che per el presente ho tenute»69. In realtà, dalle testimonianze allegate al suo fascicolo (fra cui quella di Tizzano70), appare chiaro come si trattasse dell’ennesima spontaneità fittizia. Già nel 1548 un don Antonio Dell’Olio (o Del Loio) aveva dichiarato che Basalù e Busale (con altri ancora) erano «tutti d’una medesima opinione luterana», raccontando del modo picaresco in cui i due s’erano fatti beffe di un tentativo di riconvertirli al cattolicesimo, mangiando in tutta risposta «un salsiccione il dì de venerdì o de sabato»71. Come «lutherano» era stato definito «messer Iulio Basalù dottor» anche da Ranieri Gualano, in una deposizione del 1551. Nel giugno dell’anno seguente, poi, l’abate Villamarina (vittima della beffa del salsiccione) aveva rivelato come Basalù si fosse spinto ben oltre le dottrine luterane, poiché negava la divinità di Cristo e l’autenticità di quelle parti dei vangeli che sembravano asserirla. Dal gennaio al luglio del 1553, infine, s’erano susseguite conferme e precisazioni da parte di altri pentiti valdesiani 25
(Ambrogio da Pozzo, Antonio d’Alessio, Girolamo Capece e Matteo Busale)72 che l’avevano inchiodato senza scampo: il 7 settembre di quell’anno era stato spiccato a suo nome un mandato di cattura dall’Inquisizione romana73. All’atto di presentarsi a Venezia, pertanto, Basalù era ricercato esattamente da un anno e mezzo. Questa volta a presentarsi non era un chierico malgré soi ma un laico, che prendeva le mosse dai suoi anni universitari, trascorsi a Padova a partire dal 1538. Lì, oltre dieci anni prima dell’intreccio tra radicali napoletani e veneti, era giunto da «bonissimo christiano», aduso a confessarsi almeno una volta al mese. Il giovane studente, tuttavia, aveva avuto la «mala fortuna» d’essere parente di Girolamo Busale, allora agli esordi del suo percorso ereticale e ben ambientato a Padova prima del trasferimento da Piacenza rivelato da Laureto. L’abate seguiva le lezioni «de uno padre don Marco [da Cremona] de Sancta Iustina, qual legeva le epistole di san Paolo. Et par che quel padre teneva la giustification per la pura fede et senza opere». Tale idea folgorò Girolamo, che «ogni giorno» «me diceva alchune cose in questa materia»74, rivelerà Basalù, il quale, studente in legge, era digiuno di teologia, offrendo al parente una facile opportunità di far affiorare dubbi tra certezze religiose che non dovevano essere granitiche. In particolare, Busale «uno giorno usò questa autorità: ‘Si ex operibus iusticiae Christus gratis mortuus est’». Bastò questo per gettare Giulio in una crisi profondissima, poiché considerare la salvezza come frutto esclusivo della morte di Cristo, senza bisogno delle opere umane, significava sposare il nerbo del luteranesimo: la giustificazione per fede. A ciò Basalù cercò in un primo momento di opporre qualche obiezione, affermando: «La Giesa tiene el contrario»; ma la sua impreparazione teologica lo lasciò in balia di quei dubbi tanto provocatori quanto seducenti, e per i quattro anni del corso universitario ne fu ossessionato: «Io steti fin al ’42 – rivelerà – sempre pensando sopra questa cosa». Terminati gli studi e spostatosi a Venezia in vista del suo ritorno a Napoli, il neo-dottore in legge andò «a visitar uno pre[te] napolitan che era a San Zorzi, don Germano de Minadois, per licentiarmi da lui». Fu con sua gran sorpresa che Minadois (discepolo di Valdés75) «me intrò in questi medesimi ragionamenti et mi allegò la medesima auctorità, sopra la qual andai pensando tutto quel viaggio»76. Quella frase pronunziatagli sia da Busale sia da Minadois gli galleggiava nella mente tormentandolo, viatico certo, così gli pareva, 26
per sprofondare in un abisso ereticale: e tuttavia quell’abisso finì con l’attrarlo sempre più. Giunto a Napoli, riferirà, «el primo che mi visitò fu Mathio Busale fratello del sudetto abbate, et mi parlò di questa oppenion». Già roso dal dubbio, il giovane non trovava requie: ovunque andasse si imbatteva in qualcuno che cercava di indurlo a far propria quella dottrina contraria al cattolicesimo, come gli accadde nuovamente quando Matteo Busale lo condusse «a visitar alcuni signor grandi, che erano discipoli del Valdés [...] et tenevano quella oppenion, dove fui accettato et avanzato»77. È bene soffermarsi su quest’ultima asserzione, con la quale Basalù svelava d’aver sciolto il primo nodo sul quale s’era tanto arrovellato. Giulio non ammetteva solo di essere stato «accettato» da un mondo velato dal più fitto segreto, ma rivelava pure coscienza d’esser stato «avanzato», dando l’immagine del tracciato sul quale si era incamminato: un percorso graduale, che l’avrebbe portato a conclusioni ben più radicali, ricalcato sul metodo adoperato da Valdés, che di quell’esoterica pedagogia maieutica ispirata agli alumbrados era stato geniale assertore78. In tal modo Basalù aveva cominciato ad addentrarsi nel «divino palazzo» (una metafora valdesiana desunta da Maimonide) dei «secretos de Dios», abbandonando la schiera di quanti si limitavano a contemplarlo dall’esterno, per accogliere il principio della giustificazione per fede e compiere il primo passo fatto da tutti gli iniziati alle dottrine dell’esule spagnolo. Una prima soglia, questa, sulla quale si fermarono in molti, cui la voce interiore dello spirito non aveva suggerito di andare oltre, di muoversi «di consequentia in consequentia» – di dedurre le «illationi che ho cognosciuto poi potersi fare da tali principii», come avrebbe confessato Carnesecchi79 – fino a dissolvere uno dopo l’altro i capisaldi del cristianesimo. Su questo piano, la singolare vicenda di Giulio Basalù appare sintomatica di molti aspetti del valdesianesimo, all’insegna del quale si sarebbe snodato anche il suo successivo itinerario ereticale: sebbene il maestro fosse ormai scomparso, il giovane legista fu assorbito nel movimento da alcuni suoi allievi, grazie ai quali poté entrare in contatto con uno dei più intimi discepoli dell’esule spagnolo, che l’avrebbe condotto lungo tutta la scala esoterica, fino a raggiungere le stanze più segrete del «divino palazzo» e a «frugare fin dentro le casse». Il metodo usato nella conversione di Basalù fu analogo a quello che Valdés aveva praticato con i suoi primi adepti80. «Essendo in questa oppinione – proseguirà infatti Giulio – praticavo con uno che 27
praticava con li dicti signori et [si] chiamava Zuane de Villafrancha spagnolo, et era servitor del viceré et, perché l’hera infermo, andavamo molti ogni giorno a visitarlo, et lui continuamente parlava di questa oppinion»81. Come Tizzano, anche Basalù entrò così nel gruppo più radicale del movimento valdesiano, un gruppo nel quale aveva guadagnato posizione preminente il misterioso Juan de Villafranca, che qui si vede affacciarsi nuovamente sulla scena, infermo ma in posizione sempre più centrale. Seguendo il metodo graduale appreso da Valdés, in una prima fase egli insistette solo sulla giustificazione, non incontrando troppo interesse in Giulio che, una volta accolta «ditta oppinion», parve non volersi porre altri problemi dottrinali. Gli bastava quell’«autorità», agitata da Girolamo Busale e don Germano Minadois, in virtù della quale era iniziata la sua crisi religiosa. Ben presto, però, Villafranca smise di insistere sulla giustificazione, «et vedendo che io l’havevo accettata mi comenzò far molte consequentie»: la rete valdesiana si accingeva a catturare un nuovo adepto. «In mancho di 4 mesi, di consequentia in consequentia, con el fondamento solo della ditta oppinion mi persuase che non li era intercession de santi, purgatorio, adoration de imagine, iubilei, confessione auricolar, in le qual tutte oppinion cascai senza altro studio»82. Con la sapienza pedagogica appresa dal maestro, Villafranca traeva le ovvie «illationi» che derivavano dall’accogliere il principio della giustificazione per fede. In realtà si è già accennato come Valdés proponesse una variante originale del principio luterano, ammettendo in parte una sfera di libero arbitrio e non svalutando del tutto il valore delle opere. Ma Basalù ciò non comprese, sebbene Villafranca non avesse mancato di fargliene cenno: «Mi parlò anchora de predestination et libero arbitrio, ma questi non li ho mai intesi», ammetterà. A quel punto il legista avrebbe potuto definirsi quindi un «lutherano», avendo superato il primo scalino lungo direttrici analoghe a quelle di Tizzano; in realtà, era solo l’inizio di un itinerario religioso dagli esiti più radicali che si potessero immaginare al tempo. Per il momento, comunque, l’adepto aveva già di che riflettere, e il maestro non mancò di lasciargli il tempo necessario per digerire il tutto: «Redutto a questo termine, mi lassò star in queste oppinion da altri 4 mesi». Di quattro mesi in quattro mesi, però, i gradi andavano percorsi e oltrepassati, e Villafranca riprese a tessere la tela. «Doppo mi comenzò a parlar de oppinion de maggior importanza, cioè del sacra28
mento che era puro segno»: dal Lutero rivisitato da Valdés si passava a Zwingli, insomma, per procedere poi oltre, fino al livello antitrinitario definito da Tizzano (impropriamente) anabattistico. Infatti, lo spagnolo gli pose subito dopo il problema «della divinità in Christo, negandola»: «Diceva esser puro homo, ma pieno abundantemente de spirito de Dio», aggiungendo «che le anime delli reprobi moreno con il corpo et che quelle de fideli si salvaranno»83. Si può immaginare lo shock prodotto nel legista da quelle «consequentie», dissolutrici dei fondamenti della fede cristiana. Aveva impiegato quattro anni per ammettere il principio della giustificazione, ed ecco che nel giro di otto mesi da quel principio aveva visto trarre deduzioni che ribaltavano ogni ortodossia. Cristo puro uomo; un predestinazionismo da cui affioravano echi materialistici, con le anime della maggior parte degli uomini – i «reprobi» – destinate a morire con il corpo; l’inferno ridotto conseguentemente a niente più che un’invenzione a fini di lucro e di dominio, al pari se non peggio del purgatorio già negato dai riformatori. Basalù ne fu tanto sconvolto da non ricordare poi su quali basi Villafranca lo avesse condotto fino a quell’approdo: «So ben che io steti parechi giorni che non volsi più andar da lui, et steti circa dui mesi pensando sopra questa cosa, parendomi troppo grande»84. Ogni certezza vacillava. Ma quel gorgo ereticale era troppo seducente e Basalù non resistette: «Pur tornai là, et in quel medesimo tempo aldiva [scil. udivo] alchuna lettion da quelli dottori filosofi». Quei filosofi finirono così con lo smuovere l’ultimo ostacolo alla liberazione della sua più autonoma individualità: «Finalmente – ammetterà – entrai in queste oppinion, che l’anima era mortal così de’ reprobi come de’ fideli, fondandola sopra raggion natural et mie chimere»85. Non solo, dunque, a quel punto egli aveva fatto proprie tutte le «consequentie» suggeritegli dai suoi eretici maestri, ma la sua mente fervida si era spinta ancora più lontano, oltrepassando l’ultimo grado dell’insegnamento di Juan de Villafranca e le stesse opinioni diaboliche descritte da Tizzano, fino a teorizzare la mortalità di tutte le anime e a formulare principi che di religioso non avevano più nulla. «Raggion naturale e mie chimere» erano le basi sulle quali Basalù diceva di essere giunto fino a quelle conclusioni estreme: e si badi che più che un approdo era un ulteriore passaggio verso conseguenze ancora più eversive, alle quali egli pervenne fantasticando nella più totale libertà, senza alcun vincolo al dettato delle Scritture 29
o ad alcuna autorità: «La maggior parte delli miei ragionamenti era senza Scrittura ma de fantasia – confesserà –, perché mai ho letto né uno evangelio né una epistola de san Paolo integra»86. Un approccio che lo condusse inesorabilmente alla negazione di ogni religione: «Fatta questa ressolution ognun pol pensare quello che ne succiede. Così da mia posta, con quel fondamento falso [la mortalità dell’anima], veni a negar tra mi medesimo ogni sorte de religion così christiana come ebrea et ogn’altra»87. In tal modo Basalù si spinse al di là d’ogni confine. Spiegando meglio cosa volesse intendere, infatti, aggiunse: Mi ridevo d’ogni cosa [...]. Negavo la messa, el battesmo, l’untion, le religion ecclesiastiche et tutti li sacramenti, la creation del mondo. Me ridevo di Moysè et delli profetti, de David et de tutte le historie et dicevo che in ogni religion, oltra la christiana, si vedeva miracoli, et che Christo era stato homo da bene che haveva insegnato el ben viver. Et dicevo el concubinato non esser peccato et in conclusion mi ridevo d’ogni cosa.
È difficile sfuggire all’impressione di anacronismo indotta da siffatte considerazioni. Alcune idee sembrano prese dal Campanella più radicale della congiura antispagnola del 1599 e dell’Ateismo trionfato in italiano88. In molti casi sembra di udire le opinioni del mugnaio Domenico Scandella detto Menocchio89, condannato a morte in Friuli in quello stesso 1599 del tentativo campanelliano. Soprattutto, però, fortissima è la sensazione di scorrere un catalogo di idee libertine, e delle più eversive. Non sarebbe sorprendente leggere affermazioni di tale portata in Giulio Cesare Vanini o nel Theophrastus redivivus, monumenti dell’incredulità secentesca. Eppure, quelle idee di Basalù risalgono ai primi anni Quaranta del XVI secolo, nel che sembra possa trovarsi una conferma all’ipotesi di legare eresia radicale e libertinage. Peraltro, Giulio terrà a sottolineare come da un certo momento in poi avesse continuato a frequentare le riunioni dei valdesiani, «a li ragionamenti de le quale mi son trovato presente», ma sempre più alla lontana, come se quei ragionamenti gli apparissero un vino annacquato: Io in verità non solamente non le credevo ma non le intendevo perché, essendo intrato in opinione che morto il corpo morisse l’anima di ognuno, ogni opinione andò per terra, credendo che tutte le religione fossero inventione di homini per indur li homini al ben vivere. Onde non vo30
levo affaticarmi per intender le diverse opinion di religione, non ne credendo alcuna, ma stavo ascoltar per haver quelli intertenimenti et amicitie. Et per il più non parlavo mai, salvo di quelle opinione che ho ditte nel mio constituto et con quelli che ho ditto90.
Va sottolineato ancora l’atteggiamento libertino che Giulio aveva finito con l’assumere nei confronti della religione: simulazione e dissimulazione, mortalità dell’anima e dunque inesistenza di inferno, purgatorio e paradiso come d’ogni vita ultraterrena, svalutazione dei miracoli, le religioni come invenzione umana per tenere a bada i popoli, eternità del mondo, concubinaggio lecito, Cristo uomo da bene che aveva insegnato a vivere rettamente. In tali idee eversive, che Basalù condiva con irrefrenabile ironia, pare ascoltare echi di Lucrezio, del Machiavelli più sulfureo, dell’Erasmo radicale, dei libertini spirituali, il tutto rivisitato valdesianamente in una chiave di assoluta libertà individuale, perfettamente coerente con quello che sarà il libertinismo del Seicento. Certo, è necessario comprendere con maggiore precisione che cosa Basalù volesse dire affermando di non credere in alcuna religione, e sarebbe un errore catalogarlo sic et simpliciter come un ateo senza Dio. Nelle more della conclusione del processo, lo stesso messer Giulio fu costretto a chiarire questo punto. In una lettera agli inquisitori del 9 luglio 1555, il giorno stesso dell’abiura, si lamentò del fatto che nelle «piazze si ragionava» dei suoi casi e che «dicevano io non haver creduto esservi Dio»91. Merita attenzione il fatto che a metà del Cinquecento nelle piazze di Venezia si parlasse di un uomo che aveva negato l’esistenza di Dio; come del resto avveniva anche altrove: non solo nel chiuso di segrete conventicole ma anche nello spazio pubblico, perfino per le strade, tanto da sembrare credibile che un Menocchio potesse ascoltare ragionamenti che giungevano a esiti tanto radicali e trarne spunti per la sua eversiva concezione del mondo e della divinità92. D’altra parte, nell’Esortazione al martirio (1552) Giulio da Milano aveva richiamato «un altro archisinagogo chiamato Silvio Vicentino, [il quale] dice che la fede non è altro che l’oppenione de l’huomo, secondo che la persona se l’immagina e fabrica nel suo cervello, di maniera che non afferma l’una fede essere più vera né migliore dell’altra»93. Quel che per ora interessa, comunque, è la precisazione formulata da Basalù nella lettera accennata, laddove volle chiarire quanto fosse «falso che io non habbia 31
creduto esservi Dio, perché anzi io non credevo altro che un solo Dio governator di tutte le cose et massime del homo, il qual Dio havesse a dar gloria a quella parte di homini che li havesse piacciuto a quel tempo et di quel modo che li havesse piacciuto»94. Specificazioni importanti, che impediscono di parlare a stretto rigore di ateismo. Ma Basalù non aggiunse a ciò nient’altro, rinviando per il resto a quanto aveva confessato in precedenza. Propugnatore di una sorta di proto-deismo filosofico intinto di materialismo, individualista tanto radicale da spingere la libertà di pensiero sino all’affermazione della mortalità dell’anima, alla negazione delle religioni e della stessa creazione del mondo, un uomo comune come Giulio Basalù assumeva il profilo di un vero e proprio libertino, svelandosi come uno dei personaggi più radicali del Cinquecento. Ci si può chiedere che cosa rimanesse di Valdés e del valdesianesimo al termine di questo viaggio oltre i confini dell’incredulità. Giulio stesso ribadì più volte come a quelle conclusioni fosse giunto «non avendo lettere de theologia et della Scrittura, ma havendo caminato per el più con el semplice mio intelletto»95. Con quello sfumato «per el più» già il legista rivelava l’importanza avuta sulla sua evoluzione da maestri come Busale e Villafranca. Inoltre, sebbene tenesse sempre a ribadire la sua ignoranza teologica (nel che si può forse scorgere un’altra traccia riconducibile a Valdés), Basalù ammetteva d’avere letto vari libri e ne dava l’elenco: De libri prohibiti ho letto Luthero De servo arbitrio et questo quasi tutto, alchune carte delli commentarii alli Galati; una epistola de Calvino, questa l’ho laudata et mostrata a molti, el libro De fugiendis impiorum sacris, el Beneficio de Christo, molte cose del Valdés, alcune tragedie, il Valla De falsa donatione, Pasquino in estasi, Annotation de Mostero in dui o tre lochi et questo ho laudato sopra san Matheo dove parla del sacramento; qualche pocho delle annotation de Erasmo, et l’ho laudato perché mi pareva che negasse la divinità in Christo, qualche carta del Alchorano, Martin Luthero De abroganda missa et contra annabatistas qualche carta; uno certo Iubileo et alcuni discorsi del sopradetto Latantio Rognoni contra el sacramento. Et quasi tutti li ho letti in Napoli et qui alcuni96.
Giulio non era dunque tanto digiuno di cultura religiosa: s’era abbeverato ai capisaldi della Riforma, da Lutero a Calvino, aveva condiviso la lettura radicale di Erasmo97 e di Valla, aveva letto il Pasquino 32
in estasi di Curione e opuscoli di Pier Paolo Vergerio, spingendosi addirittura a studiare alcuni passi del Corano, il che, peraltro, dà ulteriore sostegno agli echi islamici colti nelle confessioni di Tizzano. Nulla in questo elenco rimandava, invece, alla cultura classica greca o latina. Sebbene Basalù si fosse spinto a una posizione di tipo materialistico, nessun riferimento emerge a fautori antichi del materialismo come Epicuro o Lucrezio né ad autori moderni che la cultura classica avevano ripreso come Machiavelli98. Merita sottolineare anche la totale assenza di riferimenti all’aristotelismo eterodosso padovano e in particolare a Pietro Pomponazzi, al quale in genere gli studiosi riconducono le dottrine sulla mortalità dell’anima in età rinascimentale. Tale silenzio, però, poteva essere indotto da vari fattori e non è necessario dedurre da esso l’ignoranza di Lucrezio e Pomponazzi, giacché entrambi erano noti negli ambienti napoletani frequentati da Giulio Basalù. Nello stesso tempo, è certo che egli apprese da Villafranca la teoria cripto-materialistica della morte delle anime dei reprobi e della salvezza di quelle degli eletti. E va rilevato come, anche su tale dottrina, Villafranca avesse tratto ispirazione da Juan de Valdés99. Se infatti sembra che Valdés non avesse scritto alcunché di esplicito su questi temi, è pur vero che egli riteneva che esistessero gli «eletti di Dio», facendo riferimento a una «resurrezione dei giusti»: il che era coerente con una parte decisiva della dottrina di Villafranca, secondo cui solo agli «eletti» erano concesse resurrezione e vita eterna. A leggere il Catechismo valdesiano, tuttavia, emerge come non necessariamente la visione predestinazionistica conducesse ai risvolti materialistici sottesi in Villafranca. In quel testo che ebbe grande diffusione per l’Europa col titolo di Lac spirituale si leggeva: Che nel tempo determinato dalla divina maiestà verrà Christo glorioso et triomphante a giudicare li vivi et li morti, havendo Dio risuscitato tutti li morti, et che in questo giudicio universale coloro che non haveranno accettato la gratia dell’evangelio di tal maniera che la fede non sia stata efficace in loro saranno condannati a pena eterna come increduli et infideli, et coloro che havranno accettato la gratia dell’evangelio et postisi nell’acqua del battesimo come Noè si pose nell’arca, acquisteranno vita eterna gloriosissima et felicissima100.
Apparentemente, dunque, Valdés perorava una visione ortodossa in materia di resurrezione delle anime, immaginando la vita eter33
na per chi avesse accettato il messaggio di Cristo e la «pena eterna» per tutti gli altri. Se però si confronta la prima edizione del Catechismo (del 1545) con una versione del testo conservata manoscritta in un codice senese, tutto il passo relativo a «coloro che non haveranno accettato la gratia dell’evangelio di tal maniera che la fede non sia stata efficace in loro saranno condannati a pena eterna come increduli et infedeli» svanisce nel nulla, sicché il dettato valdesiano presenta già un significato meno incoerente rispetto alla visione perorata da Villafranca. Ancor più assimilabile ad essa è il passo in esame, se lo si confronta con la seconda e terza edizione dell’opera, uscite rispettivamente nel 1549 a Basilea e nel 1550 a Pavia. Lì il silenzio del manoscritto senese diventa esplicita ammissione e i condannati a «pena eterna» diventano condannati a «morte eterna». Una differenza sostanziale col testo della prima versione a stampa, che può forse trovare spiegazione nella circostanza che quest’ultima uscì dall’ambiente dei valdesiani moderati, che non sposavano la dottrina della morte delle anime dei reprobi né tanto meno non credevano all’inferno; ma la discordanza può risalire anche alla circolazione di manoscritti non del tutto identici, tali da riflettere un mutamento nel pensiero dell’esule spagnolo oppure la loro destinazione a interlocutori diversificati, più o meno capaci di comprendere e accettare gli esiti più avanzati della sua riflessione religiosa. La lettura radicale delle altre lezioni, tra l’altro, affiora non solo dall’insegnamento di Villafranca, ma anche dal ciclo di affreschi che Iacopo Pontormo dipinse, su commissione di Cosimo I de’ Medici, nel coro della basilica di San Lorenzo a Firenze, ciclo basato sul testo del Catechismo e nel quale erano raffigurati anche una Resurrezione degli eletti e un Giudizio universale, che rappresentavano, appunto, l’ascesa al cielo dei soli eletti, mentre una massa di corpi giaceva inerte sulla terra, nella putrefazione della «morte eterna», senza né purgatorio né inferno destinati ad accoglierli. Del resto, a ulteriore riprova di come la dottrina del sonno delle anime dei giusti e della morte di quelle dei reprobi trovasse radici nel pensiero valdesiano, vale la pena di ricordare che dall’editto contro gli alumbrados di Toledo emerge come essi ritenessero che «Dios no punía la culpas» e che pertanto «no avía infierno»101. Non c’è da sorprendersi, quindi, se nel commento dedicato al vangelo di Matteo, lo stesso Valdés aveva potuto affermare che i giusti sarebbero stati «abilitati a vita eterna [...], dalla quale abilitazione sono esclusi quelli che non credono in Cristo perché, 34
benché risusciteranno a tempo, non viveranno in eterno e per sempre», destinati «non a vita eterna, ma a morte eterna»102. L’originario valdesianesimo di Basalù, insomma, appare non solo potenzialmente compatibile con il suo approdo materialistico, ma addirittura come una sua fondamentale premessa, che dipanava i suoi esiti imprevedibili attraverso l’educazione alla libertà, al metodo del dubbio e dell’approfondimento progressivo cui anche Giulio era stato addestrato, benché alla tesi della mortalità di tutte le anime egli fosse arrivato poi da sé, in quanto logica «consequentia» delle tesi espostegli dal maestro. Se di un cospicuo numero di anime si perorava la morte col corpo, in fondo, perché non estendere il principio a tutte le anime? Giulio stesso avrebbe candidamente ammesso di non aver capito che cosa intendesse dire Villafranca quando gli aveva parlato della predestinazione. Così, non avendone compreso il principale fondamento, la dottrina della mortalità dei soli dannati (e non dei predestinati) gli doveva essere apparsa astrusa. Molto più semplice, a quel punto, tranciare di netto e ritenere tutte le anime mortali. Si trattava dunque di un approdo legittimo all’interno del valdesianesimo, che non necessariamente era basato sulle filosofie materialistiche dell’antichità e del Rinascimento. Non si può quindi escludere a priori che Basalù conoscesse le tesi di Lucrezio o Pomponazzi, ma sembra più probabile che nel suo caso l’approdo materialista discendesse dalle premesse valdesiane portate alle più estreme conseguenze da Juan de Villafranca, essendo semmai da approfondire la questione se nella formulazione della loro ipotesi Villafranca o lo stesso Valdés (nonché gli alumbrados) non si fossero ispirati anche a filosofie materialistiche quali quella epicurea. Tra le fonti cui Giulio confessava d’essersi abbeverato, d’altronde, non mancavano «molte cose del Valdés», accompagnate da quel manifesto del valdesianesimo che era il Beneficio di Cristo. È dunque anzitutto al movimento valdesiano che va ricondotto anche il suo percorso ereticale. Dopo essere stato ammesso ai segreti itinerari dell’illuminazione interiore, Basalù era divenuto parte integrante di quel mondo eterodosso che pullulava, dissimulato, tra palazzi nobiliari, monasteri, botteghe e strade napoletane. Erano quelli i suoi compagni di fede, e nel corso del processo Giulio svelò i nomi di tutti quelli con cui aveva interloquito di materie scottanti, la gran parte dei quali andavano ricondotti proprio al movimento valdesiano. Giulia Gonzaga innan35
zitutto, dalla quale confesserà d’essere andato spesso103, rimanendo con lei «tre o quatro volte solo», e talora incontrando altre persone, come l’arcivescovo di Otranto Pietrantonio Di Capua, che aveva sentito «ragionar alchuna volta». In occasione di tali colloqui aveva ricevuto «anche da detta signora [...] alchuna cosa de Valdés, cioè [le Cento e dieci divine] consideratione, et altre quale detto Valdés fece [a] instantia de detta signora [donna Giulia]»104. Ma l’elenco dei valdesiani da lui frequentati era davvero cospicuo, uno dei più dettagliati e completi di cui si disponga: oltre al maestro Villafranca, Basalù denunciò Lattanzio Ragnoni105, il protonotario Pietro Carnesecchi, donna Brianda Sánchez106, l’abate Busale e i suoi due fratelli Matteo e Bruno, il barone Consalvo di Bernaudo, messer Pietro Cirillo, donna Isabella Breseña, don Benedetto Fontanini da Mantova107, il barone Cesare Carduino108, don Germano Minadois, il barone Mario Galeota109, messer Ferrante Brancaccio110, don Ranieri Gualano, messer Antonio Imperato, Gian Vincenzo Abbate111, don Apollonio Merenda, messer Scipione Capece e fra’ Girolamo Capece, l’abate Marcantonio Villamarina, Giovanni Laureto, il marchese Galeazzo Caracciolo, don Lorenzo Tizzano e tanti altri (in tutto fece oltre sessanta nomi), che elencò seguendo un metodo che è ignoto se fosse indotto dagli inquisitori o frutto della sua mente di legista. Giulio, infatti, enumerò i propri complici attribuendogli volta a volta le specifiche eresie, fornendo un quadro talmente dettagliato che gli inquisitori lo utilizzarono per farne una sinossi (allegata al suo fascicolo) ben nota agli studiosi in quanto scoperta e pubblicata nell’Ottocento da Luigi Amabile, ma che tuttavia semplificava eccessivamente alcuni punti, non riuscendo a cogliere tutte le sfumature presenti nelle testimonianze di Basalù, che aveva fornito un elenco assai più accurato di quello elaborato da Tizzano. Se quest’ultimo aveva aggregato le diverse credenze in tre livelli, Giulio differenziava nel primo livello coloro che accettavano solo la giustificazione per fede da quelli che ne deducevano man mano tutte le conseguenze, distinguendo dunque in sottolivelli gli aderenti alle «lutherane opinioni» e rivelando una volta di più il gradualismo del maestro e i limiti che ciascun discepolo aveva raggiunto o si era rifiutato di oltrepassare. Altrettanto può dirsi del livello successivo, quello già radicale che Tizzano aveva accomunato sotto la definizione di «opinioni anabattistiche», tra i cui adepti, dopo avere accettato di considerare anche 36
la messa come un’idolatria, c’era chi negava legittimità al sacramento dell’eucaristia (i cosiddetti sacramentari112), chi negava anche la divinità di Cristo (gli antitrinitari) e chi aggiungeva a tutto ciò la falsificazione parziale dei vangeli, la credenza nella mortalità delle anime dei reprobi e la liceità del concubinaggio. Vale la pena di rilevare in questo livello lo scarto rispetto alla testimonianza di Tizzano, che poneva la credenza della mortalità delle anime dei dannati (e dunque dell’inesistenza dell’inferno) tra le «diaboliche opinioni» e non fra quelle «anabattistiche», corrispondenti al livello qui descritto da Giulio Basalù (che si trattasse dello stesso livello è confermato dalla sovrapposizione delle restanti idee: dalla negazione della messa al sacramentarismo, dall’antitrinitarismo alla convinzione della parziale falsità dei vangeli). Nondimeno, ciò potrebbe discendere da confusione di Tizzano stesso, che più volte mostrò di correggere le proprie affermazioni, mentre non sono da escludere anche più o meno consapevoli pressioni degli inquisitori che, come si è visto, probabilmente lo condizionarono nel presentare le sue rivelazioni. Che la credenza nella mortalità delle anime dei reprobi appartenesse a questo livello è confermato da altre testimonianze, nonché dal fatto che essa figurava tra i punti approvati dal sinodo di Venezia del 1550, benché non vada sottaciuto come anche tra le opinioni della cosiddetta nuova setta napoletana denunciata da Manelfi (equivalente alle «diaboliche opinioni») si parlasse del tema negli stessi termini. In ogni caso, se sarà opportuno tornare sulla definizione dei livelli in cui si articolava il movimento, è importante per ora sottolineare come da un certo momento in poi (a uno stadio che può definirsi antitrinitario e cripto-materialistico) finisse la fase dell’apprendistato e ognuno traesse da sé le «consequentie» che gli parevano opportune. Nonostante gli approdi differenziati dei vari adepti, pure Basalù fornì l’immagine di un movimento animato da una consapevole tolleranza interna, dando nel corso del processo anche le coordinate spaziali di quelle conversazioni tanto libere e ardite. «Di tutte le sopradette cose – dirà – s’è ragionato in diversi lochi: in casa del detto Villafrancha, delli detti Busali, de Antonio de Alessio, de Giovanni Thomaso Bianco, della thesoriera [Brianda Sánchez], della Brisegna, del baron Bernaudo et in casa mia»113. Quanto ai discorsi sulla giustificazione per fede, nel suo secondo costituto precisò che «oltra li lochi dove si ha parlato de questa materia, [...] se ne ha parlato in 37
San Francesco in Napoli, dove sta la detta signora donna Iulia [Gonzaga], et in San Severino con don Germano [Minadois]»114. Incontri talora più aperti talora più riservati, ma sempre informati a un metodo che sottendeva il rispetto delle opinioni altrui: «Quasi con tutti – terrà a precisare – [si discuteva] discorrendo et non disputtando»115. «Quasi con tutti» giacché, riferendosi a Busale, dirà che «costui è stato un gran diavolo et gran temerario, perché inquietava ognuno con chi praticava et lui solo di quanti ho cognossuto disputava de le sue opinione, et si persuadeva che ognuno si aquietassi a le sue ragioni»116. Fatta questa eccezione, per il resto Giulio descrisse un’atmosfera di discussioni libere e aperte, ancor più tollerante di quella delineata da Laureto: «Non ho ditto che ne li ragionamenti sopraditti si rispondesse da li altri per modo di disputa perché non si disputava, ma erano simplici ragionamenti». Insomma, scompaginate le fila del radicalismo tra processi, fughe e pentimenti, nell’estate del 1555 gli inquisitori disponevano degli elementi per comprendere le articolazioni delle eversive trame eterodosse sviluppatesi nella penisola italiana. Il livello delle informazioni permetteva di affinare le conoscenze sulle strutture, sui diversi gradi, su chi aveva pensato cosa, quando e dove. Il cumulo di notizie date da Basalù fu ragguardevole, e non si esagera affermando che il suo processo rappresentò, per la conoscenza del radicalismo d’ispirazione valdesiana, ciò che i costituti di Manelfi furono per la scoperta del radicalismo d’orientamento anabattista. La differenza essenziale stava nella circostanza che l’ex sacerdote marchigiano aveva aperto ciò cui Basalù avrebbe posto fine di fatto. Il primo rivelò qualcosa di completamente sconosciuto, mentre il secondo mise gli inquirenti nelle condizioni di chiudere il cerchio, benché permanessero ancora delle zone oscure. Non erano risolte le incongruenze sui livelli più radicali tra la testimonianza di Basalù e quella di Tizzano; ma soprattutto le «diaboliche opinioni» apparivano l’esito comune di un vero e proprio gruppo, la cui esistenza sembrava confermare la notizia della nuova setta rivelata da Pietro Manelfi. Lo stesso Giulio, del resto, aveva fatto un cenno a due compagni che gli avevano parlato, «oltra de tutte le sopradette cose, del rebaptesmo in laude della religion hebrea et altri insonii, credo annabatisti». I due erano Busale e Laureto, e per quanto Basalù paresse sminuirne l’autorevolezza («io mi ridevo»), aggiungeva poi di essersi opposto ad essi «per paura che non mettessero rumor in la città»117. Successivamente 38
avrebbe raccontato con maggiori dettagli l’episodio, confermando quanto confessato da Laureto: [Busale] ritornò a Padova dove stette fino al principio del 1551, al qual tempo venne in Napoli insieme con Gioan Laureto et ragionò di molte opinione anabaptistice et di molte hebree, che non mi riccordo perché non le intendevo. Ma so che parlava del rebaptesmo et ne ragionava publicamente talmente che, havendolo represo più volte et fattolo reprendere da li suoi et non giovando, io mi partì da Napoli dubitando di qualche rumore, ma li suoi lo fecero partire, et io ritornai, né mai più l’ho veduto118.
Anche dalla sua testimonianza, quindi, emergevano tracce di un gruppo che spingeva a coagulare le libere istanze di chi oltrepassava il secondo livello in una specifica proposta. Riferendosi a Tizzano, Giulio aveva rivelato d’avere discusso con lui diverse volte, «et parlandomi lui de dogmi hebrei et interpretatione di propheti, me ne burlavo et li davo indicii che non credevo cosa alcuna». Erano molteplici, insomma, gli indizi che convergevano nel confermare l’esistenza di un gruppo giudaizzante ma al contempo orientato verso idee di tipo diverso. Per sciogliere questo e altri interrogativi sarebbe stato necessario passare dall’indagine sui singoli alla visione d’insieme, dalla repressione alla comprensione. Ma gli inquisitori non avevano motivo per interessarsi a tutto ciò poiché, a quel punto, per il Sant’Ufficio il radicalismo poteva rubricarsi tra le emergenze ormai risolte: le energie andavano concentrate sui ben più potenti valdesiani d’ispirazione moderata, sugli «spirituali», da Pole a Morone a Carnesecchi. Già dal 1553 semmai, già dal rogo ginevrino di Miguel Servet, il problema s’era fatto nuovamente stringente in terra riformata, dove molti degli esuli radicali avevano cercato e trovato asilo. Così, nella penisola italiana quelle vicende restarono per secoli sotto la polvere delle carte dell’Inquisizione, trovando forse inconsapevole ascolto nella prudente circolazione di idee eversive che nella seconda metà del Cinquecento non mancarono in Italia (da Bruno a Menocchio a Campanella). Negli ambienti dell’esilio, invece, tra gli anni Cinquanta e Sessanta quelle posizioni continuarono ad alimentare il dissenso religioso, indotto dall’istituzionalizzarsi della stessa Riforma in Chiese non meno autoritarie di quella romana. In tal modo, le radici italiane del più avanzato radicalismo euro39
peo non furono recise dall’oblio, e delle vicende ricostruite fino ad ora si mantenne l’esile filo di una memoria storica che, col tempo, si ammantò sempre più dei caratteri nobilitanti di una tradizione tesa alla ricerca dei padri fondatori. Non v’è da sorprendersi, pertanto, se dal De falsa et vera alla Bibliotheca anti-trinitariorum il nome di Juan de Valdés fu collocato dagli stessi antitrinitari nella galleria dei propri antenati illustri119.
Capitolo II
Protagonisti, livelli e intrecci di un movimento ereticale
1. Il «tempo di Villafranca spagnolo» L’autorevolezza di chi guidò l’evoluzione radicale di parte del movimento valdesiano era fuori discussione: i discepoli ne conoscevano la familiarità avuta col grande maestro. Si tratta di un personaggio avvolto nell’oscurità: nulla o quasi si sa della sua vita; e neanche il suo profilo ereticale è stato finora oggetto di ricerche approfondite. Quest’altro maestro di libere coscienze, sfuggente come tanti protagonisti del radicalismo religioso, era un compatriota di Juan de Valdés: il suo nome era Juan de Villafranca. Diverse testimonianze accreditano l’immagine degli stretti rapporti che lo legavano all’esule spagnolo. Nel suo ultimo processo, Pietro Carnesecchi diede, al riguardo, pochi ma chiari elementi: Di Villafranca posso ben affermare questo: che mentre ch’io ero a Napoli in vita del Valdés lo vedevo praticare molto intrinsicamente seco, et mi ricordo havere sentito il detto Valdés parlare con molto honore et affetione di lui, lodandolo come inclinato alla pietà et che attendesse molto alla mortificatione. Ma altra notitia non hebbi di lui mentre stetti a Napoli, né d’allhora in qua non l’ho più visto né sentito parlare di lui se non che intesi – doppo credo il ritorno mio di Francia – che egli doppo la morte del signor Valdés qualche anno s’era ingolfato nelle heresie et che era deventato sacramentario: ma non mi ricordo bene da chi mi l’habbia inteso1.
41
Non molto in effetti, ma abbastanza per far affiorare la profondità del rapporto che intercorreva tra i due connazionali e per avere un’idea dell’alta considerazione di Villafranca nutrita da Valdés, che ne aveva parlato a Carnesecchi «con molto honore et affetione». Analoga immagine traspare infatti da altre fonti: il sacerdote napoletano Girolamo Spinola affermò che «il Villafranca era discipolo intrinseco del decto Valdesso»2. «Intrinseco», proprio come l’aveva definito Carnesecchi. Simile, seppur più dettagliata, era stata inoltre la testimonianza di Tizzano, al quale Villafranca aveva fatto da tramite con Valdés e le sue idee. Fu Villafranca – «un altro spagnolo suo più amico di me», l’avrebbe definito – che lo iniziò ai primi passi dell’esoterico percorso valdesiano, sia col fascino delle parole sia facendogli leggere testi del maestro: «Mi prestò poi molti delli scritti soi», avrebbe rivelato nelle sue confessioni3, da cui si desume come il legame tra Valdés e Villafranca implicasse un rapporto di collaborazione. Don Lorenzo, infatti, in un primo momento aveva cercato di parlare con l’esule spagnolo, benché avesse poi notato come con lui «non se allargasse molto». Alla richiesta di poter leggerne qualcosa, Valdés aveva acconsentito e lo aveva messo nelle mani di uno dei suoi più «intrinseci» discepoli, grazie al quale – confesserà Tizzano – «io più largamente intesi le sue opinioni». Villafranca, dunque, ne aveva stimolato i dubbi sull’ortodossia cattolica e l’aveva condotto lungo una scala coerentemente valdesiana, fino a quelle che avrebbe definito impropriamente posizioni anabattistiche, approdi radicali dai quali si sarebbe spinto ancor più oltre. Già dalla testimonianza di Tizzano, insomma, Villafranca era emerso come una figura cardine del movimento valdesiano. Non però al livello – dissimulato ma pienamente pubblico – di Ochino e di Vermigli, il cui ruolo di predicatori li esponeva molto più verso l’esterno. Discorso che può estendersi anche a personalità come Marcantonio Flaminio e Giulia Gonzaga, che per lettere o per rango erano rivolti alla dimensione pubblica della socialità. Villafranca, invece, era tra coloro che si muovevano dietro le quinte con grande discrezione, che fungevano da trait d’union con quelle coscienze già rose da inquietudine, nelle quali la predicazione, la conversazione e la lettura avevano instillato il tarlo del dubbio. Per usare ancora la bella immagine di Valdés, Ochino e Vermigli stavano alle porte del «palazzo divino del vivere cristiano»4, preparando l’accoglienza a chi volesse addentrarvisi con una scelta 42
compiuta in assoluta libertà. Toccava poi ad altri, come Villafranca, il compito di accogliere i visitatori che si erano affacciati sulla soglia, conducendoli, ove volessero, fin nelle più segrete stanze. Che il ruolo di Villafranca fosse proprio questo, almeno fino alla morte di Valdés, lo suggeriscono varie testimonianze. Don Spinola rivelò alcuni dettagli di una conversazione avuta con lo spagnolo e con l’abate Marcantonio Villamarina: Li decti dui, parlando con me del sacramento dell’altare, ad proposito che io me ombrava de certa predica che era venuta al’hora stampata de Bernardino de Siena, che parlava contro el santissimo sacramento del altare, et si male non me ricordo diceva che non ci era il signore presente. Et quelli me dissero tutti dui che io non era capace né tanto innanzi che havesse possuto intendere quello, ambi dui declarandomi che quello che era scricto in decta predica esser la verità5.
Emerge qui, ancora, la pedagogia esoterica e graduale del magistero valdesiano: Villafranca e Villamarina redarguivano don Spinola dicendogli che non poteva capire tali cose, non essendo «tanto innanzi che havesse possuto intendere quello». Un «innanzi» che faceva il paio con l’essere «avanzato» utilizzato da Giulio Basalù nell’evocare il suo ingresso nel movimento valdesiano. Ma è il passo precedente, relativo al tema del contraddittorio, che risulta di notevole interesse: Spinola aveva compreso che la predica di Ochino poteva contenere germi eterodossi sul sacramento dell’eucaristia. Così, dopo aver letto il testo che il tema evocava ambiguamente, egli aveva sentito la necessità di passare a una più profonda riflessione, a un confronto fondato su una più appartata e pertanto più libera conversazione. Un tentativo di approfondimento che l’aveva spinto a rivolgersi proprio all’umbratile figura di Juan de Villafranca. Un’analoga vicenda (ma con esiti molto differenti) aveva raccontato poi Matteo Busale, fratello di Girolamo, che confessò d’essersi avviato lungo un percorso eterodosso dopo aver parlato con l’eretico spagnolo, anch’egli a seguito delle riflessioni indotte da una predica: «Io venni in amicitia del Villafranca perché, andando alla predica di San Nicola, ragionammo una volta», confesserà nei suoi costituti6. Il suo ruolo nel movimento valdesiano, la grande abilità oratoria di cui pareva esser dotato, il carisma che doveva emanare la sua figura di socratico maestro, fecero sì che dopo la morte di Valdés Vil43
lafranca fosse tra coloro (come Giulia Gonzaga e Marcantonio Flaminio) che ne raccolsero il testimone. In particolare, lo spagnolo fu il protagonista della radicalizzazione del discorso valdesiano, la guida delle personalità più inquiete, verso i gradi ultimi di un percorso che portava alla liberazione da ogni dogmatica e al sovvertimento di qualsiasi religione. Come si è accennato, quasi nulla si sa della sua vita. Su questo piano, però, c’è da notare come Villafranca portasse lo stesso cognome della moglie del viceré don Pedro de Toledo, il quale grazie a lei era, appunto, il marchese di Villafranca. Non è noto se sussistessero linee di parentela o di affinità tra i due spagnoli, seppure ciò sia ipotizzabile, mentre pare certo che di Toledo Villafranca fosse un collaboratore. Basalù lo definì «servitor del viceré»7, al quale lo disse vicino pure Carnesecchi8. In nessun elenco relativo al personale di Toledo, tuttavia, v’è riferimento al nome suo; ma Spinola ricordò che «lo quondam Villafranca spagnolo [...] alhora [poco dopo la morte di Valdés] era ali servitii della duchessa de Castrovillari»9, vale a dire di donna Isabella de Toledo, figlia del viceré e moglie (dal 1540) del duca di Castrovillari Giovanbattista Spinelli. La notizia sembra dunque confermare una grande vicinanza (se non proprio una parentela) di Villafranca alla casa dei Toledo. Con sicurezza si sa inoltre che a un certo punto egli fu colpito da un male che si rivelò fatale: Matteo Busale testimoniò che si fosse «ammalato de mal de milza»10, sicché è probabile che Villafranca fosse stato colpito da cirrosi epatica11. Come che sia, all’indomani dell’insorgenza del male che ne stroncò la vita, dopo un breve periodo trascorso ancora in casa sua12 – dove avevano vissuto anche Villamarina, un «messer Lodovico [Guinigi] locchese et Ambrosio di Apozzo»13 –, Villafranca si trasferì dapprima in casa del discepolo Antonio d’Alessio14, per poi trovare agi maggiori in casa di Isabella Breseña, dove spirò nel 154515. È bene indugiare sulla circostanza che localizza la morte di Villafranca nella residenza della sua compatriota. Evidentemente, infatti, non si trattava solo dell’aiuto tra connazionali che vivono in terra straniera. Dalle confessioni di Laureto era emerso che sia egli stesso sia Girolamo Busale avevano trovato ricovero all’ombra del patronage di donna Isabella: Laureto impiegato nella corte del governatore di Piacenza e Busale assunto come «segretario» della nobildonna. Prima di partire per l’avventura in terra ottomana, inoltre, Giovanni era passato da Piacenza per chiedere non solo consiglio ma 44
quasi certamente anche aiuto materiale. E a Piacenza si era rifugiato pure Basalù, sebbene non ne facesse cenno nei suoi costituti: all’indomani dei primi arresti seguiti alle rivelazioni di Manelfi, anche Giulio ebbe asilo da Isabella, e così come Laureto e Tizzano in quella fase concitata erano passati da Ferrara, Basalù vi si recò al seguito dell’eretica spagnola, con la quale andò nel 1552 a Consandolo, alla corte di Renata di Francia16. Busale e Villafranca, Laureto e Basalù, esponenti del più estremo radicalismo, ebbero l’aiuto dalla nobildonna, in casa della quale, anche in sua presenza, avvennero conversazioni volte a criticare i più radicati dogmi della cristianità. Del resto, nel percorso illuminato da Juan de Villafranca, l’accettazione della posizione sacramentaria precedeva la negazione della divinità di Cristo. È pur vero quindi che non ci sono prove di un’adesione di Breseña a posizioni più radicali di quelle sacramentarie; nondimeno, le sue strette relazioni con radicali e il suo ruolo di patrona di una vera e propria rete sembrano indicare che le strade che la portarono dalla Napoli valdesiana all’esilio in terra riformata non fossero proprio lineari. D’altronde, non è privo di significato il fatto che, anche nel momento dell’esilio, le fossero dedicate opere da personalità legate alla dissidenza radicale come Curione e Ochino17. E in ogni caso, ove si ammetta che Isabella non avesse valicato il sacramentarismo, va sottolineato il suo atteggiamento di estrema tolleranza, di apertura di fronte a opinioni che portavano alla fuoriuscita dal cristianesimo, se non dalla religione. Ma è bene ritornare a Villafranca, al suo ruolo nel movimento valdesiano. Basalù lo descrisse in questi termini: «L’ho sentito ragionar più volte, in presentia di molti, de le sue opinione et era tenuto come maestro»18. D’altronde, in merito al suo rango di «maestro», le fonti vanno tutte nella stessa direzione. Tizzano parlò di un «tempo di Valdés» e di un «tempo di Villafranca», lasciando intendere che alla leadership valdesiana fosse succeduta quella del suo amico spagnolo, almeno sull’ala radicale del movimento. Naturalmente, non va dimenticato come all’interno di essa non vi fosse un unico leader: «Tra noi non era chi facesse il capo ma ognuno indifferentemente chi poteva trovar più errori li comunicava con li altri», testimoniò Matteo Busale19. E Giulio Basalù, nello stesso costituto nel quale definì «maestro» Villafranca, aggiunse che all’interno del gruppo radicale «li infrascritti parlavano come maestri tacendo li altri: lo abbate Busal, il Villafranca, il libraro piacentino, Gregorio de Salerno, don Lo45
renzo Tizzano et Mattheo francese heremita»20. Ciò era in linea col carattere relativamente aperto del movimento valdesiano, con quella franca discussione che gli adepti potevano spingere sino alle più estreme conseguenze, col dubbio elevato a metodo senza vincolo alcuno nel principio d’autorità o nella dogmatica teologica. La pluralità di maestri dava anche il segno di quanto nel movimento si manifestasse un’esperienza collettiva, che vedeva un impegno di riflessione, di propaganda e di proselitismo anche da parte degli allievi che, volta a volta, raggiungevano i gradi di conoscenza dei maestri stessi. Il metodo di Villafranca, al pari di quello di Valdés, era un metodo socratico, non rivolto a imporre le proprie idee agli adepti ma a spingerli a ragionare individualmente, portandoli alle più estreme conseguenze attraverso lo stimolo maieutico21. Un maestro del quale, pur in assenza di veri e propri capi, le fonti testimoniano la preminenza assunta sull’ala radicale del movimento dopo la morte di Juan de Valdés. Non a caso, già dal luglio del 1553 il Sant’Ufficio ordinò al cardinale vicario dell’Inquisizione a Napoli, Scipione Rebiba, di consegnare a Roma tutti gli indizi raccolti su Villafranca, sebbene fosse morto quasi da un decennio, e di procedere «usque ad exhumationem et combustionem» del cadavere22. L’autorevolezza dello spagnolo, il suo profilo di vero e proprio leader del radicalismo valdesiano, si riscontrano scorrendo le testimonianze relative al suo intenso magistero. Giulio Basalù rivelò che era stato Villafranca a condurlo «di consequentia in consequentia» a negare dapprima «intercession de santi, purgatorio, adoration de imagine, iubilei, confessione auricular», facendolo giungere al livello definito da Tizzano come «luterano». Successivamente, l’aveva indotto a considerare la messa un’idolatria e l’eucaristia soltanto un simbolo, a negare la divinità di Cristo, ad affermare la mortalità dell’anima, salvo quella dei veri fedeli, e infine a dubitare dell’autenticità di alcune parti dei vangeli. Agli sviluppi successivi, invece, Giulio sarebbe giunto poi da solo, dando libero corso all’itinerario individuale illuminato fino a un certo punto dal proprio maestro. «Di consequentia in consequentia»: era in quel metodo che si svelava l’ispirazione valdesiana – fondata su dubbi progressivi, sull’«experientia» e non sull’autorità – da cui Villafranca era animato23. Un metodo teso a un’acquisizione di libertà, suggeriscono le fonti, che appare pervasivo quanto le stesse idee che quel metodo era teso a fare emergere. Se fino a un certo punto, infatti, gli allievi giungevano a 46
negare la divinità di Cristo, la verginità della Madonna e altri dogmi fondamentali della cristianità, in molti casi da quella soglia in poi si dipartivano percorsi diversi e a volte divergenti, ma accomunati appunto da quel metodo graduale segnato dall’invito a coltivare la propria fede in modo soggettivo. Ne è emerso un saggio dalle vicende narrate in precedenza; ed è agevole trovarne conferma in altre deposizioni. Matteo Busale spiegò agli inquisitori tempi e modi della sottile opera di conversione cui era stato indotto dal misterioso Villafranca. La soglia di partenza, come per ogni valdesiano, qualunque ne fosse il livello di consapevolezza dottrinale, era stata anche per il fratello del più famoso abate la giustificazione per fede, sulla quale si innestavano – per chi avesse dato segno di desiderare approfondimenti – le originali mediazioni escogitate da Valdés. Per giungere a tale primo grado il gioco era condotto da Villafranca con circospezione: «Dal principio me entrava pian piano – rivelerà Busale – et me ragionava di queste cose che ho detto [la giustificazione per fede] [...]; et poi mi monstrava alcune autorità, et monstrava de dubitar et diceva: ‘Bene, come intendereste questo?’ Et inanzi mi faceva dubitar nell’autorità et poi, come era cascato nel dubio diceva: ‘Ben, quando se intendesse cossì, non vi pare a voi che stesse bene?’»24. Un sottilissimo gioco di dubbi e di ragionamenti, di autorità e di critica delle autorità, che s’insinuava fra le certezze per smontarle piano piano. Una volta che la giustificazione era accettata, Villafranca incalzava l’interlocutore: «Ben, quando se intendesse cossì, non vi pare a voi che stesse bene...?». Logica, filologia, retorica, psicologia, oltre che ovviamente teologia, convergevano nell’indurre l’adepto a trarre le dovute «illationi» da quel primo passo eterodosso. Se la giustificazione dei peccati l’aveva data Cristo col beneficio della croce, non avevano senso indulgenze, confessioni, preti, digiuni, purgatorio, preghiere ai santi e alla Madonna. Allorquando l’adepto cadeva nella rete, il maestro lasciava che le nuove idee maturassero in lui per qualche tempo (Basalù parlò di quattro mesi). Successivamente il dubbio tornava a essere agitato, sempre più inquietante: il conduttore del gioco iniziava a trarre nuove «consequentie», che consentivano al discepolo un successivo «avanzamento» e il passaggio al livello che può definirsi radicale. In un primo momento Villafranca restava in alveo luterano, presentando anche la messa come un’idolatria; ma radicalizzando subito dopo la sua posizione, in direzione 47
zwingliana. Demolite le superfetazioni della dogmatica cattolica, aboliti cinque sacramenti su sette, era il metodo in sé a spingere al dubbio anche sui restanti, e in particolare sull’eucaristia, presentata da Villafranca come un simbolo e null’altro. A ciò, tuttavia, non seguiva la discussione sul battesimo: un silenzio da non sottovalutare e che, come si vedrà, derivava dal rifiuto dei cardini dottrinali dell’anabattismo, nonché dal discredito di cui godeva l’anabattismo stesso. Decisivo era invece portare il neofita a considerare un simbolo l’eucaristia: era quello che permetteva al maestro di spostare l’accento sulla figura di Gesù. Dal sacramento al dogma. Se si dubitava della presenza del corpo di Cristo nell’ostia consacrata, non era difficile a quel punto il passaggio successivo, teso a suscitare il dubbio sulla stessa divinità del fondatore del cristianesimo. E infatti anche Matteo Busale rivelerà che a un certo punto Villafranca lo persuase a creder che non era la trinità ma un solo Dio, che Christo non era Dio ma che Dio habitava in Christo; et mi persuase la Nostra Donna, ma questo dubitativamente, che havesse hauto un altro figlio. Persuasemi delli dormienti che quando morino dormino, che non resuscitano sin alla venuta del giuditio. Persuasemi anchor che lo advento de Christo havesse da regnar milla anni. Mi persuase anchora che nel sacramento non fusse altro che segno et che non ci fusse il corpo de Christo ma solo una commemoratione25.
Una conferma di quanto fin qui ricostruito, salvo le implicazioni millenaristiche sulle quali sarà bene ritornare. Per comprendere meglio l’impegno proselitistico di Juan de Villafranca, per penetrare in modo analitico nell’ultimo livello cui conduceva i suoi discepoli, occorre allargare lo sguardo agli aderenti al gruppo radicale che si raccolse attorno a lui. Le riunioni di quel gruppo avvenivano in diversi luoghi e, a quanto pare, con incontri frequenti caratterizzati da appassionate discussioni, intervallati da periodi di distacco che si protraevano per alcuni mesi. Gli incontri si tenevano «a casa del detto Villafranca»26 e, dopo l’inizio della sua malattia, in quella di Antonio d’Alessio e poi di Isabella Breseña, dove lo spagnolo aveva trovato cure e ospitalità. Ma non era il domicilio di Villafranca l’unico luogo di ritrovo dei valdesiani radicali. Il servitore di Girolamo Busale, Biagio Marese, confessò che «se univano insieme, et quando in casa del detto Villafranca et quando in 48
casa di Cesare Carduino et quando in casa di Hierolamo Busale et quando in casa de Giovanni Thomasso Blancho et quando in casa de messer Antonio d’Alessio in una sua massaria fuora Napoli [nel luogo] detto Capo di Monte, benché più frequentemente pratticavano in casa de Villafranca et de Antonio d’Alessio»27. Basalù testimoniò che «s’è ragionato in diversi lochi: in casa del detto Villafrancha, delli detti Busali, de Antonio de Alessio, de Giovanni Thomaso Bianco, della thesoriera [Brianda Ruiz], della Brisegna, del baron Bernaudo et in casa mia»28. La lista delle persone presso le quali avvenivano gli incontri dà ulteriormente il segno di come nel movimento si intrecciassero adepti che erano giunti a gradi di dissidenza differenti. Osservando con attenzione i nomi elencati, però, si trova del pari una conferma che nell’ambito del movimento esistesse quantomeno un doppio livello, con i moderati luteraneggianti (nelle varie gradazioni) da un lato e i più radicali (nelle diverse sfaccettature) dall’altro. In particolare, sembra che né Isabella Breseña (salvo quanto detto prima) né Brianda Ruiz né Cesare Carduino né il barone Bernaudo avessero dubitato della divinità di Cristo, eppure i più radicali di fronte a loro non avevano timore di parlarne apertamente. Tutti e quattro erano sacramentari, e le testimonianze convergono nel porre l’adesione a questa dottrina al livello radicale, passaggio immediatamente precedente alla negazione del dogma trinitario. In questo contesto, dunque, sembrerebbe di scorgere una separazione tra radicali e moderati. Semplificando in modo estremo, si può affermare che si erano create due grandi ali nel movimento valdesiano. Tutti si incontravano con tutti, ma delle opinioni più radicali si parlava soltanto con chi oltrepassava un certo livello, al quale si accedeva considerando la messa un’idolatria per poi passare al sacramentarismo. Solo da questo punto in poi si aveva accesso all’ala del «divino palazzo» più riservata, sebbene poi ognuno fosse libero di limitarsi ad affacciarsi su alcune delle stanze, senza penetrarvi. Molti invece decisero di frugare dietro ogni porta e fino «nelle casse». Per avere un’idea più precisa dell’ala radicale del palazzo è, quindi, opportuno descrivere con maggiore precisione le varie stanze segrete che la componevano. È necessario cioè – fuor di metafora – definire con maggiore precisione i vari gradi di cui si componeva il livello radicale cui si era iniziati da Juan de Villafranca, assegnando al contempo a ciascun grado i personaggi che quelle opinioni avevano deciso di accettare. 49
Non è semplice classificare i radicali sulla base degli orientamenti dottrinali. L’estrema libertà che da un certo grado di conoscenza in poi caratterizzava quegli eterodossi impedisce di collocarli con precisione su questo o quel gradino di una scala esoterica che si può, peraltro, ricostruire in modo frammentario. Non manca, inoltre, qualche contraddizione fra le testimonianze, sicché la classificazione proposta, che ordina gli aderenti sulla base degli orientamenti religiosi, va intesa in senso tendenziale: utile comunque a dare un quadro più preciso rispetto a quello conosciuto fino ad ora. Prima di procedere, però, è bene accennare all’intreccio fra trame religiose e orditi sociali. In effetti, pochissimi nel gruppo radicale erano i personaggi ascrivibili all’élite socio-politica, con una sorta di inversione dei ruoli rispetto all’ala moderata del movimento che, sebbene popolata anche da persone semplici, vedeva ai suoi vertici grandi aristocratici e influenti gentildonne, raffinati umanisti e potentissimi ecclesiastici. A parte forse lo stesso Villafranca, e fatta eccezione per Scipione Capece, nessun nome altisonante emerge all’interno dell’ala radicale di quel vasto movimento. Al massimo figurano persone dotate di qualche agiatezza, come i Busale, Giulio Basalù, Tobia Citarella e Giovan Tommaso Bianco, e per il resto non più di un razionale della Sommaria come Giovan Francesco Coppola29 o un abate «gentilhuomo» (Villamarina) s’incontrano fra coloro che si spinsero oltre i limiti della dogmatica cristiana. Numerosi erano invece i semplici frati (e gli sfratati), ai quali si affiancavano altre persone d’umile condizione sociale: diversi servitori, un musico, un marmista, uno scrivano. E si può anticipare che tale rapporto tra basso livello sociale e alto tasso di radicalismo era ancora più marcato per l’altro gruppo radicale che agitò l’Italia al tempo: gli anabattisti del NordEst. Una combinazione che deve sottendere una più complessa relazione e sulla quale, tuttavia, per ora la documentazione non permette di andare oltre la definizione del problema. Si è visto come il passaggio dal primo livello (che può definirsi moderato) a una posizione che presupponeva conseguenze radicali fosse morbido: considerando anche la messa un’idolatria, Villafranca pareva invitare l’adepto a procedere oltre nell’accettazione delle «illationi» di intonazione luterana, tratte a partire dal principio della giustificazione. Alla negazione della messa, però, subito dopo seguiva il rifiuto del sacramento dell’eucaristia, con un primo passo che rivelava già una presa di distanza dal luteranesimo. Lo sposta50
mento al vero e proprio radicalismo era segnato dal terzo punto di quel secondo livello di conversione, la negazione della divinità di Cristo; ed è da questa base che si deve partire per identificare gli aderenti al gruppo radicale, mentre vanno tralasciati i vari sacramentari, arrestatisi un passo prima di quella soglia estrema. Non pochi quella soglia avevano invece oltrepassato, come Gregorio da Salerno, che «havea molte chimere, de le qual ragionava volentieri» ed era considerato dai radicali tra i «maestri»30. Già il suo caso (se non bastassero quelli di Laureto, Tizzano e Basalù) mostra quanto sia rischioso classificare in modo rigido quelle figure sfuggenti: difficilmente le sue «chimere» possono incasellarsi nella mera credenza nell’umanità di Cristo che emerge dalla testimonianza di Giulio Basalù. Ad ogni modo, sembra che a questo punto si fossero attestati anche alcuni ecclesiastici, come i benedettini siciliani don Clemente alias Francesco da Messina31, e don Angelo, pure di Messina, amico di Benedetto Fontanini32. Non oltre questo grado, inoltre, giunse l’abate Marcantonio Villamarina33, convivente per qualche tempo di Villafranca34, benché fosse poi rientrato nell’alveo dell’ortodossia, ma diventando «familiare» del cardinale Giovanni Morone: il che gli avrebbe portato nuovi guai col Sant’Ufficio35. E non ritennero di oltrepassare il grado antitrinitario neanche alcune persone molto semplici, come Rocco da Taranto, a quanto pare già anch’egli frate (cappuccino) e poi servitore di Tobia Citarella36, o Persio Calabrese, servitore di Giulio Basalù37, giunto pure al grado della negazione della divinità di Cristo; così come il musico Bartolomeo da Messina alias Rositano, che lavorava alle dipendenze del cardinale di Burgos Juan Álvarez de Toledo, fratello del viceré di Napoli e autorevole membro dell’Inquisizione38. Umili origini aveva quasi certamente anche un certo Andrea Riera, arrestatosi sullo stesso grado, sul quale non si hanno informazioni relative allo status sociale, anche se quasi certamente va identificato con un «Andrea di Nieri, marmoraro napolitano», che abiurò pubblicamente a Roma il 4 novembre del 1554. L’identità tra i due, oltre che dall’omonimia, dalla sovrapponibilità dei cognomi e dalla prossimità delle date di costituti e abiura (13 ottobre e 4 novembre 1554), sembra dimostrata dal fatto che in entrambi i documenti si attesta che Riera/di Nieri «negava la realità del sacramento [dell’eucaristia], la deità di Christo, et che era huomo come noi, nato di seme humano di Giuseppe et di Maria, con altre crudeli biasteme»39. Inoltre, Basalù fece riferimento a «doi altri ta51
gliapietra [...] napolitani» di cui non ricordava il nome40, ed è più che probabile che tra essi vi fosse Andrea di Nieri che faceva, appunto, il «marmoraro». Dopo il primo vero e proprio grado radicale, che implicava anche la negazione della trinità e della verginità della Madonna, Villafranca dava una virata materialistica alla teoria della predestinazione cui aveva preparato l’adepto sin dal primo livello; la svolta era infatti anticipata dal rifiuto di rivolgere le preghiere ai santi, giustificato non solo dalle implicazioni del beneficio di Cristo, ma anche dal fatto che, così sosteneva Villafranca, i santi dormivano. Con il passaggio al livello radicale, l’adepto apprendeva che quel sonno dei santi altro non era che la condizione fisica degli eletti dopo la loro morte. Essi si sarebbero risvegliati, sarebbero risorti, con l’avvento finale di Cristo; e in questa visione si faceva strada la negazione dell’inferno su basi materialistiche: con la «morte eterna» delle anime dei reprobi. Fino a questo punto sembra giungesse il napoletano Antonio d’Alessio, che si astenne dall’accettare una sola conseguenza dell’itinerario sul quale fu condotto da Juan de Villafranca: la falsità parziale dei vangeli. D’Alessio, in una deposizione resa agli inquisitori nel 155241, diede conto in modo particolareggiato delle idee che l’avevano agitato negli anni precedenti, elencando le proprie eresie in 33 punti. Per quanto riguarda il primo livello iniziatico, d’Alessio mostrava una certa confusione, ammettendo un margine di libero arbitrio (solo per fare il male), ma rivelando al contempo un contraddittorio determinismo, con esiti che ribaltavano le conclusioni precedenti. «Negando la libertà de l’homo – confesserà – ho creduto che tutte le cose [che] occorrono necessariamente venghino, et così ho tolto la contingentia del poter far et non far, havendo tolta la libertà». La presunta impossibilità di scegliere implicava per d’Alessio che «essendo l’huomo fatto figliol de Dio, per qualunque opera faccia cattiva non perdi la gratia divina, perché il padre non può manchar al figliolo. Et cossì ho creduto anchor che l’heredità non possi esser tolta a colui che crede et è fatto una volta figliolo de Dio, perché anchor che pecchi non li è imputato a peccato». Questo rigido predestinazionismo, dunque, svelava un approccio simile a quello antinomiano dei libertini spirituali, secondo i quali le azioni degli eletti non comportavano peccato. La libertà negata ritornava così in realtà assoluta, giacché ogni pensiero, ogni azione, non potevano configurarsi come vincolati ad alcuna etica né dottrina religiosa. Per 52
il resto, Antonio ricalcava le «lutherane opinioni» indotte da Villafranca per come le avrebbero descritte Tizzano, Basalù e altri ancora: non credeva al purgatorio né ai miracoli dei santi o della Madonna, non riteneva che a questi ultimi (né alle immagini né ai morti) andassero rivolte le preghiere, rifiutando del pari ogni valore ai pellegrinaggi, all’estrema unzione, alle indulgenze, ai digiuni, ai canti in Chiesa, all’acqua benedetta. Non mancavano sue interpretazioni personali anche su altri punti del primo livello: rispetto ai sacerdoti disse di aver «creduto che meglio saria che li preti che non sono casti et vivono in fornicatione pigliassero moglie, anchor che meglio saria esser casto», senza negare la funzione sacerdotale e limitandosi a credere «che meglio sarebbe levar tante relligioni de frati et che si vivesse all’apostolica con li preti soli, come nella primitiva Ecclesia», riconoscendo d’altronde una certa utilità alla stessa confessione, pur senza ritenerla «de iure divino». Rimodulazioni in chiave soggettiva delle idee che i suoi maestri gli avevano trasmesso, secondo l’individualismo caratteristico del movimento valdesiano del quale erano tipici anche gli approdi radicali, benché d’Alessio (al pari di altri) non avesse accettato di dedurne tutte le «consequentie»: riteneva l’andare a messa un’idolatria, considerava l’ostia solamente un simbolo, pensava che «Christo non sia concetto si non comunalmente son concetti tutti di seme umano, et che il signor Iddio li desse tutti quelli doni et gratie che mai maggiori se ne potessero dar et che fusse figliolo de Dio unigenito per via de doni et gratie et non per consustantialità». Una concezione sulla quale laconicamente commentava: «Et cossì credo esser cascato miseramente ne l’opinione de Arrio». Inoltre, pur non accettando (o almeno non confessando) che i vangeli fossero falsificati in parte, d’Alessio aveva creduto nella mortalità delle anime dei reprobi e dunque nell’inesistenza dell’inferno. Il napoletano aggiunse poi un punto che non era emerso, se non in modo indiretto, da altre testimonianze. D’Alessio, infatti, rivelò d’aver ritenuto «che l’heretici non deveno esser abruciati, ma che vivant et convertantur»42. Una perorazione della tolleranza così netta è della massima importanza, in quanto spiega quell’atteggiamento di mutuo rispetto delle altrui opinioni già emerso in vari casi, e che è lecito estendere allo stesso Villafranca e al movimento nel suo complesso. Ne risulta una prova di come il nesso antitrinitarismo-tolleranza non vada cercato solo nel socinianesimo e comunque nell’antitrinitarismo successivo 53
al rogo di Servet, come abitualmente si ritiene, ma già nel radicalismo valdesiano. La libertà di discussione, infatti, al di là delle intemperanze di Girolamo Busale, svela anche una cosciente rivendicazione della libertà religiosa. E che ciò derivasse dalla lezione valdesiana lo dimostrano alcune affermazioni dello stesso Valdés. Nella settantaseiesima delle sue Cento e dieci divine considerazioni il maestro aveva scritto: «Mi debbo guardare come dal fuoco, di perseguitare alcun uomo di qualsivoglia maniera, pretendendo servire a Dio in ciò»43; e nel commento al vangelo di Matteo aveva aggiunto: Saria sanissimo conseglio a tutti gli uomini il guardarsi di prender opinione alcuna nelle cose spirituali e divine mentre che sono uomini non rigenerati né rinovati per spirito santo, e anche allora sta loro bene di attenersi alla àncora della fede cristiana e allo intento del viver cristiano, serbando il decoro cristiano, e nel resto non ligarsi ad opinione veruna perché, come si ligano ad una, si obligano ad difenderla e, come la voglion difender, s’appartano dalla mansuetudine cristiana e dal decoro cristiano44.
Fu sulla base di simili premesse che molti lasciarono fluire quell’ansia di scoperta di nuove verità. E non a caso anche dalle confessioni di un altro benedettino di Monte Oliveto, Matteo d’Aversa, affiorarono le stesse parole pronunciate da d’Alessio pochi mesi prima: «Ho creduto che li heretici non devono essere abbruciati ma che vivant et convertantur»45. L’identità delle parole fa insorgere il sospetto che in esse risuonasse la voce degli inquisitori, ma soprattutto rivelava la lezione appresa dai maestri valdesiani; ciò che conta, infatti, non è l’uso di una formula piuttosto che un’altra, quanto il concetto che quella formula lasciava venire alla luce. Per concludere con la classificazione del livello radicale, occorre soffermarsi sull’ultimo punto in esso previsto: la parziale falsificazione dei vangeli. Si trattava di un discorso legato alla posizione antitrinitaria: l’obiezione più semplice da rivolgere alla negazione della divinità di Cristo era quella di rinviare a passi dei vangeli che apparentemente l’affermavano. Esigenze filologiche, dunque, imponevano di fornire una risposta convincente a tali possibili obiezioni, che Villafranca parava evocando sapientemente Erasmo e lasciando approdare l’adepto all’ultimo grado. Tra coloro che accolsero tutte le «consequentie» del livello radicale furono Biagio Marese di Maratea, servitore di casa Busale46; il benedettino veronese Cesare Maf54
fei, ospite dei Busale e morto in casa di Giulio Basalù, nel quale le posizioni ereticali si affiancavano alle indagini alchimistiche47; e poi il napoletano «dottor» Giovan Tommaso Bianco (o Blanco), pure legato a Basalù, del quale era stato compagno di studi a Padova e come lui dotato di una certa agiatezza48. C’erano, ancora, due altri ecclesiastici, entrambi «heremiti»: fra’ Cristoforo Milanese, ospite di casa Busale, che leggeva il vangelo commentando «‘questa cosa ce è stata agionta questa no’; et fra le atre dicevasi che ce era stato agionto quella cosa che disse Iesu Christo che li impii resurgeranno»49; e fra’ Matteo Francese50, anch’egli incluso tra i «maestri» da Giulio Basalù e successivamente incarcerato: sebbene non siano note le imputazioni che lo condussero in prigione, è facile immaginare che, come la gran parte dei suoi compagni radicali, anch’egli fosse travolto dalle inchieste inquisitoriali51. Benedettino di Monte Oliveto come d’Aversa, Tizzano e Laureto era Girolamo Capece, il cui caso dimostra ulteriormente come non fosse il solo Villafranca ad agitare dubbi ma gli stessi adepti: giunti ai gradi superiori della scala esoterica, si impegnavano essi stessi nell’azione di propaganda e di proselitismo, non senza aggiungere talora proprie interpretazioni. Capece – forse congiunto di Scipione – riconobbe che a parlargli delle opinioni più radicali era stato pure Villafranca, ma non solo lui, e non sempre per primo. Dopo aver ricostruito l’ambiente nel quale era maturata la sua svolta eterodossa, ricordando «Villafranca et messer Ludovico [Manna] messinese», «don Lorenzo [Tizzano]», «l’abbate Busal et lo frattello messer Mattheo», «un messer Iulio Basalù dottor et un messer Francesco Calabrese», Capece confessò tempi, modi e idee della sua virata radicale: Ho tenuto et creduto che, secondo dice Erasmo, per la varietà de’ testi grechi et latini che ci havrebbe possuto esser agionto o manchato per lo scriver et scorretione di stampa al Testamento Nuovo. Et per questa ragione si deve creder più al Vecchio per esser sempre serbato con diligentia; et questo mi fu persuaso dallo don Lorenzo [Tizzano] per corroborarmi che Christo non era Dio, et cossì ho tenuto per dui anni. Per altre autorità dattemi dal medesmo Esaia che ecce virgo concipiet non se intendeva per la vergine Maria ma per altra donna; et altre autorità del medesmo Esaia, ecce servus meus, et anchor per il Testamento Nuovo dicea che Christo non se fe’ mai Dio ma figliolo sì. Et ad alcune autorità del 55
detto Testamento Nuovo diceva intendersi altrimenti che li dottori della Chiesa hanno interpretato, come quello ego et pater unus sumus et Verbo caro factum est et altre simili, et anchor quello di san Paolo: Cum in forma Dei esset non rapinam etc., secondo par che Erasmo l’esponi. Ho tenuto et creduto per il medesmo spatio de dui anni la dormitione de’ giusti sin a l’advenimento de Christo, essendomi persuaso dal medesmo don Lorenzo con allegarmi alcune autorità d’Ezzecchielle: Putas ne vivent ossa ista, et di Paolo che sempre chiama dormitione la morte de’ giusti et quello de’ libri di Re che disse Samuele: Cur me a somno excitasti?; et cossì medesmamente l’esterminatione delli impii per l’autorità dittami dal medesmo del psalmista: Non resurgunt impii in iuditio, sed tamquam pulvis, et d’Esaia: Mortui tui non vivent, et nel medesmo capitolo: Mortui mei vivent. Ho tenuto et creduto l’advenimento de Christo con trionfo et che regnerà mille anni con gli suoi eletti, havendo soperato Antichristo, et se farà la resurretione christiana generale, et renderà il Regno al padre, persuasami da un Francesco Calabrese che veniva in compagnia del detto don Lorenzo52.
Era una testimonianza preziosissima – e non solo per i riferimenti all’impegno propagandistico di vari soggetti – dalla quale affioravano frammenti ulteriori delle discussioni che animavano il movimento valdesiano, riferimenti precisi a passi biblici e il rinvio all’Erasmo radicale, tanto importante per gli eretici italiani in generale e per i valdesiani (e Valdés stesso) in particolare53. Anche in Capece emergeva, inoltre, uno sfondo millenaristico che faceva il paio con la testimonianza di Matteo Busale. L’olivetano rivelò di esservi stato spinto «da un Francesco Calabrese che veniva in compagnia del detto don Lorenzo». Il millenarismo non apparteneva, dunque, al patrimonio radicale di Juan de Villafranca, e quasi certamente neanche Busale trasse ispirazione in ciò dallo spagnolo. Se infatti in un primo momento il fratello dell’abate, nel costituto del 5 luglio del 1553, ricostruì il suo percorso di adesione al radicalismo soffermandosi sulle fasi in cui nel movimento rifulgeva la stella dell’eretico spagnolo, in un successivo costituto del 18 agosto, messo alle strette dagli inquisitori sulle eresie di don Tizzano, Busale ricordò che «aspettava che venisse nostro signor Iesu Christo come messia, come li giudei, per re temporale et che non fosse venuto prima se non per insegnare la voluntà di Dio, e far partecipe della gentilità et dottrina che voleva Dio, che havesse il populo suo, et non eramo risoluti se questo ufficio del re temporale l’havesse da far Christo o alcun altro»54, vi56
sioni che Matteo attribuì anche a se stesso e che traevano fonte da Tizzano e non da Villafranca. S’è visto, del resto, come Basalù avesse rivelato che proprio Tizzano gli aveva parlato «de dogmi hebrei et interpretatione di propheti»55, e anche Giulio non mancò di evocare il nome di Francesco Renato, che aveva «molte chimere di interpretatione et di ponti de la lingua hebrea». Affiancando le rivelazioni di Matteo Busale e Girolamo Capece a quelle di Tizzano e Basalù, pertanto, possono cogliersi altri indizi che conducono alla nuova setta di cui aveva parlato (pur confusamente) don Pietro Manelfi. L’ipotesi secondo cui alcuni valdesiani spintisi al di là del livello radicale s’erano coagulati attorno a un progetto comune, insomma, pare trovare conferma ulteriore. La tesi appare ancor più convincente scorrendo la confessione di fra’ Matteo d’Aversa, olivetano convertito da Lorenzo Tizzano: In principio, questo don Laurentio Ticiano in camera de don Hieronimo Capece disse una gran laude in esaltatione del nostro signor Iesu Christo che Dio li haveva accommodato tutti li suoi thesori et cetera. Dapoi questa laude, successive disse che si maravigliava che gli homini venisseno in questo errore a tenerlo per Dio, attento che non era necessario et disse molte cose delle quali non mi ricordo per comprobare che non fosse Dio, fra le altre mi ricordo che disse questo, quel testo nelli atti delli apostoli Probatum virum a Deo, et che in un certo concilio dove si disputò de divinitate Christi erano più gagliarde le ragioni che facevano contra la divinità et mi esshortò a legger detto concilio etc. Io li replicai contra adonque [ciò che] dice quel testo della annunciatione che Concepit de spiritu sancto, et lui mi rispose che quello si posseva intendere che Christo era figliolo di Dio ma non Dio. Poi disse: chi sa se ci sia stato agionto [agli evangeli], et io li risposi che quel non si trova, ma ben si prova per Erasmo che ci è stata agionta la historia della adultera, che io mi ricordavo haver letto; esso ne rispose che tutta quella historia che dice Antequam sciat vocare patrem reprobare malum et eligere bonum, che l’hanno applicata al nascimento di Christo che fu già adimpita in altri, in un re, et mi mostrò nelli Propheti tutte quelle medesime parole etc.56.
Oltre a lasciare scorgere modalità della conversione alle opinioni radicali, confermando pure come non fosse il solo Villafranca a spingere sul proselitismo, questa testimonianza rivela una notizia a dir poco sorprendente, mai riscontrata prima. Il monaco affermò che per convincerlo Tizzano gli aveva parlato di un «certo concilio dove 57
si disputò de divinitate Christi», concilio nel quale s’erano profilate varie posizioni e nel quale le «ragioni» degli antitrinitari erano risultate «più gagliarde». Sebbene non sia da escludere che il riferimento fosse a un concilio dell’antichità, sembra più probabile che egli evocasse il concilio di radicali tenuto a Venezia nel 1550 (il che consentirebbe tra l’altro di datare la conversione di d’Aversa a dopo la sua celebrazione), ed è sconcertante apprendere che quel concilio avesse partorito un testo, a stampa o più probabilmente manoscritto: Tizzano lo esortò «a legger detto concilio», dal che si deduce che del concilio di Venezia fosse stata prodotta una verbalizzazione, sulla quale, però, non sussistono ulteriori indizi. Ad ogni modo, d’Aversa proseguiva lasciando intendere come il tentativo di Tizzano avesse avuto un esito felice: Ho tenuto et creduto che Christo non possa esser Dio et homo, pensando che non era possibile che Dio si coniungesse con un corpo humano, et questo per persuasion di don Lorenzo suddetto, et in quel ragionamento dissi io che mi pareva più eccellenza et grandezza de Christo che essendo homo Dio li havesse donata tanta gratia di constituirlo giudice del mondo, et delli vivi et delli morti, che se l’havesse per potestà ordinaria. Don Laurentio disse costoro, li cattolici, par che voglino far un pasticcio a mescolar la divinità con la humanità etc. Io li dissi che mi pareva impossibile che Christo fosse nato di seme humano ma io haveria creduto che fosse nato miracolosamente per virtù di Dio et senza seme humano, ma non che fusse Dio. Don Lorenzo rispose che questo non poteva esser perché bisognava confessar o che fosse Dio o nato di seme humano et puro homo57.
Le precisazioni logiche, la retorica, gli slanci del neofita, tutto in questa confessione riflette la vitalità di quegli scambi, che portavano inquiete personalità a perdersi per labirinti ereticali. Una volta accettata l’umanità di Cristo, Matteo la condiva di considerazioni personali che lasciavano affiorare l’essere umano con le sue visioni, le sue attitudini, i suoi limiti evidenti. Ma il maestro non lasciava scorrere l’entusiasmo troppo in là, e parando possibili aporie orientava l’adepto verso i lidi ai quali gli premeva che approdasse. Infatti, Tizzano portò d’Aversa (con l’aiuto di altri come Matteo Busale) a dubitare dell’autenticità di molti luoghi del vangelo, a ritenere che l’inferno non esistesse e che le sole anime dei santi dormissero fino al giorno del giudizio, mentre i reprobi macerassero nella morte eter58
na. Fin qui Lorenzo si era limitato alle opinioni radicali apprese da Villafranca, che aveva impropriamente definito «anabattistiche»; ma con d’Aversa spinse ancor di più l’acceleratore, parlandogli delle «diaboliche opinioni», che il confratello mostrò d’apprezzare particolarmente: Mi è piaciuta quella authorità che ha detto N., don Lorenzo et N.: et anchora Christo non è venuto come messia ma come nuntiatore della volontà del padre et della legge evangelica ma quando verrà come messia, verrà in potestate magna, et restituet regnum Israel, et la regnarà con tutti li eletti soi per un gran spacio di tempo, et allhora serà adempita quella profetia conflabunt lanceas etc.58.
Emerge qui un’ulteriore prova del fatto che tra quanti s’erano spinti oltre il livello radicale ci fosse un vero e proprio gruppo, rivolto peraltro al proselitismo. Lorenzo Tizzano, Matteo e Girolamo Busale, Matteo d’Aversa, Girolamo Capece, Francesco Renato: non poteva essere un caso, poiché è evidente che una parte del movimento si era posta l’obiettivo di raggiungere una posizione comune che rivisitava il radicalismo di Juan de Villafranca, con una spinta verso un giudaismo in cui s’intrecciavano echi islamici e materialistici. Posizione che, all’indomani del concilio di Venezia, Busale e i suoi avevano ulteriormente complicato negando il valore del battesimo agli infanti. Nonostante Villafranca non avesse detto alcunché riguardo alla necessità del ribattesimo, non mancano tracce che di ciò si dibattesse tra i valdesiani radicali. Basalù avrebbe rivelato che al ritorno da Venezia Busale «ragionò di molte opinione anabaptistice et di molte hebree». E quasi certamente anche d’Aversa aderì alla virata anabattistica, così come Raffaele da Roccaguglielma, chirurgus ricordato da Ambrogio da Pozzo e da Villamarina insieme con un certo Cosimo, pure da Roccaguglielma. Raffaele abiurò il 4 novembre del 1554 a Roma, e se dalle testimonianze allegate al processo Basalù sembra che avesse tratto tutte le conseguenze del magistero radicale di Juan de Villafranca, dalla sua abiura risulta che dicea costui più crudeli biasteme di tutti, convinto che Christo era huomo e non Dio et nato da Giusef et Maria come noi e che per molti anni havea creduto che nel Giordane havesse ricevuta la divinità nel battesimo. Negava il battesimo di fanciulli, admettea che adulti si dovesser battezare. Che Christo non era consustanziale al padre perché fusse figliolo 59
di Iddio come noi di nostri padri, e ch’el primo capitolo di san Giovanni nell’evangelio et altri luoghi eran stati aggionti o si dovevano intender altrimenti59.
Non può sfuggire come ben prima delle decisive riflessioni di Lelio Sozzini quegli eterodossi si ponessero il problema del significato da dare al primo capitolo del vangelo di Giovanni, così come risulta anche dalla confessione di Villamarina, secondo cui Villafranca «negava parte de l’evangelio di san Giovanni et delli altri evangelisti dove era attestata la divinità de Christo». Ciò che qui importa osservare nondimeno è come nel chirurgo (probabilmente un barbiere o uno speziale) si sovrapponesse il livello radicale delineato da Villafranca alla credenza nell’invalidità del battesimo ai fanciulli e della necessità del ribattesimo agli adulti. Del resto, che Girolamo Busale si fosse messo a «insegnar questa doctrina»60 dopo il suo ritorno dai territori veneti l’avevano detto Laureto e Basalù; e che a qualcuno l’abate avesse rivelato la novella anabattistica è confermato da uno scrivano che aveva aderito al movimento quando Valdés era ancora in vita: Ambrogio da Pozzo. In quel 1553 zeppo di pentiti e di indagati, da Pozzo61 confessò infatti agli inquisitori le ormai note opinioni «luterane», oltre ai dubbi sulla divinità di Cristo e la verginità di Maria, le credenze sulla mortalità dell’anima e, insomma, tutte le idee caratteristiche del livello radicale ispirato da Juan de Villafranca. A queste idee, però, Ambrogio ne aggiunse due ulteriori, vale a dire che fosse «lecito pigliar moglie con ogn’altra parente eccetto che con suor carnale»62 (opinione che sostenne di aver condiviso col solo Villafranca) e «che lo baptesmo si deve dar alli adulti et dandosi alli figlioli si deve reiterar», idea che dichiarò d’avere in comune col solo Girolamo Busale. Importa poco il fatto che in realtà ai due andassero aggiunti almeno Laureto, Raffaele da Roccaguglielma e altri ancora, mentre ciò che conta è che dall’abate da Pozzo aveva attinto questa significativa deviazione dal tracciato radicale delineato da Juan de Villafranca. Dedotte tutte le «illationi» da quell’itinerario, insomma, i valdesiani seguivano poi percorsi autonomi, sebbene a quanto pare si fossero delineate due tendenze di fondo tra i più radicali, soprattutto dopo la morte del maestro, con un’ala più incline a un cripto-giudaismo arricchito da innesti islamici e successive aperture anabattiste e un’altra più radicale ancora, nel cui ambito alcuni erano giunti 60
alla negazione non solo del cristianesimo ma di ogni religione istituita, in nome di un materialismo non comune nella cultura del XVI secolo. Tra costoro, oltre Basalù, va annoverato il suo amico Tobia Citarella, un agiato mercante che era tra i pochissimi cui Giulio avesse rivelato gli approdi del suo percorso eterodosso e, a quanto egli stesso rivelò, l’unico che avesse condiviso le sue beffarde «chimere et fantasie» d’intonazione libertina63. All’elenco di questi personaggi giunti alle posizioni più estreme del dissenso religioso europeo del Cinquecento64, inoltre, occorre aggiungere quanto meno un’altra e più celebre personalità, il più autorevole esponente dell’ala radicale del movimento valdesiano: Scipione Capece. 2. Eresia radicale ed epicureismo: Scipione Capece da Dio alla natura In una delle deposizioni allegate al processo contro Giulio Basalù, Raffaele da Roccaguglielma rivelò che «un giorno, son da quattro anni in circa, in casa, in presentia de don Lorenzo Titiano [...], sentitti detto don Lorenzo e Iulio Basalù che ragionavano che havevano buona speranza che Scipione Capece doventasse homo da bene, che volevano inferire heretico»65. Basalù, una delle fonti di questa notizia, avrebbe precisato che Capece si era effettivamente spinto a negare la divinità di Cristo, ma non sapendo (o non volendo) dirne molto di più: «Con Scipion Capece – si limiterà ad ammettere – ho ragionato una sola volta in una sua villa, ma de le sue opinione ho hauta noticia dal Tizzano et dal Coppula»66. In effetti, era stato Tizzano a fornire maggiori particolari sulle sue scelte eterodosse, ponendolo su un livello iniziatico ancor più alto di quello sul quale lo aveva collocato Basalù. In particolare, Capece era tra coloro con i quali Lorenzo aveva «parlato et conferito le opinione prime lutherane et le seconde anabattiste et così le terze diaboliche», cioè: «Con misser Francesco Renato, con l’abate Busale, con misser Mattheo Busale, con lo signore Scipione Capece, quale è morto, con misser Giovanni Francesco Coppola di Napoli, con misser Giovanni Laureto della Cava, li quali tutti mostravano di acquiescere ad queste opinioni»67. Secondo la testimonianza dell’olivetano, dunque, Capece apparteneva alla cosiddetta «nuova setta», quella cripto-giudaica di Tizzano, dei Busale e dei loro compagni. Di conseguenza, a parte 61
non credere all’inferno, l’aristocratico napoletano non solo avrebbe negato la divinità di Gesù ma ne avrebbe escluso la natura di messia: profeta maggiore di altri profeti, come diceva il Corano, ma niente di più. Né si sarebbe limitato a criticare la veridicità di singoli passi dei vangeli, spingendosi a rigettare in toto l’autenticità del Nuovo Testamento. In realtà, il suo profilo di fine umanista e di grande giurista lo pone su un piano diverso rispetto agli altri valdesiani radicali, e dalla sua produzione emerge un radicalismo ancor più spinto di quello dei «diabolici», senz’altro meglio assimilabile (pur nelle differenze inevitabili) agli approdi estremi e personali di Basalù o di Citarella. Scipione Capece era la personalità di maggior prestigio dell’intero gruppo radicale, l’unico – a parte forse Villafranca e Villamarina – che socialmente potesse rapportarsi ai grandi aristocratici valdesiani d’ispirazione moderata. Non a caso, su Capece si dispone di fonti più cospicue, ed egli è l’unico tra gli eretici meridionali non fuggiti oltralpe di cui siano note opere a stampa. Nondimeno, anche sulle sue vicende si estende quella densa nebbia che avvolge tutti i protagonisti fin qui presi in esame. Nato a Napoli verso la fine del XV secolo68, Scipione era figlio della nobile Maddalena de Loffredo, appartenente a un’importante famiglia di giureconsulti69, e del celebre giurista Antonio Capece, docente universitario, a lungo membro del supremo organo giurisdizionale del Regno di Napoli: il Sacro regio consiglio70. Grazie a entrambi i genitori, quindi, Scipione poteva contare su stretti legami coi maggiori giuristi del suo tempo, vantando pure nobili ascendenze, benché il suo antichissimo casato (ascritto al Seggio di Nido) non vada confuso con quello degli omonimi Capece del Seggio di Capuana, coi quali però non è da escludere l’appartenenza a un ceppo comune71. Cresciuto alla scuola di umanisti come Giovanni Pontano e Pietro Summonte, oltre che a quella paterna, sin da giovane Scipione aveva frequentato gli ambienti dell’Accademia Pontaniana, conoscendo alcuni dei principali esponenti della cultura napoletana del primo Cinquecento, quali i suoi stessi maestri e altri come Iacopo Sannazaro, Girolamo Carbone, Agostino Nifo, Giano Parrasio e Antonio de Ferraris detto il Galateo. Una lettera indirizzata a Capece da Aldo Manuzio parrebbe testimoniare che nel 1513 il grande editore gli avesse inviato una copia delle opere di Pontano e delle orazioni di Cicerone uscite dai suoi torchi72; ma probabilmente è un falso, poiché la prima edizione del62
le Orationes uscita dalle officine dei Manuzio risale al 1519, e dunque a quattro anni di distanza dalla morte dello stesso Aldo73. Certa è invece la sua conoscenza del terzogenito di Manuzio, Paolo, che, scrivendo al comune amico Girolamo Seripando74, lodò la grande erudizione di Scipione75 e nel 1546 stampò la sua opera principale, il De principiis rerum, da lui anteposto persino al De rerum natura di Lucrezio76. Un legame da sottolineare quello con Manuzio, considerati i rapporti tra l’editore veneziano e gli ambienti dei valdesiani moderati77. Nell’anno accademico 1518-19 Capece ebbe il suo primo incarico nello Studio di Napoli – ove ancora insegnava il padre Antonio – come lettore di Institutiones imperiales78, mentre poco dopo si trasferì in Calabria, quasi sicuramente in qualità di luogotenente di Cosenza79, incarico che mantenne almeno fino al 1526, non essendovi d’altronde sue tracce a Napoli precedenti il 1529, quando in apertura del De bello neapolitano di Camillo Querno80 apparve a stampa un suo epigramma. Nel 1526 Scipione sposò la patrizia napoletana Giovanna Caracciolo (parente di Galeazzo), e in tale occasione l’umanista cosentino Antonio Telesio, zio e maestro del più famoso Bernardino, dedicò agli sposi un Epithalamium81. L’amicizia con Telesio e la stessa presenza a Cosenza di Capece offrono qualche conferma all’ipotesi dell’esistenza di uno stretto legame tra l’Accademia Pontaniana e l’Accademia cosentina82, sorta attorno al filologo Aulo Giano Parrasio, anch’egli frequentatore della Pontaniana. A parte Parrasio, probabilmente già conosciuto a Napoli, fu a Cosenza che Capece poté venire a contatto con molti di quegli accademici della città bruzia che avrebbe successivamente frequentato nella capitale: Antonio Telesio stesso, i fratelli Bernardino e Coriolano Martirano e altri ancora, tra i quali forse il giovane Bernardino Telesio83. Negli anni Trenta Scipione era di nuovo stabilmente a Napoli, impegnato in un’alacre attività editoriale: nel 1532 uscì, a cura sua e del conte Giovan Francesco Di Capua, un’edizione delle poesie di Pietro Gravina; in quello stesso anno pubblicò – per Sultzbach – l’Inarime, poemetto pregno di echi pagani dedicato a Vittoria Colonna, incentrato sulla ricostruzione fra mito e storia delle vicende dell’isola di Ischia, prediletta dalla poetessa che di lì a poco, come lo stesso Capece, sarebbe stata sedotta dalle inquietudini del valdesianesimo84. A queste prime prove, che danno il segno di quanto Scipione avesse ripreso a frequentare gli ambienti colti della capitale, 63
seguiva nel 1533 – ancora per Sultzbach – la prima edizione del De vate maximo, poema dedicato alla vita del Battista, che ebbe una significativa circolazione europea, anche in ambienti eterodossi: basti pensare che nel 1542 uscì a Basilea in una raccolta di Poemata sacra praestantium poetarum presso Oporinus, che sarà editore del Pasquino in estasi di Celio Curione, della Tragedia del libero arbitrio di Francesco Negri, della versione del Nuovo Testamento curata da Sébastien Castellion, del De haereticis an sint persequendi e presso il quale lavorerà un personaggio legato alla dissidenza radicale come Pietro Perna85. E non vanno tralasciati i giudizi favorevoli che del De vate maximo diedero personalità del mondo zurighese come il naturalista Konrad Gessner e il teologo Iosias Simler86. All’attività filologica e alla produzione poetica ben presto Capece affiancò quella giuridica87, e nel 1534 riprese l’insegnamento universitario, ereditando la cattedra paterna di Ius civile della sera88. L’anno seguente, all’arrivo dell’imperatore a Napoli, ebbe dal Seggio di Nido l’incarico di pronunciare innanzi a Carlo V un’orazione89, e da ciò Pietro Giannone dedusse – arbitrariamente – che derivassero le fortune di Scipione, spiegabili invece in primo luogo col prestigio del nome paterno e di un casato dotato di potenti reti parentali oltre che, ovviamente, con le sue qualità90. Non si sa con certezza fin quando mantenne la cattedra nello Studio: Mazzuchelli parla del 153591, Giannone pospone la data al 1537, ed è possibile che ne restasse titolare fino al 1539, quando fu nominato consigliere del Sacro regio consiglio, succedendo anche in ciò in un incarico già ricoperto dal padre Antonio, scomparso l’anno prima92. La nomina nel massimo organo giurisdizionale dello Stato segnò l’acme della sua carriera pubblica. Nel frattempo, la personalità di Scipione si affermò nel panorama culturale della capitale, e fu proprio a casa sua che si perpetuò l’uso delle riunioni invalso tra vecchi pontaniani come Giano Anisio, Girolamo Borgia, Agostino Nifo, Bernardino Rota (amico di Carnesecchi e marito di una Porzia Capece) e vari altri93, cui s’aggiunsero man mano valdesiani (e Bianchi di giustizia) come Giovan Francesco Alois detto il Caserta94 e Mario Galeota, e poi Marcantonio Flaminio, Galeazzo Caracciolo e altri ancora, nonché una vera e propria colonia di cosentini. Diversi accademici della città calabrese, infatti, dopo la morte di Parrasio finirono col gravitare per lo più su Napoli, raccogliendosi attorno al segretario del Regno Bernardi64
no Martirano nella sua splendida villa di Leucopetra presso Portici. I ridotti di umanisti a Leucopetra hanno indotto alcuni a ritenerli espressione di un’autonoma «Accademia Martirano»95. L’identità di molti dei partecipanti a questo consesso e a quello degli epigoni della Pontaniana raccolti attorno a Capece, però, induce a rigettare tale ipotesi e a considerare invece i due luoghi (palazzo Capece e villa Martirano) come sedi d’elezione di un unico milieu almeno fino al 1543, quando col forzato trasferimento di Capece a Salerno sarebbe prevalso l’uso di riunirsi a Leucopetra. Capece stesso, d’altra parte, è indicato tra i partecipanti alla cosiddetta Accademia Martirano e così pure pontaniani come Giano e Cosimo Anisio, Agostino Nifo, Bernardino Rota, Antonio Telesio e altri ancora, mentre Martirano appare nell’elenco di pontaniani elaborato da Minieri Riccio sulla base delle fonti coeve. Non sembra da sottovalutare, d’altra parte, neanche il fatto che tra le poesie dedicate da Anisio sia a Capece sia ai fratelli Martirano ve ne fosse una Ad Coriolanum [Martiranum] et Capycium 96. La questione dell’accademia riunita attorno a Capece è della massima importanza ai fini dell’indagine sui gruppi del dissenso religioso che percorsero la Napoli del Cinquecento. A parte Scipione, numerosi furono i punti di contatto tra pontaniani e valdesiani, non senza vere e proprie sovrapposizioni. In questo contesto un ruolo di trait d’union ebbe l’abate Giovan Francesco (Giano) Anisio, dalle cui opere affiorano i segni dei molteplici rapporti che legarono il mondo degli umanisti a quello degli eterodossi. Tra i destinatari dei suoi versi e delle sue epistole, a parte significative evocazioni di Erasmo e di Lorenzo Valla, v’era appunto Scipione Capece97; ma c’erano poi lo stesso Juan de Valdés, Pier Martire Vermigli98, Mario Galeota, Girolamo Capece, Marcantonio Flaminio, Apollonio Merenda99 e un protagonista della diaspora europea come Valentino Gentile, nel quale sembra affiorare, come in Capece, l’intreccio tra radicalismo valdesiano e Umanesimo pontaniano. Si trattava, insomma, di due movimenti strettamente connessi tra di loro. Non sarà inutile ricordare che lo stesso Valdés aveva offerto col suo Diálogo de la lengua la prima matura teorizzazione del castigliano moderno. In quel testo uno degli interlocutori era un Coriolano che si ritiene fosse il vescovo di San Marco Coriolano Martirano, fratello di Bernardino100, il che ripropone il legame tra gli ambienti accademici e quelli del movimento valdesiano. Tracce di cultura umanistica, d’altra 65
parte, sono emerse dalle deposizioni di diversi radicali, con i riferimenti a Valla e a Erasmo. Va sottolineato quindi come i due gruppi si alimentassero a vicenda, occupandosi in alcuni casi di questioni analoghe, sulle quali è più che probabile che ci fosse uno scambio di opinioni: si pensi al tema della mortalità dell’anima. Che se ne dibattesse con apporti reciproci in entrambi i consessi – e non solo dai valdesiani radicali – è provato da una lettera di Flaminio a Giano Anisio, che gli aveva richiesto lumi proprio su questo problema. Flaminio sembrava riconoscere retoricamente che «coloro hanno forse ragione di mettere in dubbio l’immortalità de l’anima, come veggiamo c’hanno fatto alcuni philosophi»101, con parole che danno un primo indizio sui referenti culturali ai quali riallacciare una questione che doveva riferirsi non solo a uno scambio di idee tra i due, ma a un dibattito più ampio (evocato da quei «coloro» cui Flaminio si era riferito) di cui la lettera rivela l’esistenza. È probabile che le tesi di Pomponazzi avessero contribuito ad alimentare tali discussioni, mentre, come si vedrà, è sicuro che lo stimolo fosse venuto anche dalla lettura del De rerum natura di Lucrezio. Se il riferimento ai filosofi riporta al Rinascimento eterodosso, al radicalismo valdesiano riconduce un ulteriore indizio offerto da Flaminio, che, dopo aver tranquillizzato Anisio spiegandogli che i valdesiani come lui non dubitavano dell’immortalità dell’anima, aveva soggiunto: «Io per me voglio lasciar queste dispute a coloro che non credono a Christo benedetto, li quali se staranno ostinati ne la impietà, conosceranno finalmente con lor eterno supplicio che l’anima non muore»102. Emergeva ancora una volta in questa pur dura risposta l’attitudine alla tolleranza tipica del movimento valdesiano, in tutte le sue sfumature. Non erano certo torture, scomuniche, abitelli, abiure o roghi che Flaminio invocava contro quei radicali, che peraltro si guardava bene dal denunciare, mentre legava la dimostrazione del loro errore al giudizio di Dio, cui sarebbe spettato il castigo per quelle terribili «impietà». Nel riferirsi a «coloro che non credono a Christo benedetto» egli pareva evocare proprio i valdesiani antitrinitari e materialisti guidati da Juan de Villafranca, di cui anche Capece condivideva le idee. La lettera dimostra dunque quanto pontaniani e valdesiani, lungi dal limitarsi a condividere la loro socialità in nome delle delizie arcadiche, intrecciassero discussioni su temi scottanti e suggerisce come un argomento cruciale sia del radicalismo valdesiano sia di quello rinascimentale potesse alimentarsi di succhi scaturiti 66
dall’incontro di tradizioni differenti, in un confronto aperto ed eclettico di idee, che è tipico del valdesianesimo in ogni gradazione e caratterizza del pari l’Umanesimo meridionale. D’altronde, sarebbe strano immaginare impermeabilità tra valdesiani e pontaniani riguardo a un argomento d’interesse comune – e di tale importanza – come il destino ultraterreno dell’anima; il tema era proprio del valdesianesimo più radicale e oggetto di riflessioni dello stesso Valdés. Per quanto riguarda gli accademici e più in generale gli umanisti, poi, vale la pena di ricordare la presenza in quegli anni a Napoli di un docente dello Studio e pontaniano come Simone Porzio103, fautore di una visione radicalmente naturalistica dell’aristotelismo ispirata ad Alessandro d’Afrodisia ma anche a Pomponazzi. Nel De mente humana disputationes del 1551 Porzio avrebbe affrontato il problema seguendo – pur non senza distinzioni – l’impostazione del De immortalitate animae del mantovano: negando l’immortalità sulla base della dimostrazione filosofica e accettandola (almeno in apparenza) come dato indiscutibile di fede. Si può evocare inoltre il calabrese Tiberio Russiliano Sesto104, quasi certamente anch’egli in contatto con i pontaniani: allievo dell’aristotelico averroista Agostino Nifo, definiva Pontano «Jovianus noster». Anche Russiliano era fautore di un naturalismo radicale dai tratti materialistici e sostenne una tesi prossima a quella della mortalità dell’anima, sebbene contrapponendosi (quantomeno formalmente) alle tesi esposte da Pietro Pomponazzi. Come si è detto tuttavia, a parte il valdesianesimo, non è solo in quest’ultimo e nell’aristotelismo padovano che va trovata la fonte del problema, ma soprattutto nella conoscenza dell’epicureismo lucreziano: alla dimostrazione della mortalità dell’anima era dedicato pressoché l’intero terzo libro del De rerum natura (vv. 94-829), e il nome di Lucrezio circolava negli ambienti napoletani almeno sin dal Quattrocento. Per cogliere la diffusione di idee lucreziane è esemplare proprio il De principiis rerum di Capece, massima espressione della filosofia naturale d’ispirazione materialistica nella Napoli della prima metà del Cinquecento. Certo, è bene sottolineare quanto Scipione prendesse formalmente le distanze dall’amato poeta su alcuni punti specifici della sua visione, e in specie sulle teorie atomistiche (De principiis rerum, I, 204-230 e 259-345), sulla concezione del vuoto (I, 286-304 e 341-345) e sugli infiniti mondi (I, 196-204; 282-284; 341-345), ma anche sulla negazione dell’intervento divino nelle vicende umane (I, 252-257) nonché specificamente sulla mor67
talità dell’anima (I, 257-258). Tali critiche non vanno sottovalutate, dimostrando in primo luogo quanto il materialismo di Capece traesse fonte non solo dall’epicureismo (e dal radicalismo valdesiano), ma anche dal naturalismo presocratico nonché dallo stoicismo105. Non bisogna neanche però cadere nell’atteggiamento opposto, dando peso eccessivo alle critiche espresse al De rerum natura, come avrebbe fatto il gesuita Ignazio Bracci, curatore di un’edizione di opere capeciane uscita nel 1594, pronto a giustificare l’autore da qualsiasi ombra d’eterodossia – di cui probabilmente al tempo doveva conservarsi l’eco – che il riferimento all’epicureismo poteva evocare nel lettore106. Anzitutto, come sottolinearono sia Bembo sia Manuzio nelle epistole edite in apertura all’opera107, era la struttura stessa del De principiis rerum a essere squisitamente lucreziana, nel tentativo di elaborare una teoria della natura in forma poetica e in lingua latina. Capece stesso, inoltre, riservava parole di entusiasmo al grande poeta, non a caso l’unico autore a esser citato in tutta l’opera e definito «pater [...] Lucretius» (I, 238), «magne pater» (I, 246). Se alla critica dell’atomismo e del vuoto lucreziani egli dedicava un certo spazio, distendendosi in disquisizioni teoriche e nell’elencazione di controprove empiriche, del tutto incidentali erano invece le contestazioni ai temi dell’intervento divino e della mortalità dell’anima108, evocate per parare possibili accuse e non affrontate analiticamente, giacché di nessun interesse per la visione tutta naturalistica e materialistica del poema di Capece109. Il fatto che i temi fossero solo richiamati e non sceverati, dunque, svela una strategia di dissimulazione. È noto infatti dalle confessioni di Tizzano che Scipione aderì quantomeno alla teoria dell’annichilamento delle anime dei reprobi: la critica rivolta a Lucrezio sulla mortalità dell’anima, pertanto, era fittizia e avanzata per fugare i sospetti che tale dottrina fosse accolta anche da lui. In effetti, poi, non era sul pedissequo calco di Lucrezio che Capece elaborò la sua teoria sull’anima, che nel De principiis rerum non fu enunciata espressamente ma si può evincere indirettamente. Il napoletano poneva come origine di tutte le cose quello che egli definiva aer, principio squisitamente corporeo e materiale che avrebbe irrorato di sé tutto l’universo. Ora, all’aer varie volte (II, 343; 366; 427; 434; 477) Scipione assegnava il nome di anima, che egli considerava come un sinonimo e quindi assumeva un significato materialistico, che ricorda lo pneuma degli stoici e degli stessi epicurei110. Non è azzardato, pertanto, associare l’aer capeciano a una 68
raffinata forma di panteismo: quest’anima – in un caso pure definita spiritus (II, 453) – l’autore vedeva esalare dagli incendi e dalle armi da fuoco, e allorquando si dedicava alla critica dell’atomismo sosteneva (I, 130-152) che nessun corpo può generarsi da sé, mentre bisogna che prima sia deceduto un altro corpo, facendo propri orientamenti che si richiamavano alla metempsicosi pitagorica, rivisitata in una chiave tutta materialistica, nella quale l’anima si risolveva nell’aer ed era identificabile in una mente eterea («aetheriae mentis») che di etereo non aveva nulla: un’anima corporea che periva e poi rinasceva («resurgit», «renascit»)111. A Lucrezio (De rerum natura, V) si può ricondurre – sebbene non senza differenze – anche la teoria sulla corruttibilità del mondo (De principiis rerum, II, 489617; 737-741), apparentemente ortodossa rispetto a chi, come Basalù, riteneva il mondo eterno, rifiutando così la creazione divina. In realtà l’ortodossia vacillava non poco di fronte a una corruttibilità che Capece estendeva al cielo, considerato come non distinto dal mondo sublunare, a differenza del sistema aristotelico e di ciò che prescriveva l’ortodossia romana. L’umanista-giurista e filosofo-eretico riteneva sia il mondo sia il cielo di un’unica natura, e nell’indugiare a elencare casi empirici che rivelavano un’esistenza di lunghissima durata Capece omologava gli astri del cielo alle conchiglie, ai reperti archeologici e ai coralli, escludendo in tutti casi che si potesse parlare di eternità112. A simulazione va pertanto ricondotta la dedica del poema a Paolo III, definito «rex superum superique patris mens unica» (I, 8). Nel papa egli indicava in esordio addirittura colui «per quem / ipsa parens vires natura accepit et ortus» (I, 8-9), l’artefice primo della natura, in un tono talmente encomiastico da svelare la falsità dell’assunto: tutto il poema capeciano era rivolto proprio a indagare «naturae mundique [...] quae semina primum / quae causae fuerint, atque unde exordia rerum» (I, 1-2); e di quei primi semi la causa originaria non indicava né in Dio né tanto meno nel papa, ma nell’aer. Non a caso in un passo dedicato alla natura del fuoco (II, 188-197), attraverso la critica al mito di Prometeo il napoletano demoliva la credenza che il fuoco fosse stato donato agli uomini dal cielo, esortando a basarsi in primo luogo sui sensi per comprendere i fenomeni della natura, senza celare, ancora una volta, il suo debito nei confronti di Lucrezio. Questi suggeriva di fondarsi sulle percezioni sensibili per ricondurre al cielo l’origine del fuoco in chiave materiali69
stica, legandola alla caduta di un fulmine su materia infiammabile o allo sfregamento di due corpi terrestri (De rerum natura, V, 10911104). Di Dio, d’altronde, nel De principiis rerum vi sono tracce rarefatte: un vago accenno (sempre nell’invocazione iniziale, che lo stesso Lucrezio aveva indirizzata all’alma Venus) al «conditor orbis immensi» nonché un non meno sfuggente riferimento al «coelicolum pater», e poi al «coelique parens terraeque repertor» (II, 482), al quale retoricamente Scipione chiedeva l’ispirazione per riuscire a individuare i principi primi della natura, in un’argomentazione però condotta soltanto in relazione alla fisica materialità delle cose, che poco o punto spazio concedeva all’azione di quel «coelique parens terraeque repertor» (II, 982) citato un’ultima volta in chiusura del poema, in un’invocazione accorata rivolta da Capece per ricondurre a lui l’intimo amico Onorato Fascitelli. Il Dio del De principiis rerum appare insomma artefice distante di non si sa bene cosa, confinato su uno sfondo incolore nel quale non si distingue il suo operato: un Dio che potrebbe equipararsi all’altrettanto vago Dio di Basalù, benché l’ispirazione di Capece tendesse verso il panteismo mentre quella di Basalù a una sorta di proto-deismo. In un solo caso, incidentalmente e sempre nella dedicatoria al papa, Scipione evocava i «Christi signa»; e al «virginis alvo» dedicava un cenno retorico in chiusa dell’opera, mentre non citava mai né santi né angeli né demoni o qualunque altra creatura inintelligibile con «sensus» e con «vera ratione», esclusivi fondamenti dell’epistemologia e del metodo sottesi al De principiis rerum. In una delle dimostrazioni rivolte a negare il concetto di spazio infinito, Capece faceva riferimento all’inesistenza di alcun «locus [...] superus [...] aut inferus» (I, 427); e sebbene in quel passo non sembrasse riferirsi a paradiso e inferno ma all’universo fisico, in realtà dissimulava evocando proprio quelli, come dimostrano le confessioni di Tizzano, che svelerà come Scipione non credesse quantomeno all’esistenza dell’inferno. Il De principiis rerum mostra, insomma, quanto anche la conoscenza del pensiero classico giocasse un ruolo decisivo nella radicalizzazione delle idee del movimento valdesiano. La dottrina valdesiana sulla mortalità dell’anima poté nutrirsi ulteriormente della conoscenza della teoria lucreziana e della declinazione panteistica che ne aveva dato l’umanista napoletano; alle cui vicende biografiche è opportuno a questo punto ritornare. Dopo i successi mietuti nella 70
Napoli degli anni Trenta, i primi sospetti cominciarono ad addensarsi sul suo conto: il 26 febbraio 1543 Scipione fu destituito dalla carica di consigliere del Sacro regio consiglio e costretto a riparare a Salerno. Tradizionalmente si è legata tale destituzione al fatto che Capece fosse eretico, ma nessuna traccia documentale ne offre testimonianza113: in particolare nessun riferimento a problemi religiosi pare emergere dal decreto che ne sancì la sostituzione nel Consiglio di Santa Chiara. Se in un primo momento, infatti, fu tramandato un brano del documento in cui si faceva riferimento a una «infamiae nota», con la pubblicazione del testo integrale Altamura mostrò come la formula suonasse al contrario: «Sine eiusdem Scipionis aliqua infamiae nota»114. D’altra parte, la politica repressiva di Toledo nei confronti dell’eterodossia sembra prendesse piede solo dal 1544, con la pubblicazione in ottobre della prima prammatica tesa alla censura dei libri d’argomento religioso, presto seguita (nel 1547) dal tentativo di introdurre l’Inquisizione spagnola che suscitò la rivolta dei napoletani. In realtà, la questione è più complessa e ancora oscura, e vale la pena di affrontarla non solo perché può aiutare a capire il motivo della destituzione di Capece, ma anche perché da essa emergono tracce che spingono a legare i fatti del 1547 alla diffusione del valdesianesimo, nonché a spiegare perché poco prima del tentativo toletano (fra il 1546 e il 1547) eretici napoletani come Busale, Basalù e Tizzano fossero costretti a darsi alla fuga. Il legame tra valdesianesimo e repressione era stato colto dagli storici coevi: secondo Castaldo il ciclo di prediche tenute da Ochino a Napoli nella Quaresima del 1539 aveva messo i più accorti sull’avviso che fra le parole del senese potessero celarsi messaggi volti a ribaltare alcuni fondamenti dell’ortodossia115. In quello stesso periodo erano affiorati sospetti anche sul conto di Pier Martire Vermigli che, commentando le epistole paoline in San Pietro ad Aram, aveva messo in dubbio che se ne potesse trarre la certezza dell’esistenza del purgatorio, il che comportò un intervento delle autorità e «gli fu proibita la lezione»116. Fra il 1540 e il 1541, infine, la predicazione di fra’ Giovanni Buzio da Montalcino suscitò reazioni indignate: il predicatore Teofilo Scullica, uomo di fiducia del futuro Paolo IV Gian Pietro Carafa, «disputò» col Montalcino per «molti giorni»117, e lo stesso Toledo, in una lettera del 31 luglio 1541, richiese a Paolo III di emanare un breve «para proceder contra fray Juan de Montalchino, conventual de santo Francisco, sobre ciertos herrores lute71
ranos que aqui ha predicado y leido»118. Ancor prima della morte di Valdés quindi, nonostante la straordinaria prudenza dei valdesiani, le autorità civili e religiose avevano iniziato a subodorare la circolazione di discorsi eterodossi, varando provvedimenti come la proibizione delle lezioni di Vermigli e sollecitando un’inchiesta su Giovanni Buzio. La predicazione ochiniana aveva innescato una larga diffusione di dottrine ereticali in tutti gli strati della società, persino fra i conciatori di pelle, che ne discutevano pubblicamente nella piazza del Mercato: sarebbe stato strano che di tutto ciò nessuno si avvedesse. Probabilmente legata a tali vicende fu anche la sospensione della cattedra di Umanità dello Studio imposta da Toledo nel 1541119, mentre nell’agosto del 1542 le clamorose fughe in terra riformata di Ochino e di Vermigli confermarono i sospetti. Come scriverà Castaldo, proprio allora «uscirno in stampa senza nome dell’autore certi libretti; uno de’ quali fu il Sommario della Scrittura; l’altro il Beneficio di Cristo; con alcune opere di Filippo Melantone e di Erasmo tutti pieni d’empietà e d’eresie. I quali libri [...] pubblicamente si vendevano e leggevano»120. Ancora poco prima dell’istituzione del Sant’Ufficio, del resto, in una lettera al cardinal Gonzaga dell’8 luglio 1542 il suo agente a Roma Nino Sernini lo aveva avvertito che a Roma i maggiori sospetti convergevano su Modena, Lucca e Napoli, dove si «crede che ’l male sia in gli grandi»121. Non c’è da sorprendersi, pertanto, che sin da allora si nutrisse «qualche dubbio delli scritti lassati dal Valdés»122. È molto probabile che tutto ciò contribuisse a far emergere i primi sospetti anche sul conto di Capece, che da pontaniano e amico di Anisio aveva potuto frequentare sia Vermigli sia Valdés, nonché lo stesso Bernardino Ochino. Il 21 luglio del 1542 fu promulgata la bolla Licet ab initio, che rinnovò l’Inquisizione: sebbene in un primo periodo il Sant’Ufficio romano non esercitasse giurisdizione sui territori del Regno di Napoli123, bisogna ricordare che tra i membri della congregazione incaricata di guidare il Sant’Ufficio v’erano il fratello del viceré Juan Álvarez de Toledo, il patrizio napoletano Gian Pietro Carafa e il patrizio cosentino Pier Paolo Parisio: tutti in grado di avere notizie sulla diffusione dell’eterodossia a Napoli e nel Regno. Toledo aveva al suo servizio un esponente dell’ala radicale del movimento valdesiano, Bartolomeo da Messina; con suo fratello don Pedro collaborava Villafranca, e suo nipote Luis, figlio del viceré, era amico di Capece. Carafa, dal canto suo, aveva disseminato la sua Napoli di spie: collabo72
ratori come Scullica e gli stessi teatini, le cui denunce d’eresia avanzate contro Valdés e i suoi discepoli all’indomani della morte dello spagnolo «avevano trovato nel Carafa un ovvio referente»124. Il cardinal Carafa apparteneva poi a una tra le più potenti famiglie del Seggio di Nido – del quale facevano parte anche i Capece –, oltre a esser parente dei Caracciolo, al cui casato apparteneva la moglie di Scipione125. Pier Paolo Parisio, infine, insigne giurista (benché canonista) al pari di Scipione, in quanto parente di Parrasio nonché legato ai Martirano, avrebbe potuto conoscere Capece e in ogni caso avere informazioni riservate su di lui. Il 12 luglio del 1543 da Roma fu emanato un severissimo Edictum contra bibliopolas et librorum impressores atque dohanarum officiales126, seguito dalla prammatica del 15 ottobre del 1544 con la quale don Pedro de Toledo proibì stampa, vendita e possesso dei libri d’argomento religioso, stampati nei precedenti venticinque anni, in mancanza dell’autorizzazione del cappellano maggiore127. Molto probabilmente, però, le pressioni romane sul governo napoletano avevano avuto effetto già da prima. Il 14 febbraio del 1543 infatti, dodici giorni avanti la sostituzione di Capece, lo studente polacco Jan Ma¸czinski aveva scritto da Napoli a un suo corrispondente in Svizzera: «Cognosces ex his litteris quantum interea impiorum saevitia exmeruerit [...]; a Caesaris locum tenente continua sollicitatione obtinuerunt Bernardini de Senis et aliorum rectius de Christo sententium opera non solum legenda prohibere se et igne damnari»128. Contestualmente alla destituzione di Capece, dunque, il viceré aveva già avviato la politica censoria, proibendo le opere di Ochino (e altre ancora) e condannandole ad ardere sul rogo. A quanto pare, in questa strategia ebbe un ruolo di rilievo il predicatore domenicano Ambrogio Salvio da Bagnoli che, secondo il suo biografo Sebastiano Pauli, «tanto adoprossi» affinché i libri di Ochino fossero censurati, da ottenere «che tutti questi ad un fascio si portassero avanti la chiesa madre, ed ivi, dopo aver contro d’essi lungamente e dottamente perorato, si abbrugiassero»129. Tale ricostruzione trova conferma nel racconto di Castaldo, secondo il quale «nel largo che sta dinanzi la porta maggiore dell’arcivescovado [...] furono portate tutte queste opere ed altre che potevano esser sospette, e dopo una bella e cristiana predica ivi fatta dal padre [...] Ambrogio di Bagnoli dell’ordine dei predicatori, furono arse pubblicamente»130. Poiché Castaldo datava il rogo all’indomani della 73
diffusione di alcuni libri eretici tra i quali il Beneficio di Cristo, è probabile che esso avvenisse nel 1543, data di uscita della prima edizione del Beneficio stesso. Tenendo presente poi la lettera di Ma¸czinski, è ipotizzabile che il rogo avvenisse nei primi mesi di quell’anno: in un periodo prossimo alla destituzione di Capece. Nei primi anni Quaranta, insomma, le maglie della rete repressiva cominciavano a restringersi, e tra i primi a restarvi impigliati – al di là delle formule di rito – fu proprio Scipione, che tra i valdesiani rivestiva uno dei ruoli di maggior rilievo negli apparati del governo. Di qui la sua decisione di trasferirsi nel Principato di Salerno131, ospite del potente principe Ferrante Sanseverino e di sua moglie, Isabella Villamarina de Cardona, alla quale sembra che Scipione fosse legato da rapporti parentali132. Qui probabilmente egli avviò un’opera di propaganda eterodossa, poiché proprio negli anni del suo soggiorno salernitano, e precisamente nel 1546, risulta la presenza a Salerno di Ambrogio Salvio da Bagnoli, chiamato dalla principessa a combattere la diffusione di idee eretiche: «La heresia – testimonierà Salvio – era andata avante in detta città, non solo fra gentilhomini, cittadini et artigiani, maschi et femine, ma anco fra alcuni de li canonici de detta cattedrale chiesa di Salerno [...], et insino alle donne dalle finestre parlavano di questa heresia»133. Qualche anno dopo, evidentemente sulla scorta dei ricordi paterni, Torquato Tasso (il cui padre Bernardo era stato segretario del principe Sanseverino e legato a Capece134) nel dialogo Il Gonzaga overo del piacer onesto (1580) avrebbe fatto dire ad Agostino Nifo che era «tolerato Scipione Capece ne la corte di Salerno»: Non dee [l’imperatore] sottoporre i suoi cittadini a gli strazi e a’ tormenti dell’Inquisizione e alla vergogna ancora e all’infamia civile che troppo rigorosamente è loro minacciata: perciò che la falsità dell’opinioni non può ragionevolmente recare infamia, se non quand’ella o è accompagnata da pertinazia, o congiunta a volontà perversa di corrompere e d’infettare altrui. La quale perversità de volontà, perché non si trovava nel Peretto [Pietro Pomponazzi] e nel Porzio, filosofo l’un mantovano e napolitano l’altro, furono negli Studi publici tolerati, tutto che si sapesse publicamente che l’uno e l’altro di loro non più oltre credesse di quel ch’Aristotele avesse creduto. E per la medesima ragione fu o, per dir meglio, è tolerato il signor Scipione Capece nella corte di Salerno, il quale non sol aristotelico d’opinione ma seguace anco d’Alessandro [d’Afrodisia], è per altro virtuosissimo gentiluomo135. 74
È difficile dire se Scipione fosse effettivamente «tolerato», poiché la stessa Villamarina non era aliena da simpatie valdesiane, ed è lecito ipotizzare che proprio per precostituirsi un alibi, mostrandosi timorata di fronte al rumore che agitava la città, la principessa avesse invitato Salvio136. D’altro canto, lo stesso principe Ferrante – al di là della sua successiva adesione al calvinismo in Francia –, già nel 1537 aveva cercato di ottenere che Ochino tenesse una predica a Salerno; e proprio negli anni in cui Scipione viveva alla sua corte, Ferrante s’era posto dubbi di natura religiosa, chiedendo a Girolamo Seripando chiarimenti sulla questione del libero arbitrio137. Non è noto neanche quale preciso ruolo Capece rivestisse nella corte dei Sanseverino, benché sicuramente esercitasse mansioni politiche importanti se non, di fatto, di alter ego del principe nei periodi di reggenza della moglie derivanti dalle sue prolungate assenze138. Certo è in ogni caso che don Ferrante lo attrasse nell’orbita più stretta del suo patronage, mettendolo nelle condizioni di vivere con agio grazie all’ospitalità offertagli e ad alcune rendite (che Scipione cumulò a quelle di cui già godeva)139, dalle quali peraltro emerge la continuità dei rapporti intessuti tra Capece e gli ambienti umanistici e valdesiani negli anni della residenza salernitana: tra gli affittuari di alcuni casali assegnatigli da Sanseverino compaiono sia Simone Porzio sia il «celeberrimus rei medicae doctor» Donato Antonio Altomare140, nei quali si può cogliere quel nesso tra indagine religiosa e indagine scientifica rappresentato al massimo livello da Scipione e che s’è già evocato per l’alchimista ed eretico Cesare Maffei. A Salerno Scipione si dedicò anche alla stampa di alcune opere: nel 1544 rieditò una sinossi di storia delle istituzioni in chiave comparata, il Magistratuum Regni Neapolis qualiter cum antiquis Romanorum conveniant compendiolum, nel quale avanzava tra le righe la tesi secondo cui il Senato romano avesse mantenuto potestà anche in epoca imperiale e che ciò dovesse valere anche per il Regno di Napoli, dove esso era rappresentato dai barones141. Ripubblicò poi nel 1546 una raccolta di Decisiones Sacri regii consilii del padre Antonio e in quello stesso anno uscì per i tipi di Manuzio anche il suo capolavoro, il De principiis rerum142. Nel 1549 Capece poté fare ritorno finalmente a Napoli, ottenendo un terreno confinante con una sua proprietà fuori le mura, dove fece edificare una villa nella quale ritirarsi143. A questo periodo sembra risalire l’incontro di cui avrebbe parlato agli inquisitori Giulio Basalù, mentre traccia di rapporti con 75
altri valdesiani radicali emerge anche dai suoi affari: nel 1549 cedette a Giovan Tommaso Bianco per 3.000 ducati l’entrata annua di 300 ducati di cui godeva sulle «rendite dell’ufficio della misuratura della dogana del sale di Napoli»144. Scipione morì il 9 dicembre 1551145, appena in tempo per non essere coinvolto nei processi inquisitoriali che di lì a breve si aprirono contro i valdesiani (radicali o meno). Tra il 1553 e il 1555 sia Tizzano sia Basalù sia Raffaele da Roccaguglielma ne rivelarono agli inquisitori gli approdi ereticali e il coinvolgimento nelle trame del movimento, sebbene dandone un’immagine incapace di penetrare nelle sfumature che al valdesianesimo aveva dato la sua filosofia naturalistica. 3. Mutamenti marrani: Girolamo Busale e Francesco Renato Posto Capece in disparte dall’esilio, il gruppo raccoltosi attorno a Villafranca dopo la sua scomparsa continuò a riunirsi a Napoli all’incirca per un anno, procedendo nella distruzione dei capisaldi di ogni ortodossia. Le testimonianze raccolte dal Sant’Ufficio dal 1551 al 1555 suggeriscono che si fosse coagulato all’interno dell’ala radicale del movimento valdesiano un vero e proprio sotto-gruppo che, oltre a intensificare la critica religiosa, era giunto a delineare una nuova proposta: i suoi adepti escludevano la natura messianica (e non solo la divinità) del Cristo e bollavano l’intero Nuovo Testamento come un’invenzione. Era la nuova setta di cui parlò Manelfi, costituita dai seguaci delle opinioni diaboliche rivelate da Tizzano. Come si è anticipato, il delatore marchigiano considerò tali sviluppi successivi al concilio celebrato a Venezia nel 1550; ma don Lorenzo – fonte di Manelfi – chiarì come a quelle posizioni i napoletani fossero giunti molto prima, e in particolare tra il 1545 e il 1546, all’indomani della morte di Juan de Villafranca. Le testimonianze concordano anche nell’indicare i protagonisti di quella virata, marrana più che diabolica; e se Tizzano vi giocò un ruolo importante, due sono le personalità che spiccano in quello sviluppo, due calabresi: Francesco Renato e il turbolento Girolamo Busale, che acquisì grande ascendente su alcuni adepti dell’ala radicale, contribuendo a portare il radicalismo valdesiano al di fuori del Regno di Napoli. Le sue vicende sono meglio note grazie agli studi di Aldo Stella, ma da un nuovo spoglio delle fonti e da documenti finora non utilizzati emer76
gono elementi che permettono di comprendere meglio la figura di questo maestro dal caldo temperamento. Girolamo era figlio di Martino Busale (o Busal o de Busal), già luogotenente del tesoriere regio di Calabria Ultra (la Calabria meridionale) nel 1520-22146 e poi titolare di un imprecisato ufficio di natura finanziaria, esercitato sempre nel territorio calabrese147. Busale padre si era poi trasferito a Napoli, impegnandosi nella mercatura e raggiungendo una certa agiatezza148. Tradizionalmente si ritiene che la famiglia avesse radici converse, ma la questione merita un approfondimento. Tra gli indizi che paiono confermare l’ipotesi occorre sottolineare la conoscenza dell’ebraico che le testimonianze riconoscono a Girolamo Busale. Inoltre, fuggito dall’Italia, egli raggiunse dapprima Alessandria d’Egitto – dove i Busale avevano parenti149 – e successivamente Damasco, ove pare finisse i suoi giorni esercitando l’arte sarcitoria150. Un altro indizio, infine, può trarsi da quel monumento all’antitrinitarismo cinquecentesco che fu il De falsa et vera, dove si accenna ai suoi ultimi giorni damasceni e dove Girolamo è definito «calaber sed patre hispano»: doveva trattarsi di «marrani», pertanto, più probabilmente che di «cristiani novelli». A queste tracce, già note, possono aggiungersi dei riferimenti reperibili nell’archivio dell’Inquisizione, che sembrano fornire più di una conferma all’ipotesi delle origini marrane di casa Busale. In un sommario delle cause contro gli imputati di giudaismo nel Regno di Napoli, infatti, risulta tra gli accusati una Porzia Busale: si consideri che questa Porzia fu inquisita quasi sicuramente nei primi anni Cinquanta, allorquando furono indagate (e condannate ad abiurare) le «sorores» di Girolamo Busale; non è da escludere, pertanto, che Porzia fosse proprio una di loro. In ogni caso, è molto probabile che dell’abate Porzia fosse una parente, come sembra dimostrare un riferimento che si trova nello stesso fascicolo inquisitoriale, in un elenco delle famiglie residenti a Napoli sospette di giudaismo: si tratta quasi esclusivamente di famiglie catalane, e tra queste non manca menzione di «casa Busales». Alla luce di tali elementi, sembra assumere anche una luce particolare la stessa condanna comminata a un altro dei fratelli di Girolamo, Prospero, che oltre ad abiurare in forma privata nel 1553, fu costretto a versare una pensione di 50 ducati a tali «Martiale» e suo figlio Alessandro, «olim hebrei»151. Tali indizi danno adito a pochi dubbi, ulteriormente fugati dagli esiti del percorso ereticale di Girolamo, che sarebbe giunto a parlare pubblicamente 77
«in laude della religion hebrea». La presenza di Martino Busale in Calabria, del resto, non va sottovalutata: la regione meridionale fu una delle terre ove maggiormente affluirono gli esuli della diaspora sefardita, che quasi certamente vi condusse anche i Busales dopo il 1492152. E tutto ciò trova piena conferma in un altro documento vaticano, nel quale Martino è ricordato come «laico Caesaraugustano», proveniente cioè dalla città di Zaragoza53. Fors’anche per cancellare ogni traccia delle radici marrane della casa, sia Girolamo sia suo fratello Prospero furono avviati alla carriera ecclesiastica, nell’ordine basiliano. Nel 1529, ancora minorenne154, Girolamo ottenne la commenda dell’abbazia calabrese di Sant’Onofrio, nella diocesi di Mileto, su indicazione del cardinale Andrea de Valle155: un monastero non molto ricco, le cui rendite si aggiravano attorno ai 100 ducati che, peraltro, Busale si era impegnato a garantire al cardinale, almeno in un primo momento156. Il rapporto con quello che appare sin dall’inizio come il suo patrono proseguì su un analogo crinale fino alla morte del cardinale stesso (1534), fondandosi su un legame di scambio in base al quale l’abate cumulava piccoli benefici in qualità di prestanome: un legame che, considerando la minore età di Girolamo al tempo, è lecito supporre che risalisse a rapporti intercorsi fra de Valle e suo padre Martino Busale. Piuttosto chiari sono i passaggi che testimoniano un rapporto di vero e proprio patronage: due anni dopo, sempre grazie al cardinale, l’abate venne in possesso del decanato di una «ecclesia Cotronensis» i cui frutti, parimenti, il cardinale riservò a sé157. Morto quest’ultimo, forte dell’appoggio garantitogli dall’ex segretario del cardinale, Felice Morone, Busale non cessò di cumulare benefici e anzi riuscì a far inserire nel gioco anche suo fratello: nel 1535 cedette a Prospero l’abbazia di Sant’Onofrio158, per ottenere l’anno dopo una pensione annua sulla parrocchia di San Nicola in diocesi di Nicastro159 e, nel 1538, due nuove abbazie poste nella diocesi di Mileto: San Lorenzo d’Arena e San Costantino de Panaìa160. In quello stesso anno Girolamo si recò a Padova per iscriversi all’università, dove frequentò il proprio parente Giulio Basalù, nel quale instillò i primi dubbi religiosi161. Sembra infatti che proprio a Padova l’abate si avviasse lungo i sentieri dell’eterodossia, alla scuola dell’anziano predicatore benedettino don Marco da Cremona, che nell’abbazia di Santa Giustina «leggeva le epistole de san Paolo. Et par che quel padre teneva la giustification per la pura fede et senza 78
opere»162. Infervorato dalle sue prime esperienze ereticali, Girolamo iniziò a cercare di fare proseliti, a cominciare dallo stesso Basalù, che avrebbe riferito che «ogni giorno quest’abbate me diceva alchune cose in questa materia». Si sono viste le conseguenze che il proselitismo di Busale avrebbe avuto sul giovane Giulio, che si fermò fino al 1542 a Padova, mentre l’abate ritornò in patria qualche anno prima163. Nel frattempo, aveva cumulato altre prebende ecclesiastiche se nel 1540 cedeva una parrocchia di cui era titolare localizzata nella baronia di Rocca Angitola164. E certamente in Calabria era nel gennaio 1543 – per sbrigare affari relativi ai suoi benefici –, dove gli indirizzarono una lettera da Napoli il fratello Matteo e il cugino Giulio165. È ignoto se al ritorno da Padova, prima di raggiungere la Calabria, l’abate avesse già intessuto rapporti col movimento valdesiano. Certo è che a contatto con quel mondo erano entrati Matteo Busale e Giulio Basalù, che in quella missiva lo informavano dei loro progressi nel cammino di una nuova fede. Il che sembra confermare quanto ipotizzato da Aldo Stella166, secondo il quale a quel tempo l’abate non era ancora andato oltre l’accettazione della giustificazione per la fede. Il passaggio a un radicalismo sempre più accentuato, dunque, sarebbe avvenuto dopo il suo ritorno a Napoli nella prima metà del 1545: anche nel suo caso frequentando il gruppo animato da Juan de Villafranca. Sebbene non si possa affermare con certezza che fosse stato lo spagnolo il primo a spingere Girolamo più avanti nel suo percorso nell’eterodossia – si può ipotizzare che altri esponenti dell’ala radicale (il fratello e il cugino in primis) avessero avuto tale ruolo – pochi dubbi sussistono sul fatto che fu l’impulso di Villafranca a spingere anche lui in un abisso ereticale sempre più profondo. Come che sia, fra il 1543 e il 1545 Girolamo fu piuttosto impegnato dal disbrigo dei suoi affari nella regione calabrese. Nel 1544 abbandonò la titolarità della Chiesa parrocchiale di Santa Caterina «de Mesimeri», nella diocesi di Reggio Calabria, riservandosi una pensione annua sulle rendite167, e all’inizio dell’anno seguente rinunciò, sempre a favore del fratello Prospero, al decanato crotonese e alle due abbazie ottenute dopo aver lasciato quella di Sant’Onofrio168. A quel punto, quindi, salvo la pensione e forse qualche ulteriore entrata garantitagli dal fratello e dal patrimonio familiare, Girolamo Busale s’era liberato dei benefici ecclesiastici fino ad allora conquistati. Va rettificata pertanto l’immagine secondo cui, ancora all’inizio degli anni Cinquanta, egli disponesse di «grandi» rendite 79
ecclesiali, calcolate attorno ai 1.000 scudi, sebbene il problema consistesse in sé nel fatto che rendite continuasse a percepire169. Meno indebita è la definizione di Busale come abate per il periodo successivo alla metà degli anni Quaranta, benché non fosse più titolare di alcuna abbazia. L’ultimo documento relativo agli anni calabresi risale al maggio del 1545170, sicché è da ritenersi che non più tardi d’allora171 raggiunse Napoli ed entrò in contatto col movimento valdesiano, prendendo parte alle riunioni orientate da Juan de Villafranca172. Ben presto, a quanto pare, conquistò all’interno del gruppo una certa autorevolezza, come testimonierà Basalù includendolo fra coloro che erano considerati «maestri»173. Il contatto con il gruppo radicale, quindi, stimolò Busale a spingersi più in là lungo la strada dell’eterodossia: alla scuola di Villafranca apprese a trarre tutte le «illationi» derivanti dall’accettazione della giustificazione, a dubitare della presenza di Cristo nell’eucaristia, della stessa divinità di Gesù e della verginità di Maria, a credere al sonno delle anime dei giusti e alla morte di quelle dei reprobi, così come a non dare troppo credito alla veridicità delle Sacre Scritture. Passato dal livello moderato a quello radicale, si spinse anch’egli, insomma, fino all’ultimo grado del magistero dell’eretico spagnolo. Tuttavia, non s’arrestò qui il suo tormentato itinerario spirituale: in capo a poco, infatti, e in specie all’indomani della morte di Juan de Villafranca, Girolamo fu tra coloro che aderirono alle opinioni diaboliche di cui parlò Tizzano, escludendo la natura messianica di Gesù e bollando in toto il Nuovo Testamento come apocrifo. Decisivo in tale processo, a parte il portato delle sue origini marrane, fu l’incontro con Francesco Renato: fu proprio quest’ultimo, infatti, che introdusse nel movimento «molte chimere di interpretatione et di ponti de la lingua hebrea»174, nel che Busale potrebbe avere tratto impulso a ritornare alle radici della sua identità familiare e a propendere in modo sempre più accentuato per una religiosità dalle tinte giudaiche. D’altra parte, non è da escludere che anche Renato avesse origini marrane, seppure non vi siano prove che suffraghino l’ipotesi. Francesco Renato, alias Francesco Calabrese o Francesco di Calabria, era un ex predicatore cappuccino nativo di Crotone175. Pressoché certa è la sua identità con un cappuccino dallo stesso nome presente nel 1539-40 in Lombardia, che a seguito di una «calamitosa carestia» fondò a Como «l’Opera della misericordia, [...] accolta di lai80
ci assistiti da tre canonici, che s’incaricavano di raccogliere denaro e di distribuirlo ai poveri». Iniziativa orientata da spirito caritatevole che ebbe un notevole successo: «più di 4.000 pani distribuiti settimanalmente»176. Strettamente legato a Bernardino Ochino, nel capitolo provinciale dei cappuccini milanesi del 1542 Francesco Calabrese fu nominato vicario provinciale e all’indomani della fuga del predicatore intervenne presso il vescovo di Verona, Matteo Giberti, per chiedergli di procurare al senese un salvacondotto papale che lo garantisse dall’arresto. L’intento era quello (improbabile) di riportare Ochino in Italia, e nel rifiutare il progetto non senza imbarazzo Giberti, in una missiva in cui continuava a esprimere affetto verso «il nostro padre» («sempre non solo lo chiamarò ma lo amarò per tale sin tanto che lui medesimo non me lo precida»), avvertiva Francesco che «alcuno di voi non si deve muovere per andare a trovare il padre, essendo in parti suspette», senza celare il timore che «facendo mostra di andar per fare questi uffici li anderete con animo, quando non lo tiriate dalla vostra, di lasciarvi tirar da la sua, e restare ancora voi là»177. Il futuro Renato, dunque, attraverso il predicatore senese era entrato già in contatto col valdesianesimo, e il legame con Ochino spiega anche perché dopo un paio di anni, ignorando i consigli di Giberti e svestito nel frattempo l’abito, Calabrese si fosse recato nei Grigioni178, dove risulta la sua presenza intorno al 1544 insieme con un altro cappuccino «excucullatus», Girolamo Milanese: entrambi «asserebant se celebris illius patris Bernhardini Ochini discipulos»179. Francesco assunse le vesti di pastore della comunità di Vettan e la sua predicazione rivelò ben presto ai suoi «auditores» un eloquio «promptum, doctum, audacem et ingeniosum», entusiasticamente accolto dagli abitanti della comunità, che «quasi oraculum divinitus demissum venerabantur». Egli sosteneva che «infantes non esse baptizandos, donec ad perfectum rationis suae iam confirmatae usum pertingerent». A parte tali inclinazioni anabattistiche, Francesco riteneva che gli eletti fossero esenti dal peccato e che la salvezza discendesse solo dalla grazia di Dio e non dal beneficio di Cristo; infine era convinto che le anime dormissero fino al giorno del giudizio180. Naturalmente un corpus di idee tanto radicali non passò inosservato e Calabrese fu chiamato a difendersi, in una pubblica disputa convocata a Süss, contro un fronte che accomunava cattolici e riformati, concordi nel condannarne le dottrine e nell’imporgli, dopo due giorni di aspro dibattito, l’espulsione dai Grigioni181. 81
Subito dopo il nuovo esilio, fra il 1544 e il 1545, Francesco Calabrese giunse a Napoli182 dove, postosi a servizio di una non precisata «signora vedova» come maestro dei suoi figli183, entrò in contatto con l’ala radicale del movimento valdesiano. Secondo Biagio Marese, quando arrivò a Napoli Renato era già piuttosto avanzato sul percorso dell’eterodossia, «eccetto de divinitate Christi, la qual anchora teneva; ma poi che lui venne in Napoli, me disse che non la teneva più»184: una testimonianza che concorda con le accuse mossegli nei Grigioni, in cui non v’era cenno a posizioni antitrinitarie, benché la sua concezione della salvezza implicasse già di fatto la svalutazione della divinità di Cristo. Francesco Renato impresse nel gruppo radicale un segno profondo delle sue dottrine. Secondo la testimonianza di Tizzano, infatti, fu lui a indurlo a spingersi verso le «diaboliche opinioni», precisando che alcune di quelle idee non erano opera di Villafranca, ma di «misser Francesco Renato, il quale è stato frate de cappuccini; et si ben io ho ditto ne la mia confessione di Padua – rettificherà – che hebbe[ro] origine a tempo di Villafranca spagnolo, melius recordatus dico che in me ha[nno] havuto origine dal ditto misser Francesco, il che è stato per la mia mala memoria et non per altro fine»185. Renato aveva insomma assunto una posizione di preminenza all’interno del gruppo radicale, soprattutto dopo la morte di Villafranca: fu lui a dare la spinta decisiva verso l’accettazione di alcuni cardini del giudaismo, come può vedersi dall’approccio che promosse nella critica delle Scritture186. Nella linea valdesiana sviluppata da Villafranca, infatti, v’era una svalutazione spiritualistica dell’importanza dei testi sacri187, ed egli non mancava di avanzare dubbi sulla veridicità di alcuni passi del Nuovo Testamento. Ma sarebbe difficile vedere in un allievo «intrinseco» di Valdés come Villafranca un assertore della totale falsità dei vangeli, dal momento che l’esule spagnolo fu ben lungi dall’asserire alcunché di simile. È ben probabile, quindi, che fosse proprio Renato a spingere da un’attitudine umanistico-radicale nei confronti delle Scritture (accentuata dallo spiritualismo alumbrado) verso una visione pregna di giudaismo. A giudizio di Renato il Nuovo Testamento era falso e Gesù non era né Dio né il vero messia: «Il nostro signor Iesu Christo non è il vero messia promesso nella lege et nelli profeti, [...] il messia ha da venir et [...] non è venuto», sosteneva il calabrese, con evidente analogia rispetto alla tradizione ebraica. Del resto, a tal riguardo Raffaele da Roccaguglielma aggiunse che secondo la «secta» 82
del Renato «Christo doveva venir un’altra volta a regnar et de poi salvar tutti li hebrei»188, dando il segno della colorazione giudaica di quel millenarismo riscontrato in Girolamo Capece e in Matteo Busale. Così già al tempo di Renato, già tra il 1545 e il 1546, si configurò nell’ala radicale del movimento quell’ulteriore avanzamento che Tizzano avrebbe definito diabolico e Manelfi identificato con la nuova setta. Avanzamento che coinvolse diversi allievi di Juan de Villafranca come Lorenzo Tizzano, Girolamo e Matteo Busale, Matteo d’Aversa, Giovanni Laureto e altri tra i quali Girolamo Capece, Ambrogio da Pozzo e Raffaele da Roccaguglielma. Ricondurre al mero giudaismo le posizioni di Renato e dei suoi compagni, nondimeno, sarebbe un grave errore. Dalla testimonianza di Tizzano e da altre fonti è noto che i «diabolici» mantennero la credenza materialistica nella mortalità delle anime dei reprobi e della resurrezione di quelle degli eletti, opinione tipica del livello radicale delineato da Juan de Villafranca, e certo poco consona alla religione ebraica. Lo stesso Tizzano, inoltre, aggiunse che l’ex cappuccino insegnava che «il nostro signor Iesu Christo è stato tantum profeta come li altri profeti», anche se «have havuto magior spirito et maggior dono di Dio de li altri profeti»: dottrine che sembrano rinviare non tanto al giudaismo quanto alla religione islamica. È nel Corano infatti che Gesù viene presentato come profeta e gli viene assegnata una certa preminenza su altri suoi predecessori: «A Gesù figlio di Maria abbiamo dato prove manifeste e lo abbiamo rafforzato con lo spirito della santità»189, si legge nel testo sacro della tradizione musulmana. Più di profeti quali Abramo o Mosè, Gesù vi è presentato come dotato della santità, del dono di resuscitare i morti e di altri attributi (talora assenti nello stesso Maometto) in grado di testimoniarne la natura di grande profeta. L’intreccio con la tradizione islamica non deve sorprendere, poiché Giulio Basalù confessò di aver letto alcune pagine coraniche e dall’ultimo processo celebrato contro Valentino Gentile risulta che fra le sue carte ne furono ritrovati alcuni estratti190. Il che dimostra la spregiudicata libertà con cui i radicali erano pronti a rivolgersi all’analisi comparata delle religioni, con un atteggiamento aperto e disponibile al confronto che svela, ancora una volta, la tolleranza che allignava nel movimento valdesiano. Calabrese/Renato, dunque, appare come protagonista del radicalismo di matrice valdesiana al pari di Villafranca e di Girolamo Bu83
sale, vero e proprio eresiarca che portò alcuni dei napoletani a oltrepassare le posizioni del maestro spagnolo, dando un decisivo contributo alla configurazione di un sotto-gruppo all’interno del movimento che, di lì a poco, si pose in contatto con l’altra principale realtà del radicalismo italiano di quel tempo: gli anabattisti del Nord-Est. Molti, tra cui Renato, infatti, tra il 1546 e il 1547 abbandonarono Napoli dirigendosi a Venezia, un itinerario collettivo che è difficile considerare casuale e che occorre legare alla repressione degli anni Quaranta. Durante quel viaggio, nondimeno, Calabrese «fu preso per camino», e dal suo arresto in poi se ne persero le tracce191. Fu in tal modo agevolata l’ascesa di Girolamo Busale, l’altro protagonista della svolta marrana, che finì con l’acquisire quel rango di preminenza che ne fece il protagonista di una nuova fase del movimento valdesiano. Non si sa con precisione quando Busale lasciò Napoli per dirigersi prima a Venezia, poi a Piacenza e successivamente a Padova. Sicuramente ciò avvenne non dopo il giugno del 1548 e, considerando che nel passaggio da Napoli a Venezia Girolamo incontrò Lelio Sozzini, si può retrodatare la sua partenza almeno al 1547, quando Lelio abbandonò l’Italia per la prima volta192. Sulla base della testimonianza di Bruno Busale, Aldo Stella ha supposto che Girolamo partisse nel 1546, poiché quando egli ritornò a Napoli in compagnia di Laureto, nel 1551, l’ex abate avrebbe detto al fratello «che ’l voleva andar a Napoli a visitar la madre, che era cinque anni che non l’havea veduta»193. Ciò non permette di datare con certezza al 1546 la partenza, che sarebbe potuta avvenire fra quell’anno e i primi mesi del seguente. In ogni caso, nel giugno del 1548 egli era a Venezia, dove incontrò – insieme con Basalù – l’abate Villamarina, che li redarguì nel tentativo di riportarli sulle sponde del cattolicesimo194. Ma invano, e anzi Busale e Basalù se ne fecero beffe, mangiando un «salsiccione il dì de venerdì o de sabato» ed esortando Villamarina e il sacerdote Antonio Dell’Olio che lo accompagnava a «magnarne; et loro recusando, cioè il detto prete et messer Marc’Antonio, quelli dissero: ‘Anchor state in superstitione papistica?’»195. Dopo «doi o tre mesi», come avrebbe rivelato Laureto, Girolamo lasciò Venezia per ritornare a Padova, «ma li venne occasione et andò a Piacenza a servir la signora donna Isabella Brisegna et suo marito»196. Fu intorno all’autunno del 1548, dunque, che egli fu assunto come segretario a Piacenza, dove orchestrò il passaggio di 84
Laureto dal luteranesimo all’antitrinitarismo e poi a quegli ulteriori approdi che spiegano la successiva conversione di Giovanni all’ebraismo197. Già alla data del soggiorno piacentino Busale mostrava d’essere andato molto innanzi nello studio della lingua ebraica, oltre che del greco, e nel suo proselitismo rivelava un entusiasmo ancor più intenso di quello dei tempi della conversione di Giulio Basalù. Era ormai pervaso da un’ansia che ne faceva un caso limite all’interno del movimento valdesiano: «Costui è stato un gran diavolo et gran temerario – avrebbe confessato Basalù –, perché inquietava ognuno con chi praticava et lui solo di quanti ho cognossuto disputava de le sue opinione, et si persuadeva che ognuno si acquietassi a le sue ragioni»198. All’inizio del 1550 Girolamo ritornò poi a Padova199: secondo Laureto per «studiar philosophia»200, per il fratello Bruno «non per causa di studio ma per spasso»201. In realtà, quello spostamento preparava un momento capitale nella storia del radicalismo religioso. In capo a poco infatti, raggiunto anche da Laureto, Busale entrò in contatto con alcuni anabattisti veneti, e in specie con Benedetto dal Borgo e Nicola d’Alessandria: «Ci scoprirno la loro doctrina anabatistica – avrebbe confessato Laureto – et fecero sì che ci persuasero a ribaptizarsi, havendone insegnato che il baptesmo del papa non valea. Et così il ditto Benedeto rebaptizò me, et quel Nicola rebaptizò l’abbate»202. Erano i primi passi di quegli incontri tra veneti e napoletani sui quali l’ex chierico cavese era stato reticente nei suoi costituti, e sui quali è giunto il momento di fare chiarezza.
Capitolo III
Anabattismo e antitrinitarismo
1. Tradizione e storia È ignoto il momento esatto in cui, nei primi mesi del 1550, i napoletani guidati da Girolamo Busale entrarono in contatto con gli anabattisti del Nord-Est, dando avvio a un tentativo di compenetrazione tra forme diverse di radicalismo. Grosso modo in questa fase, secondo un’antica tradizione, si sarebbero tenuti i cosiddetti collegia vicentina, riunioni di antitrinitari a cui avrebbero preso parte, oltre a Busale stesso, alcuni dei protagonisti del radicalismo religioso italiano del Cinquecento, da Lelio Sozzini a Bernardino Ochino, da Valentino Gentile a Niccolò Paruta. Ancora oggi, tuttavia, non v’è certezza sullo svolgimento di tali incontri, nei quali si è indicata la nascita di un fenomeno europeo come l’antitrinitarismo sociniano. Prima di procedere sulle vicende di Busale e nel ricostruire l’incontro tra valdesiani e anabattisti, dunque, è necessario soffermarsi su quella tradizione per vagliarne la veridicità, cercando al contempo di capire se ci fossero collegamenti tra i supposti collegia e gli intrecci tra veneti e napoletani. Le riunioni vicentine sono datate dagli storici a un periodo antecedente il 1550: il loro svolgimento è abitualmente collocato nel 1546. Di tali assemblee si venne a conoscenza grazie a tre esponenti della storiografia secentesca d’ispirazione sociniana: Andrzej Wiszowaty, Christopher Sand e Stanisław Lubieniecki, che tramandarono senza dubbio una tradizione orale ricevuta dai loro maggiori. 86
A parte le fonti orali, tutti e tre facevano riferimento ad alcuni manoscritti – risalenti al tardo Cinquecento – di Stanisław Budzyn´ski, che si voleva avesse conosciuto Lelio Sozzini di persona. Di tali opere non c’è da tempo alcuna traccia, ma sembra da escludere che i sociniani inventassero di sana pianta una notizia di tale rilevanza, tesa a risalire alle origini più antiche dell’antitrinitarismo moderno e, dunque, del credo religioso dei sociniani stessi. Certo, è probabile che col tempo la memoria degli eventi si fosse alterata, che nei racconti orali si fossero sovrapposte confusioni quando non invenzioni, contribuendo alla rarefazione di un grumo di verità che doveva pur sussistere: in fondo non si trattava di notizie tramandate lungo un arco plurisecolare. Wiszowaty nacque nel 1608, Lubieniecki nel 1623, Sand nel 1644. Dai propri maggiori avevano potuto, quindi, ascoltare racconti che dagli eventi non erano così tanto distanti. Wiszowaty del resto era figlio di Agnese Sozzini, e cioè dell’unica figlia avuta da Fausto che, pur non essendo tra i supposti partecipanti agli incontri vicentini, era stato in stretto contatto con molti di coloro che potevano avervi preso parte: lo zio Lelio Sozzini in primo luogo. In merito a quanto i sociniani avevano narrato non mancarono polemiche e incertezze, animate per lo più da premesse apologetiche, fondate su basi ancora più malcerte di quelle da cui avevano tratto il loro racconto i sociniani stessi. Solo a partire dall’Ottocento alla vicenda dei collegia si dedicò attenzione con l’ausilio di fonti d’archivio, sebbene a muovere gli autori di quelle pionieristiche ricerche permanesse una sottile vena apologetica. Esemplari furono gli studi del pastore svizzero Friedrich Trechsel1 e dell’abate italiano Bernardo Morsolin2. Il primo dedicò ampio spazio alla questione dei collegia nella sua opera sul socinianesimo, ma non portò alla luce documentazione tale da confermare la versione accreditata dalla tradizione, salvo un riferimento reperito in Castellion a una più tarda (seppur fondamentale) lettera ai vicentini fratres dell’antitrinitario piemontese Matteo Gribaldi Mofa, limitandosi per il resto alla critica delle fonti letterarie sei-settecentesche. Più approfondito e per la prima volta fondato su fonti inquisitoriali fu, invece, lo studio condotto dall’abate Morsolin: ancora oggi la sintesi più vasta dedicata all’argomento. Morsolin avanzò drastici dubbi sulla tradizione dei collegia. Un primo spoglio della documentazione veneta gli rivelò che, nel 154647, non esisteva traccia a Vicenza della diffusione di eresie parago87
nabili a quella sociniana, mentre non mancavano notizie sulla circolazione di idee di ispirazione riformata, il che lo indusse a ritenere che il racconto degli «storici degli antitrinitari si debba ripor tra le favole»3. Allo stesso tempo, l’abate cercò di porre il problema da un’altra angolazione: «Ben diversa si presenta la cosa a chi n’accoglie nudo e spoglio, se così si può dire, d’ogni ornamento il racconto»4, affermò, osservando che «alle conventicole [riformate] inauguratesi in Vicenza nel 1546 [...], fecero seguito quelle di una setta che, pur professando gli errori di diversi eresiarchi, si chiamava degli anabattisti». Considerando il livello delle conoscenze storiche del tempo (non si aveva neanche notizia dei costituti di Manelfi), Morsolin non poteva sapere di essere arrivato a un passo dalla risoluzione dell’enigma, e infatti se ne allontanò immediatamente, inanellando una serie di clamorosi errori, sebbene poi la documentazione utilizzata lo mettesse nelle condizioni di inserire, in una trama errata, l’ordito che serbava consistenza al tessuto della narrazione. Riaffioravano dall’oblio, pur confusi da sviste e abbagli, nomi e circostanze tali da disegnare una prima mappa del dissenso radicale del NordEst. Né Morsolin mancò di notare intrecci con gli antitrinitari napoletani, sottolineando come alcuni ponti potessero gettarsi tra la sua indagine e quanto tramandato dalla tradizione sociniana. Nonostante gli errori e le molte imprecisioni, dunque, la ricerca di Morsolin lasciò emergere tracce decisive, suggerendo anche una pista da seguire per svelare il mistero delle adunanze vicentine. Ma le tracce rimasero sepolte tra i fascicoli inquisitoriali, e neanche la pubblicazione dei costituti di Manelfi stimolò ulteriori approfondimenti della spinosa questione. A riprendere in mano i documenti segnalati dall’abate fu, quasi un secolo dopo, Aldo Stella, nel primo dei suoi fondamentali studi sull’anabattismo veneto5, nel quale tuttavia affrontò l’enigma dei collegia su fragili basi, lasciandolo irrisolto, come egli stesso avrebbe poi riconosciuto, e sottolineando che «questa tradizione dei collegia vicentina non appare suffragata dalle fonti storiche coeve»6. Non è pertanto un caso che a quella tradizione non dedicassero alcun cenno né Ginzburg, nella sua edizione dei costituti di Manelfi, né Gastaldi, nella sua Storia dell’anabattismo, mentre credito prudente alla tradizione hanno dato Firpo e Rotondò, senza però affrontare analiticamente una questione che in questa sede non può essere elusa. Occorre allora ripartire dai testi che della celebrazione dei col88
legia tramandarono notizia, risalendo alla tradizione sociniana, la cui testimonianza più antica è nella Narratio compendiosa, quomodo in Polonia a trinitariis reformatis separati sint christiani unitarii di Andrzej Wiszowaty, edita in appendice alla Bibliotheca anti-trinitariorum di Christopher Sand. La ricostruzione ripercorreva la genealogia delle fonti antiche dell’antitrinitarismo, per giungere poi alla protesta di Lutero, Zwingli, Calvino, Menno Simons7 e passare alle autentiche scaturigini dell’antitrinitarismo moderno: «Circiter annum à Christo nato 1546 – scriveva –, in Italiae ditione Veneta, apud Vincentiam [sic!], de religionis negotio colloquia atque collegia sunt inchoata a sociis fere 40, qui receptam de Deo trino opinionem in dubium revocarunt»8. Wiszowaty aggiunse che due tra i partecipanti ai collegia erano caduti nelle maglie dell’Inquisizione e condannati a morte, mentre altri erano stati costretti a darsi alla fuga per evitare una sorte analoga9. Subito dopo si soffermò su quello che definì il «praecipuus» dei convenuti a quei supposti colloquia atque collegia: il proprio avo Lelio Sozzini, che lo stesso nipote Fausto (suo nonno) aveva posto all’origine dell’antitrinitarismo sociniano. Da Lelio prese le mosse anche la Bibliotheca anti-trinitariorum di Christopher Sand, che nella voce dedicatagli così lo presentò: Laelius Socinus Italus, Senensis patricius, Mariani Socini iunioris filius. Natus anno 1525. Circa annum 1546 instituerat cum sociis suis itidem Italis, quorum numerus quadragenarium excedebat, in Veneta ditione, collegia colloquiaque de religione, in quibus potissimum dogmata vulgaria de trinitate ac Christi satisfactione hisque similia in dubium revocabant. Memorantur autem in hac societate fuisse Leonardus abbas Busalis [...], Laelius Socinus, Bernardinus Ochinus, Nicolaus Paruta, Valentinus Gentilis, Iulius Trevisanus, Franciscus de Ruego, Iacobus de Chiari, Franciscus Niger, Darius Socinus, Paulus Alciatus etc. Hac re palam facta, gravi obruti sunt persecutione et quibusdam capitis supplicio affectis, caeteri dispersi vitam praesentissimo periculo subducentes patriam excessere, ac in diversas oras se contulere10.
Secondo questa ricostruzione, intorno al 1546 non solo Lelio, ma anche altri protagonisti dell’eresia italiana ed europea, in numero di circa quaranta, sarebbero convenuti in territorio veneto dando vita a colloqui di religione, nei quali avrebbero messo in dubbio il dogma trinitario e si sarebbero interrogati sul valore della passione di 89
Gesù. Fin qui Sand ripeteva quanto già detto da Wiszowaty; ma aggiunse dettagli importanti, e ricordò ulteriori partecipanti rispetto a quelli evocati da quest’ultimo: Bernardino Ochino, Valentino Gentile, Giampaolo Alciati, Niccolò Paruta e altri ancora. Vale la pena di rilevare come in questo passo Sand non facesse riferimento a Vicenza, ripetendo pressoché alla lettera la formula usata da Wiszowaty («Veneta ditione»). Ma più avanti nel testo, nella voce dedicata a Niccolò Paruta, specificò come questi fosse stato «inter eos qui circa annum 1546 in agro Veneto, prope Vincentiam, congregationes de rebus sacris habebant». L’ultimo a tramandare la tradizione ai secoli seguenti fu Stanisław Lubieniecki, che nell’Historia Reformationis Polonicae si distese più a lungo dei suoi predecessori sull’argomento dei collegia, ma ancora una volta al fine di esaltare il contributo di Lelio Sozzini. Lubieniecki evidenziò come la via per la verità fosse stata indicata ai suoi compatrioti polacchi «non tantum» dalla Riforma della «vicina Germania», ma soprattutto dall’Italia: «Ex Italia quidem praestantium ingeniorum officina [...] merito veritatis caelestis arma apud se conflata ad nos misit»11. Qui inseriva il discorso sui colloqui vicentini, della cui conoscenza si dichiarava debitore dei manoscritti di Stanisław Budzyn´ski. Dopo essersi soffermato sugli aspetti dottrinali dei collegia, Lubieniecki elencò i partecipanti a quei dibattiti avvolti da un’aura leggendaria: Erat ex hac pia societate abbas quidam Bucali [sic!] dictus qui arcanis suis collegiis et studiis evulgatis, in praesentissimo cum versarentur [sic!] discrimine salutis, una cum aliis 40 viris fuga se eripuit, et quam [sic!] christianus inter christianos habere non poterat, apud Turcas quaesivit et invenit salutem. Thessalonicam isti concesserant, exceptis tribus, Iulio Trevisano, Franco de Ruego et Iacopo de Chiar, quorum illi duo Venetiis suffocati, tertius iste morte naturali obiit. Et abbas quidem Damasci vitam finivit. Qui vero ad Turcas se non contulerunt, silentio tempestivo tecti, nec tamen satis in patria tuti, in Helvetia, Moravia, tandem et in nostra Polonia refugium invenerunt. Inter hos Laelius Socinus senensis fuit12.
Riportate le menzioni più antiche rintracciabili sui collegia vicentina, è opportuno soffermarsi su di esse con acribia maggiore, muovendo dal problema della data della loro presunta celebrazione, tradizionalmente individuata nel 1546 o al massimo nel 1547, quando 90
Lelio Sozzini partì per il suo primo viaggio in Europa. Ma a ben vedere: quel 1546 (o al più 1547) era una data precisamente indicata dai sociniani? Wiszowaty scrisse «circiter annum a Christo nato 1546», così come fecero sia Sand («circa annum 1546») sia Lubieniecki («circa annum 1546»). Tutti e tre gli storici, dunque, fecero precedere l’indicazione di quella data per loro essenziale da un prudente e vago «circa». Ora, potrebbero addursi decine di esempi nei quali gli stessi autori – spinti anche dall’esigenza di disporre degli annali della propria evoluzione dottrinale – datarono gli eventi in modo magari errato ma molto puntuale, con riferimenti precisi ad anni se non a mesi e giorni. Perché tanta prudenza, quindi, nel caso di un evento periodizzante come i collegia, se non perché c’era piena coscienza che sulla data della loro celebrazione non vi erano certezze? Evidentemente i sociniani non si sentirono in grado di definire con precisione la data di quegli incontri, deducendola probabilmente da quel 1547 che costituiva ai loro occhi (salvo negare la partecipazione di Lelio Sozzini) l’imprescindibile terminus ad quem. Si tratta, pertanto, di un caso di cristallizzazione storiografica di una notizia fornita dalle fonti in maniera più sfumata. Solo successivamente, tra Sette e Ottocento, soprattutto a seguito della Historia antitrinitariorum di Friedrich Bock13, la data del 1546 divenne canonica e a nessuno venne in mente che potesse essere soltanto indicativa. Se non era il 1546, allora, quando si sarebbero potuti tenere (se si tennero) quei mitici colloqui? Non v’è dubbio che il terminus a quo sia posteriore al 1546 stesso, in considerazione della sicura presenza ai collegia di Girolamo Busale, ancora a Napoli negli anni precedenti; mentre il terminus ad quem non sembra possa porsi dopo il concilio di Venezia del 1550. Definita questa prima e ancora troppo ampia cornice cronologica, occorre rileggere i testi della tradizione sociniana anche per verificare se quelle riunioni si fossero tenute solo a Vicenza. In realtà, come per la datazione, anche per la localizzazione gli studi cristallizzarono una notizia nient’affatto certa. Wiszowaty scrisse infatti che gli incontri si erano tenuti in «ditione Veneta, apud Vincentiam»; Sand parlò dapprima di «Veneta ditione», per specificare poi «prope Vincentiam»; Lubieniecki, infine, affermò che gli incontri avevano avuto luogo «in agro Veneto, Vicentiae et in aliis urbibus». Risalta qui una prima incongruenza fra le tre versioni: sia Wiszowaty sia Sand parlavano di territorio veneto e specificavano che gli incontri erano 91
avvenuti nei pressi di Vicenza, mentre Lubieniecki parlava pure di Vicenza, ma aggiungeva che si erano svolti anche in altre città. Sembra pertanto assodato che Vicenza (o il suo contado) fosse stata teatro di un episodio importante nelle vicende del radicalismo religioso; ma dalla ricostruzione elaborata dai sociniani pare anche sia lecito ipotizzare che ulteriori località fossero state sedi di simili confronti dottrinali. Messo in dubbio il quando e il dove, mostrato come le fonti non indicassero, in modo netto, Vicenza 1546, resta da verificare il cosa: si trattava proprio di collegia? In effetti, in un primo momento Morsolin insistette sul termine «accademia», per rifiutarlo però senz’altro, ritenendolo troppo impegnativo; Cantimori, al contrario, pensò di puntare proprio sul termine «accademia», utile in quanto da lui considerato poco impegnativo. Solo in seguito divenne prevalente il riferimento al termine collegia, che rinvia a incontri alquanto strutturati. Anche su ciò è dunque necessario risalire alle fonti sociniane: Wiszowaty li definì «de religionis negotio colloquia atque collegia»; Sand «collegia colloquiaque de religione» e poi «congregationes de rebus sacris»; Lubieniecki «collegia et colloquia pia», parlando poi di «societate». La definizione di collegia, quindi, scaturiva dagli stessi sociniani. Non è necessaria un’approfondita indagine di semantica storica per vedere come col termine colloquia ci si riferisse a qualcosa di non strutturato, mentre congregationes e societates paiono evocare qualcosa di più stabile, così come collegia. Per quanto riguarda in particolare l’ultimo vocabolo, si può ricordare come nell’antica Roma vi fossero i collegi dei pretori, i collegi dei tribuni, i collegi degli aruspici ecc.; e interessante è l’uso del termine fatto da Cicerone (Sext. 14), che considerò sinonimi collegium, societas e concilium. Andando all’epoca moderna, invece, è sufficiente evocare il collegio cardinalizio, il Sacro collegio. Vale la pena di evidenziare, ad ogni modo, come i sociniani utilizzassero in tutti i casi due termini in particolare, colloquia e collegia, ponendoli l’uno accanto all’altro, separati da una congiunzione e in un caso pure da una virgola, quasi a voler indicare due cose distinte, collegate ma pur sempre distinte. Di qualche interesse può essere infine il fatto che i termini fossero declinati al plurale, il che pare suggerire che i tre storici non intendessero indicare un unico evento ma incontri diversi, più o meno formalizzati e più o meno coevi. 92
Rilevato che le fonti attestano una localizzazione, una cronologia e una descrizione dei fenomeni ben più vaghe di quanto gli storici abbiano fin qui riconosciuto, resta da porsi un altro quesito, riguardo la celebrazione a Venezia, nel settembre del 1550, del concilio che segnò il passaggio di molti radicali dall’anabattismo a posizioni antitrinitarie. Tale evento solleva la questione, ovvia ma finora elusa, del perché la tradizione sociniana trasmettesse la memoria di riunioni più ristrette (tenute a Vicenza e in altri luoghi) e non del concilio generale veneziano. Se il problema dei sociniani era quello di porre una data di inizio al loro movimento, alle scaturigini italiane dell’antitrinitarismo, perché non riferirsi alla più vasta e rappresentativa assemblea che i radicali italiani tennero in quegli anni e che segnò il primo trionfo delle tesi antitrinitarie? Possibile che se ne fosse persa la memoria, a differenza degli incontri vicentini? Certo, ciò sarebbe potuto derivare dalla tendenza a sopravvalutare l’importanza di Lelio Sozzini, che nessuna fonte indica come presente al concilio veneziano. La questione nondimeno resta in piedi, e per dipanarla è necessario soffermarsi ancora una volta sui costituti di Pietro Manelfi. Fu lui a rivelare la celebrazione a Venezia, nel settembre14 del 1550, di un concilio generale di radicali italiani, alcuni dei quali già in esilio: Et così dell’anno 1550 del mese di settembre si ritrovorno sessanta fra ministri et vescovi de anabattisti in Venetia a concilio, ove per quaranta giorni digiunando, orando et studiando le Scritture sacre, determinassemo così questi articoli: 1. Cristo non essere Dio ma huomo concetto del seme di Ioseph et di Maria, ma ripieno di tutte le virtù di Dio15.
Seguivano altri nove punti di non minore radicalità, che offrono un quadro delle acquisizioni dottrinali del concilio e su cui gli studiosi si sono concentrati, salvo soffermarsi su altri dettagli come la supposta partecipazione al consesso di Curione, che pochi mesi prima (in maggio) aveva licenziato le Cento e dieci divine considerazioni di Juan de Valdés: un testo – è bene ricordarlo – che circolava negli ambienti radicali del Nord-Est. La riscoperta della testimonianza manelfiana a fine Ottocento causò sconcerto tra gli storici, inducendoli a privilegiare il passo poco sopra riporta93
to, che rivelò la celebrazione del concilio, e quello immediatamente successivo, che ne elencava gli sconvolgenti approdi dottrinali. Poca importanza, invece, si diede al passo che precede di qualche riga la notizia del concilio stesso, nel quale si parla del motivo per cui l’assemblea fu convocata. Eppure, in quel passo all’apparenza secondario c’è una traccia, una vera e propria pista rivelatrice16, poiché esso sembra alludere con chiarezza proprio ai collegia vicentina. Parlando della sua conversione all’anabattismo, Manelfi spiegò: Stetti alquanti mesi che non volsi credere questa dottrina [anabattistica]; ma dopoi, venendo in Ferrara, trovai un messer Giuseppe da Vicenza [...], dal quale anco mi fu parlato di questa dottrina; et finalmente, convinto da lui con molti lochi della Scrittura, accettai tal dottrina et mi feci ribattizare da Titiano con quattro altri compagni, tra quali era un frate del carme detto fra Francesco da Lugo. Di là andai a Vicenza con gli altri compagni, ove in una congregatione venemmo a quel passo del Deuteronomio ove Dio dice: «Prophetam suscitabo de fratibus tuis, et ponam verba mea in ore ipsius etc. tamquam me ipsum audite», et fussemo in differentia fra noi se Cristo fosse Dio o huomo. Et per risolvere questo dubio concludessemo che si chiamasse tutti gli ministri delle congregationi de lochi a Venetia a concilio17.
Secondo questa ricostruzione, dunque, poco prima della celebrazione del concilio di Venezia c’era stata una «congregatione» a Vicenza, durante la quale s’era manifestato un dissidio aperto che aveva spaccato la setta anabattista, al punto da suggerire la convocazione di un autentico concilio. Oggetto del contendere era stata la questione della divinità di Cristo, e il passo biblico sul quale si scatenò il conflitto campeggiava nel De trinitatis erroribus di Miguel Servet18. Al di là di questo non secondario aspetto, ciò che qui importa sottolineare è che, secondo Manelfi, a Vicenza si tenne una «congregatione» nella quale si discusse della divinità di Cristo negata da alcuni dei partecipanti. Indubbiamente, luogo (Vicenza) e tema (natura di Cristo) erano sovrapponibili alla tradizione sociniana ridotta al suo scheletro essenziale. Pertanto, se si dà il dovuto peso a questa circostanza affiancandola alla rivisitazione del mito dei collegia vicentina, la ricchissima documentazione veneziana consente di ricostruire quegli eventi sospesi in un limbo di incertezza. 94
2. Nuova luce sui «collegia vicentina» (e «patavina») Per ricomporre le trame di quegli avvenimenti è necessario tornare sulle orme di Girolamo Busale. Tra la fine del 1549 e l’inizio dell’anno seguente egli era tornato a Padova – dove aveva preso casa «in el borgo de Vignali»19 –, raggiunto poco dopo da Laureto. I due erano entrati in contatto con Benedetto dal Borgo e Nicola d’Alessandria, che si erano rivelati loro come anabattisti, convincendoli a farsi ribattezzare. Quella partita a quattro svelata da Laureto – lo si è anticipato – celava qualcosa di molto più complesso: egli stesso avrebbe confessato che al gruppo s’erano aggiunti altri «compagni», coi quali avevano «pigliata una casa a Santa Catherina»20. Inoltre, dal Borgo e d’Alessandria non erano due qualsiasi eterodossi, bensì due dei principali esponenti dell’anabattismo del Nord-Est. Trevigiano, «messer Nicola de Alessandria» fu definito da Manelfi come il «capo di tutta la compagnia d’anabattisti in Italia», «quale hora habita in Padova però sempre in qua e in là andando, conferma gli heretici nella loro perfidia, laonde se fosse rovinato costui con Titiano et Marc’Antonio [del Bon] d’Asola, sarebbe rovinata tutta la perversa compagnia degli anabattisti, perché costoro sono i capi»21. Manelfi esagerava nel definirlo il «capo di tutta la compagnia d’anabattisti in Italia», e infatti subito dopo correggeva il tiro accomunandolo a due altri personaggi. D’altra parte, al tempo delle sue rivelazioni dal Borgo era uscito di scena da diversi mesi, e le fila del radicalismo andavano scompaginandosi tra fughe e pentimenti. Di conseguenza, non è da escludere che nell’ottobre 1551 – quando Manelfi si presentò agli inquisitori – i tre nomi indicati fossero al vertice dell’organizzazione anabattistica. Il delatore non sbagliava poi nel sottolineare l’importanza di quel ricco mercante trevigiano, che anche in virtù delle sue sostanze (oltre che del suo proselitismo appassionato) si trovava in una posizione di preminenza in un mondo segnato, salvo rare eccezioni, da un modesto livello economico e sociale. La sua generosità fu essenziale nella strutturazione delle sette radicali del Nord-Est: occorrevano denari per finanziare i viaggi di chi era dedito al proselitismo, per aiutare i fratelli più poveri, per procurarsi i libri proibiti, per affittare le case da destinare agli incontri clandestini. Non a caso lo stesso Manelfi dichiarò che «messer Nicola d’Alessandria [...] soccorre con denari quasi tutte le Chiese anabattiste dove bisogna», come avrebbero confermato altre te95
stimonianze, fornendo ulteriori dettagli sulla sua munificenza. Il trevigiano fu tra i primi a esser guadagnato alla causa da chi pare avesse introdotto l’anabattismo nei territori del Nord-Est: quel Tiziano evocato da Manelfi fra i tre «capi» della setta. E tra i primi convertiti c’era l’altro interlocutore di Busale e di Laureto, Benedetto dal Borgo22, anch’egli discretamente facoltoso e notaio in Asolo, dove già intorno al 1545-46 aveva orchestrato la conversione di molti compaesani, tra cui Paolo Beltramin23 e i colleghi notai Giuseppe Sartori24 e Marcantonio del Bon (il terzo dei capi ricordati da Manelfi)25, che avrebbero pure avuto in seguito un ruolo capitale nella strutturazione dell’anabattismo. Nel marzo del 1547 (ma le indagini risalivano all’anno precedente) dal Borgo era stato inquisito insieme con altri asolani e dal processo era emersa la sua alacre opera di proselitismo. Messer Benedetto e i suoi seguaci negavano il valore sacramentale dell’eucaristia («la si fa in commemoratione di Christo»), che gli uomini avessero il libero arbitrio, che esistesse il purgatorio e che ci si dovesse confessare al sacerdote. Nessun valore riconoscevano ai digiuni, alle messe né alle preghiere ai santi. Rifiutavano inoltre la potestà pontificia, «dicendo che ’l papa meritava esser coronato da turcho et non con mitria»; escludevano il culto delle immagini e ritenevano che sacerdoti e vescovi potessero prender moglie («saria meglio una moglier che tener puttane»), il tutto condito da una carica predestinazionistica che sembrava avvicinarli alla dottrina calvinista26. Inizialmente dal Borgo e compagni non si erano spinti fino all’anabattismo: gli unici indizi in tal senso potrebbero trovarsi nella svalutazione del valore dell’acqua benedetta, poiché alcuni – tra cui il medesimo dal Borgo – ritenevano che il battesimo si potesse impartire anche con «l’acqua delli fossati»27. In ciò, tuttavia, non emergevano critiche al battesimo in quanto sacramento, e a ben vedere era solo un modo greve d’esprimere un’ispirazione riformata, tendente a eliminare le sovrastrutture superstiziose da un rito cristiano che si voleva rendere più puro. Tra i pochissimi libri la cui lettura emerse dal processo del 1547 c’erano – oltre alla Bibbia28 – il Beneficio di Cristo e la Tragedia del libero arbitrio di Francesco Negri, testi che non permettono di dimostrare una posizione tendente all’anabattismo, per quanto diffusi anche negli ambienti radicali. Ad ogni modo, pare che il gruppo sacramentario asolano fosse piuttosto nutrito: Antonio dal Borgo, fratello di Benedetto, lo avrebbe quantifica96
to tra le 180 e le 190 persone, aggiungendo con enfasi: «Et ogni zorno andiamo crescendo»29. Dal Borgo probabilmente esagerava, ma è certo che la diffusione delle idee sacramentarie in paese era capillare: un teste informato dei fatti avrebbe affermato che di eretici ad Asolo ce n’era «una mastellata»30. Scomunicato e condannato al bando, il notaio dal Borgo non aveva tardato a riaffacciarsi nel suo villaggio31, e a partire dall’autunno del 1549 iniziò a dare un altro colore alla sua ansia di proselitismo, spingendola decisamente in chiave radicale. Anche nel suo caso la conversione avvenne a seguito dell’arrivo nella comunità di «un angelo di Alemagna, el qual diceva cose grande»32: ancora una volta il misterioso Tiziano, «uno con la barba granda»33, che si profila quale cifra decisiva della svolta anabattistica del Veneto. Al pari di Juan de Villafranca e di altri leader dell’eterodossia più radicale, anche Tiziano è avvolto da una fitta caligine, seppure il suo fantasma aleggi costantemente sull’evoluzione dell’anabattismo del Nord-Est e molte fonti concordino nel descriverlo come uno dei più autorevoli (se non il più autorevole) tra gli esponenti della setta anabattistica34. Pietro Manelfi, che ne fu ribattezzato, testimoniò che «per quanto io so, lui portò questa dottrina anabattista in Italia»35. E sebbene spesso l’ex sacerdote confondesse la realtà (volontariamente o meno), altre fonti attendibili confermarono quanto aveva sostenuto. Il fratello minore di Girolamo Busale, Bruno, assicurò un paio di mesi dopo che Tiziano stesso (da cui pure fu ribattezzato) «diceva che havea hauta l’authorità d’Alemagna»36. Il veneziano Alvise de’ Colti, molto addentro a quelle vicende, confermò il giorno seguente agli inquisitori che «Ticiano fo il primo che portò d’Alemagna questa cosa [l’anabattismo]»37. Il vicentino Giuseppe Cingano, anch’egli tra i principali anabattisti, ribadì qualche giorno appresso che «uno Ticiano» aveva «portato questo diavolo de heresia de ribatizar da Alemagna in queste bande»38. Versione ulteriormente ripetuta dall’autorevole del Bon due mesi dopo: «Ticiano [...] credo che sia stato prima origene di questa cosa, cioè di questa setta»39. È molto probabile che con «Alemagna» debba intendersi qualche territorio svizzero, secondo un uso allora diffuso; ciò sembra dimostrato da una lettera inviata il 7 agosto del 1549 a Heinrich Bullinger dal pastore di Chiavenna Agostino Mainardi, che avvertiva il capo della Chiesa zurighese dell’espulsione dai Grigioni per anabattismo di un certo «Titianus», amico dell’eresiarca Camillo Renato40. Considerando l’i97
dentità del nome e l’analogia delle idee sostenute dai due personaggi, ma soprattutto osservando la concordanza dei tempi tra l’espulsione di questo Tiziano e l’avvio della predicazione anabattistica nel Veneto, non v’è dubbio che si tratti dello stesso uomo. E numerose fonti dimostrano come d’Alessandria e dal Borgo (e al seguito di quest’ultimo il gruppo asolano) fossero stati tra i primi a essere avvinti dalla sua eversiva propaganda: in capo a poco Tiziano e i suoi discepoli iniziali avevano convertito e ribattezzato un numero di individui ragguardevole, contribuendo alla proliferazione di comunità d’orientamento anabattistico in varie regioni del Centro e del NordEst della penisola: dal Veneto al Friuli all’Istria alla Romagna alle Marche, non senza falliti tentativi in Lombardia e in Toscana. Tra il 1549 e il 1551 Treviso e alcuni villaggi del suo circondario, Asolo, Padova, Cologna Veneta e Badia Calavena (presso Verona), Vicenza e alcune sue ville, Venezia, Cittadella, Serravalle di Treviso, Udine, Bolzano, Pirano e Momorano (presso Capodistria), Pola, Cherso, Badia Polesine (vicino Rovigo), Rovigo, Consandolo e Ferrara, Ripe (presso Ancona) e altri luoghi ancora videro sorgere Chiese (per parlare di Chiesa bastavano un paio di adepti) che si riconoscevano nel radicalismo anabattistico diffuso da Tiziano e da discepoli sempre più numerosi41. Le idee propugnate da Tiziano (quelle che Manelfi definirà le opinioni «antique de anabattisti») erano effettivamente orientate verso una forma di anabattismo, per quanto questo termine possa accomunare tendenze diverse. Intanto, pur partendo da una visione antisacramentale che tanto doveva alla riforma zurighese – di cui nel Veneto non mancavano le tracce42 – Tiziano era proceduto ancora innanzi, dichiarando falso il battesimo agli infanti e necessario il ribattesimo di adulti consapevoli nelle scelte della fede. A parte questo aspetto, poi, altre sue opinioni erano tali da giustificare l’uso della categoria d’anabattismo. Secondo la testimonianza di Manelfi, Ticiano cominciò a predicarmi la dottrina anabattista [...], dicendo ch’io non ero battizzato perché non havevo fede quando fui battizzato, et delle altre openioni antique de anabattisti, come è che li christiani non possono esercitare magistrati et signorie, dominii et regni, prima per l’authoritate di Christo «reges gentium dominantur, vos autem non sic», poi ancora per la legge che dice «non occides», et perché lo apostolo dice che la spada è data a’ gentili «ad vindictiam malefactorum» et non a’ chri98
stiani, imperò niuno christiano può essere re, duca, principe, né esercitare magistrato alcuno, et questo è uno de primi principii de anabattisti, et altre openioni; non era però ancora fra tali anabattisti concluso contra la divinità di Christo et altri articoli novi determinati et conclusi nel concilio che fu fatto in Venetia43.
Tra le dottrine diffuse dall’inafferrabile Tiziano emergeva il caratteristico distacco dalla vita pubblica, che provocò sconcerto ulteriore negli inquisitori e nel potere politico per il timore che gli anabattisti fossero anche dei rivoluzionari. In effetti, ciò sottendeva l’atteggiamento mistico di chi voleva costituire una settaria comunità di santi; non a caso il divieto di portare armi o di esercitare magistrature era rivolto solo agli iniziati alla setta, nulla dicendo Tiziano rispetto alla sovversione dell’ordine costituito, benché fosse previsto che il vero cristiano (cioè l’anabattista) non dovesse prestare giuramento. Rispondendo a una precisa domanda, de’ Colti rispose: «Signori, credetemelo che loro sono et vogliono esser obedienti alli principi, né mai ho sentito dir altramente»44. Identica risposta fornì Bruno Busale, nonostante le pressioni degli inquisitori: Parlavi insieme del governo, della potestà temporale et de principi? Respondit: Signor no, saepius replicando signor no, cum saepius de hoc interrogaretur. Li fo detto advertissi di dir la verità perché te la faremo dir in altro modo se non la dirai [scil. ti tortureremo]. Respondit: Signor no certo; anzi havemo detto che li principi sono constituiti da Dio45.
Al riguardo molto chiara fu la testimonianza del vicentino Matteo dalle Maddalene, il quale rivelò che il vescovo anabattista di Vicenza, Giacometto «stringaro» da cui era stato convertito, «mi insegnò circa la potestà che questa Chiesa [degli anabattisti] [...] dovesse esser suggetta alle potestà dei signori temporali a pagare i suoi datii et ad obedirgli [...] in tutte le cose circa le cose del mondo; ma nelle cose della fede non obedire né a loro né [a] padre né madre né [a] nessun altro»46. In modo analogo si espressero altri come il rodigino Gian Maria Beato47, pure autorevole esponente di quel mondo radicale, il quale precisò che anche dal Borgo «dicea che si dovesse obedir alli magistrati temporali et darghe obedientia et revere[n]tia, et che la potestà era data da Dio alli signori per punir li maleditti et governar la sua Republica, et tenerli pacifichi»48, con una concezione 99
legalitaria che suggeriva nondimeno una rivoluzionaria distinzione di ambiti tra Chiesa e Stato. Comunque, l’eversione vera e propria era nei rapporti interni alla setta, e pure Benedetto impartiva gli insegnamenti di Tiziano che avevano atterrito le autorità laiche e religiose: «El non voleva che tra noi ghe fusse magistrato che desse sententie de sorte alchuna, anci el diceva che bisogna esser tutti eguali et che la robba tra de noi fusse comune; et el non voleva tra de noi altro magistrato che el vescovo over ministro che leggesse, batezasse et insegnasse la dottrina, et el diacono che havesse el cargo de riscuoder le elemosine et darle alli poveri»49. Si trattava, insomma, di orientamenti comuni all’anabattismo europeo dopo la sanguinosa repressione della guerra dei contadini e della comunità di Münster, la «nuova Sion», finita anch’essa in un massacro. Drammi che avevano imposto una profonda ridiscussione dei principi dell’anabattismo, con l’affermazione di uno spirito comunitario e non violento, nutrito da un deciso richiamo alla carità che poteva trovar facile ascolto in epigoni di un movimento come quello valdesiano. Insomma, allorquando dal Borgo e d’Alessandria entrarono in contatto con Girolamo Busale, erano essi stessi eresiarchi e leader riconosciuti di una setta dotata di una sia pur esile organizzazione e di una dottrina ormai delineata. Il teatro dei loro primi incontri, del resto, era Padova, uno dei centri principali dell’anabattismo italiano, come avrebbe testimoniato con dovizia di dettagli don Manelfi. Secondo l’elenco fornito dal delatore marchigiano (incompleto ma estensibile attingendo ai processi veneti), nella città universitaria erano stati guadagnati alla causa anabattistica un certo «cavadenti» di cui non si conosce il nome50, un «Salvatore venetiano, merciaro» – presso la casa del quale s’era svolto almeno un incontro tra veneti e napoletani51 –, insieme con altri piccoli commercianti come «maestro Gaspare [Menzato], strazzarollo»52. C’erano inoltre vari artigiani: «maestro Francesco spadaro al Portello», detto «lo Spagnoletto», a casa del quale pure si vedevano i radicali padovani53; «il fabro del Portello» mastro Cristoforo54; «maestro Biasio, calligaro»55; «maestro Bernardino [Prandi?], sarto». Quest’ultimo, convertito da Busale, si faceva leggere dal vicentino Giuseppe Cingano brani del Catechismo di Valdés, di libri di Vergerio e di Stancaro, di Butzer e Calvino. Manelfi ne ricordò anche la moglie – che si chiamava Orsolina Marangon –, con la quale viveva «sotto il portico di San Francesco», accogliendo anch’essi nella loro casa i radicali e dando ospitalità al100
lo stesso don Manelfi56. Orsolina non era la sola donna attiva nella comunità di Padova: don Pietro evocò anche tre sorelle del «depintor» anabattista vicentino (ma residente a Padova) «Hieronimo Speranza57 [...], [le] quali vanno inducendo le donne nella sua setta anabattistica»58, nonché la consorte di «Lovise [de’ Colti], maestro de scola al Portello»59, che pure condivideva col marito l’adesione alla setta radicale. A costoro si aggiungevano «altri assai anabattisti ch’io non mi ricordo il lor nome»60 «avenga che li conosca in faccia»61. «Maestro Lovise» de’ Colti (probabilmente esagerando) quantificò la comunità padovana nel momento del suo maggior fulgore in oltre un centinaio di adepti62; e merita evidenziare come si trattasse in larga parte, con l’eccezione dello stesso de’ Colti (maestro di scuola, ma anche bandito per omicidio), di un universo di modesto livello economico e sociale, composto da artigiani, piccoli mercanti, donne e operai: gente comune, insomma, con un parallelo inevitabile con l’ala radicale del movimento valdesiano. Così come a Napoli, pertanto, la cultura e la personalità di Girolamo Busale non faticarono a imporsi. Agli anabattisti padovani ricordati da Manelfi, infatti, s’erano ben presto aggiunti anche nella sua ricostruzione «messer Bruno [Busale] napolitano»63 e suo fratello «Geronimo Busale»64, nonché «messer Giovanni [Laureto] napolitano et messer Benedetto [Florio/Tizzano] pur da Napoli»65. I due gruppi presero a vedersi sempre più frequentemente, spesso di notte, in vari luoghi appartati, per quanto prevalentemente nella casa di fronte a Santa Caterina, dove abitualmente ci si incontrava di domenica66. Laureto riferirà che i colloqui patavini si protrassero per tre mesi circa, sicché si può ipotizzare che si svolgessero in un arco di tempo compreso tra il febbraio e il maggio del 1550. Erano quelli gli incontri in cui «ogniun diceva quel che li pareva», che proprio per questo assunsero pieghe conflittuali che si acuirono fino a quando si raggiunse un punto di stallo: le divergenze d’opinioni si cristallizzarono e il clima iniziò ad arroventarsi. Per risolvere il cul de sac in cui veneti e napoletani s’erano ficcati, fu convocato un colloquio più ampio, cui parteciparono rappresentanti di varie comunità e al quale intervenne lo stesso Tiziano, che non aveva preso parte ai colloqui dall’inizio – essendo impegnato nell’azione di proselitismo –, ma che ben presto s’era unito al gruppo67. Dalla confessione del maestro de’ Colti, presente all’incontro, è noto che «si ridussero in quella casa a Santa Catherina in Padova»: 101
Marc’Antonio [del Bon] d’Asolo, Paulo [Beltramin] d’Asolo, Ticiano, Iseppo [Sartori] d’Asolo [...], Iulio [Gherlandi] da Treviso68, Bastian [Pesente] da Treviso69, Zuan Maria de Beatis da Rovigo et uno altro da Rovigo pur, che non mi ricordo il suo nome [Francesco Della Sega?]70, Zuane dall’abbadia71, Iacometto sartor da Treviso72, Zuan da Poschiavo da Vicenza73, Iulio Calegaro da Vicenza, Iseppo Cingano [pure da Vicenza] si ben mi ricordo, Hieronimo Busale abbate, Bruno suo fratello, Zuane [Laureto] scolaro, il servitor dell’abbate nominato Antonino74.
L’elenco dovrebbe essere incompleto: mancano, tra gli altri, messer dal Borgo e don Tizzano75 nonché probabilmente d’Alessandria e qualche altro padovano. Il catalogo dei partecipanti elencava comunque rappresentanti dalle comunità maggiori, a rimarcare l’importanza di quella «congregatione» patavina convocata per risolvere i dissidi. Tuttavia quell’assemblea non partorì risoluzioni, e si giunse anzi a una fase di stallo: La difficultà – testimonierà del Bon – era che Christo fusse o non fusse stato cognosciuto avanti el batesmo et che le prophetie che erano nel evangelio avanti detto batesmo parlasseno in altro proposito, et che Iesu Christo fusse nato de copula carnal come li altri homeni, cioè da matrimonio de Ioseph et de Maria; et sopra de questo, anchora che fusse stato parlato longamente, se rimase quasi irresolute, ben la maggior parte de noi tenevamo ch’el fusse nato de matrimonio76.
La scintilla che aveva innescato il conflitto e sulla quale Laureto aveva sorvolato (non incalzato del resto da inquisitori già informati) era stata dunque la proposta, probabilmente avanzata da Busale, di ritenere Cristo un uomo nato da Giuseppe e da Maria. Niente di più del primo grado del livello radicale al quale Girolamo era stato iniziato al tempo di Juan de Villafranca e al quale egli stesso aveva iniziato altri come Laureto. Nonostante l’ex abate e i suoi si fossero spinti già da circa un lustro a gustare i sapori marrani delle opinioni «diaboliche», non le mettevano nel piatto di quelle discussioni, limitandosi in un primo momento a radicalizzare il discorso con la negazione della nascita divina di Gesù. Da quanto si evince dalle testimonianze, neanche la parziale falsità dei vangeli era stata ancora agitata dai meridionali, che su questo aspetto sembra si fossero inizialmente limitati a porre il problema in termini di interpretazione dei testi e non di autentica falsificazione. Così come pare che fino a quel 102
momento nulla fosse emerso sulla mortalità delle anime dei reprobi e sull’inesistenza dell’inferno. Si spiega così perché Manelfi avrebbe poi ritenuto erroneamente che la nuova setta giudaizzante fosse sorta dopo la celebrazione del concilio di Venezia: in realtà, usando l’esoterico metodo valdesiano, i napoletani iniziarono con l’agitare dubbi solo sulla divinità di Cristo, attendendo con paziente pedagogia che gli interlocutori accettassero il grado antitrinitario, per poi condurli sulla via dell’ulteriore radicalizzazione. La strategia, pur alla lunga vincente, doveva però scontrarsi con l’opposizione dei seguaci delle antiche opinioni guidati da Tiziano, che lungo tutto l’arco dell’incontro-scontro tra anabattisti e antitrinitari (ma le definizioni sono semplificate in eccesso) fu a capo dell’ala che si potrebbe definire tradizionalista, ferma a uno stretto biblicismo e alla non violenza comunitaria degli anabattisti. I colloqui padovani, insomma, per quanto ispirati inizialmente a un franco confronto tra due forme diverse di radicalismo, finirono col condurre i partecipanti in un vicolo cieco di contrapposizioni inconciliabili. In effetti, si fronteggiavano due distinte tendenze del radicalismo religioso. La visione perorata con convincenti argomenti da Busale era più accattivante per un uditorio non certo preparato a comprendere un dogma come quello trinitario e un mistero come quello della verginità della Madonna. Giacometto «stringaro», influente vescovo anabattista (poi antitrinitario) di Vicenza, «lo lodava grandemente che l’era un grand’huomo et dotto»77; così come avrebbe fatto poi il De falsa et vera, che ne avrebbe tramandato alla tradizione sociniana la figura di «vir integritate theologicaque facultate nemini secundus». Anche i più edotti nelle cose di fede non potevano fare a meno di notare quanto Girolamo potesse esser convincente: nei modi impetuosi con cui condiva i propri ragionamenti, ma anche grazie alle sue conoscenze dottrinali, irrobustite dal suo padroneggiare il latino, il greco e l’ebraico. Qualità, tutte, che gli davano un innegabile vantaggio rispetto all’afflato misticheggiante di Tiziano. Molti così abbandonarono le primitive posizioni, aderendo all’antitrinitarismo perorato dai napoletani: Giacometto, del Bon e altri, tra i quali dal Borgo e d’Alessandria; cosicché, con i napoletani finirono per schierarsi non solo gli asolani ma anche i padovani, tra i quali il radicalismo di Busale andò prendendo piede al punto che questi sarebbe stato eletto vescovo degli antitrinitari patavini all’indomani del concilio di Venezia, dal dicembre del 1550 al febbraio 103
del 155178, finché non fu costretto con Laureto alla fuga a Napoli che lo avrebbe portato all’esilio in terra ottomana. D’altra parte, i radicali meridionali avevano avuto l’astuzia di accettare il ribattesimo, mostrandosi più aperti al confronto rispetto agli anabattisti fedeli a Tiziano che – probabilmente anche per la sua rigidità – vide via via sfaldarsi la rete che aveva intessuto fino ad allora. Tiziano, che prese parte in varie occasioni ai colloqui padovani79, fu alla testa di quanti si opposero risolutamente all’accettazione degli articoli proposti dai seguaci di Busale; ma l’«angelo de Alemagna» vide svanire il frutto di tanto lavoro: molti e autorevoli suoi primi adepti si schierarono contro di lui, inducendolo infine ad allargare il dibattito, a uscire da Padova e a coinvolgere più compagni possibile per cercare di riprendere il controllo della situazione. Così lo scontro si trasferì da Padova a Vicenza, e furono celebrati quelli che la storiografia avrebbe poi definito i collegia vicentina. La scelta di Vicenza non era casuale. Anche lì – grazie alla propaganda di del Bon, dal Borgo e d’Alessandria – s’era strutturata una comunità anabattistica corposa, una delle principali, con quella padovana, dell’anabattismo italiano, composta – secondo Manelfi – da «cinquanta o sessanta fra huomeni et donne»80. Caratteristica della comunità vicentina, ancor più di quella patavina (e a differenza di quella asolana), era la preponderanza di persone semplici: tra le eccezioni, i fratelli Giulio e Girolamo Sandrini, notai, Alessandro Pasin, «natural de uno gentilhomo di Pasini», e «Polonio, figlio de Theseo de Brogia»81. Tra i leader anabattisti vicentini figuravano, invece, personaggi come il già evocato merciaio Giacometto «stringaro»82, vescovo della comunità vicentina, che ribattezzò «da 25 a 30» suoi concittadini e fu tra i protagonisti della vittoria degli antitrinitari; o come il sarto Giuseppe Cingano, anch’egli favorevole alla svolta indotta dai napoletani, nella cui casa – dove s’appoggiavano d’Alessandria e altri come Beltramin – avvennero varie riunioni di radicali del Nord-Est83. Un merciaio e un sarto affiancati da altri artigiani e piccoli mercanti, che pure avrebbero condiviso la radicalizzazione delle proprie idee: diversi sarti e calzolai in particolare, ma anche garzoni, operai, donne del popolo, merciai al dettaglio (di stracci, di bottoni, di pane), umili preti. Oltre allo stringaro e a Cingano, Manelfi ricordò «maestro Giovanni de Dolthani, callegaro» (calzolaio) e «drappier»84, originario di Poschiavo, nella casa del quale si vedevano a volte i radicali e che rivestiva a Vicenza l’ufficio 104
di diacono. Poi «maestro Antonio», dapprima «sacerdote» e successivamente pure «callegaro», di cui era compagna di fede la «moglie» Martina85. Così come a Padova, infatti, molte delle consorti degli aderenti alla setta avevano seguito le scelte radicali dei mariti. A parte Martina, c’era Lucrezia, sposata con «Mathio dalla Maddalena, battilana», uno dei più impegnati anabattisti vicentini86, ma anche la moglie del profumiere «maestro Francesco muschiaro87» e quella del «Rasciarollo» («stratiarollo»)88, oltre alle sorelle di Silvio Rasonier. A costoro si affiancavano il «tintore» «maestro Mattheo del Castello», la casa del quale era un’altra delle sedi d’incontro89; «maestro Giulio, callegaro»90, anch’egli tra i più influenti membri della setta vicentina e conquistato dai napoletani alle loro idee; «maestro Lovisetto, sarto»91, «il zotto, sarto» di nome Matteo92, «con assai altri», di molti dei quali sono noti sia il nome sia lo status sociale93. Lo stesso Manelfi aggiunse il bolognese «maestro Iacobo bottonaro et la moglie et uno suo garzone di bottega», nonché «il gobbo vendipane in piazza»94, che va identificato con «uno Iacomo zotto fornaro» il «qual è anche gobbo» ricordato da Giuseppe Cingano e da Francesco Bosato e che si chiamava Gian Giacomo di Forcini95. Ma a parte coloro i quali furono denunciati da Manelfi, possono evocarsi anche tre altri straccivendoli: «Mattheo strazzaruolo», nel domicilio del quale fu celebrato almeno un incontro, «Tognetto strazzaruolo» e «Antonio strazzaruolo». E ancora: «Iseppo Manetto», «Antonio marzaro», «Gabriel marzaro over sensaro», «Francesco Carletto», «Hieronimo cimatore zotto», «Battista [o Benedetto, il nome non è chiaro] sartore»96, «Andrea cimador», Antonio dal Ponte, «bottaro» originario di Bolzano con due suoi fratelli97, «Zampiero fornaro», che pure ospitò in casa Marcantonio del Bon98, più vari altri sarti: «Iacomo sartor et uno suo fratello che ha nome Gasparo», sarto anch’egli; «uno Antonio sartor senza piedi» detto «el piede di legno»; «Alvisetto sartor», già garzone nella bottega di Giuseppe Cingano; l’ex sarto Francesco (o Checo) de Brotton, ribattezzato dallo stesso Cingano mentre era costretto a letto «amalato»; «Francesco da Breganzo detto Bosato»; «Giulio sartor»; «Bernardin sartor»99; lo zoppo «Luca sartor, che era forestier et soleva lavorar in bottega di Iseppo Cingano et dove gli veniva dato da lavorare»100. Un gruppo cospicuo di persone in larga parte d’umile estrazione, cui andava aggiunto un nucleo disseminato «in tre ville del Vicentino fra tre o quattro miglia vicino a Vicenza [composto] da sedici per105
sone fra maschi et femine»101. Tra di essi, sempre caratterizzati da bassa condizione culturale e socio-economica, un «homo di pessima natura et instrutto de diabolica heresia»: Lorenzo Borgato di Bolza che «tra le altre sue nefandissime opinioni» riteneva «che la Chiesa è una moschea de farisei, [et] Christo non esser nato dalla vergine Maria et che quella è stata una meretrice»102. Un modo estremo di porsi nel quale del resto Borgato non era affatto isolato. Tra i radicali vicentini, infatti, c’era il già evocato Silvio Rasonier103, così chiamato perché il padre era fabbricante di rasoi. Manelfi lo presentò in questi termini: «Silvio, già anabattista et hora non crede le Scritture essere stà fatte per lo spirito di Dio, né la Nova né la Vecchia, sì come mi ha riferto più volte Marc’Antonio [del Bon] d’Asolo sudetto, qual ha parlato con detto Silvio più volte sopra queste cose, poiché detto Silvio è uscito dall’anabattistaria»104. Analogamente lo descrisse Giulio da Milano: «Un altro archisinagogo chiamato Silvio vicentino dice che la fede non è altro che l’oppenione de l’huomo, secondo che la persona se l’immagina e fabrica nel suo cervello. Di maniera che non afferma l’una fede essere più vera né migliore dell’altra»105. Un’incredulità che si può affiancare a quella di personaggi come Giulio Basalù, Scipione Capece, Tobia Citarella e, c’è da supporre, vari altri. Vicenza, pertanto, era il luogo naturale dove spostare lo scontro. Ciò tuttavia finì per favorire i napoletani e i loro neo-sodali, che anzi lì poterono intessere ulteriori alleanze, d’altra parte già viste emergere nell’assemblea generale celebrata a Padova. In fondo, i protagonisti della svolta anabattistica della comunità vicentina erano stati proprio del Bon, dal Borgo e d’Alessandria, sicché essi potevano contare sul prestigio guadagnato dalla loro precedente propaganda e supporre di trovare un terreno fertile, favorevole alle nuove visioni indotte da Busale e accolte da essi stessi. Su questo piano, meno felice era la scelta per Tiziano, che tuttavia non aveva alternative all’allargamento del dibattito: per cercare di arginare le perdite, se non per ribaltare i nuovi equilibri che si andavano delineando. Furono così celebrate due assemblee (i collegia vicentina) che, a quanto pare, si tennero all’inizio dell’estate (probabilmente in giugno) «fuori di Vicenza dietro la Rocha vecchia, fra certe pradarie a mezzo certi hunari [ontani]», alla presenza dello stesso Tiziano106. Come prevedibile, il clima fu piuttosto teso107. Manelfi (presente alle riunioni) riferì che il dissenso divenne insostenibilmente duro 106
quando si giunse «a quel passo del Deuteronomio ove Dio dice: ‘Prophetam suscitabo de fratribus tuis, et ponam verba mea in ore ipsius etc. tamquam me ipsum audite’, et fussemo in differentia fra noi se Cristo fosse Dio o huomo»108. Un resoconto analogo avrebbe fornito pure Cingano: «In li predetti nostri reduti l’è stato fatto de gran dispute perché alchuni volevano che Iesu Christo fusse concetto de seme humano, alchuni non volevano intrar in questa oppinione, di modo che mai la se ressolse et questa oppenion rimase indiscussa»109. Rafforzati dagli asolani, ma anche da vicentini come Giacometto, Cingano e Giulio «callegaro», nonché dallo stesso Manelfi e da altri ancora, i napoletani mantenevano la posizione, negando la divinità di Cristo e la verginità della Madonna. Non limitandosi a questo, peraltro, calarono un’altra carta sul tavolo della discussione, sostenendo, in aggiunta, la parziale falsificazione dei testi evangelici110. Tiziano, dal canto suo – sempre secondo la testimonianza di Giuseppe Cingano –, «non fu mai di quella oppenion, perché el voleva star sul evangelio». Mentre i seguaci di Busale affermavano che nei casi di incongruenza fra la tesi sostenuta (in specie l’umanità di Cristo) e il dettato evangelico bisognasse dedurre la parziale falsificazione delle Sacre Scritture, Tiziano, coerentemente con l’anabattismo europeo, restò fedele a uno stretto biblicismo, opponendosi con forza a quella che gli sembrava una deriva foriera di deviazioni enormi. Il carismatico capo anabattista si ancorava a quelle che Manelfi avrebbe definito le «antique opinioni», senz’altro più vicine al pur variegato mondo dell’anabattismo europeo: perorava che «li beni fusseno comuni», «persuadeva che chi haveva facultà et robba ghe ne desse a chi non ghe ne haveva»111. Ma su questi principi Busale e i suoi non avevano sollevato particolari obiezioni. La comunione dei beni, in fondo, era un’idea limite che gli stessi veneti non avevano attuata112, salvo spingere sulla pratica della carità, in merito alla quale non c’erano motivi di dissenso con gli epigoni radicali del valdesianesimo. In ogni caso, non era interesse di Girolamo porre problemi sulle tesi fondamentali dell’anabattismo, e non è certo un caso che egli avesse fatto ribattezzare suo fratello Bruno da Tiziano, in un evidente (pur se fallimentare) tentativo di trovare una qualche intesa. La strategia di Busale era quella di condurre quegli anabattisti verso posizioni sempre più avanzate, dapprima facendogli accettare le eversive dottrine apprese da Juan de Villafranca, per poi spingerli 107
più oltre. Tutt’al più erano gli anabattisti a porre problemi all’ex abate, agitandogli il fatto (fondato o meno che fosse) che «magnava del sangue della bestia», che godesse di benefici d’origine ecclesiale. Ma i problemi principali erano altri e gli scontri si concentravano sull’umanità di Cristo, sulla verginità di Maria, sulla parziale falsità delle Scritture. Peraltro, vista evidentemente la posizione di forza acquisita, i napoletani non si limitarono a questo, e a Vicenza sul tappeto fu posta anche la credenza nella morte eterna dei reprobi e la convinzione che «l’inferno era lo inferior della terra», giungendo così all’ultimo grado del magistero di Juan de Villafranca113. Né i colloquia patavini né quelli vicentini insomma sanarono il conflitto, contribuendo anzi ad acuire il tono dello scontro a causa dell’ulteriore radicalizzazione del discorso da parte dei meridionali. Tiziano e i pochi restatigli fedeli continuarono a persistere sulle «antique opinioni», e in capo a poco, a quanto pare, fu celebrato un ennesimo colloquio a Ferrara (il cosiddetto sinodo di Ferrara). Secondo la testimonianza di del Bon: Ci trovassimo una volta insieme in Ferrara dove era Nicola de Alessandria, Benetto Borgo, Titiano, Francesco da Rovigo, un Battista Tabachin de terra de’ Grisoni, Iseppo Sartor et potrebbe esser altri che non me ricordo, dove fu ragionato anchora in simil materia; et anchor che tutti restorno quieti della humanità di Christo et dell’evangelio, pur anchora alcuni erano che non assentivano che Christo fusse puro huomo et che non fosse stato aggiunto all’evangelio114.
Ancora una volta di fronte all’affacciarsi del principio critico secondo cui si poteva asserire la falsificazione di parti delle Scritture, Tiziano «contrastava grandemente [...], perché lui allegava che destruggendo una parte se veniria a destrugger il tutto»115. Le posizioni erano ormai cristallizzate e non erano certo i colloqui informali a potere decidere della dottrina che la setta avrebbe accolto o meno. Peraltro, in quell’atmosfera surriscaldata evidentemente fu commessa qualche leggerezza, se il Sant’Ufficio nel giugno del 1550 emise un mandato di cattura nei confronti di Nicola d’Alessandria, che si rifugiò a Pisa116. Del Bon ricordò che a Vicenza l’aria era divenuta irrespirabile117. L’Inquisizione iniziava ad affilare le sue lame, e un clima intollerante affiorava persino all’interno del mondo radicale, scosso dai conflitti emersi fra Padova e Vicenza. Nello stesso perio108
do, infatti, Benedetto dal Borgo fu scomunicato dalla comunità di Cittadella, restata fedele a Tiziano: un atto molto grave, che contribuì alla convocazione del concilio o sinodo118 (ma forse sarebbe preferibile chiamarlo «collegio») di Venezia119. Non è il caso di ritornare diffusamente su quel momento decisivo della storia del radicalismo italiano ed europeo, né sulle dichiarazioni più o meno mendaci fornite al riguardo da Manelfi, analizzate nel dettaglio sia da Stella sia da Ginzburg, ai lavori dei quali è bene rinviare anche per una descrizione più puntuale dell’avvenimento. Certo è che le conclusioni del concilio sancirono il successo delle tesi dei meridionali. Basti ricordare l’elenco delle risoluzioni accettate dalla maggioranza dei partecipanti, il catalogo degli «articoli novi determinati et conclusi nel concilio che fu fatto in Venetia»120 fornito da Manelfi e confermato da altre testimonianze121: 1. Christo non essere Dio ma huomo concetto del seme di Ioseph et di Maria, ma ripieno di tutte le virtù di Dio. 2. Maria havere havuto altri figliuoli et figliuole dopo Cristo, provando per più lochi della Scrittura Cristo havere havuto fratelli et sorelle. 3. Non essere natura angelica creata da Dio [...]. 4. Non essere altro diavolo che la prudentia humana, et così quel serpente quale dice Moisè haver sedutto Eva, non essere altro che la prudentia humana, perché non ritrovamo nelle Scritture niuna cosa creata da Dio esserle nemica se non la prudentia humana, come dice Paolo Alli Romani. 5. Gli impii nel dì del giuditio non risuscitare, ma solo gli eletti de’ quali è stato capo Cristo. 6. Non ci essere altro inferno che ’l sepolcro. 7. Gli eletti quando moreno dormire nel Signore, et non andare altrimente le anime loro a fruire cosa alchuna fin al dì del giuditio, quando saranno risuscitate; l’anime dell’impii perire insieme col corpo, come fanno tutti li altri animali. 8. Il seme humano havere da Dio forza di produrre la carne et lo spirito. 9. Gli eletti essere giustificati per la eterna misericordia et charità di Dio senza nessuna opera visibile, intendendo senza la morte, il sangue et gli meriti di Cristo. 10. Cristo essere morto alla demostratione della giustitia di Dio et giustitia intendevamo il cumulo di tutta la bontà et misericordia di Dio et delle sue promissioni122. 109
Busale riuscì dunque a imporre le tesi corrispondenti all’ultimo grado del percorso iniziatico guidato da Juan de Villafranca, che aveva man mano rivelato tra gli incontri padovani e quelli vicentini. I primi due punti ribadivano l’antitrinitarismo già emerso nei colloqui di Padova e al punto 4 la condanna alla «prudentia humana» riproponeva un topos della lezione di Juan de Valdés123. Per il resto, i punti dal 5 al 7 riaffermavano l’inesistenza dell’inferno ed equiparavano le anime mortali dei reprobi a quelle degli animali, precisando quanto già sostenuto nei collegia vicentina. Gli ultimi due punti, però, pur non spingendosi fino alle diaboliche opinioni, a ben vedere le preparavano in modo sottile, giacché era evidente come la posizione di Gesù fosse stata ulteriormente sminuita con la negazione del beneficio di Cristo, il significato della cui morte si riduceva «alla demostratione della giustitia di Dio». Così, è ancora più evidente come la cosiddetta «nuova setta» altro non fosse che l’esito ultimo della propaganda dei napoletani, e non qualcosa di diverso rispetto all’evoluzione che aveva portato da Padova a Venezia. Il successo di Busale, ad ogni modo, fu pressoché totale, poiché tutte le comunità anabattiste ne accettarono quantomeno l’antitrinitarismo, salvo quella di Cittadella, e lo stesso Tiziano finì con l’allinearsi alle «nuove opinioni»124. Non è chiaro se anche gli altri punti emersi a Venezia fossero stati accolti e compresi da tutti, mentre è certo che i punti principali – l’umanità di Gesù con la conseguente parziale falsità dei vangeli e la negazione della verginità di Maria – registrarono l’adesione della stragrande maggioranza. La svolta antitrinitaria risulta evidente sin dalla ritualità della setta: fino a quel momento Tiziano aveva battezzato «in nome del padre, figliolo et spirito santo»125. Dopo Venezia la formula mutò: «Dappoi el venne un’altra dottrina nova», confesserà Giacometto (che battezzò in entrambi i modi), e si passò a battezzare «in nome de Iesu Christo, perché non tenevamo la trinità»126. Il trionfo per i meridionali non poteva esser più completo. Nel dicembre del 1550, infatti, Busale fu nominato vescovo della comunità di Padova, sancendo il proprio successo sull’ala tradizionalista. A quel punto, i napoletani avrebbero spinto ulteriormente sulla radicalizzazione dottrinale, come suggerisce la testimonianza di Manelfi sulla cosiddetta nuova setta e come si può intuire dagli ultimi due punti approvati dal concilio di Venezia. L’ulteriore radicalizzazione sfiorì però sul nascere, giacché quel mondo fu messo a soq110
quadro dall’Inquisizione. Nel febbraio del 1551 dal Borgo (su cui pendeva un mandato di cattura dall’anno precedente) fu tratto in arresto a Rovigo, dove fu giustiziato sul rogo il 17 marzo127. Sebbene Benedetto non si fosse pentito e non avesse rivelato nome alcuno, il clima divenne insostenibile. Busale e Laureto fuggirono diretti a Napoli128, dove significativamente si recò anche Silvio Rasonier. Agli inquisitori era ormai chiaro che nei territori del Nord-Est erano circolate idee di una radicalità inaudita, tali che nemmeno «Martin Luther mai si ha pensato»129. Sempre in febbraio fu arrestato un altro asolano, Francesco Sartori (fratello di Giuseppe), che non ebbe la stessa fermezza di dal Borgo e, ancor prima di Manelfi, diede agli inquisitori notizie relative alla setta anabattista dagli orientamenti antitrinitari. Manelfi, poi, si presentò agli inquisitori di Bologna e il 17 ottobre fornì un quadro dettagliato di nomi, circostanze e luoghi che mise le autorità nelle condizioni di gettare una rete a fitte maglie su tutta l’organizzazione italiana del radicalismo religioso. Ai primi di dicembre fu arrestato il rodigino Gian Maria Beato, presso il quale si era rifugiato dal Borgo e che arricchì il quadro di utili dettagli130. Nella notte fra il 18 e il 19 dicembre del 1551, infine, il Consiglio dei Dieci della Serenissima organizzò una vasta operazione di polizia tesa a debellare quella che fu definita «una congiura de ribaldi contra il stato di paradiso et del mondo»131. Una ventina di quei «ribaldi» caddero subito nelle mani degli inquisitori, altri vennero costituendosi man mano, e in un paio d’anni (salvo più tardivi casi come quello di Giulio Basalù), fra il 1551 e il 1553, l’Inquisizione riuscì a debellare la trama anabattistica e antitrinitaria dipanatasi tra il NordEst e il Sud d’Italia. Molti tra i più influenti personaggi di quella fase del radicalismo italiano riuscirono a trovare rifugio all’estero, chi in territori dell’Impero ottomano, chi nelle più vicine terre svizzere o in altre città europee. Restano a questo punto da confrontare le risultanze storiche sin qui recuperate con la tradizione sociniana, iniziando dai luoghi in cui si sarebbero svolte le adunanze. Come s’è visto, in base al dettato dei tre storici sarebbe assurdo limitare la localizzazione dei collegia alla sola Vicenza, mentre si deve parlare di più luoghi (città e non solo) dell’area veneta. Se questo è vero, indubbiamente i colloqui padovani, vicentini e ferraresi, seguiti dal concilio di Venezia, danno un solido ancoraggio reale alla tradizione, poiché l’unica differenza consiste nella presenza di Ferrara (non sottoposta al domi111
nio della Serenissima), dove però si svolse un incontro d’importanza secondaria, salvo eventuali intrecci con il gruppo di Giorgio Siculo, sui quali sarà opportuno ritornare. Chiarito il dove e passando al cosa, dall’analisi dei testi è emersa la circostanza che in base alla tradizione sociniana si possono identificare due gruppi di fenomeni che si svolsero in varie occasioni, colloquia e collegia, ricordando che col primo termine pare si debbano intendere eventi non strutturati, mentre col secondo sembra che il riferimento sia a riunioni più formalizzate. Ora, se si considerano gli incontri di Padova, Vicenza e Ferrara è legittimo assegnarli alla categoria di quelli che i sociniani definirono colloquia; se si fa riferimento, invece, all’assemblea veneziana, alla quale presero parte secondo Manelfi solo gli «episcopi di detta Giesa»132, è altrettanto legittimo catalogarla nella categoria dei collegia, secondo il lessico di Cicerone, che considerava collegium sinonimo di concilium. Se ne dovrebbe dedurre che i collegia non erano quelli che la storiografia avrebbe localizzato a Vicenza, ma quello poi definito il concilio o sinodo di Venezia, mentre i veri collegia, quelli di cui ha parlato la storiografia, sarebbero quelli che potrebbero chiamarsi più propriamente i colloqui vicentini, patavini e ferrarese. Il problema, tuttavia, non è quello di sostituire un termine a un altro, quanto di capire come quegli eventi fossero sovrapponibili con quanto tramandato dalla tradizione sociniana. Si può passare, dunque, al quando. Se si considerano ammissibili le ipotesi avanzate, non si vede perché non dovrebbe esser lecito datare al 1550 eventi che i sociniani dicevano avvenuti «circa annum 1546». L’unico reale problema, su questo piano, sarebbe l’impossibilità della presenza di Lelio Sozzini, salvo rientri in Italia di cui per ora non si sa assolutamente nulla. Il che conduce, in conclusione, al chi. Il ragionamento fatto su Sozzini va evidentemente (in quanto fuoriusciti) esteso a Bernardino Ochino e al medico piemontese Giorgio Biandrata133, che nondimeno, pur essendo uno dei protagonisti dell’antitrinitarismo europeo, non fu esplicitamente ricordato da nessun sociniano, contrariamente a quanto scritto da Aldo Stella. Così come non fu evocato (diversamente da quanto pensavano Ruffini e Morsolin) il nome del giurista Matteo Gribaldi Mofa134, che invece fu tra i pochi radicali della diaspora che avrebbe potuto esser presente a qualcuno degli incontri veneti. Sin dal 1548, infatti, Gribaldi insegnava all’Università di Padova, dove mantenne la cattedra 112
fino all’aprile del 1555. Che fosse già al tempo del suo incarico patavino in contatto con gruppi eterodossi è dimostrato dalla sua presenza al capezzale di Francesco Spiera – il giureconsulto di Cittadella morto in preda ai tormenti del rimorso per essere stato costretto ad abiurare –, il cui caso fu raccontato in vari scritti poi riuniti in silloge che lo resero celebre in Europa. Tra di essi, ce n’era anche uno di Gribaldi datato 1548, nel quale già affioravano fremiti critici verso il calvinismo e la sua rigida dottrina della predestinazione: il motivo di fondo, secondo Gribaldi, per cui Spiera era caduto nel più cupo sconforto135. Il suo dissenso verso Calvino sarebbe emerso clamorosamente qualche anno dopo, al tempo del caso Servet, quando egli fu il primo a opporsi frontalmente al brutale rigore calviniano, mentre nel 1549 poteva ancora scrivere al riformatore di Ginevra per raccomandargli Pier Paolo Vergerio136. A quanto pare, la sua eterodossia negli anni padovani era di dominio pubblico: un fra’ Antonino Barges confessò che si era trovato «in Bergamo con il Gribaldo, [che] ha fama pubblica che è luterano, et lui mi persuadette» e poi «mi accompagnò in Ginevra»137. E in una lettera che l’ambasciatore di Venezia a Roma Matteo Dandolo inviò nel giugno 1550 al Consiglio dei Dieci, così il diplomatico ricostruì una discussione avuta con il papa Giulio III: Et poi [il papa] disse ancho di Padoa che quasi non se ne può havere pacientia che in quel Studio ove sonno tanti scolari teneri et nobeli si possono fornire di questa detestanda dottrina. Della qual Padoa io gli dissi, per haverne molta pratica come privato et in reggimento che gli son stato, non ne havevo mai sentita parola. Mi disse: non la trovareste cossì hora; so ben quel ch’io vi dico. Ma per il vero di quel Studio qui per molti è diffamato di tal set[t]a un dottor Piamontese condotovi già non molto tempo a uno de’ primari luoghi di legge138.
Che quel «dottor Piamontese» fosse proprio Gribaldi non v’è dubbio, e d’altronde nel 1552 il Sant’Ufficio aprì nei suoi confronti un’indagine formale139: circostanza che, evidentemente, non dovette turbare più di tanto né il giurista né gli amministratori dell’Università, se vi continuò a insegnare apparentemente indisturbato fino all’inizio del 1555, ottenendo persino un aumento di stipendio per l’anno accademico 1553-54. In quegli anni il giurista faceva la spola tra Padova e il suo castello di Farges presso Ginevra, e si trovava nel113
la capitale del calvinismo durante il processo contro Miguel Servet, schierandosi apertamente contro l’intransigenza di Calvino e scrivendone «ad vicentinos fratres»140. È dunque molto probabile che un legame tra Gribaldi e il mondo del radicalismo veneto ci fosse, e sebbene le fonti non sembrino offrire ulteriori prove, è difficile immaginare che il gruppo di Busale, addentro al mondo universitario patavino e dedito a un’alacre opera di proselitismo, non si ponesse l’obiettivo di coinvolgere quel professore pubblicamente eterodosso che, almeno dal 1552, fu guadagnato alla causa antitrinitaria. Da una lettera di Guglielmo Grataroli, infatti, è noto che intorno a quella data Gribaldi aveva letto il De trinitatis erroribus e i Dialogi de trinitate di Servet e che nelle sue lezioni padovane lodava frequentemente il medico e antitrinitario aragonese141. Il cremonese Francesco Scudieri, poi, testimoniò di un tentativo di convertirlo all’antitrinitarismo che Gribaldi accompagnò col prestito del manoscritto di una delle due opere servetane142. Considerando tutto ciò, pertanto, si può ipotizzare che il giurista non partecipasse agli incontri veneti (difficilmente un uomo del suo rango si sarebbe tanto esposto), ma che ne fosse quanto meno al corrente e in qualche modo coinvolto. Incerta è anche da considerare la presenza di Niccolò Paruta, emigrato a Ginevra e poi in Moravia. Morsolin e Stella ipotizzarono che Paruta potesse identificarsi con Nicola d’Alessandria, ma Ginzburg e Firpo hanno mostrato la labilità del nesso. Peraltro, come emerge dai costituti di Laureto, d’Alessandria si rifugiò a Salonicco e non risulta ad oggi una permanenza di Paruta in terra ottomana. Secondo Firpo, quindi, «il richiamo ai collegia vicentina non può [...] non apparire come una posteriore ricostruzione di un passato prestigioso in relazione a un personaggio di primo piano per la storia dell’antitrinitarismo»143. Un giudizio che può estendersi ad altri personaggi assenti come Bernardino Ochino e Lelio Sozzini, che semmai riprese i rapporti con i radicali in Italia al suo ritorno nella penisola nel 1553, quando fu ospitato da Matteo Gribaldi. Confermata dalla documentazione, invece, è la presenza di «Iulius trevisanus» e di «Franciscus de Ruego», gli unici a parte Sozzini ricordati da Wiszowaty: Iulius era Giulio Gherlandi e Franciscus era Francesco Della Sega, che partecipò ai colloquia patavina, mentre Iacobus de Chiari, che successivamente fu aggiunto al gruppo, 114
potrebbe essere Giacometto da Treviso (presente al collegio di Venezia), ma anche Giacometto «stringaro» che partecipò a quest’ultimo, oltre che ai colloquia patavina e vicentina. Confermata è anche la presenza di Girolamo Busale. A riguardo di quest’ultimo, Sand lo incluse come il primo della lista, ma invece di Girolamo lo chiamò «Leonardus abbas Busalis», un abbaglio che lo storico ripeteva sulla scorta del De falsa et vera, dove pure il nome di Busale era indicato erroneamente in Leonardo. Del resto, Sand non dedicò all’abate alcuna voce, sicché è chiaro che al suo tempo l’importanza del calabrese era ormai ridotta a un’eco lontana, desunta appunto dal De falsa et vera. Lo stesso errore compiuto da Biandrata (autore del capitolo dove comparve il nome di Busale) è significativo, in quanto rivela come sin dagli anni Sessanta su di una base veritiera si fosse sovrapposta una mitografia che aveva sempre più confuso la memoria relativa alle evoluzioni del radicalismo religioso italiano. Sebbene non vada sottovalutata la circostanza che in effetti Busale fosse universalmente noto come l’«abate» più che col suo nome di battesimo, tutto ciò sembra mostrare come i fili tra la prima e la seconda generazione di antitrinitari fossero ormai esili, individuabili in poche persone. Ciò non significa eliminare Lelio Sozzini o Bernardino Ochino dal primitivo coagularsi di un discorso antitrinitario in Italia, ma più semplicemente attribuire agli stessi colloquia e al collegium veneti la giusta importanza, vedendo in essi soltanto uno dei possibili approdi (per quanto significativi) di un fluire di discorsi, attitudini e idee ben più complesso e di più lunga durata. Per essere più chiari: non è la partecipazione o meno a quegli incontri che fa la differenza rispetto alle evoluzioni del radicalismo religioso maturato in terra italiana. Nello stesso tempo non bisogna neanche eccedere, come fecero i sociniani (e poi Cantimori e fino a un certo momento Rotondò), nel sopravvalutare l’importanza avuta da Lelio Sozzini, che non fu l’unico protagonista di un’evoluzione che fu invece plurale e collettiva, sintomo dell’esistenza di un vero e proprio movimento, differenziato in vari gruppi ma unito in una rete di cui è possibile ricostruire i legami e le evoluzioni, dal momento italiano a quello dell’esilio. Insomma, anche sui partecipanti a quegli incontri si sovrappose una comprensibile tendenza dei sociniani a nobilitare gli eventi, che spiega perché accanto a persone senz’altro presenti come Busale, Giulio Gherlandi e Francesco Della Sega si vollero altri la cui partecipazione resta un mistero, come Valentino Gentile, Giampao115
lo Alciati144 e Francesco Negri145, affiancati da altri ancora quasi certamente assenti, come Lelio Sozzini, Niccolò Paruta e Bernardino Ochino. 3. La setta e il movimento: due tendenze del radicalismo europeo Ricostruite le vicende dei conflitti che animarono il mondo del radicalismo italiano alla metà del Cinquecento, resta da approfondire il perché del fallimento di quell’esperienza, non potendosi ciò ricondurre sic et simpliciter alla pur decisiva stretta repressiva dispiegata dall’Inquisizione. In effetti, gli incontri e le assemblee che si susseguirono nel 1550 videro emergere spaccature profonde tra due concezioni diverse della fede. Il dubbio critico spinto fino a ritenere false le Scritture, l’antitrinitarismo, una vera e propria tendenza all’incredulità: queste e altre posizioni erano estranee alle «antique opinioni» degli anabattisti, e coerentemente Tiziano si batté per tenere ferma la barra su quelle dottrine. Ma non fece altrettanto la maggioranza di quelli che alle «antique opinioni» dapprima avevano aderito, e ciò anche perché in larga parte erano persone incolte, sulle quali il dotto e carismatico Busale poté avere gioco facile. Personalità come del Bon, dal Borgo o d’Alessandria, però, erano ben lungi dall’essere poveri e ignoranti. Soprattutto, quindi, fu decisiva l’abilità politica dimostrata dall’abate, che, dispiegando la sua strategia entrista, non diede peso alle differenze tra le concezioni sue (e dei suoi compagni) e quelle degli anabattisti, mostrando anzi di accettarle e proponendosi, conseguentemente, come portatore di una lettura più avanzata e non in opposizione alla fede dei suoi interlocutori. Non è da sottovalutare, al riguardo, il fatto che Bruno Busale fosse stato ribattezzato da Tiziano. Il Busale maggiore alternò propaganda esplicita a simulazione e dissimulazione, come dimostra il fatto che non mise subito nel piatto della discussione tutti i frutti del valdesianesimo più radicale, né tanto meno si spinse a evocare le inquietudini marrane delle «diaboliche opinioni». Simulazione e dissimulazione, dunque, erano architrave della strategia dei napoletani, il che è ulteriormente suggerito dal fatto che l’incompatibilità tra forme diverse di radicalismo non riguardava i soli anabattisti più coerenti, come Tiziano, ma risaliva ai principi essenzia116
li del valdesianesimo, nonostante su ciò Busale e i suoi avessero steso un velo di silenzio. Per comprendere quanto profonda fosse per i valdesiani la divergenza con l’anabattismo occorre tornare a ripercorrere i momenti del processo di conversione al radicalismo guidato da Juan de Villafranca, che si asteneva dall’evocare battesimo e ribattesimo, sospendendo la critica ai sacramenti avanzata nei primi livelli dell’iniziazione e spostando l’attenzione dai sacramenti al dogma della trinità. Villafranca demoliva passo passo sei sacramenti su sette, mentre subito dopo orientava il discorso su tutt’altro piano. Un silenzio non casuale, che derivava da motivazioni rilevanti, che contribuiscono a spiegare gli scontri visti dispiegarsi nel Nord-Est alla metà del secolo. Considerando la scarsa importanza riconosciuta dai valdesiani agli aspetti ecclesiologici e liturgici – al punto che era ammesso di assistere nicodemiticamente alla messa –, è facile ricondurre tale disinteresse alla natura rituale del battesimo (e del ribattesimo). L’esempio della messa appena fatto, nel contempo, invita a considerare il fenomeno meno scontato di quanto possa apparire. Alla messa, infatti, era consentito di assistere ma simulando e, nel percorso graduale di conversione, coloro che si spingevano oltre l’accettazione della giustificazione per fede e delle sue conseguenze passavano dal livello moderato a quello radicale proprio attraverso la negazione della messa. La stessa eucaristia era inoltre un rito, e anche in questo caso il percorso iniziatico orientava l’adepto a criticarla. L’apparente silenzio sul battesimo, pertanto, la sua mancata contestazione in quanto rito (oltre che sacramento), discendeva da cause più remote, sulle quali vale la pena di indagare. Valdés aveva evitato di soffermarsi sulla questione del battesimo, liquidandola con un «e par necessario che si faccia così»146. Resta da spiegare, tuttavia, perché Villafranca non traducesse il disinteresse in critica espressa, così come aveva fatto con i restanti sacramenti. Dietro quel silenzio, insomma, c’era qualcos’altro. Un indizio in tal senso danno le rivelazioni di Giulio Basalù, che fra i testi letti durante la sua iniziazione incluse «contra annabatistas qualche carta». È difficile stabilire a quale scritto volesse riferirsi, vista la quantità di opere e libelli antianabattistici che percorsero l’Europa dopo la guerra dei contadini e il violento assalto ad essi di Lutero. Ma è proprio il modo in cui Giulio ne riportava il titolo a essere rivelatore, giac117
ché svela che, in realtà, nel processo di conversione al radicalismo valdesiano il silenzio sul battesimo era affiancato alla critica espressa «contra annabatistas». L’atteggiamento insieme silente e critico di Villafranca si riconnetteva alla realtà storica del radicalismo europeo della prima metà del Cinquecento, clamorosamente percorso dalle tensioni indotte dal settarismo d’ispirazione anabattistica. Le ribellioni che insanguinarono l’Europa – dalla guerra dei contadini147 a Münster148 – gettarono un’ombra di discredito totale su quel radicalismo estremo, il che senza dubbio condizionò anche i valdesiani, la cui raffinata e nicodemitica religiosità era certo poco incline all’esaltazione profetica e alle tensioni rivoluzionarie149. Di tale pessima fama vi sono infinite tracce, ed è interessante coglierne l’eco ancora nel 1565, in una lettera di Giorgio Biandrata al leader antitrinitario polacco Grzegorz Paweł in cui, nella fase di fondazione dell’Ecclesia minor, gli consigliava di evitare accuratamente di agitare la scottante questione del battesimo agli infanti150. Saggio suggerimento, eppure inascoltato: l’Ecclesia minor fratrum polonorum avrebbe rappresentato l’unico tentativo di realizzare una convivenza fra tendenze anabattistiche e antitrinitarie destinato a qualche durata. Fu tuttavia una convivenza conflittuale, e gli scontri sulle concezioni anabattistiche – dalla separazione dal mondo al ribattesimo degli adulti – furono oggetto di dissidi che si perpetuarono nell’inconcludente verbosità del cosiddetto sinodo ininterrotto di Raków. Fausto Sozzini, del resto, non accettò mai di ribattezzarsi e criticò la pratica del ribattesimo nel De baptismo aquae disputatio, nel quale considerò il battesimo un adiáphoron151, un elemento inessenziale alla vera fede. Gli esiti del confronto-scontro tra radicalismo antitrinitario e anabattistico che percorse l’Europa del Cinquecento suggeriscono quanto a indurre al disinteresse e alla critica di Villafranca non fosse solo il discredito che circondava gli anabattisti stessi. Non si trattava soltanto d’opportunità: dopo la tragedia di Münster, infatti, con personalità come Menno Simons152 e Jakob Hutter153 si erano consolidati orientamenti non violenti, con un netto distacco rispetto alle tendenze millenaristiche e rivoluzionarie degli anni precedenti. Tuttavia, almeno fino agli incontri veneti, ciò non aveva indotto i valdesiani a mutare d’opinione, giacché le differenze erano in realtà ben più marcate: erano molti dei principi stessi dell’anabattismo che si ponevano a notevole distanza da quelli perorati dal valdesianesimo. 118
Sebbene di anabattismo al singolare non si possa a rigor di termini parlare, in effetti se ne possono identificare alcuni tratti comuni, come dimostrano testi come i sette articoli della Confessione di Schleitheim del 1527154, contro i quali Calvino fondò il suo attacco contro la secte des anabaptistes ancora nel 1544 e che affiorano tra le «antique opinioni» dei discepoli italiani di Tiziano155. Già nella premessa ai sette articoli si faceva polemico riferimento ad «alcuni falsi fratelli [che] si sono allontanati dalla fede avendo erroneamente creduto di usare e di praticare la libertà dello spirito e di Cristo. Costoro, però, hanno smarrito la verità e si sono abbandonati (a loro arbitrio) alla lussuria e alla libertà carnale, e hanno ritenuto che la fede e l’amore possano fare e tollerare tutto e che nulla sia per loro né dannoso né riprovevole, dal momento che essi credono così»156. Sin dalle scaturigini dell’anabattismo era affiorata una frattura tra il rigorismo settario di questa tendenza e il ben diverso atteggiamento di quanti propendevano verso più fluide tendenze «spiritualizzanti e libertine»157, che ponevano l’accento su una libertà individuale irriducibile a qualsiasi Chiesa o setta, rispettando chi avesse idee diverse. Non è dunque un caso che gli incontri tra movimenti spiritualistici e sette anabattistiche che si dipanarono nell’Europa del Cinquecento – dalla Strasburgo degli anni Venti-Trenta158 al Veneto degli anni Cinquanta alla Polonia della seconda metà del secolo – offrirono ragioni di conflitto più che di compenetrazione. Né sarebbe potuto essere altrimenti, giacché le differenze erano profonde e investivano la sostanza stessa del modo di intendere e praticare la religiosità. Col rito del battesimo agli adulti si segnava l’ingresso in una nuova Chiesa – la «vera Chiesa» –, inculcando negli adepti inclinazioni settarie lontane dallo spiritualismo valdesiano, caratterizzato al contrario dal suo rifuggire ogni istituzionalizzazione ecclesiale, destinata di per sé a limitare gli ambiti di libertà interiore che insegnava a percorrere il valdesianesimo. Alla chiusura settaria corrispondeva peraltro, negli anabattisti, quasi sempre un esasperato biblicismo, il che approfondiva ulteriormente la distanza con la libertà critica e alumbrada con cui insegnava a porsi Valdés di fronte al testo sacro, per non parlare dello spregiudicato atteggiamento dei più radicali, che giungevano a ritenere false alcune parti dei vangeli quando non l’intero Nuovo Testamento: di tale frattura tra i due mondi rispetto all’approccio verso le Scritture è emerso chiaro il segno nella posi119
zione di Tiziano, che «contrastava grandemente, [...] perché lui allegava che distruggendo una parte se veniria a destrugger il tutto». L’individualismo dei valdesiani, inoltre, induceva a una stretta socialità coi compagni di fede, caratterizzata da un forte senso dell’aiuto reciproco derivante dall’accentuazione degli aspetti morali del cristianesimo, e in specie dell’amore e della carità. Proprio in quanto costituita da individui consapevoli di poterla pensare in modo diverso, però, tale socialità non si strutturava mai in Chiesa né presentava la chiusura settaria e la separazione dal mondo tipica dell’anabattismo. Certo, come ebbe a sottolineare Troeltsch, l’istituzionalizzazione in Chiesa era qualcosa di diverso dalla strutturazione in setta. Non a caso l’intolleranza spinta fino alla condanna a morte emerse sia tra i cattolici sia fra i riformati, ma non tra gli anabattisti. Nello stesso tempo, già negli articoli della Confessione di Schleitheim, se non si era evocato il ricorso alla forza in coerenza col principio che il cristiano non potesse tenere la spada né giudicare, si era teorizzata la prassi del bando, della scomunica dei «fratelli e sorelle, i quali tuttavia scivolano e cadono talvolta in qualche fallo e peccato e ne sono inavvertitamente sorpresi»159: una concezione rigorista tipica delle forme di anabattismo che percorsero l’Europa, come mostrano per il caso qui indagato le scomuniche lanciate dai fratelli veneti contro dal Borgo e Laureto e come svelano anche altre testimonianze. Matteo dalle Maddalene rivelò come Giacometto stringaro gli avesse insegnato che allorquando un fratello «havesse commesso adulterio o robato o biastemato o fatto qualche altro eccesso contra la nostra dottrina, colui che lo vedeva lo reprendeva et admoniva da solo a solo, et se colui non si emendava, tornava un’altra volta ad admonirlo insieme con un altro, et se questa seconda volta il non si emendava colui lo diceva poi a tutti, et questo tale era scacciato dalla nostra Chiesa»160. Anche tra gli stessi antitrinitari in fondo, nel momento in cui raggiunsero in Transilvania lo status di confessione ammessa, affiorò quella stessa intolleranza per sottrarsi alla quale avevano percorso le plaghe europee: la disputa non adorantista spaccò il mondo della dissidenza antitrinitaria, con Giorgio Biandrata e Fausto Sozzini concordi nel condannare l’estremismo di Ferenc Dávid, convinto che una volta negata la divinità di Cristo non gli si dovessero più rivolgere neppure le preghiere. Una convinzione che costò la condanna al carcere dell’eretico ungherese e ne causò la morte161. 120
Una tale intolleranza, connessa al processo di istituzionalizzazione tipico (pur in gradazioni diverse) sia di Chiese sia di sette, era incompatibile con qualsiasi forma di valdesianesimo, contraddistinto al contrario da un cosciente riconoscimento della libertà religiosa e ostile a ogni logica ecclesiale. Inoltre, la vita comunitaria rigorista e disciplinata che cercava di fare degli anabattisti una «comunità di santi», e che si spingeva fino alla comunanza dei beni predicata dagli hutteriti ma anche – come si è visto – da alcuni anabattisti italiani, era troppo vicina al monachesimo per essere accettata dai discepoli ed epigoni di Juan de Valdés, che aveva affermato: «Aunque soy un pobre gentilhombre, huelgo de bivir a la real»162. Sebbene con minori pretese, era sicuramente più vicino a quest’habitus che a quello di Tiziano Bruno Busale quando, a domanda degli inquisitori «‘a che fine, a che effetto facevi questa professione [di fede ereticale], a che volevi riuscire?’, respondit: ‘A vivere bene, et non altro’»163. Né tra i valdesiani v’è traccia del rifiuto anabattistico – presente già nella Confessione di Schleitheim e ribadito da Tiziano – di partecipare alla vita pubblica: Valdés trattava affari riservati dell’Impero, Villafranca collaborava col viceré e Capece era ascritto alla massima magistratura del Regno di Napoli, per limitarsi solo a qualche esempio164. Certo, gli incontri veneti dimostrano che ci fu almeno un’occasione in cui si tentò un intreccio tra l’approccio individualista e critico dei valdesiani radicali e quello comunitario e biblicista degli anabattisti. Indubbiamente c’erano le basi per una discussione comune, e se n’è visto un saggio nella concordia raggiunta sui principi luterani e – si può aggiungere – sacramentari. Anche su posizioni più radicali, poi, in teoria le possibilità d’incontro non mancavano: basti pensare alla dottrina del sonno delle anime, tipica non solo dei valdesiani radicali ma anche di alcuni gruppi anabattistici165, benché non di quelli veneti, che accolsero tale idea proprio dai napoletani, che la misero sul tappeto in occasione dei colloqui vicentini. Peraltro, la versione valdesiana del sonno delle anime era carica d’un predestinazionismo che sottendeva una vena materialistica, espressa nella mortalità delle anime dei non eletti: una variante che non risulta presente nelle concezioni anabattistiche di alcun tipo, e tanto meno in quelle del Nord-Est, dove già dagli anni Quaranta s’era diffusa invece una forma di predestinazionismo priva d’ogni eco materialistica. Anche dove sembra ci siano sovrapposizioni, pertanto, oc121
corre procedere con grande cautela; e ciò vale ancor di più per il nesso che pare potersi istituire su un tema come quello della poligamia, proclamata a Münster e poi perorata da Bernardino Ochino, che tuttavia sembra piuttosto atipica sia per gli anabattisti sia per i valdesiani166. I punti di incontro erano insomma inferiori rispetto a quelli di scontro, e ciò lasciava presagire il fallimento del tentativo fatto da Busale con i suoi compagni. Indubbiamente, il settarismo comunitario e una pur minima organizzazione davano agli anabattisti una forza di cui i valdesiani – e in genere i movimenti spirituali e libertini – non potevano disporre nel loro individualismo estremo, il che contribuisce a spiegare la strategia intessuta dai napoletani nel tentativo di entrare all’interno dell’organizzazione dell’anabattismo, con lo scopo di attrarre una tra le più solide forze radicali del momento. Ma le divergenze sarebbero affiorate clamorosamente, e in ciò vanno cercate le cause del conflitto che nel 1550 contrappose i radicali del Nord-Est a quelli del Sud, segnando due forme diverse (se non incompatibili) di radicalismo. Tutto ciò dimostra quanto sia errata la persistente definizione di anabattismo antitrinitario, spesso utilizzata per descrivere le forze radicali dell’eresia italiana, e che può applicarsi solo alla breve e fragile convergenza tra veneti e napoletani, oltre che ai fratelli polacchi dell’Ecclesia minor, almeno fino a un certo periodo167. Non sembra infatti che, nonostante la sua difesa di Servet, l’eresiarca siciliano Paolo Ricci alias Lisia Fileno alias Camillo Renato – legato a posizioni anabattistiche nutrite da uno spiritualismo radicale – avesse sposato posizioni antitrinitarie. Non almeno da ciò che emerge dalla ricognizione effettuata da Antonio Rotondò168. Discorso diverso va fatto invece per un altro siciliano, il benedettino cassinese Giorgio Rioli alias Giorgio Siculo, che coniugò istanze dell’anabattismo con una posizione antitrinitaria: Negava costui tutti gli sacramenti della Chiesa, la libertà della Chiesa et più diceva l’anima nostra non esser creata da Iddio ma dagli huomini insieme col corpo. Diceva non esservi né inferno né purgatorio ma l’anima nostra andar volando per aria sino al giorno del giudicio et quando serà in gratia più non potere peccare et quando serà peccato più non poter ritornar in gratia, negava costui la trinità et molte assai altre cose et tutti gli miracoli dil sacramento esser fatti per opera dil diavolo169. 122
Tale ricostruzione risulta confermata, almeno in parte, dalle abiure di alcuni seguaci del Siculo, processati tra il 1567 e il 1568: il benedettino cassinese Antonio da Bozzolo e il medico e professore Francesco Severi. Entrambi erano giunti a rifiutare il battesimo agli infanti e a esprimere dubbi sul dogma della trinità170, nonché a sostenere la dottrina del sonno delle anime post mortem, seppure seguendo una concezione meno eversiva di quella dei valdesiani radicali, giacché i seguaci di don Giorgio ritenevano che dopo il giudizio universale ai dannati fossero comunque riservate le pene eterne dell’inferno, nel mentre per i discepoli di Villafranca e di Busale al sonno dei malvagi non subentrava nient’altro che la morte eterna, con la resurrezione riservata ai soli eletti171. Prosperi ha evidenziato come le radici del «soggettivismo spiritualistico estremo» dei seguaci del siciliano non possano risalire al monachesimo benedettino cassinese, nell’alveo del quale inizialmente si era mosso il «satanico» don Giorgio. Dove cercare, allora, nessi con un anabattismo antitrinitario allorquando tale vero e proprio sincretismo fu estremamente raro nell’Europa del Cinquecento? Varrà la pena di ricordare che Giorgio Rioli fu condannato a morte a Ferrara nel maggio del 1551, poco dopo il rogo di dal Borgo e poco prima delle rivelazioni di Manelfi. Se questo può sembrare un legame estrinseco con le vicende qui ricostruite, sarà bene aggiungere che a Ferrara Rioli era attivo e seguito da discepoli devoti («la setta di Georgio») già nel decisivo 1550, in quella stessa Ferrara che in quel medesimo anno fu tra i centri dei gruppi radicali del NordEst. Tutto ciò è stato evidenziato da Ginzburg, che ha sottolineato come nell’estate ferrarese del 1550 si concretizzasse la possibilità di un incontro tra i due gruppi, giacché Siculo vi era ancora a piede libero (fu imprigionato in settembre) e Tiziano vi soggiornò per circa un mese. Ginzburg ha poi dimostrato come almeno un personaggio permetta di legare i seguaci di Siculo ai radicali del NordEst: il medico Pietro Bresciani di Casalmaggiore, vicino sia alla setta di Rioli sia a Tiziano, col quale fu cacciato dai Grigioni nel 1549. In base a ciò, lo storico torinese ha dedotto che «è impensabile che in quell’estate Tiziano non avesse rapporti con l’amico che aveva conosciuto nei Grigioni»172. Del resto, si è visto come in quel momento, in quell’estate del 1550, Tiziano si dibattesse in una situazione di difficoltà, conseguente agli insuccessi mietuti sia ai colloqui padovani sia a quelli vicentini. Pertanto, pare probabile che cer123
casse alleanze ulteriori, e di qualche prestigio, per riequilibrare una situazione che gli appariva compromessa. In questa prospettiva, la stessa scelta di convocare un colloquio di radicali a Ferrara sembra porsi in una luce più congrua. Si può aggiungere, inoltre, che almeno un altro personaggio potrebbe connettere i due ambienti: don Antonio Pagano, cappellano della duchessa di Ferrara (e vicino a Renata di Francia era pure Bresciani). Pagano era legato ai radicali del Nord-Est, ed è probabile che fosse vicino anche alla setta del Siculo173. Poiché quindi risulta documentato almeno un nesso tra i due ambienti (e forse due), è apparso probabile sia a Ginzburg sia a Prosperi che il radicalismo di Rioli trovasse le sue radici anche nella predicazione di Tiziano. Tuttavia, a parte la critica al battesimo, tale ricostruzione cozza con la realtà dello scontro che segnò i radicali italiani nel 1550. S’è visto, infatti, come Tiziano cercasse di mantenere la barra sulle «antique opinioni» degli anabattisti, opponendosi all’antitrinitarismo critico dei napoletani. La posizione antitrinitaria di Siculo, dunque, non poté essere indotta da Tiziano, che in quell’estate del 1550 era anzi il più risoluto oppositore degli antitrinitari. Stesso discorso va fatto per il sonno delle anime perorato dal visionario siciliano. Anche in questo caso, infatti, si tratta di dottrine che non appartenevano alla cultura anabattistica di Tiziano, ma a quella valdesiana di Busale. Pertanto, se si vuole trovare un nesso tra il mondo radicale germinato attorno al Siculo e quello diffuso nel Nord-Est è ai valdesiani radicali e ai loro alleati che sembra utile guardare e non agli sconfitti anabattisti. Piuttosto, le eresie di Rioli dimostrano che il tentativo di Tiziano di intessere nuove alleanze a Ferrara, se vi fu, dovette registrare un ulteriore fallimento. Non a caso, tra i lacerti di documentazione superstite nessuna traccia si trova in Siculo delle «antique opinioni» care a Tiziano e agli anabattisti, e dalla confessione di Antonio da Bozzolo sembra piuttosto emergere una presa di distanza da alcune di quelle dottrine174. Tutto ciò non fa che contribuire a dare il giusto peso ai vari legami con personalità vicine al movimento valdesiano che Siculo intrattenne negli anni precedenti la sua svolta radicale. Basti pensare al primo autore del Beneficio di Cristo, Benedetto Fontanini, al quale Rioli era legato strettamente. Una vicinanza significativa, ancor più se fosse confermata l’ipotesi avanzata da Ginzburg, Prosperi e Fragnito175, secondo i quali Fontanini fu indagato nel 1550 insieme 124
con l’altro benedettino Luciano degli Ottoni per eresie analoghe a quelle professate da Rioli nel suo Libro grande – e dunque anche per anabattismo e antitrinitarismo. Esito più che probabile, laddove si consideri che già Basalù aveva collocato Fontanini al grado sacramentario, cioè a quello dopo il quale, nel magistero di Villafranca, si negava la divinità di Cristo. Dal che si può osservare come da analoghe premesse si potesse giungere a conclusioni simili pur muovendo lungo percorsi differenti. Del resto, Fontanini non fu l’unico contatto col mondo valdesiano di don Giorgio, sullo sfondo della vita del quale si muovono «ombre potenti» come Marcantonio Flaminio, Ercole Gonzaga, Camillo Orsini e, soprattutto, Reginald Pole: colui al quale Siculo avrebbe rivelato i segreti comunicatigli in una visione mistica da Cristo in persona176. A parte i rapporti personali, poi, molte dottrine centrali di Rioli – la dissimulazione, il gradualismo esoterico, l’illuminazione – rinviano alla «grammatica» e alla «retorica» di Juan de Valdés. La stessa insistenza sul libero arbitrio di don Giorgio, pur nutrita anche da echi benedettino-pelagiani, era certo meno contraddittoria rispetto al valdesianesimo di quanto lo fossero sia la posizione cattolica sia quella luterana. D’altronde, già Ginzburg aveva evidenziato la vicinanza di Siculo a Fontanini, «personaggio così strettamente legato al circolo del Valdés» da lasciar supporre legittimamente che la stessa teoria della dissimulazione espressa nell’Epistola [...] alli cittadini di Riva di Trento potesse trovare nel valdesianesimo le proprie radici177. E lo stesso Prosperi, pur senza approfondire la questione e lasciando l’esule spagnolo sullo sfondo del suo suggestivo affresco178, non ha mancato di sottolineare, riferendosi a un viaggio a Napoli di Siculo, che «con l’ambiente di Juan de Valdés non erano mancati i contatti durante la redazione del Beneficio di Cristo; le strade erano diverse, ma c’era un contesto comune e non mancavano i legami personali»179. Il sincretistico anabattismo antitrinitario di Rioli, insomma, potrebbe trovare spiegazione nella particolare temperie del 1550 italiano, e probabilmente non è da addebitare alla sola stretta repressiva la non grande incidenza che il suo messaggio ebbe negli sviluppi degli anni successivi, quando le due tendenze (anabattismo e antitrinitarismo) furono piuttosto distinte e le declinazioni italiane delle eresie radicali si diffusero nei territori europei seguendo strade diverse, anche se talora nuovamente convergenti. Nessun seguace di 125
don Giorgio appare tra gli esuli italiani studiati da Delio Cantimori, mentre un ruolo da protagonista assunsero valdesiani della diaspora come Bernardino Ochino e Valentino Gentile, che avrebbero approfondito la questione dell’antitrinitarismo contribuendo a fondarla su più solide basi dottrinali, disinteressandosi sia della questione del battesimo (pur agitata dall’ultimo Servet180) sia delle altre «antique opinioni» degli anabattisti. Anche restando su suolo italiano, sembra che ulteriori indizi sullo scarto esistente tra il settarismo anabattistico e il radicalismo libertineggiante di parte del movimento valdesiano possano trarsi da un caso più tardo e di norma avulso dalle ricostruzioni di storia ereticale, quello del mugnaio Domenico Scandella, detto Menocchio181. Richiamando l’attenzione sulla possibilità che questi avesse tratto alcune delle sue opinioni (pur rivisitate alla luce di un sostrato di credenze contadine) dal contatto diretto o indiretto con gli ambienti radicali del Nord-Est, Ginzburg ha mostrato anche le aporie rispetto a punti nodali dell’anabattismo, evidenziando, tra l’altro, come il mugnaio friulano non desse peso alcuno alla questione del ribattesimo: «Credo che subito nati siamo batteggiati – avrebbe confessato –, perché Iddio ci bateza che ha benedetto ogni cosa»182. A fronte di questa e di altre incongruenze, istruttivo sembra un confronto fra le idee di Scandella e quelle di personaggi come Giulio Basalù. Le similitudini sono sorprendenti, non limitandosi a un generico antitrinitarismo (Cristo puro uomo, la Madonna non vergine ecc.) peraltro avulso dalla tradizione anabattistica. Menocchio riteneva Gesù un semplice uomo ma attribuendogli «maggior dignità»183, al pari dei valdesiani giunti alle diaboliche opinioni che avevano tratto la definizione dalla lettura del Corano (probabilmente letto dallo stesso mugnaio). Scandella vedeva in Gesù un «homo da bene», esattamente come l’aveva definito Basalù. E come quest’ultimo riteneva le religioni un’impostura politica, si disinteressava al problema del battesimo e rivelava incomprensione per la predestinazione184, condendola con un’incredulità nella vita ultraterrena analoga a quella del legista napoletano ed espressa con parole molto simili: «Cavai questa mia opinion che morto il corpo morisse anco l’anima, poiché di tante e diverse sorte di nationi chi crede a un modo et chi a un altro»185. Analoghe a quelle dei valdesiani radicali erano inoltre la credenza nella falsificazione dei vangeli e l’insistenza sulla carità186, oltre che sulla tolleranza e più in genera126
le sulla libertà individuale187, secondo tendenze che poco avevano a che fare col settarismo anabattistico (salvo la questione della carità); e così come Basalù, Menocchio ci teneva a precisare che «quelle opinioni ch’io ho havuto lo ho cavate dal mio cervello»188, benché come il legista anche il mugnaio non avesse mancato di leggere testi che ne avevano orientato le credenze. Naturalmente, la vulcanica personalità di Scandella aveva poi rielaborato in modo personale molte di quelle idee eterodosse (come Basalù, d’altronde), e tuttavia la sovrapposizione tra molte sue opinioni e alcuni cardini del radicalismo valdesiano è indubbia: Ginzburg aveva d’altro canto sottolineato come «il suo radicalismo religioso, anche se occasionalmente si era nutrito dei temi della tolleranza medievale, s’incontrava piuttosto con le raffinate teorizzazioni religiose degli eretici contemporanei di formazione umanistica»189. In effetti Menocchio era nato nel 1532. Al tempo del processo subito da Basalù aveva quindi 23 anni, e dai primi interrogatori del mugnaio (del 1583) emerse come alcune idee le avesse maturate da circa un trentennio190: dal 1553 e dintorni, esattamente allorquando s’era diffuso nel Nord-Est il radicalismo dei napoletani. Menocchio stesso non mancò di ricordare d’essersi più volte recato a Venezia191, e si ricorderà come Basalù avesse lamentato che del suo caso si parlava nelle «piazze» della città lagunare. Inoltre, come s’è visto, tra i radicali del Nord-Est non mancavano gli adepti friulani né i mugnai. Se proprio si vuol cercare uno sfondo ereticale dietro le opinioni a volte stravaganti di Domenico Scandella, insomma, non sembra sia proficuo guardare né ai catari né agli anabattisti stricto sensu – come pur s’è fatto –, ma a quel momento particolare dell’anabattismo veneto in cui, per una breve fase, fu dominante la visione antitrinitaria, critica e materialistica indotta dai valdesiani radicali. Certo, non mancavano le differenze: Basalù era più propenso a una forma di proto-deismo, mentre Scandella indulgeva verso il panteismo. Ma una posizione analoga può ravvisarsi anche tra i valdesiani come Scipione Capece, che definì l’aer come il principio divino sparso ovunque, usando lo stesso termine («aere») utilizzato successivamente da Menocchio192, sebbene quest’ultimo identificasse tra varie contraddizioni l’aria con Dio e vedesse nel fuoco il principio primordiale del mondo193. Naturalmente, infatti, con ciò non si vuol ipotizzare che Scandella avesse letto il De principiis rerum (pur sempre edito a Venezia, però), mentre non è escluso che al riguardo le fonti del mu127
gnaio fossero orali e piuttosto indirette; ciò che invece conta è che le contraddizioni rilevate da Ginzburg tra le opinioni di Scandella e le tendenze anabattistiche sono almeno in parte risolte attraverso il legame col radicalismo valdesiano, penetrato nel Nord-Est alla metà degli anni Cinquanta, al quale Menocchio poté attingere attraverso vari canali di circolazione delle idee: un radicalismo che anche in un caso estremo e atipico come il suo rivela caratteri differenti da quello degli anabattisti.
Conclusioni
Eretici e libertini
Esclusa la possibilità di adoperare la nozione di anabattismo antitrinitario, resta il problema di come classificare gli esiti dei più radicali valdesiani di cui si sono qui ricostruite le vicende e le opinioni. Si tratta di operazione complessa, considerando i lidi cui si spinsero personalità come Giulio Basalù, Scipione Capece e altri promotori di convinzioni religiose così personali che può apparire indebito inserirle in questa o quella corrente di pensiero. Tale operazione, nondimeno, è tutt’altro che forzata: forzato essendo piuttosto il tentativo di lasciare personaggi come Basalù in una categoria residuale. È questa la posizione di Aldo Stella, che ha definito «saltuario e troppo superficiale» l’«itinerario religioso di quell’avvocato napoletano che fu sollecito, per salvaguardare i suoi interessi professionali, ad abiurare»1, confinando le sue posizioni in una sfumata categoria di scetticismo. Ora, a parte l’indebita sottovalutazione, è davvero possibile definire Giulio e i suoi compagni come degli scettici? Per uscire dal generico di una declinazione dello scetticismo in una mera inclinazione al dubbio, è opportuno ricordare che lo scetticismo è una corrente filosofica, scaturita dalle idee del mitico Pirrone di Elide e divulgata da opere come le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, gli Academicorum libri di Cicerone e, soprattutto, le Istituzioni pirroniane e l’Adversus mathematicos di Sesto Empirico. Gli europei dell’età moderna conobbero lo scetticismo antico a partire dalla pubblicazione delle Istituzioni pirroniane nel 15622. Tra le eccezioni ad oggi note possono ricordarsi Gian Francesco Pico della 129
Mirandola e Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheim: salvo a dimostrare che Basalù (o qualcuno dei suoi amici) conoscesse gli scritti e il pensiero di Pico o Agrippa, difficilmente lo si può definire uno scettico, se non per la sua attitudine radicale al dubbio. In realtà, il suo atteggiamento sembra derivasse da tutt’altre fonti: dal metodo critico dell’Umanesimo filologico, che trovò un terreno fecondo negli ambienti colti meridionali, radicalizzandosi a contatto con l’individualismo di valdesiani come Busale e Villafranca. Basalù lesse sia Valla sia Erasmo; e le testimonianze descrivono il metodo di Villafranca come incline a suscitare dubbi, anche a partire dal dettato scritturale, secondo un carattere tipico del pensiero di Juan de Valdés3. Che all’attitudine al «dubbio critico» (non scettico) si fosse pervenuti negli ambienti della dissidenza religiosa, era anche una conseguenza della rottura dell’unità del cristianesimo avviata da Lutero: se questi aveva dimostrato che la verità non stava nel magistero papale, ottenendo un successo clamoroso in nome dell’incoercibilità della coscienza, perché non dubitare delle opinioni dello stesso Lutero? Già dagli anni Trenta-Quaranta del Cinquecento, agli europei erano alquanto chiare le differenziazioni indotte dall’avvio della Riforma: dai luterani agli zwingliani ai calvinisti, fino agli anabattisti e ai libertini4. Una volta sovvertita l’unicità della Chiesa, perché non ragionare dubitando invece che per dogmi e per autorità? Il problema fu posto da più parti, e a contatto con l’individualismo radicale di movimenti come quello valdesiano era lecito aspettarsi che il dubbio critico conducesse a conclusioni estreme. D’altro canto: «Dubius in fide est haereticus»5. Si potrebbe aggiungere al quadro cognitivo che favorì in Europa l’insorgere del dubbio, lo sconvolgimento causato dalla scoperta di quel nuovo mondo di cui le Scritture non avevano parlato6, anche se al riguardo si possono avanzare solo ipotesi nel caso qui in esame: nessuna prova dimostra tra i valdesiani radicali coscienza delle conseguenze della scoperta dell’America. Al di là del rischio di anacronismo insito nel definire Basalù o altri suoi compagni come degli scettici, sono le posizioni dello stesso Giulio a smentire tale classificazione. Neanch’egli infatti giunse al termine del suo percorso all’epoché, alla sospensione del giudizio caratteristica delle scuole scettiche. Dubitando di certezze consolidate, al contrario, aveva cercato di raggiungere qualche essenziale ve130
rità, e Giulio volle sottolineare di credere in un Dio regolatore. Non sospese, dunque, il giudizio su tutto ciò che riguardasse il mondo trascendente; anzi, lungi dal fermarsi alla fede in Dio, Basalù fece proprie varie opinioni estreme: credeva alla mortalità dell’anima e alla falsificazione delle Scritture; credeva nella liceità del concubinato e nell’eternità del mondo; credeva che «tutte le religione fossero inventione di homini per indur li homini al ben vivere». E anche nella negazione egli non era meno fermo: non credeva alla transustanziazione e neanche che Cristo fosse Dio; non credeva che la Madonna fosse vergine né all’inferno o al paradiso; non credeva in alcuna religione. Su questo piano, semmai, può osservarsi come Basalù si spingesse oltre la posizione (pure molto radicale) che avrebbe perorato Sébastien Castellion nel De arte dubitandi 7. Lungi dal presentarsi come uno scettico, ma fautore di un estremo dubbio critico, il savoiardo mirava a trovare essenziali verità, che dai dubbi e dalle fratture indotte dalla Riforma riportassero la pace e l’unità in nome di pochi articoli di fede. L’esistenza di un dio, come in Basalù, era la prima di tali nozioni, ma anche la convinzione dell’autenticità delle Scritture e della supremazia del cristianesimo sulle altre religioni. Certo, Castellion si riferiva a un cristianesimo ridotto a norma morale, ma Giulio Basalù si era posto su un piano più eversivo rigettando in toto il cristianesimo, che equiparava alle altre religioni considerandolo un’invenzione umana. Si trattava, comunque, di un modo più radicale di porsi lungo una scia dai tratti analoghi a quella che avrebbe percorso Castellion. Il percorso di Basalù e di altri valdesiani non fu pertanto il frutto di una stramberia, e neanche fu dovuto all’accettazione dello scetticismo. Se si vuol proprio evocare la cultura classica per comprendere le fonti del radicalismo valdesiano, più fondato è il riferimento all’epicureismo di Lucrezio, vate della mortalità dell’anima. Sebbene tra i napoletani prevalesse la dottrina del sonno delle anime dei giusti e della morte di quelle dei malvagi, non mancarono personalità come Basalù e Capece che spinsero in chiave più materialistica tale concezione, affermando la mortalità di tutte le anime. Il nome di Lucrezio del resto circolava a Napoli almeno dal Quattrocento: da Lorenzo Valla8 a Michele Marullo9, fino a Pontano, Girolamo Borgia e Sannazaro10. Per non parlare di Palingenio Stellato, «tutto pervaso di ammirazione per Epicuro e Lucrezio»11. Nel milieu degli accademici 131
cosentini, poi, tracce lucreziane emergono in Parrasio, in Antonio Telesio e soprattutto nel medico Vincenzo Pontieri (o Ponterio), autore di un commento perduto al De rerum natura12. Nondimeno, la maggiore espressione della presenza di Lucrezio tra i napoletani è data da Scipione Capece, che nelle sue opinioni mostrava i segni sia dell’epicureismo sia dell’eterodossia soggettivistica di Juan de Valdés. Proprio questo intreccio tra Riforma e Rinascimento, che affiora nei frutti radicali di Capece, ribadisce la difficoltà di ridurre il radicalismo valdesiano a questa o quella categoria della cultura europea del Cinquecento. Scartate le nozioni di scetticismo e di anabattismo antitrinitario, resta il problema di come inquadrare Basalù, Capece e gli altri valdesiani radicali nelle correnti culturali di quel tempo. Certo, si potrebbe far ricorso alla categoria di antitrinitarismo, e tuttavia per quanto la negazione della divinità di Cristo fosse comune a tutte le forme del radicalismo valdesiano, essa rappresentava solo il primo passo di un percorso ereticale più complesso già in Juan de Villafranca. Si è messo in rilievo, invece, quanto le idee di Basalù fossero sovrapponibili a un catalogo di concezioni libertine: mortalità dell’anima, una sorta di proto-deismo, eternità del mondo, una certa licenza carnale, le religioni come «inventione di homini per indur li homini al ben vivere»; un’ironia, a volte sboccata, nei confronti delle religioni e di personalità come David e Mosè; Cristo come mero «homo da bene che haveva insegnato el ben viver»; l’inesistenza di paradiso e inferno e i miracoli visti in tutte le religioni, e dunque in nessuna. Se queste (e altre) idee sono patrimonio della più radicale tradizione libertina del Seicento, sono del pari patrimonio di Giulio Basalù e di altri suoi contemporanei. D’altra parte, studiosi come Busson, Wirth, Cavaillé e van Veen, oltre a dimostrare l’esistenza di un libertinismo del Cinquecento, rivelano quanto esso vada ricondotto sì alla cultura rinascimentale, ma anche a esperienze della Riforma radicale. Su questo piano, i punti di contatto diventano maggiori se si considera che sia van Veen sia Wirth (ma anche Firpo e Millet) hanno legato i libertini attaccati nel 1544-45 a quelli che nel 1544 Calvino aveva definito i «nicodemiti»13. Tale nesso si giustifica sul piano dell’analogia di idee e di comportamenti: sia i libertini sia i nicodemiti facevano un uso consapevole di simulazione e dissimulazione. E qui Wirth ha legato al libertinismo cinquecentesco l’esperienza di Otto Brunfels, sul quale ave132
va insistito Carlo Ginzburg nel suo studio sul nicodemismo. Su un piano analogo si è posta van Veen, sostenendo che «during the 16th century the lines between Libertinism and Nicodemism were fluid»14. Simulazione e dissimulazione, svalutazione delle Scritture, spiritualismo sfociante nel soggettivismo religioso, «eccesso di libertà» nelle idee e nei comportamenti, questi e altri elementi permettono di legare libertinismo e nicodemismo, tanto da portare Millet ad affermare che «tout libertin est aux yeux de Calvin un nicodémite»15. Tale affermazione può sembrare che semplifichi la realtà, non mancando tra i due fenomeni le differenze; eppure è condivisibile il giudizio secondo cui «le libertinage spirituel apparaît comme une forme à la fois singulière et extrême de nicodémisme. Si le nicodémite est potentiellement un libertin, le libertin réalise à l’état pur les tendances fondamentales du nicodémisme»16. Si tratta di un modo di inquadrare il problema che si sposa felicemente con l’idea di vedere nel movimento valdesiano una gamma di posizioni dalle più moderate (nicodemitiche) alle più radicali (nicodemitiche e libertine). D’altronde, il nesso tra nicodemiti e libertini era giustificato da Calvino stesso. Il che non sembra essere stato sinora rilevato, nonostante basterebbe leggere un passo del Contre les libertins in cui, descrivendo la loro «liberté diabolicque», Calvino evidenziava come il couvrent aussi soubz le manteau de ceste liberté la simulation de consentir à toute impieté et idolatrie. C’est qu’ilz permettent à un homme de s’agenouiller devant un idole, porter chandelles, faire pelerinaiges, chanter messes et faire semblant de s’accorder à toutes les abominations des papistes, jasoit qu’il s’en mocque en son cueur. Si on leur replique que nous devons glorifier Dieu en noz corps17, que nous devons confesser Jesus Christ devant les hommes, que nous devons protester nostre foy devant le monde, au lieu de respondre, ilz ne font que mettre en avant ce bouclier de liberté18.
Già questo passo mostra come Calvino legasse i libertini ai nicodemiti, ma è il brano successivo a esser decisivo, laddove il riformatore sospendeva l’argomentazione: «Pource que j’ay amplement escrit de ceste matiere en un autre traicté, j’ayme mieux là renvoyer les lecteurs que de m’y arrester davantaige pour ceste heure»19, con un rinvio evidente proprio all’Excuse aux nicodemites nella quale, specularmente, aveva evocato i «Lucianesques ou Epicuriens» tra i 133
simulatori, senza approfondirne i caratteri poi sviluppati nel Contre les libertins e in altre opere come il Des scandales20. E si badi che non fu solo Calvino a legare nicodemiti e libertini, ma anche suoi contemporanei come Pierre Viret21. Posto che nicodemiti e libertini appartenevano – per Calvino e altri riformatori – a un medesimo genus, ciò favorisce l’ipotesi di legare il libertinage al movimento valdesiano, se si considera quale pregnanza avessero per Valdés e per il valdesianesimo simulazione e dissimulazione, quest’ultima intesa come cosciente teoria e non solo come pratica prudenziale22. Al pari del legame tra libertini e nicodemiti in generale, però, ciò non può bastare: la consonanza d’idee e di atteggiamenti non è argomento sufficiente (seppur fondamentale) per instaurare rapporti che, al di fuori d’ulteriori prove, potrebbero apparire concessioni a un’astratta storia delle idee. In particolare, se è emerso che Calvino accomunava nicodemiti e libertini, chi garantisce che con i nicodemiti si possano identificare anche i valdesiani? Si tratta di una questione antica, e alcuni hanno proposto di vedere l’Excuse aux nicodemites come rivolta solo al pubblico di lingua francese. Tuttavia, è arduo sostenere che il riformatore di Ginevra – che aveva soggiornato alla corte ferrarese di Renata di Francia – non sapesse nulla delle vicende dei dissidenti italiani e delle loro simulazioni e dissimulazioni. Tra coloro che vivevano «entre les papistes» ai quali Calvino si rivolgeva nel pamphlet, se c’erano i francesi c’erano indubbiamente anche gli italiani: in nessun luogo il riformatore si riferiva esplicitamente alla Francia, mentre costantemente diceva di indirizzarsi in generale a coloro che vivevano «en pais papistes»23. Per quanto riguarda poi specificamente i valdesiani, non può sottovalutarsi la circostanza che nel 1542 Ochino fosse giunto a Ginevra, dove si trovava negli anni in cui l’Excuse andava a stampa. Ochino che aveva scritto a Vittoria Colonna: «Dapoi che farei più in Italia? Predicar sospetto et predicar Christo mascarato in gergo?»24; e nel proemio alle sue Prediche edite a Ginevra nel 1542 aveva fatto riferimento alla simulazione e alla dissimulazione con cui aveva intessuto le sue prediche in Italia25. Calvino dunque – che aveva accolto a Ginevra «Bernardinus noster»26 – già nel 1542 disponeva di fonti dirette che testimoniavano quanto in Italia valdesiani come Ochino e Vermigli (con i loro numerosi estimatori) avessero simulato e dissimulato le loro opinioni. Certo, il testo calviniano era redatto in lingua francese; ma già nel Petit traité monstrant ce que doit faire un homme fidèle connaissant la 134
verité de l’évangile quand il est entre les papistes del 1543 – già nel testo che aveva innescato le polemiche a cui il riformatore replicò con l’Excuse –, dedicato ad analogo argomento e pure scritto in francese, Calvino non aveva mancato di richiamare al fianco della Francia altri paesi tra cui, appunto, l’Italia27. Infatti, ben presto (nel 1549) dell’Excuse e del Petit traité uscì una versione in latino, che ne attestava il pubblico internazionale di riferimento, di lì a poco seguita proprio da due edizioni in italiano: nel 1551 e nel 1553. La prima traduzione italiana sembra offrire, peraltro, un ulteriore indizio per avvalorare l’ipotesi che Calvino si riferisse anche ai valdesiani. In un passaggio, infatti, il riformatore evocava i «prothonotaires delicatz»28 in cui vari studiosi, tra cui Cantimori, avevano creduto di individuare il protonotario Carnesecchi, che può corrispondere al ritratto fornito nell’Excuse non solo per la carica da lui rivestita. Altri storici, però, hanno evidenziato quanto il riferimento fosse troppo sfuggente per identificare qualcuno in particolare e, ritenendo il testo rivolto al pubblico francofono, hanno proposto di vedere in quel prothonotaire qualche transalpino. Considerando la fallacia dell’inquadrare la polemica calviniana in un solo contesto nazionale, quest’ultimo assunto perde consistenza, ma ciò non è sufficiente a confermare l’ipotesi Carnesecchi. Nel rigettarla, ad esempio, Ginzburg ha sostenuto che il destinatario dell’ironia calviniana fosse il protonotario Celio Calcagnini, ritenendo che Calvino si riferisse a un italiano ma escludendo che si trattasse di Carnesecchi, giacché il riferimento sarebbe stato esplicito e compromettente29. Si tratta di un argomento da non sottovalutare, poiché il riformatore aveva evitato di fare riferimento a nomi e fatti specifici. Nondimeno, proprio perché il suo intento era di dare ai destinatari «occasion d’entrer en leurs consciences»30, qualche indizio che potesse esser compreso dai bersagli delle sue rampogne doveva pur fornirlo, e ciò sembra confermato dalla distinzione posta da Calvino stesso tra la dissimulazione che velando rivela (da lui ritenuta lecita) e l’autentica simulazione31. Infatti, è in realtà probabile che con quel «prothonotaires delicatz» Calvino volesse evocare, dissimulando, appunto Carnesecchi, ben noto a Ochino e facilmente individuabile ma solo a un lettore di lingua italiana che fosse addentro agli ambienti eterodossi (si ricordi che l’attività inquisitoriale era ancora agli albori). Non è dunque un caso che nel volgere il testo in italiano pochi anni dopo – quando l’Inquisizione aveva invece dispiegato le vele – Ludovico Domenichi 135
rendesse nicodemiticamente quel «prothonotaires delicatz» in «dilicati monsignori»32. Né d’altra parte può dimenticarsi come a quella data esuli quali Pier Paolo Vergerio e Francesco Negri avessero esplicitamente denunciato personalità come Reginald Pole, Giovanni Morone, Marcantonio Flaminio, Ascanio Colonna, Camillo Orsini e altri ancora33. A questi indizi si può aggiungere un’altra circostanza: Calvino sosteneva d’aver coniato il termine di nicodemiti poiché erano essi stessi che rivendicavano l’esempio di Nicodemo raccontato nel vangelo di Giovanni (3, 2)34; ora, tra i rari autori che invocarono «quel gran maestro d’Israel chiamato Nicodemo, il quale di notte [...] venne a parlare [a Gesù]», c’era Valdés35, e si badi che proprio a quel Nicodemo «qu’il est venu voir nostre Seigneur de nuict»36 si riferiva Calvino. Non mancano, inoltre, altri richiami che tra le righe sembrano lasciar emergere il profilo dell’esule spagnolo: secondo il riformatore i nicodemiti «alleguent qu’il est expedient d’y proceder petit à petit»37, laddove è facile pensare anche al gradualismo della lezione valdesiana. Già nel Petit traité, poi, Calvino aveva indicato tra i simulatori coloro che ritenevano che «basta che Dio segretamente sia da ciascuno conosciuto, e che dentro nel core si gli dia gloria», quelli convinti «che Iddio è contento dell’animo solo»38, con un linguaggio che richiama il «camino secreto» indicato da Valdés ai suoi discepoli. Come non pensare anche ai valdesiani, d’altronde, quando uno dei problemi avanzati da Calvino era quello di assistere simulando al rito della messa? In realtà, non v’è motivo per escludere dai nicodemiti calviniani i valdesiani39, cosicché il nesso tra valdesianesimo e libertinage può fondarsi su un altro tassello. Non sarà inutile ricordare che Calvino definiva i libertini per tali, ma a quanto egli stesso scriveva essi preferivano definirsi «spirituelz»40. Si trattava dunque di correnti analoghe della dissidenza europea, percorse da una comune attitudine individualistica al dubbio critico e alle libertà: di coscienza e di ricerca innanzi tutto, ma anche di espressione, di comportamento e di riunione, sebbene queste spesso si coprissero del manto protettivo della dissimulazione. Il tentativo di apparentare i valdesiani radicali a quelli che Calvino definiva libertini risulta pertanto giustificato, e ciò consente di dare il giusto peso alle diverse analogie di idee che possono evidenziarsi tra le due tendenze: così come Basalù e altri suoi compagni, «ilz prennent le diable, le monde, le peché pour une 136
imagination qui n’est rien [...], ilz veulent dire que ce sont vaines pensées, lesquelles on doit oblier comme songes»41. «Ilz rejectoyent audacieusement les Escritures»42, aggiungeva il riformatore di Ginevra, che tornava in più occasioni a mostrare quale atteggiamento avessero i libertini di fronte al testo sacro. A questo riguardo più oltre specificava che du commencement ilz se moquoyent apertement, quand on leur allegoit l’Escriture, ne dissimulans point qu’ilz la tenoyent pour fable. Bien est vray que ce pendant ilz ne laissoyent pas de s’en servir, s’il y avoit quelque passage qu’ilz peussent destourner en leur sens [...]. Car ilz retiennent tousjours ce principe, que l’Escriture, prinse en son sens naturel, n’est que lettre morte et qui occist, et pourtant que il la faut laisser pour venir à l’esprit vivifiant43.
Un modo radicale di porsi del tutto simile a quello degli allievi di Juan de Villafranca, che alla base mostra un’ascendenza spiritualistica analoga a quella di Juan de Valdés. Così come omologhi a quelli dei valdesiani radicali sono comportamenti, attitudini, modi di pensare dei cosiddetti libertins spirituels, in relazione ai quali torna il tema della simulazione e della dissimulazione: «C’est un des principaux articles de leur theologie, qu’il faut avoir l’art de se contrefaire pour tromper le monde. [...] Comme ilz ne font point conscience d’idolatrer sans aucun scrupule, ilz font semblant d’adherer à toutes les superstitions des papistes, pource que selon leur sentence toutes choses externes sont en la liberté du chrestien»44. Una descrizione che sostanzia ulteriormente il nesso libertinismo-nicodemismo-valdesianesimo radicale qui proposto. Secondo Calvino, poi, alcuni libertini «estoyent adonnez à une folle curiosité, appliquans leur esprit à question vaines et superflues [...]; et ne se contentants de la simplicité de l’Escriture, voltigeoyent en l’air en des speculations frivoles, ou pour satisfaire à leur folle convoitise, ou pour se monstrer subtilz et de haute intelligence»45: un atteggiamento di spregiudicata e libera ricerca (senza alcun vincolo dogmatico) che corrisponde sia all’habitus mentale rivelato da Giulio Basalù sia al movimento valdesiano in generale, e in particolare all’ala più radicale ispirata da Juan de Villafranca. Tale libertà per Calvino portava i libertins «à une licence charnelle et à mener vie dissolue»46. Un libertinage de mœurs al quale si può affiancare la giustificazione del 137
concubinato proposta dai radicali napoletani, e forse la stessa poligamia evocata dall’ultimo Bernardino Ochino. Infine, Calvino spiegava che tra i libertini vi erano «divers degrez d’escholier», secondo un gradualismo che, ancora una volta, riporta al valdesianesimo in tutte le sue sfumature47. Tuttavia, a fronte di queste e altre consonanze non mancano le differenze, connaturate del resto a ogni esperienza fondata sul soggettivismo. Se la posizione dei valdesiani radicali tendeva verso una forma estrema di antitrinitarismo, che ha molti tratti in comune col deismo del secolo seguente, i libertini denunciati da Calvino sembravano propendere verso il panteismo48. Tale aspetto non va sopravvalutato giacché è errato applicare al XVI secolo le distinzioni raffinate tra panteismo, deismo e antitrinitarismo tipiche di epoche seguenti; inoltre, non bisogna dimenticare che Villafranca, riferendosi a Cristo, lo «diceva esser puro homo, ma pieno abundantemente de spirito de Dio», laddove i libertini, secondo Calvino, «appellent Jesus Christ esperit»49: un’opinione simile sosterrà Gentile (inizialmente legato ai valdesiani), e comunque a una forma di panteismo propendeva il De principiis rerum di Capece. Nell’affermare che rispetto a Cristo «ilz le composent de l’esprit de Dieu qui est en nous tous»50, Calvino lasciava inoltre affiorare un tema che caratterizzerà tutto l’antitrinitarismo, da Servet a Gentile ai Sozzini: la possibilità di divinizzazione dell’uomo al pari di ciò che si riteneva fosse accaduto al Cristo. D’altra parte, ancora come Basalù e tutto l’antitrinitarismo, «ilz useront bien de plusieurs belles sentences comme voulans magnifier sa vertu», dove affiora quella riduzione del cristianesimo a etica che lega il valdesianesimo a Erasmo e Castellion, Montaigne al libertinismo secentesco, il deismo all’Illuminismo. La differenza fra antitrinitarismo e panteismo non va del pari sottovalutata, mentre occorre sottolineare come non si possano sovrapporre sic et simpliciter libertini spirituali e valdesiani radicali come se fossero la stessa identica cosa. Tra le differenze che si possono evocare, basti ricordare che, al pari degli anabattisti, sembra che i libertini descritti da Calvino tendessero all’abolizione della proprietà e a una forma comunistica di convivenza analoga a quella degli anabattisti. Pur con questa avvertenza, le convergenze restano maggiori, ed è in questi valdesiani radicali spinti verso inquietudini libertine che possono trovarsi alcune radici di nuovi modi di concepire e praticare le libertà, che facendo perno sulla coscienza individuale scardina138
vano ogni Weltanschauung organicistica e comunitaria, contribuendo a dissodare il terreno per il ribaltamento che, tra Seicento e Settecento, segnerà l’eclissi delle libertà come privilegio e l’alba delle libertà come diritti universali. Certo, qui si è indicato uno tra i molteplici fattori che contribuirono a questa rivoluzione lenta e contrastata, e si è cercato di dare il segno della complessità di una vicenda plurisecolare, che andrà seguita passo passo per evitare le semplificazioni di una storia delle idee avulsa dalla storia reale. Occorre rimarcare, a ogni modo, quanto il percorso qui indicato non vada ridotto al solo ambito delle teorie sulla tolleranza, ma debba considerarsi come traccia archeologica di una genealogia più generale. Il caso di Capece dimostra quanto potessero alimentarsi a vicenda il radicalismo religioso e l’indagine spregiudicata sulla natura; quanto nell’intreccio libertino tra Rinascimento materialistico e Riforma radicale potessero affiorare nuove concezioni che ribaltavano non solo gli assunti della fede, ma anche punti essenziali della visione del mondo e del cosmo tramandata dal Medioevo di matrice aristotelico-scolastica. Il De principiis rerum mostra come anche la conoscenza del pensiero classico potesse giocare un ruolo negli esiti più radicali del valdesianesimo (e d’altronde non va dimenticata l’origine stoica del concetto di adiáphora). Ma il De principiis suggerisce pure di leggere il rapporto tra umanisti ed eretici come un momento del più generale passaggio dall’indagine religiosa a quella filosofica e scientifica, che fu uno dei fattori decisivi del processo di désenchantement du monde 51 vissuto dalla cultura occidentale: un percorso complicato e denso di contraddizioni, che prima di conoscere il momento della dissociazione tra teologi, filosofi e scienziati a lungo percorse strade anche intrecciate. L’identificazione in una stessa figura quale Capece della ricerca su piani che oggi appaiono tanto differenziati rimanda ad altri – e più tardi – protagonisti della cultura meridionale, come Giordano Bruno e Tommaso Campanella, ma anche a personalità meno note come il medico ed eterodosso Agostino Doni, e inevitabile è il riferimento a ricercatori coevi a Capece quali Otto Brunfels (spiritualista radicale, medico e botanico) o ad altri medici come Giorgio Biandrata, Pietro Bresciani, Marcello Squarcialupi, Donato Antonio Altomare, Francesco Severi e soprattutto Miguel Servet, uno dei maggiori teorici dell’antitrinitarismo, che intuì la circolazione sanguigna prima che William Harvey la traducesse in una teoria scientifica. In effetti, uomini come Servet, Bruno e 139
Campanella, grandi innovatori sul piano della cultura filosofica e scientifica e al contempo radicali nelle scelte religiose, sembrano svelare un nesso che meriterebbe un approfondimento. Non è qui la sede per sviluppare un tema di simile complessità; e tuttavia il caso di Capece rivela intrecci che qui sarà sufficiente evidenziare, seguendo le intuizioni di Alexandre Koyré52. Basti pensare al rilievo riconosciuto all’esperienza, fondamento del valdesianesimo e al centro della filosofia di Capece come di tutta la più avanzata cultura napoletana in età moderna: per quanto sia persino ovvio che l’esperienza cui si riferiva Valdés53 – relativa alla fede e legata al principio dell’illuminazione spirituale – non possa sovrapporsi al criterio dell’esperienza con la quale indagare la natura, non deve neanche caricarsi la gnoseologia e l’epistemologia di uomini del Cinquecento delle distinzioni di chi vive secoli dopo la rivoluzione scientifica. Sembra difficile che a quel tempo nella mente di uno stesso uomo che scriveva sia di fede sia di scienza potesse crearsi una dissociazione netta tra l’indagine religiosa e quella filosofico-scientifica: non sarà inutile ricordare che la prima edizione del De principiis rerum uscì con la ristampa del De vate maximo, sicché è probabile che nell’habitus mentale di Capece i due tipi di ricerca si alimentassero l’un l’altro, in un processo di sempre più spinta radicalizzazione. Sul piano religioso egli aderì allo spregiudicato sperimentalismo del radicalismo valdesiano, e sul piano scientifico fondò la sua indagine sull’uso non meno ardito di una ragione ritenuta inscindibile dai casi esperienziali. Proprio questo aspetto invita a considerare in modo più sfumato le differenze tra indagine religiosa e indagine scientifica e mostra come in uno stesso individuo ispirazioni diverse potessero favorire l’emergere di più avanzate sintesi. Il metodo adottato nel De principiis rerum esprimeva la consapevolezza dell’importanza dell’investigazione empirica, congiunta all’elaborazione razionale nei processi di conoscenza dei fatti naturali54. Tutte le critiche erano condotte da Capece alternando digressioni teoriche a casistiche empiriche, in un succedersi di esempi che, volta a volta, mostravano la fragilità o il rigore di questa o quella dottrina: le stalattiti e le conchiglie, i fulmini e i tuoni, i rimbalzi della palla nel gioco, il fragore delle armi, gli andamenti del clima, la caduta dei gravi, le comete e i venti; questi e altri dati esperienziali costellavano la critica di ogni dottrina, così come l’affermazione di ogni sua teoria. Quando giungeva a parlare di un evento inconsueto (una pioggia co140
lor sangue), Scipione non solo non esitava a darne una spiegazione razionale e naturale, ma criticava il terrore popolare che ne elaborava letture irrazionali, ritenendolo un atroce prodigio dal quale scampare con lacrime e preghiere solenni55, in un’argomentazione che richiama Lucrezio56 e che ha del pari un sapore libertino e illuministico. Così come di tono libertino e illuministico – e già più scientifica rispetto ai Della Porta, Bruno e Campanella – appare la critica che Capece muoveva all’astrologia dei «magi» (I, 91-98). La cultura umanistica napoletana si era del resto aperta precocemente ai temi di carattere naturalistico: il calabrese Giovanni Brancati, bibliotecario di Ferrante d’Aragona, aveva tradotto la Naturalis historia di Plinio. Lo stesso Pontano aveva dato un importante contributo scrivendo il De rebus coelestibus, l’Urania e i Meteora, e altrettanto aveva fatto Valla, sebbene con minore sistematicità. Il Galateo poi, peraltro poco ortodosso in materia religiosa, era convinto della necessità di fondare il percorso conoscitivo sulla ratio e sull’experientia, così come avrebbe fatto Scipione Capece e secondo un indirizzo che sarà a lungo tipico della cultura meridionale più avanzata. Ancora: Giovan Battista d’Amico57, ispirandosi all’aristotelismo eterodosso padovano, disegnò nel suo De motibus corporum coelestium iuxta principia peripatetica sine eccentris et epicyclis un sistema che, pur all’interno della visione geocentrica, faceva a meno degli eccentrici e degli epicicli, evidenziando alcune aporie della visione tolemaica. Si può continuare con Basilio Sabazio58 – probabilmente anch’egli in contatto con i pontaniani –, che elaborò una teoria delle meteore da cui emergevano limiti ulteriori delle visioni dominanti, e l’eterodosso Marcello Palingenio Stellato nel poema Zodiacus vitae (1536), apprezzato da Giordano Bruno, in un eclettico e originale incontro fra neoplatonismo ed epicureismo immaginò una visione del cosmo eterno e infinito59, così come eterno considerava il mondo l’eterodosso e naturalista radicale Tiberio Russiliano Sesto60. Prima ancora della critica di Bernardino Telesio all’aristotelismo, Capece aveva contestato la fisica dello Stagirita, asserendo con Sabazio l’identità tra il mondo celeste e il mondo sublunare61 – che riteneva entrambi originati dall’aer – e legando l’argomentazione alla critica della teoria del moto di Aristotele. Aveva poi escluso – con Sabazio e Valla62 – che il fuoco fosse un elemento primario (II, 129 sgg.) e negato che gli elementi fondamentali della natura fossero quattro 141
(I, 612 sgg.), come prescriveva l’aristotelismo, riconducendoli invece a uno soltanto, l’aer appunto: nel che c’era un riferimento alla scuola ionica (in specie ad Anassimene), ma soprattutto allo pneuma degli stoici e degli epicurei. Infine, sebbene continuasse a muoversi in una cosmologia tolemaica, Capece, dimostrando di conoscere le tesi di d’Amico, contestava la teoria degli eccentrici e degli epicicli, muovendo però obiezioni alla teoria delle sfere omocentriche, che d’Amico aveva rispolverato riprendendola da Eudosso e da Aristotele63. Il De principiis rerum e più in generale il caso di Capece, insomma, svela ulteriori aspetti di quel retroterra culturale di natura critica e umanistica che, a contatto con l’individualismo sperimentale del valdesianesimo, contribuì alla sua radicalizzazione, preparando il clima dal quale fiorirà la stagione del più maturo naturalismo meridionale64: da Bernardino Telesio a Giordano Bruno, da Ferrante Imperato a Nicola Antonio Stigliola, fino al Campanella della Philosophia sensibus demonstrata e dell’Apologia pro Galilaeo, che segnerà il più consapevole approdo di un atteggiamento teso a rivendicare le libertà di pensiero, ricerca ed espressione. Con personalità come Capece, pertanto, già dalla prima metà del secolo iniziò anche a Napoli quell’eversivo slittamento culturale, caratteristico della cultura europea, che portò personalità irregolari come Servet a legare le indagini sulla religione a quelle sulla natura iuxta propria principia. Del resto, una volta accolta la critica alla divinità di Cristo e lasciata sullo sfondo la religione come discorso etico, nel passaggio dalla fede e dalla grazia dei valdesiani moderati al Cristo «homo da bene» di quelli radicali diveniva agevole il passaggio da Cristo alla natura. Le strade che si aprivano a chi volesse proseguire nella ricerca non erano poi tante: approfondire la critica antitrinitaria, come avrebbero fatto esuli come Gentile e Ochino, o lasciare il problema sullo sfondo (difficile del resto occuparsene nell’Italia controriformistica), spostando l’attenzione dal creatore al creato di un Dio lasciato sempre più lontano dal mondo e dalla storia. In conclusione, occorre quindi sottolineare come nel mondo della dissidenza radicale d’ispirazione valdesiana si coagulassero elementi di diversa provenienza, che favorirono l’emersione di nuovi modi di intendere e praticare le libertà, non solo nel campo religioso ma anche in ambiti come quello delle ricerche sulla natura: elementi prodromici a quel successivo e accidentato percorso che por142
terà, tra il secolo del Barocco e quello dell’Illuminismo, all’emergere delle teorie e dei linguaggi dei diritti. Qui si è inteso dimostrare come il groviglio che precede la loro emersione fosse più intricato di quanto le letture oggi dominanti siano disposte a riconoscere, e quanto in alcuni dei settori più radicali della dissidenza religiosa emergessero succhi che avrebbero favorito anche nuove configurazioni del discorso politico. Si è inteso qualificare l’orientamento di tali gruppi ereticali come libertino, in quanto caratterizzato da opinioni e attitudini che li inducevano a rivendicare una piena e individualistica libertà dai tratti già moderni. La nozione di libertinage, del resto, è particolarmente indicata giacché non fu soltanto la dimensione spirituale e religiosa a nutrire le radici di quel virgulto che diverrà l’albero delle libertà. Si è visto, infatti, come dall’intreccio tra valdesiani e pontaniani si fosse registrato un fruttuoso scambio tra spiritualismo alumbrado e materialismo epicureo, con una radicalizzazione che favorì gli esiti filosofici e irreligiosi di personalità come Giulio Basalù o Scipione Capece. Nell’incontro libertino che avvenne nel caso qui indagato tra Rinascimento materialistico, Umanesimo critico, Riforma radicale e altri fenomeni come l’alumbradismo e il marranismo, insomma, sembra possa indicarsi una traccia di una discontinuità storica, che mostra da una specifica angolazione le articolazioni dell’emergere di un nuovo modo di intendere i discorsi e le pratiche di libertà, in un atteggiamento critico, sperimentale e soggettivo che, dalle indagini sulla religione e sulla natura, si sarebbe presto esteso al discorso politico.
Note
Abbreviazioni ACDF ASV Capece, Opere
Archivio della Congregazione per la dottrina della fede Archivio di Stato di Venezia Il poema «De principiis rerum» di Scipione Capece patrizio napolitano illustre scrittore del secolo XVI. Colla traduzione in verso italiano sciolto, e le annotazioni di Francesco Maria Ricci romano abate benedettino cassinese. Dello stesso Capece il poema «De vate maximo», l’«Elegie», gli «Epigrammi», e due prose latine. Con le notizie storiche e critiche ecc. del conte Mazzuchelli, oltra le molte altrui testimonianze, Venezia 1754 Processo Basalù ASV, Sant’Uffizio, Processi, bb. 13 e 159 Processi Carnesecchi M. Firpo, D. Marcatto, I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi (1555-1567), 2 voll., Città del Vaticano 1998-2000 Processo Morone M. Firpo, D. Marcatto, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, 6 voll., Roma 1981-95
Introduzione 1 C. Ginzburg, A. Prosperi, Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo», Torino 1975, p. 51. 2 Cfr. almeno M. Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali». Studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi religiosa del ’500 italiano, Firenze 1990; Id., Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento (1993), Roma-Bari 2004; Id.; Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino 1997; Id., Dal sacco di Roma all’Inquisizione. Studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana, Alessandria 1998; Id., Vittore Soranzo vescovo ed eretico. Riforma
145
della Chiesa e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari 2006; Id., La Riforma italiana, in É. Boillet (a cura di), Antonio Brucioli. Humanisme et évangélisme entre Réforme et Contre-Réforme, Paris 2008, pp. 7-20; cfr. anche Id., Introduzione, in J. de Valdés, Alfabeto cristiano. Domande e risposte. Della predestinazione. Catechismo, Torino 1994; i monumentali Processo Morone; Processi Carnesecchi; M. Firpo, S. Pagano, I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo (1550-1558), 2 voll., Città del Vaticano 2004. 3 A parte gli studi citati nella nota precedente cfr. J.C. Nieto, Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España e Italia (1970), México-Madrid-Buenos Aires 1979; Los Valdés. Pensamiento y Literatura, Cuenca 1997; S. Pastore, Un’eresia spagnola. Spiritualità conversa, alumbradismo e Inquisizione (1449-1559), Firenze 2004. 4 Cfr. D.A. Crews, Twilight of Renaissance. The Life of Juan de Valdés, Toronto-Buffalo-London 2008. 5 I. Bonfadio, Le lettere e una scrittura burlesca, a cura di A. Greco, Roma 1978, pp. 91-92. 6 Presentando la prima edizione di J. de Valdés, Le cento e dieci divine considerazioni, a cura di T. Fanlo y Cortés, Genova-Milano 2004, pp. 155 e 158. 7 Cfr. P. Lopez, Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant’Uffizio, Napoli 1976, p. 152. 8 Firpo, Introduzione, cit., p. CXLIX. 9 Ivi, pp. CXXXIII-CXXXIV. 10 R. Pintard, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle (1943), Genève 2000. 11 L. Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais (1942), avant-propos de H. Berr, postface de D. Crouzet, Paris 2003. Ha negato ogni nesso tra eresia e libertinage A. Tenenti, Libertinismo ed eresia fra la metà del Cinquecento e l’inizio del Seicento (1963), in Id., Credenze, ideologie, libertinismi tra Medioevo ed Età moderna, Bologna 1978, pp. 261-85. Su questa linea sembra porsi anche D. Foucault, Histoire du libertinage des goliards au marquis de Sade, Paris 2007, p. 9: «Libertinage et hérésie sont [...] des dissidences de nature radicalement différente». Nel dipanarsi della sintesi, però, Foucault accenna a vari nessi tra personalità o movimenti della Riforma radicale e lo sviluppo della miscredenza libertina. 12 Cfr. Aspects du libertinisme au XVIe siècle, Paris 1974 (nel quale trovò spazio il saggio di M. Bataillon su Juan de Valdés nicodémite?) e soprattutto H. Busson, Le rationalisme dans la littérature française de la Renaissance (1957), Paris 1971, p. 9 e passim, dove si fa riferimento a «une tradition libertine qui traverse tout le moyen âge», alimentatasi proprio nel corso del Cinquecento a contatto col Rinascimento ma anche con le propaggini radicali della Riforma. G. Schneider, Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo (1970), Bologna 1974, pp. 51 sgg., ha poi dimostrato come un uso moderno del termine «libertino» diverso da quello latino originario (libertinus = schiavo affrancato) fosse diffuso già nel XVI secolo, a far data dagli scritti antilibertini di Calvino (1544-45). E in alcuni canti goliardici del Duecento J. Wirth, «Libertins» et «épicuriens»: aspects de l’irréligion en France au XVIe siècle (1977), in Id., Sainte Anne est une sorcière et autres essais, Genève 2003, ne ha mostrato una variazione semantica ancor più antica, col vocabolo a evocare la sfrenatezza nel comportamento. Infine, J. Barthas, Machiavelli e i «libertini» fiorentini (1522-1531). Una pagina dimenticata nella storia
146
del libertinismo, in «Rivista storica italiana», CXX, 2008, pp. 569-603, ha evidenziato come nella prima metà del Cinquecento per libertini s’intendessero i partigiani radicali del repubblicanesimo democratico a Firenze e a Siena. 13 Calvino usò la definizione nella Brieve instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes (1544), in I. Calvini Opera omnia denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, series IV, vol. II, a cura di M. van Veen, Genève 2007, pp. 33-142; ma soprattutto in Id., Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz (1545), ivi, vol. I, a cura di M. van Veen, Genève 2005, pp. 45-171. Il riformatore tornò sul tema in testi contro personaggi sconosciuti o personalità come Dirck Volckertszoon Coornhert. Sui cosiddetti libertini spirituali, oltre a Busson, Schneider, Wirth, van Veen, cfr. O. Millet, Calvin et les «libertins»: le libertin comme clandestin, ou de la sphère clandestino-libertine, in «La Lettre clandestine», V, 1996, pp. 225-40; D. Foucault, L’amoralisme hédoniste et libertaire des Libertins spirituels combattus par Calvin, in M. Daumas (a cura di), Le plaisir et la transgression en France et en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, Pau 2006, pp. 271-305. 14 Schneider, Il libertino, cit., pp. 53 sgg. 15 M. van Veen, Introduction, in Calvino, Contre la secte [...] des libertins, cit., pp. 11, 26 e passim Significativa una citazione riportata in Schneider (Il libertino, cit., p. 104) da G. Farel (Le Glaive de la parolle veritable, tiré contre le bouclier de defense: duquel un cordelier libertin s’est voulu servir pour approuver ses fausses et damnables opinions, Genève 1550, p. 222): «Et c’est la façon des heretiques, d’ainsi temerairement jaser et inventer, comme on voit de Servetus en l’affaire de la trinité, qui a tasché contre l’Escriture et tous les anciens en escrire. Et les anabaptistes, libertins, epicuriens et tous telz errans, ensuivent ce trac»; cfr. anche ivi, p. 223, dove il riformatore si riferiva a «quelque italien», affermando che dalle idee che circolavano tra di essi «sont sortiz les libertins». Wirth ha pure proposto un legame fra libertinage e antitrinitarismo, e lega eterodossia e libertinismo altresì F. Berriot, Spiritualités, hétérodoxies et imaginaires: études sur le Moyen âge et la Renaissance, Saint-Étienne 1994. 16 J.-P. Cavaillé, Libertinage, irréligion, incroyance, athéisme dans l’Europe de la première modernité (XVIe-XVIIe siècles). Une approche critique des tendances actuelles de la recherche (1998-2002), in «Les Dossiers du Grihl», http://dossiersgrihl.revues.org/. 17 Id., Libertino, libertinage, libertinismo: una categoria storiografica alle prese con le sue fonti, in «Rivista storica italiana», CXX, 2008, pp. 604-55, in particolare p. 636. 18 Ivi, p. 637. Cavaillé ha inoltre visto (con Schneider) nel libertinismo una forma di «antinomianesimo», secondo cui il libertino si pone al di là del bene e del male e come «il cristiano in stato di grazia è svincolato dalle leggi morali prescritte dal decalogo» (p. 613 e nota). Anche questa posizione la si vedrà emergere tra alcuni valdesiani radicali. 19 Calvino, Contre la secte [...] des libertins, cit., pp. 119 e 121-22. 20 M. Firpo, Calvino e la Riforma radicale: le opere contro nicodemiti, anabattisti e libertini (1544-1545), in «Studi storici», XLVIII, 2007, pp. 100-101. 21 Cfr. ad esempio Valdés, Alfabeto cristiano, cit., pp. 107-108. 22 M. Firpo, Il problema della tolleranza religiosa nell’età moderna. Dalla Riforma protestante a Locke (1978), Torino 1983. 23 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 5r (deposizione di Antonio d’Alessio, 19 di-
147
cembre 1552). Identiche le parole di Matteo d’Aversa (3 luglio 1553), i cui costituti sono in D. Berti, Di Giovanni Valdes e di taluni suoi discepoli secondo nuovi documenti tolti dall’Archivio Veneto, in «Atti della R. Accademia dei Lincei, Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», 1877-78, pp. 61-81, in particolare p. 79. 24 Su Valentino Gentile è in corso uno studio da parte di chi scrive. 25 Cfr. M. Firpo, «Disputar di cose pertinente alla fede». Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano, Milano 2003, pp. 286-87 e nota. 26 Cit. ivi, pp. 316-17.
Capitolo I 1 J. H. Elliott, A Europe of Composite Monarchies, in «Past and Present», 137, 1992, pp. 48-71. 2 Cfr. R. Villari, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647 (1967), Roma-Bari 1994; Id., Inquietudini, mutamento e prudenza nella politica barocca, in corso di stampa; G. D’Agostino, Parlamento e società nel Regno di Napoli. Secoli XV-XVII, Napoli 1979; A. Cernigliaro, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli: 15051557, 2 voll., Napoli 1984; G. Galasso, Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino 1994; Id., Storia del Regno di Napoli, vol. II, Torino 2006; P.L. Rovito, Il viceregno spagnolo di Napoli. Ordinamento, istituzioni, culture di governo, Napoli 2003. 3 Cfr. S. Miccio, Vita di don Pietro di Toledo (1600), in «Archivio storico italiano», IX, 1846, pp. 3-89; G. Coniglio, Il viceregno di don Pietro di Toledo (1532-53), 2 voll., Napoli 1984; C.J. Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553), Salamanca 1994. 4 Coniglio, Il viceregno, cit., vol. I, p. 148. B. Croce, Storie e leggende napoletane (1919), Milano 1990, p. 235, ricorda anche un più o meno contemporaneo editto di Carlo V «che vietava, sotto pena di morte e di confisca, ogni conversazione e pratica con eretici e sospetti eretici luterani». 5 G. Rosso, Istoria delle cose di Napoli sotto l’impero di Carlo V, citato in L. Amabile, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti, Città di Castello 1892, vol. I, p. 130 e nota. Sembra che gli arresti fossero effettuati il 7 agosto 1536. 6 Cfr. D. Cantimori, Umanesimo e religione nel Rinascimento, Torino 1975; P. Lopez, Clero, eresia e magia nella Napoli del viceregno, Napoli 1984; C. De Frede, Ricerche per la storia della stampa e la diffusione delle idee riformate nell’Italia del Cinquecento, Napoli 1985. 7 Il passo, tratto da una versione manoscritta dell’Istoria di Castaldo, è in Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles, cit., p. 450. Nell’edizione a stampa dell’Istoria data da Gravier (1769) non v’è riferimento né a Valdés né a Flaminio. Su Castaldo cfr. A. Ceccarelli, «Nuova istoria» di Antonino Castaldo. Oppositore politico, accademico dei Sereni e notaio dei Genovesi nella Napoli del Cinquecento, in «Clio», XLI, 2005, pp. 5-29. 8 L’espressione è in Processi Carnesecchi, vol. II, p. 146. 9 A. Caracciolo, De vita Pauli quarti [...], Coloniae 1612, p. 240. Si tratta di una versione ridotta e autocensurata dell’inedita vita di Paolo IV scritta in italiano. M.
148
Firpo, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d’eresia (1992), Brescia 2005; E. Belligni, La storiografia teatina, in M. Firpo (a cura di), «Nunc alia tempora alii mores». Storici e storia in età postridentina, Firenze 2005, pp. 141-68. 10 Miccio, Vita di don Pietro, cit., pp. 27-29. 11 I. Simler, Oratio de vita et obitu clarissimi et praestantissimi theologi domini Petri Martyris Vermilii [...], Tiguri 1563, pp. 7rv. 12 N. Balbani, Historia della vita di Galeazzo Caracciolo [...] (1587), Firenze 1875, p. 14. 13 J. de Valdés, Le cento e dieci divine considerazioni, a cura di T. Fanlo y Cortés, Genova-Milano 2004, p. 158. 14 Processi Carnesecchi, vol. II, p. 143. 15 Già nell’immediatezza della fuga di Ochino (1542) negli ambienti inquisitoriali romani si «nutriva qualche dubbio delli scritti lassati dal Valdés». E sin dal primo Indice dei libri proibiti (1549) furono vietate tutte le opere valdesiane. Nel mondo riformato la consapevolezza degli esiti radicali del valdesianesimo risale quantomeno ai primi anni Sessanta del Cinquecento (M. Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali». Studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi religiosa del ’500 italiano, Firenze 1990, pp. 89 nota, 105-106, 114 sgg. e passim). 16 P. Lopez, Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant’Uffizio, Napoli 1976, p. 152. Sacerdote napoletano, nato verso il 1514, Gualano entrò in contatto con i valdesiani aderendo alla giustificazione per fede. Amabile (Il Santo Officio, cit., vol. I, p. 139 nota) lo definì sulla scorta di Antonio Caracciolo «spia dei teatini», e in effetti a partire dal 1551, quando fu arrestato dall’Inquisizione, fu delatore e accusatore di vari valdesiani. Cfr. Processo Morone, vol. I, pp. 338-39 nota e passim. Uno stralcio di una sua deposizione (del 1551) è in Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 2v; cfr. inoltre ACDF, Stanza storica, Decreta, I, 1548-1558, cc. 56rv, 59r, 60v, 64rv; Processi Carnesecchi, vol. II, p. 968. 17 C. Ginzburg, I costituti di don Pietro Manelfi, Firenze-Chicago 1970, pp. 6869. Manelfi riferì di aver avuto le notizie non solo da «Benitto neapolitano» (Benedetto Florio alias Lorenzo Tizzano), ma anche dal vicentino «Gieronimo Speranza et dalle sorelle d’esso Gieronimo, anabattiste anche loro», da «uno Salvatore venetiano che sta in Padua etc.», nonché da «Marco Antonio [del Bon] di Asolo [...], [il quale] me disse che Benitto sudetto gl’havea riferto tutto quanto ho detto di questa setta et esso Benitto mi confirmava haverli detta tale dotrina». 18 Costituti di Giovanni Laureto, in M.E. Pommier, L’itinéraire religieux d’un moine vagabond italien au XVIe siècle, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», LXVI, 1954, pp. 293-322, in particolare p. 317. I costituti di Laureto sono in ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11. Ivi, b. 25, si trova una sua confessione datata 5 ottobre 1553. 19 Ginzburg, I costituti, cit., pp. 47, 68, 69. Fecero il suo nome anche altri indagati come Alvise de’ Colti (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 28r, 24 dicembre 1551) e Marcantonio del Bon (ivi, b. 158, f. III, c. 31rv, 3 marzo 1552). 20 Cfr. ivi, b. 9, f. II, carte non numerate. Il capitano di Padova, Francesco Contarini, il 22 dicembre 1551 lamentava il fatto che Laureto fosse irreperibile. 21 Cfr. E. Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna 2000, pp. 381-402 e passim; Ead., La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII), Roma 2006, pp. 68-77.
149
22
Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 318. Ibid. Non è certa l’identità di questo Francesco Proda. Pommier (L’itinéraire religieux, cit., p. 297 nota) suppone che possa essere il capitano Francisco de Prado, segnalato in N. Cortese, Feudi e feudatari della prima metà del Cinquecento, in «Archivio storico per le Province napoletane», LV, 1930, p. 85. Un Francesco de Prado fu reggente della Gran corte della vicaria nel 1532 (G. Intorcia, Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII, Napoli 1987, p. 145). 24 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 318. 25 Ibid. 26 Isabella Breseña (o Breseño o Brisegna) esercitava spesso supplenza delle attribuzioni del marito a causa delle sue ripetute assenze, da cui la denominazione di «governatrice» con cui era nota. Copia del processo postumo intentatole nel 1569 dal Sant’Ufficio (ma manca la sentenza) è in ACDF, Stanza storica, E 2-e. Nuove prospettive sul suo ruolo di leader di una rete di eterodossi legata al movimento valdesiano suggerisce E. Belligni, Evangelismo, Riforma ginevrina e nicodemismo. L’esperienza religiosa di Renata di Francia, Cosenza 2008, pp. 261-62 e passim. La data dell’estate 1548 riportata nel testo, in cui Laureto avrebbe preso servizio a Piacenza, a parte quanto desumibile dalle datazioni di Laureto stesso, emerge da una lettera di Giulia Gonzaga (in B. Amante, Giulia Gonzaga contessa di Fondi e il movimento religioso femminile nel secolo XVI, Bologna 1896, pp. 443-44). Don García Manrique de Mendoza aveva ottenuto l’incarico di governatore di Piacenza già dal 1547, ma in un primo momento la moglie non aveva potuto accompagnarlo. Lo raggiunse nell’estate del 1548: al 10 luglio di quell’anno risale la detta lettera di Giulia Gonzaga, da cui si desume che doña Isabella si era messa in viaggio da Napoli. 27 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 318. 28 La consapevolezza che in terra riformata non si potesse discutere del dogma trinitario emerse dopo il rogo di Miguel Servet (1553), nonostante la precedente condanna a morte (1547) del «séditieux, blasphémateur et athée» Jacques Gruet, sul quale cfr. F. Berriot, Un procès d’athéisme à Genève: l’affaire Gruet (1547-1550), in Id., Spiritualités, hétérodoxies et imaginaires: étude sur le Moyen âge et la Renaissance, Saint-Étienne 1994, pp. 315-29. 29 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 318. 30 Ivi, pp. 318-19. Si trattava del pellicciaio di Bassano Domenico Cabianca, impiccato a Piacenza il 10 settembre del 1550. Cfr. la voce dedicatagli da D. Caccamo in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XV, Roma 1972, pp. 689-90 (dove si trova il riferimento al «parlare alla libera» fatto in un dispaccio a Ercole II d’Este dall’ambasciatore Alfonso Trotti); S. Caponetto, La Riforma protestante nell’Italia del Cinquecento (1992), Torino 1997, pp. 268-70; A. Prosperi, L’eresia del libro grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta (2000), Milano 2001, pp. 217-19 e passim. 31 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 319. 32 Ibid. 33 Ibid. La data della partenza di Busale risulta dai costituti di suo fratello Bruno (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, c. 8r, 13 febbraio 1552). 34 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 319. 35 Ivi, pp. 319-20. 36 Ivi, p. 320. 37 Ibid. Bruno Busale fu arrestato il 21 dicembre del 1551. Convocato due giorni dopo per essere esaminato, si presentò «con poca barba nera e zoppo». Disse di 23
150
abitare «alli heremitani in Padova in casa di donna Catherina vicentina» (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 23v). 38 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 320. 39 Ivi, pp. 320-21. 40 Ivi, p. 321. 41 Laureto non fornì la data della partenza, che si deduce dai movimenti delle galee di Ferrante Sanseverino, giunte a Costantinopoli poco prima del Natale 1552 e ripartite per Chio poco dopo il 16 gennaio del 1553. Cfr. C. De Frede, Rivolte antifeudali nel Mezzogiorno e altri studi cinquecenteschi (1977), Napoli 1984, pp. 26465. 42 «Giovanni Laureto ho cognossuto al ditto tempo del 1551 et ho inteso de le sue opinione per relatione del ditto abbate [Busale]. Poi l’ho cognossuto qui [a Venezia] che venne da Costantinopoli et diceva esser stato hebreo. Li dissi che ad ogni modo dovesse ritornar a la fede christiana catholica, et lui mi disse esser ritornato per questo. Si consigliò con me come dovea governarsi. Li dissi quello havea a fare. Lui andò, per quanto mi refferì, dal padre inquisitore, il quale lo fece presentare a questo tribunale voluntariamente et fu posto in prigione». Cfr. Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù, 21 maggio 1555). 43 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 322. 44 Gli ultimi esiti noti della sua vicenda sono descritti da Basalù: «In prigione [...] io l’ho veduto una volta. Dapoi mai più ne ho hauto nova, né so quello che sia seguito di lui. [...] Fu detto che se ne era fuggito di prigione et che fu bandito» (Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate, IV costituto di G. Basalù). 45 La data del primo costituto padovano di Tizzano è ignota, ma al 6 ottobre 1553 risale un ordine dell’Inquisizione romana che fa da terminus ad quem: «Dominus Laurentius, apostata Montis Oliveti, Paduae degens: scribatur per reverendum commissarium reverendo domino nuncio Venetiis quod faciat eum capere» (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, 1548-1558, c. 118r). Matteo Busale, in un interrogatorio del 18 agosto 1553 che fa da terminus a quo, fece invece riferimento a un Tizzano ancora libero (D. Berti, Di Giovanni Valdes e di taluni suoi discepoli secondo nuovi documenti tolti dall’Archivio Veneto, in «Atti della R. Accademia dei Lincei, Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», 1877-78, pp. 67 e 79). I costituti di Tizzano, editi da Berti, sono in ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. VI, carte non numerate. 46 Ginzburg, I costituti, cit., pp. 47, 68, 69. Così come Laureto anche Tizzano (citato col nome con cui lo aveva denunciato Manelfi, Benedetto Florio) risultava contumace all’ordine di arresto eseguito dal capitano di Padova (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 9, f. II, carte non numerate, 22 dicembre 1551). Oltre che dai costituti di Manelfi, il nome di Tizzano/Florio era emerso anche da altre fonti. Marcantonio del Bon testimoniò sulla sua permanenza padovana, dando pure conferma di ciò che il marchigiano aveva dichiarato sulle sue eresie: «El ragionamento suo fu che mi voleva mostrar per le prophetie che ’l messia non era venuto et che non era adimpito quanto era prophetizato per loro propheti del advenemento de Christo, et havea lingua hebrea» (ivi, b. 158, f. III, c. 37v). Col suo vero nome Tizzano era stato denunciato da vari valdesiani arrestati nel 1553: Ambrogio da Pozzo (costituti del 4 gennaio), Girolamo Capece (7 giugno), Matteo d’Aversa (3 luglio), Matteo Busale (5 luglio e 18 agosto) e Biagio Marese (18 settembre): cfr. Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 7rv, 8v, 9r-10r; Berti, Di Giovanni Valdés, cit., pp. 77-79.
151
47 Costituti di Lorenzo Tizzano, in Berti, Di Giovanni Valdés, cit. p. 67, confessione del 30 dicembre 1553. 48 Ivi, p. 72. 49 Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 2v-10v. 50 La data della condanna risulta da un inventario di processi e sentenze relativi agli anni Cinquanta che è in ACDF, Stanza storica, I. 4 b (Collectanea scripturarum ad Sanctum Officium pertinentium), carte non numerate. Che in seguito Tizzano fosse richiamato dal Sant’Ufficio risulta dal Processo Basalù (b. 13, f. II, c. 10rv), dove compare lo stralcio di una sua deposizione del 22 giugno 1554, e da ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 175r, dove alla data del 17 marzo 1556 è riportato il seguente ordine: «Repetatur Laurentius Tizianus Siculus [sic!], et detur reverendissimo de Motula [Scipione Rebiba] qui curabit huiusmodi repetitionem contra Marium Galeottum». Cfr. anche ivi, c. 146r. 51 Matteo Busale nel 1553 testimoniò che Tizzano aveva circa quarant’anni (Berti, Di Giovanni Valdés, cit., p. 79). Busale lo descrisse «con barba tonna e mista, pieno di volto, di statura mediocre, li occhi bianchi, naso piccolo e stretto». 52 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., pp. 68-69. 53 Ivi, p. 69. 54 Ibid. 55 Ivi, pp. 69-70. 56 Ivi, p. 71. 57 Ibid. Imperato fu membro della Compagnia dei Bianchi della giustizia come altri valdesiani (Mario Galeota, Ferrante Brancaccio, Pietrantonio Di Capua, Ranieri Gualano, Giovan Tommaso Minadois, Giovan Francesco Alois, Scipione d’Afflitto, Andrea Sbarra e Sigismondo Miñoz), a cui ben presto si opposero i teatini, e la vicenda dei Bianchi si intrecciò col più ampio e aspro confronto che contrappose gli spirituali agli zelanti capeggiati da Gian Pietro Carafa. Probabilmente fra il 1552 e il 1553, in contemporanea con l’avvio dei processi contro i valdesiani, avvenne la loro espulsione dalla confraternita (G. Romeo, Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma, Firenze 1993, pp. 105-30). Notizie su Imperato in Berti, Di Giovanni Valdés, cit., pp. 69 e 71; Lopez, Il movimento valdesiano, cit., pp. 154, 157, 162-63; Processi Carnesecchi, vol. II, pp. 56 e nota, 82, 97 e passim. 58 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 71. Su Caracciolo cfr. Balbani, Historia della vita, cit.; B. Croce, Vite di avventure di fede e di passione (1936), Milano 2002, pp. 199-297; e la voce dedicatagli da W. Monter in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XIX, Roma 1976, pp. 363-68. 59 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 73, interrogatorio del 27 ottobre. 60 Ivi, p. 71, confessione del 30 dicembre. 61 Ibid. Su Pietro Antonio Cirillo (o Ciarrillo o Zurrillo o Zarrillo) cfr. P. Scaramella, «Con la croce al core». Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564), Napoli 1995, pp. 49-50, 83 e passim, dove è definito come canonico, mentre in una sua deposizione del 9 dicembre 1552 (Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 3v) è qualificato come «utriusque iuris doctorem». Cfr. anche Processo Morone, vol. I, pp. 378-79 nota. Il suo legame col movimento valdesiano è testimoniato anche da Giulio Antonio Santoro, del quale sembra fosse parente (Scaramella, «Con la croce al core», cit., p. 49). 62 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 71. Parte della documentazione processuale sul barone Consalvo di Bernaudo è in ACDF, Stanza storica, I. 4 b. Cfr. inol-
152
tre ivi, [G.A. Santoro], De persecutionis haereticae pravitatis historia, cc. 31r sgg.; ivi, Decreta, I, cc. 62v, 85r, 105r, 117r, 125r, 127v, 130rv; Processo Morone, vol. I, pp. 381-82 nota. Su Fiorillo, rifugiatosi a Ginevra nel 1553, cfr. Scaramella, «Con la croce al core», cit., pp. 48, 58-59 e passim. 63 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 75, interrogatorio del 28 ottobre 1553. 64 Ivi, p. 70. 65 Cfr. L. Sozzini, Opere, a cura di A. Rotondò, Firenze 1986, in particolare pp. 24-30. 66 Ginzburg, I costituti, cit., p. 34. 67 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 9, f. II, carte non numerate. I costituti di Matteo dalle Maddalene in questione non sono datati, ma i suoi primi costituti sono del gennaio 1552 e la copia dell’abiura (ivi, b. 158, f. II, cc. 90r sgg.) ha la data del 1° febbraio. Si tratta, dunque, di rivelazioni precedenti le confessioni di Tizzano. 68 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 70. 69 Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 111v della numerazione moderna (I costituto di G. Basalù, 2 marzo 1555). 70 In un primo momento Tizzano non fece il nome del legista, ma in una deposizione resa il 22 giugno del 1554 (ivi, b. 13, c. 10rv) aggiunse: «In lo constituto mio di Venetia non mi son recordato dir come messer Giulio Basalù dottor di legge è stato mio complice in le mie opinioni, le quali lui ha tenute come me: anzi lui nelli principi me ha instrutto in esse. Et gran parte delle mie opinioni quali ho scritte ho intese similmente da lui et da messer Mattheo Busal». 71 Ivi, cc. 1r-2r, 28-30 settembre 1548. Cfr. inoltre D. Marcatto, «Questo passo dell’heresia». Pietrantonio Di Capua tra valdesiani, spirituali e Inquisizione, Napoli 2003, pp. 35 nota e 81-82 nota. 72 Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 3r sgg. Ulteriori conferme (tra cui quella di Tizzano) giunsero anche in seguito. 73 ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 115v: «Iulius Basalù, Neapoli degens: capiatur». 74 Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 112r (I costituto di G. Basalù). 75 Benedettino, legato al movimento valdesiano, Basalù lo rivide a Napoli nel 1549 e nel corso del suo processo gli attribuì posizioni sacramentarie. Germano era fratello di Giovan Tommaso Minadois (1505-55), consigliere di Carlo V, docente di Diritto canonico nello Studio di Napoli ed erede dei beni che Valdés possedeva nel Regno. Cfr. la scheda dedicata ai due fratelli in Processo Morone, vol. I, pp. 380-81 nota. 76 Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 112r. 77 Ivi, c. 112v. 78 Cfr. Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali», cit., pp. 59-60 e passim; Id., Introduzione, in J. de Valdés, Alfabeto cristiano. Domande e risposte. Della predestinazione. Catechismo, Torino 1994, pp. LXXV sgg. e passim. 79 Processi Carnesecchi, vol. II, p. 145. 80 Sulle «forme di aggregazione e di proselitismo» utilizzate da Valdés e sul suo metodo gradualistico di conversione ha richiamato l’attenzione Firpo. Esemplare il caso di Pietro Carnesecchi descritto in Tra «alumbrados» e «spirituali», cit., pp. 24-39, ma cfr. anche Processi Carnesecchi. 81 Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 112v. 82 Ibid. 83 Ivi, cc. 112v-113r.
153
84
Ivi c. 113r. Ibid. 86 Ivi, c. 115r. 87 Ivi, c. 113r. 88 Cfr. L. Amabile, Fra’ Tommaso Campanella. La sua congiura, i suoi processi, la sua pazzia, 3 voll., Napoli 1882; T. Campanella, L’ateismo trionfato overo riconoscimento filosofico della religione universale contra l’antichristianesimo macchiavellesco, a cura di G. Ernst, 2 voll., Pisa 2004; L. Addante, Campanella et l’«Ateismo trionfato»: du paradigme au texte original, in «Les Dossiers du Grihl», http://dossiersgrihl.revues.org/. 89 Cfr. C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ’500, Torino 1976. 90 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 91 Ivi, carte non numerate (lettera del 9 luglio 1555). 92 Sul problema si ritornerà, ma va rilevato fin d’ora come in ciò vi sia l’ennesima confutazione della tesi di L. Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais (1942), avant-propos de H. Berr, postface de D. Crouzet, Paris 2003, che aveva negato la possibilità che nel Cinquecento si profilassero fuoriuscite dal cristianesimo. Si può incidentalmente aggiungere un riferimento sempre relativo a Napoli che è in ACDF, Stanza storica, I. 4 b, Brevia summaria contra aliquos nominatos in causa iudaismi [...], c. 13v, dove è riportato il caso di tal Mario Vitaliano (marzo 1570) che, secondo alcune accuse, «diceret se in Deum non credere». Ma può evocarsi anche il caso di Flaminio Fabrizi descritto da V. Lavenia, L’arca e gli astri. Esoterismo e miscredenza davanti all’Inquisizione, in Storia d’Italia. Annali, 25, a cura di G.M. Cazzaniga, Torino 2010, pp. 289-321. Sul tema dell’ateismo cinquecentesco cfr. F. Berriot, Athéismes et athéistes au XVIe siècle en France, 2 voll., Lille 1984; M. Hunter, D. Wootton (a cura di), Atheism from Reformation to the Enlightenment, Oxford 1992; J.-P. Cavaillé, Libertinage, irréligion, incroyance, athéisme dans l’Europe de la première modernité (XVIe-XVIIe siècles). Une approche critique des tendances actuelles de la recherche (1998-2002), in «Les Dossiers du Grihl», http://dossiersgrihl.revues.org/. 93 G. da Milano, Esortazione al martirio [...], s.l. 1552, p. 145. Cfr. Ginzburg, I costituti, cit., p. 43 nota; U. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, vol. II, Torino 1981, p. 574 nota. 94 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (lettera del 9 luglio 1555). 95 Ivi, b. 159, f. II, c. 116v (II costituto di G. Basalù, 5 marzo 1555). 96 Ivi, c. 115rv (I costituto). 97 S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580 (1987), Torino 1990. 98 Da Machiavelli Basalù avrebbe potuto trarre anche tracce lucreziane. Cfr. S. Bertelli, Noterelle machiavelliane. Un codice di Lucrezio e di Terenzio, in «Rivista storica italiana», LXXIII, 1961, pp. 544-53; Id., Noterelle machiavelliane. Ancora su Machiavelli e Lucrezio, ivi, LXXVI, 1964, pp. 774-92; J. Barthas, Au fondement intellectuel de l’irréligion machiavéllienne, Lucrèce? Controverses, notes et considérations, in J.-P. Cavaillé, D. Foucault (a cura di), Sources antiques de l’irréligion moderne: le relais italien XVe-XVIIe siècles, Toulouse 2001, pp. 67-90. 99 Per quanto segue cfr. M. Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino 1997, pp. 122-36; cfr. anche la Nota al testo dello stesso Firpo a J. de Valdés, Catechismo, in Id., Alfabeto cristiano, cit., pp. CLXX-CLXXVIII. 85
154
100
Valdés, Catechismo, cit., pp. 199-200. Il testo dell’Edicto de los alumbrados de Toledo è in A. Márquez, Los alumbrados. Orígines y filosofia (1525-1559) (1972), Madrid 1980, pp. 229-38. Sul nesso tra la lettura degli alumbrados e Valdés anche su questo punto cfr. Firpo, Gli affreschi di Pontormo, cit., p. 130, che ha però evidenziato come gli alumbrados prevedessero la salvezza universale e non dei soli eletti. 102 J. de Valdés, Lo evangelio di san Matteo, a cura di C. Ossola, Roma 1985, pp. 303-304. Cfr. Firpo, Gli affreschi di Pontormo, cit., p. 132. Ancora più chiaro al riguardo è un passo del trattatello Della predestinatione, della gratia et del libero arbitrio, della fede et dell’opere, in Valdés, Alfabeto cristiano, cit., pp. 173-74: «Quanto alla predestinatione intendo che, essendo tutti gl’huomini condennati alla morte eterna per la disubedientia del primo huomo, il nostro misericordioso Dio ab aeterno conobbe et predestinò certo numero di quelli ad effetto che, passando per la morte, vengano alla resurretione et così conseguino vita eterna; et intendo che di questi che Dio conobbe et predestinò è andato chiamando di tempo in tempo, secondo che quelli sono venuti nel mondo, quando uno et quando un altro; et intendo che questi che ha chiamati ha giustificati, et quelli che ha giustificati resuscitarà, glorificarà et darà [loro] vita eterna. Tutto questo intese così san Paulo, secondo si vede nelle sue epistole et principalmente in quella che scrisse alli Romani, et è ancor conforme a questo quel che dice Giesù Christo nostro signore parlando delle sue pecorelle: ‘Et nemo rapiet eas de manu mea’. Questi predestinati intendo che hanno ben causa di riconoscere in loro stessi la misericordia di Dio et, quando mi volto a considerare l’altro numero delli huomini non predestinati, intendo che non hanno di che dolersi di Dio non essendogli fatto agravio niuno, in quanto è esequita in loro interamente la sententia di morte eterna data contra il primo huomo per la disobedientia et transgressione». 103 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto). 104 Ivi, b. 159, f. II, c. 116r (II costituto). E tuttavia nel IV costituto Basalù avrebbe precisato di non averlo «mai sentito parlar di opinione ma, come ho detto, l’ho veduto molto intrinseco con la signora donna Giulia Gonzaga» (ivi, carte non numerate). Su Di Capua cfr. Marcatto, «Questo passo dell’heresia», cit. 105 Ragnoni entrò in contatto con i valdesiani all’inizio degli anni Quaranta. Basalù lo incluse tra i sacramentari e ne ricordò un’opera «contra el sacramento». Trasferitosi a Venezia, dove fu ospite di Carnesecchi (già frequentato a Napoli) e rivide Basalù, nel 1551 Ragnoni esulò a Ginevra aderendo al calvinismo e succedendo nel 1557 a Celso Martinengo alla guida della Chiesa italiana. Morì nel 1559 (Processo Morone, vol. I, p. 307 nota). 106 Amica di Giulia Gonzaga, Brianda Ruiz era moglie del tesoriere generale del Regno Alonso Sánchez e figlia del suo predecessore nella stessa carica (Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles, cit., p. 361; Processi Carnesecchi, vol. II, pp. 57 e nota, 81, 96-97 e passim). 107 Sul benedettino autore della prima versione del Beneficio di Cristo basti il rinvio all’edizione del Beneficio a cura di S. Caponetto, Firenze-Chicago 1972. 108 Barone di Parete, ascritto al Seggio napoletano di Nido, Carduino fu valdesiano della prima ora e in casa sua si riunirono diverse volte anche i radicali. Sospettato almeno dal 1547, fu arrestato nel 1552 e, inviato a Roma, processato col barone di Bernaudo al quale era legato. Abiurò nel marzo 1553 e ritornò a Napoli nel 1555, ma nel 1564, all’indomani dell’arresto di Giovan Francesco Alois (suo stretto sodale), fu nuovamente fatto oggetto di indagini e nel 1567 fuggì col figlio 101
155
Camillo a Ginevra, dove nel 1572 ottenne la borghesia; cfr. Processi Carnesecchi, vol. I, pp. 60, 165 nota; vol. II, pp. 1138-39 e nota; il processo Bernaudo conservato in ACDF, Stanza storica, I. 4 b; [Santoro], De persecutionis, cit. (ivi); e cfr. la raccolta dei Decreta, I, cc. 96r, 99v, 102r, 123v, 164v. 109 Nato verso la fine del XV secolo, barone di Monasterace per successione al padre Bernardino (consigliere del Sacro regio consiglio dal 1518 al 1537) morto nel 1540, Mario Galeota fu attivo nella diffusione delle opere di Valdés, che fece copiare e stampare in casa sua. Processato una prima volta a Roma nel 1554-55 fu arrestato nuovamente con l’ascesa al soglio di Paolo IV, riuscendo a fuggire dal carcere di Ripetta nell’agosto del 1559 per l’assalto alle prigioni del Sant’Ufficio seguito alla morte di papa Carafa. Ritornato a Napoli e ottenuta l’assoluzione nel 1560, fu arrestato di nuovo nel 1564 e considerato tra i fomentatori dei tumulti di quell’anno contro l’Inquisizione. Trasferito a Roma, fu sottoposto a un terzo processo nel 1566 e condannato a cinque anni di carcere. Tornato a Napoli nel 1571, morì nell’85 (Lopez, Il movimento valdesiano, cit.). 110 Su Ferrante Brancaccio, aristocratico napoletano legato a Flaminio e discepolo di Valdés, cfr. ibid. e Processi Carnesecchi, ad nomen. 111 Su Giovan Vincenzo Abbate (o Abate) cfr. Processo Morone, vol. VI, p. 428 nota; Processi Carnesecchi, ad nomen. Servitore di Giulia Gonzaga, Carnesecchi (Processi Carnesecchi, vol. II, p. 221) lo definì «amico della memoria et dottrina di Valdesio». Fu arrestato nel 1552 e condotto a Roma, dove abiurò e fu rilasciato su cauzione (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 90v, 99v, 107v). 112 L’uso del termine «sacramentari», a parte in fonti successive come i Processi Carnesecchi, è registrato nei costituti di Ambrogio Cavalli dell’11 ottobre 1555 (cfr. A. Casadei, Donne della Riforma italiana: Isabella Bresegna, in «Religio», XIII, 1937, p. 58), che alla domanda dell’inquisitore «quomodo intelligat illud verbum sacramentarii, respondit: Intendo sacramentari quelli che non tengono li sacramenti et che tengono che Christo realmente non sia nel hostia consacrata». 113 Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 115r (I costituto). 114 Ivi, c. 116r (II costituto). 115 Ivi, c. 115r (I costituto). 116 Ivi, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto). 117 Ivi, b. 159, f. II, c. 115r (I costituto). 118 Ivi, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto). 119 Cfr. De falsa et vera unius Dei patris, filii, et spiritus sancti cognitione libri duo [...] (1568), a cura di A. Pirnát, Utrecht-Budapest 1988; C. Sand, Bibliotheca antitrinitariorum [...] (1684), prefazione di L. Szczucki, Varsoviae 1967; D. Ricart, Juan de Valdés y el pensamiento religioso europeo en los siglos XVI y XVII, Lawrence (Kansas) 1958; Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali», cit.; Id., Introduzione, cit.
Capitolo II 1 Processi Carnesecchi, II, p. 1134. Più elusivo era stato il protonotario nel suo precedente processo: alla domanda degli inquisitori «an [...] audiverit fuisse habitum suspectum de haeresi vel pro haeretico quendam nuncupatum Villafrancha vel suspectum de haeresi», Carnesecchi aveva risposto: «Di Villafranca ho inteso non so che cosa in questa materia, che io non me recordo», aggiungendo, però, subito
156
dopo: «Quanto al Villafranca ho inteso che egli [è] caduto in questi suspetti d’heresia molti anni dapoi la morte del dicto Valdés» (ivi, I, pp. 60-61). 2 P. Lopez, Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant’Uffizio, Napoli 1976, p. 156. 3 Costituti di Lorenzo Tizzano, in D. Berti, Di Giovanni Valdes e di taluni suoi discepoli secondo nuovi documenti tolti dall’Archivio Veneto, in «Atti della R. Accademia dei Lincei, Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», 1877-78, p. 69. 4 J. de Valdés, Sul principio della dottrina cristiana. Cinque trattatelli evangelici, a cura di E. Boehmer, Halle sulla Sala 1870, pp. 23-25. 5 Lopez, Il movimento valdesiano, cit., p. 156. 6 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate. 7 Ivi, b. 159, f. II, c. 112v. 8 Carnesecchi evocò «un Villafranca che stava col viceré don Pietro» e «un Villafranca spagnolo che stava con don Pietro di Tolledo viceré alhora di Napoli» (Processi Carnesecchi, II, pp. 81-82 e 97). 9 Lopez, Il movimento valdesiano, cit., p. 156. 10 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate. 11 Si ringrazia il dott. Vincenzo De Rose per i chiarimenti al riguardo. 12 Secondo Biagio Marese, la casa di Villafranca «stava in Napoli in loco detto Ecclesia» (Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 7r). 13 Ivi, c. 7v. 14 Deposizione di Ambrogio da Pozzo (ivi, c. 7r). 15 Ivi, carta non numerata (IV costituto di G. Basalù). 16 Cfr. E. Belligni, Evangelismo, Riforma ginevrina e nicodemismo. L’esperienza religiosa di Renata di Francia, Cosenza 2008, pp. 261-62, che cita dai costituti di A. Cavalli. In un documento edito da A. Casadei, Donne della Riforma italiana: Isabella Bresegna, in «Religio», XIII, 1937, p. 59, dal titolo Eretici che erano in Ferrara al tempo di madama Renea, si fa pure riferimento alla presenza di «Hieronimo Busal». 17 Curione le dedicò la prima edizione delle Opere di Olimpia Morato (Basilea 1558); Ochino la Disputa intorno alla presenza del corpo di Giesù Christo nel sacramento della cena (Basilea 1561). Va ricordato anche l’entusiastico commento fatto da Sozzini (L. Sozzini, Opere, a cura di A. Rotondò, Firenze 1986, pp. 280-81 e nota), dopo un incontro con la donna a Zurigo, in una lettera a Bullinger. 18 Processo Basalù, b. 13, f. II, carta non numerata (IV costituto di G. Basalù). 19 Berti, Di Giovanni Valdés, cit., p. 80. 20 Processo Basalù, b. 13, f. II, carta non numerata (IV costituto di G. Basalù). 21 M. Firpo, Introduzione, in J. de Valdés, Alfabeto cristiano. Domande e risposte. Della predestinazione. Catechismo, Torino 1994, p. LXXXI. 22 «Scribatur ad vicarium Neapolitanum mittendo indicia quae habentur adversus Iohannem Villafranca, et procedat usque ad exhumationem et combustionem» (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 111r, 4 luglio 1553). 23 M. Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali». Studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi religiosa del ’500 italiano, Firenze 1990, pp. 54-55 e passim. 24 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate. 25 Ibid. Busale fu inquisito nel 1553 come tutti i membri della sua famiglia (tranne il latitante Girolamo e Bruno, arrestato già dal dicembre 1551) e fu prodigo di informazioni abiurando in forma privata così come sua moglie e le sue sorelle. Il
157
suo processo si concluse nel 1554. Cfr. ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 112r, 113r, 117v, 120rv, 122v; alla c. 126r si legge («sub die secunda ianuarii 1554»): «Macteus Bussalis: reverendissimus cardinalis de Carpo, attenta infirmitate ipsius Mactei et mortis periculo, prout in fide medicorum tenoris etc., in causa dicti Mactei sententiet et condemnet et poenitentias imponat, commutet et moderetur, et auctoritatem moderandi et immutandi respective sibi reservet, prout sibi videbitur, causam decidendo etiam auctoritate reverendissimorum dominorum inquisitorum et suorum collegarum». In una lettera di Michele Ghislieri a Marcello Cervini (Roma, 4 agosto 1553) v’è un ulteriore riferimento a Busale: «Sono stati condotti qua da Napoli don Pietro de Castilla [...], et un messer Mattheo Busal [...]. Il Busal confessa errori enormissimi et è di quelli che non han creduto la divinità di Christo Iesu nostro signore»; cfr. G. Buschbell, Reformation und Inquisition in Italien um die Mitte des XVI. Jahrhunderts, Paderborn 1910, p. 321 e la voce dedicata a Busale da A. Jacobson Schutte, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XV, Roma 1972, pp. 478-79. 26 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 8v (deposizione di M. Busale). 27 Ivi, c. 7v. 28 Ivi, b. 159, f. II, c. 115r (I costituto di G. Basalù). L’abate Villamarina (ivi, b. 13, f. II, c. 3r) aggiunse una casa posta «in Echia fora di Napoli quale la tiene in affitto un luchese nominato Ludovico Guinigi». 29 Coppola rivestì tale ruolo dal 1549 (G. Intorcia, Magistrature del Regno di Napoli. Analisi prosopografica secoli XVI-XVII, Napoli 1987). Basalù si riferì a lui elusivamente: «Giovanni Francesco Copula ho cognossuto in Napoli ma non ho hauta molta conversatione con lui. De le sue opinione ho hauta noticia dal Tizzano et da Mattheo Busale. Questo credo che sia in Napoli et era rationale de la Sumaria» (Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate, IV costituto di G. Basalù). Negli atti del processo (ivi, c. 11r) v’è un estratto di una deposizione di Coppola (15 febbraio 1554) che nulla aggiunge, salvo confermare quanto detto da Basalù sui loro rapporti. Tizzano nei suoi costituti (pp. 71-72) lo incluse fra coloro coi quali aveva parlato delle opinioni «diaboliche», ma specificando di ignorare se a quelle opinioni assentisse. Era in ogni caso giunto almeno alla negazione della divinità di Cristo. 30 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù): «Gregorio di Salerno ho cognossuto in Napoli in casa de li Busali et del Bianco. È morto già [da] molti anni». 31 «Francesco da Messina ho cognossuto in Napoli et ho ragionato con lui solo. Del 1544 over ’45 stava in casa del signor Antonio Grisone per maestro de li sui figli. Non ho poi hauta nova di lui. Era prima monaco, et si chiamava don Clemente» (ibid.). 32 «Don Angelo ho prima cognossuto in Palermo monaco cassinense, poi seculare in Napoli in casa del Citarella. Le sue opinione ho intese da lui stesso: alcune volte era presente il Citarella et il Tizzano. Non so nova alcuna di lui, già [da] quattro anni che lo lassai a Napoli» (ivi, alla c. precedente il riferimento a Fontanini). Sui due benedettini Basalù aggiunse: «De li doi monaci del ditto ordine non so cosa alcuna, chi fussero et dove siano, ma alhora uno ne stava in casa del Copula, l’altro non so, et de le sue opinione ho inteso dal ditto don Angelo» (ibid.). Cfr. anche A. Prosperi, L’eresia del libro grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta (2000), Milano 2001, pp. 59 e 396 nota. Che don Angelo fosse messinese e che avesse professato a San Placido di Colenerò (Messina) risulta da un documento edito in B. da
158
Mantova, Il Beneficio di Cristo, a cura di S. Caponetto, Firenze-Chicago 1972, p. 452 nota. Questo don Angelo non va confuso con Angelo da Messina, al secolo Ludovico Manna. Che i due don Angelo non siano la stessa persona si evince dai costituti di Basalù, che ricordò entrambi i personaggi (Manna in Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate, IV costituto di G. Basalù). 33 Basalù confessò d’averlo «cognossuto in Napoli, et delle sue opinione mai ho parlato con lui in particolare che mi riccordi, ma ne ho hauta relatione dal Villafranca, in compagnia del quale lui stava. Et molte volte era presente a li ragionamenti del Villafranca. Questo è in casa del reverendissimo cardinal Morrone, et sono molti anni che si è ricconciliato» (Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate, IV costituto di G. Basalù). Villamarina ammise d’«haver praticato in Napoli dal ’42 insino all’anno 1546 con molti heretici et conosciutoli [per] tali», e che «prima conobbi uno signore Giovanni de Villafranca spagnolo, il quale so, per diversi ragionamenti hauti seco in diversi lochi in Napoli, che era lutherano et negava l’invocatione de santi, il purgatorio, la confessione, l’authorità del papa, tenendo il resto dell’opinioni lutherane, anzi negava l’esistentia de Christo nostro signore nel santissimo sacramento del altar. Il medesmo divenne anabattista, negava la divinità del salvator nostro Iesu Christo et negava parte de l’evangelio di san Giovanni et delli altri evangelisti dove era attestata la divinità de Christo. Et questo so perché esso in più volte in più tempi et lochi me ha detto queste sue opinioni» (ivi, c. 2v). 34 Cfr. ivi, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 35 Su Villamarina Carnesecchi rivelò: «Io lo cognosco et lo cognobbi insino l’anno 1540 o ’41 in Napoli, essendo egli venuto a visitare il Valdés et il Flaminio alcuna volta et essendo poi venuto in compagnia del Flaminio et mia da Napoli a Roma, dove poi che fu gionto in puochi giorni se accomodò al servitio del cardinale Morone per mezzo non so si era del Prioli o del Flaminio, nel qual servitio credo si truovi ancora adesso» (Processi Carnesecchi, II, p. 263; cfr. inoltre ivi, pp. 268, 37677 e passim). Villamarina, «gentilhuomo napoletano» (forse legato da parentela alla principessa Isabella Villamarina o Villamarino de Cardona), aveva conosciuto Morone a Roma tra il 1529 e il 1533; entrato ai suoi servizi intorno al 1541, era poi tornato a Napoli ed entrato in contatto col gruppo radicale attraverso Villafranca. Dopo esser stato indagato (abiurò nel 1552) s’impiegò stabilmente al servizio di Morone. Ciò gli comportò un nuovo arresto, nel 1558, ma fu scarcerato poco dopo (Processo Morone, vol. I, pp. 313-14 nota; M. Firpo, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d’eresia, 1992, Brescia 2005, pp. 138, 269, 393 e passim; Lopez, Il movimento valdesiano, cit., pp. 49, 120-23, 125). In ACDF, Stanza storica, I. 4 b, allegato alla sentenza contro Alessandro Archirota, v’è un estratto da un costituto di G.F. Alois (datato 13 gennaio, ma senza indicazione dell’anno: è probabile che si tratti del 1553) in cui si legge: «Alla Roccha Guglielma ci era ancora un’altra setta di questi anabatisti, tra li quali ci era Marc’Antonio Villamarina, qual havea un’abbazia [...], fra’ Matteo d’Aversa, monaco di Mont’Oliveto et [...] ci era ancora lo signor Giovan Battista della Tolfa, et don Alessandro Archirota monaco di Mont’Oliveto». 36 «Rocco di Taranto era servitor del Citarella, et le sue opinioni ho intese da don Lorenzo Tizzano e parte da lui stesso, ma non credo in presentia di altri. Non so dove costui sia, et credo fosse stato per avanti frate scapucino». Cfr. Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). Rocco fu successivamente processato (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 156v, 28 agosto 1555): «Rocchus de Taranto et Ioannes Vincentius de Charo: committatur causa eorum
159
reverendo domino vicario Neapolitano». Nessun riferimento a un Rocco da Taranto si trova in C. Cargnoni (a cura di), I frati cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, 5 voll., Perugia 1988-93, dal che si può dedurre che Rocco fosse il suo nome di battesimo. 37 «Persio Calavrese è stato mio servitore in Napoli. Ho ragionato con lui senza presentia di alcuno; non so dove si trovi. Lo lassai del 1551» (Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate, IV costituto di G. Basalù). 38 «Bartolomeo da Messina alias Rositano ho cognossuto in Napoli et ho ragionato con lui solo per il più, ma alcuna volta vi era il Tizzano. Stava in Roma con il reverendissimo cardinal Burgos per musico. Al presente credo sia in Napoli» (ibid.). 39 ACDF, Stanza storica, I. 4 b, [G.A. Santoro], De persecutionis haereticae pravitatis historia, c. 39v. Da uno stralcio di una deposizione del Riera/di Nieri (13 ottobre 1554) allegato al Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 11r, risulta che era imputato, tra l’altro, «de divinitate Christi, de virgine Maria quae non esset virgo». 40 Ivi, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 41 Ivi, cc. 3v-6r. D’Alessio fu arrestato a Napoli nel dicembre del 1552 subendo anche il sequestro dei beni. Il 9 marzo fu condannato alla fustigazione pubblica e, condonatogli il sequestro dei beni, dovette pagare 200 scudi d’oro al Sant’Ufficio e subire condanna alle triremi. Pronunciò pubblica abiura a Roma il 21 marzo 1553, restando tuttavia agli arresti. In data 9 maggio la pena alle galere gli fu revocata in luogo di altri 200 scudi di ammenda e gli fu assegnato «pro carcere» di poter restare in «domum propriam». Gli fu inoltre imposto di seguire la messa con l’abitello tutte le domeniche e i giorni festivi. Tra il 25 e il 30 maggio fu nuovamente arrestato (posto «loco carceris» nel monastero di San Pietro in Vincoli) e gli arresti domiciliari gli furono commutati con l’assegnazione «pro carcere, loco domus suae habitationis, totum monasterium Sancti Anelli de Neapoli» (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 96v, 98v-99r, 106v, 108rv; ivi, I. 4 b, [Santoro], De persecutionis, cit.). 42 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 5r. 43 J. de Valdés, Le cento e dieci divine considerazioni, a cura di T. Fanlo y Cortés, Genova-Milano 2004, pp. 363-64. 44 Id., Lo evangelio di san Matteo, a cura di C. Ossola, Roma 1985, p. 347. Cfr. anche ivi, p. 431: «Intendo quanto si deve guardare ogni uomo di pigliar opinione niuna, perché sempre, dopo d’averla pigliata, si obliga di difenderla». 45 Cfr. i costituti d’Aversa del 3 luglio 1553, in Berti, Di Giovanni Valdés, cit., p. 79. 46 In chiusura della deposizione di Marese (Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 8r), gli inquisitori annotarono: «Li errori confessati per detto Biasio sonno questi, cavati in substantia: cioè del papa che fusse Antichristo et della potestà sua, de esu carnium, de ieunio, de diebus praeceptis Ecclesiae, de purgatorio et suffragiis, de invocatione sanctorum, de dormitione sanctorum, de sanctissimo sacramento eucharistiae, d’additione et diminutione evangelii, de celibatu, de negatione sanctissimae trinitatis, de divinitate Christi et de virgine Maria, de sacramentis Ecclesiae, de missa, de confessione, de votis». Basalù (ivi, carte non numerate, IV costituto) così lo ricordò: «Biasio Marrese era et credo sia in Napoli in casa de li Busali, che li serve per sollicitator di cause. L’ho udito parlar poche volte de le sue opinione, alcuna volta in presentia de li Busali et del Tizzano. Et è di Marathia». 47 «Cesare Maffei ho cognossuto in Napoli prima in casa de li Busali, poi veniva spesso a visitarmi, ma poche volte ragionava con me di opinione, ma ragionava
160
di alchimia, essendo lui molto pratico in quelli esercitii. Si infermò del 1551 in casa mia, dove morì. Era veronese, et credo fossi stato monaco cassinese» (ibid.). 48 «Giovanni Thomaso Bianco ho cognossuto prima in Padova, che era mio compagno di studio, dapoi in Napoli. Et conversavamo dal Villafranca, et havemo conferito insieme le opinione, cioè le sue. Credo sia in Napoli, ma credo che già molti anni si sia reconciliato voluntariamente» (ibid.). In un primo momento (il 2 luglio del 1549) Bianco ammise con gli inquisitori d’avere discusso con i suoi compagni di opinioni luterane, precisando di non condividerle in molti casi. Il 9 luglio fu scarcerato da Tor di Nona, ma con obbligo di permanenza a Roma, dove restò sotto processo fino al 1550. Arrestato nuovamente, in un interrogatorio del 1554 fece alcuni nomi dei suoi «complices» (tutti riconducibili all’ala radicale) e ammise d’aver acconsentito a «opinioni» ben più estreme: nell’agosto del 1555 risultava ancora sotto processo; cfr. Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (prima deposizione) e ivi, c. 11v (seconda deposizione); ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 13v, 14r, 23v, 27r, 155r. Nella deposizione del cappellano dei Bianchi Giovanni Beffa del 18 luglio 1566 (Lopez, Il movimento valdesiano, cit., p. 160) si parla di Bianco e si smentisce la sua riconciliazione: «Lo predecto magnifico Ioan Thomase [Bianco] io l’ho tenuto per heretico so[no] molti anni, et in particolari ne so questo, che stando io vicario in Ugento nell’anno 1560 in circa et andando verso Casale novo per servitio de monsignore de Ugento, come fui ad certi casali de quilli luochi, stando allogiato con uno arciprete dellà, domandando de chi erano li casali, intesi dal decto che l’havea tenuto in pegno o teneva da la Regia corte il predecto Iohanne Thomase. Et io, intendendolo nominare et essendome suspecto, cominciai ad dimandare se in dicti casali ci era novità de opinioni. Lo dicto arciprete me rispose che ci erano stati cinque homini del decto casale infestati de heresia da homini dependenti et con saputa et intelligenza del Iohanne Thomase». Il caso rivela come diverse riconversioni al cattolicesimo di radicali furono indotte dalla repressione inquisitoriale e favorite dagli editti di grazia di Giulio III: non pentito ritorno all’ovile, ma spesso semplice simulazione. Vale la pena di aggiungere come il 20 maggio del 1549, poco avanti il primo arresto, Bianco acquistasse per 3.000 ducati da Scipione Capece «ducati 300 di entrata annua che aveva nella misura della dogana del sale di Napoli». Cfr. A. Altamura, Per la biografia di Scipione Capece (1959), in Id., Studi di filologia italiana, Napoli 1972, p. 180. 49 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 11r (deposizione di Andrea Riera). Bianco nel 1554 indicò fra’ Cristoforo tra i suoi complici (ivi, carte non numerate); l’abate Villamarina fra coloro che «tenevano contra la divinità de Christo et evangelio» (ivi, c. 3r); Ambrogio da Pozzo (ivi, c. 6v) lo accomunò alle proprie opinioni salvo il battesimo agli adulti e la liceità del matrimonio tra parenti. Matteo Busale (ivi, c. 8v) lo incluse fra coloro che negavano la divinità di Cristo e la verginità di Maria, proclamavano la mortalità dell’anima dei reprobi e il sonno delle anime dei giusti e dubitavano della veridicità delle Scritture. 50 «Mattheo Francese ho cognossuto prima in casa de li Busali in Napoli, dove l’ho sentito ragionar de le sue opinione. Erano presenti li Busali, il Marrese, Gregorio di Salerno, il Villafranca, il Bianco et alcuno altro che non mi riccordo per esser stato questo ragionamento del 1543. Poi l’ho cognossuto in prigione in Napoli, come ho ditto nel mio constituto. Di costui non so nova alcuna già [da] molti anni» (ivi, carte non numerate, IV costituto di G. Basalù). Tizzano aveva attribuito al francese le sue opinioni sull’eucaristia: «In questa opinione ribalda del sacramento sanctissimo del altare me indusse un fra Mattheo Francese quale non ho nominato
161
in la confessione di Padua, il quale andava vestito di un abito bigio, et erat nullius ordinis» (costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 70). 51 «Ho dato et procurato elemosine per molti delli sopradetti che l’eran poveri et particolarmente al sopradetto Matheo Francese, essendo lui preson in Napoli» (Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 115v, I costituto di G. Basalù). In ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 123r, 28 novembre 1553, v’è riferimento a un «Macteus Nazarenus, Gallus» citato insieme a un «frater Hieronimus Pignanus, Calaber», ma nessun riferimento si fa alle loro eresie ed è arduo dire se si trattasse della stessa persona. 52 Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 9v-10r. Il 14 aprile di quell’anno l’olivetano era stato convocato dall’Inquisizione: «Frater Hieronimus Capece, congregationis Montis Oliveti: reverendus Pighinus scribat quod veniat Romam et se praesentet coram reverendissimis» (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 103r). 53 S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580 (1987), Torino 1990; Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali», cit.; L. D’Ascia, Erasmo a Napoli, in M. Bosse, A. Stoll (a cura di), Napoli viceregno spagnolo. Una capitale della cultura alle origini dell’Europa moderna (sec. XVI-XVII), Napoli 2001, vol. I, pp. 167-75. 54 Berti, Di Giovanni Valdés, cit., p. 80. 55 Processo Basaslù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 56 Costituti di d’Aversa, in Berti, Di Giovanni Valdés, cit., p. 78; e in Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 7r. [Santoro], De persecutionis, cit., c. 36r (ACDF, Stanza storica, I. 4 b) ne ricorda l’abiura pronunciata il 16 marzo 1554 insieme con altri sedici eretici: «Costui negava la divinità di Christo ne le epistole di Paulo et in Isaia [...], dicea di matti et scelerati et sporchi errori et ch’el vangelo di Luca da lui interpretato» presentasse delle interpolazioni. Più oltre Santoro si riferiva sicuramente a lui nel ricordare che tra i diciassette c’era chi riteneva «che l’heretici non si deveno scomunicare, che l’Inquisizione non gli deve persequitare, che l’excommunica nol noce», che «il battesmo in acqua pura doversi fare». Tracce delle traversie processuali (subì anche la tortura) di «frater Macteus de Aversa» (dal giugno 1552 al 1554) sono ivi, Decreta, I, cc. 70v, 87v, 88v, 90r, 95rv, 96v, 97r, 100v, 106v, 109v, 111r, 120r, 121v, 124v, 126v, 127v, 128r, 149v. Gli fu assegnato il proprio monastero «loco carceris» e il 17 giugno del 1555 ebbe «licentiam deponendi abitellum, et quod vadat ad omnes horas et audiendam missam, sed statim redeat ad carcerem sibi assignatum». Cfr. anche Buschbell, Reformation und Inquisition, cit., p. 320: «Di poi la partita di vostra reverendissima illustrissima signoria, don Mattheo di Aversa ha hauto la fune et stette saldo, ma de poi tre o quattro giorni confessò molti errori, tra li altri ch’era stato sacramentario et che credeva non fusse possibile che Christo Iesu nostro signore fusse Dio» (Ghislieri a Cervini, Roma, 4 agosto 1553). 57 Berti, Di Giovanni Valdés, cit., p. 78. 58 Ibid. I personaggi coperti dalla N. potrebbero essere G. Busale e F. Renato. 59 Cfr. le deposizioni di Villamarina (Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 3r) e da Pozzo (ivi, c. 6v). Uno stralcio della deposizione di Raffaele da Roccaguglielma allegato al Processo Basalù (cc. 10v-11r, 24 giugno 1554) nulla dice sulle sue posizioni. In ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 126v, 2 gennaio 1554, si fa riferimento a «Raphael de Roccha Guilielma, chirurgus» e in data 12 febbraio 1555 (c. 139v) si legge: «Raphael de Rocca Guilielma: fiat copia sententiae». La citazione riportata nel testo è ivi, I. 4 b, [Santoro], De persecutionis, cit., c. 40r. 60 Costituti di Giovanni Laureto, in M.E. Pommier, L’itinéraire religieux d’un
162
moine vagabond italien au XVIe siècle, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», LXVI, 1954, pp. 319-20. 61 Don Spinola (in Lopez, Il movimento valdesiano, cit., p. 156) rivelò come «più volte in li tempi predecti, credo vivente Valdesio et credo poco dopoi, andando più volte in casa del magnifico Ioanne Vincenzo Abbate, uno deli condiscipuli del decto Valdessio, ho visto alcune cose del decto Valdessio sopra l’evangelii et sopra l’epistole di san Paolo, che li copiava in casa del decto Ioanne Vincenzo, ipso sciente et consentiente, Ambrosio de Puzo». Lopez (ivi, p. 120 nota) suppone che fosse uno scrivano sulla base di quanto detto da Spinola e da Tizzano (costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 71: «Messer Ambrosio che stava col signor locotenente della Summaria»). Arrestato nel dicembre 1552, condannato alle galere il 9 marzo 1553, pronunciò pubblica abiura a Roma il 21 marzo. Il 9 maggio l’Inquisizione ordinò: «Transmittatur ad triremes iuxta sententiam». Fu liberato dai ceppi il 29 gennaio 1554: «Liberetur a triremibus et assignarunt pro carcere unam cameram in monasterio Sancti Dominici civitatis Neapolitanae, a qua non exeat nisi ad audiendum missam in diebus dominicis et festivis cum palliolo solito, nuncupato pacientia, super omnia eius corporis indumenta, et caveat non exire et de tuto carcere sub poena 300 scutorum, et monasterium obliget se de retinendo eum in dicta cella ad beneplacitum reverendissimorum dominorum cardinalium inquisitorum» (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 99v, 107r, 109r, 129v). Da sottolineare la presenza di da Pozzo in San Domenico poco prima che vi entrasse Giordano Bruno, che proprio in quell’ambiente maturò i propri dubbi in materia trinitaria; cfr. V. Spampanato, Vita di Giordano Bruno (1921), prefazione di N. Ordine, Paris-Torino 2000; L. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, a cura di D. Quaglioni, Roma 1993; M. Ciliberto, Giordano Bruno (1990), Roma-Bari 2000. 62 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 6v. 63 «Ali seguenti io ho parlato de tutte le sopradette mie chimere et fantasie, cioè de mortalitate animae cum consequentibus supradictis: Thobia Citarella, Antonio d’Alessio, don Lorenzo Tizzano et Matheo Busale, ma de questi quatro el primo solo mi assentì» (ivi, b. 159, f. II, c. 115r). Nel suo IV costituto (ivi, b. 13, f. II, carte non numerate) Basalù aggiunse: «Tobia Citarella ho cognossuto in casa sua in Napoli del 1550 et ci visitavamo al spesso. Con costui presi strettissima amicitia et con lui ho conferito ampiamente tutte le mie opinione et lui con me le sue. Costui era mercante et è morto già uno anno, ma alcuni mesi avanti che morisse credo che si ricconciliasse voluntariamente, et io per lettere l’ho esortato a farlo». È ignoto se fosse parente di Citarella un Vito Antonio Citarella processato a Napoli nel 1589 per poligamia – P. Scaramella, Inquisizioni, eresie, etnie, dissenso religioso e giustizia ecclesiastica in Italia (secc. XVI-XVIII), Bari 2005, pp. 262, 271, 290, 292 – né sono noti rapporti parentali con i Citarella del Banco Citarella e De Rinaldo, uno dei quattro maggiori banchi di Napoli: G. Muto, Tra «hombres de negocios» e banchi pubblici: progetti di autonomia finanziaria nello Stato napoletano (secoli XVIXVII), in «Studi storici Luigi Simeoni», XXXIII, 1983, pp. 85-101. 64 L’elenco elaborato è incompleto. Un prete Camillo da Eboli e un Mariano Ginosa pugliese «servitor di Ravaschieri», che abiurarono il 16 marzo 1554, sembra si fossero spinti a opinioni sovrapponibili alla terza posizione rivelata da Tizzano. All’ultimo grado del magistero di Villafranca pare fosse giunto «Fabrizio Recco, bel giovane napoletano», che abiurò il 4 novembre 1554: negava la divinità di Cristo e la verginità di Maria, oltre a ritenere «che il paradiso era in questo mondo haver la gratia de Iddio», dormendo fino al giorno del giudizio i «santi», mentre a quel tem-
163
po gli empi non avrebbero «a trovare diaboli né tormenti né inferno» (ACDF, Stanza storica, I. 4 b, [Santoro], De persecutionis, cit., c. 39v). 65 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 10v. La testimonianza pare collocare al 154950 la conversione di Capece, che fu precedente. 66 Ivi, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 67 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., pp. 71-72. 68 A lungo si è ritenuto che Capece nascesse nel 1508 in base all’errata interpretazione di un passo di una sua elegia, De suis ac suorum temporum miseriis, datata (anch’essa erroneamente) al 1538. Altamura, Per la biografia, cit., pp. 161 sgg. ha dimostrato che la data di nascita va posta nell’ultimo ventennio del Quattrocento. 69 I Loffredo, ascritti al Seggio di Capuana, rappresentano un importante caso dell’ascesa del ceto togato tipica della storia meridionale. 70 Nel 1516 Antonio Capece divenne consigliere del Sacro regio consiglio, restandolo fino al 1537. Docente di Ius civile della sera e di Ius feudale nello Studio di Napoli, morì nel 1538 (E. Cannavale, Lo studio di Napoli nel Rinascimento, Napoli 1895, pp. 58-59 e passim; A. Cernigliaro, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli: 1505-1557, 2 voll., Napoli 1984, vol. I, passim; Id., «Patriae leges privatae rationes». Profili giuridico-istituzionali del Cinquecento napoletano, Napoli 1988; Intorcia, Magistrature, cit., pp. 185-87; R. Pilati, «Officia principis». Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento, introduzione di R. Ajello, Napoli 1994; G. Coniglio, Il viceregno di don Pietro di Toledo (1532-53), 2 voll., Napoli 1984, vol. I, pp. 163 e 183). 71 Il Seggio di Capuana era formato da tre gruppi corrispondenti a tre quartieri: i Caracciolo, i Capece e gli Ajenti (Aggiunti), termine con cui si indicavano le famiglie ascritte più di recente. I Caracciolo costituivano un unico lignaggio suddiviso in vari rami, mentre se le case accomunate dal cognome Capece (Minutolo, Sconditi, Aprano, Zurlo, Piscicelli, Galeota, Tomacelli, Latro, Bozzuto, Cybo) appartenessero a un unico lignaggio fu questione dibattuta fra i genealogisti: Elio Marchese li stimò appartenenti a unico ceppo, al contrario di Scipione Ammirato e di Carlo Borrelli. M.A. Visceglia (Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna, Milano 1998, pp. 141-72) ha mostrato come con la seconda metà del Cinquecento, attraverso la fondazione di un Monte di famiglia (1584), i Capece passassero da un’organizzazione consortile (analoga a quella degli Alberghi della nobiltà genovese) a riconoscersi come un gruppo familiare rappresentato da un comune stemma. Ferdinando della Marra accomunò anche i Capece di Nido allo stesso ceppo, scisso in «multiplices uberrimosque [...] ramos», facendo anche riferimento alle vicende descritte da Visceglia (Capece, Opere, pp. XXXIII-XLIII, citazione a p. XXXVII). 72 La lettera è in Altamura, Per la biografia, cit., p. 174. 73 G. Parenti, Capece, Scipione, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XVIII, Roma 1975, pp. 425-28, in particolare p. 427. 74 A Seripando è indirizzata un’elegia di Capece (Opere, cit., p. 266). 75 Parenti, Capece, cit., p. 427. 76 Nella dedicatoria alla principessa Villamarina (Capece, Opere, pp. XLV-XLVIII). 77 L. Braida, Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra inquietudini religiose e «buon volgare», Roma-Bari 2009. 78 Cannavale, Lo Studio di Napoli, cit., pp. 58-59. 79 Altamura datò al 1519 il suo incarico riportando una lettera (datata 6 feb-
164
braio, ma senza l’anno) indirizzata da Cosenza a Pietro Summonte da Capece, che evocava le sue «occupationes administrandae provinciae». Ma l’unica certezza è il terminus ad quem, che è il 1526, anno della morte di Summonte. Quanto al suo ruolo, parrebbe che Capece si riferisse all’incarico di governatore; ma dal 1519 al 1520 si succedettero nella carica Belisario Acquaviva, Paolo de Racho e Pietro Antonio Sanseverino, mentre dal 1520 tornò Fernando de Alarçon (Intorcia, Magistrature, cit., p. 109), già governatore dal 1506. Peraltro, di norma al governatorato accedeva personale militare, mentre a Cosenza era prevista la figura del luogotenente, con giurisdizione sulla città e i suoi casali: è probabile che Capece esercitasse tale ufficio, usualmente appannaggio di personale giuridico. 80 L’opera fu edita da Sultzbach e Cancer. 81 Altamura, Per la biografia, cit., p. 162. Poeta, letterato e docente universitario di Retorica a Milano, Roma e Padova, su Antonio Telesio non esistono studi aggiornati. 82 B. Croce, I fratelli Martirano (1897), in B. Martirano, Aretusa e Polifemo, Soveria Mannelli 2002, pp. 111-18, considerava i Martirano tra i «prosecutori nel napoletano di quel movimento accademico che dalla Pontaniana dà la mano all’Accademia di Cosenza» (p. 111). Sulla prima fase dell’Accademia cosentina cfr. S. Quattromani, Di Giano Parrasio e di altri autori cosentini del XVI secolo, in Id., Scritti, a cura di F.W. Lupi, Rende 1999, pp. 257-69; G.P. d’Aquino, Oratione [...] in morte di Berardino Telesio philosopho eccellentissimo agli Academici cosentini, Cosenza 1596; S. Spiriti, Memorie degli scrittori cosentini (1750), Bologna 1970. 83 Tra gli altri accademici cosentini frequentati da Capece può ricordarsi Leonardo Schipani, che scrisse un’elegia De Scipione Capycio nel 1534 (Altamura, Per la biografia, cit., pp. 174-75). Quanto a Bernardino Telesio, considerando che visse in simbiosi con lo zio Antonio lungo gli anni della sua formazione, è difficile che non conoscesse Scipione, idee del quale affiorano dal De rerum natura iuxta propria principia e dagli opuscoli naturalistici. Tradizionalmente si data al 1518 il trasferimento di Telesio a Milano, ma la data non è confermata da documenti. Cfr. F. Fiorentino, Bernardino Telesio, ossia studi storici su l’idea della natura nel Risorgimento italiano, 2 voll., Firenze 1872-74; L. De Franco, Introduzione a Bernardino Telesio, Soveria Mannelli 1995; Bernardino Telesio nel 4° centenario della morte (1588), Napoli 1989; Atti del Convegno internazionale di studi su Bernardino Telesio, Cosenza 1990; R. Sirri, M. Torrini (a cura di), Bernardino Telesio e la cultura napoletana, Napoli 1992; R. Bondì, Introduzione a Telesio, Roma-Bari 1997. 84 Sul circolo di Ischia raccolto attorno a Vittoria Colonna cfr. S. Thérault, Un Cénacle humaniste de la Renaissance autour de Vittoria Colonna châtelaine d’Ischia, Paris-Firenze 1968 (su Capece cfr. pp. 217-18). 85 Su Oporinus cfr. M.S. Steinmann, Johannes Oporinus. Ein Basler Buchdrucker um die Mitte des 16. Jahrhunderts, Basel-Stuttgart 1967; su Perna cfr. L. Perini, La vita e i tempi di Pietro Perna, Roma 2002. 86 L’opera ebbe anche altre edizioni. Benedetto di Falco scrisse che circolava a Napoli «da tutte dotte e latinissime mani» (Capece, Opere, p. 197). Riuscì nel 1546 con l’editio princeps del De principiis rerum. Per i giudizi di Gessner e Simler cfr. ivi, pp. LII-LIII. 87 Probabilmente nel 1537 (ma P. Manzi, Annali di Giovanni Sultzbach, Firenze 1970, p. 101, data a dopo il 1540) uscirono per Sultzbach gli Scripta Scipionis Capycii super titulo de acquirenda possessione ubi multa utilia in practica, et in materia feudorum et constitutionis Regni continentur; nel 1540 circa (per lo stesso edi-
165
tore) e poi nel 1544 (a Salerno) andò a stampa il Magistratuum Regni Neapolis qualiter cum antiquis Romanorum conveniant compendiolum. Nel 1541 uscì a cura di Scipione per i Giunti di Venezia (ma forse ve n’è un’edizione anteriore) una silloge di decisioni rese dal padre in Santa Chiara. 88 Cfr. Cannavale, Lo Studio di Napoli, cit., p. 64. La cattedra di Ius civile prevedeva un insegnamento mattutino, sul Codex iustinianeo, e uno serale, sul Digesto (cfr. anche N. Cortese, Politica e cultura a Napoli dal Cinquecento al Settecento, Napoli 1965, p. 90). Scipione non succedette nella cattedra direttamente al padre (che però ne era stato titolare fino a pochi anni prima), ma a Gasparro de Leo. 89 G.B. Pino, Il triompho di Carlo V, Sultzbach, Napoli 1536 (cfr. E. Valeri, «Italia dilacerata». Girolamo Borgia nella cultura storica del Rinascimento, Milano 2007, p. 25 nota). 90 P. Giannone, Istoria civile del Regno di Napoli (1723), XXXII, V, 8, seguito da Altamura, Per la biografia, cit., p. 165. Alle sue qualità e al suo rango fece invece riferimento Scipione stesso nel De principiis rerum (II, 839-840) per spiegare il suo momento apicale prima della caduta in disgrazia. 91 G. Mazzuchelli (Notizie storiche e critiche intorno alla vita e agli scritti di Scipione Capece [...], in Capece, Opere, p. XIII e note) si basò su due menzioni che reperì nel Rimario di Benedetto di Falco (Napoli 1535) e nell’edizione dei Commentari di Donato all’Eneide di Virgilio data da P. Flavio (Napoli 1535). Nessun cenno a insegnamenti successivi al 1534-35 in Cannavale, Lo Studio di Napoli, cit. 92 La nomina avvenne il 16 dicembre 1539, il 18 entrò in carica (Altamura, Per la biografia, cit., pp. 175-76). 93 A Capece sono dedicati vari componimenti da Giano Anisio, sia in Variorum poematum libri duo, Neapoli 1536, sia nelle Epistolae de religione et epigrammata, Neapoli 1538. Valeri, «Italia dilacerata», cit., ha reperito tre epigrammi dedicati da Borgia a Scipione. Altri riferimenti in Capece, Opere. 94 Nato verso il 1510, Alois fu detto il Caserta in quanto lì la sua famiglia deteneva vasti beni. Inserito negli ambienti della Pontaniana, fu amico di Paolo Manuzio, Paolo Giovio, Marcantonio Flaminio e Scipione Capece, al quale era legato da legami parentali (erano entrambi sposati in casa Caracciolo). Alois fu inoltre legato a Carnesecchi, Galeota, Brancaccio e Bernaudo, a Giulia Gonzaga, Giovan Tommaso Minadois e a Galeazzo Caracciolo. Attivo nel diffondere l’eresia nel Casertano, Alois fu arrestato dall’Inquisizione nel 1552 e condotto a Roma. In seguito all’abiura (e dietro il pagamento di una cauzione di 2.000 scudi), dopo un periodo di domicilio coatto tornò a Napoli, ma nel 1562 fu imprigionato di nuovo e svelò i nomi di molti compagni nel tentativo di salvarsi. Fu decapitato e poi arso sul rogo a Napoli il 4 marzo 1564 (con Bernardino Gargano): la sua esecuzione diede il via a un nuovo tumulto contro l’Inquisizione. Cfr. la voce dedicatagli da M. Rosa in Dizionario biografico degli Italiani, vol. II, Roma 1960, pp. 515-16; Processo Morone, vol. I, pp. 377-78 nota; ACDF, Stanza storica, I. 4 b (Processo Bernaudo); ivi, [Santoro], De persecutionis, cit.; ivi, Decreta, I, cc. 62v, 87v, 88v, 98v, 102v. 95 C. Minieri Riccio, Cenno storico delle Accademie fiorite nella città di Napoli, in «Archivio storico per le Province napoletane», V, 1880, p. 143; F. Pometti, I Martirano, Roma 1897, pp. 39-40. T.R. Toscano, Letterati corti accademie. La letteratura a Napoli nella prima metà del Cinquecento, Napoli 2000, pp. 265-98, mette in dubbio l’esistenza della Pontaniana «come vera accademia» dopo la morte di Sannazaro, ipotizzando che «se sul piano del prestigio culturale non si può immaginare di collocarlo [Martirano] allo stesso livello del Capece, niente si oppone, in as-
166
senza di obiettivi riscontri in contrario, a ritenere che proprio intorno a lui, a partire almeno dal novembre del 1535, abbiano continuato a riunirsi gli ultimi pontaniani». Toscano stesso però ricorda un passo di Capece nel quale definì Luis de Toledo, figlio del viceré, «ducem et moderatorem Academiae nostrae». Un’accademia dunque ben esisteva e ciò emerge soprattutto dalla dedicatoria di P. Flavio a L. de Toledo edita nel commentario di Donato all’Eneide, da cui si evince pure che l’Accademia si riuniva da Capece: «Cum Scipione Capycio est mihi, clarissime ac vere illustris adolescens, magna familiaritas, quam mihi colendam semper putavi, eiusque domum optimo cuique apertissimam frequentare soleo, quo viri litterati, ac studiis doctrinisque dediti solent convenire, ut de rerum ac verborum ratione, bonisque auctoribus colloquantur» (Capece, Opere, p. 287). Per il resto, l’argomentazione è limitata a quella che Toscano non esita a definire «una considerazione banale» (p. 291), secondo cui da Panormita a Pontano a Sannazaro i principi dell’Accademia avevano avuto «la disponibilità di una villa famosa e sufficientemente spaziosa per ospitare riunioni e conviti, tranne il Capece». Ma lo stesso Toscano riporta un passo di Fabricio Luna (1536) in cui si riferisce al «palagio» di Scipione, e sarebbe strano che i Capece di Nido non disponessero di una casa comoda a Napoli. Inoltre a «conspicuas aedes» fa riferimento Capece stesso nel De principiis rerum (II, 837) e fuga ogni dubbio l’epistola di Flavio col richiamo alla «domum apertissimam» di Scipione. 96 Cfr. Anisio, Variorum poematum, cit., p. 10v. 97 Cfr. Ad Scipionem Capycium, ivi, pp. 15v e 30v; Id., Epistolae de religione, cit.: Ad Scipionem Capycium (p. 8v) e Ad Honoratum [Fascitellum] et Scipionem (pp. 11v-12r). 98 Sui rapporti tra Anisio e Vermigli cfr. P. Mc Nair, Pietro Martire Vermigli in Italia. Un’anatomia di un’apostasia (1967), Napoli 1971, pp. 170 sgg. 99 Anisio, Variorum poematum, cit., p. 8r. Su Merenda cfr. la nota dedicatagli in Processo Morone, vol. I, pp. 241-43; T.R. Castiglione, Il rifugio calabrese a Ginevra nel XVI secolo, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», VI, 1936, pp. 165201; C. De Frede, Un calabrese del Cinquecento emigrato a Ginevra (Apollonio Merenda), in «Archivio storico per le Province napoletane», 3a serie, X, 1971, pp. 313; L. Pertile, Apollonio Merenda, segretario del Bembo, e ventidue lettere di Trifone Gabriele, in «Studi e Problemi di Critica testuale», XXXIV, 1987, pp. 9-48; G. Moro, A proposito di antologie epistolari cinquecentesche (precisazioni su B. Pino e i Manuzio, T. Gabriele, A. Merenda e P. Bembo), ivi, XXXVIII, 1989, pp. 71-99; Firpo, Inquisizione romana, cit.; Id., Vittore Soranzo vescovo ed eretico. Riforma della Chiesa e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari 2006; D. Marcatto, «Questo passo dell’heresia». Pietrantonio Di Capua tra valdesiani, spirituali e Inquisizione, Napoli 2003, ad nomen. 100 Cfr. l’Introduzione di J.F. Montesinos a J. de Valdés, Diálogo de la lengua, Madrid 19766, p. XLIII e nota. 101 Marcantonio Flaminio a Giano Anisio (Napoli, febbraio 1540-primavera 1541), in M. Flaminio, Lettere, a cura di A. Pastore, Roma 1978, p. 107. 102 Ibid. 103 Nato a Napoli nel 1496, discepolo di Nifo forse a Salerno, autore di varie opere fra cui un De rerum naturalium principiis (Napoli 1553) ispirato all’aristotelismo radicale di Alessandro di Afrodisia e di Pomponazzi, Porzio fu lettore di Logica dal 1520 al 1525 nello Studio di Pisa e poi (almeno dal 1531, ma forse già dal 1529) docente di Filosofia e di Metafisica nello Studio di Napoli, dove insegnò fi-
167
no al 1545 per poi tornare a insegnare a Pisa e, nell’anno accademico 1552-53, nuovamente a Napoli. Morì nel 1554. Cfr. E. Garin, L’Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento (1947), Roma-Bari 2000, pp. 163-64; N. Badaloni, Inquietudini e fermenti di libertà nel Rinascimento italiano, Pisa 2004, pp. 157-60; M. Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo. Eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I, Torino 1997, pp. 188-89 e nota; C. Vasoli, Simone Porzio e l’aristotelismo napoletano, in Bosse, Stoll (a cura di), Napoli viceregno, cit., vol. I, pp. 125-52. 104 Tiberio Russiliano Sesto nel 1515 era iscritto allo Studio di Napoli, dove probabilmente si addottorò. Vagò poi fra Bologna, Ferrara, Firenze, Pisa e Padova alla ricerca di una cattedra fin quando non approdò negli anni Venti in Sicilia, dove insegnò a Messina o a Palermo. Se ne conoscono due opere: Apologeticus adversus cucullatos, a cura di L. De Franco, Cosenza 1991, che gli causò l’accusa di eresia costringendolo all’abiura (a Firenze nel 1519) e che avrebbe apprezzato Gabriel Naudé, e Universalia Porphiriana (Palermo 1526); cfr. L. De Franco, Filosofia e scienza in Calabria nei secoli XVI e XVII, Cosenza 1988, pp. 9-61. 105 Nel De principiis rerum è nominato solo Lucrezio, ma traspaiono riferimenti agli ionici, ai pitagorici, ad Anassagora, Empedocle e Democrito, ad Aristotele e agli stoici. 106 Cfr. Scipionis Capicii patritii neapolitani De principiis rerum libri duo. Eiusdem de divo Johanne Baptista De vate maximo libri tres. Et elegiae quaedam cum epigrammatis, Neapoli 1594. È probabile che su questa edizione gravassero echi dell’eterodossia di Scipione: se ne può cogliere una traccia nell’insistere sulla «summa probitate» del «virum optimum» Scipione da parte di Ferdinando della Marra, in un suo profilo dedicato al giurista basato anche su fonti orali (Capece, Opere, pp. XXXIII-XLIII). Il profilo si dilungava nei giudizi di probità e ortodossia («poeta optimus religiosissimus» ripieno di «christianae pietatis»), attribuendo a Capece una non sua Cristeide. Ben diverso l’atteggiamento del benedettino romano Francesco Maria Ricci, curatore dell’edizione del 1754, che evidenziò alcuni richiami all’epicureismo e le cui annotazioni sono zeppe di riferimenti a Copernico, Ticho Brahe, Galilei, Gilbert, Torricelli, Keplero, Gassendi, Descartes, Boyle, Newton ecc., dei quali Ricci si affannò a fare di Capece un precursore. Benché Ricci non mancasse di segnalare (ma di rado) alcune asserzioni contrarie alla religione, non fece riferimento alla critica capeciana a Lucrezio come aveva fatto Bracci e anzi in alcuni casi svelò un certo interesse per la fisica epicurea. Spesso le sue annotazioni paiono uscire dalla penna di un illuminista più che di un benedettino; ma significativamente egli stesso accennò ai suoi legami con Francesco Valletta. Sia l’edizione del 1594 sia quella del 1754 uscirono su interessamento di discendenti di Scipione appartenenti all’ordine ecclesiastico: il vescovo di Nicotera Ottaviano Capece e i due fratelli (abati, benedettini cassinesi come Ricci) Antonio e Giustino Capece (cfr. Capece, Opere, pp. VI-VII). 107 Possono leggersi ivi, pp. XLIV (Bembo) e XLV-XLVIII (Manuzio). 108 «Sed longe errarunt qui sic statuere parentem / semina naturam rerumque expromere causas, / obscuris mersi in tenebris, veraque remoti / a ratione procul, qui nil mortalia summum / caelicolum curare patrem casusque putarunt / illa regi, aethereasque animas ut corpora, vitae / lumine dilapso pariter succumbere leto» (De principiis rerum, I, 252-258). 109 Tra i passi nei quali emerge un naturalismo sfociante nel materialismo cfr. ivi, II, 71-82. Dopo un excursus lucreziano sull’origine delle parole Capece affermò:
168
«In principiis naturae haud est elementum / id corpus quo non contingit cuncta creari / ex primo, aut in idem extremum resoluta redire / fitque ipsum ex alio, inque aliud se solvit abitque: / sed prima id prorsus genitis est rebus origo / atque elementum ex quo, ut dictum est, concrescere primo / caetera, in extremumque resolvier [sic!] omnia certum est / ipsumque ex alio nequaquam semina ducit, / inque aliud sese nulla ratione resolvit. / At reliquis si prima quidem quis semina rebus / plura elementa esse, haec credat tamen ipsa creari, / inque vicem solvi, vera a ratione recedit». 110 Significativamente nella sua traduzione Ricci rendeva quasi sempre «anima» con «aria». 111 «L’anima non è su questo sfondo che la forma di un corpo determinato coinvolta nel gioco delle vicissitudini, in modo abbastanza conforme alle teorie dell’antico pitagorismo» (Badaloni, Inquietudini e fermenti, cit., p. 157). 112 Ma non mancano punti di contraddizione rispetto alla teoria dell’eternità, mentre certa è l’omologazione del cielo alla terra. Alla tesi della non eternità riconduce il De principiis F. Bacchelli, Sulla cosmologia di Basilio Sabazio e Scipione Capece, in «Rinascimento», nuova serie, XXX, 1990, pp. 137-39. 113 Già Ricci legò l’allontanamento di Capece alle vicende religiose. Altamura accennò agli intrecci tra valdesiani e pontaniani ma ignorando le menzioni su Capece rese note da Berti e da Amabile, il che gli impedì di legare l’accusa di eresia alla destituzione considerandola un’ipotesi da dimostrare. Più probabile ritenne che con la sua destituzione Toledo mirasse a colpire Ferrante Sanseverino, ma è questa ipotesi che è in realtà da dimostrare. Nel 1543 i rapporti fra Toledo e Sanseverino non erano idilliaci, ma l’aperta rottura che causò nel 1551 la fuga del principe fu successiva al tumulto napoletano del 1547 contro l’Inquisizione. Certo nel 1552 due fratelli di Scipione, Muzio e l’abate Francesco, furono implicati con altri partigiani di Ferrante in una congiura antispagnola tesa a far entrare i turchi dal porto di Trani in combutta con i francesi (C.J. Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553), Salamanca 1994, p. 332 e nota). L’abate Francesco è probabilmente da identificare con l’abate Francesco Capece ricordato da S. Ammirato, Il Rota overo delle imprese [...], Napoli 1562, pp. 128-30. Se l’identificazione è corretta andrebbero aggiunti ai fratelli di Scipione i cavalieri Cesare e Vincenzo Capece, pure evocati nella stessa opera (e non manca un accenno allo stesso Scipione a p. 200, dove si parla del suo amore non corrisposto per una donna di casa Altomare). 114 La formula fu riportata per intero già da C. Minieri Riccio, Biografie degli accademici pontaniani dal 1442 al 1543 (1881), Bologna 1969, che però ne ribaltò il senso. Il documento di destituzione è in Altamura, Per la biografia, cit., pp. 176-77. Hernando Sánchez (Castilla y Nápoles, cit., p. 497) torna sulla citazione monca («infamiae nota») per supporre che Capece fosse implicato in pratiche di corruzione. Ma l’ipotesi non è suffragata da documenti, mentre che Capece fosse eretico è certo. Con Scipione fu destituito (con la stessa formula che non pare tipica del linguaggio burocratico del tempo) Nicola Giacomo de Rainaldo (o de Raynaldis) e per L. Amabile (Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti, Città di Castello 1892, vol. I, p. 193) anch’egli era coinvolto dalla circolazione di idee eterodosse. Considerando il rango di Scipione, è probabile che la destituzione fosse stata fatta senza clamore ma proprio in virtù della sua eresia. Del resto, proprio l’insistenza sul fatto che sia Capece sia de Rainaldo fossero stati allontanati «sine aliqua infamiae nota» pare un’excusatio non petita indotta da
169
voci circolanti. Alle sue infauste vicende Capece si riferì sia nel De principiis rerum (II, 840-849), dove evocò anche la possibilità dell’esilio, sia nell’elegia De suis ac suorum temporum miseriis, edita postuma (nel 1594) e di datazione incerta (Capece, Opere, pp. 269-71). 115 A. Castaldo, Istoria [...], Napoli 1769, p. 74. 116 Ivi, p. 66. 117 Ivi, p. 65. Su Buzio cfr. la voce redatta da J. Tedeschi per il Dizionario biografico degli Italiani, vol. XV, Roma 1972, pp. 632-34. Frate minorita conventuale, fu celebre predicatore. Nel 1538 Buzio predicò a Bologna la giustificazione per fede venendo espulso dalla città. Trasferitosi a Napoli, tra il 1540 e il 1541 fu coinvolto in una serie di dispute col domenicano Teofilo Scullica, stretto collaboratore di Gian Pietro Carafa e poi commissario generale del Sant’Ufficio (Firpo, Inquisizione romana, cit., pp. 258-59 e nota). Buzio fu poi arrestato dall’Inquisizione: torturato più volte, fu impiccato e arso in Campo dei fiori il 4 settembre 1553. La sera del 21 marzo di quell’anno Buzio aveva recitata pubblica abiura a Roma (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 35v, 36r, 61v, 65v, 66v, 68v, 71rv, 72v, 86r, 100v, 101r102r, 113v-114rv; ivi, I. 4 b, [Santoro], De persecutionis, cit.; cfr. inoltre Processi Carnesecchi, II, p. 1111; Amabile, Il Santo Officio, cit., vol. I, pp. 137-38 e nota; Marcatto, «Questo passo dell’heresia», cit., pp. 80-81 e nota). 118 P. Lopez, Inquisizione stampa e censura nel Regno di Napoli tra ’500 e ’600, Napoli 1974, p. 32 e nota. Sulla scorta di Castaldo si data la predicazione di Buzio al 1539; ma la lettera di Toledo al papa è del 1541. 119 Hernando Sánchez, Castilla y Nápoles, cit., p. 496. La cattedra di Umanità, tenuta come lettore da Summonte tra il 1522 e il 1526, passò poi a Giovan Battista Filocalo, che la resse in vari periodi. Tra il 1536 e il 1539 la cattedra non ebbe titolare. Tornò Filocalo nel 1540-41 e fu l’ultimo docente prima della soppressione. 120 Castaldo, Istoria, cit., p. 74. 121 M. Firpo, Dal sacco di Roma all’Inquisizione. Studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana, Alessandria 1998, p. 125. 122 Id., Tra «alumbrados» e «spirituali», cit., p. 89 nota. 123 Sull’Inquisizione nel Regno di Napoli cfr. Amabile, Il Santo Officio, cit.; Lopez, Inquisizione stampa e censura, cit.; G. Romeo, Una città, due inquisizioni: l’anomalia del Sant’Ufficio a Napoli nel tardo ’500, in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», XXIV, 1988, pp. 42-67; Id., Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, Firenze 1990; Id., Aspettando il boia. Condannati a morte, confortatori e inquisitori nella Napoli della Controriforma, Firenze 1993; Id., Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Napoli 1997; Id. (a cura di), Il fondo «Sant’Ufficio» dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli. Inventario (1549-1647), in «Campania sacra. Rivista di Storia sociale e religiosa del Mezzogiorno», XXXIV, 2003; P. Scaramella, L’inquisizione romana e i valdesi di Calabria (1554-1703), Napoli 1999; Id., Inquisizioni, eresie, etnie, cit. 124 M. Firpo, «Disputar di cose pertinente alla fede». Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano, Milano 2003, pp. 199-200. 125 Parente dei Carafa era inoltre Marcello Capece, amante della duchessa di Paliano Violante Diaz Garlon moglie del duca Giovanni Carafa, che fu ucciso dal duca stesso (e analoga sorte subì Violante per mano del fratello) a seguito della scoperta dell’adulterio. Non è stato tuttavia possibile appurare se Marcello e Scipione appartenessero allo stesso casato, pur essendo probabile. Cfr. O. Niccoli, Rinasci-
170
mento anticlericale. Infamia, propaganda e satira in Italia tra Quattro e Cinquecento, Roma-Bari 2005, pp. 134-35 e 143-49. 126 Lopez, Inquisizione stampa e censura, cit., p. 29. 127 Il testo della prammatica è in C. De Frede, Ricerche per la storia della stampa e la diffusione delle idee riformate nell’Italia del Cinquecento, Napoli 1985, p. 134. 128 Cfr. D. Cantimori, Umanesimo e religione nel Rinascimento, Torino 1975, p. 12 nota. Analoghe disposizioni furono emanate in altri Stati italiani. 129 Citato in Lopez, Inquisizione stampa e censura, cit., pp. 29-30. 130 Castaldo, Istoria, cit., p. 75. 131 La sua presenza a Salerno è attestata almeno dal febbraio 1544 (Altamura, Per la biografia, cit., p. 170 nota). Nello stesso anno, in novembre, Scipione fu convocato a Napoli in un processo intentato a lui e tal Cesare da Bologna (definiti «conventos») da un Francesco Concio (definito «actorem»). Cfr. ivi, p. 178. 132 Che tra Capece e la principessa vi fosse un rapporto di parentela lo dice Mazzuchelli, Notizie storiche, cit., p. XVI e nota, sulla scorta di Iacopo Gaddi che la definì «consanguineam» di Capece. Certo tra i due c’era un legame: nella dedicatoria del De principiis rerum a lei indirizzata da Manuzio, Capece è definito «Capicius ille tuus tuarum laudum laudatissimus», «tui studiosissimo» (Capece, Opere, p. XLVII). Nessun riferimento v’è nell’epistolario della principessa edito da L. Cosentini, Una dama napoletana del XVI secolo: Isabella Villamarina principessa di Salerno, Trani 1896. L’unica esile traccia è in una lettera in cui Isabella evocava un «signor abbate Capece» (probabile parente di Scipione, il cui fratello Francesco era abate) al quale pareva piuttosto legata (p. 153). 133 Il documento è in M. Miele, La penetrazione protestante a Salerno verso la metà del Cinquecento secondo un documento dell’Inquisizione, in Miscellanea Gilles Gerard Meerseman, vol. II, Padova 1970, pp. 846-47. L’eresia cui faceva riferimento Salvio era l’incredulità nella transustanziazione. 134 Cfr. B. Tasso, Li tre libri delle lettere [...]. Alli quali s’è aggiunto il quarto libro (1559), a cura di D. Rasi, Bologna 2002, pp. 139v-140v e 185rv. Tasso dedicò a Capece alcune odi e presentò a Bembo il De principiis rerum. 135 T. Tasso, Il Gonzaga, overo del piacere onesto, in Id., I dialoghi, a cura di E. Raimondi, vol. III, Firenze 1958, pp. 240-41. 136 La principessa deteneva, per sua stessa ammissione, alcuni testi di Valdés (Lopez, Il movimento valdesiano, cit., pp. 170-71). 137 Il principe chiese a Seripando «se la presentia de Dio benedetto mette necessità al libero arbitrio, et se quel che la maestà de Dio prevede del fine de l’huomo forzatamente ha da seguire et succedere» (R. Colapietra, I Sanseverino di Salerno. Mito e realtà del barone ribelle, Salerno 1985, p. 188). 138 A un suo impegno presso la corte salernitana si riferì Mazzuchelli (Notizie storiche, cit., pp. XV-XVII e note), ipotizzando che si occupasse dell’amministrazione dei feudi e della famiglia del principe quando questi era assente. Cfr. anche Tasso, Li tre libri, cit., p. 140r: «Il signor prencipe pochi giorni sono ha avuti lunghissimi ragionamenti con essomeco della virtù vostra, e m’è stato sommamente grato che le attioni vostre non pur habbiano aguagliata la speranza che aveva sua eccellenza di voi, ma avanzata l’opinione degli huomini; di che io non fui mai in dubbio: perché la vostra prudentia et integrità mi prometteva questa et maggiore cosa. Io me ne rallegro quanto debbo e quanto posso, così per servitio del signor prencipe, come per honor vostro; sperando che et sua eccellentia della vostra virtù, et voi del-
171
la sua gratitudine debbiate ugualmente rimanere sodisfatti; et io come servidore dell’uno et dell’altro, participe d’ogni vostro utile et riputatione» (B. Tasso a S. Capece, da Anversa a Salerno, s.d. ma 1544 circa). Ulteriore conferma sul ruolo esercitato a Salerno da Capece è in una lettera di un altro uomo di fiducia di Sanseverino, Vincenzo Martelli, che nella primavera del 1548 si lamentava del fatto che Scipione ne avesse fatto sequestrare l’abitazione a causa della sua lunga assenza da Salerno, rimarcando peraltro il ruolo di guida che aveva nei confronti della principessa (Colapietra, I Sanseverino, cit., p. 199 nota). 139 Per alcune entrate garantitegli da Ferrante cfr. la nota seguente. Nel 1542 Scipione risultava titolare di una rendita annua di 300 ducati «sulle rendite dell’ufficio della misuratura della dogana del sale di Napoli» (Altamura, Per la biografia, cit., p. 180). Qualche altro introito gli derivava da un terreno posto presso Porta reale a Napoli (ivi, pp. 179-80). 140 «Per il signor Scipione Capeci per li casali tenia messer Simon Portio, cioè Vatolla, Ortodonico e Cosentini per ducati 100 a dicto suo, ducati 102 [...] et per il dicto per il casal tenia messer Donato Antonio Altomare quali havia tutti li sopraditti ius luendi sopra Camella ad decto signor Scipione ducati 102» (ivi, p. 179). Su Altomare cfr. Processi Carnesecchi, I, p. 60 e nota; II, p. 81 e passim. Il 1° dicembre del 1552 fu imprigionato e inviato a Roma. Liberato su cauzione il 21 dicembre, abiurò in forma privata nel marzo 1553; cfr. ACDF, Stanza storica, Decreta, I, cc. 88v-90r, 96r, 97v; ivi, I. 4 b, [Santoro], De persecutionis, cit., c. 33r (donde è tratta la definizione riportata nel testo). In Marcatto, «Questo passo dell’heresia», cit., pp. 165-66, è trascritta una lettera di Girolamo Morra a Ferrante Gonzaga (del 1552) nella quale si dà notizia della sua cattura ed è definito «amico et servitore» di Giulia Gonzaga. In una missiva di Seripando ad Augusto Cocciano (Amabile, Il Santo Officio, cit., vol. I, pp. 143-44 nota) si evoca il suo arresto: «Me ne so meravigliato, havendo sempre inteso che li suoi studi erano solo nell’arte ne la qual era eccellente, et è il primo qui che ha posto la medicina per miglior strada che non era pria». Cfr. la voce dedicatagli da A. Merola, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. II, cit., pp. 568-69. 141 Cfr. la voce Senatores (Capece, Opere, p. 280). 142 L’opera ebbe altre edizioni e una circolazione europea. Uscì nel 1548 a Parigi (per Nicolaus Divitem) insieme al De elementis et eorum mixtionibus libri quinque di Gasparo Contarini, con ristampe nel 1556 e nel 1564. Dopo l’edizione napoletana del 1594, se ne ebbe un’altra a Francoforte col De rerum natura di Lucrezio e il De animorum immortalitate di Aonio Paleario nel 1631. Anche nel Settecento il De principiis ebbe più ristampe, mentre in seguito cadde in un oblio che dura tuttora. Tra i pochi che gli hanno dedicato attenzione va segnalato Bacchelli, Sulla cosmologia, cit. 143 Vari documenti sulla costruzione della villa in Altamura, Per la biografia, cit., pp. 179-81; sicuramente a questa villa fece riferimento Basalù evocando il suo incontro con Capece. Si tratta quasi certamente della tenuta di Antignano (alle porte di Napoli, corrispondente a una zona del Vomero), di cui è detto signore in varie fonti. 144 Ivi, p. 180. 145 «Die 9 decembris 1551 obiit dominus Scipio Capicius et fecit cortinam magnam de crimosino, seu rubeam, et positus est cum cassa lignea in cappella Sancti Georgii inter sepulturam» (ivi, p. 172 nota). 146 J. Mazzoleni, Fonti per la storia della Calabria nel viceregno (1503-1734) esi-
172
stenti nell’Archivio di Stato di Napoli, Napoli 1968, p. 325: «Comptum [...] Martini Busal locumtenentis regii tesaurarii Calabriae Ulterioris, annus 1520-1522». Che Girolamo fosse figlio di Martino lo affermò egli stesso, come si evince dal documento citato nella nota seguente. Anche Manelfi nei suoi costituti lo disse «figliolo di Martino Bussala neapolitano» (C. Ginzburg, I costituti di don Pietro Manelfi, Firenze-Chicago 1970, p. 68). 147 In un documento del 1545 si fa riferimento a un «officium capsarii, alias banquerii»: «Hieronimo de Busal, clerico [...] vetat quominus molestetur, sub quovis praetextu, super debitis patris sui Martini de Busal, laici Caesaraugustani, qui officium capsarii, alias banquerii, gesserat» (F. Russo, a cura di, Regesto vaticano per la Calabria, vol. IV, Roma 1978, p. 117, 20 febbraio 1545). 148 In Archivio di Stato di Napoli, Sommaria. Partium, vol. 273, cc. 143v-144r, 10 marzo 1547, si trova la «franchigia di Martino de Busal per ciò che per suo uso fa portare in Napoli da Tropea e da Pizzo»: in un caso «sei thomola de diverse legume, quactro barilocti de agresto et vino cocto, certe peze de formagio et casicavalli et sey presucti», in un altro «una bocte de oglio, doe thomola de legume, doe altre de fico et fructi sechi et uno barile de mele», e in un altro ancora «una bocte de oglio per magnare». Il riferimento al «magnare» così come al «suo uso» sembra indicare che Martino facesse giungere a Napoli quelle vettovaglie per destinazioni domestiche; in realtà, come mostrato da G. Galasso, Economia e società nella Calabria del Cinquecento (1967), Napoli 1992, p. 143 nota, che ha pubblicato il documento, erano formule adoperate dai mercanti dell’epoca per aggirare alcuni dazi con l’assenso della stessa regia corte. 149 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 320. 150 Processo Basalù, b. 13, f. II, carta non numerata (IV costituto di G. Basalù). Cfr. inoltre il De falsa et vera unius Dei patris, filii, et spiritus sancti cognitione libri duo [...] (1568), a cura di A. Pirnát, Utrecht-Budapest 1988, p. 43, nel quale v’è conferma della destinazione finale dei suoi pellegrinaggi in Damasco (cui fece riferimento Basalù) e cenno all’attività sartoriale: «Abbas Busalis [...] vitam arte sarcinatoria Damasci traducendo finire coactus est». 151 ACDF, Stanza storica, I. 4 b, Brevia summaria contra aliquos nominatos in causa iudaismi, et imputatos de apostasia a fide et de haeresia. Item Nota plurimorum qui sunt suspecti vel inquisiti de apostasia vel haeresia. Item Nota familiarum suspectarum de iudaismo et descendentium a iudeis catalanis, documento relativo a Napoli. Il riferimento a Porzia Busale è alla c. 8v, mentre quello alla possibile datazione del suo processo (vi si ricorda Giulia Gonzaga) è alla c. 12r. Alle cc. 14v-15r v’è l’elenco delle famiglie sospette di giudaismo. I Busales sono menzionati alla c. 15r. Per quanto riguarda le sorelle di Girolamo cfr. ivi, Decreta, I, cc. 118v (12 ottobre 1553) e 120v (3 novembre 1553); per Prospero cfr. ivi, c. 121r (14 novembre 1553). 152 Sulle ondate conseguenti alla cacciata dai domini della Spagna (1492) e del Portogallo (1497) cfr. A. Milano, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1992; A. Foa, Gli ebrei in Europa. Dalla peste nera all’emancipazione XIV-XIX secolo, Roma-Bari 1999. Cfr. inoltre E. Benbassa, A. Rodrigue, Storia degli Ebrei sefarditi. Da Toledo a Salonicco (2002), Torino 2004. Sulla Calabria cfr. O. Dito, La storia calabrese e la dimora degli ebrei in Calabria dal secolo V alla seconda metà del secolo XVI [...] (1916), Cosenza 1989. 153 Cfr. supra, nota 147. Caesaraugusta era il nome della Zaragoza romana. 154 «In minori aetate» è definito ancora il 23 aprile 1531 (Russo, a cura di, Regesto vaticano, cit., vol. III, Roma 1977, p. 401). Considerando che si sarebbe reca-
173
to nel 1538 a Padova per gli studi universitari potrebbe essere nato intorno al 1520 se non un po’ più tardi. 155 Ivi, p. 375: «Hieronimo de Busal, clerico Neapolitano, commendatur monasterium Sancti Honuphrii, ordinis sancti Basilii, Militensis diocesis, [...] per resignationem Andreae cardinalis de Valle» (2 aprile 1529); ibid.: «Andreas cardinalis de Valle resignat monasterium Sancti Honuphrii [...] in favorem Hieronimi de Busal, clerici Neapolitani» (20 aprile 1529). Il monastero di Sant’Onofrio, tra i rari monasteri basiliani sopravvissuti nella Calabria del Cinquecento, si trovava in una zona denominata Chao, poi chiamata Sant’Onofrio (nome dell’attuale comune in provincia di Vibo Valentia) in onore del monastero. Andrea de Valle (1463-1534), appartenente a nobile famiglia romana, fu eletto vescovo di Cotrone nel 1496. Reggente della Cancelleria apostolica nel 1503-1505, ottenne il vescovato di Mileto nel 1508 e partecipò al V Concilio lateranense del 1512. Segretario apostolico durante il pontificato di Giulio II, il 1° luglio 1517 fu creato cardinale. A partire da quel momento, inserito al più alto livello nella politica pontificia, cumulò un numero notevole di benefici ecclesiastici, amministrando varie diocesi meridionali non solo in Calabria. Nel 1522 riebbe il vescovato di Cotrone. L’anno seguente lasciò il vescovato di Mileto e nel 1524 quello crotoniate. Dalla vicenda di Girolamo Busale si evince quanto, pur avendo abbandonato la titolarità delle diocesi calabresi, de Valle avesse mantenuto una rete di patronage sul territorio. Cfr. K. Eubel, W. van Gulik, Hierarchia catholica medii et recentioris aevi [...], vol. III, Monasterii 1923, pp. 180, 244, 255-56 e passim. 156 Russo (a cura di), Regesto vaticano, cit., vol. III, p. 375: «Hieronimo Busal [...], commendatur monasterium Sancti Honuphrii, [...] per cessionem Andreae cardinalis de Valle, cui reservantur fructus et regressus» (23 aprile 1529); ivi, p. 377: «Dominus Felix Moronus, secretarius reverendissimi domini cardinalis de Valle, nomine domini Ieronimi de Busal [...] obligavit se pro annata monasterii Sancti Honofrii [...], cuius fructus 100 ducatus non excedunt, et commendatur eidem [...]. Et promisit solvere cum primum perceptio fructuum, ut supra reservatio cessabit, sub poenis etc.» (1° giugno 1529). 157 Ivi, p. 377: «Felici Moroni, secretario Andreae cardinalis de Valle, reservantur fructus decanatus ecclesiae Cotronensis, solvendi a Hieronimo Busal, decano» (11 marzo 1531); ivi, p. 400: «Dominus Hieronimus Busal, decanus ecclesiae Cotronensis, per dominum Christophorum Scariti, Militensis diocesis, procuratorem suum, consensit assignationi omnium et singulorum fructuum dicti decanatus in favorem domini Felicis Moroni, reverendissimi cardinalis de Valle secretarii, quoad vixerit libere percipere et exigere, loco pensionis annuae, necnon regressus et conceditur» (1° aprile 1531); ivi, p. 403: «Dominus Felix Moronus, clericus Firmanensis, consensit resignationi decanatus ecclesiae Cotronensis, in favorem Hieronimi Busal, clerici Cotronensis» (5 agosto 1531). 158 Ivi, p. 459: «Prospero Busal [...] commendatur monasterium Sancti Onuphrii [...] per cessionem Hieronimi Busalis, cum mandato Casertanis et Caietanis episcopis ac vicario generali episcopi Militensis de executione» (23 agosto 1535); ivi, p. 460: «Procuratorium Hieronimi, abbatis monasterii Sancti Honuphrii de Chao, [...] pro resignatione ipsius monasterii seu abbatiae in favorem Prosperi Busal, ipsius constituentis fratris, vel domini Felicis Morroni, clerici Firmanensis» (29 agosto 1535); ivi, p. 461: «Dominus Hieronimus Busal, clericus Militensis diocesis, commendatarius monasterii Sancti Honofrii de Chao, [...] consensit resignationi commendae huiusmodi in favorem Prosperi etiam Busal, eiusdem Hieronimi fra-
174
tris» (14 settembre 1535). Va dunque corretta la notizia secondo cui ancora negli anni Quaranta-Cinquanta Girolamo Busale fosse in possesso dell’abbazia di Sant’Onofrio. Nel suo interrogatorio del 13 febbraio 1552 (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, c. 8r) Bruno Busale fece riferimento a quella abbazia attribuita a suo fratello Girolamo, specificando che «sono parecchi anni che l’ha renontiato ad un altro mio fratello, niente di mancho tutti lo chiamano abate». Bruno Busale tuttavia non fece riferimento alle altre commende che Girolamo ricevette dopo aver ceduto quella di Sant’Onofrio, benché anche di queste si fosse disfatto prima del suo ritorno in Veneto. Quanto al beneficio ottenuto nella diocesi di Nicastro, pur se successivo alla morte di de Valle probabilmente alla sua rete clientelare va ricondotto anch’esso, avendo il cardinale avuto quella diocesi, sebbene per un brevissimo periodo, dal 5 al 17 maggio 1518 (Eubel, van Gulik, Hierarchia catholica, cit., pp. 255-56). 159 Russo (a cura di), Regesto vaticano, cit., vol. III, p. 481 (12 novembre 1536). Nel 1543 Girolamo avrebbe ceduto anche questa prebenda a Prospero (cfr. ivi, vol. IV, p. 89, 22 gennaio 1543). 160 Ivi, p. 12: «Hieronimo Busal [...], cubiculario et familiari suo, commendatur monasterium Sancti Laurentii de Arena et Sancti Constantini de Panaia, ordinis sancti Basilii, Militensis diocesis, [...] per cessionem Felicis Moroni, cum mandato episcopo Casertano et archidiacono ecclesiae Militensis ac vicario generali episcopi Militensis de executione» (21 marzo 1538). 161 Non è noto quali fossero i legami di lignaggio fra i Busale e i Basalù, tra i quali c’era sicuramente una parentela e probabilmente erano cugini: Bruno Busale (costituto del 26 dicembre 1551, in ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, Processus contra anabatistas, c. 30r) fece riferimento alla «casa [a Venezia] di messer Francesco Basalù mio barba». Francesco Basalù era anche il nome di uno dei fratelli di Giulio Basalù (Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 117rv), ma così si chiamava effettivamente un loro zio, come risulta da una lettera indirizzata a Giulio dall’altro suo fratello Benedetto (da Roma, 3 settembre 1552, ivi, b. 13, f. II, carte non numerate), dove si parla di un «messer Francesco nostro zio». 162 Ivi, c. 112r (I costituto di G. Basalù). Su don Marco da Cremona cfr. A. Stella, Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo. Nuove ricerche storiche, Padova 1969, pp. 18-23; B. Collett, Italian Benedictine Scholars and the Reformation. The Congregation of Santa Giustina of Padua, Oxford 1985, pp. 82, 111-12 e passim; G. Caravale, Sulle tracce dell’eresia. Ambrogio Catarino Politi (1484-1553), Firenze 2007, pp. 72-73 e note. 163 Giovan Tommaso Bianco (1549) riferì che «essendo io retornato in Napoli dalli studi de l’anno ’43 vel circa, trovai alcuni amici miei [...], li quali me ragionavano d’alcune opinioni che correvano alhora per Italia, secondo l’opinione de fra Gerolamo, quale poco avanti per alcuni anni si era partito» (Processo Basalù, b. 13, f. II, carta non numerata). Da questa deposizione si può dedurre che prima del 1543 Girolamo Busale si era allontanato da Napoli, così come affermato qui nel testo; ma vi si trova pure conferma che a quel tempo Girolamo non era andato oltre la giustificazione per fede, accogliendo al massimo le sue conseguenze «luterane». Solo a opinioni simili, infatti, Bianco fece riferimento. 164 Russo (a cura di), Regesto vaticano, cit., vol. IV, p. 43: «Iohanni Petro Artisano providetur de parochiali ecclesia Sanctorum Isidori et Anargirii, in baronia Rocchae Angitolae, Militensis diocesis, [...] per resignationem Hieronimi de Busal, per Antonium, Sanctae Mariae de Cassanova [sic!], Neocastrensis diocesis, procu-
175
ratorem suum, factam et admissam» (2 aprile 1540). La baronia di Rocca Angitola, corrispondente all’attuale comune di Maierato in provincia di Vibo Valentia, era inserita nel Principato di Mileto, tenuto dalla famiglia Hurtado de Mendoza. 165 Processo Basalù, b. 159, f. II, c. 116v. In quello stesso anno (il 22 gennaio) risulta la sua presenza in Calabria dal documento nel quale cedette i suoi diritti sulla parrocchia di San Nicola (in diocesi di Nicastro) a Prospero (Russo, a cura di, Regesto vaticano, cit., vol. IV, p. 89). 166 Stella, Anabattismo e antitrinitarismo, cit., pp. 24 sgg. 167 Russo (a cura di), Regesto vaticano, cit., vol. IV, p. 105: «Iohanni Moleti providetur de parochiali ecclesia Sanctae Catharinae de Mesimerii, Rheginensis diocesis, [...] per resignationem Hieronimi Busal, clerici Militensis, cui reservatur annua pensio super eius fructibus» (30 maggio 1544); cfr. anche ivi, p. 107 (23 giugno 1544). 168 Ivi, p. 116: «Prospero Busal providetur de decanatu ecclesiae Cotronensis et commendatur monasterium Sancti Laurentii de Arena et Sancti Constantini de Panaghia [...], cum retentione monasterii Sancti Honuphrii, eiusdem ordinis et diocesis» (30 gennaio 1545). 169 Pietro Manelfi aveva testimoniato in tal senso: «Geronimo Busale, fratello di messer Bruno, quale ha grandi benefici; si partì da Padova et passò al padre a Napoli per rinontiare gli benefici acciò fosse accettato nella compagnia degli anabattisti, perché essi non vogliono alchuno fra loro che abbia beneficio o preminentia alchuna, se non la renontia» (Ginzburg, I costituti, cit., p. 45); cfr. anche ivi, p. 68: «Gieronimo Bussala [...], il qual era ministro alhora di detta giesa di Padoa [...] et havea circa mille scudi d’entrada de beneficii, li quali promesse alla Chiesa nostra rinonciare, non potendo altrimenti stare con li anabattisti; et dicevamo che magnava del sangue della bestia, cioè del papa, per tenere benefici». Alle «non exiguis fortunis» di Busale farà riferimento anche il De falsa et vera, cit., p. 43. 170 Russo (a cura di), Regesto vaticano, cit., vol. IV, p. 117: «Dominus Hieronimus Busal [...] nomine Prosperi Busal, obligatur pro communi servitio monasterii Sancti Laurentii de Arenis, ordinis sancti Basilii, Militensis diocesis, [...] per cessionem commendae eiusdem eidem factae» (11 maggio 1545). 171 In effetti l’ultimo documento che attesta la sua presenza fisica in Calabria risale al 20 febbraio 1545 ed è il documento relativo all’attività paterna citato supra, nota 147. 172 Cfr. Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 2v-3r, deposizione di M. Villamarina, che oltre ad attestare la presenza di Busale alle riunioni animate da Villafranca, ricordò che alcuni incontri avvenivano in casa di Busale stesso. Cfr. anche ivi, cc. 6v-7r (deposizione di A. da Pozzo); ivi, cc. 8v-9r e altre carte non numerate (deposizione di M. Busale, dalla quale è noto che fu prima lui a conoscere Villafranca rispetto a suo fratello); ivi, cc. 7r-8r (deposizione di B. Marese, che pure ricordò le riunioni da Busale e narrò come fosse stato Busale stesso a condurlo da Villafranca); ivi, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 173 Ibid. 174 Ibid. 175 Come appartenente all’ordine dei cappuccini indicarono Renato sia Tizzano (Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 70) sia Marese (Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 8r) sia Basalù (ivi, carte non numerate, IV costituto), che ne ricordò il ruolo di predicatore. Quanto al suo luogo di nascita cfr. ivi, c. 11r (deposizione di Raffaele da Roccaguglielma). Riguardo al cognome Renato successivamente assunto
176
dal cappuccino, è molto probabile che, come il più noto Camillo, Calabrese lo avesse adottato a seguito della sua conversione. Tra breve lo si vedrà, d’altronde, agire nel 1544 nei Grigioni, la stessa area dove operava negli stessi anni Camillo Renato. 176 F. Chabod, Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti (1938), in Id., Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V, Torino 1971, p. 266. Stella, Anabattismo e antitrinitarismo, cit., pp. 26-27, ha proposto il legame tra i due personaggi. Certo è che cappuccino era il Francesco Calabrese radicale, e cappuccino era del pari il Francesco Calabrese ricordato da Chabod. Andrebbe dunque corretto quanto ipotizzato da D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti, a cura di A. Prosperi, Torino 1992, che lo aveva qualificato come francescano. A parte la possibilità che francescano fosse stato in origine, ad ogni modo, si può notare come in una più tarda cronaca del cappuccino Ruffino Poeti da Siena (1554 circa-1623) si facesse riferimento a un suo breve passaggio tra i francescani: «Tornò il padre fra’ Francesco [di Calabria] con alcuni altri tra’ zoccolanti nella partita dell’Ochino, e poi tornò tra’ cappuccini, perché teneva certo che li cappuccini avessero affatto a mancare e ciò fece per salvarsi con onore». Riferendosi al generalato di Francesco da Jesi, Ruffino riferiva poi che «tornorno molti che erano mancati per la partita del mal vecchio Occhino, tra il quali fu il padre fra Francesco da Calabria, il quale allora [1543] si trovava provinciale della provincia di Milano. Tornò questo buon padre [...] in questo tempo, con tanta profonda umiltà e con tanta contrizione, che era un stupore, e oltra le penitenze ordinarie, ne fece poi tante da sé che era una meraviglia. A l’ultimo finì la vita sua santamente nel luogo di Napoli, dove molti secolari per la divozione che gli avevano, andavano frequentemente a visitar la sua sepoltura» (Cargnoni, a cura di, I frati cappuccini, cit., vol. II, pp. 1185, 1645, 1678, 1391 e nota). Tra le righe di questo ritratto edificante traspaiono i problemi che Calabrese ebbe a causa del suo rapporto con Ochino. Inoltre, nel suo trasferimento a Napoli emerge ulteriore conferma all’ipotesi sull’identità con l’omonimo radicale. 177 La risposta di Giberti è in Cargnoni (a cura di), I frati cappuccini, cit., vol. II, pp. 269-75 (citazioni a pp. 269 e 273). Cfr. anche G. Miccoli, La storia religiosa, in R. Romano, C. Vivanti (a cura di), Storia d’Italia, vol. II, tomo 1, Torino 1974, p. 1014. La lettera era datata 26 settembre 1542. 178 Cfr. Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 8r (deposizione di B. Marese): «Messer Francesco Renato calabrese, il quale, per quello che intesi, era stato frate scappuccino, et che dapoi si spogliò et andava vestito da secolar et che era stato in Alemagna [scil. in Svizzera] et per alcune parte de christianità». 179 P.D. Rosio de Porta, Historia Reformationis Ecclesiarum Raeticarum [...], vol. I, Curiae Raetorum et Lindaviae 1772, p. 67. 180 Ivi, pp. 68-69. 181 Ivi, pp. 70-75. 182 Processo Basalù, b. 13, f. II, c. 8r (deposizione di B. Marese): «Ne l’anno 1544 seu 1545 sopervenne anchor un messer Francesco Renato calabrese». 183 Ivi, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 184 Ivi, c. 8r. 185 Costituti di Lorenzo Tizzano, cit., p. 70. 186 «Che le Scripture sancte et evangeliche siano false perché si ritrova alcuna contraditione in esse non tamen vere ma certo modo apparente. Et lo primo che mi indusse in queste opinioni fu misser Mattheo Busale, il quale me scomenzo a parlar di questo, benché poi il ditto misser Francesco Renato similmente me ne
177
parlò» (ivi, pp. 70-71). Che fosse stato Matteo Busale e non Renato il primo a parlare a Tizzano di questa visione non significa che fosse stato Busale a portare tale idea nel movimento: si è già visto quanto gli adepti facessero anche attività di proselitismo. 187 Valdés considerava lo studio dei testi sacri come una «fioca candela». Nelle Cento e dieci divine considerazioni aveva scritto: «La cognizione che acquistano di Dio coloro che ’l conoscono per le sante Scritture intendo che è simile alla cognizione che un ignorante e idiota acquista d’un famosissimo litterato, leggendo le cose che egli ha scritto» (considerazione II, p. 176; cfr. anche la considerazione LXIII, pp. 324 sgg., Che la santa Scrittura è come una candela). Valdés riteneva che la sua fede «non dipenda da Scritture né stia fundata in quelle, ma [...] dipenda da inspirationi e esperientie e stia fundata in quelle» (Valdés, Lo evangelio di San Matteo, cit., p. 123). Vale la pena di sottolineare come questa lettura non vada confusa con «l’espressione di un misticismo come percorso privilegiato attraverso il quale l’uomo possa giungere a una sorta di folgorante contatto diretto con la divinità, di fusione e annullamento in essa, di visione estatica della sua natura per mezzo delle tradizionali scale ascetiche e viae codificate dall’‘ascensus mentis in Deum’» (Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali», cit., p. 49). 188 In Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 10v-11r Raffaele da Roccaguglielma aggiunse: «In questa secta erano Mattheo Busal, Francesco de Cotrone calabrese, Cesare Maffeo et Iulio Basalù». La presenza nell’elenco di Basalù dimostra quanto dichiarato da egli stesso, e cioè che pur avendo rivelato solo a pochissimi i suoi approdi, aveva continuato comunque a frequentare gli altri radicali. 189 Corano, sûra II, v. 87. Cfr. pure ivi, v. 253: «A tali inviati [i profeti] abbiamo dato rispettive preminenze. Fra essi vi è a chi Iddio parlò [Mosè] e chi Iddio sollevò di alcuni gradi: a Gesù figlio di Maria abbiamo dato le prove manifeste e lo abbiamo confortato con lo spirito santo». Vari altri luoghi rivelano la preminenza assegnata nel Corano a Gesù: «Gesù è presso Dio come Adamo» (sûra III, 59); «Iddio potente e sapiente lo elevò a sé» (sûra IV, 158); «O Gesù figlio di Maria, ricorda la mia grazia verso di te e verso tua madre, quando ti confermai con lo spirito della santità [...]. Tu foggiavi, col mio permesso, la creta in forma d’uccelli, e vi soffiavi dentro e diventavano, col mio permesso, uccelli. Guarivi, col mio permesso, il cieco dalla nascita e il lebbroso. Facevi, col mio permesso, uscire i morti dalla tomba» (V, 110). Vale la pena di ricordare anche le obiezioni coraniche al dogma trinitario: «Il messia, Gesù figlio di Maria, è soltanto l’inviato di Dio, e il suo verbo che egli ha gettato a Maria, e uno spirito da lui. Credete in Dio e nei suoi inviati e non dite ‘tre’. Desistetene, sarà meglio per voi. Iddio non è che un dio solo. Lungi dalla sua gloria l’avere un figlio» (IV, 171); «Miscredenti sono invero coloro che dicono: ‘Iddio è il terzo di tre’. Non v’è altro dio che un Dio solo» (V, 73). 190 Cfr. B. Aretius, Valentini Gentilis iusto capitis supplicio Bernae affecti brevis historia [...], Genevae 1567. Va sottolineato che il De falsa et vera evidenziò come la dottrina trinitaria avesse creato la frattura fra cristiani da un lato ed ebrei e musulmani dall’altro. Sull’intreccio tra nuove idee di libertà e confronto con la tradizione islamica cfr. F. Berriot, Islam et liberté de conscience à la Renaissance, in Id., Spiritualités, hétérodoxies et imaginaires: études sur le Moyen âge et la Renaissance, Saint-Étienne 1994, pp. 221-33. La prima traduzione italiana del Corano fu pubblicata a Venezia nel 1547, ma già dal 1543 era disponibile ai lettori europei il testo latino. In quello stesso anno era uscito Alcorani seu legis Mahometi et evangelistarum concordiae liber di G. Postel. Cfr. W.J. Bouwsma, «Concordia Mundi»: The Ca-
178
reer and Thought of Guillaume Postel, 1510-1581, Cambridge (Mass.) 1957, pp. 520; C. De Frede, Cristianità e Islam nel Cinquecento: a proposito della prima traduzione italiana del Corano, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», nuova serie, XV, 1967, pp. 34-38; Stella, Anabattismo e antitrinitarismo, cit., p. 29 nota. 191 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 192 A. Rotondò, Introduzione, in Sozzini, Opere, cit., pp. 24-29; V. Marchetti, Gruppi ereticali senesi del Cinquecento, Firenze 1975, p. 64; Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù): «Lelio Socini ho cognossuto prima in Padova, poi in Bologna, poi qui come figliolo di messer Mariano lettor famoso et mio precettore. De le sue opinioni hebbi noticia da l’abbate Busale. Andò già in Alemagna. Hora non so dove sia». Rotondò ha riconosciuto decisiva importanza all’incontro di Sozzini con Busale. Basalù pose Lelio fra coloro che negavano la divinità di Cristo ben prima che scrivesse il commento a Giovanni (I, 1). 193 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, c. 8v (costituto di B. Busale, 13 febbraio 1552). Successivamente pare che Girolamo avesse manifestato al fratello l’intento di proseguire per Messina (ibid.). 194 Processo Basalù, b. 13, f. II, cc. 1r-2r (deposizione di A. Dell’Olio). 195 Ivi, c. 1v. Cfr. anche la deposizione di Villamarina (ivi, c. 3r), che raccontò lo stesso episodio. 196 Ivi, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 197 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 318. 198 Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 199 Due lettere di Isabella Breseña del 7 dicembre 1549 rivelano che a quella data Busale era ancora al suo servizio. La prima è indirizzata alla duchessa di Ariano: «In questa [lettera] non harò più da dirle, poi che con miser Paulo scrise apieno, se non suplicarla se degni per il signor abbate Busal farmi asaper come si trova, il che mando a posta a tal effeto, si che cara signora fatemene degna et poi che lui dirà il resto, sendo persona a chi io veramente amo, farò fine, ma non di adorarvi, amarvi più che l’anima et resto basciandovi tutta tutta signora mia illustrissima mille volte». Nella seconda lettera, indirizzata al segretario della duchessa Tomaso Campana, si legge: «Io scrivo ala mia signora marchesa di Terranova et poi ch’è il signor abbate il portator di questa, non dirò altro se non remetermi a lui et racomandarmi a voi di tutto core» (Casadei, Donne della Riforma, cit., p. 53). La datazione del nuovo trasferimento di Busale a Padova è deducibile anche dalle dichiarazioni di Laureto, che si fermò a Piacenza nel biennio 1548-49. Ma soprattutto è noto che Girolamo raggiunse Padova al massimo nei primi mesi del 1550 dagli avvenimenti successivi, per i quali cfr. il capitolo seguente. Sugli spostamenti di Busale in questa fase cfr. anche Processo Basalù, b. 13, f. II, carte non numerate (IV costituto di G. Basalù). 200 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 318. 201 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, c. 8r (costituto di B. Busale, 13 febbraio 1552). Considerando gli sviluppi del soggiorno padovano è pressoché certo che l’eretico meridionale fosse informato dell’esistenza dei circoli di anabattisti e che dunque il viaggio non fosse indotto né da cause universitarie né per spasso. 202 Costituti di Giovanni Laureto, cit., p. 319.
179
Capitolo III 1 F. Trechsel, Die protestantischen Antitrinitarier vor Faustus Socin. Nach Quellen und Urkunden geschichtlich dargestellt, vol. II, Heidelberg 1844, pp. 391-408. 2 B. Morsolin, L’Accademia de’ sociniani in Vicenza, in «Atti del Reale Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 1878-79, pp. 458-93. 3 Ivi, p. 475. 4 Ivi, p. 476. 5 A. Stella, Dall’anabattismo al socinianesimo nel Cinquecento veneto. Ricerche storiche, Padova 1967, pp. 55-61. 6 Id., Dall’anabattismo veneto al «Sozialevangelismus» dei fratelli hutteriti e all’Illuminismo religioso sociniano, Roma 1996, p. 103. 7 A. Wiszowaty, Narratio compendiosa, quomodo in Polonia à trinitariis reformatis, separati sint christiani unitari, in C. Sand, Bibliotheca anti-trinitariorum [...] (1684), prefazione di L. Szczucki, Varsoviae 1967, p. 209. 8 Ivi, pp. 209-10. 9 Ivi, p. 210. 10 Sand, Bibliotheca anti-trinitariorum, cit., pp. 18-19. Cfr. anche p. 25. 11 S. Lubieniecki, Historia Reformationis Polonicae. In qua tum reformatorum tum antitrinitariorum origo et progressus in Polonia et finitimis provinciis narrantur (1685), Varsoviae 1972, p. 38. 12 Ivi, p. 39 (corsivo nel testo). 13 Nella voce su Giampaolo Alciati F.S. Bock, Historia antitrinitariorum [...], 2 voll., Regiomonti et Lipsiae 1774-76, vol. I, p. 7, lo incluse fra coloro «qui collegia in agro vicentino anno 1546 instructa visitarunt»; in quella su Niccolò Paruta (vol. II, p. 588) scrisse che era stato «inter eos qui anno 1546 famosissima collegia in agro Veneto prope Vincentiam [sic!] frequentarunt». 14 Sulla datazione del concilio Marcantonio del Bon (che vi aveva preso parte e che dichiarò che Manelfi non era presente) testimoniò in modo lievemente difforme dal marchigiano («credo che fosse di novembre o ottobre del ’50», in ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, c. 32v). Considerando che i costituti di del Bon sono del marzo del 1552 (più tardi di quelli di Manelfi) e data la formula dubitativa utilizzata per la datazione dallo stesso del Bon, non sembra che ciò sia sufficiente a mettere in dubbio la data settembrina, confermata da altre testimonianze. 15 C. Ginzburg, I costituti di don Pietro Manelfi, Firenze-Chicago 1970, p. 34. 16 Si fa riferimento alla proposta metodologica di Id., Spie. Radici di un paradigma indiziario (1979), in Id., Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Torino 2000, p. 164 e passim. 17 Id., I costituti, cit., p. 34. 18 M. Servet, De trinitatis erroribus libri septem, [Haguenau] 1531, p. 49v. Una lettera pseudo-melantoniana del 1539 faceva già riferimento alla diffusione delle idee servetane in Italia, e fra il 1547 e il 1549, a ridosso degli avvenimenti qui descritti, il De trinitatis erroribus (ma forse anche i Dialogorum de trinitate libri duo) era stato diffuso nel Nord-Est da Giorgio Filalete detto il Turchetto, il quale – testimonierà un fra’ Antonino Barges – «è pistifero et ha portato in Italia el libro chiamato Michiel Serveto translato, et ha fatto gran danno»; cfr. ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 159, c. 63r (4 dicembre 1554). Ivi, b. 25, f. IV, carte non numerate (processo contro Isabella della Frattina, testimonianze di Caterina Sauli e di Ettore Donato) si legge sul Turchetto (così chiamato «perché era turcho e fu fatto christia-
180
no») che fece circolare «uno libro latino che trattava della trinità, quale era stato composto dal Serveto»; cfr. anche A. Stella, Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo. Nuove ricerche storiche, Padova 1969, pp. 134 sgg. Tra i legami del Turchetto con italiani va segnalato quello con Ludovico Manna, che poté fare da tramite con i radicali; del resto tra il 1547 e il 1549 il Turchetto fu a Padova. 19 Secondo la testimonianza del sarto padovano Bernardino convertito da Busale (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, c. 47r, costituto del 18 gennaio 1552). 20 Costituti di Giovanni Laureto, in M.E. Pommier, L’itinéraire religieux d’un moine vagabond italien au XVIe siècle, in «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», LXVI, 1954, p. 319. 21 Ginzburg, I costituti, cit., p. 51. Cfr. anche ivi, p. 77: «Messer Nicola d’Alessandria grande anabattista; per le sue heresie la sua moglie si è partita da lui, il quale soccorre con denari quasi tutte le Chiese anabattiste dove bisogna». Sull’importanza di Nicola d’Alessandria (figlio di Vincenzo) e per varie notizie sul suo apostolato cfr. ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 9, f. II, carte non numerate (costituti di Paolo Beltramin). Anche d’Alessandria, come Tiziano, «mi diceva cose grandi», confesserà Beltramin, che era stato convertito da Benedetto dal Borgo. Ma il suo ruolo centrale e il suo impegno finanziario sono confermati da pressoché tutte le testimonianze: ivi, b. 158, f. II, cc. 31v-33r (costituti del notaio trevigiano Luca de Fener, o de Fenero o de Ferrero, marito della sorella di Nicola, Isabella d’Alessandria); ivi, cc. 36v-37r (costituti di Giuseppe Cingano); ivi, f. IV, cc. 13v-14r (costituti di Perin del fabro). Francesco Sartori (ivi, f. II, c. 28v) riferì che d’Alessandria era ministro e che «aveva officio ch’el andava predicando la parola». Nella b. 8, f. XXXI, c’è un fascicolo che lo riguarda. Fu spiccato nei suoi confronti un mandato di cattura sin dal 1550 (ancor prima dei costituti di Manelfi) e l’ordine d’arrestarlo fu reiterato nel dicembre 1551. La fuga lo salvò da morte certa: d’Alessandria esulò, con la moglie e altri compagni, a Salonicco. 22 Sull’autorevolezza del futuro vescovo anabattista di Asolo Benedetto dal Borgo (o Borgo o del Borgo o de Borgo o di Borgo o de Burgo) sul movimento anabattista del Nord-Est ha richiamato l’attenzione Stella. Fra le testimonianze che ne evidenziano la preminenza, indicativa è quella di Giuseppe Sartori, che riferì del fallimento di una missione guidata da Tiziano tesa a convertire all’anabattismo alcuni fiorentini: «Al nostro partir da Fiorenza ne fecero instantia che dovessemo mandarli uno altro, perché non si satisfacevano de noi, et in el animo nostro pensassemo de mandarli [...] messer Benetto dal Borgo» (ivi, b. 158, f. IV, c. 57rv). Sartori affermò che ad Asolo dal Borgo era «il capo», col titolo di «vescovo et ministro», e che quando questi era fuori ne faceva le veci Marcantonio del Bon (ivi, b. 158, f. II, c. 28r). Cfr. anche ivi, b. 9, f. II, carte non numerate (costituti di P. Beltramin). 23 Il facoltoso asolano Paolo Beltramin (o Beltramino o Beltramini) partecipò ai momenti essenziali del passaggio dall’anabattismo all’antitrinitarismo: fu presente a Padova, a Vicenza e al concilio di Venezia. Il suo fascicolo processuale, con i costituti e l’abiura, è ivi, b. 9, f. II; cfr. anche ivi, b. 158, f. III, cc. 93v-94r. Ricercato come gli altri asolani da prima delle rivelazioni di Manelfi, si consegnò il 24 marzo 1552 a Treviso. Dalla sua abiura (del 1552) emerge che Beltramin ebbe una posizione oscillante tra Tiziano e Busale e che alla fine si mantenne sulle vecchie opinioni, abbandonando la setta dopo la svolta antitrinitaria. Beltramin confessò «ch’io non credeva alli concili né ad altre scritture salvo che al Testamento Vecchio et Nuovo, nel qual Testamento Nuovo noi tenevamo che la prima parte dell’evan-
181
gelio di san Matteo et di san Luca in quella parte dove parla della incarnatione di Giesù Christo fosse una additione allo evangelio, et similmente in san Giovanni, dove dice tres sunt qui testimonium dant in coelo, nel qual articolo però noi eravamo di diverse opinioni, perché alcuni tenevano che la incarnatione di Giesù Christo fosse ex semine Ioseph et Mariae, et altri la tenevano de spiritu sancto, et in questo io era dubbio, et hora credeva ad un modo hora ad un altro, et da questo è proceduto che io mi sono cavato fuora di questa setta». Beltramin datò al carnevale del 1550 l’inizio della sua conversione e ne raccontò anche le fasi: convertito da del Bon, d’Alessandria e dal Borgo, «un di loro [altrove svelò che era d’Alessandria] mi buttò sopra il capo dell’acqua pura, ritrovandosi in una valle, dicendo: Io ti battezzo in nome del padre, del figliolo et dello spirito santo. [...] Prima che io fossi ribattezzato rinonciai a tutte le opere del papa, nominandolo per Antichristo, et a tutte le cose che haveva determinato la Chiesa romana, tenendo et credendo che non vi fosse cosa di buono». Aggiunse poi altri elementi tipici del credo riformato e concluse confessando «che io ho creduto che nel sacramento dell’altare non fosse il vero et real corpo et sangue di Giesù Christo in quel modo che tiene la santa romana Chiesa predetta, ma che quel sacramento fosse puro segno della comemoratione della cena». Francesco Sartori (ivi, b. 158, f. II, c. 28v) testimoniò che nella setta Beltramin non rivestiva incarichi, ma in realtà Beltramin stesso confessò di avere avuto l’ufficio di apostolo (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate). 24 Giuseppe Sartori, figlio di Giovan Maria, fu coinvolto nel processo contro gli asolani del 1547 (ivi, b. 6, f. V). Ulteriormente convertito da Benedetto dal Borgo, nella casa del quale fu ribattezzato da d’Alessandria, fu forse presente ai colloqui vicentini e partecipò al concilio di Venezia. Successivamente si recò a San Gallo, dove restò circa nove mesi. Tornato in Italia, fu arrestato nel 1552. Il testo dell’abiura (del dicembre 1552) è ivi, b. 9, f. II (copia ivi, b. 158, f. IV, cc. 86r-88v). Confessò d’aver creduto «che Giesù Christo fosse generato dal seme di David secondo la carne, intendendo per copula carnale, et dichiarato figliuolo di Dio in potestà et virtù». Tra i più attivi della setta, ammise d’essersi «trovato molte volte in diversi luoghi con diversi di questa setta, dove si ragionava di queste opinioni. Et specialmente mi trovai in uno ridutto di alcuni di noi, fatto qua in Venetia, dove si disputò et si concluse quanto ho detto di sopra circa il nascimento del nostro signor Giesù Christo, et sono andato tuttavia vagando per diversi luoghi et città, in Italia et fuori d’Italia, tenendo compagnia et stretta familiarità con altri, che havevano di queste impie annabattistice, et altrimenti heretice opinioni». Copia di due suoi costituti dell’agosto 1552, nei quali fornì conferma sugli esiti dottrinali del concilio di Venezia, sono ivi, b. 158, f. IV, cc. 35r-37v. Altri costituti ivi, cc. 56r-57v e 58v-59r. Sia Giuseppe sia suo fratello Francesco Sartori definivano «mio barba» Beltramin. 25 Marcantonio del Bon (o da Prata) di Asolo, già coinvolto dalla predicazione sacramentaria di dal Borgo, fu tra i protagonisti di quelle vicende, sia nella fase dell’anabattismo sia nella svolta antitrinitaria. Il testo della sua abiura (recitata in pubblico nel giugno 1552) conferma alcune delle conclusioni del concilio di Venezia testimoniate da Manelfi (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate). Dichiarò di aver creduto «quod Deus esset solus et non trinus; quod Christus esset verus homo natus ex matrimonio [...]; quod Maria virgo habuisset alios filios et filias; quod fideles mortui in Domino dormirent usque ad resurrectionem, quod non esset aliqua distinctio animae a corpore, et quod traductio huius vocabuli animae ex hebreo melius in lingua latina sonaret sub vocabulo vitae [...]; quod impii non resurgerent in iuditio sed sepulchra eorum essent domus eorum in aeternum». Affermò inoltre
182
che san Girolamo nel rendere la Vulgata avrebbe operato modifiche rispetto alle lezioni ebraica e greca. Interessante era anche l’affermazione secondo cui «inter fideles omnes non esset aliquod discrimen», che rinvia all’egualitarismo anabattista e rivela come nell’accogliere le novità introdotte da Busale gli anabattisti mantenessero la barra su diverse «antique opinioni». Del Bon fu nuovamente processato nel 1573: il fascicolo che lo riguarda è ivi, b. 34, dove è definito «gentil’huomo» e «legum doctor», di professione «advocato», mentre al tempo del primo processo risultava essere «notario». Copia dei suoi costituti del 1552 ivi, b. 158, f. III, cc. 28v37v e 40r-41r. 26 Ivi, b. 6, f. V: si tratta di un incartamento di 36 cc. più altre non numerate. Dal processo del 1547 emerge la professione di notaio di dal Borgo e si fa riferimento ad alcuni suoi beni in territorio di Asolo (una «domus cum duobus campis»). In questa casa il notaio si riuniva con i suoi complici identificati in «Paulus Beltraminus, Marcantonius del Bon, Iosephus Sartor, Perinus del fabro, Paschalis de’ Paschalinis, et Antonius de’ Burgo fratris Benedicti». Tra gli altri asolani ricordati nell’incartamento vi sono il sacerdote Vittore Raimundo, il francescano fra’ Stefano Boscaia, il calzolaio Bernardino Nosadin (di cui sono conservati costituti e abiura) e altri ancora: Francesco Bombarda, Francesco de Nardò, Loise de’ Guido, Felice dal Borgo ecc. 27 Ivi, c. 9v (costituti di A. dal Borgo, che peraltro negò di avere affermato alcunché di simile). 28 Non è chiaro se la Bibbia letta fosse in volgare, ma è probabile considerando che da tempo era disponibile la traduzione di Brucioli e che gli altri testi letti dagli asolani (il Beneficio di Cristo e la Tragedia del libero arbitrio) erano in italiano. Sulle traduzioni della Bibbia e i connessi problemi di censura cfr. G. Fragnito, La bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna 1997; Ead., Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, Bologna 2005. 29 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 6, f. V, c. 6rv (interrogatorio di V. Festaro). Il teste affermò che comunque sapeva che ad Asolo di eterodossi ce «ne sono assai». Manelfi (Ginzburg, I costituti, cit., p. 78) testimoniò che dagli anabattisti asolani «ho inteso che in Asolo vi sono molti lutherani, ma io non li conosco». Dalla documentazione processuale Antonio dal Borgo appare non meno impegnato del fratello nel proselitismo, benché negasse ogni addebito (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 6, f. V, cc. 8r sgg.). Solo un po’ meno reticente sarebbe stato nel 1552 (ivi, b. 158, f. IV, cc. 4v-6r), nel dichiarare che non aveva accettato la svolta antitrinitaria e neanche l’anabattismo, salvo ritenere che i bimbi morti non battezzati si salvassero. 30 Ivi, b. 6, f. V, cc. 5v e 6r, il teste Sebastiano Priore dapprima testimoniò che «per fama non sono molti», ma poco dopo rettificò incalzato dall’inquisitore, affermando quanto riportato nel testo. 31 Sia della scomunica e del bando sia del suo ritorno ad Asolo (dal quale fu nuovamente scacciato) dava notizia in una lettera del 10 marzo 1551 Lorenzo Raimundo, dietro richiesta degli inquisitori di Rovigo (ivi, b. 9, f. II, carta non numerata). 32 La definizione è di Beltramin, che a sua volta la riferì a del Bon (ivi, b. 9, f. II, 5 maggio 1552). Beltramin confessò che del Bon gli diceva che «Idio havia mandato un angelo di Alemagna el qual diceva cose grande, et che l’era andato alla volta della Romagna. Dicens interrogatus: Alhora el non me lo nominò, ma dappoi l’ho cognosciuto et si chiama Ticiano, non so el suo cognome ma ho inteso che l’hè da
183
Ceneda». Effettivamente del Bon nei suoi costituti si riferì espressamente sia a Ceneda (attuale Vittorio Veneto) sia all’«Alemagna» (ivi, b. 158, f. III, c. 31r). Anche il vicentino Matteo Montanaro confermò che «Titian [...] diceva esser di Ceneda» (ivi, c. 12r); ma altri parlarono di luoghi diversi (Firenze, Serravalle di Treviso, Conegliano). Su Tiziano cfr. Stella, Anabattismo e antitrinitarismo, cit.; Ginzburg, I costituti, cit.; U. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, vol. II, Torino 1981, ad nomen. 33 La definizione è di Isabella de Fener (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 37v). 34 Non c’è da sorprendersi che Tiziano abbia ispirato la fantasia dei Luther Blissett autori del romanzo Q (Torino 2000) di cui è il protagonista. 35 Ginzburg, I costituti, cit., p. 62. 36 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 25r (costituti di B. Busale, 23 dicembre 1551). 37 Ivi, c. 29r (costituti di A. de’ Colti, 24 dicembre 1551). 38 Ivi, b. 158, f. II, c. 36v (costituti di G. Cingano, 13 gennaio 1552). 39 Ivi, f. III, c. 31r (costituti di M. del Bon, 3 marzo 1552). 40 Cfr. C. Renato, Opere documenti e testimonianze, a cura di A. Rotondò, Firenze-Chicago 1968, pp. 228-30. 41 A parte l’elenco di comunità fornito da Manelfi, altre testimonianze confermano la capillare diffusione della setta anabattista evocando ulteriori Chiese come quella di Bolzano, ricordata da Alvise de’ Colti che vi si recò incontrandone il ministro «Zuan Maria monaro [mugnaio]» e diversi fratelli da lui istruiti (anche dei dintorni) che de’ Colti ribattezzò (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, c. 67v). Quanto alla struttura della setta, de’ Colti testimoniò che «loro vogliono che quando dui o 3 si congregano, là sia la Chiesa» (ivi, b. 11, f. III, Processus contra anabatistas, c. 28r). Beltramin (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate) precisò: «Io mi son trovato alla elettione delli ministri di questa nostra Chiesa, li quali erano vescovi, apostoli et diaconi, et io anchora fui eletto apostolo, l’ufficio del quale era di andare predicando la parola, et questa dottrina». Ulteriori dettagli sui ruoli di vescovo, diacono e apostolo diede anche il vicentino Giulio callegaro (ivi, b. 158, f. III, cc. 58v59r). Si trattava di un tentativo di istituzionalizzazione fondato sulla parità dei fedeli, fra i quali si sceglieva un vescovo incaricato di orientare il dibattito – sulla base della lettura dei testi sacri in volgare – e di impartire il battesimo, un apostolo dedito al proselitismo e un diacono con compiti organizzativi e di tesoriere. L’uso del termine «Chiesa» (la «vera Chiesa») è attestato in più testimonianze, e se sarebbe più corretto parlare di setta, va evidenziato quanto tale termine comparisse altrettanto spesso nelle testimonianze. Beltramin precisò: «La qual setta noi chiamavamo Chiesa» e analogamente si espressero Francesco spadaro (ivi, b. 158, f. IV, cc. 27v sgg.), Francesco Sartori (ivi, b. 6, f. V, carte non numerate), che evocò «questa setta che noi chiamavamo Chiesa d’annabatisti», Gian Ludovico bronzier (ivi, b. 158, f. II, c. 96v) e Biagio callegaro (ivi, f. III, c. 3r). 42 L’anabattismo del Nord-Est insisteva proprio sulla critica ai sacramenti, sicché per i sacramentari il passaggio alla negazione della validità del battesimo non era netto. In tal senso può dirsi che l’anabattismo trovò nel Nord-Est terreno fertile e ciò spiegherebbe anche perché molti aderenti alla setta non confessarono altre eresie oltre alla negazione dei sacramenti (pedobattesimo incluso). Dimostra una simile ipotesi proprio il caso dei sacramentari asolani, ma analoghe considerazioni possono farsi sulla comunità di Vicenza, a proposito della quale de’ Colti, che fu ministro, fornì tale quadro sull’evoluzione radicale: «La causa di ciò è stato uno
184
Marc’Antonio [del Bon] de Asolo [...], e uno Beneto [dal Borgo] pur da Asolo con uno messer Nicola [d’Alessandria] da Treviso, li qualli venendo in Vicenza predicarono il battesimo [...]; et poiché tutti questi che sono incorsi in questa loro oppinione herano et vivevano ala luterana [...] non è meraviglia niuna si ne sono incorsi tanti in simili oppinion, poiché con facilità credevano» (ivi, b. 24, f. II, carte non numerate). Chiaramente la definizione di «luterano» va intesa in senso generico. Sulla diffusione di idee zwingliane in Veneto cfr. Stella, Dall’anabattismo veneto al «Sozialevangelismus», cit., pp. 94 sgg. Sulle posizioni riformate a Vicenza cfr. A. Olivieri, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, Roma 1992. 43 Ginzburg, I costituti, cit., p. 63. Cfr. anche ivi, p. 33. 44 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 29r. Cfr. anche ivi, b. 158, f. II, cc. 64v-65r. Per il riferimento al giuramento cfr. ivi, c. 46r (costituti di F. Bosato). Questi diede per il resto conferma degli altri orientamenti, affermando che si dovesse obbedire all’autorità politica (ma non al papa); che chiunque fosse titolato (principe, duca ecc.), magistrato o capitano dovesse abbandonare titoli e cariche ove volesse entrare nella setta; che per gli anabattisti i magistrati temporali dovessero astenersi dall’impartire condanne che implicavano la morte o tormenti fisici. 45 Ivi, b. 11, f. III, c. 25v. A parte altre testimonianze riportate nel testo, diverse sono le conferme riguardo all’obbedienza ai magistrati; Francesco Sartori ad analoga domanda rispose: «Noi semo d’oppinion che si habia a obedirli» (ivi, b. 158, f. II, c. 27r). Ma cfr. anche, ad esempio, l’interrogatorio del vicentino Gian Giacomo di Forcini (ivi, c. 87v). 46 Ivi, c. 68r. Analogamente si esprime ivi, b. 9, f. II, carte non numerate. 47 Gian Maria Beato o Beati o de Beatis di Rovigo, chiamato anche «Manfredino», come rivelò lui stesso. Nel 1551 aveva circa 24 anni e dichiarò: «Non fo altro essercitio et vivo di entrada» (cioè di rendita). Il suo fascicolo processuale è ivi, b. 6, f. V, cc. 1r sgg. Altri costituti ivi, b. 158, f. II, cc. 70v-74r. Ivi, f. III, cc. 20v-22r, c’è l’abiura, e nello stesso fascicolo si trovano altri documenti che lo riguardano. Fu interrogato una prima volta il 7 dicembre del 1551; il suo arresto avvenne prima, dunque, della retata antianabattistica partita da Venezia pochi giorni dopo. Fu ricordato da Manelfi fra gli anabattisti di Rovigo insieme con sua moglie Caterina, che da nubile si chiamava de’ Doti o Dotto (i suoi costituti sono ivi, f. II, cc. 49r52r; f. III, c. 18rv, alle cc. 26r-28r la sua abiura; i costituti della madre Lucia Bonacorso, molto ricchi di notizie, sono ivi, f. II, cc. 52r-55v). Nel suo primo costituto Beato confessò d’essere stato convertito da dal Borgo – che aveva soggiornato in casa sua poco prima d’esser condannato – e d’avere avuto rapporti con Tiziano, di cui ospitava un figlio. Partecipò ai colloqui padovani e al concilio di Venezia, come testimoniato da Giuseppe Sartori (ivi, f. IV, c. 36r). I costituti di Beato si soffermano sulle tecniche di conversione di dal Borgo, ricostruendo nel dettaglio dottrine e riti da lui insegnatigli. Rivelò di come fosse stato nominato dal leader asolano diacono, col ruolo di tenere i «danari da dar poi a poveri». 48 Ivi, f. II, c. 72r (costituti del 27 gennaio 1552). 49 Ivi, c. 72v. Diverse testimonianze confermano tale quadro. Francesco Sartori confessò d’aver creduto «che nella Giesa di Christo nissuno possa esser principe o duca, o vero esercitar magistrato temporale» (ivi, b. 8, f. XXXII, carte non numerate; ivi, b. 158, f. II, c. 27r). Analogamente si espresse Giacometto stringaro per quanto riferito da Matteo dalle Maddalene (ivi, c. 68v). Beltramin (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate) sostenne che «io ho tenuto et creduto insieme con gli altri di questa nostra Chiesa, che in essa nostra Chiesa non si admettesse alcun magistrato
185
temporale, et giudice ministro di giustizia, et che noi volevamo che tutti fossero eguali, et che tra noi non vi fosse soperiorità, o maggioranza». Beltramin diede conferma inoltre di altre dichiarazioni di Manelfi: «Io mi son trovato – confessò – una volta fra le altre in una nostra congregatione fatta qui in Venezia, dove fu parlato che nella nostra Chiesa non si accettassero depintori, scultori, spadari, et simili arti». Il che confermò anche Giuseppe Cingano (ivi, b. 158, f. II, cc. 38v-39r), che specificò che non era lecito neanche rivolgersi all’autorità giudiziaria e che «nissuno potesse portare arme di sorte nissuna». Al divieto di esercitare alcuni mestieri aveva fatto cenno Manelfi (Ginzburg, I costituti, cit., p. 48), parlando di uno spadaio veneziano: «Maestro Giovan Maria [ma Giovan Giacomo] spataro, ma non fa più ’l maestro, perché gli anabattisti non vogliono alchuno che facci arme, né depintori». Quanto alla comunità dei beni, si trattava più di un’idea che di una pratica. Al principio fecero riferimento anche altre testimonianze, come quella del sarto padovano Bernardino (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, c. 60v). 50 De’ Colti (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 28r) lo incluse fra i partecipanti ai colloqui padovani ma non ne rammentava, come Manelfi, il nome. A lui fece riferimento anche Biagio callegaro (ivi, b. 158, f. III, c. 2v) che dichiarò di non conoscerne il nome identificandone però l’abitazione. Nella b. 9, f. II, v’è traccia delle difficoltà avute dagli inquisitori nel rintracciarlo. Il capitano di Padova, Francesco Contarini, scrisse il 22 dicembre 1551: «Potria essere che non fusse quello che desiderava haver le excellentie vostre, perché ge è anche qualchun’altro che cavadenti». Stella, Dall’anabattismo al socinianesimo, cit., p. 92, lo chiama Giammaria. 51 Che la sua casa ospitasse almeno un incontro lo rivelò Manelfi. Sfuggito alla cattura nel dicembre 1551 (il 22 il capitano di Padova informò che non era riuscito a trovarlo), si consegnò spontaneamente a Padova il 21 marzo 1552 (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 9, f. II, carte non numerate; cfr. anche i suoi costituti, ivi, b. 158, f. IV, cc. 15v-16r e 48r, dove risulta che si era trasferito a Padova poiché bandito da Venezia per omicidio). Il suo nome fu fatto anche da Biagio callegaro (ivi, f. III, c. 2v), che ne localizzò l’abitazione al Portello. 52 Nativo di Castelfranco, residente prima a Padova e poi a Mestre, Menzato fu accusato di aver partecipato ai colloqui padovani da de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, c. 28r). Il suo nome fu fatto anche da Biagio callegaro (ivi, b. 158, f. III, cc. 1v-2v) e da Beltramin (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate). Di professione straccivendolo, per qualche mese fu al servizio di d’Alessandria, che lo ribattezzò. Nei suoi costituti ammise di saper leggere e scrivere. Fu arrestato a Mestre nel 1552. La sua abiura è ivi, b. 9, f. II, i suoi costituti ivi, b. 158, f. IV, cc. 44v, 45v-47v, 84rv (a cc. 91r92v copia dell’abiura). Confessò, tra l’altro, di credere che la Chiesa «era una Babilonia», che «morto l’huomo l’anima andasse immediate in paradiso per gratia di Dio», che «ritrovandomi in necessità ho anche dissimulato et mostrato di credere che Maria madre di Giesù Christo benedetto havesse avuto degli altri figliuoli oltre esso Giesù Christo». Difficile dare un’interpretazione di quest’ultima asserzione, la dissimulazione che Menzato disse d’avere esercitato con i suoi compagni potrebbe aver reiterato con gli inquisitori. Ma non è da escludere che fosse tra i pochi che si attestarono sulla linea di Tiziano: confessò anche il suo allontanamento dalla setta, che ne causò la scomunica da parte di Giacomo da Treviso. Fu condannato a varie penitenze e «a servire dui anni continui al remo nelle galee». 53 Ginzburg, I costituti, cit., p. 46 nota, l’ha identificato con «lo spadaio padovano chiamato Spagnoletto di cui Giovan Giacomo, spadaio veneziano, diceva che
186
‘fa profession della Scrittura’». L’ipotesi è confermata da Spagnoletto stesso, che nei suoi costituti affermò di chiamarsi «Francesco spader detto Spagnoleto», ammettendo peraltro di saper leggere e scrivere. A Padova si era però trasferito, mentre si diceva nativo di Milano (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, cc. 94r-97v). Biagio callegaro lo definì «indorador de arme» (ivi, c. 2v). La sua abiura è ivi, f. IV, cc. 27r-29r. Confessò d’esser stato «sedotto da alcuni heretici et annabatisti [...], et così pratticando con loro mi son ridutto in alcune case, et luoghi in Padova, dove uno de’ principali che era chiamato ministro leggeva qualche passo del Testamento Novo vulgar, et poi ne lo esponeva, per li quali ragionamenti et pratiche [...] son entrato in opinion annabatistice, et altrimenti heretice». Tra queste la convinzione che «l’hostia consecrata dal sacerdote non sia il vero et real corpo di Iesu Christo ma ch’el sia pura pasta»; il rifiuto della confessione («perché el basta confessarsi a Dio»), dei dogmi, degli ordini e dei decreti stabiliti dalla Chiesa e altre idee riformate. Fu ribattezzato da d’Alessandria a Padova, «in casa di Francesco da Rovigo». Nessun riferimento Spagnoletto fece all’antitrinitarismo né ad altre posizioni emerse dal concilio di Venezia, ma può ipotizzarsi un prudente silenzio al riguardo. Da una deposizione di de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, c. 27r) risulta che la sua abitazione «vicino al Portello» era uno dei luoghi ove avvennero i colloqui padovani. Fu condannato ad abiurare in pubblico e «al remo nelle galee» (ivi, b. 158, f. IV, c. 31r). Quanto allo spadaio Gian Giacomo ricordato da Ginzburg, che fu tra coloro che denunciarono Spagnoletto, viveva a Venezia ma era di Trento (la sua abiura e altri incartamenti che lo riguardano sono ivi, b. 11, f. III; cfr. anche ivi, b. 158, f. III, cc. 19r-20v, 44r-45r, 68v-69r; ivi, f. IV, cc. 34r-35r; alle cc. 79r-81v copia dell’abiura) e aveva aderito alla svolta antitrinitaria («contra la incarnatione di Iesu Christo benedetto et contra la virginità di Maria madre sua»), al contrario, sembra, di sua moglie Angelica, ribattezzata in casa loro da del Bon. Fu condannato al carcere perpetuo e liberato per le sue condizioni di salute nel dicembre del 1563. Del Bon confermò che casa sua era stata sede di riunioni (ivi, c. 33v). Il nome di Gian Giacomo fu fatto anche da Cingano (ivi, b. 158, f. II, c. 40v) e da Gian Maria Razer (ivi, f. III, c. 50r). Fu arrestato con la moglie già nel dicembre 1551 e il 29 di quel mese l’Inquisizione intimò alle autorità veneziane di consegnargli i due prigionieri (ivi, f. II, c. 55v). 54 Per il nome di battesimo del «maniscalco al Portello» cfr. ivi, b. 11, f. III, c. 14v. 55 Biagio callegaro, figlio «de mastro Leonardo bottar», confessò d’esser stato ribattezzato da del Bon (ma nella bozza dell’abiura compare, cancellato, il nome di d’Alessandria, che aveva rivelato nei suoi costituti) e d’aver creduto che «Giesù Christo sia puro huomo nasciuto del seme di Ioseph et di Maria di legitimo matrimonio». Fu arrestato alla fine del 1551 e inviato a Venezia, dove abiurò l’anno dopo. Il testo dell’abiura è ivi, b. 9, f. II, carte non numerate; copia ivi, b. 158, f. III, cc. 65r-66v. Secondo la deposizione di de’ Colti la sua casa padovana fu sede d’incontri (ivi, b. 11, f. III, c. 27r; ivi, b. 158, f. IV, c. 4r). Altri costituti di Biagio sono ivi, f. III, cc. 1r-3v e 5rv. Il suo nome emerse anche dalle testimonianze di Giuseppe Cingano (ivi, f. II, c. 40v) e Gian Ludovico bronzier (ivi, c. 97r). 56 Biagio callegaro (ivi, f. III, c. 2v) e Bruno Busale (ivi, b. 11, c. 24r) testimoniarono che anche la loro casa fu sede di incontri. I costituti di Bernardino (gennaio-febbraio 1552) sono ivi, b. 158, f. II, cc. 47r-48r e 60v-61r. Il 23 febbraio 1552 fu interrogata sua moglie (ivi, cc. 59v-60v). Bernardino dichiarò di avere al tempo 29 anni e confessò d’esser stato «persuaso da uno abbate napolitano» di nome
187
«Hieronimo» «et anche da altri scolari sui compagni quali si sono partiti da Padoa [que]sta quaresima» di cui non ricordava il nome, salvo che di «uno Gioanni» [Laureto]. Nella conversione del sarto avevano pure giocato un ruolo Cingano, de’ Colti e Manelfi, che alloggiò in casa sua. Confessò di conoscere passi di un libro di Francesco Stancaro e d’aver posseduto «certi libretti del Vergerio», tra i quali «certi libretti pizoli di istruir putti» (quasi sicuramente il Lac spirituale, cioè il Catechismo di Valdés, era tra questi), «uno sopra li atti delli apostoli et sopra li fioretti de san Francesco», nonché alcuni «libri grandi, cioè el Bucero et el Calvino»; tutti questi libri gli venivano procurati e letti da Cingano secondo la sua stessa ammissione, giacché confessò di non saper leggere (cc. 47r e 60v-61r). Il cognome Prandi è aggiunto da Stella, ma non è stato possibile trovarne conferma documentale. 57 Speranza, che partecipò sia ai colloqui padovani sia a quelli vicentini, esercitava la professione di «depintor» secondo la testimonianza di de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, c. 26r). Non è noto se avesse accettato l’obbligo di non esercitare più il suo mestiere per come imposto dalla setta. Da una testimonianza di Cingano risulta che morì intorno al 1560 «a Verona in preson» (ivi, b. 24, f. II, c. 80v). Biagio callegaro affermò che era originario di Vicenza (ivi, b. 158, f. III, c. 3v), il che fu confermato da Giacometto stringaro, che lo ribattezzò (ivi, f. IV, c. 43v) e da altri. Il 18 luglio del 1573 l’ex anabattista bassanese Alessandro Geccheli (o di Gechele) ammise di aver conosciuto Speranza e di sapere che una sua sorella era stata condotta in Moravia dal medico padovano d’orientamento radicale Nicolò Buccella (ivi, b. 34, f. Prata Marc’Antonio, carte non numerate). 58 Ginzburg, I costituti, cit., p. 46. 59 Manelfi (p. 47) aggiunse che in seguito «costui fu separato et scacciato dagli anabattisti perché insegnava alli fanciulli di segnarsi colla croce». Si tratta del veneziano Alvise de’ Colti (o di Colti o Colti), figlio di «Zuan di Colti», i cui primi costituti (del 24 dicembre 1551) sono in ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, cc. 26r-29v, mentre gran parte della documentazione che lo riguarda (inclusa l’abiura) è ivi, b. 24, f. II, cc. 68v-79r, 84r-85v e altre carte non numerate. Cfr. inoltre ivi, b. 158, f. IV, cc. 3v-4v; ivi, f. II, cc. 62r-65v e 79v-80v; ivi, f. III, cc. 67v-68v (dove si trova conferma alle affermazioni manelfiane); ivi, cc. 75r-76r, c’è una sua supplica, alle cc. 76v-79r, v’è copia dell’abiura e alle cc. 83r-85v la sentenza. Secondo Gian Maria Razer (ivi, f. II, c. 31r) de’ Colti parlava il tedesco e aveva esercitato la professione di «sensale del Fontego dei Todeschi» a Venezia, dalla quale era stato poi bandito per omicidio (quest’ultima circostanza la confermò lui stesso). Trasferitosi a Vicenza, si diede all’insegnamento «di abbaco» e fu convertito e ribattezzato da d’Alessandria e da Giacometto stringaro, al quale successe nel ruolo di ministro a Vicenza, ribattezzando a sua volta diversi nuovi adepti. In seguito si trasferì a Padova, dove esercitò anche il mestiere di maestro («teneva schola de leggere et scrivere»). Tra i protagonisti dell’anabattismo veneto, prese parte ai colloqui padovani e al concilio di Venezia, sul quale (e in genere sul radicalismo del Nord-Est) rivelò vari particolari. Una volta arrestato, cercò di sminuire le sue responsabilità, definendosi «poverino idiota» e sottolineando – pur mentendo – i dubbi che diceva d’avere avuto sulla pura umanità di Cristo. In realtà il suo mestiere di maestro, il fatto che sapesse leggere e scrivere, la sua conoscenza del tedesco, oltre al suo incarico di ministro, rivelano quanto forzata fosse la sua affettata ignoranza. Riferendosi a de’ Colti, Razer disse agli inquisitori: «Se poteste haver costui nelle mani lui vi diria il tutto, perché esso conosceva tutti». Al tempo del suo primo arresto Alvise aveva 30 anni e si presentò con «barba rossa, longa». Fu condannato nel 1552 ad
188
abiurare e subì la galera per poco meno di un triennio, dopo il quale ritornò a Vicenza, dove ebbe la sua principale residenza per circa diciotto anni, non senza vivere per alcuni periodi a Roma, Milano e in altri luoghi (ivi, b. 24, f. II, c. 73v). Fu arrestato di nuovo nel 1569: secondo varie accuse «teneva la parte di ugonotti, laudando la fede lutherana e biasimando quella dei cattolici»; ma non mancarono testimonianze che parlavano di anabattismo: Andrea Pagello, che con lui «praticava», parlò di «opinioni molto stravagante come de anabattisti, che voleno che le donne siano comune et la robba, et de rebattizarsi». Dagli inquisitori fu descritto come «un huomo di mediocre statura alquanto grosso», aveva abbandonato l’insegnamento e si era dedicato alla mercanzia «di bestiami, grisi et altre cose». Tra la documentazione che lo riguarda ci sono anche i verbali delle torture cui fu sottoposto più volte nonostante lamentasse d’essere «stroppiato» e nonostante contrario parere medico per le numerose ferite riscontrategli (il che servì solo a passare dalla corda ai carboni ardenti). 60 Ginzburg, I costituti, cit., pp. 75-76. 61 Ivi, p. 47. 62 «Ho inteso che siamo più di 100» (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 26v). 63 Il suo nome fu fatto anche da del Bon (ivi, b. 158, f. III, c. 31v), che lo incluse tra i partecipanti ai colloqui padovani. Ma cfr. ivi, b. 11, f. III, c. 23v (costituti di B. Busale, 23 dicembre 1551). Condividevano col più giovane Busale e con Tizzano l’«habitatione alli heremitani in Padova» «dui altri scholari napolitani»: «Antonio napolitano» e «Horatio Drao napolitano». 64 Cfr. Ginzburg, I costituti, cit., pp. 45 e 75. 65 Ivi, p. 47. Cfr. anche i costituti di de’ Colti (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. IV, c. 28r). 66 È la casa affittata da d’Alessandria e ricordata da Laureto. Ne parlò anche Bruno Busale, che disse che gli incontri avvenivano «ogni domenica» (ivi, b. 11. f. III, c. 30r); altri luoghi di riunione erano «al Portello in casa delli scolari de Rhovigo» (ivi, b. 158, f. IV, c. 14r, costituti di Perin del fabro), in casa di Biagio callegaro, del sarto Bernardino, di «Francesco spader» e poi: «Hora a Santa Croce in un horto là sotto le mure, dove se calavamo senza licentia di patroni dell’horto [...]; et hora a Ponte corbo in un altro horto di un gobbo berettaro», secondo la testimonianza di Biagio callegaro (ivi, f. III, cc. 2v-3r). A incontri prevalentemente notturni «in certi hortali», e «in casa di uno Biasio calegaro e di uno Francesco spadaro che sta al Portello», oltre che nella casa di Santa Caterina e in «diversi luoghi fuora» (ad esempio «fuori del borgo, alla foresta»), fece riferimento de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, cc. 26v-27r). 67 Che Tiziano non avesse preso parte dall’inizio ai colloqui padovani è testimoniato da G. Sartori, che rivelò come lui stesso, Tiziano e altri (come Giulio callegaro) fino a febbraio si fossero fermati a Firenze (dove Tiziano ribattezzò Manelfi), per poi spostarsi a Imola, Casalmaggiore, Cremona e Finale (presso Villa Estense): ivi, b. 158, f. IV, cc. 56v-57v. L’intervento di Tiziano ai colloqui padovani dovrebbe datarsi al marzo-aprile del 1550. 68 Il fascicolo su Giulio Gherlandi è ivi, b. 18. Nativo di Spasiano, presso Treviso, fu ribattezzato da d’Alessandria e aderì alla svolta antitrinitaria. Esule in Austria a seguito della retata inquisitoriale del 1551, riparò poi in Moravia. Tornato in Italia in varie occasioni, fu catturato nel 1561 e l’anno dopo condannato a morte
189
per annegamento a Venezia. Cfr. Stella, Dall’anabattismo al socinianesimo, cit.; Id., Anabattismo e antitrinitarismo, cit., ad nomen. 69 Al trevigiano Sebastiano Pesente non fece riferimento Manelfi. Detto Pesarino, Bastiano era mercante e Stella (ivi, p. 48) lo indica come cognato di Benedetto dal Borgo. A Bastiano si riferì la sorella di d’Alessandria Isabella (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 37v), raccontando l’incontro avuto da lei con Tiziano. Fu tra i partecipanti al concilio di Venezia. 70 Potrebbe trattarsi di Francesco Della Sega, nativo di Rovigo e ben presto coinvolto dalla predicazione anabattistica a Padova (dove era studente) da d’Alessandria, che lo ribattezzò (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate, costituti di P. Beltramin). Parteggiò sin dal principio per la svolta antitrinitaria. Successivamente emigrò, dapprima in Austria per poi raggiungere la Moravia. Nel 1562, mentre organizzava la fuga da Cittadella di circa venti persone, fu scoperto e catturato. Fu condannato a morte per annegamento nel febbraio 1565. Cfr. Stella, Dall’anabattismo al socinianesimo, cit.; Id., Anabattismo e antitrinitarismo, cit., ad nomen. 71 Giovanni di Badia Calavena, menzionato da Manelfi fra gli anabattisti del suo paese insieme a «Giulio berettaro con altri assai» (Ginzburg, I costituti, cit., pp. 41 e 78), partecipò al concilio di Venezia secondo la testimonianza di G. Sartori (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 36r) e per quanto ammesso da lui stesso, che però tese a sminuirne l’importanza sostenendo che «non fu deliberata cosa alcuna che mi ricordi». Riferì che dal Borgo gli aveva parlato dell’antitrinitarismo e di non avervi aderito. Ma in tutte le testimonianze tese a svalutare il suo ruolo. 72 Al trevigiano Giacometto sartor fecero riferimento anche Giuseppe Cingano (ivi, f. II, c. 41r), Perin del fabro (ivi, f. IV, c. 12v), Giacometto stringaro (ivi, c. 40v) e Luca de Fener (ivi, f. II, c. 89v). Manelfi lo definì «compagno» di d’Alessandria, notizia confermata dalle dichiarazioni di Cingano e di Perin. 73 Il vicentino Giovanni da Poschiavo. Su di lui e sugli altri vicentini menzionati cfr. infra, note 83, 84, 90. 74 Ivi, b. 24, f. II, c. 3r (costituti di A. de’ Colti, 29 dicembre 1551). 75 Stella, Dall’anabattismo al socinianesimo, cit., pp. 91-92 nota. 76 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, cc. 31v-32r. Analoga ricostruzione fornì de’ Colti: «L’abbate e i suoi [...] promossero la materia di Christo, ch’el sia concetto di spirito santo o di seme humano». Dopo vari scontri, per risolvere «questa difficultà, vennero tutti qui in Venezia» (ivi, b. 24, f. II, c. 3, costituti del 29 dicembre 1551; cfr. anche ivi, b. 11, f. III, c. 27v). Cfr. anche la testimonianza di Bruno Busale: «Di Christo dicevamo ch’era homo et non Dio» (ivi, c. 24v), ma specificando che Cristo fosse «fiol di Ioseph, ma secondo il spirito fiol di Dio» (ivi, c. 25r), secondo la visione di Villafranca e di antitrinitari dell’esilio come Valentino Gentile e Matteo Gribaldi. 77 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, c. 77r (costituti di M. dalle Maddalene). 78 Secondo la testimonianza di B. Busale (ivi, b. 11, f. III, c. 30v) e, come visto, di Laureto e Manelfi. 79 Che Tiziano prendesse parte ai colloqui padovani (pur non dall’inizio) è comprovato da varie fonti. De’ Colti lo affermò nei suoi costituti del 29 dicembre 1551 (ivi, b. 24, f. II, c. 3r), precisando quanto affermato il 24 dicembre (ivi, b. 11, f. III, c. 29r). Altrettanto aveva testimoniato Bruno Busale il 23 dicembre (ivi, cc. 23v25v), che peraltro confessò che fu Tiziano a ribattezzarlo (ivi, c. 25r). 80 Ginzburg, I costituti, cit., p. 74. Perin del fabro parlò di un’ottantina di per-
190
sone (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 13r), mentre Gian Ludovico bronzier di una cinquantina (ivi, f. II, c. 97r). Dai documenti veneziani si possono identificare oltre quaranta persone. 81 Ad essi fece riferimento Giacometto stringaro, che li aveva ribattezzati (ivi, b. 158, f. IV, cc. 40rv e 43v). «Messer Giulio [Sandrini] et suoi fratelli» furono evocati anche da Manelfi (Ginzburg, I costituti, cit., p. 44). A Polonio che «non fa mestier nissuno», figlio di «Theseo da Brogian», si riferì Francesco Bosato (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, c. 45r), che lo disse ribattezzato da Giacometto in casa di Matteo dalle Maddalene. 82 Giacometto si diceva «vicentin» ma con origini pugliesi (era figlio di Nicola di Trani). Fece risalire la sua conversione all’arrivo a Vicenza di «uno de Voltolina», Giambattista Tabachin, «el qual vene a Vicenza con uno Ticiano» (ivi, f. IV, c. 40r), ma decisiva influenza ebbe d’Alessandria, che lo ribattezzò. Varie testimonianze ne segnalano la preminenza sul mondo eterodosso radicale vicentino e molti furono da lui ribattezzati («da 25 in 30 [...] in Vicenza solamente», come confessò egli stesso: ivi, c. 43v). Partecipò ai colloqui padovani, a quelli vicentini e al concilio di Venezia e ammise le sue opinioni «contra la santissima trinità». A Giacometto è stato attribuito da Stella, Dall’anabattismo al socinianesimo, cit., pp. 67-71, un testo dal titolo La revelatione: l’unico scritto noto scaturito dal radicalismo del Nord-Est. Vi emerge il momento di passaggio dall’anabattismo all’antitrinitarismo. Si tratta di un manoscritto formato da sei cc. (con undici facciate vergate), redatto in forma di lettera, conservato in ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 9, f. II, carte non numerate. Il manoscritto è allegato al fascicolo ove è conservata l’abiura di Giacometto (che è in copia anche ivi, b. 158, f. IV, cc. 95v-97r), che segue di poche carte; e tra l’abiura e il testo vi è una lettera (del 25 agosto 1552) nella quale si dà conto del rinvenimento e del sequestro del manoscritto in casa dello «stringaro». Ciò ha tratto in inganno Stella, mentre il testo è in realtà di Tabachin, come ha notato Ginzburg, Il formaggio e i vermi, cit., pp. 176-77 nota. La lettera fu mostrata dagli inquisitori a Tabachin, che se ne assunse la paternità dicendola rivolta ai compagni di fede riparati nei domini ottomani (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 53r; ivi, cc. 39v43v). 83 Giuseppe Cingano (o Zingalo) al tempo esercitava la professione di sarto, ma poi svolse quella di «sansaro publico». Nonostante nei suoi costituti cercasse di sminuire il proprio ruolo, incalzato dagli inquisitori confessò che casa sua era sede di riunioni e che fu incaricato di alcune missioni. Peraltro, nella sua dimora abitò d’Alessandria, che l’aveva ribattezzato. Giuseppe partecipò sia ai colloqui padovani sia a quelli vicentini, aderendo alla svolta antitrinitaria, come confessò nel suo primo processo: nell’abiura ammise d’aver creduto «che Giesù Christo sia concetto del seme di Ioseph et di Maria et non del spirito santo, et che essa Maria madre di Giesù et nel parto et dopo il parto non sia stata vergine». Fu arrestato nel dicembre 1551 (i suoi primi costituti sono datati 13 gennaio 1552) e, dopo aver rivelato vari particolari e fatto i nomi di numerosi complici, gli furono inflitte l’abiura e diverse penitenze. Nel 1570 fu condannato dal Sant’Ufficio, nonostante relapso, a essere recluso in un monastero «loco carceris», avendo manifestato intenzione di emigrare a Lione e simpatie per Ginevra, benché nei suoi costituti negasse ogni addebito ma con gran reticenza, e dichiarò persino di non ricordare per quali «articoli» fosse stato costretto ad abiurare nel 1552, salvo che «per haver tenuto pratica et compagnia con anabattisti», negando d’essere stato ribattezzato nonostante la sua abiura testimoniasse il contrario. Al di là dei suoi comprensibili silenzi, a quan-
191
to sembra a quel tempo aveva assunto una posizione calvinistica. Cfr. ivi, b. 24, f. II, c. 1v, costituti di Bartolomeo Bertozzi o Bartocci, 1568, che dichiarò: «Conosco anchora in Vicenza doi sensali, uno si chiama il Zingalo, che credo si chiami Giosepho di proprio nome [...], et il detto Cingano [...] mi domandò se in Lione havesse trovato di essercitare il suo mestiero, che ci saria andato volentieri per vivere al modo che si fa in Genevra, et io dissi che pensaria che haveria trovato, et ultimamente lui ci andò a stare a Lione con un suo cognato chiamato Francesco della Renalda». Il suo incartamento processuale è ivi (alle cc. 2r-5r e 7r, 19r-22r, 61v-63r, 65v-66v, 79v-84v, 85v-86v), con vari costituti, il verbale della tortura e altra documentazione (suppliche, pareri medici sulla possibilità di torturarlo, interrogatori a testimoni, ordini inquisitoriali, copia della prima abiura, la sentenza ecc.). Altri documenti alle carte seguenti, non numerate. Tra questi una lettera alle autorità venete del capitano di Vicenza Davide Trevisan (del 25 dicembre 1551) in cui dava conto dell’arresto, tra gli altri, di Cingano, «che ha fama di esser di primarii et che teniva scola di heresia». Diversi suoi costituti relativi al primo processo sono ivi, b. 158, f. II, cc. 34v-42v. Il suo nome è costantemente presente nelle testimonianze sugli anabattisti vicentini. 84 Ginzburg, I costituti, cit., pp. 42-43 nota, lo identifica con il vicentino «Zuan de Poschiavo», che partecipò ai colloqui padovani secondo la testimonianza di de’ Colti (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 26r). Giovanni è ricordato anche nei costituti di Prudenzia Fornaseri, moglie di «Iacopo sutor» (1556: ivi, b. 24, f. II, carte non numerate). E a uno «Zuane calegaro da Poschiavo» fecero riferimento Beltramin (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate) e Cingano, che ne rivelò il ruolo di diacono (ivi, b. 158, f. II, cc. 35r e 37r). Un «Gioanni callegaro da Poschiavo» fu evocato dallo stesso Manelfi in un secondo elenco degli anabattisti vicentini nel quale non ricompariva il nome di «maestro Giovanni de Dolthani». L’identificazione, pertanto, è certa. La sua casa fu sede di riunioni secondo le testimonianze di Perin del fabro (ivi, b. 158, f. IV, c. 13r), di Matteo dalle Maddalene (ivi, b. 158, f. II, c. 67v), che lo definì «drappier», e di Gian Giacomo di Forcini (ivi, c. 87r). 85 Manelfi (Ginzburg, I costituti, cit., p. 73) fece nuovamente riferimento a lui in questi termini: «Maestro Antonio ch’è stato prete et hora callegaro et la sua moglie, qual al presente lavora in casa del sudetto maestro Gioanni». Quanto alla moglie «Martina», fu tra le prime a essere arrestate nella retata antianabattistica del dicembre 1551. Il suo nome figura nel rapporto inviato dal capitano di Vicenza alle autorità veneziane il 25 dicembre (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 24, f. II, carte non numerate). 86 Vicentino, il battilana Matteo dalle Maddalene (o dalla Madalena o della Maddalena) nei suoi costituti e nell’abiura (gennaio-febbraio 1552) confessò d’esser stato «sedutto da uno Iacomino stringaro in Vicenza» (ivi, b. 158, f. II, c. 66r; ivi, b. 9, f. II, carta non numerata); Giacometto confermò affermando di averlo battezzato (ivi, b. 158, f. IV, c. 43v). Altrove (Ginzburg, I costituti, cit., p. 73) Manelfi ne parlò in questi termini: «Maestro Mattheo da la Maddalena battilana et la moglie et la cugnata [ma prima si era riferito a un «cognato»]; a costui li è nato puto o puta già molti mesi et non l’ha ancora battizzata». E infatti, in b. 9, f. II, ove è copia dell’abiura di Matteo, è presente anche un interrogatorio della moglie Lucrezia, nel quale l’inquisitore le poneva la domanda se avesse battezzato i figli. Nel suo primo costituto (del 28 dicembre 1551) Lucrezia aveva rivelato la frequentazione che il marito aveva con Giacometto «stringaro», «che andava insegnando et amorbava ogni cosa» (ivi, b. 11, f. III, c. 34v). Lucrezia cadde nella prima schiera di ar-
192
resti scattati nel dicembre del 1551. Il suo nome compare tra quelli comunicati dal capitano di Vicenza alle autorità veneziane il 25 dicembre (ivi, b. 24, f. II, carte non numerate). Matteo fu tra i più attivi nella comunità vicentina, partecipò ai colloquia vicentina e la sua casa fu luogo d’incontro. A parte la moglie e la cognata (o il cognato) denunciate da Manelfi, fu coinvolto nel suo percorso ereticale anche suo fratello Marcantonio (ibid.). I costituti di Matteo sono ivi, b. 158, f. II, cc. 66r-69v (dove si sofferma nel dettaglio sul rito della cena e sul problema delle relazioni della setta col potere) e 74r-79v. Ivi, cc. 90r-93r, altra copia dell’abiura. Fu tra i partigiani della svolta antitrinitaria. 87 In altra testimonianza Manelfi lo definì «perfumiero» (Ginzburg, I costituti, cit., p. 73). Come «Francesco muschiaro» lo ricordò anche Cingano (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, cc. 35r e 41v), che aggiunse: «Fa far di bottoni» e che ne evocò anche la moglie. Un documento che lo riguarda, dove è ricordato come «Francesco detto muschiaro», è ivi, f. III, c. 63r. 88 Potrebbe trattarsi di «uno Perin strazzaruol» evocato nei costituti di Cingano tra i partecipanti ai colloqui vicentini (ivi, f. II, cc. 35r e 41v; ivi, b. 24, f. II, c. 81v) e ricordato anche da Marcantonio dalle Maddalene (ivi, carte non numerate), da Francesco Bosato, che lo disse battezzato da Giacometto (ivi, b. 158, f. II, c. 45r), e da Matteo dalle Maddalene (ivi, c. 78r). Questo Perin si può identificare forse con un «Piero Secco» ricordato nei costituti di Prudenzia Fornaseri (1556, ivi, carte non numerate). C’erano tra gli anabattisti vicentini, però, almeno tre altri straccivendoli ricordati da «Iacopo sutor» marito di questa Prudenzia (ibid.): «Mattheo strazzaruolo», «Tognetto strazzaruolo» e «Antonio strazzaruolo». Anche Giacometto riferì di un «Matheo strazaruol» (ivi, b. 158, f. IV, c. 43v). 89 Fu indicato tra i partecipanti ai colloqui vicentini da Cingano (ivi, f. II, c. 41v). Il suo nome era emerso anche dai costituti di de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, c. 26r), di Beltramin (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate), di Gian Giacomo di Forcini (ivi, b. 158, f. II, c. 85v) e di Perin del fabro (ivi, f. IV, c. 13r), che svelò che la casa di Matteo era sede di riunioni, così come confessò pure Cingano (ivi, f. II, c. 35v). 90 Il calzolaio mastro Giulio prese parte sia ai colloqui padovani sia a quelli vicentini ma non, pare, al concilio di Venezia. Il suo nome fu tra quelli dei primi arrestati comunicati dal capitano di Vicenza alle autorità veneziane il 25 dicembre 1551; l’anno dopo abiurò. Il suo nome emerse anche da altre testimonianze: Marcantonio dalle Maddalene (ivi, b. 24, f. II, carte non numerate), Cingano (ivi, b. 158, f. II, cc. 35v e 39r); Francesco Bosato (ivi, c. 44r); Gian Giacomo di Forcini (ivi, c. 86r); Pasqualin de’ Pasqualini (ivi, f. IV, c. 3r), Perin del fabro (ivi, c. 13r) e de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, c. 26r). I suoi costituti, del 17 marzo 1552, la sentenza e l’abiura sono ivi, b. 9, f. II, carte non numerate; copia dei costituti del 17 e altri del 19 marzo ivi, b. 158, f. III, cc. 57r-59v. Ivi, alle cc. 73r-74v e 79rv, c’è copia dell’abiura inframezzata da documenti relativi a de’ Colti, e alle cc. 81r-83r copia della sentenza. Dichiarò di essere figlio di Giacomo di Santa Corona di Vicenza e confessò, tra le altre cose, d’essersi fatto ribattezzare (da del Bon) e d’aver ritenuto che «Christo fusse puro homo nasciuto del seme di Ioseph et da Maria di legittimo matrimonio santo et ordinato da Dio». 91 Anch’egli prese parte ai colloqui vicentini secondo la testimonianza di Cingano (ivi, b. 158, f. II, c. 41v, dove ricordò «Alvisetto sartor»). Il suo nome fu fatto anche da de’ Colti (ivi, b. 11, f. III, c. 26r), da Beltramin (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate), da Perin del fabro (ivi, b. 158, f. IV, c. 13r) e dallo stringaro (ivi, c. 40v). 92 Secondo Ginzburg, I costituti, cit., p. 44 nota, potrebbe identificarsi con un
193
«Mattheo sartore zoppo» ricordato nei suoi costituti del 1556 dal sarto padovano «Iacopo sutor» (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 24, f. II, carte non numerate). Un «Mattheo sartor che sta in Vicenza», definito «un povero zotto», fu ricordato anche da Cingano (ivi, c. 81r, 7 maggio 1569). L’identificazione sembra certa, considerando l’identità di nome, città, mestiere, problema di deambulazione e ambiente frequentato, sebbene sia da evidenziare che negli stessi costituti di Cingano gli inquisitori gli fecero in più occasioni nomi di suoi vecchi complici come Matteo dalle Maddalene e Girolamo Speranza, rispetto ai quali non ebbe difficoltà ad ammettere che erano stati coinvolti nei processi contro gli anabattisti. Nel caso di questo Matteo, invece (quasi certamente per coprirlo essendo suo amico), disse che «non ho mai ragionato seco delle cose pertinente alla santa fede». In realtà, de’ Colti già dal 1551 aveva confessato che proprio in casa di Matteo era stato ribattezzato, «uno anno e mezzo» prima, da d’Alessandria e da Giacometto (ivi, b. 11, f. III, c. 28v). Il nome dello «zotto» fu fatto anche da Perin del fabro (ivi, b. 158, f. IV, c. 13r). 93 Ginzburg, I costituti, cit., pp. 43-44. 94 Ivi, p. 74. A un «Iacometto bottoner» si riferì anche Perin del fabro (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 13r). Francesco Bosato rivelò che «Iacopo dei bottoni [...] che fa bottoni» era di origine bolognese ed era stato tra i primi a farsi ribattezzare (ivi, f. II, c. 45r). Il fornaio Gian Giacomo di Forcini confermò che anche la moglie del «bottoner» era stata coinvolta nella setta, così come il cognato e la sua consorte (ivi, cc. 85v-86r). 95 Ivi, b. 158, f. II, cc. 35r (Cingano) e 44v (Bosato). Alle cc. 85r-88r un suo interrogatorio del 30 gennaio 1552 nel quale è descritto come «gobbo et zotto con barba nigra». Ammise di saper «lezer malamente» e di esser stato ribattezzato da de’ Colti (che lo conobbe poiché acquistava da lui il pane), che lo indusse a credere nella pura umanità di Cristo. Fu molto largo nel rivelare nomi di altri vicentini. Un «fornasier» fu evocato anche da Giacometto (ivi, f. IV, c. 41r). 96 Tutti costoro furono denunciati da «Iacopo sutor», che va anch’egli aggiunto al gruppo (fu ribattezzato da Giacometto) e che nel 1556 rivelò che dopo le abiure successive ai processi del 1551-55 la comunità vicentina aveva continuato a professare idee radicali: «Io ho sentito dire a Matteo dalle Maddalene, [nome non chiaro] sartore [e a] Iseppo Cingano che non credono nella Chiesa romana et che credono né più né manco come fanno gli annabattisti et come facevano avanti che abiurassero» (ivi, b. 24, f. II, carte non numerate). I nomi di Antonio marzaro e dello straccivendolo Matteo furono fatti anche da Cingano (ivi, b. 158, f. II, cc. 35r e 36r), che riferì della riunione a casa sua. A Francesco Carletto si riferì anche Matteo dalle Maddalene (ivi, b. 158, f. II, c. 77v) e potrebbe identificarsi con un «Francesco sensar» denunciato dal veronese Bartolomeo dalla Barba (ivi, f. III, c. 70r). «Hieronimo cimador zotto da Vicenza» fu ricordato anche da de’ Colti (ivi, f. II, c. 80r). 97 Ivi, f. II, c. 44v (costituto di F. Bosato). Ad Andrea cimador fece riferimento anche Matteo dalle Maddalene (ivi, c. 77v), che indicò in Antonio dal Ponte il bottaio ricordato da Bosato. 98 Ivi, f. III, c. 11v (costituto di M. Montanaro). Anche quest’ultimo, peraltro, ribattezzato da dal Borgo, fu tra gli anabattisti vicentini che aderirono alla svolta antitrinitaria e va, pertanto, aggiunto all’elenco: benché nativo dei dintorni, lavorava a Vicenza come tintore. 99 Ivi, f. II, cc. 35r, 39v, 41v (costituto di G. Cingano). I costituti di Bosato, ricchissimi di nomi, sono ivi, cc. 42v-46v. La sua abiura è ivi, cc. 55v-58r; l’assoluzio-
194
ne ivi, cc. 58r-59r. Il suo luogo d’origine, Breganze, è presso Vicenza. Il nome di «Giulio sartor» fu evocato da Giulio callegaro (ivi, b. 9, f. II, carte non numerate; ivi, b. 158, f. III, c. 57r). «Bernardin sartor» fu ribattezzato da Giacometto (ivi, b. 158, f. IV, c. 43v) e fu chiamato in causa anche da Bosato (ivi, f. II, cc. 44v-45r), che rivelò pure il nomignolo del «zotto senza piedi» e il fatto che anche il Gaspare fratello di «Iacomo sartor» esercitasse l’arte sarcitoria. Ad Alvisetto sartor e a Bernardin sartor si riferì anche Matteo dalle Maddalene (ivi, f. II, c. 77v), e «Alvise» fu ricordato pure da Giulio callegaro (ivi, f. III, c. 57r). 100 Ivi, b. 158, f. II, c. 64r (costituto di A. de’ Colti). Il suo problema di deambulazione fu evocato da Matteo dalle Maddalene (ivi, c. 78r). 101 Ginzburg, I costituti, cit., p. 44. 102 Sono parole del capitano di Vicenza (che rinviava ai costituti di Borgato), nella lettera in cui informava le autorità veneziane dei primi arresti compiuti a Vicenza (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 24, f. II, carte non numerate). Borgato era «compagno di quel Zuan Maria munaro» (ricordato anche da Beltramin, ivi, b. 9, f. II) ritenuto «esser uno de’ principali de questi ribaldi», che tuttavia era riuscito a sfuggire alla cattura. Né il capitano era riuscito a rintracciare uno dei figli di Tiziano, che era stato indicato come residente nelle ville di Vicenza. Trevisan inoltre dava conto alle autorità venete dell’arresto compiuto dall’Inquisizione di un «Zuan salcizaro, homo perfido et pessimo in questa setta», ritenuto anch’egli come «uno di principali de’ molti mecanici infetati di questa diabolica heresia». Il capitano lamentava che l’arresto del salsicciaio aveva messo altri sull’avviso, permettendone la fuga. Al salsicciaio fece riferimento anche Matteo dalle Maddalene includendolo, però, tra i «lutherani» (ivi, b. 158, f. II, c. 78r). 103 Si tratta del Silvio Rasonier ricordato prima. Nel suo rapporto alle autorità veneziane del dicembre 1551 il capitano Trevisan ammise che non «si po saper chi sii quel notato Silvio». 104 Ginzburg, I costituti, cit., p. 73. Conferma dei rapporti tra Silvio e del Bon nei costituti di quest’ultimo (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. III, cc. 33v-34r). Il cognome di Silvio risulta dalla testimonianza di Cingano, che lo disse «fiol di uno che faceva li rasoi» (ivi, f. II, c. 36v). Partecipò ai colloqui vicentini. 105 La citazione si concludeva così: «Aggionge di poi, che se alcuna fede fosse la vera, sarebbe l’anabattistica, si come quella che ha maggior colore di verità de tutte quante le altre» (G. da Milano, Esortazione al martirio [...], s.l. 1552, p. 145). Sull’Esortazione cfr. U. Rozzo, L’«Esortazione al martirio» di Giulio da Milano, in A. Pastore (a cura di), Riforma e società nei Grigioni. Valtellina e Valchiavenna tra ’500 e ’600, Milano 1991, pp. 63-88. 106 Ginzburg, I costituti, cit., p. 74. A «uno ridutto fora della città» fece riferimento anche Giuseppe Sartori, che parlò di una prima assemblea cui intervennero circa quattordici persone e di una seconda con sedici o diciotto presenti, oltre a riferire della presenza di Tiziano (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 58v). 107 Sartori (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 58v) testimoniò che «legevemo sopra el Testamento esortandosi uno con l’altro a star constanti et non se redir et ad aiutar el fratello, ché tutti si chiamavemo fratelli». Dalla deposizione emerge come ci fosse un clima di tensione che le esortazioni alla costanza e all’aiuto reciproco dovevano esorcizzare. 108 Ginzburg, I costituti, cit., p. 34. 109 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, cc. 37v-38r (costituti di G. Cingano, gennaio 1552).
195
110 Riguardo alla falsificazione delle scritture Manelfi confessò: «Noi anabattisti [si riferisce a un periodo successivo alla svolta antitrinitaria] non potemo tenere altri libri che la Scrittura sacra, la qual Scrittura Nova et Vecchia tutta accettiamo, escetto il primo et secondo capitolo dello evangelio di san Mattheo et il primo et secondo et parte del terzo capitolo di san Luca. [...] Per tre cause noi non accettiamo detti capitoli: la prima è perchè nei detti capi se dice Christo signore nostro essere nato de spirito santo, et noi volemo che sia nato di seme di Ioseph. La seconda perché quello solo è lo evangelio che si conforma con li propheti, et li detti capitoli secondo la dottrina nostra non si conformano con li propheti. La terza causa è perché nella epistola de san Hieronimo a papa Damaso ritrovamo che il detto pontefice comette a san Hieronimo de aggiungere, minuire, correggere li evangelii, et noi dicevamo che li detti capitoli erano delli aggiunti de san Hieronimo» (Ginzburg, I costituti, cit., pp. 63-64). 111 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, cc. 37r-37v. 112 A domanda degli inquisitori: «Della communion di beni dicono niente?» de’ Colti rispose: «C’è stato ben rasonato, ma non si sforza nesun; ognun può tener et galder il suo» (ivi, b. 11, f. III, c. 29r). 113 Secondo la testimonianza di Matteo dalle Maddalene (ivi, b. 158, f. II, cc. 78v-79r). 114 Ivi, f. III, cc. 33r-33v (costituto da M. del Bon). L’asolano specificò che anche a Ferrara Tiziano continuò a rifiutare la credenza nella pura umanità di Cristo e nella falsificazione dei vangeli. Conferma sulla celebrazione dell’incontro ferrarese nella testimonianza di Perin del fabro, che sembra fosse tra i pochi a non accettare la svolta antitrinitaria (ivi, f. IV, cc. 12v sgg., in particolare cc. 14v-15r). A una convergenza a Ferrara fece riferimento anche de’ Pasqualini (ivi, c. 2v). 115 Ivi, f. III, c. 33v (costituto di M. del Bon). 116 Cfr. ivi, b. 8, f. XXXI, carte non numerate. Il mandato di cattura è datato Venezia, 22 giugno 1550. Al ricovero pisano fece riferimento del Bon, che rivelò come a d’Alessandria fosse stato poi inviato Girolamo Speranza per invitarlo al concilio veneziano (ivi, b. 158, f. III, cc. 35v-36r). 117 «Gionse messer Paulo Beltramin, dicendomi che si dovessemo partir de lì [da Vicenza] perché era certo moto de persecution» (ivi, cc. 30v-31r). Il che i due compagni fecero subito, partendo con Giuseppe Sartori e recandosi a Ferrara passando prima da Mantova. A Ferrara presero «una camera a fitto et vi ritrovassemo Benetto da Borgo, el qual era venuto alhora de terra de Grisoni» (ivi, c. 31r). In seguito si recarono a Venezia per il concilio. 118 «Concilio» tendeva a definirlo Manelfi, mentre «sinodo» era vocabolo adoperato preferibilmente dagli inquisitori (che spesso parlavano anche di «congregatione», mentre per gli incontri padovani e vicentini usavano il termine «ridutti»); Manelfi stesso, però, usò anche il termine «sinodo». Considerando che i ministri delle comunità erano definiti vescovi e diaconi, non sarebbe sorprendente che proprio uno di questi vocaboli (concilio o sinodo) fosse stato adoperato dai partecipanti all’assemblea. 119 Manelfi (Ginzburg, I costituti, cit., p. 34) testimoniò che «per risolvere questo dubio [della divinità o meno di Cristo] concludessemo che si chiamasse tutti gli ministri delle congregationi de lochi a Venetia a concilio». Analoga giustificazione fornì de’ Colti (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 24, f. II, c. 3r, 29 dicembre 1551). Giuseppe Sartori disse che il concilio fu convocato «per esser stato scomunicato messer Benetto dalla giesia de Cittadella, perché l’haveva detto che Iesu Christo era na-
196
sciuto de matrimonio de Ioseph et de Maria, cioè nasciuto de copula, et per esser intravenuta tal dissension el fu fatto tal ridutto» (ivi, b. 158, f. IV, c. 36r). Il pellicciaio Pasqualin de’ Pasqualini confessò che «messer Agustin [Tealdo] maestro di scuola me disse che Benetto [dal Borgo] era cascato in una gran heresia che Christo non era nato de verginità de Maria, ma ch’el era fiol de Ioseph et ne disse che non dovesseno parlar con lui» (ivi, c. 2r). Subito dopo Pasqualin poneva il concilio di Venezia, al quale confessava d’aver partecipato (c. 2v). Rispetto alla posizione di Tealdo, anche Manelfi (p. 79) notò come «in Citadella [...] vi è ministro maestro Agostino, non so di che luoco, sfratato, non so di che ordine, et costui non ha voluto accettare la dottrina nova determinata nella sinodo già fatta in Venetia». Sul maestro di scuola e leader anabattista (probabilmente non «sfratato» come lo voleva Manelfi) Agostino Tealdo e più in generale sulla comunità di Cittadella cfr. E. Zille, Gli eretici a Cittadella nel Cinquecento, Cittadella 1971. 120 Ginzburg, I costituti, cit., p. 63. 121 Gian Ludovico «bronzier», ministro della comunità di Badia Polesine (Rovigo), convertito insieme con altri compaesani da dal Borgo, partecipò al concilio e testimoniò il 6 febbraio del 1552 che a Venezia «li ragionamenti nostri forno cercha alle cose della fede, ragionassemo quello che chadauno credeva et restassemo tutti in uno medemo creder, come è che tutti credevemo in uno solo Idio, credevemo uno solo Iesu Christo nostro mediator suo figliolo et nostro redentor nato morto et resuscitato secondo le promesse fatte da Idio, una sola Giesia, et restassemo in questo che Iesu Christo sia nato huomo del seme di Iosephe de matrimonio» (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, cc. 96r e 98v). Conferma su alcuni aspetti (umanità di Cristo e falsificazione dei vangeli) anche dai costituti di del Bon (ivi, b. 158, f. III, cc. 23v sgg.). Al problema dell’umanità di Cristo fecero pure riferimento de’ Pasqualini (ivi, f. IV, c. 2v) e Matteo dalle Maddalene (ivi, f. II, c. 77r), che diede conferma del fatto che al concilio avevano partecipato due persone per ogni Chiesa così come dichiarato da Manelfi, ma indicando i partecipanti di cui gli aveva parlato Giacometto (presente a Venezia), fece riferimento ad almeno tre asolani (dal Borgo, del Bon e Beltramin), e gli stessi tre furono ricordati anche dal «bronzier» (c. 98r). Pure de’ Pasqualin ammise di aver preso parte all’assemblea, sicché il numero degli asolani andrebbe elevato almeno a quattro. 122 Ginzburg, I costituti, cit., pp. 34-35. 123 D’altra parte fu Manelfi stesso a ricordare la circolazione delle Cento e dieci divine considerazioni di Valdés negli ambienti del radicalismo del Nord-Est (ivi, pp. 26 e 58-59). 124 Sembra infatti che Tiziano si rifugiasse in seguito nuovamente nei Grigioni e che, arrestato di nuovo, nel 1554 confessasse di aver aderito alla dottrina antitrinitaria, oltre a ribadire le «antique opinioni» (P.D. Rosio de Porta, Historia Reformationis Ecclesiarum Raeticarum [...], vol. I, Curiae Raetorum et Lindaviae 1772, pp. 78-80). 125 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. III, c. 25r (costituto di B. Busale). 126 Ivi, b. 158, f. IV, c. 43v. 127 Sul processo e la condanna di dal Borgo cfr. Stella, Dall’anabattismo all’antitrinitarismo, cit., pp. 72-79. In ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 6, f. V, nell’abiura di Francesco Sartori (1551) si fa riferimento al fatto che Benedetto era stato «abrusiato a Rhovigo per heretico». Ad analoga notizia fanno riferimento del Bon (ivi, b. 158, f. III, c. 30r) e altre testimonianze. Nella b. 9, f. II, c’è una lettera datata 10 marzo 1551 in cui si parla del suo arresto (di cui lo scrivente dice d’esser venuto a
197
conoscenza tre giorni prima) e due altre datate 9 giugno e 19 novembre 1550 in cui si parla di un ordine di cattura spiccato nei confronti non solo di Benedetto ma anche di suo fratello Antonio, di Paolo Beltramin, Marcantonio del Bon, Giuseppe Sartori, Pasqualin de’ Pasqualini e Perino (o Perin o Piero) del fabro (o del favro), qui più volte ricordato e che Ginzburg, I costituti, cit., p. 50 nota, identifica in un «Piero figliolo di Marc’Antonio mareschalco». In ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, cc. 11r e 12r sgg., vi sono vari costituti di un Perin calegaro di Asolo, figlio di «Zuanantonii favro da Asolo», ed è certamente questo calzolaio il personaggio in questione. 128 Secondo Manelfi (Ginzburg, I costituti, cit., p. 71) nei confronti di Busale era stato spiccato mandato di cattura dall’Inquisizione, al quale, però, era riuscito a sottrarsi grazie a un avvertimento: «Io so che a noi fu revelato quando la Signoria illustrissima volse fare pigliare in Padoa lo abbate Hieronimo sudetto et altri». Nessuna traccia è stato possibile trovare di tale mandato di arresto. Forse si riferisce a Busale un ordine del Sant’Ufficio romano, del 13 luglio 1553, contro un «frater Hieronimus, Calaber», negli stessi giorni in cui furono arrestati i suoi fratelli Prospero e Matteo insieme alla madre e alle sorelle (ACDF, Stanza storica, Decreta, I, c. 111v). 129 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 8, f. XXXII, carte non numerate. La citazione nel fascicolo relativo a Francesco Sartori (arrestato nel febbraio) in una comunicazione datata 21 febbraio 1551 in cui si denunciano le eresie degli asolani. Poche carte più oltre, immediatamente prima di un documento datato 23 febbraio, si trova un elenco delle eresie imputate ai ricercati: a parte le opinioni luterane radicalizzate dalla negazione degli altri sacramenti, si dice che «hanno avuto ardimento di dire che san Ioseph, sposo della Nostra Donna era un bel zoveno, volendo inferir ch’el nostro signor Iesu Christo non esser nato di Maria vergine». Le notizie furono confermate da Francesco Sartori. Ma già nell’estate del 1550 (si ricordi che in giugno era stato spiccato ordine di cattura contro d’Alessandria), gli inquisitori avevano potuto trarre elementi sulle sette del Nord-Est dai costituti del vicentino Giovan Maria Bagozzo (del 26 e 29 luglio 1550, cfr. ivi, b. 8, f. XI, carte non numerate), dai quali emersero notizie sul ribattesimo e sul proselitismo anabattista a Vicenza. Chiaramente, considerando che proprio in quell’estate maturò la svolta antitrinitaria, nessun riferimento ad essa v’è nei costituti di Bagozzo. 130 Cfr. ivi, b. 6, f. V, c. 4r (costituti di G.M. Beato, 10 dicembre 1551). Il rodigino diede anche ulteriori riferimenti sulle letture che si facevano in quel mondo: oltre alla Bibbia, «l’Enchiridion d’Herasmo, il Beneficio di Cristo et uno trattato d’orazione del cardinale Fregoso». Il riferimento a Fregoso è al suo postumo Pio et christianissimo trattato della orazione uscito nel 1543 a Venezia. Quanto al Beneficio, Antonio dal Borgo ammise di averlo letto già nel 1547 (ivi, c. 10r). 131 Sono parole del nunzio Lodovico Beccadelli in una lettera al cardinale Innocenzo Del Monte, del 19 dicembre 1551, in cui gli annunciava l’avvio della retata (F. Gaeta, a cura di, Nunziature di Venezia, vol. V, 21 marzo 1550-26 dicembre 1551, Roma 1967, p. 330). Tra gli arrestati, Bruno Busale, Giuseppe Cingano, Alvise de’ Colti, Bartolomeo dalla Barba. 132 Ginzburg, I costituti, cit., p. 66. 133 Su Giorgio Biandrata cfr. la voce di A. Rotondò, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. X, Roma 1968, pp. 257-64. Cfr. inoltre Id., Studi di storia ereticale del Cinquecento, 2 voll., Firenze 2008; D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti, a cura di A. Prosperi, Torino 1992; A. Pirnát, Il martire e l’uomo po-
198
litico (Ferenc Dávid e Biandrata), in R. Dán, A. Pirnát (a cura di), Antitrinitarianism in the Second Half of the 16th Century, Budapest-Leiden 1982, pp. 157-90; la prefazione di Pirnát alla ristampa anastatica del De falsa et vera unius Dei patris, filii, et spiritus sancti cognitione libri duo [...] (1568), a cura di A. Pirnát, Utrecht-Budapest 1988; M. Balázs, Early Transilvanian Antitrinitarianism (1566-1571). From Servet to Palaeologus, Baden Baden-Bouxwiller 1996. 134 Tra gli studi recenti su Gribaldi cfr. D. Quaglioni, «Iis, qui vix usquam locum tutum inveniunt». Giuristi, riformatori religiosi, fuorusciti. Matteo Gribaldi Mofa (†1564), in «Laboratoire Italien. Politique et Société», III, 2002, pp. 79-92; dello stesso Quaglioni cfr. la voce redatta per il Dizionario biografico degli Italiani, vol. LIX, Roma 2002, pp. 345-49. Ma cfr. il profilo di F. Ruffini (1928), in Id., Studi sui riformatori italiani, Torino 1955, pp. 45-140; Cantimori, Eretici italiani, cit.; Rotondò, Studi di storia ereticale, cit.; U. Plath, Nocheinmal «Lyncurius». Einige Gedanken zu Gribaldi, Curione, Calvin und Servet, in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», XXXI, 1969, pp. 583-610; Id., Calvin und Basel in den Jahren 15521556, Basel-Stuttgart 1974, pp. 154-63; C. Gilly, Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistesgeschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt, Basel-Frankurt am Main 1985, pp. 298-318. Diversi riferimenti, tutti datati 1550, sono in E. Martellozzo Forin (a cura di), Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini, vol. III, tomo 3, Padova 1971, pp. 383-84, 397, 401-402, 407-10, 412, 416. 135 Sul caso Spiera (e sull’intervento di Gribaldi) cfr. A. Prosperi, L’eresia del libro grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta (2000), Milano 2001, pp. 102 sgg. Il testo del giurista uscì nel 1549 (ma datato Padova, 27 novembre 1548). 136 Gribaldi a Calvino, idibus novembris 1549, in I. Calvini Opera quae supersunt omnia, vol. XIII, Brunsvigae 1875, coll. 447-48. 137 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 159, c. 63v (testimonianza di fra’ Antonino Barges, incartamento relativo ai processi 1554-55, 4 dicembre 1554). In un memoriale dello stesso Barges che pare successivo (ivi, b. 8, f. XXIII, in L. Perini, Ancora sul libraio-tipografo Pietro Perna e su alcune figure di eretici italiani in rapporto con lui negli anni 1549-1555, in «Nuova Rivista storica», LI, 1967, pp. 370-71) sono riferite altre specificazioni: «Quando io andai in Geneva, io vi andai con il Gribaldo, il quale mi aveva inpromesso darmi uno suo castello a fito, et così in Padua cum duo frati sfratati de la charità, uno de Ferara, deto Anibale [Gormo] et l’altro messer Francesco [Scudieri], non so di qual loco fusse, ma stava in la charità in Venetia, il quale si fermò di poi in Padua in casa de li Bucella, dicendo que bene potesse vivere da luterano in Padua, sensa andar in Geneva; et [così] fra loro dua frati partirno la elemosina che li aveva dato madama da Ferrara. Aniballe et io andammo cum il Gribaldo, avendo auto lui nostri denari, insino in Geneva [...]. Que il Gribaldo sia luterano la cosa è certa et lui non lo nega, et con quanti lui ragiona de la religione [...] si fa conoscer per tale sensa rispeto; et in Geneva, Basilea, Chiavena, per tuto, si ha per tale, ben que al presente molti di queli luterani e maxime di Geneva, come è il Calvino, il conte Celso Martinengo da Bressa, gli voleno male, perché lui tene la openione di Christo che teneva il Serveto, che fu brussato in Geneva vivo da li luterani lo ano passato, o pocho più che fu che non mi ricordo». 138 P. Paschini, Venezia e l’Inquisizione romana da Giulio III a Pio IV, Padova 1959, p. 43. 139 ACDF, Stanza storica, Decreta, I, 16 agosto 1552, c. 77r: «Macteus Gribaldus: scribatur ad nuntium Venetiis et certioretur de omnibus ut procedat contra
199
eum». Ivi, in data 23 aprile 1555 (c. 146r), Gribaldi compare di nuovo, ma null’altro vi si legge fuorché il suo nome. La data del decreto è, tuttavia, significativa. Secondo Ruffini, infatti, Gribaldi fu costretto a lasciare l’università (e l’Italia) il 22 aprile del 1555 non più sicuro «ob monachorum insidias». Sebbene Ruffini non potesse conoscere (per la chiusura degli archivi dell’Inquisizione romana) la precedente indagine avviata già nel 1552, non può non notarsi la coincidenza di date tra il secondo decreto inquisitoriale e la sua ricostruzione. 140 [S. Castellion], Contra libellum Calvini in quo ostendere conatur haereticos jure gladii coercendos esse, [Olanda 1612], p. 25. 141 La lettera (che è presso la Universitätsbibliothek di Basilea) è stata edita, con datazione al 1560, da L. Perini, Note e documenti su Pietro Perna libraio-tipografo a Basilea, in «Nuova Rivista storica», L, 1966, p. 162: «Dico, cum in hanc urbem venissem ante octo annos Hieronymum Massarium Italum [...] dedisse mihi mutuo non petenti vel scienti opus illius nefandae memoriae Serveti sesquiheretici, cui titulus erat De erroribus trinitatis, cum quibusdam similis argumenti Dialogis, quem legi et Deo auxiliante cognovi qualis esset, ac restitui illimet. Quem cum non probarem sed acriter reprehenderem, ille volens mihi persuadere haereses illas, allegavit mihi ospitem [sic!] suum apud quem triennio fuit, et Petrum Pernam, qui multa exemplaria talia distraxerit hinc inde, et inter alios unum dederit Gribaldo iurisconsulto, qui eo perlecto dixerit haec verba: nunquam cognovi quid esset Christus, nisi Serveto lecto et ipsum postea semper etiam in publicis lectionibus Patavii valde laudabat, dicens dictum esse Servetum a servando veram doctrinam et ibi reliquit etiam sectam aliquam talem occultam». Al di là della datazione della lettera, la testimonianza pare riferirsi a fatti avvenuti prima del rogo di Servet. 142 «Quando monsignor Gribaldo era in Padova, hebbi sua amicitia per mezo d’un suo figliastro studiante, dimandato messer Cesare, il qual di musica molto si dilettava, et due figliole del Gribaldo piccole, le quai imparavano, et così alle volte cantavamo insieme; hora, intendendo da alchuni ch’il detto Gribaldo negava la trinitade et parendomi duro a crederlo, me ne volsi certare et domandatolo, mi confessò ingenuamente il tutto et che faccevamo quatro et cinque Dei et non un Dio solo, come c’insegna la sacra Scrittura et confessa la santa et catholica Chiesa; et duo Christi, non uno Christo. Uno passivo, l’altro impassivo: questo mortale, quello immortale, etc.», seguiva una ricostruzione del dialogo avuto da Scudieri con Gribaldi che proseguiva con il giurista che «affirmava havere in sua sentenza Ignatio, Hyreneo, Tertulliano, Lattantio et molti altri antiqui, gli quai mi mostrerebbe s’io volessi. Io gli dissi che non mi curava, et ch’haveva altro che fare. [...] Mi diede [...] uno libretto piccolo a stampa il qual era suo di compositione, quanto intesi da un monsignor polacho, ma era intitolato di Servetto». Estratto dal processo contro Scudieri (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 15, carte non numerate), in Perini, Ancora sul libraio-tipografo, cit., pp. 395-404. Scudieri affermò anche di aver frequentato Lelio Sozzini, Dario Senese e un bresciano «della setta di Georgio» Siculo. 143 M. Firpo, Antitrinitari nell’Europa orientale del ’500. Nuovi testi di Szymon Budny, Niccolò Paruta e Iacopo Paleologo, Firenze 1977, p. 194. 144 Su Alciati cfr. A. Pascal, Gli antitrinitari piemontesi. La vita e le dottrine di G. Paolo Alciati, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXII, 1920, pp. 3-62; Id., Processo contro Paolo Alciati signor della Motta, ivi, XXIII, 1921, pp. 3664; S. Kot, Le mouvement antritrinitaire au XVIe et XVIIe siècle, Paris 1937; Cantimori, Eretici italiani, cit.; D. Caccamo, Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transil-
200
vania (1558-1611). Studi e documenti (1970), Firenze 1999; V. Marchetti, La storiografia ungherese sul rapporto tra la critica antitrinitiaria sozziniana e le origini dell’unitarismo transilvano del Cinquecento, in «Archivio storico italiano», CXXVIII, 1970, pp. 361-405; Rotondò, Studi di storia ereticale, cit.; Firpo, Antitrinitari, cit.; Balázs, Early Transylvanian Antitrinitarianism, cit. 145 Su Negri cfr. G. Zucchini, Francesco Negri a Chiavenna e in Polonia, in «Clavenna», XVII, 1978, pp. 3-10 e i diversi lavori di E. B. Barbieri, tra cui Note sulla fortuna europea della «Tragedia del libero arbitrio» di Francesco Negri da Bassano, in S. Peyronel Rambaldi (a cura di), Circolazione di uomini e d’idee tra Italia ed Europa nell’età della Controriforma, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 181, 1997, pp. 107-40; Id., Pier Paolo Vergerio e Francesco Negri: tra storia, storiografia e intertestualità, in U. Rozzo (a cura di), Pier Paolo Vergerio il giovane, un polemista attraverso l’Europa del Cinquecento, Udine 2000, pp. 239-76. 146 Ma tracce che suggeriscono una critica di Valdés al pedobattesimo paiono emergere dalla CIV delle Cento e dieci divine considerazioni, cit., pp. 448-50: «Potria ben Dio salvarci nel dì del giudizio senza l’acqua del battesimo, e pare che pigli per mezzo l’acqua per condescendere alla nostra fragilità, la quale fa che più facilmente crediamo d’essere salvi per il battesimo, che non crediamo di doversi salvare senza il battesimo, se bene non ci fidiamo nell’acqua ma nella parola dell’evangelio di Dio, che promette di salvarci per il battesimo, e così saremo salvi nel giudizio universale, non perché ci battezziamo ma per la fede con la quale ci battezziamo» (p. 449). 147 Sulla quale cfr. G.H. Williams, The Radical Reformation (1962), Kirskville (Missouri) 1992, pp. 137-74. 148 Sul tragico esperimento di Münster del 1534-35 cfr. ivi, pp. 553-82; Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, pp. 520-76. 149 Ricondotte a dissimulazione le pose profetiche di Busale, sembra difficile immaginare un valdesiano convinto come Melchior Hoffmann di essere il profeta Elia o come Jan Matthijs di essere il profeta Enoch. 150 «De paedobaptismo, quem derepente proscriptum audio, nunc quid sentiam scribere non possum. [...] Scis anabaptistarum nomen omnibus invisum fuisse esseque et omnem doctrinam suspectam» (M. Sipayłło, a cura di, Akta Synodów Róz´nowierczych w Polsce, vol. II, Warsawa 1972, p. 358). 151 Cfr. Kot, Le mouvement antitrinitaire, cit.; S. Cynarski (a cura di), Raków ognisko arianizmu, Kraków 1968; Firpo, Antitrinitari, cit.; L. Szczucki, The Beginnings of Antitrinitarian Anabaptism in Lithuania and Poland in the Light of a So-far Unknown Source, in J.-G. Rott, S.L. Verheus (a cura di), Anabaptistes et dissidents au XVIe siècle, Baden-Baden-Bouxwiller 1987, pp. 343-58; Id., Fausto Sozzini in Polonia 1579-1604, in L. Szczucki (a cura di), Faustus Socinus and His Heritage, Kraków 2005, pp. 113-28. Il De baptismo aquae disputatio è in F. Socini, Opera omnia in duos tomos distincta, vol. I, Irenopoli [Amsterdam], post annum Domini 1656, pp. 709-38. 152 Cfr. Williams, The Radical Reformation, cit., pp. 589-600 e passim; Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. II, pp. 24-67 e passim. 153 Cfr. Williams, The Radical Reformation, cit., pp. 638-57 e passim; Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. II, pp. 473-529 e passim. 154 L’anabattismo non può ridursi ai sette articoli: personalità come Hans Denck o David Joris dimostrano come ogni rigidità classificatoria sfumi la complessità del reale. Tuttavia, Denck e Joris vengono di norma inseriti in un sottotipo di anabattismo pregno di spiritualismo, se non proprio al di fuori dell’anabattismo stesso.
201
Cfr. Williams, The Radical Reformation, cit., pp. 248-63 e passim (Denck) e 724-31 e passim (Joris); Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, pp. 230-43 e passim (Denck), mentre per Joris cfr. vol. II, pp. 20-24, 38-48 e passim. Su Joris cfr. inoltre il capitolo a lui dedicato in R.H. Bainton, La lotta per la libertà religiosa (1951), Bologna 1972, pp. 123-46, che sintetizza Id., David Joris Wiedertäufer und Kämpfer für Toleranz im 16. Jahrhundert, Leipzig 1937; e G.K. Waite, David Joris and Dutch Anabaptism 1524-1543, Waterloo (Canada) 1990. Per quanto riguarda gli articoli di Schleitheim cfr. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, pp. 216-20; il testo in italiano in J. Macek, La riforma popolare, Firenze 1973, pp. 73-81. 155 Cfr. Brieve instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes (1544), in I. Calvini Opera omnia denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, series IV, vol. II, a cura di M. van Veen, Genève 2007; ma fra gli oppositori dell’anabattismo va ricordato anche Bullinger (cfr. H. Fast, Heinrich Bullinger und die Taüfer. Ein Beitrag zur Historiographie und Theologie im 16. Jahrhundert, Weierhof 1959). Alcuni concetti dei sette articoli, la Chiesa separata, il distacco dalla vita pubblica, la scomunica, il ribattesimo degli adulti, lo stretto biblicismo, il rifiuto della spada, erano già presenti nelle dottrine degli oppositori di Zwingli a Zurigo – i cosiddetti Fratelli svizzeri, come Konrad Grebel e Felix Mantz – e percorreranno tutto l’anabattismo cinque-seicentesco incluso quello veneto. Se dalla revisione della storiografia mennonita fino agli anni Settanta del Novecento era prevalsa la tendenza a distinguere la versione svizzera dell’anabattismo da quella tedesca – identificata in Thomas Müntzer, nei cosiddetti «profeti di Zwickau» (Nikolaus Storch, Thomas Drechsel e Markus Stübner) e nella rivolta dei contadini –, vari studi hanno poi mostrato legami più stretti di quanto ipotizzato dalla storiografia mennonita. 156 Macek, La riforma popolare, cit., pp. 74-75. 157 Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, p. 207, ma il termine «libertinismo» affiancato a «spiritualismo» è presente in tutta l’opera senza alcun tentativo di definizione. 158 Fra gli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta da Strasburgo passarono molti protagonisti del radicalismo europeo: anabattisti sia rivoluzionari che spirituali, epicurei, antitrinitari, nicodemiti, mistici, personalità inclassificabili. Si possono ricordare Andreas Karlstadt, Otto Brunfels, Jacques Lefèvre d’Étaples, Hans Denck, Sebastian Franck, Miguel Servet, Melchior Hoffmann, Johannes Campanus, Kaspar Schwenckfeld, Martin Borrhaus (Cellarius). Cfr. C. Ginzburg, Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del ’500, Torino 1970, pp. 85-90, 108-12 e passim; Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, pp. 261-308; L. Felici, Tra riforma ed eresia. La giovinezza di Martin Borrhaus (1499-1528), Firenze 1995, pp. 97-112 e passim; M. Lienhard (a cura di), Les débuts et les caractéristiques de l’Anabaptisme, The Hague 1977; Id. (a cura di), Croyants et sceptiques au XVIe siècle. Le dossier des «Épicuriens», Strasbourg 1981; Rott, Verheus (a cura di), Anabaptistes et dissidents, cit. 159 Macek, La riforma popolare, cit., pp. 75-76. Il testo proseguiva prescrivendo: «Questi devono essere ammoniti per due volte segretamente e la terza volta vanno pubblicamente ammoniti davanti a tutta la comunità o vanno sbanditi secondo il comandamento di Cristo». 160 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. II, c. 69rv (costituti di M. dalle Maddalene). 161 Cfr. Firpo, Antitrinitari, cit.; Id., Il problema della tolleranza religiosa nell’età
202
moderna. Dalla Riforma protestante a Locke (1978), Torino 1983; R.H. Williams, The Christological Issues between Francis Dávid and Faustus Socinus during the Disputation on the Invocation of Christ, 1578-1579, in Dán, Pirnát (a cura di), Antitrinitarianism, cit., pp. 287-322; Balázs, Early Transylvanian Antitrinitarianism, cit. 162 Così scriveva al cardinale Gonzaga il 1° dicembre 1535 (J. Montesinos, a cura di, Cartas inéditas de Juan de Valdés al cardenal Gonzaga, Madrid 1931, p. 62). 163 ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 11, f. IV, carte non numerate. 164 Al riguardo andrebbero sviluppate le notazioni di F. Gui, La Riforma nei circoli aristocratici italiani, in S. Peyronel Rambaldi (a cura di), Cinquant’anni di storiografia italiana sulla Riforma e i movimenti ereticali in Italia 1950-2000, Torino 2002, pp. 69-124, che lega le vicende religiose dei valdesiani alle trame socio-politiche. Cfr. anche Id., L’attesa del Concilio. Vittoria Colonna e Reginald Pole nel movimento degli «spirituali», Roma 1998. 165 Sosteneva la dottrina del sonno delle anime Karlstadt e lo stesso Lutero in un primo momento ne era stato attratto (cfr. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, pp. 50-51 e nota, che ricorda come tale dottrina fosse caratteristica del radicalismo italiano, ma anche tipica del taborismo). Quanto a quelli che più propriamente possono definirsi anabattisti, salvo casi che difficilmente possono classificarsi sic et simpliciter per tali, come Karlstadt stesso o Camillo Renato (ma anche Francesco Renato e altri coevi agitatori dei Grigioni), non sono numerose le tracce esplicite di adesione a tale visione, che non emergeva espressamente, del resto, dalla Confessione di Schleitheim. Tuttavia, poco prima degli incontri veneti Calvino incluse nel suo attacco contro gli anabattisti del 1544 (fondato sulla confutazione dei sette articoli) un suo precedente scritto, rivolto a confutare la dottrina del sonno delle anime (poi riedito autonomamente come Psychopannychia nel 1545) che, secondo lui, «les anabaptistes tiennent tous communement». Il problema andrebbe approfondito ma cfr. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. II, p. 409 e note; Williams, The Radical Reformation, cit., ad indicem: psychopannychism; immortality of the soul; mortalism; soul-sleep; thnetopsychism; G. Ricuperati, Il problema della corporeità dell’anima dai libertini ai deisti, in S. Bertelli (a cura di), Il libertinismo in Europa, Milano-Napoli 1980, pp. 369-415. Non mancano ulteriori testimonianze della circolazione di queste idee in Italia in anni successivi. Nella Tavola delli inquisitori del molto reverendo padre fra Cipriano Uberti dell’ordine de’ predicatori inquisitore di Vercelli, d’Ivrea e d’Agosta Pretoria (1586), edita da P. Simoncelli, Inquisizione romana e Riforma in Italia, in «Rivista storica italiana», C, 1988, pp. 5125, a p. 124 si ricorda l’operato dello stesso Uberti, «sotto il quale fu confutata l’heresia nova di coloro che dicevano niuno ha da entrare in paradiso sino al giorno del giuditio». In C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ’500, Torino 1976, pp. 136-38 e passim, è evocato il caso del mugnaio Pellegrino Baroni, detto Pighino «el grasso», residente a Savignano sul Panaro, che fu processato nel 1570 poiché credeva che «non vi fusse inferno né purgatorio, e che erano inventione de preti e frati per guadagnare», che «morto il corpo morta l’anima» e che «tutte le fedi erano buone». 166 Ma sarebbe necessario istituire un confronto analitico. Sulla poligamia a Münster cfr. Gastaldi, Storia dell’anabattismo, cit., vol. I, pp. 543-46. Per quanto riguarda Ochino cfr. i suoi Dialogi XXX, 2 voll., Basileae 1563, vol. II, pp. 186-227. 167 Una distinzione tra forme diverse di radicalismo e in specie fra tendenze spiritualistiche e anabattistiche fu evidenziata, già tra fine Ottocento e inizi Novecento, negli studi dedicati a personaggi come Franck, Hoffmann, Joris e altri radicali
203
da A. Hegler. Successivamente E. Troeltsch, Le dottrine sociali della Chiesa e dei gruppi cristiani (1912), 2 voll., Firenze 1941-60 propose su basi sociologiche la tripartizione in Chiese, sette e mistici o spirituali. Nondimeno le differenziazioni si affermarono soltanto nel secondo dopoguerra: emblematica è la posizione di Cantimori, Eretici italiani, cit., che adoperò una nozione di anabattismo comprendente tutto l’arco dei suoi eretici: anabattisti in senso proprio (pochi in verità) e antitrinitari; una generalizzazione che lo accomunava a studiosi come E.M. Wilbur e S. Dunin-Borkowski. La differenziazione si è venuta imponendo grazie a studiosi come H.S. Bender e soprattutto R.H. Bainton e G.H. Williams. Il primo, in La riforma protestante (1952), Torino 1994, ha separato gli anabattisti da quelli che ha definito gli «spiriti liberi» (free spirits), mentre Williams, The Radical Reformation, cit., ha proposto una tipologia tripartita – comprendente gli anabattisti, gli spiritualisti e i razionalisti evangelici –, a sua volta suddivisa in diversi sottotipi. Relativamente alla tipologia di Williams e alle rigide caratterizzazioni dell’anabattismo in senso mennonita di Bender e altri ha avanzato sode obiezioni A. Rotondò, I movimenti ereticali nell’Europa del Cinquecento (1961), in Id., Studi di storia ereticale, cit., vol. I, pp. 1-43, che pur rimarcando la necessità di distinguere all’interno delle correnti radicali ha dimostrato come per i mennoniti le distinzioni derivassero da esigenze confessionali ed evidenziato quanto le tipologie alla Williams forzassero una realtà più fluida. Successivamente Rotondò avrebbe contraddetto tali avvertenze metodologiche, proponendo una rigida distinzione all’interno dell’antitrinitarismo (pre e post-sociniano) in Calvino e gli antitrinitari italiani (1968), ivi, vol. I, pp. 297-321. Nella più recente edizione delle Opere di Sozzini, invece, si registra un parziale ritorno al primo Rotondò. 168 Su Renato cfr. G.H. Williams, Camillo Renato (c. 1500-?1575), in J. Tedeschi (a cura di), Italian Reformation Studies in Honor of Laelius Socinus, Firenze 1965, pp. 105-83; A. Rotondò, Per la storia dell’eresia a Bologna nel secolo XVI (1962), in Id., Studi di storia ereticale, cit., vol. I, pp. 249-95; Renato, Opere, cit. 169 Cfr. Prosperi, L’eresia del libro grande, cit., p. 232. Su Siculo cfr. anche C. Ginzburg, Due note sul profetismo cinquecentesco, in «Rivista storica italiana», LXXVIII, 1966, pp. 184-227; Id., Il nicodemismo, cit., pp. 170 sgg.; B. Collett, Italian Benedictine Scholars and the Reformation. The Congregation of Santa Giustina of Padua, Oxford 1985, pp. 213-45 e passim. 170 Antonio da Bozzolo confessò che «il credere tre persone in un Dio et che Christo sia realmente nel saccramento dell’altare, et credere al simbolo d’Athanasio, sono certe cose simili alle consuetudini delli infedeli et increduli della christiana verità», ma aggiunse «che il padre, el figlio et il spirito santo in divinis sono tre signori et no un solo signore» (Ginzburg, Due note, cit., p. 217). 171 Né Prosperi (L’eresia del libro grande, cit., pp. 263-77 e passim) né Ginzburg (Due note, cit., p. 189 e nota) paiono dar peso a questa essenziale differenza. Ginzburg deduce la credenza nell’inesistenza dell’inferno in Siculo e nei suoi seguaci dall’abiura di Antonio da Bozzolo e da un passo dell’Epistola di Georgio Siculo [...] alli cittadini di Riva di Trento contra il mendatio di Francesco Spiera, et false dottrina di protestanti, Bologna 1550, p. 16rv, nel quale il siciliano si riferiva tuttavia solo alla morte fisica, cui sarebbe seguita la «dormicione», mentre nel momento del giudizio universale i malvagi sarebbero stati «iustamente condannati nel stagno del fuoco infernale, quod est mors secunda»: «Non solamente sarano privati della patria celeste et della christiana redentione, ma crudelmente condennati nella morte seconda, che seranno le pene infernali eterne» (p. 17r). Identica pare anche la dottrina confessata
204
da Antonio da Bozzolo, dal ferrarese Nascimbene Nascimbeni e, sulla base di quanto riporta Prosperi, da Francesco Severi. Antonio da Bozzolo confessò di ritenere «che li demoni et l’anime de dannati non sono nel fuoco infernale [...], ma fra tanto vanno vagando per questo aere caliginoso sino al dì del giuditio, che all’hora saranno condannate al fuoco infernale»; e Nascimbeni ricordò tra le sue eresie che «animas impiorum non adhuc in inferno poenis affligi, verum in aere caliginoso, et reservari post resurrectionem iudicii cum diabolo et angelis eius igne perpetuo cruciandas» (Ginzburg, Due note, cit., pp. 216 e 219). Il che non esclude che altre fossero le dottrine professate da Siculo nel perduto «Libro grande», ma le testimonianze ricordate paiono smentirlo. 172 Ginzburg, Il nicodemismo, cit., p. 178; Prosperi, L’eresia del libro grande, cit., pp. 197 e 209-10. Su Bresciani e sui rapporti con la cerchia di Renata di Valois del medico e di altri radicali si sofferma anche E. Belligni, Evangelismo, Riforma ginevrina e nicodemismo. L’esperienza religiosa di Renata di Francia, Cosenza 2008, pp. 239-42. Costituto e abiura di Bresciani (Bologna, 18 gennaio e 10 aprile 1552), con l’ammissione di aver avuto rapporti col Siculo, sono in F. Chabod, Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti (1938), in Id., Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V, Torino 1971, pp. 41215 (cfr. anche ivi, pp. 337-41, 344-46 e passim); i documenti che collocano Bresciani nell’ambito dell’anabattismo dei Grigioni sono in Renato, Opere, cit., pp. 223 e 229, dove nella succitata lettera di Mainardi a Bullinger è affiancato a Camillo Renato e a Tiziano; cfr. anche ivi, pp. 322 e 325. Conferma alle accuse di Mainardi fornì Giovan Battista Tabachin, che confessò di esser stato ribattezzato nei Grigioni da «Piero Casalmazor de Cremona» (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 49v). È da sottolineare come Tabachin (successivamente incline all’antitrinitarismo) fosse inizialmente legato a Tiziano, con il quale giunse a Vicenza per fare opera di propaganda. Riferendosi a Tabachin Giacometto stringaro disse: «Vene a Vicenza con uno Ticiano, et tuti dui andavano insegnando queste dottrine [anabattistiche]» (ivi, c. 40r). 173 Sul legame di Pagano con i radicali del Nord-Est cfr. ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 158, f. IV, c. 56v (costituti di G. Sartori). Riferendo del viaggio compiuto a Firenze agli inizi del 1550 l’asolano aggiunse che egli, Tiziano e de’ Colti si erano spostati «per ritrovar don Antonio capellano della duchessa de Ferara qual era scappato da Ferara per paura de esser preso per heretico». Per i rapporti con la cerchia di Renata di Francia cfr. Belligni, Evangelismo, Riforma ginevrina e nicodemismo, cit., p. 240. 174 Antonio da Bozzolo affermò di ritenere «che li signori temporali non debbono permettere che ne i suoi dominii sia giudicato secondo le leggi canoniche o civili, ma si debbono fare li giuditii secondo li precetti giudiciali della legge mosaica, et che li dottori et quelli che hanno detto la legge mosaica essere abrogata, quanto alli precetti giudiciali sono ignoranti, perché più obbligano adesso che non obligavano avanti l’advento de Christo» (Ginzburg, Due note, cit., p. 217). 175 C. Ginzburg, A. Prosperi, Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo», Torino 1975, pp. 174-76 e passim; Iid., Le due redazioni del «Beneficio di Cristo», in Eresia e Riforma nell’Italia del Cinquecento. Miscellanea I, Chicago-Firenze 1974, pp. 137-204; G. Fragnito, Ercole Gonzaga, Reginald Pole e il monastero di San Benedetto Polirone. Nuovi documenti su Luciano degli Ottoni e Benedetto Fontanini (1549-1551), in «Benedictina», XXXIV, 1987, pp. 253-71. Su degli Ottoni cfr. la voce di G. Fragnito in Dizionario biografico degli Italiani, vol. XXXVI, Roma 1988, pp. 169-73; Prosperi, L’eresia del libro grande, cit.; Collett, Italian Be-
205
nedectine Scholars, cit., pp. 119-37 e passim. Interessante un intervento del benedettino al Concilio di Trento riportato da C. Faralli, Per una biografia di Luciano degli Ottoni, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 134, 1973, p. 45, in cui sottolineò l’inconciliabilità tra fede e conoscenza scientifica. 176 Secondo la testimonianza di don Giacomo Coppino: «Io intesi stando nel medesimo monasterio di Santo Giorgio [...] che un don Giorgio Sicolo da Catania diceva che una sera a hora di compieta alle 23 hore li apparrebbe un Christo, quale diceva che Christo li haveva aperto il petto e dentro si vedeva tutti i dubbi della Scrittura sacra e diceva che lo stesso Christo li haveva detto che andasse al concilio [di Trento] a parlare col cardinale Polo d’Inghilterra» (C. Madonia, Un’appendice senese dei processi contro la «Setta Giorgiana», in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», 160, 1987, p. 36). 177 Ginzburg, Il nicodemismo, cit., pp. 173-74, dove si accenna anche alla possibilità di nessi con gli ambienti che facevano capo a Camillo Renato e alla «propaganda nicodemitica di Capitone». 178 M. Firpo, Giorgio Siculo. Discussione del volume di Adriano Prosperi, in «Storica», XVIII, 2000, pp. 143-52. 179 Prosperi, L’eresia del libro grande, cit., pp. 142 e 418 nota. 180 Il caso della Christianismi restitutio, in cui Servet perorò l’antipedobattismo, conferma il quadro fin qui delineato. L’unico interesse dello spagnolo, infatti, era quello di estendere anche al battesimo la critica antisacramentale in una logica in cui non trovano spazio le altre «antique opinioni» degli anabattisti (M. Servet, Christianismi restitutio/Restitución del cristianismo, a cura di Á. Alcalá, 2 voll., Zaragoza 2006). 181 Discutendo nel 1976 sulla «Rivista storica italiana» il volume di Ginzburg, G. Spini (Noterelle libertine, ora in Id., Barocco e puritani. Studi sulla storia del Seicento in Italia, Spagna e New England, Firenze 1991, pp. 377-90) ha proposto di cercare nella conoscenza di idee riconducibili al libertinismo le radici delle opinioni di Menocchio. Trame libertine che, però, per Spini escludevano a priori ogni rapporto con l’eresia più radicale e con la Riforma in genere, affondando le radici in pensatori come Machiavelli, Pomponazzi, Cardano o al più Giordano Bruno. La lettura di Spini non ha avuto fortuna in Italia e S. Bertelli (Il libertinismo italiano di Giorgio Spini, in «Rivista storica italiana», CXIX, 2007, p. 193 e nota) ha liquidato sia la sua ipotesi sia quella di Ginzburg (un «qui pro quo»), giudicando Menocchio «un relitto cataro» e accogliendo non senza forzature la lettura elaborata da A. Del Col nella sua introduzione ai processi subiti da Scandella. In realtà, contrariamente a quanto ritenuto da Bertelli, Ginzburg non aveva legato alla sola ipotesi di tipo antropologico la spiegazione delle visioni di Menocchio, evocando il mondo del radicalismo del Nord-Est (e sarebbe stato strano che non lo avesse fatto l’editore dei costituti di Manelfi) e introducendo la variabile antropologica del condizionamento esercitato da uno strato profondo di matrice contadina (indipendente dalla Riforma) anche per spiegare la trasposizione che Scandella aveva fatto di alcune idee che Ginzburg giudicava potesse avere appreso dagli ambienti ereticali cinquecenteschi. Lo stesso Del Col ha evidenziato come i contatti tra il mondo del radicalismo veneto e il mondo di Menocchio non mancassero: ad esempio, molti abitanti di Cinto, un paese tra Portogruaro e Pordenone, emigrarono in Moravia, raggiungendo le locali comunità anabattistiche originate proprio dai dissenzienti veneti. Cfr. A. Del Col (a cura di), Domenico Scandella detto Menocchio. I processi dell’Inquisizione (1583-1599), Pordenone 1990, p. XLVII.
206
182
Ginzburg, Il formaggio e i vermi, cit., p. 23 e passim. Ivi, pp. 8-9. 184 Ivi, pp. 24-25. 185 Ivi, p. 55. 186 Ivi, pp. 14-15. Sulla falsificazione dei vangeli, Ginzburg ha notato come in ciò emergesse una differenza netta con gli anabattisti; riconducendo le opinioni di Menocchio anche al radicalismo napoletano invece si risolve l’aporia. 187 Ivi, p. 23 e passim. 188 Ivi, p. 33. 189 Ivi, p. 60 e passim. 190 Ivi, pp. 3-5 e 23. 191 Ivi, p. 136. 192 Ivi, pp. 76-82, 95 e passim. 193 Ivi, pp. 122-23. 183
Conclusioni 1 A. Stella, Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo. Nuove ricerche storiche, Padova 1969, p. 16 e passim. 2 R.H. Popkin, Storia dello scetticismo (1979), Milano 2000. 3 Tra i passi valdesiani che possono richiamarsi cfr. la CIII delle Cento e dieci divine considerazioni (a cura di T. Fanlo y Cortés, Genova-Milano 2004, pp. 44548), dove l’apologia del dubbio rivela una tensione verso la verità che impedisce di parlare di scetticismo. Quanto a Erasmo, è fondamentale il capitolo dedicato a Il dubbio da S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580 (1987), Torino 1990, pp. 197-222, che si sofferma sui valdesiani napoletani. Sembra forzata, però, l’affermazione secondo cui Erasmo «di quell’arte [l’ars dubitandi] può essere considerato l’inventore e il primo maestro a livello europeo» (p. 197). Al di là della considerazione metodologica (comune a Bloch, Venturi e Foucault) che non ha granché senso per la ricerca storica andare alla ricerca di mitiche origini delle pure idee, la filologia di Valla e di altri umanisti presenta già caratteri essenziali del dubbio critico. Non sarà inutile ricordare, peraltro, che Erasmo conosceva le correnti scettiche dell’antichità. 4 Esemplare al riguardo è un più tardo passo di Ochino: «Se vuoi vedere quelli che sono in verità evangelici, bisogna che veda le Chiese christiane riformate che sono in Germania, in Elvetia, in Francia et negl’altri luoghi: il che facendo trovarai che una Chiesa è zuingliana, l’altra luterana et che alcuni sono anabattisti, gli altri libertini, et così di diverse sette et fra loro molto diversi et contrarii» (M. Firpo, «Disputar di cose pertinente alla fede». Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano, Milano 2003, p. 310). Di tale consapevolezza ci sono tracce innumerevoli, e basti evocare la testimonianza di Pietro Carnesecchi, il quale pure mostrò contezza delle divisioni in cui si era ramificata la Riforma (Processi Carnesecchi, II, p. 558). Occorre a ogni modo sottolineare quanto la proliferazione di posizioni ereticali fu fomite di confusioni, a volte indotte da scelte controversistiche, ma a volte frutto di cattiva conoscenza. Indicativo, tra i tanti, un brano tratto dai costituti di A. dal Borgo del 1547. A domanda dell’inquisitore se avesse opinioni luterane, dal Borgo rispose: «Io voria sapere che cosa è opinione lutherana». Al che l’inquisitore replicò:
207
«Le opinione lutherane sono a negar che Christo vegni in la hostia consacrata» (ASV, Sant’Uffizio, Processi, b. 6, f. V, c. 9r). 5 Seidel Menchi, Erasmo in Italia, cit., p. 214. 6 Cfr. R. Romeo, Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento, presentazione di R. Villari, Roma-Bari 1989. 7 S. Castellion, De arte dubitandi et confitendi ignorandi et sciendi, a cura di E. Feist Hirsch, Leiden 1981. 8 E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano. Ricerche e documenti, Firenze 1961. 9 Cfr. V. Prosperi, Di soavi licor gli orli del vaso. La fortuna di Lucrezio dall’Umanesimo alla Controriforma, Torino 2004, pp. 139-40. 10 G. Solaro, Lucrezio. Biografie umanistiche, Bari 2000, pp. 5 sgg.; E. Valeri, «Italia dilacerata». Girolamo Borgia nella cultura storica del Rinascimento, Milano 2007, p. 43 e nota; Prosperi, Di soavi licor, cit., pp. 150-52 e passim; H. Jones, La tradizione epicurea. Atomismo e materialismo dall’Antichità all’Età moderna (1992), Genova 1999, pp. 179 sgg. 11 Garin, La cultura filosofica, cit., p. 84; Prosperi, Di soavi licor, cit., pp. 15258. Accenni all’epicureismo tra i pontaniani in N. Badaloni, Inquietudini e fermenti di libertà nel Rinascimento italiano, Pisa 2004, pp. 54-55 e 103-104. Garin (p. 82) riconosceva già in Panormita tracce di Lucrezio, che non era ignoto in età medievale, e basti evocare Boccaccio. 12 «Vincenzo Ponterio avanzò forse nelle medicine quanti mai sono stati da molti anni in qua, né perciò lasciò mai di investicare i secreti della philosophia, e della lingua greca, e latina. Fece una sposizione sopra i sei libri di Lucrezio [...] ma fugli involato, e caddene in tanto dispiacere che dopo questa perdita non fu veduto mai ridere [...]. Fece un libro di annotazioni sopra l’Istoria naturale di Caio Plinio [...] ma tolto dal mondo per mano d’un micidiale scellerato non ebbe spazio di condurlo al suo fine. Hebbe in molta riverenza Coriolano Martirano, ed il Martirano fe’ molta stima del Ponterio. E leggonsi tante lettere dall’uno all’altro, che se ne potrebbe formare un volume ben grande» (S. Quattromani, Di Giano Parrasio e di altri autori cosentini del XVI secolo, in Id., Scritti, a cura di F.W. Lupi, Rende 1999, p. 266). 13 Excuse de Iehan Calvin a messieurs les nicodemites, sur la complaincte qu’ilz font de sa trop grand’ rigueur (1544), in I. Calvini Opera quae supersunt omnia, vol. VI, Brunsvigae 1867, coll. 593-614. 14 M. van Veen, Introduction, in Response à un certain Holandois [...] (1562), in I. Calvini Opera omnia denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, series IV, vol. I, a cura di M. van Veen, Genève 2005, p. 199. Ma va letta l’intera introduzione, che mostra i nessi fra libertinismo e nicodemismo attraverso la figura di Dirck Coornhert, le cui idee sono sovrapponibili in vari aspetti a quelle dei valdesiani radicali. Cfr. anche A. Rotondò, Atteggiamenti della vita morale italiana del Cinquecento. La pratica nicodemitica (1967), in Id., Studi di storia ereticale del Cinquecento, 2 voll., Firenze 2008, vol. I, p. 208. Tende a far prevalere la lettura di due fenomeni distinti E. Garavelli, Lodovico Domenichi e i «Nicodemiana» di Calvino. Storia di un libro perduto e ritrovato, Firenze 2004, p. 15 e passim, come già A. Biondi, La giustificazione della simulazione nel Cinquecento, in Eresia e Riforma nell’Italia del Cinquecento. Miscellanea I, Chicago-Firenze 1974, pp. 11 e 44-57. 15 O. Millet, Calvin et les «libertins»: le libertin comme clandestin, ou de la sphère clandestino-libertine, in «La Lettre clandestine», V, 1996, p. 237. Tra le argo-
208
mentazioni di Millet, a parte il discorso su simulazione e dissimulazione, sull’approccio verso le Scritture ecc., è pregnante la constatazione che «comme dans le cas des libertins spirituels, cette religion [le nicodémisme] se confond avec la revendication de l’autonomie de la conscience personnelle» (ivi, p. 234). 16 Ivi, p. 239. Cfr. anche M. Firpo, Calvino e la Riforma radicale: le opere contro nicodemiti, anabattisti e libertini (1544-1545), in «Studi storici», XLVIII, 2007, p. 98. 17 Corsivo nel testo. La citazione rinvia a I Cor. 6, 20. 18 Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz (1545), in Calvini Opera omnia, cit., vol. I, pp. 122-23. 19 Ivi, p. 123. Van Veen rinvia in nota all’Excuse. 20 Calvino, Excuse, cit., col. 602. Calvino si limitò a evocare i più radicali perché (come affermò egli stesso) il testo era rivolto ai nicodemiti moderati, ritenuti recuperabili al contrario dei radicali. Ai cosiddetti seguaci di Epicuro Calvino avrebbe dedicato il Des scandales (1551), a cura di O. Fatio, Genève 1984, dove affiorava il nesso tra eresia radicale e Rinascimento nell’inclusione tra gli epicurei di Servet accanto ai Rabelais, Dolet, Des Périers, Agrippa. Significativamente Calvino avrebbe incluso nella «epicureorum caterva» anche Valentino Gentile, cfr. Impietas Valentini Gentilis [...] (1561), in Calvini Opera quae supersunt omnia, cit., vol. IX, Brunsvigae 1870, col. 367. Il nesso tra epicurei (e lucianici) e libertini è anche in P. Viret, L’Interim fait par dialogues (1565), a cura di G.R. Mermier, New YorkBerne-Frankfurt am Main 1985, dove insistiti sono i riferimenti ad «atheistes, epicuriens et libertins» (pp. 113-15). 21 Nel De origine, continuatione, usu, autoritate, atque praestantia ministerii verbi Dei (citato in M. Van Veen, Introduction, in Calvino, Contre la secte [...] des libertins, cit., p. 13 e nota). C. Ginzburg, Il nicodemismo. Simulazione e dissimulazione religiosa nell’Europa del ’500, Torino 1970, p. 201, ricorda poi un altro testo di Viret in cui appare l’omologazione: l’Admonition et consolation aux fidéles, qui délibérent de sortir d’entre les papistes, pour éviter idolatrie del 1547 (pp. 65 e 67); ma è esemplare il capitolo dedicato da Viret a Les Libertins in L’Interim, cit., pp. 115, 131-32 e passim, dove simulazione e dissimulazione sono considerate elementi costitutivi del libertinismo. 22 Su questo piano profonde sono le consonanze con la dissimulazione d’opposizione secentesca di cui ha parlato R. Villari, Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento, Roma-Bari 1987; cfr. anche J.-P. Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au XVIIe siècle, Paris 2002. Sul nicodemismo in Valdés cfr. M. Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali». Studi su Juan de Valdés e il valdesianesimo nella crisi religiosa del ’500 italiano, Firenze 1990, pp. 43-84 e passim; Id., Introduzione, in J. de Valdés, Alfabeto cristiano. Domande e risposte. Della predestinazione. Catechismo, Torino 1994, pp. LXIX-LXXXIX e passim. 23 Cfr. Calvino, Excuse, cit., col. 610 e passim. L’unico riferimento alla Francia è in un passo che non consente di ritenere l’opera rivolta al solo mondo di lingua francese (ivi, col. 608). Alla conoscenza nel mondo riformato del nicodemismo degli italiani già da prima che Calvino scrivesse l’Excuse aux nicodemites fa riferimento Firpo, Calvino e la Riforma radicale, cit., pp. 98-100. 24 B. Ochino, I «dialogi sette» e altri scritti del tempo della fuga, a cura di U. Rozzo, Torino 1985, p. 123. 25 Ivi, p. 127. Il proemio è datato Ginevra, 10 ottobre 1542.
209
26
Cfr. Firpo, «Disputar di cose pertinente alla fede», cit., p. 290. G. Calvino, Libro del fuggir le superstizioni che contrastano alla sincera confessione della fede, traduzione del 1551 del De vitandis superstitionibus (1549) che riuniva il Petit traité e l’Excuse (riedito in Garavelli, Lodovico Domenichi, cit., p. 225). 28 Calvino, Excuse, cit., coll. 598-99. 29 Ginzburg, Il nicodemismo, cit., p. 164 nota. 30 Calvino, Excuse, cit., col. 597. 31 Id., Libro del fuggir le superstizioni, cit., p. 196. 32 Escusazione di Giovan Calvino a’ nicodemiti, i quali si lamentano del suo troppo rigore (in Garavelli, Ludovico Domenichi, cit., p. 234). 33 M. Firpo, Vittore Soranzo vescovo ed eretico. Riforma della Chiesa e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Roma-Bari 2006, pp. 372-77. 34 Calvino, Excuse, cit., col. 596. 35 Valdés, Le cento e dieci divine considerazioni, cit., p. 422. Sulle rare menzioni di Nicodemo in chiave nicodemitica cfr. Ginzburg, Il nicodemismo, cit., pp. 15455 e passim. 36 Calvino, Excuse, cit., col. 608. 37 Ivi, col. 605. 38 Id., Libro del fuggir le superstizioni, cit., pp. 196-97 e passim. 39 Anche M. Firpo, Riforma protestante ed eresie nell’Italia del Cinquecento (1993), Roma-Bari 2004, p. 133, ha sottolineato «gli espliciti accenni ai ‘protonotari delicati’». 40 G. Schneider, Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo (1970), Bologna 1974, pp. 52-53. 41 Calvino, Contre la secte [...] des libertins, cit., p. 86. 42 Ivi, p. 53. 43 Ivi, p. 75. 44 Ivi, p. 71. 45 Ivi, p. 63. 46 Ivi, p. 64. 47 Ivi, p. 55. 48 «Ilz tiennent, qu’il n’y a qu’un seul esprit, de Dieu, qui soit et qui vive en toutes creatures [...], qu’il n’y a que un seul esprit qui est par tout» (ivi, pp. 82-83). 49 Ivi, p. 79. 50 Ivi, p. 108. 51 M. Gauchet, Le désenchantement du monde Une histoire politique de la religion (1985), Paris 2005; Id., Un monde désenchanté? (2004), Paris 2007; Id., La condition historique. Entretiens avec F. Azouvi et S. Piron (2003), Paris 2005. 52 A. Koyré, Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle allemand (1955), Paris 1971. 53 Sul significato di esperienza in Valdés cfr. Firpo, Tra «alumbrados» e «spirituali», cit., pp. 50 sgg. 54 Tale posizione percorre tutta l’opera, per quanto sembri a volte emergere una preminenza riconosciuta al senso (De principiis rerum, II, 201-206). Ma Capece aggiungeva che quelli che non avevano usato il senso, «longe [...] vera a ratione vagarunt», e tra i versi che mostrano come egli ritenesse necessario legare l’esperienza alla ragione merita citare quanto egli scriveva nel criticare la tesi secondo cui l’aria era un elemento di per sé caldo e la terra di per sé freddo: «Nec ratio admittit 27
210
nec vis capit ardua mentis. / Nam quodvis ut sit corpus frigensve calensve / accipimus sensu eque effectu noscimus ipso (I, 652-654). In un altro passo, poi, Scipione invitava ad adoperare la «certa ratio» da affiancare al senso degli animali, in un richiamo a quello che sarà un topos del libertinismo secentesco. 55 De principiis rerum, II, 455-464. 56 De rerum natura, V, 1186-1197. 57 E. Peruzzi, Un contemporaneo di Telesio: Giovan Battista Amico e la teoria delle sfere omocentriche, in R. Sirri, M. Torrini (a cura di), Bernardino Telesio e la cultura napoletana, Napoli 1992, pp. 241-56; L. De Franco, Filosofia e scienza in Calabria nei secoli XVI e XVII, Cosenza 1988. Poco si sa sulle vicende del cosentino Giovan Battista d’Amico (o Amico o Amici o d’Amici): fu assassinato ventiseienne a Padova nel 1538, età che si deduce dalla sua unica opera nota, edita a Venezia nel 1536, ove si legge: «Haec conscripsit Ioannes Baptista Amicus Ioannis Baptistae Amici Consentini filius posthumus, vigesimum quartum annum agens». A quanto pare conosceva, oltre al latino, il greco e l’ebraico. Nel 1540 la sua opera fu riedita a Parigi a cura di Postel, che lo definì suo «amicissimus». Un riferimento al suo libro è forse in una lettera di Flaminio a Gasparo Contarini (8 luglio 1536), in M. Flaminio, Lettere, a cura di A. Pastore, Roma 1978, p. 38. 58 F. Bacchelli, Sulla cosmologia di Basilio Sabazio e Scipione Capece, in «Rinascimento», nuova serie, XXX, 1990, pp. 137-39. 59 Id., Note per un inquadramento biografico di Marcello Palingenio Stellato, in «Rinascimento», nuova serie, XXV, 1985, pp. 275-92; Id., Palingenio Stellato e la sua fortuna europea, in M. Bosse, A. Stoll (a cura di), Napoli viceregno spagnolo. Una capitale della cultura alle origini dell’Europa moderna (sec. XVI-XVII), Napoli 2001, vol. I, pp. 153-66. Stellato (maestro di scuola nato forse a Capua verso la fine del Quattrocento e morto a Cesena verso il 1539) era portatore di una visione della religione che andrebbe approfondita: le sue ossa furono disseppellite poiché «Marcellus Palingerius [sic!] Stellatus nihil credens neque divinitatem Christi Cesenae perfidus mortuus est» (ivi, p. 163). Riteneva che «un unico spirito pervade tutti gli animali, ma appare difforme e vario perché i corpi che ne partecipano non sono organizzati ed articolati ad uno stesso ed unico livello di perfezione» (ivi, p. 157). Le consonanze con i libertini non si esauriscono in ciò, come evidenziato da Bacchelli, e si può aggiungere che anche in Campanella si possono scorgere paralleli con questo umanista eretico e libertino. 60 De Franco, Filosofia e scienza in Calabria, cit., p. 28. 61 De principiis rerum, II, 739 sgg. 62 Bacchelli, Sulla cosmologia, cit., pp. 135-36 nota. 63 De principiis rerum, II, 767-809. 64 Sui naturalisti napoletani cfr. R. Villari, La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini 1585-1647 (1967), Roma-Bari 1994; Id., Inquietudini, mutamento e prudenza nella politica barocca, in corso di stampa.
Indice dei nomi*
Abbate (o Abate), Giovan Vincenzo, 36, 156, 163. Abramo, 19, 83. Acquaviva d’Aragona, Belisario, 165. Adamo, 178. Adamo, Pietro, XIV. Addante, Luca, 154. Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius, 130, 209. Ajello, Raffaele, 164. Alarçon, Fernando de, 165. Alcalá, Ángel, 206. Alciati, Giampaolo, 89-90, 115-16, 180, 200. Alessandro, ebreo converso, 77. Alessandro di Afrodisia, 67, 74, 167. Alois, Giovan Francesco, detto il Caserta, 64, 152, 155, 159, 166. Altamura, Antonio, 71, 161, 164-66, 169, 171-72. Altomare, famiglia, 169. Altomare, Donato Antonio, 75, 139, 172. Álvarez de Toledo, famiglia, 44. Álvarez de Toledo, Juan, 51, 72, 160. Álvarez de Toledo, Luis, 72, 167.
Álvarez de Toledo, Pedro, 4-5, 44, 7173, 157, 169-70. Álvarez de Toledo Spinelli, Isabella, 44. Alvisetto sartor, 105, 193, 195. Amabile, Luigi, 36, 148-49, 154, 169-70, 172. Amante, Bruto, 150. Amici, vedi d’Amico. Ammirato, Scipione, 164, 169. Amos, 11. Anassagora, 168. Anassimene, 142. Andrea cimador, 105, 194. Angelica, eterodossa veneziana, 187. Angelo da Messina, 51, 158-59. Angelo da Messina, vedi Manna, Ludovico. Anisio, Cosimo, 65. Anisio, Giovan Francesco (Giano), 6466, 72, 166-67. Antonino, servitore di Girolamo Busale, 102. Antonio, procuratore di Girolamo Busale, 175. Antonio, studente napoletano, 189. Antonio callegaro, 105, 192. Antonio da Bozzolo, 123-24, 204-205.
* Questo indice comprende anche nomi di personaggi mitologici e biblici.
213
Antonio marzaro, 105, 194. Antonio sartor, 105. Antonio strazzaruolo, 105, 193. Archirota, Alessandro, 159. Aretius, Benedictus (Benedikt Marti), 178. Ariano, duchessa di, vedi Di Capua Gonzaga, Isabella. Ario, 53. Aristotele, 74, 141-42, 168. Asburgo, dinastia, 4. Atanasio, 204. Azouvi, François, 210. Bacchelli, Franco, 169, 172, 211. Badaloni, Nicola, 168-69, 208. Bagozzo, Giovan Maria, 198. Bainton, Roland H., 202, 204. Balász, Mihály, 199, 201, 203. Balbani, Niccolò, 149, 152. Barbieri, Edoardo, 201. Barges, Antonino, 113, 180, 199. Baroni, Pellegrino, detto Pighino el grasso, 203. Barthas, Jérémie, XIV, 146, 154. Bartolomeo da Messina, alias Rositano, 51, 72, 160. Basalù (o Besalù), famiglia, 175. Basalù, Benedetto, 175. Basalù, Francesco jr., 175. Basalù, Francesco sr., 175. Basalù, Giulio, XI, 15, 25-39, 43-47, 4951, 53, 55, 57, 59-62, 69-71, 75-76, 7880, 83-85, 106, 111, 117, 125-27, 12932, 136, 143, 151, 153-55, 157-64, 172-73, 175-79. Bataillon, Marcel, 146. Battista (o Benedetto) sartor, 105 Beato, Gian Maria, detto Manfredino, 99, 102, 111, 185, 198. Beccadelli, Antonio, detto il Panormita, 167, 208. Beccadelli, Lodovico, 198. Beffa, Giovanni, 161. Belligni, Eleonora, XIV, 149-50, 157, 205. Beltramin, Paolo, 96, 102, 104, 181-86, 190, 192-93, 195-98.
Bembo, Pietro, 68, 168, 171. Benbassa, Esther, 173. Bender, Samuel H., 204. Benedetto da Mantova, vedi Fontanini, Benedetto. Bernardin sartor, 105, 195. Bernardina, monaca in San Francesco di Napoli, 20. Bernardino (forse Prandi), eterodosso padovano, 100, 181, 186-89. Bernardino da Siena, vedi Ochino, Bernardino. Bernaudo, Consalvo, 20, 36-37, 49, 152, 155-56, 166. Berr, Henri, 146, 154. Berriot, François, 147, 150, 154, 178. Bertelli, Sergio, 154, 203, 206. Berti, Domenico, 148, 151-52, 157, 160, 162, 169. Bertozzi (o Bartocci), Bartolomeo, 192. Biagio callegaro, 100, 184, 186-89. Bianco, Giovan Tommaso, 37, 49-50, 55, 76, 158, 161, 175. Biandrata, Giorgio, 112, 115, 118, 120, 139, 198. Biondi, Albano, 208. Bloch, Marc, 207. Boccaccio, Giovanni, 208. Bock, Friedrich S., 91, 180. Boehmer, Eduard, 157. Boillet, Élise, 146. Bombarda, Francesco, 183. Bonacorso de’ Doti, Lucia, 185. Bondì, Roberto, 165. Bonfadio, Iacopo, VIII, 146. Borgato, Lorenzo, 106, 195. Borgia, Girolamo, 64, 131, 166. Borgo, vedi dal Borgo. Borrelli, Carlo, 164. Borrhaus, Martin (Cellarius), 202. Bosato, vedi Francesco da Breganze. Boscaia, Stefano, 183. Bosse, Monika, 162, 168, 211. Boureau, Alain, XIV. Bouwsma, William J., 178. Boyle, Robert, 168. Bracci, Ignazio, 68, 168. Brahe, Ticho, 168.
214
Braida, Lodovica, 164. Brambilla, Elena, 149. Brancaccio, Ferrante, 36, 152, 156, 166. Brancati, Giovanni, 141. Bresciani, Pietro, 123-24, 139, 205. Breseña Manrique de Mendoza, Isabella, 8, 13, 15, 20, 36-37, 44-45, 48-49, 84, 150, 179. Broccolo Tommasi, Selene, XIV. Brogia, Polonio de, 104, 191. Brogia, Teseo de, 104, 191. Brucioli, Antonio, 183. Brunfels, Otto, XI, 132, 139, 202. Bruno, Giordano, 39, 139, 141-42, 163, 206. Buccella, famiglia, 199. Buccella, Nicolò, 188. Budzyn´ski, Stanisław, 87, 90 Bullinger, Heinrich, 97, 157, 202, 205. Burgos, cardinale di, vedi Álvarez de Toledo, Juan. Busale (o Busales o Busal o de Busal o Bussala), famiglia, 37, 49-50, 54-55, 77-78, 158, 160-61, 173, 175. Busale, Bruno, 13, 36, 84-85, 97, 99, 101-102, 107, 116, 121, 150, 157, 17576, 179, 184, 187, 189-90, 197-98. Busale, Girolamo, 8-13, 15, 20, 22, 2426, 32, 36, 38-39, 43-45, 48-49, 54-55, 59-61, 76-80, 83-86, 89-91, 95-97, 100-104, 106-107, 110-11, 114, 11617, 122-24, 130, 150-51, 157, 162, 173-76, 179, 181, 183, 188, 198, 201. Busale, Martino, 77-78, 173. Busale, Matteo, 16, 26-27, 36, 43-45, 47, 55-59, 61, 79, 83, 151-53, 157-58, 161, 163, 176-78, 198. Busale, Porzia, 77, 173. Busale, Prospero, 77-79, 173-76, 198. Buschbell, Gottfried, 158, 162. Busson, Henri, 132, 146-47. Butzer, Martin, 100, 188. Buzio, Giovanni, 71-72, 170. Cabianca, Domenico, 150. Caccamo, Domenico, 150, 200. Calcagnini, Celio, 135. Calvin, Jean (Calvino), XI-XII, 32, 89,
100, 113-14, 119, 132-38, 146-47, 188, 199, 202-203, 208-10. Camillo da Eboli, 163. Campana, Tommaso, 179. Campanella, Tommaso, 30, 39, 139-42, 154, 211. Cancer, Mattia, 165. Caniato, Giovanni, XIV. Cannavale, Ercole, 164, 166. Cantimori, Delio, 92, 115, 126, 135, 148, 171, 177, 198-200, 204. Capece, famiglie, 62, 164, 167. Capece, Antonio, 62-64, 75, 164. Capece, Antonio, abate, 168. Capece, Cesare, 169. Capece, Francesco, 169, 171. Capece, Girolamo, 16, 26, 36, 55-57, 59, 65, 83, 151, 162. Capece, Giustino, 168. Capece, Marcello, 170. Capece, Muzio, 169. Capece, Ottaviano, 168. Capece, Scipione, 36, 55, 61-76, 106, 121, 127, 129, 131-32, 138-43, 161, 164-72, 210-11. Capece, Vincenzo, 169. Capece Rota, Porzia, 64. Capitone, vedi Kópfel, Wolfgang. Caponetto, Salvatore, 150, 155, 159. Caracciolo, famiglia, 73, 164, 166. Caracciolo, Antonio, 148-49. Caracciolo, Galeazzo, 5, 20, 36, 63-64, 152, 166. Caracciolo Capece, Giovanna, 63. Carafa, famiglia, 170. Carafa, Gian Pietro, vedi Paolo IV. Carafa, Giovanni, 170. Caravale, Giorgio, 175. Carbone, Girolamo, 62. Cardano, Girolamo, 206. Carduino, Camillo, 156. Carduino, Cesare, 36, 49, 155. Cargnoni, Costanzo, 160, 177. Carletto, Francesco, 105, 194. Carlo V d’Asburgo, imperatore, VIII, 34, 64, 148, 153. Carlo VIII di Valois, re di Francia, 3. Carlostadio, vedi Karlstadt, Andreas.
215
Carnesecchi, Pietro, 6, 27, 36, 41-42, 44, 64, 135, 153, 155-57, 159, 166, 207. Carucci da Pontormo, Iacopo, 34. Casadei, Alfredo, 156-57, 179. Caserta (il), vedi Alois, Giovan Francesco. Castaldo, Antonino, 5, 71-73, 148, 17071. Castellion, Sébastien, 64, 87, 131, 138, 200, 208. Castiglione, Tommaso R., 167. Caterina, affittacamere vicentina, 151. Cavaillé, Jean-Pierre, XII, XIV, 132, 147, 154, 209. Cavalli, Ambrogio, 157. Cazzaniga, Gian Mario, 154. Ceccarelli, Alessia, 148. Cellarius, vedi Borrhaus, Martin. Cernigliaro, Aurelio, 148, 164. Cervini, Marcello, vedi Marcello II. Cesare, discepolo di Matteo Gribaldi, 200. Cesare da Bologna, 171. Chabod, Federico, 177, 205. Chiari, Iacopo de, 89-90, 114. Cicerone, Marco Tullio, 62, 92, 112, 129. Ciliberto, Michele, 163. Cingano, Giuseppe, 97, 100, 102, 104105, 107, 181, 184, 186-88, 190-95, 198. Cirillo, Pietro, 20, 36, 152. Citarella, famiglia, 163. Citarella, Tobia, 50-51, 61-62, 106, 158, 163. Citarella, Vito Antonio, 163. Clemente VII, papa, VIII. Clemente da Messina, alias Francesco da Messina, 51, 158. Cocciano, Augusto, 172. Colapietra, Raffaele, 171-72. Collet, Barry, 175, 204-205. Colonna, Ascanio, 136. Colonna d’Avalos, Vittoria, 63, 134, 165. Colti, Alvise de’, 97, 99, 101, 149, 184, 186-90, 192-94, 196, 198, 205. Colti, Zuan de’, 188.
Commodaro, Ivan, XIV. Concio, Francesco, 171. Coniglio, Giuseppe, 148, 164. Contarini, Francesco, 149, 186. Contarini, Gasparo, 172, 211. Coornhert, Dirk Volckertszoon, 147, 208. Coppino, Giacomo, 206. Coppola, Giovan Francesco, 50, 61, 158. Cortese, Nino, 150, 166. Cosentini, Laura, 171. Cosimo da Roccaguglielma, 59. Cosimo I de’ Medici, duca di Firenze, poi granduca di Toscana, 34. Crews, Daniel A., 146. Cristoforo, eterodosso padovano, 100, 187. Cristoforo Milanese, 55, 161. Croce, Benedetto, 148, 152, 165. Crouzet, Denis, 146, 154. Curione, Celio Secondo, VIII, 5, 33, 45, 64, 93, 157. Cynarski, Stanysław, 201. d’Afflitto, Scipione, 152. D’Agostino, Guido, 148. dal Borgo, Antonio, 96-97, 183, 198, 207. dal Borgo, Benedetto, 10-11, 85, 95100, 102-104, 106, 108-109, 111, 116, 120, 123, 181-83, 185, 190, 194, 19698. dal Borgo, Felice, 183. Dal Borgo, Michela, XIV. d’Alessandria, Nicola, 10, 13, 85, 95, 98, 100, 102-104, 106, 108, 114, 116, 18182, 185-91, 194, 196, 198. d’Alessandria, Vincenzo, 181. d’Alessandria de Fener, Isabella, 181, 184, 190. d’Alessio, Antonio, 16, 26, 37, 44, 4849, 52-54, 147, 160, 163. dalla Barba, Bartolomeo, 194, 198. dalle Maddalene, Lucrezia, 105, 192. dalle Maddalene, Marcantonio, 193. dalle Maddalene, Matteo, 22, 99, 105, 120, 153, 185, 190-97, 202.
216
Damaso I, papa, 196. d’Amico, Giovan Battista jr., 141-42, 211. d’Amico, Giovan Battista sr., 211. Dán, Róbert, 199, 203. Dandolo, Matteo, 113. da Passano della Frattina, Isabella, 180. da Prata, vedi del Bon, Marcantonio. d’Aquino, Giovan Paolo, 165. Dario Senese, 200. D’Ascia, Luca, 162. Daumas, Maurice, 147. Dávid, Ferenc, 120. Davide, re d’Israele, 31, 132, 182. de Brotton, Francesco (Checo), 105. de Caro, Giovan Vincenzo, 159. De Cola, Stefania, V, XIV. de Dolthani, Giovanni, 104, 190, 192. de Fener (o de Ferrero), Luca, 181, 190. de Ferraris, Antonio, detto il Galateo, 62, 141. De Franco, Luigi, 165, 168, 211. De Frede, Carlo, 148, 151, 167, 171, 179. degli Ottoni, Luciano, 125, 205. del Bon, Marcantonio, 95-97, 102-106, 108, 116, 149, 151, 180-85, 187, 189, 193, 195-98. del Castello, Matteo, 105, 193. Del Col, Andrea, 206. de Leo, Gasparro, 166. della Marra, Ferdinando, 164, 168. Della Porta, Giovan Battista, 141. Della Rovere, Giuliano, vedi Giulio II. Della Rovere, Giulio, 31, 106, 154, 195. Della Sega, Francesco, 89-90, 102, 108, 114-15, 187, 190. della Tolfa, Giovan Battista, 159. Dell’Olio (o Del Loio), Antonio, 25, 84, 179. Del Monte, Giovanni Maria, vedi Giulio III. Del Monte, Innocenzo, 198. Democrito, 168. Denck, Hans, 201-202. de Racho, Paolo, 165. de Rainaldo, Nicola Giacomo, 169. De Rinaldo, famiglia, 163.
De Rose, Vincenzo, 157. Descartes, René, 168. Des Périers, Bonaventure, 209. Diaz Garlon Carafa, Violante, 170. Di Capua, Giovan Francesco, 63. Di Capua, Pietrantonio, 36, 152, 155. Di Capua Gonzaga, Isabella, 179. di Falco, Benedetto, 165-66. di Forcini, Gian Giacomo, 105, 185, 192-94. Diogene Laerzio, 129. Dito, Oreste, 173. Dolet, Étienne, 209. Domenichi, Ludovico, 135. Donato, Elio, 166-67. Donato, Ettore, 180. Doni, Agostino, 139. Doti (o Dotto) Beato, Caterina de’, 185. Drao, Orazio, 189. Drechsel, Thomas, 202. Dunin-Borkowski, Stanislaw, 204. Elia, 201. Elliott, John H., 148. Empedocle, 168. Enoch, 201. Epicuro, 33, 131, 209. Erasmo da Rotterdam, VII, 9, 31-32, 5457, 65-66, 72, 130, 138, 198, 207. Ercole II d’Este, duca di Ferrara, 150. Ernst, Germana, 154. Eubel, Konrad, 174-75. Eudosso, 142. Eva, 109. Ezechiele, 56. Fabrizi, Flaminio, 154. Fanlo y Cortés, Teodoro, 146, 149, 160, 207. Faralli, Carla, 206. Farel, Guillaume, 147. Farnese, Alessandro, vedi Paolo III. Fascitelli, Onorato, 70. Fast, Heinold, 202. Fatio, Olivier, 209. Febvre, Lucien, XI, 146, 154. Feist Hirsch, Elisabeth, 208. Felici, Lucia, 202.
217
Ferrante I d’Aragona, re di Napoli, 141. Festaro, Vittore, 183. Filalete, Giorgio, detto il Turchetto, 180-81. Filocalo, Giovan Battista, 170. Fiorentino, Francesco, 165. Fiorillo, Simone, 20, 153. Firpo, Luigi, 163. Firpo, Massimo, XIV, 88, 114, 132, 14549, 153-57, 159, 162, 167-68, 170, 178, 200-202, 206-207, 209-10. Flaminio, Marcantonio, 5, 42, 44, 64-66, 125, 136, 148, 156, 159, 166-67, 211. Flavio, Giovanni Paolo, 166-67. Florio, Benedetto, vedi Tizzano, Lorenzo. Foa, Anna, 173. Foix, Odet de, 3. Fontanini, Benedetto, 36, 51, 124-25, 158-59. Formica, Marina, XIV. Fornaseri, Prudenzia, 192-93. Foucault, Didier, 146-47, 154. Foucault, Michel, 207. Fragnito, Gigliola, 124, 183, 205. Francesco Calabrese (o di Calabria), alias Francesco Renato, 24, 55-57, 59, 61, 76, 80-84, 162, 176-78, 203. Francesco da Breganze, detto Bosato, 105, 185, 191, 193-95. Francesco da Jesi, 177. Francesco da Lugo, 94. Francesco da Messina, vedi Clemente da Messina. Francesco da Rovigo, vedi Della Sega, Francesco. Francesco d’Assisi, 188. Francesco muschiaro, 105, 193. Francesco sansar, vedi Carletto, Francesco. Francesco spadaro, detto lo Spagnoletto, 100, 184, 186-87, 189. Franck, Sebastian, XI, 202-203. Frattina, Isabella della, vedi da Passano della Frattina, Isabella. Fregoso, Federico, 198. Gabriel marzaro (o sensaro), 105.
Gaddi, Iacopo, 171. Gaeta, Franco, 198. Galasso, Giuseppe, 148, 173. Galateo (il), vedi de Ferraris, Antonio. Galeota Bernardino, 156. Galeota, Mario, 6, 17, 36, 64-65, 152, 156, 166. Galilei, Galileo, 168. Garavelli, Enrico, 208, 210. Gargano, Bernardino, 166. Garin, Eugenio, 168, 208. Gasparo sartor, 105, 195. Gassendi, Pierre, 168. Gastaldi, Ugo, 88, 154, 184, 201-203. Gauchet, Marcel, 210. Geccheli (o di Gechele), Alessandro, 188. Gentile, Giovanni Valentino, XII, 21, 65, 83, 86, 89-90, 115, 126, 138, 142, 148, 190, 209. Gessner, Konrad, 64, 165. Gesù Cristo, VII-IX, 6-7, 9, 18-23, 25-26, 29-35, 37, 46-49, 51-62, 66, 70, 73, 76, 80-83, 89-91, 93-94, 98-99, 102-103, 106-10, 119-20, 125-26, 131-34, 138, 142, 151, 155-56, 158-63, 178-79, 182, 185-88, 190-91, 193-94, 196200, 202, 204-206, 208, 211. Gherlandi, Giulio, 89-90, 102, 114-15, 189. Ghislieri, Michele, vedi Pio V. Giacometto sartor, 102, 115, 186, 190. Giacometto stringaro, 99, 103-104, 107, 110, 114, 120, 188, 190-95, 197, 205. Giacomo di Santa Corona, 193. Gian Giacomo spadaro, 186-87. Gian Ludovico bronzier, 184, 187, 191, 197. Giannone, Pietro, 64, 166. Giberti, Matteo, 81, 177. Gilbert, William, 168. Gilly, Carlos, 199. Ginosa, Mariano, 163. Ginzburg, Carlo, VII, 88, 109, 114, 12328, 135, 145, 149, 151, 153-54, 173, 176, 180-81, 183-89, 191-98, 202207, 209-10. Giorgio Siculo, vedi Rioli, Giorgio.
218
Giovanni, evangelista, 60, 136, 159, 179, 182. Giovanni Battista, 64. Giovanni da Poschiavo, vedi de Dolthani, Giovanni. Giovanni di Badia Calavena, 102, 190. Giovio, Paolo, 166. Girolamo, 183, 196. Girolamo cimador, 105, 194. Girolamo Milanese, 81. Giulio II, papa, 174. Giulio III, papa, 7, 15, 25, 113, 161. Giulio berettaro (o beccaro), 190. Giulio callegaro, 102, 105, 107, 184, 189, 193, 195. Giulio da Milano, vedi Della Rovere, Giulio. Giulio sartor, 105, 195. Giunti, famiglia, 166. Giuseppe, padre di Gesù, 21, 51, 59, 93, 102, 109, 182, 187, 190-91, 193, 19698. Giuseppe da Vicenza, 94. Gonzaga, Ercole, 72, 125, 203. Gonzaga, Ferrante, 172. Gonzaga Colonna, Giulia, 13, 15, 17, 20, 35-36, 38, 42-43, 150, 155-56, 166, 172-73. Gormo, Annibale, 199. Grataroli, Gugliemo, 114. Gravina, Pietro, 63. Gravier, Giovanni, 148. Grebel, Konrad, 202. Greco, Aulo, 146. Gregorio da Salerno, 45, 51, 158, 161. Gribaldi Mofa, Matteo, 87, 112-14, 190, 199-200. Grisone, Antonio, 158. Gruet, Jacques, 150. Gualano, Ranieri, 6, 25, 36, 149, 152. Guery, Alain, XIV. Gui, Francesco, 203. Guido, Alvise de’, 183. Guinigi, Ludovico, 44, 158. Gulik, Wilhelm van, 174-75. Harvey, William, 139. Hegler, Alfred, 204.
Hernando Sánchez, Carlos José, 148, 155, 169-70. Hoffmann, Melchior, 201-203. Hunter, Michael, 154. Hurtado de Mendoza, famiglia, 176. Hutter, Jakob, 118. Iacobo bottonaro, 105, 194. Iacomo sartor, 105, 195. Iacopo sutor, 192-94. Ignazio, 200. Imperato, Antonio, 17, 20, 36, 152. Imperato, Ferrante, 142. Intorcia, Gaetana, 150, 158, 164-65. Ireneo, 200. Isaia, 55-56, 162. Jacobson Schutte, Anne, 158. Johannes Campanus, 202. Jones, Howard, 208. Joris, David, XI, 201-203. Jouhaud, Christian, XIV. Karlstadt, Andreas (Carlostadio), 202203. Kepler, Johannes (Keplero), 168. Kopernik, Mikołaj (Copernico), 168. Kópfel, Wolfgang (Fabricius Capito, Capitone), 206. Kot, Stanislaw, 200-201. Koyré, Alexandre, 140, 210. Lattanzio, Lucio Cecilio Firmiano, 200. Laureto, Giovanni, X, 7-17, 20, 23-24, 36, 38-39, 44-45, 51, 55, 60-61, 83-85, 95-96, 101-102, 104, 111, 114, 120, 149-51, 162, 173, 179, 181, 188-90. Lautrec, visconte di, vedi Foix, Odet de. Lavenia, Vincenzo, 154. Lefèbvre d’Étaples, Jacques, 202. Leonardo bottar, 187. Lienhard, Marc, 202. Loffredo Capece, Maddalena de, 62. Loffredo de, famiglia, 164. Lopez, Pasquale, 146, 148-49, 152, 15657, 159, 161, 163, 170-71. Lovisetto sartor, 105, 193.
219
Lubieniecki, Stanisław, 86-87, 90-92, 180. Luca, evangelista, 162, 182, 196. Luca sartor, 105. Lucrezio Caro, Tito, 31, 33, 35, 63, 6670, 131-32, 141, 168, 172, 208. Luna, Fabricio, 167. Lupi, F. Walter, 165, 208. Luther, Martin (Lutero), VII, XII, 9, 19, 29, 32, 89, 111, 117, 130, 203. Luther Blissett, pseudonimo collettivo, 184. Macek, Joseph, 202. Machiavelli, Niccolò, 31, 33, 154, 206. Ma¸czinski, Jan, 73-74. Madonia, Claudio, 206. Maffei, Cesare, 54-55, 75, 160, 178. Mainardi, Agostino, 97, 205. Manelfi, Pietro, 6-7, 13, 15-16, 21-24, 37-38, 45, 57, 76, 83, 88, 93-98, 100101, 103-107, 109-12, 123, 149, 151, 173, 176, 180-86, 188-93, 196-98, 206. Manetto, Iseppo, 105. Manfredino, vedi Beato, Gian Maria. Manna, Ludovico, alias Angelo da Messina, 55, 159, 181. Manrique de Mendoza, García, 8, 150. Mantz, Felix, 202. Manuzio, Aldo, 62-63. Manuzio, Paolo, 63, 68, 75, 166, 168, 171. Manzi, Pietro, 165. Manzoli, Pier Angelo (Marcello Palingenio Stellato), 141, 211. Maometto, 83. Marangon, Orsolina, 100-101. Marc’Antonio mareschalco, 198. Marcatto, Dario, 145, 153, 155, 167, 170, 172. Marcello II, papa, 158, 162. Marchese, Elio, 164. Marchetti, Valerio, 179, 201. Marco da Cremona, 26, 78, 175. Marese, Biagio, 16, 48, 54, 82, 151, 157, 160-61, 176-77. Maria, madre di Gesù, VII, 19, 21-22, 47-
48, 51-53, 55, 59-60, 80, 83, 93, 102103, 106, 108-10, 126, 131, 160-61, 163, 178, 182, 186-87, 191, 193, 19698. Márquez, Antonio, 155. Martelli, Vincenzo, 172. Martellozzo Forin, Edda, 199. Martina, eterodossa vicentina, 105, 192. Martinengo, Celso, 155, 199. Martirano, Bernardino, 63-65, 73, 16566. Martirano, Coriolano, 63, 65, 73, 165, 208. Marullo, Michele, 131. Marziale, ebreo converso, 77. Marzo, Enzo, XIV. Massario, Girolamo, 200. Matteo, evangelista, 32, 34, 54, 182, 196. Matteo d’Aversa, 54-55, 57-59, 83, 148, 151, 159-60, 162. Matteo francese, 46, 55, 161-62. Matteo sartor, 105, 194. Matteo strazzaruolo, 105, 193-94. Matthijs, Jan, 201. Maymon, Mosheh ben (Maimonide), 27. Mazzoleni, Jole, 172. Mazzuchelli (o Mazzucchelli), Giovanni Maria, 64, 166, 171. Mc Nair, Philip, 167. Medici, Giulio de’, vedi Clemente VII. Melanchton (Melantone, Philip Schwarzerd), 72. Menzato, Gaspare, 100, 186. Merenda, Apollonio, 13, 36, 65, 167. Mermier, Guy R., 209. Merola, Alberto, 172. Miccio, Scipione, 148-49. Miccoli, Giovanni, 177. Miele, Michele, 171. Milano, Attilio, 173. Millet, Olivier, 132-33, 208-209. Minadois, Germano, 26, 28, 36, 38, 153. Minadois, Giovan Tommaso, 152-53, 166. Minieri Riccio, Camillo, 65, 166, 169. Miñoz, Sigismondo, 152. Moleti, Giovanni, 176.
220
Molho, Anthony, XIV. Montaigne, Michel Eyquem de, 138. Montanaro, Matteo, 183, 194. Monter, William, 152. Montesinos, José F., 167, 203. Morato, Olimpia, 157. Moro, Giacomo, 167. Morone, Felice, 78, 174-75. Morone, Giovanni, 39, 51, 136, 159. Morra, Girolamo, 172. Morsolin, Bernardo, 87-88, 92, 112, 114, 180. Mosè, 30, 83, 109, 132, 178. Münster, Sebastian, 32. Müntzer, Thomas, 202. Muto, Giovanni, 163. Nardò, Francesco de’, 183. Nascimbeni, Nascimbene, 205. Naudé, Gabriel, 168. Nazareno, Matteo, 162. Negri, Francesco, 64, 89, 96, 116, 136, 201. Newton, Isaac, 168. Niccoli, Ottavia, 170. Nicodemo, 136, 210. Nicola da Trani, 191. Nieri, Andrea di, vedi Riera, Andrea. Nieto, José C., 146. Nifo, Agostino, 62, 64-65, 67, 74, 167. Nigro, Umberto, XIV. Noè, 33. Nosadin, Bernardino, 183. Ochino, Bernardino, XII, 5-6, 21, 42-43, 45, 71-73, 75, 81, 86, 89-90, 112, 11416, 122, 126, 134-35, 138, 142, 149, 157, 177, 203, 207, 209. Olivieri, Achille, 185. Oporinus, Johannes, 64, 165. Ordine, Nuccio, 163. Orsini, Camillo, 125, 136. Ossola, Carlo, 155, 160. Pagano, Antonio, 124, 205. Pagano, Sergio, 146. Pagello, Andrea, 189. Paleario, Aonio, 172.
Palingenio Stellato, Marcello, vedi Manzoli, Pier Angelo. Panormita (il), vedi Beccadelli, Antonio. Paolo III, papa, 69, 71. Paolo IV, papa, 5, 71-73, 148, 152, 156, 170. Paolo di Tarso, 7, 26, 56, 78, 109, 155, 162-63. Parenti, Giovanni, 164. Parisio, Giovan Paolo (Aulo Giano Parrasio), 62-64, 73, 132. Parisio, Pier Paolo, 72-73. Paruta, Niccolò, 86, 89-90, 114, 116, 180. Pascal, Arturo, 200. Paschini, Pio, 199. Pasini, famiglia, 104. Pasini, Alessandro, 104. Pasqualini, Pasqualino de’, 183, 193, 196-98. Pastore, Alessandro, 167, 195, 211. Pastore, Stefania, 146. Pauli, Sebastiano, 73. Paweł, Grzegorz, 118. Perin del fabro, 181, 183, 189-90, 19294, 196. Perin strazzaruol (forse Piero Secco), 193. Perini, Leandro, 165, 199-200. Perna, Pietro, 64, 165, 200. Persio Calabrese, 51, 160. Pertile, Lino, 167. Peruzzi, Enrico, 211. Pesente, Sebastiano, detto Pesarino, 102, 190. Peyronel Rambaldi, Susanna, 201, 203. Pico della Mirandola, Giovan Francesco, 129-30. Pietro, apostolo, 18. Pietro di Castiglia, 158. Piero di Marc’Antonio mareschalco, 198. Pighino, ecclesiastico calabrese, 162. Pighino el grasso, vedi Baroni, Pellegrino. Pignano, Girolamo, 162. Pilati, Renata, 164.
221
Pino, Giovan Battista, 166. Pintard, René, XI, 146. Pio V, papa, 158, 162. Pio da Carpi, Rodolfo, 158. Pirnát, Antal, 156, 173, 198-99, 203. Piron, Sylvain, XIV, 210. Pirrone di Elide, 129. Plath, Uwe, 199. Plinio il Vecchio, 141, 208. Poeti, Ruffino, 177. Poggiola, Lucrezia, 20. Pole, Reginald, IX, 39, 125, 136, 206. Pometti, Francesco, 166. Pommier, Edouard M., 149, 162, 181. Pomponazzi, Pietro, 33, 35, 66-67, 74, 167, 206. Pontano, Giovanni (Gioviano), 62, 67, 131, 141, 167. Ponte, Antonio dal, 105, 194. Pontieri (o Ponterio), Vincenzo, 132, 208. Pontormo, Iacopo, vedi Carucci da Pontormo, Iacopo. Popkin, Richard H., 207. Porta, Pietro Domenico Rosio de, 177, 197. Porzio, Simone, 67, 74-75, 167, 172. Postel, Guillaume, 178, 211. Pozzo, Ambrogio da, 16, 26, 44, 59-60, 83, 151, 157, 161-63, 176. Priore, Sebastiano, 183. Priuli, Alvise, 159. Proda (forse de Prado), Francisco, 8, 150. Prometeo, 69. Prosperi, Adriano, VII, 123-25, 145, 150, 158, 177, 198-99, 204-206. Prosperi, Valentina, 208. Quaglioni, Diego, 163. Quaglioni, Domenico, 199. Quattromani, Sertorio, 165, 208. Querno, Camillo, 63. Rabelais, François, 209. Raffaele da Roccaguglielma, 59-61, 76, 82-83, 162, 176, 178. Ragnoni, Lattanzio, 36, 155.
Raimondi, Ezio, 171. Raimundo, Lorenzo, 183. Raimundo, Vittore, 183. Rasi, Donatella, 171. Rasonier, Silvio, 31, 105-106, 111, 195. Ravaschieri, famiglia, 163. Razer, Gian Maria, 187-88. Rebiba, Scipione, 46, 152. Recco, Fabrizio, 163. Renalda, Francesco della, 192. Renata di Francia, vedi Valois d’Este, Renata. Renato, Camillo, vedi Ricci, Paolo. Renato, Francesco, vedi Francesco Calabrese. Ricart, Domingo, 156. Ricci, Francesco Maria, 168-69. Ricci, Paolo, alias Lisia Fileno, alias Camillo Renato, 96, 122, 177, 184, 203206. Ricuperati, Giuseppe, XIV, 203. Riera, Andrea, 51-52, 160-61. Rioli, Giorgio, alias Giorgio Siculo, 112, 122-26, 200, 205-206. Rocco da Taranto, 51, 159-60. Rodrigue, Aron, 173. Romano, Ruggiero, 177. Romeo, Giovanni, XIV, 152, 170. Romeo, Rosario, 208. Rosa, Mario, 166. Rositano, vedi Bartolomeo da Messina. Rosso, Gregorio, 148. Rota, Bernardino, 64-65. Rotondò, Antonio, 88, 115, 122, 153, 157, 179, 184, 198-99, 201, 204, 208. Rott, Jean-Georges, 201-202. Rovito, Pier Luigi, 148. Rozzo, Ugo, 195, 201, 209. Ruffini, Francesco, 112, 199-200. Ruiz de Alcaraz, Pedro, VII. Ruiz Sánchez, Brianda, 36-37, 49, 155. Russiliano Sesto, Tiberio, 67, 141, 168. Russo, Francesco, 173-76. Sabazio, Basilio, 141. Salvatore, eterodosso veneziano, 100, 149.
222
Salvio da Bagnoli, Ambrogio, 73-75, 171. Samuele, 56. Sánchez, Alonso, 155. Sand, Christopher, 86-87, 89-92, 115, 156, 180. Sandrini, Girolamo, 104. Sandrini, Giulio, 104, 191. Sannazaro, Iacopo, 62, 131, 166-67. Sanseverino, famiglia, 75. Sanseverino, Caterina, 17-18. Sanseverino, Ferrante, 14, 74-75, 151, 169, 172. Sanseverino, Pietrantonio, 17, 165. Santoro, Giulio Antonio, 152-53, 156, 160, 162, 164, 166, 170, 172. Sartori, Francesco, 111, 181-82, 184-85, 198. Sartori, Giovan Maria, 182. Sartori, Giuseppe, 102, 108, 111, 18183, 185, 189-90, 195-98, 205. Sauli da Passano, Caterina, 180. Sbarra, Andrea, 152. Scandella, Domenico, detto Menocchio, 30-31, 39, 126-28, 206-207. Scaramella, Pierroberto, 152-53, 163, 170. Scariti, Cristoforo, 174. Schipani, Leonardo, 165. Schneider, Gerhard, 146-47, 210. Schwenckfeld, Kaspar, 202. Scudieri, Francesco, 114, 199-200. Scullica, Teofilo, 71, 73, 170. Seidel Menchi, Silvana, 154, 162, 207208. Seripando, Girolamo, 63, 75, 164, 17172. Sernini, Nino, 72. Servet, Miguel (Serveto), XI-XII, 21, 39, 54, 113-14, 122, 126, 138-39, 142, 147, 150, 180-81, 199-200, 202, 206, 209. Sesto Empirico, 129. Severi, Francesco, 123, 139, 205. Silvio Vicentino (o da Vicenza), vedi Rasonier, Silvio. Simler, Iosias, 64, 149, 165. Simoncelli, Paolo, 203.
Simons, Menno, 89, 118. Sipayłło, Maria, 201. Siragusa, Danilo, XIV. Sirri, Raffaele, 165, 211. Solaro, Giuseppe, 208. Sozzini, Agnese, 87. Sozzini, Dario, 89. Sozzini, Fausto, 21, 87, 89, 118, 120, 138, 201. Sozzini, Lelio, XIII, 21, 60, 84, 86-87, 8991, 112, 114-16, 138, 153, 157, 179, 200, 204. Sozzini, Mariano, 89, 179. Spagnoletto (lo), vedi Francesco spadaro. Spampanato, Vincenzo, 163. Speranza, Girolamo, 101, 149, 188, 194, 196. Spiera, Francesco, 113, 199. Spinelli Giovan Battista, 44. Spini, Giorgio, 206. Spinola, Girolamo, 42-44, 163. Spiriti, Salvatore, 165. Squarcialupi, Marcello, 139. Stancaro, Francesco, 100, 188. Steinmann, Martin S., 165. Stella, Aldo, 76, 79, 84, 88, 109, 112, 114, 129, 175-77, 179-81, 184-86, 188, 190-91, 197, 207. Stigliola, Nicola Antonio, 142. Stoll, André, 162, 168, 211. Storch, Nikolaus, 202. Stübner, Markus, 202. Sultzbach, Johannes, 63-64, 165. Summonte, Pietro, 62, 165, 170. Szczucki, Lech, 156, 180, 201. Tabachin, Giovan Battista, 108, 191, 205. Tasso, Bernardo, 74, 171-72. Tasso, Torquato, 74, 171. Tealdo, Agostino, 197. Tedeschi, John, 170, 204. Telesio, Antonio, 63, 65, 132, 165. Telesio, Bernardino, 63, 141-42, 165. Tenenti, Alberto, 146. Tertulliano, Quinto Settimio Florenzio, 200.
223
Thérault, Suzanne, 165. Tiziano, ministro anabattista, 94-104, 106-10, 116, 119-21, 123, 181, 18386, 189-91, 195-97, 205. Tizzano, Lorenzo, alias Benedetto Florio, 6, 13, 15-25, 28-29, 33, 36-39, 42, 45-46, 51, 53, 55-59, 61, 68, 70-71, 76, 80, 82-83, 101-102, 149, 151-53, 15764, 176-78, 189. Tognetto strazzaruolo, 105, 193. Toledo de, vedi Álvarez de Toledo. Torricelli, Evangelista, 168. Torrini, Maurizio, 165, 211. Toscano, Tobia R., 166-67. Trechsel, Friedrich, 87, 180. Trevisan, Davide, 192, 195. Troeltsch, Ernst, 120, 294. Trotti, Alfonso, 150. Turchetto (il), vedi Filalete, Giorgio. Uberti, Cipriano, 203. Valdés, Alfonso de, VIII. Valdés, Juan de, VII-XII, 5-7, 13, 15, 1721, 23, 25-29, 32-36, 40-47, 54, 56, 65, 67, 72-73, 82, 93, 100, 110, 117, 119, 121, 125, 130, 132, 134, 136-37, 140, 146-49, 153-57, 159-60, 163, 167, 171, 178, 188, 197, 201, 209-10. Valeri, Elena, 166, 208. Valla, Lorenzo, 9, 32, 65-66, 130-31, 141, 207. Valle, Andrea de, 78, 174-75. Valletta, Francesco, 168. Valois d’Este, Renata, 13, 45, 124, 134, 199, 205. Vanini, Giulio Cesare, 30. van Veen, Mirjam, 132, 147, 202, 208209. Vasoli, Cesare, 168. Venere, 70.
Venturi, Franco, 207. Vergerio, Pier Paolo, 33, 100, 113, 136, 188. Verheus, Simon L., 201-202. Vermigli, Pier Martire, 5, 42, 65, 71-72, 134, 167. Villafranca, Juan de, XI, 18-21, 23-25, 28-29, 32-37, 40-50, 52-57, 59-60, 62, 66, 72, 76, 79-80, 82-83, 97, 102, 107108, 110, 117-18, 121, 123, 125, 130, 132, 137-38, 156-57, 159, 161, 163, 176, 190. Villafranca, marchese di, vedi Álvarez de Toledo, Pedro. Villamarina, Marcantonio, 16, 20, 25, 36, 43, 50-51, 59-60, 62, 84, 158-59, 161-62, 176, 179. Villamarina de Cardona Sanseverino, Isabella, 74-75, 159, 164, 171. Villari, Rosario, XIV, 148, 208-209, 211. Viret, Pierre, 134, 209. Virgilio Marone, Publio, 166. Visceglia, Maria Antonietta, 164. Vitaliano, Mario, 154. Vivanti, Corrado, 177. Waite, Gary K., 202. Wilbur, Earl Morse, 204. Williams, George Huntston, 201-204. Wirth, Jean, 132, 146-47. Wiszowaty, Andrzej, 86-87, 89-92, 180. Wootton, David, 154. Zampiero fornaro, 105. Zille, Ester, 197. Zingalo, vedi Cingano, Giuseppe. Zuanantonio favro, 198. Zuan Maria munaro, 184, 195. Zuan salcizaro, 195. Zucchini, Giampaolo, 201. Zwingli, Huldreich, 29, 89, 202.
Indice del volume
Introduzione Eresia radicale, valdesianesimo, «libertinage» I.
«Di consequentia in consequentia». Approdi radicali del valdesianesimo
VII
3
1. La diffusione dell’eresia nel Regno di Napoli, p. 3 - 2. Giovanni Laureto, p. 7 - 3. Lorenzo Tizzano «alias» Benedetto Florio, p. 16 - 4. Giulio Basalù, p. 25
II. Protagonisti, livelli e intrecci di un movimento ereticale
41
1. Il «tempo di Villafranca spagnolo», p. 41 - 2. Eresia radicale ed epicureismo: Scipione Capece da Dio alla natura, p. 61 - 3. Mutamenti marrani: Girolamo Busale e Francesco Renato, p. 76
III. Anabattismo e antitrinitarismo
86
1. Tradizione e storia, p. 86 - 2. Nuova luce sui «collegia vicentina» (e «patavina»), p. 95 - 3. La setta e il movimento: due tendenze del radicalismo europeo, p. 116
Conclusioni Eretici e libertini
129
Note
145
Indice dei nomi
213 225